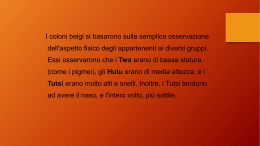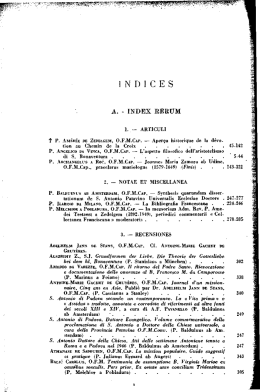Abilità di base e PARLARE SCRIVERE in vista dell’ESAME PREPARAZIONE ALL’ESAME ORALE: IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 1 La guerra del Vietnam p. 1 2 La guerra fredda (Elisa, a.s. 2008-2009) p. 4 3 Il conflitto arabo-israeliano p. 32 4 I conflitti in Africa p. 49 5 La nostra società multietnica, tra accoglienza e razzismo p. 66 6 L’uomo e la natura: il dovere di vivere in armonia p. 69 preparazione all’esame orale: il colloquio pluridisciplinare Laboratorio 3 4. Parlare e scrivere Guida all’esame 1 La guerra del Vietnam p. 147 Musica Woodstock, canzoni contro la guerra del Vietnam Infuria la guerra in Vietnam e nel 1968 inizia la contestazione giovanile: prima negli USA, poi in Francia, quindi nel resto dell’Europa. Il movimento di protesta contro la guerra si diffonde rapidamente negli Stati Uniti e nel mondo. Nelle città europee si moltiplicano le manifestazioni anche attraverso i testi delle canzoni di alcuni interpreti della musica di quegli anni. All’apice della diffusione della cultura hippy e del movimento pacifista, che voleva riunire in una tre giorni di «peace and music» tutti coloro che in misura diversa si richiamavano ai suoi principi, venne ideato e organizzato il festival di Woodstock, tra il 15 e il 18 agosto del 1969 nello stato di New York, in un paese chiamato Bethel. Woodstock era stato pensato come un festival di provincia, ma accolse inaspettatamente più di 400 000 giovani. Si alternarono sul palco ben 32 musicisti e gruppi, fra i più famosi del momento: fu per questo che la manifestazione ebbe una grande valenza simbolica e, nello stesso tempo, rappresentò un grande evento nella storia del rock. Gli artisti che si esibirono sul palco furono, nell’ordine, i seguenti: Richie Havens n Country Joe McDonald n John Sebastian n Sweetwater n The Incredible String Band n Bert Sommer n Tim Hardin n Ravi Shankar n Melanie n Arlo Guthrie n Joan Baez n Keef Hartley Band n Santana n Canned Heat n Mountain n Janis Joplin & The Kozmic Blues Band n Sly & The Family Stone n Grateful Dead n Creedence Clearwater Revival n The Who n Jefferson Airplane n The Grease Band n Joe Cocker n Country Joe & The Fish n Ten Years After n The Band n Blood, Sweat & Tears n Johnny Winter n Crosby, Stills, Nash & Young n Paul Butterfield Blues Band n Sha-Na-Na n Jimi Hendrix E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c o n e s p a n s i o n i ONLIN E 1 Joan Baez Soprannominata l’usignolo di Woodstock dopo la sua celebre esibizione al festival, Joan Baez è una cantante folk statunitense, nata a New York nel 1941 e da sempre impegnata per la difesa dei diritti civili e nella lotta contro la guerra. Pacifista convinta, la Baez si schierò contro l’intervento militare americano in Vietnam fin dal 1964. Dall’esperienza del 1972, quando trascorse il periodo natalizio in una Hanoi (dal 1954 al 1976 la capitale del Vietnam del Nord) distrutta dai bombardamenti, nacque l’album Where are you now, my son? Fra i suoi brani più celebri ricordiamo: Diamonds & Rust, There But for Fortune, The Night They Drove Old Dixie Down, We Shall Overcome, Love Is Just a Four-Letter Word, Farewell Angelina, Sweet Sir Galahad, Joe Hill. In Italia ebbe molto successo la sua interpretazione del brano di Gianni Morandi, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. We Shall Overcome We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome some day. Oh, deep in my heart, I do believe, we shall overcome some day. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace some day. Oh, deep in my heart, I do believe, we shall overcome some day. We’ll walk hand in hand, we’ll walk hand in hand, we’ll walk hand in hand some day. Oh, deep in my heart, I do believe, we shall overcome some day. Black and white together, black and white together, black and white together some day. Oh, deep in my heart, I do believe, we shall overcome some day. Noi trionferemo Noi trionferemo, noi trionferemo, noi trionferemo un giorno. Oh, in fondo al cuore ci credo, noi trionferemo un giorno. Noi vivremo in pace, noi vivremo in pace, noi vivremo in pace un giorno. Oh, in fondo al cuore ci credo, noi trionferemo un giorno. Noi cammineremo mano nella mano, noi cammineremo mano nella mano, noi cammineremo mano nella mano un giorno. Oh, in fondo al cuore ci credo, noi trionferemo un giorno. Neri e bianchi insieme, neri e bianchi insieme, neri e bianchi insieme un giorno. Oh, in fondo al cuore ci credo, noi trionferemo un giorno. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 22 C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d’America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne se cantava Help e Ticket to ride o Lady Jane o Yesterday. Cantava Viva la libertà ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò fu richiamato in America. Stop! Coi Rolling Stones! Stop! Coi Beatles stop! Gli han detto vai nel Vietnam e spara ai Vietcong… C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota ratatata. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù: nel suo paese non tornerà adesso è morto nel Vietnam. Stop! Coi Rolling Stones! Stop! Coi Beatles stop! Nel petto un cuore più non ha ma due medaglie o tre… E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 33 2 La guerra fredda Elisa, a.s. 2008-2009 p. 148 Storia / Cittadinanza e Costituzione Gli anni Sessanta: la guerra fredda e la crisi di Cuba del 1962 La guerra fredda è un conflitto che a partire dalla seconda metà del 1945 vide come protagonisti gli Stati Uniti d’America e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, paesi usciti dalla Seconda guerra mondiale come le due uniche superpotenze. Senza mai sfociare in uno scontro effettivo combattuto con le armi, grazie al potere deterrente del vastissimo arsenale nucleare posseduto da entrambe le nazioni contrapposte, il conflitto si risolse in uno stato di continua tensione politico-economica e diplomatica tra gli stati che costituivano i blocchi formatisi attorno a USA e URSS, nonché in una serie di guerre locali combattute soprattutto nel Terzo Mondo. La durezza del confronto tra i due giganti ebbe origine in primo luogo nell’inconciliabilità delle ideologie poste alla base del sistema statunitense e di quello sovietico (capitalista l’uno, comunista l’altro), che ispiravano quindi interessi geopolitici opposti. Il carattere di bipolarità prodottosi nello scenario mondiale semplificò d’altra parte il quadro internazionale, congelando molte delle dinamiche di scontro che avevano caratterizzato il precedente sistema, dominato da più potenze, con l’esito paradossale di garantire il più lungo periodo di pace nella storia dell’Europa contemporanea. Il successo del comunismo in Russia nel 1917 (durante la Rivoluzione d’ottobre) e la formazione dell’Unione Sovietica furono visti con forte sospetto dalle principali nazioni occidentali (Stati Uniti inclusi) e dal Giappone, che intervennero nelle vicende successive del paese sostenendo le Armate bianche controrivoluzionarie in lotta contro i bolscevichi, sino a tutto il 1922. L’Unione Sovietica venne isolata diplomaticamente fino alla Seconda guerra mondiale, quando anch’essa entrò a far parte del fronte costituitosi contro le potenze dell’Asse. La liberazione dell’Europa orientale dalle forze nazifasciste attuata dalle armate di Stalin determinò l’inclusione di quella Il blocco occidentale Il blocco comunista E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 44 regione nella sfera d’influenza sovietica, alterando profondamente l’equilibrio politico internazionale prebellico. Dopo una fase iniziale di indecisione, il presidente americano Harry Truman adottò una linea politica decisa nei confronti di Stalin, rivedendo molte delle posizioni concilianti assunte su diversi temi dal suo predecessore, Franklin Delano Roosevelt, al fine di prolungare oltre la fine delle ostilità l’alleanza con URSS e Gran Bretagna. La crescente diffidenza reciproca caratterizzò quindi le relazioni tra le due superpotenze. Mentre nuovi motivi di tensione sorgevano in seguito ai tentativi sovietici di estendere la propria influenza in Iran e in Turchia, un discorso tenuto da Stalin nel febbraio del 1946, che confermava l’inconciliabilità tra i sistemi comunista e capitalista, sciolse gli ultimi dubbi statunitensi circa le reali possibilità di cooperazione con gli ex alleati. Enunciando nel marzo del 1947 la dottrina Truman in difesa dei diritti di libertà e autonomia dei popoli, il presidente degli Stati Uniti inaugurò la politica di contenimento del «pericolo sovietico», inviando aiuti economici e militari a quelle nazioni (come la Grecia e la Turchia, le prime a beneficiare degli aiuti) che per la loro instabilità interna erano particolarmente esposte alla propaganda comunista e alle mire espansionistiche di Mosca. Fu in questo contesto di confronto a tutto campo che il giornalista Walter Lippmann coniò il termine «guerra fredda», che entrò subito nell’uso comune. Venne definita «guerra fredda» anche in contrapposizione alla «guerra calda» di cui l’umanità conserva ancora un tragico ricordo. Sul fronte interno delle nazioni occidentali, un tratto caratteristico della guerra fredda fu l’insieme di provvedimenti (molto diversi per estensione e radicalità) adottati per controllare l’attività di partiti, movimenti o semplici simpatizzanti comunisti; negli Stati Uniti la sindrome del «pericolo rosso», particolarmente acuta negli anni Cinquanta, trovò esemplare manifestazione nelle campagne di denuncia del senatore Joseph McCarthy. Molto più efficace fu invece l’iniziativa lanciata dal governo statunitense nell’estate del 1948: un piano quadriennale di aiuti economici per oltre tredici miliardi di dollari destinati alla ricostruzione dell’economia e del sistema produttivo dell’Europa occidentale (il cosiddetto piano Marshall), compresa la Germania Ovest. Con la creazione della NATO (1949), il sistema integrato di difesa militare della regione euro-atlantica, che coordinava le forze armate delle principali nazioni europee, degli Stati Uniti e del Canada, si tentò di garantire la difesa collettiva nell’eventualità di un attacco dell’URSS e dei suoi alleati. Estensione e portata della guerra fredda crebbero peraltro nello stesso 1949 a seguito dell’esplosione della prima bomba atomica sovietica (che, ponendo fine al monopolio atomico statunitense, diede il via a una continua corsa al riarmo) e del successo in Cina della Rivoluzione comunista guidata da Mao Zedong. La corsa agli armamenti porterà gli Americani a sperimentare nel 1952 un nuovo ordigno nucleare: la bomba H, detta anche bomba termonucleare o bomba all’idrogeno, dotata di una capacità distruttiva cento volte superiore a quella atomica esplosa in Giappone. Un anno dopo, anche l’URSS raggiungeva lo stesso risultato. L’immediata alleanza di Mao Zedong con Stalin fece rientrare anche l’Estremo Oriente nella scena dello scontro bipolare. Proprio in quest’area si verificò infatti la crisi più pericolosa del conflitto, quando il regime comunista della Corea del Nord invase la Corea del Sud nell’estate del 1950, dando inizio alla guerra di Corea. Sotto gli auspici delle Nazioni Unite, ma con l’effettiva leadership statunitense, una forza d’intervento internazionale frenò l’avanzata nordcoreana ristabilendo il precedente status quo nella penisola a prezzo di un sanguinoso conflitto protrattosi per tre anni. La crisi coreana inasprì la guerra fredda: le due superpotenze intensificarono la corsa agli armamenti in un diffuso clima di sospetto. Il governo americano, nonostante le tradizioni democratiche, scatenò una campagna contro l’opposizione agitando il rischio del comunismo. Iniziò così una persecuzione contro chiunque mostrasse simpatie politiche di sinistra nota come «caccia alle streghe», in quanto creò un clima non lontano da quello che nel Medioevo aveva portato al rogo migliaia di donne sospettate di stregoneria. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 55 Intanto negli Stati Uniti cresceva l’espansione economica e si imponeva la società dei consumi. Ricchezza e benessere, tuttavia, non erano equamente distribuiti; anzi, si accentuarono le disuguaglianze sociali a danno dei ceti più poveri, come le minoranze etniche. Particolarmente dura era la condizione dei neri, che rappresentavano il 10% della popolazione. Le loro condizioni erano molto inferiori rispetto a quelle dei bianchi e vennero denunciate, a metà degli anni Cinquanta, da movimenti organizzati, che rivendicavano una parità dei diritti. Il «Movimento per i diritti civili dei Neri» era guidato dal pastore protestante Martin Luther King, che si ispirava alla lotta non violenta di Gandhi. Nel 1960 fu eletto presidente degli Stati Uniti il democratico John Fitzgerald Kennedy, i cui principali obiettivi erano la distensione nei rapporti con l’URSS e i diritti civili per gli afroamericani nell’eliminazione delle discriminazioni razziali a favore della pace. Alla morte di Stalin nel 1953 seguì un periodo di rallentamento della tensione, durante il quale il quadro generale sembrò stabilizzarsi, soprattutto dal 1955, da quando Nikita Krusciov divenne capo dell’URSS e denunciò la tendenza autoritaria e dittatoriale di Stalin. Nel 1955, mentre la Germania federale entrava a far parte della NATO e le nazioni del Blocco orientale opponevano a quest’ultima il patto di Varsavia, si formava un terzo blocco, quello dei paesi non allineati (per la maggior parte appartenenti al cosiddetto Terzo Mondo), deciso a non accettare che lo scontro tra USA e URSS condizionasse tutto il pianeta. Una nuova fase di tensione riprese sul finire degli anni Cinquanta a causa della costruzione, da parte di entrambi gli schieramenti, di missili balistici atomici intercontinentali: il muro di Berlino, eretto nel 1961, divenne il simbolo della guerra fredda. Esso impediva la fuga dei cittadini di Berlino Est verso la Germania occidentale. Nel 1962 sembrò essere imminente una guerra nucleare, quando l’URSS installò a Cuba, sua alleata, alcuni missili in grado di raggiungere il territorio statunitense. Il mondo fu sull’orlo della catastrofe: solo il senso di responsabilità di Kennedy e la prudenza di Krusciov salvarono in quel momento l’umanità. Un contributo decisivo alla risoluzione della crisi di Cuba venne anche dagli appelli di papa Giovanni XXIII, successore di Pio XII, che si propose la salvaguardia della pace e l’elevazione del tenore di vita delle popolazioni più povere. Egli si rivolse direttamente a Kennedy e a Krusciov, svolgendo una preziosa opera di mediazione che facilitò l’esito positivo della vicenda di Cuba. Questi, nel 1963, firmarono un trattato per mettere al bando gli esperimenti nucleari. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 66 Pochi mesi dopo la firma del trattato, Kennedy fu assassinato a Dallas (novembre 1963) e Giovanni XXIII moriva per cause naturali, mentre Krusciov veniva destituito dalla sua carica (ottobre 1964). L’esito della crisi cubana dimostrò la possibilità di passare da uno scontro frontale, teso all’eliminazione dell’avversario, a una «coesistenza competitiva» tra le due superpotenze, le quali d’altra parte stavano assistendo a un progressivo ridimensionamento della rispettiva egemonia: Mosca dovette subire la rottura dell’alleanza con la Cina di Mao e affrontare la rivolta della Cecoslovacchia (Primavera di Praga), chiaro segno del malessere presente oltrecortina; dal canto loro gli Stati Uniti conobbero una pesante sconfitta nella guerra del Vietnam. In tale contesto il generale e politico francese Charles de Gaulle condannò l’intervento statunitense contro i comunisti in Vietnam (in questa chiave, nel 1966 ritirò la Francia dal comando militare integrato della NATO ed espulse tutte le basi statunitensi dal territorio francese, pur continuando a partecipare all’Alleanza atlantica). Con l’avvento degli anni Settanta veniva così inaugurata la politica della distensione, con i colloqui SALT (Negoziati per la limitazione degli armamenti strategici) intesi sia a rallentare l’ormai costosissima corsa al riarmo, introducendo forme di controllo degli armamenti, sia ad arginare il pericolo di guerre nel Terzo Mondo. Il processo di distensione subì un brusco colpo d’arresto con l’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1979 (guerra dell’Afghanistan) e l’imposizione della legge marziale in Polonia nel 1981 per stroncare i moti di protesta guidati dal movimento democratico di Solidarność; il governo statunitense decise dapprima di non ratificare il trattato SALT II, quindi, sotto la presidenza di Ronald Reagan, di rilanciare drasticamente la competizione nucleare, dando seguito al costosissimo progetto dello scudo di difesa spaziale, nonché di incrementare il sostegno ai movimenti di resistenza ai regimi comunisti in America latina, Asia e Africa. Nel 1985 Michail Gorbaciov, esponente di punta di una nuova generazione di leader politici, giunse al potere in Unione Sovietica; lanciando le parole d’ordine glasnost, che significa «trasparenza», e perestrojka, che significa «ristrutturazione», il presidente si accinse a riformare radicalmente il sistema sovietico per porre fine alla lunga contesa con l’Occidente, i cui costi erano divenuti per Mosca ormai insostenibili. Conseguenza diretta di ciò fu il crollo delle tensioni tra Est e Ovest (sancito dalla sottoscrizione di nuovi accordi sul disarmo nucleare e convenzionale), e all’interno del Blocco Orientale il ridimensionamento dell’egemonia sovietica. La caduta del muro di Berlino nel novembre del 1989 e il successivo sfaldarsi dell’intero blocco comunista, la riunificazione delle due Germanie nel 1990, il collasso e la disgregazione dell’URSS nel 1991 furono le principali tappe che posero fine alla guerra fredda. Sembrarono maturati i tempi per l’instaurarsi di un nuovo «ordine mondiale», ma questa prospettiva venne immediatamente smentita dal sopraggiungere di crisi come la guerra del Golfo o il conflitto in Iugoslavia, che hanno allungato molte ombre sulla futura fiMichail Gorbaciov e Ronald Reagan sionomia del quadro internazionale. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 77 Lingua straniera Inglese John Fitzgerald Kennedy John Fitzgerald «Jack» Kennedy (May 29, 1917 – November 22, 1963), often referred to by his initials JFK, was the 35th President of the United States, serving from 1961 until his assassination in 1963. On November 22, 1963, when he was hardly past his first thousand days in office, Kennedy was killed by an assassin’s bullet as his motorcade went through Dallas, Texas. He was the youngest man elected President and the youngest to die. His Inaugural Address offered the memorable injunction: «Ask not what your country can do for you: ask what you can do for your country». His economic programs launched the country on its longest sustained expansion since World War II; before his death, he laid plans for a massive assault on persisting pockets of privation and poverty. Responding to ever more urgent demands, he took vigorous action in the cause of equal rights, calling for new civil rights legislation. His vision of America extended to the quality of the national culture and the central role of the arts in a vital society. His administration saw the beginning of new hope for both the equal rights of Americans and the peace of the world. 88 Martin Luther King Martin Luther King, Jr., (January 15, 1929 – April 4, 1968) was born Michael Luther King, Jr., but later had his name changed to Martin. He was the leader of the African-American civil rights movement. King took his ideals from Gandhi. He encouraged African Americans to protest without the need of violence. He soon became world famous when he told his supporters, and the people who were against equal rights, that only peaceful ways should be used to solve the problem. In 1964 black people finally were allowed to vote in elections. In the eleven-year period between 1957 and 1968, King traveled over six million miles and spoke over twenty-five hundred times, appearing wherever there was injustice, protest, and action; and meanwhile he wrote five books as well as numerous articles. In 1964, King became the youngest person to receive the Nobel Peace Prize for his work to end racial segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent means. By the time of his death in 1968, he had refocused his efforts on ending poverty and opposing the Vietnam War, both from a religious perspective. On the evening of April 4, 1968, while standing on the balcony of his motel room in Memphis, Tennessee, where he was to lead a protest march in sympathy with striking garbage workers of that city, he was assassinated. In 1963 King delivered his I have a dream speech. There, he raised public consciousness of the civil rights movement and established himself as one of the greatest orators in U.S. history. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE I have a dream I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. So we have come here today to dramatize a shameful condition. In a sense we have come to our nation’s capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked «insufficient funds». We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. […] There will be neither rest nor tranquillity in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has en- E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 99 gulfed the Negro community must not lead us to distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. […] I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: «We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal». I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the colour of their skin but by the content of their character. […] I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day when all of God’s children will be able to sing with a new meaning: «My country, ’tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim’s pride, from every mountainside, let freedom ring». E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 10 10 And if America is to be a great nation this must become true. So let freedom ring from the mighty mountains of New York! Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania! Let freedom ring from the snowcapped Rockies of Colorado! Let freedom ring from the curvaceous slopes of California! Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia! Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee! Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi! From every mountainside, let freedom ring. And when this happens, when we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God’s children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual: «Free at last! Free at last! Thank God Almighty, we are free at last!». Io ho un sogno Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione per la libertà nella storia del nostro paese. Cento anni fa un grande americano, alla cui ombra ci leviamo oggi, firmò il Proclama sull’Emancipazione. Questo fondamentale decreto venne come un grande faro di speranza per milioni di schiavi negri che erano stati bruciati sul fuoco dell’avida ingiustizia. Venne come un’alba radiosa a porre termine alla lunga notte della cattività. Ma cento anni dopo, il negro ancora non è libero; cento anni dopo, la vita del negro è ancora purtroppo paralizzata dai ceppi della segregazione e dalle catene della discriminazione; cento anni dopo, il negro ancora vive su un’isola di povertà solitaria in un vasto oceano di prosperità materiale; cento anni dopo, il negro langue ancora ai margini della società americana e si trova esiliato nella sua stessa terra. Per questo siamo venuti qui, oggi, per rappresentare la nostra condizione vergognosa. In un certo senso siamo venuti alla capitale del paese per incassare un assegno. Quando gli architetti della repubblica scrissero le sublimi parole della Costituzione e la Dichiarazione d’Indipendenza, firmarono un «pagherò» del quale ogni americano sarebbe diventato erede. Questo «pagherò» permetteva che tutti gli uomini, sì, i negri tanto quanto i bianchi, avrebbero goduto dei principi inalienabili della vita, della libertà e del perseguimento della felicità. È ovvio, oggi, che l’America è venuta meno a questo «pagherò» per ciò che riguarda i suoi cittadini di colore. Invece di onorare questo suo sacro obbligo, l’America ha consegnato ai negri un assegno fasullo; un assegno che si trova compilato con la frase: «fondi insufficienti». Noi ci rifiutiamo di credere che i fondi siano insufficienti nei grandi caveau delle opportunità of- E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 11 11 ferte da questo paese. E quindi siamo venuti per incassare questo assegno, un assegno che ci darà, a presentazione, le ricchezze della libertà e della garanzia di giustizia. […] Non ci sarà in America né riposo né tranquillità fino a quando ai negri non saranno concessi i loro diritti di cittadini. I turbini della rivolta continueranno a scuotere le fondamenta della nostra nazione fino a quando non sarà sorto il giorno luminoso della giustizia. Ma c’è qualcosa che debbo dire alla mia gente che si trova qui sulla tiepida soglia che conduce al palazzo della giustizia. In questo nostro procedere verso la giusta meta non dobbiamo macchiarci di azioni ingiuste. Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete di libertà bevendo alla coppa dell’odio e del risentimento. Dovremo per sempre condurre la nostra lotta al piano alto della dignità e della disciplina. Non dovremo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica. Dovremo continuamente elevarci alle maestose vette di chi risponde alla forza fisica con la forza dell’anima. Questa meravigliosa nuova militanza che ha interessato la comunità negra non dovrà condurci a una mancanza di fiducia in tutta la comunità bianca, perché molti dei nostri fratelli bianchi, come prova la loro presenza qui oggi, sono giunti a capire che il loro destino è legato con il nostro destino, e sono giunti a capire che la loro libertà è inestricabilmente legata alla nostra libertà. Questa offesa che ci accomuna, e che si è fatta tempesta per le mura fortificate dell’ingiustizia, dovrà essere combattuta da un esercito di due razze. Non possiamo camminare da soli. […] Non ho dimenticato che alcuni di voi sono giunti qui dopo enormi prove e tribolazioni. Alcuni di voi sono venuti appena usciti dalle anguste celle di un carcere. Alcuni di voi sono venuti da zone in cui la domanda di libertà ci ha lasciato percossi dalle tempeste della persecuzione e intontiti dalle raffiche della brutalità della polizia. Siete voi i veterani della sofferenza creativa. Continuate a operare con la certezza che la sofferenza immeritata è redentrice. Ritornate nel Mississippi; ritornate in Alabama; ritornate nel South Carolina; ritornate in Georgia; ritornate in Louisiana; ritornate ai vostri quartieri e ai ghetti delle città del Nord, sapendo che in qualche modo questa situazione può cambiare, e cambierà. Non lasciamoci sprofondare nella valle della disperazione. E perciò, amici miei, vi dico che, anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno. È un sogno profondamente radicato nel sogno americano, che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni: noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono creati uguali. Io ho davanti a me un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 12 12 i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi, sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. Io ho davanti a me un sogno, che un giorno perfino lo stato del Mississippi, uno stato colmo dell’arroganza dell’ingiustizia, colmo dell’arroganza dell’oppressione, si trasformerà in un’oasi di libertà e giustizia. Io ho davanti a me un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere. Io ho davanti a me un sogno, che un giorno ogni valle sarà esaltata, ogni collina e ogni montagna saranno umiliate, i luoghi scabri saranno fatti piani e i luoghi tortuosi raddrizzati e la gloria del Signore si mostrerà e tutti gli essere viventi, insieme, la vedranno. È questa la nostra speranza. Questa è la fede con la quale io mi avvio verso il Sud. Con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza. Con questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti discordie della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza. Con questa fede saremo in grado di lavorare insieme, di pregare insieme, di lottare insieme, di andare insieme in carcere, di difendere insieme la libertà, sapendo che un giorno saremo liberi. Quello sarà il giorno in cui tutti i figli di Dio sapranno cantare con significati nuovi: «Paese mio, di te, dolce terra di libertà, di te io canto. Terra dove morirono i miei padri, terra orgoglio del pellegrino, da ogni pendice di montagna risuoni la libertà». E se l’America vuole essere una grande nazione possa questo accadere. Risuoni quindi la libertà dalle poderose montagne dello stato di New York! Risuoni la libertà negli alti Allegheny della Pennsylvania! Risuoni la libertà dalle Montagne Rocciose del Colorado, imbiancate di neve! Risuoni la libertà dai dolci pendii della California! Risuoni la libertà dalla Stone Mountain della Georgia! Risuoni la libertà dalla Lookout Mountain del Tennessee! Risuoni la libertà da ogni monte e monticello del Mississippi! Da ogni pendice risuoni la libertà! E quando lasciamo risuonare la libertà, quando le permettiamo di risuonare da ogni villaggio e da ogni borgo, da ogni stato e da ogni città, acceleriamo anche quel giorno in cui tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, cattolici e protestanti, sapranno unire le mani e cantare con le parole dell’antico canto: «Liberi finalmente! Liberi finalmente! Grazie Dio Onnipotente, siamo liberi finalmente!». E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 13 13 Francese Le Internet Dans les années 1970, pendant «la guerre froide» entre les Américains et les Soviétiques, la menace des missiles nucléaires est considérable. En cas de conflit, l’ennemi attaque d’abord les centres de communication pour empêcher toute défense. Pour éviter ce danger, l’armée américaine imagine un réseau de communication fonctionnant en toute situation, qui permettrait au gouvernement d’être en contact constant avec les militaires et les scientifiques. Le secret est dans son nom: «net», qui signifie en anglais «filet»; en effet le système est une sorte de toile d’araignée, le WWW, le «World Wide Web», qui couvre la planète. Très vite le système a rencontré la faveur des scientifiques et des étudiants; les «internautes», qui dialoguent d’un bout à l’autre de la planète, cherchent de la documentation ou des textes dans les bibliothèques ou créent des journaux électroniques. Les «netsurfers» sont à l’heure actuelle des millions et on n’arrive plus à les compter. Si on n’a pas d’ordinateur, on peut fréquenter les «cybercafés», où des dizaines d’ordinateurs sont à la disposition du public. Attention, pour «surfer» il faut taper correctement l’adresse du site qu’on veut visiter. Pour «surfer sur le Net», tu dois avoir un ordinateur avec un logiciel de communication et un modem, la petite boîte qui sert à relier l’ordinateur au réseau téléphonique. Pour entrer dans le réseau, tu dois t’abonner à un serveur, un ordinateur plus puissant qui fonctionne comme porte d’entrée du système. Ensuite, tu peux aller chercher n’importe où tes informations, ou participer à n’importe quel «forum» de discussion sur le clonage, l’astrologie ou… les boutons de roses, au prix d’un appel téléphonique local, même si tu es branché sur un ordinateur de la Californie ou de l’Australie. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 14 14 Geografia Cuba: caratteri geografici, economici e politici Il territorio Cuba è la più estesa isola dell’arcipelago delle Grandi Antille, tra l’Oceano Atlantico, il Mar delle Antille e il golfo del Messico. Esse comprendono anche altre 3 isole: Hispaniola, Giamaica e Puerto Rico. Cuba non è solamente un’isola, ma anche un arcipelago che comprende quasi 4200 isole e isolette dette cayos che circondano l’isola principale. È situata nella parte settentrionale del vasto arcipelago dei Caraibi ed è la sua isola più grande. A nord si trovano gli Stati Uniti, separati da Cuba dallo Stretto di Florida largo solo 180 km e l’Oceano Atlantico Settentrionale. A ovest si trova il Canale dello Yucatán che la separa dal continente centro-americano, a sud il Mar dei Caraibi e a est il Canale Sopravento che la separa da Haiti. La Repubblica occupa l’intera isola, e le varie isolette circostanti, come l’Isola della Gioventù (Isla de la Juventud), con l’eccezione della Baia di Guantànamo, una base navale che è stata data in «prestito» agli Stati Uniti nel 1903. Il litorale, prevalentemente basso e paludoso, è circondato da moltissime isole più piccole e isolotti corallini. Al territorio cubano appartengono più di 1600 isole minori, di origine corallina. Cuba è costituita in gran parte da un’ampia pianura calcarea. Le zone montuose, situate nel sud-est e nel centro, sono intervallate da ampie e fertili vallate. La costa è generalmente bassa. La barriera corallina, che si estende all’esterno dell’arcipelago di Camagüey, è, con i suoi 400 km di estensione, la seconda del mondo per importanza dopo quella australiana. Nello sviluppo della costa si trovano profonde e ampie insenature che costituiscono bacini portuali naturali di eccezionale valore e bellezza, sedi dei porti commerciali storici di Cuba come L’Avana, Santiago di Cuba e Cienfuegos. I fiumi sono caratterizzati da un corso assai breve, data la forma stretta e allungata dell’isola. Sono però ricchi d’acqua, anche se il loro regime è determinato dalle piogge: alcuni hanno tratti sotterranei a causa della formazione carsica del terreno. Il più lungo è il Rio Cauto (370 km) che, a differenza degli altri, scorre in senso longitudinale. Le sue sorgenti si trovano nella Sierra Maestra e sfocia nel golfo di Guacanayabo. Il Rio Toa forma numerose cascate e, essendo ricco di acqua, è sfruttato per la produzione di energia elettrica. Il clima è caldo umido, ma reso vivibile dall’influenza del mare. Solo tra agosto e ottobre si verificano situazioni di enorme disagio per la popolazione, a causa del passaggio, sull’arcipelago, di cicloni provenienti da sud-ovest. Le temperature sono comprese tra 20 °C e 30 °C e le precipitazioni sono abbondanti e di forte intensità nel periodo estivo. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 15 15 La flora La flora cubana è estremamente varia e suggestiva e conta oltre 8000 specie. La foresta pluviale è concentrata in alcuni tratti delle zone montagnose. Le pianure e le alture di modesta elevazione furono deforestate fin dai primi secoli della conquista spagnola per utilizzarne il prezioso legname, soprattutto mogano e tek, principalmente per la costruzione di navi. Oggi al loro posto, si estendono decine di migliaia di chilometri quadrati di colture. La canna da zucchero rappresenta sicuramente la coltura dominante e l’industria a essa collegata ha goduto negli ultimi anni di una grande modernizzazione, grazie a nuovi macchinari e fertilizzanti, aumentando così notevolmente i raccolti, stimati intorno a sette milioni di tonnellate l’anno. Un’altra produzione molto importante è quella del tabacco; non tanto per il ricavo ottenuto quanto per il prestigio ormai riconosciuto in tutto il mondo. In percentuale maggiore vengono coltivati anche agrumi, mais, caffè e agave, quest’ultima utilizzata per la fabbricazione di cordami. Il dolce paesaggio cubano è fortemente caratterizzato dalla presenza della palma reale, che svetta in piccoli e grandi gruppi o anche solitaria, in ogni angolo del paese; se ne contano oltre 70 milioni di esemplari. La palma reale è inserita nell’emblema nazionale di Cuba che ne rappresenta la repubblica. Con le sue foglie, particolarmente resistenti, si fabbricano da secoli i tetti delle case di campagna, cesti e cordami. Il fiore nazionale è la mariposa (farfalla in spagnolo), che deve il nome alla sua forma e ai colori che la rendono molto simile all’insetto. La fauna La fauna è varia e abbondante ed è priva di specie velenose, sia fra gli insetti che fra i rettili e i pesci. L’iguana, mostruosa ma innocua, è presente in molte zone dell’isola. Nelle aree paludose sono presenti il coccodrillo e il caimano, che possono raggiungere i 3 metri di lunghezza. Essendo specie a rischio di estinzione, il governo cubano ha costituito delle aree di protezione per questi grandi rettili. Le coste pullulano di uccelli marini, tra cui spiccano svariate specie di sterne, cormorani e pellicani; per i più fortunati è possibile ammirare anche degli splendidi colibrì. In genere è abbondante la presenza di uccelli. Famoso è il tocororo, una sorta di pappagallo che, con il suo elegante piumaggio bianco, rosso e azzurro, riproduce i colori della bandiera nazionale. Le acque cubane, in particolare vicino alla barriera corallina, offrono uno straordinario spettacolo di pesci multicolori di varie dimensioni come i pesci pappagallo, i pesci pagliaccio e i pesci angelo. Questo meraviglioso spettacolo è meta di decine di migliaia di turisti subacquei da tutto il mondo. L’economia L’economia cubana è trainata dall’agricoltura, che conserva tuttora una grande importanza. Zucchero e tabacco restano i prodotti principali, ma, grazie a terreni molto fertili, si sono diffuse anche le coltivazioni di riso, caffè, ananas, mais e patate. Discreti sono l’allevamento e la pesca. Le risorse del sottosuolo quali petrolio, nichel (di cui il paese è tra i maggiori produttori mondiali), cobalto e rame sono modeste. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 16 16 L’economia cubana venne colpita duramente nei primi anni Novanta a seguito del collasso dell’Unione Sovietica e del blocco economico del Comecon, con il quale commerciava di preferenza. L’embargo statunitense (chiamato bloqueo dai cubani), in vigore dai primi anni Sessanta, impedisce all’economia cubana di svilupparsi bloccando l’import-export da e verso gli USA. Nell’ottobre 2007 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato per la sedicesima volta una mozione (184 voti favorevoli, 3 assenti, 4 contrari e l’astensione della Micronesia) per chiedere agli Stati Uniti la cessazione dell’embargo. Problemi più recenti comprendono l’alto prezzo del petrolio, la recessione nei mercati chiave per l’esportazione come zucchero e nichel, i danni provocati dagli uragani, il turismo depresso e le instabili condizioni economiche mondiali. Tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004, sia i livelli del turismo che i prezzi del nichel sono aumentati, così come il commercio cubano con gli USA, a dispetto dell’embargo finanziario e commerciale. Forti legami commerciali sono stati intrapresi dal governo con il Venezuela del presidente Chávez, in un’ottica pan-iberoamericana. Un altro importante fattore nella ripresa dell’economia cubana sono le rimesse degli emigranti. Il passaggio dal governo di Fidel Castro al governo di Raul Castro ha portato alcune misure di parziale liberalizzazione. L’industria comprende fabbriche per la trasformazione dei prodotti agricoli e impianti per la raffinazione del petrolio, la cui produzione resta però insufficiente al fabbisogno interno. Nel terziario è in espansione il turismo. Durante gli anni Sessanta il governo cubano dovette tutelare i boschi per via del precedente disboscamento. Il governo attuò in tutta l’isola dei programmi di rimboschimento che riportarono le foreste a ricoprire il 27,7% del territorio; il legname prodotto è prevalentemente quello dei pini. L’industria della pesca è prevalentemente gestita da piccoli operatori o da cooperative; il governo ha incentivato lo sviluppo della pesca ottenendo un aumento del pescato annuo. All’inizio degli anni Sessanta lo stato nazionalizzò tutte le industrie straniere (soprattutto statunitensi) presenti nell’isola, il governo varò dei programmi di automazione dell’industria dello zucchero, vennero riorganizzate anche le industrie lattiero-casearie e l’allevamento. Nel paese sono presenti anche industrie tessili, industrie alimentari, l’industria del tabacco e della raffinazione del petrolio; minima è invece la produzione di cemento, birra, acciaio e fertilizzanti. L’energia elettrica del paese è per lo più generata da impianti alimentati a petrolio, a carbone o con scarti della canna da zucchero. Nelle vicinanze di Cienfuegos è in costruzione una centrale nucleare. Il turismo rappresenta una risorsa sempre crescente nell’economia del paese. Il tenore di vita, pur con le molte difficoltà presenti, è nel complesso migliore di molti paesi dell’area e i servizi sociali nel campo dell’istruzione e delle strutture sanitarie sono di buon livello. Nel settore primario è occupato il 22% della popolazione attiva, nel secondario il 16% e nel terziario il 62%. Popolazione e città La popolazione cubana si compone in maggioranza da bianchi discendenti dai coloni spagnoli (70%), mentre i mulatti e i neri sono delle consistenti minoranze (17,3% e 12,4%). Si nota facilmente che i neri sono meno numerosi qui che nelle altre Grandi Antille; questo fenomeno ha cause storiche, dato che fino alla fine del XIX secolo Cuba non è stata coltivata da parte dei colonialisti spagnoli, che utilizzavano l’isola come base militare e navale. Mancando l’agricoltura di piantagione non c’era chiaramente alcun bisogno di deportare in questo luogo manodopera nera in schiavitù. Lo spagnolo è la lingua ufficiale, ed è parlato, senza inflessioni dialettali di sorta, da E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 17 17 larghissima parte della popolazione, che lo assume dunque come elemento unificante della realtà nazionale. La popolazione urbana è in netta prevalenza (70%) ed è concentrata nella capitale L’Avana, anche se non nel modo esclusivo che caratterizza il resto del Terzo Mondo; a Cuba è stata infatti realizzata una rete di piccole città (tra i 50 000 e i 100 000 abitanti) che assorbe buona parte dei flussi migratori provenienti dalle aree rurali. Ciò ha impedito a Cuba di conoscere la profonda miseria delle periferie metropolitane. Negli ambiti dell’istruzione e dei servizi socio-sanitari, Cuba ha raggiunto livelli elevati, che la pongono ai primi posti tra i paesi in via di sviluppo. Oltre il 75% dei cubani vive nelle città. La capitale, come già detto, è L’Avana, città di oltre due milioni di abitanti con un antico quartiere coloniale, ricco di L’Avana splendidi edifici, dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Ma è anche una città moderna e vivace, sede di università e centro economico e politico del paese. Altri centri sono: Santiago de Cuba (la vecchia capitale dall’impronta barocco-coloniale e un attivo polo industriale oltre che grande porto sul Mar dei Carabi), Camagüey, Santa Clara e Guantànamo, dove gli USA mantengono una base militare, da tempo rivendicata da Cuba. La storia Cuba rimane una colonia spagnola fino al 1898, anno in cui, a seguito della guerra tra Spagna e Stati Uniti, passa sotto il dominio di questi ultimi. Pur favorendo nel 1902 la nascita di una Repubblica cubana autonoma, gli USA mantengono il controllo economico dell’isola e il diritto di intervenire nella sua politica. La rivoluzione che nel 1959 rovescia la dittatura del generale Batista pone fine a questo stato di cose. I capi della rivoluzione sono Fidel Castro ed Ernesto Guevara (detto Che). Il presidente Castro crea una Repubblica popolare ispirata al modello sovietico, in contrasto con la politica dell’USA. Con l’appoggio dell’Unione Sovietica, ha inizio un periodo di nazionalizzazione delle attività economiche, prima in mano a società straniere. Questa è l’occasione per l’URSS di acquistare una base economica e politica proiettata verso l’Ame- Che Guevara e Fidel Castro rica Latina, nonché un punto di osservazione militare delle iniziative statunitensi.Tale situazione conduce sull’orlo di gravi crisi internazionali. La caduta del regime comunista in Unione Sovietica, e quindi la perdita del suo sostegno, determina una pesante crisi economica, aggravata dall’embargo sulle merci da parte degli USA. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 18 18 La bandiera cubana La bandiera di Cuba venne adottata ufficialmente il 20 maggio del 1902. Il suo disegno si dice sia stato ispirato dalla bandiera statunitense; il medesimo disegno, con colori invertiti, è stato adottato anche dalla bandiera di Porto Rico. Risale al 1850 la prima apparizione del vessillo, che combina tre colori: rosso, bianco e blu. Le tre strisce blu rappresentavano gli stati in cui era suddivisa Cuba all’epoca; le due strisce bianche simboleggiano la forza del combattente idealista, mentre il triangolo di colore rosso ricordava il sangue versato in una guerra per l’indipendenza; la stella bianca, solitaria, è il simbolo dell’assoluta libertà rispetto alle altre nazioni. Arte e immagine La Pop Art (1962) Pop Art è il nome di una corrente artistica della seconda metà del XX secolo, nata precisamente nel 1962, anno della crisi cubana. La Pop Art è una delle più importanti correnti artistiche del dopoguerra. Discende direttamente dal graffiante cinismo della Nuova Oggettività e dalla semplicità equilibrata del Neoplasticismo, del Dadaismo e del Suprematismo. Esordisce in Gran Bretagna alla fine degli anni Cinquanta, ma si sviluppa soprattutto negli USA a partire dagli anni Sessanta, estendendo la sua influenza in tutto il mondo occidentale. Questa nuova forma d’arte popolare (pop è infatti l’abbreviazione dell’inglese popular, «popolare») è in netta contrapposizione con l’eccessivo intellettualismo dell’Espressionismo Astratto e rivolge la propria attenzione agli oggetti, ai miti e ai linguaggi della società dei consumi. L’appellativo «popolare» deve essere inteso però in modo corretto. Non come arte del popolo o per il popolo ma, più puntualmente, come arte di massa, cioè prodotta in serie. E poiché la massa non ha volto, l’arte che la esprime deve Hannah Höch, Cut with the Kitchen Knife throuessere il più possibile anonima: solo così potrà essere com- gh the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in presa e accettata dal maggior numero possibile di persone. Germany, 1919-20 In un mondo dominato dal consumo, la Pop Art respinge l’espressione dell’interiorità e dell’istintività e guarda, invece, al mondo esterno, al complesso di stimoli visivi che circondano l’uomo contemporaneo: il cosiddetto «folclore urbano». È infatti un’arte aperta alle forme più popolari di comunicazione: i fumetti, la pubblicità, i quadri riprodotti in serie. Il fatto di voler mettere sulla tela o in scultura oggetti quotidiani eleE s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 19 19 vandoli a manifestazione artistica si può idealmente collegare al movimento svizzero Dada, ma completamente spogliato da quella carica anarchica e provocatoria. La critica alla società dei consumi, degli hamburger, delle auto, dei fumetti si trasforma presto in merce, in oggetto che si pone sul mercato (dell’arte) completamente calato nella logica mercantile. Ciò nonostante gli artisti che hanno fatto parte di questo movimento hanno avuto un ruolo rivoluzionario introducendo nella loro produzione l’uso di strumenti e mezzi non tradizionali della pittura, come il collage, la fotografia, il cinema, il video. La sfrontata mercificazione dell’uomo moderno, l’ossessivo martellamento pubblicitario, il consumismo eletto a sistema Keith Haring, Untitled, 1967 di vita, il fumetto quale unico, residuo veicolo di comunicazione scritta, sono i fenomeni dai quali gli artisti pop attingono le loro motivazioni. In altre parole, la Pop Art attinge i propri soggetti dall’universo del quotidiano, in specie della società americana, e fonda la propria comprensibilità sul fatto che quei soggetti sono per tutti assolutamente noti e riconoscibili. Con sfumature diverse, gli artisti riprendono le immagini dei mezzi di comunicazione di massa, del mondo del cinema e dell’intrattenimento, della pubblicità. La Pop Art infatti usa il medesimo linguaggio della pubblicità e risulta dunque perfettamente omogenea alla società dei consumi che l’ha prodotta. L’artista, di conseguenza, non trova più spazio per alcuna esperienza soggettiva e ciò lo configura quale puro manipolatore di immagini, oggetti e simboli già fabbricati a scopo industriale, pubblicitario o economico. Questi oggetti, Andy Warhol, Marilyn, 1967 riprodotti attraverso la scultura e la pittura, sono completamente spersonalizzati. Nelle mani di un artista pop le immagini della strada si trasformano nelle immagini «ben fatte» dell’arte colta. I temi raffigurati sono estremamente vari: prodotti di largo consumo, oggetti di uso comune, personaggi del cinema e della televisione, immagini dei cartelloni pubblicitari, insegne, foto di giornali. A partire dagli anni Novanta del XX secolo si è avuta una revitalizzazione di questa tendenza artistica, che va sotto il nome di NeoPop. Roy Lichtenstein, In the Car, 1963 E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 20 20 Tecnologia e Informatica La fusione nucleare della bomba all’idrogeno (o bomba H) La fusione nucleare consiste nel fondere due nuclei leggeri per formarne uno pesante. Il processo è analogo a quello che avviene nel Sole e nelle stelle e potrebbe essere prodotto artificialmente anche sulla Terra. Oltre alla formazione di nuovi elementi, la fusione nucleare comporta la formazione di una grandissima quantità di energia. Per poter fondere due nuclei bisogna avvicinarli vincendo la forza di repulsione che esiste tra i protoni. Per far sì che la fusione avvenga, sono necessarie temperature elevatissime, che ancora oggi è quasi impossibile raggiungere. Dalla fusione nucleare si ottiene un’enorme quantità di energia, dovuta al difetto di massa: una volta che i due atomi si fondono, la loro massa non è pari alla somma delle masse dei due nuclei, ma minore. La differenza tra la somma delle masse di partenza e la massa finale si è convertita in energia seguendo la legge di Einstein, la quale afferma che l’energia prodotta è uguale alla massa per il quadrato della costante c (velocità della luce: 300 000 km/s). Gli elementi più idonei per la fusione sono gli isotopi dell’idrogeno (deuterio e trizio), che dalla loro fusione formano un atomo di elio e un neutrone libero. L’importanza della fusione non consiste solo nell’energia prodotta che risulta essere maggiore di quella della fissione nucleare, ma consiste nel fatto che è un’energia pura, ovvero i prodotti della fusione non sono radioattivi come quelli della fissione, inoltre l’idrogeno è un elemento che sul nostro pianeta si può trovare facilmente e con i minimi costi (si pensi al mare che ne è pieno). La prima teoria sulla fusione nucleare fu fatta dal fisico Hans Bethe nel 1938 in base allo studio del Sole. Infatti per spiegare gli elementi chimici prodotti all’interno del Sole c’era un unico modo ed era quello della fusione tra protoni e nuclei. Per questa sua teoria vinse il Nobel nel 1967, e nel 1983 ci fu un altro Nobel in questo campo per l’astrofisico americano William Fowler che approfondì lo studio delle reazioni nucleari nelle stelle. La prima produzione di energia da fusione nucleare, invece, risale al 9 novembre 1991 in Gran Bretagna dove il reattore a fusione sperimentale europeo (Jet) produsse, per la prima volta, energia da fusione nucleare. Questa fu la prima fusione controllata della storia (la seconda avvenne dopo due anni dal reattore americano del tipo Tokamak); in passato infatti la fusione era raggiungibile solo in maniera non controllata nelle bombe H (chiamate bombe a idrogeno o termonucleari). E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 21 21 La Bomba H La bomba all’idrogeno o bomba H (più propriamente bomba a fusione termonucleare incontrollata, in gergo «la superbomba») è una bomba a fissione-fusione-fissione in cui una normale bomba atomica, che serve da innesco, viene posta all’interno di un contenitore di materiale fissile insieme a degli atomi leggeri. Quando la bomba atomica (bomba A) esplode, innesca la fusione termonucleare dei nuclei degli atomi leggeri; questo processo provoca a sua volta la fissione nucleare del materiale che la circonda. In questo tipo di bomba dunque l’energia liberata deriva oltre che dalla fissione nucleare anche dalla fusione termonucleare fra nuclei di isotopi diversi dell’idrogeno: il deuterio e il trizio. La prima bomba H venne sperimentata dagli USA nel novembre del 1952. L’Unione Sovietica sperimentò il suo primo ordigno (alla cui realizzazione molto contribuì Andrej Sakharov) nell’agosto 1953. Seguirono il Regno Unito, la Repubblica Popolare Cinese e la Francia rispettivamente nel 1957, 1967 e 1968. A differenza della bomba A la bomba H non è mai stata impiegata in operazioni belliche. Analogalmente alla bomba A la bomba H può essere installata su diversi sistemi d’arma: aerei, missili balistici, missili lanciati da sottomarini. Nel 1961, in una serie di test nucleari, l’URSS fece esplodere la più potente bomba H mai realizzata (la bomba Zar) la cui potenza era 4 500 volte superiore della bomba all’uranio lanciata su Hiroshima (Little Boy). 22 22 Musica John Coltrane: il free jazz Il free jazz è una forma di jazz nata tra New York e Chicago, nei primi anni Sessanta, parallelamente al sorgere delle grandi battaglie razziali di Martin Luther King e, soprattutto, di Malcolm X: Black Power sarà sempre un marchio distintivo dei musicisti «free». Ha rivestito e riveste, perciò, una grande valenza sociale. Come indica il nome si tratta di un tipo di musica libera, completamente al di fuori degli schemi: uno dei limiti estremi raggiunti negli anni è stata la partitura per quintetto che prevedeva la libera improvvisazione contemporanea di tutti gli strumenti secondo l’estro del momento. I caratteri di novità di questo stile rispetto ai precedenti consistono nella frammentazione e irregolarità del ritmo e della metrica, nella atonalità che può arrivare fino al rumorismo, nell’assorbimento di tradizioni musicali provenienti da ogni parte del mondo (tanto che può essere considerato un antenato della world music) e soprattutto nella tensione, intesa come intensità e liricità, che talvolta assume caratteri orgiastici e liberatori. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE Uno dei molti musicisti «free» di rilievo è John William Coltrane (Hamlet, 23 settembre 1926 – New York, 17 luglio 1967). Tra i più grandi sassofonisti della storia del jazz, ha sicuramente lasciato un segno profondo nel tessuto di questa musica. «Trane», come fu anche soprannominato per il suo irruente fraseggiare, è stato uno dei più importanti innovatori del jazz degli anni Sessanta, ponendosi come cerniera tra la poetica del bebop e la rivoluzione del free jazz. Il pensiero musicale di Coltrane, colto nelle diverse fasi della sua evoluzione, ha creato folle di proseliti e di imitatori tutt’oggi attivi sui più disparati palcoscenici del mondo. Il passaggio breve ma intenso, di questo grande musicista, sulla scena del jazz ha marcato un profondo discrimine tra la musica degli anni Cinquanta e quella degli anni seguenti: in appena un secolo di storia, il jazz si è trasformato da musica popolare in musica colta. Coltrane fu il primo a esplorare i suoni del sax soprano. Egli ottenne da questo strumento un sound sinuoso e serpentino. La grana del suono del sax soprano può definirsi scarna e funzionale al senso religioso della musica di Coltrane. La musica creata con questo strumento è fatta di melodie sinuose ed eteree, di carattere mistico (basti ascoltare la celebre esecuzione di My favorite things, contenuta nell’album omonimo). I Beatles (dal loro primo disco del 1962) Love Me Do è un brano composto da Paul McCartney e incluso nell’album di debutto dei Beatles, Please Please Me del 1963 (nel quale è comunque firmato Lennon/McCartney). Viene ricordato soprattutto per essere il loro primo singolo, pubblicato nel Regno Unito il 5 ottobre del 1962 dalla Parlophone, anno corrispondente alla crisi cubana. I Beatles sono stati un gruppo musicale britannico, originario di Liverpool e in attività dal 1960 al 1970. Hanno segnato un’epoca nella musica, nel costume e nella moda e di conseguenza nella Pop Art. Considerati uno dei maggiori fenomeni della musica contemporanea, a distanza di vari decenni dal loro scioglimento ufficiale, e dopo la morte di due dei quattro componenti, i Beatles contano ancora un vasto seguito. Secondo la EMI, la casa discografica che tra il 1986 e il 1987 ne ha recuperato i diritti, le rie- John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney, dizioni dei loro dischi hanno venduto oltre un miliardo di copie. George Harrison Per la rivista Rolling Stone, i Beatles rappresentano il gruppo musicale più importante e influente del XX secolo. Numerosi sono i loro fan club, esistenti in ogni parte del mondo. Inoltre, l’aura, per molti versi non sempre codificabile secondo canoni comuni, che circonda lo sviluppo del loro successo a livello mediatico, e lo straordinario esito artistico raggiunto come musicisti-rock, sono tutt’ora oggetto di studio. I quattro componenti del gruppo erano: John Lennon (John Winston Lennon, Liverpool, UK, 9 ottobre 1940 – New York, USA, 8 dicembre 1980). Voce solista, suonava la chitarra ritmica, l’armonica, il pianoforte e il banjo. Era, insieme a Paul McCartney, l’autore della maggior parte dei brani. Fu ucciso davanti al Dakota Building di New York, dove abitava, l’8 dicembre 1980 da Mark David Chapman, un suo squilibrato ammiratore. Paul McCartney (James Paul McCartney, Liverpool, UK, 18 giugno 1942). Basso, voce solista, chitarra, pianoforte, batteria e, talvolta, mandolino; condivide insieme a John Lennon la paternità della stragrande maggioranza dei brani dei Beatles; dopo i Beatles fondò il complesso dei Wings, sciolto nel 1980. È tuttora in piena attività. Particolare curioso: sua è la batteria in Back in the USSR, Dear Prudence e The Ballad of John and Yoko, brani registrati in assenza di Ringo Starr. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 23 23 George Harrison (Liverpool, UK, 25 febbraio 1943 – Los Angeles, USA, 29 novembre 2001). Chitarra solista, sitar, talvolta voce solista e autore dei brani. Suoi sono brani spesso innovativi e diversi dalla linea melodica del gruppo, come Don’t Bother Me o Within You Without You. Per i Beatles ha scritto, tra l’altro, anche While My Guitar Gently Weeps e Something. È morto il 29 novembre 2001 durante un soggiorno a Los Angeles (California) a causa di un carcinoma maligno. Ringo Starr (Richard Starkey jr., Liverpool, UK, 7 luglio 1940). Batteria, percussioni e talvolta voce solista. Compose durante la sua carriera nei Beatles due canzoni soltanto: Don’t Pass Me By e Octopus’s Garden (scritta durante un soggiorno in Sardegna), che divenne molto celebre in tutto il mondo. Venne scelto anche come voce solista in Act Naturally, Yellow Submarine e With a Little Help From My Friends. Rivelatosi particolarmente portato alla recitazione, fu il protagonista del film Help!, e mentre faceva ancora parte del gruppo recitò nel film The Magic Christian insieme a Peter Sellers. John Lennon, Imagine Un brano molto simbolico di quel periodo, di John Lennon, è Imagine, arrivato ai primi posti delle classifiche, sia in Europa che negli Stati Uniti. L’album sarebbe diventato il suo disco di maggior successo, soprattutto grazie alla grande notorietà della title track, diventata un inno internazionale del pacifismo. Il brano che dà il titolo all’album, Imagine, è probabilmente il più rappresentativo di tutta la produzione di Lennon. Fu concepito come «un messaggio per il mondo», un inno alla pace e all’eguaglianza. Imagine Imagine there’s no heaven It’s easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today... Imagine there’s no countries It isn’t hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace... You may say I’m a dreamer But I’m not the only one I hope someday you’ll join us And the world will be as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world... You may say I’m a dreamer But I’m not the only one I hope someday you’ll join us And the world will live as one Immagina Immagina non ci sia il Paradiso prova, è facile Nessun inferno sotto i piedi Sopra di noi solo il Cielo Immagina che la gente viva al presente... Immagina non ci siano paesi non è difficile Niente per cui uccidere e morire e nessuna religione Immagina che tutti vivano la loro vita in pace... Puoi dire che sono un sognatore ma non sono il solo Spero che ti unirai anche tu un giorno e che il mondo diventi uno... Immagina un mondo senza possessi mi chiedo se ci riesci senza necessità di avidità o fame La fratellanza tra gli uomini Immagina tutta le gente condividere il mondo intero... Puoi dire che sono un sognatore ma non sono il solo Spero che ti unirai anche tu un giorno e che il mondo diventi uno... E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 24 24 Bob Dylan, Blowing in the wind Bob Dylan, nome d’arte di Robert Allen Zimmerman (Duluth, 24 maggio 1941), è un cantautore, compositore e chitarrista statunitense. Nella sua lunga carriera è stato ed è tuttora anche uno scrittore, poeta, pittore, attore e conduttore radiofonico e rappresenta una delle più importanti figure nella musica degli ultimi cinquant’anni. La maggior parte delle sue canzoni più conosciute risale agli anni Sessanta, quando l’artista si è posto come figura chiave del movement, il movimento di protesta americano. Canzoni come Blowing in the wind e The times they are a’changing sono diventate gli inni dei movimenti pacifisti e per i diritti civili. I testi delle sue prime canzoni affrontano temi politici, sociali e filosofici, e risentono di influenze letterarie, sfidando le convenzioni della musica pop e appellandosi alla controcultura del tempo. Blowing in the wind è il titolo di una famosa canzone di contenuto pacifista scritta da Bob Dylan nel 1962 e pubblicata la prima volta l’anno successivo. Questo brano è da molti considerato il manifesto della generazione dei giovani statunitensi disillusi dalla politica portata avanti negli anni Cinquanta e Sessanta dal loro paese e sfociata dapprima nella guerra fredda e poi nella guerra del Vietnam. Quando scrisse questo motivo, Dylan non era ancora quel paladino della controcultura che dopo pochi anni avrebbe rimesso in discussione, con la propria attività artistica di poeta e musicista, antichi pregiudizi e paure nuove; ma già allora, giovane cantastorie proveniente da un piccolo sobborgo minerario del Minnesota, era in grado di mostrarsi cosciente e padrone (in termini di comprensione del senso delle cose) dei nuovi pericoli derivanti dall’era atomica (i temi del fall out erano peraltro già stati illustrati con amara e sofferta poeticità dai cantori della beat generation, in primis Jack Kerouac e Allen Ginsberg). Tre semplici strofe sono in questo caso sufficienti al compositore per interrogarsi su tematiche sociali ed esistenziali. In particolare, al centro della sua visionaria poeticità sono il senso della condizione umana e l’incapacità dell’uomo di ripudiare in maniera definitiva e totale ogni tipo di guerra. Nel ritornello, rivolto metaforicamente a un ipotetico amico, nel quale si potrebbe identificare l’intera umanità, viene data una risposta che lascia uno spiraglio all’ottimismo: una risposta che c’è, e che a portarla basterà un soffio di vento. Joan Baez e Bob Dylan E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 25 25 Blowing in the wind Soffia nel vento How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, ’n’ how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, ’n’ how many times must the cannon balls fly before they’re forever banned? The answer, my friend, is blowin’ in the wind, the answer is blowin’ in the wind. How many years can a mountain exist before it’s washed to the sea? Yes, ’n’ how many years can some people exist before they’re allowed to be free? Yes, ’n’ how many times can a man turn his head, pretending he just doesn’t see? The answer, my friend, is blowin’ in the wind, the answer is blowin’ in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? Yes, ’n’ how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, ’n’ how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowin’ in the wind, the answer is blowin’ in the wind. Quante strade deve percorrere un uomo prima di poterlo chiamare un uomo? E quanti mari deve navigare una bianca colomba prima di dormire sulla sabbia? E quante volte debbono volare le palle di cannone prima di essere proibite per sempre? La risposta, amico, soffia nel vento, la risposta soffia nel vento. E quanti anni può una montagna esistere prima di essere erosa dal mare? E quanti anni possono gli uomini esistere prima di essere lasciati liberi? E quante volte può un uomo volgere il capo e fare finta di non vedere? La risposta, amico, soffia nel vento, la risposta soffia nel vento. E quante volte deve un uomo guardare in alto prima di poter vedere il cielo? E quanti orecchi deve un uomo avere prima di poter sentire gli altri che piangono? E quante morti ci vorranno prima che lui sappia che troppi sono morti? La risposta, amico, soffia nel vento, la risposta soffia nel vento. Fabrizio De André, La guerra di Piero Fabrizio Cristiano De André (Genova, 18 febbraio 1940 – Milano, 11 gennaio 1999) è stato un cantautore e poeta italiano. Nelle sue opere ha cantato prevalentemente storie di emarginati, ribelli, prostitute e persone spesso ai margini della società. I suoi testi sono considerati dei veri e propri componimenti poetici e, come tali, inseriti in molte antologie scolastiche di letteratura. Nei suoi quarant’anni di attività musicale Faber, soprannome (derivante dall’amore del futuro cantautore per i famosi pastelli della nota marca in questione) datogli dall’amico d’infanzia Paolo Villaggio, ha prodotto quindici album; un numero relativamente modesto, probabilmente determinato dalla grande attenzione dell’autore alla qualità delle sue opere. Lungo tutta la propria carriera De André ha collaborato, sia per la parte musicale che per la parte testuale, con altri artisti: le canzoni di cui De André è autore sia del testo che della musica sono infatti otto in quasi quarant’anni di carriera. È stato anche uno degli artisti che maggiormente hanno valorizzato la lingua genovese, oltre che, anche se in quantità minore, il sardo gallurese e il napoletano. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 26 26 La guerra di Piero La guerra di Piero, canzone celeberrima dell’inizio degli anni Sessanta, è il racconto al contempo dolce e triste della contradditorietà e stupidità della guerra, fatto dal punto di vista di chi l’ha vissuta in prima persona, un semplice soldato. Dormi sepolto in un campo di grano non è la rosa non è il tulipano che ti fan veglia dall’ombra dei fossi ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. E mentre gli usi questa premura quello si volta, ti vede e ha paura ed imbracciata l’artiglieria Non ti ricambia la cortesia. Cadesti in terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato. Così dicevi ed era inverno e come gli altri verso l’inferno te ne vai triste come chi deve il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso lascia che il vento ti passi un po’ addosso dei morti in battaglia ti porti la voce chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Cadesti in terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia crepare di maggio ci vuole tanto troppo coraggio Ninetta bella dritto all’inferno avrei preferito andarci in inverno. Ma tu non lo udisti e il tempo passava con le stagioni a passo di giava ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l’anima in spalle vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore. E mentre il grano ti stava a sentire dentro alle mani stringevi un fucile dentro alla bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano non è la rosa non è il tulipano che ti fan veglia dall’ombra dei fossi ma sono mille papaveri rossi. Sparagli Piero sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore soltanto il tempo avrà per morire ma il tempo a me resterà per vedere vedere gli occhi di un uomo che muore. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 27 27 Scienze e Matematica James Watson e Francis Crick: la decifrazione della struttura del DNA James Dewey Watson (Chicago, 5 aprile 1928) è un biologo statunitense, che scoprì la struttura della molecola del DNA insieme a Francis Crick e Maurice Wilkins con i quali ricevette anche il Premio Nobel per la Medicina nel 1962 per le scoperte sulla struttura molecolare degli acidi nucleici e il suo significato nel meccanismo di trasferimento dell’informazione negli organismi viventi. Nell’ottobre del 1951, Watson iniziò la sua collaborazione al Cavendish Laboratory, il noto dipartimento di fisica dell’Università di Cambridge, dove incontrò Francis Crick. Watson e Crick avviarono una intensa collaborazione intellettuale che portò alla risoluzione della struttura del DNA in meno di un anno e mezzo. Avevano infatti le qualifiche e le motivazioni necessarie per sostenere un tale lavoro: Crick avrebbe risolto le equazioni matematiche che governano la struttura a doppia elica; Watson portava con sé l’esperienza del phage group. Nell’aprile del 1952, Luria avrebbe dovuto tenere un discorso a un meeting nel Regno Unito, ma dovette rinunciare al viaggio per motivi di salute. Watson pensò dunque di utilizzare lo spazio originariamente riservato a Luria per presentare il suo lavoro sul DNA radioattivo e le varie prove a favore della localizzazione dei geni negli acidi nucleici. In quel periodo stavano avendo grande risonanza le scoperte di Maurice Wilkins (con cui Watson collaborerà) come il calcolo della larghezza del filamento di DNA di tipo B, individuato proprio attraverso studi di diffrazione a raggi X (stimato essere pari a 2 nanometri). Nel 1952, Watson e Crick beneficiarono in modo fortunoso delle conseguenze di due viaggi. Per prima cosa, Erwin Chargaff visitò l’Inghilterra in quell’anno e fornì importanti delucidazioni ai due riguardo alla biochimica dei nucleotidi, di cui conoscevano pochissimo. In secondo luogo, Linus Pauling non visitò l’Inghilterra. Il suo viaggio, già pianificato, fu annullato per ragioni di tipo politico; non poté così avere accesso ai dati sulla diffrazione a raggi X del DNA portata a termine dal King’s College fino alla loro pubblicazione nel 1953, assieme al modello della doppia elica. Con la sua lunga esperienza, infatti, Pauling avrebbe potuto dedurre da quei dati la struttura del DNA anche con un anno di anticipo rispetto a Watson e Crick. Nel corso del 1952, in ogni caso, a Watson e Crick fu richiesto di non lavorare sui modelli molecolari della struttura di DNA. L’attività ufficiale dei due sarebbe stata l’analisi con diffrazione a raggi X del virus del mosaico del tabacco, il primo organismo virale a essere stato individuato (1886) e purificato (1935). Attraverso la microscopia elettronica, infatti, erano stati individuati cristalli di virus all’interno delle piante di tabacco. Nel 1954, Watson scoprirà dalla diffrazione a raggi X che la struttura del virus era di tipo elicoidale. Nonostante questa assegnazione, in ogni caso, Watson e Crick continuarono a lavorare sulla struttura del DNA, senza peraltro alcun tipo di sanzione. I due ricercatori sognavano di divenire per il DNA quello che Pauling era stato l’anno prima per le proteine. Pauling, tuttavia, era giunto alla struttura delle proteine applicando la sua notevole esperienza nel campo chimico: né Watson né Crick, invece, erano molto ferrati in materia. I due biologi si rivolsero così a Rosalind Franklin, che aveva già portato a termine notevoli lavori sul DNA e poté fornire loro numerose conoscenze chiave per portare a termine il lavoro. Servendosi dei lavori non ancora pubblicati della Franklin e di Wilkins, i due poterono dedurre la struttura a doppia elica, che pubblicarono sulla rivista NaE s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 28 28 ture il 25 aprile 1953. In particolare, Rosalind Franklin contribuì nell’individuare la funzione dei gruppi fosfato degli acidi nucleici. La ricercatrice chiarì la loro posizione esterna, suggerendone la funzione di supporto. Watson e Crick ne conclusero dunque che l’informazione risiedesse nell’ordine delle quattro basi azotate. Watson ebbe invece un ruolo chiave nella scoperta dell’appaiamento delle basi azotate, il fondamento della stessa struttura e funzione del DNA. In seguito al fondamentale contributo di Jerry Donohue, che gli spiegò la corretta struttura chimica delle quattro basi, Watson provò a «giocare» con i modelli delle quattro La struttura del DNA individuata nel 1953 basi azotate. Poté rendersi così conto che le coppie A:T e C:G, da Watson, Crick e Wilkins tenute insieme da ponti idrogeno, sono strutturalmente similari. Watson fu in grado di spiegare la cosiddetta regola di Chargaff, secondo cui la quantità di guanina è pari a quella di citosina e quella di adenina è uguale a quella di timina. Watson, Crick e Wilkins ricevettero il Premio Nobel per la Medicina nel 1962 per la scoperta della struttura del DNA. L’esclusione della Franklin dal premio è dovuto alla sua morte di cancro nel 1958, probabilmente a causa delle radiazioni a cui i suoi studi l’avevano lungamente sottoposta. Nell’immaginario comune, la scoperta della struttura del DNA è legata ai soli Watson e Crick. Nella comunità scientifica è opinione diffusa che i motivi di ciò siano legati alla scarsa reputazione di Wilkins (che secondo molti era solo «alla ricerca di pubblicità») e, soprattutto, alla morte della Franklin. Nel 1968 Watson scrisse il suo secondo libro, La doppia elica, uno dei saggi di maggior successo dell’epoca. L’opera raccoglieva un «dietro alle quinte» di questa scoperta, presentando le personalità di chi vi aveva partecipato. Il titolo originale scelto da Watson era Honest Jim, soprattutto per rispondere alle velate accuse di essersi servito dei risultati della Franklin prima che fossero pubblicati. Watson non aveva particolarmente gradito le voci di critica che furono rivolte al suo atteggiamento nei confronti della ricercatrice. Attraverso il libro chiarì che, davanti alla sfida di battere sul tempo Pauling, i dubbi e le precauzioni della Franklin sui suoi dati erano soltanto un ostacolo da aggirare. Wilkins e altri si trovarono al posto e al momento giusto per permettere a Watson e Crick di fare tutto ciò. Anche per questi motivi, La doppia elica cambiò la visione del grande pubblico riguardo al mondo della scienza. Allo stesso modo, il primo libro di testo di Watson, La biologia molecolare del gene, pubblicato per la prima volta nel 1965 (e ristampato nel 1970, 1976 e 1987), fissò un nuovo standard per i libri di testo, soprattutto a livello stilistico. Il suo terzo testo, Biologia molecolare della cellula, pubblicato nel 1983 e ristampato nell’1989 e nel 1994, ebbe il merito di far convergere un vasto gruppo di ricercatori su un unico progetto innovativo. Il quarto libro di testo, DNA ricombinante: un corso breve, pubblicato nel 1983 e ristampato nel 1992, ha raccolto le tecniche attraverso le quali l’ingegneria genetica ha potuto portare tante nuove informazioni riguardanti il funzionamento degli organismi. Tutti questi testi sono tuttora in stampa. Nel 1968, Watson tornò negli Stati Uniti come direttore del CSHL. Nel 1974 il CSHL divenne la sua residenza definitiva e nel 1994 ne divenne presidente. Nel 1988 Watson fu nominato vicedirettore per la ricerca sul genoma umano al National Institutes of Health (NIH) e l’anno successivo ne divenne direttore. Si dimise da questo incarico nel 1992, dopo aver lanciato un’iniziativa globale che puntava alla mappatura e la messa in sequenza del genoma umano, offrendo il suo genoma personale, che dal 2007 è consultabile gratuitamente in internet. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 29 29 Educazione motoria La pallavolo La pallavolo, o volley (forma abbreviata dell’inglese volleyball), è uno sport giocato da due squadre con un pallone su un terreno di gioco diviso da una rete. Oltre a quella propriamente detta, ci sono differenti versioni del gioco adottabili per permettere di giocare in specifiche circostanze, e da esso sono derivate altre specialità, che possono avere regole simili, ma non identiche, quali il beach volley, il foot volley o il park volley. È presente nel programma dei Giochi olimpici estivi dal 1964. È uno degli sport più praticati a livello scolastico. Già nell’antichità esistevano giochi con la palla che possono essere considerati i predecessori della pallavolo. I Romani, per esempio, eseguivano esercizi con la palla a scopo di divertimento e svago: la palla veniva colpita con la mano aperta, palmo rivolto verso l’alto. In Italia una specie di pallavolo era giocata nel Medioevo e le sue origini possono essere ricercate addirittura in antichi giochi greci e romani. In Germania fu introdotto nel 1893 un gioco chiamato faustball, ma il merito della costruzione della pallavolo in forma moderna, nata ufficialmente nel 1895, va riconosciuto a William Morgan, istruttore di educazione fisica presso un college dell’YMCA di Holyoke, nel Massachusetts (USA). In effetti si possono trovare similitudini fra la faustball e il gioco ideato da Morgan; è anche vero che differivano in alcune caratteristiche di base: nella faustball, per esempio, la palla poteva toccare il terreno anche due volte, mentre nella versione di Morgan la palla doveva essere giocata al volo. Il 6 febbraio 1895 Morgan radunò alcuni insegnanti nel college di Springfield per la dimostrazione di un nuovo sport, da lui chiamato minonette (da minon, «micio», che era stato il nome di un gioco con la palla praticato da nobili e dame due secoli prima in Francia). Con l’aiuto di due squadre composte da 5 membri, tra cui il sindaco e il comandante dei Vigili del fuoco di Holyoke, avvenne il battesimo di un nuovo gioco sportivo con caratteristiche profondamente diverse dagli altri sport in voga a quel tempo. Una caratteristica peculiare era quella di non prevedere il contatto fisico tra i partecipanti, per cui la destrezza, la prontezza dei riflessi, la capacità di concentrazione e l’agilità prendevano il posto della qualità fino ad allora primaria nelle attività sportive: la forza. La minonette era quindi destinata ad atleti non più massicci e pesanti, bensì agili, con una buona elevazione, capaci di destreggiarsi nel gioco acrobatico. Fu però Alfred T. Halstead, il 6 febbraio del 1895, a cambiare il nome di minonette, un po’ troppo femminile, in volleyball (letteralmente «palla sparata»). Egli riuscì a imporre questo sport nei college YMCA sparsi un po’ in tutti gli Stati Uniti. Due anni dopo la pallavolo si praticava anche nella maggior parte dell’America del Sud (Brasile, Argentina, Uruguay). Nel 1898 la pallavolo giunse a Manila, nelle Filippine, grazie a un insegnante di educazione fisica americano; proprio ai filippini viene attribuita l’invenzione della «schiacciata». In Cina e in Giappone ottenne un successo strabiliante. In Europa arrivò durante la Prima guerra mondiale. Per un lungo periodo è stata giocata in due modi differenti: all’occidentale e all’orientale, con la cosiddetta regola dei tre tocchi. Nel 1938 venne introdotto un fondamentale che rivoluzionò il modo di giocare: il «muro». furono soprattutto i paesi dell’Est che lo utilizzarono con sistematicità. Nel 1947 i rappresentanti di 15 federazioni si ritrovarono a Parigi e crearono la Federazione Internazionale di Volleyball (FIVB). Nello stesso anno in Italia fu creata la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo). Nel 1949 si disputò il primo Campionato del mondo, ma solo nel 1964, ai Giochi di Tokyo, la pallavolo entrò a far parte degli sport olimpici. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 30 30 Le regole La gara viene disputata da due squadre con sei giocatori ciascuna. Ogni squadra ha a disposizione sei riserve, compreso il libero, che, generalmente, è sempre in campo in sostituzione di un giocatore di seconda linea, di solito il centrale. Il numero massimo di sostituzioni è sei, con un vincolo: se A sostituisce B, nello stesso set, B può rientrare in campo solo al posto di A. Caso a parte è quello del libero: le sostituzioni che lo coinvolgono non sono conteggiate. Esse sono illimitate, ma ci deve essere sempre un’azione di gioco fra due di queste sostituzioni. Lo scopo del gioco è realizzare tanti punti facendo cadere la palla nel campo avversario (fase di attacco), impedendo, ovviamente, che l’altra squadra faccia altrettanto (fase difensiva). Una squadra vince un punto quando la palla tocca il campo avversario, quando tocca la zona libera o finisce fuori dal campo dopo un tocco di un avversario, in caso di errore (attacco fuori) o fallo dell’altra squadra. La partita è divisa in set, i quali vengono vinti dalla prima squadra che arriva a 25 punti, con almeno due punti di margine dall’altra; in caso contrario si va avanti a oltranza finché il margine di una delle due non arriva a due punti. Al termine di ogni frazione di gioco, vi sono 3 minuti di pausa e le squadre sono obbligate a Le zone del campo e la rotazione dei giocambiare campo. catori La partita si disputa al meglio dei 5 set, ossia vince la squadra che ne conquista tre. Nel caso si arrivi a un punteggio di set 2-2, il quinto viene chiamato tie-break e viene giocato ai 15 punti, sempre con il vincolo dei due punti di scarto. Nel tie-break non si segue l’alternanza del possesso di palla da parte della squadra che effettua il primo servizio, che viene nuovamente scelto casualmente come all’inizio della partita, e il cambio campo si effettua al raggiungimento dell’ottavo punto. Il campo è suddiviso in due zone: la zona d’attacco e la zona di difesa (dalla linea dei tre metri a fondo campo). Vi è un’ulteriore suddivisione teorica di ogni metà campo in sei zone numerate. In pratica sia la zona d’attacco sia quella di difesa vengono suddivise ognuna in tre parti e numerate: si assegna il numero 1 alla zona di difesa a destra, il numero 2 alla zona d’attacco a destra e si prosegue in senso antiorario fino alla zona 6, corrispondente a quella centrale di difesa. La rotazione dei giocatori per il turno al servizio comporta che ogni giocatore all’inizio di ogni azione occupi una determinata zona del campo: si avranno quindi tre giocatori di prima linea e tre giocatori di seconda linea. La rotazione iniziale di ogni set viene decisa dall’allenatore che la consegnerà all’arbitro il quale controllerà, prima del fischio d’inizio, l’esatta disposizione dei giocatori. La squadra che parte con il possesso di palla è la squadra al servizio, mentre l’altra è chiamata squadra in ricezione. Il giocatore di zona 1 della squadra al servizio si porta dietro la linea di fondocampo e, al fischio dell’arbitro, mette la palla in gioco (ha 8 secondi di tempo per farlo) effettuando il servizio; la palla deve oltrepassare la rete e giungere nel campo avversario. L’azione continua fino a che la palla non tocca il campo, è inviata fuori dal campo o una squadra non la rinvia correttamente. La squadra che vince un’azione di gioco conquista un punto. Se il punto è assegnato alla squadra già al servizio, essa continua a servire. Quando la squadra in ricezione vince l’azione, conquista oltre al punto anche il diritto a servire e i suoi giocatori ruotano di una posizione in senso orario, in modo che chi si trovava in zona di battuta passerà in zona 6, mentre il giocatore che era in prima linea in zona 2 andrà a servire in zona 1. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 31 31 3 IL CONFLITTO ARABO-ISRAELIANO p. 149 3a STORIA Bruno Segre, Il villaggio della pace Quando Bruno Hussar morì a Gerusalemme nel febbraio del 1996, il cardinale di Milano Carlo Maria Martini rivolse alla comunità di Nevé Shalom/Waahat as-Salam (il villaggio «della pace» che Hussar aveva fondato in Israele) un messaggio di cordoglio nel quale, fra l’altro, scriveva: «Padre Hussar, che ho conosciuto personalmente e ho apprezzato quale profeta di riconciliazione e pace in Israele, ha realizzato il sogno di unire ebrei, cristiani e musulmani in una vita intessuta di preghiera e silenzio, e rimarrà sempre un luminoso esempio di fede e di speranza». Coinvolto da decenni, quale diretto e partecipe testimone, nel dramma del conflitto che ha fatto del Vicino Oriente, per oltre mezzo secolo, una delle aree più calde e a rischio del mondo, Hussar si è speso senza risparmio e con acuta intelligenza per modificare quella situazione: lavorando a far cadere i muri della paura, a sgretolare gli stereotipi, a promuovere la conoscenza dell’altro e a costruire entro una realtà solcata da dolorosissime lacerazioni ponti di rispetto, collaborazione e amicizia. Nevé Shalom/Waahat as-Salam è un villaggio cooperativo nel quale, dalla seconda metà degli anni Settanta, vivono insieme ebrei e palestinesi di cittadinanza israeliana. I membri del villaggio dimostrano in modo tangibile che ebrei e palestinesi possono senz’altro coesistere quando diano vita, assieme, a una comunità basata sull’accettazione, il rispetto reciproco e la cooperazione. L’idea di creare strutture scolastiche che potessero esprimere e diffondere gli ideali di coesistenza e uguaglianza di Nevé Shalom/Waahat as-Salam nacque nella comunità assieme alla nascita dei primi figli. L’idea prese corpo nella forma di un asilo nido binazionale dal quale, con l’andar degli anni, sono poi nate una scuola materna e una scuola elementare (dalla prima all’ottava classe). Dopo diversi anni di attività, tali strutture hanno aperto le porte anche ai bambini dei villaggi vicini. Oggigiorno la scuola elementare e quella materna contano complessivamente 210 bambini (ebrei e arabi in numero paritetico), due terzi dei quali provengono dai villaggi vicini. Per avere ulteriori informazioni sul villaggio, collegati a: http://xoomer.virgilio.it/idformis/cultura.htm E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 32 32 3B ITALIANO Galit Fink - Mervet Akram Sha’ban, Se vuoi essere mia amica (in La pace difficile, Edizioni il capitello) Il brano seguente è un breve epistolario tra Galit, ragazza israeliana di dodici anni che vive a Gerusalemme, e Mervet, palestinese di tredici anni di Dheisheh (un campo profughi situato su una collina vicino a Betlemme). 9 agosto 1988 Da nove mesi esatti molti giovani palestinesi, giovani che non sanno cosa significhi vivere in un paese indipendente, combattono contro l’esercito israeliano. È appena stato coniato nel sangue e nella paura un nuovo nome: «intifada»1. Ormai, quello della violenza sembra essere l’unico mezzo di espressione possibile tra israeliani e palestinesi. Il numero delle vittime è in aumento, soprattutto nelle file palestinesi. Eppure, i giovani che militano nell’intifada, la cui età va dai sette ai ventidue anni, armati di pietre, hanno deciso di strappare agli israeliani quello che i paesi arabi non sono riusciti ad ottenere in più di quarant’anni di guerra: la creazione di uno stato palestinese. Nella zona est di Gerusalemme2, il quartiere arabo della città, l’esercito rinviene un documento segreto: è il testo di una dichiarazione di indipendenza del popolo palestinese. L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina3 (OLP) annuncia la nascita di un governo in esilio. Il Primo Ministro, Itzhak Shamir, mette in guardia i palestinesi: «Se tenteranno di mettere in pratica il loro progetto, la nostra risposta sarà durissima». La tensione è al culmine. Gerusalemme, 9 agosto 1988 Mi chiamo Galit. Ho dodici anni. Sono israeliana. Provo una strana sensazione al pensiero di scrivere a una palestinese. Come se fosse un sogno, un bel sogno. Ho voglia di scriverti tante cose sulla mia vita. Provo a descriverti come sono: sono alta un metro e quaranta, ho i capelli castani e gli occhi scuri. Peso trentaquattro chili! In casa vivono cinque bambini, compresa me, che sono quella di mezzo. Abitiamo in una casetta in stile arabo a Bakaa, il quartiere di Gerusalemme dove sono nata. Mamma l’ha ereditata da sua nonna quando questa è morta, perché ha avuto molta cura di lei quando era vecchia e malata. 1. intifada: «sollevazione». Si intende la rivolta, iniziata nel 1987, dei giovani arabi palestinesi contro lo stato d’Israele, caratterizzata da atti di disobbedienza civile e dall’uso di armi improprie. 2. Gerusalemme: città santa per ebrei, cristiani e musulmani, capitale di Israele. 3. Palestina: nome moderno della biblica Terra Santa. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 33 33 Un giorno ti racconterò tutta la storia della mia famiglia. È una storia molto lunga, e ci sono delle cose molto tristi da raccontare, troppo tristi per un giorno come questo. Guardando sulla cartina, ho scoperto che abiti soltanto a quindici chilometri da casa mia. Purtroppo, mi è impossibile venirti a trovare laggiù; perché dicono tutti che è troppo pericoloso. Scrivimi. Voglio sapere chi sei. Galit 15 agosto 1988 Durante i festeggiamenti per il nuovo anno islamico, giorno importantissimo dal punto di vista religioso, gli scontri si fanno particolarmente violenti. Il mattino seguente, la radio annuncia che, in seguito ai conflitti con i militari, venti palestinesi sono rimasti feriti e sono ora ricoverati in ospedale. Anche sette israeliani, tra cui quattro bambini, sono rimasti feriti a causa di una bomba molotov4 lanciata contro il loro autocarro. All’alba, un bulldozer militare sradica l’aranceto dove si era rifugiato il responsabile dell’attentato. Nello stesso momento, alcune jeep dell’armata israeliana, munite di altoparlanti, decretano lo stato di coprifuoco su tutti i territori occupati. Da questo momento in poi, sarà proibito uscire dalla propria casa. Dheisheh5, 15 agosto 1988 Non so come rivolgermi a te. Non so se vuoi essere mia amica. So molto poco di te e della tua vita, ma provo già amicizia per te. Mi chiamo Mervet. Sono una ragazza intelligente, carina e volonterosa. Non odio nessuno. Amo la gente. Ma più di ogni altra cosa, voglio vivere libera nel mio paese, come te. A parte la mia famiglia, nessuno sa che ti scrivo. Se le mie compagne di scuola lo venissero a sapere, sicuramente ce l’avrebbero con me perché ho un’amica ebrea. Ma visto che la nostra scuola è chiusa, non c’è per icolo che mi possano fare delle domande. Da noi, qui a Dheisheh, la vita è molto dura a causa dell’intifada, ma io sono molto felice in famiglia. Ne ho sei, di fratelli e sorelle, e io sono la seconda. I miei fratellini sono talmente turbolenti, che ho dovuto chiudermi nella camera dei miei genitori per poterti scrivere. Li sento gridare fin da qui, ci siamo, è cominciata la battaglia! Bisogna che vada a vedere che cosa sta succedendo! A presto. Mervet 4. bomba molotov: bomba incendiaria rudimentale, costituita da una bottiglia riempita con liquido infiammabile. 5. Dheisheh: campo profughi situato su una collina vicino a Betlemme, nella regione di Gerusalemme, dove vivono circa 7000 palestinesi. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 34 34 22 agosto 1988 In seguito ai gravi scontri che si sono succeduti e all’inasprirsi della violenza, il governo israeliano decide di espellere venticinque palestinesi. Nella notte, un elicottero militare li conduce al di là della frontiera libanese. Gerusalemme, 22 agosto 1988 Cara Mervet, è gentile da parte tua rispondermi così in fretta, e con una foto, poi! Confesso che ti immaginavo completamente diversa. Pensavo che portassi il velo. Ho così tante cose da imparare sulla vostra religione, i vostri usi. Mi sembra proprio che i tuoi fratellini siano dei veri diavoletti. Credimi, è comunque meglio avere dei fratelli più piccoli piuttosto che averne uno più grande con cui, quando si litiga, si perde sempre. Mio fratello maggiore, Eyal, ha quattordici anni. Tutto quello che sa fare è contraddirmi. Pensa che ha persino osato dire: «Sei matta ad avere un’amica araba, la sua gente ci tira le pietre addosso!». Ma non preoccuparti, non ho nessuna intenzione di farmi influenzare. Irit e Yaël sono le più piccole. Loro, almeno, sono dei veri angioletti – tranne quando si va a far compere. Sono io che vado a prenderle alle quattro quando escono da scuola. Mi occupo di loro anche alla sera, quando i miei genitori escono. Mia sorella maggiore si chiama Tally. La adoro. Mi presta il suo walkman, e anche i suoi vestiti, quando non mi stanno troppo larghi. Purtroppo, ben presto sarà arruolata nell’esercito. Allora potrò dormire nel suo letto; ma lei non sarà più là a difendermi da mio fratello Eyal. Mamma si chiama Levana, che in ebraico significa «Luna». È originaria del Marocco, dove vivevano i miei nonni prima di trasferirsi in Israele. Lavora nell’agenzia di stampa del governo, all’ufficio personale. Anche se rientra molto tardi la sera, trova sempre il tempo di prepararci i dolci più buoni del mondo. Papà lavora a Yerolin, in una fabbrica di vestiti dove ci sono anche degli arabi. Papà mi ha anche detto che ci sono degli operai che vengono dal vostro campo. Questo mi ha fatto venire un’idea: perché un giorno non prendi anche tu l’autobus del mattino con loro? Io verrei a prenderti a Yerolin. Così ti farei visitare Gerusalemme. È molto bella, te l’assicuro. Io, i campi profughi6 li ho visti solo in televisione. Ho visto che le strade erano molto strette, e che la gente dormiva per terra. Ma è proprio così? Scrivimi. Galit 6. campi profughi: villaggi provvisori, durati in realtà decenni, creati dai palestinesi dopo la guerra del 1948. I rifugiati vivono in situazioni precarie, senza acqua corrente, in condizioni igieniche malsane. È difficile conoscere il numero esatto dei profughi palestinesi dislocati in Libano, Siria, Giordania, Cisgiordania, Gaza, si pensa ammontino a 2 milioni e mezzo. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 35 35 4 settembre 1988 Mentre l’esercito moltiplica gli arresti nei territori occupati, all’interno di Israele si leva una voce in difesa della pace, una voce che implora di dare avvio ai negoziati con i palestinesi. Un israeliano, Abie Nathan, soprannominato «il pilota della pace», si reca a Tunisi per parlare con Yasser Arafat, leader dell’OLP; a causa di questa sua iniziativa, Abie rischia la prigione. Infatti, la legge israeliana vieta qualsiasi contatto con i rappresentanti di un’«organizzazione terrorista», quale infatti viene considerata l’OLP. Dheisheh, 14 settembre 1988 Mia cara Galit, non voglio deluderti, ma non credo di poter venire a Gerusalemme a trovarti. Mio padre non mi lascerà mai andare là da sola. I soldati arrestano qualsiasi palestinese incontrino per strada. Se devo essere veramente sincera con te, non esco quasi mai da Dheisheh. Prima dell’intifada, qualche volta andavamo a fare delle gite a Gerico, oppure in spiaggia a Gaza. Tutti insieme, andavamo a fare dei picnic nel villaggio dei miei nonni. Facevamo arrostire sulla griglia il fegato con i pomodori, le cipolle e i peperoni. Bevevamo tè e coca-cola. I grandi si sistemavano sotto un albero e discutevano. Noi bambini cantavamo e ballavamo intorno a loro. Era il periodo in cui adoravo saltare con la corda e la portavo sempre con me. Una volta, con i miei genitori, sono andata fino al Mar Morto7. È tutto quello che conosco di Israele. Adesso capisci perché è così difficile per me venire a trovarti? Se almeno mio padre potesse portarmi con sé… Mio padre si chiama Aakram. Conosce anche l’ebraico. Fa il conducente di autoambulanze all’ospedale di Betlemme. Una volta faceva il poliziotto, ma poi ha deciso di smettere, perché quel lavoro, non gli piaceva tanto. Quando la sera lui rientra più tardi del solito, siamo tutti un po’ preoccupati, perché non si sa mai, con i tempi che corrono. Anch’io ho una sorella più grande. Ha quindici anni e si chiama Majda. È soprattutto lei che aiuta la mamma. Si occupa del bucato e sa anche preparare il pane. Poi tocca a me portarlo al forno, che si trova all’angolo con la nostra strada. L’altra mia sorella si chiama Manaal. Ha due anni meno di me. Papà dice che è la più bella della famiglia, per i suoi occhioni blu. L’altro giorno, mamma le ha detto che ormai era già grande abbastanza per andare a prender l’acqua per il bucato. Io però l’ho accompagnata, perché ha ancora paura dei soldati quando esce da sola. Da noi, i bambini dormono tutti nella stessa stanza, a parte Nizar che dorme ancora nella camera dei miei genitori, perché non ha ancora compiu7. Mar Morto: lago della Palestina, situato a 395 metri sotto il livello del mare (massima depressione terrestre). È talmente salato che alcune specie di pesci e di microrganismi non possono vivere in queste acque. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 36 36 to due anni. Divido il materasso con Khader e Wafa, che sono più piccoli di me. Majda dorme con Manaal vicino alla finestra e Mohammad, che ha dieci anni, dorme sul suo materasso vicino alla porta. Nella camera dei miei genitori c’è un lettone e un grande armadio tutto bianco. Adoro andare a vestirmi nella loro camera, perché posso provarmi i vestiti davanti allo specchio di mamma. Mamma è la donna più bella che conosca. Come quello di tua mamma, anche il suo nome significa qualcosa: «Vittoria», Intissar in arabo. Quest’anno, il giorno più bello di tutti è stato quello della festa della mamma. Con l’aiuto di Majda, ho preparato dei dolci e le abbiamo fatto tantissimi regali: una camicia da notte, un manifesto e dello smalto per unghie – sono stata io a sceglierlo. Papà le ha comprato uno stampo per dolci, e in più ha regalato un bel paio di scarpe alla nonna. Io e tutti i miei fratelli abbiamo ballato e cantato per loro. Sono felice anche quando festeggiamo i nostri compleanni, oppure quando vengono degli amici a cena. Presto ci sarà il matrimonio di mio cugino. A casa giochiamo molto, soprattutto adesso che non andiamo più a scuola. Di sera, se ci si annoia, e papà non guarda la televisione, gioca con noi e ci fa cantare. Manaal preferisce recitare le poesie, mentre io, che conosco le più belle canzoni patriottiche della Palestina, preferisco cantare. Cerco di insegnarle anche ai miei fratellini, ma il giorno dopo non si ricordano più niente. Allora si mettono a danzare e a battere il ritmo con le mani. Ormai sono otto mesi e mezzo che le autorità israeliane hanno chiuso la nostra scuola. Abbiamo dovuto ridare indietro tutti i nostri libri. All’inizio ero contenta. Adesso, invece, mi annoio. Ne ho abbastanza di giocare alla settimana e di saltare con la corda. Allora, ho cominciato a frequentare le riunioni delle donne palestinesi sempre più spesso. Sono riunioni che si svolgono qui a Dheisheh. Un giorno, mi è stato chiesto di recitare una poesia durante la festa dell’Università di Bir-Zeit8. Era una poesia dedicata a tutte le mamme, e la mia maestra ha detto che ero stata «meravigliosa». Ero felicissima, perché certo non pensavo di essere «meravigliosa». Durante l’ultima riunione, le donne presenti mi hanno detto che presto ricominceremo ad andare a scuola. Sono contenta, perché adesso mi sono resa conto di quanto sia importante essere istruiti. La scuola ha fatto nascere dentro di me idee giuste, piene d’amore e di comprensione per gli altri e per il mio paese. Non voglio rimanere ignorante. Non voglio che i miei connazionali siano degli analfabeti. E tu cosa pensi della scuola? Anche la tua scuola è chiusa? Vorrei anche sapere quali giochi ti piace fare, e se giochi ancora. Mervet 8. Bir-Zeit: università palestinese che si trova a nord di Gerusalemme. Gli studenti, come alcuni loro insegnanti, sono impegnati in attività a favore della creazione di uno stato palestinese. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 37 37 14 settembre 1988 Quattro settimane prima delle elezioni la commissione incaricata di garantire un regolare svolgimento democratico, vieta la partecipazione del partito «Kach» del rabbino 9 Meir Cahane. «L’ideologia di questo partito è una minaccia per la democrazia in Israele», afferma tale commissione. I militanti kach, soprannominati «le camicie gialle», propugnano idee razziste e invocano l’espulsione di tutti gli arabi; vogliono che i giornali «non patriottici» vengano chiusi, e chiedono l’arresto di tutti quegli israeliani – in primo luogo i giornalisti – «che amano gli arabi». Inoltre, il partito Kach vorrebbe sostituire la legge civile israeliana con una legge fondata sui precetti religiosi, vecchia di più di quattromila anni. La stessa settimana, in Algeria, dopo tre giorni di combattimenti, una sollevazione popolare viene brutalmente soppressa dalle forze dell’ordine. Duecentocinquanta manifestanti rimangono uccisi. La destra israeliana propone all’esercito di utilizzare gli stessi mezzi per domare la rivolta palestinese. Una proposta che non viene neppure presa in considerazione dai responsabili della sicurezza, che tuttavia impongono il coprifuoco in tutte quelle regioni dove gli scontri sono più cruenti. 30 ottobre 1988 Le elezioni legislative avranno luogo tra tre giorni. Chi vincerà? La destra nazionalista, e le sue posizioni più estremiste, oppure la sinistra, che propone soluzioni più concilianti riguardo al problema palestinese? La campagna elettorale si fa serrata e gli incidenti che si moltiplicano nei territori occupati rischiano di far oscillare il consenso dell’opinione pubblica da un lato o dall’altro. A Gerico, verso sera, una madre ebrea e i suoi tre bambini muoiono arsi vivi in seguito a un attentato contro un autobus. L’opinione pubblica è sotto shock. La regione di Gerico viene dichiarata «zona vietata ai giornalisti». Dheisheh, 30 ottobre 1988 Cara Galit, hai ragione quando dici che la guerra va bene solo se è un gioco. Da noi, qui a Dheisheh, il gioco preferito si chiama «gli arabi e i soldati», l’unico che mi piace ancora fare di tanto in tanto. Ci si divide in due squadre. I ragazzi impersonano i soldati, le ragazze e i bambini più piccoli fanno la parte degli arabi. Gli arabi manifestano, e i soldati cominciano a colpirli. Gli arabi corrono a nascondersi, e alcuni si fanno arrestare. Altri cadono a terra perché sono, per così dire, feriti. Quando gioco con Mohammad, i miei fratelli e gli altri bambini del quartiere, io faccio sempre la parte del dottore. Allora corro a curare i feriti con degli stracci vecchi e 9. rabbino: presso gli ebrei, titolo di dottore della legge e guida spirituale e religiosa di una comunità. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 38 38 una bottiglia d’acqua. Naturalmente, alla fine sono sempre gli arabi a vincere… Però so anche cosa significano le manifestazioni vere. Ce ne sono spesso, qui a Dheisheh. Tutti tirano le pietre. I bambini si burlano dei soldati, gridano e scrivono sui muri delle frasi come: «Con l’anima e col sangue, vendicheremo i nostri martiri». Quando i soldati si avvicinano, scappiamo a gambe levate. Ho paura che un giorno o l’altro Mohammad si faccia arrestare, ha sempre le tasche piene di pietre. Tu mi chiedi cosa penso del popolo israeliano. Per me, è come tutti gli altri popoli. Gli israeliani sono liberi e hanno cose che noi non abbiamo. Non mi piacciono gli ebrei perché hanno preso la nostra patria e trattano male gli arabi. Ma non conosco altri israeliani al di fuori dei soldati. Qui, nessuno ha intenzione di smettere di tirare le pietre, e continueremo così fino a quando ci saranno i soldati. Soprattutto da quando è cominciata l’intifada, i soldati, con i loro arresti, la gente ferita e quella uccisa, ci hanno reso la vita veramente difficile. Lanciano gas lacrimogeni, usano i fucili e demoliscono le nostre case. Fortunatamente, la nostra casa non è stata toccata. Hanno soltanto rotto lo scaldabagno. Comunque, a casa siamo sempre un po’ preoccupati. Ho uno zio che si nasconde dal giorno del suo matrimonio. Qualche volta viene a salutare di nascosto sua moglie, e nessun altro può vederlo. L’altro fratello di mia madre e mio nonno sono in prigione a Hebron10. La nonna si lamenta sempre di aver avuto quattro figli e di essere comunque costretta a vivere da sola. Per fortuna, la nostra casa è proprio vicino alla sua. Manaal ed io andiamo spesso ad aiutarla a sbrigare i lavori di casa. Le è sempre piaciuto raccontarci un sacco di storie sulla bella vita che conducevano in Palestina, prima del 1948. La prossima volta ti racconterò la nostra storia di profughi. La nonna, che ha settantacinque anni, non perde mai la speranza. Lei dice sempre: «Sono disposta a perdere anche i miei figli, purché i loro figli ritrovino la nostra patria». E tu, come vivi l’intifada, lì a Gerusalemme? Dalla foto che mi hai mandato, ho visto che hai un bellissimo sorriso. Mervet 14 dicembre 1988 Cinque giorni fa, i palestinesi hanno celebrato il primo anniversario dell’intifada, senza che si siano registrati incidenti. Il bilancio del l’UNRWA 11 è preoccupante. Su 24 000 palestinesi rimasti feriti in Cisgiordania, e 12 000 a Gaza, il 58 per cento ha meno di quindici anni. Ma proprio ieri, a Ginevra, ha avuto luogo un avvenimento storico che ha riacceso la speranza nei cuori di coloro che desiderano la pace: davanti 10. Hebron: città palestinese e capoluogo della regione che porta lo stesso nome, situata a sud di Gerusalemme. 11. UNRWA: (United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees). Organizzazione istituita dalle Nazioni Unite nel 1949 per amministrare gli aiuti ai profughi palestinesi. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 39 39 all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Yasser Arafat ha riconosciuto per la prima volta il diritto di Israele di vivere in pace e in completa sicurezza, e ha dichiarato di voler rinunciare completamente ad ogni forma di terrorismo. Ha lanciato un appello direttamente agli israeliani: «Su, avanti, facciamo la pace, quella pace che si addice agli uomini coraggiosi». Fino a quel momento, i palestinesi non avevano mai riconosciuto la risoluzione del 1947 firmata dalle Nazioni Unite, che stabiliva la creazione di uno Stato ebraico e di uno Stato arabo. Gli abitanti dei territori occupati danzano nelle strade. Gerusalemme, 14 dicembre 1988 Cara Mervet, come puoi dire che odi gli israeliani, se non hai incontrato altro che soldati? Proprio tu che dicevi che non avresti mai odiato nessuno… Io penso che sia giusto che anche voi abbiate la vostra patria, ma lo sai, tu, che molti arabi vorrebbero cacciarci in mare, noi ebrei? Nessun israeliano può tollerare una cosa così terribile. Perché gli arabi e gli ebrei non fanno altro che essere in guerra? Perché i genitori dei bambini arabi permettono che i loro figli lancino i sassi contro le nostre macchine? L’intifada è una guerra senza armi, ma chi può sapere come andrà a finire? La nonna di Haïfa mi parlava spesso della guerra, quella vera. Lei era molto vecchia e malata, ma se ne ricordava come se fosse stato il giorno prima. Nonna è di origine ashkenazita12, della Cecoslovacchia. Aveva sedici anni quando i tedeschi l’hanno deportata in un campo di concentramen to13 con la sua famiglia. Papà non era ancora nato. I suoi carnefici concedevano dieci minuti ad ognuno per fare il bucato. Un giorno lei ci ha messo un po’ più di tempo, e un altro ebreo del campo l’ha denunciata. Ha ricevuto cinquanta frustate. Una delle vertebre è andata fuori posto, e lei ha sofferto di dolori alla schiena per tutta la vita. Mi diceva sempre che era un miracolo se era ancora viva. All’inizio, le storie che mi raccontava mi facevano venire gli incubi. Ho cercato di disegnarli, ma non sempre ne sono stata capace. È papà quello che disegna meglio, in famiglia. Usa sempre un pennarello nero e un foglio bianco. Nient’altro. Fa anche delle piccole serie di disegni, che assomigliano a dei fumetti. Nel primo disegno si vede un gruppo di prigionieri dietro al filo spinato e degli uccelli all’orizzonte. Nel secondo, i prigionieri sprofondano in un buco. Nell’ultimo, si vede solo più il buco, i prigionieri sono scomparsi, e gli uccelli volano tutt’intorno al di sopra di questo buco. Quando ho voglia di vederli, sono costretta ad andare a rovistare fra le varie cose, perché nessuno di questi disegni è incorni12. ashkenazita: nome con cui si definiscono gli ebrei provenienti dall’Europa centrale e orientale, in particolare dall’Austria, dalla Germania, dalla Polon ia e dalla Russia. 13. campo di concentramento: nella Seconda guerra mondiale, sistema carcerario applicato su larga scala dai nazisti per l’eliminazione di massa degli ebrei e di altri avversari politici e razziali. Tristemente famosi per il numero delle vittime quelli di Auschwitz e Treblinka. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 40 40 ciato. Papà è un artista. Disegna, scolpisce, e inoltre si occupa di tutti i lavori più faticosi in casa e in giardino. Non ha ancora finito di costruire l’acquario, che già vuole ingrandire la casa. È vero, comunque, che siamo un po’ allo stretto. Papà e mamma dormono nel soggiorno, e hanno messo Irit e Yaël nella stanzetta vicino alla cucina. Il mio letto e quello di Eyal si trovano nell’ammezzato14, e Tally dorme proprio sotto di noi. Non ci lamentiamo. È comunque bello avere una famiglia numerosa, non credi? A presto. Galit 1 gennaio 1989 Il primo gennaio ricorre l’anniversario della nascita del movimento Fatah. Ma non è un giorno di festa. In un periodo di occupazione, questa ricorrenza, come qualsiasi altro anniversario, data storica o festa religiosa, si trasforma in una giornata di scontri con l’esercito. Nove palestinesi feriti vengono ricoverati in ospedale prima di sera. Durante la notte tredici palestinesi, tra cui Ibrahim Faraj, venticinque anni, vicino di casa di Mervet, vengono espulsi dai territori occupati e condotti in Libano. Dheisheh, 1 gennaio 1989 Mia cara Galit, bisogna proprio che divida con te la mia felicità: hanno riaperto la scuola, e il nonno verrà rimesso in libertà entro la fine dell’anno! Era stato mandato in prigione perché avevano trovato degli esplosivi nascosti nel nostro giardino, tre anni fa. In questo periodo ho una valanga di compiti da fare, perché dobbiamo recuperare il tempo perduto in questi mesi. Rimaniamo con il viso affondato nei libri ogni sera. Non c’è mai stato così tanto silenzio in casa. Avevo promesso di raccontarti la storia della mia famiglia. I miei nonni vivevano in un villaggio vicino a Hebron. Mi raccontavano che erano soliti riposarsi sul prato, coltivare i legumi e cucirsi gli abiti da soli. Questo villaggio si chiamava Zacaria, ma ora non esiste più. Nel 1948, i palestinesi hanno dovuto abbandonare le loro terre, perché sono stati cacciati dagli ebrei. A quell’epoca Dheisheh non era nient’altro che una collina disabitata, e i miei nonni sono venuti a stabilirsi qui, insieme ad altri esiliati. All’inizio, non avevano una casa, erano senz’acqua e non avevano niente con cui ripararsi. L’UNRWA ha dato loro delle tende dove dormire. Quando pioveva, le strade venivano invase dalla pioggia ed erano piene di fango. Durante le notti d’inverno, i bambini piangevano per il freddo, e a ogni folata di vento, le loro tende rischiavano di volare via. La nonna era costretta a fare due chilometri a piedi per andare a cercar legna e prendere acqua. L’acqua che riusciva a trasportare nell’orcio doveva bastare loro per tutta la settimana. Mangiavano, arrostito sul fuoco, il cibo che proveniva dall’UNRWA, perché non avevano più niente. 14. ammezzato: qui si intende soppalco. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 41 41 Ancora oggi, le famiglie più povere di Dheisheh continuano a ricevere il cibo da questa organizzazione. Dopo il 1950, gli abitanti del campo hanno cominciato a costruire delle casette. Una camera per una famiglia composta da cinque persone, e due per le famiglie più numerose. Dopo quindici anni, i miei genitori sono riusciti a costruire una grande casa di tre camere e cucina, dotata di acqua ed elettricità. Il posto che preferisco è la terrazza, perché ha una bella vista su Dheisheh e sulla strada. Da là, posso anche vedere i soldati che si avvicinano. Non mi hai ancora raccontato come si sta a Gerusalemme. Mervet 30 gennaio 1989 Dopo sei mesi di detenzione amministrativa, Faycal Al-Husseini viene rimesso in libertà. È un uomo di circa cinquant’anni, che abita nel quartiere arabo di Gerusalemme. Figlio del leggendario Abdel-Kader Al-Husseini, comandante in capo delle forze palestinesi all’inizio della guerra arabo-israeliana del 1947, e morto in combattimento nell’aprile del 1948, Faycal, soprannominato «Il Moderato», è la personalità di spicco dei territori occupati. Più tardi, sarà lui a guidare la delegazione palestinese in occasione dei negoziati con Israele. Tuttavia, la Guerra delle Pietre si fa ancora più violenta: a Betlemme, numerosi veicoli militari o appartenenti a coloni15 vengono presi a sassate, mentre a Gaza cinquecento giovani mascherati organizzano una manifestazione sfilando con le bandiere palestinesi. Secondo il deputato A. Rubinstein, ventinovemila palestinesi, sono stati arrestati dall’inizio degli scontri; e tuttavia, non si contano che ottomila capi d’imputazione e quattromila condanne. 22 febbraio 1989 Dopo quattro guerre arabo-israeliane, che si sono succedute dal 1948, l’Egitto è il solo paese arabo ad aver firmato un trattato di pace con Israele. Oggi, l’Egitto si sta premurando di aiutare gli altri paesi arabi e i palestinesi, in particolare, a giungere a un accordo con Israele. Al Cairo, capitale egiziana, si fa un primo passo significativo in questa direzione: per la prima volta, l’Unione Sovietica collabora con gli Stati Uniti per tentare di dare avvio ad un dialogo tra palestinesi e israeliani. Eduard Shevardnadze, Ministro degli esteri sovietico, si incontra con Moshe Arens, Ministro degli esteri israeliano, e poi con il leader dell’OLP, Yasser Arafat. Senza successo. Malgrado le pressioni internazionali che si fanno ogni giorno più insistenti, i due rappresentanti rifiutano di sedersi al tavolo dei negoziati. 15. coloni: gli israeliani insediatisi nei territori arabi occupati. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 42 42 Dheisheh, 22 febbraio 1989 Cara Galit, non sai quanto piacere mi abbia fatto ricevere la tua lettera. Ora posso dire di stare imparando a conoscerti sempre meglio. Quello che mi scrivi riesce a distrarmi un po’. Vedi, anche a me piacerebbe fare la tua stessa vita; ma soprattutto, vorrei che tu non provassi mai cosa significa vivere in questo modo: è così duro, credimi. Ci sono sempre più arresti, e il coprifuoco dura ormai per interi giorni consecutivi. I soldati arrestano i ragazzi per un nonnulla. Vogliono impedire l’intifada. Allora, gli uomini che distribuiscono i volantini vanno in giro di notte, di nascosto. Portano tutti una «keffià»16 sul viso, in modo che sia impossibile riconoscerli. Ma non ci sono soltanto i soldati di cui aver paura. Anche tra noi ci sono dei traditori17, come in tutte le guerre. Una volta mi hai scritto che facevo male a odiare gli israeliani. Adesso non potrei mai dire una cosa simile, perché tu, per esempio, sei israeliana, e noi riusciamo a comprenderci molto bene. Ma ti assicuro che i soldati che vengono mandati qui sono veramente degli esseri spregevoli. Ci maltrattano, e ci picchiano come se fossimo degli asini. Un giorno, nel cortile della scuola, un bambino ha perso l’occhio a causa di una pallottola di caucciù. Io sono svenuta. Non riuscirò mai a dimenticare ciò che ho visto. Ieri sera abbiamo accolto in casa un ferito. Ho visto arrivare i «chabab»18 dalla finestra. Trasportavano un corpo, e ci hanno chiesto ospitalità per dare i primi aiuti al malato. L’uomo era coperto di sangue perché aveva un proiettile nello stomaco. Mio padre non poteva fare molto per aiutarlo. Lavora all’ospedale, ma non è un medico. Comunque, ha cercato di localizzare dove si trovava la ferita. Poi, dei soldati hanno suonato alla nostra porta, e mia mamma allora è uscita fuori per dir loro che non c’era nessuno in casa. Dopo che questi se ne sono andati, lei è corsa dai vicini per andare a telefonare. Un quarto d’ora dopo è arrivata una macchina e ha trasportato il ferito in ospedale. Questo pomeriggio ci hanno detto che è stato operato e che non è più in pericolo di vita. Abbiamo tirato tutti un gran sospiro di sollievo. Prima, i giovani si annoiavano di meno, perché a Dheisheh c’erano più attività da fare. C’erano i campi da tennis, un campo da pallacanestro e un club per i giovani. Questo è stato chiuso anni fa dai militari, perché il nostro campo è molto conosciuto per la sua attività politica. A parte la povera gente, nel campo ci sono anche molti prigionieri, perché gli abitanti non hanno mai rinunciato alla militanza. Da quando è iniziata l’intifada, gli israeliani hanno eretto una barricata molto alta, affinché non si possano lanciare le pietre sulla strada. L’eserci16. keffià: tipico copricapo arabo. 17. traditori: i collaborazionisti, i palestinesi che aiutano gli israeliani acquistando terreni per loro conto o dando informazioni. 18. chabab: giovani militanti palestinesi dell’intifada, la cui età va dai dodici ai venticinque anni. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 43 43 to ha bloccato tutte le entrate tranne una. È molto vicina alla nostra scuola, ma non è certo quella più vicina a casa nostra. Devo fare il doppio di strada. Quando piove per tanto tempo, come è successo in questi ultimi giorni, la gran salita che conduce a casa si trasforma in un torrente di fango. Uno degli altri gravi problemi di Dheisheh sono le fognature. Il campo è talmente sovrappopolato, che l’acqua sporca straripa invadendo i marciapiedi, e scorre senza sosta, per tutto il giorno. Tu mi chiedi se abbiamo dei negozi. Sì, ne abbiamo, ma non molti. Soltanto una dozzina. Da noi, i negozi sono aperti soltanto la mattina. E quando c’è lo sciopero generale proclamato dall’intifada, rimangono chiusi tutto il giorno. A Dheisheh compriamo i legumi e le provviste. Se abbiamo bisogno di scarpe o di vestiti, papà ce li porta da Betlemme. La drogheria di Abou-Roulouz si trova proprio in fondo alla nostra strada. Quando ero più piccola, ogni giorno, dopo la scuola, andavo a giocare a nascondino davanti alla sua porta. Abou-Roulouz ci rimproverava spesso, perché facevamo troppo rumore. È un vecchio di sessant’anni che ama i bambini, ma che, come tutti i grandi, si innervosisce se ci si agita troppo. Per farci stare zitti, cominciava a raccontarci come si viveva una volta in Palestina. Conosce tutti quelli che abitano nel campo e da dove proviene ogni famiglia di Dheisheh. Giocava con noi agli indovinelli. Chiedeva il nome a ciascuno di noi e poi ci diceva: «Tu, tu vieni da Zacaria. Tu, tuo padre è nato a Beit Etab e tua nonna a Albourej». Manaal, mia sorella, che allora aveva soltanto sei anni, credeva che fosse veramente un mago. Quando si è piccoli, è come se si vivesse un’altra vita. Quando avevo cinque anni, credevo vivessimo a Zacaria. Avevo paura dei soldati e, devo ammetterlo, più di quanta ne abbia Manaal ora. Non osavo uscire in strada. Ora do le pietre ai chabab, e l’esercito mi sembra una cosa normale. Non gioco quasi più. Passo il mio tempo a leggere, oppure a piantare fiori. Fare la maglia non è sicuramente il mio forte. Tu sei certamente più brava di me. C’è soltanto una cosa che vorrei davvero imparare a fare: costruire un braccialetto palestinese. Domani andrò a trovare Fatia, una mia vicina di casa che ha quindici anni. Ha promesso di insegnarmi come si fa a tessere insieme i tre colori della nostra bandiera. Se non è troppo difficile, potrei farne tre, così tutte le mie sorelle ne avranno uno. Porto già un braccialetto simile ma, quando vado a scuola, faccio di tutto per nasconderlo sotto la manica del grembiule. I soldati non devono vederlo. È proibito, come le bandiere che i ragazzi appendono ai fili dell’elettricità. Non guardo molto la televisione. Soltanto di tanto in tanto. Papà, che parla l’ebraico, sente quasi tutti i giorni il telegiornale sul vostro canale. Io, qualche volta, guardo gli sceneggiati arabi, ma non sarei in grado di raccontarti la storia, perché perdo almeno una puntata su due. L’unico programma che mi piace veramente è un cartone animato che si chiama Tom e Jerry. I loro scherzi e i loro movimenti bizzarri mi fanno molto ridere. Trovo così buffo che, una volta tanto, un gatto e un topo alla fine riescano ad andare d’accordo. Spero di non averti annoiato con la mia lunga lettera. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 44 44 Dimmi, conosci degli arabi a Gerusalemme? Come sei fortunata, tu, a vivere a Gerusalemme. Spero che nessuno dei tuoi cugini faccia il servizio militare da noi. Dimmi la verità, ti prego. Mervet 14 marzo 1989 Sulla spiaggia di Taba, nella penisola del Sinai, un ufficiale dello Tsahal19 piega con cura la bandiera bianca e blu di Israele. Un altro ufficiale, egiziano, in uniforme bianca, issa la bandiera del suo paese. Taba, un minuscolo territorio sul Mar Rosso che i due paesi si sono contesi per anni, è ridiventato egiziano. L’ultimo conflitto tra i vecchi nemici si è risolto «tra amici». Questo simbolico atto di pace non ha arrestato la violenza quotidiana: una scuola femminile organizza una manifestazione, nel corso della quale una banca israeliana viene assaltata a sassate, e il traffico bloccato da pietre e immondizie. Un gruppo di coloni, appartenenti al «Comitato per la sicurezza delle strade» (affiliato al movimento Kach), si abbandona ad atti di vandalismo nel suk 20 di Hebron, rovesciando bancarelle, spaccando vetri, distruggendo merci e sparando colpi d’arma da fuoco. Gerusalemme, 14 marzo 1989 Mia cara Mervet, la tua lettera non mi ha per nulla annoiata. Anzi, mi ha fatto molto piacere; sai, non avrei mai immaginato che la tua vita fosse come tu me la descrivi. Ti rendi conto? Noi abitiamo a un quarto d’ora di distanza l’una dall’altra, ed è come se abitassimo su due pianeti lontanissimi. La cosa peggiore è che noi non c’entriamo niente, in tutto questo. Mi chiedo spesso perché gli arabi e gli ebrei non fanno altro che combattere. So che tanto tempo fa gli arabi hanno invaso le nostre terre, e che poi noi le abbiamo riconquistate. E adesso, questa terra, la vogliono tutti. Ho chiesto a papà dell’esercito. Nessuno della mia famiglia fa il milouim 21 nei territori occupati. A proposito, mi spieghi un po’ meglio cosa succede quando c’è il coprifuoco da voi? Forse è vero che sono fortunata a vivere a Gerusalemme, come dici tu, ma credimi, non è un paradiso neppure qui. È vero che Gerusalemme è una città bellissima, che ha una vista magnifica, musei e tanti negozi, ma la guerra si fa sentire anche da noi. Mi hanno detto che, nella città vecchia, le donne arabe aiutano gli uomini a colpire gli israeliani. Molti soldati sono rimasti uccisi. Se soltanto gli arabi e gli ebrei smettessero di combattere. Ormai sono mesi che non vado più nella città vecchia. I miei genitori me 19. Tsahal: l’esercito israeliano. 20. suk: caratteristico quartiere delle città arabe, ricco di botteghe e mercati. 21. milouim: servizio militare obbligatorio a cui è tenuto ogni israeliano almeno una volta l’anno fino al compimento dei cinquant’anni di età. Il periodo varia da tre a sei mesi. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 45 45 l’hanno severamente proibito. È terribile non poter essere liberi. Prima andavo al «Kotel»22 quasi tutte le settimane. Si può infilare tra le pietre un foglietto con su scritto un desiderio a cui teniamo in modo particolare. Se Dio è d’accordo, allora il nostro desiderio si avvera. Naturalmente bisogna essere pazienti. Ti assicuro, ho infilato dozzine di questi bigliettini affinché papà smetta di fumare, ma per adesso non ha funzionato! Mio nonno Yaacov, quello che viene dal Marocco, di tanto in tanto va a pregare al Kotel, perché porta fortuna. È a lui che affido i miei desideri, adesso. È l’unico della famiglia che possa andare a far spese nella città vecchia. Spesso torna con frutta e legumi. La mamma e la nonna hanno sempre paura che gli possa capitare qualcosa. Il nonno le rassicura sempre perché, dice, conosce gli arabi. Viveva con loro quando abitava in Marocco. E poi, visto che parla la loro lingua, se mai dovesse succedergli qualcosa, sa che è in grado di parlare con loro e di difendersi. Non conosco molti arabi, a parte il nostro giardiniere e una donna che viene a vendere la frutta nel nostro quartiere. Gli altri arabi sono semplicemente delle persone che incontro quando vado in fabbrica a trovare papà. Prima dell’intifada, papà aveva un amico arabo che lavorava in fabbrica con lui. Spesso veniva a salutarci, e qualche volta, di sabato, andavamo a far visita alla sua famiglia. Vivevano in una fattoria con un frutteto, e allevavano ogni genere di animali: polli, conigli, capre. Quando i bambini mi portavano in giro a visitare la fattoria, era veramente divertente. Ci facevamo dei grandi sorrisi e parlavamo a gesti. Adesso, il posto dove abitano è diventato molto pericoloso per noi. Rischiamo di essere presi a sassate. Mi dispiace non vederli più. Erano così gentili con noi. Mi ricordo come servivano il caffè, in quelle tazze minuscole come le tazzine delle bambole. D’altra parte, voi non bevete lo stesso tipo di caffè che beviamo noi. Il caffè israeliano è più leggero e viene servito in tazze più grandi. Noi aggiungiamo la polvere nell’acqua calda, mentre voi la fate bollire insieme, non è vero? In TV stanno trasmettendo il telegiornale: vado a spegnerla, sono così stufa di sentire che, ogni giorno, ci sono morti, feriti, sofferenza. Tra l’altro, tra poco arriverà Ayala. È la mia migliore amica. Visto che i miei genitori stasera sono fuori, lei viene a darmi una mano a prendermi cura di Irit e Yaël. Ayala è la ragazza più gentile della mia classe. Ci conosciamo dall’asilo. Dopo la scuola andiamo a passeggiare in città e, d’estate, andiamo insieme in piscina. Quando le ho raccontato la nostra storia, lei ha capito. Le altre non sanno che ci scriviamo. Chissà, forse sarebbero invidiose, o magari farebbero finta di non credermi solo per il gusto di stuzzicarmi. Sono talmente antipatiche che non mi importa affatto che sappiano che ho un’amica araba. Mi piacerebbe anche parlarti del mio quartiere. Ti ho già detto che abito in via Betlemme. Infatti, è la vecchia strada che conduceva fino a Betlem22. Kotel: «il muro». Si intende il muro del pianto, ciò che rimane del grande Tempio ebraico di Gerusalemme, distrutto dall’esercito romano nell’anno 70 d.C. È considerato un luogo sacro. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 46 46 me, proprio accanto a te. I nostri vicini sono molto gentili, e comunque tutti qui si aiutano l’un l’altro. Quando papà ha mal di testa, per esempio, si fanno in quattro per trovare un’aspirina. Se vedo passare una vecchietta con le borse della spesa, subito mi offro di aiutarla. L’unico che veramente non sopporto è il nostro droghiere. Il vostro mi sembra una persona molto gentile, come dovrebbe essere un nonno, per esempio, mentre il nostro non fa che farmi venire i nervi. Non riesco più a sopportare i suoi scherzi, che non fanno ridere nessuno. E inoltre ho notato che deruba i clienti. Se mi lamento, ha il coraggio di rispondermi che sono stupida e che non capisco niente. Ma, come dice la nonna, «c’è bisogno di tutto un po’ per fare il mondo». Anche mia nonna Ninette abita a Bakaa. È comodo, perché impiego soltanto cinque minuti per andare a trovarla. Ci andrò domani pomeriggio. Mi ha promesso un costume per la festa di «Purím»23, domenica prossima. Di tutte le nostre feste, è quella che preferisco. In quell’occasione si mangia un dolce che si chiama «l’orecchio di Haman». Come racconta una vecchia leggenda, Haman era un uomo malvagio che faceva del male agli ebrei, molto tempo fa, in Persia. Mangiare un suo orecchio è un po’ come vendicarsi di lui. Quali sono le vostre feste? A me piace la festa di Purím, perché ci si mette in costume. Mi piace anche travestirmi per giocare. D’estate, in giardino, io, Irit e Yaël giochiamo a un gioco che noi chiamiamo «la Corte Reale». Irit e Yaël si vestono come due principesse, e io sono la regina. Mi pettino con uno chignon e mi sistemo un foulard come se fosse una corona. In quei momenti, dico a me stessa che forse un giorno farò l’attrice. Hanno suonato. A presto, Mervet. Galit La corrispondenza continua per quasi due anni. Mervet e Galit si conoscono in modo più profondo e manifestano il desiderio di un incontro. Finalmente, dopo moltissime difficoltà le due ragazze possono conoscersi di persona. L’incontro 6 aprile 1991. Il sabato del «compromesso» si annuncia decisamente piovoso. Galit è combattuta tra due sentimenti opposti, a causa della sua decisione di incontrare l’amica/nemica palestinese. Tuttavia, l’idea che non correrà il rischio di incontrare qualcuno che conosce la tranquillizza un po’. Mervet, da parte sua, è un misto di eccitazione e di apprensione. È seduta accanto allo zio sul sedile posteriore del taxi che la sta portando a Gerusalemme. Silenziosa, guarda attraverso il finestrino il paesaggio che scorre davanti ai suoi occhi, sotto la pioggia torrenziale. Il taxi ha appena oltrepassato uno sbarramento, e si dirige ora verso la Città Santa. Quando arriva al belvedere del quartiere di Talpiot, il cielo è 23. Purím: festa che si celebra in febbraio in ricordo della liberazione degli ebrei di Persia ad opera di Mardocheo, dopo che il re Haman ne aveva decretato lo sterminio. A partire dal XVI secolo ha assunto caratteri simili al nostro carnevale. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 47 47 più sereno. Intimidita, Mervet scende dalla macchina, e Galit le viene incontro lentamente. È molto elegante, tutta vestita di nero; Mervet indossa il suo bel vestito bianco, che usa per i giorni di festa. Sorridendo, si salutano e si stringono la mano. Sono i primi istanti passati insieme. Mervet si asciuga gli occhi, Galit cerca goffamente di sistemare l’ombrello. – Quanti anni hai, adesso? – chiede Mervet in inglese. – Quattordici. E tu? – Quindici – risponde Mervet fissando l’orizzonte della vallata, dove nel frattempo si è disegnato un arcobaleno. – È bello qui… A qualche metro da loro ha luogo un altro incontro, quello tra i loro due zii: Jawdat e Shlomo, un militante pacifista israeliano. Nel clima disteso che si è venuto a creare, subito i due cominciano a parlare della situazione politica: i prossimi negoziati di pace, la recente visita a Gerusalemme di James Baker…24 Ci dirigiamo25 verso la casa di Shlomo, situata al confine con Ger usalem me, vicino a un villaggio palestinese. Mentre camminiamo, Jawdat comincia a conversare con Galit, e Shlomo coglie Mervet di sorpresa, rivolgendosi a lei in arabo. Poi Shlomo le racconta di aver trascorso la sua giovinezza in Marocco, e allora Mervet si sforza di ricordare la parola «sefardita», con cui si designano le origini delle persone come lui. Galit ha preparato il tè, e si stupisce che Mervet rifiuti con gentilezza i suoi dolci; siamo in pieno ramadan! Il tè viene dunque servito dopo il tramonto, in una bella teiera d’argento di Marrakech. È arrivato il momento di scambiarsi i regali. Galit riceve un braccialetto palestinese fatto da Mervet. La giovane israeliana lo indossa subito, avendo cura di nasconderlo immediatamente sotto la manica del vestito. Il compromesso continua. A sua volta, Galit dà a Mervet un foglio bianco dove ha disegnato le bandiere delle loro due nazioni. La bandiera palestinese non è finita. Galit ne ha tratteggiato il contorno, ma confessa di non conoscerne i colori. Mervet, allora, prima di prendere il disegno, si mette a colorare. Entrambe hanno portato con sé la macchina fotografica, quella che ho regalato a tutt’e due lo scorso anno. La foto ricordo viene scattata con il flash. Ormai si è fatta notte da tempo. Alcuni mesi dopo, verso la fine dell’ottobre 1991, a Madrid hanno inizio i primi negoziati per riportare la pace in Medio Oriente. Mi sembra che tutto questo le riguardi molto da vicino, e nello stesso tempo sia estremamente lontano da loro. Ignoro se adesso Galit abbia cambiato idea riguardo alla Palestina, o quale vendetta contro Israele stia meditando Mervet. A migliaia di chilometri da loro, proseguono le trattative di pace tra israeliani e palestinesi. E anche la guerra. da G. Fink - M. Akram Sha’Ban, Se vuoi essere mia amica, Edizioni E. Elle 24. James Baker: ex segretario di stato USA, negoziatore per i rapporti arabo-israeliani. 25. ci dirigiamo: con le due ragazze c’è Litsa Boudalika, la giornalista belga che ha fatto loro da tramite. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 48 48 4 I CONFLITTI IN AFRICA p. 150 ITALIANO Paola Caridi, La partenza (in La pace difficile, Edizioni il capitello) Questo racconto è ambientato in Ruanda nei primi anni Novanta. Il Ruanda, paese dalle mille colline, è una terra lussureggiante e fertile, dal clima gradevole che fa pensare a una continua primavera. In questo paese, dall’alta densità demografica, l’odio fra le due etnie che lo abitano, hutu e tutsi, ha scatenato guerre, devastazioni e orrori. Si narrano le vicende di Melchior, un ragazzino ruandese di stirpe hutu, che si trova a essere coinvolto nelle ferocissime lotte tribali che insanguinano il Ruanda, opponendo la sua etnia a quella tutsi. Melchior è un personaggio immaginario, ma la sua situazione, le sue paure, i suoi desideri non differiscono per nulla da quelli delle migliaia di bambini e ragazzi che nella realtà stanno soffrendo la violenza della guerra civile ruandese. La situazione politico-sociale L’origine delle violenze in Ruanda Contrasti secolari hanno diviso gli hutu, di origine bantu, dediti all’agricoltura, e i tutsi (watussi, conosciuti per l’alta statura), pastori nomadi di origine etiopica e di tradizioni guerriere, che sono stati a lungo la casta dominante nonostante gli hutu costituissero il 90 per cento della popolazione. Alla fine del XIX secolo, la colonizzazione tedesca prima, e quella belga poi, favorì nel regno del Ruanda-Urundi la monarchia tutsi, che fu scelta per amministrare il paese, mentre gli hutu rimasero legati ai tutsi da vincoli feudali. Nel 1959 la ribellione della maggioranza hutu costrinse alla fuga i tutsi: in molti, per evitare di essere uccisi, si rifugiarono in Uganda, dove fondarono un fronte patriottico. Iniziata nel 1990 una nuova, terribile guerra porterà, dopo quattro anni, alla vittoria dei tutsi. Rappresaglie e massacri causarono oltre un milione di morti e l’esodo di due milioni di hutu, soprattutto verso lo Zaire, senza suscitare l’intervento delle potenze mondiali. Nel racconto Le mille colline della paura si fa riferimento a un episodio dell’aprile 1994, quando un aereo che trasportava i due presidenti hutu del Ruanda e del Burundi fu abbattuto mentre si apprestava ad atterrare a Kigali. La morte del presidente ruandese Habyarimana provocò nel paese un’ondata di violenza inaudita contro i tutsi e gli hutu moderati. Nei mesi successivi, più di 500 000 ruandesi furono massacrati da milizie estremiste hutu, mentre riprendeva l’avanzata delle truppe dell’FPR (Fronte Patriottico Ruandese). Fallito ogni tentativo di mediazione tra le due parti, la guerra civile prosegue. Nel luglio 1994 l’FPR ebbe il sopravvento sulle milizie hutu e conquistò Kigali. Temendo la rappresaglia dei tutsi, un’immane ondata di profughi – tra i quali possiamo immaginare Melchior e Jean-Marie, protagonisti del racconto – sconfinò in Tanzania e nello Zaire, formando enormi accampamenti nei pressi della città di Goma, dove scoppiarono presto epidemie di colera. Nonostante la successiva dichiarazione di cessate il fuoco, gli esuli hutu si rifiutarono di rientrare nel paese per il timore di vendette. Nel novembre del 1994 fu istituito un Tribunale internazionale per i crimini nel Ruanda. Nel frattempo si aggravavano le condizioni dei rifugiati nei campi profughi, spesso controllati dalle milizie estremiste hutu. Nel settembre del 1995 il governo zairese iniziò il rimpatrio forzato di 15 000 hutu, che venne bloccato dall’intervento e dalla mediazione delle organizzazioni internazionali. Nel novembre 1995, un incontro tra i capi di stato della regione, presieduto dall’ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, rinnovò l’auspicio di un ritorno dei rifugiati in patria. I rientri volontari dei profughi furono comunque rari, resi difficili anche dalla critica situazione politica dell’intera area. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 49 49 Nel 1996 il tribunale che avrebbe dovuto giudicare i responsabili dei massacri non aveva ancora iniziato i lavori e le prigioni ruandesi erano piene di persone in attesa di giudizio (circa 70 000, che diventarono più di 100 000 nel 1997). Nel 1997 la situazione dei profughi subì un ulteriore peggioramento dopo la presa del potere di LaurentDésiré Kabila in Zaire, che raggiunse un accordo con le autorità ruandesi per lo smantellamento dei campi profughi e il rimpatrio più o meno forzato delle centinaia di migliaia di persone che ancora li abitavano. Mentre circa un milione di profughi rientravano in Ruanda, aggravando una situazione politica e sociale già critica, decine di migliaia si inoltravano nelle foreste zairesi, esposti alla fame, alle malattie e alle violenze delle milizie di Kabila. Nel 1997 circa l’85 per cento delle entrate ruandesi era costituito dagli aiuti internazionali e il paese era ancora lontano dal raggiungere una stabilità politica e sociale. MAR M TUNISIA MA RO CC O EDITE RRANE O ALGERIA EGITTO SA HA MAR RA OC C. LIBIA GIBUTI NIGERIA ETIOPIA LIA REP. CENTRAFRICANA MA RU N ME GUINEA GABON EQ. SO CONGO (EX ZAIRE) TANZANIA RUANDA BURUNDI OCEANO INDIANO ANGOLA ZIMBABWE NAMIBIA BOTSWANA MALAWI ICA AFR SUD AR BICO ZAMBIA MOZAM OCEANO ATLANTICO UGANDA KENYA O BENIN CONG TOGO ERITREA SUDAN GASC BU RK FA INA SO CIAD CA LIBERIA NIGER GHANA SIERRA LEONE GU INE A C D’A OSTA VOR IO GAMBIA GUINEA BISSAU MALI SO SENEGAL ROS MAURITANIA MADA OCEANO ATLANTICO SWAZILAND LESOTHO UGANDA Goma CONGO RUANDA Kigali (EX ZAIRE) Lago Tanganica BURUNDI Lago Vittoria TANZANIA E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 50 50 L a partenza Melchior ha gli occhi chiusi per la paura. Suda freddo, tanto da sentire la sottile maglietta di cotone che gli si attacca alla pelle. Attorno a lui solo il frusciare delle grandi foglie di banano, scosse dal vento. Il ragazzo socchiude gli occhi lentamente, molto lentamente. All’inizio non riesce a distinguere bene la massa che ha di fronte nella penombra, ma pian piano gli occhi si abituano alla semioscurità. – Aaaahhhh! Aiutoooo! Melchior si ritrova seduto sul letto, madido di sudore. L’incubo è stato terribile. Lui in mezzo alla foresta, da solo, e di fronte una mosca dalle dimensioni enormi, grande come un ippopotamo. Non è la prima volta che il ragazzo si sveglia nel cuore della notte, urlando per lo spavento. Succede ormai regolarmente da qualche settimana, da quando sono cominciate ad arrivare notizie di una nuova guerra, stavolta più vicina alla loro zona, nella prefettura di Ruhengeri, nel nord del Ruanda. Alla fine di gennaio del 1992 sono giunte prima le voci, rimbalzate di villaggio in villaggio, di collina in collina, poi i racconti di quelli che sono fuggiti. Quattro giorni fa è arrivato nel loro villaggio anche un cugino di Callixte, il suo migliore amico, scappato dalla zona più vicina per sfuggire agli attacchi degli inkotanyi, gli «invincibili». Ha raccontato degli uomini armati che sono arrivati, dei suoi genitori spaventati, delle poche cose messe insieme in fretta prima della fuga. – Quelli del Fronte patriottico1 hanno messo anche le mine nei campi – aveva detto il cugino François, dopo aver raccontato le sue peripezie. – Ma ne sei sicuro? – aveva chiesto, spaventato, Melchior. – Giuro, l’ho sentito con le mie orecchie. Un nostro compaesano lo stava raccontando a mio padre. Glielo aveva detto suo fratello – aveva risposto il ragazzo, punto nel suo orgoglio, con molta determinazione. – Ma perché? – aveva chiesto Melchior. – Non lo sai? Così in questo modo non possiamo più tornare a casa. Come facciamo a coltivare le piante di caffè? Saltellando tra le mine? – aveva detto François con una smorfia. Melchior si era alzato di scatto, aveva salutato Callixte e suo cugino, e se ne era tornato a casa. Durante il tragitto aveva ripensato alle parole dell’antipatico François. I guerriglieri del Fronte Patriottico, le mine, la fuga. Ne aveva sentito parlare di sera, dagli uomini riuniti in conversazione con suo padre attorno a un otre pieno di birra di banana. – Vogliono ammazzarci tutti. Siamo hutu, non avranno mai pietà di noi. Stavolta ci sono riusciti, i rifugiati, a passare la frontiera dall’Uganda 2. Ci faranno la pelle. – Dobbiamo prepararci a combattere. 1. Fronte Patriottico: il Fronte Patriottico Ruandese (FPR), formato in maggioranza da profughi tutsi provenienti dall’Uganda, ha conquistato il potere nel corso dell’estate 1994, con una delle più sanguinose guerre civili della storia recente. 2. la frontiera dall’Uganda: i profughi e i guerriglieri tutsi avevano trovato ospitalità nello stato confinante. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 51 51 – Ma cosa vuoi combattere? Abbiamo solo machete3. – Dobbiamo prepararci a fuggire. – E per andare dove? – A Kigali. «A Kigali, la capitale, la città. Ma a farci cosa? E poi, perché i guerriglieri del Fronte Patriottico vogliono ammazzare dei semplici contadini? Hutu, tutsi… come c’entra tutto questo? Cosa c’entrano, insomma, i miei vecchi compagni di scuola tutsi?». I pensieri turbinano nella testa di Melchior. Gli stessi pensieri che, di notte, producono mosche gigantesche e altri mostri. – Povero il mio Melchior! Un altro brutto sogno, non è vero? La voce di sua madre è sempre suadente e rassicurante, ma il ragazzo non dà a vedere il piacere che gli fa quello sguardo affettuoso. Ha ormai quindici anni, è il primogenito di sei figli, ma sua madre lo tratta, talvolta, come Simon, l’ultimo arrivato che ancora si attacca al suo seno. – Non ti preoccupare, mamma. E scusami se ti ho svegliato – dice scontroso Melchior. La donna si alza e fa per andarsene. – Mamma… – Dimmi, Melchior. – Dovremo veramente andarcene anche noi di qui? – Forse. Melchior non ha il coraggio di domandarle perché. Si gira dall’altra parte e si riaddormenta. – Melchior! Tienimi un attimo Simon, per favore. Sua madre si aggiusta la grande tela variopinta sulla maglietta a maniche corte, avvolgendosela sulla schiena e poi attorno al seno. Melchior mette il bambino nel «marsupio» ricavato dietro le spalle con la forte stoffa di cotone, dove il rosso del fondo si mischia con il verde e il giallo dei motivi a fiori. Sistemato il fratellino, il ragazzo spinge la carriola di legno carica di masserizie, vestiti e cibo; prende per mano Marie, la penultima e la sua preferita, la sorellina di due anni, intenta a giocare con l’acqua di una pozzanghera, e s’incammina dietro i suoi genitori. Destinazione: Kigali. L’intero villaggio, comprese le piccole fattorie dei dintorni, si è mosso verso la capitale. I tutsi se ne erano già andati prima, erano fuggiti per paura di essere ammazzati dagli altri abitanti del villaggio per vendetta. Lungo lo stretto sentiero di rossa terra battuta che scende sul fianco della collina, si forma un’ordinata e coloratissima fila di uomini, donne, vecchi e bambini scalzi, che trascinano con sé ogni sorta di cose: dalle capre alle pentole. Melchior si sorprende per il silenzio di quell’esodo, rotto solo dagli oggetti che sbattono fra di loro sulle carriole, e dalle risa e i pianti dei bambini. Gli adulti tacciono, pensano al futuro incerto nella capitale: dove andranno a dormire? Chi darà loro da mangiare e da lavorare? Quando torneranno a casa? 3. machete: coltelli lunghi e pesanti, comunissimi tra le popolazioni agricole, nelle zone tropicali ed equatoriali. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 52 52 Melchior dà un ultimo sguardo alla sua terra, alla vegetazione lussureggiante e prepotente delle montagne lontane, a quella più dolce delle colline, alla lunga serie di terrazze addomesticate dall’uomo, interrotta solo dai banani, dalle vecchie capanne di argilla col tetto a cono, dalle nuove case più moderne, che alla paglia hanno sostituito la lamiera. Poi allunga il passo per raggiungere il padre, un bell’uomo di trentacinque anni, alto e con le spalle ben larghe, la fronte spaziosa, gli occhi allungati e profondi, il naso largo e schiacciato, tipico degli hutu. Manuel è un contadino, come lo erano suo padre, suo nonno e i suoi antenati, che avevano sempre e solo lavorato. Anche il padre di Melchior aveva sempre e solo pensato prima ad aiutare i suoi genitori e poi, quando si era sposato nella chiesa della missione, a sfamare la sua famiglia in una terra rigogliosa ma stracolma di gente. Non aveva potuto studiare perché la scuola dei missionari bianchi era troppo lontana e lui doveva lavorare nei campi. Aveva, però, subito voluto che Melchior e via via gli altri figli che Dio gli aveva mandato frequentassero la numerosissima classe che padre Piero, un vecchio missionario venuto in Ruanda da un piccolo paese vicino a Venezia, era riuscito a metter su vicino al villaggio: avrebbero almeno imparato a leggere e a scrivere, anche se sarebbe stato impossibile mandarli alla scuola superiore. E la scuola era fatta veramente con poco: assi poggiate su tronchi al posto dei banchi, lavagnette al posto dei quaderni. – Quanto dovremo ancora camminare per arrivare a Kigali? – chiede Melchior guardando i suoi lunghi piedi scalzi impolverati. – Non lo so, ragazzo mio. Ma la strada è ancora lunga. Non pensarci e va’ ad aiutare tua madre. Manuel, che spesso si specchiava ragazzo nei tratti e nelle movenze del suo primogenito, aveva usato un tono un po’ duro, mascherando il disagio per non aver potuto evitare questo calvario 4 alla sua famiglia. Il luogo del mistero Dall’alto della collina il campo profughi sembra un formicaio. Insetti variopinti che corrono lungo i sentieri tra le innumerevoli e improvvisate capanne di legno e frasche, tonde come un igloo. E poi il fumo, il fumo che sale dai mille piccoli focolari accesi dalle donne per cucinare. – Dov’è Kigali? – chiede interdetto5 Melchior. – Non puoi vederla, è oltre quelle colline laggiù – gli risponde il padre indicando il sud. – Noi, però, ci fermeremo qui – conclude affrontando il sentiero in discesa che conduce ai confini del campo. Ma la sosta al campo, per fortuna, non è lunga. Solo qualche settimana per ambientarsi, ritrovare alcuni parenti alla periferia di Kigali e trasferirsi da loro al gran completo. Il cugino Cyprien è stato uno di quelli che ha fatto fortuna, in famiglia. Fa il barbiere, e ha messo su un negozietto vicino al mercato, sul quale campeggia un’appariscente insegna in metallo dipinta 4. calvario: lunga serie di sofferenze, dal nome del colle dove fu crocifisso Gesù. 5. interdetto: confuso, disorientato. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 53 53 di azzurro. Tramite le sue amicizie, è riuscito a trovare per Manuel un lavoro stagionale al mercato che consiste nell’aiutare a scaricare la merce. Una fortuna, perché trovare lavoro a Kigali, con la massa crescente di profughi che sta invadendo i dintorni, è diventato praticamente impossibile. Niente lavoro, invece, per Melchior. Dopo aver aiutato un po’ sua madre a tenere a bada i piccoli, come buona parte dei suoi coetanei, gironzola per la città che si stende sul grande altopiano. Poi, via per strada a chiacchierare o a dare due calci al pallone. – Melchior! Non fai altro che bighellonare. E io sono qua che divento vecchia con i tuoi fratelli. È il ritornello di sua madre, che a trent’anni ne dimostra più di quaranta. – Non ti preoccupare – è la risposta automatica del ragazzo, che cerca di nascondere, dandole le spalle, uno sguardo malinconico al viso tirato e al corpo appesantito di sua madre. «Ha ragione. Non faccio altro che camminare senza meta» pensa Melchior, mentre si immerge nei colori e nel rumore assordante del mercato principale di Kigali. Per lui, che viene dalla campagna, la capitale è una scoperta continua, un tesoro che non si esaurisce mai. Le urla ritmate dei venditori, le discussioni infinite della compravendita, i caschi di banane, le ceste e le tele stese per terra piene di sorgo, di mille tipi di fagioli, di manioca6 per fare la focaccia… Tutto questo lo esalta, forse anche perché contrasta così tanto con la calma e i ritmi quieti della campagna. C’è però un luogo, nella città, che lo attira più di ogni altro. Ci è arrivato per caso, durante uno dei suoi «viaggi» attraverso la capitale che l’hanno condotto sino all’estrema periferia. Lì, proprio dove le ultime case lasciano spazio alla campagna, c’è un muro alto, interrotto solo da una cancellata da cui s’intravvede una costruzione bassa, a un piano. Misterioso è quello che succede al di là del muro. Gli unici indizi sono il vociare continuo di bambini e una targa accanto al cancello. La scritta dice solo: «Centro Santa Maria degli Angeli». Melchior passa sempre più spesso lì davanti, e sempre di più la curiosità lo consuma. – Come ti chiami, ragazzo? La voce roca alle sue spalle lo fa sussultare. Melchior si riscuote: col suo corpo magro e dinoccolato è appoggiato da chissà quanto tempo a un grande albero dall’altro lato della strada, a una decina di metri dal cancello. Si è fermato a fantasticare, senza neanche accorgersene, sul suo «luogo del mistero». – Allora, «senza nome», da dove vieni? – continua un po’ brusca la voce, usando uno strano accento che non sembra proprio kinyarwanda, la lingua ruandese. – Mi chiamo Mmmelchior – riesce a dire, senza voltarsi per il timore, aggiungendo poi il nome del suo villaggio. – Ah, ah, allora sei andato a scuola da quel vecchio testone di don Piero! Appena sente il nome del suo maestro, il ragazzo si gira di scatto per la 6. sorgo… manioca: il primo è un cereale e il secondo un tubero. Sono alimenti di base per le popolazioni delle aree tropicali. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 54 54 sorpresa e si trova di fronte un uomo bianco alto e nerboruto7, dai capelli e dalla lunga barba ormai grigi. Indossa una cam icia bianca e un paio di pantaloni beige di sottile tela di cotone. – Passata la paura, Melchior? – Qqquale paura? Ma lei chi è? Perché conosce padre Piero? – Ancora scosso, Melchior chiama a rapporto tutte le sue forze per passare al contrattacco. – Con Piero giocavamo a calcio insieme, piccolo mio. Tu non eri ancora nato quando io riuscivo sempre a infilargli un gol, nel campetto, proprio dietro la chiesa di San Giorgio. E poi il seminario, Roma, la missione… Vecchi tempi… L’uomo si interrompe per un momento, e i suoi profondi occhi azzurri cercano un pezzo di memoria e un gol in un freddo e umido pomeriggio invernale, là in Veneto. Poi si riscuote e i suoi occhi tornano a Kigali. – Be’, insomma, forse è il caso che mi presenti anch’io e che la finisca di fare il burbero: mi chiamo Luigi, dirigo quest’orfanotrofio. Ma senti, hai proprio intenzione di star qui sotto l’albero per tutto il giorno? Ti propongo un bel bicchiere d’acqua e un po’ di fresco al di là della strada – dice il missionario, girandosi verso l’ingresso del centro e accingendosi ad attraversare senza neanche attendere l’assenso di Melchior. Il ragazzo lo segue di buon grado. Padre Luigi ha le chiavi del «luogo del mistero». Al di là del cancello, un altro mondo accoglie Melchior. Il largo spiazzo che divide il muro dalla bassa costruzione principale di mattoni rossi è pieno di bambini che giocano e si rincorrono, gridando gioiosamente. Al saluto di padre Luigi, rispondono assediandolo per chiedergli dov’è stato e cosa ha portato loro. Poi, di colpo, si calmano accorgendosi dell’estraneo accanto al missionario. Ma è questione di un attimo: finita la sorpresa, i bambini cominciano a occuparsi di Melchior e a bombardarlo di domande, mentre il ragazzo segue frastornato padre Luigi verso la casa. Sulla porta li accoglie un giovane prete ruandese, alto, dal portamento eretto, quasi regale. Il viso, dai lineamenti minuti, colpisce per la serenità che emana. – Bentornato, don Luigi – dice il sacerdote accogliendolo con un largo sorriso. – Stavo rischiando di impazzire senza di te. I nostri piccoli, quando ci si mettono, sono terribili. Pascal non ha fatto altro che piangere perché non ti trovava più – continua, girando lo sguardo verso un frugoletto8 di quattro-cinque anni poco più in là, nascosto dietro una delle colonne della veranda. – Pascal, vieni qua! – esclama padre Luigi. – Perché piangi? Non ti piace stare con Jean-Marie? Melchior assiste alla scena in silenzio, senza staccare gli occhi dal giovane prete. I tratti del suo viso e la magrezza del corpo tradiscono il fatto che Jean-Marie è un tutsi. E da quando è scappato dal Nord, Melchior si irrigi7. nerboruto: forte, muscoloso. 8. frugoletto: bambino molto vivace. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 55 55 disce ogni volta che vede un uomo dell’altra etnia. Si dà dello stupido, sa che non può incolparlo di ciò che altri fanno dalle parti di Ruhengeri, ma non riesce a frenarsi. Nel villaggio c’erano dei tutsi, e vivevano in armonia con gli altri, senza che a nessuno venisse in mente di chiedere a quale gruppo appartenessero. Poi è venuta la guerra… e poi ci si è messo anche suo cugino Albert, il figlio di Cyprien il barbiere, a parlar male dei tutsi, a dire che la pagheranno cara e che non riusciranno mai a rientrare in Ruanda dall’esilio al quale sono costretti da decenni in Uganda. Prima dovranno fare i conti con lui e con quel gruppo di scalmanati ragazzi hutu con i quali s’incontra là, vicino al mercato. – Bene, Melchior, ti presento Jean-Marie, il mio preziosissimo e insostituibile aiutante. Un amico tutsi Il ragazzo torna spesso all’orfanotrofio: ci trascorre più ore di quante ne passi a casa con i suoi. Ci sono per il momento quaranta bambini – hutu e tutsi, senza distinzione – scampati non si sa come alla guerra o alla fame. Padre Luigi gli ricorda il suo vecchio maestro del villaggio, così sbrigativo nei modi, eppure così attento e partecipe a tutto ciò che succede dentro le mura del suo centro. Melchior dà una mano a lui e alle suore per assistere i bambini. Li fa mangiare e giocare e, quando la situazione lo richiede, lava i piatti in cucina. Talvolta fa anche la guardia di notte, per evitare che qualche ladro scavalchi il muro. In cambio, padre Luigi lo fa mangiare lì con loro e, quando riesce a risparmiare, gli dà una piccola paga. È già qualcosa per Melchior, che può in questo modo dare il suo contributo per accrescere il piccolo bilancio famigliare. L’unico, serio problema è Jean-Marie. Melchior non riesce proprio a parlare con quel giovane prete dal portamento altero, di poco più vecchio di lui. Gli avevano detto che aveva studiato al seminario maggiore di Kigali. Da Nicole, la cuoca, aveva saputo che Jean-Marie era stato anche a Roma, in Vaticano, per approfondire gli studi. «Tutte le fortune le ha lui. E io, per i suoi compari, ho dovuto anche abbandonare la mia casa!». L’invidia lo consumava, tanto da fargli evitare qualsiasi contatto. Alcune volte gli era anche accaduto di non riuscire a controllarsi, e di rispondere in modo indisponente ad alcune osservazioni di Jean-Marie. Un’antipatia di cui tutto il centro, dopo tanti mesi, si era accorto. – Ti sto antipatico, vero? Melchior ha un sussulto. Non si aspettava una domanda così diretta da parte di Jean-Marie. In Ruanda nessuno fa mai domande così, nessuno è tanto indiscreto da impicciarsi dei sentimenti altrui. – Non è vero – bofonchia a bassa voce, chiedendosi con sospetto dove Jean-Marie abbia imparato questo strano comportamento, così lontano da quello a cui è abituato. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 56 56 – Ma dai, si vede benissimo che non mi puoi sopportare. Va bene, non posso certo sperare di piacere a tutti. Vorrei però almeno capire perché – incalza il sacerdote. Il ragazzo distoglie lo sguardo, non sa proprio cosa rispondere. – Sai cosa dicono di noi ruandesi? Che non si riesce mai a capire cosa pensiamo, che nascondiamo sempre quello che ci frulla nella testa, che dietro i nostri sorrisi e le nostre gentilezze non si sa mai cosa si cela. Forse è così. Ci ho riflettuto molto, e penso che l’unica via di uscita sia essere chiari fra di noi. Insomma, se tu vuoi lavorare qui e io devo lavorare con te, dobbiamo parlare sinceramente. Allora, dimmi, non mi puoi sopportare perché sono tutsi? La domanda di Jean-Marie mette il ragazzo alle strette. – Sì, è così – riesce a dire Melchior. – Ne ero sicuro. Ma io non ho colpa se tu sei dovuto fuggire a Kigali dal nord. – Ma allora perché quelli della tua etnia ci hanno fatto scappare dalle nostre case? – chiede Melchior, che ora può finalmente sfogare tutto il suo rancore. – E perché le bande armate di hutu, quelli che chiamano gli interahamwe, vanno in giro per il paese ad ammazzare tutsi, senza che nessuno dica alcunché? Perché i potenti hutu hanno mandato via i tutsi, tanti e tanti anni fa? Perché non vogliono dare loro il diritto al ritorno, non li fanno rientrare nel loro paese e li lasciano lì in Uganda? Perché… Mio povero Melchior, è così difficile da spiegare… Neanch’io so darti risposte chiare. Gli occhi di Jean-Marie si fanno tristi. Dovrebbe raccontare al ragazzo dei suoi nobili antenati, dei secoli trascorsi prima che arrivassero i tedeschi e poi i belgi per colonizzarli. Di quando il re, il Mwami, era tutsi, immagine di suo padre Imana, il Dio, chiamato dal popolo Nyagasani, il signore sempre giusto. E di quando i tutsi erano quasi tutti suoi vassalli. E dei leggendari Ybimanuka, gli inviati dal cielo che secondo la tradizione avevano fondato il regno. Dovrebbe anche raccontargli della raffinata corte di Nyanza9, delle danze dei giovani rampolli, gli Ntore, di fronte al tamburo sacro. I tutsi, allora come adesso, erano pochi, ma erano in compenso una minoranza nelle cui mani era accentrata buona parte del potere. Ora no, anzi. Del potere avevano mantenuto solo il ricordo. E Melchior dovrebbe a sua volta raccontare a Jean-Marie del duro lavoro dei suoi poveri antenati. E dell’ubuhake, il contratto-capestro stretto dai contadini con i loro feudatari10, quasi tutti tutsi. Suo padre Manuel gli aveva spesso narrato la storia del «fascio d’erba», il simbolo offerto al signore guerriero per chiedere la sua protezione e poter lavorare la terra della collina. Così i suoi avi erano divenuti umugaragu, delle specie di servi. E 9. Nyanza: città nel sud del Ruanda. Vi risiedevano, durante il regno del Ruanda-Urundi, il monarca e la sua corte. 10. contratto-capestro… feudatari: un contratto particolarmente duro e difficile da rispettare (quasi fosse un capestro, cioè una corda per impiccare, che «strozzava» la loro vita) che legava i contadini ai padroni della terra. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 57 57 poi, pian piano, era nata la ribellione ai soprusi, la voglia di prendere il potere, di escludere l’altro. C’erano riusciti, alla fine, a escludere i tutsi da tutto. Era successo qualche decennio prima, quando il Ruanda era divenuto indipendente. La giustizia, però, non aveva vinto: aveva avuto la meglio solo il desiderio di rivincita. Nessuno dei due, né il giovane prete tutsi né il ragazzo hutu, spezzano quel silenzio carico di memorie che li unisce. Continuano a guardarsi negli occhi appannati, persi nel caos della loro storia. – Melchior, hai fatto pace con Jean-Marie? Allora potremo giocare tutti e tre assieme!!! La voce argentina del piccolo Pascal interrompe il silenzioso dialogo tra i due giovani. – Penso proprio di sì – risponde al suo posto Jean-Marie, accarezzando la testolina del bambino senza distogliere lo sguardo da Melchior. Da quel giorno, il ragazzo hutu e il prete tutsi trascorrono ore insieme, a parlare, a raccontarsi della vita della grande città e di quella della campagna, della storia del Ruanda, e poi del seminario, di Roma, del sacerdozio. Quando ha tempo, Jean-Marie dà lezioni a Melchior, che ha più volte dichiarato l’intenzione di continuare gli studi e prepararsi al duro concorso per l’ammissione alla scuola superiore. Odio e paura È sera. Melchior sta per uscire dall’orfanotrofio per rientrare a casa, quando sente il fragore di un’esplosione. Jean-Marie e padre Luigi escono sulla veranda in tempo per sentire una seconda esplosione. – Viene dalla zona dell’aeroporto – commenta il missionario. – Cosa sarà successo? – chiede allarmato Melchior mentre si asciuga il sudore freddo che all’improvviso gli imperla la fronte. Ha i brividi, come quando – ormai due anni fa, prima di fuggire dal nord alla volta di Kigali – si svegliava terrorizzato nel cuore della notte in preda agli incubi. Padre Luigi scompare dentro casa. Dalla veranda Melchior sente la sua voce alterata mentre al telefono chiede spiegazioni ad amici e correligionari11. Le ore scorrono lente prima che la notizia circoli di bocca in bocca per la città e giunga anche nel piccolo centro: il presidente12 è morto, e con lui anche quello del Burundi e un gran numero di ministri e consiglieri. Hanno fatto esplodere l’aereo sul quale viaggiava, poco prima che atterrasse. Ci ha rimesso la vita anche il suo medico personale. Seduto sotto il cielo carico della stagione delle piogge, nell’aria fresca della notte, Melchior non riesce a distogliere lo sguardo da quel punto lontano da cui è giunto il rumore sordo, pieno, netto dell’esplosione. – Ho paura – dice a Jean-Marie, che non risponde. Uccidete tutti i tutsi. È venuta l’ora della vendetta. Bisogna far pagare i conti in sospeso… 11. correligionari: appartenenti alla stessa religione. 12. il presidente: il presidente ruandese Juvenal Habyarimana. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 58 58 La voce gracchiante alla Radio delle Mille Colline riscuote Melchior e JeanMarie dallo strano torpore nel quale sono immersi. Si guardano increduli. Tutti in Ruanda ascoltano la radio, dovunque, nelle case, in mezzo alla strada mentre si attendono i pulmini taxi o di fronte ai negozietti. Quello che corre sulle onde arriva a tutti come un tam-tam. E la radio, ora, spinge la gente all’odio e alla violenza cieca. – È terribile, Jean-Marie. I «miei» vogliono uccidervi tutti. Melchior ha il cuore pieno di vergogna, tanto che non riesce a guardare il giovane sacerdote negli occhi. – Sarà quel che Dio vorrà, amico mio – dice Jean-Marie con voce roca. – Raccogliamo ora ciò che gli ambiziosi e gli assetati di potere hanno seminato per anni tra noi: odio. Odio inutile e insensato. – Odio senza ragione e tanta paura – continua Melchior, chiudendo gli occhi. – Sai, Jean-Marie, quando siamo fuggiti dal villaggio lo abbiamo fatto non perché ci abbiano costretti, ma per il terrore della vendetta. E prima di me e della mia famiglia, i tutsi che vivevano nel paese sono scappati per paura di essere uccisi da noi, per ritorsione. La paura ci sta facendo impazzire. E non sappiamo nemmeno per quale ragione. L’alba coglie Melchior e Jean-Marie ancora lì, stesi sulle panche della veranda. La luce pallida del sole appena sorto scuote il ragazzo, che si alza senza far rumore per non svegliare Jean-Marie, si avvia verso il cancello ed esce dall’orfanotrofio. Kigali gli appare così diversa da ieri. Uno strano silenzio ha sostituito gli spari che erano echeggiati per tutta la notte, come se la città fosse un uomo che trattiene il fiato in attesa di qualcosa di tremendo. Come se Kigali fosse Pompei poche ore prima dell’eruzione del Vesuvio13. Bande di uomini armati di fucili e di machete girano per le strade, chiedendo i documenti alla poca gente che s’arrischia a uscire di casa. Spesso non è evidente a quale etnia appartengano, perché i tratti somatici tradiscono la mescolanza del sangue; ma sulle carte d’identità c’è scritta la tua sentenza di morte o al contrario la tua sopravvivenza. Sulla carta d’identità c’è il marchio: tutsi oppure hutu. Da alcune abitazioni esce fumo, altre hanno i vetri in frantumi e portano evidenti i segni del saccheggio. Il mercato è deserto, nonostante sia l’ora dell’arrivo dei commercianti. – Ehi, tu cosa stai facendo in giro? Melchior si ferma di scatto, poi si gira lentamente. Davanti a lui ci sono cinque uomini dall’aria esaltata, quasi invasata14. – Allora, rispondi, sennò t’ammazzo come un cane!! – urla istericamente uno di loro, un ragazzo dell’età di Melchior, che brandisce un machete. – Fermo, Sylvestre, è mio cugino. 13. Come… Vesuvio: la capitale del Ruanda, immobile in uno strano silenzio, è paragonata a Pompei, la città vicino Napoli distrutta dalla famosa eruzione del Vesuvio nell’agosto del 79 d.C. 14. invasata: ossessionata, come se il loro animo e la loro mente fossero stati posseduti dall’odio per i tutsi. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 59 59 Albert, il figlio di Cyprien il barbiere, giunge all’improvviso, in tempo per salvare Melchior che lo guarda esterrefatto. – Te l’avevo detto, due anni fa – gli dice Albert, con una voce metallica e inquietante – che avremmo regolato i conti. Ora è giunto il momento, è arrivato il segnale che aspettavamo da mesi. Faremo pulizia, non troveranno collina sulla quale rifugiarsi. Li elimineremo tutti, anche i bambini, perché non diventino gli adulti di domani. Tu però devi essere più prudente, Melchior. Io ti consiglierei di non tornare più da quei tuoi amici del centro. Potrebbe essere pericoloso… Melchior non riesce a trovare parole per rispondere alla follia omicida di suo cugino. Riesce solo a voltarsi e ad allontanarsi velocemente dalla banda di interahamwe. Ha appena girato l’angolo per entrare in una delle traverse che si dipartono dal mercato, quando un urlo squarcia l’aria, quello di un uomo colpito a morte dal machete di Sylvestre. Melchior cade sulle ginocchia, tenta di tapparsi le orecchie con le mani che premono convulsamente sulle tempie, e comincia a singhiozzare. La mattanza15 è iniziata. Il tempo di salutare la sua famiglia, mettere le sue poche cose in una sacca, e Melchior è di nuovo all’orfanotrofio. Sa che quello è il suo posto e il suo destino, ancor di più dopo l’incontro con Albert. Ha appena chiuso il cancello alle sue spalle quando riprendono gli spari, stavolta più vicini di quanto lo fossero stati nella notte. «È scoppiato l’inferno» commenta tra sé e sé. E una strana calma si impadronisce di lui mentre, come un automa, prepara la difesa dell’orfanotrofio. – Cosa volete? – chiede preoccupato padre Luigi ai tre uomini che urlano fuori dal centro, aprendo, ma solo di poco, il cancello. – Ehi, padre, vogliamo vedere se dentro ci sono degli sporchi tutsi – risponde uno di loro, gli occhi iniettati di sangue. – Hanno ucciso il presidente. La pagheranno tutti! – gli fa eco un altro. – Qua non c’è nessuno. Solo bambini e religiosi. Andatevene. Qui nessuno può entrare. Questa è come un’ambasciata. Ma soprattutto è un luogo sacro, è la casa di Nostro Signore Gesù Cristo! E voi siete battezzati, vero? – dice il missionario con voce dura. – Certo che siamo battezzati. E andiamo a messa tutte le domeniche come ogni buon cristiano. Ma attento, padre. Quei delinquenti di tutsi sono riusciti a sporcare anche la chiesa e a vestire gli abiti sacerdotali. Non difenderli, o sarà peggio per te – risponde ridendo quello che sembra il capo. – Non osare minacciare un uomo di Dio! Vai via, e porta con te i tuoi compari! – conclude padre Luigi sbattendogli in faccia il cancello. Di lontano, sulla veranda, Melchior segue la conversazione animata che si svolge attraverso la cancellata. – Volevano Jean-Marie, vero padre? – chiede Melchior senza neanche attendere la risposta. – E io darò loro quello che vogliono. Jean-Marie sta sulla porta, col volto teso. 15. mattanza: massacro simile, nella sua sanguinaria ferocia, all’uccisione dei tonni imprigionati nelle tonnare. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 60 60 – Non dire stupidaggini. Tu da qui non ti muovi. Prima devono ammazzare me – chiude seccamente padre Luigi. – E anche me – aggiunge Melchior, e incomincia a ridere. Tutto d’un tratto gli è venuto in mente di quando lui avrebbe voluto vedere morto Jean-Marie. – Quanto mi stavi antipatico, Jean-Marie. Avrei tanto voluto strozzarti! – continua Melchior ridendo convulsamente. Dopo il primo momento di sorpresa, Jean-Marie e padre Luigi vengono contagiati da quel riso isterico, fino ad arrivare alle lacrime. – Padre!!! Sono entrati! Sono entrati! Nicole, la cuoca, è sconvolta, non riesce a parlare. Ma non c’è bisogno di spiegazioni. – Tutti i bambini in chiesa. Di corsa! Io vado a fermarli. Jean-Marie e Melchior, voi scappate dal cancello principale! Via, via di qui, e che Dio vi assista, figli miei… – urla il missionario mentre si dirige dietro alla casa, oltre il campo giochi, verso quella parte di muro che gli interahamwe hanno scavalcato. Melchior e Jean-Marie eseguono gli ordini di padre Luigi senza fiatare. Corrono senza fermarsi, oltre il cancello, per le strade di Kigali dove il silenzio si mischia alle grida di dolore. Non sanno neanche loro per quanto tempo hanno corso prima di raggiungere la campagna evitando i gruppuscoli di armati che pattugliano la capitale, rifugiandosi nei vicoli al minimo rumore. Quando arrivano al bosco di banani è ormai sera. Decidono di fermarsi lì ad aspettare l’alba. Dormono a turno, per evitare brutte sorprese, ma il sonno è talmente lieve che quando il sole sorge, il viso di entrambi è tirato. – E ora, dove andiamo? – domanda Melchior. – Non so – risponde Jean-Marie. – Sono molto indeciso. Dobbiamo assolutamente uscire dal Ruanda. Quello che sta succedendo a Kigali è solo l’inizio. Vedrai, cominceranno a darci la caccia anche nelle campagne, dappertutto… – Hai ragione – continua il ragazzo, e racconta al giovane sacerdote dei folli propositi di suo cugino Albert e degli altri interahamwe. – Hanno detto che non vi lasceranno collina o foresta nelle quali trovare scampo. – Il Burundi sarebbe il paese più vicino – dice Jean-Marie. E ho anche dei buoni amici a Bujumbura. Ma assieme al nostro presidente c’era anche il loro, sull’aereo che hanno abbattuto ieri… – E allora? – E allora anche lì è pericoloso: hutu e tutsi, pure in Burundi, non vanno troppo d’accordo. Dovremo andare nello Zaire. Conosco la strada, è quella verso il lago Kivu, ci sono andato varie volte. Poco oltre la frontiera, a Goma, c’è una missione cattolica dove lavora un sacerdote che conosco. Ci rifugeremo lì. Presa la decisione, i due giovani si incamminano verso nord-ovest, verso Gisenyi, facendo ben attenzione a evitare la strada principale e i suoi pericoli. Salgono e scendono dalle mille ripide colline del loro paese, dorE s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 61 61 mono dove capita, nelle foreste, vicino alle piantagioni, a distanza di sicurezza dalle case e dai villaggi che incontrano. Mangiano banane e tutto ciò che possono raccogliere senza dover chiedere a nessuno. La paura di essere assaliti è tanto forte da far evitare loro qualsiasi contatto con le persone. E come dar loro torto… Durante il cammino hanno attraversato un villaggio, non ne ricordano neanche il nome. Era deserto. Poco più in là la chiesa, costruita dai missionari. Jean-Marie è entrato nel tempio. Non sentendo nulla, Melchior lo ha seguito. Lo ha trovato in ginocchio, il corpo scosso dai singhiozzi, di fronte a uno spettacolo orrendo: uomini, bambini aggrappati alle loro mamme… Tutti uccisi. Sono corsi via in lacrime. Non si sono detti una parola per ore, vagando per la foresta nella notte, mentre sopra di loro una splendida volta stellata rendeva tutto più irreale. Sono poi caduti spossati dal dolore e dalla stanchezza, e si sono addormentati. La piccola Ésperance Un fruscio fa sobbalzare Jean-Marie, che batte piano sulla spalla di Melchior per farlo destare. – Cosa c’è? – dice il ragazzo con la voce roca, voltandosi di scatto. – Sshh. Sta’ zitto! – sussurra imperioso Jean-Marie. – Ho sentito un rumore. Veniva da lì – prosegue indicando una radura e, alzandosi pian pianino, si avvicina agli alberi. Al ripetersi del fruscio Jean-Marie corre verso quella direzione. – Non mi far male. Ti prego! Non fare quello che hanno fatto alla mia mamma! Dall’oscurità compare una bambina, uno scricciolo dagli occhi pieni di terrore. – No, non ti preoccupare – le dice con voce dolce Jean-Marie. – Non ti faremo nulla… Guarda, le mie mani sono vuote. La bimba non si rassicura: vorrebbe scappare, ma Melchior dalla parte opposta la prende fra le braccia e comincia a cantarle una canzone, la stessa nenia che gli cantava sua madre per fargli prendere sonno dopo gli incubi notturni. La piccola prova a divincolarsi, poi cede, poggia il suo capo sulla spalla del ragazzo e piange. – Tu non sei cattivo come gli altri… – Quali altri? – chiede Melchior. – Quelli che hanno fatto male alla mia mamma. Lo sai, non si muoveva più… E allora sono scappata per andare da mio zio. Devo dirlo allo zio, devo andare in città… La vocina diventa sempre più flebile, sino a che la bambina si addormenta. – Povera piccola. Avrà sì e no l’età del nostro Pascal… – dice Jean-Marie ricordando i suoi orfani del centro. – È inutile riportarla al suo villaggio. La porteremo con noi a Goma – dice Melchior sistemandosela sulla schiena. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 62 62 Dopo due giorni di cammino lungo il sentiero raggiungono la cima della collina. Di lontano compaiono le prime ville di Gisenyi, quelle dei ricchi ruandesi che ai bei tempi andavano a passare le vacanze lungo le rive del grande lago Kivu. – Ci sei mai stato? – Jean-Marie chiede a Melchior. – No. Prima di venire a Kigali non mi ero mai mosso dal mio villaggio. Qualche volta, però, passavano da noi degli stranieri, americani, europei… Andavano a vedere i gorilla nel parco dei vulcani, su a nord – risponde Melchior. – Già, i gorilla… Hai sentito parlare di Diane Fossey16? Era una donna che per studiare il comportamento dei gorilla era andata a vivere con loro. Parlava con loro, stava assieme al branco per ore. Li proteggeva… – Ah, vuoi dire l’«americana» – lo interrompe Melchior. – Certo che ne ho sentito parlare. La ammazzarono i bracconieri. Sai, lei non voleva che cacciassero e uccidessero i gorilla. Ma per loro, venderli agli stranieri voleva dire un bel gruzzolo. Così mantenevano tutta la famiglia! – Lo so. Ora non saremo conosciuti solo per aver ammazzato Diane Fossey e i suoi gorilla… – Ho fame. La voce della bambina li distoglie dalla loro tristezza. – Hai ragione, piccola mia. Troveremo qualcosa per il tuo stomaco. Ma prima devi dirci qual è il tuo nome – le sussurra Jean-Marie. – Michelle – risponde pronta. – È un bel nome – interviene Melchior. – Ma ti piacerebbe averne un altro? La bambina lo guarda interdetta, ci pensa un po’ su, poi sul suo viso compare un bel sorriso: – Sì. – Bene, facciamo un gioco. Ti chiameremo Michelle fino a che non arriveremo in una grande casa dove ci aspettano tanti amici. Lì ti dirò il tuo secondo nome – le dice Melchior ammiccando. – Non me lo dirai prima? – gli chiede un po’ delusa Michelle. – No. Ma vedrai, sarà una bella sorpresa. Jean-Marie e Melchior camminano di buona lena, alternandosi nel compito di portare in braccio la piccola Michelle per non farla stancare troppo. Parlano senza sosta, ridono, come se la presenza della bambina avesse riportato loro un po’ di serenità e avesse fatto scomparire il dolore. Aggirate le ville di Gisenyi, i tre proseguono verso nord, superando il grande lago Kivu, la barriera naturale che li separa dallo Zaire. Arrivati abbastanza vicino al posto di frontiera, Jean-Marie e Melchior si fermano per osservare a distanza la situazione e decidere il da farsi. – Dovremo presentare i documenti ai soldati – dice Jean-Marie. – Bene, così faremo una bella fine… – risponde ironico il ragazzo. – Perché mai. Sono sempre dei pubblici funzionari, e dall’altra parte ci sono i doganieri zairesi… – Li vedi quei ragazzi accanto ai soldati? – chie- 16. Diane Fossey: la storia di questa etologa ha ispirato il film Gorilla nella nebbia. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 63 63 de Melchior indicando tre giovani che parlano vicino alla sbarra bianca e rossa su cui è scritto Dogana. – Sì, li vedo… – risponde interdetto Jean-Marie. – Mi gioco la testa che sono della stessa pasta di quel tipaccio di mio cugino Albert – osserva con tono sicuro Melchior. – Non accetto la scommessa. Mi fido. E allora bisognerà trovare il modo di passare dall’altra parte senza farci vedere. È difficile che tutta la linea del confine sia pattugliata – conclude il sacerdote. – Sono d’accordo con te, ma sarà ben difficile trovare il varco, senza conoscere la zona. La voce di Melchior è decisamente preoccupata. – Ma io la zona la conosco! – dice qualcuno. Il sangue si è gelato nelle vene dei due giovani, che afferrano la piccola Michelle per proteggerla. Dietro di loro compare un vecchio sdentato, con un buffo cappello di stoffa a forma di cono. Indossa una camicia ormai stinta, piena di buchi, e un paio di pantaloncini dal colore indefinibile, tanto sono sporchi. Nei suoi occhi brilla una luce di follia, mentre con la bocca aspira nervosamente il fumo dalla sua piccola pipa. – Vi porto io di là. Ma voi cosa mi date in cambio? – chiede il vecchio. Jean-Marie e Melchior si guardano interdetti. – Secondo me è il matto del villaggio. Non lo vedi come ci guarda? Non possiamo fidarci – dice Melchior all’orecchio del suo compagno. – Ma cosa abbiamo da perdere… Se ci provassimo da soli, avremmo ancora meno possibilità di riuscita! – gli risponde Jean-Marie. – E se ci consegna agli interahamwe? – chiede con tono nervoso il ragazzo. – Lo sai che è bello il tuo cappello? Me lo regali? – dice Michelle al vecchio divincolandosi dall’«abbraccio» dei giovani, mentre questi continuano a confabulare. – Michelle! Vieni qui! – urlano i due, all’unisono. – Anche a mio nonno mancavano i denti. Non poteva mangiare quasi nulla… Il vecchio accarezza la testa della bambina, e comincia a parlare fitto fitto con lei, a bassa voce. I due ridacchiano guardando Jean-Marie e Melchior, che non sanno più cosa fare. – Sai cosa ti dico? Io mi fido di Michelle. Lei sa riconoscere dov’è il bene! La Provvidenza farà il resto – dice Jean-Marie. – Va bene. Proviamoci. Vecchio, ti possiamo solo dare una camicia quasi nuova – conclude Melchior. Il vecchio annuisce, continuando a fumare e a parlottare con Michelle. Il gruppo decide di aspettare l’imbrunire per attraversare la frontiera e di riposarsi fino a quel momento. Quando l’oscurità è abbastanza profonda, il vecchio si alza e fa un cenno ai giovani. Si mettono in fila e si incamminano in silenzio. Jean-Marie e Melchior tentano di capire dove li stia portando il vecchio, ma il buio è talmente fitto che dopo mezz’ora ci rinunciano. Sono proprio nelle mani del matto del paese. I passi pesanti lungo il sentiero colgono i due impreparati. – Alt! Chi va là! E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 64 64 La voce imperiosa è a venti metri da loro. Non passa che qualche secondo e all’ordine segue il rumore secco e ritmato del caricamento del mitra. – Chi va là! Fatevi riconoscere o sparo! – Mio caro Deogratias, sei sempre il solito. Possibile che non sai ancora riconoscere il rumore dei miei passi? La voce del vecchio è calma, la follia sembra scomparsa dal suo volto mentre si avvicina al militare. I due giovani si sono intanto acquattati e Melchior ha messo per precauzione una mano sulla bocca della bambina per evitare che faccia rumore. – Ehi, vecchio, mi hai fatto preoccupare. Cosa ci fai a quest’ora da queste parti? Non sei a dormire? – chiede il soldato, che deve conoscerlo da lungo tempo. – La vecchiaia è una brutta cosa, figliolo. Non riesco mai a prendere sonno. E poi stanotte sono sicuro di ritrovare la mia gallina – risponde. – Ancora con la storia della gallina? Lo vuoi capire che oramai la tua gallina è nella pancia di qualcuno? – dice ridendo Deogratias. – Non dire così! Sai che non è vero. E poi gli spiriti mi hanno detto di cercarla qui… – Va bene, vecchio, cerca la tua gallina. Fammi sapere quando l’hai trovata. Buona notte. La grassa risata del militare echeggia nella foresta mentre si allontana velocemente. Il vecchio ritorna dai giovani, fa cenno di alzarsi e il gruppo riprende il cammino. – Vai veramente a cercare la tua gallina? – chiede Melchior. – Mio caro, devi sapere che essere matto è una gran bella condizione. Puoi raccontare quello che ti pare, anche le cose più incredibili, e tutti ti crederanno senza batter ciglio. Con la storia della gallina perduta ho accompagnato di là dalla frontiera un sacco di gente, non so più neanch’io quanta, gente che aveva guai con la giustizia o non so che cosa. Devo dire che quel povero Deogratias comincia a farmi quasi pena… Non passa neanche un’ora che il matto si gira verso Jean-Marie e gli dice: – Datemi la camicia. – Perché? – chiede il sacerdote. – Perché siete liberi. Il Ruanda è alle vostre spalle. Jean-Marie si gira e incontra gli occhi di Melchior, i due si stringono in un forte abbraccio, sotto lo sguardo interrogativo della bambina che, sentendosi esclusa, comincia a strattonarli. Allora Melchior la prende in braccio e le schiocca un sonoro bacio sulla fronte. – Visto che sei stata così brava, ti dirò ora quello che ti ho promesso – le dice ridendo. – Il nome! Il nome! – Espérance17. Ti chiamerai d’ora in poi Espérance. da AA.VV., Diversi, ma uguali, Signorelli 17. Espérance: parola francese che significa «speranza». E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 65 65 5 LA NOSTRA SOCIETà MULTIETNICA, TRA ACCOGLIENZA E RAZZISMO p. 151 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 5a AA.VV., I pregiudizi (in Vorrei vivere una giovinezza bella, Edizioni il capitello) I pregiudizi Vivere insieme a persone «straniere» che hanno una mentalità diversa dalla nostra è quello che ciascuno di noi deve imparare a fare: per scelta consapevole o, più semplicemente, perché costretto dalle circostanze. La convivenza è un’«arte complessa» (definizione tratta da M. Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili, Bruno Mondadori) che non si può improvvisare. È necessario agire su molti fronti, senza dimenticare che nessuna soluzione estrema (tentativi d’isolamento, espulsioni forzate o, al contrario, accettazione senza controllo) ha mai dato esiti positivi. E, soprattutto, bisogna dimostrarsi tanto aperti di mente da rinunciare a credere in stereotipi che sembrano voler definire in maniera inequivocabile il carattere di un popolo. Gli «stereotipi» sono idee che non cambiano, valutazioni su qualcosa o qualcuno date per sicure prima ancora di conoscere ciò di cui si parla. Uno «stereotipo» è anche un «pregiudizio», tanto più grave quanto maggiore è il numero di persone che coinvolge: com’è possibile vivere accanto non a una sola persona, ma a un intero popolo che si giudica in modo negativo? Del resto, oggigiorno, dire a qualcuno che è uno «straniero» è molto strano, non soltanto perché l’Unione Europea ha di fatto abbattuto molte frontiere, ma anche perché ciascuno di noi ha ereditato da culture diverse stili e modelli di vita (certe pietanze, il credo religioso, il modo di scrivere o di contare, persino la meta delle vacanze…). Ecco un breve testo in lingua tedesca: si tratta di una poesia intitolata Cittadini del mondo. Che cosa si dice, secondo te? Dein Christus ein Jude Dein Auto ein Japaner Deine Pizza italienisch Deine Demokratie griechisch Dein Kafee brasilianisch Dein Urlaub türkisch Deine Zahlen arabisch Deine Schrift lateinsch Und Dein Nochbar nur ein Ausländer? Il fatto che esistano «barriere mentali» che è necessario superare, per accettare gli altri e saper vivere insieme in armonia, non significa dire che l’immigrazione sia un fenomeno sempre e comunque positivo o che si debba consentire in modo incontrollato. Di immigrazione si discute moltissimo e ogni uomo politico ha la sua «ricetta» o la sua proposta per affrontare il problema. «Punti caldi» nel dibattito politico sono soprattutto l’immigrazione clandestina e quella islamica, associata spesso, nell’immaginario collettivo, al terrorismo e agli attentati suicidi. 5B Fabrizio Gatti, Schiavi nel XXI secolo Il brano è presente nella sezione ONLINE «Il piacere di leggere», Antologia vol. 3 (7. Noi cittadini del mondo). Leggilo con attenzione, poi approfondisci il tema dei DIRITTI UMANI con le seguenti notizie pubblicate da Amnesty International. E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE 66 66 LA PAROLA AGLI ESPERTI PER APPROFONDIRE... I diritti umani Nel 1948 è stata proclamata dall’Onu la Dichiarazione universale dei diritti umani, per affermare il valore di ogni individuo. Sicuramente ne avrai già sentito parlare, ma sapresti dare una definizione appropriata di «diritti umani» e precisare in che cosa consistono? Ecco alcune notizie in materia pubblicate da Amnesty International, un’associazione non governativa che dal 1961 si batte per il rispetto della dignità umana in ogni parte del mondo. Che cosa sono i diritti umani? I diritti umani sono l’elemento fondamentale che consente a ogni persona di vivere con dignità in quanto essere umano. Soltanto grazie ad essi, infatti, è possibile costruire la libertà, la giustizia, la pace ed è rispettandoli che l’individuo e la comunità possono svilupparsi integralmente. L’evoluzione dei diritti umani ha le sue radici nei grandi avvenimenti della storia umana, in particolare nella lotta per la libertà e l’uguaglianza ovunque nel mondo. I principi basilari dei diritti umani – come il rispetto per la vita e per la dignità umana – sono inoltre presenti nella maggior parte delle religioni e delle filosofie. Essi sono proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Altri documenti, come le convenzioni internazionali sui diritti umani, stabiliscono cosa i governi devono o non devono fare per garantire i diritti delle cittadine e dei cittadini. A n n n aratteristiche C dei diritti umani I diritti umani non devono essere acquistati, guadagnati o ereditati: essi appartengono a ogni individuo sin dalla nascita. I diritti umani sono quindi «diritti naturali». n I diritti umani vanno intesi come un insieme: infatti concorrono tutti assieme alla costruzione della libertà, della sicurezza e di un dignitoso tenore di vita per ogni individuo. Se un diritto viene minacciato, sono minacciati tutti gli altri diritti. I diritti umani sono quindi «diritti indivisibili». I diritti umani sono gli stessi per tutti gli esseri umani, senza distinzione di origine etnica, sesso, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale. Tutte le persone nascono libere e uguali in dignità e diritti. I diritti umani sono quindi «diritti universali». In genere i diritti umani sono suddivisi in tre categorie: I diritti umani non possono essere sottratti: nessuno ha il diritto di privarne un’altra persona, per nessuna ragione. Gli individui conservano i diritti umani persino quando le leggi dello Stato non li riconoscano o li violino: in caso di schiavitù, per esempio, gli schiavi conservano i propri diritti anche se essi sono apertamente violati. I diritti umani sono quindi «diritti inalienabili». 1. Diritti civili e politici (detti «diritti di prima generazione»). Sono «orientati alla libertà». Comprendono il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona; alla libertà dalla tortura e dalla schiavitù; alla partecipazione politica; alla libertà di opinione, espressione, pensiero, coscienza e religione; alla libertà di associazione e riunione. B Categorie dei diritti L IAl PAROLA p i a c e r e AGLI d i l Ee SP g gEeRTI re 67 2. Diritti economici e sociali (detti «diritti di seconda generazione»). Sono «orientati alla sicurezza». Comprendono il diritto al lavoro; all’educazione; a un soddisfacente tenore di vita; al cibo; a un’abitazione e alla salute. 3. Diritti ambientali, culturali e allo sviluppo (detti «diritti di terza generazione»). Comprendono il diritto di vivere in un ambiente pulito e protetto dal degrado e i diritti allo sviluppo culturale, politico ed economico. Quando affermiamo che ogni individuo deve godere del riconoscimento dei propri diritti, affermiamo anche che ogni individuo ha la responsabilità di rispettare i diritti degli altri. C La Dichiarazione universale dei diritti umani Il documento più famoso sui diritti umani è la Dichiarazione universale dei diritti umani (DUDU). Il suo messaggio centrale è il valore fondamentale e innato di ogni essere umano. La Dichiarazione è stata adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 all’unanimità, con la sola astensione di otto paesi. Comprende un insieme di diritti ritenuti fondamentali per ogni essere umano, senza fare distinzioni di appartenenza etnica, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altre condizioni. Afferma che i governi hanno promesso di difendere alcuni diritti, non solo per le cittadine e i cittadini ma anche per le persone di altri paesi; in altre parole, i confini nazionali non sono barriere che impe- discano di aiutare altri esseri umani a ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Dal 1948 la Dichiarazione ha rappresentato lo standard internazionale dei diritti umani. Nel 1993 una conferenza mondiale di 171 stati, il 99% della popolazione mondiale, ha ribadito il proprio impegno per i diritti umani. D Status legale Sebbene la DUDU sia il documento che ha ispirato la maggior parte della legislazione internazionale in materia di diritti umani, non è in sé un documento legalmente vincolante. Tuttavia, come affermazione generale di principi, ha una certa importanza nel mondo dell’opinione pubblica. I suoi principi sono diventati strumento legale con il Patto internazionale sui diritti civili e politici (International Covenant on Civil and Political Rights, in sigla ICCPR) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, in sigla ICESCR). I paesi che hanno ratificato questi Patti si impegnano a promulgare leggi volte alla protezione di questi diritti umani. Purtroppo, più della metà dei paesi del mondo non li ha ancora ratificati. Esistono inoltre strumenti regionali per i diritti umani ispirati alla DUDU, come la Carta africana dei diritti umani e dei popoli; la Convenzione europea sui diritti umani e la Convenzione americana sui diritti umani. Anche molte legislazioni nazionali garantiscono i diritti umani. Amnesty International, Primi passi, EGA L IAl PAROLA p i a c e r e AGLI d i l Ee SP g gEeRTI re 68 6 L’uomo e la natura: il dovere di vivere in armonia p. 152 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 6A Fulco Pratesi, Son tornate le cicogne Il brano è presente nella sezione ONLINE «Il piacere di leggere», Antologia vol. 1 (5. Un mondo da salvare). 6B La lotta contro i cambiamenti climatici. L’UE apre la strada -µ&VSPQBJONPWJNFOUP -BMPUUBDPOUSPJDBNCJBNFOUJ DMJNBUJDJ -µ6&BQSFMBTUSBEB 69 69 6OJPOFFVSPQFB Per documentarti in maniera completa, collegati a: http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/75/it.pdf E s e m p i d i t r a c c e d i c o l l o q u i o , c oI ln pe isapcaenr se i od n i i l eONLIN g g e r eE
Scaricare