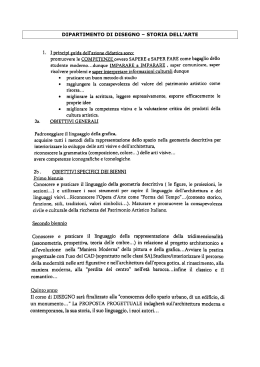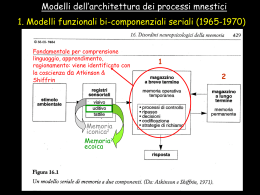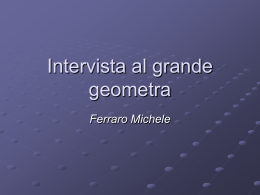4 EDITORIALE Renato Nicolini Pubblicando Cemento romano la CLEAN richiama alla nostra attenzione Cemento amato analogo libro d’interviste agli architetti napoletani. Che differenza tra le due città! A Napoli domina il piacere dell’architettura, l’orgoglio di avere costruito… Solo partendo dalla verità si può fare critica, e l’eccesso della propria convinzione non la maschera certo. Ne usciva un quadro vivo del potere, Marcello Canino che lascia cadere di nuovo a terra il monocolo che un allievo gli aveva raccolto, e lo schiaccia accuratamente col piede… E’ difficile raccontare con più efficacia il complesso rapporto tra vecchio e nuovo, l’ostacolo rappresentato da una simile convinzione nelle ragioni della tradizione, e per contrasto il valore liberatorio di quello che – malgrado questo – si è fatto d’innovativo… Cemento amato è stato uno dei primi libri a rompere in maniera convincente con le storie dell’architettura troppo schiacciate sulla politica, in bianco e nero, da un lato i reazionari dall’altro i progressisti. Forse le cose più importanti che sono state fatte in Italia sono quelle anfibie, ad esempio il sistema di tutela dei beni culturali in Italia, fondato sull’autonomia delle Sopraintendenze e sugli Istituti Centrali, messo a punto di Cesare Brandi e di Giulio Carlo Argan quando era ministro Bottai, dunque sotto il fascismo. Questo testimonia l’importanza dell’autonomia, la specificità del contributo dei singoli progettisti… A Roma regna invece tra gli architetti la vocazione al pentimento, la necessità di rivedere, riscrivere, a volte quasi completamente, quello che si era detto a Diego Lama… E’ come se la verità non fosse mai tale (certo, si può sempre ripensare, ci si può pentire, solo i cretini – come è noto – non cambiano mai idea…) ma qualcosa di perennemente indefinito e provvisorio, su cui si può sempre tornare sopra, per meglio armonizzarla al quadro delle convenienze d’insieme… E’ tanto più singolare – partendo da queste premesse d’orgoglio – la relativa assenza degli architetti napoletani nelle polemiche discussioni sul Comune di Napoli inevitabilmente innescate dalle prossime elezioni. Sentendomi legato a Napoli, ho pensato di rispondere alle sollecitazioni di Benedetto Gravagnuolo perché chiedessi le primarie del PD, non già candidandomi ma mettendo per iscritto le mie idee. Così è nato PeramareNapoli, che la CLEAN si appresta a stampare, arricchito da 21 illustrazioni, 7 architetti, 7 fotografi, 7 artisti… Non mi interessa la possibilità di successo di queste proposte, il loro gradimento, ma la loro rispondenza alla mia idea di quello che servirebbe alla città. Mi piacerebbe che altri seguissero il mio esempio… La città, l’architettura e la politica hanno bisogno, per ritrovare linfa vitale, di liberarsi dal peso del calcolo opportunista – che molte volte mi sembra alla radice dell’astrattezza e della perdita della capacità di emozionarsi, di mettersi in gioco, di indignarsi… Il potere pubblico esercita di per sé una sorta di ricatto permanente sui progettisti… E’ il potere a decidere gli incarichi, a selezionare… E’ l’unica ragione che mi viene in mente per spiegare le troppo poche denuncie per l’indecisionismo che ha caratterizzato questioni delicate come quelle di Bagnoli, di Napoli Est, del mancato recupero delle periferie del dopo terremoto (i cui progetti pure Antonio Cederna aveva indicato come esempio di qualità europea…), del degrado del centro storico, della decadenza di progetti come il Museo Aperto ed il Maggio dei Monumenti. Eppure, Napoli ha una sua tradizione di rapidi recuperi, di iniziative che stupiscono… Non è mai troppo tardi per riaffermare le ragioni del progetto, la sua capacità di rovesciare le aspettative, di collegare domini separati, di indicare la strada del nuovo… Oggi appare imprevedibile, impossibile: domani ci potrà meravigliare l’evidenza delle connessioni che fino all’ultimo non sapevamo vedere. 5 L’INVENZIONE ARCHITETTONICA ALL’EPOCA DELLA PERDITA DEI CONFINI Aldo De Poli Questo testo raccoglie i temi presentati in una conferenza tenuta presso il Dipartimento Arte, Scienza e Tecnica del costruire dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. La lezione era rivolta agli allievi del Dottorato di ricerca in Progettazione architettonica ed urbana “Il progetto dell’esistente e la città meridionale”, diretto dalla prof.ssa Laura Thermes. Qualche tempo dopo, lo stesso testo, registrato sotto la forma di un’intervista in un’aula di Parma, è stato trascritto a cura di Marcello Marchesini ed è stato inserito nelle pagine della sua tesi di dottorato del XVI ciclo, dal titolo “Innovazione come trasgressione in architettura. Dalle avanguardie storiche alla ricerca contemporanea del nuovo”. Dall’intero testo rimasto inedito, si è poi estratta una versione ridotta che è stata pubblicata in Architettura di rara bellezza, catalogo del III Festival dell’Architettura di Parma, Reggio Emilia, Modena, tenuto nel 23-29 ottobre 2006, edito a cura di Enrico Prandi da Festival Architettura Edizioni, Parma 2006, a pp. 170-179. Qualche altro stralcio è stato inserito arche in corti articoli apparsi sulla rivista di architettura “Area”. Trasgressioni collettive e trasgressioni individuali 1 Sono considerate regole quelle convenzioni che valgono solo per dei brevi periodi della storia. In genere prendono origine da una forte intuizione individuale. Ma dopo una prima affermazione, quando già inizia ad affermarsi una generazione successiva, mutano di segno: così è successo tra Boullée e Durand, tra Malevič e El Lissitskij, tra Le Corbusier e alcuni (cattivi) seguaci. Diventando convenzioni, le pratiche applicative possono anche finire per mettere in cattiva luce i principi innovatori di un maestro. Esistono due tipi di trasgressione: una trasgressione individuale ed una trasgressione collettiva. La trasgressione individuale si ha ogni volta che si interpretano nel concreto dei sistemi acquisiti di regole. Sulla spinta di un forte apporto soggettivo, tali certezze vengono quotidianamente messe in discussione. Procedere verso la trasgressione collettiva invece è un compito del tempo, è il compito della storia. Per evitare penose caricature, i compiti dei diversi attori sociali devono essere bene espliciti. Nel corso degli anni si ripete sempre un medesimo processo. Mentre compete alla società il compito di sovrintendere al progetto dei significati, quindi il dar valore o il togliere valore ai principi come atto consapevole di attribuzione di identità sociale, all'architetto o al tecnico resta il più riduttivo compito di occuparsi del progetto delle forme. Ogni gruppo di valori, all'inizio si afferma in una forma contraddittoria, sperimentale, arcaica, persino violenta e di parte. Poi, poco a poco, la sua necessità viene meglio definita e tutto trova un ruolo. Il valore collettivo diventa, di volta in volta, codice, regola, precetto, manuale, ma anche uso, licenza, moda, amenità o bizzarria. Nelle fase matura iniziano ben presto invisibili momenti di trasgressione. Prima attraverso piccoli episodi di elaborazione individuale, poi attraverso un repentino atto di rottura, accanto ai significati, cambia il modo di presentarsi delle forme, finché ad un tratto a tutti è evidente che si è affermato un altro, diverso, persino rivoluzionario, sistema di valori. I momenti di trasgressione individuale ci saranno sempre, perché sono la materializzazione di un ovvio processo logico, dall'astratto al concreto, dal collettivo all'individuale, dal noto all'ignoto. Talvolta, romanticamente, definiamo questo ignoto come valori poetici, o apporto individuale all'identità epocale. E non si tratta di una trasgressione intesa come superamento: non credo che Borromini sia più barocco del suo tempo. Rispetto all'identità del suo tempo è forse meno scolastico, è meno universalista, è più inquieto. Sa organizzare in modi inediti la sperimentazione, ma non rappresentata di per se un'alternativa al suo tempo, perché egli stesso è il Barocco. Questo dimostra che la trasgressione individuale, involontaria, osservata minuto per minuto, in quanto interprete dello spirito del tempo, è sempre accettata. Anzi diventa necessaria. Ci sono poi anche altre trasgressioni collettive, che potremmo definire delle mancate mutazioni. Le idee emigrano molto lentamente e un atteggiamento culturale per affermarsi a fondo ha bisogno di molto tempo. Tra esperimenti e verifiche le idee vivono intensamente, per almeno il tempo di una generazione, per poi forse ripiegare, ma per non scomparire mai più. Un primo esempio, per positivo: la lunga stagione del Palladianesimo internazionale, con i lenti passaggi concentrici da Roma a Washington, da Vicenza a Pietroburgo. Un secondo esempio, per negativo: dove è finita la peggiore eredità del Movimento Moderno, quella raffigurata sugli scarni telai edilizi semplificati in c.a.? Questa innovativa tradizione, a favore della casa per tutti e della città per tutti, non è mai scomparsa, anzi oggi, in gran parte del cosiddetto "terzo mondo", si afferma come la principale cultura 1 Cfr. A. De Poli, Creare è facile. Imitare è difficile. Sette diversi modi di attuare nel progetto un principio di intenzionale imitazione, in “Area”, n. 51, 2000. 6 costruttiva del tempo presente. Mai del tutto cancellata, per continuità o per necessità, continua a manifestarsi. Anche molto vicino a noi. Permanenze regionaliste ed eredità razionaliste Ogni contesto culturale può fornire un esempio di come dei gruppi di valori di diversa origine si possano rapidamente trasformare in acclamate convenzioni. Persino il patrimonio di forme di produzione popolare, espresso dal Regionalismo può essere considerato materia di studio per un'accademia, al pari di un omogeneo corpus di altri precetti formali. Questo avviene perché anche un riduttivo regionalismo incompiuto, sa esprimere regole. Soprattutto oggi che può essere assunto per frammenti e può essere simultaneamente declinato a scale diverse. Dalla ripresa della struttura dell'insediamento urbano alla permanenza di un tipo edilizio tradizionale, da una stretta relazione con un ambiente naturale all'impiego smaccato di una rustica pietra a vista. Tutto va rivisto in termini nuovi. Perché c'è anche chi, oggi, propone volontariamente uno spazio urbano di intenzionalità regionalista, cercando di ricreare una sorta di un antica spazialità pre-industriale e pre-razionalista, magari con edifici modernissimi. E non si tratta di Leon Krier, ma di Renzo Piano. Egli diventa regionalista quando a Berlino suggerisce espressamente una spazialità urbana delimitata, senza stacchi, una zona pedonale, con nuove finte pietre, dai toni in terra di Siena, che è il contrario di tutte le regole della crescita della città di Berlino, con i suoi scanditi allineamenti, i suoi volumi fissi e le sue strade di ampia dimensione. Oggi si può essere regionalisti anche in un solo lato di un nuovo edificio: citando una copertura a falda, un camino esterno, una balaustra o una pergola, come nelle case dell'area Saffa di Vittorio Gregotti a Venezia. Si può essere regionalisti anche solo nella scelta di un materiale: attraverso una parete non intonacata, come nella casa Alessi di Aldo Rossi, oppure mediante un'apertura in vetro alla Mies tra possenti pareti di pietra, come nel regionalismo astratto di Eduardo Souto de Moura. Persino il vernacolare, i tanti vernacoli del mondo, in modo imprevisto, possono esprimere dei sistemi di regole, che diventano meglio visibili ad altre scale dimensionali e in impreviste occasioni di applicazione. Anche se sembra offuscata dalla nostalgia, esiste una vivace trasgressione sottile che non comporta da subito nuovi patrimoni di segni mai visti. Da dove nasce allora il nuovo? Questo nella storia si verifica per gradi: ad un certo punto qualcuno, usando gli stessi strumenti di prima, ma dilatando, accorciando, spostando, cambiando di ruolo, dà forma e apparenza ad una nuova composizione di elementi, ricomponendo in un altro modo elementi di per se già noti. Il nuovo assetto spaziale cresce, si espande, si trasforma e ancora, dopo una generazione, può forse diventare regola condivisa. Tuttavia, i grandi movimenti culturali, che portano con se un'innovativa concezione dello spazio, restano ancora pochi. In tutto il dopoguerra se ne riconoscono solo un paio. Il Post-moderno, ad esempio, è stato un movimento di fortissime radici, e ciò è accaduto quando il nuovo si è ridotto a una variazione di facciate, oppure alla narrazione dello stesso brano con altre parole, ma non con altri codici; si pensi, per esempio, all'AT&T Building di Philip Johnson. Nessun altro edificio americano postmoderno degli anni ‘80 ha per davvero innovato un volume in sezione, proponendo una diversa articolazione dello spazio. Al contrario, al di là dei successi mediatici, è possibile accogliere come una nuova espressione quella spazialità anche paradossale, espressa dalle opere di Frank Gehry, accanto alle recenti proposte di Diller & Scofidio, con quell’accanito lavoro sulle forme continue e sulle strutture a nastro. Sta crescendo una nuova generazione di forme concave e convesse. Se ne vedranno presto tra noi altri esempi, sia originali, sia dirette imitazioni. Ciò significa che, a Novecento finito, è necessario ridimensionare certe svolte inizialmente ritenute importanti, ma che si sono già dimostrate, nella realtà, molto più effimere di quello che si credesse all'inizio. Solo poche grandi tensioni generano nuove radicali concezioni di spazio: forse una o due per ogni secolo. Occorre allora fare piazza pulita di alcuni atteggiamenti culturalisti tutti a favore della novità estetica, complici di posizioni d'avanguardia di corta durata. Se oggi molta architettura del terzo mondo, tra tanti disastri è ancora involontariamente razionalista, se non lecorbusierana, vuol dire che sopravvive nel mondo una cultura sociale di bisogni tardo-razionalisti. Ciò vuol dire che c'è un'inerzia di comportamenti diffusi, che c'è una realtà concreta molto più forte di quella vetrina rappresentata del mercato delle immagini, con la sua esistenza artificiale alimentata da piccoli aggiustamenti espressi da continui colpi di scena. La trasgressione collettiva, che c'era all'inizio di una nuova fase, non si è esaurita, anche se le fasi storiche che l'hanno determinata si sono ormai confuse e sovrapposte. Una prevalente condizione eclettica Molto del nuovo portato in Italia dal gusto liberty si è tradotta in realtà un'affermazione di controllato eclettismo, frutto di lezioni storiciste. Lo si vede negli insegnamenti di Boito e nei suoi allievi come Sommaruga, oppure lo si vede nello storicismo esotico di D'Aronco; c'è in più una forte componente artigianale, tutta italiana, di pezzi unici, che non ha poco a che vedere con l'estetica per l'industria. Nell'eclettismo italiano non c'è alcuna 7 intenzione di fondare uno stile, si trovano invece molte culture che hanno tutte una loro storia. Agli architetti non compete il compito di dover creare uno stile. Non se ne devono preoccupare, perché un tale compito appartiene, semmai, alla società. Chi si esprime in questo modo, creando fuorvianti equivoci sono soprattutto gli storici dell'arte, da Hope a Pevsner, che degli edifici, guardano per prima cosa le facciate. Non aiuta molto chi, con un facile messaggio, cerca l'avanguardia nel dettaglio di una facciata. All'inizio non era così. Seri autori, ancora del XIX secolo, usavano ben altri approcci: lo stile è il sangue o la linfa, afferma ad esempio Viollet-le-Duc. E questa linfa alimenta un corpo che continua lentamente a cambiare. Nella sua volontà di ammaestramento, trasmessa da un uomo colto della seconda metà dell'Ottocento, egli invita a non confondere la questione dello stile con quello della forma: ci può essere una forma gotica, una forma rinascimentale, una forma contemporanea, ma ciò non significa che l'apparenza debba per forza diventare un codice. Non riuscendo a diventare stile, l'eclettismo dell'inizio del secolo, diventa altro. Diventa desiderio, erudizione, avvicinamento al mondo presente, attitudine collezionistica, estratto del catalogo delle esposizioni industriali, perdita di ideologia, bisogno di identità. Molti ismi si caricano di una connotazione politica e, al di là della flessibilità estetica che avevano all'inizio, diventano un codice utile per fissare un'identità culturale regionale. Come nel caso del particolarismo magiaro o del particolarismo sloveno, riaffermato in opposizione a quello austriaco all’inizio del XX secolo. Rispetto ad altre tradizioni artistiche europee, curiosamente in Italia nelle fasi iniziali non si cerca di denominare autonomamente un movimento dai nuovi connotati, ma vi si antepone un tranquillizzante neo. Neoclassico, neogotico, neorealismo, neoliberty. I bilanci, si sa, richiedono responsabilità sgradite. Come afferma Umberto Saba, gli italiani non potranno mai fare la rivoluzione, perché non sono parricidi. Mascherato dal neo, si preferisce far prevalere il senso della riproposta. Con il consenso di tutti l'impegnativa consacrazione del nuovo può attendere. Multicuralismi e pluralità figurativa Alla conclusione del XX secolo l'eclettismo ha perso la sua valenza nostalgica. Molto importante è l'apporto teorico di Robert Venturi, che, insieme a Aldo Rossi, è un grande innovatore della teoria dell'architettura della seconda metà del XX secolo, per la sua capacità di trasformare il ruolo delle parti che compongono l'architettura. In contrasto a quella dilagante pluralità di lingue, che Adolf Loos definiva come il parlare esperanto. Se Aldo Rossi rivaluta la memoria e la grande cultura senza tempo, Robert Venturi oppone la sua nozione di multiculturalismo. Il multiculturalismo trasmette valori, perché evoca un mondo a più voci, con meno certezze e più protagonisti, che però mantiene intatta la centralità dell'impegno dell'architetto. Non viene eluso il potere di scegliere, ma non viene più posto il problema della coerenza. In “Out of ordinary”, di fatto, Robert Venturi dichiara di non fare parte di nessun movimento, di essere in grado di usare tutte le tecniche di progettazione assorbite nel corso della propria esperienza trentennale nell'architettura contemporanea e fa capire di essere anche capace, forse, di segnalare nuovi codici. A noi interessa capire come la posizione di Venturi, altrettanto di quella di Aldo Rossi (anch'egli noto viaggiatore e sperimentatore di più universi formali, dal classico all'esotico), si ponga in contrasto con i monoculturalisti della propria generazione. Quali erano allora i Five o gli Hit Tech. A questo punto, il problema di Gio Ponti è lo stesso di Rafael Moneo: c'è un atteggiamento ideologico che è caduto. Si iniziano a riscoprire gli intrecci di un'integrità compiuta anche nel multiforme Le Corbusier con la sua componente classicista, beaux arts, razionalista, figurativa e regionalista. Se la coerenza del linguaggio si presenta come un falso problema, lo è anche la coerenza con lo spirito del luogo. Se oggi in un nuovo edificio, che collocato in un contesto storico, a differenza della classica Rotonda, presenta su ogni lato un fronte diverso, non è certo per una mal interpretata ragione di stile, ma è perché ogni fronte è riuscito a stabilire una diversa relazione con i caratteri espressi dal luogo o dal contesto. Al contrario dello stile, la pluralità figurativa diventa indice di radicamento, perché segna la conclusione di un percorso conoscitivo. Perché l'accoglienza di ogni multiculturalismo, diretto e indiretto, arricchisce l'identità del luogo. Oggi, i vocabolari sono altri. Ma bisognerebbe meglio riconoscere quale potere di sintesi abbiano assunto figure controverse, come Rem Koolhaas o Herzog & de Meuron. Di fronte a posizioni così lontane, c'è da pensare che ci sia almeno uno, fra tutti, che in questo momento sta ancora sperimentando radicali occasioni di trasgressione individuale. Citazione, Copia, Riduzione simbolica, Meticciaggio, Alterazione Bisogna possedere dei codici condivisi, bisogna avere delle culture comuni2. La trasgressione funziona solo nell'ambito di una cultura comune: se tutti indossano vestiti pesanti, denudarsi è una trasgressione, mentre nel 2 A. De Poli, op. cit. 8 campo dei nudisti non lo è. Quindi è necessario, caso per caso, cogliere questi momenti di cultura comuni. Al di fuori delle definizioni di Robert Venturi, con questa specie di esotismo cosmopolita oggi imperante, non abbiamo più alcuna idea di architettura che si presenti come regola ben definita. Nelle teatrali elaborazioni di Jean Nouvel, esposte anche alla Triennale del 2002, non c'è più alcun segno che riporti il progetto ad un tempo ed ad un luogo naturale. Si notavano interni che sembrano degli esterni, si vedevano cortili coperti che sembravano radure di giardini con specchi d'acqua e gruppi di alberi. Ma anche piazze che sembravano grotte con luci notturne sempre accese anche in spazi illuminati dal sole. C'è oggi una strategia di comunicazione in digitale che ha contribuito ad abolire la natura, il tempo, il luogo, il giorno e la notte. Davanti a messaggi con così poche radici, così gratificanti, così artificialmente piacevoli, ma anche così complessi, davanti a volumi cavi così apparentemente edificabili anche se ricostruiti in post-produzione, non si capisce più che cosa si sta citando. Né un grattacelo, né una colonna, ma nemmeno un cilindro! Alludo qui all'ultima grande citazione trasgressiva che è quella evocata del grattacielo di Adolf Loos per il concorso del Chicago Tribune: che resta un'operazione molto concettuale dove principi di astrazione, omaggio al mondo latino, irrisione della funzione, decontestualizzazione e cambio di scala aprono nuovi punti di vista verso nuovi modi di comporre. E' finita la composizione per tipi a basso costo, con soluzioni spaziali predefinite come proponeva il Movimento Moderno. Si procede verso l'ignoto facendosi forza con figure indimenticabili sospese nel mito. Più che la copia, dunque, è la riduzione simbolica a interessarci. Giacché, se per citazione si intende in primo luogo la Trascrizione letterale di un preciso testo, o forma, o figura, la riduzione simbolica deriva da una Simulazione convenzionale. È molto diffusa in architettura, ma si presenta come una tecnica imitativa di difficile classificazione. Esige una cultura comune di valori semantici ampiamente condivisi. E’ la premessa per grandi invenzioni. Decontestualizzazioni semantiche e cambiamenti di significato Occorre un veloce cambio di mentalità. Il Movimento Moderno, come il classicismo, ci ha educato a vedere l'edificio come una realtà unica e compiuta, mentre in un edificio pubblico del mondo antico può essere riconosciuto anche per un solo un elemento di identificazione, quale la facciata del palazzo reale, la cupola della cattedrale, la torre civica del municipio, la loggia del mercato. Oggi dobbiamo riconoscere che anche i più dozzinali centri commerciali, con le loro fantasiose denominazioni, le Ciminiere, le Arcate, le Piramidi, le Torri, già forniscono un esempio di demonumentalizzazione dell'intero edificio a favore dell'attenzione sulla singola parte, caricata però dei massimi significati simbolici. Un esempio convincente è rappresentato dal progetto per l'Università Cattolica di Milano di Giovanni Muzio. Un solo intervento puntiforme, per la torre o porta di ingresso, unito alla biblioteca diventata aula magna, ha cambiato radicalmente il disegno di due grandi chiostri: con pochi interventi puntuali in contesti già molto strutturati si possono totalmente cambiare le relazioni, tra vecchio e nuovo. Così si supera l'importanza della citazione, che richiede consensi, culture comuni, licenze all'interno di regole. E si attua un principio intenzionale di riduzione simbolica. Oggi con un contesto generale più indefinito, con un'urbanistica che lascia la città senza autore, con gradi di libertà apparentemente illimitata sperimentabile in siti più circoscritti, si può contare su sistemi più complessi di nuove regole. Il progetto d'oggi interpreta antinomie di valori, che introducono pluralità di intenzioni, più limitati compiti celebrativi, sapendo sfruttare al meglio il sostegno di più tradizioni culturali. Partendo dall'accettazione di principi universali di aggregazione di forme semplici, il progetto d'oggi accoglie al suo interno una pluralità di funzioni diverse, ammette cambi di scala, accetta decontestualizzazioni semantiche e cambiamenti di significato. Molti processi compositivi d'oggi accolgono approcci che sono già stati sperimentati nel campo dell'arte. La trasposizione di una citazione, è, per esempio, scrittura frequente nella composizione musicale e nel testo letterario. Ma torniamo alla colonna. Un esempio di citazione, che diviene riduzione simbolica è la colonna d'angolo. Quell'immagine che Aldo Rossi, trae da un angolo di un palazzo esistente a Venezia, lungo il Canal Grande, forse progettato dal Filarete. Quella perentoria solitaria colonna come conclusione della facciata, così bianca, disadorna, monolitica, alta quanto l'edificio, viene riproposta per risolvere altri spigoli: prima a Perugia, poi a Berlino, poi a Milano. Se doppia riappare a Torino, se multipla dilaga a Fukuoka. Sia che rappresenti l'esito unico di una colta operazione intellettuale, sia che sprofondi tra altri segni in un pasticciato collage pop, nella relazione che stabilisce con tutto quello che abbiamo chiamato regole, l'uso iconologico di questa colonna anticipa un altro modo di comporre. Perché contribuisce a determinare l'identità del luogo trasferendovi echi di nuovi mondi multiculturali. Non è più un palastro o una lesena, ma è un vero edificio o una parte di un edificio. Come la nota scultura di Cèsar, quel pollice alto quanto un paracarro, dalla superficie dorata, che sta al centro di un vuoto, non comunica più l'immagine di una parte del corpo umano, così conclu- 9 dendo una lunga catena di citazioni dotte, la colonna può diventare pura astrazione. C'è stato molto lavoro intellettuale intorno, su dimensione, materiale, espressione creativa. Ora è diventata un'altra cosa: fronte edilizio, limite urbano, segnale nella metropoli, teatro della memoria. Quando dalla storia per un solo elemento edilizio si attingono tante identità, il guardare indietro e in avanti diventa condizione normale per avanzare. C'è di più di una citazione. E' evidente che vorrebbe un nuovo vocabolo. Reinventare delle mitologie condivise Accettazione di non luoghi, di non scelte, di non identità, accettazione di essere senza radici perché si è degli eterni immigrati: è facile, allora, avere bisogno di alcune mitologie collettive, che aiutino ad affrontare processi che sono in continua evoluzione. Il ruolo della mitologia, ed anche della religione, non deve essere quello di dare risposte preconfezionate e dogmatiche, ma deve far guardare lontano, adattando i grandi valori ai bisogni della gente. Ecco un esempio. Oggi in India tra le circa seimila divinità della tradizione indù, è stata riportata in auge la venerazione verso una coppia di dei, marito e moglie, presentati assieme a due bambini grassi (grasso in India significa benessere). Negli ultimi anni si sono diffuse ovunque le immagini sacre di tale coppia, che è venerata nelle case nel ceto medio, con tanto di lumino acceso. Estratta dal profondo del mito millenario, al momento giusto, è stata riportata in primo piano una coppia di esseri superiori, che bene rappresenta e protegge le nuove famiglie mononucleari, che lentamente si emancipano dal modello, ancora prevalente, della grande famiglia patriarcale. L'esempio dimostra come una mitologia in continua evoluzione e una religione viva siano capaci di dare una risposta "alta" ad un certo preciso bisogno della società. Così dovrebbe avvenire nella politica. In fondo così avviene anche per l'architettura: non abbiamo una lettura circostanziata del passato, abbiamo una lettura retrospettiva del passato; cerchiamo di tanto in tanto conferme di valori, dimenticando tra operazioni di oblio e di rivalutazione, la consistenza delle risposte già date. Di fronte a un evidente spaesamento, cerchiamo in qualche modo delle premesse consolatorie, perché, proprio nel passato c'è quel dèjà vu di cui abbiamo bisogno. Quando si arriva a desiderare la copia di ciò che già c'è stato, o la prefigurazione di ciò che si vorrebbe che ci fosse stato, si è già vissuto un percorso critico, dall'allusione all'ideazione. Così facendo si attraversano vari gradi di uno stretto rapporto con la tradizione. Si arriva alla citazione, alla copia, alla trasgressione, al meticciaggio e, alla fine, all'alterazione. Quando si arriva all'alterazione, le tracce della realtà precedente si sono dissolte: al loro posto c'è già un altro modello di comportamento. Tralasciando l’alterazione, in tutti gli altri casi, allusione, citazione, copia e trasgressione, c'è un fattore interpretativo nuovo che io chiamo riduzione simbolica; non è più la copia, ma è un sottile atto logico, che tiene conto della ricerca di avanguardia nella letteratura e nelle arti: cambio di scala, cambio di contesto, reinterpretazione di significato e soprattutto rinuncia a controllare l'intero accettando l'estetica del frammento. L’avanguardia nell’epoca della perdita dei confini Per incidere, un nuovo valore, deve investire quella condizione di saturazione del consenso che riesce ad esprimere solo una cultura quando è profondamente condivisa. Le trasgressioni collettive, viste molto in grande corrispondono a quelle che un tempo si chiamavano rivoluzioni. Esse sono sempre in corso, ma solo nei momenti di frattura diventano palesi a tutti, mentre in altri momenti si celano dietro tranquillizzanti sistemi di valori acquisiti. Non ci sono più le trasgressioni individuali avanguardistiche alla Duchamp: ci vorrebbero continue dimostrazioni per capire in che cosa consiste oggi l'avanguardia. Oggi per un cosmopolita cittadino del mondo la trasgressione prende le ovvie forme della contaminazione e del metissaggio. Tutto avviene molto in fretta come in un inevitabile processo extrasoggettivo. La difficoltà è saper conservare principi di orientamento. Per un severo cittadino europeo, che non vuole spartire nessuno dei propri radicati valori, la vera forma di trasgressione resta il proprio silenzio e l'autoiconoclastia, intesa come un rifiuto di comunicare la propria immagine. Quindi né Wahrol né Bukowski, ma Sallinger o Beckett, oppure Thomas Bernhard e Aki Kaurismaki. Proponendo un’intensa produzione c'è ancora, in Europa, chi riesce a far pensare, separando tra immagini e fatti reali, tra vita e opera. C'è ancora la possibilità di apprezzare un bel pensiero, dai toni elevati, espresso in assenza di clamore3. Salvaguardato così anche il supremo individualismo, oggi sembra che le grandi svolte avvengano altrove: ci sono veri sommovimenti che vanno cercati in mondi non troppo lontani, per esempio tra le ritualità dei nuovi barbari che condividono con noi la città. Certamente c’è del nuovo nelle controversie internazionali. Ci sono nuove espressioni culturali proposte da altre classi sociali del globo, che finora sono restate escluse. Ma ci sono anche nubi di pessimismo all'orizzonte. Si teme che prevalga l'irrazionale ed il mostruoso. 3 Cfr. A. De Poli, v. Teoria dell’architettura, in Enciclopedia dell’Architettura, vol. 4, edito a cura di Aldo De Poli da Motta ArchitetturaIl Sole 24 Ore, Milano 2008, pp. 254-259. 10 In certi romanzi recenti di letteratura d’avanguardia americana, si sta abolendo la terza e la prima persona. La terza persona è la storia, assicura la dimensione epica, mentre la prima, l'io narrante, da sempre dà voce alla coscienza. Molta letteratura americana recente è invece impostata sullo you, tu devi dire questo, tu devi fare questo, che deriva dal rap e dai precetti religiosi. Oggi, per la prima volta nel mondo anglosassone, i giovani scrittori di New York, bianchi e neri, parlano attraverso lo you. Forse il campo della trasgressione è questo: dar vita ad un diverso senso del tempo, far parlare un soggetto nascosto, evocare un protagonista della storia che neppure pensavamo che esistesse. Prima c'eravamo noi, con le nostre certezze epocali, poi c'ero io, con il mio solipsismo di individuo consapevole; oggi c'è anche un nuovo soggetto: tu, che viene interpretato da qualcuno che non sappiamo neanche chi sia. La mutazione riesce sempre ad esprimere un imperativo vitale, magari presentato in forma di slogan di facile memoria. 11 EDOARDO PERSICO ATTRAVERSO IL RICORDO DI ALFONSO GATTO Maurizio Cecchetti È come se quella pallottola cieca e vagante – quella della morte che viene senza preavviso – avesse colpito l’amico più caro accanto a noi, quello col quale dividevamo spalla a spalla la trincea, quello che vedeva più lontano e più chiaramente di noi; è come sentirsi vivi al posto di un altro, un altro che era l’amico e anche il faro, uno per cui ci saremmo esposti ai venti e alle tempeste per seguirlo ed essere all’altezza della sua profezia. È così che si leggono certe pagine che Alfonso Gatto scrisse negli anni Trenta ricordando Edoardo Persico («mi sembrava terribile che tutti gli uomini vivessero ingiusti al suo posto»: tutti gli uomini, dunque, anche se stesso). Per questo e opportunamente nelle pagine introduttive agli Scritti di architettura di Alfonso Gatto, editi ora da Aragno (pagine 236, euro 20), Giuseppe Lupo delinea una sorta di continuità del poeta italiano con la polemica e l’impegno etico di Persico, quando, dopo la morte di quest’ultimo nel 1936 (non aveva compiuto ancora 36 anni, condirettore con Giuseppe Pagano di «Casabella», in realtà ne fu il vero innovatore sia grafico che concettuale), Gatto firmò mensilmente alcune cronache sulle pagine della rivista fino al novembre 1938. Primo in Italia a capire davvero il nuovo linguaggio dell’architettura, primo a riconoscere la grandezza assoluta di Wright (anche su Le Corbusier, perché capace di dare all’architettura il suo massimo valore spaziale – metafora della “libertà dello spirito” in atto), Persico fu per molti, all’epoca, una specie di veggente. Napoletano, interlocutore per un certo periodo di Piero Gobetti, amico di Lionello Venturi, fantomatico viaggiatore nelle terre d’Europa fino alla Russia (ma forse è soltanto leggenda), avido e intelligente consumatore della stampa straniera, cattolico e lettore di Maritain, crociano e poi critico di Croce, dotato di uno stile evocativo, ricco di sfumature letterarie, e di una vasta cultura, Persico fu davvero il profeta e il paladino di un gusto nuovo, senza cascami retorici, e per questo "naturalmente" contro il classicismo fascista. Già Lionello Venturi – citato anche dallo stesso Gatto nel 1947 – aveva descritto con precisione l’aura mistica e il magnetismo che emanava da Persico: «Sentivamo che la sua cultura era grandissima, anche se aveva assai poco di comune con la nostra. E con meraviglia ci accorgemmo che d’un volo, senza scomporsi, giungeva là ove noi s’arrivava lenti e affaticati». Dunque non a caso, raccogliendone il testimone, Gatto firmava il necrologio di Persico su «Casabella» ponendo in esergo questa sua frase: «Gli artisti debbono affrontare, oggi, il problema più spinoso della vita italiana: la capacità di credere a ideologie precise, e la volontà di condurre fino in fondo la lotta contro le pretese di una maggioranza "antimoderna"». Bellezza ed etica ricomposte nella categoria di gusto, contro il sentimento dell’«inaridire fatalmente la nostra vita in un problema di stile». Detto questo, è bene ricordare le costanti del discorso di Persico che vengono espresse da Gatto con piglio dialettico assai diverso da quello profetico e sintetico – universalistico, vien da dire – dell’amico scomparso: Europa contro lo sciovinismo imperante negli anni del regime; critica della retorica classicista; ricerca dei punti fermi di un nuovo linguaggio moderno: il primato di Wright (ovvero dell’architettura come «messaggio umano e non soltanto tecnico», scrive nel 1945 Gatto vergando la prefazione al volume Architettura organica del maestro americano). Leggendo questi scritti usciti sotto diverse testate o in libro fra il 1935 e il 1976, si sente che, rispetto al fuoriclasse che aveva capito prima di tutti dove stava andando l’architettura nuova – e questo veniva a Persico da una intrinseca vocazione artistica che lo vide compagno di viaggio dei Sei pittori di Torino prima, e poi lavorare con Nizzoli e altri, progettando anche alcuni spazi a Milano –, Gatto è piuttosto il gregario che difende il vantaggio prodotto da «un esame critico che fondò in Italia la proprietà di un linguaggio storico per l’architettura». In realtà, ciò che Persico ogni volta introduce con uno scarto geniale spostando un po’ più lateralmente lo sguardo sui problemi per poterne cogliere meglio il contrappunto concettuale, in Gatto diventa resistenza rispetto a un confine che è quello guadagnato dall’amico scomparso. Non c’è dunque una elaborazione di nuove mete, o uno sguardo che apre nuovi scenari come spesso accade nelle parole di Persico, che hanno la forza di uno slogan o un motto ideale, c’è la difesa di quel che fin lì è stato raggiunto, e anche una forte presa di posizione etica, per esempio contro la speculazione che, già nel dopoguerra, metteva le sue mani sull’Italia e anziché produrre una più adeguata misura dell’abitare depauperava quel poco di buono che sopravviveva. Scrive Gatto nel 1964: «Si moltiplica la proprietà, ma le case, assicurate al nostro nome, "nostre" non sono più: non sono fatte a nostra somiglianza, allineate già sul nascere dalla esteriorità con cui sembriamo esporle agli occhi, quasi preservandole dall’uso. Sono case neutrali, in ghingheri, senza sostanza». E oggi, purtroppo, non c’è nemmeno questa qualità esteriore. Leggendo si ha la sensazione che Gatto sia stato, negli anni, il custode di una “memoria”; non quella delle idee, ma quella degli uomini concreti che hanno cercato di mettere in pratica un nuovo verbo, salvati di fronte alla storia in qualche caso dal loro aver pagato di persona: Pagano, Terragni, Giolli, Labò, Rogers, Banfi. Esaltati 12 e amati nell’aura luminosa lasciata dalla cometa, quella ideale di Persico, del quale oggi – purtroppo– esiste in commercio solo un volume, incompleto, degli scritti, mentre ben poco si è fatto negli ultimi vent’anni per approfondirne la figura, a tratti anche misteriosa, di critico di rango europeo che fu una delle coscienze intellettuali più lucide del Ventennio. 13 HABAKKUK Giacinto Cerviere Nell’Atlantico e forze Alleate nel 1942 erano impotenti di fronte agli U-boot, i terribili sottomarini che la Germania utilizzò anche nella Prima guerra mondiale per attaccare i convogli militari e commerciali. Risultava difficile monitorarli non avendo a disposizione basi di scalo intermedio necessarie per i già programmati piani d’invasione dell’Europa. Molte idee incredibili vennero prese in considerazione per sbloccare la situazione, tra cui la costruzione della portaerei-iceberg Habakkuk. Quando Lord Mountbatten era stato messo da Churchill a Capo delle Operazioni Combinate inglesi, chiamò a raccolta un raggruppamento di scienziati e creativi invitandoli a produrre idee senza porsi limiti. Molte furono scartate, alcune prese in seria considerazione. Il “Progetto Habakkuk” di Geoffrey Pyke venne collocato tra queste ultime. Pyke condusse una vita incredibilmente avventurosa ed eccentrica. Già nel 1915 come corrispondente s’introdusse in Germania e venne facilmente acciuffato e internato in un campo di prigionia nei sobborghi di Ruhleben, vicino Berlino. Si finse pazzo, fuggì e ritornò incolume in Inghilterra. Per Pyke nulla era impossibile. Geoffrey Pyke nel 1942 riferì a Lord Mountbatten che sarebbe stato verosimile trasformare un iceberg in un enorme aeroporto galleggiante. In questo modo gli U-boot nazisti avrebbero invano tentato di affondare una portaerei siffatta. Anche se Pyke non fu il primo a pensare una piattaforma di ghiaccio mediooceanica di scalo aereo, fu di certo lo studioso che stimolò le forze militari a procedere un passo oltre. L’idea iniziale di Pyke si basava sull’approvigionamento di giganteschi blocchi di ghiaccio tagliati direttamente nelle zone artiche, poi trasportati nel medio Atlantico dove sarebbero stati uniti e utilizzati come piste per l’atterraggio di aerei. Si optò infine per la creazione di qualcosa che dovesse assomigliare più ad una nave di ghiaccio che ad un iceberg, cioè a qualcosa a metà tra l’alta ingegneria e la natura estrema, la più grande costruzione flottante della storia. Se i siluri nemici le avessero creato falle, immediatamente sarebbero state occluse con acqua pompata dal mare e regrigerata, poi spalmata dai bracci dei bulldozer. Una serpentina interna a tutte le pareti dell’imbarcazione la rendeva simile ad un colossale freezer. Gli uomini a bordo sarebbero vissuti come sui ghiacciai. La trovata di Pyke fu subito riferita a Wiston Churchill. Entusiasta lo statista approvò il progetto battezzato “Habakkuk”, o “Abacuc”, come uno dei profeti del Vecchio Testamento. Studi e ipotesi sul caso si perfezionarono. Era chiaro che l’aeroporto galleggiante glaciale prima o poi sarebbe caduto in liquefazione. Ma il processo di scioglimento sarebbe avvenuto molto lentamente per via delle pareti di ghiaccio cosparse di una sostanza, ancora tutta da studiare, che ne avrebbe allungato la conservazione. L’aeroporto doveva per forza subire una deriva naturale verso sud. Queste incessanti correnti marine si potevano contrastare installando 26 bimotori elettrici. Furono studiate tre versioni dagli architetti navali. Le dimensioni del progetto finale Abakkuk II erano incredibili: duemila piedi di lunghezza per il decollo dei bombardieri (610 mt) e trecento di larghezza (91 mt); 40 piedi di spessore (12 mt). Il tutto doveva pesare pressappoco due milioni di tonnellate. Il più grande transatlantico esistente all’epoca, di 86mila tonnellate, era il Queen Mary. La naveiceberg poteva trasportare, anche al riparo, enormi quantità di mezzi aerei e da sbarco. Arrivò il momento in cui tutto doveva essere sottoposto ad esperimenti. Per motivi di contenimento dei costi si scelse il sito canadese di Patricia Lake, vicino alla comunità urbana di Jasper. L’obiettivo prossimo era convincere gli americani a sostenere il progetto. Nel 1943 a Patricia Lake, in una anonima “baracca” di lamiera, si diede avvio alla costruzione del modello. Per la struttura futura si passò dal semplice ghiaccio ad un composto ben più resistente. Una scoperta incoraggiò Lord Mountbatten più che mai. Si trattava di uno studio condotto da due scienziati americani i quali avevano ottenuto un materiale di grande resistenza e durata, a base di ghiaccio e cellulosa. Gli ingredienti erano carta riciclata mescolata con acqua con un rapporto 14-86. Una volta refrigerato il composto a 40° si sarebbe ottenuta una sostanza leggera in grado di galleggiare, e in più dotata di una durezza incredibile. Il super-ghiaccio fu battezzato pykrete, unendo il nome di “Pyke” con “concrete”. Il materiale resisteva molto bene alla pressione, come pure al calore e agli esplosivi in una certa misura. Poteva essere con facilità segato o tornito. L’impressione che ne ricavò Lord Mountbatten, lo portò a pensare che la strada per la realizzazione di Habakkuk fosse spianata. Ma i costi che incombevano sull’operazione erano strabilianti. Impiegare la cellulosa era un problema, scarseggiava e avrebbe messo a rischio l’uso della stampa. Si parlò di un impegno finanziario di 6 milioni di sterline e la partecipazione all’impresa di duemila persone. Inoltre, i problemi strutturali non furono risolti del tutto. Il pykrete era sì resistente alla pressione, ma con i mesi si osservò una sua lenta e graduale deformazione, l’effetto creep, forse rettificabile con una più accurata selezione dei materiali. Nemmeno gli americani ne erano convinti completamente pensando che soltanto nel 1945 la nave sarebbe stata completata. Il progetto fu infine abbandonato. Il prototipo costruito in Canada si sciolse solo dopo un anno, ma servirono due estati. In futuro si immaginarono impieghi di questo materiale sempre più utopici, come la costruzione di 14 un’isola-stato indipendente. L’idea di costruire immense opere architettoniche flottanti si è spostata ora in ambito civile. Progetti commerciali futuribili come quelli pensati da Jean-Philippe Zoppini (Z Island), Alexander Asadov (Floating Aerotel) e Jacques Rougerie (Sea Orbiter) vorrebbero dimostrare come il dislocamento urbanistico di attività umane sulla superficie marina possa consentire la costruzione di comunità o complessi turistici ad impatto zero, liberi da costi di bonifica geologica persistenti, pronti a rispondere a possibili mutamenti di scenari climatici avversi. Di recente i tedeschi Frank e Sven Sauer ripercorrono in qualche modo l’idea di Habakkuk con l’hotel Blue Crystal al largo di Dubai scavato in un iceberg. Quanto a Geoffrey Pyke, dopo la guerra visse sempre più da eremita, dimenticato e deriso dai media britannici. Morì suicida nel 1948. Il Times lo ha riconosciuto come una delle più originali figure del nostro secolo. 15 LA COSTRUZIONE PLASTICA DELL’ARCHITETTURA Alberto Cuomo Nel confronto tra cultura occidentale e cultura orientale, che l’epoca della globalizzazione ha determinato in termini più stringenti rispetto al passato, tanto più a proposito del costruire/abitare, non si può non fare riferimento a Martin Heidegger ed ai suoi colloqui sull’arte con alcuni intellettuali giapponesi. Nonostante la “reticenza” di Heidegger ad esprimersi sull’oriente, infatti, il suo pensiero conosce già nei primi anni venti l’interesse di numerosi visitatori giapponesi, in gran parte provenienti dalla “Scuola di Kyoto”, i quali si recano in Germania a seguire le sue lezioni: Tanabe, Miki, Nishitani, Tsujimura e, particolarmente, il conte Kuki Shuzo. Ed è proprio nel ricordo di quest’ultimo che, tra il 1953 ed il 1954, in occasione della visita del prof. Tezuka, dell’Università Imperiale di Tokyo, Heidegger elabora il testo di un dialogo tra un interrogante ed un giapponese nel quale, sin dalle prime battute, emerge la difficoltà di indagare sulla struttura dell’iki, l’essenza dell’arte giapponese, con l’ausilio dell’estetica europea, secondo il tentativo condotto dal conte Shuzo1. All’interlocutore che rileva tale difficoltà nel fatto che i giapponesi si lascerebbero “traviare dall’elemento concettuale di cui lo spirito delle lingue europee dispone” svalutando come qualcosa di indefinito e vago ciò che rivendica sotto la sua signoria il proprio modo di esistere, Heidegger, l’interrogante, oppone un più grave rischio proveniente dallo stesso colloquiare affermando: “il pericolo dei nostri colloqui si nascondeva nella lingua stessa, non in ciò che noi discutevamo, e neppure nel modo in cui cercavamo di discuterlo”. Vale a dire che, avendo definito “più o meno felicemente il linguaggio la dimora dell’Essere… se l’uomo grazie al suo linguaggio abita nel dominio dell’Essere, è da supporre che noi europei abitiamo in una dimora del tutto diversa da quella dell’uomo orientale”. Discorrendo cioè con il “giapponese”, Shuzo/Tezuka, in lingua tedesca, ad Heidegger, non solo sembra che l’indefinito con cui si manifestano le nozioni orientali, quale quella stessa dell’iki, si riconduca fatalmente alle determinazioni della concettualizzazione metafisica occidentale, ma anche che il proprio porsi all’ascolto del linguaggio, il tentativo di cogliere la sua essenza, non necessariamente debba valere per l’essenza del linguaggio orientale, tanto da non avere alcuna certezza su come il venire a colloquio del dire europeooccidentale e del dire asiatico-orientale possa trovare un modo “nel quale risuoni l’eco della stessa sorgente”. Del resto se, come spiega il conte Shuzo, l’iki vive nella struttura binaria della casa giapponese, quale immersione nel “fra i due”, ovvero nell’assenza di imperiose separazioni tra interno ed esterno, nella labilità della porta-parete scorrevole dalle opache trasparenze della carta shoji e nell’uso dei materiali dal doppio colore, al modo della duale bellezza attribuita alla geisha di Edo, delicata ed imperiosa, disponibile ed altera2, la sua traduzione nella terminologia occidentale quale “apparire sensibile attraverso il cui vivente incanto traluce il soprasensibile” appare già una riduzione della sua sfumata ed aperta significazione – “soffio della quiete che luminosamente rapisce”3 – nei tradizionali e determinati concetti propri alla metafisica ed alla estetica occidentali, relativi alla distinzione tra mondo sensibile e mondo ultrasensibile. Sarà però proprio dalla spiegazione dell’interlocutore giapponese circa l’ulteriore indefinitezza dei due termini associati all’iki, l’iro, il colore, il sensibile, in cui si “intende qualcosa di essenzialmente diverso e superiore rispetto al sensibilmente percepibile” ed il Ku, il Vuoto, l’Aperto, “tuttavia altro dal semplice soprasensibile”, a ridonare ad Heidegger la “fiducia… che il colloquio possa felicemente riuscire”4. Correlato l’Essere al Vuoto, quale infinita apertura del possibile, invece che alla positiva interpretazione della metafisica, da cui è ripreso il nome solo per incamminarsi verso la sua essenza autentica, la fiducia di Heidegger è ulteriormente invogliata dall’interesse che mostrava conte Shuzo, manifestato ai suoi allievi e testimoniato dal suo interlocutore, verso il procedere ermeneutico, secondo il quale l’approssimarsi al senso non si offre nella lineare e diretta acquisizione della cosa sensibile, l’oggetto ma anche il suono percepibile della parola, da parte del concetto, quanto piuttosto in una verwindung, un percorso circolare di aggiramento dell’essenza, il “circolo ermeneutico”, attraverso il quale coglierne il centro senza mai afferrarlo definitivamente. E’ stato infatti osservato, da Giorgio Pasqualotto, come il muoversi aggirante del linguaggio che promana dall’Essere prescindendo dalla volontà del soggetto, egli stesso, dalla lettura heideggeriana di Rilke, rivoltato tra vita e morte, presenza e assenza, non solo l’aggirarsi intorno ai sentieri della metafisica da parte dell’andenken, il 1 M. Heidegger, Da un colloquio nell’ascolto del linguaggio, in In cammino verso il linguaggio, trad. it. di A. Caracciolo e M. Caraccciolo Perotti, Milano, 1973, p. 83 e segg. 2 Kuki Shuzo ne, La struttura dell’iki, a cura di G. Baccini, Adelphi, Milano, 1992, mette in luce, sin dall’introduzione, la struttura binaria, ambigua, dell’iki , in particolare, sulla seduzione e la Geisha v. pp. 54-64. 3 M. Heidegger, op. cit., p. 93. 4 M. Heidegger, ibidem, pp.93-101. 16 pensiero rimemorativo, ma anche il pensare la cosa in circoscrizioni linguistiche in definitiva inconcluse, presenti molte analogie con la forma di pensiero del buddismo zen, il quale “affronta il processo di conoscenza di un oggetto e il processo di soluzione di un problema, non seguendo una scansione lineare di proposizioni polarizzata verso un punto fisso che costituisce l’oggetto da conoscere o il problema da risolvere, ma tracciando una serie di proposizioni che si dispongono intorno a questo punto, nella consapevolezza di non poterlo mai catturare e definire una volta per tutte: così, se la logica conoscitiva del pensiero occidentale si è data quasi sempre nelle forme dell’induzione e della deduzione lineare, quella del pensiero orientale si è invece quasi sempre data – almeno nella gnoseologia buddista e in quella taoista – nella forma dell’accerchiamento concentrico dell’oggetto da conoscere e del problema da risolvere, nella consapevolezza che essi non possono mai venire posseduti in modo definitivo”5. È quindi tale prossimità, la quale sembra far emergere, oltre le differenze della lingua, un fondo comune, a sollecitare l’interrogante del colloquio heideggeriano verso la domanda circa il nome stesso del linguaggio nella lingua nipponica, onde cogliere da esso, secondo un procedimento tipico delle analisi che Heidegger conduce nel suo pensare, ciò che si manifesta, anche per i giapponesi, quale essenza del dire. Senza soffermarsi qui su come, a sua volta, l’interlocutore legga la metafora heideggeriana su “il linguaggio come dimora dell’essere” una modalità propria al definire nipponico che, attraverso il dire metaforico, tocchi l’essenza senza definirla, e tralasciando di percorrere l’intero colloquio, nel quale Heidegger esplora molti luoghi della propria riflessione filosofica, è nella espressione con cui viene chiamato il linguaggio, offerta dal giapponese, a farsi luce la possibile relazione tra il definire orientale ed il definire occidentale, la loro comune fonte, e, dal senso stesso che assume il linguaggio nelle due definizioni, la comune essenza del conoscere, dell’interrogarsi sull’Essere. Dopo aver mostrato come, nella propria lingua, il dire abbia a che fare con i “cenni”, a riconfermare la presenza nelle definizioni di una in articolazione, di un non detto, l’interlocutore di Heidegger rivela come la parola giapponese che indica il linguaggio sia Koto ba, “fioritura di petali che promana dal messaggio rischiarante della grazia”, e, se il termine grazia conduce in maniera fuorviante ad un pensare/dire perentoriamente presentativi, alla bellezza dell’estetica occidentale, il filosofo tedesco, l’interrogante, attraverso Sofocle, legge nella charis la capacità generativa la quale, dalla lingua greca, si manifesta nel termine tedesco dihton, dikten, il poetare, come “scaturire del messaggio del disvelarsi della Differenza”6. Emerge in questa modalità generativa, e nella metafora stessa della fioritura, l’eco di un altro ricorso ai greci, quello posto nella lettura della Fisica di Aristotele compiuta da Heidegger alla fine degli anni venti, nei corsi di Marburgo, e ripresa nel 19397, nel periodo cioè delle visite e dei discorsi dei suoi estimatori giapponesi di cui rende conto nel colloquio, nella quale si fa luce una interpretazione della Natura analoga a quella orientale che la intende in una motilità riproduttiva della differenza in cui traluce l’essere. Vale a dire che, proprio nella definizione giapponese sembra offrirsi il senso che Heidegger attribuisce al linguaggio, una naturale disposizione dell’uomo il quale, proprio rispondendo all’appello dell’Essere che in esso risuona, nel farsi servo, nel piegarsi al suo ascolto, si rende libero, capace di intendere, nelle stesse determinatezze del significare, l’Aperto indefinibile da cui esse si generano, l’evenire che si rende nel loro affiorare, mai identificabile a sua volta in un nome da cui costruire una metafisica, quanto come un echeggiare del silenzio. Se quindi è nel colloquio, nell’aperto confronto tra i due interlocutori, che il linguaggio, oltre l’aspirazione a circoscrivere l’essenza delle cose di cui dice, quella stessa dell’Essere da cui profferisce, manifesta il suo porsi in cammino verso se stesso, la sorgente che lo genera e che in esso si mostra, è altresì nell’arte, nella diktung della poesia, che le circoscrizioni del dire manifestano l’infinita apertura dell’origine, secondo quanto si manifesta anche nella definizione, offerta nel 1958 ad Heidegger da Hisamatsu, dell’arte zen, detta Gei-do, una via, un cammino, il quale, ricercata l’origine, proviene dal suo vuoto ed attraversa le stesse rappresentazioni delle cose rese dall’arte perché esso “zampilli” dal fondo8. Il ricorso ad Heidegger ed al suo confronto con la cultura ed il linguaggio giapponese lascia rilevare come la distanza tra il mondo occidentale e quello orientale, presente anche nell’esperienza costruttiva, non sia facilmente colmabile. Del resto non è forse proprio l’architettura occidentale una manifestazione della metafisica cui appare alieno il mondo orientale? Roland Barthes ha segnato questa distanza: “in occidente… tutte le città sono concentriche; ma, conformemente al movimento stesso della metafisica occidentale, per la quale ogni centro è la sede della verità, il centro delle nostre città è sempre pieno: luogo contrassegnato, è lì che si raccolgono e si condensano i valori della civiltà: la spiritualità (con le chiese), il potere (con gli uffici), il denaro (con le banche), 5 G. Pasqualotto, Oltre la tecnica: Heidegger e lo zen, in Il Tao della filosofia, Nuova Pratiche, Parma, 1989, pp. 150-158. M. Heidegger, op. cit., pp. 102-124. 7 M. Heidegger, Sull’essenza e sul concetto della ΘΥΣΙΣ. Aristotele, Fisica, B, 1, (1939) in Segnavia, trad. it. di F. Volpi, Adelphi, Milano 1987. 8 M. Heidegger e H. S. Hisamatsu, L’arte e il pensiero, in “Micromega”, 1/98, pp. 181-187. 6 17 le merci (con i grandi magazzini), la parola (con le agorà: caffè e passeggiate). Andare in centro vuol dire incontrare la ‘verità’ sociale, partecipare alla pienezza superba della ‘realtà’”. In oriente invece, la sua più grande città, Tokio, “presenta questo paradosso prezioso: essa possiede sì un centro, ma questo centro è vuoto. Tutta la città ruota intorno ad un luogo che è insieme interdetto e indifferente…forma visibile dell’invisibile…un’idea evaporata, che sussiste non per irradiare qualche potere ma per offrire a tutto il movimento urbano il sostegno del proprio vuoto centrale”, mai colmo, tale anche da lasciar dispiegare l’immaginario circolarmente, per corsi e ricorsi, intorno ad un soggetto assente9. La stessa singola architettura presenta concezioni affatto diverse che si possono sintetizzare nel suo elemento maggiormente simbolico, il tetto. Conservando il riferimento al senso del costruire occidentale manifesto nella parola tekton, testo, texture, tettonica, nel tetto delle costruzioni d’occidente, nella parola e nell’oggetto, appare del tutto dimenticata la radice originaria del termine che lo designa, tec-, la quale, connessa alla techne, secondo quanto spiega ancora Martin Heidegger, implica l’affiorare, il “far apparire qualcosa tra le cose presenti”10, il lasciar venire, cioè, alla presenza, laddove tale senso dell’insorgere, che in esso a pena permane, si rende piuttosto, attraverso l’espressione latina, tego, come un coprire, un concludere, un culminare, un condurre a fine, quale termine o meta ideale. Radicandosi al suolo, l’architettura occidentale allestisce cioè i suoi organamenti tettonici per risolversi in uno slancio verso la luce, in una esposizione alla verità, essa stessa quindi sua manifestazione, al contrario di quella orientale che, priva di radicamenti terreni, solo poggiata sul suolo, fa del tetto il suo elemento iniziale, un affiorante e protettivo luogo d’ombra, un modo per raccogliere nella indeterminatezza del suo buio le cose, i cui contorni si offrono al vuoto, al nulla. Secondo quanto ha scritto Junichiro Tanizaki: “la bellezza delle cattedrali occidentali è legata allo slancio dei tetti che sembrano trafiggere il cielo con pinnacoli acuminati. All’opposto nei templi buddisti del nostro paese, nere tegole riparano l’intero edificio, che sembra abbia scelto di accucciarsi sotto la loro ombra densa e protettiva. Non solo nell’architettura religiosa, ma anche nei palazzi imperiali, o nelle comuni case d’abitazione, ci colpiscono, prima di ogni altro particolare, l’immensità del tetto di tegole o paglia e l’ispessirsi dell’ombra sotto le gronde. Talvolta anche in pieno giorno, mura e pilastri sembrano inghiottiti da un buio di spelonca, e questo accade in costruzioni imponenti come i templi di Chion-in o di Hongan-Ji a Kioto… l’imposizione dei nostri tetti è simile all’apertura di un parasole: marca sul terreno un perimetro d’ombra, di cui ci riserviamo il dominio; là aggiusteremo, poi, la nostra casa. Anche le case occidentali hanno un tetto, che tuttavia non sembra tanto destinato a schermare la luce solare, quanto a… ridurne il carico d’ombra, studiando, per ogni locale, l’esposizione migliore ai raggi del sole”11. Ma, se il sottolineare la distanza tra le configurazioni dell’abitare occidentale ed orientale tende a manifestare la difficoltà e, forse, l’impossibilità, di un loro confronto, così come hanno rilevato Leonardo Benevolo e Manfredo Tafuri nelle loro ricostruzioni circa le influenze del modernismo sull’architettura giapponese ovvero della cultura orientale sull’architettura moderna12, è proprio il lasciar colloquiare le estreme diversità a potersi intendere, secondo la lezione di Heidegger, come un mettersi in cammino verso una comune origine. Appaiono così prive di esiti le scorciatoie rivolte a leggere l’esperienza architettonica giapponese recente alla luce delle tendenze occidentali, così come è accaduto per Tadao Ando e Arata Isozaki o per i più attuali Toio Ito e Kazuyo Sejima traguardati, pur in superficiali riferimenti alla cultura orientale, tra Le Corbusier ed il minimalismo, la trasparenza modernista e l’aspirazione al nulla delle odierne tendenze espressive cosiddette decostruttiviste13. 9 R. Barthes, L’impero dei segni, trad. it. di M. Vallora, Einaudi, Torino, 1984, p. 39 e segg. Martin Heidegger si sofferma sul prefisso tec- in Costruire abitare pensare, in Saggi e discorsi, trad. it. di G. Vattimo, p. 106. 11 J. Tanizaki, Libro d’ombra, trad. it. di A. Ricca Suga, Bompiani, Milano, 1995, paragrafo 8, p. 39 e segg. 12 Manfredo Tafuri, in L’architettura moderna in Giappone, Cappelli, Rocca San Casciano 1964, mette in luce come, nel tentativo di “realizzare l’unità contradditoria della cultura” di cui parla Sartre a proposito della nuova universalità del mondo e della storia, pur tra le reciproche influenze tra occidente ed oriente, sia significativo che nella lingua giapponese manchi tanto il termine che il concetto di “architettura” (p. 23), per rilevare la distanza tra lo “Skihui”, un concetto intermedio tra nuovo e tradizione, dell’architettura giapponese e il freddo razionalismo tecnico-industriale dell’architettura occidentale (p. 111). Già nel 1960, Leonardo Benevolo, dal quale Tafuri riprende alcune considerazioni, in Storia dell’Architettura Moderna, Laterza, Bari, p. 831, aveva messo in luce la distanza tra l’esperienza architettonica occidentale e quella giapponese, colmata solo attraverso l’imperiosa volontà del nuovo corso politico del dopoguerra di collegarsi alla nostra cultura. 13 Non si vuole qui negare la reciproca influenza tra architettura occidentale moderna e cultura giapponese, basti pensare a Wright, a Taut, o all’ispirarsi di Tange a Le Corbusier, ma non sembra condivisibile il tentativo condotto in passato dalla rivista “Casabella”, che dedica il n. 608-609 del Gennaio-Febbraio 1994 al Giappone, di accorciare le distanze catalogando, nei diversi saggi, i singoli architetti del sol levante sotto etichette proprie all’arte occidentale. Anche recentemente i saggi di Andrea Maffei, Toyo Ito, Mondadori Electa, Milano, 2003 e di Angelo Marotta, Toyo Ito. La costruzione del vuoto, Marsilio, Venezia, 2010, tendono a leggere l’opera dell’architetto giapponese non in controluce rispetto all’enignatico senso del 10 18 Ricorrendo invece ancora al colloquio heideggeriano, oltre ogni vocazione a ricercare il luogo della convivenza delle esperienze costruttive occidentali ed orientali, è probabile che il suo incamminarsi verso la enigmatica fonte delle differenti dicibilità intraveda in essa anche la comune origine delle due diverse arti del costruire. E’ indicativo che Heidegger, ad illustrare il farsi presente dell’Aperto nelle definizioni, lo schiudersi del circoscritto dire la cosa alla polisignificanza del primo nome, il manifestarsi dell’evenire nell’uso delimitato del linguaggio, utilizzi metafore costruttive, tanto che uno dei suoi più attenti esegeti, Hans George Gadamer, individua proprio nell’architettura la funzione “fondante” delle altre arti, l’allestirsi linguistico in cui meglio si rende il farsi presente dell’Essere nel suo nascondimento14. E tuttavia, se nelle metafore costruttive Heidegger mostra la rilucenza umbratile dell’Essere in architetture in cui la funzione del risiedere appare più labile – si pensi, ad esempio, alle pagine riguardanti il ponte sul Reno attraverso i versi di Holderlin – a proposito del “farsi corpo dell’Essere nella sua opera instaurante i luoghi” egli ricorre invece alla scultura, Die Plastik15. Se cioè, così come ha mostrato in tanti scritti, il luogo, con il suo raccogliere le cose nella coappartenenza di quella che egli chiama quadratura, Geviert, antecede lo spazio, la stadion-spatium come intervallo, ambito del dominio misurante, quello stesso tecnico-scientifico, essendo la più originaria disposizione localizzativa dell’uomo ad aprire allo spazio offrendogli senso, è nella scultura che, con le sue circoscrizioni spaziali non riferibili ad una immediata loro usabilità e misurabilità, ad un delimitato significato, maggiormente si rende manifesto l’installarsi dell’Essere come apertura, il dislocarsi della spazialità, incorporata nei volumi, nelle e tra le figure scolpite, come emergenza dal vuoto, ma anche come insorgenza del vuoto, del fare-spazio, che in essa si accorda come “contrada”, “luogo disboscato”, “radura”, lichtung, o nella terminologia rilkiana assunta dal filosofo, “chiaro bosco liberato”. Vittorio Ugo ha letto la lichtung come la luminosità che emerge dall’ombra, si direbbe il farsi luce dell’ombra, ricavando dalla possibile correlazione dei concetti heideggeriani di Zwiefalt ed Entfalung, riferiti al ripiegare dell’Essere nell’ombra delle cose ed, insieme, al suo dispiegarsi in esse, con i sensi connessi al gioco degli origami giapponesi, il possibile rapporto, per quanto paradossale, tra la plasticità dell’architettura barocca, secondo la lettura leibniziana del Deleuze, ed il più rarefatto gioco d’ombre dell’architettura giapponese16. Si delinea quindi in tale lettura, alla maniera che nel colloquio heideggeriano, non certo l’affinità tra i modi dell’architettura occidentale e quelli dell’architettura orientale, essendo il barocco del tutto lontano dal mondo costruttivo giapponese, quanto una possibile, originaria, prossimità da riconoscere in una plasticità intesa nel farsi pieno del vuoto, in cui questo si nasconde per mostrarsi nell’evenire della forma, ovvero nel rendersi della luce all’ombra la quale, nell’inseguirsi delle penombre, ne mostra ancora l’affiorare. Del resto, nel suo breve scritto sulla scultura, Heidegger richiama la sua concezione dell’arte quale “messa in opera della verità”, da non intendere nei termini hegeliani all’interno di una progressiva approssimazione all’Identico, all’Assoluto, alla luce piena della verità. Tra i suoi saggi, forse, quello in cui meglio si precisa la riflessione sull’arte, non certo una estetica17, è tratto dalla conferenza su L’origine dell’opera d’arte, dove l’arte è analizzata in relazione all’attività linguistica dell’uomo, non solo quella verbale, ma anche quella connessa ad altri modi di comunicare e significare. Per Heidegger il linguaggio è l’ambito del “colloquio” che siamo “dal tempo in cui «vi è tempo»”, in cui “gli dei vengono alla parola e un mondo appare», essendo la poesia che l’adopera «istituzione in una parola dell’essere”, nel senso che essa non trae dalle cose l’essenza, non scopre il fondamento del mondo nel suo abisso, non deriva essere ed essenza da ciò che è presente, ma li crea, li dona, appunto li istituisce. Essendo la sua materia il linguaggio, in essa, non solo nella chiacchiera, quanto nel suo poetare, vige però il pericolo di rendere l’essere, mediante le immagini poetiche, solo un ente. Poesia autentica è “vuoto” della cultura zen, di fatto un pieno effusivo, quanto nel riflesso di questa nel pensiero occidentale, si direbbe il principio nullo di Schopanhauer. Allo stesso modo le architetture di Kazuhyo Sejima le quali, pur affidate dal critico de “Il Sole 24 ore”, n. 296 del 30.10.2005, p. 43, ad una felice definizione che ne rileva le “amniotiche trasparenze”, sono rinviate al fluttuare liquido dello spazio, comune alle esperienze del decostruttivismo, e non al loro soffuso chiaroscuro, al loro valore calligrafico ed essenziale, proprio all’arte giapponese. 14 H. G. Gadamer, Verità e metodo, trad. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano, 1983, p. 192 e segg. 15 Heidegger affronta in particolare la questione della scultura nella conferenza tenuta nel 1964 alla galleria Erker su Artescultura-spazio, pubblicata con il titolo Corpo e spazio, trad. it. di F. Bolino, Il melangolo, Genova 2000. Il testo riveduto per la pubblicazione tedesca nel 1969 era stato riprodotto con il titolo L’arte e lo spazio, trad it. di C. Angelino, Il melangolo, Genova, 1979. 16 V. Ugo, Σγκώµιον σκιάς. Elogio dell’ombra. La concezione giapponese dello spazio architettonico, in AAVV. La polifonia estetica, a cura di M. V. Ferraiolo, Guerini, 1996, v. in particolare p. 303 e segg. 17 Sull’analisi dell’arte in Heidegger, non una estetica, dal momento che, se nell’arte si rivela nascondendosi l’essere, o insieme essere e non essere, una disciplina estetica ridurrebbe, come la metafisica, l’essere presente nell’opera a mero motivo di rappresentazione o di affettività, cfr. S. Givone, Storia dell’estetica, Laterza, Bari, 1988, pp. 159-163 o anche M. Perniola, L’estetica del novecento, Il Mulino, Bologna, 1977, pp. 161-168. 19 quindi quella che manifesta “il linguaggio originario di un popolo” ovvero il sopravvenire del linguaggio da cui si determinerà il procedere storico, quella che possiede la fragranza e l’innocenza dei primi nomi, quella che nel linguaggio si distanzia dal proprio stesso dire per essere pura apertura dell’essere in cui gli enti appaiono verso la nominazione, quella che si accorda al silenzio del principio, Grundstimmung. Luogo dell’Aperto, in cui si mostra l’insorgenza dei nomi, la poesia quindi non è interpretabile per il suo contenuto, quasi fosse l’acqua del bicchiere o il frutto del ramo, né per il sentimento e le emozioni che promuove o quale sostegno del concetto, di una filosofia, ponendosi, nell’accogliere il senza nome, quale fenditura del linguaggio, commessura, entro cui il movimento oscillante delle parole, Schwingungsgefüge, tra contenuti, ritmi, immagini, rende l’altra oscillazione tra senso e non senso intrinseca al primo schiudersi del linguaggio. Per questo Heidegger preferisce al termine Poesie, con cui il senso comune designa il poetare, il termine Dichtung il quale, dal latino dicere-dictare, indica il dettare e, nella derivazione dal greco deiknymi, “il mostrare, il rendere visibile, manifesto qualcosa sul cammino che gli è proprio”, essendo il poetico non esclusivo dell’arte quanto proprio all’abitare, all’essere, reso nel dire che sa porsi ed apre al suo ascolto18. Nella sua conferenza Heidegger accenna alla follia di Hölderlin per soffermarsi anche sulla derivazione filosofica del poeta, e se la sua poesia non è da intendere strumento del pensiero, pur richiedendo il pensiero, se il pensare sul poetico può esercitarsi solo alleggerendosi tanto da sciogliersi come la neve su una campana onde non mutarne il suono, a sua volta l’irrazionalità del poeta non si risolve nel libero suono efflorescente di immagini, ponendosi in una lontananza quale “protezione della notte”, si direbbe un notturno aprirsi del pensare, del dire. E’ indicativo che la poesia di Hölderlin sia richiamata in sequenza con l’analisi dell’arte di un altro presunto folle, van Gogh, ovvero di un dipinto raffigurante un paio di scarpe contadine dove il filosofo mostra come l’usabilità delle scarpe, il loro essere mezzo, in cui si presenta la totalità del “mondo”, quello contadino, la sua “fidatezza” stabile nel costante afflusso della libertà della terra, non si renda nella loro utilizzazione materiale, né nei procedimenti della loro fabbricazione, né in una eventuale loro descrizione, quanto proprio nell’opera del pittore la quale, rivelando l’esser-mezzo del mezzo e quel “mondo” in cui è mezzo, apre al suo originarsi, a ciò che il paio di scarpe è in verità. L’arte, più che con la bellezza, quindi, ha a che fare con la verità, non raffigurata però nella evidenza della realtà, ma messa in opera, agita cioè in un produrre il quale pur su-ponendo un mondo, pur costituendosi in una storicità, lascia balenare, nella cosa, nell’ente che pure l’oggetto d’arte è, l’Aperto che pone ogni storia, l’origine, essa proprio poetica, presso cui si pone. L’arte, la poesia, perciò “non significa escogitazione sbrigliata e arbitraria o abbandono all’irreale della semplice rappresentazione fantastica. Ciò che la Poesia, come progetto illuminante, dispiega nel non-esser-nascosto e progetta nel tratto della figura, è l’Aperto che essa fa in modo si storicizzi, e precisamente in maniera tale che l’Aperto, nel seno dell’ente, porti l’ente stesso a risplendere e a risuonare”19. E’ indubbio come la riflessione heideggeriana sulla poesia, sulla differenza tra cosa ed opera, sul fondarsi dell’opera nel mondo per additare l’Aperto, la “lotta” tra Mondo e Terra, invogli i temi di Essere e Tempo, gli assunti sull’utilizzabilità delle cose mondane nell’esistenza quotidiana e il suo aprirsi verso l’apertura dell’aletheia, la lichtung presente nella mondità ed insieme fuori della mondità. Temi che a propria volta inoltrano la metafora naturalistica di bosco e radura verso la lettura dell’arte in cui più si manifesta un utile, l’architettura, quella del tempio la quale, disposta dalla necessità e dall’utilizzabilità, sia dei modi costruttivi che simbolici, si apre, dal suo uso, dal suo esporre un Mondo, al luogo/non luogo, all’apertura, occlusa da quel Mondo che da essa “si ritira”, ravvisabile nella Terra, “l’assidua-infaticabile-non-costretta” su cui si fonda ogni Mondo essendone altresì lo s-fondo, il sempre-aperto della s-fondatezza20. Donandosi quindi la “verità” heideggeriana non come meta per un pacificato riposo della Ragione, dell’identico cui si rende il reale, ma come conflitto tra “mondo” e “terra”, tra il mondeggiare del mondo, il mondano, il suo esporsi ad un significato e l’infinita disposizione della Terra all’evenire, la sua aperta capacità proliferativi del senso, la scultura, secondo l’esegesi di Gianni Vattimo, offrirebbe alla stessa architettura il senso dell’abitare come einraumen, un fare spazio che è altresì un disporre le cose in vista dell’Aperto, nel senso che essa, come mostra il Gadamer, “attrae su di sé l’attenzione dell’osservatore, e d’altra parte lo rimanda anche al di là di se stessa, verso quel più vasto contesto vitale che l’accompagna”. Il costruire plastico dell’architettura non si determinerebbe quindi tanto nei caratteri formali, in una sorta di plasmabilità manipolativa della costruzione, così come è nelle odierne esperienze contemporanee del 18 M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, in Sentieri interrotti, trad. it. di P. Chiodi, La Nuova Italia, Città di Castello, 1984 pp. 56-60. Sulla relazione del pensiero di Heidegger con i poeti e particolarmente con la poesia di Holderlin che illumina il filosofo sul mondo greco iniziale antecedente l’inizio della cultura occidentale cfr. F. De Alessi, Heidegger lettore dei poeti, Rosenberg e Sellier, Torino, 1991. 19 Ibidem, sul quadro di van Gogh p. 18 e segg. richiamato nei capitoli successivi Opera e verità e Verità e arte. 20 L’analisi sull’architettura attraverso l’ergersi del tempio in M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, in Sentieri interrotti, cit., p. 27 e segg. è molto nota ed introduce la riflessione sulla «lotta» tra Mondo e Terra che è messa in opera nell’arte di cui scrive Gianni Vattimo in La fine della modernità, Garzanti, Milano, 1985, v. Ornamento Monumento, pp. 8797. 20 progetto informatico pervenuto a tecniche di modellazione parametrica spacciate quali metodologie avanguardistiche, quanto, sempre a seguire Vattimo e Gadamer, nel gioco tra località e contrada, fondo e sfondo, tra la necessità augurale fondativa di luoghi all’abitare, di spazi di vita mondana, e l’ulteriore necessità sfondativa del rimanere in vista dell’Aperto, tra il necessario radicarsi al suolo e l’aprirsi dell’orizzonte verso cui si distendono altri possibili cammini. E’ pertanto in questo carattere plastico proprio della scultura, come modo di conchiudere lo spazio, attrarlo a sé con i diversi possibili sensi che espone, ed insieme nel suo rendersi periferica rispetto all’orizzonte cui pure apre, che si manifesta la possibile prossimità tra architettura occidentale ed architettura orientale, secondo quanto accade al tempio greco dell’esempio heideggeriano, chiuso ed opaco nella cella ma aperto all’intorno nei colonnati, o al Torii, il portale shintoista rivolto al vuoto del panorama giapponese, dal termine tori, uccello, ad indicare la necessaria relazione tra terra e cielo, mondo umano e mondo divino. Un carattere sicuramente rintracciabile anche in architetture contemporanee o recenti che segnano, dilatandola, l’immensa periferia che è la città, tanto quella sorta anticamente in occidente quanto la nuova presente nei territori d’oriente, cui fanno ombra sia le riproposizioni di chiuse rifondazioni logiche del costruire, con il loro armamentario metafisico, sia le avventure grammatologiche della cosiddetta decostruzione architettonica le quali, come fu per l’espressionismo in esse malcelato, pure guardano all’oriente e che, come è per le opprimenti sculture di Gehry o Hadid, tendono ad invadere l’intero spazio (si pensi al masterplan della Hadid per Istambul), ad annullare il gioco tra fondo e s-fondo proprio alla scultura, elevando il vuoto, il nulla, secondo quanto sembra denunciare lo stesso Derrida in Eisenmann o in Libeskind, a nuovo fondamento, nuovo imperioso principio metafisico, da cui, oltre ogni messianesimo, malgrado l’origine ebraica di tanti architetti decostruttivisti, si impone un autoreferenziale gioco inventivo, caricatura, dato anche l’imporsi surdeterminante delle logiche computerizzate, di una presunta libertà creativa. Non si può evitare di rilevare come l’odierno farsi plastico dell’architettura e del paesaggio sia riferito da Mario Perniola proprio all’architettura decostruttiva rappresentata da alcuni degli architetti citati o al farsi sensibile dell’inorganico nel tecnomorfismo21, tra Foster e Shin Takamatsu, per il vero artefici di un duttile eclettismo costruttivo, e tuttavia non si può, analogamente, accantonare la critica di Adorno, di cui Giorgio Pasqualotto legge le affinità con il pensiero di Heidegger, alla invadenza scultorea ed al totalitarismo decostruttivo letti però nella musica wagneriana e nella dodecafonia schonberghiana – un primo esperimento di “parametrismo” musicale – intesi entrambi modi della volontà di potenza propria al coercitivo mondo della tecnica 22. Del resto il medesimo Perniola, aveva inoltrato, in un precedente testo, il sentire inorganico delle nuove tecnologie verso un neoantico effetto egizio, quasi a sollecitare l’idea di una plasticità che pure nella movimentazione libera ritrovi la ferma monumentalità della pietra simbolo, secondo quanto riconosce già Platone, della più decisa legge, del più saldo dei poteri, e pure configurazione dell’enigma, sicuramente aliena alle odierne architetture plastiche cui egli si riferisce, in cui il contradditorio incontro delle forme, più perentorio che ricco di ambiguità, espone persino le configurazioni della statica ad un futile gioco inventivo domenicale e lo spazio allestito ad un andare apparentemente inconcluso, del tutto controllato nella combinatoria dei passi, privati del tempo oltre ogni suo compiersi23. Risalendo la kehre, la svolta heideggeriana che si rivolge all’Essere producendo le riflessioni sull’arte, nel cammino tornante proposto da Vincenzo Vitiello24, appare possibile ricondurre la metafora spaziale circa la scultura, che pure meglio si addice all’architettura, alla interpretazione temporale dell’Essere, per leggere nella 21 Mario Perniola ne Il sex appeal dell’inorganico, Einaudi, Torino 1994, particolarmente nel capitolo Paesaggi plastici, p. 105 e segg, sembra riprendere l’analisi di Renato Barilli ne Il ciclo del postmoderno, Feltrinelli, Milano 1987, sul tecnomorfismo architettonico, movimento in cui si raccoglierebbe tanto il postmoderno quale “ripetizione differente”, recupero straniato del passato, suo ironico remake, secondo la teoria del Jencks, che quello estenuato, debilitato di Ihab Hassan. Proseguendo le idee di Mc Luhan, Barilli vede nei mezzi elettromagnetici la possibilità di riconsiderare in maniera disincantata il passato, la storia, verso nuove possibili forme e sensi nella smaterializzazione degli stili e nella loro compresenza. Diversamente dall’ottimismo di Barilli, Katherine Hayles, in How we become posthuman, The University of Chicago press, Chicago 1999, ipotizza, in virtù dell’avvento dell’informatizzazione, un cyberspace nel quale l’uomo in fine scompare. 22 Giangiorgio Pasqualotto, in op. cit. 10 n. p. 153, cita il saggio di Franco Volpi, Adorno e Heidegger, soggettività e catarsi, “Nuova Corrente” n. 81, 1981, pp. 91-121, per rilevare, oltre le critiche cui in altri saggi sottopone i due filosofi, la comune convergenza nel “ribellarsi del pensiero a quella forma di «manifestazione della volontà di volontà» che si chiama tecnica…”. I testi in cui Theodor W. Adorno sottopone a critica il wagnerismo e la musica atonale sono: Wagner Mahler, trad it di M. Bortolotto, Einaudi, Torino, 1966 e Filosofia della musica moderna, trad. it di G. Manzoni, Einaudi, Torino, 1959, in particolare il capitolo Schönberg e il progresso, p. 35 e segg. 23 M. Perniola, Enigmi. Il momento egizio nella società e nell’arte, Costa&Nolan, 1990, e, particolarmente il capitolo L’effetto egizio: il compimento del tempo, p. 85 e segg. 24 La lettura a ritroso della kehre di Heidegger, ovvero quella di Essere e Tempo alla luce delle successive riflessioni sull’Essere è proposta da Vincenzo Vitiello, Heidegger: il nulla e la fondazione della storicità, Argalia, Urbino, 1978. 21 relazione tra fondo e s-fondo coagulata nell’opera architettonica lo stagliarsi del presente sull’orizzonte del tempo, di una temporalità compresa di passato e futuro, in modo da poter interpretare il progetto tra la visione proposta dal Vattimo, quale atto interpretativo-proiettivo della tradizione, malamente volgarizzata dal postmodernismo storicistico teorizzato da Portoghesi, e la figura dell’Angelo rilkiano, pure ricorrente in Heidegger, nella lettura di Massimo Cacciari, in-stans di precipitazione di storia e futuro, “balzo di tigre” che si produce nella e dalla pratica quotidiana dei gesti uguali tramandati dai padri verso il rinnovarsi dell’evento in cui si da la cosa, l’abitare25. Per concludere con il Goethe di Heidegger può dirsi che anche per l’architettura non vale l’aspirazione ad offrire corpo ad una imperiosa verità, manifesta sia in presunte logiche costruttive che nelle affermazioni circa la libera creatività offerta dal computer all’odierno agire desiderante, quanto lasciarla aleggiare nei dintorni come un suono di campane disteso nella pace delle nostre contrade26, o, se si vuole, come l’eco dilungata della nota di uno shakuhachi zen o di un dunchen tibetano nel silenzio delle valli d’oriente. . 25 Cfr. il dibattito svoltosi su “Casabella” tra Cacciari e Vattimo, ovvero M. Cacciari, Nichilismo e progetto, n. 483, Settembre 1982, e Risposta alle risposte, n. 489, Marzo 1983, G. Vattimo, Abitare viene prima di costruire, n. 485, Novembre 1982. 26 Si veda la chiusura del testo di Martin Heidegger su L’arte e lo spazio, op. cit. LA QUESTIONE DELLA COMPOSIZIONE A PARTIRE DA DERRIDA E DELEUZE1 Dario Giugliano “… a Bisanzio si occupavano del sesso degli angeli nel momento in cui già i Turchi squassavano i bastioni…”. È Louis-Ferdinand Céline nel suo romanzo postumo, uscito nel 1969, Rigodon, che ci riporta un’ennesima versione di quell’adagio notissimo, che voleva l’élite bizantina impegnata in disquisizioni sottilmente astruse, quando non addirittura palesemente inutili, in considerazione soprattutto del fatto che, “là fuori”, come si usa dire con un’espressione comune tra i filosofi (solitamente i peggiori, tra quelli che si occupano di questa pratica che è la filosofia), qualcosa di più urgente, come l’assedio della propria città, (ci) chiama. L’esercito nemico sta per irrompere in città, con tutto ciò che ne seguirà, in termini di devastazioni, saccheggi, violenze, massacri e i capi, vale a dire le guide spirituali della città, non trovano niente di meglio da fare che discettare del sesso degli angeli. Per quanto possa sembrare bizzarro, è immediatamente da notare che sono state testé evocate una serie di questioni, che possiamo considerare fondamentali per avvicinarsi al lavoro filosofico di Derrida e Deleuze. In particolare, quello della scrittura filosofica derridiana è stato spesso accostato a un esercizio bizantino, nel senso proprio di assolutamente arbitrario quando non inutile e fuorviante. A titolo di esempio riporto qui un giudizio di Umberto Eco, che in Semiotica e filosofia del linguaggio, a proposito del modo simbolico, scrive: “Si legga l’appassionante dibattito avvenuto tra John Searle, uomo denotativo e letterale, che crede che la menzione di copyright voglia dire che un brano non può essere riprodotto senza permesso, e Jacques Derrida che, quanti altri mai rabbinico e cabalistico, dalla semplice menzione del copyright trae occasioni per infinite inferenze sulla fragilità dell’altrui linguaggio, e la sua infinita decomponibilità. Ci si troverà di fronte a una perfetta messa in opera del modo simbolico rispetto a testi che originariamente non volevano comunicar per simboli. Ridotta al rango di Torah, la parola di Searle, infinitamente decostruita, dà modo a Derrida di leggere altro, sempre Altro da ciò che l’avversario credeva di dire e da cui è stato detto”2. I due protagonisti del dibattito, Searle e Derrida, sono individuati con due coppie di aggettivi, che per il filosofo francese viene pure a essere evidenziata dalla coloritura superlativa: denotativo e letterale Searle; il più rabbinico e cabalistico di tutti Derrida. Si tratta, alla fin fine, di un giudizio negativo, comune a molti commentatori del pensiero di Derrida, che viene a essere accomunato a quanti cercano di far dire, ostinatamente, ciò che ogni testo proprio non vuole dire e che, di fatto, letteralmente non dice. Che senso avrebbe, allora, un simile esercizio bizantino se non, appunto, un senso puramente ludico, che l’urgenza della vera vita, della vita reale, concreta, sempre tenderebbe ad annullare? Un gioco, dunque, inutile come tutti i giochi e, è il caso di puntualizzare, nemmeno tanto divertente. Per quello che riguarda Deleuze, poi, il leggendario aneddoto, ricordato da Céline, con cui ho iniziato ci porta direttamente nel cuore della questione che vorrei affrontare e che potrebbe essere ridotta alla semplice, si fa per dire, domanda: “Che cos’è una composizione?”. Dovremmo, per rispondere, nel collegare questa questione al pensiero di due filosofi che hanno avuto a che fare con la causa della differenza, vedendone marcato il proprio pensiero in maniera indelebile, dovremmo, dicevo, compiere un necessario passaggio per i loro testi, senza per questo ridurci a fare una sorta di sterile riassunto della loro filosofia. Non credo sia utile, qui, metterci a fare la storia della filosofia di Deleuze e Derrida in merito alla questione della composizione. Piuttosto, sarà più utile affrontare direttamente la questione della composizione a partire dal loro pensiero, pensando con loro, quindi, e cercando, per quanto sia nelle mie possibilità, di rilanciarne la portata. È necessario a questo punto chiarire che ho accomunato due filosofi – e non è la prima volta che lo faccio – che spesso si ritiene siano non accomunabili. L’ho fatto e continuerò a farlo, confortato da un’affermazione dello stesso Derrida, scritta in occasione della morte di Deleuze: “Per quanto riguarda le ‘tesi’, ma la parola non è adeguata – e soprattutto la tesi di una differenza irriducibile alla opposizione dialettica, una differenza ‘più profonda’ di una contraddizione (Differenza e ripetizione), una differenza nell’affermazione gioiosamente ripetuta (‘sì, sì’), la presa in considerazione del simulacro – Deleuze resta forse, malgrado tante dissomiglianze, colui che ho sempre ritenuto essermi più vicino tra tutti coloro che appartengono a questa ‘generazione’. Non ho mai avvertito dentro di me la benché minima ‘obiezione’, nemmeno virtualmente, contro alcuno dei suoi discorsi, anche se mi è capitato di brontolare contro questa o quella frase dell’Anti-Edipo (glielo avevo detto un giorno 1 Una prima versione di questo scritto ha costituito la traccia per una lectio, presso il Dottorato in Composizione architettonica della Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, all’interno di un ciclo seminariale, dal titolo La differenza dell’architettura, in un incontro, il 12 novembre del 2009, che vide coinvolto Sergio Givone e il sottoscritto, su invito del Prof. Franco A. Mariniello, al quale, unitamente a tutti i docenti, i dottorandi e gli studenti della Facoltà che furono presenti, intervenendo attivamente nel dibattito che seguì, va la mia più sincera e sentita riconoscenza. 2 U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, Einaudi, Torino, 1984, pp. 232-33. 22 23 mentre stavamo tornando insieme in automobile da Nanterre, dopo una soutenance di tesi su Spinoza) o forse contro l’idea che la filosofia consista nel ‘creare’ concetti”3. Derrida è chiaro, denotativo, letterale, diremmo: non ostante qualche brontolio verso questa o quella frase, l’accordo c’è ed è indiscutibile, tanto da non lasciar sorgere nessuna obiezione, mai. Per me basta questo. Dicevamo di Deleuze, riguardo l’aneddoto di apertura, ovvero riguardo la questione, contenuta in esso, dell’urgenza della vita che chiama, con la sua irriducibile concretezza, questione che in Deleuze si presenta ribaltata. Vediamo. Deleuze, nel testo di una conferenza dal titolo “Che cos’è l’atto di creazione?”, a un certo punto riflette proprio su questa questione dell’urgenza, connessa a un’altra questione, quella del differimento. Deleuze sta parlando di cinema, di un cineasta in particolare, Kurosawa, che viene a essere messo in relazione a Shakespeare e Dostoevskij. In quest’ultimo, in particolare, Deleuze rintraccia una formula, che viene definita la formula dell’idiota: in genere i personaggi di Dostoevskij “sono sempre coinvolti in situazioni urgenti, questioni di vita o di morte, ma, allo stesso tempo, sanno che c’è una questione ancora più urgente – e non sanno quale. Ed è questo che li ferma”4. La vita, la vera vita con le sue urgenze si ferma, perché c’è una questione più urgente e non si sa quale, ovvero, più avanti, riprendendo il discorso su Kurosawa, Deleuze accenna a un’ipotesi. “In I sette samurai, i personaggi sono coinvolti in una situazione d’urgenza – hanno accettato di difendere il villaggio – e sono continuamente tormentati da una questione più profonda, che sarà rivelata alla fine del film, quando essi se ne vanno, dal capo dei samurai: ‘Che cos’è un samurai?’ Che cos’è un samurai, non in generale, ma in quell’epoca particolare? Uno che non è più buono a nulla. I signori non ne hanno più bisogno e i contadini sapranno ben presto difendersi da soli. Per tutto il film, malgrado l’urgenza della situazione, i samurai sono ossessionati da questa questione, degna dell’Idiota: noialtri samurai, che cosa siamo?”5. Una questione essenziale, quindi, viene costantemente a interrompere l’urgenza della situazione. Se fosse concesso maggiore spazio, potremmo creare un parallelo tra questa riflessione di Deleuze a partire da Dostoevskij e la riflessione che Sergio Givone, nel suo Dostoevskij e la filosofia, compie sullo scrittore russo in merito al problema della temporalità associato alla promessa di salvazione del mondo da parte della bellezza in un orizzonte apocalittico6. Ritorniamo sui nostri passi. Volendo ridurre ai minimi termini tutto il discorso di Deleuze, operazione sempre rischiosa, in verità, ma necessaria a un testo sintetico, dovremmo dire che l’arte, negli esempi letterari e cinematografici presentatici da Deleuze, si presenta sempre come un atto di resistenza, come qualcosa che resiste al tempo. Questa sorta di formula, che abbiamo evocato in sintesi, non mancherà di essere esposta dallo stesso Deleuze in chiusura del testo della conferenza citata prima, laddove afferma che “l’arte è ciò che resiste, anche se non è la sola cosa che resiste. Di qui il rapporto così stretto tra l’atto di resistenza e l’opera d’arte. Ogni atto di resistenza non è un’opera d’arte, sebbene essa lo sia in un certo modo. Ogni opera d’arte non è un atto di resistenza e tuttavia, in un certo qual modo, lo è”7. Lasciamo per un attimo decantare questi concetti e rivolgiamoci al senso di tutto il discorso fin qui svolto, rintracciandone un possibile ascendente. Nel rispondere alla questione circa l’essenza dell’atto di composizione, siamo finiti, sulla scorta di una conferenza di Deleuze sull’atto di creazione, a pensare la resistenza dell’atto artistico allo scorrere del tempo e siamo arrivati a pensare a questo grazie alla riflessione sul modo d’essere dei personaggi di alcuni romanzi e di alcuni film: essi resistono alle urgenze della vita, all’incalzare dei tempi dell’esistenza, occupandosi d’altro, occupandosi in altro, investendo cioè le proprie energie in situazioni che a prima vista non hanno nulla del carattere della necessità e dell’emergenza della vita. Ecco l’arte, potremmo dire. E potremmo pure rintracciare un’ascendenza di tutto questo discorso nel testo sapienziale veterotestamentario. Nel capitolo 13, dedicato al tema dell’idolatria, ai vv. 10 e sgg. della Sophia Salomonos possiamo proprio leggere qualcosa che riguarda da vicino il discorso a cui stiamo accennando. Lì si parla della nascita dell’arte, in una sorta di genesi genealogica, rintracciata col metodo di una fenomenologia del possibile. Se a un abile legnaiolo, dopo aver lavorato un ceppo di legno, ricavato da un albero segato, aver formato un utensile “per gli usi della vita” (Sap 13, 11) e utilizzato gli scarti per accendere un fuoco con cui cucinare, pranzare e saziarsi, gli avanza ancora del legno, “proprio buono a nulla, / legno distorto e pieno di nodi, / lo prende e lo scolpisce per occupare il tempo libero; / senza impegno, per diletto, gli dà una 3 J. Derrida, Dovrò vagare da solo, tr. a cura di F. Polidori, in “aut aut” nn. 271-72, 1996, pp. 8-9. G. Deleuze, Che cos’è l’atto di creazione?, tr. a cura di G. Bianco, in “aut aut” n. 309, 2002, p. 43. 5 Ibidem. 6 Cfr. S. Givone, Dostoevskij e la filosofia, Laterza, Roma-Bari 2006, p. 92 nota 32, in cui viene evocata un’analoga scena di indecisione del Principe Myskin, scena che si inscriverebbe a sua volta nella cornice più ampia della “fissazione del tempo” (ibidem), perché il riscatto del mondo da parte della bellezza può comprendersi solo a patto di riconoscere a quest’ultima lo statuto di senso stesso, la cui unità emergerebbe unicamente a partire dal paradosso di un futuro che reca in sé i motivi del passato, di un futuro anteriore, capace di legare “l’istante eterno” del trapasso all’intelligibile “e la morte” (ivi, p. 88): “Solo dall’al di là del futuro, il tempo compiuto si lascia investire da un’unità di senso che lo conserva per sempre, togliendolo a se stesso: appunto, ‘il tempo non ci sarà più’” (ibidem). 7 G. Deleuze, op. cit., p. 47. 4 24 forma, / lo fa simile a un’immagine umana / oppure a quella di un vile animale” (Sap 13, 13-14). Ecco come nasce l’arte. Il legnaiolo crea un idolo, cioè qualcosa che farà parte di quella tipologia di oggetti che sono riconoscibili come “lavori di mani d’uomo (erga cheiron anthropon), […] lavorati con arte (technes emmeletema)” (Sap 13, 10). Vediamo. L’origine dell’arte sarebbe la stessa di quella dell’idolatria, che ha come principio essenziale quello di essere costituita dall’adorazione di opere, erga, di mani umane, che operano non in funzione di una necessità, ma per puro diletto e, soprattutto, nell’ozio (argia). Questi, dunque, i caratteri essenziali dell’arte come idolatria: essere opera umana non finalizzata ad alcunché di utile, sullo sfondo di una non dichiarata dialettica tra necessario e voluttuario. Da qui discenderebbe l’infelicità di chi confida in essa, perché ripone “in cose morte le sue speranze (en nekrois ai elpides auton)” (Sap 13, 10). L’opera, il simulacro, l’idolo è morto, nato morto, diversamente dal dio, che è spirito vivente. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’opera nasce con degli scarti, nei “tempi morti” dell’esistenza e il suo stesso venire alla luce e stare al mondo non ha una finalità se non coincidente col fatto stesso di esistere. Non solo. Nel capitolo 14, che al verso 12 ricorda come “l’invenzione degli idoli fu l’inizio della prostituzione (arche gar porneias epinoia eidolon)” e “la loro scoperta portò la corruzione nella vita”, si afferma altresì che essendo invalsa l’usanza, presso i sudditi, che vivevano in province lontane, di adorare le statue dei sovrani, si finì “per adulare con zelo l’assente, quasi fosse presente (ina os paronta ton aponta kolakeuosin dia tes spoudes)” (Sap 14, 17). Sotto certi aspetti riscontriamo in questa organizzazione concettuale, che risente ovviamente della riflessione sulla mimesi svolta nell’ambito del platonismo, quegli elementi che andranno a costituire nei secoli l’assiomatica estetologica (e non solo estetologica) occidentale. Occorrerà attendere la potente macchina filosofica kantiana per vedere, almeno apparentemente, riabilitate alcune di queste posizioni teoriche e sottolineo apparentemente, perché a tutt’oggi c’è chi teorizza, per esempio, sulla necessità della presenza piena del significato, così come sulla necessità di una volontà significante che preesisterebbe sempre a ogni sua possibile realizzazione concreta; così come c’è chi teorizza, circa i nostri due filosofi, sebbene il bersaglio polemico, in questo caso è costituito maggiormente dagli scritti di Derrida, che la loro sarebbe una filosofia nichilista, senza speranza, una sorta di virus, che porta morte e distruzione, il tutto ovviamente in nome pure di una certa ortodossia kantiana. E non sembri esagerata tale affermazione; basti leggere una delle pubblicazioni più recenti al riguardo, il libro di Nikos A. Salingaros Antiarchitecture and deconstruction, tradotto in italiano con il titolo Antiarchitettura e demolizione. La fine dell’architettura modernista, che è tutto un tuonare moralistico contro il decostruzionismo, che, a detta dell’autore, starebbe distruggendo ogni buona ragione di un sano modernismo inaugurato con l’Aufklärung. Basterà sfogliare il capitolo “Il virus ‘Derrida’” e operare dei prelievi testuali pure solo casuali, per rendersi conto di quello che sto dicendo. Scrive Salingaros: “A partire dagli anni sessanta, la decostruzione ha cercato di minare le basi di qualsiasi struttura ordinata. […] La decostruzione, come un parassita, necessita di una struttura ordinata (reale o latente) su cui agire per poi distruggerla. […] Questo approccio assomiglia al modo in cui i virus sopravvivono e prolificano. […] La sua strategia consiste prima di tutto nel farsi ingerire da un ospite ignaro; nel forzare l’ingranaggio interno dell’ospite per fare nuove copie del virus; e nel diffondere il maggior numero di copie possibile, per massimizzare la possibilità di infettare nuovi ospiti. Il virus richiede un ospite più complesso da invadere e distruggere, ma non può vivere autonomamente. Di origine francese, la decostruzione ha infettato la maggior parte delle discipline universitarie nel mondo”8. E via di questo passo. Del resto, pure nel giudizio di Eco, citato all’inizio, non era forse sottesa un’apologia dell’originale rispetto alla copia, della letteralità rispetto alla simbolicità, dell’unità e integrità rispetto alla decomponibilità, in una sola espressione, di una soggettività creatrice in senso forte? Il tutto poi assumendo che le posizioni filosofiche che stiamo esaminando siano, appunto, apologetiche al contrario e cioè della copia rispetto all’originale, della simbolicità rispetto a una letteralità del testo e così via, cosa che resta invece tutta da dimostrare. Ma ritorniamo alla questione di fondo e chiariamo subito un punto che è rimasto sospeso. Nel titolo di questo intervento è posta la questione della composizione, ma sin qui ho utilizzato un testo di Deleuze che sembrerebbe affrontare il tema della creazione, come mostra chiaramente il suo titolo. Come starebbero insieme creazione e composizione? Stanno insieme allo stesso modo in cui Deleuze ci ha fatto notare che stanno insieme l’atto di resistenza e l’opera d’arte. Una composizione non è una creazione, mentre sotto certi aspetti, possiamo dire, anzi, dobbiamo dire che una creazione è sempre una composizione. E qui entriamo nel vivo delle questioni che ci interessano più di ogni altra cosa, voi architetti e me che mi sto occupando di quella zona di confine tra filosofia e architettura. Chiariamo, intanto, anche un’altra questione di fondo, quella concernente il rapporto tra arte e architettura. Ancora Deleuze analizza i termini di questo rapporto nel suo ultimo libro scritto con Félix Guattari. Mi rendo conto di quanto singolare sia attribuire a Deleuze affermazioni che portano una doppia firma, ma, l’ho premesso 8 N. A. Saligaros, Antiarchitettura e demolizione. La fine dell’architettura modernista (2004), tr. a cura di D. Vannetiello, G. Pucci, J. Michalas e S. Borselli, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 2007, p. 109. 25 all’inizio di questo mio intervento, non si tratta qui di fare una storia della filosofia di Deleuze, non solo perché i suoi libri son tutti disponibili e pure tradotti per chi non conoscesse il francese - quindi sarebbe del tutto superfluo da parte mia intrattenervi su quanto potreste agevolmente fare da soli - ma soprattutto perché la posta in gioco qui riguarda proprio la messa in discussione della categoria di soggetto, di soggetto firmatario, di autore, di creatore, di inventore. Insomma, sia Derrida, occupandosene costantemente lungo tutta la sua attività filosofica, che Deleuze, il quale potremmo dire che l’ha messo in pratica, disperdendo l’iniziativa della sua propria firma e della sua propria riconoscibilità, “firmando” assieme a un altro, a Guattari, alcune tra le sue opere maggiori, entrambi, dicevo, hanno messo in discussione l’idea stessa che ci possa essere un soggetto forte, in senso idealistico, all’origine di qualsiasi atto, compreso l’atto della propria scrittura medesima. Possiamo qui ricordare, ancora a titolo esemplificativo, quanto Deleuze scrive rivolgendosi alla sua allieva e amica Claire Parnet, in un libro, Conversazioni, peraltro scritto pur’esso a quattro mani con la stessa Parnet: “Questo è proprio il momento di esercitare il metodo: tu ed io possiamo servirci di noi in un altro blocco o da un’altra parte, con te e le tue idee per esempio, in modo da produrre qualcosa che non appartiene a nessuno di noi in particolare, ma sta fra 2, 3, 4, … n. Non è più ‘x spiega x, firmato x’, ‘Deleuze spiega Deleuze, firmato l’intervistatore’, ma ‘Deleuze spiega Guattari, firmato te’, ‘x spiega y firmato z’. La conversazione diventerebbe allora una vera funzione. Dalla parte di… Bisogna moltiplicare le parti, spezzare tutti i cerchi a vantaggio dei poligoni”9. E ancora più esplicitamente, qualche decina di pagine dopo, sviluppando proprio la questione artaudiana del “dalla parte di…”: “Il fine, la finalità dello scrivere? Ben più al di là ancora di un divenire-donna, di un divenire-negro, animale, ecc., al di là di un divenire-minoritario, si presenta l’impresa finale di divenire-impercettibile. Oh, no, uno scrittore non può augurarsi di essere ‘conosciuto’, ‘riconosciuto’. L’impercettibile, carattere comune della più grande velocità e della più grande lentezza. Perdere il volto, superare o perforare la parete, limarla con grande pazienza, scrivere non ha altro fine”10. Questa è l’idea, di fronte a cui ci troviamo, di una pratica come la scrittura, che il senso comune ci ha abituati a pensare come creativa. Essa, invece, conduce all’”acquisizione di una clandestinità”11, che è la stessa a cui si rivolge Deleuze quando afferma che con Guattari si sono “intesi, completati, spersonalizzati l’uno nell’altro, singolarizzati l’uno attraverso l’altro, insomma amati”12. Ora, se le cose stanno così, capirete agevolmente il perché, avendo deciso proprio di trattare questo argomento della composizione, come critica, messa in crisi della creazione e relativa emersione della funzione compositiva, l’ultima cosa da fare era pensare a una ricognizione storiografico-filologica di motivi deleuziani e/o derridiani. Dicevamo del rapporto tra arte e architettura. In Che cos’è la filosofia?, Deleuze e Gattari scrivono che “l’arte comincia forse con l’animale, almeno con l’animale che ritaglia un territorio e fa una casa (le due azioni sono correlative o addirittura si confondono talvolta in ciò che si chiama un habitat)”13. Sembrerebbe che qui si faccia coincidere la genesi dell’arte, genesi funzionale, ovviamente, proprio con l’architettura e, per averne una conferma, basta leggere qualche pagina dopo: “L’arte comincia non con la carne, ma con la casa; per questo l’architettura è la prima delle arti. Quando Dubuffet cerca di isolare un certo stato di art brut, è innanzitutto verso la casa che si volge, e tutta la sua opera si staglia tra l’architettura, la scultura e la pittura. E, per quanto riguarda la forma, l’architettura più ricercata non cessa di costruire e congiungere piani e lembi. Per questo la si può definire una ‘cornice’, un incastro di cornici diversamente orientate che si imporrà alle altre arti, dalla pittura al cinema”14. L’artista, che è sempre un architetto, l’abbiamo sentito, sarà allora anche sempre un compositore, proprio nel senso musicale del termine. Cosa fa, infatti, un compositore? Mette insieme dei suoni, ovvero, “progetta”, con la partitura, uno spazio-tempo di organizzazione sonora ovvero, come li definisce Deleuze, di “blocchi di sensazione che fungono da linguaggio”15. Ecco che l’arte, “sia che si serva di parole, di colori, di suoni o di pietre”16, utilizza sempre lo stesso procedimento compositivo: mette insieme blocchi, ovvero ne organizza in progetto l’esecuzione, che poi sarà la vera e propria creazione. Mi spiego meglio, ricorrendo adesso al testo derridiano. Siamo abituati a pensare alla genesi di un’opera d’arte in base al paradigma della creazione: un’opera nasce quando un’artista la crea. Derrida ci aiuta a rivedere radicalmente questa posizione. Un’opera nasce quando una comunità politica ne legittima l’esistenza. Sembrerebbe che Derrida ci inviti a spostarci dall’orizzonte genetico della creazione a quello della cosiddetta risoluzione. In realtà le cose stanno in maniera un po’ più complessa. Ma leggiamo direttamente dal testo di un’intervista, in un punto in cui Derrida e i suoi interlocutori si concentrano sulla questione della firma. Il problema posto è apparentemente semplice: l’effetto 9 G. Deleuze e C. Parnet, Conversazioni (1977), tr. a cura di G. Comolli e R. Kirchmayr, Ombre corte, Verona 2006, p. 25. Ivi, p. 52. 11 Ibidem. 12 G. Deleuze, Pourparler (1990), tr. a cura di S. Verdicchio, Quodlibet, Macerata, 2000, p. 16. 13 G. Deleuze e F. Guattari, Che cos’è la filosofia? (1991), tr. a cura di C. Arcuri, Einaudi, Torino, 2002, p. 185. 14 Ivi, p. 188. 15 Ivi, p. 176. 16 Ibidem. 10 26 della firma è o non è riducibile all’effetto del patronimico? Posto così, sembra effettivamente un problema semplice; invece, si tratta di un problema abissalmente complesso che coinvolge le questioni dell’origine e del nome del Padre. Lasciamo sullo sfondo queste questioni e vediamo come possiamo far funzionare la cosa a partire da quello che ha detto Derrida, per il quale, ovviamente, l’effetto di firma non è mai riducibile a quello di patronimico. La firma, secondo Derrida, non è altro che una sorta di sigillo performativo, un vero e proprio “performativo con cui una persona si impegna in qualcosa, con cui si conferma in modo performativo che si è fatto qualcosa – che questo è fatto, che sono io che l’ho fatto”17. Quindi, quando un artista firma un’opera, vale a dire quando decide che è finita, perché ovviamente potrebbe, materialmente, pure non firmarla, allora, dice Derrida, c’è un effetto di firma, che attesterebbe il fatto che c’è stato un evento. Ora, secondo il senso comune, il momento della creazione a questo livello potrebbe ben dirsi compiuto: un autore ha creato un’opera, cioè l’ha fatta nascere, portandola alla luce e decretandone la compiuta riuscita col suggello della propria firma. Invece, Derrida fa notare che a questo livello non si è compiuto proprio nulla. Infatti, per Derrida, “tutto inizia con la controfirma, con il ricevente, con ciò che noi chiamiamo il ricevente. L’origine dell’opera risiede in definitiva nel destinatario, in chi ancora non esiste, ma è qui che la firma inizia. In altre parole, quando qualcuno firma un’opera, abbiamo l’impressione che la firma sia una sua iniziativa. È qui che essa inizia; lei o lui produce questa cosa e poi firma. Ma questa firma è già prodotta dal futuro anteriore della controfirma, che sarà venuta a firmare questa firma. Quando firmo per la prima volta significa che io sto scrivendo qualcosa che so che sarà stata firmata solo se il destinatario giunge a controfirmarla. Dunque la temporalità della firma è sempre questo futuro anteriore che naturalmente politicizza l’opera, l’abbandona a qualcun altro, cioè alla società, a un’istituzione, alla possibilità della firma”18. Riprendendo il filo di un discorso a cui prima abbiamo solo accennato, potremmo dire che è solo a partire da un passato come futuro, un passato che viene dal futuro, che un’opera può nascere, acquistando un senso. Ma questo, di fatto, lo si può dire di ogni invio comunicativo. Sappiamo quanto Derrida abbia insistito su questioni come queste per tutta la sua vita. Abbandonandoci ancora al rischio di una formula, potremmo dire che in definitiva Derrida ci sta dicendo, diversamente da quello a cui siamo abituati a pensare, che la prassi precede sempre, essa finisce per essere quella cornice che precede, costituendo. È dallo spazio di relazione che si instaura tra autore opera e pubblico che emerge il senso di ognuno di questi elementi, è lo spazio di relazione tra loro, è l’effetto di cornice che li tiene insieme che fa sì che un autore, un’opera e un pubblico siano tali. Essi potranno essere ciò che sono solo a partire da quello che comunemente noi saremmo abituati a pensare come il momento finale e tutto sommato pure trascurabile, perché, contraddittoriamente, da un lato pensiamo l’arte come un’attività e dall’altro poi pensiamo che possa fare pure a meno di pubblico, tanto ciò che conta è appunto solo l’attività dell’artista creatore. Invece, a rigore, se è un’attività, la cui essenza riposa sul versante della prassi, allora sarà la sua “pratica di utilizzo”, il modo in cui sarà utilizzata, vissuta da una comunità, che è sempre politica, ci ricorda Derrida, che farà sì che un’opera possa essere tale. Sarà l’autore, allora, che a rigore dovrà scomparire e di fatto scompare, mettendosi “dalla parte di…”, dice Deleuze parafrasando Artaud, dalla parte di chi parla una lingua minore, degli analfabeti, ancora per citare Artaud, dei clandestini, insomma, in una parola, di chi è infame, cioè, di chi, letteralmente, è privo di fama, di tutti coloro che, anonimamente, in modo spersonalizzato, ma intenso, completo e singolare, amano ciò che anche gli architetti, componendolo, regalano al mondo. 17 J. Derrida, Adesso l’architettura, tr. a cura di F. Vitale e H. Scelza, Libri Scheiwiller, Milano 2008, p. 47 (sottolineature mie, d. g.). 18 Ivi, p. 50. 27 TEMPI ALLA RINFUSA E PROGETTO Carmine Piscopo L’arbitrio della conservazione Cosa conserveremo delle nostre città? Quali paesaggi, quali immaginazioni, quali prove concrete del nostro tempo? Quale il futuro della storia? Preservation of Change è lo slogan lanciato da Rem Koolhaas alla XII Biennale di Architettura di Venezia (2010). Più che un paradosso, una critica radicale alla macchina della conservazione, al “moralismo arbitrario” con cui vengono definiti i criteri di tutto quanto conserviamo. E, per differenza, di tutto quanto non conserviamo e, dunque, trasformiamo. È il ritratto di un circolo vizioso che porta immense parti del nostro pianeta verso la conservazione radicale (un destino che riguarda sempre più le grandi città), mentre altre aree del pianeta sempre più velocemente sono destinate a una sovraccelerazione di trasformazioni. Alla base, la paura del cambiamento: temiamo il nostro futuro e dunque conserviamo il nostro passato. Opponendo alla conoscenza e alla memoria la nostalgia e il nostro radicamento. Paura del cambiamento Il nostro tempo costruisce paesaggi come rovine e mette in mostra il passato, secondo un taglio diviso tra paura del futuro, desideri senza nome e utopie vissute come già realizzate. Così le città si fanno Cronocaos, ovvero luogo del conflitto e dei paradossi del tempo, come un gigantesco artefatto collettivo che rimesta strati in un rigurgito di storia. Un inarrestabile, instabile, caotico, divenire che adegua Oriente e Occidente, bellezza e orrore e marca come inattuale e rugginosa la supponenza dell’architettura. Il punto, allora, è cosa conservare e cosa trasformare. E perché. “In un vortice di cambiamento è fondamentale comprendere cosa resterà ‘lo stesso’. […] Cosa, fuori da questa generica zuppa, merita la vita eterna”1. La macchina del tempo Preservazione, conservazione forzata, prescrittiva, retroattiva, stratificazione, accumulo, deposito: un gigantesco edificio della memoria fa già ombra al futuro. Così, Saramago, in Tutti i nomi, già descriveva l’Archivio della Conservatoria Generale come una costruzione in tutto simile a un Cimitero, i cui scaffali si perdono nelle viscere della città, come i rami di un albero formati da nuclei costruiti e agglomerati che si sovrappongono alle facciate dei palazzi. Se la storia non è più un divenire certo, dovremo pensare le nostre città come macchine del tempo pronte a coniugare le tracce del passato con il cambiamento, il nomadismo con la residenzialità, il deserto con l’abitazione dell’uomo, gli spazi privilegiati con quelli negletti e dimenticati. La trasformazione con la conservazione. Come accade in Songlines di Bruce Chatwin (da cui Rem Koolhaas trae spunto per Singapore Songlines), un libro dedicato ai canti degli aborigeni, dove i miti delle origini si intrecciano con le mappe dei sentieri e dei luoghi abitati. Dove l’urbano, per poter continuare a crescere, si fa antiurbano, e la storia, dialettica di governo delle contraddizioni, lungo il filo dell’inclusività, della simultaneità, dell’attualità. Macchine del tempo, come laboratori urbani dove “Older e Newer will be in permanent dialogue”2. Dove, all’abbandono e al disagio sociale dei luoghi si contrappongono nuovi manufatti per nuove forme di comunità, come accade a opera di Todd Sounders nella sperduta e poverissima isola di Fogo nell’Atlantico. Dove, di fronte al dolore del cambiamento, l’architettura si dispone come macchina per una comunità ritrovata, come accade nel progetto di Shigeru Ban per la città di L’Aquila. In un mondo sempre più insidiato da allargamenti di forbice che annunziano disastri, la storia non potrà che costruirsi secondo una ragione flessibile, come una prudente astuzia, per non lasciarsi sfuggire dalle mani il futuro della memoria. Tempi alla rinfusa o Cronocaos Un pianeta, il nostro, da mettere in teca, per salvarlo dal rischio dell’autofagocitazione, ma anche dalla nostra paura del futuro e del progresso? O, piuttosto, (d’impulso dello scrupolo del parricidio, per effetto collaterale del ritorno del rimosso, in totalizzante solidarietà all’interno dell’orda) un pianeta da ridisegnare integralmente ad 1 R. Koolhaas, Cronocaos, XII Biennale di Architettura di Venezia, 2010. R. Koolhaas, Singapore Songlines. Ritratto di una metropolis Potemkin … o trent’anni di tabula rasa, a cura di Manfredo di Robilant, Macerata, Quodlibet, 2010. 2 28 altezza delle aspettative del presente o delle proiezioni en avant, come avevano già preconizzato i futuristi (“[…] come gli antichi trassero l’ispirazione dell’arte dagli elementi della natura, noi – materialmente e spiritualmente artificiali – dobbiamo trovare quell’ispirazione negli elementi del nuovissimo mondo meccanico che abbiamo creato, di cui l’architettura deve essere la più bella espressione, la sintesi più completa, l’integrazione artistica più efficace”3)? O, forse, su suggerimento della terzietà, fondata sull’ inclusività e sull’esigenza di aprirsi a variabili, che l’arroganza della ragione pregiudizialmente scarterebbe, cercare una via di mezzo? Certamente, da come si scioglierà questo complicatissimo nodo, dipenderanno le sorti non solo dei nostri paesaggi, ma anche più complessivamente della vita sulla terra, talmente sinergica e inestricabile è l’interdipendenza funzionale oggi dei fattori che agiscono la macchina del reale. Il cui profilo è venuto cambiando notevolmente, rispetto a quello del passato, sotto molteplici aspetti, ma particolarmente sotto quelli dello scorrere e del manifestarsi dei tempi e del lievitante ispessimento della corteccia terrestre. Riguardo al primo aspetto, pressoché abissali sono le distanze che ci separano dall’antichità. Diversamente da quanto risulterebbe dall’anagrafe geologica, dove la durata di pochi millenni è pressoché irrilevante, la percezione e la sperimentazione del tempo si sono venute sempre più differenziando e sofisticando, aprendo squarci sul versante non solo dell’architettura. Nell’ambito delle culture mesopotamiche, il tempo dell’uomo sul nostro pianeta si presentava di una linearità e di una misurabilità, che potevano (e dovevano) essere comprese anche dai bambini. Gli inizi della vita apparivano recenti e di facile conteggio. A fronte di questo scenario, il futuro si configurava come uno spazio disteso in lunghezza più che in larghezza tutto da attraversare, anche se con pena e rischi gravi, che facevano rimpiangere gli aurei tempi del passato. Così, la narrazione del futuro si intrideva di mobili ombre di pessimismo e si avanzava col viso rivolto a ciò che era stato, che faceva da pietra di paragone. Il reticolo, tuttavia, della paideia antica presentava degli squarci profondi inferti dalla sapienzialità filosoficoreligiosa e dalla mitologia, che introducevano enigmi da decrittare e interrogativi di una vastità e di una cogenza, che possono essere e sono tuttora anche per noi attuali. Entro tale materia rientra la scoperta del concetto dell’incomparabilità dei tempi lunghi con i tempi brevi. Erodoto (Storie) racconta di un dialogo intrattenuto da lui con un sacerdote egiziano, il quale, dopo avere ascoltato le considerazioni erodotee sulla civiltà greca, conclude con saggezza, chiudendosi infine in un cerchio di incolmabile lontananza, che tutta quell’effervescenza della civiltà greca deriva dai tempi giovani, che sono a suo fondamento, ma che il tutto è una piccola cosa a confronto con la civiltà egiziana che scaturisce da tempi lunghissimi che risalgono all’origine del mondo. Ancora più denso di suggestioni simboliche è il racconto biblico (Genesi) della torre di Babele, progettata e avviata a costruzione per raggiungere il cielo, ma rimasta inconclusa, per la punizione voluta dall’alto dell’arroganza e della presunzione degli uomini. Per molti secoli, questo racconto ha costituito tema di interpretazione, nella cultura ebraica innanzitutto, ma anche in tante altre culture, sul registro della negatività, della difficoltà della comunicazione presso il genere umano innanzitutto a causa della molteplicità delle lingue e dell’irrecuperabilità della lingua unica e universale del tempo di Adamo. Ma quest’ermeneutica pessimistica non contiene e conclude tutta la pregnanza di insegnamenti allegorici del racconto, in quanto, come si è venuto scoprendo sempre meglio nella modernità, la narrazione avvisa chi legge innanzitutto che la progettualità totale e la pianificazione unilaterale e arbitraria, in scollegamento dalle relazioni con la terrestrità e con tutte le fenomenologie degli spazi e degli ambienti biologici, si ispira a un arbitrio che non può non andare incontro allo scacco finale, che tocca puntualmente ad ogni insorgenza di folle e sterile autoreferenzialità o di univocità. Ben diversa coscienza del tempo e dei tempi è nell’uomo moderno, dall’uomo-massa al filosofo. Se il primo vive nel tempo come il verme nel formaggio e se il secondo (v. Husserl, Heidegger, Jaspers, gli ermeneutici) indaga su una condizione fondante dell’esserci, sia l’uno che l’altro guardano al reale non come a un evento che ha un principio e una fine, alla maniera dell’uomo antico, ma come a una sostanza densa, però anche pastosa e porosa, che ci prende, ci tiene, ci manipola. Ci dà terrore (e tremore), quasi ostilmente, e, intanto, disperatamente ci innamora. Ma quel che più apre squarci sulla contemporaneità è la simultaneità dei tempi diversi e discordi, il loro reciproco intrecciarsi, come fasci e fibre, come armature differenti, come correnti dalle direzioni antagoniste. Così, Ernst Bloch scriveva che differenti tempi storici scorrono nel medesimo tempo cronologico, tali da dar vita a una sorta di non-contemporaneità di tempi che vivono nello stesso tempo. Su questa base, George Kubler, ne La forma del tempo, inquisiva il tempo come un oggetto formato da differenti classi formali, per ritrovare sequenze, durate e soluzioni collegate, dentro cui si innerva l’agire umano. Dalle Considerazioni inattuali di Nietzsche in qua, dove si rompe lo schema concettuale dell’unidirezionalità del tempo, dove è il presente –si afferma– che modifica il passato, un’intera letteratura si interroga sul tempo. Per conciliare, come una prova einsteiniana, lo 3 A. Sant’Elia, Architettura futurista, Milano 11 luglio 1914. 29 sguardo dell’osservatore che guarda il treno passare con lo sguardo del viaggiatore che si trova sul treno. Per mostrare quanto la causa può essere posteriore all’effetto o quanto la memoria non conosce tavole periodiche del tempo. Fino ad André Chastel, che nel suo lavoro dedicato al progetto del quartiere Les Halles a Parigi, sottolinea quanto la storia non sia un divenire certo, bensì essa si disponga come l’ordine delle simultaneità. Con questo paesaggio eteroclito di tempi differenti, che si spettacolarizzano soprattutto per il trovarsi insieme alla rinfusa, concorda pienamente lo spazio-spazzatura (Junkspace) di Rem Koolhaas, su cui ha molto icasticamente richiamato l’attenzione il medesimo architetto. E siamo, qui, al secondo aspetto che si citava sopra, cioè all’ispessimento patologico e artificiale della crosta terrestre d’impulso dell’aggressività e della distruttività dell’uomo. L’urbanizzazione sempre più accelerata e intensa del pianeta, che si esprime per concrezioni non programmate, su spinte e bisogni di una crescita travolgente della popolazione terrestre, su coazioni del sistema macroeconomico costituito sull’esigenza di un innalzamento costante del pil delle comunità e degli Stati, su domande di potenziamento delle tecnologie, su allettamenti del gusto e rinnovamenti delle offerte sui mercati, sta modificando in superficie, in altezza, in profondità il profilo e la natura dell’involucro planetario. Della pelle originaria del nostro pianeta oggi avanza solo qualche lacerto, che, inserito, in un contesto artificiale, ha perduto la sua funzione naturale, assolvendo un compito secondario di arredamento e di citazione di un’altra condizione ormai smarrita e rimasta appena impigliata nella memoria. In tutto ciò, se una dialettica si lascia intravedere e rappresentare, è quella del confronto brutale tra grattacielo e favela, tra monumentalismo e minimalismo degradato. Tra orgoglio di vantata “venustas” e squallore di spregiata “deformitas” o, peggio, “foeditas”. Ma anche tra piantumazione di cemento e desertificazione moderna. Questo impasto di orrore e di bellezza, di perversione e di modernità, che ogni giorno di più innalza i suoi livelli e allarga le sue latitudini, ha come teatro principale e più avanzato le coste orientali dell’Asia, dalla Corea meridionale in giù. A tale teatro si guarda da sociologi, economisti, politici, antropologi, architetti, studiosi di geografia umana per la rilevazione e lo scandaglio di questioni comportamentali, relazionali, organizzative, produttive inedite nella storia del genere umano. Ma ad esso anche si guarda come ad anticipo di situazioni che presto si diffonderanno e che già attualmente si stanno diffondendo altrove. Che si ritrovano nelle nostre città, come nel cortile di casa. Ma l’irrobustimento e la dilatazione della materialità artificiale, il flusso del magma di nostra produzione che irrigidisce, intralcia e fibromatizza il tessuto che irretisce il pianeta, non sono determinati unicamente dai corpi di fabbrica ipogeicamente e apogeicamente posti in essere, in quanto con questi corpi interagisce e fa massa una gran quantità di altri manufatti, dai grandi macchinari statici alle macchine in movimento, dal televisore al libro, alla strip, al telefonino, all’orologio da polso e alla bic, che non solo occupano spazio, ma che impongono allo spazio di adattarsi e, caso mai, di ridisegnarsi ad altezza di bisogni che si moltiplicano di giorno in giorno e che, ogni nuovo giorno, si riformulano per varianti seduttive e funzionali. Anche questi manufatti, dunque, come tutte le altre presenze materiali artificiali, operano in interfaccia nell’esistente. Funzionano per i fini per cui sono introdotti nel mondo, ma insieme pongono problemi di loro smaltimento e perfino di loro memoria e sollecitano in ambito antropologico continui aggiornamenti e riconversioni di abilità, oltre che reazioni psicologiche e prelogiche, quali regressioni, scatenamenti di libido, sostituzioni e invenzioni (imperialistiche) di nuova realtà da parte dell’Io, culti feticistici, come nell’analisi svolta da Jean Baudrillard4. Se è vero che all’interno dei sistemi strutturati, gli intrecci e gli scambi di funzioni possono produrre delle variabili indipendenti e delle tensioni che procedono per proprio conto, a quale progettualità ci si potrà appoggiare, dunque? E, di fronte alle sfide di un esistente che funziona da schiacciasassi e schiacciasogni, di fronte ai fallimenti clamorosi della ragione onnicomprensiva e totalizzante, possiamo ancora pretendere di progettare il futuro? Nell’ambito del pensiero debole, diffuso a fine millennio in Italia in un clima di decomposizione delle certezze forti e delle narrazioni ottimistiche del reale e alimentato da accorti suggerimenti ermeneutici, la prudenza ha suggerito non di non navigare per i mari della speculazione, ma di procedere a vista, lungo le coste delle terre emerse. La razionalità è stata invitata ad essere più umile, più sobria, più autocontrollata, in certo senso più pragmatica. In questa medesima direzione si sono mossi i continuatori della Scuola di Francoforte e altre tendenze, quale quella del razionalismo critico, dove è risultato fondamentale l’atteggiamento flessibile di tener conto degli effetti imprevedibili, dell’”ordine spontaneo” e della terzietà. L’insegnamento di Popper, ad esempio, è servito non poco a fare assumere cautele nei confronti di uno storicismo unidirezionale, a vantaggio di una contattazione più produttiva delle insorgenze di nuove possibilità, di nuove finalità, di nuove contraddizioni. A essi, si aggiungono 4 J. Baudrillard, Il sistema degli oggetti, Milano, Bompiani, 1972. 30 oggi nuovi studi, fondati sulla lateralità, sul filo del disoccultamento degli aspetti latenti e di inclusione del vissuto, dell’emotivo, dell’asimmetrico, dello spontaneo, dell’anonimo, oltre che del privato inteso come risorsa di integrazione e di sinergia col pubblico. L’impegno essenziale e comune di questi autori, che non sono né pochi, né isolati, è di saldare i conti con la modernità, di avvicinare architettura e realtà e, insieme, di procedere nella speculazione e nella prassi, con l’ausilio di più attuali e stringenti teorie, nel segno del dilemma proposto da Le Corbusier: “Architettura o Rivoluzione”. In questo senso, una posizione particolarmente interessante, è quella di Rem Koolhaas. Non del Koolhaas sovversivo e puntuto dissotterratore della paranoia critica di Salvador Dalì degli anni giovanili, l’autore del manifesto Delirious New York (1978), ma del progettista e del teorico passato dall’OMA all’AMO, che, mentre si affaccia verso la nuova frontiera della “città generica” e della “Bigness”, si è rimboccato le maniche e si è messo a lavorare nel grande caos del “Junkspace”. Il cui profilo egli affida a una specie di tracciato di sismografo dai velocissimi passaggi: “Le creature terrestri vivono oggi in un asilo grottesco… Il Junkspace prospera nel progetto, ma il progetto muore nel Junkspace. Non c’è forma, solo proliferazione… Le superstringhe di grafica, gli emblemi trapiantati nel franchising, le sfavillanti superstrutture di luce, led o video descrivono un mondo senza aurore che nessuno può reclamare, sempre unico, totalmente imprevedibile, eppure intensamente familiare. […] Il Junkspace inventa storie da ogni parte, i suoi contenuti sono dinamici e tuttavia stagnanti, riciclati o moltiplicati come in una clonazione: forme in cerca di funzione come paguri in cerca di un guscio vuoto… Il Junkspace perde le architetture come un rettile perde la sua pelle, rinasce ogni lunedì mattina. […] Gli architetti pensarono per primi al Junkspace e lo chiamarono Megastruttura, soluzione finale che avrebbe permesso di trascendere il loro enorme impasse. Come Torri di Babele moltiplicate, le megastrutture sarebbero durate fino all’eternità, brulicanti di sottosistemi impermanenti che sarebbero stati capaci di mutare nel tempo, oltre il loro controllo. Nel Junkspace, lo schema si rovescia: non vi sono che sottosistemi, senza megastrutture, particelle orfane in cerca di una cornice o un ordine. Ogni materializzazione è provvisoria: tagliare, piegare, strappare, rivestire: la costruzione ha acquistato una nuova morbidezza come la sartoria…”5. In questo spazio, dove le clonazioni, le tautologie, le sostituzioni costituiscono il tessuto connettivo di una liquidità primaria e di un pacificato ricambio di parti, di oggetti, di individui, i veri accadimenti sono le performance (grottesche e assurde) dei segni e dei rapporti fra i segni. L’unica legge è della consumazione dei rapporti, non importa se tra manufatto e manufatto o tra persona e manufatto. Perché tutto è segno all’interno di un sistema di scambi da manuale cibernetico e di istruzioni per l’uso. Tutto è tutto (e niente) e ridiventa sé stesso nella postumità. Gli scenari visitati, scandagliati e restituiti alla coscienza critica da Koolhaas sono sostanzialmente da The Day after, di una funebrità postapocalittica, che rinviano, per analogia, alle teorie della catastrofe e alle narrazioni della fine della storia, non secondo la rappresentazione di Fukuyama suggerita prevalentemente, se non esclusivamente da ottimismo ideologico (il liberalismo come approdo universale e finale del cammino dell’uomo), ma in maniera abbastanza ravvicinata agli enunciati di Baudrillard circa l’implosività “postuma” coatta e destituita di senso di questa nostra contemporaneità. Questi paesaggi della fine, Koolhaas li osserva neutramente, impassibilmente, da viaggiatore che cerca riscontri e finisce per trovare appunto solo riscontri all’infinito, come egli documenta nella mostra Cronocaos. I fotogrammi lì esposti, accompagnati da essenziali didascalie, citano, attraverso particolari colti con fulminea istantaneità nella loro instabile esposizione al Junkspace, una situazione di universale disastro dovunque identica, anche se mutano le latitudini e, con esse, i cromatismi e le iconologie. Basta avvicinare fra loro i fotogrammi fra quelli esposti di tre località fra loro distanti: quello di un hotel sulle Alpi, quello di un’auto nel deserto libico e quello dell’interno di un deposito di bidoni di vernice in un paese sottosviluppato. Il primo simula una ripresa per cartolina illustrata da conservare o da mandare affettuosamente a persone amiche. Ma, se l’occhio si posa non passivamente, bensì criticamente sul fotogramma, non può non sorprendere che, dietro l’apparenza dell’idillio, grida un orrendo scandalo, quello di uno stupro, di un turpe incastro di lindo e accurato progettino architettonico realizzato in un paesaggio di una purezza delle origini, ormai violata e definitivamente perduta. Questo identico oltraggio si ripresenta in un’altra ripresa per pseudocartolina illustrata, quella di un’auto nuova, tutta sfolgorante di vanità e di vernice metallizzata in un angolo di deserto libico tessuto da distese di sabbia e da erezioni di sculture rocciose dei primordi. Anche qui, senza parole, si denunzia da sé un pacificato disastro, di rimescolamento di natura e industrialismo, di un cortocircuito che avviene tranquillamente entro un mezzogiorno di fuoco. 5 R. Koolhaas, Junkspace. Per un ripensamento radicale dello spazio urbano, a cura di G. Mastrigli, Macerata, Quodlibet, 2006, pp. 69-71, passim. 31 Qualcosa di molto affine dice anche il terzo fotogramma dedicato all’interno di un capannone, che fa da deposito di bidoni di vernice, da cui avanza per uscire all’aria un operaio, un custode o forse uno che si è fermato a curiosare. Chi sia costui, non si sa, né è importante sapere: quello che conta invece è la sua presenza di uno che si allontana, si trova lì per caso, quasi un superstite o forse uno strumento antiquato di supporto all’opera di stoccaggio e di spostamento della merce in bidone. Anche questa è un’ulteriore prova di una situazione che è esondata dal suo alveo e trascina con sé di tutto, compresi gli anonimi, insignificanti esseri umani. In questo universo abbandonato dalla speranza, che cresce per effetti collaterali di destrutturazioni e assemblaggi di materiali fra loro eterogenei, dove bello e brutto si rovesciano l’uno nell’altro attraverso vasi comunicanti, nient’altro resta da fare per Koolhaas che dire la verità, per quanto scomoda, anzi terribile essa sia. Per l’architetto, non resta che il lavoro, un lavoro duro a denti stretti, disinfestato di ogni pomposità o mistificazione, innanzitutto della spettacolarizzazione di sé come architetto. Se qualcosa, invece, di importante e di decisivo egli può fare, riguarda lo smascheramento dei luoghi comuni e dell’ottimismo, lo svuotamento degli stereotipi, la collaborazione da tecnico a evitare che il Junkspace si ingorghi e in sé rigurgiti. Ed è qui che Rem Koolhaas lancia la sua provocazione: se tutta l’architettura di età superiore a 25 anni venisse raschiata, un intero territorio si libererebbe, come una riserva strategica in grado di assolvere problemi che non riusciamo più a risolvere. Tra essi: l’urbano6. 6 R. Koolhaas, Cronocaos, op. cit. 32 FONDARE IL PROGETTO SUL REALE Vincenzo Ariu La fede in un mondo esteriore indipendente dall'individuo che lo esplora è alla base di ogni scienza della natura. Poiché tuttavia le percezioni dei sensi non danno che indizi indiretti su questo mondo esteriore, su questo "reale fisico", quest'ultimo non può essere afferrato da noi che per via speculativa. Ne deriva che le nostre concezioni del reale fisico non possono mai essere definitive. Se vogliamo essere d'accordo, secondo una logica per quanto possibile perfetta, con i fatti percettibili, dobbiamo essere pronti a modificare queste concezioni, altrimenti denominate il fondamento assiomatico della fisica. In realtà, un colpo d'occhio alla evoluzione della fisica ci permette di constatare che questo fondamento ha subìto, nel corso dei tempi, cambiamenti profondi. Albert Einstein1 È possibile fondare il progetto sul reale? Questo tema non è insolito nella storia delle teorie architettoniche. Nella cultura italiana degli anni ’60 e ’70 è stato al centro delle riflessioni delle correnti culturali dette di “Tendenza” e in particolare dei “Neo-razionalisti”. Autori come Aldo Rossi e Giorgio Grassi, debitori del pensiero critico del direttore di Casabella-Continuità, Ernesto Nathan Rogers, hanno provato a sviluppare diverse declinazioni del tema, cogliendo aspetti interessanti, oggi forse dimenticati, seppure invischiati delle ideologie del tempo. Proverò, quindi, a ridefinire il problema utilizzando il metodo scientifico confutando il saggio “l’architettura della realtà” scritto nel 1977 da Antonio Monestiroli, rigoroso architetto e intellettuale milanese vicino ad Aldo Rossi. Pur non condividendone in toto le argomentazioni, la citazione di Einstein non è a caso, penso che il saggio possa ampliare la riflessione su un tema che oggi sembra dimenticato, ma che rappresenta quell’orizzonte di senso necessario a qualsiasi azione progettuale. Il problema che pone Monestiroli è essenziale: trovare il filo rosso che lega i sistemi formali dei quali si avvale l’architettura e il fine per il quale l’architettura stessa è costruita. Una semplificazione necessaria, nella quale vi è la consapevolezza che le relazioni tra forme, costruzione e finalità sono inestricabili e reciproche. L’architettura è sintesi di una complessità. Cogliere l’idea fondante può significare avvicinarsi al suo fine ultimo. In questa ricerca delle ragioni del costruire è fondamentale lo sviluppo storico degli edifici, i quali hanno determinato i temi sintetizzati in configurazioni tipiche e ricorrenti. Il tema specifico dell’architettura rispecchia le esigenze della collettività. L’architetto è colui che deve, dopo averlo individuato, svilupparlo (svolgerlo) nel modo migliore. Nel tema di architettura è racchiuso un sapere sedimentato storicamente che trascende il sapere degli individui di un tempo storico determinato. I temi sono tutti già posti storicamente seppure essi mostrano un diverso grado di sviluppo e quindi il problema dell’architetto è contribuire al loro sviluppo cercando di perfezionarli e renderli il più aderenti possibile alle esigenze profonde della collettività. In questo senso per Monestiroli l’architettura è una disciplina che ha per obiettivo la conoscenza del reale, rappresentato dalla sua funzione profonda, la quale non è altro che la sua ragione d’essere. La ricerca del reale in architettura, quindi la sua ragione d’essere, si traduce nella necessità di rivedere e perfezionare le forme affinché esse rispondano per approssimazioni successive al loro senso. Sinteticamente lo studioso milanese sostiene: “… Dire che l’architettura è la manifestazione della ragione degli edifici, questa mi sembra la definizione più convincente, significa distinguere nel procedimento due diversi aspetti di essa: il primo di conoscenza e definizione di tale ragione, attraverso il processo di generalizzazione della funzione, il secondo di costruzione di un sistema formale atto a rendere manifesta tale ragione. Il problema pertanto consiste non tanto nell’accettare o nel negare il rapporto di forma con il significato, …, quanto nel definire i modi della conoscenza e della definizione di tale significato e i modi in cui si stabilisce il rapporto fra questo e le forme dell’architettura”. La ragione delle forme architettoniche è quindi la sedimentazione contemporanea di un sapere esperenziale che si è consolidato storicamente. Significa che la ragione dell’architettura non è congelata, non è immutabile, ma è in evoluzione, in continuo approfondimento e manifesta l’autocoscienza degli uomini. Ed è questo il nocciolo del saggio di Monestiroli che lega profondamente l’architettura alla vita reale. La storia dell’architettura, in questo senso in sintonia con le tesi del materialismo storico di matrice marxiana, rappresenta il materiale sul quale si concentra il lavoro del progettista perché in essa sono visibili le dinamiche evolutive umane. È evidente che se Il progetto è atto conoscitivo e la storia dell’architettura è il risultato delle ricerche specifiche sui vari temi, è improponibile che esso si fondi solo su se stesso. La riflessione di Monestiroli a questo punto rientra a piè pari 1 A. Einstein, Come io vedo il mondo, Milano, Giachini, 1966, pp. 111-119 33 nelle ricerche che, negli anni ’60 e ’70, hanno caratterizzato il dibattito disciplinare italiano, cioè la riflessione sui tipi architettonici e la loro corrispondenza alle attività umane. Più interessante ai fini dell’approfondimento del rapporto tra l’architettura e la realtà è l’epilogo nel quale lo studioso approfondisce il concetto di “utopia della realtà”, rielaborando il pensiero di Ernesto Nathan Rogers, inteso come conoscenza di una realtà sperata dagli uomini la quale diventa l’orizzonte nel quale costruiamo il nostro progetto in continuità tra passato e un possibile futuro. L’orizzonte generale del pensiero diventa un punto di arrivo rispetto ad una realtà storica dell’architettura e permette un possibile superamento della conoscenza acquisita ed un graduale avvicinamento ad una realtà dell’architettura probabilmente inarrivabile e quindi utopica. Il compito dell’architetto è conoscere le esigenze autentiche e generali della collettività (l’utopia del suo tempo) ed essere consapevole dell’attuale stato di conoscenza del tema architettonico da sviluppare, affinché esso venga superato. Il rapporto tra progetto di architettura e realtà è per Monestiroli la presa di coscienza da parte dell’uomo delle ragioni profonde del costruire. La conclusione dell’analisi del saggio di Monestiroli non può comunque astenersi da alcune critiche propositive. Il saggio, e forse molte delle riflessioni di quegli anni, si appoggia su una concezione di razionalità idealista di matrice Hegeliana, per la quale: “tutto ciò che è reale è razionale; tutto ciò che è razionale è reale”. Come nel celeberrimo aforisma Hegeliano, si intravede nel pensiero di Monestiroli una eccessiva fiducia nella ragione ed in questo modo si evidenzia la difficoltà del pensiero razionalista: in un ordine nel quale la legge è già tutta conosciuta e non vi è più posto per la libertà e la creatività della coscienza. In questo senso la riflessione di Monestiroli appare in parte irrigidita da un concetto di realtà che non tiene conto di alcune riflessioni critiche del pensiero contemporaneo. Senza addentrarci nei meandri dell’epistemologia contemporanea è sufficiente ricordare la critica di Karl Popper al criterio di significanza neopositivistico, dalla quale discende inevitabilmente il rifiuto del procedimento induttivo come metodo per giungere a conclusioni di valore universale (come lo sono le teorie scientifiche) partendo dall'analisi di un numero necessariamente finito di casi particolari. Popper osserva che il problema dell'induzione può essere riassunto nella domanda: "siamo giustificati razionalmente a passare dai ripetuti esempi di cui abbiamo avuto esperienza agli esempi di cui non abbiamo avuto esperienza?" Secondo Popper, è del tutto illusorio sperar di costruire una logica di tipo induttivo che, a partire da un numero necessariamente finito di asserzioni singolari sia capace di condurre ad asserzioni di carattere universale, come le leggi e le teorie scientifiche. La credenza che la scienza proceda induttivamente da fatti empirici a teorie è logicamente ingiustificata, poiché non esiste alcuna regola che possa garantirci che "una generalizzazione inferita da asserzioni vere, per quanto ripetute spesso, sia vera". Il rifiuto popperiano dell'induzione ha un'importante conseguenza: la scienza non può partire dai fatti per costruire le sue teorie ma, al contrario, deve inventare le teorie con l'immaginazione e poi controllarle mediante i fatti. La crescita della conoscenza, quindi, non deriva da un accumulo di osservazioni, ma si presenta come uno sviluppo che scaturisce da un problema. Ad esso si tende di dare una soluzione mediante dei tentativi teorici, i quali vanno corretti, soprattutto mediante la discussione critica, cercando di eliminare gli errori, cosa che non porta alla teoria vera bensì al sorgere di nuovi problemi. Tale modello ci costringe a riconoscere che la verità non può essere raggiunta: essa deve quindi essere vista più come un ideale regolativo che come traguardo da conseguire effettivamente. Noi ci avviciniamo sempre alla verità, proponendo teorie sempre migliori, cioè che spiegano di più e che sono meglio controllabili. Applicando queste osservazioni critiche di Popper al nostro problema è indubbio che il rapporto tra realtà e architettura non può che essere costruito a priori dal progettista sulla base di una ipotesi di realtà. Data per scontata l’impossibilità di fondare l’architettura sul reale in senso filosofico, ma da un’idea di “reale” minore che è comunque il frutto del dato sensibile deviato già all’origine dall’osservatore-architetto. In questo senso è credibile “immaginare” che l’insieme delle architetture esistenti siano un dato “reale”, il quale racchiude in se tutta una serie di riflessioni, correzioni e adeguamenti alle esigenze parziali collettive ed individuali che si sono succedute nel processo storico. Il problema è che comunque questo accumulo di pensieri e riflessioni, anche contraddittori tra loro, è oggi invisibile se non in tracce e indizi presenti nella materia e nella forma. Il dato reale è soltanto quello visibile, il resto non può che essere ipotesi e interpretazione. La stessa letteratura disciplinare fa parte di quell’invisibile complessità delle ragioni che ha determinato il dato fisico, ma anch’essa non può che essere dato fisico parte dell’interpretazione. L’insieme dei dati fisici sono il dato più oggettivo nel quale può imbattersi il progettista e dalla sua analisi non può che partire la possibile definizione di un progetto che vuole fondarsi sul reale. Il dato fisico è, come abbiamo già detto, quindi il frutto della storia e rappresenta l’idea di realtà parziale orientata dal progettista in un determinato tempo. 34 Partendo da questi presupposti che delimitano le nostre possibilità di determinare il fondamento dell’architettura, è possibile recuperare le metodologie conoscitive che hanno cercato di individuare le ragioni delle forme dell’architettura e le hanno trovate nella necessità di rispondere alle esigenze della collettività. È evidente che le ragioni dell’architettura hanno a che fare con l’idea di abitare che di volta in volta l’uomo e la collettività si sono date. Il problema è che queste esigenze, che si sono manifestate nel divenire dell’architettura, non costituiscono una progressione conoscitiva di quella che può essere considerata la ragione stessa della sua forma o configurazione. La storia dell’architettura in questo senso non rappresenta un materiale omogeneo e progressivo che permette la conoscenza delle ragioni delle forme dell’architettura, anche se in essa è possibile scorgere temi e idee di architettura che hanno rappresentato risposte ad esigenze ancora oggi condivise. Ed è qui che la storia dell’architettura diventa strumento conoscitivo. L’approfondimento del dato fisico non può fare a meno di applicare tutte le metodologie utilizzate nelle analisi dei contesti anche se queste non rappresentano un avanzamento conoscitivo assoluto ma semplicemente un’interpretazione finalizzata alla conferma dei presupposti per la realizzazione del progetto nel presente. La “realtà” minore nella progettazione architettonica potrebbe quindi trovarsi in una posizione opposta da quella idealista ipotizzata dal Monestiroli. Più che essere il punto inarrivabile della presa di coscienza degli uomini, essa più prosaicamente è il punto di inizio di un processo non solo sconosciuto, imprevedibile e indeterminabile fondato (o meglio realizzato) dal passato e proiettato verso l’ignoto (… il solito angelo di Klee interpretato da Walter Benjamin). Se è così la realtà minore sulla quale è fondata l’architettura è assimilabile al contesto, nel senso del dato fisico caricato di tutto ciò che ne ha determinato la forma attuale. L’altra “realtà”, anch’essa minore seppure determinante, sulla quale è sempre fondato il progetto di architettura è rappresentato dalle dinamiche e dalle volontà della società in generale (quindi dallo scontro e l’accordo politico delle volontà individuali). Questa realtà è il propulsore necessario alla modificazione dello stesso contesto ed è legato ad esigenze e desideri eterogenei e parziali raramente orientati da un sapere comune. Come per il contesto, la realtà delle volontà politiche della società va interpretata. In sostanza il progetto di architettura, il quale rappresenta in fondo la costruzione della realtà in cui è possibile vivere, si fonda su due uniche realtà minori preesistenti: il contesto e la volontà collettiva. L’elaborazione che porta alla definizione della forma non può che essere una interpretazione di questi due dati. Affinché l’interpretazione sia credibile e condivisa (… magari nel tempo storico) è necessaria l’analisi approfondita dei due dati a nostra disposizione e fare quello sforzo conoscitivo di cui parlava Popper, cioè ipotizzare soluzioni ad un problema e su esso imbastire una discussione critica al fine di individuare nuovi problemi. 35 PENSIERO E ARCHITETTURA NON LINEARI Mario Coppola Vi sono due difficoltà preliminari quando si voglia parlare di complessità. La prima sta nel fatto che il termine non possiede uno statuto epistemologico. Ad eccezione di Bachelard, i filosofi della scienza e gli epistemologi lo hanno trascurato. La seconda difficoltà è di ordine semantico. Se si potesse definire la complessità in maniera chiara ne verrebbe evidentemente che il termine non sarebbe più complesso. (…) il problema è ormai quello di trasformare la scoperta della complessità in metodo della complessità. Edgar Morin Il nostro tempo ci pone dinanzi a fenomeni che coinvolgono insieme e trasversalmente aspetti molteplici della realtà, fenomeni non riducibili a elementi distinti, “finiti” e per questo chiari e semplici. Eppure questi fenomeni – come la devastazione dell’ecosistema (e la conseguente desertificazione e diminuzione di biodiversità a scala globale, che ci riguarda sempre più da vicino), i disastri naturali, le guerre infinite, la povertà diffusa in larga parte del pianeta, le crisi economiche, l’atomizzazione sociale – influenzano in maniera profondissima la nostra società, toccando insieme politica e economia, individualità e comunità, in una connessione biunivoca e scambievole di causa-effetto che riguarda da vicinissimo anatomia e fisiologia del territorio antropico, dalle metropoli alle architetture, essendo insieme genesi, articolazione e produzione dei linguaggi compositivi contemporanei. Dalla presa coscienza di ciò, deriva la necessità di una svolta nella lettura del reale, che non è semplificabile in categorie ristrette e comode, che per questo non si offre a delle interazioni semplici e semplicemente gestibili, ma che in ogni campo delle attività umane richiede invece un nuovo approccio, una nuova struttura del pensare volta alla “costruzione di una metodologia, di una epistemologia e di un’ontologia pluraliste”1, capace di tenere insieme più verità e più aspetti di ciascuna verità, costituendo quindi una rete interattiva, adatta alla multidimensionalità del reale. “Ci si deve quindi preparare al nostro mondo incerto e aspettarsi l’inatteso, che è il contrario del rassegnarsi a uno scetticismo generalizzato. E’ sforzarsi a pensare bene, rendersi capaci di elaborare e usare strategie, e, infine, fare con tutta coscienza le nostre scommesse. Sforzarsi a pensare bene è praticare un pensiero che si sforzi senza sosta di contestualizzare e globalizzare le sue informazioni e le sue conoscenze, che senza sosta si applichi a lottare contro l’errore e la menzogna a se stesso”.2 Il pensiero complesso può quindi essere considerato come una sintesi capace di scavalcare finalmente l’annosa contrapposizione del vecchio “pensiero forte”, l’ideologia assolutizzante di tutti i devastanti –ismi novecenteschi, che ha prodotto le lacerazioni più profonde e dolorose della storia dell’umanità, e del recente “pensiero debole”, l’antitesi posta in Italia da Vattimo nella volontà di decostruire l’impalcatura pericolosa e pericolante delle vecchie ideologie, alla quale però è necessario dare seguito per non cadere in un relativismo “assoluto” altrettanto paralizzante, una terra bruciata da un’arbitrarietà senza scampo, che legittima la diffusione di tendenze prive di ogni etica, talvolta obiettivamente negative per una equa convivenza civile e per il benessere dell’ecosistema terrestre, come Maurizio Ferraris ha dichiarato di recente, sottolineando il paradosso che risulterebbe dalla sostituzione nelle aule dei tribunali del “la legge è uguale per tutti” con un ambiguo “non esistono fatti ma interpretazioni”, l’assunto vattimiano su cui a ben vedere pure è impossibile fondarsi concretamente per promuovere e garantire la comune, umana e sacrosanta ricerca della felicità. Tale pensiero implica l’individuazione di un punto di vista il più ampio possibile, contenitore e connettore di una pluralità di altri punti di vista, evitando di cadere nella tentazione di una semplificazione di segno opposto, una sorta di “olismo” in cui la dimensione della complessità viene inscatolata in un’”impressione”, la sensazione di percepire un tutt’uno metafisico, come talvolta avviene nel caos sublime fuksasiano. Punti di vista incapaci di spaziare includendo aspetti molteplici e differenti potrebbero rivelarsi inadatti a interagire con l’insieme delle complessità, puntando all’ottimizzazione di un singolo aspetto e producendo di conseguenza un peggioramento di molti altri aspetti che non sono subordinati a quello affrontato ma invece inestricabilmente interrelati, un po’ come in un organismo vivente, dove la quantità di interconnessioni impedisce di agire a livello locale ignorando le conseguenze a livello sistemico. La complessità deve entrare a far parte del codice genetico della struttura del pensare e anche, quindi, della sfida sul terreno dell’architettura, che è la struttura fisica dell’abitare, muovendo la ricerca verso un linguaggio contemporaneo in grado di stabilire un rapporto dialogico tra le diverse istanze, una relazione circolare e non più lineare tra volontà compositiva e diverse “dimensioni” del reale, nella volontà di metterne a sistema e di organizzarne i diversi gradi di complessità, interagendo con i feedback prodotti dalle varie istanze, determinando quindi un approccio “intelligente” e adattivo, diverso da quello dominante, che, schiavo tra l’altro di sistemi economici disumanizzanti, tende a identificarsi con singole prospettive spesso di breve periodo, 1 2 G. Bocchi e M. Ceruti, La sfida della complessità, Mondadori, Milano, 2007. E. Morin, La testa ben fatta, Raffaello Cortina Editore, 2000. 36 enfatizzando di volta in volta singole questioni come fossero chiavi interpretative indipendenti e autonome. Questo limite accomuna anche alcune tra le più costose e rinomate scuole internazionali di architettura, che negli ultimi anni hanno concentrato la propria ricerca sul tema della “continuità differenziata”, muovendo i loro allievi nella direzione di una complessità e di una continuità spaziale che da sola offra la garanzia di una libertà d’espressione interindividuale, sebbene nella volontà di massimizzare l’output finale di un tempo limitato di lavoro, tutti gli altri temi attualmente ineludibili nel dibattito accademico – si pensi alla relazione coi tessuti della città storica, che resta il nocciolo duro e il maggior patrimonio delle metropoli europee, oppure all’impellente tema energetico e ambientale – vengono quasi completamente esclusi da una ricerca che nonostante gli sforzi resta semplificativa, tutt’altro che adatta a rispondere alla varietà delle esigenze del nostro tempo. Contemporaneamente, le tendenze internazionali fanno proprie tematiche assai poco “grandangolari”, facendone motivo di distinzione, e quindi firma stilistica, brand commerciale facilmente riconoscibile, in maniera da accattivarsi le più ampie fette di mercato, vendendo e rivendendo uno stile le cui ragioni nascono spesso da un singolo aspetto della realtà, ricercando nei dintorni di questa dimensione soluzioni che, nonostante siano effettivamente valide riguardo la prospettiva data, offrono delle risposte assai carenti da molti altri punti di vista, insufficienti quindi nel quadro d’insieme, soprattutto considerata la grande scala di intervento e un considerevole arco temporale di interesse. Questo processo di commercializzazione dello stile compositivo provoca di fatto, attraverso una rapida diffusione e un’emulazione acritica, nuovi paradigmi, “rigidi” e “anelastici” quanto quelli precedenti, generando tanti “International styles” tutti ciechi di fronte alle necessità del nostro tempo perché autocostipatisi in ambiti ristretti, che spesso non tengono conto della differenza tra culture come tra zone climatiche, che non interagiscono in modo consapevole e creativo con il contesto preesistente che ogni volta è diverso e chiede soluzioni particolari, in una gamma che spazia dai tessuti urbani storici alle aree ancora non antropizzate, passando per aree industriali dismesse, periferie desolate e altre migliaia di sfumature. Tra le più consolidate e diffuse macro-tendenze, quella legata al dinamismo e alla continuità differenziata riscuote probabilmente il maggior successo commerciale: tale tendenza, se effettivamente promuove una spazialità nuova, che scavalca alcuni punti deboli del modernismo come la ripetizione seriale e la rigidezza d’impianto, talvolta lascia prevalere scelte dettate esclusivamente dalla ricerca di un’eleganza accattivante che si cura poco dei tessuti preesistenti – minando così l’assetto spaziale contestuale e la relativa fruizione e generando non-luoghi alienanti e disumani – oppure produce una domanda energetica e di risorse naturali sproporzionata e insostenibile. Un’altra macro-tendenza di successo è quella legata al tema dell’energia e della eco-compatibilità: nonostante tali problematiche vadano indubbiamente affrontate, gli interventi caratterizzati dall’approccio sostenibile spesso, seppur riescono ad abbattere i costi energetici e di materie prime, entrano in crisi dal punto di vista spaziale, nell’atto di offrire una giustificazione puramente tecnica a scelte compositive che invece sono precipuamente umane, dettate da background sociali e culturali, e che, se non governate e articolate con consapevolezza, entrano in conflitto con il contesto, quando non costituiscono, nei casi limite, un peggioramento delle qualità morfologiche ambientali. Un altro paradigma attualmente dominante è quello legato alla relazione con la città storica, che sottolinea il tema della “riconoscibilità” e del rispetto/salvaguardia del tessuto storico. Questa prospettiva privilegia i caratteri immanenti del tessuto urbano, producendo interventi molto sensibili al contesto spaziale storico che però di frequente cadono nella rinuncia dell’apporto del pensiero, dell’arte e della tecnica contemporanea, rischiando di restare intrappolati in una paralisi stilistica che riproduce stilemi non più attuali e tessuti spaziali identici ai preesistenti, non rispondendo alle necessità proprie della società contemporanea, complessa e “liquida” – per dirla con Bauman – e ignorando così le spinte provenienti da problemi di natura psicologico/percettiva, urbanistica e ambientale che affliggono comunità ed ecosistema. Le teorie di Morin sulla complessità sono indissolubilmente legate alla ricerca architettonica contemporanea, e la sua riflessione si connette in maniera brillante alle parole profetiche di Alvar Aalto: “L’architettura moderna è stata funzionale principalmente sotto il profilo tecnico, sottolineando soprattutto il lato economico dell’attività edilizia. Ciò è certamente vantaggioso per produrre ricoveri necessari agli esseri umani, ma costituisce un processo assai costoso in rapporto ad altri fattori vitali. Il funzionalismo tecnico non può esaurire i compiti architettonici… se si potesse sviluppare l’architettura passo per passo, cominciando dall’economia e dalla tecnica e continuando poi con le funzioni umane più complesse, l’atteggiamento dei funzionalisti sarebbe accettabile. Ma è impossibile. L’architettura non solo copre tutti i campi dell’attività umana, ma deve essere sviluppata contemporaneamente in tutti questi campi. Altrimenti, avremo solo risultati unilaterali e superficiali… Non che la razionalizzazione fosse di per sé sbagliata, in quel primo e ormai superato periodo del movimento moderno: l’errore fu di non spingerla in profondità.” Vale a dire che l’intuizione aaltiana, un richiamo alla svolta verso una razionalizzazione spinta “in profondità”, al di là di una linearità cartesiana rigida e sterile e degli aspetti di cui si era consapevoli all’inizio del secolo scorso, invoca un salto verso la consapevolezza della complessità dei bisogni umani: “Invece di combattere la mentalità razionalista, la nuova tendenza mira a proiettare i metodi razionali dal piano tecnico a quello umano… L’attuale fase dell’architettura è senza dubbio nuova e ha il preciso scopo di 37 risolvere problemi di ordine psicologico… Il funzionalismo è giusto a condizione che sia esteso al campo psicosomatico. Questo è il solo modo di umanizzare l’architettura.” Umanizzare l’architettura continua a essere uno dei principali obiettivi della ricerca contemporanea, nella volontà di superare la desolazione di pianificazioni e progettazioni “disumane”, che all’interno delle loro equazioni non hanno mai conteggiato i fattori che entrano in gioco nel momento in cui l’essere umano interagisce con lo spazio, da quello scultoreo a quello urbano, e che hanno quindi a che fare con l’identità e con la dignità individuale. Negli ultimi decenni è diventato inevitabile guardare al territorio antropico nella sua interezza di organismo vivente, nella sua imprescindibile relazione con l’ecosistema di cui esso stesso fa parte, abbandonando molti principi (tra cui zoning e compartimentazione territoriale, urbana e architettonica; impermeabilità alle risorse naturali; eterotrofia e conseguente inquinamento) nella volontà di mettere a fuoco la questione energetico/ambientale – ormai indispensabile in un quadro sempre più catastrofico, dove la biodiversità diminuisce in maniera direttamente proporzionale alla crescita di aree desertificate – al pari di quella relativa alla cura e alla salvaguardia della città storica e quindi dell’innesto di tessuti nuovi accanto a quelli preesistenti, per la riqualificazione di aree desolate, affinché tessuti antichi e nuovi siano parte dello stesso organismo urbano e territoriale senza ferite e cicatrici, senza la genesi di zone a cavallo tra vecchio e nuovo, embolie che segregano il patrimonio culturale da un lato, de-valorizzandolo, privandolo di vitalità e novità, e creano periferie tristi e desolate perché scisse dalle radici culturali e identitarie dall’altro. Non si tratta, evidentemente, di “sragionare”, muovendo verso un dominio onirico di dubbia interpretazione, generato da una creatività sguinzagliata e svincolata da ogni giusta restrizione, ma di scommettere in un nuovo “razionalismo”, sorretto e articolato da un’umanità consapevole della sua identità e quindi della sua imprescindibile relazione col resto della biosfera. “La scommessa è l’integrazione dell’incertezza nella fede o nella speranza. (…) A un pensiero che isola e separa si dovrebbe sostituire un pensiero che distingue e unisce. A un pensiero disgiuntivo e riduttivo occorrerebbe sostituire un pensiero del complesso nel senso originario del termine “complexus”: ciò che è tessuto insieme. (…) Un pensiero che collega e che affronta l’incertezza. Il pensiero che interconnette rimpiazzerà la causalità unilaterale e unidirezionale con una causalità circolare e multi referenziale, mitigherà la rigidità della logica classica con una dialogica capace di concepire nozioni allo stesso tempo complementari e antagoniste, completerà la conoscenza dell’integrazione delle parti in un tutto con il riconoscimento dell’integrazione del tutto all’interno delle parti”3. Così come Morin si riferisce al metodo della complessità, Aalto probabilmente si riferiva a un metodo di progettazione capace di mettere a fuoco un gran numero di variabili, necessarie affinché l’umanità nella sua accezione più attuale e comprensiva, e quindi la sua identità complessa e irriducibile, sia ragione del progetto, tenendo conto contemporaneamente di tutti quei fenomeni che un involucro spaziale, sia esso di scala architettonica o di scala territoriale, mette in moto nelle persone che ne sono influenzate – a partire dagli angoli che descrivono il perimetro di una stanza fino a quelli che definiscono una piazza – così come in ogni altro elemento della rete di interazioni di cui è parte. Aalto prosegue: “Al punto in cui siamo, dobbiamo unire la ricerca di laboratorio al gioco, e viceversa. Troveremo un orientamento adeguato solo quando le forme logiche saranno colorate da una seria presenza artistica e ludica…”. La dimensione ludica evocata da Aalto è proprio la capacità di cui parla il filosofo francese di “trascendere” la linearità logica aristotelica, nel gioco circolare e dialogico tra questa e la capacità creativa umana che è al di sopra della logica e che sta alla base di ogni rivoluzione scientifica (come descritto da Kuhn nel celebre “The Structure of Scientific Revolutions”) muovendo quindi la ricerca verso un’architettura più consapevole, che, come suggerisce il padiglione finlandese del maestro – dove una parete lignea ondulata e inclinata fa vibrare lo spazio, dinamizzandolo e scuotendolo, ponendo valori psicologici e spirituali in cima alle ragioni generatrici del progetto – abbia nel proprio codice genetico tutte le ragioni di cui possiamo avvalerci per promuovere la libertà d’espressione interindividuale, partendo dalle radici storiche delle nostre città e sfruttando il sole, il vento e il suolo per la rimozione del maggior numero possibile di barriere alla libertà d’interazione creativa tra le persone e tra queste e l’ambiente circostante, antropico e naturale che sia, in una profonda e consapevole simbiosi con il resto dell’ecosistema. 3 Ibidem. 39 LA STRADA TRA PIANO E PROGETTO Roberto Secchi Le città hanno un’anima - come suggeriva Marcel Poète1? Le città sono dotate di individualità irriducibili? Derivano la propria unicità dal territorio cui appartengono e di cui sono espressione - come asseriva Hugo Häring2? Osservando la storia delle città e i processi della loro evoluzione morfologica si può cogliere il modo singolare in cui ciascuna ha portato ad espressione nelle proprie forme i caratteri delle civiltà che le hanno fondate ed abitate. Pur nella analogia delle condizioni economiche e sociali, della diffusione dei paradigmi filosofici e scientifici che possono attribuirsi alle diverse fasi storiche, le città rifiutano i tentativi d’imposizione di modelli di sviluppo e di organizzazione nello spazio degli insediamenti umani in contrasto con la loro individualità. Riemergendo con la forza della propria struttura configurativa, deformano i modelli e li declinano secondo i propri caratteri singolari ed unici. Dove affondano le radici di tale resistenza? Probabilmente le ragioni imposte dalla geomorfologia risultano determinanti nella fase di fondazione e lasciano un’eredità conformatrice potente, marcano con il proprio imprinting le azioni successive. Se la definizione dell’impianto urbano di fondazione si deve a diversi fattori, il tracciamento delle strade ha comunque un ruolo decisivo. Tra tutti i fatti e gli artefatti che costituiscono le città, le strade sono gli elementi dotati di maggiore per-manenza. I tracciati sono incisioni sulla crosta terrestre di uno straordinario potere fondativo. Nel suo saggio Il libro dell’orologio a polvere Ernst Jünger ha messo bene in evidenza la rilevanza della ruota nella determinazione dei caratteri della nostra civiltà. Innanzitutto egli ha sottolineato il legame della strada con lo sviluppo della tecnica: “Non possiamo pensare la ruota come un fatto isolato; dobbiamo pensarla insieme con la strada. Fino ad allora c’erano sentieri, percorsi anche dalla selvaggina, piste e mulattiere. Da questo momento c’è la strada. Pfad, sentiero, rimanda a piede, il latino pes: 1 M. Poète, La promenade à Paris au XVII siècle. L’art de sepromener. Les lieux de promenade à Paris et aux environs, Librairie Armand Colin, Paris 1913; Introduction à l’urbanisme. L’évolution des villes. La leçon de l’Antiquité, riedizione a cura di Hubert Tonka, Paris, 1967. 2 H. Häring, Zwei Stadte: eine physionomische Studie zugleich ein Beitrag zur Problematik des Stadtebaus, in “Die Form”, Heft 8, 1926; in “Daidalos Berlin Architectural Journal”, n. 4, 1982. in Bassa Sassonia si usa ancora la parola pedden per «camminare». Weg, via, riporta invece a radici che indicano il moto di trasferimento, radici che si celano anche nella parola latina veho, trasporto, o in quella tedesca Wagen, vettura. Strasse indica infine la strada lastricata, che offre la resistenza alla ruota munita nel frattempo di chiodi o di cerchioni metallici; unisce fra loro i luoghi principali”3. Considerazioni analoghe possono essere sviluppate in altre sfere linguistiche. La ruota non può essere pensata senza la strada, ma neanche la strada senza la ruota. La strada istituisce il luogo, l’arrivo e la partenza, il percorso e la sosta, l’insediamento e la colonizzazione della terra. La strada distingue, disgiunge ed unisce, crea le condizioni della convivenza e dell’incontro. La strada ha una straordinaria permanenza nel tempo perché costa molto, perché su di essa si impiantano gli insediamenti, perché imponendo modalità collettive di uso e di percezione del territorio finisce per definirne la figura. Le radici storiche della configurazione delle città si riconoscono innanzitutto identificandone i tracciati. L’archeologia ci ammaestra su tale questione. “Si può immaginare la diffusione delle strade - scrive ancora Jünger - come una trama inizialmente molto rada di fili sottili, che lentamente si infittisce sino a formare una rete che imprigiona la terra … Visto nell’insieme e nel volgere del tempo, il processo non è arrestabile; le smagliature vengono ritessute, i ponti distrutti ricostruiti”4. Viene alla mente Il ponte sulla Drina, il romanzo di Ivo Andriċ, nel quale il ponte che mette in comunicazione i territori della Serbia e della Bosnia si fa testimone delle innumerevoli tragedie della guerra e simbolo della speranza di pacificazione5. “Qui vediamo all’opera il potere unificante, continua Jünger - il significato stesso della ruota: è lecito supporre che con essa si sia trasformato il diritto delle genti; che, forse, sia addirittura nato allora. Il fatto che le strade siano sopravvissute a guerre, popoli e culture è un segno positivo, un simbolo della ragione che si incarna nella storia e che deve essere trasmessa alle generazioni future”6. La strada viene associata ad una visione progressiva George Grosz, Straße, 1915 3 E. Jünger, Il libro dell’orologio a polvere, Adelphi, Milano, 1994, pp. 90-91. Tit.orig. Das Sanduhrbuch, Klett-Kotta Verlag, Suttgart, 1954-57. 4 Ibidem. 5 I. Andrić, Il ponte sulla Drina, Arnoldo Mondadori, Milano, 1960. 6 Ibidem. Karl Volker, Zement, 1924 40 della storia, la tecnica vi è ancora presentata come un motore di quella visione. Diverso è lo sguardo di Luigi Pirandello. In uno dei suoi racconti - non a caso intitolato Romolo egli racconta la fondazione di una città con la consueta disincantata lucidità: “… Carri, uomini a cavallo, qualcuno raro a piedi, passavano e tutti sentivano di quella solitudine uno sgomento che a mano a mano diveniva oppressione intollerabile. Che era per essi quello stradone? Lunghezza di cammino; via da fare. Chi poteva pensare di fermarcisi? Un uomo. Questo vecchio qua. Allora sui trent’anni, andando un giorno d’estate appresso ai pensieri che lo traevano fuori dal consorzio degli altri uomini a cercare nella solitudine la sua ventura, ebbe il coraggio di fermare in mezzo a questo stradone l’ombra del suo corpo. Sentì forse che in quel punto tanti come lui, passando, avevano, avrebbero sentito il bisogno d’un poco di riposo, d’un poco di conforto e d’aiuto. E disse ‘qua’”7. La città nasce dall’atto di rifuggire la solitudine della strada; presto alla prima casa si aggiunge la seconda e così via; presto lo spazio si fa teatro di azioni contrapposte di possesso ed uso dello spazio. Ma, “… quando disse ‘qua’, non aveva certo in mente questa borgata d’oggi, la città di domani. In questa prevale il conflitto, ‘la guerra allineata’ prodotta dalla civiltà dei piani regolatori, che obbligano le case a stare in riga”8. “Le strade appartengono alle nostre più antiche realizzazioni … - scrive ancora Jünger. Accade per le strade ciò che si verifica per i luoghi di culto: seguono sempre la traccia più antica. Quando le percorriamo ci imbattiamo anche nei primi rapporti di proprietà, quando la terra era ancora un bene comune come lo sono oggi i deserti e il mare. Sono fenditure nella dimensione dell’incommensurabile, che esse hanno distrutto ma la cui libera percorribilità è rimasta loro impressa: orme immortalate dei più antichi predecessori”9. Con la strada si manifesta il dominio dell’uomo sulla Terra, con la rete delle strade la Terra viene misurata e ripartita, con la strada si pone la possibilità della conoscenza e dell’asservimento della Terra, nella strada si instaura la possibilità di libertà degli uomini, ma anche l’instaurazione del limite, che “imprigiona” la Terra nella rete. Ne La Isola di cemento James Graham Ballard ha più recentemente metaforizzato la condizione esistenziale della società contemporanea: a causa di un incidente stradale un automobilista finisce nello spazio residuale lasciato dalle 7 L. Pirandello, Romolo, in Novelle per un anno, Arnoldo Mondadori, Milano, 1951, pp. 34-40. 8 Ibidem. 9 E. Jünger, op. cit. rampe di uno svincolo autostradale e vi rimane prigioniero10. Le strade sono ferite aperte nella continuità dell’aperto, segnano un limite ed un luogo di scambio tra porzioni dello spazio. Moltiplicandosi ed interconnettendosi definiscono strutture organizzative degli spazi insediativi, siano essi urbani o agricoli. Generano nuove e sempre più rapide possibilità di incontro, ma, se troppo veloci e poco permeabili, possono produrre anche segregazione e persino desertificazione dei territori attraversati. In ogni caso, usiamo figure paradigmatiche per sintetizzare i caratteri ed il funzionamento degli insediamenti umani - definiamo l’impianto urbano lineare, monocentrico, pluricentrico, radiocentrico, a cluster, a rete, ecc. Parlando di forma urbis non ci limitiamo certo alla sola figura dei tracciati, consideriamo gli elementi morfologici primari legati alla struttura del supporto geomorfologico e ambientale, consideriamo gli elementi emergenti e quelli di più lunga durata, consideriamo alcune grandezze decisive per descriverne la forma, come la densità, l’estensione, le modalità di crescita. Ma l’ideogramma in cui si può riassumere l’organizzazione fisica e la vita urbana è di solito ricondotta allo schema dei tracciati stradali. Nella strada si manifestano due essenze: la costruzione dell’artefatto e la strategia di colonizzazione della terra. La strategia è la disposizione nel tempo e nello spazio delle truppe nel conflitto militare. In senso figurato la strategia è la disposizione nel tempo e nello spazio dei mezzi di colonizzazione della terra. Attraverso la strada si determinano le direzioni e i tempi secondo cui attraversare i territori, congiungere luoghi, gerarchizzare, avvicinare. La strada è un artefatto - l’etimologia del termine discende dal latino strata, che indica la stratificazione dei materiali di cui è costituito e l’azione necessaria alla sua costruzione. Nella trattatistica classica la strada è tema architettonico. Ancora nel Trattato del Milizia venti pagine sono dedicate alla strada dei Romani ed alle tecniche della sua costruzione e ne confermano l’appartenenza alla teoria e alla pratica dell’Architettura. Fino a tutto il Settecento architettura e ingegneria civile sono una cosa sola. Il progetto della strada di città come quella di campagna, così come i ponti e gli acquedotti è ancora ascritto alle prestazioni del mestiere ed alla cultura dell’architetto. “L’invenzione facilita il lavoro, e quello che difficilmente si consegue colla mera forza, si ottiene facilmente, e in copia con le invenzioni ingegnose. Così soddisfansi costantemente i domestici bisogni, e si somministra il superfluo agli esteri. Allora l’Architettura apre, e Bruce Bomberger, Freeways Schema di una strada di grande traffico multipiano Vista prospettica del Plan Cerdà di Barcellona 10 J. Ballard, L’isola di cemento, Feltrinelli, Milano, 2007. Sistemazione di Porte Maillot a Parigi, 1930 41 prepara la strada al commercio; fabbrica navi con porti, e con moli, per ricoverarle con sicurezza; forma strade, e argini ne’ marassi, e nei siti più disastrosi, spiana, trafora montagne, colma valloni, getta ponti su i profondi e rapidi fiumi, taglia canali, devia torrenti, costruisce ritegni, dissecca paludi e laghi: sormonta in somma ogni ostacolo opposto dalla natura al progresso del traffico, facilitando con questi mezzi il trasporto delle merci, e il passaggio de’ viandanti da un paese all’altro”11. Come artefatto la forma della strada è strettamente legata alle sue tecniche di costruzione e alla necessità di garantire prestazioni idonee alle tecniche del trasporto ed alle tecnologie dei veicoli. Per questo motivo essa è intimamente relazionata agli sviluppi del pensiero scientifico ed alle sue applicazioni nella tecnica. Il passaggio dal traino al motore e alle diverse modalità di alimentazione di quest’ultimo ha determinato - e determinerà ancora vere e proprie rivoluzioni. In quanto artefatto la strada si presenta con caratteristiche morfologiche assai diverse se è extra-urbana o di città, poiché diversi sono i mezzi di trasporto che la percorrono e diverse le prestazioni che sono loro possibili, poiché diverso è il complesso di relazioni in cui essa si trova coinvolta nell’ambiente urbano o extraurbano attraversato. La strada è fattore strategico poiché stabilisce il collegamento tra insediamenti o tra insediamenti e aperto, stabilisce le gerarchie tra i luoghi, indica la direzione dello sviluppo insediativo, indica le modalità d’uso del suolo che attraversa. L’atlante storico delle città ci mostra tutta la gamma degli impianti urbani come specifiche modalità di relazione dimensionali e formali tra strade e perimetri edificati. La letteratura della cultura urbanistica dedica all’impianto dei tracciati stradali un ruolo sempre più determinante nella definizione delle strategie del piano a partire dal primo dopoguerra e straordinario nella metropoli contemporanea. I modelli di pianificazione urbana al volgere del Novecento sono caratterizzati dallo studio delle reti della mobilità, come fattore decisivo dello sviluppo urbano e della qualità della vita della città, sia nell’ipotesi che si afferma a favore delle grandi concentrazioni, sia in quella antiurbana delle Garden Cities, delle Città satelliti o delle Città lineari. Tra le due essenze - artefatto e fattore strategico del piano - oscilla la vita ed il destino della strada: essa è da un lato oggetto dell’azione del progetto mirato alla costruzione nello spazio di un tracciato percorribile, dall’altro il frutto di una decisione della 11 F. Milizia, Principj di Architettura Civile, Seconda edizione veneta, Riveduta, emendata ed accresciuta di figure disegnate ed incise da Gio.Battista Cipriani Sanese, Bassano, 1804. pianificazione dell’uso dello spazio nel tempo. Questa stessa duplicità è stata alla base della disgiunzione delle discipline scientifiche, delle competenze professionali, dei poteri autoritativi, delle istituzioni amministrative che se ne sono occupate. La crisi anticipata nel XIX secolo è maturata nella seconda metà del XX secolo e si è approfondita nella contemporaneità. Disgiunzione del rapporto piano/architettura, strada/edificio La nascita della strada ferrata ha determinato una competizione con la strada carrabile che sussiste tutt’oggi12. Questa competizione è competizione tra due diverse tecnologie di trasporto. Gomma e ferro si contendono il trasporto di passeggeri e merci sulle lunghe percorrenze. Le due tecnologie danno luogo a prestazioni diverse: più flessibile l’una, più certa l’altra. L’una non può che essere dedicata al trasporto pubblico, l’altra accoglie e promuove il trasporto privato. Le ferrovie presentano vincoli inderogabili di tracciato per quanto riguarda curve e pendenze e si adattano a fatica alle morfologie dei territori, necessitano di ponti e gallerie, le strade presentano una maggiore adattabilità. Non mancano esempi di strade che seguono con attenti accorgimenti le modellazioni dei territori più accidentati. Tuttavia la nascita delle autostrade veloci ha avvicinato le due categorie di reti; le alte velocità dei vettori impongono ad ambedue vincoli di tracciato simili. Le reti ferroviarie e le reti autostradali tagliano brutalmente i territori e riconfigurano i paesaggi, siano essi naturalistici, rurali o urbani, sovrapponendosi alla sedimentazione dei segni di antropizzazione con una propria logica per lo più estranea alle morfologie prodotte dalle stratificazioni storiche. Ne risulta un conflitto tra un universo di figure che disegnano le grandi maglie della mobilità sui territori secondo le geometrie della retta e del mistilineo, con curvature assai larghe, e l’universo delle figure che costituisce le micro maglie, più attente alle modellazioni geo-morfologiche, alla giacitura ed alla forma dei volumi edilizi. La strada extraurbana obbedisce ad un insieme di ingiunzioni poste dalle tecnologie e dalle norme mirate in primis all’ottenimento della sicurezza - che tende ad isolarla dagli altri fattori costitutivi del paesaggio e dell’ambiente. La sua progettazione è demandata a processi di produzione specialistica 12 Sulla storia della strada ferrata in Italia nelle sue relazioni con il territorio cfr.: P. B. Gardin, Ferrovie italiane – Immagine del treno in 150 anni di storia, Editori Riuniti, Modena, 1988; R. Dell’Osso, Architettura e mobilità, CLUP, Milano, 2001; O. Fantozzi Micalio, Le strade ferrate: trasformazioni urbane e territoriali; permanenze, uso e prospettive, Alinea, Firenze, 2000. Sezione e pianta tipo di una strada attuale 42 dalla concezione alla realizzazione. La sua gestione è affidata a enti e strutture ad hoc. Le procedure di valutazione ed approvazione solo recentemente vedono integrate competenze diverse finalizzate alla verifica dell’inserimento paesaggistico e dell’integrazione territoriale e si collocano quasi sempre a valle dei processi di progettazione. L’autostrada a pagamento è chiusa in un recinto. I suoi accessi sono possibili solo ai caselli, anche le aree di sosta e di rifornimento, sono intese come esclusivi servizi della mobilità, ovvero degli utenti in transito, non presentano che le funzioni più strettamente legate alla cura dei veicoli e dei passeggeri e sono chiuse a loro volta. Per questi motivi la strada extraurbana è per lo più concepita come un tubo di sezione costante - piattaforme variabili a secondo della classe di appartenenza in ragione della capacità, della velocità massima ammessa nei limiti della sicurezza, della distanza della percorrenza, che si muove possibilmente in orizzontale e disegna curve larghissime. Innesti, intersezioni e svincoli sono studiati al fine primario di garantire la massima fluidità nella sicurezza. Si moltiplicano pertanto le grandi opere che ne accompagnano e caratterizzano i tracciati, incidendo spesso le terre, inducendo importanti rimodellazioni dei terreni con opere di scavo e riporto, imponendo talvolta gigantesche opere di sostegno, scavalcando avvallamenti con importanti viadotti o forando con gallerie i rilievi che si interpongono al più breve sviluppo dei tracciati. Quando la strada extraurbana entra in città come autostrada urbana o con la denominazione di strada veloce, tangenziale, variante, raccordo, ecc., essa confronta le sue caratteristiche morfologiche con le forme degli insediamenti e con le esigenze dell’habitat urbano. Il conflitto si fa durissimo. Non è più solo un conflitto tra due universi di figure, è soprattutto un conflitto tra rapporti dimensionali, tra scale di pertinenza, tra spazi pubblici. Le reti della mobilità veloce si sottraggono alla continuità degli spazi pubblici dei tessuti urbani e rendono spesso difficoltosa la loro accessibilità. Principali linee di ricerca della Modernità sul rapporto piano/architettura, strada/edificio Nella città compatta dell’Ottocento prima e nel modello haussmaniano dei percements poi, può ancora scorgersi l’ultima testimonianza dell’integrità dello spazio urbano, come risultato del piano urbano e del progetto edilizio, come insieme inscindibile di pieni e vuoti, di case e strade, innervato dalla rete fortemente gerarchizzata ma continua dei grandi viali, delle strade secondarie, delle strade di distribuzione agli équipements, delle strade di distri- buzione ai servizi e alle abitazioni sino ai corridoi degli appartamenti13. Nella città dell’Ottocento, l’eredità del modello barocco è ancora viva: gli spazi pubblici formano la vera armatura della forma urbana costituendosi in sequenza sulle strade e sulle piazze di maggiore rilevanza. La pratica della lottizzazione e della zonizzazione disegna il piano insediativo ritagliando il territorio in isolati a destinazione unica o mista, da edificare sfruttando al massimo le superfici a partire dal perimetro, a cortina, con altezza e profondità dei corpi di fabbrica rinviati alle norme dei regolamenti edilizi. Il risultato di questo convergere di pratiche tecniche dell’urbanistica e dell’edilizia produce una formidabile omogeneità della struttura e dell’immagine urbana. Le città capitali dell’Occidente presentano tutte strade assurte a mito e simbolo della loro cultura e della loro identità. Alcuni boulevards parigini, alcune Strassen berlinesi, alcune roads londinesi sono state elette a centri della vita urbana, teatro della nascita di veri e propri tipi antropologici del secolo della Belle Epoque. Sono state il soggetto preferito della letteratura14 e della pittura prima dell’Impressionismo, poi dell’Espressionismo15. Il più delle volte queste strade occupano le aree centrali, hanno ricevuto nell’Ottocento la loro configurazione e la loro immagine base e conservano ancor oggi il loro ruolo. Già nella prima metà del secolo scorso sono state oggetto di misure di salvaguardia e di conservazione della consistenza ottocentesca. Le modificazioni subite nel Novecento e nella contemporaneità non ne hanno intaccato per lo più struttura ed aura. Se è vero che il modello della città dell’Ottocento costituisce l’ultima configurazione strettamente integrata delle strade e degli insediamenti, è altret- Berlino. Nodo stradale su più livelli nel Centrocittà Piano del quartiere Siemensstadt a Berlino 1930 13 Sull’urbanistica dell’Ottocento, teorie e piani, cfr.: G. Piccinato, La costruzione dell’urbanistica: Germania 1871-1914, Officina, Roma 1974; C. Aymonino, Le capitali del XX secolo: Parigi e Vienna, Officina, Roma, 1975. 14 E’ vastissima la letteratura tra Ottocento e primo Novecento che assume la strada a soggetto privilegiato della narrazione: si ricordano qui a titolo esemplificativo il racconto di N. V. Gogol, Nievskij prospekt, in Opere Complete, Mondadori, Milano, 2006, nel quale la Prospettiva Nievskij viene descritta dall’alba alla notte inoltrata come una straordinaria galleria dei ceti sociali e dei tipi umani e la figura del boulevardien nel formidabile romanzo di S. Kracauer, Jasques Offenbach e la Parigi del suo tempo, Marietti, Milano, 1984. 15 La pittura dell’Impressionismo ha celebrato i boulevards parigini come ambiente urbano per eccellenza. La pittura dell’Espressionismo, e George Grosz in particolare, hanno fatto della strada un oggetto imprescindibile della critica sociale e dell’introiezione dell’orrore. Hans Reichow, schema di distribuzione dalla rete principale alla rete locale di un quartiere di abitazioni; schema della rete secondo i dettami dell’“Urbanistica organica”. Autogerechte Stadt 1959 43 tanto vero che in essa si producono i prodromi della settorializzazione caratteristica della metropoli contemporanea. Proprio l’allontanamento dal cuore della città degli équipements urbains, come i mattatoi, le fiere e i mercati, gli ospedali, le caserme e le prigioni, determina i primi insediamenti dotati di reti proprie della mobilità totalmente disgiunte dalle reti del continuum urbano. Alla fine dell’Ottocento le mirabili sezioni di Eugène Hénard testimoniano il grande sforzo dell’ingegneria del tempo di stabilire il collegamento tra insediamenti o tra insediamenti e aperto, di realizzare la massima integrazione del progetto architettonico all’altezza delle esigenze di modernizzazione della città16. Le strade corrono ora su più livelli, compare una stratificazione dei sottoservizi, delle reti del trasporto pubblico e del trasporto privato ispirata a principi di economia e di razionalità e non disgiunta dall’organizzazione degli edifici. La sezione della strada è la risultante della complessità di relazioni spaziali necessarie all’organizzazione moderna delle tecniche della alimentazione e della circolazione urbana, ma non interferisce negativamente sulla qualità dello spazio privato dell’abitazione, né sulla qualità dello spazio pubblico della passeggiata sul trottoir. In splendide immagini di una Parigi del futuro, crocevia, svincoli e ponti, stazioni ferroviarie e moli di attracco dei battelli sulla Senna si integrano nel paesaggio della Capitale Mondiale con nuovi edifici di dimensioni gigantesche, moderni e accattivanti nelle proprie immagini evocatrici di continenti e civiltà lontane. La celebre lottizzazione del Plan Cerda di Barcelona, i progetti di Soria y Mata per la Ciudad Lineal a Madrid, gli schemi ideogrammatici delle Garden Cities di Howard rifondano i rapporti tra progetto delle infrastrutture urbane e modelli insediativi, affermano la rilevanza del trasporto pubblico nella pianificazione urbana e annunciano il tema della salvaguardia dell’ambiente. Le elaborazioni delle avanguardie architettoniche all’inizio del Novecento tentano di rifondare i rapporti tra piano, progettazione delle infrastrutture e progettazione degli edifici, ma l’unità della città ottocentesca è ormai infranta. Le ricerche condotte in questo campo si permeano da questo momento di visioni radicalmente opposte alla città reale e si condannano al destino dell’utopia, lasciando a testimonianza della loro grandezza soltanto delle schegge. Queste non possono che alludere, alludere soltanto, alle visioni totalizzanti e alle speranze che le hanno generate, ma raramente incidono sulla reale modificazione dell’organizzazione urbana. Per citare alcune delle linee principali di questa ricerca e i punti di svolta più significativi si fa qui un rapido excursus su alcune tra quelle che hanno costituito e continuano a costituire ancor oggi il seme di nuove proposte e sperimentazioni. Mort de la rue è il titolo del sesta parte de La Ville Radieuse17. Le Corbusier ridisegna la città ridefinendo la struttura della circolazione: separa la mobilità meccanica che immagina su una quota distinta dalla quota dei percorsi pedonali, che si snodano a terra nella continuità del parco urbano. Nello schema della città di un milione e mezzo di abitanti, “... la rete di autostrade assicura il servizio (completo, efficace, necessario e sufficiente) … ogni maglia della città della residenza ha quattrocento metri di lato”. La struttura a scacchiera, eredità della città dell’Ottocento, è cancellata. Considerando Parigi, New York e Buenos Aires la densità varia tra 300 e 650 abitanti ettaro. Il nuovo modello realizza una densità territoriale assai più bassa a fronte di una densità fondiaria altissima, concentrata nei redans e nei grattacieli della City. La questione dei rapporti di interdipendenza densità/circolazione, rete/tipologia edilizia è aperta e indagata a fondo. Il passaggio dalla città del cavallo alla città dell’automobile impone un cambiamento radicale, le maglie della griglia urbana si allargano, la gerarchia tra macromaglie e micromaglie si rafforza, le diverse reti della circolazione si specializzano e si disgiungono, occupando non solo le due dimensioni del piano si stratificano a diverse quote. Lo spazio urbano è radicalmente riorganizzato secondo la stratificazione delle reti della mobilità e la distribuzione delle attività: al suolo marciano i pedoni, al disopra le automobili, ascensori conducono ai diversi piani degli edifici per un’altezza di cinquanta metri e fanno parte anch’essi della rete degli spazi pubblici, così come le strade sovrapposte che innervano i redans, le spiagge sul tetto giardino delle abitazioni a 50 metri di altezza, mentre i servizi comuni giacciono ai piedi dei redans alla quota più cinque. Già negli anni Venti Le Corbusier si fa carico delle problematiche dell’ingegneria dei trasporti, studia attentamente le sezioni tipo delle strade, le intersezioni, gli incroci e gli svincoli, nodi complessi e su più quote, classifica e progetta soluzioni tecniche accurate. Comprende l’enorme rilevanza della strada nella configurazione del paesaggio urbano per le sue virtù di artefatto alla grande scala. Disegna formidabili visioni della città del futuro, ove la strada veloce, ora, in forma di Copertina di un libro Frank Lloyd Wright, Prospettiva del centro comunitario al Point Park Pittsburgh (Pennsylvania), 1947 16 E. Hénard, La costruzione della metropoli. Alle origini dell’urbanistica, Marsilio, Padova, 1982; J. L. Cohen, Etudes sur les transformations de Paris et autres écrits sur l’urbanisme, L’Equerre, Paris, 2003. 17 Le Corbusier, La Ville Radieuse, 1933, Editions Vincent Fréal & Cie, Paris, 1964, VI Partie: La Ville Radieuse, p. 119. Schemi del modello di rete: tra la macromaglia territoriale e l’insediamento residenziale c’è la “Environmental area” 44 galleria, si immerge nella stratificazione dei suoli urbani rimodellati per ospitare i servizi, ora, in forma di viadotto, sorvola i grandi spazi-parco sottostanti. Più tardi lo stesso Le Corbusier cerca l’estrema sintesi di strada ed edificio disegnando i celebri piani di Algeri, São Paulo, Rio de Janeiro e Montevideo, ma infine lascia a Chandigar la testimonianza inequivocabile della sua convinzione che solo una chiara e netta distinzione gerarchica delle reti della circolazione può garantire l’organizzazione funzionale e la vivibilità dello spazio urbano. La Berlino degli anni Venti è forse la metropoli europea teatro della pianificazione e della progettazione urbana più avanzata18. La questione dei trasporti per la GrossBerlin dà luogo ad una vasta gamma di sperimentazioni progettuali. Le reti della U-Bahn e della S-Bahn vengono sviluppate in modo tale da abbracciare l’intero territorio e le nuove Siedlungen. I nodi urbani principali vengono ridisegnati come grandi attrattori, ove si fa densa la presenza delle attività direzionali, commerciali e ludiche della città. Si inventano soluzioni per rendere compatibile lo spazio pubblico con la circolazione dei mezzi di trasporto. Si imposta il grande asse nord/sud della città con il progetto di Mach19, che sarà portato a compimento solo recentemente, con la riunificazione e la ristrutturazione della capitale. Hilbersheimer pensa ad una ristrutturazione radicale del Centrocittà, basata sulla demolizione dei tipici isolati e la loro sostituzione con un impianto fondato sulla stratificazione di attività: dalla quota della circolazione e dei parcheggi, contenuta in una grande piastra orizzontale, si innalzano i volumi destinati alle attività commerciali e direzionali e sopra di essi le abitazioni20. La GrossBerlin segue il modello del decentramento delle abitazioni con la politica della fondazione delle Siedlungen. Queste nuove unità insediative situate ai margini del Centrocittà, sono servite dalla ferrovia urbana e dotate dei servizi ritenuti allora indispensabili all’abitazione, si organizzano su impianti a bassa densità con grandi viali e strade di distribuzione ben gerarchizzate, variazioni tipologiche sapienti, forte identità in rapporto ai siti colonizzati. Nel caso berlinese non si adottano gli schemi rigidi e astratti dell’urbanistica razionalista ortodossa, come al Dammerstock. Autori come Martin Wagner, Bruno e Max Taut, Scharoun, Salvisberg, Häring, Gutkind, Forbat, 18 L. Hilberseimer, L’architettura degli anni Venti a Berlino, Franco Angeli, Milano, 1974. 19 M. Machler, Weltstadt Berlin Schriften und Materialen dargestellt und herausgegeben von Ilse Balg, Galerie Wannsee Verlag, Berlin, 1986. 20 L. Scarpa, Martin Wagner e Berlino. Casa e città nella Repubblica di Weimar, 1918-1933, Officina, Roma, 1983. Mebes ed Emmerich, Bartning adottano soluzioni attente all’interpretazione dei luoghi di insediamento. La viabilità è razionale ed efficiente, disgiunge strade carrabili e percorsi pedonali, ma configura anche gli spazi nell’aderenza alle forme degli edifici e degli spazi aperti. Al di là dell’Oceano si erano intanto affermate le parkways di Olmsted21. Nate per collegare tra di loro parchi urbani tra più città o della stessa città, nell’era della civiltà di massa e del weekend, della preoccupazione degli amministratori di creare occasioni per soddisfare le esigenze del tempo libero, le parkways sono strade panoramiche, larghe e alberate, con complanari su cui si innestano i percorsi secondari dei territori attraversati. Il loro impatto sul paesaggio è assai basso, l’attenzione posta al tracciato e all’allestimento garantisce la mimetizzazione con il contesto o istituisce il nuovo paesaggio della percezione in velocità. La letteratura critica suggerisce che il modello della parkway delle origini si debba al lavoro di Olmsted ed ai suoi studi sulla città di Parigi e più in particolare dell’Avenue Foch presa a modello22. Molti sono gli esempi delle prime parkways a partire da quelle di Buffalo, oggi strenuamente difese da comitati per la loro salvaguardia ed il loro restauro, spesso sotto tutela come beni architettonici. Ben presto tuttavia le parkways si trasformano in freeways ed infine in highways, perdendo le loro caratteristiche originarie si adeguano alle esigenze poste dalla velocità e dalle esigenze di ristrutturazione urbana. Nella New York degli anni Trenta, Moses si fa promotore della modernizzazione mediante la demolizione di interi brani di tessuto urbano e la costruzione delle principali arterie a scorrimento veloce - il caso ad esempio della West Side Highway, l’Autostrada Cross Bronx - che ridisegnano la forma della città, ma anche del Jones Beach State Park a Long Island e la Nothern State Parkway, che realizzano i grandi spazi dell’evasione di massa dalla congestione urbana. “Quando vi trovate ad operare in una metropoli troppo piena di costruzioni – affermava Moses - dovete aprirvi la strada con una scure di carne”23. Tra le visioni urbane maturate nella prima metà del ventesimo secolo forse quella rappresentata nelle La King’s Highway di Minneapolis: planimetria e veduta aerea 21 C. E. Beveridge, P. Rocheleau, Frederick Law Olmsted: Designing the American Landscape. Universe Publishing, New York, 1998. 22 AA.VV., Boulevards, rondas, parkways … des concepts de voies urbaines, in “CERTU”, Dossiers n. 84, janvier, 2000. 23 M. Berman, Nella foresta dei simboli: note sul modernismo a New York, in L’esperienza della modernità, Il Mulino, Bologna, 1985, p. 359. Ed. orig., All that is Solid melts into Air. Experience of Modernity, Simon and Schuster, New York, 1982. Yona Friedman, Progetto di una città reticolare sovrapposta alla città esistente: nuovi rapporti con il paesaggio 45 vedute di Brodoacre City ci propone la visione più profetica. Il fenomeno della città dispersa attua nella città reale l’ideale wrightiano dell’urbanizzazione estensiva e della mescolanza del rurale e dell’urbano. Il modello di sviluppo americano basato sulla motorizzazione e sulla mobilità sino al nomadismo urbano è vincente. Anche le grandi concentrazioni di attività in colossi edilizi che accolgono nel loro ventre le automobili e si pongono come giganteschi nodi della mobilità e della densità metropolitana disegnati da Wright conoscono oggi i loro eredi24. Non poche sono le ricerche e le proposte degli anni del secondo dopoguerra che tentano di rinsaldare un rapporto ormai reciso. Fino ad allora la strada urbana era pensata insieme con gli edifici e gli spazi pubblici. Traffic in town di Colin Buchanan ha sancito la disgiunzione del progetto della strada dall’architettura degli edifici25. Gli anni Sessanta sono particolarmente fecondi in questo campo di ricerche. Le nuove visioni urbane si avvalgono di macrostrutture che coincidono con l’ossatura della nuova città. Su di esse si aggregano le cellule edilizie. Si afferma un tentativo di rilettura unitaria della città e si affronta il tema della nuova dimensione ipertrofizzando le infrastrutture. Non si tratta solo della mobilità, ma più complessivamente di un nuovo sistema di servizi, spazi pubblici e nuove tecnologie. Si mettono in campo i problemi della crescita e della flessibilità, dell’organizzazione industriale della produzione edilizia e dell’equità sociale. Nascono nuove utopie, come quelle dei gruppi Metabolism ed Archigram, di Yona Friedman e di Maillot, di Kenzo Tange, di Paul Rudolph, di Louis Kahn. Architetti come Bakema e Stirling, Leslie Martin, Costantino Dardi, si mostrano estremamente sensibili al tema della infrastruttura e del suo rapporto con il paesaggio urbano26. Già le esperienze delle New Towns inglesi e scandinave, da Cumbernauld a Runcorn, a Vallingby, avevano saputo coniugare infrastruttura urbana e nuovo insediamento attraverso lo strumento della sezione complessa27. Nasce un’architettura a sezione continua, rappresentata con sezioni prospettiche lungo il fascio delle percorrenze carrabili e pedonali che innervano la nuova immagine urbana. Anche l’Asse Attrezzato di Roma disegnato come nuovo Centro direzionale della città, risente di 24 F. L. Wright, The disappearing city, W. F. Payson Ed., New York, 1932. 25 C. Buchanan, The Buchanan Report: Traffic in towns, The Parliamentary Secretary, Ministry of Transport (Lord Chesman), November 1963, vol. 253. 26 Neoavanguardie utopie anni Sessanta. 27 Un efficace inquadramento delle teorie delle New Towns nella storia del Planning è in Scott Campbell, Susan Fainstein, Readinds in Planning Theory, Blackwell Publishing 2003. questa impostazione, un denso fascio infrastrutturale su cui si innestano gli edifici della direzionalità trasferiti dal Centro storico ed i nuovi insediamenti residenziali28. Questo complesso fascio di infrastrutture, mentre libera dalla congestione da traffico il centro di Roma e indirizza lo sviluppo della città nella direzione del settore urbano più denso di attività e popolazione, è pensato tridimensionalmente, si svolge nello spazio su più quote e dà luogo a sequenze di spazi pubblici . In questo contesto, il caso di Kahn si presenta come del tutto particolare: mentre le altre elaborazioni citate si proiettano nel futuro esaltando le nuove possibilità offerte dallo sviluppo della tecnica e sulla necessità di rifondare le gerarchie tra i fattori costitutivi dello spazio urbano e si affidano alle grandi dimensioni della rete infrastrutturale, Louis Kahn volge piuttosto lo sguardo sul passato delle città – soprattutto quelle di area mediterranea - e ne ricava i principi della costruzione della città avvenire29. Il traffico urbano viene disciplinato e arrestato ai margini della City, intercettato da grandi silos che prendono la forma di moderni monumenti urbani. Rinascono nella città contemporanea le Agorà e i Fori, spazi pubblici per eccellenza della città antica. La stagione del Postmodernismo in architettura si apre a partire dal ripensamento dell’eredità del passato. La critica all’International Style, al neorazionalismo, al radicalismo delle avanguardie della modernità conducono all’insorgere di un pensiero urbano e architettonico che rilancia le forme archetipiche dei tracciati urbani e degli edifici nell’impianto e nei dettagli. Si pretende di coniugare le forme antiche con le tecniche costruttive, le tecnologie ed i programmi dell’economia e della società del consumo. Il volume di Jane Jacobs Vita e morte delle grandi città, pubblicato nel 1961, riscuote un enorme interesse ed apre una nuova stagione: quella della ricerca di strategie di contrasto della “Grande Tragedia della Monotonia” attribuita alla città prodotta dal Modernismo: “... passeggiate che collegano luoghi assolutamente anonimi, e nelle quali nessuno passeggia; strade a scorrimento veloce che sventrano la città: questo non significa ristrutturare le città: significa metterle a sacco”30. A questa denuncia seguono, nei decenni successivi gli interventi di pedonalizzazione, il trasferimento negli shopping malls degli spazi pubblici fino ad allora ospitati dagli assi commerciali urbani, i tentativi di Bakema & Van den Broek, Uffici e laboratori T.n: O. Istitutobper la ricerca scientifica Apeldoorn 1964-73 V. Delleani, M. Fiorentino, R. Morandi, V., F. e L. Passarelli, L. Quaroni, Progetto dell’Asse Attrezzato di Roma e prospettiva degli spazi pubblici stratificati sull’asse infrastrutturale, 1967 28 L’Asse Attrezzato di Roma fu presentato da Bruno Zevi in “L’architettura - Cronache e storia”, numero doppio 238-239, agosto-settembre 1975. 29 Il progetto di L. I. Kahn per Philadelphia è ben documentato nella monografia di R. Giurgola e J. Mehta, Louis Kahn Architect, Ed. Artemis. 30 J. Jacobs, Vita e morte delle grandi città (1961), Einaudi, Torino, 1969. Paul Rudolph, progetto di densificazione di un asse urbano nella Lower Manhattan Expressway, 1972 46 riprodurre atmosfere da giardino in spazi sicuri, rigorosamente separati dalla città esterna, trafficata, pericolosa ed inquinata. Si cominciano ad immaginare spazi urbani spettacolari, in grado di attirare capitali e persone e di far valere ogni città nella competizione prodotta dallo strapotere del mercato. La teatralità delle soluzioni è spesso la chiave di volta delle soluzioni adottate. La Piazza d’Italia di Charles Moore ne è un emblematico esempio31. Maurice Culot e Leon Krier a Bruxelles celebrano e rivendicano l’identità de La Ville Européenne, riproponendo prospettive urbane di sapore ottocentesco, Ricardo Bofil progetta per Parigi un gigantesco crescent con colonne e capitelli di vetro, Paolo Portoghesi ripropone il tridente della piazza del Popolo di Roma per un Piano di zona della periferia romana. I modelli, barocchi e neo classici conoscono un nuovo successo32. La critica del modernismo non si limita tuttavia alla ripresa di temi del passato, denota anche una nuova sensibilità per l’ambiente e il patrimonio. Si apre così una stagione di sperimentazioni di pianificazione e di progettazione architettonica e urbana, consapevoli dello stato di degrado ambientale ed urbano promosso dalla egemonia tecnocratica del secondo Novecento, intese a ritrovare possibili nuovi accordi con il paesaggio, l’ambiente, il patrimonio dei centri storici e della stessa buona architettura moderna. Il paesaggio tende a diventare il centro delle attenzioni dei ricercatori del settore dell’architettura, dell’urbanistica, della pianificazione, del design, tanto da diventare un terreno di ricerca conteso e un termine declinato in mille accezioni. Il progetto delle infrastrutture entra in questo campo di tensioni, come fattore decisivo, piuttosto in senso negativo. Nascono le verifiche d’impatto ambientale, che, tuttavia, ponendosi quasi sempre a valle dei processi di progettazione, non incidono in modo sostanziale sulla qualità degli interventi. Si moltiplicano tuttavia le ricerche e le realizzazioni intonate ai temi della sostenibilità ambientale e alla integrazione territo- riale e paesaggistica. Negli anni Ottanta i progetti urbani di Barcellona acquisiscono in Europa un ruolo guida nell’avanzamento delle discipline del settore. I rapporti tra piano delle infrastrutture ed architettura delle strade conoscono nuove soluzioni e configurano prospettive di importanti mutazioni del paesaggio metropolitano. Negli ultimi vent’anni la ricerca - documentata dalla pubblicistica - ha offerto numerosissime produzioni critiche e realizzazioni sperimentali33. Ripercorrendo a grandi linee la produzione della cultura architettonica nelle espressioni più avanzate della ricerca, si possono individuare diversi approcci alla definizione delle relazioni tra la strada e l’edificio, tra lo spazio della casa e quello della strada, tra lo spazio della percorrenza e della velocità e quello dello stare e della quiete. La strada urbana, almeno sino alla permanenza della città compatta per isolati con edificazione a cortina, risulta sostanzialmente inscrivibile nelle geometrie, nelle dimensioni, nei ritmi della struttura configurativa dello spazio urbano. Il contrasto tra l’universo delle figure dettate dalle regole imposte dalla tecnologia della strada e l’universo delle figure derivate dalla tradizione architettonica si fa palese e irriducibile con l’avvento della highway, la strada veloce che attraversa la città nella brutale indifferenza alle relazioni con il contesto fisico immediato. Un tema forte dell’architettura contemporanea è costituito dal superamento di questo contrasto. L’avvento delle nuove tecnologie informatiche nei processi progettuali, l’impiego delle geometrie non lineari e di programmi di modellazione informatica evoluti alimentano la ricerca di soluzioni complesse degli artefatti stradali e delle loro relazioni con l’ambiente naturale o artificiale attraversato. L’“architettura dei flussi” tenta di risolvere il conflitto in una simbiosi dei due sistemi figurativi - quello del mistilineo della strada e quello della griglia e della stereometria34. Le strategie della stratificazione orizzontale delle reti della mobilità sotto le reti d’impianto degli edifici si vanno diffondendo nei nodi urbani più densi e congestionati. L’ibridazione strada- Louis I. Kahn, City Tower Philadelphia, 1957. Disegno del centro città 31 Sul Postmodernismo, cfr.: D. Harvey, La crisi della modernità. Alle origini dei mutamenti culturali, EST, Milano, 1997. Tit. orig., The condition of Postmodernity, Basil Blackwell, 1990. 32 Per la produzione di M. Culot cfr.: M. Culot, Ici, ailleurs, autrement, Architectures Autrement, AAM, 2006. Per la produzione di L. Krier cfr.: L. Krier, Architettura. Scelta o fatalità, Laterza, 1995. Per il progetto di R. Bofill, The Spaces of Abraxas (1982), Marne-la-Vallée, Francia cfr.: R. Bofill/Taller de Arquitectura: Buildings and Projects 1960-1985, introduction by R. Bofill, postscript by W. A. James (1988). Per il progetto di Casale di Gregna di P. Portoghesi cfr.: A. M. Leone, (a cura di), Il secondo PEEP di Roma, Comune di Roma, U.S.P.R., Roma, 1986. 33 Barcellona anni Ottanta: O. Bohigas (1986), Reconstrucciò de Barcelona, Mopu Dl, Madrid. Ed. it., L. Zazzara, (a cura di), Ricostruire Barcellona, Etaslibri, Milano, 1992. 34 Sull’architettura dei flussi, cfr.: L. Manovich, The poetics of urban media surfaces, in “First Monday”, Special Issue n. 4: Urban Screens: Discovering the potential of outdoorscreens for urban society, Chicago, UIC University Library, febbraio 2006; F. Choay, Espacements. Figure di spazi urbani nel tempo, Skira, Milano 2003; M. Castells , La città delle reti, Marsilio, Venezia 2004; A. Jacobs, E. MacDonald, Y. Rofé, The boulevard book. History, Evolution, Design of Multiway Boulvards, MA, MIT Press, Cambridge, 2001. Paolo Portoghesi, studi per un “Quartiere nella periferia romana”, 1983. Planimetria 47 edificio è sperimentata sulle tracce delle prime elaborazioni dei Maestri del Movimento Moderno. La strada extraurbana è ripensata in modo tale da poter costituire un elemento qualificante del paesaggio e un’occasione per garantire il presidio delle problematiche ambientali. L’interesse per il paesaggio che investe le varie articolazioni della disciplina madre dell’Architettura suggerisce che si cerchino nuove forme di accordo, se non addirittura di alleanza tra architettura e agricoltura, due pratiche da sempre sorelle dell’attività di modificazione della Terra35. Nel settore più propriamente trasportistico si afferma il primato della plurimodalità del trasporto e la rilevanza dei nodi di scambio nella concezione e nella gestione della rete. Si fa strada in Europa la tendenza al ripristino delle linee tranviarie e all’installazione di linee del trasporto pubblico su sede riservata36. Si impongono nuove strategie fondate sulla convinzione della necessità di riequilibrare il rapporto tra mobilità privata e mobilità pubblica. Si comprende anche che la realizzazione della linea del trasporto pubblico offre opportunità per la riqualificazione urbana dei quartieri e per il rilancio degli spazi pubblici e si fa fattore strategico della pianificazione. Naturalmente quanto sommariamente delineato non costituisce che il sintomo di un movimento profondo che attraversa questo settore della ricerca. Esso si palesa ancora in episodi isolati e realtà assai circoscritte. Si è ben lontani dalla conquista di una visione integrata della progettazione nei diversi settori e di una cooperazione tra i soggetti dei processi della trasformazione della città, del territorio e del paesaggio. La realtà ordinaria ci presenta una situazione assai arretrata e talvolta addirittura catastrofica. Principali tendenze evolutive della città contemporanea Se inquadrato nella complessità delle relazioni istituite con il territorio e la città, lo studio delle infrastrutture costituisce un formidabile punto di vista per l’osservazione e la descrizione delle tendenze evolutive della città e a maggior ragione 35 T. Paquot, C. Younès, (sous la direction), Habiter, le proper de l’humain Villes, territoires, Philosophie, Editions de La Découverte, Paris 2007; La renaissance des quatre éléments, Editions de La Découverte, Paris, 2002. 36 Valga per tutti il caso del Tramway des Maréchaux di Parigi. Inaugurato nel 2006, sarà terminato nel 2012. Il suo tracciato insiste sulla traccia dell’antica cinta muraria della città. La sua realizzazione coincide con una grande opera di riqualificazione urbana. La lunghezza del percorso è di 17 km con 17 fermate dal Pont du Garigliano a Porte d’Ivry, raccoglie 25 milioni di passeggeri l’anno ed è connesso con quattro linee del Metro. della città metropolitana contemporanea. Richiamando le tesi e le argomentazioni di David Mangin sulla “Settorializzazione del sistema viario”, che si compie con il passaggio dall’isolato - come fattore costitutivo della forma degli spazi urbani nell’unità di strada e edificato nella pratica corrente di urbanizzazione, al settore come maglia della rete della mobilità, si vuole sottolineare il compiersi di una tendenza evolutiva della città contemporanea latrice di numerosi fattori di degrado dell’habitat37. Il modello, cui si ispirano quasi tutti i piani urbanistici e i progetti degli insediamenti urbani, progettati negli ultimi cinquanta anni, - come già ricordato - riceve la sua formulazione teorica da Colin Buchanan all’inizio degli anni ‘60. Lo schema, che scinde non solo le strade a secondo dei mezzi di percorrenza e delle relative velocità, ma anche delle diverse funzioni e delle diverse scale, è diventato il modello pressoché indiscusso della città contemporanea. Le strade e le reti che costituiscono la struttura urbana vengono riguardate prevalentemente nell’ottica trasportistica secondo i parametri della capacità e della velocità. Le ragioni della morfologia urbana portate negli stessi anni dagli studi del settore dell’analisi urbana condotta da geografi, urbanisti ed architetti restano inascoltate. La visione riduzionista, sospinta dalla cultura specialistica dell’ingegneria delle strade, ben sostenuta dalla autonomia istituzionalizzata delle competenze e dagli imponenti sviluppi della tecnocrazia, relegano in posizione subordinata se non addirittura ininfluente le preoccupazioni dei progettisti per valori propri della progettazione urbana della tradizione architettonica come la connettività, la gerarchia, i profili e la qualità dei nodi. Si afferma il fenomeno dello sprawl che investe in tutto il mondo le aree metropolitane travolgendo ogni resistenza dell’antagonismo città campagna. La riduzione delle densità nelle aree centrali e la dispersione urbana determinano una nebulosa insediativa, si costituisce la “città arcipelago” il cui corollario è la nascita dalla “campagna urbana”38. Già alla metà del secolo scorso un grande cantore della strada - Jack Kerouac, nel romanzo Dalla città alla metropoli - racconta il suo arrivo a New York non in nave o in aereo, ma in pullman, dalla regione del Rhode Island, come la percezione di una straniante alternanza di spazi abitati e di spazi vuoti, una serie sorprendente di situazioni urbane tanto diverse da far pensare a un’assoluta assenza di Eric Owen Moss, The City of the Future, Los Angeles 2106 37 D. Mangin, La ville franchisée. Formes et structures de la ville contemporaine, Editions de la Villette, Paris, 2004. 38 P. Donadieu, Campagnes urbaines, Actes Sud/ENSP, 1998. MONOLAB, studio per la pianificazione dei vuoti urbani di Rotterdam e i riassetto della mobilità. La Autostrada A20 che costituisce l’asse urbano che attraversa da nord a sud la città è assunta a caso studio, 1997-98 48 logica39. Il grande sviluppo della domanda di case unifamiliari e di forme di insediamento antiurbano a bassa densità e la estromissione dal centro della città di molte attività, prima quelle produttive industriali e artigianali, poi quelle direzionali ed infine quelle commerciali e ricreative, insieme con la creazione di una rete della mobilità veloce, totalmente svincolata dai sistemi insediativi, ha determinato un consistente abbassamento delle densità ed una forte dispersione urbana. Le conseguenze di questo fenomeno sono evidenti in termini di diseconomia, degrado ambientale e sociale. Nascono le strategie di interpretazione e d’intervento del fenomeno: per citarne alcune si ricordano la Stadtlandschaft (Cittàpaesaggio) con le visioni architettoniche ed urbane di Hans Scharoun negli anni della ricostruzione post bellica, che si collocano nella linea di ricerca del Funzionalismo organico e dell’Organische Stadtbaukunst40. Ma non coincidono con l’ideologia antiurbana, che aveva avuto origine con il movimento delle Garden Cities; la Zwischenstadt (Città-tra) di Thomas Sieverts degli anni Ottanta, che trasforma in un disegno di scala territoriale l’alternanza di brani di campagna e aree urbanizzate delle grandi regioni metropolitane41; gli esperimenti di Andrea Branzi che in “Agronomica” disegna negli anni Duemila una campagna urbana terziarizzata e postindustriale42. Complementare con il fenomeno dello sprawl si afferma il fenomeno della enclavizzazione. Molteplici spinte inducono alla realizzazione di insediamenti chiusi , esclusi dalla continuità degli spazi pubblici passanti tipici della città della tradizione sino a metà del XX secolo, connessi solo alle principali arterie di attraversamento dei territori e delle città. Il fenomeno dell’enclavizzazione, inizialmente tipico dei soli insediamenti industriali e dei grandi équipements urbains, riguarda oggi tanto la residenza quanto la grande distribuzione e la direzionalità e si estende al settore degli spazi per il tempo libero, la ricettività e le attività ludico-ricreative, ma anche al settore della cultura, della religione, della ricerca, dell’associazionismo e della convegnistica. Il grande rilievo 39 J. Kerouac, La città e la metropoli, Newton Compton, Roma, 2000. 40 H. Bernard Reichow, Organische Stadtbaukunst; von der Grossstadt zur Stadtlandschaft, G. Westermann, Braunschweig 1948. 41 T. Sieverts, Zwischenstadt zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land, Vieweg&Sohn, Braunschweig/Wiesbaden 1998. Ed. ingl. Cities without Cities. An interpretation of the Zwischenstadt, Routledge 2001. 42 A. Branzi, Agronomica. Tre teoremi per un’ecologia del mondo artificiale, per ‘Chiudere il cerchio’, in “Modo”, Milano, 1990 e Verso un’ecologia del mondo artificale, in “Interieur 90”, Koertrjik (Belgio), 1990. dell’associazionismo e della convegnistica nella definizione delle dinamiche sociali contemporanee è stato messo in evidenza da Peter Sloterdijk in Ecumes, ove nella dimensione quantitativa e qualitativa, si descrive il fenomeno che investe il calendario degli eventi e la programmazione d’impiego di luoghi eletti ad ospitarli e delle infrastrutture materiali e immateriali indispensabili al loro successo43. Il fenomeno dell’enclavizzazione non risparmia la residenza. Complessi sempre più esclusivi per fasce di reddito, per fasce di età, per affinità etniche, religiose o confessionali danno luogo a “riserve” residenziali che aspirano all’autosufficienza e precludono l’accesso ai non iscritti ai loro circoli esclusivi44. La natura dello spazio pubblico cambia: non è più la strada, né la piazza, ma lo spazio interno al recinto. Come tale non è più lo spazio di tutti, non è più aperto giorno e notte, né tutti i giorni, esclude funzioni, si specializza, seleziona gli utenti. Lo spazio della strada tende a divenire spazio residuale tra i perimetri degli spazi di pertinenza recintati da barriere sempre più impermeabili, controllate con tecnologie sempre più sofisticate disposte nei pochi accessi. L’accessibilità agli edifici anche d’uso collettivo si fa più difficile, si riducono gli spazi intermedi tra lo spazio privatissimo dell’auto e quello pubblico delle attrezzature a servizio della comunità. Il tema dell’insicurezza urbana prende il sopravvento. Ritornano i fenomeni di segregazione già evidenziati dalla geografia e dalla sociologia urbana negli anni Sessanta, in nuove forme non più tanto legate alla geografia delle classi, quanto alla composizione multietnica delle città e alle dinamiche “tribali” degli stili di vita indotti dalle mode. La strada che per tutto l’Ottocento e sino agli anni Settanta aveva costituito il cuore pubblico delle città, tanto da determinarne l’immagine simbolo, perde il suo fascino e si inaridisce. Il traffico la prende in ostaggio, l’inquinamento la rende invivibile. Non è più gradevole. Talvolta diviene addirittura impossibile passeggiare in città. L’accesso agli edifici d’uso collettivo non si propone più con evidenza dalla strada, raramente è celebrato da atri e scale imponenti. Anche il portale d’ingresso sulla facciata spesso è di dimensioni modeste, se non addirittura dissimulato. Si accede direttamente all’interno dell’edificio dal parcheggio di pertinenza. Marco Di Giorgio, Maurizio Moretti, Roberto Secchi, nodo di scambio di Ponte Mammolo a Roma 2003 43 P. Sloterdijk, Sphären III - Schäume, Plurale Sphärologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2004. 44 G. Reale, Modificazioni spaziali indotte dall’insicurezza urbana, Tesi di dottorato in Architettura Teorie e Progetto, Università di Roma “Sapienza”, 2007. John Dutton (autore di “New American Urbanism: Reforming the Suburban Metropolis”), New Los Angeles Greenway, 10 Freeways into a grassy and pleasant stretch of promenades, vertical farms, bike lanes, and transit hubs 49 Si assiste al passaggio dallo spazio pubblico allo spazio settorializzato Le tendenze alla specializzazione ed alla definizione non solo di zone a diversa destinazione, ma di veri e propri recinti autoreferenziali (vivibili cioè secondo codici di comportamento preordinati) produce una progressiva erosione dello spazio pubblico ed il progressivo degrado delle aree di interfaccia tra enclave, sospingendo in aree residuali le attività non conformi ai codici istituiti nelle aree enclavizzate. Non è più solo il caso degli aeroporti e dei centri commerciali, ma quello delle varie “cittadelle” dello sport, del cinema, del benessere, della musica, delle arti, delle scienze, dei musei, delle fiere, ecc. Questi complessi, a volte di dimensioni colossali, sono dotate di reti della mobilità efficienti al loro interno, ma di fragili innesti sulle macroreti della mobilità, soprattutto del trasporto pubblico. La mobilità assurge a valore primario della vita urbana: lo sviluppo economico richiede mobilità del prodotto e del lavoro, né l’affermarsi delle tecnologie informatiche e lo sviluppo delle reti virtuali diminuiscono il bisogno dello spostamento fisico45. Tuttavia la crescita della mobilità non è direttamente proporzionale alla crescita dell’accessibilità. Le due grandezze talvolta si presentano addirittura in contrasto. La prevalenza del trasporto privato sul trasporto pubblico, del trasporto su gomma sul trasporto su ferro genera, nella maggior parte delle grandi città del mondo, fenomeni di congestione e di inquinamento al limite. Si pone con forza il problema di ridensificare la città, ostacolandone il processo di dissoluzione nel territorio. Si propongono strategie antisprawl46. Emerge in tutta la sua evidenza la problematica della relazione tra flussi e densità. Con quale grandezza misurare il rapporto tra quantità del flusso e densità urbana? Le strategie del trasporto e quelle della pianificazione urbana passano per questo nodo. Ordinariamente la forma della città contemporanea non è percepibile; dimensioni, mancanza di confini, dispersione nel territorio ne hanno compromesso la visione. Per quanto ci si ponga a di- stanza si prova la sensazione di essere comunque all’interno di una nebulosa dai contorni inafferrabili. Se ci si solleva dalla crosta terrestre, le città ci appaiono come gigantesche, informi agglomerazioni. Ma di notte la diversa intensità della luce si distribuisce nello spazio in modo tale da rivelarne la struttura. Più in particolare le scie luminose lasciate dai vettori in movimento disegnano il sistema circolatorio che 45 D. De Kerckove, Architettura dell’intelligenza, Testo&Immagine, Roma, 2001. 46 L. Reale, Densità, città, residenza. Tecniche di densificazione e strategie anti-sprawl, Gangemi, Roma, 2008. nutre la vita urbana. La distribuzione dell’intensità luminosa suggerisce la distribuzione della congestione urbana. Dove c’è densità di attività, dove convergono più numerosi e densi i flussi della comunicazione e della mobilità sul territorio, lì si verificano i fenomeni della congestione. Questa semplice osservazione mette in correlazione la morfologia urbana alla fenomenologia della congestione. Si può ipotizzare che evoluzione della forma urbana e congestione costituiscano un parallelismo in grado non solo di descrivere la città, ma anche di spiegarne la dinamica trasformativa. Una serie storica dei grafi della mobilità potrebbe illustrare con sufficiente chiarezza la realtà del parallelismo ipotizzato. Prima di procedere oltre tuttavia è necessario abbozzare l’accezione di “congestione” che si intende usare. Il termine è infatti usato in diverse accezioni, sia che, più in generale, ci si riferisca alla congestione urbana, sia che, nell’ambito della letteratura della mobilità, ci si riferisca alla congestione del traffico. La congestione è infatti una grandezza relativa, scaturisce da un rapporto ed è pertanto circostanziale. Numerose sono le parametrizzazioni in uso e diverse le unità di misura impiegate nella sua descrizione e contabilità. è di particolare interesse studiare il rapporto tra congestione urbana e congestione della mobilità. In effetti la supposizione di questo rapporto come fattore della dinamica evolutiva delle città spinge a considerazioni che attengono tanto alla geografia urbana, quanto alla pianificazione urbana e territoriale. Il trasferimento della congestione, sia urbana che del traffico, dai centrocittà, dalla “città consolidata” nel caso romano, alle aree periurbane, in conseguenza del decentramento di attività e di nuove morfologie insediative, apre importanti quesiti sulla progettazione del futuro assetto e delle strategie di controllo della congestione. Si parla qui di controllo per due ragioni: da un lato, accanto alla consueta valutazione negativa della congestione della mobilità, vanno posti i valori della congestione urbana come densità, mixité, vitalità degli insediamenti umani, né va dimenticata la funzione propulsiva generata dalla logica degli attrattori urbani nelle strategie di pianificazione; dall’altro non si è affatto certi che l’eliminazione tout court della congestione urbana generi effetti positivi sulla vivibilità della città e sulle spinte della sua “naturale” evoluzione. Parlare di governo e di controllo sembra in prima ipotesi assai più prudente e virtuoso, poiché suggerisce la possibilità di considerarne tutta la complessità di agente della trasformazione territoriale e urbana da indirizzare. In ogni caso, al prodursi dei fenomeni descritti a grandi linee consegue l’enorme consumo di suolo, il costituirsi dell’area metropolitana in forma di arcipelago con una debole rete di collegamento tra Justus Dahinden, Urban structures for the future, 1971 Algeri, capitale dell’Africa del Nord, 1931-34; “Biologia urbana” la rete di una città di 500.000-600.000 abitanti. Studi per l’urbanizzazione di Fort l’Empereur NL Architects, Parkhouse Carstadt, Amsterdam 1999 50 le isole, consegue la desertificazione di molte aree della campagna o delle aree industriali dismesse, l’istituzione di riserve naturalistiche e parchi e il costituirsi di veri e propri ambiti di “campagna urbana”. A contrastare la proliferazione di terreni incolti abbandonati o interclusi tra nuove espansioni, a contrastare una diffusione urbana incontrollata e pervasiva ed il conseguente gigantesco consumo di suolo emergono - soprattutto a partire dagli anni ‘70 in tutta Europa - strategie intese a salvaguardare ambiente e paesaggi e a valorizzare le risorse ambientali e del patrimonio storico archeologico e paesistico47. Quanto riassunto in poche righe è naturalmente argomentato ampiamente dalla letteratura scientifica. Da essa altrettanto sommariamente possono desumersi anche i principali fattori scatenanti delle tendenze evolutive descritte: - il progressivo disimpegno dello Stato, il decentramento e il conseguente conflitto tra le autorità centrali e le autorità locali, la pianificazione e l’urbanistica contrattata, la globalizzazione dell’economia e della cultura; - l’aumento ed il livellamento della vita (intensificazione, velocizzazione, narcisismo di massa, ubiquità/ simultaneità, omologazione, conformismo, consumo); - la straordinaria diffusione del mezzo privato di locomozione - autovetture e moto (si è prossimi alla soglia di uno per abitante); 47 COE, European Landscape Convention, Firenze 2000. La Convenzione Europea del Paesaggio è firmata a Firenze nel 2000 da vari Stati membri. Per politica del paesaggio si intende “… la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentono l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio” (Convenzione Europea del Paesaggio, 2000, Art. 1, comma b). Per la rifondazione dello sviluppo rurale, i più recenti programmi promuovono: la multifunzionalità dell’agricoltura ovvero la salvaguardia e la promozione del ruolo polivalente dell’agricoltura in termini di offerta di beni e servizi (turistici, di accoglienza, cura e manutenzione del territorio rurale, ecc.); la multisettorialità ovvero l’ammodernamento dell’economia agricola attraverso la diversificazione delle attività, al fine di creare nuove fonti di reddito e di occupazione e contrastare lo spopolamento, l’invecchiamento degli addetti e l’abbandono del patrimonio edilizio rurale. Tra i numerosissimi documenti e saggi, cfr.: ESDP, European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, Office for Official Pubblications of the European Communities, Luxembourg, 1999; A. Clementi, (a cura di), Interpretazioni di paesaggio. Convenzione Europea e innovazioni di metodo, Meltemi, Roma, 2002. - la forte concentrazione della distribuzione, la crisi del commercio diffuso, l’affermarsi del brand e delle catene commerciali; - l’enorme sviluppo dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, lo strapotere del marketing. I cinque fattori sommariamente delineati sono interdipendenti e concorrono tutti insieme a produrre l’attuale volto della città contemporanea. Debbono essere studiati insieme considerando le relazioni reciproche tra densità, flussi e morfologie insediative e osservando le ricadute che hanno sull’ambiente, la qualità della vita, l’evoluzione della forma urbis. Quando si parla di reti urbane è bene avere ben presente questo quadro di interdipendenze per rifuggire dall’idea che una buona soluzione della rete infrastrutturale intesa unicamente come rete della mobilità possa garantire la qualità dell’abitare. Principali tendenze evolutive della città contemporanea nel caso romano Come vedremo in altri capitoli del volume, Roma non sfugge alle tendenze suddette. Qualche richiamo alla struttura urbana nel secolo scorso, prima e dopo la guerra - si ritiene che l’inizio della pratica della settorializzazione possa farsi risalire per Roma al Piano Regolatore del 1931 ed alle sue varianti successive47 -, alle fasi della ricostruzione, del boom economico e alla fase dell’abusivismo, sino all’attuale nuovo Piano Regolatore, può darne validi riscontri. In particolare il fenomeno della settorializzazione è diffuso, ma raramente concretizza il modello teorico in soluzioni compiute ed efficienti, almeno sul piano dello zoning e della funzionalità di rete. Nella stragrande maggioranza dei casi, complessi residenziali e di attività - più o meno enclavizzate sono letteralmente “appesi” alle macromaglie della mobilità urbana con esili connessioni, soprattutto quella del trasporto pubblico, terribilmente carente per quantità e organizzazione. La struttura morfologica radiocentrica della città soffre terribilmente della carenza di connessioni controradiali. Per questo finisce quasi tutto per gravare sull’unica, forte infrastruttura anulare. Se la settorializzazione della struttura insediativa rispetto alla rete della mobilità non appare mai o quasi mai compiuta ed efficiente, la settorializzazione delle discipline e delle competenze istituzionali è fortemente radicata: solo oggi Ministero delle Infrastrutture e Ministero dei Trasporti e dell’Ambiente sono riuniti in una sola struttura e comunque bisogna lamentare lo scarso coordinamento con il Ministero dei Lavori Pubblici. Le Amministrazioni impegnate nel settore soffrono terribilmente della mancanza di una visione integrata. Politiche della casa, politiche dei trasporti, Eric Owen Moss, The City of the Future, Los Angeles 2106 Zaha Hadid, Moscow International Business Center, Il progetto della trasformazione urbana Costantino Dardi, 1969 e Motel AGIP 51 politiche delle infrastrutture, si sono sviluppate senza la necessaria visione strategica coordinata negli obiettivi, nei tempi, nei metodi e negli strumenti. Assessorati e Dipartimenti scompongono il campo della pianificazione e della progettazione, senza che siano messi in atto sufficienti canali di comunicazione delle informazioni e di integrazione dei processi. La pianificazione territoriale, l’urba-nistica, l’ingegneria trasportistica, l’ingegneria per l’ambiente costituiscono altrettanti campi disciplinari le cui applicazioni integrate sul territorio si attuano prevalentemente attraverso le società d’ingegneria e di consulenza, raramente si integrano alla fonte. Roma registra poi una grande debolezza della pianificazione delle infrastrutture, che è associata sino agli anni Novanta ai grandi eventi, e torna ad esserlo anche oggi - di nuovo Campionati di calcio ed Olimpiadi - e non è il prodotto di una pianificazione strategica elaborata con continuità e coerenza. Preponderante è stato invece e a lungo il piano dell’edilizia pubblica, con i vari PEEP e in particolare con le 167, ma ancora oggi con i piani di recupero e con le nuove centralità urbane e urbane metropolitane, che si pongono in qualche modo sulla loro scia, considerando soprattutto la forte percentuale di edilizia residenziale programmata o ottenuta dai soggetti proponenti in fase di contrattazione. Ai piani di edilizia pubblica si è voluto erroneamente assegnare un ruolo di catalizzatori della pianificazione territoriale ed urbana nell’ottica del decentramento e della distribuzione equilibrata delle risorse e delle sue ricadute. Negli ultimi venti anni la localizzazione della grande distribuzione e della direzionalità si è costituita essenzialmente intorno al Grande Raccordo Anulare. La dispersione urbana si è sommata all’abusivismo delle borgate della prima gene-razione ed all’abusivismo più recente. Principi di inquadramento teorico/Parole d’ordine ed indirizzi progettuali Si ritiene opportuno richiamare anche alcune considerazioni d’ordine teorico valide in generale per il progetto urbano e territoriale che nel caso specifico assumono una particolare rilevanza e declinazione ed hanno ispirato la sperimentazione progettuale presentata nella seconda e terza parte del volume: - il rapporto indissolubile città/territorio e la necessità, ormai assolutamente matura per Roma, di guardare la città dall’esterno piuttosto che dal suo centro; di riguardarla come nodo di una rete di rotte aree, flussi immateriali, flussi di merci e viaggiatori, meta, ma anche luogo di transito; è maturo il tempo di considerarne il futuro come area metropolitana e di più come entità transurbana. è forse utile ricor- dare qui il magnifico disegno del Mediterraneo di Le Corbusier, delle rotte aree e della navigazione puntate sulle grandi città; di ricordare le considerazioni del suo allievo Wogenscky sul “naturale” e incontrastabile sviluppo urbano sulle linee di comunicazione48; - la temporalità come fattore decisivo della pianificazione e della progettazione per conseguire flessibilità, adattività, inclusività; - l’eterogeneità e l’individualità delle parti urbane e degli elementi come valore, fattore di sviluppo e di evoluzione, garanzia dei processi dinamici della complessità; garanzia dell’autorganizzazione riproduttiva; - il prodursi di uno stile d’uso della viabilità dall’utente contemporaneo in rapporto all’impiego delle nuove tecnologie informatiche - da internet ai navigatori satellitari - alla pubblicità ed alla segnaletica, che determina la personalizzazione degli itinerari, la continua trasgressione degli itinerari ordinari codificati, la codificazione e la variazione dei programmi di spostamento in tempo reale e la trasformazione della strada in un canale comunicazionale che annuncia gli eventi in corso o a venire nei territori attraversati. I ragionamenti e gli obiettivi progettuali non mirano alla trasformazione radicale, ma si inquadrano nell’ottica della razionalizzazione e del miglioramento, considerando le esigenze: - della competitività urbana nello sviluppo e nella coesione territoriale; - della compatibilità ambientale nella salvaguardia e nella valorizzazione del paesaggio e del patrimonio; - della espressione architettonica con il rilevare e conformare ciò che è latente, che preme per emergere come evoluzione delle forme dell’individualità territoriale ed urbana di Roma. Questi obiettivi possono essere conseguiti attraverso: - il progetto della connessione; - il progetto della trasformazione compatibile; - il progetto della densificazione e di strategie antisprawl (senza tuttavia demonizzare lo sprawl e ricordando che densità è altra cosa che concentrazione); - il progetto di nodi qualificati ad alta densità e mix funzionali inclusivi di attività di livello superiore, ma dotati di specificità locali (ricordando che il progetto della mixité è innanzitutto progetto dell’organizzazione sociale); - il progetto di nuovi spazi pubblici passanti; - il progetto delle connessioni tra i poli e le centralità; 48 Cfr.: R. Secchi, Une architecture de l’espoir, in P. Misino, N. Trasi, (a cura di), André Wogensky. Raisons profondes de la forme, Editions Le Moniteur, Paris, 2000. 52 - il progetto della fluidificazione e del potenziamento delle reti, curando in particolare i rapporti tra le microreti degli insediamenti residenziali con le macroreti e istituendo reti intermedie; - il progetto della integrazione dei trasporti pubblici con i trasporti privati, considerando sedi e modalità (linee ordinarie e linee ad alta velocità, tecnologie e formule d’impiego); - il progetto della mitigazione degli impatti; - il progetto del contenimento dei fenomeni di degrado e di deriva indotti sui territori dalle lacerazioni delle continuità infrastrutturali dell’alta velocità. - il progetto della campagna urbana come strumento di riqualificazione degli insediamenti tipici della dispersione e come collante tra enclaves. Come suggerisce David Mangin, in questa prospettiva è opportuno considerare due velocità e tenere presente che per conseguire più fluidità rapida la velocità e la capacità portano lo stesso segno, mentre per conseguire una fluidità lenta bisogna puntare a più capacità e minore velocità. La fluidità rapida ha effetti controproducenti sulla qualità urbana. Infatti le strade concepite per la fluidità rapida si comportano come oggetti tecnici autonomi che generano rotture nefaste per il funzionamento della città. “L’estrema gerarchizzazione della rete si associa a una politica sistematica di proliferazione e conduce a concentrare i flussi sui pochi assi primari, favorisce la saturazione della rete rapida all’interno dell’agglomerato urbano mentre la velocità e i vantaggi di accessibilità ottenuti in periferia incoraggiano l’espansione urbana e favoriscono gli sviluppi economici e commerciali intorno ai nodi di scambio”49. La fluidità veloce incrementa inoltre la congestione e l’insicurezza. La fluidità lenta della mobilità promuove la qualità urbana. Essa attenua le lacerazioni urbane promuove la multimodalità e la riconquista dello spazio pubblico. 49 D. Mangin, op. cit. 53 ORGANICISMO MONUMENTALE V/S PARTICOLARE IN SANTIAGO CALATRAVA Giovanni Bartolo Il tema della grande dimensione in architettura è stato affrontato in svariati modi e sin dall’antichità l’uomo si è cimentato nella composizione di grandi tracciati urbani, edifici monumentali complessi o parte di articolati organismi urbani. In origine l’uomo costruiva le proprie dimore nella natura o ispirandosi alla natura, in primis nelle caverne, sull’acqua, sugli alberi, per proteggersi dai pericoli, utilizzando diverse tecnologie e tecniche costruttive, ma integrandosi sempre con l’ambiente che lo accoglieva. Con l’evoluzione dell’uomo si sono evoluti anche i modi di costruire e di concepire gli spazi, sebbene, dal punto di vista del rapporto con la natura il sistema compositivo, sotto certi aspetti, ha subito un involuzione nel tempo. Concepire uno spazio come un vuoto da riempire, senza tener conto di ciò che lo circonda, spesso ha rappresentato il punto critico dei progettisti nel loro affrontare i diversi temi della composizione architettonica. Il caso più emblematico si è avuto con il cosiddetto razionalismo moderno, allorché l’architettura, oltre il superamento degli stili storici, si proponeva di determinare un mondo del tutto artificiale e, quindi, di essere costruita in un qualsiasi luogo indipendentemente dalla geografia e dagli aspetti ambientali. Ancora oggi, pur con l’aumentata sensibilità verso la storia e l’ambiente, sebbene molti architetti riescono a dialogare con i luoghi interagendo con essi e rispettandone l’identità, molti altri invece si travestono da esploratori di nuove tecnologie o ricercatori di presunte future vocazioni, forzando gli aspetti dei luoghi in cui determinano le proprie scelte compositive. Un caso simbolo è l’archistar Santiago Calatrava. Nato a Beninamet, nei pressi di Valencia, dove ha frequentato la Scuola di Architettura e la Scuola di Arti e Mestieri. Dopo la laurea, nel 1975, si è iscritto alla Scuola Politecnica Federale (ETH) di Zurigo per la laurea in Ingegneria Civile. In questi anni Calatrava studia Le Corbusier, la cui cappella Notre Dame du Haut gli permette di esaminare come le forme complesse possano essere comprese e generate. Nel 1981, dopo aver completato la tesi di dottorato “Sulla piegabilità delle strutture” (“Zur Faltbarkeit von Fachwerken”), inizia l’attività professionale aprendo uno studio a Zurigo. Lo stile di Calatrava può riassumersi in un concetto visuale e, si direbbe, spettacolare dell’architettura determinato dall’interazione della forma con i principi statici dell’ingegneria. I suoi lavori infatti spesso sono ispirati alle forme ed alle strutture che si trovano in natura ingigantite nel palcoscenico terri- toriale. Per quanto primariamente noto come architetto, Calatrava è del resto anche scultore e pittore, sostenendo che l’architettura sia nel combinare tutte le arti in una sola. Uno dei suoi progetti più recenti è un grattacielo residenziale composto da dodici case a schiera a forma di cubo impilate una sulla cima dell’altra. Le case a schiera salgono lungo un asse centrale secondo uno schema a scala in modo che ciascuna di esse abbia il proprio tetto. Il design della townhouse in the sky che sarà costruita a New York nel quartiere finanziario di fronte all’East River ha attirato una clientela molto ricca, disposta a pagare la forte somma di trenta milioni di dollari americani per ogni cubo. Molto apprezzato negli USA, Calatrava ha anche redatto il progetto del Fordham Spire di Chicago, un grattacielo non ancora costruito e due dei tre ponti che attualmente attraversano il Trinity River di Dallas, Texas, mentre il terzo è in fase di disegno. Quando anche quest’ultimo sarà ultimato Dallas sarà l’unica città del mondo ad avere tre ponti disegnati dall’architetto (ingegnere) spagnolo, insieme a Reggio Emilia dove, all’inizio del 2007, sono stati ultimati i tre viadotti lungo il nuovo asse attrezzato che accompagneranno la realizzazione della copertura del nuovo casello autostradale della A1 e della Stazione Mediopadana TAV. Da “artista”, Calatrava spesso utilizza nella sua invenzione di forme lo schizzo ad acquarello, sulla base del quale il personale dello studio sviluppa il progetto architettonico e strutturale. Una delle sue opere più grandi è la Ciudad de las Artes y las Ciencias ovvero, in lingua italiana, la Città delle arti e delle scienze che si costituisce come un unico impianto architettonico composto da cinque differenti strutture suddivise all’interno in tre aree tematiche: arte, scienza e natura. Il complesso sorge a Valencia, in Spagna, sul vecchio letto, ora spostato, del fiume Turia e copre una superficie 350.000 mq. Progettato interamente dall’architetto valenciano ed iniziato nel luglio 1996, la Ciudad è considerata un esempio di architettura organica che, grazie a qualità costruttive d’avanguardia, riesce ad armonizzare gli elementi tecnologici con i contenuti, lasciando però trasparire la tradizione mediterranea del mare e della luce attraverso un gioco di colori tra l’azzurro dei grandi stagni d’acqua a cielo aperto e il bianco del cemento. Il centro è una vera e propria “città nella città”, costituito dalle seguenti strutture, note con i loro nomi valenciani: 54 - El Palau de les Arts Reina Sofía Un monumentale edificio dalle forme molto singolari destinato alla creazione, alla promozione e alla diffusione di tutte le arti sceniche. - L’Hemisfèric Una struttura architettonica di 13.000 mq concepito per fondere insieme le vibranti sensazioni suscitate da un planetario con l'impatto visivo delle immagini cinematografiche in formato IMAX Dome e gli spettacoli audiovisivi prodotti da un modernissimo laser OMNISCAN. La forma dell’edificio (con un dorso di testuggine) riprende l'idea di un gigantesco occhio umano, la cui metà superiore è virtualmente completata nell'occhio del visitatore dal riflesso dell'edificio osservabile in uno stagno rettangolare di 24.000 mq. - L’Umbracle Un edificio situato nella parte meridionale del complesso, lungo 320 metri e largo 60, costituito da un parcheggio su due piani per automobili (fino a 900) e pullman (fino a 20) e una passeggiata superiore nota come Paseo de las Esculturas (in italiano viale delle sculture) abbellita da un giardino alberato contenente una grande varietà di piante di specie diverse. - El Museu de les Ciències Príncipe Felipe Un museo scientifico interattivo con una forma che ricorda vagamente lo scheletro di un enorme dinosauro, suddiviso su tre piani principali di circa 8.000 metriquadri ciascuno: Tecnópolis, El Escaparate de la Ciencia (la vetrina della scienza) e Formas y Estructuras (forme e strutture). Al secondo piano è inoltre presente El legado de la ciencia (il lascito della scienza) in cui si apre un’esposizione sulla vita e le opere dei Premi Nobel Severo Ochoa, Santiago Ramón y Cajal e Jean Dausset. - Parco oceanografico di Valencia Uno dei più grandi acquari d'Europa, un parco oceanografico all'aria aperta posto su di una superficie di 110.000 mq. Al suo interno sono rappresentati tutti i differenti habitat marini di mari e oceani attraverso più di 40.000 specie diverse. Quindi come si è capito un enorme progetto, un enorme complesso che oltre a fare cultura sulla scienza fa soprattutto business, un centro che deve attrarre turismo, far girare un economia legata all’attrazione. Solitamente per l’architettura di Calastrava, dati i suoi riferimenti naturalistici, si parla di un nuovo organicismo. Ma quanto c’è di organico nelle sue opere? In termini energetici, ad esempio, quanto consuma il complesso della Ciudad? La risposta è: “tantissimo”! Un vero spreco di risorse che fortunatamente si ripaga con le molteplici visite giornaliere pure molto care, in certi casi in un rapporto sproporzionato tra l’offerta dei servizi ed il costo d’ingresso alla struttura. Ciò per affrontare le spese delle centinaia di addetti, ad esempio, impie- gati giornalmente nelle vasche a pulirne il fondo, o a pulire l’esterno e l’interno dei fabbricati, per non parlare dei costi degli impianti di raffreddamento e di ricircolo dell’aria negli ambienti dalle enormi pareti vetrate. Trascurando il discorso sulle risorse e sui consumi l’organicismo, se mai questo sia un valore, non sembra rintracciabile neppure nelle forme. Queste sono effettivamente tratte dalla natura, come è per la “foglia” usata quale copertura del Palau de les Arts Reina Sofía, o per la forma del guscio di testuggine dell’Emisfero o, ancora, per quella dell’occhio umano, dell’ossatura del dinosauro e via discorrendo. E tuttavia viene da pensare, nell’inflazione delle forme naturali utilizzate, che, in definitiva, il loro sovrapporsi artificioso faccia del tutto perdere di senso al concetto di organicità, il quale è riferito alla vitalità stessa della natura più che alle forme morte, gli scheletri, pedissequamente imitati. Quanto al riferimento alla tradizione moderna spagnola che pure si ascrive alle opere di Calatrava, in questo progetto gli elementi di ispirazione gaudiana, quali sono ad esempio i torrini-scala del parcheggio che ricordano i comignoli di Gaudì a Barcellona, o i rivestimenti di ceramica a mosaico irregolare degli elementi in cemento, (le sedute lungo il viale alberato, ed i bordi delle vasche) sembrano essere maggiormente citazioni posticce che non veri omaggi alla storia ed alla tradizione. Se può apparire comunque non del tutto deprecabile il tentativo di operare con l’architettura in favore del business turistico, al modo di quanto hanno fatto altri prima (Ghery a Bilbao, o Pei al Louvre parigino ecc.) la critica più significativa riguarda l’intervento, un ponte, per una città che di per se stessa è già caratterizzata dal turismo e che vede proprio nel sistema dei ponti un suo carattere, Venezia. Le polemiche sul progetto di Calatrava per il quarto ponte sul Canal Grande nascono in primo luogo dalla scelta dei materiali, il vetro, destinato, quale pavimento posto sull’acqua ad opacizzarsi ed usurarsi in tempi brevi, sì da perdere il carattere di trasparenza legato al cristallo della tradizione veneziana. Ma è l’ideologia arrogante dell’archistar, incurante di luoghi, persone e cose su cui affermare il proprio verbo, a sollecitare le critiche maggiori. Data infatti la mancata attenzione del progetto verso gli utenti con difficoltà motorie, questi, giustamente, chiesero che, dopo 434 ponti costruiti a Venezia nei secoli senza attenzione per l’handicap, il primo dei ponti moderni potesse facilitare il percorso ai disabili. Possibile che proprio Calatrava, l’architetto che si ispira alle forme della natura, e quindi all’uomo, non si fosse posto l’obiettivo di conciliare l’arte con il rispetto dei diversamente abili e delle leggi vigenti? Messo alle strette, il Comune chiese al progettista di trovare una soluzione e Calatrava, dopo alcuni tira e molla, quasi seccato per i problemi posti, pur accon- 55 sentendo ad adeguare il progetto ha insistito, in una lettera di risposta al sindaco, nel suggerire ai disabili «l’attraversamento orizzontale mediante vaporetto» ovvero «il superamento del canale a livello dell’acqua con i servizi dell’Actv». Infine la soluzione è stata trovata affiancando al ponte di cristallo ormai opacizzato una ovovia (funivia con piccole cabine di forma ovale o tondeggiante) che, nascosta ai piedi dell’arcata, è posta all’interno di una botola la quale, aperta a richiesta, lascia salire la cabina rivolta ad accogliere la persona disabile e, scorrendo lungo la parte esterna del ponte le consente l’attraversamento, in danno alla immagine stessa del nastro posto sull’acqua, che perde il suo carattere di leggerezza, e del disabile costretto a faticose manovre. Un esempio di come, spesso, rivolti a grandi temi ed a grandi investimenti le archistar perdano del tutto la dimensione vera, spesso più modesta, delle cose. 56 DISEGNARE INTERPRETANDO ARCHITETTURE Andrea Santacroce “Il disegno è una forma di comunicazione con l’io e con gli altri. Per l’architetto, è anche, tra i tanti, uno strumento di lavoro, una forma di apprendere, comprendere, comunicare, trasformare: una forma di progetto.”1 Disegnare architetture è come fare un'altra cosa; non è come progettare ma è progettare disegnando. E’ due gradi superiore al normale tempo di riflessione: se progettando si pensa e poi si disegna, non importa come, con le squadrette, con autocad, con photoshop con qualunque strumento, per disegnare architetture bisogna prima di tutto disegnare pensando, poi immaginare disegnando e poi progettare disegnando non avendo come obiettivo finale una forma ma una idea di architettura. La mano si allena a disegnare un concetto che non è ancora il progetto, è un embrione, una forma autonoma di architettura che poi, con il disegno tecnico, assumerà la propria natura costruttiva. “L’architetto potrà utilizzare altri strumenti; ma nessuno sostituirà il disegno senza qualche perdita, nemmeno il disegno sostituirà quello che appartiene agli altri.”2 Il disegno detta il tempo del pensiero, ci aiuta a pensare; se disegno uno spazio questo acquista una dimensione e diviene uno spazio concreto nel quale può essere collocato un oggetto: un terza dimensione, un mondo parallelo che diviene luogo che accoglie le nostre architetture pensate. Anche lo stesso modo di disegnare diviene il modo di essere così come diceva Aldo Rossi “I modi di rappresentare e la stessa rappresentazione costituiscono già di per sé una forma di progettazione. Quella relativa alla rappresentazione è una questione estremamente importante, soprattutto perché l’architettura deve essere pensata.”3 Allora lo schizzo diviene una operazione che anticipa il progetto, diviene un passaggio fondamentale per preparare le basi dell’idea progettuale. Il disegno tecnico ne stabilirà le sue scelte costruttive. Così tramite il disegno fisseremo il metodo per sviluppare la nostra ricerca architettonica. Il disegno ha sempre avuto una sua autonomia rispetto al progetto e alla stessa rappresentazione del progetto. Ci consente di controllare lo spazio ma è parallelamente un altro testo che dice di più rispetto la misura ed i processi costruttivi. Anche Vittorio Gregotti pone l’accento sulla capacità del controllo del disegno come rappresentazione e interpretazione della realtà attraverso il progetto.“Il mezzo di rappresentazione, simbolico o geometrico che sia, non è né obbiettivo né indifferente: esso non si istituisce solo come rappresentazione ma come controllo del reale, esso indica e fa parte dell’intenzione progettuale anche nelle sue forme di apparente neutralità comunicati- va.”4 Il linguaggio e la rappresentazione divengono lo strumento di comunicab-ilità dell’idea progetto. Ed ancora sulla conoscenza della condizione costruttiva del disegno Franco Purini si esprime così: ”La vera vista dell’architetto è il disegno. Il segno grafico possiede una capacità separatrice dei corpi che non ha eguali nella sua incisività chirurgica. Poiché l’architetto deve conoscere il mondo fisico per intervenire su di esso, e il mondo fisico è composto di oggetti, la loro analisi approfondita e ripetuta diviene essenziale per la composizione dell’abitare nelle varie articolazioni. Essendo gli oggetti costituiti da parti autonome formate, anche se la loro conformazione è stata pensata in vista di una loro congiunzione – parti dotate a loro volta di una identità volumetrico/materica e di una peculiare condizione costruttiva – è necessario conoscere prima di tutto l’insieme cui essi danno vita e successivamente le loro singole componenti, il ruolo che esse svolgono nel tutto nonché le connessioni.”5 Su tale questione, anche Giorgio Grassi è eloquente: “Considero il disegno anzitutto come un mezzo adeguato rispetto alla costruzione. Rendere visibile, misurabile, in qualche modo verificabile il progetto nelle sue diverse fasi, anticiparne le soluzioni, per così dire, con spirito di verità: questa e non altra credo sia la funzione specifica del disegno, di qualsiasi tecnica o mezzo di rappresentazione ci si avvalga.”6 Ci chiediamo, allora, se possono alcuni sistemi di rappresentazione del progetto rendere evidente e scientifico il processo progettuale. Cioè se oggi sia più importante ritornare al significato processuale del disegno più che alla figura imbellettata dell’immagine del progetto. Ultimamente l’utilizzo costante di strumenti di grafica che esasperano il fotomontaggio ed il rendering sembra che abbiano svuotato di significato la rappresentazione dell’architettura che da sempre hanno prodotto mondi paralleli a quello della costruzione ed arricchendone i temi di ricerca. Ad esempio i disegni assonometrici dell’esperienza neoplastica divengono essi stessi metodo e principio costruttivo ma anche poetica e dichiarazione di un processo di ricerca. Tali disegni rendevano leggibili tridimensionalmente i loro edifici, ma proponevano, in funzione direttamente progettuale, un linguaggio architettonico. L’assonometria è un metodo di tra- Schizzo di Alvaro Siza per il Museo Fondazione Iberê Camargo di Porto Alegre Disegno di Aldo Rossi, senza titolo 57 scrizione spaziale degli oggetti particolarmente idoneo a fornire indicazioni costruttive e di montaggio che si articolano nello spazio in modo vario e complesso; è una proiezione misurabile e nello stesso tempo astratta: assume un dato obbiettivo per la capacità di scomporre l’oggetto e lo spazio così come avviene proprio nelle scomposizioni dei piani assonometrici di Teo Van Doesburg. Questo tipo di disegno produce una modalità di rappresentazione catalogativa e classificatoria; contribuiscono a formare un discorso che sarebbe potuto essere sconclusionato senza l’ausilio di regole interpretative. Così il disegno assonometrico classifica alcune parti significative degli oggetti osservati o progettati con la tecnica dello smontaggio e dell’assemblaggio riordinando pezzi diacronici di un complesso articolato di azioni nel progetto; si preoccupa di disarticolare parti di uno stesso racconto che, nella sua forma finita, è muto, afono, enigmatico, mentre la disaggregazione esplosa degli elementi minimi, occupati nell’unità, dimostra la semplice ed essenziale autonomia delle parti nel tutto. L’uso di una rappresentazione oggettiva dell’architettura produrrebbe la capacità di discernere il processo deduttivo del progetto e la chiarezza teorica del processo. Direbbe Purini “Rappresentare significava usare uno strumento oggettivo che tutti, diciamo, possono decodificare in un modo anche estremamente soggettivo: c'è stata una dialettica molto interessante che percorre le opere di tutti gli architetti tra oggettività, tradizionalità del codice e uso soggettivo del codice stesso. Per cui noi immediatamente riconosciamo una prospettiva di Wright da una prospettiva di Le Corbusier, uno schizzo di Alvar Aalto da uno schizzo di Alvaro Siza che riprende gli schizzi di Alvar Aalto come fonte; però, nonostante Alvaro Siza si rifaccia al modo di disegnare di Alvar Aalto, noi immediatamente riconosciamo che uno è uno schizzo di Alvar Aalto e l'altro è uno schizzo di Alvaro Siza perché il soggetto interviene sempre dentro la convenzione per assegnare una riconoscibilità speciale al disegno.”7 Questa riconoscibilità ‘speciale’ che conserva lo schizzo permette al disegno di divenire altro: da trasmissibilità tecnica a concetto. Gior-gio Grassi in un recente libro su Leon Battista Alberti parla proprio dei tipi di disegno della manualistica del cinquecento. Nel trattato dal titolo L’art de bien bastir i disegni servono a fissare l’idea del progetto e propongono un grado di previsione rispetto a quelli usati per la costruzione, per la comunicazione del progetto esecutivo. “Se quelli di cui si è parlato finora erano necessari per fissare l’idea del progetto e per controllarne il risultato, specialmente la logica e la coerenza del risultato, questi altri disegni sono necessari anzitutto per istruire circa la costruzione, per trasmettere le in- formazioni necessarie, e non hanno altro mezzo che questo per farlo, sono disegni essenziali e schematici, che non concedono nulla di sé se non il loro contenuto, sono fatti di linee di angoli e di misure, come dice Alberti, tutte le linee, tutti gli angoli e tutte le misure che sono necessari per individuare il progetto in ogni sua parte.”8 Allora il tema del disegno interpretativo nell’architettura rimane una questione aperta; è forse una questione cruciale, il punto di collegamento tra il modo di pensare ed il modo di essere di una società, cioè il grado di livello di approfondimento che la ricerca raggiunge in un determinato periodo storico. Questa forma del disegno che non saprei definire univocamente (schizzo, descrizione, lettura, rappresentazione, fotografia del reale) rimane un atto interno all’architettura, tra la descrizione tecnica e la fissità del concetto. E’ di questo avviso anche Roberto Collovà quando dice che “la separazione tra ideazione ed esecuzione di origine albertiana, ha perduto, per le condizioni attuali, quella nuova qualità che consisteva nella possibilità del controllo a distanza. Il controllo della realizzazione di un’idea, come la duttilità del progetto erano fondati in gran parte sulla disponibilità degli elementi certi della architettura classica.”9 Infine, come ultima riflessione, pensiamo che queste idee sul disegno siano trasversali a tutte le questioni che si affrontano oggi in architettura. E’ lo strumento con cui si può trovare un equilibrio dinamico tra le forme naturali o artificiali esistenti e le nuove utopie: il disegno come espressione dell’utopia e luogo dove la didattica e la ricerca dovrebbero provare a concentrarsi per alimentare questo stato d’espressione necessario e vitale. Disegno senza titolo di Franco Purini Disegno del progetto della casa dello studente di Chieti, Giorgio Grassi 1 A. Siza, “L’importanza di disegnare” in Siza. Scritti di architettura, Skira, Milano, 1997. 2 A. Siza, op. cit. 3 A. Rossi, “Alcuni miei progetti” in Aldo Rossi. Architetture 1959-87, Electa, Milano 1987 4 V. Gregotti, “Il territorio dell’architettura”, ed. Feltrinelli, Milano 1966 5 F. Purini, “Il disegno” in Comporre l’architettura, ed. Laterza, Bari, 2000. 6 G. Grassi, “Un parere sul disegno”, in “Giorgio Grassi. I progetti, le opere, gli scritti”, Electa, Milano, 1996. 7 F. Purini, Conferenza tenuta il 30.05.2005 on line http://utenti.multimania.it/alexcid8/21purini.htm 8 G. Grassi, “Il disegno e la costruzione” in “Leon Battista Alberti e l’architettura romana”, ed Angeli, Milano 2007 9 R. Collovà, “Un frammento in scala 1:1” in XIX Esposizione Internazionale Triennale di Milano, catalogo della mostra, Elemond, Milano, 1996. Disegni assonometrici di Casa Privata 1920, Theo Van Doesburg 58 Il SAPPORO DOME… UNO STADIO CHE STUPISCE!!! Francesca Buonincontri Sapporo Dome, o Hiroba (piazza, spazio aperto) come è stato soprannominato, è uno stadio polifunzionale realizzato a Sapporo, sull’isola di Hokkaido, in Giappone, nel 2001, in occasione del Campionato mondiale di calcio del 2002. Sapporo, capitale di Hokkaido, la più settentrionale delle quattro isole principali del Giappone è oggi la quinta più grande città giapponese, con una popolazione di circa due milioni di abitanti, ma è una città atipica per questo paese, dall’aspetto simile a quello delle città nordamericane, con grandi viali e parchi su tracciato ortogonale, realizzata solo nel 1868, con l’assistenza degli Stati Uniti, su richiesta del governo giapponese. Pur essendo sullo stesso parallelo di New York, la città giapponese riceve un flusso di aria fredda dalla Siberia che ne abbassa notevolmente la temperatura (la temperatura media annua è 8,5 ° C, e in alcuni luoghi e in particolari inverni raggiunge anche -40 °C), il problema principale da affrontare nella costruzione di uno stadio era quindi rendere possibile lo svolgimento di attività sportive anche nei freddi mesi invernali oltre, naturalmente, la capacità di ospitare un evento importante come la Coppa del Mondo. La soluzione è stata trovata dall'architetto Hiroshi Hara (autore della Stazione di Kyoto e di Umeda Sky Building), in collaborazione con Atrium Phi Architectural Research Office e Atrium Bunku, che ha progettato il primo stadio al mondo ad avere il campo di gioco che si solleva, ruota su se stesso di 90° e trasla fuori dal corpo principale con un sistema di sollevamento ad aria. Lo stadio include tutte le attrezzature per gli sport all'aperto, si trasforma da campo per il baseball (sport preferito dai giapponesi), su un tappeto erboso artificiale, in campo di calcio su prato erboso naturale, può ospitare concerti, esposizioni e può, soprattutto essere usato tutto l'anno, anche durante l'inverno gelido di Sapporo, caratterizzato da venti siberiani, abbondanti piogge e nevicate. L’idea di creare un'architettura mobile, nella quale gli elementi che la compongono possono modificarsi in base alle esigenze degli utenti è stata sperimentata negli ultimi decenni più volte e con interessanti soluzioni. Già negli anni '60 Kisho Kurokawa ha proposto la sua teoria del metabolismo in cui parti o componenti integrate in un insieme urbano o architettonico potevano modificarsi in un sistema estensibile. Nel 2000, questa teoria è stata applicata in scala molto più ampia nel Saitama Super Aren, situato nella periferia di Tokyo e che in questi giorni sta acco- gliendo i profughi senza tetto per il terremoto dell'11 marzo. Si tratta di un'arena polifunzionale, retrattile che può trasformarsi, in uno stadio per 37.000 persone, in un gran spazio con una capacità di 22.000 spettatori o una sala da concerto da 5000 posti a sedere. In soli 20 minuti è possibile lo spostamento di una struttura a scomparsa alta 41,5 metri, che pesa circa 15.000 tonnellate e, che si muove ad una distanza di 70 metri, portando con sé circa 9000 posti a sedere. Con lo slittamento non si spostano solo i posti ma anche i bagni, i corridoi, gli uffici e le attrezzature varie che si adattano perfettamente alle nuove funzioni. Lo stadio di Sapporo, a sua volta, modifica addirittura i modi usuali di costruire gli stadi coperti e, invertendo i termini del problema, al fine di mantenere vivo il prato naturale per il calcio, costruisce un campo mobile che esce fuori dallo stadio invece di applicare la soluzione più comune di una copertura retrattile la quale comunque farebbe ombra al fondo erboso determinandone l’inaridimento. Il progetto dello stadio è il risultato di un concorso internazionale, indetto nel 1996, vinto dall’architetto giapponese Hiroshi Hara, specialista nella utilizzazione integrale delle correnti di aria, che ha ideato per il suo stadio un design aerodinamico, innovativo, nell’obiettivo, a suo dire, di rendere chi lo vive e lo guarda più felice. Hiroshi Hara dichiara che fare architettura oggi è più facile per il contributo che possiamo avere dalle nuove tecnologie, per cui progettare “… è un'investigazione matematica e numerica per realizzare altre forme e processi che non potevano portarsi a termine in altri tempi.” Alla domanda su come nascono le forme ideate, egli risponde che la sua architettura è condizionata soprattutto dal desiderio di sorprendere e di riuscirci introducendo novità nelle forme semplici e basilari usate in passato. Per il Sapporo Dome, Hiroshi Hara si è proposto di raggiungere il massimo della leggerezza possibile ed ha per questo disegnato una forma simile a quella di un globo aerostatico, con un’enorme cupola (circa 53.000 mq) a forma di conchiglia, dal colore cangiante poggiata sul verde. Lo stadio si trova immerso nel bellissimo paesaggio di Hitsujigaoka, una piccola collina a circa 7 km dal centro di Sapporo, ed è all'interno di un'area di 31 ettari denominata “Giardino dello sport”. La struttura è composta da travature reticolari spaziali che trasferiscono i loro carichi ad un anello di colonne poste sul perimetro 59 della costruzione e la forma aerodinamica della cupola, in acciaio inossidabile, è originata dal bisogno di una copertura che, coprendo un enorme spazio, lo lasciasse libero da elementi statici in modo che il vento potesse spazzare via la neve accumulata. La cupola è stata ricoperta da una struttura curva di fibra di vetro (teflon) che ne aumenta la rigidità e protegge dal freddo, inoltre, essendo trasparente, il tetto consente l'ingresso del 16% di luce naturale, evitando il calore solare in estate. La pianta dello stadio ha la forma di un paio di occhiali dove ogni lente è occupata da una arena diversa, il campo da baseball all'interno e il campo di calcio all’esterno, onde far crescere l’erba all’aperto, ma la particolarità sta nello spostamento, mediante un sistema di sollevamento dello stadio “sospeso”. Il processo dinamico di trasformazione per passare dalla configurazione del campo di baseball a quello di calcio avviene in cinque ore, il campo con l’erba naturale viene spostato nell'arena al coperto, in modo da poterlo utilizzare anche in inverno, attraverso l’apertura meccanizzata di un muro largo 90 metri. La maggior parte del tempo della trasformazione viene speso per rimuovere il manto erboso del campo da baseball, formato da 110 sezioni di erba artificiale, che deve essere arrotolato, mentre le pareti scorrevoli vengono azionate elettricamente e i sedili esterni si ritraggono quando le pareti scivolano all’aperto, con altri sedili girevoli che si muovono insieme con il campo di calcio che è sospeso. La collinetta del lanciatore e le basi sono conservate sotto il pavimento dell’arena, e allorquando il campo viene spostato per emergere, esso ruota di 90°, le pareti si richiudono ed i sedili a scomparsa vengono tirati fuori, in modo da completare la conversione in stadio. Il campo di calcio, il cui strato di erba, terra, sabbia, tubi per il riscaldamento, lastre di cemento e travi metalliche pesa circa 8.300 tonnellate, viene spostato mediante un sistema pneumatico che genera un cuscino d'aria il quale solleva con facilità il campo, riducendo il suo peso del 90 % collocandolo su 34 cuscinetti che lo trasportano alla velocità di quattro metri al minuto, per 25 minuti totali, fino all'interno dello stadio. Lo spostamento del campo si accorda col movimento delle due aree gradinate, a mezzaluna, che si spostano anch'esse in modo da adeguarsi alle forme e alle misure diverse del campo per il calcio e per il baseball. Alla base del progetto ritroviamo la filosofia dell'architettura della casa giapponese basata sulla massima flessibilità, ottenuta con schermi di bambú scorrevoli ed elementi mobili. La stessa mobilità permette ai numerosi posti dello stadio una gran varietà di configurazioni in modo da adattarsi alle diverse utilizzazioni dello stadio e ogni sedile può muoversi autonomamente per avere una vista panoramica del campo e di quello che succede negli altri gradini. Gli spalti, della capienza di 42.831 posti, sono realizzati in una forma a gradonata conica con inclinazione di 27° in modo che anche agli spettatori seduti nei posti più lontani abbiano una buona visione del campo. La costruzione è alta, elevandosi dalla superficie del campo di circa 68m ed ha 4 piani sopra i campi, due sotto i campi, per un totale di area edificata di 53.800 mq ovvero un totale dei piani di 97.503 mq, con l’arena al chiuso che misura 14.460 mq e l’arena all’aperto 18.800 mq. Il centro della città di Sapporo è collegato allo stadio mediante un sottopassaggio pedonale di soli dieci minuti di cammino, mentre per chi vuole servirsi dell'auto c'è un parcheggio dotato di 1.700 posti auto. Un osservatorio sulla sommità del Dome, a circa 53 metri dal livello del campo di calcio, raggiungibile con una grande scala mobile, permette di ammirare il paesaggio e vedere anche interamente l'interno dello stadio. Nel Sapporo Dome vediamo applicata la teoria dell'architetto Hara, questo stadio stupisce per la forma, coinvolge per le possibili trasformazioni e, forse, può rendere veramente un pò più felici i visitatori. 60 MILANO FUTURA NEL RECUPERO DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE Nello Luca Magliulo Lo scenario milanese nelle trasformazioni urbane appare forse oggi il più interessante del nostro paese. In un’epoca come la nostra, dove i territori edificabili scarseggiano e dove l’architettura è alla ricerca di una propria identità storica, lo scenario lombardo sembra quasi dare inizio all’attività di nuova urbanizzazione italiana. Gli interventi previsti investono un milione e trecentomila mila metri quadrati di suolo, dove si procede alla realizzazione di nuovi edifici al posto di vecchie stazioni fuori uso e fabbriche ormai vecchie di decenni. Senza contare altri cinque milioni e mezzo destinati alla nascita di nuovi quartieri residenziali che necessiteranno di moderne infrastrutture. Una situazione che si è resa possibile in seguito alle varianti apportate al Piano regolatore del 1954, già modificato nel 1980 e che oggi permette di intervenire là dove non era possibile costruire. In questo senso la città più europea d’Italia cerca di reinventare il proprio look costruendo molti grattacieli anche per seguire una politica di risparmio del suolo, con tre nuove linee-metrò e l’obiettivo di raggiungere i due milioni di abitanti entro il 2030. In questo grande ambito di intervento si perseguono scopi di riqualificazione di aree dismesse della città e ai suoi confini con una politica di recupero del suolo interessante, in quanto risposta alle problematiche della scarsa disponibilità del suolo edificabile ed a quelle della mancanza di case, attraverso una nuova visione del Social Housing, dove scompaiono del tutto gli interventi statali sovvenzionati (fatta eccezione per rari casi) e compare, accanto all’intervento privato, la residenza “convenzionata” per le fasce deboli (la regola ne prevede per ogni quartiere circa un 30%). Secondo questi principi di filosofia progettuale sono stati pensati interventi come quello di Santa Giulia e di CityLife. Entrambi i quartieri nascono come interventi di sostituzione di realtà preesistenti: il primo occuperebbe il posto dei vecchi stabilimenti Montedison e delle acciaierie Redaelli nella zona Sud-Est di Milano, il secondo darebbe vita ad un nuovo quartiere nell’area della Fiera della città in sostituzione del vecchio, svuotato dal trasferimento degli abitanti nel nuovo polo di Rho-Pero. Il complesso residenziale di Santa Giulia, attualmente ancora in costruzione, che dovrebbe ospitare un massimo di ottantamila abitanti, è concepito su di un’area di un milione e duecentomila metri quadrati a cavallo tra i quartieri Rogoredo e Taliedo, secondo le direttive del masterplan redatto dall’architetto Norman Foster. Al suo interno sono previste, oltre alle residenze, le più diverse funzioni, quali attrezzature sportive, un grande parco, parcheggi, strutture alberghiere e centri conferenze. L’intento è di creare “una città nella città”. Per la realizzazione degli edifici sono stati chiamati in causa altre numerose figure di spicco, come per esempio Peter Zumthor, il quale dovrebbe occuparsi della progettazione della chiesa del quartiere. Da un punto di vista urbanistico Santa Giulia è divisa in due aree edificate ben distinte corrispondenti alle precedenti due zone industriali. Al centro di queste ultime, come elemento di separazione, nascerà il grande parco, mentre il ruolo di elemento di congiunzione sarà affidato a un percorso parzialmente interrato che prenderà il nome di “strada Paulesse”. Nell’area corrispondente ai vecchi stabilimenti Montedison, da progetto, erano previste residenze di lusso inserite in un contesto caratterizzato da attività commerciali e ricettive (alberghi, un centro congressi di circa ottomila posti e la chiesa di Peter Zumthor) che sembrano essere attualmente ferme in cantiere a causa di una crisi economica della società addetta ai lavori. La seconda area, quella ex Redaelli, è attualmente realizzata. Sono visibili ad oggi le residenze libere e convenzionate affiancate da edifici terziari come l’azienda televisiva SKY. In questi edifici si riconoscono alcuni caratteri morfologici e tipologici di rilevante interesse: si tratta di edifici a corte con testata principale commerciale ed altri in linea. Entrambe le tipologie attestano il commercio su di una strada principale che dovrebbe essere attraversata da una linea tramviaria (ancora non realizzata) per evitare l’ingresso alle automobili, trasformando l’area in questione in uno spazio completamente pedonale e destinato alla vita commerciale. Caratteristiche che accomunano tutti gli edifici sono la doppia altezza al piano terra, utile sia per le attrezzature commerciali sia per gli ingressi al residenziale, e l’elemento di copertura, tali da definire per tutti i corpi edilizi un attacco a terra ed uno al cielo netti e forti. Il piano terra, nel lato commerciale, è scandito da pilastrature molto alte che creano porticati luminosi e ampi. Il sistema delle doppie altezze comporta una variazione degli alloggi che nel corpo centrale risultano simplex mentre in copertura diventano duplex, andando da una metratura in pianta minima di settanta metri quadrati fino ad un massimo di trecentocinquanta. Al fianco di queste tipologie ne dovrebbero poi nascere altre per disabili e per studenti. Morfolo- 61 gicamente l’impianto generale si affida ad un modello propriamente italiano che vede il sistema residenziale affiancato da un parco, senza operare tentativi di inserire la residenza nel verde secondo modi anglosassoni lontani dalle nostre abitudini urbane. Oggi il cantiere è fermo a causa di problematiche legate all’inquinamento del suolo e, dopo la realizzazione degli edifici descritti, di cui manca ancora il completamento dell’asse centrale commerciale, il parco e la restante parte del quartiere non hanno ancora visto la posa in opera della prima pietra. Sugli stessi principi progettuali si basa CityLife, progetto di riqualificazione del quartiere storico della Fiera di Milano nato dalla compartecipazione di Zaha Hadid, Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Pier Paolo Maggiora. Anche in questo caso il cuore pulsante del progetto è un grande parco pubblico che, oltre ad essere un polmone di verde per la città, insieme con la piazza e le tre torri, mira a diventare un luogo pubblico per eccellenza per il tempo libero dei cittadini e la vita sociale. Due elementi, dunque, il parco e le torri che simboleggeranno il primo l’aspetto ecologico, l’altro quello architettonico. Le tre torri (di centottantasei metri quella di Zaha Hadid, di duecentoventuno metri quella di Arata Isozaki e centosettanta metri quella di Daniel Libeskind) dovranno diventare il simbolo identificativo del nuovo quartiere. La prima con il suo corpo completamente vetrato, mostra subito i segni tipici della progettista iraniana che ha progettato una forma organica trasparente deformata attorno ad un asse di rotazione centrale nel suo percorso verticale. La seconda è un parallelepipedo di vetro fermo e compatto, mentre la terza torre contrappone un blocco lapideo pesante ad un altro di vetro curvo intersecati fra loro. Cinque aree attorno al parco saranno destinate al residenziale. Di grande risalto sono le residenze di Daniel Libeskind, edifici in linea curvi rotti da geometrie forti rivestiti di elementi lapidei e grandi vetrate. Ad esse si oppongono gli edifici residenziali progettati da Zaha Hadid, la cui organicità si riflette sulle facciate attraverso sistemi di vetrate ampie e curve come gli aggetti e le logge, alternanza di materiali in facciata e tagli particolari in copertura. Tutte le residenze sono accumunate dalle tipologie degli alloggi con cellule abitative bilocali, trilocali, plurilocali e attici extralusso. Grande attenzione nella pianificazione è stata data al sistema dei trasporti che prevede una ulteriore pedonalizzazione dell’ex area Fiera, attraverso nuove linee di trasporti pubblici per le torri, la piazza e il parco, al fine di evitare in maniera totalitaria l’ingresso delle automobili all’area. Successivamente alle residenze, alle torri con la piazza ed al parco, a completamento del quartiere sorgeranno attrezzature pubbliche come il Museo di Arte Conte- mporanea, il Palazzo delle Scintille (un centro per l’infanzia) e infine si eseguirà la ristrutturazione del Vigorelli, che tornerà ad essere il centro delle attività sportive di Milano. L’immagine complessiva del quartiere tende ad esaltare gli elementi distintivi dei singoli progettisti i quali a tratti sembrano avere trovato un modo per ottenere un’unità identificativa dell’intero complesso senza però perdere le proprie singole peculiarità distintive progettuali. Andando indietro di qualche anno, nel 2001, un altro intervento di notevole spessore e sulla stessa falsa riga dei precedenti, può ritenersi sia stato quello del nuovo Portello, sorto nel cuore dell’ex area industriale, dove erano ubicate le fabbriche Alfa Romeo, dismessa nel 1986. Nel 2001, sulla base del progetto redatto dallo studio Valle, partiva infatti il grande progetto di riqualificazione che prevedeva una serie di interventi firmati da alcuni tra i più importanti architetti italiani. Ancora ritornava l’elemento del parco come parte fondamentale del progetto, caratterizzato da una serie di salti di quota e da uno specchio d’acqua centrale, con il ruolo di luogo di miglioramento ecologico e visivo dell’intero contesto immediato. In tal modo l’impatto visivo del parco si riversava in maniera forte sia sugli edifici, dato il loro posizionamento planimetrico, sia sulla loro tettonica. Infatti, relativamente agli aspetti visivi, soprattutto per le torri progettate da Cino Zucchi, la collocazione degli immobili in maniera quasi casuale ed irregolare serviva a creare scorci prospettici verso l’area verde. Dal masterplan di progetto si nota il tentativo, non ancora visibile del tutto, di rendere il parco un'attrezzatura rivolta anche ad accogliere altre strutture a carattere sociale, come è per l’inserimento di un asilo. La spaccatura del quartiere in due parti, generata dall’asse stradale centrale, è superata con un percorso pedonale sopraelevato che collega la parte residenziale con la fascia terziaria e commerciale verso l’area Fiera. In questo punto si colloca una piazza fra gli edifici mentre nel polo opposto si introduce un grande centro commerciale. In questo modo si è voluto bilanciare le funzioni del nuovo quartiere con l’immediato contesto anche se sembra perduto il diretto contatto nella traccia storica. La parte realizzata del quartiere fino ad oggi consta del parco e delle residenze progettate da Cino Zucchi, in parte destinate all’edilizia convenzionata, in parte privata. Le prime, che presentano tipologia a torre, sono completamente rivestite in mattoni con prospetti caratterizzati da giochi geometrici che rompono la pienezza del mattone, alternando vuoti e pieni generati con logge e pannelli di diverso materiale e colore tali da mettere in risalto la regola geometrica delle bucature e le relative eccezioni. Non solo, ma, a pianta quadrata, con vano scala centrale, le torri offrono tre alloggi per piano per quattro 62 persone ed anche in pianta, come in prospetto, ripresentano il sistema della regola e dell’eccezione con l’impianto quadrato rotto da un aggetto a sbalzo su di un solo lato che ne altera la geometria. L’impianto delle residenze non convenzionate si basa su due tipologie diverse, a torre ed in linea. Ancora una volta il tema della regola e dell’eccezione si ripete facendo dialogare l’edilizia convenzionata con quella libera le quali si richiamano l’una con l’altra, nell’impianto e nel modo di trattare prospetti e volumi. Sia nella torre che nell’edificio in linea ancora una volta il volume è trattato con il mattone di rivestimento e la sua forte geometria è interrotta da una doppia pelle che genera una sovrastruttura tale da trasformare le logge della precedente tipologia edilizia in balconi aggettanti che danno maggiore respiro alla pianta. Il sistema delle bucature del volume è accentuato anche in questo caso con pannelli pieni di diverso materiale e finitura i quali si alternano con le finestre e che si ripetono nei parapetti, a volte pieni, a volte aperti. Un altro punto di incontro tra le due tipologie (libera e convenzionata) è il modo di concludere l’edificio nel loro attacco al cielo, dal momento che in entrambe si prolunga la facciata in alto oltre la fine del volume, dilungando però le torri convenzionate con un pieno, e quelle dell’edilizia libera con la sovrastruttura di facciata ed i suoi elementi minimi. Sicuro merito dell’architetto è stato quello di sapere avvicinare le due tipologie, destinate ad utenze di differente fascia sociale, distinguendole ma senza far divenire tale distinzione un “peso sociale”. Ultimo intervento da citare è quello della riqualificazione dell’ex area industriale OM (Officine Meccaniche) IVECO. Nel 1975 nasce questa grande ditta per la produzione di veicoli industriali che nel 1980 appare già in dismissione. Nel 1995 il Comune di Milano adotta un PRU di riqualificazione per l’area in questione, approvato nel 1998 e la cui attuazione parte nell’anno successivo con la demolizione dei capannoni industriali. All’interno del PRU si persegue l’obiettivo di un nuovo quartiere residenziale, affiancato anche in questo caso da un grande parco con la seguente suddivisione delle funzioni: 51% dell’edificato destinato a residenze, il 15% al terziario, il 5% al produttivo e la restante parte al commerciale. Il Masterplan prevede tuttavia che il parco venga ad essere frazionato in più parti dal blocco centrale delle residenze, per cui in totale si ottengono tre aree verdi attrezzate al servizio sia del nuovo complesso che delle aree al contorno. Il blocco residenziale centrale è un sistema planimetricamente molto forte caratterizzato da un asse centrale, quasi ottocentesco, ai cui lati si distribuiscono le residenze di due tipologie, a torre e a corte aperta. Altri edifici, agli estremi del viale centrale, sono destinate ad attrez- zature di diversa natura e destinazione d’uso. Ortogonali all’asse centrale, una serie di percorsi suddividono in lotti più piccoli l’area edificata per un richiamo al tessuto urbano circostante e per collegare le diverse zone al verde ed alla città. Aspetto interessante che distingue questo dagli altri interventi è la presenza non solo di edilizia residenziale libera e convenzionata, ma anche sovvenzionata. La parte fino ad oggi realizzata delle residenze riguarda le due torri centrali affidate all’architetto Massimiliano Fuksas. L’impianto delle torri nasce da uno studio della pianta la cui organizzazione vede la sistemazione del vano scala in posizione laterale come variante al tema tipologico proprio all’edificio alto e le cellule abitative di tre tipologie diverse per due, tre o quattro persone. L’elemento di aggregazione fra le diverse cellule è l’ambiente cucina, trattato come un rettangolo arretrato rispetto alla linea di prospetto ed attorno al quale ruotano di novanta gradi le cellule abitative. In tal modo l’impianto generale della torre perde la sua matrice quadrata diventando il risultato di una rotazione a trecentosessanta gradi della pianta dell’alloggio. Il risultato sull’intero volume è un sistema di elementi arretrati o avanzati che realizzano per ognuno dei quattro prospetti un’immagine sempre diversa. Mentre le parti avanzate del prospetto sono trattate con finestrature a nastro la dove il prospetto arretra nascono dei balconi molto aggettanti. La diversificazione delle due parti è accentuata ancor di più dal cambio di materiale. In totale si utilizzano due tipi di materiali, cemento a faccia vista e elementi lapidei di rivestimento. L’aspetto più caratteristico delle due torri è sicuramente il modo concludere in alto i due volumi con una grande copertura che a sbalzo chiude la parte superiore degli edifici e che, creando un ulteriore piano vivibile, stende una sorta di “cappello” bucato, per ovvi motivi di peso e di luce, con tagli continui e sottili. E’ chiaro che al di là della qualità architettonica o dell’interesse che questi edifici possono suscitare, l’aspetto fondamentale di tutte le proposte in via di realizzazione è nella volontà di cambiare il volto di una città la quale sembra volersi riprendere quegli spazi che sembravano essere un peso cercando di trasformarli in luoghi di qualità. In un territorio come il nostro, dove il problema del suolo edificabile diventa ogni giorno più incombente, il recupero delle aree dismesse sembra l’unica strada percorribile, sia con demolizione e ricostruzione, sia attraverso il recupero vero e proprio. Se la realizzazione di nuovi quartieri in Italia sembra sempre più “in estinzione”, più semplice sembra essere forse la strada del recupero dei vecchi preesistenti complessi residenziali. 63 STOCCOLMA E AMBURGO CAPITALI VERDI Massimo Squillaro La qualità di vita o di “benessere” della popolazione di una comunità, città o nazione, è un argomento importante in economia, scienze politiche, sociologia oltre che in architettura, quale sapere che opera specificamente per il raggiungimento di tale obiettivo. Quando una città ha una buona qualità ambientale, significa che la maggioranza della sua popolazione può fruire anche di una serie di vantaggi politici, economici e sociali che le permettono di sviluppare con discreta facilità le proprie potenzialità umane e condurre una vita relativamente serena e soddisfatta. La cattiva qualità dell’ambiente urbano è quindi un problema acutamente sentito dagli amministratori delle città e dagli abitanti. Tuttavia, le condizioni ambientali differiscono notevolmente tra le città e le regioni d'Europa, anche a causa dei diversi livelli di applicazione delle norme e degli orientamenti in materia di ambiente. Ogni anno la Commissione Europea sull’Ambiente assegna il titolo di “Capitale verde” a una città europea, con almeno 200.000 abitanti, che si sia distinta per le politiche adottate in tema di sostenibilità ambientale, in particolare rispetto ad alcuni parametri essenziali quali il contributo locale per la lotta al cambiamento climatico, i trasporti pubblici e le soluzioni di mobilità sostenibile, lo smaltimento dei rifiuti, l’accessibilità degli spazi verdi pubblici, l’inquinamento acustico, la qualità dell’aria, la lotta agli sprechi, l’impiego dell’acqua, la gestione sostenibile del territorio. Per gli anni 2010 e 2011 la Commissione ha offerto il titolo rispettivamente a Stoccolma e ad Amburgo. Le due città si sono distinte in questi anni per le politiche urbane orientate a garantire la cosiddetta “qualità e sostenibilità urbana”, sulla base dei contenuti della Carta di Lipsia del 2007, che auspica uno sviluppo urbano in grado di integrare le dimensioni della qualità urbana in termini ambientali, garantendo la progettazione di spazi accessibili, confortevoli, sicuri e nel rispetto delle risorse naturali, di per se stessa foriera di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione ai temi introdotti dalla Convenzione Europea del Paesaggio. Questa nuova tendenza nelle politiche urbane cambia il tradizionale modello economico dell’espansione quantitativa (crescita) con quello del miglioramento qualitativo (sviluppo) e poiché è la città e, più in generale, il territorio il luogo in cui si esprime il conflitto tra modalità di consumo ed effetti negativi sull’ambiente, è proprio qui che viene affrontata questa contraddizione, sperimentando nuove modalità di intervento e trasformazione. La dimensione in cui sostenibilità ambientale e qualità formale producono gli esiti più concreti è quella della progettazione urbana e quando parliamo di sostenibilità del progetto urbano ci riferiamo alla scala più appropriata del quartiere, poiché la dimensione ridotta consente di gestire a livello locale questioni quali il consumo idrico ed energetico, l’inquinamento acustico, la raccolta differenziata e di coniugare insieme la qualità morfologica con le strategie della progettazione bioclimatica. Amburgo e Stoccolma, rispettivamente con i progetti dei quartieri Hafencity e Hammarby, rappresentano due esempi di quelle che vengono definite “buone pratiche” di progettazione di quartieri sostenibili. Una progettazione urbana attenta a soddisfare il cosiddetto “buon abitare” e a determinare il grado di sostenibilità di una parte di città, si fonda su alcuni principi e indirizzi progettuali la cui applicazione rappresenta una condizione necessaria per poter qualificare un quartiere come sostenibile: la struttura dell’impianto urbano e le relazioni con il contesto, l’accessibilità e il sistema della mobilità, il sistema degli spazi aperti e le procedure di attuazione, il controllo della qualità. Un impianto urbano dalla morfologia compatta offre la possibilità di destinare ampie superfici al verde pubblico e al sistema degli spazi aperti; allo stesso tempo la forma strutturata e coesa dell’insediamento garantisce una riduzione del consumo di suolo e la possibilità di assicurare la mixitè funzionale degli edifici. Altri vantaggi di questa struttura urbana sono l’accessibilità, attraverso il trasporto pubblico, che riduce al minimo gli spostamenti veicolari, la mobilità pedonale e ciclabile che garantisce l’accessibilità anche dai quartieri circostanti, la Hafencity vista dall’alto 64 massima permeabilità all’uso da parte dei cittadini, una maggiore riconoscibilità del progetto grazie alla definizione dei margini, del segno urbano e l’identità, il riconoscimento e il senso di appropriazione da parte dei cittadini. L’attenzione alla riduzione dei consumi di energia si esplica nella progettazione delle coperture per garantire la massima penetrazione dell’illuminazione naturale, nella valutazione delle altezze degli edifici, in una adeguata progettazione del sito che punta a ottimizzare il guadagno solare passivo, in una attenta definizione degli spazi verdi che consente di ottimizzare i costi del condizionamento estivo, nei sistemi di captazione e riuso dell’acqua piovana per l’approvvigionamento idrico dell’insediamento. Il quartiere di Hafencity occupa un’area molto estesa di circa 150 ettari, recuperata al sedime del porto ormai in dismissione in un progetto ambizioso che ospiterà nel 2017 circa 12.000 abitanti e 40.000 addetti che lavoreranno negli edifici a funzioni speciali. Un bilanciato mix funzionale, improntato ai principi di qualità del progetto urbano, garantisce complessità e al tempo stesso vivibilità a tutte le ore del giorno e della notte; residenze, uffici, spazi commerciali, spazi per la cultura e ricreativi fungeranno da polo di attrazione per i residenti e gli impiegati nel quartiere. Un riuso intelligente di pregevoli esempi di archeologia industriale e un approvvigionamento energetico dell’intero insediamento fornito da impianti geotermici o solari, da pompe di calore che sfruttano l’acqua dell’Elba e piccole centrali periferiche a legna. L’impianto urbano riprende la tradizione degli isolati con corte interna, che richiama la densità edilizia della vicina Amburgo storica. L’intento progettuale è quello di dare vita ad un’addizione urbana che dalla città storica tragga le principali linee di crescita e la scala dimensionale, nonché la complessità garantita dalla compresenza di molteplici funzioni, trovando d’altra parte tra i suoi punti di forza la ricchezza e la varietà delle diverse scelte architettoniche. La pianta del nuovo insediamento si sviluppa con una griglia edificata, che assicura una efficace delimitazione degli spazi pubblici tra cui parchi urbani, giardini pubblici, specchi d’acqua e viali alberati. Solo alcuni edifici, posti in posizioni significative e panoramiche, raggiungeranno altezze più alte con funzione di “belvedere”, ed ospitando le principali funzioni urbane andranno a costituire dei nuovi landmark all’interno del profilo urbano. Il progetto per il quartiere di Hammarby nasce come riqualificazione di un’area industriale ormai in disuso ai margini dalla capitale svedese. Situata sul margine sud dell’isola di Södermalm, intorno ad uno specchio d’acqua artificiale, il quartiere si colloca in posizione privilegiata rispetto agli elementi naturali: estesi fronti d’acqua in rapporto diretto con la foresta Nacka. Dal punto di vista energetico, tecnologie per il trattamento delle acque ed energia elettrica, calore e biogas, prodotti da fonti rinnovabili e dal riuso dei rifiuti umidi, garantiscono il risparmio e il recupero di energia per altri usi compatibili. L’intervento è compatto e costituito da 11.000 alloggi per circa 25.000 abitanti e 10.000 addetti in attività produttive, basato su un impianto costituito da isolati a corte aperta che garantiscono un sistema di relazioni e continuità tra lo spazio urbano ed il sistema del verde. Nel suo insieme rinvia ad un’estensione dei brani di città formati sul modello della griglia che caratterizza le espansioni ottocentesche più prossime al centro. La struttura urbana dell’insediamento è concepita per essere attuata in 12 comparti (Kyarteret) indipendenti, autosufficienti dal punto di vista energetico e dimensionati ciascuno per 2.000 abitanti. Questa modalità di attuazione consente di realizzare il progetto urbano per parti (considerati anche i tempi medi di realizzazione di questi interventi) senza snaturare la natura complessiva del progetto. Non è un caso che per ognuno di questi comparti l’amministrazione abbia provveduto ad una stesura, in accordo con i costruttori, dei cosiddetti Quality Program contenenti le linee guida e le prescrizioni riguardo i caratteri urbani e architettonici delle unità da realizzare. Nella progettazione di entrambi i quartieri sostenibili il tema dell’accessibilità è affrontato attribuendo nuovi ruoli ai diversi sistemi di mobilità e sovvertendo la tradizionale gerarchia dei flussi a vantaggio della mobilità pedonale e ciclabile. Nel caso di Hafencity la riduzione del traffico di attraversamento e penetrazione nei lotti privati è ottenuta disincentivando la possibilità di parcheggio e favorendo il trasporto pubblico anche con forme innovative quali pool car o car sharing. Inoltre una rete fittissima di Hammarby sul fronte acqua 65 percorsi pedonali e ciclabili garantiscono la piena fruizione e la permeabilità degli spazi. L’Hammarby Allee è invece il grande viale di attraversamento del quartiere di Hammarby sul quale si sviluppa il trasporto pubblico principale e dove sono localizzate funzioni commerciali in prevalenza ai piani terreni degli edifici. La mobilità interna è essenzialmente pedonale o ciclabile. Il collegamento alla rete del trasporto pubblico metropolitano è affidato alle linee su ferro (linea tranviaria Tvarbanan tram service) e gomma che percorrono l’asse centrale della Hammarby Allee. Le fermate del bus e del tram non sono più distanti di 300 metri da ciascuna abitazione e gli stessi servizi (scuole, aree gioco e piccoli esercizi commerciali) sono facilmente raggiungibili a piedi. Qui è stato anche progettato un parcheggio per automobili che in seguito dovranno essere alimentate con impianti a biogas, ed in linea generale non è incentivato l’utilizzo del mezzo privato grazie anche alla progettazione di assi stradali trasversali, a servizio delle residenze, a fondo cieco. Inoltre la quota di parcheggi pertinenziali per alloggio è di 0,7, mentre sono presenti in quote rilevanti i parcheggi per bici. I marciapiedi sono attrezzati con piste ciclabili e zone di sosta per le due ruote. Il tema della qualità urbana si concretizza nella massima attenzione alla costruzione dello spazio pubblico, come spazio connettivo, collettivo e socializzante con luoghi in cui si incrociano flussi pedonali, ciclabili e di trasporto pubblico, con grande capacità di attrazione e con condizioni tali da garantire forti legami di socialità. Per raggiungere questi obiettivi lo spazio pubblico è riconoscibile, attraverso la definizione dei suoi margini, e accogliente sia in termini di sicurezza sia di comfort ambientale. Ad Hafencity, ad esempio, gli spazi aperti si compongono su un impianto che interconnette luoghi privati e luoghi pubblici. Appositi accordi hanno definito, in sede di progettazione, la fruibilità pubblica degli spazi privati in prossimità delle funzioni urbane di eccellenza come la Stazione marittima, laddove è più probabile la compresenza di visitatori esterni e abitanti o lavoratori. Ad Hammarby invece è il grande viale centrale del quartiere con le piazze e gli slarghi circostanti a diventare il vero luogo di sosta e di socialità. Continuità e discontinuità, ampie superfici degradanti verso il mare (le terrazze Magellano e Marco Polo) e piazze più piccole e circoscritte tra gli isolati, caratterizzano i contrasti del sistema degli spazi pubblici, dove il rapporto acqua e terra viene fantasiosamente interpretato dai progettisti. A ciò si aggiunge la scelta di uniformare i materiali per le pavimentazioni e l’arredo urbano, attraverso i diversi comparti del quartiere, assicurando un elemento di continuità chiaramente percepibile pur nell’ampia diversificazione architettonica. Una rete puntuale di esercizi commerciali, collocati ai piani terreni degli edifici lungo strade e piazze, garantiscono ulteriormente la vitalità degli spazi. contesto geopolitico della globalizzazione? Ripensare l'avvento e le trasformazioni della metropoli diventa allora una mossa necessaria per riconoscere il presente e prefigurare il futuro. AA.VV., a cura di E. Rocca Estetica e architettura Il Mulino, Bologna, 2008 Da Kant a Derrida, da Schopenhauer a Heidegger, da Nietzsche a Ricoeur e a Vattimo, il volume presenta una serie di testi fondamentali per comprendere il rapporto tra l'estetica moderna e l'architettura. Nel percorso che l'architettura ha compiuto dalla nascita dell'estetica nel Settecento fino ai giorni nostri emerge come essa, inizialmente esclusa dalle "belle arti", e considerata gradino più basso tra le arti nella prima metà dell'Ottocento, assuma nel Novecento una nuova centralità per la riflessione estetica. Se da un lato l'architettura rischia così di diventare l'arte suprema dell'estetizzazione della quotidianità, e l'architetto l'erede della volgarizzazione del mito moderno del genio, dall'altro essa offre oggi all'estetica l'opportunità di ridefinire il proprio statuto, ripensando la questione dei bisogni dell'essere umano, e ripensando la stessa bellezza come un peculiare bisogno. L. Benevolo La fine della città Laterza, Bari, 2011 Il mio mestiere è l'architettura. Mi sembra più esatto dire così che non ‘faccio l'architetto', perché l'architettura è una cosa difficile da avvicinare e io ho tentato di farlo con vari mezzi: progettare edifici, disegnare piani regolatori, collaborare alla redazione di leggi, scrivere libri o articoli di giornale, insegnare la storia dell'architettura. Non ho potuto ancora scegliere di fare una sola di queste cose, perché lo scopo che questa disciplina si pone, vale a dire migliorare anche solo di poco l'ambiente fisico in cui vive la gente, è troppo importante e difficile per tentare di raggiungerlo in un unico modo. Qualche volta è possibile costruire un piccolo pezzo di questo ambiente in un contesto accettabile; qualche volta bisogna tentare di correggere questo contesto, cioè aiutare l'amministrazione pubblica a fare i piani urbanistici; qualche volta invece si scopre che occorre prima rifare le leggi; e qualche volta ancora che non si può fare nessuna di queste cose e dunque non resta che riflettere e scrivere. AA.VV., a cura di M. Vegetti Carocci Filosofie della metropoli Roma, 2009/2010 Che cos'è la città? Questa domanda risuona in Europa quando, dalle travolgenti trasformazioni della modernità, emergono i contorni inquietanti e misteriosi della metropoli. Per rispondere alla sua sfida i principali autori discussi in questo libro - Weber, Spengler, Simmel, Benjamin, Kracauer, Jùnger, Foucault, Deleuze, Derrida - sondano un campo di analisi rimosso dalla filosofia politica classica, che ha scelto lo Stato come suo oggetto privilegiato. Del resto, proprio quando la metropoli sembra realizzare il destino dell'Occidente, lo sfaldamento dei criteri politici e sociali della modernità pone una nuova questione: come interpretare il ruolo e il senso della città nel N. Emery L’architettura difficile Marinotti, Milano. 2007/2008 Oggi l'architettura riscuote un grande successo. È persino ovvio: più essa si spettacolarizza, e più essa viene spettacolarizzata. Ma proprio questo successo potrebbe essere l'indice di una crisi di senso. E una crisi di senso si apre quando una disciplina smarrisce le cause essenziali per cui essa esiste e per cui dovrebbe agire, progettare e costruire. Guardando una parte certo non minoritaria dell'architettura contemporanea, quella più gettonata sulle riviste di ogni genere, si ha l'impressione che l'architettura si esaurisca in un gioco di forme, rese sempre più insolite e quasi impenetrabili. Se non che tutte queste forme, proprio come quelle della moda, vanno presto incontro a una certa stanchezza e inflazionandosi si svalutano rapidamente. In questa situazione sembra più che opportuna una riflessione filosofica sugli scopi e sull'essenza del costruire. Una riflessione, come quella sviluppata in questo libro, che si confronta in modo serio e rigoroso con il significato attribuito all'architettura da Platone e da molti altri pensatori e artisti, in particolare Mondrian e Joseph Beuys. Ne risulta una sorta di mappa filosofica, necessaria oltre che per capire e criticare l'attualità, anche per cercare risposte progettuali migliori, provviste di senso e valore non effimero. L’anziano Platone, per chi smarriva lo scopo di preservare la salute dell’intero territorio e rincorreva esclusivamente l’interesse disciplinare privato invocava il controllo e la censura e talvolta finanche le “bastonate”… Probabilmente esagerava, ma oggi bisognerebbe cominciare a far scoprire in primo luogo la virtù dell’autocontrollo creativo, in vista di una decolonializzazione dello spazio. La libera ricerca estetica dovrebbe insomma andare di pari passo con la cura tesa a risolvere in maniera socialmente ed ideologicamente sostenibile l’organizzazione dello spazio inteso come fondamentale bene comune.
Scaricare