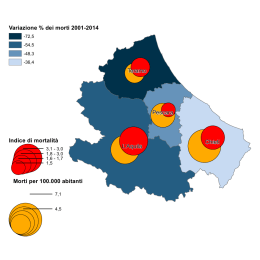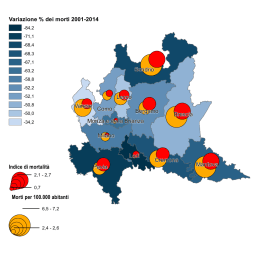Insegnare la Resistenza StoriaE – Anno 3 - n. 2 – Maggio 2005 Antologia di testi letterari Letteratura e Resistenza di Elena Farruggia Presentiamo, nel vasto panorama della letteratura su questo tema, la sintesi di un percorso di approfondimento realizzato in occasione del Cinquantenario della Resistenza dal prof. Rudi Zinelli in un progetto comune che ha coinvolto la V PD dell’ITC in lingua tedesca Kunter e la V AC dell’IPIA in lingua italiana Galilei nell’anno scolastico 1994-95. Il percorso (che nella sua completezza prevede anche una riflessione sul cinema) prende avvio dalla Prefazione di Calvino all’edizione del 1964 de Il sentiero dei nidi di ragno: L’esplosione letteraria di quegli anni in Italia […] fu un fatto fisiologico, esistenziale, collettivo. Avevamo vinto la guerra e noi più giovani - che avevamo fatto in tempo a fare il partigiano - […] sentivamo la vita come qualcosa che può ricominciare da zero. Molti racconti nacquero da quel clima. […] La voce anonima dell’epoca era più forte del singolo scrittore. […] L’essere usciti da un’esperienza -la guerra civile - che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva un’immediatezza di comunicazione tra lo scrittore e il suo pubblico. Si era tutti alla pari: carichi di storie da raccontare, ognuno aveva vissuto vite irregolari,drammatiche, avventurose, ci si strappava la parola di bocca. La rinata libertà di parlare fu per la gente subito smania di raccontare: nei treni che riprendevano a funzionare […] ogni passeggero raccontava le vicende che gli erano accorse. Ci muovevamo in un multicolore universo di storie. Chi cominciò a scrivere si trovò cosí a raccontare le stesse storie dell’anonimo narratore orale: alle storie che avevamo vissuto di persona […] si aggiungevano quelle che ci erano arrivate già come racconti […]. Durante la guerra partigiana le storie appena vissute si trasformavano e trasfiguravano in storie raccontate la notte attorno al fuoco,, acquistavano già uno stile, un linguaggio, un umore come di bravata [….] Il neorealismo non fu una scuola. […] Fu un insieme di voci -in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse Italie, anche – o specialmente – delle Italie più inedite per la letteratura […]. La Resistenza rappresentò la fusione tra paesaggio e persone. Fu da questa possibilità di collocare storie umane nei paesaggi che nacque il neorealismo. […] Al tempo del “Sentiero dei nidi di Ragno”, creare una “letteratura della resistenza” era ancora un problema aperto, scrivere il “romanzo della resistenza” si poneva come un imperativo; a due mesi dalla Liberazione c’era già “Uomini e no” di Vittorini nelle vetrine. […] Noi che eravamo stati partigiani di montagna volevamo il nostro romanzo. Su queste considerazioni si innestano una serie di letture (qui ridotte rispetto al progetto originale) che ci danno conto di come, negli anni - o meglio nei mesi - immediatamente successivi alla fine della guerra, le esperienze della lotta partigiana venissero trascritte in una forma letteraria che, semplificata col termine di “neorealismo”, comprendeva in realtà stili e scelte narratologiche molto differenti, collegate tra loro però da un “comune sentire”. Vittorini, in Uomini e no, tenta di unire l’oggettività storica e la sua ispirazione lirica, senza capire che quest’ultima è un limite nei confronti della prima. Nel titolo stesso poi c’è già l’atteggiamento retorico che appare chiaro nell’episodio dei Morti di Largo Augusto: gli uomini (i partigiani) che sono dalla parte giusta capiscono tutto; gli altri, gli oppressori, sono il Lupo, il Male, che colpisce l’umanità nei suoi punti più deboli (le donne, i vecchi, i ragazzi, le bambine) non rispettando neppure la dignità della morte. Pavese non riesce a essere totalmente oggettivo in quanto le “sue” Langhe non sono reali, ma sono riviste come un luogo mitico, in cui lo scrittore, incapace di partecipare attivamente alla resistenza, cerca di superare almeno la visione retorica (alla 49. Da sinistra a destra: Fenoglio, Vittorini, StoriaE rivista di storia e didattica della storia. Sovrintendenza Scolastica Bolzano. www.emscuola.org/labdoc storia/storiae 33 storiae Vittorini) ponendosi di fronte ai morti (tutti, anche quelli nemici) con un bisogno di capire, di giustificare quelle morti: solo realizzando gli ideali per cui si è combattuto, sostiene l’autore, si potranno giustificare le morti e la guerra civile. Così, la guerra è finita solo per i morti; per i vivi continuerà il peso dei morti finché non si realizzeranno gli ideali per cui si è combattuto. Calvino stesso, cercando di uscire dalla retorica con la scelta della resistenza vista da un bambino (Il sentiero dei nidi di ragno, Ultimo viene il corvo) ne dà un’immagine favolistica che allontana gli aspetti drammatici. Fenoglio realizza le fusione paesaggio-uomo. Milton conduce la sua guerra infangato, infreddolito, bagnato; il paesaggio delle Langhe, le colline da scavalcare, i fiumi da guadare perché i ponti sono minati, la nebbia che avvolge tutto (e permette ai repubblichini di catturare Giorgio), la paura di un altro inverno di guerra, sono i veri, mille ostacoli che i partigiani affrontavano nella loro guerriglia di montagna. Ma appunto Milton conduce la sua guerra; nel racconto via via si perde il motivo comune, e predomina la “questione privata”. Il personaggio letterario, il romanzo classico, così, in Fenoglio si fondono strettamente con la realtà, ci danno uno “spaccato” della resistenza che esce dalla retorica, dalla mitizzazione e che diventa davvero una questione “umana”. Uomini e no Elio Vittorini I morti al Largo Augusto non erano cinque soltanto; altri ve n’erano sul marciapiede dirimpetto; e quattro erano sul corso di Porta Vittoria; sette erano nella piazza delle Cinque Giornate, ai piedi del monumento. Cartelli dicevano dietro ogni fila di morti: Passati per le armi. Non dicevano altro, anche 34 storiae i giornali non dicevano altro, e tra i morti erano due ragazzi di quindici anni. C’era anche una bambina, c’erano due donne e un vecchio dalla barba bianca. La gente andava per il Largo Augusto e il corso di Porta Vittoria fino a piazza delle Cinque Giornate, vedeva i morti al sole su un marciapiede, i morti all’ombra su un altro marciapiede, poi i morti sul corso, i morti sotto il monumento, e non aveva bisogno di sapere altro. Guardava le facce morte, i piedi ignudi, i piedi nelle scarpe, guardava le parole dei cartelli, guardava i teschi con le tibie incrociate sui berretti degli uomini di guardia, e sembrava che comprendesse ogni cosa. Come? Anche quei due ragazzi di quindici anni? Anche la bambina? Ogni cosa? Per questo, appunto, sembrava anzi che comprendesse ogni cosa. Nessuno si stupiva di niente. Nessuno domandava spiegazioni. E nessuno si sbagliava. C’era, tra la gente, il Gracco. C’erano Orazio e Metastasio; Scipione; Mambrino. Ognuno era per suo conto, come ogni uomo ch’era nella folla. C’era Barca Tartaro. Passò, un momento, anche El Paso. C’era Figlio-di-Dio. E c’era Enne 2. Essi, naturalmente, comprendevano ogni cosa; anche il perché delle donne, della bambina, del vecchio, dei due ragazzi; ma ogni uomo ch’era nella folla sembrava comprendere come ognuno di loro: ogni cosa. Perché? il Gracco diceva. Una delle due donne era avvolta nel tappeto di un tavolo. L’altra, sotto il monumento, sembrava che fosse cresciuta, dopo morta, dentro il suo vestito a pallini: se lo era aperto lungo il ventre e le cosce, dal seno alle ginocchia; e ora lasciava vedere il reggicalze rosa, sporco di vecchio sudore, con una delle giarrettiere che pendeva attraverso la coscia dove avrebbe dovuto avere le mutandine. Perché quella donna nel tappeto? Perché quell’altra? E perché la bambina? Il vecchio? I due ragazzi? II vecchio era ignudo, senz’altro che la lunga barba bianca a coprire qualcosa di lui, il colmo del petto; stava al centro dei sette allineati ai piedi del monumento, non segnato da proiettili, ma livido nel corpo ignudo, e le grandi dita dei piedi nere, le nocche alle mani nere, le ginocchia nere, come se lo avessero colpito, così nudo, con armi avvelenate di freddo. I due ragazzi, sul marciapiede all’ombra di Largo Augusto, erano invece sotto una coperta. Una in due, e stavano insieme, nudi i piedi fuori della coperta, e in faccia serii, non come morti bambini, con paura, con tristezza, ma serii da grandi, come i morti grandi vicino ai quali si trovavano. E perché, loro? Il Gracco vide, dove lui era, Orazio e Metastasio. Con chi aveva parlato, nella vigilia nell’automobile, di loro due? Con l’uno o l’altro, egli aveva parlato tutta la sera, sempre conversava con chi si incontrava, e ora lo stesso parlava, conversava, come tra un uomo e un uomo si fa, o come un uomo fa da solo, di cose che sappiamo a cui pur cerchiamo una risposta nuova, una risposta strana, una svolta di parole che cambi il corso, in un modo o in un altro, della nostra consapevolezza. Li guardò, dal lato suo dell’angolo che passava attraverso i morti, e una piccola ruga venne, rivolta a loro insieme allo sguardo, in mezzo alle labbra di quella sua faccia dalle tempie bianche. Orazio e Metastasio gli risposero quasi nello stesso modo. Come se lui avesse chiesto: E perché loro? Mossero nello stesso modo la faccia, e gli rimandarono la domanda: E perché loro? Ma c’era anche la bambina. Più giù, tra i quattro del corso, dagli undici o dodici anni che aveva, mostrava anche lei la faccia adulta, non di morta bambina, come se nel breve tempo che l’avevano presa e messa al muro avesse di colpo fatta la strada che la separava dall’essere adulta. La sua testa era piegata verso l’uomo morto al suo fianco, quasi recisa nel collo dalla scarica dei mitragliatori e i suoi capelli stavano nel sangue raggrumati, la sua faccia guardava seria la seria faccia dell’uomo che pendeva un poco dalla parte di lei. Perché lei anche? Gracco vide passare un altro degli uomini che aveva conosciuto la sera prima, il piccolo Figliodi-Dio, e fu un minuto con lui nella sua conver- 51 sazione eterna. Rivolse a lui il movimento della sua faccia, quella ruga improvvisa in mezzo alle labbra, quel suo sguardo d’uomo dalle tempie bianche; e Figlio-di-Dio fece per avvicinarglisi. Ma poi restò dov’era. Perché lei? il Gracco chiedeva. E Figlio-di-Dio rispose nello stesso modo, guardandolo. Gli rimandò lui pure: la domanda: Perché lei? Perché? la bambina esclamò. Come perché? Perché sì! Tu lo sai e tutti lo sapete. Tutti lo sappiamo. E tu lo domandi? Essa parlò con l’uomo morto che gli era accanto. Lo domandano, gli disse. Non lo sanno? Si, sì, l’uomo rispose. Io lo so. Noi lo sappiamo. Ed essi no? la bambina disse. Essi pure lo sanno. Vero, disse il Gracco. Egli lo sapeva, e i morti glielo dicevano. Chi aveva colpito non poteva colpire di più nel segno. In una bambina e in un vecchio, in due ragazzi di quindici anni, in una donna, in un’altra donna: questo era il modo migliore di colpir l’uomo. Colpirlo dove l’uomo era più debole, dove aveva l’infanzia, dove aveva la vecchiaia, dove aveva la sua costola staccata e il cuore scoperto: dov’era più uomo. Chi aveva colpito voleva essere il lupo, far paura all’uomo. Non voleva fargli paura? E questo modo di colpire era il migliore che credesse di avere il lupo per fargli paura. Però nessuno, nella folla, sembrava aver paura. La casa in collina Cesare Pavese Niente è accaduto. Sono a casa da sei mesi, e la guerra continua. Anzi, adesso che il tempo si guasta, sui grossi fronti gli eserciti sono tornati a trincerarsi, e passerà un altro inverno, rivedremo la neve, faremo cerchio intorno al fuoco ascoltando la radio. Qui sulle strade e nelle vigne la fanghiglia di novembre comincia a bloccare le bande; quest’inverno, lo dicono tutti, nessuno avrà voglia di combattere, sarà già duro essere al mondo e aspettarsi di morire in primavera. Se poi, come dicono, verrà molta neve, verrà anche quella dell’anno passato e tapperà porte e finestre, ci sarà da sperare che non disgeli mai più. Abbiamo avuto dei morti anche qui. Tolto questo e gli allarmi e le scomode fughe nelle forre dietro i beni (mia sorella o mia madre che piomba a svegliarmi, calzoni e scarpe afferrati a casaccio, corsa aggobbita attraverso la vigna, e l’attesa, l’attesa avvilente), tolto il fastidio e la vergogna, niente accade. Sui colli, sul ponte di ferro, durante settembre non è passato giorno senza spari - spari isolati, come un tempo in stagione di caccia, oppure rosari di raffiche. Ora si vanno diradando. Quest’è davvero la vita dei boschi come si sogna da ragazzi. E a volte penso 35 storiae se non fosse che la guerra ce la siamo covata nel cuore noialtri - noi non più giovani, noi che abbiamo detto « Venga dunque se deve venire» - anche la guerra, questa guerra, sembrerebbe una cosa pulita. Del resto chi sa. Questa guerra ci brucia le case. Ci semina di morti fucilati piazze e strade. Ci caccia come lepri di rifugio in rifugio. Finirà per costringerci a combattere anche noi, per strapparci un consenso attivo. E verrà il giorno che nessuno sarà fuori della guerra - né i vigliacchi, né i tristi, né i soli. Da quando vivo qui coi miei, ci penso spesso. Tutti avremo accettato di far la guerra. E allora forse avremo pace. […] E’ qui che la guerra mi ha preso, e mi prende ogni giorno. Se passeggio nei boschi, se a ogni sospetto di rastrellatori mi rifugio nelle forre, se a volte discuto coi partigiani di passaggio (anche Giorgi c’è stato, coi suoi: drizzava il capo e mi diceva: «Avremo tempo le sere di neve a riparlarne»), non è che non veda come la guerra non è un gioco, questa guerra che è giunta fin qui, che prende alla gola anche il nostro passato. Non so se Cate, Fonso, Dino, e tutti gli altri, torneranno. Certe volte lo spero, e mi fa paura. Ma ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini. Sono questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta e si ha paura a scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno, che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce a questo sangue, giustificare chi l’ha sparso. Guardare certi morti è umiliante. Non sono più faccenda altrui; non ci si sente capitati sul posto per caso. Si ha l’impressione che lo stesso destino che ha messo a terra quei corpi, tenga noialtri inchiodati a vederli, a riempircene gli occhi. Non è paura, non è la solita viltà. Ci si sente umiliati perché si capisce - si tocca con gli occhi - che al posto del morto potremmo essere noi: non ci sarebbe differenza, e se viviamo lo dobbiamo al cadavere imbrattato. Per questo ogni guerra è una guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede ragione. […] Io non credo che possa finire. Ora che ho visto cos’è guerra, cos’è guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbe chiedersi: - E dei caduti che facciamo? perché sono morti? -Io non saprei cosa rispondere. Non adesso, almeno. Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero. Ultimo viene il corvo Italo Calvino La corrente era una rete di increspature leggere e trasparenti, con in mezzo l’acqua che andava. Ogni tanto c’era come un battere d’ali d’argento a fior d’acqua: il lampeggiare del dorso di una trota che riaffondava subito a zig-zag. - C’è pieno di trote, - disse uno degli uomi- 36 storiae 52 ni. - Se buttiamo dentro una bomba vengono tutte a galla a pancia all’aria, - disse l’altro; si levò una bomba dalla cintura e cominciò a svitare il fondello. Allora s’avanzò il ragazzo che li stava a guardare, un ragazzotto montanaro, con la faccia a mela. - Mi dai, - disse e prese il fucile a uno di quegli uomini. - Cosa vuole questo? - disse l’uomo e voleva togliergli il fucile. Ma il ragazzo puntava l’arma sull’acqua come cercando un bersaglio. «Se spari in acqua spaventi i pesci e nient’altro», voleva dire l’uomo ma non finì neanche. Era affiorata una trota, con un guizzo, e il ragazzo le aveva sparato una botta addosso, come l’aspettasse proprio lì. Ora la trota galleggiava con la pancia bianca. - Cribbio, - dissero gli uomini. Il ragazzo ricaricò l’arma e la girò intorno. L’aria era tersa e tesa: si distinguevano gli aghi sui pini dell’altra riva e la rete d’acqua della corrente. Una increspatura saettò alla superficie: un’altra trota. Sparò: ora galleggiava morta. Gli uomini guardavano un po’ la trota un po’ lui. - Questo spara bene, - dissero. Il ragazzo muoveva ancora la bocca del fucile in aria. Era strano, a pensarci, essere circondati così d’aria, separati da metri d’aria dalle altre cose. Se puntava il fucile invece, l’aria era una linea diritta ed invisibile, tesa dalla bocca del fucile alla cosa, al falchetto che si muoveva nel cielo con le ali che sembravano ferme. A schiacciare il grilletto l’aria restava come prima trasparente e vuota, ma lassú all’altro capo della linea il falchetto chiudeva le ali e cadeva come una pietra. Dall’otturatore aperto usciva un buon odore di polvere. Si fece dare altre cartucce. Erano in tanti ormai a guardarlo, dietro di lui in riva al fiumicello. Le pigne in cima agli alberi dell’altra riva perché si vedevano e non si potevano toccare? Perché quella distanza vuota tra lui e le cose? Perché le pigne che erano una cosa con lui, nei suoi occhi, erano invece là, distanti? Però se puntava il fucile la distanza vuota si capiva che era un trucco; lui toccava il grilletto e nello stesso momento la pigna cascava, troncata al picciolo. Era un senso di vuoto come una carezza: quel vuoto della canna del fucile che continuava attraverso l’aria e si riempiva con lo sparo, fin laggiú alla pigna, allo scoiattolo, alla pietra bianca, al fiore di papavero. - Questo non ne sbaglia una, - dicevano gli uomini e nessuno aveva il coraggio di ridere. - Tu vieni con noi, - disse il capo. - E voi mi date il fucile, - rispose il ragazzo. - Ben. Si sa. Andò con loro. Partì con un tascapane pieno di mele e due forme di cacio. Il paese era una macchia d’ardesia, paglia e sterco vaccino in fondo alla valle. Andare via era bello perché a ogni svolta si vedevano cose nuove, alberi con pigne, uccelli che volavano dai rami, licheni sulla pietre, tutte cose nel raggio delle distanze finte, delle distanze che lo sparo riempiva inghiottendo l’aria in mezzo. Non si poteva sparare però, glielo dissero: erano posti da passarci in silenzio e le cartucce servivano per la guerra. Ma a un certo punto un leprotto spaventato dai passi traversò il sentiero in mezzo al loro urlare e armeggiare. Stava già per scomparire nei cespugli quando lo fermò una botta del ragazzo. - Buon colpo, - disse anche il capo, - però qui non siamo a caccia. Vedessi anche un fagiano non devi più sparare. Non era passata un’ora che nella fila si sentirono altri spari. - È il ragazzo di nuovo! - s’infuriò il capo e andò a raggiungerlo. Lui rideva, con la sua faccia bianca e rossa, a mela. - Pernici, - disse, mostrandole. Se n’era alzato un volo da una siepe. - Pernici o grilli, te l’avevo detto. Dammi il fucile. E se mi fai imbestialire ancora torni al paese. Il ragazzo fece un po’ il broncio; a camminare disarmato non c’era gusto, ma finché era con loro poteva sperare di riavere il fucile. La notte dormirono in una baita da pastori. Il ragazzo si svegliò appena il cielo schiariva, mentre gli altri dormivano. Prese il loro fucile piú bello, riempí il tascapane di caricatori e uscí. C’era un’aria timida e tersa, da mattina presto. Poco discosto dal casolare c’era un gelso. Era l’ora in cui arrivavano le ghiandaie. Eccone una: sparò, corse a raccoglierla e la mise nel tascapane. Senza muoversi dal punto dove l’aveva raccolta cercò un altro bersaglio: un ghiro! Spaventato dallo sparo, correva a rintanarsi in cima ad un castagno. Morto era un grosso topo con la coda grigia che perdeva ciuffi di pelo a toccarla. Da sotto il castagno vide, in un prato piú basso, un fungo, rosso coi punti bianchi, velenoso. Lo sbriciolò con una fucilata, poi andò a vedere se proprio l’aveva preso. Era un bel gioco andare cosí da un bersaglio all’altro: forse si poteva fare il giro del mondo. Vide una grossa lumaca su una pietra, mirò il guscio e raggiunto il luogo non vide che la pietra scheggiata, e un po’ di bava iridata. Cosí s’era allontanato dalla baita, giú per prati sconosciuti. Dalla pietra vide una lucertola su un muro, dal muro una pozzanghera e una rana, dalla pozzanghera un cartello sulla strada, bersaglio facile. Dal cartello si vedeva la strada che faceva zig-zag e sotto: sotto c’erano degli uomini in divisa che avanzavano ad armi spianate. All’apparire del ragazzo col fucile che sorrideva con quella faccia bianca e rossa, a mela, gridarono e gli puntarono le armi addosso. Ma il ragazzo aveva già visto dei bottoni d’oro sul petto di uno di quelli e fatto fuoco mirando a un bottone. Sentí l’urlo dell’uomo e gli spari a raffiche o isolati che gli fischiavano sopra la testa: era già steso a terra dietro un mucchio di pietrame sul 53 37 storiae ciglio della strada, in angolo morto. Poteva anche muoversi, perché il mucchio era lungo, far capolino da una parte inaspettata, vedere i lampi alla bocca delle armi dei soldati, il grigio e il lustro delle loro divise, tirare a un gallone, a una mostrina. Poi a terra e lesto a strisciare da un’altra parte a far fuoco. Dopo un po’ sentí raffiche alle sue spalle, ma che lo sopravanzavano e colpivano i soldati: erano i compagni che venivano di rinforzo coi mitragliatori. - Se il ragazzo non ci svegliava coi suoi spari, - dicevano. Il ragazzo, coperto dal tiro dei compagni, poteva mirare meglio. Ad un tratto un proiettile gli sfiorò una guancia. Si volto: un soldato aveva raggiunto la strada sopra di lui. Si buttò in una cunetta, al riparo, ma intanto aveva fatto fuoco e colpito non il soldato ma di striscio il fucile, alla cassa. Sentí che il soldato non riusciva a ricaricare il fucile, e lo buttava in terra. Allora il ragazzo sbucò e sparò sul soldato che se la dava a gambe: gli fece saltare una spallina. L’inseguí. Il soldato ora spariva nel bosco ora riappariva a tiro. Gli bruciò il cocuzzolo dell’elmo, poi un passante della cintura. Intanto inseguendosi erano arrivati in una valletta sconosciuta, dove non si sentiva piú il rumore della battaglia. A un certo punto il soldato non trovò piú bosco davanti a sé, ma una radura, con intorno dirupi fitti di cespugli. Ma il ragazzo stava già per uscire dal bosco: in mezzo alla radura c’era una grossa pietra: il soldato fece appena in tempo a rimpiattarcisi dietro, rannicchiato con la testa tra i ginocchi. Là per ora si sentiva al sicuro: aveva delle bombe a mano con sé e il ragazzo non poteva avvicinarglisi ma solo fargli la guardia a tiro di fucile, che non scappasse. Certo, se avesse potuto con un salto raggiungere i cespugli, sarebbe stato sicuro, scivolando per il pendio fitto. Ma c’era quel tratto nudo da traversare: fin quando sarebbe rimasto lì il ragazzo? E non avrebbe mai smesso di tenere l’arma puntata? Il soldato decise di fare una prova: mise l’elmo sulla punta della baionetta e gli fece far capolino fuori dalla pietra. Uno sparo, e l’elmo rotolò per terra, sforacchiato. Il soldato non si perse d’animo; certo mirare lí intorno alla pietra era facile, ma se lui si muoveva rapidamente sarebbe stato impossibile prenderlo. In quella un uccello traversò il cielo veloce, forse un galletto di marzo. Uno sparo e cadde. Il soldato si asciugò il sudore dal collo. Passò un altro uccello, una tordella: cadde anche quello. Il soldato in- 38 storiae ghiottiva saliva. Doveva essere un posto di passo, quello: continuavano a volare uccelli, tutti diversi e quel ragazzo a sparare e farli cadere. Al soldato venne un’idea: «Se lui sta attento agli uccelli non sta attento a me. Appena tira io mi butto». Ma forse prima era meglio fare una prova. Raccattò l’elmo e lo tenne pronto in cima alla baionetta. Passarono due uccelli insieme, stavolta: beccaccini. Al soldato rincresceva sprecare un’occasione cosí bella per la prova, ma non si azzardava ancora. Il ragazzo tirò a un beccaccino, allora il soldato sporse l’elmo, sentí lo sparo e vide l’elmo saltare per aria. Ora il soldato sentiva un sapore di piombo in bocca; s’accorse appena che anche l’altro uccello cadeva a un nuovo sparo. Pure non doveva fare gesti precipitosi: era sicuro dietro quel masso, con le sue bombe a mano. E perché non provava a raggiungere il ragazzo con una bomba, pur stando nascosto? Si sdraiò schiena a terra, allungò il braccio dietro a sé, badando a non scoprirsi, radunò le forze e lanciò la bomba. Un bel tiro; sarebbe andata lontano; però a metà della parabola una fucilata la fece esplodere in aria. Il soldato si buttò faccia a terra perché non gli arrivassero schegge. Quando rialzò il capo era venuto il corvo. C’era nel cielo sopra di lui un uccello nero che volava a giri lenti, un corvo forse. Adesso certo il ragazzo gli avrebbe sparato. Ma lo sparo tardava a farsi sentire. Forse il corvo era troppo alto? Eppure ne aveva colpito di piu alti e veloci. Alla fine una fucilata: adesso il corvo sarebbe caduto, no, continuava a girare lento, impassibile. Cadde una pigna, invece, da un pino lí vicino. Si metteva a tirare alle pigne, adesso? A una a una colpiva le pigne che cascavano con una botta secca. A ogni sparo il soldato guardava il corvo: cadeva? No, l’uccello nero girava sempre piú basso sopra di lui. Possibile che il ragazzo non lo vedesse? Forse il corvo non esisteva, era una sua allucinazione. Forse chi sta per morire vede passare tutti gli uccelli: quando vede il corvo vuol dire che è l’ora. Pure, bisognava avvertire il ragazzo che continuava a sparare alle pigne. Allora il soldato si alzò in piedi e indicando l’uccello nero col dito, - Là c’è il corvo! - gridò, nella sua lingua. Il proiettile lo prese giusto in mezzo a un’aquila ad ali spiegate che aveva ricamato sulla giubba. Il corvo s’abbassava lentamente, a giri. Una questione privata Beppe Fenoglio Verso le dieci di notte, Milton, anziché riessere a Treiso con Leo, era in un casale sperduto alle falde della immensa collina che dà su Santo Stefano e Canelli, a due ore di cammino da Treiso. Nel buio la casa l’aveva trovata a tentoni, ma 55 la conosceva a memoria. Era bassa e sbilenca come se si fosse ricevuta sul tetto una tremenda manata e non si fosse mai più riassestata. Era grigia del medesimo grigio del tufo del vallone, con finestrelle slabbrate e quasi tutte mascherate da assiti fradici per le intemperie, con un ballatoio di legno anch’esso marcio e rattoppato con parti di latte da petrolio. Un’ala era diroccata e le macerie si ammucchiavano intorno al tronco di un ciliegio selvatico. L’unico sorriso lo faceva, quella casa, dalla parte del tetto rimessa a nuovo, ma faceva senso, come un garofano rosso infilato nei capelli di una vecchia megera. Milton fumava e guardava fisso il magro fuoco di tutoli di meliga, dando le spalle alla vecchia che stava affondando i piatti della cena in una conca di acqua fredda. [..] Senza girar gli occhi la vecchia gli disse: - Tu hai la febbre. Non alzar le spalle. La febbre non vuole che le si alzino le spalle. Ne hai appena un’oncia, ma ce l’hai. A ogni boccata Milton tossiva o si sforzava convulsivamente di soffocare la tosse. La donna riprese: - Stavolta ti ho fatto mangiar male. - Oh no! - disse Milton vivamente. - Mi avete dato un uovo! - Questo fuoco di tutoli non scalda, eh? Ma la legna va risparmiata. L’inverno sarà lunghissimo. Milton annuì con le spalle. - Sarà l’inverno più lungo da che mondo è mondo. Sarà un inverno di sei mesi. - Perché di sei mesi? - Non avrei mai creduto che avremmo dovuto passare un secondo inverno. Nessuno venga a dirmi che lui l’aveva previsto o gli dò in faccia del bugiardo e del millantatore -. Si voltò a metà verso la vecchia e aggiunse: - L’altro inverno avevo un bellissimo pellicciotto di agnello. Verso la metà di aprile lo buttai via, sebbene fosse bellissimo e sebbene il cuore mi si stringa sempre un po’ al buttar via la mia roba. [..] Quel pellicciotto lo buttai dietro una siepe, dalle parti di Murazzano. Allora ero convinto che prima del nuovo freddo avremmo avuto tutto il tempo di rovesciarne due di fascismi - E invece? Invece quando sarà finita? Quando potremo dire fi-ni-ta? - Maggio. - Maggio!? - Ecco perché ho detto che l’inverno durerà sei mesi. - Maggio, - ripeté la donna a se stessa. - Certo che è terribilmente lontano, ma almeno, detto da un ragazzo serio e istruito come te, è un termine. E’ solo di un termine che ha bisogno la povera gente! Da stasera voglio convincermi che a partire da maggio i nostri uomini potranno andare alle fiere e ai mercati come una volta, senza morire per la strada. La gioventù potrà ballare all’aperto, le donne giovani resteranno incinte volentieri, e noi vecchie potremo uscire sulla nostra aia senza la paura di trovarci un forestiero armato. E a maggio, le sere belle, potremo uscire fuori e per tutto divertimento guardarci e goderci l’illuminazione dei paesi. Mentre la donna parlava, descriveva l’estate della pace, una smorfia dolorosa si disegnò e fermò sulla faccia di Milton. Senza Fulvia non sarebbe estate per lui, sarebbe stato l’unico al mondo a sentir freddo in quella piena estate. CALVINO I., Ultimo viene il corvo, Einaudi, Torino 1949. FENOGLIO B., Una questione privata, Einaudi, Torino 1963. PAVESE C., La casa in collina, Einaudi, Torino 1948. VITTORINI E., Uomini e no, Bompiani, Milano 1945. 50. - 55. Acquarelli originali di Maria Lenar- 39 storiae
Scaricare