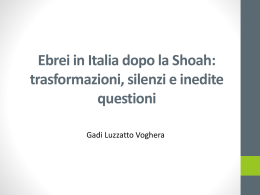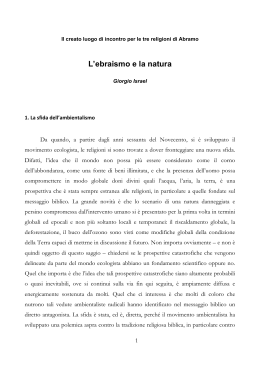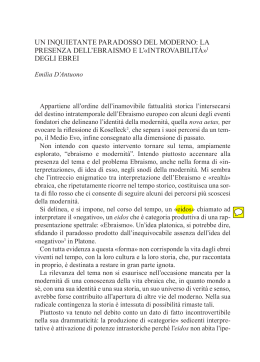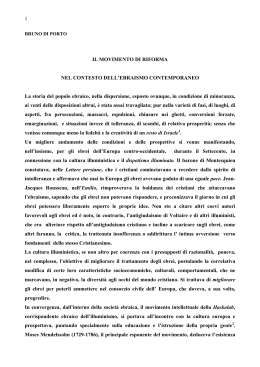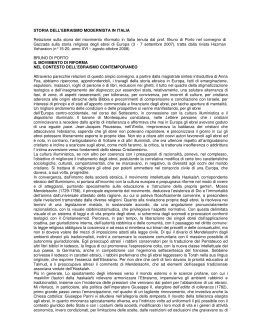Fiona Diwan: “L’ebraismo è costruzione mai finita...” Milano, maggio 2002 Come sei arrivata nella tua posizione? «Potrei rispondere che ci sono arrivata per caso, come spesso accadono le cose, anche quelle importanti. Ma tutti sappiamo che non c’è nulla di meno casuale del caso. Tutto obbedisce a una logica a volte evidente a volte occulta. Insomma si diventa sempre, presto o tardi, quello che si è. Per quanto mi riguarda ho fatto per dieci anni l’inviato speciale occupandomi di attualità, inchieste, cultura, politica.... Nulla di più naturale, quindi, che l’approdo a una rivista come Gulliver: un magazine che ha come “mission” editoriale quella di declinare viaggi e modernità, spirito contemporaneo e tempo libero, nuove mete e antropologia, stili di vita con la cultura, le tendenze... Certo, mi piaceva molto scrivere articoli ma amo molto anche fare il direttore e pensare a un giornale nella sua interezza, nel suo disegno complessivo. Diciamo che se prima facevo la “solista” suonando un solo strumento, oggi faccio un lavoro che somiglia di più a quello del direttore d’orchestra: continuando con la metafora musicale, decido i brani e gli strumenti più adatti per comporre la partitura che di volta in volta verrà “suonata” sul giornale. E questo è entusiasmante». Che cosa lega te e il tuo lavoro all’ebraismo? «Questa è una bella domanda. Difficile. Credo che sia un fatto sottile, qualcosa che ha a che fare più con un atteggiamento critico, diciamo disincantato, che non con qualcosa di preciso e concreto. L’ebraismo mi ha regalato “uno sguardo dal ponte”, una visione più a distanza delle cose. È un’attitudine: cercare di non prendersi troppo sul serio, trovare sempre il lato umoristico delle cose, anche quando sono drammatiche, mai tradire una vocazione “morale” o una dimensione di “impegno”, come si diceva una volta. Il giornalismo è prima di tutto comunicazione: in questo caso si tratta allora di comunicare agli altri, sul giornale quando è il caso di farlo (magari con servizi ad hoc) ma anche ai colleghi, nel mondo del lavoro e delle relazioni day by day, che cosa voglia dire essere ebreo e che cos’è l’ebraismo, così poco conosciuto e su cui banalità, luoghi comuni e ovvietà si sprecano, credetemi, a tutti i livelli dell’interlocutore: medio, basso o alto». Qual è il legame tra il tuo senso della famiglia e l’ebraismo? «La famiglia è per me l’ambito in cui più di si dispiega l’ebraismo, è la pienezza, la realizzazione tangibile del mio essere ebrea. Ad esempio cerco il più possibile di fare kabbalat shabbat il venerdì sera e di arrivare più presto rispetto alle altre giornate di lavoro. Passo ore con le mie figlie a leggere dei midrashim che mi hanno particolarmente colpito o entusiasmato e loro sanno che la mamma va, un giorno la settimana, da un maestro per studiare la Torah. L’ebraismo è studio, costruzione mai finita di una identità su cui tornare e ritornare in una perenne interrogazione, capacità e volontà di trasmettere non solo la memoria storica ma anche la lezione dei nostri maestri come una linfa viva a cui attingere sempre, e sempre suscettibile di essere reinterpretata, rivisitata. Ma l’ebraismo è per me soprattutto una cosa: amore per la vita come valore supremo, amore per la vita che poi altro non è che amore per il divino. E lo dico anche a rischio di sembrare ovvia o scontata. Edmond Jabès, un poeta contemporaneo che ha attraversato tutti gli orrori del secolo passato, ebreo nato al Cairo nel 1912 fuggito dall’Egitto nel 1957 e morto a Parigi nel 1991, scrive nel Libro delle Interrogazioni: “Distruggeremo la porta per arrivare alla porta? Calpesteremo l’erba per arrivare al fiore? Abbatteremo il tronco per arrivare ai rami? Spezzeremo il ginocchio per arrivare alle spalle?... La morte è la monotona ascesa della morte”. Ecco, dice Jabès, tutto questo non è mai stato né sarà mai l’ebraismo. Tutto questo è l’antitesi della nostra tradizione. Da non dimenticare, dico io. Specie di questi tempi.»
Scaricare