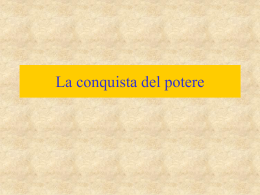SENTIERI
DELLA
I SENTIERI DELLA RICERCA
rivista di storia contemporanea
EDIZIONI CENTRO STUDI PIERO GINOCCHI CRODO
2
I Sentieri della Ricerca
è una pubblicazione del Centro Studi Piero Ginocchi, Crodo.
Direttore
Angelo Del Boca
Condirettori
Giorgio Rochat, Nicola Labanca
Redattrice
Severina Fontana
Comitato scientifico
Aldo Agosti, Mauro Begozzi, Shiferaw Bekele, Gian Mario Bravo, Marco
Buttino, Giampaolo Calchi Novati, Vanni Clodomiro, Basil Davidson,
Jacques Delarue, Angelo d’Orsi, Nuruddin Farah, Edgardo Ferrari, Mimmo
Franzinelli, Sandro Gerbi, Mario Giovana, Claudio Gorlier, Mario Isnenghi,
Lutz Klinkhammer, Nicola Labanca, Vittorio Lanternari, Marco Lenci, Aram
Mattioli, Gilbert Meynier, Pierre Milza, Renato Monteleone, Marco Mozzati, Richard Pankhurst, Giorgio Rochat, Massimo Romandini, Alain Rouaud,
Alberto Sbacchi, Gerhard Schreiber, Enrico Serra, Christopher SetonWatson, Francesco Surdich, Nicola Tranfaglia, Bahru Zewde
3
La rivista esce in fascicoli semestrali
Direttore Angelo Del Boca
Editrice: Centro Studi Piero Ginocchi
Via Pellanda, 15 - 28862 Crodo (VB)
Redazione e stampa: Coop. Vicolo del Pavone
Via Giordano Bruno, 6 - 29100 Piacenza
N. 2 - II Sem. 2005 Numero di registrazione presso il Tribunale di Verbania: 8, in data 9 giugno 2005
Poste italiane spa
Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1
Prezzo di copertina euro 12,00
Abbonamento annuale euro 20,00
Abbonamento sostenitore euro 100
C.C.P. n. 14099287 intestato al Centro Studi Piero Ginocchi
via Pellanda, 15 - 28862 Crodo (VB)
causale abbonamento: ISDR
La pubblicazione di questa rivista
è stata possibile grazie al generoso contributo di:
Provincia
Verbano Cusio Ossola
4
Comune di Crodo
BANCA POPOLARE DI INTRA
Sommario
editoriale
7
Un appello ai lettori
di Angelo Del Boca
storia locale
11
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
di Filippo Colombara
49
Le cartoline e i francobolli delle brigate garibaldine in Valsesia
di Edgardo Ferrari
storia nazionale
55
Il peso della storia.
La memoria della Resistenza nell'Italia repubblicana
di Giovanni A. Cerutti
79
Le istituzioni militari e la loro evoluzione nella società italiana
contemporanea
di Luigi Caligaris
Africa e dintorni
87
L’apartheid nell’Italia fascista
di Aram Mattioli
109 L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo.
Tra organizzazione del consenso, disciplinamento del tempo libero e
«prestigio di razza»
di Gianluca Gabrielli
137 L’Algeria di Alexis de Tocqueville.
Soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
di Domenico Letterio
5
167 I nove capi storici algerini del 1954
di Gilbert Meynier
studi sull’europa
179 Il gioco degli specchi deformanti:
stereotipi e autostereotipi tra Italia e Germania
di Giorgio Novello
terrorismo, nuove guerre, genocidi
201 Terrorismo, guerriglia, resistenza:
considerazioni per un dibattito attuale
di Mario Giovana
209 Nuove guerre?
Crisi dello Stato, mercenari, criminalità, interventi umanitari:
uno sguardo d’insieme
di Andrea Beccaro
237 Notizie da un genocidio lontano.
La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
di Chiara Calabri
271 Tra l’incudine araba e il martello israeliano.
La quarantennale lotta di Yâsir ’Arafât
e del movimento di liberazione palestinese
di Stefano Fabei
rassegna bibliografica
287 L’Italia fascista contro tutti
in un ventennio di guerre dissennate
di Angelo Del Boca
291 La fiaba vera e triste della «principessa etiope»
di Nicola Labanca
297 Schede di Angelo Del Boca, Sabrina Michelotti, Massimo Romandini,
Matteo Vecchia, Gaudenzio Barbè, Federica Guazzini
321 Notizie sugli autori di questo numero
6
Un appello ai lettori
Un appello ai lettori
di Angelo Del Boca
La vita delle riviste di cultura, in modo particolare quella delle riviste
di storia contemporanea, non è per nulla facile. È risaputo. Salvo
pochissime, che possono godere per la stampa e la distribuzione,
dell’appoggio di una casa editrice, tutte le altre debbono affrontare ogni
anno il problema cruciale dei finanziamenti. Generalmente le riviste
usufruiscono del sussidio di istituzioni pubbliche e private, non sempre
facile da ottenere e comunque soggette a variazioni, il più delle volte al
ribasso. Altre riviste puntano invece sugli abbonamenti, che garantiscono
un discreto afflusso di denaro. Ma anche disponendo di 500 abbonamenti
non si tiene in vita una rivista.
È quindi necessario giungere ad un compromesso: contare sugli
abbonamenti e nello stesso tempo sollecitare le sovvenzioni delle
istituzioni pubbliche e private. Talune riviste, infine, hanno anche fatto
ricorso alla pubblicità, seppure di prestigio.
Quando gestivamo «Studi Piacentini», potevamo valerci dell’appoggio,
quasi continuo e generoso, del Comune di Piacenza, della Provincia di
Piacenza e della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e dell’introito di
circa 200 abbonamenti (in gran parte sottoscritti dai soci dell’Istituto
Storico della Resistenza e dell’età contemporanea). Poiché le spese della
redazione erano a carico dell’Istituto ed il direttore della rivista ed i
collaboratori non percepivano, come del resto oggi, alcun compenso, la
rivista veniva spedita gratuitamente a circa 800 fra studiosi, biblioteche,
istituti di ricerca, università, archivi storici, centri culturali, in Italia e
all’estero.
Nel trasferirci dall’Emilia al Piemonte, per i motivi che abbiamo già
esposti nell’ultimo numero di «Studi Piacentini» e nel primo de «I sentieri
della ricerca», ci siamo subito attivati per la ricerca dei necessari
finanziamenti rivolgendoci, innanzitutto, alle tre più prestigiose e dotate
istituzioni della regione: la Compagnia di San Paolo, la Fondazione
7
Angelo Del Boca
Banca Popolare di Novara per il territorio e l’Assessorato alla Cultura
della Regione Piemonte. Il 21 ottobre 2004 ricevevamo la risposta della
Compagnia di San Paolo, a firma del Segretario generale Piero Gastaldo.
Essa diceva: «Pur comprendendo le esigenze manifestate, desideriamo
segnalare in merito che tale forma di sostegno non rientra tra le modalità
operative e le priorità di intervento della Compagnia». Il 20 giugno
2005 giungeva anche la risposta della Fondazione Banca Popolare di
Novara, a firma del suo presidente, l’ex ministro Siro Lombardini.
Diceva: «Pur apprezzando l’attività della tua rivista, è spiaciuto al
Consiglio non poter accogliere la tua richiesta in quanto le motivazioni
rientrano in quelle che il Consiglio ha stabilito di non poter considerare».
L’inizio, dunque, non era certo brillante, anche se, nel frattempo,
avevamo ottenuto qualche aiuto, modesto, ma comunque molto gradito,
dalla Provincia del Verbano, Cusio, Ossola, dalla Banca Popolare di Intra,
dal Comune di Crodo e dalla Comunità Montana Antigorio, Divedro,
Formazza.
Il 20 settembre 2005, infine giungeva la risposta, questa volta positiva,
dell’Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, lo storico Gianni
Oliva. Con questo più sostanzioso contributo potevamo lavorare con
maggiore serenità, tuttavia non avevamo ancora raggiunto la piena
copertura delle spese, che è di 13-15 mila euro all’anno, per due numeri.
Anche la nostra rivista si trova perciò costretta, per quadrare i bilanci,
ad aprire una campagna per gli abbonamenti. Ci rivolgiamo,
innanzitutto, ai nostri abituali lettori, che per diciotto anni hanno
ricevuto gratuitamente «Studi Piacentini» e i primi due numeri de «I
sentieri della ricerca», e alle istituzioni (biblioteche, università, istituti
di ricerca, ecc.) che hanno fruito dello stesso vantaggio. Abbiamo
bisogno, per garantire la continuità della nostra pubblicazione, di
acquisire almeno 300 abbonamenti. Dall’esito di questo appello potremo
trarre anche alcune utili conclusioni. È gradita questa rivista? Ha trovato
una sua precisa collocazione nel panorama delle pubblicazioni che si
occupano, in modo particolare, dell’Africa e del colonialismo italiano?
In altre parole, ha maturato il diritto alla vita o può tranquillamente
scomparire?
Nel lanciare questo appello ai lettori e alle sopracitate istituzioni, ci
tornano alle mente le parole che l’amico Giorgio Agosti affidava nel
1964 al suo bellissimo diario: «Rifletto malinconicamente sulla parte
che mi è sempre riservata di far anticamera presso i potenti della terra,
8
Un appello ai lettori
per cavare gli scarsi aiuti che consentono di vivere alle iniziative laiche.
Non chiedo per me, e solo per questo accetto la parte sgradevole. [...]
Questo accattonaggio a volte mi umilia e mi deprime». Ma non a
sufficienza, nel nostro caso, per farci desistere dal proposito di proseguire
quella ricerca storica che abbiamo sempre cercato di condurre con
metodo, passione, coerenza e senso di responsabilità.
9
Angelo Del Boca
10
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
storia locale
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari
del Novarese
di Filippo Colombara
La propaganda è la cosa più convincente: guarda anche oggi come ti ossessiona...
e noi ci crediamo tutti! La propaganda presentava il duce come... come si chiama
quello lì... Rambo! Era l’uomo forte, virile, tu lo vedevi trebbiare a braccia nude,
a muscoli scoperti, tutto... Lo vedevi fare qualunque cosa, lui guidava aerei,
guidava... Gli italiani erano un po’ soggetti e si sono riscattati con Mussolini...(Bortolo
Consoli).
Benito Mussolini è certamente uno dei personaggi che più hanno segnato
il destino degli italiani nel Novecento. La sua dittatura, tra le più longeve
d’Europa, ha condizionato la vita dei cittadini allora e anche in seguito,
tramite una memoria indulgente che ha assecondato le ambiguità di un
Paese dalla democrazia incompleta.
A breve distanza dall’epilogo del regime si è sviluppato un sentire comune
che ha relativizzato il Ventennio, offuscando gli aspetti coercitivi ed
evidenziando gli elementi di progresso e modernizzazione. Nel limbo, ma
con i dovuti distinguo, sono finiti gli ultimi mesi, periodo di lunga durata
politica, strumentalizzato e sottoposto a torsioni tali che ancora oggi a
rivendicare il senso di quelle ragioni anziché essere i motivi dello scatenarsi
di una guerra civile, sono le violenze che l’hanno caratterizzata.
Da oltre mezzo secolo, a decidere le sorti di quel passato sono una serie
di memorie complesse, a volte lontane tra loro e conflittuali. L’appartenenza
a esse, però, non ha impedito la condivisione di alcuni aspetti permeati
dall’azione della propaganda. Il ruolo ricoperto da Mussolini nei ricordi
della gente comune è di primo piano: sia per le responsabilità che si è assunto
nella storia nazionale e sia per l’efficace promozione della sua figura nella
costruzione dell’italiano fascista.
11
Filippo Colombara
Intendimento di questo lavoro è analizzare alcune forme del ricordo,
fornendo elementi su come oggi si è stratificata quell’esperienza. Al centro,
padrone della scena, si staglia Mussolini, o meglio i vari Mussolini, quelli
rappresentati dal suo corpo (visto, toccato, sognato, inventato) e quelli relativi
all’esperienza dittatoriale: il Mussolini prevaricatore che si sovrappone alla
memoria del regime, quello che si scinde distinguendo e ripartendo le
responsabilità, quello travolto dalle efferatezze dell’ultimo conflitto armato e
quello salvifico per quanti non intendono recedere dalla sua visione del mondo.
Visto, toccato, sognato
Durante gli anni trenta, poter vedere Mussolini dal vivo in carne e ossa
pare essere un desiderio particolarmente diffuso1. La propaganda ha
compiuto un buon lavoro e rispondere a un bisogno del genere, per alcuni
semplice curiosità, per altri vero e proprio dovere morale, è un impegno a
cui pochi si sottraggono.
Anche la provincia di Novara, come molti altri territori nazionali, lo
accoglie a più riprese. Nel 1914 vi giunge come direttore dell’«Avanti!»,
alla ricerca di sottoscrizioni per il quotidiano; nel 1925, ormai protagonista
istituzionale, si reca all’aeroporto di Cameri per le grandi manovre; si
ripresenta ancora nel 1932 per l’inaugurazione dell’autostrada TorinoMilano e nel 1934 in visita ufficiale. Nell’aprile dell’anno successivo partecipa
con i ministri degli Esteri francese e inglese alla conferenza di pace di Stresa
e quattro anni dopo è nuovamente a Novara.
Per le genti della provincia il ricordo di Mussolini si collega in genere a
quest’ultima visita, avvenuta il 18 maggio 1939.
L’organizzazione di quella giornata risulta complessa ma ben rodata,
dopo anni di manifestazioni simili lungo la penisola. I preparativi seguono
procedure codificate e il podestà di Novara, per far bella figura, obbliga i
cittadini a tinteggiare e intonacare le abitazioni in cattive condizioni situate
lungo il tragitto del corteo2. La regia dell’evento è oltremodo impegnativa:
dall’allestimento delle scenografie, come l’arco di trionfo e il fascio littorio
di cinquanta metri installati in piazza Vittorio Emanuele II, alla tempistica
dei cerimoniali. Fatiche ricompensate dalle parole di elogio che il duce
pronuncerà al termine della manifestazione3.
L’apparizione di Mussolini, per quanti si ammassano nel capoluogo e
nei paesi attraversati dal corteo, dura un attimo brevissimo, ciononostante,
12
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
la messa in scena del popolo riesce per bene. Il gran numero di testimoni
dell’evento sottolinea la capacità degli apparati fascisti, dopo diciassette
anni di dittatura, di mobilitare le piazze. Soprattutto i giovani cresciuti con
il regime rammentano la giornata, annoverandola tra gli episodi storici
vissuti.
Il 18 maggio, quindi, dalla pianura e dai paesi di montagna ci si muove
per assistere alla venuta di Mussolini. A Novara: «Siamo partiti il giorno
prima, abbiamo dormito nel campo sportivo, eravamo in tanti, gente da
tutta la provincia. Alla mattina ci siamo svegliati e siamo andati in piazza,
dove hanno inaugurato l’ufficio postale» (Vincenzo Giovinazzo). «Ero andato
in corriera con la sezione fascista di Nonio... Era in grande uniforme.
Bisognava stare attenti solo a dire “Alalà, alalà” e basta... per osannarlo»
(Celeste Ardizzi). «C’era tanta gente, ma il duce l’abbiamo visto per poco
tempo. Mi ricordo che passava con la macchina, era in piedi» (Maria Cerri).
«Siamo andati giù in treno per vedere il duce. Ero vestita da giovane italiana
e c’era questo uomo, un bell’uomo che ha fatto il discorso… L’ho visto
quella volta lì» (Mariuccia Lilla). «Eravamo vestiti da giovani italiane,
avevamo il cartello con scritto: “Giovani italiane di Crusinallo”» (Alma
Puppieni).
La capacità di riempire piazze e strade con questo nuovo rito di massa è
un impegno non limitato al capoluogo ma si estende ai maggiori centri
della provincia attraversati dal duce. Ad Arona: «È passato di lì quando io
ero in collegio. Mi ricordo che eravamo sul viale della stazione, avevano
piazzato delle tribune per vederlo. Come è entrato, arrivava dalla strada
della stazione, si è alzato sulla macchina, ha salutato e poi è andato... Era
tutto imbandierato, le bandiere partivano dall’inizio della strada nuova,
quella che arriva a Dormelletto, e lui è andato verso Biella. Era il ’39»
(Nicola Tosi). «Forse l’ho visto ad Arona dove c’era come una festa... Era
prima della guerra. Lui veniva e gridava... c’erano anche i suoi seguaci che
venivano a fare i discorsi per cercare di tirare la gente dalla sua parte. Noi
giovani siamo andati a vederlo per curiosità, in quel tempo non avevamo
idee, pensavamo a divertirci» (Roberto Ferretti).
A Borgomanero: «Avevamo il treno gratis, solo per andare sul treno
gratis suma ’ndai vèga ’nca ’l duce. Abbiamo preso il treno a Omegna e
siamo scesi a Borgomanero. Io ero proprio sul corso, là davanti... Un bèl òm
l’éra, un bell’uomo era. Era in macchina, dopo noi siamo andati per conto
nostro... Lo volevo vedere così, una curiosità, lo vedevamo sempre nel cinema
e ’lóra questa volta c’era sul serio e siamo andati» (Angela Pettinaroli)4. «È
13
Filippo Colombara
venuto una volta... c’era tutto uno schieramento, noi del collegio siamo
andate a vederlo. C’era tanta gente che gridava: “Duce, duce”, ma niente
altro di particolare. Eravamo tutti riuniti in una grande piazza... poi è arrivato
lui su una macchina e ha parlato» (Giuseppina De Micheli). «Io l’ho visto,
ero vestita da piccola italiana. Lui era venuto per inaugurare la Casa del
littorio di Borgomanero, che è lì dove c’è il campo sportivo. Siamo andate
tutte noi delle elementari di Gozzano» (Anna Maria Ranzini).
A Romagnano Sesia: «La giornata era molto preparata, io ero già fuori
dalla scuola di quinta quindi non ero già più... tutti i bambini li hanno
portati sul ponte, hanno fatto degli archi e poi sono venute tutte queste
camicie nere, una preparazione stupenda si può dire...» (Francesco Rinolfi).
«Mi ricordo che c’era tanta gente per vedere il duce per curiosità eh, è la
curiosità, perché io non potevo vederlo, per dire, ma però per la curiosità
ho voluto vederlo anch’io» (Pierino Dariani). «L’è pasà da Rumagnàn tanti
ani fa. Ero una giovinetta e mi e ’l Massimo, a pe’, siamo andati giù sul pónt
da Rumagnàn. L’è pasà ’l Duce, un bèl òm, un bèl muretón»5 (Cesarina Bonola).
«Mi han vestito da piccola italiana e m’han mandato giù. Ero tutta contenta,
ero piccola ancora, ero tutta contenta e mio papà: “Ti n’acurgiarài”. Ma sì
che sapevo io, andavano tutti, mi sembrava di vedere chissà che grande
bella roba. Avevo sette o otto anni, non so» (Rina Della Zoppa)6.
I motivi che inducono a presenziare all’evento sono svariati e travalicano
disciplina e adesione al regime: si è attratti per curiosità; spesso le aziende
retribuiscono la giornata lavorativa; si viaggia gratis e in città ci si può
soffermare davanti alle vetrine dei negozi. Sono presenti aspetti ludici, anche
se la scampagnata si guasta per via della lunga attesa e del freddo - quel
giorno piove -, come racconta una donna di Prato Sesia.
Io sono andata a vederlo a Novara, perché la filatura [di Grignasco] mi pagava la
giornata. C’era un mio cugino che abitava lì alla Mulògna che lavorava con me e lóra
l’è gniù e l’è dì: «Vardè dòni, se vurì ’v pagu la giurnà». «Ah sì, ’lóra si ni pagu la giurnà,
cià ch’i ’nduma» e infatti siamo andati. Io sono andata a Novara, ci hanno caricate su
un treno che hanno dovuto spingerci sopra, erano i vagoni delle bestie ecco, invece
qui [a Prato Sesia] la Maria, la Adelaide, la Natalina, tüti già morti, sono andate a
Romagnano vestite da massaie rurali.
Quando siamo arrivate giù faceva un freddo e ho detto: «Déh, sun da sté qui ‘n sta
piasa...», tutta circondata da piccole italiane che cantavano «Duce, duce, duce, duce»
e dicevo: «Ah no, mi dòne ’dès mi i vagh». «Ma tèi mata neh, se ti vè fö da qui ’t masu...».
Io e una mia amica che lavorava con me siamo andate là, ci siamo sedute su un
paracarro, di là un momento arriva uno: «Allarme, allarme arriva il duce!» «Ah sì,
14
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
custa l’è bèla, déh Pulèt suma da livè sü?». «Ma va ’n po’ là va, lasa ch’al pasa». E infatti
uno dice: «Fate il saluto, fate il saluto». Dopu ’n po’ i fagh: «L’è bén inteligént cul lì, ma
l’è da féni criné cul lì». Quell’anno lì c’era persino ancora tre garibaldini, mi ricordo
che era lì al teatro Coccia che siamo andati, ecco sul balcone c’erano ’sti tre garibaldini,
la piazza era grande ma era piena di gente, noi ci hanno lasciate là, ci hanno dato un
sacchetto con dentro cioccolato, due aranci, mi ricordo, due michette e la filatura ci
ha pagato la giornata (Albina Baraggiotta )7.
La narrazione della donna, ricca di particolari, appare a tratti ironica e
con tanto di premonizioni. Come il padre di Rina Della Zoppa smorza la
contentezza della figlia di vedere Mussolini con un lapidario «Te ne
accorgerai», così Albina Baraggiotta attenua l’eccitazione delle compagne
con la secca frase: »È ben intelligente quello lì, ma ha da farci piangere
quello lì». In entrambi i casi si tratta di avvertimenti portatori di infausti
presagi. Affermazioni che spiegano il passato posizionando i narratori dalla
parte della storia vincente, a riprova della loro odierna giusta collocazione
ideale. Siano state realmente pronunciate o meno quelle parole, il loro
compito è di fungere da verdetto morale e, nello svolgimento narrativo, da
chiosa finale.
Caratteristiche di gran parte dei racconti su Mussolini, sono però i tratti
essenziali, la brevità, talora decisamente telegrafica, e l’assenza di aneddoti.
È plausibile che i testimoni, allora adolescenti, siano in difficoltà nel costruire
in modo compiuto il ricordo; tuttavia, le descrizioni sommarie si potrebbero
anche interpretare come indisponibilità ad affrontare ulteriori riflessioni su
di un fatto che si preferisce porre in secondo piano. L’episodio è stato
significativo ma non ha originato cambiamenti e non si intende aggiungere
nulla.
Nonostante tali limiti, o proprio per via di essi, le narrazioni sono
provviste di elementi che connotano pregi e difetti del capo del fascismo. I
suoi aspetti fisici, per esempio, meticolosamente promossi da anni di regime,
sono ben descritti dagli intervistati. Questo è un ricordo che solo
parzialmente si attiene alla visione del personaggio - ad andar bene intravisto
da lontano - quindi si confonde con i gadget di propaganda oppure si
corrobora di giudizi emessi nel dopoguerra: «Era proprio come si vede nelle
foto: piuttosto grosso, non tanto alto, né bello né brutto. Stava nel mazzo
’nsèma j auti. A sentirlo parlare era simpatico» (Cesarina Fioramonti)8.
«Ricordo che è passato sulla macchina che sembrava... praticamente come
è stato descritto in tutte le cose, superbo, tutte quelle cose lì, l’impressione
da bambino non si può neanche descrivere bene... eravamo digiuni di certe
15
Filippo Colombara
cose, antifascismo» (Pier Antonio Agarla). Al più: «Era grosso, tracagnòt. Ha
parlato un bel po’ ma non mi ricordo cosa diceva. Noi dovevamo stare lì in
piedi ad ascoltarlo, in silenzio assoluto» (Alma Puppieni)9.
Mussolini è percepito come protagonista di rilievo e lo si propone tramite
un’immagine di maniera che risente degli stereotipi del personaggio: «Era
un bell’uomo, ben tenuto come capo di stato. Era di media altezza... ma
aveva una voce vibrante che si faceva sentire» (Clotilde Rampone). «Aveva
occhi fissi in una maniera agghiacciante...10 faceva venire la pelle d’oca»
(Anna Maria Ranzini). «Aveva un bel fación. Era grande, con un berretto in
testa, con la divisa bella. Era imponente, con le mani sulla vita. Non era
arrabbiato, però faceva un po’ soggezione» (Maria Salvadego)11. «Era un
uomo imponente eh... molto imponente, io l’ho visto quella volta lì e basta...
Poverino, ha fatto una brutta fine anche lui» (Nicola Tosi).
Alle aggettivazioni alte e positive coltivate nell’immaginario degli italiani,
di uomo dominatore e ideale amante della nazione, si contrappongono
quelle negative prodotte dagli avversari: superbo, arrogante, «pallone
gonfiato». Rammenta un’operaia allora quindicenne:
Io ho fatto proprio il periodo delle scuole in cui ci hanno infarciti di Mussolini e di fasci
fino a non poterne più. E quando una cosa è troppa stroppia. Già nella mia famiglia non
eravamo granché propensi, ecco, però dopo col mio ragionamento vedevo che era una...
un pallone, un pallone. L’ho visto, son contenta d’averlo visto, che mio marito diceva:
«Tu sei andata fino a Romagnano per vedere Mussolini, io non avrei neanche fatto un
passo». Io invece sono contenta d’averlo visto, ho visto un bel pavone, ecco. A
Romagnano, nel ’39, quando passò a visitare, forse a tastare il polso che poi l’anno dopo
ha dichiarato la guerra. Io ho visto un bel pallone, un bel pallone gonfiato, eppure tutti:
«Viva il duce, viva il duce», non si poteva gridare diversamente (Edmea Mora).
Differenti valutazioni, al di là delle appartenenze politiche, si avvertono
sul piano generazionale. Le figure proposte dalle donne più giovani, che si
soffermano sugli aspetti estetici, e delle adolescenti, colpite dal comportamento
altero che induce soggezione, contrastano in diversi casi con l’immagine delle
trentenni e quarantenni. Tra queste, infatti, prevale la volontà di ricondurre
la figura del dittatore nei canoni dell’ordinario, di quello «stare nel mazzo»
già notato da Cesarina Fioramonti. «Non ricordo bene... Era un uomo
normale, ma aveva un aspetto...» (Angela Zampone); «Aveva delle arie! Era un
uomo normale... però ci faceva fare di tutto quel duce» (Maria Cerri). Inoltre,
mentre le giovani sottolineano la prestanza fisica, le anziane indirizzano il
ricordo in un ambito temporale più ampio: «L’ho proprio visto di persona...
16
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
Ah, quante cose ormai passate della vita... Sì, signora, nella vita quante cose
che si passano» (Assunta Poletti)12; «Eh sì, l’unica roba che ho visto io nella
mia vita è Mussolini, perché non uscivo mai di casa... con tre bambini e il
negozio...» (Carmela Fornara). La memoria del duce appare inserita nella
visione complessiva dell’esperienza individuale, che contempla anche periodi
precedenti al fascismo, quando, ricorda un intervistato, «Non si recitavano
preghiere a scuola, a quei tempi là eravamo più liberi» (Giuseppe Arienta).
Senza proporre tesi di alterità generazionale13, questi brevi cenni sono indicativi
dell’influenza dei gruppi comunitari di appartenenza nella costruzione delle
memorie e del debito nei confronti dei quadri sociali a cui si appoggiano14.
Le diversità tra il ricordo adolescenziale e quello di età matura sono evidenti
e determinano la qualità delle narrazioni. Le intervistate allora trentenni,
infatti, condividono con le più giovani il fascismo, il secondo conflitto
mondiale, la resistenza e con la propria generazione anche i decenni precedenti.
La scelta di propendere per un’interpretazione pacata e oculata della figura
del duce tiene conto di questi aspetti.
L’insieme dei racconti qui considerati, però, appartiene a generazioni
cresciute o nate con il regime, di conseguenza l’immagine di Mussolini che
emerge è soprattutto quella promossa dalla propaganda: un’immagine frutto
degli apparati di regime la cui influenza dura ancora oggi. La potenza degli
slogan, delle fotografie, dei filmati, dei frammenti di discorsi riverberano
nel momento in cui si tratta di allestire i ricordi del periodo. Specie nella
descrizione di eventi minori - come in fondo è questo - si fa uso della
propaganda per confezionare il racconto. Al passaggio di Romagnano, narra
Cesarina Bonola, allora operaia ventenne, «C’erano dei bambini e ricordo
ben [che] ha detto: “Bambini...” cume dì: bambini che erano soldati di
domani. Mi ricordo quella roba lì, l’ünica vóta che sun vistlu».
Mussolini, del resto, appare come un capo di stato capace di accreditare
la propria figura tra la gente comune, un leader partecipe della cultura della
piazza, anzi in grado di innovarla mescolando tradizione e modernità,
riversandovi individui-massa di diversa estrazione nella maniera tipica delle
adunate oceaniche15.
Vedere il duce è poi un bisogno psicologico di affezione e protezione.
Come per i re, si avverte la sacralità della sua persona - che dopo i falliti
attentati acquista la fama dell’invulnerabilità16 - e ne consegue l’attribuzione
di poteri taumaturgici17. Per questi motivi donne in lutto desiderano toccarlo
per propiziare la resurrezione dei loro morti18, altre confidano in un suo
intervento per salvare il figlio gravemente malato19; il piccolo sordomuto,
17
Filippo Colombara
protagonista di una lettura scolastica, acquista udito e vista osservando
Mussolini annunciare l’impero in piazza Venezia20 e giovani repubblichini
gli baciano la mano in segno di devozione e di reverente saluto21. Anche
una stretta di mano, un buffetto sulla guancia assumono il senso del tocco
regale, se non di guarigione almeno di protezione e salvezza. Atti che i
testimoni non esplicitano in questi termini ma che risultano centrali nel
racconto. Negli aneddoti che seguono è infatti rimarcato il contatto fisico
realmente avvenuto o solo presunto.
Da bambina sono stata premiata perché ero brava a scuola, era l’ultimo anno di scuola,
al teatro Dal Verme di Milano ed era presente il duce. [...] Mi ricordo che mi ha
stretto la mano e mi hanno regalato ventimila lire della Cassa di risparmio di Milano
(Giuseppina Pavan).
Ricordo che quando avevo otto anni, nel 1937, mi hanno fatto vestire con la divisa:
gonna blu e camicetta bianca con colletto alla marinara. Ci hanno radunato su l’éra,
sull’aia ricoperta di catrame dove si faceva seccare il riso, ce n’era una nella mia frazione,
e abbiamo cantato una canzone: «La bella balina / sfuggita di mano / oscilla sul piano
/ qua è là, qua e là». Contemporaneamente facevamo muovere tra una mano e l’altra
una pallina che poi abbiamo buttato in aria. Ci hanno applaudito. Era stato fatto in
onore della visita del duce, era la primavera del 1937 ed era accompagnato dal fattore,
signor Bruschi, che era fascista. Noi eravamo in otto o nove, tutte bambine. C’eravamo
solo noi, sembra una favola, invece è la verità. [...] Mi ricordo che il duce mi ha strucà
la mascèla22 e allora mi è andata via tutta la paura e ho fatto l’inchino. Perché lui se n’è
accorto che volevamo scappare, così ha cercato di calmarci. Avevamo fatto tante prove
a scuola con la maestra e siamo state proprio brave. Poi il duce ha fatto un piccolo
discorso, perché aveva premura di andare in un altro paese. C’era poca gente perché
da noi [Porto Tolle, Rovigo] c’erano pochi fascisti (Maria Salvadego).
Clotilde Rampone: «Sì, l’ho visto... era per una festa. Siamo andati al casinò di Pallanza,
al ricevimento che avevano fatto perché arrivava il duce. Ha fatto il discorso sul balcone
del palazzo municipale, poi è sceso e siamo andati in corteo al mausoleo Cadorna per
l’inaugurazione fatta dal duce».
Virginia Paravati: «Lei l’ha visto bene?».
Clotilde Rampone: «Sì, di presenza. Ci ha dato la mano, perché ero vicino a una donnetta
che gridava: “Viva il duce, viva il duce». Così, per il pericolo che fosse una parola
d’ordine per far intervenire qualcuno per disturbare il corteo, i fascisti si sono prodigati
per fermarla, ma il duce ha detto: “No, perché volete fermarla?” e le ha dato la mano
mentre diceva queste parole. Io che ero vicino mi sono trovato con la sua mano offerta
a me. Per questo l’ho apprezzato molto».
18
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
In questi tre racconti si contemplano certamente gli «errori» in cui
incorrono i narratori. Nell’ultimo aneddoto, per esempio, non è vero che
Mussolini partecipa alla traslazione della salma di Cadorna nel nuovo
mausoleo. Quel giorno del 1932 sul lungolago di Pallanza sono presenti il
duca d’Aosta insieme all’onorevole Delcroix, che tiene il discorso
commemorativo, e Costanzo Ciano, che legge il messaggio del duce23. Ma
anche rispetto agli altri due racconti: è davvero Mussolini il personaggio
che le bambine incontrano o è una costruzione leggendaria fondata su una
propaganda ossessionante?
Alcune descrizioni del 18 maggio 1939, poi, fanno intendere che non si
è assistito a uno spettacolo qualunque, che non si è trattato del passaggio
della storia davanti a dei «senza storia», ma di un vero e proprio incontro
tra i due soggetti; una relazione che non si svolge tra «noi» massa anonima
e «lui» ma tra «me» e «lui», in un rapporto di accettata sudditanza. Il pronome
personale utilizzato dagli intervistati è spesso plurale, ma talora sottintende
quello singolare, e lo sguardo negli occhi può sancire il contatto: «Aveva
uno sguardo così fisso - mamma mia - faceva paura guardarlo. Girava la
faccia proprio verso di noi, mi ricordo. Noi applaudivamo» (Anna Maria
Ranzini). A volte il rapporto diretto «tu per tu» è chiaro: «L’ho incontrato lì
per andare a Romagnano; ecco che veniva in su, ecco, e tanti che facevano
con la mano così [salutavano] e l’ho visto bene come vedere lei ’desso, per
dire» (Pierino Dariani).
In certe narrazioni, corredate da toni familiari, pare di trovarsi di fronte
a un vero e proprio incontro tra l’umile uomo comune e il capo supremo.
Pierino Dariani dichiara di averlo «incontrato che veniva in su», un normale
appuntamento a due mentre la calca di persone assiepate ai margini della
strada non è altro che contorno scenografico. Allo stesso modo, quando
l’operaia Clotilde Rampone vede Mussolini a Pallanza, è quest’ultimo a
offrire la mano alla donna, la quale apprezza molto il gesto. In ambedue i
casi l’incontro, pur in mezzo alla folla, è singolare e non ha eguali in quanto
valore e prestigio. Del resto, come sostiene Maria Salvadego, «c’eravamo
solo noi, sembra una favola, invece è la verità». Un «noi» sempre all’insegna
dell’incontro privilegiato, che in altri casi induce il testimone a immaginare
di essere proiettato nella grande storia.
Il duce era una persona che mi era molto simpatica, che aveva un fascino, aveva un
magnetismo particolare, che penso avesse, naturalmente con le debite proporzioni,
anche Napoleone verso i suoi seguaci. Senza spiegare perché c’erano certi momenti
19
Filippo Colombara
che l’essergli vicino mi dava un senso di felicità. Questo mi è capitato a un pranzo,
una volta che era venuto a Venezia a Palazzo Reale, con la gente fuori che chiamava
perché venisse al balcone, mi è passato vicino, aveva la sciarpa verde di gran ufficiale
e guardava la folla... A me pareva di essere una persona storica, che fosse un momento
molto importante della mia vita, una roba che uno si mette in testa, non ha alcuna
spiegazione almeno evidente dal punto di vista pratico. È una sensazione che molti
possono provare, penso che anche i comunisti potessero provare qualcosa di simile
con Togliatti (Angelo Berenzi).
L’incontro con i personaggi della grande storia, per la gente comune,
avviene anche durante l’esercizio del proprio mestiere. A Cesare Castellano,
per esempio, capita di radere la barba al generale Graziani: «Era un tipo
taciturno, quando andavo io non osavo parlare. Tutto il rispetto, gli facevo
la barba, lo ringraziavo, mi pagava volta per volta». A un cuoco di Armeno,
invece, succede di cucinare per Ciano e Mussolini.
Marco Guarnori: «Noi per lavorare si andava sempre via. Una volta bisognava andare
a Roma, perché c’erano i francesi che insegnavano; allora gli chef erano tutti francesi
ed erano tutti a Roma. Poi ho girato un po’ dappertutto. Io ho conosciuto gente che
avete appena sentito nominare: Mussolini, Ciano».
Studente: «Come erano queste persone a tavola?».
Marco Guarnori: «Erano esigenti, Ciano era molto esigente: a lui bisognava dare,
quando si serviva d’estate, la carne fredda e il prosciutto tutto tagliato a pezzi. Ricordo
che una sera è arrivato a mangiare alle undici, mi trovavo di guardia e non ho potuto
dargli i pezzi, perché li avevo già dati a un’altra persona, ha piantato un pasticcio da
cani!».
Studente: «In che ristorante si trovava?».
Marco Guarnori: «Io mi trovavo all’ambasciata, lì facevano tutti i banchetti del ministero
degli Interni. Mussolini l’ho servito in Sardegna. Allora per servire quella gente lì e
per lavorare bisognava essere iscritti al partito fascista. Mussolini l’ho rivisto durante
la guerra, io ero chef al Principe di Torino. Una sera Ciano si trovava lì a dormire, era
d’inverno, faceva freddo e avevano acceso i caloriferi con quel poco gasolio che c’era,
ed è scoppiato un termosifone, con un baccano... proprio nella camera adiacente a
quella di Ciano. Lui, in pigiama, è arrivato giù nella hall alle tre di notte a vedere che
era successo. Dice: “Qua è un attentato!”. Poi c’era sempre Edda Mussolini che veniva
lì perché era una crocerossina, allora era in Piemonte».
Studente: «E Mussolini a tavola?».
Marco Guarnori: «Mussolini era malato di ulcera e allora mangiava sempre pesce bollito
e verdura bollita. Quelle quattro o cinque volte che l’ho servito in Sardegna ho preparato
pesce e legumi bolliti».
Studente: «Era gentile verso di lei e il personale?».
20
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
Marco Guarnori: «Parlava poco e noi avevamo poco contatto con lui, perché poi stava
tre piani sotto terra. Aveva i suoi camerieri che servivano. Mi ricordo che c’era un
cameriere che veniva lì sempre e raccontava che una volta, durante un convegno a
Stresa con Mussolini e i francesi o gli inglesi non mi ricordo più chi fossero, alla sera
è venuto un temporale fortissimo, proprio mentre Mussolini stava rientrando nel
salone da pranzo, è andata via la luce e si sono trovati tutti con la rivoltella in mano».
In questa narrazione, peraltro, fa capolino il corpus di voci sulla salute
di Mussolini: dicerie sulla sua ulcera24 che accompagnate a quelle sulla sifilide
sono frutto di particolare attenzione da parte degli antifascisti, consci che
la buona salute del regime debba molto a quella del maestro di Predappio.
Le voci sulle condizioni fisiche, del resto, lo seguiranno per tutta la vita,
prendendo particolare vigore durante la guerra, al punto che nell’autunno
1942 si parla della sua morte, avvenuta per malattia o a seguito di un
intervento chirurgico. Si tratta di false notizie ma che rispecchiano il reale
declino politico che sta subendo la sua immagine25. Nell’ultimo periodo di
vita, invece, i supposti sintomi di follia, argomento di dileggio della sinistra,
sono fatti propri da quanti, a destra, utilizzano questa ipotesi per giustificare
gli errori politici e le sconfitte militari, che un capo dalle «qualità
straordinarie», qual è sempre stato il duce, non si sognerebbe di
commettere26.
Al Mussolini visto con i propri occhi si affianca, inoltre, quello che si
crede di avere incontrato. I meccanismi escogitati dalla propaganda affinché
egli eserciti una forte attrazione sono del resto notevoli; solo così è
giustificabile il consolidarsi in taluni ricordi della certezza di averlo veduto
persino in luoghi decisamente improbabili.
La leggenda della sua ubiquità è ben presente nella pubblicistica del tempo
e già abbiamo rinvenuto indizi nelle nostre interviste. Mussolini è rintracciabile
ovunque: vicino a ciascuno come padre premuroso piuttosto che come occhio
del grande fratello. In un libro di letture per ragazzi si afferma:
Egli appare a quando a quando in quell’angolo d’Italia dov’è meno atteso. Fu visto
nella strada di una grande città, al mattino, fermo con volto sorridente, tra i bimbi
che andavano a scuola.
Lo vide, nella notte, sogguardando sotto la visiera dell’elmetto, un soldato che montava
di guardia.
Lo sentì accanto un marinaio, nella sera di tempesta.
Lo scorse un contadino accanto a sé quando arava, in ottobre, a reggergli la lunga asta
del vomere e puntare per il solco profondo27.
21
Filippo Colombara
Nulla di più strano se oggi si può rammentare di aver assistito al suo
arringare folle dai balconi del proprio paese o persino sulle sponde del
torrente vicino casa.
«Mi ricordo che il duce con i capi del fascismo di Crusinallo e della zona
hanno parlato una volta dal balcone della casa di mia zia, che dominava la
piazza di Crusinallo» (Maria Pirovano). L’affermazione è una stranezza e
non corrisponde alla realtà, anche se trova conferma da un’altra intervistata:
«Una volta è venuto sul balcone a Crusinallo della casa Pirovano. Faceva la
sua propaganda per il suo partito... Era appena prima della guerra. [...] In
piazza c’era tanta gente che applaudiva e diceva: “Viva il duce”» (Cesarina
Fioramonti). Esemplare la testimonianza di una terza informatrice: «Ho
visto il duce con la Petacci. Erano giù allo Strona di Crusinallo. Io ero
ancora piccola, ma andavo già a lavorare, avrò avuto un quindici anni.
Loro forse erano venuti per la guerra d’Etiopia» (Maria Cerri).
Ma a Crusinallo Mussolini non è mai stato e neppure a Loreglia, in
valle Strona, ciononostante: «L’ho visto a Loreglia. Era andato dove c’è la
scuola, sul balcone e aveva fatto un discorso. Era prima della guerra e
c’era tanta gente a vederlo. Io non sono andata perché lo vedevo da casa
mia... Era un uomo normale, ma aveva un aspetto...» (Angela Zampone).
Sulla venuta nel paesino dell’alto Cusio insiste un’altra intervistata: «Mi
sembra che è passato una volta a Loreglia per fare una visita, ma non sono
sicura. Era con il suo seguito. Non si è fermato, ha continuato. È venuto
a Loreglia perché lì c’era un po’ una base dei fascisti. Mi ricordo che
anche alcuni miei parenti istruiti che erano andati via, in città a lavorare,
ritornavano in paese, si trovavano e così si diffondevano le idee» (Maria
Zamponi).
Un contributo all’ubiquità di Mussolini, inoltre, lo forniscono le
imitazioni e le emulazioni di gregari e ammiratori. Tra i gerarchi in campo
nazionale, come tra i capi milizia di paese, è un susseguirsi di riproposizioni
del duce, o meglio, della rappresentazione grottesca del suo corpo28. Vi si
atteggiano nell’inflessione della voce, nel modo di scandire le frasi durante
i discorsi29, in posa davanti alla macchina fotografica, nelle movenze in
pubblico durante le cerimonie - con tanto di busto retto e braccia ad anforetta
sui fianchi30 -, oppure nella sequenziale battaglia del grano31. Sono stilemi
che amplificano la parola e soprattutto la presenza del capo in ogni
circostanza. Modi ossessivi di permeare la vita di ciascuno della sua presenza,
che nella memoria si attualizzano nella ripetizione quotidiana del rituale:
«Tutti andavano in piazza ad applaudire il duce e dicevano: “Viva il duce”,
22
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
ma lo dicevano solo perché avevano paura. Tutte le sere usciva sul balcone
per fare i discorsi sul fascismo» (Aurora Rossari).
Altri aneddoti appartengono alla serie di racconti imperniati sul Mussolini
emigrante e fannullone. Confluiscono in questo repertorio vicende di
matrice socialista e antifascista e può accadere che s’impongano
approssimazione temporali e spaziali nonché la trasposizione ideologica: il
ventenne emigrante Mussolini non è più socialista ma già fascista o, tutt’al
più, un fannullone e liggera.
Liliana Perazzi: «Mio papà aveva un fratello, lo zio Giacomo, che ha lavorato in
Svizzera assieme a Mussolini...».
Giovanni Perazzi (il padre): «È morto pochi anni fa, ha lavorato con Mussolini alla
galleria del Sempione».
Filippo Colombara: «Cosa raccontava suo fratello?».
Giovanni Perazzi: «Raccontava che erano tutti lingéri...32 sono venuti fino a Boca per
bere il vino buono...».
Liliana Perazzi: «Lo zio era uno che lavorava e mangiava, non aveva mai una lira in
tasca, una volta han fatto una colletta per comperargli un paio di pantaloni, io ricordo
una volta che mio zio era tornato gli avevo detto: “Io zio fossi al tuo posto gli manderei
una bella lettera, fatti sentire che sei un amico, senti cosa ti dice”, ma lui era contrario».
Filippo Colombara: «Ma cosa diceva di Mussolini?».
Luigina Perazzi (altra figlia): «Mah, diceva che era uno che non aveva voglia di lavorare
ecco, aveva più voglia di comandare che di lavorare e ha fatto una brutta fine... però
l’han fatta tanti altri».
Avevo un amico di famiglia che faceva il sarto che era andato in Francia ed era nella
medesima camera di Mussolini. Erano nella stessa camera assieme e raccontava che il
duce sputava sui muri e bestemmiava, diceva quei particolari lì... Questo signore era
socialista si chiamava Lorenzo Guidetti ed era di Agrano, e il duce gli aveva detto: «Se
hai bisogno qualche favore scrivi a me, però con l’indirizzo a sinistra». Così lui sapeva
e apriva la lettera, se no le cestinava. Questo socialista era un pensatore, con quelle
idee un po’ rivoluzionarie... però, nonostante l’idea diversa, era amico. Un’altra volta
gli aveva detto: «Perché hai scelto la camicia nera come simbolo del fascismo?». E lui
ci aveva risposto: «Perché è la negazione di tutti i colori»... Teste esaltate, dopo è stato
coinvolto anche lui, Hitler e mica Hitler, bah! (Renata Brasola).
Il futuro duce non ha mai lavorato al traforo del Sempione. I suoi periodi
di emigrazione si svolgono in Svizzera: dall’estate 1902 al novembre 1904 e
dal 1908 al 1910, non in modo continuativo. I racconti, pertanto, di natura
leggendaria, assolvono al compito di contrastare il mito di Mussolini; lo
23
Filippo Colombara
colpiscono sul piano etico, sulla propensione al lavoro come valore, aspetto
compreso e condiviso dalle classi popolari. Questo del Mussolini fannullone
e vagabondo è uno stereotipo diffuso nel periodo. Tra le dicerie di paese, nelle
discussioni in osteria si riscontra sovente un repertorio del genere33 e basta
poco per rischiare la delazione. A San Maurizio d’Opaglio, per esempio, il
socialista Angelo Gioria, detto Capèl tund, viene denunciato per aver dichiarato
che il duce «non può rientrare in Isvizzera perché oberato di debiti»34.
Meno fortunato, invece, il destino di Claretta Petacci, sulla quale il
giudizio è a volte condizionato dai pregiudizi del ruolo di donna/amante.
«Mussolini era un bell’uomo, grosso. Si diceva che aveva lasciato sua moglie
per andare con la Petacci» (Giuseppina Freschini). «Era una bella signora,
alta ben vestita. Si vede che il duce le passava qualcosa per vestirsi. La
chiamavano la Petacci perché andava con il duce» (Maria Cerri). La fine
drammatica, tuttavia, lascia posto alla pietà e indirettamente forse al riscatto
dell’immagine di donna comune coinvolta in vicende troppo grandi per
lei. «Mi ricordo che sono andata a Milano a trovare mia sorella a piazzale
Loreto, un paio di mesi dopo che la Petacci era stata uccisa. Mi ricordo
perché mi ha sempre fatto male vedere dei vestiti della Petacci appesi al
muro in alto. A terra c’erano dei sassi, si vede che glieli avevano lanciati.
Quel lavoro lì l’hanno fatto quando era già morta, già appesa, che bisogno
c’era? Era solo vandalismo» (Esterina Borioli)35.
Il buon regime della paura
Nodo centrale del dibattito sulla memoria di Mussolini e uno degli aspetti
rilevabili dalle fonti orali è l’accostamento con l’esperienza della sua dittatura.
Il fascismo, in quanto organizzazione dello Stato piuttosto che
movimento politico, è descritto raramente staccato dall’immagine del capo.
Accade spesso, infatti, che alla richiesta di parlare del regime, gli
intervistati conducano la risposta alla figura del duce, proponendo una
connessione o piuttosto una sovrapposizione tra Mussolini e fascismo.
Io sono nata col fascismo, quando andavo a scuola c’era già quello lì. Ad ogni modo
quando c’era il fascismo, che c’era il duce, io non è che voglio lodarlo neh, però ha
fatto tante cose, per i malati ha fatto tanti ricoveri, tanti sanatori, tante colonie per
ragazzi, sono andata anch’io in colonia... Non è che io lodo eh, perché poteva star
fuori benissimo dalla guerra (Giovanna G.).
24
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
È un uomo che ha fatto tanto anche di bene, non solo di male: la mutua, le ferie, tutte
quelle cose lì che sono state messe negli stabilimenti (Esterina Borioli).
La pensione, la mutua, tante cose erano buone. Quelle che ha fatto il duce. Lui veniva
criticato perché era lui il capo e su di lui andavano tutte le critiche (Settima Fornara).
Faceva cose buone come gli ospedali, le scuole (Carolina Lianò).
Di buono poi il duce ha fatto le pensioni, altro non mi ricordo (Maria Cerri).
Vi è, come si nota, perfetta sintonia con la propaganda; tutti i fermenti
innovativi di una società in via di modernizzazione passano attraverso le
volontà del suo capo. Egli appare come il fautore di uno stato sociale, colui
che ha realizzato un nostrano New Deal, anziché il creatore di uno Stato di
polizia36. Uno Stato che anche tramite il rigido controllo sociale dell’azione
assistenziale e previdenziale fonda il potere sugli individui. Gli istituti citati
dai nostri interlocutori (pensioni, mutue, colonie per bambini, ecc.) non
erano usufruibili al di fuori di un’adesione al regime controllata dalla «culla
alla bara» dalle innumerevoli organizzazioni del partito-Stato37.
La dittatura si autoassolve tramite il leader, il quale richiama su di sé tutti
gli elementi positivi dell’esperienza, non lasciando nulla a collaboratori e
gregari. Nel rapporto duce/fascisti, come è stato suggerito in più occasioni,
prevale il paradigma di distinzione tra bene e male, tra positività e negatività38.
Il passato ricordato impone ai testimoni di non tradire quanto si è creduto a
suo tempo e, quindi, di salvare Mussolini, la cui opera era improntata a
conseguire il bene degli italiani e il cui unico errore fu la partecipazione alla
seconda guerra mondiale, mentre gli apparati dello Stato fascista, costituiti
da individui incapaci, ladri e profittatori erano i reali colpevoli di ogni sopruso.
Questi pareri esulano dall’adesione degli informatori a correnti politiche e di
pensiero reazionarie e talvolta, come in quasi tutti i casi sotto riportati,
provengono da una base popolare di segno opposto. Del resto non è solo un
problema di propaganda, occorre anche salvare se stessi agli occhi delle nuove
generazioni per «l’involontaria» compromissione con un siffatto progetto
totalitario; un progetto che narra di un tempo lontano, della gioventù, di
quando bastava essere allineati e coperti per sopravvivere.
Marino M.: «Il fascismo aveva capito fin da allora che alcune cose sono sbagliate ma altre
invece... A parte la distruzione delle Camere del lavoro, dei sindacati e tutto il resto, quella
di creare organizzazioni che raccogliessero i lavoratori dopo il lavoro, è stata una bella idea
che però non raccoglieva i favori della gente, perché erano tutti i fascisti che vi partecipavano.
25
Filippo Colombara
Io non credo che il fascismo abbia sbagliato tutto, non è assolutamente vero. Noi abbiamo
avuto la mutua nel ’28 e si è cominciato a creare qualcosa che potesse essere il nucleo di
una futura generazione. Certo che chi lo eseguiva...».
Filippo Colombara: «Riscontri una differenza tra Mussolini e i gerarchi fascisti?».
Marino M.: «Sì, secondo me Mussolini come idee era vicino al socialismo è che dopo
è stato mal seguito. Che Mussolini per arrivare al potere abbia dovuto far fuori
Matteotti, i fratelli Rosselli... Gramsci, noi ragazzi allora non lo sapevamo, lo abbiamo
saputo dopo. Però in linea di massima Mussolini ha fatto una rivoluzione sociale: dal
1915, prima della prima guerra, al 1925, c’è stato un cambiamento grandissimo,
un’evoluzione culturale, di pensiero e tutto il resto».
Edmea Mora: «I fascisti erano dei fanatici secondo me e secondo tanti che la pensano
come me, erano semplicemente dei fanatici e lui probabilmente impartiva un ordine
e quell’ordine poteva anche essere giusto, però loro nella foga di fare travisavano
l’ordine ecco, e lì subentrava poi la prepotenza, l’arroganza ecco».
Filippo Colombara: «Il clientelismo».
Edmea Mora: «E appunto: “Se tu paghi la tessera sei dei nostri se no”. Il motto famoso:
“Chi non è con noi è contro di noi”, c’era quella differenza lì e più il fascismo era,
diciamo, zoticone e più era tronfio e più travisava gli ordini ricevuti dall’alto.
Mussolini... onestamente, certe istituzioni avran cambiato nome però ci sono anche
adesso, perciò sotto sotto lui avrebbe voluto non so una cosa in un certo modo e gli
altri i lombrichi, formiconi, che c’erano in giro, han travisato tutto portandolo poi
alla rovina definitiva, ecco...».
Filippo Colombara: «Poi la guerra...».
Edmea Mora: «Poi fu la guerra. Ha fatto degli sbagli enormi, ma ha fatto anche delle
cose giuste, sensate, come l’istituzione delle ferie, cassa mutua, tante cose, i
tubercolosari. Ci sono ‘ste cose, non si possono negare, e queste non le hanno inventate
questi, c’erano già, le otto ore lavorative... Invece prima era d’un’Ave Maria all’altra,
tante cose non bisogna negarlo, però... Ha sbagliato in tante cose, ha sbagliato a far la
guerra... Poi facilone, andava in un posto c’era un gruppo di aerei, andava nell’altro
quegli aerei li spostavano di là, allora: “Oh, siamo armati”... Mandarli in Russia con
gli scarponi di cartone, ecco, tutto lì».
La differenza tra Mussolini e i fascisti non saprei dire, perché io non sono stata in
contatto con loro. Penso però che erano i fascisti che prendevano in mano le redini e
rovinavano tutto e non lui... erano i suoi coetanei. Ha dato in mano troppo ai suoi
coetanei (Cesarina Fioramonti).
Il fascismo è finito perché quelli che seguivano Mussolini non facevano le cose bene e
allora la gente ha reagito. Però il fascismo aveva troppe cose che facevano paura.
Meglio che è finito (Settima Fornara).
26
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
Questo tipo di racconti, a volte estremi, conducono all’agiografia: «Io,
come le dico, ero una ragazza, non... Però ho sentito una volta un discorso
di Mussolini, appunto che lui diceva... sapeva di avere tutti questi uomini
al suo fianco, ma diceva: “Io ho questi uomini con il pugno in tasca”, perché
li pagava. Ed erano tutti quelli importanti. Quello me lo ricordo ma mica
sempre stavo a sentire i discorsi di Mussolini, sa com’è» (Angiolina A.).
Le opinioni dei testimoni, che del fascismo hanno introiettato i dettami
educativi, sono spesso trasmesse alle generazioni immediatamente successive,
le quali, talvolta, producono risultati speculari sotto il profilo culturale.
Alla domanda di cosa abbia rappresentato per l’Italia Mussolini, un operaio
comunista afferma:
Eligio Borella: «Io sono del ’39. Per me Mussolini, dai libri letti, perché mi piace
anche leggere, da quando era direttore dell’ “Avanti” a quando è diventato presidente
del Consiglio praticamente era sempre socialista eh! Però dopo lui - secondo la mia
idea - si è montato un po’ la testa, si è accerchiato di certa gente, che si sono montati
la testa anche loro. Ha fatto il famoso sbaglio di allearsi insieme a Hitler, cioè prima
con gli agrari... Perché forse forse se Mussolini non faceva il famoso asse al giorno
d’oggi era un eroe d’Italia».
Filippo Colombara: «Perché?».
Eligio Borella: «Perché in fondo in fondo - non è che io adesso lo metto sul piedistallo
- se guardiamo tante bonifiche fatte giù dalle parti delle Lepontine... come spiegano i
libri eh, perché io non ero nemmeno nato. Cioè ha sbagliato quella cosa lì. Ci ha
mandati al macello».
Filippo Colombara: «Tu dici l’errore suo è stato quello di aver fatto la guerra...».
Eligio Borella: «Quando invece poteva star fuori da tutti».
Filippo Colombara: «Invece i fascisti?».
Eligio Borella: «Ci sono fascisti e fascisti. I fascisti li distinguo in due, cioè quelli che dicevano:
“Quelli là sono i più forti e vado di là” e poi quelli che si volevano vendicare di qualcuno:
“Adesso comando io e adesso faccio fuori te”. Quindi uno si adeguava al più forte...».
Filippo Colombara: «Senti, non c’era anche un altro tipo di fascista, quello convinto
di essere dalla parte giusta?».
Eligio Borella: «Sì, i volontari che andavano... ma anche lì bisogna fare una distinzione;
andavano giù [in Africa] anche per fare una certa fortuna eh!».
Filippo Colombara: «Secondo te c’era in Italia un fascista che era convinto di essere
dalla parte giusta?».
Eligio Borella: «C’è ancora adesso qua a Omegna... e dichiara che è un fascista di
Mussolini... Io ammiro più queste persone che certa gente...».
Filippo Colombara: «Ho capito, ma volevo chiederti un’altra cosa, c’è differenza tra i
fascisti in generale e Mussolini?».
27
Filippo Colombara
Eligio Borella: «Per mio conto Mussolini è stato guidato dal Consiglio, perché arrivare
a far fuori suo genero è arrivato perché non era lui che comandava, era il Gran Consiglio
che comandava. In ultimo no, cercava di scappare da vigliacco, faceva più bella figura
farsi prendere che scappare...».
Considerazioni diverse tra la figura di Mussolini e quella dei suoi uomini
rinviano, peraltro, al tradizionale rapporto sovrano/sudditi presente nelle
società europee. Storicamente, infatti, si è consolidato un immaginario sociale
sulla figura del buon sovrano tra i cui canoni rientra quello di essere la
rappresentazione della giustizia «poiché un monarca ingiusto è la negazione
della regalità»39. Il re, secondo il popolo legittimista, è sempre giusto e se
qualcosa non va, se le tasse sono inique, le colpe ricadono sui cattivi consiglieri
che lo hanno ingannato, siano essi i signorotti locali, i funzionari o il clero40.
Del resto, lo stesso leggendario Robin Hood non combatte il legittimo sovrano
Riccardo, ma lo sceriffo di Nottingham, funzionario statale e per giunta al
servizio dell’usurpatore principe Giovanni. E i popolani, nel corso della storia,
insorgono contro i soprusi e le gabelle in nome dei re e degli zar, senza pensare,
però, «a uno zar reale, o a qualsiasi reale sovrano, ma allo zar ideale del popolo
legittimista, figura che non ha riscontro nella realtà»41.
Qualcosa del genere succede con Mussolini e una documentazione di
rilievo è ormai disponibile non solo nella memoria orale ma anche nelle
fonti coeve: dalle note informative della polizia sui sentimenti degli italiani
verso il regime alla corrispondenza di gente comune sottoposta a censura
durante la guerra42.
Il giudizio complessivamente positivo dell’azione di Mussolini si deve,
poi, all’efficacia di una propaganda che trova buona accoglienza nei riceventi,
«a prescindere dal battage e dai mezzi dispiegati»43, perché capace di toccare
le corde giuste, come, per esempio, lo spirito dell’italianità, ambito nel
quale il capo del fascismo riesce a incarnare sogni e bisogni popolari
impiegando orgoglio e fierezza nazionale come elementi salienti del
successo44.
La costruzione dell’identità fascista del paese richiede, inoltre,
innumerevoli sforzi che si tramutano, a livello educativo, in un susseguirsi
di riti e celebrazioni. Nelle scuole di provincia, come in quelle di città, tra
gli anni venti e trenta, si accelera il processo di edificazione dell’Italia
fascista mediante la pratica dell’anniversario45, cioè di un sistema di
organizzazione dell’identità degli italiani attraverso la costante ripetizione
calendariale, anno dopo anno, del ricordo di eventi e personaggi cari al
28
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
fascismo e alla monarchia sabauda. Tracce evidenti di questi atti
permangono nei Giornali di Classe redatti dagli insegnanti. In essi si
elencano le cadenze rituali da rispettare ed emergono le tematiche di
carattere propagandistico promosse dal regime46.
Nella piccola scuola di Boleto, per esempio, che tra il 1928 e il 1944
conta una ventina di alunni distribuiti tra la prima e la terza classe, la vita
quotidiana trascorre costellata da una miriade di ricorrenze. Annota
un’insegnante il 28 ottobre 1930:
Marcia su Roma. Accenno come dopo la guerra l’Italia era caduta in mano a chi non
sapeva guidarla; parlo dei disordini, degli scioperi, delle ribellioni. Occorreva un uomo
dal polso di ferro: Mussolini, il solo condottiero che sapesse guidare l’Italia ai suoi
fulgidi destini. E il Re lo nominò suo Primo Ministro47.
Dal punto di vista delle tematiche storiche l’anno scolastico è
contraddistinto dalle gesta degli eroi: da quelle del piccolo genovese
Giambattista Perasso, detto Balilla, il quale «al grido “La rompe” diede il primo
impulso alla rivoluzione che terminò colla scacciata degli austriaci»48, a quelle,
nel giorno della mamma, di Carmela Borelli, che «si spogliò delle sue vesti per
riparare dalla bufera le sue bambine, salvandole così da sicura morte e
sacrificando se stessa»49. Argomenti di attualità sono l’anniversario della morte
del quadrunviro Michele Bianchi, le imprese di Italo Balbo nei voli
transoceanici, la guerra in Etiopia e le innumerevoli ricorrenze fasciste: dal
tesseramento alle organizzazioni, alla fondazione dei fasci di combattimento,
al Natale di Roma, alle inaugurazioni dei gagliardetti, ai saggi ginnici.
Ho distribuito le tessere ai Balilla e alle Piccole Italiane - scrive la maestra - e cercato
(come sempre) di far capire ai bambini la nobiltà della loro divisa, ma che non basta
portare la divisa esternamente, bisogna che i Balilla e le Piccole Italiane imparino, da
piccini, ad essere buoni50.
Dopo qualche mese:
23 febbraio 1931. XII anniversario della fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento
a Milano, per opera del Duce, il 23 marzo 1919. Accenno ai bambini come l’Italia
dopo la grande guerra si trovasse in istato miserrimo, in mano di gente di mala fede,
di sovversivi senza patria che spingevano il popolo allo sciopero, al disordine, alla
rivolta. Ma Iddio non abbandonò l’Italia e ci diede in Benito Mussolini il Duce della
riscossa, la salvezza della nostra amata Patria51.
29
Filippo Colombara
A fianco della memoria fascista si colloca quella monarchica, anch’essa
non da meno nel segnare i giorni con le varie commemorazioni di nascite,
matrimoni, imprese e scomparse degli appartenenti alla famiglia Savoia:
dal genetliaco del re,
Ieri, sabato 11, ho parlato a lungo del nostro Re, della sua vita in trincea, di tanto
bene che fece e fa continuamente all’Italia, di tutta la Famiglia Reale e dissi anche in
quale occasione dolorosa Egli diventò Re d’Italia. Ho fatto scrivere una cartolina
d’augurio a nome della nostra scuola e l’ho spedita a Roma al nostro Re. Alcune
bambine portarono dei fiori che vollero mettere sotto il ritratto del Re. Prima d’uscire
dall’aula, i bambini oltre il solito saluto alla Bandiera, fecero spontaneamente il saluto
romano al quadro del Re e io feci cantare l’inno alla «Croce di Savoia»52
all’«augusta Principessa di Piemonte», la quale, durante la guerra in Etiopia,
«continua le tradizioni delle donne Sabaude. Col piroscafo “Cesarea” è partita
oggi, quale Crocerossina Volontaria, per l’Africa Orientale»53.
L’impiego di eroi popolari, sia nelle commemorazioni ufficiali sia
soprattutto nella quotidianità scolastica, da affiancare alla mitizzazione dei
personaggi di Casa Savoia, nonché di Benito Mussolini - sistemato tra i
grandi statisti in compagnia di Giulio Cesare, Napoleone e Cavour54 - sono
le prime condizioni per muovere verso la creazione dell’identità nazionale.
Una consonanza di aspirazioni che sul senso di appartenenza e di coesione
tra simili ripone una forza ben maggiore dell’internazionalismo proletario
uscito sconfitto dalla Grande Guerra.
L’identità dell’italiano, del resto, congiuntamente alla legittimazione del
blocco dominante e all’assunzione e propagazione di valori positivi da parte
della comunità nazionale, è da porsi tra le funzioni proprie delle idee-guida
del fascismo55.
I risultati della divulgazione di una visione forte del mondo, anziché di
una propaganda artificiosa e surrettizia, accompagnati da un’interpretazione
fantastica e leggendaria della figura del capo, costituiscono i sedimenti culturali
impiegati anche dalle memorie di base per la rievocazione del passato.
Mussolini, pertanto, uomo della provvidenza, bravo italiano in grado di
riscattare la nazione nell’agorà delle società occidentali.
Tuttavia, basta allontanarsi dalla centralità della figura del duce e dialogare
su violenza squadrista e guerra civile, perché i giudizi sul fascismo e sui vent’anni
di regime producano una diversa valutazione. In molti casi, le voci positive
sugli atti di carattere sociale (ma all’interno di un controllo politico) compiuti
da Mussolini si associano a quelle negative sul resto del suo operato ed
30
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
esprimono critiche nei confronti del Ventennio, talvolta accomunate, come
si è detto, alle azioni dei gregari. Aspetti del genere emergono soprattutto dai
colloqui con informatori che non hanno da tutelare una particolare immagine
pubblica di sé, gente comune che di quelle vicende ha memoria e non teme
di contraddirsi se per un verso apprezza i risultati di una certa politica sociale
e immediatamente dopo traccia il quadro negativo del periodo.
I documenti orali utilizzati per affrontare questo tema, va precisato, sono
tratti in massima parte da interviste realizzate tra gli ospiti di una casa di
riposo dell’alto Cusio, persone anziane che trascorrono l’ultima fase della vita
in modo sufficientemente distante dalle diatribe del mondo, un periodo –
parafrasando Bobbio – impiegabile per scavare nei ricordi, riflettere sul passato
e marcare meglio la proprio identità56.
I fascisti erano terribili. Hanno ucciso mio cognato che si chiamava Leonardi Giuseppe
nel periodo della resistenza. Erano tutti vestiti di nero, marciavano e cantavano le sue
canzoni, erano a Crusinallo. Si mettevano insieme, facevano una specie di marcia e
cantavano e se qualcuno non «andava» lo prendevano. Tra noi ragazze non si parlava
di fascismo, perché non si poteva parlare, però eravamo tutti uniti, nessuno voleva il
duce... e allora si lavorava e basta. [...] C’era paura. Venivano anche in casa a vedere se
c’erano delle armi. Sono venuti anche a casa nostra (Maria Cerri).
Ricordo che avevo paura... tutti avevano paura, perché erano momenti brutti, perché
i miei padroni dicevano che si aspettavano che succedeva qualcosa di brutto. Quando
andavo al mercato vedevo i fascisti con le divise, erano in gruppo, avevo paura, perché
sapevo che davano l’olio di ricino, anche se a me non hanno mai fatto niente. Mi dava
fastidio fare il saluto fascista quando li incontravo, però bisognava farlo e stare zitti:
questa era la regola per poter vivere tranquilli (Lidia Volpones).
Mi ricordo le camicie nere che andavano a prendere i comunisti con il manganello e
davano l’olio di ricino. A Gravellona c’era la caserma dei fascisti e c’era qualche capo
di Gravellona. Mi ricordo che andavano anche nelle case per vedere se c’erano nascoste
bandiere rosse. Se le trovavano portavano le persone in caserma e loro avevano paura.
La caserma era proprio vicino a casa mia, c’era poca strada da fare. Ho visto portare
dentro dei comunisti... che paura... due o tre li hanno anche uccisi (Settima Fornara).
C’erano le squadracce, formate da due o tre persone. Prendevano un antifascista, lo
tenevano fermo e giù olio di ricino. Mi ricordo, per sentito dire, di due meridionali
Sculli e Crocitti, che avevano una trentina d’anni ed erano fascisti. Questi qui hanno
preso uno di vicino a Novara che si era chiuso in un gabinetto e l’hanno accoltellato
perché era antifascista (Vincenzo Giovinazzo).
31
Filippo Colombara
Il fascismo è stata una cosa negativa e non positiva, perché c’erano delle restrizioni nella
libertà. Io mi sono sposata nel ’37 e sono andata in viaggio di nozze a Ginevra. Era il
primo maggio e mi ha fatto specie vedere nelle stazioni svizzere le ragazze che offrivano
mazzetti di mughetti per celebrare il primo maggio, che da noi era una giornata lavorativa.
Il fascismo era un partito totalitario e inducevano a pensarla come loro. Avevo più o
meno quindici anni e sapevo che persone che non la pensavano come loro erano
sottoposte a vigilanza. Vedevo anche che andavano a perquisire le case per vedere se
c’erano bandiere rosse. Ma di queste cose non si parlava, prima di tutto perché non si
poteva tanto parlare e poi una donna... cosa vuole (Ermanna Rizzoni).
Manganelli, olio di ricino, caccia alle bandiere rosse e affermazioni come:
«avevamo paura», «non si poteva parlare» sono i rimandi immediati
all’esperienza vissuta. Aneddoti efficaci per introdurre il ricordo di un clima
colmo di timori e paure.
A Omegna erano tutti fascisti per forza, perché si aveva paura. Noi non parlavamo di
fascismo neanche con le amiche perché avevamo paura. [...] Di politica in fabbrica non
si parlava perché c’erano le ruffiane che andavano in ufficio a riferire... era pericoloso.
Quando si usciva dalla fabbrica si andava in fretta a casa e... dentro (Aurora Rossari).
Avevamo paura che venissero in casa a fare disastri... Per quello stavamo zitti. Sono
andati a casa di tanti che erano «fissi» con le idee; i fascisti andavano, spaccavano
tutto e davano anche l’olio di ricino (Roberto Ferretti).
A quei tempi dovevamo restare in casa perché giravano i fascisti e noi avevamo paura.
Mio papà mi diceva che aveva paura... lui non era fascista (Giuseppina Freschini).
In modo significativo gli intervistati estremizzano le condizioni del vivere
quotidiano, selezionando le parole adeguate a rappresentare sentimenti e
inquietudini provati.
Volevano solo soldi e roba e eravamo tutti schiavi... specialmente gli uomini. [...]
Quando c’era qualche festa bisognava stare attenti a come si parlava. A qualche ubriaco
magari scappava una parola sbagliata e giù botte da orbi. Davanti a tutti, eh! e guai
parlare. Ridere quando ridevano, stare seri quando erano seri. Io rimanevo male quando
vedevo dare le botte... Ho sempre cercato di stare zitta, ma mi dispiaceva (Santina
Mengozzi).
Allora eravamo come schiavi. Non potevo dire qualcosa contro di lei, per esempio,
perché riportavano al fascio. Non c’era libertà di parola (Celeste Ardizzi).
32
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
Non c’era libertà come adesso. Eravamo schiavi di noi stessi! Mi ricordo ancora le
manganellate... (Giuseppe Giovenzani).
C’era un’atmosfera un po’ tesa che dava fastidio, però era bello uscire la domenica.
Era però più bello pensare di uscire che non uscire regolarmente, perché avevamo
sempre l’animo triste per via di questo clima. La cosa peggiore è stata la mancanza di
libertà, la tensione che c’era nell’aria e che erano i fascisti a crearla... Tutto un insieme
di cose che ci facevano vivere male. Sono contenta di aver potuto vivere in un periodo
diverso, dove si può esprimersi e, soprattutto... dove non c’è la paura (Lidia Volpones).
Come si nota le parole scelte appaiono ferme e chiare: Mengozzi, Ardizzi
e Giovenzani usano senza problemi il termine «schiavi» per affermare la
propria opinione sulla vita durante il fascismo. Termine eccessivo, certo,
ma appropriato per ricordare gli obbligati silenzi e le deprivazioni che hanno
condizionato le culture familiari. Esemplare un altro racconto:
Fiorina F.: «Mio figlio era un balilla, doveva mettere la divisa: pantaloni neri corti, il fez e
la camicia nera. Doveva andare alle esercitazioni e anche quando andava a scuola doveva
vestirsi così. Lui era contento perché... sa com’erano i bambini, basta che trovavano da
divertirsi. Per me il fascismo era come un ruìna famìli, perché quello che facevano non era
bello. In fabbrica non si potevano fare discussioni. Bisognava dire sempre che era cotta
anche se era cruda, perché c’erano le ruffiane che se sentivano qualcosa andavano in ufficio».
Virginia Paravati: «Suo marito come la pensava?».
Fiorina F.: «È sempre stato comunista e forse anche per quello non trovava lavoro. Lui
tutte le mattine andava in stazione a vedere se c’era qualche lavoro da fare, perché
c’era sempre qualcosa da fare in stazione, così lavorava... e ce la siamo cavata. Nel ’35
è stato assunto alla Cobianchi, dove faceva il capo piazzale. Nessuno lo ha aiutato a
entrare... Avevano bisogno di un capo piazzale e così...».
Virginia Paravati: «In casa parlavate di fascismo?».
Fiorina F.: «Cercavamo di non parlarne neanche quando c’erano i figli, perché - sa
com’è - loro frequentando i gruppi fascisti la pensavano in modo diverso, perché
conoscevano solo quello, erano nati con il fascismo».
Le affermazioni della donna, pur nella loro essenzialità offrono un quadro
lucido delle divisioni generazionali all’interno delle famiglie: genitori che
non dialogano di politica in presenza dei figli perché «loro frequentando i
gruppi fascisti la pensavano in modo diverso». Anche un’altra intervistata si
sofferma sulle divisioni prodotte dal regime nelle comunità: a Loreglia, per
esempio, non si annoverano fascisti tra gli anziani - individui formati dalla
tradizione e quindi piuttosto riservati - ma tra i giovani, perché «erano stati
33
Filippo Colombara
coltivati così» (Maria Zamponi). Con poche parole le due testimoni
riassumono il significato di un mondo privo di diritti politici e lacerato sul
piano culturale.
Diversamente, per ovviare alle paure e per non rimanere coinvolti in
vicende tragiche, l’unico rimedio - indotto e stimolato dal potere - risulta
essere quel farsi gli affari propri, tipico di culture già intrise di individualismo
e familismo. Prevale l’amore per il quieto vivere e specie durante i mesi
della repubblica sociale molti decidono di evitare scelte di parte, attendendo
l’evolversi della situazione ed esponendosi solo dopo, a conflitto concluso.
Il periodo fascista è stato un periodo tranquillo. A casa nostra non si leggeva, alla sera ci
trovavamo tutti insieme, anche con i fratelli. Questa era la nostra vita: di giorno si
lavorava e di sera stavamo tutti insieme con la lanterna a petrolio. Non si parlava di
politica anche perché i fascisti ci conoscevano e visto che non disturbavamo ci hanno
sempre lasciati tranquilli (Esterina Borioli).
In quel momento importante era poter andare a lavorare. Di fascismo mio papà non
voleva discorrere, lui voleva essere libero da tutto. Non voleva essere da una parte o
dall’altra e mi séri ’na fiòla... sì che navi a pinsà certi ròb. [...] Mi ricordo questa guerra,
püsè che piànsgia e suspirà... Poi non si poteva neanche parlare. Invece prima della
guerra bastava non molestare e si andava bene57 (Alma Puppieni).
Bisognava stare attenti a come ci muovevamo nei posti pubblici, perché il fascio avrebbe
voluto che tutti si iscrivessero ma c’erano quelli che non volevano iscriversi. C’era un
clima di tensione, non si era liberi. Bisognava stare attenti alla sera... C’era tensione.
Però se li lasciavi stare si poteva vivere. In quei momenti si diceva che il fascismo era
bellissimo e noi siamo cresciuti così. Con la guerra d’Africa e quella di Spagna ho
cominciato a pensare a tante cose e il fascismo non sembrava più così bello. [...] Però
la vita era normale, per noi che siamo nati nel fascismo bastava stare quieti, lavorare e
starsene a casa (Giuseppina Pavan).
Il riandare al passato causa anche pesanti censure, tanto che ancora oggi
permangono dei timori nell’essere troppo espliciti. Alla richiesta di
un’opinione sul fascismo, Maria Cerri risponde: «Io ho sempre lavorato... e
basta» e Giuseppina Freschini: «Più che andare a lavorare... Poi dicevano
che [Mussolini] l’avevano appiccicato su un muro e gli sputavano addosso...
Ha sbagliato a fare la guerra».
In altri casi, pur in presenza di giudizi pronunciati con fermezza, i racconti
sono vistosamente impoveriti, affiorano divagazioni e talora i silenzi. Alle
spalle di una descrizione essenziale si cela il non detto, i fatti privati, i drammi
34
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
e le violenze che la guerra civile ha originato. È il lato oscuro di queste
memorie, mai pacificate e incapaci di negoziare una versione narrabile di
quelle vicende.
Peraltro verso, sono sorte memorie contrapposte. Com’è intuibile, un
ventennio di regime, il suo tragico epilogo e gli anni successivi, tra continuità
e innovazione politica, hanno lasciato pesanti tracce; un’intera generazione è
nata e cresciuta con il fascismo e in taluni casi i suoi appartenenti hanno
elaborato una memoria priva della volontà di rivedere criticamente
quell’esperienza. Una memoria che per interpretare la realtà dei fatti si è valsa
di una lettura del passato satura di rancori, generatrice di asti nei confronti
del movimento partigiano e fautrice di un certo modo di pensare. Ancora
una volta a propendere per il fascismo, a preservarlo dal punto di vista
ideologico e storico è il ricordo di Benito Mussolini; per chi si pone su posizioni
parecchio moderate - senza dichiararsi fascista - è indubbio il suo impiego.
Clara C.: «Credevo nel fascismo perché sono cresciuta sotto la sua dottrina. Anche a
scuola la maestra insegnava il programma che il fascismo rilasciava all’inizio dell’anno
scolastico. Non ho mai capito perché il fascismo fosse così importante nella dottrina
scolastica. Noi entravamo e la maestra magari ci dava un dettato sul duce... e così noi
dovevamo fare il tema. Io ho sempre dato fiducia al duce... Sono i fascisti che hanno
tradito il suo credo!».
Virginia Paravati: «Qual era il suo credo?».
Clara C.: «La giustizia. Noi anche dopo la guerra e ancora per parecchi anni abbiamo
utilizzato il contratto nazionale di lavoro studiato dal duce: mutua, assicurazione, pensione».
Virginia Paravati: «Cos’è che non ha funzionato allora?».
Clara C.: «Quello che non funzionerebbe oggi se andasse al potere un altro: la gelosia
del potere».
Virginia Paravati: «Si ricorda quegli anni in modo positivo?».
Clara C.: «Sì, mi piaceva fare il capo delle giovani italiane, mi piaceva la disciplina...
mi piace ancora adesso avere l’ordine». [...]
Virginia Paravati: «Era normale diventare fascisti?».
Clara C.: «Sì, perché siamo cresciuti sotto quella dottrina».
Virginia Paravati: «E come mai qualcuno non ci credeva?».
Clara C.: «Perché l’idea non è riuscita a superare il carattere di quelle persone».
Virginia Paravati: «Lei le stimava quelle persone?».
Clara C.: «Io stimavo il fascismo per quello che scriveva, perché quello che metteva in atto
era un’altra cosa, gli italiani erano altra cosa. Io non facevo politica, stimavo anche le idee
degli altri, perché per me è importante credere nelle idee, credere in qualcosa. Del resto
mio papà non era fascista, non è mai stato iscritto al fascio, io sì perché ero obbligata per
ragioni di studio e di lavoro».
35
Filippo Colombara
Angiolina A.: «Ma guardi, io ero una ragazza e a me poco interessava di Mussolini,
non ne volevo né bene né male, perché sa, se uno parlava male di Mussolini andava al
“confine” eh, non si poteva perché c’era la dittatura. Però tutto sommato per me non
era un uomo cattivo, benché non sono mai stata una fascista neh, perché io non ero
un bel niente».
Filippo Colombara: «Cosa vuol dire “Non era un uomo cattivo”?».
Angiolina A.: «Non era un uomo cattivo perché si ricordi bene che noi si andava a
lavorare ma si lavorava sempre. All’epoca di Mussolini ci han dato una settimana di
ferie, óhu, ma lo sa che festa grande per noi! Una settimana di ferie prima non esisteva.
Poi cosa c’è arrivato, la mutua, ma prima ancora per Natale ci ha dato la tredicesima,
e abbiamo comperato qualche cosina eh, mi capisce. Invece, quando avevamo il nostro
Giuanìn caghèta, il nostro re Vittorio Emanuele III, che quello lì lo chiamavamo così
perché era un guerrafondaio, c’era una miseria enorme. Io la fame l’ho fatta in tempo
di guerra, dico la verità, perché non c’era... Ma però nel periodo di Mussolini la fame
a casa mia non l’abbiamo mai fatta, perché noi abitavamo qui nelle case della De
Angeli e si può dire che per quello che ci facevano pagare d’affitto la casa era regalata,
poi avevamo la luce a gratis, l’acqua gratis. Sa, Frua58 era una bravissima persona, dava
tanto a noi operai, invece gli altri di Omegna che lavoravano negli altri stabilimenti
non avevano quello che avevamo noi. Poi nelle case avevamo tanto giardino e allora il
tempo non era come adesso, prima il tempo aveva le sue stagioni, perciò avevamo
tanto, tanta verdura, tanta frutta. Si mangiava e si stava bene, ha capito!».
Filippo Colombara: «Da quello che si ricorda negli anni trenta il livello di vita è
migliorato, si stava meglio...».
Angiolina A.: «Rispetto a quando c’era il re, io non ero al mondo, ma sentivo mia
mamma che diceva... non mi faccia parlar male. Quello lì ha cominciato nell’11 e nel
’12 la guerra in Libia, poi cosa ha fatto, dal ’15 al ’18, poi c’è stata la rivoluzione fascista
e piütöst che bugià un pè ha lasciato entrare Mussolini a fare la marcia su Roma e “tintintintintintéla”. Tutto sommato il re l’ha mai fai niente, quello che abbiamo avuto, questa è
la pura e santa verità, l’abbiamo avuto da Mussolini. È lui che ci ha dato, quello che ha
sbagliato questo uomo è mettersi con Hitler, ha rovinato l’Italia, anzi poi dopo il ’35’36 abbiamo avuto l’Africa, l’impero e lüi l’è diventà imperatore, pòd ma capì, dopo l’ha
fac’ svèltu a firmà cula del ’40-’45, però è stata finita anche per lui»59.
Mariolina M.: «Pensando a quei momenti lì era meglio allora che adesso, perché
adesso a che punto siamo? Se c’era ancora Mussolini, Mussolini non c’era più va beh,
poteva essere un suo figlio non so, ma siamo arrivati al punto che non si è neanche
più sicuri di stare in casa e di uscire! Dove abito io a [...] rimane un po’ fuori, una
volta era pieno di gente e adesso siamo rimasti due famiglie. Ci vediamo al mattino...
e alla sera quando viene notte fa paura, perché isolati e con tutto quello che si sente.
Non c’è mai stato niente e quest’anno per la prima volta hanno rubato in una casa
vicino alla mia... non c’è più la gente, non c’è più la socialità di una volta, chi rovina
36
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
è la televisione... Poi la gente è cambiata, non è più quella di una volta, sono falsi, le
hanno addosso tutte». [...]
Filippo Colombara: «Volevo chiederle, c’erano delle differenze tra il duce e i fascisti in
genere, i fascisti locali si comportavano in maniera corretta...».
Mariolina M.: «Da quello che mi ricordo io si sono sempre comportati in maniera
corretta, dicevano che ai primi tempi quando è andato su il fascio - ma io non ero
nata - davano l’olio di ricino, però non so se è vero perché io non ero nata, questo era
del ’21, ’22».
Filippo Colombara: «Nel suo paese non sa se ci sono state persone che hanno avuto
queste storie?».
Mariolina M.: «Ma sì dicevano, però non so se era vero. Dicevano che c’erano...
Difatti c’è stato un mio parente alla lunga, padre di due bambini, che in tempo di
guerra i partigiani l’hanno prelevato, l’hanno portato e l’hanno ucciso perché dicevano
che era fascista. Io non ho mai sentito che faceva del male a nessuno, andava via,
lavorava, andava a vendere i polli e se da giovane ha partecipato a quelle cose lì, a dare
l’olio, sempre se è vero perché io non mi ricordo di niente, non lo so». [...]
Filippo Colombara: «Volevo chiederle della guerra, nel ’40 c’è stata la dichiarazione di
guerra...».
Mariolina M.: «No, nel ’39 nel mese di giugno...».
Filippo Colombara: «No era il ’40».
Mariolina M.: «Ah sì, so che era il mese di giugno, la data non me la ricordo più. E
quel mese tutti piangevano. Erano preoccupati perché andavano via, chi tre chi quattro
in famiglia, a casa mia in pochi mesi ne sono andati sotto quattro eh».
Filippo Colombara: «Del duce cosa si diceva allora?».
Mariolina M.: «In quel momento lì non dicevano niente del duce, perché dicevano:
“La guerra è sempre stata e sempre sarà”, non dicevano niente, né bene né male.
Proprio male male io non ho mai sentito parlare, han parlato poi male in ultimo,
quando c’è stato l’8 settembre del ’43, che è andato giù il fascio. Allora ne parlavano
male e tutte le colpe erano del duce, mentre prima no. Del duce e della Petacci, che
aveva questa amante, ecco».
Rossana Mangeruca: «Senta signora, ma qui a [...], dalla parte proprio della gente che
lavorava, il fascismo com’era sentito?».
Ada Milani: «Ma in principio c’è stato sa, sono andati su un po’ con la prepotenza,
allora erano un po’ schisc’, poi quando han visto tante cose, per esempio come le
pensioni, come per i medici così, cambiavano un po’, ecco. E allora s’évan quasi tüc’
fascista, ecco, a dir la verità».
Enrica C.: «Eravamo tutti fascisti, il fatto è che poi non hanno il coraggio di ammetterlo,
non so perché, perché o per amore o per forza si doveva essere iscritti al fascismo. [...]
Mio papà era andato a lavorare in Germania e naturalmente la nostra famiglia era tacciata
di fascismo. Va bene, siamo cresciuti in quell’ambiente e io dico sinceramente che fino
al ’43 sono stata una fascista fervente, perché nata e cresciuta con quell’ideale. Per me il
37
Filippo Colombara
duce era il non plus ultra, dopo naturalmente s’è visto gli sbagli che ha fatto, se sono
stati sbagli, perché bisogna anche vedere l’influenza che ha avuto quell’altro su di lui. È
stato forse un po’ succube di Hitler. Ma lì si deve anche pensare questo: o sei con me o
sei contro di me. E essere contro a quello lì, l’Italia la faceva in un boccone come ha fatto
con la Polonia, vero? Però quando c’è poi la seconda repubblica di Salò, naturalmente
tutti gli ideali sono caduti capisci? I fascisti di allora io non li potevo vedere perché
erano delinquenti semplicemente, era tutta la feccia poi che si era raggruppata. Comunque
mi hanno anche detto che io ero una spia dei fascisti e sono venuti a prendermi una
sera. Due partigiani mi hanno portato via un’ora, però quello lì era un partigiano all’acqua
di rose, era un trombone più che altro, perché era venuto senza un’autorizzazione del
comando, c’era stata una soffiata al comando, però uno di [...], quello che ha fatto poi
del male a mio padre, ha detto: “No, vi sbagliate”. Lui doveva venirmi a prelevare e
portarmi su al comando. Ha detto: “No, garantisco io che quella ragazza non se la
intende di sicuro con i fascisti”, perché il paese era sempre pieno tutte le notti».
Le testimonianze, di cui abbiamo dato un ampio stralcio, appartengono
a quell’area culturale del paese che ha interpretato positivamente
l’esperienza fascista. Dalle parole delle intervistate emergono cenni sulla
gamma di temi riaffermati dalla destra fin dal dopoguerra. «Mi piaceva la
disciplina... mi piace ancora adesso avere l’ordine» dice Clara; allora «c’era
più ordine su tutto» ribadisce Mariolina, precisando che erano migliori
quei tempi dato che oggi «non si è neanche più sicuri di stare in casa e di
uscire». Clara, ancora, stimava il fascismo «per quello che scriveva», ma
non per quanto realizzava e ciò a causa degli italiani, che «erano un’altra
cosa». La donna, in questo caso, richiama una posizione propria degli
ambienti neofascisti. Si tratta del giudizio evoliano di infelice disposizione
di gran parte del popolo ai valori fascisti. Gli italiani sono interpretati dal
punto di vista antropologico come una nazione pulcinellesca, originata
dall’incrocio di molte razze, alcune delle quali caratterizzate da
atteggiamenti furbeschi, prive di spirito di sacrificio e disposte a cambiare
opinione con estrema leggerezza per il proprio tornaconto. Secondo queste
tesi, i motivi d’insuccesso del fascismo consistono nell’aver sopravvalutato
il carattere degli italiani60.
Di seguito compaiono argomentazioni già riscontrate: dal Mussolini
regale e propugnatore di giustizia, rammentato da Clara, all’elencazione
delle opere di carattere sociale istituite dal duce, ricordate da tutte le
intervistate. Singolari nelle narrazioni sono poi gli atteggiamenti ingenui,
finti o reali, proposti da Clara, che non comprende l’importanza attribuita
dal fascismo all’indottrinamento scolastico, e da Mariolina, la quale non è
38
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
certa che i fascisti dessero l’olio di ricino agli avversari, dato che non ha mai
assistito di persona a fatti del genere.
Infine, si manifestano le distinzioni sulle responsabilità degli eventi.
Angiolina, per esempio, salva Mussolini e affossa il re, giudicato ambizioso,
poco preoccupato delle condizioni di miseria del popolo e colpevole delle
guerre prefasciste, ed Enrica distingue tra il fascismo del Ventennio - a cui
aderì con fervore - e la repubblica sociale, che ha raccolto nelle proprie
schiere un coacervo di individui.
Da queste testimonianze, altre se ne potrebbero aggiungere, appare chiaro
che nel mezzo secolo trascorso dalla fine del regime il dibattito su
quell’esperienza ha indotto, anche in parte di strati popolari, riflessioni
superficiali piuttosto che prese di coscienza. Si è preferito accantonare anziché
comprendere quei venti anni di storia italiana, per poi, in periodi favorevoli,
esibirli nuovamente all’insegna del buon tempo andato e di un generico
bisogno di ordine.
Io, le dirò, per me era meglio quando c’era il fascio che adesso; io non sono fascista,
non tengo a nessun partito, ma per me sì. Perché c’era più ordine. Il duce ha messo
l’ospedale, la pensione, ha fatto le colonie marine dove sono andati tutti, ha fatto
tante cose, ha fatto anche del male perché ha fatto anche lui le sue; ha avuto i tradimenti,
ha sbagliato anche lui ma ha fatto anche tante cose belle. E c’era più ordine su tutto,
era una lira era una lira, spettava dieci lire spettava dieci lire. Adesso, cosa vuole, la
roba continua ad aumentare, la pensione diminuisce, non so cosa dire io, se possono
portano via anche quella poca pensione come magari avverrà un giorno, altro cosa
c’è? (Mariolina M.)
Note al testo
Il saggio fa parte di un progetto di ricerca sulla memoria del fascismo e della resistenza
nel Piemonte nord-orientale, che ho in corso da diverso tempo. Un primo saggio:
Memorie di una guerra infinita. Fonti orali e tipologie di trasmissione dell’esperienza è
pubblicato in «Ieri Novara Oggi. Annali di ricerca contemporanea», 4-5, 1996, pp.
28-90. Un secondo saggio, che riprende e amplia un paragrafo del precedente, L’identità
del nemico nella memoria resistenziale del Piemonte nord-orientale, è pubblicato nel
volume Introduzione alla storia orale, vol. II, Esperienze di ricerca, a cura di Cesare
Bermani, Odradek, Roma 2001, pp. 23-39. Un terzo saggio, Il carnevale di Mussolini.
25 luglio 1943: simboli e riti di una comunità nazionale, è pubblicato in «l’impegno.
Rivista di storia contemporanea», 1, 2005, pp. 31-57. Il presente testo, riprende
39
Filippo Colombara
anch’esso un paragrafo del lavoro del 1996, ma lo amplia notevolmente. Per la sua
stesura, occorre ringraziare Virginia Paravati, che ha raccolto e messo a disposizione
numerosi documenti orali e ha discusso parti dell’elaborato.
1
Cfr. LUISA PASSERINI, Mussolini immaginario. Storia di una biografia 1915-1939,
Laterza, Roma-Bari 1991, p. 203.
2
Cfr. GAUDENZIO BARBÈ, Mussolini a Novara, supplemento al «Corriere di Novara»,
17 marzo 1975, p. 6.
3
Cfr.: «L’Italia Giovane», 17 e 20 maggio 1939; 18 maggio 1939: la visita di Mussolini
a Novara e in provincia, realizzazione di Ugo Schleifer, Carlo Brezzi, Carlo Viana,
pellicola non sonorizzata, durata: 11’12”, in A passo ridotto. Cineguf, Cinegil ed
esperienze cinematografiche a Novara negli anni ’30 e ’40, video vhs a cura di Adolfo
Mignemi e Marco Fontana, in Novara fa da sé. Ascesa e declino della dittatura fascista
in terra novarese 1922-1943, Isrn-Provincia di Novara, Novara 1999; La visita di
Mussolini nel Novarese del 1939, in La scena del dittatore. 8 ottobre 1934: Mussolini a
Novara, cd-rom a cura di Adolfo Mignemi, ibid. In quest’ultimo supporto sono
riprodotte anche le immagini del grande arco di trionfo realizzato a Orfengo, porta
d’ingresso della provincia, con la scritta: «La Provincia di Novara saluta nel Duce il
fondatore dell’Impero».
4
Traduzione: Siamo andati a vedere anche il duce. [...] Era un bell’uomo.
5
Traduzione: È passato da Romagnano tanti anni fa. Ero una giovinetta e io e il
Massimo, a piedi, siamo andati giù sul ponte di Romagnano. È passato il Duce, un
bell’uomo, un morettone.
6
Traduzione: Te ne accorgerai.
7
Traduzione: C’era un mio cugino che abitava lì alla Mulògna che lavorava con me e
allora è venuto e ha detto: «Guardate donne, se volete vi pagano la giornata». «Ah sì,
allora se ci pagano la giornata, cià che andiamo». [...]«tutte già morte» [...]. «Deh,
devo stare qui in questa piazza...» [...]. «Ah no, donne adesso io vado». «Ma sei matta
neh, se vai fuori di qui ti ammazzano...» [...]. «Ah sì, questa è bella, deh Poletti
dobbiamo alzarci?». «Ma vai un po’ là vai, lascia che passi». [...] Dopo un po’ dico: «È
ben intelligente quello lì, ma ha da farci piangere quello lì».
8
Traduzione: Stava nel mazzo insieme agli altri.
9
Traduzione: Traccagnotto.
40
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
10
Negli occhi si rispecchia il suo «carattere insieme multiforme e irriducibile (o la
pretesa di esso)» (LUISA PASSERINI, Mussolini immaginario cit., p.73).
11
Questo incontro, come vedremo più avanti, avviene in una circostanza diversa dalla
visita novarese.
12
La testimone vede Mussolini non nel 1939 ma negli anni venti, alla stazione
ferroviaria di Domodossola.
13
Cfr. La memoria come oggetto sociologico: intervista ad Alessandro Cavalli a cura di
Anna Lisa Tota, in La memoria contesa. Studi sulla comunicazione sociale del passato, a
cura di Anna Lisa Tota, Franco Angeli, Milano 2001, p. 35. Per un’analisi delle
generazioni, cfr. Età e corso della vita, a cura di Chiara Saraceno, Bologna, Il Mulino,
1986.
14
Cfr. MAURICE HALBWACHS, I quadri sociali della memoria [1925], Ipermedium, Napoli
1997, pp. 34-35.
15
Cfr. MARIO ISNENGHI, L’Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai
giorni nostri, Mondadori, Milano 1994, pp. 310-313.
16
Cfr. LUISA PASSERINI, Mussolini immaginario cit., pp. 74-75.
17
Sui poteri taumaturgici cfr. MARC BLOCH, I re taumaturghi. Studi sul carattere
sovrannaturale attribuito alla potenza dei re, particolarmente in Francia e in Inghilterra
[1924], Einaudi, Torino 1973; su quelli di Mussolini cfr.: CLAUDIO FOGU, «Il Duce
taumaturgo»: Modernist Rhetorics in Fascist Representations of History, «Representations»,
Winter, 57, 1997, pp. 24-51; SERGIO LUZZATTO, L’immagine del duce. Mussolini nelle
fotografie dell’Istituto Luce, Editori Riuniti-Istituto Luce, Roma 2001, pp. 145-175.
18
Cfr. MARGHERITA SARFATTI, Dux, Mondadori, Milano 1926, pp. 297-298.
19
Cfr. FRANCO CIARLANTINI, Mussolini immaginario, Sonzogno, Milano 1933, p. 114.
20
Cfr. L’italiano nuovo. Letture della II classe elementare, Libreria dello Stato, Vallecchi,
Firenze 1936. Il brano è riportato in LUISA PASSERINI, Mussolini immaginario cit., p.
200.
21
A titolo esemplificativo, cfr. «Un giovane milite della Rsi bacia la mano a Mussolini.
Nord Italia, 1944», immagine fotografica riprodotta in SERGIO LUZZATTO, Il corpo del
duce. Un cadavere tra immaginazione, storia e memoria, Einaudi, Torino 1998, fig. 3.
41
Filippo Colombara
22
Traduzione: Dato un buffetto sulla guancia.
23
Dell’evento esistono i seguenti filmati Luce: Giornale muto n. 966; Giornale sonoro
n. 93; Documentario sonoro n. 9031, cfr. ADOLFO MIGNEMI, L’immagine della vita
provinciale nei filmati «Luce» (1928-1944), in Novara fa da sé cit., pp. 59, 62.
24
Cfr. MIRIAM MAFFAI, Pane nero. Donne e vita quotidiana nella seconda guerra mondiale,
Mondadori, Milano 1987, p. 77. Sulla salute del capo del fascismo, cfr. PAUL O’BRIEN,
Al capezzale di Mussolini. Ferite e malattia 1917-1945, «Italia contemporanea», 226,
2002, pp. 5-29.
25
Cfr. ANGELO MICHELE IMBRIANI, Gli italiani e il Duce. Il mito e l’immagine di Mussolini
negli ultimi anni del fascismo (1938-1943), Liguori, Napoli 1992, pp. 170-172.
26
Cfr. SERGIO LUZZATTO, Il corpo del duce cit., p. 138.
27
ANGELO NIZZA e RICCARDO MORBELLI, La leggenda di domani. Racconto per ragazzi,
popolani e soldati, Corbaccio, Milano s.d., citato in LUISA PASSERINI, Mussolini
immaginario cit., pp. 197-198.
28
Cfr. LUISA PASSERINI, Torino operaia e fascismo. Una storia orale, Laterza, Roma-Bari
1984, p. 136.
29
Tra i tanti si veda e si ascolti il discorso di Italo Balbo alla folla di emigrati italiani a
New York dopo la trasvolata oceanica del 1933 (uno spezzone è contenuto nel
documentario televisivo Emigranti, di Roberto Olla, Raitre, «La Grande Storia», 18
febbraio 2002).
30
Tra le numerose immagini in cui si propone questo stereotipo, per esempio, due
fotografie relative a manifestazioni pubbliche svoltesi nel borgo cusiano di Gozzano:
«Cerimonia alle Scuole elementari» in FRANCESCO RUGA, Gozzano. Storie senza Storia.
I primi cinquant’anni di vita gozzanese del Ventesimo secolo, Eos Editrice, Oleggio 1997,
p. 93; «12 maggio 1935, posa della prima pietra della Casa San Giuseppe» in ID.,
Gozzano. Sguardi sul Novecento, Eos Editrice, Oleggio 2000, p. 135.
31
Cfr. «Il segretario federale fascista di Novara, Gianni Mariggi, raccoglie un covone
di grano durante la cerimonia per la trebbiatura in piazza Vittorio Emanuele»,
fotografia riprodotta da ADOLFO MIGNEMI, Immagini per piccole e grandi cronache
novaresi: Bonzanini e la fotografia di avvenimenti pubblici, in Umberto Bonzanini
1900-1988. Gli occhi di un’epoca, a cura di Marco Rosci, Eugenio Bonzanini, Novara
2000, p. 192.
42
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
32
Inteso come liggèra, combriccola di scapestrati.
33
Cfr. LUISA PASSERINI, Torino operaia e fascismo cit., pp. 128-130.
34
Archivio Comune Castelli Cusiani, XV, 224-3, Circolari e corrispondenze, 19281937, lettera del commissario prefettizio al prefetto di Novara del 20 agosto 1929.
Sulle vicende di Angelo Gioria, cfr. FILIPPO COLOMBARA, Pietre bianche. Vita e lavoro
nelle cave di granito del lago d’Orta, Alberti libraio, Verbania 2004, pp. 181-182.
35
Giudizi femminili sostanzialmente pacati e ben diversi da quelli maschili emessi anche
da protagonisti del fascismo all’indomani della Liberazione. Per il giornalista Paolo
Monelli, la donna era una capricciosa «brunetta ricciuta e popputa (proprio il suo tipo)»
(PAOLO MONELLI, Roma 1943 [1945], Einaudi, Torino 1993, p. 41); per Cesare Rossi,
fascista della prima ora, il decadimento mentale di Mussolini era dovuto all’abuso di
afrodisiaci impiegati per soddisfare gli appetiti sessuali dell’amante (cfr. CESARE ROSSI,
Mussolini com’era. Radioscopia dell’ex dittatore, Ruffolo, Roma 1947, p. 279).
36
Cfr. ADRIAN LYTTELTON, La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929, Laterza,
Roma-Bari 1974, pp. 481-482.
37
Su questi aspetti, cfr. P AUL C ORNER , Fascismo e controllo sociale, «Italia
contemporanea», 228, 2002, pp. 394-402.
38
Su questi aspetti, già dibattuti in passato, cfr.: LUISA PASSERINI, Torino operaia e
fascismo cit., p. 134; SILVIA PERTEMPI, Montemassi. Terra e miniera in una comunità
della Maremma, Rosemberg & Sellier, Torino 1986, pp. 129, 134; NICOLA TRANFAGLIA,
Labirinto italiano. Il fascismo, l’antifascismo, gli storici, Nuova Italia, Firenze 1989, pp.
41-57. Per il Novarese cfr.: FILIPPO COLOMBARA, La terra delle tre lune. Classi popolari
nella prima metà del Novecento in un paese dell’alto Piemonte: Prato Sesia. Storia orale e
comunità, Vangelista, Milano 1989, pp. 224-226; MARTINA MERLO, Piccole e grandi
storie. Cireggio durante la Resistenza, Amministrazione comunale, Omegna 1992, pp.
15-16.
39
ERIC J. HOBSBAWM, I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale [1959], Einaudi, Torino
1974, p. 153.
40
Cfr.: Ibid., pp.152-153; PETER BURKE, Cultura popolare nell’Europa moderna,
Mondadori, Milano 1980, p. 150; BRONISLAW BACZKO, Immaginazione sociale, in
Enciclopedia, vol. VII, Einaudi, Torino 1979, p. 76.
41
ERIC J. HOBSBAWM, I ribelli cit., p. 154.
43
Filippo Colombara
42
Cfr.: Le illusioni la paura la rabbia. Il fronte interno. 1940-1943, a cura di
Aurelio Lepre, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1989; SIMONA COLARIZI,
L’opinione degli Italiani sotto il regime, 1929-1943, Laterza, Roma-Bari 1991;
A URELIO L EPRE, L’occhio del duce. Gli italiani e la censura di guerra 1940-1943,
Mondadori, Milano 1992; ANGELO MICHELE IMBRIANI, Gli italiani e il Duce cit.;
PIETRO CAVALLO , Italiani in guerra. Sentimenti e immagini dal 1940 al 1943, Il
Mulino, Bologna 1997.
43
PIETRO CAVALLO, Italiani in guerra cit., p. 24. Solo nel 1942, precisa l’autore:
«Scompariva quello che era il compito fondamentale della propaganda, orientare e
indirizzare, fornendo modelli di comportamento adeguati al momento. Di fronte al
contrasto sempre più evidente tra informazione ed esperienza diretta era quest’ultima,
ovviamente, a prevalere» (ibid., p. 250)
44
Cfr. LUISA PASSERINI, Mussolini immaginario cit., pp. 61-70.
45
Cfr. MARIO ISNENGHI, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla
cultura fascista, Einaudi, Torino 1979, pp. 170-171.
46
Per giornali scolastici del Novarese e Vercellese cfr.: [ADOLFO MIGNEMI], Tenere
menti incolte. Quotidianità scolastica e fascismo, in Sì e no padroni del mondo. Etiopia
1935-36. Immagini e consenso per un impero. Interventi e materiali, a cura di Adolfo
Mignemi, Regione Piemonte-Isrn, Torino-Novara 1983, pp. 137-153; «Cronache ed
osservazioni sulla vita della Scuola». Cravagliana 1940-1945, a cura di Alberto Lovatto,
«l’impegno», 1, 1991, pp. 42-50; CLAUDIO SAGLIASCHI, Il cerchio di ferro e di fuoco.
Note sull’impegno pratese durante la 2ª guerra mondiale, Tipolito Valsesia, Romagnano
Sesia 1995, pp. 483-494; TIZIANO BOZIO MADÈ, Libro e moschetto. Cronache quotidiane
dai registri di scuola, «l’impegno», 2, 1995, pp. 44-49.
47
Archivio Comune di Madonna del Sasso, IX, Boleto, Giornale scolastico 1930-31,
ottobre 1930.
48
Ibid., Giornale scolastico 1929-1930, 5 dicembre 1929.
49
Ibid., 12 febbraio 1930.
50
Ibid., Giornale scolastico 1930-31, 5 dicembre 1930.
51
Ibid., 23 febbraio 1931.
52
Ibid., Giornale scolastico 1928-29, 11 novembre 1928.
44
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
53
Ibid., Giornale scolastico 1935-36, 26 marzo 1936.
54
Cfr. A.M. [ADOLFO MIGNEMI], Bella copia, brutta copia. Note sulla quotidianità
scolastica, «Ieri Novara Oggi», 4, 1980, pp. 434-463.
55
Cfr. PIER GIORGIO ZUNINO, L’ideologia del fascismo. Miti, credenze e valori nella
stabilizzazione del regime, Il Mulino, Bologna 1985, pp. 50 ss.
56
Cfr. NOBERTO BOBBIO, De senectute e altri scritti autobiografici, Einaudi, Torino
1996, pp. 49-50.
57
Traduzione: io ero una ragazza... sì che andavo a pensare a certe cose. [...] più che
piangere e sospirare.
58
Si tratta di Giuseppe Frua, uno dei proprietari dell’azienda tessile De Angeli Frua.
59
Traduzione: piuttosto che muovere un piede [...]. E lui è diventato imperatore,
puoi solo capire, dopo ha fatto in fretta a firmare quella del ’40-’45.
60
Cfr. FRANCESCO GERMINARIO, L’altra memoria. L’Estrema destra, Salò e la Resistenza,
Bollati Boringhieri, Torino 1999, pp. 86-90. Sulle posizioni evoliane, cfr. JULIUS EVOLA,
Il fascismo visto dalla destra. Con note sul III Reich [1964], Settimo Sigillo, Roma 1989.
Elenco degli informatori, luoghi e date delle interviste
Le interviste sono state realizzate in varie occasioni e quasi tutte tra la metà degli anni
ottanta e l’inizio del nuovo secolo. Una decina appartengono alla ricerca di storia
orale svoltasi a Prato Sesia tra il 1984 e il 1985 da me (FC), con il contributo nella
prima parte di Gisa Magenes (GM). Altre interviste sono state raccolte negli anni
seguenti sempre da Colombara e Magenes; in qualche seduta sono presenti il ricercatore
Adolfo Mignemi (AM), e la studentessa Martina Merlo (MM). Un colloquio è stato
condotto da allievi della scuola media di Armeno: Valentina Ceresa, Luca Maio,
Claudio Maulini, Silvia Regalli, coordinati da Gisa Magenes. Rossana Mangeruca
(RM), invece, ha fornito copia di una delle sue interviste realizzate ad negli anni
settanta a Gozzano su fascismo e resistenza. Gran parte dei colloqui, infine, sono stati
realizzati nel 2001 da Virginia Paravati (VP) appositamente per questo lavoro.
Gli informatori resi anonimi sono indicati con nomi fittizi racchiusi tra virgolette.
«Angiolina A.» (Omegna, 1923), operaia. Omegna, luglio 2001 (FC).
Pier Antonio Agarla (Romagnano Sesia, 1932), operaio. Romagnano Sesia, 2 febbraio
1985 (FC).
45
Filippo Colombara
Celeste Ardizzi (Nonio, 1908), falegname. Omegna, 11 luglio 2001 (VP).
Giuseppe Arienta (Prato Sesia, 1911), operaio. Prato Sesia, 7 novembre 1985 (FC).
Albina Baraggiotta (Prato Sesia, 1911), operaia. Prato Sesia, 14 febbraio 1985 (FC).
Angelo Berenzi (Rovigo, 1900, res. a Novara), giornalista. Novara, 27 maggio1985
(GM-AM).
Cesarina Bonola (Prato Sesia, 1919), operaia. Prato Sesia, 25 ottobre 1984 (FC).
Eligio Borella (Omegna, 1939), operaio. Omegna, 29 ottobre 1986 (FC).
Esterina Borioli (Omegna, 1907), operaia. Omegna, 6 giugno 2001 (VP).
Renata Brasola (Omegna, 1925), operaia. Omegna, 10 gennaio 2002 (FP-VP).
«Enrica C.» (Gozzano, 1922), operaia. Gozzano, dicembre 1979 (RM).
«Clara C.» (1914), impiegata. Omegna, luglio 2001 (VP).
Cesare Castellano (Cassano delle Murge, 1913, res. a Verbania), barbiere. Omegna,
26 luglio 1999 (GM).
Maria Cerri (Lesa, 1907, res. a Omegna,), operaia. Omegna, 28 giugno 2001 (VP).
Bortolo Consoli (Vigolo, 1924, res. a Omegna), operaio. Omegna, 24 giugno 1991
(FC-GM-MM).
Pierino Dariani (Prato Sesia, 1901), operaio. Prato Sesia, 19 febbraio 1985 (FC).
Rina Della Zoppa (Prato Sesia, 1925), operaia. Prato Sesia, 5 ottobre 1984 (FCGM).
Giuseppina De Micheli (Crusinallo, 1925), insegnante elementare. Omegna, 13 luglio
2001 (VP).
«Fiorina F.» (Gravellona Toce, 1907), operaia. Omegna, 16 luglio 2001 (VP).
Roberto Ferretti (Tapigliano, 1921, res. ad Armeno), operaio. Omegna, 11 luglio
2001 (VP).
Cesarina Fioramonti (Casale Corte Cerro, 1907), operaia. Omegna, 16 giugno 2001
(VP).
Carmela Fornara (1896), negoziante. Prato Sesia, 7 febbraio 1985 (FC).
Settima Fornara (Gravellona Toce, 1908), operaia. Omegna, 25 agosto 2001 (VP).
Giuseppina Freschini (Agrano, 1912), operaia e contadina. Omegna, 13 luglio 2001
(VP).
«Giovanna G.» (Loreglia, 1924, res. a Omegna), operaia. Omegna, 23 febbraio 1991
(GM).
Giuseppe Giovenzani (Pallanza, 1905), giardiniere. Omegna, 26 agosto 1999 (GM).
Vincenzo Giovinazzo (Bovalino Murge, 1916, res. a Omegna), impiegato. Omegna,
13 giugno 2001 (VP).
Marco Guarnori, cuoco. Armeno, 27 gennaio 1995 (Studenti-GM).
Carolina Lianò (Napoli, 1915, res. a Omegna), casalinga. Omegna, 9 luglio 2001
(VP).
Mariuccia Lilla (Sovazza, 1924), contadina e operaia. Omegna, 29 dicembre 2001
(VP-FC).
«Marino M.» (1924), operaio. Omegna, giugno 1991 (FC-GM-MM).
46
L’immagine di Mussolini nelle memorie popolari del Novarese
«Mariolina M.» (1924), contadina e operaia. Omegna, dicembre 2001 (VP-FC).
Santina Mengozzi (Svizzera, 1910, res. a Omegna), operaia. Omegna, 17 luglio 2001
(VP).
Ada Milani (Gozzano, 1898), collaboratrice domestica, sarta, mondina. Gozzano,
dicembre 1979 (RM).
Edmea Mora (Prato Sesia, 1924), operaia. Grignasco, 25 ottobre 1984 (FC).
Giuseppina Pavan (Bagnolo di Po, 1914, res. a Milano), casalinga. Omegna, 21 agosto
2001 (VP).
Angela Pettinaroli (Omegna, 1923), operaia. Omegna, 12 luglio 2001 (FC).
Giovanni Perazzi (1894), operaio. Romagnano Sesia, 2 febbraio 1985 (FC).
Liliana Perazzi (Prato Sesia, 1934), operaia. Romagnano Sesia, 2 febbraio 1985 (FC).
Luigina Perazzi (Grignasco, 1920), operaia. Romagnano Sesia, 2 febbraio 1985 (FC).
Maria Pirovano (Crusinallo, 1905), operaia. Omegna, 15 giugno 2001 (VP).
Assunta Poletti (Alzo, 1906), operaia. Omegna, 5 aprile 2000 (GM).
Alma Puppieni (Crusinallo, 1920), operaia. Omegna, 18 giugno 2001 (VP).
Clotilde Rampone (Quarna Sotto, 1914), impiegata. Omegna, 5 luglio 2001 (VP).
Anna Maria Ranzini (Cavallirio, 1926, res. a Gozzano), casalinga. Cesara, 30 ottobre
2001 (FC-VP).
Francesco Rinolfi (Prato Sesia, 1926), coltivatore diretto. Prato Sesia, 21 febbraio
1985 (FC).
Ermanna Rizzoni (Cireggio, 1914), impiegata. Omegna, 26 giugno 2001 (VP).
Aurora Rossari (Francia, 1907, res. a Omegna), operaia. Omegna, 15 giugno 2001
(VP).
Maria Salvadego (Porto Tolle, 1929), operaia e mondina. Omegna, 6 giugno 2001
(VP).
Nicola Tosi (Paruzzaro, 1926), cameriere. Omegna, 14 luglio 2001 (FC-VP).
Lidia Volpones (Pordenone, 1917), collaboratrice domestica. Omegna, 8 giugno 2001
(VP).
Angela Zampone (Loreglia, 1905), operaia. Omegna, 11 luglio 2001 (VP).
Maria Zamponi (Loreglia, 1916), operaia e contadina, 5 luglio 2001 (VP).
47
Filippo Colombara
48
Le cartoline e i francobolli delle brigate garibaldine in Valsesia
Le cartoline e i francobolli delle brigate garibaldine in
Valsesia
di Edgardo Ferrari
A sessant’anni di distanza, può essere ancora di qualche interesse
ricostruire, sulla base della documentazione conservata presso l’Istituto per
la storia della Resistenza in provincia di Vercelli di Borgosesia, le vicende
delle cartoline delle brigate Garibaldi e dei progetti per l’emissione di una
serie di francobolli. Facciamo riferimento alle copie della corrispondenza
intercorsa fra Cino Moscatelli, comandante delle divisioni garibaldine in
Valsesia, ed Alfredo Dominietto durante i primi mesi del 1945. Cominciamo
pure dalle cartoline, edite comunque dopo il 25 aprile. Si tratta di sette
soggetti (mm. 103x148, stampa a sei colori) dal titolo: Ecco il mio stemma!,
Motorizzazione Garibaldina, Carburazione Garibaldina, Ecco i banditi...!!,
Pronto soccorso, Pari siamo: Io la scabbia e tu le pulci!, Il dilemma... Milanese.
49
Edgardo Ferrari
Al retro recano la scritta: «Brigate Garibaldi, baciate dalla gloria, le prime
nella lotta, le prime nella vittoria!» e di fianco la caratteristica stella alpina.
Furono disegnate da Alfredo Dominietto (Gio Rossi è lo pseudonimo)
nell’inverno 1944-45 a Piode in Valsesia ed arieggiano i soggetti delle
cartoline satiriche di Bertiglia e di altri autori sulla seconda guerra mondiale.
In data 25 gennaio 1945, Moscatelli, anche a nome di Ciro (Gastone) e di
Aldo (Secchia), scrive ad Alfredo: «Bellissimo l’acquarello delle pulci e della
scabbia, veramente indovinato e l’ho già mandato ad una persona che, con
gli altri, vedrà di farmeli riprodurre in cartoline». È facilmente riconoscibile
il risultato finale: si tratta della cartolina dal titolo Pari siamo: Io la scabbia
e tu le pulci. Il 5 aprile Cino sollecita: «Hai smesso la fabbricazione [delle
cartoline]? Guarda che noi abbiamo già trovato chi le stampa. Trova altri
soggetti e butta giù».
Le cartoline furono poi stampate a Milano, nei primi giorni della
Liberazione, dalla Casa d’arte Rota, con la quale la delegazione lombarda
del Comando generale delle brigate Garibaldi aveva avviato trattative fin
dal febbraio 1945. Diffuse in grande quantità, furono associate anche ad
una lotteria dell’ANPI numerandole in luogo dei biglietti.
Tutti e sette i soggetti furono ristampati, insieme con altro materiale,
nel 1973 a Borgosesia, quando fu concessa la medaglia d’oro al valor militare
alla Valsesia.
E passiamo ai progetti per i francobolli, che sottintendono la volontà di
essere pronti per la gestione dei servizi civili, ormai prossima, anche in
esecuzione di una direttiva del CLNAI, rappresentante del legittimo governo
italiano, a provvedere alla costituzione di un potere amministrativo ed al
funzionamento dei servizi essenziali al momento dell’accendersi
dell’insurrezione nazionale popolare.
In gennaio, Moscatelli scrive ad Alfredo: «Anche per i francobolli avrei
bisogno di parlarti, perchè siccome dispongo solo di attrezzatura tipografica
non so se mi sarà possibile riprodurre la soprastampa dei tuoi modelli sui
francobolli».
Ma dal marzo le prospettive sono diverse: ecco gli stralci della
corrispondenza al riguardo:
«Come già d’accordo farei una serie completa e precisamente: da cent.
50; lire 1; lire 2; lire 2,50 e in più un francobollo espresso. Credo inutile
fare un francobollo da 50 e 100 lire come tu proponevi. Di ogni tipo di
francobollo farai due serie complete e su una metterai “Posta Garibaldina”
e sull’altra serie metterai “Posta Partigiana” [...] Inoltre dovresti preparare
50
Le cartoline e i francobolli delle brigate garibaldine in Valsesia
delle sovrastampe per i vari tipi di francobolli già in corso tenendo conto
che la sovrastampa noi possiamo farla solamente con mezzi tipografici, cioè
senza clichés e quindi sia componibile a mano» (18 marzo 1945).
«Ti rimando pure i francobolli. Bellissimo Garibaldi, meno riuscito i
dieci fucilati. [...] mi hanno fatto osservare che bisogna mettere poste italiane
e non garibaldine. Direi quindi di mettere “Poste Italiane” e il prezzo a lato
mentre dall’altra può benissimo rimanere la stella alpina o un CLN come
già l’avevi fatto nelle sovrastampe...» (21 marzo 1945).
«Da parte nostra potremo fornire la carta filigrana ingommata. Per i
modelli di sovrastampa dei francobolli ti limiterai a fare una dicitura “Posta
partigiana”. Sia nei francobolli nostri che tu disegnerai sia per quelli sui
quali faremo la sovrastampa dovresti ideare tu una sigla CLN (quella che
avevi già fatto andava bene) e studiare il posto migliore per collocarla sul
francobollo» (5 aprile 1945).
L’idea dei francobolli, che non si sono realizzati, viene comunque coltivata
anche a Liberazione avvenuta. Il 30 giugno 1945, su carta del CLN/CVL
intestata Zona Militare «Valsesia» - Comando, Cino Moscatelli manda a
dire per lettera a Scoccimarro, ministro delle Finanze del governo Parri: «è
nostro vivo desiderio, poter celebrare la liberazione della Patria colla
emissione di una serie di francobolli commemorativi delle gesta dei
51
Edgardo Ferrari
52
Le cartoline e i francobolli delle brigate garibaldine in Valsesia
partigiani. A tal uopo ho inviato a Roma un mio incaricato (latore della
medesima) affinché possa ottenere l’autorizzazione per la stampa ed
emissione dei sopradetti francobolli».
L’autorizzazione non venne; i soggetti predisposti da Dominietto
furono utilizzati per dei chiudilettera, otto in tutto, che recavano la
dicitura «Poste Garibaldine» accanto al valore (cent. 50, 1 e 2 lire) e che
furono anch’essi ristampati nel 1973.
La considerazione finale su questa vicenda di francobolli, studiati e
non emessi, può essere la seguente: in tutti i protagonisti della Resistenza
era presente l’esigenza di legalità (le carte in regola di fronte alla storia):
lo prova la discussione sulla dicitura «Poste Garibaldine» o «Italiane».
D’altra parte la «repubblica» partigiana dell’Ossola non emise suoi
francobolli in attesa delle autorizzazioni richieste e si limitò a far eseguire
delle prove, sulle quali si innescò subito, dopo la rioccupazione, un
tentativo di truffaldina speculazione dei fascisti. I quali non avevano
mostrato scrupoli con la soprastampa GNR di Brescia, effettuata
disinvoltamente, all’insaputa dello stesso ministero delle Poste, nel
dicembre 1943 e con l’altra del gennaio successivo, ordinata dalla
segreteria del fascio di Alessandria.
La lezione di rigore morale e di senso della responsabilità fornita dal
comando delle brigate Garibaldi in Valsesia anche a riguardo della vicenda,
che abbiamo brevemente illustrata, non ha perso lo smalto iniziale e può
essere riproposta oggi, valida così, senza aggiustamento alcuno.
53
Edgardo Ferrari
54
Il peso della storia. La memoria della resistenza nell’Italia repubblicana
storia nazionale
Il peso della storia.
La memoria della Resistenza nell’Italia repubblicana
di Giovanni A. Cerutti
Tre libri pubblicati in occasione del sessantesimo anniversario della
Liberazione approfondiscono la riflessione sul significato della Resistenza
e sulla costruzione di una memoria consapevole e svincolata da quello che
Alberto Cavaglion definisce il «labirinto senza via d’uscita che è la
commemorazione, ossia l’adattamento del passato ai bisogni del presente,
con i suoi idoli da venerare, i suoi nemici da aborrire». Si tratta di La
resistenza spiegata a mia figlia di Alberto Cavaglion, uscito per i tipi de
L’ancora del Mediterraneo; 25 aprile. La competizione politica sulla memoria
di Roberto Chiarini, uscito per i tipi di Marsilio e La guerra della memoria.
La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 ad oggi di Filippo Focardi,
uscito per i tipi di Laterza. Pur nella diversità degli approcci scelti e delle
tesi sostenute sono percorsi da una comune sensibilità - già anticipata dal
volume di Sergio Luzzatto, La crisi dell’antifascismo, uscito lo scorso anno
per i tipi di Einaudi - segnata dalla consapevolezza di vivere la stagione del
passaggio generazionale in cui, per citare ancora Cavaglion, è necessario
«cimentarsi con le ragioni della storia, che non sono le stesse della vita».
La guerra della memoria di Filippo Focardi - docente di Storia
dell’integrazione europea presso l’Università Roma Tre e autore di studi
sui crimini di guerra tedeschi e italiani - è divisa in due parti. Nella prima
Focardi mette a punto una periodizzazione delle vicende della memoria
della Resistenza nel dibattito politico italiano; nella seconda - molto corposa,
di circa 230 pagine e davvero utile - pubblica gli articoli e i testi dei discorsi
più significativi dei protagonisti di quel dibattito, ordinati secondo la
periodizzazione proposta. Sei sono le scansioni temporali individuate da
55
Giovanni A. Cerutti
Focardi: Le origini della narrazione antifascista della guerra. 1943-1947;
Crisi della «narrazione egemonica» antifascista. 1948-1953; Tenuta e rilancio
della «narrazione egemonica» antifascista. 1953-1960; L’affermazione del
«paradigma antifascista» e il confronto fra «Resistenza rossa» e «Resistenza
tricolore». 1960-1978; La sfida alla memoria pubblica della Resistenza. Dalla
«grande riforma» di Craxi alla proposta di riconciliazione di Fini; Il
presidente Ciampi e la «rifondazione della memoria della Resistenza». Punto
di partenza della ricostruzione di Focardi è la definizione della memoria
pubblica della guerra elaborata dall’antifascismo, che si sovrappone
all’universo di memorie frammentate di singoli e di gruppi e che è stata in
grado di attivare nella società italiana processi di identificazione, fino a
diventare memoria collettiva. Una memoria i cui tratti fondamentali
vengono elaborati già all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943 e
che è costruita per far fronte alle esigenze politiche determinate dal nuovo
scenario che si apre: controbattere la propaganda della Repubblica sociale
imperniata sugli argomenti del tradimento dell’onore nazionale, mobilitare
la società italiana nella lotta contro i tedeschi e ridiscutere con gli Alleati, in
vista degli assetti post-bellici, lo status di nemico sconfitto, a cui, nonostante
la cobelligeranza, era stata imposta la resa senza condizioni (p. 4). Questi in
sintesi i capisaldi della «narrazione antifascista»: «il popolo italiano aveva
subito la dittatura fascista ed era stato trascinato da Mussolini e dai suoi
“scherani” in una guerra invisa, a fianco di un alleato detestato come la
Germania; i soldati italiani avevano combattuto con valore sacrificandosi
per una guerra condotta in condizioni di grave inferiorità e impreparazione;
si erano distinti dai commilitoni tedeschi per l’umanità dimostrata verso le
popolazioni dei paesi occupati; erano stati costantemente traditi sul campo
di battaglia dai camerati germanici; non appena la dittatura mussoliniana
aveva allentato la presa, il popolo italiano aveva mostrato i suoi veri
sentimenti antifascisti; tutto il popolo italiano aveva partecipato alla lotta
di liberazione nazionale, non solo le forze armate e i partigiani ma anche i
civili, che avevano sostenuto la Resistenza pagando un grave tributo di
sangue, come attestavano le numerose stragi perpetrate dai fascisti e dai
tedeschi; gli italiani, al fianco delle truppe alleate, avevano liberato con le
proprie forze le città dell’Italia centro-settentrionale sconfiggendo i tedeschi
e i loro complici fascisti; l’Italia aveva ottenuto con ciò un pieno riscatto,
tanto da poter essere considerata moralmente vincitrice» (p. 11). Secondo
Focardi, nell’urgenza della lotta politica venivano elusi alcuni passaggi
fondamentali della storia nazionale, quali l’esistenza di un consenso popolare
56
Il peso della storia. La memoria della resistenza nell’Italia repubblicana
al fascismo, il favore dell’opinione pubblica alla guerra a fianco della
Germania in vista di una rapida vittoria e il carattere di guerra civile della
Resistenza, secondo la lezione di Claudio Pavone.
Il lavoro di Focardi, però, non si concentra sull’analisi critica della
«narrazione antifascista» alla luce delle acquisizioni della ricerca storica,
anche se sullo sfondo resta l’idea - che appare esplicitamente solo in alcuni
accenni nelle conclusioni del saggio - che solo questa indispensabile
rivisitazione sia in grado di costruire il futuro della memoria della Resistenza.
Descrive, invece, il modo in cui questa memoria ha attraversate le diverse
stagioni politiche della Repubblica. Da subito viene sottoposta a
sollecitazioni violentissime in seguito alla estromissione delle sinistre dal
governo nel 1947, prima, e dal risultato delle prime elezioni politiche del
18 aprile 1948, poi, che, introducendo nel sistema politico italiano le
dinamiche della guerra fredda, attivano la linea di frattura
dell’anticomunismo. La memoria della Resistenza diventa terreno di aspra
contesa politica all’interno della coalizione che aveva guidato la lotta
antifascista, spezzandosi tra la Resistenza «nel segno della libertà», evocata
dalla Democrazia Cristiana e dalle forze moderate, e la Resistenza come
«rivoluzione interrotta» attorno a cui mobilitarsi, evocata dalle sinistre (p.
27). Focardi osserva molto acutamente che la Democrazia cristiana utilizzò
solo parzialmente la risorsa politica della costruzione di una memoria
patriottica e attenta al valore morale della Resistenza, così ben radicata nella
sua cultura politica. Si mosse, invece, più in funzione difensiva, preoccupata
di neutralizzare l’uso politico della Resistenza fatto dalle sinistre. Credo si
possa dire che questa scelta, probabilmente storicamente necessitata come
vedremo più avanti analizzando il lavoro di Chiarini, privando l’opinione
pubblica moderata di una tradizione compiuta a cui riferirsi, ha avuto
conseguenze di lungo periodo negative sul consolidarsi della memoria della
Resistenza in ampi strati della società italiana, facendo venir meno una
risorsa in grado di legarli solidamente alla scelta della democrazia come
punto di non ritorno ereditata in tutta Europa dalla sconfitta del progetto
egemonico di Hitler. Nel nuovo clima mutano di segno anche le richieste
di pacificazione avanzate dalla destra nostalgica, che diventano espliciti inviti
alla riabilitazione in funzione anticomunista, a cui non sono insensibili
settori a cui fa riferimento la maggioranza governativa (p. 28).
La battuta d’arresto della Democrazia cristiana alle elezioni politiche
del 1953, che non riesce a guadagnare il premio di maggioranza previsto
dalla nuova legge elettorale, sul fronte politico interno, e la morte di Stalin,
57
Giovanni A. Cerutti
che chiude la fase più aspra della guerra fredda, su quello internazionale,
segnano un cambiamento nella percezione della memoria della Resistenza,
che torna a svolgere il ruolo di evento legittimante della Repubblica. Simbolo
di questo passaggio è il discorso del Presidente della Camera dei Deputati
Giovanni Gronchi, figura di spicco dell’antifascismo cattolico, tenuto il 22
aprile 1955 in occasione della celebrazione a Camere riunite del decennale
della Liberazione. In questo discorso, Gronchi non solo riprendeva i cardini
della narrazione antifascista della guerra, ma poneva la Resistenza come
comune punto di riferimento per le forze democratiche del paese al di là
delle divisioni politiche, punto di riferimento in grado di produrre «“uno
sforzo concorde verso forme, istituti, costumi di democrazia sostanziale”
fondati “sulla libertà e la giustizia”, “sulla tolleranza delle opinioni”,
“sull’impero della legge”, “sulla rivalutazione costante di quei valori
nazionali” che non avevano niente a che fare “con le infatuazioni
nazionalistiche”, ma rappresentavano piuttosto “il solo terreno fecondo e
l’atmosfera vivificatrice di ogni progresso”» (p. 37. Le citazioni del discorso
di Gronchi provengono da G. Gronchi, Discorsi parlamentari, Senato della
Repubblica, Roma 1986, pp. 472-480). Di lì a poco Gronchi sarà eletto
Presidente della Repubblica e sotto la sua presidenza inizierà il processo che
è stato definito di «disgelo costituzionale», caratterizzato dall’attuazione di
alcuni istituti, quali il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte
Costituzionale. Questa ricostruzione, che individua il punto di svolta verso
l’affermazione della memoria antifascista nella società italiana alla metà degli
anni cinquanta, dopo la fine della prima legislatura, rappresenta una delle
novità del lavoro di Focardi. Generalmente, infatti, il punto di svolta è
individuato nella reazione popolare al governo Tambroni del luglio del 1960,
e nella conseguente apertura della fase dei governi di centro-sinistra. Focardi
sottolinea invece, argomentando la sua tesi con fatti tratti dalla cronaca
politica, che l’allontanamento delle maggioranze centriste dalla narrazione
antifascista trova limiti invalicabili nell’opinione pubblica, che non è disposta
a rimettere in circolo memorie nostalgiche. Ragion per cui nessuna
narrazione alternativa riesce a sostituirsi alla narrazione antifascista, pur
duramente logorata dalle contrapposizioni politiche.
Negli anni sessanta i valori e la memoria della Resistenza diventano
patrimonio condiviso della società italiana. Momento culminante di questo
processo furono le celebrazioni del ventennale, che segnò l’ufficializzazione
della festa. Per la prima volta venne istituito un comitato nazionale per le
celebrazioni sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica. E
58
Il peso della storia. La memoria della resistenza nell’Italia repubblicana
proprio il discorso del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat,
pronunciato a Milano il 9 maggio 1965 in occasione della manifestazione
più importante tra quelle previste dal programma del ventennale, può essere
considerato il simbolo di questa condivisione. Dopo aver separato le
responsabilità del popolo italiano da quelle del fascismo e aver reso onore al
valore dei nostri soldati, Saragat riaffermava la continuità tra antifascismo e
Resistenza, descritta come secondo Risorgimento, che aveva coinvolto tutti
i ceti sociali. Quindi ripercorreva tutte le tappe della Liberazione, dalle
quattro giornate di Napoli all’insurrezione dell’aprile del 1945. Passava
quindi a sottolineare «il “significato politico e storico” della Resistenza: non
“lotta di un partito per fini di partito”, ma “lotta di un popolo organizzato
in diversi partiti alleati tra di loro per la sua assunzione all’autogoverno” e
“atto supremo di riconciliazione nella libertà dell’immensa maggioranza
degli italiani”. L’unità dei partiti del Cln aveva significato per Saragat “volontà
di accettare una convivenza democratica”. Su questa base era nata la
“Repubblica democratica fondata sul lavoro” nella quale gli italiani si erano
riconosciuti». Saragat concludeva riconoscendo i limiti delle realizzazioni
compiute sulla via del progresso sociale rispetto alle attese nutrite nel 1945,
consegnando alle generazioni successive il compito di completare l’opera
iniziata dalla sua generazione con la Resistenza (pp. 45-46. Le citazioni del
discorso di Saragat provengono da G. Saragat, Quarant’anni di lotta per la
democrazia. Scritti e discorsi 1925-1965, a cura di L. Preti, I. De Feo, Mursia,
Milano 1966, pp. 651-662). Parallelamente a questo sforzo unitario, però,
le forze politiche non rinunciarono comunque ad utilizzare la memoria
della Resistenza come strumento di mobilitazione politica.
A partire dalla fine degli anni sessanta la memoria della Resistenza torna
ad essere oggetto di contesa politica. Prima emerge la sfida del movimento
studentesco, che rifiutava la retorica celebrativa unitaria delle
commemorazioni ufficiali per rivendicare la dimensione di classe della lotta
partigiana. Ma questa volta il bersaglio polemico non sono solo i partiti
moderati di governo, ma anche il Partito comunista e le forze organizzate
della sinistra, accusate di aver imbrigliato le potenzialità rivoluzionarie della
Resistenza (pp. 46-47). Poi negli anni settanta la sfida terroristica alle
istituzioni dello stato porta al centro della contesa proprio il significato
della Resistenza. A partire almeno dal 1972 per una vasta aerea della sinistra
radicale il 25 aprile diventa occasione di «mobilitazione antifascista» sia
contro il «fascismo squadrista» del Movimento sociale, sia contro il «fascismo
di stato» della Democrazia cristiana. Ma anche «i riformisti del Psi e i
59
Giovanni A. Cerutti
revisionisti del Pci» finiscono sul banco degli accusati, colpevoli di «far da
palo alla reazione» (pp. 48-49). Per reagire a questi attacchi, e soprattutto
agli attacchi che nel frattempo crescevano per intensità e qualità delle
formazioni terroriste che si richiamavano alla sinistra e alla strategia eversiva
delle forze legate al neofascismo, i partiti tradizionali scelsero di richiamarsi
alla Resistenza in termini fortemente politici. In un quadro di sostanziale
convergenza a difesa delle istituzioni minacciate, rafforzata sul finire degli
anni settanta dalla politica di «solidarietà nazionale» elaborata da Moro e
Berlinguer - il cui scopo era di ristabilire l’intesa fra cattolici e comunisti
del periodo resistenziale interrottasi nel 1947 - e culminata nella formula
dell’«arco costituzionale», ciascun partito dispiegò le proprie strategie. Il
Partito comunista e il Partito socialista si appellarono ai valori dell’«unità
antifascista» rimproverando alla Democrazia cristiana l’equidistanza
condensata nella formula degli «opposti estremismi» e pericolose connivenze
con gli ambienti reazionari che all’interno e all’esterno delle istituzioni
pensavano a sbocchi autoritari. La Democrazia cristiana replicava ribadendo
il proprio ruolo storico di garante della libertà e della democrazia
riconquistate con la lotta di liberazione contro tutte le ideologie totalitarie,
senza rinunciare a lasciar trapelare qualche accusa di contiguità ideologica
tra il Partito comunista e il terrorismo di sinistra. Ma dopo il drammatico
rapimento e assassinio di Aldo Moro e la successiva elezione alla Presidenza
della Repubblica di Sandro Pertini, queste contrapposizioni finirono sempre
più sullo sfondo, lasciando al centro della vita politica italiana la memoria
antifascista della Resistenza, unico fondamento possibile delle istituzioni
repubblicane (pp. 50-55).
Un nuovo mutamento di quadro politico all’inizio degli anni ottanta,
con l’affermarsi della formula di governo detta di «pentapartito» che riporta
all’opposizione il Partito comunista, prelude a un attacco senza precedenti,
e per certi versi non ancora terminato, a quello che Nicola Gallerano in un
suo famoso saggio ha definito il «paradigma antifascista». Attacco che trae
spunto dalla strategia politica del nuovo segretario del partito socialista
Bettino Craxi, che prevedeva un radicale cambiamento delle istituzioni
repubblicane, considerate inadeguate rispetto alla nuova fase storica. Per
attuare la «grande riforma» era, però, indispensabile metter mano alla
Costituzione «nata dalla Resistenza», tanto più considerando che era origine
della legittimazione democratica del Partito comunista, che naturalmente
si oppose frontalmente a questa strategia. La discussione serrata sul futuro
della sinistra, diventa confronto serrato sulle origini e sulla storia della
60
Il peso della storia. La memoria della resistenza nell’Italia repubblicana
Repubblica, impostato con buone ragioni da Craxi come sfida al Partito
comunista sul nesso antifascismo-democrazia, essendo l’antifascismo
condizione necessaria, ma non sufficiente della democrazia. Ma oltre a
provocare la rottura del fronte dei partiti eredi del Cln, che avevano elaborato
la narrazione antifascista, questa azione ha rimesso in circolo nel discorso
pubblico, più o meno consapevolmente, argomenti polemici nei confronti
della memoria della Resistenza che riecheggiavano motivi tipici
dell’anticomunismo della guerra fredda. Sponda autorevole di questa
operazione è stato Renzo De Felice, l’autore della monumentale biografia
di Mussolini, che già nel 1975 aveva anticipato alcune delle sue tesi nel
volume laterziano Intervista sul fascismo. In due interviste rilasciate a Giuliano
Ferrara e pubblicate dal «Corriere della sera» tra il dicembre del 1987 e il
gennaio del 1988, De Felice sosteneva che l’antifascismo di matrice
resistenziale era ormai insufficiente e forse dannoso per creare una «autentica
democrazia repubblicana». Il nodo storiografico centrale attorno a cui De
Felice costruisce questa tesi è la descrizione degli avvenimenti del biennio
1943-1945 come guerra civile tra due fazioni minoritarie, subita dalla
maggior parte della popolazione che pensava soltanto alla sopravvivenza
quotidiana. Parallelamente si sviluppava sui grandi mezzi di comunicazione
di massa un’azione tesa a banalizzare il fascismo, proposto soprattutto
attraverso le vicende private dei suoi protagonisti e descritto come un regime
sostanzialmente paternalista che aveva pur sempre rappresentato la via
italiana alla modernizzazione (pp. 57-59). Con il crollo del sistema politico
che aveva caratterizzato il primo cinquantennio repubblicano, l’apparizione
di partiti estranei alla lotta resistenziale e soprattutto l’ingresso nell’area di
governo del Movimento sociale nel 1994, questa offensiva culturale diventa
una concreta pressione sulle istituzioni dello stato a dar corso a una nuova
memoria pubblica pacificata, che si lasciasse alle spalle la contrapposizione
ormai logora fascismo/antifascismo, superando le divisioni della guerra civile
e riconoscendo in questo modo pari dignità storica e morale alle due parti
in lotta. Ancora una volta l’esigenza è tutta interna al sistema politico e
riguarda la legittimità del nuovo blocco conservatore che si crea in Italia tra
il 1993 e il 1994. Essendone il Movimento sociale, poi Alleanza nazionale,
parte integrante, la sua estraneità ai valori legittimanti della Repubblica
diventa un problema di tutta la coalizione. Viene, allora, recuperato il
dibattito sull’identità nazionale alimentato dalle tesi di Renzo de Felice e
Ernesto Galli della Loggia, secondo i quali l’8 settembre 1943 aveva
rappresentato la fine dell’idea di patria. Di fronte all’incapacità della
61
Giovanni A. Cerutti
Repubblica antifascista di ricostruire un’adeguata identità nazionale era
giunto il momento di superare l’eredità della Resistenza per elaborare,
attraverso la riconciliazione, una memoria condivisa da tutti gli italiani su
cui fondare una comune identità nazionale (pp. 61-66). A questo proposito
Focardi osserva in modo pertinente che è del tutto opinabile l’idea della
necessità di una memoria condivisa, sostenuta anche da qualche esponente
della sinistra come Luciano Violante, rilevando come tutte le grandi nazioni
democratiche che sono nate da traumi e guerre civili si reggono su salde
memorie pubbliche elaborate dalla parte vincitrice (p. 78). Peraltro sembra
che nel caso italiano più che di memoria condivisa - cioè accettata da tutti
coloro che riconoscono che i valori e la prassi della democrazia siano il
fondamento del patto sociale - si possa parlare di memoria contrattata,
fondata sullo scambio di reciproci riconoscimenti, indipendentemente dal
ruolo giocato dalle proprie memorie di riferimento nel percorso storico
verso l’affermazione della pratica della democrazia in Italia. Ma se l’attacco
al paradigma antifascista, già pesantemente indebolito dallo scontro interno
alla sinistra degli anni ottanta, viene condotto con lucidità, l’area politicoculturale del nuovo blocco conservatore non riesce a elaborare una tradizione
alternativa (p. 67). Si attacca il 25 aprile, ma non si riesce a dire con cosa
sostituirlo; si scredita una classe politica, ma non si indicano quali sono i
modelli a cui far riferimento nella storia italiana; si linciano gli esponenti
della cultura antifascista, prediletti i terribili azionisti, che hanno militato
in un partito sciolto più di cinquant’anni fa, ma non si è in grado di
recuperare all’interno del pensiero democratico una tradizione culturale
alternativa. Restano solo la revanche, le piazze intitolate a Mussolini e
Almirante, e le vie Gramsci cancellate, con uno sguardo ossessivamente
rivolto al passato, che sembra indicare che le radici di Alleanza nazionale
affondino comunque ancora molto profondamente nella memoria fascista.
Di fronte a questa pesante sfida, negli anni novanta si è assistito a una
nuova e imponente mobilitazione a difesa della Resistenza, il cui punto di
partenza è individuato da Focardi nella manifestazione di Milano del 25
aprile 1994. E se sul piano dei discorsi ufficiali l’asse portante di questa
mobilitazione è stato il canone tradizionale della narrazione antifascista,
negli interventi sulla stampa hanno incominciato a prendere corpo nuove
sfumature. Discutendo le questioni poste dalla storiografia revisionista quali
l’interpretazione dell’8 settembre, il carattere di guerra civile della Resistenza,
il ruolo del Partito comunista, i contrasti interni al Cln, il rapporto fra
governi del Cln e partitocrazia la trama della narrazione tradizionale si è
62
Il peso della storia. La memoria della resistenza nell’Italia repubblicana
arricchita - con particolare riguardo ai toni, fermi, ma lontani dall’enfasi
celebrativa degli anni sessanta e settanta - articolandosi meglio, senza mutare
la sostanza. Peraltro un’attenta analisi degli articoli e degli interventi scritti
durante il sessantennio repubblicano mostra come temi quali il carattere di
guerra civile della Resistenza, il riconoscimento che l’antifascismo e la lotta
resistenziale riguardassero una minoranza rispetto alla massa della
popolazione, le tensioni all’interno delle forze antifasciste e l’importanza
decisiva degli eserciti Alleati nella vittoria finale siano sempre stati presenti,
anche se ricompresi nel momento epico e corale della lotta contro il
nazifascismo (pp. 79-80).
Nuovo coagulo della memoria antifascista è diventato in questi anni il
ricordo delle stragi e delle brutalità dei nazisti e dei repubblichini di Salò,
ricordo cui non è estranea quasi nessuna delle comunità del Paese. Si è
riattivata, così, la tradizionale narrazione antifascista, in cui gli italiani sono
descritti come vittime del nazifascismo e viene esaltata la formula del popolo
unito in lotta contro la tirannide. L’involontario risvolto negativo di questa
raffigurazione è, però, la rimozione delle colpe degli italiani dietro al comodo
alibi del «bravo italiano», eludendo i temi quali il colonialismo italiano, la
persecuzione antiebraica, la partecipazione italiana alla guerra dell’Asse e le
politiche di occupazione portate avanti nei territori aggrediti (pp. 83-87).
Argomenti che sono stati al centro della riflessione della storiografia, ma
che non sono riusciti ad alimentare il dibattito pubblico. Manca
completamente un confronto e una consapevolezza sul ruolo svolto dall’Italia
fascista come stato aggressore e oppressore. È questa la lacuna principale
che impedisce il consolidamento di una memoria saldamente ancorata ai
valori democratici, lasciando spazio a una memoria alternativa che ha come
orizzonte la costruzione di un nuovo nazionalismo come progetto identitario,
considerato più adatto al mondo post-bipolare. Se nella costruzione della
narrazione antifascista tradizionale la rimozione dei crimini fascisti aveva
una sua ragione d’essere - vuoi politica, il trattato di pace, la legittimazione
dei partiti antifascisti, vuoi psicologica, la «rimozione terapeutica», per
consentire agli italiani di aderire al nuovo corso democratico - oggi questa
rimozione è diventata l’ostacolo principale alla costruzione di un’identità
democratica. Per larghi strati del paese e della sua classe dirigente il fascismo
è ancora un regime in fin dei conti benevolo, adeguato all’indole degli italiani
e con alle spalle alcuni meriti storici, che vanno dal ristabilimento della
legge e dell’ordine, alla modernizzazione del paese e non il moderno
esperimento totalitario che è stato. Si tratta del processo che Emilio Gentile
63
Giovanni A. Cerutti
ha definito di «defascistizzazione retroattiva», funzionale a un modello di
identità nazionale rivolto al passato, in cui l’amor di patria prescinde dalla
valutazione degli obiettivi che la comunità nazionale persegue (pp. 112113).
Un intero capitolo - l’ultimo - è dedicato all’azione del Presidente Ciampi,
che viene definito da Focardi il «Presidente della Rifondazione della memoria
della Resistenza» (pp. 94-107). La principale preoccupazione di Ciampi
viene identificata da Focardi nella riaffermazione del significato patriottico
della Resistenza in esplicita contrapposizione alla tesi della «morte della
patria», fino ad entrare in aperta ed esplicita polemica con Galli della Loggia
sulle colonne del «Corriere della sera». In questi anni Ciampi ha riaffermato
il carattere della Resistenza come guerra di liberazione nazionale, ispirata
dai valori risorgimentali declinati in senso mazziniano, permeati, cioè, dal
rispetto per gli altri popoli e dal senso di fratellanza europea, il cui orizzonte
è stato la conquista della democrazia, che si è tradotta nella Costituzione
repubblicana, tuttora valida e rispondente ai sentimenti del popolo italiano.
I tre capisaldi del pensiero di Ciampi si possono ritrovare nel discorso
pronunciato ad Ascoli Piceno il 25 aprile 2002 e pubblicato da Focardi a
pagina 340. Il primo è l’idea di «Resistenza allargata», in cui convivono la
resistenza attiva dei soldati e dei partigiani che presero le armi; la resistenza
silenziosa della gente, che prestò aiuto e soccorso a feriti, combattenti e
fuggiaschi, esponendosi a gravi rischi; e la resistenza dolorosa dei prigionieri
nei campi di concentramento. Una Resistenza in cui tutti si possono
riconoscere e nessuno può vantare il monopolio. Il secondo è rappresentato
dalla dimensione europea della Resistenza, momento cruciale di lotta per
la democrazia e la libertà che accomuna gli italiani agli altri popoli europei.
Il terzo è la promozione di una memoria intera, che non trascuri nessun
aspetto della storia del paese e che sia fondata sulla giustizia. Se in larga
misura si tratta della riproposizione del canone tradizionale della narrazione
antifascista, con qualche rischio di contribuire a una memoria nuovamente
centrata sulle vicende che hanno visto gli italiani nel ruolo di vittime, la
salda connessione stabilita da Ciampi tra la Resistenza italiana e le Resistenze
europee - viste come il momento in cui le società europee di fronte alla
sfida del nazismo compiono la definitiva scelta verso gli istituti democratici
- sembra essere davvero la nuova frontiera della memoria antifascista.
25 aprile. La competizione politica sulla memoria di Roberto Chiarini si
concentra, invece, sull’analisi delle caratteristiche delle memorie che hanno
64
Il peso della storia. La memoria della resistenza nell’Italia repubblicana
attraversato il sessantennio repubblicano e delle dinamiche che si sono
instaurate fra di loro, con particolare riguardo alla contrapposizione tra
quella che viene definita la «memoria iperpolitica» delle sinistre e la «memoria
impolitica» della Democrazia cristiana. Chiarini, docente di storia
contemporanea alla facoltà di Scienze politiche dell’Università statale di
Milano, ha a lungo insegnato Storia dei partiti e dei movimenti politici,
integrando nei suoi corsi l’analisi storica con l’attenzione per le dimensioni
organizzative dei partiti e per i vincoli sistemici, ed è uno dei pionieri dello
studio del neofascismo italiano fin dalla ricerca condotta con Paolo Corsini
sul neofascismo bresciano pubblicata nei primi anni ottanta.
Punto di partenza dell’analisi di Chiarini è la distinzione netta tra la
memoria della guerra 1940-1943 depoliticizzata e la memoria della guerra
civile 1943-1945 iperpoliticizzata. La prima, centrata sulla pietas per le
vittime incolpevoli e sul dolore e i sacrifici degli italiani, ha come obiettivo
di descrivere l’Italia come un paese estraneo alla guerra, con lo scopo di
estrometterla dalla storia nazionale per consegnarla esclusivamente alla storia
del fascismo. La seconda descrive due Italie che si affrontano in nome di
due idee alternative e inconciliabili di ordine istituzionale e politico (pp.
10-11). Nella loro inconciliabilità Chiarini rileva un tratto comune alle
due memorie della guerra civile nella forte carica politica, che fissa in modo
potente l’identità dei militanti, ma specularmente esclude in modo
altrettanto potente la maggior parte dell’opinione pubblica (pp. 12-13).
L’analisi della memoria partigiana della Resistenza mette in luce i tratti
che le impediscono strutturalmente di diventare memoria collettiva.
L’esperienza di vita della lotta partigiana è descritta da Chiarini, sulla scorta
della letteratura antropologica, come liminare, punto di passaggio reale e
simbolico tra un passato da eliminare,il fascismo, e un futuro tutto da
costruire, la democrazia. In questo modo diventa occasione per ridefinire
la rete dei rapporti sociali e delle rappresentazioni collettive della vita
associata. La democrazia a cui fa riferimento, in modo del tutto non
consapevole della distinzione, non è la democrazia rappresentativa - pluralista
e procedurale - che ha come orizzonte la mediazione nonviolenta dei
conflitti, ma la democrazia diretta, in cui, nel microcosmo della banda
partigiana, le voci dissonanti sono assorbite dal senso di appartenenza
generato dalla solidarietà comunitaria. L’enorme patrimonio di energie
morali generato dalla partecipazione alla guerra partigiana trova, inoltre,
molte difficoltà ad essere speso nella costruzione di un progetto sociale dai
contorni definiti. Così la Resistenza finisce per perdere il suo valore
65
Giovanni A. Cerutti
intrinseco, per diventare fonte di legittimazione di un processo in atto nella
vita politica e sociale italiana, trasformandosi in dialettica aperta alla lotta
politica. E per questa via perdere la possibilità di diventare tradizione civile
unitaria di tutto un popolo (pp. 29-31). Valorizzando la natura
strutturalmente conflittuale del paradigma antifascista e considerandolo
via privilegiata, se non unica, alla realizzazione della democrazia
repubblicana, questa elaborazione della memoria finisce per cozzare
frontalmente contro l’idea di politica prevalente in un paese senza nessuna
esperienza di pluralismo sociale e culturale, che le attribuisce lo stesso fine
della morale del padre di famiglia, che deve salvaguardare l’unità e la
solidarietà interna al di là di ogni motivo di discordia. Insistendo sul carattere
di prospettiva per il futuro dell’esperienza vissuta, finisce per rendersi estranee
anche le aree più solidali alla Resistenza, che, mosse più da scelte umane
che dall’impegno ideologico, hanno comunque vissuto la guerra come una
tragedia. Chiarini evidenzia, quindi, una contraddizione all’interno
dell’antifascismo tra una domanda politica di inclusione e un’offerta
identitaria di esclusione, tra la descrizione, cioè, della Resistenza come lotta
di liberazione di tutto un popolo, sostenuto dall’impegno morale verso il
riscatto democratico e l’elaborazione di una memoria centrata sulla
distinzione tra partigiani rivoluzionari e la maggioranza degli italiani
attendista (pp. 37-39).
L’ampia fascia della società italiana che la memoria antifascista non riesce
a interpretare è pur tuttavia assolutamente estranea alla memoria neofascista,
che oltre ad essere anch’essa estremamente politicizzata, facendo del conflitto
la prassi dei rapporti sociali, rappresenta un sistema di credenze
inesorabilmente consegnato al passato dalla vicende tragiche della guerra.
Inoltre la posizione irriducibilmente antisistemica dei gruppi neofascisti è
totalmente incompatibile con la naturale predisposizione di questi settori
sociali a valutare comunque positivamente l’ordine costituito. È una fascia
maggioritaria nella società italiana, la cui impoliticità si traduce in un diffuso
scetticismo verso i protagonisti della nuova vita politica. La cifra del suo
atteggiamento è la passiva ricezione di un orizzonte di valori e convincimenti
che affondano le loro radici nell’esperienza della sopravvivenza quotidiana
mescolata con elementi ricavati dal magistero esercitato dalle agenzie sociali
tradizionali: la parrocchia, la famiglia, il sistema educativo. Una fascia di
società italiana profondamente influenzata dalla propaganda del regime,
nei confronti della quale si era trovata completamente esposta, senza alcun
strumento per vagliarla criticamente, i cui stessi quadri di percezione della
66
Il peso della storia. La memoria della resistenza nell’Italia repubblicana
realtà erano stati interiorizzati attraverso i processi di socializzazione primaria
e secondaria messi in opera dal fascismo. E che non è in grado di elaborare
una propria memoria - Chiarini la definisce «memoria immemore», a causa
del rifiuto di riprodurre le ragioni del conflitto che si è appena lasciato alle
spalle - perché non ha identità, non è un gruppo sociale definito, ma è
dispersa. Non ha quindi una diretta proiezione politica, ma ha un potenziale
politico altissimo. È orientata naturalmente verso destra dalla sua
disposizione a contrastare le spinte modernizzanti nella vita economica e
sociale e secolarizzanti nella vita culturale (pp. 16-22).
Per la collocazione politica di questa «zona grigia» degli impolitici sarà
decisiva la rottura del fronte antifascista consumata nel 1947 e
definitivamente consolidata dalle elezioni del 1948. Nel clima ancora di
scontro frontale dei mesi immediatamente seguenti la fine della guerra non
ci sono spazi per una «terza scelta» tra fascismo e antifascismo. Tra due vie
entrambe rigettate finisce per disperdersi tra la protesta dell’Uomo
qualunque di Giannini, l’astensionismo e il sostegno non troppo convinto
alla Democrazia cristiana, ai liberali e ai monarchici. Ma quando si profila
la nuova frattura dell’anticomunismo trova la sua collocazione nella
Democrazia cristiana, il partito che si presenta ai suoi occhi come garante
dell’ordine, argine alle sinistre e portatore di una declinazione debole
dell’antifascismo. Per Chiarini la svolta del 1947-48 è decisiva ed irreversibile
nel tracciare la mappa politica dell’Italia repubblicana. Si rompe il vincolo
della solidarietà antifascista e la sinistra è spinta a radicalizzare la sua lettura
del fenomeno fascista, allontanando irrimediabilmente il mondo moderato,
assolutamente incompatibile con ogni visione della politica come conflitto.
Non solo, ma l’antifascismo diventa risorsa politica da spendere nella
contrapposizione contro la Democrazia cristiana del centrismo. In questo
passaggio si bruciano tutte le possibilità dell’antifascismo di diventare la
cultura condivisa di tutte le forze politiche democratiche dell’Italia
repubblicana, che secondo Chiarini aveva margini di praticabilità sulla base
della lettura in due tempi delle vicende della Seconda guerra mondiale - il
tempo dell’espiazione delle colpe del fascismo (1940-1943) e il tempo del
riscatto democratico (1943-1945) - come percorso dalla dittatura alla libertà,
in grado di interpretare attese e sentimenti di gran parte dell’opinione
pubblica italiana. E il 25 aprile come festa della nazione democratica, che
celebrava contemporaneamente la fine della guerra e la liberazione del paese,
saldando la guerra di liberazione con la pacifica convivenza ristabilita, era
adeguato a impostare una memoria nella quale tutti si potessero riconoscere,
67
Giovanni A. Cerutti
ovviamente tranne i neofascisti irriducibilmente determinati a non
riconoscere legittimità morale, prima ancora che politica, alla Repubblica.
A questo proposito Chiarini, riprendendo una considerazione di Sergio
Luzzatto e la riflessione di Paul Ricoeur, critica con molta forza il concetto
di memoria condivisa. Le memorie tra antifascisti e fascisti non possono
essere condivise, non fosse altro perché i fatti sono incancellabili e richiedono
di trovare un loro senso per il presente e per il futuro. Non è quindi una
memoria condivisa quella che è mancata. È mancata semmai, secondo
Chiarini, una memoria egemone, capace di trovare orizzonti nel passato e
nel presente, in grado di interpretare un fronte di sensibilità capace di
assicurare una larga base di legittimità e consenso alla nuova Repubblica e,
in questo modo, di integrare anche identità e memorie separate. Inoltre
una società democratica resta tale, se non riduce ad un unica memoria la
pluralistica e conflittuale varietà delle identità politiche e culturali. L’altro
ostacolo alla costruzione di una sicura memoria democratica è individuato
anche da Chiarini, così come da Focardi, dall’assenza di una strategia tesa a
fare i conti fino in fondo con l’eredità del fascismo. Addebitando solo al
fascismo la responsabilità della guerra e alla classe dirigente la responsabilità
di aver portato al potere, prima, e sostenuto, poi, il regime, si sono introdotte
alcune distorsioni della memoria che hanno impedito l’incontro tra «l’Italia
nata dalla Resistenza» e l’«Italia uscita dalla sconfitta» (pp. 23-28).
La frattura dell’anticomunismo, sostituendosi a quella antifascista come
criterio di organizzazione del sistema politico, introduce un’asimmetria tra
il piano della legittimità politica e il piano della cultura politica diffusa.
L’arena politico-parlamentare è caratterizzata dalla presenza di entrambe le
fratture, che produce una logica tripolare, ben descritta da Giovanni Sartori,
fondata sull’illegittimità delle due opposizioni di destra e di sinistra, che
assegna alla Democrazia cristiana non solo la posizione centrale di perno di
qualsiasi maggioranza di governo, ma anche la risorsa di depositaria della
legittimità politica. Le correnti dell’opinione pubblica - alimentate da schemi
di percezione della realtà in sintonia con il fascismo, che infatti li ha
accuratamente coltivati, agenti a livello pre-cosciente e perciò con una grande
capacità di orientare i comportamenti - individuano il nemico politico come
male sociale, antitetico al proprio sentire semplificato, e faticano ad assimilare
visioni e logiche della retorica antifascista. Da questa asimmetria ne
discendono altre due. La prima, interna alla società politica, riguarda il
diverso grado di illegittimità tra le due opposizioni, che consente
all’opposizione di sinistra, esclusa dal governo sulla base dell’anticomunismo,
68
Il peso della storia. La memoria della resistenza nell’Italia repubblicana
di partecipare al gioco parlamentare sulla base dell’antifascismo, mentre
all’opposizione del Movimento sociale non è riconosciuta legittimità alcuna.
La seconda si articola tra la società politica che pratica questa esclusione e la
società civile in cui l’allarme anticomunista stempera la distinzione tra la
memoria fascista e la memoria antifascista, garantendo un forte insediamento
della destra nell’opinione pubblica. In questo modo nell’elaborazione del
ricordo, non solo l’opinione afascista continua ad avere una parte
preponderante, ma resta in circolo anche la memoria neofascista. Si
strutturano, così, due destre. Il Movimento sociale, di chiara matrice
neofascista, inserito nell’arena politico-istituzionale, ma completamente
isolato. E una destra presente nella cultura diffusa, completamente
destrutturata e in cui si mescolano suggestioni nostalgiche e domande di
generica difesa dal pericolo comunista non connotate politicamente. In
questo secondo ambito verranno in contatto le diverse memorie non
antifasciste e si fonderanno, per prossimità, tutte le posizioni politiche che
condividono l’anticomunismo (pp. 44-48).
Una parte rilevante del volume è dedicata all’analisi delle diverse correnti
di pensiero di cui è composta questa cultura diffusa, da Giannini a Sogno,
da Longanesi a Montanelli, da Prezzolini a Guareschi mettendone in risalto
i differenti approcci e la comune distanza dalla memoria neofascista, che
continua a caratterizzarsi per la conflittualità con l’ordine istituzionale
repubblicano e per l’irriducibile vocazione antisistemica. Queste correnti
di pensiero hanno in comune l’idea che la politica non ha alcuna capacità
di produrre valori e senso, e quindi di svolgere un’azione di cambiamento
sociale. Sono antagoniste in forma simmetrica sia all’opzione antifascista
che a quella neofascista, perché di entrambe disprezzano il primato che
riservano alla politica. La stringente dinamica della guerra fredda e l’implicita
vocazione sistemica di ogni posizione impolitica le spingono inesorabilmente
verso gli antagonisti della sinistra, ma senza trovare diretta rappresentanza
politica. Si accende, quindi una competizione tra i soggetti politici meglio
posizionati per intercettarle. La competizione vede protagonisti soprattutto
la Democrazia cristiana e il Movimento sociale, ma anche, nelle diverse fasi
della storia repubblicana, i qualunquisti, i monarchici e i liberali, e, in misura
minore e a fasi alterne, i socialdemocratici. Per competere i due principali
antagonisti depotenziano la valenza politica della propria memoria, cercando
di attenuare l’una il proprio antifascismo e l’altro il proprio neofascismo.
Ma mentre il Movimento sociale - non avendo la capacità di ricomprendere
nella propria memoria anche le ragioni dei vincitori e per questa via giungere
69
Giovanni A. Cerutti
all’accettazione della prassi e dei valori della democrazia - continua ad
oscillare nella contraddizione mai risolta tra la rivendicazione orgogliosa
del proprio passato e una pasticciata opera di depotenziamento della carica
politica della difesa delle ragioni della Repubblica sociale in grado di stabilire
un contatto con la memoria immemore degli afascisti in vista della
costruzione di un blocco anticomunista, restando al livello degli espedienti
retorici, riuscendo in questo modo a non scivolare nell’illegalità, ma
continuando a restare nell’illegittimità politica, riuscendo ad interloquire
con la zona grigia dell’opinione pubblica, ma senza diventare un soggetto
credibile nell’arena politica democratica, la Democrazia cristiana riesce ad
entrare in sintonia con la galassia delle memorie afasciste. Anche la memoria
del tempo di guerra elaborata dalla Democrazia cristiana è incompiuta, e,
per di più, è esercitata senza convinzione, né sistematicità, ma sono proprio
l’incompiutezza e la leggerezza della sua memoria a diventare risorsa
strategica, consentendole sia di depotenziare l’ideologia dell’antifascismo
della sinistra, sia di mantenere isolate la destra nostalgica e quella radicale.
Nella narrazione della Democrazia cristiana la Resistenza è descritta come
testimonianza di ideali quali la fratellanza, la libertà, l’indipendenza, l’amor
di patria, inclusivi e non discriminanti, pacificatori e non conflittuali, che
originano dalla sua cultura che non interpreta la politica come origine delle
istanze etiche (pp. 84-91).
Il tratto caratterizzante di questa memoria è l’idea che la lotta di
liberazione è un’esperienza storicamente delimitata e politicamente conclusa,
il cui valore storico risiede nella fondazione della democrazia, ma le cui
origini sono di natura etica, se non religiosa. Questa lettura ha un importante
risvolto politico. Poggiando l’esperienza resistenziale su valori perenni, che
trascendono le mutevoli ragioni dell’ideologia, diventa il fulcro di un’azione
di ricostruzione ispirata a una solidarietà in grado di superare le passate
divisioni e per questa via unificare in orizzontale popolo, nazione e
democrazia e in verticale presente, futuro e passato, espungendo la parentesi
del ventennio. Depotenziando la carica di rottura del passaggio storico del
biennio 1943-1945 e ricomponendo nell’immaginario emotivo gli strappi
della guerra civile, la Democrazia cristiana riesce a recuperare l’opinione
moderata afascista, saldando una maggioranza larga senza confini a destra,
nostalgici esclusi (pp. 95-106).
L’argomento centrale di Chiarini è, quindi, che la memoria della
Resistenza si sia divisa tra due declinazione provenienti entrambe dal fronte
antifascista, ispirate da due diverse concezioni della democrazia. Una
70
Il peso della storia. La memoria della resistenza nell’Italia repubblicana
impolitica, priva di spessore storico e politico, carente nel dovere civico di
chiarire il senso del passaggio al sistema democratico, riluttante a prendere
coscienza del passato, fino a rendere possibile la sua sostanziale rimozione.
L’altra iper-politica, portata a declinare l’antifascismo come dimensione
esistenziale della democrazia, fino a farne fonte perenne di frattura, risolvibile
solo con un’altamente improbabile rivoluzione non solo politica, ma anche
sociale ed economica. Una divisione, secondo Chiarini, sempre tenuta sullo
sfondo, se non nei momenti di più acuto scontro politico, come negli anni
del centrismo. Chiarini rileva che entrambe le declinazioni rispondevano
esattamente ai bisogni di identità dei rispettivi popoli di riferimento, oltre
che alla sensibilità degli elettorati. Erano, cioè, necessitate storicamente. E,
d’altronde, hanno svolto una funzione storica nei confronti della gracile
democrazia italiana. Attraverso il comune richiamo alla Resistenza, pur
differentemente declinato, hanno costruito nel Paese un tessuto democratico
in grado di resistere anche agli strappi più volenti, come quelli della guerra
fredda e del terrorismo. Ma hanno introdotto elementi di fragilità, con cui
stiamo ancora facendo i conti. La memoria impolitica ha reso vulnerabile
la democrazia alle minacce eversive, la memoria iper-politica, facendo dei
pericoli di un nuovo fascismo la chiave di lettura privilegiata della realtà
italiana, le ha impedito di vedere con chiarezza natura e origine delle sfide
portate alla democrazia. Così, mentre l’antifascismo della memoria iperpolitica è apparso agli occhi dei suoi avversari nient’altro che un espediente
ideologico per neutralizzare l’anticomunismo, l’antifascismo della memoria
impolitica è apparso un comodo riparo dietro il quale permettere all’opinione
pubblica moderata di continuare a coltivare ambizioni autoritarie. E se
questo quadro, pur fragile, ha permesso alla democrazia italiana di
consolidarsi, la caduta del comunismo e l’allontanarsi dell’eventualità di
un ritorno del fascismo storico, ne hanno messo in evidenza tutti i limiti.
Passaggio obbligato, per Chiarini, del superamento di questa fase è
l’integrazione della Resistenza nella storia nazionale, come momento del
passaggio alla democrazia, emancipandola dalle connotazioni ideologiche
di progetti politici di parte, per consentire all’antifascismo di diventare
l’orizzonte di valori di ogni democratico (pp. 114-119).
La Resistenza spiegata a mia figlia di Alberto Cavaglion è un piccolo libro
davvero prezioso, che ripercorre con uno sguardo carico di consapevolezza
le questioni più rilevanti che ci consegnano gli anni della Resistenza. Non
quindi un libro sulle vicende della memoria della Resistenza nell’Italia
71
Giovanni A. Cerutti
repubblicana come gli altri due, ma su una possibile memoria della
Resistenza. Cavaglion - che lavora presso l’Istituto storico della Resistenza e
della società contemporanea di Torino - è un affermato studioso
dell’ebraismo italiano e ha alle spalle notevoli studi di critica letteraria e di
storia contemporanea. Autorevole specialista di Primo Levi, si era già
segnalato con la pubblicazione presso Il Mulino di Per via invisibile, una
mirabile ricostruzione delle vicende di una famiglia torinese durante la
guerra. Il titolo, sul quale qualche frettoloso recensore ha ironizzato, è meno
di maniera di quanto appaia. Cavaglion, infatti, è nato nel 1956 e la figlia
Elisa a cui si rivolge nel 1989. Non è, quindi, la generazione che ha vissuto
l’epopea che consegna il testimone militante a chi deve continuare la lotta,
e nemmeno una delle generazioni successive marchiate a fuoco dalla
militanza politica che racconta con nostalgia i bei tempi andati o con
disillusione la fine di ogni ideale o con cinismo la sua nuova sistemazione
in linea con i tempi nuovi: nel 1968 Cavaglion aveva dodici anni e, per
quanto ne sappiamo, ha speso gli anni settanta studiando. Gli intenti sono
dichiarati con ammirevole nettezza da subito. «Ogni generazione ha il dirittodovere di narrare per prima - e come meglio crede - le vicende delle quali è
stata protagonista, ma chi come noi è nato dopo [...] ha un diverso dirittodovere: cimentarsi con le ragioni della storia, che non sono le stesse della
vita». «Con questo libro [...] non intendo, nel modo più assoluto, rispondere
a quella specie di chiamata alle armi, da più parti richiesta, davanti all’attacco
portato da alcune forze politiche contro il 25 aprile e i cosiddetti “valori
della Resistenza”» (p. 8). Cavaglion dichiara esplicitamente di aver smesso
di partecipare alle manifestazioni pubbliche sul finire degli anni settanta,
urtato dalle evidenti manipolazioni politiche. Ma nello stesso tempo lascia
trasparire tutta la sua malinconia di fronte alla solitudine in cui sono lasciati
oggi i sopravvissuti di quella stagione al tramonto, a cominciare da chi
aveva spregiudicatamente cavalcato il mito della Resistenza negli anni passati.
La riflessione di Cavaglion prende le mosse da una convincente analisi
del fascismo, del quale mette in evidenza il potenziale seduttivo, tipico di
ogni potere totalitario, appoggiandosi al romanzo breve di Thomas Mann
Mario e il mago, nel quale una vicenda di cronaca nell’Italia degli anni venti
diventa metafora delle condizioni dell’Italia fascista. L’importanza di questa
dimensione, accanto a quella della forza, impongono una particolare
attenzione a chi voglia opporvisi: i meccanismi dell’incanto sono più difficili
da smontare e cimentarsi in questa impresa richiede molta pazienza.
Cavaglion introduce, quindi, due distinzioni fra chi ha subito la menzogna
72
Il peso della storia. La memoria della resistenza nell’Italia repubblicana
fascista. Una prima, che ha grande rilevanza sul piano etico, distingue chi si
è lasciato ingannare da chi non si è lasciato ingannare. Una seconda distingue
tra chi non si è disincantato mai e chi, pur prigioniero fino all’ultimo
dell’incantesimo, riesce alla fine a liberarsi. La differenza tra chi non vuole
liberarsi e chi si libera, sia pure solo dopo la dura lezione dei fatti, è oggettiva
e non può essere occultata. È questo il caso della Resistenza italiana, che
nasce solo dopo che l’incantesimo ha prodotto danni incalcolabili, ma senza
la quale la libertà che comunque l’Italia avrebbe riconquistato sarebbe stata
peggiore (pp. 15-20).
Lucide anche le considerazioni sul nodo centrale dell’armistizio.
Innanzitutto la consapevolezza che il fascismo è caduto da solo, sotto il
peso dei suoi errori e delle sue sconfitte militari, per una manovra interna al
«Palazzo», senza nessuna sollevazione popolare. Data questa premessa,
diventa più semplice capire l’estrema difficoltà in cui si è trovata una
generazione che è arrivata all’appuntamento del 25 luglio prima, e dell’8
settembre poi, senza avere alle spalle un’educazione che la abbia formata ad
essere autonoma. Così la scelta è davvero determinata molte volte da fattori
imponderabili, come mette in evidenza la citazione delle riflessioni del
commissario partigiano Kim, tratte dal Sentiero dei nidi di ragno di Italo
Calvino: «Basta un nulla, un passo falso, una impennata dell’anima e ci si
trova dall’altra parte». Il problema cui quella generazione si trova di fronte
è, quindi, quello di riscoprire la politica dopo anni di digiuno, sotto
l’incalzare degli eventi: «Corsi accelerati di sapienza antifascista», secondo
Luigi Meneghello. Il valore della lotta partigiana sta, allora, anzitutto in
questa occasione di ripensare la politica (pp. 21-27). Così come concluderà
la sua riflessione indicando una data inconsueta per ricordare la Liberazione,
Cavaglion indica come primo gesto della Resistenza italiana il tentativo dei
custodi, i cui nomi sono rimasti sconosciuti, del deposito di San Paolo
Belsito, una località a una trentina di chilometri da Napoli, di salvare i
fondi più antichi dell’Archivio di Stato di Napoli, che lì erano stati trasferiti
in previsione della guerra aerea. Nelle ultime ore che precedono la ritirata
tedesca, il 30 settembre 1943, una pattuglia di guastatori tedeschi dà fuoco
al Castello dove sono conservati i documenti, impedendo con le armi ai
custodi di intervenire. Il danno prodotto è incalcolabile, viene perduta tutta
la documentazione più antica dell’intera Italia del Sud, ma quel gesto dei
custodi segna l’inizio di una nuova consapevolezza (pp. 33-35).
Discutendo le opposte tesi circa l’8 settembre come morte della patria
e l’8 settembre come nuovo inizio, Cavaglion mette in evidenza la fragilità
73
Giovanni A. Cerutti
del terreno su cui nasce la Resistenza, che è originata dalle vicende della
storia italiana, che rimandano a debolezze antiche. Innanzitutto lo stato
italiano era di recente formazione e aveva dovuto affrontare la catastrofe
storica della Prima guerra mondiale con solo mezzo secolo di vita alle
spalle. Risentiva delle divisioni ereditate dalla storia degli stati che lo
avevano formato ed era indebolito da correnti estranee alla storia nazionale.
In primo luogo la divisione tra Stato e Chiesa, che lasciava insoluta la
questione della partecipazione dei cattolici alla vita politica nazionale.
Poi il socialismo, fattore di sviluppo nella vita sociale e nella cultura, che,
però, aveva introdotto motivi di divisione fuori e dentro il partito socialista,
culminati con la scissione di Livorno. L’esito tremendo della Prima guerra
mondiale e l’eco della Rivoluzione russa daranno forza a forme
massimalistiche di rivendicazione sociale, che provocheranno fratture che
emergeranno in tutta la loro crudezza durante la Resistenza. E infine, il
motivo di debolezza più rilevante, il fascismo, che, dopo essersi affermato
in modo violento, aveva instaurato una dittatura autoritaria, cancellando
le libertà individuali e spezzando il nesso tra nazione e libertà, che aveva
caratterizzato il Risorgimento. È su queste deboli basi politiche che poggia
il movimento partigiano in Italia. La guerra partigiana, quindi, non poteva
essere che quella che è stata, e non ha senso, secondo Cavaglion, accusarla
di non essere stata ciò che non poteva essere, o magnificarla per ciò che
non può essere stata. L’unità che si raggiunge in banda nel primo autunnoinverno è già un risultato notevole, ma era naturale che l’obiettivo
unificante di combattere il nazifascismo non sarebbe riuscito a superare
divisioni così antiche e profonde. I fini e i programmi politici restano
non compatibili e, in più, gli alleati temono, e con qualche ragione, che
da un momento all’altro la situazione precipiti come in Grecia. Chi critica
la Resistenza, così come il Risorgimento, per essere stata opera di
minoranze non coglie il punto fondamentale, e, cioè, che la gracilità della
nostra costituzione politica e sociale dipende proprio da questa ristretta
partecipazione. Assurdo pretendere che il movimento partigiano fosse in
grado di porre rimedio a debolezze così antiche e profonde, tanto più
nelle condizioni estreme del settembre del 1943. Eppure, pur con questi
vincoli esterni, la Resistenza è di gran lunga la pagina più ammirevole
scritta dagli italiani (pp. 42-44).
Fin dall’inizio la Resistenza è caratterizzata dalla sua frammentazione
sul territorio, e in ciò risiede la sua incisività. Le formazioni sono del tutto
autosufficienti e, anche quando la matrice politica è la stessa, il
74
Il peso della storia. La memoria della resistenza nell’Italia repubblicana
coordinamento è minimo. Sulla militanza ideologica prevalgono la fiducia
personale e il legame affettivo. I confini della guerra partigiana, prima ancora
che quelli della Nazione, sono quelli della singola valle, o di una parte di
essa. Un effettivo comando superiore riunificato sarà possibile soltanto alla
vigilia della liberazione delle grandi città del nord (pp. 46-47).
Cavaglion passa poi a discutere due questioni cruciali. La prima riguarda
le implicazioni dell’approccio che si propone di entrare dentro le ragioni
della storia, con particolare riguardo alle vicende della Resistenza. In questa
prospettiva è indispensabile attribuire a tutti i protagonisti uguale dignità
storica, cercando il più possibile di liberarsi da qualsiasi valutazione morale
e da ogni passione. Questo non significa restituire la ragione storica a chi
non la può avere, né sostenere necessariamente l’equivalenza delle parti,
ma senza questa premessa diventa impossibile ogni ricostruzione di quel
periodo. La seconda riguarda il concetto di «zona grigia», che è diventata la
categoria etico-politica intorno a cui ruotano la maggior parte delle
interpretazioni della storia italiana tra il 1943 e il 1945. L’espressione
compare per la prima volta come titolo del secondo capitolo dell’ultimo
libro di Primo Levi, I sommersi e i salvati, che descrive la zona «dai contorni
mal definiti, che insieme separa e congiunge i due campi dei padroni e dei
servi», e più in generale riflette sull’ambigua zona di confine dentro ciascun
individuo che separa il bene dal male e che le condizioni estreme del campo
sottopongono a pesanti sollecitazioni e nei confronti della quale Levi invita
a rifuggire da giudizi poco meditati, ma è ormai utilizzata come sostegno
all’assoluzione da ogni colpa, individuale e collettiva (pp. 55-62).
Centrate sono anche le osservazioni sulla natura dell’antifascismo della
guerra partigiana, un antifascismo diverso da quello delle origini, e che si
sovrappone a coloro i quali hanno pagato l’opposizione al fascismo con
lunghi anni di carcere. Essendo una scelta dettata dalla lezione dei fatti, è
composto da un intreccio di motivazioni ideali e di interessi contingenti.
Questo nuovo antifascismo è formato da uomini che, formatisi sotto il
fascismo, se ne sono distaccati dopo averne subito il fascino, disgustati dalle
orribili visioni e dalle privazioni della guerra, prima accettata per
l’ammirazione della «Germania che vince sempre». Da ciò discende che la
Resistenza si batte contro un regime che ha solo in minima parte i tratti del
fascismo storico. La guerra contro la Repubblica di Salò è inequivocabilmente
vinta il 25 aprile 1945. Molto meno certo è che quel giorno sia stato sconfitto
anche il fascismo andato al potere nel 1922. E forse molte strutture di
quell’Italia sono funzionanti ancora oggi (pp. 74-75).
75
Giovanni A. Cerutti
L’idea che hanno i partigiani della nuova Italia è per forza di cose confusa
e velleitaria. Non è possibile pensare che dopo vent’anni di fascismo ci sia
sufficiente lucidità in proposito. Pensare come alcuni settori della Resistenza
di riprendere il cammino interrotto nel 1922 - giudicando l’esperienza
dell’Italia prefascista come quello di una democrazia in formazione - non
tiene conto delle rotture che la Resistenza al nazismo ha determinato nella
storia delle società europee. Ma anche le prospettive rivoluzionarie, che
nascevano dalla volontà di una cesura netta con il passato, coltivate da altri
settori, non avevano alle spalle un’analisi sufficientemente accurata della
storia italiana. Ciò che accade dopo l’8 settembre mette in evidenza la debole
consistenza morale e culturale in cui è precipitato il paese, non l’energia
che precede una rivoluzione. Le coscienze si erano assopite, e non sarebbe
stato semplice riattivarle. Constata l’inadeguatezza di entrambe questa
prospettive, Cavaglion propone di definire la Resistenza come una
Rivoluzione-Rivelazione. Se il fascismo era stato, secondo la lezione di
Gobetti, l’autobiografia della nazione, la rivelazione, cioè, dei mali antichi
dell’Italia - diffusa disabitudine alla lotta politica, indifferenza per i valori
che improntano le istituzioni, scarsa disponibilità ad assumersi le
responsabilità di liberi cittadini, inclinazione alla retorica, al conformismo,
al compromesso, alla cortigianeria, al demagogismo - la guerra partigiana è
la rivelazione delle sue virtù sopite. Assomiglia a una rivoluzione per il
sommovimento generale che determina, ma non lo è per il suo carattere di
scelta imprevista fino a pochi giorni prima, che sparisce quando si torna
alla normalità. La Rivoluzione-Rivelazione è soprattutto uno scatto di
orgoglio. È una scelta verso la quale i singoli sono spinti dagli avvenimenti
e non da una consapevole preparazione. Cavaglion discute anche la
definizione di guerra civile, mettendo in evidenza che nell’Italia del 19431945 la guerra diventa civile, non nasce civile. Nelle guerre civili un popolo
è attraversato fin dall’inizio da una spaccatura profonda fra due opzioni
inconciliabili. L’8 settembre, invece, giunge dopo una bruciante sconfitta
in una guerra sostenuta dal consenso generale fino a poche ore prima, e lo
scontento che si genera è provocato dai disagi che la guerra ha provocato e
dalla frustrazione che sempre segue le sconfitte, specie se giungono al posto
di vittorie attese come certe. Inoltre la guerra civile non ha avuto le stesse
caratteristiche in tutte le regioni d’Italia. In certe regioni del centro-sud,
liberate quasi subito dopo l’armistizio, non ebbe praticamente luogo. In
Piemonte fu guerra civile in senso stretto e per un periodo relativamente
lungo. In Emilia Romagna la guerra riprese ad essere civile dopo vent’anni
76
Il peso della storia. La memoria della resistenza nell’Italia repubblicana
di interruzione. Ma la guerra fu fratricida soprattutto perché ogni partigiano
la combatté innanzitutto contro il fascismo che si portava dentro, come
ben ha messo in evidenza il lavoro di Claudio Pavone (pp. 77-89).
Penetranti anche le riflessioni sulla violenza. Cavaglion parte dalla
constatazione che non esiste una violenza buona. La violenza è sempre
violenza, e nei conflitti ci sono sempre vittime innocenti. Ma gli uomini
non possono essere ridotti all’ideologia che servono - su questo piano
l’asimmetria tra tedeschi e alleati, tra partigiani e repubblichini rimane
irriducibile, perché irriducibili sono totalitarismo e libertà - e la causa giusta
non diventa comprensibile se i suoi sostenitori sono descritti come
immacolati virtuosi e i suoi avversari come sadici. Per questo non è
convincente la tesi semplificatrice della «uguaglianza nella morte e
disuguaglianza nella vita», perché le ragioni della vita possono essere
convergenti o divergenti nello stesso schieramento (pp. 91-96).
Concludendo la sua riflessione, Cavaglion osserva che non si è mai presa
in considerazione l’idea di ricostruire la storia dei libri che sono stati scritti
o pensati durante la Resistenza, il cui valore risiede forse principalmente
nell’avere mutato profondamente il pensiero europeo. Come simbolo di
quella stagione Cavaglion ricostruisce le tormentate vicende dei materiali
preparatori delle Premesse alla Storia della politica estera italiana dal 1870 al
1896 di Federico Chabod, un’opera che rispecchia in modo icastico la
metamorfosi subita dall’idea di Europa negli anni cruciali tra il 1943 e il
1945, inserendo la storia italiana nella storia europea dei limiti del
nazionalismo, che ha generato le tragedie del Novecento. Quando sale in
montagna per unirsi alla Resistenza, Chabod si porta le carte e gli appunti
su cui stava lavorando in una baita a Dégioz, in Valsavarenche, non lontana
dagli alpeggi di Djouan, posti a 2.150 metri, da dove deriva il ceppo
famigliare degli Chabod. Costretto a riparare in Francia da un rastrellamento
tedesco nel novembre del 1944, decide di seppellirli poco lontano dalla
baita. Terminata la guerra, Chabod riesce ad arrivare alla Prefettura di Aosta
da Parigi il 10 maggio 1945, dove, per prima cosa, si procurerà un’automobile
per recuperare le sue carte: «Il 10 maggio 1945, quando il manoscritto
viene recuperato a Dégioz, possiamo mettere la parola fine. Da quel giorno
la storia riprende a fare liberamente il suo corso. Per la storia della Resistenza
il 10 maggio ha un significato più elevato del 25 aprile» (p. 103).
Mi sembra che il percorso proposto ci consegni due questioni cruciali
per il futuro della memoria della Resistenza. La prima riguarda quale sia la
77
Giovanni A. Cerutti
sua collocazione nella storia d’Italia. Il biennio 1943-1945 è un crocevia
attraverso il quale le questioni irrisolte della costruzione dello stato unitario
si intrecciano con lo sviluppo del sistema politico nei primi sessant’anni di
storia repubblicana. In quelle vicende c’è la storia della nascita del nostro
sistema democratico - con le sue rotture e le sue continuità, i suoi punti di
forza e le sue persistenti debolezze - e la lealtà a questa scelta passa
necessariamente dal rapporto con quelle vicende. La seconda riguarda
l’elaborazione di una memoria compiuta del fascismo, che diventi
consapevolezza condivisa del nostro passato. In questo senso troppe sono
ancora le zone d’ombra all’interno delle quali prosperano equivoci che
indeboliscono la nostra cultura democratica. Zone d’ombra che riguardano
la effettiva natura del regime fascista, quali il ruolo fondamentale assegnato
dal fascismo alla violenza - e, raccogliendo le suggestioni di Cavaglion, alla
menzogna - come strumento di governo; la politica di aggressione condotta
dall’Italia a danno di altri paesi, dalle conquiste coloniali alle politiche di
occupazione messe in opera nei paesi invasi; l’attiva persecuzione dei cittadini
italiani di origine ebraica. Ma che riguardano soprattutto questioni cruciali
quali il sostegno ricevuto dal fascismo e dalla guerra condotta a fianco della
Germania, le dinamiche che portarono alla liquidazione del regime sotto il
peso delle sue contraddizioni e la natura dei rapporti tra l’antifascismo che
caratterizzò il movimento resistenziale e il fascismo storico.
78
Le istituzioni militari e la loro evoluzione nella società italiana contemporanea
Le istituzioni militari e la loro evoluzione nella società italiana
contemporanea
di Luigi Caligaris
Non pochi in Italia, consapevoli della crisi di credibilità dello Stato,
prospettano cure politiche o parapolitiche per conferirgli ipso facto
prestigio e credibilità. Tuttavia sorge il dubbio che spesso si tratti non
già di lungimiranti riforme ispirate da senso dello Stato e interesse per
la nazione, quanto di accorgimenti contingenti e pragmatici per
assicurarsi il successo elettorale e poi gestire, senza troppi problemi, il
potere così assicurato.
Seppure in ogni democrazia sia fisiologico che le parti politiche facciano
quanto loro è possibile per assicurarsi la conquista del potere e la sua più
agevole gestione, tuttavia le scelte dei percorsi possibili per conseguire
entrambi gli scopi sono dettate dalle culture politiche e istituzionali delle
singole nazioni. Anche se, per tutelare le libertà democratiche e il
buongoverno, ognuna di esse dispone di una sua rete di controlli ed equilibri
affine, almeno nelle finalità, ai checks and balances americani, nelle singole
società nazionali e nei diversi momenti della loro storia differiscono i modi
per assicurarli e i ruoli assunti da politica e istituzioni.
Gli anglosassoni più che alla norma s’affidano all’autonomia di giudizio
di chi deve attuarla, mentre noi italiani, eredi di Giustiniano, attribuiamo
più valore alla norma che non a chi deve applicarla. Distinzione non da
poco. Mentre, infatti, nella società e cultura anglosassone gli organismi
istituzionali hanno forte identità e autonomia, in quella italiana essi sono
in sottordine rispetto alla norma. Nel burocratese il ricorso a termini quali
«dogma», «cattedra» o «verbo», nell’alludere a tesi e testi ufficiali, non è
solo atto d’ossequio verso chi la norma la fa propria e la detta ma rivela la
voglia di trovare riparo dietro ad essa. Per cambiare corso va detto che il
buon governo del paese non dipende solo dalla maestà della politica, dalla
saggezza delle regole o dalla solerte supervisione dello Stato di parte di
illustri garanti. Sono altrettanto importanti la qualità degli attori istituzionali,
la consapevolezza del ruolo coperto e il responsabile modo d’assolverlo.
79
Luigi Caligaris
Infine non meno importante è l’apporto del mondo intellettuale e dei media
alla formazione e diffusione di una cultura politico-istituzionale.
C’è da dubitare che in Italia, da quel che si legge o si sente, una cultura di
tale tipo ci sia e che vi sia interesse a formarla. Mentre si concedono le prime
pagine alle più marginali vicende della politica, saltuari e distratti sono gli
accenni alle istituzioni. Nel vuoto di una cultura di tale tipo e livello le
istituzioni sono divenute più fragili ed è stato per i partiti più agevole tentare
di asservirle. L’accoppiamento fra partiti e burocrazie istituzionali ha dato
alla luce la partitocrazia grazie alla quale le istituzioni hanno ceduto sempre
più spazio ai partiti. Imperdonabile errore. Senza sminuire il ruolo della politica
è ovvio che dall’affidabilità delle istituzioni dipendono in non piccola parte
le probabilità di successo nel governare lo Stato, cioè il buon governo. È
luogo comune fra i politologi che istituzioni sane e motivate «ottimizzano il
potenziale e l’influenza di una nazione» mentre vi sono «nazioni impedite ad
agire tempestivamente dalle loro stesse istituzioni».
Sono gli stessi partiti peraltro a confermare l’ingerenza della politica
nelle istituzioni quando lamentano i tentativi del fronte opposto di
condizionare le nomine delle alte e medio-alte cariche dello Stato. Nel passato
consociativo si sono tacitate le proteste spartendo fra i partiti e all’interno
degli stessi le cariche dello Stato e del parastato. È così nata la «lottizzazione»
e, assieme ad essa, i funzionari «in quota», tributari della propria nomina a
un partito di riferimento.
Non contenti di questo, i partiti hanno tentato di lottizzare oltre che gli
uomini anche gli apparati delle istituzioni. Quei metodi non hanno avuto
comunque sempre successo in quanto la loro veste surrettizia non era allora
accettabile per alcune fra le istituzioni, quali le forze armate, ancora convinte
della statualità del proprio ruolo.
Quando il periodo consociativo ha ceduto il campo a quello bipolare, si
è voluto porre fine alla lottizzazione, non più praticabile nel nuovo contesto.
Un nuovo metodo è stato legittimato e poiché nulla piace in Italia quanto
ciò che viene dall’estero, esso è stato mutuato da una cultura istituzionale
straniera liberal-democratica, quella americana. Fra tamburi e fanfare, lo
spoils system ha fatto solenne ingresso in Italia. Tuttavia, dopo decenni di
cattive abitudini, non era realistico persuadere sia i partiti sia i loro seguaci,
adusi a una pratica clientelare che aveva a entrambi giovato, ad abbandonare
criteri di scelta partitici a favore di altri, meritocratici. Perciò, con la
trasversale complicità delle parti politiche, si continuano a perpetuare, sia
pure in altre forme, i reciproci legami clientelari fra partiti e istituzioni.
80
Le istituzioni militari e la loro evoluzione nella società italiana contemporanea
Alla resa dei conti si è infatti accolta la versione più grezza dello spoils
system che consente di rimpiazzare un certo numero di funzionari con
altrettanti graditi alla parte vincente. Si è trascurata invece l’accezione nobile
di quel metodo, lo in and outer, stimolante travaso nell’amministrazione
pubblica della cultura ed esperienza della società civile con l’immissione o
aggregazione di elementi qualificati. Seppure talvolta vi siano abusi, le
istituzioni e i mass-media vigilano, la pubblica opinione è sensibilizzata e la
regola è generalmente rispettata. Ci si augura che in Italia, chiamando in
causa il «senso dello Stato» che spesso s’invoca, si sposi tale versione del
metodo americano, che la qualità dei prescelti sia alta, che la loro lealtà
verso lo Stato non sia in subordine alla parte politica. In caso contrario
quale sarà l’impatto per i servitori dello Stato, specie i meno smaliziati e i
più giovani, quando sapranno che il loro futuro dipenderà non dal merito
ma dalla benevolenza di una parte politica?
L’adozione del nuovo metodo - lo si chiami pure spoils system purché sia
bene applicato - è l’ultima tappa d’un lungo percorso seguito dalla politica
per assicurarsi la parzialità delle istituzioni, sottraendola di conseguenza
allo Stato. Ad aprire la via è stato il placet politico che, con la complicità
interessata di esponenti delle istituzioni, ha non di rado ignorato il merito
nella designazione di alte cariche dello Stato. In seguito, con solerte inventiva,
sono stati pensati altri modi per aumentare e confermare il numero dei
proseliti istituzionali. Per confermare la fedeltà impropriamente acquisita
si è provveduto, con crescente frequenza, a prorogare talune cariche oltre il
tempo previsto e l’età di congedo.
Eppure la proroga, tranne poche eccezioni, è una scelta sbagliata. Ne era
convinto Niccolò Machiavelli, secondo il quale Roma repubblicana «non
avrebbe lasciata introdurre quella consuetudine di prolungare i magistrati
[…] la qual cosa col tempo rovinò quella repubblica». Seppure venti secoli
siano passati da allora, si può confermare che la proroga è misura eccezionale
per tempi eccezionali e la può motivare solo la ragion di Stato. Se alla
designazione di alti funzionari per via surrettizia o con uno spoils system
furbesco si somma la proroga e/o l’attribuzione di ulteriori cariche a fine
mandato, come non dubitare che la politica, nel costruire carriere infinite,
voglia così assicurarsi sempiterna acquiescenza di membri delle istituzioni?
Seppure un dubbio siffatto non possa non inquietare chiunque abbia
senso dello Stato, nessuno pare che se ne preoccupi. L’anomalo abbraccio
fra politica e istituzioni ha anche altre implicazioni. Ovunque, infatti, in
nome di una migliore e più tempestiva risposta alle sfide di ogni natura che
81
Luigi Caligaris
accrescono la complessità dell’attività di governo, si rafforza l’interesse
dell’esecutivo ad aggiudicarsi le istituzioni. Tre secoli fa Alexis de Tocqueville,
attento osservatore della democrazia americana, ha messo in guardia gli
Stati Uniti da troppo stretti legami fra maggioranza, governo e istituzioni,
tali da configurare un invisibile Quarto Potere. Il suo monito ha contribuito
a convincere le istituzioni americane a introdurre anticorpi da chiamare in
causa ogniqualvolta tale eventualità si profila.
Fra gli anticorpi naturali vi è quello di restituire alle istituzioni identità
e autonomia, sottraendole all’abbraccio insidioso della politica. Su una leale
collaborazione all’insegna della «non ingerenza» reciproca dovrebbe basarsi
il loro rapporto. È forse questo il caso dell’Italia? Vi è anche da tenere conto,
sul piano delle prestazioni, dei problemi causati dalla sottomissione dei
quadri alti e medio-alti alla politica. La voglia di compiacere e il timore di
dispiacere contraddicono le esigenze di trasparenza, tempestività ed efficacia
alla base di ogni serio apparato.
Ora passiamo alle istituzioni militari, o meglio dei corpi armati dello
Stato, forze armate e forze dell’ordine. In Italia raramente di loro si parla
come di istituzioni e soprattutto inevasa è la definizione del loro rapporto
con la politica.
Su questo argomento, sul quale esiste copiosa e qualificata letteratura
straniera, non vi è in Italia un solo testo comparabile al saggio The soldier
and the State di Samuel P. Huntington. Testo a cui attingerò a piene mani
per segnalare cosa s’intenda per il rapporto fra politica e militari. Comincerò
col citare un nostro affermato intellettuale, secondo il quale quel rapporto
non merita attenzione poiché «le cose militari sono problema tecnico, non
politico». Come dire che il problema militare consiste unicamente nel gestire
tecnicamente la propria organizzazione così come la politica vuole.
Questa convinzione non è affatto isolata, anzi è ben radicata nella nostra
cultura. Se i corpi armati dello Stato, diversamente da altre e più combattive
istituzioni, sono privi di rilevanza politica, essi possono essere rivoltati da
capo a piedi, senza che nessuno voglia od osi verificarne conseguenze e
motivi. Dato inoltre che nessuno osa dire che le istituzioni sono «tecniche»,
se ne deve desumere che i corpi armati dello Stato sono meno istituzioni
delle altre, avvalorando una percezione che ne sminuisce lo status e ne
mortifica l’autonomia. Di opposto parere, Huntington afferma che «il
dibattito militare s’incentra su aspetti operativi ma le decisioni dipendono
dal modello istituzionale che le regola [...] le istituzioni militari sono soggette
a due sollecitazioni: quelle che derivano dalla minaccia alla sicurezza e quelle
82
Le istituzioni militari e la loro evoluzione nella società italiana contemporanea
delle forze sociali, ideologiche e delle istituzioni dominanti. Istituzioni
militari che riflettono soprattutto valori sociali non sanno assolvere le loro
funzioni, quelle che ubbidiscono a imperativi puramente funzionali non
sono accette alla società». Per concludere «le nazioni che sviluppano un
equilibrato rapporto fra civili e militari conseguono un grande vantaggio
nella sicurezza mentre quelle che non ci riescono finiscono per sprecare le
proprie risorse e per correre incalcolabili rischi».
A fronte di quanto sopra, alcune domande s’impongono. Si può forse
dire che quanto detto da Huntington sia riferibile a organismi privi di
rilevanza politica? Certo che no. Se il problema militare è solo «tecnico» e
non politico, non è neppure sociale, ideologico o istituzionale? Quanto
all’affermazione che vi sono paesi che non hanno sviluppato un equilibrato
rapporto fra civili e militari, come evitare che il pensiero corra all’Italia?
A questo punto occorre comprendere cosa in Italia abbia provocato tale
sostanziale declassamento del corpo militare, e perché esso si sia confermato
nei successivi periodi, con ricadute nient’affatto indolori non solo per esso
ma per lo Stato. La disattenzione verso il corpo militare come strumento di
sicurezza, negli anni della Guerra Fredda, nasce da due considerazioni: l’alta
marginalità dell’Italia nel contesto militare dell’Alleanza Atlantica e la
prioritaria attenzione da essa prestata all’ordine interno. Le cattive abitudini
sono dure a morire se, un secolo fa, secondo gli italiani «l’ideale militare era
il carabiniere» e l’esercito doveva essere «forza di pace sufficiente ad assicurare
l’ordine pubblico in qualsiasi circostanza». Allora la politica non si è fatta
carico di definire in modo chiaro il ruolo che lo strumento militare avrebbe
dovuto assolvere nel contesto alleato. La preoccupazione dominante è stata
di assicurare una vasta presenza sul territorio per motivi di ordine interno
ed esigenze di ordine socio-economico demandando alla Nato le decisioni
operative. Inoltre, con la presenza nel paese e nella politica di vene
qualunquiste, minimaliste e pseudopacifiste, i governi che si sono avvicendati
si sono ben guardati dal promuovere un serio dibattito sul corpo militare e
sul suo rapporto con la società.
Quel dibattito, invece, è stato condotto negli Stati Uniti per porre termine
«al declinare del prestigio della professione militare e al vacillare del morale
del corpo degli ufficiali». Ne è scaturita la rivalutazione dello spirito e
dell’identità militare nella convinzione che «un forte, integrato, altamente
professionale corpo di ufficiali, immune dalla tentazioni della politica,
rispettato per la fermezza del carattere, offre un contributo stabilizzante
alla stessa politica».
83
Luigi Caligaris
Così, nel contesto di un’evoluzione intellettuale più favorevole
all’istituzione militare, «le istituzioni militari si inserirono senza serie
difficoltà nella struttura politica, sociale ed economica del paese». Impietoso
un confronto con l’Italia dove non ha mai preso corpo un dibattito di pari
livello su quei contenuti. Né mai vi è stata, a sostegno dei corpi armati
dello Stato, una levata di scudi analoga a quella che negli Stati Uniti ha
unito il Congresso e i mass-media, dall’estrema destra all’estrema sinistra,
contro l’ingresso della politica nelle forze armate. Temi come lo «spirito
militare», il «comando», il «morale», rivalutati dal dibattito americano, sono
stati respinti dalla cultura del nostro paese.
In quel clima politico e culturale il corpo militare ha preferito adottare
un basso profilo disegnandosi un ruolo subordinato alla politica. I suoi
vertici non hanno profferto parola contro la propria esclusione, caso unico
in Occidente, dalla consultazione e decisione di governo su temi militari.
Nessuno che tuttora si chieda se non è un paradosso che il capo delle Forze
Armate italiane non abbia un accesso istituzionalmente riconosciuto al
Consiglio dei ministri. Si aggiunga che il luogo di consultazione e decisione
di governo nelle crisi e in guerra, ovverossia il Centro di decisione nazionale
(CDN), a vent’anni dalla sua nascita è più deserto che mai e che la linea
decisionale segue spesso canali informali. Che, con rara frequenza, il Capo
dello Stato convochi alcune autorità di governo assieme ai vertici militari è
dovuto soprattutto al rispetto di procedure rituali senza ricadute importanti
sul processo decisionale.
Si potrà dire: che importa? Importa, eccome. Tanto per fare un esempio,
il generale Wesley Clarke, ex comandante supremo della Nato nella guerra
del Kossovo, afferma che, in caso di offensiva terrestre contro la Serbia,
l’Italia avrebbe contribuito con 3.500 soldati. Che il Governo lo avesse
deciso si è saputo solo con mesi di ritardo, a guerra finita, e con l’uscita del
libro di Clarke e che le nostre truppe, non tempestivamente preavvisate del
compito, potessero essere preparate e armate a dovere per un impegno
cruento e difficile, è alquanto dubbio. In realtà, nessun governo ha mai
voluto ascoltare in sede collettiva i propri capi militari sui temi di loro
competenza, accontentandosi anche sul piano «tecnico» del parere del
ministro della Difesa notoriamente e inevitabilmente scelto fra militesenti.
In realtà ciò avviene quando la classe politica non vuole cedere spazio ai
«tecnici» neppure nel campo dove solo essi dovrebbero essere competenti.
Mai si è ritenuto necessario, come negli Stati Uniti, «dare cultura politica
agli ufficiali, attribuire responsabilità politiche alle Istituzioni militari,
84
Le istituzioni militari e la loro evoluzione nella società italiana contemporanea
disporre di un competente parere militare» per poi chiedersi «se il parere
militare è vitale per la sicurezza nazionale e se generali e ammiragli non
sono chiamati a esporre il loro punto di vista, chi mai lo dovrebbe fare in
vece loro?». È anche vero che invitare i militari a parlare non basta, importa
che si siano convinti di avere l’obbligo di esporre con franchezza il loro
parere, anche quando contrasta con l’opinione corrente o con la posizione
dei loro capi politici. Ma la tendenza ad esporsi in controtendenza alla
decisione politica è oggi sempre più rara, soprattutto in Italia dove i vertici
delle istituzioni militari hanno una remissività eccessiva verso il potere
politico, rifugiandosi nel riduttivo ruolo di fornitori tecnici di prestazioni.
La ghettizzazione dei militari in un contesto «tecnico», perché ritenuti
dalla classe politica non all’altezza di dialogare con l’eccelso Olimpo politico
ha inciso su molte scelte ad essi imposte in chiave solo politica, senza una
seria verifica della loro attuabilità. È tuttora valido, e la crisi del dopoguerra
in Irak lo riconferma, quanto asserito da Karl von Clausewitz centonovanta
anni fa, cioè che «come un uomo che non ha piena padronanza di una
lingua straniera trova talvolta difficile esprimersi correttamente, così uomini
di Stato emanano ordini che contraddicono lo scopo che si ripromettono
di conseguire». Per citare alcune sprovvedute riforme, la smilitarizzazione
della polizia e l’uscita dall’esercito dei carabinieri, due misure di cui è difficile
capire sul piano funzionale il perché, la proliferazione di modelli della difesa
esibiti da ogni ministro senza che nessuno sia mai andato in porto, le
promesse mai mantenute di consistenti aumenti del bilancio della difesa
esiguo e male amministrato, infine la fine del servizio di leva, il suo rimpiazzo
con il professionismo all’ombra del trionfo dell’obiezione con tappe
politicamente convenienti ma militarmente nocive. Tale faciloneria influisce
anche nella gestione dei corpi militari che, in assenza di chiare indicazioni
sono sbattuti ovunque secondo un presenzialismo di politica estera che
contraddice la razionalità militare. Stessa tendenza per le forze dell’ordine,
chiamate a impegnarsi nelle più varie occasioni con grave dispendio di risorse,
morali e professionali. È indubbio che un maggiore peso dei rispettivi vertici
nella formulazione delle decisioni contribuirebbe a razionalizzare le decisioni.
Non negli Stati Uniti e neppure in Italia, un metodo analogo allo spoils
system ha investito l’apparato militare tuttavia, mentre quello americano ha
finora opposto, con il pieno sostegno della nazione, precisi limiti all’ingerenza
politica, è difficile dire altrettanto di quello italiano. Mai, che io sappia, in
Italia un giornalista di rango ha messo in guardia dalla politicizzazione degli
alti gradi militari, mentre negli Stati Uniti l’autorevole Walter Lippman ha
85
Luigi Caligaris
denunciato come «intollerabile l’eventualità d’uno scisma fra generali
repubblicani e democratici! Anzi, in Italia non è passato molto tempo da
quando esponenti politici hanno rivendicato il diritto di estendere, sia pure
extra legem, lo spoils system ai vertici dei corpi armati dello Stato e i mass
media si sono limitati a prendere atto di quelle pretese quasi che esse
rientrassero nella normalità del rapporto fra istituzioni e politica. Quelle
rivendicazioni sono, a quanto pare, rientrate ma non è arbitrario temere
che si rinnovino alla prima occasione. Si aggiunga inoltre che le tecniche di
seduzione messe in opera dalla politica per aggiudicarsi la lealtà partigiana
delle istituzioni sono state rivolte anche ai corpi armati dello Stato.
Seppure oggi, grazie al Capo dello Stato, il corpo militare sia riproposto
alla nazione, non s’intravedono tentativi significativi per porre rimedio alle
vistose carenze della cultura militare. Lo scopo di un’offensiva culturale
non deve essere il concedere un premio di consolazione ai militari per i
torti subiti o assicurare loro la benevolenza, magari interessata, della cultura
e dei media. Dopo decenni di subalternità è d’obbligo che i militari, forze
armate e forze dell’ordine, si facciano essi stessi promotori convinti e
autorevoli d’un nuovo pensiero militare, d’una forte identità militare, di
un genuino spirito militare. Negli anni cinquanta, periodo critico per le
forze armate americane, si è così rivolto ai militari Sam Huntington: «Sui
soldati, i difensori dell’ordine, posa una grande responsabilità. Il più grande
servizio che essi possono rendere alla nazione è di essere fedeli alle proprie
convinzioni, di servire con spirito militare, con coraggio e in silenzio. Se
rinnegano lo spirito militare distruggono se stessi e danneggiano la nazione.
Se i civili consentiranno ai militari di aderire ai propri valori, le nazioni
stesse potranno tutelare la propria sicurezza facendo propri quegli stessi
valori».
Poco tempo fa così è intervenuto il Capo dello Stato in un suo incontro
con i giornalisti, «la regola è nella propria coscienza, nel mantenere dritta la
propria spina dorsale, la schiena dritta è nel vostro DNA!». Può non esserla
quella delle istituzioni militari?
86
L’apartheid nell’Italia fascista
Africa e dintorni
L’apartheid nell’Italia fascista
di Aram Mattioli
I. Già solo porre la questione se l’Italia fascista abbia praticato
l’apartheid ancora non molto tempo fa avrebbe provocato espressioni di
stupore e perplessità e magari anche scettici scuotimenti di capo. In effetti
fino a qualche anno fa prevalevano immagini assolutamente deformate e
minimizzanti del razzismo fascista. L’Italia di Mussolini appariva a molti
sopravvissuti e a molti storici - che avevano ancora negli occhi la barbarie
senza precedenti del «megasterminio» nazionalsocialista (Gunnar
Heinsohn) - una luminosa eccezione, perché fino al 1938 non sarebbe
riscontrabile nessuna prassi fondata sull’antisemitismo e solo da questa
data, sulla scia dell’avvicinamento politico al Terzo Reich, l’Italia sarebbe
scivolata nella discriminazione della minoranza ebrea, la cui esistenza non
sarebbe comunque mai stata minacciata prima della caduta di Mussolini
il 25 luglio 1943. Nel 1942-43 i generali e diplomatici italiani in Grecia,
Jugoslavia e nella Francia meridionale, occupate militarmente, si sarebbero
opposti all’olocausto per pura umanità, proteggendo migliaia di ebrei
dalla deportazione1. Anche dopo l’occupazione tedesca dell’Italia numerosi
piccoli funzionari, preti cattolici e semplici cittadini avrebbero sabotato
la consegna degli ebrei italiani ai tedeschi, salvando così la vita a molti
perseguitati2. Questo comportamento andrebbe spiegato come «prodotto
della generale, spontanea umanità di un popolo di antica civiltà» - così
Hannah Arendt nel suo libro La banalità del male3.
E lo storico Jonathan Steinberg, docente a Cambridge, ha parlato in
questo contesto addirittura di una «banalità del bene» tipica degli italiani,
noncuranti dell’autorità e incapaci di far male a una mosca4.
Ovviamente anche gli storici italiani si sono adoperati a tessere la
leggenda degli «italiani brava gente» 5. La riduttiva e minimizzante
87
Aram Mattioli
interpretazione della dittatura fascista risale inequivocabilmente a Renzo
De Felice, romano e professore di storia (1929-1996), che a partire dagli
anni settanta si è fatto un nome in Italia come maggiore storico
contemporaneo grazie a una monumentale biografia di Mussolini6, nei
cui volumi - che assommano a molte migliaia di pagine - l’autore presenta
l’Italia fascista come una dittatura sui generis, assolutamente
imparagonabile al Terzo Reich, perché le differenze tra i due regimi
sarebbero state «enormi». Si sarebbe trattato di due mondi, due tradizioni,
due storie nazionali talmente differenti da rendere straordinariamente
difficile guardare ad esse dallo stesso punto di vista7. Il fascismo italiano,
secondo De Felice, non avrebbe posseduto né il potenziale di violenza né
la volontà razzista di sterminio del nazionalsocialismo. Pochi anni dopo
De Felice arrivò a stabilire apoditticamente che Mussolini «non fu mai
razzista e tantomeno fu antisemita»8. Non pago di ciò, nel 1987 concluse
che l’accusa di genocidio non potesse toccare l’Italia, che quindi resta al
di fuori del cono d’ombra dell’olocausto9. E ancora nel 1993, tracciando
un bilancio delle sue decennali ricerche, De Felice delineò la tesi che il
fascismo non potesse definirsi né razzista né tantomeno antisemita10. Le
sue conclusioni si basavano sul fatto che durante il «ventennio nero» (dal
1922 al 1943-45) la stragrande maggioranza degli italiani si sarebbe
dimostrata immune al virus del razzismo e dell’antisemitismo.
Solo di recente nuove ricerche hanno corretto queste insostenibili
valutazioni dimostrando che l’Italia fascista ha in realtà portato avanti
una politica ben più intrisa di violenza e di razzismo di quanto non abbiano
voluto far credere la precedente storiografia italiana e tedesca11. Quella di
Mussolini non fu mai una dittatura dal volto umano: la violenza bellica
scatenata in Africa e nei Balcani dall’esercito italiano e il terrore della
successiva occupazione, entrambi fondati su motivazioni di stampo
razzista, costarono, entro il 1943, almeno 800.000 vite12.
In questo breve saggio si tenterà allora di dimostrare che la violenza
razzista fece parte della quotidianità dell’Italia fascista fin da subito. Inoltre
si porrà in evidenza che - a partire dalla conquista dell’Etiopia, cioè
dall’estate del 1936 - la dittatura di Mussolini si sviluppò autonomamente
in un «regime apertamente razzista» (Georg M. Fredrickson). È peraltro
evidente che il razzismo fascista ebbe una propria e peculiare impronta:
diversamente che nel Terzo Reich esso si indirizzò inizialmente soprattutto
contro gli slavi e gli africani, prima che ne fossero vittima anche gli ebrei.
È su questa circostanza storica che si fondano le riflessioni che seguono.
88
L’apartheid nell’Italia fascista
Le leggi razziali del 1938 non piovvero dal cielo, ma furono il risultato di
uno sviluppo durato a lungo, collegato a precedenti esperienze autoctone.
In effetti il successo del trapasso del 1938 in un sistema di «antisemitismo
statale»13 non può essere adeguatamente spiegato qualora si trascuri il
ruolo di battistrada esercitato dell’antislavismo e dal razzismo coloniale.
II. Il pensiero razzista muove dal presupposto che esista un ordine di
subordinazione - apparentemente biologica - dei diversi gruppi etnici e
quindi si collega strettamente al dogma dell’ineguaglianza degli uomini14.
Il razzismo si manifesta pertanto «quando un gruppo etnico o una
collettività storica domina, esclude o tenta di eliminare un altro gruppo
sulla base di differenze che esso ritiene ereditarie e immutabili»15. In
concreto, il razzismo serve a motivare e imporre una volontà di dominio.
Secondo la sociologa Karin Priester il razzismo può quindi essere definito
come «una strategia fondata su basi pseudoscientifiche, intesa a distrarre
dai conflitti sociali e volta a legittimare un predominio assoluto»16.
Già prima della marcia su Roma era percepibile alla base del fascismo
italiano una corrente razzista di questo stampo. La prima forma assunta
dal razzismo fascista fu quella della «slavofobia», la sprezzante
discriminazione degli slavi del Sud, con cui il regno d’Italia aveva in
comune il confine nordorientale già ai tempi della monarchia asburgica.
Già dall’inizio del XX secolo l’odio per gli slavi era particolarmente
marcato in molti degli irredentisti, per i quali il regno d’Italia rimaneva
uno stato nazionale incompleto, anche dopo l’unificazione del paese,
poiché oltre i confini rimanevano ancora numerose «regioni irredente».
In questi circoli nazionalisti l’aspirazione a diffondere l’«italianità» ebbe
da subito forti connotazioni antislave17. Molti di questi irredentisti
ritenevano gli slavi che vivevano sotto il dominio asburgico una «razza
inferiore», composta da contadini grossolani e ignoranti, incapaci di
una cultura evoluta18. Non poteva quindi essere negata alla superiore
civiltà italiana la giusta pretesa del confine sul Brennero con i territori
del Trentino, le città di Trieste e Gorizia, l’Istria e la costa dalmata queste erano le richieste che gli irredentisti avanzano prima della Grande
Guerra. Gli esponenti dell’irredentismo sostenevano la superiorità della
civiltà italiana e pensavano usando categorie di stampo razzista. Essi
consideravano come territorio esclusivamente italiano anche la
terraferma dell’antica Repubblica di Venezia, che fino al 1796 aveva
89
Aram Mattioli
avuto sotto di sé tutta la costa dalmata. Solo il possesso dell’intera
Dalmazia avrebbe quindi consentito all’Italia di raggiungere i propri
confini naturali.
L’odio per gli slavi crebbe quando l’Italia combatté contro l’AustriaUngheria, nel cui esercito dovevano servire molti soldati di origine slava.
Gli irredentisti percepirono sempre la prima guerra mondiale anche come
un «conflitto razziale» contro i germani e gli slavi che irrompevano dal
Nord. Nel 1919, dopo il crollo della monarchia austro-ungarica l’Italia
ottenne non solo territori posti sul confine nordorientale, con popolazioni
tedesche e slave, ma anche un confine affacciato sulla Jugoslavia, il regno
di recente fondazione che raccoglieva serbi, croati e sloveni. Rimase invece
inesaudito il sogno di avere l’intera costa dalmata, con l’eccezione della
città portuale di Zadar e delle isole di Lagosta (Lastovo), Cherso (Cres)
e Lussin (Losinj). La tesi propagandistica di una «vittoria mutilata» spinse
molti nazionalisti delusi tra le braccia del fascismo. Gli intellettuali
irredentisti Attilio Tamaro, Francesco Salata e Fulvio Suvich, tutti originari
della Venezia Giulia, introdussero l’odio per gli slavi nel movimento
fascista19.
I fascisti, che già avevano elevato la slavofobia a programma politico,
una volta preso il potere ne fecero anche una parte della propria politica
di governo. Nel 1919 i duri dei fasci di combattimento appoggiarono il
colpo di mano di Gabriele D’Annunzio contro la città portuale di Fiume,
vedendovi il primo passo per un’annessione della Dalmazia all’Italia20. In
un discorso tenuto a Pola (l’odierna croata Pula), Mussolini dichiarò
dinanzi ai suoi entusiasti sostenitori: «Davanti a una razza barbara e
inferiore come quella slava non si può agitare la politica dello zuccherino,
ma quella della frusta»21. Particolarmente odiosa agli occhi delle camicie
nere era la figura dello «slavo-comunista», che riuniva contemporaneamente due caratteristiche negative; quella di appartenere a una razza
inferiore e di avere convinzioni politiche detestabili22. Tra le prime vittime
dei fasci combattenti vi furono, oltre a comunisti e socialisti, anche sloveni
e croati. Bande di picchiatori fascisti, con il pretesto di combattere il
bolscevismo, si aggiravano per la Venezia Giulia - quindi nelle nuove
province di Trieste, Gorizia, Pola e dell’Istria -, aggredendo esponenti e
assalendo istituzioni slave23 nel tentativo di intimidire le popolazioni
con assassini, saccheggi e incendi e costringere all’esilio gli odiati uomini
di sinistra. Questo fascismo ai confini del paese si distinse già prima della
marcia su Roma per la sua particolare aggressività.
90
L’apartheid nell’Italia fascista
Subito dopo la presa del potere, nel 1922, si evidenziò che il governo
di Mussolini intendeva portare avanti con grande impegno una rigida
politica repressiva nelle nuove province, inserendo così un elemento di
potenziale conflittualità in una zona dove fino ad allora diversi popoli
avevano convissuto relativamente in pace. Trieste per esempio era una
città di mare multiculturale, a maggioranza di lingua italiana ma con un
territorio circostante di impronta fortemente slava24. Ora Roma premeva
per «italianizzare» la Venezia Giulia e in particolare la penisola istriana,
abitata in maggioranza da sloveni e croati. L’italianizzazione forzata mirava
a polverizzare la cultura e l’identità degli slavi meridionali25. In ultimo, la
politica fascista dell’assimilazione forzata si trasformò in un «genocidio
culturale»26.
In nome dell’italianizzazione forzata, l’uso delle lingue slovena e croata
venne quindi fortemente limitato e proibito nei documenti ufficiali. A partire
da quel momento, le lezioni scolastiche vennero tenute solo in lingua italiana
e con sussidi didattici italiani. Il governo centrale impose alle amministrazioni
locali l’epurazione dei funzionari slavi, chiuse giornali e istituti educativi.
Poco alla volta venne distrutta la rete di associazioni e organizzazioni culturali
slave, mentre in parallelo si procedeva all’italianizzazione dei nomi di località,
piazze e strade e ai sudditi slavi venivano affibbiati nomi italiani27. Non
contenta, Roma aumentò la pressione economica e fiscale sulle famiglie
contadine e i piccoli proprietari, costringendoli a cedere ogni loro avere. Ad
alcuni di loro non rimase altro che abbandonare la propria patria, mentre i
loro beni vennero subito trasferiti a famiglie italiane28. Il regime fascista
procedette anche contro azioni di resistenza con eccezionale durezza. Il
Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito nel 1926, emanò un
numero superiore alla media di condanne a morte per slavi definiti «terroristi»
e numerose altre condanne a pesanti pene detentive 29. La politica
dell’assimilazione forzata venne giustificata con il «diritto naturale del più
forte» e la presunta «superiorità della civiltà italiana».
In breve, l’antislavismo fascista mirava a una società in cui gli italiani
avrebbero avuto il ruolo di popolo dominatore e gli slavi quello di popolo
dominato. Pierre André Taguieff ha definito una volta questa tipologia base
di prassi razzista come «razzismo di dominio» contrapponendolo al «razzismo
di sterminio»30. In effetti si trattava di una forma inclusiva di esercizio di
potere: alla popolazione slava non veniva negato in linea di principio il
diritto ad esistere nella società dominata dagli italiani, ma doveva comunque
adattarsi alla «politica di repressione etnica» o abbandonare il paese. Così,
91
Aram Mattioli
tra il 1919 e il 1939 circa 100.000 dei 440.000 sloveni e croati preferirono
l’emigrazione a una ulteriore permanenza in Italia31. Un sistema molto più
radicale di violenza razzista fu invece quello instaurato dai fascisti nell’Africa
Orientale italiana, cui va riservata una particolare attenzione per essere stata
il terreno sperimentale del razzismo fascista.
III. Già nel 1975 lo storico britannico Dennis Mack Smith avanzò la
tesi che il contributo più notevole dell’Italia fascista al colonialismo siano
state la teoria e la prassi dell’apartheid32. E in realtà in Africa i fascisti - alla
pari delle altre potenze coloniali - non solo portarono avanti una politica
razziale, ma costruirono un sistema istituzionale di segregazione razziale,
che sotto molti aspetti anticipava quello che, dopo la vittoria elettorale del
1948 in Sudafrica dei conservatori, divenne universalmente noto come
apartheid33. Come poi nella Repubblica sudafricana, anche il sistema fascista
stabiliva l’assoluto predominio culturale, socioeconomico e politico del
conquistatore bianco, condannando la maggioranza della popolazione nera - a vivere nell’ombra, priva di diritti e relegata ai margini della società.
L’apartheid rappresenta «una forma di razzismo che si prefigge di ottenere,
tramite opportune misure legislative, la separazione più netta possibile tra
le “razze”, a mezzo della segregazione spaziale, sociale e culturale»34.
L’apartheid è espressione di una «violenza strutturale» (Johann Galtung).
Fondata su motivazioni razziali e perseguita politicamente, essa lede le chance
esistenziali delle persone di colore, respingendole al di sotto di ogni livello
che sarebbe loro potenzialmente possibile raggiungere35. Un vecchio eritreo
intravide con precisione il meccanismo dell’oppressione e della repressione,
quando nel 1993 constatava: «Allora venivamo trattati come cani, come
bestie, non come esseri umani. Ad esempio, per bere non ci davano un
bicchiere, ma un bidone o un secchio di latta, non dovevamo fare quello
che facevano i bianchi […]. Al tempo di Mussolini abbiamo fatto una vita
davvero da cani; non ci trattavano come uomini»36. Non meno chiara è la
dichiarazione di un’altra vittima della discriminazione razzista: «Ma il
fascismo non è stato un buon governo, era violento e discriminante, si
potrebbe quasi dire che era volgare nel suo atteggiamento verso i nativi
[…]. Ognuno di noi si sentiva inferiore, ovunque andasse»37.
Ben diversamente da quanto racconta la diffusa leggenda di un
«colonialismo dal volto umano», una rigida gerarchia razziale improntò da
subito la quotidianità e la società dell’Africa Orientale italiana. Naturalmente
92
L’apartheid nell’Italia fascista
gli italiani e gli altri europei erano di diritto collocati sopra ai nativi neri,
considerati «esseri inferiori». La politica razziale prescritta da Roma partiva
dal principio che anche il più rozzo analfabeta del Mezzogiorno si doveva
sentire una spanna al di sopra di ogni indigeno, anche quando appartenesse a
una famiglia aristocratica o fosse un dotto religioso o un intellettuale educato
in Occidente. Più di 12 milioni di sudditi neri erano sottomessi a un
sottoproletariato bianco che nel 1940 arrivò a contare circa 300.000 persone38.
Il sistema di apartheid instaurato dopo il 1936 non fu una invenzione
tutta fascista, ma si rifaceva a singole pratiche segregazioniste che gli italiani
avevano introdotto in Eritrea alla vigilia della prima guerra mondiale. Già nel
1908 la città di Asmara era stata suddivisa in tre zone residenziali, una delle
quali riservata esclusivamente agli europei. Nello stesso anno nell’ospedale
civile di Massaua erano stati allestiti reparti separati per pazienti bianchi e
neri. Nel 1909 la potenza coloniale istituì sistemi scolastici separati per bambini
italiani e africani, giustificati dal ministro degli Esteri, il liberale Antonio Di
San Giuliano, con le capacità intellettive presuntivamente ridotte dei bambini
africani. Nel 1916 poi un decreto proibì l’ingresso degli indigeni nel quartiere
europeo dell’Asmara, con l’unica eccezione del personale di servizio. Fino al
1930 i cinema eritrei ebbero giorni separati di proiezione per gli spettatori
bianchi e neri, un provvedimento ritenuto urgentemente necessario dal
governatore italiano per motivi di igiene e soprattutto per via dell’«odore»39.
Dopo l’annessione dell’Etiopia nel 1936, la politica razziale fascista compì
un vero e proprio balzo quantico. Per la prima volta il regime fascista si
trovò infatti a rendersi conto che molti milioni di africani vivevano sotto il
dominio italiano. Pungolato da antropologi fascisti come Lidio Cipriani,
che riteneva gli etiopi una «razza inferiore», nel 1936 il regime scoprì la
«questione della razza». Dopo la proclamazione dell’Impero, il dittatore
infarcì sempre più spesso i suoi discorsi di dichiarazioni razziste, ammettendo
pubblicamente l’esistenza di una «gerarchia fra le razze» e arrivò a parlare
della popolazione africana come di un «complesso inferiore». Per contro si
diede a rappresentare gli italiani, per i quali avrebbe contato solo il «diritto
del più forte», come una «geniale razza di conquistatori». Come per tutti i
razzisti, anche per Mussolini i rapporti tra uomini bianchi e donne nere
costituivano una spina nel fianco, perché avrebbero guastato il «prestigio
della razza». Il Duce confidò a una cerchia ristretta: «non si conquista un
impero per degenerare. Non voglio dei mezzosangue»40. Nelle file della
dirigenza fascista iniziò a metà degli anni trenta un’intensa discussione basata
su concetti fortemente ideologici quali il «prestigio della razza» e
93
Aram Mattioli
l’adeguatezza del comportamento alla razza d’appartenenza41. In essa trovò
largo spazio l’ossessione della «mescolanza delle razze», soprattutto perché i
fascisti facevano del «meticciato» il responsabile della morte di molti grandi
imperi storici42. Su questo sfondo appariva urgente una politica di «difesa
della razza italiana», un’esigenza ideologica che - trasposta nei possedimenti
d’Oltremare - portò a praticare una stretta segregazione razziale.
La politica dell’apartheid nell’Africa Occidentale italiana non fu
contrassegnata solo da una progressiva radicalizzazione, ma si esercitò in
settori sempre più ampi della vita sociale43. Nell’arco di pochi anni essa
passò dai primi provvedimenti presi all’insegna dell’improvvisazione a un
sistema concluso, che si basava su numerose leggi e decreti. Quando Benito
Mussolini venne a sapere che a Massaua un soldato italiano aveva giocato
a carte con un indigeno, diede istruzioni al vicegovernatore dell’Eritrea, il 5
maggio 1936, perché vietasse immediatamente qualunque contatto tra
bianchi e neri. Fortemente preoccupato per il «prestigio della razza» il
dittatore ordinò poco dopo che nei ristoranti i camerieri italiani non
dovessero più servire gli indigeni e che i camionisti non dovessero più
trasportare i neri44. Una prima sistematizzazione della politica di apartheid
venne data da una direttiva inviata dal ministro delle Colonie Lessona al
viceré Rodolfo Graziani il 5 agosto 1936, in cui gli si dava mandato di fare
della «separazione tra la razza bianca e quella nera» il filo conduttore della
politica italiana45. In particolare andava impedita ogni confidenza tra le
«due razze» e occorreva limitare i contatti quotidiani allo stretto necessario.
Quartieri residenziali e ritrovi dovevano essere tenuti separati e le relazioni
tra italiani e donne nere cessare. Fino a quando non fossero arrivate le
famiglie dall’Italia, potevano essere mantenuti in esercizio bordelli con
«donne di razza bianca», ordinava ancora Lessona, al fine di evitare
indesiderati contatti sessuali46. Solo un paio di settimane più tardi un
capitano dell’esercito veniva condannato a 20 giorni di fortezza e al rimpatrio
per aver permesso a una prostituta nera di entrare in un campo militare
posto sotto il suo comando47.
In seguito, non vi fu quasi nessun ambito della società che non venisse
toccato dalla politica di segregazione e discriminazione prescritta da Roma.
L’apartheid si rifletteva anche nell’immagine delle città: ad Addis Abeba,
Harrar, Jimma, Gondar e Dessiè si giunse a creare quartieri residenziali
separati per bianchi e neri. Solo nella capitale migliaia di indigeni vennero
costretti a trasferirsi in nuovi quartieri e anche il mercato, che fin dai tempi
dell’imperatore Menelik si teneva nei pressi della cattedrale di San Giorgio,
94
L’apartheid nell’Italia fascista
venne spostato nel quartiere riservato alla gente del luogo48. Poco alla volta
sorsero scuole separate, ospedali, ristoranti, bar e negozi, cinema, cimiteri e
perfino bordelli. In autobus i passeggeri neri dovevano sedersi in fondo,
perché la parte davanti era riservata ai bianchi. Gli uffici pubblici avevano
sportelli separati perché era lesivo del «prestigio di razza» che un italiano si
mettesse in fila con gli etiopici e aspettasse come tutti. Nel 1940 il viceré
Amedeo di Savoia rese noto di aver concluso un accordo con il
plenipotenziario della Santa Sede perché in futuro si tenessero messe separate
per bianchi e neri49.
Non paga di ciò, l’amministrazione coloniale discriminò la
maggioranza nera anche sotto il profilo economico. Ben presto si formò
una gerarchia professionale strutturata per razze e fondata sul principio
delle retribuzioni ineguali50. Spesso i neri non ricevevano la stessa paga
per lo stesso lavoro. Essi venivano trattati come una inesauribile riserva
di manodopera completamente priva di bisogni e ai quali si potevano
assegnare i lavori più gravosi e più ripugnanti. Naturalmente i bambini
neri non ricevevano la stessa educazione dei figli degli impiegati o dei
coloni italiani. La durata della scuola per loro si limitava a tre anni e
del resto per loro quasi non esistevano scuole secondarie. Poche nozioni
di matematica, igiene, geografia italiana e storia degli eroi fascisti erano
sufficienti, dato che per loro nella società coloniale erano previsti solo
posti di lavoro servili51.
Il sistema di apartheid venne cementato da apposite leggi razziali. La
prima legge razziale coloniale del 19 aprile 1937 stabiliva che il diffuso
fenomeno del «madamato» - vale a dire il concubinato stabile tra cittadini
italiani e donne nere (le madame) - era punibile, allo scopo di salvaguardare
così il «prestigio della razza» italiana52. L’avviare una relazione amorosa
interrazziale era da quel momento punibile con pene fino a cinque anni di
carcere. Non ci volle molto prima che venissero emanate le prime sentenze
contro uomini italiani per il nuovo reato. Il 20 maggio 1938 il tribunale di
Addis Abeba condannò a 38 mesi di detenzione un operaio che aveva avuto
con una ragazza Galla di tredici anni una relazione paramatrimoniale. Il 19
novembre dello stesso anno un tribunale di Gondar appioppò un anno di
carcere a un altro operaio che aveva convissuto per quattro mesi con una
donna nera53. Nella motivazione della sentenza del tribunale di Addis Abeba
lo scopo del divieto del «madamato» veniva descritto con parole pregnanti:
«Lo stato di superiorità fisica e morale che ogni conquistatore necessariamente possiede può essere mantenuto e conservato solo evitando ogni
95
Aram Mattioli
mescolanza familiare con le razze inferiori assoggettate»54. La mescolanza
delle razze era da evitare non solo perché ne sarebbe conseguito «il formarsi
di un popolo di meticci e quindi un popolo fisicamente inferiore», ma
soprattutto perché gli italiani non dissipassero le proprie qualità di «razza
dominante».
La disuguaglianza giuridica tra «razza dominante» e «razza inferiore»
venne accentuata dai decreti antisemiti del 17 novembre 1938, indirizzati
primariamente contro gli ebrei italiani, ma non privi di effetti anche sulla
vita coloniale. Da quel momento erano assolutamente vietati i matrimoni
tra cittadini italiani «di razza ariana» e «non ariani», quindi anche tra italiani
e donne africane. Senza peraltro citarlo espressamente, il diritto matrimoniale
italiano conobbe da allora un nuovo reato, lo «scandalo razziale». La seconda
legge coloniale sulle razze del 29 giugno 1939 puntò a una forma
istituzionalizzata di segregazione. Presentata da Mussolini e firmata da
Vittorio Emanuele III, la legge - con il titolo «Sanzioni penali per la difesa
del prestigio di razza di fronte ai nativi dell’Africa italiana» - dava un assetto
giuridico all’apartheid. La legge si fondava sul presupposto implicito che
esistessero una «gerarchia fra le razze» e una superiorità biologica dei
«bianchi» e che non si trattasse di fenomeni temporanei ma di realtà
irreversibili55. Con la legge del 1939, valida su tutto il territorio dello Stato,
il regime fascista intendeva poi difendere non solo il «prestigio della razza»
italiana, ma tutti i bianchi appartenenti alla «razza ariana». Da quel momento
potevano essere perseguiti tutti gli europei che - per esempio - frequentavano
locali riservati ai neri o avessero accettato dagli indigeni lavori lesivi del
prestigio dei bianchi. La legge riprendeva energicamente la lotta contro il
«pericolo del meticciato», rinvigorendo la proibizione del «madamato». In
realtà le condanne per questo delitto calarono di numero, anche se il
fenomeno non scomparve affatto e anzi il numero delle nascite di bambini
di razza mista crebbe ulteriormente56.
Nell’opinione pubblica italiana perdura ancor oggi la leggenda che il
colonialismo italiano fosse ben più umano di quello britannico, francese
od olandese. Questa persistente menzogna deve essere urgentemente
smentita, perché il sistema di apartheid instaurato dai fascisti nell’Africa
Orientale non ha in realtà molti precedenti storici. Solo gli stati del Sud
degli USA, l’Unione Sudafricana e la Germania nazionalsocialista
conobbero forme di segregazione razziale già prima del 1939. Nel New
South statunitense il matrimonio e il libero amore tra bianchi e persone
di colore vennero proibiti nel 1910, mentre in Sudafrica l’«Immorality
96
L’apartheid nell’Italia fascista
Act» del 1927 proibì i rapporti sessuali tra persone di appartenenza etnica
diversa: il divieto di matrimoni misti seguì nel 1949. Le Leggi di
Norimberga decretarono nel 1935 la punibilità dei matrimoni e dei
rapporti sessuali extramatrimoniali tra cittadini di sangue tedesco ed ebrei.
Ma nelle colonie tedesche in Africa le nozze tra bianchi e neri erano state
proibite ancor prima della Grande Guerra57.
Leggi che come queste mirassero alla «purezza della razza» non esistevano
nel resto dell’Africa coloniale, sebbene anche negli insediamenti d’Oltremare
britannici o francesi esistessero quartieri, locali e mezzi di trasporto separati e
anche sotto l’autorità inglese o francese fossero proibiti i contatti troppo stretti
tra bianchi e neri. Ma nessuno finiva in carcere per infrazioni a queste regole,
diversamente che nell’Africa Orientale italiana. Senza paralleli riscontri nella
legislazione coloniale di altri paesi fu anche il tentativo italiano di preservare
il «prestigio della razza» a mezzo di sanzioni legali. Il «razzismo d’apartheid»
(Wolfgang Schieder) fascista travalicò i limiti del colonialismo tradizionale58,
condannando gli indigeni dell’Africa del Nord e dell’Africa Orientale a una
vita separata e priva di dignità, che presentava molti tratti simili a quella che
dopo il 1948 condusse la maggioranza di colore del Sudafrica.
IV. L’apartheid introdotta e sperimentata in Africa spianò la strada
all’antisemitismo di Stato. In un certo modo il sistema segregazionista ripassò
dall’Oltremare alla madrepatria nel 1938, allargandosi fino a comprendere
i cittadini ebrei. Le esternazioni antisemite da parte di esponenti del regime
crebbero vistosamente dopo la conquista dell’Impero abissino. Fino a quel
momento l’Italia passava per un paese in cui l’integrazione della minoranza
ebrea nella società era molto avanzata, tanto da costituire quasi un modello.
Con l’Unità, non solo gli ebrei erano divenuti cittadini di pieno diritto, ma
anche - dopo l’abolizione nel 1870 dell’ultimo ghetto della vecchia Europa,
quello romano - erano rapidamente saliti a posizioni sociali di vertice59.
Già alla vigilia della Grande Guerra si contavano tra di essi ministri, generali,
docenti universitari, magistrati e funzionari pubblici, una volta addirittura
un primo ministro e il sindaco della stessa capitale, cosa questa che nella
coeva Germania gugliemina era impensabile60.
La presa del potere dei fascisti non comportò inizialmente un sensibile
peggioramento delle condizioni di vita degli ebrei italiani. Come centinaia
di migliaia di loro concittadini, anche fra gli ebrei italiani ve ne furono
alcune centinaia che entrarono nel partito unico dello Stato fascista e altri
97
Aram Mattioli
continuarono a occupare posizioni di spicco nella società e nella cultura.
Ancora tra il 1932 e il 1935 un ebreo - il ministro delle Finanze Guido
Jung - era membro del Gabinetto. Alla raccolta delle fedi nuziali, con cui il
governo invitò soprattutto le donne coniugate a versare i loro anelli per
sostenere le spese della conquista dell’Etiopia, parteciparono anche le
comunità ebraiche che non volevano rimanere indietro nel generale
entusiasmo per la guerra61. Nel primo decennio del suo potere, il Duce si
espresse varie volte contro l’antisemitismo, che sarebbe stato estraneo al
fascismo62. D’altra parte Mussolini ebbe una annosa relazione con la critica
d’arte ebrea Margherita Sarfatti63. Con l’arrivo al potere dei nazionalsocialisti,
l’Italia divenne un rifugio per gli ebrei in fuga, tanto che entro il 1939 il
loro numero arrivò a 18.00064. Tutto ciò non deve però portare a false
conclusioni: mirando a una stretta alleanza con la chiesa65 il Duce infatti
vietò alla prediletta figlia Edda il matrimonio con un ufficiale ebreo, che
riteneva inopportuno in un’Italia intrisa di cattolicesimo66. E naturalmente
non intervenne nemmeno contro giornali violentemente antisemiti o libri
di fascisti radicali come Roberto Farinacci, Giovanni Preziosi, Telesio
Interlandi e Paolo Orano.
All’apice della sua potenza il fascismo avviò un lento cambiamento di corso
verso gli ebrei italiani. Prendendo a pretesto la scoperta effettuata nel 1934 a
Torino dagli organi di sicurezza un circolo antifascista, cui appartenevano
numerosi ebrei, tra cui lo scrittore Leone Ginzburg e il pittore Carlo Levi, il
regime scatenò una campagna di stampa antisemita67. Sempre più spesso il
Duce e i suoi scherani addossavano all’«internazionale giudaica» la responsabilità
di tutto quello che andava storto in Italia e nel mondo. Nel febbraio 1936
diede istruzione che dal quel momento venisse rifiutata la cittadinanza italiana
agli ebrei di recente immigrazione. In questa direttiva traspariva il desiderio di
non lasciar crescere ulteriormente il numero dei cittadini ebrei. A partire dal
1936 venne attuata una seconda campagna di stampa antisemita, che doveva
preparare gli italiani alle imminenti leggi razziali. Contemporaneamente
scomparve dalla pubblicistica la distinzione tra ebrei fascisti e antifascisti, che
da allora vennero in blocco definiti «nemici dello Stato».
Questo cambiamento di rotta venne determinato da motivazioni sia di
politica interna che estera. A giustificare i nuovi provvedimenti sembrò
bastare che gli ebrei italiani fossero mediamente più tiepidi verso il regime
dei loro concittadini di fede cattolica68. Con l’esclusione degli ebrei dalla
comunità nazionale il Duce sperava di portare avanti la formazione del
«nuovo uomo fascista» e di riuscire a iniettare negli italiani una «coscienza
98
L’apartheid nell’Italia fascista
ariana». Credeva che una dinamica antisemita avrebbe spinto l’Italia un bel
tratto avanti sulla strada del totalitarismo. Inoltre il prestigio dell’Italia
nell’Europa dei dittatori non sarebbe più stato compromesso dalla tolleranza
di «comportamenti indegni per la razza». Nel segno di un «asse RomaBerlino» sempre più stretto, le leggi razziali vennero concepite anche come
un «gesto d’amicizia»69 spontaneo e assolutamente autonomo verso la
Germania nazionalsocialista.
Il 4 luglio 1938 comparve sul «Giornale d’Italia», con il titolo Il fascismo
e i problemi della razza, il Manifesto degli scienziati razzisti. Redatto nelle
sue parti essenziali sotto istruzioni del Duce dall’antropologo Guido Landra,
il manifesto conteneva una dichiarazione pseudoscientifica sull’esistenza
delle razze umane e sulla necessità di una politica razzista. Si partiva
dall’astrusa asserzione che esisteva una «pura razza italiana» di origine ariana
e che gli ebrei costituivano una razza a parte, non europea, che non si era
mai assimilata in Italia. «Gli ebrei non appartengono alla razza italiana»,
così suonava la frase chiave70. Nel Manifesto si annunciava un razzismo
biologicamente definito. In seguito questo testo raffazzonato ma firmato
da illustri accademici come Lidio Cipriani, Nicola Pende e Arturo Donaggio
assurse al ruolo di documento fondante dell’antisemitismo di Stato fascista.
A partire dalla sua pubblicazione la pressione sui circa 47.000 ebrei italiani
crebbe vistosamente. La persecuzione veniva spacciata per «indispensabile
tutela della razza italiana». Il 22 agosto 1938 il regime fece eseguire il
«censimento speciale nazionale degli ebrei» e poco dopo il Duce emanò
un’intera serie di leggi discriminatorie, sempre controfirmate dal re Vittorio
Emanuele III. Con il decreto del 5 settembre 1938 agli insegnanti ebrei
non era più consentito lavorare nelle strutture pubbliche e
contemporaneamente scolari e studenti «di razza giudea» venivano esclusi
da scuole e università71. Due giorni più tardi veniva disposta l’espulsione
della maggior parte degli ebrei stranieri entrati in Italia dopo il 1° giugno
1919. Profughi e immigrati dovevano lasciare il paese entro il termine ultimo
del 12 marzo 1939. Non solo veniva loro ritirata la cittadinanza, quando
posseduta72, ma da quel momento in poi l’Italia cessava di essere un rifugio
per nuovi profughi ebrei.
Con i «Provvedimenti per la difesa della razza italiana» licenziati il 17
novembre 193873 gli ebrei italiani non solo persero la parità di diritti ma
subirono restrizioni che ben presto si estesero a tutti gli ambiti della loro
esistenza74. In concreto, i provvedimenti proibivano le nozze tra «cittadini
italiani di razza ariana con persone di altra razza». Inoltre gli ebrei italiani
99
Aram Mattioli
non potevano più possedere terreni e immobili di valore superiore
rispettivamente a 5.000 e 20.000 lire e nemmeno impiegare nelle loro
aziende più di 100 persone. Erano esclusi dal servizio militare e non era
loro permesso tenere personale di servizio di «razza ariana». Non era loro
consentita nessuna attività nell’amministrazione militare e civile, nel partito
e nelle organizzazioni periferiche fasciste come pure nelle amministrazioni
provinciali e comunali e nelle banche e compagnie private di assicurazioni.
Nei mesi seguenti il regime di discriminazione si allargò a un numero
sempre maggiore di ambiti: gli ebrei vennero espulsi da associazioni culturali
e sportive. Non potevano più essere attivi come artisti. Ben presto non fu
più permesso loro di affittare stanze ad «ariani» o lavorare con «italiani
ariani». Il loro nome venne cancellato dagli elenchi telefonici, fu loro vietato
di entrare nelle biblioteche pubbliche, di pubblicare annunci mortuari e di
adire un’eredità75. Poco a poco i divieti di esercitare professioni e mestieri
vennero a comprendere nuovi campi. Inizialmente avevano perso il posto
gli impiegati dello Stato, delle banche e delle compagnie assicurative, ma a
partire dall’agosto 1939 anche notai, revisori dei conti e giornalisti non
poterono più esercitare. Infine vennero interdetti anche librai, fotografi,
guide turistiche e maestri di ballo. Dal 1o marzo 1940 medici, farmacisti,
veterinari, avvocati, ingegneri, chimici e agronomi ebrei poterono effettuare
prestazioni solo per persone di «razza ebrea»76.
Passo dopo passo l’antisemitismo di Stato sottrasse alle sue vittime tutti
i mezzi di sussistenza. Le famiglie benestanti e gli scienziati di punta - come
il fisico Enrico Fermi - lasciarono il paese e tentarono di rifarsi una vita in
America, mentre quelli rimasti dovettero fare i conti con una violazione dei
loro diritti sempre più sistematica. I Provvedimenti per la difesa della razza
italiana si rivelarono in breve tempo catastrofici per chi ne era oggetto. Nel
maggio 1939 lo storico dell’arte Paolo D’Ancona, che aveva perso la sua
cattedra, commentò la sua nuova situazione esistenziale con queste parole:
«Di colpo mi venne impedita ogni attività, come cittadino e come studioso:
espulso dall’esercito, cacciato dall’insegnamento universitario e - con
l’interdetto ai miei libri di testo - anche da quello scolastico, assisto alla
distruzione di tutto quello che finora ha costituito lo scopo della mia vita»77.
Con l’inizio della seconda guerra mondiale la politica antisemita si inasprì
ulteriormente. Lentamente l’Italia fascista assunse i connotati di uno «Stato
ariano e basato sulla razza»78. Il Duce non faceva mistero della sua intenzione
di sbarazzarsi di tutti gli ebrei costringendoli all’emigrazione. Il 9 febbraio
1940 comunicò ufficialmente all’Unione delle Comunità israelitiche italiane
100
L’apartheid nell’Italia fascista
che entro pochi anni tutti gli ebrei avrebbero dovuto lasciare il paese. Dopo
l’ingresso dell’Italia in guerra, gli ebrei stranieri, cui era stato ritirato il permesso
di soggiorno, vennero internati nel campo di Ferramonti di Tarsia79. Lo stesso
destino toccò a tutti gli ebrei italiani classificati come «pericolosi». Ora gli
ebrei non potevano più trattenersi nei centri turistici e sulle spiagge80. Nel
1941-42 si ebbero i primi attentati contro sinagoghe, che vennero devastate
come quelle di Ferrara, Trieste e Split. L’11 maggio 1942 il regime introdusse
il lavoro obbligatorio per i maschi ebrei, che dovettero effettuare lavori pesanti
su argini e fiumi e anche in cantieri stradali. Le leggi razziali ebbero l’effetto
di una nuova ghettizzazione. Quanto alla loro collocazione nel contesto
internazionale, lo storico fiorentino Enzo Collotti è recentemente giunto alla
conclusione che «la legislazione italiana fu - dopo quella tedesca - la legislazione
antisemita più dura in tutto il mondo»81.
Comunque l’antisemitismo attuato dallo Stato italiano non mirava
all’eliminazione fisica degli ebrei prima dell’estate 194382. L’idea più radicale
di Mussolini era quella di fare dell’Italia uno Stato basato sulla razza e
«purificato dagli ebrei» in un arco di tempo limitato e a mezzo della loro
espulsione83. Questo atteggiamento rappresenta la differenza centrale con
l’annientamento di massa dell’ebraismo europeo pianificato e sistematicamente eseguito da Hitler84. Questa differenza non può però essere
ancora a lungo invocata come motivazione per continuare a vedere sotto
una luce troppo mite l’antisemitismo dell’Italia fascista, che fu sì meno
letale, ma comunque ripugnante, quando lo si misuri con i criteri della
democrazia. E in realtà per le sue vittime fu crudele a sufficienza. In alcuni
casi, come la proibizione generale di frequentare le scuole pubbliche,
l’espulsione degli ebrei stranieri e le limitazioni alla proprietà di aziende e
immobili, le leggi razziali del 1938 volute da Mussolini anticiparono
addirittura quelle del Terzo Reich85.
Le ultime ricerche hanno mostrato che le autorità della Repubblica sociale
italiana prestarono un’efficace collaborazione alla «soluzione finale della
questione ebraica» perseguita dai tedeschi e a partire dall’autunno 1943
mandarono a morte circa 9.500 ebrei86. Il regime collaborazionista di
Mussolini stigmatizzò espressamente gli ebrei come appartenenti a
«nazionalità nemica» e si definì antisemita per principio. Il ministro degli
Interni Guido Buffarini Guidi dispose di confiscare i beni appartenenti ad
ebrei e di inviare tutti gli ebrei nei campi di concentramento. Ben a
conoscenza di quel che aspettava le vittime nelle fabbriche della morte in
Polonia, le forze di polizia della Repubblica sociale italiana rinchiusero
101
Aram Mattioli
migliaia di ebrei nei campi di transito di Fossoli e Bolzano e nella Risiera di
San Saba, prima di consegnare quegli sventurati agli occupanti tedeschi. La
macchina della deportazione nell’Italia occupata si dimostrò estremamente
efficiente fino alle ultime settimane della guerra. Sebbene i fascisti italiani
non abbiano né progettato né eseguito l’eccidio di massa degli ebrei
d’Europa, contribuirono decisamente all’estensione della politica di
sterminio della potenza occupante anche a sud delle Alpi.
V. Già molto prima dell’occupazione tedesca l’Italia fascista si era
autonomamente evoluta in uno Stato segregazionista, che praticava una
pesante discriminazione verso i suoi sudditi slavi, africani ed ebrei,
costringendoli a vivere appartati e in condizioni indecorose. L’Italia fascista
non si limitò a praticare un’occasionale politica con tratti antislavi, antisemiti
e anticamiti, ma dal 1938 corrispose pienamente a quello che George M.
Fredrikson ha recentemente definito come «regime apertamente razzista».
L’Italia aveva un’ideologia scopertamente razzista, ebbe leggi che derivavano
dall’ideale della «purezza della razza» e proibivano i matrimoni misti.
Discriminazione e segregazione si fondarono su atti legislativi. Il regime
sbarrò l’ingresso alla cariche pubbliche agli appartenenti alle razze
indesiderate e inoltre li mantenne o li costrinse in miseria87.
Certo non fu pari al Terzo Reich, ma - sullo stesso piano della
Repubblica Sudafricana e degli stati federali del Sud degli Stati Uniti l’Italia di Mussolini fece parte a pieno titolo degli stati più improntati al
razzismo nel mondo del XX secolo. Gli storici che allora come adesso lo
negano, minimizzano il fascismo italiano e irridono le centinaia di migliaia
di vittime che pagarono per la smania espansionistica e il furore razzista
dell’Italia tra il 1922 e il 1943.
Traduzione di Massimo Tirotti
Note al testo
1
Cfr. JONATHAN STEINBERG, Deutsche, Italiener und Juden. Der italienische Widerstand gegen
den Holocaust, Göttingen 1992; DANIEL CARPI, Between Mussolini and Hitler. The Jews and the
Italian Authorities in France and Tunesia, Hanover (New Hampshire) 1994. In se stessa questa
considerazione non è falsa, ma diventa scientificamente insostenibile quando queste azioni di
salvataggio vengono spiegate con motivi puramente umanitari, acriticamente generalizzate e
102
L’apartheid nell’Italia fascista
interpretate come un tipico comportamento italiano. Il generale Mario Roatta per esempio,
che nell’area del suo comando in Dalmazia sottrasse gli ebrei alla deportazione nelle fabbriche
della morte, agì contemporaneamente con durezza indescrivibile contro i «partigiani» jugoslavi.
Vedi in proposito le importanti riflessioni di Enzo Collotti in Zur Neubewertung des Italienischen
Faschismus, Enzo Collotti im Gespräch mit Lutz Klinkhammer, in «Geschichte und Gesellschaft»,
26 (2000), pp. 285-306.
2
Cfr come esempio di questa problematica forma di memoria NICOLA CARACCIOLO, Gli ebrei
e l’Italia durante la guerra 1940-1945, Roma 1986.
3
HANNAH ARENDT, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen, Monaco
i.B. 19652, p. 220 (Trad. it. La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Milano 20048,
p.186). Analoghe argomentazioni anche in J. STEINBERG, Deutsche, Italiener und Juden cit., pp.
21, 286, 292 s. e 307.
4
Ibidem.
5
Di più in DAVID BIDUSSA, Il mito del bravo italiano, Milano 1994; CARLO MOOS, Die ‘guten
Italiener’ und die Zeitgeschichte in «Historische Zeitschrift», 259 (1994), pp. 671-694; JAMES
WALSTON, History and Memory of the Italian Concentration Camps, in «The Historical Journal»,
40, 1 (1997), pp. 169-183.
6
Cfr. EMILIO GENTILE, Renzo De Felice. Lo storico e il personaggio, Roma-Bari 2003. Illuminanti
sulle opere tarde di De Felice sono le riflessioni di BRUNELLO MANTELLI, Faschismus, Geschichte
Italiens, Selbstverständnis der Republik. Kritische Anmerkungen zur jüngsten Debatte über die
Beziehung von Geschichte und Gegenwart, in Faschismus und Faschismen im Vergleich. Wolfgang
Schieder zum 60. Geburtstag, a cura di Christoph Dipper et al. Köln 1998, pp. 79-104.
7
RENZO DE FELICE, Der Faschismus. Ein Interview mit Michael Ledeen. Mit einem Nachwort
von Jens Petersen, Stuttgart 1977, p. 30. Cfr. in merito WOLFGANG SCHIEDER, Faschismus als
Vergangenheit. Streit der Historiker in Italien und Deutschland, in Der historische Ort des
Nationalsozialismus. Annäherungen, a cura di Walter H. Pehle, Frankfurt am Main 1990,
p.139 ss.; JENS PETERSEN, Der Faschismus im Urteil der Historiker, in Faschismus und Faschismen
cit. p. 50 ss.
8
RENZO DE FELICE, Mussolini il duce. Lo stato totalitario 1936-1940, Torino 1981, p. 312.
9
RENZO DE FELICE, Intervista di Giuliano Ferrara a Renzo De Felice in Il fascismo e gli storici
oggi, a cura di Jader Jacobelli, Roma-Bari 1988, p. 6. L’ intervista apparve originariamente nel
«Corriere della Sera» del 27 dicembre 1987.
10
RENZO DE FELICE, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 1993. Introduzione alla
nuova edizione tascabile, p. IX.
11
Cfr per es. La menzogna della razza, Documenti e immagini del razzismo e dell’antisemitismo
fascista, Centro Furio Jesi, Bologna 1994; Nel nome della razza, Il razzismo nella storia d’Italia
1870-1945, a cura di Alberto Burgio, Bologna 1999; ENZO COLLOTTI, Il razzismo negato, in
Fascismo e antifascismo. Rimozioni, revisioni, negazioni, a sua cura, Roma-Bari 2000, pp.355-
103
Aram Mattioli
375; NICOLA LABANCA, Storia dell’ espansione coloniale italiana, Bologna 2002; ARAM MATTIOLI,
Experimentierfeld der Gewalt. Der Abessinienkrieg und seine internationale Bedeutung 19351941, Zurigo 2005 (in corso di stampa).
12
Cfr B RUNELLO M ANTELLI , Die Italiener auf dem Balkan 1941-1943 in Europäische
Sozialgeschichte. Festschrift für Wolfgang Schieder, a cura di Christoph Dipper et al., Berlin
2000, pp. 57-74; ANGELO DEL BOCA, Colonialismo, in Dizionario storico dell’Italia Unita, a
cura di Bruno Bongiovanni e Nicola Tranfaglia, Roma-Bari 1996, pp. 157-173; GIULIA BROGINI
KÜNZI, Total Colonial Warfare: Ethiopia, in The Shadows of Total War, Europe, East Asia and the
United States, 1919.1939, a cura di Roger Chickering e Stig Förster, Cambridge, New York
2003, pp. 316-326; ARAM MATTIOLI, Entgrenzte Kriegsgewalt. Der italienische Giftgaseinsatzin
Abessinien 1935-1936, in «Viertelsjahrhefte für Zeitgeschichte», 51 (2003), pp. 311-337; ID.,
Die vergessenen Kolonialverbrechen des faschistischen Italien in Libyen 1923-1933, in Völkermord
und Kriegsverbrechen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Fritz Bauer Institut, Frankfurt a.
M., New York 2004, pp. 203-226.
13
RENZO DE FELICE, Mussolini il duce. Lo stato totalitario 1936-40 cit., p.314.
14
IMMANUEL GEISS, Geschichte des Rassismus, Frankfurt a.M. 1988, p. 25 s.
15
GEORG M. FREDRICKSON, Rassismus. Ein historischer Abriss, Hamburg 2004, p. 173.
16
KARIN PRIESTER, Rassismus. Eine Socialgeschichte, Leipzig 2003, pp. 8 e 11.
17
ENZO COLLOTTI, Sul razzismo antislavo in Nel nome della razza cit., p. 35.
18
Ivi, p. 39 s.
19
Ivi, p. 44.
20
PIERRE MILZA, Mussolini, Parigi 1999, p. 246 ss.
21
BENITO MUSSOLINI, Discorso di Pola in LUIGI SALVATORELLI, GIOVANNI MIRA, Storia d’Italia
nel periodo fascista, Torino 1964, p. 161.
22
WOLFGANG WIPPERMANN, War der italienische Faschismus rassistisch? Anmerkungen zur Kritik
an der Verwendung eines allgemeinen Faschismusbegriffes, in Faschismus und Rassismus.
Kontroveresen um Ideologie und Opfer, a cura di Werner Röhr, Berlin 1992, p. 117
23
LUIGI SALVATORELLI, GIOVANNI MIRA, Storia d’Italia nel periodo fascista cit., p.191; PIERRE
MILZA, SERGE BERSTEIN, Le fascisme italien 1919-1945, Parigi 1980, p. 99.
24
JAN MORRIS, Trieste o del nessun luogo, Milano 2003, p. 12 s.
25
Cfr LAVO C ERMELJ, Sloveni e Croati in Italia tra le due guerre, Trieste 1974; A LBERTO
BUVOLI, Il fascismo nella Venezia Giulia e la persecuzione antislava, in «Storia contemporanea
in Friuli», 26 (1996), pp. 69-87; ENZO COLLOTTI, Sul razzismo antislavo, in Nel nome della
razza, p. 52 ss.
104
L’apartheid nell’Italia fascista
26
ELIO APIH, Trieste, Roma-Bari 1988, p. 129.
27
PAOLO G. PAROVEL, L’ identità cancellata. L’ italianizzazione forzata dei cognomi, nomi e
toponimi nella Venezia Giulia dal 1919 al 1945, con gli elenchi delle province di Trieste, Gorizia,
Istria ed i dati dei primi 5.300 decreti, Trieste 1985. Così, per es., i cognomi Franceskin e
Petrovich vennero cambiati in Franceschini e Demetrio.
28
ALBERTO BUVOLI, Il fascismo nella Venezia Giulia cit., p. 77.
29
ELIO APIH, Trieste cit., p. 134.
30
PIERRE-ANDRÉ MAGUIEFF, Die Macht des Vorurteils. Der Rassismus und sein Double, Hamburg
2000, p. 157.
31
ALBERTO BUVOLI, Il fascismo nella Venezia Giulia cit., pp. 72 e 77.
32
DENIS MACK SMITH, Mussolini’s Roman Empire, Londra-New York 1976, p.123.
33
ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, vol. 3: La caduta dell’Impero, Roma-Bari
1982, p. 237.
34
GABRIELE SCHNEIDER, Mussolini in Afrika. Die faschistische Rassenpolitik in den italienischen
Kolonien 1936-1941, Köln 2000, p. 32
35
JOHAN GALTUNG, Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung, Reinbek
bei Hamburg 1982, p. 9 ss.
36
H.Y., nato in Eritrea nel 1909. Testimonianza registrata ad Addi Ugri, giugno 1993, in IRMA
TADDIA, Autobiografie africane. Il colonialismo nelle memorie orali, Milano 1996, p. 100.
37
S.A., nato in Eritrea nel 1918. Testimonianza registrata ad Asmara, giugno 1993, ivi, p. 90.
38
Cfr. per la stratificazione sociale dell’Africa Orientale italiana: FABIENNE LE HOUÉROU, L’épopée
des soldats de Mussolini en Abyssinie 1936-1938. Les «Ensablés», Parigi 1994, pp. 115-135.
39
GABRIELE SCHNEIDER, Mussolini in Afrika cit., p. 132 ss.
40
VITTORIO GORRESIO, La vita ingenua, Milano 1980, p. 111.
41
GABRIELE SCHNEIDER, Mussolini in Afrika cit., p.149 ss.
42
Cfr. LIDIO CIPRIANI, L’antropologia in difesa dell’impero, in «Corriere della Sera», 16 giugno
1936, riprodotto in GIORGIO ROCHAT, Il colonialismo italiano, Torino 1996, pp. 193-195.
43
GABRIELE SCHNEIDER, Mussolini in Afrika cit., pp. 157 e 162.
44
Ivi, p. 158.
105
Aram Mattioli
45
ALESSANDRO LESSONA, Le direttive del governo fascista per l’organizzazione dell’ impero, 5 agosto
1936, riprodotto in GIORGIO ROCHAT, Il colonialismo italiano cit., p. 189.
46
GABRIELE SCHNEIDER, Mussolini in Afrika cit., p. 205.
47
Ivi, p. 206.
48
RICHARD PANKHURST, The Ethiopian. A History, Oxford 2001, p. 240.
49
GABRIELE SCHNEIDER, Mussolini in Afrika cit., p. 205.
50
Ivi, p. 220.
51
Ivi, p. 231 s.
52
Cfr BARBARA SORGONI, Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali
interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1941), Napoli 1998, pp. 127-138.
53
ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, vol. 3: La caduta dell’Impero cit., p. 247.
54
«Rivista penale», ottobre 1938, cit. in GABRIELE SCHNEIDER, Mussolini in Afrika cit., p. 210.
55
GABRIELE SCHNEIDER, Mussolini in Afrika cit., p. 177.
56
ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, vol. 3: La caduta dell’Impero cit., p. 250.
57
GEORG M. FREDRICKSON, Rassismus cit., pp. 104 e 115.
58
WOLFGANG SCHIEDER, Faschismus als Vergangenheit. Streit der Historiker in Italien und
Deutschland, in Der Historische Ort des Nationalsozialismus, a cura di Walter H. Pehle, Frankfurt
a. M. 1990, p. 153: ID., Kriegsregime des 20. Jahrhunderts. Deutschland, Italien und Japan im
Vergleich, in Erinnerungskulturen, Deutschland, Japan und Italien seit 1945, a cura di Christoph
Cornelissen et al., Frankfurt a. M. 2003, p. 38: «Il fascismo italiano è comunque rimasto
fermo al razzismo d’apartheid; un razzismo d’annientamento come quello praticato dal
nazionalsocialismo, non si verificò in Italia».
59
Cfr. ARAM MATTIOLI, Das Letzte Ghetto alteuropas. Die Segregationspolitik der Papstkönige in
der «heiligen Stadt» bis 1870, in Katholischer Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Ursachen und
Tradition im internationalem Vergleich, a cura di Olaf Blaschke e Aram Mattioli, Zürich 2000,
pp. 111-143.
60
MICHELE SARFATTI, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Torino 2000,
p.12 s.; CARLO MOOS, Ausegrenzung, Internierung, Deportation. Antisemitismus und Gewalt im
späten italienischen Fascismus (1938-1945), Zürich 2004, p. 11 s. Uno studio su un caso
particolare è quello di ALBERTO ROVIGHI, I militari di origine ebraica nel primo secolo di vita
dello stato italiano, Roma 1999.
106
L’apartheid nell’Italia fascista
61
PETRA TERHOEVEN, Liebespfand fürs Vaterland. Krieg, Geschlecht und faschistische Nation in
der italienischen Gold- und Eheringsammlung 1935/36, Tübingen 2003, p. 170 s.
62
GABRIELE SCHNEIDER, Mussolini in Afrika cit., p. 65.
63
KARIN WIELAND, Die Geliebte des Duce. Das Leben der Margherita Sarfatti und die Erfindung
des Faschismus, München-Wien 2004.
64
KLAUS VOIGT, Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945, vol. 1, Stuttgart 1989, p. 466.
65
Cfr per le relazioni tra il regime fascista e la chiesa: ARAM MATTIOLI, E salva l’Italia nel Duce.
Die Katholische Kirche im faschistischen Italien 1922-1938, in Katholismus in Geschichte und
Gegenwart, a cura di Richard Faber, Berlin 2005 (in corso di stampa).
66
MEIR MICHAELIS, On the Jewish Question in Fascist Italy. The Attitude of the Fascist Regime to
the Jews in Italy, in «Yad Vashem Studies», 4 (1960), p. 11.
67
Cfr ENZO COLLOTTI, Il fascismo e gli ebrei, Roma-Bari 2003, pp. 40-57.
68
MICHELE SARFATTI, Gli ebrei nell’Italia fascista cit., p. 24: «In estrema sintesi si può osservare
che gli ebrei italiani erano fascisti come gli altri italiani, più antifascisti degli altri italiani».
69
RENZO DE FELICE, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 1993. Introduzione
cit., p. X.
70
Manifesto degli scienziati razzisti, 14 luglio 1938, riprodotto in RENZO DE FELICE, Storia
degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 1988, p. 55 ss.
71
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista, 5 settembre 1938, riprodotto in
ENZO COLLOTTI, Il fascismo e gli ebrei cit., p. 190 s.
72
KLAUS VOIGT, Zuflucht auf Widerruf cit., p. 280 ss.
73
Provvedimenti per la difesa della razza italiana, 17 novembre 1938, riprodotto in ENZO
COLLOTTI, Il fascismo e gli ebrei cit., pp. 193-197.
74
L’importanza dei provvedimenti antisemiti viene presentata e analizzata in modo davvero
pregnante da MICHELE SARFATTI, Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi, Torino 2002.
Cfr. anche i romanzi di Giorgio Bassani e Rosetta Loy.
75
Ivi, p. 28.
76
Ivi, p. 31 s.
77
PAOLO D’ANCONA. Note personali, 1939 (inedito), citato da MICHELE SARFATTI, Grundzüge
und Ziele der Judengesetzgebung im faschistischen Italien 1938-1943, in «Quellen und
Forschungen aus italienischen Archiven und Biblioteken», 83 (2003), p. 440.
107
Aram Mattioli
78
MICHELE SARFATTI, Le leggi antiebraiche cit., p. 26
79
Cfr. su Ferramonti di Tarsia KLAUS VOIGT, Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945,
vol. 2, Stuttgart 1993, pp. 162-174.
80
Cfr. CINZIA VILLANI, Zwischen Rassengesetzen und Deportation. Juden in Südtirol, in Trentino
und in der Provinz Belluno 1933-1945, Innsbruck 2003, p. 140 ss.
81
Zur Neubewertung des italienischen Faschismus. Enzo Collotti im Gespräch mit Lütz
Klinkhammer, in «Geschichte und Gessellschaft», 26 (2000), p. 295.
82
WOLFGANG SCHIEDER, Fascismus als Vergangenheit. Streit der Historiker in Italien und
Deutschland, in Der Historische Ort des Nationalsozialismus, cit.. p. 153; MICHELE SARFATTI,
Grundzüge und Ziele der Judengesetzgebung cit., p. 442: «Va sottolineato che in questa fase il
fascismo mirava all’eliminazione degli ebrei dal paese, non all’eliminazione degli ebrei del
paese».
83
KLAUS VOIGT, Zuflucht auf Widerruf cit., p. 482.
84
Prima dell’estate 1943 l’Italia fascista attuò comunque nei Balcani e in Africa una politica
repressiva molto simile a un genocidio. Cfr. n. 11 e n. 12.
85
MICHELE SARFATTI, Grundzüge und Ziele der Judengesetzgebung cit., p. 439 s.
86
Cfr. ad es. LUTZ KLINKHAMMER, Zwischen Bündnis und Besatzung. Das nationalsozialistiche
Duetschland und die Republik von Salò 1943-1945, Tübingen 1993, pp. 530-553; MICHELE
SARFATTI, Gli ebrei nell’Italia fascista cit., pp. 231-238; CINZIA VILLANI, Zwischen Rassengesetzen
und Deportation cit., pp. 146-178; CARLO MOOS, Ausegrenzung, Internierung, Deportation cit.,
pp. 90-101.
87
GEORG M. FREDRICKSON, Rassismus cit., p. 103.
108
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo.
Tra organizzazione del consenso, disciplinamento del tempo
libero e «prestigio di razza»
di Gianluca Gabrielli
Negli anni tra le due guerre lo sport in Europa e negli Stati Uniti incontra
uno sviluppo senza precedenti. Grazie alla crescita del tempo libero tra le
classi popolari tanto la pratica diretta dell’attività sportiva che l’attenzione
di spettatori e appassionati crescono in maniera esponenziale e divengono
fenomeno di massa. Le grandi manifestazioni internazionali come Olimpiadi
e mondiali di calcio e di ciclismo si affermano definitivamente polarizzando
l’attenzione di ampi settori della popolazione attraverso i giornali sportivi e
le trasmissioni radio. Anche in Italia la nascita nel 1927 del secondo
quotidiano sportivo, il «Corriere della Sport» e di numerosi periodici attesta
chiaramente la crescita di un movimento che lievita anche come numero di
praticanti. Dell’importanza del fenomeno sono consapevoli le gerarchie
fasciste che intervengono massicciamente sia sugli aspetti organizzativi e
infrastrutturali, sia su quelli ideologici del fenomeno. La creazione delle
organizzazioni giovanili, deputate ad esaltare gli aspetti paramilitari della
pratica sportiva, e dell’Opera Nazionale Dopolavoro, indirizzata ad
intervenire sul disciplinamento del tempo libero, costituiscono gli interventi
più importanti nel tentativo di utilizzare a fini politici questa nuova
dimensione di massa della quotidianità.
La crescente affermazione del fenomeno non rimane confinata negli
Stati Uniti e in Europa ma, seppure in forme particolari e con ritardi, giunge
nei territori soggetti a dominio coloniale. I colonizzatori infatti portavano
nel loro «bagaglio» anche le abitudini e le passioni maturate nei territori
d’origine e vi rimanevano legati proprio in quanto esse funzionavano da
contrappeso alla lontananza e ai differenti modelli di vita che la colonia
imponeva. Le gerarchie coloniali delle diverse potenze scelsero
progressivamente di intervenire nel governo del movimento sportivo che si
era andato formando e lo fecero in vari modi, potenziando e facilitando le
attività dei colonizzatori ma anche introducendo l’attività fisica e sportiva
tra le popolazioni colonizzate, sia come mera preparazione fisico-militare
109
Gianluca Gabrielli
delle truppe locali, sia anche favorendo, osteggiando o semplicemente
controllando e indirizzando secondo i propri fini l’attività sportiva tra i
sudditi.
La storia sportiva nelle colonie italiane coincide a grandi linee con il
periodo fascista; troppo trascurabili infatti sembrano i precedenti
riscontrabili nei poco popolati possedimenti dell’età liberale. Si può affermare
che fino agli anni dieci del secolo le attività fisiche e sportive nelle colonie
italiane, quando esistono, devono essere considerate come attività saltuarie
facenti parte della fase di «standardizzazione e universalizzazione delle
regole»1. Dagli anni venti il discorso cambia radicalmente: lo sport entra a
far parte stabilmente dell’identità dell’italiano che si reca in Colonia e
comincia ad esercitare un’attrattiva sulle sparute comunità nazionali del
Corno d’Africa e di Libia; la pratica si diffonde dapprima per effetto
dell’organizzazione autonoma dei coloni in società sportive e in seguito,
già dalla fine del decennio, riceve una strutturazione più stabile con le
direttive di regime per centralizzarne l’organizzazione negli Enti Sportivi
Coloniali. Nel decennio successivo, con significative anticipazioni e
differenze tra la Libia e il Corno d’Africa, le gerarchie coloniali organizzano
alcune attività anche tra le comunità indigene, oltre quelli che allora venivano
definiti «confini di razza», come forma di preparazione fisico-militare, di
disciplinamento del tempo libero e di «educazione» ai costumi nazionali.
In particolare, nel tentare di ricostruire la diffusione e le forme della
pratica sportiva ho scelto di porre attenzione soprattutto alla diversa
funzione che veniva ad assumere per italiani e popolazioni locali. Ho
deciso dunque di privilegiare il nodo del razzismo: uno dei principi che,
variamente declinati, sono comunque alla base della strutturazione di ogni
società coloniale e a fondamento del sentimento di superiorità degli
occupanti. La storia del razzismo coloniale italiano ha visto il massimo
livello di codificazioni regolamentari e legislative negli anni che vanno
dal 1936 fino alla perdita delle colonie durante la seconda guerra mondiale:
il periodo dell’impero mussoliniano2. Ma è evidente che questo razzismo
«di Stato» non nasceva dal nulla, bensì affondava le sue radici in un
razzismo diffuso e quotidiano che impregnava le forme e i modi dei
rapporti sociali tra coloni e colonizzati. È convinzione di chi scrive che
indagando tra le pieghe dei fenomeni sociali quotidiani, di cui entra a far
parte lo sport in questo periodo, potremo affinare la nostra comprensione
del ruolo avuto dal razzismo nella riproduzione del dominio e nella
strutturazione delle identità degli attori in campo.
110
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo
La ricerca sulla «esportazione» dello sport nei territori coloniali ha da
tempo compiuto i primi passi in altre nazioni con un importante passato
coloniale ed ha stimolato la riflessione di studiosi dei paesi un tempo
sottomessi al dominio3. Nel panorama nazionale invece non esiste alcun
lavoro pubblicato da cui partire e su cui fare affidamento per circoscrivere
la vastità dell’oggetto di ricerca. Per necessità quindi ho potuto solo sfiorare
alcuni aspetti che avrebbero invece meritato seri approfondimenti (come,
ad esempio, la pratica fisico-sportiva delle truppe bianche e africane),
rimandandone la trattazione approfondita ad altri studiosi o a fasi future
della ricerca.
Le fonti utilizzate sono costituite in gran parte dai giornali coloniali
che, da metà degli anni venti a Tripoli e dagli anni trenta nel Corno d’Africa
dedicarono uno spazio crescente allo sport. In alcuni casi alla fine degli
anni trenta nacquero veri supplementi sportivi ad attestare uno sviluppo
dell’attività in crescita ed un interesse notevole tra la popolazione italiana4.
Accanto a queste fonti, certo parziali, alcuni documenti d’archivio aiutano
a meglio comprendere la fase «imperiale» della gestione di sport ed
«istruzione fisica» per le popolazioni colonizzate.
Le diverse situazioni geografiche hanno richiesto analisi diversificate. In
particolare ho scelto di effettuare uno spoglio quasi completo (tutta la durata
del regime fascista) dei giornali tripolini; Tripoli infatti è una città
particolarmente significativa per la contemporanea presenza della
popolazione araba, di una folta comunità di coloni italiani e di una comunità
ebraica locale. Riguardo alle colonie del Corno d’Africa ho invece limitato
il confronto tra il 1933 e gli anni dell’impero (quindi del razzismo di Stato).
Tripoli
Nel 1921 gli italiani presenti nel territorio eritreo erano poco più di
4000 mentre in Somalia ne venivano segnalati 676. In Tripolitania,
nonostante l’occupazione italiana si limitasse ancora alle zone costiere, gli
italiani erano 19.332, di cui 7.315 militari e 370 dipendenti pubblici5.
Secondo dati del 1932, la popolazione della città di Tripoli, vero centro
nevralgico di tutta la colonia libica, era composta dalla comunità araba di
40.000 persone, da quella ebrea libica di 5.117 e da quella italiana, militare
e civile, di 23.9976. La relativamente numerosa presenza italiana e la
conquista dell’entroterra completata già nei primi anni venti furono le
111
Gianluca Gabrielli
condizioni che resero particolarmente precoce (a confronto con le altre
colonie) la normalizzazione della vita cittadina e, con essa, l’introduzione
dello sport. Come vedremo, la convivenza delle tre comunità fece sì che
nelle scelte di politica sportiva si riflettessero in maniera significativa le
diverse fasi della politica di colonizzazione attuate dalle gerarchie fasciste.
Gli anni venti
Già nel 1924 erano attivi a Tripoli numerosi gruppi sportivi militari
(Cacciatori, Sussistenza, …), ben due associazioni sportive civili (U.S. Italia
e G.S. Fulgor che organizzavano attività varie in una palestra a pagamento7),
una società finalizzata al solo canottaggio (Canottieri Tripoli) e
un’associazione israelita di ispirazione sionista (Maccabei). Le manifestazioni
pubbliche registrate sulle pagine del giornale cittadino comprendevano boxe,
ippica, nuoto e calcio. Per quest’ultima specialità esisteva un campo sportivo
presso il Molo Sparto e veniva organizzato un campionato che era già alla
terza edizione (anche se non ne risultava ancora automatica l’indizione8).
Le manifestazioni di nuoto si disputavano al porto ed erano aperte per la
prima volta alle donne; è inoltre da segnalare l’assidua presenza di atleti
israeliti alle competizioni, soprattutto di nuoto (il 20 settembre Bice Hassan
giungeva seconda nella gara per «signorine», Elia Habib secondo nei 100
metri maschili, la squadra del Maccabei incontrava in amichevole l’U.S.
Italia nel water polo).
Negli anni seguenti crebbe significativamente la partecipazione degli
atleti militari (nel 1929 si iscrissero al campionato di calcio ben 8 squadre
dell’arma composte esclusivamente di italiani; uniche squadre civili Fulgor
e Avanguardia9). Tra le specialità sportive si affermarono presto anche il
podismo10 e il ciclismo su strada (mentre l’atletica e il ciclismo su pista
vennero promossi dopo la costruzione dello stadio nel 1930).
Erano anni in cui si parlava diffusamente delle Olimpiadi africane,
previste per il 192911, che suscitavano interesse tra gli sportivi italiani12. Di
fronte a questa prospettiva nel 1928 veniva creata a Tripoli una Società
Ginnastica che, secondo la vecchia tradizione ottocentesca che ora doveva
scendere a patti con l’atletismo di stampo britannico, permettesse la pratica
di quest’attività ritenuta alla base e a fondamento di tutti gli sport; venivano
così create sezioni di ginnastica, acrobatica, atletica e pugilato e a frequentarla
erano ammessi «tutti i cittadini italiani ovunque nati e di qualunque
112
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo
religione» e quindi ne erano esclusi i sudditi13. Il controllo politico
dell’attività in forte crescita era garantito dell’Ente Sportivo Coloniale presso
il Commissariato Generale dal quale dovevano passare tutte le nuove
iniziative e i relativi regolamenti per l’approvazione14.
La partecipazione araba alle attività sportive era dapprima limitata a casi
particolari legati al costume e alle tradizioni locali che non entravano in
contraddizione con i ruoli assegnati a tali popolazioni dalla politica coloniale
italiana; ecco così le manifestazioni ippiche dove erano previste gare riservate
a fantini arabi con barracano e bardatura indigena; questo tipo di attività
accompagnò in seguito senza modifiche tutta la storia della colonia, legato
com’era alla necessità di valorizzare le qualità militari della cavalleria araba
e di incentivare l’allevamento locale15.
Nel corso del decennio però la partecipazione di atleti arabi alle attività
sportive importate dai colonizzatori era divenuta significativa; se nel 1924
un solo calciatore arabo compariva nella formazione militare del G.
Esploratori che incontrava l’U.S. Italia in amichevole, nel gennaio 1929
la squadra del Fulgor giocava in formazione mista, con 5 calciatori arabi16.
Allo stesso modo nel pugilato si passava dall’esibizione tra allenatore
italiano e allievo indigeno in margine ad una manifestazione del 1924 al
doppio incontro misto (italiano contro arabo) in una serata pugilistica
del 192817. Esempio di questa fase di parziale apertura agli sportivi locali
è il regolamento della XX Settembre Ciclistica Tripolina di fondo del 1928
che era aperta a «qualunque corridore, borghese o militare, metropolitano
o indigeno, che risieda in Tripolitania da almeno un mese». D’altra parte,
quando la vittoria della corsa andò all’arabo Mohamed Creui davanti a
Hamed Ben Mohammed mentre Costa, il favorito italiano, giunse solo
quarto, si creò un evidente imbarazzo tra le gerarchie colonizzatrici, espresso
nella cronaca del giornale tripolino: «L’addebito principale che muoveremo
al Costa è specialmente quello che egli abbia troppo facilmente dimenticato
di essere anche in gara una Camicia Nera. È augurabile che a ciò pensino i
suoi superiori e provvedano secondo il caso. Binda e Girardengo sono stati
puniti per l’identica ragione»18.
Gli anni di Badoglio
Un punto che rimane abbastanza oscuro nei dettagli è quello relativo
alla silenziosa protesta che, a partire dall’estate del 1928, la squadra ebrea
113
Gianluca Gabrielli
del Maccabei inscenò attraverso la rinuncia alla partecipazione alle varie
competizioni. La società sportiva Maccabei era stata fondata dai settori
sionisti della comunità ebraica che, anche attraverso l’attività sportiva e
culturale cercavano di sviluppare la propria aggregazione. Di fatto questa
associazione sionista spingeva per la modernizzazione della comunità libica
contrapponendosi ai suoi settori più tradizionalisti. Già attiva dai primi
anni venti, la Società dei Maccabei era fortemente impegnata in numerose
discipline sportive. Eppure, alla vigilia della settima edizione della Traversata
del porto a nuoto che aveva sempre visto gli atleti ebrei tra i protagonisti, il
giornale tripolino annunciava la loro rinuncia. Difficile capire dalle fonti
analizzate se la polemica nacque da questioni sportive (la squadra del
Maccabei era stata da poco squalificata nel torneo calcistico) oppure se vi
fossero state forzature antiebraiche da parte degli organi politici italiani che
però non trapelarono sui giornali. L’assenza polemica degli ebrei o, come si
legge in un articolo del 1933, la loro «esclusione dalle competizioni»
continuò per alcuni anni. Solo nel 1932 ritroviamo Elia Habib tra i
partecipanti alle gare di nuoto.
Ma intanto dal gennaio 1929 al governo dell’intera colonia libica era
stato nominato Pietro Badoglio. Negli anni in cui egli fu governatore si
interruppe il processo di coinvolgimento degli atleti locali nelle
manifestazioni sportive unitarie; progressivamente, con ritmi diversi nelle
diverse discipline, furono creati circuiti sportivi paralleli riservati alle
comunità arabe o ebree, anticipando un progetto che fu riproposto con
forza e divenne realtà nelle colonie del Corno d’Africa dopo la proclamazione
dell’impero e la promulgazione delle direttive razziste.
Già dal 1930 nei regolamenti di numerose specialità comparvero
significative limitazioni: ad esempio il Giro podistico di Tripoli o la Traversata
del porto escludevano dai partecipanti sia gli arabi che gli ebrei tripolini («la
gara è riservata ai soli Nazionali e cittadini stranieri»19); oppure, ad un mese
dall’inizio del funzionamento della palestra di pugilato del Gruppo pugilistico
fascista tripolino, il giornale sentì il bisogno di segnalare che «non è altrettanto
vero che il Gruppo non possa accogliere gli elementi indigeni»20 e nelle
riunioni di pugilato gli sporadici atleti africani partecipanti ritornarono a
combattere tra loro21. Nel nuovo stadio inoltre vennero organizzate varie
manifestazioni; in due di queste «Polisportive» furono disputate anche gare
ciclistiche riservate ad indigeni come cornice alle gare per «nazionali»22.
Le forzature di Badoglio arrivarono al culmine nel 1932 quando venne
indetto un torneo di calcio per squadre composte da «sudditi» (arabi e
114
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo
israeliti) che ovviamente non trovò realizzazione (tra le due comunità
esistevano tensioni dai tempi della dominazione turca). L’anno seguente si
rimediò sdoppiando l’irrealizzabile torneo unico per sudditi in due tornei
riservati rispettivamente a israeliti e musulmani: la Coppa del Decennale
per gli ebrei e, per i musulmani, la coppa Hassuna Pascià intitolata al sindaco
arabo di Tripoli recentemente scomparso, fiancheggiatore degli italiani. Al
torneo per israeliti si iscrissero 5 squadre: Maccabei, Erzel, Ben Iehudà, Tel
Aviv e Tel Hai23; il fatto che le partite del campionato si disputassero il
sabato sottolinea il senso anti-tradizionalista con cui fu proposta dalle
autorità fasciste questa manifestazione che si deve inquadrare tra gli altri
conflitti che Badoglio e, con minore intensità, Balbo ingaggiarono con la
comunità ebrea libica: con essa veniva sancito che anche nello sport gli
ebrei libici «dovevano essere trattati come gli altri indigeni»24.
1935: Balbo ripropone l’organizzazione unitaria dello sport
Dal 1934 divenne governatore Italo Balbo. Egli investì molto nel
potenziamento dell’attività sportiva soprattutto sotto la dimensione
spettacolare e turistica, con l’organizzazione di grandi manifestazioni aeree,
automobilistiche e ciclistiche di livello internazionale. Ma in questa sede
tratteremo soprattutto di altri due aspetti innovativi da lui introdotti a partire
dal 1935 nell’organizzazione dello sport tripolino. La prima novità fu la
fondazione, nel mese di dicembre, dell’Unione sportiva tripolina, società
sportiva che divenne la principale organizzatrice delle manifestazioni della
città, seguendo la parola d’ordine: «prima di tutto organizzare in ogni campo
degli sport della massa». L’Ust mise in piedi nel giro del primo anno di
attività i campionati di calcio della prima e seconda divisione e dei ragazzi
(84 partite in tutto), varie amichevoli, dieci manifestazioni di pugilato,
quattro di scherma, ventisei di tiro a volo; nella sede vennero allestiti i
biliardi e uno spazio per le letture, c’era la possibilità di giocare a dama o a
carte e di ascoltare la radio25.
L’altra grande novità fu il cambiamento di politica sportiva nei confronti
della popolazione colonizzata. Dal 1935 infatti «l’elemento indigeno, nel
passato tenuto lontano da ogni competizione a confronto sportivo con
l’elemento metropolitano, è stato [...], con giustezza di vedute da parte
delle autorità sportive federali, ammesso a svolgere la sua attività nel quadro
generale dello sport cittadino»26. Santo Di Gaetano, che si occupava di
115
Gianluca Gabrielli
sport nel quotidiano di Tripoli, sottolineava positivamente questo nuovo
corso: «Nel calcio, nel ciclismo, nel podismo, nel nuoto gli indigeni hanno
portato il contributo della loro sana passione sportiva, acuendo lo spirito
agonistico delle varie gare»27 e da un’intervista a Tosini, responsabile e
allenatore del pugilato nell’Unione sportiva tripolina, cogliamo alcune delle
motivazioni della decisione di Balbo: «So che S.E. il Governatore Generale
desidera che anche i musulmani facciano lo sport. Siamo già a buon punto
nel calcio, nel ciclismo e nel pugilato. Anche per questa categoria di pugili
- ve ne sono molti che promettono - ho intenzione di formare una buona
squadretta e se i componenti saranno degni della mia fiducia in un prossimo
avvenire cercherò di portarli in Italia per incontrare dei pugili in Patria»28.
Le associazioni sportive per musulmani erano due: la Gioventù araba
del Littorio, istituita sulla formula della Gil e seguita da Ramadan Alì, e la
Belker, seguita dal ciclista e commerciante in attrezzature ciclistiche
Mohamed Creui. I pugili musulmani invece militavano all’interno
dell’Unione sportiva tripolina o del gruppo sportivo militare dell’Autogruppo.
Italo Balbo era convinto che, «gradatamente e in posizione subalterna, i
libici potessero e dovessero essere associati allo sviluppo e al governo del
loro paese» e lo sport costituiva uno degli strumenti di questa strategia29.
Dalla politica di associazione
rimaneva invece escluso il territorio
del sud, definito da Balbo «paese
di carattere spiccatamente
coloniale, popolato da gente di
razza negroide» mentre «gli arabi
e i berberi dei territori costieri
costituiscono invece una popolazione
di razza superiore influenzata dalla
civiltà mediterranea, capace di
assimilare lo spirito delle nostre
leggi e di evolversi sul piano di
una più elevata vita sociale»30.
Alì Bagdadi, quarto in classifica generale
nella seconda edizione del Gran premio
ciclistico Legnano. «L’Avvenire di Tripoli»,
28 dicembre 1937
116
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo
Questo nuovo corso di promozione sportiva senza separazione dovette
comunque incontrare alcuni problemi e resistenze, che dalle pagine del
giornale si possono percepire solamente in modo indiretto. Un esempio in
occasione della seconda Coppa Motociclistica della Federazione Fascista: due
settimane prima della gara veniva dato risalto all’innovativa partecipazione
di motociclisti appartenenti alle squadre indigene, Gal e Belker, mentre
due giorni prima della gara gli iscritti arabi scomparivano dalle liste31. Un
altro esempio in occasione del primo campionato ragazzi, con giocatori al
di sotto dei diciassette anni, la cui classifica finale premiava a pari merito
una squadra italiana e una araba per cui veniva previsto lo spareggio; dell’esito
della finale però nulla trapelava sul giornale fino a quando, alcuni giorni
dopo, un dispaccio della federazione calcistica comunicava che non si sarebbe
proceduto a stilare alcuna classifica per le varie scorrettezze che avevano
contraddistinto il torneo; così ad una lettera pubblicata di Alì ben Mas, che
lamentava la mancata cronaca sul giornale della finale, il giornale rispondeva
attribuendo le infrazioni più numerose alla squadra musulmana (giocatori
con età superiore al limite di diciassette anni, mancanza di tesserini). Del
risultato della finale non trapelò comunque nulla (e sembra perciò
presumibile una imbarazzante vittoria della Gal)32.
La stagione del razzismo di Stato
Anche se le prime misure legislative atte ad inaugurare la stagione del
razzismo di Stato fascista risalgono alla primavera del 1936, inizialmente
non ebbero influenza sulle consuetudini maturate nella pratica sportiva
libica a partire dalle direttive di Balbo.
È utile qui ricordare che dal 1936, in base alle direttive di Mussolini e del
ministro Lessona, la vita nelle colonie italiane fu impostata sulla separazione
tra la comunità dominante e quella dominata, in onore al principio del
«prestigio di razza» che darà il nome, nel 1939, alla legge quadro del razzismo
fascista. Prima di essa, nel mese di aprile 1937, il regio decreto legge n. 880
istituiva il reato di «madamato», cioè di unione d’indole coniugale tra italiani
e sudditi, indirizzata esplicitamente a proibire le unioni miste in Africa
Orientale, ma poi estesa nel 1939 anche agli abitanti della Libia.
In coincidenza non casuale con l’approvazione del decreto legge n. 880
Mussolini, accortosi della presenza di squadre arabe nel campionato tripolino
117
Gianluca Gabrielli
a fianco di squadre composte da italiani, tramite il ministro Lessona fece
pressione su Balbo affinché interrompesse la pratica «promiscua»:
S.E. Capo Governo ha notato su «Avvenite di Tripoli» notizia che est in corso campionato
calcio cui partecipano squadre nazionali insieme con squadra gioventù araba Littorio.
S.E. Capo Governo desidera che una volta concluso campionato in corso musulmani
non siano ammessi partecipare gare sportive insieme nazionali. Prego assicurazione33.
Balbo, che come abbiamo visto sull’avvicinamento della comunità araba
aveva impostato la sua politica di governo, rispose esprimendo molti dubbi
sulla decisione e prendendo tempo:
Sia detto con tutta franchezza mi pare che giovani G.A.L. addestrati militarmente per
combattere nostro fianco possano pure giocare al calcio coi nostri soldati e coi giovani
nostre organizzazioni. Tanto più che in ogni altro ramo di sport e specialmente nella
boxe gare promiscue si effettuano con tutta regolarità e senza dar luogo ad obiezioni.
Naturalmente non mancherò ottemperare disposizioni S.E. il Capo del Governo, ma
siccome rivelare ragioni divieto dopo due anni in cui campionato si effettua con
partecipazione squadre musulmane significherebbe provocare ripercussione politica
veramente grave, dovrei regolarmi in modo da rendere inattuabile effettuazione
campionato calcio tripolino, sia facendo ritirare squadre militari, sia con altri espedienti.
Comunque, prima di passare attuazione, mi riservo di parlarne a Roma alla prossima
occasione con V.E. e il Duce34.
Il campionato 1937 si concluse regolarmente e quello del 1938 vide
ugualmente la partecipazione delle squadre arabe: la Gal I nella 1a Divisione
e la Gal II nella 2a Divisione35. Ancora sul finire del 1937 in occasione dei
campionati di pugilato era possibile leggere sull’Avvenire una esplicita
esaltazione della politica sportiva scelta da Balbo:
La partecipazione di elementi indigeni, fatto non nuovo nel pugilato tripolino, apporta
indubbiamente maggior interesse alla manifestazione. L’elemento indigeno, che nel passato
è stato tenuto lontano da ogni competizione a confronto sportivo con l’elemento
metropolitano, già da qualche anno, con giustezza di vedute da parte delle Autorità Sportive
Federali, è stato ammesso a svolgere la sua attività nel quadro generale dello sport cittadino.
Il risultato di questo nuovo andamento di cose è stato, come giustamente si prevedeva,
quanto mai ottimo.
Nel calcio, nel ciclismo, nel podismo, nel nuoto gli indigeni hanno portato il contributo
della loro sana passione sportiva, acuendo lo spirito agonistico delle varie gare36.
118
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo
Ma ormai la politica razzista del fascismo stava per arrivare al suo culmine
anche nel regno e non era più possibile temporeggiare. Per gli sportivi ebrei i
ritmi della esclusione si fecero incalzanti: l’ultima partita amichevole della squadra
calcistica del Maccabei si svolse il 16 aprile 1938 con l’Ust37; durante l’estate i
nuotatori ebrei partecipano regolarmente alle prime tre gare, poi l’organizzazione
passò alla Gil e le gare persero per sempre i partecipanti ebrei38.
Da aprile del 1938 cessarono sul giornale anche le informazioni sulla
fase finale del campionato di calcio. Due mesi dopo venne pubblicata una
lettera firmata «uno sportivo di Tripoli» che chiedeva informazioni sul
destino del torneo, ormai interrotto da tempo, lamentando il silenzio dei
dirigenti contrapposto all’interesse di giocatori e pubblico39 e quattro giorni
dopo un laconico comunicato del Direttorio della XIX Zona della Figc
«sospende[va] definitivamente i campionati in corso» e decretava che «non
[fosse] stabilita alcuna classifica e quindi assegnato alcun titolo»40.
In ottobre, dopo tre mesi di tambureggiante campagna razzista sulle prime
pagine del giornale, si riapriva il capitolo campionato. Su quello passato non
si faceva chiarezza e le reali ragioni della sospensione sembravano rimanere
un oscuro e scandaloso mistero anche per l’articolista dell’«Avvenire»:
Rivangare le ragioni di un tale provvedimento è ormai cosa vana. Una cosa sola
dobbiamo aggiungere e cioè che un provvedimento del genere arreca un male alla
buona e sana propaganda sportiva e dà adito al disinteresse da parte degli appassionati
al gioco del calcio41.
Ma dal regolamento del campionato calcistico 1938-39 si capiva che il
tempo preso da Balbo si era esaurito ed era giunto il momento di applicare le
direttive Mussoliniane del 1937 dissimulandone le motivazioni reali per non
entrare in conflitto con la comunità araba. Il nuovo regolamento recitava:
Potranno partecipare soltanto squadre di calcio appartenenti a Società Sportive
regolarmente costituite ed alle Organizzazioni del Partito […]. I giocatori partecipanti
ai due campionati dovranno essere tutti tesserati alla FGCI [...]. Potranno essere tesserati
soltanto giocatori di nazionalità e cittadinanza italiana. Il Direttorio di Zona Tripolino
allo scopo di dare sempre maggiore impulso alla propaganda calcistica locale
organizzerà, in seguito, un torneo per squadre indigeni, un torneo per squadre militari
e un torneo per riserve e ragazzi42.
In questo modo, per un anno, dal campionato più popolare in colonia
furono esclusi giocatori locali. Non poterono partecipare le squadre ebree
119
Gianluca Gabrielli
che, come abbiamo visto, non erano state più iscritte dagli anni di Badoglio
e la cui associazione sportiva, il Maccabei, fu dichiarata fuorilegge con
l’accusa di attività sovversiva nel 194143.
Non poté partecipare neppure la Gioventù araba del littorio, esclusa
anch’essa in applicazione delle direttive del razzismo di Stato. Nelle altre
discipline sportive, relativamente agli atleti arabi, non si ebbe una netta
interruzione: nel podismo e nel ciclismo continuarono le gare miste con la
partecipazione di arabi appartenenti alla Gal e all’Ust, anche se
parallelamente furono istituite manifestazioni riservate agli sportivi arabi
come forma di promozione separata44. Nel nuoto gli arabi concorrevano in
manifestazioni organizzate solo per essi o tutt’al più in batterie aggiuntive
loro riservate; nel pugilato furono sospesi gli incontri «misti» e si ritornò
agli incontri tra arabi previsti però all’interno di manifestazioni basate su
incontri tra italiani. Nel calcio, finita la fase più calda della propaganda
razzista e avvicinatasi la guerra con la necessità di utilizzare le truppe africane,
ripresero le partite miste, prima in forma di amichevoli (2 aprile 1939)45
poi anche in forma ufficiale con la nuova ammissione della Gal nel
Campionato tripolino del 194046.
Le colonie del Corno d’Africa
Somalia e Eritrea prima del razzismo di Stato
In Somalia sul finire dell’anno 1931, con alcuni anni di ritardo rispetto
alla Libia, il governatore istituiva la Federazione Sportiva Fascista come
ente direttivo con lo scopo di coordinare e disciplinare ogni attività sportiva
nella colonia. Ad essa facevano capo tutte le Società regolarmente costituite,
ed ogni gara o manifestazione doveva ricevere la sua preventiva approvazione.
Una serie di articoli apparsi sul «Corriere della Somalia» all’inizio del
1933 ci permette di misurare l’attività presente in questi anni47. Nel tennis
operava il Tennis club Mogadiscio che aveva alcuni anni di vita, raccoglieva
50 soci che usufruivano di due campi recentemente dotati di illuminazione;
era in costruzione un terzo campo e il muro di allenamento. Nel 1932
aveva organizzato il Campionato Somalo a cui avevano partecipato una
ventina di atleti (5 donne). Recentemente anche il Comando Marino aveva
costruito il proprio campo ed erano in costruzione quelli dell’aviazione e
del campo militare di Hammar Ger Geb.
120
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo
Il calcio era stato praticato dalla Società Mogadiscio (che contava 33
soci) e dal Comando Marina in competizioni amichevoli utili a smentire
l’opinione diffusa che non fosse possibile praticarlo in Somalia per il clima
debilitante. Nel 1933 si disputava il 1° Campionato di calcio della Somalia
(Coppa federazione sportiva) riservato a «squadre federate e militari
metropolitane»; ad esso partecipavano tre squadre: Milizia, Marina e S.
Mogadiscio, mentre era in formazione la squadra del R. Corpo truppe
coloniali.48 Esisteva un campo sportivo con tribunetta che recentemente
era stata adibita a spogliatoio nel basamento.
Veniva inoltre praticata la scherma per tutte le classi di età, dai balilla
agli adulti, con culmine dell’attività nell’Annuale schermistico della Somalia
giunto alla seconda edizione, e il tiro al piccione. L’atletica leggera, senza
impianti specifici, nel 1932 aveva visto una sola manifestazione «sociale»
del Comando Marina.
Tutte le attività sportive menzionate erano praticate dai coloni italiani
mentre nessun cenno veniva fatto a manifestazioni per atleti somali.
Non era molto diversa la situazione in Eritrea. Nel 1933 il commissario
sportivo Masobello dirigeva un’attività molto ridotta. Ormai da due anni
non si disputava più il campionato di calcio, né il Bracciale Cona, gara
ciclistica anch’essa interrotta. Si svolgevano invece manifestazioni di tiro al
piccione, pugilato, lotta greco-romana e sollevamento pesi 49. Nelle
manifestazioni ippiche (due nel corso dell’anno) era prevista una gara per
cavalli proprietà di indigeni e montati da indigeni. Le altre attività erano
estemporanee e fungevano da cornice a manifestazioni di celebrazione
politica (il 21 aprile, Natale di Roma, si svolse ad esempio una gimcana
ciclistica, una motociclistica e una corsa podistica a staffetta tra Giovani e
Piccole italiane; alla scuola Principe di Piemonte il saggio ginnico precedeva
la recita della tavola pitagorica e seguiva il canto di Giovinezza). Sul finire
dell’anno, su stimolo del giornale locale, il Commissario Politico organizzò
un pomeriggio sportivo con ciclismo, podismo, tiro alla fune e «palla a
sfratto»50. È evidente quindi che la dimensione dell’attività rimaneva limitata
e occasionale, spesso collegata alle organizzazioni giovanili di regime, oppure
nasceva attorno a sfide come le marce a squadre di tradizione militare51.
Tutte le iniziative segnalate sul giornale erano riservate ai bianchi52;
nella manifestazione del 21 aprile le tribune A, B e C erano per la
popolazione metropolitana, mentre «la tribuna D [era] riservata alla
popolazione indigena» a confermare che anche nell’organizzazione del
121
Gianluca Gabrielli
pubblico sportivo una divisione netta della società era già ben radicata
prima della svolta del 193653.
Gli anni dell’impero: Somalia e Eritrea
Anche se manca ancora uno spoglio sistematico della documentazione d’archivio, è certo che gli anni della conquista dell’Etiopia
spinsero le gerarchie fasciste ad attivarsi per organizzare l’attività sportiva
della popolazione indigena maschile in modo stabile, ma secondo il
netto principio della subordinazione e della separazione dalle attività
dei bianchi.
In Somalia nel 1937, accanto all’ennesima edizione del campionato di
calcio per squadre composte da nazionali, venne organizzato il primo
campionato riservato alle squadre composte da somali. La vittoria andò
all’Amaruini, le altre squadre partecipanti erano Deposito Fanteria, Jacub,
Benadir, Araba54. Il campionato fu ripetuto negli anni seguenti (nel 1938
vinse ancora l’Amaruini mentre nel 1939 vinse l’Araba).
«Somalia Sportiva», settimanale sportivo dei Fasci di combattimento,
dedicò uno spazio regolare alle cronache delle partite tra squadre indigene;
in esse facevano capolino i pregiudizi radicati nell’immaginario dei
colonizzatori: ad esempio le allusioni alla «mentalità primitiva» dei somali,
ma emergevano anche informazioni sulla nascita delle prime tifoserie e
sull’«assimilazione» degli aspetti che accompagnano lo sviluppo della pratica
calcistica, con polemiche arbitrali, contestazioni e scontri tra tifoserie che
venivano colti dall’articolista con malcelata soddisfazione, ritenendoli parte
integrante del nucleo profondo della pratica calcistica come veniva proposta
dai «colonizzatori-civilizzatori»55.
Anche le altre attività sportive per italiani apparivano in crescita in questi
anni. Agli sport già praticati in passato come tennis, scherma e tiro al
piccione, si aggiunsero ciclismo, boxe, atletica, pallacanestro, bocce, nuoto
e automobilismo (nel 1938 il 1° Circuito automobilistico di Mogadiscio
all’interno della Settimana sportiva). Furono organizzate anche le prime
attività nei centri minori, come Baidoa56.
In generale l’attività cercava, con fatica, di trovare quella continuità che
fino ad allora era completamente mancata, passando dalle «sfide»
estemporanee all’attività programmata anno per anno, come spiegava lo
stesso Ufficio Sportivo Federale della Somalia intervenendo sulla «Somalia
122
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo
sportiva» in polemica con un articolo trionfalistico comparso sul periodico
«Il Pugilatore», stampato e distribuito in Italia57.
Per i somali, oltre al calcio di cui si è detto, abbiamo notizie di due
manifestazioni loro riservate (una natatoria e una di atletica)58, e degli
incontri di apertura delle manifestazioni di pugilato, tra i «somali Mallin
Nur ed Isak Barrachin, eterni avversari che da circa due anni si trovano di
fronte in quasi tutte le riunioni»59. Tutte queste attività erano svolte tra
somali, rispettando un imperativo implicito di separatezza che si può cogliere
chiaramente anche nella organizzazione logistica delle tribune per il pubblico
del circuito automobilistico: tribune A, B, C, D, E per nazionali, mentre
per la popolazione somala erano disponibili due tribune con diversa
dislocazione60.
Anche in Eritrea, nel 1939, la pratica sportiva sembrava aver acquisito
continuità. Il campionato di calcio era sdoppiato in due gironi (Bassopiano e
Altopiano) le cui vincenti si disputavano il titolo di campione d’Eritrea; il
Torneo del Bassopiano si disputava tra nove squadre. Venivano inoltre
organizzate manifestazioni di tiro a volo, pallacanestro, podismo, ciclismo,
boxe, tamburello, canottaggio e pallacorda. Tutte queste attività erano ormai
riservate agli «ariani» per regolamento: così la federazione ciclistica comunicava
che per «disposizione del C.O.N.I. nello Statuto Sociale della Società deve
essere inserito il seguente articolo: “Condizione indispensabile per poter essere
soci è l’appartenenza alla razza ariana”»61. Parallelamente anche qui in alcune
attività è attivato un separato intervento organizzativo verso i sudditi. Nel
calcio viene costituita la Sezione Propaganda per eritrei che si deve occupare
di tutte le manifestazioni calcistiche delle società composte di sudditi. Ecco
così nascere la Coppa Enrico Toti tra le squadre dell’Hamasien, Savoia, Eritrea
e Ardita, vincitrice quest’ultima della Coppa del Direttorio per sudditi nel
1938. Nelle altre discipline sportive dallo spoglio giornalistico emergono solo
una competizione per uri e barche di porto, di contorno alla manifestazione
nautica del 28 ottobre a Massaua62, e una gara ciclistica per sudditi di contorno
alla seconda prova del campionato eritreo di ciclismo63.
Gli anni dell’impero: Etiopia
In Etiopia il 1939 fu l’anno decisivo per la promozione sportiva; nel 1936
infatti, dopo la «dichiarata» conquista del territorio, era rimasta attiva una intensa
attività di guerriglia, cui fece riscontro la feroce e spietata repressione del viceré
Graziani; anche se negli anni successivi la resistenza etiope non depose le armi,
123
Gianluca Gabrielli
l’arrivo del nuovo viceré Amedeo di Savoia-Aosta coincise con un assestamento
progressivo della vita per i numerosi italiani presenti e per la popolazione etiope,
anche se limitato ai grandi centri e alle zone «pacificate».
Lo sport degli italiani
Già dal 1938 l’attività sportiva dei bianchi aveva mutato forme, da quelle
estemporanee dei reparti militari alla nascita delle prime società sportive;
così nonostante la strutturale carenza di impianti, numerose specialità
venivano ormai praticate in maniera costante. Una rassegna generale
dell’attività sportiva dello Scioa pubblicata nell’estate del 1939 sul «Lunedì
dell’Impero» ci permette di dare uno sguardo generale all’attività degli italiani
in questa regione 64. Il calcio, come sempre, era l’attività che quasi
spontaneamente si era affermata con il maggior numero di campi sportivi
adatti e di praticanti, tanto che il campionato dello Scioa nel 1938 aveva
coinvolto ben 14 squadre65; l’anno seguente la riorganizzazione delle società
gestita dalla Federazione Italiana Gioco Calcio ridusse le squadre dello Scioa
a 7 mentre ben 57 erano le comitive in tutta l’Africa Orientale Italiana
(quindi Eritrea e Somalia comprese) con 1.111 tesserati. Più difficile la
situazione degli altri sport; la boxe vide le prime riunioni sul finire del
1937 ed ebbe vicende alterne in seguito ai trasferimenti e rimpatri degli
italiani che avevano animato l’attività: in due anni furono organizzate 8
manifestazioni pubbliche. Il ciclismo, al momento in cui fu scritto l’articolo,
contava solo 21 tesserati e tre gare nella stagione 1939, il tennis metteva in
conto due tornei e una trentina di partecipanti. Ancora al palo la scherma,
nonostante la costruzione di una pedana nel salone di un gruppo rionale,
mentre il podismo aveva sviluppato un intenso calendario di gare e staffette
dal settembre 1938, ma soffriva ovviamente la mancanza di una pista. Nel
nuoto erano state organizzate due manifestazioni nel lago Biscioftù, a 40
chilometri da Addis Abeba in un ambiente decisamente ostico e sul giornale
erano ricorrenti le lamentele per l’assenza di impianti artificiali.
D’altronde le necessità edilizie di base legate all’«edificazione dell’impero»
ponevano regolarmente l’edilizia sportiva in coda alle altre realizzazioni. Di
fronte a questa situazione spesso era solo l’attivismo organizzativo dei coloni
che cercava di sopperire alle carenze impiantistiche, ma limitandosi agli
sport come il calcio, più radicati e con minori esigenze tecniche.
124
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo
Sempre nel 1939 venne formato l’Ufficio del Coni presso l’Ispettorato
del Partito fascista in Addis Abeba affidato a Bortolo Castellani e destinato
a dare le indicazioni politiche alle Consulte sportive istituite presso i Fasci
di combattimento (mentre sugli aspetti tecnico organizzativi esercitavano
il controllo diretto le federazioni sportive)66; Nello stesso periodo il Coni
mise allo studio un progetto di campo sportivo coloniale standard da
realizzarsi nelle terre dell’impero; furono trasferite le competenze sportive
dei gruppi rionali (istituzioni che assolvevano ad attività politiche e sportive)
alle società sportive; venne iniziata dai medici sportivi la «schedatura clinica»
di tutti i tesserati per finalità medico-preventive e razziali (evitare infortuni,
seguire e conoscere l’adattamento della «razza» ad inconsuete latitudini e
altitudini)67.
Panem et circenses: l’attività sportiva per i sudditi dell’impero fascista
Anche nell’Etiopia dell’impero mussoliniano ogni attività che vedeva
coinvolti atleti italiani era interdetta agli atleti di colore; l’unica parziale
eccezione che mi è capitata sotto gli occhi in questo spoglio si riferisce al
pugilato: alla riunione del 30 gennaio 1939 al cinema Impero erano previsti
gli incontri di cornice tra gli indigeni Cassa-Gabtimer (carta) AvakiamPunretian (medi), secondo uno stile che abbiamo visto essere in uso anche
in altre colonie italiane e che permetteva la giustapposizione dello «sport
nero» allo «sport bianco» senza mescolarne gli attori. Per il resto l’attività
sportiva degli indigeni veniva organizzata dai colonizzatori in luoghi e tempi
separati da quelli dei bianchi, per motivi di «prestigio razziale» sanciti ormai
da leggi dello Stato.
Le finalità e le modalità organizzative di questa attività sono chiaramente
sintetizzate nelle parole di Teruzzi, sottosegretario di Stato per l’Africa
Italiana, che riassumeva a Starace, segretario del Partito nazionale fascista, i
primi passi dello sport indigeno nei nuovi territori dell’impero:
S.A.R. il Viceré ha curato in modo speciale l’organizzazione sportiva degli indigeni,
come mezzo efficace per dimostrare l’interessamento del Governo per le popolazioni, ed
anche distrarle da altre aspirazioni, coltivando in esse una passione innata, ed applicando
l’adagio romano «panem et circensem» [sic]. Le istruzioni date per Addis Abeba suonano
così: «Le attività sportive indigene fanno capo esclusivamente al Commissariato di Governo;
e ciò in modo tassativo, al fine di evitare ogni inopportuna confusione ed ogni inopportuno
parallelismo con le similari organizzazioni italiane [...]. In particolare per Addis Abeba voi
125
Gianluca Gabrielli
cercherete la collaborazione dei Capi di quartiere, affinché per ogni quartiere si costituiscano le varie squadre sportive che potranno trovare, reciprocamente motivo di
contestazione [...]. L’organizzazione deve agire sempre ed in ogni circostanza nell’ambito
delle consuetudini e delle usanze locali, con l’intervento sistematico dei capi indigeni
territoriali e dei notabili locali, sempre invitati in prima linea alle cerimonie cui intervengono
i ragazzi». Altre istruzioni prescrivono di valorizzare i giuochi indigeni tradizionali. Come
si vede, l’organizzazione dell’attività sportiva tra i giovani indigeni comporta quotidiani
rapporti con i capi e i notabili; osservanza di consuetudini locali, rispetto, anche, alle
divisioni sociali che vietano di accomunare, ad esempio, nelle stesse squadre figli di capi e
giovani appartenenti alle caste spregiate68.
Lo sport in questo periodo era diventato quindi uno strumento attivo
della politica portata avanti dal nuovo viceré nei confronti della popolazione
locale ai fini del suo controllo e della sua organizzazione sul modello dei
nazionali ma subordinata ad essi. La possibilità di controllare e gestire il
tempo libero di ragguardevoli gruppi di giovani etiopi, atleti e tifosi,
impegnandoli in un’attività fortemente caratterizzata in senso «occidentale»
veniva a soddisfare una esigenza fondamentale di un governo coloniale che
non contasse solamente sulla repressione. Per di più la direzione di ogni
aspetto organizzativo, fino alla decisione sull’entità del coinvolgimento dei
notabili locali collaborazionisti, doveva assicurare il massimo controllo del
fenomeno. L’ambito separato «razzialmente» nel quale veniva organizzata
l’attività ci fornisce inoltre la chiave per interpretare quell’accenno allo sport
come «passione innata» negli africani, da misurare non come un qualsiasi
accenno generico alla capacità trascinante dello sport, ma come precisa
allusione a «caratteri distintivi» di una «razza inferiore».
Purtroppo per ora non ho rintracciato gli originali delle indicazioni del
viceré cui si riferisce Teruzzi, quindi la datazione rimane approssimativa e
probabilmente precede la primavera del 1939, stagione di massimo impegno
organizzativo. In questo periodo infatti il Commissariato di Governo di
Addis Abeba affidò al Teclai Scium (capo degli indigeni, formale figura di
autogoverno subordinata totalmente ai colonizzatori) l’incarico di raccogliere
le iscrizioni dei giovani africani che intendessero partecipare alle gare.
I settori sportivi che vennero attivati furono il ciclismo, il podismo,
l’attività calcistica69 nonché gare di cavalli indigeni con fantini indigeni70.
Più che con intenti sportivi, le gare di cavalli furono organizzate poiché
rappresentavano soprattutto una misura per la promozione dell’allevamento
locale, «un primo passo verso quell’incremento da realizzarsi anche nel settore
indigeno per poi selezionare e attivare sempre più la riproduzione di buone
126
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo
razze equine»71. La vera attività sportiva per indigeni fu quella proposta nella
forma delle «polisportive» domenicali, manifestazioni nelle quali erano
normalmente previste gare di ciclismo e podismo. I partecipanti alle gare
ciclistiche erano suddivisi nelle categorie «turismo» e «corsa» (probabilmente
in base alla bicicletta e alle qualità dell’atleta), e le gare si svolgevano su
distanze al di sotto dei 50 chilometri e spesso in circuito, per favorire il
coinvolgimento del pubblico indigeno; le gare podistiche si sviluppavano su
diverse distanze dai 100 ai 5.000 metri e solo in un caso compresero anche
una specialità tecnica come il salto in alto. Il calcio fu avviato nel mese di
giugno 1939 con la creazione di due squadre, una copta e l’altra musulmana.
Dopo l’interruzione per la stagione delle piogge l’attività riprese e da
un resoconto del 1940 si apprende che era in piena attività un campionato
indigeni anche ad Addis Abeba72. Le manifestazioni polisportive furono
organizzate con grande frequenza (ben sette manifestazioni tra maggio
Una squadra che partecipa al campionato indigeni nell’Etiopia italiana.
Nell’originale «Ecco le zebre dello Scioa». «L’Azione Coloniale», X, 7 marzo 1940
127
Gianluca Gabrielli
e agosto 1939) nel tentativo di lanciare un’attività di massa che
coinvolgesse il numero più grande possibile di giovani. Dalle cronache,
che ovviamente sono fonti di cui tenere conto con molta cautela, sembra
che la risposta fosse stata notevole e che, soprattutto nelle prove
ciclistiche, si fossero attivati alcuni meccanismi di tifo e di riconoscimento
dei campioni locali tipici del fenomeno sportivo: la figura di Cassa Fadil,
ciclista plurivincitore dalle doti di grimpeur, era capace di suscitare
entusiasmo nella folla che accompagnava queste manifestazioni. La
partecipazione della popolazione locale venne d’altronde incentivata
mettendo in palio premi in denaro e in capi di vestiario e, come già
scritto, attraverso il coinvolgimento di importanti notabili locali che
collaboravano con il governo coloniale, a partire dal Teclai Scium di
Addis Abeba e da Ras Hailù Tecla Haimanot, onnipresenti alle
manifestazioni insieme alle gerarchie fasciste e titolari essi stessi di due
società sportive indigene, e continuando con numerosi altri notabili che
venivano regolarmente elencati nelle corrispondenze dedicate agli
avvenimenti dal giornale di Addis Abeba. Una di queste iniziative venne
organizzata il 27 settembre nel giorno del mascal in onore del Metropolita,
l’abuna Johannes, e dei vescovi. Tra le personalità di rilievo italiane che
presenziarono spesso alle manifestazioni e premiarono i vincitori ritroviamo
figure importanti come il direttore generale degli Affari Politici Franca e
lo stesso vice governatore generale Nasi73.
Il coinvolgimento sportivo lasciava però scoperto un altro ambito
decisivo dell’edificio ginnastico moderno: quello relativo all’educazione
scolastica, che in Italia era gestita dalla Gil e si rivolgeva a tutti, a
prescindere dal livello delle prestazioni, con finalità «eugeniche» e
premilitari. A partire da settembre 1939 un accordo tra Teruzzi e Starace
cercava di colmare questa lacuna; con esso si stabiliva che l’istruzione
fisica dei giovani indigeni fosse affidata alle strutture del partito, sia
nelle scuole governative che in quelle delle missioni cattoliche. Il senso
di questa decisione era evidente
Il Partito dovrebbe riservarsi l’istruzione fisica dei giovani indigeni in quanto questa è
la sola che ci interessa per preparare dei buoni ascari74.
Per la scelta della denominazione da far assumere a questa nuova
istituzione del partito, Teruzzi spiegava di ritenere importante non ricalcare
le formule già adottate in Italia e in Libia (Gil e Gal):
128
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo
In quanto alla denominazione non ritengo opportuna [sic] venga adottata quella di
«Gioventù etiopica del Littorio»; in Libia la «Gioventù araba del Littorio» è stata
fondata con il concetto di dare alle popolazioni un riconoscimento del grado di
evoluzione raggiunto.
Tutti i nativi della Libia hanno la qualifica di cittadini (libici); alcuni di essi godono
di una forma di cittadinanza che si avvicina in dignità e, entro i confini dei nostri
territori d’Africa, per il contenuto a quella metropolitana.
Ben diversa è la situazione nell’A.O.I. dove gli abitanti sono sudditi, il livello di
evoluzione molto basso, il distacco razziale molto forte.
È, quindi, da escludere ogni assimilazione, anche esteriore alle organizzazioni fasciste
metropolitane: assimilazione che porterebbe, in ultima analisi, i nativi ad aspirare,
uscendo dalle organizzazioni giovanili, a passare ad un inquadramento superiore che
non sarebbe consono alla loro posizione.
Ritengo, inoltre, non proprio l’uso della denominazione «Gioventù etiopica del
Littorio» poiché le previdenze da attuare riguardano anche l’Eritrea e la Somalia che
non facevano parte dell’Etiopia.
Mi sembra opportuno che gli istruttori dei giovani indigeni facciano capo ai singoli
segretari federali e non ad un unico ente in Addis Abeba per tutta l’A.O.I. ed anche
entro l’ambito di ciascun governo i ragazzi non dovrebbero avere un’unica
denominazione (che potrebbe col tempo creare uno spirito unitario e di coesione che
non dobbiamo favorire se non con particolari cautele e limitatamente a taluni effetti),
ma singoli nomi regionali, come ad esempio «ragazzi (non certo Balilla) del
Beghemeder», «Giovani dell’Uollo» ecc.75
Sono evidenti i timori che guidavano le gerarchie fasciste: ogni
associazione poteva favorire il senso di identità comune degli associati e il
passaggio dalla pratica sportiva a quella politica era un rischio immanente a
questa esperienza. La soluzione stava nel frammentare le associazioni, nel
porle in antitesi tra loro e nel ribadire la scala gerarchica tra colonizzatore e
colonizzato già fissata dal dominio e cementata dalle teorizzazioni e dalle
legislazioni razziali, evitando ogni simbologia che potesse alludere
all’uguaglianza tra africani e italiani.
Nella lettera di Teruzzi traspaiono inoltre alcune preoccupazioni circa i
rapporti tra Segretari federali e Governatori per ciò che riguardava le suddette
attività; egli specificava che i fascisti incaricati dell’istruzione fisica dei giovani
indigeni avrebbero dovuto fare capo localmente alle autorità politico
amministrative così «come i Segretari Federali, per questo lato politico,
faranno capo ai Governatori, alle cui direttive in materia ispireranno le loro
linee d’azione»76; ma Starace non diede seguito alla richiesta di Teruzzi di
specificare la diversa attribuzione dei compiti nelle disposizioni ai segretari
129
Gianluca Gabrielli
federali, lasciando un’ambiguità foriera, con molta probabilità, di conflitti
di potere e di linea organizzativa77.
L’atleta «negro»: appunti sull’immagine
Al termine di questa prima disamina aggiungo qualche parola anche su
una questione che esula dal tema specifico della ricerca ma che vi è
certamente collegata. Quale immagine dell’atleta «negro» circola in Italia
negli anni venti e trenta? Sono anni in cui gli atleti di colore raggiungono
affermazioni internazionali di grande valore anche simbolico, basti pensare
alle vittorie di Jesse Owens a Berlino nel 1936 o alla conquista del titolo di
campione del mondo di boxe da parte dell’«indigeno» senegalese Battling
Siki ai danni del francese Carpentier nel 1922… In attesa di ricerche
sistematiche che si valgano dei commenti apparsi sui giornali sportivi italiani
in occasione di questi grandi eventi simbolici, basti in questo contesto
l’analisi dell’articolo di Carlo Volpi apparso su «Lo Sport Fascista» del giugno
1929 e intitolato La razza nera nella storia del pugilato. L’articolista ripercorre
la storia dei pugili di colore, racconta «l’odio di razza» che inglesi e americani
nutrono per i neri ostacolandone la pratica sportiva e gli incontri con pugili
bianchi; sottolinea, al contrario, che «nei paesi latini non esiste questo feroce
odio di razza» tanto che numerosi pugili si sono rifugiati in Europa e America
Latina. Ma quando si deve pronunciare sul perché «la loro razza possa dare
al pugilato tanti uomini di così eccelsa classe» dal suo discorso emergono i
pregiudizi. Dapprima richiama le caratteristiche fisiche che intervengono
nel pugilato e si premura di ricordare che anche quelle che oggi un allenatore
definirebbe di tipo «neuromotorio» («una certa rapidità di riflessi») non
possono chiamarsi «intelligenza» poiché anche «in alcune specie di animali»
sono spiccatissime. Poi passa a ricordare la «resistenza al dolore» poiché «è
provato che i negri non solo sono per natura meno sensibili dei bianchi ma
vi sono dei soggetti pressoché insensibili» e quindi «in condizioni di
superiorità rispetto all’avversario»78. Quindi, la conclusione è che solo doti
di tipo fisico danno la superiorità al pugile nero, poiché egli «sul ring
dimostra spesso di essere tutt’altro che intelligente. Tutto al più egli è furbo,
trucchista e traditore poiché non conosce cosa sia lealtà» ... e continua, in
quella che mi pare una vera lezione traslata di etica del colonizzatore:
«Sul ring l’unico modo di farsi rispettare da un negro, è quello di picchiarlo,
di dimostrargli con la forza la sua inferiorità; allora diventa pusillanime;
130
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo
guai se si accorge di essere il più forte; egli è cattivo, nel senso che non
risparmia».
Animalizzazioni, richiami alla natura e all’incapacità di rispettare le regole
morali...: alcuni tra i pregiudizi pseudoscientifici attivi e diffusi
nell’immaginario, non solo italiano, degli anni venti e trenta. Tali forme
del pensiero non svanirono, come per incanto, con la perdita delle colonie;
non è difficile infatti ritrovarli, mutatis mutandis, anche nelle cronache
sportive di oggi: ecco come sulle colonne di «la Repubblica», si descrive un
concorrente afro-americano ai campionati mondiali di atletica del 1999:
«Accomodatevi, stasera liberano il gorilla più veloce del pianeta»; «questo
urla il tamburo della foresta: [...] Mister Fenomeno stuprerà i cento»79.
Quali percorsi sotterranei dell’immaginario, quali mancate rielaborazioni
del passato hanno tenuto tanto in vita questi pregiudizi, da riproporceli
oggi così offensivamente uguali?
Note al testo
1
STEFANO PIVATO, L’era dello sport, Giunti, Firenze 1994, p. 23.
2
GIANLUCA GABRIELLI, Un aspetto della politica fascista nell’impero: il «problema dei meticci»,
«Passato e presente», a. XV (1997), n. 41.
3
Cfr. ad esempio BERNADETTE DEVILLE-DANTHU, Le sport en noir et blanc. Du sport colonial au sport
africain dans les anciens territoires français d’Afrique occidentale (1920-1965), l’Harmattan, Paris
1997; ANDRÉ JEAN BENOIT, Le sport colonial, l’Harmattan, Paris 1996; PETER RUMMELT, Sport im
Kolonialismus – Kolonialismus im Sport: zur Genese und Funktion des Sports in Kolonial-Africa von
1870 bis 1918, Pahl-Rugenstein, Koln 1986; HAMAD S NDEE, Sport in Africa: Western Influences,
British Middle-Class Educationa lists and the Diffusion of Adapted Athleticism in Tanzania, «The
international journal of the history of sport», a. 17, n. 1, marzo 2000.
4
«Somalia sportiva», supplemento del lunedì del «Corriere della Somalia» dal 1937; il «Corriere
eritreo sportivo», settimanale del lunedì pubblicato da aprile 1938. Fin dal 1928 invece esisteva una
sezione della rivista «Illustrazione Coloniale» intitolata Rivista sportiva.
5
Riprendo i dati da NICOLA LABANCA, Italiani d’Africa, in Adua. Le ragioni di una sconfitta, a cura di
A. Del Boca, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 193 230, cui rimando per un’analisi più approfondita.
6
Annuario delle Colonie Italiane, Istituto coloniale fascista, Roma, 1933, p. 481.
7
L’U.S. Italia organizza corsi di ginnastica svedese, boxe, lotta greco-romana, attrezzi, ciclismo,
podismo, calcio; L’Unione Sportiva Italia, «La Nuova Italia» quotidiano della Libia, 25 settembre
1924.
131
Gianluca Gabrielli
8
Per il Campionato di foot-ball in Tripoli, lettera firmata da «Un gruppo di appassionati», «La
Nuova Italia», 1 ottobre 1924.
9
Campionato Calcio 1929, «L’Avvenire di Tripoli», 19 gennaio 1929.
10
Nel 1928 si corre già la sesta edizione del Giro podistico di Tripoli con ben 50 concorrenti
iscritti («L’Avvenire di Tripoli», 9 ottobre e 5 novembre 1928).
11
Che poi verranno annullate per l’ennesima volta e mai più riproposte. Cfr. B. DEVILLEDANTHU, La dernière bataille de Pierre de Coubertin: la conquête sportive de l’Afrique, in L’Empire
du sport Amarom, Aix en Provence 1992.
12
A.G. TEODORO, A proposito di cultura fisica,«L’Avvenire di Tripoli», 10 maggio 1928 e
soprattutto ENZO FORCELLINI, Sport e Colonie, «Illustrazione Coloniale», luglio 1928. Forcellini
era favorevole al coinvolgimento degli atleti di colore delle colonie e seguiva con interesse nella
sua rubrica le loro prime affermazioni nelle competizioni sportive internazionali.
13
Società ginnastica,«L’Avvenire di Tripoli», 1° settembre 1928.
14
Ente Sportivo Coloniale, «L’Avvenire di Tripoli», 11 settembre 1928.
15
Negli anni trenta si affiancheranno alle competizioni in pista altre manifestazioni, come il
Concorso di eleganza per pattuglie di cavalieri indigeni, al fine, come spiega l’articolista, di
«incrementare la produzione cavallina, purtroppo depauperata, ridestando tra l’elemento
indigeno spirito di emulazione e passione per l’allevamento equino»; Due importanti
manifestazioni ippiche di cavalieri a Misurata, «L’Avvenire di Tripoli», 2 giugno 1938.
16
Foot-ball, «La Nuova Italia», 12 ottobre 1924 e Il campionato di Calcio, «L’Avvenire di Tripoli»,
29 gennaio 1929.
17
La serata pugilistica alla Fiera, «L’Avvenire di Tripoli», 6 aprile 1928.
18
«L’Avvenire di Tripoli», 11 e 21 settembre 1928.
19
«L’Avvenire di Tripoli», 20 settembre 1930.
20
«L’Avvenire di Tripoli», 28 agosto 1930.
21
«L’Avvenire di Tripoli», 8 ottobre 1930.
22
«L’Avvenire di Tripoli», 26 novembre e 9 dicembre 1930.
23
«L’Avvenire di Tripoli», 21 gennaio, 11 febbraio 1933.
24
RENZO DE FELICE, Ebrei in un paese arabo, il Mulino, Bologna 1978, p. 188.
25
Un anno di attività dell’U[nione] S[portiva] T[ripolina], «L’Avvenire di Tripoli», 7 dicembre
1936.
132
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo
26
SANTO DI GAETANO, La partecipazione di squadre indigene alla prossima 2a coppa motociclistica
della federazione fascista, «L’Avvenire di Tripoli», 9 luglio1936.
27
Ibid.
28
SANTO DI GAETANO, Pugilato in colonia, «L’Avvenire di Tripoli», 27 agosto 1936.
29
GIORGIO ROCHAT, Italo Balbo, UTET, Torino 1986, p. 262.
30
ITALO BALBO, La politica sociale fascista verso gli arabi della Libia, relazione al Convegno
Volta del 1938, «L’Avvenire di Tripoli», 13 ottobre 1938.
31
«L’Avvenire di Tripoli», passim, luglio 1936.
32
«L’Avvenire di Tripoli», 9 luglio e 5 agosto 1936. Altro caso sospetto riguarda il pugile
professionista Fecti Alì che nel 1937 dovrebbe combattere con il siciliano Praticò invitato
nella colonia; pochi giorni prima dell’incontro però il giornale comunica che «avversario di
Praticò doveva essere il negretto Fecti Alì, ma ragioni varie hanno consigliato di sostituirlo con
l’aitante Licari Mariano», «L’Avvenire di Tripoli», 31 agosto 1937.
33
Lettera di A. Lessona a I. Balbo, 16 aprile 1937, Archivio Storico Diplomatico Ministero
Affari Esteri, Archivio Storico Ministero Africa Italiana, Gabinetto, b. 70, fasc. Problema razza.
34
Lettera di I. Balbo a A. Lessona, 17 aprile 1937, ivi.
35
«L’Avvenire di Tripoli», 11 e 12 gennaio 1938; inoltre la squadra dell’Ust comprendeva due
calciatori arabi.
36
I Campionati pugilistici della Tripolitania, «L’Avvenire di Tripoli», 8 ottobre 1937.
37
UST-Maccabei allo stadio Littorio, «L’Avvenire di Tripoli», 16 aprile 1938; nell’articolo si
parla di «perfetta efficienza della squadra israelita la quale pur non potendo partecipare al
campionato è allenata convenientemente».
38
Sulle manifestazioni di nuoto: «L’Avvenire di Tripoli», 17 e 31 luglio, 7, 14, 19, 20, 21, 30
agosto. Sciami Mohamed, ranista arabo, verrà invece selezionato nella formazione libica che
partecipa alla Coppa Marcello, un torneo con la finale nazionale in settembre in Italia; ciò
mentre nel regno le persone di colore venivano censite e rimandate in colonia per effetto della
campagna razziale; cfr. G. GABRIELLI, Africani in Italia negli anni del razzismo di Stato, in Nel
nome della razza, a cura di Alberto Burgio, il Mulino, Bologna 1999.
39
Si chiedono notizie del Campionato Tripolino di calcio «L’Avvenire di Tripoli», 10 giugno
1938.
40
Direttorio XIX Zona, Comunicato n. 21, «L’Avvenire di Tripoli», 15 giugno 1938.
41
Il campionato di 1a divisione, «L’Avvenire di Tripoli», 7 ottobre 1938.
133
Gianluca Gabrielli
42
I prossimi campionati di calcio tripolini di Prima e Seconda Divisione., «L’Avvenire di Tripoli»,
14 ottobre 1938. Risultano poi iscritte in prima divisione Guf, USst, Dopolavoro, Sabauda e
in seconda divisione sabauda B, sabauda C e Gil mentre non si hanno più informazioni
sull’ipotizzato campionato indigeno. Il regolamento del campionato ragazzi viene aperto ai
«giovani di cittadinanza italiana» (L’attività calcistica tripolina. «Campionato ragazzi», «L’Avvenire
di Tripoli», 24 novembre 1938).
43
R. DE FELICE, Ebrei in un paese arabo cit., p. 271.
44
Ad esempio Sahab ben Mabruk vince di breve misura la corsa podistica Mehari-Castello,
«L’Avvenire di Tripoli», 23 settembre 1938; cfr. inoltre 10 ottobre e 25 dicembre 1938, 14
marzo e 4 aprile 1939. È significativo notare che l’attività mista continuò nonostante le
federazioni sportive avessero introdotto sul finire del 1938 la discriminante ariana nei
regolamenti.
45
La forte Sabauda incontrerà oggi la rinnovata squadra della G.A.L., «L’Avvenire di Tripoli»,
2 aprile 1939.
46
Aviazione Mhaella batte GAL II per 4 a 1,«L’Avvenire di Tripoli», 26 marzo 1940.
47
A. M., L’attività sportiva in Somalia nel 1932, «Corriere della Somalia», 3, 4, 5 gennaio
1933. Commissario sportivo è il rag. Balis.
48
«Corriere della Somalia», 1 e 6 gennaio 1933.
49
«Il quotidiano eritreo», 15 gennaio 1933.
50
«Il quotidiano eritreo», 12 marzo, 18 aprile, 14 ottobre 1933.
51
A. CATONI, Una squadra di marciatori compie brillantemente il percorso Asmara-Adi Ugri, «Il
quotidiano eritreo», 24 ottobre 1933.
52
Su «Illustrazione Coloniale» di settembre 1928 erano segnalate manifestazioni sportive cui
avevano partecipato ascari eritrei. Le prove erano previste «con adattamenti particolari alla
mentalità indigena» (p. 398). È probabile che l’attività fisica degli ascari sia continuata con
funzione di preparazione militare ma non sia stata riproposta in manifestazioni pubbliche.
Una futura verifica negli archivi delle Forze Armate potrà fornire un quadro più completo
sull’argomento.
53
«Il quotidiano eritreo», 18 aprile 1933.
54
S. R[UELLA], Il calcio fra gli indigeni. Amaruini batte deposito fanteria 2-1 (0-1), «Somalia
sportiva», 2 novembre 1937.
55
STEFANO RUELLA, «Corriere della Somalia», 3, 17 gennaio, 7 febbraio, 8 agosto 1938, 28
agosto 1939.
56
ENZO PASCARELLA, Attività sportiva a Baidoa, «Corriere della Somalia», 27 dicembre 1937.
134
L’attività sportiva nelle colonie italiane durante il fascismo
57
Ufficio Sportivo Federale, Ritornello: «...le cose a posto!», «Corriere della Somalia», 19 agosto
1938; l’articolo con cui si polemizza è di EMANUELE GHIRONI, Attività Somala, «Il Pugilatore»,
n. 40, 28 luglio 1938.
58
«Corriere della Somalia», 15 novembre 1937 e 23 maggio 1938.
59
«Corriere della Somalia», 14 febbraio 1938.
60
Norme per il pubblico, «Corriere della Somalia», 15 agosto 1938.
61
«Corriere eritreo», 5 gennaio 1939.
62
«Corriere eritreo», 28 ottobre 1939.
63
«Corriere eritreo», 5 dicembre 1939.
64
CARLO GARBIERI, Rassegna generale sportiva dello Scioa, «Il Lunedì dell’Impero», settimanale
illustrato del «Corriere dell’Impero», 7 agosto 1939.
65
«Il Lunedì dell’Impero», 7 novembre 1938.
66
Il Segretario del Partito riceve il dirigente del Coni nell’Impero, «L’Azione coloniale», 2 febbraio
1939.
67
«Il Lunedì dell’Impero», 19 giugno e 25 settembre 1939.
68
Lettera [di Teruzzi] a Starace, Roma, luglio 1939, Ministero Affari Esteri, Archivio Storico
Ministero dell’Africa Italiana, Direzione Generale Affari Politici, 1937-1942, b. 92, fasc. PnfAssociazioni in AOI, 1939-40; la lettera effettivamente spedita, non conservata nel fascicolo,
conteneva «leggere varianti», come si legge nell’appunto manoscritto.
69
Ecco le zebre dello Scioa, «L’Azione coloniale», 7 marzo 1940, cit. in La menzogna della razza,
Grafis, Bologna 1994, p. 295.
70
«L’Azione coloniale», 15 febbraio 1940.
71
I risultati della polisportiva per indigeni, «Corriere dell’Impero», 13 giugno 1939.
72
Calcio che passione anche in Africa!..., «L’Azione coloniale», 7 marzo 1940.
73
Le informazioni sono tratte dalle cronache in «Corriere dell’Impero», 13 giugno 1939 e «Il
Lunedì dell’Impero», 19, 26 giugno, 3, 31 luglio, 7 agosto 1939. Inoltre altre cronache
dattiloscritte sono in Ministero Affari Esteri, Archivio Storico Ministero dell’Africa Italiana,
Direzione Generale Affari Politici, 1937-1942, b. 92, fasc. Pnf - Associazioni in AOI, 1939-40.
Alcune immagini anonime degli atleti impegnati in queste gare e delle premiazioni in Addis
Abeba. Manifestazioni sportive dei nativi, «Etiopia latina», III, 9, 1939, p. 27.
135
Gianluca Gabrielli
74
Lettera di Teruzzi al Segretario del Pnf, Roma, 17 agosto 1939, Ministero Affari Esteri,
Archivio Storico Ministero dell’Africa Italiana, Direzione Generale Affari Politici, 1937-1942,
b. 92, fasc. Pnf - Associazioni in AOI, 1939-40. Nella bozza della stessa lettera si chiariva che
la preparazione intellettuale degli indigeni, che rimaneva compito degli insegnanti delle scuole
governative e delle missioni cattoliche, doveva «essere intonata alle necessità e alle tradizioni
dell’ambiente e tenersi lontana da ogni concetto di europeizzazione, in conformità con i principi
razziali», [Teruzzi] a Starace, Roma, luglio 1939, cit.
75
Teruzzi al Segretario del Pnf, Roma, 17 agosto 1939, cit.
76
Ibid.
77
Cfr. Pnf, Foglio di disposizioni n. 1411, 17 settembre 1939.
78
Sull’«insensibilità dei negri» ecco come si esprime l’antropologo razzista Lidio Cipriani: «i
Negri […] impressionarono talvolta gli osservatori per la resistenza al dolore fisico, benché il
fatto dipenda forse ad una tendenza a dare reazioni psichiche poco vivaci a certi stimoli intensi
anziché da una ridotta acuità sensoriale», L. CIPRIANI, Considerazioni sopra il passato e l’avvenire
delle popolazioni africane, Bemporad, Firenze 1932, p. 114.
79
EMANUELA AUDISIO, Fast Usa, l’ora dei record, «la Repubblica», 22 agosto1999.
136
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
L’Algeria di Alexis de Tocqueville.
Soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
di Domenico Letterio
Il corpo di scritti in cui Alexis de Tocqueville si confronta con l’esperienza
coloniale francese in Algeria non ha mai suscitato, tra gli studiosi della sua
opera, un vivo interesse. Se si fa eccezione per la comparsa di un volume
delle Œuvres Complètes ad essi in buona parte dedicato (1962) e per un
celebre articolo di Melvin Richter del 1963, è solo negli ultimi anni che
pare possibile rinvenire le tracce di una letteratura che li tenga in qualche
considerazione1. La rinnovata attenzione per questi interventi è andata di
pari passo a una crescita dell’interesse nei confronti di altri scritti
tocquevilliani «secondari», come quelli sulla politica estera francese e quelli
sul carcere. Si tratta di un fenomeno che sembra dare vita ad una complessiva
revisione delle tassonomie che, nella storia del pensiero politico, hanno
inchiodato il pensatore francese a un ruolo di mero idolo di una tradizione
democratico-liberale da contrapporre a Marx e alle filosofie marxiste2.
Gli scritti sull’Algeria assumono in questo contesto una particolare
rilevanza, dal momento che sembrano rinviare a un’immagine di Tocqueville
assai distante da quella usuale. Un’immagine che poco spazio lascia alla
conciliante figura dell’attento osservatore delle società democratiche e dei
pericoli per la libertà che in esse albergano. Nelle riflessioni sull’Algeria, in
particolare, è possibile individuare un insieme di vettori teorici che,
considerati nel complesso del pensiero politico tocquevilliano, paiono
orientati in direzioni quantomeno divergenti, per non dire opposte. È allora
la sfida posta da questa complessità a rendere insufficienti i pur suggestivi
tentativi di giustapporre le sue riflessioni «illuminate» e quelle più
sorprendenti sui metodi spietati da utilizzare con gli algerini, tentativi volti
a testimoniare una supposta incoerenza o contraddittorietà del pensiero di
Tocqueville3. Quasi a voler suggerire, in modo quantomeno semplicistico,
che il «vero» pensiero tocquevilliano sia quello imperiale, mentre il resto
non costituisca altro che una copertura ideologica. O al contrario, da parte
dei suoi più strenui difensori, che gli scritti di Tocqueville sulle colonie
137
Domenico Letterio
altro non siano che un «incidente di percorso» dettato dal clima intellettuale
dell’epoca. In entrambi i casi, l’unica preoccupazione sembra essere quella
di un giudizio definitivo sull’eredità intellettuale di Tocqueville, nel tentativo
di capire dove egli abbia sbagliato, dove sia in contraddizione, cosa si debba
conservare e cosa rigettare della sua riflessione.
Entrambi gli atteggiamenti sono di scarsa utilità a chi cerchi tra le righe
del discorso tocquevilliano una chiave di lettura per il presente. Se
un’attenzione filologica ai frammenti sull’Algeria può senz’altro costituire
un elemento utile alla ricostruzione della sua biografia, un’analisi che
pretenda di entrare nel merito politico delle affermazioni di Tocqueville
deve necessariamente andare al di là di una loro semplice ricomposizione.
Essa, in particolare, deve spingersi ad indagare nella filigrana del suo discorso
tanto la logica intrinseca quanto gli squilibri di alcune delle categorie
fondamentali del suo pensiero.
I. Rileggere gli scritti algerini di Tocqueville significa tornare a indagare
un episodio tra i più significativi del «progetto coloniale dell’occidente»4.
Si tratta di una vicenda complessa se è vero che, come ha osservato
Abdelmalek Sayad, essa ha dato vita a un «rapporto passionale» tra ex colonia
e metropoli5. Un rapporto drammaticamente segnato tanto dalla violenza
materiale del dominio coloniale quanto da una violenza epistemica che ha
investito lo stesso nazionalismo algerino, il quale, nel combattere lo Stato
colonizzatore, ha finito per conformarsi all’ordine da esso imposto,
ereditandone la familiarità all’uso di una violenza alienante6. Le radicali
critiche a esso mosse da Sayad tracciano così un solco all’interno del quale
è necessario costringere ogni riflessione sull’Algeria contemporanea, al fine
di evitare una lettura estetizzante di un nazionalismo che ha teso ad accettare
la perimetrazione dello spazio discorsivo violentemente imposta dal
colonialismo. Tenendo fermo tale punto, è tuttavia lo stesso Sayad a ricordare
che «non è esistito alcun popolo al mondo che sia stato privato della politica
quanto il popolo algerino il quale non ha mai avuto la possibilità di
partecipare, anche solo in minima parte, al suo destino politico»7. È a partire
dal riconoscimento di ciò che si ravvisa la necessità di un’indagine che si
faccia carico di una profonda interrogazione sulle modalità attraverso le
quali la storia della colonizzazione francese in Algeria è stata narrata.
La posizione marginale cui il lavorio critico sull’opera tocquevilliana ha
consegnato gli scritti algerini rivela una delle modalità con le quali, dal
138
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
corpo delle narrazioni che formano la trama della «modernità» occidentale,
sono progressivamente espunti gli elementi che ne interrompono lo
svolgimento lineare. Se gli studi tocquevilliani «classici» si inseriscono
appieno in quel complesso di narrazioni, sia pur indicandone punti di rottura
e limiti intrinseci, il buio in cui sono sprofondati gli scritti sul colonialismo
testimonia di come tale tema ne costituisca il rimosso. Essi vanno a costituire
il lato oscuro di una specifica forma di «modernità», per la quale il
colonialismo è semplicemente una non-questione. L’aver cancellato il fatto
che Tocqueville abbia diffusamente scritto sull’Algeria rientra nel topos che,
nelle parole di Paul Gilroy, vede in esperienze come quelle del colonialismo
e della schiavitù «un residuo premoderno che scompare ogni volta che si
rivela fondamentalmente incompatibile con la razionalità illuminata e con
la produzione industriale capitalistica»8. Un’incompatibilità costruita in
modo tale da oscurare tanto i meccanismi attraverso i quali la definizione
di «modernità» prende corpo quanto le modalità di appropriazione del potere
di produrla. Si tratta di una rimozione nella quale sono coinvolte questioni
che investono nella sua interezza l’eredità politica e culturale dell’Occidente,
e disconosciuti nodi costitutivi della sua stessa autocomprensione. Ad essa
sembra allora necessario rispondere con le parole di Dipesh Chakrabarty,
secondo il quale bisogna oggi «inscrivere nella storia della modernità le
ambivalenze, le contraddizioni, l’uso della forza, le tragedie e ironie che la
riguardano»9. Per questo motivo, gli scritti coloniali di Tocqueville meritano
molta più attenzione di quanta ne sia mai stata loro riservata.
II. Abituato a considerare quella di Tocqueville una delle più alte
prestazioni del pensiero politico liberale, l’ammiratore della Democrazia in
America non può non rimanere sorpreso nella lettura degli scritti algerini.
Essi, come hanno osservato Chevallier e Jardin, «mettono a nudo nella sua
riflessione certi tratti politici che inquietano l’idealista e rassicurano il
realista»10.
La prima comparsa dell’Algeria tra le pagine tocquevilliane risale
all’ottobre 182811. Ciò avviene in una lettera indirizzata a Kergolay nella
quale Tocqueville, riferendosi alla serie di episodi che fecero seguito al famoso
«colpo di ventaglio» del dey di Algeri Hussein, auspicava che una soluzione
militare ponesse fine a «cette ridicule affaire»12. Tale episodio, per lungo
tempo considerato l’antefatto dell’invasione del 1830, si incaricò di oscurare
nella storiografia sulla conquista francese i piani del governo ultra del principe
139
Domenico Letterio
di Polignac. Questi nutriva infatti l’ambizione di consolidare l’influenza
della Francia nell’Africa mediterranea occidentale, in modo tale da aprire
i mercati della regione ad un’industria francese in forte crescita. La ricerca
di una brillante vittoria all’esterno e la necessità di blindare l’opposizione
interna costituirono dunque il motivo principale di una proiezione al di
là del Mediterraneo13. La rivoluzione di luglio rovesciò tuttavia Carlo X
pochi giorni dopo la firma della resa da parte del dey, avvenuta il 5 luglio
del 1830, e il suo successivo esilio. Fu quindi Luigi Filippo, nei diciotto
anni del suo regno, a porre le fondamenta del dominio francese in Algeria.
I moderati entusiasmi che accompagnarono la presa di Algeri non parvero
interessare il giovane Tocqueville. Nonostante un carteggio con Kergolay,
risalente all’autunno del 1833, testimoniasse di un interessamento per un
eventuale acquisto di terre nella Mitidja o nel Sahel, fu tuttavia necessario
attendere altri quattro anni perché l’attenzione per il paese africano si
manifestasse chiaramente. Risalgono infatti all’estate del 1837, quindi al
periodo che intercorre tra la pubblicazione della prima e quella della seconda
edizione della Democrazia in America14, le sue prime riflessioni sull’oramai
avviata avventura francese in Africa. Esse prendono corpo in due scritti
oggi noti come Lettres sur l’Algérie, pubblicati il 23 giugno e il 22 agosto in
un modesto settimanale di Versailles di cui Tocqueville stesso era azionista,
la Presse de Seine-et-Oise. Tali articoli costituivano il biglietto da visita con il
quale egli si candidava deputato nella circoscrizione di Versailles. Nonostante
un insuccesso nelle elezioni fece tardare di due anni l’ingresso di Tocqueville
nella vita pubblica francese, la scelta di scrivere dell’Algeria testimonia la
crescente importanza di una questione che cominciava a essere
costantemente presente nei dibattiti che interessavano l’opinione pubblica
francese.
III. Il processo di colonizzazione aveva preso spontaneamente avvio negli
anni immediatamente successivi alla presa di Algeri, in modo confuso e
senza alcuna specifica direttiva da parte del governo francese. È solo del
1834 l’ordinanza che istituì la carica di governatore ufficiale dei possedimenti
francesi dell’Africa del Nord, mentre i dibattiti parlamentari sulle modalità
di colonizzazione andarono avanti per lungo tempo. In quegli anni le pianure
più fertili dell’Algeria cominciarono a popolarsi di colons en guants jaunes,
così chiamati perché provenienti per lo più dalle file dei legittimisti. Ma
furono anche anni in cui cominciarono a manifestarsi le difficoltà di una
140
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
dominazione che la relativa facilità della presa di Algeri aveva fatto credere
assai meno complessa di quanto non tardò a rivelarsi. L’estromissione di
Hussein non aveva infatti in alcun modo significato la sottomissione del
paese. L’Algeria, entità ampiamente autonoma in un Impero Ottomano in
inesorabile declino, era posta sotto l’autorità del dey, costituzionalmente e
territorialmente incerta, resa per di più instabile dalla feudalizzazione del
potere e da intromissioni di tipo coloniale già da tempo in corso. La
capitolazione della reggenza non fece altro che sfasciare l’ossatura della sua
amministrazione, portando alla luce la natura scarsamente strutturata del
potere. Era dunque complesso lo scenario di fronte al quale si trovarono i
generali di Luigi Filippo. La conquista si diramò in numerose direzioni
senza alcun progetto unitario, con le forze francesi che si dissanguavano su
tutti i fronti e in particolare nelle regioni più impervie della Cabilia.
È a partire da queste vicende che iniziò a prendere corpo quella dialettica
di fondo tra dominazione e resistenza che avrebbe costituito la trama
continua delle relazioni coloniali. L’opposizione alla penetrazione francese
andava organizzandosi attorno ad Ahmed ibn Mohammed, nella regione
di Costantina, e al giovanissimo emiro Abd el-Kader, nell’Oranese. Questi,
in particolare, fu in grado di organizzare un esercito regolare composto da
truppe abili tanto nelle pratiche di logoramento quanto negli attacchi rapidi.
In lui Tocqueville riconobbe uno
spirito evidentemente della specie più rara e pericolosa, miscuglio di entusiasmo sincero
e di entusiasmo finto, sorta di Cromwell musulmano15.
Abd el-Kader si rivelò presto capace di riunire attorno a sé popolazioni
assai eterogenee, associando alla lotta contro gli invasori un incessante
scontro con i rivali interni. Egli si mostrò così in grado di limitare le forze
centrifughe allargando e consolidando le basi del proprio potere.
Se lo stereotipo di un Abd el-Kader «inventato» dai francesi non fa che
re-inscrivere modalità di narrazione storica che elidono la soggettività politica
della resistenza algerina, è tuttavia innegabile che i francesi fossero alla ricerca
di un simile avversario. Egli, infatti, sembrava essere l’unico capace di ridurre
una complessità che loro non sarebbero stati altrimenti in grado di governare.
È all’interno di questo quadro che si inscrivono gli accordi sottoscritti da
Abd el-Kader e dal generale Bugeaud con il Trattato della Tafna del 30
maggio 1837, con il quale i francesi riconobbero all’emiro la posizione
dominante che egli si era conquistato nel paese.
141
Domenico Letterio
IV. All’indomani del Trattato della Tafna furono pubblicate le due Lettres
sur l’Algérie. In esse Tocqueville si mostrava preoccupato per il
riconoscimento accordato ad Abd-el Kader, divenuto interlocutore unico
dei francesi, e prefigurava le linee lungo le quali avrebbe sviluppato, nei
dieci anni successivi, la propria riflessione sull’esperienza coloniale francese.
Egli considerava la resistenza algerina un residuo che non avrebbe tardato a
essere domato, e si poneva così in primo luogo il problema del governo.
Osservò infatti:
Dopo il combattimento, non tardiamo a scoprire che non è sufficiente, per governare
una nazione, averla vinta16.
Il più grosso errore compiuto dai francesi fu, a questo proposito, l’aver
fatto tabula rasa del precedente ordinamento turco che, per quanto precario,
avrebbe potuto costituire uno strumento utile al dominio sugli «indigeni».
I quadri della precedente amministrazione, così come le istituzioni culturali
e religiose tradizionali, erano agli occhi di Tocqueville essenziali al fine di
mantenere una qualche presa sulle popolazioni sottomesse. È a partire da
questi elementi che Tocqueville tracciò quelle che avrebbero dovuto essere,
a suo parere, le direttrici della politica coloniale. Egli riteneva anzitutto
necessario ottenere il controllo dell’intero paese, mirando tuttavia a una
colonizzazione ristretta da parte di emigranti francesi. Considerava
importante, nel rapporto con i cabili, sviluppare relazioni commerciali e
limitare la tentazione di sottometterli militarmente, dal momento che,
proprio in Cabila, i generali francesi stavano incontrando le maggiori
difficoltà. Infine egli si mostrava favorevole all’adozione di una strategia di
divide et impera, che consentisse di dominare le popolazioni algerine
lasciandole al tempo stesso vivere sotto le loro leggi.
In chiusura del secondo articolo, Tocqueville si mostrava convinto del
fatto che in Algeria fosse possibile, nel lungo periodo, una fusione della
popolazione autoctona con quella di coloni sempre più numerosi sulle sue
coste. A suo giudizio, non vi erano
ragioni di credere che il tempo non possa riuscire ad amalgamare le due razze. Dio
non lo impedisce certo, e solo gli errori degli uomini potrebbero mettervi un ostacolo17.
Sono parole, queste, perfettamente in linea con l’immagine prevalente
di Tocqueville. In esse sembra prefigurato l’uomo che si indignerà, nel
142
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
rapporto epistolare con Gobineau, nel confrontarsi con la tesi della negazione
dell’unità della razza umana18. Tali affermazioni sembrano inoltre entrare
in risonanza con quanto egli era andato affermando nel corso del suo viaggio
in Canada, durante il quale aveva dichiarato:
Non sono mai stato più convinto che la più grande e irrimediabile sventura per un
popolo sia quella di essere conquistato19.
V. A cavallo tra il 1840 e il 1843, Tocqueville si interessò alla storia
dell’impero inglese in India20. Si tratta di una curiosità senz’altro episodica,
una sorta di entr’acte nella sua carriera politica. Ugualmente episodico fu il
suo interesse per un’altra vicenda che riproduceva l’eterna questione del
rapporto tra razza conquistatrice e razza sottomessa, quello dell’abolizione
della schiavitù nelle Antille francesi21. L’emergere di tali tematiche nella sua
riflessione è sintomatico di tutto un complesso di questioni sulle quali egli
andava in quegli anni interrogandosi.
L’interesse di Tocqueville per l’India si manifestò per la prima volta in
una lettera ad Ampère, nella quale egli, ignorando pressoché totalmente la
storia del paese e manifestando il vivo desiderio di informarsi, chiedeva
suggerimenti bibliografici all’amico22. Nel periodo che seguì Tocqueville
lesse pressappoco tutti i principali lavori al tempo disponibili, arrivando a
progettare il piano di un’opera sul subcontinente23. Il paese asiatico continuò
a ricorrere spesso nella sua corrispondenza del 1843, per poi scomparire
definitivamente a partire dall’anno successivo. Tocqueville interruppe
ogni progetto avviato sul tema, ma solo alcuni anni più tardi, in una
lettera del novembre 1847 a Lord Hatherton, diede una giustificazione
dell’interruzione: la rinuncia a scrivere dell’India era direttamente collegata
all’impossibilità di visitare il paese24.
La frammentarietà degli appunti non impedisce l’individuazione, nelle
pagine dedicate all’India, degli elementi che più suscitavano l’attenzione di
Tocqueville. Particolarmente rilevante era il fatto che fosse egli stesso a
riconoscere il valore paradigmatico dell’esperienza coloniale inglese per una
nazione, la Francia, che da ormai dieci anni tentava di avere la meglio sulla
tenace resistenza algerina. Scrisse infatti Tocqueville:
Non c’è niente che in Francia sia meno noto delle cause che hanno prodotto e che
sostengono lo straordinario potere degli inglesi in India. Questo argomento, che è
143
Domenico Letterio
stato interessante in tutti i tempi, lo è in maniera straordinaria ora che tutte le grandi
questioni europee si incentrano in Africa. Lo è in maniera particolare per noi, dal
momento che possediamo la colonia d’Algeria25.
Nelle pagine sull’India, centrali risultano i temi del governo e
dell’amministrazione di una «società pietrificata»26, così come il ruolo svolto
dalla Compagnia. Ciò che più colpisce, a una prima lettura, è tuttavia
l’emergere di una smisurata ammirazione per quanto gli inglesi erano riusciti
a fare in quel lontano continente:
Un paese vasto quasi quanto l’Europa‘è stato conquistato nello spazio di sessanta anni
da qualche migliaio di europei sbarcati come mercanti sulle sue rive. Trentamila stranieri
governano cento milioni di uomini che per leggi, religione, lingua e usi non hanno
alcun punto di contatto con loro27.
Sono riflessioni nelle quali è difficile non sentir risuonare le Considérations
sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence di Montesquieu28,
e che costituiscono l’esatto speculare, invertito di segno, del timore
tocquevilliano che la Francia, a partire dal 1815, fosse destinata a un futuro
di inarrestabile declino. È un timore, questo, centrale nelle modalità con le
quali Tocqueville visse la politica di quegli anni, esplicitato per esempio in
un intervento di Tocqueville sulla questione d’Oriente, da egli stesso definita
la «questione del secolo»:
Una nazione che lascia fare senza di sé la più grande cosa del secolo, cade al secondo
rango, una nazione che si contenta di non perdere ma lascia i propri vicini accrescere
prodigiosamente la loro forza, finisce per trovarsene alle dipendenze29.
Dal tema della decadenza francese presero le mosse molti degli argomenti
tocquevilliani sulla necessità della conquista algerina. Una necessità piuttosto
comprensibile se era vero che il Mediterraneo, come Tocqueville stesso
andava scrivendo, era il «mare politico dei nostri giorni»30.
VI. L’interesse per l’Algeria generò presto in Tocqueville il vivo desiderio
di compiere un viaggio nel paese31. Se l’idea iniziale era quella di partire
con Beaumont nel settembre 1840, la crisi d’Oriente lo obbligò a rinviare
di un anno il suo progetto. Quello in Algeria è un viaggio che, come suo
solito, Tocqueville preparò plume à la main. Avventuratosi già nel corso del
144
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
1838 tra le pagine del Corano, egli non si preoccupò di smussare gli angoli
nell’esprimere le convinzioni cui era pervenuto:
Sono emerso con la convinzione che nel complesso, nel mondo, ci fossero poche
religioni altrettanto funeste agli uomini quanto quella di Maometto. Essa è, a mio
avviso, la principale causa della decadenza oggi così evidente nel mondo musulmano
e, per quanto meno assurda del politeismo antico, dal momento che a mio modo di
vedere le sue tendenze sociali e politiche sono infinitamente più temibili, la considero,
rispetto allo stesso paganesimo, una decadenza piuttosto che un progresso32.
In questo come in altri passi Tocqueville si mostrava ardentemente
convinto della superiorità della «civilizzazione occidentale e cristiana» su
tutte le altre. È una convinzione che egli sarebbe andato rafforzando nel
tempo, e che fu in grado di esprimere nel modo più vigoroso quando, in un
intervento parlamentare nel febbraio 1847 sul dominio francese in Algeria,
dichiarò:
La popolazione europea è giunta; la società civilizzata e cristiana è fondata33.
Tocqueville e Beaumont partirono da Tolone il 4 maggio 1841, per un
viaggio che sarebbe durato poco più di un mese. Un periodo in cui alcune
terribili crisi di dissenteria costrinsero Tocqueville per lungo tempo a letto,
precipitando le sue grandi aspettative in poche conversazioni con marinai e
militari e in cinque giorni di modesti incontri ad Algeri34. Se quello che
giunse in Africa era un «viaggiatore prevenuto»35, lo sfortunato esito del
viaggio non poté incidere significativamente sulle opinioni che Tocqueville
era andato maturando in anni di letture. Nei suoi scritti successivi si trovano
infatti largamente confermate le impressioni che egli aveva portato con sé
nell’attraversamento del Mediterraneo.
Nell’ottobre del 1841, fatto ritorno in Francia, Tocqueville diede corpo
a un lungo scritto, poi divenuto noto come Travail sur l’Algérie36. Si tratta
di un lavoro non destinato alla pubblicazione, cui egli scelse di dedicarsi
per fissare gli elementi principali del proprio pensiero su ciò che aveva
conosciuto della colonizzazione francese. Sono sostanzialmente tre i nuclei
concettuali che sembra possibile individuare all’interno del Travail. Il primo
di essi consiste in una serie di considerazioni di ordine strategico, dalle
quali traspare tutta l’angoscia che veniva a Tocqueville dal progressivo
profilarsi di una situazione in cui la Francia avrebbe potuto essere
definitivamente declassata a un ruolo di potenza di «second rang». Sono
145
Domenico Letterio
riflessioni che richiamano quelle cui già si è fatto accenno ma che assumono,
alla luce della cocente umiliazione subita nella soluzione della crisi
d’Oriente37, un accento particolarmente drammatico:
Non credo che la Francia possa pensare seriamente ad abbandonare l’Algeria.
L’abbandono che ne farebbe sarebbe, agli occhi del mondo, l’annuncio certo della sua
decadenza. […] Se la Francia indietreggiasse di fronte a un’impresa in cui si trova di
fronte soltanto le difficoltà naturale del paese e l’opposizione delle piccole tribù barbare
che lo abitano, essa sembrerebbe, agli occhi del mondo, piegarsi sotto la propria
impotenza e soccombere per la propria mancanza di coraggio. Ogni popolo che
abbandona senza difficoltà ciò che ha conquistato e si ritira tranquillamente da sé nei
propri vecchi confini, proclama che i bei tempi della propria storia sono passati. Entra
evidentemente nel periodo del proprio declino38.
Il tema del dominio coloniale chiama necessariamente a sé quello dei
mezzi da utilizzare per assicurarsi una salda presa sugli «indigeni». È questo
il secondo argomento del Travail. Tocqueville puntava dritto al nodo della
questione, sostenendo che non si dovesse in alcun modo rinunciare all’uso
di qualunque strumento utile alla distruzione della potenza di Abd el-Kader.
È difficile non rimanere sorpresi nella lettura delle parole scritte su questo
punto:
In Francia ho sempre sentito uomini che rispetto, ma che non approvo, trovare
riprovevole che si brucino i raccolti, che si vuotino i silos e, infine, che ci si impadronisca
degli uomini inermi, delle donne, dei bambini. Queste cose, secondo me, sono necessità
sgradevoli, ma cui ogni popolo che voglia fare la guerra agli arabi sarà costretto a
sottomettersi39.
Se da un lato tali affermazioni mettono in luce il lato più buio,
insospettato, della riflessione tocquevilliana, dall’altro esse permettono di
tratteggiarne con notevole chiarezza la cornice teorica. In particolare se si
considera una delle sue precisazioni:
Se in Europa non si bruciano i raccolti, è perché in generale si fa la guerra ai governi e
non ai popoli. […] Si distruggerà la potenza di Abd el-Kader soltanto rendendo la
posizione delle tribù a lui soggette talmente insopportabile che esse lo abbandonino40.
Tocqueville era convinto che i francesi si trovassero di fronte a popolazioni
prive non solo di un governo, ma finanche di volontà politica e di storia: è
in questo che deve essere ricercata la matrice delle sue considerazioni. È
146
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
una convinzione, quella di Tocqueville, che trova conferma anche nell’analisi
del «sociale»:
La verità è che non esiste ancora in Africa quello che gli europei intendono per una
società. Vi sono gli uomini, ma non il corpo sociale41.
In queste riflessioni tornano le categorie e riecheggiano le tematiche che
hanno fatto grande la Democrazia in America42. Tuttavia, se le magistrali
analisi delle società francese e americana del primo Ottocento hanno reso
imperitura la fama di un Tocqueville profeta della societé nouvelle, nel caso
dell’Algeria egli non sembra mostrare una briciola dello sforzo analitico ad
esse riservato.
Il terzo tema individuabile all’interno del Travail è costituito dal rapporto
tra dominazione e colonizzazione. Questa era considerata essenziale ai fini
del mantenimento della conquista, tanto che le due dimensioni dovevano,
per Tocqueville, andare di pari passo. Egli stesso lo affermò nel modo più
chiaro possibile:
C’è gente che pensa ancora che i francesi dovrebbero limitarsi a dominare in Algeria
senza voler colonizzare. Lo studio della questione mi ha dato una opinione del tutto
opposta43.
«Dominazione totale» e «colonizzazione parziale» erano quindi elevate a
obiettivi supremi della politica algerina della Francia44.
Tali considerazioni emergevano da una profonda revisione delle
conclusioni cui egli era giunto quattro anni prima in chiusura delle Lettres.
Se allora Tocqueville aveva considerato quasi inevitabile che le popolazioni
francese e algerina sarebbero andate amalgamandosi in terra africana, dopo
il suo viaggio egli parve di avviso del tutto diverso:
La società musulmana e la società cristiana purtroppo non hanno alcun legame, […]
costituiscono due corpi giustapposti, ma completamente separati. […] La fusione di
queste due popolazioni è una chimera che si può sognare soltanto se non si è stati sul
posto. Dunque possono e debbono esserci due legislazioni molto distinte in Africa
perché vi si trovano due società ben separate45.
Il fatto di trovarsi di fronte a due società distinte poneva ai francesi l’inedita
sfida di dar vita a un governo che sapesse conciliare la presenza sul medesimo
suolo di «razza conquistatrice» e «razza conquistata». Quello dell’incontro
147
Domenico Letterio
violento tra le «razze» è un tema che torna in maniera ossessiva negli scritti di
Tocqueville. Vi si era soffermato nelle riflessioni sull’America, poi in quelle
sull’abolizione della schiavitù nelle Antille francesi e quindi nelle note
sull’India. È tuttavia evidente che, agli occhi del pensatore francese, l’Algeria
offriva il laboratorio che meglio si prestava all’osservazione del fenomeno.
VII. Persuaso del carattere eterogeneo delle due popolazioni che si
confrontavano sul territorio algerino, Tocqueville diede corpo a un registro
narrativo che le poneva su livelli diversi del continuum che costituisce la
«storia del mondo». Una storia concepita in termini lineari, che condannava
le popolazioni algerine al passato remoto o, per utilizzare le parole di
Tocqueville, alla «prima infanzia»46. Se da un lato è ovviamente difficile
parlare di una vera e propria filosofia della storia tocquevilliana, è dall’altro
evidente che la prosa dei suoi scritti riproduce sostanzialmente immutate
delle strutture temporali ben radicate nell’autocomprensione storica dei
liberali del tempo47. Metafore come quelle utilizzate da Tocqueville erano
infatti largamente diffuse nelle riflessioni politiche del liberalismo tanto
francese quanto britannico, andando a plasmare tassonomie che costituirono
la trama stessa del potere coloniale. Le popolazioni extra-europee si trovavano
così sequestrate in quella che Dipesh Chakrabarty ha definito una «sala
d’aspetto della storia»48. Ma le parole di Tocqueville consentono di portare
ancora oltre la riflessione. È lui stesso, in un passaggio piuttosto defilato del
Travail sur l’Algérie, a osservare:
Avviene in questo momento, in quei paesi semiselvaggi dell’Africa, un travaglio sociale
molto simile a quello che ha avuto luogo in Europa alla fine del Medioevo. Abd elKader, che probabilmente non ha mai sentito parlare di quello che accadeva in Francia
nel secolo XV, agisce nei confronti delle tribù precisamente come i nostri re, e in
particolare Carlo VII, hanno agito contro il feudalesimo49.
Non era affatto casuale il periodo richiamato da Tocqueville nel tentativo
di trascinare Abd el-Kader e i suoi uomini all’interno di una struttura di
coordinate temporali che un francese del XIX secolo potesse riconoscere.
Le «tribù» algerine erano infatti relegate in uno stadio che la scansione
classica della storia occidentale colloca in una fase immediatamente
precedente a quella dell’età moderna. Esse vivevano quindi una struttura
temporale statica, qualitativamente diversa da quella di una modernità
europea che sola ha conosciuto la nascita del mondo storico. Se la divaricazione
148
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
tra «esperienza» e «aspettativa» che sostanzia la temporalità occidentale trova
nell’ideologia del «progresso» il principio in grado di significare lo scarto, la
costitutiva impossibilità di alcuna processualità produce, nel caso
dell’Algeria, una sostanziale sovrapposizione delle due50. Le popolazioni
algerine, nello spazio concettuale tracciato da queste coordinate, erano società
statiche, irriducibilmente altre, che entrarono nella storia solo perché alzate
di peso e trascinatevi a viva forza dall’intervento francese.
È esattamente questo intervento ad installare al centro degli argomenti
di Tocqueville il «movimento della civilizzazione»51. Egli si mostrava convinto
del fatto che il contatto tra «razza civilizzata» e «razza barbara», quantunque
avvenuto nel fragore delle armi, avrebbe segnato in modo irreversibile la
«storia del mondo». Una storia che vedeva protagonista il solo Soggetto
europeo, e che riservava ai popoli africani il ruolo di passivi beneficiari
della missione civilizzatrice.
In Africa è accaduto […] quello che accade tutte le volte che c’è un contatto, anche
attraverso la guerra, tra due razze di cui l’una è istruita e l’altra ignorante, di cui l’una
progredisce, l’altra regredisce. I grandi lavori che abbiamo già fatti in Algeria, l’esempio
delle nostre arti, delle nostre idee, della nostra potenza hanno agito potentemente
sullo spirito di quelle stesse popolazioni che ci combattono con il più grande ardore e che
respingono con la più grande energia il nostro giogo. […] In una parola, per me, è evidente
che, qualsiasi cosa accada, l’Africa è entrata nel movimento del mondo civilizzato e
non ne uscirà più52.
Pare significativo che la penna di Tocqueville si mostri incapace di passare
sotto silenzio una ambivalenza che egli non intendeva certo evidenziare.
Tanto che, nel momento stesso in cui più alto si fa l’orgoglio tocquevilliano
per quanto il suo paese andava facendo in Africa, egli sembrava costretto a
rilevare il contemporaneo emergere di una soggettività antagonista che
ovunque, nei suoi scritti, egli si diede incarico di rimuovere. Traspare quindi
da queste parole come l’ingresso dell’Africa nel «mondo civilizzato» fosse
stato meno trionfale di quanto Tocqueville non si sforzasse di farlo apparire.
Pare anzi piuttosto difficile negare quanto osservato da Giampaolo Calchi
Novati, per il quale «La conquista coloniale privò l’Algeria dei suoi più
fecondi contatti con l’Europa, perché d’ora in poi i modelli stranieri non
saranno più ricercati e assorbiti volentieri e spontaneamente ma saranno
rifuggiti come espressione di una dominazione odiosa»53.
Un’ultima osservazione può essere fatta a proposito delle strutture temporali
che talora affiorano di sottotraccia nella riflessione tocquevilliana. Facendo
149
Domenico Letterio
ricorso alle categorie con le quali il pensiero politico europeo è andato
costruendo in età moderna il concetto di «sovranità», Tocqueville osserva che
un emiro non comanda, come i re d’Europa, a individui ognuno dei quali può venire
isolatamente costretto mediante la forza sociale di cui dispone il principe, ma a tribù
che sono piccole nazioni completamente organizzate, di solito governabili soltanto
assecondandone le passioni54.
Ponendosi in continuità con la dottrina classica che vede nella sovranità
e nell’individuo i due poli di una concettualizzazione tipicamente «moderna»
del potere55, Tocqueville sottolinea ancora una volta l’inerenza della
popolazione algerina a una fase che precede il moderno. Sono allora assai
significative le modalità per mezzo delle quali Tocqueville rivela le
preoccupazioni in lui suscitate dal potere crescente del giovane emiro:
È […] molto da temere che Abd el-Kader stia fondando presso gli arabi che ci
circondano un potere più centralizzato, più agile, più forte, più sperimentato e più
stabile di tutti quelli che si sono succeduti da secoli in questa parte del mondo56.
Ciò che rendeva reale, agli occhi di Tocqueville, la minaccia di Abd
el-Kader era il fatto che egli sembrava in grado di articolare una resistenza
che dava corpo a un potere «centralizzato» e «stabile», che rispondeva a
tutti i crismi della concettualizzazione tipicamente europea della sovranità.
Il dominio francese, quindi, sarebbe stato unicamente garantito
dall’estirpazione dell’emergenza polemica di un’istanza capace di mettere
in discussione le artificiose strutture temporali che relegavano le popolazioni
algerine ai margini della storia.
VIII. L’interesse di Tocqueville per l’Algeria non si esaurì nelle pagine
scritte all’indomani del viaggio al di là del Mediterraneo. La conoscenza
sempre più approfondita del paese gli fece anzi ottenere la nomina di
membro della commissione extra-parlamentare per gli affari d’Africa, che
si riunì tra il 1842 e il 1843. All’epoca, le vicende algerine videro una crescita
esponenziale della violenza dei combattimenti, imboccando una strada che,
nel volgere di qualche anno, si sarebbe rivelata fatale ad Abd el-Kader. Gli
accordi presi nel Trattato della Tafna non furono sufficienti ad impedire
una ripresa delle ostilità, che puntualmente ricominciarono nel novembre
1839. L’esercito francese, accresciuto negli effettivi, era allora guidato dal
pugno di ferro del generale Bugeaud, giunto in Algeria in occasione della
150
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
firma del Trattato. Fu lui da allora in avanti a dirigere le operazioni nel
paese, facendo subire ad Abd el-Kader e ai suoi una serie di rovinose sconfitte.
L’interminabile serie di battaglie, intervallata dalla firma del Trattato di
Tangeri del 1844 e contraddistinta da una tenace controffensiva algerina
nell’anno successivo, si concluse definitivamente il 23 dicembre 1847,
allorché Abd el-Kader, in seguito all’ennesima disfatta, si consegnò nelle
mani del generale La Moricière.
Quella del generale Bugeaud è una figura che, come ha osservato Melvin
Richter, «merita più attenzione di quanta ne abbia fino a ora ricevuta dagli
storici francesi»57. Nonostante molte incertezze contraddistinguano la ricerca
storiografica sul suo conto, consolidato è il riconoscimento dei metodi
criminali che egli utilizzò nei confronti degli algerini. Tanto che la «razzia»,
nelle parole non solo di Bugeaud ma anche di Tocqueville, divenne una
pratica che chi osava resistere all’avanzata francese imparò presto a
conoscere58. È allora significativo che Tocqueville, se da un lato rimproverava
a Bugeaud di non aver fatto nulla per «lo stabilirsi di una società europea in
Africa», dall’altro rivendicava il fatto che egli fosse stato
il primo ad aver saputo applicare ovunque contemporaneamente quel genere di guerra
che, ai miei occhi, come anche ai suoi, è il solo genere di guerra praticabile in Africa59.
Si trattava di un «genere di guerra» che Tocqueville, come si è visto,
pretendeva capace di rendere «insopportabile» la vita agli algerini. Non è allora
un caso se, a capo delle operazioni, v’era chi si mostrava convinto del fatto che
«il solo modo di far cedere [i ribelli] è di attaccare i loro interessi: in primo
luogo le loro donne»60. Bugeaud si incaricava in questo modo di dare conferma
al fatto che, come ha osservato Bell Hooks, «la sessualità ha sempre fornito
metafore di genere alla colonizzazione. […] Gli uomini del gruppo dominante
violano sessualmente il corpo delle donne presenti nel gruppo dei dominati.
Lo scopo di tale atto è di ricordare continuamente ai maschi dominati la loro
perdita di potere; lo stupro è un gesto di castrazione simbolica»61.
È difficile pensare che a un osservatore attento come Tocqueville
potessero sfuggire le implicazioni più gravi dell’invito a un uso della violenza
come quello di cui egli si fece portatore. Così come difficile è credere che
egli non fosse venuto a conoscenza della ben nota pratica delle cosiddette
enfumades. Tale termine invalse a indicare l’uso, da parte dei generali alle
dipendenze di Bugeaud, di sterminare i «ribelli» soffocandoli con il fumo
di falò accesi all’imboccatura delle caverne in cui si rifugiavano. Inaugurate
151
Domenico Letterio
da Cavaignac nel 1842, tali pratiche continuarono sino al termine della
guerra coloniale, raggiungendo l’acme nello sterminio di centinaia di
«indigeni» ordinato da Pélisser nelle grotte di Ouled Riah. Si tratta di episodi
che vennero resi noti a Parigi suscitando vivo sconcerto. A titolo di esempio,
si ricorda la reazione di un membro della commissione d’inchiesta costituita
dal regno di Francia nel 1833, il quale dichiarò, non appena conosciuti i
fatti: «Abbiamo superato in barbarie i barbari che intendiamo civilizzare»62.
Su questo punto, tuttavia, Tocqueville tace63.
Certo fu lo stesso Tocqueville, come si è avuto modo di osservare, a
definire «necessità sgradevoli» le più discutibili pratiche poste in essere
dai generali francesi. Egli riteneva che episodi di questo genere fossero
inevitabili al fine di raggiungere quello che egli giudicava verosimilmente
un «bene maggiore», vale a dire quel movimento che legava in modo
indissolubile il prestigio per la Francia e la «civilizzazione» per paesi e
popoli che ancora non l’avevano conosciuta. Pare tuttavia quantomeno
singolare il fatto che, accanto a tali dichiarazioni, Tocqueville non
tralasciasse di mostrare la propria indignazione per la propensione
all’arbitrio e la mediocrità dei funzionari francesi. È quello che fece, per
esempio, in alcune note prese durante le letture con le quali si preparava
al viaggio del 1941. Egli lamentava il fatto che fosse stata accordata ampia
discrezionalità a un’autorità militare, cosa questa che egli riteneva «né
saggia, né umana, e neppure ragionevole»64:
È inconcepibile che, ai nostri giorni e da parte di una nazione che si definisce liberale,
si sia stabilito, vicino alla Francia e in nome della Francia, un governo così disordinato,
così tirannico, così oppressivo, così profondamente illiberale, […] così estraneo persino
alle nozioni elementari di un buon regime coloniale65.
Le preoccupazioni di Tocqueville si riferivano alla totale assenza, nella
fase embrionale di quello che sarebbe divenuto il governo coloniale
dell’Algeria, delle più elementari garanzie che lo Stato liberale avrebbe dovuto
offrire. Se si tratta certo di preoccupazioni legittime, è tuttavia curioso che
esse prendano corpo accanto a vigorose dichiarazioni di sostegno alla più
inflessibile repressione nei confronti degli «indigeni».
IX. Nel discorso del 9 giugno 1846 sugli stanziamenti straordinari per
l’Algeria, Tocqueville prese sostanzialmente atto di una svolta avvenuta nelle
vicende coloniali. Egli dichiarò infatti che la guerra «non [era] più un
152
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
pericolo»66. La violenta controffensiva che nell’anno precedente aveva
permesso ad Abd el-Kader di annientare l’avversario a Sidi-Brahim era stata
infatti arginata con successo dal generale Bugeaud. Abd el-Kader era stato
costretto alla fuga sulle montagne e ovunque le popolazioni algerine, affamate
e stremate dalla repressione francese, stavano facendo atto di sottomissione.
Venute meno le impellenti necessità militari era il momento, per Tocqueville,
di lanciare un ambizioso piano di colonizzazione67.
Con la mente rivolta a questo ordine di considerazioni Tocqueville,
nell’ottobre 1846, partì nuovamente per l’Algeria. Quello che egli stava per
intraprendere, accompagnato da Madame de Tocqueville e da alcuni colleghi
parlamentari, era un viaggio semi-ufficiale. Un viaggio che Bugeaud, nel
tentativo di nascondere almeno in parte le modalità con le quali era andato
conducendo la guerra, cercò di organizzare a tappe forzate. Ma l’ormai
noto parlamentare francese, guidato da un giornalista incontrato ad Algeri,
riuscì ad evitare gli ostacoli e a visitare i centri della colonizzazione in Mitidja
e nel Sahel.
Tocqueville trascorse tre mesi in Algeria, dedicandosi all’osservazione
delle dinamiche della prima colonizzazione agricola e delle relative forme
di organizzazione della proprietà68. La più compiuta enunciazione dei suoi
orientamenti sul tema è contenuta nel Rapport del 1847, al quale, tra l’altro,
«è fondamentalmente consegnata la reputazione di Tocqueville quale
pensatore coloniale»69. Si tratta di un insieme di due relazioni che Tocqueville
presentò al Parlamento francese in qualità di presidente della commissione
incaricata di esaminare i disegni di legge relativi agli stanziamenti straordinari
per l’Algeria e alla regolamentazione dei campi agricoli gestiti dai militari.
Se nella prima Tocqueville non mancò di sottolineare come la recente
«pacificazione» dell’Algeria avesse dato ragione alla sua visione strategica
del progetto colonialista, nella seconda si dedicò all’analisi delle condizioni
di possibilità di una colonizzazione civile, ritenuta improrogabile dal
momento che si era raggiunto l’obiettivo della «dominazione totale». Egli
riteneva necessario rigettare le ipotesi di una colonizzazione militare e creare
le condizioni perché gli Europei potessero sentirsi invogliati a emigrare in
Algeria.
Per Tocqueville, tali condizioni erano un presupposto essenziale alla
creazione di quella che nelle due relazioni, riprendendo un termine chiave
della Democrazia in America, era definita la «società nuova». Una società
nella quale si riproduceva sostanzialmente la stessa situazione che egli aveva
conosciuto negli Stati Uniti, cioè la coesistenza su di uno stesso territorio di
153
Domenico Letterio
«razza conquistatrice» e «razza sottomessa». Per la sua costruzione, non si
trattava di
dare la nascita a un popolo nuovo, con le sue leggi, i suoi usi, i suoi interessi, e presto
o tardi una sua nazionalità separata, ma di impiantare in Africa una popolazione
simile in tutto a noi stessi70.
L’obiettivo da perseguire, per Tocqueville, era quello di un’estensione della
Francia stessa al di là del Mediterraneo. Obiettivo che certo non fu raggiunto,
dal momento che l’unica conseguenza tangibile dell’intervento francese fu
uno «sconvolgimento totale della società colonizzata nel suo insieme, una
massiccia destrutturazione di tutte le unità sociali a tutti i livelli»71. È difficile
credere fosse questa la «società nuova» cui pensava Tocqueville.
X. Chevallier e Jardin hanno messo in luce l’insistente ricorrere, nel
Rapport del 1847, del concetto «neutro» di bon gouvernement. Servendosi
di tale termine, Tocqueville intendeva delineare il principio in base al quale
i francesi avrebbero dovuto improntare la loro politica in Algeria. In un
simile contesto un «buon governo» era, per Tocqueville,
un potere che dirige gli indigeni non solo nel nostro interesse, ma nel loro, che si
mostra realmente attento ai loro bisogni, che cerca con sincerità i mezzi per provvedervi,
che si preoccupa del loro benessere, che tiene presenti i loro diritti, che lavora con
ardore allo sviluppo continuo delle loro società imperfette, che non crede di aver
adempiuto al suo compito quando ne ha ottenuto la sottomissione e le imposte, che
li governa, insomma, e non si limita a sfruttarli72.
Se in un passaggio come questo è in prima battuta riconoscibile la
«liberalità» universalmente ascritta al pensatore francese, le categorie che
lo sottendono vanno a erigere la più radicale negazione di una libertà
politica intesa, tocquevillianamente, come «un fine e non soltanto uno
strumento; un bene in sé e non soltanto una garanzia»73. In esso è infatti
completamente obliterata la soggettività delle popolazioni algerine, materia
inerte e afona nelle mani della missione civilizzatrice francese. Sono
concetti che Tocqueville fu in grado di esprimere in modo piuttosto
esplicito, al di là del fatto che sia possibile scorgerli chiaramente tra le
righe del suo discorso:
154
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
Non è utile né doveroso lasciare che i nostri sudditi musulmani coltivino idee esagerate
sulla propria importanza né che si convincano che siamo obbligati a trattarli in ogni
circostanza esattamente come se fossero nostri concittadini e nostri pari74.
Nel termine francese sujets, tradotto qui con «sudditi», si annida un
coacervo di significati che premono tutti in direzione della sistematica
rimozione della soggettività politica dei colonizzati. Essi sono infatti
«soggetti» nell’accezione esclusivamente negativa del termine, cioè solo in
quanto assoggettati75. Il progetto coloniale non lascia alcun margine alla
possibilità di una apparizione dei «sudditi» come attori sulla scena della
storia, rifiutando di riconoscere i processi di soggettivazione che nella loro
presa di parola si danno. Esso disegna così uno spazio di esistenza politica
che li scaraventa a una distanza siderale da quello della cittadinanza e
mantiene continuamente operativo un movimento di rimozione del nucleo
polemico che si incarna nella resistenza da essi opposta.
XI. Il sujet che la conciliante prosa tocquevilliana tratteggia nei termini
di una silenziosa comparsa del teatro coloniale era in realtà protagonista
assoluto di una vicenda carica di conflitto. Una vicenda che andava
essenzialmente dipanandosi in una molteplicità di pratiche la cui inevitabile
eterogeneità trovava sintesi nel sentimento di radicale rifiuto del giogo
coloniale. Alla resistenza armata guidata da Abd el-Kader fece infatti seguito,
a partire dalla definitiva conquista del 1847, un continuo emergere delle
più varie pratiche di resistenza76. In particolare, come ha osservato Benjamin
Stora, «la storia dell’Algeria in quel momento è largamente quella
dell’insurrezione […] delle società di villaggio […] per conservare le loro
terre e opporsi all’espropriazione delle terre collettive da parte della
colonizzazione»77. Fino alla rivolta di El-Mokrani del 1871, che costituisce
«l’ultimo grande tentativo della popolazione rurale per prendere l’iniziativa
politica», quella algerina è una storia di continue sollevazioni e di una
resistenza endemica all’occupante78.
È allora estremamente significativo che una vicenda caratterizzata da
un tale antagonismo resista ad un’analisi che provi ad inquadrarla nelle
categorie amico/nemico notoriamente proposte da Carl Schmitt79. La
concettualizzazione dello spazio coloniale proposta da Tocqueville non
istituisce infatti alcun confine tra un «interno» ed un «esterno», ma al
contrario include violentemente i «sudditi» in una posizione subordinata,
155
Domenico Letterio
all’interno di uno spazio e di un tempo che aspirano a porsi come unitari.
Rifiutando di riconoscere in essi finanche degli «avversari», il dispositivo
messo in funzione da Tocqueville nega loro la possibilità di farsi padroni
del proprio destino politico. È quindi tale tentativo di riduzione ad uno a
costituire la trama delle relazioni tra dominatori e dominati. Questi sono
ridotti a nuda vita da un dispositivo di annullamento che si fa politico nel
momento stesso in cui nega il carattere oppositivo di quanto va prendendo
corpo al di là del Mediterraneo80.
La perimetrazione di uno spazio e di un tempo unitari tende quindi ad
oscurare insorgenze che si radicavano nel rifiuto delle condizioni materiali
di esistenza imposte dai dominatori. Tocqueville si mostrava incapace di
riconoscerne il carattere irriducibilmente politico a semplice motivo della
loro natura frammentaria e sostanzialmente priva di carattere nazionale,
caratteristiche che rendevano impossibile una loro sussunzione in categorie
che tendevano a rinvenire nello Stato la forma esclusiva del «politico». È
per tale motivo che lo spontaneo emergere di una resistenza alla
colonizzazione è precipitata nella categoria di «prepolitico»81. La selettiva
rimozione di determinate componenti soggettive coinvolte nell’esperienza
coloniale francese riconfigura così i termini fondamentali di quella vicenda,
obliterando il potenziale emancipativo di quelle che erano essenzialmente
delle lotte per la conquista della libertà.
La più grande sfida che i sujets pongono alle categorie con le quali
pensiamo oggi la politica risiede nel fatto che essi non avanzano alcuna
richiesta di riconoscimento nei termini da esse disegnati, ma al contrario
agiscono appropriandosi di una libertà che è loro altrimenti negata. Alla
loro inclusione violenta e subordinata nello spazio istituito dal progetto
coloniale essi rispondono rifiutando il posto loro assegnato nelle
tassonomie da esso costruite. In questo modo, i sujets oppongono alla
violenza originaria della colonizzazione un’affermazione altrettanto
originaria di una loro irriducibilità a mero «altro» del Soggetto
dell’umanesimo occidentale.
XII. Alla luce di tali considerazioni, una riflessione critica sul progetto
coloniale non può esimersi da una risalita fino ai fondamenti epistemologici
di una disciplina che riserva la «conoscenza» al solo Soggetto europeo,
relegando gli individui e le popolazioni «incontrate» nell’esperienza coloniale
– sottomesse, sterminate, oppresse – nella posizione di mero oggetto. A tale
156
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
scopo vale la pena evidenziare come sia lo stesso Tocqueville a mettere in
luce lo stretto legame tra violenza e sapere:
Si possono studiare i popoli barbari soltanto con le armi alla mano. Abbiamo vinto gli
arabi prima di conoscerli. È la vittoria che, stabilendo i rapporti necessari e molteplici
tra loro e noi, ci ha fatti penetrare nelle loro usanze, nelle loro idee, nelle loro credenze,
e ci ha infine svelato il segreto per governarli82.
Da queste parole emerge il doppio filo che lega le dimensioni del dominio
e della conoscenza. Tocqueville intendeva sottolineare come l’uso della forza
costituisse la premessa necessaria ad una «pacificazione» che consentisse
l’osservazione analitica di un «altro» ancora sconosciuto. È tuttavia
altrettanto evidente che per Tocqueville «il segreto per governarli» fosse
inevitabilmente riposto in un sapere che sapesse in qualche modo imbrigliare
l’eccedenza soggettiva incarnata nella viva individualità di chi opponeva
resistenza83. «Penetrare nelle loro usanze» non può infatti voler dire altro
che operare tale «imbrigliamento» per mezzo di una violenta appropriazione
del loro passato. Ciò che ha avuto luogo in Algeria è infatti «una
sovrapposizione violenta del ‘moderno’ su tutto il preesistente, che quando
è riuscito a sopravvivere è stato relegato nella nicchia nascosta del residuale
e irretito nella stigmatizzazione»84. Il progetto coloniale dell’Occidente si è
così sostanzialmente impossessato dei riferimenti storici necessari alla
definizione di sé degli individui e dei popoli che abitavano quelle terre.
Esso ha imposto un canone storiografico per il quale gli stessi riferimenti
all’Africa antica sono stati proclamati prossimi alla storia europea e presentati
come forme antiche di colonizzazione. Ciò avviene attraverso un processo
descritto ad esempio da Dipesh Chakrabarty, secondo il quale «con manovre
che ricordano il vecchio trucco ‘dialettico’ della ‘negazione della negazione’,
gli storici riescono a negare alla voce dell’ambivalenza la condizione della
soggettività»85. In questo modo il progetto coloniale si dà un fondamento
in senso storico facendo dell’Algeria una terra a vocazione coloniale, quindi
priva di un’esistenza politica e nazionale propria. In tale ottica, per
Tocqueville, i francesi non sono altro che dei legittimi successori dei turchi.
Da sempre abituati a una dominazione straniera, gli «arabi» avrebbero
semplicemente dovuto «obbedire ai loro nuovi padroni»86.
La negazione di uno statuto soggettivo per la resistenza al dominio
coloniale, negazione reiterata in ogni pagina tocquevilliana, costituisce
quindi il principale dispositivo attraverso il quale essa è automaticamente
157
Domenico Letterio
derubricata al ruolo di mero ostacolo al pieno dispiegarsi di quella che
Hegel definiva Weltgeschichte. Cioè una storia europea che, nel farsi mondo
facendosi singolare collettivo, investe le popolazioni della periferia con un
inaudito carico di violenza87. Tale storia si rivela così costruita senza la
presenza delle popolazioni colonizzate, le quali vi sono inserite attraverso
un movimento che Gayatri Chakravorty Spivak, riprendendo un termine
del vocabolario lacaniano, ha definito forclusione. Un movimento che non
intende semplicemente escluderle, ma che le implica in un unico gesto
teoretico e pratico che le esclude includendole, producendo in questo modo
l’unità del Soggetto europeo88.
XIII. Porre il sujet al centro dei tentativi di tirare le fila del discorso
tocquevilliano significa sfidare la continua re-inscrizione di una
rappresentazione dei gruppi subalterni «come semplice massa di manovra
delle élite, coloniali e nazionaliste, o come substrato immobile e passivo
delle vicissitudini della storia»89. La scelta di volgere l’attenzione a questi
aspetti scaturisce dal riconoscimento del fatto che la messa in evidenza di
un Tocqueville fervente colonialista non costituisce, di per sé, un nodo di
particolare interesse storico o politico. Le sue affermazioni più sorprendenti
sulla necessità di un dominio spietato erano infatti dettate, per sua stessa
ammissione, dagli imperativi dell’interesse nazionale e della «civilizzazione»
su qualunque altro ordine di considerazioni. Se quindi il «perché» di un
Tocqueville colonialista può, e deve, trovare risposta nel complesso di
argomenti da lui stesso fornito, l’unica possibilità di riflettere criticamente
su questi scritti risiede in una interrogazione sull’insieme dei dispositivi
che hanno operato in funzione della produzione, della messa in opera e del
mantenimento di un dominio coloniale non solo materiale ma anche
epistemico.
È alla luce di queste considerazioni che si è osservato come il principale
limite della riflessione tocquevilliana risieda nella portata soggettiva di
insorgenze che le categorie da lui impiegate non gli consentivano di
concettualizzare. Se da un lato era evidente a lui stesso che la resistenza
alla colonizzazione era un fenomeno tanto antico quanto la colonizzazione
stessa, dall’altro essa non era tematizzata nei termini di una presa di parola
di soggetti che rifiutavano lo stato di minorità cui il pensiero e le pratiche
coloniali tentavano di relegarli. Le istanze di libertà che essi incarnavano
non erano riconoscibili per Tocqueville, in quanto vettori orientati in
158
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
una direzione opposta rispetto a quella di un «progresso» che, secondo le
categorie del liberalismo ottocentesco, poteva originare unicamente
dall’Europa. In questa ottica, le sollevazioni anti-coloniali sono contingenti
irruzioni che emergono nella trama del «moderno» interrompendone la
continuità.
È allora nel perpetuarsi di una artificiosa e violenta separazione tra ciò
che costituisce il «moderno» e ciò che ne è tenuto al di fuori che deve essere
indagato il nocciolo di dinamiche che relegano in una posizione subalterna
individui e popoli che tuttavia, «una volta portati all’interno di questa
vicenda storica dalla violenza del dominio coloniale, […] si sono […] rifiutati
di continuare ad occuparne i margini»90. Il riconoscimento del protagonismo
che i sujets hanno mostrato deve costituire la prima «mossa» della
ricostruzione di cartografie di un passato in cui il fatto del dominio, le
pratiche di libertà ed i processi di soggettivazione che in esse si danno sono
strettamente intrecciati. La «modernità» è fatta di antagonismo e non solo
di processi espansivi, ed è per questo motivo che la presa di parola da parte
dei sujets di Tocqueville deve divenire parte della sua affermazione. Il carattere
tumultuoso della resistenza da essi opposta al dominio coloniale deve fungere
non da manifestazione di una alterità irriducibile, ma da elemento che
illumina nuove possibilità tanto per il nostro mondo della vita quanto per
la ricerca storica.
Note al testo
1
Si fa riferimento ad ALEXIS DE TOCQUEVILLE, Œuvres Complètes, III,I, Gallimard, Paris 1962,
e a MELVIN RICHTER, Tocqueville on Algeria, in «Review of Politics» XXV(1963), pp. 362-98. Si
nota per inciso che la comparsa di tali scritti avviene in anni particolarmente significativi per
la storia algerina. Vale la pena citare le introduzioni alle uniche due edizioni francesi degli
scritti tocquevilliani sull’Algeria: TZVETAN TODOROV, Introduction, in ALEXIS DE TOCQUEVILLE,
De la colonie en Algérie, Complexe, Bruxelles 1989; SELOUA LUSTE BOULBINA, Présentation, in
DE TOCQUEVILLE, Sur l’Algérie, Flammarion, Paris 2003. Tra gli interventi più recenti, JENNIFER
PITTS, L’Empire britannique, un modèle pour l’Algérie française. Nation et civilisation chez
Tocqueville et John Stuart Mill, in L’esclavage, la colonisation, et après…, a cura di Patrick Weil
e Stéphane Dufoix, Presses Universitaires de France, Paris 2005; CHERYL B. WELCH, Colonial
violence and the rhetoric of evasion. Tocqueville on Algeria, in «Political Theory» XXXI(2003).
Agli scritti algerini di Tocqueville sono infine dedicate molte parti di OLIVIER LE COUR
GRANDMAISON, Coloniser exterminer. Sur la guerre et l’Etat colonial, Fayard, Paris 2005, e di
JENNIFER PITTS, A turn to Empire. The rise of imperial liberalism in Britain and France, Princeton
University Press, Princeton 2005.
159
Domenico Letterio
2
Per una panoramica su alcuni dei temi «riscoperti» dagli studiosi di Tocqueville si può fare
riferimento al volume a cura di Umberto Coldagelli, ALEXIS DE TOCQUEVILLE, Scritti, note e
discorsi politici, Bollati Boringhieri, Torino 1996. Un’importante edizione italiana degli scritti
penitenziari è quella curata da Lucia Re, ALEXIS DE TOCQUEVILLE, Scritti penitenziari, Edizioni
di Storia e Letteratura, Roma 2002. Vale la pena fare un breve accenno alle affermazioni con le
quali Lucia Re, il cui intento si condivide appieno, conclude l’Introduzione al volume: «riscoprire
oggi gli scritti sul carcere ha […] non solo un valore storiografico e filologico, ma anche
filosofico e politico. Significa restituire alla figura di Tocqueville la sua ricchezza e complessità,
ma anche sollecitare il liberalismo a confrontarsi con le sue aporie teorico-politiche, a partire
proprio dai suoi classici più celebrati» (ivi, p. LVII).
3
Il più significativo esempio di tale atteggiamento è quello di Tzvetan Todorov, per il quale «il
colonialismo di Tocqueville è semplicemente il prolungamento internazionale del suo
liberalismo» (TZVETAN TODOROV, Noi e gli altri. La riflessione francese sulla diversità umana,
Einaudi, Torino 1991, p. 238)
4
Si utilizza tale espressione nell’accezione e con la densità di significato con cui l’ha proposta
E DWARD W. S AID , Cultura e imperialismo. Letteratura e consenso nel progetto coloniale
dell’Occidente, Gamberetti, Roma 1998.
5
ABDELMALEK SAYAD, Algeria: nazionalismo senza nazione, Mesogea, Messina 2003, pp. 29-52.
6
Per l’utilizzo del termine «violenza epistemica» si fa riferimento a GAYATRI CHAKRAVORTY
SPIVAK, Critica della ragione postcoloniale, Meltemi, Roma 2004.
7
ABDELMALEK SAYAD, Algeria: nazionalismo senza nazione cit., pp. 57-8.
8
PAUL GILROY, The Black Atlantic. L’identità nera tra modernità e doppia coscienza, Meltemi,
Roma 2003, p. 117.
9
DIPESH CHAKRABARTY, Provincializzare l’Europa, Meltemi, Roma 2004, p. 66.
10
JEAN-JACQUES CHEVALLIER e ANDRÉ JARDIN, Introduction, in Œuvres Complètes, III,I p. 18.
11
Per le note biografiche che seguono, si è fatto riferimento ad ANDRÉ JARDIN, Alexis de
Tocqueville, Jaca Book, Milano 1996, pp. 241-3 e 307-31; a UMBERTO COLDAGELLI, L’Algeria
e la vocazione coloniale della Francia, in ALEXIS DE TOCQUEVILLE, Scritti, note e discorsi politici,
cit., pp. 341-50; a JEAN-JACQUES CHEVALLIER e ANDRÉ JARDIN, Introduction cit., pp. 7-32; a
SELOUA LUSTE BOULBINA, Présentation cit., pp. 7-41.
12
Œuvres Complètes, XIII, I p. 155. Citato in Scritti, note e discorsi politici cit., p. 341n.
13
BENJAMIN STORA, Histoire de l’Algérie coloniale, La Découverte, Paris 2004, p. 13.
14
Le due edizioni della più nota opera di Tocqueville sono uscite rispettivamente nel 1835 e
nel 1840.
15
Œuvres Complètes, III,I p. 220. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici cit., p. 357.
160
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
16
Ivi, p. 141.
17
Ivi, p. 153. Citato anche in ANDRÉ JARDIN, Alexis de Tocqueville cit., p. 324.
18
Alla corrispondenza tra Tocqueville e Gobineau è dedicato un intero volume delle Œuvres
Complètes. Per la più recente e completa edizione italiana dell’epistolario, si faccia riferimento
ad ALEXIS DE TOCQUEVILLE e ARTHUR DE GOBINEAU, Del razzismo: carteggio 1843-1859, Donzelli,
Roma 1995.
19
ALEXIS DE TOCQUEVILLE, Voyage aux États-Unis, citato anche in TZVETAN TODOROV, Noi e gli
altri cit., p. 243. Le più ricche riflessioni sul viaggio in America si trovano in ALEXIS DE
TOCQUEVILLE, Quindici giorni nel deserto americano, Sellerio, Palermo 1989. Va tuttavia osservato
che nella Democrazia in America la possibilità di una integrazione tra «razze» al di là dell’Atlantico
è considerata una chimera. Le riflessioni su questo tema si trovano in Œuvres Complètes, I, I
pp. 331-431. Per l’edizione italiana, il riferimento obbligato è all’edizione a cura di Nicola
Matteucci, ALEXIS DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, UTET, Torino 1968, pp. 373484. Per una condivisibile riflessione su queste pagine si rimanda a MASSIMILIANO GUARESCHI,
Il lapsus di Tocqueville: un liberale francese, pochi indiani e molti schiavi, in Lo straniero e il
nemico: materiali per l’etnografia contemporanea, a cura di Alessandro dal Lago, Costa&Nolan,
Milano 1998, pp. 45-63.
20
Le riflessioni tocquevilliane sull’India sono contenute in Œuvres Complètes, III, I, pp. 441552.
21
Œuvres Complètes, III, I, pp. 41-126. Le parti più rilevanti degli interventi tocquevilliani su
questo tema sono tradotti in italiano in Scritti, note e discorsi politici cit., pp. 296-340.
22
Œuvres Complètes, VI,I p. 103.
23
Œuvres Complètes, III, I, pp. 476-82.
24
JEAN-JACQUES CHEVALLIER e ANDRÉ JARDIN, Introduction cit., p. 17. La lettera cui si fa
riferimento si trova in Œuvres Complètes, VI, p. 423.
25
Lettera di Tocqueville a Buloz del 2 ottobre 1840, citata in ANDRÉ JARDIN, Alexis de Tocqueville
cit., p. 328.
26
Œuvres Complètes, III,I p. 509.
27
Ivi, pp. 443-4.
28
JEAN-JACQUES CHEVALLIER e ANDRÉ JARDIN, Introduction cit., p. 20.
29
Œuvres Complètes, III,II, p. 280. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici cit., p. 234.
30
Œuvres Complètes, III,I p. 216 [corsivo nel testo]. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici
cit., p. 352.
161
Domenico Letterio
31
Per l’importanza del viaggio come costante del pensiero di Tocqueville si faccia riferimento
a SHELDON S. WOLIN, Tocqueville Between Two Worlds: The Making of a Political and Theoretical
Life, Princeton University Press, Princeton 2001, in particolare il cap. II, pp. 34-56.
32
Œuvres Complètes, IX p. 69. Citato anche in ANDRÉ JARDIN, Alexis de Tocqueville cit., p. 313.
33
Œuvres Complètes, III,I p. 310. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici, p. 394.
34
ANDRÉ JARDIN, Alexis de Tocqueville cit., pp. 314-5. Le note scritte da Tocqueville su questo
viaggio sono contenute in Œuvres Complètes, III, II, pp. 189-218.
35
ANDRÉ JARDIN, Alexis de Tocqueville cit., p. 314.
36
Œuvres Complètes, III, II, pp. 213-80.
37
ALEXIS DE TOCQUEVILLE, Scritti, note e discorsi politici cit., pp. 225-33.
38
Œuvres Complètes, III,I pp. 213-4. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici cit., pp.
350-351.
39
Ivi, p. 226. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici cit., p. 364.
40
Ivi [corsivo mio]. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici cit., pp. 364-5.
41
Ivi, p. 268.
42
Data la vastità della bibliografia sull’argomento, ricordiamo solo alcuni interventi: SANDRO
CHIGNOLA, Fragile cristallo: per la storia del concetto di società, Editoriale Scientifica, Napoli
2004; MARIA LAURA LANZILLO, Introduzione, in ALEXIS DE TOCQUEVILLE, Antologia degli scritti
politici, Carocci, Roma 2004, pp. 9-42. Per ulteriori indicazioni è possibile fare riferimento
alle ampie e aggiornate bibliografie ivi citate.
43
Œuvres Complètes, III,I p. 217. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici cit., p. 354.
44
Ivi, p. 221. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici cit., p. 358.
45
Ivi, p. 275. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici cit., pp. 372-3.
46
Ivi, p. 276. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici cit., p. 373.
47
Su questo punto si può fare riferimento a UDAY SINGH MEHTA, Liberalism and Empire: a
Study in Nineteenth-Century British Liberal Thought, University of Chicago Press, Chicago
1999, in particolare pp. 28-36.
48
DIPESH CHAKRABARTY, Provincializzare l’Europa cit., p. 22.
49
Œuvres Complètes, III,I p. 223. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici cit., p. 360.
162
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
50
Si fa qui uso delle categorie proposte in REINHART KOSELLECK, Spazio di esperienza e orizzonte
di aspettativa: due categorie storiche, in Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, Marietti,
Genova 1986, pp. 300-22.
51
JEAN-JACQUES CHEVALLIER e ANDRÉ JARDIN, Introduction cit., p. 22.
52
Œuvres Complètes, III,I p. 216 [corsivo mio]. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici cit.,
pp. 352-3.
53
GIAMPAOLO CALCHI NOVATI, Storia dell’Algeria indipendente, Bompiani, Milano 1998, p. 16.
54
Œuvres Complètes, III,I p. 218-9. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici, cit., p. 356.
55
Si veda ad esempio PIERANGELO SCHIERA, Lo Stato. Origini e degenerazioni, CLUEB, Bologna
2004.
56
Œuvres Complètes, III,I p. 224 [corsivo mio]. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici cit.,
p. 361.
57
MELVIN RICHTER, Tocqueville on Algeria cit., p. 371.
58
Per esempio, scrive Tocqueville nel Travail: «Io credo che il diritto di guerra ci autorizzi a
devastare il paese e che dobbiamo farlo sia distruggendo le messi all’epoca del raccolto, sia in
ogni occasione facendo quelle incursioni rapide che si chiamano razzie e il cui scopo è quello
di impadronirsi degli uomini o delle greggi», Œuvres Complètes, III,I p. 226 [corsivo mio].
Traduzione in Scritti, note e discorsi politici cit., pp. 365.
59
Discorso alla Camera del 9 giugno 1846. Œuvres Complètes, III,I p. 299. Traduzione in
Scritti, note e discorsi politici cit., p. 384.
60
Citato in MOHAMMED HARBI e GILBERT MEYNIER, Le FLN. Documents et histoire 1954-1962,
Fayard, Paris 2004, p. 60.
61
BELL HOOKS, Riflessioni su razza e sesso, in Elogio del margine: razza, sesso e mercato culturale,
Feltrinelli, Milano 1998, p. 36.
62
Citato in BENJAMIN STORA, Histoire de l’Algérie coloniale cit., p. 18.
63
ANDRÉ JARDIN, Alexis de Tocqueville cit., p. 324.
64
Œuvres Complètes, III,I p. 196.
65
Ivi, p. 197.
66
Ivi, p. 293.
67
ANDRÉ JARDIN, Alexis de Tocqueville cit., p. 318.
163
Domenico Letterio
68
JEAN-JACQUES CHEVALLIER e ANDRÉ JARDIN, Introduction cit., p. 15.
69
UMBERTO COLDAGELLI, L’Algeria e la vocazione coloniale della Francia cit., p. 348.
70
Citato in JEAN-JACQUES CHEVALLIER e ANDRÉ JARDIN, Introduction cit., p. 23.
71
ABDELMALEK SAYAD, Algeria: nazionalismo senza nazione cit., p. 25.
72
Citato in JEAN-JACQUES CHEVALLIER e ANDRÉ JARDIN, Introduction cit., p. 24.
73
FRANCESCO M. DE SANCTIS, Tempo di democrazia. Alexis de Tocqueville, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 1986, pp. 342-3.
74
Citato anche in ANDRÉ JARDIN, Alexis de Tocqueville cit., p. 324 [corsivo mio].
75
Si fa qui uso delle categorie di soggettivazione/assoggettamento proposte da Michel Foucault,
e attorno alle quali ruota la produzione filosofica di quella che si è venuti chiamando la scuola
«post-althusseriana» francese. Un altro riferimento importante per queste riflessioni è costituito
dalla lettura del tema del riconoscimento nella dialettica servo/padrone della Fenomenologia
hegeliana proposta da ALEXANDRE KOJÈVE, La dialettica e l’idea della morte in Hegel, Einaudi,
Torino 1991.
76
Per un breve trattazione delle battaglie che videro vincitrici le truppe di Abd el-Kader, si
faccia riferimento a BENJAMIN STORA, Histoire de l’Algérie coloniale cit., p. 16.
77
Ivi, p. 19.
78
Ivi, p. 35.
79
CARL SCHMITT, Le categorie del ‘politico’. Saggi di teoria politica, a cura di Gianfranco Miglio
e Pierangelo Schiera, il Mulino, Bologna 1972.
80
Si utilizza l’espressione «nuda vita» nell’accezione in cui è stata proposta da GIORGIO AGAMBEN,
Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995.
81
L’utilizzo sistematico della categoria di «prepolitico» è riconducibile al lavoro di ERIC J.
HOBSBAWM, I ribelli. forme primitive di rivolta sociale, Einaudi, Torino 1966.
82
Œuvres Complètes, III,I p. 309. Traduzione in Scritti, note e discorsi politici cit., p. 393.
83
Ci si serve del termine «imbrigliamento» prendendolo a prestito dall’uso fattone da Sandro
Mezzadra e Yann Moulier Boutang nell’analisi delle migrazioni contemporanee. Si veda, ad
esempio, S ANDRO MEZZADRA, Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione,
Ombrecorte, Verona 2001, pp. 56-60.
84
SALVATORE PALIDDA, Prefazione, in ABDELMALEK SAYAD, Algeria: nazionalismo senza nazione,
cit., p. 6. Su un punto simile, si veda la rilettura operata da Dipesh Chakrabarty delle categorie
164
L’Algeria di Alexis de Tocqueville: soggettività e storia nel progetto coloniale dell’Occidente
marxiane di «sussunzione reale» e «sussunzione formale» (DIPESH CHAKRABARTY, Provincializzare
l’Europa cit., pp. 71-103).
85
DIPESH CHAKRABARTY, Provincializzare l’Europa cit., p. 60.
86
MELVIN RICHTER, Tocqueville on Algeria cit., p. 380.
87
Il rapporto tra progetto coloniale e «storia del mondo» è suggestivamente indagato in RANAJIT
GUHA, La storia ai limiti della storia del mondo, Sansoni, Milano 2003. Per il concetto di storia
come «singolare collettivo» si faccia riferimento a REINHART KOSELLECK, Punto di vista e
temporalità. Contributo all’esplorazione storiografica del mondo storico, in Futuro passato cit., pp.
151-77.
88
GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK, Critica della ragione postcoloniale cit. Su questo punto si faccia
riferimento anche a SANDRO MEZZADRA, Diritto di fuga cit., pp. 95-6.
89
MASSIMILIANO GUARESCHI, Presentazione, in RANAJIT GUHA, La storia ai limiti della storia del
mondo cit., p. 8.
90
SANDRO MEZZADRA, Diritto di fuga cit., p. 101. Sull’uso del termine «margine» si veda BELL
HOOKS, Elogio del margine, in Elogio del margine: razza, sesso e mercato culturale cit., pp. 62-73.
165
Domenico Letterio
166
I nove capi storici algerini del 1954
I nove capi storici algerini del 1954
di Gilbert Meynier
Per parlare del nazionalismo algerino, si sono finora adoperate per
semplificare tre categorie:
- la categoria del nazionalismo pacifista e interclassista: tutti gli uomini
combattono per la stessa causa, siano essi ricchi o poveri, abitanti delle
campagne o delle città. È, questa, la tesi del discorso nazionalista algerino
corrente e della storiografia ufficiale algerina. Donde la formula dello
storico algerino Mahfûz Kaddache: «La Casbah non poteva conoscere i
conflitti sociali poiché tutti i suoi membri erano nazionalisti». Formulazioni
più ambiziose usando un termine proprio della matematica definiscono
il nazionalismo come una «costante» comune alle diverse classi sociali.
- la categoria del nazionalismo di classe, che si può riassumere in questi
termini: le classi popolari conducono la lotta giusta (nazionalista) contro i
possidenti che collaborano con il colonialismo. Fu questa la categoria più
feconda, sia a livello di impegno militante, sia nella ricerca scientifica.
Comprende:
1. il campo classico dello storicismo marxista. Abdel Kader condannò
i feudatari capi di tribù perché incarnavano le forze conservatrici contro
un despota illuminato musulmano, il cui progetto statale annichiliva i
loro privilegi. Si sa, gli abbienti hanno poca coscienza nazionale. La classe
popolare algerina, con l’introduzione del modo di produzione capitalistico,
diventò quindi naturalmente il ricettacolo dell’idea nazionalista. La storia
popolare algerina è improntata a questa visione. Una sua variante è
2. il fanonismo (da Franz Fanon, il teorico della rivoluzione contadina)
che trasforma la povertà e la purezza campagnole in miti sui quali si fonda
una certa politica militante algerina. Vengono esaltati i valori di impegno,
di abnegazione, di frugalità, riconosciuti come valori islamici. Questa visione
non affronta però la questione dell’inquadramento rivoluzionario nazionale:
167
Gilbert Meynier
in effetti, nella storia, non si sono viste mai, né in Algeria, né in altri paesi,
truppe andare da sole all’assalto. Mediante il fanonismo la storia del paese
poté così subire passeggere revisioni marxiste.
3. una variante operaistica. Rimasta a lungo egemonica, questa sostiene
che i quadri politici del nazionalismo venissero dalla classe operaia algerina.
Ora la suddetta classe operaia si è formata più che altro grazie all’emigrazione,
e in Francia. È vero che i primi militanti della Stella Nordafricana (l’Étoile
Nord-Africaine) erano operai algerini di Parigi. Ma si sa anche che i suoi
primi quadri non furono proprio operai. Prima dell’epoca dell’ENA,
dall’inizio del Novecento, i primi algerini a contestare il sistema coloniale
erano stati, in Algeria, commercianti, maestri delle elementari, segretari di
comuni miste (communes mixtes), addetti alla magistratura musulmana o
liberi professionisti (l’élite dei Giovani Algerini - les Jeunes Algériens -, vale a
dire gli «evoluti» - les «évolués» -).
4. Questo ha condotto alcuni marxisti a privilegiare, nell’analisi sociale
del nazionalismo algerino, la «piccola borghesia» È pertinente questo
concetto? O se ci si vuol riferire a certe analisi italiane: ci fu nel 1954 un
«blocco storico»? E, se ci fu un blocco, quali ne furono le componenti? E
come si attuò la necessaria neutralizzazione delle tensioni in modo che il
blocco funzionasse? O non sono forse più pertinenti altre teorie, come per
esempio quelle provenienti dall’area anglosassone, che prendono in
considerazione i «notabili», l’élite, le «intellighenzie»?
- il segmentarismo, contro il quale guerreggiarono aspramente i marxisti
e che considera che la società civile come un «groviglio di solidarietà» (un
matelas de solidarités, Henri Sanson) tra segmenti sociali. Tra i segmenti
esistono tensioni strutturali permanenti - si veda il sistema di alleanze e di
opposizioni delle vallate dell’Aurès evocato da Pierre Bourdieu quando era
strutturalista -, ma siffatte tensioni cesserebbero qualora un aggressore
comune minacciasse l’insieme dei segmenti. L’allargamento del groviglio
delle solidarietà, per intersegmentarismo, darebbe luogo alla solidarietà
nazionale. Ora, la solidarietà nazionale fu più che altro un mito. Il lungo
studio dell’insurrezione dell’Aurès (1916-17) che ho fatto molti anni fa mi
porta a concludere che l’Aurès di Bourdieu era alquanto immaginario. Il
che non toglie che il discorso solidaristico resta effettivamente il quadro
ideologico dell’azione degli uomini: se resistevano contro i francesi, gli
uomini proclamavano di farlo in nome della solidarietà tra gruppi; se non
lo facevano, avevano cattiva coscienza. Ci si può valere del lavoro di
168
I nove capi storici algerini del 1954
Bourdieu, ma egli confonde, in Sociologie de l’Algérie, l’immaginario degli
uomini con le pratiche sociopolitiche effettive.
Tutte queste formalizzazioni, nonostante la loro importanza sia stata
talvolta esagerata, rispecchiano una certa verità. A dire il vero, proviamo
il bisogno di prendere in considerazione, con cautela e con le debite
sfumature, diversi modelli di teorizzazione. Utilizzare un’unica categoria
di analisi significherebbe forse rifiutare il diverso storico, ossia la
molteplicità dei fattori di determinazione. Lo storico non può quindi
fare a meno di svolgere le necessarie indagini; deve studiare dei casi precisi
per vederci chiaro. Ed è quello che intendo fare studiando quello dei
nove capi storici algerini del 1954.
La scissione del MTLD (Mouvement pour le Triomphe des Libertés
Démocratiques) tra «centralisti» e «messalisti», sancita dal congresso centralista
di Algeri nell’agosto 1954, consegue al congresso messalista svoltosi in luglio
a Hornu, in Belgio. Tale rottura lascia la via libera alla corrente attivista,
che aveva animato l’OS (Organisation Spéciale), figlio bastardo del PPAMTLD1, sgominato dalla polizia francese nel 1950. All’inizio, la decisione
di rompere in modo violento con il dominio coloniale è, secondo Ben Bella,
un contratto morale tra nove uomini, contratto generato dal Comitato del
22 (giugno), al quale approda lo scacco del CRUA (Comité Révolutionnaire
pour l’Unité et l’Action), ultimo e vano tentativo - prioritarmente
antimessalista - condotto da Mohammed Boudiaf nel marzo 1954 per
riunificare il partito. Lo scoppio del MTLD fu un trauma terribile per i
militanti. Lasciò il campo libero agli attivisti.
Presentazione dei nove capi storici
Hanno in comune:
- l’età. Sono militanti abbastanza giovani. Hanno tra i 23 e i 42 anni. Si
tratterebbe, stando alle analisi dell’americano William Quandt, di un
fenomeno generazionale: giovani militanti rompono con le divisioni e con
le compromissioni del passato. Ma l’età non basta a spiegare tutto, anche se
fu effettivamente questa stessa generazione a dare dei soldati algerini
all’esercito francese durante la seconda guerra mondiale, tra cui fra i nove
169
Gilbert Meynier
tre sottufficiali (Ben Bella, Boudiaf, Ben Boulaïd) e una recluta dei Chantiers
de jeuness del regime di Vichy (Belkacem Krim).
- la ruralità. Tutti sono rurali, tranne Mourad Didouche (ma anche
questo sarebbe da vedere...). Didouche (nato nel 1927) è oriundo della
Cabila; i suoi genitori sono emigrati ad Algeri all’inizio del Novecento.
Studiò ad Algeri, e poi a Costantina, in una scuola tecnica, ma non ottenne
successi scolastici. Figlio di bettolieri della Casbah di Algeri, è un «piccolo
borghese», un outsider socioculturale: assiduo frequentatore dei bar,
Didouche; che bazzicò molto con gli europei. Questo giovanotto, il minore
del gruppo, appare come un adolescente amante dei piaceri. «Lo abbiamo
raccolto dalle fogne», diceva Ahmed Mahsas, il suo compagno un po’ più
anziano di lui (e il suo capo ad Algeri all’epoca dell’OS). Fu il partito a
dargli una veste rispettabile e ad inculcargli le virtù ritenute islamiche - in
realtà rurali - di dedizione e di frugalità.
- l’appartenenza sociale. Prima di entrare nel partito nazionalista, cinque
di loro godono di una posizione sociale che li distingue nettamente dalla
massa.
Hocine Aït Ahmed (nato nel 1926) proviene da una prestigiosa famiglia
marabuttica di Cabila. È nipote dello sceicco Mohand al Hocine. Ma suo
padre fu caid: un po’ come se in Italia un Visconti o un Medici fosse diventato
un commissario di polizia. Aït Ahmed è un grande capo di Cabila; sta alla
Cabila come i Jmblatt stanno ai Drusi (anche se l’ascendenza cabile è assai
dubbiosa). Negli studi, ha superato il primo baccalauréat prima di impegnarsi
nel militantismo clandestino.
Mohammed Boudiaf (nato nel 1919) non fa parte non della nobiltà
religiosa, ma viene da una famiglia dell’antica nobiltà di spada (al jawâd),
originaria di M’sila, nel Sud-Ovest costantinese, i Boudiaf Seddik. Pure lui
è un declassato. Titolare del primo baccalauréat, lavorò come funzionario
delle tasse prima di unirsi alla lotta clandestina nel 1946.
Larbi Ben M’hidi (nato nel 1923) si colloca un bel po’ sotto. Esce da
una modesta famiglia marabuttica costantinese, un cui membro fu caid ad
Aïn M’lila. Anche lui è un declassato, che imputa il proprio declassamento
al sistema coloniale. Dovette lavorar sodo dal cognato, sceicco Murad, a
Biskra. Ha interrotto gli studi dopo le scuole medie.
170
I nove capi storici algerini del 1954
Ahmed Ben Bella (nato nel 1918), originario della provincia di Orano,
fa parte della categoria dei piccoli notabili. È un rurale senza patrimonio di
origine, uscito da una zâwiya marocchina. La sua posizione sociale originaria
deriva in gran parte dalla sua affiliazione ad una confraternita religiosa. Ha
il profilo di un piccolo dignitario di confraternita. Ha smesso di studiare
dopo il penultimo anno delle medie francesi. È stato consigliere comunale
di Maghnia, dove occupò per qualche tempo un piccolo posto nella polizia
locale.
Mostefa Ben Boulaïd (nato nel 1917), titolare soltanto del Certificat
d’études (diploma finale delle elementari), è un homo novus. La sua posizione
sociale gli deriva dal successo economico. Fu presidente del sindacato dei
mercanti di tessuto dell’Aurès; possiede un mulino a Lambèse (oggi Tazoult)
e un’azienda di autotrasporti nel Sud della provincia di Costantina.
Mohammed Khider (nato del 1912) viene da Biskra. Fu tranviere ad
Algeri, dove si aggregò alla piccola élite sindacale algerina, non raramente
anticamera di posti dirigenti in seno al Partito Nazionalista.
Rabah Bitat, nato nel 1925 ad Ain Kerma, nella provincia di Costantina,
di tutti il meno noto, esce da una modesta famiglia originaria dall’oasi del
Suf, vicino al confine tunisino. Lavorò come operaio presso la manufattura
dei tabacchi Bentchicou di Costantina.
Belkacem Krim (nato nel 1922) è figlio di una guardia campestre della
Cabila che ebbe accesso al caidato (ma suo padre è un piccolo caid di bassa
estrazione sociale).
Oltre alla ruralità, tutti hanno un tratto distintivo comune: appartengono
a una classe o hanno una posizione sociale che li distingue dalla massa.
L’appartenenza di classe, vale a dire la posizione economica, non
neccesariamente è determinante; viceversa, la posizione che deriva dalla
discendenza marabuttica o dall’appartenenza a una confraternita è
importante. Cinque di loro portano al PPA-MTLD un «plusvalore» dal
punto di visto sociale (Aït Ahmed, Boudiaf, Ben M’hidi, Ben Bella, Ben
Boulaïd). Gli altri quattro devono invece molto, o addirittura tutto, al partito
(Didouche, Krim, Khider, Bitat).
171
Gilbert Meynier
Dunque, il profilo sociale di base non sempre è determinante. Infatti il
partito si incaricò, negli ultimi quattro casi citati, di ridisegnare il profilo sociale
dei propri dirigenti. Ma tutti hanno una notorietà o ritengono di avere talenti
incompatibili con il mantenimento della discriminazione coloniale.
- un certo livello culturale. C’è una eterogeneità e spesso una pluralità
delle fonti dell’identità culturale. Soltanto due sono bravi arabisti (Aït Ahmed
e Khider); Ben M’hidi è un arabista di competenza media. Gli altri non
sono arabisti. Tutti hanno fatto le elementari francesi, cinque hanno fatto
anche le medie, due hanno il primo baccalauréat. Per livello di istruzione, si
collocano molto al di sopra della massa algerina, in cui l’ottantacinque per
cento dei bambini, nel 1954, non va a scuola.
Tutti hanno più o meno una cultura scolastica di matrice francese. Ma
culturalmente, Aït Ahmed e Boudiaf si situano di molto sopra gli altri. Sono
gli unici due ad avere un progetto per la società algerina dopo l’indipendenza.
Aït Ahmed legge molto; le sue letture sono numerose ed eclettiche (i
classici francesi, Clausewitz, Rabindranath Tagore...); è anche un cinefilo
entusiasta, amante dei film americani. Durante il suo soggiorno nel Cairo,
venne denunciato dai compagni di lotta come «berbero-materialista». È
anche quello che pensa il major Fathi al Dib, il capo dei servizi egiziani (al
mukhabarât) incaricato dei problemi algerini. Politicamente, è praticamente
un giacobino e un laico; odia i bigotti. Preferisce il clan degli intellettuali di
Belcourt piuttosto che gli sbraitoni ignoranti della Casbah. Ma ha un buon
senso pratico. Nelle sue memorie rivela di avere nutrito, un tempo, il
desiderio di frequentare la scuola militare francese di Saint Cyr.
Boudiaf fu un giovane quadro dirigente (giugno 1953-febbraio 1954)
della federazione francese del MTLD. Venne poi incaricato dal nascente
CRUA di coordinare i preparativi del 1° novembre. È l’unico ad insistere
così tanto sulla necessità di una formazione politica di militanti che hanno
secondo lui «una educazione morale più che politica».
- mentalità, principi ed orientamenti politici.
Caso di Ben M’hidi: è integro, è un asceta; è affascinato dalle competenze
e dalla cultura. Al congresso storico del Fronte di Liberazione Nazionale
(FLN) della Soummam (agosto 1956), è impressionato dall’intellettuale
organizzatore Ramdane Abbane. Di cultura mediocre, tende a frequentare
la gente colta.
172
I nove capi storici algerini del 1954
Caso di Ben Bella: da questo punto di vista, è l’esatto contrario di Ben
M’hidi. Originalmente piccolo dignitario di confraternita, cerca di ampliare
la posizione dell’uomo di religione, il ruolo di intercessore del marabù (non
lo è per origine famigliare, ma si ispira a questo modello in politica). Professa
vagamente di voler fare il bene anche se, per riuscirci, uno deve rassegnarsi
a fare porcherie. Ai suoi occhi, la competenza è assolutamente secondaria.
Obiettivo suo: dar fuoco alla miccia (ich‘âl ul fatîla) il più presto possibile.
La sua è una ideologia della catarsi. Dato che il colonialismo è il male (e gli
vieta di tenere la parte cui aspira), occorre rompere con urgenza e violenza
con questo. L’islam professato da Ben Bella ha un taglio sociale, semplice e
popolare. È il tipico populista all’algerina (e non in senso russo: si tratta qui
di fare teoricamente il bene del popolo adoperando qualsiasi mezzo, non di
educarlo).
Caso di Ben Boulaïd: è un buon organizzatore, un buon esecutore pratico;
è insieme l’unico borghese - borghese di paese, s’intende - facoltoso nel
gruppo e colui che più spontaneamente si conforma alla mentalità popolare.
Ha vissuto quasi sempre in campagna; è l’unico a non essere rimasto mai
molto a lungo a contatto con l’ambiente cittadino. Per lo più, la sua visione
della società algerina è improntata all’immaginario sociale delle classi
popolari.
Caso di Khider: con Bitat et Krim, rappresenta coloro che sono stati
promossi socialmente dal partito. Ma è l’unico fra essi ad aver portato
qualcosa al partito. Ha reazioni da self-made man; ritiene di far parte di una
élite non riconosciuta nella cornice coloniale. Khider è magari l’unico vero
musulmano convinto, nel senso che il suo islam è insieme dotto e militante,
un islam politico, maturato grazie alla frequentazione, nel Cairo, dei Fratelli
Musulmani, all’epoca in cui egli era seguace di Saiyyd Qutb, autore di un
celebre breviario islamico, il best-seller Ma‘âlim ul tarîq. Anche lui ha
un’ideologia sociale e di rottura, ma attinge da altre fonti, più intellettuali,
e più arabe, di quelle di Ben Bella.
Caso di Bitat: questi dovette tutto al partito. Il partito gli fornì la
possibilità di frequentare ambienti che gli sarebbero rimasti inaccessibili se
non si fosse impegnato nel militantismo anticolonialista. Logicamente,
l’indipendenza fu per lui l’unico fine che gli potesse garantire il
mantenimento e la consolidazione dei vantaggi acquisti. Da questo punto
di vista, Bitat rappresentò l’unico caso di carriera riuscita: solo in questo tra
173
Gilbert Meynier
i nove capi, diventò ministro - dei trasporti - dopo il 1962, poi presidente
dell’Assemblea Nazionale.
Caso di Krim: socialmente, la sua famiglia dovette tutto all’amministrazione
coloniale. Per Krim, era urgente smentire le compromissioni dei familiari
per potersi atteggiare da leader attendibile di fronte alla massa del popolo di
Cabila. Nei cantieri della gioventù, Krim visse l’esperienza della
discriminazione. Propugnatore dei metodi sbrigativi, capogruppo attivista,
qualificato nelle memorie del summentovato funzionario egiziano delle
mukhabarât, Fathi al Dib, di Qabâ’ilî balîd (cabile ottuso), il lion des djebels
(leone dei gebel), futuro coassassino, con i suoi colleghi colonnelli, della
testa pensante e politica del FLN Ramdane Abbane - l’ideatore e
l’organizzatore del congresso della Soummam - in Marocco nel dicembre
1957, sarà al Cairo, poi a Tunisi l’anima del clan dei militari contro i politici.
Caso di Didouche: dato un suo passato di mediocre fama, il giovane
Didouche tenne certamente a redimersi. Alunno assai scarso, il suo primo
posto fu quello di funzionario del partito. Non ne occupò altri. Socialmente,
il partito non lo promosse socialmente perché la sua famiglia godeva già di
una discreta agiatezza. Ma il partito lo riscattò sul piano politico e morale e
gli conferì una posizione rispettabile. Questo giovane attivista non vedeva
l’ora di fare i conti con il colonialismo. Si distinse innanzitutto per la propria
bravura nel dar fuoco alle micce; venne usciso nel 1955, a 28 anni, e rimase,
nel FLN, il giovane martire.
La rappresentatività dei nove
I nove sposano le ragioni della massa in modo abbastanza fedele per
poterla rappresentare; ma da questa si distinguono quanto basta per poterla
dirigere.
Sono rappresentativi per la loro ruralità; uno solo viene dalla città, ma la
sua famiglia vi si è insediata da poco. Il campione dei nove è uno spaccato
abbastanza fedele dalla massa algerina.
Sono rappresentativi per la ripartizione delle loro origine geografiche.
7 su 9 provengono dalla metà orientale dell’Algeria; l’unico uomo dell’Ovest
è Ben Bella; l’unico abitante della provincia di Algeri è Didouche. Due
sono abitanti della Cabila. Cinque sono della provincia di Costantina, zona
situata nella parte più remota dell’Algeria, provincia-faro dell’irredentismo
174
I nove capi storici algerini del 1954
algerino. I costantinesi rappresentano la maggior parte della popolazione
algerina; la loro provincia è quella meno popolata dagli europei; ma la
destrutturazione della società costantinese ad opera del colonialismo è più
recente che nelle altre zone.
Le radici profondamente algerine dei nove sono confermate dal fatto
che nessuno dei nove ha conosciuto la ghirba (l’espatrio in Francia):
nessuno che abbia lavorato come operaio in Francia tra di loro. Andarono
sì in Francia, ma soltanto come funzionari del partito. La differenza è
grande con il percorso politico di Messali Hadj, il leader della vecchia
Stella Nordafricana, poi del PPA: Messali Hadj si trova in Francia dal
1918; ha una conoscenza profonda della società francese; è stato iscritto
al Partito Comunista; anche se poi ha rotto i rapporti con il movimento
operaio francese, ne ha condiviso i valori e ne ha conservato per lo meno
i modelli organizzativi. Per oltre trent’anni, la sua compagna fu Émilie
Busquant, figlia di un operaio anarchico sindacalista di Neuves-Maisons,
nei pressi di Nancy, in Lorena. Viceversa, la formazione dei nove è
estranea al vissuto e alle rappresentazioni che formarono in parte un
Messali Hadj.
Rappresentativa della massa algerina è anche la scarsa dimestichezza con
la cultura araba dotta, tranne che per due i loro. Altrettanto rappresentativo
è tuttavia l’orgoglio di parlare la lingua araba della quale sentono di essere
stati privati dai colonizzatori. Da qui la futura naturale propensione
all’arabizzazione dell’Algeria indipendente. Nonostante questo
l’identificazione culturale lascia al francese uno spazio privilegiato: il francese
costituisce la lingua della lotta politica, la cultura operativa.
Rappresentativa della massa è pure, per i due terzi di loro, l’inconsistenza
del loro pensiero politico al di là della parola d’ordine dell’indipendenza.
Cinque o sei di loro sono armati di certezze semplici, sono innanzittutto
attivisti. Cinque sono sopratutto dei party-made men o dei thawra-made
men2: Ben Bella, Bitat, Didouche, Khider, Krim.
Rappresentatività o differenza: tutti sono più o meno segnati dalla cultura
detta musulmana. Ma vi è un solo musulmano per due laici. Per tutti, però,
compreso il «marxista» Boudiaf, lo slogan islamico rimane il segno di
riconoscimento più significativo. Pochi sono profondamente credenti, il
che non esclude una tendenza alla bigotteria sociale, al contrario.
Altra differenza: nonostante l’origine sociale eterogenea, nessuno
appartiene agli spersi bassifondi rurali, o comunque nessuno vi è rimasto.
Ma tutti hanno una conoscenza, almeno pratica, dei ceti rurali. Tutti hanno
175
Gilbert Meynier
o ritengono di aver talenti; talenti che occorre far legittimare dalla classe
popolare poiché non lo ha fatto il colonizzatore razzista/stupido.
Tutti hanno conosciuto una rottura di posizione sociale e/o culturale, in
un senso o nell’altro: arretramento o promozione sociale. Finora è stato
soprattutto il primo a destare interesse. Permette di spiegare il rancore di
fronte alla discriminazione coloniale.
Tre delle figure del gruppo provengono da famiglie che annoverano o
hanno annoverato dei collaborazionisti coloniali (Aït Ahmed, Krim, Ben
M’hidi). Donde una verosimile propensione a riscattarsi da simile
ascendenza. Solo uno è un borghese facoltoso di paese. Gli spetta giustificare
la propria agiatezza nei confronti della classe popolare prendendone la guida
(Ben Boulaïd).
Quando la promozione sociale non poté essere ottenuta mediante gli
studi presso la scuola coloniale, questa venne sostituita dal partito. Finora,
questo fenomeno di promozione sociale tramite il Partito Nazionalista è
stato studiato poco dagli storici. Meriterebbe invece di esserlo giacché i
partiti svolgono un ruolo importante nell’edificazione di qualsiasi burocrazia.
E il FLN fu fondamentalmente un’autentica burocrazia - ed anche di più,
in seguito, lo stato algerino indipendente.
Prime considerazioni
L’interclassismo o l’intersegmentarismo rappresentano ad un tempo la
difesa e illustrazione del gruppo sociale di appartenenza e della società
globale. Nella lotta nazionale o nella lotta del gruppo di origine, qual è il
fine e quali sono i mezzi, nella misura in cui si tratta di una lotta unica?
I capi rivoluzionari aspirano - almeno inconsciamente - a formare la
futura classe dirigente algerina, in una logica di sostituzione al potere
coloniale. Aspirare a ciò con la Francia coloniale equivarrebbe a un suicidio
sociale, tanto è rigida la barriera coloniale che discrimina gli uomini.
Il nazionalismo non è quindi un vero e proprio «interclassismo», poiché
aspirazioni di classe e nazionalismo sono vettori orientati nella stessa
direzione. A lunga scadenza, l’interclassismo non deve certamente niente a
un comune denominatore sociale. È percepito in quanto tale finché il
colonialismo sovradeterminante conduce e falsa il gioco. Il nazionalismo
non annulla mai le tensioni sociali, culturali, politiche. Le contiene entro
limiti decenti - che possono anche essere indecenti, come attestano i
176
I nove capi storici algerini del 1954
sanguinosi regolamenti di conti all’interno del FLN o tra il FLN e il MNA
(partito messalista) - e rimanda al futuro l’aperto manifestarsi di tali tensioni
strutturali.
Nella storia del nazionalismo algerino, i primi quadri propugnatori
dell’élite sociale della Federazione degli Eletti Musulmani (gli «evoluti» o
Giovani Algerini) hanno perso il treno negli anni trenta. Così anche le
persone di estrazione popolare emigrate appartenenti alla generazione della
Stella Nordafricana.
Il blocco storico protagonista del 1954 assimila dei rurali che hanno
però avuto contatti con le città, privilegiati rispetto agli altri, che hanno
vissuto un brusco cambiamento nella loro posizione sociale, per lo più con
una scarsa cultura politica e con una propensione al moralismo e
all’attivismo. Questo blocco è attento alle esigenze della classe popolare,
ma si prefigge anche di unire le altre forze nazionalistiche attorno alla propria
bandiera per allargare la consistenza del blocco: e così fu il FLN, rafforzato
dai freni e dalle pesantezze coloniali.
Conclusioni
La provenienza sociale, nonché la memoria politica e la sedimentazione
culturale sono importanti e determinano l’impegnarsi degli uomini. L’analisi
sociale è necessaria ma non sufficiente tuttavia per spiegare la storia del
nazionalismo algerino.
Le formalizzazioni (lotta di classe, interclassismo, intersegmentarismo)
sono indubbiamente utili: sono intuizioni interessanti legittimate da un
sistema retorico (non è forse così per la maggior parte delle teorizzazioni, se
non addirittura per tutte?). Ma devono essere combinate e verificate
minuziosamente di volta in volta. E la combinazione dei molteplici parametri
è indispensabile per lo storico che non sia mosso dalla sola volontà di
elaborare un sistema.
A sua volta, la storia dell’Algeria fornisce ragguagli sull’Algeria
indipendente: circa le tensioni tra classi e segmenti, circa il permanere delle
solidarietà regionali, circa il wilayisme3. Anche adesso, gli alti funzionari
dell’amministrazione e i capi maggiori dell’esercito algerino sono
prevalentemente originari della metà orientale dell’Algeria, soprattutto della
provincia di Costantina, mentre è piuttosto la gente originaria della Cabila,
177
Gilbert Meynier
di Tlemcen e del M’zab (regione meridionale di Ghardaia) a dividersi la
tecnostruttura.
Infine, forse non ho insistito abbastanza sulla cultura militare e sul culto
dell’azione, che mostrano che l’esercito francese ebbe nella società algerina
un’importanza almeno pari - e probabilmente ben superiore per la massa a quella della scuola. Non va scordato che il servizio militare, contrariamente
alla scuola, era teoricamente obbligatorio sin dal 1912, e in pratica, dal
1916. Il numero di algerini ad essere passati per l’esercito francese fu assai
più alto del numero di quelli che frequentarono la scuola. E soprattutto si
combinò con la cultura di società profondamente mediterranee in cui il
pacifismo non-violento non è ben accetto.
Ad ogni modo, si tratti dell’islam o si tratti delle forme della violenza
nella società, il nazionalismo algerino poggiò su un necessario ripiegamento
verso forme di cultura ancestrali: necessario, in mancanza di meglio, per
legittimare le audaci iniziative che si muovevano nel segno della modernità;
necessario di fronte alla classe popolare per apporre sulla lotta il marchio
algerino.
Note al testo
1
Parti du Peuple Algérien-Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques. Il PPA fu,
nel 1937, il successore della Stella Nordafricana, proibita dal governo di Front populaire del
Leon Blum. Messo fuori legge nel 1945, il MTLD diventò, in occasione delle elezioni del
1946, la faccia legale del partito.
2
Thawra : la rivoluzione anticoloniale.
3
Patriottismo delle wilâiyyât - i circondari regionali dell’esercito partigiano algerino.
178
Il gioco degli specchi deformanti: stereotipi e autostereotipi tra Italia e Germania
studi sull’europa
Il gioco degli specchi deformanti: stereotipi e
autostereotipi tra Italia e Germania
di Giorgio Novello
Stereotipi e paradigmi
Esiste - se ci si passa il bisticcio - uno stereotipo sugli stereotipi,
intendendosi con questi ultimi (nel contesto di questo contributo) modalità
di percezione di persone o gruppi sociali cristallizzate, rigide e spesso (ma
non sempre) negative, che ostacolano una valutazione obiettiva e possono
condurre ad atteggiamenti ed azioni «irrazionali». Gli stereotipi, si ritiene
comunemente, sono sempre dannosi: comportano costi sociali ed economici
non indifferenti, favoriscono il consolidamento di situazioni subottimali,
accrescono le tensioni specie in campo internazionale. Eppure sembrano
ineliminabili. Il termine stereotipo è infatti sì relativamente recente (XVIII
secolo), ed originariamente riguarda l’arte della stampa (in riferimento alle
lastre di piombo che riproducono su supporto più stabile e meno facilmente
usurabile le matrici composte con caratteri mobili); ma il fenomeno è antico
quanto l’uomo. Un solo esempio, ma particolarmente autorevole: i Vangeli
non lasciano dubbi su quali fossero gli stereotipi negativi comuni tra gli
abitanti di Gerusalemme o del resto della Giudea e di cui erano vittime gli
abitanti delle vicine regioni di Samaria e Galilea. Poco prima dell’arresto di
Gesù, a Nicodemo viene ricordato ironicamente che dalla rozza Galilea
non vengono certo profeti1. L’impatto emotivo presso i primi ascoltatori
(in Giudea) della parabola del buon samaritano2 o dell’episodio della donna
samaritana al pozzo3 si spiegano anche alla luce dell’immagine negativa dei
samaritani stessi, ritenuti di origine e credo incerti e dubbi.
Da qui la tentazione di considerare gli stereotipi come un male necessario,
con cui convivere o magari sfruttare a proprio vantaggio. Questa è in fondo
la tesi (applicata beninteso ad un settore ben diverso da quello qui considerato)
179
Giorgio Novello
di Al Ries e Jack Trout, salutata al suo apparire un quarto di secolo fa come
una rivisitazione dei fondamenti stessi del marketing e da allora ampliata,
adattata, ritoccata ma non più messa in discussione: «la percezione è la realtà,
e la realtà è la percezione». Nella loro opera fondamentale i due sono chiari:
«La realtà che conta davvero è quella che è già nella mente del cliente. Il
nostro approccio fondamentale non consiste nel produrre qualcosa di diverso,
ma nel modificare quello che è già nella testa della gente»4.
Ma un uso mirato degli stereotipi può anche prendere la forma (talvolta
meramente strumentale) della loro negazione o del loro ribaltamento spinto
ad absurdum (il che equivale alla fine ad una loro conferma): l’effetto retorico
è assicurato. Lo scrittore cattolico tedesco Martin Mosebach fa dire ad un
suo personaggio: «L’Italia è il Paese più freddo del mondo... non in senso
metereologico, ma spirituale, dei sensi, del gusto, culturale ... si può parlare
di una predisposizione storicamente determinata degli italiani alla freddezza».
Un altro suo personaggio chiosa: «In tutti i casi nei quali gli uomini del
nord sono coinvolti emotivamente, gli italiani rimangono distaccati e
freddi»5. Artificio retorico che finisce con l’assomigliare curiosamente
all’esagerazione dello stereotipo positivo, al quale ricorre ad esempio
(garbatamente) Friedrich Christian Delius. Quest’ultimo mette in bocca
una citazione gogoliana al protagonista del suo La passeggiata da Rostok a
Siracusa, che fugge dalla DDR per visitare l’Italia ma poi rimpatria
volontariamente: «L’Italia sta al resto del mondo come una giornata di sole
sta ad una settimana di pioggia»6.
Forse è possibile un approccio più sereno. Gli stereotipi possono anche
essere visti nelle loro potenzialità positive, come piccoli paradigmi alla Kuhn:
modalità di percezione della realtà, che di quest’ultima selezionano alcuni
tratti fondamentali come riferimenti nel perseguimento di talune finalità
di ordine cognitivo e pratico (ordinare e generalizzare la realtà; comprendere
i nessi di causalità; anticipare, o addirittura prevedere, sviluppi futuri;
distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è; individuare le vie
migliori per raggiungere i propri fini)7. La semplificazione della realtà operata
dai paradigmi obbedisce ad una necessità cognitiva di ordine generale. Come
le carte geografiche, anche essi devono necessariamente essere selettivi: una
carta geografica che riproducesse perfettamente la realtà, tutta la realtà,
sarebbe inutilizzabile ed inutile. Nel momento in cui emergono altri
paradigmi, più «utili» perché si dimostrano guide più affidabili alla
conoscenza ed all’azione, i paradigmi ritenuti validi fino a quel momento
possono essere abbandonati; non necessariamente perché meno «veri» dei
180
Il gioco degli specchi deformanti: stereotipi e autostereotipi tra Italia e Germania
nuovi, ma perché meno idonei di questi ultimi al perseguimento degli stessi
fini. In questo senso anche gli stereotipi possono quindi svolgere un ruolo
come chiave di accesso graduale a realtà, individuali e sociali, che per
definizione sono estremamente complesse. Purché, sia chiaro, si riconosca
loro una funzione meramente strumentale.
È questo in fondo l’approccio scelto da un certo numero di opere,
apparentemente «leggere», che muovono dagli stereotipi, li mettono in
discussione, li verificano, li combattono, ne constatano i limiti ma in sostanza
se ne servono appunto per decifrare realtà altrimenti incomprensibili. Nella
sua versione più recente, il genere muove probabilmente dal libro di George
Mikes, un ungherese che a metà degli anni quaranta descrive in modo
graffiante le difficoltà di integrazione di uno straniero in Gran Bretagna8, e
arriva fino alle fortunatissime analisi di Severgnini sugli inglesi9 e di Giardina
sui tedeschi10. Né mancano esempi di attenzione agli autostereotipi, quelli
che un popolo (o un gruppo sociale) applica a se stesso, ad esempio nel
libro-pamphlet del tedesco Klaus Stille sui suoi compatrioti (anche se in
filigrana gli italiani vi fanno capolino come termine di riferimento:
conseguenza forse della moglie italiana dell’autore; o forse perché, come si
sostiene nei paragrafi che seguono, l’intensità delle correnti sotterranee che
legano i due popoli forse non hanno l’eguale in Europa)11.
L’analisi degli stereotipi richiede quindi innanzitutto un approccio di
tipo fattuale. È quanto cerchiamo di fare in questo contributo, dedicato ad
un caso di specie particolarmente rilevante e che abbiamo già implicitamente
focalizzato nelle righe che precedono: le percezioni reciproche tra tedeschi
ed italiani. Su queste ultime molto è stato scritto, e proprio per sottolineare
ora la stabilità, ora la flessibilità degli stereotipi. Sul primo versante, una
menzione particolare merita il contributo di Elisabetta Mazza Moneta, che
elabora organicamente un abbondante materiale empirico-quantitativo che
dimostra come, all’inizio del terzo millennio, «tedeschi ed italiani dispongano
di immagini, sia su se stessi che gli uni degli altri, che sono al contempo
molto precise e stabili nel tempo»12. Sul secondo versante, Gherardo Ugolini
propone una affascinante carrellata attraverso le non molte pagine dedicate
alla Germania dalla letteratura italiana degli ultimi sessanta anni13.
Muovendo dal neorealismo di Elio Vittorini, del primo Italo Calvino, di
Renata Viganò, per giungere ai giovani scrittori degli anni novanta, Ugolini
dimostra come lo stereotipo del tedesco barbaro e nemico, proprio della
letteratura «resistenziale» dell’immediato secondo dopoguerra, si evolva via
via in un’immagine più complessa, dapprima di un paese privo di unità
181
Giorgio Novello
interna, tormentato e nevrotico (La doppia notte dei tigli di Carlo Levi,
1959), successivamente di una società prospera e con maggior fiducia nel
futuro (La passione di Michele di Giuseppe Fava, 1980), che assume poi
venature ecologiste e pacifiste (Paso Doble di Giuseppe Culicchia, 1995) e
che sfocia in una nazione finalmente in pace con se stessa, culturalmente e
socialmente vibrante, anche se non sempre facile per gli stranieri (La moto
di Scanderbeg di Carmine Abate, 1999). L’analisi di Ugolini conferma a sua
volta un fenomeno di più ampia portata: basti ricordare come i tedeschi,
considerati nel ventesimo secolo come l’incarnazione stessa del militarismo
aggressivo, all’alba del diciannovesimo (prima di Bismarck) erano visti come
pacifici ed un po’ ottusi abitanti di vallate alpine e renane, militarmente
inetti, simpaticamente pronti alla chiacchiera e al sentimentalismo.
La polarità tra flessibilità e rigidità degli stereotipi costituisce la tela di
fondo anche di questo contributo, che peraltro muove da una prospettiva
storica che prescinde da circostanze di stretta attualità e cerca piuttosto di
sottolineare alcune costanti. Per evitare di scadere nella cronaca (o, peggio,
nella polemica spicciola), gli episodi più recenti richiamati nel testo risalgono
intenzionalmente ad alcuni anni fa (ma riguardano comunque pur sempre
la Germania riunificata con capitale Berlino). Sarà subito evidente peraltro
che nulla hanno perso della loro freschezza e che, con pochissimi
adattamenti, potrebbero benissimo aver avuto luogo oggi stesso.
Immagini e miti di fondazione
Problemi reciproci di immagine rendono i rapporti italo-tedeschi,
peraltro ottimi in molteplici campi, meno facili di quanto potrebbero esserlo.
Ciò riemerge con particolare visibilità nella stampa. Un solo esempio,
volutamente sopra le righe: Hans-Jürgen Schlamp su «Der Spiegel» del 22
maggio 1999 definiva testualmente l’Italia «il campione mondiale
dell’imbroglio statistico», un paese nel quale «le ferrovie, poste ed ospedali
offrono prestazioni da terzo mondo» in cui «l’efficienza del sistema bancario
è pari a quella del Mali» e dove le cifre sul deficit di bilancio sono «inventate
di sana pianta». Nello stesso periodo, la ADAC (il Touring Club tedesco)
distribuiva ai suoi soci in partenza per vacanze in Italia un opuscolo dal
titolo Italien - oder wie kaotisch ist der Italiener (L’Italia, ovvero: quanto è
caotico l’italiano), mentre la Deutsche Bank metteva in guardia i clienti
con un disegno in cui due turisti subivano uno scippo sotto la Torre di Pisa.
182
Il gioco degli specchi deformanti: stereotipi e autostereotipi tra Italia e Germania
Naturalmente ogni episodio va inserito nel suo contesto: l’articolo di
Schlamp era stato un incidente in un periodico di prestigio (noto peraltro
per la celebre copertina della pistola sul piatto di spaghetti), mentre la
brochure dell’ADAC usava un titolo ad effetto per far leggere un testo che
rivela invece affetto ed interesse per l’Italia. Soprattutto il tutto va relativizzato
nel contesto più ampio della normale dialettica della vita internazionale.
Qualsiasi tabloid britannico degli ultimi mesi aveva pubblicato attacchi
ben più pesanti alla Germania14, mentre il panorama editoriale francese si
era distinto nello stesso periodo per alcuni libri che prospettavano seriamente
il rischio di nuove tentazioni egemoniche della Germania e che attirano il
lettore con titoli di forte effetto15. Ciononostante, nel caso delle relazioni
italo-tedesche il fenomeno si presenta con caratteristiche specifiche che vale
la pena analizzare nelle sue radici più profonde.
Si può muovere da due premesse di ordine più generale. Innanzitutto, sia
a livello individuale che a livello di popoli, è perfettamente possibile la
coesistenza di sentimento contrastanti verso gli «altri», siano essi persone
specifiche o appunto altri popoli. È noto come in Italia e Germania vi siano
anche immagini fortemente positive dell’altro paese e come tradizionalmente
vengano attribuite reciprocamente qualità particolari in determinati campi.
Questo non impedisce che al contempo vi siano immagini anche fortemente
negative su altri aspetti e che queste possano convivere perfettamente, senza
venirne influenzate, con quelle positive. Parimenti, nella stragrande
maggioranza dei casi le immagini negative non conducono ad atteggiamenti
negativi diretti specificamente verso cittadini dell’altro paese (con la possibile,
limitata eccezione di alcune aree dei Laender dell’ex-DDR, ove peraltro taluni
atteggiamenti xenofobi che riguardano anche gli italiani sono in genere rivolti
agli stranieri in generale ed hanno motivazioni specifiche, sociali più che
economiche). È quindi legittimo e metodologicamente corretto dedicare
un’analisi alle percezioni negative ed alle difficoltà nelle relazioni reciproche
anche se, nella grande maggioranza dei casi, i rapporti bilaterali sia individuali
che tra paesi sono buoni o addirittura ottimi.
In secondo luogo, va richiamato brevemente il ruolo dei «miti di
fondazione» come elemento imprescindibile nei processi di identificazione
collettiva di entità sociali e qundi anche delle nazioni e degli stati. L’allora
ministro federale della Cultura, Michael Naumann, nel corso di un intervento
ad un convegno di studi organizzato dalla Presidenza tedesca dell’Unione
Europea a Bonn, nel marzo 1999, sul tema del ruolo della storia nella
formazione di un’identità europea, ne aveva sottolineato taluni aspetti di rilievo
183
Giorgio Novello
anche per la loro applicabilità immediata ad una lettura di taluni aspetti del
nostro argomento: «Durante la formazione di nazioni e Stati, quasi tutti i
popoli europei hanno cercato di evidenziare la propria originalità ed unicità.
Tutti i miti storici sono caratterizzati da unificazione verso l’interno e
separazione e distinzione verso l’esterno. Essi cercano di giustificare l’unità di
tutti i membri della comunità in un solo gruppo omogeneo, invocando se
possibile un’origine divina o, quantomeno, una genesi storica che risalga ad
una comunità originaria. I miti assolvono anche alla funzione di tracciare
confini rispetto ad altri popoli e i loro miti, svolgendo quindi un ruolo centrale
nel plasmare le identità nazionali e fungendo da strumenti poderosi di
promozione dell’autocoscienza collettiva. Il rivivere comunitario di grandi
momenti del passato rappresenta una parte significativa della vita delle nazioni,
che tornano alla fonte delle loro rispettive esistenze collettive attraverso
celebrazioni, anniversari, commemorazioni di ogni genere. A seconda delle
circostanze e dei momenti storici, queste autoidentificazioni collettive possono
condurre a scontri con altre nazioni e con le autoidentificazioni collettive di
queste ultime». Resta però vero, chiosa Naumann evocando il tema centrale
di questo contributo, che «i miti nazionali introducono un elemento di rigidità
nella percezione di altri popoli e nazioni ed introducono automatismi che
rendono meno facile la comprensione reciproca»16.
Impossibile dar torto a Naumann su quest’ultimo punto. Una volta posti
in essere, i miti di cui sopra tendono infatti ad essere molto resistenti e a
sopravvivere spesso annidati al di sotto del livello di coscienza, sicché i loro
effetti si avvertono molto dopo che essi hanno cessato di essere esplicitamente
e direttamente utilizzati come mezzi per la promozione dell’identità
nazionale. Nel caso di specie, per il momento in relazione alla sola Germania:
i miti collettivi tedeschi del diciannovesimo secolo (la vittoria sui Romani
nella foresta di Teutoburgo, le gesta del Barbarossa) hanno da tempo perso
il loro potenziale aggressivo17; ma, si può proseguire, essi continuano ad
agire ancora in modo indiretto, contribuendo ancora a plasmare la percezione
di sé dei tedeschi e quindi i loro rapporti con altri popoli. Considerazioni
analoghe vanno effettuate per gli italiani, come si vedrà in seguito.
Queste due premesse vanno tenute costantemente presenti
nell’analizzare un elemento fondamentale delle relazioni italo-tedesche.
Tra tutti i principali paesi dell’occidente industrializzato, Italia e Germania
sono quelli che probabilmente vivono con maggiore difficoltà il loro
rapporto con se stessi. Tra le ragioni comunemente addotte al riguardo
vi sono il forte ritardo del processo di riunificazione nazionale rispetto
184
Il gioco degli specchi deformanti: stereotipi e autostereotipi tra Italia e Germania
alle altre grandi nazioni europee, che ha condotto ad un debole senso di
identità nazionale in Italia e ad una continua ricerca di un’identità comune
in Germania; le forti identità regionali derivanti anche, in entrambi i
paesi, dalla disomogeneità delle esperienze storiche passate; e nel caso
della Germania i rapporti storicamente conflittuali con i paesi vicini.
Come per gli individui, anche per i paesi vale la regola per cui più debole
è il senso di identità individuale maggiori sono le difficoltà nella relazione
con l’esterno e maggiore è la valenza emotiva di quest’ultima, al punto
da prendere talvolta il sopravvento su una valutazione oggettiva della
realtà. L’incontro tra Italia e Germania si trasforma così alle volte in un
incontro tra due incertezze, che induce a scaricare sull’altro il peso della
propria insicurezza (che nel caso concreto può essere per l’Italia il timore
di non ottenere il riconoscimento del suo effettivo potenziale sulla scena
internazionale e per la Germania di non essere accettata come un paese
normale ma di restare per sempre un «sorvegliato speciale»)18. Il dialogo
bilaterale così ne soffre e i suoi frutti restano inferiori alle potenzialità,
nonostante non vi siano probabilmente altri grandi paesi in Europa con
una storia comune paragonabile a quella che unisce Germania ed Italia
(senza che ciò corrisponda necessariamente alla maturazione di una
conoscenza storica reciproca altrettanto approfondita). In particolare,
non esistono altri grandi paesi in Europa che per secoli abbiano convissuto
all’interno della stessa struttura politica e che abbiano avuto l’uno per
l’altro la stessa viscerale attrazione che è intercorsa tra Germania ed Italia.
Eventi come le due guerre mondali, l’alleanza tra fascismo e nazismo,
l’occupazione tedesca dell’Italia nel 1943, la resistenza e la sua
celebrazione nell’Italia del dopoguerra, l’emigrazione italiana in
Germania, le vacanze trascorse in Italia dai tedeschi e ora la grande
mobilità all’interno dello spazio europeo, hanno plasmato in modo
decisivo le immagini reciproche; ma si innestano in un sistema di relazioni
molto più antico e su immagini reciproche che obbediscono a meccanismi
con radici molto più profonde, di cui occorre tener adeguato conto nel
giudicare la tenacia di taluni stereotipi e la difficoltà a correggere
meccanismi sedimentati e consolidati da molto più delle quattro o cinque
generazioni del secolo scorso. In particolare, l’arcaicità di certe immagini
reciproche può spiegare perché esse resistano anche alla modifica della
realtà dimostrando al contempo una certa flessibilità e capacità di
adattamento ai «bisogni» ideologici e politici del momento. Grosse e
Trautmann sottolineano al riguardo i diversi «accenti» che gli stessi
185
Giorgio Novello
stereotipi (od autostereotipi) possono ricevere in epoche diverse, pur in
presenza di una sostanziale continuità19.
Germania e Italia: esse est percipi?
Sul tema delle immagini reciproche tra Italia e Germania non esiste
ancora una ricerca storica completa20. Il tema è, nonostante l’apparenza,
molto concreto. Come ricordato all’inizio di questo contributo,
l’immagine è ben più di una semplice «illusione ottica». Per Grosse e
Trautmann essa è una «costruzione cognitivo-psicologica» (kognitivpsychologisches Konstrukt) dotata di vita propria, naturalmente radicata
nella differenza tra le proprietà oggettive di una data entità (nel nostro
caso popoli e nazioni) e la riproduzione soggettiva degli stessi da parte di
determinati gruppi umani sulla base di criteri a loro propri e quindi
manipolabile, come dimostrato ampamente da ogni dittatura21. Il materiale
empirico comunque raccolto ed analizzato in studi settoriali consente
qualche riflessione di carattere generale, che è quanto si cercherà di fare
nei paragrafi che seguono, nei quali si ricorrerà il più possibile ad esempi
concreti. Va sottolineato come le relazioni culturali tra le due nazioni
precedano, ovviamente, quelle tra i due giovani Stati nazionali sorti così
tardi, e come le relazioni culturali stesse costituiscano la base su cui si
innestano i rapporti più specificamente politici a partire dal 1860-1870.
Va anche sottolineata l’asimmetria tra le percezioni tedesche e le percezioni
italiane, in quanto queste riguardano non solo il modo di rapportarsi
all’altro popolo («eterostereotipo») ma anche a se stessi («autostereotipo»).
Anche gli autostereotipi sono importanti nelle relazioni bilaterali, nel quale
ha importanza sostanziale il concetto di differenziazione. Allorché due
popoli ritengono di essere simili, l’autoidentità, che non può basarsi
efficacemente sull’autopercezione, si basa sulla percezione dell’altro come
diverso e quindi sull’eterotipo. Nel caso dei tedeschi, la ricerca empirica
ha dimostrato la grande importanza della percezione di sé incentrata su
caratteristiche positive della collettività, seppure in presenza anche di
elementi negativi. Martin Greiffenhagen cita ricerche del 1959, del 1978
e del 1988, nelle quali, sia pure in modi e con intensità decrescente, i
tedeschi si dimostravano i più convinti tra tutti i principali paesi occidentali
delle loro qualità collettive (Volkseigenschaften), ed al contempo i meno
186
Il gioco degli specchi deformanti: stereotipi e autostereotipi tra Italia e Germania
orgogliosi della propria nazionalità22. Altre ricerche sembrano indicare
che per gli italiani sia vero esattamente il contrario.
Il dato di fondo da approfondire è proprio questa singolare compresenza
di due elementi apparentemente inconciliabili: la persistenza di molteplici
modalità di percezione non positive da un lato, una vasta esperienza storica
comune (che si traduce anche in profonda attrazione reciproca) dall’altro.
Gli esempi puntuali utilizzati nel prosieguo cercheranno appunto di
sottolineare la persistenza di certi meccanismi da una fase storica all’altra.
Le parole pesano. Espressioni apparentemente anodine sono in realtà
ancora profondamente cariche di emotività. Gli italiani parlano di «invasioni
barbariche»: un termine carico di tensione, che sottintende una civiltà
superiore che cade preda di popoli più forti fisicamente ma culturalmente
più rozzi. I tedeschi parlano invece di «migrazioni di popoli»
(Voelkerwanderunge): un concetto neutro, che si concentra in modo asettico
su di un dato di fatto, minimizza le violenze ed i traumi che tali migrazioni
hanno implicato e non mette necessariamente ed immediatamente in dubbio
(come fa invece l’altro termine) la legittimità storica, morale e giuridica
dell’accaduto.
Qualunque ne sia la denominazione, l’insediamento dei germani sul
suolo romano fu un evento traumatico che si tradusse in relazioni difficili
tra le due popolazioni. Diverse sono le testimonianze scritte che testimoniano
le continue frizioni tra popolazioni latine e i germani sopravvenuti. È noto
il ritornello in latino e tedesco, che vuol essere offensivo verso i «romani»,
conservato in un glossario romanzo-bavarese del IX secolo («glosse di
Kassel»):
Stulti sunt romani
Sapunti sunt paioari [bavaresi]
Modica est sapientia in roman[is]
Plus habent stultitia quam sapientia23.
Più che i versi, che sono una comunissima espressione della difficoltà
della convivenza tra genti diverse, è interessante il termine con cui in è
tradotto il termine «romano» nel tedesco del IX secolo: «Walha», destinato
ad avere una enorme fortuna e ad assumere connotazioni spregiative. Ad
esempio, nel coro finale dei Mastri Cantori di Norimberga di Wagner, i
protagonisti gioiscono per la vittoria sulla perfidia latina (welsche Treue);
al contempo però invocano prosperità per il Sacro Romano Impero,
termine col quale viene ovviamente intesa la nazione tedesca ma che ci
187
Giorgio Novello
offre comunque un interessante caso di convivenza tra la deferenza verso
l’ideale della romanità da una parte e il disprezzo per i popoli latini
contemporanei dall’altra. Oggi, il termine «welsch» o «walsch», largamente
usato nella Germania meridionale, in Austria e in Alto Adige come
sinonimo di «italiano», ha un significato spregiativo. «Die Walsche» è ad
esempio il titolo del più riuscito romanzo dello scrittore altoatesino Joseph
Zoderer, dedicato alla difficile convivenza tra i gruppi etnici appunto in
Alto Adige e tradotto in italiano col titolo neutro (ma errato poiché la
vicenda si svolge in realtà a Bolzano) «La meranese»24. Che però,
nonostante le diffidenze reciproche, germani e latini trovassero il modo
di convivere, è confermato dalle stesse «Glosse di Kassel», che contengono
anche quello che sembra un manuale di conversazione su tematiche di
uso quotidiano, ad esempio: «dimmi come si dice questo» (indica meo
quomodo nomen habet homo iste - sage mir uueo namun habet deser man)
oppure «tagliami la barba» (radi meo parba - skir minan part) o ancora
«tagliami i capelli» (tundi meo capilli - skir min fahs).
Anche in italiano si trovano numerosi esempi della persistenza di
determinati termini, spesso con senso negativo. Innanzitutto le radici
germaniche recepite in italiano a seguito delle invasioni barbariche hanno
di solito un significato negativo (fetore, stamberga), abnorme rispetto al
termine ordinario (zanna, da Zahn, rispetto a dente) o comunque legata
alla violenza (guerra, faida, ordalia, usbergo, agguato, armi bianche)25.
Le eccezioni (guardare, guancia) sono poche e si spiegano con la necessità
di sostituire i termini latini corrispondenti spesso divenuti omofoni di altri.
Ancora oggi, millecinquecento anni dopo l’arrivo di Teodorico in Italia,
una lingua incomprensibile viene detta «ostrogoto». O ancora, come del
resto in tedesco, un comportamento particolarmente violento ed irrazionale
viene detto «vandalico». A questo proposito può esser ricordata una
campagna promozionale del Comune di Roma dei tardi anni novanta, intesa
a rafforzare il senso civico dei romani (di oggi): «un romano non può essere
un vandalo». Lo slogan, sicuramente molto riuscito, parrebbe postulare
che ancora oggi l’abitante medio di Roma conserva una qualche reminiscenza
(non diretta ma veicolata dalla scuola) del saccheggio di Roma del quinto
secolo d.C. ad opera dei vandali di Alarico e si ritiene inconsciamente l’erede
e il depositario di una cultura superiore a quella delle orde germaniche
calate dal Nord. Lo slogan del Comune di Roma faceva leva appunto su
questo senso di identificazione/distinzione, puntando sul fatto che esso abbia
una eco emotiva ancora sufficiente ad influire su comportamenti quotidiani.
188
Il gioco degli specchi deformanti: stereotipi e autostereotipi tra Italia e Germania
Vi si percepiscono ancora gli echi delle immagini della letteratura classica:
il «furor teutonicus» di Lucano26 ripreso dal «tedesco furor» di Petrarca27 e,
successivamente, nelle ultime parole del Principe di Machiavelli.
Piergiuseppe Scardigli del resto ricorda come l’immagine-tipo del germano
(alto, biondo o rosso, dagli occhi azzurri), l’antitesi nord-sud (da una parte
il sole che splende e la vita facile, dall’altra tristezza e paesaggio desolato),
quelle attitudini militari «di cui l’Europa tutta doveva poi fare prolungata
esperienza», risalgano a Tacito28.
Nei paragrafi introduttivi si è fatto riferimento alla funzione dei miti di
fondazione e alla loro antichità. La realtà storica è al massimo un punto di
partenza, che viene liberamente riplasmato e «rivissuto». Nei paragrafi che
seguono si sottolinea come le stesse due vicende (le battaglie della selva di
Teutoburgo e di Legnano) siano divenute, naturalmente in modo inverso
per tedeschi ed italiani, un momento collettivo fondante e un trascurabile
incidente storico di cui è difficile financo conservar traccia (a cominciare
dai libri di storia).
Il primo episodio riguarda il capo germano Arminio o Hermann, che
aveva ottenuto la cittadinanza romana e militava come ufficiale nell’esercito
imperiale ma che, che nell’anno 9 d.C., attaccò di sorpresa e distrusse tre
legioni romane nella foresta di Teutoburgo (Teutoburgensis saltus),
provocando il contrattacco romano degli anni 14-16 sotto la guida di
Germanico, figliastro dell’imperatore Tiberio, che nel 16 celebrerà a Roma
il trionfo per le sue vittorie in Germania, e finendo per essere assassinato
dai suoi stessi uomini. Le vicende sono descritte magistralmente da Tacito29
che nei germani vede ancora presenti quelle virtù che avevano reso grande
Roma30. Tacito è il primo glorificatore di Arminio, che egli finisce «liberator
haude Germaniae» (senza dubbio liberatore di tutta la Germania)31.
Indimenticabile è la descrizione dell’incontro tra Arminio e il fratello, che
continuava a servire come ufficiale nell’esercito romano, che lodano ciascuno
la propria scelta di vita e finiscono per rendersi conto di appartenere a due
mondi diversi ed incomunicabili32. Tacito resta comunque relativamente
isolato: non molti sono i classici che si soffermano sul mondo germanico
prima degli sconvolgimenti del V secolo33.
La figura di Arminio distruttore dei soldati di élite dell’allora superpotenza
militare rimane una costante nella storia dei germani e riacquista visibilità nel
diciannovesimo secolo, con il risvegliarsi della coscienza nazionale. Ne parla
Fichte nei suoi Discorsi alla nazione tedesca, sostenendo che non solo la storia
della Germania, ma l’intera storia del mondo sarebbe stata diversa se Arminio
189
Giorgio Novello
con la sua vittoria non avesse impedito la conquista romana di territori tedeschi
tra Reno ed Elba34. Ma il culto di Arminio raggiunge il punto culminante
durante il secondo impero tedesco, col monumento (di quasi 54 metri) opera
di Ernst von Bandel ed inaugurato da Guglielmo I il 16 agosto 1875 sulla cima
del Grotenburg, a sud-ovest di Detmold. La statua del capo germanico, di nove
metri di altezza, rivolge al cielo una spada sguainata recante la scritta Deutschlands
Einigkeit meine Staerke-meine Staerke Deutschlands Macht e guarda ad Occidente
(dove una volta erano le legioni romane e all’epoca i francesi). Ai piedi della
statua, le parole di Tacito (tranne quelle relative all’assassinio di Arminio da
parte dei suoi stessi compagni, ansiosi di concludere un accordo con Roma).
Hermann è tuttora una figura ben nota nell’immaginario collettivo tedesco. Il
monumento di Detmold resta una meta turistica non del tutto secondaria, che
celebra ancora quella che è presentata come la sconfitta più grave di tutta la
storia militare romana, che distrusse in un colpo solo un quinto dell’intero
esercito imperiale e che inflisse alle legioni un colpo dal quale esse non si
risollevarono mai del tutto. Non meno di settecento teorie sono state avanzate
circa l’esatta localizzazione del teatro della battaglia: segno questo di un enorme
interesse. Nel corso del Novecento sono stati pubblicati non meno di ventidue
opere di narrativa aventi ad oggetto le gesta di Arminio; solo nel 1998, tra titoli
originali e ristampe, sono apparsi non meno di cinque nuovi titoli35. Si tratta in
genere di opere che non brillano per ricostruzione obiettiva dei fatti; fa eccezione
in parte l’opera di Jutta Laroche, che non nasconde come Arminius all’epoca
della battaglia di Teutoburgo fosse ancora ufficiale romano, circostanza che
nelle altre opere viene in genere omessa probabilmente per allontanare possibili
accuse di tradimento.
Considerazioni speculari possono essere formulate sul secondo mito di
fondazione qui considerato: la sconfitta di Federico Barbarossa a Legnano. Il
Barbarossa rappresenta una figura significativa per l’immaginario collettivo
tedesco, nel medioevo, nell’epoca guglielmina e ancora durante il Terzo Reich
(si pensi all’operazione «Barbarossa»). Per gli italiani, il suo ricordo rimane
legato invece appunto alla battaglia del 1176, in cui l’Imperatore venne
pesantemente sconfitto da una coalizione di Comuni italiani guidati da Milano.
La battaglia di Legnano venne glorificata durante il Risorgimento come esempio
di concordia e valore nazionale. Naturalmente anche a Legnano vi è un
monumento, eretto nel 1876 quasi contemporaneamente a quello tedesco ad
Arminio; e anche la battaglia è cantata dalla letteratura (italiana) ottocentesca
che di fatto equipara tedeschi ed austriaci («a lancia e spada, a lancia e spada il
Barbarossa in campo» del Carducci). Lo stesso Manzoni parla di «germani»,
190
Il gioco degli specchi deformanti: stereotipi e autostereotipi tra Italia e Germania
intendendo ovviamente gli austriaci, nella sua composizione più esplicitamente
risorgimentale (Marzo 1821). Ancora oggi non c’è oggi cittadina della Lombardia
che non abbia una via o una piazza intitolata alla Lega Lombarda36.
È difficile, oggi, valutare se e in che modo questi miti influiscano ancora
sull’atteggiamento reciproco di italiani e tedeschi. Si possono però
formulare due considerazioni generali. Da una parte, né il mito tedesco
di Arminio né quello italiano della battaglia di Legnano sono sorti
intenzionalmente «contro» l’altra nazione. Come si è sottolineato, il loro
obiettivo era quello comune a tutti i miti di fondazione: accreditare
l’esistenza di radici comuni per popoli caratterizzati invece nella realtà
storica da un grado più o meno elevato (e nel caso di specie piuttosto
elevato) di frammentazione e divisione. Quando, in un secondo momento
(logico o cronologico) gli stessi miti vengono utilizzati «contro» una
popolazione diversa, quest’ultima non sempre coincide con quella nei
cui confornti ha avuto luogo l’originario episodio storico nella sua attualità:
Arminio viene recuperato in chiave antifrancese, la battaglia di Legnano
in chiave antiaustriaca. D’altra parte, la stessa straordinaria resistenza di
questi specifici miti collettivi rende difficile contestare il fatto che questi
lontani episodi, non per sé ma appunto per la lettura storica fattane, hanno
contribuito ancora in tempi non lontani a plasmare l’autopercezione dei
due popoli. L’uno ad esempio ne è stato rafforzato nella convinzione della
propria superiorità collettiva, l’altro nella grandezza delle sue potenzialità
dovute ad un’eredità culturale e storica senza pari, potenzialità che possono
divenire reali in caso di convergenza, anche per breve tempo, delle proprie
forze su di un obiettivo comune.
Nonostante tutto, una storia comune
La persistenza di immagini reciproche negative, sia pure motivate più
dall’aspirazione ad autodefinirsi che da vera ostilità, coesiste peraltro con
una storia per lunghi tratti condivisa, peraltro troppo nota perché sia
necessario dedicarvi qui più che qualche cenno. Il Sacro Romano Impero,
dall’incoronazione di Ottone il Grande (962) almeno fino alla morte dello
jesino Federico II (1250) e al tramonto della sua corte siculo-germanica, fu
essenzialmente una struttura italo-tedesca. Come tensione ideale lo rimase
però anche dopo, grazie anche alla mancanza di senso storico dei medievali
che in esso vedevano davvero la prosecuzione dell’antico impero romano
191
Giorgio Novello
ma che, muovendo proprio da esso, furono capaci di teorizzazioni
arditamente originali. Dante, che invoca la discesa in Italia dell’Imperatore
tedesco37, appare politicamente arcaico, ma in realtà elabora i dati empirci
del suo tempo in una visione lucidamente innovativa. Così come le teorie
sulla sovranità popolare di Marsilio da Padova, probabilmente il maggior
pensatore politico medievale, vedono la luce alla corte dell’imperatore
germanico Ludovico il Bavaro, ancora venerato in Baviera come uno dei
co-fondatori dell’identità regionale di quel Land38.
Ugualmente fondamentale è il comune ricorso al diritto romano,
recuperato, interpretato ed applicato come diritto vigente dell’impero
romano-germanico proprio in base al postulato che quest’ultimo fosse la
continuazione di quello romano e che quindi poggiasse sullo stesso corpo
normativo. In quest’opera si distinsero le Università italiane già
nell’undicesimo secolo, Bologna e Padova soprattutto, attraverso le scuole
dei glossatori e dei commentatori, intensamente frequentate anche da
studenti germanici almeno fino alla fondazione, sull’esempio italiano, di
centri universitari per lo studio del diritto (Heidelberg in primis). Di quei
tempi rimangono numerose testimonianze anche di cronaca minuta, in
particolare sui rapporti anche personali (non sempre facili ma costanti ed
intensi) tra studenti tedeschi ed italiani. Interessante al riguardo è ad
esempio la testimonianza di Gottfried Conratter, studente a Padova tra il
1557 e il 1578, molto critico nei confronti del suo paese ospite e della
didattica dell’Ateneo patavino39. Per lunghi secoli, proprio grazie al travaso
universitario tra Italia e Germania, il diritto romano tornò ad essere
effettivamente diritto vigente: il Tribunale camerale dell’Impero
(Reichskammergericht) istituito a Wetzlar (la città dove più tardi l’avvocato
Goethe conobbe Lotte) nel 1495, applicava i diritti romano e canonico
(quest’ultimo a sua volta emanazione diretta di quello romano) ed era
composto per almeno la metà da esperti di diritto romano40. Come diritto
suppletivo il diritto romano rimase in vigore in Germania fino al 1901.
Il patrimonio giuridico comune italo-tedesco (esteso anche ad altri Paesi
europei non sulla base della potestà diretta dello Stato ma esclusivamente
grazie al prestigio da esso acquisito e all’alto livello scientifico delle varie
scuole giuridiche) costituisce una base sulla quale il nuovo jus europeum
introdotto dalla Comunità Europea ha potuto in pochi decenni attecchire
e, spesso in via giurisprudenziale (e quindi proprio sulla base di quei
principi generali ampiamente forgiati dalla lunga e comune frequentazione
del diritto romano) integra o sostituisce ormai in parte rilevante i singoli
192
Il gioco degli specchi deformanti: stereotipi e autostereotipi tra Italia e Germania
diritti nazionali. In questo senso, la progressiva realizzazione di un sistema
giuridico europeo non rappresenta una rivoluzione ma semplicemente
un ritorno all’antico, quell’antico che era stato temporaneamente messo
in ombra, ma non cancellato, dall’enfasi ottocentesca sullo stato nazionale
e, poco prima, dall’ideologia illuministica della codificazione nazionale
delle leggi.
Un cenno va fatto anche all’uso comune della lingua latina. Keplero
scrive ancora in latino i suoi Astronomia Nova, Harmonice Mundi, Epitome
Astronomiae Copernicanae, Leibniz scrive in latino ancora una parte
significativa delle sue opere (De arte combinatoria, Demonstrationes catholicae,
Hypothesis physica nova de rerum originatione...); alla famosa abbazia di
Maulbronn Hoelderlin venne educato totalmente, e dopo di lui Hermann
Hesse parzialmente, in latino. L’uso di una lingua comune non significa
solo maggiore facilità di circolazione di testi e documenti e semplificazione
delle relazioni personali. Ogni lingua costituisce una visione del mondo
tutta particolare ed impregna delle sue strutture lo stesso modo di pensare
dei parlanti. La formazione viene fatta di norma sugli stessi autori che a
loro volta trasmettono e rafforzano una stessa visione del mondo. In questo
senso la lingua latina utilizzata per quasi tredici secoli dopo la caduta di
Roma ha consentito una vera cultura e letteratura europea in cui i contributi
italiani e tedeschi sono talmente intrecciati l’un l’altro da risultare
inseparabili. Basti pensare al primo e al secondo rinascimento carolingio,
opera di dotti di tutta Europa richiamati alla corte imperiale ma in larga
maggioranza etnicamente germanici (Alcuino di York, Paolo Diacono,
Paolino di Aquileja, Rabano Mauro, Eginardo...)41.
L’uso del latino non eliminava ovviamente la rilevanza dei volgari. Può
essere di interesse ricordare, nel contesto della coesistenza ed arricchimento
reciproco tra i due versanti delle Alpi, come il paragrafo conclusivo della
«Bolla d’Oro», il decreto di Carlo IV con cui nel 1356, e fino al 1806,
venne fissata la procedura per l’elezione del Sacro Romano Imperatore da
parte di sette principi elettori, siano previste disposizioni per l’insegnamento
delle lingue «tedesca, romanica e slava» per i principi imperiali, onde metterli
in grado di gestire correttamente gli affari di una compagine politica
multietnica e pertanto multilingue. Interessante anche la didattica relativa,
che prevede esplicitamente già all’epoca soggiorni nei paesi in cui si parlano
tali lingue ovvero, in mancanza di ciò, quantomeno un contatto diretto e
prolungato con persone di madrelingua42.
193
Giorgio Novello
Perché allora, nelle rispettive opinioni pubbliche ma talvolta anche
in ambiti politici ed accademici specializzati, non vi è piena
consapevolezza della comunanza storica tra Germania ed Italia, che
invece appaiono spesso diverse e lontane, depositarie di civiltà ma anche
di pregi e difetti antitetici e incompatibili?
Ancora una volta, parte della risposta può provenire dalla storia: in
particolare dalla Riforma protestante prima, dal nazionalismo ottocentesco
poi. L’opera di Lutero finisce per favorire una visione del Rinascimento
come corruzione, dominato dalla luce sinistra di Machiavelli, che
rappresenta una cesura netta col passato comune medievale. Dalla Riforma
in poi la percezione reciproca di Italia e Germania si complica, con singolari
fenomeni di cecità storica. Lo stesso Goethe non riesce a rapportarsi in
modo sereno col Rinascimento italiano e toscano in particolare. Nel suo
viaggio in Italia evita per due volte di soggiornare a lungo a Firenze,
rimpiangendolo poi per il resto della sua vita43. Eppure proprio un grande
umanista, Poggio Bracciolini, ci ha lasciato una descrizione notissima ed
idealizzata dell’indole tedesca basata sulle sue esperienze alle terme di
Baden nella primavera del 141644. Al nazionalismo ottocentesco ci si è
già riferiti più volte. I movimenti nazionali in Italia e Germania furono
di fatto alleati (a volte anche formalmente, come nel caso della guerra
italo-prussiana contro l’Austria nel 1866 che portò da una parte
all’estromomissione dell’Austria dalla Confederazione Germanica e
dall’altro alla riunificazione del Veneto al regno d’Italia). Questo dato di
fatto non venne però all’epoca percepito adeguatamente e non si tradusse
in un avvicinamento anche emotivo tra le due nazioni. La Triplice Alleanza
condusse a recriminazioni reciproche tuttora vive: si veda ad esempio la
ricostruzione delle vicende della Triplice di M. Goetemaker 45 .
Fondamentali in ciò furono ovviamente fattori oggettivi quali la
lontananza geografica, lo scarso peso militare e politico dell’Italia di allora,
l’assoluta prevalenza delle relazioni (conflittuali) franco-tedesche e italoaustriache su quelle italo-tedesche46. E abbiamo visto in precedenza come
alcuni miti nazionali, ripresi e vissuti dalle due parti rispettivamente contro
Parigi e contro Vienna (da Arminio al Barbarossa), abbiano finito per
incidere direttamente, in modo perverso, proprio sulle relazioni tra Italia
e Germania. Il tutto nonostante il parallelismo storico di tante vicende,
non solo nella realtà fattuale ma anche nella loro rappresentazione
collettiva, come Behrenbeck e Nuetzenadel hanno dimostrato
brillantemente47.
194
Il gioco degli specchi deformanti: stereotipi e autostereotipi tra Italia e Germania
Conclusione
Nel 1988, Christian Meier mise a nudo l’improponibilità attuale
dei miti di fondazione nella loro pura versione ottocentesca, perlomeno
in Germania: se i nostri nonni, scrive Meyer, potevano ancora dilatare
il concetto di «noi» (wir) fino a ricomprendervi Arminio («noi abbiamo
trionfato a Teutoburgo», così come i francesi si identificavano con
Vercingetorige e gli italiani con i romani), i tedeschi di oggi non lo
possono più dire, o almeno evitano di dirlo: un «noi» collettivo così
esteso finirebbe per ricomprendere anche la responsabilità della seconda
guerra mondiale e dell’olocausto48. Ma la lezione di Maier si applica
naturalmente al di là del caso tedesco: un «noi» che includa in un solo
concetto indifferenziato ed acritico le generazioni passate e quelle
presenti, se inizialmente può favorire un senso di identificazione, oltre
un certo livello finisce quasi fatalmente per trascendere le responsabilità
singole e solidificare il ben più pericoloso mito delle responsabilità
collettive. La questione ha quindi ramificazioni profonde, tanto più
tenaci quanto più il passato in cui affondano precede la rinascita
nazionale e nazionalista dell’Ottocento.
Occorre innanzitutto recuperare la consapevolezza fattuale al riguardo.
A livello specialistico vi è un rifiorire di iniziative: la germanistica in Italia e
l’italianistica in Germania vivono un periodo sostanzialmente positivo,
nonostante ricorrenti minacce. Vi sono iniziative specificamente mirate alla
ricostruzione del patrimonio storico comune. Un esempio tra i tanti possibili:
il Centrum Latinitatis Europae di Aquileia, che opera proprio per il recupero
della medievalità germano-romanica e di cui chi scrive è stato rappresentante
a Berlino. Tuttavia restano diverse talune strozzature (la difficoltà della lingua,
la preferenza degli studenti per soggiorni in Gran Bretagna o negli Stati
Uniti) che tolgono inevitabilmente spazio alla riflessione e alla ricerca sulle
cause più profonde di tematiche che non possono essere affrontate solo a
livello della quotidianità.
Note al testo
1
GV., 7, 52.
2
LC. 10, 25-37.
3
GV. 4, 1-26.
195
Giorgio Novello
4
AL RIES e JACK TROUT, Positioning: the battle for your mind, 20th anniversary edition, New
York 2001.
5
MARTIN MOSEBACH, Die schoene Gewonheit zu leben. Eine italienische Reise, Berlino 1997, pp.
10, 15.
6
FRIEDRICH CHRISTIAN DELIUS, Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus, Amburgo 1995, p.
143.
7
SAMUEL P. HUNTINGTON, The clash of Civilizations and the remaking of World Order, Londra
1997, p. 30.
8
GEORGE MIKES, How to be an alien, London/New York 1946.
9
BEPPE SEVERGNINI, Inglesi, Milano 1992.
10
ROBERTO GIARDINA, Guida per amare i tedeschi, Milano 1994.
11
KLAUS STILLE, Vom Volke der Deutschen. Eine heillose Legende, Zurigo 2000.
12
ELISABETTA M AZZA M ONETA , Deutsche und Italiener. Der Einfluss von Stereotypen auf
interkulturelle Kommunikation, Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Wien
2000, p. 261.
13
GHERARDO UGOLINI, L’immagine dei tedeschi nella letteratura italiana degli anni Ottanta e
Novanta, intervento al convegno «Italia ed Europa: dalla cultura nazionale all’interculturalismo»,
Cracovia, 25-29 agosto 2004, atti in corso di stampa.
14
J. KROENIG, Krauts, in «Die Zeit», 40, 30 settembre 1999.
15
PHILIPPE DELMAS, La prochaine Guerre avec l’Allemagne; ALAIN GRIOTTERAY, Voyage au bout de
l’Allemagne-l’Allemagne est inquietante; PIERE MARION, Memoires de l’Ombre, tutti usciti a Parigi
nel 1999.
16
«In the course of forming nations and states, almost all European peoples were constantly at
pains to accentuate their respective uniqueness and incomparability. The historical myths are
characterised throughout by unification inside and demarcation and separation outside. They
attempt to justify the unity of all community members in one homogeneous group by invoking
divine origin if possible, or a kind of historical genesis in an archaic primordial community.
The myths also possessed the function of marking borders to the other nations and their
myths, thus playing a key role in forging national identities and acting as powerful means of
fostering national self-consciousness. [...] Collective revivals of great moments of the past is a
significant part in the lives of nations, which return to the sources of their respective community
existences with the aid of anniversary celebrations, curricula, commemorations of every kind.
Depending on circumstances and on historical trends, such collective self-identifications can
lead to confrontation with other nations and with other collective self-identification [...] national
myths introduce an element of rigidity in the perception of other peoples and nations and
introduce automatisms which make the mutual understanding less easy»: MICHAEL NAUMANN,
196
Il gioco degli specchi deformanti: stereotipi e autostereotipi tra Italia e Germania
Europe and his Culture, in The Culture of European History in the 21st Century, Bonn 1999, pp.
15-16.
17
«heute sind alle sinnstiftenden Mythen [...] zu nichts verfallen»: M. GREIFFENHAGEN, Politische
legitimität in Deutschland, Bonn 1998, p. 67.
18
19
Ibid., soprattutto pp. 53-63.
Ibid., p. 243.
20
«gewiss steht eine historische, systematisch angelete deutsch-italienische Imagologie erst in
den Anfaengen»: ERNST ULRICH GROSSE e GUENTER TRAUTMANN, Italien Verstehen, Darmstadt
1997, pp. 243.
21
Ibid., pp. 240.
22
MARTIN GREIFFENHAGEN, Politische legitimität cit., pp. 71.
23
C. TAGLIAVINI, Le origini delle lingue neolatine, Bologna 1972, pp. 163-164.
24
JOSEPH ZODERER, Die Walsche, Frankfurt am Main 1995; J. HOLZNER (Hg.), Literatur in
Suedtirol, Innsbruck-Wien 1997.
25
Ma si potrebbe osservare anche che panzer è in realtà termine di origine veneta, e si riferiva
inizialmente alla parte dell’armatura che proteggeva il ventre.
26
LUCANO, Farsaglia, I 255 ss.
27
PETRARCA, Canzone 128, verso 93.
28
PIERGIUSEPPE SCARDIGLI, Filologia Germanica, Firenze 1975, p. 35.
29
Si veda soprattutto la visita di Germanico al campo trincerato di Varo distrutto dai Germani
e la sepoltura dei resti dei caduti: Annales, I, 61-62.
30
ELISABETTA RISARI, Introduzione alla Germania di TACITO, Milano 1991, pp. XV-XVI.
31
TACITO, Annales, II, 88: «Arminius è [...] dolo propinquorum cecidit; liberator haud duibie
Germaniae; [...] proeliis ambiguus, bello non victus, septem et triginta annos vitae, duodecim
potentiae explevit, canitur adhuc barbaras apud gentes».
32
Ibid, II. 9-10.
33
Oltre a Tacito parlano dei germani: Tito Livio, che tratta specificamente della morte in
Germania di Druso, figliastro di Augusto, e della disfatta di Varo nella selva di Teutoburgo,
alla fine del libro 142 di Ab Urbe Condita, purtroppo perso; di quest’ultimo, come di altre
parti dell´opera liviana, ci sono però state tramandate le «perioche», brevi riassunti composti
tra il terzo e il quarto secolo d.C.; Sallustio, forse nel terzo libro delle Historiae, perduto;
197
Giorgio Novello
Velleio Patercolo, comandante della cavalleria in Germania sotto Tiberio, autore delle Historiae,
opera di valore scientifico limitato e sostanzialmente panegirico dell’imperatore regnante;
Orosio, storiografo del quinto secolo d.C., convinto che i Germani sarebbero stati ben presto
assorbiti nella cultura romana, e quindi storicamente cieco di fronte al pericolo delle invasioni;
Salviano, contemporaneo di Orosio, autore del De Gubenatione Dei dove rivaluta gli invasori,
considerati più onesti e meno degenerati dei Romani in quanto meno colpevoli per non aver
ricevuto il dono della fede. Ne parla poi Sant’Agostino, nel De Civitate Dei, in cui l’azione
della Provvidenza nella storia, attraverso la nuova dicotomia città di Dio/città del mondo
supera il contrasto classico romani/barbari. Ma la prospettiva è ovviamente radicalmente diversa
da quella dei classici.
34
J.G.FICHTE, Reden an die Deutsche Nation, Hamburg 1972, pp. 136-137.
35
J. LAROCHE, Arminius, prima ed. 1993, seconda ed. 1998; F. DOEHLE, Irmintrut, prima ed.
1906, nuova edizione 1998; W. AUGSBURG, Aemilius Varro-Kommissar in Colonia, prima ed.
1983, nuova ed. 1998; G. SCHWAB, Tisiphone, prima ed. 1888, nuova ed. 1998; J. LEDROIT,
Wismunda, prima ed. 1929, nuova ed. 1998.
36
È perfino superfluo ogni riferimento alla fortuna che il termine stesso Lega Lombarda, ma
anche altri eventi e simboli ad essa collegati, hanno avuto nella vita politica italiana a partire
dalla metà degli anni ottanta.
37
O Alberto tedesco ch’abbandoni/costei ch’è fatta indomita e selvaggia/e dovresti inforcar li suoi
arcioni/giusto giudicio da le stelle caggia/sovra´l tuo sangue, e sia novo e aperto/tal che´l tuo successor
temenza n’aggia!, Purgatorio, VI, 97-102.
38
G.H. SABINE E T.L. THORSON, A history of political Theory, New York 1973, pp. 271-285.
39
A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa, I., Milano 1979, pp. 143-144.
40
Ibid., p. 169.
41
K. LANGOSCH, Profile des Lateinischen Mittelalters, Darmstadt 1965; LUIGI ALFONSI, La
letteratura latina medievale, Milano 1988; GIOVANNI CREMASCHI, Guida allo studio del latino
medioevale, Padova 1959.
42
«[i principi imperiali] incipiendo a septimo etatis sue anno in gramatica, Italica ac slavica
lingwis instruantur, ita quod infra quartum decimum etatis annum existant in talibus iuxta
datam sibi a deo graciam eruditi»: l’edizione critica della Bolla d’Oro è curata da Wolfgang
Fritz, in Monumenta Germaniae Historica, Weimar 1972.
43
M.F. CACIAGLI, Goethe e Firenze. Riflessioni sull’idea di Rinascimento nel classicismo weimariano,
comunicazione al Convegno «Goethe und Italien», Bonn 7-9 ottobre 1999.
44
POGGIO BRACCIOLINI, Del piacere di Vivere, a cura di Cecilia Benedetti, traduzione dal latino
di Violetta Candani, Milano 1995.
45
M. GOETEMAKER, Deutschland im 19. Jahrhundert, Bonn 1996, pp. 384-386.
198
Il gioco degli specchi deformanti: stereotipi e autostereotipi tra Italia e Germania
46
Ibid., p. 384-386.
47
SABINE BEHRENBECH e ALEXANDER NUETZENADEL (Hg.), Inszenierung des Nationalstaats.
Politische Feiern in Italien und Deutschland seit 1860-71, Koeln 2000.
48
C. MEIER, Was ist nationale Identität? cit. in M. GREIFFENHAGEN, Politische Legitimität cit.,
p. 65.
199
Giorgio Novello
200
Terrorismo, guerriglia, resistenza: considerazioni per un dibattito attuale
terrorismo, nuove guerre, genocidi
Terrorismo, guerriglia, resistenza: considerazioni per un
dibattito attuale
di Mario Giovana
Le vicende della seconda guerra mondiale hanno consegnato alla
storiografia (ed alla nozione comune) un contenuto centrale congruo e
chiaro del concetto di «resistenza»: opposizione attiva armata ed anche passiva
all’invasione ed occupazione straniera del suolo nazionale, con i suoi
addentellati interni di sudditanze collaborazioniste, aspirazione ad un ordine
sgombro da dittature oppressive. All’interno di questo profilo fondamentale
ed unitario - che si ritrova in tutti i movimenti europei riconducibili al
concetto - si collocavano poi nei singoli fenomeni nazionali del tempo una
serie differente di aspirazioni ed indirizzi d’ordine ideale ed ideologico
concernenti la natura degli sbocchi istituzionali, economici e sociali da
conferire ai movimenti emancipatori una volta raggiunto il traguardo della
liberazione. Tuttavia, l’essenza dello scontro e delle forze in contrasto erano
di per sé chiaramente individuabili e, per così dire, i fronti in lotta erano
politicamente ben delineati, mentre la sostanza del conflitto si presentava
priva di propellenti d’impronta propriamente religiosa e chiesastica (anche
se, naturalmente, ispirazioni e dettati d’indole religiosa concorrevano, ed
in forme spesso rilevanti, ad alimentare il fenomeno dell’opposizione ad un
sistema beluino e di ateismo militante quale era il nazismo hitleriano ed al
totalitarismo bellicista e violento quale era il fascismo).
Siamo usi di solito a ragionare di «resistenza» secondo questi parametri
di registrazione di un evento connesso alla storia europea della seconda
metà del secolo trascorso; e, di per sé, la sostanza dei termini del riferimento
rimane universalmente ammessa come dato costante di riconoscimento di
ogni altra condizione nella quale si riproducano le premesse base da cui
nasca una opposizione all’occupante straniero e si manifestino in varie forme
spinte alla conquista di libertà negate da ordini imposti ed estranei a verifiche
201
Mario Giovana
della corale volontà degli assoggettati. Adesso, il tema è balzato nuovamente
all’evidenza generale con ampiezza senza precedenti in connessione con la
tragica realtà irachena, sebbene i suoi termini fossero già drammaticamente
alla ribalta da tempo in relazione al conflitto israelo-palestinese in cui
tipologie cruente dello scontro in atto nell’ex dominio di Saddam Hussein
hanno trovato anticipazioni protratte e sanguinose. Gli avvenimenti
dell’Irak occupato dagli americani hanno fatto irruzione sulla scena
mondiale invadendo stampa e media con le cronache violente del loro
quotidiano; e attorno a questa esplosione ininterrotta di orrori, in un
paese in cui la disinvolta ed impressionante superficialità - di un presidente
- comandante delle forze armate della sua grande potenza aveva dichiarato
concluso il processo bellico, si sono aperte controversie interpretative
accese, analisi a tutto campo, feroci scambi di anatemi e si sono esercitate
(e si esercitano) tutte le sfumature di tendenze di un giornalismo
investigativo; non di rado mero strumento di pregiudiziali politiche di
parte e non meno di rado vittima della proprie particolari vocazioni
esibizionistiche, prive di decorosi retroterra culturali quanto di scrupoli
professionali, ma, per contro, anche sovente illustrato dalla serietà e dal
coraggio d’indagine di solidi protagonisti dell’informazione che non si
sono sottratti al dovere di registrare le confusioni nelle quali si sono
trovati impantanati evidenziandone i grovigli inestricabili, le limitazioni
ad attingere alla realtà dei fatti, le fitte oscurità e le molte obliquità con le
quali hanno dovuto fare i conti senza, dunque, poter approdare a dati
certi sui quali fissare i proprio giudizi.
In verità, il panorama iracheno è apparso agli osservatori disincantati
e privi di pregiudizi più o meno interessati un contenitore di tali e tanti
intrecci di elementi e fattori differenti intasati in un involucro incandescente e magmatico da rendere difficilissimo selezionare le componenti
dell’eruzione e, soprattutto, dal comporre quadri interpretativi dei suoi
fenomeni riportabili a parametri accessibili alla cultura occidentale non
soltanto europea. Cosicché, in questa gigantesca miscela, anche concetti
quali «resistenza» interna, opposizione patriottica, oppure terrorismo allo
stato brado con radici nel fondamentalismo religioso o, per contro,
finalizzato ad obiettivi politici specifici, si sono prestati e si prestano ad
interrogativi colmi di dubbi, forniscono materia ad accalorate dispute
concernenti in primo luogo la legittimità dei titoli appunto di opposizione
nazionale da attribuire all’una od all’altra manifestazione di rifiuto frontale
dell’occupazione statunitense, alla presenza di truppe di vari paesi sul
202
Terrorismo, guerriglia, resistenza: considerazioni per un dibattito attuale
territorio e, per estensione, ad ogni forma di presenza straniera nei confini
iracheni. La tecnica dilagante dei sequestri di persone - civili più che
militari, senza distinzione tra uomini e donne, tra cittadini di paesi alleati
degli USA nell’impresa bellica o formalmente estranei all’occupazione,
come nel caso dell’Italia, quando non appartenenti a nazioni svincolate
da responsabilità per l’invasione e l’occupazione, come la Francia - ha
recato ulteriori elementi di disorientamento e di incertezza nella
individuazione delle forze in gioco e nell’attribuzione di qualifiche
«partigiane», di «combattenti per la libertà» (diremmo noi) a questa o
quella violenza insorgente che crivella la realtà irachena. Gli interrogativi,
pertanto, premono da ogni parte: nel disgraziato lembo medio orientale:
è davvero in atto una «resistenza» armata indigena ed in qualche misura
popolare all’occupante ed al governo insediatosi sulle rovine del regime
saddamita? E, se mai si desse per scontato che questo accade, a quali
versanti politici o religiosi appartengono promotori e attori della rivolta?
Ancora: il terrorismo «kamikaze» che uccide spesso esplodendo
indiscriminatamente nel mucchio, e quindi cagionando in primo luogo
vittime fra gli inermi civili iracheni, è pensabile raccolga militanti e trovi
comunque complicità fra quelle popolazioni, oppure si tratta di un
fenomeno essenzialmente d’importazione, ossia di infiltrazioni dall’esterno
del paese artatamente organizzate da centrali terroristiche, delle quali una
almeno, Al Kaida, è ormai tristemente ben nota?
Un paesaggio di nebbie
L’elemento di fondo che manca per una analisi compiuta e sicura del
panorama di guerra irakeno (perché di capitolo di guerra ancora aperto si
tratta, quali che siano le contorsioni propagandistiche in senso contrario),
è costituto dalla carenza di informazioni e di dati certi per penetrare
l’intrico degli eventi bellici. Gli stessi giornalisti più animosi e scrupolosi
che hanno soggiornato nel paese si sono potuti muovere nell’ambiente in
forma parecchio limitata, sia per l’incombere dovunque di rischi gravi (a
Bagdad, ha riferito durante una trasmissione televisiva la volontaria italiana
fortunatamente strappata, con la sua compagna, ai sequestratori, è «perfino
pericoloso attraversare la strada»: il che dimostra lo scarso controllo del
territorio da parte degli americani nella stessa capitale), sia per i molti
ostacoli frapposti agli spostamenti a chi ricerca informazioni dai comandi
203
Mario Giovana
militari. Il vuoto più vistoso di conoscenze precise deriva proprio dalle
reticenze e dalle molteplici evidenti menzogne in cui si avvolgono le fonti
ufficiali - secondo una prassi tipica di tutte le occupazioni del genere condizionando al massimo la nozione esatta della situazione reale degli
scontri in atto e delle identità delle forze avversarie che vi si impegnano.
Nessuno, infatti, sembra in grado di riferire sulla natura specifica e sulla
consistenza dei gruppi che conducono azioni contro l’occupante (seguaci
di Saddam? gente reclutata all’estero? insorti di gruppi controllati da
centrali nazionaliste sunnite non necessariamente devote al vecchio
regime?), nessun dettaglio importante ci illumina sullo svolgimento reale
degli scontri che si verificano soprattutto nelle città e lungo le arterie di
grande traffico del paese, nessuna fonte ha mai precisato alcunché sul
numero esatto degli assalitori catturati nei vari combattimenti e sugli
accertamenti inerenti le loro identità nazionale, collocazione in
organizzazioni politiche o religiose più meno note, eventuali provenienze
estranee al contesto irakeno.
Malgrado le molte falle dei sistemi informativi, sembra azzardato
sostenere che sul teatro irakeno non siano in atto fatti di resistenza. Li si
possono imputare a residui del regime saddamista oppure far risalire a
nuclei minoritari di fondamentalisti radicali o, ancora, a cenacoli di
estremismo nazionalista di ceppo soprattutto sunnita insorti dopo
l’avvento dell’occupazione straniera, ma la presenza comunque di forme
di resistenza organizzata per sabotaggi e guerriglia appare incontrovertibile.
Non è certo che esse godano di appoggi popolari estesi ed incondizionati,
specie nelle zone a maggioranza sciita od a presenza curda; ma è altrettanto
innegabile che le loro attività fruiscano di omertà e supporti che ne
consentono la sopravvivenza e la mobilità prima e dopo, ad esempio, gli
agguati a convogli militari e gli assalti a caserme delle scalcinate milizie e
centrali di polizia del nuovo governo. Imboscate e sabotaggi a getto
continuo non hanno luogo se mancano tessuti in qualche modo in grado
di sorreggerli e di assicurare loro talune coperture; non cadono in uno
scontro 80 guerriglieri - tutti irakeni, viene comunicato -, come si afferma
da fonti ufficiali statunitensi per uno scontro del 22 marzo 2005, se l’azione
armata ribelle è sporadica e opera di infimi nuclei di armati. Tutto ciò di
cruento che si produce nel quadro irakeno viene rubricato sotto la voce
«terrorismo»; ma è una semplificazione che non pare corrispondere a verità
assolute e che, non distinguendo, ad esempio, tra forme di guerriglie
«militare» (i combattimenti a Najaf, ad esempio) e atti di terrorismo
204
Terrorismo, guerriglia, resistenza: considerazioni per un dibattito attuale
compiuti da singoli, non permette di avere nozione precisa di quanto
accade nel perimetro irakeno. Esiste una relazione stretta tra iniziative di
guerriglia quali le imboscate di gruppi armati e guerriglie urbane da un
lato e l’irrompere fra la folla dei mercati o l’esplodere davanti ad edifici
governativi di suicidi dall’altro? Si tratta di un’unica matrice che articola
le proprie manifestazioni, oppure il primo ordine di fatti si collega ad
una attività di centrali che conducono sistematici interventi bellici, mentre
invece il secondo ordine di imprese appartiene a centrali aventi puramente
il fine di sacrificare vite con testimonianze feroci per dimostrare
l’intolleranza verso una condizione ed i suoi responsabili, senza scrupoli
di coinvolgere chicchessia nelle mattanze e con il supremo obiettivo di
seminare vendette e terrore?
La proliferazione dei gesti «kamikaze» - a ritmo pressoché giornaliero
- inaugurati sul suolo palestinese (che hanno conferito alla fisionomia
della «resistenza» caratteri pressoché sconosciuti nel passato all’interno di
situazioni analoghe di conflitti armati) rappresenta senz’altro la cifra più
sconvolgente e micidiale della vicenda scaturita dal caso iracheno. E,
purtroppo, segna una svolta dalle conseguenze imprevedibili e di lungo
periodo nel rapporto tra tecniche repressive e contrapposti metodi di
attacco insurrezionalistico. Il nemico che si ha dinanzi non è soltanto un
essere pronto a sacrificarsi ma che bada, per naturale istinto di
conservazione, anche a difendersi: è viceversa un predestinato per propria
scelta a morire infallibilmente per cagionare più danno e morte possibili,
e quindi a contrassegnarne la massima produttività ai fini della causa
abbracciata. L’abisso della morte fisica è per lui la testimonianza del suo
assoluto annientarsi nel compito assunto e la dimostrazione che l’avversario
non ha alcun mezzo valido per contrastarlo proprio in ragione della
inumana straordinarietà della tecnica adottata. Sotto questo profilo,
l’assimilazione del termine giapponese «kamikaze» («vento divino») per
qualificare i suicidi-bomba nel teatro mediorientale, può avere una vaga
giustificazione, sebbene sia appena il caso di denunciare la forzatura;
perché, nella sua accezione propria, l’attributo giapponese di «kamikaze»
era riferito a militari dell’aviazione che si assumevano volontariamente il
compito di immolarsi su obiettivi bellici nemici (in particolare, il naviglio
da guerra) non mai puntando a stragi indiscriminate che coinvolgessero
civili: e, infatti, non esiste un solo caso di aereo recante questi «volontari
della morte» precipitatosi su agglomerati di uomini, donne e bambini
fuori dal teatro delle battaglie tra i due eserciti. Nondimeno, se si vuole,
205
Mario Giovana
un sottile fattore di legame fra i protagonisti dei suicidi cui assistiamo in
Medio Oriente ed il retroterra delle motivazioni a cui si rifaceva la logica
sacrificale dei «kamikaze» del Sol Levante è rintracciabile in una sfera
metapolitica: quella del retroterra religioso. L’imperativo di
autoannientamento che presiedeva al sacrificio dei piloti giapponesi
discendeva dall’assunzione come dogma dell’origine divina del potere
imperiale, e pertanto dell’esigenza sovrumana di assicurarne la
conservazione quando le sorti della sua integrità e della sua stessa esistenza
parevano messe a repentaglio dal precipitare ormai degli eventi sfavorevoli
(si rammenti che la pratica «kamikaze» fa la sua comparsa soltanto allorché
il Giappone è sull’orlo della catastrofe militare). I suicidi dei raid in Israele
sono per lo più preceduti - o seguiti a brevissima distanza di tempo - da
rivendicazioni affidate a brevi filmati con funzioni, si potrebbe
immaginare, anche testamentarie e «promozionali» del genere di iniziative:
il candidato - od i candidati - alla nefasta impresa si presentano
inneggiando alle ragioni del sacrificio in nome di Allah, quasi sempre
con il Corano in mano o con versetti del libro sacro stampati su drappi
che sovrastano la scena. Non pare fuori luogo pensare che i candidati a
far esplodere autobombe in Irak, sebbene non illustrino le loro imprese
con manifesti filmistici, appartengano al medesimo filone dei terroristi
palestinesi, per lo più reclutati nella disperazione e nella miseria dei campi
profughi. Il fattore religioso è pertanto la componente di spicco di questo
genere di estremismo e ricalca i moduli che nell’insieme hanno determinato
l’esperienza dei Talebani e che sono pure presenti con varie sfumature
lungo tutto il fronte dell’opposizione irakena. Se si tenta un censimento
degli episodi riferiti dalle cronache, ci si avvede facilmente che in questa
ritualità sacrificale come in altre forme di rivalsa contro gli occupanti e,
in genere, contro ogni presenza straniera ad essi connessa, mancano quasi
completamente richiami patriottici ed a rivendicazioni di libertà: ritornano
di continuo, invece, gli appelli alla grandezza di Allah e la condanna degli
«infedeli» aggressori, cosicché emerge una sorta di costante polarizzazione
attorno alla legge religiosa, punto di coagulo sul quale si incontrano
esasperatamente i convincimenti del radicalismo assassino dei gruppi
terroristici. Tuttavia, la forza di siffatta ipoteca non appartiene unicamente
alla paranoia fondamentalista, ma attinge ad una potente stratificazione
estesa che coinvolge anche zone della popolazione irakena estranea alle
pratiche dei cosidetti «kamikaze», come del resto dimostra l’esito delle
elezioni svoltesi nel paese. Otto milioni di elettori sono accorsi alle urne
206
Terrorismo, guerriglia, resistenza: considerazioni per un dibattito attuale
e ciò che è uscito dalle urne è un voto maggioritario verso una soluzione
istituzionalmente confessionale da attuare per l’Irak post-Saddam, tanto
è vero che il presidente sciita eletto dal nuovo parlamento ha preannunciato
l’adozione della legge islamica per il nuovo ordine, di fatto proponendo
un assetto costituzionale di marca iraniana, e perciò mettendo parecchio
in difficoltà quanti hanno accolto la massiccia affluenza alle urne come il
segnale di una raggiunta maturità democratica nell’alveo delle tradizioni
occidentali di una parte consistente della popolazione, a vicino
compimento del disegno di portare il paese del tutto fuori dal suo passato.
Dunque, il fattore religioso è un protagonista potente del conflitto interno
irakeno, dai settori cosidetti moderati all’ala estrema che racchiude, se
non i protagonisti diretti, i fedeli dei metodi suicidi in nome di Allah;
talché viene da chiedersi quanto i ritornanti e diffusi pronunciamenti
contro lo «straniero invasore ed occupante» non siano, in realtà, avanti
tutto, il rifiuto verso l’«infedele» impersonato dal soldato o dal civile che
calpesta il suolo del paese appartenendo a confessioni religiose diverse da
quella mussulmana.
Una mappa difficile da comporre
Fino a che non si saranno decantati in sede politica una serie di fattori
che rendono convulsa la geografia dell’incendio che percorre l’Irak odierno,
la coesistenza in quel tribolato quadro di fenomeni di rivolta e di
opposizione cruenta renderà estremamente arduo decifrarne fonti, natura
e finalità effettive. Ciò che comunque non si può non registrare è
l’incessante rinnovarsi di atti di rivolta guerrigliera o di spietate tecniche
«punitive» del nemico e di chi ne tollera la presenza - e anche di chi la
subisce da incolpevole e da inerme assoluto -, senza alcun riguardo per la
indifferenziata bestialità distruttiva delle conseguenze. Il fenomeno
«resistenza», quindi, in quel contesto, ha assunto dimensioni di «guerra
globale» che se si trasferissero nella pratica di ogni e qualsiasi insorgenza
armata gli conferirebbero connotati di «normalità stragista» con effetti di
imbestialimento senza regole e senza contenimenti degli antagonismi
dettati da razionalità e da sentimenti di rispetto umano. È appena il caso
di osservare che lo sconfinamento delle contese armate in una sfera del
genere sfugge a qualsivoglia metro di misura delle contese ideologiche e
politiche che popolano la storia dei popoli per annodarsi alle follie suscitate
207
Mario Giovana
dalle credenze religiose: e qui sta la paurosa prospettiva di sviluppo di
logiche di «crociata» che covano in ogni dettato dogmatico, non soltanto
in quelli dei seguaci di una interpretazione coranica posta a lievito di
tendenze sacrificali innestate su tradizioni tribali e governate da paludati
dispensatori di decreti che ne impongono l’osservanza a scanso di anatemi
che comprometterebbero l’anima per l’eternità, sbarrando al reprobo le
porte dei paradisi di ciascuna credenza. Quanto e come i patrimoni di
civiltà della democrazia siano in grado di perforare questa coltre di estasi
e di terrori del mistero divino, non è proprio semplice predire. Certamente,
non con i carri armati, i bombardamenti aerei dei quartieri urbani ed i
reticolati di Guantanamo.
208
Nuove guerre
Nuove guerre?
Crisi dello Stato, mercenari, criminalità, interventi umanitari: uno
sguardo d’insieme
di Andrea Beccaro
Questo articolo vuole cercare di chiarire alcune delle trasformazioni della
guerra avvenute dopo la fine del periodo bipolare quando, secondo il generale
Carlo Jean, si è sostituito «al pericolo di una guerra virtuale praticamente
impossibile, [...] la realtà di molte piccole guerre»1 che hanno moltiplicato le
minacce e gli scenari possibili. Per fare ciò ci avvaleremo di una diversa gamma
di fonti e autori. Metteremo in luce le interpretazioni più fortunate e
cercheremo di approfondire alcune tematiche specifiche con l’ausilio di libri
e saggi d’alcune riviste. In particolar modo saranno prese in considerazione la
rivista trimestrale «Parameters» e le pubblicazioni del Strategic Studies Institute
(SSI) entrambe legate all’U.S. Army. Affronteremo così il problema della
crisi dello Stato e le sue conseguenze sulla guerra. Già nel 1991 Martin van
Creveld, docente di Storia militare presso l’Università di Gerusalemme, ha
fatto notare che lo Stato è il protagonista dell’evento bellico solo nell’epoca
seguente alla pace di Vestfalia2 quando «venne sancito il principio di sovranità
nazionale e di non intervento come norma delle relazioni internazionali»3.
Teorico per eccellenza di questa situazione è il generale Carl von Clausewitz
secondo cui lo Stato è l’attore principale della guerra e la cornice politica
entro cui la sua stessa teoria politico-strategica s’inserisce. Quando il prussiano
parla di politica pensa a quella dello Stato e la considera un agire razionale per
il bene del proprio popolo4. Lo Stato nasce nell’Europa moderna grazie ad
un processo che gli consente di diventare, secondo la famosa definizione di
Max Weber, il detentore del monopolio della coercizione fisica legittima su
un determinato e ben delimitato territorio. Lo storico Charles Tilly ha definito
questo rapporto protection racket, in altre parole lo Stato estorce risorse dalla
popolazione per offrire protezione5.
Dalla seconda guerra mondiale, secondo Creveld, il periodo delle guerre
tra stati è tramontato mentre è sorto un «nuovo» tipo di conflittualità, i
LIC (Low Intensity Conflict)6. Questi conflitti hanno tre caratteristiche:
1. avvengono principalmente nei paesi poco sviluppati, se esplodono in
209
Andrea Beccaro
altri paesi sono definiti terrorismo o criminalità; 2. raramente coinvolgono
eserciti regolari da entrambe le parti; 3. non sono combattuti con armi
tecnologicamente avanzate. Per Creveld queste eterogenee forme di
conflittualità non sono forme ibride di guerra ma «Warre nel senso più
elementare e hobbesiano della parola, oltre che la più importante forma di
guerra del nostro tempo»7. Un’altra caratteristica dei LIC è che la maggior
parte delle loro vittime sono civili che non appartengono a nessuna delle
parti in lotta e spesso sono loro stessi le parti in lotta.
Attualmente questa è una forma di conflittualità molto diffusa (anche
il dopo guerra iracheno rientra in questa definizione), ma non l’unica.
Se con LIC si può intendere una varietà di conflitti (da quelli etnici a
quelli per le risorse) in Occidente si va sempre più verso la digitalizzazione del campo di battaglia. Questo grazie alla Revolution in
Military Affairs (RMA) che, lasciando molto spazio alla tecnologia, si
incentra su attacchi ad alta precisione condotti da lunga distanza;
miglioramento del comando, controllo e intelligence; information
warfare; bassa letalità delle armi8.
Secondo gli autori che in un qualche modo parlano di «nuove guerre»9
la forma di guerra che aveva in mente Clausewitz sarebbe finita perché oggi
sta morendo il suo attore principale: lo Stato. Così si prospetta la fine
dell’utilità del pensiero del prussiano e in generale del pensiero strategico
occidentale. Concetti come potere aereo, navale o la stessa RMA non
avrebbero più senso in un mondo dominato non più da stati con i loro
eserciti, ma da organizzazioni private. Molti autori sottolineano come questi
concetti non si adattino a situazioni di guerriglia, di conflitto a bassa intensità
cioè frangenti dove non ci siano due eserciti regolari a scontrarsi. Esempio
di ciò può essere la recente esperienza irachena dove lo scontro tradizionale
è stato condotto dall’America seguendo i nuovi concetti strategici ed è stato
vinto facilmente, ma il dopo ha lasciato aperti molti problemi.
Le cause della crisi dello Stato sono molte e Creveld, in un lavoro del
1999, ne identifica almeno quattro10. La nascita di diverse organizzazioni
internazionali (NATO, ONU, UE) ha limitato la libertà dei membri di
muovere guerra. Questa è una delle prerogative fondamentali della sovranità
ed è entrata in crisi anche per l’avvento delle armi nucleari. Con esse il
legame tra vittoria e autopreservazione, cioè l’idea, sfondo di tutte le guerre,
di combattere per poter poi usufruire del successo si rompe. Gli arsenali
nucleari, per Creveld, inibiscono le operazioni militari. Infatti dopo il 1945
non sono scoppiate guerre tra stati di una certa rilevanza internazionale11.
210
Nuove guerre
Gli stati non sarebbero più in grado di compiere grandi operazioni
belliche a causa del numero ridotto del personale militare. Mentre la
popolazione mondiale è triplicata dal 1945 ad oggi, gli eserciti attuali sono
molto più piccoli rispetto a quelli della Seconda Guerra Mondiale12. È vero
che ciò può essere conseguenza dell’adozione di sistemi d’arma più precisi
e potenti, ma non spiega, secondo Creveld, perché dalla fine della seconda
guerra mondiale nessun paese sia stato in grado di compiere operazioni a
largo raggio e in profondità o conquistare la capitale nemica13.
Creveld sottolinea ancora la sempre minor capacità di controllare l’ordine
interno. Gli eserciti più grandi e avanzati del mondo sono stati sconfitti in
conflitti a bassa intensità. Mettere in sicurezza da minacce quali quelle del
terrorismo una base militare o un palazzo governativo è tutto sommato
semplice. Non lo è se si vuole proteggere l’intero territorio, cosa che
comporterebbe una spesa enorme (senza peraltro avere la certezza del
risultato) e un abbassamento del tenore di vita della popolazione.
L’insicurezza crescente ha portato il privato cittadino e le imprese che ne
sentono la necessità a rivolgersi al settore privato14.
Un altro elemento che contribuisce alla crisi dello Stato e favorisce le
attuali forme di conflittualità è la globalizzazione, cioè «il massiccio
incremento dell’interdipendenza economica e della comunicazione di massa,
con il relativo fenomeno di compressione del tempo e dello spazio»15. La
libertà di movimento (di persone, merci, capitali) diventa un fattore di
stratificazione sociale tra chi è globale e chi, non essendolo, è un locale
ancorato ai vincoli spaziali. Le multinazionali si spostano dove scorgono
un’occasione di profitto, senza avere più basi territoriali definitive. Le élites
sono così sempre più extraterritoriali e slegate dai poteri politici che invece
rimangono ancorati al territorio16.
Con la globalizzazione, per Ulrich Beck sociologo alla London School
of Economics, si ha «una collocazione del politico al di fuori […] dello
Stato-nazione»17. Essa è un insieme di processi economici (deregulation,
dislocazione e accelerazione della produzione) e politici irreversibili in rapida
evoluzione. La dimensione tempo diventa irrilevante, così come quella
spazio, ma la spazialità politica moderna è lo Stato che quindi cessa di
essere il centro della politica18. Viene a mancare l’organizzazione verticale
del potere, sostituita da flussi trans-nazionali che fanno venir meno le
distinzioni interno sicuro, esterno insicuro. Nasce quella che Carlo Galli,
storico delle dottrine politiche presso l’Università di Bologna, ha definito
«l’attuale società del rischio»19. Da questa de-spazializzazione discende che
211
Andrea Beccaro
la guerra tende ad essere infinita, proprio perché manca uno spazio politico
che possa neutralizzarla. Il disordine causato dalla globalizzazione non può
contenere il conflitto ma lo crea20. Comprimendo la nozione di spazio e
tempo la globalizzazione ha grosse ripercussioni anche sulla strategia perché
permette ad azioni molto distanti d’avere effetti locali e viceversa21.
La sovranità dei governi è così minacciata da networks apolidi che
possono attraversare senza problemi confini porosi. Questi ultimi sono
diventati irrilevanti facilitando enormemente i traffici illegali (armi, droga,
lavaggio di denaro sporco, traffico d’uomini)22 non solo nelle aree dove il
liberismo è stato più devastante, come nell’ex impero sovietico, ma anche
in Occidente. Infatti dov’è la linea del fronte nella guerra alla droga: in
Colombia o nelle nostre città?23
La nuova economia si occupa di beni immateriali, di servizi e il settore
dell’informazione è fondamentale perché, come dice il politologo americano
Benjamin R. Barber, chi controlla le informazioni controlla il mondo24. Un
ruolo primario, colto perfettamente dai terroristi, è occupato dalla televisione
perché veloce, diretta ed omogeneizzante. I terroristi hanno più successo
per ciò che minacciano che per ciò che fanno perché hanno capito che
terrorizzando gli opinion makers «essi terrorizzeranno il resto del mondo
per voi»25. Così Al Qaeda si è trasformata, secondo il tenente colonnello
dell’U.S. Army direttore del Strategic Research dell’SSI Antulio J.
Echevarria, in un’arma ideologica che genera propaganda sfruttando proprio
i moderni mezzi di comunicazione che grazie ai satelliti trasmettono in
tutto il mondo26.
Proprio nella guerra al terrorismo si possono trovare alcune caratteristiche
della globalizzazione come la maggiore mobilità sia delle cose sia delle
persone. I terroristi diventano invisibili per le agenzie di sicurezza potendosi
muovere rapidamente e liberamente ovunque desiderino27.
Non tutti gli autori però sono convinti che l’era dello Stato moderno
nazionale stia finendo. Una voce in questo senso proviene da Anthony D.
Smith docente a Cambridge, il quale nota che lo Stato nazionale resta l’unica
struttura politica che abbia un riconoscimento internazionale28. Se è vero
che le operazioni economiche trascendono i confini nazionali è altrettanto
vero che l’unità base per la regolamentazione restano le economie nazionali.
Per Barber il terrorismo va combattuto globalizzando le istituzioni civili e
democratiche senza però cancellare lo Stato-nazione poiché quest’istituzione
è la migliore garante per la sovranità e dove si è dissolta (ex Jugoslavia,
Somalia, Afghanistan) si è sviluppata solo instabilità29.
212
Nuove guerre
Secondo Edward J. Villacres e Cristopher Bassford (il primo capitano
dell’Esercito americano, il secondo professore presso l’Army War College)
le «nuove guerre» non portano alla fine dello Stato, ma creano stati etnici30.
Ad esempio in Jugoslavia sono sorti, da uno Stato multietnico, cinque stati,
più piccoli e più omogenei etnicamente. Spesso sono gruppi non statuali
che si combattono, ma lo fanno con l’obiettivo di creare una nuova entità
statale. I LIC sarebbero il risultato della fine di uno Stato debole, non più
rappresentativo, che porta alla nascita di uno più forte e più vicino alla
realtà sociale del paese.
L’esempio della Bosnia, secondo i due autori, dimostra che le «nuove
guerre» sono ancora condotte con eserciti regolari guidati da politiche precise
anche se brutali. Anzi, le ragioni della guerra in Jugoslavia vanno proprio
individuate nella politica. Infatti i leader, con la fine del comunismo,
cercavano nuove basi di consenso trovate nell’identificazione etnica che
sfrutta quelle forze irrazionali a cui Clausewitz aveva dato tanto spazio31.
Anche il politologo americano John Mearsheimer vede il XXI secolo
dominato dagli stati e dalla loro competizione per la sicurezza32. Contesta
l’idea che le istituzioni internazionali possano limitare la sovranità. Critica il
fatto che la globalizzazione porti alla fine degli stati perché essi non stanno
soccombendo a queste forze, ma «stanno facendo gli aggiustamenti necessari
ad assicurare la loro sopravvivenza»33. All’orizzonte non vede un’alternativa
allo Stato e infatti il processo d’integrazione europeo, seppur tra mille difficoltà,
sta procedendo lasciando intatte le nazioni membri. Anche la risposta agli
attacchi del 11 settembre è stata data da paesi e composte di stati.
Anche per Jean quegli attentati hanno dimostrato «l’indispensabilità dello
Stato» giacché è aumentata la domanda di sicurezza dei cittadini34. L’autore
interpreta l’11 settembre 2001 come un momento di rottura che da un lato
ha posto fine ad alcune false credenze sviluppate negli anni novanta («fine
dello Stato, del territorio, della sovranità e della storia»35), dall’altro ha
provocato un riallineamento geopolitico che ha posto fine al periodo
seguente alla fine della guerra fredda36.
Certo è che in alcune zone del pianeta l’istituzione Stato è in crisi e per
questo alcuni autori prospettano un futuro dominato dall’anarchia, un
ritorno allo stato di natura di Hobbes.
La pensa così, per esempio, Robert D. Kaplan37 che nel 1994 parte
dall’Africa occidentale, dove la criminalità è dilagante, per descrivere i
problemi futuri: la scarsità delle risorse, lo scontro etnico con la conseguente
trasformazione della guerra sempre più indistinguibile dal crimine. La stessa
213
Andrea Beccaro
criminalità diventerà, anche nei paesi più avanzati, un conflitto a bassa
intensità contro cui gli attuali sistemi di giustizia ed eserciti sono impotenti.
La conseguenza sarà il lasciare sempre più spazio alle agenzie di sicurezza
privata o alla mafia urbana come avviene nelle città africane. Le città di
quell’angolo di mondo di notte si trasformano in un luogo pericolosissimo,
dove qualsiasi attività criminale prolifera e dove «il governo non ha
mandato».
In gran parte dell’Africa Kaplan non vede governi in grado di esercitare
alcun tipo di controllo. La deforestazione avanza e con essa il degrado
ambientale38, le città sono devastate e ricche di bidonville che accolgono gli
immigrati in numero sempre crescente permettendo così anche una
propagazione rapida delle malattie.
Il territorio sarà controllato da città Stato e da qualche Stato nazionale,
residuo di un epoca ormai passata, entrambi confusi con i cartelli della
droga, con la mafia e con le agenzie di sicurezza. Lo spazio politico non sarà
più delimitato da confini, ma da centri di potere39. Una siffatta mappa
politica non sarà statica, ma in continuo movimento per rappresentare il
caos imperante40.
Questa visione può sembrare troppo estrema, ma come cercheremo di
mettere in luce la criminalità sta assumendo un ruolo rilevante e la
privatizzazione della guerra introduce nuovi attori e problematiche. Come
ha sottolineato nel 1999 Mary Kaldor, ricercatrice della London School of
Economics, le imprese criminali proliferano dove c’è un qualche tipo di
conflitto o guerra41. Quando queste condizioni mancano cercano di crearle
per potersi sviluppare tranquillamente. Il caos politico è l’ambiente migliore
per il crimine come dimostra il fatto che tre delle guerre civili più lunghe
(Colombia, Afghanistan e Myanmar) si svolgono nei tre paesi che sono i
principali produttori di droga al mondo. Sandro Calvani e Martina Melis,
entrambi impegnati nello studio a livello globale della criminalità,
identificano due condizioni grazie a cui la criminalità oggi riesce a proliferare.
In primo luogo le nuove possibilità di spostamento e il decentramento
amministrativo derivanti dalla globalizzazione. Queste fanno sì che i
criminali possano utilizzare lo jurisdiction hopping (salto continuo di
giurisdizione) per confondere le diverse polizie nazionali ancora vincolate
dai confini42. La seconda è proprio la crisi profonda in cui versano molti
stati. Così, secondo i due autori, la criminalità non vince scontri diretti
contro le forze dell’ordine, ma occupa semplicemente gli spazi lasciati vacanti
da un potere ormai inesistente.
214
Nuove guerre
Paolo Sartori, rappresentante italiano presso la Southeast European
Cooperation Initiative, prende in esame il caso della Transnistria, un classico
esempio di come il collasso del potere centrale lasci mano libera a criminali
e terroristi. Questa regione è una striscia di terra tra la Repubblica di
Moldavia, che teoricamente ne avrebbe il controllo, e l’Ucraina. Dopo un
breve conflitto etnico tra il 1991 e il 1992 s’autoproclama indipendente.
Nessun paese al mondo ha riconosciuto questo stato governato da ex agenti
del Kgb e supportato dalla 14a armata russa. Ciò nonostante le autorità
moldave non hanno poteri nell’area e molti paesi occidentali intrattengono
rapporti commerciali con essa. Dalla Transnistria transita di tutto: droga,
armi, auto rubate ecc. Sul suo territorio sono presenti anche molti depositi
militari e tre fabbriche d’armi oltre a materiale chimico e radioattivo. La
Transnistria risulta legata a molte organizzazioni terroristiche, sia islamiche
sia cecene, e alla criminalità di tutto il mondo43.
Un altro tipico esempio è quello della Colombia dove la politica è
strettamente collegata al traffico di droga, come sottolinea Michael G. Roskin
professore di scienza politica presso il Lycoming College44. Lo Stato controlla
poche zone del paese e ciò è dimostrato dal fatto che dal 1990 al 2001 ci
sono stati più di 30.000 omicidi che fanno della Colombia uno dei luoghi
più sanguinosi del pianeta. Solo il 40 per cento di essi sono sottoposti ad
investigazioni e solo il 7 per cento dei casi arriva a una soluzione. Gli stessi
movimenti «rivoluzionari» colombiani ormai hanno poco di rivoluzionario,
ma producono droga e ricavano entrate enormi da questo traffico. Le FARC,
per esempio, hanno ottenuto nel 2000 il controllo di una zona (grande
quanto la Svizzera) de-militarizzata. Grazie a ciò hanno un introito annuale
pari a circa 300 milioni di dollari superiore a quello dello Stato colombiano45.
La criminalità sta quindi diventando un attore sempre più importante
nell’arena internazionale, ma che cos’è il crimine internazionale? Gli esperti
del settore non sono concordi sulla sua definizione. Alcuni preferiscono
utilizzare, anziché il termine internazionale, legato a una relazione legittima
tra stati-nazione, quello di transnazionale. Un’organizzazione criminale è
definita dal tenente colonnello dell’U.S. Army Steven R. Pelley come «una
struttura quasi formale, che resiste nel tempo, che si dedica ad un comune
scopo guidata da una leadership riconosciuta al di fuori della legge. Spesso
è basata su un’identità familiare […] ed è preparata all’uso della violenza
per promuovere e proteggere i propri interessi»46. Tre sono le caratteristiche
fondamentali che trasformano un’organizzazione criminale domestica in
internazionale: l’abilità a compiere operazioni su scala globale; un accordo
215
Andrea Beccaro
con altre organizzazioni da cui nasce la loro cooperazione; infine la forza e
la risoluzione a minacciare direttamente l’autorità dello Stato47.
Calcolare con precisione il giro d’affari dell’industria criminale è
impossibile. Una stima può aggirarsi intorno ai 15.000 miliardi di dollari
nel solo 200048. È un volume di denaro enorme che dimostra come il
crimine, con i suoi legami con terroristi e guerriglieri di varia natura, sia un
elemento fondamentale per la comprensione delle future minacce. Per
esempio nel 2003 il giro d’affari stimato per il solo oppio (escludendo
cocaina, droghe sintetiche e cannabis) è stato di circa 1,2 miliardi di dollari.
In più la produzione del 90 per cento dell’oppio mondiale è concentrata in
tre soli paesi: Afghanistan, Myanmar e Laos49.
Anche il mercato delle armi è molto redditizio. A questo commercio
illegale ha dato una notevole spinta il crollo dell’Unione Sovietica e la fine
della guerra fredda con lo smantellamento e il rinnovamento degli arsenali.
Questo ha immesso sul mercato un numero notevole di armi leggere che
negli attuali conflitti rappresentano una delle maggiori minacce, come
sottolinea Michael Klare docente del Peace and World Security Studies
presso l’Hampshire College del Massachusetts. Si pensi che tra il 1990 e
1999 sono scoppiati 49 conflitti regionali e in ben 46 le sole armi usate
erano armi leggere quali AK-47, M-16, mortai o mine50. Secondo l’ONU
nel mondo ci sarebbero 550 milioni di armi leggere, ma solo 18 milioni
sono in mano ad eserciti o polizia51. Temibili sono anche le bombe IED
(Improvised Explosive Devices) costruite in parte con materiale militare in
parte con ciò che si riesce a trovare sul mercato52. Questa tipologia di ordigni
ha creato problemi alle truppe statunitensi in Iraq tanto che il Pentagono
ha disposto l’invio di robot per la loro individuazione. Sono bombe
rudimentali facili da costruire, ma molto difficili da individuare perché
collocate ai bordi delle strade e fatte esplodere al passaggio delle truppe.
Tale mercato è estremamente pericoloso per due motivi. In primo luogo
offre mezzi di offesa efficaci a terroristi, criminali, guerriglieri aumentando
le loro capacità operative e le aspettative di sopravvivenza. In secondo luogo
lo fa a prezzi contenuti se messi in relazione ai guadagni derivanti da altri
traffici. Per esempio con 50 euro in Cambogia si può acquistare un AK47.
Un lanciagranate russo RPG7 vale intorno ai 200 euro53. Per ottenere invece
un missile terra aria SAM-7 occorrono 4000 euro. Questo è un investimento
più sostanzioso, ma permette, a chi lo compie, di spiccare un salto di qualità
guadagnando una certa capacità di deterrenza nei confronti delle forze di
sicurezza54. Inoltre, a volte, per mutare gli equilibri regionali non sono
216
Nuove guerre
necessari investimenti sostanziosi. Come ha dimostrato l’UNITA negli anni
novanta spendendo al mercato nero delle armi i guadagni ottenuti dal traffico
illegale di diamanti55.
Il legame tra criminalità e terrorismo è evidente osservando le diverse
modalità con cui i vari gruppi terroristi si finanziano. Oltre ai traffici sopra
elencati risultano di particolare importanza i rapimenti con i relativi riscatti.
Emblema di quest’attività è l’ENL (il secondo gruppo guerrigliero della
Colombia) che nel solo 2000 ha compiuto ben 3.707 rapimenti56. In questi
ultimi anni la criminalità e il terrorismo sono diventati sempre più simili,
ma secondo Fabio Armao, docente di Relazioni Internazionali presso
l’Università di Torino, li differenzia ancora l’uso della violenza: più
strumentale per le mafie, più finalizzato ad un progetto sovversivo per il
terrorismo57.
Altri traffici molto redditizi sono legati alla pirateria. Questo è un
fenomeno in forte ascesa se pensiamo che nel 2001 ci sono stati 250 atti di
pirateria mentre nel 2003 nella sola Asia se ne sono registrati 276 di cui
121 in Indonesia58.
Un’altra figura che si credeva scomparsa ed oggi tornata alla ribalta è
quella del mercenario. Storicamente gli eserciti di tutti le epoche ne hanno
fatto uso, ma con la nascita degli stati nazionali e dei rispettivi eserciti
nazionali l’uso dei mercenari si riduce drasticamente fino ad arrivare al
1947 con il protocollo di Ginevra che li mette fuori legge, cosicché le
compagnie d’oggi non si definiscono mercenarie. Le differenze tra queste e
i mercenari del passato sono profonde. Mentre i secondi erano assunti per
un solo compito, spesso mancavano di coesione, disciplina e quindi avevano
un impatto limitato sulle operazioni. Le attuali compagnie, come nota Peter
W. Singer Olin Fellow del Foreign Policy Studies Program del Brookings
Institution, hanno una forma corporativa, sono gerarchicamente organizzate
e legate a holding finanziarie; inoltre offrono una gamma di servizi. La
corporazione è l’elemento distintivo tra le moderne compagnie e i vecchi
mercenari il che le rende più efficienti ed efficaci59.
Singer individua tre ragioni che portano alla privatizzazione del settore
militare. In primo luogo la fine della guerra fredda ha costretto gli eserciti a
ristrutturarsi riducendo il personale e ha lasciato molti paesi, specie in Africa,
senza più alleati e aiuti esterni. In secondo luogo la trasformazione della
guerra con l’introduzione del RMA ha aumentato la necessità di tecnologia,
una domanda cui spesso ha dato risposta il settore civile. Inoltre i moderni
e tecnologici eserciti sono molto dipendenti dalla logistica, un settore sempre
217
Andrea Beccaro
più occupato da compagnie private. Infine Singer sottolinea il processo di
privatizzazione che si è affermato dagli anni ottanta. Questa è l’ultima
conseguenza del neo-liberismo base della globalizzazione60. Se questi sono
fattori esterni alle compagnie, Francesco Vignarca ne indica altri che ne
facilitano lo sviluppo. Innanzitutto queste imprese hanno costi di valutazione
del personale pari a zero poiché le capacità del singolo possono essere
facilmente dedotte dal suo curriculum e dal suo avanzamento di grado
nell’esercito. In secondo luogo la compagnia non ha spese d’addestramento
del personale essendo già addestrato61. È importante sottolineare il punto
poiché molte compagnie sono spesso assoldate per addestrare eserciti. Così
guadagnano in un primo momento per il lavoro svolto e successivamente
assumendo una persona già competente ed operativa.
Esiste anche un problema di definizione, perché nei primi studi si
distingueva tra Private Military Company e Private Security Company, ma
allo stato attuale sembra più corretta l’interpretazione di Singer che parla di
Private Military Firms. Il termine firms indica un gruppo economico, dato
che queste organizzazioni sono guidate dal profitto legato al commercio in
servizi professionali in qualche modo inerenti alla guerra62.
Si tratta di un fenomeno difficilmente arginabile perché sia gli stati sia
altre entità, come organizzazioni internazionali di varia natura o compagnie
commerciali, avranno sempre più bisogno di servizi militari e di sicurezza.
Lo dimostrano le cifre. Nel 2003 l’8 per cento del bilancio della Difesa
americano è stato assorbito da contratti privati63. Sempre l’America tra il
1994 e il 2002 ha stipulato 3.061 contratti con 12 diverse compagnie per
un totale di 300 miliardi di dollari64. La DynCorp, una delle più importanti
PMF, opera da anni in Qatar e Kuwait ed ora addestra la polizia dell’Iraq
post-Saddam oltre a gestire la sicurezza di Ahmid Karzai in Afghanistan65.
Singer individua tre diverse tipologie. La prima è quella delle compagnie
con capacità militari direttamente applicabili ad azioni belliche. Offrono
addestramento, comandanti, capacità di combattimento e sono composte
di ex ufficiali delle forze speciali o altri militari altamente addestrati. I loro
clienti sono principalmente soggetti, statali o meno, con scarse capacità
militari. Tipica è l’Executive Outcomes nata nel 1989 e composta di veterani
sudafricani. La sua prima operazione fu in Angola nel 1992. Dopo le elezioni
l’ONU dichiara vincente il MPLA (Movimento Popolare per l’Indipendenza
dell’Angola), ma l’UNITA (Unione per la Totale Indipendenza dell’Angola)
non accetta il risultato delle urne e immediatamente il conflitto interno si
riaccende. L’UNITA acquista il controllo di circa l’80 per cento del paese
218
Nuove guerre
tra cui la riserva petrolifera di Soyo. A questo punto diverse compagnie
petrolifere assumono l’Executive Outcomes per riconquistarla. Nel maggio
del 1995 la ritroviamo in Sierra Leone dove per conto del governo pianifica
e conduce alcune operazioni tra cui sorveglianza aerea, intercettazioni,
counter-intelligence66. Tra i suoi compiti c’era anche quello di difendere una
miniera di diamanti la quale rimase sotto il suo controllo per qualche tempo
perché il governo non è in grado di pagarla67.
Una seconda tipologia comprende compagnie che offrono consultazioni
e addestramento, servizi per le strutture tattiche, analisi strategiche, operative
e organizzative. Sono composte per lo più da ufficiali in pensione. Non
sono impiegate in combattimento e i loro contratti sono normalmente di
lunga durata e molto costosi. Celebre è la Military Professional Resources
Inc. (MPRI) per la pianificazione e l’addestramento su larga scala. Fondata
nel 1988 da ex militari americani provvede alla transizione democratica, al
peacekeeping, all’antiterrorismo e alla sicurezza in genere. Sotto contratto
del Dipartimento di Stato americano nel 1994, impiegò 45 osservatori in
Croazia dove pianificò l’Operation Storm in Krajina nel 1995 che permise
ai croati di respingere i serbi68.
Un’ultima tipologia individuata da Singer è denominata Military Support
Firms. Queste compagnie non partecipano alla pianificazione o all’esecuzione
diretta dei combattimenti, ma offrono una serie completa di servizi
funzionali: logistica, supporto tecnico e trasporto. I clienti più comuni per
queste compagnie sono degli stati coinvolti in interventi immediati ma di
lunga durata69.
Diverse sono le conseguenze legate alla privatizzazione dei conflitti e al
sempre crescente ricorso a queste figure. Per prima cosa Singer nota come
queste ultime cerchino il proprio profitto: quindi spesso potrebbero essere
tentate, più che di portare a termine le operazioni belliche a favore del loro
datore di lavoro, di perpetuare il conflitto in modo da continuare a
guadagnare. Inoltre, con l’aumento dei rischi, una PMF potrebbe essere
spinta o ad abbandonare la missione o, trovandosi ad operare in failed states
dove spesso è la forza più forte in campo, a difendere i suoi interessi70.
L’analista americano Thomas K. Adams, pur evidenziando i problemi legati
a queste compagnie, sostiene che sono solo le braccia degli stati. Singer non
è d’accordo perché se è vero che spesso agiscono per conto di stati di cui
aumentano la forza, queste compagnie sono attori privati indipendenti che
possono operare anche alle spalle dello Stato. Questo porta Singer a
sottolineare un’altra conseguenza: una nuova fungibilità della forza militare.
219
Andrea Beccaro
Infatti dalla nascita del sistema degli stati in poi si è sempre sostenuto che la
potenza economica non equivaleva immediatamente a quella militare.
Quest’ultima richiede tempo per essere costruita perché bisogna istituire
un esercito, addestrarlo, dotarlo delle migliori armi, dislocarlo in zone
strategiche. Oggi chiunque, pagando, può procurarsi una forza militare di
tutto rispetto nel giro di settimane se non di giorni71. Questo significa che
sia gruppi terroristi sia cartelli della droga possono avere capacità militari.
Esempio di ciò è la compagnia israeliana Hod Hananit (punta di lancia)
che ha operato a fianco dei cartelli colombiani di Medellin e di Calì oltre
che per Pablo Escobar72. Anche stati con una popolazione ridotta, ma ricchi,
possono crearsi un proprio esercito. Ciò chiaramente può mutare
rapidamente gli equilibri di un’area specie in un momento storico come il
nostro in cui i conflitti hanno carattere regionale. Infine anche il peso delle
alleanze potrebbe diminuire: se un alleato non viene in soccorso lo Stato
può sempre richiedere l’intervento di una PMF come già avvenuto in Papua
Nuova Guinea e nell’ex Jugoslavia73. Qui, per esempio, i paesi arabi moderati
volevano aiutare i mussulmani bosniaci. Per farlo, evitando critiche e minacce
d’altri paesi, hanno assoldato la MPRI per addestrare i loro fratelli74.
Come si può dedurre dai vari esempi qui riportati questi personaggi,
nuovi solo per quanto riguarda il loro ruolo e peso nell’attuale politica
internazionale, agiscono nelle zone più disparate e sfruttano proprio la
complessità crescente delle moderne operazioni belliche. Le situazioni in
cui si crea un ambiente così caotico sono due: il conflitto etnico e le
operazioni di pacificazione (il vero problema delle guerre moderne).
Il conflitto etnico è una delle maggiori minacce per la sicurezza regionale,
ma intervenire è estremamente difficile perché le sue radici possono essere
molteplici e spesso tipiche del singolo caso, anche se problemi economici e
ambientali, le conseguenze della fine della guerra fredda e la globalizzazione
sono comuni a tutti75. Quest’ultima crea una dissonanza tra chi la vive e chi
la subisce che spesso è portato ad abbracciare politiche dell’identità esclusive.
Se il mondo, come sostiene Serge Latuoche, docente presso l’Università di
Parigi, si sta occidentalizzando76 ovvero uniformando al modello occidentale
nel suo complesso, sicuramente una parte della popolazione recupererà le
sue tradizioni locali. Smith ammette che «più il mondo si trasformerà in un
luogo privato delle sue peculiarità locali, più saranno gli individui […] in
cerca di protezione nelle tradizioni»77.
Conseguenze estreme di questa opposizione alla globalizzazione sono il
terrorismo e il concetto di etnia. Questa è una costruzione simbolica che
220
Nuove guerre
arriva al termine di un processo storico-politico voluto e favorito da
determinati gruppi sociali coadiuvati da alcuni intellettuali78. Il tutto è
facilitato dall’aumentata istruzione e dai moderni mezzi di comunicazione
che permettono una diffusione più immediata, capillare, acritica e continua
delle idee e notizie che si vogliono diffondere79. Secondo Roberto Arbitrio,
esperto del Centro per la prevenzione internazionale del crimine dell’ONU,
i gruppi sociali interessati creano l’etnia perché «da un punto di vista
strategico l’inganno etnico appare un ottimo strumento su cui costruire
una progettualità di accesso facilitato al potere e alle risorse»80. L’identità
etnica così creata è una contrapposizione violenta che si pone tra l’essere
del proprio gruppo e il non essere dell’altro81. Queste guerre implicano
ragioni identitarie e culturali che riguardano le radici di una società, i suoi
valori e quindi non sono facilmente negoziabili. Da ciò deriva la loro lunga
durata dal momento che si prolungano mediamente sei volte di più delle
guerre tradizionali. L’obiettivo è il controllo del territorio che di conseguenza
va liberato dalla popolazione autoctona tramite stupri, omicidi di massa,
politiche dell’odio che producono un altissimo numero di rifugiati. Queste
sono, come sottolinea Arbitrio, precise strategie, non semplici atti di estrema
violenza82. Una loro caratteristica peculiare è di essere a singhiozzo, per
permettere alle parti di recuperare le forze, riorganizzarsi, riarmarsi grazie
anche agli aiuti delle comunità della diaspora e riprendere la lotta in
condizioni migliori in un secondo momento83.
Spesso il conflitto etnico avviene dove lo Stato non riesce più a controllare
il territorio. Diversi possono essere gli indicatori di questa situazione:
pressione demografica, ineguale sviluppo economico (spesso l’ineguaglianza
è tracciata proprio da linee di demarcazione etnica), rivendicazioni per un
qualche torto subito, criminalizzazione dello Stato e conseguente sua
delegittimazione, stagnazione economica, progressivo deterioramento dei
servizi pubblici, sospensione della legge, apparati di sicurezza che agiscono
come uno Stato nello Stato84. Tutto questo porta anche alla crisi umanitaria
caratterizzata da: carestia, malattie, rifugiati che sovraccaricano sistemi di
salute pubblica e di distribuzione delle risorse già allo stremo85.
Come spiega Arbitrio, anche il retaggio coloniale ha la sua importanza
come si è visto nella guerra in Rwanda nel 1994 emblematica per due
motivi86. In primo luogo essa ha dimostrato come in un conflitto etnico
l’obiettivo non è lo Stato o il vecchio tiranno, ma la popolazione stessa
spaccata da una dicotomia precisa tra un sé da difendere e un altro che non
ha diritto di vita. In secondo luogo quando un paese è diviso da linee di
221
Andrea Beccaro
demarcazione etniche la conflittualità resterà sempre. Questo perché alle
elezioni si presenteranno partiti etnici che favoriranno la propria etnia
colpendo le altre87.
Secondo la Kaldor gli interventi, in ex Jugoslavia e Somalia per fare solo
due esempi, sono finora falliti perché non si è compresa la vera natura del
conflitto88. In tali contesti dove l’autorità dello Stato è scomparsa, dove
diversi attori agiscono contemporaneamente e dove crimine, violenza e
guerra si fondono non si può ragionare in termini classici. Nell’epoca della
globalizzazione non bisogna vedere l’intervento come una violazione della
sovranità89. Si sostiene che non s’interviene in luoghi come il Rwanda perché
lontani da noi, ma il filosofo politico americano Michael Walzer si chiede
«quanto a lungo sopravvivrà la civiltà qui se non c’è già lì?»90. Il problema
di queste operazioni non dovrebbe essere la democrazia, la libertà,
l’allargamento del mercato o quant’altro ma «fermare azioni che scuotono
la coscienza»91. Inoltre spesso è la paura dei rischi a bloccare l’operazione
ma, come nota il filosofo, «interventi incruenti e missioni di pace sono una
contraddizione in termini: se fossero possibili non sarebbero necessarie»92.
Per Steven Metz, analista presso l’SSI, bisogna avere un obiettivo limitato.
Nel breve periodo si deve puntare a fronteggiare il disastro umanitario e
rispondere ai bisogni basilari. Sul lungo periodo si deve ripristinare il
controllo civile per garantire un minimo di diritti umani93. Per Arbitrio le
forze militari devono mettere in sicurezza alcune zone per ricreare le
condizioni per la convivenza civile. Solo dopo di ciò si può iniziare la caccia
ai signori della guerra e tentare di ristabilire un ordine giudiziario. Il tutto
però deve essere proporzionato alle condizioni di sicurezza che si possono
garantire94. Una missione non può dirsi coronata da successo se non riesce
a separare le categorie etniche da quelle politiche. Un altro problema
dell’intervento è che i diplomatici occidentali, per aprire delle trattative, si
rivolgono ai signori della guerra locali legittimandoli e innalzando il loro
profilo internazionale. Bisogna considerare che non sempre le parti in causa
hanno la forza e le capacità per imporre quello che firmano95.
È fondamentale comprendere che non esiste una formula strategica
comune a tutti i conflitti. Da situazione a situazione variano le cause della
violenza, i protagonisti, l’ambiente geopolitico circostante e il rischio di
escalation. Ne consegue che ogni conflitto deve avere la sua strategia diretta
contro specifiche capacità del nemico e contro il suo centro di gravità96.
Metz propone una griglia interpretativa identificando tre tipologie di
conflitto: controllato, accidentale e involontario. Il primo è il più semplice
222
Nuove guerre
perché si tratta di una situazione in cui il governo centrale deliberatamente
utilizza mezzi violenti per mantenere la sicurezza interna e consolidare il
regime. In tali frangenti potrebbero bastare pressioni diplomatiche per
arrivare a una conclusione97.
Più complesso è invece il discorso per gli altri due modelli. Infatti se il
conflitto è accidentale significa che il potere centrale è collassato e quindi
viene a mancare la controparte con cui dialogare. In questo e nel terzo
modello si rende necessario l’intervento militare con tutti i rischi correlati98.
Importante è inoltre capire, come Creveld ha fatto notare99, che questi
conflitti sono spesso guidati da interessi emotivi e non, come noi siamo
abituati a pensare, da un movente razionale100. Già nel 1994 il maggiore
dell’U.S. Army Ralph Peters giungeva alla conclusione che in futuro i soldati
si dovranno sempre più scontrare con «guerrieri»101. Le differenze tra i due
sono molte e profonde, simili a quelle con i mercenari ma non identiche. Il
soldato si sacrifica, mentre il guerriero cerca il bottino, non punta alla
conclusione delle ostilità, ma alla loro prosecuzione per continuare a
guadagnare e a sopravvivere. Il soldato è inserito in una struttura organizzata
e disciplinato102. Il guerriero invece è un individualista poco o per nulla
disciplinato. Mentre il soldato ubbidisce allo Stato, ad un ordine legale, il
guerriero è legato ad una figura carismatica, ad una causa, a chi lo paga ed
agisce sempre al di fuori della legge. Se il soldato cerca di ristabilire un
ordine il guerriero punta a distruggerlo. I guerrieri rispondono
asimmetricamente, «non giocano secondo le nostre regole» e non rispettano
trattati od ordini. Ne consegue, secondo Peters, che non si può scendere a
compromessi con loro. Una semplice dimostrazione di forza fatta con lo
scopo di «insegnargli una lezione» non ha nessuna validità e a dimostrarlo
ci sono le esperienze con Milosevic e Saddam. Per loro non esiste una via di
mezzo: o si vince o si perde103.
Intervenire in tali frangenti è complesso e complicato: per questo Metz
sottolinea quattro principi fondamentali. Il primo passo è stabilire quando
intervenire. Molti pensano che sia necessario intervenire il prima possibile.
Sarebbe ancora meglio se si potesse prevenire104.
Un secondo principio è di avere a disposizione un’ampia gamma di mezzi
e forze. Le agenzie civili sono fondamentali e devono essere responsabilizzate
in modo da non sovraccaricare di compiti quelle militari che hanno il solo
compito di ristabilire l’ordine. Una volta fatto ciò servono a poco, perché il
conflitto etnico o la pacificazione post-bellica richiedono una soluzione
politica non militare105. Quello che comunque sembra sempre necessario è
223
Andrea Beccaro
un triplice set di forze. Alte capacità militari per distruggere le forze ostili.
Forze dell’ordine, di polizia o paramilitari, per contenere e controllare la
violenza comune. Giudici per creare e far funzionare un buon sistema
giudiziario106. L’intervento deve sempre essere multinazionale ma l’alleanza
internazionale deve mantenersi compatta. Le truppe sul terreno e i
diplomatici devono rimanere equidistanti dalle parti in lotta107.
Bisogna saper modulare lo strumento diplomatico e militare. A questo
proposito è bene ricordare la frase del generale inglese Sir Micheal Rose
comandante dell’Unprofor in Bosnia nel 1994: «Non si può fare la guerra
nascosti dietro veicoli dipinti di bianco!»108. Il generale americano William
A. Stofft sottolinea come i limiti posti dalla politica ai criteri dell’operazione
siano fondamentali. Perché se il centro di gravità del nemico è posto al di
fuori della cornice politica stabilita, l’intervento non potrà avere successo.
Le tipiche costrizioni politiche sono: mancanza di supporto, di coesione e
l’ordine di evitare obiettivi esterni alla zona di intervento. Così, per eludere
il rischio di un escalation, se un gruppo guerrigliero ottiene appoggio
dall’esterno non si possono colpire le sue fonti, ma queste rappresentano
proprio uno dei centri di gravità che andrebbero eliminati109.
Il terzo principio di Metz è valutare bene il contributo che l’esercito può
dare. Di fondamentale importanza oltre alla fanteria sono: le operazioni
psicologiche per dare legittimità al nuovo governo; i genieri per i primi
passi della ricostruzione; la polizia militare110.
Il quarto principio è la strategia d’uscita. Questo è un problema spinoso
come mette in luce Jeffrey Record, professore all’Air War College in Alabama,
perché la strategia è un piano di azione militare per raggiungere un obiettivo
politico111. L’uso della forza senza calcolare le possibili reazioni del nemico
non rientra in tale definizione. La strategia richiede la formulazione di un
desiderio politico sulla forma della fine del conflitto e di conseguenza implica
l’applicazione della forza sufficiente per ottenerlo. Non sempre però si può
avere una strategia d’uscita. Un paese che è attaccato diviene l’oggetto
dell’azione militare e non il soggetto, e quindi raramente ha una strategia
d’uscita. In secondo luogo la strategia d’uscita è un ostaggio delle attività
militari, difatti una sconfitta o una vittoria sul campo di battaglia possono
profondamente mutare gli obiettivi politici. Terzo elemento da considerare
per Record è il fatto che l’intervento implica delle responsabilità nel periodo
post bellico che spesso «richiedono una presenza militare continuata nel
tempo o almeno una credibile minaccia di un ritorno dei militari»112. In
sintesi si può scegliere dove e come intervenire ma non la durata del conflitto
224
Nuove guerre
e il suo risultato. Una volta iniziata la guerra la politica diviene un ostaggio
dei risultati militari.«Ciò significa che avere in mente una strategia d’uscita
non è la stessa cosa di essere in grado di realizzarla»113.
Molti dei problemi propri di queste operazioni si sono riscoperti prima
in Afghanistan poi in Iraq114. Qui il problema principale sembra essere la
pianificazione del dopo guerra, come hanno messo in evidenza il generale
Wesley Clark (comandante dell’Operazione Allied Force in Kosovo nel 1999)
a proposito del conflitto iracheno115 e il generale italiano Fabio Mini circa
il Kosovo e Timor Est. In questi paesi la ricostruzione è ancora lontana:
questo perché l’amministrazione internazionale è «un caos burocratico fra
le varie agenzie i cui funzionari comunque facevano la bella vita tra Range
Rovers climatizzate e altre piacevolezze»116. Inoltre dopo più di cinque anni
di amministrazione internazionale restano da risolvere «seri problemi di
vuoto legislativo, in particolare nel sistema giudiziario […] e nella legislazione
commerciale»117.
Il problema non è la mancanza di risorse, ma l’inefficienza con cui sono
sperperate poiché spesso le organizzazioni ne assorbono di più per vivere di
quelle che distribuiscono alla popolazione. Il Kosovo è diventato così per
Mini «un coacervo di iniziative umanitarie non coordinate e di violenza da
parte di irriducibili albanesi, volontari venuti dall’estero, mercenari inglesi,
americani, olandesi, sudafricani ed estremisti islamici»118. Le frange più
radicali dell’UCK si sono date al terrorismo soprattutto nelle zone cuscinetto.
Il governo è completamente corrotto e non funziona. I serbi sono al sicuro
solo nelle zone difese dalla KFOR (la forza multinazionale di pace) 119. La
violenza interna e la criminalità, con un tasso di disoccupazione del 60 per
cento, sono molti presenti. L’unica istituzione che goda di un minimo di
fiducia è la stessa KFOR120.
Mini arriva alla conclusione che l’ONU si mobilita rapidamente, ma
senza un’unità di comando e senza aver prima stabilito piani precisi di
intervento per ottenere degli obiettivi. Di conseguenza investe subito enormi
cifre per creare tutto l’occorrente per far lavorare la sua burocrazia sul luogo
lasciando poco o niente per il prosieguo121.
Il fatto incredibile però è che sia il Kosovo che Timor vivono solo sugli
aiuti internazionali che rappresentano le loro uniche entrate, senza le quali
nemmeno la criminalità potrebbe sopravvivere122. Visti i risultati sembra
evidente che in questo modo non si stabilizzano le aree di conflitto e non si
va in aiuto della popolazione locale, ma si creano solo nuovi luoghi dove
criminalità, terrorismo, insicurezza, violenza e instabilità possono
225
Andrea Beccaro
proliferare123. Questo perché ciò che emerge dalle moderne operazioni
militari che vedono coinvolte organizzazioni umanitarie è il peso sempre
crescente che ha assunto il saccheggio contro di loro come elemento
principale della logistica124. Matthew LeRiche, ricercatore presso l’Università
di Londra, definisce «l’uso del sistema degli aiuti umanitari come sistema
di supporto logistico per la guerra una delle tattiche più trascurate [dagli
analisti] della guerra moderna» e ciò è causa, secondo l’autore, di numerosi
insuccessi125. Le diverse organizzazioni, pur dichiarandosi super partes, in
realtà appoggiano involontariamente una delle due parti in lotta. Infatti i
guerriglieri feriti in combattimento spesso si spacciano per inermi civili
colpiti per sbaglio per essere assistiti. I combattenti cercano di dirigere i
movimenti delle popolazioni in modo che gli aiuti delle ONG si spostino
in zone prescelte controllate da loro. Anche i governi traggono vantaggi da
questo sistema poiché lasciare il sostentamento e la cura di parte della
popolazione ad agenzie esterne alleggerisce le finanze statali permettendo
investimenti in altri settori, quali mercenari ed armi. I campi profughi sono
ideali per gestire attività criminali o per diffondere la propria ideologia.
Inoltre diventano ottimi centri per il reclutamento spesso anche di bambini
soldato, un’altra figura delle guerre moderne126. Spesso la stessa guerra si
prolunga proprio per continuare ad usufruire degli aiuti umanitari che a
loro volta non cessano finché la guerra prosegue. Le ONG e l’ONU per
operare sono sovente costrette a pagare i combattenti i quali sanno
perfettamente che non potrebbero vivere senza gli aiuti, ma sanno anche
che l’unica minaccia che le ONG possono portare è quella di ritirarsi, cosa
che ben difficilmente avverrà127.
Per cercare di capire questi problemi William Flavin, colonnello e
professore all’US Army Peacekeeping Institute, differenzia tra cessazione e
risoluzione del conflitto. La prima indica la conclusione dei combattimenti
militari che possono fermarsi anche senza che le reali cause che li hanno
scatenati siano state risolte. D’altronde già Hobbes diceva che «la guerra
[…] non consiste solo nella battaglia o nell’atto di combattersi, ma in uno
spazio di tempo in cui la volontà di affrontarsi in battaglia è sufficientemente
dichiarata»128. Così il conflitto, anche se da un punto di vista puramente
militare si è concluso, può continuare in altre forme come il terrorismo, la
guerriglia, l’insurrezione, azioni politiche o una semplice disobbedienza
civile129. Per evitare che ciò avvenga bisogna eliminare le cause del conflitto,
ma questo è un processo lungo e un problema più civile che militare. Per
Flavin la pianificazione del post conflitto dovrebbe iniziare il prima possibile,
226
Nuove guerre
coinvolgere una pluralità di agenzie ed essere multinazionale. Dovrebbe
avere chiari obiettivi, con la consapevolezza che col mutare delle condizioni
questi potrebbero cambiare e che quindi sono necessarie adattabilità e
flessibilità. Spesso si insiste per chiari obiettivi politici e precisi limiti di
tempo, ma Flavin sottolinea come questi due punti siano in realtà un danno.
Infatti porre dei chiari obiettivi politici vorrebbe dire non potersi adattare
alle circostanze mutevoli. Il limite di tempo è una costrizione ancor più
grave perché i guerriglieri possono semplicemente attendere quella data,
far ritirare le truppe straniere per poi riprendere le loro attività130.
Il richiamo a pianificare in anticipo il periodo post-bellico era già stato
formulato da Clausewitz all’inizio del secolo XIX. Infatti il generale prussiano
distingueva due tipi di guerra proprio in base alla forma della pace che si
voleva raggiungere: il tentativo di abbattere il nemico per imporre una pace
a propria discrezione, oppure solo qualche piccola conquista da scambiare
con il nemico durante le trattative131.
Come si è cercato di mettere in evidenza, l’ambiente delle guerre moderne
è particolarmente complesso. Terroristi si sovrappongono a criminali,
guerriglieri a mercenari, soldati a operatori umanitari. In più bisogna
considerare che tutto ciò non esaurisce il discorso sulla guerra moderna perché
le potenze nucleari stanno aumentando e il concetto di deterrenza, anche se
non più a livello globale come in passato, ha ancora una sua importanza su
scala regionale. Potremmo dire che oggi convivono tre diverse tipologie di
guerre. Quelle moderne che rappresentano la classica dottrina di due o più
eserciti di stati rivali che cercano di scontrarsi in battaglia manovrando in
terra, cielo e mare. Guerre post-moderne caratterizzate dall’avversione
occidentale verso le proprie perdite e quindi per evitarle si punta tutto sull’alta
tecnologia. Per molti esperti le vere «nuove guerre» sono proprio queste guidate
dai concetti strategici nati con l’RMA. Questo tipo di guerra però ha già
creato il suo antidoto: la guerra asimmetrica intesa non solo come terrorismo
ma anche nell’ottica della proliferazione delle armi di distruzione di massa
oppure di operazioni finanziarie132. Infine ci sarebbero guerre pre-moderne
dove i fattori sociali hanno un peso maggiore di quelli tecnologici. Potrebbero
essere meglio descritte con l’immagine di «sangue e ferro» perché sono guerre
dove agisco attori non statali ed etnici133.
Da questo percorso ricco di sfaccettature e assolutamente non esaustivo
del problema si può comunque dedurre che le forme della guerra sono
cambiate; ma è mutata anche la sua natura? Clausewitz distingueva tra la
natura oggettiva e quella soggettiva. Mentre la seconda è mutevole perché
227
Andrea Beccaro
legata a fattori socio-politici contingenti, la prima è immutabile ed è
caratterizzata dal pericolo, dall’incertezza e dal caso. Un’altra caratteristica
della guerra per il generale prussiano è il suo carattere camaleontico, infatti
nel Libro VIII ci ricorda che «ogni epoca ha le sue proprie forme di guerra,
le sue condizioni restrittive, i suoi pregiudizi»134.
Se ne deduce che se in questi anni sono cambiati armamenti, attori e
tecnologie non ne consegue che sia veramente mutata la natura profonda
della guerra. Le «nuove guerre» sono forse nuove per quanto riguarda i
mezzi o i protagonisti ma, come sottolinea Colin S. Gray, professore di
politica internazionale presso l’Università di Reading, riprendendo
Tucidide, riguardano oggi come nel V secolo a.C.: la paura, l’onore e gli
interessi135.
Note al testo
1
C. JEAN, L’uso della forza. Se vuoi la pace comprendi la guerra, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 3.
2
M. VAN CREVELD, The Transformation of War, The Free Press, New York 1991.
3
R. GILPIN, The Theory of Hegemonic War, in «The Journal of Interdisciplinary History», vol.
18, n. 4, 1988, pp. 591-613.
4
G. E. RUSCONI, Clausewitz, il prussiano. La politica della guerra nell’equilibrio europeo, Einaudi,
Torino 1999.
5
C. TILLY, War Making and State Making as Organized Crime, citato in P. P. PORTINARO, Stato,
Il Mulino, Bologna 1999, p. 49.
6
Questa definizione è nata tra gli anni settanta e ottanta all’interno del dibattito americano.
7
M. VAN CREVELD, The Transformation of War cit., p. 22. Warre indica proprio confusione,
discordia o contrasto.
8
S. METZ, J. KIEVIT, Strategy and the Revolution in Military Affairs: from Theory to Policy,
Strategic Studies Institute US Army College, Carlisle Barracks (PA) June 1995.
9
Per citare i più noti anche se partono da considerazioni diverse e non tutti usano il termine
«nuove guerre»: M. VAN CREVELD, The Transformation of War, cit.; M. KALDOR, Le nuove guerre.
La violenza organizzata nell’età globale, Carocci, Roma 2001; A. TOEFFLER, H. TOEFFLER, War
and Anti-War. Survival at the dawn of 21st Century, Little, Brown & Co., New York 1993.
10
M. VAN CREVELD, The rise and the decline of the state, University Press, Cambridge 1999.
228
Nuove guerre
11
Ad esempio nella crisi dei missili a Cuba nel 1962 l’America, pur contando su un vantaggio
di 10 a 1 nei sistemi di lancio rispetto all’Unione Sovietica, non ha iniziato le ostilità. Ivi, p.
344.
12
Ivi p. 345 La Germania per l’Operazione Barbarossa impiegò 144 divisioni, per un totale di
circa 3,4 milioni d’uomini. Mentre una coalizione di più paesi nella guerra del Golfo del 1991
impiegò in tutto 550.000 uomini circa.
13
Questa considerazione è rimasta valida fino al 2001, perché ora sono cadute già due capitali
(Kabul e Baghdad). Inoltre con l’operazione Iraqi Freedom l’esercito americano ha manovrato
su un territorio abbastanza vasto, circa 437.000 chilometri quadrati.
14
Per un approfondimento sulla privatizzazione dei conflitti cfr. F. ARMAO, La rinascita del
privateering: lo Stato e il nuovo mercato della guerra, in A. D’ORSI, Guerre globali. Capire i
conflitti del XXI secolo, Carocci, Roma 2003.; R. MANDEL, The Privatization of Security, in
Armed Forces & Society, vol. 28, n. 1 Fall 2001, pp. 129-151.
15
A. D. SMITH, Nazioni e nazionalismo nell’era globale, Asterios, Trieste 2000 p. 12.
16
Z. BAUMAN, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Roma-Bari 1999.
17
U. BECK, Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria, Carocci,
Roma 1999, p.13.
18
C. GALLI, La guerra globale, Laterza, Roma-Bari 2002.
19
Ivi, p. 48.
20
Ibidem.
21
M. EVANS, From Kadesh to Kandahar. Military Theory and the Future of War, in «Naval War
College Review», Summer 2003, vol. LVI, n. 3, pp. 132-150.
22
M. NAIM, The five Wars of Globalization, in «Foreign Policy», January/February 2003.
23
Ibidem.
24
B. R. BARBER, Guerra santa contro McMondo. La sfida del terrorismo alla democrazia, Marco
Tropea Editore, Milano 2002, p. 60.
25
B. R. BARBER, L’impero della paura. Potenza e impotenza dell’America nel nuovo millennio,
Einaudi, Torino 2004, p. XXII.
26
A. J. ECHEVARRIA, Globalization and the Nature of War, Strategic Studies Institute US Army
College, Carlisle Barracks (PA) March 2003.
27
Ibidem.
229
Andrea Beccaro
28
A. D. SMITH, Nazioni e nazionalismo cit., p.116. Dal 1991 sono stati riconosciuti 18 nuove
entità statuali.
29
B. R. BARBER, L’impero della paura cit., p. 54.
30
E. J. VILLACRES, C. BASSFORD, Reclaiming the Clausewitzian Trinity, in «Parameters», vol.
XXV, Autumn 1995, pp. 9-19.
31
Ibidem
32
J. MEARSHEIMER, La logica di potenza. L’America, le guerre, il controllo del mondo, Università
Bocconi Editore, Milano 2003, soprattutto il capitolo10.
33
Ivi, p. 331.
34
Jean comunque nota come lo Stato abbia perso in questi ultimi anni il monopolio dell’uso
della forza oltre a quello sull’economia e sull’informazione C. JEAN, Geopolitica del ventunesimo
secolo, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 9.
35
Ivi, p. 21.
36
Ivi, p. VII.
37
R. KAPLAN, The Coming Anarchy, in «Atlantic Monthly», 1994, n. 273, pp. 44-76. Ricordiamo
anche il lavoro di Z. BRZEZINSKI, Il mondo fuori controllo. Gli sconvolgimenti planetari all’alba
del XXI secolo, TEA, Milano 1995. Secondo l’autore il disordine mondiale deriverebbe dal
vuoto geopolitico lasciato dal crollo dell’URSS nel cuore dell’Eurasia.
38
THOMAS F. HOMER-DIXON, On The Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute
Conflict, in «International Security», vol. 16, n. 2 (Fall 1991), pp. 76-116.
39
Portando alle estreme conseguenze questa parcellizzazione del potere alcuni teorici hanno
parlato, all’inizio degli anni novanta, di Nuovo Medioevo. Cfr. A. MINC, Il nuovo Medioevo,
Sperling & Kupfer, Milano 1994.
40
L’articolo di Kaplan risale al 1994 ovvero a più di dieci anni fa, nel frattempo l’ONU è
intervenuto in queste aree con alcune operazioni di pace (UNAMSIL in Sierra Leone dal
1999; UNMIL in Liberia dal settembre 2004) che hanno certamente attenuato la violenza,
ma non risolto i problemi di fondo qui presi in considerazione.
41
M. KALDOR, Le nuove guerre cit.
42
S. CALVANI, M. MELIS, Saccheggio globale. La nuova criminalità del mondo senza frontiere,
Sperling & Kupfer, Milano 2003, p. IX.
43
P. SARTORI, Il caso della Transnistria: mafie e terroristi nella terra di nessuno, in I quaderni
speciali di Limes, quaderno speciale n. 1 del 2002 supplemento al n. 3/2002.
230
Nuove guerre
44
M. G. ROSKIN, Crime and Politics in Colombia: Considerations for US Involvement, in
«Parameters», vol. XXI, Winter 2001-02, pp. 126-34
45
Ibidem.
46
S. R. PELLEY, The Impact of International Organized Crime On U.S. National Security Strategy,
U.S. Army War College Carlisle Barracks (PA) March 2001. Per un approfondimento sui
problemi di definizione e sulle problematiche legate alla criminalità cfr. F. ARMAO, Il sistema
mafia: dall’economia-mondo al dominio locale, Bollati Boringhieri, Torino 2000; F. ARMAO, Le
mafie: una prospettiva cosmpolitica, in Manuale di relazioni internazionali, a cura di G. J.
Ikenberry, V. E. Parsi. Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 238-255.
47
S. R. PELLEY, The Impact of International Organized Crime cit.
48
S. CALVANI, M. MELIS, Saccheggio globale cit., p. 2.
49
World Drug Report 2004, United Nations Office on Drugs and Crime, p. 65.
50
M. KLARE,The Kalashnikov Age, in «Bulletin of the Atomic Scientist», vol. 55, n. 1, January/
February 1999.
51
M. NAIM, The five Wars of Globalization cit.
52
S. CALVANI, M. MELIS, Saccheggio globale cit., p. 109.
53
La facilità con cui quest’arma può essere acquistata è preoccupante. Se da un lato questo
missile è inefficace contro i moderni mezzi corazzati, la sua maneggevolezza e semplicità d’uso
lo rendono molto pericoloso in centri abitati o contro mezzi non corazzati. Lo dimostra
l’esempio del raid americano fallito il 3 ottobre 1993 a Mogadiscio.
54
S. CALVANI, M. MELIS, Saccheggio globale cit., p. 113.
55
M. KLARE, The Kalashnikov Age cit.
56
Per una panoramica più completa delle modalità di finanziamento dei gruppi terroristici cfr.
Patterns of global Terrorism, disponibili in linea sul sito http://www.cia.gov/
57
F. ARMAO, La rinascita del privateering cit., p.100.
58
Il materiale sui pirati è scarso e difficilmente reperibile. Queste statistiche sono state tratte
dal sito http://www.iccwbo.org/ccs/imb_piracy visitato il 20 gennaio 2005. Il sito contiene
anche una cronologia degli attacchi di pirati aggiornata settimanalmente.
59
P. W. SINGER, Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the Privatized Military Industry,
in «International Security», vol. 26, n. 3, Winter 2001/2002.
60
Ibidem.
231
Andrea Beccaro
61
F. VIGNARCA, Li chiamano ancora mercenari. La privatizzazione degli eserciti nell’era della
guerra globale, Editrice Berti, Piacenza 2004, p. 61.
62
P. W. SINGER, Corporate Warriors cit.
63
F. VIGNARCA, Li chiamano ancora mercenari cit., p. 11.
64
Ivi, p. 18.
65
Ivi, p. 19.
66
E. B. SMITH, The new Condottieri and US Policy: The Privatization of Conflict and Its
Implications, in «Parameters», vol. XXXII, Winter 2002-2003, pp. 104-119.
67
T. K. ADAMS, The New Mercenaries and the Privatization of Conflict, in «Parameters», vol.
XXIX, Summer 1999, pp. 103-116.
68
E. B. SMITH, The new Condottieri and US Policy cit. ma anche T. K. ADAMS, The New
Mercenaries cit.
69
P. W. SINGER, Corporate Warriors cit.
70
Ivi.
71
Ivi.
72
F. VIGNARCA, Li chiamano ancora mercenari cit., p.14.
73
P. W. SINGER, Corporate Warriors cit.
74
Ivi.
75
Ivi.
76
S. LATOUCHE, L’occidentalizzazione del mondo, Bollati Boringhieri, Torino 1992.
77
A. D. SMITH, Nazioni e nazionalismo cit., p. 12.
78
R. ARBITRIO, Il conflitto etnico. Dinamiche sociali e strategie di intervento: il caso della ex
Jugoslavia, Franco Angeli, Milano 1998, p. 15.
79
M. KALDOR, Le nuove guerre cit., p. 92.
80
R. ARBITRIO, Il conflitto etnico cit., p. 16.
81
Ivi p. 19
82
Ivi p. 151
232
Nuove guerre
83
S. P. HUNTINGTON, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano 2000,
p. 374.
84
P. H. BAKER, J. A. AUSINK, State Collapse and Ethnic Violence: Toward a Predictive Model, in
«Parameters», vol. XXVI, Spring 1996, pp. 19-31.
85
S. METZ, Disaster and Intervention in Sub-Saharan Africa: Learning from Rwanda, Strategic
Studies Institute US Army College, Carlisle Barracks (PA) September 1994.
86
R. ARBITRIO, Il conflitto etnico cit. Per una disamina sulle operazioni di peacekeeping: M.
KORNPROBST, Explaining Success and Failure of War to Peace Transitions: Revisiting the Angolan
and Mozambican Experience, in «The journal of Conflict Studies», Fall 2002, pp. 57-82. Per
cercare di comprendere come le nuove tecnologie possano modificare queste operazioni cfr. E.
SLOAN, Peacekeeping and the Revolution in Military Affairs: A Question of Relevancy, in «The
journal of Conflict Studies», Fall 2002, pp. 83-98.
87
R. ARBITRIO, Il conflitto etnico cit., p. 57.
88
M. KALDOR, Le nuove guerre cit., p. 130.
89
Ivi, p. 134.
90
M. WALZER, La politica del salvataggio, in M. WALZER, Sulla guerra, Laterza, Roma-Bari
2004, p.4.
91
Ivi p. 69
92
Ivi p. 73
93
S. METZ, Disaster and Intervention in Sub-Saharan Africa cit.
94
R. ARBITRIO, Il conflitto etnico cit., p.183.
95
Ivi, p. 136.
96
W. A. STOFFT, Ethnic Conflict: implications for the Army of the future, Strategic Studies Institute
US Army College, Carlisle Barracks (PA) March 1994.
97
S. METZ, Disaster and Intervention in Sub-Saharan Africa cit. Mao, Stalin, il governo nigeriano
negli anni sessanta, per fare solo alcuni esempi, utilizzarono la carestia a questo fine.
98
Ivi.
99
M. VAN CREVELD, The Transformation of War cit.
100
W. A. STOFFT, Ethnic Conflict cit.
101
R. PETERS, The New Warrior Class, in «Parameters», vol. XXIV, Summer 1994, pp. 16-26.
233
Andrea Beccaro
102
Per uno sguardo sull’etica e la responsabilità del soldato cfr. M. WALZER, Due tipi di
responsabilità militare, in M. WALZER, Sulla guerra cit., pp. 25-33.
103
R. PETERS, The New Warrior Class cit.
104
S. METZ, Disaster and Intervention in Sub-Saharan Africa cit. A questo proposito però Luttwak
individua due problemi. Da una parte per le élite politiche non è facile ottenere il consenso
per un’operazione che, pur essendo umanitaria, presenta comunque dei rischi. Dall’altra questi
conflitti sono intrisi d’odio e può risultare utile lasciarlo sfogare per evitare un suo riaffiorare
in futuro. E. N. LUTTWAK, Give War a Change, in «Foreign Affairs», vol. 78, n.4 , pp. 36-44.
105
W. A. STOFFT, Ethnic Conflict cit.
106
R. BRONSON, When Soldiers became cops, in «Foreign Affairs», vol. 81, n. 6, pp.122-132.
107
R. ARBITRIO, Il conflitto etnico cit., p. 170.
108
Ivi, p. 176.
109
W. A. STOFFT, Ethnic Conflict cit.
110
S. METZ, Disaster and Intervention in Sub-Saharan Africa cit.
111
J. RECORD, Exit Strategy Delusions in «Parameters», vol. XXI, Winter 2001-02, pp. 21-27.
112
Ibidem.
113
Ibidem.
114
Già nel 1977 Ken Organski sottolineava la complessità e la lunga durata di tutti i dopo
guerra, cfr. F. K. ORGANSKI, J. KUNGLER, The Cost of Major Wars: the Phoenix Factor, in «The
American Political Science Review», LXXI, 1977.
115
W. CLARK, Vincere le guerre moderne. Iraq, terrorismo e l’impero americano, Bompiani, Milano
2004.
116
F. MINI, La guerra dopo la guerra. Soldati, burocrati e mercenari nell’epoca della pace virtuale,
Einaudi, Torino 2003, p. 181.
117
Ibidem.
118
Ivi, p. 215.
119
Ne sono esempi le tensioni scoppiate nel marzo 2004.
120
F. MINI, La guerra dopo la guerra cit., p. 233.
121
Ivi, p. 246.
234
Nuove guerre
122
Ivi, p. 240.
123
Ivi, p. 246.
124
M. LERICHE, Unintended Alliance: The Co-option of Humanitarian Aid in Conflicts, in
«Parameters», vol. XXIV, Spring 2004, pp. 104-120.
125
Ibidem.
126
P. W. SINGER, Caution: Children at War, in «Parameters», vol. XXI, Winter 2001-02, pp. 4056.
127
M. LERICHE, Unintended Alliance cit.
128
T. HOBBES, Il Leviatano, Laterza, Roma-Bari 2004, p.101.
129
W. FLAVIN, Planning for Conflict Termination and Post-Conflict Success, in «Parameters»,
vol.XXXI, Autumn 2003, pp. 95-112.
130
Ibidem.
131
C. VON CLAUSEWITZ, Della guerra, Mondadori, Milano 1970, p. 9.
132
Q. LIANG, W. XIANGSUI, Guerra senza limiti. L’arte della guerra asimmetrica fra terrorismo e
globalizzazione, a cura di F. Mini, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2001.
133
Questa tripartizione delle forme di guerra è stata tratta da M. EVANS, From Kadesh to Kandahar
cit.
134
C. VON CLAUSEWITZ, Della guerra, cit., p. 794.
135
C. S GRAY, How Has War Changed Since the End of the Cold War?, in «Parameters», vol.
XXXV, Spring 2005, pp. 14-26.
235
Andrea Beccaro
236
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
Notizie da un genocidio lontano.
La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
di Chiara Calabri
La prima chiave di lettura: la guerra etnica
All’inizio dell’aprile del 1994 il Rwanda «arriva» sulle pagine dei giornali
italiani. Un piccolo paese dell’Africa centrale, lontano, geograficamente e
culturalmente dall’Italia, in pochi giorni diventa sinonimo di violenza
terribile. L’attenzione dei media si concentra in questo piccolo pezzo d’Africa
di cui ben poco si conosce, all’interno dei canali ufficiali e istituzionali
della cultura.
L’analisi di quattro testate giornalistiche italiane, prese in considerazione
come significative e rappresentative di ambienti politici e culturali diversi,
- «Corriere della Sera», «Il manifesto», «Il Messaggero», «Avvenire» -, ha
portato a rilevare un divario: da una parte si è constatata la sostanziale
ignoranza sull’Africa, ed in particolare sulle questioni dell’etnicità in Africa,
di quelli che unanimemente sono considerati i giornali più autorevoli e
voce della classe dirigente economica e politica, italiana - «Corriere della
Sera» e «Il Messaggero» -; dall’altra in linea generale, si è rintracciata una
maggiore conoscenza e volontà di approfondimento sugli eventi e le loro
cause da parte delle testate più di «nicchia», rappresentanti di fasce meno
larghe o meno emergenti della popolazione italiana, cioè «Avvenire» e «Il
manifesto». Questi due quotidiani si può dire che esprimano e attivino essi
stessi la corrente di una cultura, per così dire, «alternativa» rispetto a quella
delle istituzioni. Essi, muovendosi da due punti di partenza opposti, tuttavia
rivelano una comune attenzione per le vicende che coinvolgono paesi non
rientranti nelle tradizionali sfere d’interesse, ed una maggiore capacità di
comprensione al di là delle facili interpretazioni.
Fin dai primi giorni dello scoppio della crisi le differenze nell’approccio e
nello spazio dedicato alla crisi rwandese da ciascuna testata saltano all’occhio.
Il 6 aprile 1994 l’aereo presidenziale rwandese che trasportava il
presidente della Repubblica Habyarimana e quello del Burundi, Ntaryamira,
237
Chiara Calabri
si schiantò al suolo presso l’aeroporto di Kigali. I due presidenti avevano
partecipato a un vertice sulla stabilità dell’area dei Grandi Laghi, tenutosi a
Dar es Salam1.
Il 7 aprile, i primi quotidiani a dare la notizia che l’aereo si era schiantato
al suolo sono il «Corriere della Sera» e «Il Messaggero». Questi due quotidiani
danno, brevemente, la notizia dell’abbattimento dell’aereo: «Il Messaggero»
riferisce che l’aereo presidenziale si è schiantato al suolo e che non si conosce
ancora con esattezza la ragione della caduta, mentre il «Corriere della Sera»
sposa in pieno l’ipotesi dell’attentato, fin dal titolo. Nei due articoli si ricorda
che i due presidenti africani stavano tornando da un vertice regionale che si
era svolto a Dar-es-Salam, in Tanzania, per cercare una soluzione all’instabile
situazione burundese2. Il «Corriere della Sera» definisce il vertice di Dar-esSalam come «una riunione sulle crisi politico-etniche tra l’etnia tutsi - i
lunghi “watussi”- e l’etnia hutu - i corti “bantù”- che stanno mettendo a
ferro e fuoco il Burundi e il Rwanda»3; «Il Messaggero» ne parla come di
una discussione intorno a una «soluzione per la guerra civile che oppone i
gruppi etnici del Burundi, dove l’esercito di cinquemila uomini è comandato
da ufficiali della tribù tutsi»4.
È evidente che la lettura che emerge fin dalle prime righe dedicate al
Rwanda e alla crisi dei Grandi Laghi, è di tipo etnico: l’instabilità dell’area è
definita di natura politica ed etnica. La coppia semantica «politico-etniche»,
riferita alle crisi in Burundi, appare indissolubile. Lo scontro di identità etniche,
come è affermato nell’articolo del «Corriere», o, con più precisione, come
riporta «Il Messaggero», «tribali», è la spiegazione più immediata e naturale,
che può essere data di una situazione d’instabilità in Africa. Ritorna, fra le
righe di questi due giornali, la rappresentazione tipica dell’Africa: un’Africa
che non si conosce, lontana, ma le cui «crisi» si ha la pretesa di comprendere
e poter catalogare come politiche ed etniche. È come se, per l’Africa, la
politica da sola non bastasse a spiegare i meccanismi delle instabilità: alle
motivazioni politiche si accompagna qualcosa di più atavico e irrazionale che
è lo scontro di gruppi biologicamente diversi e che si autorappresentano in
identità contrapposte. La categoria dell’«etnicità» costituisce il facile strumento
per spiegare realtà che non si conoscono e di fronte alle quali, soprattutto,
non ci si vuole porre in maniera problematica e con un atteggiamento
comprensivo, ma si accetta e ci si accontenta di utilizzare concetti interpretativi
che rimandano il lettore a una realtà diversa, altra, arcaica, selvaggia.
Il linguaggio utilizzato dal «Corriere della Sera» rivela il razzismo che
riemerge non appena si parla di Africa: «i lunghi watussi», di cui parla
238
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
questo giornale, richiamano, all’immaginario del lettore medio italiano,
«gli altissimi negri» della popolare canzone che ha accompagnato le vacanze
di molti. Colpisce il fatto che questa definizione rozza e un po’ grezza sia
riportata proprio da uno dei quotidiani più letti in Italia e rappresentante
della borghesia industriale, ed anche intellettuale, della penisola. Essa
contribuisce a ridurre l’Africa a un’immagine da cartolina ed è sintomo
della mancanza di un reale interesse per ciò che sta accadendo, nonché
delle categorie culturali adeguate.
L’8 aprile i due quotidiani concedono una mezza pagina al Rwanda. I
titoli parlano di «caos e sangue»5, dell’«ora della vendetta» e di «violenza
tribale»6. L’articolo di Riccardo Orizio sul «Corriere della Sera» si apre con
una frase significativa: «Prima il brutale attentato all’aeroporto, poi il caos e
l’odio tribale più sanguinoso»7. Le spiegazioni che lungo l’articolo vengono
dispensate riguardo alla storia passata del Rwanda, contribuiscono ad
inquadrare l’esplosione di «odio tribale» in un passato di guerre e violenze
da cui la storia del Rwanda sarebbe caratterizzata, e che costituirebbero il
destino del paese. Il giornalista parla della storia del Rwanda come di una
storia caratterizzata da una «trentennale guerra civile tra la maggioranza
hutu e la minoranza tutsi»8.
Riguardo ai due presidenti morti nell’abbattimento dell’aereo, afferma
che «entrambi guidavano nazioni tra le più povere del mondo, in difficile
transizione verso la democrazia multipartitica, e che, soprattutto, entrambi
erano dell’etnia hutu, la più numerosa nei due paesi. Erano cioè due “corti”,
quelli che i sottili, alti e aristocratici watussi amano definire “sporchi schiavi
bantù”»9. I toni richiamano alla mente le pagine degli etnologi di inizio
secolo e dei Rapporti del Ministero delle Colonie belga che giustificavano
il sistema amministrativo coloniale, fondato sull’alleanza con i tutsi, sulla
base di differenze fisiche e morali fra i due gruppi10. Sicuramente fra gli
etnologi dell’inizio del Novecento e i giornalisti italiani che nel 1994 si
occuparono del Rwanda corrono molte differenze. Ma quello che colpisce
nei primi articoli che appaiono sulla stampa italiana a proposito della crisi
rwandese, è il totale appiattimento di ogni tentativo di spiegazione sulla
linea dell’etnicità e la mancanza di qualsiasi interrogativo volto a
comprendere meglio quello che stava accadendo. Emerge una sostanziale
ignoranza che si tenta di coprire vendendo un’immagine dell’Africa che è
risultato di un collage di modi di dire, stereotipi, pregiudizi di repertorio.
Le affermazioni erronee che impunemente sono fatte fra le righe degli articoli
del «Corriere della Sera» confermano tutto ciò: non solo è adottata
239
Chiara Calabri
acriticamente la lettura di una contrapposizione fra due gruppi etnici, ma
non è possibile ricavare notizie precise neppure sullo scontro fra le etnie:
infatti, nell’articolo del 7 aprile si parla dei «ribelli dell’ex Fronte patriottico»
dicendo che sono «in maggioranza di etnia hutu»11, mentre «Il Messaggero»
parla genericamente di «due fazioni in guerra»12.
Di primo acchito, dunque, l’idea che i lettori del «Corriere della Sera»
potevano farsi della crisi rwandese, era quella di un conflitto che rientrava
nel classico repertorio africano: un continente selvaggio, caratterizzato da
ataviche lotte fra gruppi tribali diversi, incapaci di trovare una via per lo
sviluppo e per la fuoriuscita dalla guerra endemica e dalla miseria. La
mancanza di una prospettiva storica più articolata sul Rwanda, di ogni
accenno alle eredità coloniali banalizzano il discorso e finiscono per distorcere
la realtà delle cose.
La banalizzazione attraverso stereotipi è particolarmente evidente nelle
«schede» o «finestre» che si alternano agli articoli e che dovrebbero servire a
dare un’informazione sommaria e esauriente sul paese o sulla realtà di cui si
parla.
Le schede sono molto comuni nei giornali italiani e sembrano essere un
modo utile per introdurre il lettore a un argomento di cui si sa poco. Schede
sul Rwanda si trovano sia ne «Il Messaggero», sia nel «Corriere della Sera»,
sia ne «Il manifesto» che in «Avvenire». In poche righe non è facile inquadrare
una realtà complessa e lontana come quella del Rwanda senza incorrere in
semplificazioni; ma se si procede a una lettura sinottica delle «schede» dei
quotidiani presi in esame, è interessante confrontare ciò che viene detto e
ciò che viene omesso, i giudizi, che, anche se in poco spazio, emergono, e
quindi l’immagine che il lettore ricava da questi «compendi» della storia e
della situazione rwandesi.
Anche nelle schede l’attenzione è concentrata principalmente sulla
classificazione etnica e la storia del paese è ridotta a un alternarsi indistinto
- mancano infatti, per lo più, riferimenti cronologici - di violenze fra i due
gruppi. Il succo del discorso, che ritorna, è che il Rwanda è caratterizzato
da un destino di «violenza e miseria»13 e da «una tradizione di golpe e guerre
tribali»14. Anche «Il manifesto», nella sua scheda dell’8 aprile, pur offrendo
riferimenti più espliciti e precisi al periodo coloniale e a quello successivo
all’indipendenza, tuttavia presenta come lettura principale della storia
rwandese, quella di un ripetersi di scontri etnici.
Il 9 aprile anche «Avvenire», giornale cattolico, pubblica una scheda del
paese dove oltre ai riferimenti geografici, economici e etnici si fa cenno
240
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
anche alla guerra dell’ottobre 1990. Nella scheda di «Avvenire» le dinamiche
della storia rwandese non sono ridotte allo scontro tra le due etnie, anche
se, pure qui, manca un’interpretazione più completa.
È vero che le brevi notizie riportate nello spazio delle «schede» non
possono che rivelare punti di vista limitati e semplificati. Tuttavia da esse si
ricava che tutte le testate sembrano condividere, nei primissimi giorni della
crisi, l’argomento dello scontro etnico, in maniera più o meno uniforme.
L’impressione generale è che ci sia un’immediata e generalizzata adozione
della lettura più semplice e più banale della violenza rwandese, in termini
etnici e tribali.
Anche «Il manifesto» nella scheda dell’8 aprile, che introduce brevemente
la storia del Rwanda, riprende la vulgata più comune della suddivisione
della popolazione in tre gruppi: «il gruppo maggioritario è hutu, ceppo
Bantu, che sostituì gli abitanti autoctoni, i twa, pigmeidi»15. E «Avvenire»,
negli articoli dell’8 aprile, si pone sullo stesso piano, scrivendo che «nel
Rwanda è al potere la maggioranza hutu, di ceppo negro-bantù, che ha
massacrato e costretto all’esilio gran parte della minoranza tutsi (meglio
conosciuti come watussi), etnicamente nilotici»16.
Ne esce fuori un dipinto complessivo del continente africano come
«continente selvaggio e selvaggiamente violento», un’Africa, ancora nel terzo
millennio, popolata da società dagli «strani costumi», da una umanità dolente,
condannata da e per sempre alla penuria, che sembra ritrovare le sue forze
solo nell’esercizio di una violenza atavica e irragionevole, naturale e ferina17.
Attraverso la chiave di lettura dello scontro etnico, indubbiamente, viene
colto un aspetto della crisi rwandese non secondario: l’agitazione del
«fantasma» delle identità contrapposte da parte delle autorità del governo
rwandese e dei media mobilitò la popolazione in azioni violente contro
quell’immagine dell’«altro» che, a partire dall’epoca coloniale, era stata
costruita come nemica: la campagna d’odio ebbe le sue basi e le sue casse di
risonanza proprio nell’esasperazione dei sentimenti di identità e di esclusione,
attraverso l’appropriazione di un gioco di manipolazione e di uso pubblico
della storia che era stato già utilizzato dalle potenze coloniali18. Tuttavia,
l’adozione della categoria etnica come chiave di volta per spiegare la violenza
che percorse il Rwanda fra l’aprile e il luglio del 1994, spesso pare abbia
dato adito a semplificazioni eccessive, soprattutto in quei quotidiani in cui,
ed è il caso in particolare del «Corriere della Sera» e de «Il Messaggero», gli
approfondimenti e le analisi sugli eventi rwandesi sono meno frequenti: il
rischio è stato, là dove ha prevalso l’uso della categoria etnica, quello di
241
Chiara Calabri
sposare di fatto la posizione degli stessi organizzatori del genocidio:
un’adozione senza sfumature del punto di vista etnico e l’uso di tale chiave
di lettura per tutta la storia rwandese hanno fatto rischiare la connivenza
con il regime, organizzatore del genocidio.
La lettura etnica è risultato di una pigrizia intellettuale che sembra aver
caratterizzato molti quotidiani e mass media dell’epoca di fronte alla crisi
rwandese, ed in particolare, fra le testate prese in considerazione, «Il
Messaggero» e il «Corriere della Sera». Per i giornali che rappresentano la
voce della borghesia industriale e commerciale italiana, il Rwanda costituisce
un’area estranea a ogni interesse «nazionale», per cui non vale la pena
interrogarsi se non saltuariamente, quando la crisi si fa più violenta e
scandalosa, o quando essa sembra avvicinarsi all’Italia, magari come eventuale
sollecitazione al dispiegamento di truppe italiane.
Il fatto che i maggiori quotidiani nazionali mostrino poco interesse a
comprendere la crisi rwandese, riflette i limiti non solo del giornalismo ma
anche, e soprattutto, della politica estera e della cultura italiane. La pigrizia
intellettuale che porta ad adottare la lettura più facile, quella etnica, e a non
porsi interrogativi sulle cause dell’esplosione della violenza e a non
contestualizzarla, rivela la mancanza di una tradizione culturale di studi su
aree extraeuropee e non occidentali e, in maniera più diffusa, di un senso
comune di interessamento al mondo. L’Europa e gli Stati Uniti costituiscono,
sostanzialmente, i due poli su cui si concentra l’attenzione politica - e, di
conseguenza, culturale - dell’Italia.
D’altra parte una politica estera «nana», incapace di proiettarsi su scenari
ampi e spesso ridotta a mero argomento di confronto-scontro fra i diversi
partiti, non stimola e non ha bisogno di una comprensione del mondo più
profonda19.
La lettura etnica, nel 1994, era, inoltre, particolarmente a «portata di
mano» dell’opinione pubblica europea: il dramma che si stava consumando
in Bosnia aveva coordinate di spiegazione simili: lo scontro aveva luogo fra
gruppi di popolazione che, dopo anni di convivenza, si erano identificati
come contrapposti e nemici, generando violenza e caos20. Lungo la
narrazione degli eventi rwandesi dei quotidiani analizzati, in vari passaggi
si ritrovano comparazioni fra Kigali e Sarajevo, fra il Rwanda e la Bosnia: la
triste espressione di «pulizia etnica» che risulta purtroppo nota all’orecchio
del cittadino europeo medio in relazione con le guerre jugoslave, è spesso
utilizzata in riferimento anche al Rwanda.
242
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
Dalla lettura etnica a quella «politica»
Tra le testate analizzate «Avvenire» è quella che non si limita a fornire
una cronaca della crisi rwandese, ma è ricca anche di analisi, commenti,
testimonianze che permettono di andare oltre la lettura etnica e offrono
altre direttrici di analisi della storia rwandese, delle responsabilità interne e
internazionali, a vari livelli, della crisi. Gli approfondimenti, le riflessioni,
le analisi di «Avvenire» costituiscono strumenti utili per non limitarsi ad
avere una prospettiva falsata.
Rispetto a una cultura dominante che guarda all’Africa e al Terzo Mondo
attraverso cliché banalizzanti, come ad un blocco unico e indifferenziato di
realtà sostanzialmente sconosciute che possono soltanto suscitare pietà,
commozione o orrore, il tentativo da parte di alcune voci, anche se
minoritarie, è quello di offrire altri punti di vista e elementi di conoscenza.
«Il manifesto» segue «Avvenire» nell’interessamento per la comprensione
della crisi e per l’offerta ai lettori degli strumenti adeguati per interpretarla.
Queste due testate esprimono due filoni di una cultura alternativa a
quella prevalente della borghesia italiana legata all’imprenditoria, alla
gestione della politica, al commercio. Si tratta di una cultura che tenta di
interessarsi a ciò che succede nel mondo, con uno sguardo più largo.
L’interesse nasce da due fonti diverse: da una parte quella dell’opposizione
tradizionale alla cultura dominante, di stampo comunista, dall’altra quella
cattolica e della Chiesa. Questi due ambienti, pur partendo da posizioni
nettamente diverse, tuttavia talvolta finiscono per convergere su certi temi
e per avere alcuni punti di contatto. La condivisione del medesimo interesse
per il mondo e per le aree in situazioni difficili, che da una parte prende il
nome di internazionalismo, dall’altra di solidarietà cristiana, costituisce un
terreno comune ai due settori e li contraddistingue dalla «cultura
dominante», più lontana rispetto a certi temi21. In maniera appropriata si
può parlare di una cultura alternativa: una cultura costruita da uomini
animati da un interesse prima di tutto umano e solidale per le tragedie del
mondo, e che spesso vivono in prima persona esperienze sul campo - come
i missionari ed i volontari laici che si riconoscono in varie posizioni e
associazioni -22. Grazie al contributo di queste persone, è attivato un circuito
alternativo di idee e di informazioni che vanno a colmare le deficienze della
cultura «istituzionale» e «istituzionalizzata», rilevabili, in particolare, nel
campo della conoscenza di regioni del mondo che esulano dal diretto
interesse italiano. Tant’è che le riviste specializzate sulle aree del Terzo Mondo
243
Chiara Calabri
sono in maggioranza riviste missionarie come «Nigrizia», «Mondo e
Missione», «Missione oggi».
La Chiesa, immersa in realtà spesso pericolose, si trova spesso ad essere
toccata, nei suoi stessi membri, dalla violenza che, soprattutto a partire
dagli anni novanta, è esplosa in tante parti del mondo. Molti missionari,
sacerdoti, religiosi ed anche laici, in diverse situazioni, si sono trovati ad
essere i soli testimoni di realtà di violenza estrema da cui assai spesso sono
stati colpiti anche in prima persona.
La Chiesa è stata presente in Rwanda durante tutta la guerra: i missionari,
alcuni dei quali di nazionalità italiana, sono stati gli unici a rimanere sul
territorio in mezzo all’imperversare degli eccidi. La Chiesa rwandese ha
perso molti dei suoi esponenti ed ha subito una vera e propria decapitazione:
monsignor Vincent Nsengiyumva, arcivescovo di Kigali; monsignor
Thaddée Nsengiyumva, vescovo di Kabgayi e presidente della Conferenza
episcopale rwandese; monsignor Joseph Ruzindana, vescovo di Byumba,
furono uccisi all’inizio di giugno da miliziani del Fpr, mentre il 25 per
cento dei sacerdoti rwandesi erano stati uccisi a metà giugno23. D’altronde,
molti dei massacri compiuti a danno dei civili tutsi si svolsero all’interno
delle chiese, dove tradizionalmente la popolazione cercava rifugio. L’interesse
di «Avvenire» nel conoscere non solo gli avvenimenti ma anche le loro radici
è chiaramente collegata a tutti questi elementi.
Accanto alla lettura etnica e tribale degli scontri, che si ritrova fra le
righe dei vari articoli per tutto il periodo in cui si parla del Rwanda,
«Avvenire» e «Il manifesto» mettono sul tavolo questioni diverse che
permettono di cogliere una comprensione non solo a una dimensione, della
crisi rwandese.
Accanto alle «schede» banalizzanti, «Il manifesto» pubblica un’analisi di
Giampaolo Calchi Novati - uno degli esperti africanisti italiani -, in cui si
legge che il fenomeno della contrapposizione fra hutu e tutsi è connesso
«agli strumenti e agli obiettivi che rimontano ad altri criteri di legittimazione
o di efficienza, dal colonialismo alla sommaria “democrazia” della
decolonizzazione e alle pratiche dei regimi militari, che hanno
definitivamente alterato gli equilibri»24, per concludere che la vulgata della
violenza e dell’instabilità associate alle tensioni insite nella difficile convivenza
fra le due etnie ha del vero, «ma la realtà è molto più complessa»25. Le
considerazioni di Calchi Novati permettono di attenuare il peso delle etnie
e delle identità etniche nella comprensione degli eventi rwandesi, e di
introdurre un’altra linea interpretativa che è quella della strumentalizzazione
244
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
delle identità per fini politici ed economici da parte di coloro che, negli
anni, si sono succeduti alla guida del paese, dai rappresentanti della potenza
coloniale, fino ai membri del governo di Habyarimana. Un’analisi di Piero
Gheddo apparsa su «Avvenire» del 9 aprile, si intitola così: Non solo odio
tribale ma anche sete di potere; in essa si mette in evidenza che «la stampa
occidentale sbrigativamente attribuisce i massacri in Rwanda e Burundi
all’odio razziale. Indubbiamente c’è anche questa causa ma la sola chiave
tribale non è sufficiente per leggere la serpeggiante guerra civile nei due
paesi. […] In pratica oggi la lotta e i massacri avvengono per motivi politici
interni, non per antichi odi tribali. […] La cristallizzazione delle tribù è
stata causata dai belgi che hanno cooptato nell’amministrazione e
nell’esercito e polizia i tutsi, approfondendo il fossato tra le due etnie. […]
L’odio etnico oggi è strumentalizzato da certe fazioni (di militari, di politici,
di capi tradizionali) che lo usano per regolamenti di conti»26. Considerazioni
analoghe si leggono nell’«Avvenire» del 10 giugno, a opera di Rodolfo
Casadei, che sottolinea come, pur essendo passati due mesi dall’inizio della
carneficina, «sulla stampa e sulle tv l’equivoco non è stato ancora chiarito
anzi continua ad incancrenirsi: la tragedia che ha investito il piccolo paese
africano continua a essere presentata come una guerra tribale frutto dell’odio
atavico fra le due etnie degli hutu e dei tutsi […]. Bisogna far capire che
quella del Ruanda (come altre guerre africane e non, di questi anni novanta)
non è una guerra etnica, ma una guerra dove il fattore etnico è strumentalizzato
in funzione di una lotta di potere che riguarda soprattutto élites politiche e
militari. L’appartenenza etnica, insomma, non è una realtà sostanziale che
di per sé crea contrapposizioni, ma una realtà strumentale che si getta sul
piatto della bilancia e si fa valere nel momento in cui si scatena la
competizione per l’accaparramento di risorse materiali e posti di potere.
[…] La questione dell’etnicità è stata completamente trasformata dalla
vicenda coloniale […] il colonialismo ha portato l’economia monetaria, la
burocrazia di tipo occidentale e un sistema scolastico moderno. Tutto questo
ha omologato le due etnie sia in alto (chi studiava e si arricchiva) sia in
basso (chi non ha usufruito delle nuove possibilità). Ma ha creato pure una
competizione per l’acquisizione delle nuove fonti di potere e prestigio
all’interno della nuova classe degli evoluti: chi aveva diritto alle risorse e ai
posti di comando moderni? È qui che sono rispuntate fuori, in modo
strumentale le categorie etniche: i tutsi hanno preteso la totalità del potere
in nome della tradizione, gli hutu hanno preteso la stessa cosa nel nome
della democrazia. Nel 1959 hanno vinto gli hutu, ma i benefici della vittoria
245
Chiara Calabri
sono andati soltanto a un ristretto gruppo di potere[…]. La stessa cosa si è
ripetuta ai nostri giorni: il Fpr recluta soprattutto fra i tutsi, ma non certo
nell’interesse dell’etnia, che è stata esposta alle rappresaglie del governo e
delle bande locali, bensì dei suoi leader politico-militari. Gli estremisti hutu,
che hanno istigato le folle a massacrare i tutsi, difendono essi pure interessi
di fazione e non genericamente etnici […]. Il massacro etnico, preparato
da tempo a livello propagandistico e organizzativo, serviva da cortina
fumogena per nascondere i reali interessi in gioco, cioè la lotta spietata per
il potere»27. Si tratta di analisi che paiono serie e puntuali nel mettere in
evidenza i meccanismi che hanno portato all’idealizzazione delle categorie
delle contrapposte identità e alla strumentalizzazione politica, da parte di
gruppi di potere, di tali categorie. «Avvenire» sembra dunque offrire una
lettura del conflitto che, pur riconoscendo l’implicazione dell’etnicità nello
scoppio della violenza, riscontra anche l’artificiosità della contrapposizione
identitaria violenta e atavica. Anche nell’analisi di Claudio Moffa, che
interviene sullo stesso quotidiano il 3 luglio, emerge una posizione di mezzo
fra i «colonialisti» che affibbiano tutta la responsabilità del genocidio ai
rwandesi e i «terzomondisti» che affermano che l’etnia «è categoria inventata
dai colonialisti per dividere et imperare»28.
Giampaolo Calchi Novati scrive nuovamente su «Il manifesto» che:
«all’origine del dramma del Ruanda c’è uno scontro fra due forze che
coincidono in parte con i due nuclei di popolazione che vivono in questo
ex-regno ed ex-possedimento belga, ma che per altri aspetti li attraversano,
identificandosi con rivendicazioni che hanno le solite spiegazioni: il potere,
il comando, la promozione sociale»29. Molto interessante e chiarificatrice
è l’intervista rivolta all’africanista francese, Jean François Bayart, autore
de L’état en Afrique. La politique du ventre, all’epoca direttore della rivista
«Politique africaine». Bayart è presentato come «un africanista scomodo.
Allergico ai miti e ai pregiudizi di cui si alimenta lo sguardo dei media (e
degli storici) occidentali. Ne contesta innanzitutto le litanie sul tribalismo,
frutto di “pigrizia intellettuale”, eurocentriche e fuorvianti, perché
accreditano l’idea che gli africani “non sanno fare altro che scannarsi tra
loro”»30. Dice Bayart nell’intervista: «Rimprovero agli autori marxisti di
non aver mai capito cos’è l’etnicità, vale a dire il sentimento di
appartenenza tribale. Ne hanno sottovalutato l’importanza, giudicandola
una forma di “falsa coscienza”, prodotta dall’alienazione. La storiografia
liberale ha fatto invece l’operazione contraria: ha sopravvalutato il peso
delle etnie attribuendo ai loro contrasti di interesse tutti i conflitti che
246
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
hanno insanguinato l’Africa. La verità è che le etnie in quanto tali non
esistono, ma sono una risposta alle strutture statali create dal colonialismo.
Il sentimento di appartenenza tribale, cioè, è un moderno fattore di
mobilitazione sociale e politico, mutevole d’altronde sia nel tempo che
nello spazio geografico africano. Oggi essere hutu o tutsi in Ruanda ha
valenza ben diversa rispetto al XIX secolo: all’epoca dei grandi regni
l’appartenenza etnica comportava e garantiva una serie di relazioni
economiche, politiche e culturali. […] Oggi […] parlerei di “fazioni” più
che di etnie, nel senso che in Africa operano oggi leader e imprenditori
politici in grado di mobilitare le coscienze etniche a fini di potere»31. «Il
manifesto» pubblica, inoltre, un’intervista a José Kagabo antropologo e
storico rwandese che lavora all’École des Hautes Études en Sciences
Sociales a Parigi, in cui è messa ancora una volta in evidenza la
strumentalizzazione delle identità a fini politici e di accaparramento del
potere come pratica ricorrente soprattutto là dove la democrazia è acerba.
L’articolo si intitola Un vuoto politico dietro i massacri e Kagabo afferma
che «in mancanza di un progetto e di un programma politico ci si chiude
nell’identità etnica»32. Infine, in un approfondimento dedicato all’Africa
da «Il manifesto» del 31 luglio, la giornalista Giuseppina Ciuffreda parla
anche del ruolo dell’Akazu «il clan del presidente», «cervello e braccio»
degli scontri, «deciso a non mollare profitti e privilegi di una gestione del
potere durata vent’anni»33.
Tirando le fila di ciò che si può leggere tra le righe degli articoli dei due
quotidiani presi in considerazione, emerge, dunque, che dietro lo scontro
fra le due etnie esiste una volontà politica di creare e sfruttare l’odio per
generare caos e favorire l’assunzione del potere di una parte o dell’altra e
che questa è stata la politica utilizzata anche durante l’epoca coloniale,
dall’amministrazione tedesca e poi belga.
Una problematizzazione della categoria dello scontro etnico non si ritrova
invece ne «Il Messaggero». Da questo punto di vista sembra infatti che
questo quotidiano si ostini a pensare solamente in termini di uno scontro
di tribù. In un articolo del 16 luglio, data in cui la maggioranza delle uccisioni
aveva già avuto luogo, si arriva ad annunciare che «si profila finalmente un
rallentamento del conflitto tribale»34. Il «Corriere della Sera», infine, per lo
più non ospita commenti o analisi vere e proprie, volte a comprendere la
reale natura della violenza rwandese e le implicazioni che esistono dietro di
essa, anche se, talvolta, nel corso degli articoli inserisce qualche commento
del giornalista, che mette in evidenza questo o quell’aspetto della crisi. Ma
247
Chiara Calabri
il nodo della strumentalizzazione politica delle identità etniche non emerge
se non in maniera frammentaria e deduttiva e si continua a usare, lungo
tutto l’arco della crisi, lo stesso linguaggio razzista.
Le implicazioni geopolitiche e il ruolo delle grandi potenze e della comunità
internazionale
Solamente in un momento successivo all’esplosione della crisi emerge,
in maniera diversa per ogni testata, il riconoscimento delle implicazioni
delle grandi potenze nello scoppio del genocidio, il loro ruolo ora
indifferente, ora attivo nel sostenere la violenza, il coinvolgimento di interessi
geostrategici nel conflitto rwandese.
Un articolo di Meo Elia apparso il 4 giugno su «Avvenire», tenta di
mettere in chiaro gli «equivoci» sul Rwanda, collocando la crisi in un contesto
di guerra già in atto in cui un certo ruolo sarebbe stato giocato da Stati
Uniti, Belgio, Gran Bretagna e Banca Mondiale. Si legge nell’articolo: «Chi
conosce il Rwanda sa che a partire dal primo ottobre 1990 c’è stata una
vera e propria invasione del paese dall’Uganda: un esercito armato di esuli
(per la maggior parte tutsi che avevano lasciato il paese alla fine degli anni
cinquanta e membri del Fronte patriottico rwandese) ha invaso il nord-est
del paese dall’Uganda. Va notato che i dirigenti del Fpr erano ufficiali
dell’Esercito di resistenza nazionale dell’Uganda (Nra) […]. Dall’ottobre
1990 il Fpr ha continuato la sua azione terroristica e destabilizzatrice,
mietendo vittime fra la popolazione civile. Da più parti veniva denunciata
una situazione divenuta ormai insostenibile […]. In tutto questo periodo,
mentre la stampa occidentale taceva, le cose non avvenivano senza la
complicità dell’Occidente: il Belgio non ha mai nascosto le sue simpatie
verso la parte tutsi e ha fatto notevoli pressioni presso il governo legittimo
del Ruanda, scaricando tutte le colpe dei disagi della popolazione e della
lentezza delle trattative sul presidente Habyarimana per costringerlo a fare
concessioni all’altra parte. Gli Usa sono coinvolti nell’addestramento di
numerosi ufficiali del Fpr, mascherati come soldati ugandesi: lo stesso Paul
Kagame, comandante del Fpr, è stato addestrato e diplomato sotto il
programma Imet a Leavenworth in Kansas […]. I finanziamenti al Fpr,
mascherati come prestiti all’Uganda, venivano forniti da varie democrazie
occidentali, in particolare Usa, Gran Bretagna e dalla Banca Mondiale. Come
248
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
si vede l’Occidente non è privo di colpe, meno palesi ma non meno ciniche
di quelle dei disperati rwandesi»35.
Qualche giorno più tardi appaiono poi articoli che mettono in evidenza
anche il ruolo ricoperto dalla Francia fin dall’inizio degli anni novanta in
questa zona, ed in particolare il legame fra l’élite politica francese e quella
rwandese: «Nel Rwanda sono coinvolti i francesi, soprattutto per ragioni
politiche. Ragioni poco chiare. Si sa che il presidente Mitterand, amico
personale del presidente Juvenal Habyarimana (morto nell’attentato al suo
aereo il 6 aprile scorso), ha appoggiato sottobanco il regime hutu fornendo
armi e anche un appoggio militare diretto - fino a 700 specialisti francesi
impegnati nei combattimenti - contro i ribelli tutsi […]. Nell’Africa francofona
i francesi hanno ancora le mani in pasta con le classi dirigenti»36. La politica
africana costituisce un ambito della politica estera controllato direttamente
dal presidente: la Cellule Africaine è parte dell’ufficio presidenziale stesso e
gode di una particolare indipendenza nello stabilire le sue linee di azione. Al
tempo della presidenza Mitterand, e dell’invasione del Rwanda da parte del
Rpf, responsabile della Cellule Africaine era il figlio del presidente francese,
Jean-Christophe, amico intimo del figlio del presidente rwandese
Habyarimana. La politica africana francese fu caratterizzata, durante gli anni
della presidenza Mitterand, da un alto grado di personalizzazione delle relazioni
con in vari capi africani, come mette ben in evidenza P. Marchesin nel suo
articolo apparso nel numero 58 di «Politique africaine» del giugno 1995, dal
significativo titolo Mitterand l’Africain.
Per bocca di don Isaia Bellomi, padre bianco intervistato a Roma,
«Avvenire» afferma che «questa guerra non è solo frutto dell’odio tribale
come vogliono farci credere ma di un conflitto di poteri alimentato
dall’Occidente, dal Belgio, dagli Stati Uniti e dalla Francia». Si ricava che
dietro le quinte della contrapposizione etnica c’è uno scontro fra potenze
che sostengono le due parti, in nome di interessi economici nell’area e in
nome della difesa di aree d’influenza politica e culturale. Scrive infatti
Rodolfo Casadei sempre su «Avvenire»: «Oggi come ieri la Francia sta
applicando alla lettera il dogma della difesa della francofonia, in nome del
quale l’Esagono si ritiene obbligato a intervenire ogni qual volta una regione
del mondo dove si parla la lingua francese rischia di essere fagocitata da
entità linguisticamente e culturalmente diverse […]. Poiché aveva e ha le
sue basi in Uganda ed effettivamente rappresenta una costola del Nra
(l’esercito di Museveni), fin dall’inizio il Fpr è stato presentato come un
“partito anglofilo”, una testa di ponte dell’espansionismo anglofono
249
Chiara Calabri
nell’Africa francofona […]. Oggi, in Africa, Parigi ragiona in base agli stessi
criteri della geopolitica di cent’anni fa»37. La politica francese in Africa è
sempre rimasta su toni simili a quelli coloniali: la Francia non sarebbe stata
se stessa agli occhi del mondo se avesse rinunciato all’Africa.
Anche «Il manifesto» mostra di dar credito al coinvolgimento francese
in Rwanda, facendo riferimento al rapporto Arming Rwanda di Frank Smyth,
che documenta «i rapporti assai stretti dell’ex presidente assassinato Juvenal
Habyarimana e del suo clan, l’Akazu, con la Francia. Già nel 1975, due
anni dopo aver preso il potere, Habyarimana firmò un accordo militare
con Parigi, e quando nel 1990 i ribelli del Fronte patriottico sferrarono
un’offensiva dall’Uganda, la Francia inviò truppe e artiglieria a sostegno del
governo […]. Un contratto per 6 milioni di dollari firmato a Kigali nel
1992 per l’acquisto di armi egiziane, ebbe la garanzia del Crédit Lyonnais»38.
Come «Avvenire», anche «Il manifesto» dà credito all’ipotesi della difesa
della francofonia contro l’avanzata dell’anglofonia. Il 20 maggio è pubblicata
un’intervista allo storico francese Yves Benot, che conclude che «la difesa
della francofonia di fronte all’influenza ugandese è stata il pretesto per
assicurare la presenza francese, quando nel 1990 il regime di Kigali stava
per crollare per l’azione del Fpr» e che i francesi non agiscono in base a una
razionalità riconoscibile, ma in base alla logica di «essere presenti dove
possono al di fuori dei paesi dell’ex impero»39. Anche il ruolo degli Stati
Uniti nel sostenere una delle due parti è messo in evidenza: «La divisione
[fra le due etnie] non è terminata con la fine del colonialismo […], su
questa divisione hanno impostato il loro gioco anche le potenze che hanno
tentato di sostituirsi all’influenza del Belgio nel paese e nella regione.
Innanzitutto la Francia che ha sempre mantenuto ottime relazioni con
Habyarimana (fino al suo recente assassinio) nella sua lotta contro la
“minaccia anglofona” rappresentata dall’Uganda di Museveni, appoggiata,
non a caso, dagli Usa»40.
«Avvenire» e «Il manifesto» riconoscono e mettono in evidenza, dunque,
il coinvolgimento di alcune grandi potenze nell’ipostatizzare e sfruttare le
identità contrastanti, attraverso un impegno nell’area che per certi versi ha
il sapore del vecchio colonialismo. Entrambe le testate non mancano, inoltre,
di pubblicare analisi di tipo economico, che permettono di conoscere la
debolezza dell’economia rwandese, basata sul settore primario e su colture
d’esportazione, eredità dell’epoca coloniale41, e il lascito pesante, per società
fragili come quella rwandese, dei Programmi di aggiustamento strutturale
promossi dal Fondo monetario internazionale all’ inizio degli anni novanta42.
250
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
«Avvenire» dedica anche un approfondimento sul commercio internazionale
delle armi, affermando che «i massacri che si stanno consumando in Ruanda,
a cui il mondo assiste con angoscia, sono dovuti non solo a ragioni etniche
o a retaggi coloniali, ma anche alle speculazioni dei “mercanti di morte”, i
venditori d’armi»43. Non si denuncia, quindi, solo la violenza, ma anche le
sue cause, rintracciate non solamente nell’ambito di una lotta selvaggia fra
tribù in gara per l’accesso al potere, ma anche in un sistema di rapporti
internazionali in cui le grandi potenze si impegnano a consolidare ed
estendere le rispettive sfere d’influenza.
Il quadro offerto dagli altri due quotidiani considerati non è altrettanto
chiaro.
«Il Messaggero» soltanto una volta fa riferimento al coinvolgimento di
interessi internazionali nella guerra in Rwanda, e lo fa in un’intervista al
nipote dell’arcivescovo di Kigali rimasto ucciso durante l’attacco sferrato
dai guerriglieri tutsi, a inizio giugno, contro le massime cariche della Chiesa
rwandese. Il giovane rwandese, studente in Italia, afferma di fronte al
giornalista: «L’invasione del Ruanda è partita dall’Uganda, la cui popolazione
meridionale è affine ai tutsi rwandesi. Il presidente Museveni è figlio di una
tutsi - continua Nsabimana - e il capo del Fronte patriottico, Paul Kagame,
era direttore dei servizi segreti ugandesi. Ma dietro ci sono interessi
americani, inglesi, belgi e francesi. Molti militari del Fronte sono stati
addestrati in California. Il vero obiettivo è il controllo dello Zaire orientale44,
ricchissimo di petrolio, oro e diamanti, che si può ottenere attraverso il
mio paese». E aggiunge «ma il presidente Habyalimana […] si era sempre
rifiutato di accettare una qualche sorta di protettorato straniero»45.
Certamente non mancano anche ne «Il Messaggero» analisi meno faziose,
in cui si riconosce anche il peso del presidente hutu Habyarimana e dei
suoi alleati francesi nello scatenamento della violenza. In particolare analisi
di questo tipo si collocano alla vigilia dell’Opération Tourquoise. Il 18 giugno
si riportano le conclusioni che il giornale belga «Le Soir» avrebbe raggiunto
a proposito del coinvolgimento francese in Rwanda. «Il Messaggero» parla
del coinvolgimento del Dami (Distaccamento di assistenza militare per
l’addestramento) francese a sostegno dell’esercito governativo e dei rapporti
di collaborazione col governo hutu46.
Anche il «Corriere della Sera» riconosce il ruolo svolto dalla Francia nel
sostenere Habyarimana e gli organizzatori del genocidio. Secondo il
«Corriere», infatti, «la responsabilità morale più grave è della Francia. Questo
genocidio è stato preparato a lungo dagli estremisti hutu con l’aiuto del
251
Chiara Calabri
governo di Parigi, che sta attuando in Africa centrale una sporca politica di
penetrazione. Ci sono di mezzo enormi interessi politici ed economici: il
controllo delle grandi risorse minerarie dello Zaire orientale, per esempio,
un territorio che si controlla proprio dai confinanti Ruanda e Burundi»47 e
l’Operazione Turchese, promossa dalla Francia a metà giugno dietro il
mandato dell’Onu, fa sospettare «che Parigi spinga per un intervento non
solo a fini umanitari. Il governo francese che molti accusano di aver
appoggiato le truppe presidenziali, avrebbe urgenza di intervenire per
consolidare la propria influenza sulla regione e per soccorrere i propri
consiglieri militari che già si troverebbero sul territorio rwandese a fianco
degli hutu»48; per il «Corriere» le «intenzioni solamente umanitarie della
Francia suscitano non poche perplessità. C’è chi dice che il governo francese
sia prigioniero di due stati d’animo contrapposti: la “sindrome Kouchner”
e la “sindrome Fachoda”. La prima prende il nome da Bernard Kouchner,
l’ex ministro socialista che ha teorizzato l’obbligo dell’intervento umanitario
da parte della comunità internazionale per salvare le popolazioni in pericolo.
La seconda, invece, risale all’epoca coloniale quando l’Africa era infiammata
anche dalla rivalità franco-britannica. Ecco “la sindrome Fachoda”
indurrebbe la Francia a intervenire in Rwanda per impedire che nella regione
si formi una federazione di stati la cui leadership avrebbe il suo punto di
riferimento nell’Uganda, una federazione che vivrebbe sotto l’influenza
britannica»49.
«Il Messaggero» riporta i dubbi suscitati dalla missione francese presso i
rappresentanti del Fpr50. «Il manifesto» si sofferma a mettere in evidenza le
possibili motivazioni dell’intervento francese in Rwanda: da una parte la
spinta dell’opinione pubblica, di fronte ai massacri rwandesi, per un
intervento umanitario immediato, dall’altra l’esigenza di riscattarsi da un
passato di sostegno alla fazione che si è macchiata dell’organizzazione e
dell’esecuzione del genocidio51, possono aver portato la Francia a proporsi,
di fronte anche alla passività e all’incapacità di un intervento delle Nazioni
Unite, come «pacificatrice». Giampaolo Calchi Novati scrive che «un
intervento militare può diventare [per la Francia] una scorciatoia per dare
un po’ di lustro al suo piglio di potenza che non esita se necessario a far
ricorso alla forza» e parla di «ombre di neocolonialismo»52 presenti
nell’intervento francese, mentre un altro africanista, Alessandro Aruffo, in
un’intervista sempre sullo stesso quotidiano, afferma che «questo neointerventismo, comunque camuffato e motivato ideologicamente, sta
portando non solo i francesi a ricompattare i loro tasselli africani, ma alla
252
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
negazione di ogni sviluppo autonomo sia economico sia politico dei paesi
del continente»53. «Avvenire», in un commento di Beppe del Colle, si
domanda quale efficacia possa avere un intervento di pacificazione da parte
di una potenza, come quella francese, che in Rwanda si è dedicata a una
«precisa opera di sostegno al regime responsabile in massima parte dei
massacri odierni», e più avanti specifica che «quello che a tutti i costi
l’Occidente, e in particolare l’Europa, devono evitare è suscitare l’impressione
di voler agire in Africa secondo i metodi di un colonialismo che si vorrebbe
sepolto per sempre»54.
Dalle pagine dei quotidiani italiani, quindi, in maniera piuttosto
omogenea, il ruolo della Francia in Rwanda appare in tutta la sua ambiguità
di ex potenza coloniale che, nel nuovo ordine apertosi all’inizio degli anni
novanta, cerca con tutti i mezzi di ridar lustro al suo prestigio di media
potenza, di riaffermare la sua presenza nell’Africa centrale, in nome della
difesa degli interessi materiali e strategici. D’altronde si comprende bene,
anche, come l’Opération Tourquoise si collochi in un vuoto di iniziative da
parte della comunità internazionale e in un atteggiamento di passività delle
Nazioni Unite55, che viene più volte rilevato.
«Avvenire» giunge a denunciare le storture di un ordine internazionale
in cui, alle diverse crisi non si attribuisce un peso equivalente, e in cui alle
varie aree del mondo non viene data la stessa importanza. Si trova scritto:
«si fa prima a marciare contro l’Iraq che ad avventurarsi nella ex Jugoslavia.
Sembra più grave la costruzione di una bomba atomica in Corea che la
distruzione di un intero popolo in Uganda. Gli equilibri fra le potenze
sembrano più importanti della convivenza fra la gente. Durante tre mesi in
cui sono morte centinaia di migliaia di persone [in Rwanda], l’Onu non è
stata ancora capace di prendere una decisione. Nel Consiglio di sicurezza
Boutros Ghali non riesce a trovare un appoggio nemmeno per una iniziativa
umanitaria. L’amministrazione Clinton non vuole saperne di impegnarsi
in un nuovo intervento in Africa dopo l’esperienza della Somalia. Darà
soltanto eventualmente un “appoggio logistico” […]. In Europa si cerca di
fare qualcosa all’interno dell’Ueo. Ma solo la Francia, appoggiata negli ultimi
giorni anche dal nostro governo, si agita per mettere in campo una qualche
forza di pace. Ma un Mitterand primo della classe in questa impresa lascia
adito a qualche dubbio»56. L’inazione di Usa e Onu è giudicata colpevole
anche dal «Corriere della Sera»: Ennio Caretto in un suo articolo del 16
maggio scrive che «le atrocità e i massacri mobilitano i media, la televisione
soprattutto, che a sua volta mobilita la pubblica opinione. Prendono
253
Chiara Calabri
posizione il Papa e le associazioni umanitarie, il congresso si divide. Ma
Clinton non intende ripetere l’errore della Somalia, dove l’intervento
americano fu dettato dall’esterno - allo sbarco a Mogadiscio i marines
trovarono le televisioni di tutto il mondo sulla spiaggia ad aspettarli - e finì
in un grosso fiasco. Due settimane fa Clinton ha posto criteri molto rigidi
per la partecipazione degli Usa alle operazioni delle Nazioni Unite: che
siano limitate, abbiano obiettivi chiari, siano bene organizzate, e non
presumano di risolvere i problemi politici interni del paese. La sua politica
estera è cambiata […] Clinton non vuole diventare il gendarme nel nuovo
ordine mondiale. Il Ruanda è il suo nuovo punto di partenza […]». «C’è
un limite a ciò che l’America può fare - ha detto il presidente - e al prezzo
che è disposta a pagare»57.
Anche «Il Messaggero», infine, denuncia la mancanza di volontà delle
Nazioni Unite di intervenire in tempo in Ruanda: Paolo Bonaiuti scrive
che «l’unica dimostrazione di efficienza sotto la bandiera dell’Onu venne
fornita qualche anno fa, contro Saddam Hussein. Ma allora era in gioco
l’energia dell’Occidente. Non le vite di bambini, di uomini e donne disperati,
di qualche religioso»58.
La distribuzione degli articoli
Dal confronto fra le varie letture ed interpretazioni che si ricavano
dall’analisi delle testate prese in considerazione, a proposito della crisi e del
genocidio rwandesi, si osservano diversità nella qualità delle notizie e nei
tentativi di approfondimento che fanno risaltare una differenza di interesse
a ciò che accadeva in quei giorni in Rwanda e, in maniera allargata, ai
problemi dell’Africa, fra le testate in questione. La diversità non è, però,
solo qualitativa ma anche quantitativa, relativa allo spazio dedicato alle
notizie rwandesi nei vari giornali.
Dopo aver confrontato la distribuzione degli articoli nei vari quotidiani,
quello che colpisce di più è proprio il diverso numero di articoli in cui,
per ogni quotidiano, si parla del Rwanda. Se il fatto che «Il Messaggero»
non presenti più di centotrenta articoli nel periodo che va dal 7 aprile
1994 al 31 luglio 1994, non è troppo stupefacente, pensando che si tratta
di un quotidiano con caratteristiche più regionali che nazionali, «Il
manifesto» presenta centocinquantacinque articoli nello stesso periodo, e
il «Corriere della Sera» centoquarantaquattro. Questi ultimi due dati
254
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
sembrano degni di nota: il più grande quotidiano nazionale, non solo per
diffusione ma anche per tradizione, considerato la «voce» della borghesia
emergente industriale e finanziaria italiana, con un formato di una media
di quarantadue, quarantaquattro pagine a edizione, dà alla crisi rwandese
uno spazio ridotto, addirittura, nel periodo che copre i momenti più
cruciali della guerra in Rwanda, inferiore a «Il manifesto», quotidiano
minore, rappresentante di una parte della popolazione italiana meno
«emergente», e con un formato che non supera la media delle venti,
venticinque pagine. Tuttavia «Il Messaggero», il «Corriere della Sera», «Il
manifesto» sono sullo stesso ordine di numero d’articoli ciascuno.
«Avvenire», invece, si distanzia notevolmente dalle quote delle altre tre
testate, con un numero di articoli che è esattamente doppio rispetto a quello
del «Corriere della Sera». Con i suoi duecentottantasette articoli, «Avvenire»,
anche dal punto di vista quantitativo, si differenzia rispetto agli altri. Un
così ampio spazio, concesso alla guerra in Rwanda, costituisce l’ambito in
cui ricavare interpretazioni più critiche e approfondite, grazie anche al
contributo dei missionari che sono, in particolare nei momenti di crisi più
profonda, gli unici testimoni presenti sul terreno, fonte di prima mano per
testimoniare l’incubo di ciò che hanno visto e vissuto più dal di dentro
rispetto agli inviati speciali o ai corrispondenti. D’altronde gli inviati speciali
professionisti non sono molti e soprattutto sono giornalisti del «Corriere
della Sera» e di «Avvenire», mentre «Il manifesto» e «Il Messaggero» mancano
di tali figure.
I reportage del «Corriere» sono firmati da Riccardo Orizio e da Ettore
Mo. Quest’ultimo è un inviato speciale che si è concentrato sull’area del
Medio Oriente e dell’Afghanistan piuttosto che sull’Africa, mentre Riccardo
Orizio si può definire «lo specialista dell’Africa». Il fatto che un solo
giornalista possa essere definito in questo modo, ci sembra sveli un altro
limite del giornalismo italiano, cioè la mancanza di corrispondenti esteri
che «coprano» zone extraeuropee, con una presenza stabile, che, sola,
permette di conoscere e comprendere meglio la realtà dei vari paesi. Se
quasi in ogni capitale europea si ha un corrispondente, per l’Africa ci si
accontenta di uno o due inviati speciali che, inevitabilmente, non possono
avere una conoscenza completa di ogni situazione.
«Avvenire» pubblica numerosi reportage del suo inviato speciale Claudio
Monici: egli si reca sui luoghi delle grandi tragedie e dei grandi massacri e
ne dà testimonianza grazie al supporto prezioso dei missionari che lavorano
in loco e che talvolta lo accompagnano o si fanno intervistare.
255
Chiara Calabri
Un altro elemento che svela l’importanza che viene data alle notizie sul
Rwanda è il numero delle volte in cui questo paese viene citato in prima
pagina. Per «Il Messaggero» il Rwanda costituisce argomento da prima pagina
soltanto in dieci occasioni; per «Il manifesto» in dodici; per il «Corriere
della Sera» in tredici e per «Avvenire» in quarantatre. Anche questo è segno
della priorità che viene data alle notizie e della scelta di dare precedenza e
evidenza a certe notizie piuttosto che ad altre.
La guerra rwandese si svolge nello stesso periodo di quella fase della
guerra in Bosnia che vedeva scesi in campo gli americani: alla crisi balcanica
sono dedicati molti articoli, soprattutto dal «Corriere della Sera». La guerra
bosniaca evidentemente era sentita come più vicina all’Italia e all’Europa,
non solo geograficamente. Fu percepita e riportata come una crisi che più
da vicino toccava anche gli interessi dell’Europa occidentale, in un momento
storico in cui i rapporti fra Europa e America apparivano in via di
ridefinizione. Tuttavia, anche se in alcuni quotidiani alla crisi nella ex
Jugoslavia viene dato più spazio che a quella in Rwanda, in generale il
limite di fondo dei quotidiani considerati è il numero delle pagine dedicate
agli esteri. Normalmente, in giorni in cui non sia accaduto qualcosa di
eclatante nelle zone su cui già è concentrata l’attenzione della stampa e
dell’opinione pubblica, come il Medio Oriente, le pagine degli esteri non
sono più di due, e talvolta possono ridursi anche a una59. Questo fatto
suggerisce la scarsa importanza che viene data alla politica estera in Italia, e
la tendenza a concentrarsi, da parte della classe politica, su questioni di
carattere soprattutto interno, talvolta anche non realmente significative,
intorno a cui, però, le discussioni e il dibattito politico si concentrano,
spesso anche in termini di scontro fra le opposizioni.
Elemento sconfortante è poi il fatto che, in particolare via via che la
stagione evolve verso il periodo delle vacanze, ci si rivolga al «gossip
internazionale»: abbondano le notizie sulla vicenda di O. J. Simpson, il
campione sportivo accusato di violenza sessuale, sulle vacanze di Clinton,
sulle pettinature della moglie del presidente americano Hillary60 e
sull’onnipresente monarchia inglese.
Lungo il periodo dal 7 aprile 1994 al 31 luglio l’attenzione rivolta dai
quattro giornali considerati nei confronti del Rwanda ha delle variazioni di
livelli che riproducono un andamento ondivago: se per un periodo di due,
tre giorni l’attenzione si mantiene elevata, raggiungendo una quota di più
di dieci articoli, poi per un lasso di tempo di otto, dieci giorni difficilmente
raggiungono gli stessi livelli.
256
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
In un grafico61, si potrà avere una rappresentazione, a grandi linee
simmetrica, della distribuzione degli articoli di tutte le testate, lungo l’arco
di tempo considerato. Dove si concentra l’attenzione, «Avvenire», in più di
un caso, presenta un numero di articoli superiore al doppio rispetto alle
altre testate ed anche nei periodi di minor attenzione, la quota degli articoli
di «Avvenire» è spesso quella più importante.
Scendendo poi nel particolare dell’analisi degli articoli pubblicati nei
giorni in cui si possono individuare nel grafico dei «picchi di attenzione», si
può capire quali siano i motivi che «trascinano» i quotidiani italiani a
interessarsi del Rwanda: ci si accorge che non vi è quasi mai un interesse
«puro» agli avvenimenti rwandesi, semplicemente mosso dalla volontà di
capire ciò che stava accadendo in quel paese, ma il Rwanda si guadagna
uno spazio maggiore sulle pagine dei giornali considerati, solo nei casi in
cui siano coinvolti nelle vicende rwandesi personaggi italiani o il governo
italiano stesso, oppure altre potenze occidentali, come la Francia e gli Usa,
o se gli eventi hanno caratteristiche di macabra e sensazionale spettacolarità.
All’inizio della crisi la copertura degli eventi rwandesi è assicurata da
tutte le testate. Sono i giorni, infatti, in cui, dopo aver riportato la notizia
dell’attentato all’aereo presidenziale e l’inizio dei massacri, l’attenzione della
stampa si rivolge all’evacuazione degli stranieri dal paese. I titoli che si
ritrovano in questi giorni nel «Corriere della Sera» e ne «Il Messaggero», e
che si meritano le prime pagine, parlano di «ponte aereo» organizzato dalle
varie nazioni europee per portare in salvo i connazionali residenti nel paese
africano. «Il Messaggero» titola nella prima pagina del 10 aprile: Fuga dal
Rwanda in fiamme. Migliaia di morti nella faida etnica fra Hutu e Tutsi.
L’Occidente invia truppe. Tre Hercules da Pisa per salvare gli italiani, e così
anche il «Corriere della Sera» fa riferimento alla partenza degli Hercules
per portare in salvo gli italiani. Nei giorni che seguono l’iniziale esplosione
di violenza e che coincidono con le operazioni di evacuazione degli europei,
l’attenzione del «Corriere della Sera» e de «Il Messaggero» rimane costante
e non mancano reportage che riportano i «primi racconti di morte»62. Così
durante i primi giorni dei massacri il Rwanda trova spazio, nei due
quotidiani, soltanto in quanto da quel paese fuggono connazionali e
occidentali per i quali sono organizzati ponti aerei e missioni di salvataggio.
In seguito, per alcuni giorni, le notizie sul Rwanda sono riportate in
brevi articoli o trafiletti attraverso cui il lettore è informato, in poche ed
essenziali righe, del continuo ripetersi di stragi. L’attenzione si «riaccende»,
in parte, intorno al 28 e al 29 aprile quando giunge la notizia che sono
257
Chiara Calabri
numero degli articoli
258
0
5
10
15
20
25
30
Avvenire
Corriere della Sera
Il Manifest o
Il Messaggero
La crisi rwandese nella stampa italiana
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
arrivati in Italia quarantasei orfani insieme alla volontaria laica vicentina
Amelia Barbieri, grazie a una missione di salvataggio organizzata da Maria
Pia Fanfani. I toni eroici attraverso cui la signora Fanfani racconta la vicenda
della cosiddetta «operazione Rwanda» riempiono ben mezza pagina del
«Corriere della Sera» e de «Il Messaggero».
Una rinnovata attenzione alla crisi rwandese si trova nel periodo che va
dal 23 maggio al 27. In quei giorni si svolse, infatti, la visita del ministro
degli Esteri italiano Antonio Martino alla Casa Bianca, con l’obiettivo di
rilanciare la posizione italiana sul piano della politica estera. Titola, in prima
pagina, il «Corriere della Sera» del 24 maggio: Martino: l’Italia deve contare.
Il titolare degli Esteri presenta agli Stati Uniti la nuova politica «interventista».
Un seggio permanente all’Onu, nel comando in Bosnia, «caschi blu» in
Ruanda63. Mentre da Washington arrivano le dichiarazioni del ministro
Martino sul nuovo corso della politica estera italiana, da Bruxelles giunge
la notizia che il ministro della Difesa, Previti, «ha dichiarato la disponibilità
dell’Italia a partecipare a qualsiasi iniziativa internazionale di tipo umanitario
in Ruanda, anche con l’invio di nostri Caschi blu»64. Nei giorni successivi
lo spazio lasciato alle notizie dal Rwanda è più ampio, ma, soprattutto, il
numero maggiore di articoli è dedicato alla diatriba che scoppia sulle
affermazioni del ministro della Difesa a proposito della disponibilità italiana
a intervenire a fianco dell’Onu in Rwanda. Il 26 maggio «Il Messaggero»
consacra molto spazio proprio al botta e risposta fra Ghali e Previti: i titoli
riportano che Ghali è polemico sulle esternazioni di Previti e chiede fatti
all’Italia, mentre, da parte sua, il ministro della Difesa italiano precisa di
non aver «mai parlato dell’invio dei parà»65. La questione dell’eventuale
partecipazione dei militari italiani alla missione Onu in Rwanda si prolunga
per alcuni giorni, fino alla vigilia del 10 giugno. In questa data si concentra
il numero maggiore di articoli. Infatti giunge la notizia dell’uccisione di tre
vescovi rwandesi da parte dei guerriglieri tutsi del Fpr. Il tragico evento
costituisce l’occasione per «Avvenire» di dare spazio anche ad analisi e
approfondimento sugli eventi rwandesi, mentre le altre testate, accanto alla
cronaca dell’omicidio dei vescovi, riportano le esternazioni dell’allora primo
ministro Berlusconi e del ministro degli Esteri Martino a proposito di
un’eventuale partecipazione italiana alla missione Onu in Rwanda.
Solo «Avvenire», pur non mancando di dare le notizie sulle missioni di
intervento umanitario dell’Italia e sulla questione dell’invio delle truppe
italiane, non fa di tali argomenti il fulcro della sua attenzione, che rimane
elevata anche a prescindere dalle dichiarazioni dei rappresentanti del governo
259
Chiara Calabri
attraverso reportage, interviste a missionari e analisi delle cause della guerra
e del genocidio rwandese.
Ci sembra che tutto ciò riveli una diversità nel modo di guardare, da
parte delle varie testate, alla crisi rwandese: se «Avvenire» e, anche se in
maniera meno esaustiva, «Il manifesto» riportano notizie a tutto campo sul
Rwanda, l’attenzione del «Corriere della Sera» e de «Il Messaggero» è filtrata
attraverso il binomio «Italia-Rwanda», elemento che rivela il provincialismo
di fondo della stampa italiana, specchio di una politica internazionale del
governo italiano pressoché inesistente e, in particolare, di un interesse per
certe zone del mondo, come l’Africa centrale, che non va al di là
dell’opportunismo e dell’occasionalità66.
Un altro momento in cui si concentrano gli articoli si situa intorno al
20 giugno, quando si prospetta l’intervento francese nel quadro
dell’Opération Tourquoise. Per tutte le testate analizzate, in quei giorni la
questione dell’intervento francese è prioritaria. Le nuove dichiarazioni del
presidente del Consiglio su una possibile scesa in campo dell’Italia a fianco
della Francia, attirano e coagulano nuovamente l’attenzione. I titoli parlano
dell’invio dei parà italiani a fianco dei soldati francesi, fin dalla prima pagina.
Ma su «Avvenire» e su «Il manifesto», accanto a queste notizie, pur presentate
come principali, si continuano a trovare articoli di contestualizzazione e di
analisi del ruolo francese e delle motivazioni che hanno mosso la Francia a
dichiararsi pronta ad intervenire in Rwanda e a farsi affidare la missione
dall’Onu; ne «Il Messaggero« e nel «Corriere della Sera» l’attenzione si
concentra, invece, sul possibile coinvolgimento italiano: via, via che tale
prospettiva si allontana l’interesse per il Rwanda e per l’Operation Tourquoise
scema e gli articoli sul Rwanda si fanno meno numerosi e meno ampi.
Dopo un’altra impennata nel livello d’attenzione corrispondente alle
notizie sull’avanzata dei ribelli tutsi verso Kigali e su tutto il paese, l’ultima
concentrazione si ha alla fine di luglio, dal 20 al 30. In queste date la
concentrazione degli articoli ha una nuova impennata: sono i giorni in cui
arrivano le immagini e le notizie delle masse dei profughi che si sono riversate
ai confini del paese dopo l’avanzata del Fpr. L’alto rischio di esplosione di
epidemie, i primi morti di colera e le pessime condizioni di vita nei campi
profughi attirano l’attenzione dei quotidiani. La situazione nei campi
profughi è descritta con toni drammatici: i campi sono definiti da «Il
manifesto», «i quattro campi dell’apocalisse»67, il cui aspetto è assimilabile
a quello di una «bolgia dantesca» in cui le persone sembrano «zombie senza
volontà»68, «corpi sfiniti dalla fatica che neppure la terra vuole accogliere,
260
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
terra dura, vulcanica che impedisce di seppellire i morti»69, «un inferno di
morte, fame, desolazione», «una tragedia biblica»70. I reportage sui campi
profughi si susseguono per alcuni giorni. L’impatto delle immagini che
provenivano dai campi profughi e che furono riversate sui teleschermi di
tutto il mondo fu tale che anche la presidenza americana si trovò in qualche
modo costretta e spinta dall’opinione pubblica ad intervenire in Rwanda. I
giornali italiani riportano la notizia dell’organizzazione di un gigantesco
ponte aereo umanitario statunitense che doveva paracadutare viveri sui campi
profughi. L’interessamento americano alla tragedia rwandese, insieme alle
terribili immagini e racconti provenienti dai campi al confine col Rwanda,
fungono da elementi catalizzatori dell’attenzione dei quotidiani italiani.
Già alla fine di maggio, come abbiamo visto, si era avuto un picco
nell’attenzione alla crisi rwandese: in quel caso l’innalzamento del livello
era stato legato agli interventi dei ministri della Difesa e degli Esteri che
avevano fatto intendere, anche se in maniera ambigua, la disponibilità
italiana a partecipare alla missione Onu. Contemporaneamente, però, si
erano presentate agli occhi del lettore italiano foto che riproducevano corpi
maciullati gettati nel lago Vittoria, che galleggiavano trasportati dalle acque
del fiume Akagera: il Rwanda guadagnava spazio sulle pagine dei giornali
italiani con immagini e racconti raccapriccianti insieme al dibattito politico
sull’intervento italiano. Similmente, alla fine di luglio, l’attenzione è attirata
dagli spettacolari e crudi racconti della vita nei campi profughi e, allo stesso
tempo, dall’intervento americano. Spettacolo e coinvolgimento di un paese
occidentale sembrano fungere da vettori di guida e orientamento per la
maggioranza degli organi di stampa italiani nel narrare la guerra in Rwanda.
«Avvenire» in un articolo del 24 maggio, descrive bene tutto questo: «Più di
un mese e mezzo fa, sei settimane un tempo dentro al quale si è consumata nel
paese delle mille colline una carneficina terribile, più della Jugoslavia, più di ogni
altro disgraziato luogo di guerra e morte. Si cominciò con l’annuncio di 100 mila
morti, poi 200 mila, e ancora 500 mila e poi, ora, forse, un milione di vittime.
Ma vi ricordate anche della bolgia di corpi nudi, martoriati e gonfi che navigavano
sul Kagera, il fiume che sfocia in Tanzania. Anche quelle erano immagini, grida
d’aiuto che venivano dal Ruanda e che abbiamo visto sugli schermi dei nostri
televisori più di un mese fa quando l’Onu decise di ritirare anche il contingente di
caschi blu, lasciandone una manciata inutile […]. Conclusa la “fuga” dei “bianchi”,
si chiuse anche la porta dell’informazione sull’inferno del Ruanda. Ecco che ora la
si rispalanca per sbattere in faccia alla gente distratta […] l’“allarme internazionale
per i 40 mila cadaveri che galleggiano sul lago Vittoria”. Vogliamo solo ricordare
261
Chiara Calabri
che questi uomini donne e bambini, dalla pelle saponificata e ossa con brandelli
di carne, che ora le tv fanno vedere sono gli stessi cadaveri che scendevano dal
Kagera un mese fa […]. Quelli che non si vedono sono già ossa in fosse comuni.
Un mese e mezzo è trascorso. Dove eravamo prima? Perché solo oggi abbiamo
riaperto la finestra sull’inferno?»71.
«Quello che isola definitivamente questi morti non è solo l’attesa di una
giustizia nella memoria storica di quelle terre, ma anche un’attesa della
pace allontanata dall’ignoranza, dalle omissioni e da banali analisi degli
avvenimenti»72.
In troppe occasioni l’informazione italiana si è macchiata, di fronte alla
tragedia del Rwanda, di miopia, di omissioni, di analisi banali, di disinteresse
provinciale. Tutto ciò non è privo di conseguenze se è vero, come lo è nel
nostro mondo, che «senza telecamere non esistono disgrazie»73. Un’informazione
deficiente contribuisce alla paralisi della politica internazionale. In Italia, il
rapporto fra informazione estera e politica internazionale somiglia a un cane
che si morde la coda: una politica estera di per se stessa velleitaria e
inconsistente non stimola la ricerca di una conoscenza e di una comprensione
più complete del mondo, e si autocondanna a rimanere relegata sempre
sugli stessi scenari, in una posizione tendenzialmente impotente. I canali
della cultura dominante stessa, dall’editoria, all’informazione, dal mondo
accademico a quello politico non sfociano su orizzonti più larghi e che
oltrepassino il «particulare» delle questioni interne, o delle «solite questioni».
Riuscire a ragionare attorno alle crisi che cronicamente avvolgono l’Africa
dei Grandi Laghi e il Sud del mondo, nella nostra epoca significa sapere
comprendere il contesto mondiale: si tratta di una sfida che anche l’Italia è
chiamata ad affrontare, per un rinnovamento della sua cultura, per poter
agire, con le giuste cognizioni di causa, nell’ambito della politica
internazionale.
Note al testo
1
Il dibattito sulle responsabilità dell’attentato fu molto acceso. Per una dettagliata ricostruzione
delle varie ipotesi e posizioni cfr. G. PRUNIER, The Rwanda crisis, 1959-1994. History of a
genocide, Hurst & Company, London 1995.
2
Nell’ottobre 1993 era stato ucciso, in Burundi, il primo presidente eletto democraticamente.
3
L’attentato durante l’atterraggio. Abbattuto l’aereo. Uccisi i presidenti di Rwanda e Burundi,
262
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
in «Corriere della Sera», 7 aprile 1994, p. 10. In questi primi articoli si accetta, come dato di
fatto, la classificazione della popolazione rwandese in due gruppi etnici senza porsi la domanda
di quale origine avesse tale divisione. I colonizzatori occidentali, in tutto il continente africano,
fra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, quando si affermò un nuovo tipo
di colonizzazione, non più solo commerciale, ma anche politica, contribuirono, imponendo
le loro forme amministrative e organizzative, a creare identità contrapposte in seno a
popolazioni che allora vivevano in un rapporto di equilibrio interno che fu sconvolto dalla
dominazione europea. Per uno sguardo generale sui meccanismi di contrapposizione
identitaria che gli europei contribuirono a innescare con le loro forme di organizzazione
amministrativa e fiscale, cfr. A. M. GENTILI, Il leone e il cacciatore. Storia dell’Africa sub
sahariana, Carocci, Roma 1995. Per quanto riguarda invece il caso particolare del Rwanda,
i presupposti culturali e politici della classificazione della popolazione rwandese in due gruppi
etnicamente diversi, cfr. G. MORIANI, Il secolo dell’odio, conflitti razziali e di classe nel Novecento,
Marsilio, Venezia 1999 (in cui un capitolo è dedicato al genocidio rwandese e alla sua genesi);
R.SANDERS, The Hamitic hypotesis: its origin and functions in time perspective, in «The journal
of african history», 1969, vol. X, pag. 521-532; C. G. SELIGMAN, Les races de l’Afrique,
Payot, Paris 1935; G. PRUNIER, The Rwanda crisis cit.: di questo testo sono interessanti e
utili per comprendere i brani, riportati a p. 6, del Rapport sur l’administration belge du RuandaUrundi (1925) del Ministero delle Colonie belga.
4
L’aereo con i presidenti di Ruanda e Burundi precipita in fiamme, forse è stato abbattuto, in «Il
Messaggero», 7 aprile 1994, p. 11.
5
Ruanda, caos e sangue, in «Il Messaggero», 8 aprile 1994, p. 12.
6
Ruanda, l’ora della vendetta, in «Corriere della Sera», 8 aprile 1994, p. 9.
7
Ivi. Corsivo mio.
8
Ivi.
9
Ivi.
10
Le caratteristiche fisiche furono catalogate, dai colonizzatori, con estrema precisione e connesse
a differenti qualità morali: «the Bahutu display very typical bantu features. [...] They are generally
short and thick-set with a big head, a jovial expression, a wide nose and enormous lips. They
are extroverts who like to laugh and lead a simple life», mentre i tutsi erano definiti come una
razza che non aveva niente a che vedere con quella «negra», eccetto il colore (!): «he [l’uomo
tutsi] is usually very tall, 1.80 m. at least, often 1.90 m. or more. He is very thin [...]. His
feature are fine: a high brow, thin nose and fine lips framing beautiful shining teeth. Batutsi
women are usually lighter-skinned than their husbands, very slender and pretty in their youth,
although they tend to thicken with age. [...] Gifted with a vivacious intelligence, the Tutsi
displays a refinement of feelings wich is rare among primitive people. He is a natural-born
leader, capable of extreme self-control and of calculated goodwill». Cfr. Ministère des Colonies,
Rapport sur l’administration belge du Ruanda- Urundi (1925), pp. 26 e 34, citato in G. PRUNIER,
The Rwanda crisis, cit, p.6.
263
Chiara Calabri
11
L’attentato durante l’atterraggio. Abbattuto l’aereo. Uccisi i presidenti di Rwanda e Burundi, in
«Corriere della Sera», 7 aprile 1994, p. 10.
12
L’aereo con i presidenti di Ruanda e Burundi precipita in fiamme, forse è stato abbattuto, in «Il
Messaggero», 8 aprile 1994, p. 12.
13
La scheda, in «Il Messaggero», 8 aprile 1994, p. 12.
14
Due nazioni disastrate, in «Corriere della Sera», 8 aprile 1994, p. 9.
15
Ruanda, lunga guerra, in «Il manifesto», 8 aprile 1994, p. 19.
16
Kigali, ribellione a colpi di machete, in «Avvenire», 8 aprile 1994, p. 15.
17
M. FUSASCHI, Hutu-Tutsi, alle radici del genocidio rwandese, Bollati Boringhieri, Torino
2000, p. 13.
18
Per quanto riguarda la genesi di tali sentimenti di contrapposizione identitaria e
l’interiorizzazione di essa da parte dei due gruppi della popolazione cfr. C. C ARBONE,
Colonialismo e neocolonialismo, la vicenda storica del Rwanda e del Burundi, Aracne editrice,
Palermo 1974, e G. PRUNIER, The Rwanda crisis cit. Da questi due testi si comprende bene
come l’intervento delle riforme amministrative belghe abbiano contribuito, cristallizzando
differenze che fino a quel momento si armonizzavano tra loro nella dinamica della società
rwandese precoloniale, alla nascita del sentimento di appartenenza a due gruppi contrapposti.
In particolare per una comprensione del ruolo giocato dalla Chiesa e dai missionari in questo
processo di creazione di coscienze contrapposte, cfr. I. LINDEN, Christianisme et pouvoirs au
Rwanda 1900-1990, Karthala, Paris 1999. Per una ricostruzione del ruolo giocato dai media
nel creare un clima di insicurezza e paura e poi mobilitare alla violenza cfr. J. P. CHRÉTIEN,
Rwanda. Les médias du génocide, Karthala, Paris 1995; e A. DES FORGES, Leave none to tell the
story. Genocide in Rwanda, Human Rights Watch 1999.
19
Per un’analisi generale della politica estera italiana si potranno vedere il saggio di G. CALCHI
NOVATI, Mediterraneo e questione araba nella politica estera italiana, in Storia dell’Italia
repubblicana. La trasformazione dell’Italia: sviluppi e squilibri, a cura di F. Barbagallo, Einaudi,
Torino 1995, e il testo di C. M. SANTORO, La politica estera di una media potenza. L’Italia
dall’Unità ad oggi, Il Mulino, Bologna 1991.
20
Lo scrittore Amin Maalouf, nel suo saggio intitolato L’identità, proprio parlando della ex
Jugoslavia, dà una chiara spiegazione di come i sentimenti di appartenenza e di
autoriconoscimento in una categoria o in un gruppo possano cambiare a seconda del momento
storico ed anche della manipolazione che di essi viene fatta. Scrive Maalouf: «Non lasciamo
ancora Sarajevo. Restiamoci, con il pensiero, per un’indagine immaginaria. Osserviamo, per
strada, un uomo sulla cinquantina. Verso il 1980, l’uomo avrebbe dichiarato: Sono iugoslavo!,
con fierezza ma senza particolare enfasi; interrogato un po’ più in dettaglio, avrebbe precisato
di abitare nella repubblica federata di Bosnia-Erzegovina e di venire, incidentalmente, da una
famiglia di tradizione musulmana. Lo stesso uomo, incontrato dodici anni dopo, quando la
guerra infuriava, avrebbe risposto spontaneamente e con vigore: Sono musulmano! Forse si
sarebbe persino lasciato crescere la barba regolamentare. Avrebbe subito aggiunto di essere
264
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
bosniaco, e non avrebbe apprezzato gran che di sentirsi ricordare che in passato si dichiarava
con fierezza iugoslavo. Oggi, il nostro uomo, interrogato per strada, si dichiara prima bosniaco,
poi musulmano; si sta recando per l’appunto alla moschea, preciserebbe; ma ci tiene anche a
dire che il suo paese fa parte dell’Europa, e che spera di vederlo aderire un giorno all’Unione
europea»: A. MAALOUF, L’identità, Bompiani, Milano 2002, pp. 18-19.
21
Non a caso la maggioranza dei libri che sono stati pubblicati a proposito del Rwanda dal
1994 a oggi sono di autori che rappresentano quel mondo di intellettuali che si ispirano alla
solidarietà cristiana o all’internazionalismo, ed anche le case editrici che pubblicano tali libri
fanno riferimento allo stesso ambiente. I libri apparsi in questi anni sono i seguenti: R. CAVALIERI,
Balcani d’Africa. Burundi, Rwanda, Zaire: oltre la guerra etnica, Edizioni Gruppo Abele, Torino
1997; R. CASADEI, A. FERRARI, Rwanda, Burundi. Una tragedia infinita, perché?, EMI, Bologna
1994; R. CAVALIERI, F. FERRANTE, Goma. Città dei rifugiati, Edizioni Alfazeta, Parma 1996; R.
CAVALIERI, A. TOSOLINI, Bujumbura. Città dell’odio, Edizioni Alfazeta, Parma 1995; A. FERRARI,
L. SCALETTARI, Storie di ordinario genocidio. La guerra del Kivu, EMI, Bologna 1996; V.
MISURACA, Ruanda. Diario dall’inferno, Gribaudi, Milano 1994; A. TOSOLINI, R. CAVALIERI,
Rwanda un anno dopo, volere la pace, Edizioni Alfazeta, Parma 1995. L’altro libro uscito nel
1997 è La guerra civile in Rwanda, edito da Franco Angeli, il cui autore, sotto lo pseudonimo
in kinyarwanda Umwantisi, è probabilmente una persona vicina agli ambienti del ministero
della Difesa italiano, e il cui scopo è quello di chi si sforza di differenziare la posizione governativa
italiana a proposito della guerra in Rwanda, rispetto a quella francese. Nel 2003 è uscito il
libro Istruzioni per un genocidio. Rwanda: cronache di un massacro evitabile, scritto da Daniele
Scaglione, presidente della sezione italiana di Amnesty International dal 1997 al 2000, ed
edito dalle Edizioni Gruppo Abele, mentre quest’anno sono stati pubblicati: B. B. DIOP, Rwanda.
Murambi, il libro delle ossa, edizioni e/o, Roma 2004; P. COSTA, L. SCALETTARI, La lista del
Console, edizioni Paoline, Milano 2004, I. TREVISANI, Lo sguardo oltre le mille colline, Baldini
Castoldi 2004; M. FERRARIS, G. SEGNERI, N. BERTOLINO, M. CALDOGNETTO, Rwanda, frammenti
di un viaggio, Name editore 2004. Queste opere prendono per lo più l’avvio dalla domanda:
«che cosa bisogna fare?». Nel panorama delle opere italiane sul Rwanda pare che manchi una
riflessione più profonda, forse più «accademica», che si affianchi alla letteratura di stampo
cattolico ed internazionalista, cosa che si ritrova invece in Francia, dove accanto ai reportage
giornalistici e ai dossier delle Ong si trovano pubblicazioni dei centri di ricerca che si concentrano
sullo studio dell’Africa.
22
Esempio significativo di questi canali alternativi rispetto alla cultura istituzionale è l’esperienza
della Comunità di Sant’Egidio, comunità di laici cattolica. Il 4 ottobre 1992 fu firmato a
Roma, presso la sede della Comunità di Sant’Egidio, l’accordo di pace che pose fine a una
guerra quindicennale in Mozambico. Il Mozambico ex colonia portoghese, a partire dal 1975,
anno dell’indipendenza, sprofondò in una guerra che durò per più di quindici anni. Le storie
del Mozambico e del Rwanda sono molto diverse ma accomunate dall’aver attraversato periodi
di violenza. Fra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta, proprio grazie all’iniziativa
della Comunità di Sant’Egidio, fu intrapreso per il Mozambico un processo di pace che si
concluse positivamente con la firma dell’accordo di pace. Pochi anni dopo, la stessa Comunità
cattolica si occupò della situazione algerina contribuendo alla stesura della «piattaforma di
Roma», piano che promuoveva l’integrazione politica delle varie forze in campo.
L’interessamento, che nasceva dalla volontà di essere solidali con le popolazioni sofferenti, ha
portato, nell’esperienza della Comunità di Sant’Egidio, a promuovere azioni concrete per risolvere determinate situazioni ed anche al coinvolgimento del governo italiano che, in particolare
265
Chiara Calabri
nel caso del Mozambico, fu portato a partecipare prima alle trattative di pace e poi, in maniera
attiva, nelle operazioni di peacekeeping con l’invio di truppe nel paese africano.
23
Cfr. Ucciso un sacerdote su quattro, in «Avvenire», 16 giugno 1994, p. 13.
24
Il destino comune di due presidenti, in «Il manifesto«, 8 aprile 1994, p. 19.
25
Ivi.
26
Non solo odio tribale ma anche sete di potere, in «Avvenire», 9 aprile 1994, p. 1. In questo
articolo si trova anche scritto che l’interpretazione «della guerra sedicente etnica si può applicare
correttamente a molti dei conflitti attuali (Somalia, Liberia, Bosnia, Caucaso ex sovietico)».
27
La diversità etnica è solo uno strumento nella lotta per il potere, in «Avvenire», 10 giugno 1994,
pag. 2. Per comprendere meglio questi punti, si leggeranno i testi già citati nella nota 18.
28
Missionari e Impero: o di qua o di là, in «Avvenire», 3 luglio 1994, p. 19.
29
Mal d’Africa, in «Il manifesto», 15 maggio 1994, p. 2.
30
Africa specchio del mondo, in «Il manifesto», 15 maggio 1994, p. 15.
31
Ivi. L’intervista si conclude con un interrogativo: «Prima di dare lezioni agli africani, noi
europei faremmo bene a guardare quello cosa succede in casa nostra, dalla Jugoslavia alla ex
Unione Sovietica. Chi è più primitivo?». Riguardo alla questione dell’«invenzione delle etnie»
si vedano: J. L. AMSELLE, E. M’BOLOKO, Au cœur de l’ethnie. Ethnies, tribalisme et état en Afrique,
La Découverte, Paris 1985 ; L’etnia fra «invenzione» e realtà. Storia e problematiche di un dibattito,
a cura di C. Moffa, L’Harmattan Italia, Torino 1999; C. CARBONE, Etnie, storiografia e storia
del Burundi e del Rwanda contemporanei, in «Africa», giugno 1997, pp. 159-181.
32
Un vuoto politico dietro i massacri, in «Il manifesto», 30 maggio 1994, p. 12.
33
Non solo hutu e tutsi, in «Il manifesto», 31 luglio 1994. Gli anni ottanta furono caratterizzati
da una situazione di vuoto di potere in cui emersero reti mafiose potenti che, dalla
destabilizzazione e dalla mancanza del rispetto dello stato di diritto, non potevano trarre che
vantaggi e ulteriori margini di manovra. Cfr. REYNTJENS, L’Afrique des Grands Lacs en crise,
Rwanda, Burundi: 1988-1994, Karthala, Paris 1994; Les crises politiques au Burundi et au
Rwanda (1993-1994). Analyses, faits et documents, a cura di A. Guichaoua, Karthala, Paris
1995.
34
Ruanda, esodo in attesa del cessate il fuoco, in «Il Messaggero», 16 luglio 1994, p. 12.
35
Gli equivoci sulla tragedia del Ruanda, in «Avvenire», 1 giugno 1994, p. 14. Dopo i pogrom
avvenuti sotto il regime di Kaybanda, nel 1959 e poi nel 1963-64, la diaspora tutsi rwandese si
era diffusa in tutto il mondo: comunità di rifugiati tutsi si stabilirono soprattutto nelle aree
vicine, Burundi, Uganda, Tanzania, Congo, ma anche negli Stati Uniti, in Svizzera, in Canada.
La diaspora tutsi in Uganda sostenne attivamente National Resistence Army di Museveni: Paul
Kagame e Fred Rwigyema, profughi tutsi rwandesi, furono tra i primi compagni di guerriglia di
266
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
Museveni, raggiungendo, dopo la presa del potere nel 1986, posizioni chiave nelle forze armate
ugandesi. Alle origini della nascita del Rwandan Patriotic Front, l’esercito ribelle tutsi, si pone
un gioco intricato di interessi che vanno oltre quelli regionali e attraggono l’attenzione delle
grandi potenze, in particolare degli Usa. Non a caso è dall’Uganda, paese pupillo degli Stati
Uniti e delle grandi istituzioni finanziarie mondiali, che sarà sponsorizzata la fondazione del Rpf,
quando non direttamente dagli Stati Uniti stessi. Riguardo tutto ciò si può leggere: N. DE
TORRENTÉ, L’Ouganda et le bailleurs de fonds, in «Politique africaine», ottobre 1999, n. 75; EIR
Investigative Team, Rice caught in Iran-Contra-style capers in Africa, in «Executive Intelligence
Review», 20 novembre 1998, in http://www.hartford-wp.com/archives/30/071.html; U.
FRIESECKE, Strategic considerations of the rwandan catastrophe of 1994, in «Executive Intelligence
Review», 25 giugno 2002, in http://www. larouchepub.com/other/2002/2928 arusha_uwe.html;
M. CHOSSUDOVSKY, The US was behind the Rwandan genocide: Rwanda. Installing a US protectorate
in central Africa, 8 May 2003, in http://globalresearch.ca/articles/CHO305A.html.
36
Offerte speciali al bazar della guerra, in «Avvenire», 11 giugno 1994, p. 2.
37
L’orgoglio francofono poté più del «prezioso uranio», in «Avvenire», 24 giugno 1994, p. 3.
38
Ruanda, missione Usa. Francia compromessa, in «Il manifesto», 4 maggio 1994, p. 16.
39
Ruanda, storia francese, in «Il manifesto», 20 maggio 1994, pag. 17. È possibile ricostruire
un quadro generale dei diversi interessi francesi, da quello culturale a quelli geopolitico ed
economico, attraverso vari testi. Ad esempio si potrà vedere: J. F. BAYART, La politique de la
France: de Charybde en Scylla?, in «Politique africaine», marzo 1993, n. 49; D. AMBROSETTI, La
France au Rwanda, un discours de légitimation morale, Karthala, Paris 2000; ed anche R.
CAVALIERI, Balcani d’Africa. Burundi, Rwanda, Zaire, oltre la guerra etnica, Edizioni gruppo
Abele, Torino 1997.
40
È veramente uno scontro etnico?, in «Il manifesto», 24 maggio 1994, p. 14.
41
Cfr. Repubbliche del caffè, in «Il manifesto», 21 aprile 1994, p. 12.
42
Cfr. Fmi e Banca Mondiale strangolano l’Africa con tagli e svalutazioni, in «Avvenire», 12
maggio 1994, p. 15. Prezioso strumento per comprendere gli effetti delle riforme del Fondo
Monetario Internazionale e della Banca Mondiale sulle economie africane è il testo di M.
CHOSSUDOVSKY, La globalizzazione della povertà, l’impatto delle riforme del Fondo Monetario
Internazionale e della Banca Mondiale, edito dalla casa editrice del gruppo Abele a Torino nel
1998. Inoltre si vedano i contributi: T. HORMEKU, US-Africa trade policy: in whose interest?, in
«African Agenda», in http://www.developmentgap.org/afpolicy.html; J. O. IHONVBERE,
Governance, Economics, and Interdependence: costraints and possibilities in Sub-saharan Africa,
giugno 1994, in http://www.hartford –hwp.com/archives/30 032.html e A. MBEMBE, L’Afrique
noire va imploser, in «Le Monde diplomatique», aprile 1990, pp. 10-11.
43
«Fermate i mercanti di morte», in «Avvenire», 12 giugno 1994, p. 2.
44
A proposito della questione del Congo si può leggere E. RAY, U.S. Military and Corporate
Recolonization of the Congo, in «CovertAction Quarterly», in http://www.covertaction,org/
full_text_69_01.htm. e R.CAVALIERI , Balcani d’Africa, Burundi, Rwanda, Zaire, oltre la guerra
267
Chiara Calabri
etnica, Edizioni gruppo Abele, Torino 1997.
45
«Il capo dei ribelli ordinò di uccidere l’arcivescovo», in «Il Messaggero», 12 giugno 1994, pag. 13.
46
Cfr. Ruanda, l’Europa si muove, in «Il Messaggero», 18 giugno 1994, pag. 13.
47
Le accuse alla Francia: «Così ha armato i massacratori», in «Corriere della Sera», 24 maggio
1994, p. 6.
48
«I parà francesi sono già in Ruanda», in «Corriere della Sera», 22 giugno 1994, p. 7. Il 4
ottobre 1990, subito dopo l’attacco del Rpf al Rwanda, Belgio e Francia decisero di inviare
militari nel quadro di un’azione umanitaria che aveva come obiettivo quello di difendere e
garantire la partenza dei cittadini stranieri. La presenza delle truppe straniere, in particolare
di quelle francesi, permise all’esercito rwandese di respingere l’offensiva dell’esercito
patriottico. Pare infatti che, mentre una parte degli uomini dell’esercito francese impediva
l’avanzata verso Kigali del Rpf, un elicottero guidato da un ufficiale della DGSE (Direction
Générale de la Sécurité Extérieure), il controspionaggio francese, bombardasse una colonna
che stava portando rifornimenti al Rpf. Cfr. C. BRAECKMAN, Histoire d’un genocide, in http://
www. reseauvoltaire. net/article6845.html. L’intervento militare francese vide impegnati più di
500 soldati in Kigali, e fino a 150 consiglieri militari permanenti, col compito di addestrare i
soldati delle FAR. Ad ogni offensiva importante del RPF, il contingente francese era rafforzato di
una o due compagnie che poi si ritiravano non appena la minaccia si attenuava: cfr. F. X. VERSHAVE,
Complicité de génocide? La politique de la France au Rwanda, La Découverte, Paris 1994. Diversi
testimoni rivelarono l’inquietante prossimità di istruttori francesi, giunti nell’ambito della
cosiddetta Operation Norôit nell’ottobre 1990, con le milizie Interhamwe, gruppi paramilitari di
civili armati, tristemente famosi per le loro efferatezze e collegati all’ambiente governativo. Il
ruolo del DAMI, Détachement d’assistance militaire et d’instruction, risultò piuttosto ambiguo:
il suo capo, il luogotenente colonnello Chollet, consigliere diretto di Habyarimana, nel gennaio
1992 fu nominato capo supremo delle forze armate rwandesi: egli e i suoi uomini furono
direttamente coinvolti nell’addestramento delle reclute rwandesi e, secondo alcune testimonianze,
delle milizie. Se con l’Operation Noroît i militari francesi avevano contribuito a fermare l’offensiva
del RPF, essi rimasero protagonisti attivi della guerra a fianco dell’esercito governativo. I soldati
francesi stessi verificavano ad alcuni posti di blocco le identità dei cittadini, sorvegliando coloro
che portavano sulla carta d’identità, la menzione «tutsi», e parteciparono attivamente a degli
interrogatori dei prigionieri del RPF, secondo i modi non diplomatici tipici della tradizionale
pratica interrogatoria francese.
49
Parigi: via alla missione Ruanda, in «Corriere della Sera», 23 giugno 1994, p 5.
50
Ruanda, i ribelli dicono no a truppe francesi, in «Il Messaggero», 17 giugno 1994, p. 13.
51
Allons enfants, in «Il manifesto», 18 giugno 1994, p. 15.
52
La Legione bianca, in «Il manifesto», 22 giugno 1994, p. 3.
53
Il nuovo ordine coloniale, in «Il manifesto», 20 luglio 1994, p. 16.
54
Protagonismo che deve riscattare i residui di colonialismo, in «Avvenire», 23 giugno 1994, p. 1.
268
Notizie da un genocidio lontano. La stampa italiana di fronte al dramma del Rwanda
55
La documentazione delle Nazioni Unite riguardo alle missioni in Rwanda, è raccolta in The
United Nations and Rwanda 1993-1996, The United Nations Blue Books Series, New York
1996. B. D Jones , nel suo libro Peacemaking in Rwanda, the dynamics of failure, pubblicato a
Londra nel 2001, e L. R. Melvern, nel testo A people betrayed. The role of the West in Rwanda’s
genocide, edito a New York nel 2000, mettono in evidenza i limiti delle missioni Onu nel paese
africano sconvolto dal genocidio e cercano di svelare come la cattiva comprensione, più o
meno volontaria, degli eventi, sia stata alla base del fallimento dell’intervento umanitario.
Nell’articolo di SAMANTHA POWER, Bystanders to genocide, why the United States let the rwandan
tragedy happen, in «The Atlantic», settembre 2001, in http://www.theatlantic.com/issues/ 2001/
09/power.htm, l’autrice ricostruisce la volontà politica dell’amministrazione Clinton di
mantenersi il più possibile al di fuori da un coinvolgimento più serio, ed efficace, in una
missione Onu. Il defilarsi degli Stati Uniti, reduci dall’operazione Restore Hope in Somalia,
conclusasi con la morte di soldati americani e l’abbandono del paese in mano ai signori della
guerra, fu determinante del fallimento della missione UNAMIR.
56
Tra Onu ed Europa comodo palleggio, in «Avvenire», 19 giugno 1994, p. 1.
57
Le due strategie di Clinton e Boutros Ghali, in «Corriere della Sera», 16 maggio 1994, p. 7.
58
Il mattatoio senza fine, in «Il Messaggero», 10 giugno 1994, p. 1. Paolo Bonaiuti è l’attuale
portavoce di Forza Italia.
59
In particolare si è riscontrato questo caso nel «Messaggero». Questo quotidiano ha molte
pagine dedicate alla politica interna che spesso occupa lo spazio sia del «primo piano» sia
quello specificamente consacrato agli interni.
60
La «rassegna» delle pettinature di Hillary Clinton si ritrova sia nel «Corriere della Sera», sia nel
«Messaggero». Ricercando gli articoli in cui si parla di un genocidio, ritrovare fra le esigue pagine
dedicate agli avvenimenti esteri le disquisizioni sul morale di Hillary Clinton, dedotto dall’analisi
delle nuove pettinature, è un’esperienza a tratti avvilente. Il fatto che i quotidiani maggiori, come
il «Corriere della Sera» riservino poca attenzione a ciò che succede all’estero, a meno che non
riguardi strettamente il mondo occidentale mette in evidenza una delle caratteristiche della stampa
italiana: il provincialismo. In base ad esso «da tempo in molte redazioni, anche serie e impegnate,
si tende a sostenere e dimostrare che ai lettori interessano solo gli accadimenti del portone accanto
e non quelli che li fanno sentire cittadini del mondo, il gossip più dell’analisi politica
internazionale». G. ALBANESE, Il mondo capovolto, i missionari e l’altra informazione, Einaudi,
Torino 2003, p. 3. È chiaro che sui quotidiani nazionali la priorità debba essere data alle notizie
interne, ma lo squilibrio fra il numero e la qualità degli articoli che affrontano questioni interne
rispetto a quelli che si occupano del resto del mondo, risulta decisamente eccessivo.
61
Cfr. grafico.
62
Dal Ruanda i primi racconti di morte, in «Corriere della Sera», 11 aprile 1994, p. 9.
63
Martino, l’Italia deve contare, in «Corriere della Sera», 24 maggio 1994, p. 1.
64
Ivi.
269
Chiara Calabri
65
Cfr. Ruanda, l’Onu chiede fatti all’Italia e Ma Previti frena: «Mai parlato di invio dei parà», in
«Il Messaggero», 26 maggio 1994, p. 11.
66
Sergio Romano, in un articolo del 1992, offriva questa analisi delle caratteristiche generali
della politica estera italiana: «Dalla fine del 1989, con il collasso dell’impero sovietico, la
Guerra fredda, di cui ci eravamo così abilmente serviti per affermare la peculiarità della politica
estera italiana, si è conclusa in Europa con la vittoria dell’Occidente. Ed ecco che all’avvento
della pace fra i vecchi rivali in Europa corrisponde, come necessaria conseguenza, lo scoppio
della guerra calda nel Vicino Oriente. I due avvenimenti - la pace in Europa, la guerra in
Oriente - hanno privato la politica estera italiana degli spazi che essa aveva occupato e sfruttato
negli anni precedenti: la pace, perché ha reso inutile la parte del volenteroso paciere che essa
aveva continuamente recitato nei rapporti est-ovest; la guerra, perché ha imposto all’Italia una
scelta a cui essa era politicamente e militarmente impreparata». Fra i limiti della politica estera
dell’Italia, sicuramente uno dei più pesanti è la persistente abitudine dei partiti «a monetizzare
ogni vicenda internazionale per i loro fini». S. ROMANO, Come è morta la politica estera italiana,
in «Il Mulino», luglio-agosto 1992, n. 342, pp. 718 e 720.
67
I quattro campi dell’apocalisse, in «Il manifesto», 23 luglio 1994, p. 14.
68
Ruanda, ora il flagello della peste, in «Il Messaggero», 23 luglio 1994, p. 13.
69
Parigi: in Ruanda, missione compiuta, in «Avvenire», 20 luglio 1994, p. 15.
70
Ruanda, fuga di un popolo, in «Corriere della Sera», 19 luglio 1994, p. 7.
71
Quelle immagini come una finestra sull’inferno, in «Avvenire», 24 maggio 1994, p. 1.
72
R. CAVALIERI, Balcani d’Africa, Burundi, Rwanda, Zaire, oltre la guerra etnica, Edizioni gruppo
Abele, Torino 1997, p. 16.
73
Ivi, p. 19.
270
Tra l’incudine araba e il martello israeliano
Tra l’incudine araba e il martello israeliano.
La quarantennale lotta di Yâsir ‘Arafât e del movimento di
liberazione palestinese
di Stefano Fabei
Il 5 settembre 1973 ad Algeri la IV Conferenza dei Paesi non allineati
dichiarò l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina «rappresentante
unico e legittimo del popolo palestinese». In senso analogo si espressero,
nel febbraio successivo, i Paesi islamici, a Lahore dove - ricorda ‘Abd alMuhsen Abû Mayzer, membro della delegazione dell’OLP - il Gran Mufti
di Gerusalemme, Hâjj Amîn al-Husaynî, incontrando in albergo, poco prima
dell’inizio dei lavori, Yâsir ‘Arafât, gli disse: «Sarete voi a rappresentare la
Palestina in questa conferenza. Ne ho già parlato con i rappresentanti del
Pakistan». Con queste parole il vecchio leader, prossimo alla morte, passava
il comando nella mani di ‘Arafât cui, poche settimane prima della sua
scomparsa, il 4 luglio 1974 a Beirut, raccomandò: «Attento, devi respingere
la risoluzione 242 che liquida il popolo palestinese e i suoi diritti!». ‘Arafât
raccolse il consiglio del prestigioso e rispettato parente e, come lui, da allora
in poi confidò solo sulle forze dei palestinesi, improntando la sua politica
alla loro difesa dalla tutela dei Paesi «fratelli» che avevano creato l’OLP per
garantire soprattutto i loro interessi. Per decenni ‘Arafât e la sua
organizzazione si troveranno spesso schiacciati tra l’avversario arabo e il
nemico israeliano.
A differenza del Mufti, panarabista e panislamista, ‘Arafât si è
caratterizzato per l’assenza di una esplicita ideologia, a parte il nazionalismo,
e a questo fatto sono forse dovuti la longevità politica e il «successo» di cui
ha goduto. Generoso e socievole, coraggioso e autoritario, religioso ma
disposto ad allearsi anche con il diavolo pur di liberare la Palestina, ‘Arafât
è stato un leader pragmatico, dotato di un carisma che gli ha garantito il
sostegno del suo popolo, forse anche troppo disposto a perdonargli tutto e
sempre.
Nato il 4 o il 24 agosto del 1929 al Cairo (o forse a Gaza o a
Gerusalemme: lui stesso darà spesso versioni differenti sia per accrescere il
mistero sulla sua persona, sia per il costante desiderio di proteggere la propria
271
Stefano Fabei
sfera privata: «Credo sia vergognoso parlare di sé. La nostra rivoluzione ce
lo impedisce. Bisogna parlare solo dei martiri e degli eroi caduti ...» dichiarerà
in un’intervista rilasciata a Beirut nel gennaio del 1979), trascorre in Egitto
l’infanzia e l’adolescenza. Attento osservatore di quanto accade sulla scena
egiziana e in Palestina, non ancora ventenne, tratta nel deserto l’acquisto
presso i beduini di armi e munizioni abbandonate cinque anni prima dagli
italo-tedeschi e dagli inglesi. Questo materiale, destinato all’esercito del
Jihâd guidato da ‘Abd al-Qâdir al-Husaynî, viene raccolto nella casa di questi
al Cairo, dove ‘Arafât insegna il Corano al piccolo Faysal, figlio di ‘Abd alQâdir.
A Héliopolis, il giovane Yâsir incontra spesso il Mufti, da circa trenta
anni leader della lotta di liberazione, al quale gli inglesi non permettono di
rientrare in Palestina, e nella cui casa si riuniscono i nazionalisti palestinesi.
Nel 1948, a Gaza, ‘Arafât si unisce prima alle forze irregolari della Fratellanza
musulmana quindi passa nel Jihâd al-Muqaddas di «Abd al-Qâdir che cadrà
in combattimento nel corso della prima guerra arabo-israeliana, diventando
mito e figura simbolo della lotta palestinese. Esistono altre organizzazioni
che fanno riferimento agli Stati arabi vicini e da questi meglio armate, ma
per ‘Arafât questa è l’unica a dare assoluta garanzia di indipendenza e diventa
membro del suo servizio segreto. Dalla sconfitta degli eserciti arabi, mal
guidati e male armati, capisce che i palestinesi possono e devono contare
solo sulle proprie forze. Il 1948 è l’anno della catastrofe, della nakba.
Centinaia di case arabe sono distrutte mentre la popolazione palestinese è
espulsa o deve fuggire ai massacri. Nell’arco di pochi mesi un intero mondo
finisce, con lo smantellamento da parte dei sionisti di tutte le strutture
civili, economiche, culturali e sociali della Palestina. Prima ancora che l’ONU
l’adotti, il piano di spartizione della Terra Santa è rigettato dai palestinesi e
dagli Stai arabi. Per quale ragione 1.400.000 arabi, cristiani e musulmani,
lì residenti da secoli, dovrebbero condividere la Palestina con 600.000 ebrei
da poco immigrati e che possiedono solo il 6 per cento del territorio? Solo
i comunisti, tra i palestinesi, accettano la soluzione proposta da russi e
americani; vi vedono lo strumento per porre fine al mandato britannico.
Quanti tra loro non accettano la linea del partito, appiattito sulle posizioni
di Mosca, sono espulsi e in Iraq e in Egitto pagheranno a caro prezzo
l’impegno a favore della spartizione. Neanche i dirigenti sionisti, desiderosi
di un nuovo ordine demografico, sono per la spartizione: gli arabi devono
essere espulsi e Ben Gurion incoraggia esplicitamente la pulizia etnica.
Al Cairo e a Gaza ‘Arafât dal 1948 scopre il mondo dei rifugiati (750.000
272
Tra l’incudine araba e il martello israeliano
persone, la metà della popolazione araba di Palestina): uomini e donne
disperati che hanno perso tutto e il cui numero è destinato ad aumentare.
Scopre che per il suo popolo le prospettive sono due: rassegnarsi a sparire o
combattere.
Nella striscia di Gaza, una sorta di ghetto superpopolato, viene costituita
sotto la guida degli Husaynî una Palestina in miniatura il cui governo, che
si presenta come «governo dell’intera Palestina», gode di una certa
autonomia, nonostante il controllo militare dell’Egitto. Tutti i Paesi arabi
ne riconoscono la legittimità, tranne la Giordania che teme e pretende di
rappresentare da sola i palestinesi. Nel 1951 si intensificano gli scontri tra
guerriglieri egiziani e militari britannici stazionanti lungo il Canale di Suez.
I Fratelli musulmani e i nazionalisti vogliono che gli inglesi lascino il Paese;
‘Arafât, che ritiene questi ultimi responsabili della nakba, imbraccia il fucile
e partecipa agli attacchi prima di tornare al Cairo e continuare gli studi.
Ambendo alla direzione dell’Associazione degli studenti cairoti ‘Arafât
si guadagna l’appoggio dei Fratelli musulmani, dei panarabisti, dei liberali,
del Wafd e dei comunisti. Così nel 1952 la lista palestinese vince le elezioni
e ‘Arafât diventa presidente dell’Associazione, carica che manterrà fino al
termine degli studi in Ingegneria del genio civile, nel 1956. A rinvigorire le
speranze dei giovani palestinesi delusi da re Fârûq contribuiscono Jamâl
‘Abd al-Nâser e gli Ufficiali liberi che il 23 luglio 1952 prendono il potere,
proclamando la repubblica e chiedendo l’espulsione degli inglesi. I rapporti
con il nuovo regime non saranno tuttavia sempre idilliaci; quando
nell’ottobre del 1954 scampa a un attentato dei Fratelli musulmani, Nâser
dispone l’arresto di molti membri e simpatizzanti del gruppo e ‘Arafât finisce
in prigione per un mese.
Allorché il 26 luglio del 1956 il Ra’îs annuncia la nazionalizzazione del
canale di Suez e le truppe israeliane, sostenute da Francia e Inghilterra,
entrano in Egitto e occupano il Sinai, dando inizio a un conflitto che finirà
con lo scacco della coalizione tripartita, ‘Arafât si unisce all’esercito egiziano.
A fine guerra, anche grazie all’eco suscitata dalla rivoluzione algerina e dal
montante nazionalismo arabo, ‘Arafât si convince sempre più della necessità
di creare un’organizzazione combattente palestinese.
Nel 1957, quando il clima in Egitto è cambiato, perché Israele ha
restituito ad ‘Abd al-Nâser il Sinai e Gaza, dove l’esercito del Ra’îs, timoroso
di un possibile oscuramento del nasserismo, controlla le correnti radicali
palestinesi, ‘Arafât raggiunge il Kuwait; qui il 10 ottobre 1959, con Khalîl
al-Wazîr, Salâh Khalaf e Khâlid al-Hasan, fonderà al-Fatâh. Nei due anni
273
Stefano Fabei
precedenti dedica molto tempo all’attività clandestina cercando di
guadagnarsi le simpatie dei palestinesi ai quali guardano con interesse varie
forze: dal nasserismo ai panarabisti, dai social-nazionalisti del Ba‘th al
Movimento dei nazionalisti arabi fondato da George Habâsh. Convinto
della priorità di formare una struttura militare, oltre che politica,
dall’autunno del 1957 crea nella striscia di Gaza con al-Wazîr (nome di
battaglia Abû Jihâd) uomo preparato militarmente nelle file della Fratellanza
musulmana, il primo gruppo del movimento dei fidâ’iyyîn, da cui nascerà
il Movimento di liberazione della Palestina, al-Fatâh. Lo scopo è chiaro e
privo di qualunque implicazione ideologica: liberare tutta la Palestina
attraverso la lotta armata e fondarci uno Stato arabo indipendente che
comprenda la Cisgiordania (allora integrata alla Giordania), la striscia di
Gaza e il territorio di quello che è «lo strumento dell’imperialismo, corpo
estraneo trapiantato all’interno del mondo arabo, che bisogna estirpare»,
cioè di Israele. Unica parola d’ordine è tahrîr, liberazione, il che significa
fine di Israele.
Consapevole del ruolo che possono avere le organizzazioni studentesche,
‘Arafât fonda nel 1959 l’Unione generale degli studenti palestinesi che,
integrata all’Organizzazione internazionale degli studenti di derivazione
sovietica, opererà nei Paesi arabi e in Europa. Per far conoscere al-Fatâh e il
suo programma (creare nei Paesi arabi vicini gruppi di fidâ’iyyîn indipendenti
che compiano incursioni in Israele e ovunque nel mondo si trovino
istituzioni ebraiche e interessi sionisti) ‘Arafât utilizza prima «Studenti di
Palestina», un giornale pubblicato al Cairo dall’associazione, poi il
Filastînunâ - Nidâ’ al-Hayât, («Nostra Palestina-Appello alla vita») che esce
a Beirut. Il tema ricorrente è la liberazione della Palestina per giungere
all’unità araba; i contenuti rivelano un carattere nazionalista privo di
riferimenti all’Islàm. Nel Filastînunâ si citano la Bibbia e il Talmud per
dimostrare il razzismo ebraico e compaiono brani dei Protocolli dei savi di
Sion.
Oltre ai legami con gli algerini che, conquistata l’indipendenza nel 1962,
permettono l’apertura nella capitale dell’Ufficio della Palestina, primo ufficio
di al-Fatâh, dando inizio a una collaborazione anche militare,
l’organizzazione palestinese ne stringe altri con chiunque ne condivida
obiettivi, dalla Corea del Nord al Vietnam, da Cuba allo Yemen del sud. Ad
‘Arafât e ad Abû Jihâd, che ad Algeri incontra Che Guevara, non interessa
l’ideologia e la provenienza politica dei potenziali sostenitori. Qualsiasi aiuto,
da qualunque parte provenga va bene purché non sia prevista una
274
Tra l’incudine araba e il martello israeliano
contropartita. In questa spregiudicatezza ‘Arafât è degno erede del Gran
Mufti che non aveva esitato negli anni trenta e quaranta a cercare l’appoggio
dell’Asse, schierate contro i comuni nemici: ebrei, inglesi e francesi. Per lui,
religioso ma non legato come il Mufti a una precisa ideologia o concezione
statuale (al-Husaynî aveva invece in mente un grande Stato panarabo a
struttura califfale e quindi basato sulla legge coranica), l’operazione è ancor
più facile.
Il comitato centrale di al-Fatâh nel 1963 adotta con voto unanime una
risoluzione in base alla quale l’organizzazione è vietata a qualunque
rappresentante o membro di partiti politici, dai quali gli aderenti devono
allontanarsi recidendo ogni legame. L’obiettivo è quello di garantire lo spirito
rivoluzionario e di indipendenza di al-Fatâh.
Il summit dei capi di Stato arabi, riuniti al Cairo da Nasser tra il 13 e il
17 gennaio 1964, decide di sostenere l’«entità palestinese» sia sul piano
militare sia su quello politico creando l’Organizzazione per la Liberazione
della Palestina e l’Esercito di Liberazione della Palestina. Le risoluzioni
stabiliscono però che gli organi militari e politici dei rifugiati dovranno
rimanere sotto la tutela dei Paesi ospiti. ‘Arafât, geloso custode della
autonomia palestinese, rifiuta di accettare l’idea che al-Fatâh perda la propria
libertà di movimento.
‘Abd al-Nâser vuole che a guidare l’OLP sia Ahmad Shuqayrî le cui
simpatie per il Ra’îs e la cui dipendenza dall’Egitto sono note a tutti, mentre
siriani e sauditi preferirebbero il Mufti. Tra il 28 maggio e il 2 giugno
Shuqayrî riunisce a Gerusalemme il congresso fondatore dell’OLP - il
Consiglio nazionale palestinese che fungerà da parlamento - la cui carta,
oltre a evocare i diritti dei palestinesi, fa appello alla distruzione dell’entità
sionista, rifiuta la partizione e invoca la liberazione della Palestina.
Nonostante le diffidenze nei confronti di Shuqayrî - strumento di Nâser
e in quanto tale visto con sospetto anche da re Husayn che teme gli si voglia
sottrarre la Cisgiordania - al-Fatâh gli offre la sua cooperazione, proponendo
questa soluzione: l’OLP agirà allo scoperto mentre i fidâ’iyyîn opereranno
nella clandestinità. In cambio alcuni membri di al-Fatâh entreranno
nell’organizzazione di Shuqayrî che però rifiuta l’offerta, sembra dietro
pressioni egiziane. ‘Arafât vuole accelerare i tempi della lotta armata contro
il nemico sionista e non ha fiducia in Shuqayrî e nei suoi sponsor.
Sospetti verso l’OLP e il suo capo, che lui stesso aveva nominato
rappresentante della Palestina alla Lega Araba, nutre anche il Mufti il quale
tra il 27 dicembre 1964 e il 2 gennaio 1965 presiede a Mogadiscio la IV
275
Stefano Fabei
Conferenza islamica, dove è adottata una risoluzione di sostegno alla causa
palestinese. Il Mufti che, come ‘Arafât, desidera difendere l’indipendenza
dei palestinesi, non è disposto ad accettare alcuna tutela. Shuqayrî, da parte
sua, volendo dar vita al nuovo organismo, inizia a sottrarsi all’influenza di
al-Husaynî sempre più ignorato dalla Lega Araba che si rende conto di non
poter gestire come vuole. Il Mufti - che ritiene il Supremo Comitato Arabo
il solo rappresentante del popolo palestinese - è certo più rigido come
interlocutore di Shuqayrî, pertanto molti Paesi arabi rifiutano di cooperare
con lui e con i suoi rappresentanti.
Dopo l’Algeria, nel 1964 anche la Siria permette l’apertura di un ufficio
di al-Fatâh, non senza condizioni: per preservare il Paese dalle rappresaglie
israeliane i dirigenti ba‘thisti di Damasco siriano pretendono infatti che le
azioni di guerriglia siano condotte partendo dal territorio del Libano e della
Giordania. Il 1° gennaio 1965 viene compiuto il primo attacco all’interno
dei territori occupati, cioè di Israele, rivendicato da al-’Âsifa, un’organizzazione
sconosciuta dietro la quale c’è al-Fatâh. L’operazione, di per sé fallimentare,
è comunque accolta con gioia dai palestinesi che battezzano il 1° gennaio il
giorno di al-Intilâqa, ovvero l’esplosione, l’inizio della guerra di liberazione;
in seguito sarà festeggiato da al-Fatâh, dall’OLP e da tutto il Movimento
nazionale palestinese. Nei giorni successivi altri attentati hanno luogo e di
fronte al nuovo corso ‘Arafât e il suo movimento non sanno bene se cercare
appoggio presso l’Egitto, il cui Ra’îs cerca di evitare la guerra auspicata da
‘Arafât e rifiuta di compiere azioni contro Israele, o presso la Siria che i
fidâ’iyyîn sentono più vicina a loro, soprattutto dopo che i radicali del Ba‘th
prendono il potere il 3 febbraio 1966.
I dubbi e i timori di Nâser sembrano trovare conferma nel giugno 1967,
quando nel corso della Guerra dei sei giorni Israele sconfigge la coalizione
araba, al cui fianco combattono alcuni commando di fidâ’iyyîn. ‘Arafât deve
prendere atto non solo dell’impreparazione militare degli arabi, ma anche e
soprattutto del fallimento della sua strategia, quella, appunto, di trascinare
gli eserciti fratelli in una guerra per liberare la Palestina. Israele ha vinto,
impadronendosi di grandi territori, e l’unica speranza da adesso in poi è
che il milione di palestinesi che vivono il dramma dell’occupazione si
rivoltino.
Negli anni successivi ‘Arafât sostiene la necessità di continuare le
operazioni dei fidâ’iyyîn che non solo, pensa, salveranno il movimento dalla
paralisi in cui è venuto a trovarsi dopo la sconfitta, ma daranno maggiore
visibilità alla questione palestinese. Cerca di internazionalizzare la causa
276
Tra l’incudine araba e il martello israeliano
riproponendo su scala allargata, oltre i limiti del mondo arabo islamico,
una strategia adottata trenta anni prima dal Mufti che con varie iniziative
aveva fatto conoscere il dramma del suo popolo nel mondo islamico,
cercandone l’appoggio, dal Marocco all’India. Per far ciò è necessario il
sostegno materiale, oltre che politico, dei Paesi arabi, senza tuttavia rinunciare
ai propri principi.
Nell’estate del 1967 Abû Ammâr raggiunge i territori occupati per
organizzare cellule di combattenti e a Nablus riesce all’ultimo momento a
sottrarsi agli israeliani che hanno scoperto il suo nascondiglio: lo salva,
come accadrà spesso in futuro, il suo proverbiale sesto senso. È la prima di
una serie di fughe, aspetto anche questo che lo accomuna al Mufti.
Il Consiglio di sicurezza dell’Onu il 22 novembre 1967 adotta
all’unanimità la risoluzione 242 che, per ricomporre in modo pacifico il
conflitto tra Israele e i Paesi arabi, propone la seguente formula: pace in
cambio dei territori conquistati con l’ultima guerra arabo-israeliana. Per
Nâser e re Husayn di Giordania si tratta di una soluzione onorevole; per
tutti i palestinesi, da ‘Arafât al Mufti, a Shuqayrî, costituisce la fine di tutte
le speranze del diritto alla nazionalità e quindi da rifiutare dato che è l’ultimo
tentativo dei Paesi fratelli di integrare i rifugiati. Nella IV Conferenza araba
tenuta a Khartoum dal 29 agosto al 1° settembre - diversamente dai
precedenti vertici che avevano adottato risoluzioni in cui si rivendicava la
liberazione della Palestina dall’imperialismo sionista - si parla di liberare i
soli territori occupati e cioè Gaza, Cisgiordania, Sinai e Golan. L’obiettivo,
da conseguire con azioni sul piano politico e diplomatico, è assicurare il
ritiro israeliano dalle aree conquistate dopo il 5 giugno.
Un anno dopo la Guerra dei sei giorni finisce la leadership di Shuqayrî
all’interno dell’OLP e nel luglio del 1968 i fidâ’iyyîn partecipano in massa
(68 su 100) alla quarta sessione del Cnp, riunita al Cairo, che assume una
posizione rigida, contraria a ogni rappacificazione: la lotta armata è l’unico
strumento per liberare la Palestina e l’azione dei fidâ’iyyîn rappresenta il
«nucleo della lotta di liberazione». Gli emendamenti in tal senso alla Carta
nazionale palestinese sono voluti da ‘Arafât e dai suoi che pensano per la
Palestina liberata a uno Stato «democratico» e multiconfessionale. Questo
è l’obiettivo per cui adesso vuole battersi Abû Ammâr la cui popolarità è in
aumento. Unico candidato al ruolo di presidente del Comitato esecutivo
dell’OLP, è eletto nel corso del quinto Cnp (1-4 febbraio 1969).
Guidata da ‘Arafât, che inizia ad accumulare funzioni di comando, l’OLP,
organo politico rappresentativo e organo militare dei palestinesi, comincia
277
Stefano Fabei
a imporsi tra i Paesi arabi, primo fra tutti l’Arabia Saudita. Accolto in modo
trionfale dal quinto vertice arabo (Rabat, 21-23 dicembre 1969), ‘Arafât,
adesso ha anche il diritto di voto come i capi di Stato i quali gli fanno
grandi promesse che però solo gli algerini manterranno. Con grande
disinvoltura incontra intanto gli antimperialisti di tutto il mondo, cubani,
cinesi, vietnamiti, non trascurando i rapporti con l’URSS che comunque
sostiene la risoluzione 242, disprezza i fidâ’iyyîn definendoli «avventurieri»,
rifiuta qualsiasi prospettiva di distruzione dell’entità sionista in Palestina e
solo nel febbraio 1970 accoglierà ‘Arafât molto discretamente. Non a caso
un mese dopo i partiti comunisti iracheno, giordano e libanese avallano la
nascita di un’organizzazione comunista di fidâ’iyyîn, al-Ansâr (i partigiani),
nel cui comunicato ufficiale non si fa riferimento alla liberazione della
Palestina, ma solo al ritiro dai territori conquistati da Israele nel 1967. AlAnsâr chiede di entrare nell’OLP, la cosa potrebbe migliorare i rapporti con
Mosca, ma i radicali si oppongono e qualche anno dopo il gruppo scompare.
Dopo la sconfitta del 1967 gli attacchi di al-Fatâh a Israele partono da
Stati limitrofi, quali il Libano, la Giordania e la Siria, dove si trovano il
quartier generale di ‘Arafât e campi di addestramento dei fidâ’iyyîn. In tutti
e tre i Paesi la presenza di questi determinerà una serie di situazioni
drammatiche, che confermeranno ancora una volta al di là delle promesse
e delle dichiarazioni di principio dei fratelli arabi, un’amara verità: la
solitudine dei palestinesi, che verranno di volta in volta massacrati dai
giordani, dai libanesi e dai siriani.
Dagli anni settanta in poi l’OLP - che aveva quale suo obiettivo
fondamentale la cancellazione dello Stato di Israele per fondare una Palestina
interamente araba, corrispondente a tutto il territorio del mandato
britannico - guidata dal padre-padrone ‘Arafât, la cui leadership è stata spesso
contestata ma mai messa seriamente in discussione, ha portato avanti una
doppia strategia che affiancava alla lotta armata quella di una continua,
difficile e sterile serie di trattative.
Riportiamo qui di seguito, in sintesi, prima i fatti più importanti sul
piano militare, quindi le tappe della via politico-diplomatica perseguita da
‘Arafât.
In Libano, dopo molti scontri tra fidâ’iyyîn ed esercito libanese, il 21
ottobre 1969 si arriva a un accordo, che regolarizza la presenza armata di
palestinesi nel Paese, mentre in Giordania s’intensificano gli scontri con
l’esercito di re Husayn, che, non tollerando più la presenza di uno Stato
(palestinese) nello Stato (giordano), il 17 settembre 1970, con il pretesto
278
Tra l’incudine araba e il martello israeliano
dei dirottamenti compiuti dal Fronte Popolare per la Liberazione della
Palestina, fa attaccare i campi profughi. Con la mediazione di Nâser si
arriva poi a una tregua, ma il Settembre nero è un duro colpo per ‘Arafât e
i suoi che contano migliaia di morti e feriti. Dopo il massacro giordano,
tanto più doloroso perché perpetrato dai fratelli giordani i quali sono in
maggioranza d’origine palestinese, per ‘Arafât si pone la questione di
ricostruire la resistenza che si riorganizza in Libano, dove al-Fatâh ha 3.000
combattenti. Anche qui negli anni a venire i palestinesi saranno massacrati
dai fratelli libanesi; prima durante la guerra civile del 1975; quindi nel
1976, anno in cui si verifica il 22 giugno il massacro di Tell ez-Za‘tar. Nel
1978, quando Israele invade il Sud del Libano, centinaia sono i morti
palestinesi, oltre che libanesi; nel 1981 e nel 1982 il massacro continua ad
opera degli israeliani e dei loro alleati falangisti (cristiani-maroniti) che si
scatenano in una caccia all’uomo di inaudita ferocia (Sabra e Chatila, 16
settembre 1982). Apriamo una breve parentesi per ricordare che allora gli
israeliani saccheggiarono il Centro di ricerche palestinesi asportando o
distruggendo 25.000 volumi e manoscritti, al chiaro scopo di eliminare
non solo l’OLP ma qualsiasi segno dell’identità e della storia del popolo
palestinese. Nel novembre dell’anno successivo ‘Arafât e i suoi sono costretti
subire a Tripoli l’assedio congiunto dei siriani e dei dissidenti del filosiriano
Abû Mûsà; nella primavera del 1985 sono gli sciiti del movimento Amal,
sostenuti dai siriani, a scatenare la «guerra dei campi» attaccando Sabra,
Chatila e Burj al-Barajneh. Gli scontri, con centinaia di morti tra i civili
palestinesi, finiranno solo all’inizio del 1988. A questi massacri, perpetrati
dagli arabi, vanno aggiunti gli attacchi degli israeliani che, Guerra del Kippur
a parte, compiono dal 1973 in poi centinaia d’incursioni, terrestri e aeree,
in Libano per eliminare esponenti dell’OLP e combattenti palestinesi i quali
dal luglio del 1981 sono in grado, nella parte meridionale del Paese, non
solo di reggere il confronto militare con il nemico e i suoi collaborazionisti
cristiani, ma anche di infliggergli perdite significative. Con l’operazione
«Pace in Galilea», con cui Sharon, all’inizio di giugno del 1982 si propone
la distruzione totale dell’OLP, Israele bombarda a tappeto i quartieri
palestinesi di Beirut e tutto il Libano meridionale, dal quale si ritirerà nel
giugno del 1985, mantenendo tuttavia una fascia di sicurezza tenuta sotto
controllo assieme all’Esercito del Libano del sud dal generale Lahad.
Contemporaneamente a questi eventi militari ‘Arafât e l’OLP,
riconosciuta quale «legittimo rappresentante del popolo palestinese» prima
dal vertice arabo di Algeri (26-28 novembre dal 1973), quindi dall’ONU il
279
Stefano Fabei
14 ottobre 1974, perseguono sul piano internazionale la propria
legittimazione. Il 13 novembre 1974 ‘Arafât s’impone all’attenzione del
mondo parlando alla tribuna delle Nazioni Unite, che il 10 novembre 1975
condanneranno il sionismo come forma di razzismo: «Vengo qui con un
ramoscello d’olivo - dice davanti al consesso internazionale - e una pistola.
Non lasciate che sia il ramoscello a cadermi di mano».
Dopo che tra il 12 e il 20 marzo 1977, al XIII Consiglio nazionale
tenuto dall’OLP al Cairo, viene accettata definitivamente l’idea
dell’edificazione di uno Stato indipendente su una parte soltanto della
Palestina storica, l’anno successivo ‘Arafât e la sua organizzazione subiscono
un duro colpo dagli accordi di Camp David (17 settembre 1978). Questi,
patrocinati dagli USA, prevedono il ritiro israeliano dal Sinai disimpegnando
gli israeliani dal fronte sud, e l’inizio di negoziati (che non avranno mai
luogo) tra giordani, egiziani, israeliani e palestinesi. Israele nel frattempo
continua a tappe forzate la sua politica di colonizzazione in tutti i territori
occupati nel 1967, contro ogni legittimità internazionale, e nel luglio del
1980 proclama Gerusalemme, «intera e unificata», sua capitale.
La rivoluzione islamica del 1979 accende intanto le speranze dei
palestinesi che trovano nell’Iran un altro alleato; ‘Arafât corre a Teheran ad
abbracciare l’Imâm Khomeyni e le autorità del nuovo Stato, molti cui
esponenti si sono addestrati nei campi dei fidâ’iyyîn, mentre lo Shâh sosteneva
apertamente Israele. Vedendo qualche tempo dopo nel conflitto Iran-Iraq
un evento deleterio anche per la lotta dei palestinesi, ‘Arafât cercherà, invano,
di mediare tra Khomeyni e Saddâm Husayn, al fianco del quale si schiererà
in occasione della guerra successiva all’invasione del Kuwait.
Il 9 settembre 1982, al summit arabo di Fez la risoluzione finale adottata
lancia un appello per la creazione di uno Stato indipendente, ribadisce che
l’OLP è il legittimo rappresentante dei palestinesi e invoca la pace nella
regione. Undici giorni dopo re Husayn propone la creazione di una
«Confederazione giordano-palestinese». Il 31 luglio 1988, preoccupato dal
possibile estendersi dell’intifâda ai suoi territori, annuncerà tuttavia la
decisione di rompere i rapporti legali e amministrativi tra le due rive del
Giordano, facendo così svanire la possibilità di una trattativa congiunta
giordano-palestinese in vista di una confederazione. L’OLP rimarrà così
l’unico interlocutore in campo.
Tra il 14 e il 18 febbraio 1983 il Consiglio nazionale ad Algeri,
riconfermato ‘Arafât presidente, vota un documento su un possibile Stato
palestinese in Cisgiordania e a Gaza lanciando un appello alla trattativa a
280
Tra l’incudine araba e il martello israeliano
qualsiasi forza israeliana disposta a riconoscere i diritti degli arabi.
Di là dalle speranze e dalle solenni dichiarazioni di ‘Arafât che, con grande
perizia, riesce a mantenere la leadership nell’organizzazione mostrando note
abilità diplomatiche (pensiamo, ad esempio, al Consiglio politico nazionale
tenuto ad Algeri tra il 20 e il 26 aprile 1987, quando le varie forze, eccezion
fatta per la minoritaria fazione filosiriana, si riunificano, riconfermando
così la fiducia nella leadership), i palestinesi, a più di 20 anni dalla nascita
dell’OLP, sono costretti a prendere atto che niente per loro è effettivamente
cambiato. La povertà, la disperazione, l’orgoglio di un popolo continuamente
offeso e ferito sia da Israele sia dai Paesi ospitanti la sua diaspora, determina
lo scoppio, a partire dal 7 dicembre 1987, di quella grande insurrezione
popolare in Cisgiordania e nella striscia di Gaza conosciuta come intifâda.
Iniziata spontaneamente coglie di sorpresa la direzione palestinese che
impiegherà dei mesi per riprendere il controllo degli avvenimenti. ‘Arafât e
l’OLP sono quindi costretti a sostenere la rivolta, la più vasta dopo quella
degli anni 1936-1939, per non perdere la faccia davanti al loro popolo.
Con l’intifâda emergono nuovi soggetti politici: il Movimento di
resistenza islamico (Harâkat al-Muqâwamat al-Islâmiyya) Hamâs, creato
nel 1987 dallo sceicco Ahmad Yâsîn e da Muhammad Tâhâ, e il Jihâd
islamico. La prima, organizzazione religiosa a carattere politico-militare,
non ha mai fatto mistero della sua volontà di distruggere Israele e creare
uno Stato islamico palestinese. Nata come associazione di mutuo soccorso
dopo l’occupazione israeliana del 1967, ha sempre osteggiato la politica di
‘Arafât e per questo è stata inizialmente tollerata dal governo militare
israeliano che a Gaza e in Cisgiordania aveva individuato nei movimenti
legati alla Fratellanza musulmana uno strumento per indebolire l’OLP e le
formazioni radicali palestinesi. Successivamente, con i fondi provenienti
da alcuni Paesi arabi e islamici, Hamâs cresce anche grazie alle sue strutture
assistenziali e culturali, e assume una posizione ostile al processo di
pacificazione promosso dall’OLP a partire dalla metà degli anni ottanta.
Dal 1996, a seguito della «linea dura» assunta via via dai premier israeliani
Netanyahu, Barak e Sharon, Hamâs vede aumentare i consensi nei territori
occupati. Pur non aderendo al Comando nazionale unificato dell’Intifâda
collabora con questo e nel 1989 è messa fuori legge dal governo israeliano.
Nonostante alcuni suoi importanti leader, a cominciare da Yâsîn, siano
stati di recente eliminati dagli israeliani, Hamâs resta per Israele uno dei
più determinati nemici. Il Jihâd, fondato da Fathî Shikaki (ucciso dagli
israeliani nel 1995) in seguito alla rivoluzione islamica iraniana, lotta per
281
Stefano Fabei
gli stessi obiettivi di Hamâs, ma se ne distingue per il fatto di dedicare le sue
risorse solo alla lotta armata, senza impegnarsi sul piano delle istituzioni
sociali.
Con queste due forze che si ispirano per molti aspetti agli ideali e ai progetti
perseguiti dal Gran Mufti, ‘Arafât ha dovuto assumere un atteggiamento di
volta in volta diversificato ma sempre finalizzato a evitare lo scontro
interpalestinese che costituirebbe per il suo popolo non solo un ulteriore fattore
di debolezza ma forse un vero e proprio suicidio.
Nonostante dal 1988 si sia trovato anche per questo costretto a cavalcare
l’intifâda, per evitare una possibile guerra civile, ‘Arafât non si è voluto
precludere la possibilità di continuare gli sforzi sulla via della diplomazia e
della ricerca di un riconoscimento da parte del nemico di sempre.
Nel settembre 1993, dopo trattative segrete tra OLP e Israele mediate
dalla Norvegia, ‘Arafât riesce a ottenere una storica intesa con il premier
israeliano Yitzak Rabin a Washington. Mentre l’OLP riconosce «il diritto di
Israele a vivere in pace e sicurezza» il governo israeliano riconosce
nell’interlocutore il legittimo rappresentante del popolo palestinese,
impegnandosi a negoziare con esso la pace in Medio Oriente. Il 13 settembre
a Washington, con una cerimonia ufficiale presieduta da Clinton, ‘Arafât e
Rabin firmano una «dichiarazione di principi». Non si tratta di un accordo di
pace ma solo di un quadro generale al cui interno collocare ulteriori negoziati;
è approvato il 23 settembre dalla Knesset e l’11 ottobre dal Cnp. Un mese
dopo a Taba, in Egitto, iniziano i negoziati ed entra in vigore la dichiarazione
dei principi che prevede queste scadenze: - 13 dicembre 1993 firma del ritiro
israeliano da Gaza e Gerico; - 13 luglio 1994 elezioni del Consiglio legislativo
palestinese; - 13 dicembre 1995 data limite per l’inizio di trattative sullo statuto
definitivo dei territori occupati; - dicembre 1995 ritiro dell’esercito israeliano
da Hebron. Successivamente alla firma, il 4 maggio (con cinque mesi di ritardo
sul calendario previsto) al Cairo, degli accordi «Gaza e Gerico prima di tutto»,
meglio noti come «accordi di Oslo» e rifiutati da Hamâs e Jihâd islamico, il 1°
luglio ‘Arafât, dopo 27 anni di esilio, torna a Gaza e assume la guida
dell’Autorità nazionale palestinese. L’accordo gli garantisce, insieme a Peres e
a Rabin (che sarà vittima di un attentato da parte di un estremista israeliano il
27 ottobre 1995), il Nobel per la pace, il 14 ottobre 1994. Dopo la firma il 28
settembre 1995 degli accordi «Oslo II» che prevedono l’estensione
dell’autonomia palestinese in Cisgiordania, il 20 gennaio successivo, con l’87,1
per cento dei voti, è eletto presidente dell’Anp, mentre la sua organizzazione
conquista i due terzi degli 80 seggi del Consiglio legislativo.
282
Tra l’incudine araba e il martello israeliano
L’entusiasmo per i risultati conseguiti ha però breve durata. Il 29 maggio
1996 Peres e i laburisti perdono, per poche migliaia di voti, le elezioni da
cui esce vincitrice la coalizione di destra guidata da Benyamin Nétanyahu.
Il programma di quest’ultimo non fa alcun riferimento al processo di pace
e prevede, fra l’altro, la chiusura dell’Orient House di Gerusalemme est
considerata una sorta di sede di rappresentanza dell’Anp. Il nuovo ministro
delle Finanze, Dan Meridon, il 19 luglio dichiara che «la politica di
colonizzazione di massa del Likud non sarà diversa da quella dei laburisti
[...] è chiaro che siamo determinati a non tornare alle frontiere del ’67». Il
25 febbraio 1997, in violazione degli accordi di Oslo, Israele annuncia la
costruzione di insediamenti sulle colline di Har Homa, nella zona araba di
Gerusalemme. Gli Stati Uniti pongono il veto a una risoluzione dell’ONU
che invita Israele a rinunciare alla costruzione di queste nuove colonie. Il
boicottaggio da parte israeliana costringe ‘Arafât a interrompere i negoziati.
Dopo il fallimento degli accordi di pace di Wye Plantation con
Netanyahu sul ritiro graduale di Israele dalla Cisgiordania (23 ottobre 1998),
il 4 maggio 1999, quando scade il periodo di autonomia palestinese previsto
dalla dichiarazione di principi del 1993, dietro pressione statunitense, il
vertice dell’OLP accetta di posticipare di un anno la scadenza dei termini
per la negoziazione dello statuto finale della Cisgiordania e di Gaza, e di
rinviare quindi la proclamazione dello Stato palestinese indipendente.
Successivamente alle elezioni israeliane del 17 maggio, vinte dai laburisti,
«Arafât e il nuovo premier, Ehoud Barak, firmano il 4 settembre gli accordi
di Sharm esh-Sheykh con cui viene ridefinito il calendario dei ritiri e del
ridispiegamento israeliano, l’apertura di due collegamenti tra Cisgiordania
e Gaza, l’ulteriore liberazione di prigionieri e l’accordo definitivo su tutte le
questioni rimaste in sospeso.
A Camp David, l’11 luglio del 2000, si apre la conferenza per lo statuto
finale di Cisgiordania e Gaza. Il vertice però si conclude senza alcun accordo e
senza dichiarazioni congiunte; alcune fonti imputano il fallimento alla questione
di Gerusalemme e dei Luoghi santi, ma i mediatori palestinesi riferiscono che
non c’era accordo su quasi nessun punto in discussione.
Nel settembre del 2000, con l’inizio, della seconda intifâda (scatenata dalla
provocatoria visita di Ariel Sharon all’Haram ash-Sharîf) la leadership di ‘Arafât
viene ormai apertamente messa in discussione sia da Israele e dagli Stati Uniti,
che lo accusano di incoraggiare il terrorismo, sia dai settori palestinesi più radicali,
che lo considerano troppo morbido con lo Stato ebraico e denunciano la
corruzione della sua gestione politica chiedendo una riforma dell’Anp.
283
Stefano Fabei
Il nuovo governo Sharon, vincitore delle elezioni del 6 febbraio 2001,
intensifica la politica di chiusura e isolamento delle zone controllate dall’Anp.
Numerose strade vengono bloccate dall’esercito israeliano che pratica dei
fossati per impedirne l’utilizzo da parte dei palestinesi. Nel giro di pochi
mesi, continuando questa vocazione all’apartheid, daranno il via alla
costruzione di un muro.
Con un’azione senza precedenti dalla nascita dell’Anp, tra il 16 e il 17
aprile l’esercito israeliano invade le zone a controllo arabo nella striscia di
Gaza. Vengono colpiti posti di polizia palestinese e basi di Forza 17, occupata
la zona di Beit Hanoun e il territorio della striscia di Gaza viene diviso in
tre settori con barriere dell’esercito israeliano. L’invasione provoca la reazione
americana e il segretario di Stato Powell la giudica «eccessiva e
sproporzionata»; la sera del 17 gli israeliani si ritirano dalle zone occupate.
Dal dicembre del 2001 ‘Arafât viene tenuto confinato nel suo quartier
generale di Ramallah (la Muqâta‘a) che fino a maggio 2002 viene assediato
dai carri armati israeliani per rappresaglia contro i crescenti attentati che
Israele gli rimprovera di non fermare.
Su pressione degli Stati Uniti, ideatori della «road map» per la pace in
Medio Oriente, nel marzo 2003, ‘Arafât nomina Primo ministro palestinese
Abû Mazen, ritenuto un interlocutore più credibile per i negoziati. Tra
‘Arafât e il premier da lui stesso designato si creano però subito dei contrasti
circa la linea da tenere, interpretati dagli osservatori come la dimostrazione
che il vecchio Ra’îs non ha nessuna intenzione di vedere scavalcata la sua
leadership. Il 6 settembre dello stesso anno Abû Mazen si dimette e ‘Arafât
lo sostituisce subito con Abû Ala, presidente del parlamento palestinese e
architetto degli accordi di Oslo sull’autonomia della Palestina. Pochi giorni
dopo il Governo israeliano decide di espellere il presidente dell’Autorità
nazionale palestinese dai Territori, provocando grandi manifestazioni di
protesta da parte dei suoi sostenitori. ‘Arafât in risposta al provvedimento
afferma: «Nessuno mi caccerà». Poi il rapido declino nella casa prigione di
Ramallah, prima dell’ultimo, disperato viaggio a Parigi.
Molti anni prima, quando era lontano dalla Palestina, incontrando in
Tunisia Abû Lughud e Edward Sa‘îd, due intellettuali palestino-americani,
parlando del Gran Mufti aveva detto: «Non vorrei finire la mia vita come
Hajj Amin. Era un uomo rispettabile, ma è morto da rifugiato. Quando
arriverà la mia ora, spero ardentemente di lasciare al mio popolo un
passaporto, uno Stato su una parte della nostra terra e un’identità
riconosciuta [...] Hajj Amin era un uomo forte, ha combattuto i suoi nemici
284
Tra l’incudine araba e il martello israeliano
con mano ferma. Io invece preferisco incoraggiare tutte le correnti che
compongono il mosaico del nostro popolo, perché possano coabitare sotto
il tetto dell’OLP e la nostra lotta prosegua». ‘Arafât è morto lontano dalla
patria dove ha vissuto gli ultimi giorni da assediato in casa sua, nel «soggiorno
obbligato» di Ramallah, e privo di quell’autorità che forse Israele non ha
mai veramente pensato di riconoscergli.
‘Arafât non ha nominato ufficialmente un vice e la normativa del
Consiglio legislativo palestinese prevede un iter preciso che, pur concedendo
al Presidente del consiglio i poteri lo fa solo per sessanta giorni al termine
dei quali devono svolgersi delle elezioni.
La successione, come dimostrano i recenti fatti, sarà probabilmente non
facile. Accetteranno i palestinesi il «moderato» Abû Mâzen che, come Abû
‘Alâ, non ha molto credito presso il proprio popolo e gode del gradimento
statunitense e israeliano?
Dotato forse di un carisma che gli permetterebbe di raccogliere l’eredità,
più che altro simbolica, di ‘Arafât, è un membro del Consiglio legislativo e
segretario generale di al-Fatâh in Cisgiordania: il leader dei Tanzîm, Marwân
Barghûtî, ospite chissà per quanto tempo delle carceri israeliane, per la
tranquillità dei «moderati». Non esclusa l’eventualità che l’Anp diventi l’alter
ego del governo israeliano nei Territori occupati, ad occupare il campo della
resistenza rimarrà probabilmente Hamâs, cui, nonostante la continua
eliminazione dei suoi vertici (o forse proprio per questo), guardano molti
palestinesi; del resto sembra l’unica organizzazione a preoccuparsi di dare
scuole, assistenza e servizi concreti alla povera gente.
Leader sanguigno (con la grinta del leone, in mezzo alle macerie del suo
quartier generale, giurava «Vedrò lo Stato palestinese!») che nella sua esistenza
ha alternato sventure e successi, scampando a rivolte intestine, complotti e
attentati, il fortunato ‘Arafât ha visto spesso in faccia la morte che, a differenza
della malattia, lo ha tuttavia sempre risparmiato: durante il settembre nero
del 1970 in Giordania, durante l’invasione israeliana del Libano nel 1982,
quando nel 1985 il nemico sferrò contro la sua base di Tunisi un raid aereo.
Agli occhi del suo popolo che spesso in passato lo ha adorato, anche perché
lo ha visto scampare alle situazioni più drammatiche, quando tutti lo
dicevano finito («Abû Ammâr non è morto!» gridava la folla ai funerali), ha
avuto un unico sogno: la creazione di uno Stato palestinese. Per questo
sogno, come gli aveva raccomandato il Mufti, ha rifiutato di integrare se
stesso e il suo popolo nel mondo arabo, nonostante la lingua comune e la
retorica del panarabismo. I palestinesi sono sempre stati stranieri, in Egitto,
285
Stefano Fabei
in Tunisia, in Kuwait e tali si sono sentiti. Anche per questo per decenni il
suo popolo lo ha amato, nonostante ne condannasse i cedimenti e ritenesse
un fallimento la gestione, spesso corrotta, dell’Autorità autonoma palestinese.
Ha impersonato la speranza del riscatto, facendo rinascere, pur tra tante
sconfitte e umiliazioni, l’orgoglio e l’identità di un popolo.
Nonostante la svolta moderata da lui promossa nell’ultimo ventennio
dello scorso secolo – svolta che lo ha portato ad accettare le risoluzioni delle
Nazioni Unite sulla Palestina, a riconoscere lo Stato ebraico, a rinunciare
all’arma del terrorismo ...– nonostante il progetto di un proprio Stato che
avesse sede nei Territori occupati, Abû Ammâr è stato l’ultimo esponente
della «vecchia guardia» dell’OLP, di quella mentalità combattiva propria di
uomini, come Abû Jihâd e Abû ‘Iyâd, che avevano dato la vita per garantire
ai palestinesi una terra, la loro terra, in cui vivere in pace. Pure nelle incertezze
e nelle troppe (o troppo poche, obietterà qualcuno ...) concessioni a Israele,
Abû Ammâr rimane un simbolo, il capo della comunità palestinese.
Bibliografia
ARAFAT Y., La terra e la pace, Manifestolibri, Roma 1996; DELEUZE G., Grandezza
di Yasser Arafat, Cronopio, Napoli 2002; FABEI S., Una vita per la Palestina, Mursia,
Milano 2003; FRASER G. T., Il conflitto araboisraeliano, Il Mulino, Bologna 2004;
HART A., Arafat terrorista o pacifista, Frassinelli, Milano 1984; GOWERS A. - WALKER
T., Yasser Arafat e la rivoluzione palestinese. Dalla nascita di al Fatah alla storica stretta
di mano di Washington, Gamberetti, 1994, Gamberetti, Roma 1994; GROSSMAN D.,
La guerra che non si può vincere: Cronache dal conflitto tra israeliani e palestinesi,
Mondadori, Milano 2003; KAPELIOUK A., Arafat l’irriducibile, Ponte alle Grazie, Milano
2004; MORRIS B., Vittime, Storia del conflitto arabo-sionista 1881-2001, RCS Libri,
Milano 2001; POLITO E., Arafat e gli altri, Datanews, Roma 2002; REINHART T.,
Distruggere la Palestina, Tropea, Roma 2004; RUBINSTEIN D., Il mistero Arafat, Utet,
Torino, 2003; SAID E. W., Tra guerra e pace, Feltrinelli, Milano 1998; Origini n.18 Palestina, S.E.B., Milano 2002; RUBINSTEIN D., Il mistero Arafat, Utet, Torino 2003;
SAID E. W., Tra guerra e pace, Feltrinelli, Milano 1998.
286
L’Italia fascista contro tutti in un ventennio di guerre dissennate
rassegna bibliografica
L’Italia fascista contro tutti
in un ventennio di guerre dissennate
di Angelo Del Boca
Un particolare, certo non irrilevante, che sfugge sovente ai nostalgici
del fascismo, è che il ventennio di Mussolini è stato, senza interruzioni, un
ventennio di guerre. Guerre in Africa, in Europa, su scala mondiale, che
hanno depauperato il paese, impedito lo sviluppo del Meridione, causato
danni immani e centinaia di migliaia di morti, provocato odi e risentimenti
che il tempo non riesce ancora a cancellare.
Di questo ventennio di violenze e di sangue ci parla oggi Giorgio Rochat
con il volume Le guerre italiane 1935-1943. Dall’impero d’Etiopia alla disfatta
(Einaudi, Torino 2005, pp. 460). Si tratta della sintesi più completa, più
aggiornata e più acuta prodotta sino ad oggi e, come precisa l’autore, si
tratta di «una storia militare che lasci sullo sfondo la politica estera,
l’economia e la società [...], una storia militare che sia leggibile, senza troppi
tecnicismi». È un compito, quello della leggibilità e della chiarezza, che
Rochat assolve da grande storico, denunciando non soltanto la follia delle
guerre fasciste, ma anche l’incapacità degli Stati maggiori a gestire le forze
armate, la preparazione bellica, la stessa difesa della penisola.
Prima di occuparsi dell’aggressione all’Etiopia, nell’ottobre del 1935,
Rochat esamina brevemente le varie fasi della riconquista della Libia, che
era andata quasi totalmente persa nel 1915 in seguito alla «grande rivolta
araba», e giustamente indica nella deportazione dei 100 mila abitanti del
Gebel Achdar e della Marmarica «forse il crimine più grave del colonialismo
italiano».
Alla conquista dell’Etiopia e all’edificazione dell’impero nel Corno
d’Africa Rochat dedica un centinaio di pagine, sottolineando l’avventurismo
del quadrunviro De Bono, la lucidità del maresciallo Badoglio nell’indicare
tempi e modi dell’offensiva, e il ruolo determinante di Mussolini nella
287
Del Boca
preparazione e conduzione dell’impresa. Per questa avventura, che deve
vendicare l’onta di Adua e dare al regime prestigio e potenza, il duce non
lesina uomini e mezzi, ricorrendo persino alle armi chimiche e ipotizzando
addirittura l’impiego degli aggressivi batteriologici. Data la straordinaria
supremazia delle armate fasciste e l’uso sistematico dell’iprite e del fosgene,
Badoglio e Graziani impiegano soltanto sette mesi a stroncare la resistenza
etiopica ed a costringere l’imperatore Hailè Selassiè a prendere la via
dell’esilio. Molto più difficile e costosa si rivela invece l’impresa di occupare
integralmente l’impero, ancora presidiato in talune regioni dai resti
dell’esercito abissino, e dove, col tempo, si sviluppa una nuova opposizione
armata, quella degli «arbegnuoc», dei partigiani, decisi a contrastare con
ogni mezzo la dominazione italiana.
Mussolini continua ad inviare per anni truppe e mezzi in Etiopia e si
indigna nel constatare che i focolai di resistenza si moltiplicano anziché
diminuire. «Non riusciva a capire - osserva Rochat - quanto fosse difficile
impiantare il dominio italiano su un territorio così vasto, complesso e
tradizionalmente bellicoso; per lui l’impero era soltanto un palcoscenico
per un’esibizione di forza e fermezza».
Per quanto il sovrintendente agli Scambi e Valute, Guarneri, non perda
occasione per ripetere a Mussolini «che ogni prelievo di oro dalla riserva
segna un passo avanti sulla china verso l’insolvenza, cioè verso l’abisso», il
duce, senza consultare e coinvolgere re Vittorio Emanuele III, il capo di
Stato maggiore generale Badoglio e lo stesso gruppo dirigente fascista, si
getta nel 1936 in una nuova, costosissima avventura, partecipando con 50
mila uomini alla guerra di Spagna, ovviamente dalla parte di Francisco
Franco. Ed anche in questa «crociata» contro i «rossi» non riscuote in Italia
lo stesso consenso registrato in occasione dell’invasione dell’Etiopia,
Mussolini non bada a spese e svuota i propri arsenali per sostenere lo sforzo
dei nazionalisti. E non lo frena, nel suo intento, neppure la batosta subita
dalle truppe italiane a Guadalajara. Precisa a questo riguardo Rochat:
«Guadalajara fu una sconfitta cercata, non si può dire altrimenti dinanzi a
una battaglia impostata e condotta con tanta superficialità e una tale
sottovalutazione del nemico e delle condizioni ambientali». Ma ciò che
brucia di più a Mussolini è che le sue camicie nere, che dopo l’impresa
d’Etiopia pensava fossero imbattibili, siano state battute, travolte, costrette
alla fuga da altri italiani, non educati all’insegna del littorio ma decisi
oppositori del fascismo.
Tanto la campagna per la conquista dell’Etiopia che il concorso nella
288
L’Italia fascista contro tutti in un ventennio di guerre dissennate
guerra civile spagnola non forniscono - fa osservare Rochat - che un solo e
negativo risultato: quello di incidere «profondamente sulle riserve materiali
e armamenti dell’esercito». Quando l’Italia, perseverando nella folle politica
espansionistica del duce, entrerà nel 1940 in guerra a fianco della Germania
nazista, si troverà con gli arsenali semivuoti. «Il dato più evidente - scrive
Rochat - riguarda gli automezzi, 16 mila inviati in Etiopia e 7.500 in Spagna,
che mancheranno nel 1940. Il che pone due problemi, la priorità della
politica di Mussolini e l’incapacità dell’industria nazionale di sostituire questi
materiali». E di produrne dei più moderni.
Ma non sono soltanto gli automezzi che mancano alle forze armate.
L’Italia entra in guerra con 54 tipi di cannone diversi, in gran parte ferri
vecchi; con carri armati da tre tonnellate mentre gli avversari mettono in
campo carri da 20 e 30 tonnellate; con apparecchi da caccia che sviluppano
400 chilometri orari mentre quelli inglesi superano i 600. E se la Marina
può vantare superbe corazzate da 35 mila tonnellate ed una flotta di
sommergibili di tutto rispetto, essa resterà però sempre sulla difensiva per
non essersi dotata dei radar e delle portaerei. Si aggiungano il disastro di
Taranto e la sconfitta di capo Matapan e il quadro dello sfacelo della Marina
sarà completo. «La realtà - scrive Rochat - è che nel primo anno di guerra la
Marina pagò il prezzo di una ricerca di potenza che aveva puntato tutto
sulle grandi corazzate e i rapidi incrociatori, da impiegare con prudenza
perché insostituibili, senza la necessaria attenzione al ruolo crescente
dell’aviazione e al progresso tecnologico».
Con questa somma di errori e di deficienze l’Italia fascista non poteva
che collezionare sconfitte su tutti i fronti. La mancanza di addestramento e
le scarse motivazioni provocavano, per cominciare, la disastrosa ritirata in
Grecia, seguita dall’indecoroso ripiegamento delle armate di Graziani in
Africa Settentrionale. E mentre l’impero, voluto da Mussolini per puro
prestigio, cadeva per l’impossibilità di rifornirlo di uomini e mezzi, l’Italia
si impegnava nei Balcani senza valutare le enormi difficoltà a fronteggiare
una guerriglia insidiosa ed estremamente motivata. Ma il peggior disastro
si registrava in Russia. Una campagna per la quale Mussolini aveva fornito
le armi più moderne e le migliori truppe alpine. Attaccata da quattro armate,
che disponevano di 1.170 carri e 5.600 cannoni, l’ARMIR si batteva bene,
ma presto era costretta ad abbandonare la linea del Don e ripiegare per 120
chilometri, senza mezzi di trasporto, continuamente battuta dall’artiglieria
e dall’aviazione. Si faceva strada combattendo e seminando di morti la steppa
innevata, in un calvario che non ha precedenti nella storia del nostro esercito.
289
Del Boca
Giorgio Rochat conclude la sua accurata ricerca stilando un bilancio
delle vittime del conflitto. Un bilancio che costituisce la più dura e definitiva
condanna del regime fascista. Le perdite italiane dal 10 giugno 1940 all’8
settembre 1943 sono così ripartite: morti sul territorio nazionale, 60 mila
(tra cui 25 mila civili); nella guerra contro la Grecia: 20 mila; nel corso
delle occupazioni balcaniche: 10 mila; in Africa Orientale e Settentrionale:
20 mila; nella campagna di Russia: 80 mila; morti in mare: 30 mila; per
cause diverse: 5 mila. A questi 225 mila morti vanno aggiunti i caduti nel
periodo che va dall’armistizio dell’8 settembre 1943 alla fine della guerra,
che sono altri 230 mila, per un totale di 455 mila deceduti. Si aggiungano
i feriti e i prigionieri (più di un milione e duecentomila), molti dei quali
trascorsero in cattività sino a sei anni, in condizioni precarie quando non
erano intollerabili.
«La fine della guerra fascista - scrive Giorgio Rochat - fu duramente
pagata dal paese e dalle forze armate, ma anche accompagnata da momenti
e movimenti di riscatto e rinnovamento che chiamiamo resistenza, quanto
mai diversi, ma uniti contro il nazifascismo. Una resistenza che ha quattro
«fronti». Il primo in ordine cronologico fu la cosiddetta resistenza militare,
i combattimenti contro i tedeschi delle forze armate nel settembre del 1943,
che una minoranza proseguì fino al 1944 con i partigiani jugoslavi e albanesi.
Poi ci furono la guerra partigiana, la resistenza nelle città e nelle fabbriche,
la deportazione politica. Terzo, la partecipazione delle forze armate nazionali
alla guerra di liberazione a fianco degli anglo-americani. Infine la resistenza
senz’armi dei 650mila soldati e ufficiali nei campi tedeschi di prigionia».
Lo storico valdese non dimentica neppure i 7.300 ebrei italiani, «mandati a
morire soltanto perché la bestialità nazifascista li considerava di razza
inferiore».
290
La fiaba vera e triste della «principessa etiope»
La fiaba vera e triste della «principessa etiope»
di Nicola Labanca
Sappiamo poco della classe dirigente etiopica della prima metà del
Novecento, che per semplicità definiamo «aristocrazia» (ma l’Etiopia dei
negus era una terra feudale?) e che forse meglio potremmo chiamare ceto
notabilare.
La documentazione scritta che ne rimane è ristretta, ci dicono gli etiopisti.
Mancano le cronache, come quelle antiche. L’assenza di queste fonti è
insufficientemente rimpiazzata dagli archivi coloniali, nelle cui carte i nomi
di questo o quel ras, di questo o quel degiac compaiono nei rapporti degli
osservatori segreti europei o nei documenti, talora imbarazzanti, che
comprovano il collaborazionismo di una parte di quei notabili. Anche
nell’autobiografia di Haile Selassie i nomi e le vicende di questa classe
dirigente, che pure deteneva il potere (politico, economico, militare,
religioso) a livello regionale, compaiono assai raramente: tutti sono
invariabilmente ossequiosi del negus - cosa che, sappiamo, non sempre
avvenne.
Ora disponiamo della Memoria di una principessa etiope (Neri Pozza,
Vicenza 2005, pp. 254): più esattamente di Martha, la seconda figlia della
terza moglie di degiac Zamanuel Nasibù, nato nel 1895 e divenuto kantibai
ad Addis Abeba accompagnando la modernizzazione voluta da ras Tafari
poi negus Haile Selassie. Nasibù fu uno dei comandanti (assieme a ras Desta)
della guerra etiopica sul fronte somalo nel 1935-36 e uomo di fiducia del
negus al punto da essere inviato a Ginevra per fungere da contatto con la
Società delle nazioni, presso la quale l’Etiopia invano protestò contro
l’aggressione italiana. Per via di questa missione Nasibù sfuggì alla
deportazione che colpì invece una parte importante dell’«aristocrazia» e del
notabilato etiopico all’indomani dell’invasione italiana: e che colpì anche i
suoi familiari (moglie, figli e parenti) nel 1937. Sfuggito alla deportazione
Nasibù non sfuggì alle conseguenze della guerra, che lo portarono alla morte
appunto a Davos, in Svizzera, nell’ottobre 1936.
291
Nicola Labanca
La figlia Martha Nassibou, che per cultura di formazione e per scelta
finale di residenza (vive ora a Perpignan) avrebbe usato il francese ma che
qui si firma Nasibù, alla maniera dell’età coloniale, racconta in queste pagine
gli eventi della propria infanzia: l’ambiente in cui nacque e fu cresciuta, il
prestigio sociale e politico guadagnato del padre, le vicende della guerra e
soprattutto la lunga, dolorosa deportazione dall’Etiopia in Italia cui di fatto
fu costretta la sua famiglia fra 1937 e 1945: un’Italia, quindi, fra fascismo,
guerra, Resistenza e conquista della democrazia.
Se dovessimo fare uno scrutinio filologico dovremmo notare che, nata
del 1931, Martha era troppo piccola per avere ricordi precisi dei suoi
primissimi anni: infatti dichiara esplicitamente che parte di queste memorie
sono la trascrizione dei racconti che la madre Atzede le faceva, forse anche
per tener viva nei figli deportati l’identità etiopica e «nobiliare». Inoltre la
stesura che oggi viene pubblicata pare risentire (beneficamente) non poco
di un lungo lavoro di «pulitura» di Angelo Del Boca, che sicuramente ha
perfezionato letterariamente l’esposizione e probabilmente vi ha disseminato
qua e là, a beneficio del lettore comune (che altrimenti non avrebbe potuto
orientarsi all’interno della vicenda complessa e poco nota della deportazione
dei notabili etiopici) indicazione di fatti, date ed elementi fattuali.
Ma è impossibile fermarsi a tale scrutinio soprattutto perche è impossibile
sfuggire al fascino della narrazione di Martha Nasibù.
Il libro scorre via come un romanzo e la scrittura è avvolgente, con le
sue descrizioni di ambienti, di colori, di odori così nitidamente impressisi
nella memoria di Martha. Una magnifica fotografia di copertina la ritrae in
primo piano con occhi grandi, neri ed ammiccanti, nella sua giovanile
bellezza adorna di un diadema tradizionale e di uno sciamma candido e vaporoso,
presentandosi proprio come solo una «principessa» sogniamo possa fare.
Il volume si articola in due parti. La prima si concentra sul periodo
precedente all’abbandono dell’Etiopia nel gennaio 1937. In queste pagine
il lettore è introdotto alla singolare commistione di usanze tradizionali e di
aperture moderniste che caratterizzavano la vita quotidiana del notabilato
etiopico dei primi anni trenta. Il rispetto dei riti più antichi e la macchina
Fiat alla porta, l’osservanza dei precetti religiosi più stretti e l’uso della lingua
francese per l’educazione dei figli, l’alimentazione rigorosamente locale e
gli acquisti di mobilia e vestiti provenienti (con le difficoltà dei tempi...)
dall’Europa, l’enfasi delle tradizioni guerriere «indigene» e la frequentazioni
delle migliori scuole militari del vecchio Continente (Saint Cyr), la
perpetuazione delle credenze più antiche e meno scientifiche e la curiosità
292
La fiaba vera e triste della «principessa etiope»
seguita dall’adozione dei mezzi tecnologici più aggiornati per il tempo
convivevano nella famiglia Nasibù quale Martha ce la descrive. Ripensando
alla propaganda fascista, tesa a delegittimare e a criminalizzare la figura del
Negus e tutta la classe dirigente etiopica bollate di «barbarie», «schiavismo»
e «inciviltà», quanto diverso è il ritratto dall’interno disegnatoci da Martha.
Le pagine odierne di Martha riflettono quelli che potevano essere i margini
di osservazione di una bambina del tempo: non spiegano quindi in quanto
tempo, come e sulla base dello sfruttamento di quale lavoro contadino si
erano accumulate le straordinarie ricchezze dell’«aristocrazia» etiopica dei negus
e dei ras o anche solo del notabilato dei degiac. Il suo sguardo dall’interno,
però, è di una straordinaria vividezza.
La seconda parte è dedicata alle peregrinazioni cui l’abbandono
dell’Etiopia costrinse la
madre di Martha (e già la
provenienza di questa
donna meriterebbe tutto
un altro libro suo proprio:
figlia del fitaurari Ivan
Babitcheff, venuto dalla
Russia in Etiopia nel
1896 e lì rimasto,
raggiunto poi da altra
nobiltà russa ostile alla
Rivoluzione dell’Ottobre
1917) con i suoi tre figli
e qualche parente più
stretto. Dopo l’occupazione italiana di Addis
Abeba nel maggio 1936,
alle primi avvisaglie della
«maniera forte» fascista
nei confronti del
notabilato etiopico e
ancor prima delle brutalità
seguite all’attentato a
Graziani del febbraio
1937, la moglie di Nasibù
avrebbe chiesto al vicerè
Martha Nasibù
293
Nicola Labanca
l’autorizzazione ad accompagnare i propri figli in Italia. Tenuta sott’occhio
in quanto moglie di uno dei principali avversari, militari e diplomatici,
dell’aggressione fascista, Atzede Nasibù avrà forse voluto - con una scelta
che qui viene presentata autonoma - anticipare, smussare, deviare quelle
che avrebbero potuto essere le eventuali più pesanti decisioni del potere
italiano di Addis Abeba. (Questa vicenda, fra l’altro, suggerisce di utilizzare
con cautela i documenti coloniali: chi, imbattendosi negli archivi coloniali
di questa supplica, e non avendo a disposizione - come invece adesso ha - la
versione dell’altra soggettività, etiopica, coinvolta, non avrebbe potuto
giudicare per collaborazionismo, o per debolezza, una simile scelta?)
Fatto sta che, evitando molto probabilmente conseguenze più
drammatiche e forse fatali, la scelta della famiglia Nasibù aprì una vicenda
nient’affatto «facile». Fra gennaio 1937, quando Martha e i suoi lasciano
l’Etiopia, e l’aprile 1945, quando vi faranno ritorno, moglie e figli di Nasibù
vengono rigidamente controllati dalla macchina spionistica del regime,
conoscono la realtà di un paese ormai sottoposto ad una legislazione razziale
e in cui la popolazione è divisa fra semplici pregiudizi etnografici e veri e
propri razzismi diffusi, soprattutto vengono continuamente spostati da una
località ad un’altra quasi a voler fiaccare definitivamente l’orgogliosa identità
di far parte della nobiltà etiopica dei Nasibù, per i quali l’osservanza delle
antiche tradizioni e il mantenimento del precedente stile di vita è reso
impossibile. Nei quasi otto anni di esilio, essi vengono spostati a Napoli, in
Libia, a Rodi, di nuovo a Napoli, a Tripoli di Libia, a Vigo di Fassa, a
Firenze, nella campagna aretina (a san Giustino), di nuovo a Firenze e poi
a Pozza di Fassa; nell’estate 1944 sono ancora a Firenze, ora liberata, che
poi lasceranno per Roma e Bari, in un campo di concentramento profughi
britannico, per lasciare infine la penisola ed arrivare - via Egitto, Sudan ed
Eritrea - alla tanto agognata Addis Abeba.
È impossibile riassumere qui le vicende patite, i personaggi incontrati,
gli stratagemmi ricercati dalla moglie di Nasibù - qui presentata sempre
nella sua soggettività attiva, e non come passiva sopportatrice delle tragedie
della persecuzione razziale, del fascismo e della guerra - e dai suoi piccoli,
fra cui appunto Martha, per cercare di limitare i danni già enormi dell’esilio.
I ricordi di Martha e le pagine del volume sono pieni di spunti, osservazioni,
immagini di una straordinaria ricchezza.
L’autrice avrebbe potuto scegliere, se avesse voluto, un tono d’accusa, o
anche di recriminazione. Colpisce invece un’aria leggera, quasi giocosa, in
un certo senso incantata che Martha ha voluto lasciare a questi suoi ricordi
294
La fiaba vera e triste della «principessa etiope»
infantili. Il lettore sa, e capisce, quanto dolore quest’esilio dovette arrecare
alla moglie di Nasibù, ai suoi figli strappati dalla propria terra, costretti a
cambiare scuola e amicizie e sogni ogni pochi mesi dalla logica repressiva
del regime: e l’autrice fa sentire il sottofondo di dolore della vicenda di una
famiglia precipitata dalle stelle dell’«aristocrazia» alle stalle della persecuzione
e delle case d’affitto, dei rifugi antiaerei, dell’intolleranza razziale degli italiani
nei confronti di quelli che a loro appaiono solo dei «negri». Felicemente
invece il tono della narrazione rimane aderente a quelle che, forse, furono
allora le sensazioni della piccola Martha: che appena arrivata a Napoli gioca
con i fratellini a riconoscere le macchine che passano sulla via, che vede per
la prima volta la neve, che si entusiasma per gli ottoni luccicanti del piroscafo
che conduce la sua famiglia verso la Libia (e che potrebbe portarla forse ad
una fine drammatica, se non fosse intervenuto un miracoloso contrordine),
che non capisce perche tanti bambini italiani non giochino con lei. Quando
- ormai tornati da qualche tempo ad Addis Abeba, rientrati nel loro ricercato
milieu e ripresa la strada del Vecchio Continente per intraprendere i propri
studi superiori - il fratellino le chiederà cosa ricordasse dell’Italia, Martha
risponderà: «anch’io ho dei bei ricordi dell’Italia!»
Se è un buon libro, un libro di memorialistica è sempre sospeso fra la
documentazione e la letteratura. Questo di Martha Nassibou è un toccante
documento di un passato assai poco noto che però colpisce ancor più proprio per
il tono e per la forma letterari, che farebbero scomodare il film La vita è bella.
Questa Memoria di una principessa etiope andrebbe letta nelle scuole e
raccontata agli scolari italiani odierni, coetanei di Martha, per capire - anche
se nel registro consapevolmente scelto della fiaba - cosa furono il fascismo,
il colonialismo, il razzismo.
295
Nicola Labanca
296
Le schede
Le schede
GIORGIO AGOSTI, Dopo il tempo del
furore. Diario 1946-1988, Einaudi,
Torino 2005, pp. 780
Da pochi giorni ero rientrato da
un lungo viaggio nella Spagna
franchista, ed erano apparsi sulla
«Gazzetta del Popolo» di Torino le
prime due puntate della mia
inchiesta spagnola, quando Giorgio
Agosti mi telefonò per invitarmi a
passare dal suo ufficio alla Sip. Era
molto interessato alla mia inchiesta.
Voleva saperne di più. Soprattutto
ciò che, per una ragione o per l’altra,
non avrei potuto scrivere.
Ero abituato a questa affettuosa
«convocazione». Era già accaduto
più volte, in occasione di altri miei
viaggi all’estero o in seguito alla
pubblicazione di alcuni miei libri.
Per me era un piacere e un onore
sedermi con lui, nel suo austero
ufficio, ed anticipargli ciò che avrei
scritto sulle pagine della «Gazzetta»
e riferirgli anche gli episodi che avrei
sottaciuto. Il viaggio in Spagna, ad
esempio, aveva avuto una duplice
natura. Ufficialmente ero andato in
Spagna per raccontare il paese a
vent’anni dalla fine della guerra
civile, e come salvacondotto potevo
esibire alle autorità franchiste una
dichiarazione del parroco della
chiesa di Gesù Nazareno che
certificava che ero un buon cristiano.
Ma in Spagna ero andato anche per
un altro motivo. Su incarico di
Pietro Nenni avrei dovuto prendere
contatto con alcuni esponenti dello
PSOE, i cui indirizzi avevo
imparato a memoria per non
lasciare alcuna traccia nei miei
taccuini. Di questi segreti incontri,
ovviamente, non scrissi nulla, ed
invece ne parlai a lungo con Agosti,
che era, fra l’altro, come il
sottoscritto, uno dei finanziatori del
Ruedo Iberico, la casa editrice degli
antifranchisti in esilio.
A Giorgio Agosti mi legava il
fatto di aver militato, durante la
Resistenza, nelle formazioni di
Giustizia e Libertà, di cui lui era
stato commissario politico per il
Piemonte. Un legame che si era
fatto più tenace dopo il tentativo
di Tambroni di governare l’Italia
con l’appoggio determinante dei
neo-fascisti. In quei giorni
297
Le schede
dell’estate 1960 ci si incontrava
molto spesso nei locali del Circolo
della Resistenza, soprattutto dopo
gli incidenti di Genova e i morti di
Reggio Emilia. Il momento era
particolarmente grave. Bisognava
vigilare. Impedire con ogni mezzo
un ritorno del fascismo. Ricordo
che, fra tutti noi, Agosti era il più
informato, il più accorto, il più
misurato, quello che forniva
suggerimenti concreti. Non per
nulla era stato il primo questore di
Torino, nell’immediato dopoguerra, ed aveva saputo riportare la
calma e la legalità in una città
sconvolta dalla guerra civile.
Frequentandolo, la mia ammirazione per lui cresceva di giorno
in giorno e mi ero abituato a
considerarlo, con Norberto Bobbio
e Alessandro Galante Garrone, uno
dei miei maggiori, ai quali mi
ispiravo costantemente nella mia
attività di giornalista e di scrittore.
Il mio rispetto e la mia stima per
Agosti crebbero ulteriormente
quando, nel 1990, a cura di
Giovanni De Luna, apparve il libro
Un’amicizia partigiana. Lettere 19431945, che raccoglie l’epistolario fra
Giorgio Agosti e Livio Bianco
durante i venti mesi della guerra di
liberazione. Un carteggio straordinario,
unico, fra due uomini eccezionali.
Quante volte ho riletto la frase che
Giorgio scrive a Livio il 4 aprile
1944: «Questa lotta, proprio per
298
questa sua nudità, per questo suo
assoluto disinteresse, mi piace. Se
ne usciremo vivi, ne usciremo
migliori; se ci resteremo, sentiremo
di aver lavato troppi anni di
compromesso e di ignavia, di aver
vissuto almeno qualche mese
secondo un preciso imperativo
morale».
Nel 2005, a tredici anni dalla sua
scomparsa, usciva da Einaudi, a
cura del figlio Aldo e con
un’introduzione di Giovanni De
Luna, il Diario che Agosti ha tenuto
tra il 1946 e il 1988 e che ha per
titolo una frase ricavata da un testo
di Norberto Bobbio: Dopo il tempo
del furore. Si tratta di un grosso
volume di quasi 800 fitte pagine,
ma il testo originale è molto più
ampio, circa 3500 cartelle.
L’impresa di tagliare i quattro
quinti del Diario sarebbe apparsa a
qualsiasi curatore un compito
oltremodo arduo ed ingrato. Ma
Aldo Agosti ha operato efficacemente unendo alle ben note
capacità dello storico l’affetto per il
padre e la grande conoscenza della
sua storia pubblica e privata,
cosicché si può dire che la sua scelta
dei brani è stata come guidata dal
congiunto. Come precisa nella
premessa il curatore, sono state
sacrificate le cronache della vita
famigliare, le pagine dedicate ai
viaggi e le annotazioni relative alle
attività di Agosti come alto
Le schede
dirigente della Sip e poi dell’Enel.
La prima impressione che si trae
dalla lettura del Diario è la grande,
smisurata curiosità del suo autore.
Egli segue quotidianamente le
vicende della politica italiana ed
estera con la competenza dello
studioso ed insieme con la
partecipazione appassionata di un
uomo che non ha ancora deposto
le armi, che intende vigilare sul
proprio futuro, che avverte di essere
abilitato a formulare giudizi, anche
severi, anche taglienti, persino
brutali.
Ma non si accontenta della
lettura dei quotidiani (sembra
prediligere il parigino «Le Monde»)
e divora libri a centinaia rivelandosi
un lettore esigente ed inflessibile.
Boccia, ad esempio, Lessico famigliare
della Ginzburg e definisce Il tamburo
di latta di Günther Grass
«un’accozzaglia di balordaggini e di
oscenità». Del romanzo di Mario
Soldati, Le due città, scrive
lapidariamente che «nel complesso
è un brutto libro». Ma il giudizio
più severo è per I promessi sposi di
Manzoni: «L’ho dovuto lasciare con
disgusto dopo averne scorso qua e
là diverse pagine. Quella morale
rassegnata e servile è ripugnante,
specie nel mondo del Risorgimento». Ma anche Moravia non
si salva: giudica La vita interiore
«una porcheria».
Ci sono, invece, libri che lo
affascinano e che legge «avidamente». Come Freccia nell’azzurro,
autobiografia di Arthur Koestler; La
vita di Galileo di Lodovico Geymonat;
Il gattopardo di Tomasi di
Lampedusa; le Lettere dall’America
di Gaetano Salvemini; Un giorno di
fuoco di Beppe Fenoglio. Scopre e
ammira Joseph Roth (La cripta dei
cappuccini); Tiziano Terzani (Giaj
Phong); e George Orwell (Giorni in
Birmania). Dell’Ultimo fronte di
Nuto Revelli scrive: «Non si
potrebbe immaginare una condanna
più inesorabile della guerra fascista
e un più pauroso distacco tra la
classe dirigente di allora e la
popolazione».
Ma più che i giudizi sulle sue
letture colpiscono i commenti di
taglio politico, i ritratti dei
personaggi, alcuni dei quali
indimenticabili. Per cominciare il
laico Giorgio Agosti non risparmia
critiche alla Democrazia Cristiana
e, di riflesso, al Vaticano. Dopo un
incontro/scontro con il ministro
degli Interni Mario Scelba, il
questore di Torino Agosti
commenta: «Il pugno di ferro di
Scelba non è che un pugno di latta;
la sua cosiddetta maniera forte non
serve che a porre ad inutile
repentaglio l’autorità dello Stato».
Particolarmente severo anche
con i capi dello Stato. Dopo di aver
definito «ignobile» il messaggio
diffuso da Antonio Segni in
299
Le schede
occasione del 25 aprile del 1959,
Agosti scrive: «Parla della Liberazione
come si parlerebbe di una malattia
di cui si è guariti». Di Giovanni
Gronchi dice che è «un velleitario
presuntuoso» e che «prende gli
ordini dal Vaticano». Con Giovanni
Leone è spietato: «Quando vedo la
faccia di Pulcinella di questo
individuo, che impersona gli aspetti
deteriori del nostro carattere
nazionale e della nostra politica, mi
assale la solita angoscia al ricordo
dei compagni caduti nella
Resistenza per questa Italia».
Con i capi di Governo è ancora
più brutale. Definisce Amintore
Fanfani «una canaglia intrigante».
Mariano Rumor gli ricorda «un
mollusco inerte». Giulio Andreotti
viene indicato come «il più viscido
e ambiguo esponente della DC».
Commentando la formazione del
governo Tambroni con il sostegno
dei missini, scrive il 9 aprile 1960:
«È una delle giornate più tristi e
vergognose della storia di questo
dopoguerra e segna una condanna
morale senza appello per la
Democrazia Cristiana».
Dei pontefici che si succedono
tra il 1945 e il 1988, Agosti salva
Giovanni XXIII, «un papa moderno
e di sinistra», e il polacco Karol
Wojtila. Di papa Pacelli, invece,
scrive: «Rappresenta per me la
costante, coerente, fredda negazione
di tutti i valori della Resistenza e del
300
Risorgimento [...]. Non si è
schierato mai se non a favore della
reazione». Pesantissimo, infine, il
giudizio su Paolo VI , espresso il 12
maggio 1967: «II viaggio di Paolo
VI a Fatima, in programma per
domani, è una vera porcheria. Non
poteva scegliere miglior servizio a
Salazar e scegliere un peggior
momento per valorizzare una delle
più assurde superstizioni della
Chiesa moderna».
Ma i suoi giudizi non sono tutti
negativi. La sua non è l’invettiva
continua, ossessiva dell’azionista
deluso e amareggiato, che ha visto
affermarsi un’Italia troppo diversa da
quella sognata nel «tempo del
furore». Per alcuni personaggi che si
distinguono nel dopoguerra per il
dinamismo e l’onestà intellettuale ha
anzi parole di profonda stima. Scrive,
ad esempio, il 4 ottobre 1966, dopo
aver fatto visita ad Ernesto Rossi,
ricoverato in ospedale: «Val la spesa
di aver vissuto in questo secolo
agitato soltanto per avvicinare
uomini come Rossi, Calamandrei,
Salvemini. Se ho un rimpianto, è di
non averli conosciuti prima e di non
aver potuto far nulla per loro negli
anni più oscuri del ventennio».
Scrive di Riccardo Lombardi:
«Uomini così consentono di sperare
nel genere umano anche in tempi di
rivoltante conformismo».
Una sera di gennaio del 1960,
dopo aver ascoltato, estasiato, Carlo
Le schede
Dionisotti che racconta di aver
scoperto un poema cavalleresco di
Cassio di Narni, contemporaneo
dell’Ariosto, Agosti confida al suo
diario: «Come invidio questa
continua eccitante avventura
intellettuale, a cui si abbandonano
gli amici universitari, ogni anno più
padroni dei loro mezzi tecnici, più
maturi nelle loro valutazioni, più
invogliati a proseguire». C’è
ammirazione sincera in queste
parole, ma anche una sottile invidia.
Agosti, infatti, non è soddisfatto per
il lavoro che svolge alla Sip: «L’ansia
con cui vedo giungere la fine della
settimana di lavoro è la prova del
peso crescente di questo lavoro che
non mi interessa e in cui non vedo
possibilità di avvenire. Ogni
tentativo di impostare problemi
nuovi con criteri organizzativi
moderni urta contro la divisione
della società in compartimenti
stagni, chiusi e ostili fra loro. [...].
Quante energie sorte negli anni
della Resistenza che vanno sciupate
in questo modo!».
Severo con tutti, Agosti lo è in
modo particolare con se stesso.
Scrive nel diario il giorno in cui
lascia definitivamente il lavoro: «È
l’ultima fase della mia vita
lavorativa: e in fondo non si può
dire che gli anni passati all’Enel
siano stati per me pieni di successi.
Ma quando mai ho avuto successo
nella vita?». Qui l’autocritica
raggiunge il culmine, si trasforma
in ingiusta autoflagellazione. Perché
non è vero che Giorgio Agosti non
abbia conseguito successi. Non
soltanto è stato uno dei pilastri della
Resistenza in Piemonte, un
eccellente servitore dello Stato ed un
attivo dirigente industriale. È stato
anche un grande animatore di
cultura attraverso il mensile
«Resistenza» e poi sponsorizzando
il Centro studi «Piero Gobetti» e
infine l’Istituto storico della
Resistenza di Torino, che oggi porta
il suo nome.
Riflettendo, un giorno, sulla
parte che gli è stata riservata dal
destino di «far anticamera presso i
potenti della terra, per cavarne gli
scarsi aiuti che consentono di vivere
alle iniziative laiche», annota nel
diario: «Questo accattonaggio a
volte mi umilia e mi deprime; ma
mi angoscia il pensiero che quando
non ci sarò più (o non avrò più la
posizione di relativa influenza che
ho attualmente) tutto si fermerà e
il Centro non avrà più un soldo».
Severo con se stesso sino al
punto di dubitare della stessa
validità ed opportunità del proprio
diario, scrive il 17 ottobre 1960:
«Sette anni ormai che scarabocchio
con poco costrutto questi fascicoli,
più per ostinazione contro la voglia
di piantar lì che per convinzione.
Sarebbe meglio a un certo punto
bruciar tutto». E invece, fortu301
Le schede
natamente per noi, continua a
tenere il diario sino al 9 giugno
1988, quando si arrende e annuncia
malinconicamente: «Penso che
queste saranno le ultime note su
questo inutile diario. La vista va
peggiorando e alle difficoltà della
scrittura si unirà presto l’impossibilità della lettura. [...]. Senza
ambizioni sono vissuto e con ben
poche illusioni, senza fedi
trascendenti e con fedi immanenti
sempre più incerte e oscillanti. Ma
non può essere lontano il momento
in cui quell’incomprensibile
commedia della vita volgerà alla
fine».
Giunti alla fine del diario,
avvertiamo impellente il desiderio
di leggere l’originale, quella
sterminata cronaca giornaliera di
3.500 cartelle. Perché vorremmo saperne di più di questo
straordinario personaggio che
abbiamo amato e venerato. Ci sarà,
in Italia, un editore tanto illuminato e coraggioso da prendere
in considerazione la stampa
integrale di Dopo il tempo del furore?
(Angelo Del Boca).
GIOVANNI PESCE, FABIO MINAZZI,
Attualità dell’antifascismo, La città
del sole, Napoli 2004, pp. 199
F RANCO G IANNANTONI , I BIO
PAOLUCCI, Giovanni Pesce «Visone»
un comunista che ha fatto l’Italia,
Edizioni Arterigere-EsseZeta,
Varese 2005, pp. 365
Il volume Attualità dell’antifascismo
nasce dall’incontro avuto da Pesce
con gli studenti del liceo scientifico
Galileo Ferraris di Varese ed in
questo senso è da intendersi come
un invito rivolto alle giovani
generazioni a non dimenticare ciò
che è stata la Resistenza. Il testo ha
però soprattutto l’obiettivo di
ribadire il valore ed il significato
storico della lotta antifascista contro
il revisionismo volto a negare o
sminuire il portato di questo
periodo della storia italiana.
L’opera è strutturata in due parti cui
si aggiunge un poscritto. La prima
- composta da un’intervista dibattito con Pesce, da un saggio
dello stesso e dai contributi di Fabio
Minozzi e Franco Giannantoni descrive la vita e l’opera del
Giovanni Pesce «Visone» è uno dei
più importanti personaggi della
Liberazione italiana: è stato
comandante dei Gruppi di azione
patriottica di Torino e Milano, ha
compiuto importanti e numerose
azioni contro le forze nazifasciste,
dopo la guerra ha ottenuto la
Medaglia d’oro al valore militare, è
stato responsabile della Commissione
di vigilanza del Partito comunista
italiano.
302
Le schede
comandante gappista, tratta il tema
del valore e del significato dei Gap
nella guerra di Liberazione, nonché
omaggia la figura di Dante Di
Nanni, morto dopo una strenua
battaglia contro un folto gruppo di
nazifascisti. Nella seconda parte,
invece, Minazzi discute dell’attualità
dell’antifascismo, osservando come
vi sia stata una sconfitta «politica»
della Resistenza, come «nella storia
della genesi della Repubblica
italiana la continuità abbia
nettamente prevalso e si sia
nettamente affermata a discapito
della discontinuità» e come il
fascismo-istituzionale sia uscito
sostanzialmente indenne dalla
bufera seguita al crollo del
«fascismo-di-facciata». Infine il
poscritto ribadisce quanto ancora
oggi vi sia una forte necessità di
antifascismo, poiché esso «ha
rappresentato (e rappresenta) il
massimo pericolo per coloro i quali
difendono, invece, un’Italia dei
privilegi, delle caste, del dominio
di alcuni specifici ceti e dei
molteplici piccoli dittatori che
sempre si incistano all’interno delle
differenti strutture istituzionali
facendo strame delle norme e delle
regole».
Giovanni Pesce «Visone» un
comunista che ha fatto l’Italia è,
invece, principalmente un libro
storico, volto a far conoscere a
coloro che sono nati dopo la
Resistenza alcuni degli aspetti
fondamentali di questa stagione
della storia italiana e mondiale.
Tutto il testo è basato sulle
domande-interviste di Franco
Giannantoni e Ibio Paolucci al
comandante dei gappisti torinesi;
l’opera infatti ripercorre tutti i
momenti della vicenda umana,
militare e politica di Pesce.
Partendo dall’infanzia passata nelle
miniere francesi, egli accompagna
il lettore tra i suoi ricordi: narra così
della sua decisione, maturata nel
1936 nel clima dell’internazionalismo antifascista, di partire
per la Spagna a combattere le truppe
di Francisco Franco. Fu questa
l’esperienza che, come egli ha avuto
modo varie volte di sottolineare, più
lo segnò nel cuore, e fu anche il
momento in cui conobbe alcune
delle persone che, una volta caduto
il regime fascista faranno assieme a
lui la storia della Resistenza italiana.
Dopo la sconfitta delle forze
repubblicane nella guerra civile
Pesce tornò per breve tempo in
Francia, fino al momento in cui, in
seguito alla vittoria delle truppe
italiane e tedesche, venne insieme
ad altri antifascisti prima
imprigionato e poi relegato al
confino a Ventotene. L’isola pontina
emerge con nitore dalle sue
testimonianze: lì egli conoscerà
ulteriori importanti figure della
303
Le schede
futura Resistenza e della storia
repubblicana italiana quali
Giuseppe Di Vittorio, Sandro
Pertini, Luigi Longo, ma
soprattutto Umberto Terracini,
Arturo Colombi e Camilla Ravera.
Proseguendo sul filo cronologico
che domina l’impostazione del
testo, con il crollo del regime fascista
si apre la stagione gappista di Pesce.
Fu proprio a Torino che egli
ricevette per la prima volta l’ordine
di colpire un fascista, e fu nei pressi
del torrente torinese Stura che egli
vide la strenua battaglia di Dante
di Nanni contro le forze nazifasciste.
Poi venne il trasferimento a Milano,
città nella quale vide arrestare colei
che dopo la guerra diventerà sua
moglie, Onorina «Sandra»
Brambilla.
Dei primi anni del dopoguerra,
Pesce fa proprie nel racconto le
vicende del travaglio del mondo
partigiano, del fedele rapporto che
ebbe con il Partito comunista anche
quando, pur non condividendola,
accettò la decisione di Togliatti di
concedere l’amnistia agli ex-fascisti.
E poi ancora, sempre esplicitate con
chiarezza, altre luci ed ombre del
periodo 1945-48, tra le quali la
vicenda della «Volante rossa» di
Milano, la medaglia d’oro al valor
militare, la sconfitta del Fronte
popolare e l’incarico come
responsabile della Commissione di
vigilanza del partito. Ed infine,
giungendo ai giorni nostri, la
personale analisi e la propria
testimonianza sul «caso Seniga»,
sugli anni della tensione,
sull’amicizia con Giangiacomo
Feltrinelli e sulla fine del Pci.
A corredo di questo spaccato della
vita di colui che divenne uno dei
più prestigiosi uomini della
Resistenza, e a corollario della
narrazione di più di ottant’anni di
storia d’Italia, il testo contiene in
appendice ed al proprio interno
un’ampia rassegna di fotografie oltre
che approfondite note a piè di
pagina, volte a illustrare le vicende
biografiche di svariati personaggi
dell’opposizione al fascismo (Matteo
Vecchia).
GIANNI DORE, Scritture di colonia.
Lettere di Pia Maria Pezzoli
dall’Africa Orientale a Bologna
(1936-1943), Bologna, Pàtron
Editore, 2004, pp. 266.
Presso la Biblioteca comunale
dell’Archiginnasio di Bologna è
depositato un archivio privato di
grande rilievo per la ricostruzione
storica del colonialismo italiano in
304
Le schede
Africa Orientale. Si tratta del
fondo archivistico denominato
Fondo Speciale Pia Maria Pezzoli e
Giovanni Battista Ellero, donato nel
2004 a tale biblioteca dagli eredi
dei coniugi bolognesi Pia Maria
Pezzoli e Giovan Battista Ellero,
importante funzionario coloniale
dell’Africa Orientale Italiana.
Questo corpus documentario si
aggiunge idealmente al Fondo di
etnografia e storia coloniale ElleroPezzoli, conservato presso il
Dipartimento di studi storici
dell’Università degli studi di
Bologna, dove prolungate indagini
condotte da autorevoli studiosi
hanno già prodotto frutti pregevoli.
Tra questi, Gianni Dore è ben noto
per i suoi studi e le sue pubblicazioni
su Ellero, del quale ha ricostruito la
vicenda, arricchendo il panorama
degli studi etno-antropologici
italiani condotti in epoca coloniale.
Nel 1936, Pia Maria Pezzoli seguì
il marito Giovan Battista Ellero in
Etiopia, condividendone onori e
disagi fino all’internamento di lui,
dopo il tracollo delle forze italiane
nel secondo conflitto mondiale, e
alla sua tragica scomparsa
nell’affondamento del Nova Scotia
nel novembre 1942. I carteggi
intrattenuti dalla Pezzoli durante la
sua permanenza in Africa Orientale,
sia con la famiglia in Italia sia con il
marito, nel periodo dell’internamento, si snodano lungo un arco
temporale che ricalca, grosso modo,
l’esistenza dell’Impero coloniale
italiano, avendo come estremi il
1936 e il 1943. L’attento, paziente
spoglio di questo epistolario ha
consentito a Gianni Dore di
ricostruire storicamente aspetti
tanto significativi quanto finora
poco esplorati dalla storiografia: la
visione femminile della colonizzazione italiana dell’Africa e la
quotidianità del vivere in colonia.
La storia di genere per l’ex Africa
italiana annovera ancora pochi
contributi, se si escludono i lavori
di Carla Ghezzi e di Giulia Barrera
e il rilievo dato da Nicola Labanca
agli scritti autobiografici femminili
sulle esperienze di vita vissuta in
Africa, mentre studiose quali la
stessa Barrera, Gabriella Campassi
e Barbara Sorgoni, hanno posto al
centro delle loro ricerche le relazioni
tra uomini italiani e donne
autoctone. L’epistolario di Pia
Maria Pezzoli ci restituisce
un’inusuale quanto più preziosa
testimonianza del quotidiano
coloniale.
Anna Maria Gentili, nella
presentazione al volume Scritture di
colonia, introduce il ritratto di
questa donna singolare per cultura
e temperamento, ne coglie acutamente l’atipicità del suo stare in
colonia «aliena da ogni esotismo»
ed elogia la «sapienza e sensibilità»
di Gianni Dore nell’accompagnare
305
Le schede
il lettore tra le righe della Pezzoli.
Esemplare è, infatti, l’articolata
disamina del carteggio compiuta da
Dore, il quale decompone (pp. 974) i significativi piani di lettura
offerti dall’epistolario con raffinati
strumenti analitici, mettendone
attentamente in luce i sistemi
di riferimento e sottolineando
l’importanza della trasmissione
della memoria per una più completa
comprensione del colonialismo
italiano.
Attraverso le lettere e le
fotografie conservate nel fondo
archivistico leggiamo e osserviamo,
sempre sapientemente guidati da
Dore, gli spazi domestici di una
residenza periferica dell’Africa
Orientale Italiana. Percepiamo la
«pedagogia coloniale» imposta agli
autoctoni di servizio, l’etnografia
spontanea della moglie dell’amministratore che assiste alle
cerimonie sia del regime sia della
società locale, incontra i colonizzati
di vario rango nella gerarchia del
dominio, uomini e donne, e ne
ottiene l’ammirazione per lo spirito
d’adattamento che la contraddistingue e per la sua non comune
capacità di accostarsi alla loro realtà
con una sua propria curiosità che
riesce a discostarsi dagli stereotipi e
dall’ideologia coloniale del regime
fascista. Questa documentazione
consente a Dore di offrire uno
spaccato delle problematiche
306
dinamiche degli italiani d’Africa,
seguendo gli stati d’animo di Pia
Maria Pezzoli che volgono dalle
iniziali aspettative di serenità
all’incupirsi dei giorni delle leggi
razziali antisemite, per divenire di
drammatica tensione durante la
prigionia del marito, ad opera delle
forze di occupazione britanniche.
Veniamo inoltre a conoscere
(pp. 75-86) la biografia e la vita
della Pezzoli reduce dall’Africa, con
Maria Virgilio che ne illustra la
modernità anche nelle scelte
professionali. Iscritta all’albo degli
avvocati, fu dapprima impiegata
alla Banca di Credito Romagnolo
e poi all’Ente per la colonizzazione
del Delta Padano. L’Africa non
cessa però di avere uno spazio
neppure in questa fase della vita
della Pezzoli, la quale manterrà e
coltiverà rapporti non solo con
profughi italiani ma anche con
singoli etiopici ed eritrei conosciuti
nel periodo trascorso in colonia.
L’attenta disamina di Gianni Dore
lascia quindi spazio al denso,
selezionato, carteggio, presentandone una parte cospicua che occupa
le pagine 87-219 del volume,
seguito da un accurato glossario (pp.
219-222). Il volume, elegante
nella veste tipografica e vivace
nell’articolazione interna, è infine
arricchito dall’inventario analitico,
curato da Bruna Viteritti e Maria
Grazia Bollini (pp. 223-256), del
Le schede
Fondo Speciale Pia Maria Pezzoli e
Giovanni Battista Ellero composto
di 254 tra lettere, documenti e
materiali fotografici(Federica
Guazzini).
C OLETTE D UBOIS et P IERRE
SOUMILLE, Des chrétiens à Djibouti
en terre d’Islam (XIX-XX siècles),
Karthala, Paris 2004 («Mémoire
d’Églises»)
christianisme en pays musulman, à
son developpement en contexte
colonial, enfin au maintien des
Églises au lendemain de
l’indepéndence», quando la
costituzione della neonata
repubblica di Gibuti proclamò
l’islam religione di Stato nell’ormai
lontano 1992. Una storia
complessa, rileva Prudhomme, che
sfugge alle semplificazioni e si è
nutrita, nei decenni, di esitazioni e
particolarità (la chiesa cattolica mise
le sue radici nel 1884 dapprima a
Obock, poi a Gibuti), del contesto
coloniale ritenuto portante, dei
contrasti suscitati da una laicità
combattiva e da un islam più che
mai vivo e provocatorio. Il percorso
storico specialistico si snoda
attraverso approfondite ricerche
d’archivio e la consultazione di testi
passati e recenti; un lavoro
ampiamente
documentato,
strutturalmente valido, con
l’obiettivo di riconsiderare
correttamente la storia, finora
appena delineata, della progressiva
evangelizzazione in una parte
dell’Africa dell’Est radicata sempre
nell’islamismo. Colette Dubois,
studiosa di Gibuti e docente di storia
Cinque densi capitoli, più un
dettagliato elenco delle fonti e una
non meno ricca bibliografia,
costituiscono questo interessante
volume che verte su un argomento
di sicuro interesse per lo specialista
di storia dell’Africa Orientale. I
capitoli sono intitolati: «Les
religions dans le Corne de l’Afrique
au XIX siècle», «La genèse du
catholicisme en Côte française des
Somalis. Une implantation
missionaire laborieuse et tâtonnante
(1884-1913)», «Une consolidation
précaire (1914-1945)», «L’Église,
catholique entre renouveau et repli
(1945-2003)», «Une tard venue,
l’Église protestante évangelique de
Djibouti. Un demi-siécle d’existence».
La prefazione è di Claude
Prudhomme che, a p. 6, rileva come
il volume sia soprattutto, oltre ogni
volontà di ricostruzione, un invito
«à s’interroger sur les mécanismes
qui ont conduit à l’implantation du
307
Le schede
contemporanea all’Università
d’Aix-Marseille 1, e Pierre Soumille,
specialista di storia religiosa
dell’Africa, recentemente scomparso, ma a lungo ricercatore
associato dell’Institut des études
africaines, hanno portato a termine
questo lavoro che conduce alla
scoperta e all’approfondimento
degli aspetti positivi e negativi
dell’evangelizzazione nel territorio
geografico preso in considerazione
e delle sconfitte della cristianità in
Africa nera. Era ora che alla vecchia
storiografia sulle missioni religiose,
volte ad esaltare il ruolo della chiesa
e ad ignorare quello delle resistenze
locali, tenesse dietro un riesame più
equilibrato e storicamente più
valido. Finita l’epoca dei
compromessi, è oggi possibile
studiare questo capitolo della storia
contemporanea africana e la
presenza cristiana nel Terzo Mondo
non solo sotto il profilo storico, ma
anche antropologico e geografico.
Dopo trent’anni di indipendenza,
Gibuti cerca di sviluppare la sua
difficile realtà socio-politica,
garantendo la libertà religiosa e
proponendosi come modello di
studio per altre realtà africane
(Massimo Romandini).
ANDREA BERRINI, Noi siamo la
classe operaia. I duemila di
Monfalcone, Baldini Castoldi Dalai,
Milano, 2004, pp. 244
l’orgoglio di appartenere ad una
classe, quella operaia, che sa lavorare
e bene, che «sa costruire aerei e
navi». Non è la necessità che li
spinge ma una loro scelta.Tutti
hanno vissuto la dittatura fascista,
molti hanno combattuto con le
brigate partigiane. Partono in massa,
cantando L’Internazionale e Bandiera rossa, per andare a costruire il
socialismo. La maggioranza si dirige
ai Cantieri navali 3 maggio di
Fiume, così chiamati per ricordare la
liberazione della città dal nazismo ad
opera dell’esercito popolare di
liberazione jugoslavo che comprendeva
anche alcune brigate partigiane
italiane. Molti di quegli uomini che
partono erano appartenuti ad una di
Nel 1947 duemila operai dei
cantieri aeronautici e navali di
Monfalcone partono per Fiume
per andare a lavorare nella
Jugoslavia di Tito. La Monfalcone
del dopoguerra è semidistrutta
dai bombardamenti, il lavoro
scarseggia, la direzione dei cantieri
si accinge a licenziare. Il licenziamento trova spesso origine in
ragioni politiche e significa miseria
e fame. Eppure molti dei duemila
sono «mistri» cioè operai specializzati, capisquadra, con tutto
308
Le schede
queste brigate: 1a Brigata proletaria,
divenuta poi il Battaglione triestino, una brigata composta
esclusivamente da operai di
Monfalcone.
Alla fine del 1948 la maggior parte
di loro rientra in Italia, delusa e
amareggiata. Quello che li aspetta è
l’emarginazione, la discrimi-nazione,
il silenzio. Altri devono aspettare
qualche tempo prima di rientrare:
l’appoggio alle tesi del Cominform,
con cui Stalin scomunica Tito e la
dirigenza comunista jugoslava, costa
loro l’arresto e la detenzione nei campi
di concentramento.
Il passaggio ad Est nel 1947 è
facile, è terra in cui i confini non
hanno mai avuto grande valore, per
lo meno tra la gente comune. I
monfalconesi, come molti loro vicini,
non si sentono italiani fino in fondo,
l’Italia è identificata con il fascismo,
con la dittatura, con la violenza e la
miseria. È diffuso un internazionalismo che affonda le radici
nell’impero
austroungarico,
multietnico e multilingue, ed è poi
cresciuto con Marx e il comunismo.
«Un socialismo austromarxista»
sovranazionale. Non a caso i «veci»
intervistati dall’autore raccontano che
«con l’Austria-Ungheria ogni dieci
funzionari c’erano 7 maestri e 3
gendarmi. Con l’Italia del fascio 3
maestri e 7 gendarmi».
Andrea Berrini, racconta questa
storia utilizzando la memoria dei
monfalconesi che vi parteciparono,
di chi non vi partecipò direttamente
ma che potè assistere alla vicenda,
di chi non ha assistito ma l’ha
sentito raccontare dai genitori, dagli
zii, dai nonni. Una storia tutta sul
filo di quella che Berrini non esita
a definire «memoria grande».
Incontra i protagonisti, i «veci», li
fa parlare, talvolta in dialetto, li
ascolta, e insieme a loro ricostruisce
il clima dell’epoca, le vicende
personali e collettive, il prima e il
dopo. È quando chiede il come e
soprattutto il perché che esce una
parola chiave: il sentimento. A
partire da quella parola, la cifra del
libro, l’autore non si sofferma più
solo alla superficie degli eventi ma
scandaglia sempre più approfonditamente le vite di quegli
uomini. Quasi come nella
psicanalisi, si ferma sugli
scivolamenti, sui ritorni, sugli
slittamenti della memoria e del
linguaggio: i lapsus, le rimozioni,
le cancellazioni, le improvvise
rivelazioni diventano la fonte
principale per ricostruire non solo
la storia ma le relazioni in cui si
muovevano gli attori di tale storia.
In realtà la vicenda del libro è
stata raccontata più volte nel corso
degli ultimi anni. Eppure Berrini
percepisce una coltre di silenzio. È
proprio questo silenzio che vuole
interrogare. «In questi anni è stata
fatta qualche analisi. Ma erano
309
Le schede
sempre analisi di sconfitta» dice
uno degli intervistati. Da questa
affermazione parte per raccontare
come i protagonisti di allora ben
percepiscano come le loro voci
possano essere distorte dall’attuale
polemica politica. Come sempre è
l’oggi a determinare il giudizio
sulle questioni di ieri. La questione
sulle foibe ad esempio. E il libro
non esita a descrivere come a
Trieste (e in Italia) sia in atto una
campagna di opinione che punta
a rafforzare i legami tra il centro
destra locale e il proprio elettorato,
tradizionalmente sensibile ai temi
dell’italianità ed oggi - con
l’allargamento dei confini ad est
dell’Unione Europea, i problemi
legati all’immigrazione, i nazionalismi risorgenti - quantomeno
disorientato.
I testimoni interrogati spesso
individuano le ragioni del loro
silenzio anche, ma non solo, nella
volontà di non essere strumentalizzati dalla destra attuale.
«Cosa può pensare della vostra
partenza un ragazzo di oggi?» è la
prima domanda che Berrini pone
agli intervistati. E le risposte non
rivelano un’irrimediabile sconfitta.
Nella vita non si vince e non si perde
irrimediabilmente. Spesso si allarga
anche il sorriso sulle facce di quegli
uomini. C’era l’entusiasmo, la
voglia di libertà, il desiderio di
migliorare la condizione dei propri
310
figli e non vederli asserviti nei
cantieri Cosulich, la volontà di
costruire il socialismo, e soprattutto
il grande orgoglio di appartenere
alla classe operaia, di saper costruire
navi e aerei e di essere preparati e
competenti nel mestiere.
Seguendo le storie raccontate
dai testimoni, il libro ricostruisce
il prima e il dopo. Si narra
dell’antifascismo e delle persecuzioni del regime, dell’identificazione
dell’Italia con il fascismo, la
trasformazione dei cognomi locali
in cognomi «italiani». Poi il grande
episodio della Resistenza e la
costruzione di una forte identità. Si
ripercorrono le vicende dei rapporti
all’interno del Partito comunista
italiano e di quello iugoslavo nel
momento in cui da Mosca Tito
veniva tacciato di tradimento ma
anche quando dalla stessa città
venivano speranze e modelli di
riferimento. Si rileggono le
persecuzioni e le emarginazioni del
dopoguerra e anche quelle del
ritorno dalla Jugoslavia, ad un anno
dalla partenza per Fiume.
«Ha un senso la ricostruzione
storica, precisa, degli avvenimenti
di quegli anni? Da dove viene la
necessità di ricostruire punto per
punto, nome per nome, giornata
dopo giornata gli scontri tra partiti
comunisti, tra dirigenti, che
portano al Controesodo? […] Le
loro vite sono andate in un certo
Le schede
modo perché essi così hanno
deciso. L’errore è forse stato l’aver
delegato ad altri le decisioni
politiche, l’essersi affidati alle
direttive altrui invece che cercare
di imporne di proprie.
Sicuramente, questo è il loro
rimpianto. Ed è anche il loro lascito
più importante, insieme alla
determinazione testarda, alla
vivacità intellettuale che, nei
confronti dei loro padroni e dei loro
tiranni, li ha sempre portati a voler
riflettere, discutere, capire, e
soprattutto agire in prima persona,
mettendo a rischio la propria
incolumità. Hanno voluto dare […]
l’assalto al cielo. La grandezza delle
loro storie, il fascino che non
possono non esercitare su chi li ha
seguiti, siano uno stimolo a non
cedere mai all’idea che nel mondo
decidono solo i potenti e i piccoli
uomini debbano stare a guardare,
cercando di limitare i danni». Ed è
con queste parole affettuose che
l’autore saluta i protagonisti della
vicenda. Con Renato Sarti ha deciso
di farne una trasposizione teatrale
per raccontare la più tragica
sconfitta operaia. Il titolo è: Vittoria
(Sabrina Michelotti).
GIORGIO BOCCA, L’Italia l’è malada,
Feltrinelli, Milano 2005, pp. 143.
pensa come lui, è esattamente il
contrario di quello che penso io e
quelli come me».
Da questo assunto nasce così un testo
che vaglia con minuzia innumerevoli
aspetti del vivere contemporaneo del
paese: l’eclissi dei valori, il
capitalismo sfrenato, il «fascismo che
ritorna a circolare come un odore
familiare», la presenza della mafia
nella società e la sua collusione col
mondo
degli
affari,
lo
smantellamento della Costituzione,
lo svilimento dei fori giudiziari
pubblici, la liquidazione del
sindacato, la gestione a fini politici
dell’informazione, la guerra in Iraq,
Un libro che non lascia spazio a
compromessi, un’opera che nasce
dall’urgenza di denunciare la
situazione in cui si trova l’Italia
d’oggi: questi, in breve sintesi, due
degli elementi fondamentali de
L’Italia l’è malada, il saggio che
Giorgio Bocca ha dato alle stampe
nel primo semestre di questo anno.
Per chiarire l’entità delle
caratteristiche sopra delineate, è
sufficiente riportare una frase del
volume: «ciò che pensa e dice un
uomo come Berlusconi, e chi la
311
Le schede
l’impoverimento della politica, la
fine della solidarietà sociale.
Sono questi, a detta dell’autore, i
principali mali che affliggono l’Italia;
malesseri che hanno origine, secondo
lo scrittore cuneese, in gran parte
dall’attività di un’unica figura
politica, quella di Silvio Berlusconi,
la stessa persona contro la quale
Bocca aveva rivolto un suo
precedente testo, il Piccolo Cesare
(Feltrinelli, 2002), descrivendo le
ambizioni di grandezza di colui che
da poco più di un anno era diventato
per la seconda volta Presidente del
Consiglio.
Ma la differenza tra i due libri sta
soprattutto nel loro rapporto con le
vicende narrate: se nel primo testo
Bocca dibatteva di un futuro
preconizzabile ma non ancora
compiuto, con L’Italia l’è malada lo
scrittore afferma stentoreamente che
dopo gli anni del governo della Casa
delle Libertà, l’Italia è «un paese in
cui per le persone civili la vita è
faticosa e meschina. Un paese in cui
è scomparso lo Stato».
In poche parole siamo, dice Bocca
in apertura di libro, in un regime,
ovvero «una società classista che finge
di essere senza classi, di sovversivi che
fingono di essere moderati».
Lo stile diretto e semplice, ma carico
di sprone e di spunti di riflessione,
che accompagna il lettore nella
disamina critica della realtà della
penisola ha un obiettivo ben
312
preciso: eliminare l’atteggiamento
cinico e remissivo di gran parte degli
italiani, per i quali è preferibile «la
rinuncia alla libertà pur di non avere
grane, di viver tranquilli, pronti a
ingoiare tutti i rospi». È forse
questo che spinge l’autore a non
rimanere muto di fronte alla
situazione, perché «il regime è anche
assuefazione al peggio, fastidio per
chi si oppone e conserva un minimo
di senso critico».
In Bocca la voglia di opporsi
all’andamento della realtà si esplica
anche al riguardo dell’interpretazione
dei fatti del passato, un passato che lo
scrittore ha vissuto da militante: una
critica severa è rivolta contro i fautori
del revisionismo storico, ovvero coloro
secondo i quali «la Resistenza non c’è
stata, ma ci fu solo una dura
occupazione tedesca» (come ha avuto
modo di dire l’ambasciatore Bottai),
o coloro che fanno intendere che «una
guerra di popolo con quarantamila
morti e ventimila feriti è un mito, [...]
non è storia, ma una vulgata
propagandistica del Partito Comunista» (come si evince, secondo Bocca,
dalle dichiarazioni del Presidente del
Senato, Marcello Pera).
È, insomma, in questa indignazione
verso tanti atteggiamenti del vivere
civile e politico della nazione nonché
nell’attività maieutica che da essa
scaturisce, che sta il senso primo di
L’Italia l’è malada (Matteo Vecchia).
Le schede
ANTONIO GAMBINO, Esiste davvero
il terrorismo? Fazi editore, Roma
2005, pp. 79
Antonio Gambino corre lungo
il sentiero del significato del
termine terrorismo rilevando
come a tale concetto spesso
si associ una condizione di
indeterminatezza e confusione
definitoria.
Esiste davvero il terrorismo? È
innanzitutto un volume che ha
l’intento di abbattere a poderose
spallate quel fenomeno che
l’autore definisce «pensiero
unico», cioè quella tendenza della
politica e dell’informazione delle
società occidentali che tratta in
termini univoci gli avvenimenti
che caratterizzano la contemporaneità. Una strategia che, nei
fatti, produce tre conseguenze:
nella maggior parte dei casi crea
un unanimismo di stampo
americano, autoassolve le azioni
dei governi occidentali, e al
contempo si scaglia contro gli
oppositori dell’unilateralità del
pensiero portando il fruitore
dell’informazione alla completa
assuefazione.
A livello contenutisitico, il
terrorismo, dal punto di vista della
violenza e della criminalità, è per
Gambino un fenomeno associabile
a tante altre azioni che vengono
compiute dagli stati occidentali e
che invece sono considerate dai
media e dalla politica come lecite.
Proprio su questo aspetto l’autore
insiste particolarmente, constatando che se fino a prima della
globalizzazione dell’informazione i
governi occidentali potevano
occultare i propri misfatti, ora ciò è
molto più difficile, poiché i media
hanno una diffusione capillare in
pressoché tutte le aree del globo.
Tuttavia, secondo il saggista, a
questo non corrisponde, a livello
mondiale, un’analisi sgombra da
pregiudizi. Ma da cosa deriva questa
lacuna? In primo luogo dalla già
citata tendenza a considerare il
terrorismo come un crimine diverso
dagli altri di uguale o maggiore entità
compiuti in passato dalle potenze
occidentali: in questo processo è
parte attiva l’artefatta «perdita di
memoria» di cui esse soffrono
rispetto alle proprie colpe gravi del
passato. In secondo luogo dal
processo che ha portato, dall’Iran di
Khomeini in poi, a non considerare
più gli avversari come soggetti
eticamente uguali, ma come «nemici
pubblici numero uno» nei confronti
dei quali le regole che guidano la vita
della comunità internazionale sono
sottomesse all’interesse nazionale: ne
consegue che anche il terrorismo
viene da essi considerato un male
assoluto.
Il fatto di considerare l’eversione
internazionale in termini manichei
313
Le schede
di totale positività e negatività porta
poi, a detta di Gambino, gli stati
dell’Ovest del mondo a legittimare
la propria autoassoluzione tramite
l’utilizzo di argomentazioni che
risultano essere fortemente di parte,
quali la differenziazione tra errore e
crimine e il richiamo alla guerra.
Nella categoria degli errori
l’Occidente fa rientrare, a proprio
beneficio, i tre secoli di schiavismo,
i due di colonialismo, i bombardamenti contro le popolazioni civili
cittadine durante la seconda guerra
mondiale, gli attacchi col napalm
in Vietnam, nonché gran parte delle
altre macchie del proprio passato;
resta invece definibile come crimine
tutto ciò che - naturalmente
«negativo» - è compiuto dagli
antagonisti. Di pari passo va
l’utilizzo del termine guerra, nel cui
quadro normativo gli stati che
dominano il mondo si arrogano il
diritto di far rientrare tutte le azioni
da essi compiute che presuppongono il ricorso alla violenza; per
poi non accordare un analogo status
giuridico alle azioni che vengono
compiute spesso come reazione ai
suddetti atteggiamenti.
Dopo avere posto più di un
interrogativo su quale sia la vera
essenza del «terrorismo», l’autore
giunge ad una propria valutazione
di cosa debba intendersi con il
termine. Si tratta del ricorso alla
violenza e al terrore in un contesto
314
in cui «non si sia di fronte a uno
scontro nazionale o etnico [...] ma
piuttosto a una tensione e a una
lotta di natura sociale» e che «abbia
un carattere sostanzialmente
democratico [...] e non sia, invece,
una dittatura».
Corollata da tante altre pagine
interessanti, quella di Gambino è in
sostanza un’opera che ha la capacità
di analizzare la materia da un punto
di vista alternativo e di sgombrare
il campo dalla retorica della politica
dominante; è inoltre di ampio
interesse per ciò che riguarda le
analisi comparatistiche della storia
recente e passata.
Paradossalmente, però, ha il
difetto di cadere a sua volta in qualche
eccesso di generalizzazione. Ad
esempio, pur nel rispetto delle
esigenze di un testo che si presenta
come un pamphlet, necessiterebbero
di una più articolata spiegazione frasi
come «chi [...] potrebbe davvero
credere [...] che la secolare arroganza
del mondo occidentale, il suo costante
disprezzo per tutte le culture ‘inferiori’,
ed in particolare per quella islamica,
non abbia provocato nei popoli che
le hanno subite [...] ferite durature»
generando in loro «reazioni di
frustrazione e di rivalsa non sanate e
non facilmente sanabili», così come
l’affermazione sulla «volontà di gran
parte del mondo islamico [...] di colpirci
al cuore, di entrare in guerra contro
di noi» (Matteo Vecchia).
Le schede
DOMENICO SELLITTI, I tarantini scrivevano a Mussolini, Taranto, edit@,
2004, pp.158.
Il volume è frutto di una lunga ricerca, nata quasi per caso nel solco
di un’altra destinata ad approfondire gli albori del fascismo jonico.
Ma, come accade in questi casi, ne
è nato un altro lavoro altrettanto
accattivante e ricco sia nei contenuti sia nelle considerazioni che ne
sono scaturite.
Taranto manca tuttora di un’attenta ricostruzione delle vicende locali
legate al Ventennio, pur non mancando al contrario la documentazione d’archivio da collegare alle
raccolte private che sono a volte l’ossatura di una ricerca più complessiva. È il caso di questo volume, alla
cui base ci sono soprattutto i documenti privati, lettere e corrispondenze varie, densi di nomi e fatti.
Si tratta di un lavoro paziente, con
risultati convincenti, pur nella certezza che molto ancora si potrebbe
fare. Esistono, infatti, nella città
bimare documenti importanti, ormai ingialliti e molto polverosi,
presso numerose famiglie: a volte
semplici appunti, o fogli di quaderno appena leggibili, carte stampate
o dattiloscritte o scritte a mano.
Spesso questi preziosi documenti
che testimoniano le temperie di
un’epoca passata, si accompagnano
ad una serie inimmaginabile di foto
inedite e di allegati come diplomi,
certificati, attestati. I documenti,
come quelli riprodotti nel volume,
sono spesso caratterizzati dalla
spontaneità espressiva, dal sacrificio
della punteggiatura, dalle ripetute
sgrammaticature.
Insomma, si tratta di un patrimonio eccezionale che, nel caso specifico, riguarda Taranto e i tarantini
che non esitarono a rivolgersi al
Duce (che pare ricevesse 40 mila
lettere di questo tenore al mese) o
ai vertici del Partito nazionale fascista. La corrispondenza Tarantina
era poi dirottata alla Federazione dei
fasci di Taranto perché le richieste
fossero prese in considerazione.
Così avveniva per tutte le realtà locali, ciascuna delle quali aveva le sue
lettere indirizzate al Duce. La Segreteria particolare di Mussolini
non poteva reggere il peso della lettura delle missive, che invadevano i
tavoli di Villa Torlonia, di Palazzo
Venezia, di Palazzo Chigi, della residenza di Salò. Gran parte delle
lettere non arrivava neanche al
Duce, ma si fermava molto prima
alla lettura dei burocrati preposti al
compito e, come avvenne poi, delle federazioni di appartenenza che
controllava la veridicità delle dichiarazioni e delle richieste.
Scrive Sellitti nella premessa che il
volume offre «una richiesta di dettagli e di particolari, storici ed umani, intrisi di affetti e di dispiaceri,
315
Le schede
che formano uno spaccato inedito
della città; brandelli di vita, colta attraverso lamentele, invocazioni e richieste dirette al Duce che, con paternale devozione, avrebbe dovuto
accontentare tutti indistintamente».
Tante dunque le richieste, e le più
disparate, dei tarantini del
Ventennio. Richieste di denaro, di
sussidio per i bambini a cui la famiglia non è in grado di garantire il
minimo per vivere o per tutta la famiglia indigente; richieste di iscrizione al partito; denunce di soprusi
patiti dalla locale commissione per
il riconoscimento di squadrista o
per il mancato inserimento negli
elenchi dei benemeriti del fascismo;
elencazione dei propri meriti fascisti; lodi al Duce che ha mutato i
destini dell’Italia. Vi sono anche
istanze di militari che chiedono aiuto per la carriera; istanze di gente
comune che vorrebbe lavorare e nel
mentre esalta Mussolini, più concretamente gli chiede qualcosa da
fare per non patire la fame. Non
mancano poi le lettere con richieste
curiose e in linea con i tempi, tipico
esempio di un epoca fortunatamente tramontata, ma nello stesso tempo significative per la storia.
È importante che Sellitti si sia
astenuto dal «filtrare» questa corrispondenza. La sua funzione è stata
puramente tecnica: nessun commento, nessun facile moralismo, ma
solo la presentazione di spaccati di
storia offerti alla libera lettura, e
qualche volta, al sorriso benevolo
del lettore. Il quale non mancherà
di ammirare anche le belle foto inedite che costellano le pagine del
volume, un documento di primaria importanza (Massimo Romandini).
ROSSELLA BOTTINI TREVES, LALLA
N EGRI , Novara ebraica, Novara
2005, pp. 174.
e pertanto occorreva scavare in ogni
direzione, anche la più remota,
sempre con la speranza di un colpo
di fortuna consistente in un
Piemonte, ma già con l’epiteto di
«deicidi», gente da lasciar vivere, ma
separata dagli altri, tanto da indurre
i duchi di Savoia (sec. XV e XVI) a
emanare leggi in proposito.
Le autrici sono riuscite a fornire
una data della loro prima comparsa
in Novara: anno 1448, quando
alcuni di loro lasciano memoria
A lettura ultimata diNovara
ebraica viene da pensare che le
autrici Rossella Bottini Treves e
Lalla Negri siano veramente
soddisfatte per il lavoro compiuto.
È stata indubbiamente una
ricerca dura da portare a
compimento, perché la bibliografia
locale non offriva basi d’appoggio
316
Le schede
come prestatori di denaro, attività
che presto ebbe degli imitatori tra i
cattolici, ma non a pari risultato. La
narrazione entra quindi nelle
vicende politiche ed economiche
del territorio con la segnalazione
proprio delle persone, a volte
divenute personaggi perché capaci
di distaccarsi dalla massa, fino a
suscitare perplessità per le
concorrenze nel commercio. Sono
pagine che offrono lo spaccato
locale del rapporto con gli ebrei che,
controllati attraverso le leggi e le
opinioni dei cristiani, non subirono
mai veri pogrom come in tante altre
parti d’Europa. Anche l’illiberale
vescovo Marc’Aurelio Balbis
Bertone, che governò la diocesi per
trentadue anni, non si accanì contro
di loro, ma si affidò alle leggi regie.
Così di secolo in secolo si arriva
all’Ottocento e al Risorgimento con
un discorso lieve, minuzioso nella
ricerca dalla quale risalta
l’importanza che hanno talune
vecchie pubblicazioni, come la
Guida di Novara di Napoleone
Lenta, un tipografo che ogni anno
aggiornava l’elenco delle attività
economiche e sociali della città, e
verso il quale ogni ricercatore è
quindi sempre riconoscente.
Un capitolo è dedicato al cimitero
ebraico che ha rappresentato un
punto di riferimento per stabilire
intrecci di attività e di parentela tra
gli ebrei residenti o di passaggio, al
quale segue quello riguardante le
leggi razziali del 1938, dove si
inquadra chiaramente, pur nella sua
concisione, quel periodo di
persecuzione menzionato ogni qual
volta viene rievocata la Shoah, o il
«Giorno della memoria» in ricordo
dei deportati nei campi di
sterminio. Anche a Novara c’erano
ebrei che furono sospesi dalle loro
attività a seguito di tali leggi e tra
loro è particolarmente ricordata
l’insegnante di lettere Benvenuta
Treves, che dopo la guerra si
impegnò in politica. Ma il punto
focale della ricerca è quello del
settembre 1943, quando Novara fu
occupata dai tedeschi che pretesero
dal Municipio l’elenco degli ebrei che
beneficiavano della «arianizzazione».
Qui occorre una breve, ma
necessaria esplicazione: a seguito
della legge razziale italiana erano
stati espulsi dal territorio nazionale
tutti gli ebrei che non avevano
acquistato benemerenze particolari,
come ad esempio essere stato
combattente durante la prima
guerra mondiale, aver partecipato
alla fondazione del partito fascista,
aver dato lustro alla nazione con
brevetti e scoperte scientifiche, o
aver contratto un matrimonio
misto. Costoro, classificati come
«arianizzati», avevano potuto
continuare le loro attività nel luogo
di residenza. Ma i tedeschi queste
clausole non le vollero riconoscere
317
Le schede
per cui seguirono arresti e
deportazioni per raggiungere quella
«soluzione finale» programmata da
Hitler.
Le autrici su questo breve, ma
tragico momento, hanno lavorato
bene e la narrazione è esauriente. Mi
viene spontaneo però aggiungere una tantum - anche una mia
testimonianza. Nel libro si parla dei
tedeschi che il 22 settembre si
presentarono alla Banca popolare di
Novara per confiscare i beni degli
ebrei contenuti nelle cassette di
sicurezza, oltre al denaro sui conti
correnti ed i libretti di risparmio.
Io ero stato assunto in banca a
gennaio, avevo appena compiuto 17
anni, e quella mattina ero sceso nel
caveau, con altri colleghi, per
prelevare determinati registri che
alla sera bisognava riportare giù per
paura dei bombardamenti aerei. Era
un lavoro che toccava ai più giovani
e noi eseguivamo senza fiatare.
Mentre stavamo avviandoci alla
scala per raggiungere i rispettivi uffici,
comparvero i tedeschi comandati dal
tenente SS Helmut Staube, che ci fece
cenno di depositare ciò che
portavamo allineandoci contro il
muro a destra della porta blindata del
caveau. Al mio fianco avevo un amico
assunto da poco più di un mese: era
Ugo Ronfani, che nel luglio
precedente si era diplomato all’istituto
magistrale e che dopo la guerra si
sarebbe votato al giornalismo, alla
critica teatrale ed alla stesura di libri
di saggistica. Avevamo gli occhi
spalancati su quanto stava
succedendo, meravigliati ed increduli.
Ci furono dialoghi tra il cassiere
principale, un notaio e qualche altro
funzionario della banca con questo
tenente SS che aveva un interprete di
fiducia, scattante ad ogni botta e
risposta.
Poi ci fecero cenno che
potevamo salire negli uffici con la
nostra roba: loro prelevarono i beni
degli ebrei custoditi nelle cassette di
sicurezza e non li vedemmo più. Ma
chi avrebbe osato difendere allora
gli ebrei dopo tutta quella propaganda antisemita che ci era stata
propinata? Noi giovani eravamo
disorientati (Gaudenzio Barbè).
CESARE BERMANI, Non più servi, non
più signori, Ed. Elleu-Musica, Roma
2005
nea, a partire dalla fine dell’Ottocento, è indubbiamente quello che
va sotto la definizione di «questione sociale». È stata la rivoluzione
industriale a provocarla quando
l’uomo, sottoposto a ritmi di lavo-
L’argomento che più di tanti altri interessa la storia contempora318
Le schede
ro stressanti e con un salario da
fame, ha realizzato la solidarietà con
i suoi simili per limare il divario tra
il datore di lavoro e il lavoratore:
sono nati quindi partiti e sindacati
propensi allo scopo.
La storia del movimento operaio e contadino, che oggi sembra
messa un poco in disparte rispetto
agli anni settanta e ottanta del secolo scorso, riserva sempre buoni
spunti di ricerca per le sue origini,
per i motivi della rivolta e, perché
no?, anche per il suo folclore. Nei
grandi aggregamenti di persone c’è
sempre chi ha la dote del verso, della
rima applicata ad un contenuto ben
preciso. Anche il movimento operaio ha avuto i suoi cantori e il nostro storico Cesare Bermani ha voluto cimentarsi in questo campo
concludendo una ricerca in proposito che va sotto il titolo: «Non più
servi, non più signori». È un libretto tascabile di cento pagine dove lui
narra, poiché di vera narrazione si
tratta, la vicenda dell’inno «L’Internazionale», nato in Francia e poi tradotto in tutto il mondo con più o
meno fortuna, ma comunque sempre diffuso nei movimenti di rivolta alle pretese del potere.
Bermani è scrupoloso nelle ricerche e non ha esitato a scendere nelle vicende più intime, più popolari
sulle origini del testo, elencando le
varie stesure. D’altra parte quante
altre composizioni hanno avuto tra-
vagli e modifiche su spinte esterne
o interessi specifici. Forse che, rimanendo alla Francia, la «Marsigliese» non è stata rielaborata più volte? E così altre canzoni e ballate,
dense di peripezie e di interrogativi
su chi è stato il vero autore o il vero
musicista. È di meno di tre anni fa
il riconoscimento al maestro Alfredo Mazzucchi (1878-1972), (sentenza del Tribunale dì Torino dell’ottobre 2002), di essere stato
coautore della musica di «O sole
mio», con Eduardo Di Capua
(1869-1917).
La narrazione di Bermani parte
senza ricami; egli espone la biografia di Eugène Edme Pottier (18161887), autore delle parole de «L’Internazionale», come si parla di una
persona sensibile a quelle mortificazioni cui erano sottoposti i lavoratori impegnati dalle dodici alle
quattordici ore al giorno. Si voleva
il frazionamento delle ventiquattro
ore in tre parti: otto ore di lavoro,
otto ore da dedicare alle faccende
personali (svago o studio), e otto ore
di riposo. Ma non sarebbe bastato
mettere l’argomento in un inno per
risolvere la questione. Pottier scrisse la definitiva versione de «L’Internazionale» nel 1877 dopo aver subito il carcere come sovversivo. La
relazione di Bermani ci rimanda, di
conseguenza, alla storia sociale della vicina Francia del sec. XIX, dove
la lotta contro il potere non era fa319
Le schede
cile, e viene spontaneo un confronto con quanto accadeva in Italia nel
periodo cosiddetto umbertino.
Più intrigante per «L’Internazionale» è stata poi la vicenda riguardante la musica. Quanto tempo è
occorso a Bermani per districarsi
con i fratelli Degeyter? Ma l’inno
veniva intanto conosciuto tra tutti
i proletari del mondo, boicottato dai
governi e dalla chiesa soprattutto
per quella frase che recitava così:
«Non più supremi salvatori, né re,
né Dio, né tribuni: Salvare noi lavoratori, spetta ormai solamente a
noi». Era diventato l’inno ufficiale
del 1° Maggio e di tutte le assemblee socialiste d’Europa e degli Stati Uniti d’America fino agli anni
trenta, dove veniva messo accanto
a «The Star - Spangled Banner», bella canzone sociale con parole e musica molto allegra.
La bibliografia consultata da
Bermani dimostra l’impegno profuso nella ricerca svoltasi più in
Francia che in Italia: bisogna dar-
320
gliene merito. Tuttavia ci consenta
un appunto per quanto riguarda la
messa all’Indice dell’inno durante il
fascismo, che manca. Qualche precisazione ci voleva. Era talmente
vilipeso per cui anche dopo la sua
caduta nel 1943 c’era un certo timore nel recitarlo.
Racconta Altiero Spinelli che
rientrando liberi da Ventotene a
Gaeta (periodo badogliano) qualcuno intonò «L’Internazionale»,
ma il seguito fu scarso, per cui si
ripiegò su «Fratelli d’Italia» che
coinvolse tutti.
«L’Internazionale» dalle nuove
generazioni venne conosciuto solo
dopo il 25 aprile 1945, sebbene con
qualche critica sulla marzialità della musica che richiamava un certo
militarismo da abbandonare. Bisogna ripercorrere poi le vicende sessantottine per comprendere quali
entusiasmi ha suscitato. Adesso fa
parte della storia della canzone politica (Gaudenzio Barbè).
notizie sugli autori di questo numero
notizie sugli autori di questo numero
GAUDENZIO BARBÈ - Storico novarese, autore del volume Novara nelle vecchie
carte, del 1977. Per il convegno di Belgirate del 1993 ha curato un Dizionario
biografico e dei periodici. Di recente, nel 2002, ha dato alle stampe per le Edizioni
Piero Ginocchi il libro Leone Ossola il vescovo che salvò Novara.
ANDREA BECCARO - Laureato in storia nel 2004 presso l’Università degli Studi
di Torino con una tesi dal titolo Guerra e strategia nel mondo postbipolare:
prospettive, problemi, interpretazioni, attualmente ha in corso ricerche sulle
operazioni di peacekeeping e sulle teorie della guerra di Clausewitz e Sun tzu, viste
in chiave comparata.
CHIARA CALABRI - Laureata in storia contemporanea a Firenze nel 2003, nella
sua tesi ha affrontato l’opacità della stampa italiana di fronte al genocidio
rwandese del 1994. Nel settembre 2005 ha pubblicato un articolo dal titolo Echi
da un genocidio. Rwanda 1994, sul n. 8 della rivista del movimento Sim-Storie in
Movimento, «Zapruder».
LUIGI CALIGARIS - Generale di Brigata dell'esercito, è stato anche deputato al
Parlamento europeo. Per un decennio ha collaborato alla RAI ed ai più
importanti quotidiani italiani con articoli di politica estera e commenti di
carattere militare. Fra le sue opere: Paura di vincere, Rizzoli, 1995.
GIOVANNI A. CERUTTI - Membro del Comitato scientifico dell'Istituto storico
P. Fornara e responsabile del settore editoriale. Nel 2005 ha curato presso
l’editore Interlinea la pubblicazione del diario di Carolina Bertinotti Ma la
fortuna dei poveri dura poco, che ha vinto la sessione «scaffale» del Premio della
Resistenza «Città di Omegna».
FILIPPO COLOMBARA - Dalla seconda metà degli anni settanta si occupa di storia
e di cultura delle classi popolari collaborando con istituzioni pubbliche e private.
Nell'ambito delle sue attività, svolte in massima parte all’interno di progetti di
storia orale dell'Istituto Ernesto de Martino e degli Istituti storici della resistenza
delle province di Novara e Vercelli, ha pubblicato ricerche su comunità locali e
comunità di lavoro.
321
notizie sugli autori di questo numero
ANGELO DEL BOCA - Da quarant’anni si occupa di storia del colonialismo e dei
problemi dell’Africa d’oggi. Fra i suoi ultimi libri: Gheddafi. Una sfida dal
deserto, Laterza, 1998; Un testimone scomodo, Grossi, 2000; La disfatta di Gasr
bu Hàdi, Mondadori, 2004; Italiani, brava gente?, Neri Pozza, 2005.
STEFANO FABEI - Insegna Lettere all'Istituto tecnico per le attività sociali di
Perugia. Tra i suoi libri citiamo: Guerra e proletariato, Società Editrice
Barbarossa, 1996.
EDGARDO FERRARI - Ex sindaco di Domodossola, da anni cura la rivista
«Almanacco storico ossolano».
GIANLUCA GABRIELLI - Insegnante bolognese, da tempo si occupa di didattica
della storia e conduce studi sui temi dell’antisemitismo e del razzismo nelle
colonie italiane. Al riguardo ha scritto Prime ricognizioni sui fondamenti teorici
della politica fascista contro i meticci pubblicate nel volume Studi sul razzismo
italiano, uscito a cura di Alberto Burgio e Luciano Casali, Clueb, Bologna
1996.
MARIO GIOVANA - Per lunghi anni giornalista, è autore di numerosi saggi, fra
cui Algeria anno settimo, Milano 1961; La Resistenza in Piemonte. Storia del CLN
Piemontese, Milano 1962; Storia di una formazione partigiana, Torino 1964;
Guerriglia e mondo contadino (Bologna 1988). Collabora a riviste italiane e
straniere di storia contemporanea.
NICOLA LABANCA - Docente di storia contemporanea all’Università di Siena,
si occupa di storia del colonialismo italiano. Tra i suoi studi più recenti è Posti
al sole. Diari e memorie di vita e di lavoro dall’Africa Italiana, Rovereto 2001.
Insieme a Angelo Del Boca, per gli Editori Riuniti, ha curato L’Impero africano
del fascismo nelle fotografie dell’Istituto Luce, Roma 2002.
FEDERICA GUAZZINI - È dottore di ricerca in Storia dell’Africa alla facoltà di
Scienze politiche dell’Università di Siena. Ha scritto : Le ragioni di un confine
coloniale. Eritrea, 1898-1908, L’Harmattan Italia, 1999.
DOMENICO LETTERIO - Dottorando di ricerca in Storia del pensiero politico
presso il Dipartimento di studi politici dell’Università di Torino, si occupa degli
scritti coloniali di Alexis de Tocqueville.
322
notizie sugli autori di questo numero
ARAM MATTIOLI - Ordinario all’Università di Lucerna, si è occupato di temi
inerenti la costruzione di un’identità nazionale in Svizzera. In proposito
insieme a Guy P. Marchal ha scritto Erfundene Schweiz. Konstruktionen
nationaler Identität, Zürich 1992. Tra i principali suoi interessi di studio sono
anche le ideologie totalitarie, l’antisemitismo e il colonialismo.
SABRINA MICHELOTTI - Laureata in lettere presso l’Università degli studi di
Parma, insegnante, collabora con il Centro studi per la stagione dei movimenti
di Parma occupandosi in particolare di femminismo e teorie politiche.
GIORGIO NOVELLO - Diplomatico di carriera, è attualmente ministro consigliere della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’OSCE a Vienna dopo
aver prestato servizio a Lagos, Londra, Berlino e al ministero degli Esteri tedesco
a Bonn. «Ancien élève» dell’ENA di Parigi e M.Phil. della London School of
Economics, è docente di metodologia delle relazioni internazionali all’Università di Trieste-Gorizia. È rappresentante della Universala Esperanto Asocio
presso le Nazioni Unite a Vienna.
MASSIMO ROMANDINI - Dirigente scolastico, dal 1969 al 1975 ha insegnato
in Etiopia alle dipendenze del ministero degli Esteri. Si occupa di storia del
colonialismo italiano in Africa Orientale.
MATTEO VECCHIA – Laureato in Scienze internazionali e diplomatiche presso
l’Università di Trieste, è oggi dottorando di ricerca in Storia contemporanea
presso l’Istituto italiano di scienze umane (Firenze-Napoli). Sta conducendo
studi sul terrorismo arabo e islamico, e scrive articoli di politica internazionale
su quotidiani e riviste italiane.
errata corrige
Nell'editoriale del primo numero della rivista, nel presentare il saggio di Gian Mario Bravo,
Antonio Labriola e la questione coloniale, abbiamo erroneamente accostato la figura di Antonio
Labriola a quella minore di Arturo Labriola. Ci scusiamo con l'autore del saggio e con i lettori.
323
notizie sugli autori di questo numero
324
notizie sugli autori di questo numero
LÀiÀ>Ê,"--Êð°V°
Ónn{xÊ"""--"Ê6®ÊqÊ*>ââ>ÊiÀV>Ì]ÊÎÇÊ
/i°ÊäÎÓ{ÊÓ{ÓÇ{ÎÊÊ>ÝÊäÎÓ{Ê{nÓÎxÈÊÊ
i>\ÊLÀiÀ>°}ÀÃÃJLiÀ°Ì
"
-/",
"
"--" "
>Ê£{ÊÕ>ÊÀ>VVÌ>Ê
>Õ>iÊ`ÊÌiÊÃÃ>Ê
VÊVÌÀLÕÌÊ`iÊ>}}ÀÊ
ÃÌÕ`ð
325
notizie sugli autori di questo numero
326
notizie sugli autori di questo numero
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
CENTRO STUDI PIERO GINOCCHI
EDITORIA
Via Pellanda 15 - 28862 CRODO VB
Codice Fiscale 92003940035 — Partita IVA 01793430032 — Telefono 0324.61655
ENTE GIURIDICO PRIVATO RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PIEMONTE
e-mail:[email protected]
Collana: La Memoria
Per secoli gli abitanti della Valle Antigorio hanno scavato le loro montagne e
setacciato le sabbie dei loro corsi
d’acqua alla ricerca dell’oro. Ma in realtà la vera ricchezza della Valle si è rivelata essere l’acqua delle sorgenti
termali.
30,00 Euro.
L’emigrazione, fenomeno comune nel
territorio delle Alpi, investe Antigorio
soprattutto dal XVI secolo in avanti. A
Roma ed a Bologna si formano confraternite ed associazioni laicali, puntigliosamente precluse agli estranei, le
quali, oltre a garantire i compagni psicologicamente e materialmente, hanno
pure lo scopo di aiutare i conterranei
rimasti in patria.
Euro 25,00
327
notizie sugli autori di questo numero
328
Scarica

![Le origini e la presa del potere [g]](http://s2.diazilla.com/store/data/000068864_1-7a3b7b6cfdf5e3492d6f39a327d65d39-260x520.png)