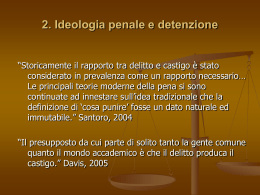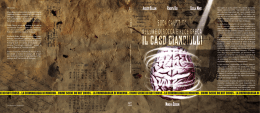Firera & Liuzzo Publishing è un marchio di Firera & Liuzzo Group © 2010 - Firera & Liuzzo Group Via Sistina, 15 - 00187 Roma www.fireraliuzzo.com ISBN: 978-88-6538-027-7 Firera & Liuzzo Group è un membro di Nicola Malizia CRIMINOLOGIA ed elementi di criminalistica presentazione di Francesco Bruno InDICE Presentazione 11 PARTE PRIMA – CRIMINOLOGIA GENERALE 1- Lo studio della criminologia 15 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Le scienze criminali La criminologia come scienza L’orizzonte della criminologia Delitto e sua definizione Diritto penale e criminologia: quale rapporto? 15 17 21 23 25 2 - La criminologia tra diritto ed evoluzione della società 27 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 27 29 32 36 38 39 46 49 51 Le teorie illuministiche La concezione liberale del diritto penale: Cesare Beccaria La Scuola Classica Il crimine: primi approcci statistici e sociologici La Scuola Positiva Cesare Lombroso e gli studi sulla personalità del delinquente La Scuola Positiva e i diversi contributi La Nuova Difesa Sociale Il contributo marxista 3 - I metodi e le fonti delle conoscenze criminologiche 55 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 55 57 58 59 65 Metodi e fonti della ricerca criminologica La ricerca di tipo quantitativo La ricerca di tipo qualitativo Altri strumenti applicati alla ricerca Il numero oscuro 4 - I fenomeni inducenti al delitto 69 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 69 71 72 75 76 La delinquenza e l’età Relazione tra razza, nazionalità e delitto Immigrazione e criminalità Pauperismo e criminalità Sistemi di controllo sociale 5 - L’imputabilità 79 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 79 83 86 89 96 101 I fondamenti dell’imputabilità Concetto di infermità Stati emotivi e passionali Imputabilità e abuso di alcool e stupefacenti Imputabilità dei minorenni La recidiva 6 - Forme di criminalità 103 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 103 106 111 115 119 121 125 127 128 130 131 132 133 133 135 141 142 144 146 148 149 150 Le sottoculture criminali Famiglia e delittuosità La criminalità economica La criminalità informatica La criminalità organizzata e le moderne tecnologie La criminalità stradale La criminalità bianca (o dei colletti bianchi) La delinquenza ed il teppismo allo stadio Il terrorismo internazionale Usura ed estorsioni Criminalità comune Criminalità ecologica Omicidi colposi per infortuni sul lavoro Criminalità e paranormale Sètte e criminalità La criminalità rurale Famiglia, scuola, mass-media e criminalità La criminalità clericale La criminalità femminile Gli omicidi in condominio I minori e l’uso distorto delle tecnologie di comunicazione Le risposte alle devianze minorili 7 - Aggressività e anormalità personologica 159 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 159 160 162 164 166 170 L’aggressività Criminali aggressivi Delinquenti normali e anormali I delitti sessuali tra violenza ed aggressività Asfissia autoerotica (o asphyxophilia) Necrofilia e necrofagia 8 - Le teorie criminologiche 175 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 175 176 176 177 177 178 178 179 179 180 180 181 182 182 183 Teoria delle aree criminali Teoria della patologia sociale Teoria dei conflitti culturali Teoria delle associazioni differenziali Teoria dell’identificazione differenziata Teorie sottoculturali Teoria dell’anomia secondo Merton e Durkheim Teoria dell’immunità differenziale Teoria del numero oscuro Teoria dell’etichettamento Teoria della disorganizzazione sociale Teoria delle aree naturali della criminalità Teoria delle tecniche di neutralizzazione Teoria delle opportunità differenziali di Cloward e Ohlin Teoria dello stimolo rafforzatore differenziato di Burgess e Akers 9 - Criminologia e psicologia 185 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 185 187 190 192 193 197 Il contributo della psicoanalisi La teoria analitica di C.G. Jung La psicologia del comportamento L’integrazione psico-ambientale La teoria non direzionale dei Glueck La teoria dei contenitori 10 - Il comportamento umano 201 10.1 10.2 10.3 10.4 201 202 204 205 Gli studi sul comportamento umano La predisposizione al crimine Il comportamento criminale violento Il cannibalismo 10.5 Il ruolo della psichiatria forense 10.6 La macchina della verità (o poligrafo) 206 208 11 - Criminalità e disturbi mentali 213 11.1 Evoluzione storica del concetto di malattia mentale 11.2 Rilevanza dei disturbi mentali ai fini della responsabilità 11.3 Relazione tra disturbi mentali e pericolosità 11.4 Le nevrosi 11.5 Le psicopatie 11.6 Le psicosi 11.7 La schizofrenia 11.8 La paranoia 11.9 L’epilessia 11.10 Il border-line 11.11 Le perversioni sessuali 11.12 Le parafilie 11.13 La pedofilia 11.14 La depressione e l’euforia 213 219 220 223 227 229 231 234 236 238 242 244 246 252 12 - Droga ed alcool nell’agire delittuoso 255 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 255 260 263 273 276 277 278 279 La diffusione della droga e l’evoluzione legislativa Consumatori, tossicodipendenza e tossicomania Le sostanze stupefacenti Relazione tra sostanze stupefacenti e delitto L’alcolismo Etilismo acuto e cronico Relazione tra alcolismo e delitto Tossicomania e adolescenza 13 - La criminologia clinica 283 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 283 284 288 290 293 Introduzione L’osservazione criminologica: il colloquio La prognosi delinquenziale La pericolosità sociale La vittimologia 14 - La violenza sulle donne e i processi di vittimizzazione 299 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 299 303 308 312 314 316 Le donne come vittime Le forme di violenza Donne e violenza intrafamiliare L’uxoricidio I centri anti-violenza Trattamento delle donne vittime di violenza PARTE SECONDA – ELEMENTI DI CRIMINALISTICA 15 - La criminalistica 323 15.1 15.2 15.3 15.4 323 328 332 333 La criminalistica e le sue origini La Polizia Scientifica RACIS e RIS UACV 16 - La medicina forense 337 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 337 338 342 343 345 351 352 354 356 360 365 Introduzione Cause di morte Il DNA Altre tecniche applicate al DNA Le nuove frontiere dell’entomologia forense Autopsia e interpretazione La tossicologia forense Le sostanze tossiche Le forme più frequenti di avvelenamento nell’uomo La perizia tossicologica La prassi della perizia tossicologica 17 - Il criminal profiling 369 17.1 Il criminal profiling 17.2 Scopi del profiling 17.3 Il ritratto parlato 369 371 375 18 - La scena criminis 377 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 377 378 Introduzione Il sopralluogo: aspetti giuridici Scena criminis: organizzazione e procedure per le operazioni di ricerca Reperti della scena criminis: tecniche di raccolta e di conservazione Il luminol La grafoscopica La biometria 380 384 395 396 399 19 - Scena criminis e reperti organici 405 19.1 19.2 19.3 19.4 405 406 406 407 Macchie di sangue umido e secco Campionamenti di sangue Liquidi organici Peli/capelli Bibliografia 409 PRESENTAZIONE è con immenso piacere che prendo visione del lavoro compiuto da Nicola Malizia, che si compendia in un interessante e atteso volume che riassume, a scopo didattico, il variegato complesso delle conoscenze che, a vario titolo, costituiscono il corpus della criminologia. Si tratta di un’opera intelligente che ha saputo fondere, nel presente volume, i contributi multidisciplinari, in particolare del diritto, della psicologia, della sociologia, della psichiatria, dell’antropologia criminale e della medicina-forense. Infine, l’ultima parte del volume contiene cinque capitoli dedicati alla criminalistica. Si tratta, in realtà, di una visione scientifica che tiene conto della natura interdisciplinare e multidisciplinare della criminologia, cui si dedicano i primi quattordici capitoli dell’Opera. Tuttavia, in un’analisi protesa al futuro, come quella compiuta dall’Autore, non si trascura la tendenza, ormai ampiamente realizzatasi nei Paesi di cultura anglosassone, di considerare le varie branche che compongono la criminologia, nell’ambito di un più generale albero da cui si diramano i rami delle scienze forensi. In realtà, quella che è ancora chiamata criminalistica, rappresenta uno spaccato sintetico ed essenziale del contributo delle scienze forensi all’investigazione criminale. All’inizio, l’Autore, esamina i cardini fondanti della disciplina, per poi procedere a una disamina delle metodologie e delle fonti delle conoscenze criminologiche. Analizza, altresì, le relazioni intercorrenti tra le fenomenologie delittuose e i fattori sociali, economici, istituzionali, situazionali, al fine di identificare le fattispecie criminose più comuni, sia tradizionali, sia di più recente emersione, dedicando una parte della trattazione alle teorie sociologiche, psicologiche e multifattoriali che concorrono alle spiegazioni del delitto. Lo studio delle implicazioni che seguono alla commissione dei crimini non può prescindere, secondo il Malizia, da un approccio incentrato anche sul ruolo della vittima, sempre più ritenuta, oggi, soggetto interagente nella complessa dinamica relativa alle origini, ai moventi e alle modalità dell’azione criminosa. è superfluo dire che l’Autore puntualizza in modo moderno e aggiornato alcune delle metodiche scientifiche della investigazione criminale che, oggi, sono molto note anche al pubblico dei non addetti ai lavori, come, ad esempio, lo psicologico profiling e l’analisi del DNA. Queste metodiche, peraltro, non sono avulse dal contenuto più generale dell’Opera, ma sono inserite in un contesto appropriato che parte dall’analisi scientifica della scena del crimine per individuarne i reperti fondamentali e per costruire, su di essi, le fasi 11 Criminologia ed elementi di criminalistica concatenate del procedimento investigativo. Il Volume è diretto agli studenti ed anche agli operatori del settore, e può trovare una ulteriore fascia di lettori anche nel pubblico più generale, perché è scritto in modo chiaro, non dà nulla per scontato, ed esprime compiutamente il pensiero dell’Autore, il quale, da anni ormai, insegna quotidianamente la criminologia in diversi corsi universitari e anche alla Forze dell’Ordine. Sono molto orgoglioso di concludere questa mia presentazione dicendo di conoscere personalmente il Malizia, del quale apprezzo le qualità umane e scientifiche. Mi è, inoltre, gradito constatare che la grande domanda di conoscenza, che negli ultimi anni si è espressa in Italia nel campo delle scienze criminali, abbia finalmente cominciato a produrre un’offerta, moderna, aggiornata, adatta alla formazione, non più costellata da semplici conoscenze, ma da contenuti e metodi di professionalizzazione. Sono convinto che anche in Italia, come negli altri Paesi, è già in atto una trasformazione sociale e tecnologica che porterà, sempre più, alla individuazione e valorizzazione delle competenze criminologiche in ambiti lavorativi diversi, crescenti e sempre più qualificati. 12 Prof. Francesco Bruno Docente di Criminologia all’Università LA SAPIENZA di Roma PARTE PRIMA CRIMINOLOGIA GENERALE CAPITOLO 1 Lo studio della criminologia 1.1 Le scienze criminali Le scienze criminali rappresentano, in una moderna dimensione scientifica, l’insieme delle conoscenze disciplinari focalizzate allo studio e all’approfondimento delle fenomenologie delittuose che interessano la società nel suo insieme. Tra questa scienze vi rientrano, oltre alla criminologia, la vittimologia, la politica penale (o criminale), il diritto penale, il diritto penitenziario, la psicologia giudiziaria e giuridica, la criminalistica. La vittimologia ha, da poco, guadagnato la dignità di scienza autonoma dalla criminologia, e ha per oggetto lo studio della vittima del crimine, della sua personalità, delle sue caratteristiche psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con il criminale, ovvero l’individuazione di quei fattori che determinano o facilitano la vittimizzazione di determinati soggetti o categorie di soggetti. Ma lo studio della vittima può contribuire, anche sotto il profilo delle tecniche di individuazione del reo, alla elaborazione del c.d profilo criminale dell’autore di un reato. Quanto alla politica penale, pur non potendola considerare come disciplina autonoma, è doveroso sottolineare che essa pone gli obiettivi che saranno successivamente perseguiti dal diritto penale: stimoli che sono frutto delle attuali sollecitazioni sociali in materia di prevenzione della criminalità, pensiamo, ad esempio, la depenalizzazione di alcune fattispecie superate di reati e la conseguente creazione di fattispecie delittuose nuove, come logica conseguenza del modificato sentire sociale. La politica penale, si avvale, nel fine ultimo di studiare, elaborare e proporre gli strumenti e i mezzi per combattere la criminalità, di molteplici saperi e altrettante discipline: pensiamo all’antropologia, al diritto penale e processual-penale, alla stessa criminologia, alla sociologia, alle scienze economiche, a quelle morali e filosofiche. Se la politica criminale è un aspetto della politica sociale, e attribuisce al diritto penale il ruolo di estrema ratio, quest’ultimo è, al tempo stesso, suo strumento e limite. 15 Criminologia ed elementi di criminalistica Mentre lo scopo della prima (politica sociale), infatti, consiste nella prevenzione della criminalità, il secondo (diritto penale), definendo di fatto i singoli crimini e le risposte che a essi vanno date, diventa il mezzo di attuazione di tale politica. Il diritto penitenziario è costituito dall’insieme delle disposizioni legislative che regolano la fase esecutiva del procedimento giudiziario penale. Recentemente, questa disciplina ha allargato il raggio di azione del proprio intervento, dalla semplice carcerazione alle varie forme di misure sostitutive o alternative alla pena detentiva. Legittimità di scienze criminali hanno anche la psicologia giudiziaria, che approfondisce le interrelazioni psicologiche tra i vari protagonisti del procedimento giudiziario (dalla persona offesa al testimone, dall’imputato al magistrato, sino all’operatore amministrativo), e la psicologia giuridica, ramo della psicologia applicato al diritto. Infatti, proprio lo studio e la comprensione dell’atteggiamento psicologico assunto dai vari soggetti che, direttamente o indirettamente, vengono in contatto con il procedimento giudiziario, si fà sempre più importante, anche dal punto di vista pratico: pensiamo al perito che deve analizzare l’imputato, al difensore nell’ambito della scelta delle strategie difensive, all’èquipe di osservazione e trattamento in ambito penitenziario, e così via. Uno dei settori in cui, maggiormente, la ricerca è stata approfondita è quello della psicologia della testimonianza; ma pensiamo, anche, alle tecniche di conduzione dell’esame incrociato nel processo penale, ai rapporti tra le varie figure professionali che vengono a contatto – e talvolta collidono – nelle aule di giustizia, o, addirittura, tra i componenti laici e togati di un medesimo collegio giudicante. La criminalistica, invece, utilizza una serie di conoscenze, per far fronte ai problemi di indagine di investigazione criminale. Può intendersi come l’insieme delle molteplici tecnologie e saperi che vengono utilizzati per l’investigazione criminale, come la balistica giudiziaria, la dattiloscopia, l’analisi di materiali biologici, dei gruppi sanguigni, delle tracce ematiche, del DNA per l’identificazione del colpevole, la ricerca dei residui di polveri da sparo, e inoltre, la medicina legale, la grafometria e la comparazione calligrafica, nonché, le indagini tossicologiche. La medicina legale tratta dell’applicazione delle conoscenze mediche al diritto, contribuendo alla elaborazione, interpretazione e applicazione di precetti giuridici che riguardano la tutela della vita e dell’integrità psico-fisica. Se da un lato, mantiene ancora l’indirizzo giuridico-forense e i tradizionali rapporti con l’amministrazione della giustizia occupandosi dello studio del cadavere e della medicina del delitto, dall’altro, particolarmente in Italia, i suoi compiti investono, ormai, tutti i rapporti fra la persona umana e l’ordinamento giuridico-sociale, trovando un’ampia collocazione nell’ambito del S.S.N.; questa apertura sociale dipende dalla valorizzazione degli aspetti medicolegali della malattia, affinché il cittadino sia reintegrato, non solo nello stato di salute, se possibile, ma anche nello stato economico, fruendo di ogni altro beneficio riconosciutogli in applicazione delle leggi sociali. Ogni fatto medico può nascondere svariati risvolti giuridici; il compito della medicina legale è proprio quello di partire dalla situazione clinica per verificare l’applicabilità di una normativa lungo un iter che, passando attraverso una semeiotica, talvolta peculiare, non ha il fine diagnostico-terapeutico, ma quello di determinare l’effettiva natura ed entità degli esiti di un particolare evento e di accertare il nesso di causalità materiale fra tale evento e gli esiti stessi (giudizio medico16 Lo studio della criminologia legale), con specifico riferimento all’ambito giuridico di competenza (penale, civile, assicurativo, ecc.). La metodologia medico-legale si applica alla diagnosi, alla prognosi e ai giudizi conclusivi che rappresentano il presupposto per la risposta a quesiti di interesse medico e giuridico. 1.2 La criminologia come scienza Bandini, nei primi anni novanta, sosteneva che la criminologia appare incerta circa le proprie finalità ed il proprio oggetto di studio, risulta divisa in indirizzi talvolta profondamente contrastanti, è condizionata da una situazione di profonda crisi, che in molti casi limita lo sviluppo, l’affermazione e la diffusione della disciplina stessa. Oggi, da parte di coloro che si approcciano allo studio della criminologia, si riscontra, per lo più, il desiderio di conoscenza delle metodologie che ineriscono, ad esempio, la criminologia clinica o applicata, oppure la criminalistica, tenuto conto, peraltro, anche della continua influenza mediatica su tali argomentazioni; ciò, a detrimento del necessario e primario approccio alla criminalità che deve concretizzarsi, in primis, nella conoscenza di quella che possiamo definire come la storia e l’evoluzione della criminologia. Nell’ultimo decennio, si è assistito ad un intenso dibattito sul ruolo di quest’ultima. Da un lato, è considerabile come scienza multidisciplinare, dove per multidisciplinare si intende quella singola branca del sapere che, per il suo autonomo sviluppo, richiede necessariamente competenze molteplici. La criminologia, pertanto, avrebbe questa caratteristica in quanto si occupa del fenomeno criminoso secondo plurime prospettive, e, in essa, andrebbero a confluire e ad integrarsi le conoscenze esistenti sul fenomeno delittuoso. Se si mantiene questo status, la criminologia, sembrerebbe orientata a rinunciare a una propria autonomia, in quanto si ripropone il problema di come una disciplina possa costituirsi quale momento di sintesi e di integrazione di conoscenze provenienti da discipline tra loro eterogenee. Per uscire da questa impasse, allora, è necessario considerare la criminologia come scienza interdisciplinare; ciò presuppone il dialogare con altre discipline autonome con le quali ha in comune lo studio del comportamento antigiuridico o antisociale, allo scopo di conoscere le sue cause e di realizzare adeguati programmi di prevenzione e di trattamento. La interdisciplinarietà, però, viene dagli studiosi considerata come una sorta di espediente epistemologico, tenuto conto che il criterio interdisciplinare non può riguardare una singola disciplina, e presuppone un’interazione fra distinte discipline, le quali possono interagire, se hanno già acquisito un’identità (e forse una pseudoautonomia), e se sono nella condizione di apportare, attraverso propri schemi concettuali, un proprio modo di definire i problemi e di impostare la ricerca. L’interdisciplinarità è un momento di convergenza funzionale ed entra in gioco successivamente al fatto che più discipline abbiano affrontato uno o più problemi in comune, tenuto conto della propria specificità e delle proprie strategie interpretative. Penati, ad esempio, sostiene che l’introduzione di un criterio interdisciplinare non preceduto da uno studio preliminare e necessariamente distinto per discipline, livellerebbe genericamente il sapere al grado di mera esperienza effettuale e di confuso ten17 Criminologia ed elementi di criminalistica tativo di una sua espressione globale non strutturata: impedirebbe, cioè, quell’articolazione analitica e quel ripensamento critico originale e creativo che costituisce l’essenza dell’assimilazione culturale della realtà da parte dell’uomo. L’interdisciplinarità è accostamento e utilizzazione di teorie e modelli sviluppati nell’ambito di determinati contesti e paradigmi dotati di linguaggi loro propri, e, come tale, “porta a una semplice sovrapposizione di fuochi giungendo, quindi, nel migliore dei casi, a enunciare proposizioni tautologiche, e, nel peggiore, alla confusione.” Ponti, all’inizio, aveva caratterizzato la criminologia come scienza multidisciplinare e interdisciplinare, successivamente rivede la propria posizione rispetto all’interdisciplinarità, affermando che la criminologia è scienza a carattere interdisciplinare, in quanto, ha anche la necessità di coltivare rapporti interdisciplinari. L’immagine della criminologia quale scienza sintetica si giustifica se essa è concepita in termini di scienza empirica, caratterizzata dal metodo induttivo, e fondata sull’osservazione tale che la scienza si riduce a un insieme di asserzioni che descrivono osservazioni, e che aumenta e progredisce amplificando il volume delle asserzioni che descrivono osservazioni. Vassalli, afferma che la criminologia esprime, oramai, l’aspirazione a una visione unitaria e sintetica del fenomeno individuale e sociale della delinquenza, nella quale si compongono le diverse esperienze e le diverse conoscenze che, a tale visione, il più possibile compiuta, possono contribuire, ordinate in relazione a chiari punti di partenza comuni e secondo una comune finalità di verità obiettiva, le conoscenze intorno al fenomeno delittuoso, ai suoi fattori, al suo modo di manifestarsi, ai suoi effetti individuali e sociali, alla sua valutazione e comprensione. Collegato a questo approccio è il metodo induttivo, secondo il quale la ricerca scientifica parte dall’osservazione, per poi, con cautela, passare alle leggi generali. Il passaggio da asserzioni particolari ad asserzioni generali viene, quindi, giustificato sulla base di un’accumulazione di fatti-asserzioni. La codificazione della criminologia come scienza sintetica deriva dall’avere confuso la comprensibile aspirazione a un sapere, il più articolato possibile, sulla questione criminale con la codificazione della criminologia quale scienza interdisciplinare, multidisciplinare. Secondo questa interpretazione, alla criminologia può essere attribuito il compito di comporre le diverse esperienze e conoscenze intorno al fenomeno delittuoso, alle sue manifestazioni, ai suoi effetti, alla sua valutazione e comprensione, purché, si prenda atto che la criminalità e il comportamento criminoso possono essere ricondotti ad unità, unicamente se si abbandona l’illusione di poter costruire un’unità disciplinare sulla base di un’integrazione di conoscenze appartenenti a discipline e professioni diverse. Allo stato attuale, tuttavia, i criminologi tradizionali non appaiono in grado di risolvere le contraddizioni della loro codificazione di criminologia, soprattutto, perché non hanno posto attenzione sul fatto che, allorché discipline e professioni diverse interagiscono, non si limitano a offrire un contributo autoreferenziale, ma producono frammenti di conoscenza e di operatività che sfuggono ai rispettivi vincoli. Per la criminologia diventa, allora, necessario immaginare che i saperi costitutivi del diritto, della medicina, della pedagogia, della psichiatria, della psicologia, della sociologia, pur conservando autonomia e originalità, rappresentano frammenti conoscitivi 18 Lo studio della criminologia e operativi che si producono durante il confronto disciplinare e professionale e che confluiscono in questo spazio; diventa, di conseguenza, necessario, prevedere un metodo che si caratterizzi quale ricerca delle condizioni che consentano al confronto di non ridursi a mera sommatoria di dati, ma che trasformi la connessione in risorsa di complementarità. Calzante l’esempio di Pisapia a proposito del dibattito sull’autonomia della criminologia. Si immagini un appartamento composto da più locali. Ognuno di questi locali rappresenta una disciplina o una professione interessate a offrire un contributo alla questione criminale: criminalistica, diritto, pedagogia, politica criminale, psichiatria, psicologia, servizio sociale, sociologia, ecc. Se si considera la criminologia (che per autodefinizione si pone quale scienza del crimine) una delle discipline interessate alla questione criminale, essa andrebbe a occupare una delle stanze dell’appartamento e non potrebbe essere delineata quale disciplina che sintetizza e integra, le conoscenze prodotte dalle altre discipline. Se identificassimo la criminologia con l’edificio che contiene quell’appartamento, essa, avrebbe la presunzione di porsi come metascienza, e le altre discipline non sarebbero che sottodiscipline della criminologia. Si pensi, invece, alla criminologia come al corridoio che attraversa i confini delle diverse stanze, corridoio che le distingue l’una dall’altra, ma che consente, a queste, di comunicare. Allorché emerge una situazione che chiama in causa alcune delle discipline presenti, ognuna di queste supera la propria soglia e, sulla base della propria competenza, porta uno specifico contributo. La criminologia, rappresenta, in quanto spazio comune e condivisibile, la condizione affinché questi contributi possano confrontarsi, mantenendo, ciascuna, la propria identità; essa si pone come spazio al cui interno le differenti discipline e professioni producono frammenti di conoscenza e di operatività che sfuggono ai rispettivi vincoli. L’immagine di criminologia che emerge è quella di un’area di sapere che si caratterizza quale potenzialità progettuale di connessione e, quindi, a mano a mano che si sviluppa il processo di interazione, quale competenza metodologica che si sostanzia nella possibilità di trasformare i contributi delle diverse discipline e professioni in risorsa di complementarità. La criminologia, pertanto, non si pone come motore di rielaborazione delle conoscenze acquisite da altre discipline, né rappresenta, per tale motivo, una scienza di secondo livello, né una metascienza nel dare senso e significato alle altre scienze; al contrario, si presenta come dimensione di costruzione di nuove conoscenze. La criminologia, pertanto, deve essere intesa quale metodo di regolazione disciplinare e professionale che attiene, non solo alla fase successiva all’emergere del confronto, ma che riguarda i processi, grazie ai quali, questa interazione si origina e si sviluppa. Canepa, a tal proposito, sosteneva che la criminologia dovesse essere concepita come ricerca criminologica. Un’intuizione, come lo stesso affermava, che è stata troppo presto abbandonata; si è preferito attestarsi sull’idea di criminologia quale scienza interdisciplinare del comportamento antisociale nelle sue varie forme: dal semplice disadattamento alle forme di antisocialità più definita in senso oppositivo, fino al comportamento delittuoso (antisocialità come delitto). 19 Criminologia ed elementi di criminalistica All’interno della ricerca criminologica, Canepa individua una ricerca fondamentale che studia le cause del comportamento antisociale prescindendo dall’utilizzazione pratica dei risultati, e, una ricerca applicata che si concreta nella programmazione di interventi per la prevenzione del comportamento antisociale. La criminologia, più che una disciplina in senso tradizionale, è, quindi, concepita come ricerca delle condizioni che consentono di strutturare domande e offrire risposte sui diversi aspetti che compongono la questione criminale: dalla produzione delle norme alle definizioni sociali di devianza e di criminalità; dall’applicazione delle norme, all’applicazione effettiva delle definizioni sociali di criminalità e devianza a soggetti specifici; dalla condanna di coloro che sono ritenuti autori di reato all’esecuzione della pena e delle misure di sicurezza, senza trascurare le vittime di reato. Norme di condotta e regole di interazione accompagnano l’individuo nella maturazione della propria esperienza sociale nel corso della vita quotidiana, ed è anche a questo insieme di norme e di regole, denominato normativo-quotidiano, che il criminologo, ma non solo il criminologo, può fare riferimento. Il fatto che l’interesse dei criminologi tradizionali sia stato quasi sempre il momento in cui le norme di condotta danno corpo a situazioni considerate socialmente negative non può fare dimenticare che una situazione problematica può essere spiegata se si hanno gli strumenti analitici per delineare le condizioni che rendono possibile un’esperienza di incontro con le norme di condotta, al fine di spiegare anche il momento di conflitto. È in un secondo momento - sul piano logico e su quello dei tempi di vita individuali - che ci si dovrebbe preoccupare di spiegare anche le articolazioni del confronto normativo che assumono caratteristiche problematiche e che, comunque, non necessariamente sfociano nel reato. De Greef riteneva la criminologia scienza in sé inesistente, sia per l’incertezza, e la contingenza, che per l’ipoteticità delle sue teorie. Se una scienza deve rispondere ai criteri di sistematicità e controllabilità, si può certamente affermare, che, ai due criteri, risponde, perfettamente, la criminologia. Per sistematicità, si intende la costruzione di un complesso di conoscenze acquisite su un determinato oggetto, integrate, in un complesso armonico e strutturato. Per controllabilità, la possibilità di sottoporre tali conoscenze al c.d. controllo di validità, sotto il profilo empirico e logico-formale. Accanto alla sistematicità ed alla controllabilità, si riscontrano: la capacità teoretica, quella cumulativa, ed infine, quella predittiva. La capacità teoretica di una scienza, si concretizza nel trasformare in proposizioni astratte – unite da nesso logico – proposizioni costituenti la c.d. teoria, finalizzate a spiegare i rapporti causali, le correlazioni, nonché le variabili dei fatti, oggetto della sua analisi, derivanti da molteplici osservazioni e dati. La capacità cumulativa consiste, invece, nella caratteristica delle scienze di analizzare, correggere, amplificare o perfezionare, attraverso teorie più recenti, quelle in precedenza formulate. La capacità predittiva consiste nello sforzo di potere prevedere comportamenti dei singoli soggetti e dell’intera collettività, anche se è d’obbligo precisare che la predizione – per tali dimensioni – presenta limiti obiettivi e fisiologici. 20 Lo studio della criminologia 1.3 L’orizzonte della criminologia Il campo di indagine della criminologia è identificabile nello studio dei fatti delittuosi, in quello degli autori di fatti antigiuridici (qualificati come reati), delle molteplici forme di reazione sociale alla criminalità diffusa, dello studio personologico della persona offesa nel reato (vittima), nonché dei fenomeni di devianza. Studi paralleli alle scienze criminali sono stati compiuti anche da altre discipline, quali la psichiatria, l’antropologia criminale, la sociologia, la statistica, la pedagogia, discipline che hanno fornito, e continuano a fornire, spunti scientifici di applicazione di indubbio valore e significato. Nonostante le diverse sistemazioni teoriche che si sono avvicendate nel tempo, e tenuto conto che la criminologia ha compiuto passi da gigante, fino ad oggi, sul piano scientifico, e del posto importante che ha finito per occupare tra le attività istituzionali, ancora oggi, le domande rimangono le stesse: • • • quanto sono vasti i confini della criminologia? qual è il suo campo di indagine e che cosa ricade sotto la sua osservazione? che tipo di relazione dovrebbe sussistere tra la criminologia e le altre discipline che si occupano dei medesimi oggetti? Bruno osserva che sostenere che la criminologia è una scienza multidisciplinare e interdisciplinare non è un'asserzione chiara e definitiva. Se si vogliono utilizzare definite e utili categorie concettuali per identificare il nucleo duro della disciplina, e capire il ruolo della criminologia moderna, si deve andare più in profondità a spiegare il significato reale delle parole, adottando un approccio che possa considerarsi effettivamente comprensivo e sistematico. Selling afferma, ad esempio, che il termine criminologia dovrebbe essere usato per designare il corpo di conoscenze scientifiche disponibili sul crimine. Il problema, tuttavia, non è risolto, nè da questa, nè da altre più lunghe e complesse definizioni. Infatti, nuove difficoltà sorgono proprio dalla necessità di dare una definizione operativa e, quindi, utilizzabile della parola crimine. Il crimine può essere definito sia come un fenomeno sociale che come un tipo di comportamento umano, sia come una violazione o infrazione della legge che come un atteggiamento morale mirato al male. La scelta dell’uno o dell’altro significato può dipendere non solo dal punto di vista che si preferisce, ma, anche, dallo scopo che si vuole raggiungere con l’analisi. Se ne deve concludere che molte e differenti prospettive coesistono insieme con molti e diversi aspetti dello stesso oggetto, nello stesso tempo e nello stesso spazio. L’unico quadro di riferimento che fornisce significato stabile e continuità ad una tale realtà così mutevole e dinamica è rappresentato dall’essere umano che può essere considerato come l’elemento essenziale che partecipa, in quanto tale, sia al sistema osservante che a quello osservato. Questa duplicità appare ineliminabile ed è ancora più complicata quando l’oggetto dell’osservazione è il comportamento dell’uomo che promana direttamente dal suo cervello, che si trova, così, ad essere contemporaneamente oggetto e soggetto di analisi e di ricerca. 21 Criminologia ed elementi di criminalistica Per questo motivo, non si può continuare a fare ciò che si è fatto da sempre, cioè considerare l’uomo, di per sè, avulso da ogni rapporto e da ogni condizionamento o, all’opposto, studiare i gruppi sociali come se fossero composti non da uomini, ma da nuclei immutabili e scarsamente interagenti. Al contrario, l’uomo non può essere studiato se non all’interno del suo ambiente e in rapporto con i diversi sistemi cui può partecipare nell’ambito di un definito quadro concettuale di realtà. Ne consegue che se ciò è vero, è vero anche il reciproco, quindi i gruppi, gli insiemi e i sistemi non possono considerarsi se non nel rapporto essenziale con l’uomo e nel significato e nella finalizzazione umani della loro esistenza. Fino ad oggi è avvenuto l’esatto opposto, e gran parte delle nostre acquisizioni scientifiche rappresentano, non l’immagine della realtà, ma quella di modelli estremamente semplificati e astratti che tendono a comprendere le strutture elementari dei fenomeni, talché si possa passare, successivamente, dal particolare al generale, e intuire, così, le leggi che governano l’universo. In altri termini, la scienza si è sempre affannata a ricercare, a tutti i livelli, gli elementi significativi dell’ordine della natura, cercando di distinguerli da quelli che rappresentano i residui del caos primigenio. All’inizio, tutto appariva semplice, tutto sembrava inquadrarsi in un grande e perfetto disegno, ma, poi, il progresso stesso della fisica ha finito per identificare delle grandi contraddizioni che, tuttora, appaiono non risolte. Lo stesso Einstein, che credeva di aver collocato ulteriori e rilevanti tessere alla ricostruzione del grande mosaico del sapere, morì, cercando, senza riuscirci, di elaborare una teoria unificata delle forze che gli consentisse di dimostrare ciò che riassunse felicemente nel celebre aforisma: Dio non gioca a dadi con l’universo. Le scoperte della fisica sembrano, però, indurre a pensare il contrario: i principi della termodinamica, l’incremento dell’entropia, il principio di non determinazione di Heisemberg, la scienza dei quanti, ecc., dimostrano come la costruzione teorica non possa essere mai considerata perfetta, e come nella natura e nell’uomo non regni la perfezione, ma, al contrario, predomini l’imperfezione. Nella natura non si riscontrano mai quelle perfette forme geometriche che l’uomo riesce a concepire e ad elaborare, ma, al contrario, essa è fatta di forme complesse ed irregolari che solo la moderna scienza ci consente di conoscere meno approssimativamente. In ogni caso, allo stato delle cose, è oggi evidente che caos ed ordine non sono termini rigidamente contrapposti, e che ognuno dei due può contenere l’altro. La scienza moderna non può fare a meno di entrambi e, se da una parte prosegue nei suoi processi di astrazione per modelli, dall’altra cerca di capire i fenomeni più complessi, attraverso tecniche che consentano un più diretto approccio alla realtà, come ad esempio, la teoria dei sistemi. È importante che nelle scienze umane si adottino approcci e modelli che siano considerati, oggi, più vicini alla realtà e che, se non ne consentono ancora una perfetta comprensione, per lo meno, non siano fuorvianti o addirittura mistificanti. In criminologia, infatti, come in tutte le cosiddette scienze umane, è assai difficile trovare le prove di quanto si sostiene, e ricerche, teoricamente e spesso anche metodologicamente sbagliate, non solo non consentono di verificare le ipotesi poste, ma for22 Lo studio della criminologia niscono dati incontrollati ed incontrollabili che nascondono e mistificano la verità, al posto di palesarla. Per questo motivo, è essenziale che l’approccio sia corretto e che il quadro di riferimento teorico del ricercatore, ma anche del professionista criminologo, sia improntato a chiare nozioni operativamente definibili e scientificamente fondate. A proposito del valore fondamentale della ricerca, il quadro di azione designato da Bruno, sembra, oggi, essere il più osservato: • • • • • • • • • • • la necessità della completezza e dell'aggiornamento della documentazione; la necessità del contributo critico preliminare e successivo degli altri ricercatori; l'indipendenza e la responsabilità del giudizio; il rifiuto di ogni pregiudizio culturale, ideologico o religioso; la libertà del ricercatore; la critica dei fanatismi; l'accettazione della realtà, comunque essa sia; la conoscenza e l'accettazione delle diverse realtà e specificità culturali; il principio della collaborazione tra gli uomini di diversa razza e cultura; la ricchezza del dubbio; il coraggio di difendere e anche di cambiare le proprie opinioni. L'approccio si basa su di una chiara definizione dei seguenti concetti fondamentali: • • • il concetto di realtà; il concetto di norma; il concetto di sistema. Da questi derivano, poi, ulteriori concettualizzazioni di base riguardanti l'operatività in campo criminologico: si tratta di tutte quelle definizioni di concetti che rendono possibile l'adozione di strategie e di strumenti mirati all'intervento e alla trasformazione della realtà attraverso lo schema: formazione - operazione - valutazione. 1.4 Delitto e sua definizione La condotta delittuosa, come già precisato, rientra nell’ambito dell’oggetto di studio della criminologia. Il delitto, che trova una sua definizione nel diritto positivo, va inteso come quel fatto che la legge penale considera tale per definizione sociale o per convenzione. Il concetto di delitto naturale, sin dal secolo scorso, si contrappone a quello di delitto come fatto contingente di natura storico - sociologica, partendo dall’idea di un reato con caratteristiche non mutabili nel tempo e nello spazio, poiché valori primari come la salute, l’integrità fisica, la vita, lo sono parimenti. Ne è testimonianza il fatto che l’omicidio, ad esempio, presente in tutte le epoche e in tutte le civiltà, sia stato sempre considerato come fatto totalmente illecito e universalmente infausto, tale da concludere che i valori umani derivino, non da princìpi di 23 Criminologia ed elementi di criminalistica carattere duraturo, bensì, dai processi culturalizzanti e socializzanti. Mantovani (e altri autori) ha creduto di individuare, oltre alle variabili storiche della criminalità, che fanno mutare nel tempo l’identificazione delle singole ipotesi di delitto, anche delle costanti, indipendenti, sia dalle valutazioni variabili del legislatori, sia dalle evoluzioni dei valori esistenti nei sistemi sociali. Le costanti sono rappresentate dai delitti naturali e da alcuni princìpi basilari, come le categorie razionali del pensiero penalistico, quali la condotta, la causalità, l’evento, la capacità, il dolo, la colpa, il soggetto passivo, le conseguenze penali, e così via. Prendendo campo l’inaccettabilità dell’idea di delitto naturale, si cercò, attraverso il principio dell’antisocialità o della pericolosità sociale, di strutturare una nuova teorizzazione per definire il delitto. La Scuola Positiva, per esempio, incentrava la politica criminale proprio sulla pericolosità, definita quale tendenza innata a compiere delitti, anche non ponendo in essere condotte legalmente proibite; pericolosità e antisocialità, rappresentavano, pertanto, solo giudizi in ragione di caratteristiche psico-somatiche o di status: tutto ciò equivaleva, quindi, a considerare antisociali anche coloro che non commettevano reati, ma che ne venivano riconosciuti capaci. Il criterio dell’antisocialità, ritenuto un puro giudizio di valore, e strettamente connesso e variabile al mutare della cultura e dei suoi contenuti, non poteva risultare un metodo valido. Si è tentato, a questo punto, di distinguere i delitti in base al criterio della maggiore o minore gravità. Alla base di tale tentativo, il primo problema da affrontare riguarda lo stabilire – a priori – ciò che può risultare grave, da ciò che tale non può essere considerato. La criminologia, sulla base di questa distinzione, avrebbe il compito di occuparsi solo dei primi e di trascurare i secondi; tra questi ultimi, rientrerebbero fattispecie criminose come la corruzione, l’illecito finanziamento ai partiti, l’evasione fiscale ecc., che, per lungo tempo, sono stati qualificati come secondari, ma che nell’ultimo ventennio hanno impegnato, e non poco, la magistratura. La gravità del reato, prevista all’art. 133 del codice penale, rappresenta uno dei parametri per l’applicazione discrezionale tra minimo e massimo della pena. Il criterio della maggiore o minore gravità del delitto, seppur criticato, riflette, però, l’impegno della criminologia in ordine, ad esempio, alla penologia minorile, laddove, per i c.d. reati bagatellari, cioè di scarsa rilevanza sociale, a seguito della riforma della giustizia minorile, è stato previsto, dal legislatore, l’istituto della rinunzia all’azione penale. La criminologia, comunque, non è destinata a occuparsi solamente dei reati più gravi che scuotono la società, ma di tutte le fattispecie di reato che possono tradursi in possibile fonte di indagine, anche se è necessario ricordare che la valutazione di maggiore o minore gravità spetta al Legislatore e al Giudice, nelle diverse sedi, e non alla criminologia o al criminologo. Inoltre, nemmeno la distinzione tra azioni che sono illecite per la loro stessa natura (mala in se) e quelle che sono tali perché proibite (mala quia proibita) possono delimitare il campo della criminologia, poiché è da ritenersi convenzionale e mutevole con le trasformazioni della società. La criminologia, secondo alcuni autori, non dovrebbe occuparsi dei c.d. delitti politici, o di terrorismo, o ancora, di delitti per motivi politici, poiché, sostengono che gli 24 Lo studio della criminologia attori di queste fattispecie si diversifichino da altri attori comuni o criminali comuni per la qualità delle ragioni ideologiche, dato che non sono mossi da motivazioni aggressive, egoistiche, lucrative, appropriative, che invece qualificano altri reati. Il compito del criminologo, in questo scenario, dovrebbe essere quello di qualificare un delitto come politico, ricercando la spinta ideologica che lo ha generato. Al fine di delimitare i confini del campo degli interessi della criminologia, è opportuno sottolineare che le condotte illecite sono esclusivamente quelle definite dalla legge e le indagini del criminologo devono avere origine da quelle definizioni. 1.5 Diritto penale e criminologia: quale rapporto? Quello che si può definire come contrasto dottrinale circa il primato del diritto penale o della criminologia, da tempo, può ritenersi concluso. È, infatti, superata l’impostazione del Ferri il quale, negando qualsiasi autonomia al diritto penale, lo riassorbiva, sostanzialmente, nella criminologia, ed è, al medesimo livello, caduta la pretesa di totale subordinazione rispetto al diritto positivo. Nuvolone, rimarcava come i rapporti tra le due discipline fossero spesso connotati da resistenza e difficoltà di comunicazione, di diffidenza, nonostante si trattasse di un contrasto concettuale artificioso, e che esistesse più di un terreno di incontro e di dialogo. L’asserzione del Nuvolone procedeva sulla base delle costanti e delle variabili in ambito penale e criminologico. Nessun primato da parte di una delle due discipline sull’altra, ma interdipendenza, autonomia, complementarietà, con il riconoscimento, sia di ambiti di competenza, sia di divergenze, al fine di una reciproca integrazione nelle scelte di politica criminale. Tra giustizia penale e criminologia può esistere infatti un divario di mezzi. La giustizia penale vigila perché siano rispettati i valori dominanti e le norme della società; opera, al fine di contenere la criminalità a livelli sostenibili; rimane ancorata al contesto del diritto positivo; rappresenta il complesso delle norme giuridiche che prevedono i singoli fatti illeciti, per i quali sono comminate conseguenze penali; è scienza normativa, legata a una impostazione di valori. La criminologia studia, invece, con orientamento multidisciplinare: l’evolvere della criminalità con il mutare dei costumi, la situazione socio-economica e l’orientamento politico-culturale dominante; le caratteristiche dei rei e il comportamento antisociale, in quanto espressione della personalità globale del suo autore; si arricchisce dell’apporto delle varie discipline afferenti; ha indirizzi di pensiero multipli; comprende, al suo interno, la criminogenesi e la criminodinamica, la metodologia di indagine sulla personalità, per giungere all’aspetto importante della c.d. prognosi dell’atto criminale, da intendere come previsione del comportamento criminale, sino al giudizio psichiatricoforense; la classificazione, prevenzione e trattamento dei rei; la organizzazione dei servizi di profilassi diretta ed indiretta, e l’assistenza, sia post-carceraria sia nel corso delle misure alternative; utilizza una metodologia che è esterna, se non estranea, ai compiti della giustizia penale; studia il funzionamento dei diversi sistemi di giustizia e di con25 Criminologia ed elementi di criminalistica trollo; contribuisce all’adeguamento delle norme di diritto positivo, nonché, alle acquisizioni scientifiche settoriali attraverso un’attività riformista. Se è vero che la criminologia costituisce una specie di camera di compensazione scientifica tra le varie discipline in lei convergenti, essa non può trarre vantaggio dalla semplice giustapposizione di queste, ma, soltanto, da una loro armonica sintesi. L’unico indirizzo suscettibile di garantirne lo sviluppo e l’efficacia operativa in appoggio al diritto penale è, pertanto, la integrazione, cioè il superamento delle barriere di parte, mitigando, quindi, le asprezze di alcuni suoi indirizzi più radicalizzati, cogliendo, nel singolo caso, le costanti e, nell’insieme, le differenze, legate all’aspetto naturalistico, usando tutti i mezzi scientificamente adeguati per una valutazione clinica individualizzata e per una corretta impostazione su base empiricamente documentata dei problemi più generali. Dal ruolo originale di scienza ausiliaria, la criminologia, è venuta così acquisendo il più penetrante ruolo di metascienza del diritto penale e della politica criminale, con funzione, non più soltanto descrittiva ed esplicativa del dato (accettato senza approfondimenti) della criminalità, ma critica rispetto ai processi selettivi dei fatti criminosi, della stessa definizione di criminalità e criminalizzazione, dei meccanismi e delle finalità dei controlli sociali. Il terreno sul quale diritto penale e criminologia più costruttivamente si incontrano è quello della politica criminale, in cui, autonomia di dati e di proposte, competenza in progettazione, elaborazione sistematica dell’impegno operativo, tecnica di attuazione, rappresentano terreno di verifica e di feed-back reciproco. 26 CAPITOLO 2 La criminologia tra diritto ed evoluzione della società 2.1 Le teorie illuministiche Nel Settecento, gli illuministi, nell’obiettivo di contenere il dominio incontrastato di uno Stato assoluto, tirannico e accentratore, suggerirono riforme decise, nelle quali gli ideali dell’umanità tratteggiavano il punto di forza, indirizzato a custodire la libertà dei cittadini contro un ordinamento giuridico alquanto arretrato, e contro lo stato di completa anarchia in cui l’amministrazione della giustizia versava. Il complesso delle riforme proposte, puntava, pertanto, alla effettiva difesa della libertà dell’individuo e alla ricerca di un punto di equilibrio, a quei tempi ancora precario, tra la difesa della società contro le azioni delittuose e il rispetto dei diritti del cittadino; gli illuministi riformatori, spinti dall’esigenza di annientare il vecchio sistema, sentirono il bisogno di agire in maniera chiara e immediata, mediante un programma di politica giudiziaria diretto a sconvolgere un sistema giuridico-sociale in cui dominava il dispotismo accentratore, che puntava, inesorabilmente, al completo abbattimento dei diritti di ciascun individuo. Sebbene, in quel periodo, fossero stati forniti utili ed eccellenti strumenti finalizzati a migliorare le condizioni in cui la pratica del diritto versava, gli illuministi riformatori non erano, tuttavia, in grado di portare a termine un progetto di rivisitazione sistematico e organico di carattere normativo. I propositi riformatori erano innegabilmente risoluti e arditi, di fronte all’attuale condizione di polverizzazione sociale e di depressione dell’ordinamento giuridico, ma le soluzioni studiate e rese note avevano un carattere disorganico, rispetto al rigore tecnico-giuridico che avrebbe dovuto sostenerle. Secondo gli illuministi, l’intimidazione e la vendetta come risposta al diritto leso non potevano, certamente, più bastare. La giustizia ed i giudici, pertanto, esercitavano un potere che era frutto di autentico arbitrio, giacchè stabilivano se considerare un fatto, come delitto, indicandone, al contempo, quantità ed entità della pena. 27 Criminologia ed elementi di criminalistica Tutto ciò si poneva in antitesi con lo spirito illuminista che contrastava energicamente il potere assoluto delle classi fino ad allora dominanti, la corruzione, la superstizione, l’arbitrio, contrapponendo - a tali dimensioni - la ragione, quale unica soluzione e come luce eterna ed universale, facendo riferimento al principio della libertà dell’uomo e dell’uguaglianza di tutti gli uomini, principio che si era oscurato per effetto della disfunzione delle strutture sociali. Cesare Beccaria e Pietro Verri, illustri esponenti dell’illuminismo giuridico italiano, ritenevano che l’obiettivo di riforma dell’ordinamento giudiziario potesse essere raggiunto attraverso una rigida rottura con il passato e che, comunque, dovesse essere improntato: a) alla semplificazione del sistema; b) alla formulazione di leggi chiare e di pronta e facile comprensione; c) alla meccanica applicazione del dettato legislativo da parte del giudice. Tutto ciò fa, inequivocabilmente, pensare a un manifesto eticopolitico pensato quale risposta immediata ai bisogni, non più rinviabili, della giustizia penale. Non possono essere sottesi i meriti che vanno riconosciuti alle riflessioni giuridicoilluministiche, che immaginarono un sistema giuridico, coerentemente e direttamente ancorato ai principi cui si ispiravano le nuove ideologie, anche se, in quelle meditate proposte di riforma, si notava l’assenza di una sistematica ricostruzione tecnico-giuridica delle delicate argomentazioni in discussione. La corrente di pensiero, ampiamente diffusa, che coincide, nella sostanza, con le proposte di riforma avanzate dagli illuministi del tardo settecento, votati alla distruzione di un apparato inefficiente e sostanzialmente iniquo, ancor prima di porsi il problema di costruirne uno nuovo, lascia, comunque, nell’ombra, quei progetti, come quello di Mario Pagano, che ideò una riforma integrale del sistema penale che trovava le radici nelle correnti di pensiero che, in quel periodo, puntavano a costruire solide basi di un sostanziale progresso civile. Pagano era cosciente della inutilità di ogni qualsivoglia tentativo di correzione legislativa priva di un’idonea valenza scientifica, e, quindi, si impegnò nello studio di una riforma organica del sistema penale, con il fine di estirpare le cause della crisi che imbrigliavano la giustizia penale. Nella concezione paganiana erano fortemente avvertiti, in una perfetta sintesi, da un lato, il rispetto dei diritti inalienabili dell’uomo, concepiti come diritti naturali e, dall’altro, la ferma difesa dei diritti dello Stato. Tenuto conto dell’insieme delle esigenze, particolarmente avvertite, della pratica il Pagano predispose un sistema penale articolato e completo, tanto da comprendere le parti tutte della ragion criminale: delitti, pene, prove, ordine di acquisire queste ed imporre quelle. L’oggetto del diritto criminale viene, pertanto, suddiviso in tre settori, dal momento che le leggi criminali o numerano i delitti e le proporzionate pene, e ciò forma la prima parte, ovvero fissano le prove richieste a dimostrare i delitti e questa è la seconda parte; o, finalmente, prescrivono l’ordine di giudizi criminali, vale a dire il processo, e quest’oggetto è compreso nella terza parte. Nella Considerazione sul processo criminale, tenta di delineare i caratteri fondamentali della riforma del processo penale e viene indicato il processo di tipo accusatorio,come quello che, meglio degli altri, è in grado di garantire la libertà dei cittadini ed assicurare, nel contempo, la giusta punizione dei colpevoli; nella Teoria delle prove, contro ogni 28 La criminologia tra diritto ed evoluzione della società preconcetta imposizione di schemi di giudizio, viene rivendicato al giudice il compito responsabile di valutare, in base al proprio libero convincimento, i fatti di causa, senza essere imbrigliato nel sistema meccanico delle prove legali. Nei Principii del Codice Penale, nonostante gli eccessi delle dottrine utilitaristiche, in un’epoca di relativismo dominante, viene ribadita l’idea della giustizia collegata a principi di diritto naturale, in vista della salvaguardia dei diritti di libertà dell’individuo. Le opere dello studioso Pagano rappresentano un unicum nel panorama riformistico illuministico, avendo dato un apporto costruttivo al progresso della scienza del diritto penale. Per la prima volta, infatti, con insolita nitidezza e cognizione delle difficili problematiche di fondo del diritto e della procedura penale, l’intera materia penalistica veniva sistemata, in maniera organica e armonica, intorno a principi fondamentali moderni e attuali, attraverso i quali veniva suggerita la riforma integrale del sistema penale, con l’obiettivo di dare alla giustizia un volto umano e coerente. Il Pagano, reperendo nel campo della giurisprudenza criminale un insieme di teorie sparsamente toccate, nè concatenate tra di loro, si proponeva di tracciare i principi fondamentali del diritto penale, conferendo dignità di scienza a questa branca del diritto, onde offrire, alla fine, al legislatore, gli strumenti per la realizzazione di un corpo di leggi unitario, organico e sistematico. “Ecco il nostro oggetto, ecco il piano, che ci abbiam proposto; ed ecco lo stato del Diritto Criminale, e di ciò che in esso vien desiderato” (Introduzione ai Principii). Il Pagano, nei Principi del Codice Penale, proponeva la riforma integrale del sistema penale, con la profonda cognizione che l’opera di rinnovamento sostanziale potesse essere realizzata solo elevando a dignità di scienza questa branca del diritto. È indubbio che sulla formazione culturale dei riformatori illuministi aveva fatto leva la lezione del Montesquieu, il quale aveva gettato le basi per il successivo dibattito penalistico settecentesco, condizionandolo profondamente, nel segno di una concezione garantista in cui la libertà del cittadino assurgeva a valore assoluto, non assoggettabile a mire utilitaristiche. Il Montesquieu, saldo difensore della libertà dell’individuo, ritenne quali punti prioritari del suo pensiero: il principio della separazione dei poteri, quello della inflessibile subordinazione del giudice alla legge, la ferrea difesa del principio della certezza del diritto, la enunciazione di leggi chiare e semplici, la coscienziosa osservanza delle formalità processuali che nel campo penale è, per i cittadini, garanzia di sicurezza. 2.2 La concezione liberale del diritto penale: Cesare Beccaria Le teorizzazioni di Cesare Beccaria furono, senza alcun dubbio, fondamentali per vivificare il dibattito su aspetti fondamentali di politica criminale, tanto da esortare alcuni sovrani illuminati, come Caterina II imperatrice di Russia, Giuseppe II imperatore d’Austria e Pietro Leopoldo granduca di Toscana, a imboccare la strada delle riforme legislative nella materia penale. 29 Criminologia ed elementi di criminalistica Il contributo dato dal Beccaria al progresso del diritto penale – con l’opera Dei delitti e delle pene – fu di indubbio valore, anche se non va sottovalutato che l’azione rivoluzionaria dell’autore, permeata da scopi prevalentemente umanitari, molto difficilmente avrebbe potuto consentire una costruzione tecnico-giuridica sistematica, poiché, i riformatori illuministi, nell’ottica di perseguire la meta di razionalizzare il sistema, per prevenire i reati e combattere l’arbitrio giudiziario, si comportarono più come politici del diritto, e meno come giuristi in senso rigorosamente tecnico. Quale espressione del pensiero francese, Dei delitti e delle pene, risente, secondo lo stesso Beccaria, delle letture di D’Alambert, di Diderot, di Elvezio e di altri enciclopedisti, incoraggiato, altresì, dal dibattito sui temi della giustizia che si svolgeva all’Accademia dei Pugni, alla quale, partecipava sotto la continua insistenza dei fratelli Verri. L’Accademia dei Pugni venne fondata nell’inverno 1761-1762, e la sua attività si protrasse fino al 1764. Animatore di quest’ultima era Pietro Verri il quale, fungeva, altresì, da coordinatore delle attività dei giovani che ne facevano parte. Nelle riunioni della società, cominciate fra pochi compagni a partire dall’inverno del ‘61-’62 e proseguite con grande successo di adesioni e di consensi nel ‘63 e nel ‘64, gli adepti discutevano, leggevano in comune, soprattutto le opere della letteratura inglese e francese in voga. Nessun programma od obiettivo preciso: l’atteggiamento complessivo dei soci era quello suggerito da chi teneva le redini. Una sorta di irriverenza e scansonatezza verso gli stereotipi della tradizione, e ancora, attenzione ed entusiasmo verso quello della nuova cultura e del nuovo mondo. Beccaria, che proveniva da un periodo di profondo sconforto, scopre nuovi stimoli, dopo aver pubblicato, appena un anno prima, un saggio intitolato Del disordine e dei rimedii delle monete, nel 1762, nello stato di Milano. Il Beccaria, a seguito della lettura delle opere degli enciclopedisti francesi e su spinta dei fratelli Verri, che gli avevano fornito anche la tematica, si interessò a tal punto che, entusiasta, iniziò a scrivere. Era, altresì, motivato dal forte stimolo ricevuto da Pietro Verri e dall’esperienza estremamente pratica del fratello Alessandro, il quale aveva ricoperto l’ufficio di Protettore dei carcerati, e, quindi, conosceva la penosa esperienza e le ancor tristi condizioni in cui versava un sistema penale che necessitava di essere transitato verso uno assolutamente nuovo. Così nacque il libro, osservò acutamente il filosofo Ugo Spirito, e le idee propositive in questo contenute, più che il risultato del pensiero dell’autore, appaiono come la sintesi di una intima collaborazione di tutti i componenti il gruppo del Caffè. L’importanza di questo intenso e appassionato dibattito, realizzatosi in un momento storico irripetibile, e grazie a una convergenza di forze animate da alti ideali, concepì un risultato importante, al quale presero parte e contribuirono tutti i partecipanti alle discussioni che avevano luogo nella c.d. Accademia dei Pugni. Fu in questo clima che si sviluppò Dei delitti e delle pene, definito, più tardi, come l’invocazione di un moralista che traccia le linee di una legislazione ideale, ispirata al rispetto della libertà. E anche se può essere condivisa l’opinione che tende ad escludere il Beccaria dal novero dei giuristi, questo, se mai fu un difetto, è stato rilevato, fu causa della sua forza propulsiva e della sua capacità di imporre la riforma di leggi inumane e inique (Vas30 La criminologia tra diritto ed evoluzione della società salli, Cesare Beccaria nel bicentenario del Dei delitti e delle pene, in La Scuola Positiva, 1964, 586). Dei delitti e delle pene era l’opera di un filosofo e non di un giurista. Le caratteristiche di quest’opera, i suoi contenuti, l’origine dai testi degli enciclopedisti francesi, procurano un’utile chiave di lettura dei suoi contenuti. I filosofi che frequentavano Il Caffè, non ignoravano l’importanza di discutere le problematiche del diritto penale e ne facevano anche oggetto di saggi, che, alla fine, però, non si prestavano ad essere considerate opere, per mancanza di rigore sistematico. L’opera di Beccaria può essere, pertanto, considerata come l’inizio della moderna storia del diritto penale. Un’opera accreditata in tutto il continente europeo, e che ricevette il plauso da parte dei massimi pensatori dell’epoca. Va sottolineato che il fine che l’autore si proponeva era quello di dare rilievo ai difetti delle legislazioni giudiziarie a lui contemporanee, e, nello stesso tempo, di prospettare possibili soluzioni per porre rimedio ai vuoti e alle ingiustizie dei numerosi sistemi penali. Cesare Beccaria, pienamente convinto del valore e della genuinità delle teorie di Jean Jacques Rousseau nel suo Contratto sociale, ed ammiratore del pensiero del filosofo inglese Locke, muove dal concetto della convivenza comune: gli uomini, sostiene, hanno sacrificato una parte delle loro libertà, accettando di vivere secondo le regole della comunità, in cambio di una maggiore sicurezza e di una maggiore utilità. L’autorità dello Stato e delle leggi è, quindi, da considerarsi legittima, finché non oltrepassi certi limiti accettati dai governati in nome del bene comune. Richiamando direttamente Montesquieu, l’autore sostiene come ogni punizione che non derivi dall’assoluta necessità sia tirannica. Il sovrano ha il diritto di punire, ma tale diritto, è fondato sull’esigenza di tutelare la libertà e il benessere pubblici dalle usurpazioni particolari: nessun arbitrio deve essere perpetrato, poiché nel decidere l’entità della pena l’unico criterio da seguire è l’utile sociale. Muovendo da tali significative premesse, le proposte avanzate dal filosofo possono, così, essere riassunte: una decisa battaglia contro l’oscurità delle leggi (perché questa conduce a una varietà di interpretazioni, spesso arbitrarie, che favoriscono gli abusi); la necessità di rendere pubblici i giudizi (per non dar adito a sospetti di ingiustizia e tirannide, e allo scopo di estirpare il sistema delle denuncie anonime, pratica che alimenta i riprovevoli istinti della vendetta e del tradimento); l’opposizione netta alla tortura e alla pena di morte (in quanto la prima non garantisce l’emergere della verità, oltre ad essere una pratica disumana, poiché davanti al dolore fisico, chiunque sarebbe disposto a confessare qualsiasi delitto); siccome il diritto di punire non deve andare oltre la necessità di tutelare i cittadini dagli elementi più pericolosi, non è giusto accanirsi sugli accusati, prima di aver provato la loro colpevolezza. Riguardo la pena di morte, questa deve essere abolita, in quanto viene meno allo spirito del contratto sociale (nessun uomo è disposto a dare la propria vita in nome della convivenza comunitaria), e perché, inoltre, non è un deterrente efficace contro la criminalità: secondo Beccaria, è indice di terrore personale l’idea di una lunga pena detentiva che non l’idea di una pena durissima, ma immediata. Secondo Beccaria, inoltre, è importante, anche, che la pena segua in tempi brevi il reato commesso, affinché l’indiziato non venga lasciato nell’incertezza riguardo la sua sorte e per imprimere nella mente dei cittadini il rapporto consequenziale colpa/pena. 31 Criminologia ed elementi di criminalistica Di particolare importanza, inoltre, due principi fondamentali del trattato che sono: l’attribuzione di un carattere laico alla pena e l’importanza della prevenzione dei delitti. Beccaria opera una distinzione tra la nozione di peccato e quella di crimine, in quanto ritiene che la punizione per non avere osservato la legge non ha niente a che fare con l’espiazione di un peccato nel senso cristiano: la pena irrogata dall’autorità giudiziaria è solo uno strumento per impedire che avvengano o si ripetano determinate violazioni. Ma è particolarmente importante cercare di prevenire i crimini, educando alla legalità; bisogna, altresì, adoperarsi e fare in modo che le leggi siano chiare e facili da comprendere per tutti, che siano rispettate e temute. Lo scopo ultimo della pena è quello di evitare il ripetersi di un danno commesso nei confronti della società, scoraggiandone, al contempo, altri: la pena non è più, nella visione di Beccaria, uno strumento per raddoppiare con altro male il male prodotto dal delitto commesso, ma un mezzo per impedire che al male già arrecato se ne aggiunga altro ad opera dello stesso criminale o a opera di altri che, dalla sua impunità, potrebbero essere incoraggiati. La pena è un mezzo di difesa, un mezzo di prevenzione sociale. Nell’opera di Beccaria emerge un convincimento molto chiaro in ordine alla utilità pratica dei provvedimenti presi o da prendere, e che lascia uno spazio ridotto a considerazioni di ordine morale, così come ben si evidenzia la posizione dell’autore nei confronti della pena di morte: questa va abolita perché non consegue gli scopi prefissi, soprattutto per tale motivo va eliminata: la sua crudeltà, la sua irreparabilità sono marginali. Beccaria, nel suo trattato, indica anche delle rare eccezioni nelle quali il ricorso alla pena capitale è ammissibile. Questo tipo di atteggiamento ha innescato numerose critiche alla sua opera in tempi recenti, poiché è stato ritenuto che il calcolo utilitaristico dei vantaggi e degli svantaggi delle pene non può essere considerato la sola base dei sistemi penali, ma, in essi, deve trovar posto il rispetto della persona umana e di quei diritti inviolabili dell’uomo che ancora oggi molto fanno dibattere. Va sottolineato che, se è possibile individuare prese di posizione discutibili in alcune pagine de Dei delitti e delle pene, in altre, Beccaria mette in risalto come l’imputato debba essere sempre considerato persona e non cosa e come non possa esistere libertà laddove questo principio non venga rispettato. Malgrado alcune affermazioni non consone, l’opera di Cesare Beccaria pone le basi per il corretto progresso dello sviluppo civile del mondo occidentale, tenuto conto del fatto che molte coscienze furono scosse in ordine ad argomenti basilari per la formazione di una società giusta e democratica, sia per l’utilità pratica che dimostrò, visto che molte delle misure auspicate nel trattato vennero effettivamente seguite ed applicate in diversi Stati. 2.3 La Scuola Classica La teoria più antica e più significativa, che per lungo tempo ha dominato e che ancora oggi conta numerosi sostenitori, è quella della Scuola classica. La Scuola Classica vede la luce in pieno Illuminismo, come autentica reazione alla drammatica situazione politica, sociale e giuridica in cui si trovava l’Italia, e nello scontro contro il sistema penale allora vigente, basato sull’uso indiscriminato della tortura e 32 La criminologia tra diritto ed evoluzione della società della ferocia delle pene. Questa dottrina, che fa propria una concezione metafisica del diritto, pone a fondamento del diritto penale i seguenti principi: a) il delinquente è un uomo uguale a tutti gli altri; b) la condizione e la misura della pena sono date dall’esistenza e dal grado del libero arbitrio; c) la pena ha una funzione etico-retributiva per il male commesso, perciò deve essere assolutamente proporzionata al reato, afflittiva, personale, determinata e inderogabile. La Scuola Classica fonda l’imputabilità sul libero arbitrio, cioè sul potere di autodeterminarsi secondo una libera e totale scelta della propria volontà. Secondo tale concezione, la pena, quale castigo per il male commesso, viene applicata se l’uomo ha volontariamente e consapevolmente scelto la violazione della norma, pur avendo, invece, la possibilità di sceglierne l’osservanza. Il reato, pertanto, rappresenta la violazione cosciente e volontaria del comando penale; ma perché la volontà sia colpevole, l’autore del reato, posto davanti all’alternativa tra il bene e il male, deve avere la concreta capacità di intendere il valore etico-sociale delle proprie azioni e di determinarsi liberamente alle medesime, sottraendosi all’influsso dei fattori interni ed esterni. Da questa interpretazione deriva che gli individui affetti da anomalie di interesse psichico o comunque immaturi, non essendo liberi (perché privi di questa libertà di scelta fra il bene e il male), non possono essere biasimati per il male commesso e quindi non possono essere puniti; e inoltre, in caso di una libertà non del tutto assente, ma limitata, la pena dovrà, in tali casi, essere diminuita. La Scuola Classica annoverò tra i suoi maggiori esponenti Francesco Carrara, il quale, in ordine al c.d. esame del reato e del suo autore, formulò teorie ben precise: innanzitutto, il pensiero giuridico di Carrara si differenzia da quello Positivo per uno studio che porta a definire il reato non come un’anomalia del commettere il male derivante da fattori antropologici o sociali, che vanno in sintesi a paragonare il criminale ad un individuo atavico e non sviluppato ma, viceversa, l’illecito penale è un ente giuridico. Il delitto infatti non è un ente di fatto, perché viene ad essere sintetizzato con una definizione generale, oltre ogni riferimento empirico, ossia come la violazione della legge della ragione rivelata, per Carrara, direttamente da Dio. È, infatti, alla divinità, che viene fatta risalire la nascita del diritto naturale di cui l’uomo deve servirsi, al fine di disciplinare la vita sociale, nata con l’inizio della civiltà stessa. Le teorizzazioni del Carrara condurrebbero al superamento degli orientamenti del Lombroso e del Ferri, infatti, essendo il reato un ente giuridico, significa che esso non ha bisogno di riferimenti ad altre definizioni appartenenti a scienze che vi confluiscono. Quindi, se un soggetto, ad esempio, viene a commettere un reato, esso è lesione dell’ordine esterno della società, non necessita di ulteriori specificazioni come quella che egli infranga la legge, perché mosso da fattori sociali estranei alla realtà giuridica. Questa considerazione riporta il reato ad una visione che appartiene al diritto penale, che lo rende per così dire autosufficiente. E ha, come seconda conseguenza, che esso trova nel diritto il proprio fondamento che è connaturato all’uomo e, dunque, viene allargato l’orizzonte del campo d’indagine della materia, che va oltre le riforme e i codici at33 Criminologia ed elementi di criminalistica tualmente vigenti. In altri termini, il richiamo è ad una sorta di jus naturale, a principi fondanti della legge; la legislazione penale è così ricondotta a un’analisi che non è una pura e infruttuosa interpretazione del diritto positivo. Tutto ciò non porta a negare la visione particolare delle norme giuridiche, ma, si ammette l’esistenza di un principio che non accetta l’esistenza di leggi contrarie alla natura dell’uomo stesso. Inoltre, va ricordato che per Carrara, il diritto deve studiare l’ordine che si origina dalla divinità ma che può essere letto solo dalla ragione; esso viene, in tal modo, a essere imposto prima ancora della legislazione stessa; è quella struttura che si può sintetizzare come della libertà; nel senso che il sistema penale viene definito come la libertà di un individuo di non sopraffare in alcun modo un altro. L’ulteriore conseguenza del delitto, come divieto di ledere l’ordine sociale esterno, è che, chi commette tali azioni deve essere punito, per definizione, solo se capace e libero; esclusivamente in questo caso si delinque, cioè, quando si possiedono queste due peculiarità: quella d’autodeterminare le proprie azioni e quella dell’intelligenza. Ciò contribuisce ad interpretare validamente la c.d. esimente valevole per la minore età; infatti, se si vaglia la maturità intellettiva e la responsabilità penale come parametri primi del delinquere, ci si trova a giustificare l’esclusione della pena per chi non si trovi in tale situazione. La questione pone un interrogativo: così procedendo, non si vengono a trattare in modo uguale, situazioni differenti, in contraddizione con il principio espresso nell’articolo 3 della Costituzione? Inoltre, stabilendo che il delitto è ente giuridico, lo si diversifica da quel diritto penale che lo porta a coincidere con la velleità dei codici e delle leggi, che sono transitorie. Tale considerazione, non è da interpretare in modo abnorme, in quanto porterebbe a definire il sistema penale come scollegato dalle leggi positive e, quindi, quest’ultime sarebbero sempre poste a distanza dai principi della verità, rivelandosi, anzi, un freno, degli elementi che impediscono la realizzazione della giustizia sulla terra, giustizia amministrata solo da Dio. Secondo tale concezione, il reato si configurerebbe quale divieto posto ad un’intelligenza libera di sovvertire l’ordine stabilito dalla legge, che non è quella regolamentata dallo jus positum, ma è quella venuta al mondo con l’uomo. Il dibattito si sposterebbe, inevitabilmente, sul campo del diritto penale, poiché, quest’ultimo, era considerato dipendente da altre discipline non giuridiche, mentre, adesso, si getterebbero le basi per ammettere la possibilità che uno Stato formuli delle leggi contrarie a quello che è il diritto naturale, superiore alle norme codificate. Altro passaggio importante riguarderebbe la funzione della pena come funzione di mantenere l’equilibrio stabilito al di sopra dell’uomo, che diventa, pertanto, una tutela giuridica, prima ancora di essere una tutela sociale. Se si definisce il delitto come ente giuridico, lo si priva di ogni altro riferimento e, quindi, tale interpretazione porterebbe alla rilevante conseguenza che esso verrebbe ad essere definito un imperativo assoluto. Quando poi si vuole differenziare la quantità e la qualità del reato, il riferimento è al c.d. grado del delitto, anche se la sua obiettività è strettamente collegata al divieto. In tale contesto, la pena verrebbe ad essere spiegata in funzione del divieto, quindi, il diritto penale non sarebbe tale se non esistesse la repressione per farlo rispettare. Se si pensa al rapporto reato/soggetti minorenni, una pena come quelle che prevedono il perdono giudiziale dei minori non sarebbe neanche ammissibile. 34 La criminologia tra diritto ed evoluzione della società Altra funzione basilare della pena è quella della c.d. minaccia, poichè, essa diviene capace di incutere timore nel violare la legge. La quantità delle pene sono dunque ricavabili rispetto al grado del delitto, e la diretta conseguenza è rappresentata dal divieto, per il legislatore, di eccedere con pene che puntino a mortificare la personalità dell’uomo e siano maggiori della rilevanza dell’azione illecita. Se è vero che siamo in presenza di una concezione moderna, sia del delitto che della pena, è altrettanto vero, però, che tale impianto non ammetterebbe l’esimente ( reati commessi da minorenni), in quanto, sarebbe lo stesso sistema a non prevedere alcuna esclusione o alcuna riduzione della misura sanzionatoria. Significativa, inoltre, l’analisi del Carrara in ordine agli scopi ed alle funzione della procedura penale: in primo luogo, l’identificazione dei colpevoli, che non deve condurre, però all’applicazione di una pena superiore rispetto a quanto commesso dagli stessi. Pertanto, il fatto, il giudizio, altro non sono che l’applicazione diretta e concreta del diritto; il Carrara, non prevede altra definizione del giudicato che non sia la seguente: o si è colpevole o innocenti, o si ammette un grado di colpevolezza o lo si esclude; la questione fondamentale non è tanto quella di prevedere per il reo un inserimento nella collettività, quanto, invece, salvaguardare l’applicazione corretta della legge, che, in tal senso, significa porre in essere gli strumenti utili, affinché il sistema del diritto non venga violato. Un paragone efficace riguarda il rapporto tra diritto penale e procedura penale: la legislazione penale rimane, essenzialmente, estranea alla realtà dei fatti, anche se incapace di modificare, se non attraverso la repressione, quella realtà di cui è solo un’astrazione. Il diritto penale ha, quindi, la funzione di proteggere un ordine superiore alla realtà giuridica degli ordinamenti, attraverso lo strumento del divieto, confermando il diritto della pena, poiché, mediante la repressione, la legge diventa efficace, ed il giudizio si trasforma in strumento per farla osservare. Anche in questo caso, mancherebbe la c.d. esimente per escludere la pena, oppure di un tipo di sanzione che abbia lo scopo di raddrizzare, ma non di punire. Secondo Carrara, però, una punizione che miri a modificare i comportamenti dei criminali sarebbe priva del fondamentale requisito di una misura penale, consistente nel condurre il criminale ad avere timore della pena, intesa quale funzionale deterrente. Qual è l’origine di tale impostazione? Il punto di partenza è, sia la cieca fede in un’entità superiore custode della giustizia, che la capacità dell’uomo di farsi garante con la ragione della legge. Secondo Carrara, amministrare in modo pieno la giustizia è compito di Dio, mentre, per l’uomo, l’unico itinerario percorribile è difendere quella collettività nata con lui. In tale ottica, il diritto penale assurgerebbe a difensore dell’uomo e di quell’ordinamento assoluto che ha il suo ultimo referente in una visione spirituale del diritto. Molteplici sarebbero le implicazioni: a) la metodologia proposta non punta ad approfondire la funzione della pena come processo migliorativo dell’uomo che è custode di una verità; b) rimane senza risposta la domanda in ordine a quale legge ideale possa essere superiore all’uomo. L’analisi del Carrara, da molti considerata legata ad un pensiero giuridico ormai datato per essere identificata come criterio di ricerca, ha lasciato, comunque, aperto un fervido dibattito. In primo luogo, il reato viene definito, in modo chiaro, quale ente giuridico, e, dunque, viene salvaguardata l’autonomia della ricerca giuridica; da una 35 Criminologia ed elementi di criminalistica cognizione certa del diritto, si procede alla deduzione di tutti gli altri corollari legali, ed anche quella della minore età (esimente). In secondo luogo, si rappresenta la non completa esaustività delle leggi positive, e al contrario, è prospettabile una legge superiore che non vada mai a ledere, ad esempio, con pene superiori alla gravità del reato, la natura e la dignità dell’uomo. Ciò ha come conseguenza che lo jus positum possa essere oggetto di critica rispetto alla legge naturale, quando esso giunge a deprezzare l’uomo, che, almeno in questo caso, torna ad essere baricentro. Per concludere, la Scuola Classica opera una scissione tra ciò che la legge giuridica, come quella morale, disciplina, (ad esempio, un individuo dotato di intelligenza e capacità di scelta), e ciò che invece è disciplinato dalle leggi fisiche e naturali. Queste due dimensioni non potranno mai divenire coincidenti, o almeno interferire tra di loro, perché il soggetto giuridico, pienamente imputabile, è in grado di scegliere di infrangere, o meno, le norme giuridiche. 2.4 Il crimine: primi approcci statistici e sociologici I primi studi statistici impiegati per l’approccio scientifico allo studio delle fenomenologie criminose iniziarono a mettere in crisi, intorno alla metà del secolo XIX, la concezione del reato quale astratta entità di diritto. La natura di tali studi era di carattere sociologico, essi puntavano ad approfondire la dimensione sociale nella quale l’uomo era inserito. Lo spazio sociale, pertanto, veniva considerato il luogo dell’agire criminoso di quegli individui che ponevano in essere azioni devianti; queste ultime, però, non venivano più considerate come il naturale prodotto, come si riteneva in passato, di sporadici comportamenti. Il belga Quételet (1796-1874) ed il francese Guerry (1803-1868), appellati, più tardi, come statistici morali, fondarono la Scuola cartografica o geografica franco-belga, e, nel secolo XIX, condussero alcune ricerche sulla distribuzione della devianza, in relazione a fattori fisici e geografici. Il sesso, le professioni, l’età, il grado di istruzione, il ceto, la razza, così come le condizioni economiche, costituirono le variabili per studiare il crimine, anche in termini di prevedibilità statistica. Quételet, ad esempio, sosteneva il principio secondo cui le leggi che governano la società sono fisse e immutabili, come quelle che governano i corpi celesti ed esistono fuori dal capriccio degli uomini. I risultati cui pervennero Quételet e Guerry, di grande interesse sociologico e criminologico, mostrarono, nel tempo, una relativa omogeneità, sia in ordine alle diverse categorie dei c.d. fatti delittuosi, sia alla costanza della loro diversa distribuzione fra le varie classi della popolazione. Il crimine, pertanto, veniva studiato, adesso, in rapporto alle condizioni sociali. Inoltre, la prevedibilità statistica dei reati, venne successivamente dimostrato, può essere ritenuta valida solo nell’ambito di spazi temporali e in condizioni macrosociali stabili. In questa fase, dove prevaleva l’interesse delle scienze criminali classiche di matrice antropologica, E. Durkheim (1858-1917) ripropose il problema del delitto, non considerandolo più come espressione di una patologia da individuare e sulla quale intervenire, ma teorizzando nuovi modelli interpretativi. 36 La criminologia tra diritto ed evoluzione della società Nello scritto dal titolo Le regole del metodo sociologico, l’autore approfondisce il delitto nel capitolo Le regole relative alla distinzione fra normale e patologico, in cui egli affronta la dimensione del delitto mediante i concetti biologici di disfunzione e patologia, spiegando, altresì, che il delitto debba essere considerato come fatto normale e, pertanto, funzionale all’esistenza stessa dell’ordine sociale. Queste ultime teorizzazioni si scontravano apertamente con le teorie dominanti in un’epoca di positivismo imperante e di lettura dei conflitti che percorrevano la società (di cui il crimine era un’espressione). Durkheim giunge ad affermare che il crimine non ha nulla di morboso, e la pena non può avere lo scopo di guarirlo, quindi la sua vera funzione deve (...) essere cercata altrove, indicando questa funzione nella sua capacità di produrre solidarietà, essendo la pena stessa espressione dell’esistenza di un ordine sociale. Va sottolineato che per la prima volta dallo sviluppo del pensiero positivista e dalla formalizzazione delle scienze umane e sociali, vi sia stato chi, studiando e approfondendo il crimine, non lo affronti quale fenomeno patologico individuale, ma ne sottolinei i caratteri della normalità e della funzionalità per l’ordine sociale stesso: il crimine ed il diritto penale che lo definisce altro non sono che l’espressione delle demarcazioni morali di una data società. È importante notare come tali teorie abbiano lo scopo di evidenziare nuovamente la sostanza normativa e convenzionale del fattore crimine, persa sostanzialmente a causa del ricorso alle simbologie di cui le scienze umane e sociali si servivano ampiamente nella fase del loro primo sviluppo. Attraverso Durkheim, pertanto, il problema del crimine ritorna ad essere un dilemma strettamente legato alla situazione storica delle società del tempo, in cui il progressivo frazionamento (o divisione sociale) del lavoro rallenta i legami sociali, facendo perdere di vista, al singolo individuo, il continuum che lo lega alla società, aumentando, al contempo, i conflitti e gli antagonismi. Tutto ciò è il risultato di anomia, (cioè assenza di norme), disinteresse per l’ordine sociale e per le regole di condotta che implica. Il diritto penale si configura, pertanto, quale unico ed efficace strumento per punire gli scostamenti dall’ordine stabilito e rinvigorire la coscienza collettiva sociale, lesa dall’infrazione. Non poche, nel merito, le critiche mosse a Durkheim: innanzitutto, nell’impianto teorico sulle funzioni del diritto penale, egli, pur individuando nell’anomia il problema della deviazione individuale, ritiene già esistente una coscienza collettiva su cui si dovrebbe fondare l’ordine sociale, dimostrando, così, un’eccessiva fiducia nella capacità degli organismi intermedi (le corporazioni professionali) che, secondo il teorico, avrebbero contribuito fattivamente a evitare fenomenologie anomiche, promuovendo azioni socializzanti negli individui, in ordine ai valori espressi dalla coscienza comune, nonché, porre in essere strumenti di mediazione nei conflitti. Il diritto penale, in tale ottica, assurge a mezzo (seppur estremo) di socializzazione, al fine di reintegrare la coscienza oltraggiata dall’infrazione. Quelli che Durkheim identificava come fattori accidentali della società, (l’anomia e i conflitti) conferendo al diritto penale il compito di integrare la maggioranza sociale non deviante, si rivelarono, successivamente, come fattori normali nello sviluppo delle società industriali. Tutta l’opera di Durkheim è orientata ad individuare quella coscienza collettiva sulla quale erigere l’ordine sociale, obiettivo che, nella società in cui visse ed operò il socio37 Criminologia ed elementi di criminalistica logo francese, difficilmente, sarebbe stato possibile raggiungere. La possibilità di realizzare una coscienza comune e di ritenere il diritto penale espressione di questa morale condivisa furono oggetto di aspre critiche. Diversamente, sarebbe stato più appropriato parlare di moralità dominante o di ordine morale dominante, che non di coscienza collettiva, rivolgendo lo sguardo, in particolar modo, all’elevato numero di conflitti che caratterizzavano le società del tempo, e tenendo presente come l’ordine giuridico prevalente altro non fosse che una palese manifestazione di quegli interessi. Gabriel Tarde ( 1843-1904) fu uno dei maggiori critici di Durkheim e definì la sua opera eccessivamente realista. Tarde, definì alquanto limitativo circoscrivere i fenomeni sociali a quelli che esercitano una costrizione, perché si sarebbero escluse tutte quelle relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla imitazione che non hanno nulla di costrittivo. Attraverso i suoi studi di archeologia criminale, Tarde mise l’accento sull’aumento dei crimini nel XIX secolo, determinato da un considerevole aumento della prosperità collegata alle prime fasi del capitalismo e favorita dalla rivoluzione industriale, contraddicendo quei principi teorici che, invece, identificavano nel pauperismo la ragione fondamentale dell’esistenza dei delitti. Lo stesso Tarde, rappresentava che, in precedenza, il sistema sociale era stabile e iniquo, ed era impossibile, per gli appartenenti alla società, modificare il proprio status o proiettare sè stessi verso forme migliorative; ciò era anche frutto di una mancata e generale sollecitazione al cambiamento, che, al contrario, li spingeva a una esasperante conservazione di valori e tradizioni varie. Se da un lato l’avvento della nuova prosperità aveva generato meccanismi di benessere sociale, contribuendo alla produttività economica, dall’altro, però, era destinata, inevitabilmente, a creare conflitti in nome delle aspirazioni e della instabilità sociale. In tale contesto, la delinquenza iniziava a crescere esponenzialmente, poiché, strettamente correlata alla nascita di nuove e fiorenti attività. 2.5 La Scuola Positiva La nascita della c.d. Scuola Positiva, che si sviluppò nel XIX secolo, è essenzialmente legata ad alcuni fattori − ritenuti costitutivi − per l’avvio di questo nuovo indirizzo teorico/criminologico. Il primo fattore è identificabile nell’affermarsi del metodo di indagine induttivosperimentale. Il secondo è da individuare nella necessità di reagire contro l’affievolirsi della difesa sociale per ristabilire un equilibrio fra garanzie individuali e garanzie sociali nel campo della giustizia penale. La Scuola Classica, è utile ricordarlo, lottava per rivendicare e proteggere i diritti individuali contro i numerosi abusi e soprusi dell’autorità nell’amministrare la giustizia penale. In questo panorama, la difesa sociale era stata particolarmente trascurata, tanto che il Frosali, così commenta: per i soggetti moralmente non imputabili, abbandonati dalla giustizia penale anche se commettevano fatti di reato, non esistevano, al di fuori di essa, provvidenze sufficienti alla difesa della società. 38 La criminologia tra diritto ed evoluzione della società Il terzo fattore che contribuì a dare origine al nuovo indirizzo fu l’inefficacia dell’allora vigente sistema penale per frenare l’esponenziale aumento del crimine. Per la Scuola Positiva, il principio base per il quale si devono spiegare tutti i fenomeni, fisici e psichici, individuali e sociali, è quello di causalità. Sulla base di tale assunto, per i Positivisti, il delitto è il risultato, non di una scelta libera e responsabile del soggetto, ma di un triplice ordine di cause: a) antropologiche; b) fisiche; c) sociali. Mentre la Scuola Classica, come è noto, considerava il reato come ente giuridico astratto staccato dall’agente, per la concezione Positivista, il reato è un fenomeno naturale e sociale, un fatto umano individuale, indice rivelatore di una personalità socialmente pericolosa. L’attenzione del diritto penale, pertanto, si sposta dal fatto criminoso in astratto, alla personalità del delinquente in concreto, dalla colpevolezza per il fatto, alla pericolosità sociale dell’autore, intesa come probabilità che il soggetto, per certe cause, sia spinto a commettere fatti criminosi. Ciò equivale ad affermare che il principio di responsabilità individuale, adesso, viene sostituito dal principio di responsabilità sociale. Tale nuova teorizzazione rinforza il principio secondo cui non avrebbe più alcun senso castigare con la pena il reo, perché fatalmente spinto da forze che agiscono dentro e fuori di lui e, obiettivo dei provvedimenti repressivi, deve essere la difesa sociale; per cui, coloro che delinquono devono essere sottoposti a misure di sicurezza che hanno lo scopo di prevenire nuove manifestazioni criminose, mediante il loro allontanamento dalla società e, ove possibile, il loro reinserimento nella dimensione sociale. Le misure individuate, al contempo, non devono essere proporzionate alla gravità del fatto, ma alla pericolosità del reo e, nella loro applicazione, devono differenziare nella forma, per adattarsi alle differenti tipologie psichiche del delinquente; devono, altresì, essere indeterminate nella durata, e derogabili con l’esaurirsi della pericolosità. Tenuto conto che anche i fattori psichici rispondono al principio di causalità (determinismo psichico), il libero arbitrio (valutato quale illusione psicologica) non ha più alcun valore. Sulla base di tale impianto teorico, la Scuola Positiva giunge fatalmente a negare la stessa categoria dell’imputabilità e della distinzione fra soggetti imputabili e non imputabili; e ciò in funzione di quanto sostenuto in ordine alla funzione della sanzione penale, che servirebbe solo come mezzo per impedire la commissione di crimini; tale asserzione non motiverebbe l’esclusione dalla sua applicazione degli autori di reato con problematiche di natura psichiatrica. 2.6 Cesare Lombroso e gli studi sulla personalità del delinquente La criminologia, dal punto di vista storico, come è noto, vede i suoi albori nell’affermarsi della cultura illuminista del XVIII secolo, ed in particolare con l’intellettuale giurista italiano Cesare Beccaria; successivamente, nell’Ottocento, con lo sviluppo delle scienze empiriche, quali la sociologia, la psicologia e l’antropologia, nasce la Scuola Positiva che si articola in due direzioni: lo studio dell’uomo che delinque, secondo l’approccio medico-biologico dell’antropologia criminale, e lo studio sociologico del39 Criminologia ed elementi di criminalistica le condizioni che favoriscono la commissione differenziale di reati in funzione del ceto sociale di appartenenza. È opportuno sottolineare che l’uomo, da sempre, ha cercato di scoprire o capire l’altro o se stesso, mediante lo studio dei tratti somatici del volto; all’origine tale disciplina era soprannominata fisiognomica, ovvero l’arte di interpretare la personalità dell’individuo. Antichissime sembrano essere le origini della fisiognomica, infatti, Platone e Aristotele affermavano che il corpo era concepito come riflesso dell’anima e solo quegli studenti il cui aspetto fisico suggeriva determinate capacità di apprendimento, venivano ammessi alla scuola pitagorica. La teoria della correlazione tra anomalia fisica e degenerazione morale, può essere definita come l’importante paradigma della concezione greca del cosmo e del bello e buono. Solo nel ‘500, con Leonardo Da Vinci, inizia la fase della c.d. fisiognomica moderna, che vede il genio pittorico esprimersi muovendo dal presupposto secondo cui la fisiologia spiega le emozioni, mentre la fisiognomica i moti dell’animo. L’approfondimento e lo studio dei moti dell’animo partendo dai tratti del volto, compiuto dal grande artista scienziato, anticipa, con inconsueta chiarezza critica, un fondamentale percorso di idee e di teorizzazioni che accompagna, da un lato, lo sviluppo della scienza psicologica, fino alla fondazione della psicanalisi, e, dall’altro, il lavoro dei pittori lungo il corso della storia occidentale. Nell’Ottocento, in pieno clima positivistico, la fisiognomica raggiungerà l’apice, sia nella pittura, con i Folli di Géricault e con le devastazioni fisiognomiche di Van Gogh (perfettamente informato sulla materia), che nella trattatistica scientifica, con le importanti teorizzazioni dell’antropologia di Darwin e con la criminologia di Lombroso. Il fondersi, sia dell’arte che della scienza, farà in modo che le stesse saranno cosí strettamente unite, da non poter piú seguire percorsi autonomi. Cartesio, nel ‘600, individuava i moti degli occhi e del volto come tra i più importanti indizi delle passioni, come anche gli svenimenti, il riso, le lacrime, i tremiti e i mutamenti di colore. È indubitabile come allora ci si riferisse sempre alla lettura di sentimenti coscienti. È solo la fine del ‘700, che i segnali esterni di un individuo vengono interpretati anche come espressione dell’insieme spazio-temporale e sociale nel quale l’individuo stesso è inserito. Tutto ciò diede l’impulso a indirizzare le indagini scientifiche in direzione criminale. Già alla fine del diciottesimo secolo, Johann Kaspar Lavater, di origine svizzera, aveva tracciato una teoria fisiologica denominata l’arte della fisiognomica, mediante la quale cercava di individuare come le caratteristiche del volto di ogni individuo conducessero a svelarne il carattere. In tale contesto, il Lavater, presentò il suo famoso Trattato di fisiognomica, cui fecero, immediatamente dopo seguito, le teorizzazioni di Josef Gall, in ordine alla c.d. frenologia, che partiva dall’analisi della forma del cranio che, secondo lo studioso, avrebbe potuto svelare le inclinazioni della persona. La fisiognomica e la frenologia, pertanto, venivano congiuntamente applicate nello studio dei volti dei criminali vivi o morti, nel tentativo di individuarne l’inclinazione al crimine, mediante l’analisi scientifica delle caratteristiche somatiche ataviche. È solo attraverso gli studi di Cesare Lombroso che la fisiognomica raggiungerà livelli scientifici altissimi. Nella sua opera principale, L’Uomo Delinquente, Lombroso, operò la funzionale distinzione della tipologia dei c.d. criminali: 1) il delinquente nato, nel quale si concentrano le citate anomalie regressive e, per il quale, la criminalità è innata nella propria natura, tale, da considerarlo quale soggetto non recuperabile, ma, al contrario, da sopprimere o da rin40 La criminologia tra diritto ed evoluzione della società chiudere, in nome del diritto della difesa della società che, in questi casi, si sostituisce al diritto di punizione. Il fulcro di questa teoria è che una certa percentuale di criminali, dal 35 al 40%, sono nati con disposizioni criminali, e che in essi si possono accertare, scientificamente, caratteristiche anatomiche e fisiologiche particolari; 1) il criminale epilettico; 2) il delinquente per impeto passionale (forza irresistibile); 3) il delinquente pazzo (criminale pazzo e debole di mente), inclusi gli individui di mentalità limitata (mattoidi); 4) il delinquente occasionale, proiettato al delitto da fattori causali diversi da quelli del delinquente nato; su questa ultima tipologia di soggetti, il Lombroso ritiene debba essere svolta un’opera di rieducazione in istituti carcerari ben organizzati. Importante sottolineare come i primi tre di questi gruppi, abbiano tutti in comune una caratteristica di natura psico-patologica. Lo stesso Lombroso definisce il criminale nato come pazzo morale, e di fatto, la sua classificazione può essere ricondotta alla principale distinzione tra criminali normali e anormali. Lombroso, inoltre, opera una ulteriore suddivisione del gruppo dei delinquenti occasionali, in tre sottogruppi: a) gli pseudo-criminali, cioè, individui che sono imputabili di un reato commesso senza intenzione o sotto l’influenza di circostanze affatto eccezionali (autodifesa e simili); b) i criminaloidi, cioè individui con una più mite variante del criminale nato; c) i delinquenti abituali di tipo non anormale, inclusi molti appartenenti alle bande criminali. Inoltre, la criminalità femminile, secondo Lombroso, trova la sua massima espressione nella mercificazione del corpo della donna. Tra gli elementi che concorrono nell’attuazione dell’azione delittuosa, egli considerò: i fattori meteorici, climatici e geologici, la razza, il tipo di alimentazione, l’alcoolismo, le condizioni culturali ed economiche, la religione, l’età e il sesso. Dalle teorie lombrosiane, la criminologia moderna ha guadagnato un insieme di saperi altamente scientifici, e la genialità del pensiero del medico torinese è ancora presente nelle pagine delle trattazioni del crimine. Lombroso aderì totalmente alle teorie fisiognomiche, tanto da sostenere che, una mattina, in un nuvoloso giorno di dicembre, nel teschio di un brigante trovò una lunga serie di anomalie ataviche analoghe a quelle che si riscontrano negli invertebrati inferiori. Questo concetto, quindi, precorse, seppur parzialmente, l’evoluzionismo darwiniano. Infatti, quasi nello stesso arco di tempo, una identica relazione tra fisiognomica e antropologia, venne stabilita da Charles Darwin, il quale sostenne come alcuni tipi di espressione, sia negli umani che nelle scimmie, fossero sempre e comunque determinati da finalità naturali, esprimendo, pertanto, un concetto che, opportunamente, operava una scissione significativa tra mente e corpo. Si deve ancora al genio lombrosiano l’intuizione secondo cui lo sviluppo embrionale dell’uomo ripercorre la filogenesi, e in qualche modo, nel delinquente, questo sviluppo può essere disturbato o interrotto. Il lavoro scientifico di Lombroso si orientò, inoltre, a paragonare il criminale al cosiddetto selvaggio, al primitivo, facendo discendere il crimine da un comportamento naturale. Quest’ultima teoria etnologica, oggi improponibile, già nel 1800, venne aspramente criticata da un altro autore contemporaneo, J. J. Rousseau, il quale propose la teoria del buon selvaggio, giungendo ad affermare che solo il progresso e l’evoluzione, potevano corrompere veramente l’innocenza primitiva dell’uomo. Comunque, nel clima 41 Criminologia ed elementi di criminalistica del periodo ottocentesco, caratterizzato da un forte scientismo, dal bisogno nevrotico di catalogare, di sistematizzare, di misurare, di schedare, l’antropologo Lombroso, raccolse, al fine di comprovare le sue teorie, un elevatissimo numero di prove e materiale fisiognomico, specialmente di natura fotografica, in gran parte proveniente da viaggiatori e studiosi, e avvalendosi anche delle attività dei commissariati, specie per ciò che attiene le foto segnaletiche. Quindi, il Lombroso, utilizzò la fisiognomica, scienza antica che aveva costituito la linfa per l’arte ed il mito, per esaltare la diversità di chi era già stato dichiarato reo, per registrare le stigmate della diversità colpevole, per documentare scientificamente le differenze. Nell’ultima edizione aggiornata della sua opera L’Uomo Delinquente viene allegata una raccolta fotografica, al contrario, invece, per quanto riguarda i suoi reperti, oggi, custoditi nel Museo di antropologia criminale della città di Torino. Il metodo fotografico - fisiognomico del Lombroso, costruito sul presupposto screzio fisico - screzio morale, era finalizzato ad effettuare veri e propri ritratti per andare oltre il solo aspetto fisico e mostrare, inoltre, lo spirito, l’indole ed il carattere del suo modello. Ed è questo, sostanzialmente, l’obiettivo che il Lombroso si proponeva di raggiungere nelle sue schedature fotografiche di soggetti considerati socialmente pericolosi, nelle sue gallerie di ritratti che dovevano diventare, e così avvenne, per decenni, esempi di riferimento per gli studiosi del crimine e per gli operatori di giustizia. Nell’ambito della fisiognomica di inizio secolo si può, pertanto, parlare di veri e propri ritratti lombrosiani; la fotografia segnaletica diventa, quindi, una sorta di impronta facciale, successivamente perfezionata dal Bertillon, che aggiunge i c.d. connotati, consistenti nella misurazione di segmenti ossei brevi: piede, mignolo, ecc, e il ritratto parlato, caratterizzato dalla descrizione degli elementi facciali, al fine di risolvere il problema della identificazione dei criminali recidivi. Umberto Ellero, fornì l’ultimo impulso a tale nuovo approccio tecnico-scientifico ideando la c.d. doppia foto, realizzata, sia di fronte che di profilo, attraverso la contemporanea esposizione del soggetto a due macchine fotografiche messe, tra loro, ad angolo retto e chiamate, appunto, gemelle Ellero. Successivamente, l’opera di Giovanni Morelli, contribuì significativamente al recupero di altri particolari fisionomici, prima trascurati, includendo anche gli sguardi; anche l’anamnesi medica entrò a far parte della schedatura, assumendo quella valenza indiziaria, prima nella letteratura di genere con Conan Doyle e poi con le tecniche indiziarie di Sherlock Holmes, fino a giungere nei tribunali. L’avvento della psicoanalisi, nel ‘900, contribuì ulteriormente all’approfondimento della fisiognomica, tanto da affermare che quello che è evidente copre, in effetti, quella che è la vera realtà sottostante, ed esprimendo la necessità di indagare l’intimo dell’uomo, per trovare la sua vera essenza. Anche la criminalistica moderna risente, oggi, dell’esperienza degli studi fisiognomici: si pensi al criminal profiling, cioè alla costruzione del profilo psicologico del soggetto - reo che rappresenta una componente essenziale dell’indagine investigativa. Vi è da rilevare che da parte di numerosi studiosi del crimine, la dottrina lombrosiana, oggi, rappresenta solo un mito e viene considerata come un insieme di teorie senza alcuna valenza che vengono riportate, nella loro essenzialità, nei volumi di criminologia, come una parte della storia di quest’ultima. 42 La criminologia tra diritto ed evoluzione della società La teorizzazione lombrosiana ed il suo uomo delinquente, degenerato, naso schiacciato, barba rada, cranio deforme, sono state definitivamente abbandonate, così come la disciplina antropologia criminale, oggi, purtroppo, disattivata in quasi tutti gli Atenei italiani. Va, comunque, ricordato che la Scuola di criminologia che ebbe origine dalla dottrina del Lombroso, prese il nome di Scuola Positiva, per manifestare la propria incondizionata adesione ai metodi sperimentale ed induttivo, quali quelli utilizzati nelle scienze naturali e sociali, contro quelli del ragionamento giuridico e deduttivo. Tra gli aderenti alla Scuola, vanno annoverati Enrico Ferri (1856-1929) e Raffaele Garofalo (1852-1934), che erano fermamente convinti della profonda influenza che sul comportamento criminale doveva avere la formazione costituzionale del delinquente individuale e l’ambiente a lui circostante, tanto da non riuscire ad ammettere la possibilità che tutti i criminali, a parte quelli chiaramente insani di mente, potessero essere considerati pienamente responsabili. I Positivisti, erano, al contempo, convinti che esistesse una ampia gamma di anomalie mentali e di inadeguatezze che, pur non conducendo alla pazzia, influenzavano il c.d. libero arbitrio del delinquente. Ciò comportava che le sanzioni difensive della società nei confronti del criminale dovevano scaturire, non in riferimento alla natura e alla gravità dell’atto compiuto ma, tenendo in considerazione il suo potenziale aggressivo individuale, riaffermando, quindi, l’importanza della fisiognomica nella valutazione e nell’accertamento della capacità delinquenziale. Tale impostazione viene rafforzata dalle parola di Van Hamel che afferma: “la Scuola Classica esorta gli uomini a studiare la giustizia; la Scuola Positiva esorta la giustizia a studiare gli uomini”. Per ciò che attiene l’aspetto inerente il Diritto Penitenziario, Lombroso, non richiese pene più severe. La sua teoria sostiene la tesi che per questa categoria di criminali non esista il libero arbitrio nel delinquere, ma, semplicemente ed esclusivamente, motivi insiti nella formazione biologica, fisica e mentale. Pertanto è opportuno insistere sul processo di rieducazione, con il fine ultimo di riabilitare il delinquente. Da qui, l’obiettivo di creare manicomi giudiziari che garantiscano al tempo stesso la cura del delinquente e la difesa della società, motivazione che sarà alla base del sistema del doppio binario del Codice Rocco, nel momento della previsione delle c.d. misure di sicurezza, abbinate alla pena classica. Lombroso incentivò, comunque, nei casi meno gravi, le pene alternative al carcere. Nel progetto di organizzazione del manicomio criminale di Pesaro, scrisse, infatti, nel 1872: “bisogna creare ai ricoverati un ambiente allegro, fornito di tutte le attrattive che possono consolare e rendere dolce la vita, concedendo loro teatri, libri, musica e pittura; eccitandone l’attività, dando libero sfogo alle loro tendenze artistiche e poetiche, con recite, con esposizioni e soprattutto con un giornale manicomiale, per dare ai malati una tribuna ove far conoscere i migliori loro squarci letterari”. I recenti studi di biologia e psicologia criminale hanno, sotto diverso aspetto, fatto rivivere la teoria dei criminali predisposti e le investigazioni statistico-antropologiche (E.A.Hooton), permettendo di sostenere l’esistenza di accertate caratteristiche anatomiche in un grande numero di criminali messi a confronto con gli individui normali che si attengono alla legge. Una importante rivisitazione degli studi investigativo-antropologici criminali è stata compiuta mediante 43 Criminologia ed elementi di criminalistica una serie di misurazioni e analisi statistiche, dal prof. Ernest A. Hooton di Harvard, su di una massa di americani. La sua dottrina, neo-lombrosiana, sostiene che i criminali, in media, sono distintamente inferiori in peso (anche dopo la correzione per le differenze d’età); essi sono più piccoli di statura; la larghezza delle spalle, la larghezza e lo spessore del torace, come pure la circonferenza della testa sono, in essi, minori; la loro altezza facciale è significativamente più piccola come pure l’altezza del naso; i loro orecchi sono più corti, la larghezza del naso maggiore, le orecchie sono più larghe in confronto della lunghezza e la faccia più bassa in confronto della larghezza. Per ciò che attiene i peli, le investigazioni, dimostrano che il gruppo dei criminali ha probabilmente meno barba, meno peli sul corpo e più capelli. I capelli rosso/bruni, sono più frequenti nei criminali che non nei non-criminali, e così pure il colore degli occhi che sono, o molto chiari, o molto scuri. La conclusione generale dell’investigazione, la quale contiene anche un certo numero di caratteristiche sociologiche, è che i criminali, considerati come insieme, sono un gruppo di individui inferiori sociologicamente e biologicamente, e la loro inferiorità fisica è soprattutto di natura ereditaria. Tutto ciò premesso, probabilmente, condurrebbe ad un vero e proprio ritorno alla fisiognomica lombrosiana che si basa sulla relazione esistente tra le differenti caratteristiche fisiche di un individuo e la sua personalità. Anche se le teorizzazioni lombrosiane sono state spesso, oggetto di critica, è comunque indiscutibile come ciascuno di noi, ogni qual volta si trovi di fronte ad un nuovo interlocutore, tenti di intuire, istintivamente, se la persona che ha di fronte a sé è cattiva o buona, sincera o antipatica, e così via. Ed è altresì innegabile come le emozioni suscitate dalle esperienze di vita, spesso tragiche, di una persona, segnino in qualche modo il suo viso, modificando i lineamenti del volto in un modo piuttosto che in un altro. Da qui, l’intreccio della fisiognomica con la psicologia, laddove, entrambe, cercano di intuire e dedurre, dal visibile, i moti più intimi dell’animo umano. La fisiognomica, nelle sue tre linee distintive, assume significati diversi, e ciò in rapporto agli approcci volgare, mimico e scientifico utilizzato dagli studiosi della materia. L’approccio volgare è caratterizzato dall’utilizzo dell’astrologia e della chiromanzia, e l’aspetto simbolico-intuitivo viene espressamente enfatizzato e privilegiato. Nell’approccio mimico vengono messi in evidenza gli elementi della comunicazione non verbale (tratti somatici, espressione corporea e facciale, segni del volto, tono della voce), che sono ritenuti elementi rivelatori del carattere di una persona. L’approccio scientifico, infine, ha l’obiettivo di seguire le teorie darwiniane e antropologiche. L’impalcatura teorica di Lombroso verrà sostenuta, più tardi, dalla figlia Gina, dal genero Ferrero, da Niceforo e Di Tullio, e anche dallo stesso Pende, malgrado la differente posizione ideologica. La figlia Gina negli anni ‘20, si occupa di opere giovanili, tra cui risalta, in particolare, La donna delinquente, dove viene rappresentata la ormai famosa corrispondenza tra prostituzione e criminalità. Si legge, infatti: “l’identità, psicologica come l’anatomica, tra il criminale e la prostituta-nata, non potrebbe essere più compiuta: ambedue identici al pazzo morale, sono per assioma matematico eguali fra loro”. Gina, comunque, non si occupa solo di riproporre i testi del celebre padre, ma rivolge la 44 La criminologia tra diritto ed evoluzione della società sua attenzione alle difficoltà della condizione femminile, e si impegna nel promuovere l’elevazione culturale e l’emancipazione sociale della donna. Alcuni scienziati, sulla base di ricerche nel campo psicologico e neurologico, sono giunti alla conclusione che, nelle persone che formulano idee creative, risulta particolarmente attiva la zona frontale del cervello che emette onde alfa da parte di entrambi gli emisferi. Secondo la fisiognomica, inoltre, concorre ad ottenere un quadro più esauriente possibile dell’individuo, un complesso di informazioni sulle tre fasce del volto che sono l’intellettiva, la sensitiva e la materiale; lo sviluppo maggiore di una fascia del volto rispetto ad un’altra, ne determina una maggiore influenza sul temperamento. La fascia intellettiva è costituita dalla fronte e indica ingegno, curiosità, fede negli ideali; la fascia sensitiva è costituita dalla base del naso, tra le ciglia e le narici, e si configura come un indicatore dell’emotività e della sensibilità dell’individuo; infine, la fascia materiale, localizzabile tra la base del naso e la punta del mento, esprime l’istintività e la sensualità. Per la fisiognomica, anche il colorito dell’individuo costituisce uno degli elementi chiave per l’analisi della personalità: un colorito pallido indicherebbe mancanza di energia, malumore e pigrizia, mentre un colorito rosa acceso, esprimerebbe sensualità ed estroversione; un colorito spento e grigiastro indica ipocondria, pessimismo e scarsa fiducia negli altri; infine un colorito che tende al giallastro è un segnale di forte irascibilità, ma anche di ascolto verso l’altro e di lealtà. Ancora secondo la fisiognomica, l’analisi delle singole parti del viso, fornisce preziose informazioni sulla personalità dell’individuo che si osserva: 1) una fronte molto alta indica la tendenza alla superficialità e all’imitazione degli altri, mentre, se è molto bassa, indica scarso sviluppo intellettuale e atteggiamento ipercritico; 2) una fronte proporzionata al resto del viso, esprime chiusura mentale e forte senso di responsabilità, ma se è alta, e presenta un rigonfiamento nella parte superiore, determinerà, in chi la possiede, difficoltà di concentrazione e stravaganza. Secondo la fisiognomica, l’analisi della personalità di un individuo sarà tanto più attendibile quanto più informazioni si avranno sulle varie parti del volto, non solo, ma se è vero che ogni parte rappresenta una caratteristica di personalità, è altresì vero che solo dall’interpretazione armonica dei vari elementi si potrà capire al meglio chi è la persona che abbiamo di fronte. Meritano particolare attenzione alcune caratteristiche del mento e del naso: un mento aguzzo, indica vivacità intellettuale con tendenza all’analisi e all’approfondimento; un mento tondo segnala creatività ed energia e capacità di mettere a proprio agio gli altri; il doppio mento indica insicurezza, bisogno di protezione e instabilità emotiva, mentre, se un mento è ben equilibrato con il resto del viso, segnala grande tenacia. Il naso è importante perché conferisce carattere al volto: il naso camuso (schiacciato e largo alla radice), indica forte empatia e personalità affettuosa; il naso all’insù indica instabilità emotiva e diffidenza; il naso greco (lungo e stretto) lascia intuire che la persona sia molto sensuale, di animo buono e leale ma anche superficiale; il naso aquilino indica forza interiore e grande carisma, energia e tendenza all’ira; il naso a patata indicherebbe tendenza all’idealismo ma, anche, una certa predisposizione alla tristezza. La fisiognomica, si basa, inoltre, sull’analisi degli occhi e della bocca: gli occhi grandi, denotano tendenza al misticismo, avversione al materialismo e insicurezza; occhi 45 Criminologia ed elementi di criminalistica piccoli indicano intuito, vitalità e furbizia; occhi rotondi segnalano creatività e bontà d’animo, vivacità intellettuale; degli occhi all’ingiù, esprimono un animo romantico, sensibile con tendenza alla depressione; gli occhi all’insù, indicano timidezza, introversione e scarsa coerenza. La bocca, si analizza attraverso le labbra: le labbra carnose indicano sensualità e istintualità, nonché capacità di instaurare rapporti di coppia armoniosi; labbra sottili, indicano introversione e tendenza al romanticismo, forte senso del dovere; un labbro superiore sollevato con gengive in evidenza denoterebbe aggressività e scarso autocontrollo, chiusura mentale; un labbro superiore ad emme, identifica un individuo con particolare senso dell’ironia e tendenza al buon umore, estroversione e avversione per la monotonia; le labbra a bocciolo, esprimono tendenza alla malinconia con instabilità emotiva e poca sensibilità verso gli altri. Altre importanti informazioni sul temperamento individuale si possono leggere, secondo la fisiognomica, anche attraverso i segni della pelle, come i nei e le rughe di espressione, segni, soprattutto questi ultimi che, derivando dalla mimica facciale, rendono unico ed espressivo un volto, raccontando molto sulla vita intima della persona. Altri teorici della fisiognomica hanno sostenuto che il volto rivela qualsiasi cosa ed è possibile analizzare la personalità di un individuo attraverso l’osservazione del suo viso, seguendo la tecnica dell’analisi facciale. È possibile, altresì, determinare attraverso i segni del viso, persino la forma e le dimensioni degli organi sessuali maschili e femminili. Esistono anche delle caratteristiche nell’analisi facciale che sono comuni sia agli uomini che alle donne: se, ad esempio, l’angolo esterno dell’occhio presenta delle linee, queste indicano forte inclinazione sessuale e disponibilità, caratteristiche che sono tanto più intense quanto più sono profonde e numerose le linee. L’esistenza di pieghe profonde ai lati della bocca, indica forte desiderio sessuale, ed ancora, una persona con mento lungo, sarà in possesso di una forte spinta sessuale. Inoltre, la quantità delle caratteristiche che si combinano tra di loro, nonché la loro intensità, contribuiscono a determinare la forza dell’inclinazione sessuale. In generale, un volto ovale, sinonimo di perfezione estetica, indica un temperamento ipersensibile, tendente alla dolcezza, creatività ma anche instabilità e timidezza; un volto quadrato, indica grande forza interiore, un carattere energico e pratico, pazienza e determinazione; un volto triangolare, denota intelligenza brillante ma scarsa fantasia, mentre un viso rettangolare o lungo, denota elasticità mentale, apertura alle novità, evoluzione intellettuale, senso estetico. 2.7 La Scuola Positiva e i diversi contributi L’impianto teorico lombrosiano, oggetto, come già evidenziato, di consensi e dissensi, inaugurò una nuova Scuola di pensiero Positiva, finalizzata a studiare, in modo più approfondito, la criminalità in generale e il crimine e il criminale, più in particolare. Enrico Ferri (1856-1929) e Raffaele Garofalo (1852-1934), il primo giurista ed il secondo magistrato, rappresentano le figure più esclusive di questa nuova Scuola. 46 La criminologia tra diritto ed evoluzione della società Garofalo, in particolare, appare più attento alla dimensione psicologica che sottende la criminalità; Ferri, invece, volge lo sguardo alla dimensione sociale del delitto. Garofalo, studioso di psicologia criminale, anche se sostanzialmente più vicino alle posizioni teoriche lombrosiane, intitola, però, Criminologia, il suo saggio più noto, svincolando la sua opera dai risultati più espliciti della ricerca antropologico-criminale. Anche per Garofalo, comunque, il delitto non è una mera convenzione definita dal codice legale, come vuole fare intendere la Scuola Classica, ma è, piuttosto, un fatto naturale, il cui concetto è ben presente nel buonsenso popolare. Scrive Garofalo: “il delitto sociale o naturale è una lesione di quella parte del senso morale che consiste nei sentimenti altruistici fondamentali (pietà e probità) secondo la misura media in cui trovansi nelle razze umane superiori, la quale misura è necessaria per l’adattamento dell’individuo nella società”. Il riferimento alle razze superiori viene ritenuto indispensabile per non creare confusione con quanto si verifica nei selvaggi, dove mancano quegli istinti altruistici che sono invece considerati fondamentali nelle società più evolute. In Garofalo, mentre natura e società si accatastano e convergono, il concetto di istinto assume coloriture etiche, e con chiari riferimenti alla frenologia che vanno ben oltre la generica spinta biologica che lo caratterizza; la statistica non è poi un semplice strumento conoscitivo, ma si identifica piuttosto con la forma stessa del conoscere. Secondo Garofalo, i delinquenti possono essere distinti in due categorie: a) la prima, caratterizzata da assenza di senso morale; b) la seconda, delineata dalla presenza di istinti morali deboli o latenti; pur prendendo atto, però, della mancanza dell’istinto pietoso e di probità, e della sostanziale perversità, non esiste alcun tipo di conclusione, in assenza di un vero e proprio delitto. Garofalo ritiene, inoltre, che la natura dell’anomalia, morbosa o meno, risulti indifferente in riferimento alle esigenze della società. Ciò che è opportuno conoscere è se l’anomalia sia permanente e l’infermità incurabile o duratura nella sua forma pericolosa nei confronti della società, ovvero, se vi sia speranza di miglioramento e di cessazione degli impulsi criminosi. Nel primo caso, non vi è alcun motivo per non trattare il pazzo come il delinquente istintivo, cioè, eliminarlo assolutamente; nel secondo caso, si avranno, da una parte, delinquenti affetti da psico-nevrosi, curabili nei manicomi, e, dall’altra parte, delinquenti per occasione e per abitudine, che possono correggersi attraverso l’imposizione di un nuovo genere di vita. Tutto ciò condurrà al tema della pericolosità sociale che sostanzierà la legge del 1904 sui manicomi e sugli alienati. Il pessimismo radicale di Garofalo deriva dalla convinzione che tutti i delinquenti sono uomini psichicamente anormali, molti anche antropologicamente; e del resto se, in condizioni analoghe, fra tanti uomini, uno solo delinque, si deve coerentemente dedurre che il fattore primo del delitto è sempre individuale, e che senza di esso le spinte occasionali rimangono inefficaci. Il delitto, pertanto, viene fatto discendere da un’anomalia individuale, e che le influenze familiari e sociali siano ritenute poco attendibili. Anche il disagio economico, interviene con modesta incisività, tanto che, il malessere individuale connesso, appare scarsamente attribuito alla sproporzione fra desideri e mezzi per soddisfarli. Il Garofalo, legato fortemente al sostanzialismo evoluzionista, sembra aver perso di vista la complessità familiare, economica e sociale della vita. Il suo contributo più origi47 Criminologia ed elementi di criminalistica nale è piuttosto da ricercare nella rappresentazione di quelle personalità delinquenziali, avulse da ogni vibrazione affettiva, che, già individuate nella letteratura del ‘500, ricorrono ripetutamente nelle più recenti nosografie ottocentesche e novecentesche, dove si discute, di sociopatici (soggetti che soffrono e fanno soffrire la società), di personalità psicopatiche, e di individui con disturbi di personalità. Al contrario di Garofalo (esperto di psicologia criminale), Enrico Ferri è invece ritenuto il sociologo della Scuola Positiva. Per Ferri, il più ampio numero di delinquenti è, infatti, costituito da quelli occasionali particolarmente influenzati da motivazioni sociali, tanto che egli elabora una sorta di piano regolatore per prevenire e reprimere la criminalità, tenuto conto, in particolare, dei problemi dei soggetti minorenni, dei malati di mente, dei tossicomani, e così via. Grispigni, a proposito delle teorie del Ferri, chiarisce che la sociologia di quest’ultimo non deve essere intesa come una disciplina avente l’obiettivo di deresponsabilizzare l’individuo per trasferire le sue responsabilità nella società, ma, piuttosto, come momento legato all’esigenza dello Stato di tutelare la propria integrità. Ferri ritiene che per un completo e valido approccio alla criminalità, lo studio della psicologia collettiva dovrebbe essere il risultato della connessione fra la psicologia individuale e la sociologia, che ha il compito di analizzare la società nel suo insieme. Il delitto, per Ferri, è sempre un fenomeno biopsicologico, legato tanto all’ambiente, quanto all’individuo, e che gli artefici di atti anti-sociali presentano un particolare temperamento criminale caratterizzato da una singolare personalità biopsichica che, non potendo subire le condizioni di esistenza sociale del presente, cede all’impulsività di un sistema nervoso degenerato, oppure squilibrato dal fanatismo. Le teorizzazioni criminologiche del Ferri raccolsero ampi consensi: Nicola Pende, uno dei rappresentanti più significativi del costituzionalismo italiano, scrive, appunto: “in Enrico Ferri, saluto il grande biologo e clinico dell’uomo delinquente, interprete, per mezzo secolo, delle leggi dell’io incosciente, determinanti, sotto la spinta provocatrice dell’ambiente, quella acutissima malattia della nostra personalità che chiamiamo delitto”. Il successo e l’incisività storica di Garofalo e di Ferri, fra i tanti teorici della Scuola Positiva, sono anche il risultato ultimo dell’impegno profuso nell’ambito giuridico in cui operano entrambi, con il conseguente allargamento di ambito, rispetto all’originario scenario lombrosiano, essenzialmente limitato dalla dimensione e dalle metodologie della scienza medica. Intorno all’orbita della Scuola Positiva, maturano, comunque, approcci molto diversi che si riscontrano, da un lato, saldamente ancorati alla biologia, dall’altro, si proiettano verso la sociologia politica, oppure, tendono a rivedere l’indirizzo ufficiale della Scuola. Secondo Virgilio, ancorato su rigide posizioni lombrosiane, i pazzi ed i criminali, entrambi degenerati, sono associati da un fragile sistema nervoso e, in particolare, del cervello. Se si rappresenta che il delitto ha un’origine morbosa, spetta alla medicina il compito, sostanzialmente preventivo, di moralizzare la comunità civile; l’attribuzione alla medicina di tale competenze, rappresenta una novità in termini assoluti, specie, se si tiene in conto che le stesse erano coordinate dai giuristi e dalla Chiesa. Altri importanti contributi vengono forniti da Colajanni e Pistolese, per ciò che attiene il rapporto tra alcoolismo e delinquenza: pur tenendo conto dell’appartenenza degli stessi all’area socialista e positivista, essi, affrontano detto rapporto in termini 48 La criminologia tra diritto ed evoluzione della società palesemente polemici, rispetto alle teorie lombrosiane, nella loro classica formulazione. Per Colajanni, in particolare, alcoolismo e criminalità hanno infatti una radice comune abbastanza semplice: la miseria con la carenza di educazione che la sostanzia. Per estirpare questi mali è poi indispensabile, secondo Pistolese, la caduta del capitalismo: “è il capitalismo che ha fatto l’alcool accessibile a tutti, perché a poco prezzo; è esso che lo offre sovente in mille guise falsificato per l’ingordigia di maggiori guadagni da parte degli speculatori”. A Di Tullio, in particolare, si deve un noto trattato di antropologia criminale aggiornato con capitoli dedicati agli argomenti più recenti come l’endocrinologia. L’insieme delle teorie lombrosiane è ancora presente nel pensiero di Di Tullio, anche se non si parla più di tipo delinquenziale, ma di personalità. Di Tullio, comunque, pur cosciente che l’antropologia criminale solleva numerosi e vasti problemi come quello del bene e del male e quelli della libertà e della responsabilità umana, intende occuparsi solo di delitto, inteso quale atto umano che va considerato e valutato in relazione al contesto sociale dove viene consumato, prescindendo, in tal modo, da qualsiasi valutazione di carattere filosofico. Di grande importanza, è poi ritenuto il rapporto con la psicopatologia, tanto più che ogni delitto è sempre l’espressione di un turbamento psichico. Di Niceforo, si ricorda, invece, una imponente sintesi in merito ai contenuti e ai dibattiti maturati attraverso il lungo itinerario della Scuola Positiva. L’opera di Niceforo, edita da Bocca in 6 volumi fra il ‘49 e il ‘54, si delinea come una sorta di riassunto critico, dove vengono affrontati argomenti di carattere criminologico, da quelli biologici a quelli sociali e motivazionali. Anche Pende, tomista in metafisica e costituzionalista in medicina, non è certo lontano dalle influenze di Lombroso, specie, quando, per risolvere il problema relativo alla sollecitazione di alcune aree encefaliche che possono provocare improvvisi focolai di aggressività, propone interventi mirati di psicochirurgia per trasformare le turbe dell’umore che guidano il comportamento di alcuni criminali; a fronte di quanto sostenuto, riferisce il caso di un poveretto che aveva da molti anni fatto il giro di tutte le carceri e che dopo adeguato intervento neurochirurgico poté essere trasformato in un pacifico ed onesto lavoratore. I contributi, sin qui descritti, testimoniano come l’opera lombrosiana sia stata efficace, esercitando, nel tempo, vaste influenze nella cultura, indirizzando la pratica giudiziaria e psichiatrica, favorendo la ricerca, sia vincolandola a quanto è oggettivamente visibile, che incoraggiando la statistica, in parallelo con la metodologia utilizzata. L’aver promosso nuove tecnologie applicate allo studio del crimine, come la fotografia, che favorisce la documentazione realistica, sia in psichiatria che in criminologia, o aver fatto comprendere il ruolo della statistica e della sociologia, sono solo alcune delle righe del testamento culturale e scientifico di Lombroso. 2.8 La Nuova Difesa Sociale Con la nascita della Nuova Difesa Sociale, si assiste al proliferare di una serie di dottrine intermedie, che, se da una parte, mantengono alcuni dei vecchi principi, dal49 Criminologia ed elementi di criminalistica l’altra, accolgono posizioni proprie dei positivisti. Lo scontro dottrinale più forte si avverte con i rappresentanti della Scuola Classica. Secondo Mantovani, il movimento che ha realizzato il maggior sforzo di sintesi è quello della Nuova Difesa Sociale, movimento di pensiero che non sopprime la nozione di responsabilità, non nega le libertà dell’uomo né rifiuta la possibilità della punizione, ma fonda la politica criminale della difesa sociale sulla responsabilità individuale, la cui realtà esistenziale viene assunta come la molla ed il motore essenziale del processo di risocializzazione e torna ad essere la giustificazione profonda della giustizia penale. Tra queste correnti criminologiche va segnalata la Terza Scuola, il cui obiettivo era quello di mediare le posizioni delle due Scuole (Classica e Positiva), infatti, da tale tentativo si origina il c.d. sistema del doppio binario, fondato sul dualismo della responsabilità individuale-pena retributiva e della responsabilità sociale-misura di sicurezza. In ordine, invece, al fondamento del diritto di punire, tale nuovo indirizzo rigetta il principio positivista della responsabilità sociale, e si accosta alla concezione classica, incentrando il diritto penale sulla responsabilità del fatto commesso con volontà colpevole e sull’ imputabilità, ma fonda, quest’ultima, non sul concetto del libero arbitrio, piuttosto sui concetti di sanità mentale e di normalità (determinismo psicologico). Per tale principio, l’uomo determina le sue azioni che derivano dal motivo conscio più forte. Alimena, a tale proposito, sostiene che, se di fronte alla stessa offesa, uno uccide ed altri no, ciò avviene perché l’uno vuole uccidere e l’altro non vuole: ciò accomuna le tesi dei liberisti e dei deterministi. Il problema di fondo rimane, perché bisognerebbe chiedersi: perché vuole uno, e l’altro non vuole, uccidere? Perché in quel momento, nell’uno, l’idea omicida costituisce il motivo maggiore, e nell’altro no, e forse non si è nemmeno presentata? Evitando dispute filosofiche e psicologiche, molti studiosi di criminologia, hanno cercato di rappresentare il concetto di imputabilità su basi anche empiriche, dando corso alla nascita di nuove teorie. In particolare, è stato autorevolmente ritenuto che la scienza del diritto penale sia in grado di spiegare il tema dell’imputabilità non considerando quale sia la soluzione teorica da prestare al problema filosofico del libero arbitrio. Secondo Antolisei, le fondamentali teorie che hanno cercato di superare l’antinomia tra libertà e causalità sono quelle della normalità, dell’identità personale e della intimidabilità. Per la teoria della normalità, l’imputabilità rappresenta la normale facoltà di determinarsi, per cui, imputabile sarebbe solo chi reagisce normalmente, cioè l’uomo sano e maturo; pertanto, se manca la normalità, è mancante la ragione stessa del punire. Questa teoria è stata sostenuta in particolar modo da Liszt e, recentemente da Nuvolone, che opera una distinzione tra il concetto di normalità per il diritto penale, da quello proprio della psicologia e della psichiatria. Se, secondo un indirizzo prettamente psicologico, non esiste un discrimen esatto tra normalità e anormalità, e tale impianto si rinviene nel nostro codice alla distinzione infermità/seminfermità, per il diritto è indispensabile assicurare un confine al di là del quale inizia la c.d. follia. Ciò non equivale a sostenere che i soggetti considerati capaci ai sensi del diritto penale siano conseguentemente normali anche per le altre scienze. Pertanto, continua Nuvolone, la normalità, per il diritto penale, è la facoltà di intendere gli oggetti della percezione, con una mente non viziata da infermità, e a un livello di maturità corri50 La criminologia tra diritto ed evoluzione della società spondente alla media di sviluppo caratteristico dell’età; la normalità è, altresì, la facoltà di adeguarsi a tale rappresentazione. Questa teoria non è comunque scevra da critiche, in quanto viene a questa contestato che il concetto stesso di normalità, su cui essa si basa, è troppo relativo, soprattutto, se si considera, che la stessa psicologia moderna esclude che esso possa essere determinato con esattezza. Deve essere inoltre osservato che tale teoria taglierebbe fuori dalla pena una serie di delinquenti, come quelli abituali e professionali, che, soventemente, presentano delle anomalie psichiche. Per la teoria dell’identità personale (Tarde, Sabatini), invece, l’imputabilità, sostanzialmente, consisterebbe nella appartenenza dell’atto all’autore, per cui l’autore del fatto sarebbe imputabile quando la condotta è corrispondente alla sua personalità, mentre, sarebbe non imputabile, quando viene meno, nel soggetto, il potere di manifestarsi secondo il proprio Io, come avviene in caso di certe anomalie psichiche. Tale teoria pone il problema dell’infermo di mente, in quanto si ritiene opinabile considerare l’azione di quest’ultimo non rispondente alla sua personalità. Per la teoria dell’intimidabilità (Alimena-Impallomeni-Vannini), l’imputabilità consiste nella capacità di essere intimiditi dalla minaccia della sanzione; per cui, chi non è compos sui (come gli infermi di mente) non può essere sottoposto a pena, poichè non sarebbe in grado di sentirne e di subirne la coazione psicologica.Tale tesi si scontra inevitabilmente con la realtà, tenuto conto che i malati di mente ed i bambini, entro certi limiti, possono sentire l’efficacia intimidatrice dei castighi, mentre non si può certo dire che tutti gli uomini subiscono l’intimidazione della pena. Le tre teorie in questione, seppur dichiaratamente diverse tra loro, sembrano, comunque, aver in comune una identica caratteristica, infatti, ciascuna di esse, sembra confondere il problema del fondamento dell’imputabilità, con quello dei criteri per determinare, chi è imputabile e chi non lo è. Pertanto, pur non comprendendo di fondarsi sul concetto di libertà di volere, dimostrano, altresì, di presupporlo, giacchè le distinzioni operate fra soggetto imputabile (normale o suscettibile di intimidazione) e soggetto non imputabile (anormale o non suscettibile di intimidazione) presuppongono che il soggetto possa agire in maniera diversa da come ha agito. 2.9 Il contributo marxista Nel XIX secolo, il marxismo, contribuendo all’interpretazione della criminalità, riuscì ad aprire nuovi e importanti scenari. Omettendo, in questa sede, di riferirne i contenuti più strettamente ideologici e politici, appare importante indagare le teorizzazioni di Karl Marx (1818-1883) e Friedrick Engels (1820-1895) a proposito del delitto. Nei loro approfonditi studi politico-sociali, essi sostengono che il delitto è una diretta conseguenza dell’apparato capitalistico e delle ingiustizie, degli squilibri e della grandi disfunzioni del capitalismo del XIX secolo. Ancora prima di Marx ed Engels, il nesso tra sistema economico e criminalità era stato oggetto di interesse e di studio da parte di Saint-Simon, di Proudhon, di Blanqui, i quali, avevano individuato elementi criminogenetici, nella natura stessa della società 51 Criminologia ed elementi di criminalistica basata sulla proprietà privata, e caratterizzata da violenza e oppressione. È utile sottolineare che gli autori menzionati non erano di matrice marxista, infatti, sostenevano che solo attraverso l’associazionismo solidaristico e la rivendicazione dei diritti per mezzo delle lotte sindacali, fuori da ogni logica rivoluzionario-proletaria, si potessero abbattere le disuguaglianze della società. La criminologia di stampo marxista, invece, riteneva che i delinquenti non appartenessero al c.d. proletariato rivoluzionario che attuava la lotta di classe per sconfiggere il capitalismo, bensì ad una parte, definita di sottoproletariato, degradato moralmente e misero, che non aveva acquisito coscienza di classe e che replicava alle ingiustizie sociali mediante la ribellione, concretizzatasi nel crimine. Di contro, un’utilizzazione complessa del marxismo emerge all’inizio del novecento con A.W. Bonger. Quest’ultimo, superando la denuncia delle responsabilità del capitalismo e della ingiustizia sociale, mette in risalto come un sistema di produzione, basato sulla proprietà privata e sul profitto, sia avverso allo sviluppo dei legami di reciprocità. Ciò equivale a dire che il capitalismo, trasformando gli uomini in individui ancora più egoisti, li predispone alle azioni delittuose. Il delitto, pertanto, secondo Bonger, non è intimamente legato a nessun particolare sistema economico, ed è nato addirittura prima del capitalismo, resistendo oggi, in sistemi socio-economici, totalmente differenti. La condotta criminale, è identificabile in un tratto costante di tutte le società: la disuguaglianza. L’analisi porta a concludere che tutte le società hanno concepito criminalità perché erano e sono società di dominanti che impongono, e di dominati che, consapevolmente o meno, rifiutano tale imposizione; perché erano e sono sistemi sociali che basavano e basano i rapporti interumani sullo sfruttamento; perché sono società composte in maniera gerarchica e autoritaria che pronunciano leggi che tratteggiano gli interessi del vertice e ne difendono i privilegi. In tale dimensione, si può confermare che la condotta antigiuridica non è prerogativa esclusiva dei gruppi sociali che, rispetto al vertice, meno possono far valere i propri interessi, e ciò con riferimento alle masse degli sfruttati, collocati nei gradini più bassi della scala sociale. L’infrazione delle norme di legge diventa un atteggiamento non evitabile, legato alla mobilità sociale anche di gruppi più vicini al vertice del sistema o al vertice stesso, seppur in misura e con modalità differenti rispetto alla delinquenza degli strati inferiori. In tutti i gruppi sociali, il crimine è presente come strumento normale di mobilità all’interno del sistema. Il volto comune del criminale, abilmente costruito dalla cultura dominante accettata dalla società, è quello di un sottoproletario, privo di istruzione, e incapace di affermarsi socialmente, anche ai gradini più bassi del sistema. L’immagine di questo tipo di delinquente è quella cui la cultura indirizza il disprezzo comunitario, lo sdegno emotivo verso il criminale, la cui condotta antigiuridica viene colta come antisociale. La criminologia, comunque, nella prima metà del novecento, è permeata anche da un approccio sociologico di impronta liberale: Shaw e McKai, appartenenti alla Scuola di Chicago, analizzano la dimensione della criminalità quale espressione della disorganizzazione sociale, derivante dal rapido seguirsi di regole di condotta in comunità prive di identità culturali, e, come concausa del progresso industriale, gli autori sostengono 52 La criminologia tra diritto ed evoluzione della società che la delinquenza, in aree laddove l’economia e la socialità sono quasi assenti, è trasferita agli appartenenti delle stesse aree o ai gruppi che in esse transitano, e ciò a causa delle cosiddette sottoculture criminali. Non meno calzanti risultano le teorie di Merton, che obiettiva i suoi studi sociologici sul concetto di anomia, inteso quale squilibrio tra le mete poste dalla cultura alla società e i mezzi, di fatto, forniti dalla stessa per conseguirle. Cloward e Ohlin puntano, invece, la loro attenzione sul ruolo esercitato, nel divenire criminali, dall’appartenenza all’uno o all’altro gruppo sociale. Anche se di impronta liberale, questi indirizzi sociologici fanno risaltare, al contempo, gli sbilanciamenti presenti nella società capitalistica, ne affermano l’indiscutibilità tale da definire come deviante colui che si allontana dalle regole, ponendosi come obiettivo la reintegrazione di tali individui nell’ambito sociale; per tale motivo, la criminologia viene definita criminologia del consenso. Alla criminologia del consenso, si contrappose la criminologia del conflitto che, riprendendo le teorizzazioni sociali e politiche marxiste, ripropose, in chiave rivoluzionaria, la soluzione delle problematiche relative ai conflitti di classe. La nuova corrente di pensiero, che contava al proprio interno marxisti di tutta Europa facenti capo alla National Conference (Inghilterra 1968), ed un gruppo italiano che faceva riferimento alla rivista La Questione Criminale, prese il nome di criminologia critica. Questa si proponeva di indagare, non sulle caratteristiche del criminale, bensì sulle ragioni per cui, una data società, qualifica come devianti certe condotte. La devianza, secondo la criminologia critica, non è più espressione di inosservanza delle norme, ma viene intesa quale conseguenza dell’oppressione della società capitalistica, che si limita a perseguire, in particolar modo, le condotte delle classi subalterne, definendole illegittime. 53 CAPITOLO 3 I metodi e le fonti delle conoscenze criminologiche 3.1 Metodi e fonti della ricerca criminologica Kaplan (1964) sosteneva che la ricerca scientifica può essere definita come un processo di osservazione deliberata e controllata. I criminologi adoperano un vasto ventaglio di metodi e tecniche per valutare quantitativamente specie e dimensione della criminalità. I dati relativi possono essere raccolti, sia svolgendo ricerche empiriche con strumenti di osservazione, o con lo studio dei casi, sia studiando le statistiche ufficiali già costruite da altre fonti. In primis, occorre precisare che non vi è un metodo scientifico, bensì vi sono diversi metodi scientifici, il cui scopo consiste nell’ottenere conoscenze attraverso osservazioni obiettive. L’esigenza che le osservazioni siano oggettive chiarisce l’importanza che gli scienziati attribuiscono alla validità dei metodi di ricerca. Essi tentano di esprimere, accuratamente, le condizioni esatte in cui sono state effettuate le osservazioni, in modo tale che altri scienziati le possano ripetere. Quindi, il criterio di produzione di conoscenza scientifica è caratterizzato da una serie di scelte ragionate che il ricercatore deve, di volta in volta, compiere. Non può certamente essere negato il fattore di soggettività, che non può essere cancellato, ma, che può e deve essere reso esplicito. L’oggettività è, quindi, la caratteristica che contraddistingue ciò che è scienza, da ciò che non lo è, ed è ciò che fa della scienza l’unico mezzo universale per acquisire conoscenze, perché, sin dall’inizio, rifiuta di considerare ogni fenomeno che non sia accessibile a tutti. La diversità dei metodi scientifici costituisce, pertanto, il percorso più idoneo per il raggiungimento di verità probabilistiche e disponibili a possibili modifiche. La formulazione dell’ipotesi rappresenta l’attività primordiale che va a definire il campo di indagine, senza chiaramente assicurarne in anticipo i risultati, ed è basata su problemi empiricamente verificabili. L’ipotesi, inoltre, non dovrebbe essere condizionata da credenze, pregiudizi e ideologie del ricercatore, mentre lo è, in ogni caso, dal suo background culturale e formativo; ha sempre carattere di provvisorietà. 55 Criminologia ed elementi di criminalistica Una volta formulata l’ipotesi da dimostrare, le fasi successive si possono semplificare nei seguenti punti: a) analisi della letteratura sull’argomento di ricerca e commento critico dei risultati conseguiti dalle altre indagini; b) scelta del metodo da utilizzare, tuttavia influenzata, quasi sempre, dalla formazione del ricercatore (psicologo, sociologo, medico, giurista, ecc.), e dagli strumenti (questionari, interviste, statistiche già rilevate, ecc.); c) in relazione al metodo, l’approccio si identifica in due tipologie: quantitativo e/o qualitativo. Il primo (quantitativo) tende a quantificare il fenomeno indagato e a porlo in rapporto ad altri indicatori sociali; può essere esplicativo, mirando cioè a spiegare perché si verifica il fenomeno studiato e perchè si correla con gli altri fattori presi in esame, oppure descrittivo, cioè descrivere come esso si manifesta in un determinato periodo storico distinguendone i molteplici collegamenti; d) il secondo (qualitativo) si pone l’obiettivo di studiare le caratteristiche, le similarità e le connessioni logiche e funzionali fra i fenomeni osservati. Si applica sia a fatti complicati considerati nella loro unicità, sia a pochi casi, come in campo clinico (per es.: studio dei casi) o sociologico (per es.: storie di vita); e) è comunque, sempre, preferibile svolgere preliminarmente uno studio pilota, utilizzando lo strumento di rilevazione prescelto su di un numero limitato di casi per controllarne la funzionalità e graduarlo sul campo, ciò al fine di evitare, nel futuro, un eccessivo dispendio economico e di energie; è il caso di una ricerca quantitativa con lo strumento del questionario: la distribuzione di esso a un numero limitato di soggetti consentirà di accertarne la chiarezza e di modificarne le domande, se incomprensibili o inadeguate, prima di stamparne un’elevata quantità di copie (con i relativi costi) e ottenere risultati di scarsissimo interesse o inutilizzabili; f ) la raccolta dei dati, attraverso lo strumento adottato: questionari, interviste, colloqui clinici, se fonte informativa sono le persone; schede di rilevazione, se si opera su materiale cartaceo (per es. fascicoli giudiziari o penitenziari, materiale peritale); statistiche già rilevate, se si studiano dati ufficiali. Comunque, va sottolineato che, soprattutto nella ricerca criminologica, l’accesso ai dati presenta non poche difficoltà legate, ad esempio, alla diffidenza dei soggetti, alla riservatezza delle informazioni, nonchè alla non omogeneità del materiale; g) l’elaborazione dei dati segue dopo la codifica e la computerizzazione degli stessi. Nel caso l’indagine si svolga su una casistica limitata, l’elaborazione può avvenire manualmente. Questa fase comporta l’utilizzo di tecniche statistiche per misurare il fenomeno in esame e quelli correlati: rapporti di coesistenza, composizione e derivazione, numeri indici, valori medi, variabilità e analisi della varianza, interpolazioni e così via; h) i dati elaborati, vengono poi condensati attraverso rappresentazioni di natura cartografica con tabelle, ortogrammi, istogrammi, grafici secondo il metodo cartesiano, diagrammi in scala logaritmica, cartogrammi, torte, ecc.. La rappresentazione grafica dei fenomeni ha lo scopo di rendere il contenuto dei dati più visibile; i) la fase finale della ricerca, è rappresentata dall’interpretazione dei dati, che deve essere eseguita in maniera obiettiva e senza forzare le risultanze ottenute. 56 I metodi e le fonti delle conoscenze criminologiche La spiegazione dei nessi causali tra il fenomeno osservato (devianza o criminalità) e gli altri fattori sociali o individuali deve realizzarsi attraverso la generalizzazione empirica, cioè secondo proposizioni che mostrano come in un certo tempo e in un certo luogo alcuni fenomeni si verifichino. Attraverso la serendipity si vuole indicare la utilizzazione del dato nuovo, non previsto nell’ipotesi di ricerca, che introduce un rapporto non direttamente osservabile e supera l’aspetto constatativo della generalizzazione, per raggiungere un livello più alto di tipo teorico, riferibile a entità ipotetiche, a costruzioni logico-deduttive. L’indagine criminologica, permette, pertanto, di passare dal momento constatativo al momento teorico-scientifico, che stabilisce leggi generali e teorie valide in ogni tempo e in ogni luogo. L’indagine successiva, risulta assolutamente necessaria per verificare i risultati di una ricerca che dovrebbero tradursi in ipotesi di partenza di un nuovo studio. Va sottolineato che i risultati della ricerca devono restare integri e non devono subìre manipolazioni decretate da preconcetti e ideologie del ricercatore, o dovute a difformità rispetto all’ipotesi e all’impostazione teorica preliminare. In altre parole, la validità di una ricerca empirica è strettamente legata all’onestà intellettuale del ricercatore. 3.2 La ricerca di tipo quantitativo Gli anni settanta ed ottanta si sono contraddistinti per quel generale potenziamento nel campo metodologico della ricerca, specie per ciò che riguarda l’applicazione del metodo statistico. L’applicazione quantitativa richiede che, una volta formulate le ipotesi da sottoporre a verifica, venga effettuata una serie di operazioni allo scopo di rendere quantificabili le osservazioni stesse, anche in previsione dell’elaborazione statistica. Il primo step utile riguarda il c.d. campionamento, che consiste nell’operare una selezione di persone o situazioni oggetto d’indagine. Le indagini campionarie permettono, pertanto, di rintracciare alcune caratteristiche su un gruppo ristretto; quest’ultimo deve, però, rappresentare la totalità di una popolazione e deve essere rappresentativo. La rappresentatività è offerta dal metodo probabilistico di campionamento in cui tutte le unità che compongono la popolazione hanno uguale probabilità di essere selezionate. Questa metodologia è, comunque, applicabile solo in presenza di un universo, per il quale sia possibile valutare l’ammontare, e per il quale possa essere predisposto un elenco numerabile. La statistica insegna che in presenza di universi ampi è opportuno ricorrere ad un campionamento a grappolo o a un campionamento stratificato, metodi, che si basano su tecniche di suddivisione della popolazione in sottopopolazioni, da cui vengono estratti diversi sub-campioni rilevati in base ad alcune variabili, ritenute rilevanti per la specifica indagine. Nel caso in cui, per svariati motivi, i metodi sopra descritti non fossero applicabili, il ricercatore potrà avvalersi del campionamento definito non probabilistico, che prevede la selezione di un campione sulla base della conoscenza diretta della popolazione, ovvero potranno essere inseriti coloro che si dichiarano disponibili o segnalati da esperti del settore. 57 Criminologia ed elementi di criminalistica 3.3 La ricerca di tipo qualitativo Le metodologie di tipo qualitativo sono state ampiamente utilizzate nell’ambito della ricerca criminologica, si pensi all’applicazione nel campo clinico o in quello sociologico. La stragrande maggioranza di coloro che si dedicano alle ricerche è orientata nell’utilizzo del metodo qualitativo, considerato più adatto a rappresentare il crimine e la relativa complessità, basandosi sulla ricerca di connessioni logico-funzionali e di similitudini, in ordine ai fenomeni oggetto di studio. Una prima distinzione con le metodiche di ricerca già evidenziate consiste nel fatto che l’applicazione del metodo qualitativo implica la produzione di dati, non sotto forma di numeri, bensì di parole; ciò equivale a dire, che i dati qualitativi sono ridotti a categorie o temi valutati in modo soggettivo. La dimensione della soggettività nell’ambito della ricerca e le problematiche connesse non rappresentano, di certo, una novità, poiché è altamente probabile che l’influenza soggettiva del ricercatore possa alterare l’osservazione. La metodologia qualitativa parte da tre assunti fondamentali: a) una visione olistica, attraverso la quale si cerca di comprendere, nella loro interezza e complessità, i fenomeni; b) un approccio induttivo, che fa sì che la ricerca parta da osservazioni specifiche per poi spostarsi verso schemi generali, derivanti dai casi studiati; c) l’indagine naturalistica, che consiste nel comprendere, naturalmente, la fenomenologia generale. Si annoverano i seguenti approcci: fenomenologico, ermeneutico, etnografico. Le ricerche fenomenologiche hanno l’obiettivo di chiarire e descrivere i significati dell’esperienza umana; gli strumenti utilizzati nell’ambito di tali ricerche è supportata, solitamente, da interviste o conversazioni, durante le quali, andando oltre le descrizioni offerte dagli individui circa il vissuto, si punta a giungere alle strutture che sottendono la coscienza. Particolarmente importante risulta essere il rapporto con il soggetto da un punto di vista empatico. L’approccio ermeneutico, proprio per la sua complessità, risulta scarsamente applicato nel campo della ricerca sociale. Si basa sul presupposto che una specifica attività può essere compresa solo se si comprende il contesto nel quale si sviluppa; metodologicamente, i dati vengono forniti, prima, al ricercatore, il quale, in uno studio di natura fenomenologica, provvederà a creare il racconto trascritto che, solitamente, è stato ottenuto intervistando i partecipanti soggetti. L’approccio etnografico comprende descrizioni di natura antropologica e ricerche naturalistiche. L’attività di ricerca si sostanzia nella comprensione, ad esempio, di particolari aspetti di un gruppo, al fine di ottenerne, successivamente, informazioni più dettagliate. Il ricercatore, penetrando sempre più nella dimensione dell’oggetto di studio, dovrà, però, mantenere un adeguato distacco. I dati ottenuti vengono annotati su un diario di ricerca. Occorre innanzitutto precisare che, in campo criminologico, si ricorre a svariati metodi d’indagine; la scelta di una specifica metodologia è influenzata innanzitutto dagli scopi che il ricercatore si prefigge. Il processo della ricerca non è lineare, bensì si configura come un ciclo di passi ripetuti nel tempo. Il punto di entrata più comune è rappresentato da una qualche forma di osservazione empirica. Il ricercatore sceglie un 58 I metodi e le fonti delle conoscenze criminologiche argomento da un infinito insieme di argomenti, in seguito, attraverso un procedimento induttivo, formula una proposta di ricerca. Il passo successivo, consisterà nello sviluppare in modo compiuto la proposta, enunciandola sotto forma di affermazione che stabilisce una relazione tra due fenomeni. Dato che l’asserzione è valida solo nell’ambito di una specifica struttura teorica, spetterà al ricercatore il compito di spiegare tale proposizione, alla luce di un più vasto sistema teorico. 3.4 Altri strumenti applicati alla ricerca a) le statistiche di massa Le statistiche di massa esprimono, in numeri, l’osservazione di fatti; privilegiano lo studio di fattori macrosociali di generale influenzamento, e non consentono l’identificazione di fattori causali e l’evidenziazione di condizioni microsociali o personali significative. Tale metodo risulta essere indispensabile per la conoscenza dell’estensione del fenomeno criminale e per l’espressione delle sue caratteristiche più generali, quali diffusione, frequenza, modificazioni quantitative e qualitative, distribuzione qualitativa in ordine al tipo di reati, qualità e gravità delle sanzioni, e così via. La statistica di massa si limita, in genere, a una descrizione fenomenologica della condotta criminale. Può usufruire di dati, pervenuti dagli organi della magistratura o da quelli della polizia, che possono essere considerati in funzione di numerose variabili (sesso, età, tipo di reato, occupazione, stato civile, razza, religione, ecc.). La statistica criminale può contenere numerose cause di errore, sia riguardo la validità dei dati, dovute all’imprecisione o non attendibilità delle fonti, sia per ciò che concerne l’interpretazione dei dati in genere, se la tecnica statistica non viene correttamente applicata. La principale causa di errore insita nella statistica di massa è legata al fatto che i dati ufficiali (reati denunciati alla magistratura, denuncie formulate dagli organi di polizia, provvedimenti penali istruiti contro gli autori, statistiche sulle popolazioni nelle carceri, ecc.) non possono, ovviamente, tener conto della statistica occulta, rappresentata dai reati effettivamente commessi, ma non scoperti. Il numero oscuro (dark number) indica, quindi, la differenza tra la criminalità effettivamente presente in un certo contesto sociale, e quella che invece risulta dichiarata e perseguita dagli strumenti costituzionali. Esso invalida, in modo più o meno rilevante, le statistiche sulla criminalità. L’indice di occultamento (rapporto fra reati noti e quelli commessi) è influenzato da innumerevoli fattori, tra i quali: - caratteristiche del reato: alcuni crimini è più difficile che passino inosservati (omicidi), rispetto ad altri di cui spesso non se ne ha neppure notizia (truffe); - atteggiamento della vittima: una delle fonti dalla quale emerge la conoscenza dei delitti commessi è la denuncia della parte offesa, ma non tutte le vittime (o testimoni) rendono di dominio pubblico il danno subito; - atteggiamento degli organi istituzionali: le iniziative di questi ultimi rappresentano un’ulteriore fonte per l’evidenziazione dei fatti delittuosi. Spesso, però, queste in59 Criminologia ed elementi di criminalistica dagini finiscono, per motivi contingenti o di scelta, col privilegiare un settore o un gruppo sociale piuttosto che un altro. Significativo, a tal proposito, è il riferimento alla delittuosità dei colletti bianchi, caratterizzata da un alto indice di occultamento, incrementato, in parte, dal mancato controllo da parte delle forze istituzionali; - qualità dell’autore del reato: fattori quali ceto sociale, razza, stato civile, nonché livello di professionalità del criminale, influenzerebbero la scoperta o la denuncia del crimine. In ogni caso, queste considerazioni dovrebbero far desistere dall’attribuire significato di causalità alle indagini statistiche, nonché dall’arbitraria generalizzazione dei risultati. In conclusione, il campo della delittuosità reale è molto più ampio di quello che convenzionalmente si ritiene, coinvolgendo larga parte della popolazione, e interessando gran parte dei gruppi sociali. Per crimine si intende qualunque fatto previsto dalla legge come reato che si manifesta, peraltro, con modalità differenti in funzione della posizione sociale e dei vari status. Mentre i delitti che costituiscono la delittuosità convenzionale sono, statisticamente parlando, appannaggio dei gruppi sociali più squalificati, gli altri gruppi sociali commettono reati di diversa natura, che sono in genere quelli meno perseguiti. Così, ad esempio, un giovane immigrato manifesterà la sua indifferenza verso le norme, rubando o rapinando in modo convenzionale, mentre il borghese disonesto, esplicherà la propria antinormatività in settori suoi propri, nelle frodi del commercio, nella corruzione, e così via. Questi delitti non convenzionali avranno, però, la caratteristica di comparire nelle statistiche redatte, sulla scorta dei soli delitti perseguiti e giudicati, in modo poco rilevante rispetto alla loro entità, ingenerandosi, perciò, la erronea convinzione che i veri delitti sono quelli convenzionali, e che questi ultimi siano molto più diffusi degli altri. b) il metodo sperimentale Come nel campo delle scienze cosidette esatte, anche in criminologia, si usa il metodo rigoroso della sperimentazione controllata. Esso consiste nel mantenere costanti o controllati tutti i fattori e le condizioni che si ritiene influenzino i risultati dell’esperimento, a eccezione della variabile o fattore ipotizzato come responsabile di determinati comportamenti del soggetto sotto osservazione. Per esempio, alcune ricerche criminologiche hanno focalizzato l’attenzione sullo sviluppo di diverse forme di terapia farmacologica per ridurre l’aggressività e il comportamento delinquenziale dei minori. L’applicazione del metodo sperimentale in tale campo implica l’uso di due gruppi di soggetti. L’uno, sperimentale o campione, l’altro di controllo. Entrambi, devono essere simili per età, quoziente intellettivo, sesso, classe sociale e ogni altra caratteristica associabile all’aggressività e al comportamento deviante. Al gruppo testato viene somministrato il farmaco, mentre, al gruppo di controllo viene somministrata, senza che lo sappia, una sostanza innocua, cioè un placebo. Successivamente, vengono confrontati i differenti comportamenti aggressivi tra i due gruppi. Vengono, infatti, svolte determinate misurazioni del comportamento ag60 I metodi e le fonti delle conoscenze criminologiche gressivo dopo l’assunzione del farmaco e confrontate con quelle fatte prima del trattamento per entrambi i gruppi. La riduzione delle spinte aggressive e delinquenziali nel gruppo sperimentale o in una sua parte, confrontate con quelle del gruppo di controllo, potrà considerarsi perciò come l’effetto della terapia farmacologica studiata. Nelle ricerche sperimentali, inoltre, la criminologia, prova varie ipotesi su come due o più variabili siano correlate ad altre. Anche in questo caso, si mantengono costanti o controllati tutti i fattori considerati significativi per il risultato dell’esperimento (variabili dipendenti), tranne la variabile indipendente, ipotizzata come determinante il cambiamento del soggetto o il comportamento allo studio. Quindi, la ricerca sperimentale, deve utilizzare metodi molto più complessi di altre, poiché i risultati ottenuti potrebbero essere dovuti anche a fattori completamente ignorati nella sperimentazione che potrebbero influenzare, contemporaneamente, i cambiamenti rilevati. Sebbene tale modello metodologico sia considerato come ideale ed estremamente rigoroso, il suo utilizzo in criminologia è abbastanza limitato, in quanto, può risultare particolarmente costoso in termini di tempo e di economia, soprattutto se il campione e il gruppo di controllo sono molto numerosi. c) le metodologie d’inchiesta Nel metodo dell’inchiesta rientrano le tecniche dell’intervista o del questionario. Esso permette di rilevare opinioni, atteggiamenti, valori, ecc., dei soggetti che fanno parte del gruppo campione della ricerca. d) la tecnica dell’intervista I dati di ricerca si possono ottenere anche con il metodo dell’intervista. L’intervista si basa sull’incontro di un soggetto, come un deviante, un detenuto o una vittima di reato, con l’intervistatore, e può essere condotta faccia a faccia o per telefono. È una tecnica completamente diversa da quella del questionario, in quanto, quest’ultimo, è compilato in maniera autonoma dalle persone partecipanti, mentre l’intervista è svolta direttamente da un intervistatore addestrato che pone le domande preparate appositamente su una scheda dal ricercatore. È chiaro che, in tal modo, aumentano considerevolmente i costi e i tempi della ricerca, ma ciò è compensato dai seguenti vantaggi: 1) si elimina quasi completamente il problema della non restituzione o del rifiuto; 2) si possono porre domande più personali; 3) l’intervistatore, può riformulare o spiegare in modo più chiaro alcune domande evitando il rischio di fraintendimenti. Entrambi gli strumenti, comunque, sono utilizzati sia per le ricerche sulla vittimizzazione, che traggono informazioni dalle vittime del reato, sia per le indagini di autodenuncia o inchieste confidenziali, in cui si chiede ai partecipanti di descrivere le loro attività criminali attuali e trascorse. In ogni caso, e qualsivoglia strumento si utilizzi, per ottenere informazioni su una larga fascia di persone definita come popolazione, è necessario selezionare un campione, essendo impossibile indagare su ogni singolo soggetto. 61 Criminologia ed elementi di criminalistica Il campione è, pertanto, un sottogruppo del contesto più ampio e deve essere rappresentativo di esso, il che significa che deve averne le stesse caratteristiche socio-demografiche (per es., in una ricerca sulle opinioni della popolazione di Palermo nei confronti della tossicodipendenza, se il 25% di essa è costituita da soggetti di età superiore ai 49 anni anche il campione dovrà contenere la stessa percentuale di soggetti ultraquarantanovenni). Va, infine, sottolineato che esistono due tipi di intervista: strutturata e semistrutturata. La prima (strutturata) si basa, in effetti, sull’uso di un questionario che consente di raccogliere sistematicamente un certo numero di informazioni di prima mano dalle persone scelte per l’indagine. Il documento di base deve essere predisposto in modo tale da soddisfare due esigenze fondamentali: trasformare in domande precise e specifiche gli obiettivi della ricerca e prevedere l’elaborazione dei dati in rapporto a essi; coadiuvare l’intervistatore nel preparare l’intervistato a collaborare. L’intervista semistrutturata, invece, prende le mosse da uno schema di massima con l’indicazione di aree tematiche obbligatorie. È informale in quanto all’interno di tali aree, il colloquio si sviluppa in base anche alle risposte dell’intervistato, ed è utile, soprattutto, per individuare fatti, credenze, sentimenti, criteri di azione, atteggiamenti e comportamenti passati e attuali. È, in effetti, dal punto di vista metodologico, molto simile al colloquio in profondità, dove prevale la tecnica della non-direttività, definita anche del colpo di sonda (probing). Con essa, si provoca una reazione con una domanda-stimolo, posta con grande apertura e calore comunicativo da parte dell’intervistatore, che consente al soggetto di esprimere sentimenti e opinioni per i quali assume un atteggiamento difensivo. e) la somministrazione del questionario Il questionario è un piano strutturato di domande che consente di verificare le ipotesi di ricerca; esso viene compilato direttamente dall’intervistato e, di frequente, viene spedito a un campione specifico di persone considerate rappresentative (cioè aventi determinate qualità o caratteristiche in proporzioni simili) rispetto a una popolazione più ampia. In criminologia si preferisce, spesso, utilizzare questionari, poiché meno costosi, in confronto ad altre forme di raccolta di dati, e si possono ottenere informazioni da un numero più elevato di soggetti (per es. cittadini, criminali condannati, vittime, ecc.), in un tempo relativamente breve, con un minimo sforzo da parte sia del ricercatore sia dell’intervistato. Comunque, l’uso dei questionari presenta alcuni problemi; prima di tutto, il rifiuto di rispondere di una parte dei soggetti; chi ha commesso un reato o è stato vittima di esso può non voler fornire informazioni personali, per diverse ragioni. È ovvio che tale situazione produce serie conseguenze sui risultati della ricerca, che possono portare a interpretazioni incomplete o distorte del fenomeno osservato. Un secondo problema è costituito dal fatto che, a volte, un numero significativo di persone potrebbe fraintendere o non capire alcune domande che presentino difficoltà, sia per la loro formulazione, sia per la loro interpretazione. Molte altre questioni si pongono all’attenzione del 62 I metodi e le fonti delle conoscenze criminologiche ricercatore nell’utilizzo dei questionari. Per esempio, molti soggetti preferiscono dare risposte compiacenti, oppure, rispondono in modo differente alla stessa domanda posta in momenti diversi (domanda di controllo sull’attendibilità); o, ancora, i pregiudizi inconsci dello studioso potrebbero colorare le domande, in modo tale da giungere a conclusioni predeterminate, senza valore scientifico. f ) la ricerca longitudinale o catamnestica Il metodo dello studio del caso consiste nell’analisi intensiva e approfondita di un singolo individuo, di un gruppo, comunità o istituzione. Lo studio può essere sviluppato in un preciso momento storico o per un periodo di tempo (studio longitudinale). Quest’ultima ipotesi permette di cogliere l’evoluzione di un fenomeno. Se è svolto in retrospettiva (studio anamnestico), è molto utile per spiegare lo svolgimento delle carriere criminali; se è svolto in prospettiva (studio catamnestico), risulta particolarmente significativo nell’analisi dell’efficacia delle misure di trattamento e recupero sociale dei condannati. I fattori considerati e gli strumenti utilizzati con questo metodo sono molteplici: anamnesi familiare per conoscere i precedenti morbosi e le caratteristiche personologiche e comportamentali dei componenti familiari (ascendenti e collaterali); anamnesi personale di tipo medico; analisi costituzionale per confrontare soma e psiche; indagine biografica per conoscere le modificazioni comportamentali e degli atteggiamenti; esame psicologico, anche con l’uso di reattivi mentali; esame psicopatologico per individuare eventuali patologie mentali; indagine sociale e familiare; osservazione comportamentale nella fase di ricerca. Per esempio, la perizia psichiatrica, ordinata durante un procedimento penale ai fini dell’accertamento dell’imputabilità e della pericolosità sociale del soggetto, potrebbe essere considerata, a tutti gli effetti, uno studio del caso; tant’è che, anche se lo scopo ultimo non è quello di ricerca, una o più perizie psichiatriche possono costituire un materiale fondamentale per lo studio di casi criminali (per es. serial killer, pedofilo: Ponti, Fornari, 1997). Tra le opere più famose in questo campo, si possono citare le numerose ricerche svolte dai coniugi Glueck (1950, 1968) per individuare i fattori familiari-situazionali e individuali più frequenti nei giovani delinquenti. L’analisi inizia con la comparazione - a tappeto - di coorti di minori delinquenti (campione) e non delinquenti (gruppo di controllo), nati nella stessa città e nello stesso anno, e frequentanti la stessa scuola, per poi passare al raffronto di multicoorti dello stesso genere, ma nate in anni diversi, per distinguere i fattori dovuti agli effetti della crescita da quelli derivanti dal periodo storico. Un altro esempio classico di ricerca, fatta secondo lo studio del caso, è quello descritto da Sutherland (1937) in The Professional Thief. L’autore intervistò un ladro professionale e ottenne informazioni in profondità che sarebbe stato difficile avere con altri metodi; studiò che cosa significasse essere un ladro professionale piuttosto che occasionale, come esso si era organizzato, e come i soggetti di questo tipo comunicavano e si collegavano fra loro. Certo le conclusioni cui era pervenuto Sutherland non possono essere generalizzate. Infatti, una delle critiche mosse al metodo dello studio casistico è che le informazioni ottenute possono essere non corrette o errate, contenere opinioni personali o molto 63 Criminologia ed elementi di criminalistica limitate. Nonostante ciò, diversi criminologi hanno continuato a utilizzare tale tecnica anche per esaminare lo stile di vita di un singolo delinquente (Geis, 1968; Klockars, 1976; Steffensmeier, 1986). Nel settore più strettamente sociologico, lo studio del caso si definisce anche storia di vita, in quanto, descrive un tipo particolare ed emblematico di criminale o di carriera criminale, senza pervenire a interpretazioni o spiegazioni specifiche. In Italia, per esempio, analisi di questo tipo sono state fatte su mafiosi, banditi, terroristi (Ghirotti, 1968; Vergani, 1968; Licausi, 1971; Marrazzo,1984). g) la ricerca trasversale o cross-sezionale L’inchiesta cross-sezionale è quella più diffusamente usata. Fornisce dati circa l’epidemiologia del delitto, ed entro certi limiti, sull’eziologia di un comportamento criminale. Essa comprende un campionamento di un insieme di individui o di gruppi, in modo da poter generalizzare i risultati ad una più ampia popolazione (detenuti dimessi dal carcere, studenti di scuola superiore, ecc.). Il campione è preso in un dato momento, i soggetti vengono intervistati o sottoposti a questionario e i dati vengono analizzati. Numerose critiche sono state rivolte a questa tecnica: in particolare, risulta difficoltoso isolare gli effetti del trattamento o dei programmi di prevenzione del comportamento criminale. I gruppi selezionati potrebbero differire tra loro già in precedenza, minando, in tal modo, la validità interna della ricerca. h) le indagini individuali I metodi individuali di indagine criminologia consistono nello studio di singoli criminali o di piccoli gruppi; mutuati dalla ricerca psicologica e medica, presuppongono che un ricercatore possa pervenire a una migliore conoscenza di un fenomeno mediante un’intensa esplorazione. Essi si diffondono per reazione allo studio di cause singole e, per contro, si avvalgono di un approccio olistico. Il metodo clinico, possibile approccio allo studio dei casi, viene utilizzato nella diagnosi di un problema personale rilevante o anormale e nella messa a punto di un programma di trattamento adeguato. Coniuga due aspetti importanti: ricerca e trattamento, e si sofferma sui fattori costituzionali, psicologici e sociali che caratterizzano ciascun delinquente. Le correlazioni fra numerose indagini individuali consentono di ricavare tendenze e caratteristiche comuni. Inoltre, tali investigazioni hanno permesso di chiarire fattori assai rilevanti della condotta deviante: fattori disturbanti familiari, caratteristiche di personalità, condizioni frustranti, tutti elementi interessanti se inseriti in un ottica di causalità circolare. Clinici provenienti da vari ambiti vengono spesso interpellati per formulare valutazioni circa il possibile futuro comportamento o la eventuale pericolosità sociale di un individuo, valutazioni che possono essere usate per incarcerare un reo o limitare in altro modo la libertà. Gli studi dei giudizi clinici predittivi di un comportamento futuro hanno evidenziato che esiste un notevole numero di falsi positivi, cioè predizioni errate. Ciò solleva la spinosa questione dell’equilibrio tra sicurezza pubblica e libertà individuale. La critica più aspra rivolta al metodo clinico è che gli individui o i gruppi selezionati per 64 I metodi e le fonti delle conoscenze criminologiche lo studio potrebbero non essere rappresentativi della intera popolazione di quegli individui o di quei gruppi. Oltre al suo impiego clinico in criminologia, l’approccio dello studio dei casi è stato anche usato nella forma di storie di vita, osservazione e osservazione partecipante. Il metodo della storia di vita comprende l’analisi di diari, biografie, autobiografie, come pure interviste, al fine di ottenere una conoscenza profonda di singoli individui o gruppi rappresentativi. Particolare attenzione viene riservata alla storia individuale come raccontata dal soggetto, all’interpretazione che egli ne fornisce, nonché alle sue esperienze e al suo ambiente. L’osservazione e l’osservazione partecipante arricchiscono ulteriormente lo studio della vita sociale e della condotta deviante, attraverso esperienze dirette con il reato e i criminali. Di solito, ciò implica il compilare un diario dettagliato, magari comprendente anche un certo numero di interviste molto approfondite. Altri ricercatori si avvalgono di registrazioni, fotografie, e così via. Un inconveniente del metodo dell’osservazione e delle storie di vita è rappresentato dall’estremo coinvolgimento personale richiesto al ricercatore, spesso causa di sgradevoli e dannose conseguenze. Contro tutte queste obiezioni, si potrebbe ribattere con la considerazione che lo studio dei casi e l’osservazione partecipante potrebbero essere utilizzati nella fase preliminare di ogni ricerca, al fine di arricchire una teoria e giungere alla formulazione di ipotesi più efficaci e alla costruzione di strumenti più appropriati. i) il metodo storico Il metodo storico, in criminologia, ha molti obiettivi: studiare il cambiamento nella natura e nella diffusione del reato nel tempo o in condizioni sociali differenti; rintracciare le fonti sociali del cambiamento delle leggi che definiscono la natura del reato; analizzare un evento o un periodo storico per il suo interesse intrinseco; isolare una particolare forma di reato o devianza e studiare le reazioni ad essa durante uno specifico periodo storico. Tale approccio, seppure molto utile, risulta spesso di non facile applicazione a causa di limitazioni legate alla parziale o totale indisponibilità dei dati presenti negli archivi. Inoltre, un altro inconveniente comune allo studio dei casi, scaturisce dalla difficoltà della scelta di un caso rappresentativo. 3.5 Il numero oscuro Le statistiche giudiziarie rappresentano il fondamentale strumento per intraprendere uno studio sulle dimensioni della criminalità; esse registrano le denunce, i giudizi e le condanne in un periodo considerato; la criminalità registrata dagli organi di controllo sociale ritrae solo una parte della criminalità reale, che è rappresentata dal numero effettivo dei reati commessi. È un dato di fatto ignoto, considerando che, per diversi motivi, non è possibile conoscere il numero esatto di tutti i reati commessi. È comunque possibile avvicinarci alla conoscenza della criminalità reale impiegando particolari tecniche di misurazione, quali le ricerche di vittimizzazione e di auto-denuncia. 65 Criminologia ed elementi di criminalistica Questi rilevamenti utilizzano metodologie che tutelano l’anonimato di chi risponde e raccolgono dati sui reati subìti o commessi dalle persone del campione considerato. La criminalità percepita rappresenta, invece, un dato soggettivo, che varia per ciascuno di noi, e indica la quantità di reati che ogni persona ritiene vengano commessi in una data realtà. Si tratta di un dato largamente influenzato dalle sensibilità personali e dalle caratteristiche oggettive dell’ambiente di vita. La criminalità percepita è quella che, maggiormente, interferisce sulla definizione individuale e collettiva dell’insicurezza e sull’intensità dell’allarme sociale. Questo allarme determina, talora, una percezione deformata della gravità dei reati e delle conseguenti azioni di polizia. La criminalità ufficiale è quella che si riferisce ai dati ufficiali, ricavabili dalle denunce dei cittadini e dalle attività autonome delle forze dell’ordine e della magistratura. La criminalità ufficiale risente dei limiti del cosiddetto numero oscuro (dark number) dei reati, cioè dell’insieme di delitti che, per diversi motivi, non arrivano a conoscenza degli uffici deputati alla raccolta delle segnalazioni. Il numero oscuro può variare a seconda della gravità dei reati e, nel tempo, in base al diverso atteggiamento dei cittadini e alla loro propensione a denunciare gli episodi delittuosi di cui sono stati vittime. Il rapporto tra reati registrati e reati commessi è detto indice di occultamento e varia da reato a reato, in relazione alla gravità del crimine. Tale indice è sempre negativo. Se si prendono in considerazione talune fattispecie di reato quali le rapine in banche, il furto di automobili, l’omicidio, il numero oscuro è molto limitato, con rapporto di occultamento vicino all’unità, mentre per altri, ad esempio, i delitti sessuali, la criminalità economica, il numero oscuro è elevatissimo. La spiegazione di tali differenze è riscontrabile nella impossibilità oggettiva che, ad esempio, un omicidio non giunga a conoscenza dell’autorità giudiziaria; lo stesso vale per una rapina in banca caratterizzata, soventemente, da clamore, soprattutto per le modalità di esecuzione; analoghe considerazioni vanno fatte per ciò che attiene la sottrazione di automobili, e ciò in virtù delle responsabilità a carico del proprietario che non ne dovesse denunciare il furto. Al contrario, il numero oscuro tende a salire, soventemente, per tre fattori fondamentali: a) atteggiamento della vittima; b) atteggiamento degli organi istituzionali; c) qualità dell’autore del reato. a) atteggiamento della vittima: deve rilevarsi che, in genere, non tutti i delitti vengono denunciati dalle vittime o dai testimoni; ciò comporta, da parte dell’autorità giudiziaria un non venirne a conoscenza; si pensi alle sottrazioni di oggetti di scarso valore, laddove la vittima non denuncia il fatto perché ritiene che trattasi di inutile perdita di tempo e che molto difficilmente l’autore del furto verrà acciuffato; anche i furti nei grandi magazzini, in numero elevatissimo, subiscono la stessa sorte: anche se l’autore viene colto in flagranza di reato, spessissimo non si procede a denuncia per evitare lungaggini di vario di tipo e la merce viene fatta riconsegnare, seduta stante, dagli addetti alla vigilanza. Ancora, per ciò che inerisce l’atteggiamento della vittima, si pensi ai delitti sessuali, laddove la parte offesa, per evitare pubblicità e clamore giornalistico, preferisce desistere; e ancora, le vittime di estorsioni da parte della malavita organizzata che, per paura di ritorsioni e danneggiamenti, non denunciano gli aguzzini; altri esem66 I metodi e le fonti delle conoscenze criminologiche pi potrebbero riguardare i tossicomani che si guarderebbero bene dal denunciare i pusher, senza i quali, non potrebbero placare la loro bramosia patologica; b) atteggiamento degli organi istituzionali: sia la magistratura che gli organi di polizia hanno il precipuo compito di identificare gli autori di reato, ma non solo, poiché, altra funzione demandata è quella di prendere l’iniziativa di ricercare fatti delittuosi non ancora noti. Può accadere, comunque, che filoni di indagini urgenti e contingenti per particolari tipologie di delitti (come quelli ad opera di immigrati, di organizzazioni criminali, e così via) in periodi più o meno lunghi impegnino in tale direzione le forze dell’ordine, disimpegnandoli da altre dimensioni criminose, quali ad esempio gli illeciti internazionali, o i delitti ad opera dei colletti bianchi, fattispecie di reati che, per lungo tempo, non sono stati perseguiti poiché vi è stata assenza di iniziative di indagine, ma che nel contesto attuale, considerata la pericolosità e l’insidia, sono al centro, oggi, di interesse giudiziario; c) la qualità dell’autore di reato: particolare importanza viene data a tale condizione, poiché non è infrequente che la posizione di un pubblico ufficiale, di un uomo ricco, influente, potente, o appartenente a classi direttive o politiche, influisca o si traduca in una relativa minore esposizione al rischio di identificazione. Altra categoria beneficiata è costituita dai minorenni, per i quali, si sa, la legge, soventemente, lascia correre, sempre tenendo conto, comunque, della qualità del reato; a questi ultimi, si aggiungono i soggetti con particolari infermità psichiche o gli anziani; così non sembra, invece, per altre categorie di soggetti, quali i tossicomani o gli sbandati, per i quali le possibilità di immunità sarebbero, oggettivamente, minori; analoga situazione si riscontrerebbe nei confronti di soggetti emarginati e che hanno minor peso sociale. 67 CAPITOLO 4 I fenomeni inducenti al delitto 4.1 La delinquenza e l’età Le statistiche criminali offrono, oggi, la possibilità di coniugare lo studio delle fenomenologie criminali con le fattispecie di reati legate all’età degli autori di crimini. Un dato è certo: la delinquenza è in percentuale superiore tra le classi di età più giovani rispetto alle classi più vecchie. Tra i 12 (se non in alcuni casi, prima) e i 19 anni, la natura dei fenomeni criminali è legata ad atti di teppismo, di bullismo, di reati contro il patrimonio, e, solo in casi rari, si registrano omicidi; tra i 20 e i 30 anni, la criminalità raggiunge il proprio culmine; tra i 30 e i 40, si assiste ad un lento declino, che aumenta, sempre di più, tra i 40 e i 60 anni, per cessare, quasi completamente, con la vecchiaia. Le statistiche di rilevamento sui reati compiuti dagli infraquattordicenni, tuttavia, non rappresentano, almeno fedelmente, il fenomeno, poiché bisogna tenere in considerazione alcuni fattori, tra cui il numero di reati compiuti e non registrati dall’autorità giudiziaria, la particolare legislazione in ordine ai reati commessi dai minorenni, e il relativo trattamento in sede giudiziaria. Altri reati attribuiti ai minori riguarderebbero le rapine, le aggressioni, i furti d’auto, atti osceni con donne, e violenze carnali. Agli adulti, invece, vengono attribuiti reati di natura più complessa, quali truffe, appropriazioni indebite, e così via; reati, invece, come gli atti di libidine su minori o l’esibizionismo, vengono attribuiti agli ultraquarantenni. Ritornando alla delinquenza minorile, se ne possono distinguere: una forma generalizzata di delinquenza minorile, a sua volta divisa in due forme: il delinquente vero e proprio, e il teppista, proprio delle grandi metropoli industriali con la formazione di bande di giovani teppisti, senza appoggio adulto (teddy-boys). Per il primo, furto e rapina e altre attività criminali sono mezzi per raggiungere la ricchezza e la soddisfazione dei propri desideri. È cauto, attento, calcola l’utilità e i rischi che gli possono venire da ogni azione. Se raggiunge una posizione economica che considera soddisfacente, abbandona l’attività criminale: questo è il suo progetto e la direzione che ha dato alla sua 69 Criminologia ed elementi di criminalistica vita. Il secondo tipo, il teppista, non si prefigge alcun fine pratico, o almeno, esso non è prevalente. Il crimine, per lui, non è un mezzo per raggiungere qualcosa di tangibile, ma è fine a se stesso. Spesso, infatti, tale tipo di delinquente, appartiene a famiglia abbiente che gli soddisferebbe ogni esigenza. Possiamo, quindi, cosi, sintetizzare le differenze: il primo compie un crimine per l’utilità che ne può ricavare, mentre il secondo lo compie per se stesso, senza prefiggersi una vera utilità, e, in genere, è poco curante delle conseguenze. Le azioni dei teppisti, spesso, appaiono quindi illogiche e stupide. Il primo tipo, infatti, non ha origine nella psicologia propria dell’infanzia, ma è semplicemente il risultato della delinquenza adulta. Infatti, in questi casi, il minore è aggregato quasi come un apprendista a una banda criminale, spesso incoraggiato dagli stessi genitori. L’attività criminale non deriva da problemi psicologici giovanili, ma dall’ambiente degli adulti in cui vive. Il teppista minorile, invece, ha la sua origine proprio nell’animo dei ragazzi e sorge come rivolta all’ordine costituito dei genitori, della società. Il teddy-boy non ha appoggi nel mondo degli adulti, che lo deridono. La banda dei delinquenti minorili può essere definita un gruppo che assume valori etici opposti a quelli della società. I componenti odiano ferocemente tutto quello che è per bene. Caratteristico è il vandalismo. Cercano di distruggere tutto quello che non appartiene loro, senza nessuno scopo. La banda cerca, poi, di essere autonoma assolutamente da interferenze esterne. Tale fine ha la chiusura ermetica agli estranei, il segreto che la circonda. Ma se l’autonomia della banda è assoluta all’esterno, l’autonomia dei singoli membri all’interno è scarsissima. È importante da notare che, spesso, tali bande scatenano deliberatamente l’ira di persone e di gruppi di persone per liberarsi dei legami affettivi che ad essi li legano. Come si può constatare, i caratteri delle gang sono molto simili a quelli delle manifestazioni più deleterie del gruppo infantile scolastico. Naturalmente, nella delinquenza minorile, quei caratteri acquistano ben altra consistenza e gravità, anche se si ritiene che la radice dei due fenomeni sia sostanzialmente la stessa: lo sbandamento, l’incapacità a inserirsi armonicamente nella società, sia per i difetti di essa, sia per le insufficienze personali, combinati variamente caso per caso. Come il fanciullo, anche l’adolescente, esplode in rivolta contro la società che lo respinge. Il delinquente minorile non riesce a inserirsi nella società per le più varie ragioni: allora, per affermare la sua personalità, non gli rimane che aggregarsi a un banda che mostra di combattere quell’ordine che lo ha respinto e, nella quale, i titoli che gli hanno impedito di affermarsi rovesciano il loro valore e diventano ambiti titoli di merito. Per ciò che attiene la delinquenza degli adulti, è necessario evidenziare che il quadro dei reati in ogni Paese è sottoposto a continui mutamenti: dalle indagini, ma anche da determinati servizi per la sicurezza pubblica (contrasto del traffico della droga e dello sfruttamento di esseri umani ridotti in schiavitù, ad esempio), emergono, continuamente, delle nuove specificità dei territori, quale riscontro della straordinaria capacità di adattamento della delinquenza alle occasioni. Si pensi al fenomeno cosiddetto delle bande in trasferta. Il nomadismo della delinquenza va, inoltre, a rinforzare le tendenze attivistiche della delinquenza locale. In agglomerati urbani di ridotta ampiezza, la delinquenza è altrettanto presente in minore intensità, segno che il controllo sociale spontaneo e la capillarità della presen70 I fenomeni inducenti al delitto za istituzionale posseggono, ancora, una certa efficacia, tanto da scoraggiare l’attività della delinquenza autoctona (che, però, in parte, compensa il surplus di sorveglianza, spostandosi altrove). Nei piccoli centri, dove è attivo un maggior controllo sociale, si può dedurre che chi delinque tende a farlo altrove; reciprocamente, anche le persone vittime di reato e nate nella piccola provincia, subiscono prevalentemente il crimine in altre località. 4.2 Relazione tra razza, nazionalità e delitto La criminologia si è spesso interrogata sul rapporto tra criminalità e diversità razziali. Lo stesso concetto di razza, di per sé ambiguo, può intendersi in una prospettiva di carattere biologico, come un aggregato di caratteristiche su base genetica. Le origini della parola razza sono state discusse, a lungo, dai linguisti, ma, ormai, è prevalsa l’opinione che fa derivare il vocabolo da un termine francese medioevale, haraz haras che significa allevamento di cavalli, in particolare, stalloni selezionati. Anzi, sempre secondo l’uso originario, con razza, si è indicato anche il risultato del processo di selezione, attraverso le varie generazioni, che ha portato a migliorare gli elementi genetici, considerati preferibili da vari punti di vista, di una particolare specie. Assai presto, tuttavia, si è passati ad usare il termine con un valore più ampio, quello di discendenza, stirpe, non solo di animali, ma anche di uomini, e, quindi, razza ha potuto indicare anche una famiglia nel senso di successione di generazioni. Con il diffondersi di una concezione del mondo di tipo positivistico, nell’Ottocento, la divisione in razze è stata estesa all’intera umanità, basandosi, però, su elementi come l’aspetto esteriore o altre caratteristiche secondarie che la scienza attuale ha messo fortemente in discussione, soprattutto in rapporto all’effettivo patrimonio genetico dei gruppi umani. Comunque, a partire dalla fine del secolo scorso si è cominciato a distinguere i vari popoli della terra a seconda delle presunte razze di appartenenza. E quel che è peggio, si sono collegati i concetti di razza e cultura, sostenendo una ipotetica superiorità di popoli di cultura occidentale, in quanto razze superiori rispetto alle altre considerate inferiori perché di tradizioni più o meno primitive. Neppure il libro di Charles Darwin − L’origine della specie (1859) − che documentò come lo sviluppo fosse prodotto dalla selezione naturale e che rivoluzionò in campo scientifico le teorie sulle differenze fra gli esseri umani, potè impedire un uso distorto del termine razza. Ispirò anzi una nuova forma di razzismo, il cosiddetto razzismo scientifico, basato sull’idea che il pregiudizio razziale svolga, addirittura, una funzione evolutiva. Le teorie biologiche sulla razza subirono profondi mutamenti negli anni trenta, quando, con l’affermarsi della genetica che documentò come non la specie, ma il gene fosse l’unità di selezione, si potè argomentare che esistevano potenzialmente tante razze quanti erano i geni. Nel 1939 Julian Huxley e Alfred Cort Haddon, nel libro, Noi europei, sostennero che i gruppi solitamente considerati razze, non erano fenomeni biologici ma invenzioni politiche, e che sarebbe stato più corretto denominarli gruppi etnici. 71 Criminologia ed elementi di criminalistica Ritornando all’interesse della criminologia per il rapporto tra razza e criminalità, si può affermare che non risultano indagini che abbiano fornito elementi significativi per spiegare tale presunto rapporto; pertanto, il termine razza dovrebbe essere sostituito con quello di nazionalità. Numerosi autori concordano, comunque, sul fatto che, sebbene si operasse la sostituzione del termine nazionalità con quello di razza, sarebbe impossibile, altresì, stabilire se un popolo sia più o meno criminale di un altro. Solo uno studio delle differenze fenomenologiche delittuose tra una nazione e un’altra offrirebbe una visione più funzionale. Mentre negli Stati Uniti, ad esempio, la delinquenza delle persone di colore, rispetto alla popolazione totale, è di gran lunga superiore per motivazioni economiche, sociali, di scolarizzazione, e la tipologia di reati è riconducibile per lo piu ad azioni delittuose di appropriazione, in Svizzera, il tasso di criminalità è percentualmente ridotto in termini quantitativi per una dimensione di benessere diffusa che spinge al delitto solo in particolari casi. La tipologia dei delitti è sicuramente diversa, poiché è di gran lunga più diffusa la criminalità bianca. 4.3 Immigrazione e criminalità Il rapporto tra immigrazione e criminalità è sicuramente un problema complesso, e ancora più complesso risulta provare che l’immigrazione determini sempre l’aumento dei reati nel Paese di destinazione. In Italia, ad esempio, un esponenziale aumento della criminalità è stato accostato a un aumento della presenza di immigrati. Tale aumento ha avuto luogo già dalla prima metà degli anni ‘70, quando, cioè, i processi migratori erano in fase iniziale. Purtroppo, risulta incontestabile che, specie nell’ultimo decennio, la quota degli stranieri implicati in fatti delittuosi è cresciuta. Questo incremento, tuttavia, nonostante si sia verificato per la gran parte dei reati e le diverse forme in cui sono stati commessi (lievi o gravi, commessi da singoli o da gruppi, espressivi o strumentali), non si è avuto per tutte le tipologie, né per tutti i livelli a cui vengono svolte le attività illecite. Si tratta di quei reati per la cui commissione è richiesta una posizione qualificata all’interno del sistema di stratificazione sociale e che, pertanto, escludono gli immigrati che si trovano ancora ai gradini più bassi. Questa situazione, però, non deve far pensare che nel sistema criminale gli stranieri occupino solo le posizioni più basse, dequalificanti e meno remunerative. Se è vero, che vi sono reati che continuano ad essere appannaggio della criminalità italiana, è anche vero che esistono delle zone di comunicazione, settori illeciti in cui si assiste a un progressivo inserimento degli immigrati anche ai livelli superiori e, addirittura, settori esclusivi della criminalità straniera. D’altra parte, anche quando vi è stato un aumento del numero dei reati commessi dagli immigrati, questo, però, non ha seguito un percorso parallelo all’intensificarsi del fenomeno immigratorio. Infatti, alcuni reati hanno avuto andamenti ciclici, con fasi di forte espansione nei primi anni di immigrazione e successive contrazioni e riprese negli anni più recenti. Inoltre, vi sono intere classi di reato che hanno fatto registrare aumenti notevoli anche tra gli stessi italiani, e che, pertanto, non si presentano come un problema specificamente straniero. Occorre, poi, tener presente che la popolazione immigra72 I fenomeni inducenti al delitto ta ha una composizione per sesso ed età diversa da quella italiana, nel senso che è più giovane ed ha una quota di maschi più elevata. Questo elemento strutturale è di fondamentale importanza nell’analisi dei fenomeni criminali, in quanto, il genere e l’età assumono un peso determinante nella propensione al crimine. Seguendo questo metodo, si potrà verificare, ad esempio, se, a parità di sesso ed età, gli immigrati commettono, più (o meno) spesso, alcuni reati rispetto agli italiani. L’idea di un rapporto diretto tra il numero di immigrati presenti e reati commessi è ulteriormente indebolita dal fatto che non tutte le nazionalità sono egualmente coinvolte in queste attività criminali. Infatti, vi sono gruppi etnici numerosi che presentano indici di criminosità inferiori rispetto a quelli italiani; ovvero, comunità di immigrati che, pur non essendo tra le più numerose, presentano indici di criminosità molto elevati; e infine, vi sono comunità etniche di particolare consistenza che esprimono una criminalità preoccupante. Il peso di ciascun gruppo, per di più, varia a seconda del reato e della posizione occupata nel sistema di stratificazione delle attività illecite: i furti e le rapine vengono compiute soprattutto dagli ex jugoslavi di entrambi i sessi (spesso minori nomadi), oltre che da marocchini, algerini e tunisini; lo spaccio di eroina, da marocchini e tunisini (e solo di recente anche dagli albanesi); il traffico di marijuana da albanesi, quello di cocaina da sud-americani; lo sfruttamento della prostituzione da albanesi e nigeriani. Questo aspetto si salda con la necessità di un’analisi di tipo culturale. Non si tratta di compilare pagelle o di distinguere tra buoni e cattivi, né di sostituire lo stereotipo dell’immigrato criminale con quello di una specifica nazionalità criminale. Si vuole solo aprire un discorso sul confronto culturale. La tesi è che la criminalità sia un fenomeno derivato anche da questo processo di confronto, che si verifica quando esso non è sufficientemente gestito dalle istituzioni, in termini di politiche di promozione e sostegno nella direzione dell’accoglienza e dell’integrazione. Il confronto può essere, di fatto, più difficile per gli immigrati che provengono da alcune aree geografiche, in quanto più complesso il processo di interazione tra la nostra cultura e quella di questi gruppi. È chiaro che quando si parla di cultura, si fa riferimento a qualcosa di dinamico, che si sviluppa: l’immigrato, porta con sé non solo usi religiosi, familiari, alimentari che perdurano nel tempo, ma, anche, atteggiamenti e opinioni che maturano nella situazione storica del Paese di origine. In questo senso, isolare le nazionalità più produttive dal punto di vista criminale non vuol dire proporre discriminazioni e chiusure selettive, bensì, indicare quelle componenti a maggior rischio criminale, in quanto, una situazione di protratta illegalità nel Paese di origine può essere alla base di una maggiore propensione a comportamenti aggressivi o violenti. I dati disponibili, inoltre, dimostrano che la criminalità è appannaggio principalmente di chi si trova nel nostro Paese in una situazione di irregolarità: ad esempio, sul totale dei cittadini extracomunitari denunciati per vari delitti, quelli senza permesso di soggiorno sono oltre il 70%, per le lesioni volontarie, il 75% per gli omicidi, l’85% per i furti e le rapine. Non v’è dubbio che la condizione di irregolarità crei le condizioni favorevoli al verificarsi di eventi criminosi; in primo luogo, perché costituisce un limite all’inserimento nel circuito socio-economico legale; in secondo luogo perché l’irregolarità porta con sé la produzione di alcuni reati quali la falsità, la resistenza all’arresto, le false generalità ecc. Inoltre, se si considera che una parte degli irregolari è composta dai 73 Criminologia ed elementi di criminalistica clandestini, sarà facile immaginare che l’immigrato irregolare, già all’ingresso, o al momento dello scadere del permesso di soggiorno o del visto, entri in contatto con realtà criminali che gli forniscono servizi di vario genere. Questo aspetto è particolarmente importante perché spiega i rapporti di soggezione che legano gli immigrati ai gruppi malavitosi organizzati che si occupano del traffico di migranti, della successiva gestione degli stessi e, soprattutto, del loro conseguente inserimento nei circuiti della devianza a tutti i livelli. Non vi è dubbio, infatti, che in questo traffico siano ravvisabili consistenti interessi di gruppi criminali internazionali che gestiscono l’organizzazione dell’immigrazione in tutte le sue fasi: dal reclutamento nel Paese di origine al transito nei diversi Paesi lungo il viaggio; dal reperimento di passaporti e documenti falsi al trasferimento e alla sistemazione iniziale nelle aree di destinazione. Ma, come avviene con la droga, gli immigrati, al loro arrivo, trovano un’organizzata rete criminale pronta ad accoglierli, destinarli, e inserirli in circuiti illeciti paralleli. Dunque, se molti elementi possono suffragare l’ipotesi che esiste un rapporto diretto tra aumento dell’immigrazione ed aumento della criminalità, altri inducono a dubitare della sufficienza delle basi scientifiche di tale tesi. Finché si continuerà ad affermare che la delinquenza straniera aumenta in rapporto diretto con l’intensificarsi dell’immigrazione, e che gli stranieri delinquono più dei nostri connazionali, si enunceranno delle verità generiche che non aiutano a capire, veramente, quali dinamiche sociali siano in atto, e che certamente non aiutano ad individuare strategie per la risoluzione del problema. Oggi, infatti, i fattori di spinta all’immigrazione e l’orientamento dei flussi si presentano fortemente condizionati dagli interessi criminali che hanno sfruttato i momenti di crisi della società civile ed hanno modificato, di fatto, i rapporti tra immigrazione e criminalità. Normalmente, coloro che sostengono che gli immigrati provocano un aumento delle forme di devianza forniscono tre prove che considerano inconfutabili: a) gli immigrati sono coinvolti nelle attività illecite del traffico e dello spaccio della droga; b) immigrate sono le donne che esercitano la prostituzione sulle strade; c) gli immigrati sono fortemente rappresentati nelle statistiche giudiziarie. Se le prime due affermazioni sono sicuramente efficaci, in quanto fanno riferimento a realtà di immediata percettibilità da parte dell’opinione pubblica, il terzo argomento, invece, necessita di alcune considerazioni. La valutazione quantitativa della criminalità straniera si fonda su dati relativi a situazioni differenti, quali il numero degli stranieri entrati nelle carceri, degli arrestati, dei denunciati, dei condannati e dei detenuti. Le diverse rilevazioni, che dovrebbero costituire il termine di confronto con la criminalità degli italiani e misurare il grado di incidenza sulla criminalità complessiva nel nostro Paese, in realtà, evidenziano numerose lacune e forniscono un quadro parziale e distorto del rapporto immigrazione-criminalità. Vi sono, infatti, molte buone ragioni per ritenere questi dati come i meno affidabili tra gli indicatori dei reati commessi dagli stranieri. Tra i fattori distorsivi, basti ricordare la proliferazione dei dati quantitativi in riferimento allo stesso individuo e la difficile attribuzione temporale dei fatti delittuosi. Per quanto riguarda il primo punto, vi è da dire che, per il censimento dei dati provenienti dalle diverse istituzioni (Ministero dell’Interno, Ministero di Grazia e Giustizia, ecc.), non è previsto, ad oggi, un sistema per eliminare l’inconveniente di segnalare un episodio di recidiva come fatto riferito ad un soggetto diverso. L’omessa rilevazione dei fatti commessi 74 I fenomeni inducenti al delitto dalla stessa persona produrrà, dunque, l’effetto di gonfiare i dati quantitativi delle diverse rilevazioni. Quanto al secondo punto, occorre precisare che non tutti i dati riescono a stabilire una connessione temporale tra l’evento criminoso e il momento repressivo: ad esempio, mentre i dati sui denunciati si riferiscono, di norma, ai soggetti segnalati per fatti avvenuti nell’anno di riferimento, quelli relativi alle condanne, viceversa, si riferiscono a manifestazioni criminose verificatesi anche negli anni precedenti. La conseguenza è che solo attraverso alcuni dati è possibile rilevare la fenomenologia criminale nell’anno preso in considerazione. Più in generale, l’imprecisione della rilevazione della criminalità degli immigrati non dipende solo da fattori di distorsione, ma anche dall’eterogeneità dei dati, dalla mancanza di razionalità e di selezione qualitativa degli stessi, dalla mancanza di indici-standard di rilevazione. Spesso, si è in presenza di indagini campionarie, poi proiettate a livello nazionale. Manca un confronto tra le rilevazioni effettuate dalle diverse istituzioni; manca un censimento della titolarità o meno di un permesso di soggiorno in capo al soggetto della rilevazione; manca un censimento del numero degli stranieri come persone offese dal reato. Tutte carenze, queste, che inficiano la corretta comprensione della realtà che si va a studiare. 4.4 Pauperismo e criminalità Mannheim sostiene che sia la povertà sia la ricchezza possono portare al delitto; le differenze motivazionali della criminalità (esistono forme di criminalità che hanno molto a che fare o niente con la povertà o la ricchezza) non debbono indurre ad accuse di scarsa coerenza teorica, perché, altrimenti, si dovrebbe accusare di confusione concettuale un cardiologo, quando sostiene che le malattie del cuore possono avere origine sia da eccessivi sforzi fisici che da inattività; un economista, quando afferma che lo stesso effetto economico − cioè l’accumulazione di un certo capitale − può essere realizzato sia guadagnando di più che spendendo di meno. Cause diverse, o persino opposte, possono avere lo stesso effetto, sebbene, naturalmente, il meccanismo causale avrà seguito una strada diversa. Le devianze criminali vengono affrontate, in un contesto moderno, sotto due ottiche fondamentali: la prima, che ritiene le devianze come esclusive conseguenze del sistema economico capitalista e, quindi, tende ad avere un atteggiamento di tipo giustificazionista; l’altra, secondo cui le politiche repressive vanno applicate solo nei confronti dell’anello più debole della catena criminale. Queste tesi, ovviamente, non sono sufficienti a interpretare e leggere le crescenti preoccupazioni tra gli abitanti delle città e i fattori che determinano la costruzione delle paure sociali più diffuse. Le condizioni di vita nelle grandi città sono ormai critiche, la diffusione del sentimento di insicurezza si esplicita in relazione a due aspetti distinti ma in qualche modo complementari: a) esiste la paura ed il timore di rimanere vittime della criminalità di strada (furti, rapine, scippi, violenze) e di altre forme di illegalità diffuse; b) il degrado urbano e il disordine sociale sempre più esteso per l’aumento della povertà, dell’emarginazione e dell’esclusione sociale, causano un forte senso di impotenza e di abbandono. 75 Criminologia ed elementi di criminalistica Sul primo elemento, si ritiene che, pur in presenza di un tasso di criminalità in lieve ma costante aumento, negli ultimi anni, questo non appare sufficiente a giustificare l’aumento dell’insicurezza generale e lo spropositato allarme sociale che crea. I dati statistici rivelano, anche, un altro aspetto interessante: in Italia, è la medio-alta borghesia, la fascia sociale che risulta più a rischio di rimanere vittima dei reati, per contro, l’insicurezza e la paura di rimanere vittima di reati è più diffusa negli strati sociali poveri, nonostante le statistiche indichino, in questa categoria, una minore diffusione dei fenomeni criminali, mentre, ad esempio, negli Stati Uniti, la situazione è completamente rovesciata, in quanto, le statistiche sulla criminalità indicano una maggiore diffusione nella popolazione più povera ed emarginata. Il crescente divario tra le diverse aree del Paese, la disoccupazione strutturale di massa, l’emergere di aree sempre più consistenti di povertà ed emarginazione, l’incremento dei flussi migratori, la riduzione dei sentimenti di solidarietà, la crescita dell’esclusione sociale, la criminalità indotta e l’aumento della microcriminalità definiscono un contesto in cui è facile prevedere sia l’aumento di fenomeni di criminalità, che l’intreccio sempre più stretto tra questione criminale e questione sociale. Lo sviluppo urbanistico, in questi anni, ha fortemente risentito dell’aumento di questi fenomeni. Gli stessi spazi urbani stanno assumendo una fisionomia nuova; da una parte, assistiamo alla configurazione di spazi in cui prevale la tendenza alla costruzione di quartieri-fortezza, ove i nuovi ricchi vivono protetti da sistemi di allarme sofisticati e da polizie private. Dall’altro, crescono, sempre più, aree di città blindate, abitate da nuovi poveri, zone che tendono a diventare dei moderni ghetti. Una città blindata alimenta il sentimento d’insicurezza che si esplicita, non solo nella paura di rimanere vittima di azioni delittuose (furti, scippi, borseggi ecc.), ma, anche, delle diverse forme in cui si diffonde il disagio urbano. La sociologia moderna ha messo in luce il nuovo concetto di povertà, non più intesa come la mancanza di beni primari di consumo, ma come assenza di strumenti, ad esempi tecnologici, che interagiscono con la vita quotidiana. 4.5 Sistemi di controllo sociale Il controllo sociale può certamente essere definito come il concetto classico delle scienze sociali, ed è identificabile con tutti i fenomeni e i processi che contribuiscono a regolare il comportamento umano e ad organizzarlo. In quest’accezione, il controllo sociale s’identifica con la morale, la religione, il diritto, i costumi, l’educazione, le rappresentazioni collettive, i valori, gli ideali, i modelli di cultura, l’opinione pubblica, le forme di suggestione e convinzione, e così via. L’insieme di questi meccanismi è strettamente connesso con il problema dell’ordine, e con quello di dare coerenza ai comportamenti di una moltitudine, e alle loro interazioni. Secondo tale modello, pertanto, ogni organizzazione di uomini che pretenda di definirsi tale, necessita di un meccanismo di controllo sociale teso ad assicurarne il mantenimento. Il diritto, quale meccanismo di regolazione praticato dallo Stato, rap76 I fenomeni inducenti al delitto presenta uno degli strumenti attraverso cui viene svolto il controllo sociale, anche se non è l’unico. Il diritto viene considerato come potere, ed esercitato per mezzo dello strumento dell’interdizione, cioè l’imposizione di un divieto o un obbligo (il precetto) e la reazione alla trasgressione (la sanzione); tenuto conto che il diritto interviene nei settori più importanti della vita associata, questo non implica, in linea di principio, che sia effettivamente il precetto, con la relativa sanzione, posto per legge, ad assicurare la conformità alla norma nei soggetti cui questa si rivolge. Si pone, però, un doppio problema: da un lato, il diritto non è l’unico agente del controllo sociale, cui, al contrario, sembrano funzionali anche meccanismi persuasivi oltre che coercitivi; dall’altro lato, il diritto stesso, la sua nascita ed il suo funzionamento concreto, sono immersi nel contesto socio-culturale, in cui un precetto assume vigore, cosicché, è possibile arrivare a distinguere tra la sfera della validità di una norma giuridica e la sfera della sua effettività. Il tema dell’efficacia delle norme giuridiche e del loro funzionamento effettivo rappresenta un impegno classico della sociologia giuridica; essa, studierebbe la società nel diritto, cioè la realtà concreta del fenomeno normativo, quella sorta di diritto libero che è il comportamento umano, più o meno difforme rispetto alle norme giuridiche, sempre pronto, nella prassi di tutti i giorni, a ricodificarle. Più precisamente, la sociologia giuridica, così intesa, andrà ad occuparsi di tutto quell’insieme di comportamenti che: - hanno per effetto norme giuridiche; - sono considerati come effetto di norme giuridiche; - sono considerati in relazione funzionale con comportamenti che hanno come effetto norme giuridiche o che sono effetto di norme giuridiche. Attraverso la sociologia giuridica, si riesce, quindi, a porre maggiormente in luce come il diritto, quale strumento di controllo sociale, interagisca con tutti gli aspetti che riguardano una data collettività, i quali, a loro volta, non vanno visti come fattori secondari nel funzionamento dei meccanismi di potere, ma come la base sociale in cui nasce e funziona, in concreto, il diritto. Collegando il diritto alla funzione imperatrice dello Stato è opportuno fare qualche passo indietro: Machiavelli, nella sua opera più celebre, parla dello stato del principe indicando, al contempo, una sua condizione personale e la somma dei suoi poteri. Il Principe di Machiavelli è tratteggiato come un sovrano che riesce ad accentrare nelle sue mani quel potere che in Italia restava ancora parcellizzato fra istanze diverse. Tale visione sintetizza il potere nella capacità di imporre la propria volontà da parte del sovrano: esso è la capacità di dettar legge e di usare la forza per farla rispettare. M. Foucault, invece, poneva il problema relativo al concetto di sovranità e del modo corretto di esercitarla da parte del Principe, che ne è titolare. La svolta fondamentale dovuta al pensiero illuminista, cioè una nuova, democratica, legittimazione del potere, non sembrerebbe avere indotto grossi cambiamenti nel modo di rappresentarsi, da parte della teoria politica, il funzionamento dei meccanismi di controllo sociale. La sovranità ha, ancora, il mero obbiettivo di esercitarsi mediante l’imposizione di obblighi o divieti e la pretesa del rispetto degli stessi. 77 Criminologia ed elementi di criminalistica L’obiettivo fondamentale, nel tempo, fu quello di individuare quale, fra le diverse modalità di governo si sarebbe potuta applicare allo stato interamente inteso. Si poteva distinguere: - - - - - il governo di se stessi (cui si ricollega la morale); l’arte di governare una famiglia (cui si ricollega l’economia); la scienza di ben governare lo Stato (cui si ricollega la politica); colui che vuole governare lo Stato deve prima saper governare se stesso, poi, ad un altro livello, la sua famiglia, i suoi beni, il suo patrimonio, e alla fine riuscirà a governare lo stato; viceversa, in uno Stato ben governato, anche i padri di famiglia ed i singoli come tali sapranno governare se stessi ed il piccolo universo sociale che li circonda. Da ciò si comprende come il potere necessiti di diventare potere creativo e non repressivo, coinvolgendo gli uomini nel meccanismo del potere stesso; ciò non equivale a dire che il potere debba essere democraticamente diviso – in forma piramidale – arrivando sino alla base, ma, al contrario, è connaturato da relazioni che, interamente sommate, costituiscono un enorme processo d’interazione, attraverso il quale le nostre società (in maniera più o meno conflittuale, con maggiori o minori resistenze) costruiscono dei significati condivisi in grado di orientarne l’azione sociale. Lo stesso Gramsci sottolineva la necessità di comprendere i meccanismi dei poteri moderni, a partire da una riconsiderazione del concetto di diritto. Più in generale, il concetto stesso di Stato che Gramsci formula è composto da un misto di forza e consenso, coercizione − autorità − e capacità di creare consensi mobilitando le forze sociali − egemonia. Secondo la visione gramsciana, lo Stato, esplica inoltre, un compito educativo che ha sempre il fine di creare nuovi e più alti tipi di civiltà, di adeguare la civiltà e la moralità delle più vaste masse popolari alla necessità del continuo sviluppo dell’apparato economico di produzione, quindi di elaborare anche fisicamente dei nuovi tipi di umanità. 78 CAPITOLO 5 L’imputabilità 5.1 I fondamenti dell’imputabilità La categoria della imputabilità, in quanto fondata sulla capacità dell’uomo di autodeterminarsi, rappresenta lo spartiacque fra soggetti da considerare penalmente responsabili e soggetti nei confronti dei quali un tale giudizio rimane escluso. La dottrina penalistica ritiene, infatti, che esista una stretta connessione fra il problema della libertà del volere ed il problema della responsabilità penale, e la maggioranza di essa sembra essere d’accordo su un punto fondamentale, ossia sull’irrinunciabilità, per il sistema penale, dell’immagine dell’uomo come essere capace di operare delle scelte consapevoli e libere. L’imputabilità penale trova allora il suo primo fondamento nella capacità di autodeterminazione dell’uomo. Tale capacità o libertà di autodeterminazione non va intesa in senso assoluto e incondizionato. Antolisei ha affermato che la volontà umana può definirsi libera nella misura in cui il soggetto non soccomba passivamente agli impulsi psicologici che lo spingono ad agire in un determinato modo, ma riesca ad esercitare poteri di inibizione e controllo idonei a consentirgli scelte consapevoli tra motivi antagonistici. Una tale concezione della libertà è quella che, secondo l’autore, più corrisponde al senso comune e allo stesso diritto penale moderno, che assume la volontà del volere non come un dato ontologico, ma come necessario presupposto della vita pratica, non come un dato scientificamente dimostrabile, ma come contenuto di una aspettativa giuridico-sociale. L’imputabilità costituisce la prima condizione per esprimere la disapprovazione soggettiva del fatto tipico ed antigiuridico commesso dall’agente, e solo riguardo ad un soggetto dotato di capacità di autodeterminazione può parlarsi di riprovevolezza o disapprovazione, in quanto, disapprovazione e rimprovero non avrebbero senso, se rivolti a soggetti del tutto privi della possibilità di agire altrimenti. Il fondamento penalistico della imputabilità è rinvenibile anche sul terreno delle funzioni della pena. Se la minaccia della sanzione punitiva deve esercitare un’efficacia general-preventiva distogliendo i singoli soggetti dal commettere reati, è chiaro che un necessario presupposto di ciò è che i destinatari del precetto giuridico siano psicologicamente in 79 Criminologia ed elementi di criminalistica grado di lasciarsi motivare dalla minaccia stessa. Allo stesso modo, se l’esecuzione in concreto della pena deve tendere alla rieducazione del reo, è necessario che il condannato sia in grado di cogliere il significato del trattamento punitivo. Tale motivabilità normativa non è presente allo stesso modo in tutti gli individui. La categoria della imputabilità trova in ultima analisi il suo fondamento nel principio della libertà dell’uomo. Il contenuto di tale libertà è stato interpretato da diverse concezioni paradigmatiche. Il principio della libertà del volere è un postulato necessario al diritto penale, in particolare per giustificare la pena in senso retributivo, per cui la pena trova la sua giustificazione solo attraverso il riconoscimento della libertà dell’uomo. Senza tale libertà di scelta, nel senso di libertà psicologica del soggetto di agire in un senso piuttosto che in un altro, la nozione di colpevolezza, quale rimproverabilità, diventa priva di significato, poiché non è logicamente possibile rimproverare a qualcuno di aver commesso un dato fatto se era necessitato a farlo. Il giudizio di rimprovero suppone la libertà di agire. La giurisprudenza, ha, in parte, condiviso tali affermazioni, ritenendo moralmente e penalmente imputabile ogni uomo la cui autodeterminazione, risultante dall’intelletto e dalla volontà, non sia impedita o turbata dall’organismo corporeo e psichico dell’agente; per cui, il delitto è penalmente perseguibile ogni qualvolta sia dovuto non a malattia del corpo o della mente, bensì a deviazioni del sentimento e al male dello spirito. Analogo trattamento viene riservato ai soggetti psicopatici, i quali, a parere della Cassazione, sono anormali nel carattere e come tali pienamente imputabili, e ciò in quanto sono in possesso di quelle condizioni psico-biologiche richieste dalla legislazione vigente affinché l’azione del soggetto venga ritenuta come causa eticamente e psicologicamente voluta dal soggetto. Attualmente, il paradigma più osservato, non solo in Italia, è quello che è stato definito di relativo indeterminismo. Questo modello è stato in prevalenza assunto anche dalla giurisprudenza più recente, che ha affermato che la capacità di volere indica l’attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che motivano l’azione. Secondo tale orientamento, ciò che rileva sono i processi psicologici di motivazione alla condotta, indipendentemente da un giudizio di responsabilità eticamente fondata sulla capacità di distinguere il bene dal male. L’imputabilità penale deve essere intesa come attitudine del soggetto a valutare il significato e gli effetti della propria condotta, ad autodeterminarsi nella selezione dei molteplici motivi. È questo l’orientamento suggerito dallo stesso codice Rocco per il quale, perché sussista la imputabilità morale, occorre la facoltà di scelta. In tal senso, il libero arbitrio, inteso quale capacità di discernere, di selezionare i motivi e di inibirsi, acquista un significato più vivo. L’art. 85 c.p. dopo aver sancito che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile, stabilisce che è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. Lo stesso articolo regola la generica capacità di agire nel campo penale, senza riferimento ad un determinato fatto concreto, ossia, nella imputabilità, la volontà è considerata al momento della possibilità, mentre, nella effettiva responsabilità penale, la volontà è considerata nel momento della sua attuazione. 80 L’imputabilità L’imputabilità rappresenta, quindi, la generica capacità di essere soggetto di diritto penale. L’art. 85 c.p. fornisce, infatti, la nozione di personalità di diritto penale, definendo la nozione di persona normale, alla quale la legge penale può essere applicata, mentre la concreta volontà dà luogo alla responsabilità, cioè a quel rapporto per cui la legge mette in conto di un determinato soggetto imputabile le conseguenze della sua azione od omissione. Presupposto della responsabilità giuridica è la possibilità, normativamente prevista, di realizzare l’attività richiesta ossia: tu devi perché puoi. Per individuare la fondamentale differenza che intercorre tra imputabilità e responsabilità, occorre fare perno sul concetto di sanzione: la responsabilità, è, appunto, la sanzione conseguente all’illecito commesso, e la sua funzione è quella di risarcire il danno o di riparare comunque il torto recato ad altri. Si preferisce, infatti, mantenere le norme che definiscono il concetto di imputabilità nel campo autonomo dedicato alle cause che escludono e diminuiscono l’imputabilità stessa, al fine di distinguere l’art. 85 c.p. dall’art. 42 c.p. Quest’ultimo dispone che nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà, ossia, considera la volontà effettiva, concreta del fatto, necessaria affinché l’individuo, genericamente capace, quindi imputabile, possa essere chiamato a rispondere penalmente di un fatto determinato. Risulta chiaro che l’imputabilità sia il presupposto logico e giuridico della responsabilità penale, e che l’espressione capacità di intendere e di volere rappresenti il fondamento, sotto il profilo psicologico, della responsabilità penale. Il principio di colpevolezza è uno dei principi base del nostro sistema penale. Esso rappresenta il terzo elemento costitutivo fondamentale del reato insieme alla antigiuridicità ed alla tipicità. Il suo ruolo centrale risulta confermato dalla sua rilevanza costituzionale, desumibile dall’art. 27 della Costituzione. Infatti, il principio della personalità della responsabilità penale in esso fissato va inteso non solo nel suo significato di divieto di responsabilità per fatto altrui, ma, anche, nel senso di responsabilità per fatto proprio colpevole. Ovvero, il legislatore costituzionale, nell’affermare che la responsabilità penale è personale, ha inteso affermare il principio secondo cui l’applicazione della pena presuppone l’attribuibilità psicologica del singolo fatto di reato alla volontà antidoverosa del soggetto. L’imputazione penale si arresta là dove il soggetto non sia in grado di governare il verificarsi degli eventi: ciò vuol dire che il rimprovero di colpevolezza implica che si presupponga, come esistente, una possibilità di agire altrimenti da parte del soggetto cui il fatto viene attribuito. Perché un soggetto possa essere colpito con la sanzione della pena non basta che abbia commesso con dolo o colpa un fatto lesivo di un interesse protetto (fatto tipico), né che la sua azione risulti non giustificata da alcuna esimente (antigiuridicità), ma è necessario che tutto il comportamento significhi un tumulto contro la forza imperativa della norma. Il momento di disobbedienza si ricollega alla personalità del soggetto, e la colpevolezza, in quanto disobbedienza, sarà sempre diversa, come diversa è la personalità di colui che agisce. Il raggiungimento di una adeguata maturità psichica (imputabilità) è la condizione iniziale perché il soggetto comprenda il significato dannoso della sua azione nel 81 Criminologia ed elementi di criminalistica giudizio di valore (espresso dalla norma) che impone l’inflizione di un castigo. Per cui, la rivolta contro l’ordine giuridico si compie nella specifica dimensione individuale in cui viene sentita l’importanza dei valori tutelati e della pretesa normativa. I fondamenti del diritto penale consentono di giungere ad una conclusione di totale e reciproca indipendenza concettuale. Il giudizio di imputabilità, infatti, riguarda la irrogabilità della pena, mentre la colpevolezza si riassume in due passaggi fondamentali, l’attribuibilità del fatto-reato e la riprovazione che ne deriva, la quale legittima la soggezione a pena. Infatti, fra quelle azioni che, in quanto coscienti e volontarie, sono attribuibili all’agente, potranno essergli imputate solo quelle commesse in uno stato di capacità di intendere e di volere. L’anima originaria della colpevolezza resta, quindi, la paternità del fatto quale responsabilità in senso meccanicistico, restando impregiudicate la punibilità del soggetto sano e maturo, e la non punibilità del soggetto insano e non maturo, e come tale non rimproverabile. Come tale, quindi, la colpevolezza è riportabile a tutte le persone fisiche. Infatti, anche prescindendo dalle ipotesi specifiche indicate agli artt. 222 e 224 c.p., è accertato che meccanismi psichici di rappresentazione e di volizione agiscono, comunque, nella mente del non-imputabile, anche se trattasi di meccanismi abnormi e distorti. Ed il compiuto giudizio di incapacità, presuppone che tali meccanismi siano stati individuati anche in relazione al fatto. La capacità di intendere e di volere Ai sensi dell’art. 85 c.p., perché un soggetto sia imputabile e quindi punibile, occorre che abbia la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che delle tre facoltà psichiche, cioè, sentimento, intelligenza e volontà, che caratterizzano l’azione nel suo lato subiettivo, il codice penale, ai fini della imputabilità, e quindi anche della infermità di mente, prende in considerazione soltanto le ultime due, e non la prima: pertanto, le anomalie del carattere e l’insufficienza di sentimenti etico-sociali non possono essere di per se stesse considerate indicative di infermità di mente, ove ad esse non siano associati disturbi nella sfera intellettiva o volitiva di indubbia natura patologica. La capacità di intendere è stata definita, in dottrina, come la idoneità del soggetto a conoscere, comprendere e discernere i motivi della propria condotta e, quindi, a valutare questa, sia nelle sue relazioni col mondo esterno, nonché nella sua portata e nelle sue conseguenze; in breve, a rendersi conto del valore sociale delle proprie azioni. Ciò non ha nulla a che vedere con la coscienza della illiceità penale del fatto. La capacità di volere è l’attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, con la possibilità di optare per la condotta adatta al motivo che appare più ragionevole e, quindi, di resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni: più brevemente, è la facoltà di volere ciò che si giudica doversi fare. Il concetto di capacità di intendere esprime, dunque, l’attitudine alla comprensione corretta della realtà, la quale, è il risultato di funzioni variabili per quantità e qualità, da individuo a individuo, o anche nella stessa persona, a seconda degli stadi e stati di vita. L’apprezzamento e la graduazione della capacità di intendere implicano una valutazione dell’intelligenza e, quindi, un’analisi dei suoi vari fattori: il grado di comprensione, l’astrazione, l’ideazione, il giudizio, il pensiero logico, la capacità critica, la rappresentazione simbolica, l’associazione di idee, l’immaginazione. 82 L’imputabilità Le cause che escludono e diminuiscono l’imputabilità Nel nostro sistema penale, le cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità appartengono a due specie: a) le alterazioni patologiche, dovute ad infermità di mente o all’azione dell’alcool o a quella di sostanze stupefacenti; b) l’immaturità fisiologica o parafisiologica, dipendenti rispettivamente dalla minore età e dal sordomutismo. In sostanza esse sono rappresentate da: 1) minore età; 2) sordomutismo; 3) vizio di mente; 4) azione dell’alcool; 5) azione degli stupefacenti. L’art. 88 c.p. disciplina il vizio totale di mente, statuendo che non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere. Nel sistema predisposto dal codice, ai fini della esclusione della imputabilità, lo stato di mente, comprensivo sia del vizio transitorio, dovuto per lo più ad infermità fisiche, sia di quello permanente, provocato solitamente da infermità propriamente psichiche, deve dunque derivare da infermità non necessariamente localizzata nella mente e quale che ne sia la gravità, essendo sufficiente che, da un lato, essa abbia generato uno stato di mente tale da escludere o almeno da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere e, dall’altro, che ne sia stata accertata l’esistenza al momento in cui il soggetto ha commesso il reato: senza che sia necessaria la sussistenza di un preciso rapporto eziologico tra la causa del vizio di mente ed il fatto commesso. Il legislatore, all’art. 89 c.p., attribuisce rilevanza anche al vizio parziale di mente, che si ha quando il soggetto, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere; in tal caso, l’agente risponde del fatto commesso, ma la pena è diminuita. Il vizio parziale di mente, non escludendo l’imputabilità, importa soltanto una diminuzione di pena, in aggiunta alla quale si applica, di norma (cioè in caso di soggetto ritenuto pericoloso), la misura di sicurezza dell’assegnazione a una casa di cura e custodia (art. 219 c.p.). Si ha, quindi, il cumulo della pena con la misura di sicurezza, con precedenza nella esecuzione della pena restrittiva della libertà personale, fatta salva la facoltà del giudice di disporre che il ricovero in una casa di cura e custodia venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine l’esecuzione della pena. 5.2 Concetto di infermità Il legislatore del 1930, con il termine infermità, intese limitare la rilevanza dell’incapacità alle sole situazioni patologiche clinicamente accertabili. Senonché, la maggioranza della dottrina è concorde nel ritenere che l’infermità non può più essere circoscritta ai soli quadri nosograficamente definiti, e che essa esprima, quindi, un concetto più ampio di quello di malattia mentale, il cui contenuto va determinato in base alla ratio delle norme sull’imputabilità. Il fatto che la disciplina legale dell’infermo di mente richiami determinate situazioni naturalistiche dà ragione dell’utilità teorica e pratica del ricorso ai sussidi della scienza psichiatrica per la corretta applicazione delle norme e delle categorie giuridiche. 83 Criminologia ed elementi di criminalistica L’utilizzazione di tali contributi in sede giuridica non può tuttavia essere meccanica. Innanzitutto, diverse sono le finalità del diritto penale rispetto a quelle della psichiatria. Nel diritto penale, la ricostruzione di determinate condizioni soggettive è in prevalente funzione dell’assoggettabilità a pena e del tipo di trattamento sanzionatorio che deve applicarsi. In psichiatria, invece, l’accertamento delle medesime condizioni è preminentemente in funzione della terapia. È ovvio, quindi, che le medesime situazioni naturalistiche possano avere rilevanza diversa, a seconda che vengano prese in considerazione nell’ambito giuridico o in quello psichiatrico. Nella prospettiva psichiatrica, tutte le alterazioni mentali classificabili secondo gli schemi della nosografia ufficiale, sono considerate e trattate come malattie mentali. Il giudice penale, sulla base di una valutazione diversamente orientata, potrebbe invece disconoscere a quei disturbi psichici rilevanza giuridica di infermità di mente. È infatti possibile che alterazioni mentali, classificabili come malattie in senso psichiatrico, siano giuridicamente irrilevanti come infermità, per non aver influito sulla capacità di intendere e di volere. Infatti, ai fini del giudizio di non imputabilità, non basta l’accertamento della infermità, ma, occorre che vi sia una connessione tra questa e l’incapacità di intendere e di volere al momento del reato. Nella normativa attuale, l’oggetto del giudizio di imputabilità passa attraverso due fasi: a) accertamento della infermità; b) graduazione del pregiudizio che tale infermità ha provocato sulla capacità di intendere e di volere. La giurisprudenza, ai fini del giudizio di cui agli artt. 88 e 89 c.p., deve, quindi, richiamarsi al concetto di infermità elaborato dalle scienze psicopatologiche. Ma queste scienze sono caratterizzate dalla presenza di differenti paradigmi, ciascuno dei quali definisce in maniera diversa il concetto di malattia mentale. Ciò individua una delle ragioni della situazione di disagio e di incertezza in cui è venuta a trovarsi la giurisprudenza. È possibile, quindi, rintracciare orientamenti giurisprudenziali contrastanti, a seconda del paradigma psicopatologico, di volta in volta, assunto, quale parametro valutativo del disturbo psichico. I tre paradigmi fondamentali di definizione della malattia mentale sono: a) quello medico; b) quello psicologico; c) quello sociologico. Al paradigma medico sono da ricondurre quelle sentenze che negano la qualifica di infermità mentale alle semplici anomalie della personalità, del carattere e del sentimento, in quanto non derivanti da tare patologiche, e ai disturbi del sistema nervoso, in quanto privi di substrato organico. È questo l’indirizzo che, seguendo una interpretazione restrittiva del concetto di infermità, delimita i casi di vizio totale di mente alle sole ipotesi nelle quali il disturbo 84 L’imputabilità psichico trovi riscontro in una deficienza organica. Allo stesso paradigma vanno ascritte quelle decisioni che, pur non facendo riferimento alla causa organica della malattia mentale, affermano la necessità che l’alterazione biologica sia almeno riconducibile alle classificazioni nosografiche elaborate dalla psichiatria. In tale ottica, la giurisprudenza ha ritenuto di escludere dalla nozione di infermità: i difetti del temperamento; i vizi del sentimento, morali o sociali, che non siano conseguenti a una malattia clinicamente accertata e catalogata dalla nosologia psichiatrica. Tuttavia, non tutti i disturbi psichiatricamente catalogati possono essere considerati infermità rilevanti ex art. 88 c.p. Infatti, le nevrosi e le psicopatie non escluderebbero la capacità di intendere e di volere. In tali casi, la ragione della non rilevanza ai fini della incapacità affonda le proprie radici in considerazioni politico-criminali di natura general-preventiva. Seguendo tali criteri, la giurisprudenza ha eletto la psicosi a tipologia esponenziale del vizio di mente, ritenendo che la nozione giuridica di infermità, rilevante per l’esclusione o la diminuzione della capacità di intendere e di volere, è compiutamente integrata nell’ipotesi di accertata malattia di mente in senso medicolegale, con tale espressione facendosi riferimento a quelle alterazioni psichiche che la scienza psichiatrica definisce psicosi e che prendono vita da processi morbosi somatici, siano essi noti, come nelle cosiddette psicosi organiche, ovvero ignoti ma comunque postulati, come nelle cosiddette psicosi endogene (schizofrenia e psicosi maniaco-depressiva), alle prime assimilate in relazione al quadro psicopatologico e alle caratteristiche nosografiche che presentano. Non mancano, tuttavia, sentenze che, pur ancora riconducibili al paradigma medico, ritengono sufficiente, per riconoscere il vizio totale o parziale di mente, l’esistenza di uno stato o processo morboso, indipendentemente dall’accertamento di un suo substrato organico o da una sua classificazione nella nosologia psichiatrica. Tale prospettiva può essere definita psicopatologica, ed in tale ottica, la Cassazione ha precisato: l’infermità mentale rilevante ai fini dell’imputabilità deve sempre dipendere da una causa patologica e, quindi, esulano dalla nozione di essa quelle anomalie caratteriali e altre anomalie del comportamento che, pur influendo sul processo di determinazione o inibizione, non siano conseguenti ad uno stato patologico suscettibile di alterare la capacità di intendere e di volere, intesa quale attitudine del soggetto a valutare il significato, gli effetti della propria condotta e autodeterminarsi nella selezione dei molteplici motivi. Alla prospettiva psicopatologica è riconducibile anche l’orientamento che vede nel criterio del valore di malattia il parametro di riferimento per riconoscere efficacia scusante ai disturbi psichici abnormi, non inquadrabili nelle psicosi e ai limiti della salute mentale. All’orientamento della giurisprudenza fondato sul paradigma medico, si contrappone quello fondato sul paradigma cosiddetto psicologico. In esso, si possono far rientrare quelle sentenze che affermano la necessità di una concreta valutazione del disturbo psichico, e che rifiutano riferimenti e classificazioni scientifiche enunciate in astratto. Si sostiene infatti che, per la sussistenza del vizio di mente, non è sufficiente che il giudice riconduca l’azione dell’imputato sotto un modello di infermità apoditticamente affermato, ma è necessario che lo stesso indichi i dati anamnestici, clinici, comportamentali o sorgenti dalle stesse modalità del fatto, rilevatori dell’asserito quadro morboso. 85 Criminologia ed elementi di criminalistica Il concetto di infermità diventa, così, un concetto di contenuto più ampio rispetto a quello di malattia mentale, e ciò consente di ricomprendere nel concetto di infermità rilevante penalmente anche i disturbi mentali atipici. In alcune sentenze della Suprema Corte si legge: a determinare il vizio parziale di mente possono essere sufficienti anche alterazioni psichiche atipiche, quante volte esse per la loro impotenza si risolvano in fattori perturbativi, in accentuata misura, della capacità di intendere e di volere, in quanto qualunque condizione morbosa, anche se difficilmente caratterizzabile sul piano clinico, può integrare il vizio di mente, sempre che siano presenti connotazioni tali da escludere o diminuire le normali capacità intellettive e volitive. L’affermarsi in psichiatria di un altro paradigma, quello sociologico, non trova, oggi, alcun riscontro nella prassi penalistica in tema di imputabilità. La spiegazione del mancato riconoscimento da parte della giurisprudenza della partecipazione sociale alla genesi della malattia mentale è costituita dal timore di un allargamento incontrollato delle maglie della disciplina relativa alle cause di esclusione della imputabilità, quale deriverebbe dal riconoscimento della qualifica di infermità mentale anche ad un generico disturbo psichico di origine sociale. L’orientamento più recente della psichiatria si caratterizza per il riconoscimento di spazi sempre più ampi di responsabilità del malato mentale, in quanto si ammette che anche di fronte ad una diagnosi di malattia, il paziente possa essere in grado di compiere responsabilmente delle scelte e di autodeterminarsi. Su questa linea si è mossa la legislazione italiana, ad esempio con la legge nº 180 del 1978, con la quale si è prevista, non solo l’eliminazione dei manicomi, ma anche la necessità di ottenere il consenso al trattamento da parte del malato di mente. Ben diversa si presenta la posizione con riferimento al diritto penale, dove parte della giurisprudenza, richiamandosi ancora alle concezioni tipiche del paradigma medico-nosografico, sembra far propria la concezione che vede un’assoluta incompatibilità tra malattia mentale e idoneità ad agire responsabilmente. 5.3 Stati emotivi e passionali Il primum movens dell’agire umano è costituito dalle emozioni e dalle passioni umane. L’essere umano, dotato di ragione, di creatività, e che esercita dominio sulla terra, sugli animali, ed ha perfetta padronanza di se stesso, racchiude due parti, una intellettiva, l’altra animale. Quest’ultima è la meno razionale, ma pur sempre umana, parte animale del nostro essere, dalla quale scaturiscono le emozioni e le passioni, attributi atavici, ancestrali dell’uomo, con i quali, insieme a sentimenti positivi, come l’affettività, l’amore, l’entusiasmo, riaffiora in determinate situazioni; una istintualità che genera gesti, talvolta apparentemente immotivati, ma comunque sempre sproporzionati rispetto alla causa, che, riuscendo a superare la sfera della coscienza, possono indurre alla commissione di delitti. Aristotele, sosteneva l’esistenza di due motori dell’azione umana, la ragione e l’emozione, affermando che se essi possono, nella gran parte dei casi, procedere di pari pas86 L’imputabilità so, divenendo così l’emozione spinta positiva che concretizza l’azione ragionata, altre volte, invece si scindono, potendo l’emozione causare un’azione non voluta o, addirittura, non condivisa dalla ragione. Affermava, pertanto, che un’azione umana nasce da un desiderio emozionale, oppure dalla consapevolezza di ciò che è bene, ma se l’armonia tra desiderio e consapevolezza viene meno, sarà inevitabilmente la passione a prendere il sopravvento. L’istintualità dell’essere umano è rappresentata dalle emozioni che non rientrano nella sfera della ragione; ciò viene confermato anche dal fatto che due diversi soggetti, di fronte a un’identica situazione che sia di una certa valenza affettiva, potranno reagire con modalità completamente diverse, a seconda dell’impianto caratteriale; ciò equivale a dire che l’emozione va studiata nelle sue modalità di integrazione nella struttura della personalità. Ferracuti definisce l’emozione quale intenso turbamento affettivo di breve durata e in genere di inizio improvviso, provocato come reazione a determinati avvenimenti, e che finisce col predominare sulle altre attività psichiche (ira, gioia, paura, spavento, afflizione, sorpresa, vergogna, piacere erotico, ecc). La passione è uno stato affettivo violento e più duraturo, che tende a predominare sull’attività psichica in modo più o meno invadente o esclusivo, sì da comportare, talora, alterazioni della condotta, che può divenire del tutto irrazionale per difetto di controllo. Ad essa sono riconducibili certe forme di amore sessuale, di odio, di gelosia, di cupidigia, di entusiasmo, di ideologizzazione politica. In termini giuridici, l’art. 90 c.p. recita che gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità. Come appare evidente da tale dettato, ai fini dell’imputabilità, le alterazioni dell’affettività sono ritenute irrilevanti, a meno che, non sottendano una comprovata infermità o seminfermità di mente, nel senso che una manifestazione dell’animo, per quanto violenta possa essere, non diminuisce la responsabilità dell’individuo, fino a quando è espressione di una psiche normale, ovvero perfettamente in grado di controllare i propri impulsi, in quanto soltanto la malattia è veramente idonea a conferire la certezza o quanto meno consentire un motivato giudizio di inimputabilità al momento del fatto. Nozione e fondamento dell’imputabilità è l’art. 85 del codice penale, esso costituisce sicuramente uno dei cardini del diritto penale italiano. Nell’articolo in questione, si fa, quindi, riferimento all’uomo nel suo complesso, dotato della facoltà di saper valutare le possibili conseguenze del proprio agire e d’altra parte, di porre la propria volontà quale inizio e causa dell’azione stessa. In altre parole, la capacità di intendere e di volere può essere considerata come capacità di decidersi secondo ragione, libertà di autodeterminarsi razionalmente. Il presupposto dell’imputabilità è, quindi, la libertà che va intesa non come libertà di poter delinquere impunemente, bensì come libertà responsabile, ossia come assunzione di responsabilità rispetto alle proprie azioni liberamente deliberate. Potremmo dire che la responsabilità di ogni singolo uomo, soggetto ed oggetto di diritto, risiede nel comprendere il valore dei propri atti, essendo tale responsabilità effettiva solo in caso di maturità psichica e sanità mentale, consistendo l’imputabilità, in un modo d’essere dell’individuo, uno status della persona, e deve sussistere nel momento in cui il soggetto ha commesso il reato. Ciò impone, pertanto, una discriminazione, intesa in senso psichico, tra soggetti normali ed anormali, ossia consapevoli o inconsapevoli al 87 Criminologia ed elementi di criminalistica momento del reato. L’insorgenza di uno stato emotivo o passionale, in un soggetto autore di reato non inficia l’imputabilità dello stesso, in quanto, in tal caso, manca il presupposto dell’anormalità psichica. Afferma il Beltrani: “dall’infermità di mente, vanno distinti gli stati emotivi (turbamenti improvvisi e passeggeri della psiche del soggetto) e passionali (odio, amore, gelosia, ecc.), che non escludono né diminuiscono l’imputabilità (art. 90 c.p.), ma possono, al più integrare gli estremi delle attenuanti di cui ai commi 2° (l’aver agito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui) e 3° (l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto) dell’art. 62 c.p.”. È opportuno sottolineare che, perché si possa riconoscere la circostanza attenuante di cui al comma 2°, il citato stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, deve essere uno stato d’animo strettamente correlato e direttamente dipendente dal fatto che lo ha causato e deve, soprattutto, possedere il carattere dell’immediatezza; ciò significa che non deve essere confuso con l’odio, la stizza o il risentimento, che subentrano col passare del tempo all’originaria emozione e fanno maturare in un animo divenuto pacato il desiderio della vendetta. Per quanto attiene al comma terzo, la circostanza di avere agito per suggestione di una folla in tumulto va valutata con una particolare analisi; non è però applicabile se si tratti di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e se il colpevole è delinquente abituale o professionale. Discorso a parte merita la gelosia, che si configura come stato emotivo originante dall’amore tradito, realmente o solo fantasticamente, che nella storia della nostra legislatura ha per decenni consentito la riduzione della pena del colpevole sotto il nome di delitto per causa d’onore, in virtù dell’ormai abrogato art. 587 del c.p. che stabiliva: “chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella”. L’art. 90 c.p., ponendosi in evidente contrasto con quanto affermato dall’art. 587 c.p., eliminava la causa d’onore dalle attenuanti previste per il delitto di omicidio, in quanto stati emotivi come l’ira e stati passionali come l’amore, l’odio o la gelosia non diminuiscono l’imputabilità. Questo, però, sempre a patto che si tratti di stati d’animo che rispecchiano un’affettività normale, in quanto altrimenti si sconfina nel vizio di mente. Anche qui è necessario operare una distinzione tra gelosia normale e gelosia patologica ai fini dell’erogazione o meno della pena, anche se spesso, distinguere tra una forma e l’altra si dimostra una mera speculazione, risultando molto arduo stabilire in qual momento dalla gelosia cosidetta normale si travalichi in quella certamente patologica, e quali segni possano rilevare in quest’ultima l’insorgere di elementi di pericolosità. Con l’art. 90 del codice penale, il legislatore, negando ogni qualsivoglia significato di tutto ciò che possa essere attitudine o habitus comportamentale, vuole così affermare l’inconsistenza della sfera affettiva e caratteriale ai fini dell’alterazione della capacità di intendere e di volere e, quindi, della negazione dell’imputabilità. Nasce così l’esigenza di un’indagine psichica del reo, esperita di concerto dal medico-legale e dallo psichiatra, in sede giudiziaria, per appurare se l’azione compiuta possa considerarsi consona rispetto alla personalità dell’autore, oppure rivelatrice di una frattura della stessa, 88 L’imputabilità al fine di poter stabilire se si sia trattato di delitto impulsivo, ma frutto, comunque, di un’attività mentale sana, o, al contrario, di uno stato solo apparentemente emotivo o passionale, ma che, in realtà, configura una vera e propria infermità di mente (es.: uno stato delirante ad impronta paranoica, ossessiva, allucinatoria; condotta emotiva di un demente; acting out di uno schizofrenico). Ciò significa che un reato compiuto nell’ambito di un sovvertimento psichico dovuto a subitanea forte emozione oppure ad intensa passione, ed in quanto tale, da tempo sofferta, non configura gli estremi di cui agli artt. 88 e 89 c.p., in quanto tali stati, di per sé soli considerati, rappresentano condizioni psicologiche e non già psicopatologiche dell’essere umano. Risulta, così, evidente la giustezza di quanto sostenuto dall’art. 90 c.p., in quanto, l’aver agito sotto la spinta dall’impeto delle passioni o in un evidente stato emotivo, non implicando alcuna compromissione della volontà, non può compromettere l’imputabilità e, di conseguenza, la punibilità del reo, sempre, ed è bene ribadirlo ancora una volta, finché non sia configurabile alcun vizio, seppur parziale, di mente. 5.4 Imputabilità e abuso di alcool e stupefacenti Alcolismo ed uso di stupefacenti sono fenomeni che hanno sempre interessato le scienze criminali, sia come fattori pregiudizievoli per la salute individuale e collettiva, sia come fattori criminogeni; difatti, assumendo tali sostanze, viene favorita la genesi di determinate condotte criminali che comportano la squalificazione sociale, l’allontanamento dal lavoro, il depauperamento, il decadimento morale, lo stato di bisogno dovuto alla tossicodipendenza, il craving (aumento). La prevenzione rappresenta una delle azioni di contrasto nella lotta contro tali fenomeni. La prevenzione è finalizzata, da un lato, a colpire le attività che favoriscono le autointossicazioni voluttuarie (produzione, commercio, distribuzione di dette sostanze), dall’altro, a promuovere, in favore degli intossicati, interventi terapeutico-riabilitativi. La repressione, ad esempio, incrimina l’ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 688 c.p.) e la guida in stato di ebbrezza (art. 132 c.s.). Il nuovo codice della strada sanziona anche la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. La norma prevede che in caso di incidente o quando si abbia ragionevole dubbio che il conducente sia sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia Stradale hanno facoltà di procedere, attraverso l’etilometro, a misurare la quantità di alcool presente nel sangue, o ad accompagnarlo presso strutture pubbliche per il prelievo di campioni di liquidi biologici (nel caso di sospetto uso di sostanze stupefacenti). Da un punto di vista medico legale, si dovrebbe concludere che chi commette un reato sotto l’azione dell’alcool o di stupefacenti deve considerarsi inimputabile o semimputabile, se la sua capacità di intendere o di volere è esclusa o grandemente scemata. Tale impostazione non è stata tuttavia recepita dal legislatore del ‘30, il quale, in materia, si è ispirato a criteri di notevole severità, per evidenti ragioni di politica criminale. Ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p., l’intossicazione accidentale, ovvero incolpevole, 89 Criminologia ed elementi di criminalistica da sostanze alcoliche o stupefacenti può escludere o diminuire la capacità di intendere e di volere. L’art. 91 c.p. dispone: “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore. Se l’ubriachezza non era piena, ma era tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, la pena è diminuita”. Perché possa configurarsi tale ipotesi, l’ubriachezza deve essere involontaria nella causa. In questa nozione rientra pertanto l’ubriachezza non intenzionale, ma non quella accidentale, ad esempio quella che dipende da negligenza o imprudenza, poiché, in tal caso, è involontario l’effetto, ma non la causa. Per tale motivo, l’ubriachezza accidentale è da escludersi non solo nel caso in cui il soggetto volle bere eccessivamente, pur senza l’intenzione di ubriacarsi, ma anche quando la contratta ubriachezza dipese da errore colposo dello stesso. Dottrina e giurisprudenza spiegano che l’ubriachezza deriva da caso fortuito o forza maggiore quando è determinata da un fatto imprevedibile o incalcolabile che interferisce di sorpresa nel comportamento del soggetto, in modo da provocare un evento che non si possa, con le ordinarie cautele, evitare (caso fortuito, ad esempio, quando si scambi per un errore scusabile, dell’alcool puro per una bevanda innocua), ovvero da una energia esterna, naturale o umana, inevitabile ed irresistibile, che soggioga la volontà e la resistenza del soggetto (forza maggiore, come nell’ipotesi dell’operaio addetto ad una distilleria che si è ubriacato per aver lavorato in un ambiente saturo di vapori alcolici in seguito ad un guasto dell’impianto, o del soggetto ubriacatosi per coazione o inganno altrui). La circostanza di essere stato ubriacato da altri, senza costringimento o inganno, non è, quindi, sufficiente a rendere accidentale l’ubriachezza. Analoga disciplina è prevista dall’art. 93 c.p. (che espressamente rinvia all’art. 91) per il caso che il fatto sia commesso sotto l’azione, non ascrivibile a colpa dell’agente, di sostanze stupefacenti. L’ubriachezza accidentale piena, cioè quella che toglie la capacità di intendere e di volere, porta al proscioglimento dell’imputato perché non imputabile. Trattandosi di uno stato transitorio, che scompare quando l’azione dell’alcool svanisce, non possono applicarsi le misure di sicurezza destinate ai casi di proscioglimento per cronica intossicazione. È, tuttavia, possibile che lo stato di incapacità sopraggiunga ad un soggetto già affetto da vizio di mente: per cui, se l’agente è affetto da vizio totale di mente, l’intossicazione accidentale nulla toglie e nulla aggiunge ad uno stato mentale già di per sé ricompreso nella sfera di operatività dell’art. 88 c.p.; in tal caso, si applicherà solo quest’ultimo. Se l’agente è invece affetto da vizio parziale di mente, la situazione muta: l’art. 91 sarà applicabile se ubriachezza ed intossicazione da stupefacenti siano piene, cioè produttive di una totale incapacità di intendere e di volere. Se l’intossicazione accidentale scemi grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, il soggetto, fruisce di una diminuzione di pena, poiché, in tal caso, la ingestione di sostanze alcoliche o stupefacenti nulla ha innovato rispetto allo stato mentale nel quale il soggetto già si trovava, così che l’agente potrà fruire di un’unica riduzione di pena, e precisamente quella contemplata dall’art. 89 c.p. cui dovrà ovviamente essere aggiunta la misura di sicurezza, altrimenti inapplicabile alla stregua del90 L’imputabilità l’art. 91 c.p.; salvo ammettere che il giudice possa ugualmente farvi ricorso, qualora dovesse ritenere l’agente pericoloso sulla scorta di un accertamento condotto ai sensi degli artt. 202 e 203 c.p. Non fa scemare, né esclude l’imputabilità, l’ubriachezza volontaria o colposa, ovvero l’ebbrezza contratta con il proposito di ubriacarsi, o colposa, cioè volontaria nella causa anche se involontaria nell’effetto. L’art. 92 primo comma c.p. statuisce che l’ubriachezza non derivata da caso fortuito o forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità; l’art. 93 c.p. estende poi tale disciplina anche al soggetto che agisca sotto l’azione di sostanze stupefacenti volontariamente o colposamente assunte. Tale disciplina si è posta in aperto contrasto con quanto invece era previsto dal codice Zanardelli che, all’art. 48, stabiliva forti diminuzioni di pena per il delitto commesso in stato di ubriachezza volontaria, e una circostanza attenuante per il reato commesso in stato di ubriachezza abituale. Le dispute sorte in dottrina riguardano anzitutto il titolo della responsabilità per il reato commesso. Le soluzioni prospettate sono state varie: dalla responsabilità oggettiva alla responsabilità a titolo di colpa, dalla responsabilità a titolo di dolo o colpa in base all’atteggiamento psichico del soggetto nel momento in cui si è ubriacato, alla responsabilità, sempre a titolo di dolo o colpa, ma sulla base dell’elemento psicologico che ha sorretto il fatto commesso nello stato di ubriachezza. Una parte della dottrina meno recente, riproponendo lo schema dell’actio libera in causa, sosteneva che per accertare l’elemento psicologico del reato commesso dall’ubriaco, occorresse risalire al momento nel quale egli si pone in stato di ebrietà: per cui, se egli si è ubriacato intenzionalmente, risponderà a titolo di dolo; se si è ubriacato per imprudenza o negligenza, risponderà a titolo di colpa. Ad esempio, se Caio partecipando ad una allegra cena con alcuni amici non riesce a controllarsi nel bere e finisce, suo malgrado, col perdere l’autocontrollo, ove provochi più tardi la morte di una persona, risponderà, comunque, di omicidio colposo. Ciò si verifica sia che l’evento letale consegua a un involontario incidente stradale dovuto ad eccesso di velocità, sia che esso derivi da una decisione volontaria influenzata proprio dallo stato di ubriachezza (Caio, in preda all’alcool, non riesce a controllare lo scatto d’ira che lo spinge ad uccidere il commensale che lo prende in giro per scherzo). Per spiegare la ratio essendi della responsabilità nelle suddette ipotesi, si è fatto riferimento alla categoria non dogmatica della actio libera in causa, elaborata dalla teologia morale, per inquadrare le ipotesi in cui, pur mancando la libera volontà nel momento dell’atto esteriore, il peccato sussiste ugualmente, in quanto può essere riportato ad un precedente libero atto del volere. Si è obiettato che, in tal modo, si confonde lo stato psicologico che provoca la condizione di ubriachezza con quello che accompagna e provoca la successiva commissione dello specifico reato. Una tale impostazione, inoltre, rischia di punire come colposi delitti commessi volontariamente (come nell’esempio prima riportato di Caio che uccide il commensale) e, viceversa, di punire come dolosi delitti involontari che seguono ad uno stato di ubriachezza volontaria (ad esempio Caio, ubriacatosi volontariamente, provoca successivamente la morte di un terzo a causa di un incidente automobilistico dovuto ad imprudenza). Antolisei sostiene che una tale teoria non considera che, per la responsabilità dolosa è necessario che il risultato sia voluto, il che non può dirsi per il solo fatto che l’agente si è ubriacato volontariamente. Per questo si ritiene che tale tesi non sia 91 Criminologia ed elementi di criminalistica conciliabile con il diritto positivo. Dottrina e giurisprudenza dominante ritengono che dolo e colpa vadano accertati con riferimento al momento in cui il reato viene commesso. Il giudice, pertanto, dovrà accertare l’elemento soggettivo che, concretamente, ha illuminato il fatto secondo i normali principi dettati dall’art. 43 codice penale; per cui l’intossicazione da sostanze alcoliche o stupefacenti sarà dolosa quando il reo, oltre ad aver voluto la condotta (assunzione delle sostanze alcoliche o stupefacenti), se ne rappresenta le conseguenze (il risultante stato di intossicazione). Essa sarà colposa quando il soggetto ha assunto le sostanze alcoliche o stupefacenti, senza rappresentarsi, pur potendolo, la conseguente intossicazione. Allo scopo di rendere l’art. 92 primo comma più compatibile con i principi costituzionali della responsabilità penale che richiede sia la imputabilità che la colpevolezza, parte della dottrina più recente, muove dal rilievo che la disposizione normativa in esame si limita ad affermare che la ubriachezza lascia sussistere la piena imputabilità, ma non dice che tale imputabilità implichi anche l’automatica colpevolezza per il fatto commesso. Per riportare anche la disciplina di cui all’art. 92 c.p. al principio della responsabilità penale personale occorre fare riferimento al momento in cui il soggetto si ubriaca, affermando che, in caso di ubriachezza piena, l’agente risponde: 1) a titolo di dolo, se si è ubriacato nonostante la previsione della commissione del reato ed accettandone il rischio; 2) a titolo di colpa, se il reato, al momento in cui si ubriacò fu da lui previsto ma non accettato o, comunque, era prevedibile ed evitabile come conseguenza dell’ubriachezza, sempre che si tratti di reato previsto dalla legge anche come colposo. Si è poi discusso se l’art. 92 c.p., primo comma, sia applicabile quando l’agente, che, volontariamente o colposamente, si è posto in stato di ubriachezza o di ebbrezza da stupefacenti, sia già, all’atto di acquisire l’ebrietà, incapace di intendere o di volere per vizio totale di mente o parziale: in entrambi queste ipotesi, sia che si ritenga che l’art. 92 c.p. dia luogo ad una finzione di imputabilità considerandosi pienamente capace un soggetto che naturalisticamente non lo è, sia che in detta norma si ravvisi più semplicemente l’affermazione del principio in base al quale una certa causa di incapacità naturalistica non è rilevante per l’ordinamento penale, le conclusioni non mutano. Nel senso che, presupponendo l’art. 92 in ogni caso un soggetto pienamente capace di intendere e di volere al momento di porsi in stato di ebrietà, ed una volta accertato che il soggetto al momento della commissione del reato era affetto da vizio totale o parziale di mente, si applicheranno rispettivamente gli artt. 88 e 89 c.p., fatta naturalmente salva, al giudice, la facoltà nel determinare, in concreto, la specie e l’entità della sanzione, e di tener conto delle particolari condizioni psichiche dell’agente. Una menzione particolare merita, infine, il secondo comma dell’art. 92 c.p., il quale dispone: “se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata”. Tale disposizione viene richiamata anche per il fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti. Secondo l’orientamento prevalente, il comma in esame sarebbe direttamente collegabile all’art. 87 c.p., il quale recita che “la disposizione della prima parte dell’art. 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità di intendere e di volere al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa”. 92 L’imputabilità L’unica peculiarità dell’art. 92 comma 2, è data dal fatto che, in tal caso, a differenza dell’art. 87 c.p., al reato commesso si applica un aumento di pena. Entrambe le disposizioni sarebbero poi riconducibili, secondo parte della dottrina, alla categoria dell’actio libera in causa. Fiandaca e Musco sostengono che secondo tale principio l’incapacità preordinata deroga alla regola della coincidenza temporale tra imputabilità e commissione del fatto criminoso, senza disattendere il principio di colpevolezza. Infatti, nell’ipotesi prevista al primo comma dell’art. 92 c.p., il soggetto, in un primo momento, si ubriaca (per il piacere di farlo o per causa involontaria), e, successivamente, commette il reato (non programmato in anticipo al momento di porsi in stato di ubriachezza). Nel caso dell’ubriachezza preordinata, il soggetto si ubriaca allo scopo di commettere un reato: ciò, perché, lo stato di ubriachezza, esercitando un’azione disinibente sul soggetto, facilita la commissione del proposito criminoso. Con la locuzione al fine di prepararsi una scusa, il legislatore fà riferimento non al semplice porsi in stato di incapacità, ma alla prospettazione di uno stato di incapacità tale da escludere il ricorso alla sanzione. Continuando l’esame delle disposizioni normative, l’art. 94 primo comma c.p. dispone: “se il reato è commesso in stato di ubriachezza (non accidentale) e questa è abituale, la pena è aumentata”. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcoliche e in stato di frequente ubriachezza. Il secondo comma dell’articolo prosegue: “l’aggravamento di pena previsto nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze”. Ai fini dell’aggravamento di pena occorre quindi: a) uno stato di intossicazione alcolica (o da sostanze stupefacenti) acuta volontaria o colposa; b) la commissione in tali condizioni di un reato; c) l’abitualità. Perché possa configurarsi la figura giuridica dell’abitualità, devono concorrere due requisiti: la dedizione all’uso di alcolici e il frequente stato di ubriachezza. La dedizione all’uso indica un vizio continuativo, una consuetudine viziosa di vita. I singoli episodi di intossicazione, infatti, devono essere tali da dar luogo a ubriachezza, e inoltre, devono essere frequenti, e cioè, tali da confermare la dedizione all’uso (e non la semplice proclività). In sostanza, occorre che lo stato di ebbrezza nel quale viene commesso il reato costituisca un episodio del sistema di vita dell’individuo. Fatti saltuari, o anche periodici di ubriachezza, non bastano a stabilire in concreto l’ubriachezza abituale. Per accertare l’abitualità non è necessario che la prova di essa risulti da precedenti condanne per reati commessi in stato di ubriachezza, o per il reato di manifesta ubriachezza ex art. 688 c.p. È noto che si può essere dediti abitualmente all’ubriachezza, anche senza aver mai subito tali condanne. L’ubriachezza abituale non esclude che quella crisi alcolica acuta che si riconnette al reato attuale sia stata procurata per facilitare il reato o per procurarsi una scusa. In tal caso, l’aggravante per l’ubriachezza abituale concorrerà con l’aggravante per l’ubriachezza preordinata (art. 92 c.p.). L’art. 94 c.p. non specifica quale aggravamento importi l’ubriachezza abituale. In tal caso si applica l’art. 64 c.p., il quale dispone che quando ricorre una circostanza 93 Criminologia ed elementi di criminalistica aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino ad un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Tali regole valgono anche per l’ebbrezza da stupefacenti. Si tenga conto però che ai sensi dell’ultimo comma dell’art 94 c.p., perché si abbia abitualità non è richiesto il frequente stato di ebbrezza da stupefacenti, ma è sufficiente che il soggetto sia dedito all’uso di stupefacenti. Vincenzo Manzini sostiene che nel concetto di dedito all’uso è insito quello dello stato frequente di alterazione psichica (richiesto esplicitamente per l’ubriachezza abituale), perché non si può essere dediti all’uso delle dette sostanze senza subirne frequentemente l’azione intossicatrice acuta. La specificazione contenuta nel codice si spiega proprio perché si può essere benissimo dediti all’uso di bevande alcoliche senza entrare mai, o entrando raramente in stato di ubriachezza. L’ubriachezza abituale, con conseguente aggravamento di pena, come ipotesi autonoma contrapposta alla intossicazione cronica da alcool (o da sostanze stupefacenti) è stata criticata fin dalla sua introduzione. Valga ad esempio di ciò quanto scrive Mantovani secondo il quale l’ipotesi autonoma di ubriachezza abituale è ritenuta discutibile in teoria e di non facile accertamento pratico, poiché mal si concepisce un ubriaco abituale che non versi in situazione patologica di intossicazione perdurante e, inoltre, perché negli etilisti abituali si ha un graduale cedimento dei freni inibitori con una sempre minore capacità di resistenza al bisogno cogente di alcool. La labilità della distinzione sarebbe inoltre dimostrata dal fatto che il codice, con evidente contraddizione, prevede all’art. 221 c.p., la casa di cura e custodia anche per gli abituali. Tuttavia, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, si ritiene che tale distinzione sia fondata. È la stessa giurisprudenza a sostenere che l’ubriachezza, anche se abituale, è sempre una intossicazione acuta, uno stato transeunte che dà luogo ad una manifestazione episodica di perturbamento delle facoltà psichiche, ma che una volta cessata, lascia il soggetto in condizioni normali. Viceversa, l’alcolismo cronico (al pari della stupefazione cronica) è un’intossicazione stabile, un’affezione cerebrale che ingenera vere e proprie psicopatie che permangono anche indipendentemente dal rinnovarsi delle crisi alcoliche. Ai sensi dell’art. 95 c.p., per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89 del codice penale. Tali disposizioni sono quelle relative al vizio totale e parziale di mente. Rinviando a quanto già detto in tema di vizio di mente, è chiaro che l’intossicazione cronica deve aver ingenerato uno stato di mente tale da escludere la capacità di intendere o di volere, o da grandemente scemarla; in tal caso, l’intossicato, non è punibile o è punibile con pena ridotta, e sottostà alle misure di sicurezza previste per i suddetti vizi di mente (artt. 219, 222 c.p.). La definizione della situazione descritta nell’art. 95 c.p. come cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti è, tuttora, oggetto di controversia. Dalla relazione del ministro Rocco al codice penale risulta che il legislatore del 1930 aveva ben presente l’incertezza di confini riscontrabile tra intossicazione cronica e dedizione all’uso di stupefacenti che, dal punto di vista del sistema sanzionatorio, veniva equiparata alla figura dell’ebbrezza abituale. Ma credette di poter cogliere la distinzione nel carattere pur sempre acuto, anche se abitualmente ripetentesi, dell’ebbrezza abituale, e nel carattere cronico della situazione di cui all’art. 95, sino al punto di descrivere la croni94 L’imputabilità ca intossicazione come un processo patologico permanente, un’affezione cerebrale, tale da produrre un progrediente e caratteristico abbrutimento del carattere e da dare origine a vere e proprie psicopatie. Talvolta, la Cassazione ha aggiunto il requisito della irreversibilità o ineliminabilità, cioè dell’impossibilità di guarigione. In una sentenza della Suprema Corte è possibile leggere: “l’intossicazione che, a norma dell’art. 95 c.p. in relazione agli artt. 88 e 89 dello stesso codice, influisce sulla capacità di intendere e di volere è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per la impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia psichica”. Invece, l’intossicazione temporanea, pur se altera la capacità di intendere e di volere, non influisce, tranne che derivi da caso fortuito o forza maggiore, sull’imputabilità, e non è giuridicamente rilevante, anche se si innesti in uno stato patologico preesistente che di per sé diminuisca, senza escluderla, la capacità intellettiva e volitiva del soggetto. In un’altra sentenza della Corte di Cassazione si è negato che a sostegno del comportamento criminoso del tossicodipendente possa ricorrere la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., dato l’istinto irrefrenabile che, in modo compulsivo, spinge il soggetto ad una continua ricerca della sostanza. Il fenomeno della compulsione, che caratterizza lo stato di tossicodipendenza, non può essere indice dell’esistenza del vizio di mente, in quanto, l’art. 54 c.p. presuppone che lo stato di necessità non sia stato volontariamente determinato dall’agente, mentre l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche con conseguente bisogno di assumerne in quantità sempre maggiori, è imputabile allo stesso soggetto. Circa la configurabilità dello stato di necessità nel comportamento del tossicodipendente in crisi di astinenza esiste una pronuncia per la quale l’applicabilità di tale scriminante al tossicodipendente autore di reato non è esclusa dalla considerazione che trattasi di comportamento volontariamente assunto, in quanto, ciò che rileva, è la sindrome di astinenza che può essere conseguenza o di apprezzabili tentativi di disintossicazione o delle difficoltà, non volontariamente causate, di reperire la droga. In tal senso, è degna di particolare menzione una sentenza del 1983 in materia di eroinomania, dove testualmente si legge: “l’eroina esercita una devastante azione distruttrice sui sentimenti e sulla volontà di chi ne abusa, sì da distogliere, deviare ed alterare i primi, subordinati all’esclusivo interesse di comunque assicurarsi la droga, e da esaltare il dinamismo della volontà nella prevalente direzione di quell’interesse da incondizionatamente soddisfare, determinando, sotto il profilo giuridico, una condizione di inferiorità psichica. Il precario apparente ed innaturale equilibrio scandito dalle periodiche assunzioni di droga, il ritmo delle quali è proporzionale al grado di assuefazione, si labializza, col fatale esaurirsi degli effetti della dose di sostegno, sino a risolversi nella cosiddetta crisi di astinenza, che è condizione propriamente patologica, configurante un autentico vizio di mente. Altra questione controversa è la parificazione attuata dalla disciplina codicistica dell’azione dell’alcool a quella degli stupefacenti, la quale risponde, secondo molti, a una visione non corretta o incompleta dei due fenomeni e delle loro differenze. L’equiparazione tra l’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti nasce, dunque, non tanto da 95 Criminologia ed elementi di criminalistica valutazioni biologiche e tossicologiche, quanto da un giudizio di valore che accomuna le due situazioni, nel senso che il ricorso all’alcool o agli stupefacenti, ed il loro abuso, rispondano sempre e comunque ad una scelta ovvero, secondo la cultura, corrente all’epoca in cui fu approvato il codice, ad un vizio In realtà, alcolismo e dipendenza da stupefacenti si presentano quali fenomeni differenziati, non solo sul piano delle motivazioni, ma anche e soprattutto, su quello degli effetti e delle conseguenze dell’intossicazione. Inoltre, mentre per l’alcolismo le conoscenze cliniche e biologiche consentono di discriminare sul piano diagnostico l’intossicazione cronica dagli altri gradi di intossicazione, ciò non può dirsi per le intossicazioni da sostanze stupefacenti. In particolare, manca in queste ultime, una patologia somatica o neurologica specifica e soprattutto, va sottolineata la diversità delle risposte individuali alle sostanze stupefacenti, in relazione a caratteristiche e disturbi di personalità, a modalità, a momento psichico e di assunzione. In merito alla assunzione protratta, la sintomatologia clinica è poco significativa, fatta eccezione per la crisi di astinenza, la cui tipologia varia in rapporto a fattori individuali, oltre che in rapporto ai diversi tipi di sostanza. Lo stesso parametro delle sindromi di astinenza è aleatorio e risulta scarsamente utilizzabile in psichiatria forense, dato che la valutazione medico-legale si svolge a distanza di tempo dal momento della commissione del fatto in stato di supposta intossicazione cronica. Solo in rapporto alla intossicazione da alcool è possibile configurare una patologia di rilievo somatico, neurologico e psichiatrico che abbia caratteristiche di permanenza e che sia costantemente osservabile oltre la cessazione dell’abuso, dando luogo a parametri di rilievo nosografico. Lo stesso non può dirsi per l’intossicazione da sostanze stupefacenti, la cui disciplina penalistica non trova validi supporti sul piano biologico. 5.5 Imputabilità dei minorenni Partendo dall’assunto che il minore non ha ancora raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da poter comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni, tale da distinguere ciò che è giusto da ciò che è ingiusto, anche il nostro codice considera la minore età tra le cause di esclusione dell’imputabilità. Ma qual è il limite di età a partire dal quale si può ritenere il soggetto capace di intendere e di volere? Se ci limitassimo semplicemente a seguire l’orientamento proprio delle scienze psicologiche, dato che l’età della maturazione psichica non è uguale per tutti, ma varia da persona a persona, si procederebbe ad un accertamento caso per caso. Ci sono però esigenze giuridiche di certezza, uguaglianza e praticità dell’accertamento che impongono l’adozione di un criterio cronologico, il quale, sulla base dei dati offerti dall’esperienza, deve essere altamente presuntivo della raggiunta maturità. Una prima acquisizione fatta riguarda la non necessaria coincidenza tra la maturità fisica e quella psichica. Se infatti abbiamo assistito ad un’anticipazione di 2-3 anni dello sviluppo puberale e intellettuale, questa, non è stata accompagnata da una maturazione affettiva, per cui l’età evolutiva si protrae nel periodo post-adolescenziale, con96 L’imputabilità cludendosi con la raggiunta maturità tra i 18 e i 25 anni, a seconda della costituzione, della razza, della religione, e così via. Per quanto riguarda la situazione italiana preunitaria, il codice penale sardo del ‘59 considerava imputabili i quattordicenni e prevedeva, nei confronti dei minori di tale età, un accertamento individuale per verificarne in concreto la capacità o meno di discernimento; i codici parmense ed estense, invece, fissavano il limite della minore età a dieci anni. Il Codice Zanardelli, come abbiamo detto, considerava non imputabili i minori di nove anni e poi prevedeva delle fasce di età (9-14, 14-18, 18-21) per le quali l’imputabilità era o subordinata alla prova del discernimento o diminuita. Già molte legislazioni straniere della prima metà del ‘900 avevano elevato la soglia dell’imputabilità all’età di 13, 14 o 15 anni. Ma altre, ancora più di recente, hanno elevato ulteriormente l’inizio dell’imputabilità, facendola cominciare a 16 anni, come per il codice russo del 1960, a 17 anni, come prevede il codice polacco del 1970, oppure, addirittura, a 18 anni, secondo il codice brasiliano. Accanto a questi esempi, possiamo trovare un’eccezione, rappresentata dal codice di San Marino del 1975 che, in considerazione della precocità dei giovani d’oggi, ha abbassato all’età di dodici anni l’imputabilità assoluta. Il Codice Rocco ha innanzitutto elevato, rispetto al suo predecessore, il limite della non imputabilità assoluta a 14 anni, elevamento giustificato dalla necessità di fondare l’imputabilità sulla certezza che l’agente abbia la capacità di intendere e di volere, e tale certezza, secondo i più recenti studi, devesi senz’altro escludere fino agli anni quattordici per tutti i minori. In secondo luogo, ha fissato il termine della minore età e l’inizio della piena imputabilità a diciotto anni compiuti. La maggiore età penale corrisponde quindi, oggi, a quella stabilita per la completa maturità dal diritto pubblico e dal diritto privato, evitando così il divario presente, invece, sotto il Codice Zanardelli, che fissava la maggiore età, ai fini non penali, a 21 anni. Infine, i minorenni sono divisi in due categorie: i minori di quattordici anni e i minori fra i quattordici e i diciotto anni. Mentre i primi sono considerati assolutamente incapaci di intendere e di volere, i secondi sono soggetti ad un accertamento della loro imputabilità o non imputabilità da parte del giudice. L’imputabilità del minore risulta quindi subordinata ad un criterio cronologico: - fino a quattordici anni il minore non è mai imputabile, perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità, senza cioè prova contraria. L’art. 97 stabilisce, infatti, che non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni; - fra i quattordici e i diciotto anni il minore è imputabile solo se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere. L’art. 98 rinuncia, infatti, a qualsiasi presunzione e subordina l’eventuale affermazione della responsabilità penale al concreto accertamento della capacità naturale: è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere. L’art. 97 pone una presunzione assoluta di non imputabilità che prescinde dall’effettivo riscontro della capacità di intendere e di volere e che quindi non può essere 97 Criminologia ed elementi di criminalistica superata neanche se il minore infraquattordicenne si presenta, di fatto, perfettamente capace. Siamo di fronte ad una presunzione iuris et de iure di incapacità, in quanto il giudice, quando abbia costatato la minore età dell’imputato, non può sostituire alla volontà del legislatore un proprio convincimento positivo in merito alla presenza dell’imputabilità. Si potrebbe dire che questa è l’unica causa di esclusione dell’imputabilità apparentemente costruita, non in relazione al concetto di capacità di intendere e di volere, bensì sulla base di un dato puramente formale quale l’età anagrafica. Però è evidente che il legislatore ha escluso l’imputabilità del minore di quattordici anni proprio perché, sulla base dell’id quod plerumque accidit, è ragionevole pensare che questi, in ragione della sua giovanissima età, sia sfornito di detta capacità. Bettiol sostiene che tale limite di età è piuttosto elevato, esso è però in linea con le risultanze della dottrina italiana e straniera. Qui, in realtà, si considera esclusa, non tanto la capacità di intendere, che solitamente viene acquisita molto prima di compiere quattordici anni, quanto piuttosto quella di volere, dalla quale, infatti, si fa dipendere la formazione del carattere e della personalità. E, dal momento che la personalità del minore di quattordici anni è ancora in fieri, si cerca di non impedirne il regolare sviluppo prevedendo, appunto, la non applicazione della sanzione penale. Senza dubbio, può capitare che, in certi casi, la presunzione di non imputabilità prevista dall’art. 97 risulti gravosa, perché in contrasto con la realtà naturalistica, ma, giuridicamente, non vi è nulla da fare: tanto più è elevato il limite di età al quale si vuole riferire l’incapacità, tanto più gravosa è la presunzione. La presunzione di non colpevolezza dell’art. 97 è insuperabile nei confronti di chi non abbia ancora quattordici anni, quindi, non possono essere adottate nei suoi confronti misure penali che implichino un addebito di responsabilità; se, per ipotesi, ciò accadesse e venisse pronunciata una condanna a carico del minore, la sentenza dovrebbe considerarsi inesistente, e tale inesistenza, secondo la giurisprudenza prevalente, può essere rilevata anche dal giudice dell’esecuzione. Diverso è il caso in cui la condanna sia stata emessa non per omessa considerazione dell’età inferiore ai quattordici anni dell’autore del reato, ma sulla base di un erronea indicazione della data di nascita. In questo caso, bisogna distinguere due ipotesi: se si è trattato di un errore materiale di indicazione negli atti processuali, ma il procedimento si è comunque svolto nella consapevolezza del fatto che si trattava di un infraquattordicenne, è lo stesso giudice che emette la sentenza a procedere alla correzione dell’errore; se, invece, il rinvenimento dell’atto di nascita è successivo o successiva è la scoperta della falsità dell’atto stesso, la soluzione più corretta sembrerebbe quella della revisione del processo, dal momento che occorre una nuova valutazione degli atti alla luce delle nuove circostanze. Ai sensi dell’art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988, il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, quando accerta che l’imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche d’ufficio, sentenza di non luogo a procedere, trattandosi di persona non imputabile. Nonostante la sua apparente chiarezza, l’art. 26 ha sollevato alcuni dubbi. In particolare il problema è se questa norma imponga sempre e comunque, laddove il fatto sia addebitato al minore infraquattordicenne, di dichiarare la non imputabilità mediante sentenza, o se si possa utilizzare anche il decreto di archiviazione, il quale, tra l’altro, evita l’iscrizione nel casellario giudiziale. 98 L’imputabilità Se, infatti, la individuazione della natura del provvedimento (sentenza) non dà adito ad incertezze quando a provvedere è il giudice dell’udienza preliminare o del dibattimento, il problema nasce quando il Pubblico Ministero si sia accorto, nel corso delle indagini, della non imputabilità dell’indagato e abbia richiesto al giudice per le indagini preliminari, organo monocratico, espressa declaratoria di non imputabilità. Mentre la giurisprudenza, infatti, sembra prevalentemente orientata verso un’applicazione letterale della norma e quindi, conseguentemente, verso l’adozione di sentenze di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, indipendentemente dallo stato e grado del procedimento, la dottrina, invece, pare orientata in senso opposto: il giudice per le indagini preliminari, in presenza di un minore di quattordici anni, anche se il Pubblico Ministero erroneamente richiede sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità, dovrebbe adottare decreto di archiviazione per infondatezza dell’accusa, potendo emettere sentenza di non luogo a procedere solo nei casi in cui la declaratoria di non imputabilità sia successiva all’effettivo esercizio dell’azione penale. Affinché venga pronunciato il proscioglimento per inimputabilità dell’agente, occorre, peraltro, che il fatto realizzato sia conforme al tipo legale e dunque, benché non colpevole, comunque antigiuridico. Tutto questo, non vuol dire che il minore di quattordici anni, prosciolto per difetto di imputabilità, debba incondizionatamente essere lasciato libero, anche se è pericoloso: al minore non imputabile che viene contestualmente riconosciuto pericoloso può essere applicata, infatti, una misura di sicurezza. Perché possa essere stabilita una tale misura occorre, però, che la pericolosità sociale del minore sia stata concretamente accertata. Le presunzioni di pericolosità sociale sono state infatti abolite, dapprima in sede di giurisprudenza costituzionale, poi, anche, in sede legislativa con la legge n. 663 del 10 ottobre 1986. Per quanto riguarda la nozione stessa di pericolosità del minore, bisogna fare riferimento all’art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 448/1988, che stabilisce requisiti più specifici rispetto a quelli che integrano la nozione comune di pericolosità sociale ricavabile dall’art. 203 del codice penale. Gli infraquattordicenni Per quanto concerne, invece, il minore che ha più di quattordici anni, ma non ha ancora compiuto diciotto anni, il codice prevede che questi è imputabile solo se, al momento in cui ha commesso il fatto, aveva la capacità di intendere e di volere. Qual è il significato di tale asserzione? Vuol dire che nei suoi confronti non opera nessuna presunzione, né di incapacità né di capacità, dovendo il giudice accertare, volta per volta, se il soggetto era imputabile o meno. Il non aver previsto una presunzione di imputabilità, ma l’aver previsto l’accertamento caso per caso dell’effettiva acquisizione della capacità di intendere e di volere, è una specifica scelta del nostro legislatore. Alla base di questa scelta, vi è la consapevolezza che fra i quattordici e i diciotto anni vi può essere la capacità di intendere e di volere necessaria per essere considerati penalmente responsabili delle proprie azioni, come vi può non essere - indipendentemente da patologie giuridicamente rilevanti - dato che si tratta di una fascia di età in cui i soggetti raggiungono la maturità richiesta ai fini penali in momenti diversi, a causa delle multiformi varietà ambientali in cui si svolge tale processo di maturazione. 99 Criminologia ed elementi di criminalistica La capacità di intendere e di volere del minore fra i quattordici e i diciotto anni viene solitamente individuata nel concetto di maturità: quest’ultima viene intesa quale armonico sviluppo della personalità, sviluppo intellettivo adeguato all’età, capacità di valutare adeguatamente i motivi degli stimoli a delinquere, comprensione del valore morale della propria condotta, capacità di soppesare le conseguenze dannose del proprio operato per sé e per gli altri, forza del carattere, comprensione dell’importanza di certi valori etici, dominio acquisito su se stessi, attitudine a distinguere il bene dal male, l’onesto dal disonesto, il lecito dall’illecito, unità funzionale delle facoltà psichiche, loro normale sviluppo rispetto all’età, capacità di elaborare i comportamenti umani a livello della coscienza, capacità di percepire criticamente il contenuto etico di un atto e di correlarlo al contesto dei rapporti e interessi socialmente protetti, capacità di volere i propri atti come risultato di una scelta consapevole, attitudine a far entrare nel proprio patrimonio di cognizioni e di esperienze il concetto della violazione, assimilazione delle regole morali e sociali in base ad un’autentica convinzione e non per un processo di imitazione formale, e così via. Assolutamente funzionale risulta la distinzione tra concetto di maturità e vizio di mente: il minore può essere immaturo ma perfettamente sano di mente. Fino a non molto tempo fa, l’unico parametro che veniva accettato per valutare la capacità di intendere e di volere era quello medico: la facoltà intellettiva viene distinta da quella volitiva, ed entrambe, vengono esaminate per valutare una loro possibile compromissione a causa di una malattia di ordine fisiologico o psichiatrico, arrivando così ad avere un quadro clinico del soggetto. Questi orientamenti restrittivi hanno tentato, cioè, di ancorare il giudizio di immaturità a criteri biologici ed organici, come le carenze o i ritardi dello sviluppo intellettivo, l’immaturità psicomotoria ed altri, per cui il ragazzo è incapace se, dalla perizia psichiatrica e da esami clinici diversi, come l’elettroencefalogramma, risulta essere mitomane isterico, epilettoide, cerebropatico, paranoide, schizoide, e così via, con attenzione, quindi, esclusivamente alle sue condizioni mentali, senza alcuna considerazione per la sua storia e per le modalità del suo reato. Un paradigma di questo tipo offre indiscutibilmente il vantaggio che la scienza medica e psichiatrica possono accertare eventuali alterazioni della funzione conoscitiva e intellettiva del soggetto con una certa sicurezza. Ma l’art. 98 c.p. fa riferimento alla situazione di un ragazzo clinicamente normale perché una deficienza clinica della personalità rientra nella diversa ipotesi di vizio di mente. E sulla base di questa considerazione, col tempo, sono stati sempre più utilizzati i contributi della psicologia dell’età evolutiva e le dinamiche adolescenziali. Il ricorso a paradigmi psicologici ha permesso di prendere in considerazione situazioni più sfumate, caratteristiche peculiari dell’individuo in via di sviluppo, come l’immaturità emotiva, le caratteropatie, le insufficienze o conflittualità di origine affettiva, che portano ad una devianza legata all’età particolare del soggetto e comune a chi si trova nelle stesse condizioni. L’utilizzo di questi nuovi parametri permette, in questo modo, di escludere l’imputabilità del ragazzo colpevole della cosiddetta ragazzata, come può essere il furto di merce. La realtà più recente ha mostrato, però, l’insufficienza anche del paradigma psicologico a coprire tutte le ipotesi in cui un adolescente non può considerarsi imputabile. Ci sono infatti delle situazioni in cui il ragazzo, benché non sia rilevabile il mi100 L’imputabilità nimo danno organico né alcuna disfunzionalità della personalità, non ha raggiunto quel grado di coscienza morale che lo possa far ritenere imputabile. È il caso del ragazzo cresciuto in un ambiente difficile, per esempio a causa di una situazione familiare gravemente disgregata o di una precoce istituzionalizzazione. Si è affermato, così, l’uso di paradigmi sociologici in grado di estendere la ricerca delle cause della devianza anche alle strutture socio-ambientali in cui il minore è cresciuto e la sua personalità si è sviluppata. 5.6 La recidiva La recidiva, consistendo nella “ricaduta” nel reato, si presenta come un istituto dogmaticamente complesso e non esente da contraddizioni. La recidiva è disciplinata dall’art. 99 c.p., in forza del quale (1° co.) può essere considerato recidivo chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro. Presupposto per la dichiarazione di recidiva è, pertanto, una sentenza di condanna (art. 533 c.p.), ovvero un decreto penale (art. 459 ss c.p.), divenuti irrevocabili ex art. 468 c.p. Il 1° co. dell’art. 99 c.p. prevede la recidiva cosiddetta semplice: chi, dopo essere stato condannato per un reato ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento sino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato. Il capoverso della stessa disposizione dispone che la pena può essere aumentata fino ad un terzo nelle seguenti ipotesi di recidiva aggravata: 1) se il nuovo reato è della stessa indole (recidiva specifica); 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente (recidiva infraquinquennale); 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena (recidiva vera), ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena (recidiva finta). Le tre ipotesi sono previste separatamente, nel senso che basta una sola di esse per dar vita al previsto aumento di pena. Se, invece, esse concorrono tra di loro (recidiva plurima), il 3° co. dell’art. 99, dispone che l’aumento della pena può elevarsi sino alla metà. L’ultima ipotesi è quella del 4° co. dell’art. 99: la recidiva reiterata, che si verifica allorquando, il nuovo reato è commesso dal già recidivo. Infine, l’ultimo comma dell’art. 99, dispone che, in nessun caso, l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato. Devono, inoltre, definirsi reati della stessa indole (per ciò che attiene la recidiva specifica), non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se preveduti da disposizioni diverse del codice penale ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concerti, caratteri fondamentali comuni. Parlando di recidiva in termini sociologici e giuridici, la precedente sentenza di condanna acquista rilievo, perché il soggetto, nonostante l’esperienza del processo, nonostante il monito a non violare più la legge, nonostante la finalità rieducativa connes101 Criminologia ed elementi di criminalistica sa all’esecuzione della pena, ha violato nuovamente la legge, dimostrando insensibilità etica sia verso l’ordinamento giuridico, che nei confronti del giudice e della società. La concretizzazione di tale ulteriore violazione si riscontra in un rimprovero maggiore che viene mosso nei confronti del recidivo, e che viene ad influire sulla gravità del reato commesso, con il conseguente aumento di pena. Se la condanna e la fase successiva dell’esecuzione avrebbero dovuto offrirgli stimoli a non delinquere, è pur sempre necessario verificare, per la recidiva, ad esempio, se il reato può essere scaturito da altre contingenze o motivazioni, o, ancora, se siano state offerte opportunità di reinserimento sociale: in tale dimensione, la figura del Giudice e la relativa discrezionalità, giocano un ruolo fondamentale nel capire il contesto degli altri elementi e l’eventuale legame successivo fra la sentenza di condanna ed il nuovo reato. Si presentano, pertanto tre possibilità: a) non ritenere la recidiva; b) ritenerla ed irrogare il conseguente aumento di pena; c) ritenerla, ma, a seguito del giudizio di bilanciamento risoltosi nel senso dell’equivalenza, non operare alcun mutamento di pena. 102 CAPITOLO 6 Forme di criminalità 6.1 Le sottoculture criminali La definizione di sottocultura criminale è strettamente connessa al sistema di regole e simboli che caratterizza il punto di vista di un gruppo che appartiene a una certa società, ma che contrasta con ciò che la cultura generale considera legale. La sottocultura criminale, come tutte le sottoculture più articolate, ha proprie tradizioni, proprio linguaggio, propri costumi, regole, codici morali, usanze, rituali: l’aspetto che la qualifica è però quello di considerare lecite e non squalificanti certe condotte antigiuridiche che gli altri gruppi sociali reputano, invece, come illegittime, anche se la sottocultura può poi condividere con la cultura generale altri sistemi normativi (ad esempio i valori familiari, l’amicizia, ecc.). In sostanza, quindi, una sottocultura non può essere totalmente diversa dalla cultura di cui fa parte (Ponti, 1990). La psico-sociologia americana ha dato un contributo fondamentale alla teoria delle sottoculture criminali, in modo particolare A. K. Cohen (1955) che ha utilizzato un modello simile per spiegare la formazione delle bande criminali giovanili. Secondo Cohen, la nascita di fenomeni sociali come le bande è strettamente connessa con le ineguaglianze sociali caratterizzanti la vita di alcuni giovani, appartenenti a classi sociali meno agiate e poste in posizioni più difficili nella ricerca dei mezzi per raggiungere efficacemente mete sociali desiderate. La stimolo alla criminalità, nei giovani appartenenti a classi sociali basse, è dovuta fondamentalmente al conflitto con la classe media, che custodisce i valori dominanti e dai quali si sentono esclusi ed estraniati. Da un punto di vista strettamente sociale, la loro carriera scolastica è più difficile, sono forzatamente spinti a frequentare scuole pubbliche che non forniscono i mezzi idonei per accedere a livelli di formazione culturali idonei, e a prepararli, pertanto, a quella competizione per tentare di risalire la gerarchia sociale. Tali giovani, inoltre, sono tendenzialmente più esposti agli insuccessi, alle frustrazioni, alle umiliazioni. Di fronte al modello accreditato di adattamento sociale, tipico della classe media, si trovano del tutto sprovveduti e segnati nel loro destino. Il sentirsi 103 Criminologia ed elementi di criminalistica esclusi dalle regole sociali, li spinge a trovare il modo di condividere la loro dissonanza culturale, cercando di organizzare nuovi rapporti interpersonali, modificando le regole del gruppo e introducendo propri criteri di status. Per superare le paure che derivano da uno stile di vita, in parte o del tutto contrario a quello del sistema normativo, mettono in atto un processo difensivo di tipo collettivo (la formazione reattiva, che si vedrà meglio nel modulo sulla psicologia del ciclo di vita), che ribalta totalmente la definizione positiva delle norme, con le sue mete e i suoi ideali condivisi a livello generale. Il sistema dominante viene metabolizzato in maniera diversa, con disgusto, e percepito come ingiusto, sbagliato e pregiudizievole; pertanto, viene rifiutato e disprezzato. I comportamenti criminosi che si innescano a causa del rifiuto totale del sistema sociale di cui si sentono vittime, sono privi, comunque, di una sostanziale carica di tipo critico; non hanno nulla a che vedere con le azioni di protesta organizzata, tipiche di chi ha assunto la tipologia adattativa del ribelle di Merton. In quel caso, le condotte emergenti sono prive di una effettiva finalità, si presentano come atti vandalici e non offrono vantaggi diretti sul piano economico. È evidente, tuttavia, che esistano delle mete secondarie che motivano la scelta antigiuridica di questi soggetti, che Cohen identifica nel maggior prestigio che essi acquistano, tramite i loro comportamenti, all’interno dei gruppi sociali di appartenenza. L’analisi di Cohen non giunge, tuttavia, a proporre una vera e propria spiegazione di questi fatti; egli si limita a descrivere il fenomeno, riconducendolo alle trasformazioni sociali in atto negli Stati Uniti fra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. Interessante, da questo punto di vista, può essere il pensiero di E. Erickson sulla formazione delle disarmonie dell’identità personale. Quest’ultimo ritiene, infatti, l’identità come l’organizzazione di una immagine coerente, omogenea, continua e stabile dell’essenza della propria personalità. La sua formazione dipende sia dai meccanismi di identificazione coi vari modelli che si succedono nel corso dell’età evolutiva, sia nei confronti dei ruoli che vengono proposti e assunti nell’ambito delle relazioni interpersonali. Questi processi, raggiungono un punto nodale proprio durante l’adolescenza, e cioè nel momento in cui vengono rimessi in discussione i modi del radicamento sociale e dell’appartenenza culturale. Durante l’adolescenza, e anche oltre, il soggetto è fortemente influenzato dall’atteggiamento degli altri, specie di coloro che vivono all’esterno del contenitore familiare. Se questa cattiva organizzazione dell’identità dà luogo a qualche iniziale comportamento problematico o deviante, si risvegliano nel prossimo aspettative negative nei confronti di tali soggetti (es. “da te non posso aspettarmi niente di buono”); ciò, talvolta, finisce con l’alterare l’identità del proprio Io (“io non posso fare niente di buono”): sicché, l’attore realizza, mediante la condotta deviante, il giudizio negativo anticipato nei suoi confronti (Ponti, 1990). Si struttura, pertanto, nel soggetto, la realizzazione di una sorta di identità negativa, che conduce a un’immagine del sé svalorizzata e degradata, che la società affronta, mediante gli strumenti di esclusione dal gruppo, ossia la reclusione, la condanna, la stigmatizzazione. Alla genesi dell’identità negativa corrisponde anche la formazione di un etichettamento sociale, e cioè, l’attribuzione di un significato negativo alla condotta di un soggetto (spesso un giovane), orientando il soggetto verso l’avvio di una carriera deviante. 104 Forme di criminalità Il problema fondamentale riguarda la c.d. interiorizzazione dei messaggi negativi che circondano il soggetto, i quali, tracciando una cornice, finiscono con l’attribuire un senso profondo alla condotta e a confermare nel soggetto la convinzione di essere ciò che appare agli altri, cioé un criminale. Secondo Erickson, in questo modo, si possono formare i tratti di personalità di tipo criminale. Negli anni Sessanta, le ipotesi di Cohen sono state riprese e ampliate da R. A. Cloward e L. Ohlin, a proposito della famosa teoria delle bande delinquenziali. Secondo questi autori, le possibilità di autoaffermazione e di promozione socio-culturale non sono equamente distribuite all’interno delle varie classi sociali; chi vive in zone economicamente meno sviluppate ha molti più problemi nel raggiungere le mete delle proprie ambizioni, a differenza di coloro che invece risiedono in zone più ricche di risorse e di strumenti adatti. Secondo Cloward e Ohlin, questi fattori, rappresentano una limitazione delle opportunità obiettive di riuscita sociale, dove la razza, il ceto, la classe sociale costituiscono i principali elementi di tale impedimento. Le bande criminali nascerebbero, allora, come risposta ai bisogni di aggregazione e di riconoscimento reciproco di questi giovani devianti, costretti al margine dalla società. In base all’abuso di sostanze stupefacenti, al ricorso alla violenza e alle modalità di esercitare la loro delinquenza, i due autori distinguono tre diversi modelli di banda: a) le bande criminali sono formate da soggetti dediti alle abituali attività appropriative illecite, quali il furto, la rapina, il racket. Questi giovani diventano, in tal modo, criminali, realizzando una più facile acquisizione degli status symbol proposti dalla cultura della classe media; b) le bande conflittuali sono invece dedite alla violenza e al vandalismo sistematico, senza finalità primariamente appropriative, ma mirando a distruggere i simboli irraggiungibili e a esprimere, così, irrazionalmente, con la violenza gratuita, appunto, la protesta di essere esclusi. Si effettua, in tal modo, un’aggressione violenta nei confronti del sistema: con l’associazione in tali bande, infatti, i giovani esprimono una ribellione e un’opportunità che combatte, mediante modalità del tutto irrazionali, gli emblemi e le mete che la società propone; c) le bande astensionistiche, infine, sono composte da quei giovani nei quali la frustrazione ha provocato una fuga che esprime il rifiuto globale della cultura stessa, dalla quale cercano di evadere mediante la tossicomania o l’alcolismo. È evidente come queste teorie siano il prodotto della cultura statunitense degli anni Cinquanta e Sessanta, mentre, oggi, presentano numerosi punti deboli. In primo luogo, la teoria che la condotta deviante debba essere una caratteristica delle classi meno agiate ha perso qualunque tipo di validità, soprattutto se si considerano i c.d crimini dei colletti bianchi, caratterizzati da ampi fenomeni di corruzione, traffico di denaro sporco, ed ancora, crimini finanziari e dell’imprenditoria. Gli studi di Sutherland, infatti, hanno mostrato, fin dagli anni Quaranta, che la criminalità non era solo una caratteristica delle classi sociali meno abbienti, ma poteva estendersi anche al mondo delle classi agiate (da qui il termine ‘colletti bianchi’). Questo comportava, di fatto, una forte critica a tutte quelle ipotesi teoriche che vedevano le cause della criminalità nelle deviazioni di una classe, quella più umile, obiettivata a trovare i mezzi leciti per conquistare le mete sociali quasi irragiungibili, pro105 Criminologia ed elementi di criminalistica poste dal sogno americano. Il fenomeno della delinquenza appariva, per la prima volta, nella sua complessità ed estensione; interessava tutti i gruppi sociali, compresi quelli più alti, benché, le sue forme, apparissero differenti e variegate. Ma ciò che particolarmente occorre segnalare è la tendenza, spesso implicita, nelle considerazioni sociologiche sulla devianza e la delinquenza, a valutare le condotte criminose come effetti di fenomeni sociali (come, appunto, l’appartenenza a classi svantaggiate), che si presentano col carattere del determinismo, quasi a giustificare ogni condotta, svincolando l’azione antigiuridica da aspetti di responsabilità. In realtà, oggi, sappiamo che la questione criminale comprende una grande quantità di fattori e, comunque, non può prescindere dalla valutazione in termini di scelta, rispetto all’azione di chi commette un crimine. Scelta che poi dà avvio al procedimento legale di sanzionamento, compresa la comminazione graduata della pena. Solo in questo modo è possibile sfuggire al pericolo insito nelle ipotesi di tipo deterministico e causalistico che finiscono con l’assumere posizioni assolutamente assolutorie, considerando la delinquenza come un fatto subìto dal criminale, prima che agito dallo stesso, in prima persona. Su questo piano si incontrano sia le posizioni dei sostanzialisti di provenienza positivistica, sia quelle del sociologismo più acritico. 6.2 Famiglia e delittuosità In questi ultimi anni, anche se in modo maggiore che nel passato, la cronaca nera italiana è stata fortemente caratterizzata da omicidi avvenuti in ambienti familiari. I mass-media si sono occupati con un interesse particolare soltanto di alcuni di loro, perchè più crudi o efferati o perché cruenti o sadicamente violenti. Per mesi abbiamo sentito parlare dei delitti di Novi Ligure, così come di quello di Cogne. Due tragedie umane che purtroppo, e non per i protagonisti, bene si sono sposate con il voyeurismo del pubblico. Ma gli omicidi in famiglia si consumano con una frequenza preoccupante ed hanno ben poco a che vedere con la spettacolarità mediatica: essi sono la manifestazione ultima, finale, del lato orribile, deviato e disturbato dei rapporti familiari e dei legami di sangue. Relazioni affettive turbate, compromesse, spesso compresse dal peso della vita quotidiana e dalla delusione delle sconfitte, soprattutto date dall’incapacità, personale e/o sociale, a realizzare un progetto di vita individuale soddisfacente. Questi eventi nefasti, per molto tempo, sono stati analizzati solo nella prospettiva psicologica, ma, oggi, che sembrano essere più frequenti, vengono chiamati in causa più elementi. Si scopre, così, che c’è una complessità di fondo molto radicata, che a stento emerge e che deve essere letta e analizzata alla luce di una complementarietà motivazionale che non è però mai esaustiva. A proposito della famiglia, l’art. 29 della Costituzione italiana recita: “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Una micro-società naturale, quindi, ma dai rapporti e funzioni estremamente complessi: attraverso di essa, infatti, si apprende la propria cultura, i valori da condividere, le regole di vita ma, nello stesso tempo, si acquisiscono ruoli e si assumono funzioni che, a seconda della vita sociale, al di fuori del proprio nucleo, si declinano in modi e maniere differenti. 106 Forme di criminalità Nel momento in cui sorgono ostacoli individualmente considerati insormontabili, scatta l’aggressività che, sempre più spesso, è veicolata verso i componenti del proprio nucleo di origine, considerati causa primaria delle frustrazioni; (come testimoniano sempre più spesso gli operatori dei Servizi Sociali), ma l’atto estremo, l’omicidio, come spesso si crede, non è sempre estemporaneo, non è sempre dettato da un impulso immediato e incontrollato. È il frutto, il più delle volte, di una lenta elaborazione, di una conflittualità interiore che affonda le sue radici lontano e che è strettamente connessa al cambiamento, nel tempo, dei ruoli familiari e sociali dei membri del nucleo di appartenenza. Le vittime degli omicidi in ambiente domestico sono prevalentemente donne, il 58,7% a fronte del 41,3% degli uomini (Eures), sono soprattutto i motivi passionali che portano agli assassinii, ma elevate sono anche le motivazioni legate ad interessi economici. In questi ultimi tempi, è andato ad aumentare il numero degli infanticidi, anche se, in realtà, sarebbe più esatto dire che se ne parla di più e i casi diventano statistici, perché di infanticidi e di omicidi di minori, la storia è piena. Inoltre, le cifre sugli infanticidi che riportano le statistiche ufficiali sono relative, perché non contemplano le morti avvenute in modo accidentale, ma, pur sempre, in presenza di almeno uno dei genitori; e poi perché quando si parla di infanticidio si intende un omicidio nei confronti di bambini appena nati; se volessimo estendere la morte ai bambini di qualsiasi età dovremmo parlare di figlicidio, e allora, i numeri sarebbero molto più alti. Il figlicidio, come reato, non è contemplato dal Codice Penale, che riconosce solo l’infanticidio e l’omicidio. Nel primo caso avremo la punizione, così, come da art. 578 del c.p.: la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma, si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Nel secondo caso, l’art. 575 del c.p.: “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ai ventuno anni”. Non si vuole entrare nel merito di un campo giuridico-dottrinale delicato come questo, quello che interessa è mettere in evidenza che, ad esempio, anche la morte di un bambino di cinque anni è omicidio, attenendosi letteralmente al codice penale. Comunque lo si voglia chiamare, la morte di un minore è sempre la negazione di una vita breve, è un atto di violenza finale sempre più spesso agito dalle madri. Per la cultura italiana, questo è veramente insopportabile, psicologicamente impossibile, umanamente incredibile. La figura e il ruolo della donna/madre/mamma è sacra. La donna che non solo vede modificare il proprio corpo per contenere e proteggere un bambino, che sopporta il travaglio fisico per portare alla vita un altro essere umano, la mamma, che culturalmente deve prendersi cura del neonato, che naturalmente deve sacrificare il suo tempo, il suo spazio, le sue relazioni, il suo lavoro, la sua carriera, i suoi affetti. Tutto questo, rientra nella normalità, nella ovvietà, nella gratuità dell’amore. La donna accetta tutto questo perché è nel suo codice culturale genetico, perché è sempre stato così nel passato, perché appartiene alla storia naturale e culturale della vita dell’uomo. Allora abbiamo donne che, per difendere i propri figli, hanno lottato, si sono umi107 Criminologia ed elementi di criminalistica liate, hanno combattuto, si sono prostituite, sono fuggite, sono morte di stenti, tutto per proteggere i loro figli e/o per garantire loro la sopravvivenza e una vita decorosa. E se questo ha significato il loro annientamento, la loro mortificazione, il loro sangue, è andato bene lo stesso, perché una donna prima di essere un individuo come tutti è una madre. Il concetto di madre rimanda a quello della Madonna, simbolo di tutte le madri, Vergine, con la sua fede sacrificale e con il suo amore, ambedue materni e incondizionati, con la sua virtù di pietà e di devozione tipicamente femminili. Proprio per questo, il valore della maternità non ha più una funzione sociale, ma un compito trascendente, all’insegna di un forte spirito di sacrificio che avvicina la donna a Dio. Per tutto questo, l’infanticidio e l’omicidio di un bambino per mano materna oltre ad essere umanamente inaccettabile, è anche culturalmente destabilizzante; ecco che allora, nel momento in cui vengono compiuti atti tanto efferati e apparentemente incomprensibili, viene chiamato in causa un deus ex machina, una presenza divina, superiore, che impone il proprio arbitrio alle donne, guidandole nel più abominevole dei delitti. Il deus ex machina è la pazzia. È come se uno spirito maligno entrasse nel corpo della donna, che diventa solo involucro, carne, senza più volontà o capacità di comprendere e la portasse a compiere l’assassinio: infatti, spesso, durante i processi, si invoca da parte della difesa l’incapacità di intendere, intesa, al contrario, quale assenza della normale capacità di valutazione dei propri atti e l’incapacità di volere, come mancanza di determinazione libera e volontaria del proprio comportamento. I due requisiti definiscono la responsabilità giuridica di un soggetto. In caso di omicidio o infanticidio, dovranno essere tenuti in considerazione quei due requisiti per una giusta valutazione di ciò che è stato commesso. E il tecnico chiamato a fare le perizie è lo psichiatra, sarà lui a dover dare giudizi di normalità o infermità mentale. Da questo dipenderà anche il tipo di detenzione a cui l’omicida sarà sottoposta. Se le imputate saranno dichiarate sane di mente saranno recluse in un carcere comune, se invece verranno considerate incapaci, e nello stesso tempo pericolose socialmente, due pesanti stigma, entreranno nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario (dalla forte caratterizzazione carceraria). Tuttavia, la discriminante è già a monte: di fronte ad un fatto di sangue si cerca, come afferma P. Barbetta, di affermare lo stato di ragione della criminale. La trasformazione cioè della trasgressione morale in trasgressione giuridica. La difficoltà di trovare un movente, o anche solo un interesse a commettere il gesto, crea uno spazio perché la difesa possa far riconoscere la malattia mentale. Sempre più spesso infatti, le Medee usufruiscono delle attenuanti. L’infanticidio è un tipo di reato particolare, tale che gli ordinamenti penali di quasi tutti i paesi del mondo limitano la pena per la madre, considerandolo meno grave rispetto al figlicidio. L’infanticidio, in Italia, è tale se avvenuto immediatamente dopo il parto (per altri paesi i tempi sono più lunghi come ad esempio il codice penale canadese che lo considera fino a 12 mesi dopo il parto), in una condizione fisica e psichica alterata da parte della donna, in cui viene dato particolare risalto alla situazione psicopatologica temporanea delle funzioni mentali relativa appunto alla fase post-parto. Non vi è, però, nella letteratura specializzata una chiara definizione psicologica o psicopatologica della personalità dell’infanticida, proprio perché, non sono solo questi gli elementi da prendere in considerazione. Infatti, un altro motivo legato alla ridotta severità della pena, alle volte, è ricercato nelle particolari condizioni culturali, sociali ed economiche in cui la donna viene a trovarsi, con 108 Forme di criminalità tutto ciò che ne consegue rispetto all’illegittimità dell’atto, in un contesto di massicce pressioni, consce ed inconsce, e forti condizionamenti sociali. Ma, spesso, la sorpresa è data dal fatto che questi omicidi maturano in ambienti che potremmo definire socialmente sani, con donne dall’apparente vita regolare, religiosa, con un percorso autobiografico fatto, anche, di molte soddisfazioni personali, questo perché il mostruoso, l’abominevole, non è esclusivo appannaggio dell’insanità mentale o della deprivazione economica. È importantissimo sottolineare che solo una piccola parte di donne che si macchiano di questi orrendi delitti sono affette, potremmo dire, da patologie mentali, che vanno dalla serie depressiva a quella paranoidea; per la maggior parte di loro si tratta, ovviamente, di disturbi della personalità causati da tutta una serie di motivi: economici, sociali, di ruolo, psicologici, e così via. Le donne non sono portate a commettere omicidi perché biologicamente inferiori (come teorizzato dalla Scuola Positiva), ma forse perché vivono una vita inferiore, ossia, al di sotto delle loro aspettative e dei loro desideri. Basta analizzare le motivazioni banali di alcune donne che uccidono i propri figli in quanto colpevoli di aver rovinato i loro corpi attraverso il parto, a quelle più complesse, di donne, che ripropongono ai piccoli le violenze che loro stesse hanno subìto, a quelle che dissimulano la gravidanza e fecalizzano il neonato (è il caso dei bambini abbandonati nelle discariche o nei cassonetti dei rifiuti). Un altro aspetto inquietante dei figlicidi è la modalità, l’atto materiale con cui viene portata a termine la vita. Ci sono moltissimi casi di morti accidentali, ma che poi, tali non sono: cadute da balconi, soffocamento nei letti, lo scivolare in una scarpata, o nei laghi o nei fiumi, il semplice cadere dalle braccia di un genitore, la cadute dalle scale, le forme di denutrizione volontaria, il collocarli all’interno delle lavatrici di casa. Molti degli incidenti domestici, come è stato dimostrato da molti psichiatri, sono causati con totale volontà di uccidere. Altre volte, si consumano dei veri e propri martìri, i bambini vengono uccisi con oggetti contundenti che fanno schizzare il sangue ovunque. Che significato può avere in un contesto così doloroso e drammatico lo spargimento di sangue? Il sangue possiede una potente carica metaforica coagulante, simboli ora terrifici, ora salvifici, connessi all’immagine nera della dissoluzione e della morte o a quella positiva della rigenerazione della vita. Il versamento di tanto sangue, sangue innocente di un bambino, ha il significato di una espiazione, è il mezzo attraverso il quale affrancarsi dalle proprie colpe, rinunciando, per propria mano, a ciò che si ha di più prezioso, alla carne della propria carne, alla propria progenie, per tornare a nuova vita, per potere avere un futuro privo di passato, come se l’atto di sangue fosse il rito di purificazione attraverso cui passare per giungere in un altro posto, in una vita serena, nuova, pulita. La soglia è attraversata, e dal sangue versato scaturisce la rigenerazione e la propria vita. In questo senso, potremmo anche spiegarci il motivo per cui anche di fronte all’evidenza, si ha la negazione dell’atto o comunque molte donne assumono, subito dopo l’omicidio, un comportamento assolutamente normale. D’altro canto, in molte religioni e civiltà del passato ci sono esempi di sacrifici umani di adolescenti e bambini, immolati per qualche divinità e per la Madre Terra, dai Maya agli Etruschi, dai Greci ai Romani, perché il sangue innocente versato era garanzia di prosperità e di vita. Il figlicidio e le sue declinazioni simboliche rappresentate da mutilazioni fisiche parziali di natura rituale, circoncisioni, clitoridectomie, infibulazioni, si rintracciano in tutte 109 Criminologia ed elementi di criminalistica le culture, e a queste, poi, si vanno ad aggiungere gli atteggiamenti violenti, le lesioni fisiche indotte da percosse, la negligenza, l’abbandono a cui i bambini sono stati sottoposti nel corso della storia. Oggi, chiaramente, si vive nel rispetto dell’infanzia, ma la cultura del bambino riesce ad affermarsi con non poche difficoltà. Giuridicamente parlando, qualcosa viene fatto attraverso le norme per tutelare l’infanzia, ma nonostante tutto, viviamo continuamente episodi cruenti di violenza e di morte. Nel nostro Codice Penale, gli artt. 575 e 578 sono solo un piccolo passo avanti ma, comunque, estremamente significativo rispetto al passato. Il primo c.p. del 1889 attenuava la colpa di infanticidio, considerandolo meno grave dell’omicidio, commesso per salvare il proprio onore o per evitare sovrastanti sevizie. L’infanticida per eccellenza era, infatti, la madre, o meglio la madre cosiddetta illegittima (nubili e adultere come da codici ottocenteschi). Con il Codice Rocco, invece, l’attenuante non era solo per le madri ma per chiunque, per motivi di onore, uccidesse un neonato. La situazione si è andata modificando con l’articolo n.1 della legge 442 del 5 agosto1981, quando la causa d’onore è stata abolita da tutti i reati che la contemplavano, per cui, si è tornati ad identificare nella madre la principale agente dell’infanticidio, senza più attribuzioni di maternità illegittima, oltre alla considerazione del gesto, in condizioni di abbandono materiale e morale. I delitti citati, come già affermato, non sempre maturano in ambienti socialmente compromessi o economicamente difficili. I mass-media, purtroppo, hanno una particolare predilezione per gli avvenimenti che scaturiscono in situazioni di normalità; parlare infatti di delitti in ambienti già fortemente problematici non fa più, quasi, notizia, anzi, per tutta una serie di pregiudizi culturali, il fatto che un bambino possa essere ucciso in una famiglia in cui ci sono problemi economici, psicologici e sociali è abbastanza normale. Ma, se un infanticidio avviene nel contesto di una famiglia non problematica, diviene clamoroso. Anche le eventuali testimonianze dei vicini e conoscenti saranno diverse: tutti, sono pronti a giurare sulla sanità mentale della madre, sulla devozione verso la famiglia, sulle cure amorose verso il bambino, sul carattere affettuoso e premuroso. Vengono, infatti, messi in moto i sentimenti comuni, la solidarietà sociale, la coscienza collettiva, la capacità culturale di lavorare ed elaborare il delitto, e si viene, quindi, a creare una empatia di sentimenti. Ma sulla scena, ci sono anche altri attori: i c.d. familiari dell’omicida. Non esiste legge e non esiste supporto psicologico che li possa tutelare e la situazione si complica nel momento in cui le donne ritornano in seno alla famiglia. Dopo un primo atteggiamento di protezione e collaborazione incondizionata, spesso, comincia a serpeggiare la diffidenza e la paura che la madre possa essere recidiva. Il reinserimento sociale è infatti estremamente difficile e lo stigma che caratterizza una donna sarà tale fino alla sua morte. Quando avvengono fatti delittuosi come la morte di un bambino, si spezzano i legami familiari, si frantuma il concetto stesso di famiglia come ricovero, protezione, si sradica il senso comune del vivere quotidiano che viene dalla famiglia e si annulla il significato culturale della socializzazione primaria. Semplicemente, essa perde il ruolo fondamentale di guida e di contenitore umorale e appare in tutta la sua fragilità, nella sua incapacità di svolgere un compito che è quello di lenire le ferite provocate da una vita non al passo con i ritmi sempre più vorticosi di una società che muta continuamente pelle. 110 Forme di criminalità 6.3 La criminalità economica Gli storici di professione, fino a qualche decennio fa, lasciavano, volentieri, il tema della criminalità economica, a sociologi e antropologi, i quali, considerando il rilievo mondiale del dibattito sulla mafia siciliana, soventemente, cadevano nella trappola interpretativa dell’eccezionalismo isolano. Fenomeni importanti di criminalità organizzata si registrano in parti consistenti del Mezzogiorno d’Italia. Il tema della faida rimanda, nel tempo, a quello degli ordinamenti primitivi e arcaici di giustizia privata o meglio comunitaria e, nello spazio, a contesti mediterranei o balcanici. L’esistenza di una mafia italo-americana porta il nostro tema su un altro continente, in un contesto plurietnico del tutto diverso da quello originario. Il periodo più recente ci induce a ragionare di organizzazioni, traffici e interessi di scala mondiale. Infine, il discorso sulla criminalità organizzata introduce i grandi temi dell’illegalismo del potere politico e sociale, i problemi di un gap di statualità che viene rappresentato come specifico della vicenda siciliana, ma che va, invece, inquadrato in contesti ben più ampi e generali. Per spiegare questa capacità della mafia di riprodursi in nuovi contesti economico-sociali, occorre interpretarla, piuttosto, come un fenomeno tipico di ibridazione sociale, cioè di stretta compenetrazione tra antico e moderno, di adattamento continuo al mutamento. Non a caso, gli studi più recenti hanno ormai abbandonato la classica distinzione tra vecchia e nuova mafia: la prima, espressione di relazioni sociali arcaiche, circoscritta alle campagne e al piccolo tessuto della società locale, poco incline all’accumulazione economica ed arroccata al codice d’onore; la seconda, sviluppatasi in ambienti metropolitani nel secondo dopoguerra, compenetrata strettamente alla classe politica per controllare i flussi di spesa pubblica dell’intervento straordinario e con legami finanziari internazionali nel settore illegale della droga. I comportamenti di criminalità economica non sono codificati come criminali, in maniera omogenea, tra i sistemi giudiziari, che, spesso, delegano la loro sanzione al diritto civile o amministrativo (come ad es. per l’abuso di posizione dominante, o l’uso ingannevole della pubblicità). Inoltre, nel caso in cui le condotte siano sanzionate penalmente, si registra una scollatura tra la previsione di illiceità del codice e una diffusa accettazione dei comportamenti illeciti in ampi strati del contesto sociale. Le condotte di criminalità economica (come ad es. le truffe) devono spesso assumere, per avere successo, l’apparenza di transazioni e di comportamenti legittimi (Nelken 1994). In molti casi, quindi, per i crimini economici, viene a mancare, del tutto, la consapevolezza che abbia avuto luogo il reato. Vittime e rei, nei contesti di criminalità economica, risultano generalmente più invisibili che sulle scene di altri delitti (Ruggiero 1996). Le modalità dei crimini economici (come per molte truffe) tendono a creare una separazione di tempi e di luoghi tra chi compie il crimine e chi ne subisce il danno. Danno che, spesso, si materializza, senza alcun esplicito collegamento, all’azione del criminale per effetto dell’ambiguità dell’oggetto e della sua marginalità. Nella divisione del lavoro tra le scienze sociali, non esiste una definizione generalmente accettata di criminalità economica, né un distinto segmento di letteratura teorica e pratica sulla criminalità economica (Kitch 1983). Ciò significa, in altri termini, che le 111 Criminologia ed elementi di criminalistica definizioni disponibili concentrano l’attenzione su specifici aspetti dei fenomeni considerati. A tre differenti aspetti, i criminali, le loro finalità, le modalità di esecuzione del crimine, possono essere ricondotte le tre principali tipologie di definizione, elaborate in letteratura. La prima concettualizzazione dell’idea di criminalità economica, attribuita al criminologo americano E.H. Sutherland, fa esplicito riferimento ai soggetti che commettono crimini economici. Nella sintesi del pensiero di Sutherland, diffusasi in letteratura, il crimine economico viene visto come delinquenza delle classi superiori o dei colletti bianchi, cioè di professionisti rispettabili, o almeno rispettati (Sutherland 1940). Il crimine economico o crimine imprenditoriale, tra i differenti illeciti messi in atto dai colletti bianchi, si qualifica, quindi, in questa accezione, come un comportamento illecito adottato da soggetti che operano internamente a una organizzazione legittima, tipicamente un’impresa, in congruità con gli obbiettivi di questa (Schrager, Short 1977). Una seconda tipologia di definizioni a cui spesso fanno riferimento, esplicitamente o implicitamente, i manuali di criminologia di scuola americana, include, sotto l’etichetta, di crimine economico, qualunque reato compiuto con finalità di natura economica, spostando il baricentro dell’analisi dagli attori criminali alle loro funzioni. Ne risulta un allargamento del contenuto della definizione potenzialmente a qualunque tipologia di crimine. Ma, al contempo, si delinea un rimando, per quanto implicito, all’idea di criminale razionale (Becker 1968), che alloca le sue risorse tra attività lecite ed illecite, massimizzando il profitto derivante dalle une e dalle altre, dati i costi e i rischi dovuti all’attività delle agenzie anti-crimine. Un’ulteriore tipologia di definizioni rimanda, infine, alle modalità di esecuzione dei crimini economici: comportamenti illeciti che presentano significative analogie gestionali con attività economiche normali e del tutto lecite (Kitch 1983). Questa definizione si articola tipicamente in tre differenti categorie di illeciti: 1) quelli commessi come attività ancillari ai business legali, sfruttando le opportunità illegali che si aprono nel mondo degli affari; 2) quelli associati alla gestione con strumenti illeciti dell’offerta di beni e servizi leciti; 3) quelli, infine, tipici della gestione (ovviamente illecita) di beni e servizi, essi stessi illeciti. Tutte le definizioni, riconducibili alle precedenti tipologie, per quanto possano essere utili per specifici obiettivi, lasciano insoddisfatti se considerate singolarmente, ma contribuiscono, nel loro insieme, ad evidenziare gli elementi da combinare per la costruzione di un concetto soddisfacente di criminalità economica: la rispettabilità dei rei, la loro tipica finalità di arricchimento, la modalità imprenditoriale dell’azione criminale. Resta vero, tuttavia, che una semplice giustapposizione dei tre elementi lascerebbe insoddisfatti ad un attenta analisi. La rispettabilità non sempre è ex-ante una caratteristica del reo, ma può divenirlo a seguito del successo ottenuto nella professione di criminale economico. La finalità di arricchimento può combinarsi ad obiettivi di acquisizione di potere o di rispettabilità, e manifestarsi, non rispetto ad un singolo comportamento criminale, ma ad un insieme concatenato di reati. La modalità imprendito112 Forme di criminalità riale, può, a volte, concretizzarsi nell’utilizzo di un’impresa formalmente legittima per la commissione del reato, come, invece, può manifestarsi nella stabile organizzazione razionale del lavoro di un gruppo di individui per la conduzione di un’attività criminale, senza per questo assumere la natura formale di impresa. Ancora, un reato può essere commesso usufruendo di strumenti resi disponibili dal ruolo che il criminale ricopre all’interno di un’impresa legittima, oppure, organizzando, parallelamente, una forma di divisione del lavoro tra individui, che, seppure di natura imprenditoriale, nulla ha a che fare con l’impresa in cui il criminale (eventualmente assieme ai suoi soci) opera. Il problema centrale per la costruzione di una definizione di criminalità economica è, quindi, quello di trovare una strada per articolare la complessità delle numerose possibili combinazioni delle diverse qualificazioni relative alle tre componenti: rispettabilità degli autori dei reati, ruolo della finalità economica dei crimini, significato della modalità di attuazione del crimine. Per districarsi in questa fitta rete di possibilità, può essere utile utilizzare il concetto di tecnologia, preso in prestito dalla teoria economica, nel suo significato più generale e astratto di capacità di combinare fattori produttivi (lavoro, capitale, conoscenza, etc.) al fine di realizzare un determinato obiettivo. Distinguendo tra tecnologie legali e tecnologie illegali, sulla base della ammissibilità o meno negli ordinamenti delle modalità con cui vengono combinati i fattori produttivi, la criminalità economica può essere individuata come l’insieme di attività economiche che vengono gestite utilizzando tecnologie illecite. Tale definizione, pur astraendo direttamente dai tre elementi individuati nelle definizioni tradizionali, consente di recuperarli, in seconda battuta, in un quadro più articolato di relazioni tra essi; ciò, in quanto il successo nell’attività economica è, nelle società moderne, associato ai percorsi di promozione sociale; allora, la rispettabilità del criminale economico sarà un corollario della sua capacità di utilizzare la tecnologia illegale per gestire la sua attività economica. La finalità del profitto non è attribuibile direttamente ad ogni singolo atto criminale, ma è connessa alla gestione con tecnologia illegale dell’attività economica nel suo complesso. L’assonanza concettuale tra crimini economici e gestione delle attività economiche è fondata sulla considerazione del crimine come tecnologia di assemblaggio dei fattori di produzione. In tal senso, la forma imprenditoriale, nel suo connotato legale, può essere, ma non lo è necessariamente, uno strumento di gestione. Il riferimento alla criminalità come tecnologia non è utile unicamente per ricomporre i pezzi del puzzle delle definizioni tradizionali di criminalità economica. Essa, infatti, offre al contempo l’opportunità di riportare ad unico denominatore una serie di elementi emersi dalla ricerca e dall’attività investigativa nel corso degli ultimi vent’anni, e altri che, invece, sono nell’agenda dell’analisi della criminalità per gli anni a venire. La gestione criminale del fattore lavoro ha assunto un’importanza sempre più determinante sia per gli equilibri dei mercati illegali, come quello della prostituzione o del traffico di stupefacenti, che per l’evoluzione di segmenti di mercato legale, totalmente o parzialmente sommersi. La gestione criminale della manodopera ha superato, negli ultimi anni, la dimensione strettamente locale e nazionale, per assumere una scala transnazionale, sviluppando legami sempre più stretti con il traffico internazionale di migranti (Savona, Lasco, Di Nicola, Zoffi 1997). 113 Criminologia ed elementi di criminalistica Nel management del fattore capitale, la rilevanza delle tecnologie illegali di gestione è cresciuta di pari passo con lo sviluppo dei processi di globalizzazione e con il diffondersi del loro impatto a livello locale. L’evoluzione del riciclaggio internazionale evidenzia, sempre più, come tale fenomeno non risponda unicamente alla logica di copertura dell’origine illecita dei flussi finanziari, ma risulti governato dalla dinamica dei rendimenti e della rischiosità dei diversi impieghi. Come le tecnologie lecite di gestione, anche quelle illecite, determinano cambiamenti e mutamenti dei flussi internazionali in risposta alle variazioni delle politiche di repressione e controllo, che ne alterano le convenienze relative (Savona, De Feo 1997). Anche sul piano delle strategie competitive, le tecnologie illegali si caratterizzano come un’alternativa al management con strumenti leciti della concorrenza di mercato. L’uso della violenza criminale costituisce lo strumento concorrenziale estremo, per la possibilità che offre, a chi ne fa uso, di competere con i concorrenti sulla definizione stessa dei diritti di proprietà sulle risorse e sui prodotti oggetto dell’attività economica (Lasco 1997). Ma anche frodi (Levi 1981), contraffazione di marchi, corruzione (Van Duyne 1997), costituiscono elementi di uno strumentario competitivo criminale, la cui funzionalità può emergere nello svolgimento di attività economiche sia illecite che invece perfettamente legali, almeno sotto il profilo formale. Le frodi possono assumere un ruolo importante anche nella gestione dei rapporti con fornitori e clienti, costituendo un elemento rilevante del meccanismo di regolazione dei legami verticali tra i settori industriali. Analizzare i crimini economici come attività economiche, gestite utilizzando tecnologie illecite, mette, inoltre, a disposizione dell’analista, un equipaggiamento concettuale indispensabile per far luce su due fenomeni emergenti sullo scenario della criminalità economica: la progressiva sovrapposizione tra criminalità organizzata e criminalità economica (Savona, Lasco, Di Nicola, Zoffi 1997), da un lato, e lo sviluppo di crescenti interdipendenze tra i principali reati economici (Savona 1997), dall’altro. Le organizzazioni criminali convenzionali, tradizionalmente dedite allo sfruttamento criminale del territorio in cui sono localizzate, tramite l’estorsione generalizzata, il controllo degli appalti pubblici e dei mercati illegali locali, il traffico di stupefacenti, si muovono verso nuovi business tipici della criminalità economica (frodi, contraffazione, ecc.), tanto più che le tecnologie illegali, su cui è costituita la loro attività tradizionale (violenza e corruzione), divengono strumenti utili a ridurre i costi di gestione di tali nuovi business e per competere con gli altri concorrenti illegali. Specularmente, le nuove opportunità per i criminali economici tradizionali, caratterizzate da una più ampia dimensione geografica delle attività (si pensi alle frodi internazionali o a quelle contro gli interessi della Comunità Europea) e da una maggiore complessità delle procedure necessarie, rendono indispensabile, per un loro efficace sfruttamento, che si possa contare su strutture criminali organizzate in grado di operare su scala transnazionale. Similmente, l’accresciuta complessità delle opportunità di affari per la criminalità economica rende necessario gestire concatenazioni anche complesse di differenti condotte illecite, nelle quali, la frode, la corruzione, il riciclaggio e la violenza costituiscono tasselli indispensabili per il successo dell’intera attività. La combinazione di tali condotte illegali interdipendenti può assumere la forma di transazioni tra differenti sog114 Forme di criminalità getti criminali, generando veri e propri mercati di servizi illegali, oppure può materializzarsi in accordi di cooperazione tra differenti soggetti criminali più o meno stabili ed efficaci, ovvero, ancora, può portare alla creazione di strutture organizzate in grado di governare al proprio interno le differenti fasi dell’attività illecita. Considerare la criminalità economica utilizzando il concetto di tecnologia illegale per la gestione delle attività economiche, sollecita, rispetto all’analisi dei due trend descritti sopra, due quesiti strettamente connessi tra loro. In quali condizioni la tecnologia illegale richiede organizzazione per essere attivata efficientemente, ovvero in quali condizioni richiede una divisione del lavoro criminale? Quali legami esistono tra differenti tecnologie illegali (la frode, la corruzione, la violenza, etc.) e a quali condizioni tali legami si manifestano all’interno di una stessa struttura organizzata, ovvero assumono la forma di transazioni tra strutture differenti? La teoria economica dell’organizzazione industriale ha costruito strumenti analitici per rispondere a domande simili in relazione a tecnologie lecite, ma tali strumenti, se opportunamente riconsiderati (Fiorentini, Peltzman 1995), possono fornire elementi di riflessione utili per analizzare le tecnologie illegali. La nuova agenda per la ricerca in tema di criminalità economica è ancora tutta da scrivere e richiede che gli economisti si abituino a considerare gli affari anche dal punto di vista della rilevanza penale, e che i sociologi e i criminologi prendano sempre più in considerazione la criminalità propria del mondo economico. 6.4 La criminalità informatica In criminologia, quando si analizza il problema della criminalità informatica, si utilizza un concetto dai contorni non ben definiti potendo questo riferirsi a una molteplicità di condotte criminose lesive dei più diversi beni giuridici: reati contro il patrimonio, contro la riservatezza e la libertà individuale, contro la proprietà intellettuale e via discorrendo. Probabilmente, questo avviene perché la tecnologia è innanzitutto un mezzo, uno strumento e, in quanto tale, può essere orientato tanto allo sviluppo quanto all’offesa. La Polizia di Stato, attraverso il Nucleo Postale e delle Telecomunicazioni, in ordine ai pericoli che presenta la rete ai nuovi sistemi di comunicazione ha, necessariamente, dovuto adeguare le proprie strutture investigative, strutturando, nel corso degli anni, unità sempre più specializzate nel contrasto ai fenomeni criminali legati all’utilizzo di tecnologie di avanguardia. La Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, nata nel 1981 con la legge di riforma della Polizia di Stato e originariamente deputata alla tutela del servizio postale e dei servizi di telecomunicazione, sta vivendo un momento di profonda trasformazione, orientando il proprio campo di azione nei settori delle comunicazioni radio, televisive, telefoniche e telematiche, così, connotandosi, sempre più, come Polizia delle Comunicazioni. In realtà, la Polizia di Stato, già nei primi anni ‘90, aveva compreso appieno le potenzialità che gli strumenti di alta tecnologia potevano offrire alle organizzazioni criminali, tanto che, presso la Direzione centrale della Polizia Criminale, fu creato, all’epoca, un team di specialisti con compiti di studio ed analisi dei fenomeni criminali 115 Criminologia ed elementi di criminalistica legati al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo alle attività illecite svolte in seno alle grandi associazioni di stampo mafioso. Nel 1996, l’attività di questa équipe di esperti è stata ricondotta al settore più ampio delle attività di contrasto ai crimini commessi nel settore delle telecomunicazioni, dando vita al Nucleo Operativo di Polizia delle Telecomunicazioni. La creazione di questo ufficio è stato il preludio di una vasta riorganizzazione di tutta la specialità: con decreto del Ministro dell’Interno del 31 marzo 1998, è stato creato il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni all’interno del quale sono confluite le risorse del N.O.P.T. e della Divisione Polizia Postale. L’articolazione attuale prevede una struttura centrale, costituita appunto dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, incardinato all’interno della Direzione Centrale (in Roma). Mentre la Direzione Centrale sovrintende ai servizi delle singole Specialità della Polizia di Stato (Stradale, Ferroviaria, Postale, di Frontiera e dell’Immigrazione), il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni presiede al supporto e al coordinamento dell’attività operativa di 19 Compartimenti regionali (localizzati nelle principali città italiane) e 76 Sezioni provinciali, contando su un organico di circa 2000 agenti. L’indagine informatica non è prerogativa esclusiva della Polizia di Stato, ma attività cui si dedicano anche altre forze dell’ordine, come Carabinieri e Guardia di Finanza. In particolare, presso quest’ultima, è stato istituito, nel luglio 2000, il Gruppo Anticrimine Tecnologico (GAT). Il Gruppo ha un campo d’azione particolarmente ampio investendo tutti i settori in cui viene impiegata la tecnologia per commettere reati: da internet al telefonino, fino ad arrivare ai sistemi di pay TV. Il coordinamento delle attività della Polizia delle Comunicazioni col GAT avviene sempre tramite la Direzione Centrale di Roma. La minaccia criminale nel mondo virtuale si distingue da quella tradizionale perché caratterizzata dal superamento delle classiche categorie di tempo e di spazio. La condotta delittuosa può concretizzarsi in più azioni svolte in tempi diversi o contemporaneamente, da più soggetti o da uno solo, in luoghi diversi o in uno spazio virtuale; la condotta innesca più processi elaborativi e di trasferimento di informazioni che passano, in tempi lunghi o in tempo reale, attraverso spazi indeterminati; possono essere colpiti immediatamente, o a distanza di tempo, una o più vittime, in uno o più luoghi. La velocità con la quale la tecnologia permette di trasferire, alterare o distruggere grandi quantità di dati e informazioni e, più in generale, di portare a termine un crimine, nonché la aterritorialità del fenomeno che può assumere una connotazione transnazionale svincolandosi dai confini dei singoli Stati, rappresentano i limiti più gravi alla persecuzione di tali forme di offesa. La diffusione a livello mondiale della rete e la scomparsa del luogo del delitto hanno creato gravi problemi di competenza territoriale, di giurisdizione, nonché, di norme applicabili, laddove vengano coinvolti più paesi e, conseguentemente, più magistrature e diverse forze dell’ordine. Tuttavia, se un crimine è commesso tramite un server situato all’estero, viene data comunicazione della notizia di reato all’Interpol (Roma), che prosegue le indagini, e alla Procura, competente per territorio (nel nostro caso quella di Firenze). Quest’ultima, verifica dove risiede il server, e inoltra (entro 24 ore) la comunicazione all’autorità giudiziaria estera. 116 Forme di criminalità Se il sito risiede sul server di un dato paese, ma è registrato presso un altro Stato, la comunicazione della Procura deve essere effettuata ad entrambe le autorità giudiziarie. Esistono, inoltre, dei paradisi internet, come le Isole Samoa, la cui legislazione non permette alcuna forma di intervento. Internet è infinitamente vasta e i crimini che possono essere compiuti, per suo tramite, sono numerosi e articolati. Se, da un lato, buona parte degli interventi della Polizia delle Comunicazioni è promossa da specifiche richieste di singoli utenti (aziende o privati cittadini), dall’altro, emerge un dato piuttosto significativo: una notevole discrepanza tra gli attacchi ai sistemi informatici statisticamente rilevati (di numero relativamente esiguo) e quelli effettivamente portati a termine. Alla base di questo fenomeno vi sono diverse ragioni. Innanzitutto, può accadere che il soggetto colpito non sappia di essere tale, non si accorga, cioè, di essere stato vittima di un’aggressione informatica. Chi commette l’illecito può essere un esperto del settore e, trattandosi, come spesso avviene, di un soggetto interno all’azienda, può essere a conoscenza di informazioni preziose, di tipo tecnico o organizzativo, che lo pongono in una situazione tale da impedire qualsiasi rilevamento. In tal senso, gioca ovviamente il suo ruolo una inadeguata politica di sicurezza interna: responsabilità di security manager impreparati, che devono, tra l’altro, aggiornarsi continuamente, data la rapidità con la quale vengono scoperte nuove debolezze e falle di sistemi e protocolli di comunicazione, ma anche responsabilità del personale dipendente che può mettere in crisi, per ignoranza, anche la più sofisticata predisposizione di misure di garanzia (basti pensare ai famosi post-it presenti su monitor o scrivanie che riportano login e password di accesso). In altri casi, invece, è stata riscontrata nei sistemisti, sia di enti pubblici che di aziende private, una forma di ritrosia nel considerare l’attacco subìto come un fatto di reato, quando l’illecita intrusione non provoca danni. Con questi termini, ci si riferisce a quel particolare tipo di attacco, prodromico alla realizzazione di ulteriori reati, tecnicamente denominato hacking, ovvero, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.). A questo proposito, non bisogna, però, sottovalutare il fatto che un’illecita intrusione in un dato sistema che non ha causato alcun danno, può essere utilizzata dall’autore come ponte per entrare in altri sistemi, reali bersaglio e oggetto di operazioni di cancellazione di dati o di altre condotte criminose. Inoltre, se l’ipotesi delineata, ex art. 615 ter, primo comma, è perseguibile a querela della persona offesa, è pur vero che, quasi sempre, questo fatto è connesso con l’illecita acquisizione del file delle password, condotta che integra il reato di cui all’art. 615 quater procedibile d’ufficio. Ciò impone l’obbligo (almeno per i sistemisti di enti pubblici) di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p., obbligo sanzionato penalmente ai sensi degli artt. 361 e 362 c.p. in caso di omissione. Ancora, si deve tener presente che, a volte, le aziende colpite preferiscono non ricorrere alla denuncia perché il fatto di aver subìto un attacco è indice di vulnerabilità, anche di fronte a clienti attuali e potenziali. Il prezzo da pagare per la pubblicità del fatto criminoso subìto, può essere troppo alto, specie nel campo della reputazione e della credibilità. Questo fenomeno interessa, soprattutto, certi tipi di aziende come banche, istituti finanziari, compagnie assicurative, società quotate in borsa, imprese specializzate in sicurezza informatica, in altri termini, tutti quei soggetti per i quali l’offerta di sicurezza 117 Criminologia ed elementi di criminalistica costituisce una componente essenziale dell’attività esercitata. È un dato acquisito, inoltre, che, per la maggior parte di tali aziende, il ricorso alla magistratura non rappresenta una soluzione neanche a fronte di ricatti o estorsioni, posti in essere da vere e proprie organizzazioni malavitose. Accanto al cosiddetto danno di immagine, un altro elemento può trattenere le aziende dalla denuncia: il timore di una responsabilità penale, nonché civile, per eventuali danni cagionati a terzi. Deve essere chiarito, però, che in caso di attacco ad un sistema informatico, tali responsabilità sono solo quelle disciplinate dalla normativa sul trattamento dei dati personali. La legge sulla privacy (n. 675/96) prevede, infatti, l’obbligo giuridico per il responsabile del trattamento di adottare le misure necessarie alla sicurezza dei dati, l’omissione delle quali (sia dolosa, sia semplicemente colposa) è sanzionata penalmente (art. 36.) In base, poi, all’art. 18 della legge citata, chiunque cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile. Il trattamento di dati personali è, quindi, attività considerata pericolosa, e comporta un’inversione dell’onere della prova (è il gestore a dover provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, art. 2050 c.c.). Va sottolineato, d’altra parte, come sia in pratica facile sottrarsi alle suddette responsabilità: la legge richiede, infatti, la predisposizione di misure di sicurezza minime (per non dire ovvie e in alcuni casi anche ingenue). A norma dell’art. 15 (della 675/96), terzo comma, dette misure, individuate dal regolamento introdotto con D.P.R. del 28 luglio 1999, n. 318 (in vigore dal 1.1.2000), consistono, fondamentalmente, in un sistema di codici identificativi (password) per l’accesso al sistema e nell’impiego di idonei programmi antivirus, la cui efficacia e aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale (art. 4 del regolamento). La disciplina prevista dalla legge 675/96, trova applicazione, ex d. lgs. n. 171 del 1998, anche ai fornitori di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico (in particolare, quindi, agli Internet Service Provider e alle compagnie telefoniche). Un altro elemento che non può essere trascurato è che, nel cosiddetto ciberspazio, anonimità e omologazione sono attributi che qualificano gli utenti virtuali e facilitano l’occultamento di prove reali e personali. Per questa ragione, nell’attività repressiva dei computer crimes, la collaborazione dei gestori dei servizi di telecomunicazione, dei servizi internet (Internet Service Provider), dei fornitori di connettività e degli altri operatori, è un elemento imprescindibile se si vogliono ottenere risultati concreti. La professionalità del personale impegnato nelle indagini deve essere supportata, soprattutto nella fase di acquisizione delle fonti prova, dalla collaborazione spontanea di tali soggetti, nonché delle stesse vittime. Diversamente, la volatilità degli elementi probatori e la mancanza di una normativa che obblighi gli amministratori di sistema a conservare i cosiddetti file di log determinano situazioni la cui complessità, difficilmente, potrebbe trovare soluzione. In particolare, l’identificazione di un soggetto, di un luogo o di eventuali tracce di reato, che costituiscono atti tipici di polizia giudiziaria, sono, in questo settore, essenzialmente riconducibili al cosiddetto ip address, dal quale si può risalire, attraverso particolari accertamenti tecnici, a soggetti fisici. Una collaborazione spontanea, si diceva, perché tutto sembra ruotare intorno all’ip address, elemento fondamentale per tracciare e individuare il criminale informatico, ma contenuto in quei famosi file di log, la cui conservazione (per un certo periodo) non è prevista come obbligo di legge a carico degli ISP. 118 Forme di criminalità Per risalire all’autore dell’illecito, dunque, è determinante acquisire i file di log. Occorre, in proposito, chiarire che esistono diversi file di log, ciascuno deputato alla registrazione di particolari attività svolte dall’utente sulla o tramite la macchina alla quale ha ottenuto l’accesso. I file di log che qui interessano sono quelli (memorizzati sul server dell’ISP) che contengono i dati relativi all’inizio e alla fine di una sessione di navigazione di uno specifico utente (collegatosi con un certo username e una certa password), nonché, soprattutto, l’indirizzo ip del computer (indirizzo assegnato dal server stesso), che ha richiesto l’accesso alla Rete. Una volta acquisiti, tali files, vengono confrontati con i tabulati telefonici e permettono, così, di risalire all’intestatario della linea chiamante. È su quest’ultimo che, in primo luogo, ricadrà la responsabilità per l’uso illecito del computer. 6.5 La criminalità organizzata e le moderne tecnologie Le molteplici occasioni che la rete riesce ad offrire hanno inciso, specie in questi ultimi anni, in parecchie attività economiche, facilitando qualsiasi tipo di transazione e abbassando, al tempo stesso, i relativi costi. Naturalmente, anche la criminalità organizzata ha scoperto che internet può fornire nuovi benefici per i propri affari illeciti. Il lato oscuro della rete telematica riguarda: la frode, il furto, la pornografia, la pedofilia, il traffico di droga, di armi, di organi umani e quant’altro interessa e coinvolge direttamente le organizzazioni criminali mondiali. Nel mondo virtuale, come in quello reale, la maggior parte delle attività criminali è compiuta da singoli individui o da piccoli gruppi e può essere perfezionata ed utilizzata su larga scala dalle grandi organizzazioni. Si hanno, infatti, numerose prove che la criminalità organizzata stia già sfruttando a pieno regime le nuove opportunità offerte da Internet. Certamente, si continuerà ad operare nel mondo reale, piuttosto che nel c.d. Cyberspazio, e la maggior parte dei crimini informatici sarà compiuta dagli individui, piuttosto che dalle organizzazioni; tuttavia, il grado di sovrapposizione fra i due fenomeni aumenterà considerevolmente durante i prossimi anni. Prova di ciò è che non appena le Forze dell’Ordine attuano uno screening delle imprese sospette di attività penalmente rilevanti, si scopre come alcune di esse siano coinvolte, allo scopo di aumentare i loro profitti illeciti, nel settore dei crimini informatici. Le organizzazioni criminali non sono gli unici beneficiari dei c.d. mercati telematici illeciti, ma, senza dubbio, sono i più importanti a causa della competitività, frutto del loro modus operandi, costituito, essenzialmente, da minacce, violenze e intimidazioni di ogni genere. Le organizzazioni criminali, inoltre, tendono a essere particolarmente attente a individuare tutte le occasioni per incrementare le proprie attività illegali. In questo contesto, internet, e lo sviluppo continuo del commercio elettronico, offrono nuove prospettive di espansione dei mercati. Negli ultimi anni, c’è stato un aumento rilevante della specializzazione dei gruppi organizzati nel traffico di droga e di armi. I narcotrafficanti colombiani, per esempio, hanno seguito nuove strategie per differenziare il loro prodotto, sfruttando nuovi mercati in Europa occidentale e nei paesi del119 Criminologia ed elementi di criminalistica l’ex Unione sovietica. Le organizzazioni criminali hanno esperti finanziari sempre più specializzati a condurre transazioni economiche a livello internazionale. Il crimine organizzato non ha bisogno di sviluppare la perizia tecnica necessaria per navigare su internet: può impiegare i migliori esperti informatici mondiali, utilizzando (secondo i casi) ricompense o minacce pur di raggiungere i propri obiettivi. La criminalità organizzata è continuamente alla ricerca di luoghi privi di controllo, in cui condurre, con tranquillità, i propri affari illeciti. Internet rappresenta, senza dubbio, una zona franca, perché è in grado di fornire sufficienti garanzie di sicurezza e anonimia offrendo, al contempo, adeguata tutela nei confronti delle varie normative internazionali. Nel mondo virtuale non ci sono confini, e questo costituisce una caratteristica molto attraente per quasi tutte le attività criminali. Quando le autorità tentano di sorvegliare questo mondo virtuale, incontrano non poche difficoltà. Internet offre le occasioni per la commissione di varie tipologie di reato. Offre nuovi strumenti per commettere reati quali la truffa e l’estorsione (crimine, quest’ultimo, che è stato sempre una delle peculiarità delle organizzazioni di mafia). L’anonimato fornisce uno strumento ideale per molte attività proprie della criminalità organizzata. La segretezza è, solitamente, una chiave strategica e internet offre opportunità eccellenti per la realizzazione di reati, in maniera quasi completamente anonima. Il crimine organizzato si è spesso infiltrato nel sistema economico del proprio paese. Nel passato, ad esempio, la mafia, aveva propri interessi in vari settori dell’economia del paese di appartenenza. Oggi non vi sono più confini cosi ben delineati, infatti, la stessa mafia italiana, ad esempio, ha interessi economici nel sistema delle industrie chimiche di vari paesi dell’Europa, cosi come in industrie dei paesi dell’ex blocco sovietico e dell’America. Internet e il crescente sviluppo del c.d. e-commerce, presentano un nuovo terreno fertile per le infiltrazioni criminali. Tutto ciò, dovrebbe suggerire alle varie componenti del sistema economico finanziario (connesse con internet) di prestare attenzione ai futuri soci e sostenitori finanziari. In buona sostanza, il sinergismo fra crimine organizzato e internet è, non soltanto molto naturale, ma anche destinato a fiorire e a svilupparsi ancora in avvenire. Internet fornisce nuove frontiere e permette guadagni considerevoli con un livello molto basso di rischi. La multiformità delle varie forme del crimine informatico è collegata, strettamente, a una seconda tendenza, distinguibile, soprattutto, nel settore economico finanziario, individuabile nel contesto penalistico, nell’area dei c.d. crimini dei colletti bianchi. Durante la fine gli anni ‘90, numerosi sono stati i casi di organizzazioni criminali che hanno sfruttato internet, soprattutto nel settore del c.d. e-commerce. Tutto questo è stato fatto con coercizione e attraverso il controllo totale degli istituti di mediazione economico-bancaria. Internet, inoltre, è stato usato per distribuire informazioni che hanno determinato artificialmente il prezzo dei mercati borsistici. Negli Stati Uniti, i clan mafiosi coinvolti in questo genere di affari erano membri delle famiglie Bonnano, Genovese e Colombo, come pure membri immigrati appartenenti alla mafia russa. La relativa compiacenza ad usare la forza e l’intimidazione si adatta molto bene allo sviluppo della cyber-estorsione. Nei confronti dell’industria di internet, ad esempio, l’estorsione si concretizza, spesso, nella minaccia di interrompere le informazioni e i sistemi di comunicazione e di distruggere dati importantissimi. Lo sviluppo dell’estorsione telematica è una nuova tendenza significativa della criminalità moderna. Gli schemi di un’estorsione nel mondo reale, a volte, sono individuabili; al contrario, in rete, possono essere realizzati, anoni120 Forme di criminalità mamente, subendo rischi modesti e realizzando alti profitti. Questa potrebbe essere una forma di reato notevolmente sottostimata. Il crimine organizzato si sta spostando dalla dimensione reale a quella virtuale, spinto dalle numerose vulnerabilità che derivano dai sistemi informatici. I cybercrimes, quando sono collegati al crimine organizzato, presentano molteplici problematiche che coinvolgono sia i meccanismi di indagine, sia quelli giurisdizionali. Un esempio delle problematiche suddette proviene proprio dal virus insetto dell’amore, che si è diffuso in molti Stati ed è costato migliaia di milioni di dollari. Quando gli agenti del FBI sono riusciti a identificare il colpevole, uno studente filippino, hanno scoperto che nella sua Nazione non c’erano leggi in virtù delle quali lo stesso poteva essere incriminato. Le Filippine, successivamente, hanno adottato una legislazione sui cybercrimes e molti altri paesi di quell’area hanno fatto lo stesso. Nonostante ciò, i vuoti legislativi e giurisdizionali rimangono, consentendo, ai criminali e agli hackers, l’impunità. Effettivamente, è possibile che alcuni Stati cerchino di sfruttare sempre di più un atteggiamento permissivo per attrarre il commercio illecito e garantire zone franche in cui sicurezza ed impunità sono caratteristiche essenziali. È sempre più probabile che internet sia usato per le attività di riciclaggio di denaro sporco, trasformandosi, così, nel mezzo con cui si sta sviluppando il commercio internazionale. Le aste in linea, ad esempio, offrono opportunità di spostare denaro attraverso gli acquisti apparentemente legittimi, pagando molto di più del valore reale delle merci. Con questi ed altri meccanismi, è possibile spostare soldi verso i centri finanziari dei c.d. paradisi fiscali (es. Caraibi). Inoltre, poiché le operazioni bancarie elettroniche diventano sempre più diffuse, le occasioni per celare il movimento dei proventi del crimine e delle transazioni illegali si sta perfezionando di giorno in giorno. Lo svilupparsi dei collegamenti tra hackers e crimine organizzato è sempre più preoccupante. Nel mese di settembre del 2002, per esempio, due membri di un gruppo conosciuto in America con il nome di Phonemasters sono stati condannati per la violazione dei sistemi di elaborazione dati di numerose aziende di telecomunicazioni. I due cibercriminali avevano rubato vari sistemi cifrati di crittografia che hanno venduto ad alcuni gruppi appartenenti alla criminalità organizzata americana ed italiana. La nuova criminalità organizzata utilizza internet per le comunicazioni cifrate e per tutti gli altri scopi, di conseguenza, un sistema cifrato di crittografia può essere molto vantaggioso (es. ordinare un omicidio via internet o reclutare donne per lo sfruttamento della prostituzione o vendere armi e organi umani). Perciò, il crimine organizzato, si sta dimostrando flessibile all’utilizzo di tutte le opportunità offerte dalla telematica. Le implicazioni sono di grande portata e naturalmente richiedono una risposta forte dei vari governi a più livelli (nazionale ed internazionale). La risposta alla sovrapposizione crescente fra crimine organizzato e cybercrime richiede una strategia completa. 6.6 La criminalità stradale Il problema merita un’attenta analisi nelle sue articolazioni logiche: preliminarmente, non può dubitarsi in alcun modo, della rilevanza criminologica delle condotte di chi si pone alla guida di un’autovettura (come se impugnasse un’arma) e con atteg121 Criminologia ed elementi di criminalistica giamento colposo, spesso cosciente, cioè consapevole delle gravità delle possibili conseguenze, pone a grave rischio l’incolumità altrui. Peraltro, si è correttamente osservato che, nell’ordinamento giuridico italiano, il legislatore è orientato nel senso tradizionale di considerare il delitto colposo come meno grave e, perciò, sanzionabile più lievemente di quello doloso. Si tratta di un punto di vista classico, incentrato, soprattutto, sulla colpevolezza, ma che tiene poco conto della pericolosità, oggettiva e soggettiva, della delinquenza colposa della società moderna. In effetti, la tendenza alla deresponsabilizzazione della criminalità colposa, propugnata dalla volontà del legislatore e dallo stesso orientamento, assolutamente prevalente della giurisprudenza, non può assolutamente essere supinamente condivisibile, in ragione della gravità e della frequenza del fenomeno, fortemente legato al progresso tecnologico, all’automazione dei procedimenti industriali, all’enorme diffusione della motorizzazione e ai mille riflessi della trasformazione scientifica e tecnica della società contemporanea. Vi è, infatti, una considerazione fondamentale da svolgere, gravida di conseguenze sotto il profilo dell’effettività delle sanzioni e perfettamente coerente con i principi generali regolanti il nostro codice penale: se, in astratto, può essere condivisa una minore colpevolezza del criminale colposo rispetto a quello doloso, tuttavia, non certo minore è la pericolosità sociale dell’autore del reato, che anzi, sovente, manifesta peculiarità di particolare valenza criminogena, al punto che si è ritenuto di equiparare, per esempio, il delinquente stradale ad una specie di bomba innescata, pronta ad esplodere contro chiunque. Sotto un profilo vittimologico, inoltre, il pirata della strada presenta connotati di elevata pericolosità, poiché agisce contro vittime fungibili, cioè, non pone in essere la propria illecita condotta nei confronti di un soggetto ben individuato, ma è pronto a rivolgerla verso un’amplissima generalità di consociati, che si traduce in veri e propri bollettini di guerra che quantificano quotidianamente i caduti per causa della circolazione stradale, con picchi particolarmente elevati a ogni fine settimana. Si è proposto di classificare i rapporti tra il criminale e la sua vittima nella circolazione stradale, di non semplice delineazione dogmatica, in alcune situazioni fondamentali: a) reati stradali in cui si può rilevare la presenza di particolari rapporti comuni tra criminale e vittima; b) reati stradali senza vittime, tipica la guida in stato d’ebbrezza allorquando il criminale sia fermato prima di provocare incidenti; c) reati stradali con vittime ma senza trasgressori, perché gli stessi si danno alla fuga e restano ignoti; d) reati stradali in cui il trasgressore è anche vittima, tipici gli incidenti in cui il conducente riporta lesioni per un incidente dovuto ad eccesso di velocità. Tali situazioni si aggiungono a quella della c.d. vittima innocente, che non influisce in alcun modo sulla genesi del reato e subisce solo gli effetti della condotta del reo, situazione che contraddistingue la maggior parte degli eventi infortunistici. Il bene primario da tutelare in tale contesto, la sicurezza della circolazione, è costituito dall’interazione di tre elementi, e cioè, anzitutto, la strada, con le sue caratteristiche fisiche e strutturali su cui possono influire sensibilmente le condizioni metereologiche; in secondo luogo il veicolo, con i suoi dispositivi di sicurezza, ed infine l’uomo, che riveste una priorità centrale essendo la causa largamente principale degli infortuni sulla strada. Un approccio corretto del fenomeno, quindi, non può prescindere da una preci122 Forme di criminalità sa tipologia di fattori, che hanno natura tecnica, natura medico-legale e psicotecnica, e infine natura giuridica e giudiziaria: 1) sotto il primo profilo, devono essere attentamente valutati gli standard qualitativi nella costruzione di autoveicoli e dispositivi di sicurezza in genere, dall’altro, la realizzazione di strutture stradali sicure ed idonee a sostenere il peso del traffico stradale attuale, nelle più diverse condizioni climatiche. Il bilancio può considerarsi sufficientemente positivo sotto il primo aspetto, giacché, significativi miglioramenti, sia nella struttura degli autoveicoli( difesa dell’abitacolo mediante scocca assorbente l’urto) sia nei sistemi di sicurezza attiva (ABS, sistemi di navigazione antisinistro ecc.) e passiva (cinture di sicurezza, poggiatesta anatomici a sella, airbags ), si sono indubbiamente avuti grazie agli investimenti di ricerca delle case automobilistiche; 2) il fattore uomo è assolutamente centrale nell’ottica della sicurezza stradale, giacché ricerche attendibili hanno dimostrato come ad esso vada ricondotta una percentuale elevatissima dei sinistri, non inferiore al 80/90% degli eventi dannosi. Ciò investe problematiche di natura medico-legale e psicotecnica, inerenti l’effettiva idoneità e attitudine alla guida e ai sistemi di accertamento delle stesse ai fini del rilascio e del mantenimento dei documenti abilitanti, nonché problematiche di tipo criminologico, ove si tenga conto che molti sinistri non conseguono a eventi accidentali, bensì, costituiscono il riflesso di una vera e propria scelta sottoculturale del conducente, che imita modelli di condotta che si ispirano alla violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. Si tratta di un fenomeno di particolare interesse, dal momento che costituisce la causa principale dell’infortunistica stradale, che deve essere oggetto di attenta valutazione al fine di determinare un trattamento sanzionatorio caratterizzato da effettività. In effetti, la criminalità stradale costituisce una forma di devianza criminale vera e propria, che si alimenta in forza dello scarso disvalore sociale attribuito agli eventi infortunistici stradali e, parallelamente, dalla limitata effettività del regime sanzionatorio. Sotto il profilo del sesso, pur esistendo una maggiore incidenza di sinistri causati da maschi, vi è una progressiva tendenza alla piena assimilazione tra uomini e donne in relazione alle trasgressioni stradali, pur con peculiarità specifiche (per esempio, la donna ha molta più difficoltà dell’uomo a guidare al buio, e in tali condizioni aumenta molto la sua sinistrosità): infatti, il rischio medio, cioè la frequenza media dei sinistri in rapporto alle auto circolanti, valutata in centesimi, si attesta nel 12% per le femmine e nel 13, 5% per i maschi. La maggiore sinistrosità dei maschi, peraltro relativa, trova corollario nella valutazione degli effetti degli incidenti che, se provocati da maschi, sono molto più gravi: si è potuto constatare che i maschi provocano 1 morto ogni 4 feriti, le femmine 1 morto ogni 7 feriti. Le problematiche inerenti alle condizioni fisiche e psicologiche del trasgressore introducono la necessità di valutazioni medico-legali e psichiatriche: quanto alle prime, s’impone un accertamento specifico e approfondito sull’idoneità alla guida, in relazione ad eventuali handicaps motori, visivi, uditivi e fisici in genere, e una indagine su de123 Criminologia ed elementi di criminalistica terminati connotati fisiologici, quali la resistenza alla stanchezza e al sonno, che svolga un ruolo educativo sul conducente in relazione alla sua condotta futura. Quanto poi alle condizioni psichiatriche, è fondamentale individuare tutte le psicosi incompatibili con la sicurezza della circolazione che potrebbero risolversi in fattori criminogeni particolarmente gravi: si è, per esempio, potuta riscontrare un’elevata correlazione tra il c.d. disturbo antisociale della personalità e la sinistrosità stradale; come pure si sono individuate alterazioni quantitative di caratteri psicologici normali (psicopatie legate a caratteri aggressivi, esibizionisti, stressati), tra le quale la c.d. risk taking behaviour (propensione a comportamenti a rischio), che costituiscono fattori predisponenti alla violazione di regole di sicurezza stradale, assimilabili all’assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. La guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti è un fenomeno di drammatica gravità in relazione ai fatti criminosi da circolazione stradale, al punto che, su questo versante della sicurezza, è necessario estendere significativamente la prevenzione e la vigilanza, individuate dalla dottrina anglosassone come law enforcement, giacché, gran parte delle contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza vengono rilevate solo in occasione dei sinistri, circostanza che ben illustra la carenza di controlli preventivi. Si sono potute individuare alcune caratteristiche personali strettamente correlate a fatti infortunistici. Si tratta, anzitutto, di connotati psicosomatici, costituiti da alterazioni, insufficienze o disfunzioni tali da implicare difficoltà nella realizzazione di manovre di media ed alta complessità, che si risolvono in vere e proprie predisposizioni agli incidenti (accident prones). Tali fattori possono avere non solo natura fisiologica o psicomotoria, ma anche psicologica, con particolare riferimento alla c.d. recidiva sinistrosa e alla conseguente paura di rivivere l’esperienza del sinistro, che paralizza il conducente e lo predispone a subìre altri incidenti (fenomeno particolarmente diffuso per il sesso femminile), oppure, infine, sociale: infatti, la frequentazione di discoteche, con la conseguente prolungata esposizione a giochi violenti di luci e a rumori costanti superiori a 40 decibel, costituisce, a prescindere dall’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, un rilevante fattore predisponente al sinistro; analogamente, l’uso ormai frequentissimo di telefoni cellulari in assenza di dispositivi viva-voce determina una rilevante menomazione della condotta dell’autovettura (specie se priva di cambio automatico) e nel livello di concentrazione alla guida, senza che a tale comportamento consegua un trattamento sanzionatorio adeguato. Non si può sottacere, in una siffatta analisi del fenomeno, l’incidenza rilevante del fattore inerente la nazionalità: è dato di fatto, inequivoco ed evidente, che i cittadini extracomunitari si rendono responsabili al volante di autoveicoli di condotte criminali di elevatissima pericolosità, e altrettanto alta incidenza statistica, per una molteplicità di fattori spesso interattivi: nella normalità dei casi, gli extracomunitari hanno conseguito la patente di guida nei loro paesi d’origine, ove le condizioni di traffico sono imparagonabili a quelle della nostra realtà sociale, per intensità e strutture viarie; ciò fa sì che gli stessi siano gravemente inabili e pericolosi nel coinvolgimento in condizioni di traffico denso e complesso, e di fatto, determinano con elevata frequenza sinistri anche gravi; in talune situazioni patologiche ad elevatissima frequenza, gli extracomunitari, approfittando delle difficoltà di accertamento e controllo, si pongono alla guida privi di adeguati corsi di apprendimento e con patenti false, apparentemente 124 Forme di criminalità rilasciate dai paesi di origine; in casi assai frequenti, le condizioni di disagio personale e sociale, dovute alle difficoltà di inserimento nel nostro Paese, determinano l’abuso di sostanze alcoliche se non stupefacenti, i cui riflessi sull’idoneità alla guida sono tristemente e tragicamente noti: ciò ha portato a numerose recenti stragi, poste in essere, irresponsabilmente, da extracomunitari. La necessità di verificare l’idoneità psicotecnica, sotto ogni profilo, alla guida di veicoli a motore di ogni tipo da parte di tali soggetti, è, pertanto, un dovere ineludibile da parte delle autorità preposte nel nostro ordinamento giuridico. In una prospettiva generale, l’autorevole dottrina penalistica (Mantovani) riconduce la predisposizione a violare norme sulla circolazione stradale a: 1) cause psicosomatiche, tra le quali la carenza di intelligenza e la conseguente limitata capacità di prevedere ed evitare il sinistro; 2) fattori caratteriali quali l’aggressività, l’asocialità e la tendenza a commettere comportamenti devianti; 3) trasmissione subculturale dei comportamenti illeciti stradali. Lo stesso autore, in un’ottica criminologica, distingue i delinquenti stradali in: a) conducenti accident prones per cause psicosomatiche o psicotecniche, per i quali, la prevenzione si esplica mediante interventi restrittivi o limitativi della patente di guida (divieto di guidare di notte o in strade a scorrimento veloce ecc.); b) conducenti che sono criminali della strada così come sono criminali comuni, per i quali, la attività preventiva si deve ispirare alle strategie generali per la prevenzione dei comportamenti devianti; c) conducenti normali che trasgrediscono le norme stradali per assimilazione a modelli sottoculturali appresi per imitazione, che sono la tipologia più numerosa e in relazione ai quali l’attività preventiva, di tipo culturale ed educativo, potrebbe determinare i risultati più significativi. È necessario intervenire con urgenza sul trattamento giudiziario e sulla politica criminale cui si ispira il legislatore, che non può prescindere dagli apporti empirici delle scienze criminologiche. 6.7 La criminalità bianca (o dei colletti bianchi) Negli Stati Uniti, nel 1939, l’espressione criminalità dei colletti bianchi diventò celebre grazie a Sutherland. Il capo della General Motors aveva scritto un’autobiografia con il titolo Autobiografia di un colletto bianco, dove riprendeva la distinzione americana tra colletti bianchi e colletti blu, dando ad intendere di essere un operaio, ma col colletto bianco. Sutherland riprende la dicotomia, rovesciando l’immagine, fino ad allora prevalente, e secondo la quale la criminalità era un problema dei ceti popolari. Rovesciando questo impianto concettuale, Sutherland scrive un classico della letteratura scientifica per il quale, si dice spesso, avrebbe ricevuto immediatamente un Nobel della criminologia se fosse esistito un tale tipo di premio. In brevissimo tempo, le analisi di Sutherland diventano famosissime e danno vita a una vera e propria Scuola. Il termine criminalità dei colletti bianchi è riferito, prevalentemente, alle impunità delle alte figure dell’economia, accusati di compiere crimini che sfuggono facilmente ai rigori della legge: nell’esercizio di molte attività tipiche dei colletti bianchi, parecchi comportamenti sarebbero oggetto di valutazioni erroneamente clementi, comprensive, innocentiste. Reati tipici 125 Criminologia ed elementi di criminalistica della criminalità dei colletti bianchi sono la frode fiscale, la frode commerciale, e così via. La mancanza, a volte, di un rapporto diretto dell’autore del reato con la vittima e la difficoltà, a volte, di individuare una vittima specifica, sono fattori importanti nella valutazione sociale del reato. Un aspetto rivelatore del basso livello di reazione sociale e di censura sociale è l’uso frequente dell’aggettivo disonesto, invece che criminale, nei confronti degli autori di questi reati: essi, spesso, non vengono stigmatizzati come delinquenti dalla collettività, e non si considerano delinquenti. Tre aspetti, soprattutto, sono messi in rilievo da Sutherland e dagli studiosi che hanno sviluppato queste tematiche: 1) la criminalità dei colletti bianchi è assassina, sia nel senso che, spesso, le conseguenze dei reati sono devastanti non meno di quanto avviene con la violenza personale. Basti pensare al campo delle sofisticazioni alimentari o al traffico di rifiuti tossici: questo tipo di criminalità ha indubbiamente conseguenze assassine e per numeri elevati di persone. In particolare, nota Sutherland, questo tipo di criminalità uccide il senso di responsabilità e di civismo: mentre una violenza personale riunisce i cittadini nel deprecare quanto avvenuto e li induce a riaffermare i principi fondamentali della convivenza, la criminalità dei colletti bianchi mina la fiducia nelle leggi e nello Stato, distrugge la certezza del diritto e le motivazioni dell’agire morale. È assassina sia delle nostre vite sia della possibilità di stare insieme decentemente e umanamente; 2) la criminalità dei colletti bianchi tende naturalmente a nascondersi, a mimetizzarsi, a camuffarsi. Poiché la criminalità dei colletti bianchi è propria delle alte sfere della società (anche se poi si allarga socialmente e coinvolge un ampio numero di persone), questi reati vengono occultati in un’ampia gamma di modi. Chi detiene il potere ha i mezzi per tentare efficacemente di nascondere la propria criminosità, oppure di presentarla sotto una falsa luce, o ancora di dare informazioni erronee, oppure di minimizzare il senso di informazioni vere, o di sopprimere la possibilità di diffusione e di circolazione di alcune informazioni. In conclusione, la criminalità dei colletti bianchi è misconosciuta; 3) la criminalità dei colletti bianchi è impunita, anche perché misconosciuta, è spesso assassina. I motivi sono molteplici e anche facilmente intuibili. Innanzitutto, la possibilità di scoprire e provare questo tipo di crimine è in larga misura possibile soltanto ai poteri pubblici, che, teoricamente, hanno i mezzi per scalfire il muro di omertà, di connivenza, di protezione che circonda questo tipo di crimini. Gli stessi poteri pubblici sono, però, in larga misura, connessi con le stesse persone che dovrebbero perseguire. La connessione contempla un grande numero di possibilità, che vanno dalle parentele vere e proprie alle parentele più efficaci in questo ambito: affari in comune, favori reciproci, divisioni di un bottino che spesso proviene dall’affarismo della politica e dell’intervento pubblico. La fonte primaria per la criminalità dei colletti bianchi è la collusione con i poteri pubblici, dunque, come può meravigliare che il potere pubblico nelle sue molte facce (di vigilanza e di controllo, di investigazione e di repressione) lasci spesso impunita questo tipo di criminalità? Questi aspetti della criminalità dei colletti bianchi, sottolineati da Sutherland e da tutti gli studiosi interessati al tema, hanno enorme rilevanza per quanto riguarda l’ingiustizia amministrativa che vorrebbe spesso risultare assassina, misconosciuta, impunita. 126 Forme di criminalità 6.8 La delinquenza e il teppismo allo stadio Tifo, divertimento, entusiasmo, ma anche violenza, inciviltà e tafferugli. Sono ormai questi gli elementi che caratterizzano il calcio, non solo italiano, e le partite allo stadio. Le cronache di atti di violenza in Italia sono ormai numerosissime, mentre all’estero sono note le ostili rivalità tra i tifosi dei club inglesi (i cosiddetti hooligans) e quelli spagnoli, che, pur avendo pessima reputazione in argomento di civiltà, evitano tutti i problemi, perché giocano all’interno di impianti sportivi che, grazie all’assenza di ringhiere offrono uno stretto contatto tra pubblico e giocatori, ma senza rischi. Da non trascurare sono gli scontri tra opposti schieramenti durante il pre-partita, quando si accendono rivalità che crescono a tal punto da provocare numerosi arresti, feriti e, nel più tragico dei casi, morti. Tutto questo è sicuramente favorito dall’inciviltà, ma anche dagli schieramenti di polizia, inadeguati, talvolta, a fronteggiare migliaia di inferociti ultras. Oltre alle violenze fisiche ci sono anche quelle psicologiche, fatte di cori razzisti e striscioni che scagliano improperi contro popolazioni africane e contro ebrei. Tutto questo è, di solito rivolto ai tifosi e ai giocatori avversari, ma, spesso, anche la propria squadra è oggetto di contestazione per cattiva gestione o scadenti risultati: così, si innervosiscono anche gli stessi giocatori che in campo si lasciano coinvolgere in zuffe che eccitano ancor più i tifosi e inducono sugli spalti ad atti di delinquenza, violenza e inciviltà. In questi casi, sarebbe meglio che i campioni presi come modelli dagli ultras dessero il buon esempio con atti di fair play nei confronti degli avversari. Fortunatamente, ci sono anche gruppi di calciatori che invitano alla pace e non alla violenza: contro la guerra, addirittura, scendono in campo con delle magliette che indicano le loro idee ed invitano i tifosi, prima delle partite, a non lasciarsi andare ad atti di teppismo che rovinerebbero quella che, indipendentemente dal risultato finale, sarebbe una festa e un’occasione di divertimento. Le recenti disposizioni in tema di presenza negli stadi e i comportamenti all’esterno degli stessi, stanno cerando, comunque, di contenere tale delittuosità. In qualche caso, le partite vengono giocate senza la presenza di spettatori. La criminologia, già da tempo, oltre a occuparsi dello studio della violenza negli stadi, si occupa anche di costruire la personalità e il profilo psicologico del tifoso, anche se ciò, può contribuire, solo in parte, a dare risposta alle fenomenologie di violenza calcistica. Per i fanatici del calcio, il non tifoso è un soggetto con il quale, nello spazio sociale quotidiano, spesso, non si ha assolutamente nulla in comune, e con il quale è persino difficile comunicare, mentre il tifoso di un’altra squadra è percepito come un vero e proprio nemico. L’appartenenza ad un gruppo di tifosi è diventato uno dei principali strumenti di identificazione collettiva nella società moderna, e una delle principali fonti di significato nella vita di molte persone. Il tifoso è un soggetto che dirige il proprio comportamento in vista di un fine e secondo le aspettative del gruppo; per gli adolescenti, in particolare, tale aggregazione, contribuisce alla costruzione dell’identità. Chi entra nel ruolo di tifoso ultra trova, in particolare, un’identità già predisposta, con il suo corredo di norme, valori, sanzioni, credenze, ragioni e modelli d’azione. Per tali motivi, bisogna considerare la cultura di un gruppo di ultras come una cultura forte, capace di 127 Criminologia ed elementi di criminalistica trasformare la curva in un territorio in cui, al di là della provenienza sociale, delle motivazioni e degli stimoli soggettivi, dei differenti stili di vita, valgono per tutti i giovani tifosi le medesime regole e norme. Le cose cambiano quando questa cultura, che si esprime attraverso esibizioni e spettacoli all’interno degli stadi, risulta incapace di gestire l’uso della violenza, e qualche unità, soprannominata cellula autonoma, pur agendo nella curva degli ultras, non si identifica nelle regole, spesso ferree, del gruppo. È anche possibile che la cellula autonoma non abbia alcun tipo di connessione con il gruppo degli ultras, ma si mescoli ad essi per confondere. La nuova generazione degli ultras (denominati cani sciolti) ha un’età media compresa tra i 13 e i 35 anni, ma non è organizzata, gestita, guidata; la ingente mobilitazione e presenza delle Forze dell’Ordine in servizio, spesso, rappresenta, per questi nuovi gruppi, un motivo di ulteriore compiacimento per vedersi così osservati e sorvegliati, ma anche un avversario (dentro e fuori dallo stadio) con il quale misurarsi, sfogarsi gratuitamente, esibirsi, sfidare, perché, è noto che alle provocazioni e alla violenza, in qualche modo, sono tenuti a rispondere; ciò è verificabile nel caso di attacchi immotivati alle Forze dell’Ordine, anche quando i tifosi avversari sono già andati via. La violenza fuori dagli stadi è, spesso, un meccanismo complesso, alla cui base, non sempre esiste una motivazione coerente, seppur psicologica; al contrario, quello che sembrerebbe un atto intimidatorio, quale può essere il caso dell’aggressione dei supporter avversari, o aggressione indiscriminata (verso cose o soggetti diversi) può nascondere ben altro, altri progetti, o segnali anche di vendetta, spesso metabolizzata. Gli atti di violenza riescono ad aggregare, in pochissimo tempo, decine, centinaia di persone, condizione favorevole, poichè la folla violenta è quella che consente di mimetizzarsi, di scappare, di confondersi. L’assenza di motivazione si traduce in distruttività gratuita di cose o di esistenza umana, chiunque esso sia, ed è associata, soventemente, alla devastazione di luoghi pubblici, quali gli stessi stadi o vie adiacenti, gli autogrill, i treni, le autostrade di collegamento, i veicoli di altri cittadini. La violenza dell’ultra, intesa sia in un’ottica collettiva (ultras organizzati) che in un’ottica individuale (cani sciolti), non può essere indubbiamente osservata a prescindere dal resto della società, da cui assimila e accoglie tensioni e conflitti, che, in un secondo tempo, vengono agiti nella circostanza dell’incontro sportivo. 6.9 Il terrorismo internazionale Le associazioni terroristiche transnazionali presentano caratteristiche ben diverse dai gruppi criminali tradizionali, in particolare quelli di tipo mafioso: caratteristiche che costituiscono la loro vera forza, perché le rendono più sfuggenti alla conoscenza e, quindi, meno permeabili dalle indagini. Mentre le associazioni mafiose sono caratterizzate da forte strutturazione e radicamento territoriale, le cellule islamiche non sono strutturate rigidamente in un’unica organizzazione gerarchica, ma confederate tra loro, peraltro del tutto informalmente; ruotano intorno a strutture di servizio (finanziario e logistico) come Al Qaida; operano 128 Forme di criminalità con estrema mobilità nell’ambito di una rete transnazionale del terrore, nel cui ambito vengono progressivamente superate anche le identità etnico-nazionali. Anche gli obiettivi di ciascun gruppo possono essere distinti, pur essendo tutti accomunati da un denominatore comune: la guerra santa contro gli apostati e i miscredenti. Il complesso delle cellule disseminate in Italia, in Europa e in Medio Oriente, ricostituitesi a partire quantomeno dalla prima metà del 2002, in continua interazione tra loro e portate alla luce dalle indagini, costituisce una realtà stabile e consolidata, uno strumento pronto ad entrare in azione nella catena dei singoli segmenti operativi (dallo spostamento di un militante allo studio di un obiettivo, da un messaggio telefonico in codice alla collocazione finale di un ordigno), che è destinata a concludersi con l’attentato terroristico vero e proprio. Se, o forse si può dire quando, dove e in danno di quale obiettivo, ciò avverrà (contro uno Stato estero in territorio estero, contro una rappresentanza straniera o un organismo internazionale sedente in Italia, contro un obiettivo italiano all’estero o, in ipotesi, contro un obiettivo italiano in Italia), dipenderà dalle contingenze politiche del momento o dalle concrete occasioni e dagli ordini ricevuti, ma, è certo, anche in ragione dei propositi politico-religiosi di guerra a tutto l’Occidente, resi manifesti ed espliciti quasi quotidianamente, che il momento della decisione troverà le singole cellule già pronte a portare a termine la loro parte di compito. Sotto questo profilo appare evidente che, non solo la materiale detenzione di esplosivi, ma gli spostamenti di militanti, di somme di danaro, di cellulari, le comunicazioni criptate secondo concordati codici numerici, lo scambio di materiale di propaganda finalizzato al reclutamento, la disponibilità di alloggi e soprattutto la produzione costante di documenti falsi costituiscono, anche nei momenti di attesa e anche per molto tempo, le condizioni senza le quali la catena che porta all’attentato terroristico non potrebbe mettersi in moto, sono strettamente funzionali al buon esito di un’azione. Soprattutto la produzione di documenti falsi e sicuri, in cui le cellule italiane sembrano le più abili, costituisce uno strumento essenziale per l’organizzazione, in quanto, tramite essi, i suoi membri possono muoversi abbastanza tranquillamente per i Paesi europei e del Medio oriente, mantenendo i rapporti con gli associati (ben più essenziali e intensi tra paese e paese di quelli che avevano caratterizzato le organizzazioni terroristiche tradizionali), e, portandosi, al momento necessario, sugli obiettivi. Le indagini dirette all’accertamento di tali condotte richiedono un rilevantissimo impegno di mezzi umani, materiali e finanziari, spesso protratto per anni. Ebbene, se non è dubbio che le valutazioni di tali aspetti debbano fare esclusivamente carico all’organo inquirente, mentre il giudice deve restarvi indifferente nel momento decisionale, è evidente che nella valutazione del P.M. in ordine alla impostazione delle indagini, le decisioni dell’organo giudicante assumono un peso determinante. Da qui, l’esigenza non solo di P.M. specializzati, ma anche di giudici specializzati, i quali – nella loro funzione di controllo e garanzia – sappiano cogliere, fin dal primo momento degli atti di indagine, la valenza indiziaria degli elementi acquisiti, e poi controllare per tutto il corso delle indagini lo sviluppo coerente del quadro indiziario dalla sufficienza alla eventuale gravità necessaria per l’emissione del provvedimento custodiale. Dalla valutazione differenziata di materiali processuali, sostanzialmente identici e, in definitiva, dal diverso approccio giurisprudenziale al fenomeno del terrorismo 129 Criminologia ed elementi di criminalistica internazionale, discende il rischio di dislocazione delle indagini da parte degli organi centralizzati di polizia giudiziaria, nelle sedi, in cui la giurisprudenza appare più favorevole all’accusa, con la conseguenza – davvero devastante sul piano del contrasto – che le cellule terroristiche vadano specularmente a insediarsi dove minore è la pressione investigativa e/o più debole il contrasto giudiziario. In Italia, secondo vari organi di polizia, si sta anche assistendo a forme nuove di dislocazione territoriale dei jiadhisti, che, molto spesso, si spostano dalle metropoli e dalle grandi città verso cittadine minori, ove sono obiettivamente più difficili investigazioni efficaci. Più in generale, si stanno registrando segnali di trasferimento di tali soggetti, in ambito europeo, verso i paesi nordici, i cui apparati di polizia non sembrano ancora adeguati alle esigenze di contrasto a questo tipo di criminalità organizzata. 6.10Usura ed estorsioni Altra fonte di cospicui, illeciti guadagni per le organizzazioni criminali è rappresentata dall’attività usuraria e da quella estorsiva che, spesso, è diretta conseguenza della prima, perché, sempre più frequentemente, imprenditori in stato di disagio economico, a causa dell’assoggettamento al pagamento delle pesanti tangenti imposte dai clan, sono costretti a ricorrere a crediti usurari offerti loro dalle stesse organizzazioni criminali. L’azione di contrasto a questi particolari crimini, è stata, da alcuni anni, posta in essere dalla D.D.A., anche perché, il pesante velo dell’omertà che impedisce di annientare questa vera piaga sociale comincia a spezzarsi, e molte indagini sono state concluse positivamente con tempestività, grazie alla collaborazione delle persone offese. Se questa inversione di tendenza, ancora nella fase iniziale, troverà sempre maggior sviluppo, potrà essere detta una parola decisiva nel contrasto ai clan che praticano in maniera ancora massiccia tali forme di reato. Per quanto concerne le estorsioni, va rilevato che gli autori, raramente, vengono puniti, perché rimasti ignoti, innanzitutto, per radicata omertà e anche per la scarsa collaborazione delle vittime per timore di rappresaglie. Per combattere tale grave fenomeno, che tanto turbamento genera nella società e che rappresenta una piaga che affligge, sono sorte varie iniziative da parte di associazioni antiracket per squarciare il muro di omertà e per convincere gli operatori commerciali a denunziare ricatti e minacce subìte, rendendoli edotti sulla possibilità di ottenere i contributi economici previsti dalla legge. Tra i fatti più diffusi, vanno ricordate le estorsioni commesse dai datori di lavoro ai danni dei propri dipendenti, costringendo gli stessi a sottoscrivere buste-paga o quietanze di pagamento di liquidazioni, di gratifica natalizia o di altre spettanze recanti importi, in realtà mai corrisposti (o elargiti in misura inferiore) ai lavoratori, costretti a firmare sotto minaccia di licenziamenti. Tale fenomeno è apparso difficilmente accertabile a causa del timore dei lavoratori di perdere il posto, se ancora dipendenti, oppure di crearsi una fama di soggetti problematici, con scarse possibilità di trovare un 130 Forme di criminalità altro impiego nella zona dove risiedono, se già licenziati. Persistono, sempre, le condotte estorsive poste in essere, anche da stranieri, con la tecnica del cosiddetto cavallo di ritorno. 6.11 Criminalità comune La criminalità comune, con riferimento ai reati di omicidio, consumati o tentati, rapine, estorsioni e furti, con strappo o in appartamenti, pare aver confermato, nell’ultimo anno, una tendenza ad assumere caratteri di pervasività. Non esiste, si può dire, una zona franca rispetto alla presenza di soggetti isolati o piccoli gruppi di malviventi che aggrediscono la vita o il patrimonio dei soggetti più deboli ed esposti. La dimostrazione di questo dato proviene dall’esame dei crimini compiuti in questo campo, analizzata in un lavoro di quotidiano aggiornamento portato avanti in particolare da tutti gli organi di Polizia. Emerge in particolare che, rinforzata la presenza di pattuglie di polizia nelle strade di maggiore frequenza criminale, il numero dei reati, ivi perpetrati, decresce significativamente, rigonfiandosi però in zone limitrofe. In particolare, allorché gli interventi nella flagranza dei reati (che sono, in realtà, gli unici risultati conseguibili, per l’impalpabilità degli indizi che tali tipologie di reati lasciano sul posto o nel ricordo delle vittime) consentono la scoperta dei loro autori, si ha modo di verificare che purtroppo se ne è abbassata, ed anche significativamente, l’età media. A tale dato si accompagna una sostanziale indipendenza, ormai evidente, tra tossicodipendenza e reati contro il patrimonio, elementi invece, in passato, fortemente interconnessi (interconnessione da cui spesso derivavano esiti drammatici di furti e rapine, senza peraltro alcun rapporto proporzionale fra rischio e profitto). Da tale constatazione, si può ricavare una spinta criminogena, non più indotta da pressioni esterne, ma, invece, da modelli comportamentali, da crisi economica, assenza di incremento occupazionale, depressione dei valori, emarginazione e degrado urbano, elementi tutti interagenti con devastanti effetti sulla determinazione delle condotte di reato. In aumento, appare il fenomeno degli scippi, e, in particolare, di orologi di alcune, più prestigiose, marche; fenomeno particolarmente nocivo all’immagine della città, in quanto, rivolto prevalentemente contro i turisti della fascia sociale più elevata (i cittadini napoletani hanno ormai, per lo più, imparato a evitare l’ostentazione di simili beni di lusso). Si è anche potuto accertare, che gli orologi provenienti da tali reati raggiungono gli Stati Uniti (Miami, per lo più), dove viene assicurato uno smercio più facile e redditizio. Altrettanto in aumento è il fenomeno delle rapine, specie nelle strade di più fitta comunicazione, in cui vengono sperimentati metodi con cui fermare e ingannare inizialmente la vittima, sempre diversi e sempre più fantasiosi. È anche vero che i dati presentano una significativa riduzione dei furti in appartamento e (sia pure in maniera meno marcata) delle rapine in banca, ma si ritiene di poter 131 Criminologia ed elementi di criminalistica affermare che ciò dipenda dai mezzi di difesa passiva, ormai assai sofisticati e sempre più diffusi. In forte aumento anche i furti di automezzi, e ormai è improcrastinabile che si proceda a investigazione sulle vere e proprie centrali che dirigono questo traffico, sia per quanto concerne il prelievo delle vetture, sia per quanto riguarda la loro destinazione, una volta, in qualche, modo camuffate e (apparentemente) regolarizzate. La riposta alla criminalità comune non può che consistere in un dispiegamento di forze, organizzate in pattuglie operanti a presidio di aree che, solitamente, non vedevano la presenza di pattuglie di polizia, e che hanno sicuramente ottenuto, grazie alla loro visibilità, risultati non indifferenti dal punto di vista della prevenzione e della deterrenza, Una categoria di reato contro il patrimonio particolarmente dilagante è quella delle truffe alle assicurazioni, che ha visto lo sviluppo di diverse indagini tese alla repressione di veri e propri sodalizi organizzati per frodare le compagnie. Al di là della peculiarità dei singoli gruppi (taluni dediti alla falsificazione della documentazione per la emissione delle polizze, di prestiti da ottenere dalle finanziarie, altri all’alterazione delle polizze stesse, ovvero alle denunzie di falsi sinistri stradali), ciò che colpisce è l’estrema invasività del fenomeno, causata dal fatto che i soggetti che si rivolgono ai truffatori per ottenere significativi risparmi sul premio non percepiscono, a pieno, la valenza illecita della propria e dell’altrui condotta, giustificandosi con l’enorme diffusione della prassi di ottenere un enorme sconto rispetto a premi avvertiti come particolarmente esosi. 6.12Criminalità ecologica Non sembra possano farsi considerazioni ottimistiche in ordine alle caratteristiche della criminalità con riguardo ai reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio. Permane, come negli anni scorsi, un elevato grado di aggressività al territorio sia dal punto di vista urbanistico/paesaggistico, che ambientale. In molti Comuni, specie dove esistono zone non ancora completamente urbanizzate, la regola continua a essere quella della edificazione in assenza di titolo abitativo, edificazione portata a termine con reiterate violazioni di sigilli, nella convinzione che gli inconvenienti derivanti dalla risposta del sistema giudiziario siano di gran lunga inferiori al vantaggio derivante dalla edificazione abusiva. E ciò anche nei Comuni sottoposti a vincoli di carattere paesaggistico. In molte città, a fronte di un numero percentualmente minore di nuove edificazioni, che pure continuano in zone periferiche, sembra assistersi ad un sempre più intensivo sfruttamento del patrimonio abitativo esistente, in assenza di titoli abilitativi, e al di fuori di ogni forma di programmazione. Non sono, inoltre, rare, le comunicazioni di notizie di reato a carico di ignoti per violazione dell’art. 51, comma 3, D. L. vo n. 22/97 con conseguenti sequestri di aree adibite illecitamente a discariche di rifiuti pericolosi e non. Solo di rado, le indagini hanno permesso di accertare la provenienza di tali rifiuti, spesso provenienti da lavorazioni edili. Anche nel campo dello smaltimento dei rifiuti appare del tutto carente l’azione delle pubbliche amministrazioni per l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Ci si vuol riferire all’utilizzo dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 17 del D. L. vo 132 Forme di criminalità n. 22/97 che, rarissimamente, vengono eseguiti in danno dei responsabili e/o soggetti obbligati. Ancora vaste dimensioni, assumono i reati commessi in violazione delle norme di tutela del territorio e dell’ambiente. Nell’ambito di tale quadro, vengono spesso rilevati traffici riguardanti rifiuti tossici nocivi provenienti dal nord Italia che, attraverso sofisticati meccanismi di falsificazione di documenti di viaggio, vengono depositate presso discariche illegali. 6.13Omicidi colposi per infortuni sul lavoro In ordine agli omicidi colposi, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, appare tuttora rilevante l’incidenza delle violazioni alla normativa prevenzionistica nella causazione di infortuni sul lavoro. Particolarmente critico appare il settore dell’edilizia, laddove, si registra il più consistente numero di infortuni gravi e di decessi. Tale situazione imporrebbe un impiego di maggiori risorse nell’attività di vigilanza da parte delle autorità preposte, le quali operano, invece, con personale e mezzi in numero sicuramente non adeguato all’entità del fenomeno, e che sono spesso chiamate a verificare l’osservanza della complessa normativa in materia di sicurezza sul lavoro che, in tempi recenti, è stata oggetto di profonde innovazioni, che, non di rado, hanno dato origine a contrasti interpretativi e a difficoltà anche per gli stessi operatori del settore. Inoltre, il permanere di un alto numero di infortuni gravi o mortali nel settore edile è da ricollegare anche al fenomeno dell’abusivismo edilizio. Invero, laddove la realizzazione di opere è connotata dalla necessità di ultimare in fretta i lavori e dalla superficialità dei committenti e degli esecutori, immediato è il riscontro della violazione della normativa posta a tutela dei lavoratori. Ancora da sottolineare è l’aumento degli infortuni sul lavoro nell’ambito delle c.d. lavorazioni pericolose, ovvero quelle in cui vengono utilizzate sostanze chimiche e in particolare esplodenti che, per l’estrema pericolosità di tale materiale, comporta, spesso, una lesività diffusa, suscettibile di colpire una molteplicità di lavoratori, nonché di generare problemi di pubblica incolumità o di inquinamento ambientale. In relazione proprio a quest’ultimo settore, si sono registrati molteplici infortuni mortali avvenuti in fabbriche aventi ad oggetto la produzione di materie esplodenti. Invariato appare, poi, il numero degli infortuni mortali collegati all’uso di attrezzature e macchinari vetusti o, comunque, non conformi ai parametri tecnici stabiliti dalla normativa posta a tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori. 6.14Criminalità e paranormale Le cronache in questi ultimi tempi, spesso si occupano di casi, a volte inquietanti, di persone che sono rimaste vittime di sedicenti maghi, veggenti, guaritori, cartomanti, subendo, spesso, gravi danni al loro patrimonio se non, addirittura, alla salute. 133 Criminologia ed elementi di criminalistica Da più parti si invoca un intervento del legislatore che ponga freno a questo genere di attività. Anche se la legge già se ne occupa, è sicuramente non sufficiente, e una rapida sintesi, anche se non esauriente, ma indicativa, sui reati di maghi, veggenti, guaritori, cartomanti, potrà, al momento, risultare uno stimolo a denunciare e segnalare alle autorità giudiziarie. Lo svolgimento dell’attività di astrologo, grafologo, chiromante, veggente, occultista non è, di per sé, vietato. Tale svolgimento diventa proibito, e quindi il relativo contratto diviene nullo, per illiceità della causa, se contrario a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume o quando sia addirittura sanzionato da norme penali. Ciò premesso, va precisato che, seppur le predette attività non siano vietate, coloro che le svolgono integrano, nella maggior parte dei casi, gli estremi del reato di cui all’art. 661 del codice penale (abuso della credulità popolare: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a lire 2 milioni – vecchia valuta) e l’illecito di ciarlataneria (ora depenalizzato ex art. 33 legge 689 del 1981, con riferimento all’art. 121 t.u.p.s). È il caso, ad esempio, dei maghi che pubblicizzano e magnificano le proprie capacità attraverso le inserzioni pubblicitarie. In tal senso, merita segnalare le decine e decine di pubblicità ingannevoli sospese dall’IAP e dall’Antitrust, perché contrarie alle norme che disciplinano la pubblicità (per citarne alcuni: Mago Otelma, Mago Benedetto dal Papa, Mago don Cesare, Cartomanzia Servizio sociale, Talismani). Coloro che si professano guaritori, integrano, oltre a quelli sopra evidenziati, il reato di cui all’art. 348 del codice penale (abusivo esercizio di una professione – reclusione fino a tre mesi o multa da lire duecentomila a un milione – vecchia valuta e procedibilità d’ufficio). Il reato di truffa (che spesso ricorre) è più difficile da dimostrare ed è procedibile solo a querela di parte (art. 640 cod. pen.: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da lire centomila – vecchia valuta). In tutti questi casi, il locale ove viene svolta l’attività illecita può essere sequestrato e devono essere apposti i sigilli. Inoltre, le somme corrisposte dalle vittime-clienti devono essere sequestrate e restituite. Se venisse avviato un procedimento penale e tale procedimento dovesse dar luogo ad una assoluzione, i maghi potrebbero immediatamente essere contravvenzionati ai sensi dell’art. 1 comma ultimo, legge 516 del 1982: omessa tenuta delle scritture contabili e denunciati per l’omesso versamento dell’IVA e dell’IRPEF sui redditi degli ultimi cinque anni, compresa una sanzione del 100% sulle somme non versate all’erario. Tutta la giurisprudenza esistente, fino ad oggi, è a favore dei maghi (tutti assolti) a eccezione di quelli che si fregiavano del titolo di dottore, o, eventualmente, per quelli che hanno commesso il reato di truffa, magari affiancato dal reato di abuso sessuale, ed altro. Ma va precisato che la giurisprudenza esistente non fa testo, in considerazione del bassissimo numero di denunce presentate negli ultimi anni. Il reato di abuso della credulità popolare è facilmente dimostrabile. Molti antropologi si sono occupati del fenomeno dei maghi e dell’occultismo nelle televisioni private; e hanno rilevato che se molti di questi maghi sono di una evidente banalità e volgarità, molti altri, al contrario, sono di una tale spregiudicata furberia e anche intelligenza e cultura, da poter facilmente imporsi a gente fiduciosa e sprovveduta. Capire l’imbroglio, per persone evolute, è fin troppo facile: ciò che colpisce è la modernissima organizzazione aziendale del tutto: la strega, la cartomante, l’indovina, che una volta avevano la loro clientela nel quartiere, oggi, si sono dilatate nell’etere. È quasi avvilente che oggi, a tre secoli dalla nascita di Voltaire, 134 Forme di criminalità si debba assistere a questi fenomeni. Ma d’altra parte, lo stesso Voltaire, nel suo Dizionario filosofico, scriveva: “dicono che il mondo vada affinandosi, sia pure lentamente. Ma in realtà esso, dopo essersi ripulito per un pò, ricade nel fango; a secoli di civiltà seguono secoli di barbarie, come l’alternarsi del giorno e della notte”. La protezione degli sprovveduti, dei creduli è ovviamente la ratio della norma, la quale, peraltro, è di una chiarezza assoluta, tanto da rendere superflua qualunque attività interpretativa: in claris non fit interpretatio. È anche ovvio, peraltro, che una certa attività possa essere vietata, cioè costituire illecito amministrativo, pur senza costituire illecito penale. Approfittare della credulità popolare non è consentito; la legge lo vieta per tutelare le masse ingenue e ignoranti: purtroppo, questo ritorno in massa, dal più buio Medioevo dei sortilegi, dei filtri, degli amuleti, delle cartomanzie, si collega, direttamente, al diffondersi nel mondo di superstizioni, di fanatismi, di integralismi più o meno camuffati di pretesa religiosità, di violenze con pretesti ideologici. 6.15Sètte e criminalità Un particolare fenomeno della modernità è il rinnovato interesse per le sètte religiose e la preoccupazione per la loro esponenziale crescita e diffusione collegata al tema del lavaggio del cervello, come metodo di proselitismo e di condizionamento. Nei paesi occidentalizzati, caratterizzati, cioè, da un certo tipo di cultura ed economia, si sono diffusi da tempo, accanto alle religioni tradizionali, nuovi culti religiosi che propongono, ispirandosi a dottrine mutuate dall’Oriente, o creandone di proprie, una nuova dimensione umana. I vari gruppi sèttari si formano solitamente attorno a un leader carismatico che propone o rielabora una dottrina, la quale, alla fine di un percorso spirituale, si promette capace di liberare l’uomo moderno dalle angosce e ansietà della società industriale, ma che in certi casi, tragicamente famosi, ha avuto un diverso epilogo. Tutti questi fattori vengono indicati da studiosi come Cecilia Gatto Trocchi, Michele Del Re, o Jean Vernette, come fattori responsabili del proliferare delle sètte. I nuovi movimenti religiosi propongono una propria soluzione a queste contraddizioni, attraverso una liberazione, un percorso di salvezza o un accrescimento delle innate potenzialità umane per mezzo delle quali l’uomo potrebbe sollevarsi dalla propria condizione per divenire dominatore delle energie vitali, spirituali e magiche dell’universo. La caratteristica comune all’interno dell’infinita tipologia delle sètte è che ognuna di esse si dichiara portatrice di una verità,capace di cambiare il mondo. Ciascuna partendo da una critica dello stato attuale delle cose, propone una liberazione dell’uomo dalle strutture del presente. Le sètte, o nuovi movimenti religiosi, si presentano di diversi tipi. È stata riscontrata la presenza di almeno 600 gruppi nel nostro Paese. Questi, alcuni di maggiore rilevanza per numero di adepti, altri di una certa marginalità, vengono divisi secondo due tipologie: quella dei gruppi esoterico-occultisti (per es. sono compresi i Rosacroce, il Gruppo Raelliano, la Società Teosofica, il Centro Italiano 135 Criminologia ed elementi di criminalistica Firewalking, Damanhur, Ufologia, magia satanica), e quella delle religioni alternative (come gli Hare Krishna, i Testimoni di Geova, La Chiesa dell’Unificazione, i Bambini di Dio). Vengono anche definiti dei valori assoluti di distribuzione dei vari gruppi, sètte e religioni operanti in Italia, a seconda delle regioni. Il primato spetta alla Lombardia, con 75 gruppi esoterici, 9 gruppi di parapsicologia, 35 nuovi movimenti religiosi, 52 gruppi ufologici; a seguire, il Lazio, con 6 gruppi di parapsicologia, 40 movimenti esoterici, 31 religioni, 35 culti ufologici; e il Piemonte, con 1 gruppo parapsicologico, 38 gruppi esoterici, 11 religioni e 40 culti ufologici. Secondo una definizione del direttore del CESNUR (Centre for Studies on New Religions), Massimo Introvigne, il satanismo può essere definito come l’adorazione o la venerazione, da parte di gruppi organizzati in forma di movimento, tramite pratiche ripetute di tipo culturale o liturgico, del personaggio chiamato Satana o Diavolo nella Bibbia. Il teologo può adottare una definizione molto più ampia di satanismo, ritenendo che siano satanisti – anche quando non adorano esplicitamente il Diavolo, o perfino negano la sua esistenza – tutti quei gruppi che manifestano avversione o odio nei confronti di Dio e propongono nello stesso tempo all’uomo di diventare come Dio, servendosi di pratiche magiche e occulte (tanto più quando queste pratiche – come spesso avviene – comportano elementi di immoralità e di violenza). Lo storico e il sociologo hanno bisogno, invece, di delimitare l’ambito del satanismo in modo più circoscritto, per poterne identificare gli elementi distintivi all’interno del mondo molto più vasto dell’occultismo e della magia cerimoniale. Al di là delle definizioni, sebbene le sètte sataniche e il satanismo in generale, per tipologia e modalità operative, si presentino molteplici, due elementi sono pressochè costanti: l’utilizzo della magia (messe nere, evocazioni, magia sessuale, ecc.) e la figura di Satana. Compito delle criminologia moderna è quello di indagare il fenomeno del satanismo, anche se quest’ultimo termine, nella comune sensibilità, è di per sé intriso di negatività e illiceità; gravoso, per la mancanza di un particolare crimine satanista fra le fattispecie penali previste dal nostro ordinamento. L’attenzione posta al satanismo e il grande seguito che ne è scaturito a livello mediatico hanno portato studiosi di sociologia, psicologi, giuristi e antropologi a studiarne le caratteristiche cercando di definire e classificare tale fenomeno. Dai più recenti studi sul satanismo, si possono operare diverse catalogazioni che tengono conto di alcuni possibili differenti aspetti; la più famosa di queste schematizzazioni, tanto da essere richiamata nel Rapporto Italiano sulle Sètte del 1998, entro cui vengono ricondotte ideologie e tendenze sataniste, è quella che distingue tra correnti razionaliste, occultiste e del satanismo acido. Tale suddivisione, nata negli ambienti della sociologia scettica americana degli anni Ottanta, è richiamata da importanti esperti di nuovi movimenti religiosi come Massimo Introvigne e Michele Del Re. La prima forma di satanismo, il cosiddetto Satanismo razionalista, parte da una visione del mondo anticristiana, che considera Satana simbolo della ragione, della morale personale, in luogo delle costrizioni sociali, della ricerca del piacere in se stesso. Il satanismo in questo caso è, più che una religione del Diavolo, una prospettiva atea, scevra da qualsiasi riferimento religioso. Il gruppo più famoso in questa sezione è la Chiesa di Satana, fondata nel 1966 a San Francisco da Anton LaVey. Nel Satanismo occultista 136 Forme di criminalità possono essere raggruppati movimenti che aderiscono alla visione teologica della Chiesa Cattolica, ma anziché rivolgersi a Dio, professano la loro fede nel Satana biblico. Negli Stati Uniti, questo genere di satanismo è il risultato di scismi nella Chiesa di Satana; in Europa, si rifà di più all’occultismo della fine del secolo scorso. Il tempio di Set, una sètta fondata nel 1975 a San Francisco da Michael A. Aquino, in seguito all’apparizione personale di Satana, da cui riceve il comando di venerarlo, non più con il vecchio nome, ma con quello di Set, appartiene a questo gruppo. Il Satanismo acido, invece, comprende gruppi a sfondo sadico, orgiastico o drogastico, dove il satanismo, secondo alcuni studiosi, è il pretesto per atti di violenza, orge e droga-parties. Si tratta, in effetti, di piccolissimi gruppi non strutturati, che si formano e si disfano solo per compiere qualche gesto particolare. Sono quindi gruppi effimeri e disorganizzati, specializzati in crimini rituali e orge, anche se, non tutti i presunti crimini rituali e le orge, hanno sempre a che fare con il satanismo. I satanisti acidi formano piccoli gruppi di circa dieci-quindici persone, sono spesso giovanissimi, si ritrovano per consumare droga, leggere libri satanici e ascoltare il rock cosiddetto satanico. Qualche volta si spingono fino alla profanazione di cimiteri e chiese, o alla messa in scena di rituali nei boschi attorno alle città o ai piccoli paesi. La maggior parte delle notizie e degli allarmismi sul satanismo si riferisce proprio a questi piccoli movimenti, i cui esponenti, o semplici partecipanti, vengono alla ribalta delle cronache, in occasione di omicidi in nome di Satana, commessi da zelanti giovani servitori del demonio, plagiati e guidati dalla sètta, come spesso informano i giornali, oppure spinti da problemi psicologici molto più profondi, che, a volte, trovano origine nella situazione familiare, prima che in quella sèttaria, che spesso si rivela inesistente. L’ultima corrente in cui viene classificato il satanismo è quella del Luciferismo, un satanismo di orientamento manicheo o gnostico, che traduce in miti e riti, teologie in cui Satana o Lucifero è oggetto di venerazione all’interno di cosmogonie che ne fanno un aspetto buono o, comunque, necessario del sacro e della divinità. In questa corrente, il movimento organizzato più noto è quello nato a Londra nel 1961 e scioltosi nel 1974, denominato The Process. Accanto a questa distinzione di gruppi dediti al culto di Satana, si può tracciare una mappa dei soggetti che si muovono entro queste aree: - isolati tradizionali: streghe e maghi che rivestono in società l’abito dello sciamano; sono dotati di speciali legami con l’anti-dio, da consultare per ottenere fatture a morte, imprecazioni, e così via; - isolati dediti a droghe, che godono di visioni sabbatiche e infernali nel trip drogastico; - isolati psicotici, sofferenti di follia religiosa a contenuto satanista. Tra gli associati, sarebbero satanisti in senso proprio, puri, cioè legati al Satana biblico; - i gruppi satanisti tradizionali, che celebrano messe nere e hanno una fede opposta, ma parallela ai dettami cristiani; - i gruppi dediti a droghe; - gruppi di trasgressori sessuali, con tendenze sadomasochistiche e/o tendenze orgiastico-naturalistiche. 137 Criminologia ed elementi di criminalistica Sarebbero impropriamente satanisti, invece: - i seguaci di Baphomet (dio della sfera del divenire, contrapposto a Javè, dio dell’essere, della sfera celeste); - i carismatici, che credono nella rivelazione e nella venuta in terra di Satana, demiurgo buono, capace di riparare la Creazione; - i razionalisti, che identificano il demonio con le forze compresse e represse della nostra civiltà, forze che devono essere rivalutate e portate alla coscienza (influenza junghiana). All’interno dei satanismi, in senso ufficiale, si possono distinguere vari settori: un primo settore è quello dei gruppi - bande che si riuniscono attorno a un leader carismatico satanico che si propone come capo, guida del mondo dell’occulto, atteggiandosi a sacerdote o a servo di Satana, per il semplice fatto di essersi documentato sui vari testi di LaVey o aver imparato a memoria qualche rituale di Crowley. Questi gruppi non possono rientrare nella definizione di movimenti satanisti, o magici, in quanto, mancano di una struttura definita e stabile; l’organizzazione spesso ruota attorno solo a pochi contatti, spesso, semplicemente via internet, con altri gruppi più importanti e famosi, quando non manchino del tutto anche questi. Non hanno un sistema dottrinale e non vi è proselitismo, né volontà di comunicazione con il pubblico, ma rilevano per il fatto che la loro attività, spesso, si traduce in eventi criminogeni, come profanazioni di cimiteri, furti e danneggiamenti ai danni delle chiese locali, e vari altri episodi di teppismo, e rientrano, praticamente, nella definizione di satanismo acido. All’estremo opposto, si collocano i gruppi troppo organizzati, nati sulla base di filosofie complesse e, per questo, poco adatte ad essere comprese e seguite dalla totalità del gruppo, costretto ad una esistenza precaria. Un esempio del genere ci è dato da The Process, una sètta che, rielaborando l’interpretazione di Carl Gustav Jung sulla Trinità e sulla auspicabilità della riemersione del quarto elemento − quello oscuro − ha ideato una liturgia luciferiana basata sulle coppie Geova-Lucifero e Cristo-Satana, studiata anche con osservazione partecipativa del sociologo William Sims Bainbridge, fino alla fine del movimento stesso. Fra questi due estremi, si collocano i nuovi movimenti religiosi satanisti: veri e propri movimenti religiosi, con un sistema dottrinale e teologico che ha al suo centro il Diavolo. I principali sono: - Chiesa di Satana (California): fondata da Anton Szandor La Vey, che ha pubblicato alcuni libri diventati famosi in tutto il mondo: La Bibbia di Satana; Il Libro completo della strega; I Rituali satanici. Anton LaVey si fa chiamare il gran sacerdote di Satana e la sua chiesa si dà dei veri e propri sacramenti satanici: battesimo, matrimonio, funerale. La Marina Militare degli Stati Uniti indicherà la Chiesa di Satana come uno dei gruppi religiosi più diffusi tra i suoi uomini, inserendola in un manuale per i cappellani dove si espongono in dettaglio tutte le necessità spirituali dei marinai. Nel manuale, la Chiesa di Satana viene definita del potenziale umano, 138 Forme di criminalità dove Satana non è un essere antropomorfico, ma rappresenta le forze della natura. Di fatto la filosofia della Bibbia di Satana è questa: la vita è la grande indulgenza, la morte è la grande astinenza. Per questo godetevi il meglio della vita qui e ora. La Chiesa ha grande successo tra i divi di Hollywood, mentre in Europa il più alto numero di lettori delle opere di LaVey è in Italia. La Chiesa di Satana è organizzata in gruppi chiamati grotte, ed esercita la sua attività prevalentemente per posta o via internet, mezzi tramite i quali, si può richiedere l’affiliazione secondo una scala di livelli che parte dal novizio, pagando le cifre stabilite per ogni grado. È il movimento satanista più noto, a cui aderiscono personaggi famosi del mondo musicale come King Daimond e Marylin Manson. Il razionalismo e ateismo vogliono essere le uniche due componenti del credo istituito da LaVey, quando anche la messa nera, una parodia blasfema e ricca di contenuti sessuali della messa cattolica, che ne riprende il cerimoniale in una visione opposta, rappresenta uno psicodramma che deve liberare i cristiani dalle loro superstizioni e non ha nulla di effettivamente magico. Dopo lo scisma intercorso nel 1975 la Chiesa di Satana si è ridotta a operare principalmente per corrispondenza, e dopo un periodo in cui sembra per tramontare, negli anni 1989-1990, grazie alle figlie di LaVey, Karla e Zeena, e a Blanche Barton, nuova compagna del Papa Nero, l’istituzione ha riguadagnato terreno e il suo nuovo bollettino, The Black Flame, ripropone ai giovani adepti la legge del taglione. Oggi, a causa della morte, nel 1997, di Anton LaVey, la Chiesa di Satana è un’organizzazione di vendita per corrispondenza, di tessere, diplomi di membro, e altro materiale; l’organizzazione è rimasta nelle mani di Blanche Barton e di uno dei più affezionati discepoli di Anton Szandor, Peter Gilmore, che hanno spostato la sede a New York. Per quanto riguarda le figlie di LaVey, Zeena ha ripudiato il padre e ora è sacerdotessa del Tempio di Set, mentre Karla, dopo un litigio con la Barton per questioni di eredità, ha fondato, nel 1999, un’organizzazione satanica a San Francisco, chiamata First Satanic Church. - Tempio di Set: Micheal Aquino, tenente del controspionaggio dell’Esercito americano, nel 1969 conosce LaVey e, in pochi anni, diventa il suo braccio destro, l’autore di vari rituali e il direttore del periodico della Chiesa di Satana The Cloven Hoof. Nel 1975, Aquino si allontana da LaVey, apparentemente per problemi organizzativi, ma, in realtà, per il classico conflitto fra il satanismo razionalista di LaVey e idee decisamente più occultiste e convinte della realtà di Satana come essere personale. Aquino professa una grande magia nera, legata a un mito gnostico, secondo cui, il creatore del mondo avrebbe voluto negare agli uomini l’intelligenza e questi l’avrebbero ricevuta dal Principe delle Tenebre, dalla cui parte sono chiamati a schierarsi, sfidando le presunte leggi morali del mondo, che derivano dal Dio creatore limitato e ostile all’uomo. Oggi è la maggiore organizzazione satanista su scala mondiale. - Chiesa della liberazione satanica: nel 1986 un professore di inglese, Paul Douglas Valentine, fonda nel Connecticut la Chiesa della Liberazione Satanica, che appartiene alla stessa corrente del satanismo occultista di Aquino e si ispira anche ai modelli ottocenteschi descritti in romanzi come Là-bas di Huysmans. 139 Criminologia ed elementi di criminalistica - Ordine del lupo mannaro: un autore di scritti sul satanismo, Nikolas Schreck, fonda, nel 1984, l’Ordine del Lupo Mannaro (Werewolf Order). Schreck si ispira a LaVey, ma l’aggressività nei confronti del Cristianesimo è particolarmente violenta. I riferimenti al nazional-socialismo hanno suscitato simpatie in ambienti particolarmente legati al neo-nazismo. - Chiesa della guerra: la Chiesa della Guerra (COWAN) accetta molti degli insegnamenti di LaVey: si dichiara pagana e atea, ma, allo stesso tempo, vuole mantenere gli aspetti validi delle religione, cioè il rituale e i simboli. La Church of War, celebra la vita come guerra di tutti contro tutti, dove non c’è misericordia e contano solo la forza e il coraggio. Satana è il simbolo della guerra, e le guerre come grandi rituali satanici pubblici non devono essere evitate, ma favorite. Non solo l’America è protagonista del fenomeno satanico, in quanto anche l’Italia ha la sua collezione di Chiese Sataniche Ufficiali, gruppi dediti a un satanismo dichiarato, e sono: - Chiese di Satana: a Torino sono presenti due differenti movimenti che si denominano Chiesa di Satana; un gruppo nasce negli anni Sessanta e segue l’impostazione filosofica della Chiesa di Satana di San Francisco, basandosi sulla Messa Nera secondo la versione interna degli adepti di LaVey; - Chiesa della liberazione satanica: trae la sua origine dai contatti con un occultista francese degli inizi del 1970, Claude Seignolle, autore di una serie di opere sulle presenza del Diavolo nella tradizione popolare francese, conquistando una fama insolita. Questa seconda Chiesa di Satana è meno razionalista della precedente, e tenta, con i suoi rituali dal sapore forte, di evocare un Diavolo reale. - O.T.O (Ordo templi orientis): Roberto Negrini, dopo essersi interessato di dischi volanti e avere avuto contatti con diverse branche straniere dell’O.T.O, ne fonda una indipendente, che si denomina luciferiano. Negrini, tuttavia, mantiene ferma l’ideologia originaria di Crowley, per cui solo l’uomo è l’unico dio, anche se una certa dose di ambiguità nei manuali e riti del movimento ha permesso a stampa e televisione italiane di vedere in Negrini un prototipo di satanista italiano. - Confraternita di Efrem del Gatto: Sergio Gatti, vero nome di Efrem del Gatto, fonda nel 1980 a Roma la sua confraternita che ritiene Lucifero superiore a Satana e crede che sia un personaggio realmente esistente. Gatti celebrava i riti luciferiani una volta al mese nel suo Tempio sito nella zona del Monte Sacro, ed esercitava un’attività di mago a pagamento. È deceduto il dicembre del 1998 all’età di 54 anni. - Bambini di satana: le origini del gruppo dei Bambini di Satana Luciferiani di Bologna risalgono ai primi anni Ottanta, e ruotano attorno alla figura del suo fondatore, Marco Dimitri (o Bestia 666, come si definisce lui stesso), ex guardia giurata e ora sacerdote di satana a tempo pieno. Il gruppo celebrava i suoi rituali in casolari diroccati o boschi, oggi ha un tempio a Bologna. I riti comprendono messe nere e messe rosse in cui, secondo Dimitri, tutti hanno rapporti sessuali con tutti, anche di tipo omosessuale, e si ricorre, se del caso, a pratiche sado-masochistiche per scatenare certe energie. Gli adepti possono usufruire di una serie di servizi, che vanno dai matrimoni fra uomo e donna a quelli fra uomo e uomo o donna e donna, o, ancora fra donna uomo e donna, e così via. 140 Forme di criminalità La loro filosofia satanica è riassunta in sei punti: l’esaltazione del vizio; l’arte; la guerra; la scienza; lo spirito, che è orgogliosa confidenza in se stessi; la ricchezza. Nel Vangelo Infernale, Dimitri proclama: “io, Marco Dimitri, dopo la morte di Crowley, la caduta di LaVey e di Manson, data l’idiozia dell’idea dell’esistenza di una Chiesa di Satana, ridicolo controsenso, mi propongo quale riferimento mondiale del culto demoniaco. Il mio fine è essere la giovane guida di tutti i demoni della terra”. Tra il 1989 e il 1992 infiltrati dei carabinieri hanno provocato noie per Dimitri e perfino un’irruzione nel 1992 nel Savignano sul Rubicone, nel Riminese, mentre una sacerdotessa giaceva nuda sull’altare. Le conseguenze penali sono state nulle, ma è in quell’occasione che Dimitri ha perso il suo incarico di guardia giurata. Sicuramente meno famose e ancora per la maggior parte coperte da un velato mistero sono altre sette sataniche individuate: in Piemonte, i Figli di Satana; a Pescara, Le Ierudole di Ishtar (gruppo satanista tutto al femminile); in Liguria, il Sacro Cerchio dell’Alba Dorata. 6.16La criminalità rurale La criminologia, nell’ottica di diversificare i propri interessi, ha spostato anche la propria attenzione verso quei fenomeni illegali riconducibili alla criminalità rurale. Alcune indagini di settore hanno rilevato che le tipologie dei reati più diffusi, che incidono sulla percezione della sicurezza e, quindi, sui livelli di produttività delle zone rurali, vanno dal danneggiamento dei casolari al semplice furto dei prodotti della terra, sino ad arrivare, specie in talune realtà del Mezzogiorno, ai furti di attrezzature e macchine agricole, a volte compiuti per attuare il cosiddetto cavallo di ritorno. Si tratta, in quest’ultimo caso, di una vera e propria estorsione, praticata, con sempre maggiore frequenza, da individui senza scrupoli che, dopo aver contattato la vittima del furto, esercitano su di essa una forte pressione chiedendo una somma di denaro, un ricatto, contro la promessa di farla rientrare in possesso della refurtiva. Un altro fenomeno di particolare rilevanza riguarda il c.d. caporalato, vale a dire quella degradante forma di sfruttamento del lavoro subordinato, consistente nella raccolta e nel successivo trasporto nei campi di manodopera generica, sovente composta da extracomunitari, da parte di organizzazioni, non di rado vicine alla criminalità organizzata. I caporali considerano tale bacino molto economico ed efficiente, soprattutto per soddisfare esigenze di lavoro giornaliero. Il lavoratore immigrato, specie se privo di permesso di soggiorno, in cambio delle sue prestazioni, si accontenta infatti di ricevere vitto, alloggio (non sempre adeguato) e un’esigua retribuzione in nero, senza avanzare pretese riguardo alla prevista tutela previdenziale e assicurativa. L’attività di contrasto posta in essere da Magistratura e Forze dell’Ordine ha portato all’individuazione di altre e, per certi versi, più allarmanti forme di criminalità rurale, che influiscono direttamente sull’habitat e, di conseguenza, sulla sicurezza del ciclo alimentare. Ci si riferisce, in particolare, allo smaltimento e sversamento, entrambi 141 Criminologia ed elementi di criminalistica illeciti, di rifiuti e sostanze inquinanti, nonché alle attività della cupola del bestiame che, dal furto di singoli capi, è passata ai trasferimenti occulti di intere mandrie o greggi per frodare l’Unione Europea, sino ad arrivare alla macellazione clandestina e alla vendita di carni infette. Spesso, le organizzazioni criminali, avvalendosi della compiacenza di alcuni allevatori, reperiscono animali privi di garanzie sanitarie o gravemente malati, che vengono immediatamente macellati in luoghi clandestini. Le carni, previa compilazione di falsi documenti identificativi, vengono immesse sul mercato attraverso una rete di grossisti, collegata al più ampio circuito criminale. Il quadro delineato dimostra che le aree rurali sono particolarmente esposte a forme diversificate di aggressione da parte di una criminalità specializzata, con gravi rischi per l’imprenditoria agricola. Del resto, la natura stessa dell’impresa agricola, assai articolata e sovente frazionata sul territorio, non sempre agevola l’acquisizione di dati utili per attuare interventi mirati. 6.17Famiglia, scuola, mass-media e criminalità a) la famiglia Quanto al primo punto, va subito precisato che molto spesso, soprattutto nelle zone ad alto rischio di criminalità organizzata, la famiglia svolge un ruolo fondamentale per verificare l’incidenza delle riforme sociali, politiche, economiche e culturali dello Stato. Tenuto conto che il livello di benessere economico nelle famiglie è migliorato rispetto agli anni passati, deve precisarsi che la disoccupazione e il livello di povertà del c.d. proletariato sono aumentati. Il tutto non favorisce certamente la famiglia e gli aspetti che all’interno della stessa possono rappresentare fattori di sviluppo della criminalità. Se a ciò si aggiunge l’assenza o la scarsa cultura di base, e l’eventuale stato di disoccupazione, si assiste all’annientamento dell’istituzione famiglia. Le famiglie numerose, disagiate, multiproblematiche, l’uso di metodi educativi errati, la disgregazione familiare e altri fattori contribuiranno, in alta percentuale, ad agevolare l’ingresso dei soggetti più vulnerabili nel vortice del crimine. Nessuno può negare che qualsiasi bambino, per crescere sano, ha bisogno di essere guidato, ha bisogno di essere compreso, necessita di affetti e cure che, soprattutto una famiglia normalmente strutturata, può garantirgli. Il fatto di avere genitori che vivono una vita complicata, che forse sono già entrati nel circuito del crimine organizzato o che vivono in zone dove l’illegalità è norma di vita, significa, per i componenti della famiglia, assenza di punti di riferimento, e alta probabilità di percorrere la stessa strada del genitore o dei genitori. A fronte di ciò, occorre che lo Stato, nell’estrinsecazione della sua politica di prevenzione criminale, intraprenda percorsi che limitino la possibilità che la famiglia si presenti come fattore criminogenetico. Infine, se si pensa che i figli dei mafiosi sono, spessissimo, obbligati ad intraprendere la carriera criminale dei loro genitori si comprende quanto sia importante agire sulle famiglie, non propriamente inserite nel circolo 142 Forme di criminalità mafioso. A tali problematiche, dunque, si può porre rimedio solo mediante un’azione sinergica che promani dallo Stato e si rafforzi con il contributo di tutta la società civile. Gli studi sociali attuali e del passato, pur nella diversità degli approcci utilizzati, hanno sempre cercato di ricondurre la famiglia a dei modelli: pattern. Questi ultimi, purtroppo, non sono esaustivi per definire un ambito in continuo divenire e in repentino modificarsi. Il momento storico-culturale attuale, sempre più improntato e pervaso da concetti quali globalizzazione e per molti aspetti, omogeneizzazione, vede, nello stesso tempo, un concetto e una forma di famiglia sempre più differenziato e profondamente caratterizzato dalla individualità. È opportuno, allora, cercare di capire perché la famiglia, cellula base della società, sempre più spesso, diviene ambito in cui maturano fatti di violenza che degenerano poi in tragedia. Le trasformazioni della società attuale dovute a motivi politici, economici, allo sviluppo tecnologico, all’adozione di modelli culturali distanti, hanno alterato drammaticamente gli equilibri all’interno della famiglia, mettendo fortemente in discussione i ruoli da sempre stabiliti e deludendo, al contempo, le aspettative reciproche dei membri della famiglia. L’Italia fortemente caratterizza e contraddistinta dal concetto di famiglia, rispetto ad altre nazioni europee, travolta dal cambiamento, ha visto cedere uno dei pilastri della propria cultura. L’organizzazione, se vogliamo definirla primaria, il contenitore degli umori individuali, il piccolo clan capace di decidere in maniera del tutto autoritaria del destino dei suoi singoli membri, ora è svuotata del proprio significato. La difficoltà esistenziale nella gestione quotidiana porta gli individui a una continua tensione, tensione dovuta anche alla fortissima competitività su cui si basano molti rapporti sociali e lavorativi; i modelli culturali che si impongono, poi, si basano sul successo ad ogni costo e senza scrupoli, per cui, alla fine, l’individuo si ritrova stretto tra una realtà macrosociale difficile da affrontare e da superare, e una famiglia che non è più capace di dare certezze e stabilità. In questo modo, la via più semplice è quella di scaricare le frustrazioni sui congiunti e tra questi, quelli più deboli come donne e bambini. Non è infatti da sottovalutare l’influenza che i modelli culturali attuali esercitano sull’individuo. b) la scuola Se la scuola è il luogo istituzionale più vissuto dall’adolescente ed assurge al ruolo di pre-mestiere, spesso, è rigidamente orientata alla didattica senza permettere una piena espressione della propria identità e creatività; dinanzi a tali, non rari, fenomeni, spesso, la famiglia delega alla scuola la responsabilità di educare i ragazzi al vivere sociale. La scuola, oltre a essere considerata terreno fertile di cultura, di associazione, di espressione delle diverse personalità, funge, però, anche da specchio: ad esempio, a seconda del clima educativo che si crea in famiglia, il bambino assumerà determinati tratti di personalità, che possono agevolare o compromettere la sua futura socializzazione all’interno di una classe o di una scuola; secondo gli psicologi, genitori iperprotettivi possono limitare fortemente l’autonomia e la creatività del ragazzo rendendolo dipendente; genitori ostili e autoritari possono rafforzare l’aggressività; Secondo Schaefer, il clima educativo può essere di 4 tipi: a) affetto (iperprotezione) + controllo = sottomissione; b) affetto + autonomia = buona fiducia in se stessi; c) ostilità (disapprovazione, norme 143 Criminologia ed elementi di criminalistica troppo rigide) + controllo = eccessiva timidezza, timore, ansia; d) ostilità + autonomia = disadattamento sociale. Uno stato generalizzato di affetto comporterà: sottomissione, dipendenza, buone maniere, obbedienza, scarsa creatività, conformismo, attività, buon andamento sociale, indipendenza, abilità sociale. Uno stato generalizzato di ostilità comporterà: problemi nevrotici o sintomi psicosomatici, disadattamento sociale, timidezza, incapacità ad assumere un ruolo autonomo, immaturità, aggressività. c) i mass-media In questo senso, anche i mezzi di comunicazione di massa hanno la loro parte di responsabilità, soprattutto nel momento in cui propongono realtà virtuali, che vengono metabolizzate dall’io; un misto di apparenza, di ruoli, di dimensioni esistenziali, di estasi, che si traducono in pura illusione/allucinazione. Ciò provoca l’immersione del soggetto in una realtà che invita e, nello stesso tempo, suggerisce, cose impossibili da esperire, irreali, che non appartengono a nessuno, se non, come in questo caso, alla televisione. Dal punto di vista strettamente criminologico e criminogenetico, numerose sono state le teorie che hanno messo in luce la pericolosità reale del mezzo televisivo, soprattutto per gli adolescenti, unitamente al rischio di emulazione di attività e gesta. Analoghe considerazioni riguardano rivista di moda: giovani corpi bellissimi, sinuosi, apparentemente felici, indifferenti alle fatiche del vivere quotidiano. Anche questo è pervasivo e destabilizzante; basti pensare, ad esempio, che in alcuni casi di infanticidio, alcune madri hanno ammesso di aver ucciso il proprio figlio perché ritenuto responsabile di aver sformato il loro corpo a causa della gravidanza; tipici casi in cui gli equilibri sono stati fortemente compromessi e sui quali si vanno ad innestare proiezioni irrealizzabili, che formeranno una miscela esplosiva da far detonare sempre più spesso in famiglia. 6.18La criminalità clericale Anche il rapporto tra criminalità e religione ha costituito fondamento di ricerca per la criminologia; ad oggi, questa connessione risulta indimostrabile. È la storia a fornire alcuni esempi che, in un primo momento farebbero pensare ad attività delittuose da parte del potere religioso, ma che, a una ragionata analisi, si traducono in avvenimenti legati al contingente periodo politico-sociale. Si ha notizia che il primo massacro etnico-religioso avvenne a Costantinopoli il 12 luglio del 400, allorquando settemila goti ariani furono sterminati su iniziativa del vescovo Crisostomo. Poco conosciuto è il massacro di circa ventimila samaritani, avvenuto in Palestina nel 529, a seguito di una loro ribellione, dovuta alle continue persecuzioni cui erano sottoposti dai cattolici. Più note le stragi reciproche fra goti ariani e romani cattolici avvenute in Africa settentrionale e in Italia: in tal caso, si può parlare di vera e propria crociata auspicata 144 Forme di criminalità dal papato, che, quindi, è da considerare mandante e responsabile di tutti gli inenarrabili orrori che trasformarono l’Italia di quell’epoca in un deserto di fame e rovine. Le stragi non si limitavano agli eretici, ma coinvolgevano anche gli ebrei che ad Alessandria d’Egitto subirono lo sterminio parziale e la deportazione totale di questa loro popolatissima comunità, la più numerosa della diaspora. Per la repressione del paganesimo, l’imperatore Teodosio II varò un’ampia codificazione che prevedeva pene draconiane contro chiunque si ostinasse nei vecchi riti idolatrici: l’arte classica fu gravemente colpita da numerose devastazioni di insigni templi e la cultura lo fu dall’incendio dei libri, accusati di essere strumento del culto pagano (esempio famoso il rogo dei libri sibillini). Tutti i centri filosofici furono chiusi, i maestri esiliati o uccisi, come la famosa Ipazia di Alessandria, assassinata con la co-responsabilità del patriarca Cirillo; anche le Olimpiadi furono vietate, i teatri chiusi, trasformati in cave di pietra. In quest’epoca, iniziano le prime stragi fra cattolici determinate dalle ambizioni contrastanti dei diversi gruppi di potere clericali, sia a Roma sia in molte ricche sedi diocesiane. Il 26 ottobre 366, ben 137 fedeli dell’antipapa Ursino, furono massacrati all’interno della basilica di S. Maria Maggiore dai fautori di papa Damaso, tutti mercenari assoldati fra la manovalanza della criminalità dell’epoca. Abbiamo anche i primi casi di papi morti improvvisamente in circostanze da far sospettare un avvelenamento, ma il peggio in questo campo avverrà nei secoli seguenti. La complicità fra alto clero e potere politico imperiale sono state ben evidenziate: la situazione di sistematica intromissione aveva investito perfino la teologia dogmatica, poiché tutti i concili ecumenici erano convocati dagli imperatori bizantini che, spesso vi imponevano la loro volontà autocratica. In tali assemblee, il potere dei papi non era affatto preminente, come invece indicano i testi storici filo-cattolici. La pretesa dei papi di avere un primato su tutta la cristianità, proprio perché a Roma sarebbe morto l’apostolo Pietro, è polemicamente contestata dall’autore su basi scritturali e storiche. Ai nostri giorni, la situazione risulta ben diversa: la Chiesa non fomenta guerre, non opera stermini, non diffonde l’odio: al contrario, è promotrice di pace. Solo alcune cellule del suo apparato hanno destato sgomento, apprensione, coinvolgendo, al contempo, l’opinione pubblica sui drammatici episodi di pedofilia, antichi o recenti, in cui sono stati purtroppo coinvolti sacerdoti o religiosi cattolici. Alcuni casi statunitensi e canadesi hanno avuto grande risonanza, e hanno indotto singole diocesi e le conferenze episcopali nordamericane ad avviare inchieste e a proporre misure preventive. Stabilire quanti sono i preti e i religiosi cattolici pedofili non è irrilevante. Le tragedie individuali sono difficilmente descritte dalle statistiche, ma il quadro statistico può aiutare a capire se si tratta di casi isolati o di epidemie, o se vi è qualche cosa nello stile di vita del clero cattolico che rende questi episodi più facili a verificarsi, di quanto non avvenga, per esempio, fra i pastori protestanti o fra i maestri di scuola laici. La Chiesa cattolica, almeno in Nord America, ospita una percentuale di pedofili elevata e unica rispetto a tutti i gruppi religiosi dotati di un clero o di religiosi. Le statistiche parlano di migliaia di casi. In tema di abusi sessuali, Shupe, sostiene che questi sono più diffusi fra il clero cattolico che altrove, anche se le cifre correnti sono certamente esagerate. Il sociologo 145 Criminologia ed elementi di criminalistica dell’Indiana, peraltro, non è convinto che il celibato o la tolleranza dell’omosessualità spieghino il fenomeno: infatti, alcune denominazioni al cui clero non viene richiesto il celibato (episcopaliani, avventisti), o che attaccano in modo militante le campagne per i diritti degli omosessuali (mormoni), avrebbero percentuali di rischio simili alla Chiesa cattolica. Il problema, ritiene Shupe, è che la Chiesa cattolica, come la Chiesa mormone o quella episcopaliana, è una struttura piramidale, gerarchica, con un sistema che tende, naturalmente, a prescindere dalle buone intenzioni individuali, a proteggere una figura religiosa quando è attaccata dall’esterno. Questa dinamica, se ha portato in altri settori vantaggi alle Chiese organizzate in modo più gerarchico, avrebbe anche permesso ai pedofili di sentirsi, in qualche modo, protetti e tutelati. Shupe pensa che i casi di pedofilia clericale cattolica nell’ultimo trentennio, negli Stati Uniti d’America e in Canada, siano un paio di migliaia, e coinvolgano intorno all’uno per cento dei sacerdoti e dei religiosi. Ma ammette che le statistiche sono difficili perché, a partire da poche centinaia di condanne, occorre estrapolare e speculare sulla base di sondaggi, quanti casi non sono denunciati. Shupe, sostiene, inoltre, da anni, che la criminalità dei colletti bianchi è oggi affiancata, per una serie complessa di ragioni, da una criminalità clericale, diffusa presso ministri di tutte le confessioni che comprende anche, se non soprattutto, reati economici e finanziari. 6.19La criminalità femminile In Italia, si è verificata una vera e propria rivoluzione culturale e giuridica che ha inciso profondamente e a vari livelli: dalla procreazione controllata alla liceità dell’aborto, dal divorzio all’abrogazione del reato di adulterio femminile e di omicidio e lesione personale a causa d’onore, dalla legge n. 903, che sancisce formalmente la completa parità di trattamento in materia di lavoro tra uomini e donne, a quella che promuove azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. Se è vero, comunque, che la donna ha assunto un quadro di dignità indiscutibile e di parità, è altrettanto vero che si registra, altresì, un aumento del tasso di criminalità preoccupante; alcuni studiosi collegano tali attività a un concreto processo di emancipazione. Le cronache riferiscono di ingressi delle donne in ambito di criminalità organizzata, nelle quali assumono, talvolta, posizioni di leadership, comportandosi, in maniera spietata e senza scrupoli. Molti nomi di donna, inoltre, compaiono tra coloro che hanno attivamente partecipato a fenomeni terroristici. Nei vari gruppi terroristici, il ruolo ricoperto dalle donne non differiva in modo marcato da quello dei maschi. Troviamo, infatti, donne terroriste che hanno partecipato alla fase ideativa e a quella decisionale, a quella strategica e alla realizzazione del fatto criminoso. In molti attentati, è stata segnalata la presenza costante di donne nei commando che attuavano gli agguati, e questa peculiarità è presente sia nelle organizzazioni terroristiche di estrema sinistra, che in quelle di estrema destra. Questo esempio, come è ovvio, non è probante, perché sconta la situazione contingente ed anomala di un fenomeno dalle caratteristiche di eccezionalità, e che era esteso anche ad altre nazioni europee. Inoltre, racchiude un numero esiguo di casi rispetto al totale della criminalità, e, comunque, 146 Forme di criminalità registra una superiorità numerica maschile. Nella mafia, oggi, la donna sostituisce, spesso integralmente, le funzioni dell’adepto-uomo, discostandosi dalle precedenti, perché ha scelto l’impegno e il ruolo della donna di mafia, pretendendo e ottenendo di agire all’interno dell’organizzazione. Questo ha portato alcune di loro, perfino, a rinnegare mariti e figli perché pentiti, quasi che far propri i valori mafiosi fosse sinonimo di quel protagonismo negato che ha contrassegnato, e in parte ancora contrassegna, il ruolo femminile all’interno di queste organizzazioni. Il più delle volte, però, si è parlato delle donne di mafia che si sono schierate dalla parte della legalità. Una sorta di evoluzione, quindi, sembra avere interessato anche le donne di questi ambienti così particolari. Specialmente le più giovani, infatti, non vedono più nella lealtà e nella sottomissione ai loro uomini un univoco referente. I casi sono numericamente poco rilevanti, ma forniscono una sia pur parziale smentita empirica del nesso tra emancipazione femminile e aumento della partecipazione alla criminalità. D’altronde, in questo caso particolare, le donne risentono del peso di un processo di liberazione molto lento, faticoso e sofferto. Per chi, non per scelta, ma per forza maggiore, si è trovato a vivere in tali organizzazioni, liberarsi dalla cultura mafiosa con le sue ferree regole di sempre, è un’impresa difficile. Per valutare se, e in che modo, la criminalità femminile è cambiata, è opportuno fare riferimento alle statistiche criminali. Da un punto di vista strettamente quantitativo, l’inferiorità numerica dei reati commessi da donne, rispetto a quelli dell’altro sesso, è netta e costante. Negli ultimi dieci anni, i rapporti tra i sessi, in media, sono: per le persone denunciate, 18 donne ogni cento uomini; per i condannati di 15,5; per gli entrati in carcere dallo stato di libertà si riduce a 8,2 donne ogni cento uomini. Valori che non hanno subìto oscillazioni di rilievo nel periodo considerato. Si può ricordare che la componente femminile è poco presente anche in altri comportamenti devianti. Ricerche sui giovani confermano che tra le ragazze non compaiono ancora manifestazioni caratteristiche delle sottoculture e delle bande delinquenti. Per quanto concerne la situazione italiana, si denota, nell’ambito dei reati, un aumento numerico delle fattispecie: furto nei grandi magazzini, falsa testimonianza, infanticidio, e così via. Merita un particolare cenno la c.d. attività di sfruttamento della prostituzione, laddove, un’altissima percentuale di donne sono effettive tenutarie delle case di appuntamento; accanto a questa realtà ce ne sono altre, le cui protagoniste sono sempre donne, ma sfruttate, seviziate, allontanate dalle famiglie, in situazione di subalternità, per puro business. Particolare preoccupazione, desta l’aumento della criminalità femminile in ambito intra-familiare: omicidi del coniuge, maltrattamento della prole, figlicidi, violenza generalizzata. Anche le dinamiche delittuose sono mutate nel tempo: oggi, le donne, le mamme uccidono di più (si pensi ai casi di incuria nei confronti di bambini che muoiono per denutrizione, a quelli in cui i bambini sono stati uccisi perché introdotti dentro una lavatrice, ad altri che vedono bambini massacrati durante il sonno o in situazioni di veglia, oppure affidati o venduti per placare il desiderio di qualche pedofilo). Anche per la criminalità femminile è opportuno tenere in debito conto la c.d. cifra oscura, e ciò in ragione di un’elevata quantità di reati che vengono consumati, ma di cui l’autorità giudiziaria non ne viene a conoscenza. 147 Criminologia ed elementi di criminalistica 6.20Gli omicidi in condominio La criminologia moderna ha iniziato a muovere concretamente i propri passi nella direzione, assolutamente nuova, di forme di criminalità, che, nel passato, non rientravano nel proprio campo d’indagine. Ci si riferisce alle forme delittuose che maturano in condominio, ad opera degli inquilini degli stabili. La cronaca giornalistica, pur occupandosi di alcuni casi, può semplicemente limitarsi ad esporre, o meglio a raccontare, i fatti, le dinamiche, ma è compito del criminologo indagare sul perchè, e, in maniera approfondita, sul come. La rivalità condominiale è costellata da una serie di eventi che, solitamente, si esauriscono in attacchi verbali (soprattutto durante le riunioni di condominio), anche se, nel passato, non sono mancati i c.d. passaggi all’atto delittuoso, quali derivazioni dirette di antichi dissapori, o di vendette per torti subìti. In qualche caso, la rivalità, metabolizzata nel tempo, ha portato a vere e proprie stragi, spesso, pianificate nei dettagli e perpetrate con intenzioni precise. In questo caso, la razionalità era semplicemente obiettivata al male, perché, in tali soggetti, mancavano o risultavano traviate proprio quelle regole introiettate di giustizia e ingiustizia. Per comprendere sino in fondo l’origine di un atto di violenza o di omicidio in condominio, è opportuno costruire analiticamente il profilo personologico dell’autore o degli autori. Se ci confrontassimo con questi assassini, non ci sorprenderemmo di ascoltare le motivazioni, del tutto razionali, ai loro gesti. Solitamente, l’atto delittuoso è la risultante di eventi ripetutisi, come rumori molesti dei vicini, di neonati che piangono, di contenziosi in denaro, di problematiche inerenti costruzioni aggiuntive o abusive, e così via. Tutti elementi che, nella psiche di particolari individui, possono trasformarsi in fattori criminogenetici. Spesso, tra i condòmini, risulta mancante la capacità empatica, consistente nel mettersi nei panni altrui, di perdonarne gli aspetti sgraditi, di comprendere le motivazioni di alcuni gesti. Quando questa capacità empatica è presente, la convivenza è serena ed i sentimenti di odio vengono ridimensionati; questi ultimi, non si producono a un tale livello di intensità da condurre all’atto aggressivo. Gli omicidi non sono, in un’alta percentuale di casi, generati da sentimenti di odio cieco e senza controllo, frutto di un minus empatico, quanto piuttosto da una totale assenza di emotività, un’anaffettività completa e pervasiva, che è la vera essenza della psicopatia. In tali soggetti, non c’è amore, ma non c’è neppure odio, c’è il silenzio dell’emozione, il vuoto sentimentale, una voragine di intelletto traviato senza il supporto di un sufficiente coinvolgimento empatico. Ciò è anche il risultato della freddezza con cui, tali soggetti, riescono a costruirsi, al momento, un alibi, senza manifestare, successivamente, alcun segno di pentimento o ravvedimento. 148 Forme di criminalità 6.21I minori e l’uso distorto delle tecnologie di comunicazione L’avvento di nuove e sempre più sofisticate tecnologie ha migliorato e qualificato, in modo particolare, la comunicazione, contribuendo, da un lato, ad accorciare le distanze e, dall’altro a rendere più agevole l’assolvimento di una serie di funzioni prima impensabili. È altrettanto vero, però, che la tecnologia, spesso, può diventare anche un’arma da rivolgere contro un individuo ed i suoi diritti, tale che, in ambito europeo, in particolar modo, il tema dei minori e dell’uso delle nuove tecnologie viene affrontato nella dimensione del presente e del futuro. Il cellulare (o telefonino), ad esempio, rappresenta uno strumento che ormai sempre più spesso vediamo usato con perizia (quasi da invidia) da giovani e giovanissimi. Il cellulare, sempre più tecnologico e convergente, richiede un’attenzione specifica per evitare che possa essere mezzo di danno, specie, per i più piccoli. Ciò che era nato per accorciare le distanze, dando la possibilità di comunicare continuativamente, sta ottenendo, anche, l’interesse della criminologia moderna e, parimenti, la mobilitazione da parte di organizzazioni per la tutela dei minori, associazioni di genitori, organizzazioni di consumatori, operatori di reti mobili, fornitori di servizi, fabbricanti di telefoni e di reti internet. Se, da un lato, la comunicazione mobile rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo delle economie e delle società europee, dall’altro, è necessario, altresì, riflettere sui fenomeni nuovi, di carattere criminogeno, che stanno interessando le tecnologie della comunicazione. L’analisi riguarda i problemi legati ai contenuti e ai comportamenti, quali l’accesso a materiale illegale o nocivo, il bullismo, o l’invio, tra bambini o adolescenti, di messaggi e foto a carattere offensivo o compromettente; a ciò si aggiunge il preoccupante fenomeno della seduzione di minori, consistente, attraverso la messaggistica telefonica, in tentativi da parte di uno sconosciuto di diventare amico di un bambino al fine di incontarlo; e ancora, in generale, i rischi per la tutela della vita privata dei minori. Negli ultimi anni, il numero di bambini o di giovani che utilizzano i telefoni cellulari è aumentato vertiginosamente; allo stesso tempo è cresciuto in modo altrettanto esponenziale il numero di funzionalità di cui sono dotati i telefoni cellulari. Secondo un sondaggio del maggio 2006, in Europa, il 70% dei giovani tra i 12 e i 13 anni e il 23% dei bambini d’età compresa tra gli 8 e i 9 anni possiede un telefono cellulare. Oggi, i telefoni cellulari permettono di inviare e ricevere messaggi video, di utilizzare servizi d’intrattenimento (ad esempio scaricare suonerie, giochi, brani musicali e filmati), di accedere a internet, e di utilizzare servizi basati sulla localizzazione degli utenti. Le videocamere e le tecnologie fotografiche di cui sono dotati, oramai il 70% dei telefoni cellulari, (specie quelli di ultima generazione), innescano, con particolare riferimento agli adolescenti, da un lato, meccanismi legati alla sperimentazione delle funzioni stesse del telefono, dall’altro, l’utilizzo di tale strumento che, in particolari occasioni, funge da elemento criminogeno e ricattatorio. A tal proposito, ci si riferisce ai recenti casi in cui, certe forme di violenza, di sopraffazione, di negazione dei diritti e della libertà, viaggiano da un cellulare ad un altro, o, attraverso la rete internet. Violenze perpetrate all’interno delle scuole, nelle aule, nei luoghi di ritrovo degli adolescenti, oppure, in abitazioni private, tutte consumate 149 Criminologia ed elementi di criminalistica con estrema leggerezza, filmate attraverso le videocamere e diffuse, come fosse solo un gioco. Adolescenti con problemi di disabilità che vengono scherniti, minacciati, percossi, ma, al contempo, ripresi da un occhio tecnologico, sempre più sofisticato. La spettacolarità di tale tipologie di violenza ha il solo compito di sbalordire gli altri, farli ridere e divertirli. Accanto a questi nuovi e contemporanei tragici eventi, anche la sessualità gioca la sua parte. Dietro le violenze, gli stupri, i rapporti sessuali tra minorenni, le attività sessuali generalizzate, queste ultime vissute precocemente, e, spesso consensualmente da parte delle adolescenti, vi è, oggi, uno strumento, il telefonino, che può essere utilizzato come un’arma: quella del ricatto. Tutti questi eventi sono il prodotto di una società che è diventata incapace di gestire le nuove generazioni. L’uso distorto delle tecnologie deve trovare soluzioni, anche drastiche. Occorrerebbero segnali, in particolar modo provenienti dalla giustizia minorile, dinanzi a tali casi di indirizzo penalistico. Le famiglie degli adolescenti non sono contrari all’uso del telefono cellulare da parte dei loro figli, anche perché, tale strumento consente il controllo, in ordine alla loro ubicazione, quando sono fuori di casa; sarebbe opportuno, allora, che le memorie dei cellulari venissero, periodicamente, controllati dagli stessi genitori, per indagarne il contenuto, in ordine a numeri, messaggi, foto e video. Se tali fenomenologie delittuose, a opera di minori, dovessero moltiplicarsi, sarà opportuno, in un immediato futuro, affidarne il controllo contenutistico ai fornitori dei servizi di telefonia ed internet, e ciò a scopo di tutela e di promozione dei diritti umani. 6.22 Le riposte alle devianze minorili Il nuovo processo minorile ha operato un cambiamento non indifferente dal punto di vista di operatori, servizi e comunità. Oggi, infatti, il recupero del soggetto che impatta con il sistema penale richiede una programmazione estremamente personalizzata d’interventi che vede impegnati ed interagenti vari soggetti: il minore, la famiglia, l’ambiente in cui vive (scuola, lavoro...), i servizi sociali ministeriali e quelli del territorio e, naturalmente, la Magistratura. Anche la ricerca pedagogica e psicologica sul trattamento educativo dei minori disadattati e devianti consente di compiere alcune osservazioni interessanti. In primo luogo, oggi si assiste ad un progressivo abbandono del modello di trattamento comportamentista, centrato in pratica sulla richiesta di una modificazione del comportamento sulla base di una contrattazione che tendeva a risolversi in un sistema di rinforzi positivi e negativi. In altri termini, l’idea è che un minore agisce, in modo più o meno deviante, sulla base degli schemi di significato che possiede. Prima di pretendere che un minore smetta di giocare il solo ruolo che sa giocare, bisogna che gli sia data l’opportunità di utilizzare, e far propri, schemi, alternativi di pensiero e azione. Il cambiamento del comportamento segue, non precede, il processo di costruzione e ricostruzione identitaria che l’intervento educativo dovrebbe favorire. Appare ovvio che quest’indicazione è in linea con la più ampia questione riguardante 150 Forme di criminalità la costruzione del progetto educativo. Quest’ultimo consente di sviluppare alcune riflessioni fondamentali: a) La relazione con l’educatore è il principale motore del cambiamento. Una prima componente necessaria è rappresentata dall’investimento affettivo e dalla gestione pedagogica del transfert. I processi d’identificazione, d’affiliazione, d’attaccamento, di dipendenza, incidono nella storia evolutiva del minore. Perché si trasformino in momenti educativi funzionali, essi devono essere presi in considerazione e trattati in modo congruente con le specifiche esigenze evolutive del minore. La disponibilità, i segni dell’accoglimento affettivo, le funzioni di sostegno, strutturazione e contenimento svolte dall’educatore, costituiscono il fondo del terreno relazionale su cui articolare norme, regole e autorevolezza. Perchè tale relazione sia costruita come strutturante e rassicurante, la quotidianità del rapporto appare fondamentale. Il che rileva la debolezza dei modelli educativi, quando questi si risolvono in incontri saltuari con l’educatore. Inoltre, la dimensione della progettualità è connessa alla comunicazione al minore di una positiva scommessa sulle sue capacità, abilità, competenze. L’ipotesi di fondo è che l’orientamento al futuro, la dimensione progettuale siano fattori costitutivi dell’identità: scopi da raggiungere, progetti cui partecipare diventano dei dispositivi per cominciare a sperimentare l’efficacia e la praticabilità di nuovi e differenti modi di pensare e di agire. In altri termini, la presa di distanza dal passato è il prodotto di un differente modo di agire nel presente e di pensarsi nel futuro. La comunicazione tra minore ed educatore deve rispondere a un modello circolare, cioè dare al minore la possibilità di partecipare alla contrattazione del proprio percorso, negoziare regole e norme, passare da un comportamento di ruolo centrato sull’autorità ad un modello di autorevolezza, accogliere, contenere e restituire in forma più organizzata emozioni e comportamenti disordinati. Ciò al fine di sostenere il versante rassicurante, contenitivo e strutturante della relazione e di trasformare il minore, seguendo uno schema simbolico-interazionista, in un interlocutore attivo di un processo di cui dovrebbe essere protagonista. La competenza, la disponibilità e soprattutto l’attendibilità dell’educatore e la stabilità della relazione, sostengono la probabilità che egli diventi per i ragazzi e le ragazze un riferimento autorevole di realtà. Il suo punto di vista, tradotto anche in norme e regole, diventa quadro di riferimento, orienta, sostiene e contiene reazioni e comportamenti. La costruzione delle esperienze orientate al cambiamento e dell’identità si collocano oltre la prima formazione. Questo processo di cambiamento è destinato a soggetti che hanno già vissuto esperienze e sedimentato vissuti. Nel corso della propria storia, il minore ha avuto modo di consolidare alcuni schemi di significato che egli sente propri e, spesso, per nulla disadattivi, introiettati e difesi come propri, essi possono avere maggiore o minore grado di stabilità e strutturazione in base alle esperienze vissute e alla loro stereotipia. L’intervento rieducativo costruisce contesti ed esperienze nuovi o differenti da quelli che hanno caratterizzato l’ambiente del ragazzo o che sono stati propri della sua formazione. Entro questi contesti e attraverso essi, il minore ha l’opportunità di sperimentare differenti figure e differenti modalità di essere percepito e trattato dagli adulti di riferimento, differenti aspettative e reazioni al suo comportamento, nuovi stimoli 151 Criminologia ed elementi di criminalistica e opportunità d’azione, nuove forme di comunicazione interpersonale. L’educatore sostiene il minore e lo accompagna in queste esperienze, fornendo supporti ma senza sostituirsi a lui. La condivisione di spazi, tempi, attività e momenti della vita quotidiana ha un duplice scopo: in primo luogo, consente all’educatore di conoscere a poco a poco le categorie attraverso cui il minore interpreta e fa fronte alla sua realtà quotidiana, osservando come il minore interagisce e fa fronte ai compiti e alle situazioni quotidiane e, interagendo con lui, l’educatore può comprendere la chiave interpretativa del suo mondo in modo più preciso che attraverso colloqui istituzionalizzati; in secondo luogo, se l’educatore riesce a inserirsi o a costruire un micro-ordine della vita sociale, egli ha maggiori ambiti d’intervento, condividendo ritmi, attività, luoghi della vita quotidiana che l’educatore può trasformare in ambienti più protetti e controllati, entro cui il minore può sperimentare nuovi modi di conferire ordine e dotare di senso la realtà. Naturalmente, la condivisione della vita quotidiana assume forme differenti se l’intervento educativo si svolge in strutture diverse (carcere, comunità residenziali) o se esso si articola in forme di educazione di strada o di progetti. Nella progressiva ridefinizione dell’identità personale, l’esperienza del gruppo rappresenta il contesto di costruzione o rielaborazione delle competenze sociali. Alcuni dispositivi che caratterizzano la vita di gruppo (il senso d’appartenenza, la complementarietà dei ruoli, la competitività, la cooperazione, istituzione di norme e sanzioni) possono tradursi in altrettante risorse formative. L’educatore può inserirsi all’interno di gruppi naturali o aggregazioni spontanee contribuendo a ridefinirne dinamiche interpersonali e valori, facendo anche in modo che il gruppo contenga, risolva e riassorba i suoi membri devianti perché non si creino le condizioni per la riedizione di meccanismi di espulsione che molti ragazzi potrebbero aver già subito in altri luoghi e in altri momenti. I tempi dell’intervento educativo, inteso come processo di costruzione identitaria, come un’opportunità di crescita che punta al cambiamento, si collocano sul medio-lungo termine. Alcuni fattori hanno quindi contribuito a orientare verso la territorializzazione dei servizi educativi: le conseguenze devastanti dell’istituzionalizzazione, la necessità di rispondere in termini di servizi alle misure alternative alla detenzione previste dal nuovo codice di procedura penale minorile, la necessità di prendere in carico i minori a rischio. Da questo punto di vista, hanno acquistato sempre maggiore rilevanza sociale e interesse scientifico due luoghi/modi dell’intervento preventivo/educativo: la comunità e la strada. b) Le comunità di tipo familiare L’inserimento in comunità è previsto sia per i soggetti a rischio psico-sociale, sia per i soggetti che sono già entrati nel circuito penale. L’allontanamento dai contesti abituali è stabilito sulla base del principio della protezione del minore e non dal minore. In tal senso, la residenzialità consente di lavorare sulla funzione strutturante delle routine quotidiane e su quella contenitiva della relazione con gli educatori. I principi pedagogici di base che regolano la comunità sono essenzialmente: la vita quotidiana come contesto educativo, l’equilibrio tra rapporto individualizzato e dinamiche relazionali di gruppo. La vita residenziale non è vista come puro 152 Forme di criminalità contenitore o appoggio al ragazzo, ma come la reale chiave di volta dell’intervento educativo, infatti, accoglimento, sostegno, contenimento, mediazione con ambienti non protetti (la scuola, i familiari), condivisione di esperienze attuali, progetti futuri, nuove opportunità di relazione, dovrebbero caratterizzare la vita del ragazzo in comunità. Attualmente, sembra che la formula più indicata per interventi di tipo preventivo/rieducativo sia la comunità, con un numero di ospiti non superiore alle dieci unità. Le dimensioni contenute del gruppo di residenti, consentono, infatti, l’instaurarsi di significative relazioni faccia a faccia e la costruzione di una nuova storia condivisa e significativa fatta di rituali della vita quotidiana, ma anche di eventi salienti, tutte precondizioni per l’instaurarsi di nuovi modi di agire e di pensare. c) L’educazione di strada In Italia, la figura professionale dell’educatore di strada acquista sempre maggior rilevanza sia sul piano della riflessione pedagogica che su quello della progettazione di interventi. In alcune città (Palermo, Torino, Milano, Bologna, Napoli), sono in atto modelli di intervento formulati intorno a quest’idea. L’idea di fondo è l’inversione di direzione: non è il minore che va o è condotto al servizio sociale, è il servizio che va verso il minore e lo incontra o lo aggancia là dove si trova, ciò consente di raggiungere utenti che forse non avrebbero mai incontrato i servizi e che spesso sono quelli che ne hanno maggiore bisogno. I presupposti sono quelli della pedagogia territoriale, particolarmente indicati ad orientare l’intervento educativo in ambiti, in cui la devianza ha, o rischia di avere, carattere strutturale e non occasionale, in quanto sostenuta e legittimata dal tessuto sociale e dalla cultura locale. I caratteri distintivi di questo servizio sono: conoscenza delle categorie locali, regole, norme e modelli di comportamento attraverso cui adulti e minori interpretano e ordinano la loro realtà, stabiliscono significati, stringono alleanze, contrattano modalità e margini di accesso al loro mondo, accordano fiducia o diffidenza. La conoscenza di questo ordine di fattori è decisiva: un minore che ha abbandonato la scuola a Napoli e ha contatti con la criminalità, può aver trovato, in questo, non solo una gratificazione economica personale, ma anche il modo di contribuire responsabilmente al bilancio familiare. L’educatore si troverà di fronte a una scelta che trova legittimazione sul senso del dovere o sull’attaccamento familiare. Ancora, è stato accennato che la devianza può funzionare come un vero e proprio percorso formativo, costellato da prove d’iniziazione alla vita adulta in cui il coraggio, l’intraprendenza e la spregiudicatezza sono fondamentali. In questo senso, qualunque opportunità alternativa rischia di non fare alcuna presa sul minore se non si inscrive sulle categorie locali, se non risponde alle esigenze del tessuto sociale. L’accesso dell’educatore, la sua accettazione da parte del quartiere, della strada, dei gruppi naturali, dipende largamente, nelle prime fasi, dalla sua capacità di trovare dei margini di compatibilità tra il suo ruolo, le sue funzioni e il campo in cui si trova. La ricerca di una sinergia e di una reciproca legittimazione con la gente del luogo sono fondamentali. Il quartiere, la strada sono una rete di relazioni fortemente 153 Criminologia ed elementi di criminalistica strutturate, nei cui confronti, l’educatore è, in prima istanza, l’estraneo; in questa rete, altri sono gli adulti di riferimento, quelli che hanno ascendente sul ragazzo, quelli a cui questi accorda fiducia e rispetto, alla cui fiducia e rispetto sono interessati. Per acquistare credibilità agli occhi del ragazzo, l’educatore deve, in primo luogo, acquistarli agli occhi degli altri, deve farsi legittimare dagli adulti di riferimento. Il lavoro dell’educatore di strada, comincia, dunque, con la costruzione di un certo grado di consenso sociale, egli deve ottenere legittimazione e autorevolezza prima di tutto agli occhi di chi è diventato un modello di riferimento per il ragazzo. Due sono i nodi centrali contro cui si scontra l’educazione di strada: - - il primo ha a che fare con il confronto perdente con i guadagni che provengono da un’economia illegale; il secondo concerne lo scontro con i modelli che i minori hanno assimilato. Il primo nodo è di difficile soluzione pedagogica, perchè l’economia illegale è terribilmente competitiva rispetto alle proposte di qualsiasi educatore, anche se dipenderà tutto dalla misura in cui il tessuto relazionale legittima, tollera, incoraggia, ignora i traffici illegali del minore. Il secondo nodo è invece al cuore di questo intervento educativo. Uno dei compiti dell’educatore di strada è quello di diventare un modello alternativo rispetto a quello o a quelli che la famiglia, il quartiere e la strada propongono. Perchè il modello identitario proposto riesca ad affiancarsi prima e sostituirsi poi ai modelli rilevanti per il soggetto, l’educatore deve diventare oggetto di investimento affettivo. Ciò comporta un’attenzione alla costruzione della relazione con il minore, un lavoro di mediazione con gli adulti del quartiere più vicini ai ragazzi, l’inserimento dell’educatore nei gruppi naturali e conseguente coinvolgimento di una base più allargata di destinatari del progetto educativo. Il processo di cambiamento del quadro normativo, avviato dal nuovo codice di procedura penale per i minorenni, ha comportato una ridefinizione dell’assetto organizzativo e gestionale dei servizi dell’amministrazione della giustizia minorile. Il sistema dei servizi della giustizia minorile rappresenta, infatti, l’area di supporto all’implementazione delle linee, delle strategie politiche e, più specificatamente, delle decisioni prese dall’autorità giudiziaria nell’ambito della competenza penale. Ai preesistenti servizi (come l’ufficio di servizio sociale e l’Istituto Penale), si affiancano nuovi servizi, come il Centro di Prima Accoglienza, la Comunità Educativa, i Centri Diurni Polifunzionali, titolari della nuova filosofia dell’azione penale e di tutte le misure penali in area esterna, che, come si è detto, rappresentano l’attuale tendenza di politica preventiva in Italia. L’ufficio di servizio sociale costituisce il servizio che accompagna il ragazzo nel suo percorso penale, dall’inizio alla fine. Opera sulla base di un mandato istituzionale che ne prevede l’immediata attivazione dal momento in cui, a seguito di denuncia, un minore entra nel circuito penale. Il nuovo codice prescrive l’attivazione del suo intervento nei confronti del minore, entro 96 ore dall’inizio del suo stato d’arresto e di fermo. L’ufficio, cura, inoltre, il progetto educativo del minore in misura cautelare non 154 Forme di criminalità detentiva, gestisce la misura della sospensione del processo e della messa alla prova e segue complessivamente tutte le misure alternative e sostitutive. Svolge, altresì, compiti di assistenza in ogni stato e grado del procedimento e predispone la raccolta di informazioni utili per l’accertamento della personalità del minore su richiesta del P.M. L’Istituto Penale, spazio originariamente preposto all’esecuzione della misura cautelare detentiva e della pena, vede una sua ridefinizione organizzativa più funzionale a un’azione educativa sempre più integrata con i servizi della giustizia minorile e del territorio. Il Centro di Prima Accoglienza (CPA) è una struttura filtro che ospita i minori arrestati e fermati per un massimo di 96 ore in attesa dell’udienza di convalida; si tratta di un servizio finalizzato a evitare l’impatto con il carcere e che si connota strutturalmente come una casa, dove gli operatori minorili accolgono, informano, sostengono il minore e avviano una prima prefigurazione del progetto educativo, se il minore resterà nell’area penale. Le altre nuove tipologie organizzative, comunità e centri diurni polifunzionali, rappresentano servizi di supporto all’intervento in area penale esterna e vedono attualmente prevalere la formula del convenzionamento o della cogestione con le forze del privato sociale. Il recente Progetto ’98, elaborato dall’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, costituisce una sintesi delle esperienze maturate in quella fascia d’intervento nota come ‘area penale esterna’ (misure cautelari non detentive, messa alla prova, riconciliazione), il cui aspetto caratterizzante è dato da una relazione operativa che si dispiega, oggi ed in prospettiva, al di fuori degli ambienti istituzionali in un rapporto, sia pure non semplice, di stretta interdipendenza con i servizi locali e con i contesti socializzativi di appartenenza del minore. La concretizzazione di tali presupposti prende avvio da una modifica strutturale che, nelle future tendenze di politica preventiva, si realizza nel Centro Polifunzionale di Servizi, una struttura situata nei territori di competenza dei diversi Centri per la Giustizia Minorile. Il Centro Polifunzionale si compone di diversi servizi: Servizio di prima accoglienza, Servizio sociale, Servizio diurno polifunzionale, Servizio comunità, Servizio controllo rafforzato. Appare ipotizzabile, per il prossimo futuro, che i primi due servizi evolveranno coerentemente con gli sviluppi dell’innovazione in corso. Il servizio diurno rappresenta, invece, l’espressione più immediata dell’obiettivo di garantire continuità con l’esterno. Tale struttura, infatti, non è riservata esclusivamente agli autori del reato, ma si rivolge ad un’utenza mista che accede alle attività proposte tramite invio nel territorio (scuole, parrocchie, servizi sociali territoriali ecc.). Gli ultimi due servizi, costituiscono quelli più direttamente organizzati in forma istituzionale secondo modalità contenitive, diversamente articolate sulla base delle caratteristiche del ragazzo, della sua posizione giudiziaria o di problematicità presentate. Il servizio di controllo rafforzato sostituisce l’Istituto Penale ma, sostanzialmente, ne ripropone la logica per tutti quei casi che non possono accedere ad ipotesi meno strutturate. I servizi comunità si differenziano, al loro interno, fra comunità filtro, con funzioni di accoglienza, inserimenti comunitari a medio e lungo termine e comunità protette, rivolte a quei ragazzi per i quali risulta inadeguato o prematuro il collocamento presso strutture territoriali. Questa nuova articolazione dei servizi e la complessità della proposta organizzativa, sempre più orientate ad un’apertura al territorio di appartenenza del minore a 155 Criminologia ed elementi di criminalistica rischio e/o che delinque, richiede la valorizzazione della multidisciplinarietà e la specializzazione delle figure che si occupano del ragazzo, l’interazione con i servizi e le professionalità del territorio, ma, soprattutto, la fluidità sia di circolazione interno-esterno, sia di passaggio del minore fra strutture e servizi. Nel quadro della promozione di diritti e di opportunità dell’infanzia e dell’adolescenza, il diritto allo studio assume un ruolo centrale, soprattutto se inteso come diritto alla qualità e alla promozione del successo formativo; in questo modo, il fenomeno della dispersione scolastica e dell’insuccesso educativo assume sempre più il significato di chiave di lettura non solo del servizio scolastico, ma dell’intero sistema formativo; è, infatti, un fenomeno complesso, sia per la sua fenomenologia (mancati ingressi, evasione dall’obbligo, abbandoni, ripetenze, bocciature, frequenze irregolari), che per la pluralità di cause, interne ed esterne alla scuola, che lo determinano. La dispersione scolastica è, pertanto, il sintomo di una situazione complessiva di disagio e disadattamento che, laddove l’insuccesso scolastico si correla, a seconda dei contesti territoriali, ad altre cause di natura socio-economica-culturale, può condurre, come nel caso Napoli, a fenomeni di rischio, marginalità e devianza. Non essendo riducibile a un modello lineare di causa-effetto, va analizzato attraverso un approccio globale che superi la frammentazione degli interventi. Conseguentemente, per coniugare diritto allo studio e qualità dell’istruzione e della formazione, è necessaria un’azione integrata, interistituzionale che assuma come centrale la realtà dell’alunno all’interno di un sistema di relazioni e sia funzionale all’organizzazione e realizzazione di un servizio integrato alla persona. In linea con questo quadro teorico-metodologico, il Ministero della Pubblica Istruzione ha promosso in tutte le province piani organici di intervento che hanno due presupposti: l’area territoriale come unità d’intervento e l’interistituzionalità. L’organizzazione dei suddetti piani ha previsto la costituzione di Osservatori, a livello provinciale e di area: essi, hanno consentito l’individuazione di compiti rispetto all’analisi del territorio, alla ricognizione dei bisogni, alla progettazione integrata, al coordinamento e alla gestione delle risorse, al fine di evitare la frammentazione e la sovrapposizione degli interventi, secondo una logica di rinforzare sul territorio il sistema formativo integrato. Il modello d’intervento ha visto la scuola e il territorio gestire le problematiche legate al disagio e alla devianza, integrando competenze e compiti dei diversi attori del processo. La metodologia di rete si è confermata come l’unica risposta possibile che il territorio può dare alla complessità tipica del nostro sistema sociale, allo scopo di evitare le forti autoreferenzialità dei diversi enti e istituzioni pubbliche, lo spreco di risorse professionali ed economiche. Per consolidare le relazioni interne agli osservatori, garantire la progettualità e l’intervento, sono stati adottati protocolli d’intesa, accordi di programma, protocolli operativi a sostegno dei progetti. Per ciò che attiene la prevenzione nei confronti dei minori, si deve sottolineare che particolari esperienze di prevenzione della devianza minorile sono state compiute nel nostro paese in contesti sociali e scolastici. Un primo modello colloca l’attività di prevenzione in base alla fase di sviluppo del comportamento criminale. È questo il modello medico di G. Caplan (1964), che presenta tre tipi di prevenzione: la prevenzione primaria, che svolge la sua funzione allo scopo di rimuovere o diminuire quei fattori criminogeni presenti nell’ambiente fisico e sociale attraverso interventi educativi, di politica sociale e urbanistica; la prevenzione 156 Forme di criminalità secondaria, tesa all’individuazione precoce di potenziali delinquenti, soprattutto giovani, per i quali sono promossi interventi in grado di ridurre il rischio di comportamenti antisociali; la prevenzione terziaria entra in gioco in seguito alla commissione di un crimine e per tale motivo è finalizzata ad evitare la recidiva. Una prevenzione situazionale, rivolta ad ostacolare fisicamente il compimento dei reati, rappresentando una forma di prevenzione meccanica. Infine, abbiamo gli interventi di prevenzione individuale, che possono essere realizzati facendo o meno ricorso a ricerche di tipo predittivo. Nel primo caso, i soggetti bersaglio di questi interventi sono quelli in età infantile e preadolescenziale, i quali sono stati individuati come a rischio delinquenziale; nell’altro caso, gli interventi, pur essendo diretti a bambini e preadolescenti problematici, sono soprattutto indirizzati alla promozione e al benessere degli stessi soggetti e delle loro famiglie, più che alla preoccupazione per gli atti delinquenziali. Un ambito di ricerca che negli ultimi anni è in fermento è quello del bullismo e delle prepotenze nelle istituzioni scolastiche; lo scopo di queste ricerche è mirato alla progettazione e alla realizzazione di strategie rivolte al contenimento e alla riduzione del fenomeno, attraverso la collaborazione e l’aiuto di insegnanti, genitori e gruppo dei pari. In Italia, le esperienze effettuate come prevenzione della devianza minorile risentono, naturalmente, della diversità dei contesti di applicazione, delle diverse metodologie adottate, degli obiettivi e delle risorse utilizzate per la loro applicazione. 157 CAPITOLO 7 Aggressività ed anormalità personologica 7.1 L’aggressività Il termine aggressività indica sia il comportamento finalizzato all’adattamento dell’uomo, in modo attivo, creativo e disponibile, al mondo che lo circonda, sia il comportamento violento, inteso come aggressività fisica verso un essere umano con l’intenzione di fare del male. La definizione di aggressività non è chiara: nella revisione della letteratura, infatti, vari Autori, esponenti di impostazioni teoriche diverse, hanno affrontato il problema privilegiando, maggiormente, lo studio delle origini e delle cause della condotta aggressiva, piuttosto che il suo spessore clinico. Storicamente possiamo riconoscere tre posizioni teoriche divergenti: 1) aggressività come fenomeno teso alla distruzione; 2) aggressività intesa come istinto innato di controllo e comando; 3) aggressività come risultato di due istinti umani fondamentali: quello della morte e della distruzione combinato a quello dell’amore e della vita. In tutti i casi, l’aggressività si esprime con manifestazioni cognitive, emotive e comportamentali (Rohrlich, 1998). Il DSM-IV non prevede specificamente un disturbo aggressivo, ma il termine aggressività compare nei criteri di diversi quadri clinici per cui la stessa si configura più come una dimensione transnosografica che non come un elemento psicopatologico nucleare e strutturante. Nel disturbo del controllo degli impulsi non classificati altrove (NAS), esiste il disturbo esplosivo intermittente, i cui criteri diagnostici includono la presenza di episodi ricorrenti, isolati, di incapacità di resistere agli impulsi aggressivi, che causano gravi atti aggressivi o distruzione della proprietà. Anche in altri disturbi mentali classificati nel DSM IV, l’impulsività, la rabbia e l’aggressività fanno parte del quadro psicopatologico; nella schizofrenia, nell’episodio maniacale, nella demenza, nell’abuso di sostanze, nell’alcolismo, nei disturbi di personalità (e in quelli borderline e antisociali in particolare), i comportamenti aggressivi sono ben descritti. In altri disturbi, l’aggressività può essere presente in forma diversa, come nel caso delle valenze suicidarie del depresso, degli attacchi di rabbia durante l’attacco di panico, dell’intolleranza dell’ossessivo. La valutazione standardizzata, già comples159 Criminologia ed elementi di criminalistica sa nelle forme di aggressività manifesta, pone problemi ancora maggiori quando l’aggressività è mascherata o indiretta, sia per i pochi strumenti proposti, sia per la difficoltà della raccolta dei dati mediante l’osservazione del comportamento, quando le condotte aggressive sono meno obiettivabili La valutazione dell’aggressività risulta particolarmente aleatoria quando si basa su quanto il soggetto riferisce, come si verifica con gli strumenti di autovalutazione o con le scale compilate dall’osservatore sulla base dei dati ricavati dal colloquio. Più attendibile dovrebbe essere la valutazione del comportamento da parte di un osservatore esterno anche se, in realtà, anche l’osservazione pone alcuni problemi, primo fra tutti, quello più strettamente legato alla natura stessa dell’aggressività che, generalmente, è un comportamento episodico, piuttosto che una condizione stabile o un comportamento abituale o frequente. Di solito, nel caso dei comportamenti episodici, la valutazione può essere effettuata sulla base dell’osservazione di un frammento del comportamento in questione, in quanto, esso sarà, con buona probabilità, rappresentativo della condizione abituale del soggetto. Nel caso dell’aggressività, tuttavia, la normale osservazione clinica offre difficilmente l’opportunità di coglierne direttamente anche solo dei frammenti; spesso, solo un’osservazione del soggetto nel suo setting naturale e per un periodo sufficientemente protratto può consentire di cogliere eventuali manifestazioni aggressive, anche se sporadiche. Si potrebbe pensare, in alternativa, a una valutazione dell’aggressività in un setting sperimentale in cui, controllando e modificando la situazione e gli stimoli, il comportamento aggressivo possa essere in qualche modo provocato e quindi misurato. Esperienze, in questo senso, sono state fatte, ma restano limitate al campo della ricerca e avrebbe poco senso (né sarebbe comunque agevole) trasferirle a quello clinico. Nonostante queste difficoltà e questi limiti, l’aggressività può essere indagata e valutata con risultati soddisfacenti, non soltanto mediante i classici questionari di personalità, ma anche attraverso questionari specifici; inoltre, utilizzando le tecniche proiettive, l’aggressività può essere studiata anche quando non è espressa, quando investe i livelli più profondi. Poiché i soggetti con deficit intellettivi o disfunzioni organiche cerebrali possono manifestare, con buona frequenza, comportamenti aggressivi, nella valutazione dell’aggressività di questi soggetti può essere indicato l’uso di test di efficienza, come la Wechsler Adult Intelligence Scale WAIS (Wechsler, 1974) o il Bender Visual Motor Gestalt Test (Bender, 1938), anche se, naturalmente, i risultati migliori si ottengono impiegando i test, i questionari, le RS che indagano in maniera più mirata l’aggressività, sia essa espressa in maniera diretta o indiretta. 7.2 Criminali aggressivi Le condotte aggressive sono dirette a provocare danno, fisico o psicologico, ad altri individui. Ma da cosa dipendono? Si è sicuri che non dipendano da eredità genetica? Cesare Lombroso, antropologo e psichiatra, come già accennato in precedenza, si sforzò di evidenziare, nei criminali, note morfologiche particolari, considerandole espressioni di un’anomalia di formazione. 160 Aggressività ed anormalità personologica Distinse, come è noto, due tipi di delinquenti: il delinquente nato, per il quale la criminalità è insita nella propria natura; il delinquente occasionale, portato al delitto da fattori causali diversi. Il delinquente nato era considerato un soggetto non recuperabile, da sopprimere o da rinchiudere, mentre per i delinquenti occasionali si poteva prevedere la rieducazione in carcere. Nel suo lavoro principale, L’uomo delinquente, del 1876, Lombroso sosteneva che i criminali non compiono azioni aggressive per un atto di volontà malvagio libero e cosciente, ma piuttosto perché hanno tendenze malvagie, originate da un’organizzazione fisica e psichica diversa dall’uomo normale. Lombroso studiò a lungo i crani, le facce, i piedi, le abitudini di vita di famosi criminali, allo scopo di dimostrare scientificamente che l’uomo delinquente possedeva tratti subumani che lo differenziavano dal resto della popolazione ed erano responsabili delle sue tendenze aggressive. Questi studi non hanno prodotto risultati scientificamente dimostrabili e oggi questa teoria è stata definitivamente abbandonata. Nella ricerca moderna sulle strutture neuroanatomiche, è parso chiaro che i sistemi neuronali coinvolti con il comportamento aggressivo sono localizzati soprattutto nel sistema limbico e nel tronco dell’encefalo. Diversi studi hanno dimostrato, ad esempio, che lievi stimolazioni elettriche del sistema limbico nei ratti, sollecitano violenti attacchi nei confronti degli animali vicini. Ricerche sull’influenza del sistema neuroendocrino hanno individuato nel testosterone, ormone sessuale maschile, un importante modulatore dei comportamenti aggressivi, che spiegherebbe anche la maggiore aggressività dell’uomo rispetto alla donna. Anche nelle donne particolarmente aggressive sono stati trovati alti tassi di testosterone. Quello che non è ancora chiaro è se sia l’aggressività che porta ad avere alti livelli di testosterone o se sia il testosterone che determina i comportamenti aggressivi. Come sempre, fra psicologia e biologia, la teorizzazione tende ad intrecciarsi. I dati della ricerca più recente tendono, comunque, a lasciare aperta la possibilità che fattori genetici influenzino l’aggressività, ma solo in modo indiretto, determinando problemi nello sviluppo cognitivo (es. deficit dell’attenzione, basso Q.I, ecc.) che, a loro volta, possono sfociare in condotte anti-sociali. Naturalmente, oltre alla natura, è stata indagata anche la cultura, attraverso ricerche condotte su gemelli e bambini adottati, per vedere quale aspetto avesse la prevalenza nel determinare la condotta aggressiva. Questi studi hanno prodotto tuttavia risultati non sono sempre chiari e coerenti. è stato indagato l’ambiente sociale e non si è potuto certo negare che la povertà, il sovraffollamento delle periferie metropolitane, l’assenza di spazi per qualsiasi forma di attività ricreativa e la carenza di igiene, generano sempre una sensazione di abbandono e di disperazione, che può condurre a comportamenti aggressivi come strumento di evasione e rivalsa sociale. Oltre a questo, le crisi economiche, le guerre, la fame, le malattie, possono produrre fenomeni ancor più evidenti di criminalità. Anche la psicoanalisi si è occupata di trovare un’origine alle condotte aggressive, e lo stesso Freud individuò, in un primo momento, l’aggressività come una reazione alla frustrazione sperimentata da una persona durante la ricerca del piacere (ad esempio, il neonato cerca il suo piacere nel cibo, che però non sempre gli viene dato al momento in cui lui ne sente il bisogno; da qui la frustrazione e l’aggressività, che rappresenta una strategia comportamentale per allentare lo stato di tensione generato dal mancato 161 Criminologia ed elementi di criminalistica soddisfacimento immediato del suo bisogno). In una fase successiva, Freud formulò, invece, la teoria della pulsione di morte, Thanatos, antagonista dell’istinto di vita, Eros. Obiettivo dell’istinto di morte era quello di far tornare l’individuo allo stato inorganico di partenza e, a questo, si opponeva l’amore, o Eros, con la sua forza vitale. Il comportamento aggressivo, secondo questo modello, avrebbe dunque il duplice scopo di portare all’esterno questa forza, altrimenti auto-distruttiva, e di ridurre lo stato di tensione pulsionale. In entrambi i casi, però, Freud non mise in discussione il concetto per cui l’aggressività era sostanzialmente una caratteristica innata dell’esistenza umana. E la sua visione della vita era, non a caso, molto pessimista. Le tesi di Freud sono state anche confermate dai c.d. etologi. Konrad Lorenz in testa, che si chiede: cosa fanno gli animali a cui non è permesso lottare per il cibo, per l’accoppiamento, per la difesa del territorio, per il rispetto della loro posizione gerarchica all’interno del gruppo? Esprimono aggressività, si cimentano in estenuanti lotte. Da un punto di vista etologico dunque, l’aggressività è un istinto primario, trasmesso ereditariamente per favorire l’adattamento della specie, anche umana. Gli esemplari maggiormente aggressivi infatti hanno sempre maggiori possibilità di successo nella sfida per la sopravvivenza e possono riprodursi trasmettendo le proprie caratteristiche. 7.3 Delinquenti normali e anormali Fin dall’inizio dell’Ottocento, parallelamente all’affermazione del concetto di pericolosità sociale, si assiste a un sempre maggiore intervento degli psichiatri nello studio e nell’interpretazione di alcuni clamorosi delitti, dando inizio ad un progressivo sviluppo della psichiatria forense con elaborazione di nuove categorie nosografiche, basata, soprattutto, sulla patologia degli istinti e degli affetti. Ma, solo con la fine dell’Ottocento, in tale settore di studio, si verificò una radicale evoluzione, con l’affermarsi della concezione deterministica. è in questo periodo che sorse e si sviluppò la Scuola Italiana di Antropologia Criminale, che introdusse gli strumenti clinici finalizzati alla valutazione della pericolosità sociale: la scienza medica, estese, così, il proprio interesse da alcuni ed eccezionali casi di delinquenza all’intera gamma dei soggetti che commettevano reati. La letteratura del tempo testimonia che i freniatri si preoccupavano, da un lato, di sottrarre il malato di mente alla carcerazione, dall’altro, di collaborare al controllo sociale, attraverso la struttura manicomiale. Tuttavia, l’internamento in manicomio criminale del prosciolto per vizio totale di mente, non era prassi univoca e ineludibile, dedicandosi un’attenzione differenziata ai soggetti riconosciuti affetti al momento della commissione del reato da una malattia mentale che si era poi risolta. Tale prassi, tramontò definitivamente con l’entrata in vigore del codice Rocco e occorrerà attendere le sentenze della Corte Costituzionale del 1982-83 perché si affermi la possibilità di lasciare esente da conseguenze penali il prosciolto per vizio totale di mente. è noto come, in Italia, il codice Rocco abbia dato vita ad un sistema ibrido fondato su un compromesso in tema di pericolosità sociale psichiatrica, concetto che si configura come connotato contemporaneamente da parametri medici e parametri giuridici, il cui carattere più giuridico che scientifico era dimostrato anche dal fatto che la peri162 Aggressività ed anormalità personologica colosità sociale era spesso oggetto di presunzione legale, senza bisogno di un accertamento da parte del perito psichiatra. Si è visto, anche, come il concetto di pericolosità, mentre continua ad avere notevole rilievo in campo giuridico penale, è stato nettamente superato nelle normative riguardanti i servizi psichiatrici, cosicché, mentre la scienza psichiatrica si è rinnovata in modo radicale, la psichiatria forense ha ignorato ogni sostanziale mutamento, spesso arroccandosi su posizioni e richieste, basate su concezioni risalenti all’inizio del secolo, ormai del tutto superate. è forse in considerazione della difficoltà di una prognosi criminale, oltre che per la consapevolezza delle conseguenze stigmatizzanti ed emarginanti che tale giudizio comporta, che il perito tende a centrare tutto il suo elaborato sulla diagnosi psicopatologica, e trascura, o considera in modo marginale, la valutazione relativa alla pericolosità sociale, che, in genere, è limitata a poche righe della relazione conclusiva. Occorre, preliminarmente, notare come l’attuale normativa in materia di misure di sicurezza manicomiali sia il frutto di riserve e perplessità, anche per effetto di uno sviluppo della psichiatria che andava via via ponendo in dubbio la validità scientifica delle nozioni di imputabilità e pericolosità sociale, sottoponendo, inoltre, a revisione critica, le tradizionali nosografie e il concetto stesso di malattia mentale. Il criterio classificatorio nosografico classico distingue i disturbi psichici in anomalie psichiche (distinte a loro volta in deficienze intellettive, reazioni psicogene abnormi e personalità abnormi) e malattie psichiche o psicosi (distinte a loro volta in psicosi organiche e psicosi endogene). 1) Le deficienze intellettive sono caratterizzate da uno sviluppo dell’intelligenza inferiore alla media, attribuibile a carenze congenite o culturali ovvero, specie per le forme più gravi, a un processo morboso anteriore all’età della maturità intellettiva che non viene mai raggiunta (idiozia, imbecillità, insufficienza mentale); 2) Le reazioni psicogene abnormi indicano anomalie episodiche, non abituali, consistenti in una risposta psichica inadeguata per quantità, qualità o durata a eventi esterni emotigeni o psicotraumatizzanti e chiaramente causata da tali eventi; 3) Le personalità abnormi indicano, invece, quelle anomalie praticamente costanti nel soggetto, tali da potersi considerare attributi stabili della personalità. Le reazioni psicogene e le personalità abnormi si distinguono ulteriormente, a seconda che presentino tendenze nevrotiche (nevrosi d’ansia, isteriche, depressive, ossessive, compulsive, postraumatiche, da indennizzo, neurastenie, ecc.), caratterizzate da stati d’ansia in misura eccedente e più duratura rispetto a quella presente in ogni persona, espressione di una conflittualità non risolta, generata da conflitti interiori o interpersonali o con l’ambiente sociale, ovvero, tendenze psicopatologiche (reazioni esplosive, a corto circuito, primitive, negativistiche; personalità istrioniche, esplosivi, impulsivi, disaffettivi, fanatici sessuali, instabili, insicuri, ipomaniacali, ecc.), caratterizzate da anomalie del carattere che favoriscono comportamenti di disturbo e di sofferenza per gli altri, mentre, di regola, mancano conflitti interiori. Dal punto di vista della pericolosità sociale, si deve tener presente che le persone affette da disturbi nevrotici tendono a introiettare gli effetti dei propri conflitti e, quindi, di regola, non pongono problemi di notevole disadattamento sociale e, da un punto di vista statistico, sono di scarso significato criminologico, pur comportando sofferenze personali e familiari (salvo i casi di passaggio all’atto o acting out nevrotico, cleptomania a base ossessiva, e altri casi particolari); le persone affette da psicopatie, invece, pongono più frequentemente problemi di disa163 Criminologia ed elementi di criminalistica dattamento sociale, vivendo una maggiore conflittualità con il mondo esterno, e sono statisticamente molto frequenti nell’ambito della delinquenza abituale e professionale, violenta ed aggressiva. 7.4 I delitti sessuali, tra violenza e aggressività Com’è noto, l’ordinamento penale non prevede le specifiche configurazioni dell’omicidio sessuale e tanto meno degli omicidi sessuali multipli, attribuibili a un unico autore in rapporto ad analogie inerenti a circostanze di tempo, di luogo e di modus operandi. Si tratta di reati che assumono, tuttavia, particolare rilievo nel campo della psichiatria forense: posto che, una volta identificato, l’autore di delitti siffatti viene pressoché sistematicamente sottoposto a perizia psichiatrica. Perizia che, più che dai riferimenti anamnestici a pregressa patologia mentale o a pregressi comportamenti abnormi dell’autore dei reati, è il più delle volte motivata dai fatti-reati, di per se stessi considerati, con particolare riguardo alla tipologia delle vittime e alle circostanze in cui i delitti sono stati realizzati. Il problema della qualificazione aprioristica di determinati omicidi come sessuali e del presunto autore degli stessi come delinquente sessuale rinvia ai complessi rapporti tra sessualità e cultura da un lato, e tra sessualità e diritto, dall’altro. Rapporti che riflettono il modo di porsi della collettività nei riguardi della sessualità, e, di riflesso, il modo di porsi del legislatore (per quanto concerne la produzione legislativa) e dei magistrati (per quanto attiene all’attività giurisdizionale) nei settori che, direttamente o indirettamente, chiamano in causa la sessualità. Si pensi, ad esempio, alle travagliate vicende legislative e alle altrettanto travagliate vicende giurisdizionali in ordine ai problemi del controllo e della soppressione della fertilità, del danno alla funzione sessuale e alla capacità di procreare, del transessualismo e della rettifica di sesso anagrafico, alle norme contro la violenza sessuale di cui alla legge n. 66/96, e così via. Senza alcuna pretesa di approfondire in questa sede l’ampio e variegato tema dei rapporti tra sessualità e cultura da un lato, e fra sessualità e diritto, dall’altro, ci si limita unicamente a rilevare che in questi ultimi anni si è realizzato, nel campo della divulgazione criminologica, quanto si era verificato in passato in altri settori (letteratura, attività artistiche, ecc.), ovvero una proposizione e una lettura, per c.d. aperta, della nozione di sessualità, la quale, per quanto concerne i delitti a ipotetica matrice sessuale, per effetto della suggestione operata dai mass-media, si è progressivamente caratterizzata come nozione alla quale sarebbero sottese rilevanti quote di morbosità e di violenza. In questo contesto, hanno assunto particolare pregnanza emozionale per l’opinione pubblica i delitti che vengono attribuiti ai cc.dd. serial killers, e, più recentemente, anche i delitti che rinviano alla pedofilia. Particolare attenzione deve essere rivolta alle tecniche di accertamento medico-legali nel caso di delitti sessuali connotati da violenza e aggressività. Le indagini giudiziarie in tema di violenza carnale si svolgono normalmente in tre direzioni: a) sul luogo nel quale è avvenuto il fatto, che può essere una località aperta o un ambiente chiuso; b) sulla vittima che si dichiara aggredita e violentata; c) sul presunto colpevole. Durante il sopralluogo giudiziario si dovranno ricercare macchie di sperma, sangue o peli su bian164 Aggressività ed anormalità personologica cheria, altri oggetti o sulla vittima; rilevare le impronte digitali nell’ambiente; reperire sostanze ad azione afrodisiaca, stupefacente, narcotica o antifecondativa; individuare i segni lasciati dalla colluttazione e dalla reazione difensiva della vittima; raccogliere resti di indumenti stracciati, bavagli, lacci od oggetti di specifico significato sessuologico. In caso di morte della vittima, occorre cercare sul suo corpo, oltre ai segni delle lesioni mortali, quelle del delitto sessuale, le tracce di secreto spermatico, peli sulla cute e in tutte le cavità. Per ciò che attiene la diagnostica dei delitti sessuali sulla vittima, essa si divide in: 1) anamnesi, che serve soprattutto a mettere a suo agio l’esaminando. L’interrogatorio su come si sono svolti i fatti consente di verificare concordanze o discordanze con i risultati dell’istruttoria e mette in luce particolari utili per dedurre le modalità della violenza e le sue conseguenze. Lo studio del comportamento dell’esaminando in questa fase, ne permette di inquadrarne il carattere, la moralità, l’emotività, la ritrosia o la sfrontatezza, permette di giudicare lo sviluppo mentale ed eventualmente la necessità di un esame psichico approfondito per diagnosticare l’esistenza di una malattia mentale che condizionasse un’inferiorità psichica, oppure, se residuano turbe psichiche importanti. Può aiutare, inoltre, a mettere in luce una simulazione di violenza, condotta fino al punto da procurarsi ecchimosi e graffiature. Se è possibile, l’esame delle vesti della vittima, permette di riconoscere strappi di allacciature, asportazione di bottoni, lacerazioni indicative di una lotta. Potranno portare tracce organiche del colpevole o della vittima quali sangue, sperma, peli, capelli, saliva e altre secrezioni. 2) Esame obiettivo, che deve verificare se lo sviluppo somatico sia tale da consentire un’efficace resistenza all’aggressore, quindi, si ricercano le lesioni somatiche accertando se sono riferibili all’epoca in cui il reato fu consumato. E inoltre: a) lesioni da costrizione: possono essere ecchimosi e graffi al viso, al collo, agli arti superiori, al torace, dovute a manovre di immobilizzazione, sulla faccia interna delle cosce da divaricazione delle stesse, ma anche più gravi, da corpi contundenti, nel tentativo di stordire la vittima o vincerne la resistenza; b) lesioni da eccitazione sessuale, quali ecchimosi da suzione, ecchimosi digitali da palpamento, ferite da morso; c) lesioni da perversione sessuale, quali percosse o flagellazioni; d) lesioni da tortura, come tagli, pizzicotti, ustioni da sigaretta, ecc.; e) lesioni da congiunzione carnale: 1. deflorazione, consistente nella rottura dell’imene durante il primo coito completo. L’imene presenta spesso delle incisure congenite che ne interessano il bordo senza arrivare alla base d’impianto; le rotture da deflorazione sono profonde, e distribuite solo nella metà posteriore, si mettono bene in evidenza stirandolo anteriormente con adeguato strumentario o premendo anteriormente durante esplorazione rettale. Le lesioni recenti comportano tumefazione, arrossamento, ecchimosi e modesto sanguinamento, ma già dalla terza giornata cominciano a ripararsi, completandosi il processo in 8-10 giorni. Sono possibili deflorazioni senza coito e, viceversa, coiti senza deflorazioni per particolare elasticità della membrana; 2. lesioni da coito violento: nella donna adulta si producono ecchimosi ed escoriazioni sulla mucosa del vestibolo o sulle grandi e piccole labbra. Se il coito, anzichè violento, è abusivo, la normale lubrificazione evita lesioni dei genitali. Se il fatto è molto recente, si possono repertare tracce di sperma in vagina, peli vulvari; è sempre opportuno prelevare campioni di secrezione vulvo-vaginale per esami di laboratorio. Nella bambina stuprata, le lesioni sono molto profonde e gravi, possono interessare la vulva, la vagina, il perineo, il retto, la vescica o i fornici vaginali; frequenti le complicanze emorragiche o infettive, anche mortali. Al165 Criminologia ed elementi di criminalistica tre volte, l’atto sessuale di un adulto con bambine si limita al coito vestibolare, in questo caso i residui di sperma si possono trovare intorno ai genitali o sulle vesti. L’uso di falli artificiali o di altri corpi estranei può portare a lacerazioni della mucosa vulvo vaginale o rettale anche in donne adulte (atti di libidine violenta); 3. lesioni da coito anale: lo sfintere anale contratto offre notevole resistenza alla penetrazione, per cui, sono frequenti ecchimosi escoriate della mucosa rettale, rottura di vasi emorroidari o addirittura lacerazioni dello sfintere. Le lesioni più superficiali riparano in pochi giorni. Lo sperma viene eliminato alla prima evacuazione spontanea dell’ampolla rettale; 4. Lesioni da coito orale: la vittima è in genere ridotta all’impotenza psichica, per cui, asseconda l’aggressore; questo ha il duplice effetto di evitare lesioni orali alla vittima e genitali all’aggressore. Lo sperma può essere deglutito o sputato, nonostante la pulizia orale è possibile rinvenire spermatozoi nella saliva se il prelievo è effettuato entro alcune ore dalla violenza; 5. Lesioni da rapporti carnali ripetuti: nella violenza carnale continuata si potranno riscontrare lesioni ecchimotiche o ferite in stadi evolutivi diversi, soprattutto per manovre sadiche da parte dell’aggressore, poichè in genere, dopo la prima violenza, subentra uno stato di apatia e di passività che non permette ulteriori tentativi di resistenza. Per ciò che attiene l’autore della violenza, l’esame del presunto colpevole ha lo scopo di accertarne le tendenze sessuali, le condizioni mentali e fisiche, la forza muscolare, l’idoneità al coito. Talvolta si rilevano lesioni lasciate sul suo corpo dalla reazione della vittima. Un tempo la violenza carnale era un delitto compiuto da una sola persona; oggi invece assume sempre più le caratteristiche di un crimine di gruppo. 7.5 Asfissia autoerotica (o asphyxophilia) In ambito criminologico, l’asphyxophilia viene definita come un particolare tipo di parafilia, e considerata una pratica estrema e pericolosa. Solitamente, viene impiegata nell’auto-erotismo e si basa sul soffocamento/strangolamento, anche se, tale tecnica può essere utilizzata nel sesso di coppia. La pericolosità dell’asphyxophilia si concentra nel momento in cui l’azione non viene arrestata in tempo, dando luogo, per la vittima, a stati di incoscienza (per mancata ossigenazione del cervello) e impedendo alla stessa di smettere tale gioco, che porta, in numerosissimi casi, al c.d. decesso per asfissia. Nel sesso di coppia, ha inizio con una fase definita soft, e con il tempo si arriva a situazioni di cui si perde il totale controllo. Secondo recenti dati dell’OMS, ogni giorno, in tutto il mondo, 10 persone muoiono a causa di tali tecniche erotiche. Ricompressa tra le parafilie, l’asphyxophilia consiste, pertanto, nel gratificarsi sessualmente tramite auto-strangolamento o asfissia: uno studio compiuto dall’FBI ha stimato che la morte per asfissia autoerotica costituisce il 31% dei moventi nelle impiccagioni di tutti i giovani adolescenti. Lo strangolamento o l’impiccagione (anche incompleta) durante la masturbazione sembra che dia delle forti sensazioni erotiche. Generalmente viene praticata stringendo il collo o infilandosi un sacchetto di plastica in testa, o stringendo il collo in legacci da strangolamento, o, ancora, attraverso l’induzione di corrente elettrica, areosol o propellenti vari di natura chimica. 166 Aggressività ed anormalità personologica Le pratiche di asfissia autoerotica sono state documentate fin dal 1600, principalmente in Oriente e successivamente in Sud America: esse venivano anche utilizzate come trattamento per disfunzioni sessuali e impotenza. Generalmente, nei casi di asfissia autoerotica una caratteristica costante della vittima è la sua nudità: sono molto rari, infatti, i casi in cui i soggetti erano vestiti; qualora ci si trovasse di fronte a casi di questo genere, è più probabile che si tratti di un vero e proprio suicidio e non di un incidente di percorso. Molto spesso, vengono ritrovati sulla scena del crimine materiale pornografico o abiti femminili, che, probabilmente, il soggetto indossa giocando il doppio ruolo del sadico, che immagina di essere l’assassino, e di una personalità masochista, femminile, in cui una donna viene torturata. Purtroppo, su queste scene, si notano, spesso, tracce di tentativi o meccanismi di autosalvataggio, evidentemente falliti. Tecnicamente, la sindrome dell’asfissia autoerotica viene descritta dagli esperti come impiccagione eroticizzata e ripetitiva, meglio conosciuta, appunto, come asphyxophilia. Viene praticata sia da uomini che da donne; può essere la causa di una morte per apparente impiccagione o per asfissia, senza prove evidenti di un omicidio e senza indizi per avvalorare la tesi del suicidio. Anche i serial killer si sono spesso interessati particolarmente a questa modalità erotica, primo fra tutti, l’agente di polizia Gerard Schaefer, in forza nella comunità rurale di Brevard, in Florida. Schaefer rapiva giovani autostoppiste che poi conduceva nel bosco, immobilizzandole o legandole strettamente fino al sopraggiungere della morte, associando le torture all’impiccagione; alcune delle vittime, abbandonate nel bosco, furono rinvenute in avanzato stato di decomposizione mentre altre, invece, erano miracolosamente sopravvissute. Anche i Serial Killer John Gacy, Joseph Berdella e Gianfranco Stevanin erano dediti a questo tipo di pratiche utilizzate per la soppressione delle loro vittime, strangolandole, soffocandole e, addirittura, in alcuni casi, anche fotografandole, per perpetuare l’estrema eccitazione dell’attimo fatale precedente alla morte. Un maschio, bianco, età intorno ai 25 anni, venne trovato morto nella sua stanza d’albergo. Il cadavere era completamente nudo e in posizione supina, il capo era alzato da terra, poiché una cordicella di cuoio era stretta intorno al collo e legata ad una maniglia; intorno a lui vi erano delle riviste pornografiche. Un’attenta indagine medico legale chiarì che non si trattava nè di suicidio, nè di omicidio. Come è possibile che un medico legale o un investigatore si trovi davanti a una morte, avvenuta apparentemente per impiccagione, o tecnicamente per asfissia, senza prove evidenti di un omicidio e in privazione totale di indizi atti ad avvalorare la tesi del suicidio? La spiegazione, per quanto drammatica e sconvolgente, è, in realtà, terribilmente semplice: la vittima stava cercando solo una gratificazione sessuale attraverso l’utilizzo di una pratica erotica piuttosto desueta, ma in netta crescita, e terribilmente pericolosa, anche se esaltante. Si pensi che il fenomeno ha registrato, solo negli Stati Uniti, 320 casi nel 2002, saliti drammaticamente a quasi 1.000 casi nel 2004. Naturalmente, per ovvi motivi, non sempre è possibile determinare con certezza le reali cause della morte o identificare il numero esatto dei decessi riconducibili a questa 167 Criminologia ed elementi di criminalistica categoria, il che spiega l’estrema flessibilità delle statistiche, ma appare evidente che la tendenza è in costante aumento. Non si conosce dunque il numero esatto delle persone decedute nel corso dell’espletamento di tali pratiche erotiche, né il numero di soggetti che ne fanno regolarmente uso, ma si sa per certo che il fenomeno interessa comunemente maschi compresi nell’età adolescenziale tra i 12 e i 25 anni, per almeno il 71% dei casi accertati. Gli aspetti medico legali che possono indurre gli investigatori a sospettare eventuali casi di morte per autoasfissia erotica sono generalmente: strangolamento, impiccagione, legacci da strangolamento, soffocamento e compressione del petto, e, più genericamente: decessi sospetti avvenuti per infarto, colpo apoplettico o assideramento, che potrebbero parimenti essere riconducibili alle più comuni pratiche autoerotiche. Ultimamente, le modalità di esecuzione di queste particolari attività di autogratificazione sessuale vengono parificate anche a una serie di fenomeni minori, tutti estremamente pericolosi e in grado, se applicati in mancanza di condizioni di sicurezza, di condurre alla morte del soggetto per: compressione del collo o del torace, esclusione dell’ossigeno, chiusura delle vie aeree, elettrocuzione e inalazione di gas, assunzione di veleni, eccitanti, sedativi o dopanti, miscugli di sostanze tossiche o non tossiche ma pericolose se mischiate assieme, somministrazione incontrollata di anestetici, bondage o giochi erotici estremi di ruolo e di coppia. Per quanto macabro possa sembrare, la diffusione massima di questa pratica si ebbe quando, all’epoca delle impiccagioni, vennero notate nei cadaveri degli impiccati tracce di erezione, e in alcuni casi anche di eiaculazione, sopravvenuta al momento contestuale della morte. Poi spiegato scientificamente, il fenomeno venne originariamente collegato alla carenza di ossigeno e allo stato di asfissia che è legato all’impiccagione, anche se tutti i patologi sanno che è cosa piuttosto comune riscontrare nei cadaveri, anche in assenza di morti asfittiche, alcune gocce di sperma sull’orifizio uretrale, dovute semplicemente alla paresi e al rilassamento post-mortem degli sfinteri. Questo genere di pratiche, comunque, ebbe originaria diffusione in Oriente e in Sud America; in India, ancora oggi, sono frequenti i giochi erotici tra bambini messi in atto tramite soffocamento o impiccagione, e anche la letteratura non ha mancato di dare il suo contributo, con opere quali Justine del Marchese de Sade, Billy Budd di Melville, e Godot di Beckett. Risale al 1856, invece, la prima pubblicazione scientifica sull’argomento a firma dello psichiatra francese De Boismont, che riscontrava come circa il 30% dei casi sospetti di adolescenti o adulti maschili deceduti per impiccagione era legato a manifestazioni evidenti di erezione o eiaculazione. In seguito, nel 1928, un’enciclopedia austriaca pubblicò la voce penis strangulation, come pratica di asfissia autoerotica. Successivamente, fu Bloch a descrivere le pratiche di soffocamento delle donne durante i rapporti sessuali, e fu Ellis a narrare dell’impulso di strangolare l’oggetto di desiderio sessuale. Gonzales, Vance e Helpburn furono i primi a introdurre l’argomento in ambito forense. Nel 1953, Stearn pubblicò uno studio effettuato su una casistica di 97 suicidi avvenuti nel Massachusets tra il 1941 e il 1950, provando che 25 persone di quelle 97 168 Aggressività ed anormalità personologica non avevano avuto alcuna intenzione di suicidarsi, ma erano piuttosto decedute nel corso dell’espletamento di pratiche di asfissia autoerotica. Successivamente, negli anni settanta, l’FBI commissionò un’apposita ricerca, eseguita dall’agente speciale Roy Hazelwood e dallo psichiatra Dr. Park Dietz, in collaborazione con la dottoressa Ann Burgess, i cui risultati vennero pubblicati nel libro Autoerotic Fatalities, al momento, il trattato più completo ed esaustivo sull’argomento. Originariamente, si pensava che questa pratica interessasse solo le fasce adolescenziali, successivamente venne invece provato che, se pur con minore incidenza, il fenomeno riguardava anche maschi in età adulta. Uno dei casi più esemplificativi al riguardo concerne il caso di un maschio, adulto, di 47 anni, divorziato, di professione dentista, rinvenuto cadavere nel suo studio con una maschera da anestesia sul volto. Anche le donne, che in un primo tempo si riteneva non fossero interessate dal fenomeno, possono a volte essere dedite a questo tipo di pratica, che, per definizione, si riterrebbe erroneamente maschile. Caso esemplificativo quello di una donna di 35 anni, ritrovata impiccata nell’armadio del bagno di casa sua: il cadavere, rinvenuto nudo in uno spazio angusto nei pressi dell’anta dell’armadio, aveva i piedi appoggiati contro il muro ed era in posizione prona, un vibratore ancora funzionante a contatto con la vagina della donna indirizzò gli investigatori inizialmente verso altre piste, fino a quando la figlia, di soli nove anni, della vittima testimoniò che erano sole in casa al momento del fatto. In ogni caso, oggi, gli investigatori sanno che una nudità, completa o parziale, nei casi di asfissia, strangolamento o impiccagione, può far propendere decisamente le indagini verso la pista dell’asfissia autoerotica. Confondono invece le statistiche: i casi in cui i parenti più prossimi, rinvenendo il cadavere nudo, si affrettano a rivestirlo, inquinando le prove e modificando la scena del crimine. A volte, poi, la maggior parte delle morti autoerotiche sono caratterizzate da travestitismo o masochismo; in questi casi, le vittime, eterosessuali e di sesso maschile, indossano capi di abbigliamento femminile. Si ipotizzano, allora, giochi di ruolo in cui il soggetto, indossando panni femminili, simuli di immedesimarsi in una donna allo scopo di sdoppiarsi per creare una doppia personalità, in cui, il lato maschile, di tipo sadico, possa infliggere punizioni erotiche all’altra personalità, femminile, caratterizzata da un evidente masochismo, di modo che, idealmente, è una donna ed essere torturata e seviziata. Tracce di questa pratica, che non è mai stata riscontrata all’inverso, ossia casi di donne travestite da uomini, si ritrovano nel film-cult, il Silenzio degli Innocenti. Risale al 1994 un caso esemplificativo in questo senso: un ingegnere di 46 anni viene trovato morto nella sua abitazione, appeso a un gancio e travestito da donna con minigonna nera, collant e tacchi a spillo; nel video registratore, una cassetta hard che riproduce la medesima simulazione, nell’esecuzione della quale, però, il malcapitato, avrebbe avuto difficoltà a collegare il complicato marchingegno di cappi e nodi scorsoi, inducendosi inconsapevolmente la morte. Nel 1981, l’agente speciale dell’FBI, Roy Hazelwood, delineò le caratteristiche tipiche della scena classica di morte per asfissia autoerotica, che sono: prove di asfissia prodotte 169 Criminologia ed elementi di criminalistica da strangolamento o impiccamento, posizione del corpo favorevole a causare la morte per asfissia, indizi che la morte sia causata da un incidente o da un mancato funzionamento dei mezzi di salvataggio, elementi sulla scena del crimine che provino un meccanismo di autosalvataggio fallito, prove di attività sessuale solitaria, in mancanza dei quali si può ipotizzare un omicidio, un suicidio assistito o un incidente occorso durante un rapporto sessuale a due persone, prove di aiuti alla fantasia sessuali, pornografia o altro materiale presenti sulla scena della morte, precedenti indizi di dedizione alla pratica autoerotica, nessuna intenzione o motivazione apparente che possa giustificare il suicidio. In questo senso, risulta particolarmente eclatante il caso di un cadavere rinvenuto in un canale, di una donna morta per asfissia e annegamento. Il fidanzato della vittima, arrestato, di soli 26 anni, dichiarò che la donna era morta per strangolamento durante un gioco erotico di coppia, ma fu arrestato per omicidio perché la ragazza, in realtà, aveva solo perso i sensi, trovando poi la morte per annegamento solo al momento in cui l’indiziato tentava di occultarne il presunto cadavere gettandolo in un corso d’acqua. 7.6 Necrofilia e necrofagia La necrofilia consiste essenzialmente nel realizzare la soddisfazione sessuale attraverso contesti di morte, che siano scene macabre o rituali ad essi legati o addirittura contesti rappresentati proprio da un atto sessuale con il cadavere: a proposito di quest’ultima possibilità, in linea di principio, il necrofilo non è responsabile della morte del partner. Di fronte al cadavere, il soggetto affetto da tale parafilia, può masturbarsi o esigere, per il soddisfacimento della propria carica sessuale, una penetrazione giungendo così all’amplesso. L’elemento più che centrale in questa perversione è la deumanizzazione del partner/vittima, elemento peraltro molto importante già per quanto riguarda il feticismo; tale deumanizzazione non è altro che il tentativo complesso e contorto, da parte del soggetto, di soddisfare la carica a riguardo di desideri impossibili. Relazionandosi col cadavere, il soggetto annulla completamente il rischio di minacce o prepotenti sensi di colpa: così facendo, ossia raggiungendo l’amplesso con un partner deumanizzato, può trasformare vecchie sconfitte infantili in momenti di trionfo e soddisfazione. Certo è che la necrofilia può essere espressa a più livelli: attraverso la capacità immaginativa, e dunque rimanere fantastica, magari pagando una prostituta che si finga morta; può essere vissuta attraverso un amplesso con oggetti inanimati tipo le bambole gonfiabili. L’estremo è rappresentato dal realizzare, in pieno, tale forza sessuale, ossia procurandosi in qualche modo un cadavere oppure ‘generandolò’, ossia uccidendo qualcuno a tal fine. La gravità in chiave morale di questo disturbo, più che esplicarsi nell’immagine fisica stessa di un atto sessuale consumato con un cadavere, può essere ben chiara, facendo alcune considerazioni: di solito, si parla di normalità delle condotte sessuali quando il comportamento si svolge tra soggetti realmente consenzienti e non reca disagio, sofferenza o problemi legali (nella cultura di riferimento) a nessuno dei partecipanti all’attività, quando non rappresenta una condotta esclusiva svolta come una compul170 Aggressività ed anormalità personologica sione e non interferisce con lo svolgimento di attività lavorative e/o sociali; allo stesso modo, si definisce patologico, quando causa, anche ad uno soltanto dei partecipanti all’attività, disagio, sofferenza, interferenze con le attività lavorative e/o sociali, quando si compie come una compulsione, quando reca danni, quando causa problemi legali. Vedendo così la questione, può sicuramente risaltare la macabra deumanizzazione del partner che rende una tale scelta di condotta sessuale piena e colma di psicoticismo e negazione del senso di realtà. Freud suddivide le perversioni a seconda che sia mutato l’oggetto o la meta; è nella prima categoria che egli include la necrofilia per la quale gli individui che pur pretendendo l’intero oggetto avanzano su di esso richieste ben determinate, strane o mostruose, persino quella che debba essere un cadavere indifeso, e che tale rendono con criminale violenza per poterne godere. Freud sostiene, ancora, che proprio nel campo della vita sessuale si incontrano difficoltà se si vuole tracciare un confine netto fra la mera variazione all’interno dell’ambito fisiologico e i sintomi patologici. Tuttavia, certe perversioni dal punto di vista del contenuto, si allontanano talmente dalla normalità che non possiamo fare a meno di dichiararle morbose, in special modo quelle nelle quali la pulsione sessuale giunge nel superare le resistenze (pudore, disgusto, orrore, sofferenza) ad atti stupefacenti (coprofilia, necrofilia). Sembra quindi possibile dedurre, dalle parole di Freud, che le sole vere perversioni siano queste, e ciò farebbe supporre che, proprio perché estreme, esse siano quantomeno rare. Al contrario, anche queste vivono sempre presenti, anche se in parte mascherate, in ognuno di noi. Questa affermazione tende ad essere provocatoria, ma ciò non toglie che istinti necrofili, coprofili e cannibalici sono parte integrante della psiche umana. Il mito, come sappiamo, è la rappresentazione di qualcosa che appartiene all’umanità intera e la necrofagia è scritta nel mito: Zeus, figlio di Crono e di Rea, sarebbe stato divorato come i fratelli, se la madre non lo avesse nascosto sul monte Ida. Se il mito ci pare troppo lontano, basta cercare in epoche ben più recenti per ritrovare decine di casi descritti e documentati anche in anni recentissimi. Negli anni venti, Karl Denice, il cannibale della Slesia massacrò e divorò almeno 31 persone. In Germania, negli anni trenta, Peter Kuerten, il famoso mostro di Dusseldorf, assassinò nove bambine, delle quali bevve il sangue. In Russia, tra il 1978 e il 1990, Andrei Romanovich Chikatilo, soprannominato il mostro di Rostov, violentò, uccise e in parte mangiò, 21 bambini, 14 bambine e 18 giovani donne. A Milwaukee, alla fine degli anni ottanta, Jeffrey Dahmer, si cibò di almeno tre delle sue 17 vittime. Nel 1995, i due fratelli Novinov, Anatolij di 23 anni e Andrij di 18, furono condannati per aver ucciso e poi mangiato un vagabondo. “Non tutto − dichiararono al processo - soltanto le parti più gustose”. Le perversioni possono essere definite come comportamenti psico-sessuali che si esprimono in forme atipiche rispetto alla norma. L’estensione di questo concetto è dunque strettamente dipendente dal tipo di norma che si assume come criterio di riferimento. Freud parla di completo sviluppo della libido che, dopo aver percorso la fase orale, anale e fallica, si esprime in quella genitale come relazione eterosessule; definisce perversa ogni condotta che si discosta dalla norma, o in ordine all’oggetto sessuale, come nel caso dell’omosessualità, della pedofilia, della zooerastia, o in ordine alla zona 171 Criminologia ed elementi di criminalistica corporea, quando il piacere sessuale è raggiunto con parti del corpo di per sé non deputate all’esercizio della sessualità, o in ordine alla meta sessuale che può essere raggiunta solo in presenza di condizioni di per sé estrinseche, come nel caso del feticismo, del travestitismo, della scopofilia, dell’esibizionismo, del sadomasochismo e simili. Da questo repertorio, risulta che Freud limita il concetto di perversione alla sfera sessuale ma solo perché ritiene che queste deviazioni, come nel caso dei disturbi dell’alimentazione, dipendano dalle ripercussioni della sessualità sulle funzioni nutritive. Assunta come norma l’organizzazione genitale, tutte le forme di regressione o di fissazione a stadi precedenti, in cui la sessualità si esprime attraverso pulsioni parziali strettamente legate alle diverse zone erogene, sono considerate perverse. Naturalmente, se si considera la sessualità originariamente perversa in quanto non si stacca mai completamente dalla sua origine, quando il piacere non era cercato in un’attività specifica, ma annesso ad attività dipendenti da altre funzioni come l’alimentazione, la defecazione, ecc., allora, è perversa ogni attività sessuale che non si sia definitivamente staccata dalla polimorfia che caratterizza la sessualità infantile. Freud definisce la perversione come il negativo della nevrosi, nel duplice senso che il perverso mette in atto impulsi che il nevrotico rimuove, e che di fronte all’angoscia, il perverso, si difende regredendo a forme di sessualità infantile, mentre il nevrotico adotta altre forme di difesa successive o sostitutive della regressione. Il termine necrofilia fu coniato dal belga Guislain verso la metà del diciannovesimo secolo per definire una categoria di alienati distruttivi e che in seguito fu applicato a ogni tendenza manifesta a compiere atti sessuali con un cadavere. Galimberti definisce la necrofilia come un investimento erotico di scene macabre che approda a rituali con significati funerei ricercati, contemplati, e talvolta eseguiti, fino a giungere, in casi più rari, a rapporti sessuali con cadaveri. Per E. Fromm, la necrofilia va letta come la forma più radicale dell’aggressività umana che si oppone alla biofilia o amore per la vita. Associata a pulsioni sadiche, la necrofilia non è esente da un tratto feticistico nell’accezione del feticismo del cadavere. Rientrano in questo quadro la necrofagia che induce a cibarsi dei cadaveri e il necrosadismo che sembra più prossimo alla necrofilia che al sadismo, dato che la vittima, per ragioni evidenti, non prova dolore, e consiste nella mutilazione e nello scempio di cadaveri, con i quali si sono generalmente avuti in precedenza rapporti sessuali. A volte, il necrosadismo sostituisce interamente l’amplesso; altre volte, invece, come nel caso di Jack lo Squartatore, il necrosadismo si manifesta come fase conclusiva dell’assassinio sadico. Il termine necrofagia (o cannibalismo) si riferisce invece alla pratica reale o rituale di mangiare la carne dei propri simili; nel mondo animale è noto nella mantide religiosa e in alcune specie di ragni. Il termine cannibalico, in particolare, è stato adottato dalla psicoanalisi in riferimento alla fase orale dello sviluppo libidico, e, più specificamente, alla componente sadica presente in tale fase dove si assiste al desiderio di incorporazione dell’oggetto amato che sarà sostituito, nel corso dell’evoluzione psicosessuale, dall’identificazione. L’incorporazione, o introiezione, rappresenta una forma di identificazione primaria analoga a quella che caratterizza il cannibalismo dei primitivi, motivato, secondo Freud, dalla credenza che assimilando in sé, mediante ingestione, parti del corpo di qualcuno, ci 172 Aggressività ed anormalità personologica si impadronisce anche delle qualità che a costui erano proprie. Lo stesso significato di appropriazione è attribuito da Freud al pasto totemico, compiuto agli albori della storia dell’uomo, quando i figli si allearono tra loro e, dopo aver ucciso il padre che interdiceva loro l’uso delle donne del clan, lo divorarono. Il senso di colpa che ne seguì segnò la fine dell’orda primitiva e l’inizio dell’organizzazione sociale, della morale e della religione. K. Abraham suddivide la fase orale in due sottofasi: di suzione, caratterizzata dalla fusione di libido e aggressività, e di morsicamento e attribuisce l’aggettivo cannibalico soltanto alla seconda, dove distingue un cannibalismo parziale da un cannibalismo totale. Quest’ultimo senza alcuna limitazione, è possibile solo sulla base di un narcisismo illimitato. In questo stadio è tenuto in considerazione soltanto il desiderio di piacere del soggetto. L’interesse dell’oggetto non trova assolutamente considerazione; l’oggetto viene distrutto senza alcuno scrupolo. Lo stadio del cannibalismo parziale porta ancora in sé i chiari segni della sua origine dal cannibalismo totale, ma ne differisce anche in modo radicale. Il primo inizio di considerazione dell’oggetto fa qui la sua comparsa. Questo parziale riguardo è da considerare come primo inizio dell’amore oggettuale in senso stretto, poiché significa l’inizio di un superamento del narcisismo. Aggiungiamo subito che l’individuo, a questo stadio evolutivo, è ancora ben lontano dal riconoscere un altro individuo come tale accanto a sé, e dall’amarlo fisicamente o psichicamente nella sua totalità. Il desiderio è ancora quello di prendere una parte dell’oggetto allo scopo di incorporarlo; questo significa, nello stesso tempo, però, una rinuncia alla meta puramente narcisistica del cannibalismo totale. Anche Abraham afferma che gli stati più gravi di rifiuto dell’alimentazione del melanconico rappresentano un’autopunizione per gli impulsi cannibaleschi, ma il suo interesse per la rappresentazione cannibalica dell’oggetto perduto è rivolto al lavoro del lutto in analogia alla concezione che il lutto, nella sua forma arcaica, si esprime nel divoramento dell’ucciso. Tuttavia, mentre con Abraham il gesto cannibalico viene esplorato soprattutto nel suo versante finalistico, con M. Klein, questo concetto è impiegato soprattutto nell’area della patologia depressiva, dove la pulsione cannibalica, se è eccessiva, è causa della melanconia: il processo fondamentale della melanconia, secondo Freud ed Abraham, è quello della perdita dell’oggetto amato. La perdita reale di un oggetto reale, o un evento analogo che abbia lo stesso significato, ha come risultato che l’oggetto viene collocato nell’Io. A causa, tuttavia, di un eccesso di pulsioni cannibalesche nel soggetto, questa introiezione abortisce e ne consegue la malattia. La fase cannibalesca è, quindi, la prima organizzazione della libido in cui l’attività sessuale e il cibo non sono ancora differenziati e la meta sessuale consiste nell’incorporazione dell’oggetto. L’identificazione è la fase preliminare della scelta oggettuale: l’Io vorrebbe incorporare in sé tale oggetto e, data la fase cannibalesca, vorrebbe incorporarlo divorandolo. L’aggressività mescolata alla pulsione sessuale è un residuo di appetiti cannibaleschi a cui partecipa l’apparato di impossessamento che serve a soddisfare l’altro grande bisogno (l’assunzione del cibo) ontogeneticamente più antico. Freud sostiene che dei tre più antichi desideri pulsionali, cannibalismo, incesto e omicidio, la nostra civiltà ha vietato a tutti solo il primo. Nel 1921, parlando dell’identificazione e del fatto che essa si comporta come un derivato della prima fase orale del173 Criminologia ed elementi di criminalistica l’organizzazione lipidica, ricorda che il cannibale rimane fermo a tale stadio; egli ama i nemici che mangia e non mangia se non quelli che in qualche modo può amare. Sartre affermava che il più alto atto d’amore era divorare l’amato per portarlo in se per sempre. 174 CAPITOLO 8 Le teorie criminologICHE 8.1 Teoria delle aree criminali Secondo questa teoria, è l’ambiente l’elemento fondamentale per la genesi di un comportamento criminale; ed è da questa dimensione che risulta funzionale partire, iniziando, in termini operativi, dall’indagine di determinate zone, nelle quali la percentuale di criminalità è superiore ed evidente, ma, nonostante l’avvicendamento degli abitanti, rimane persistente: questi ambiti vengono denominati aree criminali. Queste sono rappresentate, in massima parte, da quartieri degradati, dove alta risulta essere la domanda di assistenza economica e sociale, e dove le dimore sono eccezionalmente gremite, a detrimento, evidentemente, delle condizioni generali di salubrità, nonché di igiene. Nelle aree in questione, è, inoltre, maggiore la presenza di minoranze etniche e di soggetti emarginati dalla società. Chi abita queste aree ha poche possibilità e facoltà di scelta, poiché l’unico modo di andare avanti è quello di adattarsi. Questi soggetti rappresentano per la società un fattore degradante, ed è per tale motivo che vengono respinti dal mondo evoluto; la società li ghettizza, negando qualsiasi forma di riscatto o risocializzazione; ed ecco, allora, che l’unica forma di sostentamento, diventa l’attività criminale generalizzata, con il compimento di fatti previsti dalla legge come reato, con particolare riferimento ai furti, o alle rapine. Laddove risulti maggiore il processo di industrializzazione, e quindi il controllo istituzionale, minore sarà la densità criminale. Al contrario, in Paesi dove regna l’oppressione e le condizioni socio-economiche sono instabili, le aree criminali assumono proporzioni smisurate e diventano ingovernabili; quando a tali fattori si sommano odi razziali, scontento economico e mancato riconoscimento dell’autorità di governo, prendono il sopravvento associazioni o bande criminali che dettano le loro leggi, spingendo, in taluni casi, la popolazione ad azioni di guerriglia o a vere e proprie guerre. 175 Criminologia ed elementi di criminalistica 8.2 Teoria della patologia sociale Secondo questa teoria, la società risulta essere un insieme di parti tra loro integrate e in equilibrio. è Talcot Parsons, teorico di origine americana e appartenente al c.d. Strutturalismo a porre le basi di uno studio più incisivo della società, rappresentando, inoltre, che la socializzazione è strettamente legata al meccanismo di ruoli e di apprendimento. Il ruolo viene inteso come un insieme di aspettative e di comportamento, legate a posizioni sociali occupate da figure come i genitori, gli operatori amministrativi, e così via. Parsons, vede la società, quindi, come un aggregato di ruoli, conferendone, poi, alle istituzioni la metabolizzazione e l’apprendimento. I comportamenti devianti, secondo la visione del teorico americano, altro non esprimerebbero se non una patologia di carattere sociale dovuta a una deficienza di apprendimento dei ruoli. Se la devianza viene considerata come patologia individuale, secondo Parsons, si è in presenza di patologie mentali, che tendono a distorcere la percezione della realtà sociale, retta da un equilibrio. I critici hanno ritenuto questa teoria apparentemente conservatrice, poiché mancante di un’analisi efficace, nonché permeata di contraddizioni e conflitti. La teoria è da ritenersi, comunque, interessante poiché, sotto l’ottica dei ruoli e delle conseguenti aspettative, è in grado di offrire singolari spunti di riflessione per ciò che attiene la dimensione della strutturazione sociale. 8.3 Teoria dei conflitti culturali Il punto di partenza di questa teoria è rintracciabile in quella che viene definita come perdita di potere dei comuni sistemi di controllo sociale: quando un individuo si trova al centro di sistemi culturali disuguali, è possibile che questi creino una sorta di instabilità del singolo, spingendolo a una condotta deviante. Il problema riguarderebbe, pertanto, quella generale mancata integrazione, da parte degli individui, causata dalla necessità di dover vivere in uno spazio sociale connotato da valori e dinamiche ambientali estremamente differenti e, soventemente, in contrasto con i propri; pertanto, questi soggetti percepiscono una crisi di valori etici che, un tempo, dava loro la possibilità di potere mettere a punto, e regolare, la propria condotta. Il vivere secondo due sistemi culturali diversi si tradurrebbe, per il soggetto, in una situazione di incertezza, di disagio, di insicurezza, esponendolo a un serio rischio di disadattamento che può portarlo a comportamenti criminali, che avranno la duplice funzione di estinguere entrambi i sistemi di valori, rimpiazzandoli con la propria cultura di carattere deviante. Quando sarà la società a rigettare e discriminare l’ospite estraneo, unitamente alla sua originaria cultura, allora, i conflitti culturali, denominati secondari, diverranno particolarmente difficili. 176 Le teorie criminologiche 8.4 Teoria delle associazioni differenziali Secondo questa teoria, attraverso l’interazione con altri individui, e quindi, mediante il processo comunicativo, verbale e non, è possibile, per Sutherland, apprendere il comportamento criminale. Il meccanismo di apprendimento del crimine si attiva, in particolar modo, all’interno di un micro-gruppo, connotato da relazioni interpersonali. Nelle associazioni differenziali, i normali mezzi di comunicazione (mass-media), che non hanno la peculiarità di essere mezzi di relazioni interpersonali, ma impersonali, sembrano, a tal fine, meno efficienti. Secondo questa teoria, l’apprendimento del crimine comporta, altresì, l’apprendimento di tutte le tecniche connesse alla commissione del crimine, incluse quelle relative ai comportamenti dell’autore. Il soggetto, successivamente, orienterà la sua condotta in base alle interpretazioni apprese, favorevoli o sfavorevoli, ed inerenti la codicistica legale. Quando all’interno del gruppo dove vive, le caratterizzazioni favorevoli alla violazione della legge sono in eccesso rispetto a quelle sfavorevoli, secondo Sutherland, un soggetto diviene criminale. Un individuo, pertanto, diviene un criminale, non solo perché è stato in contatto con modelli criminali, ma anche a causa di un isolamento dai modelli che criminali non sono. Dovranno, altresì, essere tenuti in considerazione ulteriori elementi quali l’intensità, la frequenza, la durata. 8.5 Teoria dell’identificazione differenziata La teoria delle associazioni differenziali venne rielaborata − nel 1960 − da Glaser, il quale, sulla base della teoria dei ruoli, convertì la teoria dell’associazione differenziale in quella denominata dell’identificazione differenziata. Glaser, nella sua rielaborazione, sosteneva che ai fini dell’apprendimento della criminalità risulta fondamentale l’identificazione con modelli criminali, più che l’associazione con tali modelli. L’elemento fondamentale per la criminogenesi è, quindi, il meccanismo di identificazione, quale processo psichico; attraverso quest’ultimo, si tende, in maniera inconscia, a somigliare a certi modelli, selezionati come ideale del proprio Io. Durante tale processo, l’individuo fa, conseguentemente, come propri, anche i valori normativi ed etici associati a tale schema ideale introiettato. L’identificazione non richiede un contatto interpersonale, poiché può avvenire anche verso modelli immaginari o reali, con i quali non si è stati in relazione diretta. L’identificazione con soggetti criminali può avvenire in diversi modi: a) a seguito di partecipazioni dirette ad associazioni di delinquenti; b) mediante una stima positiva dei ruoli delinquenziali rappresentati dai mass media; c) a seguito di una reazione negativa a energie che si oppongono alla criminalità. In ultima analisi, la teoria di Glaser consente, in tal modo, di fare chiarezza sulle c.d. azioni criminali commesse da parte di soggetti che sono comunemente inseriti in insiemi sociali non criminali. 177 Criminologia ed elementi di criminalistica 8.6 Teorie sottoculturali Intorno al 1955, Choen enunciò la teoria delle sottoculture devianti, derivante dagli aspri conflitti tra classi superiori e classi inferiori della società. Il fulcro della teoria è identificabile nell’aspirazione, da parte degli individui appartenenti alla classe proletaria, di raggiungere le medesime mete culturali degli individui della classe sociale superiore. La base di partenza dei primi è sicuramente quella di uno svantaggio. Choen era convinto che tale aspirazione si traducesse in una reazione negativistica, in direzione di quei valori che non possono raggiungere; pertanto, il negativismo innescherebbe meccanismi di reazione, connotati da atti criminali, quali il teppismo, gli atti vandalici, o il generale distruttivismo. Choen ritiene trattasi di una specie di formazione reattiva, e non un conflitto reale verso la cultura che domina. 8.7 Teoria dell’anomia secondo Merton e Durkheim L’analisi del comportamento di soggetti che si trovano in differenti posizioni rispetto alla pressione culturale indifferenziata, rappresenta per Merton, che appartiene al c.d. movimento Strutturalista, un fondamentale punto di partenza per la spiegazione del crimine. Il meccanismo di adattamento a tali pressioni sarebbe produttivo, o meno, di comportamenti devianti. Alla base dell’attività criminale, pertanto, è rintracciabile una disuguaglianza tra mete culturali accettate e mezzi per guadagnarle; ciò porterebbe l’individuo ad una condizione di anomia. Il concetto di anomia mertoniano è quindi differente da quello di Durkheim. Il soggetto che è sottoposto alla pressione culturale per il raggiungimento delle mete, quali il denaro, il successo, il potere, e così via, in mancanza di mezzi per raggiungerle, può, secondo Merton, porre in essere i seguenti comportamenti: 1. conformismo, consistente nell’utilizzo di mezzi leciti che non danno, comunque, la possibilità di raggiungere le aspirate mete; 2. l’innovazione, che si connota, invece, per l’uso indiscriminato di mezzi, totalmente illegali per raggiungere le mete; 3. il ritualismo, secondo il quale, si assiste a una concentrazione nel seguire in modo rituale i mezzi, senza aver cura degli obiettivi; 4. la rinunzia, che si attua attraverso una sorta di rifugio psicologico nelle sostanze stupefacenti o nell’alcol; 5. la ribellione, costituita da una vera e propria condanna ideologica dei mezzi e delle mete. Secondo la visione del sociologo francese Durkheim, il crimine, invece, è un fattore sociale la cui interpretazione è da riferirsi alla società, e, pertanto, dimora al di fuori dalla coscienza dei soggetti. L’emigrazione persistente di un gran numero di persone dalle campagne alle aree urbane, a seguito dei vistosi processi di industrializzazione, ha portato gli individui a transitare verso un nuovo sistema culturale, non più come quello rurale, basato su un sistema collettivo, redistributivo, tradizionalista, bensì, verso quello fondato su una solidarietà urbana, razionale, individualista, nonché industriale. Secondo Durkheim, ta178 Le teorie criminologiche le transito porta i soggetti, soventemente, alla mancanza di norme, all’inadeguatezza o all’incertezza delle stesse (anomia). Il meccanismo anomico, subito dai soggetti che si trovano nel nucleo caratterizzato da spinte sociali e culturali contrastanti, favorirebbe, in tali contingenze, il crimine. L’attualità di questa teoria è palese, poiché spiegherebbe il transito dalla solidarietà organica a quella tipicamente meccanica, ancora presente in alcuni spazi geografici. 8.8 Teoria dell’immunità differenziale Nel saggio Lo stereotipo del criminale, Chapman rappresenta che la criminalità nota non è collegata all’effettiva commissione dei reati. Secondo l’autore, esisterebbe una discriminazione dei soggetti in base all’appartenenza alla classe sociale, al potere, alla visibilità sociale. Il soggetto appartenente a una fascia debole della società, deculturalizzata, povera, godrebbe, pertanto, di una generalizzata e inferiore immunità ai meccanismi di selezione della rappresentazione sociale e del controllo istituzionale. Lo strumento per eccellenza rilevatore, di tale differenza, è la statistica giudiziaria, che mostrerebbe una maggiore inclinazione al crimine da parte di classi certamente svantaggiate. 8.9 Teoria del numero oscuro Di particolare attualità è la teoria del numero oscuro, formulata da Sutherland, a cavallo tra gli anni ’40 e ’50. è importante sottolineare che le indagini criminologiche compiute in quel periodo monitoravano i crimini commessi da classi svantaggiate o povere, eludendo, al contrario, quelli perpetrati dai colletti bianchi, cioè da coloro che occupavano, nella società, posizioni di rilievo. è bene notare che l’attenzione dei ricercatori e dell’opinione pubblica statunitense – nel dopoguerra – fosse unicamente orientata all’approfondimento dello street crime (crimine da strada). Gli studi di Sutherland mostrarono, nel tempo, che la teoria del numero oscuro e dell’indice di occultamento relativo al rapporto tra reati conosciuti e reati commessi, dovesse abbracciare, non una parte della società deviante, ma la maggioranza totale; da ciò l’opportunità di indirizzare, in altro modo, gli studi sul crimine, introducendo, altresì, nuovissimi parametri. Procedendo con la vecchia impostazione, le azioni criminali immesse nelle statistiche ufficiali, secondo Sutherland, sarebbero solamente quelle effettivamente scoperte e denunciate all’Autorità Giudiziaria, ma che fornirebbero, però, una quantificazione non completa e non rispondente al dato reale; le statistiche ufficiali non contemplerebbero, pertanto, i crimini commessi dai colletti bianchi, poiché, non sarebbero denunciati alla giustizia e non passerebbero al vaglio dell’opinione pubblica. Particolare impulso, nell’ambito della teoria del numero oscuro, venne data all’atteggiamento della vittima, al suo ruolo, alla sua propensione alla denuncia, e ciò con particolare riferimento alla stessa natura dei crimini subìti. 179 Criminologia ed elementi di criminalistica 8.10Teoria dell’etichettamento La teoria dell’etichettamento valuta il crimine come meccanismo di etichettamento sociale. Tale meccanismo, che può pervenire, come ultimo stadio, alla costruzione del sé deviante, è determinato da un intervento selettivo della società sullo stesso deviante. Il percorso della devianza del soggetto è frutto di una progressiva costruzione in base all’azione della società. Lemert, ad esempio, opera una distinzione in due fasi: a) devianza primaria, che rappresenta la fase vera e propria della commissione del crimine; b) devianza secondaria, corrispondente alla fase di identificazione sociale. Lo status di criminale è, quindi, il risultato finale di un processo di interazione tra l’aspetto psico-sociale dell’azione deviante e del suo attore, e l’effetto socio-psicologico della reazione sociale. Il deviante, secondo Becker, è un individuo, cui questa etichetta è stata attribuita con esito positivo. Il suo indirizzo primario di ricerca è costituito dalle carriere devianti, quali arresti ed etichettamenti sociali e pubblici, come elementi che spingono verso una nuova identità. L’importanza del processo di etichettamento ha anche l’obiettivo di analizzare le possibilità di reversibilità di una carriera deviante. Per gli studiosi dell’etichettamento, il crimine è frutto di un sviluppo unidirezionale, come costruzionismo del crimine. Secondo tale visione, l’uomo, apparirebbe scosso da ragioni esterne multifattoriali, evidenziandosi, così, una riduzione dell’importanza della capacità di selezione e pianificazione volontaria della mente incidente, in ultima analisi, sul comportamento sociale. L’individuo, secondo gli studiosi dell’etichettamento, penetrerebbe, pertanto, nei meccanismi di selezione sociale, solamente come mero oggetto di selezione. 8.11 Teoria della disorganizzazione sociale La disorganizzazione sociale, secondo i sociologi polacchi Thomas e Znaniecki, rappresenta il punto di partenza di attività criminose. La loro teoria prende spunto dai fenomeni socio-culturali connessi all’immigrazione dei contadini polacchi negli Stati Uniti. L’entrata in nuovo Paese, secondo i due studiosi, innescherebbe inevitabili fratture e conflitti culturali, nonché disorientamento generalizzato. Il rapporto disarmonico tra culture differenti e i disagi che vengono a crearsi hanno la peculiarità di produrre, pertanto, disagi e tensioni, responsabili, in ultima analisi, di fenomeni e/o comportamenti criminali, in particolar modo se una delle due culture appartiene ad uno strato socio-economico di minore rilevanza. Questa teoria fonda i propri postulati sulle trasformazioni sociali derivanti dalla rivoluzione industriale nel tessuto della dimensione sociale. Il processo di industrializzazione, e in particolar modo le fenomenologie sociali strettamente collegate, quali l’emigrazione, la conseguente urbanizzazione, la caduta della antecedente struttura a carattere agricolo, condurrebbero a pesanti fenomenologie di cambiamento e instabilità, elementi, questi, che determinerebbero un mancato equilibrio di componenti, sui quali si fondava la precedente strutturazione dei sistemi di controllo sociale. 180 Le teorie criminologiche A ciò, va aggiunta la trasformazione economica, quella degli status, la repentina miscellanea di popoli, valori, culture, costumi, abitudini, che conducono a una significativa perdita di azione delle istituzioni indirizzate al controllo sociale. In ogni tempo, comunque, qualsiasi mutazione dell’assetto sociale ha innescato un gran numero di conflitti a causa dell’instabilità sociale e della perdita di riferimento a un aggregato di norme, tendente a regolare numerosi aspetti della vita sociale; sistema inadeguato, oggi, tenuto conto delle trasformate condizioni sociali, e dei nuovi rapporti formatisi. Secondo la teoria della disorganizzazione sociale, l’esponenziale aumento di criminalità appare strettamente collegato e dipendente dal processo di industrializzazione, dalla neo-organizzazione sociale e dal rapido succedersi di conflitti e da trasformate regole di condotta: una dimensione di drammaticità e instabilità rintracciabile in Paesi degradati, laddove, pallidi sono i tentativi di industrializzazione, e a cui sono legati lotte e rivolte sociali e/o politiche. Da non trascurare l’impatto del singolo individuo in una società connotata da disorganizzazione, da instabilità, da trasformazioni immediate: il soggetto perde la possibilità di autogoverno, di regolazione rispetto a norme di comportamento precedenti; non riconosce più quei valori e quegli ideali costituenti l’impalcatura della sua vita e della sua condotta, spingendosi verso un sistema disorganizzato ed incidente sulla sua condotta. Altro problema affrontato dagli studiosi riguarda l’esistenza, nella società, di contraddizioni normative: una società è disorganizzata poichè non educa i propri adepti agli aggregati normativi fondamentali, spingendoli, senza rendersene conto, a comportamenti devianti, e ciò poiché sono le norme stesse a risultare contrastanti. Questo stato di cose condurrebbe, sia i soggetti singoli, che le associazioni di individui, a tenere in maggiore considerazione le influenze provenienti dai loro ambienti ed i loro interessi, invece di perseguire il benessere generale. 8.12Teoria delle aree naturali della criminalità Secondo questa teoria, la criminalità sarebbe maggiormente presente in particolari aree, laddove è alta l’immigrazione e dove maggiore è la disorganizzazione sociale. Tali fenomenologie vennero osservate da numerosi sociologi, tra cui Burgess, Park, Shaw, McKenzie. Secondo tale impostazione, pertanto, l’ambiente delle città che presenterebbe tali caratteristiche si presterebbe a divenire motore criminogenetico. La teoria, nel tempo, subì forti critiche, poiché gli studi successivi mostrarono, con evidenza, che tutte le aree urbane, al loro interno, erano connotate, in misura, più o meno eguale, da fattori che potevano innescare comportamenti criminali. Inoltre, in aree a bassa incidenza migratoria, la qualità dei reati compiuti era assolutamente differente, sia sulla base delle caratteristiche degli autori, che su quella delle modalità operative. 181 Criminologia ed elementi di criminalistica 8.13Teoria delle tecniche di neutralizzazione La valorizzazione dell’uomo come costruttore del proprio ambiente e del proprio mondo, e come unico responsabile della propria devianza, fu il fondamento della teorizzazione di David Matza (1969). Secondo quest’ultimo, non può eludersi, comunque, in tale contesto, l’influenza della società che, attraverso i meccanismi sanzionatori ed etichettanti, punta a razionalizzare la devianza del soggetto. A questo, però, secondo il teorico, è demandata la funzione di reazione o rinnegamento del marchio di deviante impresso dalla società; pertanto, il soggetto potrà operare la scelta di aderire all’etichetta o rimodulare, in maniera totale, la propria identità, offrendo ai consociati un’immagine totalmente diversa di sé. Matza ritenne, comunque, che anche i peggiori criminali subissero l’influenza delle regole sociali e riuscissero a porre in essere i comportamenti criminali, grazie alla loro capacità di neutralizzare la morale e le regole sociali, nonché il senso di colpa. Ciò avverrebbe tramite l’applicazione, ante delictum, di specifiche tecniche, quali il disconoscimento della propria responsabilità, il definire minimo il danno provocato, la negazione della parte offesa, la condanna di soggetti che condannano, il rifarsi a ideali più eminenti. 8.14Teoria delle opportunità differenziali di Cloward e Ohlin La teoria delle opportunità differenziali risulta particolarmente influenzata dalla teorizzazione del Sutherland. Cloward e Ohlin, nell’esplicazione di tale teoria, accostarono sia la teoria dell’anomia di Merton che la teoria delle associazioni differenziali dello stesso Sutherland. Fulcro fondamentale della teoria sarebbe la posizione che nello spazio sociale occupa ciascun individuo, con particolare riferimento alle opportunità legittime e a quelle illegittime. I due teorici concordano nel ritenere che esista un’unica meta (o obiettivo) identificata nel successo economico e non un insieme di mete da raggiungere. Tale obiettivo può essere raggiunto sia mediante le opportunità legittime che quelle illegittime. Bisogna tenere conto, però, che gli individui si trovano a operare in sistemi di opportunità differenziali, che condizionano le loro preferenze ed i loro comportamenti; pertanto, condizioni economico-sociali sfavorevoli si traducono in una restrizione delle opportunità di affermazione e di promozione sociale. La diversa presenza di opportunità illegittime in una definita area urbana determinerebbe la formazione di tre tipologie differenti di sottoculture denominate rispettivamente come: 1. criminale (giovani inclini a furti e rapine); 2. conflittuale (giovani inclini a danneggiamenti e vandalismo); 3. astensionistica (caratterizzata da alcolismo, tossicomania, partecipazione a gruppi di tendenza eversiva). 182 Le teorie criminologiche 8.15Teoria dello stimolo rafforzatore differenziato di Burgess e Akers Sulla fine degli anni ’60, Burgess e Akers, riformulando la teoria di Sutherland, introdussero come elemento fondamentale il c.d. stimolo rafforzatore. Secondo gli autori, il comportamento criminale è acquisito secondo i principi del comportamento operante e l’apprendimento si verifica sia in situazioni non-sociali, che sono rafforzanti o discriminative, sia nell’interazione sociale in cui il comportamento di altre persone è rafforzatore o discriminativo nei confronti di quello criminale. La teoria dello stimolo rafforzatore differenziato sostiene che un contesto non-sociale può rinsaldare una determinata scelta, e, dunque, può sviluppare la nozione, secondo la quale il crimine è acquisito solo attraverso l’interazione sociale. In accordo con Glaser, Burgess e Akers individuano l’importanza nel meccanismo di apprendimento, anche dei gruppi di riferimento che non sono direttamente in contatto con il soggetto, ma filtrati dai normali mezzi di comunicazione, oltre a quelli primari e agli altri con i quali si è intrinsecamente associati. 183 CAPITOLO 9 Criminologia e psicologia 9.1 Il contributo della psicoanalisi La psicoanalisi può considerarsi, certamente, una delle prime scienze che si è posta l’obbiettivo di fornire un paradigma interpretativo del crimine legato alla struttura psicologica e ai meccanismi dinamici agenti nell’uomo. L’essere umano, secondo Freud, sarebbe, per sua natura, antisociale, e si adeguerebbe ai dettami sociali solo per paura o per convenienza. L’antisocialità (e con essa i comportamenti criminali) sarebbe, pertanto, la condizione originaria comune, pronta a manifestarsi in situazioni in cui le inibizioni perdono la loro efficacia. Quando le pulsioni libidiche o aggressive dell’Es riescono a sopraffare le opposte spinte della conformità sociale, messe in atto dal Super-io, si innescano i comportamenti, da parte dell’individuo, contrari alla società e di natura criminale. In tale dimensione, assume un ruolo centrale il processo di identificazione con le figure parentali, fondamentale, nell’ottica psicodinamica, per la realizzazione di una struttura superegoica funzionale. Secondo la prospettiva di Alexander e Staub (1929), il crimine è interpretabile secondo una riduzione dell’efficacia del controllo da parte del Super-Io. Tale circostanza darebbe vita a varie forme di criminalità in base al livello di efficacia residuale del Super-io. Nella delinquenza fantasmatica, ad esempio, è ancora possibile, nel soggetto, arginare le pulsioni antisociali dislocandole su azioni fantastiche (es. identificandosi con il personaggio cattivo di un film). La delinquenza colposa, manifestata attraverso una condotta imprudente che provoca disgrazie, può rappresentare una forma di dislocazione più complessa che provoca ugualmente il danno desiderato dall’Es, senza dover rispondere alle controspinte del superego. Nella delinquenza nevrotica, il crimine rappresenta, viceversa, un sintomo della presenza di una situazione conflittuale profonda, che vuole essere risolta dal soggetto, come nel caso della delinquenza da senso di colpa. In tali forme di azione criminale, come sottolineato da Reik, il soggetto sentirebbe una profonda angoscia dovuta al senso di colpa che scaturisce dai tabù del parricidio e dell’incesto, per cui il comportamento criminale e spesso la correlata ricerca di punizione 185 Criminologia ed elementi di criminalistica possono evidenziare il bisogno di attenuare quel senso di colpa attraverso un crimine, anche se, questa volta, concretamente commesso. La delinquenza occasionale si verificherebbe in circostanze particolari (es. in caso di delitti passionali), quando si delineano situazioni favorevoli allo svincolo dal controllo del superego. Nella delinquenza normale, il Super-io perde completamente la sua capacità di controllare le spinte pulsionali, e il comportamento criminale può emergere con facilità. L’interpretazione psicoanalitica del crimine prende in considerazione anche la maturazione e l’efficacia dell’Io, attribuendogli responsabilità nel comportamento criminale, quando diminuisce la sua capacità di dilazionare le pulsioni. Anche l’Es può rappresentare un elemento significativo nella criminogenesi, nella misura in cui le pulsioni istintuali da esso prodotte risultano particolarmente virulente ed incontenibili. Secondo le teorie comportamentistiche di stimolo-risposta, diversi stimoli e condizionamenti ambientali, attraverso il meccanismo del rinforzo, radicano nell’individuo quegli elementi direttamente correlati con il comportamento antisociale e criminale. Nel 1939, Dollard, ad esempio, sosteneva che ogni forma di aggressione da parte dell’uomo è legata a una precedente frustrazione di un bisogno importante. Nell’impossibilità di raggiungere il successo sociale, l’individuo può porre in essere forme di aggressività verso la società (persone, beni individuali ecc.). Il ripetersi delle frustrazioni costituirebbe, poi, un rinforzo per le risposte aggressive. (Ponti, 1990). Le teorie sulla deprivazione relativa Lea e Young nel 1984, sviluppano il concetto di deprivazione relativa, attorno al quale costruiscono un interessante quadro teorico. Gli autori riconsiderano i fattori eziologici (patologia, povertà, razza) che, però, non generano direttamente negli individui una condizione di deprivazione e, quindi, non possono essere associati direttamente al crimine. Tali circostanze possono, però, generare un generico malcontento dovuto a un aumento delle aspettative, a fronte di insufficienti possibilità di raggiungimento delle mete. La situazione di malcontento può generare, in seguito, delle rappresentazioni individuali o sub-culturali di deprivazione relativa, ma tale processo è frutto della costruzione e della significazione da parte dell’individuo. La deprivazione relativa rappresenta, quindi, non una mancanza materiale, ma la significazione della mancanza con caratteri negativi (presenza di un processo di significazione) che genera il malcontento. (De Leo, Patrizi, 1999). I primi studi moderni sulle correlazioni tra personalità e crimine sono ad opera dello studioso belga Etienne De Greeff. La personalità costituisce, per De Greeff, una disposizione prefissata a reagire in un certo modo a uno stimolo, e deriva dall’insieme delle esperienze passate. De Greeff (1947), studiando la criminogenesi, ha individuato dei tratti tipici della personalità criminale, fra cui merita attenzione il c.d. silenzio affettivo di alcuni delinquenti che, secondo l’autore, deriva dal loro sentimento di essere stati sottoposti a un’ingiustizia. De Greeff, per spiegare il comportamento criminale (la criminodinamica) introduce il concetto di stato pericoloso, che è costituito da una fase di equilibrio psichico instabile nel soggetto che precede l’esecuzione di un crimine. L’autore formula anche il concetto di passaggio all’atto, fase in cui la situazione precipita e avviene l’esecuzione del delitto. Analizzando la criminodinamica degli omicidi, De Greeff nota, ad esempio, tre fasi identificabili che precedono l’ideazione del crimine. La prima fase, definita del consenso mitigato, la fase dell’assenso formulato, e la fase del periodo di crisi. 186 Criminologia e psicologia Nella fase del consenso mitigato possono emergere dei segnali che anticipano l’evento criminale; nella fase dell’assenso formulato, si riscontrano, talvolta, comportamenti offensivi, di tipo legale, di tipo verbale, od omissioni; nella fase del periodo di crisi, il soggetto coscientizza la necessità di passare all’atto ed entra nello stato pericoloso che condurrà al crimine. Un altro interessante contributo allo studio personologico dei delinquenti è stato fornito da Pinatel (1968), che individua un nucleo centrale della personalità di taluni criminali, costituito da quattro tratti fondamentali: l’egocentrismo (che consente di ignorare i giudizi); la labilità emotiva (che consente di non tener conto delle conseguenze del crimine); l’aggressività (che consente di effettuare talune azioni criminali e superare gli ostacoli) e l’indifferenza affettiva (che consente di ignorare le sofferenze della vittima). Tra i contributi più recenti, riportiamo quello di Frechette e Le Blanc (1987) che delineano una sindrome della personalità criminale, rappresentata da una specifica struttura psicologica, che, in alcuni individui, si sovrappone ad altre strutture di personalità, favorendo l’acting out. La sindrome, comprende tre tratti: l’iperattività delittuosa, la dissocialità e un notevole egocentrismo. Le Blanc e Frechette affermano che, nei delinquenti di spessore elevato, i fattori sociali ed ambientali ingeriscono con il comportamento, ma sempre mediati dai tratti della sindrome della personalità criminale. Yochelson e Samenow (1976) sostengono che i tratti di personalità del delinquente sono in realtà presenti in forma attenuata in tutti gli uomini. è la presenza intensa di tali tratti che determina una specifica personalità criminale. I due autori statunitensi affermano che la mente del delinquente possiede generalmente una grande energia, e presenta della caratteristiche ricorrenti: facilità di eccitamento, fantasie di dominio, di potere e di trionfo, paura diffusa e persistente, sospettosità. Un’altra condizione tipica del pensiero criminale è costituita, per Yochelson e Samenow, dallo stato zero, durante il quale, nel soggetto, si rilevano una scarsa autostima e una sensazione di disperazione, unite a sentimenti di superbia e ricerca spasmodica del potere. L’unione di questi fattori sarebbe in grado di spingere alcuni criminali verso la ricerca del dominio e dell’illegalità. Le ricerche di Pinatel sono state sottoposte a verifica da Canepa (1974), che ha condotto uno studio su un campione di delinquenti recidivi mediante colloqui e strumenti psicodiagnostici, cercando di localizzare i tipici tratti di personalità. La ricerca ha fornito poche conferme all’ipotesi di Pinatel. Altre indagini (Favard 1985) non sono riuscite a determinare se i tratti di personalità tipici rappresentino una particolare intensità di tratti diffusi in tutti gli individui e, soprattutto, se tali tratti siano la causa o semplicemente l’effetto di una vita da delinquente. 9.2 La teoria analitica di C.G. Jung Il pansessualismo freudiano, caratterizzato dalla concezione per cui, al centro del comportamento psichico degli esseri viventi, vi è l’istinto sessuale, venne sostanzialmente rifiutato da Jung. Nella concezione junghiana dell’uomo, invece, il tratto caratteristico più importante è la combinazione della casualità con la teleologia. Il comportamento dell’uomo non è condizionato, soltanto, dalla sua storia individuale e di membro della 187 Criminologia ed elementi di criminalistica razza umana (casualità), ma anche dai suoi obiettivi e dalle sue aspirazioni (teleologia). Sia il passato come realtà, sia il futuro come potenzialità, governano il nostro comportamento presente. Jung sostiene che entrambi le posizioni sono necessarie in psicologia per giungere a capire perfettamente la personalità. Il presente, infatti, è determinato non solo dal passato (casualità), ma anche dal futuro (teleologia). Un atteggiamento puramente casuale conduce l’uomo alla disperazione, perché lo rende prigioniero del passato. L’atteggiamento finalistico, invece, dà all’uomo un senso di speranza e uno scopo per cui vivere. La concezione junghiana della personalità considera la direzione futura dell’individuo e, nello stesso tempo, è retrospettiva, nel senso che si rifà al passato. Jung, vede nella personalità dell’individuo il prodotto e la sintesi della sua storia ancestrale. Egli pone l’accento sulle origini razziali dell’uomo. L’uomo nasce già con molte predisposizioni trasmesse dai suoi antenati e queste lo guidano nella sua condotta. Quindi, esiste una personalità collettiva e razzialmente preformata che è modificata ed elaborata dalle esperienze che egli riceve. La personalità consta di un certo numero di istanze e sistemi separati ma interagenti. I principali sono: l’Io, l’inconscio personale e i suoi complessi, l’inconscio collettivo e i suoi archetipi, la persona, l’animus e l’anima, l’ombra: 1) l’Io è la mente cosciente; 2) l’inconscio personale è formato dalle esperienze che sono state rimosse, represse, dimenticate o ignorate, e da quelle troppo deboli per lasciare una traccia cosciente nella persona; complessi: il complesso indica un contesto psichico attivo i cui elementi molteplici (sentimenti, pensieri, percezioni, ricordi) sono unificati dalla comune tonalità affettiva. Un esempio è il complesso materno; 3) l’inconscio collettivo appare come il deposito di tracce latenti provenienti dal passato ancestrale dell’uomo. Esso è il residuo psichico dello sviluppo evolutivo dell’uomo, accumulatosi in seguito alle ripetute esperienze di innumerevoli generazioni. Così, dal momento che gli esseri umani hanno sempre avuto una madre, ogni bambino nasce con la predisposizione a percepirla e a reagire ad essa. Tutto ciò che si impara dall’esperienza personale è sostanzialmente influenzato dall’inconscio collettivo che esercita un’azione diretta sul comportamento dell’individuo sin dall’inizio della vita; 4) l’archetipo è una forma universale del pensiero dotato di contenuto affettivo. Tale forma di pensiero crea immagini o visioni che corrispondono, nel normale stato di veglia, ad alcuni aspetti della vita cosciente. Il bambino eredita una concezione preformata di una madre generica, che, in parte, determina la percezione che egli avrà dalla propria madre. In tal modo, l’esperienza del bambino è la risultante di una predisposizione interna a percepire il mondo in un determinato modo e dell’effettiva natura di tale realtà. Vi è, di regola, corrispondenza tra le due determinanti, poiché l’archetipo stesso è un prodotto delle esperienze del mondo compiute dalla razza umana, e tali esperienze sono in gran parte simili a quelle di ogni individuo; 5) la persona è una maschera che l’individuo porta per rispondere alle esigenze delle convenzioni sociali. è la funzione assegnatagli dalla società, cioè il compito che essa attende da lui. Questa maschera, spesso, nasconde la vera natura dell’individuo. La persona è la personalità pubblica, quegli aspetti che si palesano al mondo o che l’opinione pubblica attribuisce all’individuo, in opposizione alla personalità privata che esiste dietro la facciata sociale; 6) l’anima e l’animus: l’archetipo femminile nell’uomo è detto anima, quello maschile nella donna animus; 7) l’ombra, è costituita dagli istinti animali 188 Criminologia e psicologia ereditati dall’uomo nella sua evoluzione. Di conseguenza, l’ombra, simboleggia il lato animale della natura umana. Nella teoria della personalità di Jung, occupa un posto centrale il Sé, che è il punto centrale della personalità, intorno a cui si raggruppano tutti gli altri sistemi; esso li mantiene uniti e conferisce alla personalità l’equilibrio, la stabilità e l’unità. Il Sé è lo scopo della vita, un fine per cui l’uomo lotta costantemente, ma che di rado riesce a raggiungere. Jung concepiva la personalità o psiche come un sistema dotato di energia e parzialmente chiuso, perché a esso si deve aggiungere l’energia proveniente da fonti esterne, per esempio dal mangiare. Per spiegare la dinamica della personalità, Jung ricorre, come Freud, al concetto della libido, ma, mentre per Freud la libido è un concetto collettivo delle tendenze sessuali dell’uomo, per Jung, il termine libido è sinonimo di energia psichica e a seconda che la libido sia diretta preminentemente verso l’interno o verso l’esterno. Jung opera, inoltre, una interessante distinzione tra introversione ed estroversione. L’atteggiamento introverso tende ad orientare la sua energia psichica verso il mondo interiore (pensieri ed emozioni), mentre l’atteggiamento estroverso orienta la sua energia verso il mondo esteriore (fatti e persone). Ambedue questi opposti atteggiamenti sono presenti nella personalità, ma, di regola, uno di essi è dominante e cosciente, mentre l’altro è subordinato e inconscio. Vi sono quattro funzioni psicologicamente fondamentali: il pensiero, il sentimento, la sensazione e l’intuizione. Ciascuna di queste funzioni ci consente di adattarci al mondo e alla vita. Il pensiero utilizza dei processi logici; il sentimento utilizza dei giudizi di valore; la sensazione percepisce i fatti e l’intuizione percepisce le possibilità presenti dietro i fatti; il pensiero è intellettivo, con esso, l’uomo cerca di comprendere la natura del mondo e se stesso; il sentimento è il valore delle cose in rapporto al soggetto; la sensazione ha la funzione percettiva, apporta fatti o rappresentazioni concrete del mondo. L’intuizione è la percezione attraverso processi dell’inconscio; l’uomo intuitivo va al di là dei fatti e costruisce elaborati modelli della realtà. Il pensiero e il sentimento sono denominati funzioni razionali, poiché fanno uso del ragionamento. La sensazione e l’intuizione sono funzioni irrazionali, perché basate sulla percezione del concreto e del particolare. Nell’individuo, sono presenti tutte e quattro le funzioni ma, di regola, una delle quattro è altamente differenziata e svolge un compito preminente nella coscienza venendo, così, denominata funzione superiore. La meno differenziata delle quattro è detta funzione inferiore, ed è rimossa e inconscia; essa si esprime nei sogni e nelle fantasie. Jung fondò le sue concezioni psicodinamiche su due principi fondamentali: il principio di equivalenza e quello di entropia. Il primo asserisce che se un valore diviene più debole o scompare, la quantità di energia a esso legata non andrà perduta per la psiche, ma riapparirà in un nuovo valore. L’indebolimento di un valore si accompagna inevitabilmente al sorgerne di un altro (la fine di un hobby sarà in genere compensata dal sorgere di un altro). Il principio di entropia afferma che la distribuzione di energia nella psiche tende a un equilibrio o armonia. Fra due valori di diversa forza, l’energia tenderà a passare dal più forte al più debole fino a raggiungere uno stato di equilibrio. Tutta l’energia psichica di cui la personalità dispone viene utilizzata per due fini generali. Una parte è spesa nell’esecuzione del lavoro necessario al mantenimento della vita e alla propagazione 189 Criminologia ed elementi di criminalistica della specie: queste sono funzioni istintive. L’energia eccedente quella utilizzata dagli istinti può essere impiegata in attività culturali e spirituali. Per Jung, lo sviluppo può svolgersi in senso progressivo o regressivo. Per progressione, Jung intende un soddisfacente adattamento dell’io alle richieste dell’ambiente esterno e ai bisogni dell’inconscio. Se un evento frustrante interrompe il movimento progressivo, la libido non potrà più essere investita in valori orientati verso il mondo o estroversi, di conseguenza, regredirà verso l’inconscio, legandosi a valori introversi. Tuttavia, Jung ritiene che uno spostamento in senso regressivo non debba avere necessariamente effetti negativi permanenti: esso infatti può aiutare l’Io a trovare il modo di aggirare l’ostacolo e riprendere il suo cammino. Il fine ultimo dello sviluppo è rappresentato dall’autorealizzazione. Per raggiungere tale scopo è necessario che le diverse istanze della personalità si differenzino ed evolvano completamente. Una personalità sana ed integra si otterrà solo consentendo a ogni istanza di raggiungere il più alto grado di differenziazione e di sviluppo. Il processo attraverso il quale si raggiunge tale stato è detto processo di individuazione. La funzione trascendente è in grado di conciliare gli indirizzi opposti dei diversi sistemi e di operare per il raggiungimento del fine ideale della totalità perfetta. L’energia psichica può essere spostata, cioè trasferita da un processo di un dato sistema ad un altro processo dello stesso o di un sistema diverso. La sublimazione è lo spostamento dell’energia dai processi primitivi, istintivi e meno differenziati, a processi altamente spirituali, culturali e maggiormente differenziati. 9.3 La psicologia del comportamento Nato negli Stati Uniti negli anni immediatamente precedenti la prima guerra mondiale, il behaviorismo, come nuovo indirizzo, venne fondato da J. B. Watson, con il suo manifesto del 1913, Psychology as a Behaviorist Views It “La psicologia esaminata da un behaviorista”. In realtà, all’alba dell’opera di Watson, le concezioni behavioristiche avevano iniziato a fare la loro comparsa nella psicologia americana attraverso l’opera di alcuni studiosi di psicologia animale comparata come E. L. Thorndike e R. M. Yerkes. Quest’ultimo, inoltre, divulgando agli americani, nel 1909, il lavoro di Pavlov sui riflessi condizionati, aveva contribuito, in modo determinante, al volgersi del pensiero americano in tale prospettiva. Spetta però a Watson il merito di aver sintetizzato e reso esplicito quello che era l’orientamento di molti. Il behaviorismo di Watson può essere sintetizzato in pochi punti: a) lo psicologo deve prendere in esame il comportamento, e cioè le risposte esplicite che l’organismo dà a determinati stimoli ambientali; b) tutti gli eventi interni possono essere ignorati senza alcuna perdita per la scienza; c) l’introspezione (che, particolarmente nella psicologia europea, era stata sino ad allora il principale strumento d’indagine) deve essere abbandonata, risultando mancante del fondamentale requisito dell’osservabilità e della controllabilità interpersonale. Per comportamento, Watson intendeva ogni movimento muscolare, o secrezione ghiandolare, o attività bioelettrica del sistema nervoso, che fosse comunque osservabile. La psicologia doveva allora diven190 Criminologia e psicologia tare la scienza delle connessioni tra stimoli ambientali e risposte, connessioni, che i primi behaviorismi concepivano soprattutto in termini di riflessi condizionati. L’influenza dell’opera di Watson fu enorme, specialmente negli Stati Uniti (in Europa l’eco fu minore e vi furono serrate polemiche contro il behaviorismo soprattutto da parte degli psicologi della Gestalt). L’estremo radicalismo della posizione di Watson non era però accettabile e, dopo questa prima fase di behaviorismo, cosiddetto ingenuo, negli anni ‘20 e ‘30, le concezioni behavioristiche ricevettero una nuova sistemazione a opera di altri autori. Tra questi, particolare importanza si attribuisce a B. F. Skinner, che evidenziò la necessità di distinguere il comportamento rispondente da quello operante: il primo, quale frutto di riflessi innati o condizionati con un meccanismo pavloviano ed evocato dagli stimoli appropriati (elicitato) indipendentemente dalla volontà del soggetto; il secondo, frutto di condizionamento operante, in cui, a differenza del pavloviano, l’apprendimento si crea per associazione tra stimolo e risposta, e non tra due stimoli. Un notevole apporto teorico fu fornito da C. Hull, che formulò una serie di postulati (la cui dimostrazione deve stare alla base dello studio del comportamento), e dai suoi collaboratori della Scuola di Yale, in particolare da K.W. Spence, che pose l’accento sulla necessità di studiare le variabili intervenienti, poste tra stimolo e risposta, nascoste nel sistema nervoso dell’organismo, come costrutti ipotetici che possiamo dedurre dal comportamento in presenza di determinati stimoli. E ancora, seppure in una posizione distaccata rispetto agli altri behavioristi, da cui fu spesso accusato di mentalismo, E. C. Tolman, secondo il quale, il comportamento è intenzionale (purposive behavior), in quanto, l’organismo (anche quello animale) apprende che un certo complesso di stimoli (segno) è legato a un altro complesso (significato), determinandosi, così, una mappa cognitiva di situazioni ricorrenti. Questa fase, detta del neo-b, pur non essendosi ancora esaurita (vitali sono ancora le scuole di Skinner e di Spence), è stata seguita dopo la II guerra mondiale da una nuova fase, denominata da Berlyne, del cenobehaviorismo. Tale fase è stata, comunque, contrassegnata da una serie di apporti di diversa natura, ma anche di interpretazioni diverse, da autore ad autore, tanto da render difficile darne un quadro riassuntivo globale. Questi apporti possono essere comunque così sintetizzati: 1) la considerazione delle nuove scoperte che venivano realizzate in campo neurofisiologico, e in particolare quelle sull’attività del sistema reticolare e sull’arousal; 2) la scoperta delle opere di Jean Piaget, sino allora, per motivi prevalentemente linguistici, pressoché sconosciuto agli studiosi nordamericani, e la conseguente rivalutazione della considerazione evolutiva nello studio del comportamento; 3) la conoscenza del lavoro compiuto tra le due guerre dagli studiosi russi, che, pur senza contatti con il mondo occidentale, si erano mossi in una direzione, sotto certi aspetti, analoga a quella dei seguaci del behaviorismo. A tali apporti, va aggiunta la profonda influenza che hanno avuto sulla psicologia, soprattutto nordamericana, la cibernetica, la teoria dell’informazione, la teoria statistica della decisione e, più di recente, la linguistica, in particolare, l’opera di N. Chomsky (pur essendo il pensiero di questo studioso criticato spesso dai behavioristi per il suo innatismo). Il panorama teorico si è venuto così articolando maggiormente, e si è fatto più complesso e, se la collocazione di alcuni autori in questa corrente di pensiero è relativamente agevole, per altri, soprattutto per quelli che hanno reagito al b. di tipo watsonia191 Criminologia ed elementi di criminalistica no e al neo-b. di tipo hulliano o skinneriano, rivalutando l’importanza dei processi cognitivi, il problema è più delicato. Così, da un lato, vi è l’opera di autori come il citato Berlyne e lo psicologo canadese D. O. Hebb, su cui ha avuto un’influenza predominante la neurofisiologia, vista però, non in senso riduzionistico ma funzionale. Dall’altro, vi sono stati contributi di varia natura; particolarmente significativa a questo proposito l’opera di Miller, studioso, soprattutto, del linguaggio e della teoria dell’informazione, che, in collaborazione con uno psicologo matematico, E. Galanter, e uno psiconeurologo, K. H. Pribram, ha dato vita con Plans and the Structure of Behavior (Metodi e struttura del comportamento) ad una delle più importanti opere teoriche della psicologia contemporanea, in cui, nell’ambito dello studio del comportamento, si rivalutano i processi cognitivi e si rifiuta una concezione dell’uomo semplicistica in puri termini stimolorisposta. E ancora, significativa nella stessa prospettiva, è l’opera di Broadbent, che con i suoi studi sull’attenzione, ha dimostrato i limiti che ha l’organismo umano nell’elaborare le informazioni che gli provengono dall’ambiente. La scuola behaviorista, sino agli anni Sessanta, aveva esercitato un dominio, pressoché assoluto, sulla psicologia sperimentale, perdendo, in seguito, la propria centralità; in generale, la maggior parte dei ricercatori aderisce oggi ad altre correnti di pensiero, prima tra tutte, il cognitivismo. La polemica tra questa impostazione e il behaviorismo è particolarmente vivace, e verte, soprattutto, sulla liceità di studiare i processi mentali, negata dai behavioristi, che ritengono che lo studio dello psicologo debba limitarsi al comportamento, e che parlare di mente sia fare della metafisica e non della scienza. Va però detto che molti cognitivisti sostengono l’esistenza di una continuità fra le proprie posizioni e quelle del behaviorismo, e ritengono che la loro psicologia sia un rinnovamento del behaviorismo stesso. La crisi del behaviorismo ha comunque avuto come effetto una sostanziale modificazione del campo di ricerca della psicologia. Tipico esempio ne è la profonda modificazione degli studi sull’apprendimento che costituivano gran parte della ricerca behaviorista, e che oggi sono affrontati in modo abbastanza diverso, con un certo abbandono delle tematiche del condizionamento. A fianco a questa crisi si assiste, però, alla rinascita di alcune applicazioni derivate dal b., e, in particolare, della cosiddetta behavior therapy (terapia del comportamento). Tale sviluppo si ha anche in Italia, dove opera un gruppo abbastanza numeroso di psicologi behavioristi (E. Caracciolo, P. Meazzini, e così via). 9.4 L’integrazione psico-ambientale La criminogenesi è stata individuata, dalle varie teorie criminologiche, sia nelle caratteristiche dei singoli individui, che nei fattori sociali. Negli anni ‘50 e‘60 si tentò di considerare, congiuntamente, l’individuo ed il suo contesto sociale: questo tentativo caratterizzava la dimensione dell’integrazione individuo/ambiente. Se l’ambiente veniva ritenuto quale fattore criminogeno, l’obiettivo era quello di giungere alla spiegazione del perché non tutti gli individui reagivano allo stesso modo ai fattori criminogeni legati al loro ambiente e alle loro condizioni socio-economiche; analogamente, altro quesito riguardava la circostanza per la quale soggetti con uguali caratteristiche abnormi di personalità non divenissero tutti delinquenti. 192 Criminologia e psicologia Il problema fondamentale, pertanto, era quello di capire tale difformità di comportamento. Le riposte giungevano dalle varie discipline, e ognuna di esse elaborava teorie, cercando, al contempo, di individuare elementi psicologici, sociologici, psichiatrici, che giustificassero tali difformità di condotta. Rimaneva, comunque, il quesito in ordine alla condotta normale, posta in essere da soggetti multiproblematici. Importante, inoltre, era comprendere quanto il fattore individuale e quanto quello sociale potessero incidere nella condotta criminosa. 9.5 La teoria non direzionale dei Glueck La ricerca effettuata dai coniugi Glueck, nel 1950, rappresenta una fase decisiva per la criminologia, anche se, successivamente, è stata criticata e replicata con metodi diversi; si ricorda quella effettuata a Portorico, nel 1975, da parte di Ferracuti, Dnitz, e De Brenes (Bandini, Gatti, Marugo, Verde 1991). I coniugi Glueck effettuarono il loro studio su un campione di 500 giovani delinquenti e 500 non delinquenti, tutti però simili per età, gruppo etnico, estrazione sociale e culturale, e aspetto economico, toccando tutti i punti delle loro vite, e, dunque, gli aspetti biologici, sociologici e psicologici. Non essendo possibile, in questa sede, riportare interamente i risultati della loro ricerca, ci si soffermerà su quelli che più da vicino interessano, e cioè i risultati che riguardano i rapporti parentali, e quelli che riguardano la personalità dei giovani intervistati. La prima parte della ricerca, che riguarda i rapporti e l’inserimento dei giovani, delinquenti e gruppo campione, all’interno della famiglia, si apre con i risultati che riguardano la struttura familiare e la sua genesi, per verificare le conseguenze dell’influenza dell’ambiente familiare sul futuro comportamento e sulla futura personalità dei soggetti analizzati. Preme sottolineare che le famiglie d’origine dei due gruppi non erano diverse: stesso numero di componenti, stessa estrazione socio-culturale, e, soprattutto, i soggetti provenivano tutti da ambienti poveri e degradati. In primo luogo, fu rilevato che in un quarto delle famiglie paterne dei delinquenti, contro meno di un quinto dei non delinquenti, erano presenti gravi turbamenti emotivi o disturbi della personalità: psicosi, psiconevrosi, epilessia, omosessualità; i dati si eguagliavano (o quasi) per le famiglie di provenienza dei padri, mentre, per le madri, risultava che le metà di quelle dei delinquenti, contro un terzo di quelle dei non delinquenti, proveniva da famiglie con casi di alcoolismo. Per quanto riguarda il fattore criminalità, esso risultava presente nelle famiglie di provenienza dei delinquenti, da uno a tre membri, contro un numero molto esiguo per le famiglie di provenienza dei genitori dei non delinquenti. Per quanto riguarda l’istruzione, entrambi i gruppi, provenivano da famiglie con un basso grado di istruzione. Anche nella genesi delle famiglie di appartenenza vi erano delle eguaglianze; le madri dei soggetti appartenenti ad entrambi i gruppi risultavano essersi sposate prima dei 21 anni, anche se, qualche differenza affiorava: 4 matrimoni su 10, contro 3 su 10 dei non delinquenti, risultavano forzati; inoltre, le madri dei delinquenti, in misura molto maggiore rispetto a quelle dei non delinquenti, avevano sofferto di malanni fisici, sviluppo mentale ritardato, alcolismo, e avevano commesso reati sin dal periodo adolescenziale. Gli stessi problemi e le stesse differenze erano affiorate dal raffronto tra 193 Criminologia ed elementi di criminalistica i padri dei ragazzi. Si è detto che l’estrazione socio-economica delle famiglie era, in entrambi i casi, bassa, nonostante ciò, nel gruppo dei delinquenti, i padri, in rapporto di 5 a 1, risultavano essere dei cattivi lavoratori, cioè soggetti pigri, svogliati, poco interessati al lavoro, ed inclini a cambiarlo spesso. Inoltre, 4 famiglie su 5, contro 1 su 5 dei non delinquenti, erano costrette a chiedere un aiuto esterno per risolvere i problemi economici. Risulta evidente che, seppur i soggetti dei due gruppi fossero stati scelti in un contesto di base simile, alcune differenze affioravano nella formazione e nella genesi delle famiglie dei delinquenti, rispetto a quelle dei non delinquenti. Famiglia: in questa parte della ricerca, vennero valutati aspetti che riguardavano più da vicino la vita all’interno della famiglia dei due gruppi. In primo luogo, risultò che le famiglie dei delinquenti tendevano molto di più a vivere alla giornata, contraendo continui prestiti e spendendo molto più di quello che guadagnavano; mancava, dunque, un’oculata gestione familiare. Inoltre, guardando al decoro familiare, e cioè all’ambizione delle famiglie, la volontà di migliorarsi, la presenza del senso della responsabilità, e la difesa del buon nome della famiglia, risultarono presenti solo in 1 su 10 delle famiglie dei delinquenti, contro le 4 su 10 dei non delinquenti. Per quel che riguarda il rapporto tra i genitori, risultò che esso era buono solo in un terzo delle famiglie dei delinquenti, contro due terzi di quelle dei non delinquenti, ed inoltre, in 1 su 3 delle famiglie dei delinquenti, contro 1 su 7 di quelle dei non delinquenti, la crisi familiare era sfociata in un abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei due genitori, quasi sempre il padre. In entrambe le famiglie, le madri si occupavano direttamente della gestione del focolare domestico, ma in maniera molto diversa; ragazzi privi di appoggio domestico risultavano molto più numerosi tra i delinquenti, solo meno di 1 madre su 10 risultò schiava dei divertimenti collettivi; regolari abitudini di questo tipo esistevano solo in 11 delle 500 famiglie di provenienza dei non delinquenti, contro le 50 dell’altro gruppo. Ed ancora, solo in 2 famiglie su 10 dei delinquenti gli amici dei figli erano ben accetti in casa, contro un terzo di quelle dei non delinquenti; inoltre, nelle case delle famiglie dei delinquenti erano assenti i mezzi di svago per i ragazzi, come giocattoli o libri, ed in generale, fu rilevato che solo in 20 delle 500 famiglie dei delinquenti era presente un qualunque mezzo di svago, contro il 69% delle famiglie dei non delinquenti. Infine, per quel che riguarda il senso di solidarietà familiare, esso era presente in meno di 2 famiglie su 10, contro le 6 su 10 per i non delinquenti. Prima di soffermarsi sulla vita dei ragazzi all’interno della famiglia, i Glueck, aprirono questa parte della loro ricerca con dei dati di statistica anagrafica. Da ciò, si dedusse che 2 delinquenti su 10, contro 1 su 10 per i non delinquenti, erano stati concepiti fuori dal matrimonio, e inoltre 6 ragazzi su 10, in entrambi i gruppi, avevano un genitore nato all’estero. Le famiglie dei delinquenti erano solo di poco più numerose rispetto a quelle dei non delinquenti, 7 membri in media contro 6, ma, nelle prime, era più frequente il caso di seconde nozze di uno dei genitori, e quindi della presenza di fratellastri e sorellastre. Negli alloggi dei delinquenti, si notava, però, maggiore affollamento, con soggetti che vivevano, dormivano e mangiavano nella stessa stanza, dunque, con una maggiore presenza di competizione emotiva per attirare l’attenzione dei genitori, e una situazione di promiscuità sessuale più diffusa. Per quel che riguarda l’ordine di nascita dei soggetti delinquenti, non furono rilevate differenze statistiche interessanti, e, dunque, i delinquenti non erano, come buona parte della dottrina sosteneva, più numerosi tra i primogeniti o gli ultimogeniti. 194 Criminologia e psicologia La stabilità della famiglia è un altro parametro particolarmente importante per una normale crescita psicologica. Dalla ricerca risultò che la maggior parte dei ragazzi delinquenti aveva avuto esperienze di vita disorganizzata, circa il 50% contro il 10% dei non delinquenti; inoltre, 6 famiglie su 10 dei delinquenti, contro le 3 su 10 dell’altro gruppo, furono sciolte da separazione, divorzio, abbandono improvviso di uno dei coniugi o morte di uno di essi. La rottura del nucleo familiare venne valutato con attenzione, poiché era già noto che sarebbe potuto risultare particolarmente traumatizzante per il ragazzo vivere la scissione parentale; dai dati si evinceva che solo meno della metà dei ragazzi delinquenti aveva potuto sperimentare la vita in una famiglia stabile, mentre per la maggior parte di loro la vita fu trascorsa in una famiglia spezzata, se non addirittura inesistente. Infine, furono valutati, per quel che riguarda i rapporti tra genitori e figli, i legami affettivi all’interno della famiglia e l’interessamento dei genitori per i figli. In primo luogo, si accertò che solo 4 su 10 padri dei delinquenti, contro 8 su 10 dell’altro gruppo, erano affettuosi e comprensivi con i propri figli, e così anche le madri, 7 su 10 per i delinquenti, contro il 95% per i non delinquenti. Al contrario, fu notato, però, che 4 madri su 7 per i delinquenti, contro 1 su 7 per i non delinquenti, erano eccessivamente protettive verso i figli, innescando un particolare processo di dipendenza, insicurezza e deresponsabilizzazione. Per quel che riguarda l’affetto dei figli nei confronti dei genitori, come era prevedibile, i delinquenti, in numero molto maggiore, dichiararono di non sentire un particolare legame affettivo nei confronti dei genitori. Infine, nelle famiglie dei delinquenti, fu anche riscontrata la mancanza di un modello educativo stabile, costante ed univoco; nella maggior parte dei casi, i ragazzi erano solo puniti, spesso in maniera violenta, per le loro malefatte, senza che poi gli fosse spiegato quello che era giusto fare e quello che era ingiusto o illecito. Intelligenza e criminalità: il test utilizzato per misurare il Q.I. (quoziente intellettivo) dei ragazzi fu il Wechsler-Bellevue, che misura il quoziente globale, ma divide anche l’intelligenza in due campi, quello pratico e quello verbale, permettendo un’analisi più approfondita dei soggetti. Per quanto riguarda i risultati generali, non furono riscontrate differenze tra i due gruppi: in entrambi i casi furono rilevati dai 140 ai 150 ragazzi che avevano un Q.I. da 90 a 100, e dai 346 a 359 ragazzi che avevano un Q.I. da 60 a 90. Maggiori differenze furono riscontrate nel rapporto tra gli usi che i due gruppi facevano dell’intelligenza verbale e di quella esecutiva o pratica. L’aspetto verbale del processo intellettivo riguarda l’uso dell’intelligenza astratta, e cioè la capacità di ragionare, riflettere, ricordare, essere logici. In questo campo, i delinquenti mostrarono maggiori carenze, che non potevano essere spiegate solo con una minore propensione agli studi. In ogni caso, le differenze rilevate furono comunque minime, tanto da non poter definire i delinquenti meno intelligenti dei non delinquenti, ma forse utili per poter affermare che i ragazzi delinquenti erano portati a prediligere e sviluppare un’intelligenza diversa da quella verbale. Infatti, nei test che riguardavano l’intelligenza nell’esecuzione, e cioè l’aspetto pratico dell’intelligenza, i due gruppi si eguagliavano, ed anzi, in alcune prove, i delinquenti risultarono più veloci e pronti dei non delinquenti. Questi risultati furono comunque l’ulteriore conferma che non esiste correlazione tra deficit mentale e delinquenza. Dinamiche emotive: in questo campo, risultò che solo il 15% dei delinquenti, contro il 31% degli altri, si sentiva adeguato nel comportarsi e nell’esprimersi, al contrario 195 Criminologia ed elementi di criminalistica fu riscontrato nei delinquenti una percentuale maggiore, 28% contro 14%, di soggetti tendenti all’attività e al dinamismo. I sintomi del comportamento aggressivo erano presenti in numero molto maggiore tra i delinquenti, mentre l’estroversione, intesa come acting out, era presente nel 59% dei delinquenti, contro il 29% dei non delinquenti; la stabilità emotiva era riscontrata nel 18% dei delinquenti contro il 50% dei non delinquenti. Tendenze estetico-appetitive: più numerosi risultarono i delinquenti con spiccata tendenza alla sessualità precoce e promiscua, 20% contro 6%, ed anche quelli tendenti all’avidità, 21% contro 14%. Orientamento della personalità: i dati ci dicono che solo il 25% dei delinquenti, contro il 49% del gruppo di controllo, risultava essere convenzionale in tutti gli aspetti della propria vita, e che solo il 9% dei delinquenti, contro il 54% dei non delinquenti, risultò essere coscienzioso. Molto scarsi tra i delinquenti anche i soggetti realistici, 8% contro 29%, e i soggetti pratici, 19% contro 35%. Inoltre, fu riscontrata nei delinquenti una quasi totale mancanza di autocritica, accompagnata da uno spiccato egocentrismo. Conflitti emotivi: traumi, paure, angosce, sensi di colpa e frustrazioni erano presenti nel 75% dei delinquenti contro il 38% dei non delinquenti. Il piano emotivo dal quale sorgevano, in massima parte, tali conflitti era il rapporto con il padre, 23% contro 5%, e dall’incapacità dei ragazzi delinquenti di costruirsi una sana identificazione sessuale, 30% contro 12%. Risultavano, al confronto, quasi assenti i conflitti esterni alla famiglia, anche se il 33% dei delinquenti, contro il 18% dei non delinquenti, era afflitto da un conflitto d’inferiorità fisico e psichico. Metodologia di risoluzione dei conflitti: fu appurato che il 68% dei delinquenti, contro il 31%, era solito risolvere i propri problemi riversandoli all’esterno, inoltre, come gruppo, i delinquenti risultarono quasi immuni al senso di responsabilità, e tendenti all’acting out immediato, quando la pressione e l’ansia iniziavano a salire. Il meccanismo preferito per i non delinquenti risultò invece essere quello opposto, e cioè l’introversione, 42% contro il 5% dei delinquenti. Carattere e delinquenza: la prima parte della perizia psicologica e psichiatrica della ricerca è stata integrata da una seconda parte che riguardava il carattere ed il temperamento dei soggetti analizzati. Il metodo d’indagine utilizzato fu la somministrazione del test di Rorschach, utilizzato, anche oggi, nelle perizie psichiatriche e psicologiche. I risultati furono divisi in varie categorie. In questo quadro furono valutati i seguenti parametri: a) l’autoaffermazione, cioè la facoltà di affermare la propria personalità, le proprie esigenze e la propria opinione in modo diretto ma senza aggressività esagerata. Questo tratto fu riconosciuto in meno di un decimo dei delinquenti, e solo in un piccolo numero dei non delinquenti; b) l’affermazione sociale, cioè la volontà di affermarsi nell’ambiente sociale. Questo tratto fu riscontrato nel 45% dei delinquenti e nel 27% dei non delinquenti; c) la sfida, cioè un meccanismo reattivo, una forma di affermazione aggressiva dell’Io in risposta ad un senso profondo di debolezza e insicurezza; d) la remissività, cioè la rinuncia all’affermazione a tutti i costi del proprio sé, nel tentativo di raggiungere la sicurezza sottomettendosi all’altrui autorità; questo tratto fu riscontrato nel 27% dei delinquenti e nel 80% dei non delinquenti; e) il senso di insicurezza, cioè quella vaga impressione di non aver fatto presa sulla vita, fu riscontrato 196 Criminologia e psicologia in maniera uguale, o quasi, in entrambi i gruppi, 89% dei delinquenti contro 96% dei non delinquenti; f ) il senso di non essere amati e desiderati. Questo sentimento, anche se solitamente represso o inconscio, può condurre ad un eccessivo bisogno di attenzione e dunque ad un forte desiderio di successo e riconoscimento. Anche questo fattore fu riscontrato in percentuali molto elevate e pressoché identiche in entrambi i gruppi, 92% dei delinquenti contro il 97% dei non delinquenti; g) il senso della propria nullità, cioè la sensazione per cui i nostri pensieri, sentimenti ed idee non sono riconosciuti come validi o interessanti, fu riscontrato nel 59% dei delinquenti contro il 64% dei non delinquenti, anche il senso di non essere apprezzati, molto simile come concetto al precedente, risultò essere presente nel 36.1% dei delinquenti, contro il 24.5% dei non delinquenti; h) sentimenti che indicano una resa o una sconfitta. Questi elementi si riscontrarono in percentuale molto maggiore tra i non delinquenti, e infatti il senso di impotenza si riscontrò nel 42% dei delinquenti contro il 54% dei non delinquenti, mentre il senso di insuccesso e di sconfitta fu riscontrato nel 44% dei delinquenti contro il 63% dei non delinquenti; i) tendenze narcisistiche furono riscontrate nel 23% dei delinquenti contro il 14% dei non delinquenti; tendenze masochistiche, si ritrovarono nel 15% dei delinquenti contro il 37% dei non delinquenti; l) tendenze sadiche, si riscontrarono nel 49% dei delinquenti contro il 16% dei non delinquenti; m) la tendenza all’acting out fu riscontrata nel 44% dei delinquenti contro il 19% dei non delinquenti; n) il potere di autocontrollo fu riscontrato nel 39% dei delinquenti contro il 66% dei non delinquenti. Le vere e proprie psicopatologie come: psicosi, nevrosi, monomanie e forme schizofreniche furono riscontrate solo in pochissimi soggetti che appartenevano al gruppo dei delinquenti, ma il dato statistico risulta irrilevante. Con questi ultimi dati sulla presenza di vere e proprie patologie mentali si chiude il dato psicologico della ricerca Glueck. Tale studio resta documento fondamentale nella ricerca criminologica, anche se, successivamente, non mancarono critiche sui metodi scelti per eseguirlo, e soprattutto chiarisce che, sotto l’aspetto strettamente psicologico, non esistevano differenze enormi tra i due gruppi analizzati. Le differenze che infatti i ricercatori rilevarono non furono tali da poter affermare che il crimine è una prerogativa di psicopatici e menti patologiche, né che i delinquenti siano così diversi dai soggetti che non delinquono, e né che esistono dei tratti di personalità specifici del crimine, sottolineando, dunque, che la psicologia di un criminale resta dato fondamentale per comprendere i suoi atti, ma da integrare in una multidisciplinarietà auspicabile anche negli studi moderni. 9.6 La teoria dei contenitori La teoria del controllo sociale, o teoria dei contenitori, di W. C. Reckless (1961) rappresenta un tentativo di integrazione dei fattori individuali e ambientali della devianza. Essa considera in modo specifico l’azione dei controlli interni ed esterni, capaci congiuntamente e vicendevolmente, di regolare la condotta umana. I contenitori interni, quelli, cioè, legati alla struttura dell’individuo, sono responsabili dell’adeguamento del comportamento agli stimoli socio-ambientali e sono rappre197 Criminologia ed elementi di criminalistica sentati da un buon autocontrollo, da un buon concetto di se stessi, dall’alta tolleranza alle frustrazioni, dalla capacità di socializzazione, dal senso di responsabilità, dall’abilità a trovare soddisfazioni sostitutive, dalle razionalizzazioni idonee a ridurre la tensione. I contenitori esterni, di tipo normativo-culturale, costituiscono il freno che agisce nell’immediato contesto sociale del soggetto, e che gli permettono di non oltrepassare il limite normativo. Essi sono rappresentati dalle aspettative sociali, dalla sorveglianza ed efficacia dei sistemi di controllo sociale, dalle opportunità di sfoghi alternativi, dalle opportunità di consensi nel proprio ambiente, dall’identità e dal senso di appartenenza a un gruppo. A questi, si aggiungono la famiglia e gli altri gruppi di rinforzo (istituzioni, apparati di prevenzione e repressione, ecc.), normalmente preposti al controllo e al contenimento dell’individuo. La carenza di contenitori interni o esterni costituisce, per il soggetto, un elemento di vulnerabilità che rende conto, nel singolo caso, delle ragioni della condotta deviante. Per le evidenti correlazioni esistenti tra essi, la mancanza di contenitori interni può essere compensata da un valido sistema di contenitori esterni e viceversa. In ragione di questi freni, alcune ricerche hanno spiegato il livello particolarmente basso di criminalità di alcuni gruppi di immigrati degli anni ‘60 nei Paesi europei importatori di manodopera. In una ricerca condotta sugli immigrati pakistani e indiani di Bradford, ad esempio, si pervenne alla conclusione che le ragioni del loro basso livello delinquenziale erano da ricercare nell’esistenza di comunità solidali e coese nelle quali essi vivevano. L’importanza del consenso, dell’integrazione e dell’esistenza di persone significative di riferimento, fu riscontrata anche in una ricerca sugli immigrati italiani di Liegi. Secondo un altro studio, condotto a Ginevra nella prima metà degli anni ‘60, le possibilità che un italiano commettesse un reato, variavano a seconda del grado di integrazione sociale raggiunto. Gli immigrati italiani, infatti, potevano essere distinti in tre categorie: una prima, della quale facevano parte i cosiddetti stagionali, coloro, cioè, che ogni anno ritornavano in Italia per uno o due mesi; una seconda, nella quale rientravano coloro che avevano un permesso di soggiorno, legati per un anno ad un lavoro fisso; una terza, nella quale rientravano le persone con un permesso d’établissement, coloro, cioè, di lunga permanenza (oltre dieci anni) che godevano di tutti i diritti dei cittadini di quel Paese a esclusione dei diritti politici. Fu riscontrato che gli italiani appartenenti alla prima e alla terza categoria commettevano reati meno frequentemente di quelli della seconda. Questo fu correlato al diverso grado di integrazione raggiunto: infatti, l’essere stagionale garantiva loro un buon inserimento, quantomeno nella comunità dei loro connazionali; viceversa, quando ottenevano un permesso di soggiorno, questi si trovavano nella fase più delicata dell’immigrazione in quanto si distaccavano, sempre più, dal gruppo di origine, senza essersi ancora sufficientemente integrati nella società di accoglienza. Infine, dopo dieci anni, avevano ormai raggiunto un buon livello di integrazione nella nuova comunità. In altre parole, se gli immigrati italiani che violavano la legge aumentavano, passando dagli stagionali a quelli con un permesso di soggiorno valido un anno, per diminuire nuovamente fra i residenti ultradecennali, era anche perché gli appartenenti alla prima e alla terza categoria godevano di più solidi legami con la comunità (locale o di connazionali) circostante. La teoria del controllo sociale è stata utilizzata anche per dare ragione del maggior tasso di criminalità degli immigrati della 198 Criminologia e psicologia seconda generazione rispetto a quelli della prima. Anche in questo caso, la differenza fu attribuita all’indebolimento dei fattori di contenimento della condotta deviante e, in particolare, dei legami tra figli e genitori. La prima grande ricerca in merito fu condotta nei primi decenni del secolo sui contadini polacchi immigrati negli Stati Uniti. Si legge in questo studio che, quando questi vivevano nel loro Paese, erano organizzati in famiglie forti e solidali e svolgevano la funzione educativa in modo molto più ricco e meglio ordinato che in America. I figli venivano iniziati ben presto a tutte le attività dei genitori e, in questo modo, assimilavano e imitavano in maniera irriflessa la loro organizzazione di vita. Ma la situazione cambiava una volta giunti in America. I giovani, sottoposti agli stimoli di una società più progredita, riducevano le partecipazioni alle attività dei genitori, apprendevano gli usi e i costumi della nuova società dalla vita di strada e, spesso, erano essi stessi a fungere da mediatori tra la società circostante e i genitori. Così, veniva ad essere irrimediabilmente intaccata ogni autorità e controllo sui figli che, anzi, quando entravano in contatto con la nuova realtà, si lasciavano sedurre dai piaceri e dai desideri indotti da uno stile di vita completamente differente. In queste condizioni, era naturale che, per ottenere ciò che soddisfacesse quei desideri e quei piaceri, commettessero furti o rapine. Agli stessi risultati si giunse, qualche anno più tardi, attraverso una ricerca effettuata sulle bande giovanili di Chicago. Gran parte dei giovani che facevano parte delle centinaia di bande di quella città provenivano da famiglie italiane, polacche, irlandesi, slave. Si sostenne che ciò era dovuto alla progressiva perdita di controllo sui figli da parte degli immigrati, come del resto era normale che accadesse in un ambiente sociale così diverso da quello originario. L’assimilazione troppo rapida e superficiale del modello americano aveva, di fatto, accelerato la disintegrazione del controllo della famiglia sui figli e indebolito, di conseguenza, un importante contenitore della devianza. Non sono mancate, poi, ricerche che hanno dimostrato il contrario e, cioè, che gli immigrati della seconda generazione commettono meno reati di quelli della prima, anche se più frequentemente degli autoctoni. In questo caso, è stato dimostrato che le ragioni del minore tasso di criminalità è da rapportare all’integrazione favorita dalle strutture istituzionali, quali ad esempio, la scuola, che crea le condizioni favorevoli per ridurre gli svantaggi sociali iniziali e rafforza i legami con figure significative di riferimento. Se, generalmente, la teoria del controllo sociale arriva oltre il limite della teoria del conflitto culturale, anche per questa, tuttavia, vi sono importanti obiezioni, in parte analoghe a quelle mosse per l’altra. In primo luogo, la teoria del controllo sociale non riesce a dar conto delle trasformazioni che nel corso del tempo hanno avuto i comportamenti devianti degli immigrati, né tantomeno della differenza tra la devianza espressa dagli immigrati del Nord e quelli del Sud del nostro Paese. In secondo luogo, per comprendere gli effetti dell’indebolimento del controllo sociale, sarebbe opportuno integrare detta teoria con i concetti di anomia, di stimolorisposta all’aggressione-frustrazione, di associazione differenziale, di identificazione differenziale, secondo gli insegnamenti della sociocriminologia e nella prospettiva di una devianza multifattoriale. 199 CAPITOLO 10 Il comportamento umano 10.1Gli studi sul comportamento umano La psicologia cognitiva, divenuta successivamente un movimento soprannominato cognitivismo, è una branca della psicologia sperimentale che studia il comportamento e la vita mentale. Il cognitivismo fonda la sua teoria a partire da un modello della mente umana come elaboratore di informazioni provenienti dagli organi sensoriali. Il fine della psicologia cognitiva è quello di coniugare lo studio del comportamento e delle capacità cognitive umane con la riproduzione di questi mediante sistemi artificiali. Per ottenere questo risultato, la psicologia cognitiva è sostanzialmente interdisciplinare, poiché si avvale dei metodi, degli apparati teorici e dei dati empirici di numerose discipline diverse tra le quali la psicologia, la linguistica, le neuroscienze, le scienze sociali, la biologia, l’intelligenza artificiale e l’informatica, la matematica, la filosofia e la fisica. La psicologia cognitiva nasce verso la fine degli anni ‘50, fondamentalmente come reazione polemica nei confronti della scuola che da anni, soprattutto in America, dominava il panorama culturale; ecco che, allora, il comportamentismo fu il vero e proprio punto di partenza per lo sviluppo delle scienze cognitive, in quanto gettò le basi per una psicologia fondata empiricamente. Entrambe le discipline, infatti, si basano su una scientificità di tipo naturalistico, nel comune tentativo di assimilare lo studio della mente umana alle scienze fisiche. Dal punto di vista dell’epistemologia, la psicologia cognitiva assume la posizione ontologica del realismo critico, secondo la quale viene accettata l’esistenza di una realtà esterna strutturata, ma, allo stesso tempo, viene rifiutata la possibilità di conoscerla completamente. è proprio da questa premessa teorica che si genera la diatriba con il movimento comportamentista: l’oggetto di studio non è più (soltanto) il comportamento umano, bensì gli stati o processi mentali fino ad allora considerati una dimensione insondabile e non conoscibile scientificamente. Tale presa di posizione nei confronti dello studio dell’attività psichica si traduce, praticamente, nell’accettazione dell’analisi introspettiva come metodo conoscitivo, e nell’affermarsi della concezione di comportamento umano come risultato di un processo articolato e variamente strutturato di elaborazione delle informazioni. In questo senso, il cognitivismo fa proprie 201 Criminologia ed elementi di criminalistica le scoperte derivate dalla cibernetica e dagli studi sull’intelligenza artificiale, al fine di comprendere gli algoritmi che sostanziano l’attività mentale. Nel corso del tempo, si sono evidenziati diversi approcci allo studio del crimine che hanno ipotizzato le origini del comportamento criminale localizzate nella psiche dell’individuo, nel suo patrimonio genetico, nell’ambiente sociale, nelle psicopatologie o, ancora, nelle diverse modalità di attribuzione di significato alla realtà o nella capacità di adattamento alle norme. Talune scuole criminologiche si sono attestate su posizioni critiche, ponendo in discussione il rapporto stesso tra individuo e un sistema normativo che è culturalmente e socialmente determinato e, come tale, non necessariamente accettabile da tutti. Evidentemente, la scelta teorica del criminologo risulta fortemente influenzata dal suo stesso rapporto ideologico con il sistema sociale. Posizioni consensuali e integrate degli studiosi saranno maggiormente legate a una visione del crimine in termini di disfunzionalità e anomalia (ricercata in aree psicologiche, psicopatologiche e sociologiche). Posizioni maggiormente conflittuali, invece, orienteranno probabilmente lo studioso su valutazioni attinenti ai rapporti di potere tra gruppi sociali, ricercando la spiegazione del crimine nelle dinamiche di reazione sociale, di etichettamento, di esclusione, di stigmatizzazione. In realtà, soventemente, le teorizzazioni mostrano semplificazioni ed esasperazioni concettuali che non corrispondono alla realtà. Il concetto stesso di causa, applicato al comportamento umano, necessita di estrema cautela, proprio in ragione degli infiniti fattori che influenzano l’agire dell’uomo, posti su piani genetici, biologici, psicologici, sociali e talvolta fortuiti, mediati e organizzati, tra l’altro, dalla variabile primaria indotta dalla razionalità e dalla libertà di scelta. La ricerca di una causa specifica dovrà, quindi, essere intesa come maggiore o minore peso di una variabile all’interno di una dinamica complessa o, meglio ancora, come un fattore di possibile ingerenza. Un ulteriore elemento da considerare è quello relativo alla grande diversità che intercorre spesso tra i vari crimini. Taluni comportamenti criminali sembrano, infatti, essere maggiormente influenzati dalle variabili biologiche e psicologiche (es. i crimini violenti), mentre altri appaiono maggiormente correlati a dinamiche sociali. 10.2La predisposizione al crimine La teoria della predisposizione al crimine, già all’inizio del ‘900, aveva iniziato il suo complesso percorso di validazione scientifica, e la genetica, che si presentò come disciplina in grado, non solo di spiegare l’origine delle differenze individuali, ma anche di predirne la perpetuazione nel corso delle generazioni, apparve, in quel periodo, come la scienza più idonea per raggiungere tale obiettivo. Era, comunque, logico che le leggi della genetica esercitassero particolare fascino per chi tentava di leggere, in termini biologici, la complessa struttura della società. Già all’inizio degli anni ‘20, dopo l’identificazione della natura genetica di alcune gravi malattie, come l’emofilia e la distrofia muscolare, e del riconoscimento dell’ereditarietà di alcune caratteristiche biologiche minori, si iniziò a ipotizzare la possibile ereditarietà di malattie mentali e di anomalie comportamentali. 202 Il comportamento umano Le prime osservazioni di concentrazioni familiari di casi di criminalità fecero dedurre, tanto rapidamente quanto erroneamente, che le predisposizioni alla delinquenza, all’alcolismo, al furto, alla prostituzione e, persino, alla tendenza a vivere in povertà, fossero genericamente determinate. L’inquadramento del problema della devianza sociale in un contesto generico rafforzava il convincimento che, non solo le disuguaglianze sociali fossero attribuibili esclusivamente a differenze di merito e di capacità individuali, ma che esse dipendessero da caratteristiche biologiche ereditabili. L’ipotesi genetica spiegava, inoltre, la concentrazione in gruppi relativamente ristretti, sia dei comportamenti socialmente desiderabili, che di quelli delittuosi e lo stabilirsi di gerarchie e stratificazioni sociali destinate a perpetuarsi nelle generazioni, appunto, per ragioni genetiche. Conoscenze elementari dei principi della genetica, mescolate a pochi concetti di eugenica e al solido quanto errato convincimento della ereditarietà biologica della criminalità portarono, nel 1907, alla emanazione della prima legge sulla sterilizzazione coatta di persone con caratteristiche comportamentali indesiderabili. Successivamente, analoghi provvedimenti vennero adottati estesamente in Germania, in contrasto con le leggi vigenti, ben prima dell’ascesa di Hitler al potere. Per oltre vent’anni, vennero effettuati interventi di sterilizzazione coatta su minorati psichici e persone asociali, fino a quando, nel 1933, venne approvata la legge per la prevenzione di nuove generazioni affette da malattie ereditarie, alla cui stesura collaborarono i genetisti con Verschuer, Fisher e Lenz. Seguirono, oltre 300.000 interventi di sterilizzazione di persone giudicate indegne di riprodursi, da speciali Tribunali per la Sanità ereditaria. Successivamente, si passò alla somministrazione di quella che Hitler definiva una morte misericordiosa a oltre 70.000 disabili. Risulta da un’indagine governativa che, tra il 1935 e il 1975, vennero sterilizzate in Svezia circa 63.000 persone, soltanto metà delle quali consenziente. La genetica del dopoguerra si rivolse a due importanti obiettivi: da un lato, la ricerca delle cause materiali dell’ereditarietà biologica, dall’altro lo studio della genetica di popolazione per comprendere i meccanismi dell’evoluzione. I risultati di queste indagini costituiscono ormai capitoli fondamentali della storia delle scienze biologiche. Una volta dimostrato che il DNA è la base materiale dell’eredità biologica, averne compreso la struttura, il codice genetico e le caratteristiche funzionali, e aver trovato il modo per manipolarlo in laboratorio, all’inizio degli anni ‘80, si aprì la fase che ha portato all’attuale conoscenza dell’intera successione dei nucleotidi nel DNA di diversi organismi, incluso l’uomo. La disponibilità di nuovi metodi, basati sull’analisi del DNA, risvegliò, altresì, l’interesse per lo studio dell’ereditarietà dei comportamenti. Molto più serie e numerose furono le indagini per scoprire le basi genetiche di alcune patologie psichiatriche che potevano attivare meccanismi criminogenetici. Dopo oltre un ventennio di ricerche, i risultati sono abbastanza diversi da quelli attesi: non sono stati identificati geni per la schizofrenia o per la depressione, né sono state trovate mutazioni associate in modo inequivocabile e causale a tali patologie, per cui si ritiene che, in tali malattie, venga ereditata una predisposizione, i cui effetti possono manifestarsi con diversa intensità fino al livello clinico, verosimilmente a seconda dell’esperienza di vita individuale e forse del contributo di altri geni minori. 203 Criminologia ed elementi di criminalistica 10.3Il comportamento criminale violento L’approccio psichiatrico/psicologico al comportamento criminale assunse, nel passato, due forme, spesso collegate tra loro. Lo psicologo tentò di stabilire dei programmi riabilitativi; mentre lo psichiatra conduceva esperimenti con una sempre più vasta gamma di droghe psicotrope, infatti, un gran numero di prigionieri fu in effetti utilizzato come cavia inconsapevole della psichiatria, per testare quelle droghe; i detenuti negli anni ‘30 e ‘40, invece, furono usati quali cavie inconsapevoli dell’elettroshock e degli esperimenti per la psicochirurgia. Comunque, nel 1974, dopo uno studio altamente controverso condotto del tutto erroneamente, come si scoprì in seguito, venne determinato che nessun grande programma poteva fornire le prove della propria efficacia nella riabilitazione del criminale. Di conseguenza, lo psicologo si allontanò più o meno furtivamente dalle celle per mancanza di sovvenzioni, mentre lo psichiatra iniziò a diminuire l’impiego droghe, in modo sempre più crescente. Oggi, malgrado le ricerche psichiatriche per l’individuazione delle fonti genetiche e neurologiche del comportamento criminale (approdate a nulla), la riabilitazione di un criminale viene, tuttora, comunemente considerata un’utopia. Essere violenti significa far uso della forza (fisica, verbale, psicologica) per esprimere i propri sentimenti e per raggiungere i propri obiettivi attraverso la sopraffazione temporanea o permanente dell’interlocutore. Spesso si riscontra, nell’autore di una azione violenta, un substrato di aggressività. Non esiste, però, una correlazione lineare tra aggressività e comportamento violento. L’aggressività, entro certi limiti, è una normale reazione dell’organismo, che si trasmette in parte geneticamente e in parte viene indotta dall’ambiente, attraverso meccanismi di apprendimento psicologico e sociale. L’aggressività ha, soprattutto, una funzione di conservazione della specie in quasi tutti gli esseri viventi, compreso l’uomo. I principali fattori responsabili della maggiore o minore pulsione aggressiva negli esseri umani possono essere: a) alcuni specifici tratti di personalità (il temperamento); b) una bassa tolleranza alle frustrazioni; c) psicopatologie (come depressioni, psicosi, disturbi di personalità); d) aspetti neurofisiologici ed endocrini; e) l’uso di droghe e farmaci psicoattivi (specie alcool e cocaina); aspetti socioambientali (es. deprivazione); f ) aspetti culturali (quali appartenenza a subculture devianti, cultura violenta nella famiglia, gruppi di riferimento violenti, ecc.). Il processo di socializzazione umano ha, però, progressivamente introdotto dei meccanismi di canalizzazione delle spinte aggressive in modalità condivise e accettate, e, generalmente, non-violente, regolate da leggi codificate e consuetudinarie. Gli individui riescono a contrastare la propria aggressività attraverso un processo di pensiero (più o meno complesso) che si basa sull’anticipazione mentale degli effetti del proprio comportamento, e sulla significazione della propria azione. In tale fase, vengono valutate le conseguenze negative e i vantaggi collegati a una possibile azione violenta. Quando l’esito di tale percorso pone nella mente del potenziale autore di un crimine una serie di significati favorevoli al cosiddetto passaggio all’atto, il comportamento criminale viene, allora, progettato e, se le circostanze contestuali sono favorevoli, eseguito. Se l’esito del percorso di significazione conduce, viceversa, l’individuo a una valutazione negativa (rispetto all’esecuzione del crimine), possono manifestarsi forme di 204 Il comportamento umano canalizzazione e scarico della pulsione aggressiva attraverso modalità legali (il classico pugno sul muro o più frequentemente il semplice alzare la voce). In realtà, la produzione di idee criminali, talora molto violente, avviene, di frequente, anche nella mente di individui che non hanno commesso, e non commetteranno, mai, alcun crimine. In queste persone, le regole morali, la compassione della vittima, la paura della sanzione penale e sociale impediscono l’esecuzione dei crimini (ma non sempre l’immaginazione). Nei cosiddetti criminali, invece, per vari motivi, tale forma di ostacolo diviene inefficace, e le pulsioni aggressive si materializzano attraverso un’azione violenta. La differenza tra un uomo violento e uno non-violento è così dovuta solo in parte all’indole (più o meno aggressiva), ed è invece fortemente connessa all’efficacia dei sistemi mentali di inibizione e canalizzazione dell’aggressività. Anche il crimine violento, quindi, non è un irrefrenabile impulso animalesco, ma un’azione, in parte razionale, diretta a uno scopo, condotta da un individuo ai danni di altri individui (o dell’ambiente). La logica che conduce l’individuo alla violenza può essere, ovviamente, fortemente viziata dalla presenza di una dimensione psicopatologica, ma essa è da considerarsi, comunque, una produzione del pensiero umano. In tale ottica, il comportamento criminale può essere spiegato utilizzando le normali regole che valgono per il comportamento umano (normale e patologico). L’uomo, orienta, infatti, le proprie azioni (comprese quelle criminali), attraverso un processo di significazione della realtà esterna, attribuendo significato alle sue percezioni e fornendo quelle risposte comportamentali che ritiene adatte alle sue esigenze personali. Questo processo di significazione è inizializzato e influenzato da aspetti pulsionali e motivazionali preesistenti (siano essi neurofisiologici, farmacologici, psicologici, psicologico-sociali, sociologici, e psicopatologici), ma ciò non basta a provocare direttamente il crimine. 10.4 Il cannibalismo Il più famoso cannibale è sicuramente Hannibal Lecter, lo psichiatra antropofago, personaggio sconvolgente nato dalla penna di Thomas Harris, autore del Silenzio degli innocenti. E poi, c’è la strega cattiva della fiaba di Andersen Hansel e Gretel, la quale attira i due bambini nella casa di marzapane allo scopo di mangiarli. Ma, al di là delle pratiche cannibalistiche di gruppi etnici documentate dall’antropologia, non è necessario cercare tra favole e film per trovare personaggi reali che, spinti da desideri ingovernabili, hanno ucciso, sezionato e mangiato gli sventurati capitati tra le loro mani. Uno dei primi serial killer cannibale documentato dalla storia è Gilles De Rais, compagno d’armi di Giovanna D’Arco, che tra una battaglia e l’altra dava sfogo all’impulso di rapire, uccidere, sezionare, e poi mangiare bambini. E poi c’è la Contessa Bàthory, una sorta di Dracula al femminile, che uccideva giovani donne per poi berne il sangue, convinta che questa pratica regalasse benessere al corpo e ringiovanisse la pelle. Più recentemente, Nikolai Dzhurmongaliev, un omicida seriale che dopo aver massacrato le 205 Criminologia ed elementi di criminalistica sue vittime, si sbizzarriva nel preparare gustosi piatti etnici che offriva ai suoi sfortunati commensali. Jeff Dahmer, passato alla storia come il mostro di Milwaukee, è uno dei più violenti serial killer della storia. Uccise, seviziò e tagliò a pezzi almeno undici persone e, durante il processo, ammise che mangiare i cadaveri gli procurava un senso di totale controllo e aumentava l’eccitazione sessuale. Dopo aver accuratamente depezzato il cadavere della vittima, Dahmer prelevava le parti più succulente, cuore, fegato e bicipiti, e li cucinava in padella, oppure alla brace, gustandoli con salse per insaporirli, proprio come se fossero bistecche di carne animale. Ma cosa spinge un serial killer a diventare cannibale? Già all’inizio del secolo scorso, Sigmund Freud scriveva in Totem e Tabù, che la pratica di mangiare carne umana di vittime corrispondeva a un impulso di interiorizzazione e di appropriazione dell’altro. In realtà, spiega il padre della psicanalisi, la crescita del bambino nei primi anni di vita è scandita da una serie di fasi: la prima è la fase orale. In questo periodo, il bambino si nutre dal seno della madre e quindi la suzione diventa fonte di vita. Nel comportamento cannibalico, l’appagamento di questo desiderio rimasto latente è esasperato, e diventa l’unica modalità per instaurare un rapporto con l’altro. Bruno sostiene che nei serial killer cannibali, gli impulsi normalmente presenti in tutti noi si ingigantiscono, fino a diventare patologici. In molti serial killer, questo tipo di comportamento patologico è irrefrenabile e ha la stessa radice di un qualsiasi comportamento affettivo che, mentre nella persona normale si esaurisce in un bacio o in morsetti affettuosi, in un individuo con disordini psicologici diventa un fatto da vivere fino in fondo. Infatti, secondo Fava, impulsi e fantasie cannibaliche fanno parte della struttura profonda della psiche umana. Si pensi alla madre che dice al bimbo “ti mangerei” o a certi comportamenti sessuali o affettivi connessi con il mordere. Secondo il Dipartimento di Studi Psicologici dell’Fbi, la differenza tra i serial killer e i serial killer cannibali è che, mentre i primi, in genere, progettano l’omicidio e uccidono con rapidità, i secondi sono più violenti ed efferati, adescano la vittima in maniera casuale e dopo averla brutalmente massacrata, si accaniscono sul corpo sventrandolo. Secondo Joel Norris, studioso americano dei serial killer, alla base del cannibalismo ci possono essere delle disfunzioni dell’ipotalamo, una regione del cervello che regola l’attività sessuale, dell’umore e di altre funzioni primarie dell’uomo, come mangiare e bere. Il cannibalismo sarebbe, dunque, causato da uno squilibrio ormonale che determina l’incapacità del cervello di misurare le proprie emozioni. 10.5Il ruolo della psichiatria forense La psichiatria forense è una disciplina che collega il diritto alla medicina. Il suo ruolo varia non solo in virtù degli ordinamenti di ciascun paese, ma anche in relazione al tempo e alle spinte etico-sociali. In particolare, appare interessante il diverso ruolo che assume lo psichiatra forense nell’ordinamento giudiziario italiano e in quello statunitense. Nel nostro Paese, egli opera, sia nel processo che nella fase della esecuzione della pena, anche con funzioni 206 Il comportamento umano diagnostiche incidenti sul giudizio di colpevolezza; negli USA, invece, fornisce solo consulenze in merito alla presunta malattia mentale, senza alcuna possibilità di influenzare le scelte del giudice. La psichiatria forense è stata definita come l’applicazione della psicopatologia, della semiologia e della diagnostica psichiatrica ai problemi via via suscitati dai protagonisti del processo penale, civile e canonico, in riferimento a norme e disposizioni contenute nei rispettivi codici e in leggi complementari. Da questa definizione si può agevolmente comprendere che questa disciplina esalta e specifica il rapporto che intercorre fra la medicina e il diritto, rapporto alcune volte misconosciuto, ed altre volte esasperato, che varia da Stato a Stato e di tempo in tempo. In particolare, appare quanto mai interessante procedere a un confronto fra la disciplina come concepita in Italia e come intesa nel più importante stato di common law, ossia gli Stati Uniti. Storicamente, negli stati di civil law e almeno fino al secolo XVII, la medicina non si occupò delle malattie mentali che, per ragioni di opportunismo o di voluta ignoranza e di paura, venivano eziologicamente spiegate in termini di possessione diabolica, eretismo, peccato. Dunque, il pazzo che commetteva un reato non era considerato malato, bensì indemoniato. Solo nel 1800, grazie alla Scuola francese, nelle persone di Esquirol, Georet, Marc, Leuret, si introdusse nella pratica forense la nozione di monomania come causa che escludeva la punibilità e si affermò, più in generale, un nuovo concetto di follia intesa come malattia dell’anima, curabile con la terapia morale, purchè istituzionalizzata. Di contro, in Italia, la psichiatria, conformandosi alla più rigida impostazione oraganicista, propose una diversa interpretazione del problema riconducendolo nell’alveo della biologia, della neurologia, dell’anatomia e finendo per definire le malattie mentali come affezioni del cervello, acquisite o congenite, primitive o secondarie. Con l’affermarsi della psichiatria scientifica, il rapporto fra quest’ultima e il diritto appare mutare in maniera sostanziale. In particolare, la psichiatria forense, con l’emanazione del codice Rocco e con la fine delle grandi discussioni teoretiche sull’imputabilità, assunse un ruolo sempre più evidente di strumento tecnico di garanzia della corretta applicazione delle previsioni codicistiche in materia di capacità di intendere e di volere. Ma la vera esaltazione del ruolo dell’operatore psichiatrico, e dunque della stessa psichiatria forense, avviene con le previsioni del nuovo codice di procedura penale, in cui egli calca la scena, tanto nella fase dibattimentale del processo, con l’intervento peritale, quanto, in seguito, nella fase della esecuzione della pena, con finalità terapeutiche e rieducative. Ma, se nella fase di trattamento del reo, l’obiettivo è quello di recuperarlo attraverso modificazioni oggettive delle condizioni di vita, che favoriscano una nuova capacità di socializzazione ed evitino la ricaduta nei delitti, nella fase processuale, il fine è quello di diagnosticare la capacità di intendere e di volere dell’agente e, dunque, di formulare un giudizio circa la sua imputabilità. Inoltre, in virtù del combinato disposto degli artt. 88 e 222 c.p., il soggetto riconosciuto non imputabile, dopo essere stato prosciolto, non viene abbandonato al proprio destino, ma viene ricoverato in un ospedale psichiatrico o presso case di cura e 207 Criminologia ed elementi di criminalistica custodia, ovvero in istituti o sezioni per infermi di mente, dove sarà approntata una terapia adeguata diretta al recupero e alla risocializzazione dello stesso. In tale contesto, appare opportuno distinguere alcune cause che, secondo il dettato codicistico e la letteratura in argomento, escludono o diminuiscono l’imputabilità: 1) cause fisiologiche: l’età (minore di anni 14 e minore degli anni 18 se nel momento che ha commesso il fatto non aveva la capacità di intendere e di volere); 2) cause morbose: a) infermità; b) sordomutismo; c) cronica intossicazione da alcool e/o stupefacenti. Particolare rilievo rivestono ai fini della psichiatria forense le infermità che possono essere definite come diagnosi di stato o sindromica più estesa di quella di malattia. Esse possono essere: 1) malattie mentali o psicosi dovute a motivi organici, a malattie somatiche, a processi psicopatologici su base non funzionale (schizofrenia, psicosi maniaco-depressiva) con alterazioni psichiche di tipo quantitativo; 2) malattie psichiche non somatiche e prive di base organica comportanti disturbi della personalità. In questo contesto, solo le reazioni abnormi, intese come interruzione di continuità con il precedente stile di vita del soggetto (che devono presentarsi, cioè, come atti di sproporzione evidente del rapporto causa-effetto riferito all’evento), possono associarsi a una possibile compromissione dello stato di coscienza e a una possibile presenza di disturbi dispercettivi o idee di riferimento che, oltre ad essere di durata relativamente breve, hanno valore di malattia e potrebbero configurare un vizio parziale o totale di mente. 10.6La macchina della verità (o poligrafo) Nella nostra lingua si chiama macchina della verità, in inglese e americano, lie detector; un’altra definizione comune ad entrambe le lingue, più utilizzata dai tecnici e dagli specialisti, è poligrafo (in inglese/americano polygraph). Sostanzialmente, è un dispositivo elettrico, molto simile a quello dell’elettrocardiogramma o dell’elettroencefalogramma, che, mediante un circuito piuttosto semplice, rileva le variazioni di certi parametri psicofisiologici, come la pressione del sangue, la respirazione (toracica e addominale), la conduttanza cutanea (ovvero la sudorazione del palmo delle mani) e produce, per ciascuno di essi, un tracciato. Per lo più, viene utilizzata nell’ambito giudiziario, soprattutto in America, molto più che in Italia e in Europa. Una legislazione molto precisa (e differenziata Stato per Stato) indica campi e regole di applicazione di questo tipo di interrogatorio come strumento di indagine di un crimine. Il dibattito tra detrattori e sostenitori dello strumento e delle sue procedure, è molto vivace. È stato anche formalizzato un protocollo di utilizzo della macchina che comprende processi tecnici, ma, soprattutto, fasi precise, secondo cui l’esaminatore deve procedere; fasi la cui mancata applicazione implica il venir meno delle garanzie di una corretta rilevazione (detection) della verità (o della menzogna). Le fasi, sinteticamente, sono: - pretest, cioè un’intervista informale che l’esaminatore destina all’esaminato; essa si basa su una serie di domande neutre preliminari, al fine di calibrare la macchina 208 Il comportamento umano sui parametri psicofisici dell’esaminato. Questa fase può durare, a discrezione dell’esaminatore, circa 1 ora; - design questions, dove l’esaminatore, alla luce della fase di pretest, definisce le domande rilevanti per l’indagine; - in-test, che segna l’inizio dell’esame; l’esaminatore pone circa dieci domande delle quali solo 3 o 4 sono rilevanti per l’indagine; le altre domande sono domande di controllo, molto generali, per verificare lo stato di normalità dell’esaminato, quello che, in linea di principio, dovrebbe corrispondere alla verità; - post-test, durante il quale l’esaminatore analizza i dati delle risposte fisiologiche e determina se la persona ha detto la verità oppure ha mentito. Così come per il tracciato cardiaco, si costituisce un tracciato come normale. Le differenze rilevate dallo stato definito come normale devono essere spiegate, analogamente a quanto, nelle patologie cardiache, certi tipi di alterazione del tracciato vengono considerate segno di precise alterazioni patologiche. Il poligrafo rileva, quindi, alcuni parametri fisiologici: respirazione toracica, respirazione addominale, conduttanza cutanea, pressione sanguigna. Questi stessi parametri, vengono alterati da varie situazioni: guidare nel traffico, ad esempio, è causa di un aumento dell’accelerazione cardiaca e respiratoria (e questo spiega i nostri comportamenti patologici quando siamo alla guida). Nel caso della macchina della verità, vengono poste due ulteriori relazioni: quella tra normalità e verità, e quella fra scostamento dalla normalità e menzogna; lo scostamento dalla normalità, secondo questi quattro parametri, è considerato un valido indicatore della presenza di una menzogna. Secondo le ricerche di Daniel Langleben, docente dell’Università della Pennsylvania, dire bugie, per il cervello, è una gran fatica. Infatti, ci sono una gran quantità di aree cerebrali diverse che si mettono all’opera quando i soggetti dell’esperimento si trovano a dire una bugia, rispetto alle aree cerebrali implicate in una risposta veritiera. Ecco, in sintesi, il protocollo dell’esperimento: un gruppo di 18 volontari è stato sottoposto al seguente test: è stata loro fornita una serie di oggetti da nascondere in tasca; poi sono state loro mostrate immagini, alcune delle quali riproducevano gli oggetti in loro possesso; infine, è stato chiesto loro di mentire alle domande dell’intervistatore circa il possesso, o meno, di quell’oggetto. Per eseguire l’interrogatorio, ogni volontario è stato fatto accomodare all’interno dell’apparecchiatura per la risonanza magnetica, uno strumento che ha permesso di osservare cosa accadeva nel suo cervello. Le immagini prodotte dalla risonanza hanno mostrato un’intensificazione dell’attività cerebrale, nel momento in cui il soggetto ha iniziato a mentire, ma, solo in zone ben localizzate del cervello: il giro del cingolo e il giro frontale. Il primo, coinvolto nell’inibizione della risposta e nel monitoraggio degli errori, il secondo che pare rivestire un ruolo critico nell’attenzione. Da questo, gli sperimentatori che riportano l’esperimento, deducono che: il nostro cervello è sempre pronto per dire la verità, mentre, per mentire, deve organizzarsi, attivarsi ed agire, in una sorta di lavoro extra non previsto. Attorno a queste ipotesi, si possono fare molte considerazioni, ma, badando a non tirare in campo tutte le questioni filosofiche sulla verità e la menzogna, né le differenze 209 Criminologia ed elementi di criminalistica tra verità soggettiva e verità condivisa, passando per il sottile confine tra fantasia e menzogna, è opportuno individuare due elementi: a) il fondamento ideologico di questa relazione tra normalità psico-fisiologica (e quindi, per estensione, psichica) e verità, è costituito da un’attribuzione di valore che proviene da una tradizione etica e religiosa molto precisa (da San Paolo a Sant’Agostino al rito della confessione); b) la promozione scientifica di tale valore, passa, nel caso della macchina della verità, attraverso la costituzione di un’altra relazione: quella che viene posta tra l’istinto (inteso come lo stato più puro, biologico) dell’uomo e il suo essere sincero e veritiero, anzitutto, con se stesso (e pensiamo anche all’atteggiamento psicoanalitico), prima che con gli altri. Sembra, invece, che il valore positivo che viene attribuito alla verità abbia un significato non tanto psichico o individuale, quanto sociale o socio-evoluzionistico, e che, quindi, appartenga e debba restare di pertinenza dell’etica, più che della neurologia o della psicofisiologia. In una società, è importante che ciascuno si possa fidare dell’altro e la società si evolve solo se ciascuno può contare su questo. Pertanto, la verità è una condizione del vivere sociale e, come tale, va garantita e sancita, senza coperture ideologiche o pseudoscientifiche, ma in tutta la sua pragmatica utilità. Al di là delle motivazioni ideologiche sul fondamento scientifico di questo tipo di studi sperimentali e all’obiettivo di rilevare in modo inequivocabile la presenza di una bugia analizzando il processo mentale che la bugia richiede, troveremo probabilmente due differenti operazioni, laddove la risposta vera e sincera ne prevede una sola: se a un soggetto viene chiesto, ad esempio, il nome, e lo stesso deve per qualche motivo mentire, potrebbe avere un leggero ritardo nella risposta, dovuto al fatto che è abituato a rispondere, ad esempio, Marco; il soggetto, pertanto, recupera l’operazione più facilmente disponibile (Marco, appunto), ma interviene un processo di controllo superiore che gli impedisce di dirlo, per una serie di altre considerazioni; deve recuperare nella memoria un altro nome disponibile da fornire come risposta all’interlocutore e dirlo: il processo è più elaborato e dovrebbe richiedere, quindi, più tempo, una frazione di secondo, un istante, ma sufficiente ad un orecchio allenato (o ad una macchina molto sensibile) a dare perlomeno un allarme (se non un’indubitabile rilevazione). Se si pensa, però, agli attori, e a come sanno essere più convincenti delle persone reali, stanno essi mentendo? No, assolutamente. Dicono la verità utilizzando una tecnica che pare ancora più complessa, ma probabilmente non lo è: credono alla storia che si sono costruiti o che qualcuno ha costruito per loro, ci credono in ogni più piccolo dettaglio, e con tutto il loro essere. E agiscono, parlano e pensano secondo questa narrazione, forse come i bambini, quando ci raccontano delle loro storie, e di loro stessi dentro le loro storie. Raccontarsi una storia, convincente o meno, non importa, l’elemento fondamentale è crederci; scriverla e riscriverla nella nostra mente: è questa complessa configurazione tenuta insieme dalla narrazione (dalle sue implicazioni, dalle contestualizzazioni di cui è capace) ciò che va naturalmente a costruire la nostra verità; e se il narratore è abile (e se la racconta ad arte) non c’è macchina della verità che tenga. 210 Il comportamento umano Quando una persona dice una bugia, utilizza parti del cervello diverse da quando dice la verità, e questi cambiamenti cerebrali possono essere misurati con la tecnica della risonanza magnetica funzionale (FMRI). Lo sostiene uno studio presentato dalla Radiological Society of North America. I risultati suggeriscono che, un giorno, la FMRI potrebbe essere usata come macchina della verità, con risultati più precisi del poligrafo. Misurando con la FMRI l’attività delle aree cerebrali associate alle bugie, sostiene Scott H. Faro della Temple University, si potrà determinare se il soggetto sta dicendo la verità. A tal fine, è stato compiuto un esperimento con undici volontari. A sei di essi è stato chiesto di sparare con una pistola giocattolo, mentre agli altri cinque, no. Tutti, però, dovevano affermare di non aver sparato. I ricercatori hanno esaminato i singoli individui con la FMRI, e, contemporaneamente, con il normale poligrafo che viene usato come macchina della verità. Il poligrafo misura tre risposte fisiologiche: il respiro, la pressione del sangue e la capacità della pelle di condurre elettricità, che aumenta con la sudorazione. In tutti i casi, sia il poligrafo sia la FMRI sono riusciti a distinguere le risposte veritiere da quelle false. Durante le bugie, la FMRI ha mostrato l’attivazione di diverse aree cerebrali nel lobo frontale (mediale inferiore e pre-centrale), temporale (ippocampo e temporale medio) e limbico (cingolato anteriore e posteriore). Nel caso delle risposte vere, la FMRI ha invece mostrato attivazione nel lobo frontale (inferiore e mediale), temporale (inferiore) e nel giro cingolato. Nel complesso, quando un soggetto diceva una bugia, si attivavano più aree cerebrali, rispetto a quando diceva la verità. Poiché le risposte fisiologiche possono variare da individuo a individuo e, in alcuni casi, essere regolate, il poligrafo non viene considerato uno strumento del tutto affidabile per individuare una bugia. Secondo Faro, tuttavia, è ancora troppo presto per affermare se la FMRI possa essere ingannata nello stesso modo. 211 CAPITOLO 11 Criminalità e disturbi mentali 11.1 Evoluzione storica del concetto di malattia mentale La riforma sanitaria relativa all’assistenza psichiatrica venne approvata il 13 maggio 1978, dopo un lungo dibattito alla Camera e al Senato; si tratta della legge 180, successivamente integrata dalla legge 833, dello stesso anno, riguardante la costituzione del Piano Sanitario Nazionale. Con tale normativa, si abbandonava un sistema coercitivo, di contenzione, basato su terapie meramente mediche e di correzione proprie degli ambienti manicomiali, per giungere a un nuovo sistema, improntato al riconoscimento della dignità della malattia e, quindi, della dignità dell’individuo malato; il tutto chiaramente sorretto da un cambiamento di intervento terapeutico basato su una nuova rete di strutture e di servizi a carattere dipartimentale. Il discorso sulla salute mentale, in Italia, è particolarmente problematico, poiché il suo carattere non è solo di natura medico-clinica ma anche sociale, assistenziale e politico. è, infatti, un tema scottante che rientra nelle problematiche affrontate dal Welfare State, e anche per questo, soggetto a continue discussioni. Come affermano M. Tansella e G. De Girolamo: i disturbi mentali costituiscono un importante problema di sanità pubblica per vari motivi: essi presentano un’elevata frequenza nella popolazione generale, in tutte le classi di età: sono associati a significativi livelli di menomazione del funzionamento psicosociale (cioè di difficoltà nella attività della vita quotidiana, nel lavoro, nei rapporti interpersonali e familiari, ecc..); sono all’origine di elevati costi sia sociali che economici. Il malato di mente, in tempi non lontani, era soggetto all’isolamento e alla discriminazione. La patologia era uno stigma, aveva quindi un significato meramente spregiativo che si poneva in antitesi con gli stereotipi relativi alla cosiddetta normalità, considerata tale dalla cultura di riferimento. Con la nuova legge, nonostante inadempienze e ritardi amministrativi e a volte carenze strutturali, si è riusciti, comunque, a dare voce all’individuo, alla sua dignità, intesa come valore intrinseco della persona, valore che non si traduce come mera funzionalità, come atti, ma come essere. In ritardo di circa 70 anni rispetto alla Francia − che già nel 1838 aveva varato la legge sugli alienati − l’Italia data la sua prima normativa sulla salute mentale solo nel 1904. è 213 Criminologia ed elementi di criminalistica la legge n. 36 del 14 febbraio, che consta di soli undici articoli che prevedono le norme di ammissione e di dimissione dall’istituto manicomiale, regolamentano il lavoro dei direttori e impartiscono le regole amministrative da seguire. L’art. 1, comma primo di tale legge definisce i malati di mente come persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o a gli altri o riescano di pubblico scandalo o non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi. L’azione più importante era finalizzata, non alla cura basata sulla ricerca delle motivazioni dei disagi provati e al successivo intervento terapeutico, quanto, piuttosto, all’isolamento dell’individuo dalla società: rinchiudere uomini e donne che non agivano quotidianamente secondo le regole dominanti nella cultura e nella società di riferimento era fattore essenziale affinché la società stessa mantenesse il proprio equilibrio. Ma isolare in strutture carcerarie, perché tali erano gli istituti manicomiali, non equivaleva a risolvere il problema, anzi, dal momento che la tranquillità sociale era considerata l’elemento più importante (così come importante era vivere in una società sana, di buoni principi e profondamente religiosa), nei manicomi, molto spesso, venivano rinchiusi anche quegli individui che, semplicemente, non vivevano secondo le regole culturali dominanti di quella data società. Ovviamente, il malato non guariva ma, piuttosto, sprofondava, sempre più, nei deliri della sua mente. Di particolare importanza, l’art.10 riguardante la gestione dei cadaveri degli alienati, che prevedeva l’uso dei corpi e anche dei malati da parte degli uomini di scienza. In particolare, l’articolo recita: nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale e a lasciare a disposizione i malati e i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti. Tale articolo riguardava, anche, i manicomi pubblici e privati. Nel secondo dopoguerra, la necessità di una normativa si ripresenta in maniera pressante. Come scriveva il deputato Ceravolo nella sua proposta di legge alla Camera dei Deputati il 17 novembre del 1953: “bisognava appellarsi a criteri di umanità e giustizia perché sostituisce il concetto della custodia di chi è colpito da un male guaribile, il concetto di cura, e redime l’infermo dalla ingiusta qualifica di delinquente potenziale”. Dopo diverse proposte di legge, il 18 marzo 1968 fu varata la legge n. 431. è probabilmente il primo vero tentativo di restituire dignità e dimensione umana all’individuo. Ciò che fino a questo momento era considerato aberrante, mostruoso e disumano, ciò che aveva alimentato a dismisura le paure della comunità, ciò che aveva portato ad azioni e comportamenti deliranti perché basati sulla non conoscenza, adesso conquista una categoria di riferimento e una definizione ben precisa: malattia mentale. Questo restituisce, apparentemente, all’individuo, la sua vita. Il malato deve essere considerato come tale, non più come un criminale, e la sua patologia va curata e prevenuta. Di importanza fondamentale, testimone di una reale volontà di cambiamento, è l’art. 11 che, di fatto, abroga l’art. 604 n. 2 della legge 36/104, che prevedeva l’obbligo della registrazione del malato nel casellario giudiziario. L’iscrizione in questo casellario era come la marchiatura a fuoco, in Francia, dove secondo il Codice Penale del 1810, si applicava sulla spalla la lettera P a coloro i quali erano condannati ai lavori forzati a tempo, così come nel 1893, in Inghilterra, si tatuavano i delinquenti tra le gambe o nello spazio interdigitale dei piedi. In questo modo, gli individui, anche una volta tornati in libertà, o comunque reintegrati, avrebbero avuto per sempre, indelebilmente, il segno dell’infamia. Ancora, con la legge n. 431 non si affronta il tema dei manicomi. La leg214 Criminalità e distrurbi mentali ge 180 è da poco preceduta da un referendum abrogativo della legge 36 del 1904. Con questa normativa, si apre una nuova era per la psichiatria, perché uno dei punti cardini è il trattamento sanitario volontario. La concezione dell’individuo malato è totalmente altra rispetto alle precedenti: l’intervento terapeutico non è finalizzato a diminuire la sua pericolosità sociale ma a curarlo, a migliorare la convivenza con se stesso e, quindi, con gli altri. Anche la definizione stessa della patologia cambia: da pazzia a disagio mentale. Si restituisce dignità anche attraverso le definizioni, le parole. Se l’insanità mentale era legata a concetti di possessione o di devianza, il disagio mentale esprime la difficoltà di vivere da parte di un essere umano, ed è necessario, quindi, riequilibrare la sua salute. E questo è un punto focale: il concetto di salute. In psichiatria, la salute è la condizione di assenza della malattia, malattia che si rivela negando la salute. Ma come si definisce la malattia? E soprattutto come si stabilisce il confine tra normale e patologico? Come afferma M. Augè, la malattia è un paradosso, in quanto si presenta come fattore meramente individuale, poiché si sperimenta sulla propria persona e, nello stesso tempo, è il più sociale degli eventi, perché le categorie per definirla sono sociali, appartengono a quegli schemi di riferimento, a quelle norme che ogni data società umana si dà e nelle quali si riconosce. Ogni anormalità costituisce il segno di qualcosa che è già avvenuto o che sta per accadere: qualcosa che non tocca soltanto il soggetto individuale ma, direttamente o indirettamente, coinvolge rapporti d’interesse comunitario (V. Lanternari, 1994). In antropologia, il concetto di salute non si costituisce a partire dalla sua contrapposizione con la malattia, ma è strettamente legato all’ambito culturale di riferimento. Come afferma U. Fabietti: “l’analisi di tale dominio (concetto di salute) rivela le numerose connessioni e la densità di significati sociali e culturali che investono il corpo umano, sia laddove esso venga interpretato in una dimensione strettamente biologica, sia laddove gli eventi che lo riguardano diventino il fulcro per un’elaborata riflessione sulla costituzione della persona e sulle relazioni che la legano all’ordine sociale (2001)”. Anche la malattia mentale, come il concetto più generale di malattia, va inteso in rapporto alla propria cultura, quindi, solo individuando le coordinate culturali di riferimento, e identificando il posto e il ruolo che ciascun individuo ricopre e svolge in una determinata società si può comprendere la malattia. Essa, quindi, deve essere interpretata, determinata di significato e questo può essere sia di natura eziologica che sociale o anche entrambe. Comunque sia, è una manifestazione del sé che si esprime attraverso un suo proprio linguaggio e suoi propri rituali che, ovviamente cambiano, a seconda del tipo di società: vi sono quelle in cui l’individuo è pensato come un insieme di elementi caldi e freddi in equilibrio e armonia e, quindi, la malattia si insinua negli interstizi di questi elementi, nel punto esatto in cui si avvicinano e corrono paralleli, e concorre a destabilizzare questa armonia, per cui, la cura è finalizzata al ripristino delle proporzioni degli elementi; vi sono altre società in cui l’individuo è considerato come agito da un principio spirituale (anima) e, quindi, la malattia può essere il furto o la compromissione di tale essenza vitale; o, ancora, società in cui l’individuo è rappresentato come articolazione di una res extensa e di una (separata) res cogitans, e quindi la malattia sarà affezione di ciascuno di questi domini, malattia del corpo o della psiche (F. Vacchiano). 215 Criminologia ed elementi di criminalistica è chiaro che ogni cultura, nel momento in cui si dà delle norme di riferimento concepisce e sviluppa anche le devianze da tali norme. Ad esempio, presso i Wolof del Senegal, la malattia mentale risulta essere una punizione per non aver rispettato alcuni aspetti di un determinato rituale, mettendo, quindi, in evidenza tutta quella serie di obblighi morali e pragmatici nei confronti dei defunti; presso i Wirràrika del Messico, l’insanità mentale può essere frutto di un anatema scagliato da uno sciamano verso il quale magari non si è portato rispetto; ancora, presso le culture animiste, la pazzia è frutto di una contaminazione di uno spirito maligno che abita luoghi proibiti come foreste, paludi, e così via. Per cui, le azioni insane dell’individuo saranno determinate da questa possessione, così come accadeva durante il Medioevo quando l’Inquisizione accomunava gli eretici ai pazzi: “non tutte le persone accusate di stregoneria erano inferme di mente, ma, quasi tutti gli infermi di mente erano considerati streghe, maghi, posseduti da incantesimi” (G. Zilboorg, H. Henry). Ippocrate, nel V secolo a.c., considerava la follia una malattia del cervello, mentre per il Cristianesimo era espressione della possessione da parte del demonio e pertanto punibile con le più crudeli torture. Nel Medioevo, invece, l’insano di mente era largamente accettato dalla comunità, ne era parte integrante e costituente; la follia era il lato oscuro della quotidianità, era il male nel bene e l’esistenza tragica degli individui, che oscillava tra la vita e la morte, conviveva con questa immagine inquietante e familiare. In un momento storico così fortemente impregnato di religione, il folle rappresentava la vacuità dell’esistenza umana, la caducità delle speranze, il confine sottile tra la luce e le tenebre, e proprio per questo, l’insano di mente era custode segreto di un sapere oscuro, altro, di una dimensione parallela a quella della realtà quotidiana, che aveva in seno le verità. è a partire dall’età moderna, che la pazzia comincia ad essere considerata una malattia, ma una malattia morale piuttosto che mentale: la considerazione della follia come crimine e non come malattia, determina la prevalenza della concezione etica su quella giuridica e condanna al silenzio e alla vergogna tutte quelle forme di alterità che, nel Medioevo e nel Rinascimento, avevano trovato la loro rappresentazione nel mondo fantastico e miracoloso. Il malato di mente comincia ad essere relegato in ambienti ben definiti, gli ex lebbrosari: emblema di queste nuove locazioni è l’Hôpital General di Parigi, fondato nel 1656, che Foucault definisce il terzo stato della repressione. Questa struttura è del tutto autonoma ed ha diritto di vita o di morte sull’esistenza dei suoi ospiti. Da qui, comincia la storia dell’internamento, del maltrattamento, della deprivazione totale. è ovvio pensare che in queste strutture era presente un’umanità molto varia: da veri malati a criminali a dissidenti politici; ma anche individui dalla sessualità incerta o dediti a costumi sessuali licenziosi. La follia, in questo periodo, veniva a rappresentare la diversità, la devianza, ciò che era contro natura, e si potrebbe affermare, contro cultura; era associata al mostruoso, all’aberrante, al corrotto e al marcio. Nel tardo XVIII sec., si comincia ad operare una distinzione, si libera la follia dalla collusione con altre forme di devianza, ma viene ulteriormente isolata. Sul finire del XIX sec., diventa vera e propria malattia. Chiaramente, nel corso del tempo, anche gli interventi terapeutici sono cambiati e sono proprio questi che ci danno la misura delle umiliazioni e le torture subìte dai degenti. Possiamo parlare, ad esempio, della terapia dell’acqua, tanto usata in 216 Criminalità e distrurbi mentali Francia nei primi anni del ‘800. Esquirol, medico e responsabile del manicomio Charenton, dal 1826 al 1833, prescriveva vari tipi di bagni a seconda della gravità delle patologie: potevano essere bagni tiepidi, bagni di immersione freddi o ancora bagni a sorpresa, per cui, ad esempio, si prendeva un malato e lo si gettava di forza nelle acque di un fiume anche in pieno inverno. Ma c’erano anche docce praticate inserendo il tubo nel retto a diverse profondità. La terapia dell’acqua era legittimata dalla credenza che a seconda della temperatura, l’acqua potesse cambiare la circolazione del sangue e, quindi, il modo in cui questo affluisce alla testa, da cui dipendono le patologie. Oltre a questi interventi, molto usato era il salasso (in realtà se facciamo un discorso più ampio, il salasso, a quei tempi, era considerato la panacea per tutti i mali, perché, per qualsiasi tipo di malattia, si interveniva prima in questo modo), praticato anche attraverso l’uso di sanguisughe poste sugli organi genitali. Veniva praticata, anche la flebotomia, consistente nell’immersione dei piedi in acqua bollente con l’aggiunta di acido muriatico, purganti ecc. Ciò, in quanto sopravviveva la concezione arcaica della malattia come punizione di una cattiva condotta, come forma esplicita di una quotidianità vissuta non seguendo le regole della comunità; quindi, era necessario il rito purificatore attraverso la fuoriuscita di quei liquidi del corpo che avevano corrotto l’anima (e la testa). Usata era, anche, l’elettricità galvanica o magnetica, per lo più posta, sempre, sulla zona anale o testicolare, ma come afferma V. Andreoli, illustre psichiatra contemporaneo: “la forma più spettacolare ed efficace però, era quella del ferro rovente applicato sulla nuca o sull’occipite” (1991). C’erano fustigazioni con fasci di ortica o fruste di pelle. Ancor più drammatica, se possibile, è la sorte a cui erano destinate le donne, trattandosi di vere e proprie sevizie: si va dalla clitoridectomia alla cauterizzazione, ma venivano praticate anche l’ovariectomia e la dilatazione cruenta del collo dell’utero. Charcot, psicanalista, per curare l’isteria, utilizzava una cintura che, per mezzo di una vite a pressione, comprimeva la regione ovarica di sinistra. Questi interventi non sono dissimili dalle sevizie che le donne tutt’oggi subiscono in vari paesi del mondo. Nella prima metà del ‘900 fa la sua comparsa l’elettroshock. è singolare la situazione da cui ha poi origine questa idea. è il 1937, il dott. U. Cerletti, allora direttore della Clinica di Neuropatologia e Psichiatria di Roma, assiste, visitando il mattatoio di Roma, all’applicazione di corrente elettrica sulla testa dei maiali. Con questa tecnica applicata agli uomini, il paziente giunge al coma e all’arresto delle funzioni vitali: il cuore e il respiro si fermano almeno per un pò di tempo; la rinascita è condotta con tecniche di rianimazione e, nel giro di alcuni minuti, il folle cammina, rinato, nella sua stanza (V. Andreoli, 1991). Non dimentichiamo, inoltre, gli interventi invasivi quali la lobotomia che riduceva nell’individuo, da un lato, la patologia, ma, con essa, anche la sue capacità critiche e relazionali. Alla luce di tutto questo, ci rendiamo conto come con la legge 180 ci sia stata una vera svolta epocale. L’art 1, comma 1, afferma: “gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari”. E il comma 2: “nei casi di cui per legge, e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato, possono essere, invece, disposti dall’autorità sanitaria nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura”. 217 Criminologia ed elementi di criminalistica Già da questo primo articolo si evince la restituita dignità al malato come individuo e la restituzione del rispetto dei suoi diritti fondamentali quali, ad esempio, la libertà di scelta. L’art. 34 comma 4 della legge 833 del 1978, articolo che riguarda i casi in cui invece si possa ricorrere al trattamento sanitario obbligatorio, afferma che: “questo può svolgersi in condizioni di degenza ospedaliera, solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accertati dall’infermo, e se non vi siano le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere”. Secondo la normativa attuale, la degenza in ospedale ha una durata massima di una settimana rinnovabile, e ha inizio con la proposta del medico curante, rivolta al sindaco che, nella sua qualità di autorità sanitaria, ne dispone il provvedimento. Da notare che il sindaco − come si affretta a specificare anche l’art. 33, comma 3 della legge 833/78 − interviene in virtù della sua autorità sanitaria e non anche di pubblica sicurezza come invece era previsto per la legge 36 del 1904 e dall’art.1 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza. La proposta del medico, prima di giungere al Sindaco, deve essere convalidata da un medico dell’unità sanitaria locale che deve motivare tale convalida, in relazione all’art. 34, comma 4 della legge 833/78. La nuova normativa sulle patologie psichiche ha una visione completamente diversa: abolendo le strutture manicomiali, come nuovo territorio della psichiatria, utilizza tutta una serie di istituzioni che possano essere alternative e interdipendenti tra di loro. In questo modo, si intende realizzare una fitta rete di servizi, il cui scopo non sia quello di internare ma ricercare, continuamente, soluzioni riabilitative per quegli individui che soffrono di disagio mentale. Di fondamentale importanza è anche il confronto con chi soffre: concentrarsi sulle storie di vita, sull’ambiente in cui si è vissuto, sugli stimoli ricevuti e sulle esperienze avute, aiuta a comprendere. Dell’importanza della terapia della parola già ne parlavano S. Freud e J. Breuer: “un’immagine che sia stata sfogata a parole non si rivede più; solo con l’ultima parola dell’analisi scompare l’intero quadro morboso” (J. Breuer, S. Freud, 1976). Ed ancora, in tempi più recenti: “la parola è la rappresentazione di un sintomo, dunque, un segno che lo individua e lo maschera. Gli rimane l’idea di una parola che, liberatasi nella ritualità della relazione terapeutica, genera la soluzione d’un conflitto come se il conflitto fosse in quella parola, ora detta” (V. Andreoli, 1991). Se è vero che con la legge 180 c’è stata una reale svolta epocale nella considerazione del disagio mentale, pur tuttavia, questa normativa non è esente da critiche. La gestione del problema psichiatrico da parte delle singole regioni non sempre ha dato risposte soddisfacenti, e ciò per tutta una serie di motivazioni, non ultima proprio dal punto di vista operativo, il passaggio da una normativa a un’altra. In realtà, i punti su cui si dibatte da tempo, sono sia di natura tecnica che socio-sanitaria. Non sempre gli ex-manicomi, ad esempio, sono stati smantellati; più spesso, c’è stata una riconversione poiché è stato impossibile creare strutture alternative e, parallelamente, vi è stata la proliferazione di case di cura private che, molto spesso, salgono agli onori delle cronache (nere) perché veri e propri lager; per quanto riguarda i Dipartimenti di Salute mentale, da più parti, si lamenta la poca specializzazione del personale che dovrebbe essere sottoposto a continua formazione; inoltre, c’è la gestione della malattia a livello sociale: la famiglia e 218 Criminalità e distrurbi mentali i cittadini. Molto spesso, le associazione dei familiari dei malati lamentano il loro stato di abbandono da parte delle strutture psichiatriche e delle istituzioni; ci sono casi molto gravi, in cui il trattamento sanitario obbligatorio, per il periodo di tempo sancito dalla legge, risulta insufficiente; di contro, le strutture intermedie predisposte all’assistenza psichiatrica risultano insufficienti per soddisfare tutte le richieste. Quindi, sarebbe necessario creare una rete di strutture con compiti differenziati che siano però interagenti tra loro, al fine di affrontare la malattia in tutte le sue forme e le sue gravità. Ci sono, poi, difficoltà di convivenza a livello sociale con i malati psichici. In moltissimi casi, la situazione di stigma della malattia permane, per cui, è difficile trovare una locazione indipendente per il disagiato che non viene accettato, ad esempio, dai vicini di casa. Paradossalmente, mentre in passato la realtà manicomiale garantiva la sistemazione a lungo termine dei malati, oggi, c’è un reale abbandono di chi soffre, e le famiglie, per la maggior parte composte da persone anziane, non riescono a gestire le varie situazioni. Molto spesso, poi, i casi più gravi di malattia mentale si riscontrano presso famiglie che già vivono situazioni di indigenza o che comunque hanno problemi. La legge prevede dei protocolli d’intesa con le varie ASL ed i Comuni, per trovare delle soluzioni e delle locazioni ma, dopo un impegno formale iniziale, le aspettative vengono subito disattese per tutta quelle serie di problemi su indicati. 11.2 Rilevanza dei disturbi mentali ai fini della responsabilità Si pone, quindi, il problema di valutare il rapporto fra lo stato psicopatologico ed il comportamento criminale, cui corrisponde un criterio o metodo di accertamento della responsabilità. Schreiber ha individuato tre diversi metodi di valutazione della responsabilità penale: 1) il metodo psicologico normativo, che consiste nel valutare l’esistenza di malattie o disturbi psichici e valutarne l’incidenza sulla capacità di intendere e di volere. Circa i fattori psicopatologici, non sempre la legge li definisce, mentre si limita a far riferimento a concetti molto generali, che poi sono interpretati estensivamente. Per quanto attiene la capacità di intendere e volere, nella maggior parte dei sistemi penali, che seguono tale metodo valutativo (e sono quello danese, francese, olandese, austriaco, irlandese portoghese, svizzero, tedesco, greco e il nostro), è sufficiente che manchi anche solo una di esse perché il soggetto non sia considerato punibile. Come rileva Pulitanò, il primo metodo, quello misto, è fatto proprio dal nostro codice penale. In base a tale metodo, quindi, non occorre solo individuare lo stato patologico, ma, anche, la verifica normativo-giurisprudenziale della rispondenza di tale stato a una condizione di infermità tale da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere o entrambe; 2) il metodo puramente psicopatologico considera non punibili i soggetti affetti da determinate malattie mentali, senza valutarne la loro incidenza sulla capacità di intendere e di volere (Norvegia e Svezia seguono questo metodo). Ne consegue, ed è 219 Criminologia ed elementi di criminalistica l’esempio svedese, che il malato mentale venuto a contatto con la giustizia penale non può essere sottoposto a sanzioni penali punitive, ma deve essere sottoposto a misure di trattamento psichiatrico; 3) il metodo puramente normativo non considera i problemi psicopatologici, ma valuta solo se, al momento del fatto, sussisteva la capacità di intendere e di volere. Tale metodo non è seguito in nessuno dei paesi europei (almeno di quelli membri dell’U.E.) e fa capolino solo in quelli in cui l’elemento psicopatologico, interpretato in modo estensivo, conduce a effetti distortivi e ad abusi contrari al senso di giustizia. Occorre, anche, chiarire che esiste un legame tra il criterio utilizzato per definire il disturbo psichico e il criterio per rilevare il rapporto tra disturbo e imputabilità: quanto più è allargato il criterio diagnostico, più è vincolante il rapporto tra malattia mentale e comportamento. Nonostante il maggior sforzo critico dei magistrati, ancora oggi, il legame tra disturbo psichico e comportamento criminoso, soprattutto per quanto attiene i reati di violenza, resta in piedi. Anche se non esiste più il meccanicismo per il quale il malato di mente è solo per questo prosciolto, si cerca il legame di causalità tra lo stato patologico e l’atto criminoso, come se questo fosse sintomo della malattia, del disturbo. In realtà non sembra che si possa affermare che il reato sia sintomo della malattia, e ciò anche nei casi più gravi ed efferati. La valutazione dei problemi connessi con l’imputabilità e la responsabilità penale a livello dei casi individuali, nel campo delle scienze di tipo clinico, come sono la psicologia e la psichiatria, hanno evidenziato come i periti non sono scientificamente qualificati per fornitore pareri, se non veri e propri giudizi, in merito a questioni morali e filosofiche, come la responsabilità o l’imputabilità penale. Giustamente, Canepa, fà notare che il parere del perito è trasformato, dal magistrato, in un giudizio morale sulla responsabilità, e, quindi, sulla libertà del soggetto che deve essere giudicato; ma il perito non ha la competenza per esprimersi sulla responsabilità e sull’imputabilità; da qui, la richiesta di revisione di tali concetti in seno al codice penale. Per Canepa, il perito dovrebbe limitarsi alla comprensione clinico-fenomenologica dell’atto criminoso ed elaborare un programma di trattamento finalizzato alla risocializzazione. 11.3 Relazione tra disturbi mentali e pericolosità Nella versione originale del codice Rocco, nei confronti dei prosciolti per vizio di mente, vigeva la presunzione di pericolosità, e, di conseguenza, l’obbligo di assegnazione all’O.P.G. (Ospedale Psichiatrico Giudiziario), per un tempo predefinito nel minimo, ma non nel massimo, in funzione della gravità del reato e non della malattia. L’ avvenuta guarigione prima dello scadere del termine della misura, così come la concreta e reale non pericolosità del soggetto, non avevano alcuna rilevanza. Analogo regime vigeva per i seminfermi, con l’ulteriore incongruenza che la misura si aggiungeva alla pena diminuita. Ciò sulla base di una duplice presunzione: accertata infat220 Criminalità e distrurbi mentali ti la incapacità di intendere e di volere del soggetto conseguente ad una sua infermità psichica, viene presunta dal legislatore la di lui pericolosità sociale; a sua volta, però, la norma, presume, pure, che l’infermità cui è collegata la pericolosità, individuata rispetto al momento della commissione del fatto, perduri fino a quando si procede all’applicazione della misura di sicurezza. La conseguenza, inaccettabile sul piano costituzionale, è che può subìre la misura di sicurezza un soggetto che, nel lasso di tempo intercorso tra i due momenti predetti, sia guarito dallo stato di alterazione mentale, senza che però ciò valga a differenziarlo, sul piano giuridico, da chi è ancora infermo. Solo la legge 663/1986, abrogando ogni fattispecie di pericolosità presunta, ha risolto definitivamente il problema del binomio pericolosità sociale-infermità mentale, consentendo, così, di considerare quest’ultima, non più come una causa speciale di pericolosità, ma come un qualsiasi fattore che, interagendo con gli altri, può esercitare un’efficacia criminogena; si può, quindi, escludere l’applicazione della misura, non solo quando l’infermità è venuta meno o è migliorata, ma, anche quando, pur essendo questa immutata rispetto all’epoca della commissione dei fatti, risulti comunque improbabile che il soggetto ponga nuovamente in essere comportamenti lesivi degli interessi della collettività: in altri termini, si può affermare, che anche la pericolosità sociale dell’infermo di mente deve accertarsi, non soltanto sulla base di emergenze di natura medico-psichiatrica, ma sulla base di tutti quei criteri di valutazione di cui all’ art. 133 c.p.; quindi, il giudice è legittimato a prendere in esame qualsiasi elemento utile a detto accertamento, compreso l’ambiente in cui il soggetto liberato verrebbe a vivere e operare, e la presenza ed efficienza o meno di presidi territoriali socio-sanitari ai fini della continuità nell’assistenza psichiatrica; da ciò, consegue che detto accertamento è compito esclusivo del giudice, che non può abdicarvi a favore di altri soggetti, quali il perito, né rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali e comportamentali in cui si trova il soggetto interessato, eventualmente indicati dal perito. La conseguenza dell’attuale disciplina è che, nei confronti dell’autore di reato, anche gravissimo, che sia stato prosciolto per vizio totale e che non venga riconosciuto pericoloso, non è previsto nessun provvedimento ed egli sfugge a qualsiasi terapia o cura appropriata. La mancanza di alternative intermedie tra l’internamento in istituto e la rimessione in libertà, senza possibilità di imporre alcuna forma di controllo o di aiuto agli infermi di mente, investe di una grossa responsabilità il giudice e lo psichiatra forense, chiamato a esprimere un giudizio di pericolosità, che si traduce, o in una profonda limitazione della libertà personale, o in una totale rinuncia alla difesa sociale. Unica soluzione intermedia che può aprirsi per il malato di mente giudicato socialmente pericoloso è la possibilità che, in sede di accertamento della pericolosità prima dell’esecuzione in concreto della misura o successivamente in sede di riesame della pericolosità, il magistrato di sorveglianza dichiari non venuta meno, ma attenuata, la sua pericolosità sociale e disponga la conversione della misura manicomiale in quella della libertà vigilata, meno lesiva della libertà personale. Inoltre, persiste la difficoltà di conciliare il dubbio e lo scetticismo sulle capacità predittive della psichiatria, che come tutte le scienze che hanno per loro oggetto l’uomo, non è una scienza esatta, con la necessità, da parte del 221 Criminologia ed elementi di criminalistica diritto, di risposte certe. L’ampliamento del ruolo e della responsabilità del perito psichiatra, porta, quest’ultimo, ad esprimersi sulla pericolosità sociale, fino ad essere chiamato, tenuto conto dell’ampia delega operata abitualmente dai magistrati in favore dei tecnici chiamati a esprimere il loro parere, a operare un giudizio che, secondo l’opinione dominante, non è da considerarsi di competenza medica e ad assumersi una responsabilità che non gli compete, tra i due opposti rischi di sconfinare in una sovrastima della pericolosità sociale o di agevolare i simulatori che, se giudicati inimputabili, e non pericolosi, non subiranno alcuna sanzione. Meglio sarebbe, secondo tali autori, che allo psichiatra fossero riservate considerazioni tecniche su elementi quali le caratteristiche individuali della malattia, l’eventuale miglioramento o guarigione della stessa, le indicazioni terapeutiche, la prognosi legata al tipo di interventi; elementi che poi il giudice utilizzerà per effettuare (egli stesso) il giudizio di pericolosità, non delegabile ad altri, avvalendosi anche di tutti quei dati per la cui valutazione non è necessaria una competenza di tipo medico, quali la gravità del reato, l’allarme sociale, i fattori situazionali, i precedenti penali, e così via. Altri autori, poi, ammettono la competenza predittiva del perito psichiatra, ma, solo se congiunta alla formulazione di un programma terapeutico. Il binomio prognositerapia, dimostratosi valido in ogni settore della medicina, conserverebbe la sua validità anche in psichiatria forense, coinvolgendo nei progetti terapeutici i servizi psichiatrici civili territoriali, che sono, oggi, abilitati ad occuparsi anche dei malati di mente in detenzione, siano essi imputati o condannati. Naturalmente, ciò che i critici della capacità predittiva della psichiatria contestano non è la necessità di formulare predizioni nella quotidianità del vivere, bensì, il fatto di gabellare per scientifiche, prognosi che non sarebbero più sicure di quelle basate sul senso comune. Resta però il fatto che, se si deve ammettere che, al folle residua, pur sempre, uno spazio di libertà, sappiamo anche che ogni disturbo mentale comporta una riduzione di questa area. Inoltre, le dinamiche dei disturbi mentali sono note alla psichiatria, e le reazioni dei soggetti che ne sono affetti sono più rigide di quelle delle persone sane, più frequentemente stereotipate e più agevoli ad essere previste. Nonostante ciò, non sono possibili certezze, perché il malato non è guidato, nella propria condotta, soltanto dalle dinamiche psicopatologiche, che, seppur rilevanti, non eliminano la sua libertà di scelta. Le predizioni psichiatriche sono, pertanto, possibili, ma contengono un margine ineliminabile di errore, che impedisce di farle assurgere a dignità di certezze scientifiche. Posto però che il diritto penale vigente deve poter disporre, per il suo corretto funzionamento, così come dei giudizi di colpevolezza, anche di quelli di pericolosità sociale del reo malato di mente, la psichiatria può fornire al giudice ulteriori elementi di valutazione, ma la responsabilità ultima del giudizio di pericolosità è pur sempre del giudice, nella veste di peritus peritorum, non potendo attribuirsi al perito la funzione di arbitro del conflitto fra la sicurezza sociale e la libertà individuale. In conclusione, ai fini dell’accertamento della pericolosità sociale del soggetto affetto da malattia di mente, occorre tener presente che nulla consente di affermare con certezza che in determinate circostanze di tempo e di luogo, o sotto determinate spinte emotive o psicologiche, il malato di mente possa, o meno, porre in essere azioni delittuose che non sarebbero compiute, nelle stesse condizioni, da una persona sana; ma, anche che in materia di prognosi comportamentale, non può negarsi che l’esistenza di una malattia mentale o 222 Criminalità e distrurbi mentali di disturbi alla sfera neuro-psichica, costituisce un elemento tale da pesare in modo rilevante. Sotto tale profilo, il giudice dovrà attendersi, dall’indagine tecnica, specifiche indicazioni circa l’attualità della malattia, il livello di intensità con cui essa si presenta, la possibilità di attuare, in ambiente diverso dallo stato di libertà, adeguate terapie con ragionevole previsione di efficacia, la compatibilità della condizione morbosa del soggetto con l’inserimento in un ambiente (sociale e familiare) di cui siano state preventivamente valutate la natura e le caratteristiche di recettività, gli elementi di danno che possono derivare al malato dalla privazione della libertà, nonché gli elementi che possono determinare il soggetto alla perpetrazione di nuovi reati. Acquisiti tali elementi di valutazione tecnica, il giudice dovrà esprimere, sulla base di questi, ed utilizzando i criteri di cui agli artt. 203 e 133 c.p., il giudizio circa l’esistenza, la permanenza, l’attenuazione o il venir meno della pericolosità, pur tenendo presente che, in tali casi, l’infermità psichica, in quanto condizionante l’attuazione stessa della prognosi di pericolosità, è l’elemento di maggior peso ai fini di quest’ultima. 11.4Le nevrosi Il termine nevrosi (letteralmente impoverimento di ordine nervoso) fu preso in prestito dalla metà del ‘800: questo comprendeva la neurastenia (o nevrastenia), che significa mancanza di energia, e l’esaurimento nervoso (accezione di tipo popolare). Si pensava che ogni malattia psichica fosse correlata a una patologia di un’area specifica del cervello. Il quadro era molto vago, e solo verso la fine del ‘800, Freud cominciò ad organizzare una comprensione eziopatogenetica delle nevrosi; il primo studio fu sull’isteria, malattia già nota da tempo. I primi psicopatologi che si occuparono delle nevrosi furono Janet e Charcot. Fu quest’ultimo che diede una descrizione e un significato preciso al termine isteria che, seppur introdotto da Ippocrate, era assai ampio. È una malattia dovuta a cause psicogene che produce uno stato di sofferenza importante (es. diminuzione delle capacità lavorative), con perdita delle capacità operative sia nel soggetto che ne è affetto, che nelle persone che gli stanno attorno: è una malattia che produce una grossa quantità di sofferenza familiare. Il modello freudiano parte da un’ipotesi della psiche, che risulta centrata su una funzione principale che è l’Io, ed un’altra area importante che è l’inconscio, del quale non siamo consapevoli. In un corretto funzionamento, queste due aree sono in continuo scambio (omeostasi della coscienza dell’io): è uno scambio qualificato, preciso e selettivo (ad esempio, la città contenuta dalla muraglia che seleziona il passaggio). Questo scambio è il luogo dove si verificano le alterazioni che originano le nevrosi. I meccanismi di difesa dell’Io: i meccanismi di difesa dell’io sono dei meccanismi presenti in tutti noi, sono una funzione psicologica, (sono le guardie della città) che sono in parte coscienti e in parte incoscienti. Ogni meccanismo di difesa è tipico di una categoria di nevrosi: lo spostamento è relativo alla nevrosi fobica, la formazione reattiva è tipica della nevrosi ossessiva, la conversione invece è relativa all’isteria. Le nevrosi d’ansia, invece, comprendono la nevrastenia e la nevrosi ipocondriaca. Meccanismo di difesa della rimozione: ogni cosa alla quale non siamo attenti è ri223 Criminologia ed elementi di criminalistica mossa, questo avviene come un meccanismo fisiologico necessario per lasciare posto ad una nuova informazione; è un meccanismo costante e continuo, la cui funzione avviene in modo selettivo e automatico dove alcuni contenuti hanno un carattere conscio, mentre altri rimangono sempre inconsci. I contenuti psichici hanno una loro valenza energetica; secondo questa valenza, sarà più o meno possibile rimuoverli. La rimozione è un fenomeno per cui i contenuti della coscienza vengono gettati fuori dalla coscienza stessa ma possono, in un soggetto sano, essere recuperati e riutilizzati. Un contenuto psichico viene rimosso quando non ci serve più, o quando non è coerente con l’orientamento che l’Io possiede; i nostri contenuti psichici scompaiono da un lato, ma possono ricomparire da un’altra parte. L’inconscio confonde, contamina, mette tutto insieme; la coscienza distingue, separa, ha una funzione di discernimento, di distinzione. I nostri contenuti psichici quando vengono allontanati, si mischiano in un unico contenitore, peraltro contaminato. L’attività specifica della coscienza è quella di distinguere i contenuti psichici. Psicopatologia della rimozione: ogni qualvolta un contenuto psichico con un certo valore energetico viene eliminato, insieme a quelli che non hanno un valore energetico, si realizza una rimozione psicopatologica. Ogni cosa che non è compatibile con la struttura primaria della coscienza, viene rimossa (pregiudizi sentimentali come l’omosessualità, il desiderio di uccidere, e così via). Per comprendere sostanzialmente qual è la nostra area rimossa, bisogna pensare a tutto quello che ci fa vergognare, viceversa, per l’area ideale, sarà tutto quello del quale siamo orgogliosi. Il nevrotico è colui che rimuove i contenuti psichici con una carica energetica importante perché non li ritiene compatibili con la propria coscienza. La differenza fondamentale è che un soggetto sano, prima o poi, si accorge dei contenuti che ha eliminato e va a recuperarli, il nevrotico questo non lo farà mai. Se si rimuove un contenuto con un elevato valore energetico (quantità di libido), questo produce un’attivazione inconscia; l’inconscio attivato per mantenere rimosso il contenuto ha bisogno di una grande quantità di energia. Il soggetto si troverà a spendere un’enorme quantità di energia per evitare che il contenuto non torni a galla. Lo psicotico rimuove i contenuti psichici e non può più reintegrarli, dal momento che avesse questa capacità non sarebbe psicotico ma verrebbe considerato nevrotico: la sua struttura dell’Io, come contenitore, è troppo fragile. Il rito nevrotico è diverso da un rito sano, il nevrotico evita il contatto con quella cosa da esorcizzare (esorcismo significa in greco: “giuro che no”), ponendo un muro. È un rito fallimentare che ha come obiettivo la difesa del soggetto da questo evento che crea paura, ma che, allo stesso tempo, è molto attraente. È un sistema di distanziarsi dall’oggetto che necessita di riti sempre più potenti per mantenere questa distanza. Nello psicotico, questi si presentano sotto forma di stereotipie e manierismi. Esistono anche dei segni sintomatici di nevrosi infantili nei soggetti adulti: - - 224 balbuzie: aumentano nelle situazioni di disagio e ansia; onicofagia: impulso a mangiarsi le unghie; frequente nei bambini ma riscontrabile anche nell’adulto; l’onicofagia è una via per scaricare dell’ansia con sotteso simbolismo aggressivo o autodistruttivo, non disgiunto da un aspetto rituale che, paradossalmente, svolge una funzione rassicurante; Criminalità e distrurbi mentali - - pavor nocturnus: angoscia che insorge durante la notte, frequente nei bambini che si risvegliano a occhi spalancati in preda al panico; solitamente, dopo una breve rassicurazione, c’è una ripresa del sonno tranquillo e al risveglio, una totale amnesia dell’accaduto; inoltre, non è un sintomo isolato, ma si accompagna ad altri disturbi quali l’enuresi, irrequietezza motoria, reazioni ansiose, solitamente dovute a conflitti con l’ambiente familiare, e la conseguente incapacità di affrontare la situazione; enuresi: perdita involontaria e incontrollata di urine dopo il quarto anno, età soglia, per l’autoregolazione dello sfintere urinario. Escluse le cause organiche, le ragioni vanno ricercate nell’ambito psicogeno negativo dell’ambiente circostante, che induce il soggetto ad atteggiamenti di protesta e di negativismo. Per ciò che attiene la dimensione personologica, il nevrotico è in continuo stato d’allarme. Vi è una diffidenza basale tra la coscienza e la natura stessa dell’individuo. Paura dell’ignoto e del nuovo dove il soggetto deve rassicurarsi in continuazione. L’atteggiamento del soggetto affetto da nevrosi d’ansia è una difficoltà ad accettare tutto quello che non conosce. Chi non è ansioso, non ha difficoltà ad accettare le nuove esperienze. Chi soffre di nevrosi d’ansia, è, di solito, una persona conservatrice; ha una tendenza a leggere negativamente tutto ciò che lo circonda e in questa lettura negativa si rileva anche una grossa aggressività. Questo tipo di individuo autolimita la propria esistenza in modo molto marcato. Arriva il momento che si verifica una crisi acuta d’angoscia (ad esempio presentimento di morte improvvisa), dove il soggetto si sente bloccare il fiato, vi è una oppressione retrosternale, la persona si sente morire, vi possono essere svenimenti, e così via. Le nevrosi più diffuse sono: 1) nevrosi d’ansia ipocondriaca (che si riscontra, soprattutto, in alcune aree della popolazione, ricorrente negli anziani, secondo il modello culturale, ed in quelle persone che hanno una scarsa dimestichezza con il proprio lato psichico, emotivo, sentimentale, e che esprimono i disagi piuttosto sul lato somatico; nel soggetto con ansia ipocondriaca, c’è una sensazione che il corpo si rompa, come nella sintomatologia dell’angoscia dove vi è la paura di avere dei problemi fisici (cardiopatie, tumori, ecc.). La nevrosi d’ansia ipocondriaca è una lettura della cenestesia in modo ansioso, dove vi è un’angoscia d’avere una malattia corporea; 2) nevrosi fobica: l’ansia viene canalizzata mediante il meccanismo di difesa dello spostamento; il soggetto vive costantemente sulla difensiva, ha paura di tutto, soprattutto di ciò che non conosce (nessuna nuova, buona nuova), non tollera il confronto, desidera tanto che ci fosse qualcun altro al suo posto; quando dà la mano, contemporaneamente la ritira. Teme tutto e organizza la sua vita su questo atteggiamento. È sempre in condizione di allarme e la fuga è un elemento ricorrente: è l’antiesplorativo per eccellenza. Le fobie più diffuse sono: - paura degli spazi aperti (agorafobia): l’ansia che insorge quando si tratta di uscire di casa da soli può essere lieve o giungere a vere e proprie crisi di panico che possono portare a svenimenti, sensazioni di vertigine e talvolta anche ad una perdita del controllo sfinterico; 225 Criminologia ed elementi di criminalistica - - - - - - - paura degli spazi chiusi (claustrofobia): paura dei luoghi chiusi o troppo affollati, come ascensori, gallerie, scompartimenti dei treni, cabine telefoniche e simili, dove, in alcuni casi, prevale la sensazione di soffocamento e oppressione, in altri quella di essere rinchiusi o imprigionati. La claustrofobia e le reazioni a essa associate rimandano filogeneticamente alle risposte di terrore degli animali posti in una situazione in cui non hanno la possibilità di fuga; paura dell’autostrada: è un percorso dove non si può ritornare in dietro (il tempo passa), quello che si è fatto è fatto, ed è irreversibile; chi può tornare indietro è l’adolescente, capace di fantasticare; paura delle gallerie: la galleria può rappresentare il canale del parto, dunque vi è una paura della nascita, anche questa è irreversibile; sul piano simbolico indica la difficoltà di cambiamento, di passaggio. È un cambiamento da una situazione a un’altra. La nostra coscienza è in grado di percepire la realtà in base alle misure spazio/tempo. C’è un’evoluzione della coscienza umana in base al bisogno; man mano che aumenta la rappresentazione di sviluppo che si ha di sé, si cerca più spazio (scoperta dell’America, viaggi spaziali, ecc.); paura degli animali con tante zampe (ad esempio, ragno - aracnofobia): reazione fobica di repulsione nei confronti dei ragni, più diffusa tra le donne perché, secondo la psicanalisi, questa fobia è legata alla paura della distruttività materna che la donna può inconsciamente avvertire dentro di sé e trasporre nella realtà esterna, indirizzandola ad un oggetto sostitutivo che nella fattispecie è il ragno; paura dei topi: sono delle organizzazioni di specie che, da sempre, si sono associate alle organizzazioni umane; queste si nascondono nei sottofondi, nelle fogne, penetrano ovunque, sono dei portatori di malattie, stanno tra quello che noi rimuoviamo, e noi rimuoviamo gli istinti (sesso, morte, ecc.); paura dei serpenti: il serpente è un animale che non si può addomesticare; simbolicamente rappresenta l’istinto puro dove a uno stimolo c’è una risposta; paura dello sporco (rupofobia): fobia per lo sporco, che innesca un meccanismo ossessivo che costringe il soggetto ad affaccendarsi in continue pulizie. Secondo la psicoanalisi, la rupofobia può nascondere un inconfessato rifiuto della sessualità, dello sperma, delle mestruazioni, della gravidanza, che il soggetto vive in modo conflittuale. 3) Nevrosi isterica: viene detta anche isteria di conversione, è una grande malattia con una storia molto antica ed è molto complessa. Ha una connotazione etica negativa, soffre di una serie d’imputazioni mediche, dove oggi c’è ancora chi la considera come qualcosa di poco morale. Questo tipo di personalità nasce in un soggetto che si sviluppa aderendo a una immagine ideale dell’Io e che non rispetta un reale sentimento dell’Io. Questo capita se il soggetto cresce in un ambiente dove, per essere amato, deve corrispondere a un certo modello, che finisce per adottarlo, non essendo più quello che si sente di essere. Il soggetto isterico rifiuta la natura, rinvia costantemente delle immagini di amabilità, per ottenere un consenso. Quando una persona si trova in un ambiente di questo tipo, finisce per identificarsi con il modello che gli viene imposto per riuscire ad essere amata; si instaura quindi un mec226 Criminalità e distrurbi mentali canismo di falsificazione delle proprie emozioni, sino alla legittimazione di un comportamento in modo automatico. Esistono, nel soggetto, dei germi basali per questa doppia personalità. Nel soggetto, si inizia a costruire un’identità di sé falsificata, c’è uno sviluppo di un falso sé, un’identità falsa che inganna il soggetto stesso. 4) Nevrosi ossessive: la personalità ossessiva è definita da una parola greca: anancastica, che significa necessità obbligata; normalmente, esiste un rapporto di interscambio funzionale con l’area istintiva, ma nella personalità anancastica, ciò avviene attraverso un filtro di regole di comportamenti precostituiti. Sono persone assenti, o vissute come tali, che burocratizzano la propria esistenza e quella altrui: sul piano affettivo-emotivo, sono fredde e regolamentano ogni loro azione e scambio emozionale. Sono una grande sventura, molto simili alla struttura paranoide. Vi sarà un’altra parte dell’ordine trasgressivo che si manifesterà come ad esempio in episodi cleptomania (il giudice preciso e regolamentato che ruberà al supermarket), o di esibizionismo. 11.5Le psicopatie Le psicopatie, che includono anche le c.d. caratteropatie, rappresentano degli stati e non delle malattie; esse non fanno parte del campo degli interventi psichiatrici; tuttavia, da sempre, sono considerati dalla psichiatria, a seguito delle problematiche forensi indotte. Le psicopatie implicano una serie di comportamenti trasgressivi delle regole sociali. Raramente gli interessati vengono ricoverati in ospedale psichiatrico se non si innesta una psicopatologia secondaria (alcolismo, tossicomania, ecc.). Sulla genesi e la problematica originaria, si è discusso per lungo tempo, dato che veniva considerata frutto di una patologia cerebrale di derivazione epilettica, dovuta alle frequenti alterazioni dell’EEG, motivo per il quale, è sempre stata trattata con una terapia anticonvulsiva, anche in assenza di crisi. Uno dei collegamenti principali riguardava la caratteristica epilettica che si manifestava anche nelle psicopatie, termine attualmente non più in uso. Oggi, è noto che il nucleo fondamentale risiede in un disturbo affettivo. La provenienza del soggetto a livello di nucleo familiare è fondamentale: si riscontra un’assenza di rete affettiva, manca un referente affettivo che abbia una certa stabilità; la madre può essere prostituta, il padre etilista, il fratello tossicodipendente o delinquente, e così via. In realtà, non è indispensabile la presenza di una famiglia come quella su indicata; è sufficiente, ad esempio, una situazione di separazione o di delega (perché si tratta di una famiglia in carriera), da parte dei genitori, a cose come i giochi o a persone non continuamente presenti, che acquisiscono il significato di sostituto affettivo, per indurre condizioni psicopatiche nel bambino. L’importanza di un oggetto amabile stabile, nel senso di elemento proiettivo, è fondamentale, perché permette di introiettare queste caratteristiche: la stabilità affettiva porta a un’inerzia che consente di assorbire il mondo pulsionale e, quindi, la trasformazione in scelte comportamentali organizzate. Quello che accade tragicamente a una struttura psicopatica è la povertà di capacità trasformativa; è la mancanza di trasformare un livello istintuale-pulsionale a un livello 227 Criminologia ed elementi di criminalistica affettivo, per cui, la risposta è conseguentemente un agito (acting out). Lo sviluppo affettivo si realizza grazie alla capacità di sopportare le frustrazioni. Lo psicopatico è un soggetto che non sa che cos’è una vita affettiva godibile: le emozioni in lui non esistono, sono pulsioni, quindi agiti. Dal punto di vista clinico, gli elementi caratteristici si notano molto precocemente in un soggetto psicopatico: già a livello di infanzia. La famiglia di provenienza dello psicopatico, se così la si può definire, ha una struttura psicopatica: è piuttosto un’aggregazione sociale che altro. Analoga cosa avviene anche nei bambini istituzionalizzati precocemente. Si tratta quindi di un bambino che non ha limiti a livello di aggressività, non ha una distinzione tra oggetti propri e quelli altrui, non ha una stasi spaziale, è irrequieto: nessun gioco o azione possono tranquillizzarlo. Si osserva una precocità sessuale (e non solo), tipica di un’età più avanzata. Essendo alterata la funzione affettiva, il soggetto psicopatico ha una difficoltà di apprendimento sin dalla tenera età, in quanto, presuppone una capacità di sopportare le frustrazioni. È ricorrente che diventi, in una scolaresca, il capro espiatorio, in quanto, la precocità in vari ambiti, porta a uno sconvolgimento dell’ambiente scolastico stesso: piccola delinquenza, tossicodipendenza, precocità sessuale, e così via. Giunto alla maturità, lo psicopatico si inventa il quotidiano: può diventare il gregario di una delinquenza organizzata, diventare una prostituta, oggi non infrequente anche a livello maschile. Si innestano patologie secondarie come la tossicodipendenza, alcolmanie che contribuiscono ad amplificare lo stato psicopatico; un evento molto frequente è che si producono degli accidenti dell’ordine suicidale: morte per overdose, morte per AIDS, ecc. Vi è una capacità di percezione in questi soggetti su quello che accade a loro comprendono per un tempo troppo breve, per poi ripartire per il loro percorso patologico. In casi meno estremi, paradossalmente opposti, in una famiglia in carriera, ad esempio, vi possono essere i presupposti per una struttura psicopatica. L’ambiente tipico per uno psicopatico è quello dell’uniforme, o dell’ambiente uniformato, dove vi è uno statuto di organizzazione dell’aggressività: infermieri, psichiatri, forze dell’ordine. Vi sono individui che, in seguito a patologie di ordine psichico, solitamente nell’ambito nevrotico, si trovano in una posizione di vantaggio secondario, dove, ad esempio, l’istituzionalizzazione crea una situazione di beneficio come poter mangiare, dormire, non lavorare. Si trovano a mimare una patologia di ordine nevrotico: sanno tutto sulla loro malattia, conoscono tutti i tipi di psicanalisi e sono stati in molti ospedali; si tratta, in tali casi, di psicopatici pseudo-nevrotici. Vi sono, invece, patologie a livello di turba della personalità dell’ordine psicopatico, che virano in un ambito psicotico. La psicopatia non è una malattia bensì uno stato; da adulti, le cose non si modificano più. Con i bambini si può lavorare invece in modo efficace: famiglie affidatarie, adozioni, e così via, rappresentano ambienti che hanno un certo spessore affettivo. Si tratta, in realtà, di un’azione preventiva. Non esistono terapie, si possono proporre dei contenitori, più che dare una certa stabilità; un’organizzazione comportamentale è una valida soluzione che impedisce comunque di far acquisire al soggetto psicopatico un’esperienza. 228 Criminalità e distrurbi mentali 11.6Le psicosi Il termine psicosi, in uso nella letteratura psichiatrica a partire dal XIX secolo, veniva utilizzato per indicare le malattie mentali in generale. Successivamente, è emersa, sul piano concettuale, la necessità di suddividere alcune di queste malattie con la denominazione nevrosi. Da allora, l’evoluzione dei due termini, si è espressa su piani diversi, ma entrambi validi. Il gruppo delle nevrosi si è lentamente delineato, sino a comprendere le affezioni nelle quali, in mancanza di lesioni organiche, si imputava il disturbo a un cattivo funzionamento dell’apparato psichico (malattie funzionali). Questo concetto si basava principalmente sul criterio di disturbo di una sola funzione, sulla sua reversibilità e su alcune caratteristiche intrinseche del disturbo stesso, che seguiva leggi differenti dalle malattie a carattere organico. A loro volta, queste ultime, erano contraddistinte con il termine di psicosi. Successivamente, questo criterio è stato mitigato, e molte classificazioni moderne usano il termine psicosi anche per alcune affezioni senza reperto anatomico (psicosi funzionali) che rientrano, però, più specificamente, nella competenza della psichiatria, poiché si traducono in una sintomatologia essenzialmente psicopatologica per caratteristiche di gravità, di molteplicità dei fenomeni morbosi e di irreversibilità dei disturbi. Attualmente, nella psichiatria clinica, il concetto di psicosi è estremamente ampio e comprende tutta una gamma di malattie mentali, sia manifestamente organiche, sia con eziologia ancora discussa e non sufficientemente chiarita. Il raggruppamento di queste malattie, sotto il termine di psicosi, si basa su criteri psicopatologici e sociali. Dal punto di vista psicopatologico, il concetto di psicosi rimane definibile in modo presuntivo, sia per la gravità dei disturbi psichici sia per il decorso progressivo e per lo più irreversibile, con modificazione, non solo quantitativa, ma anche qualitativa, nei confronti della normalità. Sotto un profilo sociale, la psicosi è definibile in base al contegno spesso imprevedibile e genericamente alienato dello psicotico, con scarsa partecipazione alla psicologia normale. Per queste ragioni spesso compaiono nelle definizioni correnti delle psicosi criteri diversi, come l’incapacità di adattamento sociale, la maggiore o minore gravità dei sintomi, la perturbazione delle facoltà di comunicazione, la mancanza di consapevolezza della malattia, la perdita del contatto con la realtà, il carattere non comprensibile dei disturbi, le alterazioni più o meno profonde e irreversibili dell’Io. Il contributo sperimentale al chiarimento del concetto di psicosi non sempre ha potuto basarsi su dati obiettivi di anatomia clinica e di psicofisiologia, poiché la psicosi è strettamente legata a un profondo disturbo della personalità in genere e non riducibile a elementi semplici. Pertanto, i dati sperimentali che si sono potuti utilizzare a questo riguardo hanno un significato vago e di valore molto particolare. Le osservazioni principali si riferiscono all’azione di alcune sostanze tossiche (psicodislettici) capaci di produrre disturbi psicotici inquadrabili nelle psicosi modello. Questi disturbi, tuttavia, si sono rivelati per lo più transitori e non hanno sufficientemente chiarito i presupposti anatomo-clinici sopra enunciati. Anche il contributo dato dalle varie correnti psichiatriche e psicologiche alla definizione del concetto di psicosi si è espresso in termini variabili a seconda dell’indirizzo seguito e non ha permesso di ricavare una definizione unitaria, per cui, è opportuno esaminare i vari punti di vista, per meglio chiarire il problema nei suoi termini generali. Gli indi229 Criminologia ed elementi di criminalistica rizzi organo-genetici si mantengono su un piano biologico, anche riguardo alle forme in cui la lesione organica non è dimostrata; ammettono, dunque, che pure in questi casi, l’anatomia e la fisiologia del cervello possono essere alterate da un agente morboso occasionale o da un fattore costituzionale. Gli indirizzi a impostazione psicologica non ammettono, invece, l’intervento organico in questi ultimi casi: l’alterazione psichica sarebbe legata a cause psicologiche che evolvono in senso psicopatologico. In questa dimensione, stimoli psichici, con particolari modalità di azione e di elaborazione, potrebbero portare a disturbi mentali, non solo transitori, ma anche stabili e progressivi. Tra gli indirizzi psicologici, la psicoanalisi ha individuato, fondamentalmente, il denominatore comune delle psicosi in una perturbazione primaria delle capacità di investimento affettivo della realtà, e considera la maggior parte dei sintomi psicotici come tentativi secondari di ripristinare questo legame oggettuale con la realtà. Alcune dottrine eclettiche, dal canto loro, hanno individuato la causa della psicosi in fattori psicobiologici; secondo queste correnti, esisterebbero psicosi in senso biologico e in senso psicogenetico. Questi aspetti, per lo più, coesisterebbero in ogni esperienza psicotica, anche se in proporzioni molto variabili da individuo a individuo, e definirebbero in senso fenomenologico ed eziopatogenetico i vari tipi di psicosi. Le cause delle psicosi si possono considerare di tre ordini: organiche, costituzionali e psichiche. L’importanza delle cause organiche è ormai nota in molti esempi di psicosi. Infatti, non c’è alcun dubbio che una psicosi acuta confusionale dipenda da una condizione tossica o tossinfettiva, e che la paralisi progressiva sia dovuta all’infezione luetica. L’importanza della costituzione appare anch’essa sufficientemente manifesta nell’accertata eredità di talune psicosi, per esempio, della psicosi maniaco-depressiva, o nel ripetersi di episodi psicotici nel corso della vita di uno stesso individuo. Molti fattori psichici possono essere causa di psicosi, attraverso meccanismi diversi: nella psicosi maniaco-depressiva, ad esempio, episodi melanconici insorgono, talvolta, dopo una causa emotiva più o meno grave; analogamente, una psicosi delirante può insorgere in seguito a un insuccesso professionale, a una delusione sentimentale o a un qualsiasi trauma psichico. II meccanismo patogenetico di queste affezioni consisterebbe in una particolare azione di difesa della personalità di fronte all’angoscia prodotta da determinate situazioni psicologiche che l’individuo non riesce ad affrontare e a superare. Quasi sempre, comunque, la psicosi, con tutto il suo corteo sintomatologico, è il risultato di fattori organici, psicologici e costituzionali e sarebbe un errore non cercare di rintracciare, nell’evoluzione e nella prognosi della malattia, ciascuno di questi fattori che potrebbero apparire di non chiara osservazione a un esame piuttosto superficiale. Una classificazione razionale delle psicosi appare difficile per la mancanza di un criterio unico al quale uniformarsi. Alcune psicosi sono dovute a cause determinate o hanno una base anatomo-patologica conosciuta: si possono citare, ad esempio, la paralisi generale, le psicosi acute e quelle che accompagnano le malattie infettive, le malattie endocrine e dismetaboliche, alcune intossicazioni croniche (alcoolismo, tossicomania), le psicosi puerperali, le psicosi che si manifestano in corso di malattie organiche cerebrali (traumi, encefaliti e tumori) e le psicosi dell’età involutiva. Altre psicosi sono ancora troppo poco conosciute dal punto di vista eziologico e anatomo-patologico per poterle inquadrare e delimitare in modo altrettanto preciso, secondo un criterio biologico. Tuttavia, alcune di queste forme hanno acquistato un’individualità 230 Criminalità e distrurbi mentali nosologica incontestata, come la psicosi maniaco-depressiva e la schizofrenia. Una trattazione a parte è stata riservata dagli esperti alle psicosi deliranti caratterizzate da un delirio cronico sistematizzato non schizofrenico, quali la paranoia, le reazioni paranoidi e la parafrenia. 11.7La schizofrenia Per molto tempo, la malattia mentale, e la schizofrenia in particolare, è stata studiata da due punti di vista spesso tra loro contrapposti. Il primo approccio considera ogni prodotto comportamentale della persona quale esito di normalità o anormalità della struttura e del funzionamento del cervello (approccio biologico); il secondo, si interessa invece ai comportamenti quale esito di modalità di relazione e di integrazione sociale più o meno funzionali o disfunzionali (approccio psicologico e sociale). I due approcci tendono, oggi, a integrarsi in una visione che considera struttura (cervello) e funzione (mente) quali elementi indivisibili e mutuamente interconnessi alla base di ogni comportamento umano. Nelle malattie che coinvolgono il cervello o la mente, il peso del danno strutturale può variare da situazioni, in cui è ravvisabile una netta e pesante compromissione di quelle in cui più forte è la valenza psicologico-relazionale (come nelle cosiddette nevrosi). In ogni caso, pur con ruoli e importanza differenti, è sempre la struttura che determina la funzione e, quest’ultima incide sulle modalità di esplicazione della struttura. Allo stato delle conoscenze attuali, se nella schizofrenia non è possibile parlare di malattia cerebrale alla stregua dell’Alzheimer, il ruolo dei fattori biologici è comunque centrale nel creare gli aspetti di vulnerabilità che, da un lato, favoriscono uno sviluppo della personalità problematica e, dall’altro, costituiscono il terreno su cui si innestano i fattori scatenanti, dati dagli eventi stressanti della vita o da stili disfunzionali di comunicazione o relazione all’interno della famiglia. Il progressivo affinarsi delle tecniche di indagine sul cervello e gli sviluppi della genetica hanno consentito di individuare quattro principali fattori biologici che aumentano la probabilità di sviluppare una malattia schizofrenica: 1) fattori genetici; 2) anomalie strutturali del cervello; 3) anomalie nel funzionamento del cervello; 4) problemi nello sviluppo neurologico. In particolare, le anomalie strutturali (per lo più a carico dell’emisfero sinistro o dei lobi frontali) e del neurosviluppo (dovuto a mancanza di ossigeno alla nascita o a malattie della madre in gestazione) sembrano correlati con i sintomi negativi della malattia; le anomalie di funzionamento (essenzialmente alterazioni nella circolazione dei neurotrasmettitori cerebrali, specie la dopamina e la serotonina) sembrano invece più legate alla produzione di sintomi positivi. Un aspetto importante connesso ai fattori biologici è dato dal concetto di vulnerabilità: spesso, il danno cerebrale o le alterazioni del neurosviluppo rimangono silenti fino a quando la maturazione di particolari sistemi neuronali in epoca adolescenziale non mette a nudo, di fronte al moltiplicarsi degli stimoli esterni e alle maggiori richieste di adattamento agli eventi stressanti, il deficit acquisito, esponendo la persona al231 Criminologia ed elementi di criminalistica le falle, nell’integrazione tra ambiente esterno e capacità di risposta dell’individuo. La schizofrenia non è una malattia ereditaria, ossia, non è dovuta sempre e necessariamente a un gene dominante o recessivo che transita dai genitori ai figli. Del resto, la maggior parte dei genitori delle persone con schizofrenia non ha questa malattia, e, viceversa, i figli schizofrenici hanno, per lo più, genitori sani. Numerose ricerche hanno, tuttavia dimostrato, che esiste una tendenza alla familiarità, per cui, tanto più stretto è il legame di parentela con un soggetto schizofrenico, tanto più aumentano le probabilità di sviluppare la malattia. In particolare, il rischio di ammalarsi, per un parente di primo grado, è del 10 per cento. Tale probabilità aumenta per i figli, se entrambi i genitori hanno questa malattia: il rischio sale infatti al 40 per cento. La relazione tra struttura genetica e rischio di sviluppare la malattia, inoltre, è stata illustrata con maggior forza negli studi sui gemelli. Se, infatti, nei gemelli eterozigoti (ossia con patrimonio genetico differente), il rischio che entrambi i fratelli sviluppino la malattia è del 10 per cento, in quelli omozigoti (ossia identici), il rischio sale al 40-50 per cento. Il ruolo della familiarità genetica, quale ulteriore tassello nel puzzle dei fattori che incrementano il rischio, è stato, infine, provato negli studi effettuati sulle adozioni: in questo caso, la probabilità di rischio per i figli di genitori schizofrenici si avvicina a quella della popolazione generale. Da ultimo, un cenno al ruolo del clima emotivo della famiglia e delle modalità di relazione e comunicazione al suo interno: spesso, come vedremo più avanti con la teoria del doppio legame, non è la familiarità genetica a favorire la malattia, quanto una familiarità con modelli di comunicazione e interazione schizofrenogenici. I farmaci usati per la cura della schizofrenia (antipsicotici) agiscono a livello chimico sul funzionamento del cervello. In particolare, la loro finalità è il riequilibrio di particolari disfunzioni nel meccanismo che regola l’attività dei neurotrasmettitori cerebrali, disfunzioni riscontrate con frequenza nelle persone con schizofrenia. Tra queste, uno dei meccanismi maggiormente compromessi sembra essere quello legato alla dopamina, una sostanza che regola la capacità di gestire gli stimoli esterni (e l’eventuale loro sovrabbondanza) e il comportamento motorio. Nei soggetti schizofrenici è stata spesso rilevata una quantità in eccesso di dopamina, situazione che determina una eccessiva permeabilità agli stimoli e una compromissione nella capacità di filtrare e organizzare le informazioni che provengono dall’ambiente esterno e interno all’individuo. È per questo che molti antipsicotici hanno una spiccata azione antidopaminergica, in modo da riequilibrare i livelli di dopamina nel cervello e garantire una maggiore efficienza nella gestione degli stimoli. Oltre alla dopamina, anche l’attività di altri neurotrasmettitori può risultare compromessa: tra questi la serotonina, che ha un meccanismo d’azione simile a quello di alcune droghe allucinogene (LSD 25) e il cui eccesso è stato postulato alla base di alcuni fenomeni allucinatori, tipici di molti soggetti schizofrenici. La schizofrenia è una patologia determinata da una serie di cause, alcune ancora sconosciute che, rinforzandosi l’una con l’altra, creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Dei fattori biologici si è già parlato: questi agiscono da impronta strutturale e chimica del cervello di un individuo, creando una o più condizioni di vulnerabilità (genetica, morfologica, biochimica) che, in presenza di particolari condizioni temporali (per esempio, l’adolescenza), e di particolari eventi di vita (per esempio, la fine della scuola e l’ingresso nel mondo lavorativo), possono innescare l’avvio del processo patologico. 232 Criminalità e distrurbi mentali Proprio il modo in cui l’individuo si è costruito, nel suo contesto sociale e familiare e intorno ai propri elementi di vulnerabilità biologica, determina il modo in cui risponderà all’ambiente. In questa ottica, le cause psicologiche e sociali sono date da tutti quei fattori interni alla persona (peculiarità nello sviluppo della personalità, nell’organizzazione delle funzioni cognitive, nello sviluppo emotivo e affettivo), ed esterni (eventi particolarmente stressanti, per esempio un lutto, i momenti di passaggio quali il matrimonio, il servizio militare, l’ingresso nel mondo del lavoro, o anche particolari situazioni di emarginazione sociale ed economica) che, interagendo tra loro e sulla base delle indicazioni fornite dal substrato biologico, scatenano la malattia. La schizofrenia è una psicosi grave. Kraepelin l’aveva denominata dementia praecox. Bisogna premettere che la schizofrenia è stata usata come etichetta per una tale quantità di patologie e di sintomi che molti studiosi ne rifiutano la validità. In realtà, se si presta attenzione al primo elemento che si presenta, emerge un dato di fondo difficilmente contestabile: lo schizofrenico non è più pienamente responsabile di se stesso. In secondo luogo, presenta una manifesta incapacità di organizzare coerentemente, o dialetticamente, le idee. Le conclusioni delle argomentazioni sono connesse alle premesse solo lontanamente, o non lo sono affatto. Talvolta, le associazioni di termini avvengono solo per assonanza, non per significato o inerenza, ed allora si hanno catene verbali del tipo: abbondanza, eleganza, mattanza, ignoranza, stanza, panza, riluttanza, oltranza. L’incidenza della schizofrenia a livello mondiale pare sia dell’1% sull’insieme della popolazione. Stranamente, vi sono aree geografiche nella quale l’incidenza è più alta come l’Irlanda occidentale. Più facile comprendere come i grandi agglomerati urbani presentino percentuali più alte. Di solito, si manifesta tra i 15 ed i 25 anni di età, e in media, cinque anni più tardi tra le donne rispetto agli uomini. Tra le cause, è spesso stato dimostrato che l’ereditarietà svolge un certo ruolo. I parenti di primo grado di individui affetti da schizofrenia hanno una probabilità del 10% di venire a loro volta interessati da questa psicosi. Secondo alcuni studi a indirizzo biologico, alla base vi potrebbero essere dei danni cerebrali. Le tecniche di visualizzazione cerebrale, soprattutto la T.C (tomografia computerizzata) e la scintografia a emissione positronica, hanno evidenziato la presenza di anomalie strutturali e funzionali nel cervello degli individui affetti da schizofrenia. Inoltre, è stato dimostrato che l’assunzione di farmaci a contenuto anfetaminico possano provocare un malessere di tipo schizofrenico. Secondo alcuni studiosi, la schizofrenia può manifestarsi insidiosamente, a poco a poco. L’individuo diviene sempre più solitario e introverso, perde vitalità e motivazioni, cessa di avere interessi culturali, arriva a dichiarare, come il filosofo Comte, che non ha più alcun bisogno di tenersi informato e di leggere, perchè ha capito tutto. Questo lento deterioramento può passare inosservato per mesi o persino per anni. Solo ad un certo punto diviene chiaro che l’individuo soffre di fissazioni (le idee fisse trovate da Pierre Janet) e/o di allucinazioni. Ma non è raro che la malattia si manifesti improvvisamente, in seguito a forti eventi traumatici. Vi è una letteratura sterminata riguardante le psicosi di guerra e sui reduci dalla guerra nel Vietnam. Le fissazioni possono assumere contenuti ideali svariati: come il credere di essere un personaggio famo233 Criminologia ed elementi di criminalistica so o Gesù Cristo, o qualche altro rilevante personaggio storico, oppure nell’identificarsi in una funzione come quella dell’unto del Signore, salvatore della patria, difensore della fede, e così via. Nella schizofrenia paranoide, la malattia comporta manie di grandezza che sono direttamente proporzionali alla pochezza culturale e morale dell’individuo. Tuttavia, è stato osservato che il paranoico si differenzia notevolmente dagli altri sofferenti per un maggiore stato di vigilanza e per la superiore coerenza nel pensiero e nell’argomentazione. Gli schizofrenici catatonici stanno generalmente immobili per periodi lunghissimi e sono refrattari a svolgere qualsiasi tipo di compito o a qualsiasi tentativo di farli muovere. Solo occasionalmente, hanno esplosioni di tipo motorio che li costringono a vagare senza alcuna meta. 11.8 La paranoia Il termine paranoia vuol dire pensare di traverso e, spesso, viene indicata ora come l’espressione di una malattia mentale, ora di un’anomalia costituzionale, ora di un complesso di disturbi ideativo-comportamentali con integrità delle funzioni affettive e intellettive. Il disturbo primario consiste nella comparsa di un giudizio non correggibile né con la critica, né con l’esperienza, né con la persuasione, e che innesca il delirio. Il delirio è una condizione psicopatologica che è possibile trovare in diverse sindromi psichiatriche. La terapia del delirio presuppone una valutazione diagnostica, quindi, al fine di valutare l’efficienza di questo trattamento, è utile fare una approfondita analisi semiologica di questa sindrome. Il delirio è definito come una falsa certezza soggettiva non modificabile né con la logica, né con l’evidenza. Tuttora, tale definizione si basa sui tre criteri fondamentali formulati da Jaspers. Egli delimitò, psicopatologicamente, il delirio con le seguenti caratteristiche: 1) la certezza soggettiva, cioè la convinzione straordinaria attraverso la quale viene mantenuta quella determinata idea; 2) l’incorreggibilità, cioè, l’impossibilità di essere influenzati dall’esperienza concreta o da confutazioni; 3) l’impossibilità del contenuto, cioè un alterato giudizio di realtà. Altra caratteristica fondamentale che spesso si accompagna al delirio è la sua struttura autocentrica, cioè il paziente è sempre e comunque elemento centrale all’interno della sua esperienza delirante, rivestendo il ruolo di protagonista del suo mondo trasformato o in via di trasformazione. La psicologia classica propone, inoltre, una serie di distinzioni puramente descrittive di altre caratteristiche del delirio. La percezione delirante è, secondo Schneider, l’attribuzione di un significato abnorme a una percezione corretta. L’intuizione delirante è, invece, una nuova e inspiegabile certezza non basata su una percezione. La rappresentazione delirante, infine, è secondo Jaspers, un ricordo o una rappresentazione mentale basata sul ricordo con l’attribuzione di un significato delirante. La psicopatologia europea suddivide il delirio in primario e secondario, a seconda che questo compaia rispettivamente, nell’esistenza dell’individuo come fatto puramente nuovo non derivabile dalle esperienze di vita pregresse, oppure, abbia un carattere di derivabilità comprensibile da una serie di eventi esperiti dal paziente o sia logica conseguenza di precedenti disturbi psicopatologici. 234 Criminalità e distrurbi mentali Il delirio può presentarsi con un livello di organizzazione formale variabile. La sua struttura dipende dalla complessità dei temi deliranti, dalla coerenza con i quali essi si intrecciano, e dalla chiarezza e precisione con le quali essi vengono esposti dal soggetto. Ne deriva che vi sono vari livelli di strutturazione del delirio, spesso collegati al tipo di patologia o al diverso stadio di questa. Il grado di organizzazione formale, insieme con il contenuto del delirio, sembra condizionare il comportamento del paziente, il quale, ovviamente, sarà più influenzato a seconda di quante aree della sua vita psichica siano coinvolte. Ad esempio, il delirio di rovina e di colpa può portare il paziente a mettere in atto un comportamento suicidario, mentre quelli di persecuzione e gelosia possono determinare comportamenti aggressivi. L’analisi dei temi e dei relativi contenuti del delirio deve essere effettuata dal medico come aiuto all’indagine diagnostica, considerato come alcune tematiche si presentino più spesso in alcune patologie psichiatriche piuttosto che in altre, pur tuttavia, senza che vengano considerate come segni patognomonici. Quattro tematiche fondamentali caratterizzano il delirio: la prima, riguarda il senso di minaccia e pericolo per la propria incolumità con contenuti di riferimento, di persecuzione, di influenzamento e ipocondriaci; la seconda area tematica considera la dominanza e il controllo alle quali sottendono contenuti di grandezza, erotomanici, e di onnipotenza; il terzo tema raggruppa sotto i temi di rinuncia e passività, i deliri di colpa, indegnità, rovina; l’ultima area include nelle tematiche della sessualità e della riproduzione contenuti di gelosia ed erotomanici. La modalità emozionale con la quale il paziente vive l’esperienza delirante è, anch’essa, di estrema importanza. Riguardo alla relazione che legherebbe la risonanza emotiva al delirio, si possono delineare due posizioni: la prima, considera il delirio come conseguente a una alterazione del tono dell’umore (depressione, mania), in questo caso si parla di delirio secondario; la seconda posizione, invece, considera il delirio come indipendente dal tono dell’umore (schizofrenia, paranoia, parafrenia) e viene incluso nella categoria dei deliri primari. Nei deliri secondari, i temi piu frequenti correlati con la depressione riguardano contenuti di colpa e rovina, mentre, nella mania, sono più spesso di grandezza e onnipotenza. Secondo il DSM IV, quando i contenuti sono in accordo con i tipici temi della patologia di base si parla di delirio congruo all’umore; quando invece i contenuti deliranti non appaiono in accordo, si parla di delirio incongruo. Un altro aspetto da considerare dal punto di vista semiologico, è come il paziente delirante viva la propria esperienza di delirio. Nella schizofrenia, ad esempio, la risonanza emotiva del paziente al proprio vissuto delirante può essere estremamente variabile. In acuto, e durante le bouffés deliranti, infatti, risulta più frequente un’intensa risposta emotiva; al contrario, quando la patologia si cronicizza, si può assistere a una sorta di indifferenza emotiva, da parte del soggetto. Spesso, si può notare una certa discordanza tra temi deliranti e le espressioni sia mimiche che verbali del paziente. Al contrario, nella paranoia, il vissuto emotivo del paziente è sempre di notevole entità. Esistono, infine, una serie di condizioni intermedie (parafrenie), nelle quali la risonanza emotiva si muove all’interno di una vasta scala. Il delirio, infatti, può esser considerato il sintomo di patologie psichiatriche a volte molto complesse, ed è per questo motivo che, al fine di valutare l’efficacia del tratta235 Criminologia ed elementi di criminalistica mento sulla condizione delirante, è utile fare un’analisi semiologica approfondita di questa patologia, che permetta di comprendere come e perché il farmaco agisca maggiormente su alcuni aspetti, piuttosto che su altri. 11.9 L’epilessia L’epilessia è una malattia o, meglio ancora, una sindrome patologica. Questo è il primo dato importante da sottolineare. Infatti, per moltissimo tempo, si associava la crisi epilettica a qualcosa di demoniaco, di inspiegabile e, soprattutto, era considerata un fenomeno da nascondere. Si dice soffrissero di tale patologia grandi personaggi, come Alessandro Magno, Giulio Cesare, Giovanna D’Arco o Napoleone; certamente, ne soffrivano Dostoevskij, Flaubert, Paganini, Van Gogh, una prova, comunque, che l’epilessia non lede le capacità intellettive, né il rendimento nella vita pratica. Nelle forme abituali, non porta nessuna menomazione nell’ambito della vita quotidiana e del successo professionale. L’epilessia è caratterizzata dalla ripetizione di crisi epilettiche, dovute a una iperattività delle cellule nervose cerebrali (i cosiddetti neuroni). Si verifica, infatti, paradossalmente, un eccesso di funzione del sistema nervoso: alcune cellule del cervello incominciano a lavorare a un ritmo molto superiore al normale, producendo la cosiddetta scarica epilettica (che si registra con l’elettroencefalogramma) e la crisi epilettica (che si riconosce dal resoconto o con l’osservazione del paziente). Esistono due tipi di epilessia. Nel primo (epilessie primarie o idiopatiche), la tendenza a provocare le crisi è costituzionale; questi pazienti non presentano alcuna lesione cerebrale e sono, dal punto di vista neurologico, del tutto normali, a parte questa singolare caratteristica. Nel secondo (epilessie secondarie o sintomatiche), che comprende la maggioranza dei pazienti, l’epilessia si sviluppa in seguito ad una lesione cerebrale. Si va da disturbi dell’ossigenazione cerebrale al momento della nascita (evento molto frequente), a malformazioni della corteccia cerebrale, fino a tutte le patologie acquisite del cervello, come infezioni, traumi, tumori, disturbi circolatori. Ogni evento morboso che lede la corteccia cerebrale, può, infatti, dare origine, nel corso degli anni, a un focolaio responsabile dell’epilessia. Questi pazienti presentano, talora, altri segni neurologici quali disturbi motori, ritardi di sviluppo, deficit attentivi. In un buon numero di casi, non si riesce a trovare la causa, e l’epilessia viene definita criptogenetica. Le crisi si rivelano con un breve e improvviso disturbo delle funzioni nervose. Hanno in genere durata breve (meno di un minuto) e si possono manifestare con sintomi diversi da caso a caso, a seconda della funzione dei neuroni cerebrali coinvolti. Le crisi possono essere rare, ma, nella maggior parte dei casi, si ripetono frequentemente, anche molte volte nella giornata. Fra una crisi e l’altra non è presente, solitamente, alcun disturbo. La manifestazione più importante è la sospensione improvvisa della coscienza, con caduta a terra e comparsa di movimenti di tipo convulsivo (tremori e scosse muscolari). In altri casi, la perdita di coscienza si accompagna ad azioni compiute in modo automa236 Criminalità e distrurbi mentali tico (masticare, inghiottire, parlare, toccare o spostare gli oggetti), oppure a un blocco motorio. A volte, la coscienza è conservata, e il malato può avvertire sensazioni particolari quali lampi di luce, rumori, formicolii a una parte del corpo, gusti o odori strani, improvvise sensazioni di angoscia o euforia, la sensazione di essere in sogno, immagini di ricordi del passato. I caratteri comuni delle crisi sono: la loro imprevedibilità, l’impossibilità di controllare in quel momento le funzioni nervose e il proprio comportamento, la breve durata (le crisi durano pochi secondi o pochi minuti, raramente più di 10 minuti), l’inizio e la fine improvvisi. In generale, le crisi si dividono: in crisi generalizzate e crisi parziali. Le crisi generalizzate, tipiche dell’epilessia primaria o idiopatica, consistono in mioclonie (improvvise scosse muscolari degli arti o del tronco, che, raramente, provocano cadute a terra ma spesso fanno cadere gli oggetti di mano); assenze (improvvise sospensioni della coscienza della durata di 5-30 secondi, talora accompagnate da qualche scossa dei muscoli palpebrali; sono facilitate dalla respirazione forzata); crisi convulsive generalizzate, (o grande male, caratterizzate da perdita di coscienza, irrigidimento tonico e scosse cloniche di tutta la muscolatura, con caduta a terra, morsicatura della lingua e talora perdita di urine; è la manifestazione epilettica più importante e impegnativa, per i rischi di trauma, ma anche per l’impegno respiratorio e cardiovascolare prodotti dalle contrazioni massive della muscolatura). Le crisi parziali sono tipiche dell’epilessia secondaria sintomatica o criptogenetica. Si dividono in due grandi categorie, le crisi parziali semplici e le crisi parziali complesse. Le crisi parziali semplici, sono caratterizzate da segni di attività parossistica di una zona del cervello con funzioni specifiche: scosse muscolari a un arto (crisi motorie), sensazioni abnormi in un territorio cutaneo (crisi somatosensoriali), sensazioni visive (crisi visive), sensazioni acustiche (crisi uditive), sensazioni fastidiose allo stomaco e alla gola, con palpitazione e rossore del volto (crisi vegetative, la cosiddetta aura epigastrica), impressione di già visto o già vissuto (crisi dismnesiche), pensiero forzato, cioè una improvvisa idea che domina la mente (crisi cognitive), stati di animo di paura improvvisa (crisi affettive). In tutte le crisi parziali semplici, la coscienza è conservata. Nelle crisi parziali complesse, invece, la coscienza è compromessa, e il paziente appare confuso (crisi confusionali); talora, mostra movimenti automatici del volto e del tronco (crisi psicomotorie). Sono tipiche dei focolai della corteccia dei lobi temporali o frontali. Tutte le crisi parziali, semplici o complesse, possono diffondere all’intero cervello e concludersi con una crisi convulsiva di grande male. Il male principale è proprio il rischio di essere soggetti, in maniera imprevedibile e incontrollabile, a momenti, seppure brevi, nei quali non si è più in grado di governare il proprio comportamento. In queste occasioni, si resta esposti a tutti i rischi ambientali, ad esempio, se il disturbo della coscienza compare improvvisamente, mentre il paziente sta utilizzando una macchina utensile o mentre sta guidando l’auto, oppure, mentre è in casa, e la perdita di coscienza avviene di fronte a un fornello acceso e all’acqua che bolle. Inoltre, il frequente ripetersi degli episodi, specialmente in alcune forme di epilessia del bambino, può comportare un ritardo dello sviluppo intellettivo. Infine, le implicazioni sociali dell’essere epilettico possono costituire un problema grave per l’integrazione nella scuola, nel lavoro e nella realizzazione della propria vita affettiva e dei diritti civili. 237 Criminologia ed elementi di criminalistica 11.10Il border-line La psicopatologia borderline, per molti anni, ha trovato difficile collocazione nosografica, al limite fra l’area delle nevrosi e quella delle psicosi, venendo, quindi, variamente identificata come sindrome pseudonevrotica, stato limite, sindrome marginale. Kraepelin ha descritto forme attenuate di demenza precoce già nel 1887. Bleuler ha introdotto il concetto di schizofrenia latente, per indicare condizioni cliniche particolari, in cui, questa latenza psicotica, sembra svolgere un ruolo rilevante in quadri clinici, solo apparentemente nevrotici o caratteriali. Ey ha definito questi quadri clinici schizonevrosi, considerandoli espressione dell’evoluzione dalle nevrosi alle psicosi. Altri autori hanno considerato gli stati border-line come disturbi mentali propriamente detti, dotati di stabilità e coerenza interna, dandogli dignità diagnostica autonoma. Nelle nosografie psichiatriche classiche, tali condizioni psicopatologiche di confine erano descritte come quadri sindromici complessi e vari, che includevano: 1) sintomi d’ansia intensa, prolungata e pervasiva; 2) sintomi nevrotici (ossessioni, fobie, manifestazioni isteriche, neurastenia, ecc.); 3) sintomi psicotici (idee di riferimento, ideazione paranoidea, ecc.); 4) disturbi cognitivi transitori con episodi confusionali occasionali; 5) comportamenti impulsivi ed aggressivi, tipici delle personalità psicopatiche. Recentemente, alcuni autori hanno dato specifico rilievo, in questi soggetti, alla presenza di un’inadeguata modulazione dell’impulsività, sottolineando la rilevanza clinica dei comportamenti aggressivi auto ed eterodiretti, dei gesti autolesivi, dei sentimenti di rabbia, eccessiva e non proporzionata alle situazioni in cui si esprime, nonché dell’incapacità di questi pazienti a dilazionare la gratificazione e a tollerare le frustrazioni. Contrariamente ai disturbi psicotici propriamente detti, il decorso di queste condizioni patologiche viene descritto, classicamente, come cronico, con scarsa tendenza al deterioramento, con ricorrenti crisi d’instabilità affettiva e frequenti comportamenti disadattivi di natura impulsiva. Solo con la pubblicazione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), III edizione e successive, la psicopatologia borderline è stata inquadrata tra i disturbi di personalità. Il DSM-IV definisce il Disturbo border-line di Personalità (DBP) come una modalità pervasiva d’instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé e dell’umore con una marcata impulsività, comparse nel corso della prima età adulta e presenti in vari contesti, come indicato da cinque o più dei seguenti elementi: a) sforzi disperati di evitare un reale o immaginario abbandono; b) un quadro di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzate dall’alternanza tra gli estremi di iperidealizzazione e svalutazione; c) alterazione dell’identità: immagine di sé e percezione di sé marcatamente e persistentemente instabili; d) impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per il soggetto, quali spendere, sesso, abuso di sostanze, guida spericolata, abbuffate; e) ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari o comportamento automutilante; f ) instabilità affettiva dovuta a marcata reattività dell’umore (es. episodica intensa disforia, irritabilità o ansia che di solito durano poche ore e soltanto raramente più di pochi giorni); g) sentimenti cronici di vuoto; h) rabbia immotivata e intensa o difficoltà a controllare la rabbia (es. accessi di ira, rabbia costante, 238 Criminalità e distrurbi mentali ricorrenti scontri fisici, ecc,); i) ideazione paranoide o gravi sintomi dissociativi transitori, legati allo stress. Nelle società occidentali, secondo recenti studi epidemiologici, il Disturbo borderline di Personalità (DBP) presenta tassi di prevalenza, morbilità e mortalità in rapido aumento. Alcuni studi hanno evidenziato che la prevalenza del DBP, nella popolazione generale, raggiunge l’1,8%, superando la prevalenza della stessa schizofrenia. I pazienti con DBP rappresentano un’elevata percentuale dei soggetti per i quali sono richieste ed effettuate consulenze psichiatriche. Secondo alcuni studi osservazionali, essi rappresentano l’11% dei pazienti ambulatoriali e, in alcune strutture psichiatriche, il 23% dei pazienti ricoverati. In uno studio su pazienti con DBP, circa la metà del campione aveva fatto ricorso a un servizio ambulatoriale di salute mentale, nei sei mesi precedenti l’indagine, e il 19,5% era stato ricoverato, in una struttura psichiatrica, nell’anno precedente. La sintomatologia psicopatologica manifestata dai soggetti con DBP, in genere, appare significativamente invalidante. In un campione di pazienti con DBP, ricoverati consecutivamente presso l’Università di Pittsburgh, il 62,2% aveva avuto, in passato, condotte suicidarie e circa il 50% aveva avuto altri comportamenti autolesivi. Il numero di pazienti con DBP che si era ucciso variava tra il 3% e il 9,5% della popolazione di pazienti trattati, una percentuale simile a quella evidenziata nei soggetti affetti da disturbi depressivi o da disturbi psicotici. La definizione nosografica attuale del DBP prevede una sintomatologia clinica meno ampia di quella attribuita, nelle descrizioni tradizionali, alle cosiddette sindromi marginali. Il sistema diagnostico DSM permette un perfetto inquadramento nosografico del singolo caso clinico, ricorrendo all’utilizzo dei diversi Assi diagnostici, ma introduce, inevitabilmente e implicitamente, un’artificiosa sovrastima della comorbidità psichiatrica. Diverse ricerche hanno evidenziato, infatti, un’alta comorbidità fra DBP e altri disturbi psichici d’Asse I. Lo studio di comorbidità della psicopatologia borderline si presenta, oggigiorno, alla stregua di un’analisi di correlazione tra DBP ad altre condizioni cliniche d’Asse I. Recenti osservazioni hanno confermato un elevato tasso di comorbidità e sostanziali affinità eziopatogenetiche fra disturbo borderline e disturbi dell’umore, al punto che il disturbo depressivo maggiore sembrerebbe correttamente diagnosticabile, in circa la metà dei pazienti border-line. In particolare, risulta che: a) i pazienti con DBP hanno una depressione più grave dei soggetti con altri disturbi di personalità; b) i pazienti con DBP e con depressione maggiore, in comorbidità, hanno una storia clinica con più numerosi e gravi tentativi di suicidio, rispetto ai soggetti affetti da depressione maggiore; c) i pazienti con DBP, depressione maggiore ed elevati livelli di impulsività/aggressività, presentano una più alta incidenza di dipendenza da sostanze d’abuso. Il rapporto intercorrente tra impulsività e condotte suicidarie è stato oggetto di numerose indagini cliniche e neurobiologiche. L’impulsività sembra essere significativamente associata a comportamenti autolesivi, tra i pazienti psichiatrici. Nei soggetti con DBP, l’impulsività, è il tratto di personalità più fortemente correlato ai comportamenti suicidari. Alcuni indici clinici e biologici d’impulsività risultano più elevati nei soggetti con comportamenti d’automutilazione. Un basso livello del tono serotoninergico centrale si correla significativamente tanto ai comportamenti impulsivo-ag239 Criminologia ed elementi di criminalistica gressivi, quanto alle condotte suicidarie. Alcuni di questi studi, sembrano suggerire la presenza di un comune substrato psicopatologico e/o neurobiologico tra impulsività e suicidio. In apparente contraddizione, numerose altre osservazioni cliniche sostengono che i traumi infantili si associano significativamente a comportamenti autolesivi e suicidari, espressi in età giovanile o adulta. Inoltre, un’alta frequenza di traumi infantili sembra essere presente negli adulti depressi con alti livelli d’aggressività, impulsività e comportamenti suicidari. Esperienze di abuso nell’infanzia si correlano a un’età più precoce della condotta suicidaria, che può presentarsi già in età infantile o adolescenziale. L’impulsività potrebbe essere considerata, in una prospettiva più ampia, un tratto ereditario, aggravato da esperienze d’abuso e da traumi infantili, che si correla significativamente all’aggressività e alle condotte suicidarie. Secondo alcune osservazioni, per esempio, il livello d’impulsività e d’aggressività di tratto, non la gravità obiettivabile di depressione, è direttamente correlato al numero e alla frequenza dei tentativi di suicidio. Nei parenti di primo grado di adolescenti suicidi, sono stati evidenziati alti livelli d’aggressività e una forte familiarità per il suicidio. In uno studio, inoltre, la gravità della depressione, valutata in modo obiettivo dal clinico, non ha permesso di distinguere i pazienti con recente tentativo di suicidio dai pazienti depressi di controllo. Al contrario, i livelli d’aggressività e d’impulsività sono risultati significativamente più elevati nei soggetti con tentato suicidio. Notevole rilevanza psicopatologica assume la comorbidità tra DBP e disturbo bipolare dell’umore. Sulla base degli elevati tassi di comorbidità familiare, evidenziata già negli anni ‘90, numerosi ricercatori hanno suggerito una relazione tra DBP e disturbi dello spettro bipolare, fino a ipotizzare di includere le manifestazioni del disturbo border-line fra quelle proprie dello spettro bipolare. Altri autori sostengono che sia impossibile soddisfare i criteri del DSM-IV per un episodio maniacale in assenza di condotte impulsive. Altri, ancora, riferiscono livelli d’impulsività, misurata con scale specifiche di valutazione psichiatrica, costantemente presente negli episodi maniacali. Un’elevata impulsività è evidenziabile nei pazienti bipolari, anche nelle fasi eutimiche. Ciò potrebbe indicare che l’impulsività si esprime, nei disturbi bipolari e in quelli correlati, sia nelle componenti psicopatologiche di stato, sia in quelle di tratto. Da quanto premesso, è possibile ipotizzare un modello interpretativo dell’impulsività nel soggetto border-line, nel framework stress/vulnerabilità, in cui tratti biologici e di personalità possono predisporre a un abbassamento della soglia individuale di passaggio all’atto, mentre, condizioni di intenso stress ambientale, possono precipitare la condizione clinica. Esiste una frequente comorbidità, ben nota in clinica, tra DBP e abuso d’alcol e droghe. Secondo alcune ricerche, circa il 75% dei pazienti con DBP presenta una condizione d’abuso/dipendenza da sostanze, mentre circa il 20% dei soggetti, con abuso di sostanze, presenta un DBP. L’abuso e la dipendenza da sostanze voluttuarie è un comportamento complesso, che non può essere considerato semplicisticamente e, sempre, di natura impulsiva. Ciò nonostante, un soggetto con abuso/dipendenza da sostanze, in condizioni di stress soggettivo, può assumere impulsivamente le droghe d’abuso, a volte in modo repentino, imprevisto ed eccessivo. L’impulsività, sembra svolgere un ruolo patogenetico nell’esordio e nel prosieguo della dipendenza da sostanze. L’abuso può essere più frequente, più intenso e meno controllato, quindi, potenzialmente più peri240 Criminalità e distrurbi mentali coloso, in soggetti impulsivi. Tassi più elevati di abuso e dipendenza da sostanze sono presenti, in alcune osservazioni, tra aggressori impulsivi e soggetti con disturbo esplosivo intermittente. Diversi studi hanno evidenziato livelli più elevati d’impulsività tra i soggetti tossicodipendenti, rispetto ai controlli sani. Alcuni ricercatori hanno riscontrato, tra i pazienti con DBP e dipendenza da sostanze, l’utilizzo di un maggior numero di differenti droghe e maggiore impulsività, rispetto ai soggetti non border-line. Altro importante aspetto è quello dell’impulsività: nel XIX secolo, Pinel ed Esquirol hanno introdotto in psichiatria il concetto di impulso istintivo coniando il termine di monomania istintiva. In origine, tra queste monomanie, erano incluse: l’alcolismo, la piromania e l’omicidio. In realtà, la definizione stessa dell’impulsività è controversa e non univoca, in ambito psichiatrico. Alcuni autori definiscono il comportamento impulsivo come la tendenza a reagire immediatamente agli stimoli ambientali emotivamente rilevanti, senza controllare a sufficienza l’intensità della risposta, altri considerano l’impulsività una predisposizione, ossia un comportamento biologicamente determinato, caratterizzato dalla tendenza ad agire rapidamente, senza pianificare la propria azione, in assenza di una valutazione razionale e/o consapevole di tutte le conseguenze dell’atto. Le caratteristiche essenziali dei disturbi del controllo degli impulsi sono: 1) l’incapacità a resistere all’impulso, alla spinta o alla tentazione di eseguire un atto pericoloso per sé o per gli altri; 2) il crescente senso di tensione o attivazione prima di commettere l’atto; 3) un senso di piacere e/o gratificazione al momento di commettere l’atto con successivo ed immediato rilassamento. Anche a una osservazione superficiale, non può sfuggire l’affinità esistente tra i disturbi del controllo degli impulsi e la disregolazione omeostatica edonica (disedonia). La stessa impulsività potrebbe essere interpretata come espressione disadattiva del controllo motivazionale, esercitato da circuitazioni neurobiologiche, filogeneticamente arcaiche, che includono i nuclei della base, la corteccia prefrontale, l’accumbens e l’amigdala. L’attività di tali strutture risulta orientata, infatti, da un lato, a facilitare l’approccio agli stimoli ambientali gratificanti (ricerca del piacere) e, dall’altro, al distanziamento attivo degli stimoli ambientali avversivi o potenzialmente pericolosi (aggressione/fuga). Il DSM-I (1952) ed il DSM-II (1968) dell’American Psychiatric Association, (APA) non includevano tra i disturbi mentali: il gioco d’azzardo patologico, la piromania e la cleptomania che, solo nel 1980, hanno avuto un inquadramento diagnostico nel DSM-III. Quest’ultimo, accanto a questi disturbi del controllo degli impulsi, ha riconosciuto una dignità diagnostica anche al disturbo esplosivo intermittente e al disturbo esplosivo isolato. Solo sette anni dopo, nel DSM-III-R (APA, 1987) veniva eliminato il disturbo esplosivo isolato, per l’elevato rischio d’errore diagnostico correlato ad un singolo episodio di comportamento aggressivo. Il disturbo esplosivo intermittente è stato mantenuto, nonostante fossero emersi seri dubbi sulla sua validità ed è stato riconosciuto valore diagnostico alla tricotillomania. La categoria diagnostica del DSM-IV (APA, 1994) definita come disturbo del controllo degli impulsi, non altrove classificati, è considerata una categoria diagnostica residua, anche se, nel DSM-IV, non esiste un’altra aggregazione categoriale di disturbi dell’impulsività. In questo gruppo diagnostico venivano inclusi: il gioco d’azzardo patologico, la piromania, la cleptomania, il disturbo esplosivo intermittente, la tricotillomania ed il disturbo del controllo degli impulsi non altrimenti specificato (NAS). Fatte queste considerazioni, sembra evidente 241 Criminologia ed elementi di criminalistica una insufficiente attenzione diagnostica ai disturbi dell’impulsività, non solo nell’ambito della moderna interpretazione spettrale dei disturbi mentali, ma, persino, nel più tradizionale ambito nosografico categoriale. I sintomi caratteristici del disturbo border-line di personalità, secondo alcuni ricercatori, sono riconducibili a tre fattori fondamentali: 1. il disturbo interpersonale-relazionale; 2. la disregolazione comportamentale impulsivo-aggressiva; 3. la disregolazione affettiva con instabilità emotiva. In quest’ottica, il disturbo relazionale includerebbe l’instabilità nelle relazioni interpersonali, il disturbo d’identità, il sentimento cronico di vuoto. La disregolazione comportamentale comprenderebbe l’impulsività e il comportamento auto ed eteroaggressivo. La disregolazione affettiva esprimerebbe l’incapacità di affrontare condizioni di stress ed includerebbe l’instabilità dell’umore, la reazione di rabbia improvvisa, eccessiva e ingiustificata, nonché l’evitamento di un abbandono immaginario o reale. I soggetti border-line presentano brusche oscillazioni affettive, con un’intensa e disadattiva reattività all’ambiente, soprattutto nelle relazioni interpersonali. È stato ipotizzato che la stessa instabilità emotiva possa essere interpretata come un fenomeno impulsivo. I rapidi cambiamenti relazionali, in risposta a stimoli spesso modesti, sembrano essere affini al comportamento impulsivo, definito come la tendenza a reagire immediatamente senza controllare a sufficienza l’intensità della risposta. 11.1Le perversioni sessuali Il concetto di perversione sessuale, che si riallaccia al canone di normalità dominante in una certa società, in una certa epoca, ha subìto, nel DSM, una notevole evoluzione nel corso degli anni. Nell’edizione DSM-III-R del 1987, i disturbi sessuali sono classificati nella categoria principale delle disfunzioni sessuali, che riguardano disturbi inerenti l’attività sessuale normale (ad es. impotenza, eiaculazione precoce, frigidità, ecc.). Il termine, una volta in uso, di perversione sessuale, è stato sostituito col termine parafilia dal greco filìa (attrazione) e para (deviazione) e cioè attrazione per la deviazione. La parafilia presenta come caratteristica l’attrazione sessuale per: 1) oggetti non umani; 2) sofferenza o umiliazione propria o del proprio partner (non solo simulata); 3) attrazione verso bambini o persone non consenzienti. La psicanalista americana Louise J. Kaplan aggiunge ulteriori elementi alla descrizione della perversione sessuale, definendola come attrazione irresistibile verso un comportamento sessuale anomalo o bizzarro, con la caratteristica di essere un gesto coatto, imperativo, ripetitivo, stereotipato e che implichi almeno uno dei seguenti comportamenti: a) attività sessuali che usino un oggetto sessuale inanimato al fine di raggiungere l’eccitamento sessuale; b) attività sessuali con esseri umani che comportino sofferenze e/o umiliazioni reali o simulate; c) attività sessuale con partner non consenziente. Lo psichiatra italiano Gio242 Criminalità e distrurbi mentali vanni Jervis, nella sua definizione di perversione sessuale, evidenzia ulteriori aspetti di questi comportamenti, mettendo in evidenza che: a) il soggetto ha da sempre difficoltà a trattenersi dal soddisfare i propri impulsi; b) ha costanti difficoltà a valutare la discrepanza dei propri atti rispetto alle norme dominanti e, insieme, ha difficoltà a valutare le conseguenze di questi atti; c) procura, con questi atti, imprevisti seri danni (anche psicologici) a se stesso e/o significative sofferenze ad altre persone; d) è di intelligenza normale e non presenta chiari disturbi nevrotici, né reali disturbi psicotici; e) tende a reiterare, stabilmente, forme di comportamento disapprovate dalla mentalità dominante, spesso, ma non sempre, a contenuto sadico. La prassi clinica evidenzia quadri patologici non sempre così definiti, esistono anche altre forme di perversione, alcune forme di perversione sconfinano in altre; spesso, il soggetto perverso mette in atto, nello stesso tempo, diversi tipi di perversione, o sostituisce una perversione con un’altra meno pericolosa o più adatta alla situazione. Nella descrizione della psicanalista americana Louise J. Kaplan, si definisce, come già evidenziato, la perversione come gesto coatto, imperativo, ripetitivo, stereotipato, mettendo così in evidenza uno degli elementi base della perversione e cioè il suo carattere di fissità, di ripetizione di una serie di gesti e rituali sempre uguali. Questa caratteristica distingue la perversione dai comportamenti sessuali anomali o bizzarri, ma liberamente scelti e variati; comportamenti cioè che due partner sessuali decidono di assumere se lo desiderano; partner che normalmente vivono il sesso in maniere diverse, decidendo di volta in volta se farsi coinvolgere o meno in giochi di particolare tipo, con la libertà di proporli e accettarli o meno, e variando nel tempo i propri comportamenti e giochi sessuali. In altre parole, a differenza di chi ha una sessualità libera e variata, chi mette in atto la performance perversa, non ha scelte; la sua eccitazione passa solo attraverso quel comportamento e non altri; attraverso la messa in atto della perversione, la persona cerca di combattere uno stato di forte ansia, o di profonda depressione, o di disturbi psicologici così forti ed invalidanti che possono sconfinare dal quadro delle nevrosi a quello delle psicosi. E ancora, la perversione è una strategia psicologica che richiede, per essere soddisfatta, una messa in atto, una cosiddetta performance, in genere di carattere sessuale. La messa in atto della perversione placa le ansie e la disperazione del vivere, e dà alla persona l’impressione di poter sopravvivere, superando i traumi subìti durante l’infanzia. Il che significa che, quasi sempre, il perverso è una persona che, da bambino, ha subìto traumi, spesso di carattere sessuale, che hanno lasciato dei danni nella struttura della personalità. Questi danni non sono mai stati affrontati in maniera conscia; restano presenti nell’inconscio della persona come nuclei che non hanno seguito la maturazione della sua personalità; colui che porta in sé questi danni è, quindi, spesso, un portatore inconsapevole. Ma questi danni agiscono anche nel presente della persona, divenuta adulta, e producono fortissimi malesseri, sull’origine dei quali, l’individuo non ha coscienza. Attraverso la perversione, che possiamo vedere come drammatizzazione di questi eventi infantili, il perverso cerca di dominare ricordi di situazioni che nell’infanzia erano troppo eccitanti, paurose o umilianti per essere dominate. La perversione rappresenta, quindi, per la maggior parte dei casi, il tentativo che un adulto mette in essere, per cercare di esorcizzare i propri traumi infantili. Questo avviene, sia attraverso la semplice replica del trauma (semplificando: se io da bambino venivo picchiato sadicamente da un genitore, posso chiedere al partner sessuale di picchiarmi, 243 Criminologia ed elementi di criminalistica ripetendo così la situazione infantile); sia attraverso una messa in scena a ruoli alterati (nell’esempio di prima divengo io colui che picchia e assumo quindi il ruolo del genitore che sottometteva attraverso la violenza). Il bambino non amato o amato inadeguatamente si convince di essere lui stesso la causa della mancanza di amore da parte dei genitori, e può cercare di compensare questa perdita da grande mettendo in atto un rapporto di dominazione, nel quale ha l’illusione (attraverso il dominio esercitato su un altro essere) di riacquistare i suoi poteri perduti nell’infanzia. Un rapporto di dominazione può essere scelto, adottando la parte dello schiavo, anche per tenere nascoste le proprie capacità, nella paura che vengano sottratte come una volta fecero i genitori. Una tecnica simile, quella cioè di assumere il profilo più basso possibile, viene adottata in campo non sessuale, per dare agli altri la sensazione di debolezza e provocarne l’allentamento del controllo. Altra caratteristica della perversione è che essa, finché dura (anni o tutta la vita), diventa l’interesse centrale nella vita della persona. La perversione ha carattere di fissità, cioè di comportamento coatto, ossessivo, ripetitivo. Si diversifica dai comportamenti ossessivo-compulsivi (come ad es., il lavarsi continuamente le mani, il mettere sempre in ordine la casa, i rituali rassicuranti del controllare se la porta è chiusa, se la manetta del gas o dell’acqua sono sulla posizione spento, se l’interruttore generale della luce è chiuso, ecc.), perché questi rituali vengono vissuti, da chi li mette in essere, come rassicuranti, curativi e buoni. Il perverso, invece, sa benissimo che sta facendo qualcosa di cattivo, moralmente sbagliato, socialmente condannabile, ma parte del sollievo che prova dalla perversione proviene anche dalla sfida e superamento dei codici morali comuni. Il perverso, inoltre, ha la necessità di tenere sempre in evidenza idee di peccato e di colpa, anche se accompagnate dalla somministrazione a sé o agli altri di sofferenze; è concentrandosi su queste sofferenze che il perverso riesce in qualche modo e per un pò di tempo a dominare i terrori, le umiliazioni e le ferite morali e fisiche che hanno costituito il nucleo dei suoi traumi d’infanzia. In molti casi, la perversione serve a mascherare tendenze che l’educazione morbosa subìta dalla persona fa ritenere inaccettabili. L’uomo che è stato allevato in un clima rigido e maschilista, nel quale ogni genere di tenerezza viene proibita e condannata, da adulto, può assumere attraverso la perversione un comportamento di esagerata mascolinità, virilità, dominio, per nascondere, così, la normale componente femminile del suo animo. La perversione trova alimento negli stereotipi sociali di uomo e donna, nei ruoli e nell’identità di genere, cioè in tutti quei comportamenti che la società ha codificato come da uomo e da donna. Le perversioni, in altri casi, giocando sulle identità sociali, permettono all’uomo di identificarsi con il ruolo della donna, senza però perdere la faccia della mascolinità. 11.12 Le parafilie Parafilia è l’attuale termine scientifico per definire l’insieme di quelle condotte sessuali più note con i nomi di perversioni o deviazioni sessuali. Affrontare un discorso generale sulle parafilie senza suscitare anche un seppur minimo imbarazzo o prese di posizione nette sull’argomento è compito senza dubbio ar244 Criminalità e distrurbi mentali duo se non impossibile. Questo perché, nonostante le numerose rivoluzioni sessuali, la sessualità rimane uno dei più importanti modellatori della personalità, dell’identità e della vita sociale di ogni individuo. Se al tempo di Sigmund Freud, in un contesto sociale in cui la sessualità non risultava essere argomento di discussione, poteva avere un senso parlare di perversioni definendole come quelle attività sessuali finalizzate su regioni del corpo non genitali, oggi, in seguito a quei cambiamenti sociali messi in moto proprio dal movimento psicoanalitico, in seguito alla nascita della sessuologia clinica e quindi alle ricerche sulla sessualità, una simile diagnosi rischierebbe di valutare, come patologiche, le condotte sessuali della quasi totalità della popolazione mondiale. Tutti gli individui cosiddetti normali hanno delle fantasie e mettono in atto delle pratiche sessuali che potrebbero apparentemente sembrare perverse, ovvero, ognuno di noi conserva un nucleo che possiamo anche definire perverso, che si integra in un processo di personalità e di comportamento che risulta comunque normale. La linea tra normalità e patologia, nella sessualità, è sempre legata ad aspetti quali la non esclusività, la non compulsione del comportamento e, ricordiamo, soprattutto al consenso reale dei partner sessuali. Parliamo, infatti, di normalità delle condotte sessuali quando tale comportamento si svolge, innanzitutto, tra soggetti realmente consenzienti e non reca disagio, sofferenza o problemi legali (nella cultura di riferimento) a nessuno dei partecipanti all’attività, e non rappresenta una condotta esclusiva svolta come una compulsione, e non interferisce con lo svolgimento delle attività lavorativa e/o sociale. Allo stesso modo, si definisce il comportamento sessuale patologico, quando causa anche a uno soltanto dei partecipanti all’attività, disagio, sofferenza, interferenze con le attività lavorative e/o sociali, quando si compie come una compulsione, quando reca danni, quando causa problemi legali. Attualmente, le parafilie sono previste nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV, 1994). Quando ad esempio, il pedofilo cerca di giustificare la propria condotta parafiliaca portando, come esempio, altre culture o società antiche, dimentica che egli vive in un contesto diverso da quelli che porta come prova che la sua condotta sia da definire normale. La negazione di vivere all’interno di un contesto socio-culturale che non sia in grado di giustificare un certo tipo di comportamento, tanto da definirlo patologico, probabilmente rappresenta un processo difensivo che va utilizzato nella valutazione diagnostica di tali pazienti. Le parafilie classificate dal DSM-IV (1994) sono le seguenti: - - - - esibizionismo: esposizione dei propri genitali a un estraneo che non se l’aspetta; feticismo: uso di oggetti inanimati che non siano limitati a strumenti, come il vibratore, progettati per la stimolazione tattile dei genitali; frotteurismo: toccare e strofinarsi contro una persona non consenziente; pedofilia: attività sessuale con uno o più bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli). Il soggetto pedofilo deve avere almeno 16 anni ed essere di almeno 5 anni maggiore del bambino o dei bambini con cui ha attività sessuali. Non viene incluso il soggetto tardo-adolescente coinvolto in una relazione sessuale perdurante con un soggetto di 12-13 anni; 245 Criminologia ed elementi di criminalistica - - - - - masochismo sessuale: atto (reale, non simulato) di essere umiliati, picchiati, legati o fatti soffrire in qualche altro modo; sadismo sessuale: azioni (reali, non simulate) in cui la sofferenza psicologica o fisica (inclusa l’umiliazione) della vittima è sessualmente eccitante per il soggetto; feticismo da travestitismo: il travestimento di un maschio eterosessuale; voyeurismo: atto di osservare un soggetto che non se lo aspetta mentre è nudo, si spoglia, o è impegnato in attività sessuali; parafilia non altrimenti specificata (NAS): questa categoria diagnostica viene inclusa per codificare quelle parafilie che non soddisfano i criteri per nessuna delle precedenti. Gli esempi includono, ma non si limitano, a: - - - - - - - scatologia telefonica (telefonate oscene); necrofilia (attrazione sessuale per i cadaveri); parzialismo (attenzione esclusiva per una parte del corpo); zoofilia (attrazione sessuale per gli animali); coprofilia (uso delle feci per l’eccitazione sessuale); urofilia (uso delle urine per l’eccitazione sessuale); clismafilia (uso dei clisteri per l’eccitazione sessuale). Va ricordato che ogni parafilia deve durare per almeno sei mesi e devono essere presenti fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti e intensamente eccitanti sessualmente che comportino le azioni di cui sopra. Ogni condotta sessuale, per essere definita parafiliaca, ha necessità di causare disagio clinicamente significativo o compromissione dell’area sociale, lavorativa o di altre aree importanti del funzionamento. Il trattamento delle parafilie è piuttosto complesso, soprattutto quando il paziente ha già messo in atto processi difensivi in grado di far negare che il comportamento sia patologico. Occorre, sempre, un’attenta valutazione diagnostico-differenziale, soprattutto, per escludere altre forme psicopatologiche, come ritardo mentale, disturbi gravi di personalità (in particolare il disturbo border-line) e altre patologie. Una volta valutato il funzionamento globale del paziente, sarà possibile orientare verso la forma di intervento, quasi sempre piuttosto lunga e tortuosa, adatta per ogni specifico caso. 11.13 La pedofilia La pedofilia rientra, infatti, nella grande classificazione delle parafilie e l’eziologia delle parafilie rimane in gran parte intrisa di mistero. Nel corso degli anni, sono state elaborate diverse ipotesi interpretative riguardo all’origine del comportamento pedofilo. Le teorie sessuologiche di vecchio stampo, che hanno dominato la psicologia e la psichiatria fino ai primi del novecento, consideravano le perversioni sessuali semplicemente come delle sindromi psicopatologiche caratterizzate da alterazioni qualitative dell’istinto sessuale. Con lo sviluppo della scienza psicologica e psichiatrica sono state prodotte varie teorie sull’origine della pedofilia, alcune in evidente contrapposizione con altre. 246 Criminalità e distrurbi mentali L’atto pedofilo è legato, secondo la psicoanalisi classica, a fissazioni e regressioni verso forme di sessualità infantile, consistente nell’arresto dello sviluppo psicosessuale, dovuto a un trauma precoce o all’aver vissuto la propria sessualità in ambiente restrittivo. Oppure, la pedofilia, sarebbe il risultato di conflitti sessuali raggiunti senza il contributo della fantasia, probabilmente per un insuccesso o per una formazione distorta della coscienza causata da una patologia. La pedofilia si fonderebbe sull’angoscia di castrazione, che ostacola il perverso nel raggiungimento di una sessualità adulta e lo fa regredire a una pulsione parziale (anale, orale, e così via). La paura di affrontare una donna adulta, lo fa ripiegare verso un soggetto meno potente e quindi, meno ansiogeno, con il quale può evitare la penetrazione o, se l’affronta, ciò avviene da una posizione di forza. Altri autori hanno distinto un comportamento o fantasia pedofiliaca di natura occasionale e il vero pervertito pedofilo ossessivo, che deve avere un’attività sessuale con un bambino, per non soffrire di una intollerabile e angosciosa ansia. Il pedofilo occasionale, secondo alcuni studiosi, è certamente la tipologia più diffusa, mentre è relativamente più raro il pervertito ossessivo. In tale ottica, si possono quindi distinguere due tipi di pedofili, secondo lo stadio di sviluppo cui si sono fissati i conflitti psicologici profondi. Le basi su cui fonda questa teoria sono comunque esclusivamente derivate da osservazioni cliniche e, in ogni caso, spiegano molto poco del perché viene scelta da alcuni individui la pedofilia come meccanismo di difesa, piuttosto che qualsiasi altro possibile meccanismo difensivo. Socarides afferma, in tal senso, che il meccanismo più importante nella pedofilia omosessuale è l’incorporazione del bambino maschio al fine di rinforzare il senso di mascolinità, sconfiggere l’ansia della morte, rimanere giovani per sempre e poter ritornare al seno materno. Il parafilico, secondo la moderna psicoanalisi, è quindi una persona che non è riuscita a completare il normale processo di sviluppo verso l’adattamento eterosessuale, fissazione o regressione a forme di sessualità infantile che persistono nella vita adulta. In quest’ottica, ciò che distingue una parafilia dall’altra è il metodo scelto dalla persona per far fronte all’ansia, causata dalla minaccia di castrazione da parte del padre e di separazione dalla madre. La mancata risoluzione della crisi edipica tramite l’identificazione con il padre-aggressore (per i ragazzi) o la madre-aggressore (per le ragazze), provoca un’impropria identificazione con il genitore del sesso opposto o una scelta impropria dell’oggetto per le catarsi libidica. I parafilici, per placare le loro angosce di castrazione, sono costretti ad esaminare costantemente i propri o altrui genitali; in più, il fattore decisivo che impedisce il raggiungimento dell’orgasmo attraverso il rapporto genitale convenzionale è l’angoscia di castrazione. Le perversioni assolvono, pertanto, la funzione di negare la castrazione. Ricercatori psicoanalisti più recenti hanno, però, concluso, che la sola teoria pulsionale è insufficiente a spiegare molte delle fantasie e dei comportamenti perversi che vengono visti clinicamente, e che ad una lettura comprensiva, gli aspetti relazionali delle perversioni sono cruciali. Secondo Stoller (1975), l’essenza della perversione è la conversione di un trauma infantile in un trionfo adulto. I pazienti sono spinti dalle loro fantasie a vendicare umilianti traumi infantili, loro inflitti dai genitori. Il metodo di vendetta è quello di disumanizzare e umiliare il loro partner durante la fantasia o l’atto perverso. L’attività perversa può anche essere una fuga dalla relazio247 Criminologia ed elementi di criminalistica nalità oggettuale (Mitchell, 1988). Molte persone che soffrono di parafilie si sono separate e individuate in maniera incompleta dalle loro rappresentazioni intrapsichiche della madre. Il risultato è che sentono che la loro identità come persone separate viene costantemente minacciata da una fusione o da un inglobamento da parte di oggetti interni o esterni. L’espressione sessuale può essere l’unica area nella quale riescono ad affermare la loro indipendenza. Un altro aspetto del sollievo esperito dai pazienti parafilici dopo che hanno messo in atto i loro desideri sessuali è il loro sentimento di trionfo sulla madre che controlla dall’interno (Gabbard, 1995). In particolar modo, i pedofili hanno bisogno di dominare e controllare le loro vittime, come se supplissero ai loro sentimenti di impotenza durante la crisi edipica. Alcuni teorici, credono che la scelta di un bambino come oggetto d’amore da parte dei pedofili sia una scelta narcisistica. Secondo la visione classica, la pedofilia rappresenta una scelta oggettuale narcisistica; in quanto, il pedofilo vede il bambino come un’immagine a specchio di se stesso bambino. Il narcisismo risulta dalla fissazione edipica, dove il pedofilo si identifica con sua madre e vede sè stesso nel bambino. Kaplan (1993) ritiene che i pedofili siano considerati degli individui deboli e impotenti; scelgono bambini come oggetto sessuale in quanto questi pongono meno resistenza o creano minore ansia dei partner adulti, permettendo cosi ai pedofili di evitare l’angoscia di castrazione. Si è, inoltre, appurato che molti pedofili soffrano di una patologia narcisistica del carattere, ivi comprese delle varianti psicopatiche del disturbo narcisistico di personalità; l’attività sessuale con bambini prepuberi può puntellare la fragile stima di sé del pedofilo. In maniera simile, molti individui con questa perversione scelgono delle professioni nelle quali possono interagire con bambini perché le risposte idealizzanti dei bambini li aiutano a mantenere la loro immagine positiva di se stessi. D’altra parte, il pedofilo spesso idealizza questi bambini; l’attività sessuale con loro comporta, pertanto, la fantasia inconscia di fusione con un oggetto ideale o di ristrutturazione di un sé giovane, idealizzato. L’ansia riguardo all’invecchiamento e alla morte può essere tenuta a distanza attraverso l’attività sessuale con bambini. Quando l’attività è associata a un disturbo narcisistico di personalità con gravi tratti antisociali, come parte di un’evidente struttura caratteriale psicopatica, le determinanti inconsce del comportamento possono essere strettamente collegate alle dinamiche del sadismo. I pedofili sono frequentemente essi stessi delle vittime di abusi sessuali infantili e la conquista sessuale del bambino è lo strumento di vendetta, un senso di trionfo e di potere può accompagnare la loro trasformazione di un trauma passivo in una vittimizzazione perpetrata attivamente (Gabbard, 1995). Kraemer (1976), ritiene che le origini delle tendenze pedofile vadano ricercate nelle primissime interazioni madre-bambino, in quanto, i bisogni narcisistici di auto-amore della madre potrebbero essere trasmessi al figlio in maniera eccessiva a causa del bisogno della madre di essere idealizzata dal figlio; ciò avrebbe come effetto la sostanziale dilazione del processo di separazione-individuazione del bambino. Alcuni psicoterapisti che trattano i colpevoli di abusi sessuali contro i bambini sembrano aderire alla teoria che la pedofilia è causata dal fatto che i colpevoli sessuali siano stati loro stessi abusati durante l’infanzia (Groth, 1979). Garland e Dougher (1990) coniano per questa nozione l’espressione: teoria dell’abusato abusatore. 248 Criminalità e distrurbi mentali I reati dell’aggressore adulto possono essere, in parte, una ripetizione e un riflesso di un’aggressione sessuale che egli ha subìto da bambino, un tentativo distorto di dare uno sbocco a traumi sessuali precoci irrisolti. Possiamo osservare, infatti, come alcune aggressioni sembrano, talvolta, ripetere gli aspetti della vittimizzazione da loro subìta; e cioè l’età della vittima, i tipi di atti compiuti e così via. La teoria dell’abusato/abusatore pone anche in risalto come, statisticamente, tra i pedofili, vi sia un elevato numero di vittime di abuso sessuale infantile. Questa teoria si fondava originariamente su una doppia spiegazione teorica di impronta psicodinamica: il soggetto adulto replica la vittimizzazione subìta da bambino, secondo le medesime modalità patite allora; una volta adulto ottiene il trionfo proprio in ciò in cui da bambino era stato vittima: l’atto perverso è odio erotizzato, un atto di vendetta mediante cui il passato è cancellato e trasformato in piacere e vittoria. Le vittime di abuso sessuale infantile, dunque, agirebbero sessualmente e aggressivamente per ridurre gli affetti dolorosi e le sensazioni provati più volte in occasione del trauma precedente, oltre che per superare il senso di impotenza, l’immagine di sé negativa, la perdita di fiducia negli altri e il timore di pericolo incombente, che costituiscono gli altri aspetti post-traumatici legati all’abuso sessuale. Groth afferma che la motivazione di base che spinge l’abusatore ad agire non è di natura sessuale, ma comporta l’espressione di bisogni non sessuali e di aspetti esistenziali non risolti; l’abuso è quindi un atto pseudosessuale al servizio di bisogni non sessuali. Questo autore ha anche diviso i molestatori di minori in due categorie: - regrediti, coloro che hanno sviluppato un orientamento sessuale ed interpersonale adeguato alla loro età, ma che, in talune circostanze, possono regredire ad un orientamento sessuale rivolto ai bambini; - fissati, in cui l’interesse sessuale primario non si è mai sviluppato oltre il livello di interesse verso i minori. Un’altra parte di ricerche sulle origini della pedofilia sostiene che gli aggressori sessuali sono, con molta probabilità, cresciuti in famiglie devianti. Tali studi affermano che, statisticamente, i criminali sessuali appartengono con molta probabilità a famiglie disfunzionali. In uno studio volto a ricercare il grado di identificazione genitoriale risultò, ad esempio, che soggetti definiti pedofili avevano un grado di identificazione bassa verso i loro genitori, rispetto a un gruppo di controllo rappresentato da studenti di un college o rispetto a un gruppo di soggetti definiti criminali in genere. Queste scoperte supportano la nozione che i criminali sessuali sono differenti da altri criminali nella loro percezione di identificazione genitoriale. La mancata identificazione può evidentemente giocare un ruolo importante nello sviluppo di un disordine psicosessuale. Esiste, anche, una pedofilia femminile, sebbene il giudizio clinico tradizionale ha sostenuto che le perversioni sono rare nelle donne. Questo punto di vista è cambiato negli ultimi anni, come risultato della ricerca empirica e dell’osservazione clinica che hanno dimostrato come le fantasie perverse siano di fatto comuni nelle donne. In uno studio esauriente sulle perversioni nelle donne, Kaplan (1991) sottolinea che i clinici non sono stati in grado di identificare le perversioni nelle donne, poiché implicano delle dinamiche più sottili rispetto alla sessualità più prevedibili delle perversioni maschili. Delle attività sessuali che derivano dalle parafilie 249 Criminologia ed elementi di criminalistica femminili, fanno parte le tematiche della separazione, dell’abbandono e della perdita. Ad esempio, alcune donne che hanno subìto da bambine delle violenze sessuali, adottano un modello di sessualità femminile esasperato, nel tentativo di vendicarsi sugli uomini e di rassicurarsi sulla propria femminilità (Gabbard 1995). Il modello di comportamento abusante si può spiegare in base alla compresenza di quattro fattori: il primo, per cui, l’abusatore ritiene i bambini sessualmente attraenti: l’abuso sessuale soddisfa alcune rilevanti esigenze emozionali dell’abusatore; il secondo, che evidenzia la ricerca di una sensazione di dominio dopo essere stato vittimizzato, oppure il fatto che lui stesso è infantile. Il bambino è una fonte di attivazione sessuale e di gratificazione e, dunque, è presente una preferenza sessuale per partner sessuali di età infantile; il terzo, relativo a un risultato di condizionamento o di essere stato, a propria volta, vittima di abuso sessuale infantile. Fonti alternative di gratificazione sessuale sono bloccate o inibite per varie ragioni e, quindi, si tratta di fattori che impediscono all’abusatore di soddisfare le sue esigenze con soggetti adulti; il quarto, che identifica in tale soggetto le seguenti caratteristiche: fobie, scarse abilità sociali, mancanza di autostima. La psicodiagnostica psichiatrica ipotizza l’esistenza di: - una pedofilia primaria che comporta, in una certa misura, un’integrazione dell’io pedofilo e una conseguente stabilità della sua personalità; - una pedofilia secondaria, conseguente ad altre gravi psicopatologie come la schizofrenia, alcune psicosi organiche ed altre condizioni in cui la personalità si disintegra, provocando una serie di comportamenti perversi. Secondo Glasser (1989), la pedofilia è un comportamento che fa parte di un gruppo di perversioni che condividono un nucleo composto da due aspetti: 1) aggressività, che ha come scopo l’imposizione della sofferenza ed è finalizzata a neutralizzare le minacce alla sopravvivenza mentale e fisica dell’individuo pervertito; 2) annientamento, le relazioni intime con gli altri, viste generalmente come normali, vengono viste come pericolose o distruttive dai pervertiti, poiché, in tali situazioni, si sentono completamente sotto il controllo dell’altro. Il focus emotivo della relazione del pedofilo con gli altri è su se stesso. Il modello cognitivo sostiene che i pedofili cerchino qualsiasi mezzo per giustificare le loro azioni e utilizzino per esempio la pornografia come fonte di rassicurazione. In essa, i pedofili, vedono altri adulti che fanno le cose che loro stessi fanno o vorrebbero fare, e ciò crea un’aurea di normalità intorno all’abuso, che può allentare le loro inibizioni e costituire il primo passo di un’escalation che può arrivare fino agli atti più turpi. In tale ottica, viene rifiutata decisamente l’idea che la pornografia serva come valvola di sfogo, utile a dirottare l’energia sessuale lontano dal compimento materiale dell’abuso. La pedofilia viene considerata dai cognitivisti alla stregua di un comportamento additivo, come avviene per l’assunzione di alcool e di droga, ed essa, perciò, non può essere contenuta e combattuta offrendole materiale che invece la alimenta. Tra le caratteristiche dello stile cognitivo dei pedofili vi è la minimizzazione dell’abuso; infatti, nei loro racconti, l’abuso, viene definito come qualcosa di consensuale e, in un certo senso, desiderato dal bambino stesso. I pedofili, spesso, si difendono adducendo come scusa per il 250 Criminalità e distrurbi mentali loro comportamento, la disoccupazione o un fallimento familiare. Queste non sono altro che razionalizzazioni difensive, che fungono da fragili giustificazioni. Quando i pedofili sono sinceri (se mai lo sono), essi, ammettono che sono sessualmente attratti dai bambini e che le loro fantasie masturbatorie sono quelle tipicamente ossessive di pedofili che hanno avuto e che continuano ad avere rapporti sessuali con bambini. Le giustificazioni fornite da questi soggetti arrivano, talvolta, ad accusare il bambino, descrivendo l’accaduto come un incidente di cui il bambino o la bambina sono stati la causa. In questo senso, i pedofili, ritenuti da Wyre uomini di intelligenza superiore alla norma, sono molto abili nel manipolare chi sta loro intorno e coinvolgere così anche gli eventuali psicologi ed assistenti sociali in questo pericoloso circolo di eteroattribuzione della causa dell’abuso. La tendenza, ad esempio, di molti operatori a considerare il pedofilo, primariamente ed essenzialmente, come parte di un sistema relazionale, rinforza involontariamente questo circolo e permette al pedofilo stesso di avere buon gioco nel gettare su un sistema familiare o sociale disfunzionale la colpa del suo comportamento perverso. Alcuni autori hanno ipotizzato la presenza di distorsioni cognitive (Pithers, 1989; Marshall, 1997). Si tratta di un’ipotesi abbastanza controversa, dal momento che non tutti gli autori definiscono tali distorsioni allo stesso modo. Alcuni, infatti, includono, nel concetto la negazione e la minimizzazione degli effetti dell’abuso, altri si limitano alla percezione distorta degli atti del bambino e altri ancora vi inseriscono atteggiamenti più generali verso la sessualità. Anche in questo caso, però, la presenza di distorsioni cognitive non può essere considerata fattore eziologico specifico, in quanto gli abusatori distorcono le percezioni in termini vantaggiosi per loro e, solo secondariamente. riferiscono il loro desiderio deviante di fare sesso con il minore: è questo il precursore indicativo, non la percezione distorta. Di conseguenza, le interpretazioni distorte del comportamento dei bambini possono portare a convinzioni non appropriate, mentre è più difficile che siano le convinzioni a produrre le percezioni stesse. Secondo Howells (1981), dal momento in cui i bambini sono coinvolti abbastanza frequentemente in varie forme di attività sessuale con i loro coetanei, l’associazione tra eccitamento sessuale e caratteristiche corporee ancora immature degli altri bambini potrebbe condizionare una risposta sessuale a lungo termine (quando diventano adulti) nei confronti dei corpi immaturi. Decisivo, in questo processo, sarebbe la potenza dell’impulso sessuale adolescenziale che potrebbe facilitare tale distorto processo d’apprendimento. Se questa teoria spiega facilmente come cominci l’attrazione sessuale per i bambini, non spiega, però, perché la maggior parte degli individui passi attraverso l’adolescenza avendo avuto esperienze sessuali, senza però diventare un adulto pedofilo. L’autore suggerisce che la repulsione da parte dei coetanei e l’ostilità genitoriale potrebbero agire come rinforzi negativi e produrre così un’avversione per il rapporto sessuale adulto-bambino, favorendo, così, lo sviluppo di una sessualità adulta. Viceversa, se l’adolescente si sentirà ansioso circa la possibilità di avere contatti con un individuo sessualmente maturo, ancor più cercherà il contatto con i bambini. Problematiche di relazione con gli adulti in generale, potrebbero, anche, svilupparsi proprio per la difficoltà di crescere uscendo dalla pedofilia. Come la maggior parte delle teorie fin qui considerate, anche questa, lascia irrisolte alcune importanti questioni, quali, ad esempio, come il pedofilo giunga a compiere il suo primo abuso. 251 Criminologia ed elementi di criminalistica Esiste un’altra grave e preoccupante forma di manifestazione pedofila, e riguarda la c.d. pedopornografia on-line (o pedofilia via internet). La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha a disposizione, da poco tempo, un’importante e innovativa tecnologia messa a disposizione (gratuitamente) da Microsoft, per combattere il fenomeno della pedopornografia online. Il nuovissimo sistema denominato Child Exploitation Tracking System (CETS), Sistema di Tracciamento Contro la Pedopornografia, consentirà alla Polizia Postale, che in Italia è il principale organo di polizia preposto a contrastare i reati sulla Rete, di tracciare eventuali tentativi di pedopornografia online e di indagare con maggior efficacia gli individui e i siti internet sospetti. Un sistema che permetterà ai più giovani, pertanto, di navigare nella Rete con maggiore sicurezza. Il nuovo sistema CETS è stato sviluppato da Microsoft in collaborazione con la Polizia Canadese e numerose Polizie internazionali, dopo che un detective della Polizia di Toronto si era rivolto direttamente a Bill Gates nel 2003 per avere un aiuto tecnologico che consentisse di affrontare il fenomeno, fortemente in espansione. Già nel suo primo anno, CETS ha dato brillanti risultati nell’ambito di investigazioni nazionali ed internazionali: gli arresti totali effettuati dalla Polizia canadese sono stati oltre 140. Il Child Exploitation Tracking System permette alla Polizia Postale di dialogare fra le proprie 76 sedi territoriali, abbattendo, considerevolmente, i tempi di indagine, e consente, a livello internazionale, di relazionarsi con i Paesi che hanno adottato o adotteranno progressivamente la piattaforma CETS, scambiando un’enorme mole di dati e informazioni in tempo reale, ponendo, pertanto, il Sistema di Tracciamento contro i Pedopornografi on line come la prima piattaforma veramente internazionale per la caccia alla pedopornografia. L’alto grado di automazione del sistema rende possibile tenere sotto controllo e confrontare, all’istante, un’imponente massa di dati, documenti, profili personali e domini web, rendendo molto più agevole la caccia alle illegalità e allo sfruttamento dei minori sia sul territorio italiano, sia nelle indagini che coinvolgono più Paesi, essendo la pedopornografia on line senza confini. 11.14 La depressione e l’euforia Esistono forme di depressione che producono una perdita totale del sentimento della vita; queste forme si chiamano comunemente melanconia e consistono in un umore depresso, accompagnato da un grave svilimento del senso del proprio valore. La persona è costantemente attraversata da un’angoscia senza limiti, indefinibile quanto alle sue cause e ai suoi effetti, aggravata da autoaccuse il cui contenuto è palesemente esagerato. Un’altra forma molto grave è la malattia denominata disturbo bipolare, o psicosi maniaco-depressiva. Questa malattia è caratterizzata dall’alternarsi da due fasi di umore contrapposto: una fase di umore depressivo si alterna con una di umore esageratamente euforico. Sia la melanconia che la forma maniaco-depressiva sono condizioni particolarmente gravi, che richiedono un intervento molto specifico e tempestivo. Sono condizioni 252 Criminalità e distrurbi mentali particolarmente debilitanti, paragonabili a forme di malattia organica, e richiedono la massima attenzione e, in primo luogo, un intervento inteso a modificare il tono dell’umore. Esse non vanno, cioè, confuse con gli altri stati depressivi, caratterizzati da uno stato di tristezza e di tedio, poiché, in questi ultimi, la capacità di lavorare e di svolgere le normali attività non è compromessa, anche se può essere resa difficoltosa dalla sofferenza provata; in queste forme meno gravi, domina, inoltre, un senso di insoddisfazione che non ha nulla a che fare con la perdita del sentimento della vita o con l’esagerato, irrequieto e angoscioso iperattivismo della condizione maniacale. Le autoaccuse sono prodotte da un senso di responsabilità eccessivo ed immaginario che però schiaccia la vita morale della persona come un reale misfatto. Il melanconico ha innanzitutto un atteggiamento caratterizzato dalla grandezza e dell’immensità; quando si ritiene responsabile di qualcosa, egli, in realtà, pensa di essere colpevole e arriva a considerarsi un criminale. Nonostante non abbia nulla da rimproverarsi, o addirittura nonostante una vita morale irreprensibile e rigorosa, la persona melanconica riterrà, in egual modo, di avere compiuto dei misfatti di cui potrà essere accusata e per i quali può considerarsi un grande criminale. L’episodio a cui si riferisce il melanconico, nelle sue autoaccuse, può essere anche reale, anche se non lo è sempre; ma in ogni caso, il melanconico, assume su di sé una responsabilità del tutto sproporzionata a ciò che è accaduto. L’evento in cui si è trovato coinvolto è sempre caratterizzato da una perdita o da una separazione da qualcuno o da qualcosa; questo episodio può essere, ad esempio, il ricovero di un proprio genitore in un ospedale per anziani, di cui la persona si sente colpevole; oppure una malattia di un genitore o di un partner, che fa precipitare la persona in una angoscia che si trasforma presto in autoaccusa melanconica. La depressione può alternarsi ad uno stato di esagerata euforia, detta condizione maniacale. Nella forma maniaco-depressiva, troviamo due condizioni emotivamente molto diverse, ma che hanno entrambe sullo sfondo l’angoscia. Nella fase depressiva, infatti, l’umore è così negativo e così profondamente triste da coincidere con uno stato angoscioso vero e proprio: è una angoscia pervasa dal senso del nulla e della morte; la persona vede in modo cupo se stessa e il mondo circostante e si sente senza via di scampo in una condizione di disperazione. Nella fase detta maniacale, si instaura, invece, un’euforia associata con la necessità imprescindibile di agire e di fare: ogni attività che già appartiene alla sfera di interessi della persona diviene importantissima, fondamentale, ma per breve tempo. L’euforia diviene, con il tempo, talmente inquieta ed esagitata da essere paragonabile all’angoscia vera e propria. Via via che la condizione di euforia aumenta, la persona fa sempre più fatica a portare a termine le attività iniziate; cresce l’inquietudine; ogni attività occupa, ora, un tempo brevissimo e questo tempo diviene sempre più breve: la persona passa da una cosa all’altra nel giro di pochissimo tempo e l’euforia, a poco a poco, è diventata vera e propria disperazione. In questa fase, la persona è, in genere, potentemente reattiva, è espansiva, ironica, si lascia trascinare nelle discussioni e si appassiona. Ripensando a questa condizione, la persona può avere un certo rimpianto, come se si trattasse di un periodo di vita intensamente vissuta. Perché una condizione venga definita maniaco-depressiva, non basta però questa alternanza dell’umore; è necessario, anche, che nella condizione maniacale, la perso253 Criminologia ed elementi di criminalistica na compia atti palesemente caratterizzati dall’impossibilità di mettere freni alla propria volontà: spese folli e acquisti esagerati, accompagnati da sentimento di una propria grandezza e della grandezza di ciò a cui ci si appassiona. Non basta, cioè, per parlare di fase maniacale, il fatto che la persona manifesti forme anche accese di reattività e di aggressività. 254 CAPITOLO 12 Droga e alcool nell’agire delittuoso 12.1 La diffusione della droga e l’evoluzione legislativa La legislazione italiana ha costantemente considerato reato la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, adottando, al riguardo, misure repressive e sanzionatorie sempre più incisive, anche in ossequio agli impegni assunti, con l’adesione ad alcune importanti convenzioni internazionali. Nei confronti del consumatore di droghe, l’ordinamento giuridico ha, invece, previsto, nel corso degli anni, provvedimenti anche molto differenti l’uno dall’altro. La prima legge sulla droga, la n. 396 del 18 febbraio del 1923, espressione di un orientamento politico-sociale che, a differenza di quello attuale, considerava il consumo di droga un vizio, prevedeva la punibilità del consumatore solo qualora la sua condotta potesse rappresentare un pericolo per l’ordine pubblico; tale rigidità di giudizio si accentuò con la legge n. 1041 del 1954 che arrivava a considerare il consumatore di stupefacenti pienamente equiparato al produttore e allo spacciatore, applicando, sia pure in ritardo, le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1936 tendenti a ribadire la necessità di incriminazione a cascata, per evitare possibili impunità per coloro che entrassero anche occasionalmente nel mondo della droga. Nel corso degli anni Settanta, si determinò, nella giurisprudenza italiana, la necessità di distinguere i consumatori di droga dagli spacciatori e dai trafficanti. L’approccio in questo senso si concretizzò nella legge n. 685 del 1975 che applicava le direttive impartite dalle Convenzioni di New York del 1961 e di Vienna del 1971. La premessa fondamentale di questa svolta nella legislazione italiana fu la crescente consapevolezza della natura di malattia sociale dell’abuso di droghe e la visione dell’assuntore di sostanze stupefacenti quale persona bisognosa di un supporto medico, psicologico e sociale. Pur ribadendo l’illiceità della detenzione di droga, la legge contemplava un’ipotesi di non punibilità, caratterizzata da due elementi essenziali: uno, soggettivo, legato alla finalità di uso personale non terapeutico della droga, l’altro oggettivo, costituito dalla modica quantità di sostanza detenuta. La causa di non punibilità poteva essere accertata solo mediante procedimento penale, la persona che deteneva una modica quantità di droga non era passibile di pena 255 Criminologia ed elementi di criminalistica ma, qualora si fosse rifiutata di sottoporsi volontariamente al trattamento disintossicante, poteva essere obbligata a curarsi con provvedimento giurisdizionale. Dopo alcuni anni di applicazione, si manifestarono in Italia numerose critiche a tale approccio normativo. In particolare, secondo l’opinione prevalente, si ritenne che il concetto di modica quantità poteva determinare una certa impunità degli spacciatori, e non contrastare sufficientemente l’attività del consumatore-spacciatore. La legge n. 162 del 26 giugno 1990 (racchiusa nel T.U. delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990) ha segnato una svolta nell’evoluzione legislativa italiana in materia, in quanto, insieme al divieto dell’uso personale di sostanze stupefacenti e a un rifiuto di qualsiasi tesi antiproibizionistica, ha potenziato sia gli strumenti destinati all’attività di prevenzione e recupero, attraverso il finanziamento di innumerevoli attività informative e socio-sanitarie, sia la risposta sanzionatoria e i poteri investigativi nei confronti delle attività illecite. Tale normativa ha introdotto l’assoggettamento a sanzioni amministrative, come il ritiro del porto d’armi, del passaporto e della patente di guida, per tutti coloro che, per uso personale, illecitamente importino, acquistino o comunque detengano sostanze stupefacenti (art. 75). Prima del referendum popolare dell’aprile del 1993, l’uso personale, inoltre, era rigidamente legato al quantitativo della sostanza usata, che non doveva comunque, superare la dose media giornaliera. Il ricorso all’Autorità Giudiziaria ed alle sanzioni penali, avveniva soltanto se la condotta illecita era più volte reiterata (art. 76). Inoltre, il consumatore di stupefacenti poteva evitare l’applicazione delle sanzioni (sia amministrative che penali), sottoponendosi ad un programma terapeutico, l’inosservanza del quale, faceva irrogare nuovamente altre sanzioni. Tali previsioni, così come l’intero articolo 76, sono state tutte abrogate dal referendum del 1993. La portata innovativa della legge non è stata però intaccata dal referendum, anzi, ne è risultata invigorita. Essa consiste nell’attività di recupero del tossicodipendente, ricercata costantemente dal Prefetto durante l’applicazione del procedimento amministrativo di cui all’art. 75. Accanto alle norme inerenti il consumo, vi sono poi quelle che sanzionano la produzione ed il traffico illecito di stupefacenti e che non si differenziano in modo sostanziale dalla disciplina precedente alla riforma del 1990. Il sistema è costituito da due gruppi di reati, che si distinguono in base al carattere individuale o associativo. In ciascuno dei sottogruppi, le sanzioni si differenziano e si basano sulla natura della sostanza stupefacente, a seconda che si tratti di droghe pesanti (indicate nelle Tabelle I- III del D P R 309/90) o leggere (Tabelle II- IV). Le condotte prese in considerazione dall’art. 73 del D.P.R. 309/90 coprono tutte le possibili ipotesi in cui la produzione e il traffico di stupefacenti può concretamente manifestarsi. È punita anche la illecita detenzione, ovviamente fuori dalle ipotesi di utilizzazione di droga per uso personale. Sono previste alcune circostanze che comportano un consistente aumento della pena, in relazione a condotte di produzione o traffico riferite ad ingenti quantitativi di stupefacenti o ad uso di armi. Queste circostanze, aggravanti, trovano sovente applicazione nei casi di traffico internazionale di stupefacenti. L’altro sottogruppo di reati è rappresentato dal delitto di associazione finalizzata al narcotraffico che, rispetto alla originaria norma incriminatrice prevista dalla vecchia leg256 Droga e alcool nell’agire delittuoso ge, si differenzia per un sensibile inasprimento delle pene detentive e per una migliore precisazione delle condotte criminose (art. 74). Tali norme si sono rivelate particolarmente efficaci nella repressione della produzione e del traffico della droga, soprattutto nei confronti delle grandi organizzazioni criminali che operano a livello internazionale. Nell’ambito del sistema repressivo penale delle condotte finalizzate alla produzione e al traffico di stupefacenti, l’ordinamento riserva un trattamento particolare al tossicodipendente, privilegiando, nella fase detentiva, l’aspetto del recupero e assecondando le scelte trattamentali e curative. In particolare, tra le misure cautelari alternative alla custodia in carcere, il giudice può ritenere opportuno adottare nei confronti del tossicodipendente, gli arresti domiciliari nella comunità terapeutica o di riabilitazione presso cui il tossicodipendente ha in corso un programma terapeutico di recupero, qualora l’interruzione dello stesso possa pregiudicare la sua disintossicazione. L’art. 89 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (provvedimenti restrittivi nei confronti di tossicodipendenti) vieta, addirittura, che il giudice possa disporre la custodia in carcere, salvo per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, del tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell’ambito di una struttura autorizzata, nel caso in cui una forzata interruzione possa pregiudicare la disintossicazione dell’imputato. Gli artt. 90 − 93 prevedono che, nei confronti di persona condannata a pena detentiva non superiore a 3 anni per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, il Tribunale di Sorveglianza possa sospendere l’esecuzione della pena per una durata di 5 anni, qualora accerti che la persona si sia sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico. L’art. 94 prevede l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di pena detentiva inflitta nel limite di 3 anni. Presupposti di questo istituto − così come di quello contemplato dall’art. 90 − sono il riconoscimento dello stato di tossicodipendenza e un programma terapeutico già iniziato o concordato. Il D.L. 14 maggio 1993 n. 139, convertito nella legge 14 luglio 1993, n. 222, contenente disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezioni da HIV e di tossicodipendenti, ha introdotto alcune importanti modifiche nel regime della detenzione per il tossicodipendente. Ha, infatti, modificato parzialmente l’art. 89, introducendo la possibilità di revocare la custodia cautelare già in fase di esecuzione, qualora il soggetto manifesti l’intenzione di sottoporsi a un programma di recupero, anche se non ancora iniziato. L’art. 286-bis c.p. prevede il divieto di mantenere la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV in stato avanzato, qualora si verifichi una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione; inoltre, è stato modificato l’art. 146 c.p., mediante la sospensione temporanea dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti di persona affetta dalla medesima infezione. Il D.P.R. 309/1990, pur rappresentando il cardine della normativa sulla tossicodipendenza in Italia, è stato oggetto di aspre critiche che hanno condotto al referendum dell’aprile del 1993, i cui esiti sono stati recepiti dal D.P.R. 5 giugno 1993, n.171. L’intervento referendario ha abrogato alcune norme della legge del 1990, modificando in parte l’approccio normativo, soprattutto per quanto riguarda il consumatore di droga. In sintesi, il sistema legislativo italiano in materia di tossicodipendenza, dopo gli effetti 257 Criminologia ed elementi di criminalistica abrogativi del referendum del 1993, vieta penalmente solo le attività destinate alla produzione, vendita, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. È venuto meno − in base all’abrogazione del comma 1 dell’art. 72 − il divieto dell’uso personale non terapeutico, senza, tuttavia, optare per la liberalizzazione delle sostanze stupefacenti e mantenendo l’illiceità dell’uso personale. Altra conseguenza del referendum è stata l’abolizione della dose media giornaliera, che non presenta più il discrimine per distinguere tra consumo personale e spaccio. L’uso personale può essere, quindi, desunto da qualsiasi circostanza e non è più legato a un prefissato parametro normativo. Bisogna precisare che l’esclusione di ogni rilievo penale riguardo il semplice uso personale non si è tradotto, però, in un atteggiamento di indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno del consumo di droga. Al contrario, in base alla normativa vigente (art. 75), il Prefetto convoca dinanzi a sé o ad un suo delegato, la persona segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti al fine di accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione nonché individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. Il Prefetto, ove l’interessato volontariamente richieda di sottoporsi a un programma terapeutico socio-riabilitativo, sospende il procedimento amministrativo avviato dalla segnalazione e, decide l’invio del segnalato al Servizio per le Tossicodipendenze, che predispone il programma terapeutico di disassuefazione e concorda il luogo più idoneo dove svolgerlo. Il programma deve essere, in ogni caso, formulato nel rispetto della dignità della persona ed in considerazione anche delle esigenze di lavoro, nonché delle condizioni familiari e sociali del tossicodipendente. Al termine del programma, il Servizio Sanitario pubblico locale, redige una relazione sul comportamento del soggetto, che dovrà essere sottoposta al Prefetto per valutare in merito alla eventuale archiviazione del procedimento sanzionatorio. Il mancato rispetto di tale programma prevede l’applicazione di sanzioni amministrative. Prima del referendum abrogativo del ‘93, i tossicodipendenti che persistevano nel consumo di droga o non ottemperavano al programma terapeutico, erano passibili di sanzioni penali mentre ora, il Prefetto dopo aver invitato − anche ripetutamente − il tossicodipendente segnalato al rispetto del programma terapeutico, deve applicare le sanzioni amministrative previste per legge. Il T.U. 309/1990, oltre a regolare in termini giurisdizionali il consumo e il possesso di sostanze stupefacenti ha provveduto − in maniera organica e globale − a regolamentare tutti i profili relativi alla politica contro la droga. Infatti, ha individuato gli organismi preposti alle attività di coordinamento degli interventi, sia a livello centrale (Governo, Ministeri) che periferico (Regioni, Province e Comuni). Nel suddetto T.U., recentemente modificato per effetto dell’entrata in vigore della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (cosiddetta legge Lumia), sono state definite anche le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi (Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla Droga, Fondo Sanitario Nazionale), nonché gli strumenti legislativi per l’organizzazione della lotta al traffico e gli ostacoli all’esplicazione delle attività delle grandi organizzazioni criminali. 258 Droga e alcool nell’agire delittuoso La nuova legge ha definito in maniera organica gli strumenti di rilevazione epidemiologica del fenomeno nonché di monitoraggio degli interventi. Il governo deve presentare al Parlamento, ogni anno, una relazione sull’andamento del fenomeno, onde consentire alle forze politiche di promuovere iniziative legislative adeguate alle nuove esigenze; inoltre, deve convocare ogni 3 anni una Conferenza Nazionale a cui partecipano tutte le istituzioni pubbliche e private che operano nel settore. (La prima Conferenza Antidroga si è tenuta a Palermo dal 24 al 26 giugno 1993. La seconda Conferenza dal 13 al 15 marzo 1997 a Napoli). La normativa vigente (art. 13 D.P.R. n. 309/90) stabilisce che le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero della Sanità sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14 del citato D.P.R., in sei tabelle, approvate con decreto del Ministro della Sanità. Le predette tabelle contengono l’elenco di tutte le sostanze e i preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono sottoposte a continuo aggiornamento. L’articolo 14, nello stabilire i criteri per la formazione delle tabelle, distingue le sostanze dalle preparazioni. Con il termine sostanze (stupefacenti o psicotrope) si indicano, generalmente, le droghe aventi origine naturale o di sintesi, mentre il termine preparazione si riferisce alle soluzioni o ai miscugli che, indipendentemente dal loro stato fisico, contengono una o più sostanze psicotrope: - nelle tabelle I e III sono ricomprese le c.d. droghe pesanti quali l’oppio e suoi derivati, le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante da queste estraibili, le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante, le sostanze di tipo barbiturico ad effetto ipnotico e sedativo, nonché ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica nell’assuntore. Vi rientrano, altresì, le preparazioni che contengono le sostanze elencate nelle tabelle I e III; - le tabelle II e IV contengono le c.d. droghe leggere (es. cannabis indica e i prodotti da essa ottenuti − i.e. marijuana, olio di hashish) e le preparazioni che contengono le sostanze in esse indicate. Nella tabella IV sono comprese le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica e psichica di intensità e gravità minori rispetto a quelle delle tabelle I e III; - nella tabella V sono elencate le preparazioni contenenti le sostanze indicate nelle tabelle I, II, III e IV quando, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentano rischi di abuso e, pertanto, non devono essere assoggettate alla disciplina (penale) delle sostanze con cui vengono prodotte; - nella tabella VI sono indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza. Le sostanze e le preparazioni delle Tabelle I, II, III, e IV costituiscono oggetto della repressione penale, mentre quelle delle Tabelle V e VI sono sottoposte soltanto a controlli amministrativi. 259 Criminologia ed elementi di criminalistica La nuova e recente legge sulla droga, in Italia, prevede, sostanzialmente: la depenalizzazione del consumo; l’eliminazione del concetto quantitativo per distinguere tra uso personale e spaccio; la reintroduzione della divisione delle sostanze per tabelle, e conseguente distinzione tra droghe pesanti e leggere; l’ampliamento delle pene alternative al carcere. Il consumo personale di sostanze stupefacenti resta un illecito, ma viene sanzionato solo se comporta azioni irresponsabili o pericolose verso terzi. La guida in stato di alterazione, il consumo di droga per via endovenosa in un luogo pubblico, l’abbandono di siringhe incustodite, il coinvolgimento attivo di minori nel consumo, sono puniti con sanzioni, che vanno dalle multe alla perdita di punti della patente, al divieto di guidare. Per i minori, è inoltre previsto l’obbligo di segnalazione ai servizi sociali e ai genitori. La nuova normativa sulle droghe elimina la dose massima consentita, restituendo al giudice la discrezionalità di decidere − caso per caso − se la quantità di sostanze detenuta dal tossicodipendente sia destinata ad uso personale o a spaccio. Nel secondo caso viene comunque previsto un riequilibrio del sistema delle pene (la precedente legge trattava parimenti la cannabis, la cocaina e l’eroina, con la reclusione da 6 a 20 anni), in modo da distinguere il piccolo spacciatore-consumatore dalle grandi organizzazioni mafiose di spaccio. Si allarga, inoltre, il ventaglio di ipotesi di pene alternative al carcere. La certificazione dello stato di tossicodipendenza torna di esclusiva competenza del servizio pubblico, con l’estensione, ai privati, della possibilità di certificare lo stato di tossicodipendenza ai fini delle misure alternative al carcere e della sospensione dell’esecuzione della pena. Per quanto riguarda il capitolo della riduzione del danno, la nuova normativa fissa i criteri generali a cui devono conformarsi i progetti (ad esempio, le sperimentazioni si devono basare su evidenze scientifiche) ma lascia alle singole Regioni la libertà di decidere le modalità concrete con cui attuarli. 12.2Consumatori, tossicodipendenza e tossicomania a) Consumatori Circa il 3% della popolazione mondiale (185 milioni di persone) ha abusato di droghe durante lo scorso anno, secondo l’UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Una piccola percentuale della popolazione mondiale abusa di cocaina (13 milioni di persone) o di oppiacei (15 milioni abusano di eroina, morfina e oppio). Ma la sostanza più consumata è la cannabis (usata nell’ultimo anno da più di150 milioni di persone), seguita dalle ATS, le sostanze stimolanti di tipo amfetaminico (38 milioni, di cui 8 milioni consumatori di ecstasy). Questi i dati presentati nella nuova edizione del World Drug Report, in due volumi. Il primo volume illustra le tendenze del mercato e fornisce analisi dettagliate delle tendenze in atto; il secondo volume comprende statistiche particolareggiate sul mercato internazionale della droga. Ci sono, inoltre, 1,3 bilio260 Droga e alcool nell’agire delittuoso ni di fumatori nel mondo, sette volte più dei consumatori di droga. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa 200.000 persone sono morte a causa dell’abuso di droga durante il 2000, l’equivalente dello 0,4% di tutti i decessi nel mondo. Il tabacco, invece, vanta decessi pari a 25 volte (4,9 milioni), l’equivalente dell’8,8% di tutte le morti. Se la misura usata per liquidare l’invalidità sono gli anni di vita, l’abuso di droga causerebbe la perdita di 11,2 milioni di anni di salute di vita, ma il tabacco causerebbe una perdita di cinque volte maggiore (59,1 milioni). Tra i punti salienti del World Drug Report 2005, vi sono alcune buone notizie che giungono dalle due più vaste aree di produzione di droghe: nel sud-est asiatico, la coltivazione del papavero da oppio continua a calare in Myanmar e Laos, mentre nella regione delle Ande la coltivazione di coca registra un sostanziale declino per il quarto anno di seguito in tutti e tre i principali paesi produttori (Colombia, Perù e Bolivia). In termini di impatto sulla salute, gli oppiacei sono la droga più problematica del mondo. Essi causano la morte per il 67% dei trattamenti per droga in Asia, per il 61% in Europa e per il 47% in Oceania. Nel sud-est dell’Asia, le metamfetamine stanno costituendo il problema principale. La cocaina è ancora al primo posto nell’intero continente americano, ma negli USA, l’abuso di cocaina tra gli studenti sta declinando. In Africa, la cannabis continua a dominare la domanda (65%). Ecco alcuni dei nuovi dati presentati nel rapporto: nel corso di dieci anni la quantità complessiva di sostanze illecite sequestrate è cresciuta, con gli incrementi più alti per le sostanze stimolanti di tipo amfetaminico (ATS); la conversione di quantità di droghe sequestrate in unità equivalenti (una dose tipica assunta dai consumatori di droga) riflette un forte incremento del totale dei sequestri, da 14 bilioni di dosi nel 1990 a 26 bilioni nel 2000 con segnali di stabilizzazione nel 2001/2002. I sequestri in termini unitari sono più alti nel continente americano (10,4 bilioni di dosi), seguito dall’Europa (7,4 bilioni), dall’Asia (5,5), dall’Africa (2,4) e dall’Oceania (0,08); su base pro-capite, comunque, la classifica subisce questi cambiamenti: le Americhe (12,1 unità o dosi sequestrati pro-capite), l’Europa (10,2), l’Africa (2,9), l’Oceania (2,6) e l’Asia (1,5); la produzione illecita globale di oppio è rimasta stabile, tra le 4.000-5.000 tonnellate dai primi anni ‘90, ma ha avuto un incremento quella concentrata in Afghanistan; le coltivazioni di coca sono diminuite del 30% dal 1999 al 2005 a seguito dell’incremento dei sequestri dei laboratori dalla metà degli anni ‘90 nei paesi sviluppati, il consumo di sostanze stimolanti di tipo amfetaminico (ATS) sembra aver avuto un picco negli ultimi due anni; il mercato della cannabis resta costante, con un incremento di consumo nel Sud America, in espansione sui mercati dell’Europa occidentale ed orientale, così come dell’Africa; sebbene il mercato delle sostanze stimolanti di tipo amfetaminico (ATS) sia in espansione, il tasso di incremento sembra essere rallentato, rispetto al rapido incremento che lo ha caratterizzato negli ultimi dieci anni. b) Tossicodipendenza La tossicodipendenza può essere definita come un comportamento compulsivo o una condotta tossicomanica per cui, una persona si trova progressivamente a non potere controllare il suo desiderio di assumere una certa sostanza presente in natura o di sintesi, legale o illegale, nonostante i rischi e i danni che derivano tanto sul piano sociale o relazionale che sanitario. Nonostante l’avvio delle campagne di prevenzione, in questi 261 Criminologia ed elementi di criminalistica ultimi anni, il numero di giovani che ricorrono a sostanze psicoattive non ha cessato di aumentare. Da alcuni anni, l’assunzione di droghe sembra sempre più motivata dal desiderio del cosiddetto sballo o dalla volontà di aumentare le prestazioni. Per questi motivi, le modalità di assunzione sono cambiate: si osservano maggiormente forme di poliabuso per meglio controllare o sfruttare gli effetti delle singole sostanze, e anche per riscontrare il rischio di dipendenza. Mentre il numero dei tossicodipendenti da eroina in cura presso i Ser. T., cioè i servizi per le tossicodipendenze, o le comunità terapeutiche, è relativamente costante negli ultimi anni, si stima che più della metà dei ragazzi abbia fatto uso occasionale di sostanze psicoattive o frequenti amici che le assumono. Come tutte le condotte tossicomaniche, la dipendenza nei confronti di una droga si manifesta con una serie di sintomi che si possono così riassumere: a) impossibilità di resistere all’impulso di ricercare la sostanza; b) tensione interna crescente prima di iniziare il comportamento; c) piacere o sollievo al momento dell’assunzione o della sua preparazione; d) perdita del controllo già all’inizio del comportamento. Almeno 5 degli 8 criteri seguenti: - - - - - - preoccupazione frequente per il proprio comportamento; la ricerca della sostanza richiede più impegno di quanto si vorrebbe; sforzi ripetuti per ridurre o smettere; molto tempo passato ad attivare il comportamento o a rimettersi dai suoi effetti; riduzione delle attività sociali, professionali, familiari determinata dal comportamento; impegno nel comportamento che impedisce di assolvere agli obblighi sociali, familiari o professionali; perseveranza nonostante i problemi sociali, finanziari o fisici; agitazione o irritabilità se è impossibile attuare il comportamento. La tossicodipendenza è un processo per cui sotto gli effetti associati della sostanza ripetutamente assunta (sia a livello dell’organismo che del sistema nervoso) e delle condotte necessarie per procurarsela, si producono delle modificazioni a livello delle sinapsi che portano l’individuo a desiderare sempre più di ripetere l’esperienza della tossicomania. c) Tossicomania L’utilizzo di sostanze voluttuarie è un fenomeno normale del comportamento umano, diffuso in ogni società. Nella progressione verso lo stato di tossicomania si possono distinguere diverse fasi. L’avvicinamento iniziale alla droga o fase di induzione, che determina il primo contatto con la droga stessa è, di solito, caratterizzato dalla disponibilità della droga, dalla curiosità e dallo spirito di emulazione. Quasi sempre, la prima esperienza con la droga non è piacevole, suscita, anzi, spesso, ansia e malessere. Presto, tuttavia, si passa alla fase in cui l’individuo ottiene sensazioni piacevoli ed effetti gratificanti. Dopo un certo intervallo di tempo dall’ultima somministrazione della droga, l’individuo accusa una sen262 Droga e alcool nell’agire delittuoso sazione di malessere e di inquietudine, secondo alcuni legata alla diminuzione dei livelli ematici e cerebrali del farmaco. Il soggetto sa che tale malessere va combattuto con un’ulteriore somministrazione di droga che produce in lui benessere ed euforia. Con il progredire della tolleranza e dello stato di dipendenza fisica, l’intervallo di tempo che separa la somministrazione della droga dalla comparsa dei sintomi di privazione diventa sempre più breve. La tossicomania, infatti, è la condizione determinata dal ripetuto impiego di certe sostanze psicoattive ed è caratterizzata da tre elementi: 1) assuefazione al farmaco; 2) tolleranza ai suoi effetti; 3) tendenza alla intossicazione cronica. 1)L’assuefazione, si manifesta con il desiderio di un certo farmaco, dal cui impiego si ricercano effetti psichici piacevoli. Con la brusca sospensione del farmaco, si viene a creare il cosiddetto quadro clinico della sindrome dell’astinenza e l’instaurarsi della dipendenza; 2) la tolleranza, invece, può essere definita una forma di adattamento cellulare a un ambiente chimico estraneo. A causa della tolleranza, l’attività del farmaco psicoattivo diminuisce graduatamente; 3) tendenza alla intossicazione cronica: a questi due aspetti possono essere attribuite le conseguenze nefaste delle tossicomanie. Il desiderio di evitare la sofferenza della sindrome di privazione costituisce un potente meccanismo di rinforzo dei fattori psichici che, in origine, hanno spinto il soggetto all’uso di droghe voluttuarie, d’altra parte, la tolleranza obbliga ad usare dosi sempre più elevate e rende perciò sempre più difficile, costoso e pericoloso evitare la sindrome di astinenza. L’assumere queste sostanze regolarmente fa si che l’organismo non abbia il tempo di eliminare le sostanze tossiche ad esse associate, e si instaura lentamente un’intossicazione cronica con grave danno degli organi (es. fegato e cervello). 12.3Le sostanze stupefacenti La classificazione, di seguito riportata, tiene conto, altresì, delle nuove sostanze che, pericolosamente, stanno circolando tra gli adolescenti. a) Eroina L’eroina che si acquista nel mercato illecito è una polvere fine oppure in piccoli granuli, di colore dal bianco al marrone chiaro, di odore leggermente pungente e dal sapore amaro, costituita in realtà da una miscela di sostanze la cui composizione è molto variabile. La dose è, in genere, confezionata in un piccolo pezzo di carta argentata (quella che si trova dentro i pacchetti di sigarette), oppure in bustine di plastica. Anche la percentuale di eroina contenuta nella dose o bustina può variare notevolmente a seconda del numero di passaggi intermedi dal produttore al consumatore: si va dal 50% e oltre, alla traccia minima (meno dell’1%). In media, la percentuale di eroina contenuta in una dose, si aggira attorno al 10%. Proprio a causa della notevole variabilità della percentuale di eroina che si può trovare nella bustina, il consumatore, non ha alcun modo 263 Criminologia ed elementi di criminalistica di sapere la quantità di eroina pura che sta per assumere. Le altre sostanze che possono essere presenti nella eroina da strada sono classificabili in: - sostanze che, pur non avendo effetto stupefacente, simulano alcune caratteristiche dell’eroina (ad esempio, il sapore amaro). Queste sostanze sono indicate con il nome di adulteranti (ad esempio caffeina, procaina, lidocaina, fendimetrazina, aminofenazone, barbiturici, chinina, stricnina); - sostanze aggiunte con l’unico scopo di diluire l’eroina e di realizzare quindi un maggior profitto dalla vendita. Queste sono indicate con il nome di diluenti (ad esempio, zuccheri, acido citrico, bicarbonato, acido borico); - sostanze estratte dall’oppio assieme alla morfina e presenti nella bustina da strada come impurezze (ad esempio, acetilcodeina, narcotina, papaverina). A volte, oltre all’eroina, possono essere presenti altre sostanze stupefacenti, come ad esempio cocaina (la miscela di eroina e cocaina è nota con il nome di speedball) o amfetamina (bombitas). Al contrario di quanto comunemente si crede e di quanto generalmente viene riportato dai media, quello che rende pericolosa l’eroina da strada, e che in genere causa fenomeni di aumento della mortalità in un’area geografica e/o in un ristretto arco di tempo, non sono le sostanze aggiunte all’eroina (il cosiddetto taglio) ma, invece, la variabilità della percentuale di eroina che può essere contenuta nella bustina che si acquista dallo spacciatore. All’origine di questi fenomeni, vi è, infatti, la temporanea presenza sul mercato di preparati contenenti percentuali di eroina più elevate di quelle normalmente reperibili e tali da non essere tollerate da molti consumatori di eroina. In altre parole, non è la natura del taglio, ma la occasionale riduzione del taglio a rendere pericolosa l’eroina da strada. Nei paesi occidentali, il modo più diffuso di somministrazione o auto-somministrazione dell’eroina è l’iniezione in vena (pera, buco) dopo avere sciolto il contenuto della bustina in acqua. Gli strumenti che vengono utilizzati per il buco sono la siringa da insulina, dell’acqua (spesso vengono usate le fiale di acqua distillata per preparati iniettabili che si comprano in farmacia), il cucchiaino, un accendino o un’altra fonte di calore, del succo di limone (che servono a sciogliere la polvere in acqua), e un filtro (per rimuovere sostanze non disciolte dalla soluzione che verrà iniettata; in genere viene usato il filtro di una sigaretta). Generalmente, l’iniezione viene fatta nelle vene degli avambracci; in alcuni casi, vengono scelte altre aree del corpo che sono normalmente coperte da indumenti, come le gambe, i piedi o anche gli organi genitali. L’eroina viene anche inalata (sotto forma di polvere, sniffata), o fumata. Un’altra modalità di assunzione, indicata come “chasing the dragon” (“inseguendo il drago”), consiste nel bruciare l’eroina sopra ad una lastra e nell’inalare i fumi attraverso un piccolo tubo o una banconota arrotolata. La via inalatoria viene in genere scelta, sia nella convinzione (sbagliata) che l’eroina se non è iniettata in vena non produca dipendenza, sia per evitare i rischi di infezione che sono associati al buco. Per questa ragione, è stata riscontrata una recente tendenza all’aumento della scelta di questa via di assunzione rispetto all’iniezione in vena. Quest’ultima, è, in ogni caso, la via di assunzione che produce un effetto stupefacente più rapido e più intenso. Negli ultimi anni, si sta diffondendo tra i consumatori di eroina la tendenza ad assumere anche altre sostanze d’abuso assieme all’eroina. Tra queste ci sono soprattutto 264 Droga e alcool nell’agire delittuoso l’alcol, alcuni farmaci sedativi e tranquillanti (Valium, Darkene, Roipnol, Tavor) e altre sostanze stupefacenti (cocaina, ecstasy, hashish e marijuana). Questo comportamento è molto pericoloso perché agli effetti dell’eroina sull’organismo si possono aggiungere quelli prodotti dalla/e altra/e sostanza/e, aumentando significativamente il rischio che si producano effetti tossici anche in soggetti consumatori abituali di eroina. Per la stessa ragione, è molto pericoloso, per un soggetto in trattamento con metadone o con altri farmaci sostitutivi dell’eroina (es. buprenorfina), continuare ad assumere eroina, oppure, anche altre sostanze d’abuso (alcol, sedativi, tranquillanti, stupefacenti, ed anche altro metadone al di fuori di quello prescritto). Un consumatore cronico di eroina assume, in genere, tra i 100 milligrammi ed 1 grammo al giorno, divisi in 2-4 dosi. L’eroina è una sostanza che produce assuefazione. Ciò vuol dire che in un consumatore che continuasse ad assumere tutti i giorni sempre la stessa dose, l’effetto prodotto sull’organismo sarebbe progressivamente minore. Per questo motivo, i consumatori di eroina tendono con il passare del tempo ad aumentare la dose assunta. Questo fenomeno, legato al progressivo adattamento dell’organismo all’eroina (tolleranza), è reversibile: l’astinenza volontaria o forzata, per esempio conseguente ad un periodo di detenzione in carcere, dall’eroina, per un periodo anche relativamente breve (un paio di settimane sono sufficienti) causa una riduzione della tolleranza. Ciò significa che, se un soggetto, dopo un periodo di astinenza, riprende a usare l’eroina nelle stesse dosi che assumeva prima, rischia di incorrere, quasi certamente, negli effetti tossici della sostanza. Il fenomeno della perdita della tolleranza è considerato una delle principali cause di morte per intossicazione acuta da eroina. Oltre ai segni più evidenti nei consumatori di eroina per iniezione, e cioè i segni di agopuntura o buchi, generalmente agli avambracci, ma anche in altre parti del corpo (gambe, piedi, organi genitali), sono: a) la parola impastata; b) il rallentamento nei movimenti; c) la tendenza alla sonnolenza; d) il prurito insistente; e) le pupille a spillo. L’iniezione di eroina provoca nel giro di pochi secondi una forte sensazione di piacere, denominata flash, spesso descritta come un intenso orgasmo sessuale, accompagnata da una sensazione di euforia e da vampate di calore. Dopo questo effetto, che dura pochi minuti, subentra una seconda fase caratterizzata da calma, rilassatezza, soddisfazione, e distacco da quanto succede all’esterno. Questo effetto si esaurisce, entro 26 ore dall’iniezione. Se l’eroina viene inalata o fumata, gli effetti sono qualitativamente uguali, ma sono meno rapidi e meno intensi. L’eroina ha anche una potente azione depressiva sul sistema nervoso e ottunde sia gli stimoli esterni che quelli interni sgradevoli: il dolore, le angosce, le paure, l’urgenza del sesso. Entro un periodo di tempo che va da 2 sino a 6 ore dopo l’iniezione o l’inalazione di eroina, agli effetti piacevoli cominciano a subentrare quelli spiacevoli: agitazione, dolori diffusi, bisogno che a poco a poco diventa irrefrenabile di assumere un’altra dose. In un tempo piuttosto rapido (bastano poche dosi), si sviluppa una forte dipendenza che si manifesta come desiderio prepotente di assumere nuovamente la droga, e come spinta a procurarsela con ogni mezzo. L’assunzione abituale di eroina determina una progressiva riduzione delle sostanze che nel cervello agiscono sui meccanismi che regolano la percezione del dolore (le più note delle quali sono le endorfine), oltre che la perdita di gran parte dei recettori, attraverso i quali 265 Criminologia ed elementi di criminalistica la sostanza agisce sulle cellule nervose. Se non viene assunta una nuova dose di eroina, la mancanza della sostanza, in aggiunta alla riduzione delle endorfine e dei recettori, provoca la comparsa della crisi da astinenza. La crisi da astinenza comincia a manifestarsi dopo poche ore dall’ultima assunzione e raggiunge il massimo di intensità entro 1 o 2 giorni. I principali sintomi della crisi da astinenza comprendono agitazione, allucinazioni, insonnia, dolori diffusi, tremori, aumento della produzione di sudore, di saliva e di muco nasale, nausea, vomito, diarrea e crampi addominali, e sono tanto più intensi quanto maggiore è stata la durata del consumo di eroina. La crisi da astinenza scompare dopo l’assunzione di una nuova dose o, nel caso in cui l’astinenza prosegua, nel giro di 3-7 giorni. Quando la dose di eroina è superiore a quella che l’organismo è in grado di sopportare (overdose), o quando l’eroina viene assunta unitamente ad altre sostanze che ne potenziano gli effetti (alcool, sedativi, tranquillanti), la sensazione di calma e rilassatezza si trasforma in una progressiva depressione del respiro e del sistema circolatorio, sino a giungere all’arresto cardiocircolatorio e quindi alla morte. A parte il rischio di contrarre patologie infettive, l’uso prolungato di eroina produce una progressiva debilitazione fisica. Gli organi più direttamente interessati sono fegato, reni e polmoni. La presenza di particelle insolubili nel liquido iniettato può causare fenomeni di otturamento dei vasi sanguigni e la conseguente morte delle cellule irrorate da questi vasi. La reazione immunitaria ai vari contaminanti presenti nell’eroina di strada è all’origine dell’artrite (infiammazione delle articolazioni) e di altri problemi reumatici. b) Cocaina La cocaina è uno stimolante molto potente che ha effetto direttamente sul cervello. Conosciuta come la droga degli anni Ottanta e Novanta per la sua popolarità in quel periodo, non è certamente una sostanza nuova, ma una delle più antiche. L’effetto stimolante e di riduzione della sensazione di fatica che si ottiene masticando foglie di coca è conosciuto da migliaia di anni, la sostanza pura è invece utilizzata da oltre 100 anni. La cocaina è estratta dalle foglie di alcuni arbusti del genere delle eritoxilacee, diffusi e coltivati nel Sud America. Nei primi del Novecento, essa fu utilizzata come ingrediente principale di numerosi tonici ed elisir per alleviare i sintomi di diverse malattie. Oggi, è considerata una sostanza estremamente pericolosa ed è classificata fra le più potenti droghe d’abuso. La cocaina si trova nel mercato illecito in due forme: il cloridrato, che ha l’aspetto di una polvere bianca o bianco-avorio ed ha sapore amaro, e la base libera che si presenta, invece, sotto forma di scaglie o tavolette di varia forma e dimensioni e di colore dal bianco sporco al marrone. Il cloridrato può essere inalato, sciolto in acqua, oppure iniettato in vena. La base libera normalmente viene fumata. La cocaina venduta dagli spacciatori è spesso tagliata (diluita) con sostanze come l’amido di granturco, lo zucchero a velo, raramente il bicarbonato o il talco. Nella cocaina di strada, può anche essere presente procaina, lidocaina o altri anestetici locali che simulano alcune caratteristiche della cocaina (sapore, effetto di anestesia locale sulla lingua). Inoltre, la cocaina può essere mischiata con altre droghe come l’eroina o le amfetamine. 266 Droga e alcool nell’agire delittuoso Crack è il nome in gergo che viene dato ai cristalli di cocaina (base libera). Il termine crack deriva dal particolare rumore che questa sostanza produce quando viene bruciata. Il crack produce una forte euforia in meno di dieci secondi. La sua popolarità tra gli emarginati delle periferie urbane, in particolare negli Stati Uniti, è dovuta ai bassi costi di produzione e al prezzo contenuto. La cocaina può essere inalata, iniettata o fumata (da sola o mescolata a tabacco o a marijuana). L’assunzione mediante masticazione delle foglie è limitata esclusivamente ad alcune popolazioni sudamericane. Se inalata, normalmente con dei cannelli o con banconote arrotolate, la sostanza attiva passa attraverso le mucose nasali nel sangue. L’iniezione, invece, è la via più diretta e produce effetti istantanei e più marcati. Il fumo, attraverso speciali pipette, passa dai polmoni, nel sangue, quasi con la stessa velocità dell’iniezione. Molti tossicodipendenti la inettano o la inalano, mescolata all’eroina. Il consumo di cocaina può variare da occasionale a ripetuto e compulsivo. Non esiste una modalità di utilizzazione sicura o priva di rischi. Qualunque tipo di uso può portare all’assunzione di quantità tossiche di sostanza, provocando seri problemi cardiovascolari o cerebrali, che possono dar luogo anche a una morte improvvisa. L’uso ripetuto di cocaina, in qualunque forma, provoca dipendenza e altri danni alla salute. Sono state realizzate molte ricerche per studiare il modo in cui la cocaina produce i suoi effetti piacevoli, e la ragione per cui provoca dipendenza. Ciò avviene, probabilmente, attraverso il suo effetto sulle strutture profonde del cervello. Gli scienziati hanno scoperto che quando vengono stimolate alcune zone del cervello si produce una sensazione di piacere. Uno dei sistemi neurali che sembra siano più interessati dalla cocaina trova origine in una regione molto profonda del cervello chiamata area ventrale del tegmento (Avt). Le cellule nervose che partono dalla Avt si estendono alla regione conosciuta come nucleus accumbens, una delle aree chiave del piacere nel cervello. In studi su animali, ad esempio, tutto ciò che produce piacere, dal bere al mangiare, dal sesso a molte droghe, aumenta l’attività del nucleus accumbens. Gli studiosi hanno scoperto che quando si sta svolgendo un’azione che provoca piacere, i neuroni nella Avt aumentano la secrezione di dopamina nel nucleus accumbens. I segnali di piacere vengono cioè comunicati da neurone a neurone, attraverso la emissione di dopamina nei punti di connessione (sinapsi) tra i neuroni. Le droghe possono interferire proprio con questo processo. La cocaina, ad esempio, blocca l’eliminazione della dopamina dalla sinapsi provocandone l’accumulo. La conseguente stimolazione continua dei neuroni è all’origine dell’euforia riferita dai consumatori. L’uso continuo di cocaina crea tolleranza. Ciò significa che la persona che la assume, ha bisogno di dosi sempre maggiori e frequenti per ottenere lo stesso effetto. Secondo recenti ricerche, durante il periodo di astinenza dall’uso di questa droga, il ricordo dell’euforia associata al consumo o soltanto alla stessa può causare il desiderio incontrollabile di assumerla anche dopo lunghi periodi in cui non è stata consumata. Gli effetti della cocaina si manifestano quasi subito dopo il suo uso, e possono durare da alcuni minuti ad ore. Coloro che utilizzano cocaina in piccole quantità (fino a 100 milligrammi) si sentono euforici, pieni di energia, disposti alla conversazione e mentalmente attivi, attenti, in particolare, alle sensazioni visive, uditive e tattili. La cocaina può anche diminuire, temporaneamente, il desiderio di mangiare e dormire. Al267 Criminologia ed elementi di criminalistica cuni consumatori riferiscono che la droga li aiuta a compiere sforzi intellettuali e fisici più rapidamente; altri, parlano di effetti opposti. La durata degli effetti euforici di questa droga dipende dal modo in cui è stata utilizzata. Più veloce è l’assorbimento nel sangue (come nel caso dell’iniezione in vena o dell’inalazione del fumo), più intenso è l’effetto e più breve la sua durata. Le sensazioni di benessere provocate dall’inalazione possono durare dai quindici ai trenta minuti, mentre, quelle conseguenti al fumo variano dai cinque ai dieci minuti. Gli effetti fisiologici a breve termine che la cocaina produce sono: contrazione dei vasi sanguigni, dilatazione delle pupille, aumento della temperatura corporea, del ritmo cardiaco e della pressione arteriosa. Se le quantità utilizzate superano i 100 milligrammi, gli effetti si intensificano e possono provocare comportamenti inusuali e violenti. I consumatori possono provare tremori, vertigini, spasmi muscolari, paranoia e, dopo successive assunzioni, reazioni tossiche simili a quelle prodotte dall’avvelenamento da amfetamina. Tra gli effetti a breve termine della cocaina, è da segnalare la riduzione della percezione del rischio che può originare comportamenti pericolosi per il consumatore stesso e per la salute di terzi (ad esempio, guida pericolosa). Alcuni utilizzatori riferiscono di sentirsi irritabili, agitati e di soffrire di ansia. In qualche rara occasione, l’uso di cocaina per la prima volta può provocare una morte improvvisa. I decessi per cocaina sono provocati generalmente da arresto cardiaco o da convulsioni causate da blocco respiratorio. La cocaina provoca una forte assuefazione. Una volta provata, è molto difficile controllarne e limitarne l’uso. Si ritiene che la dipendenza da questa sostanza e i suoi effetti stimolanti, siano il risultato della sua capacità di impedire l’assorbimento della dopamina da parte delle cellule nervose e di provocarne, quindi, un accumulo nell’organismo. Il cervello produce dopamina come sistema di gratificazione e il funzionamento di molte droghe dipende, direttamente o indirettamente, dalla maggiore o minore presenza di questa sostanza nell’organismo. La cocaina può, inoltre, provocare una considerevole tolleranza in chi la assume, tanto che molti tossicodipendenti riferiscono di non riuscire a provare le stesse sensazioni di piacere dopo un uso continuato. Allo stesso tempo, alcuni individui possono sviluppare nel tempo una maggiore sensibilità agli effetti anestetici e convulsivi di questa sostanza, tanto da provocarne la morte dopo l’assunzione di quantità relativamente piccole. Esiste una notevole quantità di complicazioni mediche associate all’uso di cocaina. Fra le più frequenti: complicazioni cardiovascolari, come irregolarità nella frequenza del cuore, malattie cardiache, problemi respiratori che provocano dolori al petto, effetti neurologici che causano ictus, convulsioni ed emicranie, complicazioni gastrointestinali che provocano dolori addominali e nausea. L’uso di cocaina provoca vari tipi di malattie cardiache. Si sa che questa droga causa fibrillazione ventricolare, accelera i battiti del cuore e la respirazione, aumenta la pressione arteriosa e la temperatura del corpo. I sintomi fisici possono includere confusione mentale, dolore al petto, febbre, spasmi muscolari, convulsioni e coma. Gli effetti negativi della droga sono collegati alle diverse modalità di assunzione. Quando la si inala regolarmente, ad esempio, la cocaina può provocare una perdita di sensibilità dell’olfatto, causare emorragie nasali, problemi di deglutizione, raucedine ed 268 Droga e alcool nell’agire delittuoso una irritazione del setto nasale che causa una condizione cronica di irritazione delle narici e di secrezione di muco. Quando viene ingerita, la cocaina può provocare cancrena all’intestino perché riduce il flusso di sangue. Coloro che la iniettano, possono contrarre flebiti ed altre infezioni, come anche reazioni allergiche alla droga o alle altre sostanze da taglio ad essa associate. La cocaina tende a ridurre il desiderio di alimentarsi, per cui il suo uso abituale provoca perdite di peso e malnutrizione. Gli scienziati hanno dimostrato che esiste un’interazione potenzialmente pericolosa tra cocaina e alcol. c) Cannabis La cannabis contiene più di 400 composti chimici, di cui 61 cannabinoidi, tra i quali, il delta 9-tetraidrocannabinolo (THC) è il più potente come attività psicoattiva; inoltre, nel fumo di cannabis, sono presenti più di 350 sostanze chimiche, simili a quelle del fumo di sigaretta. I cannabinoidi, molto liposolubili, attraversano rapidamente le membrane cellulari ed entrano nel cervello dopo pochi minuti dalla inalazione del fumo di uno spinello ed entro un’ora dalla ingestione orale. Il THC si lega nel cervello a dei recettori specifici scoperti nel 1988, i recettori endogeni, attivando una serie di reazioni cellulari che portano all’effetto acuto dei cannabinoidi. Ad essere coinvolti sono i sistemi cerebrali che controllano il tono dell’umore: la memoria, le funzioni intellettuali e cognitive, il dolore, il controllo dei movimenti, le attività delle ghiandole endocrine, il sistema cardiovascolare e altre funzioni vitali. La cannabis produce, così, uno stato di coscienza oniroide (sognante), nel quale le idee appaiono sconnesse, incontrollabili e liberamente fluenti. In genere, si produce una sensazione di benessere e rilassamento (il cosiddetto sballo), effetti che non durano più di 2 o 3 ore dopo l’assunzione. Mancano, ad oggi, evidenze convincenti di un effetto prolungato o di postumi. Uno studio specifico ha confrontato le abilità di memoria, attenzione e apprendimento tra due gruppi di studenti di college: uno di consumatori abituali di marijuana e uno di consumatori occasionali. Dopo 24 ore di sobrietà da tutte le droghe e alcol, i test hanno rivelato, nei consumatori abituali, un maggior numero di errori e maggiore difficoltà nel mantenere la concentrazione. Come ogni sostanza che causa euforia e riduce l’ansia, la cannabis può provocare dipendenza, tuttavia, il consumo intenso e le lamentele di incapacità a smettere sono rari. La cannabis può essere usata in maniera episodica, senza evidenze di disfunzionalità sociale o psicologica. Nel 16-29% dei consumatori abituali, alla brusca sospensione della droga, può comparire una sindrome da astinenza con agitazione, ansia, aggressività, insonnia e tremori, mentre il rischio di sviluppare una dipendenza in chi la usa saltuariamente è stimato nel 10%. È vero, infatti, che negli USA, ogni anno, 120.000 persone iniziano un trattamento per la loro tossicodipendenza da marijuana ma, d’altro canto, i soggetti che risultano positivi ai test sul posto di lavoro, spesso, sono obbligati a chiedere il trattamento. L’uso di marijuana costituisce, comunque, un problema di droga, sebbene la sua importanza tossicologica sia incerta. Come incerto è un altro argomento molto dibattuto: il rischio di passare ad altre droghe illecite. Secondo alcune stime, i soggetti dipendenti da cannabis hanno una probabilità 28 volte superiore rispetto ai non consumatori di passare ad altre droghe illecite, ma si tratta di un’associazione più forte per l’età di 14-15 anni. 269 Criminologia ed elementi di criminalistica In ogni caso, le conoscenze attuali non consentano di affermare che la cannabis abbia un impatto significativo sul tasso di decessi. Il buon senso, però, suggerisce di tentare di non minimizzarne gli effetti negativi, ovvero di scoraggiarne l’uso da parte degli adolescenti, di non usarla quando si guida o si lavora, e di evitarla, se si soffre di disturbi cardiaci. d) Allucinogeni Gli allucinogeni naturali estratti dal psylocibe mexicana (fungo magico) furono, in passato, utilizzati nelle cerimonie religiose dei popoli del Messico e dell’America Centrale. In particolare, erano molto utilizzati, a tali scopi, i funghi di psilocibina, lunghi funghi scuri che, con il deperimento, tendono a scurirsi ulteriormente, fino a diventare bluastri, i quali contengono due sostanze allucinogene: la psilocibina e la psilocina. I sacerdoti messicani pensavano che questo fungo (teonanacatl: “carne di dio”) permettesse di entrare in comunicazione con gli dei e portasse ad acquisire facoltà magiche e curative. Gli Aztechi, invece, ritenevano sacro il cactus peyotl, la pianta da cui si ricava un allucinogeno naturale, la mescalina, che si consuma in forma di bottoni freschi o secchi e da effetti simili a quelli dell’LSD. I mescaleros, indios del centro America, avevano fatto dell’assunzione del cactus peyotl (peyote), il fulcro dei cerimoniali religiosi come strumento di illuminazione e trascendenza. La mescalina ha ispirato un’opera letteraria: Le Porte di Aldous Huxley, il quale riteneva che tale sostanza fosse il mezzo più efficace per gettare luce su le zone della coscienza umana che la cultura occidentale, improntata alla razionalità, aveva messo in ombra. L’autore fece anche da cavia agli esperimenti con cui gli psichiatri Osmond, Smythies, Hoffer stavano indagando la possibilità di studiare i meccanismi biologici della schizofrenia attraverso l’induzione di psicosi sperimentali con mescalina. Gli allucinogeni non producono assuefazione ma ingenerano una fortissima tolleranza: la stessa sostanza, assunta a distanza di pochi giorni, non fa più effetto. L’LSD è un prodotto di sintesi che viene commercializzato sotto forma di pillole di varia dimensione, di piccoli francobolli, o zollette di zucchero. La composizione del prodotto è varia e incerta, così come i dosaggi: si pensa che esistano diversi tipi di LSD. Questa è un’unica sostanza, ma compare sul mercato con diversi tagli (amfetamine, ecstasy, stricnina). I tagli influenzano fortemente gli effetti, in particolare la fase finale nella quale l’effetto della sostanza scende. La PCP (fenciclidina), altra sostanza di sintesi, può essere ingerita o fumata. La dose efficace di questa sostanza è di 2-5 milligrammi. Essa viene spesso addizionata ad altre sostanze per potenziarne gli effetti. Il fungo psilocibina, l’LSD, la mescalina e il peyote sono assunti oralmente. Il peyote e la fenciclidina (PCP) possono essere anche fumati. Raramente gli allucinogeni sono assunti per endovena. La dietilamide dell’acido lisergico o LSD è un allucinogeno di semisintesi derivato dall’acido lisergico, presente negli alcaloidi della segale cornuta. L’LSD viene sintetizzato a partire dall’acido lisergico che viene ottenuto da alcaloidi (ergometrina) estratti dagli sclerozi, che rappresentano la forma vegetativa della Claviceps purpurea, parassita sulle piante di segale. Sul mercato clandestino, l’LSD, nei primi anni ‘80, circolava in 270 Droga e alcool nell’agire delittuoso forme diverse: polveri farmacologiche usate, poi, per riempire capsule di gelatina, cubetti di zucchero e carta assorbente. L’LSD veniva anche incorporata in una matrice di gelatina che veniva tagliata, dopo solidificazione, in cubetti detti vetro di finestra. Attualmente, le formulazioni più frequenti sono strisce di carta o compressine. L’uso è per via orale (compresse, micropunte o francobolli imbevuti di una soluzione alcolica di LSD), specie in locali di ritrovo giovanile. Può causare l’insorgenza di bad trip (attacco di panico, talora episodi psicotici transitori) e flash-back che persistono per mesi dopo l’interruzione dell’uso. Il problema più grave può essere l’insorgenza di una psicosi cronica, probabilmente legata alla slatentizzazione di elementi psicopatologici in personalità ad elevata vulnerabilità. A basse dosi possono intensificarsi i suoni e le luci, accentuando gli impulsi sensoriali esterni. Non si è dimostrata l’instaurazione della dipendenza fisica dopo uso cronico, anche se si instaura il fenomeno della tolleranza. Un uso prolungato di LSD, anche fino a diversi mesi dopo la cessazione dell’uso, provoca difficoltà di memoria, turbe comportamentali, ansia e depressione fino all’allontanamento dalla vita sociale. L’assunzione di allucinogeni, quindi di LSD, può comportare: allucinosi, disturbo delirante, disturbo percettivo post-allucinogeno, disturbo dell’umore. Nell’allucinosi si notano turbe percettive in stato di piena vigilanza (illusioni, allucinazioni, sinestesie). Nel disturbo delirante, il soggetto ha la convinzione che le turbe percettive di cui fa esperienza nel corso dell’allucinosi corrispondano alla realtà. Il disturbo dell’umore può insorgere entro 1-2 settimane dall’inizio dell’uso della sostanza e persistere per più di 24 ore dopo la cessazione dell’uso stesso. Ci possono essere elementi depressivi o maniacali. Il disturbo percettivo post-allucinogeno (flash-back) consiste nel ricorrere all’esperienza allucinogena (pochi secondi), anche dopo diverso tempo (mesi) che la si è interrotta. I flash back si fanno meno frequenti con l’andare del tempo. Una reazione tossica comune a tutti gli allucinogeni è il viaggio (trip): una reazione ansiosa acuta simile a un episodio schizofrenico acuto. Tale effetto dura dalle quattro alle dodici ore, ma può prolungarsi per giorni o mesi, in quanto gli allucinogeni sono liposolubili e permangono nei depositi adiposi diversi tempo dopo l’assunzione. Persone che hanno sperimentato il viaggio provano il fenomeno del flash-back, istanti nei quali si ha l’impressione di rivivere la situazione psichedelica originale, anche quando la sostanza non è stata assunta. L’uso prolungato può provocare psicosi; personalità fragili e vulnerabili possono rimanere gravemente squilibrate per moltissimo tempo, fino ad arrivare a danneggiare permanentemente l’equilibrio psichico. Gli effetti sono: vertigini, debolezza e sonnolenza, nausea, sinestesie; vedere/odorare i suoni, sentire/odorare i colori, tensione interna che trae sollievo da risate o pianto; allucinazioni visive, ondate ricorrenti di fenomeni percettivi, ipervigilanza e riflessi muscolari iperattivi, ipertensione e ipertermia, sudorazione e tremori, contrazioni uterine. I casi di morte che si sono verificati sotto l’effetto di LSD e di altri allucinogeni derivano da azioni incontrollate dovute all’alterata percezione della realtà circostante. e) Amfetamine Le amfetamine sono derivati sintetici dell’efedrina e appartengono al gruppo dei farmaci simpaticomimetici, stimolanti del sistema nervoso centrale. Usate in medicina come terapia sintomatologica della narcolessia e del morbo di Parkinson, provocano 271 Criminologia ed elementi di criminalistica assuefazione ed effetti collaterali (aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, insonnia e allucinazioni). L’abuso di amfetamine viene classificato tra le tossicodipendenze e può causare psicosi acute e collasso cardiocircolatorio o respiratorio. L’assunzione provoca senso di benessere e invulnerabilità, riduce l’appetito, facilita il rendimento fisico solo per prove di resistenza, in quanto riduce la sensazione di fatica. Da un punto di vista sportivo è a tutti gli effetti doping e, a prescindere da considerazioni morali, l’uso di amfetamine da parte di un atleta è del tutto irresponsabile. Infatti: a) i benefici (riduzione del senso di fatica) sono comunque temporanei a causa di una rapida dipendenza; occorre aumentare le dosi, aumentando però anche il senso d’eccitazione per bloccare il quale l’atleta deve ricorrere ai barbiturici che a loro volta danno dipendenza. Basta questo quadro perché un soggetto normale si astenga da questa forma di doping; b) sono frequenti disordini cardiaci molto gravi, a volte mortali, causati da dosi eccessive o dalla soppressione del senso di fatica che spinge l’atleta oltre i propri limiti; c) fra gli effetti collaterali c’è l’ipertermia, un nemico che è già difficile combattere nelle prove di una certa durata in condizioni non ottimali di temperatura. f ) Le nuove droghe Ecstasy: è una droga sintetica con effetto allucinogeno e stimolante. I danni acuti dell’ecstasy sono legati al rialzo termico (che può arrivare fino a 41 °C con rischio di morte): coagulazione del sangue, autodistruzione delle cellule muscolari, alterazione della funzionalità epatica (epatite acuta) e renale, attacchi cardiaci; in alcuni casi, si è verificata un’epatite fulminante non collegata all’ipertermia. Fra le reazioni acute all’ecstasy si devono segnalare anche crisi d’ansia o depressive. I danni cronici sono soprattutto psichici, in quanto la droga agisce sul sistema di recupero della serotonina: psicosi, dissociazione dell’io e, probabilmente, con l’uso continuato, la lesione delle cellule cerebrali che rilasciano e recuperano la serotonina. Accanto all’ecstasy, si stanno affermando droghe naturali, un ulteriore esempio di come anche il naturale possa essere dannoso: - Gotu kola − droga vegetale ricavata dalla centella asiatica; l’assunzione provoca tachicardia, ipertensione, ansia, irritabilità e, a forti dosaggi, insonnia. - Hoja madre − droga vegetale ricavata dalla calea zacatechichi, detta anche “hoja de Dios”; l’assunzione a forti dosaggi provoca tachicardia, ipertensione, ansia, irritabilità e insonnia. - Lattuga silvestre − droga ricavata dalla lactuca virosa; l’assunzione inibisce la libido. - Kava o kawa − droga ricavata dalla pianta omonima (Piper mesthysticum) della famiglia delle Piperacee diffusa in Polinesia e nelle Hawai; l’assunzione a forti dosaggi provoca tachicardia, ipertensione, ansia, irritabilità e insonnia. Da notare che a bassi dosaggi è ansiolitica e sedativa. È stata comunque accertata la sua tossicità epatica: dal 1999 si sono verificati in Germania, Svizzera e Stati Uniti 11 casi di pazienti che, dopo aver assunto prodotti a base di Kava kava, hanno sviluppato un 272 Droga e alcool nell’agire delittuoso - - - - quadro clinico di insufficienza epatica tanto grave da richiedere il trapianto del fegato. Yohimbe o iohimbe − droga ricavata dalla corteccia di una Rubiacea (Corynanthe yohimbe) dell’Africa tropicale; l’assunzione provoca ansia, vomito, nausea, tachicardia, ipertensione, vertigini e irritabilità. Muirapuama o mirapuama − droga ricavata da un albero (Lyriosma ovata) della famiglia delle Olacacee, che cresce nel Brasile settentrionale, in Cile e in Guiana; l’assunzione provoca tachicardia, ipertensione, ansia, irritabilità e, a forti dosaggi, insonnia. Ska pastora − droga (detta anche “hierba de la virgin”) derivata dalla Salvia divinorum, la cui assunzione ad alti dosaggi causa distorsioni nella percezione spaziotemporale; se fumata, provoca gravi irritazioni a naso, bocca e gola. Rosa lisergica − droga vegetale ottenuta dalla Argyreia nervosa, la cui assunzione causa nausea e vomito. 12.4Relazione tra sostanze stupefacenti e delitto La correlazione fra tossicodipendenza e criminalità può considerarsi uno dei campi di studio maggiormente affrontati dalla criminologia moderna. Preliminarmente, distinguiamo: a) una criminalità diretta, quale risultato della commissione di reati sotto l’effetto di sostanze psicoattive; b) una criminalità da sindrome da carenza, quale risultato della commissione di reati durante tale situazione clinica; c) una criminalità indiretta, quale risultato della necessità di procurarsi il denaro per acquistare le sostanze usate; d) una criminalità da ambiente, quale risultato della interazione fra il contesto sottoculturale di alcuni tossicodipendenti e le aree criminose nelle quali essi sono soliti confluire. Nel primo caso, è difficile comunque distinguere quando il comportamento delittuoso sia favorito dall’effetto propriamente farmacologico della sostanza, oppure se sia espressione del deterioramento della personalità o dell’appartenenza a una sottocultura criminosa e violenta, da cui, non raramente, provengono i più gravi tossicomani. È da osservare che l’uso di droga non induca di per sé alla commissione di atti violenti o di altri delitti; le alterazione psichiche legate all’effetto acuto delle droghe, solo raramente, inducono ad uno stato di alterazione facilitante gesti insensati, azioni incontrollate o violente. I delitti commessi per l’effetto diretto di droga sono, perciò, statisticamente poco rilevanti. I dati scientifici indicano che in situazioni eccezionali, sotto l’effetto di alcune droghe, si possono avere disturbi psichici che si evidenziano in: alterazioni del controllo, perdita o diminuzione delle inibizioni, stati psicotici, stati confusionali o di eccitazione, esaltazione del tono dell’umore. Disturbi psicopatologici di tal genere possono provocare reati violenti, aggressioni sessuali o d’altro tipo, azioni incongrue, condotte pericolose. Sono, peraltro, manifestazioni che possono verificarsi con l’uso di tutte le sostanze psicoattive, e perciò anche di psicofarmaci. Comportamenti inconsulti o vio273 Criminologia ed elementi di criminalistica lenti direttamenti legati all’effetto farmacologico delle amfetamine, o della cocaina o degli allucinogeni sono stati segnalati, ma raramente. Sembra, invece, palese che l’assunzione di cannabinoidi, stimoli l’effetto di comportamenti astensionistici, stati di quiete e di piacevole inerzia o di bonaria euforia: atteggiamenti difficilmente di natura criminogenetica. L’eroina è, invece, una droga criminogena, non tanto per l’azione farmacologia immediata, ma, soprattutto, per cause indirette. La percezione sociale della pericolosità dell’eroinomane si ricollega, almeno in parte, a comportamenti per lo più imprevedibili, sulla base degli effetti farmacologici della sostanza. Nel secondo caso (comportamenti dovuti a sindrome da carenza o astinenza), si tratta, invece, di atti delittuosi che vengono commessi in una particolare condizione di sofferenza angosciosa, che può portare a difficoltà di autocontrollo, fino alla perdita completa dello stesso, legata all’urgenza di procurarsi rapidamente la droga. Particolarmente importante risulta, ai fini dell’imputabilità per reati commessi in stato intensivo astinenziale, l’individuazione del c.d. punto K, che consente di conoscere, con dati approssimativi, il passaggio che conduce il soggetto nella fase denominata “passaggio all’atto criminale”. In sostanza, man mano che la sindrome da astinenza aumenta, il fattore temporale (tempo), diventa nullo, in quanto lo stato di assenza della coscienza tenderà ad estraniarsi dalla realtà, e necessariamente all’assenza dal tempo e dallo spazio (A. Silvestri, Il punto K, I.S.G, 2000). Più frequente è, invece, la criminalità indiretta, in cui si individua una correlazione mediata con la droga (soprattutto eroina). In questo caso, ci si trova di fronte, spesso, a uno stato di dipendenza da oppiacei grave, associato a un’alterazione dell’introiezione normativa morale. In particolari condizioni personali e sociali, l’eroinomane, può adottare comportamenti tipici di un delinquente abituale: le vessazioni e le estorsioni verso i familiari, e ben più spesso i furti, le aggressioni, le rapine, gli scippi, la prostituzione, lo spaccio di stupefacenti al minuto sono, in questi casi, i mezzi utilizzati per procacciarsi il denaro. Si tende, dunque, ad attribuire a tali soggetti una particolare pericolosità sociale, sia per l’elevato numero e costo per la collettività dei reati contro la proprietà, sia per la diffusione capillare delle attività di spaccio. Vi è, anche, tra droga e criminalità, una correlazione ambientale: vi sono, cioè, alcuni contesti sociali dove il consumo di droghe è particolarmente intenso e dove confluiscono i tossicomani; spesso, sono aree urbane dove anche la criminalità comune è uno degli aspetti strutturali tipici. Va osservato, comunque, che fra i delinquenti comuni, l’uso di droghe è molto diffuso (di eroina e anche di cocaina) e che, in certe aree di delinquenza comune, molti delinquenti abituali, divengono tossicomani; questa condizione può chiamarsi tossicomania dei delinquenti, accanto a quella della delinquenza dei tossicomani. Questa distinzione risulta comunque piuttosto artificiosa nel contesto quotidiano, in quanto, si osserva, quasi, una sovrapposizione dei modelli comportamentali segnalati. I delitti compiuti dai tossicomani in connessione con l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti possono collocarsi in tre categorie ben distinte: - delitti specifici, in violazione del T.U. 309/90; - delitti compiuti sotto l’azione di sostanze stupefacenti; 274 Droga e alcool nell’agire delittuoso - delitti compiuti allo scopo di procurarsi sostanze stupefacenti o i mezzi per acquistarle. I delitti specifici, frequentemente compiuti dai tossicomani in violazione del T.U. 309/90, si riferiscono alla detenzione illecita di stupefacenti, in quantità non modiche per uso proprio, o in quantità per uso altrui. La norma consente, cioè, la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti e colpisce il tossicodipendente che, per alimentare la sua abitudine, si dedica al piccolo spaccio di stupefacenti, che è, probabilmente, il delitto di più frequente riscontro, fra quelli commessi in violazione della legge speciale. Un altro delitto relativamente frequente, ma difficilmente dimostrabile in concreto, è rappresentato dall’induzione all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 76): è, appunto, questo delitto che alimenta il proselitismo. Secondo Ponti, si possono rilevare alcuni tipi di carriera criminale che ricorrono con frequenza: - soggetti che hanno conservato l’integrazione sociale: fanno uso di canapa, passano alle amfetamine, qualche volta agli oppiacei: la presunzione della loro pericolosità è immotivata; - soggetti inseriti nella sottocultura dei drogati: l’appartenenza ad una specifica associazione differenziale costituisce un alto rischio di criminalità e gli appartenenti ne subiscono le conseguenze; - i dipendenti da eroina: essi stanno divenendo, nella quasi totalità, autori abituali di atti criminosi, trovando solo nel delitto la possibilità di reperire i mezzi per procurarsi la droga. Le sostanze stupefacenti interferiscono con le funzioni psichiche e possono alterare la capacità di intendere e di volere (art. 85 del codice penale). Si distinguono: a) intossicazione acuta: in riferimento agli articoli 92 e 93 del codice penale, si ha che lo stato di intossicazione acuta da sostanze alcoliche o stupefacenti, che non derivano da caso fortuito o da forza maggiore, non ha rilevanza sull’imputabilità. Quindi per quanto riguarda le droghe, il Legislatore attribuisce all’individuo la responsabilità della condizione in cui si viene a trovare. Gli atti compiuti in condizioni di non capacità di intendere e di volere sono la conseguenza di una scelta operata in condizioni di normalità psichica; b) intossicazione cronica: in riferimento all’articolo 95 del Codice penale, si ha che, per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 (vizio totale di mente) e 89 (vizio parziale di mente) del codice penale. Il tossicodipendente cronico può essere giudicato ma non necessariamente incapace di intendere e volere. L’intossicazione cronica, per essere riconosciuta come malattia e, quindi, vizio totale o parziale di mente, deve indurre un’alterazione psichica permanente. Tale concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con una sentenza del 1995: la psicopatia permane indipendentemente dal rinnovarsi dell’azione di assumere le sostanze psicotrope. Il perito clinico quindi deve cercare le alterazioni psichiche permanenti che devono essere documentate da un danno organico definitivo e non suscettibile di modificazioni anche con la sospensione della sostanza. 275 Criminologia ed elementi di criminalistica 12.5L’alcolismo L’alcoldipendenza o alcolismo è un fenomeno che si verifica in una percentuale di consumatori di alcolici, ed è caratterizzata dall’impossibilità di smettere l’uso di alcol, nonostante la persona si renda conto che quella sostanza (alcol etilico) le fa male e che quindi voglia smettere di assumerla. In altre parole, quella persona si trova a essere schiava dell’alcol e a non poterlo più controllare. Si possono fare diagnosi di dipendenza alcolica se ci si trova in presenza di almeno tre o più delle seguenti caratteristiche: 1. bisogno di dosi sempre più elevate di alcol per raggiungere l’effetto desiderato (aumento della tolleranza o assuefazione); 2. comparsa di malessere (fisico e/o psichico), se la persona non beve (sindrome di astinenza); 3. impossibilità di controllarsi nel bere; 4. desiderio persistente della sostanza e impossibilità di ridurne l’uso; 5. continua ricerca della sostanza, fino ad arrivare al punto che gran parte del suo tempo viene speso in questa ricerca o per riprendersi dagli effetti dell’intossicazione; 6. interruzione di attività lavorative, ricreative, contatti sociali, a causa dell’uso della sostanza; 7. persistenza nell’uso della sostanza, nonostante la consapevolezza delle conseguenze negative (fisiche, psichiche, sociali). L’alcolismo si sviluppa progressivamente in un periodo di tempo più o meno lungo (di solito anni), e comporta una serie di conseguenze a livello fisico, psichico e sociale. I danni possono colpire qualunque persona, di ogni età sesso e ceto sociale e possono colpire vari settori della vita di una persona. Si può parlare, infatti, di: - danni fisici epatici, neurologici, cardiaci, sessuali, e così via; - danni psichici come ansia, depressione, psicosi, disturbi di personalità, e così via; - danni sociali come perdita di lavoro, divorzi, violenza sui minori, incidenti stradali, infortuni sul lavoro, e così via. Fino a non molti anni fa, si pensava che l’alcolismo fosse un vizio, cioè un comportamento volontario negativo e quindi moralmente riprovevole. Negli ultimi anni, invece, è apparso sempre più evidente, in seguito al progresso delle conoscenze scientifiche sull’argomento, che la dipendenza da alcol è dovuta, non tanto alla mancanza di volontà del soggetto, ma a una serie di fattori che possiamo raggruppare in: - fisico-genetico, metabolici, neurologici; - psichici: disturbi psichici di varia natura che provocano sofferenza e facilitano la ricerca dell’alcol come conforto; - sociali: cultura del bere, pressione sociale, abitudini e stile di vita. 276 Droga e alcool nell’agire delittuoso Ciascuno di questi fattori, da solo, non è in grado di creare disturbo, e, quindi, perché il problema si manifesti, è necessario che siano contemporaneamente presenti più fattori come condizione predisponente, e che sopravvenga una causa occasionale scatenante. Una volta che il disturbo è apparso, il suo mantenimento sarà reso possibile da altri fattori, cosiddetti perpetuanti, vale a dire da fattori che contribuiscono a far continuare il legame del soggetto con l’alcol. In base alle nuove conoscenze, sappiamo che il soggetto dipendente da alcol non ha più il controllo volontario sulla sostanza. I suoi comportamenti sono dettati da meccanismi che scattano automaticamente e lo rendono schiavo, impedendogli di staccarsi dalla sostanza, anche quando egli, si rende conto che è indispensabile farlo. È per questo motivo che attualmente gli studiosi considerano l’alcolismo una malattia, e non più un vizio. Nel vizio, è il soggetto che controlla l’alcol, nella malattia, è l’alcol che controlla il soggetto. Un tempo, l’alcolismo, essendo considerato un vizio, veniva solo biasimato e condannato. Ora che è apparso chiaro che si tratta di una malattia, viene affrontato come tutte le altre patologie, cioè, con la ricerca di rimedi efficaci per risolvere i tanti danni che provoca sia all’individuo che all’intera società. Negli ultimi anni, sono stati sviluppati molti programmi terapeutici che si sono sempre più affinati, permettendo di vedere risultati concreti che un tempo erano impensabili. Tali risultati costituiscono una realtà per tante persone che riescono a trarne beneficio, e al contempo, una fonte di speranza e di incoraggiamento per quanti sono ancora in preda alla dipendenza, ma che vogliono venirne fuori. Si può, quindi, affermare, senza dubbio, che l’alcolismo si può curare, anche se questo non significa che sia facile farlo. Questa malattia è caratterizzata, infatti, dal rischio costante di ricaduta, per cui, non basta smettere di bere, ma è fondamentale non ricominciare a farlo. Smettere può non essere difficile, ma continuare a restare in sobrietà non è altrettanto facile. Perché una persona possa curarsi, è indispensabile che abbia la spinta giusta a farlo, che sia, cioè, motivata correttamente. La motivazione scatta quando una persona si rende conto che l’alcol costituisce un problema e che non riesce a risolverlo da sola. Constata che la sua vita viene pesantemente condizionata da quella dipendenza e che i problemi che ne derivano gettano la persona stessa, e chi le vive accanto, in un vero e proprio inferno. Arriva un momento in cui non è possibile andare avanti a vivere in quel modo. Questo è il momento giusto per smettere. Per alcuni, purtroppo, questa consapevolezza non si verifica o arriva troppo tardi, e cioè, quando i danni sono ormai irreversibili. Spesso, la persona può tentare da sola di smettere ma, se non ci riesce, non deve demoralizzarsi, perché questa malattia è un macigno soffocante che la sovrasta; allora, è necessario chiedere aiuto ad esperti che possano fornire tutto l’appoggio e le conoscenze per affrontare il problema. 12.6Etilismo acuto e cronico L’intossicazione può essere acuta (alcolismo acuto) o cronica (alcolismo cronico). a) L’alcolismo acuto è dovuto all’effetto, dapprima disinibente e poi depressivo, dell’alcol sul sistema nervoso centrale; si distinguono tre quadri: 1. l’ebbrezza sempli277 Criminologia ed elementi di criminalistica ce, in cui, da un iniziale stato di eccitamento psicomotorio con euforia, senso di benessere, iperattività, si passa, gradualmente, a uno stato depressivo con ottundimento della coscienza, rallentamento ideomotorio, fino al sonno profondo o, in alcuni casi, al coma; 2. l’ebbrezza complicata, le cui manifestazioni, simili alle precedenti, sono più rilevanti; 3. l’ebbrezza patologica, caratterizzata da manifestazioni particolarmente intense o abnormi, che compare anche per dosi modeste di alcol e si osserva in caso di psicopatie, lesioni cerebrali, insufficienze mentali, epilessie. b) L’alcolismo cronico, dovuto all’abuso prolungato di alcol, comprende alterazioni della personalità e alterazioni psicotiche legate al danno cerebrale organico prodotto dall’alcol. Il deterioramento della personalità si manifesta con accentuazione di tratti del carattere, deficit dell’attenzione e della volontà, perdita di interessi, turbe dell’emotività, labilità dell’umore, comportamento sociale inadeguato, diminuzione della capacità di critica e di giudizio, turbe del pensiero e della memoria. La compromissione di tutte queste funzioni può condurre a un quadro di demenza alcolica. Tra le alterazioni psicotiche (o psicosi alcoliche), si possono osservare: il delirium tremens; il delirio di gelosia nei confronti del partner, spesso accompagnato da atteggiamenti diffidenti e aggressivi; encefalopatie carenziali, come la encefalopatia di Wernicke (quadro psicotico acuto con disturbi della coscienza, deliri, allucinazioni, ipertonia, discinesie ecc.) e la sindrome di Korsakoff (con perdita della memoria, disturbi della coscienza, discorsi sconnessi). Terapia Il trattamento dell’alcolismo nelle forme acute gravi (in particolare nel coma) prevede una terapia intensiva con tutte le misure di rianimazione; impiego di antibiotici, polivitaminici, soluzioni glucosate; con alcune cautele, si induce sedazione (particolarmente usate a tale proposito le benzodiazepine nella sindrome di astinenza). Nell’alcolismo cronico, il trattamento presenta maggiori difficoltà, per le implicazioni a livello organico, psicologico e sociale: fondamentali, sono la motivazione e la collaborazione del soggetto; a volte, si consiglia il ricovero in reparti specialistici. In questi casi, la terapia, si basa sull’abolizione dell’alcol, sulla disintossicazione, cioè sul trattamento della patologia organica (epatoprotettori, vitamine ecc.), e sul divezzamento, per annullare il desiderio dell’alcol e la dipendenza. Indispensabili sono, inoltre, azioni psicoterapiche individuali o di gruppo, nonché interventi psicosociali protratti in stretta collaborazione con l’ambiente familiare e sociale del soggetto. 12.7Relazione tra alcolismo e delitto Nonostante siano state condotte numerosissime ricerche sul legame tra abuso di alcool e condotte criminose, esistono, ancora, sul problema, dei luoghi comuni che vanno abbattuti. Risulta, infatti, fuorviante e privo di solido fondamento scientifico, ritenere esistente una sorta di predisposizione genetica, a carattere ereditario, nell’abuso di sostanze alcoliche. Anche il generico richiamo ad un presunto rapporto diretto tra 278 Droga e alcool nell’agire delittuoso abuso di alcool e criminalità è affermazione imprecisa ed incompleta. Vi sono, infatti, tutta una serie di reati che, per la loro stessa indole e commissione, necessitano di una lucidità di intelletto che non può avere un soggetto etilista. Alcune ricerche hanno, inoltre, dimostrato, come la relazione tra gli effetti dell’alcool e criminalità sfumi e venga mediata da molteplici variabili cognitive ambientali e socio-culturali. L’unica distinzione rilevante ai fini criminologici può essere fatta tra etilismo acuto e cronica intossicazione da alcool. Nel primo caso, la perdita dei freni inibitori e morali e del controllo delle pulsioni ha come diretta conseguenza quella di agevolare il soggetto a tenere condotte aggressive sia verbali che fisiche. Nel secondo caso, l’intossicazione acuta da alcol (o da stupefacenti) sia essa volontaria, colposa o preordinata non è, di per sé idonea ad eliminare l’imputabilità, fatte salve le ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore. Discorso a parte meriterebbe tutta la delinquenza colposa legata alla violazione delle norme sulla circolazione stradale a seguito di abuso di alcol. Sta di fatto che taluni casi di intossicazione acuta da alcol hanno pacificamente assunto, nell’ottica clinica, valore di malattia in senso proprio, senza che ciò abbia alcuna rilevanza dal punto di vista giuridico. Al criminologo spetta, dunque, il compito di superare queste differenze intrinseche, operando nella complessità e tentando di spiegare il fenomeno nella globalità della sua manifestazione e nelle sue conseguenze dal punto di vista sociale. 12.8Tossicomania e adolescenza I comportamenti a rischio adolescenziali possono essere considerati dei modi per provare sensazioni nuove e forti, con la componente relativa alla sfida e alla sperimentazione di sé. Negli ultimi anni, è aumentato considerevolmente, da parte della criminologia moderna, lo studio sui comportamenti ad alto rischio dei giovani adolescenti, comportamenti messi in atto da soli o in gruppo, segnalati perché contengono elementi di auto o etero-distruttività: lanciarsi da un ponte legati a un elastico senza misure di sicurezza; camminare sui cornicioni; attraversare torrenti in piena; guidare a forte velocità; sdraiarsi sulla riga di mezzeria di una strada; sfidarsi a chi si toglie per ultimo da una situazione pericolosa come: dai binari del treno, da uno scatolone in mezzo alla strada; a ciò si accompagnano, uso di sostanze stupefacenti o alcoliche. Il rischio che questi comportamenti hanno sulla salute può essere immediato, come nel caso della guida pericolosa, prima causa di morte in età adolescenziale, oppure, posticipato nel tempo, come nel caso dei disturbi dell’alimentazione, delle condotte sessuali a rischio, del fumo di sigarette, dell’assunzione di droghe e dell’abuso di alcol. In generale, correre dei rischi fa parte della norma in questa fase dello sviluppo; A. Tursz (1989), infatti, sottolinea la necessità di considerare gli aspetti positivi e funzionali del rischio che, per l’adolescente, può corrispondere a una volontà profonda di rinnovarsi, a un desiderio di indipendenza e di autonomia oppure all’esplorazione delle proprie capacità e dei propri limiti. 279 Criminologia ed elementi di criminalistica Jeammet (1991) sottolinea come la stessa fase adolescenziale potrebbe costituire di per sé un rischio, mettendone in evidenza la dimensione di crisi evolutiva corrispondente ad una esigenza di cambiamento puberale, psichico e psicosociale. Ciò che caratterizza l’adolescenza, statisticamente parlando, è infatti la presenza di alcuni compiti evolutivi specifici, che riguardano l’acquisizione di una identità sessuale stabile, il riconoscimento del sé corporeo, il distacco dal mondo infantile, la costruzione degli ideali. Bisogna, quindi, sottolineare come i comportamenti a rischio assolvono spesso, a questa età, funzioni ben precise, sebbene siano dannose dal punto di vista fisico, psichico e sociale, sembrano fornire all’adolescente una via di uscita alle insicurezze e alle incertezze sperimentate in questa fase della vita. Per quanto pericolosi per sé e per gli altri, essi potrebbero venire ricercati, perché permettono di raggiungere alcuni obiettivi che sono molto importanti per gli adolescenti, quali, ad esempio, l’affermazione della propria identità e la costruzione di relazioni sociali affettive. Molti ragazzi riescono a raggiungere questi scopi, attraverso strade adattive, senza mettere in pericolo il loro benessere fisico, psicologico e sociale; sono, quindi, in grado di gestire le ansie e i problemi della discontinuità, senza distruggere il loro senso di unità interiore; altri adolescenti, invece, non trovano altro modo per realizzare questi obiettivi, se non attraverso quelli che abbiamo definito comportamenti a rischio. Per affermare la loro adultità ed autonomia, essi ricorrono, allora, a condotte sessuali sconvenienti e, a volte, molto precoci, in opposizione alle norme sociali e/o familiari, ecc. (molte fra le condotte a rischio aiutano l’adolescente a sentirsi adulto facendo ciò che fanno i grandi). Inoltre, alcuni comportamenti specifici permettono anche l’identificazione con il gruppo dei pari: fumare sigarette, bere, avere rapporti sessuali come fanno i propri amici, permette loro di sentirsi al pari, facilitando, in tal modo, l’accettazione nel gruppo. Il gruppo dei coetanei ha, infatti, una funzione molto precisa e fondamentale per lo sviluppo e la crescita individuale: nei coetanei, il ragazzo ha modo di riconoscere meglio la propria identità di adolescente, ha una conferma di ciò che egli è per sè stesso e per gli altri e la possibilità di condividere con loro nuove norme e nuove esperienze. I conflitti e le crisi possono essere considerati una componente insita di questo periodo, una sorta di patologia latente che va seguita con attenzione e vigilanza allo scopo di evitare che essa si radichi nei meccanismi profondi di maturazione della personalità (Laufer, Laufer, 1986). Choquet, Marcelli, Ledoux (1993), sulla stessa linea, affermano che l’adolescenza stessa è un rischio, ovvero, che non ci sarebbe adolescenza senza assunzione di rischi, a tal punto che un’adolescenza silente, senza nessun colpo di testa, potrebbe anche insospettire. Jack (1989) ha osservato che l’assunzione di rischi e la sperimentazione in genere, durante l’adolescenza, sono considerati comportamenti normali perché aiutano gli adolescenti a raggiungere una sana indipendenza, un’identità stabile e una maggiore maturità. Ciò nonostante, l’assunzione di rischi sembrerebbe essere una delle maggiori cause di mortalità tra gli adolescenti soprattutto quando vittime di incidenti. L’autore osservò che anche le gravidanze adolescenziali sono spesso favorite dalla convin280 Droga e alcool nell’agire delittuoso zione di una sorta di immunità personale, rispetto alle conseguenze negative, come se gli incidenti, ad esempio, capitassero solo agli altri, come se si fosse superiori anche al contagio di malattie come l’Aids, insomma, come se gli eventi negativi reali della vita non riguardassero l’adolescente che, quindi, potrebbe ritenersi, sempre, al di sopra di tutto questo. Purtroppo, le cronache, così come anche i dati statistici, confermano il contrario. Ritenere che l’adolescenza comporti inevitabilmente manifestazioni comportamentali autolesive può indurre la convinzione che qualsiasi condotta bizzarra e pericolosa rientri nella normalità; adottando un punto di vista simile, il rischio è quello di minimizzare la gravità di certe manifestazioni e quindi di non prevenire e di compromettere l’avvenire dell’adolescente (Carbone, 2000). Una serie consistente di studi ha messo in rilievo che i comportamenti a rischio sono tra loro collegati; tali comportamenti includono il consumo di alcol, di tabacco e di droghe, il sesso non protetto, la guida pericolosa. Emerge, così, un altro aspetto molto importante dei comportamenti a rischio, questi non si presentano in modo isolato, ma si collegano in vere e proprie sindromi, o costellazioni, che comprendono differenti comportamenti (Bonino, Fraczek, 1996). Gli adolescenti sarebbero protagonisti di rapporti sessuali promiscui e non protetti, sono altresì coinvolti, rispetto ai soggetti non promiscui sessualmente, negli altri comportamenti a rischio. Nel sottogruppo dei promiscui, il consumo forte e abituale di tabacco riguarda il 37% dei soggetti, il consumo forte di alcol riguarda il 60%, e quello abituale di marijuana sfiora il 44%. Ma anche la guida pericolosa e la devianza sono più frequenti fra gli adolescenti promiscui rispetto ai non. Si riscontrano risultati analoghi anche esaminando la ricerca sul consumo di sostanze: gli adolescenti che usano abitualmente marijuana, sono in maggior misura forti bevitori, forti fumatori di sigarette e sono maggiormente coinvolti nella guida pericolosa e nell’attività sessuale a rischio. Anche la guida spericolata, così come quella in condizioni psicofisiche alterate, non si presenta come un comportamento isolato, ma è legata ad altri comportamenti a rischio. La metà dei soggetti che guidano pericolosamente è altamente implicata anche nell’uso di sostanze psicoattive e nelle condotte devianti. All’interno del gruppo dei soggetti che guidano infrangendo il codice penale (poiché guidano in condizioni psicofisiche alterate) e che rappresentano il 10% del campione totale, i 2/3 fumano sigarette e consumano alcolici, i 3/4 fumano spinelli e, inoltre, sono maggiormente coinvolti in forme persistenti di devianza. 281 CAPITOLO 13 La criminologia clinica 13.1 Introduzione La funzione predominante della Criminologia clinica o applicata è quella di integrare e far dialogare le scienze criminali con le scienze dell’uomo. La sua utilizzazione pratica si riversa, soprattutto, nell’ambito della giustizia penale, dove fornisce contributi interpretativi sulle dinamiche psicologiche e sociologiche, che sono alla base del comportamento criminale, orientando, così, l’opera di applicazione della norma da parte del giudice. Il termine clinica è mutuato dalla scienza medica e si riferisce all’insieme degli interventi del criminologo che tendono a riconoscere, interpretare, curare e prevenire i comportamenti illegali nel singolo individuo e che si riflettono nella società, costituita da altri individui. L’applicazione delle conoscenze della criminologia clinica si estrinseca, pertanto, nelle seguenti dimensioni: a) nella fase processuale, nella quale fornisce apporti sulla personalità dell’imputato, così che il giudice possa disporre degli elementi conoscitivi (componenti soggettive del singolo caso) per la migliore individualizzazione della sanzione; b) al momento dell’esecuzione, mediante l’osservazione scientifica del condannato, tecnica che, dalla magistratura di sorveglianza, viene utilizzata per l’individualizzazione delle modalità secondo le quali la pena dovrà essere eseguita (es. affidamento al servizio sociale, semilibertà, eccetera). L’osservazione tiene conto delle caratteristiche personologiche, situazionali, microsociali e di pericolosità del soggetto. Attraverso l’osservazione scientifica della personalità in prospettiva criminologica è possibile acquisire informazioni su: 1. criminogenesi (caratteristiche individuali e sociali che hanno avuto peso nella scelta delittuosa); 2. criminodinamica (meccanismi interiori che hanno condotto al delitto); 3. predizione (prospettive future di recidiva o di risocializzazione efficace); c. durante la detenzione: per indirizzare tecniche di trattamento risocializzativo. L’osservazione criminologica prende, quindi, in considerazione i tratti della personalità del soggetto, le caratteristiche dell’ambiente sociale dove il soggetto è inserito e il significato che psiche e ambiente hanno avuto nei confronti del comportamento delit283 Criminologia ed elementi di criminalistica tuoso del singolo soggetto osservato. Comunemente, si articola in una fase diagnostica e in una fase prognostica. La fase diagnostica viene eseguita, solitamente, mediante i seguenti strumenti: • colloquio criminologico; • reattivi mentali (di efficienza intellettiva e di personalità); • inchiesta sociale (condotta dall’assistente sociale) sull’abituale ambiente di vita del soggetto; • esame comportamentale fatto dall’educatore (atteggiamento nei confronti della disciplina carceraria); • dati documentali (curriculum criminoso, sentenza di condanna, precedenti sentenze). La fase prognostica o predittiva rappresenta un momento di grande responsabilità etica e morale per il criminologo, poiché può generare due tipi di errore di valutazione: il falso positivo (quando si valuta il soggetto potenzialmente pericoloso e invece non lo è) e il falso negativo (quando si valuta il soggetto non pericoloso e invece esso si mostra recidivante). La valutazione prognostica del criminologo si basa, normalmente, sui seguenti fattori: a) risultati dell’osservazione; b) parametri (famiglia di origine disastrata, carriera criminosa, tossicodipendenza, ecc.); c) ricerche criminologiche pregresse; d) sistemi predittivi statistici. Per una predizione equilibrata emerge, nell’esperienza clinica, la necessità di un giudizio integrato che si basi quindi sia su parametri statistici che sulle caratteristiche individuali emerse dall’osservazione. 13.2L’osservazione criminologica: il colloquio Il criminologo clinico, nell’esame della personalità, deve agire come il ricercatore scientifico (ossia, colui che ricerca per conoscere), non interessato ai problemi del bene e del male, del giusto o sbagliato, del meglio o del peggio (sono compiti che spettano al giudice o ad altre professioni), ma deve ancorare il suo compito a criteri di scientificità: limitarsi a valutare le affermazioni d’ordine categoriale e non normativo, vale a dire occuparsi di quelle affermazioni concernenti ciò che è, non ciò che dovrebbe essere. La criminologia clinica nulla può decidere su come la società (o anche la vita, quindi, il futuro stesso del paziente osservato) dovrebbe proseguire il suo cammino, e non opera in senso pedagogico su questioni attinenti la criminologia sociale o la politica criminale. È questo il canone che distingue la criminologia clinica, ancorata in senso epistemologico a dei criteri di scientificità, dalla criminologia sociale, dalla sociologia, dalla psicologia, dalla psichiatria, dalla religione, dall’etica sociale e dalla filosofia politica e sociale. Il criminologo clinico, che agisce come il ricercatore scientifico, usa criteri di obiettività e di neutralità etica. Per obiettività si intende che le conclusioni cui si perviene come risultato dell’indagine e della ricerca sono indipendenti dalla razza, credo, profes284 La criminologia clinica sione, nazionalità, religione, preferenze morali e propensioni politiche del ricercatore, anche se questo tipo di obiettività è difficile da raggiungere alla perfezione, perché il ricercatore deve sempre fare i conti con i pregiudizi sociali e anche di quelli propri della sua personalità. La neutralità etica implica che lo scienziato, nel suo ruolo professionale, non debba schierarsi nell’ambito di questioni di significato morale o etico. Lo scienziato, in quanto tale, non ha preferenze etiche, religiose, politiche, letterarie, filosofiche, morali. Il fatto che egli abbia delle preferenze come cittadino, rende ancora più importante che egli se ne liberi come scienziato. In tale qualità, egli è interessato non a ciò che è giusto o sbagliato, bene o male, ma soltanto a ciò che è vero o falso (Bierstedt R., 1957; Fortunato S., 2000). Nell’osservazione scientifica della personalità, si deve distinguere: a) il delinquente dal criminale; b) il delinquente (o il criminale) occasionale da quello patologico; c) il detenuto in luogo (in attesa di giudizio o meno) dall’autore di reato (Pisapia G.V., 1987). Il colloquio criminologico clinico deve rispondere a: problemi diagnostici (di criminogenesi e criminodinamica), prognostici (previsioni di comportamento futuro) e d’indicazioni di trattamento criminologico (Merzagora I., 1987); inoltre, per quanto sia difficile da raggiungere, deve prefiggersi uno scopo di risocializzazione: ossia, far rinascere in un detenuto il desiderio di essere parte della comunità umana fargli lentamente ammettere o tollerare il punto di vista di un’altra persona (Balloni, Sabattini, 1971). Nel porsi l’obiettivo della risocializzazione, il criminologo clinico si differenzia dallo psicologo o dallo psichiatra o da altre figure professionali che studiano la psiche. Il compito sociale professionale dello psichiatra è di occuparsi della prevenzione e cura della patologia; quello dello psicologo è la prevenzione; dello psicoterapeuta, della cura dei malati di spirito, compiti necessari ma insufficienti per capire il crimine: sia perché, spesso, la cura non cura; sia perché la prevenzione è già di per sé un terreno minato; sia perché, in sintesi, sono saperi (teorie) che hanno poco o nulla di scientifico in senso epistemologico delle scienze. Pensiamo a quanto possa essere pericoloso o prevedibile, nello studio dell’osservazione scientifica della personalità, ricorrere alla psicoanalisi per scavare nell’inconscio (ipnosi, interpretazione dei sogni, ecc.) per fini prognostici. Oppure, porsi in termini psicoterapici con il detenuto che, come tecnica, porterebbe ad un inevitabile transfert tra analista e analizzato, a causa delle condizioni di rigorosa disciplina e ordine imposti dal carcere, per la rottura con il mondo esterno, per la fragilità psicologica che da tutto ciò deriva, e così via; o ancora, porsi in termini psichiatrici, cercando di dare una spiegazione biologica o farmacologica (o entrambe) al comportamento umano, che porterebbe a vedere correlazioni causali anche tra il caldo torrido dell’estate e l’aggressività, quindi a psichiatrizzare il trattamento. Con questo, non si vuole negare l’importanza del ruolo dello psicoanalista, dello psicoterapeuta o dello psichiatra, che possono e devono collaborare in tandem con il criminologo clinico, ma si deve sempre tenere conto che la natura del colloquio criminologico è diversa da quella terapeutica o psichiatrica, in quanto non abbiamo un paziente che chiede di essere curato o aiutato, ma è lo Stato che chiede al criminologo clinico di osservare in termini scientifici la personalità del detenuto. Inoltre, la terapia (psicologica) o la cura (psichiatrica) si pongono sempre l’obiettivo di guarire il paziente, ma, mentre nella terapia o nella cura è il paziente che si sot285 Criminologia ed elementi di criminalistica topone spontaneamente ad esse e si attende dei risultati (impegnandosi in cambio ad osservare la terapia stessa o la cura), in carcere, invece, il detenuto non richiede nessuna terapia né cura, e lo stesso colloquio criminologico, ai fini del trattamento, è imposto o suggerito, ma non scelto di sua iniziativa (come avviene quando ci si rivolge allo psicologo o allo psichiatra). Inoltre, l’opera dello psicologo e dello psichiatra viene, ancora oggi, vista con particolare scetticismo, permeata da diffidenza, e forse da paure inconsce. Il criminologo clinico è distante da tali figure professionali perché egli non deve orientare la sua azione al fine di conformizzare la personalità del detenuto, né deve cercare di minimizzare i guasti che un sistema ingiusto produce ai danni di persone socialmente sfavorite (Bandini, Gatti, 1987). In altre parole, non deve né psicologizzare né psichiatrizzare la personalità del detenuto per fini trattamentali o altro (Fortunato S., 2003). L’indagine (diagnosi e prognosi) del criminologo clinico è prettamente criminologica, e il colloquio ha fini valutativi, poiché quel che in realtà sarà oggetto d’indagine peritale potrà riguardare il giudizio diagnostico e prognostico per l’idoneità o meno a fruire di misure alternative alla detenzione, il tipo della misura che è preferibile adottare, l’opportunità di avere licenze premio, la convenienza di sottoporre il soggetto a un regime di sorveglianza particolare; e, in generale, vari quesiti che l’Autorità giudiziaria o la Magistratura di sorveglianza ritengano utile e possibile porre. (Marzagora, I, 1987). Il colloquio criminologico è obiettivato, in primis, alla raccolta dei dati: 1. generalità ed informazioni: data e luogo di nascita, parto e svezzamento, normalità, precocità o ritardo nello sviluppo, prime fasi di vita fisiologica (linguaggio, cammino); 2. notizie sulla famiglia di origine: livello di istruzione, situazione economica e sociale, occupazioni, interessi, esistenza di fratelli e sorelle, età e caratteristiche, rapporti con loro, sentimenti o risentimenti, conflitti, senso di superiorità o inferiorità, ammirazione e identificazione; 3. atmosfera familiare: ricordi sui genitori nei primi anni di vita, i rapporti dei genitori fra loro e dei genitori con il soggetto, attaccamento alla famiglia, preferenza per un genitore o per un altro, giudizio sui genitori, disciplina familiare, la famiglia come fonte di conforto e di sicurezza; 4. atteggiamento nei giochi e con gli altri bambini (cooperativo, aggressivo, importuno, timido, passivo, ecc.); 5. carriera scolastica: età di inizio e fine della scuola, motivi interruzione studi, classi ripetute, rapporti con i compagni e con gli insegnanti, atteggiamento nei confronti dello studio; 6. atteggiamento verso il gruppo dei pari, figure di identificazione; 7. ambizioni e ideali adolescenziali e giovanili; 8. il servizio di leva; 9. disciplina, frustrazioni, ecc.; 10. esperienze sentimentali e sessuali, legami affettivi, matrimonio, atmosfera coniugale, difficoltà, accordo o disaccordo, separazioni o divorzi; 11. i figli e i rapporti con loro. Malattie, infortuni, precedenti psicopatologici, loro importanza nella vita di relazione e lavorativa; 12. carriera lavorativa, costanza o meno nel lavoro, interessi extraprofessionali; 13.uso di alcool o di droghe; 14. difficoltà di adattamento; 15. scopi e aspirazioni per il futuro ideali e personali. (Marzagora. I, 1987). Secondo Bisio B. (1975), il colloquio criminologico si deve occupare di: a) indagare come il soggetto abbia ceduto all’azione dei motivi che su di lui hanno agito; b) determinare perché non lo hanno inibito altri motivi (sociali, individuali, morali, religiosi, giuridici, ecc.); c) ricercare come il soggetto è arrivato a concepire, e sotto quale aspet286 La criminologia clinica to, l’azione antisociale, dalla quale si è ripromesso la soddisfazione di un interesse; d) conoscere come è stata la preparazione e l’esecuzione del reato; e) passare allo studio del comportamento onde determinare come la personalità umana reagisce ai vari stimoli e nelle varie condizioni L’osservazione criminologica è fondamentale per la Magistratura di sorveglianza, oltre che per formulare il piano di trattamento, anche per fonrire alla magistratura di sorveglianza le informazioni sulla personalità per le decisioni relative alle misure alternative, sia per riferire alla direzione del carcere sulla personalità dei detenuti in vista di provvedimenti disciplinari o di benefici, sia, infine, per risolvere problemi di cattivo adattamento carcerario. L’osservazione scientifica della personalità consiste: 1) Momento diagnostico, che punta a conoscere i tratti di personalità e le caratteristiche socio-ambientali che consentono di ricostruire la criminogenesi e la criminodinamica. L’osservazione è eseguita da più persone con competenze diverse e le indagini si concretizzano poi in un giudizio collegiale, cui partecipa anche il direttore dell’istituto. a) Momento fondamentale di ogni osservazione è innanzitutto il colloquio clinico. Il suo scopo è quello di cogliere la criminogenesi, cioè di fornire una spiegazione di come abbiano interagito le caratteristiche psicologiche del soggetto con le sue particolari esperienze di vita, con i fattori sociali e ambientali e la particolare situazione al momento della commissione del delitto. Oltre a ciò il colloquio, punta a conoscere la criminodinamica: come è stato compiuto il singolo delitto o se si è sviluppato tutto un progetto di vita indirizzato al crimine. Non si indagano le modalità materiali di commissione dell’atto, ma l’intrecciarsi delle dinamiche psicologiche e il loro interagire nelle motivazioni. L’indagine è eseguita su mandato del sistema penale per fini di giustizia; l’osservatore non può schierarsi col soggetto come accade nel caso dell’alleanza terapeutica. Ciò comporta il rischio di mancanza di sincerità da parte dell’esaminato. b) L’osservazione può avvalersi di reattivi mentali che forniscono un ausilio, anche se il loro impiego, spesso, non consente di soddisfare i compiti ed i fini dell’osservazione criminologica, né di stabilire se il soggetto è sincero. Generalmente, vengono impiegati i seguenti tests: - di efficienza intellettiva, che permettono una valutazione qualitativa e quantitativa dell’intelligenza esprimendola con il QI (quoziente intellettivo); - reattivi di personalità, che consentono di valutare l’affettività, la capacità di adattamento, la maturità, le tendenze reattive, i modelli di identificazione, la capacità di sopportare le frustrazioni, i meccanismi di difesa, e così via; 287 Criminologia ed elementi di criminalistica c) l’inchiesta sociale è un’indagine condotta nell’ambiente naturale di vita del soggetto assumendo informazioni sul suo conto. L’analisi riguarda la famiglia, i gruppi frequentati dal soggetto, le relazioni esterne, lo stile di vita familiare, e così via; d) l’esame comportamentale descrive e analizza le modalità di condotta nei confronti della disciplina carceraria, dell’autorità, degli operatori e dei compagni di detenzione; A tale esame è delegato l’educatore che vive a quotidiano contatto con i detenuti ed è l’organizzatore di tutte le attività socializzanti all’interno della prigione, nonché, il tramite per i rapporti con l’esterno e della mediazione tra l’autorità e la comunità dei reclusi; e) è necessario, poi, conoscere i dati documentati delle precedenti vicende del soggetto, il curriculum criminoso, le informazioni della polizia, dei carabinieri, dei servizi sociali. 13.3 La prognosi delinquenziale La prognosi delinquenziale, come lo stesso termine indica, rappresenta uno strumento che consente una previsione in ordine alla possibilità del soggetto di ripetere certe esperienze devianti o, al contrario, di sapersi reinserire in maniera produttiva e socialmente accettabile nella società esterna. Si cerca, pertanto, di esprimere un parere finale complessivo sulla personalità del soggetto, così come si rileva al momento dell’osservazione, sulla natura e sull’entità del cambiamento eventualmente in lui verificatosi dal momento dell’ingresso in istituto, e sul modo in cui egli sembra proiettarsi nel futuro. Per ciò che attiene quest’ultimo aspetto, oltre che a considerare i propositi espressi dal soggetto stesso, si cerca di valutare, con obiettività, le sue effettive motivazioni, le sue capacità di revisione critica, le sue attitudini, cioè tutti quegli elementi che possono condizionare un autentico distacco dal mondo delinquenziale e un concreto processo riabilitativo. In questa prospettiva, si considerano, ovviamente, anche tutte le informazioni relative ai dati ambientali e, in genere, alle condizioni esterne che possano ritenersi importanti ai fini del reinserimento del soggetto. In base a tali valutazioni, appare possibile formulare un programma di trattamento che miri a potenziare gli aspetti positivi già esistenti nella personalità del soggetto osservato e, mediante opportune iniziative, cerchi di colmare le lacune e le carenze di vario grado e natura, che possano essere pregiudizievoli ai fini di un concreto processo maturativo. Occorre precisare, infine, che l’osservazione non può ritenersi conclusa con la chiusura del caso, vale a dire con l’elaborazione della sintesi finale e con la formulazione delle ipotesi di trattamento. Tecnicamente, la fase predittiva del comportamento delittuoso prevede un giudizio sull’eventualità del futuro reiterarsi del comportamento delittuoso. Il contributo del criminologo è limitato alla fase dell’esecuzione penale, mentre ogni predizione nel momento processuale è delegata esclusivamente al giudice. La previsione 288 La criminologia clinica è basata sulla statistica, tramite la quale si vanno a considerare, ad esempio, quali tratti sono frequenti in soggetti recidivi. Tuttavia, non è possibile sapere se il comportamento futuro del delinquente sarà conforme a quello indicato dalla statistica, e ciò, rientra nel campo delle incognite revisionali che dovranno tenere conto dei seguenti parametri: - la persona è dotata di liberta di scelta, per cui ogni predizione contiene necessariamente possibilità d’errore; - la formulazione di una predizione comportamentale negativa viene, entro certi limiti, ad influenzare a condotta futura. In concreto, la previsione del comportamento sociale può essere realizzata utilizzando molteplici parametri, per esperienza o per precedenti ricerche criminologiche ritenute più significative. Per quanto attiene la persona, alcune caratteristiche risultano negative, come: la bassa intelligenza, le anomalie reattive, i disturbi di personalità, la tossicodipendenza e l’alcolismo, l’incostanza nella carriera scolastica, le sfavorevoli condizioni socio-economiche gli ideali antisociali di vita, la precocità del disadattamento, l’inserimento in sottoculture delinquenziali. Per quanto riguarda la famiglia, sono negative: la disgregazione e la carenza affettiva. Per ciò che attiene la carriera criminosa sono indizi prognostici sfavorevoli: l’inizio precoce dell’attività delittuosa, l’alta frequenza e numero di recidive, la brevità dell’intervallo di libertà tra successive condanne, l’appartenenza a una sottocultura delinquenziale, la non occasionalità dei reati. Il giudizio deve tenere conto di tutta una serie di parametri (giudizio integrato). Il più noto dei sistemi predittivi è quello di Glueck che consiste nell’attribuire un diverso valore e quindi un diverso punteggio ai singoli parametri utilizzati per la predizione. Il punteggio attribuito a tali indici è il risultato del più frequente riscontro di tali caratteristiche in un gruppo di delinquenti, rispetto ad un gruppo di controllo di giovani con condotta regolare. Questo test comprende tre tavole: 1) I fattori predittivi legati alla famiglia: - - - - - sistema educativo del padre nei confronti del figlio; sorveglianza del minore ad opera della madre; atteggiamento affettivo del padre; atteggiamento affettivo della madre; coesione della famiglia. 2) I fattori predittivi caratteriologici (ricavati col Rorschach): - - - - - desiderio di affermazione sociale; sfrontatezza; diffidenza; tendenza distruttiva; labilità emotiva. 289 Criminologia ed elementi di criminalistica 3) La terza tavola comprende il tratti di personalità ricavati dall’esame diretto; - - - - - spirito d’avventura; tendenza al passaggio all’atto; suggestionabilità; caparbietà; instabilità emotiva. È bene precisare che ogni caso osservato viene sottoposto a revisione periodica e a un aggiornamento, soprattutto per valutare gli eventuali sviluppi degli aspetti della personalità più suscettibili di evoluzione, per prendere atto di possibili cambiamenti, e, soprattutto, per verificare il grado e la partecipazione del soggetto al programma di trattamento ipotizzato nella relazione finale. 13.4La pericolosità sociale Affinché sia possibile una prognosi di futura condotta criminale, il delitto si pone come condizione necessaria ai fini del giudizio di pericolosità, ma non sufficiente, dovendo la sua valutazione essere integrata con l’esame di tutti gli elementi attinenti alla personalità, all’ambiente e al comportamento del reo. L’art. 203 comma 2 c.p., stabilisce che la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’art. 133 Codice Penale. Di conseguenza, l’accertamento della pericolosità deve essere compiuto attraverso l’integrale ricognizione di tutti i fattori che riguardano non solo la gravità del reato, ma anche la capacità a delinquere del reo. I criteri individuati dal Legislatore sono, dunque, i medesimi previsti per la determinazione della pena. Tuttavia, è chiaro che i fattori che riguardano la capacità a delinquere del reo, visti in chiave prognostica, possono presentare un significato diverso da quello assumibile in chiave retributiva, in funzione del fatto che il reato commesso viene in rilievo non come tale, ma come sintomo di probabile futura recidiva. Gli elementi indizianti di pericolosità, rilevanti ai fini della capacità a delinquere del reo, sono, ai sensi dell’art. 133 c.p.: i motivi a delinquere e il carattere del reo; i precedenti penali e giudiziari e in genere la condotta e la vita del reo antecedenti al reato; la condotta contemporanea o susseguente al reato; le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Il codice penale del 1930, nella sua formulazione originaria, prevedeva due forme di pericolosità: la pericolosità accertata di volta in volta dal Giudice (art. 204 comma 1, c.p.); la pericolosità presunta dalla legge (art. 204 comma 2, c.p.). Nel primo caso, il giudizio di pericolosità viene integralmente rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, pur guidato dai criteri cardine dell’art. 133 del Codice Penale. L’accertamento giudiziale si articola nelle due fasi dell’accertamento delle qualità indizianti, da cui dedurre la probabile commissione di reati, e della prognosi criminale, ossia il giudizio sul futuro criminale del soggetto, effettuato sulla base di tali qualità. 290 La criminologia clinica Va inoltre precisato che, al fine di evitare di disporre l’applicazione di una misura di sicurezza a chi, pericoloso al momento del fatto, cessi di esserlo prima della conclusione del giudizio, la pericolosità va accertata con riferimento, non solo al momento della commissione del fatto, ma anche al momento in cui il giudice ordina la misura di sicurezza. E in base al principio nulla periculositas sine crimine, non può applicarsi una misura di sicurezza a chi sia divenuto pericoloso dopo il fatto per cause sopravvenute, dovendo esistere una interdipendenza fra pericolosità e reato, senza la quale manca il presupposto garantista perché scatti il sistema preventivo di sicurezza. L’art. 204 comma 2 c.p., nella sua originaria formulazione, prevedeva alcune rilevanti deroghe al principio di accertamento giudiziale della qualità di individuo socialmente pericoloso, stabilendo: “nei casi espressamente determinati la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge”. Nondimeno, anche in tali casi, l’applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all’accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato: dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi previsti dal primo capoverso degli artt. 219 e 222 c.p.; dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso. È altresì subordinata alla qualità di persona socialmente pericolosa, l’esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso previsto dal primo capoverso dell’art. 222, cinque in ogni altro caso. Si trattava, in tali casi, di presunzione di esistenza (cioè al momento del fatto) e di persistenza (cioè anche al momento della applicazione della misura). Dette presunzioni riguardavano i seguenti soggetti: a) i prosciolti per infermità psichica, per intossicazione cronica da alcool o stupefacenti, per sordomutismo o per minore età, se trattasi di delitto non colposo per il quale le legge commina l’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo edittale a due anni (art. 222 c.p.); b) i condannati, per delitto doloso o preterintenzionale, a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione da alcool o stupefacenti o per sordomutismo, quando la pena comminata dalla legge per il delitto non è inferiore nel minimo a cinque anni ( art. 219, comma 1 c.p.); c) i condannati alla reclusione per delitto commesso in stato di ubriachezza abituale o di intossicazione abituale da stupefacenti (art. 221 c.p.); d) i condannati per reato di ubriachezza abituale o per reato commesso in stato di ubriachezza abituale, agli effetti del divieto di frequentare osterie; e) i minori imputabili condannati per delitto commesso durante l’esecuzione di una misura di sicurezza cui erano stati sottoposti perché non imputabili; f ) i condannati alla pena della reclusione per almeno dieci anni; g) i condannati ammessi alla liberazione condizionale; h) i delinquenti abituali presunti (art.102 c.p.). In tutti i predetti casi, la fattispecie di pericolosità era costruita dal legislatore in via normativa, attraverso una presunzione iuris et de iure, che escludeva ogni facoltà di accertamento in concreto da parte del giudice. Il nodo problematico sul quale si gioca la stessa legittimazione sostanziale delle misure di sicurezza è rappresentato dal giudizio di pericolosità e dai criteri utilizzati per il suo accertamento. 291 Criminologia ed elementi di criminalistica Padovani afferma che sul piano strutturale esso differisce profondamente dal giudizio di responsabilità. Quest’ultimo è, infatti, di tipo diagnostico, nel senso che si basa interamente sull’accertamento e sulla valutazione di dati noti o comunque conoscibili. Il giudizio di pericolosità, invece, è di tipo prognostico, nel senso che, mentre l’accertamento si riferisce a determinati elementi che assumono valore indiziante, la loro valutazione è orientata prospetticamente in funzione di un dato sconosciuto, costituito dalla condotta futura del reo. La fondatezza del giudizio di pericolosità, secondo il Padovani, dipende pertanto da due fattori: 1) dalla rilevanza dei fattori indizianti; 2) dai criteri utilizzati nel procedimento di inferenza probabilistica . Nell’accertamento del giudizio di pericolosità, oltre al reato commesso, entra in gioco una serie di elementi indizianti, che il Padovani distingue in: elementi sintomatici reali ed elementi sintomatici personali. I primi gravitano intorno al reato, o perché ne implicano la reiterazione (come si verifica nella abitualità o nella professionalità, artt. 102 e 105 c.p.), o perché ne suppongono una particolare gravità (in astratto, come accade nell’art. 222, comma 1 e 2 c.p., per il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario; o in concreto, come nelle ipotesi in cui viene richiamata l’entità della condotta inflitta: ad esempio nell’art. 229, nº 1 e nell’art. 230, comma 1 nº 1 c.p., ai fini della sottoposizione alla libertà vigilata), oppure, infine, perché lo individuano come particolare tipo criminoso a rilevanza sintomatica privilegiata (come, ad esempio, nell’ipotesi dell’art. 538 c.p. che autorizza, e in certi casi impone, l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva a chi sia condannato per i delitti in materia di prostituzione). Gli elementi sintomatici personali, sono, invece, connessi alle peculiarità del soggetto, considerato in rapporto a dati caratteriali (come, ad esempio, l’essere dedito al delitto ai fini della abitualità ritenuta dal giudice ex art. 103 c.p.), a condizioni incidenti sull’imputabilità (come ad esempio nelle ipotesi dell’art. 222 c.p., per quanto riguarda l’infermità psichica, e dell’art. 224 c.p. per quanto concerne l’età), o alla condotta di vita (come nel caso dell’ubriaco abituale o della persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, art. 221 c.p.). Nella valutazione criminologica dei fattori indizianti, il Padovani sostiene che gli elementi sintomatici reali assumano un peso dominante rispetto agli elementi sintomatici personali, e che spesso i fattori indizianti reali sono assunti in una dimensione fortemente astratta, connessa a valutazioni di mera gravità edittale del reato commesso (come, ad esempio, si verifica nelle ipotesi degli artt. 219, 222, 224, comma 2 e 3 c.p.), senza alcuna considerazione per il concreto atteggiarsi dell’episodio criminoso nella personalità del soggetto. Questa accentuata propensione ad affermare il primato di valutazioni puramente legali nelle fattispecie sintomatiche di pericolosità deve considerarsi positiva, in rapporto al fatto che gli elementi indizianti reali servono a circoscrivere le situazioni tipo, in presenza delle quali, il giudice deve poi procedere all’ulteriore accertamento della pericolosità in concreto. L’unico rischio è che, attraverso una troppo rigida predeterminazione di limiti normativi astratti, finiscano con l’essere sottratti al vaglio di pericolosità soggetti in effetti pericolosi. È un rischio che consiste in sostanza nella formazione implicita di presunzioni di non pericolosità. Basti pensare, in proposito, alla ipotesi del prosciolto per infermità psichica da una contravvenzione, da un delitto colposo o da un altro delitto, punibile con la sola pena pecuniaria o con la reclusione non superiore nel 292 La criminologia clinica massimo a due anni (art. 222 comma 1 c.p., per il quale è in pratica preclusa ogni forma di intervento preventivo, anche se il reato commesso, pur nella sua ridotta gravità legale, consenta di evidenziare in rapporto alla infermità che lo ha determinato, una pericolosità molto elevata). Ma un tale rischio, secondo Padovani, può essere considerato il prezzo inevitabile che l’ordinamento deve corrispondere alla esigenza di tutela della libertà personale, quando la sua restrizione si prospetta come conseguenza di un giudizio prognostico inevitabilmente incerto. Tuttavia i rischi insiti in una tale regolamentazione erano di altra natura. La preponderanza di fattori indizianti reali non assumeva una funzione limitativa dell’accertamento di pericolosità, bensì una funzione costitutiva. Il meccanismo di applicazione delle misure di sicurezza si riduceva, nella maggioranza dei casi, al riscontro degli elementi indizianti, ai quali veniva collegato un significato sintomatico assoluto senza alcun accertamento in concreto della pericolosità. In tale prospettiva, dunque, la previsione di elementi sintomatici personali accanto ad elementi sintomatici reali, consentiva, raramente, di incidere sull’automatismo della conseguenza sanzionatoria, dato che, di norma, si trattava di elementi accertati in sede di valutazione della responsabilità, ed assunti nella fattispecie sintomatica di pericolosità in una dimensione aprioristica. Ad esempio, il prosciolto per infermità psichica, in quanto autore di un reato doloso punibile con la reclusione superiore nel minimo a due anni, era ricoverato per ciò stesso, in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.), a prescindere dal significato che l’infermità, rilevante per escludere l’imputabilità, assumesse in chiave prognostica di pericolosità. 13.5La vittimologia In criminologia, l’attenzione posta alla vittima e al suo ruolo, più o meno attivo o passivo che sia stato, è di fondamentale importanza per capire la genesi e lo sviluppo dell’evento criminale. Agli inizi della criminologia, l’attenzione veniva riposta completamente sul criminale o sull’azione deviante, mentre la vittima veniva percepita come totalmente passiva ed in balia degli eventi. Quando è stato rilevato che alcuni soggetti avevano avuto delle responsabilità per la propria vittimizzazione (ad es. avevano provocato l’aggressore oppure avevano ignorato dei segnali di pericolo), il focus di indagine si è spostato, comprendendo tutti gli attori della scena criminale. In un ambito criminale, può essere utile una definizione di vittima di questo tipo: quel soggetto che in maniera diretta o indiretta (ad es. attraverso minacce) ha subìto un danno fisico, psicologico o economico durante la commissione di un crimine. Le funzioni della vittimologia sono principalmente due: una funzione preventiva, con lo scopo di tentare di ridurre il numero di vittime e le circostanze contestuali nelle quali è più probabile essere vittimizzati (attraverso la ricerca e lo studio sulle specifiche proprietà bio-psico-sociali della vittima e del suo rapporto con l’aggressore), ed una funzione riparativa per ridurre gli effetti dei danni fisici e psicologici arrecati grazie allo studio degli effetti sulla vittima riscontrabili sia a breve che lungo 293 Criminologia ed elementi di criminalistica termine. La vittimologia, dunque, studia la sfera bio-psico-sociale della vittima, ma anche il rapporto da essa avuto con il proprio aggressore, il contesto ambientale (fisico e psicologico) entro il quale è stata compiuta un’azione criminale e, nel caso di vittima sopravvissuta, le conseguenze fisiche (danni biologici), psicologiche (traumi a breve-medio-lungo termine) e sociali (reazioni del gruppo primario, come la famiglia, del gruppo secondario come ad es. gli amici, e delle agenzie di controllo come le forze di polizia o i tribunali). Tornando alle origini, la vittimologia nasce nel 1948, anno nel quale Von Hentig pubblica The criminal and his victim. Tra i suoi concetti fondamentali tre sono particolarmente importanti: criminale-vittima (non si nasce vittima o criminale, ma sono gli eventi a determinare i ruoli); vittima latente (per cui ci sono alcune categorie di vittime che, per fattori sociali o psicopatologici, hanno una particolare predisposizione ad essere vittimizzate); rapporto vittima-aggressore (per cui bisogna porre particolare attenzione al tipo di relazione esistente fra la diade). Un altro concetto fondamentale è quello discusso da Mendelsohn (1965), ovvero quanta responsabilità attribuire alla vittima all’interno dell’azione deviante. Nella classificazione vengono riscontrati diversi gradi di colpa: vittima del tutto innocente (come i bambini); vittima con colpa lieve e vittima per ignoranza (es. passeggero che, a bordo di un’auto, distrae il guidatore e, causando una sbandata del veicolo, questi rimane ferito e ucciso); vittima colpevole quanto il delinquente e vittima volontaria (come il suicidio nella roulette russa, il suicidio per adesione o in coppia, etc.); vittima maggiormente colpevole del delinquente (come nel caso della vittima provocatrice e della vittima imprudente); vittima con altissimo grado di colpa e vittima come unica colpevole (ad es. il criminale che aggredisce una persona e viene da questa ucciso per legittima difesa). Un’altra classificazione secondo la quale un soggetto può contribuire alla propria vittimizzazione viene compiuta da Sparks nel 1982 e prevede: la precipitazione, se la condotta della vittima incoraggia il comportamento del futuro aggressore (come ad es. la provocazione fisica o verbale); la facilitazione, ovvero se la vittima in maniera conscia o inconscia si trova in contesti a rischio (come, ad es., una persona che attraversa un punto della città di notte particolarmente malfamato); la vulnerabilità: la vittima è in pericolo per una sua particolare condotta o posizione sociale (ad es., alcune persone vengono mobbizzate sul posto di lavoro in quanto sottoposti non graditi); l’opportunità: se la vittima in quel particolare momento è una facile preda per l’aggressore (ad es., persone anziane che vanno a ritirare la pensione) e l’attrattività: ovvero la vittima è in possesso di un qualcosa che potrebbe richiamare l’interesse del criminale (ad es. un rappresentante di gioielli). Le modalità di vittimizzazione, ovvero quali sono i sistemi attraverso cui un aggressore può sottomettere un’altra persona, possono essere: abuso sessuale, abuso verbale, abuso emotivo o psicologico (attraverso, ad es., la denigrazione dell’altro, soprattutto nel lungo periodo, e la conseguente diminuzione di autostima), abuso spirituale (ad es., senso di tradire le proprie tradizioni religiose o quando la vittima pensa che la fede non lo protegga), abuso economico, abuso sociale (come scherzi esagerati, critiche eccessive e continuate, accuse false controllo costante dei movimenti del soggetto vittimizzato, ecc.). Fattah (1979) ha elencato una serie di parametri relativi alle vittime e alle loro pos294 La criminologia clinica sibilità di essere colpite: • • • • • • • • • • occasioni: strettamente collegate con le caratteristiche dei potenziali bersagli (individui, familiari, affari) e con le attività e i comportamenti di questi obiettivi; fattori di rischio: in particolare relativi a caratteristiche socio-demografiche, quali l’età e il genere, la zona di residenza, l’assenza di protezione, la presenza di alcool e così via; assalti motivati: gli assalitori, soprattutto non professionisti, non scelgono la loro vittima/obiettivo in maniera casuale, ma la selezionano secondo specifici criteri; esposizione: l’esposizione a potenziali assalitori e a situazioni e ambienti ad alto rischio aumentano il rischio di essere vittima di reati; legami: l’omogeneità delle popolazioni di vittime e autori suggeriscono che l’associazione differenziale è importante sia per la vittimizzazione sia per il reato e il comportamento criminale. Così, individui che sono a contatto sul piano personale, sociale o professionale con potenziali delinquenti, corrono un rischio più elevato di rimanerne vittime rispetto a coloro che non lo sono; ore e luoghi pericolosi: i rischi di vittimizzazione non sono distribuiti in modo uguale nel tempo e nello spazio. Ci sono momenti pericolosi come la sera, la notte inoltrata e i fine-settimana, e ci sono ugualmente luoghi pericolosi come quelli di intrattenimento, dove il rischio di essere vittima di determinati reati è più elevato rispetto all’abitazione o al posto di lavoro; comportamenti pericolosi: determinati comportamenti di tipo provocatorio aumentano il rischio di vittimizzazione violenta, mentre altri comportamenti caratterizzati da negligenza e superficialità aumentano le possibilità di una corretta vittimizzazione. Esistono comportamenti pericolosi che rendono questi atteggiamenti di per sé accattivanti in situazioni pericolose dove la propria capacità di difendersi e proteggersi nei confronti di attacchi è molto ridotta. Un esempio di queste situazioni è l’autostop; attività ad alto rischio: aumentano ugualmente le potenzialità di vittimizzazione. Fra queste, si trovano la ricerca di divertimenti, che può includere attività illecite e illegali. È risaputo inoltre che talune attività come la prostituzione portano con sé un potenziale di vittimizzazione più elevato della media; atteggiamenti difensivi e comportamenti prudenti: dal momento che numerosi rischi di vittimizzazione possono essere facilmente evitati, gli atteggiamenti della gente nei confronti di questi rischi possono influenzare le loro possibilità di vittimizzazione. Va da sé che coloro che corrono il rischio sono destinati ad essere vittimizzati con maggiore frequenza di coloro che lo evitano. Ciò significa che la paura della criminalità è un fattore importante nella riduzione della vittimizzazione di coloro che sono spaventati, per esempio gli anziani, che prendono più precauzioni, limitano le proprie attività diurne e notturne, riducendo così la propria esposizione e vulnerabilità alla vittimizzazione; predisposizione strutturale e culturale: esiste una correlazione positiva fra powerlessness e deprivazione e frequenza di vittimizzazione. Parimenti, stigmatizzazioni culturali e marginalizzazione aumentano il rischio di vittimizzazione, designando determinati gruppi come bersaglio giustificato o vittime culturalmente legittimate. 295 Criminologia ed elementi di criminalistica Lo studio della vittima, al di là dell’esatta interpretazione del fatto concreto e dell’accertamento delle responsabilità individuali, mira alla finalità della prevenzione del crimine. La prevenzione, oltre che con interventi sulla vittima, deve avvenire attraverso azioni sull’ambiente perché solo tali misure possono efficacemente influenzare il tasso di criminalità e di vittimizzazione. È più facile e realistico cercare di intervenire sul comportamento della vittima che sulla condotta del criminale, soprattutto se si prende atto che: la probabilità di divenire vittima di un crimine non è ugualmente distribuita fra tutti gli individui; le circostanze costituiscono una sorta di predisposizione specifica nei confronti di determinati reati e le predisposizioni specifiche possono distinguersi in funzione dell’origine, della loro permanenza nel tempo, della loro natura. Dunque, la vittimologia tende, a fini preventivi, a mettere a fuoco il comportamento vittimogeno dei soggetti e le occasioni sociali o tipiche che agevolano il delitto; inoltre, tende a responsabilizzarli per far sì che la loro negligenza non possa favorire condotte criminali, che potrebbero essere scoraggiate con una maggiore attenzione. A soddisfare tali esigenze può risultare utile innanzitutto un’attività informativa e divulgativa, già all’interno delle scuole. Questa conoscenza porrebbe l’individuo in condizioni di poter evitare quelle situazioni o quei comportamenti che possono esporlo a maggior pericolo. In tema di riparazione del danno subito dalla vittima, prevale l’aspetto economico, anche per il danno morale che si concretizza in uno stress psicologico, ma la sua entità è simbolica. Peraltro, il danno da stress psicologico, variando a seconda della vittima, rende più problematica una condanna al risarcimento. Di maggiore utilità risulterebbe, invece, la costituzione di centri d’assistenza che potrebbero aiutare la vittima a superare le difficoltà derivanti dal reato. Ecco perché è auspicabile l’introduzione o il miglioramento di alcune iniziative post-delictum, quali: prendersi immediatamente cura della vittima; evitare alla vittima inutili intromissioni mediche, della polizia, della stampa; dare consigli alla vittima per il risarcimento e la riparazione; offrire denaro per superare le prime necessità; assistere la famiglia in attività successive al delitto, come ad esempio i funerali; attivarsi presso le società di assicurazioni e incoraggiare la vittima a denunciare il fatto. Anche nell’ambito di organizzazioni sovranazionali hanno trovato una sempre maggiore considerazione il ruolo della vittima e soprattutto le esigenze di protezione della stessa. Nell’organizzare iniziative di aiuto alle vittime, è importante entrare nell’ordine di idee che bisogna cercare di dar loro quello di cui hanno bisogno e non quello che è preordinato o che noi riteniamo sia loro utile. Come viene ricordato da una delle associazioni che coordina le attività di chi si occupa di aiuto alle vittime, bisogna dare alle vittime l’appoggio che lo Stato, in tutte le sue strutture, centrali e locali, non ha il tempo di dare, vale a dire l’assistenza necessaria nell’immediatezza dell’accaduto e lungo il percorso-calvario della vittima con quella vittimizzazione secondaria che ne è appunto la caratteristica principale, a partire dall’indifferenza e dalla colpevolizzazione da parte di istituzioni, parenti della vittima, parenti e avvocati dell’autore. L’assistenza, diretta e indiretta, alle vittime, comprende quindi aspetti medici, psicologici, legali, burocratici, logistici, relativi alla prevenzione contro la rivittimizzazione. 296 La criminologia clinica è ugualmente importante sottolineare le opportunità relative all’informazione e alla sensibilizzazione di chiunque possa esserlo, dalle autorità centrali e locali per l’impianto di iniziative e la collaborazione in quelle già in atto, alle vittime, reali e potenziali, ai singoli ed alle associazioni per attività di volontariato, ai gestori dell’informazione per la presentazione corretta delle problematiche e la pubblicizzazione delle iniziative. 297 CAPITOLO 14 La violenza sulle donne ed i processi di vittimizzazione 14.1Le donne come vittime La violenza contro le donne rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più diffusa nel mondo: essa nega il diritto delle stesse all’uguaglianza, alla sicurezza, alla dignità, all’autostima e, inoltre, il loro diritto a godere delle libertà fondamentali. La violenza nei confronti delle donne esiste in tutti i Paesi, attraversa tutte le culture, le classi sociali, le etnie, i livelli di istruzione, di reddito e tutte le fasce di età. Nessun Paese può affermare di essere immune da tale fenomeno. A milioni vengono picchiate, aggredite, stuprate, mutilate, assassinate, private del diritto all’esistenza stessa. Nel mondo, almeno una donna su tre, nel corso della propria vita, ha subìto o subirà gravi forme di violenza. Sia in tempo di pace che in tempo di guerra, le donne subiscono atrocità, semplicemente per il fatto di essere donne. Nonostante il fatto che la maggior parte delle società condanni tale fenomeno, nessuna di queste può affermare di esserne indenne: l’unica diversificazione consta nelle forme e nelle tendenze esistenti nei vari Paesi o regioni. La realtà è che le violazioni contro i diritti umani delle donne vengono spesso tollerate come pratiche culturali oppure giustificate sulla base di errate interpretazioni di principi religiosi. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne del 1993, definisce la violenza sulle donne come “qualunque atto di violenza in base al sesso, o la minaccia di tali atti, che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali, o psicologiche, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata delle donne”. Questa definizione presenta la violenza nella sua dimensione di rapporto di forza tra i sessi, e parte dalla constatazione che la violenza contro le donne è uno dei principali meccanismi sociali tramite i quali le donne vengono costrette alla subordinazione dagli uomini. La definizione della violenza viene così ampliata, facendovi rientrare sia 299 Criminologia ed elementi di criminalistica le sofferenze fisiche che quelle psicologiche, compresa la minaccia di tali azioni, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà nella vita privata e/o pubblica. È violenza, ogni abuso di potere e controllo che si manifesti attraverso il sopruso fisico, sessuale, psicologico ed economico. Questi diversi tipi di violenza possono presentarsi isolatamente o, come spesso accade, combinarsi insieme, in modo che una forma di controllo apra le porte all’altra. Ciò accade, soprattutto, quando la vittima e chi usa la violenza sono legati da un rapporto affettivo (il partner, il padre, l’amico di famiglia ecc.). Anche nelle aggressioni subite da estranei, tuttavia, la violenza fisica si può accompagnare a minacce, umiliazioni e limitazione della libertà di movimento. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha suggerito di distinguere tre diverse forme di violenza perpetrata a danno delle donne: - violenza interpersonale, comprende quelle forme di prevaricazione che si consumano nei rapporti interpersonali quotidiani, sia all’interno delle mura domestiche sia in ambito extrafamiliare, spesso con finalità di sfruttamento sessuale; - violenza organizzata, che si concretizza in tutte le forme di violenza compiute all’insegna di motivazioni politiche, sociali ed economiche, rivolte spesso contro uno specifico gruppo etnico; - violenza auto-inflitta, la quale è generata dall’umiliazione subìta. Molte vittime tendono ad isolarsi volontariamente a seguito degli abusi subìti o a procurarsi ulteriori violenze, fino ad arrivare a veri e propri tentativi di suicidio, quasi per auto-punirsi, perché si sentono in colpa a motivo dei soprusi subìti. Sempre la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne, nella Risoluzione dell’Assemblea Generale, del dicembre 1993, così enunciava: “la violenza contro le donne è la manifestazione di una disparità storica nei rapporti di forza tra uomo e donna, che ha portato al dominio dell’uomo sulle donne e alla discriminazione contro di loro, ed ha impedito un vero progresso nella condizione delle donne”. La violenza contro la donna viene definita, sia dall’ONU che dalla U.E., violenza di genere, cioè una violenza che si annida nello squilibrio relazionale tra i sessi e nel desiderio di controllo e di possesso da parte del genere maschile sul femminile. La violenza di genere è rimasta a lungo invisibile: avveniva nell’ombra, in quanto coincideva con i valori dominanti, le tradizioni e le leggi a tal punto da rendere il fenomeno un fatto naturale, comune, normale. La violenza non è soltanto quella eclatante, quella dai titoli da prima pagina dei giornali, che indigna per i primi periodi ma che poi viene dimenticata; esiste un’altra forma di violenza, molto più diffusa e sicuramente meno rumorosa: la violenza quotidiana. Tale forma di violenza è tutto tranne che eccezionale: essa non si riferisce solo al campo della sessualità biologicamente intesa ma, spesso, attiene alle relazioni normali tra i sessi, quelle inserite cioè nella routine e nella quotidianità. È la violenza che si consuma dentro le mura di una casa o di un ufficio, ovvero in tutte quelle situazioni nelle quali una donna può essere provocata e indotta, con la violenza, ad assumere un atteggiamento o a svolgere un’azione. Secondo il rapporto di Sheila Henderson, presentato al Comitato per l’eguaglianza tra donne e uomini presso il Consiglio d’Europa (Lienderson, 1997), almeno una 300 La violenza sulle donne ed i processi di vittimizzazzione donna su cinque, subisce, nel corso della sua vita, uno stupro o un tentativo di stupro; quasi tutte le donne hanno subìto una o più molestie di tipo sessuale quali: telefonate oscene, esibizionismi, molestie sul lavoro e così via; infine, una su quattro fa l’esperienza di essere maltrattata da un partner o ex partner. A riguardo, la ricerca condotta a Napoli dall’ISERS (Istituto di Ricerche Sociali) nell’ambito del Progetto URBAN, ha evidenziato che il 66,2% dei maltrattamenti denunciati riguarda un partner maschile come autore, e che nel 78,8% il luogo ove si manifesta la violenza è la casa. Le statistiche comunitarie ci dicono, in base ad indagini sui dati inerenti i reati negli Stati membri, che in Europa, la violenza rappresenta la prima causa di morte delle donne nella fascia di età tra i 16 e i 50 anni e nel nostro paese si ritiene che ogni tre morti violente, una riguardi donne uccise da un marito, un convivente o un fidanzato. L’aspetto più inquietante della violenza contro le donne è il suo essere trasversale. A differenza di quanto solitamente pensato, né l’etnia, né l’età, né lo status sociale, né le condizioni economiche e culturali sono indicatori affidabili al fine di individuare luoghi di possibile violenza. Un dato sconcertante, soprattutto per chi ha giustificato, o meglio, ha dato una spiegazione della violenza sulla donna, individuando nella povertà e/o mancanza di cultura le basi della sua esistenza, è dato dai risultati che ci vengono forniti dai diversi Enti internazionali e non (ad esempio, Amnesty International) che si occupano di analizzare il fenomeno. Se per decenni, infatti, l’occidente ha sempre circoscritto la vessazione femminile nei confini geografici e sociali dei paesi in via di sviluppo e nella povertà, ora deve fare i conti con la realtà, che lo vede comparire sul banco degli imputati con l’accusa di non esserne esente. Anche la faccia bella del mondo, fatta di ricchezza e istruzione, di beni di consumo (spesso inutili) e paladina di politiche democratiche, ha qualcosa della quale vergognarsi: non più l’indigenza economica o l’assenza di istruzione possono essere considerate terreno fertile per la generazione dell’abuso e del maltrattamento femminile. Accanto al mostro, privo di cultura e istruzione, vi è un altro soggetto, istruito e benestante, spesso professionista o dirigente. È altrettanto falso che tale fenomeno riguardi solo alcune fasce sociali, quelle svantaggiate ed emarginate in realtà, questo è un fenomeno trasversale, che può riguardare chiunque: donne di ogni età, razza e classe sociale; così come di ogni età, razza e classe sociale sono i soggetti che attuano la violenza. Gli studi segnalano che la maggior parte degli episodi di violenza è posta in essere da uomini privi di particolari problemi legati all’alcool, alle droghe e ai disturbi psichici, e mostrano come la violenza non è da attribuire a uomini che nella loro storia familiare sono stati vittime e/o testimoni di violenza. Da una parte alcool, droghe e disturbi psichici non sono cause, ma elementi che possono far precipitare la situazione; dall’altra, gli studi dimostrano che non tutti i bambini, vittime o testimoni della violenza, diventino uomini violenti. Gli operatori che lavorano sul campo, da sempre, hanno sottolineato come, ancora oggi, sia impossibile stabilire, con certezza, le proporzioni del fenomeno. Non si può facilmente dare un quadro esaustivo dello stesso, infatti, i dati che emergono dai diversi studi svolti in materia, risultano piuttosto approssimativi, per via di quel meccanismo psicologico di autodifesa dimostrato dalle donne che le porta a non denunciare la propria condizione. 301 Criminologia ed elementi di criminalistica Tale situazione si può constatare con maggior frequenza nel caso della violenza domestica. Qui le cifre riflettono solo in modo molto limitato e approssimativo l’entità effettiva del fenomeno. Le indicazioni che la vittima fornisce a una ricercatrice o ad un agente di polizia, rispetto alle esperienze fatte in materia di violenza domestica, sono influenzate dai più svariati fattori: una donna può voler serbare il silenzio perché teme ulteriori repressioni; forse desidera dimenticare al più presto tutta la storia più che ottenere giustizia, e quindi ritiene opportuno non parlarne in modo da poter dimenticare tutta la vicenda molto più velocemente; spesso la stessa vittima si sente il vero e unico colpevole di tutta la faccenda, e ciò mostra la complessità della situazione che ella si trova ad affrontare. Simili situazioni contribuiscono a far sì che, accanto alla cosiddetta zona chiara, ossia ai fatti noti, vi sia sempre anche una zona oscura. E sull’entità di queste cifre oscure non è possibile dire molto. Innanzitutto, la violenza sulle donne non è un fenomeno limitato: i dati forniti dalle maggiori organizzazioni che si occupano della questione, mostrano l’esatto contrario. Alcune forme si trovano in molte culture: si pensi, per fare qualche esempio, allo stupro o alla violenza domestica; altre, invece, sono specifiche di alcuni contesti socioculturali, ad esempio, le mutilazioni sessuali o gli omicidi a causa della dote. La violenza agita contro le donne può essere occasionale, un evento isolato, oppure una situazione continua che si protrae nel tempo. In quest’ultimo caso non si esplica in forma singola, ma suole essere la combinazione tra diverse forme. Un esempio è rappresentato dalla violenza domestica dove intervengono generalmente violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica. Violenze diverse possono essere fra loro connesse: la violenza contro i figli, ad esempio, è spesso accompagnata da violenza domestica contro la madre. Non è neanche possibile a livello empirico misurare un cambiamento dell’entità delle violenze nel corso degli anni, a causa delle difficoltà che hanno impedito l’emergere del fenomeno. Il catalogo delle forme di violenza si è sempre più ampliato: oggi, vengono denunciati e scoperti nuovi fenomeni violenti che fino a non molti anni addietro erano considerati come dei comportamenti normali. Si tratta di situazioni che, in passato o in altre aree culturali, non venivano o non vengono affatto considerate come violenze, per esempio, lo schiaffo da parte del marito o, prima del matrimonio, dal padre, come misura educativa; oppure lo stupro nell’ambito della relazione coniugale. Ugualmente, la violenza nella sfera familiare era considerata una questione privata e non giustificava nessun intervento, sia esso pubblico che privato. Senza dubbio, oggi, è aumentata la percezione del fenomeno violenza, soprattutto quella che avviene in ambito familiare. Se rispetto a qualche anno addietro oggi si sente maggiormente parlare del fenomeno, ciò è da ricondurre, non ad un aumento della violenza in seno alla società ma, probabilmente, alla crescente visibilità del fenomeno, grazie all’attività delle varie associazioni che si occupano della questione ed ai mezzi di informazione. 302 La violenza sulle donne ed i processi di vittimizzazzione 14.2Le forme di violenza Al concetto di violenza deve essere attribuito un significato più ampio di quello strettamente legato all’esercizio del potere nella sfera sessuale in senso stretto. La violenza agita contro la donna è una forma di prevaricazione a tutto campo, caratterizzata dal fatto che è esercitata da un singolo uomo o da un contesto maschile su una donna. Diverse sono le forme di violenza che le donne, nelle varie culture, subiscono nel corso della loro esistenza e a qualsiasi età. Alcune di queste colpiscono la donna durante l’infanzia, ad esempio, l’infanticidio; altre, si presentano ancor prima, come l’aborto selettivo. Basti pensare alla Repubblica Popolare Cinese, all’India e alla Corea del Sud, dove alle donne non viene nemmeno garantito il naturale diritto alla vita a causa di una rigida disposizione che pretende di pianificare le famiglie tramite la politica del figlio unico e la preferenza assoluta per il maschio piuttosto che per le femmine, poiché queste ultime sono considerate un peso per la famiglia. Altre forme di violenza che subiscono le donne nel corso della loro esistenza e con l’aumentare dell’età sono i matrimoni precoci e forzati o le mutilazioni genitali femminili. Mentre, sono violenze che riguardano donne di qualsiasi età: le vessazioni fisiche, sessuali e psicologiche; lo stupro e l’incesto; lo sfruttamento della prostituzione ed in ambito pornografico; la tratta delle donne; la gravidanza forzata; l’uxoricidio. Inoltre, è bene distinguere due diversi aspetti del suo manifestarsi: da una parte vi è la violenza sessuale, dall’altra, la violenza domestica. Con quest’ultima espressione, si fa riferimento alle vessazioni commesse all’interno dell’ambito familiare, ovvero si indicano le sevizie da parte del coniuge, del padre o da parte di altri membri della famiglia. Rientra nell’ambito della violenza domestica anche quella agita dai datori di lavoro o amici della vittima. Ciò che caratterizza tale categoria di violenza non è il luogo dove la violenza viene agita, ma la particolare relazione che lega la donna all’aggressore: si tratta, appunto, di un legame sentimentale, che può essere una relazione di parentela o di amicizia. In genere, si svolge sulla scena dei rapporti familiari e, principalmente, dei rapporti di coppia. Questa tipologia di violenza ha come scopo quello di sottomettere la donna ed acquisirne il controllo. È questa la violenza più diffusa, quella più difficile da individuare e che arreca maggiori danni alla salute, sia in termini fisici che psichici, perché tende a diventare abitudinaria. Le forme di violenza domestica e quelle di violenza sessuale non sono proprie esclusivamente dell’una o dell’altra categoria di violenza, ma si possono presentare, ora nell’ambito dei rapporti familiari, ora all’esterno. Generalmente, però, si classificano tra le forme di violenza domestica: il maltrattamento psicologico, quello fisico ed economico, il comportamento persecutorio (c.d. stalking), le mutilazioni genitali femminili ed altre pratiche tradizionali pregiudizievoli per le donne. Se nell’immaginario comune, lo stupro viene compiuto da estranei, in genere di notte e per strada, la realtà, invece, ci mostra una diversa verità. La maggioranza degli stupri avviene ad opera di conoscenti. La violenza sessuale nei confronti delle donne, contrariamente ai luoghi comuni, viene agita nel 75% dei casi da parte di una persona conosciuta: marito, ex-marito, fidanzato, ex-fidanzato, partner, amico, conoscente, collega o datore di lavoro. 303 Criminologia ed elementi di criminalistica La materia ha ricevuto una nuova regolamentazione con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996, Norme contro la violenza sessuale. Una delle maggiori innovazioni apportate da tale legge è sicuramente l’introduzione di un unico delitto di violenza sessuale, regolato dall’art. 609-bis. Particolare forma di stupro è quella di gruppo. Il codice penale disciplina tale fattispecie all’art. 609-octies, 1° comma: la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis. Si caratterizza per essere il frutto di un preciso progetto diretto ad infliggere intenzionalmente alla vittima un grado di umiliazione molto elevato. Il gruppo rappresenta l’occasione per dare sfogo alla propria crudeltà. Il fatto di agire la violenza insieme ad altri soggetti comporta, per chi la compie, un minore senso di colpa. Le donne sono vittime di discriminazioni e di violenze sia in tempo di pace che in tempo di guerra; in quest’ultimo caso, la violenza carnale viene utilizzata spesso come un’arma. Lo stupro di guerra, soprattutto nei conflitti con un forte connotato etnico, come quelli nei Balcani, è il mezzo per umiliare e demoralizzare il nemico attraverso la distruzione e la denigrazione delle donne del suo stesso gruppo. Utilizzare lo stupro come un’arma di guerra è diventato oggi una strategia intenzionale di diversi gruppi combattenti in molti conflitti armati nel mondo. Amnesty International ha più volte sottolineato come la violenza colpisce in più modi le donne nei conflitti armati: le bambine soldato sono regolarmente stuprate dai propri commilitoni; le donne e le bambine estranee ai combattimenti vengono mutilate, stuprate e uccise come si trattasse di un’arma di guerra; il rientro dei soldati nelle proprie case produce un ulteriore aumento della violenza domestica. I conflitti armati stanno avendo un impatto devastante sulle donne, che va ben al di là della violenza insita nella guerra. Ricordiamo i fatti di cronaca nei conflitti che hanno avuto luogo in Bosnia Herzegovina e in Ruanda negli anni ‘90, che hanno attirato l’attenzione per il forte livello di atrocità commesso contro le donne. Nel 1993, il Centro per i Crimini di Guerra di Zenica, aveva documentato 40 mila casi di stupro in Bosnia, ma le cifre reali sono ritenute ben più alte. Gli omicidi, gli stupri sistematici e generalizzati così come le altre forme di violenza sessuale sono stati utilizzate con lo scopo di demoralizzare il nemico e di sterminarlo. Purtroppo, non solo i nemici si macchiano di tali forme di crudeltà. Durante i conflitti armati, le donne diventano vittime non solo della violenza da parte dei soldati nemici, ma anche di operatori di pace e di funzionari dei programmi di aiuto, cioè di coloro che dovrebbero invece assicurare la loro incolumità. Quando il conflitto cessa, purtroppo, quasi mai cessano, né diminuiscono le violenze. La violenza sessuale, soltanto di recente, viene riconosciuta come arma di guerra in ambito internazionale. Nell’ambito del diritto internazionale pubblico, infatti, vengono prese in considerazione le condizioni dei civili, i quali pagano in prima persona, molto spesso con la propria vita, le condizioni belligeranti. Con la Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 1949, nonché i Protocolli aggiuntivi relativi alla protezione delle vittime dei 304 La violenza sulle donne ed i processi di vittimizzazzione conflitti armati internazionali e non internazionali (rispettivamente Protocollo I e Protocollo II), entrambi del 1977, vengono vietati e considerati come crimini di guerra, indipendentemente dal fatto che vengano commessi da personale civile o militare, ogni forma di violenza contro: la vita, la salute o il benessere fisico o psichico dei civili, in particolare l’omicidio; la tortura, sotto qualsiasi forma, sia essa fisica o psichica; le pene corporali e le mutilazioni; gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; la prostituzione forzata e ogni forma di offesa al pudore; la cattura di ostaggi; le pene collettive e la minaccia di commettere uno qualsiasi degli atti sopra citati (art. 75 Protocollo I). L’art. 76 Protocollo I, nonché art. 27 Convenzione di Ginevra e art. 4 Protocollo II prendono in considerazione le donne, al fine di assicurare loro una speciale protezione, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore. Nel 1974, l’Assemblea Generale dell’ONU aveva chiesto, nella sua dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi d’emergenza e di conflitti armati, un divieto di attaccare e bombardare la popolazione civile. Donne e minori avrebbero dovuto essere risparmiati da tutti i conflitti armati, e in nessun caso si sarebbe potuto negare loro l’accesso ad alloggio, cibo, acqua, cure sanitarie ecc. I recenti fatti in atto in Libano mostrano come, a tali dichiarazioni di intenti e buoni propositi in tempo di pace, non scaturiscano effetti in tempo di guerra. Il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, il 22 febbraio del 2001, ha sancito che lo stupro etnico e la schiavitù sessuale, usati come strumenti di terrore, sono crimini contro l’umanità. Rientrano nelle forme della violenza sessuale, oltre allo stupro, anche le molestie sessuali, la tratta delle donne a scopi sessuali e le mutilazioni genitali femminili. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, oppure atto che possa creare ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti. Le molestie sessuali costituiscono una forma di discriminazione in base al sesso e si possono manifestare in varie forme. La forma verbale consiste in apprezzamenti verbali, aventi come oggetto la sessualità o il corpo femminile; la molestia relazionale consta in richieste, implicite o esplicite, di rapporti sessuali; quella visiva, quando consiste in sms offensivi, foto pornografiche lasciate in prossimità di oggetti di proprietà della donna, dello spogliatoio o delle toilette femminili; infine, quella fisica, consiste in contatti intenzionali con parti del corpo femminile. Si tratta, dunque, di comportamenti non graditi né sollecitati dalla donna. Rientrano nell’ambito della molestia, le offerte, implicite o esplicite, di agevolazioni o privilegi sul posto di lavoro in cambio di prestazioni sessuali, così come le intimidazioni, le minacce, i ricatti subìti dalla donna per aver respinto comportamenti maschili finalizzati al rapporto sessuale. È proprio l’ambiente lavorativo il luogo dove con più frequenza si verificano le molestie. Nel 1991, la Commissione Europea ha emanato una Raccomandazione sulle molestie sessuali in ambito lavorativo, alla quale è stato affiancato un Codice di buona condotta. Altra forma di violenza riguarda la c.d. tratta degli esseri umani. Ancora oggi, a causa delle ingenti somme di denaro che l’accompagnano, la tratta di essere umani è ampiamente praticata. Le vittime di questa moderna forma di schiavitù sono prevalente305 Criminologia ed elementi di criminalistica mente donne, sia adulte che bambine, le quali vengono destinate prevalentemente alla prostituzione e alla pornografia. Solitamente, si tratta di donne provenienti da Paesi poveri e in via di sviluppo che, attraverso la forza o l’inganno (magari con la falsa promessa di un lavoro), vengono sottratte dai loro luoghi d’origine per poi essere ridotte in schiavitù nei paesi occidentali. Spesso, tale sottrazione, avviene ad opera dello organizzazioni criminali locali. L’Italia è attivamente impegnata nella lotta contro il traffico di donne e bambini a scopi di sfruttamento sessuale. A tal riguardo, l’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 286 del 2003, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prevede la concessione di un permesso di residenza speciale alle vittime di questo commercio, e prevede la loro partecipazione ad un programma sociale di assistenza per l’integrazione. La durata del permesso di residenza è di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o più. Nel caso di tale forma di violenza sessuale esiste una forte correlazione tra discriminazione sessuale e discriminazione razziale, spesso poco discussa. In altre parole, il traffico di donne è stato accompagnato spesso da atteggiamenti razzisti, frequentemente indirizzati contro le donne appartenenti ad alcuni gruppi razziali ed etnici (per esempio, donne immigrate e indigene). Ciò significa che l’ideologia razzista alimenta la tendenza alla mercificazione della sessualità femminile. Quello della mutilazione genitale femminile è un tema complesso e doloroso, che comprende molti aspetti: le relazioni di genere, la sessualità, l’assistenza sanitaria, l’istruzione, i diritti umani, i diritti delle donne e dei bambini, il diritto allo sviluppo. Per mutilazioni genitali femminili (m.g.f.) si intendono una serie di pratiche, che mirano ad alterare la conformazione degli organi genitali esterni, non per finalità terapeutiche, ma per controllare il piacere e il corpo delle donne. Ogni definitiva e irreversibile rimozione di un organo sano è una mutilazione. In situazioni di normalità, infatti, non vi è assolutamente alcuna ragione medica, morale, o estetica, per sopprimere alcune o tutte le parti che compongono gli organi genitali femminili esterni. Viene effettuata, quasi sempre, in condizioni sanitarie abominevoli, senza anestesia e, soprattutto, su bambine, anche in tenerissima età. Gli effetti sulla salute sono devastanti, e colpiscono le donne in ogni momento della loro vita sessuale e riproduttiva. La mutilazione genitale femminile viene distinta in tre differenti forme: la circoncisione, la clitoridectomia e l’infibulazione. Gli strumenti impiegati per compiere la m.g.f. comprendono: coltelli, lame di rasoi, forbici e pezzi di vetro. Raramente vengono sterilizzati prima dell’operazione, e ciò comporta l’insorgere di cistiti, ritenzione urinaria, infezioni vaginali, oltre all’alta probabilità di contrarre l’AIDS. L’anestesia non è quasi mai impiegata. L’età della circoncisione varia tra i diversi gruppi etnici. In genere, nelle bambine, tra i tre e gli otto anni, ma può essere eseguita tra la prima settimana di vita e i venti anni di età. Ad esempio, in Etiopia, viene eseguita nell’ottavo giorno dalla nascita; in Egitto, dai tre agli otto anni, nella Tribù Masai, poco dopo il matrimonio. In alcuni casi, la pratica segue dei veri e propri riti con canzoni, danze, abiti speciali e cibo. Vi sono anche determinati periodi nei quali viene eseguita la mutilazione: nelle aree urbane, l’operazione avviene durante le vacanze scolastiche, in genere giugno o luglio per permettere alle ragazze di riprendersi dall’operazione; nelle aree rurali, il perio306 La violenza sulle donne ed i processi di vittimizzazzione do abituale è la fine della primavera o l’autunno, perché coincide con il termine della stagione piovosa, e le ragazze sono ben nutrite e in grado di tollerare l’operazione. La mutilazione genitale femminile è praticata, principalmente, in Africa e in Asia, ma è stata riscontrata anche in alcune regioni dell’America Latina (Perù, Brasile, Messico), tra le tribù aborigene dell’Australia e in Russia. Anche in occidente si assiste a tale fenomeno, infatti, gli immigrati africani hanno portato queste usanze negli Stati Uniti e in Europa, in particolare in Gran Bretagna. Anche se nessuna religione prevede espressamente tali pratiche, è proprio nelle religioni che esse trovano maggior vigore. La religione che maggiormente abbraccia tale pratica è l’islamismo, anche se è bene sottolineare che nessuna parte del Corano le menziona e che in nessuna parte può individuarsi una giustificazione. Infatti, non tutti i musulmani seguono il costume come, ad esempio, in Arabia Saudita, Iraq, Iran, Algeria, Marocco, Tunisia e Libia. Tale appiglio deriva dal fatto che l’islamismo, come la maggior parte delle altre religioni, considera la sessualità femminile come un istinto primario che deve essere controllato. La visione comune sostenuta dalle religioni è che la sessualità femminile deve essere controllata e che il sesso, avendo solo finalità riproduttive, deve essere praticato esclusivamente tra i due coniugi. La purezza sessuale di una donna rappresenta l’onore della famiglia, quindi, la rimozione degli organi genitali femminili esterni è un provvedimento atto a ridurre il desiderio sessuale, necessario per salvaguardare la verginità e l’onore della donna e per rafforzare la sua fedeltà. Viene inoltre considerata necessaria per impedire la masturbazione, proibita dalla legge islamica. Tale fenomeno non è diffuso solo tra gli islamici, ma anche tra i cristiani e gli ebrei. Poco hanno a che fare le religioni con tali pratiche: si tratta, infatti, di fuorvianti interpretazioni dei principi religiosi che hanno aiutato la sua legittimazione e che presuppongono una visione contorta della sessualità femminile. La m.g.f. viene giustificata, oltre che con la religione, anche con la tradizione e con false credenze. Ad esempio, in alcune tribù in Costa D’Avorio, si ritiene che la circoncisione intensifichi la fertilità, mentre, spesso, il risultato è l’opposto; altre tribù, come i Dogon del Mali, credono che la clitoride sia un organo pericoloso, perché si pensa che durante il parto, il contatto con la clitoride possa provocare la morte del nascituro; i Bambara del Mali credono, invece, che la clitoride possa uccidere un uomo se, durante il rapporto, entra in contatto con il suo pene; in Egitto, nel Sudan, in Somalia ed in Etiopia, considerano necessaria l’asportazione della clitoride per diventare puliti e puri. La mutilazione genitale femminile è, ancora oggi, ampiamente praticata. Sulla base di una quantità limitata di dati disponibili, si è stimato che, a livello mondiale, abbiano subìto mutilazioni genitali tra i 100 e i 132 milioni di ragazze. Ogni anno, si calcola che circa altri 2 milioni di ragazze, di solito bambine di età compresa tra i 4 e i 12 anni, subiranno una qualche forma di mutilazione dei genitali. I governi hanno, adesso, l’obbligo di adottare le misure necessarie per abolirla, quale effetto degli impegni, da loro assunti, sottoscrivendo la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. Anche lo Stato italiano si è trovato nella necessità di dover affrontare il fenomeno a causa delle numerose migrazioni degli ultimi anni. In Italia, vivono migliaia di don307 Criminologia ed elementi di criminalistica ne infibulate e, ogni anno, numerose bambine con genitori provenienti soprattutto dai paesi dell’Africa sub-sahariana rischiano di essere sottoposte a questo rituale. Sarebbero oltre 40 mila nel nostro Paese le donne che hanno subìto mutilazioni sessuali e, ogni anno, almeno 6 mila bambine di età compresa fra i 4 e i 12 anni sono sottoposte a questo tipo di violenza. Al fine di prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti, e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello all’integrità fisica, è stata emanata la legge n. 7 del 9 gennaio 2006, recante: disposizioni concernenti “la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminili, […] in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne […], così come dichiara l’articolo 1 della suddetta legge”. Tale norma prevede, all’articolo 6, l’introduzione nel codice penale di due nuovi articoli: l’art. 583-bis, intitolato: “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, che prevede la reclusione da 4 a 12 anni a carico di chi praticherà la mutilazione, e che tale pena verrà aumentata di un terzo se la mutilazione viene compiuta su una minorenne, nonché in tutti i casi in cui viene eseguita per fini di lucro; e l’art. 583-ter, pena accessoria. Il provvedimento prevede, inoltre, la predisposizione di campagne informative rivolte agli immigrati provenienti dai paesi in cui sono effettuate tali pratiche, in modo da diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona e il divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile. 14.3Donne e violenza intrafamiliare La violenza intrafamiliare si caratterizza per essere agita, di solito, da uomini che con le vittime hanno o hanno avuto un rapporto di fiducia, intimità o potere. Tale fenomeno annovera tra le sue vittime: figli, moglie, ascendenti in linea retta ed, eventualmente, gli altri membri della famiglia, quali fratelli o sorelle del coniuge. Tra le vittime della violenza, senza alcuna ombra di dubbio, i soggetti più indifesi sono i figli minori. Tra questi, le bambine si trovano a subìre, già da piccole, alcune forme di discriminazione. Si pensi, ad esempio, alle società nelle quali si attribuisce molto valore ai figli di sesso maschile; in tali contesti, la discriminazione contro le bambine può assumere forme estreme quali gli aborti per selezionare il sesso del nascituro. La conseguenza di tale provvedimento è stata una crescita sproporzionata dell’aborto selettivo dei feti femminili e, dunque, uno squilibrio numerico tra i sessi. Secondo i risultati del lavoro svolto dal Centro di Ricerca Innocenti dell’UNICEF, in India, sono stati rilevati 10.000 casi di infanticidio femminile all’anno. La cifra non prende in considerazione il numero di aborti effettuati al fine di prevenire la nascita di un bambino. Un’altra indagine ufficiale in Cina ha messo in evidenza che, con la politica del figlio unico, il 12% di tutti gli embrioni di sesso femminile viene eliminato con l’aborto o in altro modo. 308 La violenza sulle donne ed i processi di vittimizzazzione In molti Paesi in via di sviluppo, principalmente l’Asia del Sud, l’Africa del Nord, il Medio Oriente e la Cina, le bambine ricevono meno cibo dei bambini. In tali Paesi, la mancanza di attenzioni e di cure, provocata dalla discriminazione tra bambine e bambini, rappresenta la principale causa di malattia e di morte delle prime tra i due e i cinque anni di età. Non solo nei Paesi in via di sviluppo, ma anche nei paesi industrializzati, i soggetti della violenza familiare sono soprattutto le donne, coniugate o conviventi, i figli e gli ascendenti in linea retta. Per quanto riguarda la relazione marito-moglie, le maggiori violenze possono essere distinte in: psicologica, fisica, economica e sessuale. Di solito, la violenza che viene compiuta sulla donna, in ambito familiare, non è unica ma, contemporaneamente o in tempi successivi, convergono su di lei varie forme di maltrattamento. Si caratterizza, quindi, per essere un fenomeno abbastanza complesso: tutte le molteplici forme (sessuale, fisica, psicologica e economica) si intrecciano l’una con l’altra, tanto che risulterebbe alquanto difficile, nel caso concreto, individuare dettagliatamente le diverse forme. Il danno arrecato alla donna sarà tanto più irreversibile quanto più la violenza si protrae nel tempo e quanto più la vittima è isolata da una rete relazionale. È violenza fisica ogni forma di intimidazione o azione in cui venga esercitata una aggressione fisica su un’altra persona. Ma non riguarda esclusivamente quest’ultimo tipo di aggressione, che causa ferite richiedenti cure mediche di emergenza, ma anche ogni contatto fisico mirante a spaventare e a rendere la vittima soggetta al controllo dell’aggressore. Tali comportamenti possono essere evidenti, come spintonare, costringere nei movimenti, privare del sonno, bruciare con le sigarette, privare di cure mediche, rompere oggetti come forma di intimidazione, sputare contro, dare pizzicotti, tirare calci o pugni, strappare i capelli, l’essere chiusi in una stanza o fuori di casa, l’essere tenuti forzatamente svegli o minacciati con un arma; altre sono più sottili e si rivolgono a qualcosa a cui la donna tiene (animali, oggetti, vestiti, e così via), o ai mobili della casa, o a qualcosa che le è necessario (i documenti, il permesso di soggiorno). Si tratta di vere e proprie dimostrazioni di forza o di crudeltà. Tra i maltrattamenti fisici rientrano, pure, le pratiche tradizionali che recano danno alle donne: mutilazione dei genitali femminili e l’ereditabilità della moglie (la pratica di trasmettere in eredità la vedova e tutte le sue proprietà al fratello del marito deceduto). In definitiva, per violenza fisica si intende ogni forma di aggressione contro la donna che abbia per oggetto il suo corpo e le sue proprietà. Nessuna di tali forme può e deve essere sottovalutata, e deve essere valutata all’interno del contesto dove si compie. L’aggressore agisce senza un motivo ben determinato, ciò mette la vittima in una situazione di soggezione continua, poiché, non sa mai in quale momento verrà aggredita e, qualsiasi motivo, può essere un pretesto scatenante. È soprattutto la strategia della paura, più che i maltrattamenti fisici, che tengono la donna in uno stato di timore costante. La componente psicologica più pesante, infatti, consiste nell’imprevedibilità dell’aggressione. Pertanto, la vittima potenziale consuma ogni energia per evitare accuratamente ogni comportamento che potrebbe provocare una reazione aggressiva verbale o fisica del partner. La mancanza di controllo 309 Criminologia ed elementi di criminalistica sulla propria incolumità fisica determina uno stato di incertezza e difficoltà permanente che porta la donna a cercare di compiacere il partner per evitare che si verifichino episodi violenti. In ambito penale, la violenza fisica comprende tutti i tipi di lesioni personali (ex art. 582 c.p.), le percosse (ex art. 581 c.p.), i maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p.), fino al tentato omicidio o all’omicidio (ex art. 575 c.p.). Quando si parla di violenza psicologica, si fa riferimento a ogni comportamento volto a intimidire e perseguitare la donna o a isolarla. Si pensi alle minacce di abbandono o di maltrattamenti, alla minaccia di allontanamento dai figli, alle aggressioni verbali, alle continue umiliazioni, alla distruzione degli oggetti che hanno un valore affettivo per lei, alle persecuzioni telefoniche e al controllo della posta. Per cercare di isolarla, le si impedisce di lavorare, di andare in chiesa, di incontrare gli amici e gli altri membri della famiglia, la si obbliga a rimanere in casa senza telefono e senza la disponibilità di un’auto. La violenza psicologica accompagna sempre la violenza fisica e la prepara, anche quando non degenera, verso questo tipo di maltrattamento. Il messaggio che passa attraverso il maltrattamento psicologico è che, colui il quale ne è oggetto è persona priva di valore. Ciò induce chi lo subisc, ad accettare, in seguito, altri comportamenti violenti. Si tratta di atteggiamenti che si insinuano gradualmente nella relazione e che finiscono, inconsciamente, per essere assecondati dalla donna, senza che ella riesca a percepire quanto le siano dannosi. Allo stesso tempo, il maltrattamento psicologico procura una grande sofferenza, e, parte del dolore provato, dipende dal non riuscire a dare un nome a questo stato di grave disagio: la donna continua a sentirsi confusa e sofferente, ma senza capirne il perché. Le donne possono non rendersi conto che quello che stanno subendo è un vero e proprio maltrattamento. La violenza psicologica si configura come un insieme di strategie lesive della libertà e dell’identità personale dell’altro, con conseguente insicurezza, paura e svalutazione di sé. In questo tipo di maltrattamento, è sempre presente un’eccessiva responsabilizzazione della donna, che si attiva per far fronte a tutti i compiti e le richieste che le vengono fatte dall’abusante, nella continua speranza di non adirarlo e dimostrare la propria adeguatezza come partner e come madre. Anche se meno percepibile rispetto alle altre, la continuata violenza psicologica, la tortura emotiva e la vita passata nel terrore, sono spesso più insostenibili della brutalità fisica; e lo stress mentale provoca un’alta incidenza di suicidi e tentativi di suicidio. In ambito penale, si possono ricondurre a tale forma di violenza, i reati di: lesione (ex art. 582 c.p.), quando cagionano una malattia del corpo e della mente; ingiuria (ex art. 594 c.p.); violenza privata (ex art. 610 c.p.); minacce (ex art. 612 c.p.); maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p.); e il reato di sequestro di persona (ex art. 605 c.p.). È violenza economica nell’ambito familiare, ogni condotta diretta a controllare e limitare l’indipendenza economica della moglie. Con tale comportamento si vuole impedire che la moglie diventi, o possa diventare, economicamente indipendente in modo da poter esercitare su di essa un controllo indiretto, ma estremamente efficace. La donna viene privata del diritto di decidere e agire autonomamente e liberamente rispetto ai propri desideri e scelte di vita. 310 La violenza sulle donne ed i processi di vittimizzazzione Tale forma di maltrattamento, può essere attuata mediante molteplici comportamenti, quali: privare la moglie delle informazioni relative alla propria condizione di reddito; non contribuire alle spese domestiche; impedire la ricerca di un lavoro o del suo mantenimento; privare o controllare lo stipendio; costringere la donna a firmare contratti o garanzie senza fornire le informazioni rispetto ai rischi e alle procedure di rivalsa; costringerla a contrarre debiti; tenerla in una situazione di privazione economica continua; intestare tutti i beni a nome proprio o a nome dei propri familiari per impedire ogni accesso legale ai beni comuni; rifiutarsi di pagare un congruo assegno di mantenimento o costringerla ad umilianti trattative per averlo; licenziarsi per non pagare gli alimenti. Non sempre la donna ha una chiara percezione della violenza economica di cui è vittima. La violenza economica trapela come uno degli aspetti di un quadro di violenza più complesso, emergendo concretamente nel momento in cui la donna decide di iniziare un nuovo percorso di allontanamento dalla relazione distruttiva di maltrattamento. Dal punto di vista penale, alla violenza economica, si possono ricondurre i reati di: violazione degli obblighi di assistenza familiare (ex art. 570 c.p.); maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p.); violenza privata (ex art. 610 c.p.). La violenza sessuale non è solo quella perpetrata da estranei. Anche se compiuta da parte del marito, si configura come un delitto contro la libertà personale. Con il matrimonio, infatti, i coniugi non acquisiscono il diritto di poter disporre a loro piacimento del corpo dell’altro; nessun dovere coniugale obbliga a non disporre liberamente e secondo la propria volontà il proprio corpo. Anche all’interno del rapporto di coppia si può verificare lo stupro, ciò tutte le volte in cui si ha l’imposizione di rapporti sessuali non graditi, di pratiche indesiderate o di rapporti che comprendano in essi il far male fisicamente o psicologicamente. Solitamente, tale violenza è accompagnata sia da quella fisica (la messa in atto dello stesso mediante la forza ), che da quella psicologica (ottenere un rapporto sessuale mediante ricatti psicologici). La violenza sessuale da parte del coniuge è un fenomeno molto grave ma che difficilmente viene portato alla luce. Le vittime, raramente, trovano il coraggio di denunciare il proprio partner, anche perché trattasi di un genere di violenza che, a differenza dei maltrattamenti fisici, lascia segni meno percepibili. Il timore di non essere credute o delle conseguenze di una denuncia, oltre alla necessità di mantenere unita la famiglia, sono i motivi che inibiscono la donna a denunciare il marito che le ha usato violenza. Occorre sottolineare come le vessazioni sessuali e lo stupro ad opera di un partner non sono considerati reato nella maggioranza dei paesi del mondo, e in molte società, le donne non considerano il sesso forzato come stupro se sono sposate, o coabitano, con chi glielo impone. Indagini svolte in molti paesi dimostrano che circa il 10/15 % delle donne riferisce di venire costretta ad avere rapporti sessuali con il partner, contro la propria volontà. Tale forma di violenza trova regolamentazione nell’articolo 609-bis e seguenti del c.p., come nell’ipotesi di violenza agita da estranei. 311 Criminologia ed elementi di criminalistica 14.4L’uxoricidio Dal latino uxor-oris, che significa moglie, con il termine uxoricidio, ci si riferisce, in senso restrittivo, all’assassinio della moglie da parte del marito ma, in generale, con esso si fa riferimento all’uccisione di uno dei due coniugi per mano dell’altro consorte. Uno dei primi e interessanti studi scientifici sul tema dell’uxoricidio in Italia è stato condotto nei primi anni ‘80, prendendo in considerazione, secondo un approccio multidisciplinare (medico, psichiatra, psicologo, assistente sociale, educatore), 27 delitti che sono transitati nel Centro di Osservazione di Roma-Rebibbia nel periodo di tempo compreso tra il 1955 ed il 1975. Dall’analisi di questi casi, emersero alcuni dati degni di attenzione relativamente all’autore del delitto, alla famiglia d’origine di quest’ultimo e alla vita all’interno dell’istituzione matrimoniale. Dall’Indagine Istituzionale condotta dal centro Eures per l’anno 2000, è emerso come il più alto numero di fatti di sangue, consumatisi tra le mura domestiche, si registri tra i coniugi con una percentuale del 27,7 %. Elevato è anche il numero degli omicidi a carattere passionale che avvengono tra gli ex-coniugi o ex-partner con una percentuale dell’8,9 %, guadagnando così un quarto posto dopo l’uccisione dei genitori da parte dei figli (15,0 %) e dei figli per mano dei genitori (12,7 %). I delitti a sfondo passionale si consumano soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud, con le rispettive percentuali del 44,4 % e del 32,2 %. Per quanto concerne il sesso, a farne maggiormente le spese sono le donne che, si è già visto, essere le vittime privilegiate di omicidi in ambiente domestico con una percentuale del 58,7 % contro un 41,3 % degli uomini. Oltre ai delitti a sfondo passionale, compiuti di impulso o forse covati sordamente, il maggior numero di omicidi all’interno della coppia, di solito, è il risultato di una separazione: in particolare, nel caso in cui non ci sono figli, tale separazione può essere motivata dall’interesse economico e trattasi di omicidi molto rari; sono, invece, più diffusi quei delitti che avvengono in coppie con figli in seguito ad una separazione. Come emerge, infatti, da un’analisi statistica relativamente agli anni 2002 e 2003, gli autori di omicidio sono per lo più uomini, con una percentuale dell’87,5 % e solo il 12,5 % sono donne. Inoltre, queste ultime costituiscono il 52,5 % delle vittime contro un 37,5 % degli uomini. La maggioranza di donne quali vittime di omicidio, la si può anche spiegare risalendo al diffuso clima di violenze e di maltrattamenti di cui, ancora oggi, continua ad essere bersaglio la donna. Si parte, per esempio, dal maltrattamento psicologico e/o fisico e sessuale e si innesca come un circolo vizioso dal quale diventa difficile per lei uscire. Un altro fattore che contribuisce all’aumento dei delitti familiari, con la donna quasi sempre nel ruolo di vittima, è relativo al rapporto di struttura della società: il fatto che, oggi, marito e moglie lavorino, ha provocato non pochi problemi in seno alla famiglia, la quale non ha trovato un sostegno adeguato nella nostra società e nelle istituzioni, e la coppia è stata costretta a decidere di troncare il rapporto. Le separazioni, inoltre, implicano il dovere affrontare processi molto lunghi e faticosi che scatenano aspri e duri contrasti e che, a volte, possono portare al delitto. Come emerge dalle statistiche italiane, in una relazione conflittuale di coppia, sono soprattutto le donne a rimanere vittime di omicidio per mano del partner. In Italia, 312 La violenza sulle donne ed i processi di vittimizzazzione o comunque nei paesi occidentali, questi omicidi possono essere il risultato di continui e ripetuti maltrattamenti o di separazioni non accettate o di gelosie o di interessi economici. In altre parti del mondo, invece, una donna finisce per essere vittima di omicidio da parte del partner, per altri motivi, difficili da comprendere per noi occidentali, in possesso di una cultura totalmente opposta alla loro. Prevalentemente nei paesi dove la maggioranza della popolazione è musulmana (Bangladesh, Egitto, Giordania, Libano, Pakistan, Turchia), ma non solo limitatamente ad essi, viene praticato il delitto d’onore, che consiste nell’uccisione della donna da parte del partner maschio o da parte di un altro membro maschio della famiglia (padre, zio, fratello, ecc.), poiché sospettate di un comportamento considerato vergognoso o disonorevole. In più, nei processi penali, gli assassini vengono giustificati o condannati a pene ridotte e viene rimproverato alla donna di tenere un comportamento osceno. In quest’ultimo, non solo si annovera l’effettiva colpa di adulterio della donna ma, anche il solo sospetto che una donna abbia una relazione sentimentale non consentita dalla sua famiglia e dalla società: scambiare un sorriso o una parola con un giovane che passa sotto casa, per una ragazza, può essere letale; avere prima del matrimonio rapporti sessuali con l’uomo che si dovrà sposare è dannosissimo per la donna, che rischia di essere uccisa se solo uno dei membri maschi della famiglia lo viene a scoprire o ne abbia il sospetto. L’onore della famiglia è sacro, inviolabile e deve essere protetto e difeso anche dal sospetto di infedeltà. Tale modus vivendi che discrimina il sesso femminile viene giustificato nel nome di Allah e presentato come legge islamica; in realtà si tratta di pure mistificazioni, infatti, il delitto d’onore è una pratica pre-islamica, senza un reale presupposto religioso e si devono ricercare le sue origini nel karo kari, una pratica tribale che prevede la morte per qualunque persona sia sospettata di avere una relazione illecita. In Giordania, il paese dove tali delitti sono più frequenti, gli assassini rischiano solo da tre a dodici mesi e non sempre vengono arrestati, o perché riescono a fuggire, o perché giustificati come suicidi o incidenti. Nel caso in cui vengono presi dei provvedimenti, si tratta solo di sanzioni sproporzionatamente miti, specialmente se il responsabile ha meno di 18 anni. Le vittime sopravvissute a tentativi di omicidio sono costrette a vivere sotto custodia protettiva in prigione o in case di sorveglianza o di correzione a volte per anni, sapendo che rinunciarvi significherebbe la morte per mano della famiglia. Mentre, chi minaccia la vita di queste donne, gode della più completa libertà. L’indulgenza che viene praticata nei confronti di questi carnefici è inammissibile: ciò succede perché il delitto d’onore non è considerato un reato ma un giusto castigo per queste donne. Sono donne infelici e sole, soprattutto dentro le proprie famiglie, usate, sfruttate fino ad essere accusate di un peccato di infedeltà che non hanno commesso e punite per un diritto che non viene loro riconosciuto: il diritto a vivere. Senza dovere andare troppo lontano nel tempo e nello spazio, anche nella nostra cultura era d’uso il delitto d’onore. Il sistema di valori che vigeva fino a poco tempo fa (anni ‘50 e ‘60) nelle famiglie italiane, soprattutto del centro-sud, obbligava i mariti, i padri e i fratelli a sorvegliare rispettivamente le mogli, le figlie e le sorelle per smascherare e ostacolare qualsiasi relazione illegittima e nemmeno il sistema legislativo puniva tali atroci delitti. 313 Criminologia ed elementi di criminalistica La legge a favore del cosiddetto delitto d’onore venne promulgata durante il fascismo: il Codice Rocco, all’art. 587, prevedeva la riduzione di un terzo della pena nei confronti di chiunque uccidesse la moglie, la figlia o la sorella per difendere l’onore suo e/o della famiglia. È solo dopo gli anni ‘70, successivamente alle battaglie a favore del divorzio e dell’aborto, e dopo la riforma del diritto di famiglia nel 1975, che si comincia a fare strada una maggiore coscienza di cambiamento fino ad ottenere, il 5 Agosto 1981, con la legge n. 442, l’abrogazione del matrimonio riparatore e del delitto d’onore. Ancora oggi, come si legge dalle cronache, gli omicidi tra coniugi continuano ad essere praticati ma l’espressione delitto d’onore ha lasciato il posto a ben altre locuzioni (follia, delitti passionali, delitti per gelosia) che vogliono mostrare la progressiva trasformazione verificatasi nel corso degli anni verso un modello di vita, di famiglia e di coppia più democratico, basato sulla fiducia reciproca e sulla pari dignità tra uomo e donna 14.5I Centri anti-violenza Le Nazioni Unite sono il primo organismo che, nel 1985, sottolinea la gravità della violenza contro le donne, e che, cinque anni più tardi, riconosce come la violenza contro le donne nel contesto familiare sia il crimine nascosto più diffuso nel mondo. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, tenutasi a Vienna nel 1993, oltre a proclamare l’universalità e l’inalienabilità dei diritti umani delle donne, auspica che ogni Stato assuma l’obbligo di proteggere le donne e si impegni per la scomparsa della violenza contro le stesse. La tutela della donna, e la sua protezione dalla violenza, è oggetto di una serie di convenzioni internazionali. Si ricordi la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, del 1979, la quale impegna gli Stati firmatari a condannare qualsiasi forma di discriminazione e, inoltre, a promuoverne l’eliminazione con tutti i mezzi adeguati. Tra gli obblighi che vengono assunti dagli Stati contraenti, l’articolo 5 impegna questi ultimi ad adottare ogni provvedimento adeguato al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere a un’eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne. Anche l’Assemblea Generale dell’ONU, in varie risoluzioni, ha chiaramente mostrato la propria volontà di non tollerare ulteriormente la violenza sulle donne. A tal riguardo, dopo la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza nei confronti delle donne del 1993, l’Assemblea ha approvato ulteriori importanti dichiarazioni. Nel 1998, con la dichiarazione Crime prevention and criminal justice measures to eliminate violence against women, ha sollecitato gli Stati ad affrontare seriamente e in maniera globale la lotta alla violenza sulle donne; nel 2003, con un’altra dichiarazione, Elimination of domestic violence against women, ha auspicato una maggiore attenzione e impegno per 314 La violenza sulle donne ed i processi di vittimizzazzione l’eliminazione della violenza domestica. Nel 2004, invece, un’ulteriore dichiarazione, Working towards the elimination of crimes against women and girls committed in the name of honour, condanna i reati d’onore perpetrati contro donne e minori. La Commissione Europea, nel 1997, avvia la sperimentazione di un’iniziativa comunitaria volta a combattere la violenza contro le donne, gli adolescenti e i bambini: Daphne. Si tratta di un’iniziativa pilota che promuove e finanzia progetti transnazionali in collaborazione con enti pubblici contro la violenza. L’idea base è di costruire un bagaglio di buone prassi contro la violenza e di incrementare e sviluppare studi sul fenomeno e reti a livello europeo tra chi opera sul territorio . La situazione italiana registra una legislazione contro la violenza sessuale ferma all’istituzione di politiche quadro, da rimandare alle istanze regionali contro la violenza domestica. Il decentramento ha, comunque, incoraggiato lo sviluppo, a livello locale, di numerose esperienze di integrazione tra politiche sociali e/o di pari opportunità, gestite da associazioni di donne, contro la violenza. Azioni che sono finanziate attraverso l’istituzione di appositi capitoli di bilancio nelle finanze degli enti locali. Nel 1997, la direttiva del Consiglio dei Ministri, riprendendo gli obiettivi della conferenza di Pechino, realizza un’indagine sistematica sulla violenza alle donne, fornendo il primo quadro conoscitivo del fenomeno. Riconoscendo la categoria della violenza domestica all’interno del Piano Sanitario Nazionale 1999-2002, gli interventi contro la violenza alle donne sono stati inseriti nelle leggi sull’assistenza socio-sanitaria. Nelle realtà locali, inoltre, si sono concretizzate esperienze di reti di intervento che coinvolgono tutti gli attori che operano nel territorio: Forze dell’Ordine, sanità, servizi sociali, associazioni. È soprattutto grazie all’attività svolta da tali Associazioni che negli ultimi anni il fenomeno della violenza contro la donna è venuto alla ribalta: non è più considerato un affare di famiglia, ma un problema che merita di essere risolto. Si deve a tali associazioni la creazione dei primi centri di accoglienza e delle strutture per l’ospitalità delle donne in difficoltà. Se da una parte, i vari organismi internazionali affrontano la questione e se anche i governi locali non si tirano indietro, tuttavia, il lavoro più importante viene svolto dalle diverse associazioni che operano sul campo e alle quali si deve la nascita dei centri antiviolenza. La nascita dei centri anti-violenza è dettata dalla sempre più crescente esigenza del movimento femminista di affrontare il gravoso problema della violenza contro le donne ed avviare una più ampia riflessione sulla questione. Basti riflettere come, con lo svilupparsi della coscienza dei propri diritti da parte delle donne, sia emerso il fenomeno della violenza intrafamiliare, per molti anni sommerso. In Italia, i primi centri anti-violenza nascono alla fine degli anni ‘80, successivamente ad un dibattito iniziato a metà degli anni ‘70 sulla legge contro la violenza sessuale. Dalla questione del riconoscimento legislativo della violenza contro le donne, si passò al problema dell’attivazione di servizi idonei a rispondere ai problemi individuali che questa pone ed, infine, all’ampliamento dell’interesse dalla violenza sessuale a quella domestica. I primi centri di Bologna e Milano adottano come modello di riferimento quello già utilizzato da decenni e con successo in Europa e in Canada. In seguito all’apertura della prima casa a Bologna e del primo centro di accoglienza a Milano, si sviluppano altri centri e case, in prevalenza nel centro-nord. 315 Criminologia ed elementi di criminalistica Molti di questi centri nascono come organizzazioni di volontariato, dove alcune donne mettono a disposizione la propria professionalità per accogliere altre donne che si trovano in momentanea difficoltà a causa del maltrattamento e della violenza subìta. Tali centri, inoltre, offrono alla donna maltrattata e violentata un percorso terapeutico affinché sia loro possibile uscire dalla solitudine e dalla frustrazione ed assumere proprie responsabilità per un futuro in autonomia. Nel sud Italia, a causa del difficile contesto socio-economico, i centri anti-violenza ritardano a nascere, rispetto al vicino nord: ciò, tuttavia, ha permesso la costruzione di azioni molto significative che si misurano costantemente con le varie difficoltà, esprimendo prassi forti e progettuali. Ai centri anti-violenza si deve quell’importante attività che ha permesso la rilevazione del fenomeno. A tal riguardo, bisogna ricordare come non vi sia stata, né in ambito pubblico né in quello privato, alcuna rilevazione del fenomeno della violenza, e non siano stati pensati strumenti per la rilevazione della stessa. Ciò, purtroppo, non ha permesso, e non permette, una circoscrizione e un’analisi più attenta del fenomeno tanto da poter ricavare stime più attendibili sulla sua diffusione. Per tale motivo, è stata importantissima l’attività di raccolta di dati svolta da tali centri che, seppur limitata, ha permesso di avere dati sui quali lavorare. 14.6Trattamento delle donne vittime di violenza I vari centri, nel porre l’accento su un elemento piuttosto che su un altro, si sono differenziati per l’attività di relazione che svolgono con le donne che hanno subìto violenza. Ciò è da ricondurre alla diversa storia ed evoluzione dei gruppi originari dai quali i vari centri sono venuti alla luce e, soprattutto, è da ricondurre all’incontro con altri saperi, modelli, conoscenze e contesti in cui le differenti esperienze sono fiorite. L’approccio alla donna da parte dei diversi centri si è arricchito, infatti, grazie ad un modo di accostarsi, sempre più complesso, alla tematica del maltrattamento e alle sue dinamiche, senza dimenticare l’apporto e l’integrazione di altri modelli di lettura. Ciò si evince da un interesse comune per lo sviluppo dei centri di documentazione e ricerca, all’interno delle case e dei centri di accoglienza, che grande risalto danno all’intreccio tra teoria e pratica. Generalmente, la donna che si rivolge ad un centro anti-violenza ha il primo contatto con le operatrici tramite conversazione telefonica. Per quanto concerne l’approccio metodologico, che generalmente regola questi centri, un primo aspetto da rilevare, apparentemente poco significativo, è dato proprio dai tempi di risposta degli stessi in seguito al primo contatto telefonico. È sembrato utile, a tal riguardo, rilevare se l’intercorrere di un periodo di sospensione tra la telefonata e il primo colloquio, o l’eventuale risposta immediata, corrispondano a una prassi prestabilita, oppure siano il risultato di un processo di analisi e di valutazione affinato, che consenta di differenziare le situazioni realmente urgenti da quelle che possono avvalersi di una pausa, un periodo di sospensione. 316 La violenza sulle donne ed i processi di vittimizzazzione Quest’ultimo, è volto a verificare la reale maturazione interna di una richiesta di aiuto da parte della donna. In merito a ciò, sono stati rilevati due orientamenti diversi. Da un lato, alcuni centri, come quelli di Modena e Bologna, si regolano in base alle disponibilità delle operatrici, per cui può verificarsi che la donna venga accolta il giorno dopo il primo contatto telefonico, oppure nel momento stesso in cui essa giunge al centro, senza che sia preventivamente fissato un appuntamento. In tali casi, il primo colloquio viene effettuato in mancanza di una preventiva valutazione sulla reale urgenza della situazione vissuta dalla donna e nessun significato viene dato al tempo di attesa che va dal primo approccio telefonico al primo colloquio materiale. Dall’altro lato, invece, vi sono altri centri, come quelli di Milano, Firenze e Palermo, i quali sottolineano quanto il loro agire, sin dal primo contatto, sia accompagnato da un attento esame della pericolosità reale delle situazioni e dell’esigenza di una pausa di maturazione dalla richiesta telefonica: ciò, in quelle circostanze in cui non sembrano ravvisarsi situazioni di urgenza. Questo perché si vuole evitare che la donna, spinta dalle emozioni temporanee, si rivolga al centro senza essere ancora pronta, ma, soprattutto, giunga al primo contatto visivo con gli operatori con la ferma volontà di intraprendere la strada del cambiamento. Non sono rari, infatti, i casi di donne che non si presentano all’appuntamento poiché, inibite dalla paura del cambiamento, tornano sui propri passi. Proprio per tale motivo, alcuni centri posticipano l’instaurazione del rapporto con la donna, in quanto tale insicurezza può causare ancora più danni. Alcuni centri danno moltissima importanza al primo contatto telefonico, durante il quale, in alcuni casi, l’operatore si occupa di compilare una scheda informativa contenente determinate informazioni che permetteranno all’operatore di poter meglio analizzare la singola posizione. Scendendo, poi, nel dettaglio, i vari centri si possono differenziare in base al tipo di informazioni richieste al telefono. In genere, oltre ad annotare alcuni dati anagrafici viene rilevato il tipo di problema prospettato dalla donna e se, in passato, la stessa abbia già cercato di uscire dalla situazione di violenza. Tali schede vengono a formare un vero e proprio archivio che permette agli operatori di poter meglio analizzare la donna che richiede l’assistenza, attivandosi una vera e propria attività di studio del singolo caso. Altri centri, infine, preferiscono compilare tale scheda durante il primo colloquio tenuto presso il centro. Sebbene siano diverse le modalità di intervento dei singoli centri, si può tuttavia sottolineare come essi perseguano un obiettivo comune: vale a dire il ribaltamento della posizione di vittima della donna che subisce violenza a quello di protagonista del nuovo percorso di vita che si accinge a percorrere. Strumento elettivo è la relazione: non una relazione d’aiuto qualsiasi, ma una relazione di genere, fondante un luogo (i centri e le case) e una pratica politica di gruppo, considerata l’unico mezzo efficace per combattere la violenza. Entrando più in dettaglio su alcune questioni metodologiche, è stato rilevato che, nonostante la relazione sia per tutti di primaria importanza, non vi è uniformità tra i diversi centri per ciò che attiene alla modalità di conduzione dei colloqui. Innanzitutto, il colloquio d’accoglienza si basa su alcuni punti fermi, quali: la relazione tra operatrice e vittima della violenza, la non colpevolizzazione della stessa e la proposizione di un progetto di vita che nasce dal desiderio di cambiamento della donna che proprio per questo scopo si rivolge al centro. 317 Criminologia ed elementi di criminalistica Uno degli strumenti che permettono di rileggere il lavoro fatto, è la raccolta dei dati attraverso la scheda del colloquio, la cui funzione pratica è quella di razionalizzare il lavoro del centro e rendere più semplice la ricerca e la conservazione delle informazioni. Serve, anche, da contenimento e guida nel colloquio, rende confrontabili alcuni casi e situazioni, dà valore e visibilità al colloquio d’accoglienza che viene, in questo modo, almeno per alcuni aspetti, reso anche misurabile. La scheda attraverso cui si articola il colloquio è, sicuramente, uno strumento attivo nello studio del fenomeno e inoltre è anche attraverso questa raccolta di dati che si conserva la memoria e il senso del lavoro che il centro fa, e come questo si evolva nel tempo. Il colloquio d’accoglienza, oltre a servire alle donne che si rivolgono al centro per un cambiamento di vita e per uscire dalla violenza, è anche uno strumento di studio. Esso permette di entrare nel cuore del problema e di verificare alcune ipotesi di ricerca. Al fine di un’analisi scientificamente corretta del fenomeno della violenza familiare che rimane ancora oggi un problema tanto grave quanto sommerso, occorrono dati di riferimento il più possibile omogenei e leggibili. La violenza di genere rimane ancora nascosta all’interno della struttura familiare, dove la sua presenza è negata dalle stesse vittime: spesso, neanche le donne che la vivono, si rendono pienamente conto di ciò che realmente succede né attraverso quali canali se ne perpetua l’esistenza. Svolgere un’indagine in questo complesso territorio è molto difficile e necessita che si faccia emergere con più chiarezza il problema in tutti i suoi aspetti, anche in quelli più oscuri, utilizzando efficaci strumenti d’indagine in un’accurata analisi quantitativa. Merita, inoltre, una riflessione, la questione della metodologia di lavoro con donne che hanno subìto violenza e che sono ospiti delle case-rifugio. Laddove sono più stretti i rapporti tra il centro e le case, specie al momento dell’ingresso, vi è una maggiore attenzione al percorso che la donna deve intraprendere; infatti, attraverso una valutazione congiunta, tra il responsabile del centro e quello delle case, deriverà una decisione finale, quale pre-condizione essenziale all’inserimento in struttura. In merito agli aspetti legati alla quotidianità, in alcuni casi si preferisce che sia l’operatrice della casa ad occuparsene, mentre l’operatrice del centro continua a seguire la donna in accoglienza nel suo percorso di uscita dalla violenza, mantenendo, per i colloqui, un assetto ubicato fuori dalla casa, ossia presso il centro. Dunque, se da un lato in alcuni centri si mantiene tale assetto, in altri, l’intreccio tra centro e casa è solo iniziale, rimanendo l’operatrice di quest’ultima l’unico riferimento della donna ospite. Vi è, infatti, una difformità tra l’intervento del centro di accoglienza e quello delle case. Vi è un rapporto di scambio, di segnalazione, ma non viene concordato un progetto comune. La valutazione dell’ingresso è fatta dall’operatrice della casa, così come tutto il percorso successivo, molto centrato sul rinvenimento di strumenti concreti per la costruzione di autonomia delle donne, e condotto dalla stessa operatrice, in assoluta indipendenza dal centro, potendosi, però, avvalere, se presenti, di alcuni consulenti dei centri, quali avvocati e psicologi. Le donne che vivono presso le case-rifugio sono obbligate a rispettare una serie di regole. La trasgressione più grave al regolamento rimane, per tutte le case, quella della segretezza. Rivelare la segretezza del luogo di rifugio può pregiudicare l’intero percorso formativo non solo della donna che ha trasgredito ma di tutto il gruppo delle donne conviventi. Per tale motivo, i responsabili considerano importante valutare, al momento del318 La violenza sulle donne ed i processi di vittimizzazzione l’ingresso, la percezione, da parte della donna, della pericolosità rispetto alla propria situazione, nonché della sua capacità di auto-tutela fortemente lesa dal maltrattamento. L’indirizzo della struttura è segreto, e il riferimento pubblico è quello del centro di accoglienza. La casa offre ospitalità temporanea a donne sole o con bambini per un periodo massimo di sei mesi; il possibile prolungamento di permanenze per altri sei mesi a supporto del progetto concordato con la donna è valutato e deciso del responsabile della casa, sentito il servizio sociale territoriale di riferimento del Comune. L’attivazione dell’ospitalità si determina, allorquando, sia necessario l’allontanamento della donna e dei minori dalla casa coniugale a causa di una situazione di pericolo e a supporto di un percorso progettuale di risoluzione del rapporto violento. Obiettivo dell’ospitalità è di concorrere congruentemente alla realizzazione del progetto di vita elaborato e concordato con la donna. Si tratta di fornire un luogo protetto a garanzia dell’incolumità della donna a rischio, ma soprattutto di assicurare uno spazio tempo di sospensione dell’agito conflittuale violento, che possa favorire nella donna l’elaborazione e l’esplorazione per giungere a una ridefinizione di sé, al di fuori di un rapporto violento. Se non si fanno le opportune valutazioni, l’ingresso nella casa può essere, però, rischioso perché può ostacolare il percorso della donna mortificandone le sue risorse autonome. È prevista la possibilità di effettuare ingressi urgenti. Si tratta di quei casi in cui il rischio per l’incolumità della donna e dei minori è talmente alto da non essere compatibile con il protrarsi della permanenza presso la casa coniugale. In queste situazioni, l’ospitalità è immediata e vengono riservati i quindici giorni successivi all’ingresso per effettuare il lavoro di analisi della condizione soggettivo-emotiva della donna. Questi sono gli ingressi più problematici a causa della scarsa possibilità elaborativa dell’accadimento traumatico e dello stato di choc. Una spinosa questione riguarda le donne che presentano gravi manifestazioni psicopatologiche o tossicomaniche: la scelta metodologica è stata quella di non accogliere queste donne, al di là dell’ipotesi eziologica abbracciata, che spesso rintraccia nella storia di maltrattamento l’origine dei disturbi. Inoltre, l’esclusione di donne che presentino gravi manifestazioni di marca psicotica è da ricondurre anche alla specificità dell’intervento che queste situazioni richiedono. 319 PARTE seconda ELEMENTI DI CRIMINALISTICA CAPITOLO 15 La criminalistica 15.1 La criminalistica e le sue origini Il 1800 è stato, certamente, un secolo fecondo per la criminalistica; il pensiero positivista suggeriva d’indagare la realtà con la precisione e il rigore scientifici. In questo clima di fiducia verso la scienza, non è raro trovare scienziati che si interessino di investigazioni. Su questo scenario, emerge il fenomeno letterario del poliziesco, in cui l’investigatore non è più uno dei personaggi necessari alla trama ma è il protagonista. Illustri esempi della nuova figura sono quelli creati prima da Edgard Alan Poe e successivamente da Sir Artur Conan Doyle (1859-1930). Nascono, con Dupin e Holmes, i primi ragionamenti logico-deduttivi e induttivi, avvalendosi delle innovazioni scientifiche e tecnologiche per raggiungere i loro fini, tali da potere essere considerati come criminalisti. La fermentazione razionale in atto, mette in luce Alphonse Bertillon (1853-1914); quest’ultimo era figlio di Louis, vicepresidente della Società di Antropologia di Francia, e suo fratello maggiore Jacques era un demografo. Il salotto di casa Bertillon era frequentato da scienziati di chiara fama e, probabilmente, anche Alphonse avrebbe intrapreso la carriera accademica se non fosse stato colpito da una febbre tifoidea che lo costrinse a lasciare gli studi universitari. Bertillon, a ventisei anni, dopo varie esperienze lavorative, lavorando nella Prefettura di Polizia di Parigi, superando non pochi contrasti e diffidenze, dopo poco tempo, introduce il sistema d’identificazione personale antropometrico, basato sul principio scientifico secondo cui l’ossatura umana non subisce modificazioni apprezzabili, se non per cause traumatiche, dopo il compimento del ventesimo anno d’età. Inoltre, secondo gli studi statistici di Quetelet (1791-1874), riportati nel testo dal titolo: Antropometrie eu mesure des differentes facultes de l’homme, nell’uomo, ogni misura ricorre solo in percentuale fissa, quindi, più alto è il numero delle misure assunte, tanto più bassa è la probabilità che due soggetti le presentino tutte uguali. Il segnalamento antropometrico fu seguito da quello descrittivo, a cui diede il nome di ritratto parlato, che doveva servire agli investigatori per poter memorizzare i con323 Criminologia ed elementi di criminalistica notati dei ricercati; successivamente, realizzò il segnalamento fotografico e, a tal fine, studiò e costruì, come aveva fatto per l’antropometria, vari attrezzi e accorgimenti per dare uniformità alle riprese e, per dare maggior valenza scientifica alle fotografie, vi inserì un riferimento metrico. Nel 1893, Bertillon era riuscito a custodire nell’archivio del Servizio d’Identità giudiziaria di cui era direttore, ben 500.000 cartellini segnaletici; il metodo antropometrico, dallo stesso introdotto, e ancora oggi soprannominato Bertillonage, si imponeva come il sistema di identificazione più funzionale e utilizzato da tutte le Polizie. Contemporaneamente, faceva i primi passi quello che sarà il futuro metodo d’identificazione personale per antonomasia, il c.d. metodo dattiloscopico. Marcello Malpighi (1628-1694), nel 1686, aveva già descritti i vari strati del derma e le figure che apparivano sui polpastrelli. Nel 1823 Jan Evangelista Purkinje (1787-1861) aveva pubblicato un volume, dal titolo De examne Physiologico organi visus et systematis cutanei, in cui affermava che le impronte papillari sono riconducibili a nove figure fondamentali. William Herschely, funzionario inglese in servizio nel Bengala, per impedire doppie riscossioni di pensioni, faceva apporre le impronte a coloro i quali si presentavano, e ciò, anche, per acquisire una sorta di ricevuta della somma. Henry Faulds (1843), medico scozzese trapiantato a Tokyo, raccoglieva e studiava le impronte digitali dei domestici e degli avventori dei bar; nei salotti eseguiva un gioco di società che consisteva nell’identificare la persona che aveva bevuto da un dato bicchiere e, vista la sua predisposizione in tale campo, veniva consultato dalla Polizia locale per risolvere eventi delittuosi. Sir Galton (1822-1911), medico dai mille interessi, spaziando dall’antropologia alle ascensioni in mongolfiera, teneva salotto nella sua casa londinese, facendo partecipare agli incontri illustri biologi, filosofi, geografi e antropologi. Nell’ambito, poi, dell’Esposizione Universale di Londra del 1884, aveva allestito un padiglione in cui, aiutato dal fedele Sergente Randal, previo pagamento, il soggetto era sottoposto a rilievi antropometrici; ne era misurata, la vista, l’udito, la forza muscolare, la prontezza dei riflessi e, tra l’altro, anche, assunte le impronte digitali; gli veniva rilasciato un diploma in cui si attestavano le risultanze delle misure effettuate. In realtà, la metodologia descritta era destinata a formare un grande archivio rappresentativo delle varie fasce sociali, etnie, d’età e sesso, mediante il quale, potevano essere studiate le impronte digitali. Questo studio lo portò alla conclusione che tutte le impronte erano riconducibili alle quattro figure fondamentali: adelta, monodelta, bidelta e composta, ancor oggi ritenute tali. Sebbene avesse investite molte energie nella realizzazione di una classifica dattiloscopica, indispensabile per poter ordinare e rintracciare le impronte assunte e quindi identificare il soggetto, non aveva trovato, tuttavia, un metodo valido e soprattutto spedito. Dove gli sforzi di Galton non erano giunti, in pochi mesi, al contrario, J. Wucetick (1855-1913), responsabile del servizio statistica della Polizia Argentina, nel cui ambito era inserito l’Ufficio d’identificazione di La Plata, elaborò, la prima classifica dattiloscopica, adottata ufficialmente, dopo cinque anni di vicissitudini, dallo Stato argentino, il 1° gennaio 1896. 324 La criminalistica Nel 1900, Edward Richard Henry (1850-1931), funzionario inglese in servizio nell’India britannica, realizzava la classifica dattiloscopica più utilizzata, a livello mondiale, sino all’avvento dell’A.F.I.S.. Anche se Bertillon continuava a rimanere ancorato all’antropometria, un elevato numero di Polizie utilizzava il metodo d’identificazione dattiloscopico, sia per la semplicità d’assunzione e di classificazione, che per il più ampio campo d’applicazione. Infatti, mentre l’antropometria, all’epoca, era valida a livello preventivo, a patto che il soggetto avesse compiuto il ventesimo anno d’età, la dattiloscopia poteva essere applicata anche a livello giudiziario, tenuto conto dell’immutabilità, nel tempo, delle c.d. creste papillari. Alla fine del XIX secolo, l’Italia meridionale, in particolare modo la Campania, era sconvolta dal fenomeno del brigantaggio che, in tutta la penisola, era un fatto endemico, ma che in quel contesto, stava assumendo contorni politici di restaurazione; proprio nella Questura di Napoli, nel 1892, il medico legale Abele De Blasio, chiese al questore Sangiorgi di allestire, a proprie spese, un gabinetto antropometrico. Ottenuta l’autorizzazione, costruì, nel cortile della Questura, una baracca in cui fotosegnalava pregiudicati, eseguendo il primo confronto fotografico, in Italia, di un malavitoso. Allo scopo di aggiornare le tecniche di contrasto dell’emergente criminalità, in Roma, nel 1887, il Prefetto Giovanni Bolis, con R.D. N°1201, fu autorizzato a tenere un corso pratico di perfezionamento per funzionari di P.S., che si tenne presso l’ex convento di Sant’Andrea delle Fratte. Dalle fonti dell’epoca, si apprende che furono effettuati soltanto due corsi, ognuno dei quali frequentato da 35 funzionari di varie qualifiche. Nel 1886, venne organizzato a Roma il Congresso Penitenziario e tra gli ospiti d’onore vi era Bertillon, il quale, nel suo intervento, illustrò l’importanza dell’antropometria come metodo d’identificazione personale. Intanto, Cesare Lombroso (1836-1909) aveva elaborato le sue teorie sull’uomo criminale presso la cattedra di Medicina Legale all’Università di Torino. Quasi tutte le Polizie avevano laboratori di criminalistica, e l’Italia sentì la necessità di rinnovare le proprie metodiche investigative, dando ad esse maggior certezza con l’ausilio della scienza. Il Ministro dell’Interno Giovanni Giolitti (1841-1928), accogliendo il suggerimento del Capo della Polizia, Francesco Leonardi, inviò, nel 1901 un viceprefetto a Parigi con l’incarico di prendere visione delle metodologie attuate da Bertillon che, nonostante l’affermazione della dattiloscopia, continuava a essere il faro dell’ormai consolidata criminalistica. A seguito di questa missione, si decise di tenere a Roma dei corsi di Polizia Scientifica. Il primo corso si tenne presso la sala riconoscimenti del carcere Regina Coeli a cui parteciparono 35 funzionari di P.S.; l’incarico di docente fu dato al Medico Legale Professor Salvatore Ottolenghi, assistente universitario di Lombroso. Nel 1893, diventa titolare della cattedra di Medicina Legale presso l’Università di Siena, dove, nel 1896, tenne un corso di Polizia Scientifica. Sempre nel 1893, unitamente al Funzionario di P.S. Ostorero, aveva proceduto all’identificazione di un anarchico, utilizzando tecniche fotografiche. Nel 1897, unitamente al Funzionario di P.S. Giuseppe Aloni, fonda la Rivista di Polizia Scientifica. 325 Criminologia ed elementi di criminalistica Il 25 ottobre 1903, organizza il secondo corso di Polizia Scientifica, a cui partecipano, soltanto, 14 funzionari di P.S., presso le carceri nuove site in Via Giulia; lo stesso anno, realizza la cartella biografica, sorta di foglio matricolare del criminale, in cui venivano annotati, oltre agli elementi propri del cartellino fotosegnaletico (descrizione, fotografie e impronte digitali), tutti quegli elementi oggettivi che possono far risaltare meglio la personalità del soggetto, dal comportamento scolastico alla precisazione delle eventuali specializzazioni conseguite durante il periodo militare, dall’elencazione di tutti i parenti, amici e amanti a tutte le frequentazioni criminali e penitenziarie, abitudini criminali, sociali e personali. Soltanto nell’aprile del 1904, si ebbe una sistematicità nei fotosegnalamenti. Tali operazioni, venivano eseguite presso i locali di Via Giulia, e oltre ai detenuti, venivano fotosegnalati anche i fermati e gli arrestati dalla Questura di Roma che aveva la sua sede in Piazza del Collegio Romano, nell’attuale sede del Commissariato di P.S. di Trevi, nel cui piazzale antistante, oltre a carrozze e auto di servizio, per regolamento comunale, doveva sostare, giorno e notte, almeno una botticella (denominazione romana delle caratteristiche carrozze da noleggio di piazza ancor oggi circolanti), e un taxi a disposizione dei Funzionari di P.S.. L’Ottolenghi, creò un gruppo di lavoro costituito da funzionari di P.S.; ad ognuno di essi assegnò un settore da sviluppare ed organizzare: - a Giovanni Gasti, il campo della ormai affermata dattiloscopia; - a Umberto Ellero, la fotografia; - al suo Assistente Universitario Giuseppe Falco, la parte descrittiva e antropometrica. Gasti, dovendo organizzare il casellario d’identità, prese in esame i lavori già eseguiti in tal campo, sia dagli argentini che avevano realizzata la prima classifica al mondo, che dagli inglesi, che avevano eseguiti i primi studi sull’argomento, ma non trascurò di prendere visione dell’organizzazione che si erano dati gli austriaci. Sarebbe stato molto più semplice adottare uno di questi sistemi, ma egli volle realizzare, personalmente, l’originale sistema decadattiloscopico che prese il suo nome, e risulta ancora in uso presso la Polizia Scientifica italiana. Ellero realizzò vari dispositivi fotografici, sia nel campo del segnalamento, sia in quello del sopralluogo. Giova ricordare il metodo originale con cui affrontò l’esigenza di ottenere riprese fotografiche del soggetto di fronte e di profilo in un’unica espressione. Usava due macchine fotografiche poste a 90°, i cui otturatori erano azionati contemporaneamente da un sistema pneumatico, che venne denominato come sistema delle gemelle Ellero. Nel campo del sopralluogo, ideò e realizzo un cavalletto telescopico che permetteva all’apparecchio fotografico di sopraelevarsi di oltre sei metri, infatti, all’epoca non era passata di moda la foto dall’alto ed i grandangolari non erano molto spinti; tale attrezzo venne denominato cavalletto Ellero. Ellero non si limitò soltanto a realizzare dispositivi fotografici, ma eseguì esperimenti di teleiconotipia, il telefax dell’epoca, realizzando un metodo di trasmissione dell’immagine che denominò ellerogramma che, pur permettendo di trasmettere im326 La criminalistica magini di buona qualità, era estremamente lento (circa quattro ore per trasmettere una fotosegnaletica). Nel 1907, la Scuola di Polizia Scientifica ottenne una nuova e più consona sede. Lo stesso anno, Ottolenghi, dopo aver rivisto e regolato tecnicamente l’attività di fotosegnalamento, iniziò ad inviare circolari aventi per oggetto la metodologia corretta per assumere le impronte digitali; istruzioni che nel 1910 formeranno oggetto di un’elegante, e oggi ricercata, pubblicazione, a cura del Ministero dell’Interno, che venne distribuita, in modo capillare, a tutti gli Uffici di Polizia; a cura dello stesso Ufficio, il 24 ottobre dello stesso anno, venne emanata la famosa circolare Fani, in cui venivano dettate tutta una serie di prescrizioni sul corretto modo di eseguire l’ispezione del luogo del reato. L’anno successivo, la nascente Polizia Scientifica iniziò a eseguire i sopralluoghi. La Polizia Scientifica italiana era partita in leggero ritardo rispetto alle consorelle straniere, ma guadagnava terreno e prestigio a vista d’occhio: nel 1908, erano già funzionanti ben 11 Gabinetti di Polizia Scientifica, mentre la Francia, alla stessa data, ne aveva soltanto tre: a Parigi, Lione e Marsiglia. Con R.D. del 20.8.1909, il corso di Polizia Scientifica era stato reso obbligatorio per tutti i Funzionari di P.S., ed era stato stabilito che detto corso doveva avere una durata minima di tre mesi. L’instancabile Ottolenghi riesce ad ottenere altri, attigui locali ma, l’organico è solo di undici persone. Il direttore coordina e indirizza l’attività del gruppo e cura i rapporti internazionali; nel 1912, nel corso di un convegno internazionale entra in polemica con i colleghi Edmond Locard e Reis, infatti, quest’ultimi asserivano che la nascente criminalistica doveva investigare esclusivamente sul reo, mentre Ottolenghi propugnava che dovesse estendere il proprio ambito, interessandosi anche del reato. Intanto, l’Ottolenghi aveva messo a punto una metodica analitica, analoga al ritratto parlato di Bertillon, ma applicata al sopralluogo, metodo usato ancor oggi da tutti i criminalisti che eseguono diuturnamente l’esame della scena del crimine. La direzione dei laboratori d’identità francesi erano ancora diretti da Bertillon nei quali rimarrà sino al 13 febbraio 1914, quando morì, dopo aver accumulato onori, prestigio, gloria e fama eterna, ma senza la soddisfazione di vedersi concedere la Legion d’Onore, a causa della sua irremovibile posizione sul caso Dreyfus. L’avvento della Grande Guerra porta dei cambiamenti nel gruppo di lavoro costituito da Ottolenghi; Gasti, viene chiamato a dirigere il nuovo organismo investigativo per la sicurezza interna denominato U.C.I. e, mettendo a frutto le conoscenze criminalistiche, consegue brillanti risultati contro le organizzazioni spionistiche. Al settore sopralluoghi, si dedicano i valenti funzionari Sorrentino e Giri che conseguono risultati notevoli. In Francia, Locard, rendendosi conto dell’importanza di dare valore aggiunto, ma soprattutto oggettività, ai rilievi fotografici, nel 1920, realizza un’embrionale, ma originale, metodo fotogrammetrico, costituito da reticoli sovrapponibili. Ottolenghi, pur essendo direttore della Polizia Scientifica, continua ad essere titolare della cattedra di Medicina Legale della Sapienza e continua a intrattenere rapporti ad altissimo livello col mondo accademico e scientifico, sino a fondare la rivista di medicina legale, Zacchia, in ricordo del medico legale che, nel lontano 1650, eseguiva già autopsie in Roma. Il Casellario Centrale d’identità era un sicuro punto di riferimento per tutte le forze di Polizia; il fenomeno della tratta delle bianche, molto sentito all’inizio 327 Criminologia ed elementi di criminalistica del secolo, venne affrontato, su indicazione della nascente Interpol, con il R.D. luogotenenziale 1207, che disponeva l’istituzione, presso il suddetto casellario, di uno schedario delle prostitute straniere. 15.2La Polizia Scientifica Partendo dalle intuizioni scientifiche dell’Ottolenghi (1902), la Polizia di Stato ha maturato la sua esperienza nei quasi 100 anni di presenza sul territorio nazionale, avvalendosi della presenza di nuove figure professionali (biologi, chimici, fisici, ingegneri, medici legali, psicologi ecc.), sviluppando, in tal modo, questa nuova struttura operativa che risponde al nome di Polizia Scientifica. Essa si avvale, inoltre, di strumentazioni d’avanguardia, e di continue collaborazioni con Dipartimenti Universitari, al fine di assicurare un sempre maggiore sostegno alle attività istituzionali, per tutte le esigenze dell’Autorità Giudiziaria, compreso (a titolo gratuito), l’espletamento di incarichi di consulenza e perizia. La P.S. è articolata in un servizio centrale con sede a Roma presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, in 14 Gabinetti Regionali, dislocati presso i principali capoluoghi di regione, in 89 Gabinetti Provinciali presenti in tutti i capoluoghi di provincia, e in 197 Posti di Segnalamento e Documentazione ubicati nei più importanti Commissariati di Pubblica Sicurezza. Il Servizio Centrale di Polizia Scientifica è strutturato in 4 Divisioni: - - - - Prima Divisione: affari generali, indagini speciali e studi; Seconda Divisione: identità; Terza Divisione: indagini medico-legali e biologiche; Quarta Divisione: indagini fisiche, chimiche e merceologiche. La Prima Divisione Sezione Prima: Attrezzature Tecniche, Documentazione e Trattamenti Fotografici. Si occupa di materie tradizionalmente inerenti la Polizia Scientifica, come il fotosegnalamento e la documentazione a fini identificativi. L’importante settore attrezzature tecniche e materiali si occupa della programmazione e della pianificazione degli acquisti di apparati specialistici, dei materiali indispensabili per le esigenze dei laboratori, nonché dell’istituzione e dell’ampliamento di nuovi uffici periferici. Il settore fotosegnalamento e documentazioni speciali, invece, si occupa dell’identificazione personale a fini giudiziari e di polizia. Nei vari laboratori che lo compongono, ci si occupa di sviluppo e stampa del materiale inerente l’attività di polizia giudiziaria, particolari documentazioni video e fotografiche, trattamento delle pellicole e collaudi di apparecchiature videofotografiche, riproduzione dei cartellini segnaletici (fotodattiloscopici) e riproduzione fotografica delle impronte latenti evidenziate con metodi fisici e chimici. All’interno della prima sezione, opera l’archivio, che, avvalendosi di supporti informatici, tratta la protocollazione, archiviazione e gestione degli atti del servizio. 328 La criminalistica Sezione Seconda: Indagini Speciali. Organizzata in 4 settori denominati Progetti Speciali, si occupa di: - - - - esame della scena del crimine (E.S.C); analisi della scena del crimine (A.S.C); analisi delle informazioni (A.I); analisi del comportamento (A.C). L’insieme di questi 4 settori, costituisce l’U.A.C.V. (l’Unità per l’Analisi del Crimine Violento). Scopo dell’Unità, è supportare gli organismi investigativi e l’Autorità Giudiziaria nel caso, di omicidi senza apparente movente, negli omicidi di carattere seriale o di particolare efferatezza e nel caso di violenze a sfondo sessuale riconducibili a un unico autore, attraverso un’attività di studio, analisi ed elaborazione di tutte le informazioni disponibili, relative al particolare evento criminoso. L’informatica, e più specificatamente diverse tipologie di software, subentrano a dare ulteriore manforte a questa Unità: S.C.I.P.S. (Sistema Centrale Informativo di Polizia Scientifica), per mezzo del quale tutti gli Uffici del Servizio possono scambiarsi dati tecnici, immagini ed ogni tipo di informazioni. S.A.S.C. (Sistema per l’Analisi della Scena del Crimine). La Sezione Indagini Speciali ha progettato e realizzato autonomamente questo sistema per supportare le attività dell’A.I. e dell’A.C. Il S.A.S.C. è un articolato sistema informativo in grado di gestire, in forma multimediale, e di collegare o correlare, anche automaticamente, le informazioni sottoposte all’esame dell’U.A.C.V. Sezione Terza: Didattica, Biblioteca e Pubbliche Relazioni. Il settore didattica cura l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di specializzazione di Polizia Scientifica, per il conseguimento della qualifica di Videofotosegnalatore e Dattiloscopista, riservati al personale della Polizia di Stato. Il settore biblioteca si occupa dell’acquisto di volumi specialistici e della gestione della Biblioteca del Servizio. Le Pubbliche Relazioni si occupano di organizzazione e svolgimento di visite da parte di richiedenti italiani e stranieri. La Seconda Divisione Sezione Prima: Identità Preventiva. La Sezione comprende il Casellario Centrale d’Identità, l’archivio completo di dati personali della Direzione Centrale della Polizia Criminale, al quale pervengono i cartellini fotosegnaletici redatti dagli Uffici della Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e, tramite Interpol, dalle Polizie straniere. Al suo interno, si svolgono ricerche dattiloscopiche per l’identificazione di persone precedentemente segnalate con medesime o con diverse generalità (alias). Sezione Seconda: Identità Giudiziaria. La Sezione provvede all’identificazione degli autori di reato attraverso frammenti di impronte, digitali o palmari, rilevati sul luogo del delitto. Sezione Terza: Indagini Grafiche. La Sezione effettua accertamenti su manoscritti, dattiloscritti e su documenti realizzati con stampanti collegate a personal computer. 329 Criminologia ed elementi di criminalistica L’A.F.I.S. (Automatic Fingerprint Identification System) è quel complesso tecnologico specializzato nella gestione automatizzata delle impronte digitali dato che la criminalistica moderna attribuisce all’esame delle impronte papillari (digitali e palmari) una determinante valenza per l’identificazione personale. Il software analizza ogni cartellino o frammenti inseriti, rileva i punti caratteristici di ogni impronta (codifica), le cosiddette minutiae, confronta l’impronta del dito indice (per velocizzare la ricerca) con quelle di tutti i cartellini presente nella base dati; evidenziando infine, la lista dei probabili candidati. La Terza Divisione Sezione Prima: Indagini Medico-Legali. La Sezione si occupa dell’identificazione dei resti scheletrici (diagnosi sulle specie, sesso, razza, età e individualità) dei cadaveri in fase di studio. Inoltre, rileva le impronte digitali, in caso di cattiva conservazione del cadavere, utilizzando la tecnologia laser-scanner. Interviene nell’attività patologica-forense sul territorio nazionale, in caso di rinvenimento di cadaveri sconosciuti, di vittime di disastri o in occasioni di grandi sciagure. Sezione Seconda: Indagini Biologiche. La Sezione articolata in numero di 3 settori, effettua analisi su reperti biologici costituiti da sostanza ematica, liquido seminale, saliva, formazioni pilifere e resti umani. Tramite tecniche e macchinari all’avanguardia, si svolgono analisi sul DNA sia nucleare che mitocondriale. La Quarta Divisione Sezione Prima: Indagini foniche, videoregistrazione e telesorveglianza. La Sezione, articolata in 5 settori, provvede, su specifica richiesta degli Organi Investigativi Centrali, Periferici e dell’Autorità Giudiziaria, al riconoscimento del parlante, ad effettuare servizi di intercettazione telefonica, ambientale, cellulare e fax, alla localizzazione di emissioni radio, alla bonifica di ambienti, ad appostamenti video-fotografici, all’installazione di microtelecamere e al pedinamento elettronico. Sezione Seconda: Indagini Balistiche. La Sezione si occupa: - dell’identificazione di documentazione e classificazione di armi, cartucce, bossoli e proiettili rinvenuti a seguito di episodi delittuosi, utilizzando le varie e delicatissime attrezzature presenti nei vari laboratori; - degli accertamenti tecnici, diretti a verificare l’efficienza e la funzionalità delle armi in sequestro (mediante l’impiego di dinamometri, cronografi balistici, sonde endoscopiche a fibbre ottiche, nonché di sistemi di video registrazioni applicati); - delle prove tecniche di natura comparativa su bossoli e proiettili, repertati in seguito ai sopralluoghi e agli esami autoptici (supportati da microscopi comparatori ottici e da attrezzature fotografiche computerizzate). 330 La criminalistica La Sezione si avvale, peraltro, del S.A.I.B., ovvero il Sistema Automatizzato per le Indagini Balistiche; codesto sistema è basato su un database che memorizza i dati alfanumerici relativi alle informazioni tecniche e investigative, alle indagini relative alle caratteristiche delle armi dei bossoli e dei proiettili (palla unica e spezzato), permettendo, poi, le relative ricerche incrociate. Sezione Terza: Indagini Fisiche. La Sezione si divide in 3 specialità: - il settore Revisioni dello sparo si occupa della ricerca e della relativa analisi delle tracce di particelle generate dallo sparo di armi da fuoco su superfici di varia natura (carta, indumenti, cute, ecc.). - il settore Esplosivistica cura: l’analisi di eplosivi integri, nonchè affini, come detonatori, micce e dispositivi similari (per classificarli e stabilire la provenienza), lo studio dei residui di esplosione (sottoposti a processi di estrazione e purificazione messi a punto per isolare eventuali tracce) e trattamenti chimico-elettrolitici per la rigenerazione dei numeri di matricola obliterati sulle armi da fuoco. - il settore Analisi inorganiche provvede, invece, alla identificazione di solidi cristallini; inoltre, analizza e opera le comparazioni morfologico-compositivo tra campioni solidi di terreni, vernici, vetri ecc. Sezione Quarta: Indagini Chimiche. La Sezione indagini chimiche si occupa dell’analisi delle sostanze inserite nelle tabelle del T.U 309/90 sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope. L’attività, tuttavia, si estende anche all’identificazione di altre sostanze che rivestono interesse tossicologico (sostanze da taglio, sottoprodotti di origine e di lavorazione presenti nello stupefacente e qualità e quantità dei principi attivi). Sezione Quinta: Indagini Merceologiche. La Sezione è articolata in tre settori e si occupa della natura chimico-fisica sui reperti appartenenti a numerose classi di materiali. Il settore Falso documentario e nummario accerta l’autenticità di documenti di identità e di banconote (alterazioni e contraffazioni), mediante verifica degli elementi di sicurezza. Il settore Incendi, svolge attività di sopralluogo e repertazione finalizzata all’individuazione delle cause degli stessi (ricerca ed individuazione di tracce di sostanze infiammabili, specie acceleranti o idonee a mantenere la combustione), attraverso il punto di innesco, e sue modalità, nonché, la ricostruzione della dinamica di propagazione. Il terzo settore, Fibre, vernici e materiali plastici, si occupa di effettuare esami tecnico-specifici su tutta una serie di materiali di largo utilizzo nella società, che, però, vengono a coesistere durante fatti o eventi di natura criminosa. Sezione Sesta: Esaltazione Impronte Latenti. La Sezione si occupa della evidenziazione delle impronte papillari latenti, presenti sulle superfici dei reperti sequestrati in occasione di episodi delittuosi. La Sezione interviene, anche, in caso di disastri (aerei, navali, ferroviari,ecc.) per raccogliere i dati utili al riconoscimento delle vittime. 331 Criminologia ed elementi di criminalistica Per una suddivisione interna, che dipende dal tipo di analisi svolte, questa Sezione è articolata in 2 settori denominati chimico e fisico. Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, si evince l’enorme importanza delle funzioni svolte da parte della Polizia Scientifica, non solo a servizio della Magistratura e della ricerca della verità, ma soprattutto come valido strumento per i singoli cittadini, offesi e oltraggiati dal crimine. 15.3RACIS e RIS Il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Ra.C.I.S.) è la struttura preposta a soddisfare le richieste di indagini tecnico-scientifiche di P.G., dei Reparti dell’Organizzazione Territoriale e Speciale dell’Arma, della Magistratura e delle altre Forze di Polizia. Il Raggruppamento svolge, nei casi più gravi e delicati, anche l’attività di Sopralluogo e Repertamento sulla scena del crimine. Il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche è organizzato come segue: - un reparto denominato di Addestramento, deputato alla formazione e alla qualificazione del personale nel settore delle investigazioni scientifiche; - un reparto di Analisi criminologiche, preposto ad attività di suppporto alle indagini, mediante la ricerca di elementi di connessione/analogia con altri fatti delittuosi e valutazione del profilo criminologico degli autori dei delitti; all’effettuazione di studi e ricerche sulle tecniche di esame della scena del crimine e all’aggiornamento di una banca dati sui crimini violenti; - un Reparto Tecnico, deputato ad attività di sperimentazione e controllo di qualità. I Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS) Dal Raggruppamento dipendono quattro Reparti Investigazioni Scientifiche con sede a Roma, Parma, Messina, Cagliari, retti da Ufficiali Superiori e posti alle dipendenze del Generale Comandante del Raggruppamento. La competenza dei quattro Reparti è determinata per territorio e per materia: - il Reparto di Roma è com
Scaricare