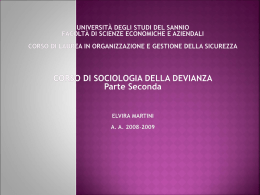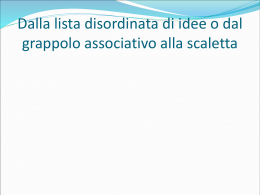A06 63 Roberto Cornelli Insicurezza e criminalità Copyright © MMVII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, 133 A/B 00173 Roma (06) 93781065 ISBN 978–88–548–1402–8 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: ottobre 2007 A Samuele e Sofia Luce, e a Chitta, sempre. Indice Introduzione 1 Capitolo 1 L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 11 1.1 “Allarme criminalità” e genesi della ricerca sulla paura 1.2 L’ “allarme sicurezza” nell’Italia degli anni Novanta 1.3 Il ruolo della ricerca criminologica in Italia 11 22 37 Capitolo 2 Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica 41 della paura 2.1 Premessa: quantificare, spiegare e definire la paura della criminalità 2.2 Quanto è diffusa? L’esigenza di quantificare 2.3 Da cosa dipende? L’esigenza di spiegare 2.4 Primo intermezzo: il dibattito sulla razionalità delle passioni 2.5 Cos’è la paura della criminalità? L’esigenza di condividere una definizione 2.6 Luci e ombre della versione criminologica Capitolo 3 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 3.1 I tre vertici della modernità 3.2 Libertà e sicurezza nella “modernità liberale” 3.3 Uguaglianza e Stato sociale. L’insicurezza nel periodo di crisi della “modernità organizzata” 3.4 Crisi della solidarietà e incertezza. Verso una “fraternità” debole 3.5 Dalle insicurezze tardo-moderne alla paura della criminalità 3.6 Le ondate di “panico morale”: la centralità della paura quale esito di strategie politiche I 41 43 50 60 72 88 93 93 99 108 124 156 162 II Indice Capitolo 4 La paura della criminalità al centro della modernità 4.1 Paura, violenza e ordine 4.2 Secondo intermezzo: l’ira di Achille e l’apparato significante delle passioni 4.3 Paura della violenza e cultura moderna 4.4 La paura dopo Hobbes 4.5 Paura della violenza e sistema penale moderno 4.6 Conclusioni Bibliografia 173 173 181 199 214 229 243 249 Introduzione Appena ho conosciuto una cosa comincio di nuovo a conoscerla Heinz von Foerster Si ritiene comunemente che l’invasione della paura nelle società contemporanee sia l’esito dell’assenza di politiche adeguate nel contrastare la criminalità dilagante e nel ristabilire l’ordine nelle città. L’aumento del numero di reati e l’efferatezza con cui vengono commessi – si dice – producono un senso diffuso d’insicurezza che si traduce in richiesta di maggiore protezione da episodi criminali e, di conseguenza, in una legittima domanda di maggiore severità punitiva. Sulla linearità di questo percorso si sono costruite gran parte delle politiche di sicurezza urbana adottate fino a oggi. Il mio lavoro si sviluppa lungo il sentiero interpretativo che unisce i tre concetti di paura, criminalità e ordine, con l’intento, però, di approfondirne criticamente ogni passaggio. Il punto di partenza dell’analisi è costituito dall’osservazione dell’esplosione dell’allarme sicurezza nell’Italia degli anni Novanta e della centralità della paura nelle esperienze quotidiane e nei discorsi pubblici (cap. 1). In quegli anni, un vortice di eventi critici – il crollo di un sistema politico, la crisi economica, la corruzione di amministratori e funzionari pubblici, le ondate migratorie, lo scontro istituzionale, le stragi mafiose – trasformarono profondamente le relazioni tra cittadini, e tra questi e le istituzioni, influendo profondamente sulle sensibilità individuali. Rabbia, indignazione, preoccupazione, delusione e sfiducia trovarono una modalità di espressione nella scena sociale e politica nelle proteste di piazza – il più delle volte organizzate da comitati, associazioni o partiti – le quali, nelle grandi aree urbane, si orientarono sui temi della vivibilità, delle inciviltà e della “microcriminalità”. L’eco mass-mediatica di questi eventi, l’enfasi politica sui sentimenti sociale di esasperazione e la crescente rilevanza dei risultati delle indagini demoscopiche sulle insicurezze delle persone contribuirono a rafforzare il 1 2 Introduzione senso di crisi della sicurezza pubblica. In questo scenario, la paura della criminalità iniziò a circolare come esperienza affettiva in grado di intercettare e rappresentare la crisi. Lo studio prosegue con la ricostruzione delle diverse prospettive di analisi sviluppatesi nel corso degli anni: la “scoperta” della centralità di questa “emozione” ha stimolato il sorgere di numerosi tentativi d’interpretazione che, consolidandosi nell’ambito di “saperi” distinti, hanno espresso diverse “versioni” della paura della criminalità. Ho utilizzato il termine “versione” in contrapposizione al termine “visione”. Riferirsi a quest’ultimo implica l’idea che certe concezioni siano più autentiche o più scientifiche di altre. La versione, invece, non s’impone, si costruisce; non si definisce nel registro della verità oppure della menzogna o dell’illusione, ma in quello del divenire: il fatto di affrontare le nostre conoscenze delle passioni come altrettante versioni del mondo o delle passioni mi sembra possa aiutarci a comprendere, senza squalificare, ciascuno dei mondi in cui tali passioni hanno potuto emergere […] se due versioni della passione sono contraddittorie, non vuol dire che sono vere o false, significa semplicemente che sviluppano versioni diverse in modi diversi, che le trasformano articolandosi a dispositivi diversi1. Così, la scelta di descrivere alcune “versioni” della paura della criminalità mira a comprendere le mappe scientifiche entro cui tali modalità interpretative si sono costruite e le istanze a cui hanno inteso dare risposta.2 Nello stesso tempo, tuttavia, tale scelta non implica necessariamente una rinuncia a esprimere una propria versione che, tenendo conto dell’apporto delle altre, punti ad ampliare la comprensione del fenomeno attraverso la proposta di una nuova prospettiva da cui osservarlo. In questa direzione, pur compiendo una ricostruzione della letteratura sul tema ed evidenziando la specifica angolatura da cui ciascun corpo di studi ha inteso analizzarlo, l’interesse che ha mosso questo studio è stato quello di rispondere ad alcuni interrogativi che ancora oggi rivestono un carattere di 1 V. Despret, Ces émotions qui nous fabriquent, ethnopsychologie de l’authenticité, Seuil, Paris, 2001 (trad. it. Le emozioni. Etnopsicologia dell’autenticità, Eleuthera, Milano, 2002, p. 29). 2 Cfr. A. Ceretti, L’orizzonte artificiale. Problemi epistemologici della criminologia, Cedam, Padova, 1992, p. 339: «ogni ipotesi dipende dunque dal proprio modo di vedere e costruire l’oggetto – allo stesso modo in cui una macchia del test di Rorschach dà luogo a risposte viste in modo differente da parte di soggetti testati – e non dipende dai controlli empirici». Introduzione 3 attualità, imboccando direzioni di riflessione e di analisi spesso inconsuete per la tradizione criminologica. “Quanto è diffusa la paura della criminalità?”. Questa è la domanda che ha dominato la prima fase di sviluppo della ricerca criminologica e che, ancora oggi, costituisce il motivo principale per cui mass-media, istituzioni, politici e associazioni commissionano, comunicano e commentano studi sull’argomento. Infatti, a partire dai primi sondaggi di opinione svolti negli Stati Uniti, l’obiettivo principale è stato quello di informare il sistema politico circa lo stato di insicurezza della collettività. Non sempre i risultati, soprattutto nei casi di maggiore rigore metodologico delle tecniche d’indagine, hanno confortato l’opinione comune relativa alla progressiva crescita dello stato di allarme delle persone; purtuttavia, essi vengono il più delle volte diffusi se, e nella misura in cui, danno sostegno alle opinioni di senso comune (par. 2.2). All’esigenza di “dimensionare” si è affiancata da subito anche quella di “determinare” le cause di questa emozione, al fine di individuare politiche adeguate che, intervenendo su di esse, potessero ridurne l’ammontare. Alla prima domanda, quindi ne è seguita un’altra: “Da cosa dipende?”. La risposta inizialmente è apparsa scontata: se si tratta, letteralmente, di paura di subire un reato, la criminalità ne costituisce necessariamente la causa principale; di conseguenza, per diminuire l’ammontare della prima non si può fare altro che inasprire le misure di contrasto alla seconda. Ben presto ci si è accorti che tale spiegazione non reggeva di fronte alla rilevazione di uno scarto tra consistenza effettiva del rischio di criminalità e livello di percezione dell’insicurezza. Vulnerabilità, quantità e qualità delle informazioni disponibili sul crimine, percezione della qualità della vita, disordine urbano, livello di coesione sociale e di fiducia istituzionale sono i principali fattori analizzati in circa quaranta anni di ricerca sulla fear of crime (par. 2.3). L’eterogeneità delle cause e la conseguente messa in crisi della concezione originaria e di senso comune, che vedeva questo stato d’animo come una semplice ricaduta sull’individuo dell’incremento del fenomeno criminale, hanno stimolato l’approfondimento sulla sua definizione. Riprendendo il significato del termine “paura” nelle scienze neuro-psicologiche – che nel primo intermezzo sulle passioni intendo considerare all’interno del più ampio dibattito sulla loro razionalità (par. 2.4) –, alcuni criminologi hanno tentato di fornire una risposta innovativa alla domanda “Cos’è la paura della criminalità?”: è un’emozione che nasce dalla percezione di una minaccia imminente messa in atto da altre persone, che consiste in una reazione psicofisica e che attiva l’individuo nella ricerca di risposte adeguate per risponde- 4 Introduzione re all’evento minaccioso. La proposta di condividere una definizione scientifica del fenomeno indagato ha l’obiettivo di evitare la proliferazione di indicatori utilizzati nelle indagini e le inevitabili distorsioni nella rappresentazione del fenomeno (par. 2.5). Analizzando le tre domande che hanno accompagnato lo sviluppo della ricerca criminologica si nota come esse siano l’espressione di tre esigenze – quella di informare la collettività, quella d’individuare delle soluzioni al problema, quella di evitare la sovra-rappresentazione del fenomeno e la predisposizione di interventi inadeguati – strettamente connesse a un interesse politico che si potrebbe sintetizzare nell’espressione “comprendere per intervenire”. Assumendo che la paura della criminalità sia preminente, contingente e, quindi, passibile di riduzione attraverso interventi immediati e mirati, la quasi totalità degli studi criminologici si è orientata nel fornire una rappresentazione del fenomeno che rendesse possibile l’elaborazione di politiche di rassicurazione. Nel fare questo, dapprima ha operato una riduzione di ogni tipo d’insicurezza sociale nel concetto di fear of crime – anche attraverso l’utilizzo nelle indagini di una vasta gamma di indicatori che rilevavano fenomeni diversi –; in seguito, nel tentativo di differenziare stati d’animo diversi e d’individuare una definizione “stretta” di paura, ha operato una riduzione del concetto di paura, confinandolo nell’ambito della dimensione corporea – reazione psico-fisica. In entrambi i casi, l’esigenza fondamentale è quella di comprendere come affrontare il senso diffuso di crisi della sicurezza pubblica: nel primo caso, riconducendo ogni tipo di preoccupazione e di ansia alla paura connessa al fenomeno criminale; nel secondo caso, fornendo una “versione stretta” di paura della criminalità, che eviti di confonderla nel “calderone dell’insicurezza” e la renda più facilmente misurabile, spiegabile e governabile. La sensazione che le modalità d’interpretazione di questa emozione si siano sviluppate nel solco dell’esigenza di elaborare interventi immediati di rassicurazione porta ad ampliare l’orizzonte della riflessione criminologica alla ricerca di versioni che permettano di coglierne le relazioni con il senso contemporaneo di crisi. Il problema non è più come risolvere la crisi della sicurezza attraverso una riduzione della paura della criminalità – sull’assunto che la seconda sostanzi la prima –, bensì come comprendere quest’ultima in uno scenario dominato dalla crisi – sul presupposto che la prima sia una delle modalità con cui si esprime la seconda. L’invito a percorrere altre strade per rispondere alla domanda “Cos’è la paura della criminalità?” proviene dall’analisi della letteratura sociologica che la interpreta come l’epifenomeno di un malessere più profondo che ri- Introduzione 5 guarda le condizioni di vita nelle società tardo-moderne. Questa versione tende a spogliarla dei caratteri di preminenza, contingenza e riducibilità, affermandone, al contrario, le radici strutturali. Da questa angolatura, la paura della criminalità s’inserisce in una rete interpretativa che ha come centro la crisi della modernità, che ho scelto di descrivere intorno ai tre ideali che hanno sostanziato il progetto moderno: libertà, uguaglianza e fraternità (cap. 3). Le istanze di democratizzazione della società e di estensione universale delle libertà borghesi, in un difficile e delicato rapporto con l’esigenza concomitante di porre dei freni ai diritti individuali in funzione di garantire sicurezza (par. 3.2), la crisi del Welfare State – inteso quale soluzione per garantire l’uguaglianza dei diritti –, connessa all’emergere di tendenze globalizzanti, alle trasformazioni nelle modalità di produzione industriale e alla crisi dello Stato-nazione (par. 3.3), e, infine, la crisi dei meccanismi di regolazione sociale, derivanti dal declino delle tradizionali forme di solidarietà che si erano costruite nell’ambito del progetto di Stato sociale come riduttore di rischi e intorno al concetto di Nazione (par. 3.4) sono le tematiche affrontate dalla letteratura sociologica contemporanea. Queste riflessioni portano a interpretare la paura della criminalità come sotto-prodotto di un più vasto e complesso sentimento d’insicurezza, come una sorta di porzione emergente di un iceberg che affonda la propria base in trasformazioni epocali le quali incidono profondamente sulle mappe che orientano nella vita quotidiana. Le diagnosi sulla modenità operate dalla ricerca sociale contemporanea e le metafore utilizzate per descriverne la crisi richiamano spesso l’idea dell’inservivibilità delle antiche mappe dello Stato, della società e dell’economia. La versione sociologica permette di situare la fear of crime in un complesso intreccio di stati d’animo connessi al declino di un modello di sviluppo economico, sociale e umano e all’assenza di un progetto alternativo. Nel contempo, essa si pone in relazione alla Politica su un piano diverso: mentre il pensiero criminologico tradizionale è orientato all’individuazione di policies efficaci – vale a dire interventi mirati capaci di ridurre nel breve periodo il fenomeno –, la riflessione sociologica, al contrario, sposta l’attenzione sulla necessità di affrontare il tema dell’insicurezza sul piano politico-culturale, ripensando alle politics – vale a dire a politiche di più ampio respiro. Pur condividendo la complessità – che non significa assolutamente insondabilità, come emerge dal lavoro di ricostruzione che ho inteso svolgere – dello scenario tardo-moderno entro cui va compresa la paura della criminalità, rimane aperto un problema: lo scarto esistente tra la sua marginalità nella versione sociologica e la centralità che occupa nell’esperienza quotidiana e nei discorsi pubblici. In altri termini, le tesi sulla crisi della modernità per- 6 Introduzione mettono di evidenziare quelle tendenze che rendono “com-prensibili” le paure contemporanee, ma non approfondiscono le ragioni per cui alcune paure occupano la scena più di altre. Com’è possibile interpretare la pervasività della fear of crime senza rinunciare a leggerla nell’intreccio delle insicurezze contemporanee? Come avviene che la prima emerga come punta dell’iceberg, lasciando le seconde sotto il livello dell’acqua? Gli studi sul “panico morale” non appaiono sufficientemente in grado di rispondere al quesito sul “perché tra le insicurezze emerge proprio la paura della criminalità?”: essi considerano la natura costruita delle passioni, ma limitano il processo di costruzione a una manipolazione politica e mediale degli stati d’animo delle persone (par. 3.6). Una possibile via per comprendere i motivi per cui la paura della criminalità è così presente e pervasiva nelle società occidentali, è quella d’indagare non tanto le modalità individuali di percezione del singolo individuo, quanto quegli orientamenti culturali (mentalità e sensibilità) comuni a larghe fasce di popolazione, che, radicandosi nelle forme istituzionali, costruiscono il modo in cui percepiamo ciò che sta intorno a noi. Così, le passioni, in quanto sensibilità che strutturano il campo culturale, possono essere intese come “apparati significanti” di un ordine morale e sociale che si vuole costruire o che si teme di perdere. Esse non sono solo “prodotti costruiti”, ma anche elementi che “orientano la costruzione” della sfera morale e politica di una collettività (secondo intermezzo sulle passioni: par. 4.2). Considerando la centralità assunta dalla paura della violenza nel pensiero filosofico-politico moderno, avanzo la tesi secondo cui questo stato d’animo – la sua presenza pervasiva nei mass-media e nelle esperienze quotidiane – costituisce uno dei punti nevralgici della produzione culturale moderna, vale a dire della costruzione, sempre conflittuale e incoerente, di quel campo di significati che, intrecciandosi con le pratiche e le forme istituzionali, costituisce la modernità. Essa reitera la riluttanza verso una condizione di violenza diffusa, “di guerra di tutti contro tutti” e sostiene il progetto moderno di costruzione di un ordine fondato sull’idea di Stato-nazione, che garantisca sicurezza – attraverso la monopolizzazione della violenza e la fondazioneconservazione del diritto – e promuova libertà, uguaglianza e fraternità (parr. 4.3 e 4.4.). Nei momenti di “crisi”, la paura ri-emerge come “segnale d’allarme”, avvisando del fatto che questo progetto non regge di fronte al divenire storico, e come “monito morale”, indicando la necessità di recuperare la tenuta di quel progetto o di individuarne un altro in grado di non abbandonare le persone – a partire dalle meno capaci – nel mezzo del “vortice” degli eventi. Introduzione 7 Sono le stesse istituzioni a ri-scoprire questo stato d’animo come risorsa simbolica per la loro legittimazione. In questo senso, più che prodotto della crisi della modernità, e quindi fenomeno tipico della tarda modernità, la paura della criminalità costituisce semmai un tratto essenziale della modernità. Questa versione della paura restituisce un significato culturale all’azione politica nel campo della sicurezza, non come semplice strumento per risolvere problemi, bensì come modalità per affermare i valori e i principi per la costruzione dell’ordine che seguirà alla modernità. Il sentiero di questa ricerca è dunque tortuoso, e il metodo utilizzato per cogliere questa tortuosità è “liquido”: non è stato determinato a priori, di volta in volta ho deciso il “passo” da tenere in relazione alle tematiche da affrontare. E non potrebbe essere diversamente: «ogni ricerca è un lungo sentiero con molti bivi e diramazioni, e a ogni bivio deve essere presa una decisione […]. Nessuna regola, nessun algoritmo può dire qual è la decisione giusta […]. Più il ricercatore concepisce il metodo come una sequenza rigida di passi, più decisioni prenderà senza riflettere e senza rendersene conto»3. Così, nel primo capitolo ho adottato prevalentemente una prospettiva di ricostruzione storica degli eventi che hanno segnato l’Italia degli anni Novanta, tesa a dimostrare la pervasività della paura della criminalità. Nel secondo capitolo ho svolto una rassegna della letteratura criminologica sul tema, arricchendola di dati empirici e di riflessioni filosofiche e psicologiche intorno all’opposizione ragione-passione. Nel terzo capitolo, ho adottato uno sguardo storico e sociologico insieme, al fine di descrivere il senso diffuso di crisi e le sue relazioni con il tema indagato. Nel quarto capitolo, il più multidisciplinare, ho ricostruito la centralità della paura nella modernità come esito di un percorso che ha attraversato i campi del costruttivismo sociale e dell’antropologia, della filosofia politica, della sociologia della devianza e della criminologia teorica. Sono convinto che questa eterogeneità, per alcuni versi necessaria a descrivere le differenti versioni prese in considerazione e per altri versi fondamentale al fine di proporre una nuova lettura, non sia più un elemento d’imbarazzo per un disciplina – la criminologia – che nel corso della sua evoluzione ha attinto da saperi anche molto distanti tra loro sempre nuova lin- 3 J. Kritz, Facts and Artefacts in Social Science, An Epistemological and Methodological Analysis of Empirical Social Science Research Techniques, MacGraw-Hill, New York, 1988. 8 Introduzione fa per “leggere” il campo penale. Non solo: l’assunzione di uno sguardo costruttivista – che costituisce una possibilità di rifondazione epistemologica della disciplina4 – comporta necessariamente l’esplorazione di altri saperi che permettano di superare l’opposizione tra soggetto osservante e oggetto osservato attraverso l’analisi dei significati che il primo attribuisce al secondo. Così, una semplice curiosità espressa dal quesito “perché tra le insicurezze emerge proprio la paura della criminalità?” ha portato a considerare questa emozione non come semplice “dato” da osservare e spiegare nelle sue relazioni causali con altri fatti, bensì come “luogo teorico” di costruzione di significati delle esperienze sociali e di produzione dell’ordine istituzionale. Ho scelto di dare conto della tortuosità di questo sentiero ripercorrendo le tappe principali del mio percorso di studio, ormai quasi decennale, su questo tema. Significativamente, i luoghi in cui ho svolto l’attività di ricerca in questo periodo hanno esercitato una forte influenza sulle direzioni del percorso intrapreso. Per questo motivo, desidero ricordare le lezioni di Criminologia tenute dal Prof. Adolfo Ceretti e gli interventi di alcuni studenti sui temi dell’epistemologia criminologica e dei rapporti tra Giustizia e Politica: dalle aule della sede provvisoria del Secondo Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano, poi approdato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca, è maturata l’idea di studiare il tema della sicurezza urbana, frequentando i luoghi in cui si cominciava a parlarne. Tra questi, la partecipazione alle riunioni del Comitato Scientifico del Progetto Città Sicure della Regione Emilia-Romagna, presieduto dal Prof. Massimo Pavarini e composto da eminenti studiosi italiani di materie sociocriminologiche, mi ha permesso di adottare da subito uno sguardo “complesso” sul fenomeno e di riflettere criticamente sulle politiche di sicurezza che si andavano affermando anche in Italia. I contatti e l’amicizia personale con tutto lo staff del Progetto Città Sicure – strutturatosi successivamente in Servizio – e, in particolare, con Cosimo Braccesi, Rossella Selmini e Giovanni Sacchini (ma davvero dovrei continuare citando tutti coloro che vi hanno lavorato e ancora vi lavorano) hanno fornito numerosissimi spunti di analisi e occasioni di confronto e dibattito – anche nell’ambito del Forum Italiano sulla Sicurezza Urbana – su temi politici e di ricerca criminologica. 4 In questa direzione, A. Ceretti, op. cit. a nota 2, pp. 336-341. Introduzione 9 Contemporaneamente, frequentando il Corso di Dottorato Internazione di Ricerca in Criminologia dell’Università di Trento e lavorando per un triennio presso il Centro di ricerca “Transcrime”, coordinato dal Prof. Ernesto U. Savona, ho avuto l’opportunità di analizzare la letteratura internazionale sulla fear of crime, di osservare da vicino le modalità di costruzione e svolgimento delle indagini internazioni di vittimizzazione (grazie alla vicinanza di Anna Alvazzi Del Frate e John van Kesteren) e osservare – anche direttamente – le esperienze politiche di altri Paesi (soprattutto il Canada). Nel contempo, ho potuto applicare queste conoscenze acquisite attraverso il coordinamento di due indagini sulla percezione d’insicurezza e sulla fiducia nelle Forze di polizia, condotte da Transcrime con tecniche di rilevazione statistica delle opinioni delle persone. Il tempo trascorso a Transcrime è stato fondamentale per la mia formazione e mi ha permesso di approfondire alcune criticità della ricerca criminologica tradizionale sulla paura della criminalità – in particolare, quella condotta con strumenti di rilevazione statistica –, anche sperimentandone direttamente potenzialità e limiti. La discussione di questi limiti mi ha portato anche a una maggiore consapevolezza circa la necessità di allargare l’orizzonte della mia ricerca. Concluso il dottorato e trasferitomi per “esigenze di vita”a Milano, la mia riflessione, anche grazie alle numerose occasioni di collaborazione con il Prof. Adolfo Ceretti, si è diretta più convintamene verso quei saperi (sociologia della conoscenza e delle istituzioni, antropologia, filosofia politica) che costituiscono dei luoghi di confronto prolifici anche per la riflessione criminologica e politico-criminale. In questi ultimi anni, la Cattedra di Criminologia dell’Università di Milano-Bicocca si è andata caratterizzando come luogo aperto, multidisciplinare e “sensibilizzante” rispetto a tematiche e ad approcci innovativi. Ad Adolfo, amico e Maestro, devo molto, soprattutto per l’incessante e produttiva ricerca di sguardi inusuali ai temi classici della criminologia. L’augurio – rivolto a lui, a me e a tutti i suoi collaboratori – è di riuscire sempre a percorrere sentieri tortuosi. Capitolo 1 L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta Criminalità, 9 su dieci hanno paura. Il 57 per cento si sente "assediato" La Repubblica, 8 luglio 2007 1.1 “Allarme criminalità” e genesi della ricerca sulla paura Un rapido sguardo all’ “emergenza sicurezza” in alcuni Paesi occidentali Nel corso degli anni Novanta anche in Italia, con qualche decennio di ritardo rispetto ad altri Paesi europei, esplose l’ “allarme sicurezza”. Non fu la prima volta che nel nostro Paese il dibattito si concentrò sul tema della criminalità dilagante. Il biennio 1974-75, in particolare, fu caratterizzato da un’intensa campagna di opinione sulla drammaticità e la diffusione del fenomeno criminale, unita alla richiesta di maggiore fermezza rispetto a fenomeni criminali emergenti, quali terrorismo e criminalità organizzata. Questo clima politicoculturale, che seguì all’approvazione della riforma penale del 1974 (decreto legge n. 99, convertito nella legge n. 220) che si era proposta, al contrario, di alleggerire il carico sanzionatorio1, supportò quell’insieme di interventi legislativi che oggi si suole definire “legislazione d’emergenza”.2 1 Cfr. A. Ceretti, R. Cornelli, Proprietà e sicurezza. La centralità del furto per la comprensione del sistema penale tardo-moderno, Giappichelli editore, Torino, 2007. 2 Giorgio Marinucci rileva come siano di per sé eloquenti il titolo e la successione temporale delle leggi: “Nuove norme contro la criminalità” (l. n. 497/1974), “Disposizione a tutela dell’ordine pubblico” (l. n. 152/1975), “Disposizione a tutela dell’ordine pubblico” (l. n. 533/1977), “Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati” (l. n. 171/1978), “Misure urgenti per la tutela 11 12 Capitolo 1 Le critiche a tale nuovo corso della politica penale non si fecero attendere. Vale la pena ricordare il severo giudizio espresso da Guido Galli, il quale interpretò la legislazione della fine degli anni Settanta nei termini di una grave svolta nelle scelte di politica criminale operata tramite l’utilizzazione in chiave repressiva del processo penale come strumento di difesa e controllo sociale. Nell’analisi del d.l. 59/1978 recante “Norme penali e processuali per la prevenzione e repressione di gravi reati” il magistrato e criminologo italiano affermò: viviamo, certo, tempi scuri: ma gli strumenti per uscirne non devono essere totalmente inidonei alla difesa delle istituzioni e della vita dell’individuo; od indiscriminatamente compressivi della libertà individuale, in nome di “ragioni di emergenza” il cui sbocco frequente ci è purtroppo ben noto”.3 In questa direzione, alcuni contestarono il presupposto stesso dell’aumento della criminalità4, altri intesero svelare le “ragioni politiche” del nuovo corso di governo della criminalità: in un periodo di crisi economica – contestuale alla prima crisi petrolifera del 1973 – l’induzione di allarme sociale serviva da un lato alle classi dirigenti per deviare l’attenzione dai reali problemi economici e dalle difficoltà di governarli politicamente, dall’altro consentiva al ceto politico – non solo di governo5 – di recuperare il deficit di dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica” (l. n. 15/1980). Cfr. G. Marinucci, “Problemi della riforma del diritto penale in Italia”, in G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), Diritto penale in trasformazione, Giuffrè, Milano, 1985, p. 351. In particolare, la legge n°152/1975 (Legge Reale) limitò drasticamente la possibilità di concessione della libertà provvisoria (art.1); previde nuove ipotesi di procedimento con rito direttissimo (art. 12, 17, 26); dilatò i presupposti del fermo giudiziario (art. 3) e ampliò i poteri di perquisizione (art. 4); estese l’uso legittimo delle armi da parte della polizia (art. 14), stabilendo una particolare procedura di favore per i reati relativi all’uso delle armi commessi da appartenenti alla forza pubblica (art. 27-32). Cfr. S. Rinaldi, “Ordine pubblico e criminalità nel dibattito della sinistra giuridica (1974-1976)”, Dei delitti e delle pene, 87/1, pp. 61-119. 3 G. Galli, La politica criminale in Italia negli anni 1974-1977, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1978, pp. 1-3. Cfr. S. Rinaldi, op. cit. a nota 2. In direzione analoga, si veda la considerazione di Domenico Pulitanò sui profili di legittimità della legislazione emergenziale: «le tendenze ad un sindacato di merito dei fini politici, avvalorate dalla legislazione dell’emergenza rappresentano sotto questo profilo un elemento di autoritarismo illegittimo». D. Pulitanò, “Delitto politico”, Digesto, IV Edizione, Utet, Torino, 1989. Cfr. anche D. Pulitanò, “Misure antiterrorismo. Un primo bilancio”, in. Democrazia e diritto, 1981. 4 Alla luce dei dati Istat relativi alla criminalità registrata a partire dal Dopoguerra, queste critiche appaiono oggi infondate. Per un approfondimento sull’andamento della criminalità nel periodo considerato si veda R. Cornelli, A. Ceretti, op. cit. a nota 1. 5 Stanislao Rinaldi accusa esplicitamente e duramente il Partito Comunista Italiano di quegli anni, a un passo dalla realizzazione del compromesso storico, di non essersi opposto alla centralità che andava assumendo l’ordine pubblico all’interno della politica penale. S. Rinaldi, op. cit. a nota 2. L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 13 consenso sociale, presentandosi come difensori della società contro il pericolo criminale. Nonostante il mutamento di segno delle politiche penali6, che nei fatti si accompagnò, proprio a partire dagli anni Settanta, all’aumento costante dei tassi di incarcerazione7, nell’Italia di quegli anni non si verificarono le condizioni politico-sociali e culturali idonee ad assecondare campagne allarmistiche e a stimolare la diffusione di richieste generalizzate di interventi di law and order. In estrema sintesi, si potrebbe dire che l’accentuata tendenza – tipica in particolar modo degli anni Settanta – a interpretare in chiave politica le situazioni sociali ha delimitato in ambiti specifici la preoccupazione per la questione criminale: nel terrorismo e nella criminalità organizzata8. In molti altri Paesi europei, al contrario, gli anni Settanta si caratterizzarono per la centralità della questione criminale nel dibattito pubblico e per l’elaborazione di progetti di politica criminale che trovarono attuazione nel decennio successivo.9 In Gran Bretagna il progetto di politica criminale avviato da Margaret Thatcher, eletta Premier nel 1979, si articolò intorno alle due parole-chiave, “ordine” e “controllo”, prevedendo un aumento dei poteri di polizia, la costruzione di nuove prigioni, l’approvazione di legislazioni più severe, il ricorso a privatizzazioni – intese quali strumento per aumentare l’efficacia e 6 Pulitanò ha utilizzato l’espressione “inversione di tendenza”, sottolineando come le risposte all’emergenza siano state diverse da quelle della tradizione liberale: «non già mitigazione verso il delinquente per convinzione, ma maggior rigore (in linea di principio) verso il negatore della convivenza civile e politica» (D. Pulitanò, “Delitto politico”, op. cit. a nota 3). 7 Cfr. M. Pavarini, “La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell’Italia del XX secolo”, in L. Violante (a cura di), Storia d’Italia. Annali 12. La criminalità, Einaudi, Torino, 1997, pp. 983-1031. 8 Il terrorismo stesso, d’altronde (e parlo principalmente di quello di sinistra), per la sua continuità ideale con i movimenti popolari degli anni Sessanta e Settanta, per il suo richiamo puntuale ai valori della Resistenza, per il forte consenso che alcune organizzazioni, quali Brigate rosse e Autonomia Operaia, avevano riscosso all’inizio della loro esperienza, è stato percepito per lungo tempo nei suoi aspetti politici più che nei suoi risvolti criminali. 9 Diversamente, in Spagna le politiche di sicurezza e di prevenzione della criminalità si affermano nel corso degli anni Novanta e si caratterizzano per la frammentarietà dei principi, dei programmi e degli attori dovuta principalmente ai problemi di transizione dal regime totalitario franchista al regime democratico durante la seconda metà degli anni Settanta e negli anni Ottanta. Si veda A. Recasens I Brunet, “Politiche di sicurezza e di prevenzione nella Spagna degli anni ‘90”, in L’Inchiesta, Anno XXXIV, n. 143, gennaio-marzo 2004, pp. 44-54. 14 Capitolo 1 l’economicità di alcuni servizi (tra cui, in particolare, quelli legati alla gestione degli istituti penitenziari).10 Nel corso degli anni Settanta, in Francia, il sentimento d’insicurezza si diffuse come peur du crime contestualmente a un rapido incremento dei tassi di criminalità, al comparire dei primi atti terroristici, ma anche all’utilizzo di statistiche per monitorare le opinioni dei cittadini rispetto al sistema di Giustizia Penale e allo sviluppo dell’ “industria della sicurezza”: le prime risposte all’insicurezza furono di tipo privatistico – vendita di sistemi di protezione dei veicoli e delle abitazioni –; successivamente furono i Sindaci a essere investiti dalla domanda di sicurezza, i quali risposero con politiche municipali che, in un primo momento, si limitarono a regolamentare e a intervenire amministrativamente. La situazione cambiò rapidamente quando, all’inizio degli anni Ottanta, il Fronte Nazionale avanzò nei consensi elettorali con una piattaforma politica fondata sul binomio insicurezza-immigrazione: da preoccupazione tecnica e amministrativa, l’insicurezza divenne preoccupazione politica11. Il Fronte Nazionale radicalizzò il dibattito sulla violenza e tutti i partiti fecero marcia indietro sul tema della cittadinanza locale.12 Purtuttavia, l’origine del discorso politico sull’insicurezza non va attribuita esclusivamente all’avanzare della Destra francese: questo tema era già entrato nel vocabolario istituzionale già qualche anno prima, quando venne redatto il rapporto Peyrefitte (1977), esito del lavoro compiuto dal Comité d’Etudes sur la violence, la criminalité et la délinquance presieduto da Alaine Peyrefitte, a cui seguirono i rapporti Dubedout e Bonnemaison. Già nel primo rapporto, la paura della criminalità veniva considerata una vera e propria minaccia per le istituzioni, in quanto testimoniava il rischio che lo Stato stava perdendo la sua prerogativa, il monopolio della violenza legittima 13. Per questo motivo, l’insicurezza doveva essere interpretata innanzitutto come una questione nazionale, posta al di sopra degli schieramenti politici. I Paesi Bassi conobbero una brusca sferzata autoritaria all’inizio degli anni Ottanta, allorquando il Primo Ministro Ruud Lubbers inaugurò una campagna di rispetto dei valori tradizionali e della legge, orientando l’intera politica penale all’osservanza dell’ordine come principio etico. Furono molti 10 Cfr. T. Jefferson, J. Shapland, “Justice pénale, criminologie et production de l’ordre: les tendances de la recherche et la politique criminelle depuis 1980 en Grande-Bretagne”, Déviance et Société, vol.15, n° 2, pp 187-221. 11 S. Roché, Le sentiment d’insécurité, Puf, Paris, 1993, p. 19. 12 Ibidem. 13 Per un’analisi delle visioni e delle politiche proposte nei tre rapporti si veda Ibidem, p. 88-100. L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 15 gli interventi legislativi che mirarono alla riduzione di garanzie processuali e all’espansione di competenze delle polizie. Ma le azioni di rigore non si ebbero solamente sul piano normativo: l’amministrazione stessa della giustizia olandese si conformò all’invito rivolto ai giudici dal Ministro della Giustizia cristiano-democratico Ernst Hirsh Ballin ad adattarsi ai sentimenti della popolazione, ormai più interessata alla protezione verso attacchi criminali che alla protezione giuridica dei diritti individuali. I principi del garantismo penale vennero gradualmente sostituiti da un approccio imprenditoriale ed efficientista: la concezione dello Stato come impresa portò inevitabilmente a considerare poco produttivi e irrilevanti le garanzie penali.14 Rivolgendo lo sguardo Oltreoceano, e più precisamente negli Stati Uniti, l’ “allarme criminalità” esplose un decennio prima, nel corso degli anni Sessanta, e il modo in cui le istituzioni (re)agirono, contribuendo in tal modo alla sua definizione e diffusione, costituì un punto di riferimento inevitabile anche per le linee di azione di molti Paesi europei. Anche sul piano della ricerca scientifica, l’approccio e la definizione dei temi collegati all’allarme sociale, operata dagli enti e dalle istituzioni statunitensi negli anni Sessanta, hanno ispirato contenuti e tecniche delle ricerche degli anni successivi. In effetti, a livello internazionale la ricerca sulla paura della criminalità si è sviluppata lungo il solco tracciato dalle prime indagini svolte negli Stati Uniti dopo la metà degli anni Sessanta. Descrivere il clima politico-culturale in cui si svolsero le indagini statunitensi può risultare di qualche utilità per iniziare a riflettere sulle modalità con cui il sapere criminologico ha affrontato questo argomento. La genesi della ricerca criminologica sulla fear of crime Le ricerche sulla paura della criminalità comparsero per la prima volta negli Stati Uniti, a metà degli anni Sessanta, contestualmente al programma di “guerra al crimine” dell’allora Presidente Lyndon B. Jonhson. Il 9 marzo 1966, in una comunicazione speciale al Congresso su Crime and Law Enforcement, Johnson esordì con queste parole: «la criminalità – il fenomeno criminale e la paura della criminalità – segna la vita di ogni Ame- 14 Si veda R. Van Swaaningen, “Criminologia critica e declino del Welfare State. Un approccio normativo al controllo sociale degli anni Novanta”, Dei delitti e delle pene, 3/94, pp. 31-56. Cfr. anche R. Van Swaaningen, “Un nuovo approccio in tema di sicurezza delle città”, in L’Inchiesta, Anno XXXIV, n. 143, gennaio-marzo 2004, pp. 23-33. 16 Capitolo 1 ricano»15. È la prima volta che il termine “paura della criminalità” (fear of crime) appare in un discorso presidenziale, e da questo momento in poi sarà utilizzato costantemente nei discorsi ufficiali di ogni Amministrazione americana.16 Johnson indicò questa emozione come il più diffuso tra i “costi” che la criminalità infligge ai cittadini e, dunque, il problema principale da affrontare in un programma governativo centrato sulla “guerra al crimine”: la paura che può trasformarci in una nazione di prigionieri barricati di notte dietro porte blindate, doppie serrature e finestre barrate. La paura che ci rende insicuri a camminare per le strade cittadine di notte o nei parchi pubblici di giorno. Questi sono costi che persone davvero libere non possono tollerare. […] L’intera nazione è unita nella preoccupazione per la criminalità, […] la sicurezza dei cittadini è il primo compito del governo”.17 L’enfasi sulla “guerra al crimine”, secondo alcuni autori18, serviva ad allontanare l’attenzione del pubblico da una sgradevole e impopolare guerra all’estero, quella del Vietnam, orientandola verso problemi di politica interna. Data l’origine politica e strumentale delle ricerche sulla paura del crimine, Richard Quinney, qualche anno più tardi, sostenne che «ci sono buone ragioni per credere che l’effettiva preparazione dei questionari sull’opinione pubblica che misurano la paura del reato non sia stata imparziale»19. Ma, probabilmente, la questione della genesi della ricerca sulla paura della criminalità negli Stati Uniti è più complessa di quello che apparve in quegli anni. Di recente, Murray Lee ha operato un’ampia ricostruzione del momento storico in cui negli Stati Uniti emerse questo tema in un articolo, pubblicato sulla rivista Theoretical Criminology, che descrive la rete di strategie e di narrative istituzionali, politiche e disciplinari connesse alla costruzione della “popolazione che teme” (fearing population).20 15 J. Woolley, G. Peters, The American Presidency Project [online]. Santa Barbara, CA: University of California (hosted), Gerhard Peters (database). Disponibile sul sito internet: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=27478. 16 Questa constatazione deriva dai risultati della ricerca per parola-chiave che ho effettuato sui documenti contenuti nel The American Presidency Project (Ibidem) nel periodo che va dal 1789 al 2007. 17 Ibidem. 18 R. Quinney, Criminology, Little Brown and Company, Boston, 1979, cit. in M.J. Lynch., “Percezione del reato da parte del pubblico”, in F. Ferracuti (a cura di), Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, vol. 4, Giuffrè editore, Milano, 1991. 19 Ibidem. 20 M. Lee, “The genesis of ‘fear of crime’ ”, Theoretical Criminology, 2001, Vol. 5(4), pp. 467-485. Il seguito del paragrafo riprende in gran parte la ricostruzione dei fatti descritti in questo articolo. L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 17 A metà degli anni Sessanta, diverse organizzazioni pubbliche e private, anche per effetto dello sviluppo di nuove tecniche d’indagine statistica, all’interno del processo di costruzione della knowledge society, incentivato dal Governo a guida democratica come supporto alle politiche di welfare inserite nel Great Society Programme21, iniziarono a intervistare singoli cittadini sulle loro personali esperienze di vittimizzazione criminale, con l’obiettivo di ottenere più accurate rappresentazioni dei livelli di criminalità: nel 1965 il National Opinion Research Centre (NORC) condusse una ricerca intervistando più di 10.000 persone; ulteriori inchieste furono realizzate dal Bureau of Social Science Research nel 1967 nella città di Washington e dal Survey Research Centre dell’Università del Michigan in molte altre città americane. Attraverso queste inchieste venne “scoperta” per la prima volta la portata della preoccupazione delle persone per la criminalità. Nella seconda metà degli anni Sessanta, contestualmente allo sviluppo di un piano di governo socialdemocratico fondato sulla lotta alla povertà e alle discriminazioni, si verificarono due fatti che ebbero grande risonanza e influirono fortemente sull’opinione pubblica: l’aumento dei tassi di criminalità registrata e le rivolte nei ghetti neri delle periferie metropolitane. La reazione fu immediata: le richieste di intervento della polizia e di “legge e ordine” iniziarono ad aumentare, anche all’interno della middle class che, precedentemente, aveva sostenuto l’assistenzialismo penale22. La risposta politica non si fece attendere: vennero modificati in itinere provvedimenti legislativi di promozione di politiche di welfare fino a stravolgerne completamente l’intendimento orginario, contribuendo in tal modo a consolidare il senso diffuso di preoccupazione. Come sottolinea Lee, il libro di Richard Harris del 1969, The Fear of Crime – la prima pubblicazione a contenere il termine “paura della criminalità” nel titolo –, indicò l’emergere dell’allarme sociale per la criminalità come risultato, almeno in 21 La diffusione di indagini statistiche in ogni settore dell’amministrazione pubblica fu principalmente il risultato di un crescente desiderio politico di ammodernamento dello Stato nell’ottica di un suo intervento diretto alla promozione del benessere. In questo senso, la raccomandazione del 1965 del Scienze Advisory Committee del Presidente degli Stati Uniti, rivolta alle organizzazioni scientifico-sociali di sforzarsi di produrre statistiche descrittive dei comportamenti degli americani si lega strettamente al Great Society Programme con il quale il Presidente Johnson si presenta al Congresso degli Stati Uniti nel 1965: la ricerca statistica sui comportamenti degli americani diventa lo strumento per la costruzione razionale di una società del benessere di stampo socialdemocratico. 22 Cfr. D. Garland, The Culture of Control. Crime and Social Order in Late Modernity, Oxford University Press, Oxford, 2001 (trad. it. La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Milano, 2004, p. 258-261). 18 Capitolo 1 parte, di stratagemmi politici23. Harris, in particolare, tracciò l’iter congressuale di una legge approvata nel 1968, The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, che aveva comportato un aumento dei poteri della polizia nel fermare e arrestare le persone sospettate di aver commesso un reato e nell’ottenere le loro confessioni. L’autore individuò alcune condizioni che ne resero possibile l’approvazione: la centralità assunta dal senatore John L. McClellan, un Democratico dello Stato dell’Arkansas, Presidente della Sottocommissione sulla Legge e sulla Procedura Penale; il clima di populismo; la preoccupazione di molti senatori Democratici circa il loro futuro politico; l’appoggio di alcuni senatori Repubblicani, tra cui il futuro Presidente Richard Nixon. Vale la pena descrivere nello specifico alcuni passaggi di questa vicenda che permettono di contestualizzare meglio l’emergere della questione all’interno del Programma governativo di Johnson. Nel 1965 il Presidente Johnson istituì la Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, presieduta da Nicholas Katzenbach, nel tentativo di elaborare soluzioni bipartisan al problema della criminalità. Questa Commissione, incaricata di spiegare le cause dell’aumento della criminalità negli Stati Uniti nell’ultimo decennio, nel 1967 fissò le linee-guida del proprio lavoro nel rapporto The Challenge of Crime in a Free Society, che sottopose all’attenzione della Casa Bianca.24 Il rapporto indicava la necessità di un rilancio delle politiche educative, di una riduzione delle situazioni di estrema povertà, di una nuova politica della casa, dell’attivazione di servizi di consulenza e di sostegno familiare, del riconoscimento di diritti civili. La Commissione Katezenbach elaborò, dunque, un insieme di misure orientate a proseguire e ridefinire il programma socialdemocratico di Johnson. All’interno dei lavori della Commissione emerse anche la necessità di una rivoluzione scientifica e tecnologica nella 23 M. Lee, op. cit. a nota 20. Il rapporto del 1967 è un documento che ha destato molto interesse tra gli esperti, e ha costituito un punto di riferimento ineludibile per la riflessione su criminalità e Giustizia Penale come dimostra il fatto che trent’anni dopo i membri dell’ US Department of Justice hanno organizzato un simposio per riflettere, insieme ai componenti della Commissione e ad altri esperti e professionisti del settore, sulle politiche del passato e cogliere spunti per un’agenda futura. AAVV, The Challenge of Crime in a Free Society: Looking Back Looking Forward. Symposium on the 30th Anniversary of the President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, june 19-21, 1997, U.S. Department of Justice, 1998. Per un approfondimento dei contenuti del rapporto della Commissione Katzenbach del 1967 si vedano anche le rassegne di Norval Morris (N. Morris, “Random Reflections on ‘The Challenge of Crime in a Free Society’ “, Law and Society Review, Vol. 2, No. 2, 1968, pp. 277-283) e di Jack D. Douglas (J.D. Douglas, “Review”, American Sociological Review, Vol. 32, No. 4, 1967, pp. 664-666). 24 L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 19 Giustizia Penale (sulla base della considerazione che la mancanza di informazioni affidabili sul crimine rendono impossibile spiegarlo e controllarlo). Nell’ambito di questa priorità, i commissari indicarono la paura della criminalità quale tema di ricerca da sviluppare all’interno delle inchieste di vittimizzazione. Alcune delle misure avanzate nel rapporto furono, poi, inserite nel The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, presentato nel 1967 dal Presidente al Congresso per l’approvazione, che venne sottoposto all’esame della Sottocommissione presieduta da McClellan. Questo passaggio congressuale determinò un’alterazione quasi totale dei contenuti della legge. McClellan era un Democratico apertamente segregazionista e dichiaratamente contrario alle due sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti che avevano riconosciuto alcuni diritti agli indagati e agli imputati, contribuendo in tal modo a ridefinire le pratiche di polizia in relazione a tali garanzie (Mallory vs United States del 1957 e Miranda vs Arizona del 1966). Egli sosteneva, infatti, che queste pronunce minacciassero la stabilità della Nazione e limitassero eccessivamente la capacità delle polizie di contrastare la criminalità dilagante. Trovandosi a presiedere la Sottocommissione nel periodo in cui essa venne interpellata riguardo al The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, McClellan ebbe l’opportunità di modificare profondamente l’impronta politico-culturale del provvedimento, con interventi diretti e attraverso consultazioni di esperti esterni fortemente orientati a politiche di stampo repressivo: nessuno di coloro che chiamò a parlare nelle sedute della commissione era criminologo, giurista o esperto di materie costituzionali; molti erano invece agenti di polizia e investigatori, pochi i giudici – e, naturalmente, solo quelli d’accordo con il suo pensiero. I discorsi su “legge e ordine” e sulla paura della criminalità che inziarono a circolare in quel periodo sono attribuibili in buona parte alle strategie discorsive adottate nella Sottocommissione McClellan. Il testo portato all’approvazione del Congresso fu, dunque, molto differente da quello presentato da Johnson, soprattutto perché l’impianto welfarista risultava più debole, e perchè prevedeva una forte limitazione dei diritti civili attraverso l’ampliamento dei poteri delle polizie nell’arrestare i sospettati e nell’ottenere confessioni. Ci fu chi si oppose al provvedimento. Tra questi, il senatore Philip A. Hart, un Democratico dello Stato del Michigan, sostenne, per esempio, che la legge fosse contraria ai diritti civili, discriminatoria e dunque incostituzionale. Ma il clima culturale esterno al Congresso spinse molti politici, anche Democratici, a votare il provvedimento, nonostante fosse reputato non con- 20 Capitolo 1 divisibile. McClellan ebbe il sostegno anche del Repubblicano Richard Nixon, che presto sarebbe divenuto Presidente, e che proprio in questa occasione stese il suo primo documento politico intitolato Toward Freedom From Fear, nel quale sostenne che per eliminare la criminalità sarebbe stato più utile il raddoppio del tasso di incarcerazione rispetto alla quadruplicazione dei fondi per il programma di “guerra alla povertà”.25 Il Presidente Johnson, pur essendo contrario al provvedimento così come modificato durante i lavori della Sottocomissione, lo firmò al solo fine di non screditare l’azione del suo Governo. Nella campagna elettorale del 1972 Nixon insistette molto sul fallimento delle politiche keynesiane di welfare, accusandole di aver aumentato l’inflazione, di non aver ridotto i livelli di criminalità e di aver alimentato le rivolte nei ghetti; nella propaganda repubblicana l’aumento della paura della criminalità divenne l’indicatore più visibile del fallimento delle politiche democratiche. Il discorso politico sulla paura della criminalità, come si è già accennato, non fu prodotto nel vuoto: le nuove tecniche d’indagine delle scienze sociali e la possibilità di quantificare il fenomeno, la nuova attenzione per la vittima di reato nella criminologia e nelle scienze sociali, la preoccupazione per le rivolte sociali e per l’aumento dei tassi di criminalità sono tutti elementi di definizione e di affermazione di un tema che avrebbe costituito un tratto essenziale del campo penale tardo-moderno. Lee parla a questo proposito di ‘fear of crime’ feedback loop per indicare il processo circolare attraverso cui le dinamiche sopra accennate interagirono per produrre e intensificare la paura della criminalità e la ricerca ad essa collegata: la ricerca sulle vittime produsse e sostenne il concetto criminologico di paura della criminalità quantitativamente e discorsivamente; questa produzione scientifica, veicolata anche attraverso i mass-media, identificò la paura come un oggetto specifico di intervento da parte della politica governativa; le tecniche di regolazione governativa, sostenute dalle indagini statistiche, si rivolsero a particolari tipi di cittadini, la “popolazione che teme”; questi tentativi di governo della paura resero la cittadinanza consapevole del suo stato di allarme per il fenomeno criminale, sensibilizzandola alla paura della criminalità; i gruppi di interesse e il sistema politico presero a riferimento la categoria della “popolazione che teme” per giustificare politiche criminali più repressive, contribuendo ad aumentare l’allarme dei cittadini; 25 M. Lee, op. cit. a nota 20. L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 21 queste dinamiche stimolarono ulteriormente l’interesse scientifico e la ricerca sulla paura della criminalità, e così via.26 La costruzione del concetto di “paura della criminalità” Da questa ricostruzione emerge come, sia pure in un’ottica di relazioni multi-direzionali tra gli eventi e non di legami causali lineari, l’origine delle ricerche sulla paura della criminalità abbia sofferto della contiguità con le istanze di regolazione governativa della società statunitense degli anni Sessanta. Tracce evidenti di questa contiguità, come vedremo nel prossimo capitolo, sono presenti nell’ambiguità del concetto di paura della criminalità e nell’approssimazione degli strumenti di analisi utilizzati. La raccomandazione emersa durante i lavori della Commissione Katzenbach di sviluppare lo studio della paura della criminalità all’interno delle inchieste di vittimizzazione trovò attuazione già nella prima indagine di vittimizzazione americana (National Crime Survey), condotta nel 1972 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti: una sezione fu interamente dedicata al nostro argomento, con l’obiettivo di comparare l’ampiezza del fenomeno con il rischio effettivo di subire un reato. È sulla base dei materiali della Commissione Katzenbach, dei discorsi politici dei Presidenti (di Johnson prima e, poi, di Nixon), degli interventi dei componenti della Sottocommissione presieduta da McClellan, dei dati della National Crime Survey e dei precedenti sondaggi di opinione che venne costruito, tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta, il concetto di “paura della criminalità”, intesa come paura che sorge in conseguenza di un atto criminale. Questo concetto ha iniziato a diffondersi anche in Italia, seguendo tali tracce, a partire dagli anni Novanta, quando l’ “allarme criminalità” iniziò a occupare le prime pagine dei quotidiani, che riportarono puntualmente i dati dei primi sondaggi di opinione sulla sicurezza realizzati da istituti privati, come quello della Doxa realizzato nel luglio del 1992 (e presentato nell’ottobre dello stesso anno)27, e delle inchieste di vittimizzazione condotte da organismi internazionali28. “La criminalità aumenta, i cittadini hanno paura”. 26 Ibidem. Ansa, 26/10/1992, “Criminalità: è in aumento secondo gli italiani/Annunciato”. 28 Ansa, 18/11/1992, “Criminalità: le vittime a rischio in Italia”. 27 22 Capitolo 1 Questo il leit motiv della comunicazione mass-mediatica e politica, che lega inscindibilmente la paura della criminalità al fenomeno criminale. Non sempre i dati delle ricerche presentate alla stampa sostenevano il taglio interpretativo dei commenti di esperti, giornalisti, politici. Ma poco importa: le ricerche erano semplicemente occasioni per riprodurre lo stereotipo: aumento della paura e incremento dei tassi di criminalità divennero due realtà autoevidenti che si sostenevano reciprocamente, senza necessità di verifica e senza ombra di dubbio. 1.2 L’ “allarme sicurezza” nell’Italia degli anni Novanta. Un vortice di eventi critici La paura della criminalità entrò nel dibattito pubblico italiano a metà degli anni Novanta in un periodo che lo storico Paul Ginsborg non esita a definire di “crisi drammatica e profonda”. Vista dal Palazzo di Giustizia di Milano – continua Ginsborg – [la crisi] assunse l’aspetto di una battaglia contro la corruzione e per la restaurazione dell’autorità della legge. Dall’osservatorio della Banca d’Italia, prese la forma di una crisi di indebitamento, che avrebbe causato la sfiducia europea e internazionale nei confronti dell’economia italiana. Vista dalla Lombardia e dal Veneto, fu una rivolta contro Roma in nome del neolocalismo e della laboriosità virtuosa del Nord. A Montecitorio, il centro focale della crisi sembrò consistere nella dissoluzione delle vecchie élites e nel bisogno impellente di definire nuove regole e nuove modalità di funzionamento del sistema politico. Nella fragile società civile di Palermo, assunse l’aspetto di una lotta disperata contro il potere mafioso.29 Il senso di crisi, che si manifestò in tutta la sua portata a partire dallo storico voto di protesta nelle elezioni dell’aprile del 199230, fu l’esito di una se29 P. Ginsborg, L’Italia del tempo presente. Famiglia, società civile, Stato. 1980-1996, Einaudi, Torino, 1998, p. 471-2. Ginsborg riporta la parte centrale di un articolo apparso sul giornale inglese The Observer il 26 luglio 1992 che descrive in modo impietoso lo stato della crisi italiana: «il paese è in uno stato di caos, in uno stato di guerra. Sta rapidamente diventando la Repubblica delle banane di Europa. Ha il più alto tasso di omicidi della Comunità Europea, una corruzione tanto palese quanto dilagante, un’economia malata, un governo impotente, e una popolazione confusa ed angosciata». Ibidem, p. 494. 30 Nelle elezioni del 1992 i voti per la DC scesero al minimo storico, dal 34,3 per cento al 29,7 per cento: il partito tenne al Sud, ma in molte «aree bianche» del Nord i consensi calarono vertiginosamente. Anche i socialisti persero voti (dal 14.3 per cento al 13,6 per cento), mentre le due formazioni politiche eredi del PCI non ebbero risultati incoraggianti, ottenendo insieme meno voti di quelli che aveva preso il L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 23 rie di eventi che fecero da sfondo a sentimenti collettivi di disorientamento, di sfiducia, d’indignazione, d’insicurezza. L’impegno europeista, concretizzatosi nel corso degli anni Ottanta e nei primi anni Novanta, introdusse nella vita politica italiana una serie di vincoli sulla politica economica che agirono come parametri di giudizio sempre più severo sul suo recente passato31. I giudizi tecnici sull’ampiezza del debito pubblico si intersecarono con l’opinione diffusa sulla degradazione del sistema dei partiti che avevano occupato posizioni governative negli anni Ottanta, sulle diffuse pratiche di corruzione, sull’incapacità di affrontare le emergenze del Paese con misure efficaci di breve periodo. Il crollo dei regimi comunisti degli anni 1989-90 e la fine del bipolarismo Est-Ovest portava a ridefinire gli schieramenti politici a livello internazionale. Anche in Italia questi eventi minarono la stabilità di un sistema politico che aveva visto, a partire dal Dopoguerra, la contrapposizione tra DC e PCI32: non solo gli elettori del PCI persero i propri punti di riferimento e furono costretti a fare i conti con la propria identità politica, in un percorso che portò a scissioni, delusioni e difficili costruzioni di assetti partitici nuovi; gli stessi elettori dei partiti di governo, non più costretti dalla necessità di difendere il blocco politico che si poneva come baluardo contro il pericolo comunista, per la prima volta si sentirono liberi di esplorare vie diverse. La fine del bipolarismo Est-Ovest accentuò anche la costituzione di nuovi assetti economici sul piano globale e in tal modo contribuì a svelare la debolezza degli Stati nazionali33, e dell’Italia in particolare, nel governare i processi economici, percepita come incapacità delle classi dirigenti nell’affrontare i problemi quotidiani delle persone. Questi eventi determinarono un aumento della sfiducia dei cittadini italiani nelle istituzioni. vecchio PCI in qualsiasi confronto elettorale dal Dopoguerra (il Pds si attestò al 16,6 per cento, Rifondazione Comunista al 5,6 per cento). Indiscussa trionfatrice delle elezioni fu la Lega Nord, che passò dallo 0,5 per cento all’8,7 per cento dei consensi, ma che al Nord arrivò anche a punte del 25,5 per cento (Lombardia). 31 Ibidem, p. 474. 32 Per un’analisi delle trasformazioni che hanno modellato i partiti italiani a partire dagli anni Novanta – nel loro rapporto con il territorio (Party on the Ground), nelle strutture centrali (Party in Central Office) e nelle istituzioni rappresentative (Party in Public Office) – si veda L. Bardi, P. Ignazi, O. Massari, I partiti italiani. Iscritti, dirigenti, eletti, EGEA, Milano, 2007. 33 Cfr. J. Habermas, Die Postnationale Konstellation. Politische Essays, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1998 (trad. it. La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1999). 24 Capitolo 1 Uno studio di Leonardo Morlino e Marco Tarchi34 dimostra la centralità dell’ insoddisfazione sociale per comprendere il crollo del sistema dei partiti italiani (political change) nell’ultimo decennio del XX secolo. Se, da un lato, tale crollo avvenne contemporaneamente alla “scoperta” della corruzione diffusa in diversi settori, all’aspro conflitto tra potere politico e magistratura, all’emergere di conflitti istituzionali (tra Capo dello Stato, Primo Ministro, Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura), alla trasformazione dei partiti tradizionali e alla creazione di nuovi partiti, dall’altro lato, questi eventi, a detta degli autori, si verificarono, in diverse forme e intensità, anche in altri Paesi europei, in cui si svilupparono analoghi sentimenti di anti-politica che non determinarono, però, mutamenti politicoistituzionali così repentini35. Il political change italiano non può essere spiegato – a detta degli autori – senza considerare una caratteristica peculiare della società italiana, che costituisce un fattore più profondo e di lungo termine rispetto a quelli considerati: la cronica e diffusa insoddisfazione all’interno della società civile che è esistita a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Questa insoddisfazione prese principalmente due forme: quella “pragmatica”, vale a dire un concreto discontent riguardante il funzionamento delle istituzioni democratiche, e quella “ideologica”, connessa a una disaffezione permanente e più pericolosa per la stabilità del sistema a causa della sua connessione con valori culturali alternativi, almeno fino agli inizi degli anni Ottanta. Negli anni Cinquanta e Sessanta, tra le due forme di insoddisfazione prevalse quella ideologica. A partire dagli anni Ottanta, invece, l’insoddisfazione ideologica diminuì, soprattutto in relazione con l’aumento degli atti terroristici e la conseguente reazione di difesa dell’ordine democratico. Si assistette, così, in quegli anni, a una diminuzione della quota di persone che auspicavano un cambio di regime attraverso una rivoluzione (da quasi il 20 per cento nel 1976 a meno del 10 per cento alla fine degli anni Ottanta). L’alto livello d’insoddisfazione tra gli italiani (nel periodo 1973-1993 superava costantemente il 70 per cento, 20 punti percentuali in più della media dell’Unione Europea)36 e il passaggio graduale da un’insoddisfazione ideologica a una più pragmatica non spiegano, tuttavia, cosa ha permesso a questa insoddisfazione di esplodere vistosamente agli inizi degli anni Novanta. 34 L. Morlino, M. Tarchi, The dissatisfied Socieity: The Roots of Political Change in Italy, in European Journal of Political Research, XXX, n. 1, 1996, pp. 41-63. 35 Diversamente, Alfio Mastropaolo sostiene che all’origine della crisi del sistema politico italiano stia proprio un sentimento diffuso di antipolitica o, meglio, l'elaborazione da parte della stessa classe politica di un discorso che da populista è diventato antipolitico a fini di legittimazione e consenso (A. Mastropaolo, Antipolitica. All’origine della crisi italiana, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli, 2000). 36 Fonte: rilevazioni Eurobarometro. L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 25 Morlino e Tarchi affrontano tale questione individuando l’esistenza di due processi simultanei: il venir meno di alcuni fattori di contenimento dell’insoddisfazione, e, contemporaneamente, l’emergere di alcuni fattori incentivanti. Tra i fattori di contenimento, gli autori segnalano la perdita progressiva della memoria collettiva del fascismo e della Guerra – memoria che, per buona parte della cd Prima Repubblica, costituì un freno ad agire contro le istituzioni democratiche –, la progressiva scomparsa del ruolo anticomunista dei partiti moderati e la diminuzione della polarizzazione del conflitto politico, con conseguente perdita del senso di appartenenza ai partiti tradizionali. Tra i fattori incentivanti vengono indicati: l’impatto delegittimante dell’inchiesta denominata “Mani Pulite”, la crisi economica, il referendum dell’aprile del 1993 – con il conseguente mutamento della legge elettorale per le elezioni parlamentari. A partire da queste considerazioni, è possibile affermare che la sfiducia nelle istituzioni costituisce un tratto essenziale della cultura italiana a partire dal Dopoguerra. Essa trovò canali di espressione nell’ambito del sistema politico vigente o, a volte, al di fuori di esso (come nel caso dei movimenti di fine anni Sessanta e degli anni Settanta), ma senza mai arrivare a determinarne il crollo. Negli anni Novanta, al contrario, priva di un apparato ideologico in grado di contenerla e in presenza di eventi fortemente critici, l’insoddisfazione si espresse in modo virulento. Due fenomeni, in particolare, segnarono profondamente il senso di crisi sociale e istituzionale italiana, l’immigrazione da Paesi extraeuropei e le inchieste giudiziarie di “Mani Pulite”. E due sentimenti, tra gli altri, accompagnarono l’emergere dell’insoddisfazione sociale: l’intolleranza per gli “extra-comunitari” e l’indignazione per la corruzione politica diffusa. L’arcipelago migratorio e l’inasprimento delle misure legislative Dal 1970 a oggi in Italia si è passati da meno di 100.000 immigrati a quasi 3 milioni. Nei primi anni (negli anni Settanta e fino agli inizi degli anni Ottanta) sono individuabili quattro principali processi migratori: arrivarono in Sicilia lavoratori tunisini che trovarono impiego nel settore della pesca e dell’agricoltura; dalle Filippine, dall’Eritrea, dall’Isola di Capoverde, dallo Sri Lanka, dalla Somalia e da alcuni Paesi latino-americani arrivarono le prime donne immigrate per svolgere lavori domestici presso le famiglie delle grandi città; gruppi di manovali jugoslavi trovarono occupazione nei cantieri edili friulani; vi fu anche un’immigrazione di rifugiati politici (per esempio dal Cile a seguito del golpe del 1973 ad opera del Generale Augusto Pino- 26 Capitolo 1 chet) e di studenti universitari asiatici e africani iscritti nelle Università italiane. 37 A questi primi flussi, se ne aggiunsero altri negli anni Ottanta e Novanta. Il più consistente fu quello dei marocchini, ma, a differenza di altri Paesi europei, in cui il flusso migratorio si caratterizzò per una prevalenza di immigrati provenienti da poche aree geografiche, in Italia si è verificato un “arcipelago migratorio”: nel corso del decennio si è assistito non solo a un raddoppio dei soggiornanti stranieri, che passa da 649.000 a fine 1991 a 1.341.000 nel 200038, ma anche a un’estensione del ventaglio delle nazionalità coinvolte nei processi migratori.39 Si registra, in particolare, l’ingresso di persone provenienti dalla penisola balcanica, a seguito dei conflitti legati al frazionamento della ex Repubblica federale Jugoslava, e, successivamente dagli altri Paesi dell’Europa dell’Est (albanesi, romeni, polacchi, ucraini). Nel 2005, dei 3.035.144 stranieri presenti regolarmente nel nostro Paese circa il 49 percento proveniva dall’Europa (in particolare da’Europa centroorientale), il 23 percento dall’Africa (soprattutto dalle regioni mediterranee), il 17 percento dall’Asia e il 10 percento dal continente americano. 40 Solo i provenienti dalla Romania, dall’Albania e dal Marocco superano – di poco – il 10 percento del totale della popolazione straniera residente in Italia (rispettivamente, l’11,9, l’11,3 e il 10, 3 percento). Quasi il 70 percento degli stranieri soggiornanti in Italia proviene, invece, da Paesi di tutti i continenti e la consistenza di ciascuna nazionalità non supera la percentuale del 6 percento (gli ucraini sono il 5,2 percento, seguiti dai cinesi, il 4,9 percento). Si è parlato, a questo proposito, di “arcipelago migratorio” come caratteristica principale dell’immigrazione in Italia. La crescita di cittadini stranieri soggiornanti ha determinato l’urgenza di definire i profili di una regolamentazione giuridica della loro presenza sul territorio italiano. Nel 1970, la posizione giuridica dello straniero veniva regolata da circolari ministeriali, mentre i primi interventi in materia d'immigrazione risalgono agli anni Ottanta. In particolare la legge n. 943 del 1986 disciplinò le condizioni di lavoro, introducendo le prime forme di tutela e avviando la prima procedura di regolarizzazione. Altri aspetti, come il sog- 37 M. Barbagli, Immigrazione e criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 46. F. Pittau, “35 anni di immigrazione in Italia”, in Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2005. XV Rapporto, Roma, 2005, pp. 69-76. 39 Ibidem 40 Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2005. XVI Rapporto, Roma, 2006, p. 11. 38 L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 27 giorno e le espulsioni, sono invece ancora regolati dal Regio Decreto n. 733 del 1931, relativo alle norme di pubblica sicurezza.41 La Legge 39/1990 (Legge Martelli) fu il primo intervento che disciplinò in maniera organica la materia dell'immigrazione, introducendo disposizioni relative a ingresso, soggiorno, espulsione e diritto d'asilo. Tale legge convertì il precedente Decreto n. 416 del 30 dicembre 1989, e tentò di fare fronte all'emergenza migratoria, affrontandola principalmente come una questione di ordine pubblico. In particolare, la legge introdusse per la prima volta lo strumento della programmazione dei flussi di immigrati, con cui venne disciplinato l'accesso di coloro che intendono risiedere e lavorare nel nostro Paese. Nel corso dagli anni Novanta, l’intensificarsi del fenomeno migratorio – di portata comunque inferiore a quanto stava accadendo in altri Paesi europei42 –, ma soprattutto la percezione diffusa di un’ “emergenza immigrazione” – a volte generica, a volte nella forma più ristretta dell’ “emergenza clandestini” – portarono a inasprire le misure legislative. Il Decreto Dini, del 18 novembre del 1995, rappresentò una svolta nella cultura politica e giuridica italiana in quanto, ampliando la casistica delle espulsioni preventive senza effettivo controllo giudiziario, e sottraendo al giudice naturale lo straniero sospettato di turbare l’ordine pubblico o condannato per reati minori, trasferiva, di fatto, alla polizia la soluzione dei problemi posti dall’immigrazione.43 La Legge n. 40 del 1998 (Legge Turco-Napolitano) riorganizzò la disciplina dell'immigrazione, cercando di superare la logica dell’emergenzialità che aveva influenzato la normativa precedente, ma riproducendo nei fatti una logica binaria comune a molte legislazioni europee: da un lato, introdusse una serie di misure a sostegno dell’integrazione sociale e lavorativa degli immigrati regolari – per la verità scarsamente applicate –; dall’altro, venne inasprito l’approccio repressivo nei confronti degli immigrati irregolarmente presenti sul territorio. La Legge, oltre a regolamentare ingresso e soggiorno, specificando diritti e doveri dello straniero e prevedendo l'introduzione di una carta di soggiorno di durata illimitata, ribadì la politica delle espulsioni preventive. Venne ampliata la casistica: alle modalità di espulsione già pre- 41 Per un’analisi della legislazione in tema d’immigrazione negli anni Ottanta si veda B. Nascimbene, Lo straniero nel diritto italiano, Giuffrè, Milano, 1988. 42 M. Barbagli, op. cit. a nota 37, p. 46. 43 A. Dal Lago, Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 8. 28 Capitolo 1 viste, quella a misura di sicurezza e quella per sostituzione della pena detentiva – si aggiunse l’espulsione amministrativa. Inoltre, vennero istituiti i Cpta, “Centri di permanenza temporanea e assistenza” (anche se, significativamente, nei discorsi comuni e ufficiali la parola assistenza venne omessa) in cui poter trattenere per un massimo di 30 giorni, (termine ampliato dalla successiva Legge n. 189 del 2002, la Legge Bossi-Fini, a 60 giorni) immigrati irregolarmente presenti sul territorio in attesa di identificazione o di esecuzione di un provvedimento di espulsione. L’opinione pubblica – a volte stimolando l’inasprimento delle misure legislative, altre volte stimolata dai discorsi politici e istituzionali che accompagnavano il processo di formazione delle leggi – inizia, soprattutto a partire dagli anni Novanta, a concentrarsi ossessivamente sulla presenza di stranieri in Italia, posizionandola al centro del vortice di eventi critici che caratterizzarono quegli anni. L’ “emergenza immigrazione”, sostenuta e legittimata da dati, opinioni e pubblicazioni di giornalisti, esperti e politici, invase le vita degli italiani, intersecando altre emergenze nazionali. Espressioni di senso comune – quali: “gli stranieri ci portano via il lavoro e le case popolari”44; “continuano a sbarcare e i politici non fanno niente per fermarli”; “le nuove mafie invadono l’Italia”45; “non hanno rispetto per niente e nessuno” – stimolarono la percezione diffusa di una stretta relazione tra immigrazione, crisi economica, inadeguatezza della politica, violenza diffusa e degrado urbano, e, al tempo stesso, cementarono nella sensibilità collettiva la contiguità dell’intolleranza nei confronti degli stranieri con sentimenti di precarietà economica, di sfiducia nella politica, di preoccupazione per la propria incolumità e di sdegno per le condizioni di vita nei quartieri periferici. Corruzione e indignazione Le emergenze tendono a confondersi nelle esperienze quotidiane e nelle rappresentazioni sociali: si percepiscono i mutamenti sociali, ma soprattutto si percepisce l’assenza di un loro governo, in un periodo in cui la classe politica diventa oggetto di critiche diffuse e di indagini giudiziarie. 44 Questa asserzione trova qualche timida replica anche sui giornali. Si veda Ansa, 29/7/1998, “Immigrazione: Zamagni, immigrati non portano via il lavoro”. 45 A questo proposito si veda, per esempio, la notizia Ansa del 13/1/1995 dal titolo “Criminalità: Vigna, ‘Mafia cinese d’accordo con SCU’ ” in cui si legge che «i clan della mafia cinese che controllano l’immigrazione illegale dei loro connazionali nel nostro paese avrebbero già stretto accordi in Puglia con la Sacra Corona Unità». L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 29 Scandali e casi di corruzione sono presenti nella storia italiana già a partire dagli anni Cinquanta, ma non ebbero effettive conseguenze politiche fino agli inizi degli anni Novanta. A partire dal 1992, le notizie sulla diffusa corruzione politica in tutti i settori della vita pubblica e sull’endemico finanziamento illecito dei partiti provocò per la prima volta una forte delegittimazione dei leader dei due più importanti partiti di governo di centro-sinistra: DC e PSI. La “questione morale”, tema storico del principale partito di oppostone, il PCI, sotto la guida di Enrico Berlinguer, esplose in modo inaspettato, tanto che si è parlato spesso di “rivoluzione” che ha avuto come protagonista e luogo privilegiato la magistratura46. A partire dall’arresto di Mario Chiesa, avvenuto il 17 febbraio 1992, si svilupparono numerosi filoni d’indagine che coinvolsero quasi tutti i partiti dell’arco istituzionale e che dimostrarono come la corruzione fosse sistematica47. Di fronte all’ampliarsi di “Tangentopoli”, termine che molto presto dal caso milanese si estese a indicare il fenomeno delle inchieste giudiziarie sulla corruzione politica avviate dalle Procure di molte regioni italiane, Governo e maggioranze parlamentari tennero un comportamento sorprendentemente diverso rispetto al passato. Di seguito il giudizio di Stefano Rodotà, che all’epoca era anche parlamentare: appaiono attoniti e poi irritati di fronte alle inchieste giudiziarie, che si svolgono in un crescente e preoccupante vuoto istituzionale […] Si determina così una situazione di forte squilibrio istituzionale, tuttavia non imputabile alla magistratura che si è limitata a riassumere la funzione propria di controllo della legalità, nei periodi precedenti impedita o da essa stessa abbandonata.48 Le inchieste di un organo indipendente, percepito come neutrale e apolitico – perlomeno fino alla controffensiva mediatica di de-legittimazione della magistratura (l’epiteto più frequente era quello di “toghe rosse”), operata dall’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, indagato per corruzione giudiziaria, falsa testimonianza, finanziamento illecito ai partiti e falso in bilancio – diede lo stimolo a molti settori della società italiana per recidere i loro legami con i partiti tradizionali. L’insoddisfazione si espresse inizialmente come rabbia-indignazione verso i politici e sostegno ai 46 S. Rodotà, “Magistratura e politica in Italia”, in E. Bruti Liberati, A. Ceretti, A. Giasanti (a cura di), Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica, Feltrinelli, Milano, 1996, pp. 17-30. 47 D. Nelken, “Il significato di Tangentopoli: la risposta giudiziaria alla corruzione e i suoi limiti”, in L. Violante (a cura di), Storia d’Italia. Annali 14. Legge, Dritto, Giustizia, Einaudi, Torino, 1998, pp. 595-627. 48 S. Rodotà, op. cit. a nota 45, p. 19. 30 Capitolo 1 giudici di “Mani Pulite”: alle scritte sui muri inneggianti al Pubblico Ministero Antonio Di Pietro, personaggio-simbolo delle inchieste giudiziarie sulla corruzione, si affiancarono momenti di tensione. Il più eclatante fu quello in cui Bettino Craxi, segretario del PSI che aveva ricoperto numerosi incarichi di Governo, all’indomani del voto della Camera dei Deputati del 29 aprile 1993 con cui venne negata l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti, all’uscita dall’Hotel Rapahel, albergo che da anni era la sua dimora romana, venne bersagliato da un fitto lancio di monete e oggetti vari provenienti da una folla di dimostranti, che sventolavano banconote da 50 o 100 mila lire e intonavano in coro “Vuoi pure queste? Bettino vuoi pure queste?” sull'aria della canzone “Guantanamera”. Altri manifestanti urlavano slogan come: “Su-i-ci-dio! Su-i-ci-dio!” e “Bettino, Bettino, il carcere è vicino!”. Craxi riuscì faticosamente a salire in auto; il cordone della polizia venne sfondato e i dimostranti iniziarono a martellare l'automobile con pugni e colpi di casco. Questo episodio fu trasmesso centinaia di volte dai telegiornali e dai programmi d’informazione e costituì il segno più evidente della fine politica di Craxi, del PSI, ma più in generale di una classe politica. Ben presto, tuttavia, la magistratura perse il sostegno dei mass-media e dell’opinione pubblica, soprattutto a partire delle ispezioni disposte dai Ministri di Grazia e Giustizia Alfredo Biondi e Filippo Mancuso nei confronti dei magistrati della Procura di Milano. Lo stesso Di Pietro fu oggetto di campagne di delegittimazione e ricevette alcuni avvisi di garanzia. Le accuse si rivelarono infondate, ma costituivano il segnale di un mutamento dell’umore collettivo: il sentimento diffuso di anti-politica si andava caratterizzando più in generale come sentimento anti-istituzionale. Indignazione e perdita di punti di riferimento (disorientamento istituzionale) costituirono i tratti essenziali del rapporto tra cittadini e istituzioni negli anni Novanta, solo parzialmente contenuti dal ruolo attivo assunto dai Sindaci in quanto referenti istituzionali più prossimi ai cittadini, anche grazie alla legge che nel 1993 introdusse la loro elezione diretta. Focolai di “protesta civile” – come la fiaccolata degli abitanti della zona intorno alla stazione centrale di Napoli, organizzata da un consigliere circoscrizionale del Msi-An nell’ottobre del 199449 – divamparono in tutta Italia, chiedendo a Sindaci più polizia e ordine pubblico, maggiore lotta alla criminalità, interventi per ridurre “l’insopportabile presenza ad ogni angolo di prostitute e travestiti”. 49 Ansa, 12/10/1994, “Fiaccolata a Napoli contro lucciole e criminalità”. L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 31 Sconcerto e rabbia per le stragi mafiose Ad aumentare il caos politico-istituzionale e a destabilizzare la società italiana concorsero anche una serie di stragi mafiose. Il 23 maggio 1992 mille chili di esplosivo fecero saltare l’autostrada presso Palermo, all’altezza di Capaci, uccidendo il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta. Il 19 luglio dello stesso anno un’autobomba esplose in via D’Amelio uccidendo il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Falcone e Borsellino erano due dei magistrati più impegnati nelle inchieste antimafia condotte, già a partire dagli anni Ottanta, dal pool investigativo coordinato da Antonio Caponnetto. A queste stragi ne seguirono altre l’anno seguente: il 14 maggio a Roma un’autobomba esplose senza provocare vittime in via Fauro; il 27 maggio a Firenze un’altra autobomba esplose in via dei Georgofili, davanti alla galleria degli Uffizi, provocando cinque morti e trenta feriti; il 27 luglio una terza autobomba esplose in Via Palestro a Milano, provocando cinque vittime. Nella stessa notte scoppiarono due autobombe a Roma, contro la Basilica di “San Giovanni in Laterano” e contro la Chiesa di “San Giorgio al Velabro”. La militarizzazione del territorio di alcune regioni italiane attuato attraverso l’invio dell’esercito, costituì il segnale evidente di uno “stato di guerra”, di una crisi dell’ordine pubblico e del sistema democratico non più gestibile con strumenti ordinari. Nell’opinione di molti50, l’uso dell’esercito apparve come una risposta necessaria per ri-affermare la sovranità statuale, anche se rendeva evidente, al tempo stesso, la sua fragilità. Il rafforzamento, in alcune zone e in alcuni strati sociali del Paese, dello spirito antimafia della società civile, che già negli anni Ottanta andava diffondendosi, dopo un primo periodo – soprattutto nelle elezioni amministrative del giugno e dell’autunno del 1993 – in cui si espresse in un orientamento politico di sostegno a volti nuovi e “puliti”, col tempo produsse effetti di sostegno al solo operato dei magistrati dei pool antimafia. I risultati di inchieste – recenti o datate ma comunque finalmente disponibili sui mass-media – palesavano una contiguità tra politici di spicco ed esponenti delle organizzazioni criminali. Tutto questo incentivò la diffusione di sentimenti di indigna- 50 In senso contrario, alcuni deputati del Partito della Rifondazione Comunista, membri della Commissione Difesa della Camera attaccarono duramente la decisione di inviare l’esercito in Sicilia, dichiarando che “è intollerabile che vi siano due regioni italiane autoccupate dall’esercito con una cultura neocoloniale” e anticipando la “richiesta della cancellazione di provvedimenti illiberali, pericolosi, del tutto inutili per combattere la mafia ed altre forme di criminalità organizzata”. Ansa, 2/9/1992, “Camera: Rif. Com. su esercito in Sicilia e in Sardegna”. 32 Capitolo 1 zione e di “anti-politica” già presenti nel Paese. Se dopo Capaci la reazione di rabbia produsse iniziative solo qualche anno prima inconcepibili, già nei momenti successivi alla strage di Via D’Amelio il sentimento collettivo volgeva verso la disperazione: la vedova di Borsellino rifiutò per il marito il funerale di Stato, e tra le forze di polizia circolò la proposta di non accettare in futuro di scortare i magistrati antimafia. Il 21 luglio 1992 nella cattedrale di Palermo le più alte autorità dello Stato e il capo della Polizia, Vincenzo Parisi, giunti per assistere al funerale di Stato dei cinque poliziotti uccisi in Via D’Amelio, si sottrassero con difficoltà alla rabbia della folla51. Mass-media e cristallizzazione dei sentimenti collettivi Il sistema dei mass-media concorse all’affermazione e alla cristallizzazione dell’insoddisfazione, dell’indignazione, della preoccupazione e della sfiducia ormai dilaganti. L’editoriale di Angelo Panebianco pubblicato sul Corriere della Sera del 10 gennaio 1999 ne è un esempio eloquente, e vale la pena riproporlo qui diffusamente. […] il procuratore generale Antonio La Torre ha esibito le cifre su quella spettacolare crescita della violenza che l'Italia tutta, anche quelle parti, al Nord e al Centro, che ne erano un tempo relativamente immuni, sta sperimentando. […] Tutti i sondaggi indicano che il senso di insicurezza e di paura è in aumento fra gli italiani. Esso va di pari passo non solo con la crescita obiettiva dei delitti ma anche (ed è la cosa più grave) con la sempre più diffusa percezione di una assoluta incapacità degli apparati preposti alla sicurezza a rimediare alle proprie inefficienze, a ricostituire accettabili condizioni di sicurezza. Gli italiani non credono, stando ai sondaggi, nella capacità dello Stato di dare, a breve termine, risposte efficienti alla crescita dell'insicurezza. E purtroppo le cose stanno proprio così. Per un insieme di cause, che sono in parte culturali, in parte politiche, in parte organizzative, non è credibile che lo Stato si doti a breve termine della capacità di fronteggiare in modo efficiente la crescente violenza urbana. […] nella stessa affermazione del termine «microcriminalità» è implicita la svalutazione del fenomeno, è implicito un tendenziale disinteresse per la sicurezza dei cittadini, è implicito, cioè, che per la classe politica, per la magistratura e le forze dell'ordine (non certo per i cittadini comuni) si tratti di fenomeni, tutto sommato, di scarsa rilevanza. Fenomeni da porre comunque in fondo alla lista delle priorità, su cui 51 P. Ginsborg, op. cit. a nota 29, pp. 493-4. L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 33 svolgere indagini serie solo se, e solo a patto che, resti un po' di tempo, dovendo magistratura e forze dell'ordine occuparsi soprattutto di «grande criminalità» e poi di corruzione e di altri delitti dei colletti bianchi. […] Poi c'è il punto dolente dell'immigrazione clandestina, una consistente fetta della quale va a nutrire le statistiche sui delitti, e a rendere sempre più pericolose le condizioni delle città. E' evidente che fattori culturali contribuiscono, oggi come ieri, a inibire la capacità di dare risposte adeguate al problema sicurezza connesso all'immigrazione clandestina. Chiacchiere tante, ma pochissimi fatti. […] E le cose non vanno meglio nel caso del sistema giudiziario la cui inefficienza, fin qui non contrastata seriamente da nessuno, continua, da decenni, ad essere denunciata a ogni inaugurazione dell'anno giudiziario. […] Ed ecco perché la violenza cresce, l'insicurezza degli italiani anche, e la risposta dello Stato latita e, plausibilmente, continuerà a latitare a lungo. Se non ci fosse stato in questi anni il «fenomeno Giuliani», il drastico, spettacolare, abbattimento della criminalità a New York da parte di una amministrazione particolarmente efficiente ed energica (poi imitata anche da altre amministrazioni in altre città americane), potremmo continuare a trastullarci con le solite chiacchiere pseudosociologiche e pseudo-culturali sulla «crisi dei valori», sull'inevitabilità della crescita della criminalità nella società fondata «sul profitto», sull'inevitabilità della insicurezza nelle condizioni proprie della società «multietnica», nonché del tardocapitalismo, e bla bla bla. Ma c'è stato, appunto, il fenomeno Giuliani, ossia la dimostrazione pratica che le chiacchiere di cui sopra erano, fondamentalmente, sciocchezze da salotti radical-chic. I luoghi comuni si confondono con le opinioni esperte, il riferimento a dati statistici “incontrovertibili” sull’aumento di criminalità e insicurezza si intrecciano con accuse d’inefficienza della classe politica – soprattutto quella di sinistra – e di latitanza dello Stato, la denuncia di aumento dei pericoli urbani dovuti all’immigrazione clandestina si accompagna al richiamo a soluzioni politiche d’Oltreoceano, da importare, semplicemente. Se le istituzioni sono lontane, corrotte e inefficienti, la magistratura si occupa solo dei grandi processi, la polizia arresta ma il giorno dopo i criminali sono liberi, la mafia controlla i territori e s’infiltra nelle istituzioni locali, gli immigrati “occupano” le strade e le piazze e fanno ciò che vogliono – questo il catalogo dei discorsi di senso comune che dai mass-media rimbalzano nei bar, per strada, nelle case, ma anche nei discorsi istituzionali e politici –, il cittadino rimane “solo”, abbandonato dalle istituzioni e diffidente verso gli altri. Affrontare i problemi quotidiani assume sempre più la connotazione di una “lotta per la sopravvivenza”. In tutti i sondaggi d’opinione pubblicati (e spesso commissionati) dai giornali, lavoro, salute e criminalità – tre temi fortemente connessi alle tre attività fondamentali del sopravvivere: procurar- 34 Capitolo 1 si cibo attraverso il lavoro, possibilità di curarsi in caso di malattia e salvaguardare la propria incolumità – sono indicati dagli italiani come preoccupazioni sempre più pressanti. La paura della criminalità nel vortice: l’emergere della “questione sicurezza” L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta, si colloca, quindi, in un vortice di eventi e di umori che trasformarono – e ancora trasformano – profondamente le relazioni tra cittadini e tra questi e le istituzioni, mettendole fortemente in crisi. Le persone vissero in diretta – in un continuo rimando tra esperienza personale, discorso pubblico e rappresentazione mass-mediatica – e simultaneamente: - il crollo di un sistema politico, individuandone la causa nell’avidità e nella corruzione dei suoi esponenti; - la crisi economica, percepita come esito di un’incapacità politica di gestire l’economia ma anche imprenditoriale di competere sul piano globale; - l’ “invasione” degli immigrati, rappresentata da navi sovraffollate e sperimentata dall’incontro quotidiano con “lavavetri” appostati agli incroci; - la “forza brutale” delle mafie, manifestatasi nelle stragi del 1992 e 1993, la loro infiltrazione nel sistema politico ed economico, e l’ingresso in Italia delle cd. “nuove mafie” di origine straniera. Rabbia, indignazione, preoccupazione, frustrazione, sfiducia, e paure di vario genere trovarono una modalità di espressione nella scena sociale e politica come “domanda di sicurezza”. Come osserva Tamar Pitch, ogni domanda sociale non è mai la traduzione letterale di bisogni definiti, ma, pur essendo in stretto rapporto con essi, presuppone intenzionalità, capacità organizzative e una progettualità: le richieste e i conflitti riguardanti i temi della casa, della salute, della cura dell’infanzia, pur strutturandosi attorno a problemi specifici, vengono motivati, contestualizzati e articolati in progetti più generali.52 Lo stesso vale per la sicurezza: la domanda sociale ad essa relativa non è la semplice sommatoria delle insicurezze delle persone, ma costituisce una riformulazione dei sentimenti delle persone in chiave politica: essa sottintende una particolare visione della società. Se negli anni Settanta le insicurezze delle persone, anche quelle legate alla sfera della criminalità, furono dotate di senso e rifor- 52 T. Pitch, “Ruolo delle donne e mutamento delle strategie di controllo sociale”, Dei delitti e delle pene, 83/1, 1983, 94-109. L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 35 mulate in una domanda di maggiore welfare – è il periodo in cui la filosofia dello Stato sociale ha pervaso anche l’organizzazione del sistema della giustizia –, a partire dagli anni Novanta i sentimenti di sfiducia, rabbia, frustrazione, insicurezza trovarono espressione in richieste di maggiore protezione dagli episodi di criminalità, e, quindi, in “domanda di penalità”. La “questione sicurezza” iniziò, così, a occupare una posizione preminente nei discorsi pubblici ed entrò prepotentemente nella comunicazione politica, innanzitutto come tema di propaganda elettorale. Ancora nelle elezioni del 1994 – quelle della “scesa in campo” di Silvio Berlusconi – criminalità e giustizia venivano presentate e discusse come temi preminentemente tecnici, sottratti alla passionalità dei proclami elettorali; solo la criminalità organizzata veniva esplicitamente richiamata come emergenza, mentre la “questione morale”, sollevata in seguito alle inchieste giudiziarie sulla corruzione e il finanziamento illecito dei partiti, appariva in modo tenue e imbarazzato. Le elezioni del 1996, al contrario, segnarono una svolta: la sicurezza nelle città entrò prepotentemente nei programmi elettorali di quasi tutti i partiti53, sia pure con approcci parzialmente diversi. Il programma elettorale del Polo per le libertà, coalizione di centro-destra, da una parte insisteva sulla rappresentazione del fallimento delle istituzioni nel contrastare la criminalità – «nei confronti degli autori non si è neanche tentato di indagare […] Cresce il numero dei delitti di violenze sulla persona, spessissimo impuniti»54 – , dall’altra stimolava l’indignazione degli elettori attraverso la descrizione, con toni emotivi e allarmistici, dell’impatto della criminalità sulla vita delle persone – «lo scippo colpisce frequentemente giovani madri che accudiscono i bambini»; «la criminalità è alimentata anche da numerosi stranieri che si insediano nelle grandi città per impiantare vere e proprie industrie del delitto: borseggio, sfruttamento della prostituzione, sfruttamento dei minori, spaccio di stupefacenti»55. L’impostazione del programma dell’Ulivo, coalizione di centro-sinistra che indicò Romano Prodi come Presidente del Consiglio, assumeva toni differenti. La rappresentazione del fenomeno criminale era più puntuale e utilizzava un linguaggio più tecnico («Da almeno due decenni si registra in Italia un forte aumento dei reati contro il patrimonio, a fronte di una diminu- 53 I programmi elettorali delle forze politiche nelle elezioni del 21 aprile 1996 sono pubblicati in AAVV, “Iniziative per la giustizia nei programmi delle forze politiche. Elezioni del 21 aprile 1996”, Documenti Giustizia, 4, 1996, pp. 897-922. 54 Ibidem, p. 902. 55 Ibidem. 36 Capitolo 1 zione di quelli contro la persona e soprattutto degli omicidi»56). L’Ulivo si concentrava maggiormente sull’analisi delle condizioni sociali ed economiche alla base dell’aumento della criminalità e dell’insicurezza e su soluzioni articolate che affrontassero la complessità del fenomeno criminale. Purtuttavia, anche nel programma dell’Ulivo s’intravidero le prime torsioni allarmistiche di un discorso che anche nel centro-sinistra divenne sempre più “sicuritario”: veniva proposta un’organizzazione della città «a misura del rischio stupro e di quello delle violenze sui minori»57. I temi sono diversi (criminalità degli stranieri versus vittimizzazione di donne e bambini) e l’enfasi con cui vengono affrontati distanzia i programmi delle due principali coalizione a confronto (toni allarmastici versus linguaggio tecnico). Ciononostante, a partire dal 1996 la domanda di sicurezza, precedentemente assunta solo da alcuni partiti marginali (Msi-An) o emergenti (Lega Nord), trova definitivamente legittimità nella Politica e, da quel momento in poi, avrebbe costituito un perno fondamentale per la costruzione del consenso a livello nazionale e locale. In questo scenario, ondate di “panico morale”58 iniziarono a investire le aree urbane, strutturando sentimenti di paura e di esasperazione per la microcriminalità, per il disordine urbano e per le inciviltà. Erano soprattutto i fatti di criminalità comune, come i furti in appartamento, gli scippi e le rapine, ad alimentare le campagne “informative” dei mass-media e le insicurezze delle persone. Gli stranieri divennero i principali bersagli del sentimento di intolleranza che si diffondeva rapidamente e che portava nelle piazze migliaia di persone in fiaccolate contro la microcriminalità e l’immigrazione. D’altra parte, i dati ufficiali della criminalità costituivano un ancoraggio sicuro per la legittimità e la riuscita di queste iniziative. Infatti, a partire dagli inizi degli anni Novanta i delitti per un decennio si attestarono su un valore medio di circa 4.920 ogni 100 mila abitanti (periodo 1990-1999), contro i 3.620 ogni 100 mila abitanti degli anni Ottanta. In particolare, i furti e gli omicidi aumentarono nel 1991 e si attestano su valori più elevati rispetto al decennio precedente, anche se nei primi anni del 2000 i furti registrati tornano ai livelli degli anni Settanta. Per i delitti contro la famiglia il salto degli inizi degli anni Novanta si caratterizza più come svolta, inversione di tendenza: i delitti iniziarono ad aumentare dopo un lungo periodo di stabilità e 56 Ibidem, p. 919. Ibidem, p. 920. 58 Per un approfondimento sul concetto di panico morale si veda cap. 2 57 L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 37 di diminuzione.59 Inoltre, la quota di reati commessi da stranieri risultava in aumento, passando dal 4,2 per cento nel 1991 al 17,4 per cento nel 2001. Alcuni studi misero in evidenza che gli immigrati regolari commettevano meno reati non solo di quelli irregolari, ma anche degli italiani60, che gli stranieri erano mediamente più criminalizzati – soggetti a maggiori controlli e fermi di polizia –61, che la percentuale di stranieri condannati aumentava più velocemente di quella degli stranieri denunciati62, che gli stranieri entrati in carcere costituivano una percentuale molto alta sul totale degli ingressi, non in linea con l’aumento delle denunce63; ma la “forza del dato statistico semplice”, vale a dire la sua facile comunicabilità, incontrava la “forza del senso comune” nella costruzione del binomio immigrazione-criminalità.64 1.3 Il ruolo della ricerca criminologica in Italia La ricerca criminologica italiana contribuì in minima parte alla diffusione dell’ allarme sociale per la criminalità: molti criminologi e sociologi adottarono un atteggiamento “critico”, orientato alla problematizzazione della questione criminale e all’elaborazione di politiche locali di segno democratico. Tale approccio, incentivato anche da istituzioni particolarmente sensibili e all’avanguardia, come la Regione Emilia-Romagna,65 anche se ebbe una qualche risonanza a livello locale – i Sindaci, investiti del problema sicurezza, poterono attingere a riflessioni e ipotesi d’intervento alternativi ai modelli repressivi importati da altri Paesi –, non riuscì a indirizzare il discorso pubblico, che sostenne in gran parte programmi politici e pratiche istituzionali orientati all’affermazione di “legge e ordine”. Ne è un esempio la legge 59 A. Ceretti, R. Cornelli, op. cit. a nota 1. A. Ascolani, “Immigrazione e comportamenti devianti nel Trentino”, in E. SAVONA, F. BIANCHI (a cura di), Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2000/2001, Giunta della Provincia Autonoma di Trento, Trento, 2001, pp. 131-179. 61 D. Melossi, “Multiculturalismo e sicurezza in Emila-Romagna: prima parte”, in Quaderni di città sicure, N. 15, Bologna, 1999. 62 M. Pastore, “Produzione normativa e costruzione sociale della devianza e criminalità tra gli immigrati”, Quaderni ISMU, 9, 1995. 63 G. Mosconi, C. Sarzotti, Antigone in carcere, Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione, Carocci, Roma, 2004, pp. 169-187. 64 Per una più ampia trattazione del tema si veda: A. Ceretti, R. Cornelli, op. cit. a nota 1 nella parte sulla criminalità degli stranieri (pp. 24-32). 65 R. Selmini, “Towards Città sicure? Political action and institutional conflict in contemporary preventive and safety policies in Italy”, in Theoretical Criminology, Vol. 9 (3), 2005, pp. 307-324. 60 38 Capitolo 1 26 marzo 2001 n. 128, nota come “pacchetto sicurezza” che previde – secondo le parole dell’allora Ministro della Giustizia Piero Fassino – «misure che assicurano maggiore certezza della pena, accelerazione dei processi, ampliamento dei poteri di indagine della polizia, inasprimento della severità per reati che destano forte allarme sociale [in particolare scippi e furti in appartamento]». La ricerca accademica rimase dunque ai margini della costruzione del concetto di paura, sviluppando perlopiù analisi in contesti locali. Sono rare le pubblicazioni scientifiche sulla paura della criminalità, anche se in aumento nell’ultimo periodo66: i criminologi italiani, in gran parte orientati all’approccio clinico oppure vicini alla prospettiva sociologica “critica” o “realista di sinistra”, intervennero poco nel dibattito sociale e politico sulla paura della criminalità, e, comunque, lo fecero in modo dissonante rispetto ai discorsi che andavano costruendosi nei mass media, negli ambienti politici nazionali, nel mondo delle imprese e del commercio. Al contrario, enti di ricerca privati – spesso commissionati dai massmedia, da enti (come la Camera di Commercio) o da associazioni di categoria (come la Confcommercio) – e pubblici svilupparono studi quantitativi sulla paura della criminalità, spesso, come è il caso dell’Istat, nell’ambito delle inchieste di vittimizzazione, sul modello della National Crime Survey (NCS) statunitense. Abbiamo già considerato il ruolo che le prime indagini americane ebbero nell’affermazione sociale del tema “paura della criminalità”. Nel prossimo capitolo daremo conto dei risultati delle ricerche che, a partire da quelle prime indagini, si svolsero a livello internazionale e che, inevitabilmente, produssero effetti anche in Italia. Dapprima, la ricerca criminologica, principalmente statunitense, tentò di dare una risposta alla domanda “quanto è diffusa la paura della criminalità?”. Successivamente, all’esigenza di quantifi- 66 Per un’ampia rassegna delle ricerche sulla paura della criminalità compiute in Italia e all’estero si veda T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, Volume II, Giuffrè, Milano, pp. 443466. Oltre alle ricerche svolte nell’ambito del Progetto Città Sicure della Regione Emilia-Romagna e pubblicate nei Quaderni di Città Sicure e a quelle svolte dall’Osservatorio sulla sicurezza del Trentino e pubblicate nei Rapporti annuali di Transcrime, mi preme citare una delle prime ricerche sulla paura della criminalità svolte in due città italiane – Genova e Siena –: cfr.G.B. Traverso, M.I. Marugo, “Opinione pubblica e violenza: una ricerca sulla “paura del crimine” in due città italiane”, in Medicina Legale. Atti delle due giornate medico-legali-criminologiche. Sessione di Criminologia, Anno XVI, No 1, 1994, pp. 66-95. L’ “invasione” della paura della criminalità nell’Italia degli anni Novanta 39 care la paura si affiancò l’esigenza di spiegarne le cause. Infine, l’eterogeneità dei risultati di ricerca spinse alcuni ricercatori a riflettere sul concetto di paura e sulla correttezza delle tecniche di misurazione solitamente utilizzate. Capitolo 2 Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura La scienza ci dà la possibilità di conoscere i mezzi per giungere a uno scopo prescelto, ma non ci aiuta a decidere quali scopi perseguire. Bertrand Russell 2.1 Premessa: quantificare, spiegare e definire la paura della criminalità La fear of crime è uno dei temi più studiati nell’ambito della letteratura criminologica internazionale: nel 1996, gli articoli, i libri e le monografie su tale argomento erano già più di 200; dopo soli 4 anni avevano toccato il tetto di 8001. L’esponenziale crescita dell’interesse scientifico è andata di pari passo alla sua sempre maggiore rilevanza nei discorsi pubblici e nelle esperienze quotidiane. Ho già osservato come la genesi della ricerca criminologica su questo tema si situi in un periodo della storia degli Stati Uniti caratterizzato dal processo di costruzione della “knowledge society”, incentivato dal Presidente Democratico Jonhson come supporto alle politiche di welfare inserite nel Great Society Programme, da alcun eventi che colpirono la sensibilità collettiva (aumento dei tassi di criminalità registrata e rivolte nei ghetti neri), anche per effetto dello sviluppo della comunicazione di massa, e dall’enfasi politica – a vari livelli, più o meno condivisa, e rispondente a diversi interessi – su questi fatti. Gli studi sulla paura della criminalità, basati sulle nuove tecniche d’indagine statistica che resero possibile una sua “quan- 1 S. Farrall, “Revisiting Crime Surveys: Emotional Responses Without Emotions? Or Look back at anger”, International Journal of Social Research Methodology, Vol. 7, N. 2, 2004, p. 158. 41 42 Capitolo 2 tificazione”, contribuirono all’affermazione, ma anche e soprattutto alla definizione, di un tema che sarebbe diventato centrale in tutti i Paesi Occidentali. Dopo una prima fase di forte contiguità tra interesse scientifico ed esigenze politiche, la ricerca criminologica intraprese percorsi che portarono ad ampliare l’oggetto d’indagine – dalla quantificazione alla ricerca delle cause –, a rilevare i limiti delle prime indagini – e di tutte quelle che continuano a riprodurre l’impostazione metodologica originaria – e, più in generale, a evidenziare le distorsioni della rappresentazione sociale e politica delle insicurezze delle persone. Purtuttavia, come osserverò nel paragrafo conclusivo (2.6), le istanze della Politica hanno continuato a costituire un riferimento fondamentale per buona parte degli studi criminologici, orientandone lo sviluppo e delimitandone il campo. La vastità e l’eterogeneità dei contributi teorici ed empirici richiede uno sforzo di sistematizzazione in grado di cogliere le linee essenziali dello sviluppo della riflessione scientifica su questo tema. A tal fine, analizzerò la letteratura criminologica facendo perno sulle tre esigenze che ne hanno accompagnato l’evoluzione: quantificare il fenomeno, spiegarne le cause e definirlo – concettualmente e operativamente. Premetterò alla trattazione della terza esigenza – nel primo intermezzo sulle passioni (par. 2.4) – un approfondimento sul tema della razionalità delle passioni, che costituisce lo sfondo su cui recentemente è stata proposta una definizione criminologica di paura della criminalità. In sede di conclusioni, evidenzierò le luci e le ombre della “versione criminologica”: evidenzierò, da un lato, le “conquiste” sul piano della comprensione del fenomeno, e, dall’altro lato, l’esigenza di ampliare l’orizzonte della riflessione criminologica alla letteratura sull’insicurezza. Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 43 2.2 Quanto è diffusa? L’esigenza di quantificare L’obiettivo di in-formare Buona parte delle ricerche sulla paura della criminalità, in Italia come in molti altri Paesi europei2 o di altri Continenti3, si è sviluppata sul modello delle prime indagini americane: si tratta di ricerche di tipo descrittivo, che misurano il livello di paura della criminalità in un dato territorio, spesso identificando le caratteristiche socio-demografiche delle persone “insicure”. L’obiettivo dichiarato di queste ricerche è principalmente quello di “informare” la collettività circa il suo stato di insicurezza. Analizzando la genesi della ricerca sulla paura della criminalità negli Stati Uniti, tuttavia, ho già notato come l’informazione scientifica abbia contribuito in modo rilevante alla formazione dei sentimenti e dei discorsi pubblici. Così, se, in origine, i sondaggi di opinione e le prime inchieste di vittimizzazione concorsero a sostenere l’idea di una paura diffusa strettamente connessa a una criminalità dilagante e della conseguente necessità di intervenire politicamente per ristabilire l’ordine violato, l’ombra di tale “tratto originario” si estende a tutte le inchieste successive. Al di là dei loro risultati – che, come apparirà evidente, non sempre forniscono un supporto alle evidenze di senso comune – queste ultime vengono spesso utilizzate come strumento a sostegno di campagne allarmistiche o di politiche di “legge e ordine”: quando dimostrano uno stato di allarme crescente, sono citate in modo puntuale, mentre quando descrivono una situazione di stasi o, addirittura, di affievolimento delle preoccupazioni sociali, vengono segnalate in modo generico, omettendone intere parti. È il caso, per esempio, dell’inchiesta di vittimizzazione dell’Istat 2002, di cui riferirò più avanti, che, nonostante contenga dati circa una sostanziale stabilità dei sentimenti di paura tra le persone rispetto alla rilevazione del 1997/1998, è entrata nel dibattito sociale e politico senza alcun confronto puntuale con le risultanze dell’indagine precedente. 2 Si vedano, in particolare, le indagini di vittimizzazione condotte dall’Home Office inglese a partire dal 1982 (British Crime Survey) e le analoghe indagini condotte dal Governo Scozzese (Scottish Crime Survey), ma anche lo sviluppo delle ricerche sulla fear of crime nei Paesi dell’Europa dell’Est. Si veda, per esempio, J. Hraba, W.-N. Bao, F. O. Lorenz, Z. Pechačovà, “Perceived Risk of Crime in the Czech Republic”, Journal of Research in Crime and Delinquency, pp. 225-242. 3 Sono molto importanti gli studi condotti dall’Australian Institute of Criminology a partire dalle indagini di vittimizzazione condotte dal Governo australiano. A dimostrazione dell’interesse crescente di questo tema a livello internazionale si considerino le ricerche di Christian Schwarzenegger sulla fear of crime in Giappone (C. Schwarzenegger, “Fear of Crime as a Social Problem in Industrialized Conutries – Is Japan an Exception?”, Hosci Riron, Vol. 27, No 2, 1994, pp. 1-13). 44 Capitolo 2 Le indagini internazionali di vittimizzazione, che si sono mosse nel solco delle NCS americane, sono state condotte con il proposito di comparare i livelli di criminalità reale e percepita nei diversi Stati in diversi periodi temporali. In tal modo, hanno contribuito a ridurre i margini di strumentalizzazione a cui sono inevitabilmente soggetti i dati nei singoli Paesi. A condizione, ovviamente, che questi partecipino continuativamente al progetto di ricerca. La paura nelle indagini internazionali di vittimizzazione Le indagini di vittimizzazione sono lo strumento maggiormente utilizzato per quantificare il fenomeno che sto indagando: oltre a rilevare gli episodi di vittimizzazione e la propensione alla denuncia, i questionari somministrati ai cittadini, telefonicamente o, più raramente, per posta o personalmente, contengono alcune domande relative alla percezione del rischio di criminalità e alla paura a esso relativa. La prima indagine internazionale di vittimizzazione (ICVS, International Crime Victim Surveys), condotta in 14 Paesi dal Ministro della Giustizia Olandese in collaborazione con l’Home Office del Regno Unito e l’Università di Losanna (Svizzera), risale al 1989, 17 anni dopo la prima indagine americana.4 L’UNICRI5, Istituto di Ricerca su Criminalità e Giustizia dell’ ONU, venne coinvolto in questo progetto nel 1991 con l’obiettivo di fornire una copertura geografica più ampia al progetto. La seconda indagine internazionale di vittimizzazione, svolta nel 1992 coinvolse 33 Paesi, la terza, condotta nel 1996, e l’ultima, condotta nel 2000, vide protagonisti 48 Paesi. Attualmente è in esecuzione la quinta indagine di vittimizzazione, già iniziata nel 2004 con il coinvolgimento di un altro istituto di ricerca dell’ONU, l’UNODC6. Uno studio compiuto sui dati del 1992 e del 1996 indica che la maggior parte degli intervistati ovest-europei (59,3 per cento), asiatici (58,7 per cento) e nord-americani (52,7 per cento) giudica improbabile subire un furto in 4 I dati presentati in questo paragrafo sono stati raccolti e commentati nell’ambito di un lavoro di ricerca confluito nel Settimo rapporto sulla sicurezza del Trentino (R. Cornelli, “Nord Italia vs Trentino: il senso di sicurezza”, in Transcrime (a cura di), Settimo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2005, Giunta della Provincia Autonoma di Trento, Trento, 2005, pp. 111-136). 5 United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. 6 United Nations Office on Drugs and Crime. Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 45 appartamento7. Al contrario in Africa, in America Latina e nei Paesi in via di sviluppo (soprattutto dell’Europa Orientale) è più diffuso il giudizio di probabilità di subire un furto in appartamento nell’arco di un anno. Tabella 1 – Percezione della probabilità di subire un furto in appartamento nei prossimi 12 mesi, per aree geografiche del mondo. Non molto probabile Europa Occidentale Nord America Paesi in transizione Asia Africa America Latina 59,3 52,7 31,9 58,7 31,3 39,6 Probabile e molto probabile 32,7 42 48,4 29,8 58,3 52,9 Fonte: Alvazzi del Frate 1998, 120 Tabella 2 – Percezione di sicurezza quando si esce di casa da solo di sera, per aree geografiche del mondo. Europa Occidentale Nord America Paesi in transizione Asia Africa America Latina poco o per nulla sicuro 29,2 32 52,9 21,3 41,2 48,3 molto o abbstanza sicuro 70,2 67,6 46,5 78,7 58,3 51,4 Fonte: Alvazzi del Frate 1998, 116 I dati di un altro studio condotto sui dati ICVS riguardanti i 17 Paesi industrializzati partecipanti all’indagine del 2000 indicano una prevalenza del 7 A partire dal 1989 nel questionario ICVS è presente una domanda relativa alla percezione della probabilità di subire un furto in appartamento nei 12 mesi successivi al momento dell’intervista. 46 Capitolo 2 giudizio di probabilità di subire un reato solo in Portogallo (58 per cento). Stati Uniti, Svezia e Finlandia sono i Paesi in cui il giudizio di probabilità è meno diffuso (16 per cento per i primi due Paesi, 13 per cento per il terzo). 8 A partire dal 1992 è stata introdotta nel questionario ICVS la domanda più usata nelle indagini sulla percezione di sicurezza, vale a dire “quanto ti senti sicuro a camminare da solo nella zona in cui vivi quando è buio?”. Lo studio compiuto sui dati del 1992 e 1996 mostra che in tutti i Paesi del mondo partecipanti alle indagini i sicuri sono più numerosi degli insicuri. Lo scarto maggiore tra sicuri e insicuri si riscontra in Asia (78,7 per cento di sicuri e 21,3 per cento di insicuri) e in Europa Occidentale (70,2 per cento di sicuri e 29,2 per cento di insicuri). Lo scarto è di pochi punti percentuali, invece, nei Paesi in via di sviluppo (soprattutto dell’Europa Orientale). 9 I dati della ICVS del 2000 su 17 Paesi industrializzati indicano che in tutti i Paesi considerati i sicuri sono molto più numerosi degli insicuri: in media gli insicuri sono il 23 per cento. In Catalogna, Australia e Polonia gli insicuri sono più del 30 per cento degli intervistati, mentre negli Stati Uniti e in Svezia gli insicuri fuori casa sono solo il 15 per cento . La ICVS del 2000 ha introdotto anche una nuova domanda relativa alla percezione di sicurezza a casa quando si è soli e fuori è buio. Nei 17 Paesi industrializzati partecipanti all’indagine il numero di persone che si sentono insicure in casa è inferiore rispetto a coloro che dicono di essere insicuri per strada (rispettivamente 6 per cento e 23 per cento). I Paesi con il più alto livello d’insicurezza in casa sono la Polonia (15 per cento), il Portogallo e l’Australia (10 per cento), mentre la maggior parte degli altri Paesi presentano un livello di insicurezza al di sotto del 6 per cento.10 Sempre a partire dal 1992 nella ICVS sono presenti item relativi alle misure di auto-protezione adottate per proteggersi in particolare dai furti in appartamento. Lo studio compiuto sui dati ICVS del 1992 e 1996 considera tre tipologie di misure di protezione. Il primo tipo consiste in comportamenti adottati al fine di prevenire la commissione di reati: ad esempio, prendere un cane da guardia, lasciare accese le luci quando si è fuori casa, chiedere ai vicini di controllare la casa, etc. Il secondo tipo consiste in ostacoli fisici messi in o- 8 J. van Kesteren, P. Mayhew, P. Nieuwbeerta, Criminal Victimisaion in Seventeen Industrialised Countries, NSCR, 2000, p. 78. 9 A. Alvazzi del Frate, Victims of Crime in the Developing World, UNICRI, Publication N. 57, 1998., p. 116. 10 J. van Kesteren, P. Mayhew, P. Nieuwbeerta, op. cit. a nota 8, pp. 80-84. Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 47 pera per evitare o rendere più difficile l’ingresso di persone non autorizzate: ad es. allarmi, serrature speciali, porte blindate, grate alle finestre, etc. Il terzo tipo consiste, invece, nell’intraprendere iniziative a livello comunitario (community-based programmes) che coinvolgono altri soggetti nella prevenzione della criminalità (cittadini, polizia, Comuni, scuole). I dati indicano che in generale le misure di prevenzione sono meno usate nei Paesi in via di sviluppo (soprattutto dell’Europa Orientale) e più usate nell’America del Nord. Le misure di prevenzione comunitaria sono le più diffuse in tutte le aree geografiche, tranne che in America Latina e Asia.11 Tabella 3 – Misure di prevenzione adottate, per aree geografiche del mondo. a livello comunitario Europa Occiden24,3 tale Nord America 39,6 Paesi in transizio18,9 ne Asia 40,1 Africa 24,4 America Latina 26,1 altre msiure sistemi di allarme 19,7 12,1 37 14 19,7 4,3 26,6 32,3 34,1 2,3 7,5 9,7 Fonte: Alvazzi del Frate 1998, 124 Il tipo di misure di prevenzione adottate nei vari Paesi dipende, ovviamente, anche dal livello di reddito degli abitanti (che possono o meno permettersi di procurarsi costosi sistemi di protezione). Considerando solo il livello di adozione dei sistemi di allarme e delle porte blindate nei 17 Paesi industrializzati partecipanti all’ICVS del 2000 si nota che le differenze sono molto consistenti: si passa da circa il 70 per cento di ricorso a porte blindate in Olanda, Inghilterra/Galles e Australia al 10 per cento di Giappone, 17 per cento di Polonia, 21 per cento di Danimarca, 36 per cento per Portogallo, 38 per cento per Spagna e 40 per cento per Francia. 11 A. Alvazzi del Frate, op. cit. a nota 9, p. 124. 48 Capitolo 2 Rispetto all’adozione di sistemi di allarme si passa dal 34 per cento di Inghilterra e Galles al 2 per cento della Polonia 12. La paura nelle indagini italiane L’Italia ha partecipato solo all’ICVS del 1992, e ciò ha impedito la possibilità di osservare le variazioni nel tempo della paura della criminalità degli italiani proprio in un periodo che ho riferito essere cruciale per la sua affermazione. Una possibilità in tal senso viene offerta dalle indagini Multiscopo sulle famiglie avviate nel 1993, e in particolare quelle che l’Istat ha condotto nel 1997-98 e nel 2002 relative alla sicurezza dei cittadini. A fianco della rilevazione di dati inerenti il sommerso della criminalità, le modalità di accadimento dei reati, i luoghi e i modi in cui le vittime hanno subito un reato, le due indagini forniscono informazioni sulla percezione di sicurezza dei cittadini negli ambienti di vita, strada e casa, sulla percezione del rischio, sulla preoccupazione per alcuni reati specifici e su altri atteggiamenti e opinioni che sono elementi costitutivi o relazionabili con il sentimento d’insicurezza. I dati dell’indagine del 2002 indicano che alla domanda “quanto si sente sicuro camminando per strada quando è buio ed è solo nella zona in cui vive?” il 27,6 per cento degli italiani ha risposto di sentirsi poco o per niente sicuro. Sono, invece, meno coloro che dichiarano di non sentirsi sicuri quando sono soli all’interno della propria abitazione (12,2%). Tabella 4 – Percezione di sicurezza fuori casa e in casa in Italia. Anno 2002 Percezione di sicurezza di soli nella zona in cui si vive Molto o Abbastanza sicuro Poco o per niente sicuro Non esce mai da solo sera da Percezione di sicurezza di sera da soli a casa 64,6 Molto o Abbastanza sicuro 87,8 27,6 7,8 Poco o per niente sicuro 12,2 Fonte: elaborazione di dati Istat 12 J. van Kesteren, P. Mayhew, P. Nieuwbeerta, op. cit. a nota 8, p. 85. Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 49 Confrontando l’indagine ISTAT del 1997/98 con quella del 2002 si riscontra per l’Italia una sostanziale stabilità del numero di persone che si sentono sicure in casa e un lieve incremento del numero di coloro che si sentono sicuri fuori casa. Purtuttavia, diminuisce il peso dei molto sicuri (da 24,3 per cento a 20,2 per cento) e aumenta quello degli abbastanza sicuri (da 38,4 per cento a 44,4 per cento). Nel 2002 circa 1 italiano su 5 ha considerato la propria zona a rischio di criminalità. È importante notare che il rischio percepito di criminalità diminuisce rispetto al 1997-98 in tutta Italia (da 23,3 per cento a 21 per cento), tranne che nel nord-est, in cui aumenta da 15,9 per cento a 17,8 per cento.13 Considerando i margini di errore statistico presenti nelle indagini campionarie, è possibile sostenere che in Italia, nel periodo 1997-2002, non si sono avute variazioni significative del senso d’insicurezza delle persone, nonostante si tratti di un arco temporale fortemente interessato da episodi di “allarme criminalità”. Questo risultato – sorprendente se si considera l’invasione della paura della criminalità nel discorso pubblico – è confermato dall’analisi delle rilevazioni di un istituto privato di ricerca (Gpf) che mostra come l’insicurezza sia rimasta sostanzialmente costante nell’arco di un ventennio, mentre nell’accezione che fa riferimento alla criminalità (e quindi all’incolumità personale), dopo un leggero aumento al principio degli anni Novanta, addirittura sia diminuita.14 Risultati di ricerca vs rappresentazione diffusa È manifesto lo scarto esistente tra i risultati di queste ricerche e la rappresentazione diffusa (che si costruisce in termini di auto-evidenza) di una popolazione sempre più attanagliata dalla paura. Ma questo non indica necessariamente una contrapposizione tra scienza e senso comune, per almeno due motivi. Innanzitutto, perché solo alcune indagini, solitamente le più rigorose metodologicamente, contrastano con la visione dominante, mentre le altre, mol- 13 Cfr. M.G Muratore., G. Tagliacozzo, A. Federici, La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione di sicurezza e sistemi di protezione, ISTAT, Informazioni, N. 18, 2004. 14 I dati di questa rilevazione sono citati in M. Maneri, “Il panico morale come dispositivo di trasformazione dell’insicurezza”, Rassegna Italiana di Sociologia, XLII, 1, 2001, p. 6. Marcello Maneri cita anche i dati di altre ricerche compiute dagli istituti Censis e Doxa da cui si ricavano risultati pressoché analoghi. 50 Capitolo 2 to più numerose e fruibili – spesso commissionate da giornali, partiti, enti locali, comitati – al contrario, la rinforzano. Inoltre, a ben vedere, anche il contenuto informativo delle prime non contrasta direttamente con il senso comune. Queste indagini, infatti, si rivolgono principalmente al sistema politico-istituzionale, non tanto per svelare “false credenze” fondate su dati scientifici – il che, a ben vedere, sarebbe un po’ come “segnare un autogol”, rivelando il carattere “relativo” della conoscenza criminologica –, quanto per fornirgli una base conoscitiva su cui articolare discorsi e politiche. Di conseguenza, l’interesse dei ricercatori si focalizza sul fornire una rappresentazione della paura che sia “comprensibile e accettabile” e, di conseguenza, che faccia leva sulla percezione di senso comune senza mai sostituirsi a essa: in alcuni rapporti di ricerca, per esempio, le parti di commento, le più lette e su cui spesso si costruisce il messaggio informativo rivolto a politici e mass-media, contengono richiami al senso comune a volte anche in contrasto con i dati riportati nelle parti descrittive. D’altra parte, lo stesso sistema politico-istituzionale, che commenta e contribuisce alla diffusione dei dati di ricerca, enfatizza quei contenuti che sono più fruibili – vale a dire che intercettano più facilmente il senso comune diffuso –, ma anche più utili alla predisposizione di misure di presa in carico dei problemi. 2.3 Da cosa dipende? L’esigenza di spiegare Il paradosso rischio-paura All’esigenza di quantificare si affiancò da subito l’esigenza di spiegare le cause della paura della criminalità, anche in funzione della necessità politica di elaborare efficaci interventi di rassicurazione. Infatti, dopo una prima fase di rilevamento della diffusione del fenomeno e di “presa d’atto” politica della sua rilevanza nella vita delle persone, l’accento si spostò sul “che fare?” e, dunque, sull’individuazione di quei fattori su cui poter intervenire per migliorare la qualità della vita. Come ho già notato nel capitolo 1, la Commissione Katzenbach e, prima ancora, lo stesso Presidente Johnson, stabilirono che la conseguenza più dannosa di un crimine violento è la paura che ne deriva. Quindi, al rovescio, l’aver subito un crimine violento venne individuata da subito come causa della paura di subire un reato. Questa asserzione costituì un assunto per molti anni. Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 51 Purtuttavia, i primi risultati di ricerca sulla paura della criminalità iniziarono a metterne in dubbio la solidità: in molte indagini i giovani maschi della classe lavoratrice, pur essendo maggiormente colpiti da episodi criminali, risultavano meno preoccupati di subire un reato rispetto a donne e anziani. Considerando questi risultati, alcuni autori ipotizzarono l’esistenza di un “paradosso”15 nelle ricerche sulla paura della criminalità: le persone anziane e le donne sono in media meno esposte a episodi criminali, meno vittimizzate, ma provano più paura di subire un reato. I ricercatori presero diverse strade per dare soluzione a questo paradosso tra rischio e paura, che portarono a rendere complesso il legame tra vittimizzazione e paura della criminalità. Il tasso aggiustato di vittimizzazione di Stafford e Galle Alcuni criminologi negarono la sussistenza del paradosso, sostenendo che non esiste alcuna discrepanza tra rischio e paura se il rischio viene inteso come “tasso di esposizione al rischio”. Mark C. Stafford e Omer R. Galle16, analizzando i dati di alcune inchieste compiute a Chicago, ipotizzarono che non tutte le persone sono egualmente esposte al rischio di subire un reato. I reati, soprattutto quelli più diffusi e che creano maggiore allarme sociale, vengono commessi – a detta degli Autori – con più frequenza fuori casa; non tutti vivono periodi di tempo analoghi fuori di casa: gli anziani, per esempio, vivono più spesso in casa che negli spazi pubblici. Ne consegue che alcuni soggetti sono più esposti al rischio di vittimizzazione di altri. La comparazione dei tassi di esposizione al rischio di ciascuna categoria di persone con il relativo livello di vittimizzazione dimostrerebbe una sostanziale corrispondenza tra rischio e paura. La quantità di tempo spesa fuori casa – aggiungono gli Autori – è in funzione dello stile di vita: differenti stili di vita comportano differenti tempi di esposizione al rischio.17 Il ragionamento è lineare: i giovani passano più tempo fuori casa e per questo subiscono più reati degli anziani; se, tuttavia, si considera il numero di reati subiti dai giovani e quello subito dagli anziani per la stessa unità di tempo in cui giovani e anziani sono fuori casa, gli anziani risulterebbero più colpiti dalla criminalità dei giovani. La loro paura risulta così, più comprensibile. 15 M. Stafford, O. Galle, “Victimization Rates, Exposure to Risk, and Fear of Crime”, Criminology, Vol. 22, N. 2, 1984, pp. 173-185. 16 Ibidem. 17 Ibidem, p. 174. 52 Capitolo 2 Stafford e Galle, quindi, proposero di utilizzare negli studi di correlazione sulla paura della criminalità non il tasso di vittimizzazione convenzionale, ma un tasso di vittimizzazione aggiustato all’esposizione al rischio: i risultati delle loro ricerche indicarono un alto livello di corrispondenza tra tasso aggiustato di vittimizzazione e paura della criminalità per buona parte dei gruppi di popolazione, tra cui gli anziani. Questo risultato implica che la paura della criminalità sia strettamente legata all’esperienza di vittimizzazione, mediata però dallo stile di vita. Vulnerabilità personale, economica e sociale Diversamente da Stafford e Galle, altri ricercatori affrontarono il paradosso tra rischio e paura introducendo nuovi fattori esplicativi della paura della criminalità: tra questi, la vulnerabilità. Secondo questo filone di studi, le donne hanno più paura perchè si percepiscono più vulnerabili degli uomini, in quanto meno in grado di fuggire o di resistere alle aggressioni fisiche e più soggette a crimini violenti, come la violenza sessuale (tanto che spesso la paura della criminalità coincide nelle donne con la paura di subire una violenza sessuale)18. Inoltre, la maggiore attenzione ai pericoli da parte delle donne, conseguenza della loro maggiore vulnerabilità, influisce sulla loro percezione dei rischi: le donne percepiscono come «a rischio» più situazioni rispetto agli uomini e questa diversa percezione del rischio porta anche a un diverso livello di paura. Numerosi studi hanno suggerito che anche le persone anziane si percepiscono più deboli e vulnerabili, e valutano con maggiore preoccupazione le conseguenze di subire un reato. Numerosi studi suggerirono che anche le persone anziane si percepiscono più deboli e vulnerabili, e valutano con maggiore preoccupazione le conseguenze di subire un reato. Più in generale, le persone vulnerabili fisicamente (cattivo stato di salute), socialmente (essere solo o poco integrato nella co- 18 In letteratura sono state avanzate quattro ipotesi esplicative degli alti livelli di paura della criminalità tra le donne: 1. ipotesi del tasso reale di vittimizzazione: se il vero tasso di vittimizzazione delle donne fosse conosciuto, sarebbe più alto di quello degli uomini e spiegherebbe i più alti livelli di paura tra le donne; 2. ipotesi della generalizzazione: le donne trasferiscono la paura da un contesto all’altro e da un tipo di vittimizzazione ad un altro più facilmente degli uomini, generalizzando così la paura; 3. ipotesi della vulnerabilità, descritta nel testo; 4. ipotesi della neutralizzazione: gli uomini neutralizzano o nascondono a se stessi e agli altri le paure molto più che le donne. Cfr. W.R. Smith, M. Torstennson, “Gender Differences In Risk Perception and Neutralizing Fear of Crime”, British Journal of Criminology, Vol. 37, N. 4, 1997, pp. 608-628. Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 53 munità) ed economicamente (avere scarse risorse economiche) sono più inclini a provare paura perché le conseguenze di un atto criminale avrebbe un impatto più devastante sulle loro vite19. Le informazioni sulla criminalità La vittimizzazione indiretta costituisce un altro fattore della paura della criminalità molto studiato, soprattutto a partire dagli anni Ottanta. Le persone che sono informate della commissione di un reato da chi l’ha subìto diventano delle «vittime indirette», perché in una certa misura sono coinvolte dall’esperienza di vittimizzazione, soprattutto nei suoi effetti. Il coinvolgimento può essere semplicemente emotivo oppure anche materiale, laddove il familiare, il conoscente o il vicino di casa assume un ruolo attivo nel tamponare gli effetti negativi dell’episodio di vittimizzazione – per esempio chiamando l’autoambulanza in caso di feriti, accompagnando la vittima alla stazione di polizia per la denuncia o anche solo evitando che la vittima resti sola. Wesley G. Skogan e Michael G. Maxfield20, nell’analizzare i dati di un’inchiesta di circa 1600 residenti di diverse città americane, scoprirono che alcune forme di esperienza mediata di episodi criminali hanno un impatto rilevante sulla distribuzione della paura. Ad analoghe conclusioni giunse Tom Tyler21: il fatto di essere informato sul verificarsi di episodi di vittimizzazione ha un’incidenza rilevante sul sentimento di insicurezza nel camminare da solo nel quartiere. Anche James Garofalo, in un articolo del 1981,22 aveva esteso la nozione di vittimizzazione indiretta alla nozione di informazione sul crimine e considerava la paura della criminalità, definita come “reazione emotiva caratterizzata da un senso di pericolo”, come il risultato della quantità e del tipo di informazioni che influiscono sulla valutazione del rischio di essere vittima di reato. Analizziamo nel dettaglio il modello di Garofalo, che aprì alla consi- 19 M. Killias, “Vulnerability: towards a better understanding of a key variable in the genesis of fear of crime”, Violence and Victims, 5, 1990. 20 W. Skogan, M. Maxfield, Coping wit crime, Beverly Hills, Sage, 1981, cit. in C. Hale, Quality Of Life, Fear Of Crime, And Implications Of Foot Patrol Policing, Ph.D. Dissertation, Michigan State University, 1983. 21 T. Tyler, “Impact of Directly and Indirectly Experienced Events”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 13, 1980, cit. in R.B. Taylor, C. Hale, “Testing Alternative Models of Fear of Crime”, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 77, 1986. 22 J. Garofalo, “The Fear of Crime: Causes and Consequences”, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 72, N. 2, 1981, pp. 839-857. 54 Capitolo 2 derazione di nuovi fattori della paura della criminalità, tra cui il sistema di comunicazione mass-mediatico. Secondo l’autore, per comprendere il processo di formazione della paura della criminalità occorre considerare la quantità e il tipo di informazioni sulla criminalità che toccano ciascuno e che dipendono da tre fonti principali: l’esperienza diretta, l’esperienza indiretta, derivante dalla comunicazione interpersonale e mass-mediatica, e la posizione nello spazio sociale, definita da un insieme di variabili quali lo stile di vita, l’età, il sesso, la razza, il reddito. L’aver subito un reato costituisce solo uno degli elementi che rendono manifesta la criminalità e costringono a valutarne il rischio: parlare con chi ha subito un reato, vedere in televisione o leggere sui giornali episodi gravi di criminalità sono situazioni che incidono sulla quantità di informazione sulla criminalità di cui si dispone. Non solo: il modo in cui si parla di questi fatti, i tipi di programmi che si vedono e le testate giornalistiche che si leggono23, lo stile con cui si vive la città (se, ad esempio, si frequentano zone a rischio o si vive gran parte del tempo chiusi in casa) e le risorse economiche e relazionali attivabili in caso di bisogno incidono fortemente sulla tipologia di informazioni sulla criminalità disponibili. L’informazione, mediata quindi da fattori che influenzano la percezione dell’informazione disponibile, fornisce una sorta di immagine nebulosa del crimine. Questa immagine – sostiene Garofano – è la base rozza su cui ciascuno elabora una valutazione personale sul rischio di criminalità che si articola su quattro questioni: prevalenza: qual è l’ammontare di certi tipi di crimini nei luoghi e nelle situazioni che io conosco? probablilità: data la prevalenza di criminalità nei luoghi e nelle situazioni che io frequento, quanto è probabile che io sia il potenziale bersaglio di atti criminali? vulnerabilità: date le mie caratteristiche fisiche e le mie risorse di autoprotezione quanto sono appetibile come bersaglio per i potenziali autori di reato? Quanto sono in grado di resistervi? 23 Per un approfondimento sulle controverse relazioni causali tra contenuti mediatici e comportamenti criminali, da un lato, e percezioni della criminalità, dall’altro si veda l’importante e imponente volume di Gabrio Forti e Marta Bertolino che raccoglie in forma di saggi gli interventi al Convegno dal titolo “LA rappresentazione televisiva del crimine” svoltosi il 15-16 maggio 2003 presso l?università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (G. Forti, M. Bertolino (a cura di), La televisione del crimine, Vita e Pensiero, Milano, 2005). Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 55 conseguenze: se qualcuno tenta o riesce a vittimizzarmi, quali perdite fisiche, psicologiche e finanziarie dovrò sopportare? Quanto riuscirò a far fronte a queste perdite? Queste valutazioni, secondo l’autore, danno spesso il via a processi di formazione della paura della criminalità. Fattori ecologici: qualità della vita e ambiente urbano Non solo le informazioni sulla criminalità, ma anche quelle sull’ambiente circostante, sulle situazioni – entrano a far parte del giudizio relativo al rischio di subire un reato: Ferraro sostenne che «per produrre una reazione di paura negli uomini, è essenziale che una situazione sia riconosciuta avere almeno un pericolo potenziale, reale o immaginario». 24 Nello spiegare il suo modello, l’autore applicò la teoria delle opportunità criminali, solitamente usata per descrivere il comportamento razionale degli autori di reato, alle valutazioni di ciascuno sulla probabilità di subire un reato. Ferraro affermò che mentre i “potenziali criminali” possono trarre vantaggio dalle informazioni disponibili sulla vita nel quartiere – tassi di criminalità, livello di sorveglianza della polizia e della comunità, etc. – per giudicare il costo del reato, le potenziali vittime possono usare le stesse informazioni per valutare il grado di minaccia alla propria incolumità o ai propri beni. In altre parole, quando le persone valutano il rischio di essere vittimizzate solitamente considerano innumerevoli indicatori ecologici, come il grado di disordine urbano, l’impegno di sorveglianza, il livello di reddito degli abitanti del quartiere e sono influenzate da caratteristiche personali, quali l’aver già subito un reato, l’essere a conoscenza di altri episodi di vittimizzazione, l’essere dotati di risorse per affrontare la minaccia potenziale (non solo le risorse economiche, ma anche quelle personali – grado di salute –, relazionali – possibilità di assistenza da parte della famiglia e dei vicini – e istituzionali – esistenza e accessibilità di servizi di assistenza). Il “filone ecologico” si affermò nel corso degli anni Ottanta, evidenziando le relazioni tra paura, ambiente urbano e qualità della vita. Chris Hale, sviluppando l’intuizione di uno studio di James Garofalo e John Laub del 1978, analizzò la qualità della vita sulla base di indicatori og- 24 K.F. Ferraro, Fear of Crime: Interpreting Victimization Risk, Albany, New York: State University of New York Press, 1995, p. 4. 56 Capitolo 2 gettivi di benessere economico, presenza di servizi educativi e culturali, livelli di inquinamento, di edificazione, di criminalità e indicatori soggettivi relativi al grado di preoccupazione delle persone per tutti questi problemi, e, a partire dai dati raccolti nell’ambito di un programma di sicurezza della città di Flint nel Michigan, dimostrò il forte legame tra sentimento d’insicurezza e percezione della qualità della vita nel quartiere.25 Altri ricercatori adottarono un’ottica riduttiva del concetto di qualità della vita – che, come si è già detto, in altri autori includeva anche4 la dimensione istituzionale dei servizi e quella ambientale dell’inquinamento – e studiarono la paura in relazione alle cd inciviltà sociali (comportamenti come ubriachezza, consumo di droghe, rumori molesti, etc.) e fisiche (graffiti, spazzatura, case abbandonate, macchine e case decadenti) di un quartiere. La paura della criminalità sarebbe indotta non solo dalla presenza di alti livelli di criminalità, ma anche da un insieme di altri segni di disorganizzazione sociale che indicano ai residenti che la loro comunità sta volgendo al peggio26. James Q. Wilson e Gorge L. Kelling, in un articolo pubblicato sulla rivista The Atlantic Monthly dal titolo Broken Windows27, descrissero il percorso attraverso cui criminalità, disordine (signs of incivility) e paura si influenzano reciprocamente. La violazione di norme condivise riguardanti gli spazi pubblici, cioè i segni di inciviltà, creano situazioni di degrado e di abbandono di aree che rischiano di diventare zone preferenziali per lo svolgimento di attività illecite. Ai primi segnali di degrado le persone tendono a evitare quelle aree che col tempo diventano sempre più «a rischio criminalità» e vengono percepite come insicure. L’ampliamento di aree off-limits diffonde nella città un senso d’insicurezza, arginabile colo con politiche che affrontino il degrado urbano. Come sintetizza Marzio Barbagli, forse il più importante portavoce italiano di questa tesi, nota come “teoria della finestra rotta”, i segni di inciviltà provocano insicurezza per vari motivi. In primo luogo, essi vengono visti dai residenti come spie del crollo delle norme che regolano la vita quotidiana e dell’incapacità di farle rispettare da parte di coloro che hanno questo compito. In secondo luogo, le persone ritenute responsabili di queste piccole violazioni – i tossicodipendenti, gli ubriachi, persino i senza fissa dimora – vengono considerate una 25 C. Hale, op. cit. a nota 20. W. Skogan, M. Maxfield, op. cit. a nota 20. 27 J.Q. Wilson, G.L. Kelling, “Broken Windows,. The Police and Neighbourhood Safety”, Atlantic Monthly, March, 1982. Cfr. anche G.L. Kelling, C. Coles, Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities, Free Press, New York, 1996. 26 Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 57 minaccia perché imprevedibili e dunque capaci di tutto, anche di commettere reati violenti. In terzo luogo, le inciviltà sono – per loro natura – molto visibili, molto più dei reati.28 Va subito aggiunto che a partire da questa teoria sono stati edificati numerosi programmi di prevenzione e di sicurezza in tutto il mondo. La stessa “Tolleranza Zero” del Sindaco di New York Rudolph Giuliani, di cui fu principale artefice il Capo della Polizia Metropolitana, William Bratton, costituisce una delle applicazioni di questa tesi criminologica, sicuramente la più “poliziesca” , dato il costante utilizzo della polizia per gestire i problemi di degrado e d’inciviltà.29 Coesione e fiducia: l’emergere della collective efficacy Due recenti ricerche, tuttavia, ampliano nuovamente lo sguardo sulla realtà sociale, spostando l’attenzione dalle inciviltà alla collective efficacy (efficacia collettiva), definita come coesione tra i residenti di una stessa area combinata con una condivisione di aspettative circa il controllo informale dello spazio pubblico. Gli studi di Robert J. Sampson e Stephen Raudenbush30 indicano la collective efficacy come il più importante fattore di contenimento della criminalità 31, del disordine e dell’insicurezza nei quartieri. In questa prospettiva, l’emergere del problema della paura viene collegato a una diminuzione dei livelli di efficacia collettiva, vale a dire a una progressivo deterioramento dei rapporti di fiducia e di solidarietà tra i residenti unitamente a un progressivo disinteresse per la vivibilità del quartiere: l’insicurezza sarebbe, in altri termini, l’effetto congiunto di una crisi di fiducia nella capacità della collettivi28 M. Barbagli, “La paura della criminalità”, in Barbagli M., Gatti U. (a cura di), La criminalità in Italia, Bologna, Il Mulino, 2002. 29 Cfr. A. De Giorgi, Zero Tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo, Roma, Derive Approdi, 2000. 30 R.J. Sampson, S.W. Raudenbush, “Systamatic Social Observation Of Public Spaces: A New Look At Disorder In Urban Neighborhoods”, American Journal of Sociology, Vol. 105, N. 3, 1999; R.J Sampson., S.W. Raudenbush, “Disorder In Urban Neighborhoods. Does It Lead To Crime?”, Research In Brief, U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 2001. 31 Si vedano anche gli studi di Uberto Gatti e Richiard Tremblay sulla relazione tra senso civico – concetto contiguo a quello di collective efficacy, ma comunque distinto soprattutto per come è stato operazionalizzato,– e tassi di criminalità. U. Gatti, R.E. Tremblay, D. Larocque, “Civic Community and Juvenile Delinquency: A Study of the Regions of Italy”, The British Journal of Criminology, Vol. 43, N. 1, 2003, pp. 22-40; U. Gatti, H.. Schadee, R.E. Tremblay, “Capitale sociale e reati contro il patrimonio. Il senso civico come fattore di prevenzione dei furti d'auto e delle rapine nelle province italiane”, Polis, N. 1, 2002, pp. 57-74. 58 Capitolo 2 tà di regolare i conflitti sociali e di sentimenti di disaffezione verso il proprio quartiere. Particolare importanza sembra rivestire la fiducia nella capacità delle istituzioni, e tra queste delle forze di polizia, di controllare il territorio. Su quest’ultimo aspetto, sono numerosi gli studi che hanno affrontato la relazione tra paura della criminalità e fiducia nelle polizie. Steven Box, Chris Hale e Glen Andrews32, analizzando i dati dell’indagine di vittimizzazione britannica (British Crime Survey), hanno concluso che le persone che hanno fiducia nel funzionamento delle Forze dell’ordine a livello locale hanno minore probabilità di provare paura della criminalità rispetto a coloro che non hanno fiducia. Questi risultati portarono gli autori a ritenere che il coinvolgimento della polizia nella vita della comunità sia una componente essenziale di ogni strategia per ridurre l’insicurezza. I dati della National Crime Victimization Survey americana del 1998 relativi alla percezione della sicurezza dei residenti di 12 metropoli americane, indicarono che il livello d’insicurezza varia al variare della soddisfazione dei cittadini per l’operato delle Forze dell’ordine [Smith et al. 1998]. Emerse, infatti, che la percentuale di chi prova paura della criminalità è più alta (l’89 per cento) tra chi si dichiara insoddisfatto dell’operato della polizia rispetto a chi si dichiara soddisfatto (79 per cento). Questi risultati sono in linea anche con quanto è emerso dall’indagine di vittimizzazione italiana dell’Istat 1997/98: l’insicurezza cresce al diminuire della fiducia nelle Forze dell’ordine. Si dichiara, infatti, poco o per nulla sicuro quando è solo per strada di sera il 13 per cento di coloro che sono molto soddisfatti dell’operato delle Forze dell’ordine, il 21 per cento di coloro che sono abbastanza soddisfatti, il 36 per cento di coloro che sono poco soddisfatti ed il 43 per cento di coloro che non sono per nulla soddisfatti. Sono molti, infine, gli studi di valutazione di programmi di riforma della polizia che dimostrano come iniziative volte ad aumentare il livello di fiducia nelle Forze dell’ordine portino ad una riduzione dell’insicurezza. Così, la valutazione dell’Interactive Community policing (ICP) Program, programma di riforma della polizia del Dipartimento di Polizia di Dallas, ha rilevato che, nelle aree in cui il programma ha prodotto risultati in termini di aumento della fiducia tra cittadini e polizia (high ICP areas), il livello di paura della criminalità è diminuito.33 32 S. Box, C. Hale, G. Andrews, “Explaining Fear Of Crime”, in The British Journal Of Criminology, Vol. 28, N. 3, 1998, p. 353. 33 Si veda lo studio di valutazione del Dallas Police Departments Interactive Community Policing Program (C. Mindel, R.F. Dangel, W. Carson, M.L. Mays, An Evaluation Of The Dallas Police Depart- Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 59 Tornando al tema più generale della collective efficacy, va sottolineato come le ricerche che la riguardano, rivolgendo lo sguardo alle dinamiche della fiducia sociale e istituzionale e della coesione sociale, abbiano posto all’attenzione degli studiosi e dei decisori politici la complessità socioculturale delle paure delle persone – da cui deriva, implicitamente, la necessità di elaborare politiche articolate in grado di affrontare tale complessità. In questo senso, tali studi empirici presentano alcune affinità con la riflessione sociologica sull’insicurezza, che – come emergerà dalla lettura del prossimo capitolo) – affronta in modo specifico i temi della “crisi” e della “fiducia” nelle società tardo-moderne e descrive la paura della criminalità come epifenomeno di un malessere più generale e radicato nelle trasformazioni sociali e culturali in atto. La presa d’atto di una confusione metodologica e terminologica Di segno completamente diverso rispetto ai tentativi esplicativi finora descritti è l’interpretazione del “paradosso vittimizzazione-paura” avanzata da Randy L. LaGrange e Kenneth F. Ferraro34: il maggior livello di paura della criminalità tra gli anziani sarebbe dovuto a un errore di stima derivante dal non corretto uso degli indicatori per misurare la paura della criminalità. Lo studio dei due autori affrontò la relazione tra età e genere, da una parte, e paura della criminalità, dall’altra, utilizzando l’indicatore di paura della National Crime Survey (NCS) e altri 13 indicatori alternativi – tra cui indicatori di percezione del rischio e indicatori di paura per specifici reati. Come ipotizzato dagli autori, l’analisi produsse risultati contraddittori: quando si utilizzava la domanda della NCS (“Quanto sicuro ti senti o ti sentiresti a stare fuori da solo nel tuo quartiere di notte”), le donne più anziane riportavano di avere molta più paura delle donne più giovani; quando si utilizzavano gli indicatori alternativi relativi a specifiche paure, gli adulti più anziani riferivano di avere meno paura rispetto ai giovani adulti. Inoltre, gli indicatori di percezione del rischio e quelli di paura della criminalità non ge- ments Interactive Community Policing Program - 1995-1999: Final Report, Center for Research, Evaluation And Technology, University of Texas at Arlington, 2000). Risultati simili emergono dagli studi di valutazione dei programmi di polizia di Montreal (programma SPCUM, Service de Police de la Communauté Urbaine de Montréal) in Canada, di Chicago (programma CAPS, Chicago Alternative Policing Strategy), di West Palm Beach (programma di Community Policing in tre comunità locali) e di Portland negli Stati Uniti. 34 R.L. Lagrange, K.F. Ferraro, “Assessing age and gender differences in perceived risk and fear of crime”, Criminology, Vol. 27, N. 4, 1989, pp. 713-715. 60 Capitolo 2 nerarono risultati equivalenti. I livelli di percezione del rischio erano più elevati dei livelli di paura della criminalità. Come si può notare anche da questa breve e necessariamente incompleta rassegna 35, il riconoscimento dell’esistenza di un “paradosso vittimizzazione-paura”, ha spinto, da un lato, alla ricerca delle cause della paura della criminalità idonee a spiegare la discrepanza tra i tassi di criminalità e i livelli di paura della criminalità; dall’altro, più recentemente, ha aperto la strada alla critica dei tradizionali strumenti di rilevazione del fenomeno36. Infatti, come osservano alcuni autori37, i risultati contrastanti nello studio dei suoi fattori sono perlopiù il frutto della confusione delle metodologie utilizzate negli studi empirici e, in particolare, della confusione dell’utilizzo del termine “fear of crime”. A partire da queste intuizioni, alcuni recenti studi si sono esplicitamente dedicati alla definizione teorica e operativa del concetto di paura della criminalità. Questo corpo di ricerche, per la verità non particolarmente vasto, riprende più o meno apertamente il dibattito sulle emozioni in campo filosofico e psicologico. Vale la pena descrivere brevemente i contorni di questo dibattito, premettendo tale trattazione a quella più specifica relativa alla definizione dell’oggetto delle indagini criminologiche. 2.4 Primo intermezzo: il dibattito sulla razionalità delle passioni L’opposizione ragione/passioni nel pensiero filosofico occidentale Le idee teoriche sulle emozioni sono spesso fondate sulla considerazione che si tratti di fattori di deviazione della razionalità nel pensiero, nel comportamento e nelle relazioni tra gli individui.38 Questa concezione, rav35 Una rassegna delle variabili solitamente utilizzate nella ricerca criminologica sulla paura della criminalità è presente nello studio empirico di Stephen Farrall, Jon Bannister, Jason Ditton e Elisabeth Gilchrist del 2000 sulla “varianza” della paura della criminalità con riferimento a un modello esplicativo che integri fattori psicologii e socio-demografici (S. Farrall, J. Bannister, J. Ditton, E. Gilchrist, “Social Psychology and The Fear Of Crime”, British Journal of Criminology, 40, 2000, pp. 399-413). 36 R.L. Lagrange, K.F. Ferraro, op. cit. a nota 34. 37 C. Hale, “Fear of Crime: A Review of the Literature”, in International Review of Victimology, 4, 1996, pp. 79-150. 38 T. Magri, “Ridare cittadinanza alle emozioni”, in T. Magri (a cura di), Filosofia ed emozioni, Feltrinelli, Milano, 1999, pp. 7-10. Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 61 visabile in moltissime espressioni di senso comune, viene da lontano e ha caratterizzato a lungo il pensiero filosofico occidentale: «segno manifesto di un potere estraneo alla parte migliore dell’uomo [le passioni] lo dominerebbero, distorcendone la chiara visione delle cose e sviandone la spontanea propensione al bene». 39 Platone fu il primo a definire le passioni “malattie dell’anima”: nel Fedone le descrisse come chiodi che conficcano l’anima nel corpo e ne rendono difficile, spesso impossibile, la purificazione e il finale congiungimento con il divino. 40 La passione attua un cedimento dell’anima di fronte alla pressione esterna. Nel libro IV della Repubblica, lo stesso Platone, però, avanzò un altro modello esplicativo del funzionamento delle passioni, che verrà ripreso anche da Aristotele, non più fondato su una lotta tra interno (anima) ed esterno (corpo), bensì sul conflitto interno all’anima stessa, che vede contrapporsi diverse cariche energetiche attive nella dimensione psichica. Le passioni costituiscono un polo dell’anima, al cui estremo opposto è collocata la ragione; sono energie pericolose, perché, se ribelli alla guida razionale, possono deviare l’anima dal corso di una vita buona e giusta. Mario Vegetti descrive nello specifico questi modelli eziologici, accennando, da un lato, la loro influenza sul pensiero occidentale e sottolineando, dall’altro lato, come questo processo di “medicalizzazione dell’universo passionale” fosse contestuale e funzionale alla nascita di forme di governo cittadino a base egualitaria, le poleis, in cui l’eccesso emotivo risultava pericoloso e destabilizzante. Il freno alle passioni, nelle tecniche di combattimento – nella falange oplitica, in cui la salvezza di ciascuno dipende dalla sua compattezza, in opposizione al furore eroico, pericoloso per la compattezza della falange – come nelle decisioni assembleari, costituiva l’elemento su cui fondare la cittadinanza.41 Tratterò più avanti, in particolare nel secondo intermezzo (capitolo 4), il tema delle relazioni tra passioni – paura, innanzitutto – e produzione di ordine sociale, proprio a partire dallo studio di Vegetti sull’ira nel mondo antico. In quella sede avanzerò anche un altro possibile sguardo sulle passioni, intese come “costrutti culturali”. 39 R. Bodei, Geometria delle passioni. Paura, speranza e felicità: filosofia e uso politico, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 7. 40 M. Vegetti, “Passioni antiche: l’io collerico”, in S. Vegetti Finzi (a cura di), Storia delle passioni, Editori Laterza, Bari, 1995, pp. 47-48. 41 Ibidem, pp. 39-73. 62 Capitolo 2 Per ora è importante sottolineare come la “medicalizzazione delle passioni” nel mondo antico abbia portato anche alla costruzione di una tassonomia – di matrice platonica e via via arricchitasi con il contributo dei filosofi stoici – di straordinario interesse per la sua vicinanza alle elaborazioni più recenti. Se le passioni sono “malattie”, la loro definizione e la contestuale classificazione diventano necessarie per curarle e governarne gli effetti perversi nell’individuo e nella comunità. In breve, alla base del sistema di classificazione è situata la coppia piacere-dolore; con l’aggiunta della dimensione temporale del futuro, essa produce la seconda coppia desideriopaura, da intendersi rispettivamente come attesa del piacere e attesa del dolore.42 Quindi, l’opposizione ragione/passioni e la medicalizzazione delle seconde costituiscono le due polarità su cui si è articolato il pensiero filosofico. Infatti, a partire dalle definizioni platoniche, si sviluppa una lunga tradizione di pensiero e di senso comune che vede le emozioni, e, più in generale, gli stati d’animo, opposti alla ragione e, quindi, irrazionali e istintive. Remo Bodei, attraverso un’analisi di ampio respiro teorico e storico che trova il suo perno nella concezione dell’ “amore intellettuale” e nella critica alle passioni – in particolare a paura e speranza – di Baruch Spinoza (16321677), evidenzia come queste siano state considerate da buona parte del pensiero filosofico come vizi da estirpare per giungere a un perfetto autocontrollo. Proprio la concezione di Spinoza innova in questo campo: essa «si contrappone a tutto campo a una schiera di filosofie antiche e moderne, che hanno preteso di padroneggiare, pilotare, snervare o canalizzare le passioni, mediante comandi della ragione, decreti della volontà o esercizi spirituali»43 e avanza la tesi che si tratti non di vizi, bens’ di espressioni della natura da comprendere e da emancipare. In particolare, gli obiettivi polemici presenti nell’Etica del filosofo olandese sono lo stoicismo e Cartesio, accomunati dall’idea che sia possibile un dominio completo del Logos sulle passioni. Se nella tradizione platonica e aristotelica il problema era quello di riconvertire (sublimare) il potenziale energetico del fondo passionale dell’apparato psichico mettendolo al servizio del progetto di un’anima diretta alla verità, alla giustizia e alla costruzione del sapere e della “bella città” in cui gli uomini potessero finalmente vivere da uomini e non da leoni44, con lo stoicismo antico gli affetti non vanno addomesticati, bensì estirpati, combat42 Ibidem, p. 55. R. Bodei, op. cit. a nota 39, p. 181. 44 M. Vegetti, op. cit. a nota 40, p. 61. 43 Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 63 tuti frontalmente. La passione, che si esprime attraverso il corpo, non è che distorsione e sviamento dell’anima; l’uomo, con la forza della ragione, deve bilanciare la debolezza del corpo45. In questo senso, lo stoicismo manifesta un nuovo interesse per il legame tra passioni e corpo, riprendendo la prima concezione platonica, quella espressa nel Fedone: l’anima è soltanto ragione e la passione è una malattia che viene da fuori ma che è in grado di sprigionare una sua perversa energia che fa uscire l’io fuori di sé. In questo movimento di espulsione delle passioni dall’anima al corpo emerge chiaramente anche una diversa concezione antropologico-politica del processo di costruzione della soggettività: se nella Repubblica di Platone e in Aristotele il materiale affettivo deve essere governato dalla ragione ma, al tempo stesso, la sua carica energetica è essenziale per il movimento dell’anima verso le buone opere, nel pensiero stoico perché l’io possa costruirsi secondo la norma della natura, che lo vuole soltanto razionale, le passioni vanno radicalmente rimosse. In tal modo gli affetti perdono ogni rilevanza ai fini della costituzione della soggettività morale46: diventano inutili e pericolose. La visione stoica dell’opposizione ragione-passioni, che ripercorre i contrasti “anima-corpo”, “intelletto attivo-emozioni passive”, soggettivitàpulsionalità, ha avuto una forte eco nella concezione filosofica e di senso comune dei secoli successivi. In particolare, nella filosofia seicentesca le passioni vivono una radicale neutralizzazione47: il “cogito ergo sum” di Cartesio relega le passioni a deragliamenti dal giusto ordine naturale. Nell’ottica di René Descartes (15961650) le passioni fungono da lenti d’ingrandimento: ingigantendo i loro oggetti, fanno apparire molto più grandi e importanti tanto i beni quanto i mali. Nono sono necessariamente negative, anzi: in se sono quasi tutte buone: rafforzano e fanno durare nell’anima pensieri che è bene che essa conservi. Occorre, dunque, ridimensionarne gli effetti distorsivi nella rappresentazione 45 R. Bodei, op. cit. a nota 39, p. 203-8. Antitetica a entrambe (platonica e stoica) è la concezione dello scetticismo: secondo Sesto Empirico, le passioni non esistono nella forma “naturale” della vita, né sono radicate nell’anima. Si tratta piuttosto di miraggi, di distorsioni ottiche prodotte proprio dall’esistenza di teorie etiche normative. Facendoci credere che esistono beni e fini da perseguire, mali da evitare, imponendoci l’osservanza di questa o quella “arte del vivere”, coinvolgendoci infine nelle indecidibili controversie tra scuole rivali, queste teorie rendono la vita incerta ed inquieta: non le cose, ma le opinioni infondate che le person hanno sulle cose, provocano il nostro turbamento, ci rendono infelici. (Sesto Empirico, Contro gli etici, IV, p. 113. Cfr. M. Vegetti, op. cit. a nota 40, p. 66.). 46 Cfr. M. Vegetti, L’etica degli antichi, Editori Laterza, Roma-Bari, 1989. 47 S. Moravia, “Esistenza e passione”, in S. Vegetti Finzi (a cura di), Storia delle passioni, Editori Laterza, Bari, 1995, pp. 3-38. 64 Capitolo 2 della realtà, così da ridurne anche l’incidenza perturbativa sull’intelletto. Questa operazione è possibile se si è dotati di générosité, vale a dire di un animo capace di valutare se stesso e gli affetti che lo coinvolgono nella giusta misura. E il perno di queste attività di trasformazione delle passioni è la volontà.48 Anche Spinoza, pur distaccandosi dal pensiero stoico e da quello cartesiano, ritiene che le passioni distorcano la realtà e deformino la conoscenza; egli, tuttavia, indica come fallimentare il tentativo illusorio cartesiano di soffocare le passioni, in quanto fondato sull’idea di una separazione tra anima e corpo che risulta incapace di spiegare la dinamica con cui la prima influenzi il secondo, e propone di sostituire alla volontà, riferita soltanto alla mente, la cupiditas (desiderio), vale a dire l’appetito cosciente di se stesso e imputabile insieme alla mente e al corpo. Per il filosofo le passioni sottopongono gli uomini a fluttuazione dell’animo, impedendo loro una conoscenza adeguata della cause ed esponendoli a incessanti conflitti; in particolare paura e speranza sono ostacoli in vista della transizione a un grado maggiore di perfezione e di esistenza. Ma, a differenza di Platone e degli stoici, in Spinoza questa transizione non si raggiunge attraverso una “giusta misura emotiva” (metriopatheia) – come in Platone e Aristotele – e neppure attraverso l’eliminazione di questi ostacoli: la transizione avviene attraverso la metamorfosi delle passioni in affetti, che implica una polarizzazione della loro forza verso fini realmente raggiungibili, sottraendola, così, a fluttuazioni inutili e pericolose. La transizione viene regolata dalla cupiditas, elemento costitutivo dell’uomo – il quale per sua natura segue ciò che serve alla sua conservazione – e può essere ascendente, quando prevalgono laetitia e amor, ma anche discendente, quando prevale la tristizia, a cui ciascuno è sottoposto dai casi della vita (fortuna) e dalla sua arrendevolezza. Così, le passioni subiscono una continua trasformazione in due direzioni: verso un incremento della gioia e della potenza di vivere oppure verso il prevalere dell’infelicità. In questa tesi, qui solamente accennata, Spinoza riconosce, dunque, un contenuto positivo delle passioni, la cui energia può essere utilizzata per aumentare la vis existendi. Purtuttavia, esse continuano a essere considerate, in prima battuta, come forze istintive (fluttuazioni naturali) pericolose, a meno che non vengano opportunamente canalizzate in percorsi ascensionali e trasformate, dunque, in affetti sotto la guida del desiderio di ciascuno di preservarsi nel suo essere. 48 Cfr. R. Bodei, op. cit. a nota 39, pp. 272-311. Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 65 Così, anche il riconoscimento di una “funzione positiva” rimane ancorato a una visione che le oppone all’intelletto49, che perdura anche oltre l’Illuminsimo. Nonostante la grande raffinatezza della ricerca filosofica e psicologica che le ha investite, si è storicamente affermata una specie di presunzione di colpa a carico delle emozioni. Curiosamente, tale presunzione è implicita anche nelle teorie che riconoscono la loro funzione positiva e, anzi, la loro indispensabilità. […] Le emozioni sono positivamente importanti soltanto perché, per loro natura, restano fuori dalla portata dei criteri cognitivi e pratici denunciati come illusori.50 Le più recenti teorie filosofiche delle emozioni si sono mosse in direzioni diverse da quelle descritte finora. I fattori più importanti sono stati l’affermazione nel corso degli ultimi cinquant’anni, della psicologia cognitiva e, successivamente, delle neuro-scienze, più attente alle funzioni e disfunzioni mentali delle emozioni, e lo sviluppo e la stabilizzazione disciplinare della filosofia della mente e, quindi, della discussione della relazione tra mente e corpo.51 Di seguito discuterò di questo nuovo sguardo e della sua effettiva portata innovativa. Il riconoscimento di una base cognitiva nelle emozioni Nell’ambito di una concezione filosofica che si propone di superare il dualismo ragione/passioni, alcune recenti studi di psicologia cognitiva affermano la presenza di elementi di razionalità all’interno delle seconde, riconoscendo il ruolo della “base cognitiva”: si tratta di un ricordo, di una percezione, di un giudizio, di un atto d’immaginazione o di una supposizione da cui dipende l’emozione. Tale elemento cognitivo viene graduato in relazione alle diverse specie di stati d’animo che costituiscono l’universo passionale. 49 La concezione della paura di Thomas Hobbes – come osserverò meglio nel capitolo 4, in cui dedicherò alcune pagine al pensiero del filosofo inglese – disarticola questa opposizione paradigmatica: posta al centro della costruzione dell’ordine istituzionale, essa non viene intesa come stato d’animo irrazionale, bensì in rapporto dialettico con la ragione49: è una paura che comporta un ragionare, essendo connessa all’attività di prevedere un male futuro e di provvedere a rimuovere le situazioni di pericolo. 50 T. Magri, op. cit. a nota 38, p. 8. 51 Ibidem, p. 9. 66 Capitolo 2 Sulla base del lavoro di Gozzano52 e di Calabi53, le passioni possono essere distinte in tre categorie: i sentimenti, le condizioni emotive (o umori) e le reazioni emotive. I criteri di distinzione normalmente utilizzati sono tre: la causa di attivazione, l’oggetto e il legame con la base cognitiva. I sentimenti sono caratterizzati da un’estensione temporale che manca alle emozioni e, per questo, è difficile individuarne l’origine. Sono preoccupato di non superare l’esame ma non so dire in quale preciso momento ho iniziato a preoccuparmi (sentimento), mentre è più facile dire in che momento, durante l’esame, ho provato paura di non superarlo (emozione). I sentimenti sono caratterizzati dall’incapacità dell’individuo di dire esattamente cosa li ha causati, pur avendo chiaro l’oggetto verso il quale sono diretti. Come riferisce Gozzano, «è ben difficile dire con precisione perché o quando una persona ha iniziato ad amare un’altra persona, ma si sa chi si ama, ossia non è possibile individuare la causa del sentimento mentre non si ha alcuna difficoltà a indicare l’oggetto del sentimento» 54. Nel caso dei sentimenti, quindi, le valutazioni (analisi cognitiva) dell’oggetto dei sentimenti integrano il sentimento stesso e lo caratterizzano come struttura complessa: «per considerare l’amore, noi possiamo integrare il nostro sentimento di amore con giudizi sulla qualità della persona amata»55. Nelle condizioni emotive (o umori), invece, l’individuo non riesce né a risalire a una causa della sua condizione né a individuare un oggetto specifico della sua condizione. Spesso si è allegri, ansiosi o malinconici per nessun motivo in particolare e senza che ci sia un oggetto preciso verso cui dirigere l’allegria, l’ansia o la malinconia. Le condizioni emotive si caratterizzano per il fatto di essere prive di un oggetto intenzionale e di avere un legame molto debole con la base cognitiva. Questa ultima, quando interviene, modifica la condizione emotiva in un altro stato d’animo: l’allegria generica viene presa come tale dall’individuo, il quale non cerca ragioni per essa, né la motiva in alcun modo. L’eventuale interpretazione della condizione tramite elementi cognitivi trasforma tale passione in qualcosa di diverso: un sentimen- 52 S. Gozzano, “Ipotesi sulla metafisica delle passioni”, in T. Magri (a cura di), Filosofia ed emozioni, Feltrinelli, Milano, 1999, pp. 13-50. Cfr. anche N.H. Frjida, The Emotions, Cambridge University Press, Cambridge, 1986. 53 C. Calabi, “Che cosa hanno in comune l’amore, il disprezzo e l’assassinio premeditato? Emozioni, base cognitiva e razionalità”, in T. Magri (a cura di), Filosofia ed emozioni, Feltrinelli, Milano, 1999, pp. 51-94. 54 S. Gozzano, 1999, op. cit. a nota 52. 55 Ibidem. Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 67 to, se viene individuato l’oggetto dell’allegria, un’emozione intenzionale se viene individuata sia la causa sia l’oggetto.56 Nelle reazioni emotive, infine, causa e oggetto sono identificabili e spesso coincidono. Gli studiosi sono concordi nel sostenere che tale stato d’animo insorga per una causa specifica, la quale costituisce, al contempo, l’oggetto. Così, per esempio, la paura di essere aggrediti sorge per il fatto di aver sentito un rumore, il quale viene interpretato come segnale di allarme per una possibile e futura aggressione. Sul legame con la base cognitiva, invece, esistono diverse tesi. Alcuni, per esempio, distinguono tra reazioni emotive, caratterizzate da assenza di base cognitiva, ed emozioni intenzionali, caratterizzate da una compresenza, sia pure debole, tra gli stati intenzionale ed emozionale. La paura di essere aggrediti può essere causata dal fatto di sentire un rumore improvviso: in questo caso si parla di “reazione emotiva”, scatenata da una percezione improvvisa. D’altra parte, la paura di essere aggrediti può essere l’effetto di ritenere, mentre si cammina per strada, che un estraneo prima o poi ci possa aggredire: questo è il caso dell’emozione intenzionale, in cui l’emozione è fortemente legata a una valutazione (analisi cognitiva) di ciò che può accadere. Altri studiosi, invece, ritengono che la reazione emotiva abbia sempre un legame con uno stato cognitivo, anche se non sempre si tratta di una vera e propria valutazione razionale. Prendiamo il caso di una persona che prova paura perché sente un rumore in casa: questa emozione nasce non tanto dal fatto che si sente un rumore, in una sorta di rapporto meccanicistico tra stimolo e risposta, bensì dalla circostanza che quel rumore sia “percepito” come un segnale di allarme che qualcosa di pericoloso sta per accadere – per esempio, perchè evoca una situazione di pericolo precedentemente vissuta dalla persona. Dunque, le emozioni (inserendo in questa categoria sia le reazioni emotive sia le emozioni intenzionali) hanno spesso un legame con la base cognitiva.57 Tra gli altri, Keith Oatley sottolinea come questo tipo di passioni insorga in circostanze particolari, definite eliciting conditions, sulla base del significato psicologico dell’evento, vale a dire della sua valutazione soggettiva58: gli eventi vengono valutati principalmente in relazione agli scopi 56 Ibidem. C. Calabi, op. cit. a nota 53. K. Oatley, Best Laid Schemes. The Psychology of Emotions, Cambridge University Press, Cambridge, 1997 (Trad. It. Psicologia ed emozioni, Il Mulino, Bologna, 2003). 57 58 68 Capitolo 2 dell’individuo in quel determinato momento della sua esistenza. In base a questo presupposto, un evento viene giudicato in modo diverso quanto più favorisce, avvicina o rende probabile il raggiungimento di uno scopo.59 In questo senso, si potrebbe citare il caso in cui, a seguito di un lieve incidente stradale, gli automobilisti provano rabbia, e non un’altra emozione, quale, per esempio, lo sconforto, poiché interpretano quel fatto come ostativo al raggiungimento di un obiettivo fortemente desiderato, come potrebbe essere l’arrivare puntuale a un impegno di lavoro, l’assistere a uno spettacolo teatrale o il riposarsi a casa dopo una giornata di lavoro. Ma questo legame non è sempre presente, soprattutto se s’intende la base cognitiva come uno stato mentale razionale. È possibile, infatti, che questa sia costituita da una sorta di stato inconsapevole di pre-categorizzazione che agisce classificando immediatamente gli input esterni come stimoli per reazioni differenziate. Così, per esempio, sentire l’urlo di un bambino piccolo può attivare im-mediatamente una reazione di protezione, mentre udire lo sparo di una pistola produce automaticamente una reazione di difesa. Nella tabella 5 sono sintetizzate le principali caratteristiche degli stati d’animo individuati. Tabella 5 - Durata, causa, oggetto e base cognitiva degli stati d’animo stato d'animo sentimento estensione temporale esteso nel tempo causa inizio e causa difficilmente individubili causa difficilmente individuabile condizione emotiva estesa nel tempo reazione emotiva presenza di una limitata nel tempo causa scatenante oggetto base cognitiva esempio oggetto individuabile integrazione con stati cognitivi (valutazioni, giudizi) es. amore: dura nel tempo, non si sa quando precisamente sorge, si sa verso chi è rivolto, viene integrato con giudizi sulla qualità dell'oggetto oggetto non individuabile es. allegria: viene presa come tale dall’individuo, il quale non cerca ragioni per essa e non è rivolta a qualcosa di specifico. L’eventuale interpretazione autonomia da stati della condizione tramite elementi cognitivi cognitivi trasforma tale passione in qualcosa che non è: un sentimento, se viene individuato l’oggetto dell’allegria, un’emozione intenzionale se viene individuata sia la causa sia l’oggetto presenza di un oggetto che spesso coincide con la causa scatenante presenza di una es. paura di essere aggrediti: è scatenata da un base cognitiva che fatto concreto (es. rumore insolito), interpretato integra la causa come pericoloso, e costituisce una reazione a quel fatto. Dura finchè dura la percezione del pericolo scatenante 59 V. D’Urso, “Introduzione all’edizione italiana”, in K. Oatley, Best Laid Schemes. The Psychology of Emotions, Cambridge University Press, Cambridge, 1997 (trad. It. Psicologia ed emozioni, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 15). Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 69 La prevalenza del “corpo” nelle emozioni Le emozioni si caratterizzano anche per le reazioni fisiologiche che accompagnano il loro verificarsi. Nonostante non sempre al variare delle emozioni si riscontrino meccanismi fisiologici diversi – spesso, al contrario, alcune reazioni psico-fisiche (per esempio, l’aumento del battito cardiaco o della sudorazione) ricorrono costantemente in molte manifestazioni emotive –60 e, quindi, tali meccanismi non possano essere considerati elementi distintivi delle diverse emozioni, queste ultime vengono spesso indicate, più che altri tipi di passioni, come reazioni “comprensibili” nelle loro manifestazioni corporali. Si potrebbe dire che sono stati d’animo fortemente legati alla dimensione istintiva, più che a quella volontaristica. In effetti, ciò che caratterizza il pensiero scientifico è la tendenza maggioritaria a considerare le emozioni come dei processi psico-biologici, il cui luogo privilegiato di leggibilità è il corpo61. La base cognitiva costituisce un elemento marginale rispetto al processo fisiologico, vero nucleo caratterizzante questo tipo di passione. Così, se, da un lato, la letteratura più recente intende superare l’opposizione ragione/passioni attraverso il riconoscimento della presenza di elementi cognitivi all’interno di ogni stato d’animo, dall’altra parte, la classificazione dell’universo passionale in sentimenti, umori ed emozioni, con la conseguente marginalità della base cognitiva in queste ultime, ripropone l’opposizione tra anima e corpo e, con essa, un’interpretazione “fisicalistica”62. In tale versione, non tutte le passioni, ma solamente le emozioni vengono collocate entro la dimensione corporea dell’uomo quali forze psichiche tendenzialmente autonome dalla volontà. Inoltre, il solo sapere legittimato a “parlarne” è quello costituito dalle scienze che studiano il funzionamento del corpo: le neuro-scienze e le bioscienze. Nel prossimo paragrafo intendo osservare come l’emozione della paura sia stata tematizzata a partire da questa versione così presente nella letteratura psicologica. 60 Questa constatazione costituisce uno degli argomenti più convincenti a favore del ridimensionamento dell’interpretazione fisicalistica di cui discuterò nel prossimo paragrafo, e del riconoscimento della “culturalità” delle emozioni (cfr. Secondo intermezzo nel capitolo 4). 61 V. Despret, Ces émotions qui nous fabriquent, ethnopsychologie de l’authenticité, Seuil, Paris, 2001 (trad. it. Le emozioni. Etnopsicoplogia dell’autenticità, Elèuthera, Milano, 2002, pp. 34, 35). 62 Parla di interpretazione “fisicalistica” Sergio Moravia per indicare quelle letture – o meglio, versioni – che collocano le passioni nella dimensione corporea. Cfr. S. Moravia, op. cit. a nota 43. 70 Capitolo 2 Fisiologia della paura Molti neuro-scienziati e psicologi ritengono che la paura sia un’emozione molto specifica: nasce dalla percezione di un pericolo e consiste in una reazione psicofisica63. La dimensione del pericolo, che integra gli elementi del dolore e dell’attesa (tempo) – già indicati da Platone – sono fondamentali nella definizione psicologica della paura; ma ancora più importante è il processo fisiologico ad essa connesso. Il modo in cui Anna Oliverio Ferraris descrive l’emozione della paura costituisce un esempio emblematico di come l’interesse scientifico si diriga principalmente verso un’interpretazione fisicalistica delle emozioni. La psicologa italiana, infatti, descrive come la paura sia all’origine di un evento biologico che si sviluppa su tre livelli: quello del sistema nervoso simpatico, quello neuro-ormonale e quello dei nuclei sottocorticali.64 In estrema sintesi, l’autrice indica che in stato d’emergenza il sistema nervoso simpatico comporta l’entrata in funzione di sinapsi (o giunzioni nervose) che funzionano attraverso la mediazione di una sostanza, la noradernalina, che ha degli effetti a livello del cervello e quindi del comportamento”65. Una serie di segni sono collegati all’entrata in funzione del sistema nervoso simpatico: aumenta la tensione muscolare e una grande massa di sangue affluisce verso muscoli e cervello. Anche i surreni – in particolare la porzione midollare – entrano in funzione sia per l’intervento del sistema nervoso, sia per intervento dell’ipofisi, una ghiandola a secrezione interna che controlla la secrezione di tutte le altre ghiandole periferiche (oltre ai surreni anche tiroide e ghiandole sessuali). In particolare l’ipofisi secerne un ormone, l’ACTH (ormone corticotropo), che a sua volta stimola la porzione corticale dei surreni a produrre i suoi ormoni. Se la situazione di emergenza è di breve durata i surreni si svuotano dei loro ormoni sostenendo le reazioni di emergenza, ma se la situazione di stress dura a lungo i surreni aumentano di volume nello sforzo di fare fronte alle necessità. L’organismo, liberando una quantità sempre più importante di ormoni provoca dei disturbi via via più rilevanti, che a loro volta aumentano lo stato di paura. 63 G. Nardone, Oltre i limiti della paura, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2000. A. Oliverio Ferraris, Psicologia della paura, Editore Boringhieri, Torino, 1980, pp. 37-43. Si veda anche A. Oliverio Ferraris, “Le emozioni primarie in un’ottica di psicologia storica: note per una storia della paura”, in D. Galati (a cura di), Le emozioni primarie, Bollati Boringhieri, Torino, 1993, pp. 142161. 65 Ibidem, p. 37. 64 Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 71 Al terzo livello sono interessate alcune strutture che fanno parte del paleoencefalo, cioè i nuclei sottocorticali, quei nuclei che sono prevalentemente sviluppati nei mammiferi primitivi e che esistono anche nel cervello umano. Questi nuclei fanno parte del sistema limbico, che comprende tre grandi strutture: setto, amigdala e ippocampo, legate da connessioni nervose e che ricevono e inviano vie nervose all’ippotalamo, che a sua volta è collegato con l’ipofisi.66 Le strutture del sistema limbico formano un insieme di nuclei e di stazioni nervose che entrano in attività sia nelle reazioni di paura che in quelle di rabbia. Su questo punto vi sono idee contrastanti, ma le osservazioni condotte sui mammiferi mostrano che le situazioni di pericolo danno luogo a comportamenti di attacco (aggressività) o di fuga (paura) a seconda dei fattori situazionali specifici o dello stato fisico del soggetto. In base a queste considerazioni, una persona prova paura quando, in una certa situazione, si percepisce in pericolo e, sulla base di questo input, il suo “corpo” reagisce in un determinato modo: aumenta il battito cardiaco e la pressione sanguigna, la respirazione si fa più lenta, i muscoli s’irrigidiscono. Questa reazione porta, poi, ad attivare tutti i sensi al fine di individuare soluzioni e comportamenti utili a evitare il pericolo. Da questa angolatura, il “corpo” emerge come nucleo centrale del processo emotivo, punto di congiunzione tra la percezione del pericolo e l’attivazione di comportamenti. Non solo, esso è un fattore determinante degli atteggiamenti di coloro che si trovano in stato di pericolo: lo stato d’emergenza attiva automaticamente i sistemi nervoso simpatico e neuroormonale e i nuclei sottocorticali, i quali governano, a seconda delle situazioni specifiche, l’insorgere di strategie comportamentali. La volontà, in tale ottica, non rileva: è il “corpo” che determina l’agire; attraverso la sua lettura è possibile comprendere le emozioni e agire su di esse per limitarne le potenzialità distruttive nel soggetto e nella comunità. In sintesi: le emozioni nell’universo passionale In questo primo intermezzo sulle passioni ho ripercorso sinteticamente il pensiero filosofico, che, a partire da Platone, le ha interpretate, con diverse sfumature, come elementi di deviazione della razionalità, fattori di disordine individuale e sociale e, dunque, entità da governare, sopprimere o canalizzare in funzione del raggiungimento della felicità e della pace sociale. Anche 66 Ibidem. 72 Capitolo 2 quando è stata riconosciuta una loro funzione positiva, è stata al contempo riaffermata la loro distanza dalla ragione. A parte alcuni casi isolati – per esempio la “paura ragionante” di Hobbes (par. 4.2) –, solo recentemente, con l’avanzare della ricerca scientifica (psicologia cognitiva e neuro-scienze) e degli studi di filosofia della mente, si è riconosciuta una presenza razionale all’interno delle passioni, la cui intensità varia in relazione ai diversi tipi di stati d’animo individuati. Così, se gli elementi cognitivi sono parti integranti dei sentimenti, le emozioni sono state definite come passioni a basso contenuto volontaristico, tendenzialmente irrazionali e istintive, e comprensibili nella loro espressione corporea. In questo senso, la paura è stata definita, scientificamente, come emozione che si sostanzia nella reazione psico-fisica a una minaccia percepita (versione fisicalistica della paura). Questo modo d’intendere la paura, come indicherò nel prossimo paragrafo, ha costituito un punto di riferimento per la proposizione di una definizione scientifica di paura della criminalità. 2.5 Cos’è la paura della criminalità? L’esigenza di condividere una definizione La proposta di una definizione condivisa Il dibattito sulle passioni che ho riportato nelle sue linee essenziali – sintetizzabili nel superamento dell’opposizione ragione-passioni e, contestualmente, nella tendenza a situare le emozioni nell’ambito della dimensione corporale – ha influito anche sulle definizioni di paura della criminalità riscontrabili in letteratura. Nel discorso criminologico, la presenza di una base cognitiva di questa emozione è ravvisabile, per esempio, all’interno della distinzione concettuale tra insicurezza soggettiva e insicurezza oggettiva. La prima viene definita come la paura di subire un reato indipendentemente dalla probabilità che questo si verifichi; con la seconda ci si riferisca a un sentimento di preoccupazione per la criminalità, ben ponderato sulla effettiva diffusione della criminalità. Sono molti gli studiosi che hanno sviluppato questa distinzione fondamentale. Purtuttavia, le direzioni imboccate non sempre sono sfociate in definizioni tra loro concordanti. Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 73 Già agli inizi degli anni Settanta Frank Fustenberg67, a partire dai risultati di alcune ricerche compiute a Baltimora, dimostrò come la preoccupazione in astratto per la criminalità (concern about crime) avesse una diffusione e un’intensità molto diverse dalla paura in concreto (fear of crime); di concern about crime e di fear of crime parlò anche Garofalo68. Louis Guerin69 definì, invece, la paura in astratto come la preoccupazione nei confronti di un fenomeno riguardante genericamente la società e la paura concreta come il timore evocato da un fenomeno concreto, in stretto rapporto con la vita quotidiana dell’individuo. Hugues Lagrange70 riprese i concetti di préoccupation sécuritaire, intesa come giudizio politico sulla realtà, e di peur du crime, intesa come apprensione concreta, per analizzare più approfonditamente le realtà di Grenoble e Tullins-Fures, ma si spinse anche alla ricerca di strumenti metodologici idonei a misurare le due manifestazioni d’insicurezza indicate: egli distinse tra jugenents non-réflexifs, di carattere generale e non riferiti alla propria sfera individuale (indotti da domande quali: è aumentata le criminalità negli ultimi anni? Si può essere violenti senza ragione?), e jugements réflexifs, riguardanti abitudini e paure rapportate alla vita quotidiana dell’individuo intervistato (Si sente insicuro a casa? Uscirebbe da solo la sera?). Più di recente, in Italia, Marzio Barbagli71e Licia Nardi72 hanno distinto due diversi aspetti del sentimento di paura, la paura personale di essere vittime di un reato (fear of crime) e la preoccupazione per la criminalità come fenomeno sociale (concern about crime). Queste distinzioni concettuali, non sempre sovrapponibili, hanno portato nel corso degli anni all’utilizzo di indicatori diversi per misurare la paura della criminalità: ciò ha comportato un’estrema variabilità dei risultati a seconda degli strumenti di rilevazione usati. Questi, d’altra parte, risultano spesso imprecisi e inadeguati ai fini della rilevazione del fenomeno in oggetto: a volte non misurano la paura, ma altri stati d’animo, altre volte non misurano la paura riferita alla criminalità, ma paure dall’oggetto indefinito. Già Kennet F. Ferraro e Randy LaGrange73 rilevarono che in buona parte della 67 F. Fustenberg, “Public Reaction to Crime in the Street”, American Scholar, vol. 40, 1971. J. Garofalo, op. cit. a nota 22. 69 A. Louis-Guerin, “La peur du crime: mythes et réalités”, Criminologie, Vol. 16. N. 1, p. 69. 70 H. Lagrange, “Appréhension et préoccupation sécuritaire”, Déviance et Société, vol. 16, 1992. 71 M. Barbagli, Egregio signor Sindaco. Lettere dei cittadini e risposta dell'istituzione sui problemi della sicurezza, Il Mulino, Bologna, 1999. 72 L. Nardi, “Il senso d’insicurezza”, in M. Barbagli, (a cura di), Rapporto sulla criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 525-554. 73 R.L. Lagrange, K.F. Ferraro, op. cit. a nota 34. 68 74 Capitolo 2 ricerca le domande riguardanti la percezione del rischio di criminalità sono erroneamente utilizzate per misurare la paura del crimine: valutazione del rischio e sentimento d’inquietudine sono due stati d’animo distinti, e il fatto che una persona si ritenga a rischio di subire un reato non significa automaticamente che tema di subirlo. Inoltre, gli strumenti di misurazione della paura di subire un reato spesso non misurano in modo adeguato uno stato emotivo riferito al fenomeno criminale, bensì un’ansietà generica, indicata da alcuni come “formless fear” (paura senza forma): si tratta di un sentimento generico di malessere nel vivere quotidiano, non necessariamente determinato dalla criminalità. La domanda “Quanto ti senti o ti sentiresti sicuro a camminare da solo nel tuo quartiere di notte?”, utilizzata dalla National Crime Survey statunitense e da molte altre ricerche, non può essere un indicatore di fear of crime proprio per questo motivo: l’intervistato potrebbe avere paura dell’attacco di un cane, di essere investito da un’auto, o potrebbe semplicemente avere paura del buio. 74 Infine, di recente alcuni criminologi dello Scottish Centre For Criminology e curatori della Scottisch Crime Survey, hanno avanzato l’ipotesi che gli item utilizzati in molte indagini in realtà siano sensibili più alla “rabbia” degli intervistati che alla loro paura.75 Attraverso interviste di follow-up a persone già intervistate con questionari standard sulla paura della criminalità, hanno rilevato come le persone che risultavano dall’indagine “impaurite” (fearfull) – e cioè che avevano dichiarato di sentirsi insicuri – nei colloqui con i ricercatori dimostravano una più vasta e complessa gamma di stati d’animo, tra cui principalmente fastidio, rabbia, prudenza nell’uso degli spazi pubblici.76 In breve, i principali problemi riscontrati riguardano la confusione sulla definizione concettuale e operativa di paura della criminalità: secondo alcuni si tratta di un concetto piglia-tutto77, che racchiude in sé ogni tipo di opinioni, attitudini e sentimenti negativi; altri hanno evidenziato i rischi di stru- 74 F.P. Williams, M.D. McShane, R.L. Akers, “Worry About Victimization: An Alternative and Reliable Measure for Fear of Crime”, Western Criminology Review, 2, 2000. 75 Si veda l’intensa produzione in tema di paura della criminalità dello Scottish Centre For Criminology, e in particolare: J. Ditton, S. Farral, J. Bannister, E. Gilchrist, K. Pease, “Reactions to victimisation: why has anger been ignored?”, Crime Prevention and Community Safety: An International Journal, Vol. 1, N. 3, 2000, pp. 37-54. 76 S. Farrall, op. cit. a nota 1. 77 M. Pavarini, “Bisogni di sicurezza e questione criminale”, Rassegna di Criminologia, 4, 1994, pp. 435-462. Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 75 mentalizzazione politica, attraverso l’utilizzo di indicatori diversi a seconda che si voglia enfatizzare o sottostimare il fenomeno. 78 Questa situazione di caos metodologico e terminologico ha indotto rfecentemente ad ancorare in modo più diretto la riflessione criminologica al dibattito più generale sulle passioni, al fine di proporre una definizione scientificamente fondata e, dunque, condivisibile. Nella vita di tutti i giorni l’emozione della paura è un’esperienza comune per tutti gli esseri umani, per i quali – si sostiene – non è più misteriosa di altre emozioni o stati d’animo, quali la rabbia o la gioia79. La versione “fisicalistica” della paura della criminalità Per recuperare un significato preciso del termine “paura della criminalità”, recentemente si è proposto di darne una definizione tenendo conto dei più recenti risultati della ricerca psicologica sulle emozioni. Adottando una prospettiva che ho definito “fisicalistica”, la paura della criminalità è stata definita come quella reazione psicofisica che nasce dalla percezione di una minaccia imminente messa in atto da altre persone. Un esempio può chiarire questo modo d’intendere questa emozione: si può dire che una persona prova paura quando, seduta sul divano di casa a leggere un libro, sentendo un rumore fuori dalla finestra, im-mediatamente sposta il suo sguardo dal libro alla finestra e, nel contempo, si verificano una serie di mutamenti fisiologici che la predispongono a difendersi dal pericolo percepito. Le caratteristiche della paura sono: - concretezza dell’oggetto (segnale di pericolo): si prova paura nel momento in cui si percepisce qualcosa come pericoloso, anche se, immediatamente dopo, si scopre che non si trattava di un pericolo reale. La concretezza del segnale di pericolo (il fatto di percepire qualcosa come pericoloso) è, dunque, diversa dalla effettività del pericolo (la sussistenza di un pericolo effettivo); - reazione psicofisica: lo stato di paura consiste in cambiamenti riguardanti il battito cardiaco, la respirazione, la tensione muscolare, la pressione sanguigna, risultanti da mutamenti fisiologici che riguardano i sistemi nervoso simpatico, neuro-ormonale e limbico; 78 R. Cornelli, “Cos’è la paura della criminalità e quanto è diffusa”, in L’Inchiesta, N. 143, 2004, pp. 62-74. 79 M. Warr, 2000, Fear of Crime in the United States: Avenues for Research and Policy, Measurement and Analysis of Crime and Justice, U.S. Department of Justice, vol. 4, pp. 451-489. 76 Capitolo 2 - temporaneità: si smette di provare paura nel momento in cui l’evento percepito inizialmente come minaccioso perde tale caratteristica perché viene scoperto essere non effettivo (per esempio si scopre che il rumore era stato prodotto da un gatto che passava in giardino e non da un aggressore), o anche perché si trasforma da pericolo in danno effettivo. In questo senso, la paura di subire un’aggressione, intesa platonicamente quale “attesa del dolore”, svanisce quando la persona viene effettivamente aggredita: altri stati d’animo, quali sofferenza, panico o paure di altro tipo subentrano ad essa); - marginalità della base cognitiva: si sottolinea come la paura sia l’effetto di una percezione o di una valutazione della realtà (la percezione di un pericolo), ma non si sostanzi in quel processo cognitivo80. Questa descrizione identifica lo stato d’animo che stiamo indagando come “reazione emotiva” e permette di distinguerla da altre passioni contigue, quali l’ansia (che viene collocata nella categoria delle condizioni emotive) e la preoccupazione (situabile nella categoria dei sentimenti), e da altri stati mentali non passionali, come la valutazione del rischio. Di seguito, tenendo conto del dibattito sintetizzato nel paragrafo precedente (2.3), intendo approfondire meglio le differenze tra queste passioni riferite alla criminalità. Paura e ansia: la paura è generata da un concreto segnale di pericolo, anche se la minaccia si dimostra non reale o non effettiva, ed è limitata nel tempo (svanisce allo svanire della minaccia). Al contrario, l’ansia viene definita come un’inquietudine continua, sostenuta dal presentimento, non basato su segnali concreti esterni, che qualcosa di spiacevole o pericoloso sta per accadere. In questo senso, l’ansia può essere considerata una condizione emotiva: non ha un oggetto concreto verso cui dirigersi e il soggetto difficilmente ne riconosce la causa. Paura e preoccupazione: la preoccupazione è un sentimento basato sulla percezione della realtà circostante mediata da valori e da giudizi personali, e non necessariamente rapportato all’attualità di esperienze vissute81. Quando si è preoccupati per qualcosa, non si attivano processi psicofisici e neppure si avverte che qualcosa di spiacevole sta per accadere, ma normalmente si ha 80 81 Ibidem. H. Lagrange, S. Roché, L’insécurité: histoire et règulation, Paris, HIESI, 1993, p. 11. Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 77 qualche problema che occupa la mente e i pensieri. Brodeur82 chiarisce la differenza tra paura e preoccupazione in maniera molto suggestiva citando l’esempio dei residenti del Québec che possono essere preoccupati per il problema della fame nel Terzo Mondo, ma che sicuramente non hanno paura di soffrire la fame per se stessi. 83 Gli stati d’animo della preoccupazione e dell’ansia sono simili in quanto entrambi mancano di una causa scatenante identificabile dal soggetto. Differiscono perché l’ansia non ha un oggetto facilmente identificabile mentre la preoccupazione è rivolta verso qualcosa. Paura e valutazione del rischio: la valutazione del rischio, a livello personale, è una valutazione soggettiva della probabilità di subire un reato, a livello generale, è la valutazione di quanto è diffusa la criminalità in un determinato territorio84. Due esempi possono meglio chiarire le differenze tra paura e valutazione del rischio. Il primo esempio riguarda il caso di chi pratica sport estremi: sa che ciò che sta facendo è pericoloso, è cosciente dei rischi che corre e valuta la possibilità di esserne vittima, ciononostante non prova paura, bensì euforia. Il secondo esempio si riferisce al caso dello spettatore di un film horror: sa bene che quanto sta facendo (assistere a una proiezione cinematografica) non è per niente pericoloso e che il rischio di subire personalmente ciò che vede sullo schermo è in quel momento inesi- 82 Si veda in Department of Justice Canada, Fear of Crime in Canada, 1995, rapporto reperibile al sito web http://129.128.19.162/docs/feardoj.html. 83 Garofalo ha concettualizzato la paura (fear) e la preoccupazione (worry) in modo diverso, ma comunque molto interessante. Egli definisce paura come una reazione emotiva caratterizzata da un senso di pericolo e dall’ansia prodotta dalla minaccia di un danno fisico. Come nella definizione proposta nel testo, anche per Garofalo la paura è una reazione emotiva legata alla percezione di qualcosa di dannoso per la persona. Divesamente dalla definizione proposta, il concetto di paura di Garofalo è più ristretto: la paura è prodotta dalla minaccia di un danno fisico alla paersona, e non di una perdita di beni. L’ autore sostiene che la reazione ad una perdita di beni è più cerebrale e calcolata e può essere descritta come preoccupazione (worry), mentre la paura (fear) è più automatica e emozionale. Quindi nella visione di Garofalo la minaccia di un danno fisico e quella di una perdita di beni generano due differenti reazioni, paura nel primo caso, preoccupazione nel secondo caso. Garofalo stesso, tuttavia, in un altro punto dello stesso articolo, riconosce che se la perdita di proprietà è di valore elevato, in riferimento alle risorse della persona, allora può produrre paura (fear), estendendo così il concetto di danno fisico (physical harm) al concetto di danno al benessere fisico (harm to the physical well-being). Ma riconoscere che anche la perdita di beni può portare a reazioni di paura (fear) significa riconoscere che la differenza tra paura e preoccupazione non sta nella diversa causa scatenante (perdita di beni o danno fisico), quanto nel diverso tipo di stato d’animo: la paura più emotiva, la preoccupazione più cerebrale e calcolata. Ed è su questi tratti caratteristici che si è insistito nel testo. Si veda J. Garofalo, 1981, op. cit. a nota 22. 84 Si veda anche K.F. Ferraro, R.L Lagrange, “The Measurement of Fear of Crime”, Sociological Inquiry, n. 57, 1987; W.R. Smith, M. Torstennson, op. cit. a nota 18. 78 Capitolo 2 stente; nonostante ciò egli prova una sensazione di paura, riconoscibile per la reazione psico-fisica che si determina. Nell’ultimo paragrafo analizzerò criticamente l’esigenza di definire scientificamente i confini della paura della criminalità, avanzando la tesi che questa sia l’esito dell’assunzione da parte della criminologia di un ruolo ancillare rispetto alla Politica, quale scienza orientata a fornire spunti e strumenti per l’elaborazione di interventi efficaci, e, nel contempo, costituisca un freno ad ampliare gli orizzonti della riflessione criminologica. Per il momento, vale la pena approfondire ancora un ultimo aspetto e osservare come la “versione fisicalistica” abbia portato all’individuazione di alcune “distorsioni” nella rappresentazione del fenomeno analizzato. L’inadeguatezza degli indicatori La delimitazione del concetto di paura della criminalità, intesa quale passione distinta dalla preoccupazione per la criminalità, dall’ansia e dalla valutazione del rischio criminale, ha permesso di approfondire l’inadeguatezza degli indicatori normalmente utilizzati nelle indagini campionarie85 e il rischio di sovra-rappresentazione del fenomeno determinato da un loro uso “improprio”. Qualche esempio può chiarire meglio alcune insufficienze degli strumenti di misurazione. I dati dell’indagine multiscopo dell’Istat del 2001 mostrano che in Italia il 66 per cento degli intervistati ritiene che la criminalità sia il problema prioritario nel Paese86: questo significa che la stessa percentuale di intervistati teme di subire un reato? Sulla base della definizione proposta, la risposta è negativa: gli intervistati, infatti, sono indotti dalla domanda a fondare il proprio stato d’animo (la preoccupazione) su giudizi non riflessivi, cioè di carattere generale e non riferiti alla propria sfera individuale (la criminalità in generale); quando si è preoccupati per qualcosa normalmente si ha un problema che occupa i pensieri e chiedere agli intervistati se si ritiene la criminalità un fenomeno preoccupante permette di intercettare questo stato d’animo e non quello della paura, che è una reazione anzitutto fisiologica a un pericolo imminente percepito dalla persona. 85 86 C. Hale, 1996, op. cit. a nota 37. L. Nardi, op. cit. a nota 72, p. 527. Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 79 Similmente, in un recente studio, serio e approfondito, sulla criminalità in Italia si legge che nell’ultimo decennio la quota delle famiglie italiane che giudicano la zona in cui abitano molto o abbastanza a rischio di criminalità è rimasta quasi immutata, mentre variazioni rilevanti vi sono state in alcune regioni: “laddove la frequenza di alcuni reati violenti […] ha subito una forte flessione […] la paura della criminalità è diminuita. Laddove invece il tasso di borseggi, di furti in appartamento e di rapine è salito più rapidamente […] questa paura è cresciuta [i corsivi sono nostri]”.87 È opportuno, in questo caso, parlare di paura? Oppure è preferibile riferirsi, in questo caso, alla valutazione del rischio di criminalità nella zona in cui si vive? Ogni stato d’animo – come ormai sappiamo – integra un giudizio o una valutazione sulla realtà circostante. Nel caso della preoccupazione, questa “base cognitiva” è forte ed è un elemento costitutivo dello stesso sentimento (sono preoccupato per la criminalità perché nel contempo valuto grave la sua diffusione). Nel caso della paura, è molto debole e costituisce solo un fattore scatenante e separato dal processo emotivo vero e proprio. La valutazione sulla realtà circostante, quindi, sia in termini generali (valutazione della diffusione di un fenomeno) che in termini specifici (valutazione che un certo evento possa accadere) integra e costituisce la base del sentimento di preoccupazione e può essere il terreno su cui possono proliferare reazioni di paura. In ogni caso è qualcosa di profondamente diverso questa. A partire da queste criticità e per tenere insieme tutti gli indicatori tradizionalmente utilizzati per misurare il fenomeno, si è diffusa la tendenza a considerare la natura multi-dimensionale88 di quel concetto che solitamente viene indicato con il termine fear of crime, e che altrove ho proposto di sostituire con quello più generico d’insicurezza.89 Si parla così di una dimensione cognitiva e una dimensione emotiva, misurabili a diversi livelli: in generale (senza specifico riferimento a un ambito particolare), nella zona in cui si vive o a livello personale. Così, item quali “Quanto si sente sicuro camminando da solo per strada ed è già buio?”, oppure “Quale problema nella realtà di oggi ritiene più preoccupante?”, o ancora “Ritiene la zona in cui vive a rischio di criminalità?”, o, infine, “Provi a ricordare l'ultima volta che è uscito/a nella sua zona quando era già buio. Lei 87 Barbagli M., op. cit. a nota 28, p. 30. P. Wilcox Rountree, “A Reexamination of the Crime-Fear Linkage”, Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol. 35, N. 3, 1998, pp. 341-372. Cfr. anche M. Santinello, P. Gonzi, L. Scacchi, Le paure della criminalità: Aspetti psicosociali di comunità, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 95-98. 89 R. Cornelli, op. cit. a nota 78. 88 80 Capitolo 2 ha cercato di evitare certe strade o certi luoghi oppure determinate persone per motivi di sicurezza?”, solitamente considerati indistintamente come indicatori di paura, vengono oggi ri-considerati come indicatori di diversi stati d’animo accomunati dal riferimento alla criminalità. Tabella 6 - La multi-dimensionalità dell’insicurezza Livelli Dimensioni Cognitiva Generale Valutazione del rischio di criminalità in generale Zona di vita Valutazione del rischio di criminalità nel quartiere Personale Valutazione del rischio di subire un reato Emotiva Preoccupazione per la criminalità come problema generale Preoccupazione per la criminalità come problema del quartiere Paura della criminalità (reazione emotiva a un segnale di pericolo) Recenti studi empirico-statistici hanno dimostrato il carattere multidimensionale dell’insicurezza90. Nel prossimo paragrafo riferirò, in particolare, i contenuti di una ricerca che io stesso condussi qualche anno fa proprio su questo argomento, e che evidenziò chiaramente, a partire dall’analisi dei dati di due indagini condotte in Trentino e in Emilia-Romagna, come l’utilizzo di indicatori diversi possa comportare rappresentazioni incongruenti del fenomeno indagato. II rischio di sovra-rappresentazione delle paure: i risultati di una ricerca condotta in due regioni italiane Qualche anno fa, in uno studio sulla paura della criminalità91, condotto su due campioni indipendenti92 relativi a due data-base – creati, il primo, da 90 F.P. Williams, M.D. McShane, R.L. Akers, op. cit. a nota 74. R. Cornelli, op. cit. a nota 78. L’utilizzo di due campioni indipendenti ha permesso di verificare con maggiore precisione le ipotesi di partenza. Entrambe le indagini si riferiscono al 2001: le interviste sul campine trentino sono state 91 92 Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 81 Transcrime-Università di Trento nell’ambito dell’indagine sulla percezione d’insicurezza dei trentini93, e il secondo, dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito delle attività di ricerca del Progetto “Città Sicure”94 – avanzai una critica sull’inadeguatezza degli indicatori di paura della criminalità normalmente utilizzati e sulle distorsioni provocate da un loro utilizzo acritico. Vediamo nel dettaglio l’iter di questo lavoro e i risultati a cui portò. L’indagine di Transcrime sull’insicurezza dei trentini considerava quali indicatori d’insicurezza per l’analisi delle componenti principali otto item. Si tratta degli item normalmente utilizzati in letteratura per misurare le diverse componenti della paura della criminalità. condotte nel mese di gennaio, mentre quelle sul campione emilano-romagnolo sono state condotte nel mese di giugno. Vista la diversità del periodo di rilevazione delle due indagini è interessante segnalare come alcuni autori ipotizzino la rilevanza della stagionalità sul livello di paura della criminalità. Si vedano in proposito i progetti di ricerca dello Scottish Centre For Criminology al sito web http://www.scotcrim.u-net.com/researchf.htm 93 L'indagine sulla percezione d’insicurezza dei trentini, condotta nell’ambito dell’Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino, finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento e dall’Università degli Studi di Trento, è stata realizzata attraverso la somministrazione telefonica di un questionario preparato ad hoc ad un campione di 2.400 persone residenti in Trentino e di età superiore ai 14 anni. Per la scelta delle unità campionarie, inizialmente si è proceduto stratificando il campione in base all'ampiezza demografica dei comuni: i 223 comuni della provincia di Trento sono stati suddivisi in tre classi diverse. La prima classe include i comuni di piccole dimensioni, con una popolazione residente non superiore alle 2.000 unità, la seconda classe è costituita dai comuni medi, che hanno una popolazione tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, ed infine l'ultima classe include i comuni più grandi, con una popolazione oltre i 10.000 abitanti. Successivamente ,il campione è stato stratificato tenendo conto del sesso e dell'età: quest'ultima variabile include una classe tra i 14 e i 25 anni, una classe tra i 26 e i 59 anni e l'ultima che va dai 60 anni in su. All'interno delle famiglie selezionate per l'intervista, la persona da intervistare è stata scelta con criterio casuale. La somministrazione delle interviste è stata attuata avvalendosi del sistema C.A.T.I. (Computer Aided Telephone Interviewing). Per maggiori informazioni si veda R. Cornelli, S. Castellan, “La percezione d’insicurezza: le preoccupazioni dei trentini”, in E. Savona, F. Bianchi, Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2000/2001, Provincia Autonoma di Trento, Trento, 2001, p. 45. 94 L’indagine del 2001 sull’opinione dei cittadini emiliano-romagnoli sui temi legati alla sicurezza costituisce la settima rilevazione annuale condotta nell’ambito del Progetto CittàSicure. Anche in questo caso è stato somministrato un questionario ad un campione di 1.200 cittadini emiliano-romagnoli, maggiori di 18 anni, avvalendosi del sistema C.A.T.I. La procedura di campionamento ha considerato sia l’obiettivo di stimare l’atteggiamento verso i problemi di sicurezza dei residenti in Emilia-Romagna nell’anno 2001, sia l’obiettivo di valutare le variazioni rispetto al 2000. Per questo si è avuta una stratificazione del campione in 7 classi in considerazione della dimensione demografica dei comuni. La scelta dei comuni campione ha seguito il criterio di mantenere, entro ogni classe, da ½ a ¾ dei comuni campione presenti l’anno precedente e di estrarre con criterio casuale (con probabilità inversamente proporzionale alla dimensione demografica) i restanti comuni. Per maggiori informazioni si veda Sacchini G., “Le opinioni dei cittadini”, in Politiche e Problemi della sicurezza in Emilia-Romagna. Settimo rapporto annuale 2001, Quaderni di Cittàsicure, 22, 2001, pp. 75-77. 82 Capitolo 2 Tabella 7 – Item e modalità utilizzati per l’analisi delle componenti principali. Questionario Transcrime. Item Modalità 1. Quale problema della realtà di oggi ritiene più preoccupante? altri problemi / criminalità 2. Personalmente che cosa teme che le possa accadere? altri problemi / subire un reato 3. Quanto si sente sicuro/a comminando da solo/a nella zona in cui vive quando è buio? molto e abbastanza / poco e per niente 4. Quanto si sente sicuro/a quando si trova da solo/a a casa ed è già buio? molto e abbastanza / poco e per niente poco e per niente (per tutti i reati) / molto e abbastanza (per almeno un reato) 5. Quanto teme di subire un reato? 6. La criminalità in Italia è aumentata? no / si 7. Il Trentino è a rischio di criminalità? poco e per niente / molto e abbastanza 8. La zona in cui abita è a rischio di criminalità? poco e per niente / molto e abbastanza Il questionario di CittàSicure sull’Emilia-Romagna non era stato pensato in funzione di un’analisi sulle diverse componenti dell’insicurezza, e, di conseguenza, conteneva un numero più limitato di item rispetto al questionario Transcrime (Tab. 4) con le relative modalità dicotomizzate. Tabella 8 – Item e modalità utilizzati per l’analisi delle componenti principali. Questionario CittàSicure. Item 1. Quale problema della realtà di oggi ritiene più preoccupante? Modalità altri problemi / criminalità 3. Quanto si sente sicuro/a comminando da solo/a nella zona in cui vive quando è buio? molto e abbastanza / poco e per niente 4. Quanto si sente sicuro/a quando si trova da solo/a a casa ed è già buio? molto e abbastanza / poco e per niente no / si poco e per niente / molto e abbastanza 6. La criminalità in Italia è aumentata? 8. Nella zona in cui abita la criminalità è un problema … Attraverso l’analisi fattoriale degli indicatori dell’insicurezza sopra indicati nelle tabelle 7 e 8, compiuta attraverso il metodo delle componenti principali95, dimostrai come gli item normalmente utilizzati quali indicatori di 95 Nell’indagine furono utilizzati due metodi di analisi: l’analisi fattoriale secondo il metodo delle componenti principali e l’analisi delle frequenze dei singoli item. L’analisi delle componenti principali, in particolare, permette di studiare un dato fenomeno sociale complesso (nel nostro caso l’insicurezza) identificandone le componenti (o fattori). L’analisi delle componenti principali riproduce la varianza complessiva combinando linearmente tutta la varianza e la covarianza delle variabili in diversi costrutti indipendenti e con un livello di varianza riprodotta via via decrescente. L’obiettivo dell’analisi è quello di ridurre Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 83 paura della criminalità, in realtà, indicassero diverse dimensioni del fenomeno dell’insicurezza, più o meno coincidenti con quelle descritte nella tabella 6. L’analisi venne compiuta dapprima sul campione trentino, poi su quello emilano-romagnolo. Campione trentino – L’esame della matrice dei pesi fattoriali, ottenuta attraverso la fattorializzazione della matrice di correlazione tra gli indicatori, e dello scree-plot (o grafico decrescente degli autovalori), indusse a ritenere che l’insicurezza, intesa come fenomeno complesso misurato attraverso l’insieme di indicatori sopra descritti, risultasse statisticamente sintetizzabile con tre componenti (o fattori). Per avere una maggiore interpretabilità delle tre componenti identificate, venne effettuata una rotazione dei primi due assi fattoriali impiegando la tecnica Varimax, ottenendo così la matrice dei pesi fattoriali ruotati.96 Dall’esame di questa matrice (Tab. 5) emersero chiaramente tre gruppi di item: gli item 7 e 8 (Il Trentino è a rischio di criminalità? La zona in cui abita è a rischio di criminalità?) correlati con la prima componente, gli item 3 e 4 (Quanto si sente sicuro/a comminando da solo/a nella zona in cui vive quando è buio? Quanto si sente sicuro/a quando si trova da solo/a a casa ed è già buio?) correlati con la seconda componente, e gli item 1 e 2 (Quale problema della realtà di oggi ritiene più preoccupante? Personalmente che cosa teme che le possa accadere?) correlati con la terza componente. Attraverso l’analisi concettuale dei tre gruppi di item, interpretai le tre componenti individuate: la prima come “valutazione del rischio criminale”, in quanto gli item che la compongono si riferiscono a opinioni degli intervistati circa il rischio di criminalità in diversi ambiti; la seconda come “insicurezza in situazioni concrete”: gli item, infatti, si riferiscono al senso di insicurezza degli intervistati in particolari situazioni quotidiane; descrissi, infine, la terza componente come “preoccupazione per la criminalità”, poiché gli item riguardano preoccupazioni degli intervistati relative al problema criminalità a livello generale o personale, ma comunque non legate a situazioni particolari. una serie di informazioni alle sue componenti principali minimizzando la perdita di informazioni. Per un approfondimento si veda G. Di Franco, EDS: Esplorare, descrivere e sintetizzare i dati, Franco Angeli, Milano, 2001, pp. 182-184. 96 La matrice delle componenti ruotata rappresenta il peso di ciascun item rispetto alle tre componenti individuate attraverso la fattorializzazione della matrice di correlazione: si considerano significativi gli item che presentano un valore uguale o superiore a 0.30. 84 Capitolo 2 Tabella 9 – Matrice componenti ruotata. Campione trentino: item e pesi fattoriali. Componenti Item Interpretazione proposta 1 2 3 1. Quale problema della realtà di oggi ritiene più preoccupante? 0,10 -0,08 0,70 2. Personalmente che cosa teme che le possa accadere? -0,12 0,21 0,70 3. Quanto si sente sicuro/a comminando da solo/a nella zona in cui vive quando è buio? 0,09 0,75 0,07 4. Quanto si sente sicuro/a quando si trova da solo/a a casa ed è già buio? -0,02 0,72 -0,07 5. Quanto teme di subire un reato? 0,35 0,45 0,21 6. La criminalità in Italia è aumentata? 0,39 -0,05 0,37 7. Il Trentino è a rischio di criminalità? 0,81 -0,02 0,05 8. La zona in cui abita è a rischio di criminalità? 0,70 0,25 -0,09 preoccupazione per la criminalità insicurezza in situazioni concrete valutazione del rischio criminale Metodo estrazione: Analisi delle Componenti Principali, Metodo Rotazione: Varimax con normalizzazione di Kaiser Fonte: R. Cornelli, S. Castellan, 2001, “La percezione d’insicurezza: le preoccupazioni dei trentini”, in E. U. Savona, F. Bianchi (a cura di), Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2000/2001, Giunta della Provincia Autonoma di Trento, Trento. Tabella 10 – Matrice componenti ruotata. Campione emiliano-romagnolo: item e pesi fattoriali. Componenti 1 2 3 Interpretazione proposta 1. Quale problema della realtà di oggi ritiene più preoccupante? 0,06 0,06 0,98 preoccupazione 3. Quanto si sente sicuro/a comminando da solo/a nella zona in cui vive quando è buio? 0,79 0,06 0,09 4. Quanto si sente sicuro/a quando si trova da solo/a a casa ed è già buio? 0,74 0,19 0,14 insicurezza in situazioni concrete valutazione Item 6. La criminalità in Italia è aumentata? 0,05 0,98 0,06 8. Nella zona in cui abita la criminalità è un problema grave 0,61 -0,12 0,14 Metodo estrazione: Analisi delle Componenti Principali, Metodo Rotazione: Varimax con normalizzazione di Kaiser Fonte: elaborazione su dati della Settima indagine annuale sui problemi della sicurezza (2001) del Progetto Città Sicure della Regione Emilia-Romagna Campione emiliano-romagnolo – L’analisi fattoriale in tre componenti principali fu condotta anche sul campione emiliano-romagnolo. I risultati furono meno chiari: l’item 8 (Tab. 10), riferibile concettualmente a una giudizio valutativo sulla realtà circostante, risultava, invece, correlato con la prima componente, quella definibile come “insicurezza in situazioni concrete”. Purtuttavia, anche in questo caso rilevai la presenza di tre componenti e la possibilità di definirle come valutazione, preoccupazione e paura. Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 85 Tabella 11 – Analisi delle frequenze. Campione trentino Componenti dell'insicurezza Percentuale Preoccupazione Quale problema della realtà di oggi ritiene più preoccupante? Criminalità come prima scelta 33 Personalmente che cosa teme che le possa accadere? Subire un reato come prima scelta 8 Valutazione del rischio La criminalità in Italia è aumentata 83 Il Trentino è a rischio di criminalità 58 La zona di vita è a rischio di criminalità 23 Paura della criminalità Insicuro/a camminando da solo/a nella zona in cui vive quando è buio 16 Insicuro/a camminando da solo/a nella zona in cui vive quando è buio per il timore di subire un reato 10 Insicuro/a quando si trova da solo/a a casa ed è già buio 9 Insicuro/a quando si trova da solo/a a casa ed è già buio per il timore di subire un reato 8 Indice sintetico della paura della criminalità 12 Fonte: R. Cornelli, S. Castellan, 2001, “La percezione d’insicurezza: le preoccupazioni dei trentini”, in E. Savona, F. Bianchi (a cura di), Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2000/2001, Giunta della Provincia Autonoma di Trento, Trento. Tabella 12 – Analisi delle frequenze. Campione emiliano-romagnolo Componenti dell'insicurezza Percentuale Preoccupazione Quale problema della realtà di oggi ritiene più preoccupante? Criminalità (micro+macro) come prima scelta 47 Valutazione del rischio La criminalità in Italia è aumentata 62 Nella zona di vita la criminalità è un problema grave 18 Paura della criminalità Insicuro/a camminando da solo/a nella zona in cui vive quando è buio 16 Insicuro/a quando si trova da solo/a a casa ed è già buio 11 Fonte: elaborazione su dati della Settima indagine annuale sui problemi della sicurezza 2001 del Progetto Città Sicure della Regione Emilia-Romagna L’analisi fattoriale degli indicatori d’insicurezza attraverso il metodo delle componenti principali compiuta sul campione trentino e su quello emilano-romagnolo diede un supporto statistico all’ipotesi secondo cui paura della criminalità, preoccupazione per la criminalità e valutazione del rischio criminale sono tre fenomeni diversi, misurabili attraverso gruppi di indicatori in grado di coglierne le specificità. 86 Capitolo 2 Inoltre, dall’analisi delle frequenze di ciascun item (riportate nelle Tabb. 11, 12 e 13), emerse come la paura della criminalità avesse un grado di diffusione tra la popolazione molto inferiore rispetto a quello della preoccupazione o della valutazione del rischio. Tabella 13 - Le componenti dell’insicurezza: variazioni 1999-2001. Campione emiliano-romagnolo percentuale Item 1999 2000 2001 Quale problema della realtà di oggi ritiene più preoccupante? Criminalità (micro+macro) come prima scelta 41 41 47 La criminalità in Italia è aumentata 83 73 62 Nella zona di vita la criminalità è un problema grave 21 26 18 Insicuro/a camminando da solo/a nella zona in cui vive quando è buio per il timore di subire un reato 8 7 11 Fonte: elaborazione da Sacchini G., 2000, “Le opinioni dei cittadini”, in Politiche e Problemi della sicurezza in Emilia-Romagna. Sesto rapporto annuale 2000, Quaderni di Cittàsicure, 20a, pp. 43-60, e sui dati della Settima indagine annuale sui problemi della sicurezza (2001) del Progetto Città Sicure della Regione Emilia-Romagna La paura della criminalità risultava avere un grado di diffusione inferiore anche rispetto alla “paura senza forma” (formless fear): i dati dell’indagine trentina dimostrarono che la percentuale di coloro che dichiaravano di essere insicuri a casa o per strada (9 per cento a casa, 16 per cento per strada) era superiore a quella di coloro che dichiaravano di esserlo perché temevano specificamente di subire un reato (rispettivamente 8 per cento e 10 per cento). Infine, osservando i dati sulla preoccupazione per la criminalità e sulla valutazione della gravità del rischio criminale, si rilevò come il loro livello diminuisse al restringersi dell’ambito su cui incide la preoccupazione o la valutazione. Così, ad esempio, la criminalità in Italia nell’ultimo anno era considerata in aumento da parte dell’83 per cento del campione trentino e del 62 per cento del campione emiliano-romagnolo, mentre nella zona di vita la Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 87 criminalità era visto come un problema grave solamente dal 23 per cento dei trentini e dal 18 per cento degli emilano-romagnoli. 97 Da questi risultati trassi alcune indicazioni circa il rischio di sovrarappresentazione delle paure delle persone. Partendo dal presupposto – individuato dalla Risk Analysis98 – che una comunicazione approssimativa delle agenzie istituzionali deputate a informare la popolazione sui rischi contribuisca a una loro percezione sociale distorta, sottolineai come l’utilizzo di indicatori imprecisi rischiasse di portare a una sovra-stima delle paure, a volte funzionale alle esigenze della politica. La criminologia tra quantificazione e critica agli strumenti di misurazione Il percorso di analisi della letteratura criminologica che ho proposto evidenzia come la presa d’atto di una confusione metodologica e terminologica abbia portato alla ricerca di una definizione “stretta”, scientifica, di paura della criminalità, in grado di orientare la selezione degli indicatori più appropriati tra quelli usati in quaranta anni di indagini. Tale operazione ha permesso di rilevare come l’attività di quantificazione conduca a esiti molto diversi a seconda di come il fenomeno sia stato “concettualizzato” e “operazionalizzato” – vale a dire a seconda di come lo si voglia intendere e di quali domande si decide di inserire nei questionari rivolti alla popolazione. Il processo di costruzione del concetto di fear of crime – come ho ricordato nel capitolo 1 – è stato fortemente orientato da esigenze e interessi politici: basti ricordare il ruolo fondamentale, anche se non esclusivo, ricoperto da McClellan, Presidente della Sottocommissione sulla Legge e sulla Procedura Penale (par. 1.1) e, più in generale, la tendenza, a partire da quegli anni, a utilizzare le nuove tecniche d’indagine delle scienze sociali per fornire una base conoscitiva per programmi politici di intervento sui problemi sociali. Anche la ricerca delle cause, come ho accennato, ha risposto a istanze politi- 97 Si tratta di un dato confermato in numerose ricerche sul tema e, in particolare, già rilevato sin dalla prima indagine CittàSicure sui problemi della sicurezza. Si veda G. Mosconi, “Devianza, sicurezza e opinione pubblica in Emilia-Romagna”, La sicurezza in Emilia-Romagna. Primo rapporto annuale 1995, Quaderni di Cittàsicure, 2, 1995, pp. 47-48. 98 Per un approfondimento sul settore di ricerca sul rischio denominato Risk Analysis, si veda O. Renn, “Three decades of risk research: accomplishments and new challenger”, Journal of Risk Research, 1, 1998, pp. 49-71. Per una analisi sul ruolo della conoscenza nella percezione del rischio si veda B.B. Johnson, Advancing Understanding of Knowledge’s in Lay Risk Perception, reperibile al sito web http://fplc.edu/RISK/vol4/summer/johnson.htm. 88 Capitolo 2 che di una maggiore conoscenza del fenomeno a fini di un incremento di efficacia delle misure di rassicurazione sociale. Gli studi riportati in questo paragrafo sembrano, invece, andare in un’altra direzione: rilevano la confusione degli strumenti di misurazione del fenomeno, sottolineano l’eccessiva ampiezza del concetto di paura della criminalità, denunciano i rischi di sovra-rappresentazione e di utilizzo politico strumentale delle indagini. Sembrano, in altre parole, affermare una esigenza di separazione dell’interesse scientifico dalle esigenze politiche, ai fini di una più corretta comprensione del tema indagato. Ma è così solo in parte: proponendo una definizione alternativa fondata su un’interpretazione “fisicalistica”, la riflessione criminologica non rinuncia a suggerire alla Politica il modo corretto per pensare alla paura e intervenire su di essa. Più propriamente, indica una via per evitare distorsioni nella rappresentazione istituzionale del fenomeno attraverso un maggiore rigore metodologico. L’obiettivo, dunque, rimane sempre quello di fornire una base conoscitiva sempre più precisa per l’elaborazione di politiche sempre più efficaci, sulla base dell’assunto che la paura della criminalità sia un fenomeno riducibile con interventi mirati. 2.6 Luci e ombre della versione criminologica. In questo capitolo ho analizzato lo sviluppo della ricerca criminologica sulla paura della criminalità. Ho descritto la nascita del discorso criminologico nel solco tracciato dalle indagini di vittimizzazione. Lo scopo di queste indagini è stato – ed è ancora – quello di informare la collettività circa il suo stato di insicurezza e di fornire al sistema politico-istituzionale una base conoscitiva che sostenga una loro presa in carico del problema. Non sempre i risultati di ricerca sono in linea con le rappresentazioni di senso comune: le indagini italiane più rigorose dal punto di vista metodologico indicano come nel corso degli anni il livello di paura sia rimasto sostanzialmente stabile (con alcune differenze per genere, area geografica, età), in contrasto con l’opinione diffusa di una sua crescente pervasività nella vita quotidiana delle persone e con l’evidenza di una sua centralità nei discorsi pubblici. Purtuttavia tale contraddizione non si risolve in aperto contrasto: anche quando minano la solidità della visione dominante, inchieste e sondaggi di opinione entrano e circolano nella comunicazione sociale, mass-mediatica e politica per la loro funzione di sostegno del senso comune consolidato. Inoltre, ho considerato l’evoluzione della letteratura criminologica nel passaggio dall’esigenza di quantificare a quella di spiegare. Riferendo i prin- Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 89 cipali tentativi di individuare uno o più fattori esplicativi della paura della criminalità, ho accennato al fatto che questi possono essere interpretati nell’ambito di una più generale necessità politico-istituzionale di affinare l’efficacia degli interventi di rassicurazione. Così, la comprensione del fenomeno si è orientata perlopiù all’individuazione di quelle cause su sui poter intervenire in modo mirato al fine di ridurre le insicurezze delle persone. Il caso più emblematico è costituito dalla tesi nota come “Broken Windows Theory”. Il legame tra criminalità, disordine urbano e paura, tematizzato in un articolo di una decina di pagine pubblicato nel 1982 sulla rivista The Atlantic Monthly, ha influito così decisamente sulle modalità con cui si è affrontato il problema della “sicurezza urbana” soprattutto perché ha intercettato e dato risposta all’esigenza di individuare percorsi “praticabili” di intervento. In un duplice senso: da un lato, ha fornito alle comunità e istituzioni locali un obiettivo “visibile” su cui poter intervenire (le inciviltà), dall’altro ha consentito alle Forze di Polizia di trovare una nuova mission proprio in un periodo, gli anni Settanta, di aperta critica al funzionamento del Sistema di Giustizia Penale – sintetizzata nell’espressione Nothing Works – e caratterizzato dalla ricerca di forme di legittimazione basate sulla presenza fisica degli agenti nei quartieri e sulla collaborazione con i cittadini – programmi di Beat Policing, Foot Patrolling e Community Policing. Alcuni recenti studi spostano l’attenzione dalle inciviltà alla collective efficacy (efficacia collettiva), definita come coesione tra i residenti di una stessa area combinata con una condivisione di aspettative circa il controllo informale dello spazio pubblico: la paura della criminalità è l’esito di un progressivo deterioramento dei rapporti di fiducia (interpersonale e istituzionale) di solidarietà tra i residenti unitamente a un progressiva disaffezione verso il proprio quartiere. Particolare importanza sembra rivestire la fiducia nella capacità delle istituzioni, e tra queste delle forze di polizia, di controllare il territorio. In questa ottica, le misure di presa in carico del problema diventano più complesse, dovendo intervenire non tanto su obiettivi mirati (segni di inciviltà) quanto sulle dinamiche socio-culturali di una comunità (il senso di coesione e di fiducia sociale). Considero queste ricerche il punto più avanzato della ricerca criminologica sulle cause della paura della criminalità, in grado di costituire un ponte con le elaborazioni della riflessione sociologica sull’insicurezza (cap. 3). Infine, ho riferito come, a partire dal riconoscimento di una confusione metodologica e, prima ancora, terminologica, recentemente alcuni criminologi abbiano inteso recuperare il significato del termine “paura” nelle scienze neuro-psicologiche e ad applicarlo alla paura della criminalità. In questo senso, la “versione criminologica” ha attinto dall’approccio fisicalistico allo 90 Capitolo 2 studio delle emozioni: la fear of crime è stata definita come un’emozione che nasce dalla percezione di una minaccia imminente messa in atto da altre persone, che consiste in una reazione psicofisica e che attiva l’individuo nella ricerca di risposte adeguate per affrontare l’evento minaccioso. A partire da questa definizione sono stati individuati indicatori “appropriati” del fenomeno indagato. Riportando nello specifico i risultati di uno studio empirico che condussi qualche anno fa in due regioni italiane ho dato consistenza alla preoccupazione di molti studiosi circa l’esistenza di una sorta di “vizio originario” delle indagini su questo tema: già nella prima fase del loro sviluppo si sottolineò come l’imprecisione degli indicatori utilizzati fosse funzionale all’esigenza politica di enfatizzare la portata del fenomeno per deviare l’attenzione dei cittadini da altri problemi. In tal senso, ho evidenziato come l’utilizzo di indicatori diversi comporti diverse rappresentazioni del fenomeno: il rischio che si corre è quello di sovrastimare le paure della gente, provocando reazioni a catena nelle decisioni politiche, difficilmente reversibili. Allo stato attuale, quindi, la letteratura criminologica internazionale ha compiuto alcuni passi importanti verso la comprensione della “paura della criminalità”: della sua diffusione, delle sue cause e delle possibili distorsioni che le stesse indagini empiriche possono produrre nella rappresentazione e spiegazione del fenomeno. Nonostante queste “conquiste”, rimane il dubbio che non sia stato detto ancora tutto sulla paura della criminalità. Anzi, si ha la sensazione che, una volta compreso, tale fenomeno debba essere nuovamente indagato, a partire da altre prospettive. Sono principalmente due ordini di considerazioni a dare consistenza a tale sensazione. Il primo prende spunto dai più recenti risultati della ricerca criminologica: l’individuazione, nell’ambito di alcuni studi sulla collective efficacy, della centralità di temi quali la fiducia, la coesione sociale e la capacità di produrre ordine rimanda immediatamente ai contenuti della riflessione sociologica sulla crisi nelle società tardo-moderne e invita ad approfondirne l’apporto alla comprensione della paura della criminalità. Il secondo ha a che fare, invece, più direttamente con i limiti della ricerca empirica. L’ampiezza degli indicatori utilizzati nelle indagini comporta il rischio di sovra-rappresentazione, facendo confluire nella fear of crime ogni tipo di insicurezza sociale, e di una loro strumentalizzazione politica. Potremmo individuare, in questo senso, una sorta di “effetto performativo” delle ricerca quantitativa sul tema. Statistiche e sondaggi di opinione costruiscono “in laboratorio”, vale a dire all’interno dei confini del sapere scientifico a cui si riferiscono, la categoria della “paura della criminalità” come una Quantificare, spiegare, definire: la comprensione criminologica della paura 91 lente attraverso cui guardare le insicurezze delle persone – e non solo, rabbie, insoddisfazioni, indignazioni, sfiducie – e come filtro nell’attribuire loro un significato; in tal modo, tutte le insicurezze diventano paura della criminalità. Il caso della domanda più usata nelle indagini internazionali– “quanto ti senti sicuro a camminare da solo la sera?” – dà evidenza del “percorso a imbuto” cui sono sottoposte le insicurezze delle persone: queste sono rilevate da un item che non ha alcun riferimento alla criminalità, ma inserite in questionari sulla percezione della criminalità, vengono interpretate come paura della criminalità. D’altra parte, la preoccupazione di avere una definizione scientifica – non manipolabile – di paura della criminalità, utile a essere operazionalizzata in item di questionari e a fungere da variabile dipendente nelle analisi statistiche fattoriali, rischia di indurre a scegliere una versione di paura della criminalità meno elaborata, meno com-prensiva, di quelle che è possibile coltivare. Infatti, se comporta una distinzione tra paura, preoccupazione, ansia e valutazione del rischio, al tempo stesso ne svela i possibili legami e connessioni, che risultano difficilmente rilevabili in indagini di tipo quantitativo99. Una versione della paura della criminalità che non com-prendesse anche questi livelli d’intersezione sarebbe necessariamente limitata. Infine, occorre sottolineare come le esigenze scientifiche di “misurare”, “spiegare” e “definire” la paura della criminalità, se considerate all’interno del processo storico – delineato nel precedente capitolo – di invasione di questa emozione nelle società contemporanee, appaiono espressioni di una necessità della ricerca criminologica di restituire alla società e alla Politica un oggetto facilmente osservabile e comprensibile, affermandosi come disciplina di riferimento per lo studio della paura della criminalità e per l’elaborazione di policies efficaci. In altri termini, il richiamo politico alla necessità di studiare le conseguenze della criminalità sulle persone, che ha caratterizzato la genesi delle ricerche sulla paura della criminalità, e il fatto che la criminologia, soprattutto a partire dalla diffusione negli anni Ottanta delle teorie realiste di destra e di sinistra, si sia caratterizzata sempre più come “scienza orientata all’applicazione” (criminologia attuariale) ha indotto a studiare solamente «ciò che è più utile rispetto a ciò che è possibile fare». La Politica ha definito l’approccio della ricerca criminologia, dapprima indivi- 99 In questa direzione, Alfredo Verde suggerisce di leggere la paura della criminalità da un punto di vista psicanalitico come “angoscia persecutoria” (A. Verde, “La risposta pubblica alla devianza ed alla criminalità dal punto di vista psicosociologico”, in A. Gasanti (a cura di), Giustizia e conflitto sociale. In ricordo di Vincenzo Tomeo, Giuffrè, Milano, 1992, p. 281). 92 Capitolo 2 duando i temi, successivamente ponendosi come destinatario immediato e preferenziale dei suoi risultati. In tal modo, solo raramente sono state percorse strade alternative per comprendere il ruolo della paura della criminalità nella società contemporanea: si è dato per scontato – tanto nel discorso politico quanto nei presupposti teorici delle ricerche scientifiche – che fosse preminente, contingente e, quindi, passibile di riduzione attraverso interventi immediati e mirati. Un invito a percorrere altre strade, che consentano di ampliare l’orizzonte della riflessione criminologica, viene, come ho accennato, dall’ampia letteratura sull’insicurezza: essa suggerisce l’idea che la paura della criminalità sia l’epifenomeno – o anche un sotto-prodotto – di un malessere più profondo che riguarda le condizioni di vita complessive dell’uomo tardo-moderno. Di questa spunti discuterò nel prossimo capitolo, al fine di coltivare un’altra “versione” della paura della criminalità, che tende a spogliarla dei caratteri di preminenza, contingenza e riducibilità e che ne afferma, al contrario, le radici strutturali. Capitolo 3 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne La domanda che domina le società industriali non è più: come funziona l’ordine sociale? Bensì: come abbiamo inventato la modernità? Perché l’Europa occidentale è diventata la culla del progresso, della rivoluzione industriale, della conquista della natura da parte dell’uomo? Alain Touraine 3.1 I tre vertici della modernità Premessa In questo capitolo intendo descrivere alcune trasformazioni socioeconomiche, istituzionali e culturali che permettano di osservare le paure così come si manifestano oggi nelle società occidentali. Parlerò di “paure” in senso ampio, non necessariamente nel significato di “reazioni emotive”, secondo la stretta definizione discussa nel capitolo precedente; utilizzerò preferibilmente il termine “insicurezze”, più generico, che permette, tuttavia, di evitare fratture tra esperienze affettive contigue, come quelle della paura, della preoccupazione, dell’angoscia e dell’ansia. Assumerò uno sguardo storico e sociologico insieme, con un approccio che segue le impronte lasciate da David Garland in The Culture of Control, e 93 94 Capitolo 3 dallo stesso autore definito “storia del presente”1. La “storia del presente” condivide, a mio parere, con la tradizione di studi storiografici denominata “storia regressiva”, lo studio a ritroso di un evento – a partire da un fatto storico l’interesse è rivolto a metterne in luce gli antecedenti –, ma se ne distanzia per l’approccio di carattere analitico sul presente. Nella “storia del presente” l’obiettivo non è comprendere il passato, ma analizzare criticamente il presente.2 Un senso diffuso di crisi La nostra società – osservava nel 1969 Karl R. Popper, in opposizione alle «lagnanze dei pessimisti […] divenute ormai monotone»3 – è di gran lunga la migliore società mai realizzatasi nel corso della storia umana4. Nel giro di poche generazioni abbiamo conquistato quello che i nostri antenati non erano nemmeno in grado di immaginare. In nessun’altra epoca, né in alcun altro luogo, gli uomini sono stati più rispettati come tali che nella nostra società: mai prima furono tanto rispettati i loro diritti umani, e la loro dignità di uomini. Il mondo libero è riuscito ad abolire o a mitigare i maggiori malanni che hanno fino a ora insidiato la vita sociale dell’uomo: la povertà, la disoccupazione, le malattie e le sofferenze, la crudeltà del diritto penale, la schiavitù, la discriminazione religiosa e razziale, la mancanza di istituzioni educative, le rigide differenze di classe, la guerra. E tutto questo è stato ottenuto attraverso il Welfare State.5 È pur vero che tale tesi ottimistica, già minoritaria all’epoca della sua esposizione – come lo stesso Popper rilevava –, è stata soffocata dal peso della crisi del Welfare State. Purtuttavia, le parole di Popper rimangono valide ancora oggi per descrivere le numerose conquiste sociali ottenute nel corso del Novecento – beninteso, nelle società occidentali –, ma re-interpretate nell’ambito di una cornice emotiva diversa, non più ottimistica, bensì “criti- 1 D. Garland, The Culture of Control. Crime and Social Order in Late Modernity, Oxford University Press, Oxford, 2001 (trad. it. La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Milano, 2004, p. 58). 2 L’interesse è quello di «comprendere le condizioni storiche da cui dipendono le pratiche contemporanee, in particolare quelle che suscitano maggiori perplessità. L’indagine storica – insieme a quella sociologica e enologica – è qui utilizzata quale mezzo per scoprire come questi fenomeni hanno assunto le loro caratteristiche attuali. La storia che propongo non ha come obiettivo la comprensione del passato, ma è guidato da un interesse critico per il presente.» (Ibidem) 3 Popper K.R., Conjectures and Refutations, London, Routledge and Kegan Paul, 1969 (trad. it. Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino, Bologna, 1972, p. 618). 4 Ibidem, p. 625. 5 Ibidem, pp. 617-636. Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 95 ca”: le società occidentali contemporanee sono riconosciute essere tra le più sicure mai esistite, ma in queste società si è sviluppata una sorta di ossessione per il tema della sicurezza, tale da segnare profondamente le esperienze sociali, le geografie dei passaggi, le politiche pubbliche. Questo scenario di apparente contraddizione tra condizioni di benessere e di sicurezza “materiale” mai sperimentati prima, da una parte, e centralità del problema della sicurezza per i singoli individui e per la collettività nel suo insieme, dall’altra, apre il campo a diverse interpretazioni sulle insicurezze tardo-moderne, sulle loro origini e sulle loro dinamiche nelle società occidentali contemporanee. Rimangono attuali le domande che poneva Sergio Riscossa nella prefazione di un libro pubblicato nel 1990 che affrontava il tema delle paure nella società industriale: «perché abbiamo paura? È la paura di perdere l’agiatezza raggiunta inaspettatamente? O temiamo addirittura un declino della nostra civiltà?»6. I temi del “benessere a rischio” delle società occidentali contemporanee e del “senso di crisi” che le percorre ritornano continuamente nel pensiero tardo-moderno. La gran parte degli studi sociologici interpretano l’insicurezza come profondamente legata alle trasformazioni che connotano la nostra epoca come tardo-moderna, post-moderna o semplicemente moderna, ma in un senso diverso rispetto alla modernità ristretta e alla modernità organizzata delle precedenti fasi storiche: si parla di modernità autocosciente, riflessiva, liquida o critica. Al di là delle espressioni, valide solo in quanto in grado di riassumere ed evocare simbolicamente una serie di tendenze evolutive che caratterizzano il nostro presente, sembra di cogliere proprio nel concetto di “crisi” il tratto essenziale dell’epoca che stiamo vivendo, in grado di identificarla rispetto ad altri periodi della modernità in cui la fiducia – nel progresso, nella scienza, nell’uomo – costituiva il tratto essenziale del sentire collettivo. In ambito criminologico è Garland a sottolineare con forza come negli ultimi venti anni “crisi” sia la parola che ricorre regolarmente per descrivere il senso di malessere profondo che ha attraversato il campo penale7, e non solo quello. 6 S. Riscossa, “Prefazione”, in S. Riscossa (a cura di), Le paure del mondo industriale, Editori Laterza, Bari, 1990, p. IX. 7 D. Garland, op. cit. a nota 1, p. 83-84. 96 Capitolo 3 L’idea di crisi, parola greca (krisis) di probabile origine medica8, comincia a circolare nell’ambito della filosofia politica del XVII e XVIII secolo. Henri de Saint-Simon, ad esempio, distingueva all’interno della società un’epoca organica, ove i rapporti tra le componenti sociali sono regolati ed armonizzati in un’idea guida centrale, da un’epoca definita appunto “critica”, ove il venir meno della funzione omogeneizzante e del raccordo di un’idea centrale provoca il conflitto tra le componenti stesse.9 Il concetto di crisi, quindi, si lega con l’assenza di una linea-guida, di un criterio unificante, di un progetto che tenga insieme le diverse parti del sistema. Nel mondo contemporaneo, tardo moderno, l’idea di crisi pervade gli ambiti della vita sociale: la famiglia, le istituzioni, i valori, i fondamenti delle scienze e la stessa idea di scienza si dice siano entrate in crisi. Konrad Lorenz, premio Nobel per la medicina e studioso di scienze naturali, descrive, in un saggio del 197310, otto processi distinti, ma collegati tra loro, che «minacciano di annientare non soltanto la nostra attuale civiltà, ma addirittura l’umanità in quanto specie»11. Dalla sovrappopolazione della terra, che costringe gli uomini a proteggersi in maniera disumana dall’eccesso di contatti con il prossimo, alla devastazione dello spazio vitale naturale, che distrugge non solo l’ambiente esterno ma anche ogni rispetto per la bellezza e per la grandezza della creazione che lo sovrasta; dalla competizione tra gli uomini, che rende l’uomo cieco di fronte ai valori reali e lo priva della riflessione, alla scomparsa di ogni sentimento ed emozione forti; dal deterioramento del patrimonio genetico alla demolizione della tradizione, che porta i giovani a trattare gli anziani come gruppo etnico estraneo verso il quale manifestare un odio di tipo nazionalistico; dalla maggiore predisposizione degli uomini a essere indottrinati al riarmo atomico. Lorenz pone di fronte a scenari che riconosciamo come familiari non tanto perché prima ancora di considerarli veri, costituiscono argomenti fondanti le paure collettive della nostra epoca. 8 Luigi Cimmino ricorda come Ippocrate indichi con il termine krisis il mutamento decisivo che segue l’acme di una malattia, evolvendosi in senso positivo o negativo. L. Cimmino, “Giorgio Colli e la crisi della ragione”, in La Nottola, III, n. 1-2, 1984, pp. 63-85. 9 Per un approfondimento sul concetto di crisi si considerino ancora le riflessioni di Cimmino (Ibidem). 10 Il 1973 riveste un forte valore simbolico per il concetto di crisi nella modernità: come indicherò a breve, è l’anno della prima crisi petrolifera, che pone definitivamente fine alla fiducia incondizionata nel progresso economico e sociale dell’umanità e riapre la tensione tra presente e futuro, tra preoccupazione e speranza. 11 K. Lorenz, Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, Adelphi, Milano, 1974 (tit. orig. Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit, Piper & Co. Verlag, München, 1973) Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 97 Il concetto di crisi esprime bene la fisionomia dell’attuale periodo storico, rimandando solo in apparenza a quello di anomia, che ha dominato la letteratura sociologica per buona parte del XX secolo. Il concetto di anomia, così come sviluppato da Émile Durkheim, rimanda a una perdita di solidarietà tra gli organi sociali, dovuta all’assenza di una regolazione, anzitutto morale. Riguarda, in altre parole, il mancato funzionamento di un sistema con riferimento a una funzione che lo definisce: la solidarietà. L’anomia rimanda all’intelligibilità del sistema sociale, all’individuazione delle cause degli squilibri e alla possibilità, dunque, di porvi rimedio. È un concetto pienamente moderno, che esalta la ragione e il suo utilizzo nell’ambito del progetto illuministico di contenimento della violenza. L’idea di crisi, al contrario, si definisce innanzitutto in rapporto all’impossibilità stessa di comprendere e di agire: è “crisi della ragione”, sfiducia nella sua capacità di interpretare e risolvere i problemi. Ciò che oggi si lamenta è sempre di più l’incapacità di comprendere, prima ancora dell’impossibilità di agire. L’idea di crisi si definisce intorno all’assenza di un criterio di lettura e di guida dell’esperienza individuale e collettiva che sia condiviso e omogeneizzante e che possa operare anche in negativo (come l’anomia, quale negativo della solidarietà). Il concetto di crisi, dunque, si lega strettamente alla rappresentazione della politica come affetta da un male acuto, richiamando in questo modo l’etimologia medica del termine. Le diagnosi sul “politico” operate dalla ricerca sociale contemporanea, che presentano affinità strutturali tra interpretazioni neoconservatrici e interpretazioni di sinistra12 e che si ritrovano sul comune terreno di una percezione malinconica della modernità, richiamano l’idea dell’ «inservivibilità delle antiche mappe dello Stato, della società e dell’economia»13. L’insicurezza odierna assomiglia alla sensazione che potrebbero provare i passeggeri di un aereo nello scoprire che la cabina di pilotaggio è vuota14. La metafora del viaggio compiuto senza bussola, senza guida e dalla destinazione sconosciuta è non solo il leit motiv della lettura colta e volgare del mondo 12 C. Offe, «Unregierbarkeit». Zur Renaissance konservativer Krisentheorien, in J. Habermas (a cura di), Stichworte zur «Geistigen Situation der Zeit», vol. I: Nation und Republick, Frankfurt am Main 1979, p. 295 (trad. it. in C. Donolo, F. Fichera, Il governo debole. Forme e limiti della responsabilità politica, Bari 1981, p. 108). 13 G. Marramao, Dopo il Leviatano. Individuo e comunità nella filosofia politica, Giappichelli Editore, Torino, 1995, p. 8. 14 Z. Bauman, In Search of Politics, Cambridge, Polity Press, 1999 (trad. it. La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000, p. 28) 98 Capitolo 3 contemporaneo ma, più propriamente, elemento costitutivo del nostro universo simbolico. La letteratura sulla crisi della modernità è sterminata. Già Ernesto De Martino, negli appunti preparatori del libro La fine del mondo, pubblicato solamente dopo la sua morte in forma di raccolta di saggi, riflessioni e materiale preparatorio15, aveva compiuto una lettura approfondita e originale del “senso della fine” nelle società occidentali: «L’Occidente borghese vive oggi ed esprime simbolicamente (attraverso la letteratura, le arti figurative, la musica) il senso della propria fine: è un’apocalittica senza speranza, perché non è in grado di prefigurare in prospettiva nessun futuro diverso, nessuna palingenesi»16. D’altra parte, come ricorda ancora De Martino, «che il mondo possa finire è un tema antico quanto il mondo, per quanto la sua importanza culturale, la tonalità con cui è vissuto, la dinamica in cui è immerso siano diversi nella varietà delle epoche e degli ambienti storici, dei gruppi sociali e degli individui, e infine delle forme di coerenza culturale alla cui dinamica partecipa». 17 Libertà, uguaglianza, fraternità In questo capitolo intendo analizzare alcune delle trasformazioni sociali, culturali e istituzionali che danno consistenza al senso diffuso di crisi dei nostri giorni e che molti sociologi indicano come fondamento delle insicurezze dell’uomo tardo-moderno. Le descriverò intorno ai tre termini che hanno sostanziato, fino ai nostri giorni, la promessa della modernità, i tre grandi principi di libertà, uguaglianza e fraternità che fungono ancora oggi da riserva simbolica (e risorsa di legittimazione) delle organizzazioni e delle istituzioni politiche dell’Occidente: «parole maestre» della teoria democratica […], parole «iperdense», che sembrano condensare su di sé il massimo di significato e di verità, parole-nucleo: centri attorno a cui gravitano le nostre idee, ma anche i nostri conflitti. Parole “cardinali”, che ci in- 15 E. De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi, Torino, 1977, p. 8. 16 C. Gallini, “Introduzione”, in E. De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi, Torino, 1977, p. X. 17 E. De Martino, op. cit. a nota 15, p. 8. Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 99 dicano lo zenit e il nadir, il vecchio e il nuovo, il Nord e il Sud, l’alto e il basso, la sinistra e la destra. […] parole “strategiche”: ossia fortezze delle nostre credenze18. Nell’analizzare le trasformazioni contemporanee intendo approfondire, in modo trasversale, anche altri due concetti, quello di “ordine sociale” e di “dominio sulla natura”, che in qualche modo hanno costituito l’ossatura del motto “liberté, égalité, fraternité”: è la fiducia nella possibilità di contenere e controllare la violenza degli uomini, attraverso l’affermazione di un ordine sociale condiviso, e della natura, attraverso il progresso scientifico e tecnologico, ad aver costituito l’humus fertile per la costruzione dei diritti individuali, la richiesta di una loro estensione generalizzata e l’affermazione di un senso di appartenenza e di riconoscimento che, come vedremo più avanti, ha trovato un aggancio non episodico nel concetto di Nazione o di classe sociale19. Cosa accade se viene meno questa fiducia nella capacità di regolarsi e di regolare? 3.2 Libertà e sicurezza nella “modernità liberale” Premessa Nella modernità si assiste al processo di affermazione dell’individuo come soggetto autonomo e libero, e, parallelamente, dello Stato quale difensore dell’individuo e delle sue libertà fondamentali. 18 G. Marramao, op. cit. a nota 13, p. 31. Proprio in base alla considerazione dell’attualità della promessa della modernità e della valenza simbolica e di legittimazione dei tre principi di libertà, uguaglianza e fraternità, preferisco parlare di “tarda modernità” e non di “post-modernità”. Infatti, come osserva Elena Pulcini, «se è vero che lo scenario post-moderno mette in crisi il progetto della modernità (razionalità, ordine, progresso, conciliazione tra bene pubblico e privato), esso tuttavia non ne annulla o non ne smentisce i presupposti originari (libertà e sovranità dell’individuo, autoaffermazione, legittimità dei desideri e delle pretese soggettive); dei quali l’idea di illimitatezza e di insicurezza fanno intrinsecamente parte […]» (E. Pulcini, “L’Io globale: crisi del legame sociale”, in D. D’Andrea, E. Pulcini (a cura di), Filosofie della globalizzazione, Edizioni ETS, Pisa, 2002, p. 60). Analogamente, Anthony Giddens ritiene che «anziché andare incontro a un’era postmoderna, stiamo entrando in un’era in cui le conseguenze della modernità si fanno sempre più radicali e universali. Al di là della modernità, direi, possiamo percepire i contorni di un nuovo e diverso ordine che è sì “postmoderno”, ma che è anche ben diverso da quello che molti adesso definiscono “postmodernità”» (A. Giddens, The Consequences of Modernity, Cambridge, Polity Press, 1990 trad. it. Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 16). 19 G. Marramao, op. cit. a nota 13, pp. 35-39. 100 Capitolo 3 In questo scenario, la domanda di sicurezza del vivere quotidiano si è costruita intorno alla dimensione statuale e al concetto di diritto individuale: essa viene affermata come domanda individuale rivolta allo Stato di salvaguardia delle proprie libertà attraverso la regolazione della vita sociale. Ma è possibile regolare la vita sociale – vale a dire, produrre un certo tipo di ordine attraverso il controllo dei comportamenti – senza limitare, almeno in parte, le libertà degli individui? A partire da questo paradosso di uno Stato che garantisce libertà e sicurezza attraverso l’inevitabile limitazione delle libertà individuali, in questo paragrafo discuto la tesi secondo cui una parte del sentimento d’insicurezza moderno deriva dall’impossibilità, nelle società democratiche, di garantire a tutti piena libertà e totale sicurezza di diritti. Infatti, l’ideale dell’uguaglianza, che stimola istanze di riconoscimento universale dei diritti, evidenzia le contraddizioni di un concetto di libertà che, per attuarsi, richiede, nei fatti, una limitazione dei “soggetti di diritto” – storicamente verificatasi nel processo di doppia esclusione: delle categorie popolari nelle nazioni più sviluppate, e del resto dell’umanità. Lo sviluppo dello Stato sociale, esito di un difficile processo di inclusione delle masse nel sistema politico liberale, ha permesso, per un certo periodo, di arginare l’ondata delle richieste di protezione connesse al processo di democratizzazione della società e di fissare un delicato equilibrio – per alcuni aspetti, del tutto insoddisfacente20 – tra istanze di libertà ed esigenze di sicurezza. La sua attuale crisi determina la perdita anche di quel punto fermo, il ri-esplodere delle contraddizioni e il riemergere dell’insicurezza in forma diffusa – non più confinata in “luoghi” specifici. Un nuovo statuto individuale Con l’avvento della modernità, lo statuto dell’individuo cambia radicalmente: viene riconosciuto di per se stesso, indipendentemente dalla sua appartenenza ad ambiti collettivi. A partire dal XXVIII secolo si afferma un nuovo modo di intendere l’essere umano concepito quale “unità fisica e patrimoniale indipendente”, che mette in crisi le reti tradizionali che assicuravano protezione. 20 L’equilibrio risulta insoddisfacente se si considera, per esempio, il fatto che si è fondato sull’esclusione di intere categorie sociali, attraverso l’internamento nelle istituzioni totali Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 101 La proprietà individuale diventa lo zoccolo di risorse a partire dal quale un individuo può esistere autonomamente, senza dipendere da un padrone o dalla carità altrui. È la proprietà che garantisce la sicurezza di fronte agli imprevisti dell’esistenza, e a chi la possiede si riconosce una soggettività giuridica autonoma e, innanzitutto, il diritto ad essere protetto nella persona e nei beni.21 Così, «all’inizio della modernità la proprietà privata assume un significato antropologico profondo: essa appare come la base a partire dalla quale l’individuo che si affranca dalle protezioni-soggezioni tradizionali può provare le condizioni della propria indipendenza». 22 Già a partire dalla concezione di John Locke (1632-1704) di contratto sociale – posto a fondamento dello Stato moderno – e del riconoscimento di diritti individuali a salvaguardia di life, liberty e possession (vita, libertà e proprietà), gli uomini senza proprietà si trovano in un limbo politico indefinito, in quanto il loro essere “non proprietari” non può che inficiarne la razionalità necessaria per amministrare il bene comune. 23 Il Codice napoleonico del 1804 costituisce il primo atto giuridico che sancisce tale concezione moderna della proprietà. Come sostiene Hubert Multzer in una ricostruzione storico-giuridica sul concetto di proprietà in epoca romana, nell’ancien régime e in epoca moderna, il diritto di proprietà del Codice, pur essendo il risultato di un movimento lungo e complesso durato per secoli tanto sul piano pratico che su quello teorico, è senza precedenti24. L’art. 544, sia pure in modo incoerente, dichiara che la proprietà è un diritto assoluto: la proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso proibito dalle leggi e dai regolamenti. 25 L’assolutezza del diritto di proprietà, connessa al carattere sacro che le veniva riconosciuto, viene nel tempo temperata proprio da leggi e regola- 21 In epoca tardo-moderna – per l’Italia soprattutto negli ultimi quarant’anni – si è compiuto un ulteriore passo nel processo di modernizzazione che vede la proprietà costitutiva della soggettività giuridica, e che ha condotto verso una decisa trasformazione del concetto stesso di proprietà: da qualità determinante dell’individuo in principio organizzativo del sistema. Cfr. P. Barcellona, Diritto privato e società moderna, Novene Editore, Napoli, 1996, p. 222-223; A. Ceretti, R. Cornelli, Proprietà e sicurezza. La centralità del furto per la comprensione del sistema penale tardo-moderno, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 105-120. 22 R. Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé?, Edition du Seuil, 2003 (trad. It. L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2004). 23 Cfr. D. Melossi, Stato, controllo sociale, devianza, Bruno Mondatori, Milano, 2002, pp. 18-20. 24 Cfr. H. Multzer, La propriété sans le vol, Seuil, Paris, 1945 (trad. it. Proprietà senza furto, Edizioni di Comunità, Milano, 1948, p. 43). In particolare, si consideri la ricostruzione dell’autore sulla mancanza di una dottrina della proprietà nell’ancien régime. Ibidem, p. 57 25 Art. 544 del Codice Napoleonico, citato in Ibidem, p. 3. 102 Capitolo 3 menti che le attribuiscono sempre più un carattere relativo. Ma, in ogni caso, «nonostante gli attacchi che gli sono rivolti, nonostante l’importanza dello sforzo compiuto per limitarne l’esercizio, il principio stesso della proprietà non è concepito come suscettibile di relatività (…) Nonostante i progressi della filosofia sociale e della dottrina giuridica, questo principio resiste, vivo e vigoroso come i primi giorni».26 Non solo: la stretta relazione tra “proprietà” e costruzione della soggettività individuale – indicata con le espressioni “possessive individualism”27 e “individualismo proprietario”28 – costituisce un tratto sempre più caratteristico dell’età moderna. La nascita degli Stati nazionali e la contraddizione tra sicurezza e libertà Di pari passo all’affermazione di un nuovo statuto individuale fondato sulla proprietà privata si assiste alla nascita degli Stati nazionali, quale risultato di un processo di progressiva erosione dei centri di potere locali, di accentramento di funzioni essenziali – quali quelle legate alla giustizia e alla sicurezza – e di costruzione di un sistema di protezioni fondato proprio sull’individuo-proprietario: l’esistenza di uno Stato è necessaria affinché l’individuo possa disporre della libertà di sviluppare le proprie iniziative e godere in pace dei frutti del proprio lavoro. Al tempo stesso, l’esistenza di un individuo sganciato dalle reti tradizionali di appartenenza è necessaria perché possa consolidarsi il nuovo sistema di potere. Nel corso di questo capitolo, riprenderemo più volte il discorso sulla “nascita” e il “declino” dello Stato nazionale, con riferimento alla crisi dello Stato sociale, al fenomeno della globalizzazione e al concetti di nazione, popolo e fraternità. Per il momento, intendiamo soffermarci sul fatto che questo duplice processo di affermazione dell’individuo, inteso quale soggetto autonomo, e dello Stato quale difensore dell’individuo, della sua proprietà e dell’esercizio delle sue libertà fondamentali – tipico della costruzione dello Stato di diritto liberale –, da una parte, ha comportato una progressiva torsione del concetto di sicurezza in diritto individuale, dall’altra parte, lo ha legato strettamente 26 Ibidem, p. 7. C.B. MacPherson, The Political Theory of Possessive Individualism - Hobbes to Locke, Oxford, Oxford University Press, 1962 (trad. It. Liberta e proprietà alle origini del pensiero borghese: la teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke, ISEDI, Milano, 1973). 28 P. Barcellona, L’individualismo proprietario, Boringhieri, Torino, 1987. 27 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 103 alla dimensione statuale – Stato che si legittima proprio in quanto garantisce protezione ai propri cittadini). Come risultato, il bisogno di protezione si esprime in domanda individuale di intervento statale nella regolazione della vita sociale e nella salvaguardia dei diritti individuali, in un delicato e difficile equilibrio tra istanze di controllo sempre più puntuale e istanze di libertà, innanzitutto dalle ingerenze dello Stato. Se la sicurezza viene intesa come diritto soggettivo, condizione essenziale per un effettivo esercizio delle libertà fondamentali, allora ciascun individuo, ogniqualvolta si senta minacciato, richiederà allo Stato un intervento a garanzia della propria sicurezza, tanto più efficace quanto più sarà limitativo delle libertà fondamentali altrui. Maggiori saranno le richieste di protezione, maggiori saranno le difficoltà di evaderle rispettando le libertà fondamentali dei richiedenti; maggiori, in definitiva, risulteranno le aspettative frustrate che genereranno ulteriore insicurezza. Così, il sentimento moderno di insicurezza è associato, almeno in parte, alla contraddizione strutturale di uno Stato di diritto che fonda la propria legittimità sulla risposta ai bisogni di sicurezza e che, al tempo stesso, proprio per garantire una piena protezione agli individui, si trova costretto a erodere quei diritti posti a salvaguardia della vita, della libertà e della proprietà. È questo il nucleo fondamentale delle contraddizioni tra libertà e sicurezza, per cui al progressivo ampliarsi delle libertà individuali si amplia anche l’esigenza di una loro tutela, che può attuarsi solamente attraverso la fissazione di limiti alle libertà stesse. Dalla libertà per pochi all’uguaglianza Dalle considerazioni finora esposte emerge come sia impossibile tutelare in modo pieno i diritti individuali di tutti: infatti, la protezione delle libertà di alcuni (sicurezza) è tanto più effettiva quanto più limita le libertà degli altri. In questo senso, la promessa di libertà ha retto fintanto che, nella società borghese, la tutela dei diritti è stata assicurata in maniera assoluta ai pochi individui-proprietari. L’affermazione delle libertà e della sicurezza dei diritti di pochi si è attuata attraverso l’esclusione – che produceva un’insicurezza sociale politicamente invisibile – delle masse. Non è un caso che la “paura del pericolo rosso” – che riguardava innanzitutto il rischio di un accesso delle masse al sistema delle libertà borghesi – abbia spinto, nel Primo Dopoguerra, le liberal-democrazie verso i “fascismi”. I ceti che sorreggevano i partiti che sino ad allora avevano governato (liberali, radicali, ecc.) hanno tolto loro man mano ogni credito, hanno perso fiducia nella “de- 104 Capitolo 3 mocrazia parlamentare”, e hanno optato per il fascismo. Le tensioni sociali, la “paura”, il discredito dei sistemi parlamentari hanno spostato l'opinione centrista-moderata verso un tale sbocco. L'appoggio di settori del grande capitale ai movimenti fascisti è stato, ovviamente, vitale, e gli apparati di “ordine pubblico”, orientati da quelle decisive forze “retrosceniche” che sono i gradi alti delle burocrazie degli apparati statali, hanno offerto la necessaria copertura logistica e “militare”.29 A ben vedere, la modernità liberale si è costruita su una doppia esclusione: non solo quella delle categorie popolari nelle nazioni più sviluppate dell’epoca, ma anche l’esclusione del resto dell’umanità. Già Leopardi nello Zibaldone intuì il legame stretto, indissolubile, tra libertà e schiavitù: è cosa osservata dai filosofi e dai pubblicisti che la libertà vera e perfetta di un popolo non si può mantenere, anzi non può sussistere senza l'uso della schiavitù interna. (Così il Linguet, credo anche il Rousseau, Contrat social, liv. III, ch. 15, ed altri. Puoi vedere anche l' Essai sur l'indifférence en matière de religion, ch. X, nel passo dove cita in nota il detto luogo di Rousseau insieme con due righe di questo Autore). Dal che deducono che l'abolizione della libertà è derivata dall'abolizione della schiavitù, e che se non vi sono popoli liberi, questo accade perché non vi sono più schiavi. Cosa, che strettamente presa, è falsa, perché la libertà s'è perduta per ben altre ragioni, che tutti sanno, e che ho toccate in cento luoghi. Con molto maggior verità si potrebbe dire che l'abolizione della schiavitù è provenuta dall'abolizione della libertà; o vogliamo, che tutte due sono provenute dalle stesse cause, ma però in maniera che questa ha preceduto quella e per ragione e per fatto. La conseguenza, dico, è falsa: ma il principio della necessità della schiavitù nei popoli precisamente liberi, è verissimo.30 Non è concepibile la libertà senza la schiavitù, con la conseguenza di una dicotomia tra libertà, che è tale solo se assoluta, illimitata e quindi per pochi, e democrazia, che, prevedendo l’accesso alle libertà tendenzialmente per tutti, ne afferma la relatività, la limitabilità.31 Così, il programma moderno di sradicamento dell’insicurezza trova una possibilità di attuazione nel momento in cui la contraddizione si risolve nel 29 L. Canfora, Democrazia. Storia di un’ideologia, Editori Laterza, Bari, 2004, p. 231. G Leopardi, Zibaldone. Come osserva Luciano Canfora, Leopardi crede di ricavare questa sua intuizione dagli scritti di Linguet e di Rousseau: ma si tratta, in realtà, di un esito, di un’apice della sua filosofia (L. Canfora, op. cit. a nota 29, p. 365). 31 È ancora Luciano Canfora a parlare di dicotomia tra i termini democrazia e libertà, affermando che si tratta di una riflessione condivisa da Pericle – nel discorso attribuitogli da Tucidide – secondo cui «la parola che adoperiamo per definire il nostro sistema politico […] è democrazia per il fatto che, nell'amministrazione […], esso si qualifica non rispetto ai pochi ma rispetto alla maggioranza […] Però nelle controversie private attribuiamo a ciascuno ugual peso e comunque nella nostra vita pubblica vige la libertà (II, 37)» (Ibidem, p. 11) fino ad Alexis de Tocqueville che, in una nota preparatoria di un discorso parlamentare del novembre 1841, dice di amare con passione la libertà, la legalità, il rispetto dei diritti, ma non la democrazia (Ibidem, p. 26). 30 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 105 garantire la libertà a pochi a scapito della sicurezza di molti: questo avvenne nella prima fase di affermazione degli Stati nazionali assoluti e liberali32. Purtuttavia, esso inizia a vacillare con l’affermazione di società democratiche – in cui libertà deve coniugarsi con uguaglianza – e consumistiche – in cui la proprietà, da qualità del soggetto e criterio di individuazione di un ceto, si trasforma in principio di organizzazione del sistema 33 costruendo forme di parità intorno alla figura del consumatore –, nelle quali si assiste a un progressivo ampliamento della cerchia di persone a cui sono riconosciute le libertà fondamentali. Le istanze di democratizzazione delle società occidentali, che hanno proceduto di pari passo a trasformazioni nell’economia, nella società e nella cultura, hanno comportato una progressiva espansione dei soggetti portatori di diritti e di richieste di protezione. La rapidissima trasformazione tecnologica, dei trasporti, delle comunicazioni ha riempito la vita di milioni di persone di automobili, aeroplani, telefoni, fax, personal computer e internet. La produzione in serie di beni di consumo economici e durevoli – lavatrici, frigoriferi, automobili, etc. – ha permesso ad ampi settori delle classi meno abbienti di accedere a beni fino ad allora esclusivi. Si afferma anche in Italia, fin dal Dopoguerra, uno “stile di vita americano”, stimolato dal sistema di produzione capitalistico, sempre più orientato al consumo; uno stile di vita reso possibile dall’estensione del potere di acquisto, sostenuto da politiche pubbliche e da accordi sindacali, di ampie fasce della popolazione e dall’affermazione di tecniche di marketing che hanno facilitato la generazione di un flusso costante di desideri inappagati. Come sostiene David Garland con riferimento a Stati Uniti e Gran Bretagna,34 l’agiatezza economica ha costituito il punto di partenza per l’espansione della democrazia, dell’uguaglianza e dei profondi cambiamenti culturali che ne sono seguiti. Ciò vale anche per l’Italia. Le battaglie per i diritti civili e per l’integrazione di soggetti emarginati – stimolate anche dalla disponibilità di risorse finanziarie nell’ambito delle politiche di welfare – si legano stretta- 32 R. Castel, op. cit. a nota 22., pp. 25-6. P. Barcellona, op. cit. a nota 28, p. 37. «Il sistema funziona, cioè, da produttore, riproduttore e distruttore di oggetti destinati all’appropriazione e restituisce, alla fine del suo “ciclo vitale”, un soggetto in rapporto con l’oggetto consumabile (che costituisce il fulcro del sistema). Il soggetto proprietario è trasformato in soggetto consumatore. La qualità è diventata quantità: l’oggetto di “appropriazione”, in quanto tale, non è suscettibile di determinazioni che non siano puramente numeriche». Ibidem, p. 80. 34 E.J. Hobsbawm, Age of Extremis. The Short Twentieth Century 1914-1991, Pantheon Books, 1997 (trad. It. Il secolo breve. L’epoca più violenta della storia dell’umanità, BUR, Milano, 2000, p. 361). 33 106 Capitolo 3 mente ai mutamenti nello stile di vita e corrispondono alla necessità del sistema produttivo di ampliare la base sociale dei cittadini liberi e capaci di acquistare beni e servizi. In questo periodo, i discorsi che esaltano l’uguaglianza e la parità dei diritti costituiscono il tratto essenziale della comunicazione sociale e facilitano la diffusione di aspettative di inclusione sociale che, a loro volta, al di là della loro effettiva soddisfazione, consolidano lo statuto moderno dell’individuo e favoriscono una maggiore facilità nell’accesso formale al diritto. Nello stresso periodo, la struttura della famiglia si modifica a seguito, soprattutto, dell’ingresso massiccio di donne nel mondo del lavoro. Il ricorso sempre più diffuso anche nelle fasce meno abbienti a separazioni e divorzi, effetto del riconoscimento di nuovi diritti, ha portato a un aumento di nuclei familiari mono-parentali, con l’aggravarsi di problemi di cura e controllo dei figli e il sorgere di nuovi problemi d’indigenza per donne e bambini. Infine, mutamenti rilevanti hanno interessato anche la struttura urbana del territorio: il processo d’inurbamento di ampie fasce di popolazione, come effetto dell’attrattività di aree urbane sempre più industrializzate e dotate di servizi, ha comportato lo spopolamento di molte regioni italiane e l’estensione a macchia d’olio delle città, soprattutto quelle del nord, attraverso la costruzione massiccia di nuovi quartieri residenziali di edilizia pubblica. Le città si allargarono, inglobando i piccoli centri periferici e creando di fatto aree metropolitane con ampie zone periferiche prive di socialità – zone dormitorio per i lavoratori delle industrie cittadine e di recente immigrazione – e fortemente degradate. Queste trasformazioni del tessuto sociale e urbano hanno comportato l’insorgere di nuovi bisogni – di assistenza, di aggregazione e di controllo – cui le istituzioni pubbliche sono state chiamate a rispondere. E la risposta inizialmente, in Italia come in molti altri Paesi, è stata l’istituzione di un sistema di welfare che, attraverso l’impiego di ingenti risorse pubbliche per costruire la “proprietà sociale”35 e per garantire alcune importanti conquiste sociali. 35 Si potrebbe caratterizzare la “proprietà sociale” come la produzione di equivalenti sociali delle protezioni che prima erano state fornite solo a partire dalla proprietà privata (R. Castel, op. cit. a nota 22, p. 30). Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 107 Verso la crisi del sistema di welfare Nel prossimo paragrafo (3.2) descriverò gli effetti della “crisi” di questo modello sociale. Per il momento intendo sottolineare come le trasformazioni economiche, sociali e culturali che ho descritto sinteticamente abbiano portato all’aumento, da un lato, delle situazioni che necessitano di protezione (più diritti da tutelare, più case da sorvegliare, quartieri più degradati, etc.), dall’altro, delle aspettative di protezione (individui più consapevoli dei loro diritti). Il risultato è stato un aumento esponenziale di richieste di tutela che, da una parte, sostennero il progetto di progressiva costruzione del sistema di welfare, dall’altra, nelle more e nelle ombre di questa costruzione, alimentarono frustrazioni e risentimenti. Questo scenario porta Castel a dire che «l’insicurezza moderna non è il risultato di un’assenza di protezioni, ma piuttosto della loro ombra, proiettata in un universo sociale che è organizzato attorno a una richiesta senza fine di protezioni o attorno a una travolgente ricerca di sicurezza»36. L’insicurezza contemporanea è, in parte, l’effetto di una promessa non mantenuta: il connubio tra gli ideali di libertà e di democrazia hanno diffuso aspettative generalizzate di inclusione e di protezione, frustrate nei fatti dall’impossibilità di garantire a tutti gli stessi livelli di tutela e di qualità della vita. Finché lo Stato sociale, orizzonte ideale di uguaglianza, pace, ordine sociale e progresso regge come utopia 37 capace di catalizzare le richieste di tutela delle persone, le contraddizioni tra libertà e sicurezza rimangono in penombra: l’insicurezza rimane confinata nelle esperienze individuali, circoscritta a situazioni concrete, senza elevarsi a tema politico. Ai primi segnali di crisi della “modernità organizzata”, vale a dire del sistema di regolazioni collettive garantite da uno Stato di diritto sempre più coinvolto con un ruolo sociale, le persone si scoprono sole ad affrontare le difficoltà della vita quotidiana e i rischi di un futuro sempre più incerto. 36 Ibidem. Nella lettura che Alfio Mastropaolo fa del discorso tenuto da Habermas alle Cortes il 26 novembre del 1984 su invito del Presidente del Parlamento spagnolo il male più profondo che sta attraversando lo Stato sociale viene individuato proprio nella perdita di una sua legittimità conseguente alla rinuncia del suo nucleo utopico. Cfr. A. Mastropaolo, “Presentazione”, in J. Habermas, La nuova oscurità. Crisi dello stato sociale ed esaurimento delle utopie, Edizioni Lavoro, Roma 1998. 37 108 Capitolo 3 3.3 Uguaglianza e Stato sociale. L’insicurezza nel periodo di crisi della “modernità organizzata” Premessa L’affermazione dell’ideale di uguaglianza nelle democrazie di massa ha comportato un ampliamento delle aspettative d’inclusione e di estensione delle libertà e si è espressa in legislazioni di promozione dei diritti e programmi di intervento dello Stato a protezione di bisogni sociali diffusi. Le politiche di welfare, d’altra parte, hanno reso compatibili gli ideali di libertà e uguaglianza: l’ingente piano di investimenti pubblici, concepito dentro la cornice materiale della crescita economica e ideale del progresso sociale, ha garantito la tenuta di un sistema politico di tipo liberale sempre più pressato da istanze di democratizzazione, La crisi di questo modello, nell’ambito di una crisi più generale del modello fordista di produzione industriale e di un declino dello Stato nazionale sotto il peso della globalizzazione e della finanziarizzazione dei mercati, presenta forti ricadute sul piano collettivo e individuale. Il sistema statale di protezioni per gli individui, costruito intorno alla figura del maschio lavoratore e padre di famiglia, entra in crisi per le crescenti perplessità circa la sua sostenibilità, in un periodo di crisi economica, per la de-standardizzazione del lavoro, esito di mutamenti nelle modalità di produzione industriale e per il convergere di tendenze de-statalizzanti. Questi mutamenti ridefiniscono la dinamica delle relazioni interpersonali, delle identità individuali e di quelle collettive, provocando un senso diffuso di disorientamento e di insicurezza. Crisi del modello fordista di produzione industriale La prima crisi petrolifera del 1973/74 inaugurò una nuova stagione politica ed economica nel segno dell’incertezza.38 Dopo anni di straordinaria espansione, la crescita subì un drastico rallentamento e cominciò a vacillare l’equazione keynesiana tra aumento della produzione, crescita economica ed equità sociale. Le crescenti difficoltà economiche iniziarono a minare la credibilità dello Stato sociale come efficace regolatore dello sviluppo e nei Paesi che più avevano investito nella sua 38 F. Girotti, Welfare State. Storia, modelli e critica. Carocci Editore, Roma, 1998, p. 323 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 109 edificazione iniziarono a manifestarsi le prime perplessità circa la sostenibilità di forme di protezione sociale che apparivano di ostacolo al lavoro e allo sviluppo economico. Prima ancora che si potesse realizzare, nei fatti, l’idea di Stato sociale, 39 essa veniva già superata da istanze di deregolamentazione del lavoro, dei salari e delle protezioni sociali, nella prospettiva neo-liberista di una nuova centralità del mercato nella regolazione dello sviluppo economico e sociale. Nonostante per molti anni la spesa pubblica continuasse ad aumentare, anche in Italia, e numerose conquiste sindacali facessero ben sperare, lo Stato sociale, come formula di armonia e di pace, diventò esso stesso fonte di nuove contraddizioni e di divisioni politiche tra quanti intendevano conservare le protezioni acquisite e quanti proponevano drastici smantellamenti.40 Le perplessità circa la sostenibilità di un sistema sorto per controllare l’economica capitalistica e renderla compatibile con la democrazia, per ridurre le disuguaglianze e per garantire condizioni di vita dignitose ai cittadini, si diffusero rapidamente in concomitanza con la crisi del modello fordista di produzione industriale e all’affermarsi di uno scenario postindustriale sempre più articolato e complesso41. Lo sviluppo delle produzioni industriali di massa aveva indotto a privilegiare un welfare di tipo previdenziale, negoziato attraverso gli istituti della contrattazione collettiva, con prestazioni differenziate per i più importanti settori e per le grandi categorie del mondo del lavoro.42 Il modello di società che s’impose con la modernità organizzata era quello di un insieme di gruppi professionali omogenei, la cui dinamica era gestita nel quadro dello Statonazione che agiva più come riduttore di rischi che come “redistributore di ricchezza”. In questo modo, le distribuzioni di denaro pubblico intaccarono poco la struttura gerarchica della società salariale – e l’istituto della pensione 39 Questa drastica affermazione acquisisce senso all’interno dell’individuazione di tre modelli di welfare state affermatisi storicamente e dell’usuale riferimento al secondo come modello compiuto di welfare: 1) il regime liberale di welfare, che rilascia con parsimonia ai singoli beneficiari gli aiuti statali, affermatosi negli Stati Uniti nel periodo post.bellico; 2) il regime socialdemocratico scandinavo, che sottolinea la legittimità dell’aiuto statale universale; 3) i regimi conservatori, che cercano di incanalare l’aiuto statale alle famiglie e agli enti locali piuttosto che ai singoli individui, tra cui il welfare italiano. Cfr. R. Sennet, Respect in a World of Inequality, Norton & Company, New York, 2003 (trad. it. Rispetto. La diginità umana in un mondo di diseguali, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 167). 40 Cfr. C. Offe, Strukturprobleme des Kapitalistischen Staates. Aufsatze zur Politischen Sociologie, Frankfurt am Main, 1975 (trad. it. Lo stato nel capitalismo maturo, Etas Libri, Milano, 1979, p. 66); F. Girotti, op. cit. a nota 38, p. 326. 41 T. Boeri, Uno stato asociale. Perché è fallito il welfare in Italia, Laterza, Roma-Bari, 2000. 42 F. Girotti, op. cit. a nota 38, p. 327. 110 Capitolo 3 ne è un esempio: «le pensioni seguono assai strettamente la gerarchia salariale (piccolo salario - piccola pensione, grosso salario - grossa pensione)». 43 Nella società salariale che si afferma nel Dopoguerra, quasi tutti gli individui erano coperti da sistemi di protezione costruiti a partire dal rapporto di lavoro, attraverso la mediazione delle grandi forme di organizzazione collettiva, e garantiti dallo Stato, che opera come “vasta assicurazione”.44 In un assetto di tipo fordista il referente privilegiato delle politiche sociali era tipicamente il lavoratore adulto, maschio, inserito a tempo pieno in forme di occupazione permanente, con prospettive di carriera lunga, quasi sempre ampiamente prevedibili e standardizzate: in tale ottica, era del tutto naturale che gli inattivi trovassero protezione essenzialmente in qualità di familiari a carico di un capofamiglia, occupato e adeguatamente coperto da assicurazioni sociali estendibili all’intero nucleo familiare.45 Negli ultimi decenni, le trasformazioni dell’economia fordista hanno modificato profondamente anche l’organizzazione del lavoro e ridefinito il quadro di riferimento delle politiche sociali. La prospettiva, al meglio, della “crescita senza occupazione” ha portato a una rinnovata preoccupazione per la stabilità del posto di lavoro, accentuata dall’uso sistematico delle nuove tecnologie che comportano una riduzione di manodopera, quantomeno nelle grandi imprese. Con il ridimensionamento delle grandi imprese si è assistito anche a un indebolimento delle organizzazioni sindacali delle più importanti categorie industriali e, contestualmente, alla perdita di potere contrattuale da parte dei lavoratori, aggravata da continue crisi aziendali, spesso seguite da spostamenti di linee di produzione in Paesi a basso costo del lavoro. In questo scenario post-fordista si assiste all’erosione di uno dei principali presupposti delle politiche sociali tradizionali, vale a dire l’esistenza di un rapporto di lavoro stabile, garantito dalle organizzazioni sindacali, attorno a cui si sono costruiti i sistemi di protezione statali. Si assiste, in altri termini, a una trasformazione che Ulrich Beck ha definito “de-standardizzazione del lavoro”. Su questo passaggio vale la pena soffermarsi più diffusamente. 43 R. Castel, op. cit. a nota 22, p. 33. Ibidem, p. 31. 45 F. Girotti, op. cit. a nota 38, p. 328. 44 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 111 Sicurezza, lavoro e famiglia Nell’epoca industriale lavoro retribuito, professione e famiglia costituiscono il sistema di coordinate al cui interno è situata la vita delle persone46. Il sistema educativo e della formazione si fonda sulla prospettiva di un lavoro retribuito che diventa professione, modello di riconoscimento reciproco, con l’aiuto del quale si possono stabilire i bisogni personali, le capacità, la posizione sociale ed economica di chi la svolge. Il lavoro costituisce la garanzia di esperienze sociali fondamentali e di stabilità interiore: è una sorta di carta d’identità per gli altri e per se stessi. Questa stabilità, esito di conflitti e crisi di carattere politico e sociale a partire dal XIX secolo, si basa su un alto grado di standardizzazione in tutte le sue dimensioni essenziali: il contratto di lavoro, che avviene secondo standard negoziati collettivamente; il luogo di lavoro, che si concentra nelle grandi aree industriali; il tempo di lavoro, il cui orario è fissato da standard negoziati collettivamente e la cui durata è spesso determinata solo dall’ingresso nell’età pensionabile. Il sistema di certezze riguardanti la propria identità e posizione sociale inizia a vacillare proprio a partire dall’erosione della stabilità del contratto di lavoro e dall’articolarsi di sempre nuove situazioni lavorative. Le numerose forme di flessibilizzazione temporali e spaziali, che allentano la sicurezza di relazioni derivanti dal lavorare insieme nello stesso luogo, e di flessibilizzazione dei contenuti del contratto di lavoro, che sfumano le differenze tra categorie professionali e le relative identità47, portano a un’individualizzazione dei percorsi professionali48: la biografia, lavorativa e non, delle persone è “liberata” da determinazioni prefissate e viene messa nelle mani di ciascuno. Alcuni beneficiano di questa novità: massimizzano le opportunità, sviluppano le loro potenzialità, in un’ottica imprenditoriale. Si diffonde la retorica neo-liberista del self-made man o, per dirla all’italiana, 46 U. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1986 (La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma, 2000, p. 199). 47 Richard Sennet, in The Corrosion of Character, sottolinea come la flessibilità stia cambiando il significato stesso del lavoro, e anche le parole per definirlo. Il termine carriera, per esempio, evocava, anche nella sua etimologia, l’idea di un percorso professionale, una direzione che era necessario seguire per tutta la vita. Oggi il Capitalismo flessibile ha cancellato i percorsi lineari tipici delle carriere, attraverso lo spostamento improvviso di lavoratori dipendenti da un tipo di incarico a un altro. Cfr. R. Sennet, The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism, Norton & Company, New York-London, 1999 (trad. it. L’uomo flessibile, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1999). 48 U. Beck , op. cit. a nota 46, p. 195. 112 Capitolo 3 del “ciascuno imprenditore di se stesso”. Questa retorica omette di considerare che non tutti sono dotati di risorse culturali, cognitive, relazionali e materiali per supportare le spinte, proprie e indotte, a intraprendere. La realtà è spesso molto diversa dall’ideale dell’uomo libero e industrioso: più che di fronte a opportunità e sfide, sono i rischi di un percorso professionale divenuto ormai discontinuo e incerto a invadere la vita delle persone, sempre più sole nel decidere, giorno per giorno, della propria vita49. La famiglia, luogo di socialità e di sostegno, diventa più fragile proprio nel momenti in cui è chiamata a sostenere i nuovi carichi assistenziali imposti dall’inoccupazione giovanile, dalla precarizzazione del lavoro, dalla maggiore aspettativa di vita di genitori anziani, per ciò stesso più esposti al rischio della non autosufficienza.50 Famiglia e lavoro costituivano le due grandi forme di sicurezza rimaste alle persone nella modernità51. Negli ultimi decenni, la crisi congiunta di famiglia e lavoro colpisce il nucleo del sistema moderno di protezioni sociali, fondato sul modello familistico del capofamiglia lavoratore, e, in tal modo, ridefinisce la dinamica delle relazioni interpersonali. Dal verticale all’orizzontale, dal sopra/sotto al dentro/fuori. Un passo del saggio autobiografico di Richard Sennet sul Rispetto mette in luce il trionfo della “burocrazia” nell’affermazione delle politiche di welfare. Essa nasce primariamente nel settore privato dall’esigenza di eliminare la concorrenza, concentrando le attività e incorporando in un’unica entità tutti i passaggi fondamentali del processo produttivo.52 L’incremento nelle dimensioni delle aziende implicava l’aumento di potere dei burocrati al loro interno, dotati del potere reale, quello derivante dall’uso quotidiano dell’amministrazione. Per la sua forza ed efficacia, la burocrazia rigida viene presa a modello dai creatori del welfare state. 49 A. Giddens, op. cit. a nota 18. F. Girotti, op. cit. a nota 38, p. 329-330. 51 U. Beck , op. cit. a nota 46, p. 200, 52 Sennet sottolinea anche il sostanziale limite dell’organizzazione burocratica del welfare, quello di non riconoscere l’autonomia delle persone “assistite”, di incanalarle in procedure contabili e di classificazione del disagio che non consentono alle persone di parlare di sé, di dire qualcosa rispetto alla loro situazione: “queste istituzioni, che vorrebbero trattare gli utenti come esseri umani a tutto tondo, commettono il plateale errore di negare che gli utenti stessi siano competenti a entrare nel merito della loro dipendenza”. R. Sennet, op. cit. a nota 39, p. 177. 50 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 113 Purtuttavia, se inizialmente venne considerata modello di un’efficiente divisione del lavoro, col tempo apparve sempre più inefficiente per la sua tendenza a riprodursi al di là delle esigenze funzionali dell’organizzazione. Il diffondersi di lavoro a breve termine, a contratto od occasionale è l’esito di un cambiamento nella struttura delle aziende moderne, che hanno cercato di rimuovere le eccessive stratificazione burocratiche, trasformandosi in organizzazioni più piatte e flessibili. Si costituiscono non più sul criterio della gerarchia, bensì su quello della rete: le disposizioni a rete sono più mobili delle gerarchie piramidali, è molto più facile scomporle e ridefinirle per adattarsi alle sempre più mutevoli esigenze dell’economia 53. E ciò comporta che assunzioni, promozioni e licenziamenti siano sempre meno basati su regole chiare e costanti, e che nemmeno le mansioni siano ben definite. La transizione dal modello fordista di produzione al modello flessibile si accompagna al passaggio «da relazioni sociali fondate sulle forme del lavoro produttivo industriale, che delineavano relazioni sociali di tipo gerarchico e rappresentanze centralizzate [...] a relazioni sociali su ambiti particolari, di territorio, di genere, di interessi non gerarchizzabili nel contenitore nazione». 54 Col passaggio al modello di società post-industriale il problema non è più quello di essere “sopra o sotto”, ma quello di essere “dentro o fuori”: o si è inseriti nella società o si è nel vuoto sociale, nel limbo delle non persone. 55 Si passa da relazioni sociali fondate su rapporti verticali di classe a rapporti di tipo orizzontale in cui i punti di riferimento classici della società industriale (luoghi di rappresentanza di interessi, luoghi di socialità, coscienza di classe) svaniscono. Il timore non è più di essere declassati, ma di perdere ogni tipo di appartenenza sociale. 53 Cfr. R. Sennet, op. cit. a nota 47, p. 21. Interessante, a questo proposito, la lettura di De Leonardis che, nel contesto di un’analisi delle condizioni per lo sviluppo di un diverso welfare, parla di una coesistenza (e parziale contraddizione) tra la potenza distruttiva e la potenza costruttiva o organizzativa sprigionate dalla nuova economia. La nuova economia, sostiene l’Autrice, si accompagna a costi sociali così rilevanti da configurare la distruzione di alcune condizioni di base del suo stesso sviluppo. Al contempo libera una potenza organizzativa strettamente attinente alla centralità che la logica del ‘servizio’ sta assumendo nell’organizzazione della produzione e degli scambi economici (O. De Leonardis, In un diverso welfare, Feltrinelli, Milano, 1998, pp. 101-120). Cfr. anche O. De Leonardis, Nuovi conflitti a Flatlandia: la crisi del principio di terzietà e le libertà politiche, paper presentato al Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, 5 aprile 2006. 54 Si veda A. Bonomi, “Il grumo rancoroso delle identità elementari”, Narcomafie, ottobre 1993, p. 15. 55 Cfr. A. Dal Lago, “Nonpersone. Il limbo degli stranieri”, Aut-Aut. Dentro/Fuori, 275, 1996, pp. 4370. 114 Capitolo 3 Più che di “marginalità”56, si parla sempre più di “esclusione sociale”, espressione emblematica della potenza distruttiva della nuova economia caratterizzata da precarietà occupazionale, disoccupazione mascherata da autoimpiego e forme rinnovate di taylorismo. Essa si configura come esclusione dalle relazioni sociali, mancato accesso o espulsione dai commerci sociali, deprivazione culturale, comunicativa e relazionale57. Alessandro De Giorgi, attingendo dalle riflessioni di Antonio Negri e Michael Hardt, parla significativamente di “eccedenza” a indicare come la dinamica produttiva contemporanea ecceda continuamente i dispositivi istituzionali di attribuzione, riconoscimento e garanzia della cittadinanza sociale.58 La crisi del patto fordistakeynesiano, e dello Stato sociale che su quel patto si era costruito si risolve in una cronica inadeguatezza da parte delle istituzioni di governo della società a garantire inclusione attraverso il lavoro e in un ricorso a dispositivi di governo e controllo della popolazione eccedente.59 56 Per l’analisi del concetto di marginalità si fa riferimento ai seguenti autori: F. Barbano, “Bisogni della «marginalità» e produzione dei servizi sociali: emergenze e conclusioni della ricerca” in F. Barbano (a cura di), Le frontiere della città, Franco Angeli, Milano, 1982, p. 15; F. Barbano, “Marginalità versus complessità” in Studi di Sociologia, 4, 1983, p. 336; A. Ceretti, “Devianza e marginalità: due categorie a confronto”, in Marginalità e Società, 7, 1988, p. 69; O. De Leonardis, “Statuto e figure della pericolosità sociale tra psichiatria riformata e sistema sociale: note sociologiche” in Dei Delitti e delle pene, 2, p. 337. Adolfo Ceretti, in particolare, sottolinea come a partire dagli anni Settanta, le nuove forme di marginalità sociale non si circoscrivevano più al solo modello produttivo: accanto alle quote visibili che caratterizzavano ancora in senso “forte” la condizione di marginalità sociale, la partecipazione di larghe fasce di popolazione ai diversi canali distributivi creava una categoria di soggetti “semi-marginali” che si rivelarono portatori di istanze e bisogni più articolati di quelli puramente materiali. Il venir meno di centralità strutturali (classe operaia, fabbrica) e la conseguente comparsa di una fase di mobilità culturale dei bisogni imponeva una nuova domanda di “senso”, una ricerca di consapevolezza del proprio status di marginale che stravolgeva l’ordine dei bisogni e la tradizionale percezione di sradicamento, subalternità e passività, promuoveva l’identità (individuale/collettiva) stessa a bisogno, comportava una sorta di unificazione tra bisogni materiali (di condizione economica) e non materiali (vitali, rivolti al miglioramento di se stessi e della società), suggeriva nuove domande ai servizi sociali e riproblematizzava il concetto di “livello di vita” – tradizionalmente legato al punto di vista economico –, includendo al suo interno anche contenuti culturali e simbolici che provenivano da ambiti esterni alla centralità. A. Ceretti, Come pensa il Tribunale per i Minorenni. Una ricerca sul giudicato penale a Milano dal 1934 al 1990, Franco Angeli, Milano, 1996. 57 O. De Leonardis, 1998, op. cit. a nota 53, p.117. 58 A. De Giorgi, Il governo dell'eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine, Ombre corte, Verona 2002, p. 79. 59 Cfr. Z. Bauman, Waste Lives. Modernity and its Outcasts, Polity Press, Cambridge, 2004 (trad. it. Vite di scarto, Laterza, Bari-Roma, 2005). Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 115 Dal welfare rigido al welfare piatto Il processo di de-istituzionalizzazione del welfare, dunque, è strettamente connesso a un più ampio mutamento in corso nella società contemporanea: un attacco alle istituzioni rigide del mondo del lavoro e della vita politica, sorte come soluzioni «all’iniziale stato di confusione e orrore del Capitalismo industriale»60. Negli ultimi decenni, ci si è convinti sempre più che le comunità possano rispondere ai bisogni sociali meglio delle burocrazie istituzionali. Il concetto costituzionale di sussidiarietà61, per esempio, molto dibattuto nella politica italiana ed europea contemporanea, acquista un valore paradigmatico proprio nell’ambito del clima culturale anti-istituzionale dell’Italia degli anni Novanta (cap. 1), legittimando molto spesso, nella sua traduzione politica, un’ambigua richiesta di sovvenzione statale ad associazioni e comunità locali, non in grado, da sole, di far fronte alle esigenze che pretendono di affrontare. Le istituzioni pubbliche vengono fortemente criticate nel loro ruolo di fornitrici di servizi, ma chiamate in causa come erogatrici di finanziamenti per il Terzo settore. 62 Questa retorica della comunità si accompagna a “processi di trasformazione sociale delle istituzioni”63 connessi al fenomeno della globalizzazione. L’internazionalizzazione economica è diventata una “realtà della vita”64: le transazioni globali raggiungono oggi livelli non raggiunti in nessuna epoca precedente e influenzano le economie nazionali in misura mai conosciuta 60 R. Sennet, op. cit. a nota 39, p. 161. Papa Pio XI, nell’enciclica del 1931 Quadragesimo anno, ha indicato l’importanza fondamentale del principio della sussidiarietà nell’ambito della dottrina sociale cattolica. Il passaggio più rilevante afferma: “Siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle”. Questo stesso “principio di sussidiarietà” è stato citato nella prima enciclica sociale di Giovanni XXIII, Mater et magistra, ed è stato adottato dall’Unione Europea nel Trattato di Maastricht del 1992 come linea guida nella sezione intitolata “Disposizioni comuni”. 62 In questa critica alla sussidiarietà intendo mettere in luce il fatto che spesso questo concetto venga utilizzato a sostegno di interventi di privatizzazione delle politiche sociali. Condivido, invece, la proposizione di questo concetto come criterio-guida per ri-articolare l’azione pubblica in un periodo di “carsismo istituzionale”. Cfr. T. Vitale, “Sussidiarietà: un criterio giuda contro il carsismo istituzionale”, in Animazione Sociale, n. 7-8, 2006. 63 R. Sennet, op. cit. a nota 39, p. 180. 64 R. Dahrendorf, Quadrare il cerchio. Benessere economico, coesione sociale e libertà politica, Edizioni La Terza, Roma Bari, 1998, p.78. 61 116 Capitolo 3 prima. Non solo gli scambi commerciali transnazionali sono aumentati, ma si assiste anche alla moltiplicazione di imprese transnazionali con catene mondiali di produzione, all’accelerazione senza precedenti dei movimenti di capitale sulla rete elettronica collegante i mercati finanziari, nonché al tendenziale autonomizzarsi della circolazione finanziaria in una sua dinamica specifica, svincolata dall’economia reale, e all’acutizzarsi della concorrenza economica internazionale. Tutto ciò rende evidente la differenza tra le forme note dell’economia internazionale e gli aspetti inediti dell’economia globale. Queste tendenze generano domande che comportano mutamenti nell’organizzazione delle imprese. A partire dagli anni Settanta, il modello di organizzazione del lavoro basato sulla specializzazione delle mansioni e la ripetitività del lavoro in fabbrica, viene progressivamente sostituito da un modello di organizzazione orizzontale, appiattito e accorciato. «Appiattire» significa eliminare livelli intermedi della burocrazia all’interno dell’organizzazione a struttura piramidale. […] «Accorciare» significa sostituire funzioni di una organizzazione con mansioni più temporanee. […] significa anche pensare a un ritorno economico a breve termine sul mercato, piuttosto che a profitti sul lungo periodo.65 L’organizzazione piatta e corta viene solitamente rappresentata con l’immagine della “rete”. Diversamente, Sennet propone di rappresentarla come un “disco”, che contiene un’unità centrale operativa, costituita da un laser che proietta un fascio di luce che legge le tracce nell’ordine di ascolto che si desidera. Nell’organizzazione burocratica piatta esiste un’analoga unità operativa centrale costituita da un numero ristretto di dirigenti che comanda, prende decisioni, definisce compiti, giudica risultati, essendo in grado di riordinare e riprogrammare velocemente gli elementi, come fossero tracce, nel modo desiderato.66 Analogamente a quanto accadde nella prima fase di sviluppo del Capitalismo, l’azienda flessibile è diventata un modello anche per il welfare, che viene “appiattito” (flat welfare) – riduzione del numero di operatori che, a parità di fruitori di servizi, si sostanzia in prestazioni più brevi nel tempo e meno rigide nel contenuto – e si ridimensiona rispetto all’obiettivo di presa in carico del destino individuale degli assistiti (short welfare). Questo doppio 65 66 R. Sennet, op. cit. a nota 39, pp.180-185. Ibidem. Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 117 processo di appiattimento e riduzione degli spazi di presa in carico genera nuove disuguaglianze, per esempio tra utenti più passivi che necessitano una giuda e utenti più indipendenti, che richiedono più risorse67, producendo, da un lato, la monetarizzazione dei servizi – in Italia si parla sempre più di voucherizzazione delle prestazioni sociali68 –, dall’altro, un processo di individualizzazione della scelta della prestazione, in capo a persone sole, “abbandonate” dalle istituzioni. La crisi degli Stati nazionali La trasformazione dello Stato sociale, come ho già accennato, si interseca con la crisi degli Stati nazionali. Questi stanno perdendo la centralità che li ha caratterizzati per circa un secolo a fronte di tendenze economiche globalizzanti69, con la loro carica d’incertezza e capacità distruttiva, ma anche con il loro potere trasformativo e le loro opportunità emancipative70. La formazione dello Stato moderno si è caratterizzata come processo di accentramento, come tendenza dei principi a eliminare con ogni mezzo le autonomie e i centri di potere creatisi nel precedente periodo medievale. Al processo di accentramento è seguita la progressiva sostituzione della pluralità di governi locali e particolari (di natura nobiliare, cittadina ed ecclesiastica) con l’apparato organizzativo di governo facente capo al principe, fino a che la corona divenne l’unico organo costituzionale dell’ordinamento giuri- 67 Ibidem, p. 186. A partire dal 2002 la Regione Lombardia ha vincolato i Comuni a spendere il 70% dei finanziamenti provenienti dal fondo nazionale indistinto per le politiche sociali in cash (voucher o assegni di cura). Questa scelta rientra in una tendenza più ampia alla contrattualizzazione del rapporto tra fornitori e utenti di servizi sociali che sembra attribuire un ruolo più attivo alla “società civile”. Il modello lombardo del “voucher socio-sanitario” costituisce un punto di riferimento per l’elaborazione di politiche sociali a livello nazionale e si fonda su due capisaldi: la libertà di azione dei soggetti impegnati nell’erogazione di servizi e la libertà di scelta del cittadino. Tommaso Vitale analizza la diversa posizione che assumono i destinatari dei servizi in tale nuovo campo organizzativo, sottolineando come il cittadino sia considerato alla stregua di un consumatore, libero di defezionare, ma non di protestare. Si trata di una libertà di scelta che appare astratta, essendo la posizione del cittadino-consumatore asimettrica rispetto a quella del provider di servizi. Cfr. T. Vitale, “Attivazione e contrattualizzazione nel welfare locale: cambia la posizione dei destinatari?”, in La Rivista delle Politiche Sociali, 1, 2005. 69 J. Habermas, Die Postnationale Konstellation. Politische Essays, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1998 (trad. it. La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1999, pp. 39-40). 70 Pulcini parla espressamente di potenziale emancipativo del processo di globalizzazione, vale a dire di una chance, del tutto inedita e sconosciuta a fasi precedenti della modernità, di creare una forma planetaria di legame sociale, a partire dai fattori (in primis paura e incertezza) che sono all’origine dell’attuale crisi del legame sociale. Cfr. E. Pulcini, op. cit. a nota 18, pp. 57-83. 68 118 Capitolo 3 dico detentore della sovranità. Ciò comportò che l’apparato amministrativo e giurisdizionale centrale dovette assumere dimensioni macroscopiche. L’organizzazione amministrativa divenne l’elemento focale della struttura dei nuovi Stati moderni. Il meccanismo adottato dal Principe per eliminare progressivamente i numerosissimi centri di potere che ostacolavano la costruzione della sovranità centrale e per incidere in settori della vita sociale che non venivano toccati dalle forme in cui i poteri feudali si estrinsecavano, consistette nel far leva sull’interesse collettivo dell’ordine e della sicurezza interna (oltre che esterna), come premessa per un benessere comune. Il termine “polizia” è usato nell’ultima fase dell’iter di formazione dello Stato moderno proprio a indicare le finalità generali perseguite dal principe mediante il suo potere sovrano di emettere ordinanze e il conseguente potere di attuazione delle stesse ad opera del suo apparato burocratico di governo. Inizialmente, in alcune ordinanze francesi, i termini police e policitè indicano il migliore e ordinato vivere della collettività, la tranquillità sociale, la buona amministrazione; solo successivamente si riferiscono all’apparato burocratico chiamato a vigilare sull’applicazione delle ordinanze e, infine, a quella parte della burocrazia specializzatasi nella funzione di garantire ordine e sicurezza attraverso l’uso legittimo della forza. Oggi, la trasformazione strutturale del sistema economico mondiale (la globalizzazione, appunto) limita fortemente la capacità di azione degli Stati nazionali, i quali non possono più “ammortizzare” le conseguenze socialmente e politicamente indesiderabili di un mercato transnazionalizzato71. D’altro canto, le decisioni prese legittimamente dagli Stati hanno un raggio d’azione sociale e territoriale che va oltre le frontiere nazionali. Si pensi alla scelta di uno Stato di installare una centrale nucleare sul confine con un altro Stato, di non attuare il protocollo di Kyoto o di non attivare procedure efficaci di smaltimento dei rifiuti: gli effetti di tali decisioni ricadono inevitabilmente sui destini degli abitanti di altri Stati, vicini e lontani. Inoltre, lo Stato sta perdendo la sua funzione regolativa: problemi quali disoccupazione, povertà, crisi economica non possono essere affrontati dagli Stati nazionali se non con misure tanto simboliche quanto inefficaci. Le interdipendenze crescenti della società mondiale, effetto diretto della internazionalizzazione dei mercati e dei consumi e dell’intensificazione degli spostamenti (fisici e virtuali) conseguenti allo sviluppo delle tecnologie, at- 71 J. Habermas, op. cit. a nota 69, p. 21. Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 119 tua una sorta di scissione tra la politica dello Stato e il destino della società nazionale. La crisi dello Stato nazionale è essenzialmente crisi della spazialità nazionale come ambito sufficiente a tenere sotto controllo le variabili fondamentali per assicurare il benessere e la sicurezza dei cittadini72. Va osservato come il suo declino non ne implica necessariamente la scomparsa, ma il suo inserimento in un mix articolato e complesso di istituzioni e attori politici locali, nazionali, regionali e globali. Questa ridefinizione delle dimensioni spaziali degli attori politici produce, tuttavia, nuovi vuoti di legittimità: si accresce la discrepanza tra coloro cui tocca decidere e coloro su cui ricadono gli effetti delle decisioni, creando nei fatti un vuoto di democrazia. Si pensi a quanto sta accadendo in un settore fondamentale (e fondante) dello Stato nazionale: la polizia73. In tale ambito, si sta verificando un doppio processo di privatizzazione: privatizzazione della domanda di sicurezza. Lo Stato non è più il collettore delle domande di sicurezza della società: cittadini e imprese si assumono direttamente l’onere (e la responsabilità) di richiedere e ‘pagare’ servizi di sicurezza. privatizzazione dell’offerta di sicurezza. Lo Stato non è più nemmeno l’unico fornitore di servizi di sicurezza: imprese e privati organizzano e forniscono servizi di sicurezza, sia per il settore privato che per il settore pubblico. Questo doppio processo di privatizzazione è in fase così avanzata che la stessa distinzione tra pubblico e privato risulta problematica: Stato e aziende si alternano come fornitori e destinatari di servizi pubblici e privati di sicurezza. Da una parte, numerosi governi statali e locali stipulano contratti con istituti privati di vigilanza a integrazione del lavoro delle forze di polizia. Dall’altra parte, privati cittadini, associazioni e imprese organizzano attività di auto-protezione, acquistando servizi di sicurezza da imprese private, e, nello stesso tempo, richiedendo l’intervento delle polizie pubbliche. 72 D. D’Andrea, “Prigionieri della modernità. Individuo e politica nell’epoca della globalizzazione”, in D. D’Andrea, E. Pulcini (a cura di), Filosofie della globalizzazione, Edizioni ETS, Pisa, 2002, p. 33. 73 Cfr. D.H. Bayley e C.D. Shearing, The New Structure Of Policing: Description, Conceptualization, And Research Agenda, Washington D.C., U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 2001; I. Loader, “Plural Policing And Democratic Governance”, in Social & Legal Studies, 9, 3, 2000, pp. 323345; J. De Waard, “The Private Security Industry in International Perspective”, in European Journal on Criminal Policy and Research, 7, 2, 1999. 120 Capitolo 3 Inoltre, si sta assistendo, da una parte, alla decentralizzazione, dallo Stato ai governi locali, della responsabilità di organizzare e fornire servizi di polizia e, dall’altra, all’organizzazione su base territoriale delle forze di polizie statali, che rispondono sempre più del proprio operato alla comunità.74 Infine, oltre al coordinamento transnazionale delle polizie di vari Paesi, si stanno creando forze di polizia sovra-nazionali, che agiscono sui territori dei singoli Stati.75 Queste tendenze alla privatizzazione, localizzazione e internazionalizzazione stanno affermando un modello di ordine pubblico caratterizzato dalla frammentazione dei poteri decisionali e delle agenzie operative. Tutto scorre, l’insicurezza emerge Crisi del fordismo, crisi dello Stato sociale e crisi dello Stato nazionale: si ha la sensazione che una grande stagione stia volgendo al termine: «tutto scorre, non esiste stabilità, nemmeno per le promesse della prosperità, della società civile e della democrazia»76. Quali sono le ricadute di questo “scorrimento”, di questa sensazione che il mondo – un mondo, questo mondo – stia per finire, sul precario equilibrio che caratterizza le nostre esistenze? Nei periodi di crisi, caratterizzati da forti turbolenze e da rapidi mutamenti, le situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure. Zygmunt Bauman parla, in questo senso, di “società liquida” 77. La vita è precaria, vissuta in condizioni di continua incertezza 78 . Ciò che principalmente affligge l’uomo tardo-moderno è il timore di essere colti alla sprovvista, di non riuscire a tenere il passo di avvenimenti che si muovono velocemente, di rimanere indietro. Il passaggio da un welfare rigido a un welfare piatto – strettamente connesso alla pressione delle tendenze globalizzanti e alla crisi dell’economia moderna 79 – ha portato alla flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, ma anche alla de-stabilizzazione delle identità80 e alla trasformazione dei paesaggi81. 74 R. Cornelli, “Le forze di polizia in Italia: situazione attuale e prospettive di riforma”, in M. Barbagli (a cura di), Rapporto sulla criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 557-574. 75 A. Recasens i Brunet, “Le polizie”, in R. Selmini (a cura di), La sicurezza urbana, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 233-243. 76 R. Dahrendorf, op. cit. a nota 64, p. 13. 77 Z. Bauman, Liquid Modernity, 2000 (trad. it. Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002). 78 Z. Bauman, Liquid Life, 2005 (trad. it. Vita liquida, Laterza, Roma-Bari, 2006). 79 Vale la pena sottolineare come l’interdipendenza tra Stato sociale e stabilità economica sia molto stretta e biunivoca: non solo il primo è dipeso dalla disponibilità di risorse finanziarie di società divenute Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 121 La flessibilità genera “ansietà” a causa della de-standardizzazione delle carriere: stante la rapidità dei mutamenti del mercato, che ingenerano continui adattamenti nelle modalità (e nei luoghi) di produzione, distribuzione e vendita di prodotti e servizi, nessuno è in grado di prevedere quali rischi valga la pena correre e quali percorsi professionali sia preferibile seguire. L’individuo è condannato a compiere scelte incessanti su basi incerte, con un sovraccarico di responsabilità soggettive e in solitudine.82 La privatizzazione del servizi primari – in campi tradizionalmente occupati dalle politiche di welfare state83 – comporta la perdita di una dimensione collettiva della risposta ai problemi, amplificando la solitudine degli individui nel prendere decisioni “vitali”, quali quelle legate all’esigenza proteggersi dai rischi derivanti dalla perdita del lavoro, della casa, della salute, della stabilità economica. Queste tendenze, che nel complesso possiamo definire deistituzionalizzanti84, e cioè che attraggono verso una società priva di mediazioni e con i nervi scoperti, in cui le istituzioni, patrimonio di intelligenza collettiva, si deteriorano a favore dell’immediatezza delle relazioni sociali, favoriscono la percezione (anche emotiva) dei problemi in termini individuali: ciascuno vive la propria ansia da solo85, tentando di dare soluzioni personali a contraddizioni sistemiche86. Il risvolto della flessibilità che genera più confusione è forse il suo impatto sul carattere dei singoli individui. Il carattere di un uomo dipende dai suoi legami con il mondo, […] Il “carattere” indica soprattutto i tratti permanenti della sua esperienza emotiva tra la moltitudine dei sentimenti in cui tutti noi ci troviamo costantemente immersi siamo sempre impegnati nel tentativo di salvarne e rafforzarne qualcuno. Sono questi sentimenti confermati che plasmeranno il nostro carattere, definendo i tratti personali a cui attribuiamo valore di fronte a noi stessi e in base ai quali ci sforziamo di essere valutati da parte “opulente” e caratterizzate da un’economia stabile, ma anche la stessa stabilità economica è stata sostenuta dall’intervento massiccio del settore pubblico sostenuto da un ampio volume di imposte. Cfr. J.K. Galbraith, The Affluent Society, Houghton Miffin Company, Boston, 1969 (trad. it. La società opulenta, Boringhieri, Torino, 1972, p. 347). 80 Cfr. E. Pulcini, op. cit. a nota 18. 81 Cfr. S. Sassen, Le città nell’economia globale, Il Mulino, Bologna, 1997; G. Martinetti, Metropoli. La nuova morfologia sociale della città, Il Mulino, Bologna, 1993. 82 A. Giddens, op. cit. a nota 18. 83 O. De Leonardis, op. cit. a nota 53. 84 Cfr. O. De Leonardis, Le istituzioni. Come e perché parlarne, Roma, Carocci Editore, 2001. 85 Cfr. Z. Bauman, Community. Seeking Safety in an Insecure World, 2001 (trad. it. Voglia di comunità, Laterza, Bari, 2001). 86 Cfr. U. Beck, op. cit. a nota 46. 122 Capitolo 3 degli altri. Ma com’è possibile perseguire obiettivi a lungo termine in un’economia che ruota intorno al breve periodo? Com’è possibile mantenere fedeltà e impegni reciproci all’interno di aziende che vengono continuamente fatte a pezzi e ristrutturate? In che modo possiamo decidere quale dei nostri tratti merita di essere conservato all’interno di una società impaziente, che si concentra sul momento?87 L’Io tardo-moderno, caratterizzato, nell’epoca dell’ “individualismo proprietario”, da una vocazione auto-affermativa illimitata, ma anche dalla percezione del proprio vuoto e della propria debolezza, si ritrae in una sorta di “solitudine atomistica”88. E se è vero – come sottolineano, tra gli altri, Amartya Sen89 e Alessandro Dal Lago90 – che l’identità si crea nella relazione, o, meglio, nel conflitto con gli altri, in una condizione di estrema variabilità delle relazioni lavorative, familiari, amicali essa si costruisce e si frantuma continuamente, perdendo la sua funzione di “ancoraggio” nella costruzione di relazioni stabili. Per individui attanagliati dall’insicurezza del proprio status sociale, dall’incertezza del futuro, e dalla sensazione di non essere padroni del proprio presente, la tendenza dominante, anche nell’organizzazione degli spazi di vita, è quella di rifugiarsi nell’idea di comunità come spazio purificato e separato dalla società.91 La città contemporanea porta ormai in modo evidente i segni di questa tendenza. Muta lo spazio privato: la casa assume sempre più l’aspetto di una piccola fortezza, protetta da sistemi d’allarme, da inferriate, da telecamere a circuito chiuso, inserita in contesti residenziali sorvegliati92. Le forme architettoniche esprimono l’esigenza di sicurezza negli spazi privati e in quelli commerciali: i grandi shopping centers, così come i villaggi residenziali protetti da vigilantes, appaiono inespugnabili, spesso recintati da mura e filo spinato. «Garitte, mura fortificate, uso di materiali “forti”, scarto enfatizzato 87 R. Sennet, op. cit. a nota 47, p. 10. E. Pulcini, op. cit. a nota 18, p. 58. 89 A. Sen, Liberty and Violence. The Illusion of Destiny, Norton & Company, New York-London, 2006 (Trad. It. Identità e violenza, Editori Laterza, Roma-Bari). Risulta eloquente la citazione di JeanPaul Sartre secondo cui «l’ebreo è un uomo che gli altri uomini considerano ebreo; […] è l’antisemita che fa l’ebreo» (Ibidem, p. 9). 90 Alessandro Dal Lago parla di “identità reattiva in corso d’opera” per sottolineare l’aspetto dinamico dell’identità culturale, che segue e non procede il conflitto tra persone (A. Dal Lago, Lo straniero e il nemico. Materiali per l’etnografia contemporanea, Costa & Nolan, Genova, 1998, pp. 16-22). 91 Z. Bauman, op. cit. a nota 85. 92 Cfr. R. Lopez, “Hautes murailles pour villes de riches. Un nouvel apartheid social”, Le monde diplomatique, marzo 1996, p. 1. 88 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 123 tra interno ed esterno producono l’effetto fortezza nei confronti di un mondo urbano considerato ostile»93. Muta anche la relazione tra spazio privato e spazio pubblico. Gli edifici privati, costruiti con uno stile neo-medievale, comunicano immediatamente agli abitanti e ai city users un’idea diversa di città: insicura fuori, sicura dentro. Evocano la frattura tra spazio privato protetto e spazio pubblico pericoloso. Lo spazio pubblico tende, quindi, a ridursi, subendo un progressivo processo di privatizzazione. Si perde il senso stesso dell’agorà, dello spazio pubblico come spazio aperto a tutti, a vantaggio di un’idea di città come somma di spazi privati, anche collettivi, ma pur sempre fondati su un codice d’inclusione e di esclusione. Lo shopping mall costituisce un esempio emblematico di questa tendenza: è uno spazio affollato di persone, sul modello rinascimentale della città europea delle piazze e dei boulevards. Riproduce l’immagine dello spazio pubblico, pur essendo sicuro come uno spazio privato e dunque “esclusivo”: «lo shopping mall non è altro che un simulacro di città depurato dei suoi aspetti negativi»94. Nato come surrogato della città per coloro che vivevano nei sobborghi-dormitorio privi di qualsiasi luogo di vita sociale95, è diventato oggi, soprattutto nelle megalopoli, una cittadella fortificata nella città, al tempo stesso copia “purificata” della città e modello per la pianificazione della città. Lo shopping mall si propone come modello ideale per qualsiasi spazio pubblico: strade e piazze piacciono solo se somigliano a quelle degli shopping centers: senza traffico, con tanti parcheggi, ma soprattutto sicuri, nel senso di dotati di servizi di vigilanza e di dispositivi elettronici di sorveglianza. «La logica del panopticon elettronico [...] è stata così trasferita al centro urbano che, ancora una volta, per sopravvivere deve imitare lo shopping mall».96 93 G. Amendola, La città postmoderna. Magie e paure della metropoli contemporanea, Laterza, Bari, 1997, p. 216. 94 Ibidem, p. 172. 95 Giandomenico Amendola nota che in molto sobborghi nordamericani lo shopping mall costituisce spesso l’unico luogo di ritrovo, una sorta di centro cittadino. Proprio per questo motivo, la Corte Suprema dello Stato del New Jersey, nel 1994, ha ammesso la libertà di discorso e di volantinaggio nei centri commerciali, riconoscendone il valore di luoghi di attività sociale, e incidendo sulla loro natura di area privata (Ibidem, p. 167). 96 Ibidem, p. 225. In particolare «ogni settimana vengono installati in Gran Bretagna 500 sistemi urbani di sorveglianza televisiva (150.000 sono già operativi) non tanto per evitare la violenza quanto per tranquillizzare i residenti. Le città fanno, esplicitamente della sicurezza del loro centro un fattore di prestigio e di attrazione per cui tutta la nazione è stata informata quando nel ‘94 Glasgow ha messo sotto controllo le sue strade centrali con 32 telecamere». 124 Capitolo 3 Si estende, dunque, anche allo spazio pubblico quel codice di inclusione ed esclusione caratteristico degli spazi privati. Lo spazio pubblico subisce un duplice processo di “privatizzazione” materiale (da luogo pubblico a luogo privato) e ideale (luoghi pubblici assimilabili a luoghi privati in termini di accessibilità esclusiva). Citywalk ne è un esempio eloquente. Si tratta di un complesso nei pressi di Los Angeles, a metà tra il centro commerciale e il parco dei divertimenti, che offre ai visitatori (munti di biglietto d’ingresso, ovviamente) la possibilità di passeggiare «in una Los Angeles purificata in cui regna il controllo sociale»97. L’obiettivo degli ideatori del progetto è di restituire agli abitanti di una Los Angeles malconcia e pericolosa, la Los Angeles di un tempo onirico privo di violenza e criminalità. Ma questa ricerca di un rifugio non produce quasi mai la sicurezza sperata. Un interessante studio etnografico su Hampton, tipico suburb americano (città satellite della grande città, meta di residenza del ceto medio-alto bianco, in cui si conducono stili di vita più o meno omogenei), ha mostrato come anche in presenza di un tessuto sociale estremamente coeso e compatto, il problema della sicurezza non venga meno. il timore e l’insicurezza nascono in questo mondo protetto principalmente dalla possibilità dell’infiltrazione, dell’ingresso di estranei all’interno di un territorio reso sicuro dall’omogeneità e dal controllo sociale esercitato con la conoscenza diretta del vicinato. Lo dimostra il fatto che il numero medio delle chiamate urbane ricevute dalla polizia locale in un giorno, rapportato alla popolazione, è simile alla media giornaliera di chiamate in città come Chicago che hanno un ben altro livello di criminalità reale.98 3.4 Crisi della solidarietà e incertezza. Verso una “fraternità” debole Premessa Dopo un lungo silenzio nel pensiero politico moderno, il terzo vertice della promessa moderna, la fraternità, viene “riscoperta”, in conseguenza di una presa di coscienza della crisi contingente di quelle forme di appartenen- 97 Cfr. R. Lopez, “Deliri di autodifesa a Los Angeles”, Le monde diplomatique-Il Manifesto, maggio 1994, p. 4. 98 Cfr. A. Petrillo, “L’insicurezza urbana in America”, Aut-Aut. Dentro/Fuori, 275, sett.-ott. 1996, p. 89. Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 125 za basate sul concetto di “nazione” e di “classe sociale” che hanno consentito la formazione di legami di solidarietà tra individui e comunità. Èmile Durkheim, osservando le trasformazioni sociali connesse alla prima industrializzazione, riteneva fosse possibile una transizione da forme di solidarietà premoderne, garantite dall’adesione di tutti i membri di una comunità a una coscienza collettiva superiore, a forme di solidarietà nuove, fondate sulla cooperazione tra soggetti diversi e autonomi. Al contrario, oggi si ha la sensazione di essere in un’ulteriore fase di passaggio: lo sviluppo capitalistico, quello tecnologico e il pluralismo – etico, religioso, culturale, giuridico, etnico – stanno mettendo fortemente in crisi la capacità di regolazione sociale e giuridica, con il rischio di un’insufficiente costruzione di legami di solidarietà. Il Diritto – innanzitutto la sanzione penale – sembra non assolvere più la funzione di mantenimento della coesione sociale indicata da Durkheim: perde la sua capacità di definire i confini della moralità di una società, di produrre forme di integrazione e di socialità. L’esigenza di costruire nuovi legami di appartenenza orienta gli individui – soli nei luoghi del lavoro, privi di riferimenti istituzionali e regolativi, piccoli di fronte all’enormità dei rischi tecnologici e ambientali – verso forme di fraternità etnico-razziali, territoriali e religiose che indeboliscono ulteriormente la capacità di produzione di un ordine morale condiviso. L’approfondimento di questi temi porta a individuare ulteriori sfaccettature del sentimento d’insicurezza tardo-moderno che s’intersecano con il tema della crisi della capacità di produrre ordine in società capitalistiche avanzate, pluraliste e dominate dalla Tecnica e dal rischio. La fraternità dimenticata In età moderna, il valore della fraternità è stato proclamato sul piano politico, soprattutto a seguito della Rivoluzione francese, in simbiosi con quelli di libertà e uguaglianza. Purtuttavia, gli elementi del trinomio non hanno esercitato la stessa valenza ideale nella costruzione della modernità: la fraternità è stata posta ai margini, tanto da costituire una curiosa “assenza” nel pensiero politico moderno. La disputa ormai secolare tra liberalismo, socialismo e democrazia si è pressoché esclusivamente concentrata sui due poli della libertà e dell’eguaglianza, ponendosi ora il problema di distinguere tra le due dimensioni, ora di coniugarle in una sintesi superiore o semplicemente accettabile. Su questa tensione bipolare si è lungamente esercitato il complesso di dottrine politiche, economiche e sociali che si riferiva a ciascuna di quelle grandi opzioni ideali o ai loro più o meno fortunati, tentativi di composizio- 126 Capitolo 3 ne; liberaldemocrazia, socialdemocrazia, “socialismo liberale”. Dentro questa vicenda, la fraternité si presenta – almeno sotto il profilo teorico – come la dimensione dimenticata.99 Se, dunque, libertà e uguaglianza sono diventati importanti valori giuridici, riconosciuti in modo espresso da molte costituzioni moderne, la fraternità, al contrario, è stata collocata più che altro su un piano morale e sociale. A volte, è stata considerata come semplice “correttivo” all’attuazione dei primi due valori, come «meccanismo di regolazione dell’espansione dei diritti, come ambiente di composizione dei loro possibili conflitti»100: proprio in vista della fraternità la libertà può accettare limiti per realizzare una certa uguaglianza, e d'altronde quest'ultima, sempre in vista della fraternità, può acconsentire a frenare la propria espansione per non comprimere troppo la prima. A ben vedere, più che un correttivo, la fraternità è stata una vera e propria “spina nel fianco” per l’universalismo moderno, in quanto, ponendo la questione del legame, del vincolo solidaristico-comunitario, scardina la logica individualistica a cui rispondono i valori di libertà e uguaglianza, enfatizzati nelle dottrine del liberalismo e del socialismo, e propone con forza il tema dell’appartenenza, altrettanto importante rispetto a quello della cittadinanza.101 Già prima della rivoluzione francese la fraternità era sentita come un valore che qualificava determinati rapporti e che poteva tradursi in conseguenze giuridiche. Ne sono esempi: il tentativo, in epoca romana, di estendere le caratteristiche delle relazioni tra fratelli di sangue a persone con le quali tali vincoli non esistevano; l'istituto medievale dell'affratellamento, allo scopo di costituire fra due o più persone relazioni strette di solidarietà e di aiuto reciproco, su un piano di parità e nell'ambito di una comunione patrimoniale. 102 Pochi decenni dopo la Rivoluzione, invece, di fraternità non si parlò quasi più: a tale concetto si sostituì gradualmente quello di “solidarietà”, o, meglio l’uno si sostanziò nell’altro103, divenendo criterio descrittivo dell’ordine so- 99 G. Marramao, op. cit. a nota 13, p. 35. F. Pizzolato, “Appunti sul principio di fraternità nell'ordinamento giuridico italiano”, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, XIX, n. 3, 2001, p. 774. 101 Cfr. G. Marramao, op. cit. a nota 13, pp. 35-36. 102 Cfr. F. Goria, “Relazione introduttiva”, Atti del convegno su Riflessioni su fraternità e diritto, Castelgandolfo, 18 novembre 2005. 103 Sull’ “intreccio” tra i concetti di solidarietà e fraternità si veda. F. Pizzolato, Appunti, cit., pp. 747 e ss.., in particolare quando l’autore, citando Borsetto, sostiene che “la fraternità può essere considerata al tempo stesso, come il passato, il presente e l’avvenire della solidarietà: il passato poiché su questo princi100 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 127 ciale – per esempio in Durkheim, come si vedrà più avanti – più che criterio valoriale dell’agire politico. La mancata rilevanza, in epoca moderna, della fraternità come principioguida dell’azione politica ha lasciato irrisolto il paradosso tra universalismo giuridico e differenze: l’estensione universalistica dei diritti, attuata a partire dal riconoscimento di un nuovo statuto individuale – “individuo come entità autonoma” – ha risolto il tema dell’appartenenza nella costruzione del concetto di Nazione o, nell’altra grande narrazione moderna, del concetto di Classe, che pongono il problema di un’identificazione simbolica non affrontata dai due ideali della libertà e dell’uguaglianza.104 Nell’epoca della costellazione postnazionale105 e del neo-liberismo, la fraternità rientra prepotentemente nel dibattito politologico e socio-giuridico: costituisce un bisogno concreto di appartenenza, non alla società in senso astratto, bensì a un “luogo” specifico; costituisce quella spinta a identificarsi, a trovare riferimenti identitari condivisi, che oggi viene considerata, tra le altre cose, fondamento di un’ambigua “voglia di comunità”106, che si sostanzia nella ricerca di libertà, di stabilità, di appartenenza, ma che si risolve, paradossalmente, in chiusura identitaria, insicurezza e isolamento. La fraternità acquisisce anche un significato epistemico all’interno dei recenti tentativi di costruzione di un diritto che affermi un “codice fraterno” e alternativo alla logica dell’amico-nemico – la quale ha prodotto, al contrario, un «diritto chiuso nell’angustia dei confini statali»107 e politiche ossessionate dall’idea della “neutralizzazione dell’ostilità”108. Deviando lo sguardo dal codice dell’amico-nemico e liberandosi da quella singolare ossessione della politica come idea della neutralizzazione dell’ostilità, si aprono altri orizzonti. I codici fraterni stanno lì a ricordarceli: non è detto che sempre il controllo delle procedure normative debba essere rivolto a coltivare stati di devozione interna grazie alla definizione del nemico.[…] Valga per tutti l’esempio delle legislazioni nei confronti dell’immigrazione, dove paurosamente l’inimicizia si riaffaccia: è vero che purtroppo questo accade e che prevale il miope egoismo di chi pensa in chia- pio i rivoluzionari del 1789 e del 1848 si sono fondati per istituzionalizzare la solidarietà; il presente , poiché anche nell’attuale ordinamento francese il principio di solidarietà è colto come applicazione (componente) della fraternité, il futuro, poiché la fraternità è riscoperta contro la tendenza alla “burocratizzazione” della solidarietà istituzionale”( p. 747). 104 Cfr. G. Marramao, op. cit. a nota 13, p. 36. 105 J. Habermas, op. cit. a nota 69. 106 Z. Bauman, op. cit. a nota 85. 107 E. Resta, Il diritto fraterno, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. XII. 108 Ibidem, p. XIII. 128 Capitolo 3 ve di piccole e sterili devozioni, ma potrebbe essere diversamente, e non sempre queste altre possibilità sono adeguatamente coltivate.109 Senza alcuna pretesa di ricostruire una – sia pure breve – storia della fraternità nell’epoca moderna, di seguito intendo discutere la tesi secondo cui il rinnovato interesse per questo concetto non sia determinato dalla recente “scoperta” della sua marginalità nel Diritto e nella Politica, bensì costituisca la necessaria reazione a una “crisi della solidarietà”, vale a dire di quella forma di fraternità che si è sviluppata a partire dalla Rivoluzione industriale e che nella situazione attuale mostra tutta la sua fragilità. In questo senso, l’attenzione per la “fraternità” è conseguenza di una presa di coscienza della sua crisi contingente: è frutto della necessità di costruire, nel mondo tardo-moderno, nuove forme di appartenenza – e nuove forme di regolazione giuridica a loro sostegno – che consentano il consolidamento di legami tra “entità isolate” (individui e comunità). Da società meccaniche a società organiche Ne La divisione del lavoro sociale110, Èmile Durkheim individua una tendenza di fondo della società verso una sempre maggiore complessità, che comporta profondi cambiamenti non solo nell’organizzazione del lavoro, ma anche nel modo in cui le persone interagiscono tra loro. Si assiste, in particolare, a una progressiva e sempre più accentuata divisione del lavoro, che lo studioso francese considera positivamente perché corrisponde al bisogno sociale della solidarietà – differenziandosi in questo dalla visione utilitaristica espressa da Adam Smith, secondo cui la divisione del lavoro serve ad aumentare la felicità degli uomini mediante il buon funzionamento del “sistema dei fini egoistici” –; la divisione del lavoro costituisce, dunque, il fondamento della morale durkheimiana. Infatti: «in virtù di essa l'individuo ridiventa consapevole del suo stato di dipendenza nei confronti della società e del fatto che da questa provengono le forze che lo trattengono e lo frenano. In una parola, diventando la fonte eminente della solidarietà sociale, la divisione del lavoro diventa anche la base dell'ordine morale». 109 Ibidem, pp. XIII e XIV E. Durkheim, De la division du travail social, Alcan, Paris, 1993 [1893] (trad. it. La divisione del lavoro, Edizioni di Comunità, 1996). 110 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 129 Durkheim intende descrivere la corrispondenza tra differenti livelli di sviluppo della divisione del lavoro e i differenti tipi di solidarietà. Vengono esaminati due principali tipi di solidarietà: 1) la “solidarietà meccanica”, propria di una società formata da una uniformità di parti, di “segmenti” sociali elementari. Il termine “meccanica” – sottolinea Durkheim – «non significa che essa venga prodotta da mezzi meccanici ed artificialmente: diamo questo termine solo per analogia con la coesione che unisce tra loro gli elementi dei corpi bruti, in antitesi a quella che costituisce l’unità dei corpi viventi»111. In questo tipo di società le coscienze individuali soggiacciono a una coscienza collettiva di tipo religioso, sociale o cosmologico, la quale ha il compito di reprimere tutto ciò che urta contro sentimenti, pratiche, credenze, condivisi in maniera molto intensa dalla collettività. Le regole giuridiche sono perciò a “sanzione repressiva”. 2) la “solidarietà organica”, propria di una società formata da un sistema di organi differenti, ognuno dei quali ha un compito specifico, e in cui l'emergere delle coscienze individuali testimonia il progredire della divisione del lavoro. L'unità sociale non è più basata su una coscienza collettiva sovrastante ma piuttosto su una moralità data dalla cooperazione reciproca, dal riconoscimento del proprio ruolo, e quindi su una “moralità intrinseca”. Mentre la solidarietà meccanica «implica una somiglianza tra gli individui, questa [la solidarietà organica] presuppone la loro differenza. La prima è possibile soltanto nella misura in cui la personalità individuale è assorbita dalla personalità collettiva; la seconda è possibile soltanto se ognuno ha un proprio campo di azione, e di conseguenza una personalità»112. Più complesse diventano le società, più complesso e specializzato diventa il lavoro. Nelle società industrializzate, con il potenziamento delle vie di comunicazione e lo sviluppo delle città, aumentano le possibilità di contatto al di fuori dei gruppi sociali tradizionali e la divisione del lavoro progredisce quanto più numerosi sono gli individui sufficientemente a contatto da poter agire e reagire gli uni con gli altri. All’aumentare della divisione delle funzioni, dunque, aumenta la produzione della solidarietà e della cooperazione tra le persone. Purtuttavia, l’industrializzazione ha alimentato anche due forme di divisione del lavoro anti-solidali: quella “anomica” e quella “coercitiva”. La divisione anomica è priva di regole precise tra le parti (anomia) e dà origine a contrasti. Un esempio è “l'antagonismo del lavoro e del capitale” 111 112 Ibidem, p.145 Ibidem 130 Capitolo 3 nell'ambito della grande industria. Questo antagonismo – secondo Durkheim – nasce soprattutto dal fatto che la divisione del lavoro, quale esiste nella grande industria, ha l'effetto di «diminuire l'individuo riducendolo al ruolo di una macchina. Effettivamente, se egli non sa a che cosa tendono le operazioni che gli sono richieste, se non le collega a nessun fine, non può assolverle che per abitudine. Tutti i giorni egli ripete i medesimi movimenti con monotona regolarità, ma senza interessarsi ad essi e senza comprenderli». La divisione coercitiva si ha quando la distribuzione delle funzioni sociali non corrisponde più alla distribuzione dei talenti naturali. «La sola causa che determina […] la maniera in cui il lavoro si divide è la diversità delle capacità. La distribuzione avviene quindi per forza nel senso delle attitudini, poiché non c'è ragione che la si faccia altrimenti». Se così non avviene, si ha una divisione coercitiva del lavoro, in cui il rapporto tra talenti e ruolo lavorativo non è omogeneo e genera antagonismo. Durkheim insiste sul fatto che la divisione del lavoro assolva principalmente la funzione di produrre solidarietà sociale, spiegando che «la divisione del lavoro non produce la solidarietà a meno che essa non sia spontanea e nella misura in cui lo è».113 Per far sì che ciò accada, occorre superare la divisione anomica e coercitiva, facendo in modo che la divisione del lavoro si avvicini sempre più all'ideale di spontaneità che abbiamo definito. Se esse [le società organizzate] si sforzano – e debbono sforzarsi – di annullare quanto più possibile le disuguaglianze esteriori, ciò avviene non soltanto perché è una lodevole impresa, ma perché la loro stessa esistenza è impegnata nel problema. Infatti possono persistere soltanto se tutte le parti che le formano sono solidali, e la solidarietà non è possibile che a questa condizione.114 Il problema dell’anomia, dunque, non si situa nel passaggio da una società meccanica a una società organica, bensì nel venire meno, o nel mancato raggiungimento di una solidarietà di tipo organico per determinati individui e settori della società. L’anomia, che per lo studioso francese è l’inadeguatezza delle norme morali rispetto al livello raggiunto dallo sviluppo della divisione del lavoro, non emerge se le forme della solidarietà sociale si trasformano con il trasformarsi della società. Quando, invece, si verifica uno scarto tra l’aumento della divisione del lavoro, da un lato, e le forme di solidarietà e di coscienza collettiva, dall’altro, e cioè quando la solidarietà e 113 114 Ibidem, p. 370 Ibidem Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 131 la coscienza collettiva non riescono più a dar ragione all’individuo del tipo di società in cui vive115, allora l’unità della società si scompone. Con questa impostazione teorica Durkheim cerca di rispondere a due problemi tra loro connessi: quello, molto avvertito all’epoca, dell’ “individualismo” e quello del fondamento morale della società. Il suo principale interrogativo è il seguente: come può rimanere unita e integrata una società sottoposta a continue forme di differenziazione e che presenta sempre più numerose modalità di individualizzazione? Il tema è quello della coesione sociale, che caratterizza buona parte della sociologia del Novecento. In aperta polemica con il britannico Herbert Spencer, il quale, sulla base di una teoria di tipo evoluzionistico, aveva indicato nel contrattualismo – in una società basata sullo scambio – il livello più elevato della società moderna, e con un atteggiamento diffidente nei confronti dei movimenti socialisti, che vedeva come forze destinate ad accentuare la separazione tra classi e, di conseguenza, il processo anomico116, Durkheim rifiuta di pensare che l’utilitarismo sia l’unico collante sociale possibile delle società moderne, sempre meno fondate sul riferimento ad autorità religiose, e considera i codici giuridici non come manifestazione della volontà delle parti, bensì come espressione formale dei codici morali di una società. La solidarietà sociale è un fenomeno morale che non si presta di per sé a un’osservazione esatta, né, tanto meno, a essere misurata. Occorre, quindi, studiare la solidarietà sostituendo il fatto interno che ci sfugge con il fatto esterno che lo simbolizza. È il “diritto”, dunque, come “simbolo visibile” della solidarietà, che permette una «classificazione delle differenti specie di solidarietà sociale» e di stabilire se la divisione del lavoro costituisce «un fattore essenziale della coesione sociale»117. In una società fondata sulla solidarietà di tipo meccanico, come abbiamo già indicato, la difesa di pochi valori fortemente sentiti e condivisi dalla coscienza collettiva avviene attraverso un “diritto repressivo” che prevede il ricorso alla sanzione penale. Una società, invece, fondata sulla solidarietà di tipo organico, è segnalata dal diffondersi del “diritto restituivo”: un sistema definito che comprende il diritto domestico, il diritto contrattuale, il diritto commerciale, il diritto delle procedure, il diritto amministrativo e costituzionale. 115 D. Melossi, op. cit. a nota 23, p. 73. Ibidem, pp. 73-75. 117 E. Durkheim, op. cit. a nota 110, pp. 85-86. 116 132 Capitolo 3 Le relazioni regolate da tali diritti sono completamente diverse dalle precedenti: esse esprimono un concorso positivo, una cooperazione che deriva essenzialmente dalla divisione del lavoro. 118 È un tipo di diritto caratteristico di una società nella quale vengono privilegiati l’individualismo e la sua espressione più manifesta, il contratto119. Le società semplici prevedono pene severe crudeli; al contrario nelle società che si muovono verso la solidarietà organica si sviluppano sanzioni restitutive proprie del diritto civile. Il processo di differenziazione sociale di divisione del lavoro porta a una minore “densità morale della società”, sostituita però da nuovi valori e credenze etiche, le quali, tuttavia, necessitano di protezione attraverso nuove forme di regolazione giuridica. In ogni caso, nelle società complesse la sanzione penale non scompare, poiché la sua funzione, che non è – come si pensa abitualmente – quella di «correggere il colpevole [o di] intimidire i suoi possibili imitatori», bensì quella di «mantenere intatta la coesione sociale, conservando alla coscienza comune tutta la sua vitalità»120, è essenziale in ogni società in quanto permette, in un certo senso, di stabilire i suoi confini morali. Per chiarire meglio questo concetto, vale la pena riprendere le parole di Dario Melossi circa la normalità del fenomeno criminale in Durkheim: la “normalità” del fenomeno criminale risiede, in altre parole, nell’esigenza di circoscrivere un’area morale nella quale la maggior parte della società si riconosce, e che è alla base del suo senso d’identità di gruppo e di coesione sociale. Non si tratta tanto, quindi, di definire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato: l’importante, dal punto di vista della funzione sociale di un concetto di devianza (e di reazione sociale a questa), è l’esistenza di tale distinzione, a prescindere dai suoi contenuti (che sono storicamente e socialmente relativi).121 La fiducia durkheimiana nella capacità della società di esprimere, attraverso nuove forme di regolazione giuridica, i nuovi valori, le nuove credenze, la nuova coscienza collettiva, derivanti dalla torsione della società verso forme di solidarietà organiche, oggi appare anacronistica. La sensazione dominante è che lo sviluppo economico capitalistico (1), lo sviluppo tecnologico (2) e il pluralismo – etico, religioso, culturale, giuridico, etnico – (3) stia- 118 Ibidem, p. 138. D. Melossi, op. cit. a p. 23, p. 73. Ibidem, p. 126. 121 Ibidem, p. 82. 119 120 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 133 no mettendo fortemente in crisi la capacità di regolazione sociale e giuridica, con il rischio di un’insufficiente costruzione di legami di solidarietà. Crisi della regolazione giuridica (1). Le paure del Capitalismo Nella storia del Capitalismo moderno, accanto a innumerevoli crisi finanziarie, di settore o riguardanti singoli Paesi, si possono osservare quattro crisi di portata planetaria, distanziate tra loro di circa cinquanta-sessanta anni.122 La prima si verificò alla fine delle guerre napoleoniche: il calo strutturale della domanda, legato al calo di forniture militari e al nuovo innalzarsi di barriere protezioniste nel periodo della Restaurazione, si unì a un fatto traumatico, rappresentato dalle due annate agricole disastrose del 1816 e del 1817.123 Nel 1873 si ebbe la seconda crisi che riguardò un centro finanziario periferico, la Borsa di Vienna, ma che fu in grado di trascinare rapidamente Berlino, Parigi e Londra, varcando anche l’Atlantico e creando milioni di disoccupati.124 Il “Grande Crollo” della Borsa di Wall Street del 1929 fu un evento planetario, che ebbe ripercussioni sull’economia mondiale tra il 1929 e il 1933, creando un numero di disoccupati e un abbassamento delle condizioni di benessere economico che durò fino agli inizi degli anni Cinquanta.125 Infine, la quarta crisi planetaria derivò da un complesso mutamento di rapporti economico-politici concretizzatosi nello shock petrolifero dell’ottobre del 1973126. «La storia dei vent’anni dopo il 1973 – sostiene lo storico Eric J. Hobsbawm – è quella di un mondo che ha perso i suoi punti di riferimento e che è scivolato nell’instabilità e nella crisi». Il Capitalismo – come anche Ernesto De Martino aveva indicato e, prima ancora, lo stesso Karl Marx127 – ha sempre dovuto convivere con la prospettiva del proprio imminente tracollo, derivante da una crisi interna – una crisi talmente grande da mettere in discussione il concetto stesso del mercato come meccanismo di regolazione sociale – o da cause esterne – il “pericolo 122 M. Deaglio, “La paura delle crisi”, in S. Riscossa (a cura di), Le paure del mondo industriale, Editori Laterza, Roma-Bari, 1990, p. 130. 123 Ibidem, p. 131 124 Ibidem, pp. 131-132 125 E. Hobsbawm, op. cit. a nota 34, pp. 107-120. 126 M. Deaglio, op. cit. a nota 122, pp. 132-133. 127 K. Marx, Il Capitale, Utet, Torino, 1974 (libro I, cap. XXV). 134 Capitolo 3 rosso”, le paure che il Capitalismo sia sopraffatto o abbattuto da chi non ne fa parte, da chi contesta il sistema del mercato o la proprietà privata. La paura della crisi, dunque, costituisce un tratto endemico della cultura capitalistica, ma, al tempo stesso, è anticipatrice di una catastrofe mai verificatasi. La storia delle quattro crisi planetarie e delle exit strategies conseguenti dimostrano che «la ruota del Capitalismo, che per quattro volte sembrava essersi forse definitivamente arrestata, per quattro volte ha ripreso a girare con velocità crescente»128. È come se la paura della crisi contenesse in sé il proprio anticorpo. Le risposte alla crisi degli anni Trenta, dopo i primi anni di stasi e contrazione, diedero origine al modello keynesiano di politica economica e alla costruzione del welfare state, diretti ad ampliare la domanda di beni e servizi – in funzione di un allargamento della popolazione che consuma – e a costruire un sistema di protezioni dai rischi dell’economia di mercato. A più di trent’anni dalla crisi petrolifera del 1973 possiamo rilevare come le exit strategies siano state di segno molto diverso. Alla caduta del saggio dei profitti è seguita, negli anni Settanta, la nascita della "New Economy", una strategia economica fondata sulla ricerca di nuovi sbocchi produttivi e, soprattutto, sul passaggio dalla produzione di merci alla produzione di denaro a mezzo dello stesso. Si è verificata, in altre parole, una crescita a dismisura della Borsa e della Finanza, istituzioni che – come è stato dimostrato – non portano una vera e propria crescita economica, ma forti arricchimenti individuali. Globalizzazione e finanziarizzazione dei capitali diventano i due cardini della risposta alla crisi degli anni Settanta. Abbiamo già osservato come la crisi del fordismo, dello Stato sociale e dello Stato-nazione abbiano esacerbato le condizioni di precarietà dell’uomo tardo-moderno. Abbiamo anche rilevato come il declino dello Stato nazionale e la conseguente ri-definizione delle dimensioni spaziali degli attori politici abbia prodotto nuovi vuoti di legittimità e deficit democratici. Vale la pena ora insistere su un altro aspetto, più specifico, che riguarda la sfiducia emergente nella sufficienza delle misure giuridiche – e più in generale nella politica – rispetto alla regolazione dell’economia di mercato e i suoi effetti sulla stessa impossibilità di pensare a vie d’uscita collettive alla crisi del Capitalismo. 128 M. Deaglio, op. cit. a nota 122, p. 13. Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 135 Guido Rossi, ne Il conflitto epidemico del 2003, pone l’accento sulla crisi del Capitalismo finanziario e dell’economia di mercato. È, come ho già rilevato, un argomento tipico del pensiero capitalista, che Rossi sviluppa in modo originale con riferimento al declino dell’ “etica”, quale freno alla bramosia di denaro e potere. Tale declino si rende manifesto – secondo l’autore – nell’attuale epidemia del conflitto d’interessi tra gli attori della scena economica, definito come vera e propria patologia che potrebbe mettere a repentaglio la logica del libero scambio e dell’economia di mercato. La fotografia della crisi del Capitalismo fornita dallo studioso italiano è impietosa. Il mercato patisce gli opportunismi dei singoli, che agiscono per il loro esclusivo interesse, non badando alle ragioni altrui: «abbandonati a se stessi, non sorretti da opportune regolamentazioni, i mercati – soprattutto quelli finanziari – non obbediscono ai meccanismi virtuosi che molti considerano loro propri, ma tendono a incoraggiare manipolazioni e frodi. Più diventano sofisticati, più richiedono una disciplina attenta e capillare»129. L’avidità di denaro, fino a poco tempo addietro contenuta entro limiti fisiologici – anche grazie alla presenza di un’etica ampiamente diffusa nella comunità –, ha rotto gli argini, rendendo insufficiente ogni misura giuridica, sia essa penale o non penale130. Tralasciando di considerare la natura “epidemica” del conflitto, che muove l’analisi dell’autore sulle macrotrasformazioni del Capitalismo, mi preme soffermarmi sulla proposta avanzata per uscire da questa crisi. Per Rossi, il richiamo dei Legislatori a codici etici di autoregolamentazione, destinati a risolvere con comportamenti onesti conflitti reali o apparenti, costituisce la prova di una incapacità interna dell’ordinamento giuridico di superare il problema; così, «nello scenario che si apre davanti a noi, non sembrano offrirsi alternative reali a un recupero della moralità individuale».131 Il rimedio alla crisi è rimesso, quindi, alla rifondazione di una nuova etica individuale, capace di far nascere in ogni singolo operatore economico una “coscienza di sé” in grado di dar vita a una nuova “cultura della vergogna”. Solo l’intimo convincimento individuale della necessità di tenere una condotta regolata può garantire il funzionamento di un sistema economico, in cui sono gli stessi operatori a fissare di comune accordo il regolamento dei loro interessi. Nonostante all’inizio del libro Rossi sostenga che sarebbe necessario inter- 129 G. Rossi, Il conflitto epidemico, Adelphi, Milano, 2003, p. 16. Cfr. F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 13. 131 G. Rossi, op. cit. a nota 129, p. 141. 130 136 Capitolo 3 venire dall’esterno, con prescrizioni eteronome e che occorrerebbe sostituire all’anomia propria dell’individuo l’ordine proprio della legge132, è evidente come il nucleo centrale della sua tesi poggi principalmente sul “rinnovamento morale” di ciascun operatore economico, sulla natura individualistica, direi quasi intima, della risposta alla crisi. La riserva utopica dello Stato sociale – come è evidente – ha smesso di essere attrattiva persino nei periodi di crisi. Nel pensiero economico-politico dominante, l’idea di una “regolazione sociale” delle relazioni economiche – ma anche di quelle sociali – crolla per effetto dell’impensabilità di una exit strategy collettiva. Il destino del mondo sembra dipendere unicamente dal singolo individuo e dalla sua capacità di auto-regolarsi, stante la dichiarata impossibilità di regolare la crisi – endemica o epidemica – attraverso il Diritto. A partire da queste riflessioni, si potrebbe dire che la società tardomoderna sia insicura non solo perché lo smantellamento e la frammentazione delle istituzioni del welfare ha fatto sì che molte persone vivano anch’esse in una condizione frammentata e precaria (par. 3.2), ma anche perchè quest’opera di smantellamento istituzionale non ha prodotto – come, invece, i movimenti della Sinistra anti-istituzionale degli anni Sessanta e Settanta auspicavano – un mondo orientato in senso comunitario, nel quale ognuno sarebbe diventato più sensibile ai bisogni dell’altro, e in cui le relazioni sarebbero state dirette, faccia a faccia, basate sulla fiducia e sulla solidarietà.133 La risposta al deficit della durkheimiana solidarietà meccanica, determinatosi a seguito della rivoluzione industriale, è stata la costruzione della burocrazia, prima, e delle istituzioni del welfare, poi, le quali hanno prodotto forme di solidarietà nuove, fondate su relazioni orizzontali (nelle fabbriche, nei dopo-lavoro, nelle scuole, nei servizi) e su relazioni verticali (impresedipendenti; welfare state-assistiti; istituzioni democratiche-cittadini) che hanno costituito una base di fiducia per pensare al futuro. Ma se quelle istituzioni si frammentano, quali valori e quali pratiche possono tenere insieme le persone? È davvero pensabile rispondere alla crisi del legame sociale attraverso il risveglio di una morale individuale, sia pure moltiplicata per il numero degli abitanti della Terra? 132 Ibidem, p. 16. R. Sennet, The Culture of the New Capitalism, Yale University Press, New Haven-London, 2006 (trad. it. La cultura del nuovo Capitalismo, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 7). 133 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 137 In uno scenario in cui la tendenza dominante è quella alla deistituzionalizzazione e de-collettivizzazione, le tre sfide che l’individuo tardo-moderno deve fronteggiare riguardano il tempo, la qualifica e la disponibilità a rinunciare alle abitudini e a staccarsi dal passato134. Le istituzioni – come osserva De Leonardis135 – dotano gli individui di mappe cognitive, che guidano il loro agire sociale, indicando le cose da vedere e come interpretarle. Se smettono di costituire un quadro stabile di riferimento, il singolo individuo perde quegli orientamenti culturali ed esperienziali fissati in ogni biografia istituzionale, trovandosi costretto a improvvisare la propria biografia, oppure cavarsela senza pretendere che il senso della propria identità trovi sempre conferme. 136 In questa ottica, la prima sfida dell’uomo tardo-moderno, privo di mediazioni istituzionali, ha a che fare con la difficoltà di gestire relazioni precarie e a breve termine, esito di un vagare da un’attività all’altra, da un lavoro all’altro, da un luogo all’altro. La seconda sfida riguarda il fatto che nell’economia moderna, molte abilità hanno vita breve: più che verso un’impostazione artigianale, secondo cui ognuno impara a fare bene una cosa soltanto, la cultura moderna si orienta verso un ideale di meritocrazia, che guarda alle potenzialità più che all’esperienza. Connessa a quest’ultima, la terza sfida riguarda la disponibilità a rinunciare ad abitudini e a staccarsi dal passato137. Queste sfide portano alla frammentazione delle relazioni di solidarietà – che necessitano, al contrario di stabilità, tempo, fiducia nelle capacità proprie e altrui fondata sull’esperienza. L’ideale della fraternità, che in epoca moderna prende forma nel concetto di solidarietà, oggi perde sempre più rilevanza, rendono la precarietà ancora più intollerabile. Max Weber, in Economia e società, aveva descritto chiaramente la relazione tra ascesa dell’economia capitalista e declino del valore della fraternità: il mercato, abbandonato alla sua autonormatività, conosce soltanto la dignità della cosa e non della persona, non doveri di fratellanza e di pietà, non relazioni umane originarie di cui le comunità personali siano portatrici. Queste costituiscono altrettanti ostacoli al libero sviluppo della nuda comunità di mercato; e gli specifici interessi di questa, a loro volta, costituiscono la specifica base di prova di tutte queste relazioni […] Il mercato “libero”, cioè non vincolato da norme etiche, con il suo sfruttamento 134 Ibidem, pp. 8-9. O. De Leonardis, op. cit. a nota 84, pp. 52-59. R. Sennet, op. cit. a nota 133, p. 9. 137 Ibidem. 135 136 138 Capitolo 3 della costellazione degli interessi e della situazione di monopolio, con il suo mercanteggiare è considerato da ogni etica come cosa indegna di fratelli. Il mercato, in antitesi a tutte le altre comunità che presuppongono sempre la fratellanza personale, e per lo più una parentela di sangue, è alla sua radice estraneo ad ogni fratellanza.138 Il mercato non è una Gemeinschaft, ma una Gesellschaft, e come tale frantuma tutti i legami di solidarietà tradizionali, a esclusione di quelli dettati dal calcolo utilitaristico dei costi e dei benefici, portando a un “universale sradicamento”. Il processo della modernità capitalistica costituisce un evento unico […] perché si realizza attraverso un rivoluzionamento dei valori e una radicale rottura dei vincoli comunitari che facevano consistere le cerchie di vita tradizionali. L’affermarsi dell’universalismo moderno viene così a coincidere con l’esperienza dell’universale sradicamento.139 Dunque, il primo processo di proletarizzazione e l’attuale processo di destandardizzazione del lavoro si sono caratterizzati in termini di “sradicamento”: nel primo caso, lo sradicamento derivò dall’erosione dei vincoli comunitari tradizionali, connessa alla diffusione di forme di produzione a scala industriale e della scomparsa del lavoro a domicilio; nel secondo caso, lo sradicamento è l’esito di una crisi dei legami solidaristici propri delle società del welfare – che era stata la risposta moderna al primo sradicamento e che ora risulta sempre più indebolita dalla New Economy. Crisi della regolazione giuridica (2). Progresso tecnologico e rischi ambientali Il Luddismo140 fu il primo movimento organizzato di protesta contro le trasformazioni introdotte nell’organizzazione del lavoro dalla prima rivoluzione industriale. Si sviluppò all’inizio del XIX secolo in Inghilterra, soprattutto nei centri più importanti della produzione industriale di maglierie – nel Nottinghamshire e poi nello Yorkshire, nel Derbyshire e nel Leicestershire –, 138 M. Weber, Economia e Società. Comunità, Vol. I, Milano, 1968, pp. 620-621. G. Marramao, op. cit. a nota 13, p. 37. “Luddisti” fu il nome che si diedero i primi oppositori all’introduzione delle macchine nelle filande, richiamandosi a una figura storico-mitica, Ned Ludd,, su cui correvano molte leggende, tra le quali anche quella di essere stato il primo, nel 1779, a scagliarsi contro un telaio, rompendolo. F. Barone, “La paura della macchina: implicazioni metafisiche del luddismo”, in S. Riscossa (a cura di), Le paure del mondo industriale, Editori Laterza, Bari, 1990, pp. 25-27. 139 140 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 139 e si caratterizzò per le iniziative contro l’introduzione delle macchine nella produzione tessile. Le macchine erano considerate la causa della disoccupazione e dei bassi salari: da qui l’ira distruttrice contro i filatoi, negli anni 1811 e 1812, che ben presto sfociò anche in violenza contro le persone, provocando una dura reazione giudiziaria: il processo di massa del 1813 portò a numerose impiccagioni e deportazioni. 141 È un errore pensare al Luddismo come a un episodio marginale del movimento operaio. Oltre a manifestare contro i nuovi metodi di produzione e a favore del lavoro a domicilio, i Luddisti avanzarono istanze – per esempio, la riduzione degli orari dei turni, il miglioramento delle condizioni di lavoro, l’introduzione dei minimi salari, l’abolizione del lavoro minorile – che sarebbero stati assunti, dopo pochi anni, dalle nascenti organizzazioni sindacali e dal Cartismo – movimento politico-sociale britannico formato prevalentemente da uomini della “working-class”, il cui nome derivava dalla People's Charter , la “Carta del Popolo”, presentata nel 1838 alla Camera dei Comuni, che rivendicava il suffragio universale maschile, elezioni annuali a scrutinio segreto, una rappresentanza operaia in parlamento, ottenibile attraverso l'abolizione di limiti di censo per i candidati e dall'introduzione dell’indennità parlamentare. La storia del Luddismo dimostra come l’avversione alla macchina e, più in generale, allo sviluppo tecnologico, sia un tratto costitutivo dei movimenti operai, sindacali e socialisti dell’Ottocento e Novecento: ha radici profonde142 e accompagna tutto il processo di sviluppo del Capitalismo, il quale, d’altra parte, ha sempre stimolato anche un forte entusiasmo per la straordinarietà delle scoperte scientifiche e delle loro applicazioni in campo industriale. “Paura-entusiasmo” per la Tecnica è l’ossimoro affettivo che sostiene il progresso scientifico e che aumenta d’intensità in relazione alla crescente rapidità dello sviluppo tecnologico. “Benessere” e “catastrofi” sono i due opposti scenari, già presenti durante la fioritura delle “macchine”, che trovano nuovo vigore in un periodo in cui i “robot” si diffondono nell’industria e si moltiplicano in più direzioni i tentativi di creare forme di “intelligenza artificiale”. Se nella prima industrializzazione la “macchina” era considerata un’opportunità per aumentare la produzione industriale, ma, al contempo, 141 Ibidem, p. 26. Si veda, ancora, l’interessante ricostruzione della presenza dell’ “avversione per la macchina” nella letteratura anti-industrialistica dell’Ottocento e nella polemica socialista contro la rivoluzione industriale, ma anche nei romanzi e nelle poesie dell’Ottocento operata da Barone (Ibidem). 142 140 Capitolo 3 una minaccia per la vita/sopravvivenza delle persone, analogamente, nel Novecento, la Tecnica appare “vitale” per il progresso economico e sociale e, al tempo stesso, “mortalmente pericolosa” per l’umanità. Martin Rees, professore di Astrofisica e Cosmologia a Cambridge e Presidente della Royal Society britannica, nel 2003 ha pubblicato un’opera dal titolo Our Final Hour143, in cui sostiene che la civiltà attualmente presente sulla Terra ha una probabilità su due di sopravvivere oltre il XXI secolo. La colpa di un eventuale catastrofe, stando a quanto dichiara lo studioso, sarà da attribuire a scoperte scientifiche particolarmente imprudenti. Egli considera, per esempio, che i fisici possano accidentalmente generare fenomeni che potrebbero distruggere la Terra. Come caso di studio di questi rischi estremi, viene citato un progetto iniziato nel 2000 al Brookhaven National Laboratory di Long Island. I fisici coinvolti nel progetto stanno usando un acceleratore di particelle per cercare di creare un plasma formato da quark e gluone (quark-gluon plasma), un insieme di particelle subatomiche estremamente calde e dense, che riproduce le condizioni del “Big Bang” che fece esplodere il cosmo 13.7 miliardi di anni fa. Coloro che criticano il progetto sostengono che questa elevatissima concentrazione di energia potrebbe produrre almeno uno dei seguenti tre rischi: 1) potrebbe formare un buco nero – un oggetto con una così grande forza gravitazionale da non potergli scappare nulla, nemmeno la luce – che potrebbe risucchiare tutto ciò che gli sta attorno; 2) le particelle di quark potrebbero formare un oggetto molto compresso, molto più piccolo di un singolo atomo, che potrebbe “infettare” la materia che lo circonda e trasformare l’intero pianeta Terra in una sfera inerte iperdensa di circa 100 metri di diametro; 3) lo stesso spazio potrebbe entrare in una “fase di transizione” simile a quella di molecole d’acqua che si raffreddano in ghiaccio. I confini di questo nuovo tipo di “vuoto” potrebbero espandersi come una bolla, divorando la Terra ed, eventualmente, l’intero universo intorno. Per rassicurare i residenti di Long Island, i fisici di Brookhaven hanno presentato calcoli che indicano che questi rischi non si verificheranno. Lo stesso Rees ritiene molto improbabile una catastrofe che abbia come epicen- 143 M. Rees, Our Final Hour: a Scientist's Warning: How Terror, Error, and Environmental Disaster Threaten Humankind's Future in This Century On Earth and Beyond, Basic Books, New York, 2003 (trad. it. Il secolo finale. Perché l'umanità rischia di autodistruggersi nei prossimi cento anni, Mondadori, Milano, 2005). Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 141 tro il Brookhaven National Laboratory; purtuttavia, egli afferma – ed è questa considerazione, come si vedrà, a risultare emblematica – che non possiamo essere sicuri al 100 per cento che effettivamente questa non accadrà. Rees, inoltre, si sofferma sui rischi legati allo sviluppo della nanotecnologia, il cui obiettivo è la costruzione di robot piccolissimi che si riproducono come virus. I “nanobots” potrebbero avere applicazioni estremamente utili – come, per esempio, ricercare nel corpo particelle di cancro. Ma potrebbero anche sfuggire al controllo, divorando tutto ciò che sta intorno a loro e riducendo la crosta terresstre in una superficie grigia. Dopo il 2020 i nanobots potrebbero diventare una realtà diffusa cosicché la probabilità di un disastro potrebbe aumentare. Vale la pena sottolineare come, per l’astrofisico britannico, non ci siano risposte semplici a queste catastrofi futuristiche: le restrizioni alla ricerca potrebbero servire, ma anche ritorcersi contro, impedendo la scoperta dei possibili “antidoti” in grado di prevenire le catastrofi. Il libro di Rees è uno dei più recenti libri “apocalittici” (attribuendo a questo termine non tanto un giudizio di valore, quanto un carattere descrittivo all’interno dell’opposizione tra “entusiasmo” e “paura”) sulle condizioni del presente e sulle prospettive del futuro; ricorda molto da vicino alcune suggestioni fornite dalla letteratura fantascientifica degli anni Cinquanta e, in particolare, gli scenari post-umani144 descritti da scrittori come Philip Dick. Già Lorenz, come ho già riferito (par. 3.1), aveva rappresentato le minacce all’umanità derivanti da alcune trasformazioni tecnologiche, umane e sociali. La sensazione di un’imminente “fine del mondo” coinvolse, negli stessi anni, anche gli economisti. Nel 1972, gli esperti del System Dynamics Group del Massachussets Institute of Technology (MIT), sotto la guida di Tennis e Donella Meadows, pubblicarono un rapporto, promosso dal Club di Roma, (un gruppo internazionale di eminenti scienziati, statistici e uomini d’affari), su I Limiti dello sviluppo145. Il rapporto, che fu tradotto in trenta lingue, indagava le cause e le conseguenze a lungo termine della crescita di popolazione, capitale industriale, produzione di alimenti, consumo di risorse e inquinamento. 144 Il termine “post-umano” è stato utilizzato da Giacomo Marramao in una lezione che tenne lo scorso anno presso la Casa della Cultura di Milano. 145 D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens, The Limits to Growth, Universe Books, New York, 1972 (trad. it. I limiti dello sviluppo, Mondatori, Milano, 1972). 142 Capitolo 3 I risultati dello studio stimolarono un dibattito mondiale: vennero sostenuti pubblicamente, ma anche aspramente contrastati. Per lo più vennero interpretati come una predizione di rovina. In realtà, come affermano i Meadows e Jørgen Randers nella Prefazione di un libro scritto vent’anni dopo, Oltre i limiti dello sviluppo, il rapporto non descriveva un futuro preordinato, ma indicava una scelta: «certo, esso conteneva un avvertimento, ma anche un messaggio di promessa»146. Infatti, delle tre tesi che costituivano il “cuore” del rapporto, la seconda e la terza rimettevano il destino dell’umanità nelle sue stesse mani, nella sua possibilità e volontà di decidere. 1. Nell’ipotesi che l’attuale linea di crescita continui inalterata nei cinque settori fondamentali (popolazione, industrializzazione, inquinamento, produzione di alimenti, consumo delle risorse naturali) l’umanità èm destinata a raggiungere i limiti naturali della crescita entro i prossimi cento anni. Il risultato più probabile sarà un improvviso, incontrollabile declino del livello di popolazione e del sistema industriale. 2. è possibile modificare questa linea di sviluppo e determinare una condizione di stabilità ecologica ed economica in grado di protrarsi nel futuro […]. 3. Se l’umanità opterà per questa seconda alternativa, invece che per la prima, le probabilità di successo saranno tanto maggiori quanto prima essa comincerà a operare in tale direzione.147 Ai fini del nostro discorso sulla relazione tra rischi tecnologici e ambientali, da una parte, e crisi della regolazione, dall’altra, è importante sottolineare come sia il gruppo di ricerca del MIT che Rees individuino uno stretto legame tra “rischio/catastrofe” e “scelta/decisione”. Ed è proprio su questa relazione che si concentra la riflessione sociologica sul “rischio”. Niklas Luhmann, nell’Introduzione alla sua Sociologia del rischio, riflette sul fatto che: la tecnica e la consapevolezza delle proprie possibilità ad essa connessa hanno occupato il terreno della natura, e tanto la supposizione quanto l’esperienza fanno pensare che ciò può accadere più facilmente in maniera distruttiva che in maniera costruttiva. Il timore che le cose possano andare storte cresce dunque rapidamente e con esso il rischio che viene attribuito alle decisioni.148 146 D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, Beyond the Limits, Chelsea Green Publication Company, 1992 (trad. It. Oltre i limiti dello sviluppo, Il Saggiatore, Milano, 1993, p. 14). 147 D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens, op. cit. a nota 145, p. 32. 148 N. Luhmann, Soziologie des Risikos, Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1991 (trad. it. Sociologia del rischio, Bruno Mondadori, Milano, 1996, p. 6). Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 143 L’evento dannoso – secondo Luhmann – viene percepito sempre più come esito di una decisione umana, come rischio che bisogna correre, e sempre meno come fatalità. Più di qualsiasi altro fattore, l’espansione immensa delle possibilità tecnologiche ha contribuito a far sì che l’attenzione pubblica si rivolga ai rischi ad essa connessi; viceversa, è altrettanto chiaro che lo sviluppo delle nuove tecnologie – che prima poteva essere motivato in molti modi, tra l’altro da un punto di vista religioso, morale, ideologico, oppure perché veniva coinvolto il potere –, oggi nasce soprattutto in riferimento ai rischi che bisogna correre quando si introducono tecnologie nuove.149 Queste riflessioni portano a considerare centrale il passaggio, in epoca moderna, dal concetto di “pericolo” a quello di “rischio”. La distinzione tra i due concetti presuppone che sussista un’incertezza con riferimento ai danni futuri: si ha “rischio” quando il danno viene visto come conseguenza di una decisione umana, cioè viene attribuito ad essa, mentre si parla di “pericolo” quando l’eventuale danno è attribuito a fattori esterni e viene, quindi, addossato alla “natura”150. Così, il rischio si crea nel calcolo interno di condizioni situazionali esterne, presuppone un approccio scientifico nell’osservazione del presente e nella previsione del futuro. Diversamente, il pericolo capita, senza che sia riferibile a decisioni umane o sia visto come il risultato di comportamenti antecedenti.151 Nel passaggio alla modernità la dipendenza dalla decisione aumenta: sempre più situazioni e stati di fatto vengono considerati conseguenze di scelte152. Già Ulrich Beck, nel 1986, aveva intuito l’importanza della relazione tra rischio e decisione nella società tardo-moderna. In contrasto con tutte le epoche precedenti (inclusa la società industriale), la società del rischio è caratterizzata essenzialmente da una mancanza: l’impossibilità di un’imputabilità esterna delle situazioni di pericolo. In altri termini, i rischi dipendono da decisioni: essi sono prodotti industrialmente e in questo senso sono politicamente riflessivi. […] I rischi sono il riflesso delle azioni ed omissioni umane, l’espressione di forze produttive altamente sviluppate […] L’origine dei rischi che inquietano gli 149 Ibidem, p. 99. Ibidem, pp. 31-32. 151 Lo stesso evento dannoso, come un’alluvione, può essere considerato come rischio se le persone pensano che le autorità pubbliche possono fare qualcosa per evitarlo, oppure come pericolo se la gente pensa che “se deve accadere, accadrà”. Cfr. Luhmann N., 2000, “Familiarity, Confidence, Trust: Problems And Alternatives”, in D. Gambetta (edited by), Trust: Making And Breaking Cooperative Relations, electronic edition, Department of Sociology, University of Oxford, Chapter 6, pp. 94-107, available on the web-site: www.sociology.ox.ac.uk/papers/luhmann94-107.pdf. 152 N. Luhmann, op. cit. a nota 148, p. 58. 150 144 Capitolo 3 uomini non sta dunque più nell’esterno, nell’estraneo, nel non-umano, ma nella capacità, storicamente acquisita, dell’uomo, di autocambiamento, di autocostruzione e di autoannientamento delle condizioni riproduttive di tutta la vita su questa Terra. Ciò significa che la fonte del pericolo non è più l’ignoranza, ma la conoscenza.” p. 255 In questo senso, lo sviluppo scientifico e tecnologico costituisce una “minaccia”, in quanto produce sempre più pericoli, ma, al tempo stesso, una “promessa di emancipazione dalla minaccia” che essa stessa crea. Promessa teoricamente possibile attraverso l’atto di decidere, ma nella realtà sempre più debole di fronte alla crescente intensità dei rischi e alla decrescente certezza delle previsioni circa loro impatto sull’umanità. Anthony Giddens delinea lo scenario moderno del rischio in sette punti. 1. Globalizzazione del rischio nel senso di intensità: una guerra nucleare, per esempio, può minacciare la sopravvivenza di tutta l’umanità. 2. Globalizzazione del rischio nel senso di numero crescente di eventi contingenti che interessano ogni persona o almeno grandi masse di persone in tutto il pianeta; per esempio i cambiamenti della divisione mondiale del lavoro. 3. Rischio derivante dall’ambiente creato o dalla natura socializzata: l’applicazione del sapere umano all’ambiente fisico. 4. Lo sviluppo di ambienti di rischio istituzionalizzati che influiscono sulle aspettative di vita di milioni di persone: per esempio i mercati d’investimento. 5. La consapevolezza del rischio come tale: le “lacune di sapere” nei rischi non possono essere convertite in “certezze”del sapere religioso e magico. 6. La consapevolezza diffusa del rischio: molti dei rischi ai quali collettivamente siamo esposti sono noti a molte persone. 7. La consapevolezza dei limiti del sapere esperto: nessun sistema esperto può avere una conoscenza totale delle conseguenze derivanti dall’applicazione di principi esperti.153 Se il gruppo di ricerca del MIT, nel 1972, riteneva fosse possibile scegliere di imboccare un’altra strada per lo sviluppo economico, in grado di preservare l’umanità dal declino, le attuali tendenze della società del rischio, descritte compiutamente da Giddens, giustificano l’atteggiamento più cauto (o pessimista), secondo cui le risposte non sono facili, divenendo anch’esse “elementi di rischio”: possono amplificare i rischi esistenti e, nel tentativo di risolverli, crearne di nuovi. La stessa idea di sviluppo sostenibile – inteso come strategia in grado di conciliare crescita economica e preoccupazioni ambientali – è stata ormai 153 A. Giddens, op. cit. a nota 18, pp. 125-126. Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 145 accantonata154 ed emerge, semmai, il problema della governance dei rischi, ben espresso dalla considerazione di Beck sulla concomitante produzione di ricchezza e di rischi: nella modernità avanzata la produzione sociale di ricchezza va sistematicamente di pari passo con la produzione sociale dei rischi. Analogamente, ai problemi ed ai conflitti distributivi della società basata sulla penuria si sovrappongono problemi e conflitti che scaturiscono dalla produzione, definizione e distribuzione di rischi prodotti dalla scienza e dalla tecnica.155 Il governo dei rischi porta necessariamente a forme di regolazione giuridica basate sull’incertezza. Il Nomos, non potendosi poggiare sulla certezza della previsione scientifica, si fa anch’esso incerto. Il concetto di “ignoranza” in relazione all’applicazione delle scienze al Diritto diventa centrale e sostiene la scelta, compiuta anche recentemente dalla Commissione Europea con riferimento ai rischi ambientali, di adottare un principio di precauzione nelle decisioni sull’ambiente. In queste istanze di regolazione di tipo cautelativo emerge, dunque uno slittamento dal concetto di “rischio” a quello di “ignoranza”. Infatti, diversamente dal primo, la cui quantificabilità consente una specifica azione preventiva, la seconda – definibile in relazione alla capacità della scienza di quantificare e all’applicazione del sapere scientifico alle decisioni – rende opportuna l’adozione di comportamenti che, in mancanza di piena certezza scientifica, cerchino almeno di ridurre l’impatto negativo dei rischi.156 Il sapere basato sull’ignoranza, connessa alla progressiva consapevolezza delle molteplici sfaccettature e implicazioni dell’incertezza scientifica, nell’attuale condizione di crescente intensità dei rischi, non può far altro che portare a decisioni “relative”, in grado di minimizzare l’impatto del singolo potenziale evento dannoso, riducendo l’insicurezza specifica di quel caso, ma senza produrre, in generale, maggiore sicurezza. La Tecnica fa, dunque, paura perché sembra correre troppo in fretta e lasciare indietro i non-tecnici, tra cui anche i decisori politici. D’altra parte, anche il sistema degli esperti dimostra lacune nella proposizione di certezze scientifiche. Purtuttavia, il progresso tecnologico avanza, producendo «rischi 154 Cfr. B. De Marchi, M. Tamburino, “Politiche dell’incertezza, scienza e diritto. Introduzione”, in Notizie di Politeia. Rivista di Etica e Scelte Pubbliche, XIX, n. 70, 2003, pp. 3-12. 155 U. Beck , op. cit. a nota 46, p. 25. 156 Ibidem, p. 3. 146 Capitolo 3 globali ad alto tasso di conseguenze»157, e più rapidamente procede, più crea allarme, perché dà la sensazione di sfuggire a ogni controllo, individuale e collettivo, e a ogni possibilità di regolazione. A fronte della rapidità dell’evoluzione tecnologica, i tempi legislativi e politici, e prima ancora quelli psicologici e deontici158, appaiono estremamente più lunghi, risultando spesso inadeguati. Si assiste a una sorta di “degenerazione” dello strumento legislativo, il quale, non potendo più avere una funzione di regolazione o di affermazione di valori e principi, acquista un valore sempre più simbolico: mostra unicamente la volontà di presa in carico delle emergenze. La legge tende ad assolvere una funzione di rassicurazione nell’immediato, tradendo, nei fatti, la promessa di regolazione della vita sociale. Ancora una volta ci si percepisce soli, privi di quei riferimenti simbolici (scienza, istituzioni, legge) che costituivano una substrato di stabilità. Certo, la necessità di occuparsi dei problemi pratici della vita di ogni giorno costituisce un freno all’angoscia che invade chiunque pensi allo scenario dei rischi odierni. L’accettazione passiva di questo stesso scenario evoca, a volte, la riedizione di un’idea di fortuna – di fatalità, di provvidenza – tipica di una concezione del mondo pre-moderna.159 Purtuttavia, quel senso di angoscia rimane sotto traccia: è una sensazione di “fine del mondo” che cerca canali per esprimersi e che, in termini psicanalitici, può dare origine a sintomi nevrotici: «non possiamo permetterci di avere paura della fine del mondo e allora abbiamo paura dell’aereo, di dormire da soli, o siamo vittime di attacchi di panico, o non vogliamo fare figli e così via»160. È il tema della relazione tra “apocalissi culturali” e “apocalissi psicopatologiche” che De Martino iniziò a tracciare a partire dall’analisi del “delirio di fine del mondo” – secondo cui il malato esperisce come prossima a sé una catastrofe apocalittica dalle dimensioni cosmiche – e di tutte quelle forme psico-patologiche legate a un “vissuto di alienazione”, cui l’autore dà il significato di “fine dell’ordine mondano”. 161 157 A. Giddens, op. cit. a nota 18, p. 132. È la stessa concezione individuale e collettiva del vivere sociale a trovarsi sfasata rispetto all’evoluzione tecnologica. E ciò comporta, anche per l’eterogeneità culturale della società attuale, l’estrema difficoltà di giungere alla produzione di norme etico-sociali che guidino il comportamento , da un lato, e orientino l’azione istituzionale, dall’altro. 159 A. Giddens, op. cit. a nota 18, pp. 132-133. 160 M. Valcarenghi, L’insicurezza. La paura di vivere nel nostro tempo, Bruno Mondadori, Milano, 2005, p. 171. 161 E. De Martino, op. cit. a nota 15, pp. 11-167. 158 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 147 Crisi della regolazione giuridica (3). Le sfide di una società plurale Le democrazie occidentali si sono fondate normativamente sull’idea di unità del popolo, di “unità nella diversità”. La storia del pensiero politologico moderno è costellata da riflessioni e teorie sul concetto di nazione e di popolo in relazione alle idee di Stato e di democrazia162. Gli Stati nazionali europei si sono formati nel quadro di Stati territoriali pre-esistenti oppure sulla promozione avanguardistica della coscienza nazionale (è il caso dell’Italia e della Germania, per esempio). La differenza dei due percorsi può essere sintetizzata nell’espressione “from state to nation vs. from nation to state”163. Una terza generazione di Stati nazionali nacque, soprattutto in Africa e in Asia, dal processo di de-colonizzazione seguito alla Seconda guerra mondiale: questi Stati ottennero la sovranità prima ancora che le forme dell’organizzazione statale fossero importate dall’esterno e potessero mettere radici in un sostrato nazionale capace di superare le divisioni etnico-razziali. Lo Stato fu riempito a posteriori dall’idea di nazione. In questo processo l'immaginazione164 giocò un ruolo cardine, come dimostra il caso dell’indigenizzazione dello sport del cricket nella fase di costruzione della nazione indiana: questo sport, da mezzo di disciplinamento morale e politico che si inscriveva nei corpi dei colonizzati, divenne un elemento della nuova identità culturale e politica, in grado di sgretolare le forme istituzionali coloniali che la condannavano alla subalternità.165 Infine, dopo il crollo dell’Unione sovietica, la tendenza alla formazione di Stati nazionali autonomi continuò attraverso la via delle secessioni, sostenute da vecchi appelli etno-nazionalistici166. 162 Per una ricostruzione dello statuto che tale concetto ha assunto nel corso dello sviluppo del pensiero europeo moderno si veda G. Bonaiuti, Corpo sovrano. Studi sul concetto di popolo, Meltemi, Roma, 2006. 163 J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderei. Studien zur politischen Theorie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1996 (trad. it. L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 119-120). 164 Arjun Appadurai considera l’immagine come un “campo organizzato di pratiche sociali” e come una “forma di negoziazione tra siti d'azioni (individui) e campi globalmente definiti di possibilità”. Approfondiremo più avanti questo concetto, in relazione al tema della comunicazione di massa e del fenomeno dell’immigrazione. A. Appadurai, Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization, University of Minnesota Press, Minneapolis-London, 1996 (trad. it. Modernità in polvere, Meltemi, Roma, 2001, p. 50). 165 Oggi, tuttavia, la recente spettacolarizzazione e mercificazione di questo sport sembra segnare una sorta di ricolonizzazione da parte delle forze transnazionali (Ibidem). 166 J. Habermas, op. cit. a nota 163, p. 120. 148 Capitolo 3 In tutti questi casi si è assistito al richiamo all’ideale nazionale come cemento per la costruzione statuale. In particolare, nei Paesi occidentali, lo Stato aveva risposto in modo convincente al problema storico di trovare un equivalente funzionale per forme premoderne di integrazione sociale che stavano diffondendosi167, attraverso l’ “invenzione della nazione”: solo l’appartenenza alla “nazione” creava un vincolo di solidarietà tra persone fino ad allora estranee; in tal modo, lo Stato-nazione rese possibile una inedita e più astratta forma di integrazione sociale. Oggi il problema appare analogo a quello affrontato alle origini della formazione dello Stato-nazione. La globalizzazione del commercio e della comunicazione, della produzione economica e dei meccanismi finanziari, del trasferimento dei sistemi tecnologici e d’arma, ma in particolare la globalizzazione dei rischi ecologici e militari, ci pone di fronte a problemi che non sono più risolvibili né entro il quadro della Stato-nazione, né attraverso le vie consuete dell’accordo tra sovrani.168 Ho già notato come queste tendenze globalizzanti intersechino il tema della crisi della fraternità, sia con riferimento all’attuale crisi delle forme di solidarietà delle società del welfare, sia rispetto alla proliferazione di rischi tecnologici ed ambientali, che producono sfiducia nella capacità di regolazione e nuove paure. Mi preme ora sottolineare che anche il declino dell’idea di nazione è strettamente connesso alle tendenze globalizzanti – de-statalizzanti – sopra descritte, ed evidenziare come questo declino contribuisca a destrutturate le forme moderne di solidarietà e integrazione e, contestualmente, determini una vera e propria “stasi” nella capacità decisionale pubblica. Se l’unità suggestiva di un popolo era stata sufficiente per integrare culturalmente una cittadinanza definita in termini giuridici, oggi constatiamo, al contrario, un allontanamento progressivo delle “società pluralistiche” dal modello di Stato-nazione, anche per effetto delle migrazioni di massa a livello globale. È stimolante, in questo senso, la riflessione di Appadurai sulla rilevanza assunta negli ultimi anni dai fenomeni della comunicazione di massa e delle 167 168 Ibidem. Ibidem. Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 149 massicce migrazioni, e sulla centralità assunta dall’immaginazione e dalla de-territorializzazione. L’ipotesi da cui parte l’autore è che negli ultimi decenni sia avvenuta una trasformazione riguardante l’immaginazione.169 Questa gioca un ruolo diverso rispetto al passato, soprattutto in quanto è entrata nella logica della vita ordinaria, frantumando la specificità dello spazio espressivo dell’arte, del mito, del rituale:essa perde la sua contiguità con la fantasia (che porta con sé l’inevitabile connotazione di pensiero separato da progetti e azioni) e con la dimensione individuale, e si identifica sempre più come una «proprietà della collettività e non solo come una facoltà dell’individuo dotato»170. Il forte sviluppo della comunicazione mass-mediatica su scala globale e il massiccio movimento di persone che si spostano continuamente sulla Terra per i più diversi motivi sono alla base di questo mutamento di statuto dell’immaginazione: «più gente che mai considera normale immaginare la possibilità, per se stessi e per i propri figli, di vivere e lavorare in posti diversi da quelli in cui sono nati»171. Nel contempo, i fenomeni indicati rendono possibile la creazione di “comunità di sentimento”, proprio a partire da queste spinte immaginative: individui e gruppi molto distanti goegraficamente iniziano a immaginare e a sentire cose collettivamente, a instaurare sodalizi culturali che agiscono spesso indipendentemente dai confini nazionali e che costruiscono una pluralità di mondi immaginati, disarticolando l’idea della comunità nazionale. La “deterritorializzazione”, che deriva da questa proliferazione di immagini identitarie e che consiste nell'irregolare e diffusa disarticolazione di persone, informazioni, tecnologie, capitali e ideologie, crea un sistema di differenze che impediscono di considerare le unità culturali come omogenee e soprattutto definite da confini come quelli dello Stato nazionale. Dunque, in questo scenario l’idea di nazione viene minata alla base e la sfera pubblica si frantuma. Da un lato, le comunità più piccole corrono il rischio di diventare énclaves protette, a metà tra ghetti e fortezze, tanto che la comunità immaginata dell'uno diventa la prigione politica dell'altro; dall'altro lato, la comunicazione di massa su scala globale, sempre più immediata e ramificata, rende possibili i contatti tra gruppi di persone anche molto lontani geograficamente, costituendo quelle “sfere pubbliche diasporiche” che hanno la possibilità – anche in virtù della loro de-localizzazione – di mobilitare le rispettive differenze culturali a vantaggio di un'identità di gruppo “co- 169 Ibidem, p. 18. Ibidem, p. 22. 171 Ibidem, p. 19. 170 150 Capitolo 3 struita” in questo processo. Tali sfere pubbliche contribuiscono in modo notevole al fenomeno del “rimpatrio della differenza”, sotto forma di beni, segni, slogan, stili di vita, immagini e ideologie. La tensione tra globale e locale si esprime in questo processo di ridefinizione continua degli spazi a partire da identità locali, costruite culturalmente spesso su scala globale. Un esempio di questa dinamica localeglobale è il “ritorno al velo” da parte delle donne nordafricane che vivono nei Paesi europei. Alcune di loro non portavano il “velo” nel Paese d’origine, mentre, una volta arrivate in Italia, hanno deciso di utilizzarlo come segno distintivo di un’identità culturale e/o religiosa che definisce spazi e relazioni a livello locale, ma che è costruita su un piano di comunicazione globale e, insieme, locale: il velo è un segno culturale distintivo, non già perché è parte della tradizione culturale di un certo gruppo, quanto perché si costruisce culturalmente nella relazione tra immigrati e autoctoni, assumendo significati identitari diversi (affermazione di un diritto alla differenza, rifiuto a “integrarsi”, manifestazione di un’appartenenza religiosa) in relazione ai conflitti rappresentati nella comunicazione globale (il riferimento immediato è all’uso diffuso dell’espressione “Guerra di civiltà”) e locale (si pensi alle campagne di stampa contro l’immigrazione già accennate nel capitolo 1), oppure vissuti quotidianamente. In questa direzione, quanto più gli immigrati sentono che la loro originaria tradizione culturale è rispettata nel nuovo paese di residenza e quanto meno avvertono di essere osteggiati, rifiutati, minacciati o discriminati a causa della loro diversa identità, tanto più saranno inclini ad aprirsi alle offerte culturali del nuovo paese e tanto meno resteranno tenacemente aggrappati ai propri stili di vita.172 Di fronte a queste tendenze, fino a che punto è possibile oggi tenere insieme «universo della norma e multiverso delle culture, nel momento in cui identità culturali diverse – basate sull’etnia, la razza, il sesso o la religione – contestano la legittimità di un sistema di regole che si presume indifferente e neutrale?»173 Questa è la sfida di società frammentate al loro interno da una “pluralità di valori” e di “centri di potere (non solo politici, ma anche economici, culturali, religiosi, etc.) portatori di interessi, ideologie e progetti che si affiancano a quelli dello Stato (spesso in dimensioni indipendenti dal suo territo- 172 La frase è riferita da Bauman e appartiene a uno scrittore franco libanese residente in Francia, Amin Maalouf (Z. Bauman, op. cit. a nota 85, pp. 136-7). 173 G. Marramao, op. cit. a nota 13, p. 14. Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 151 rio”174; società che sono state definite anche “post-secolari”175 – indicando con questo termine non già il fallimento o la fine della secolarizzazione cui seguirebbe un “ritorno di Dio”, quanto il pluralismo delle fedi e del “diversamente credenti” che danno vita a una pluralità di stili di vita e di ethos.176 Una sfida difficile, in quanto la mancanza di un ethos condiviso accentua i processi di scomposizione del concetto tradizionale di Stato democratico (nelle sue due versioni di liberal-democratico e social-democratico) che sull’unità della nazione, il demos moderno, traeva forza e legittimità. Paolo Flores D’Arcais sostiene che la democrazia moderna è una democrazia liberale proprio perché non fa del principio di maggioranza il suo criterio supremo […] liberale è una democrazia solo se rispetta innanzitutto i diritti delle minoranze […] fino a quella minoranza estrema che è il singolo individuo, il singolo ‘eretico’, il singolo dissidente.177 Si tratta di un’affermazione che ha un valore indubbio sul piano giuridico-politico, in quanto consente di creare uno sviluppo fluido tra l’universalismo giuridico e il riconoscimento dell’ “alterità”. Ma, in realtà, il tema del riconoscimento delle minoranze – non semplicemente dei loro diritti, il che rischierebbe di appiattirne a priori l’ “alterità valoriale”, riducendo le minoranze a una sorta di super-individui richiedenti diritti allo Stato – va inquadrato, sul piano analitico, non tanto in termini di rapporto tra il tutto (Stato) e una sua parte (minoranze), bensì in termini di “scardinamento del tutto”, che perde la sua unicità, frammentandosi in tante parti. Il problema dell’ “alterità culturale” si configura, in altri termini, come un’ “aporia interna al funzionamento delle società occidentali”178, in quanto contrasta apertamente con la vocazione universalistica della cultura democratica. 174 A. Ceretti, “Presentazione”, in A. Ceretti, L. Garlati, (a cura di), Laicità e Stato di Diritto. Atti del IV Convegno di Facoltà, Università di Milano-Bicocca, 9-10 febbraio 2006, Giuffrè, Milano, 2007, p. XII. 175 G.E. Rusconi, “Lacità ed etica pubblica”, in A. Ceretti, L. Garlati (a cura di), Laicità e Stato di Diritto. Atti del IV Convegno di Facoltà, Università di Milano-Bicocca, 9-10 febbraio 2006, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 25-28. 176 Ibidem, pp. 25-47. Costantino Visconti parla apertamente di “crisi della secolarizzazione” come processo storico sociale, nel senso che «rispetto ad alcuni aspetti che di questo processo si riteneva facessero parte, si è aperta una nuova fase nella società, che, appunto, è stata definita ‘post-secolare’» (C. Visconti, “La tutela penale della religione nell’età post-secolare e il ruolo della Corte Costituzionale”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2005, pp. 1029 e segg.). 177 A. Ceretti, op. cit. a nota 174, p. XIII. 178 G. Marramao, op. cit. a nota 13, p. 42. 152 Capitolo 3 Citando il filosofo e storico delle idee Isaiah Berlin, Marramao sostiene che la tendenza filosofico-politica dominante dell’Occidente poggi su tre asserzioni fondamentali: 1. per ogni quesito autentico c’è un’unica risposta corretta, che esclude tutte le altre come erronee, non-vere: non c’è interrogativo, purchè formulato con chiarezza logica, al quale si possano dare due risposte diverse che siano entrambe corrette (e va da sé che, se non esiste risposta corretta, il quesito è da ritenersi inautentico); 2. esiste, sempre e comunque, un metodo per trovare le risposte logicamente giuste; 3. tutte le risposte corrette devono essere compatibili tra loro.179 Per una tradizione così strutturata, lo stesso conflitto di valori è inconcepibile. La società moderna, fondata sull’universalismo (ideale di uguaglianza) dei diritti (ideale di libertà), fatica a tollerare l’idea di un pluralismo politico, sociale, etico e religioso. Questo non è com-prensibile all’interno dell’ottica universalistica tradizionale, a meno che non lo si riduca a forma di rivendicazione individualistica di diritti da parte di gruppi, che perderebbero, in tal modo, la loro dimensione comunitaria. Tale riduzione fatica a imporsi; si assiste, piuttosto, al fenomeno contrario, quello della “dispersione del Diritto” e della formazione di “eccedenze”. Rispetto a questi temi risultano fondamentali le parole di Adolfo Ceretti nell’Introduzione al volume su Laicità e Stato di Diritto: nella società odierna, al declino dello Stato-ordinamento “liberale” e alla perdita di centralità dei sistemi giuridici positivi fa da contrappunto la dispersione strutturale del diritto, nonché la nascita di sfere normative asimmetriche e instabili: le società pluraliste attuali non sono più caratterizzate dal ricorso a strategie politiche calate dall’alto verso il basso, ma tendono a una politica costituzionale “aperta”, basata su un “compromesso delle possibilità”, in cui ciascuna delle parti sociali, entro i limiti costituzionali, può avviare la competizione per dare concretamente allo Stato un indirizzo di un segno o di un altro. Il centro, in definitiva, non è più un “luogo” da cui partire, ma un “luogo” da guadagnare. A partire da queste riflessioni e dalla considerazione delle “ricadute” delle decisioni politiche e/o giudiziarie, che concernono la sfera della bio-etica, e, più in generale, la questione della laicità, ancora Ceretti rileva come 179 Ibidem, p. 41 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 153 i dispositivi istituzionali di riconoscimento e garanzia delle minoranze sociali si mostrano sempre meno robusti nel riuscire a “integrare” e/o a “controllare” il reirrompere prepotente delle posizioni che non hanno trovato accoglienza – o anche solo un’accoglienza parziale – nella sfera pubblica politica. Ed è proprio intorno a questa eccedenza generata dalle istanze “non riconosciute” che intendiamo soffermarci. [...] in società che sempre meno timidamente possiamo definire multiculturali e multietniche, le aspettative di vedere (o di non vedere) riconosciuti in luoghi pubblici i propri diritti [...] insistono [...] ben al di là delle normative e delle decisioni giudiziarie che intervengono per limitarne (o permetterne) l’esposizione o l’uso. Detto altrimenti, il nodo non riesce a essere definitivamente sciolto attraverso i criteri di razionalità e di decisione condivisi in una democrazia compiuta. [...] le liti su queste materie investono valori identitari profondi e si traducono in modo crescente in una contestazione dello Stato a decidere su di esse. “Multiculturalismo”180 è la risposta filosofico-politica elaborata, a partire dagli anni Sessanta, per coniugare il rispetto delle differenze culturali con l’universalismo giuridico e per integrare il pluralismo all’interno della tradizione culturale politica liberale. Le società multiculturali potranno essere tenute insieme – sostiene Jürgen Habermas – solamente se la democrazia troverà «remunerazione non solamente nei termini di un diritto alla libertà privata e alla partecipazione politica, ma anche nei termini di un godimento profano di diritti alla ripartizione sociale e culturale»181. Il filosofo della Scuola di Francoforte riflette sul fatto che femminismo, multiculturalismo, nazionalismo e lotta contro il colonialismo eurocentrico sono fenomeni apparentati, poiché donne, minoranze etniche, nazioni e culture lottano per ottenere il riconoscimento delle loro identità collettive. 182 Di fronte a tale problema sembra, almeno all’apparenza, che la risposta debba essere diversa da quella social-liberale, di universalizzazione dei diritti, che ha sostenuto la lotta per l’emancipazione dei collettivi: la borghesia, prima, il movimento operaio, poi183. Sembra, cioè, che occorra riconoscere un genere di diritti diversi, i “diritti collettivi”, che disarticolano l’idea tradizionale dello Stato democratico di diritto, “liberale” in quanto ritagliato su diritti individuali184. 180 Cfr. J. Habermas, C. Taylor, Kampf um anerkennung im demokratischen rechtsstaat, Suhrkampf Verlag Frankfurt am Main, 1996 (trad. it. Multiculturalismo, Feltrinelli, 1998). 181 J. Habermas, op. cit. a nota 163, p. 132 182 J. Habermas, C. Taylor, op. cit. a nota 180, p. 74. 183 Ibidem, p. 64. 184 Ibidem, p. 65. 154 Capitolo 3 La fatica di Habermas è, al contrario, quella di mostrare come non occorrano fondazioni speciali o principi alternativi a quelli liberali quando si tratti di riconoscere identità culturali collettive: «la convivenza giuridicamente equiparata dei diversi gruppi etnici e delle loro forme di vita culturale, non ha bisogno di essere tutelata da diritti collettivi» in quanto «a tutela delle tradizioni e delle forme-di-vita costitutive dell’identità deve, in ultima analisi, servire unicamente al riconoscimento dei loro membri in quanto individui». 185 Da questa proposta teorica e politica, qui solamente accennata, è scaturito un ampio dibattito, difficilmente sintetizzabile in poche righe. Si pensi all’impietosa critica al multiculturalismo di Russell Jacoby in The End of Utopia. Politics and Culture in an Age of Apathy. Il sociologo statunitense osserva come le classi colte dei nostri tempi, anche quelle progressiste, abbiano ridotto il dibattito sul nostro futuro a una scelta tra “lo status quo o qualcosa di peggio”, vanificando lo spirito utopico, vale a dire l’idea che il senso del futuro possa trascendere il presente. Denuncia, in particolare, la riduzione del progressismo in multiculturalismo e l’abbandono dell’universalismo in favore del particolarismo: il multiculturalismo – sostiene Jacoby – è l’oppio degli intellettuali disillusi. È diversa l’interpretazione del multiculturalismo operata da Bauman, che lo definisce «una chiosa intellettuale sulla condizione umana venutasi a creare sotto il duplice impatto del potere-attraverso-il-disimpegno e della regolamentazione-attraverso-l’eccesso»186. L’autore esprime la difficoltà di riconoscere le identità culturali e, al tempo stesso, l’autonomia individuale, e concorda con Habermas sul fatto che l’universalità della condizioni di cittadino sia il prerequisito di qualsiasi politica di riconoscimento significativa. Il carattere universale dell’umanità non è in contrapposizione al pluralismo di forme di vita umana, ma il banco di prova di un’umanità genuinamente universale è la sua capacità di accettare il pluralismo e di porlo al servizio della causa dell’umanità: 185 Ibidem, p. 89. Z. Bauman, op. cit. a nota 85, p. 129. Bauman sostiene che la nostra è un’epoca di disimpegno, in cui gli intellettuali, diversamente che in epoca moderna, non sono votati alla “missione”, di «assistere il processo di “reimpianto degli sradicati”». Inoltre, il modello panottico di governo, basato sulla sorveglianza e sul monitoraggio dei comportamenti va rapidamente disgregandosi e cedendo il passo a un sistema di autosorveglianza e automonitoraggio, ancora più efficace della regolamentazione normativa e del controllo poliziesco: «allorché la dedizione al lavoro si trasforma in una lotta quotidiana per la sopravvivenza, chi ha più bisogno di un controllore? Con i lavoratori quotidianamente sferzati dalla paura e da una insicurezza endemica, chi ha più bisogno di manager che fanno schioccare la frusta? » (Ibidem, p. 125). 186 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 155 consentire e incoraggiare il corso sulla concezione comune del bene. Tale prova può essere superata solo se vengono soddisfatte le condizioni della vita repubblicana.187 Occorre, dunque, proteggere l’individuo/cittadino dalle pressioni sia anticomunitarie sia comunitarie; in particolare, da quella tendenza, innescata o amplificata dal clima generale d’insicurezza, a trasformare il “multiculturalismo” in “multicomunitarismo”, in cui le differenze culturali vengono utilizzate come «mattoni nella frenetica costruzione di mura difensive e di rampe di lancio», e in cui ciascuna “cultura”, intesa come “fortezza assediata”, nega i presupposti di un pluralismo sociale.188 Per l’economia di questo lavoro, importa rilevare non tanto gli esiti di questo dibattito, ancora fortemente contraddittori e irrisolti, quanto il fatto che lo stesso segni, in maniera evidente, l’urgenza di trovare soluzioni normative a quella che è stata definita “aporia” e, conseguentemente, alla drammaticità dell’attuale “stasi decisionale”, in cui l’atto pubblico di decidere perde progressivamente legittimazione e, allo stesso tempo, non produce nuove forme di fraternità. Verso una fraternità debole L’ “universale sradicamento”, prodotto dalla crisi dei legami solidaristici tipici delle società di welfare e dall’avanzamento della New Economy, rende sempre più intollerabile le forme di precarietà lavorativa, e porta gli individui a ricostruire su nuove basi – territoriali, etnico-razziali, e religiose – forme alternative di fraternità. L’azione congiunta di processi migratori dall’Africa e dell’Asia, il crollo dell’impero sovietico e i conflitti bellici esplosi nelle aree mediorientali e nei Paesi della ex-Jugoslavia hanno posto all’ordine del giorno, anche in Italia, il tema della “con-vivenza” tra individui e gruppi portatori di “istanze di riconoscimento” diverse e difficilmente armonizzabili nelle decisioni adottate dallo Stato di diritto, la cui sovranità popolare vacilla in corrispondenza con la sostituzione dell’idea di nazione con quella di società plurale. La percezione del rapido sviluppo tecnologico – con la sua carica destabilizzante sulle coscienze individuali – e il mix tardo-moderno di enfasi circa la centralità della decisione umana nel prevenire/evitare le catastrofi e, con- 187 188 Ibidem, pp. 135-6. Ibidem, p. 137. 156 Capitolo 3 testualmente, di progressiva sfiducia nella capacità di decidere rispetto a temi su cui anche la scienza si mostra incerta, danno vita al timore di commettere un errore fatale che potrebbe distruggere la vita sulla Terra. Il risultato di queste tendenze è che il Diritto – innanzitutto la sanzione penale – sembra non assolvere più la funzione di mantenimento della coesione sociale indicata da Durkheim: non è più in grado di affrontare adeguatamente e tempestivamente le situazioni che è chiamato a regolare. Le decisioni politiche e giudiziarie appaiono lunghe e inefficaci; le leggi, sempre più numerose, acquistano una valenza unicamente espressiva: mostrano all’opinione pubblica la volontà politica di presa in carico di un problema, ma spesso nulla di più. Il Diritto s’indebolisce, perdendo la capacità di definire i confini della moralità di una società, di produrre forme di integrazione e di socialità. La società attuale, dunque, risulta poco coesa e orientata verso una “fraternità debole”, una solidarietà frammentata, in cui individui soli nei luoghi del lavoro, privi di riferimenti istituzionali e regolativi, piccoli di fronte all’enormità dei rischi immanenti, cercano disperatamente forme di fraternità forti dal punto di vista identitario, ma spesso contrapposte ed esclusive: forme di fraternità identitarie non solidali. 3.5 Dalle insicurezze tardo-moderne alla paura della criminalità Crisi e sfiducia alla base delle insicurezze tardo-moderne In questo capitolo ho analizzato alcune trasformazioni dell’epoca tardomoderna, articolandole intorno ai concetti di libertà, uguaglianza e fraternità. Questi tre ideali hanno costituito l’ossatura della cultura moderna e il loro attuale “frammentarsi” comporta un senso generale di crisi che mina la fiducia nella capacità collettiva – che in epoca moderna è rappresentata dalla capacità degli Stati nazionali – di regolare la vita sociale. Nella letteratura sull’insicurezza sociale tardo-moderna i concetti di “crisi” e di “sfiducia” risultano centrali. Il primo, così come elaborato dai teorici della tarda modernità, trascende la tradizionale visione marxista secondo cui costituiva un “memento mori” 189 del sistema capitalistico, antecedente alla fuoriuscita dal Capitalismo, fase di 189 G. Marramao, op. cit. a nota 13, p. 80. Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 157 passaggio da un sistema perennemente in crisi a un sistema basato sulla trasparenza e sul consenso. L’accento ora non è più tanto sulle contraddizioni strutturali del Capitalismo e sui meccanismi di produzione della ricchezza, quanto sul complesso intreccio tra tre livelli: quello socio-economico, quello politico-istituzionale e quello antropologico-culturale. La crisi è l’esito della frantumazione delle forme di relazione, consolidatesi nel corso della modernità, tra cittadini, tra cittadini e lavoro, tra cittadini e identità, tra cittadini e città, tra cittadini e natura, tra cittadini e Stato. È una crisi delle forme tradizionali di “cittadinanza”, accompagnata da una difficoltà di intravedere strade per uscirne “bene”. Il tema in discussione, pertanto è la “sfiducia” in se stessa della cultura occidentale. 190 Sfiducia delle società democratiche nella capacità di autorigenerarsi, di creare modalità di convivenza che permettano di far avanzare, su nuove basi, l’ideale di progresso sociale e umano che ha caratterizzato la modernità, evitando la regressione, drammaticamente attuale, a forme di atomizzazione identitaria della vita sociale. La “contraddizione”, tipicamente moderna, tra realtà in cui si vive, spesso dura, e idealità da perseguire, con fiducia e convinzione – ben espressa dall’espressione gramsciana “pessimismo della ragione e ottimismo della speranza” –, sembra risolversi oggi in una “coerente”, pessimistica, sensazione di “fine del mondo”, in cui la speranza non rileva – neppure quando gli sforzi di persone e istituzioni producono positività – e domina l’angoscia. Le insicurezze tardo-moderne difficilmente possono essere scomposte in insicurezze della condizione umana – quelle angosce comuni a tutti i nostri antenati e a tutte le culture –, da una parte, e in insicurezze del nostro tempo, dall’altra.191 La percezione della “fine del mondo” insinua un senso di precarietà che è esistenziale e, insieme, culturale. È “esistenziale”, perché colpisce alla radice il sistema di stabilità di ciascuno192, costruito intorno alla capacità di procurarsi cibo attraverso il lavoro, di ripararsi da eventi dannosi e di proteggersi dall’attacco degli altri; ma è 190 J. Habermas, op. cit. a nota 37, p. 15. Si noti come il tema della fiducia ricorra, con accenti e sfumature diversi, nelle diverse discipline che affrontano il tema della crisi, dell’insicurezza e della paura della criminalità. In questo modo, i risultati degli studi criminologici sulla fiducia istituzionale e sulla collective efficacy non appaiono così distanti dalla letteratura sociologica e filosofico-politica che individua la centralità della fiducia nella comprensione della sensazione contemporanea di disorientamento e di precarietà. 191 M. Valcarenghi, op. cit. a nota 160. 192 Gli etologi hanno dimostrato come sia difficile abdicare a comportamenti consueti senza essere assaliti dall’ansia del non sperimentato. Cfr. Ibidem, p. 108. 158 Capitolo 3 anche “culturale”, perché le minacce de-stabilizzano un sistema di certezze tipico della nostra epoca e radicato nella nostra cultura. Così, la stabilità del posto di lavoro è, nel nostro sistema socio-culturale, la condizione che permette di accedere ai beni e ai servizi necessari a vivere e sopravvivere, ma un elemento che fornisce un’identità stabile a partire dalle quali dare significato alle esperienze quotidiane. Il passaggio da un lavoro fisso a un lavoro precario provoca insicurezza in quanto mette a repentaglio la continuità dell’accesso a beni e servizi e destabilizza l’identità individuale. Inoltre, la precarietà è esistenziale e culturale insieme, in quanto la percezione stessa di ciò che minaccia la nostra esistenza è l’esito di una “costruzione culturale”. Il fatto che un evento potenzialmente dannoso sia considerato in termini di “rischio”, e sempre meno in termini di “pericolo”, muta la nostra relazione con lo stesso: il distacco da una visione fatalistica del rapporto tra uomo e natura – ma anche tra uomo e uomo – incrementa la percezione dell’ “evitabilità” delle minacce e, di conseguenza, anche le aspettative di protezione. La precarietà dell’esistenza viene vista come l’esito di scelte; l’insicurezza ontologica tende così a confondersi con l’insicurezza del nostro tempo, poiché il nostro tempo ha convertito ogni minaccia esistenziale in rischio calcolabile e prevedibile. Con l’aggravante che l’incertezza della scienza ha inevitabilmente reso incerta anche questa previsione. Il calderone dell’insicurezza e la paura della criminalità Finora ho descritto come il sentimento collettivo d’insicurezza costituisca l’esito di tendenze economiche, sociali e culturali (ma probabilmente l’ordine degli aggettivi potrebbe essere anche invertito) che caratterizzano le società tardo-moderne. Come si colloca la paura della criminalità nell’ambito di questa riflessione sociologica? Bauman, per descrivere l’insicurezza parla di un generalizzato sentimento di disagio esistenziale, il “calderone dell’Unsicherheit”.193 Il termine tedesco sicherheit (ma anche il termine italiano sicurezza) condensa in una sola parola fenomeni complessi che in inglese vengono espressi con tre parole diverse, insecurity, uncertainty e unsafety, (sicurezza esistenziale, certezza e sicurezza personale) che designano, a loro volta, tre tipologie di esperienze diverse ma convergenti nel terreno comune dell’angoscia. Le tre componenti 193 Z. Bauman, op. cit. a nota 14. Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 159 della sicherheit sono le condizioni della sicurezza di sé e della fiducia in sé, da cui dipende la capacità di pensare e agire in modo razionale. Il significato e l’attuale declino di queste forme di sicurezza viene spiegato da Bauman attraverso tre ossimori: insecure security, uncertain certainty, unsafe safety. La “sicurezza insicura” è la sensazione che rimanda alla condizione del lavoro precario e a una sicurezza sociale sempre più minacciata, simile a quella «che potrebbero provare i passeggeri di un aereo nello scoprire che la cabina di pilotaggio è vuota, che la voce rassicurante del capitano era soltanto la ripetizione di un messaggio registrato molto tempo prima»194 La “certezza incerta” riguarda i meccanismi stessi del liberismo: Contrariamente a quanto suggerisce il supporto metafisico della “mano visibile”, il mercato non persegue la certezza, né può evocarla, né tanto meno garantirla. Il mercato prospera sull’incertezza (chiamata di volta in volta competitività, deregolamentazione, flessibilità, ecc.) e ne produce sempre di piùn per il proprio nutrimento. Lungi dall’essere la rovina di una razionalità forgiata sul mercato, l’incertezza ne è una condizione necessaria e un prodotto inevitabile. L’unica uguaglianza favorita dal mercato è una condizione identica o quasi identica di incertezza esistenziale, condivisa tanto dai vincitori (sempre, per definizione, tali “fino a ulteriore avviso”) quanto dai vinti.195 Per spiegare il terzo ossimoro, traducibile con l’espressione “incolumità a rischio”, Bauman utilizza ancora una metafora sul viaggio: «il viaggiatore non può scegliere quando arrivare né quando partire. L’orario degli arrivi e delle partenze non è compilato dai viaggiatori, e non c’è nulla che essi possano fare per modificarlo»196. L’unsafety è riconducibile all’intrinseca mortalità propria della persona umana che diventa “terrificante” nel momento in cui perdono di valore quelle “soluzioni collettive ai tormenti della mortalità individuale” costituite dall’appartenenza nazionale e dalla famiglia, i cui messaggi erano simili: la mia vita per quanto breve non è stata inutile né priva di significato se nel suo piccolo ha contribuito a perpetrare un’entità più ampia di me stesso (o di qualsiasi altro individuo come me), la quale precede e supererà in durata l’arco di tempo della mia stessa vita, per quanto a lungo io possa vivere; è quel contributo ad assegnare un ruolo immortale alla vita mortale.197 194 Ibidem, p. 28. Ibidem, p. 38. Ibidem, p. 42. 197 Ibidem, p. 45. 195 196 160 Capitolo 3 L’idea centrale di Bauman è la nostra assoluta impotenza di fronte alle prime due forme di Unsicherheit, non solo per il loro carattere globale, ma anche per la scomparsa di qualsiasi dimensione pubblica, e quindi politica, che li possa affrontare. «Dobbiamo avere qualcosa di cui preoccuparci, e non una cosa di qualsiasi genere, ma una cosa precisa, tangibile: qualcosa da poter almeno immaginare alla nostra portata e sotto il nostro controllo, qualcosa “sulla quale poter intervenire”».198 Siamo totalmente dipendenti dai processi globali e privi di un’agorà, di un luogo pubblico di incontro/confronto delle differenze, e troviamo (o crediamo di trovare) facilmente una forma di radicamento della domanda di beni politici locali e dal valore fortemente comunitario. In questo senso, «la protezione dell’ “incolumità” finisce per assorbire la difesa dell’insecurity e dell’uncertainty».199 Da queste considerazioni si possono trarre alcuni tratti essenziali di quella che si potrebbe definire “versione sociologica” della paura della criminalità: questa viene com-presa nel calderone dell’Unsicherheit: la sensazione di minaccia alla propria incolumità – di cui la fear of crime è parte essenziale – viene osservata nell’ambito del disagio esistenziale dell’uomo tardomoderno, costituendone, in qualche modo, una modalità espressiva privilegiata: «il discorso sulla fear of crime [diventa] il luogo appropriato in cui si riversano ansie generate altrove»200. Le differenze tra la versione criminologica (cap. 2) e quella sociologica sono evidenti. Gli studi criminologici hanno affrontato il tema della paura della criminalità dandone per scontata la rilevanza sociale. Hanno risposto a un bisogno sociale (e politico) di comprensione di un’ “emergenza”, elaborando una “versione” della paura che ne consentisse anche una “gestione” appropriata. In tal modo, la ricerca si è sviluppata intorno all’idea che questo fenomeno fosse preminente, contingente e riducibile con policies efficaci (par. 2.6). Diversamente, la letteratura sociologica ne ha evidenziato le radici economiche, sociali e culturali; ha mostrato come questo “oggetto” della ricerca criminologica sia solamente la parte emergente di un iceberg, costituito da insicurezze, angosce e paure comprensibili in uno scenario di crisi e di sfiducia diffuse; in tale versione, la paura della criminalità perde di centralità – 198 Ibidem, p. 51. Cfr. A. Dal Lago, “Esistenza e incolumità. Una nota sulle recenti opere di Zygmunt Bauman”, Rassegna Italiana di Sociologia, XLI, N. 1, 2000, p. 139. 200 W. Hollway, T. Jefferson, “The Risk Society in an Age of Anxiety: Situating Fear of Crime”, The British Journal of Sociology, Vol. 48, N. 2, 1997, p. 265. 199 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 161 l’attenzione è rivolta principalmente alle radici strutturali e culturali –, viene spogliata del suo carattere contingente – permane al permanere dei mutamenti epocali che la “comprendono” – e risulta difficilmente riducibile con interventi mirati. La centralità della paura nelle narrazioni quotidiane La “paura della criminalità” raramente appare nelle pubblicazioni sociologiche che abbiamo considerato, e anche quando appare, viene solitamente descritta come un “epifenomeno” o un “canale di sfogo” di angosce esistenziali più profonde. In questo modo, la sua presenza viene posta ai margini della “narrazione scientifica”, quando invece le “narrazioni quotidiane” – nelle sedi politiche, nei luoghi pubblici, nei mass-media, nei bar, nelle case private, per la strada, sugli autobus – la mettono costantemente al centro. Di paura della criminalità si parla spesso e ovunque, e questa sua “pervasività” nella vita quotidiana e nei discorsi pubblici – a mio avviso – non può essere trascurata. Ritengo, in altre parole, che non si debba omettere di chiedersi quali siano le condizioni culturali che fanno di questo fenomeno un fatto socialmente e pubblicamente rilevante, denso di implicazioni morali e politiche. Dunque, per fare un passo in questa direzione, occorre chiedersi perché è proprio la paura della criminalità a costituire oggi la parte emersa dell’iceberg; come accade che l’Unsicherheit, concettualmente simile alla formless fear rilevata in alcuni studi criminologici, si esprima proprio in paura per la propria incolumità e non trovi, invece, altri canali di codificazione; e ancora perché la violenza è percepita come più concreta e più tangibile rispetto, per esempio, alla disoccupazione. Queste domande ri-posizionano nuovamente l’interesse scientifico sulla “centralità” della paura della criminalità, intesa, però, non più come “assunto” – come nella letteratura criminologica tradizionale – bensì come “oggetto di studio”. La selezione del rischio Nel tentativo di dare una risposta a tali quesiti, è necessario considerare centrale la questione della selezione sociale e politica del rischio: occorre 162 Capitolo 3 studiare quegli orientamenti socio-culturali che contribuiscono alla costruzione di un fenomeno come minaccia primaria da temere201. Diversamente da quanto ho sostenuto in un articolo del 2003202, ritengo oggi che le riflessioni sociologiche sulla riduzione dell’intervento pubblico in campi tradizionalmente occupati dalle politiche di welfare state, sull’accentuata tendenza del Capitalismo consumistico all’individualizzazione e sulla ricerca di identità in comunità omogenee, siano solo parzialmente utili a descrivere questi orientamenti. Queste tesi – che ho discusso e sostanzialmente condiviso – individuano alcune tendenze che rendono “com-prensibili” le paure contemporanee, ma non approfondiscono le ragioni per cui alcune paure occupano la scena più di altre. Infatti, in base a questi studi, la paura della criminalità viene definitivamente separata dal fenomeno criminale e inserita in una “rete” narrativa che posiziona al centro la “crisi della modernità” e la “sfiducia nella capacità regolativa”; purtuttavia, rimangono in gran parte inesplorati i motivi per cui alcune minacce sono più temute di altre. Nel prossimo paragrafo descriverò il tentativo di spiegare il percorso di selezione sociale e politica del rischio prioritario da temere attraverso il paradigma del “panico morale”, rilevandone, al contempo, i limiti. 3.6 Le ondate di “panico morale”: la centralità della paura quale esito di strategie politiche? Panico morale e dicerie Gli studi sul “panico morale” costituiscono un tentativo di spiegare il percorso attraverso cui la società seleziona, tra le tante minacce esistenti, quelle preferibilmente da temere. Il termine moral panic fu coniato da Stanley Cohen nel 1972 con riferimento al clima di allarme che rapidamente si formò intorno alla presenza, in talune località balneari della Gran Bretagna, di bande giovani denominate rocks e mods. 201 S. Roché, “L’insécurité: entre crime et citoyenneté”, Déviance et Société, Vol. 15, N. 3, pp. 301- 313. 202 R. Cornelli, “Paura della criminalità e allarme sociale”, in R. Selmini (a cura di), La sicurezza urbana, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 105-115. Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 163 Le società appaiono contrassegnate, di tanto in tanto, da periodi di panico morale. Una situazione, un episodio, una persona o un gruppo di persone inizia a essere definito come minaccia per i valori e gli interessi della società; la sua natura è presentata in un modo stilizzato e stereotipato dai mass media; vengono erette barricate morali da parte di giornalisti, religiosi, politici e altre persone di destra; esperti socialmente accreditati pronunciano le loro diagnosi e soluzioni; vengono sviluppate o (più spesso) si fa ricorso a modalità per affrontare il problema; la situazione poi sparisce, si sommerge, oppure deteriora e diventa più visibile. Qualche volta l’oggetto del panico è piuttosto nuovo e altre volte esiste da molto tempo, ma all’improvviso ritorna alla ribalta. Qualche volta il panico scivola via e viene dimenticato, eccetto che nella memoria popolare e collettiva; altre volte ha ripercussioni più serie e durature e può produrre cambiamenti nella politica sociale e legislativa o anche nel modo in cui la società concepisce se stessa. 203 L’uso del termine panico morale solitamente implica l’esistenza di una sproporzione (disproportionality) tra la reazione sociale e l’effettiva gravità (rischio, danno, minaccia) dell’evento204 e individua il suo carattere temporaneo, limitato e spasmodico (volatility): è «una vampata di rabbia che si spegne da sé»205. Il concetto di “panico morale”, dunque, identifica delle ondate emotive nelle quali un episodio o un gruppo di persone viene definito come minaccia per i valori di una società; i mass media ne presentano la natura in modo stereotipato; esperti, politici e altre autorità si pronunciano in diagnosi e rimedi, finché l’episodio scompare per poi ritornare a occupare la posizione precedentemente ricoperta nelle preoccupazioni collettive»206. Le ondate di panico morale sono caratterizzate da una reazione emotiva mista di paura, indignazione e rabbia, solitamente sproporzionata rispetto all’effettiva rilevanza dei problemi: si tratta spesso di problemi sociali che esistono da decenni ma che vengono ricostruiti nelle narrative mediatiche e politiche come “nuovi” (o come oggetto di una presunta e drammatica crescita recente). La loro incidenza è esagerata dalla presentazione di statistiche che, benché non confermate dagli studi scientifici (ma a volte accade anche 203 S. Cohen, Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers (Third Edition), Routledge, New York, 2002, p. 1. 204 Nell’introduzione alla terza edizione del 2002, Cohen riconosce il fatto che questa sproporzione risulti problematica se si considera che le questioni di simbolismo, emozione e rappresentazione, connesse alla reazione sociale, non possono essere facilmente trasferite in strumenti statistici comparabili. Ibidem, p. xxix. 205 Ibidem, p. xxx. 206 M. Maneri, “Il panico morale come dispositivo di trasformazione dell’insicurezza”, Rassegna Italiana di Sociologia, XLII, N. 1, 2001, p. 14. 164 Capitolo 3 questo!), vengono rimbalzate da un mezzo di comunicazione all’altro e diventano la base per politiche di stampo repressivo o discriminatorio. La reazione di panico non avviene per via di una valutazione razionale dell’incidenza di una particolare minaccia, ma è piuttosto l’esito di un nucleo di inquietudini non ben definite che, alla fine, trovano un centro drammatico e semplificato di esplosione in un singolo incidente o stereotipo, che funge da simbolo visibile delle inquietudini. Questo centro è costituito spesso dai suitable enemies, i “nemici appropriati”, termine che sta a indicare categorie di persone con poche o nessuna difesa. I tossicodipendenti, ad esempio, rientrano in questa categoria e sono facilmente bersagli di campagne di panico morale per via della loro debolezza: sono incapaci di mobilitare difese importanti all’interno della società; sono visti come pericolosi, preferibilmente come privi di umanità; rappresentano simbolicamente la negazione di tutto ciò che è giusto e buono. 207 Il panico morale si costruisce intorno a “dicerie” che, alimentate da massmedia, politici o “imprenditori morali” – persone che hanno interessi specifici al diffondersi di ondate di panico morale – costituiscono un sistema di credenze in grado di catalizzare gli umori collettivi e di orientare le politiche. Il fenomeno delle dicerie, come osserva lo storico Jean Delumeau, non è recente. L’importanza e la funzione delle dicerie nella civiltà dell’Ancien Regime sono state sottovalutate: il loro spuntare, o meglio la loro riapparizione periodica era una costante della vita delle popolazioni […] la propagazione di voci allarmistiche circolava sempre attraverso canali non istituzionalizzati, segnava il momento in cui l’inquietudine popolare raggiungeva il parossismo. […] Essa [la diceria] è identificazione di una minaccia e chiarificazione di una situazione divenuta insopportabile. Infatti, respingendo ogni incertezza la popolazione che accetta una diceria produce un’accusa. Il nemico pubblico è smascherato; e ciò è già un sollievo.208 Proprio con l’atto di accusa nei confronti di una categoria (gabellieri, affamatori, briganti, streghe, eretici, nomadi, untori, etc.), la comunità assumeva un atteggiamento di “vittima”, ponendo le basi per un’eventuale legittimazione di probabili reazioni violente verso persone in carne e ossa. 207 A. Cottino, “Panico morale e nemici appropriati: riflessioni in margine a due contributi di T. Mathiesen e di N. Christie-K. Brunn”, in A. Gasanti (a cura di), Giustizia e conflitto sociale. In ricordo di Vincenzo Tomeo, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 209-222. 208 J. Delumeau, La peur in Occident, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1978 (trad. it. La paura in Occidente (secoli XIV-XVIII) La città assediata, SEI, Torino, 1979, pp. 271-272). Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 165 Qualche anno prima che Cohen scrivesse Folk Devils and Moral Panic, un sociologo francese, Edgar Morin, e i suoi collaboratori studiarono il caso delle dicerie diffusesi nella città di Orléans nel 1969, parlando di una sorta di “panico medievale” che s’impadronì per alcuni giorni «di una città moderna nel secolo dei mass-media»209. Voci riguardanti la sparizione di donne misero a soqquadro tutta la città, benché nessun caso di questo tipo fosse stato segnalato alla polizia; si diffuse la “quasi certezza”, per migliaia di abitanti di Orléans, che la tratta delle Bianche venisse organizzata, proprio al centro della città, nelle sale di prova di sei negozi di abbigliamento, tutti ebrei. Questa diceria è l’espressione di un mito che non è locale, in quanto il tema della “sala di prova-tratta delle Bianche” e della chiamata in causa dei commercianti ebrei non sono originari di Orléans210, e che non è semplicemente “costruito” dai mass-media. L’apparizione di un articolo su Noir et Blanc – a detta di Morin – non è sufficiente a rendere conto della nascita dello scandalo a Orléans, in quanto «altrimenti non si comprenderebbe come mai questo settimanale, diffuso in tutta la Francia, non abbia suscitato nello stesso momento scandali analoghi nelle altre città del paese».211 Purtuttavia, il ricercatore francese sottolinea come non si possa escludere che questo articolo abbia risvegliato molteplici fantasmi, ma che, in ogni caso, l’elemento importante non è tanto “l’agente enzimatico iniziale”, quanto la forza di propagazione delle voci, una volta dato il primo avvio. La diceria, che trova la sua “incubazione” in ambienti favorevoli (come i Collegi religiosi femminili di alcune zone di Orléans), una volta messa in circolazione, si manifesta come una forza “selvaggia”, capace di “propagarsi” in maniera sbalorditiva; si nutre di tutto e trasforma anche le battute dei più scettici in evidenza accusatrice. Si dice che le boutiques, alcune delle quali distano molte centinaia di metri l’una dall’altra, siano collegate attraverso una rete di passaggi sotterranei, che confluiscono in un grosso collettore sulla Loira, dove, di notte, un battello e, secondo alcuni perfino un sottomarino, viene ad effettuare il carico (Lèvy assicura di aver lanciato il venerdì, per scherzo, l’idea del sottomarino, e di averla poi rincontrata il sabato, ormai trasformata in verità certa).212 209 E. Morin, La rumeur d’Orléans, Edition du Seuil, 1969 (trad. it., Medioevo moderno a Orlèans, ERI, 1979, p. 19). 210 Ibidem, pp. 25-28. 211 Ibidem, p. 28. 212 Ibidem, p. 34. 166 Capitolo 3 Lo scandalo marcia in tutte le direzioni, coinvolgendo anche le istituzioni. Ci si chiede come mai la polizia, che pure è al corrente di tutto non arresti i trafficanti e l’angoscia collettiva trova spiegazioni che si diffondono velocemente, aumentando il panico: la polizia, prefetto e stampa sono stati comprati dagli ebrei213 Passando dallo stato del “si dice” a quello di certezza, la diceria produce metastasi: provoca processi isterici, supera le barriere di età, di classi sociali e di sesso214 e produce un’accusa che denuncia dei colpevoli imputati di odiosi delitti. Alla fine del ciclo, contrastata da varie repressioni, si sparpaglia in un brulichio di mini-dicerie e di micro-miti derivati e sotterranei: torna nell’ombra, e aspetta una nuova occasione per riaffiorare, magari con un’altra maschera. Più di recente, lo storico Philip Jenkins, autore del libro Moral Panic: Changing Concepts of the Child Molester in Modern America215, affronta il delicato tema delle ondate di panico morale riguardanti il fenomeno del child abuse. Contrariamente al titolo provocatorio, questo libro è prima di tutto un’analisi di come i fatti sociali, le ortodossie e il controllo sociale si relazionano: Jenkins mostra come un singolo e apparentemente auto-evidente fatto sociale – il credere che i bambini siano di fronte a un grave pericolo costituito dalle molestie e dagli abusi sessuali – abbia attraversato le preoccupazioni sociali in tutta la storia dell’America moderna e incroci ancora le paure della società odierna. Nel fare questo, oltre a tracciare una storia del concetto di sexual maltreatment of children, offre un’analisi storica del perchè questo tipo di ondate di panico morale emergano all’improvviso. Il libro è una storia sul come la preoccupazione di questo fenomeno è fluttuata nell’ultimo secolo, sia come intensità e sia rispetto alla direzione dalla quale si pensa che le minacce provengano. Jenkins di fatto ricostruisce, in prospettiva storica e sociologica, le modalità con cui le percezioni di pericolo crescono e si diffondono, sottolineando il ruolo svolto dall’intervento dei politici, dei media, ma anche delle helping professions. L’autore affronta anche il tema delle modifiche intervenute nelle leggi e nella procedura penale come effetto di queste ondate di panico morale, tra cui l’attuale moltiplicazione di misure legislative sul modello della Megan’s 213 Ibidem. Ibidem, p. 98. P. Jenkins, Moral Panic: Changing Concepts of the Child Molester in Modern America, New Haven, Yale University Press, 1998. 214 215 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 167 Law (che richiede che le comunità siano avvisate della presenza di autori di reati sessuali) e la creazione di nuovi tipi di condanna penale basati sull’idea che si tratti di “malati irrecuperabili”: in alcuni Stati, i condannati per reati sessuali su minori possono essere rinchiusi in strutture ospedaliere psichiatriche anche oltre il periodo di espiazione della condanna, e in altri possono essere sottoposti alla castrazione chimica. In ogni caso – sottolinea Jenkins – il sexual abuse of children è stato usato e manipolato, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, al fine di capovolgere l’intero regime riabilitativo del sistema di giustizia penale, tanto che oggi ci si confronta con le conseguenze legislative di questo panico sociale.216 Un’applicazione del paradigma del panico morale, particolarmente articolata a documentata, è quella svolta da Alessandro Dal Lago all’interno del libro Nonpersone. L’esclusione dei migranti in una società globale: il sociologo italiano descrive analiticamente i processi che, in Italia, hanno portato alla costruzione dell’ “emergenza immigrazione”, sottolineando, in particolare, il ruolo ricoperto da mass-media, politici e imprenditori morali. Negli anni Novanta – afferma Dal Lago – le forze politiche hanno ceduto al panico verso l’immigrazione, chiudendo sempre più le frontiere, creando il binomio regolari-clandestini e relegando, nei fatti, la gestione dell’immigrazione nell’ambito dell’ordine pubblico. “Tautologia della paura” è l’espressione che l’autore usa per descrivere il processo per cui, a partire dalla paura per lo straniero, si arriva alla sua “indicazione” come nemico sociale numero uno, attraverso meccanismi di discrminazione e di trasformazione di opinioni di senso comune in atti d’accusa, operata principalmente da politici e imprenditori morali (o “definitori soggettivi della situazione”: coloro che offrono incessantemente ai media la “voce” e giustificano la «trasformazione di una risorsa simbolica generica in un frame morale e sociale dominante»217). La stampa entra in gioco rappresentando la pericolosità degli immigrati e la legittimità delle proteste dei cittadini, che diventano “canovacci narrativi” 218 dominanti in grado di influenzare le opinioni politiche e il segno delle misure legislative. 216 V. Jenness, “Moral Panic: Changing Concepts of the Child Molester in Modern America (review)”, Social Forces, Vol. 79, N. 3, 2001, pp. 1208-1211; P.J. Ryan, “Moral Panic: Changing Concepts of the Child Molester in Modern America (review)”, Journal of Social History , Vol. 35, N. 2, 2001, pp. 511-513. 217 A. Dal Lago, Dal Lago A., Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 76. 218 Ibidem, p. 73. 168 Capitolo 3 Questi casi descritti in letteratura mettono in luce tre aspetti che risultano fondamentali per valutare il contributo che il paradigma del panico morale può dare alla comprensione dei motivi per cui la paura della criminalità emerge dall’agglomerato indistinto formato dalle insicurezze tardo-moderne. 1) Innanzitutto, le fiammate di panico morale divampano laddove c’è un nucleo di inquietudini accumulate intorno a una pluralità di disgrazie o di minacce. 2) In secondo luogo, l’esplosione può essere spontanea oppure “costruita”, ma in ogni caso si stabilizza e dura nel tempo per l’intervento di alcuni agenti “provocatori” o “amplificatori”: principalmente, mass media, politici e imprenditori morali. 3) Infine, l’ ondata di panico morale costituisce una modalità collettiva per affermare determinati interessi, ma anche per ridefinire i confini della moralità, producendo un nuovo ordine. Questo terzo aspetto, negli studi sulla paura della criminalità, viene solitamente relazionato agli altri due e interpretato come strategia adottata dalle classi dirigenti per consolidare il consenso o riaffermare la propria supremazia, attraverso l’individuazione di un “capro espiatorio” che permetta di deviare l’attenzione del pubblico su problemi in realtà più scottanti. In questa direzione, Marcello Maneri sostiene che le ondate di panico morale costituiscono un efficace teatro per la rappresentazione del legame che unisce politici, agenti del controllo sociale e media da una parte, e «gente» dall’altra. In particolare i politici vengono legittimati come rappresentanti e – insieme alle istituzioni addette al controllo sociale – come protettori; i media come portavoce. Le istituzioni della rappresentanza politica beneficiano più delle altre della costruzioni di un «noi» omogeneo, opaco e consensuale219. Così, la paura dei cittadini verso il fenomeno criminale, come già disse Quinney riferendosi all’insorgere di questo tema negli Stati Uniti degli anni Sessanta, è alimentata dalle élites dominanti della società per distogliere l’attenzione da fatti ben più gravi, canalizzando le insicurezze delle persone in una paura funzionale alla creazione di consenso attorno al potere costituito o alla produzione di nuove strategie di ordine sociale. 220 219 M. Maneri, op. cit. a nota 206, p. 14. Analogamente, Isabella Merzagora Betsos e Guido Vittorio Travaini affermano che «lo scomposto allarme è una strategia spesso indotta, per la quale si necessita di strumenti mediatici, efficace strumento nelle mani dei manipolatori per restringere l’autonomia degli adulti – come si fa con gli spauracchi nei confronti dei bambini per inibirne l’esploratività e l’autonomia – appunto a fini in senso lato politici» (I. Merzagora Betsos, G.V. Travaini, “Criminalità e paura: una relazione complessa”, Difesa Sociale, Vol. LXXXII, N. 3, 2003, p. 54). 220 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 169 Abbiamo già rilevato come questa affermazione sia troppo generica se considerata alla luce dei fatti storici accaduti in quel Paese in quegli anni.221 L’affermazione risulta eccessivamente semplificatrice anche nel caso in cui s’intenda esplorare a pieno la potenzialità esplicativa contenuta nel punto 3) ed evidenziata dagli studiosi delle “dicerie” (Morin, Delumeau): la diffusione di panico morale è l’effetto non solo di campagne messe a punto dalle classi dominanti per distogliere l’attenzione del pubblico su fatti gravi, quali la recessione economica, e dai ceti medi (imprenditori morali), che utilizzano il panico sociale per ottenere l’accoglimento di istanze da parte delle istituzioni statuali, ma anche dell’emergere, diffuso e trasversale a categorie professionali e gruppi sociali, di un nucleo di inquietudini che mostra un’esigenza diffusa di riconsiderare i confini giuridici e morali di una società. In effetti, osservando la proliferazione dei discorsi sulla paura della criminalità in vari contesti sociali, mi sono convinto che le persone, che vivono in famiglia, che lavorano in uffici o aziende, che si uniscono in associazioni, gruppi, comitati, che vivono nelle istituzioni formali, non sono semplicemente spettatori, ma, al contrario, contribuiscono in maniera determinante alla circolazione nella società dell’argomento “paura della criminalità”. Questo argomento a volte emerge dal basso, quando gruppi di cittadini si riuniscono per chiedere maggiore sicurezza a forze dell’ordine, politici ed amministratori. Altre volte emerge nei rapporti tra istituzioni formali, come quando i Sindaci richiedono maggiori fondi per la sicurezza al governo nazionale o il governo nazionale richiede che il sistema di Giustizia penale sia più sensibile alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Altre volte ancora emerge in modo casuale, o meglio attraverso percorsi difficili da ricostruire, coinvolgendo diversi contesti e diversi attori sociali. In questo senso, la paura della criminalità non è solo un’emozione individuale, manipolabile “a piacere” dal potere costituito; nel momento in cui diventa terreno di scontro politico, di confronto tra istituzioni e di rivendicazioni sociali, attraverso cui si creano nuovi aggregati sociali, nuove istituzioni e nuove modalità comunicative, la paura della criminalità trascende le volontà e gli obiettivi dei singoli individui, divenendo un “costrutto culturale” – e non semplicemente un “prodotto politico”. 221 M. Lee, “The genesis of ‘fear of crime’ ”, Theoretical Criminology, 2001, Vol. 5(4), pp. 467-485. 170 Capitolo 3 Si tratta semplicemente di manipolazione? L’adozione della prospettiva tradizionale del panico morale porta a interpretare la centralità della paura verso la criminalità come l’esito di una costruzione politica e mass-mediatica volta a dare alle persone un oggetto “disponibile” (albanesi-violenti, marocchini-ladri, indultati-recidivi, nomadipericolosi) su cui riversare le proprie angosce, altrimenti esplosive in altri contesti, e a costruire/consolidare il consenso attraverso l’adozione di misure di giustizia espressiva (aumento delle pene, aumento della repressione poliziesca, aumento dell’area del penalmente rilevante). In estrema sintesi, esplode la paura della criminalità e non, per esempio, la paura di perdere il posto di lavoro perché la prima è innocua per le élites dominanti e, anzi, costituisce una risorsa disponibile per una loro ri-affermazione sociale. Ma le persone hanno paura della criminalità solamente perché c’è “qualcuno” che le induce a temere quel pericolo più di altri? Il processo di selezione sociale attraverso cui la criminalità diventa la minaccia da temere per l’intera collettività si risolve unicamente nella costruzione della paura ad opera di politici, mass-media e imprenditori morali? Riformulando – ma sostanzialmente confermando – il quesito da cui prende le mosse una recente riflessione di Alessandro Dal Lago sul pensiero di Bauman, come è possibile spiegare l’installarsi della paura della criminalità nelle nostre società benestanti senza affidarsi a teorie del complotto o della manipolazione mediale?222 Ritengo che occorra partire da alcuni spunti offerti dalla Teoria culturale sul rischio di Mary Douglas223. Gli studiosi di percezione del rischio a lungo si sono occupati solamente di capacità cognitiva dell’individuo di fronte al rischio senza riconoscerne la politicità del concetto di rischio224. Per “politicità del rischio” Douglas intende la sua dipendenza da differenti visioni del mondo, che sottintendono differenti strutture di conoscenza e differenti sistemi di valore, i quali determinano le modalità con cui differenti gruppi affrontano l’esperienza comune di eventi o azioni pericolose. «Quando si trovano a dover calcolare le probabili222 A. Dal Lago, op. cit. a nota 199, p. 132. M. Douglas, Risk And Blame, Routledge, London-New York, 1992 (trad. it. Rischio e colpa, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 67). 224 Per addentrarsi nella fitta letteratura sulla percezione del rischio, privilegiando l’approccio culturalista, si veda M. Douglas, Risk Accettability According To The Social Science, Russel Sage, New York, 1986 (trad. it. Come percepiamo il pericolo: antropologia del rischio, Milano, Feltrinelli, 1991). 223 Le insicurezze delle società occidentali tardo-moderne 171 tà e valutare l’attendibilità [dei rischi], essi [gli individui] sono già imbevuti di assunti e orientamenti acquisiti culturalmente».225 Questi assunti e orientamenti hanno a che fare con la forma di relazioni sociali che la persona mantiene, con i pregiudizi culturali, come i valori condivisi e le credenze (inclusa quindi la visione del mondo e dei rapporti sociali), con le strategie comportamentali preferite e con il tipo di organizzazione in cui si vive226. Un ruolo fondamentale per le modalità di percezione del rischio è ricoperto proprio dalle istituzioni, cui gli individui «hanno attribuito il carattere di elaboratori di decisioni capaci di escludere determinate alternative e ammetterne altre». 227 Non ci sono scorciatoie, a quanto pare. Per comprendere i motivi per cui la paura della criminalità è così presente e pervasiva nelle società occidentali, occorre indagare, più che le modalità individuali di percezione del singolo individuo, quegli assunti e quegli orientamenti culturali comuni a larghe fasce di popolazione, che, radicandosi nelle forme istituzionali, costruiscono il modo in cui percepiamo ciò che sta intorno a noi. Ed è la via che intendo percorrere nel prossimo capitolo. 225 M. Douglas, op. cit. a nota 223, p. 67. Ibidem, 94. 227 Ibidem. 226 Capitolo 4 La paura della criminalità al centro della modernità Non c'è mai stata un'epoca che non si sia sentita, nel senso eccentrico del termine, moderna, e non abbia creduto di essere immediatamente davanti a un abisso. La lucida coscienza disperata di stare nel mezzo di una crisi decisiva è qualcosa di cronico nell'umanità. Walter Benjamin 4.1 Paura, violenza e ordine Agli albori della modernità Da sempre le paure e le angosce accompagnano la vita quotidiana degli individui, esprimendosi in modi diversi a seconda delle epoche storiche. E da sempre gli uomini si sono adoperati per attenuare le proprie insicurezze, attraverso la ricerca di protezioni, che sono espressione del particolare setting sociale, economico e culturale in cui sorgono. Nel Medioevo e fino al XVII secolo la precarietà delle condizioni di vita materiale dovuta alle epidemie, alla fame, al freddo e alla mortalità infantile si accompagnarono a un’inquietudine diffusa, un’angoscia, che trovò espressione e risposta, per lo più, nel sentimento religioso1. 1 Cfr. H. Lagrange, S. Roché, L’insécurité: histoire et regulation, IHESI, Paris, 1993, p.52. 173 174 Capitolo 4 L’importante lavoro di riscoperta del ruolo della paura nella storia operato di Jean Delumeau2, che si concentra sui secoli XIV-XVIII, evidenzia l’importanza di guardare ai timori collettivi, della massa come delle classi dirigenti, come elemento per comprendere la vita individuale e collettiva. Le fiammate periodiche di paura suscitate dalle pestilenze fino alla metà del XVIII secolo, le frequenti rivolte provocate un po’ dovunque, a volte dal timore della soldataglia o dei briganti, a volte dalla minaccia della fame o del fisco, hanno punteggiato […] un lungo periodo di storia europea che va dalla fine del XIII secolo fino agli inizi dell’età industriale.3 Frastornati da tragiche coincidenze e dall’incessante succedersi di calamità, come la Peste Nera, che segna nel 1348 il ritorno delle epidemie mortali, i cattivi raccolti dovuti alle mutate condizioni climatiche, le continue rivolte urbane e rurali, l’avanzata turca, la decadenza morale del papato prima della ripresa ad opera della Riforma cattolica, la secessione protestante con tutte le sue conseguenze, reciproche scomuniche, massacri e guerre, gli uomini dell’epoca cercarono una spiegazione a queste avversità che permettesse loro di uscire dalla paura e questa spiegazione, operata all’interno di una riflessione teologica, fu essa stessa all’origine di nuove paure più ampie e impressionanti. Proprio gli uomini della Chiesa affrontarono l’angoscia e l’incertezza derivanti dall’accumularsi di aggressioni – di eventi naturali e umani, reali e percepite – che colpirono le popolazioni occidentali all’inizio del XVII secolo indicando il colpevole in Satana e definendo l’inventario dei mali che è capace di provocare e la lista dei suoi agenti: Turchi, Ebrei, eretici e donne (specialmente le streghe). L’Inquisizione trovò la propria ragion d’essere e il motivo della propria durata proprio nella paura di un nemico sempre risorgente: l’eresia che sembrava assediare senza tregua la Chiesa 4. Si trattava di un catalogo di situazioni e di categorie di persone ingeneranti paure concrete e circoscritte in grado di arginare la distruttività dell’angoscia, 2 J. Delumeau, La peur in Occident, 1978, Librairie Arthème Fayard, Paris (trad. it. La paura in Occidente (secoli XIV-XVIII) La città assediata, SEI, Torino, 1979). 3 Ibidem, p. 305. 4 Ibidem, p. 23. La paura della criminalità al centro della modernità 175 Vale la pena sottolineare come proprio agli albori della nascita del mondo moderno e per tutto il Rinascimento5, in Europa vi fosse un’ampia diffusione di paura6 e di pessimismo generale sull’avvenire dell’umanità. Johan Huizinga sottolineava come chi studia davvero a fondo quell’epoca [XV secolo], ha spesso difficoltà a rintracciarne gli aspetti positivi, perché dovunque, al di fuori della sfera dell’arte, regna il buio. Nei minacciosi ammonimenti dei sermoni, negli stanchi gemiti della letteratura più elevata, nelle monotone relazioni delle cronache e dei documenti, dappertutto urlano i pittoreschi peccati e piange la miseria.7 E ancora: «[…] ogni ricerca, fatta su un materiale qualsiasi, conferma le idee più cupe. È un mondo cattivo. Il fuoco dell’odio e della violenza divampa, l’ingiustizia è potente, il diavolo copre con le sue nere ali una terra tetra. L’umanità attende da lì a poco la fine di tutte le cose».8 Nessuna epoca ha inculcato l’idea della morte con tanta enfasi quanto il XV secolo. Con il fiorire degli ordini mendicanti si affermò la predicazione popolare che, insieme alla diffusione della xilografia, costituì un mezzo di espressione di massa che rese l’idea della morte una rappresentazione molto semplice, immediata e violenta.9 Parole e immagini10 costruirono un “linguaggio della paura”, una sorta di mappa simbolica e cognitiva costruita collettivamente e in grado di orientare 5 J. Delumeau, La péché et la peur. La culpabilization en Occident (XIII-XVIII siècles), Fayard, Paris, 1983 (trad. it. Il peccato e la paura. L’idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo, Il Mulino, Bologna, p. 11). 6 Ancora Delumeau ricorda come la ricerca storica abbia in gran parte sfatato la leggenda dei terrori dell’Anno Mille fondato su testi poco numerosi e posteriori agli spaventi che pretendeva di far rivivire e come gli storici siano «unanimi nel ritenere che a partire dal XIV secolo si produssero in Europa una recrudescenza e una più larga diffusione della paura della fine dei tempi» (J. Delumeau, op. cit. a nota 2, p. 307). 7 J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, 1919 (trad. it. L’autunno del Medioevo, Newton & Compton, Roma, 1992, p. 45). 8 Ibidem. 9 Ibidem, p. 162. 10 «L’iconografia, a partire dal gotico fiorito fino a quella del manierismo, ha rappresentato instancabilmente e con un piacere morboso le quattro componenti dell’angoscia identificate dai moderni test […] il Medio Evo classico non aveva insistito in maniera così accentuata sulle sofferenze dei suppliziati. I confessori della fede si presentavano generalmente con una spetto trionfale […]. Non furono certamente mai dipinte nelle chiese tante scene di martirii, non meno ossessive per il formato dell’immagine che per la dovizia dei dettagli, di quante se ne dipinsero tra il 1400 e il 1650. I fedeli non avevano che l’imbarazzo della scelta: venivano rappresentati sant’Agata con i seni mozzati, santa Martina con il volto insanguinato da unghie di ferro, san Levino a cui fu strappata la lingua e gettata ai cani. San Bartolomeo scorticato, san Vitale sepolto vivo, sant’Erasmo a cui furono estratti gli intestini». J. Delumeau , op. cit. a nota 2, pp. 33-34. 176 Capitolo 4 l’osservazione e l’interpretazione della realtà: «si venne a costituire una sorta di “paese della paura”, nel cui interno tutta una cultura venne a trovarsi in uno stato di “malessere” e che essa popolò di fantasmi morbosi»11. La sensazione generale di insicurezza, che dava un tono cupo alla vita, colpiva non solamente gli umili e i poveri, ma anche i nobili e i magistrati, soggetti continuamente a rapidi cambiamenti di fortuna e a continui pericoli. 12 È in questo clima di pessimismo che, paradossalmente, cominciarono a intravedersi percorsi per uscire dal senso di crisi, e presero forma, come indicherò in questo capitolo, riflessioni filosofiche come quelle di Hobbes sulla “paura reciproca” a fondamento dello Stato moderno. La paura diffusa, lungi dall’immobilizzare la società, divenne, al contrario, stimolo al cambiamento, esercitando quella funzione emancipativa descritta dai classici del pensiero moderno e, di recente, anche da Elena Pulcini13, secondo cui questo stato d’animo può portare a una rinnovata consapevolezza che in fondo tutti gli uomini sono accomunati dalla condivisione della vulnerabilità e della debolezza di fronte alle minacce da essi stessi prodotte, alla presa di coscienza di quel rischio supremo e definitivo che è l’autodistruzione. Si potrebbe dire che la società moderna affondi le proprie radici proprio in quello stato di violenza e di paura descritto dagli storici e, in un certo senso, sia l’esito dei tentativi (e delle speranze) di uscirne. Ma, nonostante gli indubbi benefici – in termini di sicurezza, libertà e conquiste sociali – che la civiltà moderna ha recato all’umanità – beninteso, all’umanità di questa parte della Terra –, la paura è ancora tra noi. Oggi più di prima. In che modo è possibile comprendere oggi il suo riemergere pervasivo, la sua “invasione” nella vita quotidiana degli abitanti delle società occidentali? È sufficiente inserire la paura della criminalità nella rete delle insicurezze tardo-moderne, oppure occorre riflettere ab origine sulla sua presenza nella modernità? 11 Ibidem, p. 37. Huizinga si sofferma sulla vita emblematica di Mathieu d’Escouchy, storico dell’epoca, che ricoperse molte cariche pubbliche, ma al tempo stesso fu parte di faide familiari, scontri violenti in cui venne anche ferito, imputato e arrestato più volte e anche accusatore, in un processo di stregoneria. «Ogni volta che ripercorriamo le vicende delle persone menzionate nelle fonti di quell’epoca, troviamo un’identica immagine di vite molto intense». J. Huizinga, op. cit. a nota 7, pp. 48-49. 13 Elena Pulcini parla espressamente di “funzione emancipativi” della paura (E. Pulcini, “L’Io globale: crisi del legame sociale”, in D. D’Andrea, E. Pulcini (a cura di), Filosofie della globalizzazione, Edizioni ETS, Pisa, 2002, pp. 57-83). 12 La paura della criminalità al centro della modernità 177 Paura e ordine: l’individuazione di un percorso di analisi criminologica Nella maggior parte della letteratura sociologica, come abbiamo visto, il discorso sull’insicurezza viene indicato come tratto caratteristico della nostra epoca tardo-moderna. Nel capitolo 2 si è visto come la promessa moderna di libertà, uguaglianza e fratellanza, fondata sulla fiducia nella possibilità di contenere la violenza, attraverso l’affermazione di un ordine sociale condiviso, e di controllare la natura, attraverso il progresso scientifico e tecnologico, stia vacillando sotto il peso di trasformazioni sociali, culturali e istituzionali che danno consistenza al senso diffuso di crisi dei nostri giorni, e che costruiscono le insicurezze del nostro tempo. In questa versione, la paura della criminalità viene com-presa come epifenomeno di un sentimento d’insicurezza che ha radici molto profonde. A volte la paura della criminalità viene sottintesa, definita semplicemente come parte emergente di un malessere sommerso (la parte visibile dell’iceberg); altre volte viene spiegata all’interno del paradigma del “panico morale”: il sentimento individuale di paura verso la criminalità viene alimentato dalle élites dominanti della società per distogliere l’attenzione da fatti ben più gravi, per canalizzare le insicurezze delle persone in una paura individuata e funzionale alla creazione di consenso attorno al potere costituito, attraverso l’individuazione di capri espiatori, o alla produzione di nuove strategie di ordine sociale. Queste versioni della paura della criminalità ampliano la comprensione del fenomeno in quanto situano questa emozione all’interno di trasformazioni sociali, culturali e istituzionali, indicandola in tal modo come parte di un sentimento diffuso, o anche all’interno di strategie di produzione dell’ordine, mettendone in luce il fatto che si tratti di un’emozione “costruita” politicamente e culturalmente. La paura costituisce l’occasione per parlare di ciò che ciascuna versione individua come il “cuore della questione” – la crisi della modernità, da una parte, le strategie contemporanee di produzione dell’ordine, dall’altra –; purtuttavia, e qui sta il limite che ho rilevato in queste versioni, la sua presenza viene posta ai margini della “narrazione teorica”, quando invece le “narrazioni quotidiane” – nelle sedi politiche, nei luoghi pubblici, nei mass-media, nei bar, nelle case private, per la strada, sugli autobus – la mettono costantemente al centro dell’attenzione. È possibile che questa centralità sia semplicemente l’esito di strategie di panico morale? La paura della criminalità è semplicemente una “risorsa disponibile” per affermare nuove strategie di produzione dell’ordine sociale basate sull’esclusione? 178 Capitolo 4 Gli studi sul panico morale hanno avuto il merito di evidenziare le funzioni politiche del discorso sulla paura della criminalità e di aver svelato al dibattito criminologico come la paura della criminalità sia un’emozione “costruita”. E, tuttavia, il processo di “costruzione” sembra più complesso di quello da loro individuato. Per sviluppare a pieno l’approccio costruttivista insito anche negli studi sul panico morale, nella premessa sulle passioni posto all’inizio di questo capitolo approfondirò una versione delle emozioni, che permetta di considerarne i processi di costruzione sociale e al tempo stesso di articolarne in modo diverso la “dimensione politica”. Soprattutto con gli studi di Norbert Elias e di Pierre Bourdieu si apre un filone di ricerca che introduce l’idea di una corrispondenza tra strutture sociali e strutture cognitive e affettive. Rom Harré, come illustrerò meglio di seguito, ha evidenziato come certe emozioni scompaiano quando non hanno più un mondo in cui “coltivarsi”, e come altre si trasformino quando il mondo cambia. In questo modo l’emozione perde la sua universalità per calarsi nella realtà socio-culturale in cui si costruisce e si esprime14. Ma l’emozione non è solo la ricaduta sull’individuo di una certa realtà socio-culturale, come sembra affermare chi ritiene che la paura della criminalità sia l’esito delle trasformazioni che caratterizzano la tarda modernità – provo paura come effetto di una perdita di punti di riferimento nelle istituzioni moderne –; è principalmente una modalità collettiva di “sentire” il mondo, un modo di relazionarsi affettivamente con il mondo che contiene elementi di valutazione e interpretazione delle situazioni che si vivono – ma anche spinte alla loro trasformazione –; un’ “esperienza del mondo” che, lasciando indeterminato il rapporto di causa-effetto, esprime il proprio legame con ciò che può essere indicato come “spirito dell’epoca” (dimensione culturale), interpretandolo continuamente e contribuendo a trasformarlo (dimensione politica). L’approccio costruttivista allo studio delle emozioni, come emergerà da quanto riferirò nel primo paragrafo, apre alla considerazione degli aspetti attivi della paura della criminalità, al suo essere principalmente un costrutto socio-culturale che, a sua volta, costruisce le relazioni con gli altri e con il mondo. 14 R. Harré (edited by), The social construction of emotions, Basil Blackwell, New York, 1986. La paura della criminalità al centro della modernità 179 Nel contempo porta a riflettere in maniera diversa al perché tra le insicurezze che caratterizzano la nostra quotidianità sia proprio la paura – e in particolare quella di subire una violenza – a pervadere i discorsi pubblici e privati. I padri del pensiero moderno, che hanno, per così dire, costruito l’architettura semantica della modernità, fissando le coordinate del pensare e del sentire, hanno attribuito a questa emozione una centralità inedita. Hobbes15 ha indicato la paura della morte violenta come quella passione che può muovere gli uomini alla pace e ha individuato questo stato d’animo come l’esperienza affettiva privilegiata della relazione con l’altro e con le istituzioni nella modernità. Non solo la paura della violenza spinge le persone a delegare allo Stato la protezione delle proprie libertà, ma la stessa passione, da “reciproca”, dell’uomo verso l’altro uomo, si trasforma in “comune”, di tutti gli uomini verso lo Stato e, in quanto tale, costituisce l’emozione collettiva che fonda e legittima le istituzioni moderne, anche e soprattutto quelle penali. Come dirò diffusamente più avanti, prima ancora che sulla promessa di libertà, uguaglianza a fraternità, la modernità – o, per meglio dire, l’ordine sociale moderno – si è costruita sull’esperienza affettiva della paura ed è comprensibile che sia proprio questa esperienza a condurre e catalizzare le insicurezze quotidiane nel momento in cui le istituzioni moderne vacillano, evocando il dis-ordine. È evidente, dunque, la stretta relazione tra paura e ordine. Il tema del “governo della sicurezza dalla criminalità” è intimamente collegato «alle vicende connesse all’imporsi di un diverso ordine e una diversa priorità nell’accesso sociale alle risorse economiche, politiche e giuridiche»16, facendo intendere, in questo modo, una sorta di “strumentalità” del governo della paura ai fini di costruzione di un ordine sociale. In questo capitolo sostengo la tesi che la relazione non sia solo “contingente” – il fatto che qui e ora la produzione di un diverso ordine avviene attraverso il governo dell’insicurezza – ma sia “fondativa”, in quanto ritengo che non sia nemmeno concepibile l’ordine sociale moderno svincolato dalla paura: il nadir e lo zenit moderni17, le mappe cognitive che guidano nel selezionare le 15 Sulla modernità del pensiero di Hobbes e sulla sua influenza sul pensiero politico si vedano: D. Coli, La modernità di Thomas Hobbes, Il Mulino, Bologna, 1994; G. Sorgi (a cura di), Thomas Hobbes e la fondazione della politica moderna, Giuffrè, Milano, 1999. 16 M. Pavarini, L’amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia, Carocci editore, Roma, 2006, p. 34. 17 G. Marramao, Dopo il Leviatano. Individuo e comunità nella filosofia politica, Giappichelli Editore, Torino, 1995, p. 31. 180 Capitolo 4 cose da vedere e nell’interpretarle18, gli assunti e gli orientamenti culturali di cui si è imbevuti19, poggiano sull’esperienza affettiva della “paura di ciascuno verso ogni altro”, che costituisce il costrutto fondamentale della modernità. A partire dall’approfondimento degli spunti di riflessione ora brevemente accennati, in questo capitolo intendo discutere la tesi che la paura della criminalità sia al centro della modernità e non un prodotto estemporaneo della sua crisi. A tale fine, dapprima descriverò in che modo le emozioni possono essere intese come “apparati significanti” un ordine morale e sociale che si vuole costruire o che si teme di perdere. A partire dalle suggestioni di uno studio sull’ ira nel mondo greco antico, compiuto da Mario Vegetti, suggerirò una chiave di lettura “costruttivista” delle emozioni, che tende a considerarle non solo come “prodotti costruiti”, ma anche come elementi che “orientano la costruzione” della sfera morale e politica di una collettività. Di seguito, attraverso la ricostruzione di una sorta di “fenomenologia della paura”, compiuta attraverso la lettura di alcuni tra i pensatori moderni culturalmente più influenti, avanzerò l’ipotesi che, come l’ira – rappresentata mediaticamente nell’Iliade – costituiva nel mondo greco antico l’esperienza affettiva fondamentale in quanto reiterava la riluttanza diffusa verso una condizione di perdita della libertà, intersecando, se così concepita, il “progetto” di costruzione di un nuovo ordine, quello della democrazia ateniese, allo stesso modo oggi la paura – la sua presenza pervasiva nei mass-media e nelle esperienze quotidiane – costituisce l’esperienza affettiva fondamentale della modernità. Essa reitera la riluttanza verso una condizione di violenza diffusa, “di guerra di tutti contro tutti” e sostiene il progetto moderno di costruzione di un ordine fondato sull’idea di Stato-nazione, che garantisca sicurezza – attraverso la monopolizzazione della violenza e la fondazione-conservazione del diritto – e promuova libertà, uguaglianza e fraternità. Nei momenti di “crisi”, la paura ri-emerge in modo virulento, come “segnale d’allarme”, avvisando del fatto che questo progetto non regge di fronte al divenire storico, e come “monito morale”, indicando la necessità di recuperare la tenuta di quel progetto o di individuarne un altro in grado di non abbandonare le persone – a partire dalle meno capaci – nel mezzo del “vortice” degli eventi. 18 O. De Leonardis, Le istituzioni. Come e perché parlarne, Roma, Carocci Editore, 2001, pp. 52-59. M. Douglas, Risk Accettability According To The Social Science, Russel Sage, New York, 1986 (trad. it. Come percepiamo il pericolo: antropologia del rischio, Milano, Feltrinelli, 1991). 19 La paura della criminalità al centro della modernità 181 4.2 Secondo intermezzo: l’ira di Achille e l’apparato significante delle passioni Il “carattere soggettivante” dell’ira nel mondo greco antico Vegetti, in alcuni studi sulla storia dell’etica antica e sulle passioni nel mondo antico, descrive il “carattere soggettivante” dell’emozione collerica nel mondo greco20. Nella società arcaica descritta nell’Iliade non ci sono né Stato, né leggi, né ordine morale condiviso che possano surrogare la parola e la spada del signore. La minaccia che viene dall’altro, l’offesa subita o anche solo la paura di un’offesa, il rischio che la dignità eroica risulti sfigurata, scatenano una risposta che mobilita indignazione (menis), collera (cholos) e furore (menos) fino alla vendetta (thimos, impulso emotivo che scatena l’azione)21 capace di reintegrare la timé (l’onore) del signore. Nell’Iliade la risposta collerica alla minaccia altrui tende a essere totale e distruttiva, non lasciando al nemico se non l’alternativa tra morte e asservimento. A partire da queste considerazioni, Vegetti sottolinea come la passione dell’ira costituisca un elemento fondamentale del processo di costruzione della soggettività antica, non soltanto per la valenza educativa e politica che i greci attribuivano all’opera di Omero, quanto piuttosto perché la narrazione dell’ira di Achille corrispondeva a una narrazione dell’uomo e della società, potremmo dire a una visione antropologico-politica, fortemente radicata nella tradizione e nella cultura del mondo antico. Infatti, l’esperienza quotidiana e onnipresente della schiavitù strutturava, polarmente, la configurazione della soggettività greca nella figura della ‘libertà’. La radicalità di questa opposizione produceva la convinzione diffusa che la libertà fosse minacciata di asservimento da qualsiasi vincolo sociale imposto dalla stessa comunità dei liberi: la legge, lo Stato, la decisione dell’assemblea popolare22. 20 M. Vegetti, L’etica degli antichi, Editori Laterza, Roma-Bari, 1989; M. Vegetti, “Passioni antiche: l’Io collerico”, in S. Vegetti Finzi (a cura di), Storia delle passioni, Editori La Terza, Milano, 1995, pp. 39-73. Buona parte delle riflessioni sull’ira omerica che seguiranno in questo paragrafo sono state stimolate – quando non direttamente tratte – dalla lettura del libro e dell’articolo di Mario Vegetti sopra citati. 21 Menis, cholos, menos e thimos sono i quattro diversi termini che Omero usa per descrivere la nebulosa collerica nel primo libro dell’Iliade. Ibidem, p. 39. 22 Ibidem, pp. 41-42. 182 Capitolo 4 Per i greci era davvero difficile pensare a una libertà dalla schiavitù che fosse separata dalla pienezza della signoria. E l’ira costituiva l’esperienza affettiva privilegiata per significare la riluttanza del mondo antico alla perdita di libertà: una sorta di protezione dalla minaccia di asservimento e di affermazione della propria libertà. Nella lettura di Vegetti, Omero, narrando l’ira di Achille, non intende semplicemente descrivere una situazione affettiva di un uomo, bensì veicolare messaggi etici, affermare e diffondere una visione antropologico-politica. L’ira di Achille assume, in questo senso, un “carattere soggettivante”: comunica un modello di uomo a cui ispirarsi, fornisce una sorta di vocabolario con il quale dare significato alle proprie esperienze, costituisce un protocollo comportamentale nella vita di tutti i giorni. La rappresentazione omerica dell’ira ha anche un significato, in un certo senso, politico-culturale: afferma un mondo di valori che viene contrastato e superato dal progetto di costruzione di «forme di governo cittadino a base entro certi limiti egualitaria, le poleis»23, in cui l’eroismo e l’eccesso emotivo risultavano pericolosi e destabilizzanti, ma che, in ogni caso, rimangono presenti, costituendo all’interno del progetto di costituzione della democrazia ateniese, una polarità affettivo-valoriale legata alla perdita dell’autonomia e della libertà. Queste riflessioni portano a considerare le passioni come entità nè assolute – afferenti a una sfera “istintiva” e naturale” dell’uomo, indipendenti da qualsiasi legame “storico” e, quindi, “universali” – né individuali. Il carattere “soggettivante” descritto da Vegetti induce a considerarle, anche e innanzitutto, come degli apparati significanti o, se si vuole, dei vocabolari24 attraverso cui poter codificare il mondo, vale a dire osservarlo, interpretarlo e trasformarlo attraverso codici morali. Né universali, né individuali Prima di procedere in questo percorso d’analisi, mi preme specificare l’espressione “anche e innanzitutto”: ho detto “anche”, perchè questa versione non ne esclude altre. Non nega, per esempio, che le passioni, le emozioni in particolare, abbiano un legame con il “corpo”. La versione “fisicalistica”, descritta nel capitolo 1, mette in luce chiaramente questo legame, ma al tem- 23 Ibidem, p. 46. S. Moravia, “Esistenza e passione”, in S. Vegetti Finzi (a cura di), Storia delle passioni, Editori Laterza, Bari, 1995, p. 4. 24 La paura della criminalità al centro della modernità 183 po stesso – e questo è il suo limite – lo rende esclusivo: le emozioni sono manifestazioni corporee e nient’altro. La versione “fisicalistica” è una modalità di interpretazione degli stati d’animo, che ne permette, come abbiamo rilevato, una riduzione a fini gestionali: in quanto perturbazioni della razionalità e dell’ordine (questa è la versione dominante da Platone in avanti), vanno controllati, e il primo dispositivo di controllo è quello di confinarle esclusivamente nel luogo in cui si esprimono più chiaramente, nell’universo della fisicità, su cui è possibile una qualche forma d’intervento. La passione legata al corpo è evidente, quantificabile, governabile e manipolabile. Purtuttavia, le passioni, se private di quell’ “universo extracorporeo” di correlati intenzionali, contestuali, simbolici, normativi che danno loro un significato sociale (morale) rimangono delle mere pulsioni fisico-somatiche, difficilmente comprensibili.25 Ed è per questo che ho detto “innanzitutto”: la paura o l’ira si rendono visibili in espressioni somatiche particolari (anche se non “universali” e “univoche”, come emerge da alcuni studi antropologici26) o in alterazioni fisiologiche, ma queste espressioni e queste alterazioni sarebbero prive di senso se non fossero accompagnate da parole, da concetti, da significati. Le passioni sono anche “fisicità”, ma innanzitutto “costrutti culturali” che vengono applicati a diverse aree di vissuto per evidenziarne certe caratteristiche e dar loro una voce, un significato. In questo senso, condivido il dubbio di Bodei sull’adeguatezza dell’opposizione tradizionale (nel duplice senso di usuale e di facente parte della nostra tradizione filosofico-culturale) tra ragione e passione nel rendere conto dei fenomeni a cui si riferisce27, in particolare – aggiungo io – se interpretata come opposizione tra anima e corpo. L’autore, infatti, al termine di un itinerario di ricerca che mira a rappresentare questa opposizione nella storia della filosofia, arriva a sostenere come “ragione” e “passioni” facciano parte di costellazioni di senso teoricamente e culturalmente condizionate, anche se a noi familiari e ormai difficili da sostituire. “Ragione” e “passioni” sono cioè termini pre-giudicati, che occorre abituarsi a considerare come nozioni correlate e non ovvie, che si definiscono a vicenda (per contrasto o per differenza) solo all’interno di determinati orizzonti concettuali e di specifici parametri valutativi. Le combinazioni e le configurazioni a cui danno luogo sono certo 25 Ibidem, p. 8. Cfr. C. Lutz, “The Domain of Emotion Words on Ifaluk”, in R. Harré (edited by), The Social Construction of Emotions, Basil Blackwell, New York, 1986, pp. 267-288. 27 R. Bodei, Geometria delle passioni. Paura, speranza e felicità: filosofia e uso politico, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 7. 26 184 Capitolo 4 molteplici e varie: tutte però subordinate alla natura delle mosse e alle mappe mentali di partenza.28 È il riconoscimento di una “ibridazione” tra ragione e passioni sotto il segno della dimensione culturale che le costruisce come concetti. Come ho già rilevato (primo intermezzo: par. 2.4), l’assunto che fonda il modo tradizionale di pensare le passioni e che affonda le proprie radici nella storia della filosofia occidentale fin dai suoi albori, è quello che esse sono “affezioni” dell’anima ad opera del corpo, oppure “perturbazioni” dell’animo da domare e rendere utili sotto l’egida della ragione. Ma c’è un altro modo di guardare le emozioni, i sentimenti e i desideri, diverso sia dal considerarli “naturali e universali” che dall’evidenziarne il contenuto cognitivo (base razionale): quello di osservarli come “eventi morali” relazionati al contesto, ai rapporti sociali, alla cultura. La prospettiva costruttivista Soprattutto in seguito agli studi di Elias, si apre un filone di ricerca il quale introduce l’idea che “coltiviamo” le emozioni29. Ne La civiltà delle buone maniere, l’autore attribuisce a questi stati d’animo una dimensione interamente sociale, individuando una forte corrispondenza tra struttura della società e struttura degli affetti30. Questa prospettiva, che risulta essere l’asse portante di un’opera che descrive, attraverso l’analisi dei mutamenti dei costumi e delle “buone maniere”, il processo di civilizzazione come una sorta di “interiorizzazione dei comandi sociali”, viene chiarita meglio laddove il sociologo sostiene che 28 Ibidem, pp. 7-8. V. Despret, Ces émotions qui nous fabriquent, ethnopsychologie de l’authenticité, Seuil, Paris, 2001 (trad. it. Le emozioni. Etnopsicologia dell’autenticità, Eleuthera, Milano, 2002, p. 139). 30 N. Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes, Suhrkamp, Frankfurt, 1969 (trad. it. La civiltà delle buone maniere. La trasformazione dei costumi nel mondo aristocratico occidentale, Il Mulino, Bologna, 1998 p. 363). Lo stesso incipit dell’opea di Elias è dedicato a tale corrispondenza: «Nel riflettere sulla struttura degli affetti umani e del controllo su di essi, cercando di elaborare delle teorie in merito, oggigiorno ci si limita ad utilizzare come materiale empirico le osservazioni fatte su contemporanei che vivono in società avanzate. Si procede insomma, senza accorgersene, dall’ipotesi che sia possibile costruire teorie sulle strutture affettive e di controllo dell’uomo in generale, cioè dell’uomo di qualsiasi società, sulla base di ricerche compiute sulle strutture affettive e di controllo proprie degli uomini delle nostre società, che possiamo osservare qui ed ora. Esistono invece rilevazioni relativamente accessibili, che indicano come lo standard e il modello dei controlli affettivi possano essere differenti in società che si trovano a differenti stadi di sviluppo, e perfino in differenti strati di una medesima società» (Ibidem, p. 45). 29 La paura della criminalità al centro della modernità 185 le manifestazioni affettive e il comportamento della società derivano da una forma e da un livello che non sono affatto un principio, e che quindi non è possibile qualificare, in modo assoluto e sommario, come “incivili”, rispetto ai nostri che definiamo con il termine “civili”. Per rendercene conto, dobbiamo risalire a quel livello da cui ha origine il nostro. La “civiltà”, che siamo soliti considerare come un patrimonio che ci è semplicemente pervenuto come fatto quale ora ci appare, senza chiederci come siamo arrivati a possederlo, è in realtà un processo, o parte di un processo, nel quale noi stessi siamo coinvolti. Tutto ciò che ne fa parte – le macchine, le scoperte scientifiche, le forme politiche – è testimonianza di una determinata struttura dei rapporti umani, della società, e di un determinato tipo di comportamento umano.31 Queste parole evocano immediatamente alcuni concetti che costituiscono l’asse portante di teorie sociologiche contemporanee, tra cui quelli di “campo” e di “habitus” del “costruttivismo strutturalista” di Pierre Bourdieu: anche per questo autore nelle società avanzate, come in quelle primitive, esiste una corrispondenza tra strutture cognitive e strutture sociali. Bourdieu, tuttavia, introduce due concetti fondamentali per lo sviluppo di un’ottica conflittualista del rapporto tra strutture cognitive e strutture sociali, quelli di “campo” – che corrisponde alla struttura sociale percepita come oggettiva – e di “habitus” – disposizione soggettiva che costruisce la realtà oggettiva. L’oggetto specifico della scienza sociale non è l’individuo, questo ens realissimus ingenuamente celebrato come la realtà delle realtà da tutti gli “individualismi metodologici”; né lo sono i gruppi come insiemi concreti di individui; lo è invece la relazione tra due realizzazioni dell’azione storica. Cioè la duplice, oscura, relazione tra gli habitus e i campi.32 Il campo consiste in un insieme di relazioni oggettive storiche tra posizioni ancorate in determinate forme di potere o di capitale; è, come i campi magnetici, un sistema strutturato di forze oggettive e di relazioni, dotato di una sua “forza di gravità” specifica che s’impone a tutti gli elementi che lo compongono. Inoltre esso, come il campo di battaglia, è uno spazio di conflitti tra gli “individui socializzati” nel rivaleggiare per il possesso degli specifici capitali: quello culturale nel campo artistico, quello scientifico nelle scienze, quello sacerdotale nel campo religioso. 31 Ibidem, pp. 180-181. P. Bourdieu, L. Wacquant, Réponses. Pour une anthropologie reflexive, Edition du Seuil, Paris, 1992 (trad. it. Risposte. Per un’antropologia riflessiva, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, p. 94) 32 186 Capitolo 4 L’ habitus è un «sistema durevole e trasponibile di schemi di percezione, di valutazione e di azione, prodotti dal sociale che si istituisce nei corpi»33. E’ una“struttura strutturante” che organizza le pratiche e la percezione delle pratiche e che rende possibile la regolarità e la prevedibilità della vita sociale. Ma è, a sua volta, una “struttura strutturata” : «il principio di divisioni in classi logiche, che organizza la percezione del mondo sociale, è a sua volta il prodotto dell’incorporazione della divisioni in classi sociali».34 Derivato dalle posizioni sociali, l’habitus traduce le caratteristiche intrinseche e relazionali di una determinata posizione occupata nel campo sociale, in uno stile di vita unitario, cioè in un insieme omogeneo di scelte, di pratiche, di beni: «gli habitus sono principi generatori di pratiche distinte e distintive – ciò che l’opraio mangia e soprattutto il suo modo di mangiare ciò che mangia […] – ma si tratta anche di schemi e principi di classificazione, principi di visione e divisione e gusti differenti»35. L’insieme delle pratiche che si incorporano nell’habitus non sono frutto di una razionalità consapevole del soggetto, di un’intenzione, né, tanto meno, di un progetto. L’habitus è un operatore di razionalità pratica che trascende l’individuo, anche se rimane comunque aperto all’invenzione e alla creazione soggettiva: è una forma di collettivo individualizzato o di individuo biologico collettivizzato attraverso la socializzazione. Ciò che muove l’agire individuale si colloca per Bourdieu a un livello pre-razionale, poiché i significati delle pratiche sono definiti dalla posizione occupata nello spazio sociale, e costituiti delle disposizioni incorporate che operano ad un livello tacito. L’azione non è dunque orientata secondo il modello mezzi-fini, ma presenta un carattere “pratico”, “disposizionale”. Il rapporto tra l’agente sociale e il mondo non è la relazione tra un soggetto e un oggetto, ma un rapporto di “complicità ontologica” o di “mutua possessione” tra l’habitus (come principio socializzato costituito di percezione e d’ appreciation) e il mondo che lo determina. Si ravvisa, in altre parole, una sorta di circolarità tra struttura sociale e disposizione cognitiva: gli individui possono costruire fenomeni sociali tramite il loro pensare e il loro agire, ma tale costruzione avviene sempre all’interno di un’ineludibile struttura che mai può essere rimossa. Tra habitus e campo si istaura una relazione 33 Ibidem. P. Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Minuit, Paris, 1979 (trad. it. La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 175). 35 P. Bourdieu, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Editions du Seuil, Paris, 1994 (trad. it. Ragioni pratiche, Il Mulino, Bologna, 1995). 34 La paura della criminalità al centro della modernità 187 molto stretta di condizionamento: «il campo struttura l’habitus che è il prodotto dell’incorporazione della necessità immanente in quel campo»36; ma anche di costruzione cognitiva: «l’habitus contribuisce a costituire il campo come mondo significante, dotato di senso e di valore, nel quale vale la pena di investire le proprie energie»37. A questo proposito, per spiegare il rapporto che vincola l’individuo alla struttura, Bourdieu ha utilizzato un’immagine piuttosto efficace: come la grammatica condiziona ma non determina il nostro linguaggio, così la struttura condiziona ma non determina il nostro agire. In questa concezione della realtà sociale, il sociologo francese si colloca a metà tra il determinismo degli strutturalisti e il volontarismo degli interazionisti: la cultura non può essere ridotta a mondo di simboli dei quali gli individui dispongono con libertà assoluta, poichè l’interpretazione dei simboli e la definizione di situazioni sono sempre inevitabilmente legati a strutture che sfuggono, almeno in parte, al controllo dell’individuo. Non è questa la sede per approfondire ulteriormente la svolta teorica operata da questo autore nell’ambito della sociologia. Mi limiterò a riprendere brevemente, nel corso di questo paragrafo, il concetto di “violenza simbolica”, centrale per la comprensione dell’operatività dei sistemi simbolici come forme di legittimazione dell’ordine. Questi pochi cenni permettono, tuttavia, di intravedere alcune traiettorie di ricerca sempre più presenti nell’ambito della riflessione filosofica e sociologica contemporanea e stabilire dei ponti tra autori che si muovono nel solco, o nelle vicinanze, del “Costruttivismo”, movimento di pensiero che, in campo sociologico, ha determinato un salto di paradigma con ricadute importanti anche sul tema che in questa sede interessa maggiormente, quello dello statuto delle emozioni: nel passaggio da “elementi naturali” a “disposizioni cognitive” e, infine, a “costrutti culturali, queste vengono definitivamente contestualizzate e relativizzate, perdendo i caratteri di “universalità” e di “fisicità”. Vediamo in che modo ciò avviene. Il fisico Heinz von Foerster espresse con un interrogativo (retorico) la prospettiva che ha orientato le sue ricerche e quelle di altri scienziati di diverse discipline a partire dagli anni Cinquanta: «è il mondo la causa primaria e la mia esperienza ne è la conseguenza, o è la mia esperienza a essere causa 36 37 P. Bourdieu, L. Wacquant. op. cit. a nota 32, p. 94. Ibidem. 188 Capitolo 4 primaria e il mondo la conseguenza?»38. Riallacciandosi alle ricerche dello psicologo svizzero Jean Piaget, egli osservò come gli oggetti del mondo vengano costruiti attraverso la nostra attività nel mondo. Non è possibile una distinzione netta tra colui che osserva e l’oggetto osservato, poiché entrambi si definiscono tali attraverso la reciproca interazione. Analogamente, Peter L. Berger e Thomas Luckmann, in un’opera del 1966 divenuta fondamentale per la sociologia della conoscenza, svilupparono l’idea secondo cui la realtà sia l’esito di una costruzione sociale. La vita quotidiana si presenta come una realtà interpretata dagli uomini e soggettivamente significativa per loro come un mondo coerente. In quanto sociologi noi assumiamo questa realtà come l’oggetto delle nostre analisi. All’interno del quadro di riferimento della sociologia come scienza empirica è possibile assumere questa realtà come data […] senza indagare oltre sui fondamenti di questa realtà, compito, quest’ultimo della filosofia. Tuttavia, dato il proposito di questo trattato, non ci è possibile saltare a piè pari il problema filosofico. Il mondo della vita quotidiana non è solo dati per scontato come realtà dall’uomo comune nella condotta soggettivamente significativa della sua vita. È un mondo che si origina nel suo pensiero e nella sua azione, e che grazie a questi mantiene la sua realtà.39 Il punto da cui partono le riflessioni sulla realtà come costruzione sociale dei due sociologi è il riconoscimento che la coscienza entra in contatto con differenti sfere di realtà (quella della “realtà” e quella del sogno, per esempio), ma che tra queste realtà ce n’è una che si presenta come la «realtà per eccellenza: la realtà della vita quotidiana».40 La sua posizione privilegiata le dà diritto alla designazione di realtà dominante. La realtà della vita quotidiana è percepita come ordinata e oggettivata. I suoi fenomeni sono predisposti in modelli che sembrano indipendenti dalla mia percezioni di essi e che s’impongono su quest’ultima, la realtà della vita quotidiana appare già oggettivata, nel senso che appare costituita da un ordine di oggetti che sono stati designati come oggetti prima della mia comparsa sulla scena. Allo stesso tempo la realtà – sostengono gli autori – è organizzata intorno al “qui” del mio corpo e all’ “adesso” del mio presente. Questo hic et nunc è 38 H. Foerster, “Through the eyes of the other”, in F. Steier (edited by), Research and Reflexivity, Sage Publication, London, 1991 (trad. it. Attraverso gli occhi dell’altro, Guerini e Associati, Milano, 1996, p. 34). 39 P.L. Berger, T. Luckmann, The Social Construction of Reality, Doubleday and Co., New York, 1966 (trad. it., La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1969, pp. 39-40). 40 Ibidem, p. 42. La paura della criminalità al centro della modernità 189 il fuoco della mia attenzione alla realtà della vita di ogni giorno, che si espande a quella zona della vita direttamente accessibile alla mia manipolazione corporea, e cioè il «il mondo a portata delle mie possibilità», il «mio mondo per eccellenza»41. La realtà della vita quotidiana si presenta anche come “mondo intersoggettivo”: «il mio “qui” è il loro “là”. Il mio “adesso” non corrisponde pienamente con il loro. I miei progetti differiscono dai loro e possono anche entrare in conflitto con essi. Ma nonostante tutto io so che vivo con loro in un mondo comune. […] so che vi è una continua corrispondenza tra i miei significati e i loro significati in questo mondo». L’interazione tra individui, tra cui quella faccia-a-faccia è la più importante, è regolata da “schemi di tipizzazione” nei cui termini gli altri vengono percepiti e interpretati. Io vedo l’altro, per esempio, come un uomo, un europeo, un acquirente, un tipo gioviale, etc. e tutte queste tipizzazioni incidono sulla relazione con lui e la stessa cosa vale per l’altro: i due schemi di tipizzazione entrano in continuo negoziato. Le tipizzazioni diventano progressivamente “anonime” via via che si allontanano dall’incontro diretto: da una parte stanno quelli con cui interagisco più frequentemente e intensivamente negli incontri diretti, la mia “cerchia interna”, per così dire; dall’altra ci sono astrazioni fortemente anonime, che per loro natura non sono mai accessibili all’interazione dell’incontro diretto. La struttura sociale è la somma di queste tipizzazioni e dei modelli ricorrenti di interazione stabiliti per il loro tramite. In quanto tale la struttura sociale è un elemento essenziale della realtà della vita quotidiana.42 Il mondo intersoggettivo del senso comune viene costruito attraverso le “oggettivazioni” dell’espressività umana, che si manifesta in attività che sono accessibili sia ai loro produttori che agli altri in quanto elementi di un mondo comune. La “significazione”, cioè la produzione umana di segni, costituisce un caso di oggettivazione d’importanza cruciale, e il linguaggio costituisce il sistema di segni più importante nella società umana. Il linguaggio usato nella vita quotidiana mi fornisce continuamente le necessarie oggettivazioni e postula l’ordine all’interno del quale queste hanno un senso e in cui la vita quotidiana ha un senso per me. Io vivo in un luogo che è geograficamente designato, adopero strumenti, dagli apriscatole alle auto sportive, che sono designati nel vocabolario tecnico della mia società, vivo dentro un tessuto di relazioni umane […] che sono anch’essi ordinati per mezzo di un vocabolario. In questo modo il linguaggio 41 42 Ibidem, p. 43. Ibidem, p. 56. 190 Capitolo 4 segna le coordinate della mia vita nella società e riempie quella vita di oggettive significazioni.43 Il linguaggio, quindi, permette di oggettivare una grande quantità di esperienze e stati soggettivi, li classifica, incasellandoli in categorie generali nei cui termini esse hanno significato per il soggetto che le ha vissute e per tutti gli altri. E classificandole, esso rende anonime anche le esperienze, in quanto, una volta tipizzate, sono in linea di principio identiche a qualunque altra ricada nella stessa categoria. Attraverso i “segni vocali” si realizza il distacco immediato dall’hic et nunc degli stati soggettivi (trascendenza) e la costruzione e sedimentazione di vasti cumuli di significato e di esperienza che può poi preservarsi nel tempo e trasmettersi alle generazioni successive (integrazione). A partire da questi presupposti, Berger e Luckmann rilevano l’importanza della “consuetudinarietà” dell’attività umana come elemento di origine del processo di istituzionalizzazione: «ogni azione che venga ripetuta frequentemente viene cristallizzata secondo uno schema fisso, che può quindi essere riprodotto con una economia di sforzo e che, ipso facto, viene percepito dal suo autore come quel dato schema».44 L’abitualizzazione ha il vantaggio di eliminare la necessità di ridefinire da zero ogni situazione, volta per volta. Essa stabilizza il significato delle azioni nelle interazioni sociali: «ciascuno sarà capace di prevedere le azioni dell’altro: l’interazione di ambedue diviene quindi prevedibile». 45 In questo modo avviene quello che i due sociologi definiscono “tipizzazione reciproca di azioni consuetudinarie”: i due individui costruiscono uno “sfondo” che servirà a rendere stabili sia le loro azioni distinte sia le loro interazioni. La costruzione di questo sfondo condiviso costituisce il primo “nucleo istituzionale”, che per stabilizzarsi in ordine istituzionale, per divenire cioè realtà oggettiva, “fatto sociale” evidente come un masso sul proprio cammino (come direbbe Durkheim), occorre che si attivi un processo di trasmissione alla nuova generazione, in cui il mondo sociale, trasparente per chi lo ha costruito come biografia comune, si opacizza presentandosi agli altri con una storia «che precede la nascita dell’individuo e non è accessibile alla sua biografia comune»46. In questo vettore di senso acquista centralità l’espressione secondo cui «l’uomo costruisce la propria na- 43 Ibidem, pp. 42-43. Ibidem, p. 82. Ibidem, p. 87. 46 Ibidem, p. 91. 44 45 La paura della criminalità al centro della modernità 191 tura, o più semplicemente che l’uomo produce se stesso»47, che può essere intesa anche come paradosso: «l’uomo è capace di produrre un mondo che gli si offre all’esperienza come qualcosa d’altro da un prodotto umano»48. Non solo: questo mondo, frutto dei processi di esteriorizzazione (manifestazione dell’espressività umana attraverso l’azione) e oggettivazione, è reintrodotto nella coscienza del singolo (interiorizzazione) nel corso della socializzazione. L’ordine sociale così costruito è dunque un’ininterrotta produzione umana: «i rapporti sociali non sono parte della “natura delle cose”, e non possono essere fatti derivare dalle “leggi della natura”: essi esistono solo come un prodotto dell’attività umana».49 Ma, al tempo stesso, gli individui perdono progressivamente coscienza di questa “natura culturale” dell’ordine sociale, che viene “reificato”50 e “legittimato”. Il mondo delle istituzioni sembra fondersi con quello della natura attraverso la “reificazione” (frutto di complessi sistemi teorici, ma anche e soprattutto attivata a livello pre-teorico, come condizione normale nella coscienza dell’uomo della strada) e si stabilizza sempre più attraverso “legittimazioni”, vale a dire oggettivazioni di secondo grado che producono nuovi significati idonei a spiegare e giustificare le oggettivazioni di primo grado, vale a dire i significati già attribuiti ai diversi processi istituzionali. Berger e Luckmann distinguono quattro livelli di legittimazione (che, come sottolineano, empiricamente s’intersecano): il primo livello di legittimazione è quello definito “incipiente”: si verifica non appena un sistema di oggettivazioni linguistiche dell’esperienza umana viene trasmesso, come nel caso in cui la trasmissione di un vocabolario di parentela ipso facto legittima un sistema di parentela; il secondo livello di legittimazione dell’ordine istituzionale contiene affermazioni teoretiche in forma rudimentale, quali proverbi, massime, leggende o racconti popolari; il terzo livello di legittimazione contiene teorie esplicite grazie alle quali un settore istituzionale viene legittimato in termini di un corpo di conoscenze differenziate: «con lo sviluppo di speciali teorie legittimanti e la loro ammi- 47 Ibidem, p. 86. Ibidem, p. 92. 49 Ibidem, p. 81. 50 La reificazione è la percezione di fenomeni umani come se fossero cose, qualcosa di diverso dai prodotti umani, e quindi esterni all’uomo. Peter L. Berger e Thomas Luckmann considerano la reificazione il grado estremo nel processo di oggettivazione, per cui il mondo oggettivato perde la sua capacità di essere visto come creazione umana e si fissa come attualità non umana, non umanizzabile e inerte. Ibidem, p. 128. 48 192 Capitolo 4 nistrazione da parte di individui che si dedicano esclusivamente a questa attività, la legittimazione comincia al di là dell’applicazione pragmatica e a diventare “pura teoria”»51. Il quarto livello di legittimazione è quello degli universi simbolici, definiti come «corpi di tradizione teoretica che integrano diverse sfere di significato e abbraccino l’ordine istituzionale in una totalità simbolica»52. Esso «nasce da processi di riflessione soggettiva, che, al momento della oggettivazione sociale, provocano la costituzione di espliciti legami tra i temi significativi che affondano le loro radici nelle diverse istituzioni»53. Questo livello di legittimazione si differenzia dalle altre principalmente poiché tutti i settori dell’ordine istituzionale sono integrati in una struttura di riferimento che li include e che costituisce un universo nel senso letterale della parola, poiché tutta l’esperienza umana può essere vista come avente luogo all’interno di esso. L’universo simbolico è pensato dagli autori come la matrice di tutti i significati socialmente oggettivati e soggettivamente reali: «l’intera società storica e l’intera biografia dell’individuo sono viste come avvenimenti che si svolgono all’interno di questo universo»54. Riprenderò ancora il concetto di “universo simbolico”. Per il momento mi preme sottolineare brevemente alcune sue caratteristiche, così come descritte da Berger e Luckmann55. Innanzitutto il suo “carattere ordinante” degli stati soggettivi: l’universo simbolico crea un ordine per la percezione dell’esperienza biografica, realizzando il più altro livello di integrazione per i significati divergenti attualizzati nell’ambito della vita quotidiana nella società. In questa sua funzione ordinatrice riveste anche un ruolo di rassicurazione sociale: le situazioni incomprensibili, che non rivestono un significato condiviso, costituiscono solitamente la minaccia più grave all’esistenza scontata e abitudinaria dell’uomo (definibili come devianze o eresie): l’universo simbolico ha la funzione di collocarle in un ordine intelligibile e quindi meno terrificante. Inoltre, esso crea un ordine nella storia, collocando tutti gli avvenimenti collettivi in un’unità coerente che include passato, presente e futuro. Questa unità, soprattutto nelle società pluralistiche, è continuamente minacciata da 51 Ibidem, p. 136. Ibidem. 53 Ibidem, p. 147. 54 Ibidem, p. 137. 55 Ibidem, pp. 132-178. 52 La paura della criminalità al centro della modernità 193 altre visioni della realtà, da universi simbolici alternativi. Di fronte ad avvenimenti che rischiano di creare caos, nel senso di perdita dell’ordine istituzionale, «è facile capire perché avvenimenti di questo genere devono essere seguiti immediatamente dalle più solenni riaffermazioni del perdurare della realtà dei simboli protettori»56. Infine (una fine limitata all’interesse per il mio studio), occorre rilevare che, nonostante sia possibile vivere ingenuamente in un universo simbolico, la sua creazione necessita di una risposta teoretica da parte di qualcuno, che costituisce una legittimazione di secondo grado e un meccanismo di conservazione degli universi, ma anche di una loro trasmissione (mitologia, religione, filosofia, scienza). All’inizio di questo paragrafo mi ero ripromesso di considerare il concetto di “violenza simbolica” di Bourdieu e, alla luce di quanto detto finora, in particolare rispetto agli universi simbolici, ho gli strumenti per parlarne. Punto di partenza della riflessione del sociologo francese è l’interrogativo che, com’egli stesso riferisce in Raisons pratiques57 si era posto anche il filosofo scozzese David Hume nel saggio On the First Principles of Government del 1758: a cosa si deve la sorprendente facilità con la quale i dominanti impongono il loro dominio? Per Bourdieu non è la coercizione a costituire il principale strumento di dominio, bensì la legittimazione: per conservare l’ordine è sufficiente che vengano messi in atto dispositivi di giustificazione che affondano le proprie radici – e questo è il passaggio fondamentale – in un atteggiamento naturale dei dominati a legittimare il potere. Si tratta, tuttavia, di una “naturalità costruita”. Infatti, come per Berger e Luckmann i meccanismi concettuali di preservazione degli universi simbolici hanno successo se legati al potere detenuto da coloro che li manovrano58, anche – e più radicalmente – per Bourdieu le categorie di percezione disponibili nel mondo sociale sono inevitabilmente quelle create dal dominio: esse «non solo rispecchiano esattamente l’ordine costituito», ma «si impongono con tutte le apparenze della realtà oggettiva»59. Il dominato non può non accordare la propria adesione al dominante (quindi al dominio) quando, per pensare il suo rapporto con il dominante, dispone soltanto di strumenti di conoscenza che ha in comune con lui e che, essendo semplicemente la forma incorporata del rapporto di dominio, fanno 56 Ibidem, p. 147. P. Bourdieu, op. cit. a nota 35. P.L. Berger, T. Luckmann , op. cit. a nota 39, p. 153. 59 P. Bourdieu, op. cit. a nota 34, p. 548. 57 58 194 Capitolo 4 apparire questo rapporto come naturale60. Il “potere simbolico”, che Bourdieu definisce come il «potere di costituire il dato nell’enunciato, di agire sul mondo agendo sulla rappresentazione del mondo»61 – di creare la doxa, la rappresentazione che s’impone come oggettività e che si compie «mediante una relazione definita che crea la credenza nella legittimità delle parole e delle persone che le pronunciano»62 – costituisce il principale strumento di legittimazione del dominio, esercitando la più efficace forma di violenza che si possa concepire, quella di costringere i dominati a collaborare attivamente alla loro dominazione. E’ a questo punto che Bourdieu parla di “violenza simbolica” come «quella forma di violenza che viene esercitata su un agente sociale con la sua complicità»63. Negli studi sullo Stato, «il luogo della concentrazione e dell’esercizio del potere simbolico»64 e sulla famiglia, «una finzione, un artificio sociale, un’illusione»65, Bourdieu mostra chiaramente come la simbiosi tra strutture cognitive e struttura sociale, che opera attraverso l’incorporazione nell’habitus, si fondi sulla dialettica descrizioneprescrizione. I sistemi simbolici più potenti sono infatti quelli che, mentre sembrano descrivere una realtà sociale (la relazione tra uomini e donne, lo Stato, la famiglia, ecc.), al contempo prescrivono un modo di esistenza. E’ per questo motivo che l’analisi dell’ “accettazione dossica” del mondo è per Bourdieu il vero fondamento di una teoria realista del dominio e della politica” e costituisce il compito prioritario della sociologia. Mi sono soffermato su La costruzione sociale della realtà di Berger e Luckmann, e, più brevemente, sul concetto di “violenza simbolica” in Bourdieu, in quanto queste riflessioni permettono di creare una cornice teorica idonea ad affrontare il tema dei rapporti tra esperienze soggettive (anche di natura affettiva), universo simbolico e ordine sociale così come appare in recenti studi sulle emozioni. Il costruttivismo – la cui matrice interazionista lo rende familiare a quel corpo di studi criminologici che, a partire dalle lezioni di Herbert Mead tenuto presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Chicago negli anni Venti del secolo scorso e dalla loro sistematizzazione ed evoluzione ad opera 60 P. Bourdieu, La domination masculine, Edition du Seuil, Paris, 1998 (trad. it. Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 45). 61 P. Bourdieu, L. Wacquant, op. cit. a nota 32, p. 123. 62 Ibidem, p. 112. 63 P. Bourdieu, op. cit. a nota 60, p. 45. 64 P. Bourdieu, op. cit. a nota 35, pp. 89-119. 65 Ibidem, pp. 121-131. La paura della criminalità al centro della modernità 195 di Herbert Blumer, hanno sviluppato il concetto secondo cui la devianza costituisce un “oggetto sociale” in senso interazionista, vale a dire il prodotto dell’interazione sociale66 – ha avuto ricadute importanti nell’ambito degli studi sulle emozioni, parallelamente a un rinnovato interesse per uno sguardo antropologico sulle percezioni e sugli stati d’animo. Le passioni tra natura e cultura C’è un crescente interesse tra accademici e ricercatori riguardo all’idea che le emozioni siano entità socialmente costruite, soprattutto per la «consapevolezza sempre più forte della diversità culturale e della differenziazione cognitiva che le riguarda». 67 Secondo la teoria costruttivista dell’esperienza soggettiva, le emozioni sono costituite da atteggiamenti costruiti all’interno di sistemi di credenze culturali e di valori morali caratteristici di un determinato contesto. Questa concezione si differenzia nettamente da quella naturalistica, secondo cui le emozioni sono una risposta naturale provocata da fattori esterni presenti in una determinata situazione. Esse, nella versione costruttivista, sono «schemi di esperienza e di espressività che sono acquisiti e successivamente si caratterizzano specificamente nella situazione sociale»68. Harré e Robert Finlay-Jones, in un articolo dal titolo esplicativo, Emotion Talk Across Times, hanno mostrato come alcune emozioni diventino obsole- 66 Mi riferisco in particolare alle opere di Herbert Becker, Charles Wright Mills e Edwin Lemert.. Sia Becker che i teorici dell’etichettamento hanno sviluppato in particolare l’intuizione – presente anche in Berger e Luckmann quando sostengono che i meccanismi concettuali di preservazione degli universi simbolici spesso hanno successo se legati al potere detenuto da coloro che li manovrano (P.L. Berger, T. Luckmann , op. cit. a nota 39, p. 153) – secondo cui è il gruppo sociale dominante che, armato della propria architettura semantica, riesce a imporre una specifica definizione di devianza (Cfr. A. Ceretti e L. Natali, La cosmologia degli attori violenti. L’inedita prospettiva di Lonnie Athens, in corso di pubblicazione). In questo senso, la questione della criminalità svolge un ruolo particolarmente importante nell’attività di controllo sociale, perché il criminale costituisce il nemico pubblico numero uno, che con la sua aziona aiuta la comunità a stabilire i confini di un orizzonte comune di senso. (cfr. D. Melossi, Stato, controllo sociale, devianza, Bruno Mondatori, Milano, 2002, p. 180). Va sottolineato come recentemente l’approccio interazionsita sia stato adottato, in modo innovativo e originale, nell’ambito degli studi sulla violenza di Lonnie Athens e di Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali. Ritengo, infine, che il concetto di “penalità” definito da David Garland in Pena e società moderna (si veda oltre) e quello di “campo”, definito soprattutto in La cultura del controllo, mostrino una certa familiarità con il pensiero costruttivista. 67 R. Harré, “An Outline of the Social Constructionist Viewpoint”, in R. Harré (edited by), The Social Construction of Emotions, Basil Blackwell, New York, 1986, p. 3. 68 C. Armon-Jones, “The Thesis of Constructionism”, in R. Harré (edited by), The Social Construction of Emotions, Basil Blackwell, New York, 1986, p. 33. 196 Capitolo 4 te e scompaiano quando non hanno più un contesto che restituisce loro un significato. L’accidia, per esempio, studiata dettagliatamente nel Medioevo come stato emotivo associato alla negligenza, alla pigrizia e all’oziosità, nella società moderna sembra essersi “estinta”: ai nostri giorni – sostengono gli autori – nessuno associa una qualche emozione specifica alla pigrizia o alla dilazione nell’adempiere i proprio compiti. E questo avviene principalmente in quanto l’accidia non ha significato al di fuori di quell’universo religioso e morale in cui assumeva la propria importanza: essa era chiamata nel XIV secolo “noonday demon”, in quanto distraeva gli eremiti dai propri doveri legati alla vita ascetica; costituiva un fattore di disturbo o di resistenza a un certo ordine morale, assumendo centralità proprio in quanto ombra di quell’ordine morale. 69 In questo senso, l’accidia è un’emozione premoderna, presentando tratti peculiari che solo parzialmente possono avvicinarla alla moderna depressione: era collegata alla negligenza, alla tristezza e alla noia, ma implicava anche un disgusto nell’adempimento dei doveri religiosi. Vi sono, inoltre, emozioni che sono specifiche di alcune aree geografiche e che non hanno equivalenti in altri contesti territoriali, come nel caso del sentimento dell’amae – che potremmo indicare provvisoriamente come l’aspettarsi qualcosa dagli altri – indicato dallo psichiatra giapponese Doi come “chiave” per comprendere la struttura della personalità giapponese e che non trova riscontro nelle lingue indoeuropee. 70 Nonostante ci siano altre parole e altre espressioni che, come risultato di circostanze storiche uniche per il Giappone, risultano difficilmente traducibili in altre lingue, l’eccezionalità dell’amae è il fatto di essere, agli occhi dei giapponesi, universale e fondamentale per ogni essere umano, a tal punto che risulta difficile per un giapponese credere che non ci sia un’esatta traduzione in inglese. Se anche esistono nei Paesi occidentali amae-type feelings, questi faticano a coltivarsi in società individualistiche e, in ogni caso, diventano necessariamente qualcosa di diverso da quel sentimento che viene (o veniva) espresso in modo intenso soprattutto tra i componenti dei nuclei familiari giapponesi. Come si intravede da queste pochi cenni sull’accidia e sull’amae, dal punto di vista costruttivista le emozioni sono atteggiamenti non solo giustificati da una situazione costruita culturalmente, ma anche considerati dai 69 R. Harré, R. Finlay-Jones, “Emotion Talk Across Times”, in R. Harré (edited by), The Social Construction of Emotions, Basil Blackwell, New York, 1986, pp. 220-233. 70 H. Morsbach e W.J. Tyler, “A Japanese Emotion: Amae“, in R. Harré (edited by), The Social Construction of Emotions, Basil Blackwell, New York, 1986, pp. 289-307. La paura della criminalità al centro della modernità 197 membri della comunità come una risposta che sarebbe giusto adottare in quella situazione in quanto dimostrerebbe l’impegno dell’attore nel preservare i valori culturali che si esprimono i quella situazione. Questo carattere prescrittivo della relazione tra emozione e valori che essa riflette riveste un ruolo centrale per comprendere i processi di acquisizione delle emozioni culturalmente appropriate e di regolazione delle risposte dell’attore a situazioni che richiedono forme di espressività affettiva. Le emozioni sono un insieme di risposte, socialmente prescritte, che ciascuno deve seguire quando si trova in una data situazione; la risposta è il risultato di aspettative condivise che riguardano il comportamento appropriato da tenere in quella situazione. Da questa angolatura, le emozioni vanno interpretate principalmente nel loro rapporto dialogico o circolare con il sistema socio-culturale in cui sono inserite: non solo sono culturalmente determinate – il che non escluderebbe di per sé la compatibilità con una versione naturalistica, in quanto potrebbero essere concepite come risposte istintive a stimoli culturali – bensì sono affermazioni e motivazioni connesse al rafforzamento dei valori culturali: sono costruite da e in funzione di un determinato contesto socio-culturale. Utilizzando i concetti di Berger e Luckmann, si potrebbe dire che le emozioni, in prima battuta, sono parte dell’espressività umana e, forse più di altri stati soggettivi, esprimono l’hic et nunc del mondo di ciascuno. Immediatamente, però, nell’interazione con gli altri, vengono “tipizzate” e rese intelligibili per chi le produce e per gli altri. Questo processo di tipizzazione comporta una loro oggettivazione che le rende parte di una realtà di senso comune: questo avviene soprattutto attraverso le “parole”, le “espressioni” e i “discorsi” che indicano, descrivono, rappresentano, “parlano” di emozioni. Così, le emozioni sono parte di quello sfondo condiviso che rende consuetudinarie e reciprocamente comprensibili le azioni e gli atteggiamenti, che costituisce l’origine del processo di istituzionalizzazione e che si stabilizza in ordine istituzionale nel momento in cui viene trasmesso ad altre generazioni, perdendosi la memoria della sua origine culturale. Contestualmente alla “reificazione” dell’ordine sociale, anche le emozioni ad esso connesse si “reificano”, presentandosi agli attori sociali come naturali, oggettive e universali. Le emozioni, in quanto – inevitabilmente – “parole” di un linguaggio sulle emozioni, costituiscono anche una fondamentale strategia di legittimazione: sono elementi riflessi di un ordine morale, sociale e istituzionale, ma anche modalità per una sua continua ri-affermazione. Entrano a far parte di quel complesso di teorizzazioni che integrano diverse sfere di significato e abbracciano l’ordine istituzionale in una totalità simbolica: gli universi simbolici. Il discorso filosofico e scientifico sulle passioni, in questo modo, può essere interpretato come parte di una più ampia “visione del mondo” che, sia 198 Capitolo 4 pure sotto-traccia, non evidente alla coscienza della maggior parte delle persone che vivono ingenuamente all’interno di essa, ordina l’esperienza quotidiana e gli avvenimenti collettivi intorno a nuclei di significato condivisi. Queste considerazioni rendono evidente come le emozioni, contestualmente all’insieme delle strutture cognitive, rivestano una funzione sociale particolarmente importante: l’acquisizione e l’adozione di risposte culturalmente appropriate serve a rafforzare l’ordine, riducendo condotte ad esso contrarie. Si compie, in altri termini, un passaggio dalla funzione individuale, già accennata nel primo intermezzo (capitolo 1) e secondo cui, per esempio, la paura serve a mettere in allerta l’individuo di fronte a un pericolo imminente, alla funzione sociale: le emozioni sono utili al mantenimento dell’ordine sociale. Come Catherine Lutz ha mostrato in uno studio sulle emozioni tra gli abitanti dell’atollo Micronesiano di Ifaluk71, esistono diversi modi di concepire le emozioni. Se solitamente si ritiene che la funzione delle emotion words (parole che indicano emozioni) sia quella di dare evidenza a uno stato d’animo interiore e anche di comunicarlo agli altri, tra le popolazioni dell’Oceania, invece, sono viste come asserzioni riguardanti la relazione tra una persona e un evento, soprattutto nei casi in cui questo coinvolga altre persone. Quando un Ifaluk parla delle sue emozioni – riferisce l’antropologa – non parla di ciò che avviene dentro la sua testa o in qualche altra parte del corpo, ma di ciò che avviene nel mondo e nelle relazioni con gli altri. Il termine song, per esempio, individua il sentimento di collera giustificata e viene utilizzato quasi esclusivamente per descrivere la reazione alla trasgressione di una norma culturale o di un tabù. È l’emozione dell’oltraggio sociale ed è considerata come l’emozione appropriata per coloro che godono di un rango superiore (capo, anziani, genitori a seconda dei casi). La persona oggetto della song (collera) sperimenta la metagu (paura): se una persona prova ed esprime la collera giustificata, l’altra deve provare ed esprimere l’emozione della paura. È essenziale che ciò avvenga: per questo motivo questa modalità di relazione viene “insegnata” fin da piccoli. Come osserva Despret che ha ripreso e ampliato lo studio etnografico di Lutz, l’emozione di collera non è qualcosa “che capita” e non è neppure un giudizio emotivo sugli avvenimenti. Colui che si dichiara in stato di collera, spiega l’antropologa, dovrà negoziare questa dichiarazione con gli altri […] per un Ifaluk, il 71 C. Lutz, “The Domain of Emotion Words on Ifaluk“, in R. Harré (edited by), The Social Construction of Emotions, Basil Blackwell, New York, 1986, pp. 267-288. La paura della criminalità al centro della modernità 199 fatto di rivendicare la collera implica una caratterizzazione del mondo che deve essere oggetto di una transazione […] La collera song emerge ed è accettata solo quando le persone possono giustificare e negoziare i valori culturali e le prerogative del potere che certi membri della società in quel momento possiedono. Colui che si dichiara in collera deve riunire gli altri. E queste trattativa deve avvenire con modalità particolari in occasione di cambiamenti sociali, perché diventa un modo di riformulare la loro negoziazione.72 Da questa prospettiva, la “collera giustificata” e la “paura” costituiscono un mezzo per mantenere l’ordine sociale e per regolare le relazioni attraverso procedure che ricostruiscono ruoli sociali e valori morali. Le considerazioni finora svolte portano a confermare il fatto che le emozioni siano anche e innanzitutto “eventi morali”, in un duplice senso: costituiscono il prodotto di un universo simbolico, di una doxa del mondo che legittima e reifica un ordine morale e, al tempo stesso, in quanto parte attiva di quell’universo simbolico, prescrivono atteggiamenti appropriati e veicolano messaggi etici coerenti con la visione del mondo dominante e utili alla conservazione dell’ordine istituzionale. In questo secondo aspetto le emozioni possono essere intese – come lo studio sull’ira di Achille aveva suggerito – come “apparati significanti”. 4.3 Paura della violenza e cultura moderna La circolarità della produzione sociale di paura Dopo questa ampia premessa, ritengo doveroso riprendere il filo del ragionamento sotteso a questa trattazione, ricordando l’interrogativo da cui ha preso le mosse l’approfondimento sulle passioni: perché è proprio la paura della criminalità a pervadere la tarda modernità e non, piuttosto, altre paure o altre emozioni? Ho già ricordato come la risposta che si articola intorno al fenomeno del panico indotto nella popolazione dalle élites dominanti, soprattutto attraverso lo strumento dei mass-media, non soddisfi pienamente. Aggiungo ora che l’insoddisfazione deriva dal fatto che essa non sembra cogliere pienamente la “circolarità della produzione sociale della paura”. 72 V. Despret, op. cit. a nota 29, p. 175. 200 Capitolo 4 Mi spiego meglio. Il panico morale costituisce senza dubbio un paradigma di analisi che permette di svelare le pratiche di dominio che sono sottese alla diffusione di allarme sociale; apre un varco nella doxa dominante, rivelandone il carattere costruito in funzione di interessi o di consolidamento dell’ordine. Purtuttavia, esso non considera che, seguendo l’insegnamento di Douglas, siamo tutti imbevuti di assunti e orientamenti che hanno a che fare con la forma di relazioni sociali che la persona mantiene, con i pregiudizi culturali, come i valori condivisi e le credenze (inclusa quindi la visione del mondo e dei rapporti sociali), con le strategie comportamentali preferite e con il tipo di organizzazione in cui si vive73. Detto altrimenti, il paradigma del panico morale riduce la tematica della nascita dell’ordine istituzionale e dei sistemi di legittimazione dello stesso a una pratica di manipolazione cosciente delle mentalità e delle sensibilità delle persone ad opera dei gruppi di potere (imprenditori morali). Usando, infine, le coordinate teoriche fornite da Bourdieu, si potrebbe dire che esso si ferma alla superficie del rapporto di dominio: infatti, se, da una parte, le categorie di percezione disponibili nel mondo sociale sono inevitabilmente quelle create dal dominio, dall’altra parte va considerato che dominante e dominato partecipano entrambi attivamente alla legittimazione di quell’ordine che fissa il rapporto di dominio. Mi preme rimarcare, dunque, al di là dei contenuti specifici della teoria culturale della Douglas, di quella teoria sociale costruttivista e del pensiero di Bourdieu, il fatto che tutti questi approcci affermino più o meno esplicitamente ciò che Carlo Ginzburg ha chiamato “circolarità tra i livelli culturali”: raccontando la storia di un mugnaio friulano, Menocchio, vissuto nel ‘500 e morto bruciato per ordine del Sant’Uffizio, lo storico italiano ha rilevato un’impressionante convergenza tra le posizioni di questo ignoto gestore del mulino e quelle dei gruppi intellettuali più raffinati e consapevoli del suo tempo,74 È la circolarità di queste posizioni, com’egli afferma, che delimita il campo specifico della storia delle mentalità rispetto alla storia delle idee o storia della cultura: «essa [la storia delle mentalità] studia […] ciò che hanno 73 M. Douglas, Risk And Blame, Routledge, London-New York, 1992 (trad. it. Rischio e colpa, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 94). 74 C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500, Einaudi, Torino, 1976. Analogamente, nel corso di una ricerca sui processi di stregoneria tra Cinquecento e Seicento, lo storico italiano, analizzando in particolare il processo ai danni di Chiara Signorini tratto dall’Archivio di Stato di Modena, evidenzia come la stregoneria non sia solo una definizione imposta dalle gerarchie ecclesiastiche sulla popolazione, ma possa considerarsi, senza forzature, un’arma di difesa e di offesa nelle contese sociali. C. Ginzburg, Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia, Einaudi, Torino, 1986, pp. 3-28. La paura della criminalità al centro della modernità 201 in comune Cesare e l’ultimo soldato delle sue legioni, san Luigi e il contadino che coltivava le sue terre, Cristoforo Colombo e il marinaio delle sue caravelle». 75 Per “circolarità della produzione sociale della paura” intendo, dunque, che la paura della criminalità non è semplicemente uno strumento nelle mani dei gruppi che detengono il potere per mantenere stabili le proprie posizioni di dominio, ma è un prodotto e, al tempo stesso, un elemento caratterizzante di una “mentalità collettiva”, trasversale e diffusa, di un “universo simbolico” che dà le coordinate per percepire, “sentire” e agire e che ha forti relazioni con l’ordine istituzionale. In particolare, la tesi che intendo sostenere è che questa emozione abbia un “carattere soggettivante” nella modernità: costituisca, cioè, un elemento imprescindibile di quella visione del mondo che, intersecando gli schemi individuali di percezione, valutazione e azione, caratterizza l’uomo moderno, in particolare nei suoi rapporti con la sfera dell’ordine e della penalità. Garland indica con “cultura penale” quel campo di significati in cui sono ascritte le abitudini e le diverse procedure che compongono la sfera penale, e cioè un insieme non coerente di teorie penalistiche, di esperienze stratificate, di saggezza istituzionale e di buon senso professionale, che struttura e conferisce un senso all’agire di chi opera nel mondo penale76. L’autore fa riferimento a un concetto di cultura molto familiare ai costruttivisti e comprensivo, come sottolinea Adolfo Ceretti77, di tutti i fenomeni cognitivi, noti come “mentalità”78 (valori, categorie, sistemi di idee e di credenzea), nonché di quelli relativi agli affetti e alle emozioni, denominato “sensibilità”. Il nostro modo di “sentire” riferito alla criminalità, dunque, entra a pieno titolo nell’area della penalità, non solo in quanto prodotto, come suggerisce Garland riprendendo in particolare gli studi sui processi rituali applicati al giudizio penale e gli studi di Elias, dei modelli culturali, ma anche – sviluppando a pieno l’approccio culturalista del criminologo della New York University 75 P. Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500, op. cit. a nota 74, p. XXIII. D. Garland, Punishment and Modern Society, Oxford University Press, Oxford, 1990 (trad. it. Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale, Il Saggiatore, Milano, 1999, p. 251). 77 A. Ceretti, “Presentazione”, in D. Garland, La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Milano, 2004, p. 20. 78 È evidente come il termine “mentalità”, in questo caso, sia usato con un significato diverso da come è definito in Ginzburg e come, semmai, il concetto di cultura di Garland si avvicini più a quello di mentalità dello storico italiano. 76 202 Capitolo 4 non solo rispetto alla pena79, ma anche riguardo al «sentire rispetto al delinquente»80 – come elemento caratterizzante quei modelli. Ritengo, in altre parole, che la paura della criminalità, in epoca moderna, non sia semplicemente un’emozione individuale costruita attraverso una manipolazione operata dalle élites dominanti oppure prodotta da un sistema culturale, bensì sia uno stato d’animo che circola trasversalmente nella società e che costruisce uno dei punti nevralgici della produzione culturale moderna, vale a dire della costruzione, sempre conflittuale e incoerente, di quel campo di significati che, intrecciandosi con le pratiche e le forme istituzionali, costituisce la modernità. Prima di entrare nel vivo di questo ragionamento, mi preme fare alcune precisazioni. In quanto detto finora è sottinteso un passaggio fondamentale, che emergerà nel corso della trattazione ma che è bene esplicitare da subito: la centralità della sfera penale nella “cultura moderna”. Quest’ultima, infatti, ruota attorno a una concezione dei rapporti tra stato e suddito/cittadino in cui la monopolizzazione della violenza diffusa, operata attraverso l’accentramento delle funzioni di polizia, giurisdizionali e punitive e la concentrazione simbolica delle pratiche penali nel giudizio penale, gioca un ruolo fondamentale. Inoltre, indicando la paura della criminalità come emozione nevralgica della cultura moderna, non intendo disconoscere l’importanza di altre sensibilità – per citare qualche esempio: il risentimento, la vergogna e la rabbia81– e di altre mentalità che caratterizzano la penalità. Penso, in particolare, al movimento della giustizia riparativa, che costituisce una filosofia penale, per certi aspetti, alternativa – ma non per questo incompatibile – al processo penale moderno, in quanto capace di innovare la logica dell’intervento sul reato dando un significato diverso alla pena: non più strumento d’intimidazione – che fonda la sua efficacia sulla paura che incute sui consociati –, bensì strumento di responsabilizzazione82. È possibile tenere insieme queste diver- 79 Si veda il cap. XI “La pena come fattore culturale. Il ruolo della penalità nella creazione della cultura” (D. Garland, op. cit. a nota 76, pp. 291-319). 80 L’espressione viene usata dallo stesso Garland (D. Garland, op. cit. a nota 76, p. 237). 81 J. Braithwaite, Crime, shame and reintegration, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. Cfr. anche A. Verde, “La risposta pubblica alla devianza ed alla criminalità dal punto di vista psicosociologico”, in Gasanti A. (a cura di), Giustizia e conflitto sociale. In ricordo di Vincenzo Tomeo, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 279-289. 82 Cfr. G. De Leo, Psicologia della responsabilità, Laterza, Roma-Bari, 1998; A. Ceretti, G. Mannozzi, "Restorative Justice. Theoretical Aspects and Applied Models", Offenders and Victims. Accountability and Fairness in the Justice Process. Contribution to the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, A/ Conf. 187/ NGO. 1., 2000; I. Marchetti, La paura della criminalità al centro della modernità 203 se logiche se si concepisce la “cultura” non in modo monolitico, bensì come campo di forze in conflitto tra loro che si contendono la supremazia nel dare un senso alle pratiche penali. Questa concezione permette, d’altra parte, di attribuire il giusto peso alla relazione tra le diverse filosofie e le pratiche penali e di riconoscere come la logica punitiva fondata sull’intimidazione costituisca ancora un tratto fondamentale del sistema penale moderno. Descriverò la centralità della paura della criminalità nella modernità privilegiando l’osservazione di alcune “risposte teoretiche” che, secondo Berger e Luckmann, costituiscono un meccanismo di conservazione e di trasmissione degli universi simbolici. In particolare, l’analisi ruoterà intorno alla fenomenologia della paura in Hobbes: il pensiero del filosofo inglese, il quale, come emergerà a breve, assegna alla paura e alla violenza un ruolo centrale nella fondazione dello Stato moderno, ha costituito un termine di riferimento imprescindibile, anche per chi, come Spinoza (1632-1677), considerava il timore una passione caratterizzata dall’instabilità e, nell’intento di rimuoverlo come ostacolo difficilmente sormontabile in vista della transizione a un grado maggiore di perfezione e di esistenza83, ha sviluppato una concezione dello Stato in aperto contrasto con quella di Hobbes: il suo [dello Stato] fine non è di dominare gli uomini né di costringerli col timore a sottomettersi al diritto altrui; ma, al contrario, di liberare ciascuno dal timore, affinché possa vivere, per quanto è possibile in sicurezza, e cioè affinché possa godere nel miglior modo del proprio naturale diritto di vivere e di agire senza danno né suo né di altri. […] Il vero fine dello Stato è, dunque, la libertà.84 Non intendo, è bene sottolinearlo, compiere una sistematizzazione del pensiero filosofico-politico moderno intorno al concetto di “paura”: m’interessa, invece, a partire da alcuni spunti teorici, estrapolare una chiave di lettura per interpretare la pervasività di questa emozione nella società odierna. Un’ultima annotazione: di seguito parlerò alternativamente di paura della criminalità e paura della violenza (o paura della morte violenta). Mi sento legittimato a farlo non solo perché molti degli studi criminologici che ho ri- C. Mazzucato, La pena «in castigo». Un'analisi critica su regole e sanzioni, Vita e Pensiero, Milano, 2006. 83 R. Bodei, op. cit. a nota 27, p. 317. 84 B. Spinoza, Trattato teologico-politico, 1972, p. 482. Per un’analisi approfondita del pensiero di Spinoza, anche in comparazione a quello di Hobbes, cfr. R. Bodei, op. cit. a nota 27, pp. 91-92 e P. Di Vona, Aspetti di Hobbes in Spinosa, Loffredo Editore, Napoli, 1990. 204 Capitolo 4 portato nel capitolo 1 indicano come sia principalmente la violenza (sia sulle persone che sulle cose, sempre più percepite, in un’epoca di “individualismo proprietario”, come pertinenze inscindibili del soggetto) a scuotere le persone, ma soprattutto perché la criminalità, costituendo per definizione una frattura dell’ordine giuridico, è di per sé “violenza”.85 L’indistinzione tra criminalità e violenza, tuttavia, rischia di occultare il fatto che la violenza è anche e al tempo stesso fondatrice e conservatrice dell’autorità e del diritto, divenendo in tal modo legittima. 86 Questo scarto tra criminalità e violenza costituisce senza dubbio una questione aperta su cui si ritornerà nel corso del capitolo. Fenomenologia della paura in Hobbes Hobbes (1588-1679) ha fatto della paura il filo conduttore del suo pensiero. Sebbene altri pensatori prima di lui avessero assegnato un ruolo importante alla paura quale determinante dell’azione politica, il filosofo inglese è il primo a sostenere che «l’origine delle grandi e durevoli società deve essere stata non già la mutua simpatia tra gli uomini, ma il reciproco timore».87 Mentre gli autori precedenti ritenevano che la paura fosse un’emanazione della morale condivisa di una società e che gli oggetti della paura popolare ne riflettessero il contenuto, Hobbes, consapevole delle differenze esistenti tra gli uomini a proposito del significato del bene e del male88 in un’epoca 85 J. Derrida, Force de loi. Le «Fondement mystique de l’autorité», Editino Galilée, Paris, 1994 (trad. it. La forza della legge. Il «Fondamento mistico dell’autorità», Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 9899: «in ciò che ha di più fondamentale, il diritto europeo tende a proibire la violenza individuale e a condannare in quanto essa stessa minaccia non questa o quella legge, ma l’ordine giuridico stesso»; da qui l’ «interesse del diritto a monopolizzare la violenza. […] Questo monopolio non tende a proteggere questi o quei fini giusti o legali […] ma il diritto stesso». Il fascino e l’ammirazione esercitati sul popolo dalla figura del grande delinquente si spiega in questo modo: «non è qualcuno che ha commesso questo o quel crimine per il quale si proverebbe una segreta ammirazione; è qualcuno che, sfidano la legge, mette a nudo la violenza dell’ordine giuridico stesso»). Sulla scommessa di pensare e costruire la differenza del diritto rispetto alla legge, a partire dal riconoscimento di una loro stretta aderenza, si veda E. Resta, La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza, Laterza, Roma-Bari, 1992. 86 J. Derrida, op. cit. a nota 85. 87 T. Hobbes, De cive, edizione a cura di M. Barzaghi, Marietti, Roma, 1972, p. 26. 88 T. Hobbes, Leviatano, edizione a cura di A. Pacchi, Editori Laterza, Roma, 1996, cap. 6, p. 43 «Poiché la costituzione del corpo umano è in continuo mutamento, non è possibile che le stesse cose causino sempre in esso gli stessi appetiti e le stesse avversioni ed è ancor meno possibile che tutti gli uomini consentano nel desiderio di un solo e medesimo oggetto. Qualunque sia l’oggetto dell’appetito o del desiderio di una persona, per sua parte lo chiama buono e chiama cattivo l’oggetto del suo odio e della sua avversione, e vile e insignificante l’oggetto del suo disprezzo. Infatti i termini buono, cattivo e disprezza- La paura della criminalità al centro della modernità 205 caratterizzata da grande scetticismo riguardo all’oggettività di ogni percezione e convinzione, pone la paura come elemento costitutivo della morale, in ciò edificando in negativo il fondamento morale sul quale gli uomini avrebbero potuto vivere in pace.89 Il concetto fondamentale da cui parte Hobbes è l’istinto di autoconservazione: gli uomini, uguali nelle facoltà del corpo e della mente90 e quindi anche uguali nella speranza di raggiungere i propri fini91, diventano nemici poiché, desiderando la medesima cosa e non potendone fruire tutti, nel perseguire il loro scopo «che è principalmente la propria conservazione e talvolta solo il proprio piacere» cercano di distruggersi o di sottomettersi l’un l’altro. La condizione umana, all’infuori della società civile, cioè nello “stato naturale”, si risolve, dunque, in una «guerra di ogni uomo contro ogni altro uomo»92 in cui «ciascuno è nemico di ciascuno» e in cui «gli uomini vivono senz’altra sicurezza di quella di cui li doterà la loro propria forza o la loro propria ingegnosità»93. In questo stato di guerra le nozioni di diritto e torto, di giustizia e ingiustizia non vi hanno luogo. Laddove non esiste un potere comune, non esiste legge; dove non vi è legge non vi è ingiustizia. Violenza e frode sono in tempo di guerra le due virtù cardinali. Giustizia e ingiustizia […] sono qualità relative all’uomo che vive in società, non in solitudine. A questa medesima condizione [stato di guerra] consegue anche che non esiste proprietà, né dominio, né distinzione tra mio e tuo, ma appartiene ad ogni uomo tutto ciò che riesce a prendersi e per tutto il tempo che riesce a tenerselo.94 bile vengono sempre usati con riferimento alla persona che se ne serve, dato che non esiste nulla di simile in senso singolare ed assoluto, e nessuna regola generale rispetto a ciò che è buono e cattivo che sia ricavata dalla natura degli oggetti stessi. Una tale regola deriva piuttosto dalla dalla persona singola (dove non c’è Stato) o (all’interno di uno Stato) dalla persona che lo rappresenta, oppure da un arbitro o da un giudice che gli individui tra loro dissenzienti istituiranno di comune accordo, assegnando valore di regola al suo giudizio». 89 C. Robin, Fear, Oxford University Press, 2004 (trad. it. Paura. La politica del dominio, EGEA, 2004, pp. 36-37). 90 Sul concetto di “uguaglianza di capacità” si veda T. Hobbes, op. cit. a nota 88, Cap. XIII, p. 99 «La natura ha fatto gli uomini così uguali nelle facoltà del corpo e della mente che, benchè talvolta si trovi un uomo palesemente più forte, nel fisico, o di mente più pronta di un altro, tuttavia, tutto sommato, la differenza tra uomo e uomo non è così considerevole al punto che un uomo possa da ciò rivendicare per sé un beneficio cui un altro uomo non possa pretendere tanto quanto lui». 91 Ibidem, p. 100. 92 Ibidem, p. 101. 93 Ibidem, p. 102. 94 Ibidem, p. 103. 206 Capitolo 4 Nello stato di natura, come specifica lo stesso Hobbes in Elementi di legge naturale e politica95 ogni uomo è giudice di se stesso e dà alle cose nomi e definizioni diversi dagli altri, e da queste differenze sorgono dispute e turbamenti della pace. Si ravvisa, in questa concezione, una sorta di forma radicale di anomia, intesa non tanto come inadeguatezza delle norme morali a regolare la vita sociale (Durkheim), quanto etimologicamente come assenza di Nomos, di un codice morale condiviso, che è innanzitutto mancanza di un linguaggio comune, di un accordo su come definire e – come abbiamo imparato dai costruttivista – dare un significato alle cose. Di fronte all’esigenza di costruire un ordine della società, Hobbes parte, dunque, da individui isolati, che vivono in solitudine, in stato di guerra, piuttosto che essere orientati verso il fine ultimo o il bene comune. Questa concezione, come sottolinea Dino Pasini96, costituisce una frattura con la filosofia morale classica e cristiana. Mentre l’etica di Aristotele parte dai fini dell’azione e analizza l’ordine dell’esistenza umana in relaziona all’ordinazione di tutte le azioni a uno scopo supremo, il summum bonum, Hobbes insiste nell’affermare che non esiste alcun summum bonum: non si dà infatti in questa vita né un finis ultimus (scopo ultimo) né il summum bonum (il massimo bene) di cui si parla nei libri degli antichi filosofi morali. […] La felicità è un continuo progresso del desiderio da un oggetto ad un altro, dove il raggiungimento del primo non è altro che la via per il conseguimento del secondo. […] Considero perciò al primo posto, come inclinazione generale di tutta l’umanità, un desiderio perpetuo e ininterrotto di acquistare un potere dopo l’altro che cessa soltanto con la morte.97 Va sottolineato che la formula dello stato di guerra, è essenzialmente teorica98: è lo stesso Hobbes ad anticipare alcune possibili critiche alla sua enunciazione della “natura umana”. Rivolgendosi a un interlocutore immaginario, scettico sulla sua ricostruzione dello stato di guerra, lo invita a riflettere sul fatto che 95 T. Hobbes, Elementi di legge naturale e politica, edizione a cura di A. Pacchi, Sassoni, Firenze, 2004. 96 Cfr. D. Pasini, “«Paura reciproca» e «paura comune» in Hobbes”, in Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, IV serie, LII, 1975, pp. 641-691. 97 T. Hobbes, op. cit. a nota 88, Cap. XI, p. 78. 98 D. Pasini , op. cit. a nota 96, p. 644. La paura della criminalità al centro della modernità 207 quando intraprende un viaggio si arma e cerca di andare ben accompagnato; che quando va a dormire sbarra le porte, che addirittura quando è nella sua casa chiude a chiave i forzieri; e tutto ciò sapendo che vi sono leggi, e funzionari pubblici armati, per vendicare tutte le offese che dovessero essergli fatte. Quale opinione ha dei suoi sudditi quando cavalca armato? Dei suoi concittadini quando sbarra le porte? Dei suoi figli e dei suoi servitori quando chiude a chiave i forzieri? Non accusa egli l’umanità con le sue azioni come faccio io con le mie parole?” E aggiunge: “si può forse pensare che non vi sia mai stato un tempo e uno stato di guerra come questo, ed io credo che nel mondo non sia mai stato così in generale: ma vi sono molti luoghi ove attualmente si vive in tal modo.99 Giorgio Agamben100, nell’intento di rileggere il mito di fondazione della città moderna, indica lo stato di natura di Hobbes come “stato di eccezione”, in cui «la città appare per un istante […] tamquam dissoluta. La fondazione non è, cioè, un evento compiuto una volta per tutte in illo tempore, ma è continuamente operante nello stato civile nella forma della decisione sovrana». Torneremo più avanti sui concetti di “stato di eccezione” e di “decisione sovrana” nel pensiero di Agamben. Basti per il momento la sottolineatura del fatto che lo stato di guerra di Hobbes non costituisce un artificio logico e nemmeno una situazione storicamente determinata, un’epoca reale, bensì un fondamento mitico e al tempo stesso contingente nella società moderna: un principio interno allo Stato, che si rivela nel momento in cui lo si considera come se fosse dissolto101. Hobbes, dicevo prima, è interessato al problema della costruzione di un ordine nella società e individua nella paura della violenza, e cioè nella preoccupazione degli uomini di «trarsi fuori dal quel miserevole stato di guerra che rappresenta la necessaria conseguenza delle passioni degli uomini quando manca un potere visibile capace di tenerli soggetti e di far loro seguire i precetti» il sentimento che può muovere gli uomini alla pace: le passioni che inducono gli uomini alla pace sono la paura della morte, il desiderio di quelle cose che sono necessarie a una vita piacevole e la speranza di ottenerle con la propria operosità ingegnosa. E la ragione suggerisce opportune clausole di pace sulle quali si possono portare gli uomini ad un accordo: queste clausole sono quelle che vengono, in altri termini, chiamate le leggi di natura.102 99 T. Hobbes, op. cit. a nota 88, Cap. XIII, pp. 102-103. Ibidem, p. 121. G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino, 1995, p. 42. 102 T. Hobbes, op. cit. a nota 88, Cap. XIII, pp. 102-103. 100 101 208 Capitolo 4 La centralità di questa considerazione induce a dedicare qualche parola sul momento di passaggio dallo “stato di natura” allo “stato civile”, e cioè al momento fondativi dell’ordine e della sovranità. Nello stato di guerra di tutti contro tutti, «ciascuno ha diritto a tutto, anche al corpo di un altro»103. Hobbes chiama questo diritto “Jus Naturale”, vale a dire la «libertà che ciascuno ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della sua vita e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine»104. Il Diritto Naturale di ciascuno a tutto finisce, tuttavia, per impedire a ciascuno, per quanto forte e saggio sia, di vivere per tutto il tempo che la natura permette solitamente di vivere agli uomini. Infatti, finchè tutti hanno diritto a tutto, ciascuno è per ogni altro sovrano (homo homini lupus): può sottrargli ciò che possiede ma anche disporre del suo corpo.105 L’accostamento tra il termine “sovrano” e quello di “homo-lupus” è suggerito da Agamben106, il quale sottolinea come nell’espressione hobbesiana homo homini lupus riecheggino le formule della legge salica, della legge riparia e delle leggi di Edoardo il Confessore (1130-35) in cui il bandito viene definito nei termini di «uomo-lupo». L’antico diritto germanico si fondava sul concetto di pace (Fried) e sulla corrispondente esclusione dalla comunità del malfattore, che diventava perciò friedlos, senza pace, e come tale, poteva essere ucciso da chiunque senza che questo atto potesse essere considerato omicidio. Anche il bando medievale presenta caratteri analoghi: il bandito poteva essere ucciso o era considerato addirittura già morto. Per questi aspetti, la figura del bandito, secondo Agamben, si accosta a quella dell’ homo sacer, che non può essere sacrificato ma la cui uccisione non può essere punita, e del sovrano, la cui uccisione negli ordinamenti giuridici non è mai rubricata come omicidio, e la cui insacrificabilità si manifesta nell’impossibilità, in molti ordinamenti, di giudicare il sovrano o comunque di giudicarlo con un processo ordinario.107 103 Ibidem, p. 106. Ibidem, p. 105. 105 Il riferimento alla disponibilità del corpo dell’altro richiama immediatamente il concetto di “nuda vita” tematizzato da Agamben (G. Agamben, op. cit. a nota 101, p. 41). 106 Ibidem. 107 Si noti come lo stesso Hobbes sostenga come «nessun uomo che abbia il potere sovrano può essere giustamente messo a morte, o altrimenti in qualche modo punito dai suoi sudditi». T. Hobbes, op. cit. a nota 88, Cap. XVIII, p. 148. 104 La paura della criminalità al centro della modernità 209 L’ homo-lupus di Hobbes, dunque, non ha una vita appartenente alla natura ferina, e neppure una vita politica, o meglio politicizzata da un sovrano che ne sancisce l’uccidibilità e da un ordinamento giuridico che stabilisce la punibilità della sua uccisione, bensì una vita pre-giuridica o pre-politica che abita la soglia del diritto della città, dello stato civile, una «nuda vita»108 di cui ciascun altro può disporre ma che si pone come presupposto della costruzione del “politico” e del “giuridico”, cioè dello Stato. Queste considerazioni suggeriscono di leggere il passaggio hobbesiano dallo Jus Naturale, caratteristico dello stato di natura, alla Lex Naturalis, come percorso di politicizzazione della nuda vita e primo passo per la costruzione dello Stato moderno. Infatti, sviluppando le riflessioni di Agamben, si rileva come già nell’espressione homo homini lupus sia contenuto il passaggio fondamentale da “lupo” a “uomo”, dallo stato di natura allo stato civile, quel «forte slittamento dall’io al noi» di cui parla anche Elena Pulcini109. Ma è un noi debole, sottoposto a continue minacce: in Hobbes il noi – la dimensione politica, l’ordine statuale – non è pensabile se non a partire dal singolo, come punto di arrivo di una libera scelta individuale. Non essendoci più una comunità che precede l’individuo e che lo inserisce nelle trame di vincoli gerarchici, come ancora sosteneva il contrattualismo medievale, né un’autorità politica legittimata da autorità trascendenti, l’ordine si configura come risultato della decisione presa da individui-sovrani di conferire a un terzo il proprio Diritto Naturale. L’ordine sociale e politico, per Hobbes, si regge sul consenso di individui liberi ed eguali che per natura non soggiacciono ad alcuna autorità e che decidono razionalmente di stipulare un patto per erigere il potere politico, ma che possono sempre decidere di revocare quel patto. Da qui l’intrinseca debolezza del noi. In questo senso il filosofo inglese anticipa la tensione tra “io” e “noi”, tra individualismo e legame sociale, che risulterà essere un tema centrale della riflessione moderna110. Ho già rilevato come Hobbes ponga a fondamento dello stato di guerra il desiderio, strettamente connesso alla ricerca della propria conservazione e talvolta del piacere, che si esprime in desiderio illimitato di potere al fine di 108 Ibidem, p. 118. E. Pulcini, “La passione del Moderno: l’amore di sé”, in S. Vegetti Finzi (a cura di), Storia delle passioni, Editori La Terza, Milano, 1995, p. 147. 110 La tensione moderna tra io e noi può essere meglio descritta come «processo di autoaffermazione» dell’uomo di cui parla Pulcini citando Hans Blumenberg (H. Blumenberg, La legittimità dell’età moderna, 1966, p. 144): «l’erosione dei fondamenti teologico-metafisici consente all’individuo di scoprire la propria autonomia e di intravedere nuovi orizzonti, ma lo espone anche a nuove tensioni, paure, speranze» (Ibidem, p. 135). 109 210 Capitolo 4 assicurarsi per sempre la conservazione e il piacere111; ed è ancora una passione, la paura112, quella di ciascun uomo-lupo verso la libertà assoluta di ogni altro (la «paura reciproca») a indicare la via d’uscita dallo stato di natura, a stimolare la ragione a “cercare la pace” (la legge di natura fondamentale) e, quindi, a «rinunciare, nella misura in cui lo si ritenga necessario alla pace e alla propria difesa, al diritto su tutto e ci si accontenti di avere tanta libertà nei confronti degli altri quanta se ne concede agli altri nei confronti di se stessi»113 (seconda legge di natura). Come sottolinea Giuseppe Sorgi, nell’antropologia di Hobbes premessa alle opere politiche la paura acquista caratteristiche e dimensioni più concrete rispetto a come è stata tematizzata nelle opere filosofiche (De Corpore e De Homine): «si presenta come componente essenziale dell’attività psichica dell’uomo, si pone all’origine della sua fede religiosa, ne determina e regola la vita sociale e quella politica»114. Se la paura della morte naturale, come sottolinea Julien Freund115, sembra essere posta a fondamento della religione, è la paura della morte violenta ad avere un rilievo determinante nella teoria politica hobbesiana. Il fatto che, secondo quanto osserva Bodei116, la critica recente tenda a porre in luce quegli aspetti di razionalità e di consenso che fondano in Hobbes lo Stato moderno, non diminuisce affatto il ruolo della paura e della forza nel suo pensiero. La paura della violenza nello stato di natura117 mette in azione la ragione che innanzitutto suggerisce “opportune clausole di pace”, le leggi naturali, sulle quali si possono portare gli uomini a un accordo, ovvero a stipulare tra loro contratti o patti – in cui si trasferiscono diritti che, se mantenuti da ciascuno, sono d’impedimento alla pace dell’umanità. Ma questi patti non sono sufficienti a garantire la pace, in quanto manca un’autorità che imponga la loro osservanza. Si passa così dai patti tra uomini al contratto sociale me- 111 Il desiderio si declina in desiderio di potere perché «l’oggetto del desiderio di un uomo è quello di gioire una volta sola e per un istante di tempo, ma quello di assicurarsi per sempre la via per il proprio desiderio futuro». T. Hobbes, op. cit. a nota 88, Cap XI p. 93-94. 112 Sulla correttezza dell’uso del termine “paura” per descrivere lo stato d’animo hobbesiano si veda G. Sorgi, Quale Hobbes? Dalla paura alla rappresentanza, Franco Angeli, Milano, 1989, p. 171. 113 T. Hobbes, op. cit. a nota 88, Cap. XIV, p. 106. 114 G. Sorgi, op. cit. a nota 112, p. 163. 115 J. Freund, “La thème de la peur chez Hobbes”, Cahiers Vilfredo Pareto. Revue européenne des sciences sociales, XIII, 1975, pp. 18-19. 116 Cfr. R. Bodei, op. cit. a nota 27, p. 84. 117 Giova ripetere che lo stato di natura va inteso non già come epoca storica o ipotesi logica, bensì come tendenza della natura umana esistente al di sotto della struttura giuridico-politica. La paura della criminalità al centro della modernità 211 diante il quale si dà vita allo stato civile: l’unico modo di erigere un potere comune che possa essere in grado di difenderli dall’aggressione di stranieri e dai torti reciproci – perciò procurando loro sicurezza118 è quello di trasferire tutto il loro potere e tutta la loro forza a un solo uomo o a una sola assemblea di uomini (che, in base alla maggioranza delle voci, possa ridurre tutte le volontà a un’unica volontà). In Hobbes l’uomo non nasce, ma diventa sociale stipulando patti con altri uomini, e non per «simpatia» ma per opera della paura.119 La paura è, in tal senso, anche il fondamento del potere o, per meglio dire, del dominio, inteso quale rapporto intersoggettivo di sovraordinazione e di subordinazione, di comando e di obbedienza 120. Va notato che la paura dell’uomo-lupo hobbesiano non è, come forse ci si aspetterebbe in uno stato di natura, uno stato d’animo irrazionale, ma è in rapporto dialettico con la ragione121: è una sorta di previsione di un male futuro, è una paura che comporta un ragionare, che produce sospetto e diffidenza che conducono a volte alla fuga ma più spesso a cautelarsi dal pericolo sopravveniente. In questo senso, essa non è solo connessa all’attività di prevedere un male futuro, ma anche a quella di provvedere a parare i colpi e cercare di rimuovere le situazioni di pericolo. La paura ha dunque una funzione positiva: non paralizzante ma stimolante. È una passione ragionata e al tempo stesso ragionante;122 umana e al tempo stesso civile, nel senso che sollecita e pone in moto il processo di incivilimento dell’uomo. 123 La paura della violenza reciproca e conseguentemente dell’autodistruzione (summum malum) sono alla base, dunque, del contratto sociale, che si sostanzia nel trasferimento dei propri diritti allo Stato e che diventa efficace solo per il terrore che la sua forza incute ai contraenti. Infatti, «le leggi di natura ([…] il fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi), in se stesse, senza il terrore di qualche potere a far sì che siano osserva- 118 Per “sicurezza”, fine per cui un uomo cede ad altri il diritto di proteggersi e difendersi da sè, Hobbes non intende una pura e semplice “preservazione”, ma anche «qualsiasi altra gioia della vita che ciascuno, con un’attività consentita, senza danneggiare o contrastare lo Stato, si sarà procurata»(D. Pasini, op. cit. a nota 96, p. 665). Da notare che i due fini della pace e della difesa comune, insiti nel concetto di sicurezza, nel De Cive diventano quattro: la difesa dai nemici esterni; la conservazione della pace interna, l’arricchimento compatibile con la sicurezza pubblica e il godimento di una libertà innocua (Ibidem, p. 674). 119 Ibidem, pp. 659-660. 120 Ibidem, p. 657. 121 Ibidem, p. 658. 122 G. Sorgi, op. cit. a nota 110, pp. 171-172. 123 D. Pasini, op. cit. a nota 96, p. 658. 212 Capitolo 4 te, sono contrarie alle passioni naturali, che ci portano piuttosto alla parzialità, all’orgoglio, allo spirito di vendetta e simili»124. Purtuttavia, la sottomissione e il dovere di obbedienza degli uomini, in quanto sudditi, a un potere comune che garantisca pace e sicurezza, non comporta la scomparsa della paura, ma una sua trasformazione in “terrore”, o, come la definisce Pasini, in “paura comune” o “paura organizzata”: solo ponendo fine al potere di ogni singolo uomo per dar vita a un potere comune gli uomini possono porre fine alla paura reciproca. Ma questo potere comune, per svolgere la sua funzione di garantire sicurezza e pace, deve incutere a tutti uguale timore. Questa emozione, rivolta alla forza dello Stato, è fondamento, condizione essenziale della stabilità della società civile e della sicurezza dei sudditi e dello Stato125. È nel potere che sta l’essenza dello Stato, esito di un trasferimento del potere di vita e di morte (violenza) che nello stato di natura ciascuno agisce nei confronti di ogni altro e che è strettamente connesso allo Jus Naturale. In questo senso in Hobbes lo stato di natura sopravvive esclusivamente nella persona del sovrano (o dell’assemblea sovrana), che è l’unico a conservare il suo naturale ius contra omnes.126 A garanzia della stabilità dell’ordine sociale, ottenuta attraverso l’obbedienza di ciascun suddito alla legge, non agisce solo la paura comune del potere coercitivo dello Stato bensì una preoccupazione di secondo livello, una “paura della paura”: il timore di ripiombare, a causa dell’inefficacia del potere sovrano, nella condizione di natura caratterizzata dalla «paura reciproca». L’emozione connessa al potere comune non è dunque solamente paura dell’esercizio del potere coercitivo, ma anche dell’inefficacia o dell’improvvisa assenza di potere coercitivo, che rischierebbe di riportare gli uomini alla guerra di tutti contro tutti. Prima di concludere questa disamina della paura in Hobbes, è utile considerare le riflessioni di Norberto Bobbio circa la concezione legalistica della giustizia in Hobbes127. Bobbio ritiene che il filosofo inglese abbia espresso una delle concezioni più caratteristiche e rigorose della giustizia formale che 124 T. Hobbes, op. cit. a nota 86, Cap XVII, p. 139. Hobbes riconosce l’importanza del consenso nel sorgere dello Stato: lo stesso contratto sociale è una forma di consenso. Tuttavia, egli esplicitamente esclude che il consenso sia da solo sufficiente ad assicurare la vita di una società, data la sua incapacità a mantenere una convivenza pacifica. G. Sorgi, op. cit. a nota 112, p. 179. 126 G. Agamben, op. cit. a nota 101, pp. 41 e 42. 127 N. Bobbio, Da Hobbes a Marx. Saggi di storia della filosofia, Morano Editore, Napoli, 1965, pp. 11-49. 125 La paura della criminalità al centro della modernità 213 mai siano state sostenute: «la giustizia consiste nell’adempimento degli obblighi, quale che sia il contenuto dell’obbligo, o, considerando una particolare specie di obblighi (quelli del cittadino nei confronti dello Stato), nell’obbedienza alla legge quale che sia il contenuto della legge». 128 La legge, in quanto comando di colui che ha il potere legittimo di comandare, costituisce l’unico e non superabile criterio del giusto e dell’ingiusto. Nonostante prenda le mosse dalla legge naturale, la teoria hobbesiana giunge alla costruzione di una solida concezione positiva dello Stato che costituisce il nucleo dell’ideologia del positivismo giuridico: il diritto positivo è criterio autosufficiente del giusto e dell’ingiusto. In tal modo viene eliminato ogni riferimento al diritto naturale, inteso come complesso di principi e di norme di condotta che dovrebbero permettere di prendere posizione di fronte al diritto positivo per approvarlo o disapprovarlo. L’analisi di Bobbio mette in luce come in Hobbes, positivista per inclinazione mentale e per ragionamento e giusnaturalista per necessità, il giusnaturalismo sfoci in una concezione monastica del diritto, cioè in una negazione del diritto naturale come sistema di diritto superiore al sistema di diritto positivo. Hobbes – a detta di Bobbio – si è valso delle leggi naturali soltanto come di un espediente per dare un fondamento ben accetto al potere assoluto del sovrano, e quindi all’incontrastata supremazia del diritto positivo – ne è prova il fatto che nel sistema hobbesiano la violazione di una legge naturale da parte del sovrano non autorizza il suddito alla disobbedienza129. Hobbes è riuscito a darci il concetto di uno stato in cui è condotto alle estreme conseguenze il fenomeno della monopolizzazione statuale del diritto attraverso l’accurata eliminazione di tutte le fonti giuridiche che non siano la legge, o volontà del sovrano […] e di tutti gli ordinamenti giuridici che non siano quello statuale (in particolare dell’ordinamento della Chiesa, di quello della comunità internazionale, di quello degli enti associativi minori).130 Vale la pena ricordare, andando oltre il testo di Bobbio, come le due leggi naturali che costituiscono «quel dettame della nostra ragione che suggerisce all’uomo se vuol ottenere la pace, di obbedire in tutto e per tutto soltanto alle leggi positive»131 – la ricerca della pace (la legge di natura fondamentale) e la rinuncia, nella misura in cui lo si ritenga necessario alla pace e alla propria 128 Ibidem, p. 13. Ibidem, p. 38. Ibidem, pp. 14-15. 131 Ibidem, p. 20. 129 130 214 Capitolo 4 difesa, al diritto su tutto (seconda legge di natura) – scaturiscano non da entità sovraordinate, ma dall’uomo, dalla sua preoccupazione di uscire da uno stato di violenza diffusa. Le considerazioni finora svolte confermano la tesi secondo cui la fenomenologia della paura di Hobbes costituisce il nucleo centrale della sua teoria filosofico-politica: da una parte la paura reciproca – quella di ciascuno verso ogni altro – è a fondamento della costruzione dell’ordine sociale garantito da un potere coercitivo comune, dall’altra la “paura della paura” – il timore di ritornare alla condizione di paura della violenza diffusa – e la “paura comune” spingono l’uomo a obbedire all’ordinamento giuridico statuale. 4.4 La paura dopo Hobbes Dalla paura reciproca alla paura comune L’innovativa tematizzazione della paura della violenza come fondamento della sovranità statuale compiuta da Hobbes costituisce un termine di paragone imprescindibile per ogni pensiero filosofico-politico posteriore. Studiosi anche molto lontani cronologicamente e diversi per formazione e interessi teorici – tratterò in particolare il pensiero di Montesquieu e quello di Guglielmo Ferrero – hanno sviluppato, sia pure con toni più o meno apertamente critici – le proprie riflessioni sulla paura nel solco tracciato da Hobbes. Come ho già ricordato, anche filosofi come Spinoza, pur sviluppando teorie dello Stato alternative, hanno dovuto fare i conti con quello che costituisce un paradigma fondamentale nella concezione dell’ordine moderno. Purtuttavia, in queste ricostruzioni teorico-politiche si assiste a uno spostamento di interesse dalla “paura reciproca” alla “paura comune”: questa emozione perde progressivamente la sua funzione di fondamento dello Stato moderno per essere tematizzata principalmente come paura del potere e nel potere. Cessa di essere una passione positiva, perde il ruolo di attivazione della ragione alla ricerca dell’ordine, e assume i connotati di passione negativa, connessa all’esercizio del potere. D’altra parte, i tempi sono cambiati e lo Stato-nazione non richiede più legittimazioni: è un “dato di fatto” e come tale non pone più interrogativi sulla sua fondazione. Nuovi problemi s’impongono alla riflessione teorica: le istanze di democratizzazione delle società occidentali, che hanno proceduto di pari passo a trasformazioni nell’economia, nella società e nella cultura, comportano, da una parte, l’inclusione nella modernità di sempre più ampie fasce di popolazione, La paura della criminalità al centro della modernità 215 dall’altra parte la trasformazione dello statuto di suddito in quello di cittadino. In questo senso, non interessa tanto legittimare l’ordine istituzionale ab orgine, quanto renderlo compatibile con le nuove esigenze economicopolitiche di tutela della libertà individuale e di compatibilità con un sistema di democrazia rappresentativa. Si assiste, dunque, a uno slittamento dell’interesse filosofico-politico dalla fondazione del potere ai suoi vizi ed eccessi. D’altra parte, come sottolinea Norberto Bobbio, a partire da Marx l’idea del progresso attraverso lo Stato decade. Le correnti vive del pensiero politico ottocentesco – dal socialismo utopistico a quello scientifico, dall’anarchismo al liberalismo spenceriano, dal darwinismo sociale al vitalismo nietszchiano – considerano lo stato come la continuazione sott’altra forma, e talora la sublimazione, della lotta ferina rivelata dallo stato di natura; nello stato la violenza non è soppressa ma soltanto trasformata nella perpetua sopraffazione dei forti sui deboli, dei vincitori sui vinti, dei governanti sui governati. Lo stato è un regime di violenza e di terrore non meno dello stato di natura […]. Da momento storico positivo del progresso storico, lo stato diventa momento negativo.132 Da questa angolatura è possibile interpretare la traslazione dell’interesse filosofico dalla paura reciproca alla paura politica, ravvisabile per esempio in Montesquieu e nel giacobinismo, come l’inizio di un’incrinatura nella concezione monolitica dello Stato, che inizia a differenziarsi qualitativamente (diverse forme di Stato con diversi contenuti etici) e, a partire dalla filosofia politica ottocentesca, a calarsi nella realtà conflittuale dei rapporti di potere.133 Purtuttavia, questo passaggio non è indolore. Come sottolinea in altro modo anche Corey Robin134, la paura politica, dopo Hobbes, tende a oggettivizzarsi: nel Leviatano questo sentimento nei confronti del potere costituisce l’esito di una ri-definizione dell’oggetto della paura – la violenza dell’altro, prima, il potere del sovrano, poi – e, dunque, si caratterizza, in un certo senso, come passione costruita – e sempre presente – nella relazione tra uomini e sovrano. Negli autori successivi, al contrario, la paura politica tende a divenire il prodotto di un tipo di governo o di un modo di governare. La paura 132 Ibidem, p. 8. Cfr. anche D. Melossi, op. cit. a nota 66, p. 45. 134 Corey Robin attribuisce a Hobbes l’intuizione fondamentale circa la natura costruita della paura del sovrano, sostenendo che «poiché la paura è un’emozione duttile, modellata e rimodellata dall’istruzione morale e dall’ideologia, è ampio il potere del sovrano di definire gli oggetti» (C. Robin, op. cit. a nota 89, p. 47). 133 216 Capitolo 4 si spoglia della sua pars costruens e si riduce a sentimento individuale e collettivo prodotto dal potere dispotico. In questo modo si perde memoria non solo della trasformazione di questa emozione da reciproca a politica ma anche del fatto che essa, in ogni caso, ha sempre come oggetto la medesima violenza – diffusa nello stato di natura, monopolizzata e resa legittima nello stato civile. Ci si dimentica, detto in altre parole, che, come osserva Jacques Derrida nella sua lettura di Walter Benjamin, «il concetto di violenza appartiene all’ordine simbolico del diritto, della politica e della morale – di tutte le forme di autorità o di autorizzazione, di pretesa all’autorità almeno»135. È curioso notare come nella tarda modernità, in un periodo in cui si manifesta un senso diffuso di crisi che intacca la sovranità statuale, riaffiori nuovamente l’interesse filosofico-politico riguardo alla violenza fondatrice di ogni ordine istituzionale. Paura e dispotismo L’atteggiamento apertamente critico nei confronti dell’autore del Leviatano costituisce un tratto caratteristico del pensiero illuministico del XVIII secolo. Per citare solo alcuni tra i più celebri pensatori dell’epoca, oltre a Spinoza, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) denunciò “l’orribile sistema” e l’ “assurda dottrina” dell’ “atroce Hobbes”, Denis Diderot (1713-1784) s’oppose al ragionare violento, proponendosi di superarlo, Voltaire (16941778) indicò come doveroso per chi studia la morale iniziare a rifiutare nel proprio cuore il libro del “profondo e bizzarro filosofo”, il sottotitolo della seconda sezione di Teoria e Pratica di Immanuel Kant (1724-1804) recita “contro Hobbes”. 136 Anche Montesquieu (1689-1755) s’inserisce in questa tradizione: già a partire dall’opera Devoirs de l’Homme e, successivamente nell’Esprit des Lois, sviluppa una concezione della giustizia opposta alle tesi di Hobbes, a tal punto da affermarsi come l’anti-Hobbes137. Proprio in questa opposizione, egli instaura un “dialogo”, molto serrato, con il filosofo inglese sulla natura umana, sulla società civile e sulla fondazione del diritto e della libertà, che talvolta rivela anche alcuni tratti comuni, come nel caso della sua “fenomenologia della paura”. 135 J. Derrida, op. cit. a nota 85, p. 96. S. Goyard-Fabre, Montesquieu adversaire de Hobbes, Lettres Modernes, Paris, 1980, p. 4. 137 Ibidem. 136 La paura della criminalità al centro della modernità 217 Montesquieu, a differenza di altri pensatori illuministi, era fortemente interessato al problema delle passioni. Nella celebre tripartizione delle nature dei governi – monarchico, repubblicano, dispotico – lega ciascuna forma di governo a un principio vitale e individua proprio la paura, la crainte, come principio base del governo dispotico. La severità delle pene si adatta di più al governo dispotico, il quale hailn terrore come principio, che non alla moderazione ed alla repubblica, cui l’onore e la virtù fanno da molla. Negli Stati moderati, l’amor di patria, la vergogna e il timore del biasimo costituiscono dei freni sufficienti ad arrestare molti delitti. Il maggio castigo di una cattiva azione sarà l’esserne convinto. Pertanto le leggi civili vi potranno correggere più agevolmente e non avranno bisogno di ricorrere troppo alla forza.138 Il principio che è alla base della repubblica è la “virtù”, cioè l'amore della patria e dell'uguaglianza; il principio della monarchia è l'onore; il principio del dispotismo, il terrore (crainte). La repubblica è la forma di governo in cui il popolo è al tempo stesso monarca e suddito; il popolo fa le leggi e elegge i magistrati, detenendo sia la sovranità legislativa sia quella esecutiva. Al polo opposto della repubblica vi è il dispotismo, nel quale una singola persona accentra in sé tutti i poteri e di conseguenza lede la libertà dei cittadini. Montesquieu fa trasparire una profonda avversione per ogni forma di dispotismo: esso incarna il rovescio o l’ombra di tutto ciò che dovrebbe essere una società illuminata. Applicando alla sfera politica – in cui dovrebbe valere l’uguaglianza tra i cittadini – quei rapporti di ineguaglianza che caratterizzano la sfera domestica costituisce una forma di potere degenerato. Crainte, vertu e honneur costituiscono gli schemi di funzionamento degli Stati, principi politici fondati non più sul numero o la quantità di coloro che comandano (uno, pochi, molti, sia nella forma genuina che in quella corrotta di governo) e neppure sulla loro qualità, quanto piuttosto sulle modalità di esercizio del potere. In ciascun regime gioca sempre un’unica passione che – in quanto hegemonikon del corpo politico, cuore che promuove la circolazione sanguigna del potere – stabilisce le regole che presiedono al rapporto reciproco tra gli individui e i ceti.139 Così, il gouvernement despotique si differenzia dal gouvernement monarchique unicamente per le modalità di esercizio del potere, e non già in base alla titolarità dello stesso. 138 Montesquieu, Esprit des Lois (trad. it. Lo spirito delle leggi, Vol. I, Libro VI, Capo IX, Utet, 1996, p. 168). 139 R. Bodei, op. cit. a nota 27, p. 381. 218 Capitolo 4 A ben vedere, però, Montesquieu non confina la crainte all’interno del solo potere dispotico. Essa, al contrario, risulta un fenomeno di primaria importanza: ne Lo spirito delle leggi costituisce un termine polisenso140 (timore in genere, quello che dà vita ai fenomeni religiosi, la paura che discende dalla religione e dal potere repressivo) che interessa tutta la vita umana. Montesquieu, quindi, s’inscrive nel solco della riflessione hobbesiana sulla paura molto più di quanto non appaia. Purtuttavia, il mondo in cui visse Montesquieu, come sottolinea correttamente Robin141, non era afflitto dal turbamento del disordine, ma dall’assoluta stasi dell’ordine vigente: Luigi XIV aveva accentrato il potere nelle proprie mani: prese il controllo di tutti gli eserciti esistenti in Francia, trasformando milizie semi-private in soldati della corona; escluse l’aristocrazia dal consiglio reale, preferendo affidarsi a tre consiglieri di fiducia a corte e a un efficiente corpo di funzionari nelle campagne; gestì il potere con la superbia di un faraone, possedendo un grandissimo talento nel farsi obbedire. In questo contesto, il proposito principale del pensatore francese fu, dunque, principalmente quello di stabilire i confini del potere, più che di legittimarlo. A partire dalla considerazione che “il potere corrompe e il potere assoluto corrompe assolutamente”, Montesquieu intese porre dei limiti ai suoi eccessi: la tripartizione delle forme politiche, proposta da Montesquieu nell’Esprit des lois, indica chiaramente che egli guardava al dispotismo come ad un tipo fondamentale di governo142, che descrisse approfonditamente al fine di tracciare, nel lungo capitolo XXVIII, la costituzione fondamentale di un governo, all’interno della quale si rinviene il noto principio della separazione dei poteri e il principio dell’autonomia della giustizia come elemento necessario per qualsiasi Stato che ambisca a definirsi moderato o libero. A partire da questo presupposti brevemente accennati, ne Lo spirito delle leggi emerge una concezione della pena come intreccio tra regole procedurali a garanzia delle libertà dell’individuo e necessità del suo utilizzo come extrema ratio – retributiva e dissuasiva – di cui il giudice dispone. 143 In Monte- 140 Secondo quanto suggerisce Corrado Rosso, “crainte” andrebbe tradotta caso per caso con terrore, paura, timore. C. Rosso, Montesquieu moralista. Dalle leggi al «bonheur», Editrice Libreria Goliardica, Pisa, 1965, p. 91-92, nota 1. 141 C. Robin, op. cit. a nota 89, p. 55. 142 D. Felice, Per una scienza universale dei sistemi politico-sociali. Dispotismo, autonomia della giustizia e carattere delle nazioni nell’Esprit des lois di Montesquieu, Olschki, Firenze, 2005. 143 Cfr. D. Felice, “Autonomia della giustizia e filosofia della pena nell’Esprit des lois”, in D. Felice (a cura di), Libertà, necessità e storia. Percorsi nell’«Esprit des lois» di Montesquieu, Bibliopolis, Napoli, 2003, pp. 75-136. La paura della criminalità al centro della modernità 219 squieu la discussione sulla pena assume centralità rispetto allo scopo di impedire tecnicamente le condizioni dell’esercizio arbitrario del potere di punire, tratto caratteristico del governo dispotico.144 All’interno di queste coordinate teoriche, il filosofo francese ridimensiona l’importanza della crainte e si lancia in una «rivisitazione della paura hobbesiana che avrebbe condotto a una revisione così profonda e completa di quell’emozione, da plasmare la percezione intellettuale nei secoli a venire»145. Vediamo brevemente in che modo avviene questo ridimensionamento. Montesquieu riprende il concetto aristotelico dell’uomo animale sociale per natura. Hobbes – sostiene il filosofo francese – si è sbagliato e doppiamente. Da una parte, il desiderio degli uomini di soggiogarsi gli uni agli altri non è ragionevole. Gli uomini sono pacifici per natura e se è vero che, a volte, si fanno la guerra e trionfa la forza, non bisogna interpretare questi fatti come una tendenza fondamentale del loro essere.146 Montesquieu, in tal modo, non nega che, dal punto di vista fenomenico, esistano guerre e sopraffazioni, ma, prendendo le distanze da Hobbes, ritiene che tali eventi siano contingenti e non ascrivibili alla natura umana. Dall’altra parte, l’idea di dominio in Hobbes è sommaria, facendo leva su uno psichismo elementare. L’uomo talvolta tende ad affermare il suo dominio e la storia insegna di come ciò sia accaduto a danno di interi popoli. Ma non si tratta di atteggiamenti primitivi che esprimono una natura originaria. Al contrario l’idea di dominio, complessa e 144 Cfr. A. Ceccarelli, “Review of D. Felice (a cura di) Libertà, necessità e storia. Percorsi nell’«Esprit des lois» di Montesquieu”, Cromohs, 9, 2004, pp. 1-7 (disponibile anche su internet: http://www.cromohs.unifi.it/9_2004/ceccarelli_recefelix.html) 145 C. Robin, op. cit. a nota 89, p. 56. Si veda, inoltre, l’ampia opera collettiva, in due tomi, intitolata Montesquieu e i suoi interpreti, esito del lavoro di documentazione della vasta diffusione e penetrazione delle idee e teorie montesquieuiane compiuto da trentaquattro studiosi – coordinati da Domenico Felice, ideatore e curatore del progetto – in occasione del 250° anniversario della morte del filosofo francese (D. Felice (a cura di), Montesquieu e i suoi interpreti, 2 tt., Pisa, ETS, 2005). In particolare, segnaliamo il saggio curato da Thomas Casadei (T. Casadei, “Il senso del ‘limite’: Montesquieu nella riflessione di Hannah Arendt”, in D. Felice (a cura di), Montesquieu e i suoi interpreti, 2 tt., Pisa, ETS, 2005, pp. 805838) e il suo precedente lavoro (T. Casadei, “Dal dispotismo al totalitarismo: Hannah Arendt”, in D. Felice (a cura di), Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico, pp. 625-672) in cui si rileva la presenza del pensiero di Montesquieu nella riflessione di Hannah Arendt principalmente su tre temi: «la messa a punto, da parte della Arendt, delle nozioni di potere e legge e, seppure indirettamente, l’emergere della sua concezione del diritto; l’esplicito riconoscimento del nesso tra passioni e scienza politica, con particolare attenzione a quelle caratterizzanti le forme ‘demoniache’ del potere (presupposto, questo, sul quale si può far convergere la disamina arendtiana del totalitarismo in correlazione con quella montesquieuiana del dispotismo); la critica di una visione monistica del popolo, nella sua dimensione di massa informe e tendenzialmente passiva, cui fa da contrappunto un’articolata idea della libertà» (Ibidem, pp. 807-808). 146 S. Goyard-Fabre, op. cit. a nota 136, p. 12 220 Capitolo 4 composita, non può che manifestarsi tardivamente nello sviluppo della psicologia umana. Ed è pere questo che l’uomo non è in modo naturale e primordiale nemico dell’uomo. 147 Dunque, nonostante Hobbes e Montesquieu siano entrambi moderni, in quanto desiderosi di conoscere la natura dell’uomo per porla a fondamento di una teoria politica, la visione antropologica che esprimono è molto diversa. Montesquieu rigetta l’homo homini lupus, sostenendo che Hobbes vorrebbe che gli uomini facessero ciò che neppure i leoni fanno a loro stessi, e arriva a concepire diversamente anche la sua sfera affettiva. Infatti, l’uomo è timoroso perché sente la propria fragilità di esistenza e non perché l’altro, di fronte a lui, rappresenta una minaccia per la sua sopravvivenza, e i motivi e le passioni che portano gli uomini alla guerra nascono tutti all’interno della società, in modo particolare se questa è malsana e corrotta.148 Montesquieu nega il presupposto fondamentale della teoria filosofico-politica hobbesiana, spogliando la “paura reciproca” del suo ruolo di traghettare l’uomo dallo stato di natura allo stato civile. In tal modo, anche la concezione della legge risulta rovesciata. In Hobbes, la forza della legge esprime il potere (GoyardFabre parla di toute-puissance149) del sovrano, che non è altro che la somma dei diritti naturali individuali che il popolo, attraverso il contratto sociale, gli ha delegato; in Montesquieu le leggi positive non hanno più una unità formale e astratta, in quanto esprimono politicamente ed eticamente la singolarità concreta di una nazione; «la legislazione, nella sfera del politico, è l’elemento pratico reale al quale […] è riconnessa una vita libera». 150 Le leggi non sono più determinate dall’esercizio del potere sovrano qualitativamente indeterminato, ma sono proprie solo di alcuni tipi di potere, quello monarchico e repubblicano, mentre il potere dispotico è governato dall’arbitrio del sovrano; così anche la libertà non esiste sotto tutti i regimi: avendo bisogno di essere riconosciuta da leggi civili essa esiste solamente all’interno di uno Stato moderato. Nell’ottica di Montesquieu, dunque, il dispotismo, ma anche l’assolutismo del Leviatano, costituisce una minaccia mortale per le libertà e, politicamente, per il liberalismo. La libertà non è più, come in Hobbes, un diritto naturale individuale che precede lo Stato e che ciascuno, per paura della violenza diffusa, limita nella misura in cui lo ritiene necessario alla pace e alla propria difesa, accontentandosi di avere tanta 147 Ibidem, p. 13. Ibidem, p. 13 Ibidem, p. 37 150 Ibidem. 148 149 La paura della criminalità al centro della modernità 221 libertà nei confronti degli altri quanta se ne concede agli altri nei confronti di se stessi, bensì una condizione che si determina nella relazione tra cittadini e determinate forme di Stato. La paura, privata della sua funzione fondativa dell’ordine statuale (di ogni ordine), continua a operare in Montesquieu come contrappunto della libertà: una libertà non più concepita come naturale, che necessita di essere ridotta per consentire la pace sociale e la sicurezza (funzione positiva), bensì politica, che deriva dal tipo di rapporto esistente tra cittadini e Stato e che, dunque, può essere compressa in presenza di regimi dispotici. In tal modo, la paura diventa il principale strumento di legittimazione del potere dispotico che, per preservarsi, comprime le libertà incutendo terrore. In tal modo, la crainte perde la sua pars costruens dell’ordine sociale, e rileva solo nella sua funzione negativa di riduzione delle libertà. In sede di conclusioni di questa breve disamina della concezione della paura di Montesquieu, vale la pena accennare ancor più brevemente al suo sviluppo paradossale nel giacobinismo. Come afferma Bodei151, i giacobini, pur professando una sincera ammirazione e quasi un culto per il filosofo francese, si allontanano nettamente dalle sue posizioni, mescolandole in forme inedite. In particolare – afferma Bodei – si trasforma il ruolo della paura e della speranza: sotto la guida della ragione esse vengono ora utilizzate dai giacobini come strumento di emancipazione di tutti gli uomini del pianeta: il Terrore deve essere unidirezionale, promanare dal basso e irradiarsi verso l’alto, perché, come sosteneva Saint-Juste «occorre far paura a coloro che governano. Non bisogna mai farne al popolo». 152 Ma lo stravolgimento è ancor più profondo, investendo direttamente i rapporti tra paura e libertà: poiché i privilegiati non sono disposti a lasciarsi convincere da argomentazioni razionali e l’egoismo e l’indifferenza per il bene comune hanno messo radici nell’animo degli individui, il Terrore diventa indispensabile per rafforzare la libertà, l’uguaglianza e la fraternità.153 Una volta entrata, con Hobbes, nel pensiero politico come passione fondamentale dello Stato moderno, la paura difficilmente riesce a confinarsi in una sola forma di governo: semmai, relazionandosi a diversi valori morali e a nuove filosofie politiche, si riempie di nuovi significati che si stratificano sui vecchi, senza per questo sostituirsi a essi. Così, nella concezione del Ter- 151 R. Bodei, op. cit. a nota 27, pp. 376-443. La citazione di Saint-Juste è contenuta in Ibidem, p. 399. 153 Ibidem, p. 404. 152 222 Capitolo 4 rore da parte del giacobinismo si può rinvenire una innovativa tematizzazione della paura – ora concepita come condizione necessaria per affermare gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità – che capovolge la direzione della relazione tra terrore e potere dispotico individuata da Montesquieu, anticipando in tal modo le riflessioni di Guglielmo Ferrero. Inoltre, essa si deposita sul tema hobbesiano di “paura e ordine”, illuminandolo di una nuova prospettiva che rappresenterà un tratto basilare della politica moderna: quella dell’emancipazione attraverso l’affermazione degli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità. La paura nel potere Guglielmo Ferrero (1871-1943) è, probabilmente, lo studioso che più di ogni altro ha sviluppato l’eredità del pensiero hobbesiano su paura e potere154. Questo tema è presente fin dall’inizio della sua attività di ricerca e costituisce il caso più evidente di una tendenziale riscoperta del pensiero hobbesiano nel corso dell’ultimo secolo. Il punto di partenza della sua visione antropologico-politica è la consapevolezza di dover morire, propria dell’uomo, che non deriva da «l’astratto numero di possibilità di morire», quanto da «l’avanzante debolezza dei suoi organi e sensazioni fisiche»155. In questa prima versione della paura, Ferrero si mostra molto vicino alle teorie che individuano la paura come una mera sensazione organica dipendente dalla forza fisica che l’uomo sente di possedere. Col maturare della sua rilfessione, tuttavia, questa emozione acquista una varietà di dimensioni, finendo per assumere una funzione essenziale anche nella sua teoria politica: «per esorcizzare le sue paure esistenziali, l’uomo si dà un ordine sociale affidandosi al Potere; ma questo, se non rispetta i principi che lo legittimano, anziché eliminare la paura, la rafforza e la moltiplica legandola, in un “cerchio infernale”, all’uso della forza»156. 154 Per una comparazione delle tesi di Hobbes e di Ferrero si veda V. Mura, “Il potere della paura, la paura del potere. Le tesi di Hobbes e di Ferrero”, in D. Pasini (a cura di), La paura e la città, vol. II, pp. 103-122. 155 G. Ferrero, “The Fear of Death”, in Popular Science Monthly, 1897, pp. 236-241, cit. in G. Sorgi, Potere tra paura e legittimità. Saggio su Guglielmo Ferrero, Giuffrè Editore, Milano, 1983, p. 68. Buona parte delle riflessioni sul pensiero di Guglielmo Ferrero sono tratte o originate dalla lettura del saggio di Giuseppe Sorgi. 156 G. Sorgi, Potere tra paura e legittimità. Saggio su Guglielmo Ferrero, Giuffrè Editore, Milano, 1983, p. 67. La paura della criminalità al centro della modernità 223 È l’esperienza della guerra a far evolvere il concetto di paura in Ferrero: la guerra appare come un disastro colossale per l’universo intero con crollo di imperi e monarchie e il sorgere di fragili democrazie e di un’umanità fondata nuovamente sul sospetto e sulla paura. La guerra – secondo Ferrero – genera rivoluzioni di carattere distruttivo. Rivoluzione – argomenta Ferrero – è una parola a doppio senso che da un secolo e mezzo maschera uno dei più tragici equivoci che abbiamo potuto traviare gli uomini. Per rivoluzione noi intendiamo talvolta un orientamento nuovo dello spirito umano, una porta aperta sull’avvenire. È in questo senso che noi parliamo del cristianesimo come di una grande rivoluzione dell’umanità, poiché ha introdotto il principio dell’uguaglianza. […] Ma intendiamo anche per rivoluzione il crollo o il rovesciamento di una vecchia legalità. La sovversione totale o parziale delle regole stabilite. […] Vi sono dunque due specie di rivoluzioni dalla natura molto differente: la rivoluzione costruttiva e la rivoluzione distruttiva. La prima è sempre lenta, può svilupparsi attraverso dei secoli. La seconda è sempre brusca e rapida. Un governo può essere rovesciato in poche settimane, anzi in pochi giorni […] che provochi la caduta di un governo buono o di uno cattivo una rivoluzione distruttiva porta sempre la paura al suo seguito. È l’inevitabile accompagnamento di ogni rottura della legalità. Per discutibile che essa possa essere, una legalità è garanzia di stabilità. Quando essa crolla, lo spavento s’impadronisce degli spiriti. La Bibbia ha riconosciuto questa profonda verità allorchè dice che la terra e il cielo vacillano, quando la legge cade. Ecco dunque sorgere un legame di necessità tra disordine giuridicopolitico e paura: le rivoluzioni che hanno distrutto una legalità hanno sempre avuto un effetto immancabile: tutte hanno provocato un grande accesso di paura. È una legge d’una precisione quasi astronomica: quando in un corpo sociale la legalità è distrutta, anche se la distruzione è giusitificata dai vizi e dalle debolezze della legalità, la paura s’impadronisce di tutti gli spiriti. I primi ad aver paura sono i distruttori stessi; il panico comincia e si diffonde da loro. L’intuizione sulla paura che s’impadronisce di chi governa viene sviluppata da Ferrero all’interno di una visione antropologica fondata sulla paura non più semplicemente organica, bensì esistenziale. Egli scopre la paura non più come uno tra i tanti sentimenti dell’uomo, ma come suo elemento essenziale, e dichiara la sua coessenzialità con la stessa natura dell’uomo e con lo svolgersi della sua vita e della civiltà.157 157 G. Ferrero, Potere, seconda ed., Edizioni di Comunità, Milano, 1959, p. 76: «L’uomo è dunque la più paurosa delle creature, che trascorre la vita in mezzo a ogni sorta di paure». 224 Capitolo 4 L’uomo è il solo tra gli esseri viventi che abbia l’idea, l’ossessione, il terrore della morte. L’uomo è ossessionato dalla consapevolezza che dovrà morire e che potrà morire in ogni momento e questo comporta uno stato continuo di agitazione interna che gi fa vedere dappertutto pericoli di morte. La paura, dunque, non è più frutto di una sensazione organica, di deperimento dei propri organi, bensì esistenziale, culturale, derivante dal memento mori, dal sapere che prima o poi dovrà morire. La paura dell’uomo, proprio come in Hobbes, è anche relazionale: deriva dal fatto che l’uomo è il solo essere vivente che abbia la capacità di costruire strumenti per distruggere la stessa esistenza dell’uomo. L’esperienza della guerra consente a Ferrero di conferire attualità al concetto hobbesiano di “paura reciproca”: «più gli uomini si armano per essere sicuri e più hanno paura, perché diventano – gruppi o individui – l’uno per l’altro un pericolo sempre maggiore»158. In un altro scritto l’autore italiano sviluppa questo concetto in tutte le sue derivazioni: fra gli esseri viventi l’uomo è il più pauroso e il più terribile ad un tempo; trema davanti a se stesso e ai pericoli immaginari creati dalla sua mente, inventa e perfeziona i mezzi per far paura, per creare, regolare e manovrare la fisica della forza. Ma proprio perché ha paura e sa far paura, crede facilmente di potersi mettere al riparo, facendo paura. E più ha paura, più ne vuol provocare, sicuro che niente resiste alla fisica della forza.159 In tale sistema di paure – in parte naturali, in parte create dall’uomo stesso, vere o fittizie che siano – è necessariamente dalla “paura reciproca”, l’unica su cui l’uomo sente di poter intervenire per limitarla, che nasce la spinta a uscire da una situazione di disordine e anarchia e a creare uno strumento che permetta di rifugiarsi sotto la protezione dell’ordine sociale: il Potere. Nella visione di Ferrero il superamento della situazione di paura nei rapporti individuali (anarchia) e fra gruppi (guerra) avviene attraverso un “processo di autolimitazione” che fonda il Potere: «ognuno rinuncia a terrorizzare i più deboli per temere meno i più forti». Il Potere, così, è la manifestazione suprema della paura che l’uomo fa a se stesso. In un duplice senso: non solo il Potere hobbesianamente si fonda sul- 158 Ibidem, pp. 37-38 (cfr. anche G. Sorgi, op. cit. a nota 156, p. 77). G. Ferrero, Avventura: Bonparte in Italia, 1796-1797, Corbaccio, Milano, 1996, pp. 318-9, cit. in G. Sorgi, op. cit. a nota 156, p. 77. 159 La paura della criminalità al centro della modernità 225 la paura reciproca degli uomini che diventa paura comune verso il Potere, ma lo stesso Potere prova paura. L’analisi ferreriana, dunque, giunge a considerare questa emozione in modo bidirezionale, dei governati verso i governanti e dei governanti verso i governati. A partire da questa intuizione il pensiero di Ferrero si dirige più sulla paura di chi governa che sulla paura di chi è governato. D’altra parte, l’epoca della nascita dei totalitarismi incise a tal punto sulla sua vita intellettuale e familiare – la sua attività politica e la sua produzione intellettuale contro la dittatura lo resero inviso al nuovo regime che lo costrinse a rimanere sotto sorveglianza della polizia nella propria abitazione – da orientare il suo interesse non più tanto sui processi fondativi del potere (la “paura reciproca” e il “processo di autolimitazione”), quanto sulle istituzioni e sui meccanismi di funzionamento del potere, in cui questo sentimento ancora una volta riveste un ruolo fondamentale. L’analisi ferreriana del potere si concentra, dunque, sul tema della paura nel potere più che sulla paura del potere e, dunque, sulla dinamica del potere più che sulla sua genesi e legittimazione. Su questa linea Ferrero sviluppa un’analisi originale, indicando l’essenza del suo agire: a) nella paura per le minacce e i pericoli che gli possono derivare dall’esterno, da ribellioni e complotti, dalla reazione degli oppressi; b) nella paura che si sviluppa all’interno del potere stesso, nella coscienza di chi agisce. Il Potere – sostiene Ferrero – vive nel timore permanente dei suoi sudditi e della coercizione che deve esercitare su di loro per renderli obbedienti. La coercizione, infatti, può ottenere l’obbedienza, ma risulta incerta negli esiti, rischiando di portare a rivolte. «Il Potere [dunque] vive in perpetuo terrore»160, rischiando di attivare una dinamica – evidente nei processi di costruzione dei totalitarismi dell’epoca – che Ferrero indica come “cerchio infernale” tra uso della forza e paura: «più il potere ha paura dei sudditi più ricorre a strumenti di repressione, e più repressivo è, più cade nella paura»161. La paura, inoltre, non nasce solo dal rapporto esterno tra governanti e governati, ma scaturisce dall’interno del potere come «paura sacra della regola violata»162. È una paura che prende il sovrano nel momento stesso in cui ar- 160 G. Ferrero, op. cit. a nota 157, pp. 41-43 (cfr. anche G. Sorgi, op. cit. a nota 156, p. 86). Ibidem, p. 112 (cfr. anche G. Sorgi, op. cit. a nota 156, p. 86). 162 Ibidem, p. 33. 161 226 Capitolo 4 riva al potere «perché l’ha conquistato violando un principio di legittimità».163 Questi spunti di Ferrero sulla “paura sacra” di chi governa e, più in generale, sulla “paura nel potere” rivestono una forte attualità, richiamano alla memoria le riflessioni di autori a lui contemporanei o quasi, come Carl Schmitt (1888-1985) e Walter Benjamin (1892-1940), e più recenti, come Jacques Derrida, Giorgio Agamben. Il sovrano – sostiene Schmitt – è chi decide sullo stato di eccezione. È, nello stesso tempo, fuori e dentro l’ordinamento giuridico, in quanto è colui al quale l’ordinamento giuridico riconosce il potere di proclamare lo stato di eccezione e di sospendere la validità dell’ordinamento: egli sta al di fuori dell’ordinamento giuridico e, tuttavia, appartiene ad esso, perché spetta a lui decidere se la costituzione possa essere sospesa164. In questo senso «la sovranità segna il limite (nel duplice senso di fine e di principio) dell’ordinamento giuridico»165. Schmitt riconosce l’essenza della sovranità statale nel monopolio della decisione, e non della sanzione: «non esiste nessuna norma che possa applicarsi ad un caos. Prima deve essere stabilito l’ordine: solo allora ha un senso l’ordinamento giuridico. Bisogna creare una situazione normale, e sovrano è colui che decide in modo definitivo se questo stato di normalità regna davvero. […] Egli ha il monopolio della decisione ultima. In ciò sta l’essenza della sovranità statale»166. Il sovrano decide lo stato di normalità su cui poggiare l’ordinamento giuridico, crea la situazione di cui il diritto ha bisogno per la propria vigenza 167. E lo stato d’eccezione di-mostra nel modo più chiaro il fatto che l’autorità «non ha bisogno del diritto per creare diritto»168. Benjamin nella Critica presenta il rapporto tra potere costituente e potere costituito come quello tra violenza che pone il diritto e violenza che conserva il diritto: ogni violenza è, come mezzo, potere che pone o che conserva il diritt. Se non pretende a nessuno di questi due attributi, rinuncia da sé ad ogni validità. Ma ne consegue 163 Si considerino, in questa direzione, le riflessioni di Ferrero sull’Italia nel periodo 1922-26 (Ibidem, p. 55). 164 C. Schmitt, Politische Theologie, München-Leipzig, 1922 (trad. it. Le categorie del politico, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 3); G. Agamben, op. cit. a nota 101, p. 20. 165 G. Agamben, op. cit. a nota 101, p. 20. 166 C. Schmitt, op. cit. a nota 164, pp. 39-40. 167 G. Agamben, op. cit. a nota 101, p. 21. 168 C. Schmitt, op. cit. a nota 164, pp. 39-41. La paura della criminalità al centro della modernità 227 che ogni violenza come mezzo partecipa, anche nel caso più favorevole, alla problematicità del diritto in generale.169 Derrida sviluppa questi concetti con esiti originali. Considerando la difficoltà di distinguere tra la forza di legge di un potere legittimo e la presunta violenza originaria che ha instaurato quella autorità e che non poteva avvalersi, dunque, di alcuna legittimità precedente,170 egli arriva a riflettere sul “fondamento mistico” dell’autorità e a constatare che «l’origine dell’autorità, la fondazione o il fondamento, la posizione della legge, per definizione, in definitiva possono basarsi solo su se stesse, esse sono a loro volta una violenza senza fondamento»171. Non esiste una radicale eterogeneità tra i due tipi di violenza individuati da Benjamin, in quanto la violenza detta fondatrice è a volte “rappresentata” e necessariamente ripetuta dalla violenza conservatrice.172 Ciò che Benjamin non sottolinea – sempre secondo Derrida – è, dunque, il paradosso dell’iterabilità. «Questa fa sì che l’origine debba originariamente ripetersi e alterarsi per valere come origine, cioè per conservarsi»173. Da questa considerazione il filosofo algerino sviluppa il concetto di polizia come “forza di legge”, nella cui autorità è soppressa o superata la divisione tra violenza che pone e violenza che conserva la legge. 174 Il riconoscimento del fondamento dell’autorità come violenza senza fondamento porta a considerare la paura dello Stato nei confronti della violenza fondatrice, «capace di giustificare, di legittimare […] o di trasformare delle relazioni di diritto […] e dunque di presentarsi come avente diritto al diritto […]»175 Tutte le situazioni rivoluzionarie, tutti i discorsi rivoluzionari di destra e di sinistra […] giustificano il ricorso alla violenza adducendo l’instaurazione in corso o a venire di un nuovo diritto: di un nuovo Stato. Così come questo diritto a venire legittimerà di ritorno , retrospettivamente, la violenza che può urtare il sentimento di giustizia, il suo futuro anteriore la giustifica già. LA fondazione di tutti gli Stati avviene in una situazione che si può dunque chiamare rivoluzionaria. Essa inaugura un nuovo diritto, e lo fa sempre nella violenza. Sempre, cioè anche se non si sono avuti quei genocidi, e- 169 W. Benjamin, Zur Kritik der Gewalt, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1955 (trad. it. “Per la critica della violenza”, in Angelus Novus, Einaudi, Torino, 1962, p. 16). 170 J. Derrida, op. cit. a nota 85, p. 53. Lo stesso termine tedesco Gewalt sottolinea questa difficoltà di separare la violenza dall’autorità: esso indica la violenza, ma possa anche significare dominio o sovranità del potere legale (Ibidem, p. 95). 171 Ibidem, 63. 172 Ibidem, 88. 173 Ibidem, 113. 174 Ibidem, pp. 112-118. 175 Ibidem, p. 101. 228 Capitolo 4 spulsioni o deportazioni spettacolari cui si accompagna tanto spesso la fondazione degli Stati, grandi o piccoli, antichi o moderni, molto vicino o molto lontano.176 Se Derrida affronta il fondamento mistico della sovranità, Agemben parla di simmetria tra la struttura della sovranità e la struttura della sacratio: questa è a fondamento della relazione politica originaria, quella in cui, come ho già rilevato nel paragrafo su Hobbes, la “nuda vita”, la vita pre-politica in cui ciascuno può essere ucciso da chiunque altro, viene politicizzata dalla decisione sovrana. La prossimità tra la sfera della sovranità e quella del sacro, che è stata più volte osservata e variamente motivata, non è semplicemente il residuo secolarizzato dell’originario carattere religioso di ogni potere politico, né soltanto il tentativo di assicurare a questo il prestigio di una sanzione teologica; altrettanto poco essa è, però, la conseguenza di un carattere “sacro”, cioè, insieme augusto e maledetto, che inerirebbe inspiegabilmente alla vita come tale. Se la nostra ipotesi è corretta, la sacertà è, piuttosto, la forma originaria dell’implicazione della nuda vita nell’ordine giuridico-politico e il sintagma homo sacer nomina qualcosa come la relazione “politica” originaria, cioè la vita in quanto, nell’eslcusione inclusiva, fa da referente alla decisione sovrana.177 Ferrero non esplora il tema della “sacralità” della sovranità limitandosi a intuire il carattere sacro del fremito che prova chi esercita il potere sovrano; parla di potere illegittimo e osserva le dinamiche psicologiche innescate dalla paura della regola violata: essa provoca uno sconvolgimento dell’animo del detentore del potere illegittimo e gli oscura l’intelligenza, rivelandosi come la causa della paura che egli nutre e incute nei confronti dei sudditi. Sviluppando il tema ferreriano della «paura sacra» nelle direzioni suggerite da Derrida e Agamben, che riprendono il pensiero di Benjamin e di Schmitt, la paura che prova chi governa può essere meglio interpretata come un fremito del sovrano che regge e che, decidendo casi di eccezione ed esercitando la violenza, ha memoria dell’atto di decisione originario che ha posto l’ordine su cui si è fondato l’ordinamento giuridico e riscopre la violenza connessa a quell’atto di decisione. La paura sacra, dunque, non è tanto la paura di chi conquista un potere illegittimo attraverso la violazione di un ordine legittimo – come sostiene Ferrero –, ma può essere meglio definita come la paura di ogni sovrano legittimo che decidendo ha memoria della violenza fondatrice; non è dunque un 176 177 Ibidem, pp. 101-102. Ibidem, p. 94. La paura della criminalità al centro della modernità 229 paradosso, un vizio, del potere quando è illegittimo, bensì un tratto dell’autorità in quanto tale. Questo passaggio non emerge nel pensiero di Ferrero: egli considera la paura che viene dal Potere tutt’altro che desiderabile, tipica del governo rivoluzionario e violento e dunque qualcosa a cui porre rimedio. E il rimedio sta nella legittimità del potere, che assicura ordine e obbedienza con il consenso e che permette di interrompere quel “cerchio infernale” tra uso della forza e paura tipico del poteri illegittimi e che porta ad amplificare paura dei governati, paura dei governanti e violenza. Ferrero si ferma a queste considerazioni, lasciando sul campo alcuni interrogativi. Come può il Potere acquistare legittimità, vale a dire porsi all’interno di un ordinamento giuridico come autorità che si legittima attraverso il consenso, se prima non si impone? Può l’atto di imposizione essere disgiunto dalla violenza connessa alla fissazione di un ordine tra i tanti possibili sul quale costruire un ordinamento giuridico? All’interno dell’ordinamento giuridico il consenso può – e per le nostre sensibilità democratiche deve – costituire uno strumento di mantenimento dell’ordine, preferibile alla paura e alla violenza. Il consenso può anche costituire uno strumento dell’ordinamento giuridico per modificarsi: è il caso della possibilità di revisionare la Costituzione prevista nella stessa Costituzione. Purtuttavia non può essere uno strumento di legittimazione dell’ordinamento giuridico, lo strumento con cui si fissa un ordine, lo si impone come normale e lo si legittima in un ordinamento. L’atto di imposizione di un ordine è sempre simbolicamente connesso alla violenza e alla paura, che verranno svelate ogni volta che sarà necessario sospendere l’ordinamento giuridico per riaffermare la sovranità, appunto negli “stati di eccezione” descritti da Agamben178. 4.5 Paura della violenza e sistema penale moderno Paura e pena Nel precedente paragrafo ho osservato come la tematizzazione hobbesiana della paura della violenza a fondamento della sovranità statuale costituisca un paradigma fondamentale nella concezione dell’ordine moderno e co- 178 Cfr. G. Agamben, op. cit. a nota 101. 230 Capitolo 4 me le riflessioni del filosofo inglese siano centrali nel pensiero filosoficopolitico anche più recente. Aggiungo ora che questo paradigma, lungi dal rimanere inchiostro su carta, è entrato profondamente nelle mentalità e nelle sensibilità istituzionali, in particolare in quell’area fondamentale dell’ordine istituzionale che è la “penalità”179. È proprio a partire dal modello hobbesiano, infatti, che si sviluppa il rapporto tra paura e pena nei moderni sistemi giuridico-penali.180 Nella stessa dottrina di Hobbes, infatti, la pena viene posta in stretto rapporto con la paura, in quanto ad essa è attribuita la funzione di intimidazione generale mediante l’esempio. E non potrebbe essere diversamente: la pena è il principale strumento di coercizione nelle mani del potere per garantire ordine, e dunque sicurezza e pace. Così concepita, essa esprime la forza della legge, quella violenza monopolizzata dallo Stato-sovrano verso cui sono rivolte le paure degli individui. Dall’altra parte l’oggetto della paura, vale a dire la pena, deve essere prevedibile perché sia efficace nel disporre la volontà degli uomini all’obbedienza, e quindi la funzione penale, volta alla prevenzione generale, dev’essere posta entro chiari limiti legislativi (è un’anticipazione del principio di nullum crimen e nulla poena sine lege). Infine, Hobbes esclude le vendette private dal concetto di pena: questa cosiste esclusviamente in un male inflitto dalla pubblica autorità a colui che ha commesso od omesso qualcosa giudicato dalla stessa autorità una violazione di legge. Con queste riflessioni, che costituiscono un’embrionale dottrina penale, Hobbes anticipa le elaborazioni del massimo teorico della prevenzione generale e dello Stato di diritto nell’ambito del diritto penale, Paul Johann Anselm Feuerbach (1775-1833), il quale, nella sua aperta critica alla teoria hobbesiana dello Stato, sviluppa una concezione della pena che presenta molti punti di contatto con essa: nell’Anti-Hobbes egli afferma, infatti, che il 179 La “penalità” va intesa come «rete complessa in cui s’intrecciano istituzioni […], e varie forme di relazioni supportate da agenzie, ideologie e pratiche discorsive» (A. Ceretti, “Presentazione”, in D. Garland, Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale, Il Saggiatore, Milano, 1999, p. 11). 180 M.A. Cattaneo, “Paura e pena (Hobbes, Feuerbach e Kant)”, in D. Pasini (a cura di), La paura e la città, vol. II, 1984, pp. 89-102; M.A. Cattaneo, Anselm Feuerbach filosofo e giurista liberale,: Edizioni di comunita, Milano, 1970; M.A. Cattaneo, “Hobbes e la procedura penale”, in G. Sorgi, Thomas Hobbes e la fondazione della politica moderna, Giuffrè, Milano, 1999. Cfr. anche M. Ronco, Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 5-20. La paura della criminalità al centro della modernità 231 mezzo generalmente più sicuro per difendersi dalle offese è la minaccia di mali fisici, la quale, suscitando paura, agisce provocando una coazione psicologica181. Fra tutte le immaginabili misure di sicurezza dalle offese in genrale, nessuna è così generalmented efficace come la minaccia di mali fisici, con i quali l’azione offensiva viene condizionata. Essa agisce direttamente in modo contrario al fondamento ultimo dei desideri anti-giuridici ed elimina, causando la paura, il principio interno stesso da cui quelli provengono.182 In che misura – seguendo il filo del ragionamento di Feuerbach – la minaccia è in grado di eliminare i fondamenti dei desideri anti-giuridici? Non appena un male sensibile è posto come la condizione della possibile commissione di un atto anti-giuridico, allora, in base al principio dell’associazione delle idee, alla rappresentazione dell’oggetto dell’azione anti-giuridica deve essere unita nello stesso momento la rappresentazione del male che l’accompagna. La piima conseguenza della minaccia è dunque che l’animo viene distolto dall’oggetto dell’atto offensivo, che la sua attenzione viene rivolta a un’altra rappresentazione e così indebolita la vivacità della prima rappresentazione. Quest’ultima viene del tutto cancellata quando la rappresentazione del male, o per la sua ampiezza o per la sua vicinanza, si impone con particolare vivacità e forza. Ma la rappresentazione del male non agisce semplicemente come tale su altre rappresentazioni, bensì opera anche in modo diretto sulla facoltà di desiderare. […] Ciò presuppone, però, che il male minacciato sia così grande, che il timore di esso superi il desiderio di quell’atto, che la rappresentazione del male superi quella del bene da ottenere.183 La minaccia di mali finalizzata alla conservazione dei diritti è dunque “opportuna” e “giusta”; la “pena” è il male minacciato per distogliere gli offensori dal commettere offesa; lo scopo della minaccia della pena è l’intimidazione; il fondamento giuridico su cui poggia la minaccia è la difesa della libertà184. 181 Cfr. M. Ronco, op. cit. a nota 180, pp. 52-73. P.J.A. Feuerbach, Anti-Hobbes, Erfurt, 1798 (trad. it. Anti-Hobbes ovvero i limiti del potere supremo e il diritto coattivo dei cittadini contro il sovrano, Giuffrè, Milano, 1972, p. 108). 183 Ibidem, pp. 109-110. 184 Ibidem, pp. 111-112. Vale la pena sottolineare come in Feuerbach la stessa “inflizione” della pena sia orientata a finalità di prevenzione generale: il suo scopo non è direttamente l’intimidazione degli altri, né l’intimidazione del reo, né la difesa del delinquente; esso consiste nel rendere efficace la minaccia stessa: «la pena deve perciò essere eseguita, se la minaccia non deve diventare un suono vuoto e se non deve venire immeidtamante distrutto lo scopo che con essa ci si è prefissi» (Ibidem, p. 113). 182 232 Capitolo 4 Come in Hobbes, anche nell’Anti-Hobbes il diritto di punire viene risconosciuto in capo al sovrano, ma qui l’accento è posto sul carattere derivato di tale diritto: esso è il risultato della concessione del diritto di punire di ciascun individuo – legato al diritto di ciascuno di difendere i propri diritti –: «il diritto di punire è un mezzo naturale di difesa, che deve venire riconosciuto all’uomo come allo Stato, al cittadino come al sovrano, per la tutela dei diritti»185. In sintesi, la paura che incute il sovrano sugli individui costituisce, tanto in Hobbes quanto in Feuerbach, il meccanismo di funzionamento del potere punitivo. Nonostante nel corso dell’ultimo secolo si sia affermata una nuova razionalità penale, definita da Garland “modernismo penologico”, la quale ha ridimensionato, nell’ambito del governo del campo socio-penale, quella illuministica e il ruolo giocato dai principi liberali – quali il principio retributivo, ma anche l’idea stessa della prevenzione generale –, facendoli apparire arcaici e pre-moderni, 186 ritengo sia corretto sostenere che l’ideologia trattamentale non abbia sostituito quella classica, ma si sia semplicemente depositata su di essa. Questa considerazione è valida in particolare per l’Italia: la finalità rieducativa, nonostante sia stata inserita nel dettato costituzionale all’art. 27, ha faticato a tradursi in pratiche istituzionali. Più in generale, la permanenza del forte potere simbolico connesso alla funzione deterrente, intimidatoria o di coazione psicologica della pena si manifesta chiaramente nel riemergere, nell’attuale periodo storico di crisi del sistema penale e di declino dell’ideale riabilitativo, di modelli di giustizia prettamente retributivi, come il just desert (giusto merito), impostosi negli Stati Uniti come rimedio alla percezione di ingiustizia derivante dall’applicazione di un meccanismo sanzionatorio individualizzato. È come se le istituzioni penali, sotto il peso dei fallimenti a loro ascritti, delle accuse di scarsa funzionalità sociale e della sfiducia diffusa sui principi basilari della pena, riscoprissero come risorsa per la propria legittimazione quelle concezioni della pena che le hanno giustificate originariamente, anche se queste teorie, calate nella tarda modernità, assumono tratti peculiari. Si consideri, in 185 Ibidem, p. 116. In questo passaggio si manifesta la sostanziale differenza tra la concezione dello Stato come riduttore delle libertà e dei diritti individuali per garantire maggiore sicurezza e quella che, al contrario, gli attribuisce la funzione di protezione dei diritti e delle libertà individuali. 186 Cfr. A. Ceretti, op. cit. a nota 179, pp. 10-11. La paura della criminalità al centro della modernità 233 particolare, la centralità acquisita dalla funzione di neutralizzazione (incapacitation)187 negli ultimi decenni, che si sostanzia nell’impedire al delinquente di commettere reati, prolungando la detenzione quando i delitti previsti sono molti, e limitandola quando, invece, viene prevista una recidiva nulla o limitata. Non importa che questi tentativi di legittimazione abbiano effettivamente successo nel conservare le istituzioni: il fatto che politici, esperti e accademici si riferiscano nuovamente a quelle teorie costituisce, in ogni caso, un’evidenza di come le considerazioni di Hobbes e di Feuerbach si siano depositate nell’area della penalità moderna e cristallizzate nelle pratiche istituzionali e nelle rappresentazioni sociali. Questa asserzione viene rafforzata dall’importante lavoro di ricostruzione storica dei pensieri e delle teorizzazioni sociologiche e criminologiche intorno alla questione del controllo compiuta da Dario Melossi in Stato, controllo sociale, devianza. Lo studioso italiano individua due situazioni “idealtipiche” di relazione tra discorso pubblico e sistema della giustizia penale. Nella prima, il discorso pubblico che s’impone con successo è quello che definisce la società come colpita da uno stato di crisi e che richiede un ristabilimento dell’ordine e della coesione sociale. «In tale discorso è spesso la metafora dello Stato a far da protagonista: Leviatano come apportatore di ordine e unità o, più precisamente, di unificazione sociale (reductio ad unum) e gerarchia». 188 E poiché una delle caratteristiche centrali della sovranità è il potere di punire – in tal senso «la penalità gioca un ruolo essenziale nel tracciare i contorni e il potere della sovranità» – il compito che si tenderà ad assegnare al sistema di giustizia penale, in tale situazione, è quello di orientare la società verso un processo di unificazione, eliminando frammentazione e anarchia: quantitativamente, la produttività del sistema penale aumenta, mentre qualitativamente mutano le rappresentazioni del criminale, indicato come “nemico sociale”189. Nella seconda situazione, invece, il discorso pubblico è polarizzato sulla percezione dell’ordine sociale come soffocante e in- 187 D. Garland, The Culture of Control. Crime and Social Order in Late Modernity, Oxford University Press, Oxford, 2001 (trad. it. La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Milano, 2004, pp. 67-68); T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, Volume II, Giuffrè, Milano, pp. 382-384. 188 D. Melossi, op. cit. a nota 66, p. 5. 189 Ibidem, pp. 5-6. 234 Capitolo 4 giusto e sulla necessità di un cambiamento sociale: il sistema della giustizia penale sarà, probabilmente, il luogo in cui poter sperimentare innovazioni. Detto in altri termini, il ricorso a istanze punitive che ristabiliscano i confini della moralità e l’ordine sociale e che ricorrono all’intimidazione costituiscono un tratto costante della storia della penalità moderna, anche recente: sotto traccia nei periodi di benessere (welfare) e di progresso, in cui la tendenza è quella di umanizzare il sistema della giustizia penale, riemerge in modo palese nei momenti di crisi. Questa ricostruzione è compatibile anche con alcune considerazioni contenute nell’importante trattato di sociologia della pena – Pena e società moderna – scritto da Garland nel 1990. Il suo lavoro di sistematizzazione delle teorie sulla funzione della pena evidenzia, tra le altre cose, come nella giustizia penale moderna siano presenti due visioni contrastanti: da una parte il desiderio di punire, passionale e moralmente connotato, dall’altra l’interesse razionale, di carattere amministrativo e con finalità normalizzatrici, a gestire.190 La sua lettura originale delle opere di Michel Foucault (Sorvegliare e punire) e Max Weber (Economia e società) ha messo in risalto come la razionalizzazione e la burocratizzazione dell’apparato penale abbia rappresentato indubbiamente il momento più significativo della penalità negli ultimi duecento anni, che ha modificato il modo di concepire e impiegare la pena. La pena, in senso lato, si trasforma in un processo complesso, differenziato, che coinvolge numerosi apparati istituzionali, ciascuno dei quali latore di interessi e obiettivi distinti, che si basano spesso su supporti sociali differenti. Il risultato è quello di un campo penale sempre più frammentato, dotato di strutture e competenze burocratiche proprie, in modo tale che anche gli interventi non istituzionali (come la probation, l’assistenza sociale, la after-care, ecc.), nati come iniziative volontarie e benefiche, vengono progressivamente assorbiti e amministrati da strutture centralizzate.191 Il periodo in cui emergono le burocrazie professionali coincide con quello in cui i sentimenti punitivi vengono progressivamente emarginati dai discorsi ufficiali sulla criminalità, perché considerati vergognosi e incivili, e in cui nascono (a partire dal XIX secolo) una criminologia e una penologia scientifiche che hanno la funzione di «sostituire “la razionalità rispetto al valore”, tipica della morale penale tradizionale, con una nuova “razionalità rispetto 190 191 D. Garland, op. cit. a nota 76, p. 222. Ibidem, p. 223. La paura della criminalità al centro della modernità 235 allo scopo”, volto a utilizzare qualunque strumento tecnico per il controllo della criminalità»192. Al tempo stesso, però, riflettendo principalmente sulla teoria della pena di Durkheim (La divisione del lavoro sociale), Garland sottolinea come le forme razionalizzate non abbiano mai completamente monopolizzato il campo penale: l’emergenza delle forme burocratiche razionali non cancella la presenza di valori (non razionali) o di principi morali, ma ne nasconde solo l’operatività e ne limita gli scopi. L’agire razionale e strumentale è sempre un mezzo per il raggiungimento di un determinato fine, ossia un orientamento valoriale e un insieme di vincoli. I valori – e le scelte non razionali e gli atteggiamenti emotivi su cui essi poggiano – possono essere celati e rimossi dagli apparati burocratici, ma non scompaiono.193 Non mi soffermo sul considerare l’inadeguatezza delle espressioni che oppongono razionalità, da un lato, emozioni e valori, dall’altro. In questo momento, importa maggiormente sottolineare come lo stesso Garland dia prova della vigenza di quei principi e valori quando parla degli altri luoghi in cui le istanze morali ed emotive si esprimono – principalmente il rito dibattimentale. Ed è in questo punto del discorso che trova conferma la tesi sulla centralità della paura e dell’intimidazione nella cultura penale moderna: le corti, come gran parte dell’opinione pubblica e del mondo politico, continuano a trattare la questione della pena utilizzando espressioni di carattere morale, facendo esplicito riferimento all’importanza dei valori e veicolando messaggi emotivi. Non di rado, anche se non sempre, viene usato un linguaggio punitivo, che denuncia l’offesa, il bisogno di condanna e di risposta retributiva.194 Un’altra e più articolata conferma è rinvenibile nella constatazione (resa complessa nella sua opera successiva, La cultura del controllo) che il crollo dell’ideale riabilitativo e il riaffacciarsi di una giustizia moralmente espressiva abbiano mostrato una debolezza dell’ideologia trattamentale: i valori della compassione e del welfare non si sono radicati nella mentalità pubblica né nella politica penale, come dimostra il fatto che le pratiche istituzionali di osservazione, classificazione e normalizzazione, prima rubricate sotto “aiuto 192 Ibidem, p. 226. Ibidem, p. 230. 194 Ibidem, p. 233. 193 236 Capitolo 4 al delinquente” abbiano continuato a operare come parte essenziale dell’emergente “cultura del controllo”.195 «L’immagine della punizione e della condanna proietta quindi un’ombra molto lunga su tutto ciò che riguarda l’agire del sistema penale».196 E la paura che la sottende entra profondamente nelle pratiche e nei simboli della sfera penale. Paura e rito penale La costruzione del sistema di giustizia penale moderno – come ho già ricordato – va di pari passo alla formazione dello Stato-nazione, che si caratterizza principalmente come processo di accentramento: i principi tendono ad eliminare con ogni mezzo le autonomie e i centri di potere creatisi nei secoli precedenti a discapito del potere centrale. Il meccanismo adottato dal principe per raggiungere tale scopo consiste nel far leva sull’interesse collettivo dell’ordine e della sicurezza interna (oltre che esterna) come premessa al benessere comune. Polizia, termine che comincia ad essere utilizzato nell’ultima fase dell’iter di formazione dello Stato moderno per indicare le finalità generali perseguite dal principe di migliore e ordinato vivere della collettività, costituisce l’essenza stessa dello Stato assoluto. Successivamente, il termine polizia identifica non solo le finalità di ordine e tranquillità sociale, ma anche la stessa attività amministrativa interna dell’apparato statuale. A complemento del processo di accentramento amministrativo si assiste a un progressivo accentramento della funzione giurisdizionale: tra la fine del XVIII secolo e nel corso del XIX lo Stato-nazione progressivamente sottrae alle altre autorità secolari e spirituali la facoltà di giudicare e di infliggere pene, concentrandola nelle nuove istituzioni della giustizia penale. 197 Così, attraverso il monopolio delle attività amministrative e di regolazione della vita degli individui, da un lato, e l’accentramento delle funzioni giurisdizionali dall’altro, lo Stato-nazione scommette la propria credibilità e fonda la propria legittimità sulla capacità di garantire ordine sociale e sicurezza. Il giudizio penale assume in questo nuovo contesto socio-istituzionale una valenza simbolica diversa dal passato: non solo rito sacro e sacrificale 195 Ibidem, p. 227. Ibidem, p. 232. 197 Cfr. D. Garland, op. cit. a nota 187, pp. 97-104. 196 La paura della criminalità al centro della modernità 237 con la funzione di rappresentazione tragica degli eventi e di purificazione di chi assiste alla rappresentazione, ma soprattutto rito laico cui solo si riconosce la funzione di contenere la violenza e di restituire pace sociale. Alle forme di vendetta o di risoluzione dei confitti tra privati, non controllabili dal nuovo potere sovrano, si sostituiscono le istituzioni pubbliche, con il compito di vendicare e risolvere i conflitti tra privati. La vendetta da privata diventa pubblica, canalizzata nel giudizio, rito statuale per eccellenza. Il sogno della modernità è quello di passare nel setaccio razionale del diritto tutti i conflitti e tutta la violenza presenti nella società, e in questo modo garantire la tranquillità sociale; il giudizio penale, oltre a essere un insieme di pratiche e procedure per arrivare alla condanna del colpevole, è lo strumento simbolico-rituale attraverso cui si afferma questo sogno. Renè Girard ha rilevato come il rito sacrificale svolga una funzione catartica: permette di placare la violenza e di evitare l’esplosione dei conflitti; ma anche una funzione fondativa dell’identità sociale. «Se un uomo è attratto da qualche cosa, se fa un gesto per ridurre quella cosa nella sua sfera di possesso, subito un suo simile è indotto ad imitarlo. L’origine del conflitto è tutta qui: quando due mani ugualmente avide convergono verso lo stesso oggetto».198 Questo processo descritto da René Girard con il nome di “mimesi appropriativa”, rischia di portare alla deriva le società primitive, in quanto porta ad esiti capaci di sgretolare le fragili coesioni sociali. La rivalità che s’instaura per la conquista di ciò che è desiderabile non s’arresta più, neanche al venir meno dell’oggetto della contesa. Le persone che si fronteggiano finiscono per considerare solo il loro antagonismo. Si verifica, allora, quella che Girard chiama crisi d’indifferenziazione (o mimetica): la violenza si scatena tra gruppi di eguali senza motivo e in modo autoreferenziale. L’atto con cui è possibile interrompere il ciclo continuo di violenza insensata e che permette di fornire un’identità culturale ad un gruppo di individui è il sacrificio, un assassinio spontaneo reiterato ritualmente per evitare nuove crisi d’indifferenziazione, riproducendone la funzione pacificatrice. 199 L’assonanza tra lo stato di natura hobbesiano e la crisi d’indifferenziazione è evidente: gli uomini, spinti dal desiderio di ottenere ciò che loro serve per la conservazione o, a volte, per il semplice piacere, entrano in competizione/conflitto tra loro creando una situazione di violenza 198 R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, Parigi 1978 (trad. it., Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, Adelphi, Milano 1983, p. 23). 199 Cfr. A. Ceretti, “Dal sacrificio al giudizio: da Girard a Chapman”, in A. Francia (a cura di), Il caprio espiatorio, Franco Angeli, Milano, 1994, pp. 56-78. 238 Capitolo 4 diffusa. Per Girard, è la “violenza essenziale” il “mostro” di cui gli uomini hanno sempre cercato di liberarsi attraverso il rito sacrificale, durante il quale viene immolato un capro espiatorio affinché l’originaria e diffusa paura di tutti verso tutti venga momentaneamente placata. I riti, dunque, non sono delle tecniche con cui gli uomini cercano di mettersi in contatto con il sacro, bensì espedienti per sacrificare la paura originaria che ogni uomo ha del suo simile: una paura che deriva dal fatto che l’essere umano è sempre un potenziale portatore di morte per l’altro. Un ulteriore passaggio del pensiero di Girard risulta importante: la civiltà elimina la “violenza preventiva”, attuata attraverso il rito sacrificale, con la “violenza successiva”, cioè con la sanzione penale, non può estirpare la paura originaria che ogni uomo ha dei suoi simili; può solo contenerla, facendo in modo che essa non irrompa sulla scena sociale scatenando la guerra di tutti contro tutti.200 In tal modo, l’originale lettura di Girard sulla funzione del rito di placare la violenza diffusa e sull’ingabbiamento moderno di entrambi (rito e violenza) nella penalità, arricchisce il tema hobbesiano su paura e ordine di una prospettiva simbolica importante. Già gli studi di Durkheim sulla religione e sulla pena rivelano che la forza e la vitalità de sentimenti sociali sono salvaguardati dalla ripetizione dei rituali, i quali scandiscono la vita sociale quotidiana e forniscono un contesto ad hoc per l’espressione delle emozioni popolari. I rituali penali non sono altro che uno strumento per rappresentare e rinforzare la coscienza collettiva201. Per Girard, come per altri antropologi, il rito, anche quello penale, ha un effetto creativa rispetto al sentimento. I rituali, secondo questa tesi, non si limitano a esprimere emozioni, ma le producono, e ne organizzano il contenuto, essi sarebbero, insomma, una sorta di dimostrazione didattica attraverso la quale lo spettatore apprende cosa sentire, come reagire, quali sentimenti sono richiesti in una determinata situazione.202 I rituali penali si costruiscono intorno ai sentimenti che intendono ordinare: le aule giudiziarie sono strutturate in modo tale da rappresentare ed evocare emozioni come il rispetto della legge e l’odio per il criminale e che ser- 200 R. Girard, La violence et le sacré, Grasset, Parigi 1972 (trad. it. La violenza e il sacro, Adelphi, Milano, 1980). Per un’analisi del concetto di capro espiatorio in un’ottica multidisciplinare si veda A. Francia, Il capro espiatorio, Franco Angeli, Milano, 1994. 201 Per un’analisi del pensiero di Durkheim su questo punto si veda D. Garland, op. cit. a nota 76, p. 106 e seguenti. 202 Ibidem, p. 107. La paura della criminalità al centro della modernità 239 ve a scaricare elementi aggressivi.203 Le istanze punitive trovano un luogo per esprimersi nelle aule giudiziarie e il giudizio penale assume un ruolo simbolico centrale nel contenimento delle paure e nell’affermazione dell’ordine. In sintesi: Hobbes e la cultura penale moderna Di seguito sintetizzo per punti quanto detto finora. 1. A partire da Hobbes il tema di “paura e ordine” entra nel dibattito filosofico-politico e, più in generale, nella cultura moderna, soprattutto in quell’ambito definito come penalità. Infatti, la centralità della funzione statuale di contenimento della violenza diffusa e delle paure ad essa connesse, porta ad attribuire una rilevanza particolare, nell’ambito dell’organizzazione dello Stato moderno, alle istituzioni penali (polizie, tribunali, carcere). Queste, più di altre, rappresentano il tentativo moderno di “ingabbiare” la violenza – proprio nel significato weberiano di gestirla in modo razionale e burocratico – e su di esse sono riposte le aspettative di pace sociale. 2. Le istituzioni penali, dunque, si legittimano per la loro capacità di rassicurare e, nei vuoti di questa giustificazione – vale a dire nelle situazioni in cui sono ritenute incapaci di dare risposta alle esigenze di ordine –, trovano proprio nelle paure delle persone nuove risorse di giustificazione. Così la paura della violenza, non è solo un’emozione esperita individualmente e definita da contesti culturali, ma è anche un sentimento morale che, entrando nelle mentalità e nelle sensibilità moderne, sostiene una certa idea di ordine, entra nei modelli sanzionatori e motiva istanze punitive. 3. Lo Stato – e in particolare le istituzioni penali – presenta sempre, più o meno apertamente o intensamente, un “volto terribile”: attraverso la coercizione deve incutere paura. È ciò che Montesquieu e gli illuministi rigettavano della riflessione hobbesiana, ma che, proprio in tema di giustizia, hanno implicitamente riconosciuto confinandolo nella formula dell’extrema ratio e imbrigliandolo in regole procedurali a garanzia delle libertà. 4. La paura non rimane confinata nell’atteggiamento dei cittadini nei confronti del potere simbolico di punire: entra in circolazione nel campo penale, investendo lo stesso sovrano. Certo, parlare di sovrano in una democrazia rappresentativa a sovranità diffusa appare confinare la relazione tra paura e 203 Cfr. F. Alexander, H. Staub, The Criminal, the Judge and the Public, 1931 (trad. it., Il delinquente, il giudice e il pubblico. Un’analisi psicologica, Milano, 1978, p. 192). 240 Capitolo 4 potere in un’astrazione anacronistica. Al contrario, ritengo che la democratizzazione complichi il problema. Il cittadino di uno Stato democratico è “sovrano”, ma in un senso diverso dall’uomo-lupo hobbesiano – la cui sovranità, è bene ricordarlo, deriva dalla libertà di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua vita e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine –: egli partecipa alla sovranità statuale ed è, al tempo stesso, costruttore di una volontà comune e destinatario di quella stessa volontà. Se anche, nei fatti, la maggior parte dei cittadini non si senta così determinante nelle scelte, percependosi come un loro soggetto passivo, ciò non toglie che il processo di democratizzazione abbia portato alla definizione di uno statuto di cittadinanza in cui potenzialmente ciascuno si sente responsabile delle scelte che lo riguardano204. Il cittadino contemporaneo sperimenta, dunque, tutte le forme di paura descritte da Hobbes e da Ferrero: la paura di subire una sanzione penale, la preoccupazione di non essere in grado, individualmente e collettivamente, di garantire ordine e sicurezza attraverso le istituzioni, la paura di sommovimenti (rivoluzioni) che creino disordine e caos, la paura della violenza diffusa, che riaffiora nei momenti di crisi. Ritengo che questo intreccio di paura, violenza e penalità sia un tema altamente significativo della cultura penale moderna, modellandone le forme istituzionali e gli schemi di percezione individuale È evidente che non è l’unico: la penalità è ricca di temi significativi, per certi aspetti e sempre più spesso in conflitto tra loro, su cui via via si polarizzano le mentalità e le sensibilità collettive. Purtuttavia, mi sembra di poter affermare che ogni innovazione nel campo penale – laddove sia resa possibile – debba fare inevitabilmente i conti con la doxa secondo cui la forza del diritto sta nella capacità di monopolizzare la violenza incutendo timore nei consociati e contenendo, in tal modo, la loro paura della violenza diffusa. Crisi del sistema penale moderno La definizione di una situazione come di “crisi” o di “armonia” non può darsi oggettivamente: come osserva Melossi (p. 5), «che cosa sia una situazione di “crisi sociale” dipende ampiamente dalla prospettiva di chi definisce 204 Cfr. par. 3.4. La paura della criminalità al centro della modernità 241 tale situazione». Purtuttavia, questa considerazione sul “chi”, e cioè sul soggetto che definisce la crisi, che per Melossi è rappresentato principalmente dalle élites, impone di riprendere il concetto di “circolarità tra i livelli culturali”: se è vero che la rappresentazione della realtà che s’impone con più facilità è quella che ha maggiore forza, tale doxa, tuttavia, circola a tutti i livelli culturali e si afferma come fatto sociale oggettivo. Così, è difficile mettere in dubbio il fatto che oggi il sistema penale attraversi una profonda crisi. Al contempo, si rileva la necessità di analizzare come si sia arrivati a questa situazione, attraverso quali discorsi e quali pratiche. Altri criminologi hanno magistralmente ricostruito i contorni di questa crisi che, d’altra parte, si inscrive in quel senso di malessere più generale che investe le società tardomoderne e che ho trattato nel capitolo 3. Sinteticamente, si può affermare che la crisi del modernismo penale è una crisi di fiducia non tanto in una qualsiasi delle funzioni istituzionali (tra cui, principalmente, il controllo della criminalità), bensì nei fondamenti legittimanti le stesse istituzioni penali. Queste hanno investito tutta la loro credibilità sulla capacità di garantire ordine sociale e sicurezza; sono nate nel periodo storico di affermazione dello Stato-nazione e oggi risentono in primo luogo della crisi che sta attraversando quest’ultimo. Come ho già ricordato, In un quadro generale di eventi storici profondamente trasformativi, quali la fine del bipolarismo Est-Ovest, che porta a ridefinire i rapporti di forza economici e gli schieramenti politici sul piano internazionale e che comporta profonde trasformazioni nella percezione dei pericoli, e la crisi del sistema socio-politico nazionale, legata ad un’evoluzione della società industriale classica in società dell’esclusione, le istituzioni tutte si mostrano come “fenomenologie superstiti di un contesto, la cui coesione si sta sfaldando”205. Lo Stato sta perdendo la centralità che lo ha caratterizzato per circa un secolo, a fronte di tendenze economiche globalizzanti, con la loro carica d’incertezza e capacità distruttiva, e a fronte di un indebolimento di quello strumento politico, la legge, a cui tradizionalmente si è dato un forte valore simbolico206. 205 Si veda G.M. Chiodi, “Giurisdizione ed equità regolativa” in E. Bruti Liberati, A. Ceretti, A. Giasanti (a cura di), Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica, Feltrinelli Editore, Milano, 1996, p. 31. 206 «Quando si è gradualmente imposto il primato della legge, esso rispondeva all’esigenza di combatterecontro il privilegio, di affermare principi di uguaglianza e di tutela di diritti, di favorire lo sviluppo dei commerci, di garantire la proprietà privata e talune libertà individuali e veniva presentato come l’espressione giuridica della ragione. Ora, invece, l’idea di una ragione univoca e universale ha subito ormai molte scosse. A essa è subentrata piuttosto una valutazione ponderata degli interessi, in prima istanza decisamente economici. La legge e i suoi alti significati ne subiscono conseguenze tutt’altro che trascurabili» (Ibidem, p. 34). 242 Capitolo 4 Tra gli altri, Habermas analizza nello specifico come le tendenze globalizzanti stiano mettendo in crisi le forme nazional-statali di governo e con esse l’idea di Stato sociale e il concetto stesso di democrazia.207 Il processo di globalizzazione economica mina la capacità dello Stato nazionale di essere Stato regolatore e costringe a pensare su scala planetaria a nuove forme di gestione delle relazioni e dei problemi. Nel contempo, paradossalmente, porta a una rivitalizzazione della dimensione locale208: si assiste ad una ridefinizione delle identità su base territoriale, delle identità comunitarie, in assenza di un’idea di nazione che unifica. Il localismo (come risultato della “voglia di comunità”209) diventa un modo per rivendicare delle differenze, per costruire nuove identità in un processo che necessariamente genera conflitti tra gruppi sociali di varia natura (pseudo-etnici, religiosi, etc.). Sono queste crisi della tarda modernità a comportare un sentimento diffuso di sfiducia nelle istituzioni della giustizia: il giudizio penale perde la sua legittimità come strumento statuale di contenimento della violenza e, spogliato della sua veste simbolica, diventa semplicemente il luogo in cui riversare le aspirazioni individuali di ordine e tranquillità. La giustizia diventa un luogo di esigibilità immediata della democrazia, laddove le altre istituzioni statuali patiscono vuoti di rappresentanza210. Prende forza l’interpretazione di ogni forma di relazione interpersonale in termini giuridici, «in una sorta di pangiuridismo che invade il nostro quotidiano fino ad organizzarcelo»211, ma senza “ordinarlo” in una gerarchia di significati. In questo scenario di crisi (dello Stato-nazione, dello Stato sociale, del sistema della giustizia penale, della valenza simbolica del rito-giudizio) la paura della criminalità inizia a circolare, discorsivamente e percettivamente, e a pervadere l’esperienza quotidiana. Nel capitolo 1 ho ricordato e descritto come, a partire dagli anni Settanta negli Stati Uniti e più tardi in altri Paesi occidentali, tra cui l’Italia, la criminalità, fino a poco tempo prima oggetto delle attenzioni di scienziati e professionisti, emerge come argomento di dibattito sociale e politico diffuso, catalizzando paure di vario tipo e diventan- 207 Si veda in particolare J. Habermas, Die Postnationale Konstellation. Politische Essays, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1998 (trad. it. La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1999). 208 Cfr. E. Pulcini, op. cit. a nota 13. 209 Cfr. Z. Bauman, Community. Seeking Safety in an Insecure World, 2001 (trad. it. Voglia di comunità, Laterza, Bari, 2001). 210 A. Garapon, Le gardien des promesses. Justice et démocratie, Odile Jacob, Paris, 1996 (trad. it. I custodi dei diritti. Giustizia e democrazia, Feltrinelli, Milano, 1997, p. 34). 211 A. Ceretti, A. Giasanti, “Prefazione”. in E. Bruti Liberati, A. Ceretti, A. Giasanti (a cura di), Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica, Feltrinelli Editore, Milano, 1996, p. 10. La paura della criminalità al centro della modernità 243 do il perno attorno a cui si strutturano domande sociali di cambiamento nella gestione della penalità. Rimane aperta la questione sul perché sia proprio la paura della criminalità a costituire il perno attorno a cui si esprimono le insicurezze tardomoderne. A questo punto della trattazione, la risposta è dovuta. 4.6 Conclusioni Perché proprio la paura della criminalità? Di seguito propongo una ricomposizione per punti delle tesi principali che ho sostenuto nel corso di questa ricerca in grado di fornire una risposta al quesito ancora pendente. 1. La paura della violenza costituisce, in epoca moderna, l’esperienza affettiva privilegiata della relazione tra cittadini e Stato. Il pensiero filosofico-politico a partire da Hobbes ha attribuito a questa emozione una centralità inedita nella fondazione di un’autorità che garantisca il mantenimento della sicurezza e della pace. La paura di ciascuno nei confronti degli altri è la ragione fondante lo Stato moderno; d’altra parte, nella promessa/scommessa statuale di placare la guerra di tutti contro tutti attraverso la monopolizzazione della forza, anche il timore diffuso viene imbrigliato all’interno dell’ordine istituzionale (principalmente attraverso il giudizio penale) e canalizzato verso il potere del sovrano di punire. Le istituzioni sono temute ma ritenute necessarie: garantiscono l’ordine – funzionale al mantenimento della pace e della sicurezza – attraverso la paura, un sentimento collettivo complesso che evoca la memoria dell’homo homini lupus, vale a dire la consapevolezza della distruttività della guerra di tutti contro tutti, e la necessità della perdita di un po’ di libertà a favore di una maggiore sicurezza. Questa concezione ripercorre e modella il nostro modo di “pensare alla paura” ma anche di “provare paura”. 2. Le crisi della tarda modernità rendono fragile, precaria e incerta la vita di molti, determinando una frantumazione delle forme tradizionali di cittadinanza. Gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità hanno costituito l’ossatura della cultura moderna e il loro attuale “frammentarsi” comporta un senso generale di insicurezza che mina la fiducia nella capacità collettiva di regolare 244 Capitolo 4 la vita sociale. La sensazione di essere al capolinea della storia – la “fine del mondo” descritta da De Martino – porta le persone a percepirsi “sole” nell’affrontare una realtà sempre più competitiva, aprendo a forme di atomizzazione identitaria della vita sociale. 3. Lo stato di guerra di tutti contro tutti riemerge nell’immaginario collettivo e, con esso, il tema della violenza e la paura della paura. Nel vortice delle crisi socio-economiche e politico-istituzionali – che nell’Italia degli anni Novanta si sono manifestate nel crollo del sistema politico della cosiddetta Prima Repubblica, nella nuova visibilità di una crisi economica che da molti anni caratterizzava i Paesi occidentali, nella percezione di un’ “invasione” degli immigrati, nella debolezza dello Stato di fronte alla “forza brutale” delle mafie –, le esperienze quotidiane e i discorsi pubblici si popolano di situazioni che evocano un regresso della civiltà a forme di barbarie economiche, sociali e civili, in cui ciascuno torna a essere nemico di ogni altro, e suscitano il timore di un ritorno a una condizione in cui ciascuno deve temere la violenza degli altri e difendersi da essa. L’homo homini lupus è il riferimento simbolico disponibile culturalmente per percepire la crisi della civiltà moderna. Così, la sensazione di fine del mondo, accompagnata dalla perdita della fiducia nell’idea stessa di progresso porta alla ribalta, a tutti i livelli della vita sociale, il tema della violenza, che domina le forme culturali (mentalità e sensibilità) e orienta gli schemi di percezione individuale. Il timore di tornare a uno stato di “paura continua” caratterizza le esperienze quotidiane e i discorsi pubblici. 4. La criminalità, che per definizione è violenza che minaccia l’ordine, viene investita di una nuova luce. Non emerge più come problema sociale da affrontare nell’ambito di un progetto politico-culturale che investe la società nel suo insieme (com’era il progetto della modernità), bensì come problema individuale, che pone l’individuo solo di fronte alla propria incertezza del vivere quotidiano. Il giudizio penale, così come le istituzioni in generale, perde la sua valenza simbolica di contenimento della violenza e del disordine; e lascia sul campo delusione, sfiducia e insicurezza. Priva di un apparato ideale che le restituisca un senso politico, la criminalità emerge, nella percezione diffusa, in tutta la sua potenzialità distruttiva per l’individuo. L’immagine di una criminalità dilagante e incontenibile rappresenta l’emblema dell’indebolimento delle istituzioni nel garantire ordine, che viene ribadito giorno per giorno nei telegiornali, nelle sedi politiche, nelle piazze e nelle case. La paura dell’individuo di fronte alla criminalità s’impone quindi come argomento di dibattito sociale e politico: rappresenta a pieno la La paura della criminalità al centro della modernità 245 solitudine e l’insicurezza tardo-moderna nei confronti di fatti percepiti come sempre meno controllabili, in quanto evoca un regresso della civiltà a uno stato di barbarie. 5. La paura della criminalità costituisce la principale risorsa simbolica per la legittimazione di istituzioni in crisi. Il timore della violenza che minaccia l’ordine viene riscoperto come esperienza affettiva fondamentale nella relazione tra i cittadini e le istituzioni: questa emozione costituisce il terreno simbolico su cui le istituzioni moderne, affette da una sorta di “paura sacra” di perdere la propria capacità di creare ordine, tentano di legittimarsi e su cui, in ogni caso, si vanno costruendo nuove forme di cittadinanza. Le istituzioni penali (polizie, tribunali, carcere) più delle altre rappresentano il tentativo moderno di “ingabbiare” la violenza – proprio nel significato weberiano di gestirla in modo razionale e burocratico –: è ancora su di esse che vengono riposte le aspettative di ordine e sicurezza. Questa ricostruzione costituisce l’esito del percorso di ricerca che ho intrapreso al fine di interpretare l’invasione della paura della criminalità nelle società occidentali contemporanee. Esprime una versione che non riduce tale emozione nella sfera individuale dell’uomo, ma la attribuisce una dimensione culturale, morale e politica. Più che prodotto della crisi della modernità, e quindi fenomeno tipico della tarda modernità, la paura della criminalità costituisce semmai un tratto essenziale della modernità: ne è a fondamento, rimane sottotraccia nella sua fase di espansione connessa all’affermazione degli ideali di liberté, égalité, fraternité, e riaffiora nella sua fase critica come esperienza affettiva privilegiata di conoscenza e trasformazione del mondo. Ma in quale direzione? Di cosa parla la paura della criminalità? Un esito incerto L’insicurezza odierna è fortemente connessa al senso di crisi della modernità. La paura della criminalità sembra scoprire più di ogni altro fenomeno della tarda modernità i pericoli di questa crisi. Da quali pericoli mette in guardia? Quale via di uscita e quale messaggio etico propone? Insomma, di cosa parla oggi la paura della criminalità? Nel momento in cui viene comunicata e condivisa, essa diventa terreno di incontro tra le persone, di scontro politico e istituzionale, strumento per avanzare istanze di cambiamento fattore di legittimazione di nuove istituzioni, nuovi saperi e nuove figure professionali, opportunità per incrementare il 246 Capitolo 4 profitto di settori imprenditoriali, pretesto per sottacere insuccessi politici o recessioni economiche, per aumentare il livello di controllo e di restrizione delle libertà. Entra in quel campo simbolico di forze, che, in una dinamica conflittuale, (ri)definisce continuamente la visione del mondo che informa la nostra azione e la nostra percezione. Produce nuovi modi di pensare e di agire. Al pari di ogni altra pratica discorsiva, infatti, la paura della criminalità costituisce un criterio per leggere e modificare la realtà circostante: dà vita a classificazioni, dai quali scaturiscono nuovi modi di pensare ed agire, nuove forme e nuovi oggetti. Il caso già citato di City Walk nei pressi di Los Angeles è un chiaro esempio di questa forza generativa della paura della criminalità: essa diventa criterio per pensare, progettare e realizzare la vita in comune delle persone, producendo anche un nuovo modo di intendere le relazioni sociali. Diventa criterio per definire chi sta dentro e chi sta fuori, terreno fertile per l’espandersi di vecchie e nuove conflittualità e occasione per individuare nuovi equilibri sociali basati su identità rinnovate. Appare evidente come oggi la paura reciproca dia sostegno, sul piano individuale, alla voglia di rinchiudersi in comunità omogenee e, sul piano politico, a istanze punitive che costituiscono la principale modalità con cui le istituzioni – a partire, ovviamente, da quelle penali – tentano di recuperare il consenso dei cittadini. Questa emozione parla, in altre parole, della “necessità” di tornare a un ordine proto-moderno, a uno Stato di polizia – come prima forma dello Stato assoluto – che definisca nettamente e in forma compressa i confini della moralità: è la modalità che la nostra cultura conosce per restituire sicurezza e stabilità nelle relazioni sociali. Attorno a questa necessità si articola buona parte delle legislazioni penali, dei discorsi criminologici e delle pratiche istituzionali della tarda modernità. Appare altrettanto evidente come l’esito di questa strategia sia fortemente dubbio: la sensazione è che le istituzioni stiano inesorabilmente perdendo il loro potere simbolico di ingabbiare la violenza diffusa e contenere le paure sociali. D’altra parte, riconosco che questa emozione può esprimere anche un altro significato, che può porsi in modo conflittuale rispetto a quello appena descritto: la paura della violenza parla anche del fatto che tutti gli uomini condividono la stessa vulnerabilità di fronte alle minacce da essi stessi prodotte, richiede una presa di coscienza di quel rischio supremo e definitivo che è l’autodistruzione, e invoca la necessità di una dimensione politica dell’agire, di nuove forme di solidarietà e di nuove identità culturali e sociali garantite all’interno di un ordine istituzionale. Le perplessità sulla possibilità di costruire forme istituzionali – soprattutto in campo penale – in grado di legittimarsi senza il ricorso a forme di intimidazione sono molte. Purtuttavia, si sente l’esigenza di continuare a speri- La paura della criminalità al centro della modernità 247 mentare in tale direzione. Le tesi contenute in questo libro confermano l’utilità di questi tentativi: la paura della criminalità sta già giocando un ruolo fondamentale nella costruzione di ciò che seguirà alla tarda modernità, ma la competizione sul significato etico-politico da attribuirle non ha ancora dato un esito definitivo. Occorre scegliere quale funzione attribuire alla paura – visto che la sua presenza come fatto sociale non è più trascurabile – e giocarla nel campo della cultura contemporanea. Bibliografia AAVV, The Challenge of Crime in a Free Society: Looking Back Looking Forward, Symposium on the 30th Anniversary of the President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, june 19-21, 1997, U.S. Department of Justice, 1998. AAVV, “Iniziative per la giustizia nei programmi delle forze politiche. Elezioni del 21 aprile 1996”, Documenti Giustizia, 4, 1996, pp. 898-922. Agamben G., Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino, 1995. Alexander F., Staub H., The Criminal, the Judge and the Public, 1931 (trad. it., Il delinquente, il giudice e il pubblico. Un’analisi psicologica, Milano, 1978, p. 192). Alvazzi del Frate A., Victims of Crime in the Developing World, UNICRI, Publication N. 57, 1998. Amendola G., La città postmoderna. Magie e paure della metropoli contemporanea, Laterza, Bari, 1997. Appadurai A., Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization, University of Minnesota Press, Minneapolis-London, 1996 (trad. it. Modernità in polvere, Meltemi, Roma, 2001). Armon-Jones C., “The Thesis of Constructionism”, in Harré R. (edited by), The Social Construction of Emotions, Basil Blackwell, New York, 1986, pp. 32-56. Bandini T., Gatti U., Gualco B., Malfatti D., Marugo M.I., A. Verde, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, Volume II, Giuffrè, Milano. Barbagli, Immigrazione e criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna, 1998. 249 250 Bibliografia Barbagli M., Egregio signor Sindaco. Lettere dei cittadini e risposta dell'istituzione sui problemi della sicurezza, Bologna, Il Mulino, 1999. Barbagli M., “La paura della criminalità”, in Barbagli M., Gatti U. (a cura di), La criminalità in Italia, Bologna, Il Mulino, 2002. Barbano F., “Bisogni della «marginalità» e produzione dei servizi sociali: emergenze e conclusioni della ricerca” in F. Barbano (a cura di), Le frontiere della città, Franco Angeli, Milano, 1982. Barbano F., “Marginalità versus complessità” in Studi di Sociologia, 4, 1982. Barcellona P., L’individualismo proprietario, Boringhieri, Torino, 1987. Barcellona P., Diritto privato e società moderna, Novene Editore, Napoli, 1996, p. 222-223. Bardi L., Ignazi P., Massari O., I partiti italiani. Iscritti, dirigenti, eletti, EGEA, Milano, 2007. Barone F., “La paura della macchina: implicazioni metafisiche del luddismo”, in Riscossa S. (a cura di), Le paure del mondo industriale, Editori Laterza, Bari, 1990. Bayley D.H. e Shearing C.D., The New Structure Of Policing: Description, Conceptualization, And Research Agenda, Washington D.C., U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 2001. Bauman Z., In Search of Politics, Polity Press, Cambridge, 1999 (trad. it. La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000). Bauman Z., Liquid Modernity, 2000 (trad. it. Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002). Bauman Z., Community. Seeking Safety in an Insecure World, 2001 (trad. it. Voglia di comunità, Laterza, Bari, 2001). Bauman Z., Waste Lives. Modernity and its Outcasts, Polity Press, Cambridge, 2004 (trad. it. Vite di scarto, Laterza, Bari-Roma, 2005). Bibliografia 251 Bauman Z., Liquid Life, 2005 (trad. it. Vita liquida, Laterza, Roma-Bari, 2006). Beck U., Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1986 (trad. it. La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma, 2000). Berger P.L., Luckmann T., The Social Construction of Reality, Doubleday and Co., New York, 1966 (trad. it., La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1969, pp. 39-40). Bodei R., Geometria delle passioni. Paura, speranza e felicità: filosofia e uso politico, Feltrinelli, Milano, 2003. Boeri T., Uno stato asociale. Perché è fallito il welfare in Italia, Laterza, Roma-Bari, 2000. Bonaiuti G., Corpo sovrano. Studi sul concetto di popolo, Meltemi, Roma, 2006. Bonomi A., “Il grumo rancoroso delle identità elementari”, Narcomafie, ottobre 1993, Box S., Hale C., Andrews G., “Explaining Fear Of Crime”, in The British Journal Of Criminology, Vol. 28, N. 3, 1998, pp. 340-356. Braithwaite J., Crime, shame and reintegration, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. Calabi C., “Che cosa hanno in comune l’amore, il disprezzo e l’assassinio premeditato? Emozioni, base cognitiva e razionalità”, in Magri T. (a cura di), Filosofia ed emozioni, Feltrinelli, Milano, 1999, pp. 51-94. Canfora L., Democrazia. Storia di un’ideologia, Editori Laterza, Bari, 2004 Casadei T., “Dal dispotismo al totalitarismo: Hannah Arendt”, in D. Felice (a cura di), Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosoficopolitico, pp. 625-672. 252 Bibliografia Casadei T., “Il senso del ‘limite’: Montesquieu nella riflessione di Hannah Arendt”, in Felice D. (a cura di), Montesquieu e i suoi interpreti, 2 tt., Pisa, ETS, 2005, pp. 805-838. Castel R., L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé?, Edition du Seuil, 2003 (trad. It. L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2004). Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2005. XVI Rapporto, Roma, 2006. Cattaneo M.A., Anselm Feuerbach filosofo e giurista liberale, Edizioni di comunita, Milano, 1970. Cattaneo M.A., “Paura e pena (Hobbes, Feuerbach e Kant)”, in Pasini D. (a cura di), La paura e la città, vol. II, 1984, pp. 89-102. Cattaneo M.A., “Hobbes e la procedura penale”, in G. Sorgi, Thomas Hobbes e la fondazione della politica moderna, Giuffrè, Milano, 1999. Ceccarelli A., “Review of D. Felice (a cura di) Libertà, necessità e storia. Percorsi nell’«Esprit des lois» di Montesquieu”, Cromohs, 9, 2004, pp. 1-7. Ceretti A., Come pensa il Tribunale per i Minorenni. Una ricerca sul giudicato penale a Milano dal 1934 al 1990, Franco Angeli, Milano, 1996. Ceretti A., “Devianza e marginalità: due categorie a confronto”, in Marginalità e Società, 7, 1988. Ceretti A., L’orizzonte artificiale. Problemi epistemologici della criminologia, Cedam, Padova, 1992. Ceretti A., “Dal sacrificio al giudizio: da Girard a Chapman”, in A. Francia (a cura di), Il caprio espiatorio, Franco Angeli, Milano, 1994, pp. 56-78. Ceretti A., “Presentazione”, in Garland D., Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale, Il Saggiatore, Milano, 1999. Bibliografia 253 Ceretti A., “Presentazione”, in A. Ceretti, L. Garlati, (a cura di), Laicità e Stato di Diritto. Atti del IV Convegno di Facoltà, Università di MilanoBicocca, 9-10 febbraio 2006, Giuffrè, Milano, 2007. Ceretti A., Cornelli R., Proprietà e sicurezza. La centralità del furto per la comprensione del sistema penale tardo-moderno, Giappichelli, Torino, 2007. Ceretti A., Giasanti A., “Prefazione”. in Bruti Liberati E., Ceretti A., Giasanti A. (a cura di), Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica, Feltrinelli Editore, Milano, 1996. Ceretti A., Mannozzi G., "Restorative Justice. Theoretical Aspects and Applied Models", Offenders and Victims. Accountability and Fairness in the Justice Process. Contribution to the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, A/ Conf. 187/ NGO. 1., 2000. Ceretti A., Natali L., La cosmologia degli attori violenti. L’inedita prospettiva di Lonnie Athens, in corso di pubblicazione. Chiodi G.M., “Giurisdizione ed equità regolativa” in Bruti Liberati E., Ceretti A., Giasanti A. (a cura di), Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica, Feltrinelli Editore, Milano, 1996. Cimmino L., “Giorgio Colli e la crisi della ragione”, in La Nottola, III, n. 1-2, 1984, pp. 63-85. Cohen S., Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers (Third Edition), Routledge, New York, 2002 Coli D., La modernità di Thomas Hobbes, Il Mulino, Bologna, 1994. Cornelli R., “Le forze di polizia in Italia: situazione attuale e prospettive di riforma”, in Barbagli M. (a cura di), Rapporto sulla criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 557-574. Cornelli R., “Cos’è la paura della criminalità e quanto è diffusa”, L’Inchiesta, N. 143, 2004, pp. 62-74. 254 Bibliografia Cornelli R., “Paura della criminalità e allarme sociale”, in Selmini R. (a cura di), La sicurezza urbana, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 105-115. Cornelli R., “Nord Italia vs Trentino: il senso di sicurezza”, in Transcrime (a cura di), Settimo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2005, Giunta della Provincia Autonoma di Trento, Trento, 2005, pp. 111-136. Cornelli R., Castellan S., “La percezione d’insicurezza: le preoccupazioni dei trentini”, in E. Savona, F. Bianchi, Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2000/2001, Provincia Autonoma di Trento, Trento, 2001. Cottino A., “Panico morale e nemici appropriati: riflessioni in margine a due contributi di T. Mathiesen e di N. Christie-K. Brunn”, in A. Gasanti (a cura di), Giustizia e conflitto sociale. In ricordo di Vincenzo Tomeo, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 209-222. D’Andrea D., “Prigionieri della modernità. Individuo e politica nell’epoca della globalizzazione”, in D’Andrea D., Pulcini E. (a cura di), Filosofie della globalizzazione, Edizioni ETS, Pisa, 2002, pp. 57-83. D’Urso V., “Introduzione all’edizione italiana”, in Oatley K., Best Laid Schemes. The Psychology of Emotions, Cambridge University Press, Cambridge, 1997 (Trad. It. Psicologia ed emozioni, Il Mulino, Bologna, 2003). Dal Lago A., “Nonpersone. Il limbo degli stranieri”, Aut-Aut. Dentro/Fuori, 275, 1996 Dal Lago A., Lo straniero e il nemico. Materiali per l’etnografia contemporanea, Costa & Nolan, Genova, 1998. Dal Lago A., Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano, 1999. Dal Lago A., “Esistenza e incolumità. Una nota sulle recenti opere di Zygmunt Bauman”, Rassegna Italiana di Sociologia, XLI, N. 1, 2000. Dahrendorf R., Quadrare il cerchio. Benessere economico, coesione sociale e libertà politica, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 1998, p. 78. Bibliografia 255 Deaglio M., “La paura delle crisi”, in S. Riscossa (a cura di), Le paure del mondo industriale, Editori Laterza, Roma-Bari, 1990. De Giorgi A., Zero Tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo, Derive Approdi, Roma, 2000. De Giorgi A., Il governo dell'eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine, Ombre corte, Verona, 2002. De Leo G., Psicologia della responsabilità, Laterza, Roma-Bari, 1998. De Leonardis O., “Statuto e figure della pericolosità sociale tra psichiatria riformata e sistema sociale: note sociologiche” in Dei Delitti e delle pene, 2. De Leonardis O., In un diverso welfare, Feltrinelli, Milano, 1998, pp. 101-120. De Leonardis O., Le istituzioni. Come e perché parlarne, Roma, Carocci Editore, 2001. De Leonardis O., Nuovi conflitti a Flatlandia: la crisi del principio di terzietà e le libertà politiche, paper presentato al Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, 5 aprile 2006. De Marchi B., M. Tamburino, “Politiche dell’incertezza, scienza e diritto. Introduzione”, in Notizie di Politeia. Rivista di Etica e Scelte Pubbliche, XIX, n. 70, 2003, pp. 3-12. De Martino E., La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi, Torino, 1977. De Waard J., “The Private Security Industry in International Perspective”, in European Journal on Criminal Policy and Research, 7, 2, 1999. Delumeau J., La peur in Occident, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1978 (trad. it. La paura in Occidente (secoli XIV-XVIII) La città assediata, SEI, Torino, 1979). 256 Bibliografia Delumeau J., La péché et la peur. La culpabilization en Occident (XIIIXVIII siècles), Fayard, Paris, 1983 (trad. it. Il peccato e la paura. L’idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo, Il Mulino, Bologna). Derrida J., Force de loi. Le «Fondement mystique de l’autorité», Edition Galilée, Paris, 1994 (trad. it. La forza della legge. Il «Fondamento mistico dell’autorità», Bollati Boringhieri, Torino, 2003). Despret V., Ces émotions qui nous fabriquent, ethnopsychologie de l’authenticité, Seuil, Paris, 2001 (trad. it. Le emozioni. Etnopsicologia dell’autenticità, Eleuthera, Milano, 2002). Di Franco G., EDS: Esplorare, descrivere e sintetizzare i dati, Franco Angeli, Milano, 2001, pp. 182-184. Di Vona P., Aspetti di Hobbes in Spinosa, Loffredo Editore, Napoli, 1990. Ditton J., Farral S., Bannister J., Gilchrist E., Pease K., “Reactions to victimisation: why has anger been ignored?”, Crime Prevention and Community Safety: An International Journal, Vol. 1, N. 3, 2000, pp. 37-54. Douglas J.D., “Review”, American Sociological Review, Vol. 32, No. 4, 1967, pp. 664-666. Douglas M., Risk Accettability According To The Social Science, Russel Sage, New York, 1986 (trad. it. Come percepiamo il pericolo: antropologia del rischio, Milano, Feltrinelli, 1991). Douglas M., Risk And Blame, Routledge, London-New York, 1992 (trad. it. Rischio e colpa, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 67). Durkheim É., De la division du travail social, Quadrige Puf, Paris, 1995 [1893] (La divisione del lavoro sociale, Edizioni di Comunità, Milano, 1971). Elias N., Über den Prozess der Zivilisation. Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes, Suhrkamp, Frankfurt, 1969 (trad. it. La civiltà delle buone maniere. La trasformazione dei costumi nel mondo aristocratico occidentale, Il Mulino, Bologna, 1998). Bibliografia 257 Farrall S., “Revisiting Crime Surveys: Emotional Responses Without Emotions? Or Look back at anger”, International Journal of Social Research Methodology, Vol. 7, N. 2, 2004, pp. 157-171. Farrall S., Bannister J., Ditton J., Gilchrist E., “Social Psychology and The Fear Of Crime”, British Journal of Criminology, 40, 2000, pp. 399-413. Felice D., “Autonomia della giustizia e filosofia della pena nell’Esprit des lois”, in D. Felice (a cura di), Libertà, necessità e storia. Percorsi nell’«Esprit des lois» di Montesquieu, Bibliopolis, Napoli, 2003, pp. 75-136. Felice D., Per una scienza universale dei sistemi politico-sociali. Dispotismo, autonomia della giustizia e carattere delle nazioni nell’Esprit des lois di Montesquieu, Olschki, Firenze, 2005. Felice D. (a cura di), Montesquieu e i suoi interpreti, 2 tt., Pisa, ETS, 2005. Feuerbach P.J.A., Anti-Hobbes, Erfurt, 1798 (trad. it. Anti-Hobbes ovvero i limiti del potere supremo e il diritto coattivo dei cittadini contro il sovrano, Giuffrè, Milano, 1972). Ferraro K.F., Fear of Crime: Interpreting Victimization Risk, Albany, New York: State University of New York Press, 1995, p. 4. Ferraro K. F., Lagrange R.L, “The Measurement of Fear of Crime”, Sociological Inquiry, n. 57, 1987. Ferrero G., “The Fear of Death”, in Popular Science Monthly, 1897, pp. 236-241, cit. in Sorgi G., Potere tra paura e legittimità. Saggio su Guglielmo Ferrero, Giuffrè Editore, Milano, 1983. Feuerbach P.J.A., Anti-Hobbes, Erfurt, 1798 (trad. it. Anti-Hobbes ovvero i limiti del potere supremo e il diritto coattivo dei cittadini contro il sovrano, Giuffrè, Milano, 1972). Forti G., Bertolino M. (a cura di), La televisione del crimine, Vita e Pensiero, Milano, 2005. 258 Bibliografia Francia A., Il capro espiatorio, Franco Angeli, Milano, 1994. Freund J., “La thème de la peur chez Hobbes”, Cahiers Vilfredo Pareto. Revue européenne des sciences sociales, XIII, 1975, pp. 18-19. Fustenberg F., “Public Reaction to Crime in the Street”, American Scholar, vol. 40, 1971. Galbraith J.K., The Affluent Society, Houghton Miffin Company, Boston, 1969 (trad. it. La società opulenta, Boringhieri, Torino, 1972). Galli G., La politica criminale in Italia negli anni 1974-1977, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1978. Gallini C., “Introduzione”, in De Martino E., La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi, Torino, 1977. Garland D., Punishment and Modern Society, Oxford University Press, Oxford, 1990 (trad. it. Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale, Il Saggiatore, Milano, 1999). Garland D., The Culture of Control. Crime and Social Order in Late Modernity, Oxford University Press, Oxford, 2001 (trad. it. La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Milano, 2004). Garofalo J., “The Fear of Crime: Causes and Consequences”, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 72, N. 2, 1981, pp. 839-857. Gatti U., Schadee H.., Tremblay R.E., “Capitale sociale e reati contro il patrimonio. Il senso civico come fattore di prevenzione dei furti d'auto e delle rapine nelle province italiane”, Polis, N. 1, 2002, pp. 57-74. Gatti U., Tremblay R.E., Larocque D., “Civic Community and Juvenile Delinquency: A Study of the Regions of Italy”, The British Journal of Criminology, Vol. 43, N. 1, 2003, pp. 22-40. Giddens A., The Consequences of Modernity, Cambridge, Polity Press, 1990 (trad. it. Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo, Il Mulino, Bologna, 1994). Bibliografia 259 Ginsborg P., L’Italia del tempo presente. Famiglia, società civile, Stato. 1980-1996, Einaudi, Torino, 1998. Ginzburg C., Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500, Einaudi, Torino, 1976. Ginzburg C., Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia, Einaudi, Torino, 1986. Girard R., Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, Parigi 1978 (trad. it., Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, Adelphi, Milano 1983, p. 23). Girotti F., Welfare State, Storia, modelli e critica, Carocci Editore, Roma, 1998. Goyard-Fabre S., Montesquieu adversaire de Hobbes, Lettres Modernes, Paris, 1980 Goria F., “Relazione introduttiva”, Atti del convegno su Riflessioni su fraternità e diritto, Castelgandolfo, 18 novembre 2005. Gozzano S., “Ipotesi sulla metafisica delle passioni”, in Magri T. (a cura di), Filosofia ed emozioni, Feltrinelli, Milano, 1999, pp. 13-50. Habermas J., Die Einbeziehung des Anderei. Studien zur politischen Theorie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1996 (trad. it. L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, Feltrinelli, Milano, 1998). Habermas J., Die Postnationale Konstellation. Politische Essays, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1998 (trad. it. La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1999). Habermas J., Taylor C., Kampf um anerkennung im demokratischen rechtsstaat, Suhrkampf Verlag, Frankfurt am Main, 1996 (trad. it. Multiculturalismo, Feltrinelli, 1998). 260 Bibliografia Hale C., Quality Of Life, Fear Of Crime, And Implications Of Foot Patrol Policing, Ph.D. Dissertation, Michigan State University, 1983. Hale C., “Fear of Crime: A Review of the Literature”, in International Review of Victimology, 4, 1996, pp. 79-150. Harré R. (edited by), The social construction of emotions, Basil Blackwell, New York, 1986. Harré R., “An Outline of the Social Constructionist Viewpoint”, in Harré R. (edited by), The Social Construction of Emotions, Basil Blackwell, New York, 1986, pp. 2-14. Harré R., Finlay-Jones R., “Emotion Talk Across Times”, in Harré R. (edited by), The Social Construction of Emotions, Basil Blackwell, New York, 1986, pp. 220-233. Hobbes T., De cive, edizione a cura di M. Barzaghi, Marietti, Roma, 1972. Hobbes T., Leviatano, edizione a cura di A. Pacchi, Editori Laterza, Roma, 1996. Hobbes T., Elementi di legge naturale e politica, edizione a cura di A. Pacchi, Sassoni, Firenze, 2004. Hobsbawm E.J., Age of Extremis. The Short Twentieth Century 19141991, Pantheon Books, 1997 (trad. It. Il secolo breve. L’epoca più violenta della storia dell’umanità, BUR, Milano, 2000). Hollway W., Jefferson T., “The Risk Society in an Age of Anxiety: Situating Fear of Crime”, The British Journal of Sociology, Vol. 48, N. 2, 1997, pp. 255-266. Hraba J., Bao W.-N., Lorenz F.O., Pechačovà Z., “Perceived Risk of Crime in the Czech Republic”, Journal of Research in Crime and Delinquency, pp. 225-242. Huizinga J., Herfsttij der Middeleeuwen, 1919 (trad. it. L’autunno del Medioevo, Newton & Compton, Roma, 1992). Bibliografia 261 Jefferson T., Shapland J., “Justice pénale, criminologie et production de l’ordre: les tendances de la recherche et la politique criminelle depuis 1980 en Grande-Bretagne”, Déviance et Société, vol.15, n° 2, pp 187-221. Jenkins P., Moral Panic: Changing Concepts of the Child Molester in Modern America, New Haven, Yale University Press, 1998. Jenness V., “Moral Panic: Changing Concepts of the Child Molester in Modern America (review)”, Social Forces, Vol. 79, N. 3, 2001, pp. 12081211. Kelling G.L., Coles C., Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities, Free Press, New York, 1996. Killias M., “Vulnerability: towards a better understanding of a key variable in the genesis of fear of crime”, Violence and Victims, 5, 1990. Lagrange H., “Appréhension et préoccupation sécuritaire”, Déviance et Société, vol. 16, 1992. Lagrange H., Roché S., L’insécurité: histoire et règulation, HIESI, Paris, 1993. Lagrange R.L., Ferraro K.F., “Assessing age and gender differences in perceived risk and fear of crime”, Criminology, Vol. 27, N. 4, 1989, pp. 698715. Lee M., “The genesis of ‘fear of crime’ ”, Theoretical Criminology, 2001, Vol. 5(4), pp. 467-485. Loader I., “Plural Policing And Democratic Governance”, in Social & Legal Studies, 9, 3, 2000, pp. 323-345. Lopez R., “Deliri di autodifesa a Los Angeles”, Le monde diplomatique-Il Manifesto, maggio 1994. Lopez R., “Hautes murailles pour villes de riches. Un nouvel apartheid social”, Le monde diplomatique, marzo 1996. 262 Bibliografia Lorenz K., Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, Adelphi, Milano, 1974 (tit. orig. Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit, Piper & Co. Verlag, München, 1973). Louis-Guerin A., “La peur du crime: mythes et réalités”, Criminologie, Vol. 16. N. 1, pp. 69-83. Luhmann N., Soziologie des Risikos, Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1991 (trad. it. Sociologia del rischio, Bruno Mondadori, Milano, 1996). Lutz C., “The Domain of Emotion Words on Ifaluk”, in Harré R. (edited by), The Social Construction of Emotions, Basil Blackwell, New York, 1986, pp. 267-288. Gambetta D. (edited by), Trust: Making And Breaking Cooperative Relations, electronic edition, Department of Sociology, University of Oxford, Chapter 6, pp. 94-107, available on the web-site: www.sociology.ox.ac.uk/papers/luhmann94-107.pdf. MacPherson C.B., The Political Theory of Possessive Individualism Hobbes to Locke, Oxford, Oxford University Press, 1962 (trad. it. Liberta e proprietà alle origini del pensiero borghese: la teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke, ISEDI, Milano, 1973). Magri T., “Ridare cittadinanza alle emozioni”, in Magri T. (a cura di), Filosofia ed emozioni, Feltrinelli, Milano, 1999, pp. 7-10. Maneri M., “Il panico morale come dispositivo di trasformazione dell’insicurezza”, Rassegna Italiana di Sociologia, XLII, 1, 2001, pp. 5-40. Marchetti I., Mazzucato C., La pena «in castigo». Un'analisi critica su regole e sanzioni, Vita e Pensiero, Milano, 2006. Marinucci G., “Problemi della riforma del diritto penale in Italia”, in G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), Diritto penale in trasformazione, Giuffrè, Milano, 1985. Marramao G., Dopo il Leviatano. Individuo e comunità nella filosofia politica, Giappichelli, Torino, 1995. Bibliografia 263 Martinetti G., Metropoli. La nuova morfologia sociale della città, Il Mulino, Bologna, 1993. Marx K., Il Capitale, Utet, Torino, 1974 Mastropaolo A., “Presentazione”, in Habermas J., La nuova oscurità. Crisi dello stato sociale ed esaurimento delle utopie, Edizioni Lavoro, Roma 1998. Mastropaolo A., Antipolitica. All’origine della crisi italiana, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli, 2000. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W., The Limits to Growth, Universe Books, New York, 1972 (trad. it. I limiti dello sviluppo, Mondatori, Milano, 1972). Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Beyond the Limits, Chelsea Green Publication Company, 1992 (trad. it. Oltre i limiti dello sviluppo, Il Saggiatore, Milano, 1993). Melossi D., “Multiculturalismo e sicurezza in Emila-Romagna: prima parte”, in Quaderni di città sicure, N. 15, Bologna, 1999. Melossi D., Stato, controllo sociale, devianza, Bruno Mondatori, Milano, 2002. Merzagora Betsos I., Travaini G.V., “Criminalità e paura: una relazione complessa”, Difesa Sociale, Vol. LXXXII, N. 3, 2003, pp. 51-74. Mindel C., Dangel R.F., Carson W., Mays M.L., An Evaluation Of The Dallas Police Departments Interactive Community Policing Program 1995-1999: Final Report, Center for Research, Evaluation And Technology, University of Texas at Arlington, 2000. Montesquieu, Esprit des Lois (trad. it. Lo spirito delle leggi, Vol. I, Libro VI, Capo IX, Utet, 1996. Morlino L., Tarchi M., “The dissatisfied Socieity: The Roots of Political Change in Italy”, in European Journal of Political Research, XXX, n. 1, 1996, pp. 41-63. 264 Bibliografia Morsbach H. e Tyler W.J., “A Japanese Emotion: Amae“, in Harré R. (edited by), The Social Construction of Emotions, Basil Blackwell, New York, 1986, pp. 289-307. Mosconi G., “Devianza, sicurezza e opinione pubblica in EmiliaRomagna”, La sicurezza in Emilia-Romagna. Primo rapporto annuale 1995, Quaderni di Cittàsicure, 2, 1995, pp. 47-48. Moravia S., “Esistenza e passione”, in Vegetti Finzi S. (a cura di), Storia delle passioni, Editori Laterza, Bari, 1995, pp. 3-38. Morin E., La rumeur d’Orléans, Edition du Seuil, 1969 (trad. it., Medioevo moderno a Orlèans, ERI, 1979, p. 19). Morris N., “Random Reflections on ‘The Challenge of Crime in a Free Society’ “, Law and Society Review, Vol. 2, No. 2, 1968, pp. 277-283 Mosconi G., Sarzotti C., Antigone in carcere, Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione, Carocci, Roma, 2004, pp. 169-187. Multzer H., La propriété sans le vol, Seuil, Paris, 1945 (trad. it. Proprietà senza furto, Edizioni di Comunità, Milano, 1948). Mura V., “Il potere della paura, la paura del potere. Le tesi di Hobbes e di Ferrero”, in D. Pasini (a cura di), La paura e la città, vol. II, pp. 103-122. Muratore M.G., Tagliacozzo G., Federici A., La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione di sicurezza e sistemi di protezione, ISTAT, Informazioni, N. 18, 2004. Nardi L., “Il senso d’insicurezza”, in Barbagli M., (a cura di), Rapporto sulla criminalità in Italia, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 525-554. Nardone G., Oltre i limiti della paura, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2000. Nascimbene B., Lo straniero nel diritto italiano, Giuffrè, Milano, 1988. Bibliografia 265 Nelken D., “Il significato di Tangentopoli: la risposta giudiziaria alla corruzione e i suoi limiti”, in. Violante L (a cura di), Storia d’Italia. Annali 14. Legge, Dritto, Giustizia, Einaudi, Torino, 1998, pp. 595-627. Oatley K., Best Laid Schemes. The Psychology of Emotions, Cambridge University Press, Cambridge, 1997 (Trad. It. Psicologia ed emozioni, Il Mulino, Bologna, 2003). Offe C., Strukturprobleme des Kapitalistischen Staates. Aufsatze zur Politischen Sociologie, Frankfurt am Main, 1975 (trad. it. Lo stato nel capitalismo maturo, Etas Libri, Milano, 1979 Offe C., “«Unregierbarkeit». Zur Renaissance konservativer Krisentheorien”, in Habermas J. (a cura di), Stichworte zur «Geistigen Situation der Zeit», Vol. I: Nation und Republick, Frankfurt am Main 1979 (trad. it. in C. Donolo, F. Fichera, Il governo debole. Forme e limiti della responsabilità politica, Bari, 1981). Oliverio Ferraris A., Psicologia della paura, Editore Boringhieri, Torino, 1980. Oliverio Ferraris A., “Le emozioni primarie in un’ottica di psicologia storica: note per una storia della paura”, in Galati D. (a cura di), Le emozioni primarie, Bollati Boringhieri, Torino, 1993, pp. 142-161. Pasini D., “«Paura reciproca» e «paura comune» in Hobbes”, Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, IV serie, LII, 1975, pp. 641-691. Pastore M., “Produzione normativa e costruzione sociale della devianza e criminalità tra gli immigrati”, Quaderni ISMU, 9, 1995. Pavarini M., “Bisogni di sicurezza e questione criminale”, Rassegna di Criminologia, 4, 1994, pp. 435-462. Pavarini M., L’amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia, Carocci, Roma, 2006. Pavarini M., “La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell’Italia del XX secolo”, in Violante L. (a cura di), Storia d’Italia. Annali 12. La criminalità, Einaudi, Torino, 1997, pp. 983-1031. 266 Bibliografia Petrillo A., “L’insicurezza urbana in America”, Aut-Aut. Dentro/Fuori, 275, sett.-ott. 1996. Pitch T., “Ruolo delle donne e mutamento delle strategie di controllo sociale”, Dei delitti e delle pene, 83/1, 1983, 94-109. Pittau F., “35 anni di immigrazione in Italia”, in Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2005. XV Rapporto, Roma, 2005, pp. 69-76. Pizzolato F., “Appunti sul principio di fraternità nell'ordinamento giuridico italiano”, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, XIX, n. 3, 2001. Popper K.R., Conjectures and Refutations, Routledge and Kegan Paul, London, 1969 (trad. it. Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino, Bologna, 1972). Pulcini E., “La passione del Moderno: l’amore di sé”, in S. Vegetti Finzi (a cura di), Storia delle passioni, Editori La Terza, Milano, 1995, pp. 133179. Pulcini E., “L’Io globale: crisi del legame sociale”, in D’Andrea D., Pulcini E. (a cura di), Filosofie della globalizzazione, Edizioni ETS, Pisa, 2002, pp. 57-83. Pulitanò D., “Misure antiterrorismo. Un primo bilancio”, in. Democrazia e diritto, 1981. Pulitanò D., “Delitto politico”, Digesto, IV Edizione, Utet, Torino, 1989. Quinney R., Criminology, Little Brown and Company, Boston, 1979, cit. in Lynch M.J.., “Percezione del reato da parte del pubblico”, in F. Ferracuti (a cura di), Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, vol. 4, Giuffrè editore, Milano, 1991. Recasens I Brunet A., “Politiche di sicurezza e di prevenzione nella Spagna degli anni ‘90”, in L’Inchiesta, Anno XXXIV, n. 143, gennaio-marzo 2004, pp. 44-54. Bibliografia 267 Recasens i Brunet A., “Le polizie”, in R. Selmini (a cura di), La sicurezza urbana, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 233-243. Rees M., Our Final Hour: a Scientist's Warning: How Terror, Error, and Environmental Disaster Threaten Humankind's Future in This Century On Earth and Beyond, Basic Books, New York, 2003 (trad. it. Il secolo finale. Perché l'umanità rischia di autodistruggersi nei prossimi cento anni, Mondadori, Milano, 2005). Renn O., “Three decades of risk research: accomplishments and new challenger”, Journal of Risk Research, 1, 1998, pp. 49-71. Resta E., La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza, Laterza, Roma-Bari, 1992. Resta E., Il diritto fraterno, Laterza, Roma-Bari, 2005 Rinaldi S., “Ordine pubblico e criminalità nel dibattito della sinistra giuridica (1974-1976)”, Dei delitti e delle pene, 87/1, pp. 61-119. Riscossa S., “Prefazione”, in S. Riscossa (a cura di), Le paure del mondo industriale, Editori Laterza, Bari, 1990, p. IX. Robin C., Fear, Oxford University Press, 2004 (trad. it. Paura. La politica del dominio, EGEA, 2004, pp. 36-37). Roché S., Le sentiment d’insécurité, Puf, Paris, 1993. Roché S., “L’insécurité: entre crime et citoyenneté”, Déviance et Société, Vol. 15, N. 3, pp. 301-313. Rodotà S., “Magistratura e politica in Italia”, in E. Bruti Liberati, A. Ceretti, A. Giasanti (a cura di), Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica, Feltrinelli, Milano, 1996. Ronco M., Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena, Giappichelli, Torino, 1996. Rossi G., Il conflitto epidemico, Adelphi, Milano, 2003. 268 Bibliografia Rosso C., Montesquieu moralista. Dalle leggi al «bonheur», Editrice Libreria Goliardica, Pisa, 1965 Rusconi G.E., “Lacità ed etica pubblica”, in Ceretti A., Garlati L. (a cura di), Laicità e Stato di Diritto. Atti del IV Convegno di Facoltà, Università di Milano-Bicocca, 9-10 febbraio 2006, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 25-47. Ryan P.J., “Moral Panic: Changing Concepts of the Child Molester in Modern America (review)”, Journal of Social History , Vol. 35, N. 2, 2001, pp. 511-513. Sacchini G., “Le opinioni dei cittadini”, in Politiche e Problemi della sicurezza in Emilia-Romagna. Settimo rapporto annuale 2001, Quaderni di Cittàsicure, 22, 2001, pp. 75-77. Sampson R.J., Raudenbush S.W., “Systamatic Social Observation Of Public Spaces: A New Look At Disorder In Urban Neighborhoods”, American Journal of Sociology, Vol. 105, N. 3, 1999. Sampson R.J., Raudenbush S.W., “Disorder In Urban Neighborhoods. Does It Lead To Crime?”, Research In Brief, U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 2001. Santinello M., Gonzi P., Scacchi L., Le paure della criminalità: Aspetti psicosociali di comunità, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 95-98. Sassen S., Le città nell’economia globale, Il Mulino, Bologna, 1997. Selmini R., “Towards Città sicure? Political action and institutional conflict in contemporary preventive and safety policies in Italy”, in Theoretical Criminology, Vol. 9 (3), 2005, pp. 307-324. Sen A., Liberty and Violence. The Illusion of Destiny, Norton & Company, New York-London, 2006 (Trad. It. Identità e violenza, Editori Laterza, Roma-Bari). Sennet R., The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism, Norton & Company, New York-London, 1999 (trad. it. L’uomo flessibile, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1999). Bibliografia 269 Sennet R., Respect in a World of Inequality, Norton & Company, New York, 2003 (trad. it. Rispetto. La diginità umana in un mondo di diseguali, Il Mulino, Bologna, 2004). Sennet R., The Culture of the New Capitalism, Yale University Press, New Haven-London, 2006 (trad. it. La cultura del nuovo Capitalismo, Il Mulino, Bologna, 2006). Skogan W., Maxfield M., Coping wit crime, Beverly Hills, Sage, 1981, cit. in Hale C., Quality Of Life, Fear Of Crime, And Implications Of Foot Patrol Policing, Ph.D. Dissertation, Michigan State University, 1983. Schmitt C., Politische Theologie, München-Leipzig, 1922 (trad. it. Le categorie del politico, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 39-41. Schwarzenegger C., “Fear of Crime as a Social Problem in Industrialized Conutries – Is Japan an Exception?”, Hosci Riron, Vol. 27, No 2, 1994, pp. 1-13 Smith W.R., Torstennson M., “Gender Differences In Risk Perception and Neutralizing Fear of Crime”, British Journal of Criminology, Vol. 37, N. 4, 1997, pp. 608-628. Sorgi G., Potere tra paura e legittimità. Saggio su Guglielmo Ferrero, Giuffrè Editore, Milano, 1983. Sorgi G., Quale Hobbes? Dalla paura alla rappresentanza, Franco Angeli, Milano, 1989. Sorgi G. (a cura di), Thomas Hobbes e la fondazione della politica moderna, Giuffrè, Milano, 1999. Stafford M., Galle O., “Victimization Rates, Exposure to Risk, and Fear of Crime”, Criminology, Vol. 22, No 2, 1984, pp. 173-185. Stella F., Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè Editore, Milano, 2003. Traverso G.B., Marugo M.I., “Opinione pubblica e violenza: una ricerca sulla “paura del crimine” in due città italiane”, in Medicina Legale. Atti delle 270 Bibliografia due giornate medico-legali-criminologiche. Sessione di Criminologia, Anno XVI, No 1, 1994, pp. 66-95. Van Swaaningen R., “Criminologia critica e declino del Welfare State. Un approccio normativo al controllo sociale degli anni Novanta”, Dei delitti e delle pene, 3/94, pp. 31-56. Van Swaaningen R., “Un nuovo approccio in tema di sicurezza delle città”, in L’Inchiesta, Anno XXXIV, n. 143, gennaio-marzo 2004, pp. 23-33. Vegetti M., L’etica degli antichi, Editori Laterza, Roma-Bari, 1989; Vegetti M., “Passioni antiche: l’Io collerico”, in Vegetti Finzi S. (a cura di), Storia delle passioni, Editori La Terza, Milano, 1995, pp. 39-73. Visconti C., “La tutela penale della religione nell’età post-secolare e il ruolo della Corte Costituzionale”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2005, pp. 1029 e segg. Tyler T., “Impact of Directly and Indirectly Experienced Events”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 13, 1980, cit. in Taylor R.B., Hale C., “Testing Alternative Models of Fear of Crime”, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 77, 1986. Valcarenghi M., L’insicurezza. La paura di vivere nel nostro tempo, Bruno Mondadori, Milano, 2005 van Kesteren J., Mayhew P., Nieuwbeerta P., Criminal Victimisaion in Seventeen Industrialised Countries, NSCR, 2000. Vegetti M., L’etica degli antichi, Editori Laterza, Roma-Bari, 1989. Vegetti M., “Passioni antiche: l’io collerico”, in Vegetti Finzi S. (a cura di), Storia delle passioni, Editori Laterza, Bari, 1995, pp. 39-73. Verde A., “La risposta pubblica alla devianza ed alla criminalità dal punto di vista psicosociologico”, in Gasanti A. (a cura di), Giustizia e conflitto sociale. In ricordo di Vincenzo Tomeo, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 279-289. Bibliografia 271 Vitale T., “Attivazione e contrattualizzazione nel welfare locale: cambia la posizione dei destinatari?”, in La Rivista delle Politiche Sociali, 1, 2005. Vitale T., “Sussidiarietà: un criterio guida contro il carsismo istituzionale”, in Animazione Sociale, n. 7-8, 2006. Warr M., 2000, Fear of Crime in the United States: Avenues for Research and Policy, Measurement and Analysis of Crime and Justice, U.S. Department of Justice, vol. 4, pp. 451-489. Weber M., Economia e Società. Comunità, Vol. I, Milano, 1968, pp. 620621. Wilcox Rountree P., “A Reexamination of the Crime-Fear Linkage”, Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol. 35, N. 3, 1998, pp. 341-372. Williams F.P., McShane M.D., Akers R.L, “Worry About Victimization: An Alternative and Reliable Measure for Fear of Crime”, Western Criminology Review, 2, 2000. Wilson J.Q., Kelling G.L., “Broken Windows,. The Police and Neighbourhood Safety”, Atlantic Monthly, March, 1982. Woolley J., Peters G., The American Presidency Project [online]. Santa Barbara, CA: University of California (hosted), Gerhard Peters (database).(sito internet: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=27478). AREE SCIENTIFICO–DISCIPLINARI Area 01 – Scienze matematiche e informatiche Area 02 – Scienze fisiche Area 03 – Scienze chimiche Area 04 – Scienze della terra Area 05 – Scienze biologiche Area 06 – Scienze mediche Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie Area 08 – Ingegneria civile e Architettura Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico–letterarie e storico–artistiche Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche Area 12 – Scienze giuridiche Area 13 – Scienze economiche e statistiche Area 14 – Scienze politiche e sociali Le pubblicazioni di Aracne editrice sono su www.aracneeditrice.it Finito di stampare nel mese di novembre del 2011 dalla « Ermes. Servizi Editoriali Integrati S.r.l. » 00040 Ariccia (RM) – via Quarto Negroni, 15 per conto della « Aracne editrice S.r.l. » di Roma
Scaricare