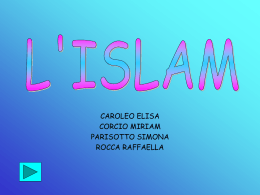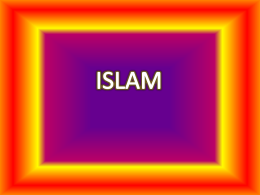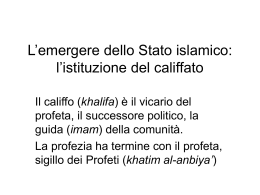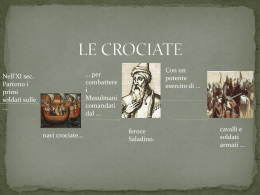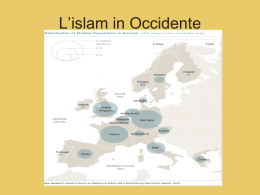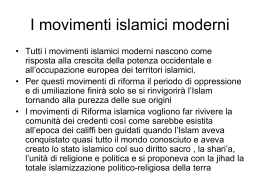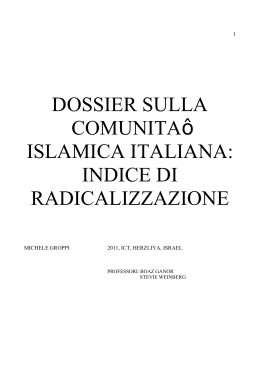'IAL, INTESE -3 I m Il dibatato in Italia I Gli ,accordiIn Eurofa n~dI da risoive~ m - SOMMARIO Editoriale 3 - successo Flash nel mondo Direttore responsabile: Gruppo di redazione: Paolo Girola Silvia Introvigne Augusto Negri Andrea Pacini Filippo Re Alberto Riccadonna Franco Trnd Collaboratori: Liliana Arduina Lucia Avaiione 4 SPECIALE INTESE Quale "Intesa" con I'islam 5 Gesù a Allah nelle scuole il Stato e confessione islamica: quali rapporti nei paesi dell'unione europea 13 Mappa del11is18min Italla 15 Roma, I'imam perde il posto 17 Annabella Balbiano Federica Bello Paolo B m c a Giovanni Caluri Cristina Capucchio C d e Eid Angela Lano Laura Operti Alessandro Sarcineili Giuseppe Scattoh Francesca Valli Francesco Zannini Giuliano Zatti Direzione Amministrazione: Centro F.Peirone - via Barbaroux, 30 - 10122 Torino tel. O[ 1.5612261 -fu. O1 1.5635015 - Attualità In Iran il 'Nobel" per la pace 18 Chi è Shirin Ebadi 19 Le Chiese d'Europa e I'islàm 21 Dialogo islamocristiano La città del cristiano La città del musulmano Bimestrale di cultura, esperienza e dibattito del Centro Federico Peirone Anidiocesi di Torino 22 23 Sito internet: www,centro-peirontit E-mail: infoacentro-peirone.it Direttore del Centro F. Peirone: Negri d. Augusto Tino Abbonamenti Italia Euro 15 Earo Euro 23 Sostenitori Euro 5 1 Copia singola Euro 3 C.C.P. o" 37863107, intestato a Centro Torinese Documentazione Religioni Federico Peirone (abbr. CTDRFF) via Barbaroux, 30 - 10122 Torino Solidarietà In occasione di feste (Natala, Pasqua, eompleannl, matrimoni, lauree) è 'cristiano' pensare anche a chi ha dl meno o non ha Ilnecessario. Chiediamo la tua parteclpazlone, IlCentro F,Peirone promuove o sostlene Intzlatlve dl aluto caritatevole alle Chiese in diffiwità, nel mondo Islamlco. Coerentemente Inoltre con il proprio scopo dl dlalogo crtstlanolslamlco, promuove inlrlative di solidarietà verso situaioni di mlseria che c l Interpellano In questl Paesi, indipendentemente dal credo rellgloso, Indlehlamo qui sotto il costo orfentativo di ogni Iniziativa, Imltando a &nere Iprogetti con &e l i k e , di qualsiasi entltb: a Adozioni intemazlonall di minori crlstlani, In Libano, le cui famiglie sono vittime di guerra. Quotaorleniaiiva: g.16Oianno pw adozione. b Sostegno alle inlzlatlve dl volontarlato delle Suor8 Elisabettine e Comboniane che lavorano gratuitamente, qlrotidlanamente, presso il iebbrosario di Abll Za 'bal, in Egitto, che accoglie malati quasl tutti rnusulmani. Costo orlentatiw: 8.1Wanno per l'adozione annuale di un malato di lebbra g. 3.100: spesa complessiva del progetto di completamento laboratorio anallsl mediche. Offerta Ilbera. %. 1.800: progeito di reinserimonto di un malato dismesso. Ofterta libera, C Aiuta alle comunità crlstlane in Sudan, me da missionari mmboniani, colpite dalla guerra promossa dal fondamentalistl Isiamld. Offerta I l h Per utteriorl infmwioni, telefonare al Centro F. Peirone. Effettuarei versamenti sul C.C.P, n, 37863107, intestato al Centro Tdnese Documentazione Religioni Fedeneo P e i m . Via Barbaroux, 30 - 10122 Torino (Cod. A01 07601; CAB 02000; CIN D), Indicare la causale del versamento. Grazie a nome dei destinatari della vostra s d i r i e i à . - II velo, contro il vuoto _;"Al Ima e Lila sono due ragazze di padre ebreo e madre cristiana (enI trambl non praticanti). Frequentano il liceo Henri-Wallondi Aubervilliers, l alla periferia di Parigi. Un giorno si presentaI, no a scuola indossando il velo. Da qui ha inizio il nuovo caso che ha messo a rumore la Francia. Un nuovo caso, dopo quello del r 1999 quando due studentesse dodicenni, ~turche,eranostateespulsedallascualameI dia per "offesa alla laicithnnon volendo rit nunclare al chador. Secondo i presidi viene violato il principio I I costituzionale di laicith, che vieta l'ostentazione di simboli di qualsiasi religione. Ma rem centi disposizioni non vietano del tutto l'uso del velo, in una Francia che deve fare i conti con 5 milioni di cittadini di cultura islamica; viene tollerato il "foulard leger", equiparato alla catenina d'oro con il crocefisso. La declslone della scuola di Lila e Alma non è stata immediata: per un certo tempo i loro : l 1 I nere il velo Ma, se;, care il vaso e stato quando le due ragazze hanno cercato di "convertire" le ceo Hanri Wallon ha provocato molte discussioni in Francia. Il padre e la madre delle due ragazme difendono, non condividendola, la scelta delle figlie, anche se le considerano influenzate 1 da ambienti maghrebini, che sarebbero vicini al fondayentalismo. Dice mamma Yamina (nata in Algeria da padre francese): 'Un giorno le mie due figlie non hanno pili mangiato la carne di maiale, poi, l'estate scorsa,hanno smesso di venlre in spiaggia a fare il bagno. Infine si sono coperte il capo. Sono certa che sono plagiate, ma la decisione del liceo non fa che radicaliezare la loro scelta". IIpadreLevy,avvocatoconsimpatiepr gressiste, critica il provvedimento della scuola e parla di un caso di 'apartheid" scolastica: "Le mie figlie portano il velo nella misura conforme ai loro principi, senza ostentazione. Qualcuno pub dire che & ridicolo, ma che senso ha obbligare due adqlescenl.alla trasgressione dei loro principi?" Alma e .Lila sostengono di aver fatto una scelta in piena autonomia. Difficile condividere la decisione delle scuole francesi. Anche quando ci fosse un'a evidente costrizione, la soluzione non 'sa re b be I P questi termini, obsoteto. Si può discutere, confrontarsi, parlare con loro. ~ eca-i si di costrizioni aravi, si pub segnalare i genitori alle autorith. E soprattutto, in questo caso si pub cercare di capire i perché. Forse si giungerebbe alle conclusioni confidate dalla nonna delle due ragazze: 'Nel vuoto di valari - ha osservato - Alma e Lila si sono rifugiate nella religione più visibile*. Internazlonals ; È S'UCCESSO a cure di Crlstlna Capucchio I 5 LUGUO KuwaIt Le elezioni leglslatlve del 5 luglio hanno dlrnastrato IIpotere degll lilamici, in prlma luogo per la flessione subita dagli esponenti più moderati (IlMovimento Codiuzbnale Islamico) a profitto dei gfuppl plh esiremlsti e in secondo luwo per l'esclusione dal Parlamento dei "Ilberali', aecusatl dl efilo-merlcani e mondlalisti. U 81 LUGtlQ.Taheren (Iran): Il vicepresidente Iraniano Nohammad Ali M I ha ammasso In una ccinfemnza stampa che la reporter canadmWZahra Kazemi e & a causa delle ferite alla testa riportate in ceirmre durate un m g g i o d e l l a @Ma. Ilgiudim Javad Emaelll, titolare deli'lnchi&& ha ordlnato I'amto d1 cinque funzbnari del Ministero per 1 SiwIzl wreii. i3 AGOSTO Dubd Un cittadino aushliano dl26 anni e la sua compagna &esca sono stabl arrestati e condannati a 6 mssi dl carckre~(pQi.mmutafiin tre anni con la cundlzionale) e 500 eum di multa p r essersi miorasamente badati in pubbllca, i8 AGOSTO Beghdad (Iraq): Un'autobomba I esplosia davantl all'arnbasclata giordana causando una decjna di moro. Non pio m!o guertlglia ma anche temrlsmo poi&& 1 prlrni indizi che emergono pwtano all'irnprendlblle e misterioso Abu Mussab al-irarkawl, considerato l'agente di O r n a nell'area. Anche la swl@del)'oble#hiafa pensare a Zarkawi. L'estmmC sta B Infawgiordano-palejnese, il suo gruppo B,composto da un bupn~riumerodl giordanl e dlspwie dl elernenii fidati, oC ire al fatto che da alcune settlmanqnotideidl Inteltlgences+ gnalavano la' rlwrnprusa dl cellule tslamldie nel mrd dbli'lraq e I iommplld sarebbm p n i i in diverse oeddentall, atlstlca.Ha corsa con maglietta a maniche corte e pantaloni lunghl alk mviglia, Ovvianiente B arrivata ultima ma e siah la prlma volta che un'afghana partecipa a una competlzlone sportiva. i27 AGOSTO P a W n : In alcune aree gnippi di provocatori fondamentallstl Islamiclseminano allarme nella eomunlt&a-istrana. Nelli cittadini dl Kasur(diocesi di Lahwe), nello stato del Punjab i l confini con I'lndia, si stanno mdtlpllcanda +lsodl di violenza al dannl della comunltà cristiana che risiede nel distretto. La fazione fondamentaitsta responsabile dl questi splsodl fa capo ad A R m d Al1 Tolu, leader islamico che ha chipubblicamente a tutti i cittadini mwlmani della di emarginare i crlstlanl, negando loro Il lavoro nei campl, non vendendo loro nemmeno 1 p d o t i i allrnentari ne~eessarialla mprawlvenza.Dopo alcun1glomi in wl la popoiazlaneha s guito questl wggerimentl, la situazione si B fatta pr%occupante: la msncanza di dbo e di lavoro sta weando una tensione generalizzata che gll osservatori temono porisa esplodere In mtiifra ki Odrnuniwcristiana ripmll~Mu8i1ilfian%:In 'PaMstan, su 156 mlliont,d! wr^ipne, I cridianl sono 11 2,594 della popola~zbne(Il 98% -no $usulmani). 27 AGOSTO Malesia Hamld Othman, consigliare del Primo Ministro M a W r Mohamd, ha dato mionealla dedsbne presa da un tribunale locale che ha didiiamto lecito Invlarela formula del trlplice rlpudio (con cui si d l ~ h l g ydeffnitivarnente ripudiata una donna) alla moglie con unjSiris sul klefonino cellulam. Il@ideo ha affermato che un Sms,?:se,mpii~nte una moderna forni dl scrittura, dlmentimndo cha per la islamica~sononecessari anche'due Wtimwii all'atto di rlpu- m h - - ..* - - r-.m h + I, . -f I Specfale Intese I Speciale Intese Sk 'prdenienza, wlkira edvissuto! -religioso. Tra i fedeli musulmani In Italla prevalgono attualmerije i ma& >chini,e complessivamente i maghrebini si attestano al primo posto (43%), seguiti da al banesi ,(20%), estremo-orientali (7%), senegalesi (6,554)e medlorientali (4,3%). Fra i vari gruppi esistono importanti differenze socj,~.religiose,sta nelle credenze Bia nelle pratiche, tanto che i sociologi descrivono questo 'isfAm plurale" con categorie trasversali ai diversi paesi d'origine: credenti parzialmente secotarlzzati (23%), musulmani di stretta osservanza (49x1,musulmani critisi-non praticanti (7%),musulmanl etno-religiosi (commistione .ci08 fra religione e culturp etnica, sopratfutb senegalesi: 10%). La prima ovvia domanda che ci poniamo & quale organismo uni,'tario potrh rappresentare ed esprimere questa complessità. -A titolo d'esempio, basterA ricordare, come & ben noto agli addetti ai lavori, che la cultura e Il sistema giurfdlco dei musulmanl albanesi, per vicende storiche diveraissime, sono agli antipodi delle credenze e norme del musulAn;ia~l &e frequentano le moWee maghrebine. Come creare dunque una rappresentamaistituzionale del musulmani, giuridicamente significativa e contrattualhienteimportante? La questione è canosciuta in tutta l'Europa. Pertanto, se i9 Italia tre associazioni islamiche (U.C.O.I.I., A.M.I., Co.Re.ls.) heqna presentato progetti d'lnteSa ~ I I $ competenti autorit8 dello Stato italiano, esse non sono realmente rappresentative dell'islhm italiano, ma solo dell1isl8m organizzato. Fra queste associazioni, I'U.C.O.I.1. (che nel proprio sito Intemet enumera 134 sedi tra moschee, sale di preghiera e centri islamici) 8 l'organizzazione piu caplllare ed estesa, che rappresenta in sostanza gli immigrati che.frequentano le moschee. Complessivamente, questo islhm ré ad hoc l?iritedocutareislamlcu per un accordo: all'indomanl del riconoscimento, sono emersi uiteriori soggetti islamici che non accethno i patti stipulati. , m CislAm delle moschee Occorre poi osservare che I'islAm non B una 'Chiesa". Non esiste un'organizazione piramidale del clero, Anzi, nella religione islamlca non esiste un ruolo di mediaziona. Lo Stato confessionale ha svolto, coerentemente, nella storia islw mica, la hfunzione di garante e tu; tore della re1jglsne e dell'applicazione dglla legge o del diritto i s l a micg nella M e i à , che dev'essee;fondata sui principi e sulle nor. religiose. Pertanto quei "furi2ibYnari religiosi" che i gruppi islamiei 95 sono inventati, in Europt~ e in l taIia, come "rappresentantin dell'islhm, sono un'autentica $tE. nezza, che, complica il problema anziche r i s o l ~ ~ r lIn o . base al menzionati pirogptti d'Intesa, infatti, gli imàm sarebbero infatti investiti di funzioni importanti, come quella di remttori e distrlb@organizzato, detto anche "IslPm ri de11'8 per mllle, o di deleg.$ti a delle moschee", non supera il "celebrareVI matimenilo in.'mo10% del totale dei musulmani in schea, o di operare come portaItalia. voce ufficiall della comunità ìslaPrima che si pensasse ad una rnim,italianaverso lo Stato. legge generale sulla libertà reli- Consideriamo pio attentamente giosa, l e sol,uzioni p ~ s ~ e t t a t ela qu,estio,ns. L'islAm delle moper riscilve~eqqllsto ii* @ma schee 6,salvo e,ccezioni, di mario della r a p p ~ d s # ~ ~ ~ ; @ %trice r i salafita, pargla che derlva sostanzlalmente'due,La p r i h : da salaf e indica i "pii antenati*' dare tempo ai musuimanj inItalia che, sdc8rid.o ques t&corrents per far emergere altri soggetti e dottrinale islamica oggi molto difconsentire una 'consultazione" fusa, sono la terza fonte della repiù ampia e una struttura ragpre- ligione, dopo Il Corano (fonte risentativa più 'plurallsta", sull'e- velata) e la sunna rnuhammadiasempio deil'iniziativa della Fran- na ffonte ispirata). I salaf so'do cia e del Belgio. La seconda: sii- una fonte interpretativa, non capulare accordi separati fra lo Sta- stitutlva, clo8 sono i garariti della to e le slngol e organizzazioni corretta interpretazione delle priislamiche, sulla base deil'aceet- me due fonti principali, che 'contazione dei principi costitunionali, servano" I'islhm nella retta via favorendo, nel lungo periodd, la delle origlnl e storicamente ooinconvergenza di diversi oraanismi cidono con i rappresentanti autgjrappresentativi in un unico srga- revoli delle prirne'tre generazlo~i, nlsmo islarnico. storiche dei musulmani, a cui &t E Invece inefficace la soluzione aggiungono alcuni personaggi' adottata dalla Spagna, di costrui- med loevali. . ' - 7 - Speciale Intese la pubblica, accanto all'educazione e all'insegnamento religiosi impartiti nel tempo libero, attraverso le scuole coraniche del sabato e della domenica, non di rado aiutate economicamente e10 loglstlcarnentedalle amministrazioni comunali. L'educazione religiosa del ragazzi musulmani del resto B varlamente percepita dalle famigt ie, spesso preoccupate più della riuscita scolastica e dell'inserimento sociale dei ragazzi, a cui pensano che possa bastare l'educazione religiosa in famiglia. La tipica elasticità del sistema consente ai genitori dei ragazzi musulmani di chiedere al Consiglio di Circolo o di Istituto, d'inserire tra le attività complementari lo studio del fatto religioso oppure di tutelare la lingua e la cultura d'origine mediante I'istituzione di appositi corsi (L. 28611998, Testo unlco dell'istruzione religiosa, art. 38), che tuttavia non possono essere asclusivi, come lamentava un apprezzato articolo dl Furio Colombo il quale, valutando la situazione di certe scuole torinesi, chiedeva che i corsi scolastici dl lingua araba fossero aperti a tutti i ragazzi desiderosi, non al soli ragazzi arabi. Non mancano soluztonl scolastiche assai problematiche, ai fini dell'integrazione delle secgn,di generazioni, come la scuola di Viale Jenner a Milano, un apartheid avulso assolutamente dal contesto italiano, o le scuole 'etniche' straniere (regolate dal D.P.R. n. 38911994 e dall'ord. Min. n. 511999) di Marara del Vallo. Roma. Milano, Torino, che intendono preparare il rientro in patria dei ragazzi delle seconde generazioni e si basano su program'mi e metodi pedagogici e didattici estranei al contesto Italiana; ma normalmente It ciclo di studi dell'obbligo si conclude senza Il rlentro, con l'isolamento dei ragazzi dalla cultura, dai costumi e dalle regole dl vlta del nostro paese. , Q ~ / discono alle figlie di frequentare l'insegnamento di ginnastlca e i corsi di nuoto, cosicche si riconosce, proprio nella scuola, un indebito tributo alla mancanza di parità e pari opportunit8 tra maschi e femmine. p ~ g d ' Se per i musulman , Brnd-pW tutti gli studenti, di qualsiasi confessione, nazionalit8 e cultura, il rispetto della liberth di coscienza e la non ingerenza educativa (Cost. arlt. 2,19,2l) sono garantite dal diritto di 'non avvalersi* dell'insegnamento della religione cattolica, bisogna ricordare che le tre associazioni Islamicheche hanno presentato bozza d'Intesa allo Stato italiano, mostrano una diversa sensiblllth riguardo all'i segnamento religioso scolasti& CU.C.0.I.I., che rappresenta soprattutto musulmani immigrati, non ne perla affatto e preferism trasmettere l'educazione religiosa nella scuola coranim domenicale; le altre due organlzzaziani, che rappresentano i convertiti italiani all'islhm, chiedono rispettivamente I'insegnamento confessionale di 'religione islamica" (A.M.I.) e l'insegnamento confessionale-storico del 'fatto religioso islarnico" (Co.Re.1~). Come spieghiamo pia dettagliatamente in altra parte di questa rivista (pag. 1f ), sarebbe auspicablle che si creassero le condizioni per l'insegnamento- scolastico della religione islamlca, che rappresenta un'opportunit8 sul piano del confronto culturale e un evento dl attuazione della tiari dignit8 delle ~ u ,, I> l-, - usujmane ~ ~ imp&~ Il dlritto di famiglia Un terzo ambito che richiede molta attenzione nella stipula dl accordi B quello del diritto familiare dei diversi paesi musulmani, nel quale il Diritto islarnico classlW ha un ruolo ispiratore determlnante, tale da chiamare in causa l'applicazione del principio di tutela dell'ordine pubblico (&,! 218/1995 art. 16) a fronte dl lstk tuzioni come il ripudio unilaterale, , - ~ - -.+ ~ . --. , - -,W,. ? ~ Nasce il Partito iskrriico tjva & di #il oomrnercianfedi or$@?&m c c h i n a , E1 Ehaie- GhaSemi gesfisce una catene dl rosticcerie. Ha scelto di rocchino di Pordenone - In tutta Itah gli iscritti m o dtre Nella primavera del 2004 il fondatore &l partito del Trivemto interide candidami alle elezioni provinciali di Pwdenone. ctlntendo scendere in campo - ha m t o ad m quotidiano nazionale AdesSO per6 b ~ b b i darci h ~ &Wganizzazione. D o a m o essere snelli, ghBaC ci& -nza confini. Questa @ la politica def futuro. Eleggeremo presidente e segretari. Con - 70 euro, ma anche niente se sionsvoW', si leggeva ottobre sul valantlno l I Speciale Inte* la poligamia, la costituzione 'ob- chini, E crea situazioni dlficilissibligatoria della doté e alcuni im- me alla donna ripudiata, messa pediment-matrimoniali, come ad praticamente sulla strada, senza esemplo J'impedimento di matrlcasa, senza lavoro, con la cura rnoniofrqla donna musulmana e dei figli,, senza un orientamento il non musulmano. per distri~amiin una societh che RecentemntB~&,s~ab inoltrata le B stata normalmente vietata fiin' Italia ri'chiedfa de'l riconoscino a quel tragico momento. Non mentmd?inco5tituzibnallt8dell'sirt. B il caso invece dei tunisini o dei 116 del D, 6.,.Che asigwil nulla pochi turchi, paesi in cui il ripudio asta matrimorilaledel paese dal- unilaterale &stato abolito. la donna strahI'6ra musutmana. Manon:bisogna di-. l glorni fmstivi mantioare che, L'ultima questione quand'anohw si fa- Anche s m a Intesa Hlevante b la regaciiitaiure il matimola Repubblica lazionekielie.fe~tinia della doi'rna.mu- italiana, r ~ l ~ ~ ~ l m vit&, a f 7 L'Italia,. i passa sul m'ana O O ~un- godono di n^memsi laico; celebra la tenon m'usulmano, il dirifu.nelri~sfo' stivil2i ~domsnicale, suo rnatrlmonio paese,in m~tq* alcune feste crlstiaconfrattoin'ltalia ~ , ~ ~ e ~ ~ , i one;~duill, i m qeC51"Ie n , ~ f ii i vaiìdo nbls m.iinpoth@esignie di C@ mase d'lorfgiri;e del-fi@aiò8 std~icge s e la donna. ' qci&le, PYA - majqria Altra questiono toplcd [a poli- delie:f&+t;e r , d i g i o ~ a negolirta .~ gatnia.' Nei casl.di poligarnla pre- da 1;6$n&3 r,dat.o,*.~~r-~hp.F?~@w~ gresa, e solo in essi, fra citiadi~ cflaItol @gAa"~&:dgìllgl.nt&e q@$ Ip @&Bi@.$&j;~iY@nn gli&*n'CfdtrsUlmarii strdnl'eri, soggiornahfi abitualmente in ttalia,'l'ltaR~~yci*~~òijioiejfi~~ia li'a 'applica li principio di ordlne ,! ~*@k -, p i bbllco 'àtZ~riuatbn,che conce- ~ 6 i a * i & m e ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ p o ' i j a ~ ' i a B n p P &e.il sogQioma9mwnon la sMtus', @ na@r&+qw>a@$&2$i;afl; i@ ahch~:aila.sewnda~~6glle di .un n,? conteinpy!@'i~ ~ $ $ j q eri 4 nEG marito musulmario8 rlccrnosc8 alla:te:$i~i&>(@ii'g~~s& nWonds ancheall'asecopda moglie; ;eai a &tfiica~eiin~+&~~kd'Itl~e,~, $ la di.lei figlii i dkitti su-ccessfiri, $li s o l ~ z i o n ~ ~ ~ v ! ~ ~ s & e ~ r i ~ ~ ~ c a t a alimenti, la ptpvidenza sociale e p& i [email protected]'blil r;i~gi;'@$eQ~Gassie~t:qtivo in cà- mani n~ll&stl~%kzì-&e~di con-. di$$@&qu@yqgb, i i s t i c -a@~ traittikcoJle@vie azidnda!i; s'emrid ~ d & t ~ ~ i i : @ a ~ iia:~pg 9j ~ td@cnk"tf w ~ di"prop~-tzionalit~~e.ràil m~ti$'cbrsl dbnatrimmii pcil- gianevoleua, mmg del.reato:.$@ g&m?ei;aleFr$nZia:i.jl:Relgigr~ #yqiene; con3ne. d.e8isiurwr~a no iritedonate a lih1f$#dlrp @@g,&aI]àyto,~~~cbI@ica com. pubblica attenuato, riai?*,'$@$ pe€&iìtb $ipotebB0 rLcpnoswre I@# "p &:S@ldca airellalum si ai versettidi Cor. 4<:3,e @oI~& 72-%-> . 129, chesembaano kansiplgge yi!rpus in.pw@oned A ~ y e ancheal musulmano,la rntfog* gfti~$@<difeaipit$islamich~dgl 4@?aÌ&tifinè deI-kqrtiad&~) edel rnia,come !scelta m[gllorelQ !.i%ar ha , ;lfiliè-d*) &e,gi&d&; ~ r a a ~ ~ ~ ~ ~ ~ , t a . s I * r a n d o- . qaL@&x qarlai8.dai. c+?stisocialj delle %- - gid:altaM$ca). miglie pofig~<&hp, -$@I@&@ In ecc. una conquiOh'altra,nqrìia .c,prapi& in -n.sfaJ18Ifini d ' i 'lhtebi-a'rianb,"il traat~$qS~~,!,Po~rdirqu bbligsgs,jqaa ai- ,yqtg,$nd~cale, ai$ai,wns-azJ6ngnita-8'la parit8 .dijirji\l ed@l~,a d6 ~ @ f i ~ n ~ ; ~ 8 r - ~ a ~ e r t u r a . d ~ l u o donna, il d i r ~ ~ s t u m d$lerigtiikdi+ògMp,&$%!ci i~fpbgriga p,udio, che in Italia non ha wr$o C@, dop'o.'annidi,diba€til~sulla legab mentre ne ha lakpratica di ' Y.aici@' del Iyqgo.~llavom, reinm u q u l m ~ ~goprattuttb.maroci, hduce m e m i d i r a p p a i fra m R%!l m a, A-*? < V : ""s ~I:E~@YIP! r -,L Speciale Intese - - ligioneeaziendaotisaieti, da K lato, a strumentali dall'altro, che si rltarcono nello sfruttamento dalla produzione del lavoratore- NO$^ $P~lorl e48'1 i q ~a oPiUnfacile i sembrano seconroluziane.r e no fsglbvrlsolte. Anchq senza I'lnte& lfifat41i~l,mu~glfn~ni in Italih g d o ~ ~ d v ae:q$Tqlosi. ri diritti. in m8teriadi li&&&el~losa l e ai L $:I@: '4. Mgltir ci#&iha~.rn#@&~t;l~te +.$& , .:, aree L - 1 . ~ a y i n à & ~ ~ ~ imore o n e islamico, per ottenere carne halgl, B consentita, in appositi macellatoi, non nei cortili o nelle case (L. 43911978: L. 10111989 attuativa dell'lntesafra Stato italiano e W munità ebraiche: direttiva C.E.E. 11411993) senza obbligo, per lo istituzioni, di servire carne;halAl nejlemense pubbliche, perchd questa prescrizione B oonsiderate.un atto di libertA religiosa ma non rientra)negli atti veri e propri dl ~ultp. &@eriali;sgparbterper .. $rnusulmznnr in cui seppellire i-propride- Alcune prlorltd funti) sacqndo il progriq rito e le Penslamo che, qual1 siano gli acproprie n0mi.e @nattilazionedel cordi, !!Integrazione pub e. deve D. P. R. 2851-1990, art. IOO), nel rispetto delle norme d'igiene di p ò l ~ ~ ~ m 6 ; ~ ~ a h % ~ ( l a in 7~P61tum iGliàja*ìgpe n&iia~~dssas%non 93 "- n .- * P Z*. cf?e possono facilitare,-in-tempi non brevi, Il riscontro delle condizbnl in vista di un'lntesa. Anzitu+ to, la questione della cittadinanza: l'Italia dovrh studiare condizionl e norme per accordare la cittadinanza ai cittadini stranieri, sull'esempio dl altri Sta. auropoi. che pub determinare I'assunzione di responsabilità verso lo Stato& la sociea italiani. Rlcordla-moche questa politica B seguita con un certo successo dalla Francia, anche se)son~molto differenti i rapporti fra.Sta2a mreligioni. Imsecondo luogo,~blaognafavorire,.coF u n ' a p ~ i t a .e wulata Ieg- né~leiuola,*~m'&~ionsu~~ine nei-palesi:a maggioranza Cslami- -1- ?.* 1 . , I che potrébbera essere interessate a-ricevere alcune còpie omaggio. ~ r a z h ! , , , : , i ,- .: . , T , 1 . ..* . . ,bl...i2,? I , . 3, , ;,l, - L , , , . , - .i,:', t ' 7 . . l ' ^ . 'L,.. . - .' , ., , . , , i - -no+Vr !:.i: ' - # # : L -- m . i r . . . . . , , i ",l, - 7 1 ., - - Speciale Intese - $ ----- 1-1: -- --'- .,. -_ _..-- W-. -.--W --.> --,-n . -1 1 3 -.E ammessa i.-. C > - I ma dl Trento applioa giufikhiite -t%ndlzlgnl per essere %ti riferimenti cdranici non di la legge e non pub introdurre un nella Comunità Europea. Non ci condanna ma di pace: 'Non C'& insegnamento currlcolare della sentiamo defraudati quando, con ~ostnkhnenella religione.La mfta religione islamica, per Il quale B tutta tranquillità e fierezza, un cjt- vla si disflngue dali"8mireM(Cor. 2, necessaria una modifica leglslatl- tadino autoctono pra~tamala sua 256), lasciando alla coscienza il va. Ci sentiamo però di auspica- conversione atl'islhrn, ma siamo difflclle compito di discernere; ' A re, anche in questo caso, un ag- defraudati, perdna a casa nostFa, v01 la vostra reI&ione a me la mia' giomamento della legge itallana. perch4.b stessa tranquillith 6 ne- (Cor. 109, e), detto non con diInfine fa riflettere il contenuto di gata ai musulmani che cambiano sprezzo o con desiderio di venun'lntewistarecentemente rila- religione. detta ma nel rlspetto del mlstero sciata ed un quotidiano italiano In proposito, sebbene la notizia di Dla, che CI sorpassa, perche da' Mtìra, d,onna. maghrebina di- abbia guadagnata due intere pa- "SeAllah.avesse voluta, avrebbe ventata crlstlana In Itali* 'La gine nel Corriere delta.Sem (3 e 4 attodi voi una sola comunifd. Vi Chiesa' di& Nura - non ci da un settembre 2003, articolo di Mqgdl ha vqlujo per& provare con quel Allam). non drisulta che nessun dia vi hadek G a w aaie Inopeimàm italiano sia Intervenuto a re buone*(Cor. 5,481. tradkiorassicurare Nura e gli altri esuli ne islamica ha qrientato In senso dalall'isl4m. Vorremmo che, in un rest~ittivo,fino ad oggi, la spiegafuturo prossimo,l musulmanl ita- zione di questi versew: chissà che Iiani considerasséro, In pace, un vento di rinn-ova.mentopossa questa posslbllitd nuova delle so- spiram tra i riiusujìì,ani~ii.€aIia. cieth~luraliste,~eprefe.r.rlssero qvocàb quei*paniqli, ma imporT.N. L cerazione. Il diritto islarnico prevede ,wrnunguq la morte ddl'apo&+I@, cpnpanna la cui ~ y c u g l b n e un 'ohtili@' d&J.'si$gojo ,lomusti mano: iiì co'mprénde nioTfò'ò't$g cHeil convertito hniservi il silgi- L zio. per non Incwriere nelh.videi za 'ieIigi_osaldel fondamentalisti. Nura'hafatto gppello, qlla Chiesa. Mons, Fikgerald, pres!dente del ~oh@cioConslglla @r 4 Dlalpgo lnterreligiaso, ha rlsposto asslcurando che la situazione delle p,ersmieflpI*rpe !d'sonouna preoccupazio~qpGs@$e dellllaCbiesa.int $$a @ {d,e,le a p,a. *M.ala C hi s ~ a ceCca,.fl &Br@u$d,e,re,nqn p,u8 im- R . pÒk6, Mons,~Fi~Qecald fa~oornunqyp,~n a++nrl~-i@phfià"iits. @la, l/b,eML rel!g(oea, Re t sensq@i li beir,t&;;di dedidem la propria raliDion~,,che SI [email protected]~ es!~ebq,~ld as,e m $0 dalla ~$kch[a,cd@auna delle 1 Speciale Intese STATO E CONFESSIONE ISLAMICA: QUALI RAF?PORTINEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA Sono attualmente tre gli Stati eTuropeiche hanno* @#cialmente ricayiosciuto I'islarn come confessione mligiosa SUI piano giuridic4:Austtia, B d g b e Spagna I rapporti traqStatos confessione @#;n . Yimpegno dl-rispettare I v . 8 )'attu@one di ,p$per l'in-ligiosa musulmana .nei diversi pl,~~a~~smo'~;ins~em4~cu~tÒdiCe1a sq&ii,f $ ~ ~ q ; ~ ~mu~ ~ i ~ palesi eurqpai son.0 differenziati. l a i c i ~ ~ d ~ ~ l i ; , d ; , ~ : ~ @ k i Z i.o n d ls~i i l b n q ndle ,sc$p!e. L&rdifferenzesonodouulesisai I ~ " t e ~ k ~ ~ ~ o d ~ l l o , t i p i ~I n ~ ~g~g~lR~p~o$dfa~l If.~l ~~~ ~ + & s t a t o F o n diversi madelli"formali con uri lo piiites~$~ssg@bbe,@~~@flqfeti@ ricon&dtpento .ufficialealStato gesjisce i rapporti con l'e todalla-i.id[i&@~I!@Stato, cuiLfa Fi,s]B~; senza p%faltrb,rluscire a confessioni r e l l g ! ~sia , alle mn- perb$s&ontro il rf&'ndscimehto ,dare.attuaziong omanica sul piacrete siuaiioni della popolarlone e$afa]eXdellalprpg$nf&~dellh relino concyeto,a quanto pmyisto:da m us-uimana~lo.caiee ~la lsua ca- giopi.erddip IbrninizIatlve:educ$ h18 iloon.cplhentp (ngoia~enpaci&di prodine una rappmsen- tive, qaelstqnziali & c u l t ~ r a h ~ l - tazl$ne.de Pvle dell'im8m l>n tanza aredibile, i'ambit~,~d~la-societ~ L ,, .*-- ++. civl!~,per quaiiwdi mril+o3di cuih, Riguardo~~m'odelligiuridici.chs &[email protected];finan; m~~agliimA~i$ilf;'&la~shtlill~ presied0no)ai,ràpportI tra.SW è z&@&:@@&a1i b,%@rif@ssioni statdfa&iuiidjim di -ldb(lo.di &l6 oonfessio~kreiigjbse in Europa se r&llgrd*é*lnq~ahtb"Wi~kome In &li& moscheerin m~n'canraoi ns,~ossgpo;idenuSicare tre.. Il pri- Germania, o a struttuuna rappresentanza mo,,.tipjgo,d,ei paesi cqttgljci, co- re che 'da loro'emanaunilaria in grado di .me spggpagnss Italia, .4 il modello no come. nei Paebi LO spagn~lo &s$rlmere un vuIto wnco~da [email protected] .second,ob rap- Bassi. Questo;m.delh, isfirionallzihto della presehtat,c&l. modello francese, lo B caratteriiato dal confessioiie islamica. ~asat~~su~ nbtta u n alaicità stata- . rieonosclmento d l à 0d1992 unfIn#esa Sono resi l~,~me~Il'tenomodelloBquelteorlmsia.pratimdel 'Gonla&mmi=ione esecutivi, sia pure 01. ~ g g ~ o l a r i z z adeg!k$fati tg~ a pluralismo religioso é ISihmica di Spagna con .difiì^itg,i wrsM maggioranza protestaqte,_cyiB da .una p r,onunciata reIQione isiamica nefasslml~ahl~e jl ,pttollco @l&o: decentiallzzazione 'le scuot,e, la cui geIl rnodel~a~o$n$ofla~r!o prevede nella sua gestione. per cui ogni stlorie P stata dapprima @%"data il riconos,cirnen,to uffi-clale delle mtifessione esercifa un ampio in- ai C a n h culturale Islamiko di t)sligio~:da~parte:de1Io2Stato(tra- sìeme di ruoli e di fuhzioni previ- . ~rriid&^s'; su-sihirièrifb a irn m.?& Goncordato.con la,Ch iesa ste n'el contesto legislativo *taapppsito 'comitato fomat& ptessa ,,@pa)jc.a e<lnme.con\e.al,tremnle,senza intervento,diréWo dello il Minisiero dell'ls'tniziorie belga. fes$bn,i &o~m.m.~wssioniampie dato-$~dn'nriiere~,taId pìiuthlishd. Lo Stab spagnolo ha Invece st'k .dal,,@~to~.d,b$&ta gfurldico e+@,"- A parlireda @le ripartizione in difpi$àz~~l'lntesa~~oh'I8 Cornmissic~ s t i o ~ , e ~ h degil d a affari fepnti modelli.ci si'può*domanda- n&.lslarnlcii:di Spagna~n'eli992, r e l i g i & i- .~ ~ ~ ~ ~ n m f l a t arer &me i o siano stiutlurafl i fapportl ahehe qul scdiitrand&i 3Gbito S I ~ ~ ~ ~ di ~ un~ peso ~ I dei"Y&flrr'3tati O ~ P .éiiropai ~ Qdon ~ l a;&m~ dopJocon<mdte difflcol& PgLr l'a molto&~p~gél@\@~Q~a~6a~llca, pbBMehbsuldna. AttuaImiht$ sua*att'ua~ione, a causa d d soran e!:~$$'~&?f &s_@q leI s la.io irdaaiigii Stati Burdpéikhq gém di rnnfljtlual~i& tra [e due or&~s~i & ~ ( i c h i aa~ ~ no:~fficlal~"e~t'~~~r~do'nò~ci~fo'~t'~@"Pihrioni avevano-dato S ~ a l i f i e i . , s ~ bl i~-. p r i ~ d # i ; ~ ~ ~ D ~ ~ @.-$ ~ ~ d6m a i -wine?-cOif'W'sldhQ @d re:i'i$osa ~6rl@Kb~kI]I nuovo fedsrazlone iC il s e ~ f i ~ - $ L ~ & $ e l l $ 4 ~ d $su! n i piiin.0 l e g i u i i d i ~ : ~ s l s t ' ~ ~ I r ' n~iiììcfg ~ o ~ -Ei ut&6&me espressione con la, Eratg!zr&! b & ~ % t g una ~ ~ y din&di témpo, diAusfiia, geigio e i&4nluzioriàlizkatk della mnf&$dne. ; s e p , a ~ q r ~ d ' ~ ; J : ~ & ~ t oSpag"-ii"iI Ie81 ne ISlamicafinSwgna. confe&bd;@~gj$w-. La$$p~ti~ne aj r fSW Ù iI 1hrrap@rticon I'lslhh soDa questei sinteti& presentazlodel b i ~ 9 $ p ~ ~ y i @ ~ ~ @ ~ n6k~olatifda~iina-~~e~hìa11e'g@ ~~~s,ab~~~I' ne-d può.immedialament¬am p l u l il Q deII'biFjoca:d&U:lWp%wauWun~ comeah in Bdglo sia in Spagna, p,ub,,b"(iqoe!!a.ij,b+q plivata'sla davi&; in-M*?lla quale gll'imhm Il rlc0n&ciinem forimale conferi~ p,er i,quiti, sia;p& gl,iacJndividui..Lo e le-m;o'schekchesbno a'nilrafe'a toL~lfa"'c~iifessibne'i~l~ica pfcl stato $l;inil);cné cbtn'8rar4jtpper un$ sveoGifi% fddemS$nner~~onoch@kpi>re&nb&' un&s'oìu2jbnb d+ia& .cib ct%& ci iegMmo o Me- ufRciai*ribllico~ufi; P%FP~'@àr~aniosai ia $p@ti dive" u(o -. " . v y: sfipII!lab mi- 1 < , ' 3 I Speciale Intese damentaliste, assai diffuse tra le moscheexIn efietti anche la scelta elettiva'risuita insoddisfacente, psrchd ?involge comunque essentidl rn;e'ntd+le> sUrnga,t~Qn$pM . prat~qntk@i"e&pws%diolh&~ gqqitano:lntorno alJemoschee, mentre la grande parte della popolazione musulmana rimane estranea non rappresentata. Infine-un' Itim$.osservazibne: sin tutti ali SMtl~eu~bei.~enche in assenza di hgporti istltuzlonall forfidliWhqla dbnfessione musulma&~Bj@ipk$m"s:fits,gSrcrnt'h:aj -mu~~da6Vil~~~ifiift&~aIh4li~~ ~6i'enzhe4i rdtigiohe, fatta salvo Il:rlsp;etto1deRordinarnentogiuridico é valbdia1~"fondarnentaI~d~i dlv,~mI shtFeirope[. L'applicazione del diritto comune~lhmodo cre'atlvo ha permesso anche di sddd'lsfa're 6sIkendb.tl'blbh'e d d ' ,. V .'I - t h~h~~l~ahi;qA~~ì#~~)~~p di'bài@ir~t~t~.$ft~nii~e~t6rd I"njs@rl~~utoe:delloStat,o.belga~ p a + ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ J f ~ o ; i ~ i ~ ; , 4 d , fonte . .. -.. * I , I " . ^ dT:nu~$b pb~b.lqmli,collegati ~ l l ~ ~idrfl$alt& t o ~ lq$i,stes$iialliln- . W,.Pf.La L Talti~,~~~a~~;lJifi~~ELgna < $ <6fl$~$*n~,ref~'i4 it,e(tlp3%d$l S E ~ ~ Q ~ ~ uhlmgna D ~ ~ @ S . M8ij:ryi~tod a l ( ; r l ~ ~ ~ ~ ~ s ~ i m e p t od~bhl fL ~ ~ w ? J ~ J , @~i+qy & ~a/G eta' u (ckgdeilqis!h,~.in::Franc\a $~vec+ -.-, rit$pp 91fjn%@.PK@M~L~F rap>pc?!@e uni s!g~glpA:-qmOl,i3:nr$ ~ ?tk + ,k$$ainmmn tq~xg~&ajja~Ig;~s,tqbU@ ;rbalmgiite' a a s . r n a e ~ ~ h ~ & ~ ~ ~ l ~ ip? lentemenaconpulti~o~~~an~Ne: ~dr~~u[~~+~~j papp~egqnfatjvq, ,della&asa:, A p ~ ~.. Di f$Snte. a a q y ~ ~ ~ h d i f f j c o l t b ~ a li~qrsi ir a t l ~ ~ : i / p d m o i o b i e t t l ~ ~badig$qgi;:dmihI'uw~fiia+pbhi stole dal gov*emo,frqrice,sar,B sta; , sta tij! ~on;i~i&Belg,ip~~e la Francia, , ,:, hggn~qp$ato~ps~,usa soluzione aflw~ f q d > jlit$rmaEiao rigsuiLlg:S4atpha: W - m i n ! t , ~&i:g~n&li i q yi;spQo s,W9 wgpt~#g @!!9~a~j@aW!l- maqeGqhpfiestigJgg4~gpyuqi5 4 p ainMtiVo. ng~,[email protected]&~tp iri. r@ppflodaq ueatiqnl ~rnnc,r@nt,9 p~11wdqJ~lii ggpplad~n~tw wu1,r~13n-a'g4a&~@20I~IIIW~. ~ w g t g ~ w i &s,%,\t*i . qn!,ultq !.io~epey,~Jy ziqng?,siqjn Belgio sia in F ~ q ~ u ~riqpqktJya,mmqp,teCn91 ia:~ 1~9..)Te"nel~OJ3~z.lorSta_ta-ha,p~gagizzqto.pcgeqito .un p r o ~ s s ò eJe,ie~-9lqqI,tfinedj. o&nerq:una a~~~lie~~hr?~<~~9~bana~~inwJgq~,&la :wof~F.@~pe-~ M ,di..!+ della;s~rnig!i~~~ n~l~qpziqneytdelle- due T- t ~ _ ~'ef- gGo$'i>~ , $o- &,s,embl~~~e!qftg,s~no-,tuitayia gssai$Qyersp: Int?elgloLl$&sem- ts.l&,3ig:g~ma&za;dj, w m a l anj~go+~ic,qoq~imes3.tg:fo~@a_l,e ;oonf~~tss~~lam:'~~sf$yi~q~la @t?mqn:@twiqugl~e:.bsUa q@pq confessione musulmana, ed 8 I Speciale.Intese 1 MAPPA DELL'ISLAM IN ITALIA -: *- - L - ; !>..* I $e si calcola la popolazione qiana in 57.440 .O00 cittadini,;& $ossibilequantiflcarelapreserua d i minoranze religiose in ltalia'in .circa 1 .l 00.000 unità. ossia :l'l,92% della popolazione corni iplessiva. Se consideriamo i re+ denti sul territorio - vaiutati fra 59 e60milioni(cifrapiùincertaper \a difficoltà di precisa re l l datg. (dell'lmmigrazione clandestlna) I!la percentuale di apparienentl a :m inoranse re1igiose sale Intorno ,sfiqyrnente wllegataal fepomenb delle mlgrazionf internadonalI, malla, e Sud-Est asiatico. Se I primi Im~igrau",negli apni 1960, c?ehqr~~ointeréss$oihmqdo een~ agvqti soprattutto per mor cregfieUqte'$riastrq'.Pa'ese negli tivi di studlo e rappresentavano ultlml q ~ i ~ d i ~ < i i i i ( . p t 6 ~ n quindi d ~ - una presenza culturalmente qualificata, negli ultlml decenni ne / I ~ c o j ~ l g ~ t Qt~ufbi una, ~b~j~ tratta. nella maggioranza dei s e r i e . d i $ i ~ ~ ~ ~ t q a jbocikli $lp ? quJtp@[email protected]~ $o,(s,Qqbvq mka- &si, di persone bisognose di trogjg~.~fl$&&~~~p~.$q~~ vare ~ n un & ~lavoro, & $ anche di livello ~ o l t basso, o per sfuggire a con'EQiopeC r (Aa-PBcini, I pdkglmdi crisi economica molto d$.]qia,? ~ ~ q a t n i c h ~ & $ f ( [ ~ ~gjzioni I r t e del proprio paese di origine, @,$eI:p@c&j3si dj intera.q@e+@n 'ran'6~1etB, & le @tuzioni italigd,, Sono espressione di questa &$ililo Ferrari-[a cura' dij,'$fuyealt8 molte comunità e centri rilevante e la su/manl In Italja. La condizione 6he tentano di radunare e indlrizg i u ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ! ~ ~ c ) r n u n i rare t a i sgli l aimmigrati, mlspesso senzal volume dl Roberto Gritti'e Magdi %e, Il/RdllnrB,Bologna 2000, +ndI successi. Infatti pare che il Allam, islam, Italia. Chi sono e pp.'21*2 [pBp.'2llj. maggior numero di musulmani cosa pensano i musulmani che SI calcala che h Eurdpa slano non partecipi attivamente a questi vivono tra noi presentl fra i 15 gruppi, restando legato soprattut(Guerini e Assoe i 17 milioni di to ai suoi connazionall o creando ciati, Milano musulrnani (solegami con altri immigratl che 2001) cerca di ia presenza is/&ca no più di un micondividono la stessa cittadina o dare una descriin & un fenomeno liardo nel mon- lo stesso tipo dl lavoro. (zionegiornalisti~ ~ i v a m e nrecsnte fe do). La stima dei L'associazione più rappresenCB, ma assai ben tativa 8i di gran lunga l'Unione musulmani con Inforrnata.Tale Se~ara~Onatoaquella cittadinanzaita- delle Comunità ed O r g a n i h n i presenza B ultedi Paesi europei, iiana è di circa Islamiche in Italia (UCOII), la cui riormente precicon tradizioni coloniali l O mila unità, dirigenza B d t tipo fondamentalipiu ampie e antiche mentre la pre- sta neo-tradizionalista; importansata (anche se con taglio polesenza di extra- te B anche la Lega Musulmana delle nostre: 'mico) dall'opera comunitari di reMondiale - Italia che controlla la del socioloao Gran Brefagna, liaione islamica moschea di Roma ed B legata alt Stefano ~ l l i & i Olanda O Francia iiltalia (clande- I'Arabia Saudita. Altre sigle come tslam Italia. Viagstini esclusi) 8 dl la ComunitA Religiosa Islamlcd gio nella seconda circa 650.000 Italiana (COREIS) hanno una vii religione del paepersone, anche vace presenza culturale, ma un se (Einaudi, Torino 2003). se i risultati del recente censi- numero decisamente minore di La presenza islamica in Italia b mento svolto dal Ministero degli aderenti. Si devono anche r i m ~ un fenomeno relativamente reInterni potranno presto fornirci dare le confraternite sufi: la pio cente se paragonato a quella di dati più attendiblll. organizzata in Italia 6 la Murialtri Paesi europel con tradizioni La maggioranza del musulma- diyya, cul appartlene la maggiocoloniali più ampie e antlche delle ni immigrati in Italia appartiene al ranza degll Immtgrati senegalesi. mostre (Gran Bretagna, Olanda o mondo sunnita (una delle tre diDecisamente minoritario, ma non Francia). Si tratta di un processo ramazioni storiche prese dalper questo insignificante, è I'islàm immigratorio le cui origini remote I'islhm nel 661, pochi anni dopo sciita, presente soprattutto nella sono state egregiamente riassun- la morte del Profeta awenuta nel zona napoletana. L'islBm sci1tq te da Andrea Pacini, direttore del 632 a Medina; le altre due sono trova un suo naturale punto di ri'Centro Studi Religiosi Comparati gli sciiti e i kharijiti.). Provengono ferimento nel['Ambasciata della Edoardo Agnelli, il quale ricorda: In larga parte dal Maghreb, con Repubblica Islamica dell'lrad "'Il progressivo costituirsi in Italia percentuali non insignificanti pro- presso la Santa Sede in quanto ,di una popolazione musuimana B venisnti~daIl'Aibania,Egitto, Soi'lran è l'unico Paese In cui lo sciC - SI . , L Speciale Intese smo sia non solo maggioritario, ma anche relÌione di Stato. Sono inoltre presenti nel nostro Paese alcune moschee, quattro in tutto, che rappr.esentanopuntl dl riferlmento fissi per tutti i musulmanl. Sono la Moschea di Roma, quella di Milanp, quella di Catania, e quella di Pa,lefmo(di proprieth tunisina). La koskhea e una realtA'mblto complessa in quanta deve essere costruitasecon& regpla la cui origine vien'e faftari~aliredl'rebva@alProfeta e svolgono: o,n(r$,glonon solo religioso, 'm'à'Si&Hb-~ociale,politico e gi,undiw; Co@e :bqnp W s a lo studlosp+gesulta pad@S,mirKtialil Samirj 'la per affrontare tutto ciò che la rlguarda (.. .) Tutte le decisioni della comunit8 vengono prese in questa sede (...) considerarla un luogo di culto B sbagliato s limitativon(Centodomande sull'lsla~,Intervista a Samir Khalil Samir,, a cura dj Giorgio Paoliuccl e Camljle Eid. Mqrietti 1820, Genova 2002, pp. 144-145). Tutte le altre "moschee" (oltre duecento in Italia, ~ecop$oAillevf) "sonocosl chiamatein modo Impro,p~l'oInquantoinverltAaono salb delle semplici sale di preghlara, anche ,se il nota caso d l viale Jennar 3 Milano dimostr-a che anqs i? q u,este "semplici sale dl preghierà" dl fa spessa polif. mos~hn~~~~n,$.~s,similab'ile sid ca e non sempke ccb'n le regole una chi5ha ~iTqtiana,ma rappre- d,ella democrazia cut n"oi siimo senta w$ttsa, dl +n;ipk@mente abituak e radicalmefife dlvbrsd (...) il luogodore la w'rhuniC sj iaduna ~ilviiafnhvigne ROMA, L'IMAM PERDE IL POSTO I/ confronto con le comunità musuimane e inquinato da frequenti polemiche. Clamorosa quella recentemente scatenata da un sermone nella Moschea di Roma, a sostegno dei combattenti islarnici Cresce I'islam in Italla, divampano l e polemiche e si moltiplicano i nodi da sciogliere, Una realtA che nei nastro Paese conta un milione di musulmani. la seconda religione in Italia. Mentre si discute sulla possibilità di stipulare un'Intesa con 14 Stato italiano, si moltiplicano gli spunti di dibathto, poIemiche e frequente'tensione. Fino a pochi mesi fa, nella grande moschw di Roma c'era un imàm che invocava'la guerra-'sa"ntta:contro i non m,usulmani. I suo1 sermo~ l a diocesi ni h a n n "incendiato"' del Papa. Non è certo un caso isolato. perché da un cgpo àtl'altro della penisola numerose moschee sono in mano a jslamici radicali. La predica contestata, venerdì 6 giugno,~eciiava:YOAllah fai trionfare,i cqmbaftenti islamici in Palestina, in Cècenia e altrove nel mondo. Q.Allah aiutaci ad annientare i nemici .~,elllIslam.O AIlah assicura ovunqu,e la voce della nazione 'dell~lsl~ìh~; L ~~~~~~~~~~~moschea di Roma Abdel Uahmoud Ib,rahimMoussa, egiziano, 32 anni - per le pàr0le pronunciate ha' ricevuto la solidariet,adi vari esponenti islamisi in Ijalia, legati ai Fratelli Musulmani e,alle:,kdrreriti di pensiero radicali. M~tti:~e~~$ii,di y l t o islamici oggi in lialia son$.qccup,ati da gruppi integ~alistiiklernazianali che la magistratya lYY%gssso portato alla luce. [ls$rrn9n@ &us>sa, subito fimo"b6alB~$in$griboe~risp+di- [a guerra santa e dagli agenti di interessi stranieri in Italia, pio contenuta la reazione del Vaticano che tende a minimizzare ['accaduto: "in fondo sono cose dette in una cola moschea italiana - commenta I'aj-civejcavo ~ j cheai L. Fitzgerald, presidente della commissione pontificia che si occupa dei rapporti con I'islam - a dare eccessivo peso a un faHo locale ci corre il rischio di comprometfere il dialogo". Bene la prudenza, ma resta il fatt0 che la m&chea è proprio quella dj Roma, la diocesi del P,apa. Inaugurata ne] 1995, ha il patrocinio>deigoverni arabi e copkttutto dellJArabiaSaudita. Lo stess<o imàm che pronunciò la khutba, [a predica, è stato inviato a Rom-a dai teologi della grande università Cairo. ~d da rjdi al Azhar cordare che il precedente imàm della brande moschea romana, 10 sh'eikh Mahmoud Hammad Sheweita, temette per la propria vita quando condannò gli attentati suicidi, 'suscitando l'ira di gruppi radicali. CosI,hanno reagito le comunità islamiche in Italia: la Lega musulmana italiana, che sostifui subito I'imàm i neri m i n sto, definì " un peccato ai giovsnto* il proclariia di Moussa; sono parole di Mario Sqialoja responsabile.+lla @once-ita[ianadella Lega musulmana mondiale, Per ~imza Rob,èrta = piccardo, segretario nazj,qnàle dell1Vcqii(Unione d?lle-comunit&' to.ab ~(&ha?~ddnfenWaincitam ~ n t i ~ , a l ~ a ; ~ y ~ l , ~ ~Fra:~ a a ~ d.oganizzazio,ji ~ ~ ~ o d i o O 0 iclamibhe ifi Ita[ial '[si .è I,anciata contro I'imàm si ch.e .hàn:rib+:5at:Qn4a,t'p;;yna !alanga di:pfotdst& Moussa ,e contcq,i musulmani in I&[ià una vera e propria caccia alAlcuni e+sponeriti:p$l@ai jtaliani' rile st.reghe de,gna di tem'pi -che terinero ,q.uelle;p,a'rola $3 cbi$rà istiga~ione~àl~à:à:3~lèn'Z'a'a'a'~i~~d~r& sperayqmp'fifiiti per sempre. Le ds[l'im$m possono piamre il rnia,~stfo<;dbgli lntern'i.Pisan~,~che. paro$@ o+m'enoe tuttavia fiorrav,visiàma ha bkies,t~l'alloniaaamentq dei: [n,esse nessun crimine legalmen"predi'catbri'di vidle"~?2".Le mosikeeita~iane,,.:affer~~&~dev&no, tepersèguibuem. essere Iibe~ate*dai~reclutatori'del- ~ 0 ~ f i u n ~ sia, u - e il fatt-0 romano si ' inserisce, l0 scorso mese di giugno, in un cantesto di crescenti tensioni con i musuImani che viVonoP transitano in Italia e che si mescola con il dramma delle carrette del mare che riversano sulle nostre coste centinaia di disperati, in gran parte musulrnani. Secondo gli Stati Uniti, l'Istituto CUIturale islamico e la moschea di Milano sono basi logistiche europee della rete di al-Qaeda (accuse respinte dai capi islamici milanesi). Le autorità italiane avviano controlli più rigorosi nelle singole moschee. Qualche imàm finisce in galera can l'accusa di sospetti legami con gruppi radicali islamici come accaduto a Cremona e a Firenze. Le minacce dell'imàm Moussa hanno suscitato profonda indignazione anche nella comunità ebraica italiana. Il Centro Simon Wiesenthal ha chiesto al Governo italiano l'immediata espulsione di Moussa. E non e finita, perché il confronto con te istanze del[a comunita musulmana continua sui banchi di scuola ed esplode il giorno d'inizio del nuovo anno scolastico. Teatro della vicenda, un antico borgo in provincia delllAquila dove scoppia la polemica per I'iniziativa di Ade1 Smith, discusso presidente delllUnione musulmani dYltaIia(quello, per intenderci, che fece a pugni con un giornalista in una televisione veneta nel gen- naio scorsb) di mettere a Scuola, o l t ~ eal crocefisso, anche un simbolo islamico (vedi altro servizio su questo Wmero della rivista, a pag. l 1), Le autorita scolastiche gli negano il permesso,e in questo sono appoggiate dalllUnione delle comunità islamiche in Italia (Ucoii) secondo cui I'iclàm non ha simboli da appendere alle pareti delle classi. Filippo Re Attualità .. LA PACE IN IRAN IL "NOBELI' PER La scelta di premiare una donna musulmana - S;hiriri Ebadi - av.vocatessae paladina dei d i m umani# une pro~ocau'oneal regime degli Aya Wlah Un Incorqggiamento all'islhm riformista: il, Nobel per la pace B stato.assegnato.questmannoa Shirin Ebadi, avvocatessa iranianaipremiata 'per i .suoi sfoni per la.democrazia e i diritti umahi*, comeB.scriito'nella motivazioiie del Comitato norvegese per il Prernlo. 'In una epoca ,di violenza ha d i f e s ~ la nori;Uldenzam,, hanpq aggiunto I giurati mn.un. eyid?rite;messaggi8squanti?nelrI'id&rn;predican.o-e -pratt@n7o;i! temre. Ma'i gkrati hanno anche( voluto sqttolin&&ire,lasua dichiarata apparten'ensa alf'isliim: "&' una m.usulmana consapevble w, vede cgnf1iftb fra l'id~+e i diritti umeni,fandamsntali", ; 11Fre,mi~ Ma si %n? donna che B wrtqdet mondo is1amigo.e dixui giurista e credente - 6 proprio se che $stato:definito "la madre dimostrare come la lettura del- di tutte le ieqcraziem.Shlrin Ebal'isl8m d ~ lAyatollah, i (O almeno di, primqdonna giudica in, lrein fldella 10ro"maggiotanZa)sia yna no al 1879 quando dovette ab,sovrastruhra *khome[nisW'~ 'se bandonaw la,cqrla dopo la rlvw, leggét0 il Corano- ha detto - vi luzione Khom~iritsja,Fa sempre accorgerete che non c'B nulla qtrenuamente difeao%la sua5idea wntro,i diritii umaniP. dj:ls[hm pl@is@, dlalettico,&lT I ns<emna; un ;pr@~l@*itamenta l$ ?dii ~'-k#i~j~sqi&~ro,n~~ alGrn"b%ll~8i.a~ uriWdi??iWnt' & "* I 8 hp ~&gi&~F$m&J1gOs~08 Ma. Q * : -LI u~g&~!plhtgrn~d*[i:~iyf~$$~@$e&&nf&,,$jgri, ~DJidgnnatoa . >l e L+a.: il ,ma@d~ i'slamic~de,ue,anrlare fiaeo$::gqctonda;i 'giur&fI.s,aprà 'lapira~~~,umti:.si! battano'Fer i' dlrlM umanl ,la demoaazia.nei loro Plagsi, nel'rnonda,is@rni~e inrjufti quej [email protected]!i lotta pw-@ir',i.tti ri aiani:ha:gkoqna di ispirazipn&e -n$ *. 6.sjqasdEbgi; da'~a.@~~~,&&. h a ~pap r s s,~!a ,notizia.d,@Lpre__rt):~ ,e . gloso:,ri~n,o~rgl~mento~. ~~:VQ[Q~Q s~ttol[neare'qhei":sj$u,62~~@re ; hf@p!$manfe s o s f e ~ @ l p d ~ m ~ cr@ig??!.i2avvocFites,sa,lcanlani pug;pssecq 8uj:esempi~ O y i ~ e ~ t,e . P?~Juft?~i frt!,~a& ìslamicq. nel qqa le$p $ p ~ spp.$'si)o *> sjppp.a che+@ l p ì p p ~ n ~ q%n.d+n+ al 1&$0;4a; qu~n@~rnénoi~s~u!~q~~a dslta@dsnig.:daodape~ss~ntgta u n'a,o'@pp$iziane:r~l d t&al'mf~f ra rn0nctwm'odefh;i~e~religiona~:sec6@~oGii:'@ddè11nnn~ia visto n& +~~6aWj66&idegp, , ~ $ & . ,, shJl~€b,adl-- dh inf&~ett@aG; - -. -- ~ t t u aitàl > - - - - ---. ---- . - I I morte nel 2002 per blasfemla? solo per aver difeso il ritorno a un IslAm autentico contro i privt* legl del clero politico. La dissi? denza in Iran 12sempre sa: questi sono, infatti, temi che animano il m degli studenti. Incontrare Shirin Eba mn non 4 difficile: riw ti nel suo studio in della Teheran alta. chador, stringe la m mlni. Picco'a d' 5 distinta accet- a w c a t o . Attenta a dimmtrxe Dariuoh Fwuhar, trovato ucciso insime alla moglie, ndl'mbito ti dei pio d&&. Ha fondatu tlAssmbzione per i diritti dei h m - Shirin EbAi si h re di a dispe me, Shirin* che in fica Quan rivoluzione Kho costretta a lasci I 4 P - L p < k ; -- y .. t T L w x r - -L . ll' A t ' l LI l- Attualità -- - -e-.. ...tF--. A .<. - - -=T --7 7 -p -.. - I . sarh aldi sta di ~pìiprimire,ilpbprio giuditutte le s s r n u s u l m a n e con- cista polaooi temporanee B se I'islSri12$lao volh di una rivoluzione liberale In do sulla situdone dei dlrlttl urnameno compatibilecon i diritti e la [ i n ? Se questo fosse vero, sa- nl in Paesi Islamici come I'lran, democrazia, rebbs un eyanto con rlcadute in I'lraq n I'Afghanlstan ha,risposto: Cintemgatlvo Pi particolarmente tutti i Paesi islamici, In tutti i po- "Si tratta di Paesl che hanno un bilancio molta negativo in termini evidente, oggi, Bon riferimento poli musuImani. L'Iran 6 Infatti l'iall'lran. QUIi masslmi pbteri - spiratore, il protettore 9il tinan- di diritti umani. Cib che sconcerta esecutivo, legislativo e g-iudizia- ziatare dèl pih importanti movi- è che chi B al potere giustifica @est9 violazioni In nome delf'irio sono concentrati ne& nlapl mentifaid@mentaI\$ yarnici. della ''~uidaspirituale";aitual~ h i h Ebad~lal~~q~'@,mbristin s@mm. F a ncora; 'I diritti umani sono mente I'ayatdlah Kharnenei, una che a l L "~àles&l",~ka 'sicuraT>< ; ,L 6 .$f~ici. Non sl p d parlare di diritti isUtuzione religlo8axhe B ester- '&nf& :wnJtt~ggn! insyf&zioLimani serniido k culture. Esiste n8.e al di sopra delk altre istltu- ne amàfqinpi) t$rtìba&i'lo'régizionl. Anche la presidanza dblla me de@,[['&$i@aJ dill'hsterno, ulio standard di vita rispettoso ~epubbllcaB nélle mayl di'un se- ma ddli'Ìììt~~ll~sfru~ndo.uttT gji della dignit8 umana che dovrebligiosa, liayqtollah Kbatàrnl, spazi di lhdsaCtt'h,chg,'riesce a be essere diffuso in tutti i Paesi esponente dellua.wrpnteriformi- chatsi in esso: djf& in gludizio @l.mondo, Possono eslstete dista. E forse.- quest'ultima hagioi- dl dissidenti, rivendicazione di versi approcci ,m a lo standard ta,,in wor suo, per.un pmmio im pari diritti alle donne in casq di d h essere<unioo". barapante,a ptenzjalmsQ~e,@e- divorzio, dlfqsa dei minorl. Non s@biii~ante,~nelm~'~ptk~eil~aj.a ha timore-del poteye. Alla fi,chie-; @ob Girda piil-consewatrice,.del clero'~quel- , la-di Kharne,~el,)~., Il Nobel pone tra I'alh,il prokil~madel rispetto del dirltuidella,donnai inrun regima>che:nerd-&.unaletturadel tutb@d!zioqle(e amtmta; Ma il premlo.assegnato all'Ebadi anche i 1 segno di una sociea >qivileimniana:che%W i,ede rlfpme [email protected]'eiadi? .ritti civili. Si sta aliandg la voce d d gioqqnC,,.ma non spla:,yn p b , cente sp@aggio ha dimast$$t% ad ewpPp,ch'q!ltp%kwiQmL ,niani'eAa~wevo!e~@?@.,fl~rti&lp~ zd!bAe, dei pppq.ti;q#%g: " [I gqnde sai%k&p,er 6 J ~ , . 2 iati , L',ag\o'mide~pg@ii$@~ stato.arr<qsAaip@mnda~naoL~8. annildi k m r e , Un vento uuovo bpjra forsg w TeJwranZE Sblrln Ehadi'e - mme ,qu_alcunaha scghg- qLLqch Walesa ,iraniano? ComSl:e,l,att8- - E T., .: . Attunlità ,,.. LE CHIESE D'EUROPA E LISLAM dchja ~#Qarn:iIdtois(4rn in Egupa"[Qr@ah[s'~Lo proino$so dal Consiglio delle ConWmnz$~,& &@i$i~~Eir'ropa (Ccpe) e: ~ b n f e r e n i delle. a chiese d'Europa (K'ek: evangelh $ ortod%ssi$angli~ani, - armerii e luterani)p q pfqnuovere.soarnbieon i1:mondo.musulmano e 8~elabbk~duggèrifien , , .- , . ,. ti sulle-ihp#&bl@ i&? @ip16$& is[arno-@W&ò La scomà.primaGgsi[fi.o@fla@@acpb!uso un qpiRglierinio:di?giGitd:.&r traccm'On bi/anzTo,dellavoro ~o,fipiuto,$8fivjsta uMondoe Missione" (n.-52003),ha int,ervhtatodo!$GiqmpiemAlberti, del Ce~troTkmbi.d~i?no?ai docu&taziohe sulle relfgioni (Cadr), unim-mppre'senfante.ifa)tg$.,k,i ,v > V liano n,f;!ilc&irtk. . , ! i I r I -- 1. - Dialogo islamo-cristiano LA CITTÀ DEL CRISTIANO Parlando dl uomini, di comunità, di luoghi e dl tempo, come si B fatto negli ultimi numeri de Il dialogo, viene spontanea qualche considerazione molto semplice anche sullo spazio occupato dai credenti, in particolare queIla spazlo preclso che Pi la città. Nelle tradizioni religiose, l a città terre n a B spesso immagine di quella celeste. Perì babilonesi la capitale era il centro del mondo dove terra e cielo si incontravano; Is antlphe cltt8 indiane erano considerate Immagine del cosmo. Al centro dl'quetle lraniane segeva i[ palauo>delre, che po@ava'il titolo di "assa.del mondo":. le iù antiche colonie romane erano orse dlsposte,ad anello, qu'ale immaginedella-terra delimitata dall'orizzonte. L'importanza di Gerusalemme, invece, come antica ~ a v i t l4 a di Israele Q di^Giuda, è da attribuire non solo alla sua posizione, ma anche 8l.favore di Dio, che afferma: .Là sarà il mio nomer (1 Re 8,29$ La ''qitta della p a c e (secondo una etimologia popolare), con h vicina rocca di Sion, sim-m bolobi una inespugnabile fortwza d ~ l l santita, a è la ucitth del grande Savranoip (sal 48), lei ucittà del nostro Dior, il dentro del mondo-dove abita il Signore (sal-135,21). Alla fine dei tempi tutti i popoti%alirannoin pellegrinaggio al monte del Signora (1s 2.2) e la pietraangolare di Sion (is28.1 6) diventerà nella badlzlone successiva un riferimento al Messia che costruisce la nuova Gerusalemme celeste, cantata dai profeti (Ez 40,2; Tb 13,17). In quanto capitale del paese, Getusalenirne B s esso chiamata'la cW" Mt 21,l: LC 19,41). La muina ell'antica Gerusalemme crea Ià-premessaper la dlscesa della.G&qsalemme celeste sulla moya te'rra (Ap 3,12). Paolo affe.@perm rimo che al po& delI'*tica ci B ne sarebbe subentraw un!gltra (Gel 4,22471, gli abewiti-,dellaquale sono il vero sdmé di Abm%m,o, chp;n,ella fede &&p Jta:va.ula:citt&:dallesalde fon&&bnta: ilcui architetto e W&trhtjttoré 'B pio stassoi, (Eb 19,('b); laAcltt8B stabue (cf Eb p P 6 R -C/ 13,14), scende dal cielo come A .questo proposito riprendlamo una sposa (Ap 21,2), piena della alcune considerazioni che ci vengloria di Dio e simbolo di eterna gono dalla Scrittura. La cittadibeatitudine (Ap 22,l). n a n a nella quale il credente tmL'esegesi medievale vide Genisa- va la piena realizzazione non B lemme come un'immagine in p m quella terrena, ma celeste: la salgressione storica: dapprima rap- vezza deriva dall'appartenanza presenta la c W di Sion dell'Antico religiosa (Fil3,ZO) e non dall'apPatto, $mila Chiesa del Nuovo Tepartenenza alla oomunit8 poliuca stamento (costituita dalle pietre viche B un dato relatlvo e rowlsove dei credenti, con centro a Ro- rio. Nasce da questo atto una ma); quindi la dimora vivente 81 reale coscienza politica che porta Dio nell'uomo e da ultimo la citt8 a valorizzare e al tempo stesso d e s t e dell'Apocalisse. La città di relativiuare la città degll uomini, Diio non B una realt8 che ha pre- mantenendo nei ri uardi dell'orceduto e neppure una realtà che ganitreizione d a e una posizim attend*Yopom:il vescovo Agostlne di riserva e di distacco, quanno, nel suo De ci&& Dei, lasclb tunque serena e propositiva. Pur scritto che la citt8 di Dia e la città vivendo in una comunla politica, dell'uomo sono certarnente.confu- il cristiano rimane fondamentalseqeunite nel mondo presente, mente in condizione di "pellegri.finshd n,on .Ie,:se~a~i:ISItl~~~qiudIno" e di straniero, ris zio. :Non ( ~ ' 8,io, qubsta posizione, trla, La polltica e o stato, =Ila paad nesgpng i@~~$cazi;o~~e con una esempio, non hanno posslbllltA dl gr@&g$ea[t$,@Co,I~tl~a e nessuna porsi come !%lemento costitutivo fGrPt~'&d! all&an2@con-unaspeclfl- e definitivo dell'esistenza, di darsi c&@i&:ddi ,b.dteii, ci08 un fondamento religioso e ~'i~@ib~6~l~dlff&kenza'della Chiesa salvifiw. Lo stato, In altri termini, Rerlalfiss~th~?del luogo dplla pre- non ub ihma:vanZare la pretesa <gh!;ere'e l'suoisegni simbqlicl SI che su ditl, $li aVppartenganoin Wkrrnb nella costruzlorie di edi- maniera esclusiva (e lo stesso si fi,cqi3qualetestlrn~nlanza~della pre- potrebbe d i'rs.della tecnologia, senza di,Crlsto in terra e di ulte- dell'sconomia, ,della scuola, del eiofi sviluppi della vicenda eccle- lavoro e via dicendo). La HbertB s ale nella storja: la "domus eccle- non iQla .pqrtecipa,ziion alla s ae" degli inizi lascid il posto alla vita po Itlca;mq, I'appartenanza al baslllca .e successtvamente al Signore,Gpsù q alla ,c.om~nlth del m6dello,a ianta mntrale o:a sim- ,salvali,nella qu'ale'le,np.rrne della rnetrie ma tiple, come preclsa In- vlta poIitica.sqn~~~om~',sup,erate terpretazionè.delle leggiarmonl- e sos es8ilb$@h;4:$prroepite nel che che regolano l'universo. Per i lom:sPhl~~6to~l;&~1ztd reale. teorici della clttà utopica del rina- 'llo~i&nb%m$@!ieMun;afleg iasclmento, l'edificio religioso viene ;iciiento~dii t0H9ziorie e di veri ica assunto come orQaninatorepri- rlspe@a lavitth-degliuomini, delmo della cltt8, posto in posizione le sue spe[$?,e,del suoi percorsi, di dominio rlspetto alle strutture ma,vrrtribuisce,a Ysecolarizzare" circostanti, dando wsl vita ad un il oterb, nelle sue yarle forme, modello urbanistica che rende vik n d o l P di ogni fiondqijento resibile la gerarchiuazione dei vaIgloso che portasse a dime'nticalorl sostenuta dall'autoriiii religio- re lo spazlo dell'uomo stesso, delsa. Se in epoca successiva, le -la sua digniih, della gratuità. Caumutate vicende eoclesiali o @ m torità è esercitata h.modo legittino alla prevalente volon archl- :mo se sLdedica al conseguitfmto tettonica di otte,nerg:@g!! affettl del bene comune ed ogni cristiaemozionali sul @ d p ~ l ~" ~ @j p no B chlamsto.ad adoperarsi non che simbolici (sb r:-qita"iq8> . q010 per il bene degiiaitri. ma ?nca), i tempi recdKtii anm-poia*b . *e per ao~ten~ere istituzioni e inila Chiesa a ridefinire non solo'ila 'ziative che servanò a migliorare modalltà delle sue costnizioni,.rrh la' città degli uomini. anche il senso della sua preseha nel mondo. Giuliano Zatti ? f' $tto P d' i P P P 'p ti % $&& P
Scarica