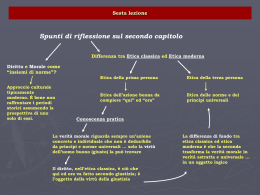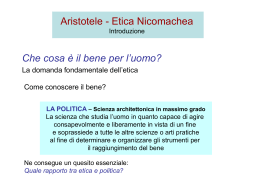Pier Davide Guenzi La relazione medico-paziente: una proposta dall’etica delle virtù. Novara, 17 dicembre 2009 La bioetica delle virtù Insufficienza e disagio nei confronti di un’etica concentrata esclusivamente sulla applicazione di principi in vista della valutazione delle azioni. Insufficienza nei confronti di un modello di prassi medicale di tipo funzionalista o contrattualista. Attenzione alla duplice soggettività impegnata nel percorso terapeutico: quella del paziente (non riducibile alla semplice afffermazione dei propri “diritti”) e quella del professionista sanitario (non riducibile al semplice profilo “doveristico” del suo agire in base ad un protocollo operativo). «La denuncia dei limiti del modello principialistico prende spunto dalla ripresa di un modello che, nel campo dell’etica medica, come nella più generale tradizione occidentale, non è certo una novità: il modello basato sull’etica delle virtù. È questo il modello che fornisce le categorie per interpretare il passaggio da un’etica che pone l’accento sull’atto in sé, ad un’etica invece che pone l’accento sull’agente, sul suo modo di essere, sul suo carattere che negli atti si manifesta e insieme si potenzia» (C. Viafora, 2006, p. 84). Cosa devo fare / Chi devo essere Interpretare il senso dell’agire medicale Modello del contratto o modello della cura Tradizionalmente l’agire medico è compreso come sostegno e cura all’interno di una relazione di profonda partecipazione al destino del proprio paziente e non semplice applicazione di prestazioni in forza di un contratto sancito sulla base dei desideri e delle scelte autonome del paziente. «Il medico non è semplicemente un venditore di beni che ha a che fare con un consumatore qualsiasi, ma un soggetto provvisto di autorità morale in rapporto di fiducia con il proprio paziente» (D. Lamb) Il fuoco del problema morale non è definito esclusivamente dalla questione su cosa si debba fare per assicurare una prestazione giusta e appropriata in base a standard etici definibili attraverso principi. L’accento si sposta sul chi dovrei essere attualizzando il tema antico della “virtù” nella prospettiva dello sviluppo pieno (to live well, to flourish) della personalità morale (character) di chi è impegnato nell’azione. «La concentrazione suoi singoli atti conflittuali, nella prospettiva di offrire con la misura dei principi soluzioni oggettive e imparzialità, fa perdere di vista la struttura motivazionale del soggetto nella sua globalità» (Viafora, 2006, 84). Una rinnovata attenzione a questa prospettiva, inoltre, rende maggiormente possibile «riaprire uno spazio per la questione centrale del senso dell’agire, questione che la prospettiva dell’etica pubblica elude sistematicamente» (R. Mordacci, 1996, p. 105). Tuttavia occorre considerare un suo possibile limite: la relatività della figura di “vita buona” e di “virtù” a sistemi culturali e valoriali differenti. Il merito principale di questa prospettiva, che costituisce un significativo guadagno nello stesso dibattito (interminabile) della bioetica pubblica, è quello di spostare l’attenzione dal “rispetto delle regole”, pure imprescindibili, ma che in sé non esauriscono la specificità del discorso etico, a quella di abilitare il soggetto a formulare un giudizio ponderato all’interno delle varie situazioni e di assumersene in prima persona il peso in modo responsabile. «Il giudizio ha un ruolo indispensabile nella vita dell’uomo virtuoso, mentre ad esempio non lo ha, e non potrebbe averlo, nella vita dell’uomo che si limita a rispettare una legge o una regola» (A. MacIntyre, 1984). La nozione chiave di phronesis e di ractio practica come regola ultima dell’agire che implica la definizione non in astratto del bene proprio connesso all’azione, ma all’interno della situazione e della sua evoluzione. Ciò richiede la capacità di misurare il proprio agire secondo il continuo riproporsi della domanda di quale sia il bene del paziente da assicurare nello sviluppo della sua condizione patologica, ponendosi comunque attentamente in ascolto della sua volontà. Non si tratta della flessibilità delle norme (relativismo morale), ma della ridiscussione dei giudizi su cosa sia buono e doveroso all’interno di una situazione a partire dalle indicazioni generali offerte dai principi. Ciò non disimpegna la responsabilità del soggetto agente dall’onere dalla propria decisione assumendo in chiave positiva la propria forza motivazionale e l’umanità della sua partecipazione al destino del paziente, insieme al quale ciascun operatore sanitario è chiamato a verificare ciò che è prioritario in vista del suo bene. Questo modello cerca di rimediare all’astrattezza dei principi «con il riferimento alla flessibilità dei giudizi prudenziali e l’avvertenza della storicità delle norme e della situazionalità dell’azione; d’altra parte, essendo le virtù espressione di un’eccellenza nell’agire pratica, esse assolverebbero al compito di indicare modelli di azione e ispirare comportamenti di azione […] a cui la regola di per sé non impegnerebbe» (Mordacci, 1996, p. 101). Il soggetto agente, come soggetto virtuoso si lascia mettere in questione dalle scelte che è chiamato a fare. «La virtù è la disposizione a lasciarsi interrogare dalla situazione e ad approfondire la provocazione dell’esperienza nell’esercizio della ragione, fino a reperirne il senso e quindi a determinare la migliore traduzione di quest’ultimo sul piano dell’agire» (Mordacci, 1996, p. 106). La tenacia terapeutica nelle situazioni critiche Oltre l’alternativa accanimento e abbandono terapeutico come modelli di azione opposti che tradiscono ugualmente l’incapacità di leggere la situazione reale del paziente. La tenacia terapeutica, intesa quale «atteggiamento e conseguente comportamento del medico, che, in presenza di possibilità ragionevoli di un’evoluzione positiva del quadro clinico e di un miglioramento della qualità di vita del paziente, continua nella ricerca e nell’uso di tecniche diagnostiche e di strumenti terapeutici appropriati» e proporzionati alla sua situazione (CNB, 1995). Due chiavi dall’etica “cattolica” Il principio di proporzionalità La continuità di cura: il caso dell’alimentazione e idratazione Il criterio della proporzionalità “E’ lecito interrompere l’applicazione di mezzi quando i risultati deludono le speranze riposte in essi. Ma nel prendere una decisione del genere si dovrà tener conto del giusto desiderio dell’ammalato e dei suoi famigliari, nonché del parere di medici veramente competenti: costoro potranno senza dubbio giudicare meglio di ogni altro se l’investimento di strumenti e di personale è sproporzionato ai risultati prevedibili e se le tecniche messe in opera impongono al paziente sofferenze e disagi maggiori dei benefici che se ne possono trarre”. Tale giudizio di proporzionalità può essere formulato: “mettendo a confronto il tipo di terapia, il grado di difficoltà e il rischio che comporta, le spese necessarie e le possibilità di applicazione, con il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni del malato e delle sue forze fisiche e morali” (Dichiarazione vaticana sull’eutanasia, 1980). Nel processo decisionale, alla luce di questa visione, il medico non è un passivo o rassegnato spettatore o semplice esecutore della volontà del proprio paziente, ma deve essere “interprete” del suo vero “desiderio”. «La richiesta di sospendere le cure dovrà spesso essere ostacolata e dilazionata ed il malato dovrà essere aiutato a superare i momenti difficili nei quali il desiderio di vivere si oscura: in molti casi dovrà essere salvato dalla sua disperazione, anche contro una volontà verbalmente espressa […] Ma alla fine il malato non può essere obbligato a rimanere in vita in situazione penosa» (M. Chiodi). Ciò non significa, però, l’applicazione meccanica di un principio di autodeterminazione, ma lo sviluppo di una relazione in un processo terapeutico tra il paziente e il medico, basato sulla pratica della verità. La continuità di cura: il caso dell’alimentazione e dell’idratazione La formulazione tipica del magistero cattolico: «la somministrazione di acqua e cibo, anche quando avvenisse per vie artificiali, rappresenti sempre un mezzo naturale di conservazione della vita, non un atto medico. Il suo uso pertanto sarà da considerarsi, in linea di principio, ordinario e proporzionato, e come tale moralmente obbligatorio, nella misura in cui e fino a quando esso dimostra di raggiungere la sua finalità propria, che nella fattispecie consiste nel procurare nutrimento al paziente e lenimento delle sofferenze» (Giovanni Paolo II, 20/03/2004) «Nell’affermare che la somministrazione di cibo e acqua è moralmente obbligatoria in linea di principio, la Congregazione della Dottrina della Fede non esclude che in qualche regione molto isolata o di estrema povertà l’alimentazione e l’idratazione artificiali possano non essere fisicamente possibili, e allora ad impossibilia nemo tenetur, sussistendo però l’obbligo di offrire le cure minimali disponibili e di procurarsi, se possibile, i mezzi necessari per un adeguato sostegno vitale. Non si esclude neppure che, per complicazioni sopraggiunte, il paziente possa non riuscire ad assimilare il cibo e i liquidi, diventando così del tutto inutile la loro somministrazione. Infine, non si scarta assolutamente la possibilità che in qualche raro caso l’alimentazione e l’idratazione artificiali possano comportare per il paziente un’eccessiva gravosità o un rilevante disagio fisico legato, per esempio, a complicanze nell’uso di ausili strumentali». Se esistono criteri di eticità per iniziare o no un trattamento gravoso e necessario; ne dovrebbero esistere anche per la decisione di interrompere tale trattamento o no. «Ciò che può non essere voluto, può essere anche sospeso. […] È la sospensione di una atto – che implica in qualche misura un intervento tecnico – nel cui contesto complessivo non si riconosce più il senso terapeutico originario» (M. Chiodi) Per chi è interessato Potete contattarmi all’indirizzo e-mail: [email protected] Vi ringrazio per l’attenzione!
Scaricare