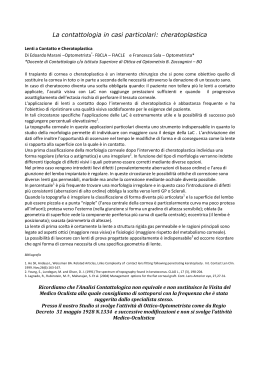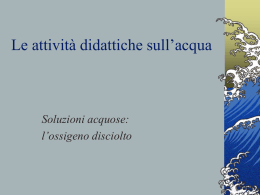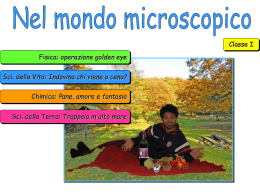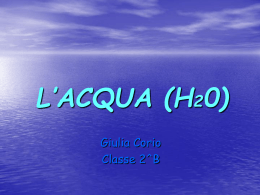Corso di chimica Materiali per l’Ottica Parte 2: Proprietà chimico-fisiche dei Materiali per Lenti a Contatto (LAC) 1 Generalità Le prime lenti a contatto erano in vetro e non utilizzabili per tempi lunghi a causa di irritazioni che provocavano. Quando (1936) William Feinbloom introdusse lenti a base di PMMA (polimetilmetacrilato, materia plastica formata da polimeri del metacrilato di metile, estere dell’acido metacrilico. Perspex/Plexiglas), le lenti a contatto divennero molto più convenienti. Le lenti di PMMA vengono anche dette lenti rigide. Le lenti di PMMA hanno anche effetti collaterali: impermeabilità all’ossigeno che non raggiungendo la cornea porta a insorgenza di diversi effetti clinici negativi. Alla fine anni ‘70 e durante gli ‘80 e ‘90, vennero sviluppati materiali rigidi permeabili all’ossigeno. Questi materiali vengono chiamati RGP (rigid gas permeable). 2 Lenti rigide e lenti morbide • Le lenti rigide offrono un numero unico di proprietà. La lente è in grado di sostituire la conformazione naturale della cornea con una nuova superficie rifrangente. Ciò permette un buon livello di visione alle persone affette da astigmatismo o aventi una superficie distorta della cornea (keratocono) anche utilizzando una normale lente sferica. • Le lenti rigide sono disponibili da moltissimi anni mentre le prime morbide sono apparse in alcuni paesi negli anni ‘60 ed approvate dalla FDA (U. S. Food and Drug Administration) nel 1971. I polimeri usati per le lenti morbide sono migliorati moltissimo negli ultimi 25 anni specie per quel che riguarda la permeabilità all’ossigeno. 3 Idrogels Nel 1999 sono state commercializzate le prime a base di silicone idrogel. Esse permettono una permeabilità dell’ossigeno elevata tipica dei siliconi ed il comfort e performance clinica degli idrogel convenzionali. All’inizio erano preferite per usi prolungati (overnight) ma recentemente vengono usate anche periodi più brevi (no overnight). 4 Ibridi Esistono anche ibridi, lente rigida/lente morbida: la prima (più piccola), rigida, sovrapposta sulla morbida di diametro maggiore. Si ricorre a questo quando una lente singola non offre la correzione ottica adeguata e comfort richiesti. 5 Tipi di lenti Esistono tre tipi di lenti: 1. DW (daily wear) “indossate” durante il giorno e rimosse prima di andare a letto. 2. EW (extended wear) che si tengono anche di notte fino a 6 o più giorni consecutivi. 3. CW (continuous wear) che si possono utilizzare fino a 30 giorni consecutivi e sono fatte con materiali più nuovi (idrogel siliconici). EW e CW possono essere utilizzate per periodi piuttosto lunghi grazie all’alta permeabilità all’ossigeno dei materiali utilizzati. 6 Lenti usa e getta (disposable) Usa e getta (disposable) • Le lenti di tipo “giornaliero” usa-e-getta sono meglio indicate per pazienti con problemi di allergia in quanto l’utilizzo limitato limita il deposito di antigeni e proteine. • Queste lenti sono anche utili per persone che ne fanno un uso non prolungato o durante attività sportive (es. nuoto) quando vi è probabilità elevata di perderle. In genere le lenti vengono usate per periodi di 2 settimane o un mese. Le lenti usate su base trimestrale o annuale non sono più tanto comuni. RGP (rigid gas permeable) durano a lungo e possono durare anche alcuni anni. 7 Proprietà caratterizzanti i materiali per LAC • • • • • • • • Densità Indice di rifrazione Trasmittanza ottica Stabilità dimensionale Permeabilità all'ossigeno Bagnabilità Proprietà meccaniche Conducibilità termica 8 Densità La densità d è il rapporto tra la massa m e il volume V della lente a contatto: d = m/V La densità (g/cm3) è un parametro importante in quanto può influire sul comfort, ma i cui valori variano relativamente poco tra un polimero e l’altro. A causa della dilatazione termica dei materiali la densità dipende dalla temperatura, dato che con l'aumento della temperatura la massa della LAC non cambia mentre il volume aumenta. 9 Densità e indice di rifrazione dei materiali per LAC PMMA Gomme al silicone PHEMA Cornea Densità (g/cm3) 1.18 1.10 1.16 1.03 Indice di rifrazione 1.49 1.43 1.43 1.37 10 Indice di rifrazione L'indice di rifrazione di un mezzo ottico è dato dal rapporto tra la velocità della luce nel vuoto c e la velocità della luce nel mezzo considerato v : n = c/v indice di rifrazione elevato: maggiore deviazione. A parità di raggi di curvatura della lente, si ottiene una maggiore potenza diottrica, o, a parità di potere diottrico, una minore curvatura. A differenza delle lenti oftalmiche, la curvatura della superficie interna della lente a contatto è condizionata dalla scelta del tipo di applicazione in relazione alla curvatura corneale. L'indice di rifrazione di un materiale dipende dalla lunghezza d’onda della luce incidente. 11 Trasmittanza % T = trasmittanza = I/I0 frazione di luce incidente di λ specificata che passa attraverso il campione (100 x T = % T). In questo grafico viene riportata in ascissa la lunghezza d'onda, nell’intervallo tra 200 nm e 800 nm (UV-VIS), e in ordinata la trasmittanza % delle lenti. Generalmente i materiali usati in contattologia trasmettono 12 più del 90% della radiazione visibile (380-780 nm). Permeabilità all’ossigeno e bagnabilità • I siliconi permettono una elevata permeabilità dell’ossigeno ma rendono la superficie della lente fortemente idrofobica e meno “bagnabile”. Questo porta a ridotto comfort e a secchezza dell’occhio. Gli idrogel vengono aggiunti ai siliconi per rendere la lente più idrofilica. • Per minimizzare l’idrofobicità residua alcune lenti vengono sottoposte a speciali trattamenti superficiali. In altre si aggiungono speciali composti che ne aumentano la bagnabilità. 13 Ossigeno: permeabilità, trasmissibilità e flusso La permeabilità è la misura della “performance” di ossigeno del materiale. Sistemi polimerici: P = DS P è coefficiente di permeabilità per un dato sistema polimerogas D è il coefficiente di diffusione del gas attraverso il polimero (dipende dalla flessibilità catene polimero e dal volume libero) S è la solubilità del gas nel polimero (rappresenta il numero di molecole di ossigeno sciolte nel materiale e dipende dall’interazione chimica fra polimero ed ossigeno) Lenti a contatto: P = Dk k è la solubilità del gas nella LAC 14 Trasmissibilità La trasmissibiltà è una caratteristica della LAC (spessore finito): Dk/t t è lo spessore del materiale o meglio lo spessore medio della parte centrale della lente. Permeabilità e trasmissibiltà: permettono di confrontare la facilità di passaggio dell’ossigeno attraverso lenti di materiale diverso. Situazione clinica: più rilevante considerare la quantità di ossigeno che di fatto raggiunge la cornea per unità di tempo. 15 Permeabilità e trasmissibilità: unità di misura unità di misura: barrer o unità Fatt Permeabilità: 10-11 cm2 s-1 ml O2 ml-1 mmHg-1 (coeff. Diff. Coeff. Solubilità) Unità ISO: 10-11 cm2 s-1 ml O2 ml-1 hPa-1 Trasmissibilità: 10-9 cm s-1 ml O2 ml -1 mmHg-1 Unità ISO: 10-9 cm s-1 ml O2 ml-1 hPa-1 16 Flusso di Ossigeno La legge di Fick calcola la quantità di ossigeno che passa dalla superficie esterna a quella interna della LAC: J = A(Dk/t)(P1-P2) J è volume di gas per unità di tempo che passa attraverso la lente di area A e spessore t con una permeabilità Dk P1 e P2 = pressione di O2 sulla superficie anteriore e posteriore della lente J/A= flusso ossigeno (j) = (Dk/t)(P1-P2) J/A = volume di gas per unità di tempo che attraversa un’area di 1 cm2 17 Flusso di Ossigeno P1- P2 = differenza di pressione di O2 sulla superficie anteriore e posteriore della lente è la forza motrice per il passaggio di O2 attraverso la lente. P1 = 159 mmHg per occhio aperto e 59 mmHg per occhio chiuso P2 dipende dalla trasmissibilità della lente 18 Flusso di Ossigeno/Trasmissibilità Valori limite 19 Materiali idrogel silicolici 20 Flusso di Ossigeno J/A= flusso ossigeno (j) = (Dk/t)(P1-P2) La misura o il calcolo di P2 la pressione di ossigeno sulla superficie posteriore della LAC è difficile Potenziale ossigeno equivalente (EOP): misura indiretta della tensione di ossigeno sulla superficie posteriore della LAC 21 Potenziale ossigeno equivalente (EOP) 1. Si espone la cornea a diverse atmosfere contenenti una percentuali note e decrescenti di O2, partendo da 21% es i misura la velocità di assorbimento da parte della cornea con un sensore polarografico. Al diminuire della percentuale di O2 diversa la velocità di assorbimento sarà più alta in quanto la cornea viene esposta ad una concentrazione di O2 più Cornea, lenti a contatto e bassa rispetto ai valori fisiologici normali. ossigeno 2. Si mette la LAC sulla cornea e si espone l’occhio a una atmosfera contenente una percentuale nota di O2: es. 21%. Si rimuove la lente e si misura la velocità di assorbimento della cornea e si confronta con i valori in assenza di lente (misurati al punto 1). Si ottiene così il Potenziale di ossigeno equivalente. Recentemente Harvitt e Bo X% O2 sensore di O2 Flusso rilevato dal sensore X% O2 0 5 10 21 t Lente test sensore di O2 Flusso rilevato dal sensore Curva di riferimento per determinare l’EOP t Figura 9 m a rcatori per ottenere una di ossigeno al di sotto della modello animale 74. I valo quelli ottenuti con la tecnic di avere a disposizione un n direttamente la tensione d contatto. Un altro noto sistema di qu 22 di ossigeno attraverso un descritto da Fatt e St.Helen Limiti del metodo Il metodo è basato sulle proprietà della lente usata ma la misura dipende anche dalle variazioni individuali della risposta fisiologica della cornea. • Misure fatte in vivo ma su animali • La lente usata è rigida e in posizione statica • Battito delle palpebre (blinking) fa spostare la lente e il rinnovo del film di liquido lacrimale apporta altro ossigeno alla cornea 23 Misura di Dk e Dk/t in vitro Metodo Polarografico Anodo di Ag (anello) : Ag → Ag+ + eCatodo (Au o Pt) : O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- la corrente è proporzionale alla quantità di O2 24 Metodo polarografico Effetto barriera: uno strato sottile di acqua è intrappolato fra lente e sensore ed agisce come barriera che riduce quantità di O2 che raggiunge superficie catodo. Il grafico del il reciproco della trasmissibilità t/Dk di lenti di spessore t diverso rispetto allo spessore t della lente si ottiene una retta dalla cui pendenza si può calcolare la permeabilità reale. 25 Metodo polarografico Effetto spessore: si assume che lo spessore della lente sia infinitamente sottile. Questo di solito non si verifica e O2 passa lateralmente attraverso lo spessore del bordo e quindi più ossigeno raggiunge il catodo e se non si fanno correzioni si sovrastimano i valori di permeabilità e trasmissibilità. International Standard (ISO) ha implementato una procedura di correzione che tiene conto del diametro del catodo e dello spessore della lente. 26 Metodo Coulombimetrico Camera di misura con due volumi separati da una membrana fatta dal materiale della lente. In una zona gas contenente ossigeno viene fatto passare sulla parte frontale della lente. Nella seconda zona passa sulla parte posteriore della lente gas che non contiene ossigeno. La variazione di concentrazione di ossigeno in questa zona può essere misurata e correlata alla trasmissibilità di ossigeno della lente. 27 Permeabilità e trasmissibilità Trasmissibilità è legata a diffusione O2 attraverso il materiale, alla solubilità dell’O2 nel materiale e allo spessore del materiale. Per aumentare la performance di ossigeno della lente si è: 1) cambiata la chimica del materiale per ottenere un disposizione più “lasca” delle catene del polimero ed aumentare la velocità di diffusione di O2 attraverso il materiale 2) aumentato il contenuto di acqua nei materiali idrogel e questo aumenta sia la velocità di diffusione che la solubilità di O2 nella lente 3) diminuito lo spessore con conseguente aumento della 28 trasmissibilità Chimica del materiale Materiali a base siliconica hanno catene molto mobili e flessibili: O 2 diffonde rapidamente all’interno. Le caratteristiche elettroniche dello scheletro ---Si-O-Si--portano ad aumento della solubilità di O2. Lenti contenenti “segmenti” siliconici hanno una solubilità di O2 100 > lenti PMMA. Lenti contenenti siliconi: - Rigide - Idrogel Rigide combinano la facile processabilità del PMMA con la più alta performance di ossigeno dei siliconi. 29 Contenuto di acqua In idrogel convenzionali il fattore che governa la permeabilità di O 2 è il contenuto d’acqua. Il polimero disidratato è essenzialmente impermeabile all’ossigeno. Acqua agisce da plastificante e rende le catene del polimero più flessibili. Il primo polimero usato per idrogel è stato il poliidrossietilmetacrilato (pHEMA) che ha 38% d’acqua e una permeabilità a O2 di circa 7·1011 barrer. Copolimeri HEMA e N-vinilpirrolidone contengono fino a 70% d’acqua. Esiste una correlazione tra contenuto d’acqua (W) e permeabilità di O2 (Dk): Dk = A e BW A e B = costanti sperimentali per un certo valore di T A = 1.67; B = 0.0397 a 35°C (T della cornea) 30 Permeabilità ossigeno e contenuto acqua del materiale 31 Trasmissibilità ossigeno e flusso di ossigeno Trasmissibilità ossigeno e flusso di ossigeno di LAC morbide commerciali 32 LAC: Monomeri e nome usato in USA per materiali idrogel 33 Trasmissibilità all’ossigeno Dk/t 34 Quantità di ossigeno necessaria Per evitare irritazione della cornea (rigonfiamento) in una giornata di uso della lente è richiesta una trasmissibilità di 24.7 (21.8) unità di O2 • Durante la notte per contenere il rigonfiamento al 4% (normale) una trasmissibilità di 87 (73) unità è richiesta • Harvitt e Bonnano indicano valori di 23 e 89 per occhio aperto e chiuso per evitare condizione di anossia dell’epitelio della cornea • Tali valori sono medi e relativi ma possono indicare se la lente è adatta ad essere portata per periodi prolungati e se potrebbe provocare una risposta ipossica durante l’uso notturno 35 Conclusioni • La permeabilità delle lenti rigide è ben documentata • La permeabilità dipende dal tipo di materiale: per rigide a base di fluoroacrilati siliconici si hanno i valori più elevati • Per lenti a base di idrogel convenzionali la permeabilità è legata al valore di % di acqua • Quando si considera la trasmissibiltà bisogna ricordare che lenti con alto contenuto d’acqua sono più spesse: quindi alta permeabilità non corrisponde ad alta trasmissibilità • I valori devono essere corretti per effetto barriera e spessore • Trasmissibiltà è riportata per lenti di 3 diottrie • Spessore e contenuto d’acqua variano durante l’uso a causa disidratazione e quindi anche la trasmissibiltà varierà • Idrogel siliconici minimizzano disidratazione e danno valori costanti di trasmissibiltà • La seconda generazione di lenti a base di idrogel siliconici danno una performance di O2 alta, un comfort più elevato, sono lenti che calzano meglio ed con proprietà superficiali più elevate. 36 Bagnabilità La bagnabilità è la capacità che un liquido ha di distribuirsi sulla superficie di un solido ; è una caratteristica estremamente importante poiché il mantenimento del film lacrimale pre-corneale, nella forma di un sottile strato capillare, è una necessità fondamentale per la compatibilità fisiologica tra paziente e lente. Le forze intermolecolari che agiscono nei liquidi e tra un liquido e un solido sono di coesione e di adesione. Le forze che agiscono tra molecole dello stesso tipo (come in una goccia d'acqua) vengono dette forze di coesione , mentre le forze che agiscono tra molecole di due sostanze diverse (come tra l'acqua e la lente) vengono dette forze di adesione. Queste forze di adesione sono responsabili della bagnabilità di 37 una lente a contatto. Coesione e adesione 38 Bagnabilità Dipende da tre proprietà: • Tensione superficiale del liquido (es. lacrimale) • Tensione superficiale del materiale (es. lente) • Tensione interfacciale fra i due 39 Angolo di contatto θ 40 Tipi di angolo di contatto θ • Di avanzamento θA: formato quando una goccia avanza lentamente: es. uscendo da una siringa, ed aumenta di volume • Di regressione θR : formato quando una goccia si ritira lentamente da una superficie che aveva bagnato : es. risucchiata da una siringa, e diminuisce di volume • θA - θR = angolo di isteresi Isteresi: dovuta a re-orientazione delle catene del polimero alla superficie del materiale. 41 Bagnabilità 42 Conclusioni sulla bagnabilità Problemi: • I valori angolo di contatto misurati in vitro non sono trasferibili a situazione in vivo (necessità di valutazioni di bagnabiltà in-vivo) • Nella misura dell’angolo di contatto di si usa l’acqua, mentre il liquido lacrimale ha composizione diversa e più complessa I risultati permettono comunque una distinzione fra i materiali così poco bagnabili da non essere adatti per lenti a contatto e i materiali in grado di mantenere 43 potenzialmente un film stabile di liquido lacrimale.
Scarica