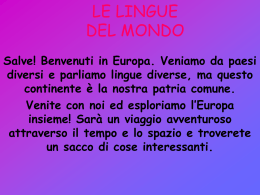ASCARI, O. GLI IRRIDUCIBILI DEL LAGER Le ragioni del “no” di un internato militare italiano in Germania di Odoardo Ascari, da «Nuova Storia Contemporanea» n.4, Roma luglio-agosto 2002, pp. 97÷116 Ho letto, col piacere che dà una strada ritrovata, l’articolo di Paolo Nello, La «resistenza clandestina”. Guareschi e gli internati militari italiani dopo l’8 settembre, comparso su questa rivista nel numero del novembre-dicembre 2001. Anch’io vissi quella drammatica vicenda, per certi aspetti molto più coinvolgente della stessa guerra, che ho combattuto col grado di sottotenente sul fronte russo, con gli Alpini della “Cuneense”, inghiottita dalla “sacca” del Don, dalla quale uscì decimata, comandata da un capitano. Sono uno degli ufficiali che, deportati nei lager nazisti (prima in Polonia, a Deblin-Irena, sulla Vistola, e, poi, addirittura a Biala Podlaska, a est di Brest Litovsk – dove fummo in 145 su 2.600 ufficiali a dire di no – poi a Sandbostel e, infine, a Wietzendorf, in Westfalia) si rifiutarono di sottoscrivere il compromesso più giustificato: quello concluso per sopravvivere. Ma oggi nessuno si ricorda di noi perché non serviamo a nessuno. Mi sembra giusto: noi non abbiamo servito nessuno. Fummo, insomma, dei prigionieri volontari: sino al 31 gennaio 1945 era possibile porre fine alla permanenza nei lager, firmando l’adesione al lavoro. Del resto, i tedeschi – che avevano richiamato alle armi i ragazzini di 14 anni – non ci avevano mai desiderato come combattenti al loro fianco: sia perché non si fidavano di noi, sia perché non sapevano come “inquadrarci”. Il grande problema della Germania era invece quello di trovare braccia per sorreggere lo sforzo estremo della guerra. Mi pare che, allo scoppio della pace, esistessero in Germania alcuni milioni di lavoratori, deportati da tutti i paesi d’Europa. Gli ufficiali italiani deportati furono, a quanto mi risulta, più di 35.000, ripartiti originariamente in diversi campi di concentramento, in Germania e Polonia: a coloro che, in un primo tempo, avevano rifiutato l’adesione alla Repubblica Sociale Italiana, fu proposto di diventare lavoratori; alla fine eravamo in pochi, in due soli campi, per quanto ne so. Per quel che mi concerne, dopo una sosta in Renania – Stalag XII A – fui deportato in Polonia, nel lager di Deblin-Irena, sulla Vistola: la cosiddetta “Cittadella”. Iniziarono così le lunghe trasferte in vagone bestiame, attraversando più di mezza Europa in condizioni disumane. Gli ufficiali furono messi, in un primo tempo, di fronte alla sola alternativa se restare “badogliani” o se aderire alla RSI. Ecco copia – per così dire originale – della “dichiarazione” che mi fu consegnata e che non è mai stata sottoscritta. DICHIARAZIONE D’IMPEGNO! Aderisco all’idea repubblicana dell’Italia repubblicana fascista e mi dichiaro volontariamente pronto a combattere con le armi nel costituendo nuovo Esercito italiano del Duce, senza riserve, anche sotto il Comando Supremo tedesco, contro il comune nemico dell’Italia repubblicana fascista del Duce e del Grande Reich Germanico. Firma Data Coloro che, a Deblin-Irena, firmarono per la RSI – con la prospettiva del ritorno immediato in Italia – furono una piccola aliquota, circa il 5%, non di più; gli altri rimasero fra i reticolati. Non ho un ricordo molto preciso di quel campo in cui passai il Natale del ’43 e nel quale il trattamento non fu disumano; ma alla fine del gennaio 1944 i “reprobi”, “monarchici”, “badogliani” furono trasferiti a Biala Podlaska, a est di Brest-Litovsk. Verso l’universo concentrazionario Ricordo ancora l’autentico terrore che ci invase quando, rinchiusi, come al solito, in settanta in ogni vagone, constatammo che il treno andava verso est, superando addirittura Brest-Litovsk, avviato verso il confine con la Russia: era come se naufragassimo in un terribile ignoto. Il campo di Biala Podlaska era già gremito di ufficiali italiani. Al nostro arrivo, trovammo un’atmosfera di resa totale. Il comandante era un ufficiale degli Alpini, il quale, purtroppo, avrebbe voluto che tutti firmassero la dichiarazione facendo intravedere una sorta di inganno verso i tedeschi: “Firmiamo tutti, torniamo in Italia, e poi si vedrà”. Fatto sta che su 2.600 internati solo 145 resistettero e furono relegati in due sole baracche: la “Pesaro” e la “Torino”. Una barriera di odio e di disprezzo si levò tra noi e coloro che avevano aderito alla RSI. Lo “stalag” 366 B si chiamò “campo Graziani”; sul campo sventolò il gagliardetto fascista. Quello fu il solo campo in cui anche i cappellani, tutti in divisa col grado di tenente, si comportarono come voleva il succitato capitano degli Alpini; e, a questo proposito, mi sia permesso di ricordare un episodio. Uno di loro, durante la messa – per la cui celebrazio- ne i tedeschi avevano messo a disposizione una baracca – disse testualmente: “Aderire alla Repubblica Sociale è un sacro dovere di fronte a Dio e di fronte agli uomini”. La sera successiva lo andammo a trovare in cinque, col pretesto che volevamo confessarci e comunicarci, fingendo di essere anche noi “optanti”. Lo incontrammo all’angolo di una baracca vicina all’ingresso del campo: lo aggredimmo, gli facemmo aprire la bocca nella quale sputammo e lo colpimmo, per la verità, con molti pugni e calci, pronunciando incredibili bestemmie. Ne ricordo una che dominava su tutte, essendo quattro degli aggressori piemontesi: “Dio faus”. E ricordo un particolare grottesco: il cappellano non era piemontese e non capiva il senso di quelle parole: fui io a fargli la traduzione: “Dio falso”. Ne chiedo scusa al lettore, ma vi sono particolari che spiegano uomini, cose e avvenimenti meglio di dissertazioni compiute, logiche e complesse: dopo averlo colpito a turno con cinque calci gli dicemmo che se avesse parlato con qualcuno, prima o poi sarebbe stato ucciso. Fu questo il solo caso di cappellani, per così dire, fedifraghi, perché negli altri campi trovammo degli autentici eroi. Comunque, questo fu il prologo al nostro trasferimento a Sandbostel, campo XB, vicino a Bremervörde, alcune decine di chilometri a sud di Brema. Vi giungemmo attraversando pressoché l’intera Polonia e la Germania, stipati in due soli vagoni: il viaggio durò otto notti e nove giorni. Non voglio qui ricordare ancora quel viaggio angoscioso perché non mi piace ispirare pietà. Basterà dire che le strutture psichiche di quattro o cinque dei deportati scoppiarono, tanto da provocare il discontrollo totale del proprio comportamento: non riuscirono insomma a sopportare i problemi e i drammi provocati dalla commistione di settanta persone in un vagone bestiame, con la porta chiusa. Ma non voglio insistere su questo aspetto, perché faccio affidamento sulla capacità di immaginazione del lettore. Dunque, eccoci a Sandbostel, a fine marzo ’44. Si trattava di un autentico universo concentrazionario, che comprendeva quattro o cinque campi, dei quali erano ospiti francesi, inglesi, polacchi e russi: gli internati italiani erano al centro. Ebbero allora inizio le offerte di lavoro, che i tedeschi accompagnavano con una riduzione di viveri e con trattamenti che sono già stati troppe volte descritti per essere qui ripetuti. Cominciò così lo stillicidio delle adesioni che venivano sottoscritte, spesso all’insaputa degli altri prigionieri, nell’apposito ufficio tedesco sito all’interno del campo. Un bel giorno i cosiddetti “optanti”, quando venivano convocati dall’altoparlante per essere avviati fuori dal lager, si profondevano in scuse e in giustificazioni verso i compagni, dicendo: “Sai, la Germania non vincerà la guerra per le quattro patate che andrò a scavare”. Tutti cercavano di farsi credere agricoltori perché la destinazione ai lavori agricoli era ritenuta il sicuro passaporto per la sopravvivenza. E i pochi fortunati che andavano a lavorare in campagna non solo risolvevano il problema principale – mangiare – ma spesso avevano anche altri conforti, tenendo presente che le donne tedesche vivevano da anni senza aver vicino un solo uomo. La maggior parte, invece, veniva messa a lavorare nelle fabbriche: sopravviveva, ma in condizioni durissime e disumane, avendo, per di più, costantemente davanti lo spettro dell’accusa di sabotaggio; ma, comunque, in qualche modo, sopravviveva. Chi aveva deciso di resistere, mentre la situazione si faceva via via più drammatica, vedeva con enorme preoccupazione assottigliarsi le file dei “resistenti”, perché ciò rendeva più probabile la realizzazione della solita promessa tedesca: kaputt. E ciò anche perché, in seguito alle continue adesioni al lavoro, gli ufficiali non optanti, prima dispersi in diversi campi sia in Polonia che in Germania, vennero concentrati in due soli campi, il più importante dei quali era, appunto, lo Stalag XB. Noi sperammo sempre che i tedeschi chiudessero le adesioni al lavoro e rendessero la nostra situazione irrevocabile; perché fin quando c’era quella possibilità, la tentazione di firmare era enorme. Noi fummo, allo stesso tempo, prigionieri e custodi del nostro onore e della nostra dignità. Questa incredibile prigionia volontaria – bastava mettere una firma e si usciva – unica nella storia, dà a coloro che sono riusciti a imporsela sino alla fine, un “diploma” da uomini abbastanza raro, diciamolo pure, in Europa. Ecco il mio: COMANDO CAMPO ITALIANO 83 Dichiaro che il Sten. ASCARI Edoardo [sic!] 55407 si trovava in questo Campo di concentramento all’atto della liberazione, il 16.4.1945. Detto ufficiale è rimasto ininterrottamente nei campi di concentramento. Allo stato degli atti, risulta che egli non ha compiuto azioni manifestanti volontà di collaborazione e non ha comunque collaborato con la Germania e con la Repubblica Sociale Italiana. Wietzendorf, 18 giugno 1945 IL COMANDANTE (Ten. Col. Pietro Testa) Debbo ammettere che io vivevo anche di odio: quando Brema, la domenica delle Palme del 1944, fu bombardata da un migliaio di aerei alleati, i prigionieri usciti dalle baracche, di notte, applaudivano le fiammate più alte degli immensi incendi che si erano sviluppati, e che si vedevano alti nel cielo: era crudele, ma la gioia era autentica. C’è di peggio. Dopo la liberazione, avvenuta “ufficialmente” il 16 aprile 1945, e in attesa del rimpatrio che avven- ne in luglio, alcuni prigionieri – e io fui tra questi – andavano in giro alla ricerca dei cimiteri tedeschi sui muri dei quali scrivevano, a caratteri, appunto, murali: “Sempre pochi”. Gli ufficiali “non optanti” Il Diario clandestino di Guareschi, che, a differenza di me, non conosceva l’odio, è il resoconto fedele della nostra vicenda umana. Per comprendere meglio, è utile ricordare che gli ufficiali “non optanti” vanno divisi in tre categorie. Vi erano anzitutto gli ufficiali “effettivi” e, in particolare, i Carabinieri, che rifiutavano l’adesione dicendo: “Io non firmo perché ho giurato fedeltà al Re”. Era una “posizione” – per così dire – che meritava ammirazione e rispetto: e i tedeschi, che pur detestavano il Re, la comprendevano perché era speculare alla loro mentalità: basterà ricordare che Hasso Von Manteuffel – quando gli fu proposto di aderire alla congiura che portò all’attentato di Von Stauffenberg – rispose, pur enfatizzando le colpe di Hitler: “Non posso, perché non ci sarà mai un Von Manteuffel spergiuro”. Tornando a noi, dunque, i tedeschi, in fondo, rispettavano i “non optanti” che si trinceravano dietro al giuramento prestato: e si trattava della grande maggioranza. Debbo dire subito che, per quel che mi concerne, il giuramento al Re – che allora giudicavo fuggiasco – mi sembrava lontano, in tutti i sensi, e non mi sentivo assolutamente vincolato dalla promessa di fedeltà a suo tempo fatta. Sentivo da quel giuramento lo stesso distacco che per certi aspetti mi sembra oggi di avvertire da avvenimenti così lontani. Insomma, quelle parole non mi vincolavano più: il tribunale a cui sentivo di dover rispondere era un altro, quello della mia coscienza. Veniva poi il “no” di coloro che avevano ideologie precise, come Alessandro Natta – che ho conosciuto – dalla cui scelta, in fondo analoga, per logica, a quella degli ufficiali fedeli al Re, mi sentivo egualmente lontano. Ecco cosa scrive Natta nel suo libro L’altra Resistenza. I militari italiani internati in Germania: La prigionia e la resistenza in essa ebbero certo gravi limiti e ombre. La ferocia dell’oppressione e il peso della sofferenza misero a nudo le virtù e i difetti di ognuno e il guasto di lunghi anni di servitù e di diseducazione politica del nostro Paese 1. Un ufficiale fiorentino, insegnante dilatino e greco in un liceo, morto di tubercolosi nel lager, diceva che i seguaci di ideologie così esclusive avevano il cervello fatto a corridoio: più di una idea per volta non passa. Insomma, chi ha subito la migrazione dalla coscienza verso una ideologia, sia essa di estrema destra o di estrema sinistra, non può comprendere le ragioni dei figli di Don Chisciotte. Che la resistenza degli ufficiali abbia avuto “gravi limiti e ombre” non è frutto di diseducazione politica ma del fatto che sono pochi gli uomini che per ragioni di dignità mettono in pericolo la propria vita: Natta non poteva capire che il foro interno dell’uomo – dove nasce il senso della libertà – è l’arbitro supremo di tutte le sue scelte. Né le successive esperienze gli avevano insegnato nulla: “semel abbas semper abbas”. La terza categoria, la meno numerosa, era composta da noi, gli ultimi figli di Don Chisciotte, l’hidalgo romantico e venturoso della vecchia Castiglia, che la saggezza non salvò dalla follia e la follia non salvò dalla saggezza, se è vero che, solo sul letto di morte, rinunciò alla cavalleria – il sogno che gli era servito per vivere – e dovette constatare che “non vi sono più passeri nei nidi di ieri”. Dicemmo no per dignità: tutto si può dire, tranne che fosse una scelta ideologica. E anche per questo che oggi è difficile spiegare la ragioni di quel no, che resta l’orgoglio della mia vita. Accettammo – e vincemmo – la sfida perché ispirati da quella oscura bellezza morale che ci sovrasta ed alla quale non sappiamo dare un nome. Più alta della patria, più forte del dovere: dignità di uomini, forse. Ho adottato questa spiegazione fornita da Paolo Monelli, in Le scarpe al sole, a chi gli domandava perché gli Alpini si battessero con tanto valore, da passare senza fatica dalla storia alla leggenda e dalla leggenda alla storia. E, dunque, completamente sbagliato, per non dire altro, parlare di scelte ideologiche o, peggio ancora, politiche: né ci attendevamo postume rivalutazioni o consensi, o bandiere spiegate al nostro ritorno: era, ripeto, la nostra dignità di uomini che ci imponeva quella scelta. Ed è per questo che, se mi guardo attorno, vedo il deserto, e penso a noi con commosso orgoglio. E ho il diritto di essere superbo. Gli “uomini guida” della Resistenza La resistenza – a Sandbostel – faceva perno su alcuni “uomini guida”, il cui comportamento costituì un punto di riferimento per tutti, man mano che arrivavano i giorni e i fatti che mettevano in crisi la decisione difficile e sofferta di resistere. Il primo, in tutti i sensi, era la Medaglia d’Oro Giuseppe Brignole, eletto a furor di popolo coman1 A. NATTA, L’altra Resistenza. I militari internati in Germania, Torino, Einaudi, 1996, p. 85. dante del campo. Egli proveniva, per così dire, “dalla macchina” – era stato cioè un sottufficiale – ma aveva un’autorità indicibile, e non solo per la Medaglia d’Oro che portava sul petto, essendo riuscito, alla guida del “Calatafimi” – un vecchio “tre pipe” dell’altra guerra – a mettere in fuga, in uno dei primissimi giorni di guerra, la flotta francese al largo di Genova, affondando, a quanto credo di ricordare, una unità da guerra nemica. Parlava un genovese italianizzato, ma aveva la forza segreta e il sangue nascosto degli eroi: gli stessi tedeschi ne erano intimiditi. Non aveva nulla dell’uomo d’arme, dell’eroe assorto: tra l’altro, camminava marcando visibilmente il passo, come se fosse su una barca. Del resto, è del tutto sorprendente che tutti avessero voluto che fosse il Comandante dei campo, nonostante il suo grado di tenente di vascello, equivalente a capitano: e nel campo vi erano ufficiali superiori, uno dei quali – un colonnello – era ufficialmente 1”anziano del campo”, ma il Comandante era lui, Brignole. Si trattava di un autentico e, per certi aspetti, inspiegabile miracolo: l’immagine per nulla guerriera di un uomo che emanava il fascino segreto ed eterno di ciò che non è spiegabile, come se la sua smisurata dignità lo elevasse a un grado superiore. Un altro uomo guida della resistenza fu Giovannino Guareschi, che era, anzitutto, un uomo libero, assolutamente lontano da ideologie astratte, con una dimensione umana letteralmente immensa. E il suo no era tanto più importante quando si pensi che gli era stato promesso, essendo un giornalista già molto noto, in caso di adesione, il ritorno in Italia. C’è di più. Molti internati ricevevano dall’Italia lettere di mogli e di madri che imploravano i congiunti di tornare a casa, firmando qualunque cosa. Ecco l’ultima pagina di una lettera tipo: Ho ottant’anni, sono sola al mondo, non ho che te. Ti scongiuro, ti prego in ginocchio di tornare, di firmare qualsiasi cosa, ma di tornare. E tua madre che ti prega, è tua madre che ha diritto di rivederti prima di morire. Adesso non mi potrai dire che ci sono ancora dei doveri con tutta la confusione che è nata. Ho saputo che il Marino è rientrato. Era questa la frase che doveva indurre il figlio a firmare. A chi riceveva lettere come questa Guareschi spiegava che anche lui aveva in Italia una famiglia, anzi, una figlia – Carlotta, la “Pasionaria” – che era nata dopo la sua cattura: ma prima di tutto, secondo lui, veniva il dovere umano e, per certi aspetti, religioso di non firmare, di resistere. A coloro che erano tentati di aderire al lavoro diceva: “Non farlo perché per i tedeschi non bisogna attaccare neanche un francobollo”. Ma la frase più celebre è quella rivolta al capitano Pinkel delle S.S.: “Io non firmo perché non ho ancora conosciuto un tedesco che, pur essendo vivo, mi fosse simpatico come un tedesco morto”. Si salvò perché il tedesco non capiva una parola di italiano e perché l’interprete, un giovane sottotenente altoatesino di pelo rosso, con il volto coperto di piccole lentiggini rosa, ebbe paura – come poi confessò –anche per sé e tradusse con poche parole confuse e senza senso la risposta “storica” di Guareschi. Giovannino, a Natale del 1944, scrisse – anzi raccontò – nella baracca 23, la Favola di Natale 2 commuovendo tutti e mettendo in favola la prigionia e i sogni di tutti. E debbo ripetere che, secondo Natta, si trattava di quelle espressioni lacrimose e qualunquistiche, tipo le favolette di Natale dei Guareschi che nel “sacrificio” della prigionia incubavano i lazzi di Candido e [si trattava di] difendersi da chi si preoccupava di mettere assieme un capitale di benemerenze e di tormenti da offrire al ritorno al migliore offerente 3. Questo giudizio – che parla a volumi su chi lo ha formulato – dimostra a che punto di autentica disumanità si possa giungere quando si soffre di migrazione dalla coscienza in capo a un mito, a un partito, a una ideologia, che diventano depositari di tutti i parametri di valutazione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto, del vero e del falso: è stata la barbarie del secolo ventesimo, impersonata dal nazismo e dal comunismo. Un altro uomo, il cui ricordo non si cancellerà mai, è Pietro Novello, capitano degli Alpini, classe 1897, combattente nella Prima guerra mondiale e poi nelle file della “Tridentina” sul fronte russo. Era il mio uomo guida; essendo io il più giovane sottotenente degli Alpini – classe 1922 – mi aveva preso sotto la sua “protezione” e mi chiamava “Balilla”. Guardavo a lui letteralmente con venerazione, perché aveva un volto sorridente, come se la vicenda drammatica che stavamo vivendo non lo riguardasse, come se, insomma, egli vivesse all’ablativo assoluto rispetto alla tragedia che ci coinvolgeva tutti. Voglio ricordare un episodio. Ci fu un momento in cui sembrava davvero che i tedeschi ci volessero uccidere: del resto avevano tante volte promesso che i “non optanti” non sarebbero mai stati consegnati vivi agli Alleati. E vi fu una sera in cui anch’io entrai in crisi. Io ero e sono ghibellino e avevo rotto con la Chiesa cattolica all’età di se- 2 G. GUARESCHI, Favola di Natale, Milano, Rizzoli, 1971. 3 A. NATTA, op. cit., p. dici anni: ma quella sera mi colsero le grandi inquietudini, e sembrava certo che ci volessero uccidere. E ora da dirsi che, nel campo, una figura di primo piano era Padre Grigoletto. Era un Cappuccino, un eroe puro, se è vero, come è vero, che riusciva a portare un pezzo della sua razione di pane in infermeria perché fosse dato a chi, ormai agonizzante per fame, e con le piaghe da decubito, stava peggio di lui. E per fare questo è necessaria una forza umana molto maggiore di quella che serve per combattere. Ebbene, una sera, quando, appunto, sembrava che per noi, “non optanti”, le speranze fossero finite, Novello mi vide davanti alla stube nella quale stava Padre Grigoletto: ero esitante e pensavo di avere con lui un colloquio sui grandi temi della vita e della morte, che sembrava vicina. Novello mi vide e, sorridendo, mi disse una frase che non dimenticherò mai: “Ma, Balilla, non vorrai mica andare a stipulare una polizza d’assicurazione proprio stasera?”. E la sua era una sicurezza sorridente, addirittura sovrumana, mi si scusi l’enfasi. Fatto si è che rinunciai al colloquio. Ricordo ancora Enrico Allorio, il grande giurista, docente di procedura civile (la disciplina più arida che esista, guardata da lontano), uomo dalla dimensione umana enorme. E ancora il professore trentino Bruno Betta, che metteva la sua cultura nutrita di civiltà al servizio di una resistenza vera: quella del pensiero e, mi si consenta l’enfasi, dello spirito. Da questa resistenza nacquero le conferenze, i dibattiti, i concorsi letterari, tutto quello che serviva a salvarci dalla tendenza istintiva a ridurci al rango di animali in lotta con la fame. Mi piace ricordare che nell’estate del ’44 “gli uomini della baracca letteraria” misero in scena l’«Enrico IV» di Pirandello: e fu proprio Gianrico Tedeschi – anche lui tra coloro che condividevano la grande sfida – l’interprete: aveva davanti a sé donna Matilde, un baldo ufficiale talmente magro e affilato da impersonare la “donna-crisi”. A Sandbostel furono anche tenuti cicli di conferenze e soprattutto furono banditi concorsi letterari di prosa e poesia. Quello per la prosa fu vinto da me. Nel motivare la concessione del premio, fu detto che si premiava il fatto che ero riuscito a non parlare di prigionìa. Il secondo premio, infatti, toccò a un ufficiale, che era un pastore valdese, autore di uno splendido racconto, dal titolo Canne al vento: ma le canne al vento eravamo noi. Infatti, l’esperienza che vivevamo era così lacerante e drammatica che, come disse la commissione, bisognava lasciarla sedimentare nel tempo per poterne cogliere gli aspetti essenziali e vederla nella sua reale dimensione. Ma la perla è il diploma che Novello disegnò per me vincitore. In esso si vede il poeta “laureato” – con gli zoccoli ai piedi – che porta la “sbobba” e procede impettito, mentre altri quattro prigionieri lo guardano come per dire: “Guarda quante arie si dà”. Sullo sfondo si vedono le baracche del lager e, davanti ad esse, i russi costretti, come bestie da soma, a trascinare i carri “M”, non con riferimento a Mussolini, ma alla prima lettera della parola merda. Nel “diploma”, ai piedi del vincitore, a destra, c’è la celebre firma di Novello con la “N” disegnata a cappello alpino, che fa intravedere i suoi lineamenti, caratterizzati dal naso e dal mento aguzzi. In basso, a sinistra, c’è la firma di Guareschi, che faceva parte della Commissione esaminatrice, presieduta dal Professor Rosario Scifo dell’Università di Palermo. Guareschi fece seguire al suo cognome il numero del suo piastrino di riconoscimento “6865”. Il nostro piastrino era infatti attraversato da una sorta di linea bucherellata che lo divideva in due parti recanti l’identica scritta, cioè il campo di provenienza e il numero. Quando un prigioniero moriva, il piastrino veniva spezzato lungo la linea bucherellata: una metà restava al collo del morto e l’altra metà costituiva, appunto, la prova che era morto. “Caterina”: una sfida ai tedeschi Ma non posso chiudere questa rievocazione senza ricordare la seconda grande sfida lanciata ai tedeschi, sfida che teneva in vita l’orgoglio, che è essenziale per vivere da uomini. A Sandbostel – lo XB – esisteva, come ormai è noto, una radio costruita fortunosamente, sottraendo, tra l’altro, la dinamo del fanale dalla bicicletta di un sottufficiale tedesco. Era stato un vero miracolo il fatto che due ufficiali fossero riusciti a sottrarre a tutti i controlli e le perquisizioni dei tedeschi la radio, denominata “Caterina”: questo era il “soprannome”, perché anche in tedesco si dice radio e non era prudente che si pronunciasse quella parola. Il 6 giugno 1944 Radio Londra dette la notizia, sia pure sommaria, dello sbarco. Il campo esplose di gioia come un melograno e tutti i prigionieri si misero a urlare come matti e a battere i pugni contro le pareti in legno delle baracche: il campo sembrava impazzito. La notizia si propagò fulminea a tutti i campi vicini: i tedeschi si guardavano attorno sbigottiti, perché non comprendevano la ragione di quella esplosione. Quando i numerosi addetti al governo del campo e alla sua amministrazione uscirono per raggiungere i loro alloggiamenti fuori dai campi, seppero, da un comunicato cauto ed elusivo dell’Oberkommando, dello sbarco: compresero allora il perché di quella esplosione di gioia ed ebbero la prova che noi avevamo la radio. Ritornarono nel campo letteralmente furibondi. E la loro ira raggiunse il parossismo quando videro il laghetto d’acqua sporca che si trovava a fianco della baracca posta al centro del campo: vi si dondolavano, pigre, tante barchette di carta, che i prigionieri avevano costruito, sacrificando anche le lettere ricevute da casa. Il capitano Pinkel convocò nel suo ufficio Brignole che, pur comprendendo discretamente il tedesco, si faceva assistere da un altro ufficiale di Marina, il Comandante Mosetti, che fungeva da suo interprete personale: e così aveva più tempo per pensare a quel che diceva, fedele all’insegnamento antico che è meglio pensare a quel che si dice che dire quel che si pensa. E questo rese ancor più furibondo Pinkel, che era un’autentica belva umana. Debbo ricordare, per inciso, che, al momento della liberazione del campo di Sandbostel da parte degli americani, i prigionieri russi, che per anni avevano subito le sue sevizie, i suoi calci, le sue frustate, lo uccisero affondandolo e risollevandolo a testa in giù nel carro pieno del liquame dei pozzi neri: non faccio commenti per non commettere peccati. Torniamo al colloquio tra Pinkel e Brignole: la prima domanda del tedesco fu la seguente: “Come fate a sapere che sono sbarcati?”. E Brignole, lentissimamente, di rimando: “Perché, sono sbarcati?”. Solo la Medaglia d’Oro che aveva sul petto lo salvò. Ma a questo punto i tedeschi ci fecero uscire dalle baracche e ci tennero in piedi per ore – molti caddero svenuti – perché effettuarono una perquisizione forsennata. Tutti i pagliericci, in cui esisteva sia pure paglia trita, furono vuotati e da quel giorno non avemmo praticamente più pagliericci e dormimmo sul legno duro. Le imbottiture delle spalle dei pastrani furono vuotate. Insomma, il campo fu rivoltato come una tasca, ma di “Caterina” nessuna traccia. Debbo, a suo onore, ricordare che protagonista del salvataggio di “Caterina” fu proprio Padre Grigoletto. I tedeschi avevano deciso improvvisamente di ispezionare la baracca comando, dove era nascosta la radio. Padre Grigoletto se la legò tra le gambe e passò lentissimo tra gli uomini della Gestapo, fingendo di leggere il breviario. Con prontezza di spirito, Brignole, presente alla perquisizione, lo sollecitò severamente, davanti all’ufficiale tedesco, ad andare a fare il suo dovere altrove. Il tedesco approvò e così “Caterina” fu portata fuori dalla zona pericolosa. E proprio Padre Grigoletto diffondeva le notizie trasmesse da “Caterina”, in occasione della recita del Rosario nella piccola baracca destinata a Cappella. Diceva, ad esempio: “Domani, su iniziativa degli ufficiali di Castelfidardo – non sono sicuro di ricordare con precisione – solenne messa di ringraziamento”, volendo dire che le truppe alleate erano arrivate, appunto, a Castelfidardo. I francesi, essendo prigionieri di guerra, erano protetti dalla Croce Rossa e ricevevano ricchi pacchi: erano ben pasciuti, ben vestiti e, soprattutto, insopportabilmente superbi. Non potemmo perciò resistere alla tentazione di vendere a loro – dietro pagamento – le notizie di “Caterina” sull’avanzata degli Alleati in Francia: onestà vuole che si dica che la caduta di Parigi – che valeva tre chili di burro – fu data ai francesi per ben tre volte. “Caterina” morì – almeno ufficialmente – perché nel novembre del ’44 la sfida ai tedeschi arrivò ad un punto per loro insopportabile. Alla porta dei gabinetti – dove erano affissi gli annunci economici per scambi tra prigionieri – fu affisso l’ordine di arrivo del Derby di Londra, il famoso “Steeple Chase”. L’ira tedesca arrivò al punto che Brignole fu chiamato e gli fu detto che se avessero trovato la radio avrebbero decimato il campo. Brignole allora ordinò di distruggerla e l’annunzio della “morte”, almeno ufficiale, della radio fu dato da Guareschi con un comunicato dal titolo: “Caterina è morta”, che io non posseggo più, e che è una delle cose più belle che io abbia letto in vita mia. Ma “Caterina” non fu distrutta: fu soltanto nascosta e interrata, anche se fu diffusa la falsa notizia della sua distruzione. Attualmente la si può vedere a Terranegra, vicino a Padova, dove si trova il museo dell’ANEI (Associazione Nazionale degli Ex Internati). A metà dicembre del ’44 accadde un fatto che sconvolse la vita nostra e del campo. I tedeschi lanciarono la controffensiva delle Ardenne e puntarono su Abbeville, minacciando di tagliare in due il fronte alleato, riportando, agli inizi, grandi successi, annunciati dai bollettini straordinari diffusi nel campo, preceduti dalle trombe wagneriane. L’effetto psicologico fu immenso. Gli internati, quasi morti di fame, vedevano non già capovolte le sorti della guerra, ma rimandata la conclusione della guerra stessa oltre i limiti della loro possibile sopravvivenza. La firma di un “internato”, che avrebbe dovuto essere un uomo guida, e che rappresentava una importantissima matrice ideologica nel campo, determinò il crollo della situazione: nei pochi giorni tra il 15 e il 20 dicembre più della metà degli ufficiali sottoscrisse l’adesione al lavoro: e noi, che restavamo fermi sulla nostra decisione, vedevamo in loro, sia pure in forma attenuata, dei transfughi. Infatti, man mano che gli “optanti” partivano, il freddo, quello vero e quello della paura, dilagava nel campo, e sembrava sempre più vicina l’attuazione della eterna promessa: kaputt. Fu, insomma, quello del ’44, il più terribile e triste Natale della mia vita, anche perché contro i “resistenti” si adottò una misura fondamentale, destinata a portare alla loro estinzione: la riduzione dei viveri. Venne così l’anno nuovo: la battaglia delle Ardenne finì con la sconfitta dei tedeschi, che si profilò verso la fine di gennaio, quando furono costretti a ritirarsi dopo perdite gravissime di uomini e di mezzi. Era stato tuttavia un momento assai difficile per gli Alleati, che avevano rischiato di dover abbandonare Strasburgo, i Vosgi e le terre del Reno appena conquistate. Basterà ricordare che prima di Natale le punte dei tedeschi erano in vista della Mosa, a cento chilometri dal punto di partenza, avevano circondato Bastogne e sembravano vicine alla riconquista di Anversa. Comunque, alla fine del gennaio ’45, i tedeschi finalmente chiusero le adesioni proclamando ancora una volta che i resistenti erano dei reprobi, dei badogliani: e che, vivi, non sarebbero mai stati consegnati agli Alleati. La conseguenza diretta della frana di adesioni fu il trasferimento nell’ultimo campo, quello di Wietzendorf – Oflag 83 – comandato da uno splendido ufficiale, il Tenente Colonnello Testa. Wietzendorf è un villaggio nella landa di Lünenburg, a metà strada fra Amburgo e Hannover, non molto lontano dal campo di sterminio di Belsen. Il trasferimento da Sandbostel alla stazione di Bremervörde – pochi chilometri percorsi a piedi – fu letteralmente penoso anche perché eravamo sfiniti: e impiegammo una notte intera, chiusi nei vagoni, per percorrere i pochi chilometri da Bremervörde alla stazione di Wietzendorf. Di qui, una nuova marcia di alcuni chilometri: per raggiungere il campo era necessario attraversare il paese: ho ancora davanti agli occhi il corteo degli spettri ambulanti che percorrevano quelle stradine pulite. A un certo punto, una donna molto giovane, sorridente, con le trecce dei capelli annodati sulla testa si affacciò e vide la colonna arrivare: allora rientrò e uscì poco dopo con un secchio di acqua gelata, che con una grande risata buttò addosso alla colonna dei prigionieri barcollanti. E ci vollero giorni perché coloro che erano stati colpiti dall’acqua fredda potessero, per così dire, guarire: un capitano di Bologna andò vicino a morire. Il campo di concentramento di Wietzendorf Ho detto che vivevamo anche di odio e con questa carica arrivammo al campo di concentramento di Wietzendorf, che era stato in origine abitato da prigionieri russi. Della vita che vi avevano condotto questi e del loro trattamento testimonia il cimitero russo sito nei pressi del campo – a circa un chilometro e mezzo a nord – nel quale si trovavano sepolte oltre 16.000 salme. Sgombrato dai russi, probabilmente per le condizioni di inabitabilità, il campo fu destinato, con la denominazione di “Oflag 83”, agli ufficiali italiani. Più di una descrizione delle baracche adibite ad alloggio, degli impianti sanitari ed igienici, vale il fatto che due commissioni sanitarie tedesche, presiedute da colonnelli medici tedeschi, avevano dichiarato inabitabile il campo. Il freddo, in quell’inverno, era letteralmente insopportabile, specie tenendo conto delle baracche nelle quali eravamo costretti a vivere: avevano una sola entrata, due sole finestre agli estremi, il pavimento in terra battuta, le travi del tetto a vista e senza altro riparo. La latrina, semplicemente indescrivibile, era sistemata in una sorta di “sporgenza” della baracca all’entrata: e così la baracca, buia e bassa, costruita con blocchi di cemento, era invasa da un fetore insopportabile. Per di più, tutti i canali di scolo delle acque di rifiuto delle latrine correvano allo scoperto, ammorbando l’aria. La durezza delle condizioni di vita era aggravata dal fatto che le tabelle viveri rimasero sempre al di sotto dei valori minimi necessari alla vita anche per individui a riposo assoluto. Nessun impianto tecnico, nessuna possibilità di intervento chirurgico, nessun mezzo di rapido sgombro per i casi di urgenza, neppure medicinali esistevano, neanche i più comuni, nemmeno in minima misura. Agli ufficiali venivano sottratti i pochi medicinali di proprietà privata, che essi erano riusciti a salvare dalle numerose perquisizioni: ma solo assai pochi di questi medicinali arrivavano all’infermeria, ove quasi tutte le cure consistevano nella buona volontà dei medici italiani. Per dimostrare che il peggio non è mai venuto, basterà ricordare che cominciò la caccia ai topi, che, tutto sommato, erano carne: il fatto trova spiegazione ricordando che, per quel che mi concerne, ero ridotto a 46 chilogrammi e avevo le piaghe da decubito. Quando si udiva lo stridio caratteristico del topo schiacciato, la baracca veniva coinvolta dall’agitazione e il fortunato di turno scendeva dal “castello” a tre piani per farne un lesso speciale, tra i commenti di chi era invidioso o di chi, nonostante la situazione disperata, restava insensibile al fascino della carne di topo. Ancora: l’acqua dei “bagni” era talmente fredda che non ci si poteva lavare: comparvero così i pidocchi dai quali tutti eravamo invasi. Un capitolo a sé meritano le cimici giganti, che si lasciavano cadere dal tetto. Non se ne erano mai viste di così grandi. Erano lunghe più di due centimetri e gli sventurati che subivano le loro punture sentivano bruciori insopportabili, specie quando, nel sonno, venivano raggiunti dalla caduta delle cimici sul volto, sul collo e sulle mani. Non è finita. Resta infatti da aggiungere che i tedeschi spesso costringevano, fucile alla mano, gli ufficiali che si erano rifiutati di lavorare, a recarsi fuori sotto scorta per sgomberare macerie, riattare strade e procurare la legna per le cucine. Il Colonnello Testa, comandante del campo, uomo di grande statura umana e morale, nelle pagine conclusive di un rapporto, rivolto al Comando delle truppe britanniche di occupazione, così scriveva 4: Negli ultimi mesi gli ufficiali sono stati sottoposti a tutte le forme di propaganda, minacce, soprusi e sono stati inviati al lavoro col sistema del mercato degli schiavi. Gli ufficiali venivano convocati in teatro, sotto la luce dei proiettori, e sottoposti alla scelta di impresari e contadini tedeschi che palpavano loro gli arti e guardavano loro in bocca quasi fossero delle bestie. Gli ufficiali che si rifiutavano di partire venivano portati fuori dal campo da sentinelle armate di fucile e baionetta. Più volte, per scovare i renitenti, sono stati fatti appelli improvvisi e gruppi di ufficiali sono stati condotti via a forza. Inoltre gli ufficiali che venivano consegnati agli ufficiali civili del lavoro dovevano passare alla condizione di civili. Veniva loro ordinato di togliersi il distintivo di grado ed i fregi dell’uniforme. 4 L’intero testo del rapporto è riprodotto in Appendice. Ho letto un ordine riservato germanico, e di questo ho conservato trascrizione mnemonica, in cui è detto che gli ufficiali che si rifiutavano di lavorare dovevano essere passati ai campi di punizione e di polizia: molti infatti vi sono stati inviati e parecchi vi sono morti. Mi pare che basti. Le nostre residue speranze di sopravvivenza erano alimentate solo da alcuni fatti esterni e dalla conseguente speranza che la guerra finisse presto. Molti dei nostri custodi, che si erano segnalati per la loro ferocia, furono, alla fine di febbraio, arruolati nei reparti combattenti e la guardia del campo fu affidata quasi esclusivamente ai territoriali, uomini sui sessant’anni. Per contrasto, sulla strada, fuori dal campo, vedemmo passare, inquadrati con la divisa della Wermacht, dei ragazzini di 13-14 anni, come quelli che appaiono in una famosa fotografia in cui si vede Hitler che accarezza uno di loro. Vedemmo anche, in quella occasione, passare i primi reparti di ragazze soldato: erano le peggiori. Ne ricordo una che, armata di tutto punto con la Maschinenpistole, si rivolgeva a noi che la guardavamo dall’altra parte del reticolato, facendo un gesto assai significativo; portava la mano libera all’altezza dell’inguine e alzava l’indice, muovendolo in senso di diniego, come per dire che a noi non ne toccava. La cosa ci lasciava del tutto indifferenti, anche perché la vita nel lager mi ha dimostrato che i desideri dell’uomo sono ordinati in una strettissima gerarchia. I nostri sogni, infatti, quelli di tutti gli affamati, erano popolati di pane, uva, fette di salame, uova: nessuno sognava donne nude. E solo dopo la liberazione, quando cominciammo a mangiare veramente – e non dimentichiamo che c’era chi aumentava di peso mezzo chilo al giorno – passeggiando per le strade di Wietzendorf, mi accorsi che esistevano anche le donne. Liberazione romanzesca Tornando all’inferno di Wietzendorf, noi avevamo sempre pensato che fosse quello il campo dove avevano deciso di eliminarci. Nel Diario clandestino, Guareschi ha narrato la storia della nostra mancata fucilazione, e la contrastata vicenda della nostra liberazione 5. Ed ecco quanto si legge, a questo proposito, nel citato rapporto del Colonnello Testa al Comando britannico: A conclusione di questo atto di accusa voglio segnalare il più infame delitto che doveva essere perpetrato nei campo e che la sola rapida avanzata delle truppe alleate liberatrici ha potuto evitare. Da elementi raccolti fra personale germanico già in servizio al campo risulta con fondatezza che nella prima decade di aprile era arrivato dalle autorità superiori l’ordine di assassinare gli ufficiali mediante azione di mitragliamento o bombardamento del campo. Risulta anche che erano state prese alcune delle predisposizioni necessarie all’attuazione del massacro. Il piano non venne attuato probabilmente perché gli avvenimenti precipitarono ed i germanici si trovarono di fronte alla certezza di dover scontare presto il delitto. Si giunse invece a quella che fu la nostra veramente romanzesca liberazione, tra il 12 e il 13 aprile. Avevamo visto con terrore che i tedeschi avevano collocato alcune batterie di “katiuscia” a poche decine di metri dal campo e sparavano verso le linee degli inglesi, i quali erano costretti a non rispondere a quel fuoco insensato per non colpire le baracche del lager: ma sapevano che, una volta finite quelle munizioni, i tedeschi non ne avevano altre. Fummo anche, in un certo senso, fortunati, proprio perché in quei giorni – la guerra era praticamente finita – fu ripetutamente diffuso per radio, dal comando delle truppe alleate, un duro ammonimento: qualora fossero state usate violenze, o peggio, ai prigionieri, la punizione sarebbe stata totale e senza riguardi. E bisogna ricordare che, nell’altra metà del nostro campo, vi erano più di mille prigionieri francesi, comandati dal Colonnello Duluc, sgomberati pochi giorni prima dai campi di concentramento situati più a ovest, raggiunti e superati dall’avanzata alleata verso est. Furono, dunque, gli eventi a indurre i tedeschi a lasciare il lager la sera del 12 aprile, lasciando soltanto il capitano Löhse, un vecchio riservista, ex insegnante di lettere antiche, col compito di gestire, appunto, il “trapasso” del campo agli Alleati. Ma questo non ci fu comunicato immediatamente, cosicché noi sapemmo di essere sostanzialmente liberi soltanto la mattina di venerdì 13 aprile, quando dalla baracca d’angolo arrivò un grido: le torrette erano deserte. Non so descrivere la gioia che provai, forse la più grande della mia vita, annegata in un pianto dirotto di meravigliosa, totale liberazione. Rimasti sostanzialmente padroni del campo, demmo fondo alle riserve di patate che vi erano nel campo, interrate in fosse, nonché a tutta la margarina e a quant’altro si trovava nei magazzini: ma per tre giorni non vedemmo nessuno. Fuori dal campo, invece, era un movimento convulso di reparti tedeschi in fuga. Ma, nel pomeriggio del 5 G. GUARESCHI, Diario clandestino, Milano, Rizzoli, 1982 (I ed.: 1949), pp. 181 SS. giorno 16 aprile 1945, alle cinque e mezzo, arrivarono i liberatori scozzesi, comandati dal maggiore Cooley. E arrivò con loro l’abbondanza, resa letteralmente imponente dal numero dei generi che ci venivano distribuiti, compresa una grande quantità di tè, che quasi nessuno consumava e che veniva usato soprattutto per il lavaggio dei piedi piagati. Ma eravamo sempre in un lager, anche se nei reticolati vi erano ampie brecce e non avevamo più né custodi, né sentinelle: e, soprattutto, eravamo brandelli e stracci ambulanti. Fu così che gli inglesi pensarono di trasferirci in una località vicina: Bergen, un grosso borgo che dista circa 15 chilometri da Wietzendorf. Fu perciò conclusa una sorta di “armistizio” di alcune ore, per consentire il nostro trasferimento a Bergen, da dove gli inglesi avevano fatto evacuare dando loro un termine di pochissime ore tutti gli abitanti – due o tremila – costringendoli a uscire dalle loro case e ad avviarsi ai paesi vicini, in cerca di ospitalità forzata. I camion destinati dagli Alleati al nostro trasferimento erano pochi e caricavano solo coloro che avevano grosse difficoltà a camminare: gli altri proseguirono a piedi incrociando gli ultimi gruppi di donne, vecchi e bambini tedeschi, che, alla spicciolata, abbandonavano Bergen. In un bosco avevamo intravisto il corpo del capitano Löhse che pendeva da un albero: ci fu poi detto che era stato impiccato perché ritenuto colpevole di avere favorito eccessivamente i prigionieri. Comunque, proseguendo nella strada da Wietzendorf verso Bergen, ad un certo punto sulla mia sinistra vidi un grosso albero: da quel tronco spuntarono due soldati scozzesi che ci salutarono. Fu la prima volta che ebbi la sensazione che la guerra fosse finita e così anch’io feci gli ultimi cinque chilometri su un autocarro guidato da un soldato scozzese che aveva già fatto un primo viaggio, trasportando i più deboli. Arrivammo così a Bergen e, verso le tre del pomeriggio, quasi duemila ufficiali si erano sistemati nelle case. Fu una emozione incredibile vedere per la prima volta, dopo quasi venti mesi, una tavola, un piatto, una tendina colorata, e i piccoli quadri alle pareti: la testimonianza di una vita di tutti i giorni, che ci era sembrata per tanto tempo irraggiungibile. C’era di meglio: nel cortile della casa che ci era stata destinata vi era un pollaio, con una trentina di galline, su cui tutti si avventarono: era carne che si aggiungeva ai viveri che gli Alleati continuavano a distribuirci: in poco tempo tutti i polli, i conigli e i maiali di Bergen furono divorati. Vi era poi la ricerca delle “riserve occulte”. Come tutti sanno, in Germania vi era il razionamento e, per gli accaparratori, era addirittura prevista la pena di morte; e molti, in Italia, erano convinti che in Germania non ci fosse il mercato nero che, da noi, fioriva alla luce del sole. E, invece, constatammo che il mercato nero esisteva anche in Germania: il che, tenendo presente il rischio che comportava, aveva come conseguenza che i viveri “proibiti” – che avevano costi altissimi venivano nascosti con estrema cura: ne furono trovati anche nelle intercapedini dei muri. Un altro ricordo: gli ex internati, armati di bastoni di ferro, andavano in giro battendo sul terreno: sembravano rabdomanti in cerca dell’acqua. E quando avvertivano una risposta sonora diversa dal solito, avevano la certezza di avere trovato il tesoro: vi erano, infatti, nascoste a varie profondità, scatolette di carne a non finire, gallette e, in particolare, moltissime scatole di frutta sciroppata. Insomma, i giardini delle case erano stati trasformati in piccole miniere. La “Bengodi” di Bergen durò più di una settimana, e cioè fino al 1° maggio 1945, quando il rimpatrio, che tutti speravamo imminente, si dimostrò impossibile. E allora non restava che riportarci nelle nostre baracche a Wietzendorf. Facemmo man bassa di tutto, ripeto tutto, quello che trovammo nelle case dei tedeschi; e ce ne impadronimmo con una sorta di autentica soddisfazione. Ripeto: riportammo con noi tutto quello che era possibile portare via, dagli indumenti alle scarpe, dai piatti ai bauli, dalla biancheria alle posate e persino ai mobili, purché fossero trasportabili sui camion che gli Alleati misero a disposizione. L’attesa fu lunga perché non vi erano i treni per noi: per mia fortuna, e grazie anche a un sotterfugio, riuscii a tornare in Italia il 29 luglio 1945, mentre la maggior parte degli ex internati dovette attendere almeno un altro mese. Come ho già detto, il secolo scorso è stato caratterizzato dalla migrazione delle coscienze. Mai si era vista una negazione più radicale del cristianesimo. Il fatto che, in condizioni letteralmente drammatiche, tanti ufficiali italiani abbiano anteposto il dettato della loro coscienza a ogni altra valutazione, anche a costo della vita, e comunque di sofferenze infinite, deve essere ricordato a questa Italia distratta e qualsiasi. E pur vero che al nostro ritorno fummo guardati da lontano perché i vincitori erano altri e la nostra Resistenza era silenziosa. Ma oggi, a mezzo secolo di distanza, si comprende che il nostro esempio resta un fatto pressoché unico in Europa: e gli uomini guida che contribuirono a renderlo possibile vanno onorati – e chiedo scusa per l’enfasi – come degli eroi. APPENDICE COMANDO ITALIANO CAMPO 83 Al Comando Truppe Britanniche Oflag 83 Nella mia qualità di Comandante dell’Oflag 83 dal giorno 9/2/1944 al giorno della liberazione 16/4/1945 e perché le Autorità Britanniche abbiano elementi per i provvedimenti contro i germanici nell’ordine dei criminali di guerra, espongo qui di seguito la situazione generale del campo, le violazioni alle norme e convenzioni internazionali, i delitti commessi dal personale germanico di questo campo. I. SITUAZIONE GENERALE DEL CAMPO Il campo di concentramento di Wietzendorf era in origine abitato da prigionieri russi. Della vita che vi hanno condotto questi e del loro trattamento, testimonia il cimitero russo sito nei pressi del campo (lato nord a circa i km e mezzo dal campo) nel quale si trovano sepolte oltre 16.000 salme. Sgombrato dai russi, probabilmente per le condizioni di inabitabilità, servì nell’autunno dell’anno 1943 allo smistamento dei prigionieri italiani che vi passarono in numero di molte decine di migliaia. Anche generali vi alloggiarono per più giorni, a terra e senza alcuna sistemazione non di conforto, ma strettamente umana. In seguito allo sgombero dei campi di Polonia, nel gennaio 1944, il campo fu destinato, con la denominazione di Oflag 83, agli ufficiali italiani. Più di una descrizione delle baracche adibite ad alloggio, degli impianti sanitari ed igienici, vale il fatto che due commissioni sanitarie tedesche, presiedute da colonnelli medici tedeschi dichiararono il campo inabitabile. Nelle camerate buie e basse, costruite con blocchi di cemento, gli ufficiali vissero per 15 mesi in un affollamento (da 50 a 90 ufficiali in ambienti da 650 m 3) che non permetteva neanche la vita normale. Spesso da 10 a 20 ufficiali per camerata hanno dovuto dormire sul pavimento in pietra, senza neanche pagliericcio o su tavoli. La paglia, per quelli che sono riusciti ad averla, non è mai stata cambiata. Dai tetti sconnessi l’acqua cadeva sui tavoli e sui letti. Durante l’inverno nell’interno delle camerate scendevano ghiaccioli da 20 a 30 cm., mentre qualsiasi riscaldamento veniva negato (4 distribuzioni di legna in ragione di 20 Kg circa per camerata in tutta la stagione). Tutti i canali di scolo delle acque di rifiuto delle latrine correvano allo scoperto, ammorbando l’aria. Le latrine erano semplicemente indescrivibili, tanto che costituiscono anche oggi la maggiore preoccupazione delle Autorità Britanniche che hanno preferito ordinare la costruzione di latrine campali. Gli impianti bagni erano del tutto rudimentali e senza nessuna garanzia igienica. Il bagno veniva effettuato una volta circa al mese in un affollamento enorme, 6, 8, e perfino 10 ufficiali per doccia e col sistema tedesco di urli, spinte o di fare tutto in un tempo assolutamente insufficiente. A tutte le richieste, pressioni, proteste per miglioramenti, quando non veniva risposto semplicemente “per ufficiali italiani era anche troppo”, che “coi traditori ecc...”, si obiettava che la Germania era al quinto o sesto anno di guerra, che anche la popolazione civile tedesca ... che si sarebbe fatto il possibile ... e la situazione non cambiava. Solo nell’autunno-inverno 1944-45 furono ricoperte alcune delle canalizzazioni delle acque putride e furono costruite delle baracche rudimentali per lavanderie e lavatoi. Fino ad allora gli ufficiali dovevano attingere l’acqua per tutti gli usi alle poche fontane (una per mille ufficiali circa), fontane che erano spesso guaste e che comunque non davano acqua potabile, sicché bisognava ricorrere alla bollitura. Infine l’infermeria per una forza di ufficiali che ha oscillato fra i 3-5 ed è arrivata ai 6mila era del tutto inadeguata. La capacità di ricovero era di 60 persone e solo nei primi mesi del 1945 fu portata a 100. Nessun impianto tecnico, nessuna possibilità di intervento chirurgico, nessun mezzo di rapido sgombro per i casi di urgenza, neppure medicinali esistevano, neanche i più comuni, nemmeno in minima misura. Agli ufficiali venivano sottratti i pochi medicinali di proprietà privata, che essi erano riusciti a salvare dalle numerose perquisizioni, ma solo assai pochi di questi medicinali arrivavano all’infermeria, ove quasi tutte le cure consistevano nella buona volontà dei medici italiani. II. VIOLAZIONE DELL E NORME E CONVENZIONI INTERNAZIONALI Il regolamento del campo era redatto in armonia con le convenzioni internazionali e citava sia queste, sia la nazione protettrice, sia la C.R. Internazionale. Evidentemente era una copia di quanto era in vigore per prigionieri di guerra delle altre nazionalità. In realtà tale regolamento non ebbe mai efficacia alcuna, se non nei casi in cui dava appiglio ai provvedimenti a nostro carico. 1° Era negato ricoprire la bara dei caduti con la bandiera della Patria. Alle mie rimostranze il comando germanico del campo rispose che “potevo ricoprirla con la bandiera della Rep. Soc. Italiana”. Così i nostri morti non hanno avuto l’onore della bandiera. 2° Non esisteva una nazione protettrice. Alle mie rimostranze veniva risposto che noi eravamo protetti dalla Repubblica Sociale Italiana. Così al danno si aggiungeva l’offesa. 3° Era proibito rivolgersi alla C.R. Int. Le lettere da me scritte mi venivano respinte. Poiché io protestavo dicendo che le lettere erano scritte in base al regolamento del campo, mi veniva risposto che il regolamento, per quanto riguardava il diritto di ricorso alla C.R. It. non aveva vigore. Di fatto però non è mai stata portata variante al regolamento in tale senso. 4° Tutti gli ordini che venivano emanati in violazione alle norme internazionali venivano comunicati solamente a voce. Inutilmente ho chiesto sempre ordini scritti. Veniva risposto che dovevo accontentarmi della parola degli ufficiali tedeschi. 5° Nessuna commissione internazionale della C.R. Int. ha mai potuto visitare il campo. 6° Inizialmente veniva usato come sistema di punizione la sospensione del servizio postale, sia individuale che collettivo. Tale provvedimento cessò dopo la mia assunzione di comando, in seguito alle mie proteste. 7° In seguito al ritardo all’appello di alcuni ufficiali, tutto il campo venne punito con la chiusura per due giorni dei locali di ritrovo (sala di lezioni, biblioteca, teatro) e della chiesa. Uguale punizione venne anche inflitta per 20 giorni ad un ufficiale. Tale punizione non venne più inflitta dopo il mio colloquio estremamente energico con il comandante germanico del campo. 8° Spessissimo venne applicata la punizione collettiva di fare restare interi blocchi in riga per più ore sotto la pioggia e la neve. Ciò per singoli ritardi all’appello! La punizione venne talora integrata con la chiusura di interi reparti del campo. 9° I soldati scontavano le punizioni in un locale interrato, di cui emergeva il solo tetto, in condizioni addirittura spaventose. Essi avevano il solo pane, talvolta neppure quello. In tale locale vennero puniti saltuariamente anche ufficiali. 10° Il locale degli arresti degli ufficiali non fu riscaldato durante tutto il decorso inverno se non saltuariamente, sotto la mia personale responsabilità in relazione agli ordini germanici, con legna sottratta alla lavanderia e con la tolleranza del personale subalterno germanico. Un ufficiale agli arresti ha riportato congelamento di terzo grado. 11° I puniti non avevano diritto alla passeggiata giornaliera, né erano loro consentite le pratiche religiose, anche se le punizioni e l’attesa di giudizio duravano lunghi periodi. 12° L’apertura dei pacchi in arrivo dalle famiglie dava luogo a provvedimenti drastici. Veniva sottratto ogni involucro di qualsiasi specie ed ogni recipiente. Spesso nel gamellino dell’ufficiale venivano versati insieme i generi più svariati, come latte condensato, pesce in scatola, tabacco, zucchero, riso, sale, ecc. Spesso con la scusa di una firma dietro una fotografia rinvenuta nel pacco o per un biglietto, veniva sottratto una parte o tutto il contenuto del pacco stesso. 13° Per lunghi periodi e soprattutto nell’inverno 1944-45, in cui la temperatura – per oltre 40 giorni – rimase meno dieci gradi e raggiunse un minimo di -19, non fu concesso combustibile per la cottura dei generi dei pacchi. Il combustibile per il riscaldamento fu dato in tutto 4 volte ed in quantità irrisoria. Si ebbero nelle camerate numerosissimi casi di congelamento di primo, secondo ed anche terzo grado. 14° Le tabelle viveri sono sempre rimaste al disotto dei valori minimi necessari alla vita per individui a riposo assoluto. Nell’ultimo inverno esse divennero addirittura tragiche e nei mesi da febbraio alla liberazione scesero addirittura al disotto delle mille calorie giornaliere. Nessuna protesta, nessun appello al diritto di civiltà e dei popoli giovarono a nulla. Le morti per sfinimento e per complicazioni dovute al deperimento si fecero sempre più frequenti. I casi di edemi da fame si contarono a centinaia, i congelamenti parziali per difetto di circolazione derivante da denutrizione erano di tutti. Due o tre settimane di ritardo nella liberazione avrebbero provocato la catastrofe del campo. 15° I generi già insufficienti, come è detto sopra, venivano ridotti ulteriormente dalla mala fede germanica. Fra i generi dovuti e non consegnati negli ultimi mesi, figurano: circa 5 tonnellate di marmellata, 20 tonn. di rape, 2 tonn. di patate. Inoltre il pane veniva dato a forma e non a peso, provocando una perdita giornaliera da gr. 5 a gr. 20 per persona; le patate venivano consegnate al lordo con terra e paglia dei depositi, cosa che provocava un calo del 10-15%. A tutte le proteste veniva risposto con argomenti che di fronte alle messe a punto si trasformavano in difficoltà di trasporto o più spesso in “ho detto così e basta”. 16° E stata sempre negata ed impedita qualsiasi assistenza della Croce Rossa Internazionale. 1 7° Medici, cappellano ed in genere sanitari, erano considerati dal regolamento del campo come non internati. In realtà hanno sempre avuto trattamento uguale a tutti gli altri. 18° Nel campo era alloggiato un gruppo di 150 soldati adibito a lavori speciali. Io potevo accedere a questi soldati solo una volta la settimana ed accompagnato da interprete germanico. 19° Le perquisizioni personali e di camerata costituirono per lunghi mesi una delle ossessioni del campo. Oltre a quelle in occasione degli arrivi e delle partenze, sistematicamente e per più mesi, venivano perquisite due o tre camerate al giorno. Gli ufficiali venivano portati fuori dalle camerate, circondati dai soldati della polizia e perquisi- ti a nudo, spesso sotto la pioggia e la neve. Veniva loro ordinato di aprirsi le natiche per mostrare l’interno dell’ano. Nel frattempo un’altra schiera di poliziotti buttava a soqquadro la camerata smontando letti, pavimenti, pareti, sicché l’ambiente restava inabitabile per più giorni. In queste occasioni requisivano le cose più impensate ed anche quelle necessarie, dalle lenzuola alla boccetta di profumo, dal pezzo di cuoio alla saponetta nuova, tutto sotto l’imputazione che ciò poteva essere impiegato alla borsa nera. (Borsa nera che ha avuto sempre una vita assai ridotta perché nulla poteva entrare nel campo dall’esterno). Oltre a queste sottrazioni, legittime secondo i tedeschi, i poliziotti rubavano tutto quello che poteva essere loro utile e soprattutto il poco tabacco e i grami viveri. Se l’ufficiale reclamava si prendeva anche gli arresti e veniva minacciato di denuncia al tribunale, per avere calunniato soldati germanici. 20° Il comandante germanico del campo non ha mai impedito che unità combattenti schierassero nelle immediate adiacenze del campo (in taluni punti fino a 20 m dal reticolato) numerose batterie di lanciagranate ed artiglierie. Ciò ha dato luogo nella notte fra il 15 ed il 16 aprile ad un combattimento nelle immediate vicinanze del campo. 21° Ma la più grande tragedia del campo è stata quella del lavoro obbligatorio. Questa non è la sede per una minuta descrizione. Per oltre sei mesi gli ufficiali sono stati sottoposti a tutte le forme di propaganda, minacce, soprusi e sono stati inviati al lavoro col sistema del mercato degli schiavi. Gli ufficiali venivano convocati in teatro, sotto la luce di proiettori, e sottoposti alla scelta di impresari e contadini tedeschi che palpavano loro gli arti e guardavano loro in bocca quasi fossero delle bestie. Ufficiali che si rifiutavano di partire, venivano portati fuori dal campo da sentinelle armate di fucile e baionette. Più volte per scovare i renitenti sono stati fatti appelli improvvisi e gruppi di ufficiali sono stati condotti via a forza. Inoltre gli ufficiali che venivano consegnati agli uffici civili del lavoro dovevano passare alla condizione di civili. Veniva loro ordinato di togliersi il distintivo di grado ed i fregi dell’uniforme. Ho letto un ordine riservato germanico, e di questo ho conservato trascrizione mnemonica, in cui è detto che gli ufficiali che si rifiutavano di lavorare dovevano essere passati ai campi di punizione e di polizia; molti infatti vi sono stati inviati e parecchi vi sono morti. A nulla sono servite le centinaia di proteste verbali e scritte degli ufficiali, né quelle mie presentate in qualità di comandante del campo. L’ultima mia protesta scritta in forma particolarmente solenne ed energica è stata diretta al comando supremo germanico (O.K.W). Per questo sono stato chiamato al comando germanico in presenza di testimonio germanico e diffidato e minacciato dicendomi che mi mettevo contro Hitler e Mussolini e che andavo incontro a gravissime conseguenze. La protesta per mia decisa insistenza ebbe corso e fu inoltrata. I germanici dicevano che il lavoro era obbligatorio per gli ufficiali, perché così era stato stabilito in un accordo fra la Germania e la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana 6. Ma noi eravamo e restavamo nei campi di concentramento come autentici volontari, proprio perché non riconoscevamo tale Repubblica e perché eravamo fedeli alla vera libera Italia. Ufficiali già inviati al lavoro, in seguito ad energico rifiuto di lavorare sono stati talvolta fatti rientrare al campo di concentramento da autorità esterne. Essi però sono stati trattenuti all’ingresso del campo, imprigionati a Wietzendorf e di qui inviati nelle carceri di Soltau e successivamente nel campo di punizione di Unterlüss. Di questi fatti non è mai stata data comunicazione al Comando Italiano del campo che ne è venuto a conoscenza solo a liberazione avvenuta. A questi ufficiali come ad altri che dalla località di lavoro obbligatorio chiedevano di parlare con me, fu negato tale permesso sotto il pretesto che da me non dipendevano più perché d’autorità passati allo stato di civili. III. DELITTI 1° Il giorno 8 marzo 1944 durante un allarme una sentinella germanica sparò 4 colpi di fucile contro alcuni ufficiali che si trovavano nell’interno di una baracca presso la porta aperta. Fu ferito gravemente il Cap. Mancini Guido e leggermente di striscio un altro ufficiale. La pallottola attraversò alcuni posti letto. Il Cap. Mancini dovette rimanere per due ore nella camerata fredda e senza alcuna cura; era, per giunta, a causa dell’allarme, digiuno da 24 ore. Nessun mezzo di rapido sgombero fu messo a disposizione per il trasporto in un ospedale. L’ufficiale morì nella notte all’infermeria italiana, dove le cure chirurgiche non potevano andare al di là della buona volontà. Da informazioni fondate, ma non controllate, sembra che l’ordine di sparare fosse stato dato alla sentinella dall’ufficiale del campo, quel giorno anche ufficiale di servizio, Cap. Leimberger. 2° Il giorno 20 giugno 1944, dopo tre o quattro minuti che era stato suonato l’allarme aereo e mentre ancora gli ufficiali correvano per raggiungere le rispettive camerate, una sentinella colpì con una fucilata il Sott. Fiorentini Salvatore. Il proietto entrò dal petto ed uscì dalla schiena attraversando il polmone destro e la pleura. L’ufficiale 6 Si allude qui all’intesa Hitler-Mussolini del 20 luglio 1944, che consentiva agli IMl, con qualche eccezione, di passare allo status di ‘liberi lavoratori’ del Reich. L’iniziativa ebbe talmente poco successo che i tedeschi finirono per provvedere a una generalizzata applicazione coatta dell’accordo. Cfr. P. NELLO, La “resistenza clandestina”, cit., pp. 157-158, nota 35. rimase a terra per oltre 10 minuti quantunque altri ufficiali chiamassero al soccorso ed il ferito stesso fosse sotto gli occhi della sentinella e di altro personale germanico. E da rilevare che il segnale d’allarme, mai ben chiaro, perché costituito da rintocchi di bossoli vuoti, era stato dato in maniera particolarmente confusa. 30 Il giorno 28 febbraio 1945 all’inizio di un allarme aereo, segnalato in modo confuso tanto che oltre metà del campo non si considerava in allarme, una sentinella sparò su un gruppo di ufficiali che si affollava alla fontana e ferì gravemente alla coscia il Tenente Zamitel Marco. 4° Colpi di arma da fuoco sparati dalle sentinelle del campo contro gli ufficiali ammontarono in tutto ad una cinquantina ed è per pura fortuna se i casi di morte o ferimento non sono stati più numerosi. Per precisare la criminalità germanica cito alcuni episodi: una sentinella ha sparato senza alcun motivo su un gruppo di ufficiali che sostavano presso la cucina. Il colpo, per combinazione, ha ferito ad un piede un soldato germanico che si trovava in quei pressi. Un soldato italiano svegliatosi ignaro che ci fosse l’allarme era uscito dalla baracca, la sentinella gli sparò senza colpirlo. Il soldato nell’attimo di panico non riusciva a riaprire la porta per rientrare in camerata e la sentinella gli sparò una seconda volta, senza colpirlo. Uno dei proiettili penetrato in camerata forò una gavetta che si trovava su di un tavolo in mezzo ad un gruppo di ufficiali – per l’accensione di un fiammifero, più di una volta fu sparato nella finestra. Tutti i colpi venivano sparati senza preavviso. 5° Il giorno 18 settembre 1944, durante l’appello, una sentinella colpiva col calcio del fucile alla faccia un ufficiale, procurandogli un’ampia ferita per il solo fatto che l’ufficiale aveva in bocca il bocchino della pipa (non la pipa). Su mia protesta la sentinella fu allontanata dal campo per un certo periodo, poi ricomparve. 6° Il giorno 3 gennaio 1945, prima dell’appello, un ufficiale ed una sentinella si scontrarono nella porta di una camerata. La sentinella perse l’equilibrio senza però cadere e per reazione colpì alla testa l’ufficiale, producendogli una vasta ferita. Si cercò di ribattere alle mie proteste che l’ufficiale aveva aggredito la sentinella e che questa aveva reagito per legittima difesa! 7° Il Ten. Col. Di Palma è stato processato ed ha scontato sei mesi di carcere duro per avere svolto fra gli ufficiali azione patriottica. Gli è stato imputato il fatto specifico di aver mostrato davanti alla tabella della propaganda germanica un cartello con la scritta “non siamo degli stupidi” (testuale in napoletano”ca nisciune è fesso”). Durante la detenzione del Ten.Col. Di Palma nel campo neanche a me era permesso parlargli. Gli è stata negata l’assistenza religiosa. 8° Il Tenente Crucioli è stato processato ed ha scontato tre mesi di carcere duro perché trovato in possesso di due radio. Ritornato nel campo ha esplicato propaganda contro il lavoro e contro la Germania: in seguito a ciò è stato nuovamente avviato al carcere con segregazione cellulare e riduzione di vitto. Ivi rimase due mesi (fino alla liberazione). 90 Il Col. Riddan ed il Ten. Col. Favaloro sono stati allontanati dal campo e processati ad Amburgo, sembra per azione antigermanica svolta all’atto della cattura. Secondo informazioni fornite dal personale germanico essi sarebbero stati fucilati. I casi su esposti si riferiscono soltanto a fatti determinati e specifici. Il trattamento però usato agli ufficiali è stato quasi sempre brutale, arrogante ed accompagnato da urli, spinte e percosse. Inoltre io mi sono limitato alla vita del campo di Wietzendorf. I viaggi di trasferimento in carro bestiame meriterebbero un capitolo a parte per il trattamento bestiale usato agli ufficiali italiani viaggianti sino a sessanta per carro, senza mangiare, senza coperte, senza modo di fare i bisogni corporali, spesso privi di scarpe, cinghie e bretelle per impedire tentativi di fuga. Attraverso le persecuzioni materiali i germanici hanno voluto creare un ambiente di incubo per fiaccare la resistenza morale degli italiani e farli aderire alle loro idee od al lavoro. Posso dire con tutta semplicità che non ci sono riusciti. Per i fatti sopra elencati, relativi al campo di Wietzendorf, io denuncio alle autorità alleate quali criminali di guerra: - Il Col. Bernardi nella sua qualità di comandante responsabile del campo. E mia convinzione che il Col. Bernardi, quantunque molto severo, abbia cercato di agevolare gli ufficiali italiani, specialmente nella questione del lavoro. Egli però temeva conseguenze soprattutto ad opera del Cap. Rorich. Sta di fatto che il Col. Bernardi era odiato dal personale germanico. Queste condizioni non escludono, peraltro, le sue responsabilità di Comandante. Il Cap. Rorich capo della polizia del campo, istigatore di tutte le persecuzioni. Il Capit. Leimberger, istigatore della morte del Cap. Mancini. Il Cap. Eilenstein, ufficiale giudiziario ed esecutore materiale delle persecuzioni e dei furti. Il Cap. Von Mollermis, distintosi nelle punizioni collettive e primo responsabile dello sciupio dei viveri dei pacchi. Il Cap. Reinschindt, capo dell’Ufficio del lavoro e primo responsabile dei maltrattamenti usati agli ufficiali in questa attività. Il Cap. Medico Girtler, responsabile delle inumane condizioni dell’infermeria del campo. Il Sonderführer (assimilato) Alesc, capo della propaganda del campo e complice delle pressioni per il lavoro. Era una delle anime nere. Il Sonderführer Hans, negriero del lavoro. Lo Zahlmeister (assimilato) Bohr, capo del servizio viveri e responsabile di tutti i generi forniti in meno del dovuto. - Il Caporale Strassmajer, complice del Bohr nelle decurtazioni dei viveri. Ha sparato con la pistola contro un ufficiale che tentava di prendere una patata. Si è distinto nei maltrattamenti. - Il solido interprete Huss, braccio destro del Cap. Rorich e distintosi nel servizio spionistico del campo, anche se non si possono citare fatti concreti. In lui si deve vedere il primo colpevole delle condanne del Ten. Col. Di Palma e del Ten. Crucioli. Era il più infido elemento del campo. A conclusione di questo atto di accusa voglio segnalare il più infame delitto che doveva essere perpetrato nel campo e che la sola rapida avanzata delle truppe alleate liberatrici ha potuto evitare. Da elementi raccolti fra personale germanico già in servizio al campo risulta con fondatezza che nella prima decade di aprile era arrivato dalle autorità superiori l’ordine di assassinare gli ufficiali mediante azione di mitragliamento o bombardamento del campo. Risulta anche che erano state prese alcune delle predisposizioni necessarie all’attuazione del massacro. Il piano non venne attuato probabilmente perché gli avvenimenti precipitarono ed i germanici si trovarono di fronte alla certezza di dover scontare presto il delitto. Segnalo, infine, quantunque ciò non riguardi gli italiani, né a quanto sembra il personale germanico ha svolto azione sugli italiani dell’Oflag 83 [sic!] che presso il campo di Wietzendorf esiste un cimitero russo in cui sono sepolti sedicimila uomini (cifra non precisabile perché alcune fosse comuni sono senza indicazione). Una accurata inchiesta potrebbe stabilire eventuali responsabilità perché è strano, anche se si fosse trattato di epidemia, che tanti uomini siano morti in un breve lasso di tempo in un campo che non poteva ricoverare, anche con ripieghi, oltre 20-30 mila persone. Il Comandante Pietro Testa Bibliografia essenziale di Giovannino Guareschi - Archivio Guareschi - «Club dei Ventitré» Via Processione, 160 - I - 43011 Roncole Verdi (PR) Tel. (39) 0524 92495 - fax (39) 0524 91642
Scaricare