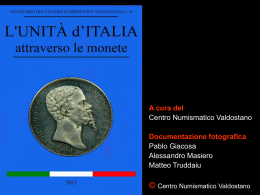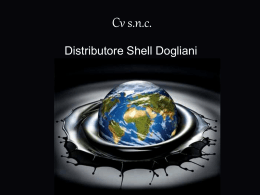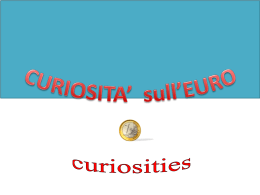STORIA DI UN CYCLECAR Nel 1920, in Italia, a più di un anno dalla conclusione della prima guerra mondiale, la vita era molto difficile, ogni giorno di più. Le materie prime erano aumentate, rispetto all’anteguerra, da dieci a dodici volte. Una camicia pagata dieci lire nel 1915 ora costava 100, un paio di calze da 5 era passato a 80 lire, la carta da 40 lire al quintale ne costava 600. Per non parlare del carbone, aumentato di 20 volte rispetto a prima della guerra, ed ora pagato 700 lire alla tonnellata. L’indice dei prezzi all’ingrosso era passato da 106 del 1914 a 492 nel 1919, per arrivare a 652 nell’estate del 1920. Se nel 1915 si importavano 18 milioni di quintali di grano e 153.000 quintali di carni congelate, ora se ne dovevano importare rispettivamente 24 milioni e due milioni di quintali. Gli approvvigionamenti fondamentali, come il grano e il carbone, dipendevano dall’estero, il che causava un insostenibile indebitamento dello Stato che ogni anno spendeva per queste due sole voci dodici miliardi. A giugno il Ministro del Tesoro stimò il deficit dello Stato in 14 miliardi, di cui sei dovuti all’importazione del grano. Pochi mesi prima la bilancia commerciale aveva registrato una differenza tra il valore delle esportazioni e il valore delle importazioni di due miliardi e 658 milioni di lire, poi ridotti ad un miliardo nel febbraio 1920. Corollario e aggravante di tutto questo, in un circolo vizioso apparentemente senza uscita, agitazioni, occupazioni delle fabbriche, scioperi, con conseguente crollo delle produzioni, attentati, tumulti, saccheggi e rivolte. Si ribellavano i bersaglieri, l’esercito schierava le mitragliatrici contro i treni di scioperanti, in larga parte operai rivendicanti aumenti salariali che tenessero conto dell’aumento del costo della vita. Le paghe erano infatti state aumentate, ma non nella stessa misura dell’inflazione: da una media giornaliera di 3,5 lire del 1914, gli operai dell’industria meccanica erano passati a guadagnarne 8,84 nel 1919 e 10,2 nel luglio 1920. La produzione era bloccata in più di tre quarti delle officine, l’intera nazione appariva paralizzata da convulsioni politiche ed economiche sempre più difficilmente controllabili. Sull’automobile si abbatté, nell’indifferenza generale, una serie di provvedimenti uno più punitivo dell’altro. A fronte di una circolazione tutto sommato esigua (31.500 autovetture, su una popolazione di 38 milioni di abitanti, per una densità di un veicolo ogni 1200 abitanti, peggio di noi stavano soltanto Portogallo e Grecia) l’automobile fu frettolosamente catalogata oggetto di lusso, al pari dei frutti canditi, degli aeroplani e degli strumenti di pesca (sic) e perciò gravata di tasse pesantissime. La benzina per uso privato era razionata: soltanto sei latte al mese, e per latta si intendeva un contenitore da 12,5 litri, che costava 54 lire a Modena, 80 lire a Montecatini, 65 lire a Reggio Emilia, 60 lire a Parma. L’importazione delle automobili era vietata, tranne per quelle provenienti dalla Francia; ciò però non aveva impedito la nascita di un vivace mercato di importazione parallela illegale. Tanto era vivace che, a fronte del divieto di importazione, lo Stato con apposita legge raddoppiò i dazi sull’importazione: con risultato che finì tassato ciò che per legge non doveva esistere. Vi fu anche qualche economista che sostenne che “per le automobili, il cui consumo non è necessario né urgente, bisognerebbe che alle fabbriche produttrici fosse imposto l’obbligo di assicurarsi della necessità in cui l’acquirente si 1 trova di far l’acquisto, per urgenze improrogabili di commercio o di industria. Con i cambi alle altezze odierne produrre e vendere automobili per uso interno è un danno gravissimo per il paese”. In realtà non fu necessario intimorire ulteriormente quei pochi, sparuti coraggiosi che si presentavano a comprare una macchina. Bastò l’aumento del prezzo della benzina, deciso nel marzo, di 40 lire al quintale, il che portava il costo a 320 lire al quintale (così si misurava allora)*. Ancora più del rincaro esasperava gli automobilisti il razionamento della benzina, quelle famose sei latte al mese che, con i consumi delle vetture in commercio all’epoca, non potevano certo assicurare una grande autonomia. Per di più qualche prefetto, per esempio quello di Milano, cominciò a vietare l’uso dell’automobile dalle 20 alle 6 del mattino e nei giorni festivi, per non parlare del divieto per tutte le giornate a rischio politico, come il primo maggio, festa dei lavoratori. Ma non bastava, non bastava mai. Si sparse la voce che il governo stava per approvare un decreto che avrebbe totalmente o parzialmente sospeso la vendita delle automobili in Italia, per favorirne l’esportazione all’estero: operazione non così facile, visto che non solo l’Italia ma tutte le nazioni del mondo stavano erigendo pesantissime barriere fiscali alle reciproche esportazioni. Non mancavano gli speculatori, soprattutto sui contratti di vendita stipulati prima della guerra, o comunque risalenti ad un’epoca in cui i costi delle materie prime non erano ancora così insostenibili. Non fu raro il caso di vetture uscite nuove di fabbrica a venti, trentamila lire e rivendute freneticamente nel giro di poche ore, fino ad arrivare alla cifra record di 125, 130 mila lire. Le fabbriche erano infatti costrette, per fedeltà ai contratti, a vendere i propri prodotti tra le dieci e le ventimila lire, quando ormai il costo reale di produzione di una vettura media era arrivato a sfiorare le cinquantamila lire. Su materie apparentemente senza importanza, come l’uso delle targhe in prova, sembrava inoltre che il governo si volesse accanire, senza una ragione chiara. La targa in prova era anche allora uno strumento usato dai concessionari e venditori per permettere ai propri clienti di provare una macchina, in vista dell’acquisto. Ma per chiedere e ottenere l’uso della targa in prova occorreva prima consultare la legge del 10 luglio 1910, il regolamento del 10 agosto 1910, quello del 30 giugno 1912, poi il regolamento del 2 giugno 1914, e quello del 10 settembre, poi il decreto del 22 ottobre, quindi il decreto del 9 novembre 1916, la legge del 20 febbraio 1918, il decreto del 24 novembre 1919, la legge del 24 settembre 1920 e se si era ancora vivi le istruzioni ministeriali del 20 dicembre 1920. Per una misera targa in prova! Scriveva Motori Aero Cicli e Sports, rinomata rivista d’autombilismo: “Non sarebbe più onesto che il governo una buona volta con brutale sincerità dichiarasse: Non voglio più sapere di automobili, voglio estirparne fin il ricordo, e al diavolo tutte le targhe in prova e non in prova, tutti i permessi, tutti i bolli, le licenze e finanche il nome dell’automobile?” Ma tutto questo era ancora niente, quando si abbatté sull’esangue mondo automobilistico la nuova tassa di circolazione. “La legge sull’aumento della tassa automobilistica é…quanto di più mostruoso, di più stupidamente dannoso abbia escogitato finora alcun ministero italiano, e appunto perciò si può essere sicuri che sarà approvata per prima e alla più lesta”. Si trattava effettivamente di un aumento da 5 a 12 volte rispetto al 1919, che già aveva registrato il raddoppio della tassa rispetto al 1918. Una Fiat 501, uno 2 dei modelli più diffusi, da 195 lire pagate nel 1919 passava a pagarne 1290; un’Ansaldo da 255 a 1740, una Rapid da 195 a 1432, una Scat da 510 a 5356. Per non parlare delle vetture di lusso, come la Isotta Fraschini 8 cilindri che avrebbe dovuto pagare la cifra record di 15.000 lire (da 765) , o la Lancia a 12 cilindri, anche lei condannata a pagare 15.000 (da 925). Si scatenò un’ondata di indignazione popolare, almeno negli ambienti che potevano aver a che fare con un’automobile. Si dimostrò che il fisco italiano pesava 25 volte in più nelle tasche degli automobilisti rispetto al fisco francese; si sostenne che con una tassazione così onerosa le vendite di automobili sarebbero crollate, con gravissimi danni ad un comparto industriale tra i più promettenti della nazione; si calcolò che lo stato non avrebbe raggiunto affatto lo scopo voluto, quello di introitare una cifra doppia o tripla rispetto ai 27 milioni di lire tratti dal settore automobilistico nel 1920, tra tassa sulla benzina, tassa di circolazione e dazi doganali, bensì una cifra di molto inferiore, in quanto il settore sarebbe andato incontro ad una totale paralisi. Non c’è da stupirsi che in una situazione così difficile tutte le industrie automobilistiche nazionali cercassero una soluzione. Occorreva trovarla, e più che in fretta, tanto più che il mercato potenziale di nuovi clienti era tutt’altro che trascurabile. Durante la guerra oltre centomila uomini erano stati addetti ai trasporti automobilistici nella sola Italia, e decine di migliaia di piloti e meccanici di aviazione si erano abituati a vivere in mezzo ai motori, a circolare in automobile o in motocicletta. Si trattava di una clientela potenziale immensa, trasversale a tutti i ceti sociali e tra loro, non ultimo vantaggio, non pochi avevano anche dimestichezza con i motori e il loro funzionamento. Già subito dopo l’armistizio la Ford aveva cercato di liberarsi dei propri stocks di modelli T invenduti, ed era stata bloccata soltanto con l’intervento dello Stato a protezione delle dogane nazionali. La strada era perciò chiara: occorreva proporre un modello utilitario, economico nell’acquisto e nel mantenimento, che non risentisse troppo degli aumenti della tassa di circolazione e del costo della benzina. La produzione nazionale annoverava, tra il 1920 e il 1921, venti industrie, per la maggior parte solide e collaudate, che producevano complessivamente una trentina di modelli. Erano l’Alfa Romeo, l’Ansaldo, l’Aurea, la Bianchi, la Ceirano, la Chiribiri, la C.M.N., la Diatto, la Fiat, l’Isotta Fraschini, l’Itala, la Lancia, la Moncenisio, la Nazzaro, la O.M., la Restelli, la Scat, la Spa, la Star e la Fast. Di queste, le ultime due erano in grande difficoltà, tanto che la Star aveva abbandonato nel 1920 la fabbricazione delle auto per dedicarsi a quella dei cuscinetti a sfere e la Fast non era riuscita a realizzare il suo annunciato tipo di vettura sportiva e aveva interrotto ogni attività produttiva. Due erano invece di costituzione recentissima, ossia l’Aurea, costruttrice di un tipo unico a 4 cilindri di cui si attendeva l’inizio delle consegne; e la C.M.N., che affrontava il mercato con una 20 HP a 4 cilindri. Delle restanti, quasi tutte, a parte l’Alfa Romeo e la Lancia, proponevano un modello di vettura leggera a quattro cilindri. Per esempio la Diatto 10 HP, di soli 916 cc di cilindrata; o la Restelli, costruita dalle Officine Isolabella di Milano, che proponeva una vetturetta torpedo a quattro posti, in grado di raggiungere i 65 km/h consumando 9 litri ogni 100 km. Questa infatti sembrava la tendenza costruttiva vincente: la vetturetta leggera, se non addirittura il cyclecar, che all’estero, 3 soprattutto in Francia, stava già conquistando ampie fette di mercato. Si trattava di una maniera per offrire un mezzo di trasporto dignitoso, eludendo la tassa di circolazione che per veicoli di peso inferiore ai 350 kg risultava irrisoria. All’Esposizione di Motociclismo di Milano del 1920 era stata presentata la Motovetturetta Brevetto Vaghi costruita dalla Ditta Lodovico Boltri di Mezzi Ganna di Milano. Era un veicolo a tre ruote, con carrozzeria torpedo a tre posti, motore a due cilindri, 8HP di potenza, 80 km/h la velocità massima. La Temperino era una veterana in questo campo: da anni commercializzava vetturette a due posti, in grado di raggiungere una velocità massima di 75 km/h, con un consumo di 5 kg di benzina ogni 100 km. Fu però soprattutto nel 1921 che furono fatti gli esperimenti più interessanti. Compare infatti per la prima volta il 7 marzo 1921, sulla rivista M.A.C.S., la pubblicità di una nuova marca torinese, la MOTOCOR, ossia “MOTOvetturetta Carrozzata Originale Resistentissima”. Si trattava di una vetturella a tre ruote, costruita dalle Officine C.O.R. di Adolfo Salza e progettata da un certo Armino Mezzo, un baffuto gentiluomo che seppe escogitare una serie di soluzioni davvero originali (a cominciare dallo slogan pubblicitario!). “La Moto Cor – recitava il dépliant di vendita – sostituisce con maggior perfezione il sidecar in tutti i suoi usi attuali sia per diporto che per trasporti”. Per di più, la Moto Cor “è sempre pronta, non richiede manutenzione, sostituisce il cavallo con vantaggio di economia e rendimento”. Il peso era di 175 kg, ben inferiore a quello massimo di 350 per poter rientrare nella privilegiata (dal fisco) categoria dei cyclecar. Il modello presentato nel 1920 (anche se sulla stampa cominciarono a comparire le prime notizie, come si è visto, soltanto l’anno successivo) disponeva di un motore a due cilindri orizzontali contrapposti, raffreddati ad aria, con una cilindrata di 575 cc. Il motore, la frizione e il cambio, a tre velocità e retromarcia, erano in blocco; l’avviamento a pedale esterno, come sulle moto; la trasmissione a catena. Il doppio telaio, brevettato, era in tubi di acciaio trafilati, con rinforzi conici interni. Quali vantaggi speciali presentava questo veicolo? Armino Mezzo non esitava a spiegarlo sul dépliant che riproduciamo in queste pagine: “1. Distribuzione uguale del peso tra le tre ruote. 2. Eliminazione assoluta delle vibrazioni del motore risultante dal perfetto equilibrio del collo d’oca e dagli scoppi ad intermittenze uguali e dalla posizione centrale del motore nei rispetti dello chassis. 3. Protezione perfetta delle catene e delle ruote dal fango, loro lubrificazione permanente. 4. Marcia silenziosa. Tutti i comandi interni. 5. Posizione comodissima del conduttore, seduto al volante” (e dove avrebbe dovuto sedersi?). Nel 1921 Armino Mezzo progetta anche una versione potenziata, di 9 HP, sempre a tre ruote, ma fornito di un motore di 745 di cilindrata (78 x 78), con i consueti due cilindri orizzontali contrapposti e, novità, valvole in testa. Le versioni disponibili comprendevano la vetturetta a due posti “per professionisti”, quella a tre posti “per diporto” (la più curiosa di tutte, con il guidatore sistemato alle spalle dei passeggeri), furgoncini “per Regie Poste e piccoli trasporti”, camioncini “commercio e porta campioni”, “speciali furgoncini per macellai” (l’unica categoria esplicitamente citata). Il prezzo era estremamente concorrenziale: 12.500 lire, con una tassa di circolazione di appena 87 lire. Una pubblicità di qualche mese successiva parla di prezzi compresi tra le 13.000 e le 13.500 lire, con una tassa di circolazione tra le 300 4 e le 350 lire, ma il discorso non cambia: una vettura media di produzione nazionale costava almeno tre volte di più: la Fiat 501, carrozzata, ne costava già 34.000, una Lancia, soltanto lo chassis, 62.000, un’Ansaldo 42.000, senza contare il successivo costo di esercizio e di mantenimento, calcolato in circa 50.000 lire all’anno, tra tassa di circolazione, benzina, chauffeur, gomme e riparazioni. Sembrava la quadratura del cerchio, sulla scia di quello che capitava all’estero, dove i veicoli leggeri e i cyclecars stavano ottenendo grande diffusione, sia per l’accessibilità del prezzo d’acquisto, sia il ridotto trattamento fiscale, sia perché rispondevano realmente alla necessità di un veicolo pratico economico ed utile. All’inizio del 1921 la Moto Cor si trasferì da via Santa Teresa 12 ai più ampi locali di via Grassi 6, dove la produzione riprese subito. Anzi, per la seconda metà dell’anno furono messi a punto anche due differenti telai a quattro ruote, su cui furono montati gli stessi organi meccanici dei modelli 7 e 9 HP. Ma gli affari non vanno granché bene, e il ricorso a versioni a quattro ruote tradisce la consapevolezza della difficoltà a far accettare al già esigente pubblico italiano una via di mezzo tra una moto e un’auto, un compromesso che non soddisfaceva nessuno. Perché in Italia non funzionava quello che funzionava in Francia, dove stava ottenendo gran successo il cyclecar Salmson, e dove anche la Peugeot presentò alla fine del 1921 la Quadrilette, il più piccolo quattro cilindri del mondo? “La costruzione della vetturetta – scriveva Auto Italiana nel gennaio 1924 – del veicolo economico, utilitario, pur se richiama l’attenzione del mondo industriale perché realmente presenta le maggiori basi per un ottimo impiego delle forze capitalistiche non trova da noi tutto lo sviluppo che potrebbe avere per le enormi somme che una fabbricazione in grande stile richiama nel circolo produttivo. Oggi si parla spesso dei cyclecars come delle vetturette per tutte le borse e più specialmente adatte alle possibilità della piccola borghesia: ma è un fatto che questi veicoli hanno, in Italia, dei prezzi così alti che spesso gli acquirenti, piuttosto che spendere 17 o 18 mila lire, preferiscono fare un maggiore sacrificio e passano il Rubicone delle ventimila lire, acquistando una vettura leggera.”. In realtà non era soltanto una questione di prezzo; era proprio l’idea di acquistare un surrogato che non piaceva, era il timore di fare la figura del “voglio ma non posso” che frenava il successo di questo tipo di soluzione. Allo stesso modo, trent’anni più tardi, e di nuovo nel dopoguerra, in Italia non si diffuse granché la Iso Isetta, quel simpatico uovo da città con apertura frontale; mentre in Germania ebbe un grande successo. All’inizio degli anni venti, perché la produzione di vetturette del genere ripagasse dei costi e nello stesso tempo risultasse competitiva sul mercato, occorreva un investimento in macchinari, stabilimenti e maestranze non inferiore ai cento milioni (di allora), così da assicurare almeno cinquanta unità costruite al giorno, quindicimila all’anno. Soltanto con simili volumi produttivi e di vendita il prezzo al pubblico avrebbe potuto restare al di sotto delle diecimila lire, diventando realmente concorrenziale. Nessuno, tra i costruttori italiani di cyclecar, poteva permettersi tanto. Armino Mezzo non impiegò molto tempo a capire tutto questo, e già nell’autunno del 1923 si presentava sul mercato con un prodotto diverso, la vetturetta EDIT. Innanzitutto era a quattro ruote, perciò non si presentava come un ibrido, ma come un’automobile vera e propria, solo di proporzioni ridotte. Il motore 5 era a due cilindri verticali in linea di 1020 cc, raffreddati ad aria, con valvole laterali e trasmissione cardanica. Scelse come ribalta d’esordio l’Esposizione Internazionale delle Invenzioni e progressi industriali, allo Stadium di Torino, dove fu esposto in uno accanto a quello di Ribetti, “un nuovo costruttore torinese, che presenta un tipo di cyclecar con motore ad un cilindro a due tempi che ha pregi ottimi, necessita solo che il pubblico possa meglio conoscerlo”, scriveva la Rivista dell’Automobile Club di Torino. Mezzo partecipò l’anno dopo anche al Salone dell’Automobile alla Fiera di Milano, dove ad esporre una vetturetta dalle caratteristiche simili alle sue vi erano altri ventisette costruttori, tra cui colossi come la Salmson, la Mathis, l’Amilcar, la Sénéchal ed altre. “La vetturetta costruita dal signor Armino Mezzo di Torino e rappresentata dalla Ditta Mascheroni di Milano attira molti visitatori come quella che risolve vantaggiosamente il problema della vetturetta utilitaria economica sul prezzo d’acquisto ed economica sulle spese di esercizio e manutenzione…La macchina è completa con tutti i dispositivi ed organi di una grande vettura: frizione a dischi multipli, trasmissione a cardano, cambio a tre velocità brevettato, freni doppi a mano e sul pedale”. Così si esprimeva “Auto Italiana” nel commentare il nuovo arrivato. Per poi aggiungere poco dopo: “Dobbiamo solo augurarci che alle ottime iniziative non manchi poi quella potenzialità economica che sola può assicurare il successo in gran serie, in modo che accanto alla grande industria nazionale dell’automobile si affermi anche l’industria della vetturetta leggera e largamente accessibile ad una classe numerosa di compratori” A questo fine nel gennaio 1924 si era costituita a Milano l’Associazione tra i costruttori, gli agenti, i rappresentanti e i possessori di cyclecars, con il nome di Unione Italiana Autociclo. I soci fondatori, tra cui lo stesso Armino Mezzo insieme ai fratelli Temperino, a Pretromilli, Ribetti, Opessi ed altri, si proponevano con questa società ogni azione utile per la diffusione dell’autociclo in Italia. Purtroppo così non successe. Imprenditori coraggiosi e lungimiranti come Armino Mezzo non disponevano dei mezzi necessari ad impiantare una produzione di grande serie, il che li bloccò ai margini del mercato decretandone la fine prima ancora che riuscissero a farsi conoscere dal pubblico. “Perché la vetturetta in Italia incontra scarsa fortuna? - si chiedeva il direttore di M.A.C.S. Mario Morasso già nel 1921, anticipando una risposta che si sarebbe rivelata valida anche negi anni a venire – Le varie iniziative sorte in Italia dopo la guerra in quest’ordine di costruzioni dopo un breve periodo di attività hanno declinato rapidamente, e talune sono già scomparse, altre non sono andate oltre i primi saggi, altre campano stentatamente. La clientela non ha mostrato di gradirle troppo. Colpa dei costruttori, contrarietà delle condizioni d’ambiente, diversità di ambiente? Forse tutte queste cause riunite insieme. Si direbbe che la clientela italiana non vuole uscire e i bisogni e le strade italiane non consentono di uscire dalla cerchia dell’automobile classico, di cui la più piccola espressione sembrerebbe quella segnata dai modelli Fiat 501, Bianchi, Ansaldo, OM, Aurea”. Armino Mezzo scomparve dalla scena automobilistica, e il suo nome ritornò soltanto nel 1940 come progettista di un originale autoveicolo trasporto merci con le ruote disposte a rombo, la cabina di guida sistemata di sbalzo anteriormente e il motore sistemato lateralmente a fianco del guidatore, per garantire la massima disponibilità 6 di carico (brevetto depositato il 10 giugno 1940). Rimangono delle sue iniziative le bellissime fotografie pubblicate in queste pagine, donate al Centro di Documentazione del Museo dell’Automobile di Torino dal figlio Angelo Mezzo, alla fine degli anni sessanta, e da allora preziosamente conservate. * Una indagine di qualche anno dopo (settembre 1924) mise a confronto i prezzi della benzina sul mercato mondiale. Nonostante fosse già scesa, le 2,70 lire al litro pagate in Italia risultavano il prezzo più alto di tutte le nazioni considerate: in Francia si pagava 1,70 lire, in Gran Bretagna 1,40 lire, in Germania 1,15 lire, in Belgio 1,10 lire, e addirittura i 48 centesimi negli Stati Uniti. Donatella Biffignandi Centro di Documentazione del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino 2003 7
Scaricare