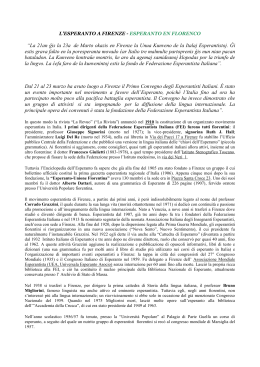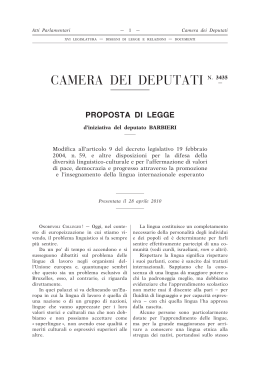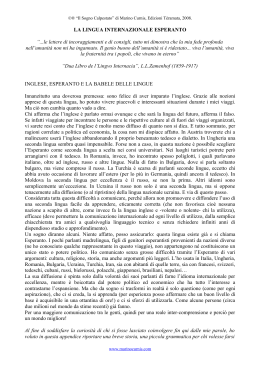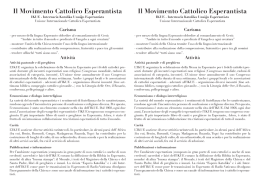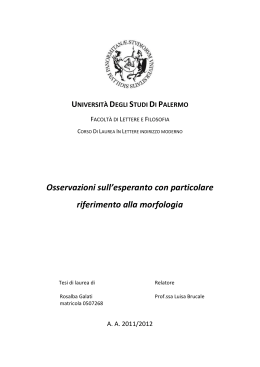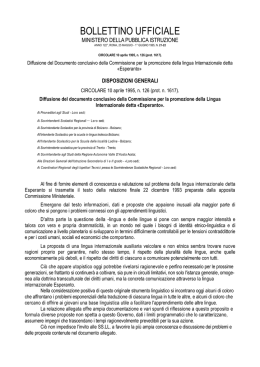Pier Marco BERTINETTO Scuola Normale Superiore, Pisa Elogio dell’adeguata imperfezione. Sulla scelta di una lingua comune per l’Europa federata DIALETTI, LINGUE ED ESERCITI Esiste una formulazione solo apparentemente scherzosa circa la differenza tra lingua e dialetto: un dialetto è una lingua priva di esercito. La battuta è generalmente attribuita, anche se non esistono documenti che lo attestino, a Max Weinreich (secondo taluni, ad Uriel Weinreich, ma è una tesi minoritaria). Benché scherzosa, questa battuta contiene un’innegabile verità; anzi, due. La prima consiste nel fatto che ciò che noi chiamiamo ‘lingue’ sono divenute tali, imponendosi a comunità via via più estese di parlanti, sulla base della condivisa appartenenza ad un’entità politica. Gli apparenti controesempi non contano. È pur vero che l’italiano è stato usato come bandiera culturale assai prima che gli italiani fossero politicamente uniti; ma sta di fatto che proprio questo cemento culturale ha poi portato alla costituzione di uno stato unitario. Si potrebbe allora obiettare che i curdi ed i baschi possiedono una lingua, pur essendo verosimilmente destinati a restar privi di un proprio stato. Ma vallo a spiegare a loro, soprattutto a quelli che si danno alla lotta armata! In ogni caso, ci si potrebbe trovare d’accordo sulla seguente puntualizzazione: affinché una lingua sia percepita come tale, non occorre che esista un’entità statuale costituita; basta che sussista una significativa spinta alla sua costituzione. La seconda verità è forse meno appariscente ai più, ma è invece quella che immediatamente si impone all’attenzione del linguista. Sul piano strutturale, non c’è alcuna differenza tra lingua e dialetto. I dialetti sono lingue. L’unica differenza sta nello statuto culturale e sociolinguistico; ma quanto all’interesse scientifico, i dialetti – e gli idiomi minoritari in genere – non hanno nulla da invidiare alle così dette lingue, ed anzi presentano non di rado aspetti che li rendono ancora più gratificanti come oggetto di studio. Sia come sia, la battuta attribuita a Weinreich mi è spesso tornata utile per introdurre, in forma tranciante e provocatoria, il problema del rapporto tra lingua e dialetto. Devo peraltro confessare di averla a lungo considerata una sapiente arguzia, e nulla più. Fino a quando, durante una mia visita in Bulgaria, ho dovuto arrendermi alla constatazione che essa è letteralmente vera. Occorre fare una premessa. Per molto tempo, le autorità bulgare – e perfino (duole dirlo) certi linguisti bulgari, per non lodevole acquiescenza politica – si sono rifiutati di riconoscere lo status di lingua al macedone, considerandolo un mero dialetto del bulgaro. Se si pensa a quale garbuglio siano, tuttora, i confini politici nei Balcani, si può ben intuire la motivazione di questo atteggiamento. Fui dunque molto sorpreso, in quell’occasione, all’apprendere che le autorità bulgare avevano repentinamente ed ufficialmente riconosciuto al macedone lo status di lingua. Ma quando venni a sapere che appena quindici giorni prima i bulgari avevano regalato un centinaio di carri armati alla Macedonia, tutto mi divenne chiaro. Il macedone cessava di essere un dialetto nel momento in cui lo si dotava di un esercito! Anche chi volesse considerarla una mera coincidenza, dovrà pur ammettere che il rapporto tra lingua e potere è tutt’altro che peregrino. La lingua che si impone è sempre quella di chi comanda. I greci disponevano di un indiscusso prestigio culturale; ma fu il latino ad imporsi nel mondo classico, e la cosa durò fintanto che si resse l’impero di Roma. Si obietterà che il latino resistette poi a lungo come lingua di cultura. Ma è un debole argomento, visto l’esito di lungo periodo. E comunque sia, gli esempi non mancano. Basti pensare alla diffusione delle lingue europee nel mo ndo come effetto della colonizzazione, cui ha fatto seguito la marginalizzazione o lo smantellamento di innumerevoli idiomi. Esattamente ciò che il latino 3 aveva fatto di molti idiomi di cui si è persa ogni testimonianza, prima di cadere a sua volta vittima di altre lingue di conquistatori. E in fondo gli è andata bene, visto che l’italiano si può pur sempre considerare un discendente diretto. Non così per tante lingue minoritarie annientate sulla superficie del nostro pianeta, e per le tante che sono ora a rischio di estinzione, per il dilagare della dominanza politico-economica della civiltà occidentale. Capisco che non tutti siano disposti a commuoversi per queste vicende. Certo, nessun individuo intellettualmente onesto resta indifferente di fronte alle storie di stragi di innocenti, compiute nei secoli da spietati gruppi di invasori, spesso neppure tanto numerosi ma certo benissimo armati.1 Quando però si viene a toccare il tema della morte delle lingue, noto spesso un atteggiamento tra il fatalista e lo spregiudicato. È sempre avvenuto; dunque non è il caso di darsene troppo pena. E poi, che male c’è? Se un giorno tutta l’umanità parlerà la stessa lingua, tanto di guadagnato. Vorrei poter condividere tanta serenità, o sia pure rassegnazione. La scomparsa di una lingua coincide sempre col tramonto di una cultura. È un intero universo di valori che viene sommerso. Non saranno stati tutti positivi, d’accordo; ma i nostri lo sono? Inoltre, se siamo di quelli che si preoccupano per il fatto che oggidì si assista, impotenti, allo sterminio di un numero impressionante di specie viventi, dovremmo avere la stessa reazione di fronte alla scomparsa delle lingue, per quanto sperdute e minoritarie esse siano. L’evoluzione naturale – un aspetto esaltante della quale è appunto lo sviluppo delle culture umane – ha impiegato migliaia di anni per produrre quei risultati che noi ora non esitiamo a distruggere, senza neppure averli ben studiati e compresi. Qui rischio di espormi all’accusa di interesse privato in atti di ufficio. Come linguista, vedo nell’annientamento degli idiomi naturali un desolante impoverimento della varietà e ricchezza tipologica, che ci viene tuttora offerta come oggetto di studio. Sì, lo so, la variegazione delle lingue non è un valore economico, alla stregua di un particolare tipo di cereale, di cui forse un giorno avremmo capito tutto il valore nutritivo, o la capacità di resistere ai parassiti. Sono dunque rassegnato al fatto di non riuscire a suscitare altrettanta commozione intorno al tema della scomparsa delle lingue. E tuttavia, mi piacerebbe che si comprendesse che i due problemi sono della stessa natura. La riduzione della varietà linguistica, e dunque culturale, potrebbe avere conseguenze altrettanto devastanti quanto la contrazione della varietà biologica, poiché rischia di ridurre le nostre difese, la nostra abilità nell’adattarci, la nostra capacità di elaborare strategie di convivenza. IL MITO DELLA LINGUA PERFETTA Stranamente, gli uomini sono sempre stati affascinati dall’idea contraria. Anziché gioire della diversità linguistica, essi hanno da un lato cercato attivamente di ridurla o quanto meno controllarla (la sottomissione è un’ovvia forma di controllo); e dall’altro lato si sono frequentemente abbandonati al mito della lingua perfetta, unitaria, primordiale. La difformità è stata addirittura vista come il prodotto di una colpa originale: l’intollerabile protervia di chi volle edificare la torre di Babele, col solo risultato di farsi confondere dall’irata divinità. Tutto ciò è probabilmente dovuto al fatto che non siamo svizzeri (tranne loro medesimi). Di solito non ci si fa caso; ma il fatto che proprio al centro dell’Europa esista uno stato in cui la coesistenza di lingue e religioni diverse sia stata assunta come un dato di fatto (mentre tutto attorno ci si dava parecchio da fare per piallare le differenze), dovrebbe quanto meno costituire un incessante motivo di stupore, se proprio ci si ostina a non volerlo considerare un modello da seguire. Ma naturalmente dai buoni esempi si trova sempre il modo di difendersi, magari ricorrendo all’ironia 1 Chi volesse un agile spaccato della tenebrosa mentalità del colonizzatore occidentale, potrà leggere LINDQVIST 2000. E poi, magari, vergognarsi un po’ di essere europeo. 4 come arma impropria. La battuta più feroce che io conosca sugli svizzeri è dovuta a Voltaire, il quale attribuì loro la caratteristica di alzarsi presto e di svegliarsi tardi. È un colpo ben assestato. Ma io mi dico che se l’essere tanto svegli serve poi ad organizzare la notte di San Bartolomeo, allora c’è poco da vantarsene. L’ostinata ricerca della lingua perfetta, che tutte supera e riassume, è stata ricostruita in maniera godibilmente istruttiva in ECO 1993, oltreché in svariati lavori di altri studiosi. Vale la pena citare ciò che Eco scrive a conclusione della sua disamina: “È [...] proprio quando si rivisitano antichi progetti che si sono mostrati utopici o fallimentari, che possono essere previsti i limiti o i fallimenti possibili di ogni impresa che si pretenda un debutto nel vuoto. Rileggere quanto hanno fatto i nostri antenati non è mero divertimento archeologico, bensì precauzione immunologica” (p. 339). È tutto amaramente vero. Ricostruire aspetti salienti della storia delle idee umane risulta, non di rado, esaltante e desolante al tempo stesso. C’è, per esempio, qualcosa di grandioso nello sforzo di risalire, sia pure attraverso improbabilissime argomentazioni, alle sorgenti del linguaggio umano (un tema non assente dalla ricerca scientifica attuale, dove peraltro viene affrontato con ben altre cautele). Ma oggi si resta stupefatti nel constatare che l’idioma originario – ed incorrotto! – è stato individuato, volta a volta, nella propria lingua medesima (magari l’olandese), ovvero in lingue diverse e lontane (l’ebraico, il greco, lo scita, l’aymará degli altopiani peruviani, e via elencando). E non meno sconcertati si resta di fronte ai numerosi tentativi di creare ex novo la lingua perfetta, quella capace di esprimere in maniera ineccepibile ogni pensiero umano, l’autentica e definitiva “grammatica dei concetti”; per costruire la quale, si partiva dalla cocciuta sistematizzazione dei possibili contenuti del reale e del pensabile, fissando poi precise corrispondenze fra determinati suoni e determinate componenti semantiche. Si pensi ai modelli approntati – tra il secolo Diciassettesimo ed il successivo – da George Dalgarno, John Wilkins, Francis Lodwick, Gottfried Wilhelm von Leibniz ed altri ancora, per i quali rimando al citato lavoro di Eco. Non ci vuol molto a capire che la combinazione meccanica di sillabe dal significato semplice e precostituito, al fine di costruire parole via via più complesse, produce ben presto effetti grotteschi per astrusità ed arbitrarietà. L’esito è esattamente contrario a quello desiderato: si vorrebbe plasmare un linguaggio assolutamente trasparente nel rapporto suono / senso, e si approda invece ad un sistema di corrispondenze non meno arbitrario di quello che è proprio di qualsiasi lingua naturale, e per giunta privo di quelle proprietà che rendono parlabili queste ultime. Alla base di questi vaneggiamenti si cela un fondamentale malinteso: l’idea che la comunicazione linguistica debba liberarsi di quel tanto di vago e sfumato che caratterizza la semantica delle lingue naturali.2 In realtà, tale vaghezza è perfettamente funzionale all’esigenza di gettare un ponte comunicativo tra individui diversi, e soprattutto all’insopprimibile bisogno di elaborare nuovi sensi. Se il nostro linguaggio si crostificasse, per maligno sortilegio, in un sistema rigidamente precostituito ed univoco di designazioni, dovremmo per sempre accontentarci di parlare di ciò che abbiamo messo in chiaro fino ad ora, ed anzi neppure di tutto. Tanto per cominciare, niente metafore: rischierebbero di inquinare la comunicazione! Ma si tratta, per nostra buona sorte, di vaneggiamenti. Non si potrebbe trovare formulazione più lapidaria e corrosiva, circa i tentativi di costruire una perfetta lingua filosofica a priori, di quella usata da Antoine-Louis -Claude Destutt de Tracy all’alba del Diciannovesimo secolo: “È impossibile che lo stesso segno abbia esattamente lo stesso valore per tutti quelli che lo impiegano […]. Dobbiamo dunque rinunciare alla perfezione” (citato in ECO 1993, pp. 312). Gli faceva eco, di lì a poco, il nostro Giacomo Leopardi, che proprio a tali prototipi di lingua (per ipotesi) perfetta alludeva, parlando nel suo Zibaldone di una “lingua strettamente universale”, la 2 Duole ammettere che persino un grande linguista come Edward Sapir sia caduto in questo tranello, laddove addita a difetto dell’inglese il fatto che esso abbondi di locuzioni fondate su verbi dal significato generico (come get), ovvero il fatto che si possa frequentemente usare una parola sia come nome che come verbo (cf. SAPIR 1937). 5 quale “dovrebbe di sua natura essere anzi un’ombra di lingua, che lingua propria”. E sentenziava: “Quest’algebra di linguaggio (così nominiamola) […] si può pur confidentemente e certamente credere che non sia per essere né formata ed istituita, né divulgata ed usata giammai”, dato che essa “dovrebbe certamente essere di necessità e per sua natura, la più schiava, povera, timida, monotona, uniforme, arida e brutta lingua, la più incapace di qualsivoglia genere di bellezza, la più impropria all’immaginazione, e la meno da lei dipendente, anzi la più da lei per ogni verso disgiunta, la più esangue ed inanimata e morta, che mai si possa concepire; uno scheletro un’ombra di lingua piuttosto che lingua veramente; una lingua non viva, quando pur fosse da tutti scritta e universalmente intesa, anzi più morta assai di qualsivoglia lingua che più non si parli né scriva” (25 agosto 1823; e si veda anche alla data 11 dicembre 1823).3 C’è però una cosa che Eco non ha detto, nella sua pur puntigliosa catalogazione dei vari tipi di lingua perfetta, vagheggiati lungo tutto l’arco della storia umana conosciuta.4 Si tratta del fatto che la lingua perfetta, in realtà, esiste, e non c’è alcun bisogno di inventarla. È la lingua che parliamo tutti i giorni. E non mi riferisco ad una in particolare, sia ben chiaro, ma a tutte. Ogni lingua naturale (inclusi ovviamente i dialetti) è perfetta, per il semplice fatto che è quanto di meglio l’evoluzione abbia prodotto nel corso di molti millenni. Esiste forse qualcuno che si propone l’ozioso problema di inventare, che so, l’ala perfetta? Ovviamente no, perché sappiamo bene che ciò di cui gli uccelli dispongono è esattamente ciò di cui hanno bisogno per volare. Il tempo per migliorare il prototipo c’è stato, e possiamo star certi che è stato utilizzato proficuamente. Lo stesso vale per le lingue. Non c’è ragione di immaginare che ce ne servirebbe una di diversa natura. Sono tutte, per definizione, perfettamente appropriate alla funzione cui sono destinate, che è quella di assicurare la comunicazione tra gli esseri umani. Se così non fosse, banalmente, faremmo fatica a capirci. Non ci si lasci ingannare dalla straordinaria varietà delle lingue umane. Al di sotto delle loro conclamate differenze, si cela un nocciolo comune a tutte. Tant’è vero che qualunque individuo è in grado di impararne una alla perfezione (non importa quale), purché vi sia esposto entro il periodo critico dell’apprendimento. È proprio movendo da questa apparentemente banale constatazione che Noam Chomsky ha potuto elaborare la sua concezione innatistica, sulla quale si sono spese troppe parole, a causa di troppi fraintendimenti. I quali, beninteso, sono stati anche alimentati da certi seguaci troppo zelanti, che hanno creduto di individuare in svariati aspetti macroscopici degli idiomi naturali la diretta manifestazione della nostra innata facoltà di linguaggio. In realtà, quello che Chomsky ha posto è un problema teorico, nonché un programma di ricerca di lunghissimo periodo. Se ogni essere umano è in grado di apprendere qualunque lingua entro un certo stadio della propria crescita, ne consegue logicamente che: (a) l’uomo deve essere dotato di un patrimonio specifico che lo distingue dagli altri primati (esprimendoci alla 3 4 Questa consapevolezza di Leopardi circa i limiti delle lingue filosofiche a priori è tanto più significativa, in quanto egli era per molti aspetti un figlio del suo tempo, non esente da pregiudizi ed errori. Mi pare giusto ricordare anche questi ultimi: Leopardi è troppo grande per aver bisogno della nostra corriva complicità. Si vedano dunque, come aspetti caduchi del suo pensiero, le sue osservazioni sul rapporto tra lingua e clima (dove il clima freddo determinerebbe, secondo un antico pregiudizio, “pronunzie […] forti ed energiche”, al contrario dei climi meridionali; 23 agosto 1823); ovvero, le sue prevenzioni a proposito del francese, la lingua “universale” per eccellenza (ivi), che proprio per questo sarebbe “incapacissima di traduzioni” (11 dicembre 1823). Non rientra tra le mie finalità ripercorrere la variegata tipologia di ciò che pertiene all’idea, o meglio al mito, della ‘lingua perfetta’. Si vedano comunque gli inventari stilati da ECO 1993 (pp. 8ss) e SWIGGERS 2001 (pp. 23ss), da cui si ricavano almeno i seguenti tipi (con miei adattamenti): (a) lingue archetipiche (mitiche, ovvero storiche ma pur sempre mitizzate), che coinciderebbero con la lingua dell’umanità originaria; (b) lingue ‘filosofiche’ a priori; (c) ‘poligrafie’, sim ili alle precedenti ma con l’aggiunta di un codice di raffigurazione grafica dei concetti; (d) lingue magiche, destinate all’effabilità mistica o alla segretezza iniziatica. A questo elenco andrebbero aggiunte le così dette ‘lingue internazionali ausiliarie’; ma, per le ragioni che sotto indicherò, preferisco tenerle distinte, anche se è innegabile che molti tra i loro ideatori le abbiano concepite come un’incarnazione di lingua perfetta, almeno sotto l’aspetto della facilitazione della comunicazione internazionale. 6 buona, potremmo parlare di patrimonio “genetico”, guardandoci però dall’attribuire a questa espressione il senso pregnante che essa avrebbe per un genetista); 5 (b) tutte le lingue devono possedere un nucleo profondo condiviso. Attenzione: profondo. Quando poi ci venga chiesto quale sia la precisa natura di questo nucleo, è onesto dire che non ne sappiamo quasi nulla, anche se c’è chi si è impegnato in questo tipo di indagine. Ma se si leggono gli scritti teorici di Chomsky, si comprende che egli per primo è ben consapevole di quanto lunga, ardua ed avventurosa sia una tale ricerca; anche se poi molti suoi entusiasti sostenitori (forse lui stesso, in momenti di minor autocontrollo) danno l’impressione di essere davvero convinti di aver trovato il bandolo. Ma c’è qualcosa che mi rende inquieto. Affermando che le lingue umane sono perfette, rischio di produrre a mia volta un fraintendimento, se non due. Non mi sognerei davvero di affermare che il tupinambà è (anzi era, dato che si tratta di una delle vittime della conquista spagnola del Nuovo Mondo) altrettanto adatto alla speculazione filosofica quanto il tedesco. Tuttavia, questo non discende da una presunta, congenita inferiorità del tupinambà in quanto lingua, bensì dagli accidenti dell’evoluzione culturale. Le lingue dei popoli dediti ad una vita in stretto contatto con la natura abbondano di parole per designare gli oggetti che popolano l’ambiente circostante – oltre a consentire di esprimere tutte le necessarie sfumature psicologiche, o le complesse costruzioni mentali che fanno parte del sapere tradizionale di quella data popolazione –; ma non hanno necessariamente maturato gli strumenti lessicali e sintatticoretorici, atti a sdipanare le più sottili disquisizioni metafisiche. Tuttavia, in linea di principio, nulla avrebbe impedito che ciò accadesse, se solo si fossero create le condizioni (tra le quali, riveste grande importanza l’adozione di un efficace sistema di scrittura, che porta inevitabilmente con sé il progressivo raffinamento delle capacità argomentative). Tutto ciò può essere condensato nella seguente formula: perfette sono le lingue naturali, non certo le culture umane che ne costituiscono lo sfondo. La seconda parte di questa frase potrebbe addirittura suonare come un truismo, se si pensa ai disastri di cui siamo capaci assieme ai nostri simili; ma essa non allude tanto all’intrinseco vizio di saggezza degli esseri umani, quanto alle discontinuità che si osservano nei livelli di sviluppo delle diverse società (per non dire dell’ovvia distanza che separa ciascuna di esse da un autentico ideale di condivisione delle risorse, rispetto dell’altro e dell’ambiente, dispiego di raziocinio). Comunque sia, le diverse lingue, in quanto specchio ciascuna di una determinata cultura, possono risultare più o meno attrezzate per assisterci in certe operazioni concettuali, o anche solo nelle nostre esigenze di denominare gli oggetti e le entità da cui ci vediamo o ci sentiamo circondati; 6 ma, e questo è l’essenziale, qualunque lingua assolve per definizione il compito cui è destinata, ossia la comunicazione interpersonale. Inoltre (fatto su cui non si insisterà mai abbastanza), benché superficialmente diversissime, tutte le lingue si assomigliano nei tratti fondamentali.7 Né potrebbe essere diversamente, visto che si assume 5 6 7 Sul delicato rapporto tra genetica e grammatica, cf. MORO [2002]. Circa la presunta capacità di certi primati, opportunamente addestrati, di adoperare frammenti di linguaggio umano sotto forma di parole o combinazioni di parole (tipicamente, pigiando su appositi bottoni), circolano opinioni alquanto azzardate. Combinare parole in maniera intuitiva, o saper interpretare il “senso” di brevi frasi convenzionali, non significa possedere una sintassi, così come spiccare un salto agitando le braccia non significa volare. E ciò sia detto senza minimamente svalutare l’importanza degli studi che vengono condotti sui primati superiori, che permettono di meglio comprendere i limiti delle loro abilità cognitive. Un esempio spesso citato, a questo riguardo, è la ricchezza di parole di cui dispongono gli eschimesi per designare i diversi stati della neve; una risorsa di cui moltissime lingue, tra cui l’italiano, non dispongono di certo. Ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi: non c’è quasi lingua che non abbia sviluppato in ambiti particolari (siano essi legati alla concretezza dell'agire o all’astrattezza dei costrutti mentali), delle peculiari capacità, che invano si cercherebbero in altri idiomi. Sarei lieto di poterne fornire un inventario, come taluni si azzardano a fare, elencando per esempio tratti quali: il carattere discreto del segno linguistico, l’arbitrarietà dei significanti, la doppia articolazione o biplanarità, la produttività, etc. Il problema sta nel fatto che, accanto a questi aspetti macroscopici, ve ne sono di molto meno appariscenti ma ancor più costitutivi, i quali attengono alle struttura profonda della sintassi (come la così detta 7 ormai concordemente che tutte procedano da un lontanissimo progenitore comune, così come tutti gli esseri umani sono riconducibili ad un’unica stirpe. L’altro fraintendimento che rischio di generare riguarda la percezione, che tutti abbiamo, di certi difetti di confezione dei nostri strumenti linguistici. Le lingue sono indubbiamente, quale più quale meno, pregne di curiosi accidenti. Non c’è alcuna ragione di principio in base alla quale l’italiano debba mancare del participio perfetto di parecchi verbi. Suppongo che a tutti sia capitato numerose volte di dover riformulare dall’inizio una frase, rendendosi improvvisamente conto che non è possibile concluderla con il participio di, che so, esigere o permanere. Di queste crepe sono acutamente consapevoli i traduttori; e spesso è proprio il confronto tra le lingue a mettere in risalto le lacune, le idiosincrasie e le rigidezze strutturali, capricciosamente distribuite nell’uno o nell’altro idioma. Se si avesse in mente, come ideale di perfezione, l’assoluta mancanza di irregolarità morfologiche o di ambiguità lessicali e sintattiche, e inoltre l’assoluta trasparenza nel rapporto suono / senso, allora tanto varrebbe mettersi il cuore in pace. Nessuna lingua è perfetta in tal senso. E tuttavia le lingue sono perfette nell’accezione sopra indicata, ossia in quanto prodotto di un’evoluzione plurimillenaria. Gli accidenti cui ho appena fatto riferimento, in fondo, sono parte di questa loro ‘perfetta imperfezione’: mostrano che le lingue sono organismi vivi, in continua trasformazione, incessantemente plasmati dall’uso, e dunque mai fissati in una presunta, definitiva assolutezza (eludendo così le nevrotiche pretese dei puristi). Ma esse sono continuamente rimodellate proprio in quanto perfettamente adeguate all’uso; talmente ben adattate allo scopo, da vivere assieme a noi, assorbire i nostri tic, riflettere le fratture del tessuto sociale. LE LINGUE INTERNAZIONALI AUSILIARIE Il tema delle lingue internazionali ausiliarie (un nome per tutte: l’esperanto) rischia di finire confuso con quello della lingua perfetta. In realtà si tratta – almeno in linea di principio – di cosa ben diversa. La confusione è incoraggiata dal fatto che anche le lingue ‘filosofiche’ a priori sono state proposte come strumento universale di comunicazione; che è esattamente il fine per cui vengono create le lingue internazionali ausiliarie. Tuttavia, queste ultime, nella misura in cui si distinguano davvero dalle prime, sono lingue a posteriori (secondo l’utile distinzione impiegata da Eco). Non si propongono l’ozioso compito di perfezionare le lingue naturali, e danno anzi per scontato il primato di queste ultime, e la necessità che esse si perpetuino all’interno delle comunità di appartenenza. L’obiettivo che si pongono i loro ideatori è quindi un altro: allestire uno strumento che faciliti la comunicazione internazionale, assumendo come punto di partenza la struttura di una o più lingue esistenti (di solito, realizzando una calcolata mistura tra alcune di esse). L’operazione consiste nel definire un lessico, generalmente allusivo del lessico di una o più lingue storicamente attestate, e nel ritagliare regole morfologiche semplici ed assolutamente regolari. Colui che si serve di questi idiomi deve quasi soltanto fare lo sforzo di memorizzare delle parole; un fatto inevitabile, quando si apprende una lingua straniera. Questi idiomi sono generalmente detti ‘artificiali’. L’etichetta è al tempo stesso appropriata e tendenziosa. Appropriata, perché sono distillati a tavolino, anziché presentarsi come il risultato di un’evoluzione spontanea. Tendenziosa, perché in realtà gli idiomi a posteriori inglobano per definizione le caratteristiche costitutive di qualsiasi lingua naturale, visto che riproducono essenzialmente la struttura sintattica di una di esse. L’impresa di realizzarle può dunque suscitare simpatia o repulsa, ma è comunque perfettamente possibile proprio (e sembra un paradosso) perché si rinuncia in partenza ad inseguire un’impossibile perfezione a priori, ‘teoria X barra’ coltivata in ambito chomskyano). Ma su di essi, purtroppo, non possiamo far altro che formulare ipotesi, probabilmente destinate a restar prive di definitiva verifica. 8 accontentandosi di ricalcare l’impronta delle lingue naturali; le quali, come si è detto, sono di per sé ‘perfette’, in quanto adeguate al proprio fine. Di siffatte lingue, tra il Diciannovesimo ed il Ventesimo secolo, ne sono state inventate non poche: Volapük , Idiom Neutral, Langue Universelle, Bopal, Spelin, Dil, Balta, Veltparl, Latino sine flexione etc. (anche a questo proposito torna utile la rassegna approntata da Eco). Non mette conto confrontarle. Anche perché, a consuntivo, la lingua che ha saputo ritagliarsi il maggior numero di consensi è l’esperanto – l’unica che possa vantare una “piccola” (neanche tanto piccola, in realtà) comunità di cultori – e sarebbe esercizio assolutamente gratuito quello di chi volesse proseguire nell’opera di affinamento. Mi pare sufficiente citare, in proposito, l’affermazione di un celebre linguista, Antoine Meillet, che pure non va annoverato tra i fautori delle lingue internazionali ausiliarie: “Toute discussion théorique est vaine: l’Esperanto fonctionne” (M EILLET 1918: 268). Il sommo studioso riconosceva che l’esperanto può essere assimilato, dal punto di vista della sua struttura e della sua funzionalità, ad una lingua naturale. Ma perché, allora, non si è affermato? La ragioni sono molte e complesse. Non escludo che la responsabilità di questa situazione sia anche da attribuirsi, in parte, all’ingenuità di alcuni tra i suoi fautori. Tempo addietro mi capitò di leggere un opuscoletto di propaganda esperantista. Come ci si può aspettare, buona parte dello sforzo dei più avventati partigiani di questa lingua è oggi indirizzato a convincerci che l’inglese è la fonte di ogni male. E l’inglese è notoriamente accusato di essere difficile a leggersi, a causa del rapporto spesso idiosincratico tra scrittura e pronuncia (il che è innegabile), nonché difficile a parlarsi (ma qui non mi ci ritrovo). Orbene, tra le colpe dell’inglese veniva additata, in quell’opuscoletto, anche quella di aver causato innumerevoli disastri aerei dovuti ad errata comprensione, da parte dei piloti, delle comunicazioni dei controllori di volo. Già, perché se invece di fraintendersi parlando inglese, ci si fraintendesse parlando esperanto, moriremmo tutti più contenti? E i parenti delle vittime rinuncerebbero al risarcimento? Talvolta, i peggiori nemici di una causa sono i suoi troppo entusiasti sostenitori. Ma vediamo allora i principali argomenti portati a sostegno dell’esperanto, e delle lingue internazionali ausiliarie in genere. A me pare che siano fondamentalmente tre. Innanzi tutto, viene vantata la regolarità e la semplicità dell’apparato morfologico. Distinguiamo. Quanto a semplicità, l’inglese è difficilmente battibile, per via della sua morfologia flessiva ridotta all’osso. Se l’esperanto dovesse misurarsi col tabassarano, coi suoi circa quaranta casi, o con certe lingue del Nepal, con il loro terrificante sistema di accordo pronominale, non ci sarebbe partita. Ma sta di fatto che la lingua che si sta affermando in tutto il mondo è l’inglese. Certo, se Hitler avesse trionfato, le cose oggi sarebbero diverse; ma forse che la relativa complessità della morfologia russa ha impedito a questa lingua di imporsi – o di venire imposta – come lingua comune entro, ed oltre, i confini dell’Unione Sovietica? Resta il problema della regolarità. Da questo punto di vista, l’esperanto dà effettivamente qualche punto all’inglese. Tuttavia, le sacche di irregolarità dell’inglese sono per lo più ristrette a parole ad alta frequenza, che proprio per la loro grande disponibilità finiscono ben presto per essere automatizzate. Intendiamoci: il problema dell’irregolarità non andrebbe in generale enfatizzato. Se quest’ultima costituisse davvero un ostacolo all’apprendimento ed all’uso, c’è da scommettere che le lingue se ne sbarazzerebbero in fretta, non appena essa venisse a crearsi per un qualche accidente evolutivo. Invece, non si dà lingua storicamente costituita che ne sia priva. Il fatto è che l’irregolarità, e così pure la complessità, della morfologia non rappresentano assolutamente un impaccio per chiunque apprenda una lingua in condizioni naturali. La difficoltà si pone soltanto per coloro che la apprendono in età adulta. Limitatamente a questo aspetto, gli esperantisti hanno ragione. Ma se la questione si riduce poi al fatto di dover apprendere l’inglese, non mi pare davvero un compito esorbitante. Diciamola tutta: da una singolar tenzone con l’inglese, l’esperanto non può che uscire perdente. Sarebbe dunque interesse dei suoi fautori non servirsi di questo tipo di motivazioni. 9 Un secondo argomento che vedo circolare nella letteratura esperantista – decisamente più persuasivo – è il fatto che questo idioma, essendosi abbeverato al lessico delle principali famiglie linguistiche europee, può rappresentare un ponte tra di esse. Nell’esperanto si trovano infatti abbondanti tracce lessicali delle tre principali famiglie linguistiche del nostro continente: romanzo, germanico e slavo (senza beninteso trascurare quel pizzico di semitico che è legato al retaggio ebraico del suo ideatore, il polacco-lituano Lejzer Ludwik Zamenhof). Un europeo che impari l’esperanto (a patto che non sia, che so, finlandese o ungherese) finisce dunque col riconoscere, sotto un tenue travestimento, una parte del proprio patrimonio lessicale. Se poi costui allarga le proprie conoscenze imparando altre lingue, non avrà difficoltà ad identificare via via, nell’esperanto, nuove tracce di vocabolario europeo. E, naturalmente, viceversa: è stato infatti sostenuto che la conoscenza dell’esperanto facilita l’apprendimento di altre lingue, proprio perché la progressiva memorizzazione del lessico condiviso viene a costare minor fatica.8 Ancora una volta, non si può fare a meno di riandare a Leopardi ed al suo “vocabolario universale europeo” (Zibaldone, 26 giugno 1821), che ha ispirato alcune pagine lucide ed appassionate di Giovanni Nencioni.9 Il problema che si poneva Leopardi era quello di contrastare il purismo Ottocentesco, che ostracizzava parole come genio, sentimentale, dispotismo, analizzare, demagogo, fanatismo, originalità, etc. in quanto estranee al repertorio dell’italiano aureo. Con molta lungimiranza, il grande recanatese osservava che queste parole, benché non coniate in Italia, sfruttano in maniera lecita e creativa il bagaglio lessicale di tradizione classica, e per ciò stesso devono risultare comprensibili a tutti gli europei. Vietarsene l’uso avrebbe significato ghettizzarsi culturalmente. Oggigiorno, c’è quasi da sorprendersi che si sia dovuto combattere simili battaglie. Il clima è cambiato al punto tale, che molti nostri connazionali – ben lungi dall’opporre resistenza ai prestiti – si direbbe quasi che provino gusto nell’anglicizzare ostentatamente il proprio italiano, senza rendersi conto dell’esito caricaturale che finiscono per conseguire. La supposta esibizione di cosmopolitismo si ribalta infatti nel suo contrario: nell’asfittico provincialismo di chi si aggrappa, senza le opportune mediazioni, a tutto ciò che presenta una tinta anglosassone. Quasi che l’espressione di un concetto appaia nobilitata, quando sia imbellettata da una patina di superficiale anglofonia. E tuttavia la lezione di Leopardi torna utile per ricordarci l’importanza non solo culturale, ma anche strumentale (come utensile glottodidattico), del lessico europeo condiviso. Uno specchio in cui tuttora possiamo riconoscerci. C’è infine un terzo argomento, che costituisce l’autentico cavallo di battaglia degli esperantisti. Il vantaggio di una lingua internazionale ausiliaria sta nel fatto che, non appartenendo a rigore a nessuno, essa può candidarsi a diventare la cosa di tutti. Sarebbe difficile negare la fondatezza di questo argomento, quando solo si osservi la situazione dell’Unione Europea. Se fosse davvero indifferente usare l’una o l’altra lingua, ci si sarebbe già trovati d’accordo sulla scelta di un idioma ufficiale. Ma è ovvio che rinunciare alla propria lingua, per adottare quella di un’altra nazione, significa dare un immenso vantaggio ai cittadini di quest’ultima. Non si tratta solo di una perdita di prestigio, di un drastico ridimensionamento della propria immagine culturale; si tratta di una perdita economica secca. I parlanti della lingua favorita non dovranno spender soldi in traduzioni (o ne spenderanno molti meno), e avranno costi molto più contenuti per quanto riguarda l’insegnamento delle lingue straniere, dato il diverso 8 9 Su questo punto, è d’uopo citare gli studi di Helmar Frank e della sua équipe. Si veda, ad es., FRANK 1980 (ma sul tema indugia anche CHITI BATELLI 1988). Sarebbe desiderabile avere ulteriori riscontri di tali risultati; che, se indipendentemente confermati, costituirebbero un argomento non trascurabile. Si noti che, nonostante il suo carattere sovrannazionale, l’esperanto resta pur sempre un idioma fortemente eurocentrico, il che potrebbe essere impugnato a suo debito. Ma se lo scopo della sua adozione fosse semplicemente quello di fornire un veicolo di comunicazione entro l’Unione Europea, questo potenziale difetto si volgerebbe in vantaggio. Cf. NENCIONI 1995; 1997. 10 peso che il problema viene ad assumere. Basta guardarsi attorno: un inglese o uno statunitense possono girare il mondo anche senza aver mai appreso una lingua straniera, mentre un italiano che conoscesse solo la propria lingua incontrerebbe grosse difficoltà. E si pensi, poi, a quanti problemi di disoccupazione vengono risolti. Ciascuno di noi ha incontrato, non solo in Italia, anglofoni di non eccelsa cultura, che sbarcano facilmente il lunario vendendo un prodotto per il cui acquisto non hanno dovuto affrontare alcuna spesa, ossia la propria lingua madre. E se anche si tratta, come spesso accade, di persone di buona preparazione culturale, il discorso non cambia di molto: resta il fatto che per loro la ricerca di un lavoro è un problema molto meno assillante che per la generalità dei non nativamente anglofoni. Una volta ho sentito dire da un amico, lettore di tedesco,10 che se si togliesse all’Inghilterra il tornaconto economico legato alla posizione dominante dell’inglese, il PIL di quella nazione scenderebbe al di sotto del livello italiano. Colui che mi dava questa informazione citava, a memoria, dati economici che diceva di aver letto in una seria indagine. Mi piacerebbe saperne di più. Sta di fatto che a me questa storia continua a far girar le scatole; e non perché io ce l’abbia con gli inglesi (che in certe cose mi piacciono anche più degli italiani), ma perché in generale i privilegi immeritati eccitano il mio istinto socialista (absit iniuria verbis; non si dovrebbe usare l’italiano per esprimere questo concetto). Si potrebbe accantonare la questione con un’alzata di spalle. In fondo, è culturalmente molto più ricco colui che sa parlare, o se non altro comprendere, almeno una lingua straniera. Quindi, peggio per gli anglofoni! Se vogliono farsi del male, si accomodino. Noi invece, più smaliziati, ci applicheremo allo studio della loro lingua; magari adottando persino l’agghiacciante formuletta delle “tre i” lanciata dall’attuale primo ministro (che a causa di ciò potrebbe forse meritarsi il titolo di “Silvio il Comico”): inglese, internet, impresa. Ora, lungi da me l’intento di svalutare la conoscenza delle lingue: tradirei il mio mestiere. Impariamo pure tutte le lingue possibili, incluso ovviamente l’inglese. Tuttavia, ho l’impressione che le implicazioni ultime della questione, in relazione agli equilibri di politica linguistica entro l’Unione Europea, siano troppo spesso ignorate. Ci si può anche rassegnare (o magari compiacere) in merito al fatto che l’inglese rappresenti il candidato più naturale al rango di lingua internazionale, a dis petto della tiepidezza dei sudditi britannici per l’idea stessa di integrazione europea. Ma dobbiamo appunto essere consci delle conseguenze. Nel campo dell’interazione politica, possedere l’idioma veicolare come seconda lingua, anziché come lingua madre, fa un’enorme differenza in termini di capacità di persuasione. E in politica – o, quanto meno, in democrazia – la persuasione è tutto. Trovo dunque sconcertante che la questione della dominanza linguistica sia tanto trascurata nel dibattito sulla costruzione dell’identità europea. So di toccare qui un tema delicato. Eppure, credo che valga la pena affrontarlo. Ma vorrei preliminarmente chiarire la mia posizione riguardo all’esperanto. Non sono mai stato un attivo esperantista. Dirò di più: non ho mai seriamente studiato la lingua (ne sfogliai solo la grammatica molto tempo fa); e quando mi trovo a leggerla, faccio la stessa fatica che farebbe la maggior parte della gente, tranne il vantaggio che mi può derivare da un certo allenamento alla lettura di lingue straniere ed al ragionamento sulle strutture linguistiche in genere. Insomma, non ho alcun coinvolgimento emotivo nella questione: nulla da perdere e nulla di personale da guadagnare. Ma proprio per questo ritengo di avere qualche giustificato titolo per parlarne. Credo che una questione tanto delicata vada affrontata con raziocinio, soppesando i pro ed i contro con la stessa freddezza con cui ci si dovrebbe comportare nell’imminenza di una decisione importante; quale potrebbe essere la scelta di una facoltà universitaria o tra due offerte di lavoro. 10 Pardon! Nel nostro paese un po’ bislacco si deve parlare di “collaboratori ed esperti linguistici”, se no si rischia di suscitare seri problemi giuridici. 11 QUALE LINGUA PER L’EUROPA? Ufficialmente, nell’Unione Europea ciascuna lingua è sullo stesso piano delle altre. Questo dovrebbe garantire la pari dignità di tutte. Ma nei fatti, come stanno le cose? Diamo un’occhiata alle statistiche. Nell’Europa a 15 stati, si contano undici lingue (ma si parla ormai di un’Europa a 25 stelle, con conseguente lievitazione del numero degli idiomi ufficiali). Dal sito <www.eurolang2001.org> ho tratto qualche tempo fa i seguenti dati: Lingua Percentuale della popolazione europea che la parla come lingua madre Percentuale della popolazione europea che la parla come seconda lingua Percentuale totale in grado di parlare questa lingua tedesco francese inglese italiano spagnolo olandese greco portoghese svedese danese finlandese altre 24 % 16 % 16 % 16 % 10 % 6% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 8% 10 % 31 % 2% 4% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 4% 32 % 26 % 47 % 18 % 14 % 7% 3% 3% 3% 2% 1% 6% Se i rapporti di forza sono questi, mi pare ovvio che la situazione, abbandonata a sé stessa, non lasci scampo. L’inglese è destinato ad imporsi in un volgere di tempo neanche troppo ampio. A questa conclusione si perviene sulla base del puro buon senso, anche senza scomodare ragionamenti sociolinguistici.11 A meno che non si creda davvero che i futuri cittadini dell’Unione Europea sapranno conversare in tutte le lingue nazionali riconosciute (più magari quelle di alcune cospicue minoranze, come il catalano o il basco). Ma è bene prendere atto del fatto che neppure gli Svizzeri, che di lingue ufficiali ne hanno solo quattro – e ci si potrebbe anche fermare alle tre principali – riescono a parlarle tutte (salvo un’esigua minoranza di poliglotti). Converrebbe quindi che smettessimo di menarci per il naso a vicenda: non è vero che il fatto di non compiere alcuna scelta circa la lingua comune, e di mantenerle tutte sullo stesso piano, assicuri davvero una pari dignità a tutte le lingue dell’Unione. Non scegliere equivale ad aver fatto una scelta; ovviamente, a favore dell’inglese. Tuttavia, lasciar campo libero a questa lingua – o, se è per quello, a qualsiasi altra – comporta i problemi cui ho accennato sopra: significa offrire un vantaggio economico e politico di immensa portata al 16 % dei cittadini dell’Unione (ma ormai molti meno, dato che stiamo entrando nell’Europa a 25 stelle). Certo, non solo a loro. Esiste, ed è indubbiamente destinata ad allargarsi, una quota di non nativamente anglofoni in grado di usare l’inglese con relativa disinvoltura (raramente, però, con autentica padronanza). Ma non mi pare che ciò modifichi di molto la situazione. Il problema che ho posto è di carattere radicale: è giusto ammettere che una quota ristretta (non importa quanto) della popolazione europea disponga in partenza di un vantaggio di incalcolabile portata rispetto agli altri? 11 La letteratura sulla dominanza dell’inglese, e sull’influsso che esso esercita sulle altre lingue, è vastissima. Mi limiterò a citare due recenti miscellanee: MUHR 2002 e SAN VICENTE 2002. 12 Resterei molto deluso se mi si rispondesse di sì. Ma se la risposta è no, allora dobbiamo avere il coraggio di trarne le ovvie conseguenze. L’unico modo per far fronte all’invadenza dell’inglese consiste nel concordare la scelta di uno strumento linguistico davvero egualitario, quale può solo essere una lingua internazionale ausiliaria. Ciò porta dunque a dire che la scelta non potrebbe che orientarsi in favore dell’esperanto, visto che è l’unica soluzione davvero disponibile, e non varrebbe certo la pena di perder tempo ad inventare eventuali alternative. M a per compiere questo passo, ci vorrebbe un coraggio che in giro non si vede. Proviamo allora a rovesciare la prospettiva. Dopo aver visto, e criticamente discusso, le ragioni degli esperantisti, valutiamo ora gli argomenti dei loro avversari. Esiste, in primo luogo, l’argomento fatalista, indubbiamente fondato e molto radicato. La sua formulazione più concisa potrebbe essere: inutile lottare contro i mulini a vento. Le lingue che si sono imposte sono sempre state le lingue dei popoli culturalmente dominanti. Ora è il turno dell’inglese, mentre al tempo di Leopardi questo ruolo era svolto dal francese. L’unica differenza sta nel fatto che la situazione attuale rischia di diventare irreversibile: quando decadrà la potenza economica e militare degli Stati Uniti, è possibile che il mondo sia già stato pesantemente anglofonizzato. E dunque: Muoia pure Sansone, gli sopravvivranno i filistei. Ora, lungi da me l’intento di negare la plausibilità di questo scenario. È evidente che, sul piano mondiale, questo è appunto lo sviluppo più probabile. Ma il problema che ho indicato sopra è un altro: ho parlato della scelta di una lingua comune europea, atta ad assicurare uguali condizioni di partenza a tutti i cittadini dell’Unione. Ciò che avverrà nel resto del pianeta, ovviamente, non potrà che riguardarci, ma è una questione da tenere ben distinta. Vorrei anzi che una volta per tutte ci si chiarisse le idee su questo punto: l’esperanto non è una scelta che va proposta contro l’inglese. Sarebbe ora di uscire da questa assurda logica del confronto, che del resto non lascia scampo. Non c’è alcun dubbio che dovremo, per ragioni fin troppo ovvie, continuare ad imparare la lingua parlata dagli statunitensi; e se un giorno la Cina diverrà la prima potenza, ci toccherà fare lo stesso con il cinese. Il punto sta tuttavia nel comprendere che sarebbe nostra convenienza, all’interno dell’Unione Europea, adottare una scelta diversa ed autenticamente egualitaria. Esiste una variante esasperata dell’argomento precedente, secondo la quale l’adozione di una lingua internazionale ausiliaria appare come un’impossibile utopia. La pretesa di insufflare la vita in un idioma che non è radicato in alcuna comunità storica è (secondo questo punto di vista) altrettanto velleitaria, quanto il voler resuscitare una lingua morta. L’obiezione è fondata: chi si attentasse a negarne la plausibilità darebbe prova di ottusa ostinazione. Oltre tutto, coloro che argomentano in questo modo non sono necessariamente ostili all’ipotesi di una lingua strumentale, ma si arrendono di fronte alle troppe difficoltà inerenti alla sua diffusione. Una scelta esperantista presuppone la convergenza di troppi fattori – e soprattutto di molte volontà – sul concorso dei quali non è lecito farsi troppe illusioni. Quindi, tanto vale adottare il rassegnato pragmatismo di Disraeli: “You cannot fight against facts, they don’t mind at all”. E tuttavia, nonostante l’indubitabile forza di questa obiezione, esistono alcuni spiragli su cui far leva. Innanzi tutto, non è del tutto vero che le lingue morte non possono essere recuperate all’uso vivo: ciò è successo in Israele con l’ebraico. Quest’ultimo non aveva mai cessato di essere impiegato come lingua di culto, e come tale ha continuato ad essere appreso lungo i secoli. Ma da ciò non si sarebbe potuto arguire nulla di più; anche il latino è stato usato come lingua di culto nella chiesa cattolica fino al concilio Vaticano II, eppure ben pochi si sarebbero azzardati a sostenere che esso potesse venire adottato come lingua viva.12 L’adozione dell’ebraico è stata evidentemente favorita dal verificarsi di circostanze eccezionali e difficilmente ripetibili. Eppure è successo. A 12 Qualcuno, in effetti, c’è sempre stato, ed il latino vanta tuttora i suoi tifosi. Del resto, abbiamo le prove che esso può adattarsi a descrivere l’odierna quotidianità, come ben sanno coloro che si collegano alla pagina dei Nuntii latini, curati da un gruppo di latinisti finlandesi, che diffondono settimanalmente un notiziario sugli avvenimenti internazionali. Per chi volesse fare questa godibilissima esperienza, l’in dirizzo è: http://www.yleradio1.fi/tiede/nuntii 13 questo punto, uno scettico potrebbe obiettare di rimando che l’adozione dell’esperanto rischierebbe comunque di restare una specie di corpo estraneo; un’anomala lingua di superstrato, parlata soltanto dalle élites in particolari circostanze e mai effettivamente adoperata nella quotidianità. Questo è molto probabile (e, credo, non solo nella fase iniziale); sarebbe sciocco negarlo, anche se il progressivo rafforzarsi delle motivazioni all’apprendimento finirebbe poi coll’accrescere la diffusione di questa lingua entro strati di popolazione via via più ampi. Ma c’è un altro fatto che non va trascurato: e cioè, l’esistenza di illustri precedenti, di cui soprattutto noi italiani non dovremmo dimenticarci. NENCIONI 1995 ha argutamente ed efficacemente parlato, proprio con riferimento alla situazione dell’italiano nei secoli passati, di una lingua “canforata”; che appunto a causa del suo carattere aristocratico, e del suo essere soprattutto una lingua letteraria piuttosto che lingua d’uso, ha potuto conservarsi lungo le generazioni con alterazioni relativamente irrilevanti. Non si può dunque dire che manchino gli esempi. Anche se, beninteso, non vanno sottovalutate le obiettive difficoltà inerenti alla diffusione di una lingua pianificata. Circola anche un’ulteriore variante dell’argomento fatalista, che si esprime con toni ottimistici, quasi baldanzosi. La formulazione diventa: E che problema c’è? Chiunque, se vuole, può imparare l’inglese: si tratterà soltanto di intensificare gli sforzi. Magari ci procureremo tutti (beh, quelli che possono) una tata anglofona; manderemo i nostri figli a studiare nel Regno Unito; assolderemo lettori madrelingua per ogni scuola media; insomma, faremo quello che, secondo certi teorici ottocenteschi della forzata toscanizzazione, si sarebbe dovuto fare per italianizzare a tappe forzate i parlanti dialettofoni dello stivale. Ovviamente, le cose non sono poi andate così. Tanto per cominciare, non c’erano abbastanza maestri toscani (o tate) da trapiantare in ogni villaggio; se anche li si fosse trovati, si sarebbero create serie distorsioni nel mercato del lavoro, con incalcolabili conseguenze; infine, non c’è motivo di credere che la gente si sarebbe docilmente adattata a vedersi espiantare la propria lingua. Perché di questo, in fondo, si tratta, anche se si preferisce non dirlo troppo ad alta voce. C’è chi ha coniato, per l’inglese, la nozione di ‘glottofagia’ (Louis -Jean Calvet, citato in CHITI BATELLI 1988) ; potrà piacere o meno, ma sta di fatto che il meccanismo è quello. Intendiamoci, non è neppure detto che la cosa non possa funzionare; la vicenda italiana ci ha pur insegnato qualcosa. Anche se la toscanizzazione dell’Italia non c’è stata, non v’è dubbio che l’italianizzazione è proceduta spedita, al punto che i dialetti hanno ormai – quale più, quale meno – i decenni contati. Le diverse varietà di italiano che si parlano nella penisola differiscono dal modello toscano, ma sono comunque forme perfettamente accettate di italiano. È persino successo, soprattutto in certe regioni d’Italia, che i genitori abbiano sistematicamente evitato, per libera scelta, di parlare in dialetto ai propri figli, per accelerare il loro processo di italianizzazione. A ciò si è poi aggiunta la capillare presenza dei mezzi di comunicazione di massa, che hanno diffuso dei modelli di lingua nazionale certo difformi tra di loro, ma comunque efficaci. Se questo è accaduto con l’italiano, non ci sono ragioni a priori per ritenere che non possa accadere con l’inglese. La vittoria sarà più lenta, e tuttavia potrà verificarsi. Magari si comincerà col trasmettere sistematicamente in televisione film in inglese con sottotitoli in italiano, e il tempo farà il suo lavoro. Ma siamo davvero disposti a pagare il prezzo che ne consegue? Che consiste, lo ripeto, nell’accettare la marginalizzazione e, in prospettiva sia pur lontana, la condanna dell’italiano, allo stesso modo in cui abbiamo acconsentito (per ragioni, peraltro, nobili e comprensibilissime) alla marginalizzazione dei nostri dialetti? Prevengo un’obiezione: Se la lingua comune fosse l’esperanto, non accadrebbe lo stesso, alla lunga? Non lo si può escludere in assoluto. Tuttavia, come ho notato sopra, è molto meno probabile, considerando che quest’ultimo, per la sua natura di lingua di servizio, non possiede la stessa forza d’urto dell’inglese. Di sicuro non si porrebbe, per esempio, il problema di uno standard da trapiantare: non esiste infatti alcun luogo del nostro pianeta che possa fornire lettori madrelingua di esperanto. Di fronte a questo idioma, siamo tutti ugualmente nudi. 14 E poi, mi si consenta un’annotazione in margine, magari un po’ pungente. Tra coloro che ritengono di possedere una discreta padronanza dell’inglese, e che certo a causa di ciò sposano la tesi dell’anglizzazione rapida e forzata, trovo che ve ne siano moltissimi che si sopravvalutano. Anche su questo punto, non vorrei essere frainteso. Non intendo svalutare, meno che mai irridere, gli sforzi di coloro che tentano di appropriarsi di una lingua straniera. Provo anzi grande simpatia per chi si arrabatta per farsi comprendere in una lingua diversa dalla propria, affrontando gli inevitabili rischi a ciò connessi: impaccio espressivo, goffaggine, involontaria generazione di imbarazzanti doppi sensi. Ma non nascondo la mia irritazione, e il mio compatimento, verso chi si mostra talmente privo di senso critico, da confondere con l’autentica padronanza il possesso puramente strumentale di una lingua. Il fatto di sapersela cavare brillantemente in circostanze pratiche – e tali sono anche le situazioni professionali – non ha nulla a che vedere con la vera dimestichezza. Io posso non aver difficoltà nel capire ciò che mi viene detto, e posso anche disporre di una discreta fluenza di eloquio; posso – ed è il mio caso – far lezione in inglese, difendendo animatamente le mie idee, senza provare alcun senso di fatica (e, ciò che più conta, senza provocare fatica e fastidio negli ascoltatori); ma la padronanza è un’altra cosa. Quest’ultima significa avere la pronta disponibilità: del lessico con tutte le sue stratificazioni e sfumature, incluse le locuzioni idiomatiche; dei più diversi schemi sintattici, che mi offrano le opportune alternative espressive; dei più efficaci moduli retorici, che conferiscano forza e appropriatezza al mio dire. Su tutti questi livelli, la precisione designativa e la persuasività di un parlante nativo risultano difficilmente battibili. Laddove io, con la mia pur lodevole fluenza, sono spesso costretto a ricorrere ai soliti e collaudati giri di parole, il mio interlocutore madrelingua mostra un’invidiabile ed efficacissima concisione; e viceversa, dove io manifesto talvolta un’impacciata laconicità, lui è in grado, se vuole, di sommergermi con un torrente di facondia. Se il mio interlocutore è simpatetico e collaborativo, non sorgono problemi nell’interazione diretta; ma se si tratta di conquistare la fiducia di un terzo, o di vincerne le resistenze, lui gode su di me di un vantaggio insormontabile. Certo, l’ho detto e lo ribadisco, esistono anche coloro che riescono a raggiungere l’assoluta padronanza di una lingua straniera. Ma a parte che questo non accade molto spesso (e comunque andrebbe valutato caso per caso), è sbagliato affrontare una questione di tale importanza dal punto di vista dei singoli. Il problema ci riguarda tutti, e si pone brutalmente in questi termini: mentre, potenzialmente, qualsiasi cittadino britannico o irlandese è in grado di scendere con ragionevole possibilità di successo nell’agone politico europeo (con tutte le possibili ricadute sul versante economico e culturale), nei restanti paesi questa possibilità è riservata ad élites più o meno piccole. Esiste poi l’argomento ‘estetico’, anch’esso molto diffuso. L’esperanto, in quanto lingua inventata, non può competere sul piano dell’intrinseca ‘bellezza’ con le lingue storicamente costituitesi. Queste ultime dispongono di una capacità espressiva incomparabilmente superiore, come è del resto dimostrato dal fatto che in tali lingue è stata scritta una ricca, varia e nutriente letteratura. Assolutamente vero. Mi parrebbe tempo sprecato provare a controbattere. Sarebbe inutile obiettare – come vedo fare da parte di certi esperantisti – che, col tempo, anche l’esperanto potrebbe sviluppare una grande letteratura. È tutto da vedersi; non venderei la pelle dell’orso. La mia convinzione in proposito non viene incrinata neppure dalla crescente disponibilità di traduzioni, in esperanto, di opere letterarie tratte dalle più svariate lingue. Non esito anzi a dire che se anche oggi l’esperanto fosse già la lingua comune di servizio, io preferirei di gran lunga continuare a leggere in italiano le opere letterarie tradotte. L’italiano possiede, come tutte le lingue di tradizione storica, una fitta stratificazione di moduli espressivi, ai quali un sapiente traduttore può attingere. Ciò conferisce alla pagina uno spessore che nessuna traduzione in esperanto (e, se è per questo, nessuna creazione originale in esperanto) saprebbe offrirmi.13 13 Dopo aver letto in anteprima questo passo, un noto esperantista, autore di poesie e romanzi in tale lingua, mi ha trasmesso per iscritto il proprio disappunto. Comprendo le sue ragioni, e ammetto senz’altro di non essere in 15 L’obiezione ‘estetica’ è dunque, in sé e per sé, perfettamente fondata. E tuttavia vorrei nuovamente ricordare i termini del problema. Facciamo attenzione: le ragioni dell’esperanto non si fondano sul fatto che esso possa competere con le lingue di tradizione storica, ma unicamente sulla sua attitudine a svolgere la funzione di lingua di servizio, soprattutto nel contesto europeo. Quanto al resto, esso non può e non deve avere alcuna ambizione a supplire al ruolo delle lingue storiche; meno che mai sostituirsi ad esse. Al contrario – e su ciò vedo che gli esperantisti consapevoli sono concordi – la forza dell’esperanto è semmai proprio quella di non costituire una minaccia per le nostre lingue, che dovranno continuare ad essere adoperate come veicolo di comunicazione nelle comunità di origine, perpetuandone i valori culturali.14 Insomma, il nostro motto non dovrà essere: Parliamo l’esperanto ed esso finirà col piacerci – anche se questo non è affatto inverosimile, a giudicare dalle entusiastiche testimonianze dei cultori di questa lingua – ma piuttosto, parafrasando Indro Montanelli: Tappiamoci pure il naso, ma usiamo l’esperanto perché ci conviene. Infine, esiste l’argomento ‘dell'inevitabile corruttibilità’: che è paradossalmente il rovescio della medaglia dell’idea, sopra esposta, relativa al carattere aristocratico, ovvero alla canforata fissità dell’esperanto. L’obiezione diventa in questo caso: ma se l’esperanto cominciasse davvero ad essere impiegato, non finirebbe per compromettere – con l’inevitabile usura – la sua assoluta regolarità morfologica, il suo furore geometrico? Non finirebbe cioè per perdere proprio le caratteristiche che ne possono inizialmente assecondare la penetrazione?15 Curiosa osservazione, questa. Non ci si rende conto che, se ciò avvenisse, vorrebbe dire che questo idioma si sarebbe ormai irreversibilmente affermato. A quel punto, non dovremmo più preoccuparcene: correrebbe con le sue gambe. Ma l’ostinato obiettore non demorde. E sia, dice costui: ma se l’esperanto comincia a diffondersi, che ne sarà della sua vantata uniformità di pronuncia? Non finirà per crearsi una situazione paragonabile a quella dell’inglese, con la frammentazione delle sue pronunce che tanto confonde le idee a chi apprende questa lingua? A quel punto, non avremmo più una lingua internazionale, ma tante varietà diverse e localmente connotate. Questa osservazione è ancora più strana della precedente. La difformità delle pronunce dell’inglese è effettivamente un ostacolo per i non anglofoni; ma non ha mai costituito un problema per i parlanti nativi, allo stesso modo in cui le diverse pronunce dell’italiano non turbano gli abitanti della penisola (e gli esempi si potrebbero moltiplicare). Questa volta toccherebbe all’esperantista dire: e che problema c’è? Quando il latino svolgeva la funzione di lingua internazionale, circolavano vari standard di pronuncia perfettamente identificabili; ma la gente (quella istruita, ovviamente) non aveva difficoltà a comprendere la lingua. 14 15 grado (per mia insufficienza) di apprezzare appieno le sottigliezze stilistiche di un testo letterario in esperanto. Aggiungo, poi, di essere molto lieto che vi siano esperantisti che praticano quest’arte; lo sviluppo di una letteratura è la premessa indispensabile per la piena maturazione di un idioma, e per la sua definitiva accettazione. Tuttavia, allo stato attuale delle cose non vedo motivo per modificare il mio punto di vista. Le lingue di grande e lunga tradizione letteraria godono, da questo punto di vista, di un vantaggio che sarebbe vano negare. E, a scanso di equivoci, aggiungo che se anche l’esperanto acquistasse lo statuto di lingua veicolare di servizio nella comunità europea, ciò non eliminerebbe la necessità dei traduttori che a Bruxelles e Strasburgo fanno tanto gridare allo spreco. Quand’anche venisse meno la necessità delle traduzioni simultanee, resterebbe comunque la delicatissima funzione di tradurre, nelle diverse lingue nazionali, i documenti comunitari, allo scopo di dirimere i sottili problemi giuridici connessi con la formulazione dei testi di legge. L’argomento è molto diffuso. È già presente in Leopardi (Zibaldone, 25 agosto 1823); e cf. almeno ECO 1993 (pp. 357) e SWIGGERS 2001 (pp. 38). 16 ELOGIO DELL’IMPERFEZIONE So bene di aver espresso in questo scritto una posizione di assoluta minoranza. Suppongo anche di essermi attirato gli strali di qualche collega.16 Tuttavia, è un vero peccato che ci si rifiuti, spesso per un malinteso pudore, di affrontare la questione nei termini sopra esposti. Senza preconcetti e con qualche dose di anticonformismo. Quanto sono venuto esponendo nelle pagine precedenti potrebbe riassumersi così. Ogni lingua umana è perfetta nella sua corrispondenza al proprio fine. L’esperanto può aspirare ad esserlo solo nella misura in cui riesce a mimare la funzionalità delle lingue naturali, lasciandosi alle spalle quell’assurda pretesa di migliorarle, che è stata a lungo l’incauto obiettivo dei glottodemiurghi. E tuttavia, l’indubbia inferiorità dell’esperanto rispetto alle lingue storiche (sul piano estetico e della ricchezza espressiva) potrà essere compensata dalla sua strumentale utilità, nel momento in cui ci si renderà conto – posto che ci si renda conto – dell’urgenza di predisporre un utensile comunicativo autenticamente egualitario entro l’Unione Europea. Sul piano strettamente linguistico, l’esperanto può insomma rivendicare nient’altro che una piena legittimità in quanto lingua (che è pur sempre molto più di nulla). La sua autentica giustificazione va invece individuata a livello politico, ovvero (come si esprime CHITI BATELLI 2002) della ragion di stato. L’attrattiva dell’esperanto non dipende quindi dal fatto che esso si approssimi ad un’ideale di perfezione, ma semmai dall’adeguatezza puramente strumentale della sua imperfezione. Il suo merito consiste essenzialmente nell’assoluta neutralità culturale: l’esperanto non offre indebite rendite di posizione ad alcuna minoranza privilegiata, né meno che mai può rappresentare una minaccia di omologazione per gli altri. Sarebbe interesse degli europei non nativamente anglofoni (ossia, quasi tutti) acquistare coscienza del problema e compiere il necessario “atto di buona volontà politica” (come dice, sia pure con scetticismo , ECO 1993, p. 342). Sempre auspicando che essi non vogliano correre – a lungo termine – il rischio dell’espropriazione linguistica e – a medio/breve termine – quello della subalternità culturale.17 Posso dunque concludere parafrasando le parole che Gino Capponi scrisse nel 1869 su Nuova Antologia (p. 682): “Ora che l’Europa unita c’è, che cosa si deve fare in materia di lingua, quando della lingua comune tuttora si disputa, tuttora si cerca? […] Più grave è fatto il nostro debito ora in tempi di sorti mutate, di sorti maggiori ma più difficili a portare; noi siamo venuti ad esse non preparati, e s’io dovessi quanto alle future condizioni della lingua fare un pronostico, direi senz’altro: la lingua in Europa sarà quello che sapranno essere gli europei”. 16 17 Ma sono, per mia fortuna, in ottima compagnia: tra i linguisti e filologi che si sono espressi a favore di una lingua internazionale ausiliaria si annoverano individui del calibro di Karl Brugmann, Gustav Meyer, Otto Jespersen, Michel Bréal, Jan Baudouin de Courtenay, Hugo Schuchardt (SWIGGERS 2001, pp. 28). E si possono aggiungere, quanto meno (secondo la testimonianza di CHITI BATELLI 1988): Edward Sapir, Rudolf Carnap, Mario Andrew Pei, Bruno Migliorini, Arrigo Castellani. Devo inoltre dire che tutti i miei colleghi che sono attivi esperantisti (non molti, per la verità) sono degli invidiabili poliglotti, a dimostrazione del fatto che l’esperanto non è la scappatoia per evitare di imparare altre lingue. Vorrei qui appoggiarmi all’autorità di un grande intellettuale italiano, Eugenio Garin: “Oggi - lo dico con raccapriccio - si afferma l’uso dell’inglese per tutto ciò che è scientifico. Ma si tratta della lingua d’un popolo; non ha, come il latino, il carattere di un codice sovrannazionale” (citato in CHITI BATELLI 1988, pp. 187). 17 Riferimenti bibliografici. CHITI BATELLI 1988 = Andrea CHITI BATELLI , La politica d’insegnamento delle lingue nella comunità europea. Stato attuale e prospettive future, Roma, Armando 1988. CHITI BATELLI 2002 = Andrea CHITI BATELLI , L’inglese distruggerà le nostre lingue? Ed è possibile porvi rimedio?, in AA.VV., Seconda miscellanea di scritti. XX Anniversario dell’Associazione Ex Dipendenti del Senato, Roma 2002, pp. 51-69. ECO 1993 = Umberto ECO, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Bari, Laterza 1993. FRANK 1980 = Helmar FRANK, L’influenza dell’istruzione propedeutica della ‘lingua straniera’ per l’apprendimento nella scuola dell’infanzia, in Scuola maggiorenne - Scuola dell’infanzia e nuovi contenuti educativi, a cura di Franco FRABBONI, Firenze, Sansoni 1980, pp. 256-269 (anche in: Helmar FRANK und Mitarbeiter, Kybernetische Pädagogik - Klerigkibernetiko. Schriften 1973-92, Band 6, a cura di Vera K. BARANDOVSKÁFRANK, Akademia Libroservo / Institut für Kibernetik Berlin 1993). LINDQVIST 2000 = Sven LINDQVIST , Sterminate quelle bestie, Ponte alle Grazie, Firenze 2000. M EILLET 1918 = Antoine M EILLET , Les langues dans l’Europe nouvelle, Payot, Paris 1918 (19282). Moro 2002 = Andrea Moro, “Linguistica mandeliana” ovvero quali domande su genetica e grammatica, «Lingue e Linguaggio» 2,1, 2002, pp. 39-58. M UHR 2002 = Der Einfluss des Englischen auf europäischen Sprachen zur Jahrtausendwende, a cura di Rudolf M UHR, Lang, Frankfurt a.M. etc. 2002. NENCIONI 1995 = Giovanni NENCIONI, Il destino della lingua italiana, «Nuova Antologia» 130, 1995, pp. 65-80 (anche in ID., Saggi e memorie, Scuola Normale Superiore, Pisa 2000). NENCIONI 1997 = Giovanni NENCIONI, Plurilinguismo in Europa, «Annali della Pubblica Istruzione» 43, 1997, pp. 3-14 (anche in ID., Saggi e memorie, Scuola Normale Superiore, Pisa 2000). SAN VICENTE 2002 = L’inglese e le altre lingue europee. Studi sull’interferenza linguistica, a cura di Félix SAN VICENTE, CLUEB, Bologna 2002. SAPIR 1937 = Edward SAPIR, The function of an international auxiliary language, «Psyche» 11, 1937, pp. 4-15 (trad. it. in ID., Cultura, linguaggio e personalità. Linguaggio e antropologia, Einaudi 1972, pp. 37-53). SWIGGERS 2001 = Pierre SWIGGERS, L’idée de langue universelle et de langue parfaite dans l’histoire de la linguistique occidentale, in Storia del pensiero linguistico: Linearità, fratture e circolarità, a cura di Giovanna M ASSARIELLO M ERZAGORA, Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia, Verona 11-13 novembre 1999, Il Calamo, Roma 2001, pp. 13-68. 18
Scaricare