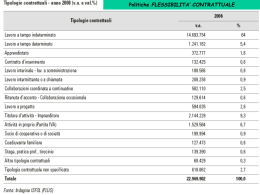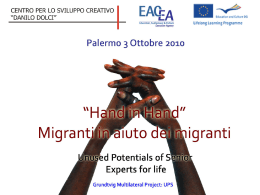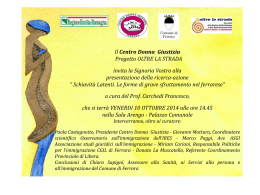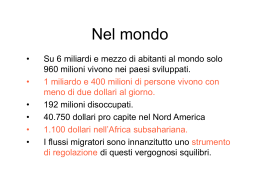L’impegno dei cristiani di fronte alle sfide dell’immigrazione Ragusa, 23-25 aprile 2005 Le condizioni per la costruzione di una società multiculturale Laura Zanfrini Università Cattolica di Milano (docente di Sociologia dei processi economici e di Sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica) [email protected] Il modello dell’insediamento È tipico dei “classici” paesi d’immigrazione, dove quest’ultima è una componente costitutiva della storia e dell’identità nazionale Le politiche migratorie sono finalizzate ad accrescere la popolazione e a sostenere lo sviluppo economico (politiche per l’immigrazione) L’immigrazione è la fase iniziale di un processo di “cittadinizzazione”, che di norma sfocia nella naturalizzazione I criteri di selezione nel passato privilegiavano gli immigrati “assimilabili”, oggi chi ha già parenti regolarmente residenti o naturalizzati e i soggetti a elevato potenziale L’obiettivo delle politiche migratorie e per gli immigrati è la piena integrazione economica e sociale L’enfasi è tradizionalmente posta sui controlli esterni (agenzie migratorie, politiche dei visti, ecc.) superati i quali il migrante è in linea di principio legittimato a competere ad armi pari sul mercato del lavoro e nella società (-->la mobilità è incoraggiata) Il modello del lavoro temporaneo È tipico dell’esperienza europea e più in particolare di quei paesi che manifestano una tradizionale reticenza a riconoscersi nel ruolo di paesi d’immigrazione Le politiche migratorie sono finalizzate a soddisfare specifici fabbisogni del mercato del lavoro, spesso di carattere temporaneo L’immigrazione è pensata come presenza a tempo e scopo determinati, l’insediamento permanente è scoraggiato e l’acquisizione della cittadinanza ostacolata da una legislazione improntata al diritto di sangue I criteri di selezione privilegiano gli immigrati originari da paesi coi quali esistono accordi bilaterali e/o in possesso di specifiche qualifiche L’obiettivo delle politiche migratorie e per gli immigrati è di scongiurare la stabilizzazione promuovendo la rotazione delle presenze, il rientro dei migranti, o la c.d. “integrazione provvisoria” L’enfasi è tradizionalmente posta sui controlli interni con l’obiettivo di garantire ai nazionali, “proprietari dello Stato”, un accesso privilegiato alle risorse e alle opportunità sociali (--> mobilità in linea di principio scoraggiata) Il modello della residenza permanente È tipico dei paesi europei con un passato coloniale ed eventualmente con l’esigenza di sostenere la crescita demografica Le politiche migratorie sono principalmente destinate a governare l’afflusso, non sempre “voluto”, di ex coloni L’immigrazione è pensata come presenza tendenzialmente permanente e l’acquisizione della cittadinanza è “automatica” o comunque regolata dal diritto di suolo I criteri di selezione recepiscono l’opportunità di concedere un trattamento preferenziale ai migranti provenienti dalle ex colonie, spesso formalizzando ex post flussi già esistenti L’obiettivo delle politiche migratorie e per gli immigrati è quello di favorire l’integrazione dei migranti e dei loro discendenti, secondo strategie che riflettono le peculiarità dei diversi approcci nazionali (assimilazionismo, principio dell’equità razziale, istituzionalizzazione delle minoranze) È un modello più flessibile del precedente, dal punto di vista sia dei controlli sul lavoro straniero, sia della possibilità di regolarizzare il proprio status Il modello dell’Europa mediterranea È tipico dei paesi europei che hanno conosciuto la loro transizione in aree di destinazione dopo l’avvento generalizzato delle politiche di chiusura Il deficit di regolazione istituzionale ha fortemente segnato le prime fasi del ciclo migratorio, accompagnandosi a una buona capacità di mobilitazione della società civile (sovraccarico funzionale del volontariato) L’obiettivo delle politiche migratorie e per gli immigrati è quello di assecondare i fabbisogni del mercato del lavoro, recependo al contempo istanze di politica estera (accordi bilaterali), di favorire la loro integrazione sociale negando al contempo i diritti politici La diffusione e il radicamento culturale del lavoro “nero”, unitamente alla disfunzionalità delle politiche migratorie, determinano un ripetuto e anomalo ricorso alle regolarizzazioni di massa Lo scarso universalismo del mercato del lavoro si declina attraverso marcati processi di etnicizzazione del m.d.l. e dequalificazione professionale degli immigrati istruiti L’insufficiente istituzionalizzazione del mercato dei servizi alla persona è un corollario di questa variante familistica dei regimi di welfare È un modello caratterizzato dalla distanza tra le previsioni di legge e la loro concreta applicazione Le peculiarità dell’esperienza italiana I punti di forza Forte capacità d’attrazione da parte del tessuto industriale Adozione di una legislazione “innovativa” nel panorama europeo Ruolo strategico della cooperazione bilaterale coi paesi d’origine Lancio di un nuovo programma per la gestione dei flussi che sposta l’enfasi dalla dimensione quantitativa a quella qualitativa degli ingressi Capacità di mobilitazione da parte dell’associazionismo e del terzo settore a sostegno del processo d’integrazione Le peculiarità dell’esperienza italiana I punti di debolezza Etnicizzazione del m.d.l. e dequalificazione (fenomeni di brain wasting) Diffusione e radicamento culturale del lavoro “nero” Ricorso reiterato ai provvedimenti di regolarizzazione di massa Insufficiente istituzionalizzazione del mercato dei servizi alla persona Scarso universalismo del m.d.l. ( seconde generazioni) Le “ipocrisie” delle politiche migratorie Politiche di blocco Persistente fabbisogno di lavoro immigrato, forte capacità d’attrazione dell’economia sommersa, totale insufficienza dell’attività ispettiva, impatto economico delle rimesse Politiche per l’immigrazione qualificata Concentrazione degli immigrati nel settore secondario del m.d.l., natura auto-propulsiva delle migrazioni, fenomeni di brain-drain, retorica “illuministica” Politiche per l’immigrazione temporanea Fragilizzazione dello status giuridico dei migranti, tensione con le istanze di fidelizzazione espresse dalle imprese, misconoscimento del ruolo dell’immigrazione come produttrice di welfare, esasperazione della concezione funzionalistica dell’immigrazione e dei rischi di concorrenzialità con le fasce più deboli Le “ipocrisie” delle politiche migratorie Regolamentazione dell’immigrazione familiare e umanitaria Tensione con lo sviluppo del diritto internazionale, dubbi di legittimità delle pratiche di esternalizzazione dei confini, misconoscimento del ruolo di questi canali per l’approvvigionamento di manodopera Adozione di un approccio olistico Tensione con la concezione funzionalistica dell’immigrazione (complementarietà), sottovalutazione del necessario legame tra politiche per l’integrazione degli immigrati e politiche per la costruzione di una società “integrata” La discriminazione È una evidente smentita di una delle fondamentali “profezie” che hanno accompagnato la modernizzazione: la caduta di rilevanza dello status ascritto nella divisione del lavoro sociale e nella distribuzione delle risorse e delle opportunità Ancorché non sempre intenzionale consente ai gruppi sociali dominanti di monopolizzare le opportunità più vantaggiose Accompagna inevitabilmente il processo di stabilizzazione delle popolazioni immigrate, per effetto del verificarsi del “paradosso dell’integrazione” È una prassi iniqua, che penalizza taluni gruppi sociali, ma che diventa anche causa di “frattura” della coesione sociale La problematicità del discorso sulla discriminazione Tensione tra l’enfasi sulle pari opportunità e una politica migratoria obbediente all’idea di complementarietà tra stranieri e autoctoni Tensione tra la diffusione dello status di denizenship e la temporaneità degli ingressi autorizzati Tensione tra l’esigenza di integrazione e la subalternità dei ruoli riservati agli immigrati Tensione tra i principi antidiscriminatori e un governo dell’immigrazione obbediente ai fabbisogni del sistema produttivo e alle istanze sicuritarie L’integrazione sociale È la coesione armonica e la convivenza pacifica di tutti gli attori che compongono una determinata società erroneamente essa è spesso definita come il processo dell’“integrarsi” da parte di categorie sociali problematiche e minoritarie, o come il sentirsi più o meno integrati; essa in realtà riguarda la capacità della società di adempiere la funzione integrativa nei riguardi dei propri attori Agli albori della sociologia l’enfasi era posta sul problema dell’ORDINE SOCIALE, venutosi a creare all’inizio del diciannovesimo secolo sotto i colpi dell’industrialismo e della democrazia rivoluzionaria L’integrazione sociale Nell’epoca della società “globale” o della globalizzazione l’enfasi si sposta sul problema dell’integrazione degli immigrati e degli appartenenti alle minoranze etniche poiché: è in atto una trasformazione in senso multiculturale della società; l’inclusione dei new comers è più difficile in ragione del declino delle agenzie integrative centrali nell’epoca fordista (grande fabbrica, sindacato, partiti politici di massa, chiese, ecc.); vi è la convinzione diffusa che gli immigrati contribuiscano in misura significativa alla “rottura” della coesione sociale; la loro esperienza è “specchio” delle problematiche dell’integrazione sociale tout-court (la società dell’incertezza) Rispetto alla versione classica del paradigma dell’assimilazione si registra un passaggio: Dall’enfasi sulla dimensione culturale all’enfasi sulla dimensione socio-economica Dalla inevitabilità e desiderabilità dell’assimilazione all’agnosticismo circa i suoi esiti e all’ambivalenza circa la sua desiderabilità Dall’unidirezionalità del processo alla natura interattiva del processo di integrazione Da una concezione primordialistica a una concezione situazionale dell’etnicità Da un’idea di progressione regolare attraverso le generazioni a quella di una molteplicità di percorsi adattivi offerti alle seconde generazioni Dall’assimilazione entro la core culture all’assimilazione segmentata Quattro aree critiche in materia d’integrazione 1. 2. 3. 4. Le trasformazioni del mercato del lavoro dentro lo scenario post-fordista L’emergenza di una questione “urbana” e la rilevanza della dimensione locale (--> modelli territoriali di integrazione) La crisi del Welfare State e la sua ridefinizione La globalizzazione e la sfida allo Stato nazionale Le trasformazioni del mercato del lavoro dentro lo scenario post-fordista I fenomeni registrati dalla ricerca empirica: l’etnicizzazione dei rapporti di impiego come componente della segmentazione del mercato del lavoro l’esposizione dei migranti e dei loro discendenti alla disoccupazione e alla sottoccupazione la segregazione di genere i processi di costruzione sociale dell’irregolarità la crescita di un “welfare parallelo” alimentato dal lavoro immigrato specie dentro la variante familista dei regimi di welfare la dequalificazione della manodopera straniera istruita Le trasformazioni del mercato del lavoro dentro lo scenario post-fordista Le forme di inclusione lavorativa: Esemplificano un modello di regolazione scarsamente universalistico ma in cui contano ancora le differenze ascritte Manifestano le aporie delle politiche migratorie rispetto alla realtà sociologica delle migrazioni Tradiscono l’aspettativa diffusa di una integrazione subalterna, che garantisca agli autoctoni un canale preferenziale nell’accesso alle opportunità e alle ricompense sociali (aspettativa avvalorata da una politica migratoria informata al principio di complementarietà tra il lavoro autoctono e quello immigrato) Confermano l’esistenza di un processo di riproduzione intergenerazionale degli svantaggi sociali L’emergenza di una questione “urbana” e la rilevanza della dimensione locale I fenomeni registrati dalla ricerca empirica: la rivalutazione dello spazio – e del territorio – come categoria interpretativa dei fenomeni sociali: la pluralità dei modelli locali di integrazione il conflitto etnico come conflitto urbano, che ha per oggetto la distribuzione dei costi reali o presunti dell’immigrazione e l’uso degli spazi pubblici la difficile costruzione del consenso verso le politiche per l’integrazione i processi di costruzione sociale della devianza e i fenomeni di vittimizzazione l’involuzione dell’atteggiamento degli europei verso gli immigrati e i richiedenti asilo L’emergenza di una questione “urbana” e la rilevanza della dimensione locale Le modalità di integrazione degli immigrati sono rivelatrici delle caratteristiche delle società locali e delle trasformazioni demografiche, economiche, sociali, politiche e culturali in cui esse sono coinvolte Ma anche della capacità progettuale di cui esse sono dotate in ordine al problema della mediazione degli interessi e alla ridefinizione delle basi della coesione sociale Lo straniero assume il ruolo di “capro espiatorio” a fronte del senso di insicurezza diffuso svelando i deficit di integrazione sociale La costruzione sociale degli stranieri come “nemici” palesa il rischio che i progetti di integrazione degli esclusi cedano il passo a istanze di protezione della società dagli esclusi Il ridisegno dello Stato sociale I fenomeni registrati dalla ricerca empirica: messa in discussione dei tradizionali modelli nazionali di integrazione progressiva convergenza delle politiche adottate dai diversi paesi europei, centralità della questione delle seconde generazioni discrezionalità amministrativa, disfunzioni burocratiche, differenziazione territoriale nel trattamento degli immigrati rilevanza – a volte sovraccarico funzionale - del volontariato grande apertura sul fronte dei diritti sociali, grazie anche all’azione di lobby svolta dalle organizzazioni “pro-immigrati” introduzione dello status di “denizen” costante preoccupazione delle amministrazioni locali di assecondare le richieste di trattamento differenziale, invisibilità degli interventi Il ridisegno dello Stato sociale Gli immigrati fungono da “cartina di tornasole” rispetto alle inadeguatezze e alle disfunzioni degli interventi di welfare L’immigrazione svela i caratteri più profondi di un sistema politico e di welfare, la concezione di democrazia che ne è alla base e di chi ha diritto a farne parte Il trattamento riservato agli immigrati (e agli altri soggetti a rischio di esclusione) denota un cambiamento del quadro ideologico e concettuale delle politiche e delle rappresentazioni collettive che penalizza i gruppi “impopolari” La trasformazione in senso multietnico della società obbliga a interrogarsi sui criteri di definizione dei diritti di cittadinanza La globalizzazione e la sfida allo Stato-nazione I fenomeni registrati dalla ricerca empirica: crescente presenza di “non nazionali” e diffusione del riferimento a identità “extra-territoriali” progressivo rafforzamento del pacchetto di diritti riservati agli immigrati a titolo permanente (ma anche ricorso sempre più diffuso ai programmi per l’immigrazione temporanea) introduzione di status giuridici intermedi tra quello di straniero e quello di cittadino esclusione degli stranieri dai diritti politici questione della doppia cittadinanza e della “doppia lealtà” introduzione della cittadinanza europea, peraltro derivata dalla cittadinanza nazionale La globalizzazione e la sfida allo Stato-nazione La circolazione internazionale delle persone obbliga a mettere in discussione il legame tra cittadinanza (nazionalità) e titolarità dei diritti (denizenship, territorializzazione della cittadinanza, membership postnazionale, ecc.) I diritti di cittadinanza hanno una valenza integrativa e simbolica e possono essere usati sia per “produrre” integrazione sia per istituzionalizzare l’esclusione Sono messi in discussione i tradizionali modelli di regolazione della convivenza interetnica, e ci si interroga sulle soluzioni possibili L’evoluzione in corso porta a emergere la problematica dei “diritti etnici” e della loro conciliabilità coi diritti individuali
Scarica