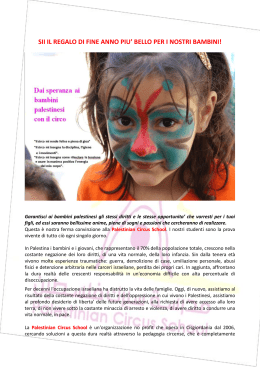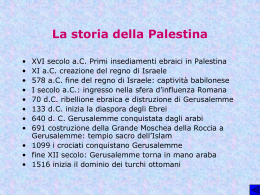Falastin diaries di Simone Ogno (Hadja, 81 anni, i suoi campi e sullo sfondo la colonia israeliana di Efrata) 1 “Qui, sui pendii delle colline, dinanzi al crepuscolo e alla legge del tempo Vicino ai giardini dalle ombre spezzate, Facciamo come fanno i prigionieri, Facciamo come fanno i disoccupati: Coltiviamo la speranza.” da Stato d’Assedio, Mahmoud Darwish 2 Partenza 12 ottobre 2011 C’ è poca fantasia nell’aria e nel titolo. E la tastiera palestinese non mi aiuta di certo. Cercavo un segno che potesse placare il flusso di pensieri, e lo trovo lì dove è sempre stato, in quelle montagne che ammiro incredulo dalla finestra di casa, ogni volta come se fosse la prima. Sì, il cielo e’ così limpido da aprirsi sulla Corsica. Casa non si vede purtroppo, ma la natura oggi sa offrire il meglio della mia terra: il Corrasi e il Mont’Albo con le cattedrali calcaree, il bastione di Nuoro che protegge la Barbagia, il profilo segreto di Tavolara e la frenesia di Olbia. Davanti a me il volto splendido di una bimba increspato dal pianto imminente, poco più avanti due preti ortodossi immobili nella loro solennità. Da Roma a Tel-Aviv è tutto meno romantico, meno evocativo. Pochi minuti all’atterraggio per Tel Aviv e l’hostess annuncia di rimanere seduti e tenere le cinture allacciate, richiesta dell’autorità israeliana, non dell’Alitalia. Severo divieto di scattare foto sul suolo israeliano: un monito forse non recepito dalla foga fotografica di alcune donne brasiliane. Ah il turismo di massa! Forse le autorità israeliane covano il desiderio di 3 colonizzare anche gli aerei italiani dopo la terra di Palestina. Il look da chierico non impedisce i controlli, non una ma tre volte, forse insospettiti dal possesso di soli 200 euro o forse non è riconosciuto l’utilizzo del bancomat. E no, non conosco Hamas e non mi recherò a Gaza se fa piacere sentirlo, cari rappresentanti dell’ “unica democrazia del Medio-Oriente”. Il controllo del passaporto e gli interrogatori durano due ore, ma alla fine il timbro incontra il mio libretto e posso entrare. Il resto è cronaca ordinaria di una cresta sul prezzo dello sherut (taxi collettivo) e birra in buona compagnia. Gerusalemme e la sua skyline al neon sotto una coperta di nuvole. In cuffia The God Machine – Scenes from the second storey Profumo di cumino 13 ottobre 2011 Giornata di fotografie e lunghe passeggiate tra i vicoli della Città Vecchia. Passi che si accalcano tra aromi di menta e cumino, processioni che si incrociano lungo la Via Dolorosa. E un venditore di intimo femminile mi porta alla mente un pensiero superficiale e ombrato di malafede: quante giovani sapranno dimostrare l’ardire dell’acquisto? Quelle stesse ragazze che paiono preferire un trucco 4 pallido, una sfumatura chiara sulla pelle bruna: che non sia l’espansione della moda africana di utilizzare tonalità che portino la pelle verso colorazioni maggiormente occidentali, per favore! Il colore olivastro raccoglie sensualità e mistero, il resto ha la passione di una luce al neon. La visita al Muro del Pianto colpisce la mia attenzione per un particolare inconsueto: la discriminazione di genere. La parte dedicata alla preghiera femminile è notevolmente ridotta rispetto alla controparte maschile, nonostante i numeri siano a favore delle donne. E non di poco L’occupazione che si fa sentire anche tra i vicoli, con la costante presenza dei militari israeliani agli incroci, dinanzi alle botteghe, a presidio dei bagni pubblici. Le luci si spengono sulla giornata, passi corali tra gli sgomberi di Sheikh Jarrah, i pensieri alla giornata di domani, quando i muri del pianto saranno ben altri. Quelli che separano e isolano. 5 Al Ma’sara 14 ottobre 2011 La Route 60 che unisce Gerusalemme a Betlemme. Al suo fianco il muro che divide, il muro dell’apartheid. Sulla destra scorre la colonia che ospita l’appartamento dell’On. Fiamma Nierenstein. Il villaggio di Al Ma’sara ci accoglie nel paesaggio assolato, puntellato da ulivi, la similitudine porta il ricordo al paesaggio a sud di Sassari che degrada verso Ittiri: Sardegna e Palestina, Mahmoud mi ricorda della similitudine e della fratellanza tra le due terre. Una veloce riunione per coordinare i lavori di questi giorni, un programma intenso, la realtà dei Popular Struggle Coordination Commitee, la scelta della nonviolenza e la raccolta delle olive come simbolo di pace, di rivendicazione della propria terra. Un corteo pacifico per riportarci alla realtà. 6 La manifestazione si snoda tra le vie del paese, le persone che si aggiungono alla spicciolata, c’è chi cita Gramsci e chi snocciola rosari, le macchine che passano suonano il clacson in segno di supporto, i passeggeri levano il pugno e le dita che cantano vittoria. I blindati dell’Israeli Defense Force non si fanno attendere, ci aspettano all’uscita del paese in una curva a sinistra, sul bordo-strada. Due camionette e dodici soldati che si oppongono al corteo, indietreggiamo. I bambini non percepiscono la tensione e la paura, al contrario di me che sento i battiti accelerati e il sudore sulla schiena. Non è colpa solo del caldo, assolutamente. Gli occhi dei soldati tradiscono la peluria che compare sul loro volto, diciotto anni da poco superati e un fucile automatico in mano, alcuni di questi non puntano a terra come stabilito dal diritto internazionale, sfiorano guance dei più giovani che sfidano le canne delle armi con bandiere e sorrisi. Continuiamo a indietreggiare sulla strada di ingresso per 7 Al Ma’sara, il numero dei soldati aumenta, prima sedici, poi diciannove. Il rapporto con i manifestanti è ormai di 1:2, un rapporto comunque falsato dall’apparato bellico israeliano. I soldati filmano e scattano le foto ai presenti, alcune con fotocamere rosa decorate di fiori, la strategia dell’intimidazione e l’archivio utile per i raid notturni: la strategia della violenza. Umm’Yad si staglia fiera dinanzi ai soldati con in mano una fotografia del figlio, condannato a 26 anni di prigione per attivismo politico. La sua casa distrutta dai bulldozer israeliani e ora costretta all’affitto, senza acqua corrente né elettricità. Una breve visita al suo appartamento è l’occasione per un futuro invito, occhi che vogliono parlare per mantenersi vivi. Da queste parti anche tramandare una storia è resistenza. Dal corteo sale “Bella Ciao”, l’inizio è solenne, il proseguo incerto, prendiamo le redini della canzone e la guidiamo a conclusione. Quando si inneggia alla libertà è impossibile rimanere indifferenti, tirarsi indietro. La manifestazione finisce sotto gli sguardi dei volontari della MezzaLuna Rossa intorno alla loro ambulanza. 8 E’ il momento del riposo, le prossime giornate andranno in crescendo. Il sole inizia nascondersi dietro i tetti di Al Ma’sara e le bandiere si levano al vento. Le bandiere di un paese usurpato che vuole scrivere il proprio futuro libero dall’occupazione. Gli ulivi di Burin 15 ottobre 2011 Al Ma’sara alle cinque del mattino è un’oasi di silenzio che desta le mani dal sonno, mentre l’alba dipinge in lontananze le alture della Giordania, lì dove si nasconde il Mar Morto. Alcune bimbe già passeggiano per le strade del villaggio, l’aria frizzante tra i capelli e un viso già sveglio. Il viaggio sino a Ramallah è un’altalena lungo i profili delle colline palestinesi, percorsi degni delle côte belghe nelle grandi classiche ciclistiche. Biscotti al sesamo per colazione, una breve sosta e nuovamente in strada; Burin si presenta indifesa, stretta nella morsa di due colonie e due out-posts, gli ulivi dei contadini palestinesi sorvegliati da un blindato israeliano. La pendenza severa della salita ci porta nelle immediate vicinanze della colonia meridionale, impossibile scorgere i volti dei coloni ma la loro presenza è comunque visibile, schierati sull’altura come tanti indiani pronti all’attacco. 9 La raccolta delle olive procede però senza alcuna tensione, durante la mattinata i coloni si ritirano nelle loro abitazioni illegali, e il pensiero non può non andare ai contrasti interni all’insediamento, perché la giornata dello shabbat è solitamente di riposo, ma questa tante volte non ha interferito nei raid portati ai contadini palestinesi e alle loro piantagioni. Il sole alto nel cielo batte sopra le nostre teste inesperte nella raccolta delle olive, ma è il clima umano quello che più aiuta nel meticoloso lavoro manuale, ci si arrampica sui rami più alti e si riempiono i sacchi con i frutti del raccolto; un’instancabile donna ci suggerisce gli alberi, guida il gruppo nella stesura dei teli sotto le fronde dove si depositano le olive, quegli stessi teli che ci accolgono per un pranzo corale difficile da dimenticare. Saliamo ancora per la collina, il raccolto con una nuova famiglia ci tiene impegnati sino ai primi sentori di tramonto, che arriva presto qui in Palestina. Il ritorno è un susseguirsi di famiglie che lungo la strada rientrano dai campi con i sacchi pieni e le scale in mano, a Ramallah le tende dei sit-in che appoggiano lo sciopero della fame dei prigionieri politici nelle carceri israeliane, il regalo più grande del sole che si tuffa nel Mediterraneo, lontano tra la bruma che sale. La luce si spegne sulle colonie di Gush Etzion ed Efrata, la stanchezza che ofusca la vista ma non la testa, dove i volti, i gesti, le stentate parole trovano un loro spazio preciso, impossibili da cancellare. Domani a Nablus sarà una giornata così: stancante, appagante, viva. 10 Il vento di Burin 16 ottobre 2011 Il rapporto che nasce dalla semplicità del lavoro di squadra, la condivisione della fatica, mani che si stringono imperlate di sudore, la soddisfazione sul volto, l’ultima oliva dell’albero che cade sul telone ormai colmo. Alla fine della giornata il numero di sacchi riempiti passa in secondo piano, che siano cinque o sei poco importa, la felicità risiede nei gesti umili che si trovano dietro il raccolto: tendere una mano verso l’ulivo, accarezzarne le foglie e raccoglierne i frutti, arrampicarsi sulle fronde più alte a salutare il sole e rendere omaggio alla vallata di Burin. Gli occhi ancora assonnati del mattino si posano su di un incidente stradale nei dintorni di Beit Sahour, solo in serata veniamo a sapere del coinvolgimento di coloni nell’impatto tra due auto, la giusta spiegazione allo spiegamento di forze militari israeliani e vigili del fuoco accorsi sul luogo. In Palestina anche la più tranquilla delle giornate riesce a nascondere tensioni e difficoltà, in questo caso lo sgombero di una piantagione di ulivi da parte dell’esercito; un ordine che pare riguardare unicamente un lato della valle dinanzi a Burin e ci porta a filmare l’intera scena dall’alto della nostra posizione, il pensiero 11 che corre a due dei nostri compagni che si trovano sul posto. La questione pare comunque risolversi senza ulteriori frizioni, con l’esito comunque tragico per il proprietario degli olivi che vede interrotta la raccolta, necessità vitale in questo periodo dell’anno, poiché le olive di un albero possono fruttare circa un centinaio di dollari. “You have not the permission to stay here”, è questo il leitmotiv salmodiato dai militari israeliani: chiedono un permesso ai palestinesi per risiedere sulla propria terra, per raccogliere le olive dai propri alberi, per esistere. Nuovamente riuniti proseguiamo di albero in albero, oliva per oliva, mentre il mulo riporta a valle i sacchi già pieni. Il sole inizia a nascondersi dietro la colonia di Yizhar con la sua telecamera puntata sugli ulivi, quì in Palestina, dove la fortuna di un raccolto è dettata dall’arbitrio occupante, dove nella stessa vallata si contrappongono felicità e disperazione. “Refusing to die in silence” 17 ottobre 2011 Il sapore del mattino è quello dolce del the al timo, smorzato solamente dall’asprezza delle immagini di una demolizione avvenuta la settimana scorsa a Betlemme: la freddezza digitale delle immagini video non riesce comunque a placare la tragedia di una famiglia. E in 12 Palestina la perdita, declinata nelle figure della casa e della terra, è una storia che perdura dal 1948. La raccolta delle olive ci porta nei dintorni di Al Ma’sara dopo la parentesi di Burin, ed è un piacere poter finalmente condividere il lavoro con i contadini del villaggio che ci ospita, una novità attesa da quattro giorni. L’accoglienza ha il sapore della politica grazie alla presenza severa di un esponente di Fatah, referente per l’area di Betlemme del Ministero dell’Agricoltura, un incontro organizzato dal Popular Struggle Coordination Committee per testimoniare la nostra presenza e quanto di positivo possa portare per la comunità. L’accoglienza palestinese che si presenta in tutta la sua magnificenza, una colazione che ha le sembianze del banchetto prima di iniziare il lavoro nei campi: è la fiducia che si costruisce a tavola, una delle più forti. Gli ulivi di Al Ma’sara non hanno però l’abbondanza riscontrata a Burin, alcuni alberi presentano le sole foglie polverose mentre in altri le olive si possono contare sulle dita delle mani. E’ frustrante, difficile negarlo, ed è amaro quando si viene a sapere dell’incendio portato il mese scorso da parte di un gruppo di coloni israeliani. Non è solo la terra a bruciare, ma la speranza, la fiducia nel curare la propria terra, la cenere che si posa è paura nelle menti dei contadini: il risultato è l’incuria, la povertà del terreno. Hassan è perplesso, forse il vento che penetra la valle ha portato alla caduta delle olive, una ragazza conferma invece gli atti di furto da parte dei coloni, forse non paghi degli incendi e a loro agio nello sradicamento degli alberi 13 poi trasportati nei dintorni dei settlements. La presenza illegale non è però il solo deterrente alla raccolta, alcuni terreni hanno perso fertilità per lo sfruttamento eccessivo nella piantagione degli ulivi, soprattutto in territori come quello di Al Ma’sara maggiormente adatti alle piantagioni di legumi e verdure. La tradizione dell’olio è una vicenda antica da queste parti, già i romani notarono le potenzialità dei luoghi, ed è sugli antichi insediamenti che il turismo potrebbe creare una nuova base di rilancio, la storia che serve il welfare, la storia che attesta la presenza palestinese e affonda le radici di un popolo nella terra usurpata. La raccolta delle olive si colora delle voci delle bambine e dei bambini, vogliosi di cantare, di conoscere, di imparare, di condividere, una vitalità spesso sconosciuta agli adulti. Il gioco della morra, le canzoni popolari e le fotografie assumono il profumo dell’attivismo in una terra dove tutto si tinge di resistenza, massima espressione del motto dei Comitati Popolari: “Refusing to die in silence”. Il silenzio che uccide, l’arrendevolezza morale. E quando nel pomeriggio veniamo a sapere di alcune famiglie che hanno sfidato le difficoltà ritornando nei campi a distanza di un anno, è una vittoria che affonda la luce nel buio dell’occupazione. “La decrepitezza morale L’inettitudine mentale Che concede alla dittatura una falsa legittimazione La vigliaccheria travestita da obbedienza In agguato nelle nostre anime denigrate È la paura di calzoni inumiditi 14 Non osiamo eliminare la nostra urina E’ questo E’ questo E’ questo Amico mio, è questo che trasforma il nostro mondo libero In una cupa prigione” La Vera Prigione, Ken Saro Wiwa Palestine 18 ottobre 2011 Riflessioni tempestose che si formano sotto un cielo sgombro di nuvole. La giornata di oggi trascorre nuovamente con la medesima famiglia di ieri, sicuramente differente rispetto all’esperienza di Burin; forse ieri la nostra presenza è stata utile ad infondere fiducia nei contadini dell’area di Al Ma’sara, oggi invece i dubbi sono tanti. Quale è il nostro ruolo? Il peso del nostro contributo? Una presenza ovattata che si disperde tra gli ulivi con passo felpato, con discrezione, senza l’ostentata presenza della passata giornata che si è riversata sulla strada principale. Le parole di H. non placano il flusso confuso dei pensieri, lo slancio politico che sfuma nell’arrendevolezza e nel timore di pronunciare le parole “occupazione”, “protesta”, “resistenza”. Il popolo palestinese non è sinonimo di attivismo politico, c’è chi ha ceduto allo status quo 15 trovando una posizione armoniosa nell’occupazione, un giaciglio di benessere familiare che sacrifica una causa nazionale. E’ l’irruento svegliarsi dal sogno di un popolo unito nella contrapposizione all’illegalità, non esiste una sola Palestina, sono molte le sue declinazioni con le quali confrontarsi. Il blindato dei militari israeliani pare lontano anni luce da noi, e invece è lì, poche centinaia di metri dalla nostra raccolta. Eppure nel mezzo c’è lo spazio delle contraddizioni, la sfiducia nei confronti dell’autorità statale palestinese che ha fallito nella missione di rappresentanza e tutela. Il procedere del confronto è comunque un esercizio necessario e ricostituente, pensare a questa terra come un blocco unico non è solo naif ma anche frutto di pregiudizio. Qui dove la contrapposizione tra città e campagne vive di regole slegate dal resto del mondo, con i casi particolari di Hebron e Jericho e la frenesia politica di Ramallah lontano dall’occupazione, che ha sostituito la balcanizzazione di Gerusalemme nella figura di capitale. Quì dove le campagne sono la roccaforte dei Comitati Popolari di Resistenza e si confrontano quotidianamente con le colonie. Da che parte sta l’arrendevolezza? Dove risiede la possibilità di un cambiamento? Non è semplice puntare il dito e rivolgere la predica. Oggi si festeggia il rilascio di prigionieri politici nelle trattative per la controparte israeliana Gilad Shalit, per le strade impazzano i veicoli bardati delle bandiere palestinesi. Oggi siamo semplice manodopera nei campi, e nella 16 frenesia di questo microcosmo forse va bene così. Domani l’ombra del muro coprirà altri dubbi. *19 ottobre 2011 Una febbre intestinale mi ha costretto allettato presso la sede centrale del Comitato a Ramallah, alcune riflessioni però sfuman0 nella strada di ritorno a casa. Il checkpoint di Qalandya con i suoi murales dedicati a Yassir Arafat e Marwan Barghouti, la versione palestinese de l’Urlo di Edvard Munch, la coda infinita all’uscita di Ramallah è il primo sentore della bantustanizzazione della Palestina, un paese che ha piena autorità all’interno dei centri abitati -quelli principali-, mentre il paesaggio non-urbano presenta l’opprimente presenza dell’occupazione: impossibile che passino trenta secondi di orologio senza scorgere la presenza militare israeliana. Come nel Sudafrica del 1951 con il Bantu Authorities Act, l’apartheid israeliano mira alla creazione di cittàstato palestinesi ad eccezione di Al-Quds (Gerusalemme), che verrebbe incorporata definitivamente dalla forza occupante. Il 1994 in Palestina è ancora lontano, ma arriverà con il suo vento di libertà. 17 La grinta dietro le lenti 20 ottobre 2011 La febbre intestinale è ormai un ricordo, la raccolta delle olive può vedermi nuovamente partecipe dopo la frustrazione di ieri. I campi odierni presentano una collocazione critica, circondati dalla colonia Gush Etzion e outposts in espansione, minacciati costantemente dalle incursioni dei settlers; una situazione aggravata dall’aggressione di un soldato da parte di una ragazza palestinese nella giornata di ieri: la ritorsione è la moneta dell’oppressore. La presenza di decine di attivisti internazionali è a testimonianza della pericolosità. Il terreno è di proprietà di S. e della sua numerosa famiglia, tanto da assumere le sembianze di una cooperativa agricola per grandezza e organizzazione; veniamo accompagnati nel raccolto dalle sue due sorelle e una dozzina di attivisti francesi, avanti nell’età ma freschissimi nello spirito. Ancora una volta è la dedizione al lavoro a stupire, l’importanza conferita a ogni singola oliva laddove il passaggio delle mani sia stato disattento, il linguaggio gestuale che trova la sua massima espressione in un cenno del viso, in una movenza del corpo, e la barriera linguistica abbattuta con la semplicità del lavoro di gruppo. Le piantagioni sono ricche di frutti, ciò dovuto anche all’impianto di irrigazione che sfrutta le tubature delle 18 colonie: nessuna illegalità, le falde acquifere si trovano sul suolo palestinese, sono altri quelli che usurpano il bene primario dell’uomo a queste latitudini. La questione dell’acqua è uno dei temi più pressanti tra le pagine del “conflitto”, seguendo un trend che non riguarda solo la Palestina ma assume prospettive globali. Le pause per lo shai (the) hanno l’importanza dei grandi momenti, lasciando lo spazio ai ricordi, ai racconti, al passato che riaffiora con automatica prepotenza. La storia di M. è quella di un giovane palestinese che ha visto il suo futuro stravolto dall’occupazione. Di strada verso Betlemme per la consegna del progetto finale del primo anno di Università, venne fermato dai soldati israeliani e arrestato. Le domande sono pressanti, spesso futili per porre in soggezione l’interlocutore. M. si mostra paziente, risponde in maniera pacata dinanzi alla richiesta del nome, nonostante il militare abbia in mano la sua carta d’identità; l’interrogatorio procede all’interno di una caserma coloniale, viene ammanettato ai polsi e alle caviglie, un cappio stringe il suo collo. Viene colpito numerose volte, sostiene due interrogatori e ricoperto di insulti e illazioni: “Volevi colpire uno dei nostri?”. M. respira profondamente e affronta il soldato con intelligenza: “Non ho niente con me, come avrei potuto colpirlo, e per quale motivo poi?”. Gli viene sottoposto un documento redatto in ebraico, M. si rifiuta di firmarlo senza conoscerne il contenuto, molti di questi fogliacci attestano l’espropriazioni dei beni dell’arrestato, l’occupazione che avanza con i suoi metodi subdoli. Il militare propone la presenza di un traduttore, M. chiede un documento scritto in arabo, non si fida. Il confronto si protrae sino al calar del sole, M. viene infine rilasciato 19 intorno alle 22, abbandonato dalle autorità all’interno della colonia, fortunatamente è notte e per le strade non circola nessuno. Un telefono lungo la strada per avvertire la famiglia, il passaggio in macchina di un contadino per raggiungere la sua casa. M. ritorna finalmente a casa, ha perso l’anno accademico ma nella sua testa ha scelto diversamente: i Comitati Popolari di Resistenza, la scelta non-violenta per affrontare l’occupazione. S. è un uomo sulla sessantina, longilineo, distinto nella sua camicia a quadri e gli occhiali che abbracciano il volto. Il berretto sulla testa gli conferisce un aspetto mite, supportato da una parlata quiete e tremolante, la sua storia è quella di un popolo costretto all’esilio sulla propria terra. Betlemme, aprile 2002, Seconda Intifada, Assedio alla Basilica della Natività. S. si trova nella sua casa con la famiglia, a un tratto una magnetic-bomb abbatte la porta d’ingresso. Le armi dei militari israeliani fanno capolino all’interno dell’abitazione, la pioggia di proiettili è pura follia omicida, M. riesce a nascondere la moglie e i figli in un angolo lontano, nel voltarsi non può fare altro che raccogliere il corpo senza vita delle madre crivellato di colpi, il ventre materno che si spegne tra le sue braccia; anche il fratello viene ucciso brutalmente. La sofferenza prosegue per una settimana, costretti in casa con i cadaveri in avanzato stato di decomposizione, il divieto al passaggio delle ambulanze, anche la Croce Rossa Internazionale rischia di finire sotto il tiro dei cecchini israeliani. E’ questo è il motivo della sfumatura ballerina nella voce di S., la calvizie e la vitiligine alle mani, i farmaci che danno sollievo alle sue notti. 20 Ciò non gli impedisce di raccontare la sua storia mentre ci conduce alla scoperta dei suoi terreni, quella placida volontà che non vuole cedere all’oppressione, indica le colonie e i rispettivi nomi, il periodo della loro formazione. Guarda con una nota di nostalgia la piccola abitazione estiva dei suoi genitori, ora decadente e senza il tetto. Quello che rimane è la grinta dietro le lenti, ciò che lo mantiene vivo, l’amore per la sua terra. In cuffia Dead Kennedys – Bedtime for Democracy Nonviolenza è fantasia 21 ottobre 2011 Il falò che illumina un paesaggio lunare, una tenda che si copre di stelle, il risveglio procede sornione tra olive e pomodori, i profumi della cucina mediterranea. Non è la cronaca di una vacanza al mare ma i preparativi per il quinto anniversario della resistenza nonviolenta ad Al Ma’sara, che ogni venerdì si mobilita in marcia verso la Junction Road 3157. Tra i punti focali nel programma del Popular Struggle Coordination Committee si trova la creatività della protesta, una maniera per non svilire la resistenza, per renderla appetibile anche ai più giovani. Le opzioni passate al vaglio del gruppo sono state numerose in questi ultimi giorni: le bolle di sapone, una chitarra che accompagnasse l’onnipresente Bella 21 Ciao o Society di Eddie Vedder, improvvisate esibizioni circensi. La scelta è poi ricaduta altrove, sortendo l’effetto desiderato. L’aria è quella delle grandi occasioni, quasi elettrica nelle nuvole fumose che si levano all’orizzonte, una tv locale che brancola alla ricerca di un’intervista, la presenza di numerosi attivisti internazionali provenienti da Francia, Spagna, Norvegia, Italia e israeliani del gruppo Anarchists against the Wall. La conclusione della preghiera del mezzogiorno sancisce l’inizio del corteo che si snoda tra le vie del villaggio e dei due adiacenti, le bandiere palestinesi che riconquistano il loro spazio, un arcobaleno della pace che si muove insieme a loro, i canti e le risate, le fotocamere che fremono per cogliere l’attimo. Il blocco effettuato dai soldati israeliani non si fa attendere, rispetto a venerdì scorso il loro numero è notevolmente inferiore e conquistiamo metri di asfalto, il corteo si arresta solo quando i blindati si pongono di traverso e impediscono il passaggio. Il nervosismo dei militari è evidente, l’inferiorità numerica pare metterli in difficoltà nonostante i manganelli e le armi automatiche: la curiosa paura dell’oppressore. Uno tra i più giovani si volta in continuazione, cerca conforto nello sguardo degli altri commilitoni quasi fosse il suo primo giorno, un altro porta continuamente la mano sulla bomboletta del tear gas, ci si aggrappa come un rosario; un altro giovane soldato si esprime con il linguaggio fisico della violenza: spintona, digrigna i denti, sbatte i piedi. L’ordine è quello di rimanere a bordo strada, all’interno della linea gialla che separa la carreggiata dai campi. 22 Tra i manifestanti c’è chi siede sull’asfalto, chi rimane immobile dinanzi all’elmetto, chi si muove al ritmo dei tamburi. Le cariche si muovono come la marea, crescono e si placano accompagnate dai manganelli, e quando colpiscono allo stomaco rimane il sapore amaro della bile; un’attivista francese sceglie di sdraiarsi e viene sollevata con la forza. M. viene colpito con un pugno allo stomaco, sbraita e si dimena, ci spiega in seguito che è una strategia ben collaudata negli anni: pochi minuti di confronto diretto che non mostrino l’inferiorità dei manifestanti, a seguire un approccio più soft e l’ultimo approccio affidato alla mediazione. L’idea covata dal nostro gruppo può finalmente vedere la luce, indietreggiamo di qualche decina di metri e raggiungiamo la macchina di un membro dei Comitati, solleviamo con un sorriso beffardo due pentole colme di pasta e le portiamo dinanzi ai militari. I piatti vengono distribuiti tra i manifestanti che ne apprezzano significato e gusto, siamo pronti per il passo successivo: offrire il cibo ai soldati. Gli sguardi sono sbigottiti, c’è chi ride davanti alla nostra mano tesa, chi rimane impassibile, si volta, rifiuta. Provo a convincere un giovane dallo sguardo fiero; “non c’è il veleno”, gli suggerisco portando alla bocca la forchetta. “Non è per il veleno, non posso comunque”, è la risposta. Gli attivisti francesi adottano lo stesso metodo con il far bretone, i risultati sono non cambiano ma l’atmosfera è rilassata, i militari non sono addestrati a contrastare queste azioni. Nel 2010 un Comandante dell’esercito 23 israeliano affermò, “We don’t deal well with Gandhi”, la giornata di oggi ne è un esempio. La manifestazione si conclude con spirito rilassato, gli attivisti rimasti percorrono insieme la strada di ritorno verso Al Ma’sara. La quotidiana illegalità dell’occupazione non spegne gli animi dei Comitati e tracciano la via per consegnare la Palestina ai palestinesi, e mentre in Europa c’è ancora chi crede nell’efficacia della resistenza armata, su queste terre cresce un germoglio di speranza: nonviolenza è fantasia. La fantasia al potere! In cuffia Loop – Heaven’s End *22 ottobre 2011 Tra i commenti al video (http://www.youtube.com/watch? v=FW9_Xk_GYPc) si può notare un simpatico “bunch of terrorists and hippies”. L’ambiguità del termine “terrorista” non ha bisogno di ulteriori commenti, ho 24 visto bambine e bambini sventolare le bandiere dinanzi ai militari armati, pacifisti internazionali e anarchici israeliani: se tutti questi vengono definiti “terroristi” allora sono fiero di aver condiviso questa esperienza con loro, e di conseguenza mi si consideri tale. Del resto non sono io né queste persone ad occupare illegalmente un altro popolo, demolire le loro case, confiscarne le terre. al-Khalil, l’apartheid e lo stomaco 24 ottobre 2011 Lo stomaco prima o poi viene fuori tra le righe di queste pagine, la testa tenta di filtrarlo e renderlo presentabile, senza la bile accumulata quotidianamente. Ci sono momenti dove il setaccio si sfalda, quando la funzione descrittiva passa direttamente dall’umoralità. Oggi è uno di questi momenti. Non voglio essere accomodante né infiocchettare le frasi, quando la penna incespica tra i quadretti della pagina che rimane bianca, quando le dita non scorrono sulla tastiera in maniera ponderata, i fogli accartocciati che volano nella spazzatura insieme ai pensieri. Non voglio assolutamente presentare i miei sentimenti mascherati da falsità. al-Khalil, Hebron per altri, è una visione che fa male, muove la vanga tra i sentimenti più torbidi, la rabbia che 25 monta davanti all’oppressione. Ogni qual volta ne parli provano a metterti in guardia, che è dura anzi durissima, ma la realtà come sempre rifila un pugno che non vedi arrivare, senti solo il dolore. I passi verso i vicoli della città vecchia e l’occupazione che non è fatta di settlements disseminati nei dintorni, l’occupazione è all’interno della città, il militare armato circola al tuo fianco, il checkpoint è un tornello che gira e gira e senza rispetto si colloca anche all’ingresso della Ibrahim Mosque sputando in faccia al religioso rispetto. Le bandiere israeliane che svettano sopra i profumi del suq, le reti metalliche che evitano una pioggia di piscio, rifiuti, sputi, insulti sulle teste dei palestinesi. Il militare israeliano che mi chiede se cammino armato e vorresti mandarlo a fare in culo, e che forse sì, sono armato ma con l’arma dell’intelligenza. All’interno della moschea le bambine nell’ora di religione che ti guardano con un sorriso di benvenuto e la curiosità della giovinezza, i fori sul muro della colona furia omicida che ha più di quindici anni, lo stucco sputato in maniera indecente sulla parete come una garza sporca, l’infezione che avanza negli animi delle persone a causa della voluta cecità di altre. Le strade dove i palestinesi devono camminare sulla destra come cani rognosi senza diritto di vivere, dove al centro della carreggiata un colono armato da la mano alle figlie in una grottesca scena familiare. L’economia di una città morta dentro, nei muri taggati di candelabri e stelle a sei punte presenti anche sulle morte, un macabro ricordo di tempi che furono e che ora sono, anche se con ruoli diversi. L’ironia tutta sghemba di un “Free Israel” sotto lo sguardo cretino di un soldato che chiama chissà 26 chi appena scatti la foto con sorriso incredulo, la cronostoria della “liberazione di Hebron” dopo l’occupazione del 1967, gli insulti sui muri e i palestinesi che resistono asserragliati in casa dietro centimetri di grate a maglie fittissime dalle quali si scorge un “this is apartheid” e come dar loro torto. Questo è l’apartheid nella sua forma più pura, una cosa da far impallidire il Sudafrica post-bellico e non sono certo io a dirlo, ultimo degli scemi, ma l’accusa proveniva tempo addietro da chi ha combattuto questo mostro inumano: Nelson Mandela e Desmond Tutu per citare due nomi a caso, forse demodè ma anche chi se ne frega. Più di mille negozi sgomberati e le macchine dei coloni che sfrecciano con il loro carico di bambini che serve uno stato israeliano in crisi demografica, i cubi di cemento armato pronti all’uso, la desolazione di un ambiente che non so come definire se non di guerra. La storia commovente della Kurduba School di Shuhada Street con il suo ingresso principale sbarrato da giri di filo spinato, costringendo i bambini un giro più lungo e 27 quindi preda facile per gli assalti dei coloni che li inseguono e li picchiano, li minacciano e aizzano contro i cani come ci racconta un bimbo che presenta ancora i segni della mano stritolata. Il cortile ormai spoglio dagli alberi che sono stati sradicati, l’ingresso secondario monitorato da volontari che accompagnano i bambini all’ora di ingresso e quella di uscita, la volontà israeliana di cancellare l’ultimo barlume palestinese nella via e procedere alla totale annessione del quartiere. E poi avanti un altro, e poi un altro ancora e così via. La casa dei patriarchi “nuovamente” sotto il segno di Davide. E di cose ce ne sarebbero ancora di più ma più ne scrivo più mi chiudo in me stesso. Chiudendomi però riesco a pensare e sono sicuro di voler tornare, di inizare qui un nuovo percorso che ormai lo sanno anche i muri, mi porterà in Sudafrica e poi nuovamente qui in Palestina per quel paragone che è ormai un tarlo nella mia testa. Occupazione è apartheid, e non c’è bisogno del pretesto razziale, è la presunta superiorità che si fonda sulla menzogna. Un cielo rosato si spegne sopra al-Khalil, anche lui sanguina. In cuffia Litfiba – 3, Amon Düül II –Phallus Dei 28 Un terzo della vita 28 ottobre 2011 Uscita meridionale di Ramallah, alle dieci del mattino il traffico in direzione di Gerusalemme è già congestionato, il venerdì è la giornata di preghiera più rilevante per il mondo musulmano e Al-Quds la terza città per importanza nella comunità islamica. Una rotonda e si svolta a destra, il percorso è obbligatorio per coloro che dal cuore politico della Palestina vogliano recarsi verso la Città Santa, fact on the ground seguente la Seconda Intifada. Ilservice-taxi si ferma dinanzi al transit di Qualandya, meglio conosciuto come checkpoint omonimo dell’adiacente campoprofughi. Una folla di persone che sgomitano per salire e ritornare a Ramallah, loro hanno già affrontato la bocca infernale. Qualandya si staglia imponente, una vela metallica di recinzioni e filo-spinato, telecamere e tornelli: pare di trovarsi all’ingresso di uno stadio italiano, ma nella sua evoluzione militarizzata. Lo sguardo viene attirato dalla presenza di file di seggiole metalliche, l’occupazione che offre il comfort all’occupato. Quattro file di persone in processione verso imbuti di freddo metallo, le sbarre sui lati, i tornelli alla fine, l’immagine dello stadio che sfuma in quella delle grandi prigioni statunitensi, quelle dei film ovvero quelle reali. 29 La fila è lentissima, i volti impassibili, un uomo arrivato dinanzi al tornello sceglie di tornare indietro,affida la sua bimba tra le nostre braccia che sorvola la recinzione, lui a seguire. I tornelli girano a singhiozzo, ogni qual volta le luci verdi si accendono non passano più di dieci persone per volta e il flusso viene interrotto, c’è chi rimane intrappolato tra le sbarre senza possibilità di muoversi sino al segnale successivo, le mani che afferrano le sbarre. 30 Un ragazzo si apre alla discussione, ha 22 anni ed è la sua prima volta a Gerusalemme, ci mostra il permesso ricevuto dalle autorità israeliane grazie alla mediazione della compagnia per la quale lavora: israeliana ovviamente; il permesso è scritto in arabo ed ebraico, la sua validità è di tre mesi. Un uomo sulla sessantina ci parla del suo passato come lavoratore in Svizzera, ed è grato della nostra presenza: gli internazionali hanno la possibilità di saltare questa immonda procedura mostrando il passaporto presso un altro ingresso, ma noi siamo lì con loro. Passato il tornello ci attende una nuova fila e il passaggio sotto un apparecchio elettronico, il carcere che si tramuta in aeroporto, gli zaini e le valigie all’interno di un apparecchio a raggi-x. La divisa porta il sorriso di due ragazze, il passaporto viene mostrato attraverso il vetro e possiamo passare, non prima di aver affrontato due ultimi tornelli. All’uscita ci attende un bus per Gerusalemme, l’attraversamento di Qualandya è durato 1h35min. Per tanti palestinesi questa è la prassi quotidiana, la sveglia deve necessariamente suonare prima che il sole sorga affinché non si arrivi in ritardo sul lavoro. Alla sera la stanchezza di una giornata deve affrontare nuovamente il transit, nel mezzo i controlli lungo le strade. Si dice che una persona trascorra un terzo della sua vita dormendo, forse un palestinese lascia un terzo della sua vita ai checkpoint. Il rimanente lo vive sotto occupazione. 31 Il cimitero dei numeri 31 ottobre 2011 Le nude colline di Ebal e Garizim accolgono Nablus in un abbraccio mortale. Qui i segni dell’occupazione israeliana sono visibili nei fori dei proiettili e nei tetti sventrati, nei vuoti urbani creati dalle bombe, nelle effigi dei martiri appese per i negozi del Suq: la Seconda Intifada è ancora viva nella memoria della città. Un manifesto in particolare si ripete sui muri, la stampa di un volto solare e sornione che ricorda quello di Mino Reitano, una data, l’effige stellata del Democratic Front for the Liberation of Palestine; inciampiamo per caso nella sua storia, in punta di piedi ci ritroviamo nuovamente dinanzi alla brutalità dell’uomo. I passi che si accalcano tra i vicoli e le scalinate, una ragazza e un bambino ci danno il benvenuto in una casa accogliente, nella penombra siede una vecchia, le mani unite in grembo e lo sguardo indecifrabile. La storia del manifesto è la storia della sua famiglia, della sua progenie, il viso raffigurato è quello di suo figlio, Hafez Muhammad Hussein Abu Zant, ucciso dall’esercito israeliano nel 1976 all’età di ventuno anni. La donna legge sui nostri volti lo stupore nel sentire la giovane età, si affretta a precisare che “sembra molto più vecchio”, un sorriso spento le increspa il volto. La storia del ragazzo inizia con passi piombati e procede tra lunghe 32 pause di silenzio. Il 17 maggio 1976 scelse di partire, un saluto frettoloso alla famiglia e la rassicurazione di un lavoro in Giordania, la notizia della sua morte che investe la famiglia in maniera inaspettata. Due giorni prima, durante una manifestazione di commemorazione della Nakba, una giovane quindicenne fu uccisa con un proiettile alla gola, l’anonima vita di un ragazzo si immola alla causa del suo popolo. E’ difficile immaginare il passaggio da studente e choiffeur di taxi in Israele a martire. Le armi provengono dalla Giordania, l’imboscata ai militari fallisce nei pressi della Jordan Valley, Abu Zant e i suoi compagni muoiono in combattimento; la notizia della sua morte viene trasmessa da una radio israeliana. La tragedia della famiglia inizia così e proseguirà per i successivi 35 anni. Il fratello di Abu Zant accorre per proseguire la narrazione, il suo negozio è nei pressi della stazione dei bus, il respiro affannoso tradisce la fretta nel raggiungerci, il desiderio di tramandare la memoria. Il corpo viene trattenuto dalle autorità israeliane, riposto in una cella-frigo e in seguito sepolto sotto un masso numerato: il cimitero dei numeri. Ubicazione e numero sono segreti, forse tre, forse quattro, nella Jordan Valley, tra le alture del Golan occupate, nel nord di Israele. Supposizioni. L’assurdità di un tribunale militare che condanna un cadavere alla pena detentiva, quindici anni o più, lapidi senza nome e corpi che non trovano degna sepoltura, abbandonati alla mercé degli animali e all’incuria del tempo. 33 Quarantaquattro anni di occupazione hanno restituito un solo corpo nel 2009, l’esistenza ufficiale dei cimiteri dei numeri resa nota da Hezbollah tre anni fa, durante un macabro scambio di corpi risalenti alla Guerra del Libano nel 2006: militari israeliani per esponenti del Partito di Dio; le cifre vorrebbero nelle mani delle autorità israeliane 338 corpi palestinesi e 195 di altri paesi (Siria, Egitto, Libano). Non solo persone morte in combattimento ma anche prigionieri politici, come il giovane deceduto in carcere nel 1998 dopo un lungo sciopero della fame, il corpo senza vita costretto a scontare il rimanente periodo di detenzione. Il 9 ottobre la salma di Abu Zant, ciò che ne rimane, ritorna tra le braccia materne, la dignità di una cerimonia funebre a distanza di anni. Verso la fine della narrazione il viso dell’anziana pare acquistare una tranquillità tradita dalle labbra tremolanti, l’orgoglio che costruisce una diga alle lacrime, “non ho mai pianto, né alla morte né alla restituzione del corpo di mio figlio” ci dice “e non ho paura, convivo con arresti e prigionia da decine di anni ormai, sono fiera dei miei figli”. E’ inutile cercare umanità in questo racconto, difficile ascoltare le parole ufficiali di giustificazione, discorsi infarciti dei termini “sicurezza” e “terrorismo”. E’ la tortura psicologica inflitta ai familiari delle vittime, colpevoli o innocenti che siano poco importa, la dignità umana è comunque calpestata. E’ l’occupazione degli animi dei palestinesi, della loro memoria, dei loro affetti. 34 Ma’aa salamah Falastin 01.11.2011 L’alba di Al-Quds che penetra i vicoli del quartiere cristiano, le prime luci della giornata inforcano le ultime ombre di una notte insonne. Lo scalpiccio che porta alla Zion Gate, un’ultima foto e l’obbiettivo che si posa sulle propaggini settentrionali di Betlemme imprigionate dal muro dell’apartheid, è il panorama a interrompere l’idillio del momento e rammentarmi dove mi trovo. Lo sherut accompagna i pendii delle colline che si affacciano sul Mediterraneo, la discesa scorre sopra la terra che si risveglia nello shabbat, giornata di festa, la vita prosegue a rilento. Il casello dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv è davanti 35 a noi, prima esibizione dei passaporti con annesse domande di routine: “chi siete?”, “cosa fate?”, “da quanto tempo?”. Al termine della mattinata il pollice e l’indice incontreranno sette volte il libretto granata, una relazione indissolubile nelle ultime tre settimane, come la sera precedente quando la polizia ci ferma chiedendo se avessimo della marijuana, un controllo minuzioso che invade la privacy del mio portafoglio. Per le autorità israeliane la privacy è questione di poco conto, gli stessi funzionari amano ripeterlo. All’ingresso del check-in l’interrogatorio procede senza eccessive pressioni, lo sguardo allarmato del giovane funzionario aeroportuale ci mette in guardia sui nostri zaini: “sono stati sempre sotto il vostro sguardo? qualcuno potrebbe averci riposto una bomba!”. Mi mordo la lingua, la risata viene soffocata con destrezza. Il controllo del mio bagaglio è affidato a una giovane ragazza dal sorriso radioso, mi confessa di essere stata a Roma il weekend precedente, la Città Eterna la ha ammaliata nonostante i prezzi proibitivi. La discussione procede su binari congeniali al sottoscritto, le parlo di vacanze e Sardegna, la invito per un soggiorno, ci penserà. Gran sorriso di entrambi. Il pensiero non può non andare a tutte le ragazze e ragazzi che si prestano al servizio militare o qualsiasi pratica connessa all’occupazione della Palestina, il rifiuto della leva corrisponde all’emarginazione sociale e la negazione di numerosi diritti civili e politici. Le vie di fuga però esistono, come gli Shministim, i giovani obiettori di coscienza imprigionati per aver rifiutato la leva nei territori palestinesi occupati; il mio 36 ragionamento pecca di ignoranza e lo ammetto, avrei bisogno di conoscere più a fondo la società israeliana, ma le domande sono incastonate come pepite nella testa: perché non rifiutate la leva in massa? Perché servite autorità tiranne? Perché gliindignados israeliani glissano il tema dell’occupazione? Forse sono domande premature, la speranza è questa. Il Nord-Africa e il Vicino-Oriente stanno cambiando, Israele ha tutto il tempo per entrare nella sua Primavera. Una volta per tutte, e per tutti. Ai controlli successivi la mia barba incolta è motivo di ilarità tra i funzionari, il passaporto risale a cinque anni fa, il volto di un ragazzino senza un pelo. Adduco l’incuria alla pelle sensibile, prontamente mi sento rispondere “perché cinque anni fa non era sensibile?”. “Lo era di meno”, rispondo io. Il viaggio verso Roma prosegue insonne, l’aereo non fa altro che scatenare un turbinio di pensieri che continua ancora. Troppi volti, troppe storie, troppe persone, troppa rabbia, troppi sorrisi, troppa volontà, troppo stupore, troppe lacrime, impossibile dare una collocazione precisa a tutto questo, ancora di più se concentrato in sole tre settimane. Vorrei scendere più a fondo, vorrei capire, vorrei conoscere nuove persone: ognuna di queste è una storia che merita di essere raccontata, dalla quale imparare. Il mio è un arrivederci, non so ancora quanto durerà l’attesa ma tornerò, è un legame che si fonda sulla sofferenza e sulla speranza, un amore incontrollato che si trova ancora nelle mani rugose e nei rimproveri di Hadja, 37 dietro le lenti di Sami, tra gli ulivi di Al Ma’sara, nella pietà che non cede al rancore. Ma’aa salamah Falastin. 38 Link utili: Assopace http://www.assopace.org/ Servizio Civile Internazionale – Italia http://www.sciitalia.it/news.php Un ponte per… http://www.unponteper.it/ Alternative Information Center http://www.alternativenews.org/english/ Anarchists Against the Wall http://www.awalls.org/ Popular Struggle Coordination Committee http://www.popularstruggle.org/ Russell Tribunal on Palestine http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/ Stop the Wall http://www.stopthewall.org/ The Electronic Intifada http://electronicintifada.net/ 39
Scaricare