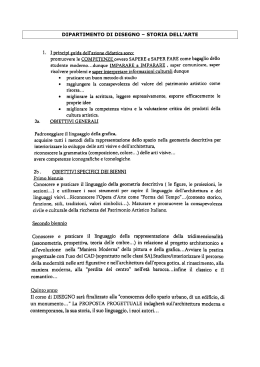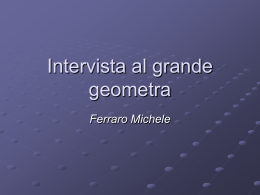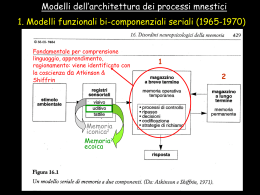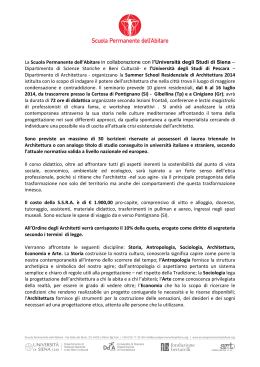BUON 2014 DUE INTERVISTE Francesco Sorrentino Le due interviste qui riportate sono state svolte in occasione di un soggiorno di studio presso le Facoltà di architettura di Madrid e di Villadolid, per svolgervi parte della mia ricerca di Dottorato che si è occupata dello sviluppo del “progetto urbano” in Europa, e dell’influenza che le teorie, sorte intorno al gruppo italiano della Tendenza, hanno avuto sulla cultura architettonica europea*. Secondo quanto ho messo in evidenza nella mia tesi, “J. I. Linazasoro rappresenta sia per il fatto che tuttora risulti uno degli architetti spagnoli maggiormente apprezzati, ma anche e soprattutto per la sua attività teorica, svolta a partire proprio dalla fine degli anni settanta a tutt’oggi, un riferimento utile alla comprensione dei risvolti più interessanti del rapporto tra cultura architettonica italiana e spagnola.” (p. 37). Nelle prime opere a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, nel lungo sodalizio professionale con Miguel Garay, ed in particolar modo, nel saggio El proyecto clásico en arquitectura (J. I. Linazasoro, El proyecto clásico en arquitectura, Gustavo Gili, Barcellona, 1981) sono infatti facilmente distinguibili molti temi di derivazione italiana, che rendono evidente la forte influenza che il gruppo della Tendenza ha avuto in Spagna. Oggi il lavoro dell’architetto spagnolo è molto distante dalle posizioni giovanili, che egli stesso ha definito dogmatiche, risalenti al periodo degli anni settanta e l’intervista, attraverso la sua preziosa testimonianza, mette in luce come, negli anni difficili della cultura spagnola, la relazione con quella italiana appariva un luogo di stimoli e di liberazione che, pure nella necessaria evoluzione degli architetti che l’interpretarono, appare essere ancora un necessario riferimento alle più aggiornate ricerche progettuali. Quanto a Simon Marchan Fiz, è attualmente docente di Estetica e Teorie delle Arti nella Facoltà di Filosofia della U.N.E.D di Madrid, ma ha ricoperto numerosi incarichi accademici presso le facoltà di architettura spagnole. In particolare è stato Professore di Teoria delle Arti e Storia dell’Arte Contemporanea nella Sezione di Arte della Facoltà di Geografia e Storia (Universidades Complutense y Autónoma, Madrid), professore ordinario di Estetica e Composizione nella Scuola Tecnica Superiore E.T.S. di Architettura di Madrid, ordinario per la stessa cattedra nella E.T.S. di Architettura di Las Palmas e di Valladolid, e Direttore del Dipartimento di Teoria e Storia dell’Architettura nonché preside delle ultime due Facoltà. Autore di numerosi scritti e saggi di estetica dell’architettura, si è interessato ai temi dell’architettura italiana degli anni settanta nel saggio La Condición Posmoderna de la Arquitectura (tratto dalla lezione inaugurale del corso 19811982 della Università di Valladolid) per cui, ai fini della mia ricerca, è stato molto utile interrogarlo sul suo pensiero. Intervista a Josè Ignacio Linazasoro F. S. Il decennio ’70-‘80 ha segnato per lei l’inizio dell’insegnamento universitario e dell’attività professionale, quale era il clima culturale che si respirava in Spagna in quegli anni e in che modo venivano lette e assorbite le esperienze in ambito architettonico provenienti dal contesto internazionale ed in particolare da quello italiano e tedesco? J. I. L. Credo che ci siamo relazionati più al contesto italiano che a quello tedesco, il contesto tedesco forse filtrava attraverso quello italiano. Non c’è qui un rapporto molto forte con l’architettura tedesca. Gli anni della Tendenza, in cui ha avuto molto influenza il pensiero di Rossi e anche, si può dire, la sua architettura, soprattutto dopo la seconda metà degli anni settanta, furono gli anni della transizione politica, si ebbe quindi l’opportunità di approfondire il dibattito sulla città storica e sui centri storici. Il pensiero di Rossi ed il suo libro L’architettura della città, tradotto dall’editore Gustavo Gili insieme ad alcuni saggi di Quaroni e di Aymonino, furono un contributo teorico importante. La mia generazione fu particolarmente influenzata dal pensiero di Rossi. Quello era un momento particolare sotto il profilo professionale, ci fu una prima crisi economica nel 1973, e ci fu una diminuzione notevole degli incarichi professionali, per cui fu essenzialmente un momento di riflessione teorica. F. S. In quegli anni l’architettura italiana costituiva un forte riferimento teorico, i testi di Rossi, Grassi, Aymonino furono fondamentali per lo studio delle città, della tipologia edilizia, del rapporto architettura‐città e architettura‐storia. Quale fu la profonda novità di quegli studi e che ruolo hanno svolto nel suo percorso di architetto e di teorico? J. I. L. Quando ho finito gli studi universitari mi sono interessato molto a L’architettura della città di Rossi, ma anche ai saggi di Aymonino, quello sulla città di Padova in particolare. Ho anche cercato, in realtà, di risalire un po’ alle origini di questi studi, ricercando i maestri che avevano influenzato il pensiero di questi architetti come Rossi, Grassi o Aymonino, e così mi sono interessato a Saverio Muratori, che è stato forse uno dei primi a portare alla luce gli studi sulla città storica e sulla tipologia edilizia, ad esempio nei libri Studi per una operante storia urbana di Venezia e Studi per una operante storia urbana di Roma. Quindi non solo Aymonino e Rossi, ma ho tentato di andare alle fonti, alle origini di questo atteggiamento sulla città. F. S. Nel metodo progettuale di Rossi è presente una forte carica immaginativa e personale che lo guida, attraverso la memoria, alla “scelta” e successiva elaborazione degli “elementi formali” che compongono le sue architetture. Tali elementi fanno parte del suo mondo interiore e si configurano, quindi, come oggetti irripetibili, frutto di una rilettura del tutto personale dell’architettura. Nel libro “El proyecto clásico en arquitectura”, lei parla di una composizione i cui elementi fanno parte di un ordine strutturale proprio dell’architettura. La composizione in definitiva obbedisce ad un principio di chiarificazione dell’ordine in cui tali elementi vengono messi in gioco, lasciando poco spazio alla libera invenzione. In questo forse lei vedeva un certo superamento della teoria di Rossi? J. I. L. Il proyecto clásico è essenzialmente una tesi di dottorato ed in realtà è stato anche un tentativo di superare le contraddizioni presenti nella teoria di Rossi. Trovo un po’ contraddittorio questo atteggiamento trattatistico che lui propone a partire dalla tipologia e dalla morfologia anche perché in quegli anni era ancora aperto il dibattito sul senso del termine tipologia. Secondo Rossi, e anche Aymonino, la tipologia è vincolata ad un senso di operatività sulla città, di rilettura dei tessuti urbani. Ho scritto un libro, precedente al Proyecto clásico, forse meno accademico, Permanecias y arquitectura urbana, in cui ho tentato di analizzare un caso diverso, quello delle città dei Paesi Baschi, giungendo alla tesi secondo la quale il discorso sulla tipologia si poteva vincolare anche al discorso della costruzione, in quanto la lottizzazione nelle città storiche non era solo una questione formale ma anche tecnica e costruttiva. Quindi questa evoluzione tipologica all’interno della città e dei tessuti urbani si poteva leggere non solo come evoluzione di parametri formali, ma anche come evoluzione dei sistemi costruttivi, alcuni rimasti inalterati dall’epoca gotica altri invece trasformati. Questo libro, Permanecias y arquitectura urbana, è importante anche per lo sviluppo successivo della mia visione dell’architettura. L’architettura di Rossi e di Grassi è soprattutto legata ad un modello principalmente formale e non costruttivo, in alcuni casi c’è un vero e proprio disprezzo per la costruzione, mentre la mia architettura è più legata alla costruzione ed alla materialità, alla forma non vista solo come un’espressione di stile ma appunto come costruzione e materia. Direi che Rossi non è propriamente un architetto, ma più un artista, è il primo “postmoderno” e anticipa la questione attuale dell’architettura nella sua deviazione verso l’artistico, ed io mi sento molto lontano da questo tipo di atteggiamento. Il superamento delle teorie di Rossi, di cui lei parla, forse è presente nel testo Permanencias y arquitectura urbana, in cui si trova il punto di partenza dello sviluppo futuro della mia architettura, in maniera meno accademica. È lì che nasce la volontà di fare un’architettura più aperta alla realtà e non fondata soltanto sulla tradizione classicista della trattatistica. F. S. Giorgio Grassi è una figura che credo sia stata importante per lo sviluppo della sua teoria progettuale. L’idea di un’architettura che trova nel suo specifico ambito disciplinare l’unico mondo con il quale dialogare, il continuo riferimento all’“inopportuno” Tessenow e alle sue architetture essenziali, la trasmissibilità del metodo progettuale ed il suo aspetto strettamente didattico, sono tutte caratteristiche dell’architetto milanese. Cosa hanno significato per lei il concetto di rifondazione disciplinare e il lavoro di Giorgio Grassi? J. I. L. Secondo me Grassi è in un certo senso più architetto di Rossi, ma anche più astratto. Grassi ha sviluppato un discorso di estrema coerenza ma si può dire ad un prezzo molto alto. Egli stabilisce sempre un rapporto tra la sua opera e quella di altri architetti ad esempio Tessenow o l’Alberti più recentemente. Penso che sia un atteggiamento molto interessante, più operativo di quello di Rossi. Grassi è comunque, però, rimasto sull’astratto, quando vedo le sue opere le ritengo sempre molto interessanti soprattutto nelle loro premesse, nella loro idea di partenza, ma per quanto poi riguarda la loro realizzazione preferirei che le avesse realizzate un architetto come Francesco Venezia. Non so se mi riesco a spiegare, manca un po’ di materialità, perfino un po’ di soggettività, l’architettura non può ridursi solo ad uno schema. F. S. Negli anni ’80 la critica al Movimento Moderno si era attestata principalmente su due fronti nettamente contrapposti. Come spiega Simon Marchan Fiz nel suo saggio “La condicion posmoderna de la arquitectura”, da un lato il fronte americano, pubblicizzato da Jenks, si oppone al Movimento Moderno attraverso una reazione al suo antistoricismo, per cui l’architettura è colta nell’aspetto puramente linguistico, di fatto allusivo, ironico e metaforico. Dall’altro lato, in Europa ed in particolare in Italia e in Germania, la reazione alla Modernità avviene sul piano del recupero di un’identità disciplinare, nel tentativo di ricucire un lacerato rapporto con la città e con la storia. Quale genere di fraintendimento provocò in quegli anni la Biennale di Venezia di Paolo Portoghesi e la sua “Strada Novissima” all’interno di una cultura architettonica volta al recupero di una propria identità disciplinare? J. I. L. La strada novissima ha rappresentato la nascita del postmoderno in Europa e l’ingresso di architetti storicisti come, ad esempio, Leon Krier nel panorama architettonico internazionale. Il livello di astrazione che la Tendenza aveva imposto negli anni precedenti si trasformò in una immagine più formale, non molto positiva a mio avviso, perché più consumistica e leggera. F. S. Tessenow nel saggio “Hausbau und dergleichen”, parla del rapporto tra tecnica e forma e conclude così il capitolo dedicato a questo argomento: “la forma tecnica non ha, come ha sempre invece il lavoro artigianale, quel cinquanta per cento di stupidità necessaria; la forma tecnica crede troppo a ciò che già sappiamo e troppo poco a ciò che ancora non possiamo sapere, ma che possiamo sentire, intuire: oppure che è lo stesso, crede troppo poco alla forma in quanto tale”. Il suo interesse per l’architettura rurale lo ha condotto ad indagare il rapporto tra tecnica costruttiva e forma, in che modo questa dinamica rientra all’interno dei suoi progetti? J. I. L. Negli anni settanta mi occupai di un lavoro di ricerca sulla casa “Navarra”, rilevando una serie di abitazioni. Questa esperienza fu molto importante, anche perché ebbi modo di analizzare direttamente l’architettura rurale, misurandola a disegnandola. Grazie a questa esperienza sono riuscito a superare l’idea del postmoderno, nel senso di stabilire sempre un rapporto molto preciso tra la forma e la costruzione. Anche per alcuni progetti iniziali, che stilisticamente sono più classici, come la Casa in Mendigorria non può dirsi che in essi la forma sia indipendente dalla costruzione. Soprattutto nel progetto della ricostruzione della Chiesa di Medina del Rioseco, il più importante in quegli anni, grazie alla riflessione sul rapporto tra costruzione e forma ho potuto effettuare una sorta di superamento della questione stilistica e trovare al di là della forma classica della chiesa un rapporto con la materialità e anche con la tipologia, visto però nel senso della costruzione. In definitiva il rapporto tra forma e costruzione, che ho analizzato nell’architettura rurale a partire da questo lavoro sulla casa Navarra, è stato di fondamentale importanza per la mia architettura, grazie al quale ho appreso che forma e struttura non sono separabili, devono essere un’unica realtà inscindibile, a differenza di quello che avviene oggi. F. S. Nel suo lavoro è evidente una ricerca costante del confronto con il luogo e, nel caso dei restauri, del rapporto con l’edificio, con la sua storia, i suoi materiali e la sua qualità spaziale. Il suo approccio al progetto in entrambi i casi non sembra avere un metodo preconfezionato, una matrice di intervento adattabile alla eterogeneità di luoghi e contesti, piuttosto sembra che i criteri progettuali subiscano un adattamento in funzione del contesto e ne risultino influenzati. In che modo si relaziona con il luogo e, nel caso del restauro, con l’edificio? J. I. L. Non ho mai fatto un restauro vero e proprio, diciamo più che ho costruito sopra un edificio, accanto o vicino, il restauro è qualcosa di diverso, obbedisce a logiche più tecniche. Credo che ho sempre pensato che l’architettura fa sempre parte di un tessuto, di un contesto più ampio. Quello che avviene tra l’architetto ed il luogo è uno scambio. Come avviene per il musicista, l’architetto non è colui che compone la partitura ma colui che la interpreta, il luogo è per me la partitura. Ciò che avviene è un movimento in due direzioni, dal luogo all’architetto e dall’architetto al luogo. Non si tratta di porre soltanto un elemento in contrasto con l’insieme, ma anche di stabilire una chiave di lettura di tale insieme attraverso l’opera dell’architetto. Diciamo allora che sono un po’ più ambizioso, cerco sempre di influire sul luogo e di modificarlo. L’intervento sull’antico non consiste nel rispettare l’antico, ma nell’appropriarsene. F. S. Quanto la costruzione di una teoria progettuale è influenzata dalla sua trasferibilità, dal suo eventuale aspetto didattico e in che modo quindi la sua attività di docente universitario ha contribuito a tale costruzione? J. I. L. Io sono un docente amatoriale, non un docente di professione. Non credo molto nella docenza come professione. Credo che l’architettura sia una forma di contribuzione alla realtà. Nella mia attività di docente universitario, mi limito ad aiutare gli studenti a risolvere i loro problemi legati allo studio, agli esami … La questione della trasferibilità del metodo mi era cara quando ho scritto El proyecto clásico, ma all’epoca ero troppo giovane e quando si è giovani si è un po’ più dogmatici. F. S. Uno sguardo alla produzione architettonica attuale ci mostra un panorama in cui l’architettura è pura espressione della forma, ricerca ossessiva del nuovo, in un gioco che, esaurite tutte le cariche ideologiche e culturali, sembra rispondere direttamente alle esigenze della nuovo capitalismo, in cui il prodotto è subordinato alla sua immagine. L’architettura sembra oscillare tra il vacuo gioco di forme e il puro marketing pubblicitario. Tutto questo conduce l’architettura a confrontarsi con strumenti e pratiche che non le sono propri. Qual è la sua opinione in merito? In quali termini lei vede possibile se non addirittura necessaria oggi una chiamata alla autonomia disciplinare dell’architettura? J. I. L. Sono completamente d’accordo. Credo che il discorso sull’autonomia disciplinare sia una questione sempre attuale. Il problema di Rossi e della Tendenza è stata la profonda contraddizione tra la difesa sul piano degli scritti teorici dell’autonomia disciplinare e la tendenza all’artistico, all’autobiografico nella pratica professionale. Credo che noi architetti dovremmo scrivere di meno e progettare di più ma dovremmo avere più opportunità per farlo. Oggi mi sento in sintonia con quegli architetti che non hanno scritto nulla, ma che hanno sviluppato un discorso profondo all’interno della disciplina. Questo dimostra che è possibile fare un’architettura molto espressiva, poetica, capace di interrogarsi sulla vita e sull’esistenza umana, che rimane legata alla disciplina, ma che lo fa con il mattone, con la malta, con le volte, con la struttura, con la materialità! Tutto questo è il linguaggio dell’architetto. Oggi ci sono molti giornalisti, molti disegnatori, che appaiono sulle riviste come architetti, che non sono solo architetti ma anche decoratori...ecc. In questo senso, il discorso degli anni settanta sulla rifondazione disciplinare, oggi è più attuale che mai. La crisi economica attuale, spero, ci dimostri che l’architettura del momento, quella delle archistars, sia stata un’architettura della immoralità. Credo che la questione morale oggi nell’architettura sia di fondamentale importanza. Intervista a Simon Marchan Fiz F. S. Giorgio Grassi e Aldo Rossi, quale la loro influenza nello sviluppo della cultura architettonica spagnola? S. M. F. Inizierò parlandole un po’ di Aldo Rossi. Io non credo che Aldo Rossi possa essere considerato propriamente un postmoderno, credo piuttosto che abbia subito una forte influenza dell’illuminismo, di De Chirico; sì, credo che lo si possa collocare in questa “linea”, tra illuminismo e De Chirico, il suo lo potremmo definire un “classicismo romantico”: rientra nella tradizione del classicismo ma possiede un fondo di romanticismo … lo collegherei, quindi, a Boullée e Ledoux per la loro tradizione illuminista e per l’interpretazione che fa del classicismo a De Chirico. Ci sono, poi, altre interpretazioni del classicismo di De Chirico, una molto celebre è quella di Andy Warhol, questa decisamente postmoderna, che in alcuni suoi quadri è molto evidente. Quella di Rossi è, invece, un’interpretazione nella tradizione illuminista, ciò è evidente, ma io parlerei, lo ripeto, di fusione tra classicismo e romanticismo. Forse mi sono dilungato, tu volevi che ti parlassi del ruolo di Grassi ed Aldo Rossi ... beh! Che dire, la loro importanza è stata, senza alcun dubbio, decisiva. Io ho potuto osservare personalmente tutta l’influenza che Rossi e la Tendenza hanno avuto sulla scuola di Madrid nella metà degli anni settanta, ci sono stati in quegli anni diversi professori e studenti che hanno scritto su di lui e sulla Tendenza, ma l’influenza più forte l’hanno avuta a Barcellona e prova ne sono i libri della casa editrice Gustavo Gili. F. S. Anche la rivista «2C», vero? S. M. F. Certo, certo, la rivista «2C», come saprai, sta per “Costruzione della Città”. Era, infatti, il rapporto tra la tipologia edilizia e la morfologia urbana la problematica centrale per gli architetti spagnoli nel decennio compreso tra la seconda metà degli anni settanta e la prima degli anni ottanta. Il problema non si poneva solamente in relazione con la produzione architettonica contemporanea ma anche con il restauro. Questo è importantissimo. È in ciò che possiamo ritrovare l’influenza non solo di Giorgio Grassi ed Aldo Rossi, ma anche delle esperienze italiane di restauro, una tra tutte, la più importante, quella della città di Bologna. Gli architetti spagnoli erano molto documentati su tale esperienza: Bologna era l’esempio, anche perché lì amministrava il P.C.I. che aveva una idea di città molto in linea con quella di diversi architetti in Spagna. La tipologia edilizia e la morfologia urbana, come dicevo, erano centrali per la nuova edilizia e per il restauro: questa era un opinione comune in quegli anni, la questione del tipo, ad esempio, non dimentichiamo che Moneo ha scritto sulla tipologia, e non solo lui. Erano quelli gli anni in cui si iniziava a guardare con primario interesse alle architetture del luogo, alle tipologie ed alle morfologie del luogo, questo spiega, a mio avviso, gli studi sulle “permanenze”, studi che ha fatto ad esempio Linazasoro, ma anche altri. F. S. Alla luce di numerose pubblicazioni fiorite intorno a quegli anni, che dinamica si produsse tra l’interesse per l’architettura vernacolare e gli studi sulla tipologia edilizia e la morfologia urbana? Quali sono gli effetti che tale dinamica ha prodotto sull’architettura? S. M. F. Credo che la relazione tra l’architettura vernacolare e gli studi sulla tipologia edilizia sia stata molto importante nella pratica, ma non tanto nella teoria, nella pratica è stata importante perché gli interventi fatti in Spagna dagli architetti sono avvenuti dopo uno studio della tipologia e soprattutto della morfologia, o meglio, sempre della morfologia urbana, ma non necessariamente della tipologia edilizia perché spesso le funzioni venivano modificate, e del resto in Italia succedeva lo stesso. L’analisi della morfologia urbana è stata sempre centrale e ciò spiega molte questioni relative al restauro, non quello dei gradi monumenti, ovviamente, ma delle case, ad esempio. Gli effetti che questa dinamica ha prodotto sono molto forti: a livello pratico favorì, infatti, una tendenza al recupero dei centri storici più che all’urbanizzazione di nuove aree, mentre a livello teorico si tentò per la prima volta di comprendere i diversi “tipi edilizi”. L’influenza, dunque, c’è stata su due livelli, entrambi molto importanti: essa ha prodotto da un lato uno studio più colto che è quello sulla tipologia edilizia e dall’altro uno, diciamo più pragmatico, sulle opere esistenti e caratterizzanti i diversi luoghi. F. S. Fullaondo e la rivista «Nueva Forma» a Madrid, Salvador Tarragò e la rivista «2C - Construccion de la Ciudad» a Barcellona. Quale è stato il ruolo che entrambe le riviste hanno avuto in quegli anni nelle due città più importanti della Spagna? S. M. F. Per quanto riguarda «Nueva Forma » io credo abbia avuto un ruolo prima, non dopo. «Nueva Forma» è stata una rivista molto importante per introdurre i movimenti artistici e architettonici moderni in Spagna, ma per il resto ebbe rilievo secondario. Importante è stata, invece, tutta la scuola di Barcellona con la rivista «Architettura bis» ad essa legata, attorno alla quale gravitavano architetti come Moneo e tutta la linea che definirei “più italiana” dell’architettura e del pensiero catalano, questo, però, solo fino alla fine degli anni ottanta, poi non più. Per quanto riguarda invece Salvador Tarragò e «Construccion de la Ciudad», si tratta in realtà di un episodio, importante, ma un episodio, che tuttavia ha avuto molta influenza in Galizia e, in parte, anche nel resto della Spagna. L’influenza di Salvador Tarragò e della rivista io credo fosse piccola, era un’esperienza forse un po’ elitaria, era come un “cenacolo” abbastanza chiuso su se stesso. F. S. Questo forse fu dovuto anche al carattere fortemente politico di questa rivista? S. M. F. Sì, fortemente politico ed anche talvolta troppo radicale nelle sue posizioni. Aveva una interpretazione marxista, basata sulla specificità dei linguaggi artistici, anche questa di origine italiana, perché vista più sotto l’estetica di Galvano della Volpe che di Lukacs, di cui anche Grassi e Rossi subirono l’influenza. Le teorie di Galvano della Volpe erano molto conosciute in ambito spagnolo, anche perché se ne apprezzava l’aspetto più moderato rispetto all’ortodossia di Lukacs. In un certo modo coincideva con la via italiana al comunismo aperta dal PCI di quegli anni, verso il quale molti architetti ed intellettuali spagnoli guardavano con grande interesse. Tarragò, invece, era troppo dogmatico ed assumeva spesso posizioni elitarie che allontanavano molti esponenti della borghesia catalana i quali ricercavano una maggiore apertura al dibattito internazionale. F. S. Forse soprattutto Grassi si interessò a questo tipo di estetica o sbaglio? S. M. F. No, certo, non sbaglia, più Grassi che Rossi. In questo periodo la teoria di Rossi e di Grassi era molto interessante soprattutto per l’architettura del passato, ma era difficilmente applicabile a quella del futuro, ciò soprattutto in relazione con i nuovi materiali e la nuova tecnologia. Era molto interessante, ovviamente, per le piccole città della Spagna e dell’Italia con una architettura da recuperare (orientate al restauro), ma meno per le città moderne interessate a nuovi progetti. La concezione progettuale di Grassi e di Rossi era per lo più “purovisibilista”, si ricollegava, quindi, ad una tradizione moderna (quella del purovisibilismo) che è chiaramente classicista ed in relazione anche con la teoria della Gestalt. Potremmo dire che, in sostanza, c’è una dissociazione tra la teoria di Rossi e la sua pratica architet- tonica: la sua architettura è, infatti, troppo formalista e purovisibilista, non ha capacità di adattarsi alle diverse realtà. A mio giudizio la sua teoria è importantissima ed ha molto da insegnare ancora oggi, ma la sua pratica è stata nefasta. Purtroppo molti architetti spagnoli, soprattutto i giovani, hanno imitato i progetti di Rossi, a mio giudizio cattivi progetti, ma non ne hanno adottato invece il suo fondo teorico. F. S. Spagna anni ’70 e ’80. Quali architetti ricorda come maggiormente ispirati ai principi de la Tendenza? S. M. F. Beh, questa è una domanda difficile perché l’ispirarsi alla Tendenza fu un fenomeno ampiamente diffuso in quegli anni, oserei dire generale. In ogni caso, se dovessi fare degli esempi citerei Moneo a Logroño, ma non, come invece molti sostengono, quello di Bankinter. F. S. A proposito, l’edificio Bankinter di Rafael Moneo è stato considerato da molti critici spagnoli (Gabriel Ruiz Cabrero) come uno dei progetti che meglio rappresentano l’influenza della Tendenza italiana. Quali affinità, secondo lei, mostra questo edificio o quello del Municipio di Logroño con i principi della Tendenza? S. M. F. Credo che Bankinter sia un’opera molto complicata perché ha influenze moderne, americane e cubiste. E’ evidente, a mio avviso, la presenza dell’influenza cubista nella frammentazione spaziale e soprattutto in pianta. In alzato, certamente sì, c’è anche l’influenza della Tendenza, in un certo modo, ma solo nella facciata, il resto dell’edificio non ha nulla a che fare con essa. Moneo, per me, è Tendenza soltanto a Logroño. F. S. L’architettura con una chiara vocazione urbana, diffusasi in Spagna intorno agli anni ’70, ha avuto per lei dei caratteri che la distinguono da altre esperienze parallele tali da conformare una specificità spagnola? Quali sono per lei tali caratteri? S. M. F. Io credo che la specificità spagnola stia nella capacità di fondere tutte le differenti influenze, italiane prima, ed internazionali poi, per esempio la tradizione nordica o quella americana, producendo un modo proprio e molto personale di fare architettura. Mi pare di non errare affermando che l’architettura spagnola abbia maturato, seppur partendo da questo incrocio di culture, una personalità autoctona, autonoma, e non solo dal punto di vista progettuale ma anche filosofico, del pensiero. F. S. A me pare che nella specificità spagnola sia presente una logica della sovrapposizione, mi spiego meglio: a Madrid, ad esempio, dove si era sviluppato un discorso attorno a «Nueva Forma», quindi sull’architettura organica ecc., quando vengono scoperti Rossi e Grassi si tende a produrre una sovrapposizione di elementi stilistici della Tendenza al linguaggio organico preesistente (che in genere si ritrova soprattutto nell’alzato, basti pensare al già citato Bankinter). Lei è concorde con questa mia osservazione? Cosa ne pensa? S. M. F. Si, certo, sono d’accordo, mi sembra una osservazione molto interessante. Questa sovrapposizione non avviene, però, solo tra Organicismo e Tendenza, molto importante è, come ho già detto, l’influenza americana, quella cubista, anch’essa rientra nelle sovrapposizioni. F. S. Postmoderno: una moda o una condizione? S. M. F. Questa è una questione a cui tengo molto, ho fatto molte discussioni su questo negli anni ’80 ed ho sempre difeso la mia posizione. Ritengo necessario fare una differenza tra la questione figurativa dell’architettura e la condizione postmoderna: la questione figurativa è formalista ed è quindi pura moda passeggera, la condizione è, invece, una questione differente. Per condizione post-moderna deve intendersi ciò che è seguito alla modernità ortodossa, una nuova modernità non della produzione ma della circolazione, una modernità che sancisce la fine dell’estetica della produzione industriale. Tale distinzione è importante perché negli anni ’80 tutta la volontà figurativa era indubbiamente postmoderna, ma la condizione postmoderna non poteva essere ridotta a volontà figurativa, era molto di più. F. S. La riduzione dell’architettura a puro gioco linguistico, così come Charles Jenks sosteneva nel suo saggio del ‘77, non può essere vista oggi come una chiara anticipazione del formalismo architettonico attuale? S. M. F. Sì, può essere vista come un’anticipazione del formalismo architettonico attuale, in quanto può favorire la transizione ad una architettura spettacolo che fa ampio uso dell’alta tecnologia e che si disconnette dai luoghi e dai contesti. D’altronde che cos’è il formalismo linguistico se non puro spettacolo? * Francesco Sorrentino, Influenze europee della Tendenza italiana. Il progetto urbano in Spagna, O. M. Ungers e la cultura tedesca, Tesi di Dottorato in Composizione Architettonica, Napoli, 2011. CRITICA E/O STORIA? L’USO DEL PASSATO COME DISCRIMINANTE Luigi Manzione “History is not a clear-cut period in the past but a total panoramic experience in which mythology, truth, writing, building and demolition intermingle.” [Crimson Architectural Historians, Too Blessed To Be Depressed, Rotterdam, 010 Publishers, 2002] Usi (e abusi) del passato La storia non è di proprietà esclusiva dello storico. Questi può farne un uso scientifico, sebbene ciò non sempre accada. Il passato può inoltre prestarsi ad essere utilizzato in modi non scientifici. Di più, si può dire che il passato sia passibile di usi non storici: questo, in architettura, è il caso frequente da parte della critica. Ed è l’uso che qui maggiormente ci interessa: in termini precisi, il “potenziale critico dello sguardo storico”.1 Usi non storici o non scientifici del passato non dovrebbero del resto sorprendere chi ha a che fare con l’architettura. Di essi si può infatti valutare l’interesse da angolazioni diverse dalla pura storiografia. Il passato dell’architettura appare allora, da una parte, un campo di ipotesi verificabili e da verificare; dall’altra – anche specificamente in quanto storia – una “esperienza totale panoramica”, permeata di sapere e di retorica. Non sempre queste due maniere di intendere il passato si presentano separate o in opposizione. Più comune è la circostanza in cui si ritrovano – più o meno dichiaratamente – intricate e stratificate. Un esempio paradigmatico di ricorso al passato in cui si intrecciano conoscenza e racconto, storia e progetto, è in Siegfried Giedion. In Bauen in Frankreich. Bauen in Eisen. Bauen in Eisenbeton (1928), Giedion affida allo storico il compito di “far emergere dal passato, districandone l’enorme complessità, gli elementi che permettono di dare slancio al futuro.”2 In questa prospettiva la storia svolge una funzione attiva e attuale, nella comprensione del presente e nell’orientamento dell’avvenire. Influenzato da Heinrich Wölfflin, Giedion connette in modo indissolubile le dimensioni del tempo (passatopresente-futuro): progetto storico e progetto critico sono per lui due facce della stessa medaglia. E questa medaglia non è altro che la lettura o, meglio, la narrazione dell’architettura quale viene delineandosi tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento. Questa lettura, pioneristica come l’architettura che presenta, si forma proiettando nel passato i segni emergenti del presente, così da lasciare intravedere le traiettorie di un progetto di futuro. Giedion inaugura uno sguardo al contempo storiografico e critico, funzionale alla costruzione del racconto del movimento moderno e costitutivo, nel metodo se non anche nella sostanza, di molte “storie” che sono state scritte sull’architettura moderna e contemporanea nel XX secolo (e nell’inizio del successivo). Non è casuale che la prima parte del suo Space, Time and Architecture (1941) si intitoli “History a part of life”. Nella prefazione al libro si precisa che “History is not a compilation of facts, but an insight into a moving process of life.”3 Quando tratta di Francesco Borromini, Giedion apre una parentesi – denominata in margine “Relation to our period” – in cui assume come termine di confronto Vladimir Tatlin. “Our” non è aggettivo riferito solo al tempo presente, ma a una sorta di appartenenza più profonda: alla nostra cultura, alla nostra civiltà immersa in quel “processo in movimento”. Il parallelo riguarda precisamente Sant’Ivo alla Sapienza e il progetto di monumento alla Terza Internazionale, significativamente definito “a clear expression of the same kind of feeling”. 4 “There is no criticism, only history” Se l’uso del passato può essere considerato come discriminante (nel nostro dominio, di un approccio insieme all’architettura e alla critica), Manfredo Tafuri esprime senza dubbio una posizione diversa e in parte alternativa alla critica operativa, inaugurata da Giedion e teorizzata da Bruno Zevi. Teorie e storia dell’architettura (1968) si apre infatti con una dichiarazione programmatica riguardo all’atto del criticare e, in particolare, al rapporto tra critica e storia: “Criticare significa (…) cogliere la fragranza storica dei fenomeni, sottoporli al vaglio di una rigorosa valutazione, rilevarne mistificazioni, valori, contraddizioni e intime dialettiche, farne esplodere l’intera carica di significati.” 5 1 P. Chabard, “Temps et critique: retours, recours et détours historiques”, in H. Heynen, J. L. Genard, T. Kaminer, Critical Tools. International Colloquium on Architecture and Cities 3, Brussels, La Lettre volée, 2011, p. 46. Alcuni riferimenti che seguono sono mutuati da questo scritto. 2 S. Giedion, Bauen in Frankreich. Bauen in Eisen. Bauen in Eisenbeton, Berlin, Klinkhardt und Biermann, 1928 (trad. francese: Construire en France. Construire en fer. Construire en béton, Paris, Ed. de La Villette, 2000, p. 1). 3 S. Giedion, Space, Time and Architecture, Cambridge, Harvard University Press, 1946 (VI ed.), p. V. 4 Ibidem, p. 51. 5 M. Tafuri, Teorie e storia dell’architettura, Roma-Bari, Laterza, 1986 (IV ed.), p. 3. La critica è in primo luogo un processo di smascheramento operato sul corpo storico dei processi, delle opere, degli autori che si analizzano. Criticare significa prendere posizione: per Tafuri il rigore delle analisi non coincide tout court con l’oggettività, ma piuttosto con la perspicacia dello sguardo e la pertinenza del punto di vista. “Ogni tentativo di separazione di critica e storia è artificioso, e nasconde un’inconfessata ideologia conservatrice. Isolare la critica in un limbo astrattamente dedito all’analisi dell’attualità – come se esistesse, poi, un tempo ‘attuale’ che non sia già tempo storico – significa accettare il ricatto delle mitologie più transeunti e mistificanti.”6 Un ricatto che peraltro condiziona ancora oggi, in forme rinnovate ma non meno pervasive, la critica dell’architettura. È evidente quindi che quando Tafuri dichiarava “There is no criticism, only history” 7 si riferiva ad una critica intesa, illusoriamente e ideologicamente, come separata dalla storia stessa. La sua posizione lasciava intravedere, oltre la crisi della critica operativa da lui evidenziata nel libro del 1968, la possibilità di “un nuovo modo di operatività” della critica stessa. È in questo senso che la sua posizione è parzialmente alternativa a quella zeviana. Ma di quale posizione si tratta? In Tafuri il progetto culturale si compenetra con il progetto didattico: l’istituzionalizzazione della storia dell’architettura non può non compiersi nella distinzione dell’architettura, in quanto pratica disciplinare, dalla storiografia e, in senso lato, dalla critica. La storia e la critica non si escludono reciprocamente, come hanno inteso concludere non pochi esegeti del pensiero tafuriano. Pur distinguendosi, formano una unità disciplinare: la critica è sempre storicamente localizzata, anche se gli “strumenti” di investigazione del “tempo presente” e del “tempo storico” restano sostanzialmente gli stessi. Tutt’altro che pura teorizzazione, questa distinzione tra l’architettura come disciplina e la storia (e la critica) sostanzia la posizione di Tafuri. Con la prospettiva permessa dalla distanza temporale rispetto alla fine degli anni ’60, si può dire che il proposito operativo di selezionare temi, immagini, figure dal “tempo presente” e dal “tempo storico” per orientare il futuro dell’architettura non si è mai compiutamente materializzato. Da questo punto di vista, Tafuri opera quasi una constatazione quando parla di progetto e utopia. Non si è mai materializzato questo proposito non perché non sia teoricamente agibile; piuttosto per la difficoltà (o l’impossibilità) di tradurre un compito di questo tipo in progetto concreto: in realtà. Non a caso, le tendenze emerse in architettura, dalla crisi del movimento moderno in avanti, sono il prodotto di selezioni ex-post più che espressioni generate a partire e nell’ambito di una direzione critica (pre)-determinata. Mentre si illude di orientare il corso degli eventi, anticipando le traiettorie del futuro, il critico sembra non poter fare molto di più che collezionare autori, opere, poetiche, forzandoli in un certo senso a costituire una tendenza, a disegnare una linea comune, a costo di semplificare, se non annichilire, le differenze costitutive delle singoli voci e degli specifici contesti. Critica prospettiva, storia à rebours Non a caso, ancora, quando si interrogano i critici, dediti a “mordere nel presente” per usare la formula di Tafuri, a proposito di exempla per una possibile architettura a venire, il silenzio cade inesorabile, chiaro segno di difficoltà. Non di reticenza, ma nel senso proprio di incapacità di indicare casi paradigmatici, quando si pretende di creare paradigmi saltando ogni mediazione tra teoria (e critica) e operatività. Il futuro deraglia puntualmente dagli schemi disegnati dal critico prospettivo e dallo storico à rebours. Questi possono valutare e spiegare, non anticipare o aggregare su basi, se vogliamo, meno fragili e contingenti di quelle che caratterizzano il lavoro del curatore. In questa chiave, la previsione del futuro da parte del critico e dello storico somiglia più alla veggenza che alla prospezione. Consapevoli o meno dell’impasse, il critico operativo e lo storico critico fanno della selezione il loro criterio di elezione. Entrambi distaccano lo sguardo dal presente: il primo per legittimare il presente stesso come possibile futuro, il secondo per falsificare, o deformare, il passato in chiave ugualmente prospettica. Selezionare equivale quindi a dislocare, in un certo senso, sia il presente che il passato per far sì che essi gemmino, per così dire, il futuro. Tafuri indicava in Giovanni Pietro Bellori il prototipo dello storico operativo, colui che sottace, per scelta deliberata, aspetti importanti delle vicende di cui tratta, nel caso dei “pittori, scultori e architetti moderni”.8 In virtù della distinzione dei “buoni” dai “reprobi”, Bellori ignora – di fatto nega – l’esistenza del barocco, proponendosi così di influenzare il corso dell’arte secondo la sua visione. Che poi, di fatto, abbia contribuito ad influenzarlo dipende più dalla tendenza dominante nella storia stessa, che dalle indicazioni o dagli occultamenti operati. Come dicevamo, critica e storia sono in realtà distinte ma non separate, o separabili, e non è detto che, se lo fossero, la storia (la ricerca storica) sarebbe meno selettiva. L’esaustività, come criterio positivistico, è continuamente messa in dubbio dagli interessi, dalle conoscenze, dagli obiettivi degli storici. Ciò nonostante, l’aspirazione a correggere il passato, o a bonificare il presente, per rendere migliore il futuro non ha fine. Giedion riproduce in 6 Ibidem, p. 196. “There is no criticism, only history”), Design Book Review, 9, 1986, pp. 8–11 (intervista di Richard Ingersoll a Manfredo Tafuri, ripubblicata in Casabella, 619-620, 1995). 8 G. Pietro Bellori, Le Vite de’ pittori scultori e architetti moderni (1672), Torino, Einaudi, 2009. 7 fondo, dopo più di due secoli, lo schema di Bellori, costruendo – come abbiamo accennato – il racconto dell’architettura moderna come legittimazione di un passato selezionato.9 “Space, Time and Architecture epitomizes la critica operativa, placing modern architecture in a tailor-made historical field reaching forwards from the past and legitimating a movement conceived in terms of rupture, dislocation, and originality. Giedion’s history projects lessons of a past, reconstructed according to present values, into a preconceived future.”10 I modelli di quello che Tafuri definiva “mordere con continuità nel presente” da parte della critica operativa, senza preoccuparsi troppo della verifica storiografica degli assunti, vanno da Nikolaus Pevsner appunto a Siegfried Giedion, da Edoardo Persico a Bruno Zevi. Qui lo sguardo storiografico si confonde e si dissolve, non solo con il giudizio critico, ma anche con il progetto per l’architettura. Nella progressiva riduzione dello spessore diacronico, la convergenza tra progetto critico e progetto storico tende a disegnare senza mediazione i tratti di un’architettura futura, di ciò che può – o deve – essere ritenuta una “buona architettura”.11 Ciò che viene criticata da Tafuri non è allora l’operatività nel discorso dell’architettura, ma l’assunzione in senso strumentale della storia per l’architettura o, in altri termini, la distorsione in direzione operativa della storia stessa. L’operatività non scompare dal discorso, né dalla pratica dell’architettura. Viene anch’essa semplicemente dislocata: dal piano del passato a quello del presente. Come sottolinea ancora Andrew Leach, “(…) just as the operative tradition assumed the characteristics of an architectural project under the guise of history, Tafuri’s proposal continues that trajectory by proposing the removal of operativity from history, aligning it properly with architecture in a form of critical practice that is at once concerned with the future, but wich makes analyses of present, and not past, conditions in order to realize future ends.”12 Storia per il progetto Per Bruno Zevi è invece il metodo storico a permettere un “riscontro scientifico” e una “comunicazione di esperienze” necessari per la pratica dell’architettura 13. Lo studio e l’interpretazione del passato sono a loro volta sollecitati all’interno della pratica architettonica contemporanea. La storia si “riflette” quindi in una metodologia della progettazione. Storia, critica e progetto sono strettamente connessi nel progetto didattico zeviano: la storia “concreta e dinamicamente intesa” si avvale della critica, “condotta con criteri scientifici” e “capace di recuperare l’intera prospettiva del passato in chiave ed in funzione dei compiti contemporanei” (p. 91). La ricerca storica e il giudizio critico sono insomma strumentali al progetto in quanto consentono all’architetto di “operare scelte circostanziate”, evitando “errori meschini ed arbitrî inconsistenti”. Sul piano della didattica, l’alleanza così sancita può tradursi nella “fusione tra i corsi di storia e di progettazione”, in modo da veicolare una “metodologia controllabile e trasmissibile” (p. 92). E, secondo Zevi, è esattamente sul terreno del metodo che occorre collocare il nodo in cui la storia “penetra” nel progetto. La storia come “metodologia operativa dell’architetto”, dunque. A quale storia si riferisce? Qual è la storia che Zevi auspica “esca dal suo guscio nobile e paludato, s’immerga nella realtà del presente?” (p. 95). In primo luogo una storia che aiuti a “pensare architettonicamente”, ossia a “ricostruire il processo formativo di un’architettura con i mezzi dell’architetto” (pp. 95-96). Il suo approccio è inclusivo: l’orizzonte della critica e della storia, intese in senso operativo, recupera un insieme di riferimenti comprendente l’edilizia minore, l’urbanistica, il paesaggio. Il fine è anch’esso strumentale, o utilitario: “L’obiettivo consiste nel ridurre e, al limite, nell’eliminare gli immensi sprechi di cui la storia è tremendamente carica, nell’opporsi alla dilapidazione di un patrimonio rivoluzionario che la pigrizia, l’alterigia, l’insofferenza mortificano e cancellano se non viene difeso e rivitalizzato costantemente da una critica capace di ribatterlo sui tavoli da disegno.” (p. 98). Il proprium della proposta di Zevi risiede nella (immediata) proiezione sul tavolo da disegno della complessità e delle contraddizioni del patrimonio di esperienze che la storia dell’architettura contiene, di cui però solo una parte ci è consegnata, mentre il resto è sempre ancora da scoprire o interpretare. Da questo punto di vista, Zevi e Tafuri sono agli esatti antipodi: all’appropriazione della storia ipotizzata da Zevi con e attraverso i mezzi dell’architettura – processo non esente da semplificazioni e riduzioni – Tafuri oppone una visione conflittuale e non “commestibile” della storia. 9 Il suo ruolo chiave per il movimento moderno è sottolineato – non a caso – da Aldo Rossi, secondo cui il contributo di Giedion “è tanto importante come quello dei più famosi architetti che egli, in gran parte, ha indirizzato.” (A. Rossi, “Introduzione”, in AA. VV., Architettura razionale, Milano, Angeli, 1973, p. 16). 10 A. Leach, “Inoperative Criticism: Tafuri and the Discipline of History”, in H. Heynen, J. L. Genard, T. Kaminer, op. cit., cit., p. 39. 11 Sebbene collocata in un contesto teorico e critico sostanzialmente diverso, la questione è ancora irrisolta se il numero 90/2013 della rivista OASE. Journal for architecture si presenta sotto il segno di “What is Good Architecture?”. 12 Andrew Leach, “Inoperative Criticism: Tafuri and the Discipline of History”, in H. Heynen, J. L. Genard, T. Kaminer, op. cit., cit., p. 39. 13 B. Zevi, “La storia come metodologia operativa”, in Il linguaggio moderno dell’architettura. Guida al codice anticlassico, Torino, Einaudi, 1973, p. 87. I numeri di pagina seguenti, senza note, si riferiscono a questo scritto, originario del 1963. “Piuttosto che rivolgersi al passato – scrive Tafuri – considerandolo come una specie di terreno fecondo, ricco di miniere abbandonate da riscoprire mano a mano rinvenendo in esse anticipazioni dei moderni problemi, o come labirinto un po’ ermetico ma ottimo come pretesto per divertenti escursioni nel corso delle quali operare una pesca più o meno miracolosa, dovremo abituarci a considerare la storia come continua contestazione del presente, come una minaccia anche, se si vuole, ai tranquillizzanti miti in cui si acquietano le inquietudini e i dubbi degli architetti moderni.”14 Il cormorano senza anello al collo Esiste, in fondo, una differenza tra lo sguardo sulla storia a partire dal presente e lo sguardo sul presente a partire dalla storia? Tra la “critica operativa” di Zevi e la “critica inoperativa” di Tafuri sono possibili alternative? Riprendiamo la parabola del cormorano proposta da Crimson Architectural Historians. La storia dell’architettura tradizionalmente intesa è, per il collettivo olandese, anch’essa una specie di “pesca miracolosa”. Una pesca come quella che – dal X secolo in Cina e in Giappone sotto il nome di Ukai – viene fatta fare ai cormorani attaccando loro un anello al collo, che permette al pescatore di recuperare il pesce senza che il cormorano lo mangi. Nella metafora, i cormorani sono gli storici dell’architettura, i pesci la storia15. Le regole disciplinari obbligano gli storici a operare con un anello al collo, a riportare cioè il pesce senza inghiottirlo. Crimson rompe questo schema. Rivendicando la piena partecipazione dello storico alla “pesca miracolosa” – senza l’anello al collo –, lo rompe in maniera deliberata e dichiarata, visto che altri prima lo avevano già rotto, di fatto e senza dirlo. Così, lo storico non si limita più a “mordere nel presente”, ma prende in pasto il passato. Liberamente e impunemente. Per Crimson, lo storico è allora colui che, nutrendosi del passato, produce racconti e rappresentazioni che possono essere immediatamente operativi, senza essere trascritti o declinati in codici altri. Senza passare attraverso il ribaltamento sul tavolo da disegno. Senza attraversare la distesa del conflitto e della contestazione. Senza cadere nella banale riappropriazione eclettica. La storia – la ricerca storica –, in quanto “elemento di trasformazione del presente”, diviene insomma un modo esplicito di legittimazione dell’architettura, in particolare della propria attività di architetti e di urbanisti. Diventa così possibile pescare in quella sterminata, “totale esperienza panoramica” che riserva il passato. Diventa finalmente possibile intrecciare gli “strumenti” e i “compiti” della critica individuati da Tafuri con la “comunicazione di esperienze” – insieme stratificate e tentate, collettive e individuali – e l’operatività (della critica e della storia) preconizzate da Zevi. La verità, il mito, l’utopia si sedimentano e si dissolvono in un processo circolare e infinito nel quale scrittura, costruzione e demolizione si affrontano e si sostengono a vicenda. Ancora una volta, ma con maggiore libertà – o lucidità – non solo la storia ritorna a essere uno “spaccato nel processo in movimento della vita”, di cui parlava Giedion, ma la vita stessa. Senza mediazioni e precauzioni. Una teoria critica? Anche un approccio tutto sommato recente come quello dei Crimson appare da rimeditare a distanza di poco di un decennio. In un momento di crisi come l’attuale – non solo di relativismo, ma di oggettiva difficoltà a delimitare il campo e le ragioni della critica – sembra opportuno chiedersi se e perché i critici abbiano allentato la presa sulla propria disciplina. Chiedersi se realmente essi hanno perduto di vista i loro compiti, abdicando alla missione che dovrebbe essere loro propria, ammesso che sia possibile individuarli ancora in maniera univoca16. Ciò che oggi appare realmente assente è una teoria critica dell’architettura. Non un apparato dogmatico, ma un quadro di riferimento entro cui collocare le posizioni e i giudizi senza lasciarli andare alla deriva, senza ridurre la critica a puro pre-testo o giustificazione. Ci si può domandare se esistono (o resistono) i margini per un’azione di “demistificazione” o se si è è invece irrimediabilmente condannati a oscillare tra indistinzione e panegirico, più o meno volontari. Non c’è dubbio che la critica debba ancora prendere posizione. Ma per farlo, è forse necessario delineare le premesse teoriche di un approccio critico. Se non si ha la capacità di rifondare una teoria della critica – una teoria critica – come si può pensare di elaborare letture e dispensare giudizi? Prima di costruire prospettive, la critica dovrebbe essere in grado di ritracciare le linee della propria identità e delle proprie ambizioni. Di ricreare una connessione con il mondo, con il pubblico, con i luoghi in cui si produce riflessione (luoghi alti e popolari; materiali e immateriali). Senza parlare in codice o in ristretti auditori, la critica dovrebbe essere capace di avvicinare l’architettura alle persone, renderla interessante e significativa. E qui ritorna il punctum della coscienza collettiva, che non è un assunto polveroso e démodé. Ma un punto da cui probabilmente ripartire, con rigore e onestà. 14 M. Tafuri, op. cit., pp. 266-267. Crimson Architectural Historians, Too Blessed To Be Depressed, Rotterdam, 010 Publishers, 2002. 16 Riprendo qui alcuni passaggi dal mio “Critica, teoria, teoria critica”, PresS/Tletter, luglio 2013 [http://presstletter.com/2013/07/criticateoria-teoria-critica-di-luigi-manzione/] 15 Qual è quindi il compito, o uno dei possibili compiti, della critica oggi? Ancora una volta, forse, e non molto diversamente da quanto sosteneva Tafuri, quello di ricostruire – come rileva Nicolas Bourriaud per l’arte contemporanea – il “gioco complesso” delle questioni emergenti in un dato momento storico, esaminando le risposte che ad esse vengono date17. Anche per l’architettura, la questione centrale non è (più) costruire il mondo a partire da un paradigma assoluto o da un’idea preconcetta, ma piuttosto “imparare ad abitare meglio il mondo”. Abitarlo meglio nell’epoca della rarefazione dell’estetico, dell’”arte allo stato gassoso”.18 Come l’estetica, come l’arte, l’architettura è essenzialmente relazione, non solo sull’asse del tempo – dove la critica e la storia, nell’orientare o meno la pratica artistica, si definiscono a partire dagli usi del passato – ma anche su quello dello spazio. Lasciando alle spalle i puri giochi linguistici, le macchine comunicative, gli oggetti spettacolari di una nuova avanguardia di breve durata, che sembra aver già perduto ogni spinta propulsiva, una prospettiva critica per l’architettura a venire potrebbe trovare origine, al pari dell’arte relazionale, dagli interstizi del mondo e dalle circostanze concrete dell’abitare, dalle forme delle relazioni umane e sociali, dagli spazi simbolici, dagli eventi condivisi. Laddove, cioè, si possono ridefinire le condizioni e ricalibrare le ambizioni di un progetto poietico e politico per l’architettura. Prima, o almeno a fianco, della critica e della storia. 17 18 N. Bourriaud, Esthétique relationnelle, Dijon, Les presses du réel, 2001. Y. Michaud, L’art à l’état gazeux. Essai sur le triomphe de l’esthétique, Paris, Stock, 2003. L’ESPRESSIONISMO SOCIALE DI BRUNO TAUT Alberto Cuomo La doppia lettura dell’espressionismo, movimento determinato storicamente e geograficamente, impegnato nella critica della condizione umana promossa dalla tecnica e dalla struttura di classe della società tedesca, ma altresì manifestazione della ribellione dell’anima, in ogni latitudine e tempo, alle statiche regole che ingabbiano il rapporto dell’io col mondo, corrente fondata sulle modalità effrattive proprie all’arte, sul carattere eversivo della creatività, è riscontrabile anche nelle analisi dell’opera dei singoli architetti che ne sono interpreti, come è nel caso del suo più emblematico rappresentante, Bruno Taut. Quando alla fine degli anni novanta Kurt Junghanns ricostruisce il clima della cultura architettonica che accolse nel 1970 il suo saggio monografico su Taut, non può non testimoniare come, nello scarso credito goduto dall’architetto in gran parte della storiografia dell’architettura, questa fosse divisa tra quanti, da Benevolo a Banham, ne individuavano l’impegno sociale e l’inclinazione all’urbanistica, e quanti, come Konrad oPosener, ne leggevano il lato “fantastico”, collegandolo persino ai soli aspetti superficiali dell’uso del colore nella costruzione1. Junghanns non cita il saggio del 1967 di Borsi e König sull’architettura dell’espressionismo, dove era stato offerto ampio spazio al lavoro di Taut, sebbene anche i due studiosi italiani sembrano propendere per una lettura unilaterale dell’architetto. In polemica con Gregotti, il quale aveva individuato nell’"ambiguità" del protagonista più complesso dell’espressionismo, tra opposizione alla società e compromesso professionale, l’apertura al nazionalismo, e con Zevi, per il quale "l’espressionismo architettonico non ha saputo elaborare una proposta urbanistica", Borsi e König, giustificando l’equivocità di Taut, tra impostazione utopica epratica edilizia, pur valorizzando gli aspetti compositivi dei suoi progetti, ne enfatizzano il versante sociale, riconosciuto nella "vocazione architettonica…destinata a risolversi nell’urbanistica"2. Ed infatti, un decennio dopo, König illustrerà come l’impegno sociale rivolto al disegno urbano, che si conduce, morto lo spartachismo ed accettati cooperativismo socialdemocratico e capitali americani, nel professionismo costruttivo di ben 14000 abitazioni, discenda, sebbene apparentemente contradditorio con i proclami poetici e le visioni utopiche, proprio dalla medesima capacità inventiva rivolta alle opere singolari, la quale, in ragione delle necessità storiche, converge nell’attitudine al disegno territoriale, ritenuta la reale dote dell’architetto, trascurata dalla critica3. E’ probabile che l’attenzione al sociale in cui sono coinvolti negli anni settanta gli storiografi, conduca le loro indagini a proiettare sui fatti interpretati la propria aspirazione all’impegno, scoprendo anche in architetti come Taut un attivismo politico, tradotto in una disposizione all’urbanistica. All’inverso, riferendo il decorso dell’architetto a quello del movimento, evolutosi, dopo la guerra, dall’utopia separata dalla vita secolare alla indagine progettuale sulle nuove possibilità tecniche e sui nuovi metodi produttivi ed organizzativi, in età postmoderna, maggiormente disposta alle forme che non ai contenuti, Paolo Portoghesi ha messo in luce in Taut, nel suo procedere dalla concezione "di una forma assolutamente libera, quasi anarchica", al vuoto creato dalla sconfitta tedesca introiettato nelle sue opere, sino all’umiltà di una vocazione al corale tale da scontare il mutismo, la vena persistente del suo ispirarsi alle forme del mondo naturale, organico ed inorganico, in sintonia con l’Art Nouveau4. Appare palese come anche tale lettura, che traduce la tensione etica di Taut in cura formale, volgarizzando il suo senso del mito in una stucchevole magia favolistica scialbamente imitativa delle fogge naturali, risenta a sua volta delle propensioni dell’esegeta il quale, immerso nella deriva postmoderna tra i segni, dove privilegia gli stilemi naturalistici, riferisce il coriaceo architetto espressionista ad un decadente tardoromanticismo incline alle delicate e molli flessuosità jugend. In fondo le due letture, di un Taut impegnato nel sociale e, pertanto, versato nell’urbanistica, e di un Taut visionario fautore di sogni urbani e di architetture fantastiche, ripropongono, non solo il dualismo attribuito all’espressionismo, quanto anche quello della critica, divisa su fronti ideologici opposti: quella americana e della Germania ovest che, sin dal testo Phantastische Architektur, di Conrads e Sperlich, ha inteso Taut alla luce del fantastico, e quella di ispirazione marxista e della Germania est, che, con Junghanns, Heinisch, Peschken, ha valorizzato il Taut ispirato al socialismo ed alla trasformazione sociale 5. Più lucidamente, nel distacco dell’analisi fenomenologica, Giulio Carlo Argan, collegando l’opera degli architetti espressionisti all’esperienza della Brücke, mette in luce in loro come il frantumarsi della forma consegua dagli stessi modi dell’industria, costituendosi per essi la fabbrica quale "luogo in cui tutti gli uomini operano una trasformazione della materia liberando la propria spiritualità nella creazione di una nuova e diversa natura", luogo 1 K. Junghanns, Ricordo dell’inizio, in AAVV. Bruno Taut 1880-1938, trad. it di D. Biasi, Electa, Milano 2001, p. 299 e segg. Cfr. V. Gregotti, L’architettura dell’espressionismo e B. Zevi, L’eredità dell’espressionismo in architettura, entrambi in «Marcatre», n. 8-9-10 1964; il dibattito è sintetizzato in F. Borsi – G. K. König, Architettura dell’espressionismo, op. cit., p.83 3 G. C. König, introduzione a B. Taut, La dissoluzione delle città, op. cit. pp. XX-XXIII 4 P. Portoghesi, Bruno Taut: architettura e natura in G. D. Salotti M. A. Manfredini,DerWeltbaumeister, Franco Angeli, Milano, 1998. 5 Cfr. W. Nerdinger, Un grande albero deve avere radici profonde. Tradizione e modernitàin Bruno Taut, in AAVV. Bruno Taut, op cit. 2 cioè di una comunità del lavoro collettivo, vero "Prometeo", che riscatta e sublima la materia conducendola, con una moderna alchimia, "ad un grado di perfezione soprannaturale, alla tersitá e alla chiarezza strutturale del cristallo", quello del padiglione espositivo del 1914 a Colonia. Di qui il sovrapporsi della prospettiva sociale manifesta nella visione di nuove configurazioni urbane con il versante fantastico reso nell’immagine architettonica la quale, in quanto tale, si ritrae dallo spazio per estendersi all’infinito ed "eliminare ogni relazione tra cosa e ambiente, coinvolgere ogni possibile ambiente nello sviluppo della propria ritmica…espressione, non più del singolo individuo, ma dell’ethos popolare dell’ideale collettivo della società" cui conformare, più che l’edificio, "in toto la nuova città e la nuova natura". Una utopia che mostra, oltre il senso politico, il suo porsi ricerca di una nuova spiritualità contro l’indursi della macchina e della società industriale borghese all’utile, ipotizzando, più che una società del futuro, una umanità ideale protesa a divinizzare se stessa attribuendosi una creatività divina. Una utopia che si offre il compito di trasformare l’ambiente e il paesaggio naturale "ma non nel senso di adattarlo alle necessità positive dell’esistenza, bensì di fare della natura stessa una grande creazione umana: l’architettura alpina di Taut, per esempio, configura quello che potremmo chiamare un 'sublime sociale'"6. Sarà da questa analisi, più aderente al credo tautiano, che, negli anni settanta, pur sollecitato dall’emergenza dei temi sociali da cui è condotto a privilegiare il Taut dei programmi di ricostruzione del dopoguerra, Argan legge "l’essenza dionisiaca, orgiastica e tragica insieme dell’immagine" espressionista dove si rivela, nel doppio movimento della degradazione del divino in materia e dell’ascesa della materia in spirito, anche la polemica sociale, il conflitto con la borghesia individuata responsabile dell’inautenticità della vita: per esistere bisogna volere esistere contro le lacerazioni della divisione delle classi, quelle del lavoro tra ideazione ed esecuzione, volere reinventare il mondo, la società, ricondurre in essa il sacro, divinizzarne i rapporti materiali, da quello primario del sesso, tanto presente nelle opere espressioniste e in Taut, sì che sia proprio la creatività sacrale dell’arte ad essere intesa impegno sociale 7. A proposito della relazione con la città, Tafuri e Dal Cò mettono in luce come l’incontro con il problema urbano negli architetti tedeschi del Werkbund sia interno alla tematica del rapporto intellettuale-metropoli. Se la nuova realtà metropolitana, nelle analisi tra Baudelaire e Benjamin, è la sede della società di massa, della folla in cui si perde ogni soggetto, ogni interiorità ed ogni storia, non più il luogo della memoria ma di chocs continui, per l’intellettuale, che scopre in essa il venir meno della propria unicità, il confronto con il suo morbo non può intraprendersi se non dalla assunzione e dalla introiezione della stessa malattia. Reiterando l’altro dissidio interno al Wekbund, tra quanti con Muthesius si appellano alla tipizzazione, vera rappresentazione di "un’etica industriale di tipo ascetico connessa alla espansione del capitale, e quanti invece, tra questi Taut, propugnano l’autonomia inventiva e la continuità con la tradizione artigiana, gli architetti tedeschi si dividono anche sui modi di intervenire nelle nuove realtà urbane, sebbene, sia che si richiamino all’astrazione geometrica patrocinata da Tessenow8 e perorata a scala sovraurbana da Hilbersemer, sia che tendano ad esternare, riflettendola nelle proprie opere, la frattura tra il soggetto ed il mondo, come fanno gli espressionisti, di fatto traducono nelle proprie metafore i modi della espansione della metropoli, oscillante tra ordine dei lotti, di volumetrie e forme ed anarchia linguistica 9. In particolare, negli espressionisti ed in Taut, più che la propensione alle tecniche di organizzazione urbana, è riconoscibile la mitizzazione della città, quella stessa della grande dimensione, la quale dall’urbssi espande ed evolve dalla propria struttura organica in quella inorganica ed artificiale della cristallinità, sino a librarsi nel cielo stellato oltre il tellus. Se cioè, tanto più nella Großstadt, l’urbano è la dimensione del logos, trasposto nelle spoglie dell’utile e dell’economico, di una regolata e gerarchica organizzazione delle classi sociali, Taut, pur rivolgendosi alla grande scala e aderendo alle logiche della costruzione territoriale animate dal profitto, manifesterà sempre l’opposizione ad un uniformato ordine, per privilegiare la variabilità delle concrezioni abitative fondate sulla volubile relazionalità degli individui, in una vocazione antiurbana o oltreurbana che tenta di integrare l’abitare, gli abitanti, attraverso parametri altri, deposti nell’intimo e rivolti al comunitario ed alla realizzazione di una spiritualità posta di là della soddisfazione del bisogno10. Ancora Tafuri e Dal Cò, rilevando come nel Werkbund, alla richiesta degli industriali di "un assalto pulito ai mercati esteri", mediante il coinvolgimento degli intellettuali nei meccanismi della produzione, corrisponda invece un dibattito del tutto ideologico, identificano nella risposta degli oppositori di Muthesius, i rappresentanti dell’avanguardia espressionista, un atteggiamento "nostalgicoregressivo", più prossimo a Schopenhauer che a Nietzsche. Ed il ricorso nostalgico al passato è ravvisato, nei poeti e negli scrittori tedeschi, anche da Furio Jesi, sebbene, secondo tale studioso, le mitologie che essi fanno rivivere, quelle del mondo dei greci, della natura, della sessualità, sono proposte o, genuinamente, come modo di 6 G.C. Argan, L’architettura dell’espressionismo (1964) op.cit., p. 218 e segg. G.C. Argan, L’arte moderna, Sansoni, Firenze 1970, cap. V, in particolare pp. 291-301. 8 Nella introduzione a Tessenow, Osservazioni elementari sul costruire, trad. it. di S. Gessner, Franco Angeli, Milano 1974, Giorgio Grassi ha spiegato come nell’autore il fare artigiano fosse inteso costruzione accurata, e la "tradizione borghese" luogo di valori consolidati sì che, nella sua lezione trovi posto sia l’aspirazione all’armonia di Speer che la tensione verso "l’elementare" di razionalisti ed espressionisti. 9 Sul Werkbund, le avanguardie e Taut, v. M. Tafuri, F. Dal Cò, Architettura contemporanea, Electa, Venezia 1976, cap. VI e VIII. 10 Manfredo Tafuri, critica le "ideologie antiurbane" degli anni ’20, in Progetto e Utopia, Laterza, Roma-Bari 1975 pp. 95-112. 7 divinizzare l’umano troppo umano, in una estremizzazione del pensiero nietzschiano, o come strumento di una opposizione al degrado della realtà, e non in una ascesi regressiva, traducendosi, dalla coscienza della "malattia" o della "colpa" da cui nascono, nell’orrore di deformate parodie, dove il divino trasecola nel mostruoso, nel diabolico e la salute in follia, secondo quanto avviene allo stesso Nietzsche. Se il mito sacralizza l’umano, con i suoi disorientamenti, i suoi conflitti, riprodotti nella polisignificanza degli intrecci e delle figure la quale mantiene vivo, il tragico senso del vivere, anche la città, con la casa, intese nello spirito borghese luoghi rassicuranti in cui la singolarità non è messa in pericolo dalla collettività, ma anche, con l’avanzare minaccioso delle nuove forze sociali escluse dal loro mondo sereno, spazi inquietanti di tenebrosi pericoli, divengono oggetto del mito, attraverso cui tentare di realizzare un nuovo umanesimo, una nuova Kultur. La tecnica e la metropoli, negli espressionisti, non vivono cioè la spengleriana attesa del tramonto, ma, manifestazioni della stessa natura, della vita, e non solo affezioni dell’inaridirsi dello spirito, possono essere ricondotte alla riproposizione di una nuova Kultur che eluda le fredde determinazioni della Zivilisation, non la Kultur del passato quanto, pur rievocativa degli antichi miti, quella di nuovi valori estetici ed etici, di una nuova spiritualità da riconquistare attraverso la stessa macchina. Il dinamismo energetico, la volontà di futuro, alimentati dalla scienza, e l’evidenza del divenire posta da Nietzsche, quella di una creatività superominica rivolta a trarre continuamente dal nulla le maschere della storia, sono i poli da cui muove il desiderio di un nuovo universo felice in Taut, fondato su una comunione interiore che sopravanzi i meccanici ordinamenti della Zivilisation. Il dolore, nel pensiero schopenhaueriano, apre alla prospettiva della conoscenza investendo l’intera esistenza e, sebbene la sofferenza in Nietzsche sembra trasfondersi di gioia, essa non trova, nell’esaltazione del sé che incede verso un ebbro relativismo, alcuna redenzione che possa pareggiarla, risarcirla. Per questo, in Taut, cogliendosi un assunto pure nietzschiano, l’oltrepassamento delle aride meccaniche della metropoli più che offrirsi alla esaltazione della singolarità può realizzarsi nella ricerca di un comune fondo interiore il quale, movente creativo e principio comunitario, sia anche fondamento di un mondo felice. Nel movimentismo non macchinista, antifuturista, in quanto proprio alla vita, perorato da Taut e rintracciabile nelle sue architetture "simmetriche asimmetriche" o nella forma-informe, oltre che nei suoi scritti, si dispone allora la dinamica di una comune interiorità rivolta a costruire l’estremo artificio di un eccentrico paradiso posto sul piano del mondo, in cui l’esistenza stessa sia sacra, ad elevare una città implosa nella sua "corona", il centro nel quale la cultura risvegli i sensi per giungere all’anima, ed affrancarla, non rinfrancarla, renderla libera di là dell’uguaglianza del socialismo da cui l’intelligenza tedesca si inoltrerà verso e oltre l’esperienza di Weimar. "Costruire la felicità" è l’impegno di Taut condotto oltre la vocazione sociale e l’urbanistica, e tale slogan potrebbe aprire di fatto tutti i suoi scritti11. "L’architettura deve riformare una dissolta religio... «Non è possibile pensare che milioni di uomini, tutti presi dalla vita materiale, vegetino senza sapere perché sono al mondo. Deve esserci qualcosa nel petto di ogni uomo che lo elevi al di sopra dell’immanente, che gli dia il senso della sua comunione con i contemporanei, la sua nazione, tutti gli uomini e tutto il mondo»"12 scriverà dopo la guerra. E non a caso il tempio, "La cattedrale gotica è il preludio dell’architettura di vetro", ricorre nel motto posto sulla brochure di presentazione del padiglione di Colonia, indicando il tema che sarà sempre presente nella propria opera. L’esaltazione della guglia protesa verso l’alto quale modello di umanità che si esalta nel primato del suo colmo, il superuomo, è stato attribuita alla lettura dell’anticristo,e tuttavia, l’icona piramidale, con i riferimenti all’oriente quale antagonista dell’occidente e del cattolicesimo compreso di dogmatiche norme, pur rinviando ad una visione laica, allorché si trasfonde nelle sembianze della cattedrale, sembra piuttosto costituirsi metafora di un nuovo credo, secondo una trasposizione analoga a quella illustrata nella ricostruzione dell’utopia del Bloch e negli assunti teologici del Troelsch, entrambi, come Taut, lettori di Nietszche e rivolti alla fondazione di una comunità riunita in quella stessa interiorità posta "oltre l’immanente" di cui narra l’architetto 13. L’interesse per la cattedrale gotica si manifesta in Taut già nell’attività pittorica e nei primi progetti della chiesa del villaggio di Gaggstadt e della chiesa del Redentore a Stoccarda, cui collabora presso lo studio di Theodor Fischer, o in quello del 1905 per un insediamento operaio raggruppato intorno alla chiesa, a rivelare come egli intenda la costruzione attività materiale indirizzata allo spirito, o, che è lo stesso, all’arte, mossa dall’anima per parlare all’anima. Un’idea dovuta alla propria formazione, all’insegnamento di Möhring, presso la scuola edile di Marienfeld e presso il suo studio berlinese, dove ha modo di conoscere Theodor Goecke, direttore dell’ufficio di piano di Berlino ed amico di Camillo Sitte, ovvero all’influenza di Fischer. Per il Sitte, infatti, la città deve fondarsi su principi etico-estetici, ovvero su un disegno il quale offra una identità ai cittadini mediante gli elementi artistici propri all’architettura dei 11 B. Taut, La dissoluzione delle città (1920), trad. it. di G. Forza, Faenza ed., Faenza 1976, p.62-63, citato da F. Desideri, introduzione a P. Scheerbart, Lesanbéndio, tradit. di P. Di Segni e F. Desideri, Editori Riuniti, Roma, 1982, XVI. 12 F. Desideri, ibidem, la citazione di Taut è presa da Die Stadtkrone, trad.it. di M. Carrara, Mazzotta, Milano, 1973, pp. 40-41. 13 Il tema della piramide, riferito all’arte e alla organizzazione sociale è nel discorso di Taut al congresso del Werkbund del 1914, è citato in I. B. Whyte, Taut visionario, in Bruno Taut 1880-1938, cit. pp. 68-69, come ripreso dal testo di Nietzsche, L’anticristo. Lo stesso autore cita un lettera del 1904 al fratello Max sulla lettura entusiasta dello Zarathustra che influenza gli stessi "SozializstischeMonatshefte". luoghi della rappresentazione pubblica. Essa cioè, con i suoi elementi emergenti, deve concepirsi come un estetico unicum in cui si aprono i vuoti delle piazze, caratterizzate dall’arte, secondo il modello dell’aggregato medioevale. Sarà pertanto in tali concetti che Taut intenderà la continuità con le idee urbanistiche di Fischer, il quale a propria volta concepisce la città come concrezione piena costituita dall’addensarsi di elementi singolari differenti, apparentemente casuale, come è per la città medioevale, ascendente verso il culmine del centro, la "corona", dove si aprono i luoghi associativi, pubblici, sostituti dell’antica cattedrale. Se, com’è per i suoi maestri, la cattedrale non è solo il centro della comunità cristiana, ma il luogo più eloquente dell’aggregazione sociale riunita nella fitta silloge urbana medioevale, nella modernità, lo spazio comunitario in cui gli uomini condividono il più alto esercizio sociale è la fabbrica, e questa, già nell’ottocento, prima ancora di Poelzig, Berlage o Behrens, con Garnier ed Horeau, viene intesa tempio laico, con le forme della chiesa romanica. In questo senso è significativo come, anche quando si allontanerà da Fischer e da Stoccarda per ritornare a Berlino, influenzato da Hermann Billing, presso il quale lavora il fratello Max, pur semplificando il proprio linguaggio nelle forme della classicità, aliena alle asimmetrie fischeriane, Taut interpreterà, nel 1908, un opificio, la sala turbine del laminatoio Harkort di Karl Ernst Osthaus, nei modi di un tempio greco il quale, appiattendo il colonnato in paraste annegate nella pietra arenaria dell’intera facciata, ricorda le linee severe di una chiesa medioevale. Sono sicuramente anni di una febbrile ricerca tipicamente giovanile, ma solo se non si intende pienamente come essa si rivolga all’ardua scoperta di un saldo fondamento spirituale, superumano e sovraindividuale, su cui è ritenuta innervata la materialità, costruttiva e sociale, e non ad un mero approdo stilistico, può parlarsi, come fa Junghanns, di una ondivaga incertezza linguistica in cui si riflette l’insicurezza politica comune alla Germania prebellica. Naturalmente è indubbio che Taut guardi al proporsi sulla scena sociale, politica, storica, del proletariato, come testimonia l’articolo scritto nel 1914, a proposito dell’Opera di Berlino, su Sozialistichen Monatshefte14, ma, pur nell’acquisizione del lavoro materiale come valore, l’operaio non si esaurisce per lui, come è per il marxismo, nel depositario della verità storica guadagnata attraverso il concreto confronto dialettico di bisogni ed interessi, per essere piuttosto il campione di una singolarità rivolta al collettivo, di una soggettività tesa all’oggettivo, di una materialità accesa verso la luce spirituale dell’arte. Vero interprete della ragion pratica, l’operaio, per l’architetto di Könisberg, in aderenza all’interpretazione del lavoro offerta dalla riorganizzazione capitalista e dal democraticismo del Consigli della socialdemocrazia, mostra una fisionomia tra i tratti dell’oltreuomo, gioioso della propria creatività sensuale, carnale, ed i caratteri offertigli, due decenni dopo, da Ernst Jünger, quelli dell’eroe soldato, conquistatore della tecnica, ricondotta, nella sua mobilitazione, oltre la linea del nichilismo decadente cui incede l’occidente e la borghesia, ad una metafisica terrena, una totalità organica nella quale sia immedesimata anche l’attività costruttiva15. Tra il padiglione del Trägerverkaufskontor, elevato a Berlino nel 1910, una struttura metallica vuota, con l’anima piena di una piccola cupola, quello della Stahlwerksverbandes a Lipsia del 1913, monumento gradonato, pure in ferro, a pianta ottagonale, sormontato in sommità da una cupola, ed il padiglione per l’esposizione del Werkbund a Colonia del 1914, Taut progetta i suoi primi quartieri operai colorati, immersi nella natura, e se i padiglioni con la loro forma piramidale e la varietà delle sfaccettature dei lati e dei vetri, si manifestano simbolo dell’impulso unitario emergente dalle dinamiche della differenziazione, i quartieri mostrano un’analoga simbologia componendo il comunitario mediante il variegato spettro cromatico e le variazioni sul tema di un medesimo tipo edilizio16. E’ allora in tale affermata coincidenza nel vetro di gotico ed oriente, probabilmente, che, dagli anni berlinesi antecedenti alla guerra sino al progetto della torre cuspidale per il concorso del Chicago Tribune, si determina in Taut, l’insistenza sul tema della cattedrale e della sua astrazione piramidale la quale, riconoscibile nelle opere di molti espressionisti, sino al frontespizio del manifesto della Bauhaus, si manifesta, montagna cosmica, simbolo del crearsi e ricrearsi della materia dal nulla, della formazione della comunità dall’anima, per irradiarsi, nell’impeto rivolto a frantumare i falsi ordini della Germania guglielmina, in scaglie di cristallo e di ghiaccio17 secondo un concetto esoterico che identifica e assimila l’azione teorica, il fervore artistico con cui egli eleva i propri padiglioni-manifesto, alla partecipe edificazione dei quartieri operai, arte muratoria promanata dalla terra e, pertanto, propriamente spirituale, rivolta ad un divinizzato stare animale dell’umano, e se i simboli rosacrociani, cabalisti e massonici, rivelano il sogno utopico, gli stessi simboli identificano i valori posti alla base di un più concreto progetto professionale e politico18 la cui vena, percorrendo l’intero ottocento affiora anche nella rivoluzione sovietica, nel modello sociale proposto ad dall’anarchico Kropotkin di cui l’architetto legge i testi. 14 Taut scriverà anche, nel 1919, come ricorda Manfredo Manfredini inop.cit. p. 21 n. 25 "DerSozialismusdesKünstlers", un articolo su un socialismo utopico, solare, spirituale, estetico. 15 E. Jünger, L’operaio, trad. it. di Q. Principe, Guanda 1991. Il dominio della tecnica da parte del “tipo attivo”, nella “fusione” tra i suoi mezzi e l’agire, investe l’annullarsi, come è nell’idea tautiana, della differenza tra città e campagna, costruito e natura. Cfr. i par. 62 e 63. 16 Echeggia nel ripetersi differente di un medesimo tipo, la classificazione, di Jacob Burkhardt, delle evoluzioni sincroniche e diacroniche dell’arte sulla base di tipologie elementari, v. A. Pinotti, Quadro e tipo. L’estetico in Burckhardt, Il Castoro, Milano, 2004, capp. V e VI. 17 M. Fagiolo, La cattedrale di cristallo, in AAVV, Il revival, a cura di G. C. Argan, Mazzotta, Milano, 1974, p. 268 e segg.. 18 M. Fagiolo, ibidem, p. 231 e segg. e G. D. Salotti, Bruno Taut: alcune note sul colore, in G. D. Salotti – M. A. Manfredini, op. cit. L’opera che, dopo la frattura della guerra, connette l’attività giovanile, solitamente intesa visionaria, a quella matura, professionale, interpretata incline al compromesso, e che ne dimostra invece la continuità, è Die Stadtkrone, conclusa nel 1917 e pubblicata nel 1919. Una continuità ulteriormente segnata da Der Weltbaumeister e da Alpine Architektur, pure concepiti e pubblicati nei medesimi anni che vedono la costituzione del Novembergruppe e, al suo interno, del più ristretto Arbeitsratfür Kunst, modellato secondo i Consigli degli operai e dei soldati, ma anche, come mostra Marcello Fagiolo, secondo l’organizzazione e lo spirito delle sette esoteriche 19. Nel corso della guerra, nel 1916, Taut aveva partecipato al concorso per la casa dell’amicizia di Costantinopoli, interpretata da una grande cupola incombente sulla pianta regolare di un edificio. In Alpine Architektur il disegno di una analoga cupola, prezioso cristallo incastonato tra le montagne, illustra, con gli altri disegni, l’aspirazione, contro l’ideologia della guerra, all’amicizia ed alla pace cui il libretto si dedica. E’ stato rilevato come i grafici del piccolo volume ispirati ad un racconto visionario di Scheerbart, secondo la testimonianza di Hilberseimer, fossero intesi, nella convinzione di Taut,del tutto attuabili, a manifestare la propensione realizzativa non disgiunta dal persistere della visione ideale. Del resto, se tra i disegni non mancano i riferimenti a mondi lontani, è la vetta dei monti, il Resegone o il Cervino, dalle forme assimilabili a cattedrali e piramidi, che, resa sito abitabile, ricorda i templi, le “montagne sacre” dell’India e delle Ande, riproponendo quella religione dell’arte, della continuità con la natura, già professata prima della guerra. La montagna, nel testo, non è solo il luogo della sfida della tecnica dalla cui mobilitazione, oltre l’applicazione alla guerra, pervenire alla abitabilità della sua solenne pace, ma, con la sua forma piramidale, è simbolo di elevazione, di ascesa/ascesi e, nella sua terribilità, manifestazione sublime dell’indicibile principio del mondo che vi si manifesta come natura, asse del pianeta, elemento di congiunzione, in ogni religione, tra divino ed umano, luogo del primo abitare, antecedente la città ed il lavoro della terra, universo stellare, nella sua coltre di neve, di cristalli ascendenti, oltre il suo limite, verso il cielo 20, così come mostrano i disegni finali, o inverno anche, di silenzio e di solitudine, da cui sfuggire la compassione che matura nel calore e circondare di veli di cielo nevoso la felicità dell’oltreuomo. Nel dopoguerra Taut, come altri architetti, tenta di dare concretezza alla propria aspirazione costruttiva, ma questa è esaltata tanto da rendere superlativa le forma, la piramide-cattedrale riportata alla maestosità della sua versione naturale, sia per offrirne l’immagine alla speranza di pace sia per determinare un ruolo significativo all’architettura, protesa a conformare tutta la terra, e non solo la città o gli oggetti d’uso su cui si attardava il Werkbund. Ed infatti nel Weltbaumeister, il principio divino, la sua scintilla, l’istanza interiore creatrice, è affidata alla figura dell’architetto, facitore dell’intero mondo, per ritrovarsi nell’inanellarsi della Gläserne Kette, il circolo iniziatico degli “architetti sconosciuti”, con gli pseudonimi scelti da Taut per sé e per il fratello Max, Glas, il cristallo, ed Ohnename, il senza nome, allusivi, pur nell’attestare la volontà di annullare il tratto personale nella fratellanza sociale, di una presenza divina, della sua assoluta trasparenza, priva dell’opacità di qualsivoglia particolare, pura ed ignota misura superumana, se si vuole l’unbekannt nietzchiano21. Successivamente ènel testo sulla Stadtkrone che Taut mostra ancora il tratto visionario esponendo la sua continuità sia con le idee del Behne e di Scheerbart presenti con propri scritti nel volume. Questo è intriso di sensi arcani e vi abbondano termini come “mistero”, “sogno”, “creazione”, “miracolo”, “disfacimento”, “decomposizione”, “morte”, “resurrezione”, nella invocazione della presenza del divino in terra. Noto sono infatti gli austeri passi della nei quali Taut, interrogandosi su “se venisse un Dio” ad offrire edifici ed ambienti non improntati banalmente alla funzionalità del vivere, afferma l’architettura “grande professione, solenne e divina” in grado di “accrescere il tesoro che è nascosto nell’animo umano”, allontanando l’individualismo per alimentare in ciascuno il senso dell’appartenenza al popolo. Il “pensiero sociale”, il socialismo, viene quindi palesemente inteso, sollecitando la riflessione di Ludovico Quaroni22, “nuova forma di cristianesimo”, di una religione misterica che divinizzi l’umano, essendo del resto la “corona”, il cerchio rosacrociano della fratellanza e dell’uguaglianza, la corona di spine di Cristo, Dio-uomo, simbolo di una comunità quale corpo divino, fondata su una linfa interiore, su un sangue comune addensato in un intimo Graal alla cui ricerca l’architetto innalza il suo tempio. Tra le illustrazioni del testo non mancano le immagini delle “montagne sacre” cinesi, tailandesi, indiane, cui si assimilano quelle delle cattedrali gotiche, a confermare l’aspirazione ad una purezza originaria ascrivibile all’oriente ed alla sua tensione alla luce, non aliena al futuro, mostrato nell’analoga raffigurazione dello skyline di New York. Una aspirazione testimoniata anche in un altro scritto di Taut dello stesso anno, Ex oriente lux, ad esprimere ulteriormente, nella volontà realizzativa del dopoguerra manifesta nel calcolo economico della Stadtkrone, il permanere del delirio utopico, dell’ansia metafisica, della vocazione a scavalcare l’oscurità della materia richiamando la luce nella densa carne del corpo. Ideata secondo una pianta circolare attraversata da grandi percorsi curvi, paralleli alle due direttrici centrali incrociate, la nuova città ideale ha “l’impostazione… della città 19 M. Fagiolo, op. cit., pp. 234-39. F. Tomatis, Filosofia della montagna, Bompiani, Milano 2005. Questo testo si chiude, come quello di Taut, con l’immagine delle “Stelle che salgono e che cadono” in cristalli di neve, che richiama il ritiro sul monte degli ulivi di Zarathustra prima di oltrepassare la Großstadt. 21 Su questi temi cfr. M. Fagiolo, op. cit., pp. 229-39. 22 Cfr. l’introduzione di Ludovico Quaroni a La corona della città, op.cit. 20 giardino”, con case basse immerse in aree verdi di coltivazione ortiva. Sebbene Taut ne detti con precisione le funzioni ed il dimensionamento, la sua configurazione sembra determinarsi secondo le linee energetiche di un magnete, di un nucleo di irradiazione energetico verso cui concorre il disegno delle costruzioni, quello della “corona” centrale, la Stadtkrone, la quale raggruppa le funzioni direzionali secondo gerarchie rappresentative a quelle culturali, teatri e casa del popolo, disposte in modo da “formare una croce verso il sole”, basamento “per la costruzione sublime che…completamente svincolata da ogni limitazione pratica troneggia su tutto il resto come architettura pura. E’ il palazzo di cristallo, costruito in vetro, il materiale da costruzione che rappresenta, nella sua essenza splendente, trasparente e rilucente, qualcosa di più di un semplice materiale comune….attraversato dalla luce del sole…come un diamante scintillante che risplende del sole come simbolo della più profonda serenità, della totale pace dell’anima”, un luogo di meditazione e di contemplazione il quale “non contiene nient’altro che uno splendido spazio”, dove “un viandante solitario trova la pura gioia dell’architettura e, salendo sulla scala che porta sulla piattaforma in cima…, vede ai suoi piedi la città e dietro ad essa il sole che sorge e che tramonta, il sole verso cui sono rivolti la città ed il suo cuore”. Come la cupola realizzata nel 1914 a Colonia, anche il palazzo, nei riflessi solari sulle vetrate policrome, sintetizza in sé le arti, pittura e scultura, una musica mai udita, un mondo di forme “completamente libero dalle imposizioni del realismo e ciò che l’anima degli artisti produce al di là degli schemi figurativi e naturalistici tradizionali” sì da suscitare, rinviando la luce il proprio infinito all’intera città, “un sentimento cosmico, di una religiosità che non può essere espressa che nel silenzio”, secondo l’esplicita citazione del maestro Eckhart. E’ palese come, nella descrizione della Stadtkrone, e nelle immagini illustrative, nella proposta di un culmine spirituale, sovrastante i bisogni pratici, fondato tuttavia sulla loro progressiva rarefazione, l’utopia tautiana sembri ricercare uno spazio di totale illuminazione innestato sulle stesse necessità della vita determinanti la storia, in una religiosità, manifesta nella sua produzione teorica e progettuale, non solo ascrivibile all’essere ebreo, del resto mai rivendicato, quanto al generale clima culturale tedesco che, dopo il naufragio bellico, alimentandosi di nuove speranze, trova esito in rinnovati interessi per la teologia e la mistica. Attraverso Behne, l’idea di una fatticità materiale che evolva nelle forme sin oltre il loro limite può essere riferita a Simmel, sebbene mai citato negli scritti frequentati ed introdotti tra i propri disegni. Docente a Berlino, collaboratore della rivista Jugend, analista dell’arte più prossima all’avanguardia riunita intorno a Der Sturm nel circolo di Walden, amico di Rodin, maestro di Behne, Simmel ed i suoi scritti trapelano anche nella scelta dei temi su cui l’architetto si intrattiene: la moda, le Alpi, la religione, la donna23. Così, uno degli ultimi testi, quello su La nuova abitazione, del 1924, si rivolge nel sottotitolo proprio a La donna come creatrice, ed aprendosi con la citazione di Semper, di cui accoglie l’interpretazione dell’ornamento come elemento simbolico in cui si sublima la pratica costruttiva, interpreta la casa, come è nel saggio di Simmel sulla Cultura femminile24, quale bozzolo centripeto, introverso, nel quale si estrinseca l’anima, la peculiare soggettività della donna, in oggettivazioni che prevedono un dinamismo stanziale, dissimili da quelle estroverse maschili, rivolte invece a dinamizzare ogni stabilità. Di qui, l’accento sul concreto funzionamento della casa, la materiale sua disposizione intorno al corpo, la quale non inclina all’idea funzionalista, quanto a rilevare la singolarità delle differenti modalità della vita e delle dinamiche interne alla medesima cellula, figura della libertà femminile, della creatività della donna intesa, proprio come in Simmel, nella capacità di movimentare lo stesso, l’interiore, l’essere, ovvero, acquietare la fluidità del vivere accogliendola in uno stare. In questo senso è indicativo che il testo si concluda con l’aforisma n. 7 della Dissoluzione delle città, secondo cui “contenuti di vita diversi (lebeninhale) creano diverse forme di vita (lebensformen)” sì che, come osserva König, non sono le funzioni astratte della statistica funzionalista a far derivare le forme, quanto le concrete, diverse, disposizioni del vivere a conformarsi nel tipo. L’abitazione cioè, per Taut, a differenza della “tana della talpa” e “capsula attorno ai nostri corpi”, non è solo un involucro atto a difendere l’uomo quanto “una sfera che contenga i suoi pensieri primi ed ultimi, le sue parole e le sue azioni…insomma un ‘nido’” estraneo all’interpretazione romantica, ma altro anche da una “sala comandi di una centrale elettrica”, luoghi, si direbbe, della simmeliana oggettivazione maschile, e concentrato sulla capacità di accoglienza del femminile, quasi generato dalla donna “creato dall’intimità della vita umana propria…(dove) il sogno rappresenta una non ancora sufficiente chiarezza interiore; il guscio con le sue ‘quattro pareti’ così semplice, ma anche così poco banale e schematico, che il sogno stesso, come idea del futuro, ne viene ampliato ed a sua volta lo amplia”25. Il testo sulla casa e la creatività femminile, concludendo sia l’itinerario teorico di Taut che l’esperienza di assessore a Magdeburgo, apre alla alacre attività berlinese per la cooperativa GEHAG, ed è evidente come, dopo la guerra, anche nell’impegno politico e professionale venga profuso tutto l’intero carico visionario dell’architetto. Basta scorrere del resto le pagine della rivista Frühlicht, prodotta in due diverse edizioni tra il 1920 ed il 1922, 23 Sono i temi su cui si intrattengono i saggi pubblicati in G. Simmel, La moda, (1895), trad. di L. Perucchi, Se, Milano, 1996. G. Simmel, Cultura femminile in La moda, op. cit. e B. Taut, La nuova abitazione. La donna come creatrice (1924) trad. it. di M. Gigliotti, Gangemi, Roma, 1986 25 Cfr. La dissoluzione delle città, trad. it. di G. Sforza, Faenza 1976, con introduzione e note critiche di Giovanni Klaus König. 24 per leggervi ancora, tra l’esaltazione delle forme libere e cristalline, quella del colore e dell’arte gotica, la fede utopistica prebellica riaccesa nel nuovo compito della ricostruzione materiale e morale della Germania. Taut riproduce infatti nella rivista ancora i testi e gli aforismi prebellici di Scheerbart, le cui idee sono riprese anche nell’articolo introduttivo di Behne, il quale non ironizza affatto, come è stato scritto, sulla Glasarchitektur, per concepire anzi il suo realizzarsi, simbolo anche di una trasparenza sociale, nell’oriente invocato alla fine del testo, antagonista della buia Europa, alba di una nuova cultura, forse il mondo della rivoluzione sovietica dove si dissolva anche ogni divisione tra città e campagna. E, del resto, proprio nel 1920 Taut licenzia il libretto con i suoi disegni ed aforismi su “La dissoluzione della città”, in cui, uno dei disegni iniziali riproduce, secondo l’idea simmeliana del valore progressivo dell’incrocio tra l’estroversa puntualità zampillante del maschile ed il raccogliersi inflorescente del femminile, l’incrocio tra i due sessi da cui si generi un universo oltreurbano posto oltre quello metropolitano proprio alla oggettivazione solo maschile. Simmeltraduce in termini di riconciliazione con la tradizione l’oltrepassamento superumano della Großstadt che aveva distrutto l’ordine urbano. E nei disegni di Taut la diffusione delle cellule nella natura, assumendo la dissoluzione dell’urbs, feconda un modello metropolitano per così dire oltremetropolitano, diffuso cioè sull’intera terra e polarizzato verso la centralità della Stadtkrone: l’oltrepassamento della grande città conduce, in termini perfettamente simmeliani, alla reinclusione nella metropoli del modello rurale, dove la singola cellula, il singolo individuo, proprio attraverso la sua differenza partecipa al corale. Il corpo, il suo tratto più essenziale che ne identifica la materialità, il sesso, è esso stesso forma architettonica, che apre ad una disseminazione nella quale annullarsi. La città, il suo corpo, costituita dall’elemento maschile e da quello femminile, la torre che si eleva superba sulla aperta corolla del fiore, si frantuma così in infiniti nuclei stellari sparsi sulla terra a riflettere l’empireo, in una occupazione del globo cioè che perda i limiti, i confini urbani, verso il ritorno ad una mobilità acquea. Il corpo, quello urbano e quello umano, si disperde nella natura, si direbbe torna alla natura, alla terra che si fa cielo, a ritrovare nella morte e nella rigenerazione la sua più intima sostanza, lo spirito, l’anima. L’architettura antica si era costruita sulle misure del corpo per richiamare il divino da cui erano state offerte. L’ottocento, dalla crisi protrattasi dal dopo rinascimento, aveva sottratto quelle misure a Dio valorizzando il corpo per se stesso, tanto da smarrirlo in conoscenze relative. Ma la sua materia, i suoi bisogni, posti dal materialismo, positivistico e dialettico, quali motori della storia, sebbene scontino in fine il relativismo ed il disorientamento, non sono più eludibili. Il primo novecento quindi non può distogliersi dalla esistenza materiale tentando anzi di ridonare al corpo esanime che si aggira nella metropoli nuova vita riconoscendo nella sua stessa carne, di qua del soffio del divino, il palpito dell’anima, una energia vitale che, segno di una divinizzazione della stessa umanità, è fondo per una nuova comunità dello spirito. E’ a questa istanza umanaoltreumana che Taut si ispira anche nel corso dell’esperienza di costruttore di quartieri operai, per cui appare del tutto sterile addebitargli una corriva adesione ai programmi economici weimariani, dal momento che tale giudizio non spiega il senso della predilezione per la tipologia a schiera nel verde nelle case di Prenzlauer Berg, nel bosco di Zehlendorf, quella per l’uso della forma naturalistica della corolla del Britz contornata dai lunghi petali delle siedlung, o l’insistenza sui componenti singolari delle cellula. Elemento semplice, prolungamento del corpo, suo “vestiario”, la casa è infatti per lui una monade rivolta alla aggregazione degli esseri, un vero e proprio luogo elementare dello spirito, atomo di raccolta dell’anima, di quella “intimità della vita umana” comune a tutti gli uomini, su cui fondare il futuro ed una nuova comunità della gioia. Ed è da essa, guscio materiale del corpo, cellula del vivente, che la città evolve, organismo pluricellulare, poliatomico, nelle strutture differenti configurate dalle diverse combinazioni, in un nuovo evoluzionismo secondo cui ogni morfologia è mossa da una dinamica intrinseca alla materia rivelativa di una originaria pulsazione vitale. Gli inizi del secolo avevano scontato la sfiducia nella possibilità di fondare sulla concretezza materiale dell’esistenza e dei bisogni, sui regolamenti fisiologici del corpo, un nuovo comunitarismo, nuovi valori condivisi cui adeguare la vita associata. La guerra aveva altresì alimentato lo scetticismo e lo sconforto. L’esigenza di ricostruire su una istanza comune, universale, una possibile armonia, o, almeno, una comunicabilità tra gli uomini, è avvertita quindi in Germania con maggiore urgenza. Per questo anche l’attività professionale di Taut di Magdeburgo e Berlino, successiva alle astratte elaborazioni teorico-poetiche, non può non dirsi improntata da una vena visionaria, dall’attesa della nuova Gerusalemme che, attraverso l’esperienza weimariana, lo rivolgerà alla rivoluzione sovietica. Attesa non priva di delusioni dalle quali sarà indotto, nella consapevolezza di non potersi rifugiare in un ascetico spiritualismo, a continuare la ricerca dell’intima radice umana nei luoghi primordiali dell’esistenza, testimoni del grado iniziale della materia e della sua primigenia scintilla vitale, al tragitto verso l’oriente, verso l’aurora in cui l’anima era solidale al corpo, ragione anteriore agli sviluppi della razionalità con le sue disastrose conseguenze. Un itinerario a ritroso, una anamnesi del futuro, una discesa nell’inconscio dell’umanità percorsa in un solitario e passato domani, in un procedere inverso a quello di altri colleghi tedeschi, prima in Giappone e poi nella Turchia di Atatürk che egli continuerà ad intendere, con Scheerbart, con Bloch, luoghi della coincidenza di declino e origine, apocalisse e resurrezione, propria ad una istanza immateriale densa di vita ed immedesimata di materia morente, forse l’intenzioned’essere husserliana riflessa nella coscienza della morte di Heidegger. ARCHITETTURA PIANIFICAZIONE POLITICA: MONDI SEPARATI NELL’ESEMPIO DI NAPOLI Antonio Franco Mariniello La realtà urbana percepita a Napoli, ma non solo qui sembra animarsi oggi o del battage mediatico su eventi occasionali più o meno spettacolari, o magari di alcune “immagini” architettoniche che vagano nella città, aleggiano sopra di essa, vengono fatte balenare nell’immaginario dei suoi abitanti piuttosto come fantasmi di meravigliosi mondi virtuali, come desideri o come incubi (dipende dai punti vista), ma mai come le proiezioni (progetti) determinate, decise e condivise di una qualche idea o visione politica/programmatica, strategica, complessiva e sistematica di città. Ciò nonostante permangono, da qualche parte (forse in alcune isole di resistenza universitaria o tra gruppi di azione e di partecipazione sociale urbana) un altro pensiero e un’altra pratica dell’Architettura/Urbanistica – come lavoro paziente, non effimero, degno della migliore eredità del Moderno - che deve tornare a farsi interprete delle aspirazioni più profonde e più serie degli abitanti, i quali chiedono di lavorare e vivere in una città sicura, pulita, ricca di servizi, di spazi di vita pubblica, di case degne di questo nome. Una resistenza ai virtualismi illusori e alle mistificazioni più corrive dei bisogni urbani più autentici capace di far sì che non si spenga del tutto l’interrogazione pubblica (cioè socialmente profonda e diffusa) che muove da sempre l’azione storica dell’architettura. Insomma, ancora oggi è necessario chiedersi: ci potrà essere una politica ancora capace di ripartire da una domanda sociale vera e sacrosanta di un abitare dignitoso e sereno, che si può produrre anche senza distruggere storie, tradizioni e valori culturali e identitari di tanti luoghi e comunità? Al contrario, certe tendenze mediatiche /spettacolari della politica dominante sembrano un modo per surrogare e mascherare questa che è ormai una evidente crisi di modelli, teorie, metodi e strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che non riescono più a sortire effetti virtuosi concreti, che non rispondono cioè ai bisogni autentici della vita contemporanea dei cittadini. Offesi da una politica inetta e indifferente, siamo sommersi da una montagna di Piani, Regolamenti e norme, che sembrano non governare o regolare più niente, lasciando le città e i territori inermi nei confronti dell’abbandono, di abusivismi di ogni genere, speculazioni immobiliari, disastri ambientali, e catastrofi naturali. Non si vuol negare che alcuni strumenti di pianificazione siano importanti e necessari, non solo per regolare nelle certezza del diritto l’ineludibile conflitto tra gli interessi urbani, ma sono utili solo se mostrano nel tempo di saper realisticamente interpretare le aspirazioni, i bisogni e i desideri legittimi e rendere migliore la vita nelle città e nei territori. Quanto ci costa, ad esempio una “pianificazione di carta” sebbene sofisticata e aggiornata alle ultime mitologie del “controllo” della dinamica territoriale? Mentre Regione e Provincia continuano ad applicarsi all’attività pianificatoria (dopo anni di gestazione/elaborazione di Piano Paesaggistico, Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Casa ), in tempi di spending review non sembri provocatorio considerare che una riduzione necessaria, ma selettiva e ragionevole, della spesa pubblica non possa non riguardare i costi di un eccesso di elaborazione pianificatoria - e di conseguente burocratizzazione - alimentato anche dalla storica bulimìa di leggi, regolamenti e norme che distingue questo nostro paese nel consesso europeo e mondiale. Prendiamo la produzione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai diversi livelli, le procedure e i tempi per la loro approvazione, le risorse finanziarie e tecniche (e politiche/amministrative) che vengono assorbite da questo complicato e tormentato ciclo: quanto costa al Paese e alla città una pianificazione territoriale/urbanistica intempestiva, lenta nella sua formazione, farraginosa, e infine inefficace - come dimostra l’enorme distanza che separa le misere condizioni attuali del territorio e delle città dalla pletora gigantesca e velleitaria di Piani e Programmi per cui si sfiancano senza costrutto intere generazioni di ceti politici e tecnici ? Quanto danno provoca una siffatta “pianificazione” alla vita delle popolazioni, allo sviluppo economico, alla salute del territorio, al valore culturale delle sue città e del paesaggio (che è ancora il bene più prezioso del Paese), alla stessa formazione culturale e civile e alla qualità della vita degli italiani ? Qualche esperto, volenteroso e acuto economista saprebbe certamente calcolarlo. Ricordo ora a me stesso che la sola Variante Generale del PRG di Napoli - di sole spese tecniche di redazione - costò alla collettività 1 miliardo e 400 milioni delle vecchie lire, senza contare i costi sociali ed economici complessivi di un mancato sviluppo che (malgrado le migliori intenzioni) quello strumento (così come concepito e congegnato) non è riuscito ad innescare. Non sembra, intanto, cogliersi tanta differenza tra la qualità dell’esistenza di coloro cui tocca vivere (il più delle volte non per scelta) in un luogo “governato” (si fa per dire) da tante di quelle norme spesso sovrapposte e confliggenti che è anche assai arduo osservare, piuttosto che in un’altra parte o città del paese, dove di Piani e regole ce ne è pochi o al limite non ve n’è affatto. Paesaggi e territori regionali tanto “pianificati”, province e città e centri storici pianificati minuziosamente (con Piani e Programmi generali e di settore, strategici e operativi, che coprono magari l’intera gamma “a cascata” imposta da una pianificazione centralistica bolsa e affannata) in questo Paese sembrano subire lo stesso tracollo di quei territori/città/paesaggi che di tanta pianificazione non “godo- no” o che non ne hanno affatto. Non a caso, chiazze di città dispersa (o diffusa che dir si voglia) o enclaves reiette, disperate e criminogene infestano a nord come a sud il Paese, mentre squilibri infrastrutturali, e incuria del suolo che produce scempi ambientali e disastri ecologici e idrogeologici, non risparmiano ormai nessun lembo della penisola. L’urbanistica italiana ha accumulato molte (troppe) leggi, ma poche esperienze pratiche efficaci, ed ora le città e i territori cominciano a chiedere il conto: dalla consapevolezza di un allarmante consumo di suolo che chiama in causa responsabilità e comportamenti politici e amministrativi, alla richiesta di nuovi criteri di ripartizione delle risorse disponibili (non sempre scarse se si contano quelle europee), fino all’urgenza di nuove forme di governo (Città metropolitane, etc.). L’ossessione normativa che sembra affliggere la pianificazione italiana l’ha spinta finora a correggersi per ulteriori addizioni, mai per sottrazione. I sofisticati ingranaggi legislativi messi a punto sono destinati a incrementare l’ingorgo di regolazioni che si intendeva superare. Insomma, nel nostro paese, la ricerca e l’elaborazione di strumenti più efficaci di pianificazione e una fiducia forse eccessiva nell’intervento legislativo mettono, però, in secondo piano gli effetti delle politiche sul territorio. La qualità della vita delle persone e delle società non è indifferente alla qualità complessiva (socialefunzionale-formale) degli spazi e dell’ambiente in cui quella vita si svolge. C’è un’arte che si occupa da sempre di tutto questo: e quest’arte si chiama Architettura. Non bastano le quantità e la loro adeguata dislocazione che la pianificazione urbanistica e territoriale pure definiscono: è decisiva la qualità architettonica durevole degli insiemi, degli organismi, delle parti e degli elementi pianificati. Questa qualità non è un lusso, perché spazi e ambienti sono lo sfondo duraturo e continuo della vita quotidiana delle persone. Ma ciò nonostante, le èlite politiche e amministrative nostrane, locali ma non solo locali, da tempo si distinguono nel panorama politico culturale europeo per una persistente incomprensione (inconsapevolezza) e sfiducia nell’Architettura, per l’incapacità insomma di cogliere fino in fondo il valore civile di questa arte/tecnica che da sempre rappresenta in forme visibili il livello di sviluppo culturale, economico e di qualità della vita sociale nelle città e nei territori. Se così non fosse presteremmo, infatti, ben’altra attenzione e ben’altre cure al patrimonio architettonico pubblico e privato, a quello archeologico come al moderno, alle condizioni del territorio, delle nostre città e dei nostri paesaggi. Viceversa si accentua (ma ciò avviene persino al livello planetario) un uso (uno sfruttamento) “politico-mediatico” delle “archistar” più alla moda, le quali prestano (a loro volta senza troppo pudore) le proprie abilità “artistiche” per imbellettare in qualche modo il degrado e il decadimento fisico urbano, specchio della sostanziale inadeguatezza delle politiche ordinarie sulla città fisica e sui territori. Ciò significa relegare di fatto l’Architettura a mero elemento accessorio, magari lussuoso, senza coglierne la natura e il potenziale critico costruttivo e rappresentativo di una socialità consapevole di se stessa, matura e coesa intorno ad una meta comune: la qualità degli spazi e delle forme per la vita individuale e collettiva nella quotidianità. Ma senza una buona politica che la promuova, che la sostenga e la difenda, non si produce buona architettura. Ecco perché essa ha bisogno oggi più che mai della buona politica. Proprio perché l’architettura è l’arte del concepire e costruire edifici e città e paesaggi, il suo significato certamente contiene - ma va ben oltre - l’ingegneria delle costruzioni, ancorché intrisa di un’ideologia tutta tecnicistica della “sostenibilità”. E dunque, proprio per uscire dall’equivoco ideologico di una malintesa autonomia dell’arte o della sua presunta “indipendenza” dalla politica (ma l’architettura è un’arte civile costitutivamente immersa nelle contraddizioni del mondo reale, e perciò della politica), proprio per invertire una perniciosa duplice deriva politico-culturale tecno-economicistica per un verso, e superficialmente formalistica per un altro verso - è necessaria la ricostruzione di una relazione virtuosa tra domanda sociale consapevole e offerta tecnica sapiente di un ambiente adatto al buon abitare umano nel mondo contemporaneo. Sapendo perfettamente che la qualità dell’offerta di ricerca progettuale incide (e concorre a formare) a sua volta sulla qualità della domanda sociale di città e di architettura. Tale questione – sempre più diffusamente avvertita nella coscienza dei cittadini - investe sia il tema della formazione universitaria per l’architettura (oggi in Italia profondamente in crisi) sia il tema enorme della ricerca di base e applicata nei centri pubblici della ricerca scientifica e culturale, e dovrebbe essere – coerentemente con i temi cruciali dell’ambiente – al centro degli indirizzi di ogni programma di politica urbana/territoriale. Troppo spesso l’opinione pubblica e gli strumenti della comunicazione di massa, comprese le riviste di settore più patinate, si attardano in schermaglie del tutto accademiche e sterili tra conservatori e innovatori. Ma la dialettica vera non è tra conservazione e trasformazione, né tra i fautori di una presunta “sobrietà” di linguaggio (che proibizionisticamente pretende di escludere l’espressione dell’inquietudine moderna e dello sperimentalismo contemporaneo) da un lato, e i sostenitori - dall’altro - di un più libero pluralismo linguistico (capace di dare forma alle differenze irriducibili, al molteplice e all’ibrido nella realtà urbana contemporanea). Questa schermaglia - tutta ideologica - in realtà nasconde la vera discriminante, che è quella che oppone chi è convinto del valore civile (e nobilmente politico) dell’architettura e del progetto/programma urbano che la realizza nella dialettica libera e democratica degli interessi legittimi nella pòlis, e chi invece si illude che le contraddizioni della città realemateriale si possano acquietare di colpo, non appena una delibera di Consiglio Comunale, Provinciale o Regiona- le sancisce le norme salvifiche di una pianificazione dirigistica, astratta, farraginosa, fondata magari (come pure accade alla Variante al PRG di Napoli) su alcuni equivoci teorici e pre-giudizi ideologici, e infine su una malcelata sfiducia nell’architettura. Ma è merito proprio della buona architettura/urbanistica - prodotta e stimolata da buone politiche e pratiche di governo urbano-territoriale, sapientemente equilibrate tra tutela ambientale e sviluppo urbano – se tante realtà urbane e ambientali europee ( in Germania, in Olanda, in Francia, in Spagna e persino in Portogallo) possono vantare trasformazioni e recuperi urbani e ambientali, e nuove realizzazioni, spesso esemplari. Proprio perché questa è la posta in campo, ritrovare cioè un ruolo civile e socialmente rilevante dell’Architettura come lavoro ideativo e costruttivo della forma fisica di una nuova polis, Napoli offre ancora, nel bene e nel male, nell’eccesso incontenibile di figura che da sempre la caratterizza, una potenza tematica e problematica tanto estreme da sollecitare energie ideative e politiche straordinarie, appunto all’altezza dei suoi eccessi. E anche in una dimensione metropolitana essa potrebbe diventare il Laboratorio pubblico di politiche progettuali ambientali e urbane per una grande città mediterranea del terzo millennio. Ricostruire tra le nuove generazioni una cultura storica della città come architettura, non reazionaria e senza nostalgie, e una coscienza dell’architettura come lavoro intellettuale e tecnico necessario per la cura della forma urbana in divenire. Pretendere poteri urbani e territoriali rinnovati, consapevoli di questa missione, dei compiti e delle sfide inedite (ma antiche al tempo stesso) della cura e della tutela della qualità ambientale, dello sviluppo del lavoro nella città e per la città, per il buon vivere in questa città e nella regione, questi gli odierni imperativi. LA FINZIONE DELLA REALTA’ Taryn Rubicone Dopo il Leone d’oro a “Sacro Gra”, il film di Gianfranco Rosi, alla Mostra del Cinema di Venezia, il primo premio del Festival del Cinema di Roma, il Marc’aurelio d’oro, a “Tir”, del documentarista Alberto Fasulo, sembra aver decretato, almeno in Italia, il riaffermarsi di un genere da tempo presente nella cinematografia, quello del documentario d’autore, o, meglio, tanto più nel caso del film vincitore a Roma, del falso documentario o, come si dice generalmente, del “docufiction” d’autore. E del resto, se a Venezia a confermare tale indirizzo del cinema italiano era presente anche un film giocato attraverso filtri documentaristici, “Via Castellana Bandiera”, di Emma Dante, a Roma “L’ultima ruota del carro” di Veronesi, che racconta la vita vera di un uomo qualunque con le sue gioie domestiche ed ipiccoli-grandi affanni, pure sembra avvalorare la tendenza a rendere alla finzione filmica documenti di vita. Il ricorso italiano alla documentazione delbanale in cui trapeli la storia, quella del nostro piccolo paese, non certo protagonista dei grandi movimenti globali, sembra voler controbattere all’invasione dei film, provenienti ormai da tutto il mondo, che investono più ampie epopee e, talvolta, più profondi interrogativi. Controbattere cioè non solo alla filmografia avveniristica ricca di effetti speciali, quanto anche a quella che, come è ad esempio nei molti soggetti sulla politica o sul mondo finanziario, pur volendo documentare il reale, ne indaga i più riposti segreti, ricercandone le ragioni oltre la coltre delle apparenze, sì da manifestare in definitiva il desiderio di sfuggire la più spicciola realtà quotidiana. Il genere docufiction non è certo nuovo, sebbene spesso nei film-documento, a differenza di quelli recentemente premiati in Italia, si tenda a rappresentare realtà drammatiche o a svolgere denunce, o, anche, a rivelare al reale più scarno i tratti poetici, senza soffermarsi sul più lineare scorrere delle cose. Basti pensare al capostipite che forse inaugura il genere, “Nanuk l’eschimese” di Robert J. Flaherty, del 1922, il quale raccontando i riti semplici di una famiglia che vive ai confini del Canada in lotta con una natura inospitale, manifesta un’aspirazione estetica, malgrado sia girato quasi tutto dal vero, che tende a sublimare gli eventi dolorosi, quasi a sfuggire la più cruda realtà (Nanuk morì di stenti due anni dopo il film). Successivamente, negli anni trenta,mentre Flaherty continuerà a documentare, in altri luoghi del mondo,storie simili a quella già narrata, fiorisce, spesso ad opera delle dittature, un altro filone di film-documentari, quello propagandistico, rivolto a mostrare la vita operosa delle città. Tra questi, i film sovietici di Vertov, che si sottraggono alla retorica di regime, come ad esempio “L’uomo con la macchina da presa”, del 1929, girato con la cinepresa in spalla a documentare la giornata di una anonima cittadina senza percorrere alcuna narrazione e allestito attraverso un sapiente montaggio di musica e immagini lungo la linea delle avanguardie sebbene già condannate. Dello stesso genere è anche “Berlino, sinfonia di una città”, di Walther Ruttmann, del 1927, montato con spezzoni brevi e, quindi, immagini in rapido movimento, al fine di mostrare l’agitarsi frenetico della città la quale, ripresa tra l’alba e la sera, viene intesa come un grande organismo vivente. Anche qui la colonna sonora concorre a rievocare i modi dell’avanguardia e, sebbene il film fosse stato approvato dalla censura, la critica di regime, rilevando l’eccessivo movimentismo, annotò come questo non consentisse, così come era nei film sovietici, di soffermarsi sulla bellezza e sull’austerità dei luoghi. Ed invero, i ritmi più lenti impressi da André Sauvage, nel 1928, a ”Étudessur Paris”, offrono di fatto, pure alla sobria realtà delle vetrine e della periferia, una impronta poetica che però tradisce in parte la frivola follia e l’ansia del nuovo che caratterizzava la capitale francese negli anni venti. Tra i film-documentari d’autore non possono non essere citati “Nogent” (1929) di un giovane Marcel Carné, in cui è documentata, con atmosfere impressioniste, una domenica estiva in una cittadina sulla Marna, con canottieri e ragazze che raccolgono fiori, o il puro gioco del montaggio di Ejzenstein, in “Romance sentimentale” girato nel 1930 a Parigi, o ancora “Las Hurdes”, del 1932, di Buņuel, che narra di una zona montagnosa, tra le più povere della Spagna, con fenomeni incestuosi e l’espandersi delle malattie, avendo come sfondo sonoro, in un surreale contrasto con la crudeltà delle scene e del racconto, l’opera tra le più classiche di Brahms, la quarta sinfonia, sino a finire con “La vie est à nous” del 1936, commissionato dal Partito Comunista a Jean Renoir, in piena occupazione nazista, per documentare lo spirito vivo della Francia. Può dirsi quindi, da questi pochi esempi, che, in origine, i film-documento, documentari i quali seguivano una sceneggiatura ricostruendo la realtà oltre il suo darsi immediato, fossero rivolti o ad esaltare, in vari modi, elogiativi o poetici, esperienze di vita, o a mostrare eventi e cose da sottoporre alla analisi o alla denuncia critica. Ed è a questo tipo di cinema, proprio nei modi di utilizzare la cinepresa e il montaggio, che si ispirano i registi italiani del neorealismo i quali, appunto, macchina in spalla, ricostruiscono sullo schermo la difficile realtà del nostro paese. E’ indicativo a mostrare come sia il film-documentario ad ispirare il cinema italiano del dopoguerra che, mentre un regista non propriamente neorealista, Michelangelo Antonioni, esordisce con un corto, nel 1943, sulla “Gente del Po”, per proseguire nel 1948 con “N.U.” un filmato sul lavoro degli spazzini di Roma, nel 1945 Giuseppe De Santis, il quale era stato l’animatore del quindicinale Cinema, diretto da Vittorio Mussolini (figlio del duce) critico dei “telefoni bianchi” e della cultura del regime, giri, con altri giovani registi, tra cui Luchino Visconti, “Giorni di gloria”, sui diversi episodi antitedeschi a Roma, in cui sono montati documenti autentici e azioni ricostruite. Il neorealismo”, però, pur ispirandosi ai modi del film-documento, segna in realtà la separazione del cinema dal docufiction e, mentre quest’ultimo evolve sino ai più recenti esperimenti di Lynch, Tornatore, Stone, Bellocchio, che costruiscono storie attraverso spezzoni documentari, approdando alla poesia di Byambasuren Davaa (“Storia del cammello che piange”) o alla critica acida diMichael Moore, il cinema-fiction, dimenticando la macchina in prolungamento dell’occhio, ha utilizzato, anche per film ispirati alla realtà, tecniche sempre più sofisticate tali da offrire, con il reale rappresentato, tutto il senso della finzione, di un raccontare cioè che tocca la vita, con i suoi sentimenti, impulsi,ragioni, attraverso personaggi e cose privi “di ogni riferimento a fatti realmente accaduti” messi in scena attraverso i dispositivi “magici” offerti dal mezzo cinematografico. Questo non sembra essere il caso dei roadmovie all’italiana “Sacro Gra” e “Tir”. Sebbene nel primo sia messa in scena direttamente la realtà, quella anonima che fiorisce intorno al raccordo romano, al contrario del secondo, in cui la storia del professore croato che si fa camionista è totalmente inventata, entrambi i film vogliono mettere in evidenza i dispositivi di documentazione filmica del reale, quasi a manifestare, in tempi in cui la finzione sembra sopravanzare la realtà e ispirandosi forse al pensiero recente di Maurizio Ferraris, l’urgenza di affidarsi alle cose concrete, di guardarle in faccia in tutta la loro evidenza, onde provare a riconoscerle oltre la patina delle interpretazioni. Se tuttavia così fosse veramente, i due film ci riporterebbero necessariamente in pieno neorealismo. E, invece, così non è, dal momento che le tipologie dei movimenti di macchina (si pensi alle riprese degli interni di abitazione in un edificio-torre della periferia romana dall’esterno delle finestre, in “Sacro Gra”, o alle prospettive grandangolari di “Tir”) sono quelle della più estenuata fiction, persino della fiction televisiva (la cabina del tir come quella del Grande Fratello), mentre gli artificiosi montaggi non hanno la freschezza del cinema italiano del dopoguerra. Viene fuori in entrambi i film un modo eccessivamente cerebrale e, in fine, inaccettabile, di fare cinema, secondo cui, da un lato, si vuole legare la fiction alla vita, fare della vita fiction o della fiction vita, e dall’altro si esaltano i più sofisticati modi di fingere la realtà, sino a confondere i piani del reale e della finzione sì da non offrire spazio né alla ragione critica né al sogno. C’è inoltre da dire che, mentre il neorealismo del dopoguerra impose il cinema italiano in campo internazionale, i due film premiati a Venezia e Roma forse a stento raggiungeranno il mercato nazionale. Né il premio romano per la miglior attricea Scarlett Johansson, la quale oltretutto ha snobbato la passerella finale, servirà ad alimentare le azioni del nostro cinema, se si producono film come i due premiati nelle kermesse nostrane, per cui, considerando come film e mostre-festival cinematografici italiani siano prodotti con finanziamenti pubblici, viene da pensare che meglio sarebbe operare nei loro confronti decisi tagli da spending review. VIVIBILITA’ E SOSTENIBILITA’: I NUOVI VALORI DELL’ARCHITETTURA Chiara Granito Il dibattito sull’ambiente che oggi caratterizza diversi luoghi di discussione e l’evidenza di alcune proiezioni statistiche non lasciano più spazio a dilazioni: la crisi ambientale è il territorio dei prossimi 50 anni di impegno scientifico, politico, tecnico e progettuale e il suo controllo diventa una sfida di dimensioni macroscopiche che coinvolge la scala planetaria, dove si apre uno scenario di opportunità future. La sfida è trasformare un sistema economico, tecnologico, politico, industriale basato sulla distruzione ambientale, sul collasso delle nostre città, in un altro culturalmente diverso, basato su una tecnologia “altra” rispetto a quella che ha innescato tutti i fenomeni di aggressione all’ambiente, una tecnologia congruente con le condizioni ambientali. “Dall’applicazione del concetto esigenziale ai comportamenti organici degli edifici verso un’architettura ambientalmente coerente devono essere definiti contenuti progettuali che corrispondano ai nuovi problemi e nello stesso tempo riscontrino valori storicamente autentici dei luoghi e non solo di maniera”1. Confrontarsi con questa sfida richiede un approccio capace di integrare creatività e innovazione tecnologica. Gli strumenti tecnici oggi sono disponibili, ma occorre una maggiore maturità intellettualesche porti ad una revisione dei modelli culturali di approccio alla progettazione e alle responsabilità “meta progettuali”, intese nel senso più ampio del termine. “Superato il primo decennio del secolo, caratterizzato dalla globalizzazione e da un’acuta crisi economica di una parte del mondo, è lecito chiedersi se esistano orientamenti per far riemergere primati scientifici e culturali passati e recenti, se esistano modi, idee, innovazioni in grado di ispirare nuovi rinascimenti, oppure se la condizione di crisi sia talmente strutturale da fare immaginare un duro riallineamento del nostro Paese e di tutta l’Europa nei confronti delle economie emergenti”2. Se si provasse a rappresentare alcuni indicatori del mondo per gli ultimi decenni, senza concentrarsi esclusivamente sull’Occidente, o sull’Europa, apparirà chiaramente la grande mobilità delle variabili e la grande trasformazione delle condizioni di vita avvenute, per giunta, con impressionante rapidità. La crisi ambientale delle nostre aree metropolitane, ci fa da tempo riflettere sulla necessità di ridefinire il ruolo del sistema antropico nei confronti del sistema naturale su cui insiste. Diventa sempre più impellente attribuire un valore economico alle risorse ambientali o, in altri termini, riferirsi agli ecosistemi per interpretare e riorganizzare le attività insediative. L’Europa affronta una sfida di notevole portata e Parlamento e Commissione Europea cercano di introdurre politiche e strumenti in grado, possibilmente, di vincerla. Tradurre la volontà di modificare il mix energetico del nostro continente in un’azione degli Stati membri per ridurre, entro il 2020, del 20% i consumi e trasformare un ulteriore 20% della conversione energetica europea in fonti rinnovabili, si concretizzerà nello sviluppo di numerosi Piani d’Azione a scala urbana, regionale, nazionale. Lo strumento attualmente più utilizzato, in risposta a tali obiettivi, è la pianificazione strategica degli insediamenti sostenibili. Gli eco-quartieri, infatti, riuniscono due concetti complementari che li rendono più accessibili per l’habitat umano e allo stesso tempo favoriscono un minor consumo di risorse naturali: compattezza e complessità. La compattezza presuppone il raggruppamento di edifici con un livello minimo di densità, sufficiente affinché possano coesistere attività diverse e, di conseguenza, un trasferimento di informazioni e relazioni. La complessità è l’altra faccia della medaglia della compattezza: rappresenta la diversità delle attività umane localizzate nelle diverse parti del quartiere. In questo modo, l’insediamento “compatto e complesso” non solo facilita mobilità e accessibilità, ma permette inoltre di dedicare più tempo alle attività sociali o personali, che nelle città diffuse inevitabilmente si perde. L’ idea di sostenibilità nei modelli urbani comporta l’ interrelazione degli interventi territoriali per la configurazione della città con fattori legati all’ambiente, al paesaggio, alla gestione ottimale delle risorse naturali e alla promozione di coesione sociale e partecipazione cittadina. Non e possibile intervenire su una parte del mosaico urbano senza considerare le ripercussioni sul resto degli ambiti. Questa prospettiva sui modelli urbani e sulla configurazione degli insediamenti non si sviluppa solo da un punto di vista strettamente territoriale, bensì attraverso un approccio integrale, poiché, come appena indicato, l’organizzazione del territorio ha un’influenza diretta sia sulla mobilità che sulla gestione delle risorse naturali, sull’efficienza energetica e sugli aspetti relativi alla coesione sociale e allo sviluppo economico. Anche la gestione delle risorse naturali presenta una chiara dipendenza dal modello di organizzazione urbana del quartiere. Una maggior necessità di sfruttamento delle risorse naturali, materiali o energetiche è collegata ad una maggior inefficienza nella configurazione spaziale, e pertanto ne subisce l’influenza. Questo rapporto tra inefficienza del modello di organizzazione urbana ed impatto ambientale si manifesta anche con una maggiore generazione di residui inquinanti ed emissioni nell’ atmosfera di particelle o gas effetto serra, con il conseguente impatto sugli effetti de1 2 G. Peretti, La complessità del progetto contemporaneo per un'architettura responsabile, Di Baio, Milano, 2009. R. Pagani, Efficienza energetica e innovazione nei sistemi urbani: i trend che sfidano la crisi, Techne, Milano, 2011. rivati dal cambiamento climatico. Infine, la coesione sociale costituisce un obiettivo prioritario del modello urbano sostenibile, ma l’ idea di coesione sociale non e un’ astrazione, si sviluppa fisicamente sul territorio, spazio dove i cittadini svolgono le proprie attività. In questo senso la coesione sociale e la coesione territoriale sono parte di uno stesso concetto ed è perciò evidente la necessità di operare secondo un approccio integrato3. “Affrontando questo tema, spesso, si parla quasi esclusivamente di «sostenibilità dei materiali e dei prodotti», legata a tecnologie e norme. Esiste una fondamentale «sostenibilità dei metodi e dei processi», che tende a migliorare la comprensione dei problemi e la qualità delle decisioni”4. Se l’innovazione si esplica quando un processo di cambiamento raggiunge una massa critica tale da superare l’inerzia del “sistema ortodosso”, è solo insistendo su metodi e processi nuovi e innovativi che si può pensare di rafforzare la responsabilizzazione degli attori che vivono e operano localmente e rafforzare i concetti di “partnership” e “coinvolgimento” su obiettivi precisi. Quartieri a gestione intelligente, fonti rinnovabili decentrate e centralizzate, eco-building, info-mobilità, combustibili alternativi, nuovi veicoli, reti avanzate, soluzioni decentrate, sono ambiti di ricerca e sviluppo dall’impatto potenzialmente rivoluzionario sui nostri tessuti urbani, ma al tempo stesso sulle nostre strutture di governo, su quelle professionali, sui nostri sistemi formativi e di ricerca in quanto la città complessa richiede necessariamente una formazione adatta alla complessità. Quest’ultimo è un tema di cui si parla molto anche in Italia, peraltro non sempre a proposito, e che meriterebbe un discorso a parte. Basti qui ricordare che la crescente complessità degli attori in gioco (si pensa all’importanza assunta dalla partnership fra pubblico e privato nei meccanismi di trasformazione della città contemporanea) impone un orizzonte di riferimento più ampio di quello tradizionale: quello appunto garantito dalla governance della città e del territorio, che non è “governo” ma va invece intesa come sistema di reti auto ed interorganizzate, in grado di definire ed implementare gli obiettivi politici pubblici con processi che mirano al dialogo, al compromesso e alla negoziazione fra soggetti governativi, amministrativi e privati, comunità, ONG, associazioni non-profit ecc. Tutti punti, questi appena elencati, da tempo radicati all’interno del miglior dibattito sulla qualità urbana: se ne ritrovano i semi nei primi anni Sessanta con gli studi di Jane Jacobs, che misero in evidenza l’importanza delle dimensioni del quartiere, della nozione di vicinato, e in particolare, dei marciapiedi urbani, con il loro intrecciarsi di funzioni diverse e il riscontro sociale che, involontariamente quanto utilmente, ne deriva, e di Kevin Lynch, che puntarono invece alla leggibilità degli spazi, alla loro vitalità, varietà e “figurabilità” 5. Non solo forma, spazio e tecnica, quindi, nella definizione degli obiettivi prioritari di un approccio sostenibile, ma soprattutto valutazione dell’incidenza che il modo di “abitare” può avere sull’ambiente circostante e quanto quest’ultimo influenzi il comportamento e le relazioni umane sia in termini di governance che di socialità. E’ infatti fondamentale comprendere se la sfrenata corsa al raggiungimento della tanto agognata efficienza energetica e alla realizzazione di insediamenti a “zero emissioni” proceda di pari passo con la considerazione delle reali necessità degli abitanti che, pur certamente educandosi alla sostenibilità, non dovranno però vedere limitata la propria vivibilità. Tale considerazione nasce dalla recente pubblicazione dei risultati prestazionali riguardanti i più noti esempi di quartieri sostenibili progettati da archistar ritenute esperte nel settore della progettazione sostenibile: si è potuto così notare che gli elevati livelli di efficienza energetica raggiunti contrastano con i bisogni degli abitanti che si considerano limitati nel modo di vivere le proprie abitazioni perché, proprio quegli elementi architettonici e tecnologici che avrebbero dovuto incidere sull’abbattimento delle emissioni inquinanti, in realtà determinano la non fruibilità degli spazi a causa di non corrette condizioni di illuminazione, calore e ventilazione, tutti requisiti necessari a garantire una buona vivibilità. Un esempio tangibile è rappresentato dall’ecoquartiere BedZed, realizzato a Sutton nella periferia sud-est di Londra, progettato dall’architetto Bill Dunster. Annualmente, infatti, Bioregional, associazione ambientalista no profit britannica, pubblica i risultati dei monitoraggi e delle verifiche sugli impianti che contribuiscono all’autonomia energeticadell’insediamento e, attraverso questi dati, è possibile capire come il raggiungimento della sostenibilità globale non sempre corrisponde agli obiettivi prefissati attraverso una valutazione ex-ante e, soprattutto, come i sistemi tecnologici che dovrebbero aumentare le prestazioni energetiche degli edifici non tengono conto del comfort interno invece ricercato necessariamente dagli abitanti. Così, nel caso specifico, si scopre che il sistema di cogenerazione alimentato a biomassa non ha mai funzionato correttamente e per questo è stato abbandonato nel 2005costringendo alla dipendenza dalle reti nazionali di approvvigionamento del servizio dell’energia; il sistema di teleriscaldamento si è rivelato problematico, così come sono emerse difficoltà nella fornitura di acqua calda in alcune abitazioni; anche l’impianto di recupero e riciclo delle acque reflue del BedZed è stato abbandonato a causa degli elevati costi di gestione. Il default non riguarda solo gli impianti ma anche que3 R. James, Promoting Sustainable Behavior, Berkeley University of California, 2010. R. Pagani, op. cit., Techne, Milano, 2011. 5 P. B. Evans, Livable Cities? Urban Struggles for Livelihood and Sustainability Paperback, University of California Press, 2002. 4 gli elementi che nell’immaginario collettivo contraddistinguono il quartiere: i coloratissimi camini a vento e le grandi serre, o meglio i “sunspaces”. I convettori hanno nel tempo perso velocità e quindi rendimento, ed inoltre sembrano non svolgere correttamente la loro funzione di riciclo dell’aria generando disagi per i residenti; lo stesso accade per i sunspacesche si surriscaldano eccessivamente nella stagione estiva, gravando in modo significativo sui costi di gestione degli impianti, soprattutto per il controllo del comfort igrotermico interno agli alloggi. Diversi, quindi, sono i problemi segnalati dai residenti che tuttavia si ritengono soddisfatti dell’aspetto sociale del loro quartiere: la presenza di giardini pensili, attività culturali e commerciali integrate, spazi comuni da gestire ha reso possibile generare relazioni che in altri luoghi “tradizionali” difficilmente potrebbero svilupparsi. Bisogna in ogni caso considerare che BedZed è stato un esperimento pilota, il primo a cercare di abbattere i costi energetici dell’architettura e a ricercare “il connubio tra l’utilizzo ottimale delle risorse naturali rinnovabili e l’aumentare dell’autonomia energetica degli insediamenti urbani, incentivando il coinvolgimento sociale degli abitanti”6. L’aspetto che stupisce è che il raggiungimento della sostenibilità ambientale e costruttiva abbia comportato una scarsa attenzione verso la sostenibilità sociale dei singoli residenti comportando un livello di vivibilità non all’altezza delle aspettative. Negli ultimi anni la questione della liveability – la “vivibilità” degli insediamenti vista come organizzazione spaziale di persone e di luoghi, un termine forse meglio traducibile in italiano con la locuzione “qualità della vita” – è diventata fra le più importanti e significative per il nostro futuro. Si tratta, evidentemente, di una nozione che contiene un alto grado di arbitrarietà e soggettività, ma, nonostante ciò, il consenso sui fattori che la determinano è sempre più ampio e condiviso. “In generale, la qualità della vita si determina quando vengono rispettate alcune condizioni in almeno tre ambiti fondamentali: la qualità ambientale, la piacevolezza alla scala di quartiere o di vicinato, il benessere individuale degli abitanti” 7. Fra le principali atouts urbane, una delle più controverse è costituita dalla elevata densità residenziale, la sola in grado di permettere aree verdi e servizi ma soprattutto trasporti pubblici efficienti sia urbani sia alla scala metropolitana e regionale. Si tratta di una questione molto dibattuta: pressoché tutti gli studi più recenti concordano sul fatto che densità elevate, purché opportunamente pianificate, possono contribuire notevolmente a ridurre la cosiddetta “impronta ecologica” delle città: minor consumo di territorio; minori investimenti nei trasporti pubblici, nelle reti fognanti ed elettriche ecc., meno strade con meno auto (queste ultime, se ben progettate, più efficienti dal punto di vista dei consumi). Ma altrettanto importanti, e più facilmente condivise, sono la positiva presenza di spazi pubblici a dimensione umana, attraenti, sicuri, pedonalizzati e polifunzionali; di un’atmosfera culturalmente e socialmente stimolante; di una mobilità che privilegi la bicicletta e i già citati mezzi pubblici; di condizioni economiche buone e diffuse, in modo da non avere sensibili squilibri sociali; di condizioni ambientali tali da garantire una generale condizione di sostenibilità. Quest’ultima, in particolare, va applicata al settore delle risorse idriche ed energetiche, all’edilizia verde ed ecologica, oltre che al rispetto per la biodiversità e l’ambiente in generale, ed è nozione che si sovrappone spesso a quella di vivibilità, condividendone in maniera sostanziale l’interesse a garantire ai cittadini una migliore esistenza 8. E’, dunque, lecito chiedersi se sia giusto privilegiare questo nuovo “high-tech” con l’etichetta sostenibile o se invece sia più corretto ripensare globalmente ad un modello progettuale, sia in termini di pianificazione che di edificazione, che consideri prioritaria l’integrazione con l’ambiente circostante recuperandone il “genius loci”, elemento allo stesso tempo materiale nella trama urbana e nelle forme architettoniche dell’insediamento, ed immateriale nelle relazioni sociali, nei modi di vita, nelle relazioni con lo spazio e il tempo; tutti reali fattori di vivibilità che si sostanziano nei comportamenti ma che strutturalmente e fisicamente rimangono impercettibili. 6 BedZed: grande flop o progetto troppo ambizioso?, www.rinnovabili.it, 2007 - «Il Giornale dell’Architettura», n. 57 dicembre 2007. A. Corradi, Le incerte vie della sostenibilità. Aziende di servizi pubblici e servizi per l'ambiente, FrancoAngeli, Milano, 2011. 8 C. Manning, The Psychology of Sustainable Behavior, Minnesota Pollution Control Agency, 2009. 7 L’ARTE GUARDATA DALLA SCIENZA Brunella Velardi Aby Warburg non avrebbe forse immaginato (o invece si?) a quali risvolti avrebbe potuto portare il suo approccio interdisciplinare alla storia delle immagini, che nei primi decenni del ‘900 era cosa del tutto nuova. Certo è che senza quel suo progetto di unire insieme tutti i campi del sapere in un’unica grande opera-biblioteca dal nome Mnemosyne, che ne fece uno dei primi e più geniali interpreti delle teorie della complessità che largo successo trovano in questi anni, la ricerca storico-artistica non sarebbe oggi così ricca di contaminazioni e non avrebbe raggiunto esiti così sorprendenti da incuriosire tanto anche i non addetti ai lavori. Ciò di cui si sta parlando è l’accostamento delle neuroscienze allo studio delle opere d’arte e delle immagini in generale, secondo diverse modalità e attraverso differenti competenze. Il collegamento ormai più immediato tra le due discipline avviene mediante la scoperta del sistema dei neuroni-specchio e la sua applicazione all’osservazione di immagini – e non solo di altri esseri umani nei quali l’identificazione è più immediata; in questo caso l’analisi critica viene notevolmente agevolata grazie alla scoperta di un effettivo, fisiologico e specifico atteggiamento da parte dell’osservatore in presenza di una data opera. Diversi e complementari alle esperienze di cui si è appena parlato sono gli esiti degli studi del neurobiologo Semir Zeki, padre fondatore della neuroestetica, il cui intento è quello di analizzare ciò che accade a livello puramente neurologico nell’atto di osservare un’immagine; sono però utili a spiegare alcuni paradossi legati alla visione. E dal punto di vista dell’evoluzione della critica d’arte rivelano in realtà l’importanza fondamentale e pionieristica delle teorie purovisibiliste dalle quali la critica novecentesca e in particolare quella warburghiana si distaccò nettamente. Il suo saggio Neurologia dell’ambiguità1 è un interessante studio sulle implicazioni neurologiche originate dalla visione di immagini “ambigue”. Affermando che “la percezione…partecipa attivamente alla costruzione di ciò che vediamo”, l’autore offre un terreno fertile per le nuove ricerche storico-artistiche, da Michelangelo alla Land Art, dalla pittura alla scultura e alla video arte. Per qualunque immagine che ci venga sottoposta, e il cui significato o contenuto non sia univoco - vale a dire che propone più interpretazioni possibili - sia essa artistica, pubblicitaria, cinematografica, documentaria etc., il cervello visivo è in grado di elaborare alternative ugualmente valide, ognuna delle quali, raggiunto lo stato di coscienza, ci apparirà di volta in volta predominante. Ciò è particolarmente evidente nel caso di immagini rappresentanti illusioni ottiche (come il triangolo di Kanizsa, in cui sembra di vedere un triangolo sebbene non ne siano rese le linee di contorno) o forme non immediatamente distinguibili come collegate a uno specifico significato (moglie/suocera, vaso di Rubin, cubo di Kanizsa, taluni esperimenti di op art). Nel primo caso siamo di fronte a una incompletezza, che il nostro cervello si incarica di integrare, affinché possiamo riconoscervi una figura nota; i fenomeni che potrebbero essere ricondotti a questa tipologia sono, per esempio, quello della percezione della luce, che ci fa apparire come continuo un flusso che, nella realtà, è intermittente, o quello della percezione dell’immagine cinematografica, costituita da una serie di singoli fotogrammi fatti scorrere velocemente davanti a un fascio di luce. L’ intervallo tra un fotogramma e l’ altro, che l’occhio umano non è, evidentemente, in grado di riconoscere, viene annullato dall’azione integrativa del cervello visivo, in modo che percepiamo soltanto il movimento delle figure. Un ulteriore esempio ci è fornito da Meyer Schapiro quando, a proposito del quadro di Mondrian Pittura I (Composi-zione in bianco e nero) del 1926, in cui una composizione di linee è “tagliata” dai bordi della tela, osserva che “è impossibile limitarsi a considerare le bande nere esclusivamente come segni dipinti separati, compiuti, diseguali e irregolari, perché, non appena le guarderemo tutte insieme, non potremo non vedere un quadrato. … siamo portati a completare le forme della sua apparenza, quasi esse continuassero in uno spazio limitrofo e invisibile”2. Nel secondo caso, invece, si tratta di vera e propria ambiguità: in questa circostanza il cervello non ha bisogno di operare con integrazioni, ma si attiva perché giungano allo stato di coscienza, alternatamente, le due (o più) possibili soluzioni. Zeki definisce bi-stabili le immagini dotate di tali caratteristiche e nota che anche l’eventuale aggiunta di elementi che costringessero il cervello a un’ interpretazione univoca della figura risulterebbe inefficace: “l’ambiguità, in altre parole, è stabile”. 1 2 S. Zeki (2004), in G. Lucignani, A. Pinotti, Immagini della mente. Neuroscienze, arte filosofia, Raffaello Cortina Editore, 2007. M. Schapiro, Mondrian. Ordine e casualità nella pittura astratta, in L’arte moderna, Einaudi, 1986. Esiste poi una terza situazione rilevante ai fini dell’analisi criticoartistica, in cui il cervello è sottoposto allo stimolo dovuto alla visione di un colore (che, come sappiamo, risulta dall’emissione di determinate lunghezze d’onda da parte della superficie “colorata” in seguito ad un irraggiamento - ad ogni tinta corrisponde un certo range di lunghezze d’onda). Quando le lunghezze d’onda non sono costanti, nel processo di percezione viene operata una sintesi, cosicché dal punto di vista cromatico avremo una visione omogenea. Si tratta di un procedimento messo in atto già empiricamente, in campo artistico, dai mosaicisti prima e dai puntinisti poi, e che trova ora una spiegazione scientifica. L’autore dimostra la possibilità di applicare gli studi di neuroestetica al campo della critica d’arte rifacendosi ad alcuni esempi celebri. Per quanto riguarda la questione della ambiguità, affermando che questa può essere riferita non solo all’ aspetto prettamente ottico ma anche a quello interpretativo, egli propone il caso del dipinto di Vermeer La ragazza con l’orecchino di perla, nel quale lo sguardo della ragazza può essere percepito come timido o accogliente, casto o carico di erotismo. Le sculture “non finite” di Michelangelo, e in particolare la Pietà Rondanini, forniscono invece un buon esempio di quell’incompletezza che stimola la produzione di integrazioni a livello cerebrale (per dirla con Belting, non solo possediamo, ma produciamo anche immagini). Sono molti gli spunti di riflessione offerti da una lettura comparata di Neurologia dell’ambiguità e scritti di altri critici contemporanei. Innanzitutto, gli studi di Louis Marin sulla pittura di Poussin3 e, più specificamente, sull’individuazione di ‘segni significanti’ che, inseriti nel dipinto, danno all’osservatore informazioni sul contenuto semantico della rappresentazione, richiamano alla mente le parole di Zeki: “Una delle funzioni del cervello è quella di fornire senso a questo mondo, ai segnali che da esso riceve” e dunque “se la funzione dell’arte corrisponde a un’estensione delle funzioni cerebrali, tese ad acquisire conoscenza del mondo, allora è ragionevole supporre che i meccanismi utilizzati per attribuire il senso al mondo siano davvero gli stessi impiegati per attribuire il significato alle opere d’arte”. Pertanto non solo esiste una forte connessione tra i processi di conoscenza del mondo e quelli di conoscenza dell’opera d’arte, ma tali processi sono anche osservabili su base neurologica: si può dire infatti che se un segno è qualcosa che sta ad indicare un significato – e nel caso dell’arte in presenza di un tratto, un gesto, un colore che ‘vogliono dire’ qualcos’altro, il cervello è indotto a ricostruire quel qualcos’altro al pari di come ricostruisce i lineamenti mancanti del Cristo della Pietà Rondanini. Senza l’intervento produttivo insito nella dinamica della percezione, infatti, gran parte delle opere d’arte, i simboli e le metafore, ci risulterebbero privi di senso. Ancora Marin ci riconduce all’attività integrativa del cervello a proposito del rapporto tra parola e immagine: “poiché sia queste righe sia queste pagine saranno senza immagini, senza quadri, in una parola senza illustrazioni, si tenterà nel descrivere le immagini e i quadri, di farli vedere, proprio perché attraverso le fantasticherie del lettore sullo scritto, e anche attraverso le immagini della memoria che ogni lettura richiama, la voce ai margini di quest’immagine o di quel quadro, si ricongiunga, tramite questa mediazione doppia e “immaginaria”, ai segni scritti e letti che silenziosamente la articolano in questo testo”. Quelle che Marin chiama “fantasticherie” non sono forse quelle attività cerebrali che, pezzo dopo pezzo, con l’ausilio di parole, memoria, conoscenza pregressa del mondo, ci permettono di ricostruire le immagini monche, incomplete, il Cristo di cui si parlava? Non importa infatti che le fonti che abbiamo a disposizione siano iconiche o verbali, o in parte iconiche e in parte verbali (come accade ad esempio nel dipinto Et in Arcadia ego, in cui la scritta che dà il titolo al quadro compare su un sarcofago, contribuendo dunque al valore semantico dell’ immagine): ciò che importa è che siano delle fonti, ovvero che costituiscano una base su cui il nostro intelletto può costruire il resto. Viene allora da chiedersi se lo stesso discorso non possa essere fatto a proposito di fonti che coinvolgono altri sensi. Più precisamente, se quando leggiamo o ascoltiamo delle parole il nostro cervello produce immagini a queste connesse, vuol dire che entrano in gioco meccanismi simili a quelli che si attivano quando vediamo un’immagine? E in tal caso, allora gli stessi meccanismi entrerebbero in gioco anche quando ascoltiamo? Se così 3 Cfr. L. Marin, Della rappresentazione, Meltemi, 2001. fosse, si potrebbe parlare di ambiguità percettiva quando vediamo la scena di un film della quale non capiamo il significato, se per esempio si voglia rappresentare una situazione di tranquillità o di pericolo imminente. E’ per questo che il regista fa ricorso alla colonna sonora: la musica che accompagnerà la scena fungerà da discriminante di una interpretazione rispetto a un’altra, e senza di essa l’immagine ci risulterà ambigua al pari della Lezione di piano di Vermeer, cui fa riferimento Zeki. In ogni caso, rimane centrale il ruolo del soggetto, che contribuisce kantianamente al procedimento di acquisizione fornendo un imprescindibile bagaglio di memoria e di esperienza (è l’esperienza stessa, d’altra parte, che ci fa riconoscere quel sottofondo musicale come angosciante e quell’altro come rilassante). La centralità del soggetto è un tema ripreso da Hans Belting nel saggio Immagine, medium, corpo4, in cui l’autore sostiene che il significato di un’immagine “diviene accessibile solo nel momento in cui si prendono in considerazione altri fattori non iconici quale medium e corpo”, intendendo con il primo lo strumento tramite cui le immagini vengono trasmesse, e con il secondo sia il corpo che agisce sia quello che percepisce. Qui entrano in gioco, accanto alla percezione che l’osservatore ha dell’opera, anche le percezioni che, per così dire, hanno colpito l’artefice prima dell’ esecuzione di quell’opera e continuano a interagire durante il suo lavoro. In tal modo il supporto (medium) può essere visto come un’ interfaccia tra gli stimoli sensoriali che transitano da un corpo all’ altro (“Le immagini …]non esistono di per sé, ma accadono; hanno luogo sia che si tratti di immagini in movimento - nel cui caso è ovvio - sia che invece si tratti di immagini statiche. Esse accadono grazie alla trasmissione e alla percezione”). Naturalmente tali stimoli non produrranno gli stessi effetti nei due soggetti (così come non producono gli stessi effetti nello spettatore che osserva l’opera più volte a distanza di un certo periodo di tempo, come ci dimostra T. J. Clark in The Sight of Death: An Experiment in Art Writing), ma ognuno di essi integrerà gli stimoli percepiti con il proprio bagaglio di esperienza per (ri)costruire un’esperienza nuova. E’ evidente quindi che quello specifico tipo di attività cerebrale su cui si sofferma Semir Zeki ha una funzione strutturale, per dirla in termini architettonici, e che senza di essa molto probabilmente non esisterebbe la cultura, ma solo una serie di conoscenze slegate tra loro. Sostiene ancora Belting che il medium regola la percezione da parte dello spettatore, nel senso che un’ immagine presenterà determinate qualità a seconda del medium che la trasmette. Ma ovviamente una volta che noi avremo memorizzato quell’immagine, essa rimarrà nella nostra mente separata dal suo medium originario. Ciò vuol dire che, riprendendo Zeki, esiste un’ambiguità che non riguarda le molteplici interpretazioni delle forme rappresentate nell’immagine, ma le molteplici interpretazioni che daremo a quell’immagine a seconda del medium attraverso il quale ci sarà sottoposta (un dipinto posso vederlo dal vivo sulla sua tela, fotografato, proiettato, ripreso in televisione, e in ultimo posso vedere anche il ricordo del dipinto che si è impresso nella mia memoria); saremo inoltre in grado di attribuire ogni interpretazione al medium che ce l’ha resa possibile, e di distinguere le varie interpretazioni tra loro. Il saggio di Belting ci riporta ancora all’ambito della neurologia quando scrive che le nostre immagini “non hanno una loro esistenza autonoma. Esse vivono nella nostra mente come “tracce e iscrizioni” di immagini viste nel mondo esterno”. Questo vuol dire che ciò che ci induce a considerare la figura di Kanizsa un triangolo è la nostra memoria ‘attiva’ (quella responsabile della produzione di immagini), che rimette in circolazione le tracce lasciate dall’ acquisizione di triangoli già visti e identificati senza ambiguità come tali. Durante e dopo il processo di acquisizione, inoltre, il corpo interviene modificando, censurando, memorizzando. A questo proposito dovremmo aggiungere che, in realtà, alcune selezioni vengono effettuate già al momento della sensazione ottica, al punto da poter stabilire che “non c’è una correlazione fissa fra il mondo ottico e il mondo della nostra esperienza visiva … C’è l’influenza dell’ esperienza passata e dell’ aspettativa, ci sono le variabili dell’interesse, ci sono l’ “atteggiamento mentale” e l’attenzione” 5. Ciò che si diceva a proposito delle diverse percezioni sensoriali può essere ricollegato alle ricerche di Freedberg e Gallese. Il sistema dei neuroni specchio da loro indagato, infatti, può essere considerato integrativo e complementare rispetto a quello dei ‘nodi essenziali’ di cui Zeki parla riferendosi all’ambito esclusivo della visione, cioè quegli stadi del percorso visivo la cui attività diventa percettivamente esplicita senza la necessità di ulteriori elaborazioni (in altre parole, i momenti in cui un’ attività stimolata dalla percezione visiva raggiunge lo stato di coscienza), poiché chiarisce come l’ acquisizione visiva veicoli anche quella emotiva, tattile e motoria. Ciò vuol dire che, di fronte a un’immagine, il cervello dello spettatore attiva strumenti che gli permettono di apprezzare ciò che vede in modo multisensoriale ed emotivo. Si tratta anche qui di una duplice operazione di percezione-acquisizione, da un lato, e immedesimazione, dall’altro, seguita da una rielaborazione-riproduzione da parte del corpo delle azioni rappresentate e assimilate. In taluni casi i neuroni specchio completano le operazioni dei nodi essenziali, come, ad esempio, nella circostanza in cui parte dell’immagine sia oscurata. Non è un caso che qui gli autori citino i Prigioni di Michelangelo, anch’essi non finiti al pari della Pietà, a proposito dei quali af4 5 H. Belting in A. Pinotti, A. Somaini , Teorie dell’ immagine, Raffaello Cortina Editore, 2009. Cit. E. Gombrich, L’immagine e l’occhio, Einaudi, 1985, p. 207. fermano che “le reazioni tendono ad assumere la forma della percezione di un’attivazione muscolare localizzata nelle stesse regioni corporee evidenziate nella scultura”. La percezione tattile, quindi, si rafforza ed esalta tramite quella visiva. Un altro passo dello stesso saggio ci riporta a una serie di riflessioni sull’ arte: “quando vediamo una parte del corpo di qualcuno carezzata o toccata, oppure due oggetti che si sfiorano, le nostre cortecce somatosensoriali vengono attivate come se il nostro corpo fosse sottoposto a una stimolazione tattile”. Gli autori dei saggi fin qui citati hanno fatto quasi sempre riferimento a opere d’arte moderna; quest’ultima frase tuttavia si adatta perfettamente a un’opera come Palla sospesa di Alberto Giacometti del 1930-31, in quanto è proprio la percezione della stimolazione tattile indotta dall’osservazione dei due elementi della scultura, che oscillando si sfiorano senza mai toccarsi, a provocare quel fastidio di natura erotica su cui insiste l’artista. Allo stesso tempo si può notare come il fenomeno descritto possa essere applicato anche al linguaggio scritto e parlato, rimandandoci di nuovo a Marin e al suo studio su Poussin e il ruolo visivo del discorso, affrontato tra l’altro anche da Michael Baxandall in Forme dell’ intenzione (ed. it. Einaudi, 2000). Qui l’autore si sofferma anche, nel capitolo dedicato a Chardin, sull’influenza indiretta del pensiero lockeiano e newtoniano nella costruzione del dipinto dell’artista francese e suggerisce una lettura dell’opera La donna che prende il tè in una prospettiva scientifica. E’ particolarmente interessante il passo in cui viene posto l’accento su come vengono avvertiti gli oggetti dipinti in base ai loro colori: richiamando la nostra attenzione sul particolare della teiera, posta quasi sul bordo del tavolo, Baxandall spiega come gli oggetti che riflettono luce rossa ci appaiano più vicini rispetto a quelli che riflettono luce blu. In effetti, Chardin tinge il tavolo di rosso e la teiera di colore scuro, perché, se la teiera fosse stata di colore chiaro, sarebbe stata percepita come sospesa nel vuoto. Siamo quindi di fronte a un ulteriore caso di possibile ambiguità: così come la colonna sonora ci avvisa che la scena a cui stiamo assistendo presagisce un pericolo e non rappresenta un momento di serenità o viceversa, qui è il colore a permetterci di percepire la teiera come al sicuro su di un ripiano e non in procinto di infrangersi a terra. Chardin ottiene in tal modo un effetto reso di norma dalla prospettiva. A giudicare dalla frequenza con cui si rintracciano riferimenti al tema dell’ ambiguità, si direbbe che esso occupa davvero un ruolo di primaria importanza nelle indagini storico-artistiche. Gombrich, però, si spinge ancora oltre, quando afferma che “la sorpresa o “trompe-l’oeil” è parte del piacere; … Ci può capitare di voler toccare la superficie per essere completamente sicuri che non vi siano altri trucchi, perché l’effetto visivo è tanto impressionante da sollevare un vero e proprio conflitto fra la nostra reazione e la nostra migliore coscienza” 6. Siamo ben consapevoli del fatto che il trompe-l’oeil è la tecnica dell’ ambiguità per eccellenza, tant’è che, come sottolinea Gombrich, la nostra esperienza, per quanto consolidata possa essere, non basta a smascherare il trucco: l’ambiguità è stabile, ci ricorderebbe Zeki. Se invece non abbiamo alcuna esperienza dell’immagine illusionistica che abbiamo davanti, allora toccarla sarà davvero necessario, o rischieremo di prendere grosse sviste, come quella di considerare Santa Maria presso San Satiro una chiesa dalla pianta a croce greca! Per estensione, allora, possiamo dire che lo stesso uso della prospettiva è finalizzato a una illusione, e di conseguenza a un gioco di ambiguità: quello tra bidimensionalità e tridimensionalità, rappresentazione sul piano e rappresentazione nello spazio, poiché, come sostiene giustamente Schapiro, “si fonda sugli stessi indizi cui egli [lo spettatore] reagisce nel trattare quotidianamente con la realtà visiva del mondo”7. Sebbene non si tratti esattamente di un trompe-l’oeil, infatti, la prospettiva albertiana è costruita proprio per “sorprendere” l’ osservatore con l’accostamento di due concetti opposti: superficie e profondità. Il cervello visivo dovrà quindi lavorare su questa opposizione in cui il piano quadro è concepito come finestra sul mondo, e come dalla finestra possiamo scorgere 6 7 E. Gombrich, op. cit., p. 210. Cit. M. Schapiro, Per una semiotica del linguaggio visivo, Meltemi, 2002, p. 113. oggetti vicini a noi e altri più lontani, così sulla tela tutte le proporzioni sono attentamente studiate perché la finestra appaia quanto più realistica possibile. La prospettiva rinascimentale non è, però, che uno degli strumenti che gli artisti hanno elaborato per rendere le loro immagini realistiche. In Olanda, ad esempio, la pittura moderna ha raggiunto un notevole grado di realismo pur senza ricorrere a quel sistema. Se la finestra albertiana può essere definita il corrispettivo sul piano delle “scatole magiche” fiamminghe, in cui il reale viene miniaturizzato con tutta la sua spazialità, un dipinto come la Veduta di Delft di Vermeer ricorre ad altri espedienti, che appaiono chiariti più dalle ricerche di Keplero sull’occhio che dall’ analisi dell’ opera stessa8. Si tratta di un realismo non costruito geometricamente ma legato alla spontaneità dell’ esperienza visiva, e tuttavia il realismo artistico rimane in qualche modo fonte di ambiguità per l’ osservatore. Ho qui esposto una serie di riflessioni scaturite dalla lettura dei saggi citati alla luce dell’indagine neurologica di Zeki, che sembra costituire un prolifico fondamento per l’analisi delle immagini e, nel nostro caso, delle opere d’arte. Sebbene, come specificato dallo stesso neuroscienziato in un’intervista a «Il Sole 24 Ore», la neuroestetica sia nata utilizzando l’arte per meglio comprendere il funzionamento del cervello, le scoperte che ne sono derivate sembrano fornire l’ appoggio, forse l’ auspicio per una “storia neuroestetica dell’arte”: uno studio che, inserendosi in quel filone di ricerche scaturite dall’insegnamento warburghiano, contribuisce a mettere insieme le tessere di quel grande puzzle che è l’esperienza artistica e allo stesso tempo, con l’ausilio della scienza, getti luce su quella conoscenza emotiva di cui parla Zeki e che proprio dall’ arte è veicolata. 8 Cfr. S. Alpers, Arte del descrivere. Scienza e pittura nel Seicento olandese, Boringhieri, 1984. L’ESPERIENZA URBANA E LA SCUOLA COME CENTRO SOCIALE Stefano Oliverio 1. Le ‘due città’ ovvero comunità, comunione, comunicazione Nel 1630, a bordo dell’Arbella, John Winthrop diede precoce e quasi archetipica espressione a quella che sarà una delle componenti fondamentali dell’ethos americano, ovverosia la centralità dell’idea di comunità: “We must delight in each other, make each other’s condition our own, rejoice together, mourn together, always having before our eyes our Communion and Community in the work, our Community as members of the same body”1. Come ha osservato Thomas Bender, nella nozione di comunità è insito non solo il riferimento a un certo tipo di spazio ma anche a un modo specifico di esperienza: “There is an expectation of a special quality of human relationship in a community, and it is this experiential dimension that is crucial to its definition… Community … is best defined as a network of social relations marked by mutuality and emotional bonds... A community involves a limited number of people in a somewhat restricted social space or network held together by shared understandings and a sense of obligation. Relationships are close, often intimate, and usually face to face. Individuals are bound together by affective or emotional ties rather than by the perception of individual selfinterest. There is a we-ness in a community; one is a member. Sense of self and of community may be difficult to distinguish. In its deepest sense, a community is a communion”2. La community cui si fa qui riferimento è, nell’efficace sintesi di Luciano Gallino, prevalentemente la “comunità locale, cittadina, o villaggio o suburbio”3, la small town, con tutte le connotazioni a essa connesse in termini di risonanze sociali (è il luogo della vicinanza e delle relazioni autentiche), politiche (è la cellula primigenia della democrazia genuina, intesa come partecipazione diretta alle deliberazioni per la conduzione della cosa pubblica), e più generalmente culturali. Da questo punto di vista la small town in quanto community rimanda – sul suolo americano – a ciò che era stato codificato in maniera epocale da Ferdinard Tönnies nella dicotomia Gemeinschaft/Gesellschaft: l’una rappresenta il dominio di “un vivere insieme intimo, privato ed esclusivo”4 in cui “le persone rimangono essenzialmente unite ad onta di tutti i fattori di separazione” 5, l’altra, invece, è un “aggregato meccanico e un artefatto” 6 in cui gli individui “sono essenzialmente separati ad onta di tutti i fattori di unione”7. Se la small town è l’americana Gemeinschaft, la big city è la Gesellschaft in cui, come sintetizzò Louis Wirth nel suo memorabile Urbanism as a Way of Life, “the greater the number of individuals participating in a process of interaction, the greater is the potential differentiation between them. […] The bonds of kinship, of neighborliness, and the sentiments arising out of living together for generations under a common folk tradition are likely to be absent or, at best, relatively weak in an aggregate the members of which have such diverse origins and backgrounds”8. La diade tönniesiana viene così re-interpretata all’insegna di un duplice modo di essere-città e di una duplice condizione cittadina: da una parte l’abitante delle piccole città che conserva l’intimità e l’immediatezza dei rapporti comunitari, quelle relazioni face-to-face che non solo dispensano calore e vicinanza ma sono alla base dell’etica democratica, come osserverà il più grande filosofo della democrazia, John Dewey9; dall’altra i grandi 1 J. Winthorp, “A Model of Christian Charity”, in P. Miller & T. H. Johnson (eds.), The Puritans, New York: 1963, vol. I, p. 198. Prendo questa citazione da R. Jackson Wilson In Quest of Community. Social Philosophy in the United States 1860-1920, Oxford: Oxford University Press, 1968, p. 1. Jackson Wilson nota, a proposito di questo sermone, come “[t]he history of ideas in America had one of its beginnings in an eloquent assertion of the ideal of community”. In una prospettiva analoga, il filosofo sociale e studioso del pragmatismo americano James Campbell ha, a sua volta, sottolineato come “[c]ommunity has long been an important topic in American thought. The question of who we are, and why, could never have been far from the surface of discussion in a society that saw itself engaged in an ongoing process of self-creation. Whatever their model of human perfection, Americans have stressed that the community provides the emotional and moral place where individuals can approximate it” (cfr. “Dewey’s Conception of Community”, in L.A. Hickman, Reading Dewey. Interpretation for a Postmodern Generation, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1998, p. 23). 2 T. Bender, Community and Social Change in America, Baltimore (Maryland): The John Hopkins University Press, 1978, pp. 7-8. 3 L. Gallino, Dizionario di Sociologia, Torino: UTET, 2006, p. 145. 4 F. Tönnies (1889), Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005, p. 3. 5 Ivi, p. 34. 6 Ivi, p. 4. 7 Ivi, p. 34. 8 L. Wirth, “Urbanism as a Way of Life”, The American Journal of Sociology, Vol. 44, No. 1, Jul. 1938, p. 11. 9 “It is said, and said truly, that for the world's peace it is necessary that we understand the peoples of foreign lands. How well do we understand, I wonder, our next door neighbors? It has also been said that if a man love not his fellow man whom he has seen, he cannot love the God whom he has not seen. The chances of regard for distant peoples being effective as long as there is no close neighborhood experience to bring with it insight and understanding of neighbors do not seem better. A man who has not been seen in the daily relations of life may inspire admiration, emulation, servile subjection, fanatical partisanship, hero worship; but not love and understanding, save as conglomerati urbani in direzione dei quali, a partire dalla fine del XIX secolo, gli Stati Uniti stavano impetuosamente movendo, grazie fra l’altro allo sviluppo delle tecnologie della comunicazione. La grande sfida che i pensatori progressisti americani si trovarono a dover fronteggiare fu quella di conciliare il plesso di istanze racchiuso nel duplice modo di essere-città, nella duplice condizione cittadina: come preservare l’intimità e la vicinanza delle small town in una costellazione socio-culturale completamente diversa (che permetteva, fra l’altro, di superare alcune delle angustie della dimensione piccolo-cittadina, prima fra tutte la scarsa eterogeneità di relazioni inter-umane)? Come, d’altro canto, valorizzare al massimo il potenziale emancipativo della grande città – la sua variegatezza in cui si ampliano gli orizzonti esistenziali e in cui si moltiplicano le possibilità di incontro e fertilizzazione incrociata tra stili di vita di diversa natura e provenienza – evitando che l’estensione delle possibilità di comunicazione giunga al punto di rottura della impossibilità di coagulare una vera comunità? In altri termini: se la small town rischia(va) di offrire sì senso di comunità ma al prezzo di una comunicazione inter-umana limitata nelle differenze – e quindi sempre esposta alla minaccia del conformismo e della narrowmindedness –, sulla big city incombe(va) il pericolo che l’intensificazione degli scambi resa possibile dal potenziamento delle reti comunicative non sia solo volano di differenziazione e ibridazione della vita sociale10 ma si tramuti nel dissolvimento di ogni legame comunitario e che l’urbanism as a way of life si riveli il dominio della spersonalizzazione e dello sradicamento. Per dirla con uno slogan che arpeggia sulle categorie adoperate nel suo sermone da Winthrop, insediarsi nell’oscillazione tra small town e big city non significa solo esplorare la versione ‘urbana’ della tönniesiana antitesi Gemeinschaft/Gesellschaft ma anche – e soprattutto – investigare se e in che modo sia possibile conservare l’esperienza della comunità come comunione e, al contempo, quella della comunicazione come amplificazione/valorizzazione delle differenze. È importante sottolineare che, benché il focus nella presente riflessione, sia sulla esperienza urbana, ossia sulla (piccola/grande) città intesa come esperienza, come modo peculiare del nostro Dasein, del nostro essere-nelmondo, ad essa si accompagna, si deve accompagnare sempre – proprio in virtù della costitutiva ‘spazialità’ del Dasein umano (una spazialità comportamentale ed esistenziale prima ancora che topografica) – anche un’esplorazione di come ri-organizzare gli spazi (urbani) al fine di tener insieme in armonia11 comunità come comunione e comunicazione, la we-ness che caratterizza la small town e lo slargamento di orizzonti e l’empowerment individuale propri della grande città (Stadtluft macht frei, secondo l’adagio che Max Weber cita nel suo Die Stadt12). Prima di offrire una interpretazione (non priva di una certa torsione esegetica) di una delle soluzioni che fu avanzata, sul suolo americano, dal più avvertito e raffinato dei pensatori che si sono cimentati con questo tema pressante della modernità (urbana), ossia il filosofo e pedagogista John Dewey, si ripercorrerà per accenni la conferenza che Georg Simmel consacrò alla grande città. La scelta di passare attraverso questo testo del sociologo tedesco non è legata solo alla sua ‘definitività’ e alla sua influenza su gran parte del pensiero novecentesco, quello che si cimenta non solo con l’esperienza metropolitana ma con l’esperienza della modernità tout court, il che non è un caso visto che l’esperienza della metropoli è la quintessenza della vita spirituale contemporanea. Si è motivati anche dal ruolo che la riflessione di Simmel ha giocato nel pensiero americano per la messa a fuoco delle coordinate teoriche per pensare la grande città come incarnazione del carattere tipico della modernità. 2. La metropoli, la vita spirituale e la scuola come centro sociale Ciò che contrassegna l’individualità metropolitana, secondo Simmel13, è l’intensificazione della vita nervosa, dovuta all’incessante e rapinoso flusso di immagini, impressioni, sensazioni cui si è esposti. Mentre nella small town il ritmo della vita mentale è più pacato e abitudinario e favorisce relazioni fondate sulla sfera emozionale, la they radiate from the attachments of a near-by union. Democracy must begin at home, and its home is the neighborly community” (J. Dewey, The Public and Its Problems, in Id., The Later Works, 1925-1953, vol. 2 (1925-1927), edited by J.A. Boydston, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1984, p. 368). 10 “The social interaction among such a variety of personality types in the urban milieu tends to break down the rigidity of caste lines and to complicate the class structure, and thus induces a more ramified and differentiated framework of social stratification than is found in more integrated societies. The heightened mobility of the individual, which brings him within the range of stimulation by a great number of diverse individuals and subjects him to fluctuating status in the differentiated social groups that compose the social structure of the city, tends toward the acceptance of instability and insecurity in the world at large as a norm. This fact helps to account, too, for the sophistication and cosmopolitanism of the urbanite” (L. Wirth, “Urbanism as a Way of Life”, cit., p. 16). 11 L’armonia cui si fa qui riferimento non ha niente di irenico ma va piuttosto intesa in un’accezione agonale, eraclitea. Per una trattazione di questo modo di interpretare l’idea di armonia sia permesso rinviare a S. Oliverio, “‘The Most Beautiful Harmony’ and Education as a Moral Equivalent of War: A Deweyan-Heraclitean Perspective”, Civitas Educationis. Education, Politics and Culture, Vol. 1, N.1, pp. 113-132. 12 M. Weber, Die Stadt, herausgegeben von Wilfried Nippel, Tübingen: Mohr, 1999 [ed. orig. 1922]. 13 G. Simmel, Die Grosstädte und das Geistesleben, in Th. Petermann (hrsg.), Die Grosstadt. Vorträge und Aufsätze zur Städteausstellung, Jahrbuch der Gehe-Stiftung, Band 9, Dresden, 1903, pp. 185-206. quale, affondando le proprie radici negli “strati inconsci della psiche”, esige “l’equilibrio di abitudini ininterrotte”, nella grande città, invece, policroma e rutilante, rumorosa e cangiante, invale “un carattere intellettualistico della vita psichica” (der intellektualistische Charakter des großstädtischen Seelenlebens), una predominanza cioè degli “strati chiari, consci e superiori della nostra psiche” (die durchsichtigen, bewussten, obersten Schichten unserer Seele). Questa prevalenza dell’intelletto è figlia diretta delle scosse, degli choc14 tipici della realtà cittadina, della desultorietà dell’esperienza ivi fatta: l’intelletto è, infatti, una sorta di “organo protettivo contro lo sradicamento” (Schutzorgan gegen die Entwurzelung) di cui l’homo metropolitanus deve dotarsi se vuole sopravvivere all’ambiente mutevole e accidentato di discrepanze che la grande città gli squaderna di fronte. Tre decenni dopo la conferenza simmeliana, a tale connotazione intellettualistica della vita metropolitana darà espressione magistrale Robert Musil – certamente non ignaro delle pagine del sociologo tedesco – nel primo paragrafo del suo opus magnum, Der Mann ohne Eigenschaften, lì dove dapprima, per descrivere una serena giornata di agosto, ricorre in chiave potentemente ironica a un lessico scientificamente e distaccatamente meteorologico, e poi conclude mostrando come nella costellazione metropolitana ogni moto dell’animo sia ricondotto a una ragione calcolante, che stempera le possibili piene emotive e ‘appiana’ anche l’esperienza-limite per antonomasia, quella della morte, riportandola alla regolarità di una formula statistica 15. Al fine di preservare una parvenza di equilibrio della propria sfera psichica e per schermarsi contro l’inondazione impressionistica di sensazioni che la grande città riversa su di lui (Simmel parla addirittura di Vergewaltigungen der Großstadt, di violenze, quasi in un’accezione stupratoria) l’homo metropolitanus deve sacrificare il dominio emozionale a quello intellettuale: questa la Ur-proposizione da cui discende tutta la potente sequela di interpretazioni dei fenomeni riconducibili all’ambito della metropoli. Anzitutto la supremazia del calcolo, di cui è emblema l’economia monetaria che impera nella grande città. Più che una notazione sociologica – ossia l’enfasi sul fatto che la grande città sia lo spazio del business – questa è, ancora una volta, un’osservazione antropologica e culturale: la metropoli proprio per l’eterogeneità, come la chiamerebbe Wirth, dei tipi umani e dei rapporti interpersonali ha bisogno di ricorrere all’esattezza numerica per regolare la propria vita. Se Wirth introduce il riferimento al calcolo statistico come necessario per studiare la variegatezza dell’esistenza urbana16, Simmel è ancora più radicale: senza la calcolabilità non sarebbe letteralmente possibile una vita nella grande città ma solo un pulviscolo esperienziale irrelato. È l’esistenza di uno “schema cronologico stabile e ultra-soggettivo”, ossia generale, collocato al di là delle esperienze singolari dei soggetti, che solo consente quel raccordo delle azioni e relazioni legate alle molteplici e svariate faccende urbane. La puntualità – prima ancora di essere una virtù o un segno di buona educazione – è, in quanto espressione di tale calcolabilità, un apriori dell’esperienza metropolitana, la sua condizione di possibilità, pena il cadere della totalità in un caos inestricabile (das Ganze [würde] zu einem unentwirrbaren Chaos zusammenbrechen). Le multiformi tecnologie della puntualità che innervano l’esistenza metropolitana, il suo Nervenleben (si pensi alle più recenti app per smartphone grazie a cui le aziende di trasporto pubblico permettono ai cittadini di conoscere gli orari di arrivo dei bus indicando il numero della palina alla fermata) non sono neutrali per la vita psichica: ogni valore dell’impulso, dell’istinto e – più in generale – del carattere qualitativo e non quantizzabile dell’esperienza umana viene eroso e, in analogia con quanto accade col denaro – l’equivalente universale che non tiene conto delle specificità delle merci – le cose perdono il loro rilievo, la loro rilevanza e la nostra relazione al mondo viene segnata da una peculiare impersonalità. Significativamente i medesimi fattori che sfociano in siffatta impersonalità alimentano anche un estremo soggettivismo, quello proprio, tuttavia, di un soggetto demondanizzato, incapsulato nel ridotto del proprio sé, blasé – scrive Simmel –, per il quale le cose sono terribilmente livellate, drenate di ogni valore. La medesima ‘contrattura relazionale’ (se ci si consente la dizione) sperimentata nei confronti del mondo (oggettuale) si ha anche verso gli altri. Ciò che caratterizza l’homo metrapolitanus è la riservatezza, la tendenziale chiusura verso i suoi concittadini, che è l’esatto rovescio della we-ness propria della small town come community. Si tratta – nota Simmel – di una manifestazione superficiale di una più profonda avversione, oltre che della necessaria protezione eretta a difesa dell’eccesso di stimolazioni che altrimenti verrebbe da un contatto così continuo, diffuso e insistente coi propri simili. Benché finora le caratteristiche della grande città siano state declinate in termini che possono apparire negativamente connotati, in realtà non bisogna dimenticare che tali specificità dell’esperienza urbana derivano dalla maggiore libertà che in essa gli individui godono (mentre in una comunità l’individualità viene limitata e si 14 Gianni Vattimo ha acutamente suggerito che sia Benjamin sia Heidegger, nella loro riflessione sull’arte nell’epoca contemporanea (che egli accomuna per la tematica dello choc/Stoss), avevano presente il saggio di Simmel sulla città: cfr. G. Vattimo, La società trasparente, Milano, Garzanti, 2000, p. 77. 15 R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1987 [ed. orig. 1930-1932]. 16 L. Wirth, “The Urban Society and Civilization”, The American Journal of Sociology, Vol. 45, No. 5, 1940, p. 750. è ridotti spesso a essere membri di una totalità) e dalla più ampia estensione della sfera di realtà che ad essa compete. Vi è una “grandezza funzionale” (funktionelle Grösse) della grande città che va “oltre i suoi limiti fisici” (jenseits ihrer physischen Grenzen) e ciò si ripercuote sulla vita che in essa si conduce che ha maggior “peso, rilievo e responsabilità” (Gewicht, Erheblichkeit, Verantwortung). La realtà effettiva ed effettuale della metropoli (la sua Wirklichkeit) consta della “totalità degli effetti che eccedono la sua immediatezza” (Gesamtheit der über ihre Unmittelbarkeit hinausreichenden Wirkungen). Da questo punto di vista la metropoli è un formidabile dispositivo di potenziamento dell’esperienza, di suo arricchimento e intensificazione e offre ai soggetti la possibilità di un’esistenza ‘allargata’, proiettata su una scena potenzialmente universale, cosmopolitica. Il pensiero progressista americano all’alba del ’900 (che ha declinato alcune delle emergenze sociali con cui ancora ci confrontiamo – di qui la sua perdurante esemplarità – pur in una costellazione socio-esistenziale per tanto versi differente) si trovava così di fronte al paradosso principe della modernità, che si sta qui reinterpretando come radicato in una differente esperienza della (piccola/grande) città. Per adoperare il lessico di John Dewey: da una parte, la comunità, se non vuole intristire nelle incrostazioni abitudinarie, negli automatismi del costume tramandato, se vuole ‘crescere’ (questo verbo decisivo in ottica deweyana), essere espansiva e ‘democratica’ (rammentando che la democrazia non è solo una forma di governo ma un tipo di vita associato e di esperienza condivisa)17, deve potenziare al massimo le due caratteristiche a) della ampiezza degli interessi condivisi e b) della varietà delle interazioni18, deve cioè essere ‘metropolitana’, tesaurizzare il patrimonio di risorse che la vita urbana dispensa; dall’altra, però, nessuna autentica comunità (democratica, prendendo questo termine come connotante la comunità nella sua realizzazione più piena19) può sussistere senza relazioni faccia-afaccia. In altre parole, per realizzare una modernità non unilaterale e dimidiata 20 si tratta di conciliare esperienza metropolitana ed esperienza della small town: come fare? Ovviamente si possono immaginare diverse traiettorie di politica urbana per rispondere a questa sfida (ma è importante aver chiari i contorni della sfida stessa). Quella che qui si indica è, attraverso una idiosincratica appropriazione di alcune idee di John Dewey, una delle possibili ‘soluzioni’. Nella sua riflessione pedagogica degli inizi del ’900 (proprio nello stesso torno di anni della conferenza di Simmel) Dewey avanzò, fra le molte altre, due caratterizzazioni della scuola: 1. allarmata dalla rastremazione dell’esperienza che i bambini e i giovani facevano del mondo a causa del diffondersi della società industriale e tecnologica, “John Dewey’s educational philosophy was in large part governed by the desire to compensate for the loss of community which occurred when the factory system replaced the “neighborhood system” of production […] Dewey’s “miniature community” of the school… was a substitute for the old neighborhood…”21. Da questo punto di vista, la scuola, fin dentro le sue pratiche pedagogiche, si profila come luogo di ri-proposizione, non passatista né nostalgica, di alcune delle forme della vita comunitaria; 2. di fronte agli impetuosi cambiamenti della scena urbana (dovuti alla presenza di popolazioni di diversa etnica e cultura, agli sviluppi della tecnica etc., insomma a tutto ciò che potremmo collocare – nella cornice della presente riflessione – all’interno della categoria ‘esperienza metropolitana’) la scuola doveva essere trasformata in un centro sociale22; essa non doveva essere solo un’istituzione dedicata all’erogazione delle conoscenze curricolari agli studenti ma diventare punto di raccordo e coordinazione di una serie di attività (di formazione continua, di ricreazione, di socializzazione interculturale delle varie comunità culturali che abitano un medesimo territorio)23. La scuola come centro sociale è il luogo in cui la dimensione comunitaria (propria della small town) e quella metropolitana (in termini di eterogeneità e varietà di interazioni sociali, costruzione di interessi condivisi a partire dalla piena valorizzazione delle differenze, ampliamento della sfera esperienziale) sono coniugate, non solo per gli allievi che la frequentano ma per tutta una collettività che ‘insiste’ su un medesimo spazio esistenziale e 17 Il riferimento è, ovviamente, a J. Dewey, Democracy and Education, in Id., The Middle Works, 1899-1924, vol. 9 (1916), edited by J.A. Boydston, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1980. 18 Ivi, p. 89. 19 “Regarded as an idea, democracy is not an alternative to other principles of associated life. It is the idea of community life itself” (J. Dewey, The Public and Its Problems, cit., p. 328). 20 J. Dewey, “Introduction to 1948 reprint of Reconstruction in Philosophy”, in Id., The Middle Works, 1899-1924, vol. 12 (1920), edited by J. A. Boydston, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1982, p. 273. 21 J. B. Quandt, From the Small Town to the Great Community. The Social Thought of Progressive Intellectuals, New Brunswick (New Jersey): Rutgers University Press, 1970, p. 98. 22 Con incredibile visionarietà Dewey già nel 1903 vedeva alcune delle potenzialità dell’istituzione scolastica, che oggi più che mai appaiono indispensabili per fronteggiare la complessità delle relazioni sociali. Ciò che qui si propone non è altro che un’estensione e un aggiornamento di ciò che Dewey suggeriva (cfr. J. Dewey, The School as Social Center, in Id., The Middle Works, 1899-1924, vol. 2 (1902-1903), a cura di J. A. Boydston, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1976, pp. 80-93). 23 Ivi, spec. pp. 90 sgg. geografico. Non si deve pensare a questa prospettiva solo come a una utopia: chi conosce la realtà degli istituti che funzionano e che fungono da centri di socializzazione ad ampio raggio (per adulti e non solo per giovani) sa che esempi di attuazione di questa possibilità – sia pure spesso in modo non sistematico né organico e troppo spesso esposto a contingenze che ne impediscono una compiuta strutturazione – già sono disponibili. Ma, oltre all’esigenza di mettere a regime questa idea di scuola, vi è un’ulteriore necessità perché tale prospettiva non rimanga un’utopia di carta, ed è una necessità che rimanda all’ambito della progettazione architettonica e urbanistica: fino a quando gli istituti scolastici rimarranno i casermoni che troppo spesso sono, in quanto dispositivi della governamentalità moderna, come Foucault ci ha insegnato a riconoscere, ossia congegni per il disciplinamento dei corpi, e non spazi della fioritura umana cooperativa, essi non potranno adempiere la funzione di ‘centri sociali’, perni di un’organizzazione del territorio che sposi la dimensione locale e quella globale, l’intimità della community e la proiezione cosmopolitica della condizione metropolitana. Se al momento di ideare la sua scuola-laboratorio nella Chicago dei primi del ’900 Dewey si pose il problema del riassetto degli spazi intra-scolastici (con altro tipo di banchi e suppellettili, che rompessero il dispositivo tradizionale segnato dalla trasmissività), l’idea di una scuola come ‘centro sociale’ esige un passo ulteriore, una riflessione interdisciplinare sui modi di progettazione degli edifici scolastici all’interno dei nostri spazi urbani. Una sfida in cui ne va di quel “genuinely modern [that] has still to be brought into existence”24. 24 J. Dewey, “Introduction to 1948 reprint of Reconstruction in Philosophy”, op. cit., p. 273. AIRES MATEUS: LA IV GENERAZIONE DELLA SCUOLA PORTOGHESE Francesca Buonincontri I fratelli Manuel e Francisco Aires Mateus1 sono tra i principali protagonisti dell'ultima generazione di architetti portoghesi, la quarta, dopo quelle succedutesi all’insegnamento di Fernando Tàvora intorno a cui si è venuta a creare la cosiddetta "Scuola di Porto", caratterizzata da un raffinato minimalismo formale ed una austerità scultorea. Dopo la seconda generazione di Alvaro Siza e la terza, rappresentata da Eduardo Souto de Moura, Josè Manuel Soares, Adalberto Dias, Gonçalo Byrne e Maria de Graça Nieto, i fratelli Aires Mateus, insieme ad altri coetanei Joao Alvaro Rocha, Antonio Portugal, Manuel Maria Reis e David Maranha, appaiono capaci di rispondere positivamente alle più diverse problematiche progettuali e di trovare soluzioni innovative strettamente collegate alle esperienze tramandate dai maestri. L'architettura portoghese, ad una analisi complessiva, mostra alcune significative costanti, quali la semplificazione linguistica, l'indipendenza da ideologie, l’adattamento all’ambiente, naturale o costruito, l’articolazione delle piante su base prospettica, l'attenzione alla luce e il riferimento alle "risorse” (forme, caratteri, materiali, genius loci) della regione, secondo il concetto del "Regionalismo Critico" di Kenneth Frampton"2, che porta a valutarla come uno dei casi esemplari della capacità di rinnovamento del Movimento Moderno, pur nella continuità di tecniche e linguaggi3. Manuel e Francisco Aires Mateus nascono a Lisbona, rispettivamente nel 1963 e nel 1964, da padre architetto e madre artista, si laureano presso l’Università tecnica di Lisbona (FA/UTL), formandosi alla Scuola di Porto. Collaborano dal 1983 al 1988 con l’architetto Gonçalo Byrne4, assimilando esperienze che si rivelano fondamentali per la loro formazione professionale, e, nel 1988, aprono a Lisbona lo studio Aires Mateus & Associados, molto attivo sin dall'inizio per i numerosi incarichi privati e pubblici, tra cui tre importanti realizzazioni affidate dall'amministrazione portoghese: la Residenza per Studenti del 1 Sull’opera degli architetti cfr.bC. Tonon (a cura di) L'architettura di Aires Mateus, Electa, Milano, 2011. 2 E. Sicignano, Portogallo 2009, in «L'industria delle Costruzioni» n .405, gen.-feb. 2009. 3 Per approfondimenti sull'architettura portoghese, cfr. N. Portas, M. Mendes, Portogallo: architettura, gli ultimi vent'anni, Electa,, Milano 1991; "Portugal", in «Costruire in laterizio», n.108, nov. dic. 2005, G. Szaniszlò (a cura di), L'identità plurale, caratteri dell'architettura portoghese, Guida, Napoli 2002, in cui la definizione di “identità plurale” è offerta da Alberto Cuomo e D. Vitale, Architetture portoghesi., Tre scritti sul Portogallo del 1984, 1987, 1999, Politecnico, Milano, 2002. 4 M. Aires Mateus, Indifferenza all'immagine, «Casabella», n. 700, maggio 2002, pp. 19-27. Campus II dell'Università di Coimbra (1996- 1999), una torre di sette piani su una pendenza artificiale realizzata mediante piastre e percorsi in uno spazio triangolare inclinato, con alloggi formati da camere doppie riunite a gruppi di due intorno ad un unico disimpegno; la Mensa nel Campus Universitario di Averio (1997), basata su contrapposizioni bilanciate, come la volumetria esterna semplice che contrasta con lo spazio interno complesso, quasi monumentale (scalone principale, differenti quote di livello, terrazze sulle vetrate), o i pieni e i vuoti che si alternano sulla geometria essenziale del corpo rettangolare, di tre piani, nell’accurato studio sulle possibilità derivanti dallo scavo della materia 5, che rendono l’opera leggera e quasi smaterializzata, in un mondo irreale, onirico, dove l' architettura si fa massa scultorea, chiusa, compatta, accessibile solo attraverso pochi tagli o sottili fessure; il Rettorato della Universidade Nova a Lisbona (1998- 2002) che si inserisce tra importanti preesistenze storiche prossime ad un Collegio dei Gesuiti, incastrandosi naturalmente nel pendio della collina su cui sorge, con un unico corpo di fabbrica ad L spesso undici metri, dall'altezza variabile, rivestito da lastre orizzontali di pietra tagliate da sottili incisioni orizzontali, le quali da particolari punti di vista lo fanno apparire "bidimensionale". Tra il 1997 ed il 2000 progettano la Sala Concerti a Lisbona e la Mensa nel Campus di Aveiro, e tra il 1998 ed il 2005 il Centro delle Arti di Sines, che con il Rettorato di Lisbona e il Centro ricerche e monitoraggio di Laguna Furnas nelle Azzorre rappresentano probabilmente gli esempi più riusciti della ricerca sul valore plastico-volumetrico della materia mostrando l'importante ruolo che essa ha nella realizzazione di un corretto rapporto tra architettura e contesto, inter5 Secondo Gonçalo Byrne, nel "desiderio di trasformare lo spazio in cosa concreta; il vuoto diviene materia prima dell’architettura", Nei lavori degli Aires Mateus il principio generatore è quello della continuità della superficie, sia sviluppata in modo piatto attraverso setti murari, sia ripiegata a creare solidi corpi tridimensionali spesso in pietra, con l’interruzione di vuoti in ombra "che accentuano il carattere geometrico della tessitura litica, stilizzazione contemporanea della stereotomia muraria antica, salda e possente." Secondo quanto rileva lo stesso Manuel Aires Mateus, il muro di pietra è "una delle più alte declinazioni architettoniche della materia", ideale "per definire e conchiudere lo spazio delle mie opere, … contenitori di vita destinati a durare. Voglio rapportarmi con la continuità della Storia e la pietra mi permette di farlo poiché resiste al trascorrere del tempo; stratificata nel dispositivo murario essa esprime un’idea di permanenza che mi sembra essenziale per la realizzazione di edifici significativi per dimensioni e destinazioni funzionali in rapporto alla città", cfr. D. Turrini, “Intervista a Manuel Aires Mateus”, in Manuel Aires Mateus. Un tempio per gli Dei di pietra, Melfi, Librìa, pretato sia in continuità che in contrapposizione. Queste opere sono anche il risultato della ricerca "diretta, ossessiva, regolata" di una spazialità interna ricca, generata dall'articolazione, secondo molteplici direzioni e quote, di vani complessi, la quale si concentra sul disegno del vuoto e sulla possibilità di rendere monumentale lo spazio interno lavorando sull’invenzione di luoghi inattesi ovvero sulla alterazione percettiva delle dimensioni reali. Gli spazi interni sono studiati con cura meticolosa del dettaglio e con una grande libertà creativa che non si lascia condizionare dalle situazioni esterne, così come i prospetti risultano indipendenti dalla suddivisione interna. In particolare il Centro delle Arti a Sines sorge all'ingresso del nucleo storico, all'inizio della strada principale di collegamento tra la città e il mare, vicino all'antico castello, e, in questo caso, gli architetti risolvono il difficile inserimento in un luogo particolarmente monumentale ricorrendo al riferimento formale dato dalle antiche mura medievali. Il progetto, si articola in 4 corpi che accolgono una galleria d'arte, la biblioteca comunale, un auditorium con 175 posti a sedere e l'archivio storico, uniti da un collegamento ipogeo, e, in un ampio spazio, che si prolunga anche sotto il livello della strada, sono collocate numerose attività, un centro di documentazione, sale espositive, una biblioteca, un cinema-teatro, ovvero, agli ultimi piani, bar e terrazze belvedere sul panorama. Il Centro ricerche e monitoraggio di Laguna Furnas (2008-2010) ospita a sua volta ambienti di studio e di alloggio temporaneo in volumi dalle forme geometriche compatte, semplici ma leggermente distorte, posti in una laguna situata in un contesto naturale di grande bellezza per l’orografia rocciosa e la ricca vegetazione. Esso è caratterizzato da uno spazio intermedio tra l'esterno e l'interno, il patio, che, come spesso accade nell'architettura degli Aires, è ottenuto per sottrazione, come per una scultura, ed è artificio per l'illuminazione diretta. Secondo quanto dichiara lo stesso Manuel Aires Mateus, esso è progettato come "una scultura, un blocco di materia prima che è intenzionalmente tagliato per catturare la luce e la stessa laguna". Diversamente, rispetto alla compattezza del centro, il corpo per gli alloggi è diviso simmetricamente in quattro unità con ingressi dai quattro lati. Il rivestimento utilizzato per muri e copertura è la pietra vulcanica locale, disposta secondo un disegno dettagliato che forma tessiture parallele omogenee le quali accentuano la leggera distorsione dei volumi trasformandoli in monoliti che sempre più, col tempo, risulteranno inglobati nella natura. Anche in quest'opera si nota l'estrema cura progettuale del dettaglio e l'autonomia degli spazi interni interamente rivestiti in legno naturale. Del 2001 è il progetto per il Concorso del Grande Museo Egizio, al Cairo che risulta vincitore di un premio speciale, mentre del 2003 sono il Museo del Faro di Santa Marta a Cascais, e il Park Hyatt Hotel a Dublino, e del 2004 la Casa di cura per anziani a Alcácer do Sal, terminata nel 2010. Nel museo del faro gli Architetti Mateus intervengono trasformando un luogo su cui si sono succeduti numerosi e rilevanti interventi, a partire dal XVII secolo. Anche qui il progetto fa propri forme, spazi, sistemi costruttivi del passato, e poggia i nuovi padiglioni d'esposizione su una delle pareti del recinto esistente del faro e del piccolo fortino militare. Le parti progettate costituiscono uno "spesso eroso muro" irregolare formato da quattro piccoli volumi rivestiti in parte da mattonelle bianche che riflettono la luce e in parte da intonaco, sempre bianco, come i muri di cinta. Ogni volume funge da spazio della galleria, mentre il sito è suddiviso in una piazza superiore che offre una bella vista sull'oceano e una piazza inferiore. Un muro che racchiude e definisce lo spazio aperto, formando, con le sue 38 camere, una spirale geometrica che sembra emergere naturalmente dal terreno, adeguandosi alla topografia e creando colpi di scena nel paesaggio fin quasi a scomparire ad un'estremità della collina, caratterizza anche il complesso della Casa di cura per anziani a Alcácer do Sal. In questo caso il complesso architettonico, che si staglia netto nell' insediamento medioevale è determinato da forme geometriche le quali formano ambienti molto vivibili con aperture di grandi dimensioni in incassi utili alla protezione solare, e balconi per ogni stanza. I geometrici volumi di un bianco accecante sono accorpati in un gioco di rientranze ed aggetti come cubetti di cristalli di sale, in riferimento all'antica produzione del sale, ricordata dal nome 'sal' della città, che crea un effetto scacchiera il quale evidenzia il contrasto tra luce ed ombra. L’articolazione del complesso è confermata anche nei sentieri percorribili a piedi con livelli di pendenza diversi per adeguarsi alle curve di livello esistenti e la distanza tra le unità indipendenti è stata disegnata per "trasformare l 'idea di percorso di vita, e il suo tempo in forma", nell'intenzione di interpretare qualsiasi spostamento in una esperienza emotiva di volta in volta diversa. Anche gli spazi interni con slarghi improvvisi, altezze raddoppiate, corridoi dalle grandi aperture, è progettato per creare l'effetto di un tempo rallentato adeguato agli anziani residenti. Del 2005 è il progetto per la Biblioteca centrale e archivio municipale a Lisbona, in cui gli architetti non operano per aggregazione ma per sottrazione, scavando, attorno ad un asse, un prisma, con l'intento dichiarato di "creare una città storica in posizione verticale". E pure del 2005 è il progetto di Ristorante a Biscai, mentre del 2006 quelli per un Edificio multifunzionale a Dubai, e per il Complesso scolastico a Vila Nova da Barquinha, terminato nel 2011, in cui diversi prismi bianchi dalle differenti altezze, con aperture tutte uguali, sono raggruppati all'interno di un perimetro quadrato e sono disposti a formare una serie di cortili interconnessi agli angoli, che originano un sistema continuo di spazi aperti. Essi determinano in tal modo spazi labirintici esterni in cui muoversi senza entrare nelle aree chiuse, e spazi chiusi attraversabili senza uscire all'aperto, in una assenza di prevalenza tra spazi primari e secondari, interni a un limite esterno creato per proteggere le aree di insegnamento dove lo stesso cortile è stato progettato come sistema alternativo di circolazione in un'area controllata. Un altro complesso scolastico è quello progettato ad Abrantes che prevede la costruzione di un edificio a piano terra formato da tre volumi pri-smatici ruotati fra loro che ospitano su di un'area di circa 5750 mq una scuola dell'infanzia ed una scuola elementare con aree per attività sociali e di sostegno, biblioteca, mensa, cucina, uffici Attualmente in corso di realizzazione è il progetto, del 2007, dell' Hotel Aquapura a Monsaraz, posto su una cava di granito nell' Alentejo in Portogallo. In esso l'acqua (drenata, riciclata) è l'elemento fondamentale per la costruzione e, per raccoglierla, sono utilizzate varie forme di serbatoi, stagni, piscine all'aperto o al chiuso, in una proposta di usi diversi, collettivi o pubblici, terapeutici, di svago, di contemplazione. L'edificio ruota attorno ad un patio centrale, riferimento all'architettura mediterranea già altre volte utilizzato dagli architetti, e la tecnica di costruzione dell'edificio è ispirata a quelle utilizzate per i ponti. All'inizio del 2008 la Città di Lisbona avvia un concorso di idee per il parco Mayer, il Giardino Botanico, gli edifici dell'ex scuola politecnica e le zone circostanti, vinto dagli Aires Mateus con un progetto che prevede l'estensione del Giardino Botanico del XVIII secolo fino al Teatro Capitolio, ristrutturato da Sousa Oliveira, in modo da realizzare un grande parco pubblico. Con questo intervento urbano la zona del parco Mayer sarà dotata di numerosi nuovi servizi, un albergo, due sale spettacolo, e il recupero del museo della Facoltà di Scienze. Il progetto tuttavia sta subendo alcune modifiche, soprattutto per le notazioni critiche degli ambientalisti, e non è ancora chiaro se saranno realizzate le biblioteche e le residenze per gli artisti previste. Del 2008, ora in costruzione, è la Nuova sede dell'Energia del Portogallo a Lisbona, probabilmente prossima icona della città, che si caratterizza per la dualità tra opacità e trasparenza, pieno e vuoto, gravità e leggerezza. Da un approfondito studio tra immagine architettonica, funzioni, controllo ambientale, efficienza energetica, deriva un progetto coerente, integrato nel contesto, continuamente mutevole a seconda del sole, della luce, degli angoli visuali, chiaro e leggibile nelle parti trasparenti che lasciano vedere il suo interno o, al contrario, opaco e misterioso. Nel 2010 gli Aires Mateus, sono invitati da Kazuyo Sejima, curatrice della 12° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia a parte- cipare all'esposizione del padiglione portoghese No Place Like- 4house, 4 films, il cui tema è la casa, "come momento di redenzione per la pratica dell’architettura”. Lo studio portoghese espone il progetto Casa Areia, che comprende piccoli alloggi vicino al mare fatti di assi in legno e ricoperti da tetti a doppio spiovente in fibre naturali, con la sabbia per pavimento nel soggiorno e nella cucina e le camere da letto allestite in strutture separate. Nel 2012 partecipano di nuovo alla 13° Biennale di Architettura di Venezia con “Radix” una struttura in lamiera brunita, ad arco, poggiata su quattro punti, con un lato sospeso sull'acqua, ancorata sulle banchine dell'Arsenale di Venezia e per il 2015 è prevista l'apertura al pubblico del Centro di creazione contemporanea Olivier Debrè (CCC Olivier Debrè), progetto selezionato tra altri 108, a Tours, un nuovo edificio che, costruito accanto ad una preesistenza progettata dall'architetto Peter Patout, si mantiene isolato da questo mediante l’interposizione di un corpo trasparente in modo tale da rafforzare il valore simbolico. Come è evidente in questa breve esposizione, gli Aires Mateus affrontano temi diversi, infrastrutture urbane, edifici pubblici, allestimenti museali, cercando sempre soluzioni raffinate e adeguate al contesto, sebbene la loro ricerca progettuale sia particolarmente indirizzata verso il tema della residenza privata in cui meglio manifestano la tendenza al surreale e all'onirico come mostrano la casa ad Alvalade del 1999, la Casa nella Serra de Mira d'Aire del 2001, la casa a Sesimbra del 2002, la casa nel Parco Naturale di Arràbida, Setubal, sempre del 2002, la casa ad Alcacer do Sal del 2003 e la casa ad Alenquer (1999 -2002) finalista al premio Fad 2003. Tra i diversi progetti di abitazioni unifamiliari, la Casa Barreira Antunes lungo il litorale Alentejano,Grandola, (2000-2002) , è la prima di un gruppo di 4 abitazioni identiche da costruirsi in tempi diversi. Come sempre, la metodologia progettuale è quella della sottrazione e da un parallelepipedo bianco illuminato da quattro patii sono scavate ampie aree d'ingresso. I 4 bianchi corpi saranno disposti ruotati l'uno rispetto all'altro intorno ad una piattaforma quadrangolare con serbatoio d'acqua e piscina, e sono stati pensati in base alle tradizionali tipologie abitative del luogo, con gli spessi muri dei casolari del territorio dell'Alentejo che proteggono lo spazio interno dal secco caldo estivo. Il primo dei quattro edifici è stato realizzato di fronte al serbatoio leggermente fuori asse. Due sole grandi aperture quadrate, volte l'una ad est e l'altra ad ovest, formano delle logge protette da porte scorrevoli vetrate che consentono di aprire la casa all'esterno, mentre pesanti pannelli scorrevoli in legno la chiudono completamente, e proprio in questa dualità, tra la massima permeabilità alla natura circostante e la massima introspezione, sta il pregio spaziale e concettuale del progetto. Gli elementi che compongono la casa sono ridotti all'essenziale, i servizi e la zona notte, coperti con un soffitto ribassato rispetto alla zona giorno, sono posti su un piano rialzato e racchiusi dal muro esterno. Questi ambienti circondano la zona giorno, che a sua volta, ruota attorno ad un patio, centro geometrico ma anche concettuale dell'abitazione, riferimento all'architettura arcaica mediterranea, aperto su di un unico lato, a sud, in modo da fare entrare la luce, tema dominante del progetto, in maniera diffusa. Questo edificio, come si ripete spesso nelle architetture degli Aires, sembra una scatola entro cui si nascondono altre scatole in un gioco continuo di contrapposizioni tra luce ed ombre, vuoti e pieni, sottrazioni ed aggiunte. Tutti i muri sono stati realizzati in muratura a doppia parete con intercapedine isolata, e all'interno tutte le superfici, comprese le pavimentazioni in marmo, sono bianche. La Casa a Brejos de Azeitão realizzata nel 2003, vincitrice del primo premio Residencia Singular RS04 (Madrid 2004) deriva dalla trasformazione di un'antica cantina, in cui i volumi delle camere da letto vengono sospesi come "stalattiti geometriche" accentuando il senso di leggerezza e luce, mentre gli altri ambienti privati posti in blocchi al piano superiore creano spazi pubblici dalle altezze differenti, con viste suggestive, affacci sorprendenti. Le soluzioni progettuali sono state dettate dall'accentuato spessore dei muri e dall'ampiezza dello spazio, gli ambienti si formano per addizione, aggregando volumi all'interno di una scatola preesistente. Internamente e in parallelo ai muri perimetrali corrono due muri bianchi che creano a piano terra due nicchie per la cucina, il bagno e le scale e che fanno da appoggio ai quattro blocchi sospesi che accolgono le camere da letto ed uno studio. I progetti di case più recenti, tra il 2007 e il 2011, sono la Casa a Coruche, la Casa a Monsaraz, la Casa ad Areia e la casa a Leira (2008-2010). In questo ultimo caso è stato costruito un archetipo di casa ben riconoscibile, simile alle casette che può disegnare un bambino: un parallelepipedo sormontato da un tetto, anch'esso bianco, senza aperture, poggiato su di un prato verde, sullo sfondo blu del cielo. Manuel Aires racconta che ha sviluppato il progetto partendo da tre considerazioni: l'assenza di grande qualità del luogo,che lo ha indotto a realizzare una casa chiusa in se stessa; la presenza, al contrario, sulla lontana collina, di un castello medievale, che gli ha suggerito un orientamento per l'apertura centrale, capace di creare un "collegamento magico"; infine l'ampiezza del progetto (circa 3200 mq) in rapporto al ridotto sito, che gli lo ha indotto a sfruttare gran parte del sottosuolo, ponendo gli spazi privati sottoterra, ciascuno intorno ad un cortile in modo da avere un proprio cortile che lo illumini, secondo un modello tipico degli architetti portoghesi (si pensi ad esempio la Casa Das Mudas Museum di Madeira di Paulo David). La casa è in tal modo svuotata del suo centro e internamente si apre all'aria e alla luce mediante un patio centrale, che attraversa in successione i tre piani della casa, dal tetto alla cantina, e che "prende la forma disegnata dalla luce, sottolineando la qualità scultorea del taglio”. Al livello intermedio, una piattaforma esterna permette di godere della vista lontana del castello. Tutte le facciate e le pareti sono state realizzate in muratura a doppia intercapedine isolata e all'interno le superfici sono anch'esse bianche come le pavimentazioni in marmo chiaro. Interessante è anche il progetto di ristrutturazione ed ampliamento realizzato ad Alcobaca, città dominata dalla presenza di un monastero del XII secolo. La casa , a tre piani, sorge su di un terreno irregolare posto sulla riva del fiume Dull, ed è stata ristrutturata con nuove finestre formate da tagli verticali che rivelano un vuoto profondo, mentre le antiche finestre sono state tamponate e racchiuse da cornici. L'ingresso è al piano intermedio e una scala collega il piano superiore e quello inferiore in cui si trova il soggiorno da cui, attraverso una grande apertura arcuata, si passa al pranzo, alla cucina e alle tre camere da letto. Tutti gli ambienti sono disposti intorno a piccoli patii quadrati e un giardino a forma di L, delimitato da un grosso muro bianco, gira intorno alla casa. Sebbene si tratti di una ristrutturazione, emergono in essa tutti i concetti compositivi degli Aires Mateus, la cui formazione nell’ambiente culturale portoghese, così segnato dalla presenza di grandi personalità, non impedisce loro di elaborare una poetica progettuale ben riconoscibile, volta a ricercare le tante possibili variabili espressive della materia e dello spazio e a raggiungere soluzioni tese ad eliminare la gravità ed esaltare, al contrario, la leggerezza, anche se sempre pensate per comunicare un senso di permanenza. Mettendo in relazione pieni e vuoti essi trasformano questi ultimi in una materia tridimensionale che viene plasmata, distribuita, in modo da stupire continuamente e generare inaspettati spazi monumentali, laddove, operando per sottrazione trasformano il volume in spazio e caricano di funzioni il pieno così da realizzare un' architettura segnata dal senso della massa e da un mutismo essenziale. In tal modo le architetture si trasformano in un "gioco di costruzioni ed incastri" e, attraverso il processo di riduzione formale che applicano, si riportano ad una sorta stato naturale primitivo, e si direbbe “originario”, nel luogo cioè in cui la “cosa” si presenta sullo sfondo del vuoto, essendo, secondo la definizione di Francesco Cacciatore vere “dimore del vuoto”6. Bibliografia Essenziale A. Acocella, L'architettura di pietra, Firenze, Lucense-Alinea, 2004. 6 F. Cacciatore, L'animale e la conchiglia, in C. Tonon, op. cit. F. Cacciatore. Abitare il limite Dodici case di Aires Mateus & Associados, presentazione di Manuel Aires Mateus, LetteraVentidue, Salerno, 2009. F. Cacciatore, L'animale e la conchiglia, L'architettura di Manuel e Francisco Aires Mateu come dimora del vuoto, in C. Tonon (a cura di) L'architettura di Aires Mateus, Electa Milano, 2011 C. Palazzolo, “Monumentalità a sorpresa”, in «Casabella» n. 710, 2003. «Architectural Record», maggio 2007. «Architectural Record», aprile 2011. «Casabella», n. 700, 2002. «Casabella», n. 763, 2008 «Darco Magazine», 07, Special issue Aires Mateus Monography, 2009. «El Croquis» n. 154, 2011. «2G» n. 28, 2002. NUOVI ORIZZONTI TRA NATURA E ARTIFICIO Antonio Mollo Le utopie non sono spesso altro che verità premature. Alphonse De Lamartine Nel 1957 i sovietici lanciano lo Sputnik; nel 1959 l' americano Explorer IV ci fotografa da 27.200 km. di altezza; nel 1961 il maggiore Gagarin effettua 17 orbite intorno alla Terra; nel 1962 il colonnello Glenn pilota la Friendship III; nel 1963 è la volta della prima donna, la Tereskova; nel 1965 Leonov galleggia per 10 minuti nello spazio; nel 1969 Amstrong compie il primo passo sulla luna1. Nel 2009 con un grande balzo in avanti, una pellicola, ci catapulta nell’anno 2154 dove una compagnia interplanetaria terrestre sbarca su Pandora, luna del gigante gassoso Polifemo appartenente al sistema stellare Alfa Centauri. Qui un giovane Sam Worthington, nel film Avatar2, veste i panni di Jake Sully, un ex marines costretto su di una sedia a rotelle, in cerca di una nuova vita su un nuovo mondo. Sullo sfondo un esercito composto da macchine/soldato, scienziati, biologi e studiosi della post-modernità, tecnologicamente più progrediti che mai, sempre più aggressivi quando si tratta di reperire risorse utili per risolvere i gravi problemi energetici che assillano il pianeta; uomini sbucati dai cieli, e blindati in balene volanti, quelle stesse della Los Angeles di Blade Runner3, inquinata, sovraffollata e invivibile, dove era proibito ledere a qualsiasi forma di vita vegetale e animale perché oramai quasi del tutto scomparse. Quella stessa umanità del film di Ridley Scott del 1982 realizza il suo cavallo di Troia in quello di James Cameron attraverso una capsula tecnologica ed un artificio chiamato avatar4 grazie a cui, conosce un mondo primordiale, anch’esso ricoperto da una natura madre e matrigna, ricca di foreste pluviali, con alberi alti anche trecento metri, ed abitato da varie creature tutte decisamente spettacolari e mostruose. Esseri animali e vegetali, connessi tra loro da un legame biochimico atto a generare un grande sistema nervoso che capillarmente mette in relazione tutto fino al punto che ogni minimo evento può generare un pericoloso effetto farfalla. Tra questi esseri scopriamo anche pseudo uomini blu, organizzati in tribù e dotati di scarse tecnologie, evidentemente perché legati ad 1 L. Prestinenza Puglisi, La storia dell’architettura 1905-2008, http://presstletter.com/2013/07/storia-dellarchitettura-1905-2008testo-completo-di-lpp/, p. 229. 2 Avatar, film del 2009, diretto da James.Cameron, prodotto e distribuito da 20th Century Fox. 3 Blade Runner, film del 1982, diretto da Ridley Scott, prodotto da Michael Deeley. 4 Attraverso un'interfaccia mentale un uomo può trasferire la sua anima e la sua coscienza nel corpo dell'avatar e controllarlo come il suo corpo. Tale collegamento viene effettuato cadendo in una sorta di coma all'interno di una speciale capsula tecnologica. altri miti ed altre leggende senza alcun Prometeo disobbediente nel proprio passato5. Pellicole apparentemente distanti dalla realtà ma che tornano subito alla mente se, come il repentino tramutarsi dell'osso in astronave in 2001 Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick, ripercorriamo velocemente notizie di nuovi rifugi lunari, progettati per essere stampati in loco6 e di continue ricerche d’acqua e forme di vita su Marte; pellicole che se guardate con un occhio sintetico sembrano contribuire alla costruzione di una nuova coscienza ecologica globale e alla materializzazione di un’angoscia profonda dell’uomo post-moderno che sa di aver occupato troppo spazio e di aver sottratto troppo alle altre specie viventi. Cinema e architettura, nonostante siano le più lontane tra le arti per nascita e sviluppo, oggi sembrano influenzarsi reciprocamente offrendoci nuovi orizzonti e possibilità di riflessioni. Alcune pellicole fantascientifiche suggeriscono possibili futuri dove sembra sempre più centrale il tema etico-strutturale dell’uomo e della società: ritrovare un rapporto tra l’artificio umano e la natura. L’Architettura, come arte di occupazione dello spazio e artificio per eccellenza, ha infatti contribuito a quell’eccesso di artificializzazione del territorio generando vuoti e deserti urbani, “… questi deserti (quartieri fantasma, aree industriali dismesse, miniere abbandonate, discariche tossiche), con tutti i loro pericoli di morte, sono creati non dalla natura ma dall’artificio umano. In questa creazione di pericolo di morte all’interno del costruito, avviene una mutazione profonda del rapporto antico tra artificio e natura. Fino a poco più di due secoli fa, nel continente europeo, era il campo limitato dell’artificio (la città dentro le mura) ad essere vissuto come lo spazio amico dentro cui la vita appariva protetta; ed era il campo illimitato della natura (tutto ciò che era fuori dalle mura) ad essere percepito come lo spazio ignoto dove il pe5 Edward Lorenz fu il primo ad analizzare l'effetto farfalla in uno scritto del 1963 preparato per la New York Academy of Sciences. Egli dimostrò attraverso numerosi studi e prove, che delle piccole condizioni iniziali producono grandi variazioni nel comportamento a lungo termine nei sistemi complessi. 6 La regolite, ovvero il "materiale incoerente, consistente di pietre e polvere, che forma il suolo lunare" (treccani.it) - e che compare anche su altri pianeti, Terra compresa - alimenterà il sistema per "stampare" i componenti del rifugio ideato dallo studio di Norman Foster nell'ambito di un'iniziativa patrocinata dall'Agenzia Spaziale Europea (European Spatial Agency, ESA): l'involucro, pensato per proteggere quattro astronauti da detriti, radiazioni e sbalzi termici (esa.int), rappresenterebbe una soluzione ai proble-mi di trasporto che nel tempo hanno ostacolato la costruzione di una base sulla superficie del satellite terrestre (smartplanet.com). ricolo di morte minacciava l’esistenza. Le mura della città dividevano l’artificio dalla natura, dunque la vita dalla morte, che venivano l’una raccolta e coltivata dentro, l’altra ricacciata e confinata fuori. Con la mutazione genetica della città in metropoli, la condizione spaziale si è capovolta: è la ipermetro poli che fa paura, è l’habitat umano (il costruito, l’artificiale) ciò da cui proviene ormai la minaccia più grave per la vita.”7 E’ di qui, evidentemente, che, da diversi decenni, si può leggere nell’opera di alcuni progettisti un rinnovato interesse per la natura, una ri-naturalizzazione dello spazio artificiale, un cambiamento delle forme legato ad un nuovo approccio culturale al progetto, ed una architettura reattiva e attenta ai cambiamenti: “… simbolo di qualcosa che, al di là della sua solidità e del suo essere protezione per l’uomo, esprime, racconta”8, comunica e rappresenta la complessità della società, sintetizzandola in un’ immagine che non si blocca in se stessa ma che è propositiva e volta al futuro, dove artificio e natura, convivono e si dissolvono ibridandosi nella ricerca di nuove forme mutanti, vitali ed ecologiche. Una modalità di approccio al progetto architettonico che sembra essersi ampliato nella scia di una tradizione di testi divulgativi di filosofi, scrittori, matematici, fisici, architetti della seconda metà dell’ottocento, come Nature’s teaching: human invention anticipated by nature9 di John George Wood o On Growth and Form di D’Arcy Thompson10, che inaugurano la tematica dell’esplorazione scientifica sulla analogia tra natura e artifici umani secondo un processo esplorativo e unificante ed indagini sulle forze che governano i processi di crescita morfologica e strutturale delle piante e degli organismi, onde ricercare riferimenti per nuove opportunità progettuali. “… Segni di questa nuova sensibilità li abbiamo visti con gli Archigram, che nel 1966 abbandonano la ricerca di macrosistemi a scala metropolitana per organismi leggeri, mobili, strettamente interrelati al contesto naturale. Ma è nell' Expò di Montreal che, con la tenda di Frei Otto e il Padiglione di Buckminster Fuller , si configurano le due principali direzioni di ricerca tese al perseguimento di un nuovo rapporto tra architettura e ambiente naturale. La prima, percorsa dal tedesco, si rifà all' ideale mimetico della tradizione romantica: le tensostrutture, infatti, riprendono la forma del paesaggio, restituendo all'habitat umano quelle linee morbide, fluide e ondulate che l'edilizia tradizionale gli ha negato. La seconda, sostenuta dall'americano, propone forme, quali le cupole geodetiche, perentorie come equazioni matematiche. "La mia cupola - afferma Buckminster - non è un gioco per il tempo libero. E' un sistema di controllo ambientale estremamente sofisticato, ottenuto con un risparmio di materiale e di fatica molto maggiore di quello che può essere ottenuto con altre strategie ingegneristiche alternative". 11 Il filone delle forme biomorfe in tante architetture contemporanee, è una conseguenza di questi scenari, dove, progetti e realizzazioni in cui la modellazione degli spazi e le morfologie strutturali riflettono principi desunti dal mondo organico, (gusci, strutture arboriformi, sezioni di corpi animali) senza limitarsi alla semplice replica di analogie superficiali e formali ma, implicando un effettivo arricchimento linguistico rispetto alla consuetudinaria sintassi architettonica ed un arricchimento del comportamento dell’edificio stesso nei confronti dell’ambiente circostante in termini di efficienza energetica e strutturale. Opere come il Centro culturale J. M. Tjibaou di Renzo Piano dove la particolare forma a guscio permette di dirottare e controllare la ventilazione generando zone di sovrappressione e di depressione o come le leggere biosfere dell’Eden Project di Nicholas Grimshaw sembrano un esempio chiaro ed esaustivo di questa tendenza. Ecco che “il sapere scientifico sbarazzato dalle fantasticherie di una rivelazione ispirata, soprannaturale, può oggi scoprirsi essere ascolto poetico della natura e, contemporaneamente, processo aperto di produzione e di invenzione, in un mondo aperto produttivo e inventivo”12. Progetti più recenti come il Gwanggyo Center di MVRDV ispirato alle forme di un termitaio ed al suo principio di ventilazione passiva sono sintomatici di un rimodellamento da parte della cultura scientifica dei principi, “… dei processi e dei metodi di progettazione dei fenomeni antropici in rapporto ad una visione eco sistemica della realtà vedendo per esempio il complesso di regole e di comportamenti delle ‘architetture’ animali oggetto di grande attenzione per un loro trasferimento in chiave prestazionale nelle architetture artificiali umane”13. In una prospettiva di questo genere che riavvicina l’uomo alla natura, “erode la diga tra naturale e artificiale e sommerge l’illusione del dominio dell’uomo sul mondo, l’architettura, come risultato del processo di trasformazione della crosta terrestre, diventa essa stessa parte della natura, ne più né meno delle barriere coralline e delle chioc- 7 D. Mazzoleni, Natura Architettura Diversità, Electa-Napoli, Napoli, 1998, p.17 8 R. Piano, La responsabilità dell'architetto, Passigli, Firenze 2007, p. 190. 9 J. G. Wood, Nature’s Teachings: human invention anticipated by nature, William Glaisher, Londra, 1875. 10 D. W. Thompson, Crescita e Forma, trad. it. Bollati Boringhieri, Torino, 1969. 11 L. Prestinenza Puglisi, La storia dell’architettura 1905-2008, http://presstletter.com/2013/07/storia-dellarchitettura-1905-2008testo-completo-di-lpp/, p. 230. 12 P. Portoghesi, Natura e architettura, Skira, Milano, 1999, p. 23, I Prigogine I. Stengers, La Nuova alleanza, Einaudi, Torino, 1993. 13 F. Tucci, Tecnologia e Natura, Alinea editrice, 2008, p. 11. ciole in cui si rifugiano gli invertebrati, né più né meno dei giardini che i bower-birds costruiscono per ritualizzare i loro accoppiamenti o delle dighe dei castori erette con infinita pazienza per sottrarre, nell’acqua del fiume, uno ‘spazio domestico’ al gioco delle correnti”14. Architetture di un futuro vicino, nate da contenuti che, architetti Utopici e Futuribili15 avevano già accolto da un bel pezzo, e altre invece, di cui sospettiamo del legame profondo alle nuove mode, a precisi processi di cosmesi edilizia, ed a precise operazioni di marketing; le quali, tutte insieme, ci lasciano con un interrogativo: “può l’Architettura che impara dalla Natura, evolutasi in un processo di continuo adattamento ad un ambiente in continuo cambiamento, diventare essa stessa Natura?”15. 14 P. Portoghesi, Natura e architettura, Skira, Milano, 1999, p. 23. B. Zevi, Storia dell'architettura moderna, Einaudi, 1953, p. 429. 15 COSTRUIRE SUL COSTRUITO Maddalena Servodio La spinta insediativa e l’intensa attività edilizia, già a partire dall’800, dovuta a fenomeni quali l’inurbamento delle principali città, lo sviluppo industriale, la crescita della popolazione e successivamente i danni causati dagli eventi bellici, ha interessato i principali centri urbani italiani ed europei determinando una significativa discontinuità nella definizione della città moderna. Nel mondo occidentale, e in particolare in Italia, le periferie urbane rappresentano la parte più ingente dell’edificato delle nostre città, (secondo dati Istat la media è del 68,52%) implicando problemi molto complessi. Dal secondo Dopoguerra ad oggi, l’edilizia residenziale, in particolare, è stata realizzata con una scarsa attenzione alla qualità della costruzione alla quale sono imputabili rilevanti danni ambientali. Il riscaldamento domestico, per esempio, è responsabile della produzione di una quota di anidride carbonica pari a circa la metà di quella totalmente immessa nell’atmosfera. Inoltre, al settore delle costruzioni è ascrivibile quasi la metà delle emissioni di altri agenti inquinanti, che contribuiscono alla formazione dell’effetto serra (si pensi anche alla capillare diffusione di condizionatori e alla massiccia presenza di costruzioni e superfici vetrate). A ciò si aggiungono ulteriori elementi quali la carenza di aree verdi e il traffico cittadino, che provocano sensibili innalzamenti di temperatura all’interno delle aree urbane ed incidono profondamente sulle condizioni microclimatiche locali e sulla formazione e concentrazione di sostanze nocive nell’aria, con ovvi e rilevanti effetti sulla salute dell’uomo e sulla conservazione dell’ambiente. L’edilizia residenziale del dopoguerra presenta una scarsa qualità ambientale dovuta a numerosi motivi di natura costruttiva: un orientamento sbagliato, in genere lungo l’asse nord-sud con le facciate principali ad est ed ovest, ma anche una disposizione planimetrica che non ha tenuto conto del mutuo ombreggiamento tra i diversi edifici, materiali con bassa massa termica e basse qualità isolanti, come pareti perimetrali realizzate in laterizi leggeri e componenti finestrate caratterizzate da un’elevata trasmittanza termica ed in generale una totale indifferenza relativa alle condizioni climatiche in cui sono inseriti. Questi edifici sono caratterizzati, dunque, da tecnologie edilizie di scarsa qualità che provocano considerevoli dispersioni di calore. Le scarse prestazioni energetiche derivano anche dall’assenza di normative specifiche che comparvero solo in seguito alla crisi petrolifera del 1973 e furono orientate a limitare le richieste energetiche per il riscaldamento attraverso un corretto isolamento dell’in- volucro edilizio e la minimizzazione delle dispersioni termiche. Oltre al degrado e alla obsolescenza degli edifici, si aggiunge anche una serialità architettonica e una scarsa qualità urbana degli spazi aperti pubblici e privati. La totale mancanza di attrezzature collettive contribuisce a ridurre la possibilità di comportamenti socializzanti facendo accrescere la connotazione negativa di questi luoghi. Nonostante ciò, è difficile pensare ad interventi di demolizione diffusa che comporterebbero non pochi problemi, data la massa di popolazione residente e le conseguenti azioni di sgombero, sebbene temporanee. Inoltre, data la particolare congiuntura economica, le politiche comunitarie si sono impegnate a sostenere programmi straordinari per l’incremento del patrimonio di social housing e gli interventi di riqualificazione potrebbero costituire una percentuale significativa nell’aumento di alloggi sociali. Numerose ricerche, best practices e sperimentazioni in Europa hanno dimostrato che è possibile tentare una riqualificazione di questo immenso patrimonio edilizio, e che essa possa rappresentare una opportunità per migliorare l’immagine del costruito. La riqualificazione del patrimonio edilizio e la volontà di accrescere la vita utile di un organismo edilizio contro la dismissione racchiudono due dei principi cardine della sostenibilità: la conservazione dell’energia e la conservazione della materia. Conservazione dell’energia spesa per il reperimento delle materie prime, la loro trasformazione, lavorazione e trasporto e conservazione dei materiali stessi che consente di risparmiare ulteriori materie prime ed energia per la trasformazione e di conseguenza ulteriori emissioni nell’aria e produzione di rifiuti. Oltre al valore di massimizzazione delle risorse, la riqualificazione assume anche un valore sociale. “Riqualificare significa intervenire sugli spazi interni degli alloggi, su quelli esterni e su quelli collettivi con una strategia organica” (E. Ginelli, L. Castiglioni, 2012). Spesso attraverso il recupero di un edificio si innescano processi di riqualificazione urbana nel suo immediato intorno, migliorando le situazioni di degrado fisiche e funzionali degli spazi e contribuendo al miglioramento di vita dei cittadini secondo il concetto di “agopuntura urbana” teorizzato dal sindaco, architetto-urbanista, di Curitiba Jaime Lerner secondo cui azioni mirate e circoscritte sulla città sono in grado di innescare processi virtuosi stimolando il rinnovamento urbano.1 “Quasi sempre è una scintilla che 1 J. Lerner, Acupuntura Urbana. Record, São Paulo, 2003. inizia un’azione, e la susseguente propagazione di questa azione. E’ questa che io chiamo una buona agopuntura. Una vera agopuntura urbana.” Oggi intervenire sull’esistente non è più una possibilità, ma una scelta ineluttabile. Ammettere questa trasformazione significa anche contrastare il sempre più diffuso fenomeno di gentrification2 dei centri storici e intervenendo sulle periferie, dove vive la maggior parte della popolazione, riuscire a portare i concetti della sostenibilità ambientale nell’architettura del quotidiano. Risulterebbe riduttivo considerare la riqualificazione come semplice miglioramento o aggiunta di soluzioni impiantistiche più efficienti e non considerare la possibilità di sperimentare nuove tipologie e configurazioni dell’architettura che ne potrebbero derivare. Trattandosi infatti, di edifici con scarso valore architettonico, gli interventi possono essere più invasivi rispetto a quelli che si potrebbero eseguire sul patrimonio storico di valore, migliorando in questo modo oltre che le prestazioni energetiche anche l’aspetto formale. “Nel passato, i nuovi valori della città scaturivano proprio dalla sue trasformazioni e le espansioni sul costruito portavano a una conquista dello spazio architettonico e urbano sorprendente. Oggi molta parte delle nostre città ha bisogno di trasformarsi e la volumetria del costruito esistente potrebbe superare il limite della bidimensionalità della facciata, per guardare a orizzonti di metamorfosi urbana efficaci” (M. Imperadori, 2009). L’intervento sull’esistente può divenire un campo di sperimentazione progettuale differendo dagli interventi di riuso e restauro degli edifici proprio per il diverso approccio compositivo poiché si interviene sull’immagine del costruito attraverso aggiunte e sovrapposizioni, oltre che sulle funzioni e sulle prestazioni energetiche. Un ruolo chiave nei processi di riqualificazione dell’esistente viene svolto dall’uso delle nuove tecnologie che non devono limitarsi all’aggiunta di “pezzi” 2 “Molti dei quartieri popolari di Londra, uno dopo l’altro, sono stati invasi da esponenti della classe media, sia medio alta che medio bassa. Non appena scaduto il contratto di locazione, modesti cottage, con due stanze al pian terreno e due stanze al primo piano, e piccole stalle dismesse, sono diventati eleganti e costose residenze. Una volta cominciato in un quartiere, questo processo di gentrification va avanti rapidamente, fino a quando tutti o quasi tutti gli esponenti della originaria classe operaia non si saranno trasferiti e il tessuto sociale dell’intero distretto sarà radicalmente cambiato” (R. Glass, 1964),in M. Guidi, F. Melis, Lagentrification: da fenomeno urbano a domanda di cambiamento, v. http://www.associazioneppg.it/co/templates/rivista.asp?articleid= 300&zoneid=33: “Il termine gentrification venne inizialmente coniato dalla sociologa tedesca Ruth Glass (1964) per definire un fenomeno di tipo sociale, geografico ed economico in rapporto al quale un quartiere di tipo operaio – prossimo al centro di una grande metropoli e le cui condizioni versavano in uno stato di forte degrado – subisce un’invasione inesorabile da parte degli esponenti della classe media, tanto da determinare una profonda trasformazione nell’identità del quartiere”. mancanti, ma fornire la risposta alle mutate esigenze e bisogni. La tecnologia ha sempre avuto un ruolo determinante nella definizione dei caratteri dell’architettura. Alcune innovazioni tecnologiche hanno apportato cambiamenti radicali nell’immagine architettonica, si pensi ad esempio, all’introduzione del vetro in grandi pannelli, anche se, dal punto di vista del confort interno abbiamo assistito ad una involuzione della tecnologia. L’utilizzo in grandi parti del vetro, non tenendo conto della corretta esposizione e del clima di riferimento, come in larga parte delle architetture dell’International Style, è andato a discapito del benessere interno degli edifici e al bisogno di impianti di climatizzazione. Secondo R. Banham “fino al diciottesimo secolo la tecnologia era integrata nell’architettura, dopo, l’arte dell’architettura andò sempre più divorziando dalla pratica di costruire e far funzionare gli edifici”. Spesso la difficoltà sta nell’accettare da parte degli abitanti il peso estetico che queste tecnologie svolgono nella nuova configurazione dell’architettura. Questo è dovuto in parte ad un processo di allontanamento della società dalla tecnologia, intesa non più come “arte del saper fare” ma come un ambito di conoscenza precluso alla maggior parte della popolazione. Pensiamo, ad esempio, ai pannelli fotovoltaici e a quanto poco la popolazione conosce il principio scientifico per cui è possibile la trasformazione dell’energia solare in energia elettrica. 3 “Ogni tecnologia cambia il paesaggio, come cambia l’architettura. (…) Gli impressionisti dipinsero i pali della luce, li accolsero nei loro quadri, eppure a nessuno sembravano così poetici. Del resto, quando ci si commuove davanti al paesaggio toscano, chi si rende conto che il cipresso sulla cima del colle ce l’ha messo l’uomo? Che i terrazzamenti non li ha fatti Dio? Ogni epoca fa il paesaggio con la sua tecnologia” (M. Cucinella). Nonostante si tratti di un tema di sviluppo recente, la riqualificazione del costruito offre un’ampia casistica di strategie e soluzioni di intervento. Le sperimentazioni hanno riguardato complessi di edilizia residenziale e sono stati per lo più ad iniziativa pubblica con programmi comunitari o nazionali. Si possono distinguere interventi finalizzati solo all’efficienza energetica che hanno riguardato l’aggiornamento tecnico- impiantistico tramite operazioni di sostituzione o sovrapposizione ed interventi che hanno affrontato la riqualificazione con un approccio più sistemico, con uno studio del progetto di architettura. Questi interventi hanno riguardato sia l’applicazione di tecnologie impiantistiche che prevedono l’uso di energie rinnovabili Res (Renewable Energy Sources), sia 3 P. Carli, L’evoluzione tecnologica e sociale nell’abitare. Questioni storiche ed epistemologiche dell’architettura, in A. Delera, Ri-pensare l’abitare. Politiche, progetti e tecnologie verso l’housing sociale, Hoepli, Milano 2013. l’integrazione di sistemi bioclimatici (serre solari, frangisole, muri Trombe-Michel) spesso aumentando la superficie degli alloggi attraverso l’aumento volumetrico in facciata o la sopraelevazione, l’inglobamento di balconi e logge o l’aggiunta di serre bioclimatiche al fine di migliorare la gestione dei flussi e ridurre i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento. È possibile estrapolare dalle varie sperimentazioni caratteri compositivi e approcci differenti con la preesistenza. Il rapporto con la preesistenza viene affrontato con modifiche della forma originaria che, a seconda dell’intensità e della leggibilità della trasformazione, vanno dalla mimesi all’integrazione, fino al contrasto.4 La lettura dei caratteri compositivi può distinguersi in due grandi famiglie: bidimensionali e tridimensionali, a seconda che si tratti di interventi leggeri di lifting delle facciate o di demolizioni selettive e aggiunte di volumi. I primi riguardano l’aggiunta di strati funzionali verticali ed orizzontali atti a migliorare le caratteristiche ambientali dell’involucro, la sostituzione di elementi tecnici come serramenti o la sovrapposizione di strati attivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. I secondi riguardano aggiunte di volumi sia localizzate che diffuse o sottrazioni selettive. Si differenziano dagli interventi bidimensionali anche perché possono modificare la distribuzione funzionale degli spazi interni per far fronte alle esigenze di nuove funzioni comuni o alle mutate esigenze dei nuovi nuclei familiari sempre più eterogenei. Quando si tratta di aggiungere volumetrie all’edificio preesistente, queste possono avvenire per addizione (al piede o in facciata), sopraelevazione o attraverso la riqualificazione dell’involucro.5 Le sopraelevazioni sono un campo molto sperimentato in quanto non necessitano di ulteriore bisogno di suolo e costituiscono gli esempi più interessanti dal punto di vista compositivo. Ne sono esempi il progetto DiddenVillage a Rotterdam degli MVRDV o la sopraelevazione realizzata dagli architetti Delugan e Meissl a Vienna. La sottrazione di volumi è utile per alleggerire la densità della costruzione, per creare spazi di connessione o spazi condominiali semi-pubblici migliorando l’equilibrio tra vuoti e pieni. È il caso della riqualificazione del blocco in Goethestrasse del quartiere Leinefelde (Turingia) di Stefan Foster Architekten o i progetti di Lucien Krolla Bèthoncourt e dell’Atelier Castro-Denissof a Lorient in Francia. Le diverse soluzioni sono caratterizzate da specifiche prestazioni tecnologiche ed esiste una corrispon4 E. Zambelli, Fenomenologia e tassonomia degli interventi di trasformazione tecnologico-architettonica in AAVV, Ristrutturazione e trasformazione del costruito, Il sole 24 ore, Milano 2004. 5 J. Gaspari, La strategia dell’addizione nei processi di riqualificazione energetica del costruito, «Il progetto sostenibile», n. 28, 2011. denza tra la forma degli elementi immessi nell’immagine dell’edificio e il deficit tecnologico, ambientale o spaziale che vuole essere sanato. Inoltre le caratteristiche delle nuove tecnologie possono costituire qualità configurazionali, si pensi alle nuove tessiture che offrono le facciate ventilate quando si tratta di interventi che interessano l’edificio nella sua bidimensionalità o all’aggiunta di giardini d’inverno o logge per gli interventi di ridefinizione volumetrica. L’attenzione del dettaglio nel punto di contatto con il nuovo intervento insieme alla caratterizzazione materica e cromatica possono enfatizzare ed evidenziare la riconoscibilità del nuovo intervento e rendere significativa la componente architettonica. Il potere trasformativo insieme alle qualità tecnologico-ambientali e funzionali-spaziali di questi interventi illustrano quanto il progetto di riqualificazione del costruito svolga oggi un ruolo determinante, dotato di una dignità ed autonomia architettonica propria quanto quello di nuova progettazione. La riqualificazione del costruito rappresenta, in conclusione, l’occasione per una riflessione sullo stato in cui versa il nostro territorio e uno strumento per porre un freno alle peri-urbanizzazione e al consumo di suolo a favore di una trasformazione del tessuto urbano ispirato ai principi dello sviluppo sostenibile. Inoltre grazie anche agli investimenti pubblici per raggiungere gli obiettivi energetici e ambientali previsti dai programmi comunitari, appare l’unico orizzonte in grado di aumentare la percentuale delle attività del settore edilizio contro gli interventi di nuova costruzione in continua decrescita e valorizzare le risorse e la capacità professionali e tecniche del nostro paese. Bibliografia M. Imperadori, Vocabolario rinnovato in «Costruire» n. 312, 2009. E. Ginellie L. Castiglioni, Perché valorizzare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblico in «Techne», n. 4, 2012. E. Piaia, strategie di riqualificazione degli insediamenti di edilizia sociale costruiti nella seconda metà del ‘900 in «Il progetto sostenibile», n. 25, 2010. J. Gaspari, La strategia dell’addizione nei processi di riqualificazione energetica del costruito in «Il progetto sostenibile», n. 28, 2011. L. E. Malighetti, Recupero edilizio. Strategie per il riuso e tecnologie costruttive, Il sole 24 ore, Milano, 2011. CREATIVITA’ COME AUTONOMIA INTELLETTUALE NELA PRAXIS UMANA Liberato Otarebill Aliberti “I nostri sogni sono standardizzati, la nostra immaginazione industrializzata, la nostra fantasia programmata. Non siamo capaci di concepire altro che sistemi iperattrezzati di abitudini sociali, conformi alla logica della produzione di massa. Abbiamo quasi perduto la capacità di sognare un mondo in cui ognuno possa essere ascoltato, nel quale nessuno sia obbligato a limitare la creatività altrui, dove ciascuno abbia uguale potere di modellare l’ambiente che a sua volta poi determina i desideri e le necessità.” Ivan Illich, La convivialità Nel mondo occidentale in cui viviamo, la pratica dell’abitare è mutata profondamente. Si sono affermate nuove modalità con le quali viviamo l’esperienza dello spazio e del tempo, mettendo in crisi il concetto di luogo tradizionalmente inteso. Dopo aver assistito al superamento dei limiti del corpo della città, nella città infinita o post-metropoli l’abitare si degrada tra le reti nervose di strade che stanno divorando linearmente il territorio, trasfigurandone l’originario carattere e definendo nuovi paesaggi temporanei e atopici: capannoni, aeroporti, megastore, cave e discariche, cartelli stradali, semafori e villette blindate. L’ipermodernità di questo scenario è configurata da un’architettura anonima e inespressiva che comporta un modo di vivere impersonale, insensibile tanto alla bellezza quanto alla bruttezza e retto da un’idea di comfort privato che si basa sull’ascensore, sull’area condizionata, sulle stanze da bagno iperarredate e soprattutto sulla “bunkerizzazione” degli spazi a base di allarmi, di codici di accesso e porte blindate. In questo territorio post-metropolitano lo spazio pubblico si limita a quello vellutato della circolazione stradale e del consumo solitario nei suoi nuovi templi costruiti per essere ripetuti altrove a tempo determinato. La comunicazione tecnologica cerca di sostituirsi al tradizionale spazio pubblico creando l’illusione di un luogo d’incontro reale, lo spazio cibernetico e virtuale quindi va annientando quello fisico del foro o della piazza, luoghi che per secoli hanno reso possibile la libertà e l’uguaglianza. A questo restringersi degli spazi pubblici reali corrisponde la progressiva perdita per il cittadino del diritto alla città. Il luogo delle decisioni non è più la polis e quindi la politica, ma il progresso tecnico e le risorse tecnologiche a cui l’economia globale si appella per re-inventarsi e trarre nuovi profitti. il cosiddetto progresso tecnico contribuisce così a modificare e trasfigurare il rapporto uomo-territorio. “La miniaturizzazione delle distanze” e l’accesso al mondo dell’alta velocità genera nuove diseguaglianze e fenomeni di de-territorializzazione: nuove elites si svincolano dalla dimensione locale verso quella globale vivendo una privilegiata condizione di entrateritorialità, mentre altri sono destinati a vivere una territorialità solitaria e isolata, sconnessa o clandestina (Z. Bauman). I nuovi immigrati, seppur definitivamente stanziati nei paesi ospitanti, vivono spesso sincronizzati con la cultura del loro paese di origine; seguendo TV satellitari, popshows e telegiornali, connettendosi via web condividono in tempo reale emozioni con i loro cari / l’ubiquità virtuale genera così fenomeni di delocalizzazione culturale. Complessità e diversità sono probabilmente l’unica vera novità interessante del territorio surmoderno non più contenitore di un'unica cultura. Questo modello di conturbamento ipermoderno genera inevitabilmente angoscia territoriale con la conseguente produzione di estraniamento tra gli abitanti ed il loro ambiente. “La città, il paese il territorio diventano indifferenti per il cittadino medio, quello che non ha il potere di mettere le mani sulla città e di mutare il volto dell’ambiente in cui vive [….] Ma la sua attività di abitare non è attività di creazione di luoghi. Egli è solo un utente. Esiste in questi casi una condizione di costante spaesamento […] l’unico spazio che i residenti hanno il permesso di organizzarsi è la disposizione dei mobili della propria casa.”1 In questo scenario, l’uomo è condannato ad essere utente e consumatore, gli è stata espropriata la capacità di trasformare e creare, cioè di usare la tecnica come mezzo per raggiungere i propri fini, intendendo per tecnica l’esercizio di una determinata attività sia essa scientifica che artistica capace di trasformare (“causa che conduce una qualsiasi cosa dall’essere non ente all’essere ente”, Platone)2. La frattura epocale avviene con l’avvento della modernità, dove la scienza monopolizza la tecnica che gira le spalle all’arte (L. Mumford). Questo nuovo regno, privo di questa essenza umana, non promuove un senso, non svela verità: semplicemente funziona. Oggi, questo meccanismo risulta funzionale unicamente alla sopravvivenza del capitalismo fles-sibile (D. Harvey), ha spogliato la vita dell’uomo occidentale da ogni senso depauperando l'ambiente e i luoghi dell'abitare. Se tutto è tecnica quindi l'arte degenera, con essa l'architettura e la fenomenologia dell'abitare. In questa società malata si è ammalato anche “colui che crea ad arte”, che nudo, cieco, disperato ha urlato. Con forte personalità ha espresso sentimenti, emozioni e valori. Con coraggio ha 1 F. La Cecla, Perdersi l’uomo senza ambiente, Laterza & Figli, Bari, 1988, pp. 37-38. 2 E. Severino, Tecnica e architettura, Raffaello Cortina, Milano, 2003, p. 68. cercato la verità, ha difeso tanto la bellezza quanto la bruttezza. L’arte, in tutte le sue forme, è un mezzo e promuove un orizzonte di senso. Appartiene a tutti perché è la capacità umana di servire la volontà attraverso l’autonomia e la creatività. Questi strumenti umani, rappresentano, come molti autori vanno dimostrando da almeno un decennio, le forze guida di un cambiamento radicale delle città contemporanee – in particolare la creatività si pone come uno dei principali obiettivi innovatore ed adeguato alle sfide attuali, elemento cardine quale potenziale sociale bottom-up di arricchimento e rigenerazione capillare. Il termine creatività è figlio dei nostri tempi, ha recente origine – entra nel nostro lessico solo nella seconda metà del '900 - sta ad indicare la capacità, facoltà, attitudine a creare qualcosa di originale, rilevante, realizzabile e utile. In origine “creare” era un'azione esclusiva delle divinità: "Che l'uomo potesse essere creativo nel pensiero e nell'azione era considerato blasfemo fino a qualche secolo fa" (M. Bendin). L’uomo non crea dal nulla pertan-to la creatività umana si esprime dunque come capacità inter-connettiva di attingere da diversi campi del sapere, da esperienze e fenomeni anche apparentemente lontani, per superare regole precedenti, attraverso un nuovo modo di osservare le regole stesse ( R.K. Merton) Ad oggi, la creatività andrebbe considerata come elemento quotidiano nella vita degli indivi-dui, parte sostanziale della loro natura, risorsa fondamentale a cui attingere per generare, creare, trasformare, formulare in maniera originale e globale, per reagire all'omologazione e all'overdose tecnicistica. La creatività nella metropoli deve essere incoraggiata attraverso l'apertura all'alterità e la diffusione di buone pratiche, l'istruzione, il flusso di talenti e sopratutto l'umanizzazione dello spazio (C. Landry), Il problema diventa quindi quello di attivare la trasformazione della città attraverso l’opera tutti gli abitanti, i networks, le associazioni e le organizzazioni cooperative. Divergente e discutibile appare invece la posizione di altri autori vedi Richard Florida - secondo cui la città creativa è quella caratterizzata dalla presenza e dall'attrattività di lavoratori altamente specialisti nel settore della creatività e della conoscenza che renderebbero la città attraente e competitiva per investimenti e crescita economica. Io trovo assurdo quindi che queste possibilità vengano limitate alle competenze di pochi eletti professionisti - Creative class -, cosa ovvia solo in mondo ordinato e prevedibile che tende a mercificare ogni cosa. Bisognerebbe legittimare e promuovere la pratica diffusa della creatività, elemento cardine dell’arte e quindi anche dell’architettura, come strumento nelle mani di tutti per modellare il proprio ambiente e arricchire il mondo di senso, per rifondare la relazione assente con i luoghi della nostra vita, per immaginare modalità collettive di riterritorializzazione urbana, pratiche di appropriazione e par-tecipazione (concetto lefebvriano di diritto alla città). In questo senso l’agire creativamente ed ad arte può rappresentare lo strumento prediletto per sottrarre dall’anonimia e dal degrado gli spazi della quotidianità, per riequilibrare l’ambiente e rigenerare i paesaggi. L’arte deve pertanto rivendicare la sua appartenenza al regno della tecnica, ristabilendola quale mezzo e non fine. Deve essere strumento capillare e vitale dell’abitare, inclusivo di sentimenti, emozioni, irrazionalità, tradizioni e soprattutto senso. Deve essere quindi un mezzo partecipato che dia forma alle nostre abitudini, che generi armonia e convivialità, capacità ecologica di creare relazioni, non solo tra gli esseri umani, ma con tutto il caos della nostra Terra e del cosmo. “Abitare è un arte. L’essere umano è il solo animale che è anche un artista e l’arte di abitare fa parte dell’arte di vivere.”3 3 I. Illich, Nello specchio del passato, Boroli, Milano, 2005, p. 56. L’ARCHITETTURA E I SUOI SURROGATI Nicola Maria D'Angelo “Menzionerò sempre l’eccellente modo di costruire degli antichi: non solo con la prescrizione e la rappresentazione, ma con i modelli in scala e gli esemplari fatti con il legno o con qualunque altro tipo di materiale … L’uso dei modelli permette di vedere e di considerare in maniera esemplare la collocazione nella regione, il perimetro dell’area, il numero e l’ordine delle parti, la stabilità delle coperture … All’Architetto che vuole spiegare il suo progetto non serve produrre modelli colorati e – come si dice – resi attraenti dalle pitture, ma solo a quello ambizioso che tenta di sedurre e occupare gli occhi dello spettatore distogliendolo da un accurato esame delle parti da valutare, per farsi ammirare”1. Così Leon Battista Alberti nel 1452 da un lato consiglia agli architetti di utilizzare gli strumenti a sua disposizione per verificare l'idea del progetto, di approfondire le qualità spaziali e materiche dell'opera attraverso la costruzione di modelli in scala e dall'altro li mette in guardia rispetto al rischio di lasciarsi prendere la mano dalle capacità degli artigiani di realizzare modelli colorati in grado di distrarre e affascinare gli spettatori, e per questo consiglia la costruzione di modelli nudi e semplici. La preoccupazione di Leon Battista Alberti ci dimostra quanto il dibattito su un corretto uso degli strumenti a disposizione dell'architetto e della rappresentazione dell'idea di progetto non sia un dibattito esclusivamente contemporaneo e legato alle nuove tecnologie. Alberti mette in guardia l'architetto rispetto alla qualità dell'opera da realizzare ed è preoccupato che la qualità dell'architettura possa essere subordinata alla volontà di affascinare gli spettatori e di conquistare il consenso. Nei secoli il rapporto tra l'architettura e la sua prefigurazione ha avuto momenti in cui, come negli anni Settanta per la “tendenza” italiana, il disegno ha acquistato una autonomia rispetto alla costruzione architettonica che ha portato l'architetto ad occuparsi sempre di più dell'ideazione e della sua restituzione grafica e a preoccuparsi sempre di meno della sua realizzazione. Oggi la prefigurazione dell'architettura costruita rischia di essere sempre più autonoma ed alle questioni teoriche legate alla composizione architet-tonica si aggiungono le potenzialità espresse dalle nuove tecnologie a disposizione dell'architetto contemporaneo esaltanti l'ideazione, il cui uso però non nasconde più soltanto il rischio messo in risalto dall'Alberti. Il CAD (Computer Assisted Design) ad esempio è stato l'antesignano dei software a servizio dell'architettura, ha consentito la costruzione di immagini degli edifici sullo schermo del computer e ha velocizzato di molto la restituzione grafica dei progetti aumentando la capacità di dettaglio. La tecnologia fu introdotta nel 1963 da Ivan Sutherland al Massachesetts Istitute of Technology e sono pochi gli architetti che da allora si sono sottratti al suo utilizzo. L'utilizzo del CAD ha suscitato le prime riflessioni rispetto non tanto alla qualità e alla fedeltà della rappresentazione digitale quanto alle abilità che il nuovo strumento rischiava di affievolire. Il sociologo americano Richard Sennett ci fa riflettere rispetto all'uso di questo tipo di tecnologie. Sennett racconta l’esperienza di una giovane studentessa del MIT che, quando nelle facoltà di architettura fu sostituito il disegno manuale, ebbe a rilevare: “quando fai il disegno del terreno da edificare, quando ci aggiungi tratteggi per il contrasto e gli alberi, quel terreno si radica nella tua mente. Arrivi a conoscerlo in un modo che con il computer non è possibile… a furia di disegnarlo e ridisegnarlo senza che sia il computer a generarlo per te”2. Questo disegnare e ridisegnare è per Sennett uno strumento di conoscenza, uno strumento che aiuta il progettista a maturare un pensiero rispetto al contesto e a prendere contatto con la realtà circostante. Ma sono tre i difetti principali che Sennett rileva nella progettazione elaborata al CAD che ne fanno una pratica scissa dalla corporeità e quindi nascondono un ulteriore rischio per gli architetti e per l'architettura. Il primo è lo scollamento tra simulazione e realtà, i render e le vision ci raccontano di strade assolate e persone felici, alberi sempreverdi mossi dal vento, vetrine pulite e gabbiani in volo, scenari tanto idilliaci quanto troppo spesso irreali. Il secondo è che la progettazione che esclude la mano disabilita anche un certo tipo di intelligenza relazionale; ad esempio una prospettiva ingannevole è capace di occultare un problema progettuale e la tentazione di nascondere i problemi del progetto è sempre molto forte. Il terzo è l’iperdeterminazione. Un progetto risolto e raccontato in ogni sua parte esclude ulteriori margini di miglioramento e esclude anche margini di adattamento degli utenti. Affidarsi al CAD rende difficile il controllo della 2 1 L. B. Alberti, De re aedificatoria, 1452, trad. it. a cura di V. Giontella, L’arte del costruire, Bollati Borighieri, 2010, p. 48. R. Sennett, L’uomo Artigiano, trad. it. A. Bottini, Feltrinelli, Milano, 2008 (ed. orig. The Craftsman, Yale University Press, London, 2008), p. 47. scala e della proporzione, fornisce l’illusione di governare il progetto a 360 gradi dando la possibilità di introdurre nella rappresentazione la quarta dimensione e fornisce la possibilità di costruire scenari prospettici irrealisticamente coerenti. Il cad come osserva l’architetto Elliot Felix, a causa della sua capacità di cancellazione e ricreazione istantanee “comporta meno conseguenze che se fosse fatto sulla carta dunque ci si riflette sopra con minore attenzione”3. Se l'architetto nel 1452 rischiava di trasformarsi in un buon venditore mettendo in secondo piano la comprensione e la valutazione delle qualità dell'architettura, oggi grazie agli strumenti a sua disposizione rischia anche di indebolire le sue capacità e le sue conoscenze. Considerando che in molti casi il progettista non si occupa più della fase realizzativa, che è di competenza del direttore dei lavori, l'architetto corre il rischio di concentrarsi solo sulla parte ideativa spingendo la prefigurazione in un altro campo ancora diverso rispetto anche a quello degli architetti degli anni settanta riferibili alla cosiddetta “tendenza”. Che una cosa fosse già completa nella concezione prima di essere costruita fisicamente è una convinzione che prende piede già alla fine del diciannovesimo secolo quando le tavole cianografiche acquistano valore legale divenendo di fatto un elemento del contratto tra progettista e committente. Quello fu un primo decisivo punto per cui una cosa è già completa nella concezione, prima di essere costruita fisicamente e se la concezione si esplicita attraverso l’uso di strumenti potenti come il CAD l’architetto rischia di introdurre nella pratica professionale la costruzione del surrogato, ovvero un succedaneo dell’architettura: il modello, il disegno virtuale, lo schizzo, non sono più strumenti di elaborazione dell’idea ma diventano l’idea. Il surrogato non è un passaggio necessario per la costruzione del progetto, diventa l’architettura, l’opera anticipata nel suo farsi, l’opera che esclude dalla sua natura tutti quei processi che in passato seguivano la rappresentazione iniziale dell’idea e poi la successiva realizzazione, l'opera che si racconta come se fosse conclusa indebolendo il momento esperienziale necessario per la sua comprensione. E’ l’opera che si esprime attraverso immagini in grado di affascinare, immagini che rappresentano un ideale da raggiungere, l’architetto inizia a preoccuparsi non solo di conquistare il consenso ma di conservarlo, per questo come ricorda Fernando Espuelas: “ci sono architetti che riescono a trasformare certi processi grafici in strumenti efficaci al servizio di una nuova architettura, in molti altri casi invece si costringe il progetto ad un processo di costruzione forzato, artificioso o tortuoso”4. 3 4 R. Sennett, op. cit.,p. 47. F, Espuelas, Madre Materia, Marinotti, Milano, 2012, p. 90. Questo per far assomigliare l’architettura al suo surrogato, un processo insensato per produrre opere che nell’ambizione di assomigliare a qualcosa di irreale finiscono per essere a loro volta un surrogato di se stesse o come ricorda sempre Espuelas: “l’edificio reale finisce per diventare il fratello sfortunato di un primogenito grafico perfetto”5. E di questi fratelli sfortunati iniziano ad essere piene le nostre città, che pure si considerano fortunate nell’accogliere architetture che non manifestano le promesse contenute nei render. E’ probabile allora, al fine di ritrovare la corretta relazione tra la rappresentazione progettuale e l’esecuzione materiale, occorra ripartire dall'ammonimento Albertiano ed utilizzare tutti gli strumenti a disposizione del progettista per verificare e valutare le qualità dell'architettura senza la preoccupazione di conquistare il consenso generando stupore attraverso immagini irreali che, in definitiva, tradiscono gli utenti, producendo architetture le quali nella loro realizzazione e materializzazione non sono in grado di essere all'altezza della loro prefigurazione. Come Gottfried Semper nell'Ottocento non bisogna preoccuparsi del progresso tecnico ma della incapacità di dominarlo senza sacrificare al suo altare quelle competenze che nascono dall'esperienza, tattile e sensoriale anche, che è ancora fondante la disciplina costruttiva. 5 Ibidem. IL LATO OSCURO DEL "DIGITALE" Mario Coppola Generalmente gli uomini non sono sinceri quando si tratta di argomenti sessuali. Essi non rivelano volentieri la loro sessualità, ma indossano un pesante cappotto (vera fabbrica di menzogne) per nasconderla, come se nel mondo del sesso facesse sempre brutto tempo. Sigmund Freud Sono ormai numerosi anni che nel panorama internazionale dell'architettura ci si è abituati a far riferimento a un genere di progettazione, un linguaggio se vogliamo, genericamente "digitale", altrettanto generalmente "parametrica", "computazionale" e via dicendo. In realtà risulta evidente a chiunque che ormai l'architettura, e quindi la progettazione, non può che essere digitale, nel senso che non può che avvalersi dell'informatica e della grafica computerizzata, e, quindi, a ben vedere non esistono più progetti "analogici", o "manuali", eccezion fatta per i fanatismi ortodossi di pochissimi "ribelli" che poco o nulla contano più nello scenario globale che di mese in mese va configurandosi. Attraverso un qualunque personal computer, non necessariamente particolarmente potente o dalla componentistica "ad hoc", è possibile progettare architettura "digitale", ma anche computazionale o parametrica: è sufficiente legare a una banalissima funzione matematica le relazioni che uniscono i pilotis di villa Savoye per trasformare il classico corbusiano in una novella architettura parametrica, che al variare di uno di questi famigerati parametri acquisisce nuove proporzioni, nuova forma. Se poi allarghiamo di pochissimo l'orizzonte, dobbiamo senz'altro affermare che nel campo dell'ingegneria aerospaziale la progettazione è "parametrica" da molto più tempo, ma in quel caso ben pochi sono stati i cambiamenti nelle linee degli aerei passeggeri dettati dal cambio di strumento progettuale: l'aereo deve "star su", e deve farlo a svariate centinaia di km all'ora, ragion per cui in quel caso i parametri sono così tanti che la creatività stessa del designer è ben poca cosa. Programmi come Katia sono alle origini della progettazione computazionale, legando tutti gli oggetti del progetto in una complessa e fitta rete di relazioni geometriche, al variare delle quali anche gli oggetti mutano di forma, dimensioni e posizioni. Nello studio di Frank Gehry, l’uso Katia fu trasformato in "Digital Project", o semplicemente "DP", da architetti e ingegneri impegnati a creare uno strumento per velocizzare la "strutturalizzazione" dei modelli in cartoncino e stagnola di Gehry, ma ancora allora l'etichetta "parametrica" o "computazionale" era ben lontana dall'essere istituita. Fu molto dopo l'arrivo delle tecnologie informatiche che iniziarono i primi concepts - successivi a quelli raccolti da Greg Lynn nella pubblicazione del 1993 "Folding in architecture" - e solo in seguito, sul finire del vecchio millennio, essi verranno rinominati con nuove etichette, il cui linguaggio prenderà forma e sostanza principalmente nello studio della più famosa dama dell'architettura, Zaha Hadid1. Lo studio Hadid, sotto l’impulso di Patrick Schumacher - che lancia nel 2008 un vero e proprio "Manifesto del Parametricismo", con tanto di euristica divisa in dogmi e tabù per aiutare i principianti a stare e restare all'interno del nuovo paradigma architettonico - non è che il più conosciuto e fortunato avamposto del movimento "digitale", che ormai conta su dozzine di studi e pratiche professionali che vi si riconoscono appieno. Alcuni nomi: Snohetta, MAD, Xefirotarch, UNStudio, lo stesso Lynn, SPAN e molti altri. L'architettura "digitale" influenza poi intere scuole: il DRL di Schumacher a Londra, master degree dell'Architectural Association pioniere nel "campo" dell'insegnamento del linguaggio "parametrico", ma anche lo SCI-Arch di Los Angeles, lo IAAC di Barcellona, fino in Italia, dove il movimento computazionale fa riferimento, più che a vere e proprie pratiche professionali o "scuole" come quelle citate, a master - tra cui quelli della IUAV e dell'InArch entrambi nominati "Architettura Digitale" - e a corsi organizzati da professionisti indipendenti. In realtà, non è affatto la "digitalità" o la "parametricità" a definire un vero e proprio linguaggio architettonico, e basta giocare un po' con Grasshopper (il plugin interattivo di Rhino che apre le porte delle geometrie parametriche a chiunque abbia un minimo di background informatico e matematico alle spalle) per rendersi conto che, come è ovvio, parametrici sono solo gli strumenti, la tecnologia che sta alla base del nuovo "linguaggio". Eppure, esiste un minimo comune denominatore di questo movimento globale, rintracciabile in ogni immagine, diagramma, rendering o piccola realizzazione (per lo più, fatta eccezione per i mega studi come quello di Hadid, si tratta di piccoli oggetti di design o installazioni temporanee) che ne fa fenomeno ben diverso dalla libertà creativa totale (dominio dell'interpretazione e quindi di un soggetto onnipotente, svincolato dall'oggetto, per richiamare la querelle filosofica odierna) degli architetti postmoderni e decostruttivi: si tratta anzitutto, in superficie, di un palese tentativo di bio-mimesi. Capovolgendo i termini della questione, nonostante ciò non sia dichiarato mai dai pionieri del movimento digitale - i quali, di contro, tengono molto a prendere le distanze da qualunque architetto esistito o vivente ma dichiaratosi estraneo al "paradigma parametrico" - o dalle stesse scuole - tutte assolutamente prive di un 1 Nominata dama del lavoro dalla Regina Elisabetta II nel 2012. vero e proprio statuto culturale che ne riconosca questa prima, palese, caratteristica (a riprova di ciò i nomi "architettura digitale" dei due master italiani, in realtà semplici corsi di formazione professionale tecnica, dove è possibile esercitarsi con i software senza entrare nel merito della questione architettonica, cioè culturale) - più che di architettura parametrico-digitale si dovrebbe parlare di una architettura bio-mimetica, deriva del filone di ricerca post-decostruttivista, la cui mimesi biologica viene tentata attraverso l'utilizzo degli strumenti computazionali parametrici, che ricordano un po' il primo uso di internet: la pornografia online, accessibile gratis da chiunque. Sempre restando all'interno di questo primo comune denominatore, possiamo affermare che la diffusione massiccia di questo linguaggio è senz'altro dovuta alla diffusione di questi strumenti - non solo i software, ma anche, ad esempio, i macchinari che rendono possibile la stampa in 3d, laser cutter, eccetera, che offrono la possibilità di creare un modello fisico di queste geometrie altrimenti solo digitali - che sono i primi rivolti al grande pubblico capaci di gestire e manipolare il genere di complessità insita nelle geometrie biologiche. Potremmo dire, facendo una ipotesi tutto sommato verosimile, che i macchinari e i programmi computazionali, generativi eccetera, non fanno altro che rendere disponibili ai più una sfera espressiva che fino a pochissimi anni fa era appannaggio esclusivo delle persone più "tridimensionalmente" dotate, più capaci di immaginare e rappresentare, a mano, la complessità geometrica delle strutture naturali. Gli sforzi olimpionici attraverso cui Wright, Le Corbusier, Saarinen, finanche il Buonarroti (si pensi naturalmente alle fortificazioni fiorentine) e gli altri architetti che hanno utilizzato la sintassi biologica nelle loro opere, riuscivano a immaginare, a gestire (anche dal punto di vista strutturale) e a rappresentare figure bio-morfe, vengono trasformati nei computer contemporanei in operazioni immediate, quasi "ottuse" nel loro automatismo. Non serve più l'intelligenza plastica dei geni dell'architettura mondiale per ottenere un guscio a forma di granchio come quello di Ronchamp, ma basta spostare un paio di punti di controllo di una manciata di splines e fare un banale loft per ottenere la copertura della celeberrima cappella corbusiana. Ebbene, è proprio in questo cambiamento che avviene un fatto a nostro parere fondamentale per la cultura architettonica contemporanea: così come la decorazione architettonica attraverso la catena di montaggio industriale all'acuta lettura di Loos diveniva immorale - per l'assoluta gratuità del gesto ripetitivo con cui le macchine dell'industria potevano replicare ornamenti, stucchi e merlature dell'architettura storica, senza per questo raccontare ed essere frutto di un'arte, la sola severa disciplina culturale grazie alla quale un tempo erano possibili triglifi e metope - allo stesso modo ci permettiamo di riprendere il pensiero del maestro austri- aco e applicarlo alla ricerca architettonica contemporanea, per affermare che è proprio la banalità - più che semplicità - con la quale è oggi possibile ottenere strutture in tutto e per tutto biomorfe (con grasshopper o maya si ottiene un complicatissimo pattern Voronoi in pochi secondi) senza la minima ricerca, senza la minima disciplina artistica - cioè praticamente senza il minimo filtro culturale - a denunciare la fine di ogni tratto di verità e di poesia di tali costruzioni. L'ovvia auto-illusorietà di un'architettura che seppur fatta dall'uomo replica in tutto e per tutto le strutture naturali - nessun visitatore potrà mai vivere la fascinazione che si ha di fronte le strabilianti rocce erose della Cappadocia, sapendo che ciò che lo circonda non è che un artefatto umano che scimmiotta la natura2 - si scontra poi con un altro scoglio: che l'uomo, così come non è capace di vivere senza costruire un complesso codice linguistico che sia tramite con gli altri uomini, così non è geneticamente fatto per vivere senza alcuna "mediazione", cioè senza alcun codice culturale, nella "natura", ove mai riuscissimo davvero ad ottenerne una in cui dai rami degli alberi germoglino baccelli abitativi. Ciò detto, risulta quindi un palese autoritarismo quello con cui il nuovo "ismo" parametrico/generativo/computazionale/eccetera mira - in una completa analogia con lo storicismo che vorrebbe tutto uguale a ciò che "è storicamente riconosciuto e convalidato" - ad un mondo dove ogni singola forma è dettame della mente di un novello zio Adolfo dell'architettura3. Questa semiologia architettonica, che è anche la tesi ufficiale di Schumacher, suggerirebbe alle persone cosa fare e dove andare, fagocitando l'essere umano all'interno di una natura artificiale che, pur fatta da lui, lo illuda e lo costringa ad obbedire al sistema produttivo, come fosse un batterio all'interno di un organismo, e come accade nei film di fantascienza che raccontano di derive tecnologicamente autoritarie e coercitive della società del consumo (del "progresso"?). Ma, al di là di questi forse ingenui scenari totalitaristi, che oltre ai neo-storicisti sono appartenuti a chiunque in passato abbia pensato di possedere la chiave di una società migliore, la bio-mimesi rimanda a sua volta a una questione ben più profonda: basta fare un breve screening dei progetti in questione per accorgersi che se dietro la comunicatività/produttività del manifesto parametrico c'è la bio-mimesi, questa è a 2 Vale la pena citare le gettonatissime e popolarissime superfici "organiche", modellate in pochi secondi e costruite tramite pannelli a doppia curvatura: non ci vuole un master in biologia per rendersi conto che, a differenza delle conchiglie o delle scaglie dei rettili che si auto-conformano ottimizzando risorse, energie e resistenza, i pannelli sono curvi perché passati per processi industriali energivori che tentano di piegare il materiale al modello 3d ottenuto senza alcuno sforzo. 3 Si legga a questo proposito il saggio breve di Schumacher pubblicato in "Being Zaha Hadid", Abitare n. 511, 2011, Milano. sua volta strumento della volontà/desiderio di svelare una carica di sensualità femminile che da sempre l'uomo ha sentito di cogliere negli scenari naturali e quindi cercato di riprodurre attraverso la sua opera (si pensi, per restare nel contemporaneo, a Modigliani o a Moore). Si modellano forme naturali perché, attraverso di esse, si tenta di esprimere e sublimare il desiderio del corpo femminile, della sinuosità erotica insita nelle linee corinzie. Si tratta, cioè, del richiamo del corpo, dell'"origine" per dirla con Esposito, che nelle strutture organiche esprime la fecondità femminea, così come il maestro brasiliano Niemeyer dichiarava schiettamente, svelando la sua volontà di esprimere questa sensualità, che poi, come è noto, originava dalle curve corbusiane dal solarium di villa Savoye, già tutt'altro che "razionalista"4, fino alla copertura organica, "selvaggia" di Ronchamp. Se mettiamo da parte la quasi sempre mancata sincerità riguardo lo spirito "organico" e bio-mimetico insito nell'architettura digitale, che si nasconde dietro mille e una ragioni (Schumacher come anticipato si rifà a una civiltà post-fordista in cui le curve e la correlazione della forma organica relazionale sono funzionali ad essere più produttivi in ufficio, senza mai dichiarare la palese ricerca per una certa proporzione, per un certo equilibrio delle linee che naturalmente può spiegarsi solo con la pulsione suddetta), il problema resta quello di una forma che, appunto, è meramente "mimetica", che non passa per alcun filtro culturale e che, quindi, non affronta il problema del codice, della memoria e, infine, dell'etica (si è accennato già ai costi in termini energetici e quindi economici delle costruzioni bio-mimetiche, ad oggi), come se Moore avesse scolpito realistici e procaci corpi di donna e Modigliani dipinto le - pur meravigliose anche se non certo opere d'arte - maliziose donnine di Manara. Invece, come testimonia la stragrande maggioranza dei progetti "parametrici", la ricerca "digitale" contemporanea finisce in un vicolo cieco che attraverso gli strumenti informatici impoverisce non solo il tema organico/biologico, che si trasforma quasi in volgare pornografia (come testimonia il recentissimo stadio di Hadid in Qatar accusato, appunto, di somigliare troppo letteralmente a una vagina), ma anche con una visione apocalittica nella quale si è del tutto perso il carattere umano in nome di quello biologico/bestiale, come se all'origine femminea e feconda non facesse da contrappeso la cultura e la memoria, pure umane, e quindi il codice storico come ordine e disciplina per la convivenza comunitaria (anche qui si 4 Meno conosciuta del manifesto dell'architettura moderna con pilotis finestre a nastro soprelevazione eccetera è la passione del corvo per la forma organica, che invece l'artista svizzero coltivava collezionando mandibole di animali, conchiglie, carapaci di granchio, scrivendo in maniera meno pubblica di trovare il senso del sacro nella forma biologica, scorgendo in essa proprio la sacralità della vita a cui fare riferimento nel progetto architettonico. pensi ad un altro stadio, sempre dello studio Hadid/Schumacher, che a Tokyo (!) è stato accusato di non avere la minima sensibilità per il contesto urbano, trattandosi di una megastruttura che convive con l'ecosistema dei grattacieli nipponici come l'alieno di Ridley Scott fa con l'equipaggio della Nostromo). Ciò che avviene oggi con il movimento parametrico e digitale, potremmo dire, è esattamente uguale e opposto a quanto avveniva con l'accademizzazione del codice europeo nell'architettura internazionale, al quale Modigliani così come Le Corbusier, anche se in forma diversa, si ribellarono attraverso nudi e curvilinea organicità 5: il versante dell'origine, della fecondità ancestrale del mondo biologico privo di codice culturale, e quindi di regole sintattiche, si è trasformato, indossando il cappotto di menzogne di Freud che ieri erano la razionalità dell'uomo che ha vinto sulla natura (mentre l'Europa e il mondo intero rischiavano di sprofondare nel male assoluto del nazismo, che potremmo definire come l'eccesso ultimo del codice sull'origine vitale, come testimoniano le oscenità di Speer o degli architetti di Stalin) e oggi sono la razionalità dell'uomo post-fordista che ha inventato il network e può usarlo per aumentare la propria efficienza a svilupparsi tecnologicamente (mentre è ormai chiaro che all'aumento di progresso tecnologico corrisponde devastazione dell'ecosistema e depressione, senso di vuoto che va di pari passo all'atomizzazione sociale, individualismo sfrenato, adolescente che preferisce giocare alla playstation o stare su facebook piuttosto che incontrare e scontrarsi con le persone fisiche). E questa accademizzazione, come sempre nella storia, acquisisce il carattere brutale di una letteralità quella dello stadio-vagina di Hadid, per esempio - che sottrae del tutto poesia e verità dalla produzione di massa del femmineo, del sinuoso biologico, che invece si trasforma in un carnaio di curve e controcurve di plastica che nulla più hanno a che vedere con gli oggetti a reazione poetica così come nulla più hanno in 5 "…[Modigliani] non accetta l'idea di una pittura analitica, la pittura dev'essere poesia. E' un limite, ma grazie a questo limite Modigliani non cederà al richiamo all'ordine, alla ragione, all'equilibrio classico. Alla «perfetta proporzione» di Gris, alla «pittura senza errori» di Braque, a Picasso che si mette a rifare Ingres, al Cubismo ‘cartesiano’ e no, infine, Modigliani oppone un'irrequietezza, una tensione interiore, che lo mettono dalla parte dei grandi ‘obiettori’, Delaunay e Duchamp" in G. C. Argan, L'Arte moderna 1770-1970, Sansoni, 2002, p. 230. E a proposito delle forme organiche, più sommessamente dei manifesti dello spirito nuovo, nel 1960 scriveva Le Corbusier: "Questi frammenti di elementi naturali, pezzi di roccia, fossili, schegge di legno, cose conformate e maturate vicino l'acqua, laghi e oceani ... che esprimono leggi fisiche, l'usura, il decadimento, e così via, non solo hanno qualità scultoree, ma anche uno straordinario potenziale poetico." (a proposito degli oggetti "a reazione poetica", scritto riportato dalla personale su Le Corbusier "Moment - Le Corbusier's secret laboratory" tenuta al Moderna Museet di Stoccolma dal 19 Gennaio al 18 Aprile 2013). comune con l'organicità in generale. Se questo movimento "digitale", una volta riportato alla sua taciuta essenza "pornografica", rivela l'impossibilità di una vita umana in questo scenario di natura artificiale, è anche vero che il codice - in architettura l'edificio storicamente riconosciuto, fatto da griglie ortogonali di travi e pilastri, finestrelle rettangolari eccetera - da solo, privato della matrice biologica, come afferma Esposito diviene meccanismo mefitico e letale e conduce all'autodistruzione, annullamento della vita (senza sforzare troppo la fantasia, si pensi ai "cimiteri" di Grassi e Ungers). Come invece testimoniano i flessuosi nudi di Modigliani, le sensuali concavità/convessità di Moore e il leggiadro drappeggio di villa Savoye - e come scrisse a chiare e inequivocabili lettere Argan nella sua celeberrima "Introduzione a F. L. Wright" del 1947 - l'origine, la radice creativa biologica e organica, è indispensabile alla Vita, e lo è soprattutto oggi, mentre le nostre megalopoli cartesiane distruggono ciò che resta dell'ecosistema terrestre. E' indiscutibile, cioè, che l'architettura come espressione dell'umana civiltà in guerra per l'emancipazione da madre natura debba cambiare, per puntare a una simbiosi con il mondo naturale che sostituisca la prevaricazione cartesiana; e ci pare ragionevole sostenere che tale simbiosi debba essere insita fin proprio nella sintassi, nella figura di questa bio-antropo-architettura, che deve essere capace di presentare tale coesistenza, tale natura simbiotica nel suo aspetto globale così come nei suoi elementi costitutivi e nel funzionamento energetico e sociale. Solo in questo modo sarebbe possibile un'architettura/arte etica, cioè, per dirla con Deleuze, etologica: un'architettura che anzitutto dica all'uomo che non è solo Uomo, che non è padrone della Terra diverso per diritto di nascita dalle altre specie viventi, ma che è invece prima di tutto proprio un vivente come gli altri, e quindi un'architettura in grado di essere insieme "uomo" come fatto storico, come codice culturale antropico, e essere umano, come homo sapiens sapiens, forma di vita contigua e coesistente con le altre. I termini del problema, quindi, diventano i seguenti: come e in che misura è possibile inserire l'origine biologica, la matrice creativa e feconda della Vita, nell'architettura contemporanea senza produrre i falsi alienanti del macello orgiastico della ricerca digitale? Come è possibile tenere conto contemporaneamente dell'origine biologica e del codice culturale, senza singhiozzi e senza contraddittorie dicotomie? Il superamento della contrapposizione cartesiana tra uomo e natura, soggetto e oggetto, ricorda molto da vicino quello dell'apparente contrapposizione tra le due creatività di Chomsky: la creatività governata dalle regole - la "tettonica" intesa come struttura ortogonale di architravi e pilastri nella quale attuare la creatività come eccezione, aggiunta o sottrazione, intersezione o incastro di elementi contraddittori, magari persino bio- morfi - e la creatività che cambia le regole - quella di Michelangelo che, nel '500, uscì completamente dai canoni e disegnò le fortificazioni fiorentine utilizzando il lessico biologico, talmente biologico che poi non ebbe il coraggio di presentare il progetto, identico al carapace di un'aragosta, perfetta macchina da guerra. Eppure sappiamo che le due creatività, di fatto, coesistono e fanno parte della vita, nella quale si succedono senza soluzione di continuità: come avviene nella definizione di soggetto interdipendente di Morin, anche in questo caso non è possibile esercitare una creatività governata dalle regole se prima non c'è stata una creazione delle regole, così come le regole non possono essere cambiate se queste non esistevano già in precedenza. Le due forme di creatività non sono che due pieghe dello stesso intessuto: bisogna trovare la forma di un drappeggio che possa contenerle entrambe. Quindi il problema è ancora una volta fondere insieme il tempio greco e il carapace di granchio, senza restare intrappolati nella creatività governata dalle regole - quelle cartesiane della separazione/bipolarismo - che vogliono la contrapposizione/giustapposizione di due coerenze conflittuali destinate a non coesistere mai armonicamente, senza essere mai l'una tessuta nell'altra: l'ordine tettonico tradizionale vs l'autoconfigurazione naturale, magari incastonati o intersecati l'uno nell'altro come due rivali costretti nella medesima casa, per giunta di proprietà del primo. Invece è necessario ricomporre insieme soggetto e oggetto in una coerenza unitaria, senza per questo inclinare tutti i pilastri finendo nel tentativo "parametrico" di evocare esclusivamente un pattern naturale (anche se, staticamente, è stato dimostrato che ciò funzioni senz'altro meglio delle strutture ortogonali, considerate le sollecitazioni orizzontali di vento e sisma, com'era ovvio visto che le strutture naturali sono per definizione ottimizzate), ma nemmeno mantenere tutti i pilastri "dritti" preservando in pieno la tettonica "storica" per rispetto di una regola siffatta inviolabile: se così facessimo ci ritroveremmo di nuovo nel dominio di chi riconosce l'esistenza di un oggetto indubitabile, regola dorata che governa la vita di soggetti altri da sé, e dovremmo poi fare un nuovo elenco "zeviano" delle "invarianti", delle regole inviolabili dell'architettura. Sicuramente non l'architettura "parametrica" (biomimetica, ndr) e la sua ricerca bio-digitale rinchiusa in se stessa, ma altrettanto sicuramente nemmeno l'architettura "neo-realista", anacronistica e quindi altrettanto falsa, retrograda al limite della necrofilia: serve qualcosa che racconti insieme della nostra storia civile e della nostra origine bestiale, inserendo la nostra umanità all'interno della nostra terrestrialità, e non pretendere che sia viceversa (d'altra parte, va da sé che è il linguaggio "culturale" a far parte di quello più ampio, naturale, come un dispiegamento finale parte di un sistema che lo contiene). Serve qualcosa che sia familiare parallelepipedo, coi suoi spigoli vivi e le sue strutture più o meno ortogonali, e insieme conchiglia che si schiude al mondo, come un canyon eroso dal vento e pervaso dall'acqua e dalla vegetazione, che offre spazi bio-antropici per l'incontro tra le persone e con gli elementi naturali; per questo è necessario conoscere e utilizzare tutta la tecnologia, parametrica e non, di cui disponiamo, piegandola allo scopo, senza perderci in essa rincorrendo l'ineffabile altro da noi che non è la natura, così come i grandi maestri usarono e governarono le più grandi scoperte tecnologiche della storia dell'architettura piegandole alla loro creatività: programmi, materiali e tecnologie innovative, tutto deve essere usato come strumento per rendere l'architettura più umana e insieme più naturale, meno energivora e meno chiusa in se stessa, in continuità con i patii e le corti eppure capace di interagire e di correlarsi agli spazi preesistenti, all'ecosistema terrestre come una ragnatela vivente. Silvano Petrosino Elogio dell’uomo economico Vita e pensiero, Milano, 2013 Ciò che bisogna opporre alla deriva distruttiva del business non è la 'gratuità', e neppure un''etica degli affari' o un''economia del dono', ma l''economia', semplicemente l'economia, anche se deve essere un'economia all'altezza del suo stesso nome. Quest'ultima, per essere tale, è come obbligata a rispondere a un doppio imperativo: essa deve misurare e calcolare (non può mai procede a caso: necessita di una ratio), ma al tempo stesso deve anche riconoscere che il suo calcolo (la sua ratio) è destinato per delle ragioni essenziali a misurarsi con l'incalcolabile. Uno stimolante saggio filosofico che, partendo da un'analisi approfondita delle radici antropologiche dell'abitare umano, arriva a denunciare la perversione di molta 'finanza creativa' e l'ingenuità delle diverse 'etiche degli affari'. posto per la prima volta in Italia, offre una risposta che diventa un fertile richiamo per chi studia e pratica l'architettura. La cultura contemporanea rivela un predominio della dimensione visiva che, pur avendo profonde radici nella storia della civiltà occidentale, raggiunge oggi proporzioni inedite. Mentre la nostra esperienza del mondo si basa sulla combinata integrazione dei sensi, l'architettura viene pensata e realizzata nel segno del solo senso della vista. Ciò finisce con l'appiattire le potenzialità del manufatto architettonico e dell'ambiente complessivo, che ne resta impoverito provocando spesso distacco e alienazione in chi lo abita. Nella prima il testo offre uno sguardo d'insieme sulla affermazione nella cultura occidentale, a partire dalla Grecia classica, della centralità dell'occhio e della visione nella pratica e nella fruizione dell'architettura. La seconda parte esamina il ruolo degli altri sensi nell'esperienza architettonica, facendo emergere la necessità del nesso corpo-architettura e di un approccio integrale, in quanto "multisensoriale", all'architettura. Giulio Giorello con Ilaria Cozzaglio La filosofia di Topolino Guanda, Parma, 2013 Emanuele Severino Intorno al senso del nulla Adelphi, Milano, 2013 Juhani Pallasmaa Gli occhi della pelle Jaca Book, Milano, 2007 L'architettura ha la capacità di coinvolgere, ispirare, accogliere e promuovere l'esistenza umana in tutte le sue espressioni. Per quale ragione, tuttavia, schemi e disegni architettonici che appaiono gradevoli su carta o sullo schermo del computerfiniscono per risultare così deludenti una volta realizzati? Questo libro di Pallasmaa, ormai un classico a oltre dieci anni dalla sua pubblicazione e qui pro- più profonda di quanto possa sembrare e dall'altro si indagano «le condizioni che rendono possibile la via di uscita». Approfondimento quanto mai necessario, giacché se si rinunciasse a discutere le aporie suscitate dal senso del nulla resterebbe in sospeso la stessa tesi di fondo del pensiero di Severino: che l'uomo e ogni altro ente «sono da sempre salvi dal nulla». Il significato radicale che il «nulla» ha assunto nella riflessione filosofica occidentale accompagna come un'ombra non solo questa forma di pensiero, ma l'intero tragitto della nostra civiltà. Radice prima dell'angoscia, il nulla turba anche e soprattutto per il suo carattere sommamente ambiguo: già Platone, infatti, osserva che pensare il nulla e parlare del nulla significa pensare qualcosa e parlare di qualcosa – come se il nemico che si ha di fronte si sdoppiasse, ingannandoci sulla sua identità. Questa nozione spaesante, che esige di essere interpretata alla luce delle forme più rigorose della speculazione, è stata affrontata da Severino a partire da La Struttura originaria (1958) e fino a La morte e la terra (2011): a tali due opere, e alla seconda in particolare, si ricollega Intorno al senso del nulla, dove da un lato si mostra come l'ambiguità sia ben Il Novecento - secolo dei totalitarismi, ma anche delle più rivoluzionarie scoperte della scienza, dalla relatività di Einstein alla doppia elica del DNA ha avuto il suo filosofo più provocatorio in un Topo che, per spregiudicatezza nell'attraversare i confini delle discipline e mettere in discussione la costellazione delle certezze stabilite, non ha nulla da invidiare a Russell, Popper o Heidegger. Mickey Mouse (Topolino per noi) ha vissuto le più bizzarre avventure e affrontato quesiti come la terribile libertà del "quarto potere", gli ambigui prodigi della scienza asservita alla guerra, l'impossibilità della giustizia e la difficoltà di trattare con le culture "altre", per non dire delle sfumate regioni del mito o dell'aldilà. Altro che Topolino tutto legge e ordine, aiutante della polizia! È invece un ribelle capace di battersi contro ogni forma di prevaricazione, anche se l'esito non è sempre la vittoria. Quello che Walt Disney e i suoi collaboratori ci consegnano alla fine di ogni episodio è un Topo sempre più dubbioso sulla natura dell'universo e il complesso mondo di "uomini e topi". Ma proprio per questo continua ad affascinare, perché la ricerca, come l'avventura, non ha fine.
Scarica