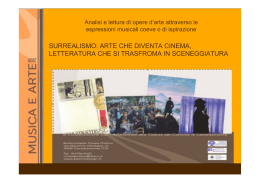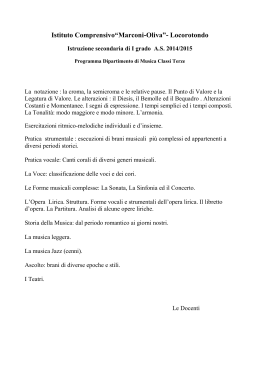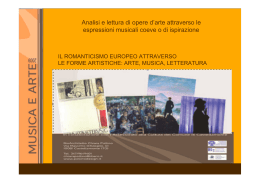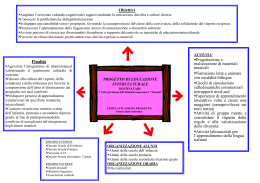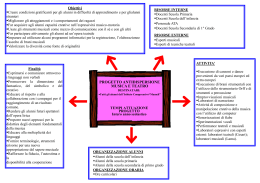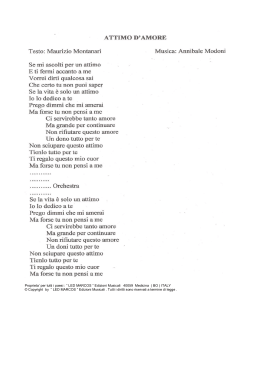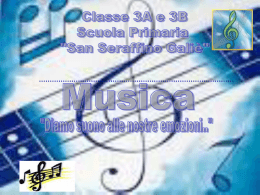Dottorato di Ricerca in Storia e Analisi delle Culture Musicali e Curriculum “Storia e Analisi delle Culture Musicali” del Dottorato di Ricerca in Musica e Spettacolo Nono Seminario Annuale dei Dottorandi 10 e 11 febbraio 2015 Aula di Storia della Musica “Nino Pirrotta” IV Piano, Edificio di Lettere e Filosofia Come ogni anno l’attività dei dottorandi in Storia e Analisi delle Culture Musicali trova uno spazio di confronto all’interno della programmazione accademica. Gli iscritti al terzo anno e i dottorandi in consegna propongono una relazione su alcuni risultati o nodi teorico-metodologici della propria ricerca. Il convegno, aperto a tutti, è introdotto da una lezione magistrale di Fabrizio Della Seta, insigne studioso verdiano, sul Trovatore. Programma Martedì 10 febbraio 11:30 Lezione magistrale Fabrizio Della Seta (Università di Pavia) Per una nuova interpretazione del “Trovatore” Pausa pranzo 14:30 Ernesto Pulignano La segmentazione del testo operistico: “Falstaff” 15:00 Alessandro Maràs Dal surrealismo al Surrealismo: musiche per “Les Mamelles de Tirésias” 2 15:30 Marco Stacca Cavatina mare e monti: tecniche e linguaggi della sortita di Dandini 16:00 Marco Andreetti Flora supercamp Pausa caffè 17:00 Diana De Francesco Liszt e il sacro: il caso di “Responsorien und Antiphonen” 17:30 Monika Prusak “Nonsense Madrigals” di György Ligeti: fonti d’ispirazione, appunti e schizzi 18:00 Renata Scognamiglio Atmosferologia e Film Music Studies: attualità (e necessità) di un dialogo Mercoledì 11 febbraio 9:30 Vincenzo Della Ratta Celebrazione della morte / Riaffermazione della vita: Glorificazione della ‘Totalità cosmica’. Analisi dei tamburi di bronzo di Dong Son in relazione al rituale funebre secondario dei Jarai (Vietnam Centrale) 10:00 Giuseppe Giordano Sull’uso del Gregoriano nelle pratiche liturgiche e devozionali in Sicilia 10:30 Raffaele Pinelli Gli aerofoni meccanici a mantice nel corpus brevettuale italiano Pausa caffè 11:30 Discussione generale 3 ABSTRACTS MARCO ANDREETTI Flora supercamp La scena della festa che precede l’entrata di Alfredo a casa di Flora nell’atto secondo della Traviata è stata spesso considerata dalla critica un luogo problematico. In un saggio del 1983 Fabrizio Della Seta ha spiegato come «Verdi non abbia saputo o voluto, con in scena solo comprimari, trovare un’ispirazione per mettere in musica la futilità […]. Possiamo constatare come le carenze si debbano imputare non tanto al materiale tematico scadente quanto alla piattezza del suo trattamento». Secondo Della Seta, infatti, la funzione di questo momento sarebbe non solo quella di lasciare ad Alfredo il tempo per cambiarsi d’abito, ma soprattutto di non dare l’impressione allo spettatore che «la casa di campagna di Violetta si trovi all’angolo del palazzo di città di Flora». Forse non è un caso che molti registi abbiano faticato a trovare una chiave per risolvere la scena in maniera convincente. Dobbiamo pensare allora che il problema risieda in una strategia drammaturgica sfocata e in materiale musicale scadente che in qualche modo necessitano di essere riscattati sul palcoscenico? Franco Zeffirelli nel suo film sulla Traviata (1983), dopo aver sfrondato senza pentimenti cabalette, quadrature e quelli che il regista ha definito «tempi morti» della partitura verdiana, amplifica le pagine in oggetto, facendone ripetere più volte a James Levine alcune cellule motiviche. La festa da Flora diventa così il clou ipertrofico del suo successo commerciale che, nonostante una certa sfortuna critica, rimane una delle opere in video più amate dal grande pubblico. Sulla scorta dell’operazione di Zeffirelli, nel mio intervento desidero proporre una lettura del finale secondo della Traviata alla luce della sfuggente categoria del «Camp»: una questione che ha assurto rilievo nella critica culturale da quando cinquant’anni fa Susan Sontag pubblicò il suo saggio Note sul 'Camp', primo tentativo di circoscrivere l’argomento per exempla. A oggi non sono state ancora indagate con sistematicità le possibili intersezioni tra l’opera in musica e il Camp, ma diversi studiosi hanno provato a fornirne una definizione sulla base delle suggestioni di Sontag. Mark Booth nel suo volume Camp toi! (1983) sostiene che «essere camp significa presentarsi come coinvolti dal marginale, con un coinvolgimento superiore a quanto il marginale effettivamente meriti». Sarebbe quindi Zeffirelli a essere camp nel suo trattamento di questa scena marginale? Oppure lo è la stessa Traviata - come d’altronde accennato da Sontag - richiedendo uno sguardo che ne accolga questa dimensione? La mia relazione suggerirà possibili risposte. 4 DIANA DE FRANCESCO Liszt e il sacro: il caso di “Responsorien und Antiphonen” Responsorien und Antiphonen (S.30) è un'opera incompleta di Liszt, edita postuma e mai eseguita. La bibliografia critica a riguardo è molto scarna, se si escludono i rari contributi di Paul Merrick, che, pur delineando gli aspetti principali dell'opera, non hanno tuttavia evidenziato la sua rilevanza in relazione alle altre opere “della riforma”. Composta intorno al 1860 allo scopo di “sintetizzare” la musica sacra cattolica riformata, mostra una forte vocazione liturgica nel pur acerbo stato di realizzazione – una raccolta di responsori e antifone dell'anno liturgico armonizzati a quattro voci ed eseguibili solo in stretta relazione al Breviarum romanum. Le sue caratteristiche – impiego esclusivo del gregoriano, esclusione di strumenti accompagnatori con la sola eccezione dell'organo ad libitum e ancoramento alla tradizione – la pongono in prima linea fra le opere riformate, impalcatura a sostegno di produzioni più mature, come Die Legende der heiligen Elisabeth (S.2) e la Missa choralis, organo concinente (S.10), che ne ricalcano intenti, strumenti e il significato profondo, la manifestazione musicale dell'io religioso lisztiano. L'intervento propone uno sguardo nuovo su Responsorien und Antiphonen, filtrato anche dall'indagine della biblioteca personale del compositore conservata a Budapest, per indagare possibili significati suggeriti da una inedita lettura. VINCENZO DELLA RATTA Celebrazione della morte / Riaffermazione della vita: Glorificazione della ‘Totalità cosmica’. Analisi dei tamburi di bronzo di Dong Son in relazione al rituale funebre secondario dei Jarai (Vietnam Centrale) I tamburi di bronzo – tra i reperti più significativi attribuibili alla cultura di Dong Son (Tonchino, VI sec. a.C. - I sec. d.C.) – hanno generato un dibattito controverso riguardo all’interpretazione delle misteriose scene su di essi raffigurate. Molti studiosi hanno rintracciato delle connessioni tra queste scene ed una ‘atmosfera austronesiana’, trovando numerose corrispondenze con l’ambito rituale delle popolazioni autoctone del Borneo e degli altipiani indocinesi. Tuttavia, nonostante le popolazioni degli altipiani dell’Indocina siano state associate ai Dongsoniani, nessuno studio dettagliato è stato finora condotto. Dunque, il presente intervento – prendendo in esame un rituale celebrato dai Jarai (un gruppo etnico parlante lingua austronesiana stanziato negli Altipiani Centrali del Vietnam) e comparandolo con le scene ritratte sul tamburo di bronzo “Ngoc Lu” (scelto come modello dei tamburi di bronzo del tipo “Heger I”) – sintetizza il mio percorso di studi dottorali volto a corroborare questa ipotesi. 5 La cerimonia che ho analizzato, chiamata Pơ thi, è un rituale funebre secondario celebrato per permettere alle anime dei defunti di raggiungere la loro destinazione finale, il ‘Villaggio degli Spiriti’. Tuttavia, oltre a questo, un’analisi attenta rivela come questo rituale si risolva in una riaffermazione della vita la quale, così come concepita nella Weltanschauung dei Jarai, è inserita in un contesto più ampio, costituito, oltre a quello degli esseri umani, dal regno dei morti e da quello delle divinità celesti. È per questa ragione che il rituale funebre secondario dei Jarai si risolve in una glorificazione di ciò che ho denominato ‘Totalità cosmica’. Come avrò modo di mostrare, le scene raffigurate sul tamburo di bronzo “Ngoc Lu” richiamano molto da vicino la celebrazione del Pơ thi dei Jarai. Dunque, è mia opinione che le scene ritratte sui tamburi di bronzo si possano interpretare come esemplificative di questo rituale e della visione del mondo ad esso connessa. GIUSEPPE GIORDANO Sull’uso del Gregoriano nelle pratiche liturgiche e devozionali in Sicilia Sebbene la pratica musicale liturgica, soprattutto a partire dall’ultimo Concilio, abbia subito concreti cambiamenti nel repertorio e nello stile, in alcuni casi i “modi” del canto liturgico tradizionale si sono conservati all’interno di alcune particolari occasioni rituali. In queste circostanze la sensibilità di cantori e fedeli nei confronti del canto scaturisce anche dall’esigenza di rinforzare il senso di appartenenza comunitaria. L’impiego del repertorio vocale riconducibile in maniera più o meno esplicita al “modello gregoriano” è stato documentato sia per un recente passato, grazie alla memoria di cantori più anziani, sia per il presente, tramite l’osservazione diretta delle pratiche tuttora in vigore in diversi centri della Sicilia. Una più accurata analisi dei materiali raccolti ha talvolta svelato una diretta provenienza, sia sul piano prettamente melodico sia su quello strutturale, di alcuni repertori liturgici “popolari” dal gregoriano. In altri casi, nonostante alcuni repertori più specifici appaiano melodicamente distanti dalle melodie gregoriane, è tuttavia osservabile un chiaro tentativo di imitarne il modello. In questa relazione, grazie anche all’ausilio di alcuni esempi audio-visuali che verranno proposti, cercherò anzitutto di descrivere i contesti culturali e le occasioni rituali in cui questi repertori si sono trasmessi e conservati, delineando un percorso espositivo proprio a partire dalle ricerche sulle pratiche musicali oggi non più osservabili. Inoltre, attraverso una valutazione più attenta dei materiali sin qui acquisiti, tenterò di offrire un primo resoconto sulla questione della persistenza di questi modelli musicali, anche alla luce di un più recente e ampio fenomeno di ripresa del canto gregoriano da parte di gruppi corali parrocchiali o di confraternite e associazioni religiose. 6 ALESSANDRO MARAS Dal surrealismo al Surrealismo: musiche per “Les Mamelles de Tirésias” Nel 1917, reduce dalla guerra, Apollinaire si dedica per la prima volta al teatro e alla musica scrivendo e allestendo Les Mamelles de Tirésias, “dramma surrealista” dagli intenti morali e civili. Con quest'opera l'autore tenta di portare a compimento il suo progetto di rinnovamento dell'arte: questa non deve più imitare la realtà ma ricrearla, a partire dai suoi stessi elementi. Superando la limitatezza della poesia, Apollinaire si rivolge a tutte le componenti dell'arte scenica, impiegando la musica nel raggiungimento di questo fine. In Mamelles i suoni non sono tuttavia relegati alla sola partitura composta (quella di Germaine Albert-Birot), ma comprendono anche i rumori del Peuple de Zanzibar e arrivano fino alle citazioni più o meno esplicite della cultura musicale contemporanea. Il risultato è quello di un'opera che insieme «mette alla prova i limiti estetici attuali» [D. Albright] ed espone la realtà in modo assolutamente anti-imitativo. Tali concetti differiscono enormemente dal Surrealismo al quale si riferirà Poulenc quando, nel 1947, intonerà Mamelles. L'evoluzione del concetto di “surrealismo” – da una teoria essenzialmente anti-imitativa ad una pratica artistica meta-analitica sviluppata secondo l'approccio psicanalitico di Breton – porterà Poulenc a non affrontare il mondo del secondo dopoguerra ma ad esplorare fra i suoi sogni e i suoi ricordi. Con l'intento di musicare la Parigi nascosta ad uno sguardo razionale, Poulenc ricostruisce una propria realtà tramite un «montaggio di rottami di ciò che è stato» [T. W. Adorno], estrinsecando il messaggio apollinairiano in modo completamente diverso. RAFFAELE PINELLI Gli aerofoni meccanici a mantice nel corpus brevettuale italiano La storia degli aerofoni meccanici a mantice ha inizio per tradizione con l’invenzione di Cyrill Demian dello strumento musicale denominato “accordion”, la cui origine è legata indissolubilmente al suo brevetto, depositato a Vienna nel 1829. Da questo momento, ha inizio una vera e propria “corsa al deposito” che vede protagonisti gli inventori/liutai in tutte quelle nazioni del mondo in cui rapidamente si diffonde la produzione delle “scatole del vento”. Le tracce della tendenza alla richiesta di brevetto sono riscontrabili in Italia, grazie al fondo Brevetti, Modelli e Marchi dell’Archivio Centrale dello Stato e a quello dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Tale patrimonio culturale che interessa parimenti gli ambiti musicologico, manifatturiero e industriale italiano, è composto da circa 800 privative. Nel mare magnum di privative depositate dal 1855 sino ai nostri giorni, i brevetti di nostro interesse fanno emergere un dato di assoluta rilevanza: essi costituiscono il 7 principale corpus brevettuale italiano per numero di depositi della macro categoria “strumenti musicali”. Partendo da tale considerazione, l’intervento intende mettere in luce l’importanza strategica di tali fondi archivistici finora esaminati solo parzialmente dalla ricerca musicologica, sia in Italia che all’estero, dimostrando come attraverso la disamina dei brevetti, qui intesi come fonti storiche primarie, è possibile contribuire alla ricostruzione storica degli sviluppi organologici degli strumenti musicali. A tal proposito, saranno presi in esame alcuni casi specifici di brevetti, dimostrando come i progetti e le informazioni contenute nei fascicoli brevettuali possono far emergere sia dati del tutto inediti che offrirne di utili per supportare le ricerche finora realizzate. Lo studio, dall’approccio transdisciplinare, intende inoltre far chiarezza sugli andamenti quantitativi e tipologico-qualitativi, nonché sulle variazioni nel tempo delle privative concesse, mettendo in luce le criticità legate al comparto della ricerca e dello sviluppo nelle aziende manifatturiere produttrici dei “mantici sonori”. Scopo del presente lavoro è quello di contribuire agli studi organologici e musicologi offrendo l’occasione per l’elaborazione di un modello di ricerca che potrebbe essere applicato anche ad altri strumenti musicali. MONIKA PRUSAK “Nonsense Madrigals” di György Ligeti: fonti d’ispirazione, appunti e schizzi Dopo la stesura dei Nonsense Madrigals (1988-1993) György Ligeti indicava la complessità ritmica come la caratteristica principale della sua tecnica compositiva, inserendola al confine tra due tradizioni polifoniche apparentemente lontane l’una dall’altra: la notazione mensurale del XIV secolo e la poliritmia dell’Africa subsahariana. Egli stesso spiegava la dimensione del nonsense, ponendolo tra l’approccio puramente tecnico e virtuoso e l’espressività del messaggio letterario inteso come ambientazione poetica piuttosto che rappresentazione del significato dei testi. Esaminando gli appunti e gli schizzi del compositore ungherese presso l’archivio della Fondazione Paul Sacher di Basilea, si identificano altre fonti d’ispirazione, che spesso creano associazioni inaspettate come il blues So What annotato insieme a Gesualdo, Dufay inserito accanto ai Beatles, o Chick Corea tra Gabrieli e Jannequin. Lo studio prende in esame i documenti autografi di Ligeti, la partitura dei Nonsense Madrigals e le pubblicazioni inerenti dell’autore e di altri studiosi (Steinitz, Lobanova, Marx, Taylor, Hofstadter, Arom, Kubik), con l’obiettivo di creare una mappa concettuale delle idee impiegate nella composizione con relativi chiarimenti, punti d’incontro ed esempi. 8 ERNESTO PULIGNANO La segmentazione del testo operistico: “Falstaff” Come segmentare un’opera fin de siècle? e in base a quali modelli formali? in altre parole, è metodologicamente corretto scomporre quei testi operistici che, di fatto, superano la logica del «numero» e delle forme canoniche a vantaggio della continuità drammatica? Nel saggio Come si segmenta il repertorio operistico Giorgio Pagannone sostiene che la segmentazione «sia un’operazione imprescindibile», e che «laddove è possibile applicarlo […] il modello della ‘solita forma’ sia lo schema più efficace, almeno per l'opera italiana»: e ciò per l’evidente persistenza che caratterizza i processi della creazione artistica. Egli sceglie di testare il modello su Otello di Boito e Verdi; questo contributo intende proseguire il lavoro con Falstaff. Ad un primo livello di segmentazione, l’ultimo lavoro verdiano si compone di tre atti, ciascuno dei quali suddiviso in due parti di diversa ambientazione. Caso unico nelle edizioni a stampa di opere verdiane, nello spartito Ricordi non vi è alcuna traccia di suddivisione in pezzi, nemmeno nell’indice; nel libretto di Boito, i metri adoperati individuano dramatis personae (doppi settenari per Falstaff, senari per le comari, ottonari per gli uomini e quinari per la coppia Nannetta-Fenton) piuttosto che sezioni destinate ad un diverso trattamento musicale. Nelle sei parti che compongono il dramma si possono comunque scorgere alcune tracce del canone ottocentesco: I, 1 è di fatto una «cavatina di sortita» di Falstaff dalle dimensioni spropositate, con adagio e “stretta” posti in corrispondenza di «posizioni emozionali» fisse e contrastanti; I, 2 ha l’ossatura d’un «numero» d’assieme; II, 2 è il Finale centrale, con sezione introduttiva e largo concertato: nel quale l'azione viene decisamente rallentata, ma mai del tutto raggelata. Fattori di coesione e transizione saldano tra loro numeri e «sezioni di numero». Tra le strategie adoperate per garantire continuità drammatica, vi è l’uso di procedimenti compositivi tipici delle sezioni cinetiche (parlante, tessuto modulante e/o durchkomponiert) anche in quelle statiche, come nei monologhi di Falstaff e Ford. Non manca il ricorso ad artifici consolidati, come il racconto di Quickly in II, 2 o la «canzone cantata» di Nannetta nell’atto conclusivo; o il ricorso a strutture assimilabili alla lyric form in alcune espansioni cantabili. RENATA SCOGNAMIGLIO Atmosferologia e Film Music Studies: attualità (e necessità) di un dialogo L’approfondimento teorico del concetto di atmosfera – avviato in Germania da Hubertus Tellenbach e dalla Nuova Fenomenologia di Hermann Schmitz alla fine degli anni ’60 – ha conosciuto nell’ultimo ventennio una notevole risonanza, anche al di fuori del dibattito strettamente filosofico. Fra gli svariati campi del sapere influenzati dalla prospettiva atmosferologica figurano anche la filosofia della musica 9 [Vizzardelli, 2007, 2009, 2010], la musicoterapia [Sonntag, 2013] e gli studi sul soundscape [Böhme 2000, Brown 2004], mentre nell’ambito dei film music studies si registra ancora un impatto modesto [Vilotic 2011]. Il mio progetto di ricerca tenta di avviare una prima indagine sui possibili contributi che lo studio delle atmosfere può offrire alla comprensione delle funzioni della musica nella costruzione dell’ontologia filmica [Bühler, Neumeyer, 2014] e nei processi di fruizione [Cohen, 2000, 2010]. La prima parte dell’intervento si concentra sulla definizione di Atmosphären come «sentimenti spazialmente effusi», corporalmente esperiti – e, di conseguenza, «quasi-oggettivi» (Schmitz) – formulando alcune ipotesi circa i principali “snodi” teorici che hanno segnato gli sviluppi dell’atmosferologia e hanno posto le premesse delle applicazioni odierne: dall’introduzione del concetto in ambito psichiatrico [Tellenbach 1968], al riconoscimento di un peculiare statuto ontologico delle atmosfere come semi-cose [Schmitz 1964-1980, 2009], fino alla “svolta estetica” di Gernot Böhme [2001], che individua proprio nell’atmosfera la chiave di volta per un ripensamento “neo-baumgarteniano” dell’estetica come teoria generale della conoscenza sensibile, riannettendo così alla disciplina domìni ormai marginalizzati, quali l’estetica della natura e delle cosiddette «arti applicate». Le conclusioni presenteranno i film music studies quale settore strategico di una nuova estetica fenomenologica, rileggendo alla luce dell’atmosferologia il carattere immersivo del suono al cinema, l’intreccio di processi emotivi e cognitivi attivati dalla musica nell’esperienza audiovisiva e le plausibili conseguenze di tutto ciò sulla forma musicale. MARCO STACCA Cavatina mare e monti: tecniche e linguaggi della sortita di Dandini L’edizione critica della Cenerentola curata da Alberto Zedda per la Fondazione Rossini da un lato aveva donato linfa nuova alla musica rossiniana e dall’altro aveva conferito un nuovo peso drammatico al ruolo di Alidoro, anche grazie al reinnesto dell’aria scritta da Rossini per la scena 7, «Là del ciel nell’arcano profondo». All’alba della prima italiana della “rinnovata” partitura, nel 1971 al Teatro Comunale di Firenze, Jean Pierre Ponnelle pone un altro fondamentale tassello al restyling dell’opera rossiniana, rileggendo il personaggio di Dandini, lo scudiero travestito da principe per ordine di Alidoro, attraverso il filtro della modernità: non più semplice maschera buffa, ma personaggio sottilmente comico e autentica rivisitazione del carattere goldoniano. Un esempio tangibile della novità insita in questo tassello del processo creativo ponnelliano si evince dalla cavatina di sortita del personaggio, «Come un’ape nei giorni d’aprile», dove una regia sagacemente ironica trae prima linfa vitale dalla musica rossiniana. L’analisi della realizzazione performativa di questo brano, attraverso il ricorso ad un’ampia documentazione iconografica (che spazia dai 10 figurini per i costumi alle foto di scena) e video (tra i quali merita menzione un inedito del 1973 proveniente dagli archivi del Teatro alla Scala) rivela un universo nascosto in cui tecniche e procedimenti della regia teatrale si intrecciano con sottili rimandi al linguaggio cinematografico, che proverò oltremodo a rimarcare attraverso la visione di alcuni frammenti della versione in filmopera del 1981. Il “nuovo” Dandini portato sulle scene italiane da Jean Pierre Ponnelle si armonizza alla cornice scenografica dell’allestimento, volge lo sguardo alle intonazioni musicali della favola antecedenti a quella rossiniana, non nega a suo modo la magia, sfugge al cliché del buffo e soprattutto re-interpreta l’idea di maschera: non più cifra del personaggio, ma segno particolare dell’interprete.
Scaricare