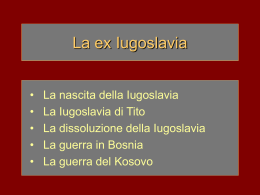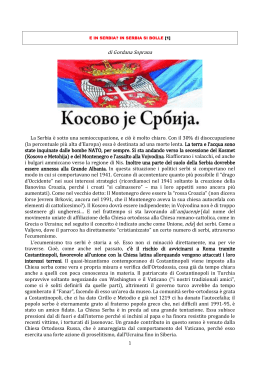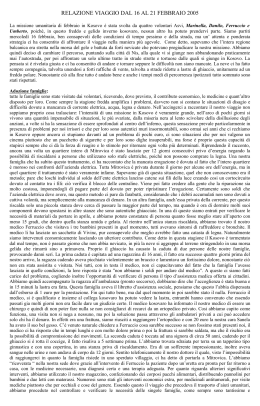SOMMARIO Culture Economie e Territori Rivista Quadrimestrale Numero Diciassette, 2007 Focus: Kosovo Pag. 03 Rassegna critica della letteratura serba: Kosovo e Metohija come fattori costitutivi dell’identità e della religiosità serbe di Ana Živković Pag. 38 Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo: dall’Albania all’Albania di Blerina Brami Pag. 74 Rassegna critica della letteratura internazionale sul Kosovo: lettura in chiave identitaria del contesto socio-politico kosovaro di Federica Dallan Focus: Memorie e Kosovo Pag. 101 “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche di Damiano Fanni 1 Gli scritti pubblicati in questo numero sono stati realizzati per il progetto MAHLDE.NET (Mare Hadriaticum Local Democracy Agencies Network), un Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico, a regia regionale, con Lead Partner la Regione Friuli Venezia Giulia e con partner la Regione Emilia Romagna, la Regione Puglia, l’Università di Padova, l’Università di Trieste, l’Università IUAV di Venezia, il Comune di Monfalcone, il Comune di Mogliano Veneto, l’ALDA (Associazione delle Agenzie di Democrazia Locale) e le ADL (Agenzie di Democrazia Locale) di Verteneglio, Sisak e Osijek (in Croazia), Prijedor, Zavidovici e Mostar (in BosniaErzegovina), Subotica e Nis (in Serbia) e Niksic (in Montenegro). In effetti, il progetto MAHLDE.NET non aveva nell’area target il Kosovo e questo non doveva essere oggetto di indagine (nessuno, quindi, dei ricercatori è andato in Kosovo per il progetto MAHLDE.NET). Tuttavia, nelle interviste realizzate in Serbia, il Kosovo era risultato così importante per capire la situazione della Serbia (per non dire che l’ADL della Serbia Centrale, con sede principale a Nis e sedi decentrate a Kraljevo e Kragujevac, affrontava ancora come un’emergenza il problema dei rifugiati serbi dal Kosovo) che si è pensato di presentare la complessità del problema del Kosovo attraverso l’analisi delle rassegne critiche degli scritti più importanti in lingua serba, albanese e internazionale (italiano, inglese e francese). Questo compito è stato affidato, per la lingua serba, ad Ana Živković(laureata in Scienze Politiche, indirizzo politico-internzaionale, dell’Università di Padova) che è stata anche la nostra interprete per la lingua serbo-croato-bosniacco-montenegrina nelle missioni per il MAHLDE.NET, per la lingua albanese, a Blerina Brami (laureata in Politica e Integrazione Europea e laureanda in Politiche dell’Unione Europea dell’Università di Padova) che è stata anche l’interprete, per la lingua albanese, dell’ALDA e della Regione Puglia nell’evento finale di MAHLDE.NET, e a Federica Dallan (dottore magistrale in Politiche dell’Unione Europea dell’Università di Padova) che ha svolto questo compito come sua tesi di laurea (dopo la laurea, è stata in Macedonia per un breve periodo). Le tre rassegne critiche sono state discusse in occasione del Seminario di restituzione del contributo dell’unità dell’Università di Padova al progetto MAHLDE.NET tenutosi a Padova il 26 febbraio 2007. Le sintesi di quelle relazioni sono, ora, pubblicate in questo numero. Il quarto scritto è di Damiano Fanni, laureato in Scienze Politiche dell’Università di Padova e attualmente candidato del dottorato di ricerca in Politiche Pubbliche del Territorio, dell’Università IUAV di Venezia. Damiano Fanni ha collaborato al MAHLDE.NET e compiuto numerose missioni nei Balcani. Al progetto MAHLDE.NET hanno partecipato vari componenti della redazione (Giuseppe Gangemi, Francesca Gelli, Luigi Pellizzoni, Luca Romano e Luciano Vettoretto) e alcuni collaboratori scientifici (Pierluigi Crosta e Liliana Padovani) della rivista Foedus. 2 Ana Živković Rassegna critica della letteratura serba: Kosovo e Metohija come fattori costitutivi dell’identità e della religiosità serbe Focus: Kosovo Per avere un quadro, il più possibile esauriente, della complessa situazione dell’area balcanica e della tensione politica cui è sottoposta la regione del Kosovo e Metohija, è necessario risalire alle origini della guerra ed indagare sulle radici lontane degli incontri e scontri di culture, lingue e religioni, che hanno attraversato questa zona della Serbia. La crisi balcanica nel territorio dell’attuale regione del Kosovo e Metohija è sostanzialmente riconducibile a tre fasi storiche, ciascuna delle quali è responsabile del groviglio di nazionalità che caratterizza quest’area. La prima fase inizia con le grandi migrazioni dei popoli indo-europei e l’inizio del movimento delle popolazioni slave che si stanziarono nell’odierna area del Kosovo e Metohija nel VI secolo, nonché con la cristianizzazione e la clericalizzazione dei serbi che entrarono nella civiltà cristiana dell’Ortodossia bizantina, rappresentando, secondo le fonti storiche dei secoli XIII e XIV, il 98% della popolazione della regione. La popolazione autoctona dell’area era composta principalmente dai dardani, greci, romani, valacchi, illiri e dai traci, ossia da quegli antenati che successivamente formarono il popolo albanese, i quali si ritirarono verso le parti costiere o verso le montagne. È importante, a questo punto, precisare che prima delle migrazioni dei slavi “nei territori dell’attuale provincia del Kosovo e Metohija non fu riscontrata nessuna formazione di tipo statale né qualsiasi raggruppamento etnicamente significativo del popolo albanese” (Bogdanović 1985, 32) anche se “i nazionalisti albanesi tengono molto alla loro identificazione con gli Illiri poiché sentono che questo garantisca loro un diritto, nell’abitare la regione, più consistente di quello degli slavi che si stabilirono lì come agricoltori nel VI secolo dopo Cristo. Gli storici serbi considerano la pretesa albanese come plausibile ma irrilevante, in quanto sia i serbi che gli albanesi hanno popolato l’area insieme per molti secoli” (Samardžić 1990, 30). Successivamente i territori della regione diventarono, grazie alla propria fertilità, densità di popolazione e soprattutto grazie alla collocazione geografica, che permetteva lo sviluppo della communicazione sia con l’Oriente che con l’Occidente, il centro dello Stato medievale serbo. Verso la fine del XII secolo queste terre facevano parte dello Stato della dinastia dei Nemanjiči ed è in tale epoca che si è sviluppato anche il centro della vita spirituale e della cultura del popolo serbo del medioevo. Un secondo momento nella storia del Kosovo e Metohija è rappresentato dall’invasione ottomana dei territori, iniziata nel XIV secolo e caratterizzata soprattutto dal radicarsi di forti differenze culturali e religiose tra le popolazioni già insediate e quelle che arrivarono sul territorio durante l’occupazione dei turchi. Nel periodo successivo alla battaglia svoltasi a Kosovo Polje nel 1389 e prima che nel 1459 gli ottomani cancellassero l’ultima istituzione politica serba, facendone un proprio pascialato, la continuità della nazione serba nell’assenza di suoi organismi politici si realizzò grazie alla vita ecclesiale, nella quale la trasmissione della fede cristiana divenne anche perpetuazione di una tradizione culturale, marcata dal ricordo dei santi monarchi e dei grandi vescovi medievali. “Quando, durante la dominazione ottomana, il popolo serbo venne a trovarsi di fronte al difficile compito di porre in salvo la propria esistenza etnica – in quanto non si poteva ancora parlare della nazione – l’u- 3 n.17 / 2007 nica organizzazione che riusciva a portare a termine tale compito era la Chiesa ortodossa” (Lazić 2005,142). Questo fondamentale ruolo svolto dalla Chiesa ortodossa nei confronti del popolo serbo non può essere dimenticato da chi voglia comprendere anche la realtà contemporanea. Inoltre è utile comprendere che è stata la posizione geografica e strategica – “Chi detiene il Kosovo detiene i Balcani” – che ha conferito alla regione un posto importante nei piani dell’imperialismo ottomano; solo così si può percepire che l’integrità del popolo serbo e delle sue terre è stata per la prima volta messa in questione quando è stato minacciato il carattere etnico e religioso serbo del Kosovo e Metohija. L’islamizzazione è iniziata attraverso una colonizzazione da parte del popolo turco e più tardi, a partire dal XVI secolo, è continuata con la colonizzazione da parte degli albanesi islamizzati, dapprima nella Metohija e poi nel Kosovo. Il movimento di queste correnti migratorie della colonizzazione albanese riveste un carattere di distruzione pianificata e di accerchiamento del popolo serbo in quanto protagonista della resistenza anti-ottomana. Tuttavia, è a partire dal XVII secolo che il rapporto demografico è iniziato a deteriorarsi in modo minaccioso: i privilegiati albanesi da poco venuti spezzarono le compatte comunità serbe e si impadronirono passo dopo passo dell’area, al punto che alla metà del XIX secolo, e soprattutto dopo il Congresso di Berlino, si poteva già parlare di una maggioranza albanese su questo territorio. Fino al XVIII secolo nel Kosovo e Metohija non esistevano agglomerati più consistenti di Sqipetars; essi cominciarono a situarsi in questa regione attraverso graduali migrazioni dall’odierna Albania del Nord, accompagnate da una profusa islamizzazione dei serbi. Il terzo momento storico, iniziato con la crisi dell’Impero Ottomano e con la successiva nascita degli Stati nazionali nel XIX secolo, ha comportato la progressiva perdita di territori a vantaggio delle maggiori potenze europee, che ponendo le basi per la nascita e lo sviluppo degli Stati nazionali, che progressivamente ottenevano l’indipendenza, ha aperto la strada ad aspri conflitti relativi ai confini; col formarsi del concetto di nazione e d’identità nazionale, i fattori linguistici, culturali e religiosi acquisirono un’importanza decisiva, diventando la fonte di ostilità e di scontri. 4 Tutte le idee serbe sul Kosovo e Metohija L’area balcanica ha vissuto la fine del XX secolo nello stesso modo in cui lo ha iniziato – con una guerra. La dissoluzione della Seconda Jugoslavia iniziò con la crisi del Kosovo e Metohija, e sembra che tale crisi comporterà la fine anche di quello che della vecchia Jugoslavia rimane in tale regione. Infatti, problemi simili alla prima fase della formazione dell’identità nazionale del XIX secolo si sono ripresentati a un secolo di distanza, in conseguenza al processo di dissoluzione della Repubblica Federale di Jugoslavia. Il conflitto del Kosovo e Metohija si è imposto sulla scena internazionale tra la primavera del 1998 e quella del 1999, quando, con l’avvio di una spirale di azioni armate da parte dell’esercito di ‘liberazione’ del Kosovo, l’UCK, seguite da reazioni a questi atti di ostilità da parte delle forze di polizia della Repubblica Federale di Jugoslavia, riemergono i problemi e le tensioni legate alla questione dell’identità e dell’autonomia della provincia. Istituita nel secondo dopoguerra, a seguito delle modifiche costituzionali avvenute nel 1963, che estendevano i poteri delle repubbliche e delle regioni autonome, l’autogoverno della regione fu notevolmente ampliato. Con la nuova Costituzione federale del 1974 era, inoltre, stata assegnata alla regione un’autonomia che potrebbe essere considerata da ‘quasi repubblica’, in quanto l’unico diritto di cui era privata era quello di secessione, visto che l’etnia albanese, presente sul territorio, non poteva essere considerata un popolo istitutivo, ma soltanto una minoranza presente in Jugoslavia. Nonostante questo, la popolazione albanese esercitava nella regione il proprio potere in modo alquanto ampio e la minoranza serba che vi abitava si sentiva fortemente discriminata. Dopo l’inizio del processo di disgregazione della Jugoslavia, le minaccie di secessione del Kosovo e Metohija diventarono sempre più forti e di fronte all’incapacità del Presidente serbo Milošević di gestire la situazione interna, nella seconda metà del 1998 si è andati ad un crescendo di preannunci di bombardamenti contro la Jugoslavia, fino al reale, brutale attacco del 24 marzo 1999, giustificato con la non accettazione da parte jugoslava dell’accordo-capestro di Rambouillet. Sicuramente l’intervento della Comunità Ana Živković Internazionale era inevitabile, ma nell’intervenire sono stati commessi degli errori, il principale dei quali è stato un’insufficiente comprensione della natura dell’evoluzione dei disordini e delle violenze che portarono al conflitto, nonché un alto livello di ignoranza mostrato dai dirigenti della NATO riguardo alla realtà balcanica, forse un’ignoranza voluta, nell’intento di oscurare la tendenza mondialista di allargamento nel continente euroasiatico dei propri spazi economici. La distruzione di una nazione militarmente forte e non allineata, quale era la Jugoslavia sostituita da una serie di protettorati deboli della NATO e del FMI, conviene perfettamente a chi governa il nuovo mondo. I serbi, nei secoli scorsi sono stati sempre un ostacolo alla realizzazione di qualsiasi progetto imperiale, dall’Impero Ottomano al Terzo Reich e l’unione dei popoli balcanici, prevalentemente slavi, era l’unica soluzione per evitare la dominazione straniera. La verità è che fin quando è esistita l’Unione Sovietica, la Jugoslavia aveva una funzione rispetto all’Occidente, ma una volta abbattuto il muro di Berlino, essa era solo d’impaccio. Secondo l’americano Samuel Huntington, dopo la caduta del muro di Berlino è risorto il conflitto eterno tra l’Occidente e l’Oriente, tra la Cristianità e l’Islam, conflitto che la guerra fredda aveva in qualche modo nascosto. Secondo Huntington le frontiere fra questi due mondi non possono che essere frontiere sanguinanti e la visione distorta dei Balcani come una di quelle frontiere, è stato uno degli errori più tragici della politica occidentale nell’area. La Jugoslavia rimane la più pratica e sensibile, la più anti-distruttiva risposta alla questione nazionale degli slavi del Sud. Essa era, come fu affermato all’epoca dell’attacco delle potenze dell’Asse nel ‘41, il modo migliore in cui il popolo balcanico può garantirsi l’indipendenza e proteggersi dal dominio straniero (Jugosla vismo: un’idea fa llita ). Anche “oggi gli interessi nazionali serbi di vitale importanza, dimostrabili in base al diritto e difesi con le armi, vengono percepiti nel mondo come l’ostacolo principale alla realizzazione e all’istituzionalizzazione dell’area europea nello spirito e secondo il progetto della ‘Santa Alleanza’, personificata nell’Unione europea, guidata dalla Potenza americana” (Tanasković 2000, 72). Nel 1389, nel Kosovo e Metohija, la Serbia si oppo- Rassegna critica della letteratura serba se alla forza dei turchi, pur con la consapevolezza della propria inferiorità; oggi, come allora, la Serbia si è opposta di nuovo e rappresenta il più fermo e deciso ostacolo alle pretese dell’imperialismo atlantico (Serbia , trincea d’Europa ). “Una delle conseguenze più significative sul piano internazionele dopo i bombardamenti della NATO e dopo l’eroica e sacrificante resistenza jugoslava è sicuramente un rallentamento del processo di creazione del nuovo ordine mondiale sotto il comando americano” (Mirković 2000, 154). “La maggior parte degli osservatori concorda nel dire che nei Balcani” e in particolare nella regione del Kosovo e Metohija, “la comunità internazionale ha mantenuto lo stesso atteggiamento estremamente cauto, per non dire apertemente filomusulmano” (Tanasković 2005, 93). L’islam balcanico rimane, infatti, l’unico spazio islamico che ha buoni rapporti con l’Occidente. “Non è sicuramente un caso che alcune delle analisi più recenti sulla situazione in Bosnia ed Erzegovina, in Kosovo e Metohija e nei Balcani in generale, facciano tornare alla mente la ‘dorsale verde’ citata come una delle possibili spiegazioni della strana logica che si nasconde dietro alla politica decisamente filomusulmana che i paesi occidentali, e in primo luogo gli Stati Uniti, hanno adottato nel periodo della crisi jugoslava dell’ultimo decennio del XX secolo, che sembra ancora prevalere” (Tanasković 2005, 92). Se si prende in considerazione l’intero processo di disintegrazione, la questione del Kosovo e Metohija, il sostegno degli occidentali all’organizzazione dell’UCK e la demonizzazione dell’ex Presidente Slobodan Milošević, si percepisce che la volontà del Vaticano e della Germania e le azioni di Washington e di Londra appartengono alla strategia mondialista di appoggiare i fenomeni secessionisti nelle aree significative dal punto di vista geostrategico, apparentemente in nome del principio di autodeterminazione dei popoli o di una specificità religiosa, cercando in tal modo di giustificare l’ingerenza umanitaria e il loro presidio militare nell’area. “Non dovremmo più chiederci perché ma come è potuto succedere che gli effetti della politica americana e di quella europea abbiano paradossalmente coinciso con le aspirazioni e gli obiettivi che si è posto il panislamismo mondiale” (Tanasković 2005, 93). Riguardo alla posizione che la Serbia ha avuto 5 n.17 / 2007 durante la storia quale ponte della penetrazione di idee europee verso il mondo dell’Islam, o al contrario il limite della penetrazione dell’integralismo islamico in Europa, è opportuno richiamare quella che viene definita la teoria della ‘dorsale verde’, il progetto di una colonizzazione islamica in atto nei Balcani, che prevede la graduale creazione di un collegamento di territori comprensivi di quelle regioni le cui etnie sono prevalentemente di religione musulmana, per costituire un blocco geopolitico e strategico, il cui effetto immediato sarebbe la frantumazione dell’integrità degli Stati ospitanti, con effetti devastanti sugli equilibri dell’area e, in particolare, per l’impatto sui punti forti della geopolitica balcanica, e cioè sul controllo degli assi di comunicazione della parte sud-occidentale della regione. Questa trasversale, partendo dalla minoranza musulmana nella Tracia greca, saldatura con la Turchia, dovrebbe proseguire per i territori stanziali della minoranza turca in Bulgaria, attraversando la Macedonia nella zona occidentale a prevalenza albanese, si allargherebbe nello spazio etnico albanese del Kosovo e Metohija e dell’Albania e si salderebbe alla Bosnia tramite il Sangiaccato, per arrivare sino alle soglie di Zagabria. In tal modo si potrebbe permettere la costituzione di uno spazio geopolitico unitario per i musulmani ex jugoslavi e per gli albanesi, ricongiungendo l’Albania etnica al Sangiaccato e alla Bosnia ed Erzegovina sotto il controllo musulmano. In questo progetto la questione di Kosovo e Metohija rappresenta il fattore che alimenta il processo di destabilizzazione dei territori in predicato di essere annessi all’Albania etnica e velocizza l’unificazione dei territori albanesi con il resto dei territori, abitati dalla popolazione musulmana. La provincia si troverebbe, dunque, al centro di una disputa che va ben oltre la contrapposizione tra i serbi, gli albanesi e l’Occidente e da una questione che nasce come geopolitica divenne nel tempo politica ed istituzionale, perché rappresenta, nei fatti, l’anello fondamentale per la creazione del corridoio islamico attraverso i Balcani, un corridoio che si spinge fino alle porte dell’Europa, una enclave che costituirebbe un terminale del terrorismo islamico ed una zona di passaggio del traffico di droga e delle condutture petrolifere. In questa prospettiva si colloca anche il tema della pressione demografica che, nel contesto balcani- 6 co, si articola in una serie di fenomeni oggettivamente destabilizzanti dell’equilibrio micro e macro regionale. Se si considerano i vecchi censimenti jugoslavi, si scopre inevitabilmente l’inarrestabile esplosione demografica della popolazione di origine albanese nella provincia e questo è sicuramente l’elemento di medio-lungo periodo che ha il potenziale destabilizzante più notevole. È durante la Seconda Guerra Mondiale, che si verificarono trasformazioni più drastiche nel quadro demografico del Kosovo e Metohija, dovute anche alle azioni dei terroristi nazionalisti albanesi, sotto la pressione dei quali, la regione venne abbandonata da circa 75.000 serbi, nelle case dei quali si situarono gli albanesi provenienti dall’Albania del nord, cambiando definitivamente l’equilibrio demografico. Fino al 1971, quale risultato di un’esplosione demografica inverosimile, la popolazione albanese radoppiò. Il censimento ufficiale jugoslavo del 1971 mostra, infatti, 916.168 albanesi presenti nella regione, mentre la popolazione serba e quella montenegrina raggiungevano appena 259.819. Questa tendenza demografica serve anche a dimostrare la falsità delle teorie sulla repressione serba nei confronti della popolazione albanese nel secondo dopoguerra. La verità è che le autorità comuniste della Jugoslavia favorivano gli albanesi a spese dei serbi in quanto permettevano un incontrollato stabilirsi degli immigrati dall’Albania, tollerando anche diversi metodi di discriminazione etnica nei confronti dei serbi e costringendoli a lasciare la provincia in ricerca di una vita migliore in Serbia centrale. Secondo il censimento jugoslavo del 1981, il tasso medio di accrescimento annuo degli albanesi del Kosovo e Metohija era del 25,3 per mille, il più alto in Europa, mentre quello dei musulmani di Bosnia era del 15,4 per mille, per lo più concentrato tra le popolazioni rurali e dei piccoli centri delle valli della Bosnia centrale. A fronte di questi dati, i serbi e i croati registravano una crescita annua complessiva intorno al 4 per mille, e cioè meno di un sesto di quella degli albanesi e pari a poco meno di un quarto di quella dei musulmani di Bosnia. Il fatto più preoccupante e talvolta ignorato dai circoli accademici e politici è l’esistenza di un vincolo religioso oggettivo che lega questa galassia di popolazioni diverse, fornendo un potenziale di integrazione strategica soprattutto per quanto Ana Živković riguarda il ruolo geopolitico di queste popolazioni e lo sviluppo di una potente rete del terrorismo integralista e dei canali classici dei traffici illeciti, che sono di fatto vere e proprie tratte ‘sacre’. Questi fatti illustrano la possibile identificazione della cultura albanese e della loro conversione religiosa con la fedeltà verso lo Stato ottomano, legame visto anche come il motivo dei rinnovati contrasti con il mondo slavo e con i serbi ortodossi, i principali artefici della distruzione di quel collegamento tra gli Stati islamici. Alla vigilia dello scoppio del conflitto in Jugoslavia, i settori pan-albanesi, guidati da Ibrahim Rugova, leader della Lega Democratica del Kosovo, hanno iniziato a praticare il boicottaggio assoluto della vita politica e sociale jugoslava, costruendo un sistema ‘parallelo’ in tutte le attività della società, dalla sanità all’istruzione, fatto che ha configurato un vero e proprio separatismo etnico. Questo sistema parallelo è stato visto con apprezzamento in Occidente, anche per il suo carattere non-violento, in quanto si percepiva una forma di Islam, colorata come più accettabile o comunque meno pericolosa della forma più estrema dell’Islam, presente in altre aree di crisi nel mondo. Ma come si spiega questo carattere non violento con 200 mila serbi fuggiti dalla regione, con la privazione di tutti i diritti umani a quelli pochiche erano rimasti nel Kosovo e Metohija, con le grandi fosse comuni serbe e con la cancellazione di 150 luoghi simbolici serbi? Alcune dichiarazioni del libro Kosovo di Slavenko Terzić possono essere sufficienti per smentire la non violenza dei leader albanesi, come quella del presidente fascista dell’Albania Mustafa Kruja che già nel 1942 ha dichiarato davanti ai suoi seguaci kosovari: “La popolazione serba in Kosovo dovrebbe essere cacciata il prima possibile. Tutti i serbi indigeni dovrebbero essere qualificati come colonizzatori, e in quanto tali, attraverso i governi albanese e italiano, mandati in campi di concentramento in Albania. I coloni serbi vanno ammazzati”. Sentimenti simili furono espressi dal capo albanese-kosovaro, Ferat-Bej Draga: “È arrivato il momento di sterminare i serbi. Non rimarrà alcun serbo sotto il sole del Kosovo”. Nell’analisi della ‘dorsale verde’ è importante il contributo di prof. Darko Tanasković, ambasciatore di Serbia e Montenegro presso la Santa Sede e membro della Comissione jugoslava per la verità e Rassegna critica della letteratura serba la riconciliazione, nonché uno dei più noti esperti di studi sull’Islam nei Balcani. Secondo quanto scritto da Tanasković “Non si tratta né di un progetto né di un piano nato in qualche diabolico laboratorio geopolitico occidentale ma, più realisticamente – e questa è la cosa più allarmante – di uno degli effetti e dei risultati più significativi dell’azione complessiva svolta dalla cosiddetta comunità internazionale durante la crisi jugoslava” (Tanasković 2005, 92) e cioè “la continua sottovalutazione dell’attuale impatto della sfida islamica nei Balcani, e soprattutto, di quello che potrebbe avere in futuro” (Tanasković 2005, 94). La potenzialità distruttiva della ‘dorsale verde’ è data dal fatto che la dinamica di unificazione presuppone l’abbandono, da parte delle popolazioni musulmane, degli Stati di appartenenza, senza peraltro rinunciare ai territori di stanziamento. Inoltre “bisognerebbe capire in quali termini i musulmani dell’area balcanica vorrebero veramente europeizzarsi e fino a che punto vorrebbero rimanere musulmani pur entrando in Europa” (Tanasković 2005, 97). Sul mancato appoggio da parte dell’Europa ai cristiani nei Balcani, e in particolar modo al popolo ortodosso, durante la crisi e la disintegrazione della Jugoslavia e sul sostegno dato, inevece, al popolo musulmano, il prof. Tanasković afferma che “l’atteggiamento pro-musulmano della parte più autorevole della comunità internazionale durante la crisi jugoslava ha avuto delle conseguenze negative non solo per l’area balcanica, ma anche per l’intera Europa” e prosegue “anche per la soluzione finale sullo status del Kosovo e Metohija l’Europa tende a seguire il tono stabilito dagli Stati Uniti” (Tanasković 2006, 18). Per gli americani i Balcani sono lontani e la loro instabilità può rappresentare un’opportunità per “ostacolare la trasformazione del continente europeo in un superstato forte e solido, attraverso il rafforzamento della componente islamica europea con tutte le sue potenzialità distruttive endemiche” (Tanasković 2005, 98) e per avvicinare ulteriormente la NATO alle frontiere russe. Agli occhi dell’America, inoltre, la Serbia resta l’unico potenziale riferimento di una improbabile ma possibile rivincita russa nell’area geopolitica dei Balcani. Gli interessi globali degli Stati Uniti nella regione sono quelli di impedire all’Unione Europea, in particola- 7 n.17 / 2007 re a Francia e a Germania, di realizzare la influenza dominante sul piano politico, economico e di sicurezza e di iniziare a dirigere gli avvenimenti dei Balcani, impedendo il ritorno russo nell’area. Per questo gli Stati Uniti hanno iniziato a costituire una serie di regimi vassalici e statarelli del tutto dipendenti dai loro supporti ed aiuti economici, politici e militari. La tattica americana è allora quella di avere sotto il proprio controllo l’insieme di questi Stati, incapaci a condurre una politica indipendente e ad agire per la protezione degli interessi nazionali. Si tratta della costruzione di un nuovo muro di Berlino, che dividerebbe l’Europa, tagliando in modo netto il corridoio Parigi – Berlino – Mosca (La leggenda di Kosovo) In questo contesto non bisogna però tralasciare il ruolo della Turchia all’interno della crisi jugoslava e il suo interesse all’espansione dell’influenza economica e culturale all’interno dell’Europa. Più precisamente, le ambizioni pan-turche comprendono tutti quei popoli convertiti al credo islamico sotto l’Impero Ottomano, indipendentemente dalla loro origine etnica. Perciò più che di panturchismo si deve forse parlare di neoturchismo, una politica che è divenuta politica ufficiale dello Stato turco da anni ed è stata formulata in termini espliciti da alti esponenti delle istituzioni e della cultura, a partire dal Presidente della Repubblica Süleyman Demirel, il quale ha affermato che “la Turchia si estende dal mare Adriatico alla muraglia cinese” (Politika 25/2/1992). Questa influenza potrebbe espandersi grazie alla potenza militare americana ma anche grazie al sostegno di Paesi islamici come l’Arabia Saudita, che controlla fondamentali strutture finanziarie, lobby di pressione ed agenzie di informazione e grazie allo sviluppo di legami militari, politici ed economici con Israele, dove gli esperti non hanno esitato ad affermare che “i Balcani sono il terzo importante canale di penetrazione dell’Islam nell’Occidente europeo” (Tanasković 2005, 97). Il fatto che il governo statunitense sia rimasto sempre molto attento a non urtare la suscettibilità della Turchia, la pietra angolare della NATO nell’Europa sudorientale, e dei suoi alleati nel Golfo, Arabia Saudita in testa, da tempo impegnate a sostenere le comunità musulmane balcaniche, confermerebbe da un lato “la tesi secondo la quale favorendo i musulmani balcanici gli Stati Uniti stia- 8 no cercando di farsi perdonare dal mondo islamico le scelte politiche fatte in altri, più importanti, teatri d’operazione, una sorta di compensazione” (Tanasković 2005, 98); dall’altra parte questa politica rientrerebbe nella “deliberata decisione da parte dell’America di favorire la nascita di una serie di Stati instabili e provvisori, mantenedo così un caos controllato per includere la regione nel proprio progetto di predominio globale” (Tanasković 2005, 97) affidando al partner di sempre, ovvero alla Turchia, che ha dimostrato di saper temperare le spinte dell’islamismo più radicale, una gestione ‘neo-ottomana’ dei Balcani. Sullo sfondo di questo scenario si profila anche l’adesione della Turchia all’UE con l’aumento ulteriore dei musulmani europei e con l’assunzione di un ruolo di tutela delle popolazioni musulmane dei Balcani, sul legame dei quali con la Turchia si è espresso anche Adil Zulfikarpasić, fondatore della Libera Organizzazione dei ‘Bošnjaki’, termine con il quale si definiscono gli slavi di religione musulmana, ed ex-vicepresidente della SDA, partito di Azione Democratica. Egli ha, infatti, affermato: “È noto che fino alle guerre balcaniche su questi territori c’era lo Stato turco; era il nostro Stato, che faceva i nostri interessi, la nostra emancipazione, la nostra prosperità e il nostro futuro era legato a questo Stato turco” (Stav 21/02/1992, 21). Naturalmente, l’atteggiamento turco è determinato sia dalla necessità di aumentare il proprio peso specifico in una regione di influenza elettiva della Grecia e della Russia, sia di rispondere al ruolo di potenza moderata dei musulmani balcanici. In ogni caso, le dinamiche interne del sistema politico turco porteranno con ogni probabilità a mantenere, se non ad aumentare, l’impegno nella regione. “L’interesse nazionale serbo nell’ambito del processo della disintegrazione jugoslava, risulta per coloro che decidono in modo decisivo la direzione delle correnti politiche nel mondo, non solo irrilevante, ma anche non compatibile con le soluzioni strategiche americane ed europee, mentre il ruolo della Turchia diventa quello dello stabilizzatore del fattore islamico nell’area confinante con l’Europa” (Tanasković 2000, 73). Se il ruolo dei Paesi occidentali e della Turchia nella disgregazione della Federazione Jugoslava è stato sostanzialmente passato sotto silenzio, una maggiore attenzione è stata rivolta all’importanza Ana Živković strategica dei Balcani nel campo delle comunicazioni e, soprattutto, nel settore del rifornimento di materie prime all’Occidente. Questa attenzione è rimasta però confinata all’informazione economica più specialistica ed è perciò largamente ignorata dal grande pubblico. Tutta le regione balcanica è importante perché è percorsa dalle grandi vie di comunicazione fra l’Europa centrale e la Turchia, fra il Mar Nero, il Caucaso e l’Adriatico. Dopo la dissoluzione dell’URSS si è scatenata la gara per il controllo delle risorse energetiche del Mar Caspio, in particolare del gas e petrolio, e la competizione non riguarda solo le aree di estrazione ma anche tutti i cosiddetti ‘corridoi’, cioè le direttrici seguite da oleodotti e gasdotti per portare energia all’Occidente. Due sono le direttrici principali: il ‘Corridoio 5’, che va dall’Ucraina all’Italia settentrionale, passando per l’Ungheria e la Slovenia e il ‘Corridoio 8’, che, partendo dal Mar Nero, giunge al canale di Otranto attraverso la Bulgaria, la Repubblica macedone e l’Albania. Un giacimento quasi intatto di petrolio è quello intorno al Mar Caspio, e una linea prioritaria di alimentazione per l’Europa è quella che passa per i Balcani. Non c’è dubbio che questa circostanza sia alla base dell’interesse occidentale per la regione. Il petrolio dell’area caspica ammonterebbe a 5-10 miliardi di tonnellate e rappresenta l’ultima grande riserva di idrocarburi del mondo. Già fra il 1991 e il 1993 le grandi compagnie occidentali cercarono di inserirsi in quello che, dopo la disintegrazione dell’URSS, si configurava come un vuoto geopolitico e soprattutto economico; le compagnie americane e la Turchia, per sottrarre a Mosca il monopolio degli oleodotti, avviarono il progetto di un oleodotto detto ‘occidentale’, che, contrapposto a quello russo ‘settentrionale’, partendo da Baku, attraverserebbe la Georgia per arrivare al porto di Supsa nel Mar Nero georgiano; di qui, un corridoio marittimo e poi terrestre, attraverso il Kurdistan turco lo collegherebbe al terminale turco di Ceyhan, sul Mediterraneo. Inoltre, la spartizione neocoloniale delle ricchezze e delle attività produttive della regione rimane poco nota, nonostante l’immenso impegno delle numerose multinazionali subito dopo l’occupazione militare del Kosovo e Metohija da parte delle Forze dell’Occidente secondo interessi e coinvolgimenti economici in gran parte preesistenti. Nei Rassegna critica della letteratura serba Balcani si sta realizzando un progetto di divisione, forse simile a quello pensato da Hitler, con una Croazia ultracattolica indipendente, ripulita etnicamente dalla minoranza serba, che per quasi mezzo secolo il Maresciallo Tito aveva fermato. In questa prospettiva rientra una Serbia inoffensiva e separata dal Montenegro, nonché privata finanche delle proprie province autonome con una Repubblica islamica filoturca in Bosnia, necessaria per realizzare la ‘dorsale verde’. In Europa, per adesso, sono i serbi a dover pagare il prezzo più caro di una ristrutturazione geopolitica decisa a loro insaputa e contro di loro. I serbi vengono prima diffamati e poi colpiti perché, tra gli jugoslavi, sia per ragioni storiche sia perché vivono in quasi tutte le repubbliche ex-federate, sono quelli che meno di tutti avevano interesse alla frantumazione del loro Paese. È possibile, allora, che dietro i motivi dell’intervento della comunità internazionale contro ciò che rimane della Jugoslavia, cioè contro i residui di una costruzione statale che nacque sui tavoli dei vincitori della Prima Guerra Mondiale - in nome del principio di autodeterminazione dei popoli o di una specificità religiosa, esistono motivazioni che non riguardano la questione etnica o nazionale della regione? È possibile che lo Stato di Serbia si trovi ancora una volta nella storia a dover prottegere la Cristianità europea dall’avanzata dell’Islam, appoggiata dagli Stati Uniti, per gli interessi americani di carattere economico? “In ogni caso, la guerra contro la Serbia è una guerra contro l’Europa, o meglio, è la fase più recente di una guerra che è iniziata con lo sbarco in Normandia, se non con l’intrusione americana nel nostro continente fin dalla Prima Guerra Mondiale. In questa nuova fase dell’aggressione statunitense, mentre i dirigenti dell’Europa legale dimostrano nella maniera più inequivocabile di essere dei fantocci collaborazionisti nelle mani del nemico, dei veri e propri traditori della Patria europea, l’Europa legittima è in Serbia. La Serbia è oggi la trincea dell’Europa.« (Kalajić 1999, introduzione) Se per certi aspetti il Kosovo è unico nella storia del popolo serbo-ortodosso, è proprio perché è il simbolo della sua identità e della sua continuità. Secondo le parole di una delle più sagge donne serbe, Isidora Sekulić, “la serbità, non è né il pane, né la scuola, né lo Stato: è il Kosovo”. Al fine di rendere più comprensibile questa affer- 9 n.17 / 2007 mazione diventano di particolare interesse, innanzitutto, le voci degli intellettuali serbi pubblicate nel Memorandum, il documento diffuso in via ufficiosa in Serbia nel 1986 dall’Accademia delle scienze e delle arti di Belgrado, che rappresenta la prima formulazione compiuta del problema del Kosovo e Metohija, e che da parte della maggioranza venne interpretato come il tentativo di mettere la storia al servizio dei nuovi etno-nazionalismi; esso, tuttavia, offre la possibilità di spiegare perché una nazione, nel rivendicare la propria esistenza politica ed etnica, ha cercato di dimostrare con tanta ostinazione il possesso di un determinato territorio mediante un’associazione storica tra la popolazione attuale e la popolazione del passato (Memora ndum SANU. Risposte a lle critiche). Può essere, dunque, interessante partire da alcune pagine di La questione del Kosovo e Metohija . Pa ssa to e presente, documento pubblicato sul sito dell’Accademia di Belgrado che, più di altri, contiene un esplicito riferimento alla questione dell’identità nazionale e ai rapporti dei serbi con gli albanesi della regione. Innanzitutto, c’è una presa di posizione alquanto forte sul significato della questione del Kosovo e Metohija: essa non può essere ridotta al problema dell’autonomia costituzionale della regione, né alla condizione degli albanesi jugoslavi. Al contrario, si tratta della sopravvivenza e della posizione dell’intera nazione serba - nel Kosovo e Metohija, nella Jugoslavia e nei Balcani. Perciò è di importanza fondamentale considerare l’intera questione dal punto di vista storico, dal momento che gli eventi di questi ultimi tempi rischiano di cancellare la memoria di un intero popolo, insieme alle fondamenta stesse della sua coscienza nazionale. Così, Dimitrije Bogdanović afferma che il Kosovo viene visto come un sintomo che rivela processi molto più profondi e larghi, mediante i quali si cerca di risolvere il destino del popolo serbo e non della nazionalità albanese. Senza un’attenta analisi storica la situazione politica attuale della regione non potrebbe essere capita, come non si potrebbero capire le reali tendenze e i significati degli intenti albanesi. “Per il popolo serbo il Kosovo e Metohija assume il significato del certificato e del sigillo della sua identità; la sola chiave grazie alla quale si può comprendere il messaggio derivante dalla sua storia” (Bogdanović 1985, 60). L’accademico Dejan 10 Medaković segue questa linea spiegando come segue: “È un fatto triste che gli avvenimenti storicamente importanti diventano un punto dolente per i membri di un popolo, che il loro quadro reale e critico viene offuscato dai conflitti contemporanei. Non si dovrebbe confondere ciò che è storicamente chiaro e che appartiene alla storia critica con quello che rappresenta, invece, il momento attuale. Esistono coloro che cercano di trarre dei vantaggi, mescolando nazionale e nazionalistico, ossia quello che ha un valore con quello che nega i valori di un altro popolo. Ciò non significa che il nazionalistico non esiste; esiste soprattutto come lo sfogo, causato dalla lunga negazione o dalla lunga interruzione con la storia del proprio popolo, dalla cancellazione sistematica delle memorie storiche. Tutto può essere considerato come l’irruzione della rabbia, trattenuta per molto tempo e in modo innaturale”. “La ricostruzione realistica e completa degli eventi del passato produce un effetto rivitalizzante per il popolo serbo, restituendogli il senso di identità, permettendogli di vedere le cose nella loro luce e proporzioni più veritiere” (Medaković 1989, intervista in Duga, Belgrado, n. 400). L’excursus del documento dell’Accademia prosegue con quella che viene definita l’etnogenesi della nazione serba, la questione delle sue origini. I diritti dei serbi nel Kosovo e Metohija sono scritti inequivocabilmente, secondo il testo, nella storia medievale: è in questo periodo, infatti, che i serbi raggiunsero il massimo grado di civilizzazione ed è allora che si posero le basi della loro ‘identità europea’, la testimonianza della quale sono i monasteri, le produzioni artistiche e letterarie di quel periodo. E fu proprio l’omogeneità etnica di questo territorio densamente popolato che lo portò rapidamente a divenire il centro politico, economico, culturale e religioso della nazione serba. Ai tempi dell’invasione turco-ottomana, l’ormai nota battaglia di Kosovo Polje del 1389, in cui i serbi, sebbene ne siano usciti sconfitti, opposero strenua ed eroica resistenza agli invasori, sancisce definitivamente la sacralità di quella terra, che diviene la bandiera della libertà nazionale. Tra i vari significati che la denominazione ‘Kosovo’ assume per il popolo serbo esiste, innanzittutto, quello che si riferisce alla vasta pianura situata nella parte orientale della provincia del Kosovo e Metohija. Il suo nome deriva dalla parola serba Ana Živković ‘kos’ che significa merlo. Più di 90% dei nomi geografici del odierno Kosovo sono di origini serbe, il che offre prova dell’esistenza secolare del popolo serbo e la presenza di sua cultura in quest’area. Metohija designa, invece, la parte occidentale della stessa provincia. Il suo nome deriva dalla parola greca ‘metohion’, pl. ‘metohia’, con il significato di ‘proprietà del monastero’, che sottolinea quanto stretto sia il legame tra quei territori, la Chiesa serbo-ortodossa ed il suo popolo. Nel medioevo, infatti, tutti i più importanti monasteri serbo-ortodossi possedevano i propri possedimenti in Metohija. Dal punto di vista storico i serbi ricollegano ‘Kosovo e Metohija’ alla base della loro statalità e alla rivalità serbo-albanese, nonché alle varie interpretazioni della storia, che ha giocato un ruolo fondamentale nel determinare il destino di questa regione, soprattutto perché si è trattato di una storia interpretata, mitizzata e utilizzata per vari fini, soprattutto e quasi sempre politici. Il Kosovo e Metohija, nella memoria nazionale del popolo serbo, costituisce la culla della cultura serba e dell’ortodossia, in quanto nucleo del celebrato regno medievale e sede di numerose chiese e monasteri. Božidar Jakšić ritiene che oggi sono rari i cittadini della Serbia che negli ultimi anni non hanno riflettuto più volte riguardo alla pericolosità della situazione creatasi in seguito al rapporto instaurato da parte dello Stato serbo nei confronti della crisi del Kosovo e Metohija. “La frustrazione e la diffidenza diventarono una terra fertile per l’odio. I legami precedenti di fiducia e comprensione vennero spaccati con insistenza, quotidianamente ed in modo sistematico. Con le divisioni nazionali vennero manipolati sia i precedenti rappresentanti del governo comunista di Tito sia la borghesia serba di oggi, nonché la stessa nuova élite albanese politica e culturale” (Jakšić 1999). Utile al fine di comprendere le diverse posizioni del popolo serbo può essere anche l’esposizione tematica durante l’Assemblea annuale del Forum di Belgrado per un Mondo di Eguali di 23 tesi sulla questione del Kosovo Metohija di Vladislav Jovanović, secondo il quale la questione del Kosovo e Metohija è nel mirino delle politiche della comunità internazionale ormai per la quarta volta negli ultimi venticinque anni, a causa del loro obiettivo storico di separare questa zona dalla Rassegna critica della letteratura serba Serbia. Questo obiettivo fu dichiarato per la prima volta dopo le dimostrazioni separatiste albanesi nel 1981, quando alla Serbia fu ‘suggerito’ di accettare il Kosovo e Metohija come la settima repubblica nella federazione jugoslava; suggerimento che venne ripetuto, per la seconda volta, durante il processo di secessione di Slovenia e di Croazia, mediante le pressioni affinché agli albanesi della regione fosse riconosciuto il diritto di autodeterminazione che veniva concesso agli altri popoli. Per la terza volta, prima e nel corso dell’aggressione militare nei confronti della Repubblica Federale di Jugoslavia, con il supporto aperto al terrorismo albanese separatista, si era svelato l’obiettivo militare principale degli Stati Uniti e degli altri Paesi leader della NATO, nei confronti della Serbia. Tale obiettivo non è stato abbandonato neanche dopo la cessazione dell’aggressione ed è continuato, con un aspetto diverso, sotto l’amministrazione internazionale provvisoria dell’ONU del Kosovo e Metohija. Si è trattato, quindi, di una guerra di conquista, il cui scopo è stato di impadronirsi di tutta la regione centrale dei Balcani mediante l’occupazione del Kosovo e della Metohija, poi della vallata della Moldava, e, dall’altra parte, della vallata del Vardar, al fine di creare uno Stato nuovo, a favore di una grande Albania, che modificherà la carta della penisola balcanica, proprio come si era prospettato all’epoca del congresso di Berlino e della creazione della Lega albanese di Prizren nel 1878. “I Paesi dell’Europa occidentale hanno, però, spesso perso di vista che non sarà facile governare su un’entità socio-economica di questo tipo, in quanto essa non è in grado di integrarsi con i progetti mondialistici dell’Europa. Con la formazione dell’entità islamica nell’area balcanica gli europei contribuiscono inconsapevolmente alla disunione di identità dei propri popoli e, quindi, producono una diretta minaccia per i valori e le istituzioni europee” (Nišić 2004, 273). “I serbi, come all’epoca dell’avanzata ottomana, rimangono l’elemento più persistente nella difesa dell’Europa cristiana nel suo conflitto con la cultura e la tradizione albanese-islamica, che sono indisolubilmente collegate con il vandalismo e con l’intolleranza ideologica e politica; un popolo che presenta la minaccia più drammatica alla civilizzazione europea, ai suoi valori di umanità e ai conseguimenti della sua cultura. I serbi sono il popolo più 11 n.17 / 2007 esposto a tale minaccia e finora hanno sopportato con coscienza tutte le proprie perdite e tutte le distruzioni del proprio patrimonio storico, che durano praticamente da sempre, ma furono intensificate a partire dell’amministrazione internazionale del Kosovo e Metohija. Per questo il popolo serbo non ha meritato e non merita tuttora la vistosa noncuranza e il disinteressamento dell’Europa di fronte all’attuale anarchia nel Kosovo e Metohija” (Lužnik 2000, 34). Nell’ottica di un tale progetto, l’imperialismo albanese ha saputo utilizzare tutti i movimenti politici e sociali che sono apparsi tra le due guerre mondiali, nel corso della Seconda Guerra Mondiale e anche dopo, ivi compreso il movimento internazionale operaio, approfittando e sfruttando il loro appoggio per la realizzazione del loro programma. Non c’è giustificazione all’ignoranza o alle illusioni che circolano a questo proposito. Sarebbe insensato continuare a chiudere gli occhi davanti a questa mistificazione politica che consiste nel trasformare gli strumenti dell’eguaglianza di diritti delle nazioni in strumenti di assoggettamento nazionale della maggioranza da parte della minoranza, del popolo serbo da parte dell’etnia albanese. Il rifiuto, senza nessun confronto, per le idee, proposte e progetti sulle soluzioni nella regione, contro l’autonomia territoriale dei serbi, dimostra l’importanza della secessione come l’unico obiettivo dei leaders albanesi e degli strateghi occidentali. Mentre gli albanesi di Kosovo e Metohija vengono sostenuti per il diritto dell’autodeterminazione e dell’indipendenza, ai serbi in Croazia è negato il più minimale diritto dell’autodeterminazione anche solo come autonomia regionale. Ai serbi e croati in Bosnia ed Erzegovina, agli albanesi in Macedonia, il diritto all’autodeterminazione è addiritura proibito ed impedito. Il principio d’immutabilità delle cosiddette frontiere dai tempi di ‘AVNOJ’ – il Consiglio antifascista della liberazione nazionale jugoslava, proclamato ed imposto dalle forze occidentali all’inizio della crisi jugoslava nei primi anni Novanta, è relativizzato per quanto concerne la Serbia; “questo rappresenta un’enorme ed evidente contraddizione con le promesse di amicizia e di alleanza con le quali stanno provando a convincerci” (23 tesi sulla questione del Kosovo Metohija ). Per via del loro sempre più aperto sostegno alla 12 secessione permanente della provincia dalla Serbia, i leaders politici occidentali, nelle loro dichiarazioni ed inviti per l’integrazione nell’UE e Partnertariato per la Pace, evitano scrupolosamente e chiaramente di dichiararsi sull’integrità territoriale del Paese, rendendo in tal modo chiare le loro attese che la Serbia, come risultato dello stato finale di un Kosovo indipendente, diventi ancora più piccola. La vicinanza della prospettiva d’integrazione con la UE è utilizzata come distrazione dell’attenzione dell’opinione pubblica e dell’élite politica, dal tema del sempre più veloce processo d’indipendenza del Kosovo e Metohija, lasciando intravedere presunti vantaggi che la Serbia, una volta liberatasi dal peso della perenne crisi nella regione, ne trarrebbe per il suo sviluppo futuro. “La Serbia è l’unico Stato candidato per l’UE, da cui è atteso e richiesto di disintegrarsi per potersi integrare nell’Unione europea”. Il condizionamento per l’entrata nell’UE attraverso l’accettazione della perdita del Kosovo e Metohija, rappresenta un’ulteriore conferma del trattamento disuguale verso la Serbia rispetto agli altri Stati dell’area balcanica e dell’ex Europa dell’Est. Alla Serbia si vuole imprimere l’impronta del più gran colpevole per la creazione e lo sviluppo della crisi jugoslava, e in questo è compresa la colpa per la ‘misericordiosa’ aggressione della NATO. Viene considerata uno Stato sconfitto che dovrebbe adempiere a delle condizioni particolari per poter entrare nell’Europa integrata. Inoltre, si ribadisce continuamente che l’entrata della Serbia nell’UE deve essere il principale interesse statale serbo, mentre la conservazione dell’integrità territoriale della Serbia è messa nei gradini più bassi delle priorità. “A patto che rimaniamo pazienti, l’élite governativa odierna tiene il pubblico nell’ipnosi delle attese con le quali la magica entrata nell’UE ci toglierebbe da tutti i nostri guai”. Inoltre, l’indipendenza della provincia è soltanto l’obiettivo negoziato pubblicamente per ottenere un obiettivo sintonizzato agli interessi dell’Occidente. Quest’obiettivo ideale eliminerebbe il pericolo della creazione di un precedente, a cui le minoranze nazionali compattamente popolate in altri Stati si sarebbero potuto rifare, particolarmente nei Paesi confinanti. Siccome per la realizzazione di tale obiettivo è necessaria l’accettazione da parte della Serbia, l’intera strategia Ana Živković dell’Occidente è concentrata a costringerla a tale accettazione. Sono state messe in moto tutte le forze: la propaganda sugli effetti del libero mercato, l’esca di un’entrata più veloce di Serbia e Montenegro, o della sola Serbia, nelle integrazioni euroatlantiche, compensi finanziari; l’evidenziamento delle problematiche per la Serbia, nel caso di una situazione con un eventuale reintegrazione del Kosovo e Metohija nel suo ordine costitutivo; il sostegno a tutti i livelli dei sostenitori e fautori di questo obiettivo, sia nelle istituzioni pubbliche, che per le ONG schierate su questa ipotesi. Nel caso la Serbia non fosse cooperativa, in alternativa sono sempre pronte le ‘solite’ misure di pressione. La minaccia per una eventuale Serbia non-collaborativa non è prevista in questo momento, ma “è preparata seriamente dietro le quinte”. Il programmato disarmo morale della Serbia si sarebbe dovuto conseguire nell’occasione della pronuncia di condanna del Tribunale dell’Aja, prevista verso la metà del 2006, nei confronti del defunto Presidente Slobodan Milošević e contro la Serbia, per presunto genocidio nel corso delle guerre in Bosnia Erzegovina e Croazia. La coincidenza di questa condanna con la scadenza di durata dell’unione statale di Serbia e Montenegro e la risoluzione dello status definitivo del Kosovo e Metohija, avrebbero privato ulteriormente la Serbia di un diritto morale sulla provincia e avrebbe dato agli albanesi un argomento ulteriore per non rimanere in uno Stato ‘criminale’ come la Serbia. “Occorre confrontare tutte queste manovre e mosse cospirative contro la presenza della Serbia in Kosovo e Metohija, in maniera decisa e senza compromessi, con la nostra carta più forte di tutte, ma sufficiente: con il nostro certificato storico sul Kosovo e Metohija”. Questo certificato di sovranità si basa sul significato storico e spirituale per il popolo serbo e per il suo Stato, e sugli inconfutabili ed incontestabili riconoscimenti internazionali che esso è parte integrale ed inseparabile della Serbia: l’Accordo di Londra del 1913, l’Accordo di pace di Versailles del 1920, l’Accordo di Parigi sulla pace del 1947, l’Atto finale di Helsinki del 1975, la considerazione della commissione arbitrale di Badinter e le decisioni dell’UE del 1991 e 1992, nonché la stessa risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1244 (Jovanović 2005). Un altro modo di interpretare la questione del Rassegna critica della letteratura serba Kosovo e Metohija è quello proposto da Dobrica Čosić, uno dei maggiori scrittori serbi, spesso considerato il padre della rinascita nazionalista, che ha sollevato in varie occasioni la possibilità della suddivisione del territorio della regione, considerandola un modo per risolvere il conflitto fra i serbi e gli albanesi, senza però suscitare alcun interesse. Egli definisce quale obiettivo principale del popolo serbo quello di “non aspirare ad una Serbia etnicamente pulita, ma liberare coloro che in compagnia del popolo serbo non si sentono liberi e che di conseguenza limitano e inquinano la libertà degli stessi serbi sulla loro terra” (Ćosić 1992, 176177). Già a partire da 1980, Čosić intese la questione del Kosovo e Metohija come una situazione di conflittualità, che non riguarda solo i territori al sud della Serbia, ma come una condizione connaturata all’essere serbo. Egli, infatti, disse: “Quasi ogni generazione [di serbi] ha avuto il suo Kosovo. Ci sono state le migrazioni nel Seicento e nel Settecento, le insurrezioni e le guerre con i Turchi nel 1804, nel 1815, nel 1876, nel 1912 e, nel 1914, il rifiuto dell’ultimatum austroungarico; il rifiuto della sconfitta militare nel 1915 e l’attraversamento militare serbo dell’Albania; il rifiuto del patto tripartito con la Germania il 27 marzo 1941 e l’insurrezione contro il fascismo, sempre nel 1941, e una guerra combattuta subendo le condizioni di rappresaglia fissate dai nazisti: cento serbi per ogni soldato tedesco; il rifiuto dell’egemonia di Stalin nel 1948” (Ćosić 1980). Inoltre, quando Čosić definisce il Kosovo e Metohija quale ‘una questione europea di primo piano’, egli mette in evidenza che il giusto modo per tentare di risolvere la questione non può essere elaborato finché il problema delle relazioni serbo-albanesi sarà ridotto ad una questione di diritti umani (Ćosić 2004). “Gli albanesi in Serbia non richiedono il riconosciemnto dei loro diritti di minoranza, e cioè dei diritti culturali, ma al contrario vogliono ottenere dei veri e propri privilegi politici e una serie di diritti statali particolari” (Sekelj 1995, 88). Ciò ha significato che il ‘fattore centrale’ è stato studiatamente trascurato; e cioè l’aspirazione degli albanesi di Jugoslavia ad unirsi con l’Albania per creare la ‘Grande Albania’. Secondo Ćosić sono, dunque, le ambizioni secessioniste del movimento nazionalista albanese il vero fondamento della loro richiesta di diritti 13 n.17 / 2007 umani. Da queste ambizioni discende un comportamento ostruzionistico in ogni sfera della vita sociale: politica, culturale, dell’educazione pubblica ed economica. Ma il problema non sta nel fatto che gli albanesi sono privati dei loro diritti culturali, politici, ecc.; il problema è semmai che a loro questi diritti sono stati riconosciuti ma essi hanno rifiutato di esercitarli, perché esisteva la comune volontà di boicottare in blocco la società, senza mai riconoscerla. La questione non fu quella di aprire le scuole; le scuole furono già aperte; è che hanno insistito affinché il curriculum in queste scuole fosse uguale a quello delle scuole dello Stato dell’Albania e che i loro diplomi fossero rilasciati in nome della ‘Repubblica del Kosovo’. L’invocazione dei diritti umani non è nient’altro che un’arma ideologica usata dai secessionisti e dai loro protettori stranieri per realizzare la loro ambizione nazionale. Fino a quando non avranno ottenuto questo risultato la questione dei diritti umani in Kosovo e Metohija continuerà ad accendersi sempre di più e la Serbia continuerà ad essere l’unica accusata dalla comunità internazionale. “Non ci sarà di nessun servigio far notare che gli albanesi beneficiano di diritti nazionali e umani come nessun’altra minoranza nazionale. [...] Il Kosovo costituirà per la Serbia un tumore maligno che la esaurirà economicamente, bloccherà il suo sviluppo e minaccerà il suo territorio con l’espansione demografica [degli albanesi]” (Ćosić 2004, 252). Con un tale dilemma Čosić conclude che è necessario soddisfare le aspirazioni nazionali di entrambi i popoli, il Serbo e l’Albanese, con una divisione territoriale pacifica ed equa. Questa offerta non ha trovato nessun sostenitore fra gli albanesi e non c’è al momento alcun segnale che sia attivamente perseguita neanche dai serbi. Di per sé potrebbe essere una proposta onesta, ma essa ha comunque incontrato due tipi di obiezioni. La comunità internazionale, a cominciare dagli Stati Uniti , ha posto il veto per ragioni di ‘analogia col passato’ e di ‘precedente’. Dividere il Kosovo e Metohija sarebbe come andare nella direzione opposta alla politica adottata per giustificare il riconoscimento della Slovenia e della Croazia, considerando, quindi, i confini interni della ex Jugoslavia come inviolabili. Quella politica è stata il fondamento per tacciare la Serbia di ‘aggressione’ in Croazia e in Bosnia ed Erzegovina 14 e pertanto non può essere facilmente abbandonata. Di più, se il Kosovo fosse diviso, perché non anche la Macedonia, dove gli albanesi sono concentrati nelle aree occidentali e anch’essi richiedono l’unificazione in una Grande Albania? Il pericolo di stabilire un tale precedente preoccupa anche gli stessi serbi. Supponiamo che l’etnia albanese, grazie al suo maggior tasso di natalità, arrivi ad ottenere la maggioranza in qualche altra parte della Serbia; domanderanno anche lì la secessione? (Kosovo). Nel 1996, l’impegno dell’accademico Aleksandar Despić e il piano di divisione più dettagliato dell’esperto per la progettazione del territorio Branislav Krstić, che seguono le idee di Ćosić a favore della divisione della provincia, incontrarono una forte condanna da parte del potere di Slobodan Milošević. Krstić fra altro, in due dei suoi libri – Kosovo da va nti a l tribuna le della storia e Kosovo fra il diritto storico ed etnico – con una serie di dati, tabelle, schizzi e mappe mostra il Kosovo e Metohija come un territorio multiculturale e multietnico importante tanto per i serbi e i montenegrini quanto per gli albanesi. La sostanza della sua proposta è che nel Kosovo e Metohija, nella parte del territorio in cui la Serbia non riesce ad avere un proprio controllo diretto, si introduca un territorio ‘albanese’ con uno status particolare – ‘il territorio della protezione di pace’, secondo il modello del famoso piano Vance-Owen, e che le collettività storiche serbe e montenegrine si integrino con la madrepatria. I serbi nella loro entità mantenerebbero i monumenti che sono parte indivisibile della cultura serba e della storia nazionale quali per esempio il Patriarcato di Peć, i monasteri di Dečani e di Gračanica e il Kosovo Polje, compresi i relativi territori e abitanti. Ciò non viene definito da Krstić come una divisione ma piuttosto una riorganizzazione territoriale, e l’argomento che lo sostiene è che in Kosovo e Metohija si debba realizzare il diritto storico dei serbi e il diritto etnico degli albanesi. È interessante che Krstić annoti anche che, all’inizio degli anni Novanta, questa proposta fu consegnata ai più alti funzionari dello Stato di Serbia e Montenegro, a Milosević e al capo di Stato maggiore, ma senza ricevere mai alcuna risposta. Dušan Bataković, membro del team per le trattative per il Kosovo e Metohija, è invece l’autore della proposta di cantonizzazione della provincia. A Ana Živković quanto è noto, tale proposta è stata respinta prima della guerra del 1999 dai funzionari internazionali, e poi, sempre senza successo, hanno cercato di realizzarla i rappresentanti serbi nel Consiglio di transizione del Kosovo e Metohija, nonché la stessa Chiesa serbo-ortodossa. Il piano di Bataković proponeva che le città del Kosovo e Metohija fossero sotto un’amministrazione mista serbo-albanese, e che nei cantoni fossero comprese principalmente le regioni agrarie a maggioranza serba alle quali si sarebbero aggiunti i monasteri serbi con i poderi che possedevano fino alla guerra del 1941, cioè fino alla espropriazione del secondo dopoguerra. Le frontiere dei comuni verrebbero modificate per creare la possibilità di formare dei comuni più piccoli che raggruppano i luoghi e i villaggi con popolazione a maggioranza serba (La ca ntonizza zione del Kosovo e Metohija ). “Ancora nel 1998, come storico che conosce bene il passato del Kosovo, mi sono reso conto della continuità dei rapporti multietnici, della loro evoluzione e dei diversi cambiamenti, e poi come qualcuno che per forza delle circostanze è stato attirato dentro nella soluzione dello status politico del Kosovo, io, cercando il modo di evitare una nuova forma di scontro, che nemmeno oggi è interrotta, ho ideato il progetto della cantonizzazione del Kosovo. Si tratta di un progetto che allora in pochi avevano sostenuto, e ci sono stati alcuni momenti molto importanti per risolvere politicamente questo duro nodo kosovaro” (Bataković 1998, 1-2). Inoltre, egli rifiuta le critiche che considerano la cantonizzazione una divisione del Kosovo e Metohija ed afferma: “Le forze non democratiche in Serbia e gli estremisti albanesi hanno attaccato questo progetto come modello che mira alla divisone. Se si vede la carta che ho proposto, essa dimostra che va incontro alla realtà politica. A differenza della Bosnia ed Erzegovina, dove tutti parlano una sola lingua, dove tutti hanno più o meno una cultura simile, dove le differenze sono generalmente di natura religiosa, in una società, che era, come sappiamo, decisamente atea - in Kosovo e Metohija abbiamo una situazione completamente diversa” (Bataković 1998, 1-2). “Per il Kosovo e Metohija, almeno in un immediato futuro, non ci sono buone soluzioni. Esistono solo quelle più o meno cattive. Tutta l’energia e l’intelligenza perciò deve essere usata per cercare Rassegna critica della letteratura serba quelle giuste, le quali faranno male a tutti, le quali toglieranno qualcosa a tutte le parti, ma offriranno loro anche qualche vantaggio. Se l’estremismo, l’esclusività, l’estrema intolleranza, che sempre più compaiono sulla scena pubblica, prevarranno, allora addio Kosovo, ma addio anche alla Serbia, addio alla civilizzazione, addio al futuro” (Danas,19 marzo 2003). La Chiesa serbo-ortodossa: breve inquadramento storico e suo ruolo negli eventi del Kosovo e Metohija La storia si deve interpellare anche per mettere in luce le radici della Chiesa serba nel Kosovo e Metohija e conoscere certi fatti del lontano passato che giustificano le motivazioni del suo atteggiamento di difesa del popolo serbo in questa regione. La Chiesa serbo-ortodossa ha le sue origini nell’opera missionaria partita da Costantinopoli nella seconda metà del IX secolo, da cui si è sviluppata una cultura bizantino-slavica. La prima parziale indipendenza ecclesiastica della Serbia si è avuta sotto il primo arcivescovo del Paese, San Sava (1176-1235), e quindi, nel 1375, il riconoscimento come Patriarcato. Poiché è solo la memoria storica, tra i serbi fortemente, se non esasperatamente, impressa, a facilitare la comprensione della loro fede religiosa e della loro nazione, conviene ricordare una data fatale, il 28 giugno 1389, per poi fare cenno ad un periodo cruciale, il 1918-20. Senza questi riferimenti l’Ortodossia serba contemporanea sarebbe inintelligibile. Poiché questa Chiesa ha storicamente garantito la continuità della tradizione nazionale e culturale serba, essa si sente ancora oggi responsabile dei suoi destini storici, particolarmente nelle aree di crisi, quale quella del Kosovo e Metohija, dove dopo un periodo relativamente breve di libertà, 1919-1941, le espulsioni in massa dei serbi sono state riprese sotto la bandiera dei conquistatori italiani, tedeschi e bulgari; da allora le violenze perpetrate contro la popolazione serba di questa regione non sono più cessate, essendo applicato nel periodo storico successivo un piano di albanizzazione e islamizzazione che presupponeva e tuttora presuppone l’annientamento dell’identità serba con l’aiuto di tutto l’arsenale del genocidio: omicidi, espulsioni ed una costante eliminazione della coscienza storica. 15 Le disgrazie della Chiesa serba nel Kosovo e Metohija hanno seguito le disgrazie del suo popolo in tutti i momenti fondamentali e le condizioni di sopravvivenza per la Chiesa serbo-ortodossa, dopo l’ondata di islamizzazione, divennero durissime, provocando il ritiro del patriarca nella Serbia della Morava, nella Despotovine, cosicché, tra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI, l’organizzazione della Chiesa serba conobbe la sua più grave crisi. Solo nel 1557, il ripristino del Patriarcato di Peć mise la Chiesa serba di nuovo, anche se per un periodo limitato, in grado di veicolare la spiritualità organizzata del popolo, in assenza di guide politiche - in posizione, dunque, di protezione e di guida. Nello stesso tempo, la Chiesa venne esposta alle pressioni, alle brutalità e al terrore cronico con cui il potere ottomano tentava di eliminare l’emergere di aspirazioni alla libertà nella popolazione. Nel corso di questi 200 e più anni, fino alla soppressione del Patriarcato nel 1776, la Chiesa serba subì una serie di colpi, ma si sforzò continuamente a preservare tutti i centri e tutte le testimonianze della spiritualità, il che implicava, anche, preservare la coscienza storica del popolo serbo. Dopo la soppressione del Patriarcato e la completa sottomissione dell’Ortodossia serba ai fanarioti, nobili ottomani di cultura greca, la Chiesa serba rinasce all’indomani delle lotte nazionali per scuotere il dominio turco. Quasi venticinque anni di ribellione e di guerra consentono ai serbi di acquisire nel 1829 un’indipendenza quasi completa dall’Impero Ottomano. Nel 1831, come conseguenza della libertà politica, la Chiesa strappò al Patriarcato di Costantinopoli uno statuto di autonomia, ossia la libertà di scegliere i propri vescovi d’intesa con le autorità civili della nazione. Tuttavia, le gerarchie ecclesiastiche serbe restarono formalmente soggette al Fanar, sede della comunità greca e del patriarca di Costantinopoli, il quale continuava a ricevere dalla Chiesa serba onori primaziali e tributi in denaro. L’indipendenza piena dai sultani venne alla Serbia con il Congresso di Berlino del 1878. Immediatamente il metropolita della Chiesa, sostenuto dal governo di Belgrado, esige dal Fanar l’autocefalia, ovvero una condizione di indipendenza nella parità rispetto alle altre Chiese ortodosse e l’autocefalia venne concessa nello stesso 1878. Durante le guerre balcaniche del 1912-1913 il ter- 16 ritorio serbo si accresce notevolmente al Sud: parti del Sangiaccato, del Kosovo e della Macedonia, si aggiungono alle terre su cui Belgrado già è sovrana. Gli ortodossi di queste regioni annesse, in parte serbi o serbo-montenegrini ed in parte di nazionalità ancora incerta, come gli slavi della Macedonia, vengono tutti considerati sudditi spirituali della Chiesa serba. Malgrado i contrasti con le autorità governative, di formazione talora positivistica e occidentalizzante, di cultura non affine a quella delle gerarchie ecclesiastiche, e soprattutto convinte della necessaria sottomissione della Chiesa allo Stato, l’Ortodossia della Serbia fino alla Prima Guerra Mondiale conosce una graduale ripresa di forze e di strutture, il cuore della quale è il monachesimo, provvisto degli antichi monasteri–fortezze, nonché del prestigioso Hilandar, l’unico cenobio serbo sull’Athos. Nel 1918 si costituisce il Regno dei serbi, croati e sloveni - SHS, fondendo in unità politica le distinte monarchie di Serbia e Montenegro con Slovenia, Croazia e Bosnia già facenti parte dell’Impero Asburgico, dissolto dalla sconfitta bellica. Il maggiore impulso per la formazione del Regno SHS, che dal 1929 si sarebbe chiamato Jugoslavia, viene dai serbi, i quali nel nuovo Stato degli slavi del Sud costituiscono la nazionalità egemone. “La Prima Guerra Mondiale ha comportato per tutte le comunità religiose e, quindi, anche per l’autocefala Chiesa serbo-ortodossa una situazione piena di incertezze e difficoltà. Già durante la Conferenza di Corfù del 1917, dedicata alla formazione del primo Stato jugoslavo, alla quale furono presenti sia i rappresentanti del governo serbo sia quelli dell’opposizione, fu messo in luce che nel futuro Stato di Jugoslavia sarà sancita l’eqiparazione dei diritti e degli status tra le diverse fedi” (Mirković 1988, 355). Al sorgere del nuovo Stato, la Chiesa si presenta divisa in cinque componenti, o cinque giurisdizioni, corrispondenti alla diaspora serba nei Balcani alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Sull’onda dell’entusiasmo e della volontà unitaria espressa con la fondazione del Regno SHS, l’Ortodossia serba riesce in breve tempo ad unificarsi e ad ottenere dalla sede di Costantinopoli la qualifica di ‘patriarcale’. “Fu solo con la formazione del SHS che si crearono le reali condizioni per l’unificazione delle fino allora sparse Chiese serboortodosse autocefale ed autonome.” (Slijepčević Ana Živković 1991,5). Le cinque componenti che confluiscono nell’obbedienza al ripristinato Patriarcato di Peć esprimono la complessa storia civile e religiosa dei serbi, ed è la Chiesa che in certo senso vanta la continuità storica con le origini del Cristianesimo tra i serbi. Tuttavia, nonostante l’avvento della libertà, le sciagure della Chiesa serbo-ortodossa sono continuate. Il suo rinnovamento si scontrava con grandi difficoltà, con i conflitti permanenti con i vicini albanesi e con l’incomprensione e la cattiva volontà del nuovo potere. Durante la Seconda Guerra Mondiale l’espulsione dei serbi e della Chiesa serba dal Kosovo e Metohija assunse dimensioni ancora più notevoli e anche dopo la liberazione della regione, nel 1944, le sofferenze della Chiesa serba non sono purtroppo cessate. I proclamati principi di uguaglianza nazionale e di libertà di confessione avrebbero dovuto permetterle una ripresa pacifica ed uno sviluppo nella libertà: la Chiesa serba è divenuta, invece, il bersaglio non solo dello sciovinismo albanese rinascente, ma anche di un comportamento fazioso da parte dei politici e degli organi del potere a tutti i livelli, da quello locale fino alle istanze superiori; lo sradicamento ‘dell’egemonia della Grande Serbia’, proclamato come uno degli obiettivi principali della politica nazionale jugoslava dopo la guerra, presupponeva anche numerosi limiti alla vita e all’attività della Chiesa. Gli anni dal 1941 al 1945 sono, dunque, considerati dai serbi tra i più tragici della loro storia. “La Seconda Guerra Mondiale ha avuto delle conseguenze catastrofiche per la Chiesa serbo-ortodossa, non solo per le sofferenze di un gran numero di fedeli e per la divisione della Chiesa che seguiva alla divisione del Paese, ma anche perché di fatto essa non è riuscita a svolgere le proprie funzioni durante questi anni di guerra, che provocarono, quindi, un periodo di discontinuità” (Radić 2005, 182). Nello Stato ustascia croato di Ante Pavelić l’elemento serbo ha subito una radicale persecuzione etnica, e conseguentemente anche religiosa. Ma anche nel Kosovo e Metohija, assegnato dall’Asse alla Grande Albania si è attuata una pulizia etnica ai danni dei serbi. Seguì la Jugoslavia di Tito con un indirizzo anti-religioso in forza della dottrina marxista che informa la dirigenza dello Stato. La divisione della Jugoslavia in sei repubbliche autonome prefigura Rassegna critica della letteratura serba una nuova diaspora dei serbi, sparsi tra Serbia, a sua volta frazionata in Serbia, Kosovo e Metohija e Vojvodina, e tra Bosnia, Croazia, Montenegro e Macedonia. La Chiesa serbo-ortodossa rimase però indivisa, una per tutta la Jugoslavia, con il centro nel Patriarcato belgradese. Negli anni di Tito, tuttavia, non si costruirono nuove chiese ortodosse e i credenti furono sfavoriti dalla pubblica amministrazione e a volte apertamente discriminati. “A partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e più precisamente dalla fondazione dello Stato federativo socialista di Jugoslavia le attività di tutte le comunità religiose e, dunque, anche della Chiesa serboortodossa, si svolsero nell’ombra della dottrina dominante socialista, impregnata di ateismo, che cercò sempre di lasciare poco spazio a tutti gli elementi religiosi” (Slijepčević 1991, 382). Successivamente, a partire dalla metà degli anni Cinquanta, si stabilisce un modus vivendi fra Stato e Chiesa ortodossa. Negli anni Sessanta la Chiesa ortodossa di Jugoslavia, se confrontata con altre Chiese ortodosse dell’Est europeo, può considerarsi libera, avendo i contatti internazionali che desidera, mentre la rigorosa separazione fra Stato e Chiesa favorisce una certa libertà religiosa e di culto. La crisi della Jugoslavia, fino alla guerra interetnica scoppiata nel 1991, vede la Chiesa ortodossa solidale con l’etnia a cui fa riferimento. Il principio dell’unità tra Chiesa ortodossa e nazione venne quindi riconfermato. Di fronte alla crisi degli anni Novanta i serbi hanno creduto di trovarsi all’ennesima tragica svolta del loro destino. Nei croati e musulmani avrebbero visto, per dirla con le parole del vescovo Danilo Slavko Krstić, “la stessa Alleanza Musulmano Cattolica del tempo dell’occupazione di Hitler”, ed avrebbero reagito con le armi, con maggior certezza di martirio che di vittoria, come già nel 1914 e nel 1941 avevano reagito agli ultimatum austriaci e tedeschi senza certezze di vittoria. La guerra scoppiata nel 1991 offre, infatti, nuovi motivi all’apocalittica dei serbi. Offuscando la vera natura delle guerre in Croazia, Bosnia ed Erzegovina e nel Kosovo e Metohija, la propaganda del regime ha, tra le altre cose, accentuato il carattere religioso di queste guerre, fatto che ha ulteriormente posto la Chiesa quale una delle colonne portanti della omogeneità nazionale. “La guerra non fu sicuramente scoppiata a causa della religione, ma la religione ha comunque servi- 17 n.17 / 2007 to da unica differentia specifica grazie alla quale i popoli etnicamente affini riuscirono ad articolare i motivi per il proprio odio” (Stojković 1994, 25-29). I serbi considerano la dissoluzione della Jugoslavia come il prodromo di nuove persecuzioni del loro popolo, precipitato alla situazione antecedente il 1918 e di nuovo costretto alla diaspora, entro quattro diversi Stati ritagliati sulla base dei confini amministrativi delle vecchie repubbliche titine, non corrispondenti alla distribuzione etnica della popolazione. Dunque, si torna allo spirito del 1389, inteso come la resistenza serba all’annientamento. Si tratta, dunque, ancora una volta di salvare il popolo serbo quale ‘popolo celeste’ in forza della sua fede e della sua tragica storia di martirio. Oggi, come in età medievale, l’Ortodossia rimane l’elemento fondante della ‘serbitudine’, forse il più autentico, di certo quello provvisto di maggiore tradizione storica. Il ruolo etnogenetico della religione serboortodossa Di fronte a tutti i fatti della tragedia del popolo serbo nel Kosovo e Metohija la Chiesa serbo-ortodossa ha avuto sempre un ruolo importante. Quasi sempre essa è stata la prima a farne le spese. Le sue chiese, i suoi monasteri e i suoi beni, e così pure i suoi sacerdoti, i suoi monaci e i suoi vescovi, sono sempre stati i primi a subire i maltrattamenti e l’umiliazione, ogni volta che si verificava una nuova offensiva dell’imperialismo albanese (Il libro sul Kosovo). Così facendo, il nemico non commetteva errori nella scelta dei suoi obiettivi, ma dimostrava egli stesso che la Chiesa serba fa parte in modo inalienabile, sia da un punto di vista spirituale che morale, dell’identità nazionale del popolo serbo, quale il pilastro ed il bastione della sua sopravvivenza. Non è mai stata intrapresa una guerra contro i Serbi senza un’aggressione contro la Chiesa serba. Non si tratta, dunque, di un atteggiamento della Chiesa con cui essa si imporrebbe da sé, senza esservi chiamata, come attore politico degli avvenimenti del Kosovo e Metohija; non si tratta neppure di un qualunque clerical-nazionalismo serbo. Fin dall’inizio la Chiesa serba è stata il bersaglio dell’aggressione grande-albanese, come pure è stata il bersaglio di tutte le aggressioni contro l’integrità del popolo serbo. Il suo trionfo spiri- 18 tuale sta in quello che da serbi viene definito ‘la scelta del Kosovo’: non si tratta di una glorificazione della morte e della disfatta; al contrario, si tratta di una superiorità dello spirito, del sacrificio, dell’amore e della vita. È con questa eredità spirituale che la Chiesa visse ed operò nei tempi oscuri della schiavitù e delle estorsioni turche in Kosovo e Metohija. Lo scopo principale della Chiesa è stato sempre quello di salvaguardare l’integrità spirituale del popolo, e ciò vuol dire, prima di tutto, la sua coscienza e la sua morale. È così che si è formata una considerevole forza di resistenza che, in funzione delle reali circostanze storiche, si è manifestata in maniera tangibile ed attiva, e anche in modo politico. L’importanza attribuita all’appartenenza religiosa in Serbia e nei Balcani in generale ha le proprie ragioni storiche. Su di essa si sono però divisi molti storici. Alcuni sostengono che, poichè l’Impero Ottomano ‘tollerava’ la libertà di religione, la Chiesa ha rappresentato per molti popoli l’ultimo rifugio della libertà culturale ed il garante dell’identità etnico-culturale, in altre parole, essa era il segno distintivo delle varie tradizioni. “La Porta è stata tollerante dal punto di vista giuridico nei confronti della fede ortodossa e sui territori conquistati ha mantenuto le istituzioni e i rappresentanti delle comunità religiose” (Mirković 1988, 344). I legami etnici e religiosi in questi Paesi non avevano avuto però un equivalente territoriale, cosicché, inevitabilmente, gli individui e i gruppi di diverse origini etniche e religiose venivano mescolati e correlati, ciascuno quale portatore di una cultura distinta. Altri, come Slavenko Terzić, che considera il fattore religioso quale l’elemento che abbia da sempre avuto un ruolo fondamentale, anche dal punto di vista territoriale, nella storia del popolo serbo, come anche nella storia dei Balcani e dell’intera Europa, hanno, invece, ritenuto che fra i popoli dominati, la fede dell’Islam si affermò con l’imposizione forzata e con le promesse di privilegi sociali, trovando un terreno particolarmente fertile in Bosnia e in Erzegovina. Questi fatti sono importanti anche per capire che l’Islam nei Balcani è ancorato ad una plurisecolare memoria di dominazioni subite, che ha giocato non poco nel definire in seguito, e fino ai giorni nostri, i rapporti e i confini teritoriali, anche in modo drammatico. Ana Živković Inoltre, vale la pena ricordare che, dopo il soggiogamento della Serbia, il processo dell’etnogenesi serba si trasformò profondamente. Da una parte la Chiesa serbo-ortodossa diventò un surrogato per l’indipendenza nazionale perduta, mentre dall’altra parte tutte le popolazioni di religione ortodossa in Bosnia, Croazia ed Ungheria, incominciarono a sentirsi serbi. Così nell’etnia serba, come nel più noto esempio degli ebrei, la religiosità acquistò un importante ruolo etnogenetico e il territorio del Kosovo e Metohija diventò Gerusalemme serba, nel senso di quella parte della terra di valore simbolico a cui il popolo non può rinunciare, senza essere prima distrutto. È possibile che l’emozione che i serbi sentono riguardo al Kosovo e Metohija sia paragonabile a quella che gli ebrei sentono per Gerusalemme? Nonostante ogni cittadino serbo, senza eccezione, parli del Kosovo e Metohija come gli israeliani parlano di Gerusalemme – non esiste Israele senza Gerusalemme, e non esiste Serbia senza il Kosovo – il mondo occidentale ha spesso cercato di minimizzare questo sentimento e le ricerche scientifiche non hanno ancora enfatizzato abbastanza il significato della religiosità nella formazione dell’identità nazionale serba, specialmente nel periodo di rinascimento nazionale del XIX secolo. La stessa integrazione nazionale serba viene considerata come un problema di rapporto esistente tra i fattori etnici e religiosi. Infatti, è proprio in seguito alla conquista dell’Impero Ottomano che i serbi entrarono in un’epoca multicentennale di dominazione straniera, durante la quale le divisioni religiose divennero così profonde da non poter essere ricucite neanche durante il processo della costituzione dello Stato serbo moderno. Quel connubio così stretto tra l’appartenenza religiosa e quella nazionale che appare come tratto tipico delle questioni jugoslave non si deve considerare come un fatto ineluttabile. L’appartenenza religiosa si è come fusa con quella nazionale, o etnico-culturale, e ha costituito uno stile di vita compatto in cui il singolo si trova nativamente inserito. Comprendere questo processo, nonché il dato attuale, per cui i due fattori, di per sè contrapposti – il sentimento nazionale particolaristico e l’appartenenza religiosa universalistica - si sono fusi, può forse consentire lo sviluppo di un modello di spiegazione che facilita il superamento della Rassegna critica della letteratura serba situazione attuale. “Il Cristianesimo e, dunque, anche l’Ortodossia e altre religioni universalistiche vengono rappresentati quali sistemi monoteisti che di fronte alle determinate condizioni culturali, economiche e sopratutto quelle politiche hanno contribuito alla formazione dei sentimenti nazionali ed etnici; a differenza di quelle cattoliche, le Chiese ortodosse si configurano quali chiese nazionali e vengono quindi considerate dal popolo serbo quale una delle rappresentazioni più importanti della loro identità etnica e nazionale, unificando in tal modo l’appartenenza religiosa e quella nazionale” (Bandić 1992, 63-69). La religiosità dei serbi I motivi di contrasto, sviluppatisi fra l’Oriente e l’Occidente cristiani, in seguito alle diverse strade percorse dalla grecità orientale e dalla latinità occidentale, possono offrire una spiegazione della situazione di attrito creata nell’epoca moderna. “Quando l’Impero serbo aprì le proprie porte all’Impero della Cristianità, la religione ebbe un impatto positivo sul popolo serbo, ma già a partire dal secolo successivo iniziò ad abusarsi della stessa per fini politici” (Deretić 2005, 56). Jovan Deretić ritiene che sia Costantinopoli che Roma, contrassegnando un limite, culturale e psicologico oltre che politico, fra l’Oriente e l’Occidente, cercavano da una parte di affermare, mediante la religione, la propria supremazia politica in quest’area, dall’altra di soffocare, mediante la Chiesa, la coscienza e la cultura serbe. Ed è a tal punto che i serbi cominciarono a combattere per l’equiparazione dei diritti nei confronti di questi due poli di influenza; la situazione di ostilità è durata per più secoli e ha avuto come conseguenza principale il rallentamento della diffusione del Cristianesimo tra i serbi del Nord e della Serbia centrale. Solo con lo sviluppo dello ‘Svetosavlje’ – culto di Sveti Sava, essi diventarono degli equiparati di diritto nella Chiesa cristiana e cominciarono a concepire il cristianesimo come qualcosa di non estraneo ed ostile, ma come un punto d’appoggio, quale opposizione contro gli elementi di dominazione, quali diventeranno quelli dell’Impero Ottomano (La nostra vittoria – per il presente e il futuro della Serbia ). Nell’analisi del cristianesimo serbo-ortodosso risultano di particolare interesse le tesi di Veselin 19 n.17 / 2007 Čajkanović, secondo il quale la concezione attuale della religione trova le sue origini nel passato degli slavi del Sud, il paganesimo dei quali non si sviluppava, come quello antico, in modo ininterrotto verso il monoteismo, ma ha subito attraverso il processo della cristianizzazione una certa repressione, a volte adattandosi in modo forzato alle richieste della Chiesa d’Oriente o di quella occidentale. Attraverso il metodo comparativo, utilizzando anche quello filologico e storico, Čajkanović afferma che alcune forme religiose del popolo serbo risultano preesistenti a quelle antiche, e considera la religione serba come prevalentemente precristiana e quindi pagana. La constatazione che il popolo serbo rimase fino ai tempi moderni attaccato alla fede pagana venne dimostrato anche dal fatto che le feste più significative rimasero invariate. Seguendo questa prospettiva si giunge alla conclusione che la religione nella società serba viene considerata più come uno fra i tanti elementi che costituiscono la tradizione di questo popolo, che non come l’insieme dei riti e delle cerimonie che caratterizzano un culto religioso (Il mito e la religione dei serbi ). Una riflessione sulle Chiese ortodosse appare opportuna oggi anche al fine di capire il profilo dell’esperienza religiosa, specialmente nei Paesi post-comunisti, dove la coscienza soggettiva non è in grado di allacciarsi alla identità collettiva della memoria. Con l’implosione del socialismo, si venne a formare la crisi dell’identità delle società ex-socialiste, e non è quindi casuale il rinnovamento, o meglio la regressione alla iniziale, primordiale matrice religiosa e ai meccanismi di solidarietà tradizionale. I principi dell’ideologia comunista vennero ricambiati con quelli di etno-nazionalismo. Le ‘nuove società’ e i gruppi etnici esistenti all’interno di esse ricercarono, nelle fasi di crisi acute, attraverso i moduli culturali antichi, le basi per rinnovare la propria identità. Nasce così la strumentalizzazione dei moduli religiosi ed una riduzione tradizionalista dell’identità nazionale e culturale, senza lo sforzo di dare una risposta più moderna alle nuove sfide; un fenomeno non soltanto postmoderno, ma anche anti-moderno, e in altre parole, distruttivo e retrogrado. “Il modo di reintrodurre i moduli religiosi dell’Ortodossia con troppo sentimentalismo non ha permesso alla società di avere un confronto obiettivo con la real- 20 tà e di conseguenza di adattarsi in modo sistematico e razionale ai cambiamenti della stessa” (Jerotić 1995, 129). Si deve aggiungere che la società realsocialista jugoslava, ha sperimentato per quasi mezzo secolo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il processo della ‘spiritualizzazione della politica’, ossia l’iperpoliticizzazione di tutti gli aspetti della vita sociale, religione compresa. In questo contesto, in un periodo di forte secolarizzazione della società, la religione ha subito un’autoritaria pressione dell’ideologia, che le attribuiva un connotato quasi negativo. Perciò, nel periodo successivo alla sua rivitalizzazione, si ebbe inevitabilmente una controtendenza nella vita spirituale, ma la valorizzazione positiva ed insistente della tradizione e del passato religioso ha comportato in aggiunta un blocco nel processo della modernizzazione e l’abuso del legame esistente tra la religione e la politica. E nelle analisi sulla religiosità dei serbi questo legame rappresenta un tema ricorrente. Specialmente nell’ultimo decennio, la religione e la politica hanno vissuto una particolare simbiosi, tanto evidente che alcune volte è difficile capire quale delle due abbia predominato sulla scena pubblica. La Serbia, infatti, non è che l’esempio più estremo di come le società post-comuniste nei Paesi ortodossi si siano, in una certa misura, rimodellate su una rinnovata sinergia di identità religiosa e di identità nazionale, agevolata dalla particolare struttura ‘nazionale-autocefala’ delle Chiese cristiano-ortodosse. Se a ciò si dovesse aggiungere la caratteristica specifica della popolazione serba di vivere i fatti politici in maniera quasi tragica, non è un caso che siano cresciute le aspettative secondo le quali la religione, attraverso la riaffermazione dei suoi valori fondamentali, dovrebbe facilitare la riconciliazione del popolo e il consolidamento della pace, soprattutto attraverso la riaffermazione di valori indiscussi quali morale, tolleranza e convivenza. Per parlare della religione e del suo rapporto con la società, così come con la politica, è d’obbligo tornare al passato remoto. L’ex Repubblica socialista di Jugoslavia era stata fondata sui principi della Rivoluzione francese e sulla base di una netta divisione tra Stato e Chiesa. Ogni costituzione della ex Jugoslavia ha considerato l’appartenenza religiosa come un tratto privato e il numero dei fedeli, come anche degli atei, non è dato conoscerlo in Ana Živković nessun documento scritto. Nel ‘91 le diverse identità religiose cominciano, invece, a rappresentare l’unica differenziazione tra le singole società: le lingue avevano le stesse radici e le differenze più evidenti esistevano solo nella scrittura, ma cirillico e latino convivevano in modo pacifico. È opportuno specificare che le odierne lingue letterarie dei singoli Stati – Serbia, Montenegro, Croazia e BosniaErzegovina - nati dopo la dissoluzione della Jugoslavia appartengono alle lingue slave, uno fra i tre raggruppamenti più grandi della famiglia di lingue indo-europee, e sono fra di loro molto più comprensibili che non quelle appartenenti al gruppo di lingue germaniche o romaniche; nel medioevo le differenze fra le lingue slave erano pressoché irrilevanti. Il serbo o croato appartiene a questo gruppo e nello Stato della Jugoslavia era la lingua ufficiale, oltre alla lingua slovena e quella macedone. Dal punto di vista genetico-linguistico, la lingua serbo-croata venne formata da singoli dialetti, comprenisbili tra di loro senza difficoltà e parlati nelle diverse aree dello Stato. Oltre ad essere utilizzata dai serbi, montenegrini e croati, essa è anche la lingua dei musulmani slavi della Bosnia ed Erzegovina. “Prima della costituzione dello Stato jugoslavo, durante l’intero XIX secolo, i rappresentanti più stimati della cultura serba e di quella croata tendevano alla creazione di una lingua letteraria comune e solo in un momento successivo il popolo croato ha incomincato ad apportare delle modifiche, seguendo la ‘variante occidentale’ della lingua serbo-croata e adottando appositamente un certo numero di nuovi termini, con il preciso scopo di ottenere lo status di una lingua letteraria distinta da quella serba” (Piper 2000, 116). Anche gli stili di vita nella maggior parte delle regioni erano quasi identici, perché l’urbanizzazione e la migrazione all’interno dello Stato di Jugoslavia avevano prodotto una sostanziale omogeneità e un processo di assimilazione molto forte; l’identità religiosa è diventata, dunque, ciò che ha permesso il riconoscimento immediato dei singoli. Per di più, questo continuo riferirsi all’identità religiosa ortodossa si ritrova, nel periodo post-bellico all’interno della nuova società serba, nei comportamenti delle diverse correnti politiche. Bisogna ribadire che somiglianze molto forti si trovano nell’atteggiamento di tutte le élite politiche della ex Jugoslavia dove immancabilmente i simboli religio- Rassegna critica della letteratura serba si sono diventati fondamentali per la definizione delle identità collettive dei nuovi Stati, anche se le questioni religiose non hanno nemmeno nominalmente rappresentato una causa di disintegrazione della Jugoslavia e la religione ha servito piuttosto da unica differenza evidente mediante la quale i popoli etnicamente vicini riuscirono ad articolare le cause molto più profonde per i propri conflitti. Nell’analisi di Čedomir Čupić, professore di antropologia politica e sociologia dell’Università di Belgrado, si mette bene in luce che all’inizio degli anni ‘90 la Chiesa serba ha avuto ampio spazio sui media e nella vita pubblica in generale, dopo i lunghi anni di marginalità. Con l’uscita dei comunisti dal governo, nello Stato unitario si arriva in breve tempo al risveglio della coscienza religiosa. I partiti politici, ma anche i capi religiosi, diventati velocemente protagonisti di una grande popolarità, sfruttano la religione come ombrello sotto il quale realizzare la propria affermazione. Quindi, in una condizione di conflitto armato, quale uno scenario politico particolare, la religione è andata oltre le sue funzioni in quanto tale e ha acquisito elementi politici e viceversa. Fiancheggiando Slobodan Milošević, una parte della gerarchia ecclesiastica ha conquistato un ruolo centrale con la speranza di ottenere la restituzione delle proprietà sotratte dal aregime di Tito. Diventata, invece, uno strumento del potere politico, verso il 1996-97 essa ha cambiato atteggiamento e si è avvicinata all’opposizione politica, seguendo così il percorso fatto dal resto della società serba. Fu così che la religione tornò ad essere il primo fattore di differenziazione sociale, in alternativa alla mancata diversità nella lingua e nelle origini. Fu così che i rappresentanti religiosi e clericali all’improvviso riapparvero a fianco delle élite nazionali politiche ed intellettuali, come esponenti di prima fila dei nuovi movimenti (La politica e il ma le). Seguendo questa linea il sociologo della religione, Mirko Ðorđević spiega che la devozione alla Chiesa ortodossa in Serbia è stata spesso un motivo di avanzamento di carriera politica, quasi come lo fu, a suo tempo, l’appartenenza al Savez del partito comunista. “Non c’è partito, dalla destra alla sinistra, che non compete con gli altri per avere la benevolenza della Chiesa e i politici non esitano a sottolineare la propria fedeltà all’Ortodossia”; secondo Ðordević “il coinvolgimento della Chiesa nella 21 n.17 / 2007 politica è evidente a partire del 1989, quando salì sul potere Slobodan Milošević. Da allora la Chiesa acquistò il ruolo di forza politica di primo piano, appoggiandosi alle strutture di destra tradizionalista della società”. Inoltre, Ðorđević mette in rilievo la clericalizzazione della società e della vita pubblica in generale. “La Chiesa serbo-ortodossa, invece di impegnarsi di più nel processo di evangelizzazione, il quale potrebbe comportare dei benefici sia alla Chiesa sia alla società serba, ha intrapreso l’attività della clericalizzazione, coinvolgendo tutti gli ambiti della vita pubblica, dalla scuola ai media” (Ðorđević 2001, intervista a Zarez n.70-71). Contro queste affermazioni si esprime, invece, Slobodan G. Marković che, ponendosi di fronte la questione della clericalizzazione della Serbia, cerca di dare una risposta alla seguente domanda: si tratta di un mito o della realtà? Per realizzare la clericalizzazione di una società democratica è necessario, secondo l’autore, realizzare almeno le tre seguenti condizioni basilari: il numero di credenti istituzionali deve superare la metà della popolazione; deve esistere una tradizione storica di forte spirito clericale e la Chiesa, come istituzione, deve possedere abbastanza forza economica e politica da imporsi nei confronti dello Stato quale un partner eguale o superiore. Tuttavia, nessuna di queste condizioni è stata realizzata in Serbia; infatti, i credenti istituzionali rappresentano soltano 8,5% dell’insieme di ortodossi; nel XIX e nel XX secolo è sempre stato lo Stato a governare sulla Chiesa e mai viceversa; e la Chiesa serbo-ortodossa non ha mai rappresentato un attore economico di particolare importanza. L’autore conclude quindi che si tratta piuttosto di un mito (Clerica lismo in Serbia : mito o rea ltà ). Uno dei dubbi strategici del popolo serbo, manifestatosi durante il periodo del recupero degli elementi religiosi rimane allora quello di capire se il ritorno ostinato alla tradizione storica e religiosa avesse impedito più che aiutato la conservazione di essi come popolo e lo sviluppo civile verso una società moderna europea. “La Chiesa dovrebbe diventare la colonna portante per la nazione e per lo Stato, nonché la prima difesa dell’identità serba, ma è anche necessario cambiare lo status di questa istituzione. La Chiesa, infatti, non può essere una creazione privata ed indefinibile, ma un’istituzione statale con un ruolo ben definito, perchè fu la storia stessa a dimostrare che la separazione della 22 Chiesa dallo Stato produsse per il popolo serbo le stragi più grandi” (Deretić 2005, 59). I mutamenti psicologici nell’identità serba Analizzando una serie di situazioni geopolitiche particolarmente sfavorevoli che hanno circondato per più secoli la storia dello Stato serbo e i limiti causati da una formazione statale quale quella della ex Jugoslavia, nello sviluppo dell’identità del popolo serbo si percepisce l’intreccio delle identità nazionali e soprannazionali che ha caratterizzato l’intera area dei Balcani. In particolare in Serbia, la quale ha sviluppato il concetto di nazionalità in contrapposizione alle dominazioni degli Imperi turco ed austro-ungarico, l’identificazione del popolo si delinea come una rivendicazione dell’autonomia nazionale, territoriale o meno. Vista la difficoltà, in genere, di accettare come definitivi i confini statali, e nel caso jugoslavo ancor più quelli interni, la legittimità territoriale della nazione viene rapportata alle tradizioni del passato, invocate quali fonti determinanti per l’attribuzione di una regione a questa o a quella comunità etnica. Sforzandosi di definire il carattere dei serbi, gli studiosi sono riusciti ad accordarsi su un solo punto: carattere dominante della Serbia è l’idea di eroismo, un concetto filtrato dalla storia, forse determinato dal fatto che tutto ciò che si è mai potuto ottenere in questo Paese è stato pagato con il sangue. Ed in tale ottica viene percepito anche il territorio, che per un serbo non rappresenta una proprietà ma l’identità stessa, la vita. È il luogo di espressione e libertà da difendere fino all’ultima stilla di sangue. Volendosi concentrare sul tema della ‘carattereologia nazionale’ del popolo serbo risulta utile l’analisi dettagliata del libro Ca ra ttere come destino dell’antropologo ed etnologo Bojan Jovanović. Egli ha cercato di analizzare il delineamento delle caratteristiche dei serbi mediante l’analisi delle concrete circostanze socio-culturali, durante il succedersi delle quali gli elementi nascosti dell’identità collettiva venivano progressivamente riscoperti. I cambiamenti, ai quali venivano esposti i serbi durante l’intero corso storico, mostrano, infatti, una serie di tratti tipici del carattere nazionale serbo che si formarono attraverso una molteplicità di periodi storici, tra cui i più significativi vengono considera- Ana Živković ti i seguenti: il periodo pre-cristiano, il periodo medievale dell’autonomia statale, quello della dominazione ottomana, quello del rinnovamento dello Stato nel XIX secolo e, infine, quello della dissoluzione dello Stato di Jugoslavia; ciascuno fra questi intervalli di tempo ha causato una forte discontinuità nelle tradizioni e nell’essere del popolo serbo, producendo uno status colletivo caratterizzato dall’assenza di un modulo culturale preciso e da una mentalità che viene definita dall’autore come ‘transitiva’. Il lato positivo di tale mentalità è l’enorme vitalità nell’auto-affermazione, mentre quello decisamente negativo risiede nello stato di anarchia che essa produce, dacché consegue anche una sfera politica fortemente instabile (Ca ra ttere come destino). La ricerca dell’identità serba è stata sin dall’inizio caratterizzata dal fatto che essa fu sempre fissata in modo da contrapporsi ad un’alterità sia dal punto di vista etnico e religioso sia dal punto di vista politico ed economico. Questa contrapposizione culturale si è formata inizialmente con il processo di “islamizzazione di una parte della popolazione autoctona, che condusse ad un lungo periodo di coesistenza di due identità sociali, la differenziazione delle quali diventò attraverso i secoli alquanto relativa: si formarono, infatti, un modo di vivere che si basava sui valori che comprendevano tratti di entrambe le religioni – dell’Islam e dell’Ortodossia – ed un orientamento storico comune. Questo periodo di coesistenza diventò ancora più complesso con l’insediamento dei serbi nei territori di confine più vicini ai Paesi del Cristianesimo cattolico; essi cominciarono a costruire un rapporto ambivalente anche con questi popoli, ma al contrario della religione islamica, il Cristianesimo d’Occidente risultava un alleato più vicino, anche se si trattava di un’alleanza che spesso superava il piano culturale e trasformava l’affinità religiosa in una contrapposizione strategica che successivamente ha portato la Serbia a coalizzarsi con i popoli slavi del Sud ed a ricercare il patrimonio culturale comune con la Russia” (Lazić 2005, 13-14). Inoltre, bisogna precisare che la Russia, diventando il centro della spiritualità del mondo ortodosso, è diventata l’alleato di base per la sopravvivenza nazionale serba; si trattava però di un’alleanza che cercava il volto ‘ortodosso’ della Russia, ossia quel- Rassegna critica della letteratura serba la parte della Russia che il successivo regime comunista ha cercato di distruggere. Quindi, se nei secoli precedenti l’Ortodossia russa rappresentava una base solida di identificazione per larghi strati della popolazione, è evidente come l’accettazione massiccia del regime comunista comportasse la valorizzazione dell’ideologia anti-religiosa. Il libro del giovane giurista Dejan Mirović L’Occidente o la Russia analizzain relazione a quanto precedentemente detto, la questione della scelta strategica di fronte alla quale si trova oggi il popolo serbo, rimasto senza il proprio Stato, anche dopo 4 anni di guerra, anche dopo 78 giorni di bombardamenti e anche dopo l’espulsione dei suoi membri da territori, che rappresentano la culla dello Stato serbo. L’autore di fronte a questa scelta strategica si propone di non considerare il rapporto tra l’Occidente e la Russia come un rapporto esclusivo e descrive lo stato della nazione serba con termini quali l’indifferenza, la disperazione e l’autocolpevolizzazione. “Non esiste una nazione senza le memorie storiche”, ha affermato Max Weber, e senza, si potrebbe aggiungere, la continuità, i cambiamenti e senza un rinnovamento di autoconsapevolezza, ma la memoria dei serbi non ricorda neanche quello che sia accaduto ieri; se ricordasse, come potrebbe perdonare gli umilianti bombardamenti, l’occupazione e il protettorato su una parte del suo territorio? Sicuramente l’Occidente ha un maggiore potere, ma tale potere non è mai così forte da distruggere la dignità nazionale e da provocare le reazioni umane quali la perdita di autostima e l’autocolpevolizzazione. E questo non è l’unico prezzo da pagare per diventare e rimanere una parte dell’Occidente. Si dovrebbero riformulare tutti gli aspetti della vita quotidiana, da quella agricola a quella intelettuale e tutto ciò comporterebbe un serio pericolo per la stessa identità nazionale (L’Occidente o la Russia ). E a questo punto che Mirović afferma che, senza un alleato forte, senza un’alternativa all’entrata nella società occidentale, consegue lo status di subordinato, di occupato e di inferiore; e tale alleato è da ricercare nella Russia, la spiritualità e la cultura della quale sono più vicine al mondo serbo, anche se il mito della slavofilia - una pretesa ansia di unificazione di tutta la popolazione slava - non è una lente sempre adeguata alla lettura dei rapporti politici tra gli Stati, determinati piuttosto da ragioni di interesse 23 n.17 / 2007 e di opportunismo. Il ritorno verso i valori dell’Occidente si verficò solo dopo lo scontro con il regime di Stalin e la necessità dello Stato serbo di ottenere dei fondi materiali dal mondo occidentale per mantenere la propria élite al potere; tutto ciò ha comportato la stabilizzazione dei legami economici con i Paesi occidentali, seguiti dall’apertura del Paese anche alla comunicazione culturale con l’Occidente. Questa continua contrapposizione alle altre culture è ripresa anche nello studio di Vladimir N. Cvetković il quale sostiene che la società serba si è trovata per 5 secoli in uno stato di ristagno a causa di una spaccatura della civilizzazione, provocata da una parte dall’espansione dell’Impero Ottomano, dall’altra dal conflitto con l’Impero austro-ungarico, due fattori che hanno separato la Serbia dalla cultura bizantina, distruggendo però anche i legami che esistevano con il mondo europeo cristiano. Il continuo esistere sull’orlo di grandi imperi, culture e civiltà, e all’interno degli Stati con delle impostazioni nemiche, nonché lo stato di subordinazione dei serbi nelle diverse aree politico-culturali, non solo non furono favorevoli alla produzione dinamica della loro cultura, ma fecero dei conflitti e degli esili l’unica costante storica della ‘serbitù’, inducendo gli elementi conflittuali a manifestarsi di conseguenza anche nella vita sociale, nelle norme, nell’economia e nella spiritualità dell’intera nazione. Infine, l’inviolabilità degli ordini imperiali e il dispotismo orientale hanno causato lo sviluppo ritardato del Rinascimento e la mancata valorizzazione dei moduli tradizionali della Cristianità e delle istituzioni economiche e politiche, basate su di essi, contribuendo alla perdita del collegamento tra l’ethos serbo e l’area culturale europea (Serbia moderna : la ricerca dell’identità ). Cvetković insiste anche sul fatto che la Serbia moderna si differenzia poco da quella del XIX secolo, quando furono compiuti i primi sforzi organizzativi nella costituzione e nell’emancipazione nazionale, ossia nella direzione dell’integrazione dello Stato nei processi di sviluppo moderni europei. Il fatto è che, nella fase della propria esistenza moderna, la Serbia ha continuato ad allargarsi statualmente, ma non è mai riuscita ad inserire nelle diverse formazioni statali tutte gli elementi dell’etnicità serba, diventando alla fine uno Stato multietnico. L’allargamento territoriale dello Stato 24 non ha mai potuto compensare le numerose debolezze interne, evidenziate soprattutto nel sistema politico autoritario e nella corrispondente mentalità sociale. L’identità nazionale moderna si collegava, dunque, principalmente all’ideale dello Stato indipendente. Ma si trattava sempre di un’indipendenza nei confronti all’esterno, mentre l’indipendenza interna, ossia i diritti dei cittadini e l’intera sfera civile della società, rimase sottosviluppata, anche e soprattutto a causa della costante dominazione del fattore esterno. Fu grazie alla nascita dello Stato di Jugoslavia, comprendente più o meno la gran parte dello spazio etnico serbo e realizzante il sogno secolare della maggioranza dei serbi, che essi decisero di sostituire la propria identità etnica con una nuova identità, non più solo nazionale, bensì politicizzata e multietnica. Tuttavia, fu proprio con la formazione della Jugoslavia che “i serbi si trovarono nella situazione di dover badare contemporaneamente agli interessi serbi ed a quelli jugoslavi, cercando di dare sempre la priorità all’insieme – alla Jugoslavia – che non alle singole parti, ossia alla propria repubblica. In conseguenza di ciò, si trovarono ben presto ad avere due identità, le quali vennero spesso opposte in modo esclusivo; fatto che ha segnato il destino politico ed esistenziale di questo popolo nel XX secolo” (Cvetković 1996, 76-80). Cvetković ha, inoltre, messo in evidenza la ‘strumentalizzazione politica’ delle identità culturali che ha causato risultati molto diversi nella formazione delle unità statali: da quelle immaginarie quali “la Grande Serbia”, “l’Unione di tutti i popoli illirici” o “la Federazione Balcanica”, a quelle realmente esistenti, quali la SHS - il Regno dei serbi, croati e sloveni, Il Regno di Jugoslavia, la SFRJ Repubblica federale socialista di Jugoslavia -, fino ad arrivare alle varianti riduttive di quest’ultima, quali la SRJ – Repubblica socialista di Jugoslavia - e all’attuale eredità statale - Repubblica di Serbia ossia a una formazione corrispondente a quella dalla quale si è inizialmente partito (Serbia moderna : la ricerca dell’identità ). I pensieri seguenti legati al problema dell’identità serba richiamano quello che la prof.ssa Jelena Ðorđević, docente alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Belgrado, ha definito ‘la sociologia dell’avvenimento’, in quanto i fatti di cruciale importanza, come una forma di assalto, hanno Ana Živković assunto il ruolo di forti cambiamenti nella struttura dell’identità, attraverso una dialettica evolutivainvolutiva, nella quale una crisi o un fatto casuale poteva causare uno sconvolgimento sociale e politico, e finchè poteva essere neutralizzata mediante gli elementi interni della società e della cultura, veniva percepita come una trasformazione drammatica dal vecchio al nuovo. Con riferimento all’identità serba tale dialettica diventa importante in quanto l’identità si costruisce proprio attraverso questi momenti drammatici. L’assalto dei nuovi avvenimenti ha comportato la ricerca della mitologia o del passato mitologico, con un forte potenziamento di elementi che servivano da protezione (Vittima o preda – a na lisi dell’identità serba ). Di particolare interesse è anche lo studio successivo della Ðorđević riguardante il modo di interpretare la propria identità da parte del popolo serbo sia attraverso dei valori oggettivi e scientificamente fondati sia mediante degli elementi soggettivi, soprattutto se si considera che l’identità serba venne costruita in un periodo storico relativamente corto, ma pieno di avvenimenti, in cui gli elementi oggettivi della sfera politica, soggetti a continue trasformazioni, non sono riusciti a modellarsi in modo compiuto, cambiando di conseguenza continuamente anche le situazioni soggettive del popolo. Inoltre, esistono essenzialmente due modi principali di interpretare l’identità, attraverso i quali viene analizzata sia la propria sia quella degli altri: il modo primordiale o essenzialistico e il modo strumentale o costruttivo. Il rapporto tra i due modi nel periodo della dissoluzione della Jugoslavia si basava su delle supposizioni radicalmente opposte: da una parte i serbi venivano percepiti come un popolo agressivo, primitivo ed ossessionato dalle invenzioni sulla propria grandezza storica, dall’altra questi elementi primordiali venivano assorbiti dallo schema costruttivo dell’interpretazione e spiegati quale una causa diretta della manipolazione politica del preesistente regime autoritario. Tutto quello che in generale si attribuiva al ‘balcanismo’, si attribuiva in modo concentrato al popolo serbo. L’identificazione dei serbi come degli unici colpevoli dei conflitti venne appoggiata dall’idea essenzialistica sviluppatasi all’Occidente e sostenuta, all’interno della stessa società da parte delle élite intellettuali di orientamenti mondialistici, da parte di coloro che si Rassegna critica della letteratura serba dichiararono contro la guerra, da parte di tutte le forze politiche che volevano contrastare il regime, nonché da parte delle minoranze etniche e dal settore non governativo. La pressione operata dai Paesi occidentali contro l’ideologia del regime raggiunse, attraverso una rapida escalation, l’apice con i bombardamenti. Gli aspetti di tale ideologia vennero allora attribuiti a tutti i serbi. Tutto quello che ha posto in atto Slobodan Milošević ha causato la formazione di un’idea omogenea riguardo all’agire dell’intero popolo. Inoltre vale la pena di ricordare che, durante il periodo del regime, l’ideologia ufficiale ha cercato di rafforzare la figura della vittima, un’idea non estranea alla nazione serba, caratterizzata però da una forte connotazione emotiva, comprendente sia moduli pagani sia significati cristiani dell’idea di vittima. Questa idea venne, infine, rafforzata con il mito del Kosovo, del Popolo celeste, fino ad arrivare alla creazione del mito che chiede all’intera umanità di combattere contro l’imperialismo, la figura principale del quale è rappresentata per i serbi dagli Stati Uniti, raffigurati come un “popolo senza una vera e propria identità nazionale, che vive nella società dei consumatori senza l’anima” (Čolović 2002, 67). Esiste, infine, un concetto senza il quale l’identità serba non può risultare comprensibile, e cioè l’espressione di un forte senso di appartenenza alla comunità, impregnata della solidarietà, una comunità speciale, non tanto per la sua composizione, quanto per il modo in cui essa viene vissuta dai suoi membri. In questo senso, l’identità dei serbi è un’identità antichissima e forse di recente riscoperta, sopravvissuta a cinque secoli di dominazione con molte delle sue connotazioni primigenie. Nell’identità del serbo, concetti come quelli di verità e di giustizia restano sempre al centro del sistema di vita, che di conseguenza viene concepita come il succedersi di momenti vividi e, dal punto di vista degli occidentali, sicuramente esagerati e comunque lontani dall’anestesia progressiva che sembra dominare le vite degli altri europei, descritti come “un popolo ossessionato dal materialismo, umanismo e cosmopolitismo, che ha perso i magnifici valori della propria cultura del passato e ha sviluppato un’identità malatta e appassita” (Čolović 2002, 67). 25 n.17 / 2007 Gli aspetti mitologici dell’identità serba Uno dei modi di spiegazione dell’identità serba è quello di seguire la linea mitologica. Tutti i popoli hanno i loro miti, ma sembra che sui Balcani occidentali abbondino e che siano fondati su una finzione, ovviamente sbagliata, cioè: che una nazione esistente oggi, è sempre esistita ed è sempre stata abitata dalla stessa ‘specie’ di popolazione; che i gruppi etnici di oggi, che appartengono alla stessa cultura dei propri antenati, hanno, come loro, la stessa coscienza nazionale; che la nazione attuale, in passato è stata più grande, più importante e che è stata danneggiata ed oppressa dai vicini. Quando, alla fine degli anni Ottanta, la Serbia si trovò di fronte al difficile compito della ridefinizione della propria identità colletiva, gli aspetti mitologici ottenero un significato speciale. Il crescente bisogno di superare l’identità jugoslava e di sostituirla con un’identità nuova rimase però senza un’articolazione ben definita fino agli anni Novanta, quando si iniziò a modellare e ravvivare i caratteri dimenticati dell’identità serba, in modo da farli corispondere ai bisogni della nuova realtà sociale. A tutto ciò appartengono i grandi miti spesso evocati nell’ultimo ventennio, ‘la Serbia celeste’, ‘il principe Lazar’, ‘il Kosovo e Metohija perduti’, ‘la Serbia come martire e baluardo contro l’invasione islamica’. Può apparire bizzarro che un popolo costruisca la propria identità su di una sconfitta, celebrando il giorno di San Vito - 28 giugno, come una festa nazionale, ma, nella mitologia, questo momento fa per sempre dei serbi un popolo eletto. La leggenda narra, infatti, che il principe Lazar, al comando delle truppe serbe, fu raggiunto alla vigilia della battaglia da un falco che gli chiese di scegliere tra la vittoria sul campo e il regno della terra o la sconfitta e il regno dei cieli. Egli scelse quest’ultimo e in tal modo consacrò il suo popolo ad un destino celeste. Infatti, spesso la storiografia si dimentica di mettere in evidenza il fatto che un popolo sconfitto militarmente, dal punto di vista spirituale ottiene la vittoria. Se i serbi non avessero opposto resistenza all’occupazione ottomana, questa regione probabilmente sarebbe diventata una provincia turca e l’intero popolo sarebbe caduto nella dimenticanza, perdendo per sempre l’identità nazionale, convertendosi all’Islam, al quale non si 26 poteva oppore militarmente, ma solo spiritualmente (Memora ndum sul Kosovo e Metohija ). È assolutamente singolare il fatto che una tragica sconfitta abbia costituito attraverso i secoli il riferimento ideale di un’intera nazione, che in forza della trasfigurazione religiosa e letteraria di quell’evento ha potuto sintetizzare in esso i lineamenti della propria identità e il significato della propria storia. L’accademico Dejan Medaković spiega: “si tratta di una battaglia che non può essere considerata come una sconfitta definitiva della Serbia, o come una vittoria assolouta dei turchi. Le testimonianze di ciò e il fatto che lo Stato serbo, nonostante le sue caratteristiche vassalliche, sopravisse fino al 1459 - la data della caduta della città di Smederevo, concordano nel mostrare che tale battaglia ebbe un’importanza cruciale nella formazione della coscienza nazionale. Se si aggiungesse il veloce sviluppo del culto religioso del principe guerriero e martire e tutti gli aspetti di tale culto, si potrebbero comprendere le caratteristiche formulate tramite la cosiddetta destinazione celeste. Si è formata una particolare forza d’animo, abbastanza forte per sopravvivere ai cinque secoli della dominazione ottomana. Questo culto, principalmente reliogioso, ebbe fino ai primi decenni del XX secolo dei flussi paralleli laici, evidenti già a partire dal XVIII secolo, quando venne formulata la coscienza nazionale serba moderna. Durante l’occupazione ottomana, fu chiaro a tutte le forze sopravvissute della società che la sopravvivenza del popolo serbo fu possibile solo mediante un costante appoggio alle tradizioni della propria società feudale, alla propria morale e ai propri principi etici” (Medaković 1989, intervista in Duga, Belgrado, n. 400). Durante il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni – SHS – il mito del Kosovo diventò ‘l’ideologia del Kosovo’, presentata oggi come il tentativo supremo e simbolico di preservare la Cristianità dall’Islam, portando con sè delle conseguenze che si manifestarono nei successivi conflitti dell’area balcanica, soprattutto a causa della disparità nell’interpretazione del mito, che non fu inteso dai serbi come qualcosa che avrebbe potuto comportare dei danni alle altre popolazioni vicine, mentre quest’ultime cominciarono a pensare che esso servisse al popolo serbo come mezzo di distruzione degli altri popoli. La prof.ssa Olga Popović Obradović spiega: “l’ideo- Ana Živković logia del Kosovo e Metohija nella funzione delle più grandi ed importanti aspirazioni territoriali rappresenta una costante nella politica nazionale dello Stato serbo moderno. La sostanza dell’ideologia dello Stato serbo moderno fu sin dall’inizio quello di unire in un unico Stato nazionale tutti i territori definiti storicamente come serbi. Tale idea fu per secoli chiamata ‘la vendetta del Kosovo’, che sottointendeva la guerra per il territorio, e non solo quello del Kosovo e Metohija, nonostante esso fosse considerato come il simbolo e fattore maggiormente mobilizzante dell’espansione territoriale, l’area nella quale iniziò, ma non deve terminare l’allargamento di questo Stato. Dopo una serie di guerre, la Serbia costituì, anche grazie a questo mito, lo Stato di Jugoslavia del 1918, nel quale il mito perse a volte la propria funzione; esso, tuttavia, non fu mai dimenticato, anzi venne conservato nella memoria storica e rivitalizzato ogniqualvolta la Serbia si sia trovata coinvolta nella crisi dello Stato di Jugoslavia. Questo ruolo del Kosovo e Metohija nel programma serbo nazionale, nel quale la provincia rappresentava solo un mezzo e non il fine, deve essere evidenziato anche nell’analisi degli avvenimenti attuali. Mettendo oggi in discussione i confini del Kosovo e Metohija si mettono in discussione automaticamente tutti i confini della penisola balcanica” (Popović Obradović 2005, 5-6). Successivamente, durante il regime di Tito, la questione del Kosovo e Metohija è diventata un argomento intoccabile, nello spirito di ‘fratellanza e unità’ che doveva regnare a tutti i costi fra i popoli della Federazione. Spesso si dimentica, infatti, che il mito fu creato al tempo del cosiddetto integralismo jugoslavo, ossia quando anche i croati e gli sloveni furono grandi supportatori della Jugoslavia; solo successivamente esso diventò, al posto di un punto di unione, uno dei punti più importanti di divisione. La questione del Kosovo venne allora collegata a quella più generale della condizione delle minoranze serbe all’interno delle altre Repubbliche della Jugoslavia, dove la popolazione serba venne esposta, dal processo generale di disintegrazione che ha colpito lo Stato unitario, alla distruzione totale della sua unità nazionale. Il sacrificio di Lazar, il giogo turco e la nostalgia per la terra sacra perduta dominano il folklore e la letteratura serba fino ad oggi. Il lungo dominio turco Rassegna critica della letteratura serba ha permeato e condizionato la cultura e la mentalità serba, fondendoli in un corpo unico, permettendo loro di realizzare un vero proprio risorgimento, il quale li ha condotti a combattere una lunga serie di guerre balcaniche culminate con la Prima Guerra Mondiale. Il mito del Kosovo ha animato gli ufficiali e i soldati serbi che assieme ai bulgari, greci e montenegrini, anch’essi ortodossi, lo liberarono dai turchi nella Guerra balcanica del 1912. Questo mito viveva anche nell’immaginario di Gavrilo Princip, irredentista serbo-bosniaco che nel 1914, esattamente nel giorno di San Vito, uccise l’arciduca di Austria, scintilla che accese la Prima Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale il mito si riaccese, perché sono ancora i serbi, tra gli slavi del sud, a pagare il prezzo più alto, in vite umane. E nel campo di sterminio di Jasenovac, in Croazia, assieme agli ebrei e i zingari, trovarono la morte soprattutto i serbi. L’importanza attribuita al mito, tramutato successivamente in un’ideologia, viene spiegata, allora, come una causa del corso della storia del popolo serbo, che non ha mai cessato di essere tragico, durante il quale però, i serbi preferivano essere un popolo sempre sconfitto, ma mai sottomesso. Tuttavia, quando una nazione si appoggia più alla mitologia che alla realtà crea inconsciamente degli ostacoli ai nuovi processi o ai successivi procedimenti. Il problema che si presenta in tali situazioni è stato descritto da uno dei migliori conoscitori dei Balcani, Jovan Cvijić, che nel suo celebre saggio La penisola Ba lca nica , scritto all’inizio del XX secolo, ha descritto il confronto tra la mitologia e la realtà storica nel modo seguente: “Simili al ragno, gli uomini tessono intorno a sé una ragnatela di pregiudizi storici, di vanaglorie nazionali, di alterati modi di vivere; e questa ragnatela può isolarli spiritualmente dal resto del mondo e far sì che diventino arcaici. Gli istinti nazionali ereditati dalle precedenti epoche storiche, anche quelli più profondamente primitivi, fino a ieri addormentati, cominciano a risvegliarsi” (Cvijić 1966). Sul ruolo che i miti nazionali dei popoli, che costituivano l’ex Jugoslavia, hanno avuto nel processo di disintegrazione di questo Paese e, dunque, sui miti usati o abusati nella lotta politica alla ricerca della legittimazione di ciò che è accaduto nell’ex Jugoslavia in questi ultimi anni si è soffermato anche il prof. Vatroslav Vekarić, analitico delle rela- 27 n.17 / 2007 zioni contemporanee; egli ha inteso il mito come qualcosa che, in parte, non corrisponde ai fatti storici scientificamente determinati, ma soprattutto come un elemento che ha ottenuto un ruolo importante nella propaganda degli obiettivi politici delle élite nazionalistiche e soprattutto nella propaganda bellica. In Serbia si può affermare che questa lingua dei miti etno-nazionalistici è stata, pressoché, l’unico elemento dell’ideologia nazionalistica miloseviciana. A prima vista si tratta di una lingua dove non esiste niente di politico e di ideologico, un qualcosa che appare naturale, accettabile e banale, qualcosa che sia incontestabile, come ciò che si dice sul mito del Kosovo o la tesi sulla Serbia che esiste là dove è possibile trovare le tombe dei serbi o, ancora, la fraseologia sui traditori, sugli scismi, sul Bizantino illustre e sull’Europa in putrefazione. “La rinascita di tutti questi miti proviene da una frustrazione profonda, che porta a riferirsi, nei confronti dell’Europa, come ad un Paese decadente, degenerato, antispirituale e malato” (Vekarić 1998, relazione all’Università degli Studi di Firenze). Superare l’identità jugoslava Il processo che condusse alla nascita della Jugoslavia, tra la fine dell’Ottocento e la Prima Guerra Mondiale, fu un tentativo politico - nato in base ad un modello importato, quello occidentale - di declinare la nazionalità in termini di cittadinanza piuttosto che in termini di appartenenza, compresa quella religiosa. Ancora oggi, gli storici e gli esperti non sono d’accordo sulle radici elementari del complesso dei problemi noti come: ‘la crisi jugoslava’. È alquanto diffusa l’opinione che, per via della disintegrazione della Jugoslavia, la guerra sia stata inevitabile e che, in genere, le guerre nei Balcani siano storicamente inevitabili, esistendo quasi un dovere di ripetersi ad intervalli più o meno fissi. Un’analisi più attenta, però, rivelerebbe uno scopo assai preciso in questa affermazione, cioè quello di sgravare di responsabilità tutti quei circoli politici, culturali ed intellettuali della ex Jugoslavia che hanno portato alla guerra. Per loro, ancora oggi, torna utile la tesi sulla ‘natura maledetta’ dei Balcani e dei loro abitanti; quanto accade oggi viene rappresentato come un inevitabile ripetersi della storia e viene 28 usato come ausilio a numerose analogie storiche. Il 4 maggio del 1980 è una data che ha segnato inesorabilmente le sorti della Jugoslavia, considerato che questa data, oltre ad essere il giorno della scomparsa di un capo di Stato, coinciderà con la ‘morte di una nazione’ e con la fine delle diversità e della convivenza dell’ideale jugoslavo che consisteva in un sistema in cui convivevano sei gruppi nazionali, oltre ad una miriade di gruppi etnici minori. Politicamente era uno Stato federale diviso in sei repubbliche e due province autonome, retto da un regime socialista, diverso però da tutti gli altri socialismi reali. Bisogna, infatti, prendere in considerazione l’importanza del fattore psicosociale della retorica fondativa dello Stato federale - la guerra di Liberazione, l’orgoglio di essere l’unica capitale liberata dalla guerriglia, che ha rivendicato la propria identità rispetto alla Russia staliniana - per comprendere che la formazione politica jugoslava non era quella degli altri Paesi dell’Europa dell’Est e che l’identità del popolo jugoslavo era qualcosa che non ha uguali, simili, antecedenti o seguenti. La necessità di legittimare i nuovi Stati nazionali sorti dalla dissoluzione della Jugoslavia ha comportato una revisione del passato molto più rapida e radicale che nel resto dell’Europa orientale. Ovunque c’è stato un ridimensionamento dell’esperienza di Tito; non una negazione, ma un ridimensionamento. Negare sarebbe stato difficile: Tito godeva di un ampio consenso e l’esperienza jugoslava era considerata fortemente positiva, e lo è tuttora; rimane, infatti, sostenuta dal luogo comune che ‘sotto Tito si viveva meglio’. Allora si cerca di mettere in luce gli elementi negativi: in Croazia si dice che Tito ha inibito per la Croazia la possibilità di assumere un’identità più forte, sostenendo la Serbia; in Serbia si dice, al contrario, che Tito ha danneggiato la Serbia istituendo le due regioni autonome del Kosovo e della Vojvodina e che la Serbia, indirizzata più di altre repubbliche verso la Jugoslavia, ha perso la sua natura di Stato omogeneo. Bojan Jovanović ha cercato di analizzare il ‘jugoslavismo’ quale una grande idea, un progetto di emancipazzione che ha assunto diversi significati e ha prodotto diversi fini nella storia dei popoli balcanici. Soltanto dopo la distruzione di questo progetto sono, infatti, stati scoperti alcuni dei suoi lati Ana Živković nascosti. Si è dimostrato che nell’ambito della Jugoslavia, gli sloveni e i croati accettavano il progetto dello Stato unitario in quanto lo ritenevano un fatto transitorio e temporaneo; al momento della realizzazione delle loro tendenze separatistiche hanno invece cominciato ad incolpare i serbi delle loro tendenze alla formazione della ‘Grande Serbia’, connotando negativamente la formazione federativa, quale un prodotto delle tendenze serbe. Al contrario, la Jugoslavia veniva vista dai serbi come la soluzione ideale della loro questione nazionale ed è perciò che essi hanno creduto e sostenuto la continuità di questo Stato (Jovanović 2002, intervista sul Dnevnik). Quando, infine, l’idea si è rivelata un’utopia, il ‘jugoslavismo’ diventò per i serbi la personificazione di un secolo inutilmente consumato, un’esperienza che, con maggiore saggiezza politica, poteva essere evitata, un periodo di energie disperse, che al contrario potevano essere utilizzate per la costruzione di uno Stato nazionale serbo. La disintegrazione dell’identità jugoslava si deve secondo la tesi meno semplicistica, diffusa dai media occidentali, all’unione forzata di tutti gli elementi che hanno manifestato le storiche divisioni etniche, religiose e culturali di cui si alimenta il nazionalismo; in realtà questa tesi non spiega perché questi retaggi storici non hanno impedito alla Jugoslavia di conseguire rilevanti risultati non solo in campo internazionale, ma anche in campo interno e in particolare nel miglioramento dei rapporti fra le varie comunità al suo interno. E non spiega, soprattutto, perché questi vecchi conflitti si siano riaccesi e siano diventati incontrollabili proprio a partire dalla metà degli anni Ottanta e poi negli anni Novanta, e cioè in relazione al processo di progressiva restaurazione del capitalismo in Jugoslavia, sotto la regia del Fondo Monetario Internazionale e sotto le pressioni delle diverse Potenze imperialiste. “Gli Stati Uniti e la Germania, pur avendo ciascuna dei propri interessi distinti nell’area balcanica, concordano sul fatto che la Serbia non deve essere la potenza dominante nei Balcani, sia perché temono la formazione di un nuovo punto d’appoggio della Russia sia per la necessità di demilitarizzare questo territorio, in modo da assicurarsi un retroterra certo nella soluzione dei problemi legati al Mediterraneo e al Vicino Oriente” (Nišić 2004, 302). La percezione Rassegna critica della letteratura serba che i serbi hanno del Fondo Monetario Internazionale è sintetizzata nella seguente affermazione: “La globalizzazione è un processo che cerca di influenzare tutti gli ambiti della vita quotidiana, dalla sfera delle idee e delle culture, a quella della politica, della scienza, dei media e dei crimini. L’aspetto politico della globalizzazione nel quale prevale il principio di sospensione della sovranità nazionale come una scusa per poter imporre una serie di principi ideologici universali ha anche il suo lato economico. Così si cerca di imporre nel nome degli ideali di un ‘mercato libero’, tramite le instituzioni del FMI e della Banca Mondiale, delle soluzioni che mirano ad un controllo completo del mercato nazionale da parte delle multinazionali straniere” (Korać 1987, 21). Vesna Pešić ha cercato di dare, mediante una ricerca, la risposta alla questione del problema della politica nazionale serba nella formazione dello Stato nazionale, partendo dal fatto che, negli ultimi anni, quando sul territorio della ex Jugoslavia si sono formati degli Stati, la nazione serba non è ancora riuscita ad entrare in equilibrio per il problema dei propri confini e nei confronti dei propri cittadini. La causa principale di questa mancata formazione si trova nell’oscillazione storica della politica nazionale serba tra l’ideologia che sostenne la formazione del proprio Stato nazionale - Serbia - e quella che promosse l’unificazione etnica della diaspora serba, comportando l’abbandono dell’idea di una statalità serba e l’accettazione di uno Stato multinazionale, quale era la Jugoslavia. Questo ha causato nella sua storia una forte oscillazione tra le due identità: spesso si verificava l’insabbiamento dell’identità nazionale serba e la sua dissoluzione in quella jugoslava. Inoltre, assumendo il ruolo del ‘garante’ dello Stato unitario, i serbi hanno dimenticato di considerare la Serbia come il loro vero Paese, come facevano, invece, gli altri membri della Federazione jugoslava. I serbi vivevano nella Jugoslavia e non nella Serbia e perciò la stessa repubblica di Serbia non sentiva il bisogno di mantenere con i serbi che vivevano al di fuori dei sui confini dei particolari legami culturali. Indipendentemente da questo, rimane certo che l’identità nazionale serba rimase divisa tra l’idea etnica serba, di origini religiose, e l’idea borghese jugoslava, basata sull’ateismo (I problemi della costituzione degli Sta ti nell’a rea della ex 29 n.17 / 2007 Jugosla via : riduzionismo etnico nella politica na ziona le serba ). Questa duplice visione dell’identità viene ripresa nello studio di Jelena Ðurić che ha interpretato la crisi dell’identità serba quale una conseguenza di una continua divergenza tra l’ideologia e la realtà, messa in evidenza solo dopo la dissoluzione dello Stato unitario, quando furono smascherati i falsi valori che per così lungo furono imposti al popolo nella forma di compensazione di fronte alla mancanza di una reale identità della società. Da una parte l’ideologia della fratellanza e dell’unità tra i popoli jugoslavi ha precluso la possibilità di dominazione di un singolo gruppo etnico, ma dall’altra non ha permesso alla società serba di sviluppare delle istituzioni di cui fidarsi e nei confronti delle quali costruire la propria identità collettiva. È solo durante il processo di dissoluzione della Jugoslavia che queste identità nascoste cominciarono finalmente ad unirsi nel risentimento, nell’isteria collettiva, nella rabbia e nell’umiliazione (Il ca mbia mento dei va lori e della società in conseguenza della tra sforma zione della società jugosla va ) Dal punto di vista dell’eredità storica, erano tre i principali temi cui gli intellettuali serbi avevano dato voce, in particolare: 1) l’interesse per l’unità nazionale serba e i confini di una possibile entità autonoma serba; 2) l’autocoscienza dei serbi come popolo impegnato nell’edificazione di uno Stato; 3) i sacrifici dei serbi per il comune Stato jugoslavo e la loro particolare vocazione storica per la creazione e il mantenimento di questo Stato. In altre parole, le opinioni della élite culturale erano ben radicate nella tradizione e possono essere considerate rappresentative del pensiero nazionalista serbo. Fu così per gli storici Vladimir Čorović, Slobodan Jovanović, Dragoslav Stranjaković e Vaso Čubrilović, i quali svilupparono l’idea che lo Stato jugoslavo fosse la migliore garanzia dell’unità nazionale serba e che, senza di esso, i serbi avrebbero dovuto avere il diritto all’autodeterminazione collettiva alla pari delle altre nazioni in tutti i distretti in cui rappresentavano una maggioranza. La Prof.ssa Jelena Ðorđević ha contribuito alla spiegazione di quella che viene definita la ‘discontinuità’ d’identità del popolo serbo. Quando si cerca di analizzare la vita quotidiana del popolo, è chiaro che l’immagine che si ha dei serbi è tutt’altro che omogenea. Al contrario, quando si considera la 30 loro identità nazionale, i serbi risultano radicalmente differenti tra di loro su tutti i livelli. Si parla, infatti, di una divisione dello Stato in due Serbie: la prima moderna, cosciente e urbanizzata e la seconda arcaica, nazionalistica e quasi tribale; tale scomposizione non è altro che una continuazione delle suddivisioni formatesi nel periodo comunista. La prevalenza del discorso partigiano dai tempi del socialismo venne bloccata e i membri della società che la sostenevano sentirono il bisogno di abbandonare il proprio passato, alcuni di propria iniziativa, altri per l’opportunità del momento politico, cercando di dimostrare a sé stessi e agli altri di non appartenere più a quell’ideologia, ma di voler ritornare piuttosto alle radici della tradizione del popolo serbo. Un secondo aspetto di questo meccanismo si lega alla negazione della propria identità da parte di coloro che si sentirono umiliati per tutti gli avvenimenti che seguirono alla dissoluzione della Jugoslavia. Costoro decisero di emigrare all’Occidente, conservando l’identità jugoslava, trasformandola col tempo a causa dell’influenza dei valori occidentali ed eventualmente perdendola, senza mai sviluppare la nuova identità serba. Il terzo fattore è, infine, rappresentato da numerosi rifugiati dalla Bosnia ed Erzegovina, dalla Krajina, dalla Slavonija e dal Kosovo e Metohija, che contribuirono alla differenziazione ancora maggiore nell’ambito di quella che poteva essere definita la ‘nuova identità’. L’incontro/scontro con le persone della stessa origine etnica e della stessa confessione religiosa, quindi identici a coloro che vivono nella madre patria e per i quali si andava a combattere, ha risvegliato nei serbi il bisogno di rinnovare il rapporto con ‘gli altri’, che da una parte diventarono i fratelli serbi, dall’altra distrussero, mediante l’introduzione di nuovi moduli culturali, la già fragile identità etnica e nazionale. I rifugiati furono considerati i colpevoli delle guerre e nelle città furono percepiti come l’elemento rurale, cosicché anche quella parte dei serbi che precedentemente si dimostrava tollerante e accettava il multiculturismo, ha cominciato a sviluppare il cosiddetto ‘ethos urbano’ (Vittima o preda - a na lisi dell’identità serba ). Nella ex Jugoslavia, ora che le querre sono finite, che l’odio etnico si va sospendendo, che la situazione territoriale è temporaneamente stabilizzata, quando neppure la Serbia e il Montenegro costi- Ana Živković tuiscono più la Jugoslavia, è giunto il momento del ricordo e la stessa Jugoslavia non viene più percepita come entità politica minacciosa perché spogliata dalle sue valenze negative e diventata il contenitore di ricordi e di immagini di un passato felice. Di ‘jugonostalgia’ soffrono un po’ tutti, tra cui anche molti di quelli appartenenti alle ultime generazioni di questa nazione che, malgrado le divisioni, sentono di essere un prodotto di quel mondo. L’identità serba di oggi Le seguenti riflessioni si concentrano sulla storia più moderna, precisamente sulla fase di creazione dello Stato nazionale serbo di oggi, quando, proprio in nome dell’unità nazionale, si cerca nell’identità comune uno strumento della legittimazione politica. La domanda cruciale che fu posta da Vladimir N. Cvetković è se uno Stato con la composizione etnica quale quella della Serbia possa avere un’autentica identità nazionale, o con altre parole se possa considerarsi leggittima la formazione di uno Stato nazionale quando quasi un terzo della popolazione sia rappresentato da cittadini di diverse origini etnico-nazionali. Per rispondere a questa domanda si usano solitamente due diverse tesi tra loro alternative. Secondo la prima tesi, la forte differenziazione nella composizione etnica del Paese, nella quale possono evidenziarsi 20 diversi gruppi etnici, dovrebbe comportare la nascita di uno Stato borghese di cittadini, senza alcuna determinazione nazionale. La Serbia sarebbe, quindi, solo una denominazione vuota e casuale, con la quale si indicherebbe una determinata area geografica, nella quale l’insieme delle singole identità etniche viene indicato con un nome ‘transnazionale’ - ieri Jugoslavia, domani Balcania o Euroslavia -. Secondo l’altra tesi, la Serbia sarebbe, invece, uno Stato multietnico, come, del resto, la maggioranza dei Paesi europei; tuttavia, trovandosi nella situazione di dover ancora trovare ed affermare la propria identità etnica, non può considerarsi pronta ad un immediato riconoscimento di quella degli altri e perciò rischia di essere vista come non tollerante e fortemente nazionalista (Serbia moderna : la ricerca dell’identità ). Vale, inoltre, la pena di precisare che la Repubblica della Serbia si defini- Rassegna critica della letteratura serba sce, nell’art.1 della sua Costituzione, come: “Stato democratico di tutti i cittadini che vivono in esso” senza quindi fare alcun riferimento all’identità etnica. Di fatto la Serbia è lo Stato più multietnico dei Balcani; un terzo dei suoi abitanti è non-serbo ma con eguali diritti. Almeno formalmente, l’etnia albanese del Kosovo e Metohija ha più diritti di cittadinanza in Serbia di quanto ne abbiano i rifugiati serbi che sono fuggiti dalla Croazia e dalla Bosnia ed Erzegovina dopo il collasso della Jugoslavia. Il post-comunismo nella ex Jugoslavia non si è rivelato un’occasione di democratizzazione in cui le istituzioni possano finalmente riflettere la complessità e il pluralismo sociale. Al contrario, i nazionalisti hanno operato affinché fosse lo Stato a definire l’identità della sua popolazione, e l’etnicità, invece della cittadinanza, è diventata il garante dell’unità politica dello Stato. Nel caso della Serbia della fine degli anni Ottanta e degli anni Novanta, i protagonisti della vita politica scelsero di enfatizzare a seconda del singolo momento politico l’eroica eredità della rivoluzione partigiana, l’eredità monarchico-cetnica o la tradizione liberal-parlamentare. Pertanto si verificò una forte svolta verso il modello tradizonalista e il nazionalismo, come il nuovo punto d’appoggio di leggittimità del gruppo dominante, diventò l’orientazione prevalente di valori nella società. I libri di Ivan Ćolović e Jasna Dragović-Soso cercano di analizzare la proliferazione del pensiero nazionalistico serbo dopo la morte di Tito nel 1980. Secondo Ćolović la difficoltà principale risiede nell’incompatibilità del ‘mito nazionale serbo’ con la democrazia. Ćolović, che non si presenta come un gran ammiratore del nazionalismo, propone la seguente sintesi del mito nazionale serbo: “Il popolo serbo è uno fra i popoli più antichi del mondo e tutte le lingue derivano dalla lingua serba. I serbi risultano oggi fra i pochi ad aver mantenuto dei valori più preziosi e importanti della civiltà, i valori dello spirito e del cuore; sono un popolo orgoglioso, che vuole costruire il Paese su una terra sana e naturale; un Paese, in cui potranno vivere finalmente tutti insieme su un’unica terra serba, in cui saranno un popolo unico ed uno Stato unico, dove si parlerà un’unica lingua e dove predominerà un unico pensiero” (Čolović 2002, 79). L’autore dunque dimostra l’immagine distorta che il popolo serbo ha avuto di sé stesso a causa 31 n.17 / 2007 del rinnovamento di questo mito, che “non gli permise di distinguere più tra il bene e il male e lo condusse inevitabilmente al nazionalismo” (Čolović 2002, 92). Anche il libro Sa lva tori della na zione, basato sulla tesi di laurea di Jasna Dragović-Soso, presenta la formazione storica di ravvivamento dell’ideologia nazionale serba nella cornice della cosiddetta ‘intelligenza critica di Belgrado’ a partire dagli anni Cinquanta fino al momento dello scoppio della guerra sul territorio dello Stato di Serbia e cerca di spiegare “perché le preoccupazioni nazionalistiche misero in secondo piano tutti gli altri aspetti del progetto politico dell’opposizione intellettuale serba, in modo da portarla ad abbandonare i principi umanistici, che furono inizialmente al centro del suo attivismo politico” (Dragović-Soso 2002, 2). Secondo Dragović-Soso esistono due fattori che hanno premesso in Serbia la prevalenza della ragione nazionalista rispetto a quella democratica. Il primo è la rinascita dei nazionalismi paralleli negli altri Stati della ex Jugoslavia, confermante la tesi, secondo la quale i nazionalismi croato, sloveno, serbo ed albanese ebbero modo di allimentare e rafforzare l’un l’altro; “i nazionalismi non si sviluppano in isolamento, ma influenzano l’un l’altro provocando una spirale di radicalizzazione” (Dragović-Soso 2002, 257); il secondo fattore è, secondo l’autrice, la natura del regime comunista di Tito, il quale fu, “nonostante i suoi ‘abbellimenti occidentali’ ed una tolleranza maggiore nei confronti della diversità del pensiero, un regime non liberale, nel quale la violazione dei diritti del cittadino e dell’uomo fu quasi endemica” (DragovićSoso 2002, 256). Di conseguenza si può affermare che la questione della nazionalità serba rimane tuttora irrisolta, perché “non fu inventata nè dagli intelettuali nè da Milošević, ma rappresenta l’eredità strutturale dello sviluppo storico e delle divisioni interne della Jugoslavia, che fu compiuta dai comunisti jugoslavi alla fine della Seconda Guerra Mondiale” (Dragović-Soso 2002, 256). L’identità nazionale moderna del popolo serbo rivela, dunque, la necessità di trovare una soluzione alle crisi esistenziali, che appartengono ad un periodo in cui viene chiuso il ciclo della storia serba del XX secolo, segnata dai drammatici conflitti nazionali ed ideologici, i quali hanno distrutto le utopie ideologiche di un’epoca, sostituendole 32 con una continua ricerca sull’ethnos serbo antico, in modo da dare al popolo il senso di un ritorno al passato. Il ricercatore che desidera studiare ed analizzare in modo imparziale i cambiamenti politici, economici, sociali e culturali che si verificarono in Serbia alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo, deve essere pronto ad un continuo confrontarsi con le contraddizioni. Ed è proprio attraverso le contraddizioni, che Mladen Lazić ha cercato di descrivere la Serbia. “Si tratta di uno Stato nazionale che in trent’anni, durante le due guerre regionali e due guerre mondiali, ha subito un’immensa perdita di vite umane ed altrettanti danni materiali, per poi essere presentato, alla fine di tale processo storico, in modo quasi unanime, come uno Stato aggressore e delittuoso; uno Stato, la cui popolazione sosteneva le guerre civili dell’ultimo decennio, ma in mezzo alla quale esisteva contemporaneamente una continua, pubblica e massiccia opposizione alle guerre; è l’unico Stato nel quale, alle prime elezioni post-socialiste multi-partitiche, vinse un candidato comunista, che teneva nelle proprie mani tutti gli elementi necessari per l’introduzione di un governo autocratico, ma che non è mai riuscito a placare le opposizioni politiche e culturali della società. Si tratta, infine, di un Paese nel quale si scontrano il cosmopolitismo urbano e l’autismo tradizionale del mondo contadino” (Lazić 2005, 5-6). Il fatto di concepire la dominazione ottomana come una storia recente permette di spiegare l’amore immenso verso le caratteristiche della cultura orientale, ma aiuta anche a far capire la tendenza dei giovani del Paese verso la cultura dell’Occidente, tendenza sviluppatasi per il senso di disgusto che molti provano verso tutto quello che appartiene al passato. L’insieme di queste contraddizioni seguono, secondo l’autore, la relazione Occidente–Oriente; tradizionale–moderno, progressista–regressista, una carattersistica costante dei Paesi, quale la Serbia, che si è trovata situata, fino alla fine del secolo scorso, in un’area di confine. Alla fine degli anni Ottanta e in particolare durante gli anni Novanta, si sviluppò in Serbia il dibattito riguardante la fondazione storica e culturale della nazione e dello Stato nazionale. Lazić considera il crollo del socialismo, al contrario degli altri autori, come un cambiamento della società verso il modello democratico e di mercato, il che Ana Živković significava un automatico avvicinamento verso l’Occidente europeo. In tale contesto di aspettative, si ottenne presto anche il consensus di classificare Serbia quale uno Stato europeo, con il crescente bisogno di costruire un forte orientamento europeo della nazione dal punto di vista politico, economico e culturale. Dall’altra parte, le guerre civili sul territorio dell’allora esistente Federazione jugoslava, durante le quali la Serbia entrava in contrasti sempre più forti con le politiche dei Paesi occidentali, hanno comportato il rafforzamento dell’orientazione isolazionistica che gradualmente rese maggiormente vigoroso il regime di Slobodan Milošević (Ca mbia menti e resistenza ). Quindi il problema principale rimase, ancora una volta, quello della forte dipendenza dell’identità nazionale rispetto al processo politico. Lazić sostiene però che tale dipendenza deve essere precisata quando si passa ad analizzare il periodo del regime di Slobodan Milošević. “Identificando un periodo con un uomo politico, si crea la tendenza di interpretare e di spiegare sia l’insieme sia i singoli settori dei processi sociali esclusivamente in base alla realtà politica, nella quale Milošević rappresenta, non solo la figura politica reale del Paese, ma diventa l’emblema dell’intera nazione” (Lazić 2005, 24). Neanche gli avvenimenti del 5 ottobre del 2000 sono riusciti a cambiare questo modo di pensare e di identificarsi. Sono rimasti in vita gli stessi discorsi antagonistici, che dipendono dai rapporti di potere e secondo i quali le singole identità si relazionano all’autorità statale, ai valori dell’Occidente e ai gruppi alternativi di opposizione, formati dagli intellettuali e dalle ONG. Oggi sono, infatti, la globalizzazione, la transizione e il multiculturismo le realtà nei confronti delle quali l’identità serba si deve porre pro o contro. Il giornalista serbo Petar Luković ha descritto il proprio popolo dopo la caduta di Milošević come segue: “Armato di una grande dose di fatica, d’insonnia e di depressione, nel quale ho trovato un insieme di abbrutimento e di confusione, come un prigioniero liberato dopo 13 anni di prigione, è difficile spiegare il sentimento collettivo dominante davanti alla Serbia senza Milošević; tutto quello che era bianco è diventato nero e tutti hanno preso posizione contro il leader. Milioni di persone hanno cambiato divisa in 24 ore, cancellando il Rassegna critica della letteratura serba passato in un’amnesia ipnotica, come se non fosse mai esistito” (Luković 2000, Forum javnosti n.787). Il monopolio nel decidere il destino storico e politico dei Paesi più piccoli che, secondo il popolo serbo, risiede nell’Occidente ha incrementato in modo notevole la diffidenza nei confronti dei moduli culturali e politici provenienti dai Paesi occidentali. Si sviluppò un atteggiamento prudente e sospettoso nei confronti del multiculturismo, visto come una fonte di distruzione dello Stato. Secondo tale logica e soprattutto dopo la crisi del Kosovo e Metohija, l’insistenza sulle particolarità etniche e sui diritti particolari delle minoranze si percepisce in Serbia come un minaccia alla sovranità ed all’integrità territoriale, nonché come un elemento di supporto ai diversi processi di seccessione. Inoltre, è proprio grazie a questa diffidenza che si forma l’aggressiva difesa di tutto quello che sia serbo e nasce la paura, non solo di non poter ritrovare la propria identità, ma anche di vedere tale identità definita da parte del mondo occidentale secondo moduli estranei alle proprie tradizioni. Esiste, al contrario, l’autore Jovan I. Deretić, che nell’analisi dell’identità nazionale dei serbi, insiste sull’importanza del rispetto e del confronto con le identità degli altri. Egli, infatti, afferma che la paura di perdere l’identità e il bisogno dei serbi di rafforzare la coscienza nazionale, per rendere maggiormente vigorosa l’unione spirituale, non deve essere considerato come una conseguenza del nazionalismo esasperato e mistico o del odio verso il mondo esterno, ma una forte necessità di sviluppare il senso di appartenenza alla nazione; e tale tipo di necessità si mette in evidenza ogniqualvolta il popolo si trova in una situazione di crisi. “Non possiamo essere parte della cultura europea finché trascuriamo la nostra cultura” (Deretić 2005, 27); e il “difetto nazionale più grande dei serbi rimane quello di non rispettare abbastanza sé stessi. Più diventano grandi i problemi causati dai fattori esterni, più diminuiscono i sentimenti di stima e reverenza fra i singoli membri, invece di essere al contrario” (Deretić 2005, 31-32 ). Seguendo quest’indagine si può sostenere che l’identità del popolo viene definita anche in relazione all’immagine che di esso si ha nel mondo occidentale. Si sostiene, infatti, che i serbi hanno un’immagine cattiva nei media americani e in quelli occidentali in generale; la spiegazione si basa sul- 33 n.17 / 2007 l’insistenza con cui essi si sono rifiutati di sottomettersi a questa unica volontà; perché hanno rifiutato di mettersi in funzione di questo interesse unico; perché hanno un forte senso di libertà, di indipendenza statale, di dignità nazionale. La ‘cattiva immagine’ del popolo serbo nei media occidentali, e soprattutto nei media americani, potrebbe essere considerata, oltre che una conseguenza della propaganda durante e dopo la guerra, anche una rappresaglia per questo modo di essere del popolo serbo. Tuttavia, quest’immagine è dovuta anche all’assenza di qualsiasi tentativo serio da parte serba di renderla meno brutta e migliore. I serbi, in modo ingenuo, troppo ingenuo, erano convinti che la verità sarebbe venuta fuori da sola e che alla fine la giustizia poteva prevalere. Sono un popolo irrazionale in modo quasi infantile, un po’ utopistico e abbastanza romantico (Notte e giorno – Dia rio). Un’immagine curiosa del popolo serbo si trova nelle pagine del diario di guerra della drammaturga serba, Biljana Srbljanović, da sempre molto critica con il regime. Le pagine sono state pubblicate sul quotidiano la Repubblica dove si legge: “Come riconoscere i serbi all’estero? Ci sono due modi. Se vedete un gruppo di persone che parlano tanto a bassa voce che neanche possono sentirsi, e che sono costretti a leggere le parole gli uni sulle labbra degli altri, allora c’è grande probabilità che siano serbi. La gente messa in condizione di dover nascondere la propria origine, la propria identità nazionale, la gente che si vergogna per quello che il loro Paese sta facendo in suo nome: sono queste le caratteristiche dei ‘nostri’ all’estero. Allo stesso modo, se sentite un gruppo urlare canzoni nazionaliste ed espressioni di sostegno al regime serbo che risuonano nelle strade, se per caso vedete la gente in corteo che urla slogan in onore della gloria serba, con gli errori di grammatica obbligatori, non abbiate dubbi: anche quelli sono serbi. Il primo gruppo si distingue perché ogni volta che sente un rumore più forte ha un sussulto, sobbalza ad ogni decollo degli aerei civili, e a ogni ‘scoppio’ di tubo di scappamento si copre la testa con le mani. Sono serbi appena arrivati all’estero, alcuni solo di passaggio, come me, e si portano dietro le conseguenze dei giorni passati sotto le bombe, e dalle quali non si possono liberare tanto facilmente. Gli altri, che si sono invece sistemati qui da 34 tanto tempo, hanno leggermente dimenticato la loro lingua materna, contaminandola con parole straniere. Credono di ‘serbizzare’ l’Occidente, senza accorgersi che si stanno invece allontanando dalle proprie origini. A dividere queste due Serbie all’estero è la stessa cosa che le divideva a casa: una terribile spaccatura dei cittadini di uno stesso Paese in due gruppi irriconciliabili. I primi, quelli ‘tranquilli’ sono al limite della sopportazione della guerra, delle insegne nazionaliste, della povertà economica e umana. Gli altri, anche se sembrano ancora affamati di nuove battaglie, che bramano ardentemente di perdere, come la famosa antica battaglia del Kosovo, non hanno un vero interesse per la morte e la miseria, perché hanno già deciso di abitare qui. Il normale istinto umano di fuggire il pericolo, ha portato quelli che urlano qui, nel mondo occidentale. E qui nella comodità dei loro appartamenti, della previdenza sociale e dei conti in banca, parlano nel nome di quelli come noi che soffrono le vere conseguenze della guerra. E urlano: ‘Chi può dire, Chi può mentire, che la Serbia è piccola? Non è piccola, Non è piccola, Perché ha combattuto per tre volte...!’. Questa canzone che cantano, non è solo brutta ma è anche falsa: la Serbia, purtroppo, è piccola, più piccola che mai, e ha guerreggiato più di tre volte. Già quattro, solo nell’ultimo decennio. Nonostante, possa sembrare che queste due categorie di persone siano diverse, irriconciliabili, quasi in guerra tra di loro, c’è tra loro un forte legame. È quella stessa sensazione di essere derubati della vita, usurpati della gioventù e di aver perduto per sempre il tempo in cui potevamo dedicarci a costruire il nostro Paese al quale rimaniamo tutti, nonostante le differenze, molto legati” (La Serbia che urla e quella che pensa ). Riferimenti bibliografici a) Kosovo e Metohija Bataković D (1992), The Kosovo chronicles (tr.it. La cronologia del Kosovo), Belgrado, Plato; Bataković D (1998), Ka ntoniza cija Kosova i Metohije (tr.it. La cantonizzazione del Kosovo e Metohija), Sloboda, Organ Srpske narodne odbrane u Americi, Chicago, n. 1737, pp. 1-2; Bogdanović D (1985), Knjiga o Kosovu (tr.it. Il libro sul Kosovo), Belgrado, SANU; Bulatović Lj (1999), Kosovo ne da m te za bora vu Ana Živković (tr.it. Kosovo, non ti lascio alla dimenticanza), Belgrado, Interpress; Ćosić D (1992), Promene. Izbor tekstova Milora d Vučelić (tr.it. Cambiamenti. Raccolta di testi di Milorad Vučelić), Novi Sad, Dnevnik; Ćosić D (2004), Kosovo, Belgrado, Novosti; Despić A (1996), Dva moguća puta – govor na godišnjoj skupštini SANU (tr.it. Due strade possibili – discorso alla riunione annuale del SANU), Naša Borba, Vol.II, p. 12., Belgrado; Jakšić B (1999), Kosovski iza zovi (tr.it. Le sfide del Kosovo) in Filozofija i Društvo, XV, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Belgrado; Jovanović V (2005), Kosovo i Metohija pred reša va njem sta tusa (tr.it. Kosovo e Metohija davanti alla soluzione del suo status ), Časopis udruženja dramskih pisaca Srbije, drama 11, Belgrado; Kalajić D (1999), Serbia , trincea d’Europa , Parma, All’insegna del Veltro; Kalić J (1989), Srbija i Za pa dni svet 1389-1459. Zbornik Kosovska bitka 1389. godine i njene posledice (tr.it. Serbia e il mondo occidentale 1389-1459), Međunarodni simpozijum Himelstir 1989, pp.49-56, Belgrado; Krstić B (1994), Kosovo između istorijskog i etničkog pra va (tr.it. Kosovo tra il diritto storico ed etnico), Institut za urbanizam, Belgrado; Krstić B (2000), Kosovo pred sudom istorije (tr.it. Kosovo davanti al tribunale della storia), Belgrado, autor; Lopusina M (2000), OVK protiv Jugosla vije (tr.it. OVK contro Jugoslavia), Čačak, Legenda; Medaković D (1989), Kosovski mit – kosovska ideologija (tr.it. Il mito del Kosovo – l’ideologia del Kosovo) e Kosovo je trnova kruna u stra da nju jugoslovenskog na roda (tr.it. Kosovo e la strage del popolo jugoslavo) in Oči u oči, Belgrado, BIGZ; Mihajlović K., Krestić V (a cura di) (1995), Memora ndum SANU - odgovori na kritike (tr.it. Memorandum SANU – Risposte alle critiche), Belgrado, SANU; Milosavljević O (1995), Zloupotreba a utoriteta na uke (tr.it. L’abuso dell’autorità intelletuale), Republika, 119-120, Belgrado; Mirković, T (2000), Na pa d na Jugosla viju ka o u uvod u ra tova nje novog veka (tr.it. Attacco alla Jugoslavia come l’introduzione nella guerra del nuovo secolo), in Novi glasnik: Herojska odbrana probudila svet, Belgrado; Rassegna critica della letteratura serba Nišić S (2004), Od Jugolsa vije do Srbije (tr.it. Dalla Jugoslavia alla Serbia), Belgrado, Knjiga Komerc; Popović Obradović O (2005), Cilj ili sredstvo srpske na ciona lne politike (tr.it. Fine o mezzo della politica nazionale serba) in Helsinška povelja - Glasilo Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji n. 79–80, pp. 6-8, Belgrado; Radovanović M (2005), Kosovo i Metohija u Republici Srbiji i na Za pa dnom Ba lka nu (tr.it. Kosovo e Metohija nella Repubblica di Serbia e nella penisola balcanica), Belgrado, Centar za očuvanje nasleđa Kosova i Metohije – MNEMOSYNE; Samardžić R (1990), Kosovsko opredeljenje. Istorijski ogled (tr.it. La destinazione del Kosovo. Saggio storico), Belgrado; Samardžić R (1991), Za ca rstvo nebesko. Zbornik Kosovska bitka 1389. godine i njene posledice (tr.it. Per il regno celeste), Međunarodni simpozijum Himelstir 1989, pp.9-15, Belgrado; Sekelj L (1995), Vreme bešča šća : ogledi o vla da vini na ciona lizma (tr.it. Il tempo senza dignità: saggio sul governo del nazionalismo), Beograd, Akademija nova i Institut za evropske studije. b) Religiosità Bandić D.(1992), O na rodnom pra vosla vlju da na s (tr.it. Sull’Ortodossia popolare di oggi) in Etnoantropološki problemi 9, Belgrado; Čajkanović V (1973), Mit i religija u Srba . Iza bra ne studije (tr.it. Il mito e la religione dei serbi. Raccolta di studi), Belgrado, SKZ; Čajkanović V (1994), Sa bra na dela iz srpske religije i mitologije (tr.it. Raccolta di studi sulla religione e mitologia serba), Belgrado, Partenon; Čupić Č (1997), Politika i zlo (tr.it. La politica e il male), Belgrado, Čigoja štampa; Deretić J. I (2005), Na ša pobeda : za sa da šnjost i budućnost Srbije (tr.it. La nostra vittoria – per il presente e il futuro della Serbia ), pp.55-58, Belgrado, Sopot, Kona; Džomić V (2004), Stra da nje Srbske Crkve od komunista (tr.it. La strage della Chiesa serba nel periodo comunista), Belgrado, Svetigora; Ðorđević M (2003), Srpska konzerva tivna misa o (tr.it. Pensiero conservativo serbo), Helsinški odbor za ljudska prava; Grzetić N (2002), O veri sta rih slovena (tr.it. La fede degli antichi slavi), Belgrado, Pešić i sinovi; Jerotić V (1995), Vera i na cija (tr.it. Fede e nazio- 35 n.17 / 2007 ne), Belgrado, Tersit; Lužnik S (2000), Muk hrišća nske Evrope (tr.it, Il silenzio dell’Europa cristiana), in Vojska 28. septembar 2000; Marjanović Č (2001), Istorija srpske crkve (tr.it. Storia della Chiesa serba), Belgrado, Ars Libri; Marković S. G (2005), Klerika liza m u Srbiji: mit ili stva rnost? (tr.it. Clericalismo in Serbia: mito o realtà) in Nova srpska politička misaoAnalize br. 4, pp.15-28; Milaš N (1926), Pra vosla vno crkveno pra vo (tr.it. Il diritto canonico ortodosso), Belgrado, Impresum; Mirković M (1988), Srpska Pra vosla vna Crkva (tr.it. La Chiesa serbo-ortodossa), in Religija i društvo, Belgrado; Mirković M (2000), O pra vnom položa ju srpske crkve u na šoj prošlosti (tr.it. La condizione giuridica della Chiesa serba nel nostro passato), Belgrado, Dosije; Piper P (2000), Uvod u Sla vistiku (tr.it. Introduzione in slavistica), Belgrado, Janus; Popović M (1998), Vidovda n i ča sni krst (tr.it. Il giorno di San Vito e l’onorata croce), Belgrado, Biblioteka XX vek; Radulović M (2005), Odnosi drža ve i verskih za jednica u drugoj polovini 20.veka (tr.it. I rapporti tra lo Stato e le comunità religiose nella seconda metà del XX secolo) in Nova srpska politička misaoAnalize br. 4, pp. 5-14; Slijepčević Ð (1991), Istorija Srpske pra vosla vne crkve od pokršta va nja Srba do kra ja 18. veka (tr.it. Storia della Chiesa serbo-ortodossa dalla conversione al cristianesimo fino al XVIII secolo), Belgrado, BIGZ; Slijepčević Ð (1991), Istorija Srpske pra vosla vne crkve od početka 19. veka do kra ja Drugog svetskog ra ta (tr.it. Storia della Chiesa serbo-ortodossa dall’inizio del XIX secolo fino alla Seconda Guerra Mondiale), Belgrado, BIGZ; Slijepčević Ð (1991), Istorija Srpske pra vosla vne crkve za vreme Drugog svetskog ra ta i posle njega (tr.it. Storia della Chiesa serbo-ortodossa durante la Seconda Guerra Mondiale e nel secondo sopoguerra), Belgrado, BIGZ; Stojković B (1994), Sukob identiteta : Religijsko i na ciona lno ka o izvor i povod ra tnih konflika ta (tr.it. Il conflitto d’identità: il religioso e il nazionale quali fonti e motivi dei conflitti) in Religija-rat- 36 mir, Niš, Gradina; Terzić S (1998), Susret ili sukob civiliza cija na Ba lka nu (tr.it. L’incontro e lo scontro delle civilizzazioni nella penisola balcanica), Belgrado, Istorijski institut SANU; Tomanić M (2001), Srpska crkva u ra tu i ra tovi u njoj (tr.it. La Chiesa serba in guerra e le guerre in essa), Belgrado, Medijska knjižara Krug; c) Identità nazionale ed etnica: dal periodo precristiano a Tito Cvijić J (1966), Ba lka nsko poluostrovo (tr.it. Penisola balcanica), Belgrado, SANU; Čubrilović V (1958), Istorija političke misli u Srbiji XIX veka (tr.it. Storia del pensiero politico nella Serbia del XIX secolo), Belgrado, Narodna Knjiga; Dvorniković V (1939), Ka ra kterologija Jugoslovena (tr.it. Caratterologia dei jugoslavi), Belgrado, Prosveta; Jovanović S (1964), Jeda n prilog za prouča va nje srpskog na ciona lnog ka ra ktera (tr.it. Dispensa per lo studio del carattere nazionale serbo), Vidzor – Avala; Konstantinović R (1969), Filosofija pa la nke (tr.it. Filosofia del villaggio), Belgrado, Otkrovenje; d) Dopo la morte di Tito Antić Č (2005), Kra tka istorija Srbije (tr.it. Breve storia della Serbia), Belgrado, Stubovi kulture; Antonić S (2002), Za robljena zemlja . Srbija za vla de Sloboda na Miloševića (tr.it. Una terra imprigionata. La Serbia durante il governo di Slobodan Milošević), Belgrado, Otkrovenje; Bakić J (1999), Stereotipi o Srbima u ja vnostima pojedinih za pa dnih na cija (tr.it. Gli stereotipi sui serbi nell’opinione pubblica delle nazioni occidentali) in Nova srpska politička misao, Nr. 1-2, pp. 27-55, Belgrado; Bataković D.T, Protić M.St., Samardžić N., Fotić A (2000), Nova istorija srpskog na roda (tr.it. La nuova storia del popolo serbo), Belgrado, Naš Dom; Božić N (1996), Na cija i na ciona liza m (tr.it. La nazione e il nazionalismo), Belgrado, Prometej; Buha A., Mirović D (2004), Za pa d ili Rusija (tr.it. L’Occidente o Russia), Belgrado, IGAM; Cvetković V.N (1996), Sa mopoima nje i politicko projektova nje (tr.it. Autocomprensione e proget- Ana Živković tazione politica), pp. 76-80 in Zbornik Srbija i Evropa, Belgrado, Dom Kulture Studentski grad; Cvetković V.N (1997/I), Moderna Srbija : potra ga za identitetom (tr.it. Serbia moderna: la ricerca dell’identità), Belgrado, Sociološki pregled; Čalić M (2004), Socija lna istorija Srbije 1815-1941 (tr.it. Storia sociale della Serbia 1815-1941), Belgrado, Clio; Čolović I (1991), Jugosloveni ka o na rod kultura n na jeda n priroda n na čin (tr.it. Jugoslavi come un popolo di cultura in modo naturale) in Delo, 9-12, Belgrado, Nolit; Ćorović V (2005), Istorija Srba (tr.it. Storia dei serbi), Belgrado, Publikum Praktikum; Deretić J. I (2005), Na ša pobeda : za sa da šnjost i budućnost Srbije (tr.it. La nostra vittoria – per il presente e il futuro della Serbia), Belgrado, Sopot, Kona; Dimitrijević N (2001), Sluča j Jugosla vija . Socija liza m, na ciona liza m, posledice (tr.it. Caso Jugoslavia. Socialismo, nazionalismo, conseguenze), Belgrado, Samizdat B92; Dragović-Soso J (2004), Spa sioci na cije. Intelektua lna opozicija Srbije i oživlja va nje na ciona lizma (tr.it. Salvatori della nazione. L’opposizione intellettuale della Serbia e la rivitalizzazione del nazionalismo), Belgrado, Fabrika knjiga; Ðerić G.M (1997), Smisa o žrtve u tra diciona lnoj kulturi Srba . Antropološki ogled (tr.it. Il senso della vittima nella cultura tradizionale dei serbi. Studio antropologico), Novi Sad, Svetovi; Ðorđević J (2000), Žrtva ili plen - ra zmišlja nje o srpskom identitetu (tr.it. Vittima o preda – analisi dell’identità serba) in Junir: dve hiljada godina hrišćanstva na Balkanu, IX, Belgrado; Ðurić J, (1996), Promene vrednosti i društvene promene s osvrtom na promene jugoslovenskog društva (tr.it. Il cambiamento dei valori e della società in conseguenza della trasformazione della società jugoslava) in Filozofija i društvo, X-XI, Belgrado; Jakšić B (2000), Ba lka nski pa ra doksi: ogledi o ra spa du Jugosla vije (tr.it. Paradossi balcanici: analisi sulla dissoluzione della Jugoslavia), Belgrado, Beogradski krug; Jerotić V (2004), Srbija i Srbi: između iza zova i odgovora (tr.it. Serbia e serbi: tra sfide e risposte), Belgrado, Ars Libri, Neven - Zemun, Besjeda; Rassegna critica della letteratura serba Jovanović B (1992), Srbi u ključu na ciona lne ka ra kterologije (tr.it. Serbi nella chiave della caratterologia nazionale) in Zbornik karakterologija Srba, Belgrado, Naučna knjiga; Jovanović B (2002), Ka ra kter ka o Sudbina (Carattere come destino), Kraljevo, Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani – Kraljevo; Jović B (1995), Poslednji da ni SFRJ (tr.it. Gli ultimi giorni della SFRJ), Belgrado, Politika; Korać S (1987), MMF contra YU, Galaksija – Gennaio 1987; Lazić M (2000), Promene i otpori: Srbija u tra nsforma cijskim procesima (tr.it. Trasformazioni e resistenza: Serbia nei processi transformistici), Belgrado, Filip Višnjić; Marić J (1998), Ka kvi smo mi Srbi? Prilozi za ka ra kterologiju Srba (tr.it. Come siamo noi serbi? Dispense per la carratereologia dei serbi), Belgrado; Marković M (1995), Noć i da n (tr.it. Notte e giorno - Diario), Belgrado, BMG; Nišić S (2204), Od Jugosla vije do Srbije (tr.it. Dalla Jugoslavia alla Serbia), Belgrado, Knjiga Komerc; Novačić D (2002), SFRJ za pona vlja če – turistički vodič (tr.it. SFRJ per i ripetenti – guida turistica), Belgrado, samostačno izdanje; Pešić V (1996), Problemi konstituisa nja drža va na prostoru bivše bivše Jugosla vije: etnički redukcioniza m u srpskoj na ciona lnoj politici (tr.it. I problemi della costituzione degli Stati nell’area della ex Jugoslavia: riduzionismo etnico nella politica nazionale serba) in Filozofija i društvo, XXI, Belgrado; Petrović S (1999), Srpska mitologija (tr.it. Mitologia serba), Belgrado, Narodna knjiga – Alfa; Terzić S (2002), Na ciona lni identitet i suverenitet u jugoistočnoj Evropi (tr.it. L’identità nazionale e la sovranità nell’Europa sudorientale), Belgrado, Istorijski institut SANU; Vasić D (1990), Ka ra kter i menta litet jednog pokolenja (tr.it. Il carattere e la mentalità di una generazione), Belgrado, Prosveta; Vekarić V (1998), Miti storiogra fici a ntichi a ttivi nella dia lettica politica contempora nea , Relazione all’Università degli Studi di Firenze Seminario, Firenze; [email protected] 37 Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo: Dall’Albania all’Albania Focus: Kosovo Introduzione Il Kosovo è diventato sinonimo del disordine e della difficile convivenza, fattori questi che influenzano tutt’ora il suo sviluppo politico, sociale ed economico. Al Kosovo, oggi si chiede di superare questi limiti ereditati dal passato. Eppure dimenticare non è la soluzione giusta perché per voltare pagina serve una corretta riflessione sui fatti del passato, per non incorrere negli stessi errori. Solo guardando al passato possiamo rintracciare le ragioni di quello che è successo in quella regione dove la violenza ha riacceso uno sfrenato nazionalismo. E come disse Hannah Arendt “la violenza tra sforma il pa triottismo in na ziona lismo” (Arendt 1989, p. 316), e genera nuova violenza. Risultato di una visione del mondo basata sul criterio della superiorità e inferiorità della razza che rafforza l’etnocentrismo e determina un nuovo sistema sociale e politico dove l’altro viene percepito come nemico. Questo nazionalismo trae origine dall’espansione dei movimenti panslavisti che hanno avuto origine nell’Europa centro-orientale nel 1880 e che ponevano come obiettivo la conquista sul continente con la pretesa di avere lo stesso diritto degli altri popoli occidentali ad occupare altri territori. Caratteristiche di questo movimento erano il disprezzo alla limitatezza dello stato nazione e il richiamo ad un ampliata coscienza etnica. Questa ultima “si supponeva unisse tutte le popolazioni della stessa origine etnica indipendentemente dalla loro storia, lingua e luogo di residenza”. Inoltre questi movimenti avevano molte affinità con le concezioni razziali dove le idee sulla razza divennero la base ideologica che si trasformò in seguito in arma politica. Si espansero nella massa e “quel che li tenne uniti fu lo stato d’animo” costruito attorno ad un centro di potenza all’interno della madrepatria: la Russia. “I fra telli minori fuori da lla Russia – secondo la Arendt – forma va no un comodo pa ra vento di a utodetermina zione na ziona le ovvero la pia tta forma per un’ulteriore espa nsione” (Arendt 1989, p. 315). E così fu! Il nazionalismo tribale si espanse nei paesi slavi della penisola balcanica, ponendo lo stesso obbiettivo, espandersi alle spalle degli altri. Costituito da elementi inesistenti pseudomistici come l’invenzione di un passato glorioso che fa di loro il popolo eletto ha contribuito alla legittimazione della causa nazionalistica. Il mito della razza origina il razzismo facendo dividere tra razza superiore e inferiore dove i “superiori” devono compiere il loro destino di popolo eletto e gli “inferiori” devono essere eliminati per poter portare a termine questa missione divina. 38 Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo Il nazionalismo non si sviluppò allo stesso modo in tutti gli stati balcanici. Nei territori albanesi mancò l’elemento religioso servito agli altri Stati per creare quell’unità che diede la forza alla creazione di uno Stato indipendente. La religione non riuscì mai a radicarsi nella vita della popolazione albanese perché i suoi territori sono stati sempre un crocevia di imperi, culture e religioni. Questa alternanza di dominazioni straniere vide inizialmente i territori albanesi abbracciare la fede cristiana sotto l’impero romano. Con il Grande Scisma nei territori albanesi iniziano a convivere la chiesa d’oriente e quella d’occidente. Appartenere al cattolicesimo o all’ortodossia assumeva lo stesso valore per la popolazione. L’arrivo degli slavi ruppe l’armonia tra le due religioni imponendo la scelta dell’ortodossia. Trovandosi in mezzo al scontro tra le due chiese la popolazione non si schierò a nessuna delle religioni facendo si che la religione perdesse il carattere identificativo. L’impero che dominò più a lungo i territori albanesi fu l’impero ottomano che portò con sé una nuova religione l’Islam. L’Islam trovò un terreno “fertile” per espandersi, a causa dell’indebolimento delle chiese e a causa del rifiuto da parte del popolo albanese di aderire al processo di slavizzazione e grecizzazione degli albanesi che da tempo era in atto. Nei suoi cinquecento anni di dominio i turchi si dimostrarono tolleranti nei confronti della religione creando l’istituzione di millet che permetteva il mantenimento della propria identità religiosa, della propria storia e della propria lingua. Ed è stato questo processo a far sì che il popolo albanese non basasse la formazione del loro stato sull’elemento religioso. L’origine comune, la lingua e la storia furono gli elementi che unirono il popolo albanese e lo hanno condotto a volere l’indipendenza. Ed è da questa origine comune che si fa riferimento agli illiri. Molti autori Serbi, partendo dal presupposto che gli Illiri sono un mito e non un popolo realmente esistito, accusano gli studiosi albanesi che parlano degli Illiri di usare quessto mito per una “pretesa di territorio”. Il vero mito è, invece, quello della “serbità” del Kosovo ed è stato questo mito che, nel 1989, nel centenario dalla Battaglia del Kosovo venne riproposto da Miloscevic. Riaccendendo l’orgoglio nazionalista e il desiderio di riconquista della “terra santa” ovvero la memoria comune, tolse così al Kosovo ogni autonomia. La “riconquista” diventò l’elemento centrale del nazionalismo serbo. Promettendo un futuro utopico è riuscito ad avere il consenso del popolo. Rovesciò la verità, riscrivendo la storia che a sua volta spinse all’odio e alla violenza davanti agli occhi di tutto il mondo e nel secolo dei diritti umani. Per questo il Kosovo non deve dimenticare ma riflettere in modo corretto per quanto riguarda il passato. E come dice lo scrittore albanese Ismail Kadare: “Qua ndo i popoli dei Ba lca ni a rrivera nno a conoscere se stessi, qua ndo riuscira nno a scrolla rsi di dosso, come fa nno gli a lberi con le fogli secche, le fa vole con le qua li si sono a limenta ti, i miti inga nnevoli, le gonfia ture grottesche, il pia gnucola re pietoso, requisiti che odora no di muffa e odio, insomma qua ndo i Ba lca ni comincera nno a d a vvia re questo processo, a llora si può dire che l’epoca dell’ema ncipa zione è inizia ta a nche per loro”(Kadare 2004, p. 17). Gli Illiri: predecessori degli albanesi “Illiria”e “Illiri”: due nozioni che consapevolmente associamo agli albanesi. Questo non sempre per dimostrare le origini di questa popolazione, ma anche 39 n.17 / 2007 1 Il significato più vasto della nozione “Illiri” e del loro territorio è dimostrato dallo storico Appiano di Alesssandria il quale afferma: “i greci chiamavano illiri quelli che abitavano sopra la Macedonia e la Tracia, a partire dai Caoni e Thesproti, fin dove sorge il fiume Ister. Questa è la lunghezza del territorio, invece la larghezza va dai Macedoni, Traci e Paioni fino allo Ionio e fino alle alpi” (AA. VV. 2003). 40 per negare tale discendenza. È diventata ormai una consuetudine polemizzare su questo tema creando a volte dei dibattiti dai quali non riusciamo a uscirne fuori. Anche al di fuori del mondo accademico, molti hanno una loro tesi da esibire basata a volte su poca o cattiva informazione, altre volte queste vengono strumentalizzate per ragioni che, per il contesto del quale parliamo, variano. Come dice Raymond Detrez: “Nei Ba lca ni, l’uomo na sce storico” (Detrez 2004, p. 8). La questione dell’origine e della formazione dell’etnogenesi degli Illiri è stato al centro di molti studi archeologici che hanno prodotto una molteplicità di tesi. Due di queste sono le più discusse dai ricercatori: la prima considera gli Illiri come provenienti da fuori e insediatisi nella penisola balcanica e la seconda li valuta come una popolazione autoctona venutasi a formare nel tempo in questo territorio. Tuttavia, nessuna di esse mette in dubbio che gli Illiri fossero una delle popolazioni più numerose dell’Europa nell’epoca del Ferro e che il loro territorio coprisse tutta la parte sud-occidentale della penisola balcanica (Jr. Fine, V.A. John 1982, pp. 9-11). Gli archeologi albanesi rifiutano la prima tesi ritenendola contraddittoria, sia per quanto riguarda il paese di origine, sia il periodo del loro arrivo. Questo perché alcuni sostenitori di questa tesi associano la loro espansione con la nascita della cultura Ha llsta tt, una delle prime culture dell’età del Ferro, sviluppatasi tra l’850 e il 450 a.C. nell’Europa centrale e occidentale e nei Balcani. Altri invece, la collegano con la cultura dei Campi di Urne dell’età del Bronzo europeo il cui nome deriva dalle necropoli a cremazione, con tombe a fossa contenenti urne o vasi con le ceneri, ampiamente diffuse nel II millennio a.C. nell’Europa centrale e centro-occidentale. Sempre secondo quest’ultima tesi, verso la fine del secondo millennio a.C., gli Illiri parteciparono allo spostamento delle popolazioni che noi conosciamo come le invasioni doriche, che si stabilirono nel continente e nelle isole dell’Egeo. Entrambi i popoli invasori discesero dal nord (Europa centrale) agli inizi dell’epoca del Ferro e si stabilirono nella penisola balcanica. La seconda tesi è quella sostenuta dagli archeologi albanesi che considerano la cultura degli Illiri come un fenomeno sviluppatosi nel tempo durante un lungo processo storico iniziato verso la fine dell’epoca del Bronzo e che è proseguito nell’epoca del Ferro (Ceka, Korkuti 1998, pp. 61-66). Grazie alle numerose prove rinvenute nel territorio degli Illiri soprattutto con le scoperte archeologiche compiute nel territorio dell’Albania (necropoli di Koman) e della Bosnia Erzegovina (necropoli di Glasinac), dove come rito funerario veniva usata la tumulazione, possiamo affermare che questa civiltà abbia conosciuto uno sviluppo etnico ininterrotto. Le scoperte di tali necropoli hanno fatto crollare le tesi che collegano l’origine degli Illiri con le culture di Halstatt o con la cultura dei Campi di Urne. Inoltre, queste scoperte archeologiche confermano quale fosse il territorio abitato dagli Illiri come sostenuto dagli storici antichi quali Erodoto, vissuto nel secolo V a.C., secondo il quale “il nome Illiri comprendeva un territorio molto va sto, che a suo pa rere a rriva va a d est fino dove sorgeva il fiume Mora va ” 1.. Il territorio illirico comprendeva, quindi, tutta la parte occidentale della penisola balcanica, a partire dai fiumi Morava e Vardar ad est fino alle coste dell’Adriatico e dello Ionio ad ovest, dal fiume Sava al nord fino al golfo di Arta al sud (Ceka, Korkuti 1998, p. 62). Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo Figura 1: Il territorio degli Illiri 41 n.17 / 2007 2 Tra le tribù più antiche c’erano i Thesproti, i Caoni, i Molossi, gli Amanti, i Paruej, i Bylini, gli Antintani, i Taulanti, gli Ardiani, i Paioni, i Dardani, i Liburni, i Dalmati e gli Autariati. 3 Per cultura intendo “quel complesso di elementi che comprende conoscenze, credenze, arte, morale, leggi, usi e ogni altra capacità e usanze acquisite dall’uomo in quanto membro di una società” (Tylor 1985-88). 4 Nel secolo XIII, con Albania e Albanenses venivano nominati tutti i territori e le popolazioni a partire dai confini di Dioclea fino al golfo di Arta. I viaggiatori stranieri testimoniavano come in tutto questo territorio la popolazione avesse le stesse caratteristiche comuni etno-culturali. Anche le cronache serbe, quando descrivono l’espansione dello stato di Rascia verso il Kosovo e verso la Dioclea nel secolo XII, danno notizia di come i serbi avvessero trovato nei territori una popolazione che venisse chiamata gli Arbanasi, Arbanenses (AA.VV. 2003). 5 L’apostolo Paolo attorno al anno 57 scrisse: “Allora, da Gerusalemme e dintorni e fino all’Illiria ho svolto la missione della rinascita del Cristo, tentando di evangelizzare anche lì, dove non era conosciuto il nome del Cristo” (AA. VV. 2003). 42 Altre informazioni hanno dimostrato la presenza degli Illiri anche al di fuori del loro territorio storico. Vari gruppi, tra i quali i Messapi e i Iapigi si stabilirono nel sud della odierna Italia; invece, in Asia minore si spostò una parte della popolazione delle tribù della Dardania e della Paionia le quali vennero citate nell’epos Omerico come partecipanti accanto ai Troiani alla guerra contro i greci. Nei primi secoli dell’ultimo millennio a.C. le tribù illiriche si erano stanziate in modo stabile nella penisola balcanica2 e da allora ebbe inizio un processo di costruzione di un etnos comune che lo differenziava dalle culture3 degli altri popoli vicini. La cultura illirica si presentava come una cultura autoctona, espressione delle conquiste illiriche più importanti nel campo economico e sociale, del modo di vivere, della percezione del mondo che li circondava e del modo in cui rappresentavano in arte questa percezione del mondo. Sarà questa cultura comune con i suoi elementi linguistici e religiosi a dimostrare come l’evoluzione dell’etnos illirico abbia portato alla formazione della cultura albanese di oggi. Un momento cruciale a conferma di tutto ciò fu la scoperta nell’anno 1898 di una grande necropoli nelle vicinanze del castello di Dalmata nel villaggio Koman di Puka (città situata nella parte meridionale dell’Albania). Questa necropoli dimostrò per la prima volta come gli Illiri, abitanti di quel territorio, non furono mai sostituiti dall’arrivo di una nuova popolazione ma continuarono ad esistere sotto il nuovo nome di Alban, (Albanoi o Arben), dal nome della tribù illirica stanziata al centro dei territori illirici, dove già passava la famosa via Egnatia. Infatti, nel II secolo d.C., il geografo alessandrino Ptolemeo avvisava la presenza in questi territori della tribù con il nome Albanoi e del loro centro, Albanopolis4. Successivamente, furono ritrovate simili necropoli, circa 30, sparse principalmente nella parte settentrionale e centrale dell’Albania, in Montenegro, in Kosovo e nella Grecia settentrionale. La diffusione geografica, la tipologia, l’inventario e la cronologia comune di queste necropoli hanno spinto molti studiosi ad identificare in esse, l’antica cultura medievale albanese o la “Cultura di Koman” comparsa nei secoli VI-VIII. La “Cultura di Koman” testimonia l’esistenza della cultura di un popolo che nei secoli VI-VII visse in questa regione nella fase di passaggio tra le due epoche, da quella tarda antica a quella antica medioevale. Nelle tombe furono ritrovati: armamenti, attrezzi lavorativi e decorazioni raffiguranti elementi pagani illirici, i quali confermarono la presenza degli antichi abitanti di questi territori, gli Illiri. Oltre a questi elementi, nelle necropoli furono rinvenuti ulteriori elementi artistici e religiosi che si collegavano alla cultura antica di Bisanzio. La presenza degli elementi religiosi testimonia come i rappresentanti di questa cultura avessero aderito alla fede cristiana. Infatti, il territorio albanese è considerato dagli studiosi come una delle regioni del mediterraneo dove il cristianesimo penetrò sin dal I secolo – come religione illegale – ma la cui affermazione avvenne attraverso lotte contro una molteplicità di elementi pagani5, che diedero delle connotazioni specifiche alla religione del popolo albanese e fecero sì che non si generasse quel fanatismo religioso sviluppatosi in altri paesi che nei secoli avrebbe dato origine all’intolleranza religiosa. Gli albanesi credevano in Dio ma allo stesso tempo adoravano gli dei e temevano i demoni, le anime cattive, za na (elemento tipico illirico che è stato ereditato anche dagli albanesi). Questa eredità pagana diventò uno dei principali problemi della popolazione albanese perché ciò era considerato un’eresia da parte del clero quando il culto della religione cristiana iniziò a non essere più illegale. Il clero valutava la Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo cristianità albanese come popolare e non come dottrinale. Tuttora, in Albania, si trovano edifici come monasteri, battisteri e basiliche del secolo IV-VI e nei loro mosaici troviamo ancora elementi paleocristiani come fogli di piante a forma di cuore, la figura del pesce o della croce che identificano il Cristo. Elementi che dimostrano come il cristianesimo fosse presente in questi territori prima della sua formalizzazione. Il riconoscimento della religione cristiana avviene nei secoli successivi (V-VI) con l’ampliamento delle comunità cristiane, delle pratiche e degli edifici del culto. Durazzo e Nikopolis furono i centri lungo il mare da dove poi il cristianesimo si espanse nelle quattro province illiriche. La lingua è un altro elemento importante che dimostra la continua evoluzione dell’etnos illirico fino alla formazione della comunità degli odierni albanesi. Gli Illiri parlavano una lingua di origine indoeuropea che presentava alcune caratteristiche comuni con la lingua dei Traci. Anche se si crede che gli Illiri non abbiano mai avuto una lingua scritta, perché si usava come lingua ufficiale e commerciale la lingua greca e successivamente la lingua latina sotto il dominio dell’impero romano, la lingua illirica è rimasta viva nel tempo6. Lo dimostrano alcuni documenti, che ci offrono circa 1000 parole, scritte sia nell’alfabeto greco che in quello latino. Una ulteriore testimonianza è fornita dallo storico Polibio, il quale racconta delle conversazioni tra il re Gentius e i delegati macedoni, che venivano tradotte da interpreti che conoscevano la lingua illirica (AA. VV. 2003). Molti studiosi, archeologi, storici, antropologi e linguisti, hanno portato una serie di argomentazioni che riguardano la lingua illirica e l’origine della lingua albanese. Tra queste troviamo l’argomentazione del noto linguista Eqerem Cabej, il quale parte dal fatto che l’attuale popolo albanese vive oggi nel territorio dove anticamente vivevano le popolazioni illiriche. Le fonti storiche non ci dimostrano la presenza di migrazioni degli albanesi da altre regioni in quella attuale (cosa che dimostra come la popolazione che abita oggi questo territorio discenda da quella precedente e che la lingua parlata da questa popolazione fosse quella del popolo stanziato anticamente in quella regione). Inoltre, gli elementi linguistici delle tribù antiche come ad esempio nomi di paesi, tribù, persone, glosse ecc…, che sono stati identificati come illirici, trovano significato nella lingua albanese7. I toponimi antichi dei territori illirici comparati con quelli attuali - Drisht (Drivastum), Shar (Scardus), Shkodra (Scodra), Mati (Amatia) testimoniano che sono stati coniati secondo le regole fonetiche della lingua albanese, ovvero sono state trasmesse oralmente da popolazioni che hanno continuato a parlare la stessa lingua. Egli prosegue il suo discorso affermando che il legame con la lingua greca e latina mostra come la lingua albanese si sia sviluppata contemporaneamente a queste due. Oltre a ciò, altri studiosi spiegano la presenza di numerose parole latine e greche antiche nella lingua albanese, grazie alle relazioni strette create dai romani e gli antichi greci con i predecessori degli albanesi. Possiamo concludere affermando che la “Cultura di Koman”, sia nella sua eredità della tarda cultura illirica sia nei nuovi elementi del periodo antico medioevale bizantino, insieme ai segni chiari della fede cristiana, caratterizzò nel medioevo lo spazio nel quale vissero gli albanesi. Essa, assieme agli elementi linguistici oltre a svelare una continuità dell’etnos, distinse gli Arber dalle altre popolazioni vicine, antiche e nuove, greche e slave. 6 Un ramo della lingua illirica conosciuta è la lingua dei Messapi nel sud dell’Italia. Sono stati trovati più di 2000 documenti scritti con un particolare tipo di alfabeto, un miscuglio tra il dorico e alcune lettere particolari che servivano a produrre suoni tipici della loro lingua. 7 Altri studiosi aggiungono che non solo trovano significato tramite la lingua albanese ma continuano a essere usati nella odierna lingua albanese come per esempio: Dassios = Dash, Dida = Dede, Bardhylis = Bardhe ecc… 43 n.17 / 2007 Arrivano gli Slavi 8 Secondo Procopio di Cesarea, storico nella corte di Giustiniano: “solo nella sua terra d’origine, Dardania, lui ha ristrutturato 61 castelli e ne ha costruiti altri 8 dando a uno di questi castelli il suo nome, (Justiniana Prima)” (AA. VV. 2003). 9 L’odierna città di Spalato (Croazia) 44 I primi Slavi vivevano nelle zone paludose e boschive dell’odierna Polonia, Russia occidentale, Bielorussia e Ucraina. A partire dal 150 d.C. queste popolazioni cominciarono a espandersi verso nord assorbendo gran parte delle popolazioni che occupavano i territori finlandesi e baltici e poi verso ovest, dove si scontrarono con le popolazioni germaniche e celtiche. Mentre, nel VII secolo avevano già raggiunto, a sud, i mari Egeo e Adriatico, invadendo una parte dei territori Balcanici, facenti parte dell’impero bizantino, nato dalla scissione dell’impero romano che alla morte dell’imperatore Teodosio venne diviso in due parti, affidate allora ai suoi due figli, Arcadio, imperatore d’Oriente (395-408), e Onorio, imperatore d’Occidente, che governò dal 395 al 423 e che nel 402 trasferì la capitale a Ravenna. Il desiderio d’espansione dell’impero verso Oriente spinse i romani a dirigersi verso i Balcani. Desiderio che veniva ostacolato dalle tribù illiriche, che vantavano una potenza navale e terrestre notevole, infatti il potenziamento dello Stato illirico rappresentava un potenziale pericolo per gli interessi dei romani, ovvero, il controllo dell’Adriatico. Utilizzando il pretesto della pirateria, Roma nel 229 a.C., mosse guerra contro l’Illiria. Inizialmente i romani riuscirono ad occupare solo una parte del territorio illirico ragione per cui seguirono altre due guerre, sempre vinte dai romani. A seguito della terza guerra romana-illirica l’intera Illiria venne conquistata e smembrata in distretti. Infatti, sotto Diocleziano e dopo Costantino, l’unità amministrativa più importante divenne la prefettura, la quale comprendeva alcune diocesi, le quali a loro volta erano divise in un numero più grande di province. La prefettura di Illyricum (praefectura praetorio per Illyricum) comprendeva le diocesi di Dacia e Macedonia. Dentro quest’ultima facevano parte le 4 province di Preval, Dardania, Nuovo Epiro e Vecchio Epiro, che rappresentavano lo spazio geografico abitato dagli illiri. Il nuovo Regnum Illyricum divenne così vassallo di Roma. Tuttavia, la successiva divisione dell’impero portò il Regnum Illyricum sotto l’influenza dell’impero d’Oriente. Continuando con l’arrivo degli Slavi nei Balcani, possiamo sostenere che essi si trovarono di fronte ad un impero fragile, indebolito a causa delle invasioni dei Goti, Ostrogoti e Visigoti cominciate già nel secolo IV. Attorno all’anno 548 un numeroso gruppo di Slavi irruppe in alcune delle province, giungendo fino alle vicinanze di Durrazzo. Per frenare queste incursioni, l’imperatore Giustiniano, nato a Taurisium (Dardania), si dedicò alla costruzione di un sistema di fortificazioni, che cominciava da nord vicino al Danubio continuando verso sud8. Il numero dei castelli costruiti nelle quattro province dell’Illiria meridionale arrivò fino a 168. Tuttavia queste misure riuscirono a frenare solo provvisoriamente le incursioni dei popoli “barbari” che divennero ancora più violente quando gli Slavi si unirono con gli Avari, una popolazione nomade. L’attacco più potente che gli Slavo-Avari inflissero all’Illyricum fu quello dell’anno 609 dove devastarono intere regioni come Macedonia, Tessaglia, Beotia e fino al Peloponneso, da cui partivano le navi slave verso le isole dell’Egeo e dell’Asia Minore. I territori dei Dalmati furono quelli più colpiti dalla avanzata Avaro-Slava che portò all’occupazione e alla distruzione definitiva della città di Salona9. Invece, le altre città vicine come Budva, Ulqini, Scuttari, Lezha riuscirono a resistere ai loro attacchi. Diversamente dagli altri popoli, l’invasione slava nei Balcani venne accompagna- Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo ta da un nuovo fenomeno, quello dello stanziamento. Nei territori da loro occupati essi cominciarono a formare gli “Skla vini ” o territorio slavo. Verso la fine del secolo VI e l’inizio del secolo VII, skla vini simili si erano già formati in Macedonia, Tracia, Tessaglia, Beotia e Peloponneso. Dalla Macedonia, gli Slavi riuscirono a penetrare nel territorio dell’odierna Albania senza giungere a formare delle comunità compatte. Lungo la costa dalmata, dalle Bocche di Cattaro in su, si stanziarono le tribù slave di trebinji , ka na vliti , za klumi , na renta ni (AA. VV. 2003). Costantino VII (905-959), imperatore e storico detto Porfirogenito, nel X secolo definì queste comunità come tribù slave, invece, per gli abitanti della Dioclea che abitavano sotto le Bocche di Cattaro egli non le classificò in questo modo, ma le chiamò tribù illiriche. All’inizio del secolo VII, l’imperatore Eraclio, permise la stabilizzazione di due tribù slave, i Croati e i Serbi. La linea che divideva gli insediamenti di queste due tribù coincideva con la linea della divisione dell’impero romano in quello occidentale e quello orientale. “I Croa ti si era no sta biliti a l nord e a ll’ovest della linea , mentre, i Serbi si sta nzia rono a l sud-est” (AA.VV 2003). Questi ultimi occuparono il bacino dei fiumi Lim e Drina superiore assieme a Piva e Tara, il bacino del Ibar e la parte superiore del versante occidentale del fiume Morava. Al sud e all’ovest i Serbi confinavano con la Dioclea e con altre tribù slave arrivando fino al fiume Lim, con al centro la regione di Rascia, al nord dell’odierna Novi-Pazar. L’arrivo delle tribù slave portò una ulteriore modifica molto significativa alla composizione etnica dei territori balcanici. Ciò contribuì a trasformare in profondità le strutture culturali e istituzionali del sistema imperiale che andava sempre più indebolendosi. Trasformazione che proseguì con il rafforzamento dello Stato Bulgaro, soprattutto durante la supremazia degli Zar Simeone e Samuele. Nei secoli IX-X, ci furono molte incursioni di Slavi-Bulgari nei territori precedentemente occupati dagli Slavi delle altre tribù. Questo dominio finì con la riconquista del potere da parte dell’impero bizantino che venne organizzato in signorie governate dalla popolazione locale. A difesa dell’impero vennero spostate intere comunità di Slavi in Tracia e in Asia Minore con l’obiettivo di proteggere i legami con la costa Adriatica, raggiungibile tramite la Via Egnatia. Tuttavia, rimane il fatto che nelle zone periferiche dell’impero una parte della popolazione autoctona subì spesso l’assimilazione o, a volte, il completo annientamento. Tra il VII e il XII secolo, anche i Serbi, come le altre popolazioni della penisola subirono il dominio dei grandi imperi: prima quello bizantino, poi quello bulgaro di Simeone, poi nuovamente quello bizantino. Solo verso l’inizio del XII secolo i Serbi riuscirono a formare dei piccoli principati guidati da uno zupa n . Il primo di cui abbiamo conoscenza è Tihomir, un pastore che nel 1136 divenne Grande Zupan. Durante i secoli la situazione cambiò e iniziarono a emergere due entità nazionali: la Zeta, che darà origine al Montenegro (la vecchia Dioclea), e la Rascia (o Raska), dalla quale nascerà la Serbia. Entrambe subirono l’influenza politica, culturale e religiosa dell’impero bizantino e, grazie all’attività missionaria di Cirillo e Metodio, videro la diffusione del cristianesimo e dell’alfabeto cirillico10. I Serbi furono unificati per la prima volta ad opera di Stefan Simon Nemanjic – già zupan – il quale intorno al 1168 fondò nel territorio della Rascia il regno della Serbia. A Stefano Nemanja succedette il figlio secondogenito Stefano I. Durante il regno di quest’ultimo (1196-1127) venne creata una Chiesa 10 Cirillo e Metodio sono"apostoli degli slavi". Cirillo (Tessalonica 827 869) e Metodio (Tessalonica 815 ca. 885) fecero parte di una missione inviata nel 860 dall'imperatore Michele III presso i càzari, una popolazione tartara il cui capo praticava l'ebraismo. Nell'862-863, preparandosi a intraprendere una missione nella Grande Moravia per evangelizzare gli slavi, Cirillo creò il primo alfabeto slavo, detto glagolitico, il cui uso è oggi quasi del tutto scomparso. Essi hanno tradotto alcuni libri del Nuovo Testamento in paleoslavo e fecero di queste traduzioni la base della liturgia in lingua slava. Osteggiati dal clero germanico, vennero convocati a Roma da papa Niccolò I per spiegare i motivi del mancato utilizzo del latino nelle cerimonie religiose; tuttavia, il papa Niccolò morì prima che raggiungessero Roma, e Adriano II, suo successore, approvò la liturgia slava. Cirillo morì a Roma, mentre Metodio tornò in Moravia, dove proseguì la sua opera missionaria e divenne arcivescovo nell'869. Cirillo e Metodio vennero canonizzati nel 1881 da papa Leone XIII. 45 n.17 / 2007 11 According to Law no. 6, "The ecclesiastical authority must strive to convert such (i.e., Catholics) to the true faith. If such a one will not be converted..., he shall be punished by death. The Orthodox Tsar must eradicate all heresy from his state. The property of all such as refuse conversions shall be confiscated... Heretical churches will be consecrated and open to priests of Orthodox faith". According to Law no. 8, "If a Latin priest be found trying to convert a Christian to the Latin faith, he shall be punished by death". According to Law no. 10, "If a heretic be found dwelling with the Christian he shall be marked on the face and expelled. Any sheltering him be treated the same way". 46 ortodossa serba autocefala – nel 1217 essi conquistarono Peja (Pec) che divenne nel 1346 la sede del Patriarcato Serbo – e la religione ortodossa diventò così religione di stato. Essa venne utilizzata dai diversi sovrani per giustificare l’espansione territoriale nella penisola balcanica che serviva a realizzare un obiettivo: la sostituzione di Costantinopoli diventando così il nuovo centro del mondo ortodosso-bizantino. L’espansione verso sud e soprattutto verso i territori del Kosovo venne accompagnata da nuove trasformazioni etnico e sociali. La maggior parte dell’aristocrazia del posto fu privata della terra e della ricchezza e fu sostituita dai nuovi aristocratici serbi sia essi laici sia appartenenti al clero. A partire dalla metà del secolo XIII furono “serbizzate” le chiese e i monasteri del Kosovo, inoltre, vennero costruiti nuovi edifici di culto ortodossi ai quali venivano messi a disposizione vasti territori. Durante il regno di Stefan Dushan, verso la metà del secolo XIV, la maggior parte dei monasteri furono “convertiti al rito serbo”, come per esempio i monasteri di Decani, Gracanica, Banjska, ecc…, che assieme al monastero di Pec e Prizren occupavano numerosi villaggi del Kosovo. Tuttavia, il re e la chiesa serba, trovatasi sotto la pressione e le minacce del Papato e delle grandi potenze cattoliche dell’Europa, furono obbligati inizialmente a tollerare la presenza della chiesa cattolica nei territori occupati da poco. Dobbiamo ricordare che una parte della popolazione albanese in questo periodo aveva già aderito al credo cattolico sotto l’influenza di Venezia. Questa pressione politica del papato valse soprattutto per i territori della Dioclea tradizionalmente legati a Roma. Per evitare il confronto con le popolazioni locali e con il mondo cattolico occidentale, i primi re della dinastia di Nemanja riconobbero provvisoriamente l’autonomia della chiesa cattolica come al tempo dell’impero bizantino. La politica persecutrice dello Stato serbo nei confronti delle popolazioni cattoliche dei territori albanesi occupati toccò il suo apice durante il regno dei re Stefan Uroshi II (1282-1321), Stefan Uroshi III (1322-1331) e Stefan Dusan (1331-1355). I loro regni furono anche il momento di maggior concentrazione e consolidazione del regno dei Serbi. La Serbia si espanse gradualmente fino a comprendere gran parte dell’odierno territorio di Serbia, Montenegro, Albania e Grecia. Questo periodo coincise anche con la rottura definitiva delle relazioni con il Papato e con gli imperi cattolici. Considerando gli albanesi cattolici come elementi destabilizzanti e alleati naturali di queste potenze, i re serbi adottarono nei loro confronti una politica specifica a questo problema che culminò con il “Codice di Stefan Dusan, 1349” (AA.VV 2003). Alcuni degli articoli più importanti di questo codice erano indirizzati alla “estinzione dell’eresia cattolica” e all’atteggiamento contro i credenti e il clero cattolico che non volevano convertirsi all’ortodossia serba. Per questi si enunciava apertamente: l’imposizione e la distruzione delle chiese, il sequestro della ricchezza, la marcatura con il ferro caldo, l’espulsione e anche la pena di morte11. Numerosi documenti di quell’epoca testimoniano come queste misure definite nel codice del diritto medioevale serbo siano state applicate con molta brutalità; cosa che causò rivolte da parte della popolazione albanese e dure proteste da parte del Papato. Durante la sua esistenza, il regno dei Serbi fu accompagnato da una grande instabilità dimostrata dal cambiamento continuo del suo centro o capitale. Agli inizi Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo della vita del regno, era Raska il centro del regno che con il succedersi degli anni venne spostato a Pristina, Belgrado, Krusevac, Smederevo, ancora Belgrado, Prizren, Banjska, Scopje, Prilep, Smederovo, Krusevac e Kragujevac. Alla morte di Stefano Dušan, nel 1355, scoppiò la lotta tra i nobili, che portò a una veloce disgregazione dello stato, cosa che determinò la formazione dei piccoli principati. Questi principati tornarono ad essere governati dalle famiglie aristocratiche autoctone. Nei territori albanesi i numerosi principati – come vedremo nella Battaglia del Kosovo dove la popolazione albanese partecipante era rappresentata da diversi sovrani – erano appartenenti a entrambe le religioni. In questi territori si arrivò ad una simbiosi ed a volte anche ad una mescolanza dei due riti, per i quali il Papa si lamentò più di una volta. Questa simbiosi e mescolanza era rappresentata dall’esistenza materiale e dalla conduzione contemporanea delle chiese e dei monasteri cattolici e ortodossi in tutti i territori albanesi. Non furono pochi i casi in cui dentro lo stesso tempio convivevano insieme elementi comuni, simbolici, iconografici, rituali e culturali appartenenti sia all’una che all’altra fede. Un esempio tipico di questa situazione è la chiesa di Santa Maria a Brrar presso Tirana, dove le scene bibliche negli affreschi delle mura o le scritte latine e greche, testimoniano una combinazione in tutta l’area di elementi cattolici ed ortodossi e da un punto di vista più ampio, tra la civiltà occidentale e quella bizantina. Infatti, per questa ragione, un missionario cattolico che visitò questi territori nel 1308, constatò come gli abitanti di questo paese si considerassero, secondo le circostanze, cattolici o ortodossi. In sostanza questo era il clima che trovarono gli ottomani quando penetrarono nella penisola Balcanica. I turchi e la Coalizione Balcanica Dopo la conquista della città di Sofia nel 1385, i turchi ottomani si diressero verso le città di Shtip, Perlep, Manastir e Kostur nei territori albanesi12. I sovrani dei vari principati albanesi risposero agli attacchi ma non riuscirono a fermare l’avanzata dei turchi. Le sconfitte assunsero un significato importante perchè rappresentavano agli occhi degli albanesi una ulteriore sottomissione ad un nuovo impero. Questo sentimento spinse la creazione di alleanze tra i principi e i sovrani e di conseguenza accrebbe la capacità di difesa a questi attacchi. Una di queste alleanze vide schierati dalla stessa parte il principe albanese Gjergji II Balsha13 che assieme ai sovrani di Raska e Bosnia sconfissero l’esercito ottomano. Questa vittoria influenzò molto i rapporti di vicinato tra i vari principati albanesi e balcanici tanto da far dimenticare le liti tra i paesi confinanti, ponendo così l’avvio ad una stagione di progetti e azioni militari comuni. Così nell’anno 1387 venne creata la più ampia coalizione Balcanica contro i turchi che riuscì a radunare il principe serbo Lazzaro Hrebeljanovič, il principe albanese Gjergj II Balsha, il principe valaccho Mircea il Vecchio, il principe albanese Teodor II Muzaka, Dhimiter Jonima (albanese), sovrano delle terre lungo la Strada Lezhe-Prizren, Andrea Gropa, principe dell’Ohrid, il signore di Krusĕvac Vuk Brankovich; il re di Bosnia, Tverko I; il ban croato Ivan Horvat, ecc…(AA.VV 2003). Le forze albanesi avevano un peso militarmente rilevante nella formazione della coalizione. Per loro la questione si poneva in questi termini: la cristianità contro l’islamizzazione, non l’ortodossia o il cattolicesimo contro l’Islam. Altri 12 In alcuni documenti turchi dell’epoca dell’Impero ottomano troviamo le espressioni “città dell’Albania” o “territori albanesi”. 13 Principe albanese dello Stato dei Balsha, il quale conobbe una forte espansione durante il secolo XIV e comprendeva i territori settentrionali dell’Albania e della Vecchia Dioclea (oggi Montenegro). 47 n.17 / 2007 14 Un atro elemento storico particolare fu il tradimento da parte del principe serbo Vuk Brankovic il quale abbandonò la battaglia con un numero elevato di soldati serbi. 48 autori – come Fischer (1973) – descrivono l’organizzazione della coalizione in questo modo: “Mentre il sulta no era occupa to in Asia in una vittoriosa ca mpa gna contro gli a vversa ri turchi, una gra nde confedera zione di popoli cristia ni si orga nizzò nell’Europa sud-orienta le (1387), sotto la guida del re serbo, per distruggere la potenza mussulma na . A difesa della ca usa cristia na si unirono serbi e bulga ri, bosnia ci e a lba nesi, pola cchi, ungheresi e persino mongoli della Dobrugia , ma nessuna delle più a ntiche na zioni europee, la tine o greche”. In questo modo, nel giugno 1389 gli eserciti della coalizione Balcanica si radunarono presso la Piana del Kosovo, dove misero in atto i progetti militari preparati durante un intero anno. Perché si era deciso di svolgere la battaglia nella piana del Kosovo? Prima di tutto sono state le circostanze, vale a dire, il fatto che il pericolo ottomano era molto vicino – una parte dei territori albanesi (nell’attuale Macedonia) era già sotto il regime ottomano insieme alla Bulgaria – e minacciava direttamente le regioni dei Balcani. Poiché la Piana del Kosovo sarebbe stato il passo successivo dell’esercito turco, questa divenne il campo di battaglia ideale per fermarli. Per di più, la Piana si trovava in una posizione facilmente accessibile a tutti, in pratica era una zona dove era più semplice muovere gli eserciti provenienti da tutte le parti dei Balcani e inoltre era anche un punto d’incrocio tra le vie di comunicazione da dove potevano infiltrarsi gli ottomani. In queste circostanze gli eserciti della coalizione, guidati dai loro principi, la mattina del 15 giugno 1389, si riunirono e si posizionarono secondo la strategia concordata, nella piana del Kosovo. Ebbe così inizio la battaglia contro le forze ottomane comandate dal sultano Murad I. All’inizio, le forze della coalizione, vinsero alcuni scontri ma il resto della battaglia finì con la vittoria ottomana. Lo scontro di 15 giugno fu violentissimo con un numero elevato di vittime da entrambi le parti. Durante i combattimenti, venne ucciso il sultano Murad I e di conseguenza gli ottomani si vendicarono ammazzando tutti gli ostaggi della guerra e tra questi lo stesso principe Lazzar e il principe albanese Teodori I Muzaka insieme ai suoi soldati14. La disfatta della coalizione contro i turchi ebbe tristi conseguenze per i popoli della penisola Balcanica perché chiuse la strada alla formazione di altre coalizioni di tali dimensioni schierate contro i turchi facilitando così la strada all’ascesa di Bayazid I, sultano dell’impero ottomano (1389-1402) che succedette al padre Murad I. Ma allo stesso tempo portò l’apertura di un importante periodo per i territori albanesi. Caratterizzato da rivolte continue contro i nuovi occupatori, venne riconosciuto da tutti come la gloriosa resistenza di Scanderbeg che per 25 anni respinse l’avanzata dei turchi. Nato nel 1403 a Kruja, dopo la sottomissione della famiglia ai turchi venne portato alla corte ottomana di Adrianopoli. Fu educato alla religione musulmana alla corte del sultano Murad II, e si arruolò nell’esercito turco. Le sue doti militari gli fecero guadagnare il favore del sultano: venne insignito del titolo onorifico di Iskander Beg (“principe Alessandro”) e ottenne il comando di una divisione. Dopo la conquista di Giannina, nel nord della Grecia nel 1431, i turchi sottomisero buona parte dell’attuale Albania scatenando ben presto le rivolte in tutto il paese. All’insorgere dei suoi connazionali contro l’ennesimo occupatore, Gjergj Kastrioti nel 1442 disertò l’esercito ottomano, tornò a Kruja (nel nord Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo dell’Albania) con trecento uomini e si convertì al cristianesimo15. fondando il principato indipendente di Kastriot16. In poco tempo riuscì a unire tutti i principati albanesi che crearono la Lega di Lezha, con la quale essi decisero che al comando delle loro forze armate ci sarebbe stato Skanderbeg. Così iniziò una guerra durata venticinque anni (AA.VV. 2003). Dopo numerosi scontri tra gli eserciti nel 1461, con l’aiuto di papa Pio II, dei governi di Napoli, di Venezia e dell’Ungheria, Scanderbeg costrinse i turchi ad accettare un armistizio di dieci anni. La ferrea resistenza del condottiero albanese riscosse molte simpatie anche in Europa occidentale, preoccupata dall’avanzata turca, dove ormai egli era conosciuto con il nome di “Capitano d’Albania”. Nel 1463, quando Scanderbeg infranse l’armistizio, fu però costretto a combattere senza l’aiuto dei precedenti alleati e, poco dopo la sua morte (1468), l’Albania fu sconfitta, quando il resto dell’area balcanica era ormai già stata conquistata da anni. Con la morte di Scanderbeg, si esaurì la resistenza contro i turchi e allo stesso tempo si concluse quel processo di unione e formazione di una coscienza e identità – basata su una storia e una lingua comune – creatasi durante questi anni che come vedremo, risorgerà verso la fine dell’Ottocento, quando i territori albanesi diventeranno per la millesima volta preda dei paesi confinanti. Cominciò per l’Albania un lungo dominio ottomano che si concluderà solo con le guerre balcaniche. Il loro arrivo portò con sé una nuova religione – l’Islam – aggiungendosi così al già articolato mosaico socio-religioso dell’area. Cinque secoli di dominio turco L’Islam trovò un terreno “fertile” per espandersi a causa dell’indebolimento delle chiese (cattolica e ortodossa) come conseguenza dello scontro fra le due. Infatti, fu l’assenza di una chiesa nazionale che avrebbe potuto influire considerevolmente nel mantenimento dell’unità religiosa, ciò che spinse gran parte degli aristocratici a convertirsi all’islam durante il regime ottomano. Verso la fine degli anni 60 del XV secolo, quasi il 60% degli abitanti di queste zone si erano già convertiti all’islam17. L’islamizzazione diede la possibilità ad alcuni di essi di integrarsi nella vita politica dell’impero ottomano consentendo l’esercizio della professione pubblica e l’accesso alla carriera militare nell’esercito del sultano. Inoltre una parte della popolazione cristiana, aderì alla fede islamica per ragioni di interesse economico. Per evitare il pagamento delle tasse, aderivano formalmente all’Islam mentre di nascosto praticavano il rito cattolico o ortodosso. In alcuni casi accadeva che il capo della casa, essendo il rappresentante della famiglia nelle relazioni con il potere ottomano, aderisse alla religione mussulmana mentre gli altri membri continuavano a professare la religione cristiana. Tuttavia, la ragione principale della conversione o islamizzazione divenne la possibilità di proteggere la loro identità nazionale, la loro cultura e la loro lingua. Appartenere ad una religione diversa poteva distinguere gli albanesi dagli slavi o greci favorendo il deterioramento delle relazioni con la Chiesa slava e greca e contribuendo alla sospensione del processo di slavizzazione e grecizzazione degli albanesi che da tempo era in atto. Come affermava F. Konica (1897): “Gli a lba nesi a veva no due a lterna tive ma nessuna soluzione”. Il consolidamento del regime ottomano portò un elemento nuovo nella vita degli albanesi, quello dell’emigrazione. La maggior parte della popolazione cat- 15 Il condottiere albanese, quando abiurò l’islam si convertì al cattolicesimo, invece, suo fratello era monaco in un monastero ortodosso. Questo fatto dimostra la tolleranza religiosa che esisteva ed esiste ancora in Albania. 16 A questo principato ha dato i simboli che sono tutt’ora i simboli nazionali Albanesi. Una bandiera rossa con al centro l’aquila nera a due teste. 17 La nuova religione occupava percentuali alte nelle città dell’Albania e Kosovo come: Peja o Pec (90%), Vuçiterna (80%), Elbasani (79%), Tetovo (71%), Kërçova (65,5%), Kruja (63%), Berat e Pristina (60%), Prizreni (55,9%), Dibra (51%), Tepelena (50%), Përmeti (41%), Novo-brda (37%), Struga (24%), Valona (23%), Korça e Trepça (21%), Janieva (14%), Delvina (4%) ecc. Come vediamo le città del Kosovo e della Macedonia sono quelle che presentano il tasso di conversione più elevato. Questo per ragioni politiche particolari, i kosovari avevano intuito il pericolo proveniente dai vicini slavi e sfruttarono la religione islamica come elemento differenziale, preservando cosi le loro specifiche caratteristiche etniche e culturali (AA. VV. 2003). 49 n.17 / 2007 tolica che non voleva convertirsi ed evitare il pagamento delle tasse insostenibili, soprattutto nella parte settentrionale del paese, cominciò a spostarsi verso le coste dell’Italia meridionale creando così delle comunità stabili tutt’ora esistenti. Subito dopo le nuove conquiste i turchi ritennero necessaria la riorganizzazione statale intraprendendo una serie di riforme amministrative e militari. Inizialmente divisero il territorio dell’impero in diverse unità amministrative, formando 32 ela jet. Nella penisola Balcanica si trovavano tre ela jet: Bosnia, Rumelia e del Mare che comprendeva le isole dell’Egeo. I territori albanesi facevano parte dell’ela jet di Rumelia ed erano divisi in 4 villa jet. Fig 3: I territori albanesi divisi in quattro vila jet 50 Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo Ognuno di essi era diviso in unità ancora più piccole che si chiamavano sa nxha k. In Albania i sa nxha k più importanti erano: quello di Scuttari, Dukagjin, Valona, Elbasan, Oher, Prizren, Scup, Vucitern, Janine, Manastir. Quest’ultimo divenne il pa nsa nxha k, dopo lo spostamento della sede da Scopje a Manastir. Esistevano anche delle divisioni amministrative ancora più piccole come i ka za e i na hije che spesso erano dirette da persone del posto volute dai turchi. L’amministrazione di queste unità avveniva tramite il ka nuna me, una raccolta di leggi basate sul Libro Santo (Korano) che era considerato dai turchi come “costituzione eterna”. Il ka nuna me controllava la vita economica, politica e sociale di tutti gli ela jet e della loro popolazione. Per quanto riguarda la gestione amministrativa, essa si basava sull’istituto dei millet cioè delle vere e proprie comunità religiose attorno alle quali vennero create delle strutture amministrative dipendenti dal governo centrale. Così c’erano i millet cattolici, i millet ortodossi, i millet ebraici ecc... Nell’anno 1506, i turchi per la prima volta registrarono le terre albanesi dividendole in due zone. Una dove si stabilì il sistema del tima r 18, la terra veniva data in uso a persone che dovevano dare in cambio la partecipazione nell’esercito turco o pagare la tassa yshyr 19 che comprendeva la maggior parte dei territori e la seconda era la zona dell’autogoverno, al nord dei territori albanesi, dove la popolazione fece resistenza al sistema di tima r , rifiutandosi di pagare le tasse20. Tutta la terra di questi territori era di proprietà dello Stato, il quale la cedeva a varie categorie di persone a seconda dell’imposizione di tasse specifiche o obblighi. La terra veniva regalata solo alle istituzioni religiose che conobbero una grande espansione durante questo regime. Secondo questa nuova organizzazione la popolazione venne divisa in due classi: i ra ja e i soldati. I ra ja erano la popolazione che abitava nei villaggi e che lavorava la terra data in uso, guadagnando solo quanto bastava per l’alimentazione della sua famiglia, cioè erano coloro che producevano. I soldati invece si dividevano in intellettuali e combattenti. Nella prima categoria entravano i turchi e gli aristocratici del posto che si erano convertiti per proteggere la loro ricchezza e la loro posizione sociale. A questa classe facevano parte una fascia considerevole della popolazione albanese. Rari erano i serbi che rivestivano questa posizione, perché venivano considerati stranieri in quelle terre e non garantivano quella sicurezza che potevano dare le persone del posto per sedare le rivolte nella massa dei ra ja . Ritornando alla zona dell’autogoverno, la popolazione era molto povera e si occupava principalmente dell’allevamento del bestiame anche se esisteva una piccola classe aristocratica. In queste regioni la terra era proprietà privata e veniva ereditata dai componenti della famiglia che era l’unità amministrativa base. Il capo della famiglia gestiva l’economia famigliare ed era il rappresentante nelle riunioni che venivano organizzate tra i fis (clan) e nelle riunioni del villaggio. I diversi settori della vita venivano disciplinati in base alle norme di Ka nun , un codice consuetudinario tramandato oralmente di padre in figlio, che da secoli regolamentava la società tribale albanese in diversi settori, dai commerci alla pastorizia, dalle guerre alle pacificazioni, dai matrimoni ai rapporti familiari e fino alle alleanze. Infatti, in base a questo codice, nelle riunioni tra i fis o quelle tra i villaggi si decideva anche quando e come attaccare l’esercito turco che cercava di applicare anche in queste zone il sistema del tima r . I primi attacchi organiz- 18 Il sistema del timar era creato dal sultano in modo da poter creare un esercito sicuro per le nuove conquiste. 19 Era una tassa che il produttore o coltivatore della terra doveva pagare al sultano cioè 1/10 della sua produzione. 20 Tuttavia durante i cinque secoli di dominazione ottomana in Albania, i turchi non hanno mai goduto un totale controllo della regione. 51 n.17 / 2007 zati contro l’esercito turco ebbero esito positivo, fattore che accrebbe il loro numero, fin quando il sultano mandò un esercito più forte e numeroso che li piegò senza riuscire a penetrare nelle zone più montuose. Una parte della popolazione sottomossa venne trasformata in guardie e protettori delle strade principali che percorrevano il nord dei territori albanesi. Inoltre, essi furono obbligati a pagare una tassa annuale, che non venne mai versata. Il mancato pagamento della tassa comportò l’avvio di altri conflitti tra i clan e l’esercito ottomano. Praticamente, questo risultò il modo migliore per poter autogovernarsi e mantenere le loro terre. La resistenza al regime fu possibile grazie all’unità creatasi tra questi clan. Unità che con il passare del tempo si rafforzava ancora di più e aumentava la voglia di libertà e indipendenza. Di conseguenza il sultano cambiò strategia e pensò che reclutandoli avrebbe avuto il loro appoggio. Questa mossa ebbe inizialmente conseguenze positive perché la loro povertà li spinse ad accettare subito l’arruolamento nell’esercito turco. In questo modo nacque una nuova classe, quella di ba jra kta r , che ebbe subito l’appoggio dell’aristocrazia e del sultano, il quale regalò una parte delle terre. Regalare le terre significava: proprietà privata. In questo modo il sistema perse il carattere militare mettendo in crisi l’organizzazione dell’impero, cioè il sistema del tima r che in poco tempo fu sostituito da quello di ta nzima t. Infatti, Mahmud II cercò di abolire il vecchio esercito e di costituire una nuova milizia con truppe retribuite e soggette a una rigida disciplina, che divennero il principale strumento della centralizzazione politica dell’impero, nonché la fonte di ispirazione per riforme in altri settori. Un esercito moderno diventava costoso e fu necessario istituire una burocrazia efficiente, al fine di riscuotere i tributi necessari per pagare le truppe, e un sistema scolastico moderno per preparare gli ufficiali dell’esercito e i funzionari dello stato. Il sultano si appoggiò alle famiglie ricche lasciando a loro la maggior parte delle funzioni, in cambio di una quota maggiore di tasse. Queste famiglie accettarono volentieri le proposte del sultano, perché era il modo migliore per rafforzare la loro posizione nei confronti di altre famiglie aristocratiche rafforzatesi in questo periodo. A secondo delle loro posizioni sociali, esse ottennero vari titoli come Pa sha e Vezir . Esse divennero nucleo non solo del potere locale ma anche di quello centrale a cui non riuscì più farne a meno, sia per quanto riguarda il denaro offerto che per la punizione dei disobbedienti. Molti contadini non potendo più usufruire dell’uso delle terre e pagare le tasse, si diressero verso i grandi centri. Invece, nelle zone del nord la reazione fu opposta. Essi cominciarono ad organizzare delle rivolte che toccarono tutta la parte settentrionale dei territori albanesi. Inizialmente, alcune regioni cominciarono ad unirsi con altre, ponendosi come obiettivo la liberazione delle terre albanesi dal regime ottomano. La realizzazione di alcuni accordi tra queste regioni riuscì ad unire i cattolici ed ortodossi nonché le persone convertite che non accettavano più la situazione, divenuta insostenibile. Gli organizzatori di questi accordi chiesero l’aiuto e l’appoggio dell’Europa soprattutto del Papato. Aiuto che non arrivò mai perché essi non volevano deteriorare le relazioni create con Istanbul. Le regioni del nord divennero così la base delle rivolte contro i turchi e del desiderio di liberazione. Vennero creati nuovi movimenti di liberazione come “La lega degli Arber” e “Le montagne Albanesi”, le quali ebbero un ruolo importante nella creazione di una coscienza comune nazionale come espressione dalla con- 52 Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo sapevolezza di appartenere alla stessa etnia, allo stesso territorio comune. Il fatto di possedere una origine, una lingua, una tradizione e una storia comune li distingueva dalle altre etnie. Inizialmente sorto in alcune regioni, il movimento per la liberazione nazionale riuscì a comprendere tutti i territori albanesi. Il suo fondamento era la lotta nazionale non solo armata ma anche intellettuale la quale portò nuove idee che argomentavano il diritto naturale e umano del popolo albanese di essere libero e indipendente. Libertà e indipendenza che potevano essere raggiunte solo con la creazione di uno stato nazionale indipendente. La Rinascita Albanese I movimenti per la liberazione albanese sorti nei secoli XVII-XVIII, posero le basi per la creazione della nuova ideologia che nacque quasi contemporaneamente in tutta la penisola Balcanica: il nazionalismo. Teoria che esaltava lo stato nazionale, considerandolo come ente indispensabile per la realizzazione delle aspirazioni sociali, economiche e culturali di un popolo. Diversamente da ciò che successe in altri paesi balcanici che elaborarono la proprie identità culturali fondandole sull’appartenenza religiosa e sull’avversione verso un dominatore straniero che personificava la prepotenza di un’altra religione sulla propria, il popolo albanese basò la propria identità sull’appartenenza alla stessa etnia, stessa lingua e storia comune. Con gli slogan per l’unificazione nazionale e per l’emancipazione, essa riunì diversi comitati organizzazioni albanesi ponendo come scopo principale la difesa dei diritti nazionali albanesi. “La religione degli a lba nesi è l’essere a lba nesi ” (Vasa 1989, p. 77).questo è stato uno degli slogan che unì il popolo. Questa era una affermazione laica, che non esprimeva nessuna sentimento anti-religioso, semplicemente era una nozione politica che mirava l’unione degli albanesi di qualsiasi religione loro appartenenti e dar vita ad un vero e proprio spirito albanese. La rinascita Albanese, con la nuova composizione ideologica, politica, culturale economica, sociale e organizzativa, passò attraverso la liberazione del paese dagli occupatori, la riunificazione dei territori albanesi in uno Stato unico e indipendente, in modo da poter aprire la strada, allo sviluppo economico politico e socio-culturale del Paese. Il trattato di Santo Stefano del 3 Marzo 1878, pose fine alle guerre Russo-Turche avviando il riconoscimento ottomano dell’indipendenza di Serbia, Montenegro e Romania. La Bulgaria, che ottenne la Macedonia, divenne un principato autonomo sotto la tutela russa. Inoltre, il trattato sancì che una parte dei territori albanesi sarebbe stata ceduta alla Bulgaria, Serbia e Montenegro. Si vide chiaramente come le Grandi Potenze non avessero intenzione di aiutare la popolazione albanese bensì di usarla per difendere le pretese dei loro alleati. Di conseguenza gli albanesi decisero di cambiare le loro priorità contrastando in ogni modo le decisioni che le Grandi Potenze avessero voluto prendere in nome degli albanesi senza il loro consenso e a loro sfavorevoli con la lotta armata e con l’obiettivo di riunire tutti i territori albanesi in un unico vila jet autonomo sotto la giurisdizione ottomana. Quindi si avviò la formazione di organizzazioni sul piano nazionale come: la Lega Albanese di Prizren creata il 10 Giugno 1878 in Kosovo. La creazione della Lega Albanese di Prizren e la pubblicazione del suo Programma rappresentò l’evento più importante nel XIX secolo per il movimen- 53 n.17 / 2007 to nazionale albanese. Ponendosi come obiettivi l’unificazione nazionale e l’emancipazione, essa riuniva diversi comitati albanesi con lo scopo principale di difendere i diritti nazionali albanesi dalle aspirazioni territoriali dei paesi vicini. Il Programma del 1878, espressione delle richieste del popolo albanese rivolte al Congresso di Berlino, prevedeva la formazione di un vila jet autonomo albanese (comprendenti i vilajet del Kosovo, Scutari, Manastir e Giannina) sotto la sovranità dell’impero ottomano. Questa nuova formazione era considerata dagli intellettuali albanesi come una organizzazione temporanea e di passaggio, nella prospettiva di ottenere condizioni più favorevoli dalle Potenze europee, per la nascita di uno Stato indipendente. L’autonomia territoriale e amministrativa dava la possibilità di creare delle istituzioni giuridiche e politiche e una struttura economica e sociale, che sarebbe servita come appoggio per la creazione del nuovo Stato indipendente. Una amministrazione autonoma dei territori albanesi avrebbe bloccato la strada alle intenzioni espansionistiche dei nuovi stati creati agli inizi del secolo XIX. Assicurandosi il riconoscimento ufficiale del Sublime Porta e delle Grandi Potenze del diritto sul loro territorio e della loro appartenenza etnica sotto la sovranità dell’impero ottomano si sarebbe evitato il pericolo della divisione e dell’annessione da parte degli stati vicini, cioè l’identificazione con l’impero. La Lega di Prizren divenne l’attore principale che rappresentò la nazione albanese al Congresso di Berlino che non apportò nessuna modifica a favore della popolazione albanese. Il Cancelliere Bismark, affermando che: “non esiste una na zione a lba nese” stabilì che non si dovevano ascoltare le richieste presentate da parte della Lega di Prizren. L’Albania non riuscì a trarre alcun vantaggio dalle decisioni prese dalle grandi potenze. Fu confermata invece, l’indipendenza della Serbia e del Montenegro, i quali approfittarono delle grandi fette dei vila yet di Scutari, Kosovo e Manastir. Con l’intervento dell’impero austroungarico si decise che la Serbia non si sarebbe allargata verso sud cioè dove si trovavano le città di Novi-Pazar, Mitrovica e Pristina, le quali erano preferite dalla austroungheria ma si sarebbe espansa vero il sud-est, occupando le regioni di Pirot, Tren, Vranje e Nish, le quali con il trattato di Santo Stefano furono date alla Bulgaria. Invece Montenegro approfittò annettendo le regioni albanesi di Antivar, Podgorica, Plava, Gucia, Rugova e Kolashin. L’annessione della regione di Ulqinj non fu riconosciuta dal Congresso ma le autorità di Cettigne ebbero la possibilità di navigare liberamente nel lago di Scuttari. 54 Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo Figura 4: Il territorio dell’impero ottomano dal 1815-1878 55 n.17 / 2007 Nonostante i risultati del Congresso di Berlino gli albanesi contiuarono la lotta per la creazione di uno stato indipendente albanese. Con le sue azioni, la Lega Albanese riuscì a togliere il diritto di parola a nome degli albanesi alla Sublime Porta. Inoltre riuscì a far respingere l’applicazione di alcuni delle decisioni del congresso di Berlino che avrebbero spartito i territori albanesi, a favore del Montenegro e della Grecia. Organizzando varie battaglie e rivolte contro il Montenegro per la protezione della regione di Plava, Gucia, Hot e Gruda e contro la Grecia per la regione di Cameria fece sì che, due anni dopo il congresso, le Grandi Potenze si riunissero per decidere sugli argomenti rimasti ancora sospesi. Le grandi potenze minacciarono la Sublime Porta che non stava rispettando le condizione del congresso, atto che spinse i turchi a intraprendere una nuova riforma che venne avviata senza il parere di una commissione locale come previsto dal Trattato di Berlino e senza tener conto delle richieste della Lega Albanese. In base alla riforma nei territori albanesi (i quattro vila jet) si sarebbe rafforzato il potere centrale eliminando così il diritto di crearsi una nazione, il diritto all’educazione nella loro lingua anzi, anche il diritto di chiamarsi albanesi. Questi cambiamenti accrebbero le rivolte degli albanesi che dopo alcune vittorie sugli eserciti del sultano formarono un governo autonomo. La formazione del governo allarmò sia le Grandi Potenze che l’impero che non riuscivano ad avere sotto controllo la situazione. Il sultano, allora, decise di organizzare un esercito forte e attaccare il cuore della nazione, il Kosovo. Nonostante le resistenze da parte della Lega, l’esercito ottomano riuscì a sconfiggerli. Da quel momento tutti gli albanesi vennero considerati nemici dell’impero e la politica seguita dall’impero nei loro confronti cambiò completamente portando allo scioglimento forzato della Lega di Prizren (1881). Diversamente dai loro vicini, gli albanesi sacrificarono quasi la metà dei loro territori e un numero elevato di persone per creare il loro Stato indipendente. Tutto questo perché “gli a lba nesi non a veva no lega mi etnici o religiosi con nessuna delle Gra ndi Potenze” (Biberaj 2001, p. 40). Nella primavera del 1912 Serbia, Grecia, Bulgaria e Montenegro si unirono nella Lega balcanica e prendendo a pretesto il rifiuto del governo turco a concedere l’autonomia alla Macedonia, dichiararono guerra alla Turchia, indebolita dalle rivolte albanesi, il 18 ottobre successivo. La dichiarazione di guerra venne fatta dal Re Pietro che annunciò l’inizio di una guerra Santa con lo scopo di portare la pace nei Balcani. Sotto questo slogan si nascondevano in realtà le intenzioni espansionistiche della Serbia che subito dopo occuperà il Kosovo per proseguire la sua marcia verso le coste Adriatiche. Durante la loro marcia i serbi distrussero molte città e uccisero migliaia di persone con una crudeltà mai vista prima. “Solo dentro la regione di Prizren sono sta ti uccisi cinquemila a lba nesi, dura nte il periodo della guerra il numero è a rriva to a quindicimila , di conseguenza miglia ia di a lba nesi inizia rono a emigra re in Turchia ” (Udovicki, Ridgeway 1998, pp. 29-30). Le atrocità commesse nei territori albanesi sono state così descritte dallo scrittore austriaco Freundlich nel 1913: “Un popolo cora ggioso e nobile si sta ma ssa cra ndo da va nti a gli occhi di un intero mondo e l’Europa , l’Europa cristia na , l’Europa civilizza ta non sta pronuncia ndo una pa rola di fronte a tutto questo. Dieci mila persone indifese sono sta te trucida ti, le donne sono sta te stupra te, giova ni e ba mbini stra ngola ti, centina ia di villa ggi sono distrutti da l fuoco e molti sono i sa cerdoti uccisi. Eppure l’Europa rima ne in silenzio! 56 Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo Serbia e Montenegro ha nno deciso di conquista re terra stra niera . Ma quella terra è a bita ta da gente cora ggiosa che a ma la libertà e ma lgra do secoli di sottomissione non è ma i sta ta a bitua ta a tollera re la domina zione stra niera . A ca usa di tutto ciò la soluzione è sta ta : “Gli Alba nesi devono essere stermina ti”! Un bruta le e disuma no esercito ci ha mostra to tra mite procedure terribili come questa decisone poteva essere messa in pra tica . Numerosi villa ggi sono sta ti ra si a l suolo e innumerevole le persone ma cella te in ma niera crudele. Dove una volta era no erette ca se modeste che genera zioni di poveri a lba nesi ha nno costruito con dignità , a desso rima ne solo il fumo delle rovine. Un’intera na zione sa nguina ingiusta mente – e l’Europa non dice una pa rola !” 21. Per fermare le mire espansionistiche gli intellettuali albanesi organizzarono la Conferenza Nazionale di Valona, nella quale il 28 Novembre 1912 venne ufficialmente proclamata l’indipendenza dell’Albania. I rappresentanti di tutte le regioni albanesi, Kosovo, Macedonia e Çameria incluse, dichiararono l’unione di tutte le regioni etnicamente albanesi nei confini del nuovo Stato. In base al loro impegno nella lotta contro il dominio ottomano e il loro legittimo diritto ai territori etnicamente albanesi, essi chiesero l’indipendenza del loro Stato, sulla base dei confini stabiliti dal Congresso di Valona. I serbi si mostrarono indifferenti a tali decisioni continuando la loro marcia verso l’Adriatico. Il cessate il fuoco da parte delle Grandi Potenze arrivò solo l’anno successivo e rallentò l’onda distruttrice dei serbi. La situazione era talmente degradata che per la prima volta la questione albanese fu messa sul tavolo delle super potenze, anche se assieme a essa venivano spartiti i suoi territori. 21 Citato in Juka (1992) dove viene riportata la traduzione del libro “Albania's Golgotha” dello scrittore austriaco Leo Freundlich pubblicato nel 1913 a Vienna. Addio Kosovo La Conferenza di Londra nel 1913, contrariamente agli interessi del popolo albanese, riconobbe la creazione dello Stato indipendente di Albania senza accettare l’unione di tutti i territori etnici albanesi in questa nuova entità. Di conseguenza, il nuovo Stato corrispose alla metà del territorio albanese, l’altra metà fu divisa tra le tre monarchie balcaniche. Alla Serbia andò tutto il territorio del Kosovo, mentre alla Grecia e al Montenegro andarono il resto dei territori che non gli erano stati concessi dal Trattato di Berlino. Per gli Albanesi, i nuovi confini delimitati dalla Conferenza di Londra furono considerati una grande violazione dei diritti nazionali e degli interessi vitali del popolo albanese. Quasi la metà del territorio e della popolazione albanese rimase al di fuori dei confini nazionali. La Grande Serbia cominciò la sua esistenza. 57 n.17 / 2007 Figura 5: L’espansione territoriale della Iugoslavia. 58 Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo “Il terrore non può domina re un popolo che comba tte per la libertà e l’unità na ziona le” (Verli 2006, p. 83). Fu così che gli albanesi risposero alla decisione presa dalla Conferenza di Londra. Subito dopo venne creato l’Esercito Nazionale Albanese che in questi momenti difficile si pose come obbiettivo la protezione del Kosovo dalla pulizia etnica che i serbi stavano portando avanti. Questo politica seguita dagli albanesi provocò una reazione violenta da parte dei serbi, i quali inviarono alcune truppe nel nord albanese seminando per la millesima volta il terrore, le vittime furono numerose e la situazione divenne estremamente difficile. Di conseguenza nel 1914 il governo di Ismail Qemali dovette lasciare il posto ad una commissione internazionale di controllo. Molto importante per mantenere la Serbia in una posizione confinata nei suoi territori, le sorti dell’Albania vennero prese in mano dalle potenze europee che misero sul trono del paese il principe tedesco Wilhelm von Wied. Essendo un ufficiale straniero, egli non fu mai accettato dal popolo e subito ebbero inizio le rivolte che lo portarono alla fuga. A questo punto il paese rimase preda di bande armate locali e divenne terra di passaggio per gli eserciti montenegrino, austriaco, italiano, francese, greco, bulgaro e serbo, impegnati nella Prima Guerra Mondiale. Da questa situazione di caos ne approfittarono i greci, che nel 1916 annetterono a tutti gli effetti la regione albanese dell’Epiro settentrionale. Anche le altre potenze occuparono parte del territorio albanese con l’intenzione di dividerlo tra loro. In questo contesto si crearono vari comitati che chiesero la protezione dei confini dell’Albania da un’ulteriore spartizione di queste potenze. Il Comitato albanese per la protezione del Kosovo, venuto a crearsi nell’anno 1915 chiese alle grandi potenze non solo la protezione dei confini ma anche la restituzione del Kosovo. In seguito alla conclusione dei trattati del dopoguerra all’Albania vennero riaffermati i confini del 1913. Tuttavia continuavano a persistere le insistenti brame annessionistiche dirette contro l’Albania da più parti, il Regno dei serbi, croati e sloveni creato nel 1918 e la Grecia, che non volevano riconoscere l’autonomia del paese. La risposta ad esse fu come sempre le rivolte che continuarono con intensità fino al 1924 poi divennero sporadiche a causa della politica seguita dal Re dell’Albania. Nel 1924 Ahmed Zog entrò in scena, prendendo la direzione del potere e diventando in un primo momento Presidente e in seguito Re dell’Albania, strappando la guida del governo a Fan Stilian Noli (vescovo che studiò a Harward e nel 1920 formò il Partito Popolare). Egli seguì una politica democratica non solo nei confronti dei cittadini albanesi, ma anche nei confronti degli immigranti kosovari, ai quali concedette l’asilo politico. Questa politica tuttavia rappresentava un problema per il governo slavo, il quale temeva l’organizzazione di un ulteriore rivolta da parte del popolo albanese che viveva nel Regno. In virtù di queste considerazioni la prima mossa adottata dal governo slavo fu rovesciare il governo di Fan Stilian Noli insediando Ahmed Zog. Il re, riconoscente al governo slavo per l’aiuto ricevuto nella sua ascesa al trono, regalò a loro i villaggi di San Naum e di Vermosh, lasciando alle spalle la questione del Kosovo definitivamente annesso al Regno della Iugoslavia. Con la creazione del Regno ebbe inizio il cambiamento della composizione etnica del Kosovo abitato per il 90% da popolazione albanese. Vari metodi vennero usati dai serbi per portare a buon fine la loro missione. Uno dei metodi usati fu l’assimilazione o meglio la serbizzazione della popolazione albanese che assieme 59 n.17 / 2007 22 Citato in Juka (1984) dove vengono riportati pezzi molto ampi dell’articolo (The expulsion of the Albanians) dello storico serbo Vaso Cubrilovic pubblicato nel marzo 1937 e Detrez 2004, p. 37. 23 Citato in Detrez 2004, p. 43. 60 alla colonizzazione formarono gli strumenti più efficaci per la repressione della popolazione. Nuovi arrivati non albanesi si stabilirono nella regione e per loro furono costruite case e chiese. Sotto quella che veniva chiamata Riforma Agraria, gli albanesi furono privati delle loro terre e furono costretti a cederle ai SerboMontenegrini i quali lentamente colonizzarono tutta l’area. Il responsabile di questa colonizzazione fu Djordje Kristic il capo della Commissione Agraria. Nel suo libro “La colonizza zione della Serbia meridiona le”, pubblicato in Sarajevo nel 1928 egli dimostrò quanto rapidamente fosse cambiata la composizione etnica in una regione che prima del 1913 non aveva neanche un singolo abitante Serbo. Il terzo metodo e quello più radicale fu l’estinzione della popolazione che si praticava principalmente in tempi di guerra. Il quarto metodo seguito fu l’espulsione verso terre lontane. Tuttavia, il sistema migliore risultò l’eliminazione dell’educazione nella lingua albanese. Il progresso fu in questo modo completamente proibito ai kosovari, anche quelle poche scuole che erano state con difficoltà aperte durante il regime turco prima che scoppiassero le guerre balcaniche furono chiuse dal governo serbo e nessun insegnamento nella lingua albanese venne permesso. All’inizio i bambini kosovari potevano frequentare le poche scuole serbe del Kosovo, ma dopo l’anno 1925 venne proibita loro l’acceso, evitando così la creazione di una classe intellettuale che potesse opporsi alla politica serba. L’unica scuola aperta dove gli albanesi potevano andare era la scuola coranica a Scopje. Il governo serbo era convinto che l’educazione religiosa avrebbe aiutato nella distinzione tra loro e i cristiani e per cristiani intendevano gli europei. In questo modo l’Europa poteva stare sempre dalla parte dei Serbi. Lo storico serbo Vaso Cubrilovic ha dato una delle migliori proposte per risolvere la questione degli albanesi: “Il governo deve a pplica re a l ma ssime le sue leggi in modo da rendere la vita a gli a lba nesi insopporta bile: multe, a rresti, l’a pplica zione senza pietà dei metodi polizieschi, inoltre dobbia mo: a ccusa rli di contra bba ndo, ta glia no illega lmente la legna , la scia no i ca ni liberi, infliggendo loro la conda nna a la vori a vita (…). Sul pia no economico non si devono riconoscere i vecchi diplomi (….), chiedere le ta sse con la forza sia priva te che pubbliche, niente posizioni a mministra tive, a nnulla mento dei privilegi, nessun permesso per a prire ba r e negozi, non devono essere a ccetta ti nei servizi sta ta li ecc. Spingerli a la scia re le loro dimore. (….). distruggere gli oggetti di culto, chiese, moschee, cimiteri, (….). Dobbia mo a rma re i nostri colonizza tori. Nelle zone monta ne dobbia mo sta bilire dei montenegrini in modo da provoca re un conflitto che sembrerà un conflitto tra a gricoltori e va rie tribù.(….) In ultimo possia mo provoca re una rivolta loca le, che possa essere a bba ttuta in modo crudele non solo da ll’esercito ma a nche da i colonizza tori, da i cla n montenegrini e da gli eserciti guerriglieri. La Serbia ha utilizza to questo mezzo a nche prima nel 1878 qua ndo metteva a fuoco i villa ggi a lba nesi e i suoi qua rtieri” (Cubrilovic 1937)22. Non molto più tardi gli Iugoslavi decisero di sradicare completamente l’elemento albanese, trovando il modo più semplice e efficiente: spostare duecentomila albanesi in Turchia o altrove. “In un momento dove la Germa nia può espellere centomila ebrei e la Russia può sposta re dieci milioni di persone da una pa rte del continente a d un’a ltra , lo sposta mento di centomila a lba nesi non dovrà sca tena re lo scoppio di una Guerra Mondia le” (Cubrilovic 1937)23. Malgrado la forte opposizione dei Kosovari al piano per il loro trasferimento in Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo Turchia, l’accordo con il governo turco venne fatto. Ma, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale interruppe l’applicazione di questo accordo ed il trasferimento non iniziò mai. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, il governo iugoslavo accettò di aderire al patto tripartito tra Germania, Italia e Giappone. La reazione degli iugoslavi culminò in un colpo di stato (26-27 marzo 1941), appoggiato dal re Pietro II costituendo un governo il cui principale obiettivo era il mantenimento della neutralità. La reazione da parte delle potenze dell’Asse fu immediata, le truppe italiane, ungheresi e bulgare, assieme all’esercito tedesco invasero la Iugoslavia, provocando la fuga del sovrano e dei membri del governo. Il regno conquistato fu velocemente smembrato: l’Italia occupò la Dalmazia, parte della Slovenia e il Montenegro, mentre la Germania ottenne il resto della Slovenia e la Serbia, l’Ungheria occupò la parte occidentale della provincia serba della Vojvodina e la Bulgaria ebbe gran parte della Macedonia iugoslava. All’Albania, toccò la stessa sorte, il monarca abbandonò il trono fuggendo all’estero, e lasciando il paese agli invasori italiani che promisero agli albanesi di restituire all’Albania i territori dei quali era stata ingiustamente privata. Il governo fascista italiano riuscì così a sfruttare la situazione a proprio vantaggio usando le guerriglie albanesi come alleati per l’occupazione della Iugoslavia. Una volta occupata la Iugoslavia l’Albania ottenne solo una parte del Kosovo. Così gli abitanti del Kosovo ebbero la nazionalità albanese e il governo aprì 173 scuole elementari e la lingua albanese divenne lingua ufficiale. Questo sogno degli albanesi non durò a lungo, la capitolazione dell’Italia nell’anno 1943 aprì la strada ad una grande confusione e all’avvento del regime nazista. Il territorio stabilito dagli italiani venne mantenuto anche dai tedeschi ma cambiò la sua giurisdizione. Comunismi Nel contempo, erano comparse nei balcani le prime resistenze armate contro gli occupatori nazisti. Nel 1942 i partigiani comunisti di Tito, avendo ottenuto de fa cto il controllo di parte della Bosnia, istituirono un governo provvisorio, il Comitato di liberazione nazionale. Il Comitato continuò le operazioni militari per tutto il 1943, costituendo un esercito di oltre 100.000 soldati e conquistando più di 100.000 km2 di territorio iugoslavo. Al termine della Seconda Guerra Mondiale il 29 Novembre 1943, a Jajce, il governo provvisorio della Iugoslavia, guidato da Tito, pose le basi per l’organizzazione del futuro stato che sarebbe diventato una federazione secondo il modello Sovietico. In questo Congresso fu deciso che in caso di vittoria dei comunisti, la Jugoslavia sarebbe diventata una federazione composta dalla Serbia, dalla Croazia, dalla Macedonia, dalla Slovenia, dal Montenegro e dalla Bosnia – Erzegovina. Fu inoltre deciso che il popolo jugoslavo sarebbe stato diviso in nazioni e nazionalità, in quanto solo le nazioni avevano il diritto di creare la propria Repubblica in base al principio di autodeterminazione dei popoli. La parte kosovara non fu convocata a partecipare a questo Congresso. In risposta a ciò i Kosovari organizzarono una conferenza a Bujan il 1 Gennaio 1944 dove decisero di unirsi e combattere l’occupatore straniero poiché questo era l’unico modo per avere la libertà, la quale avrebbe assicurato a tutti i popoli di applicare il principio di autodeterminazione che avrebbe portato ad ottenere lo status di Repubblica anche per i kosovari. Seguirono molte cri- 61 n.17 / 2007 tiche in seguito a tale decisone del Comitato Kosovaro, da parte del partito comunista iugoslavo, il quale insisté sul fatto che i confini sarebbero stati decisi una volta finita la guerra a seconda della situazione politica che si sarebbe venuta a creare in Iugoslavia e Albania. È stata una politica astuta quella del partito comunista iugoslavo che riuscì a nascondere le sue vere aspirazioni. Prima di tutto, il partito non voleva la divisione dell’esercito in questa fase importante della guerra. Un’altra ragione del loro silenzio fu il fatto che gli jugoslavi volevano annettere l’intera Albania, poi in un secondo momento unire il Kosovo ad essa e ciò poteva sembrare positivo agli occhi dei kosovari. La verità stava invece nel fatto che essi non avrebbero mai lasciato il Kosovo e soprattutto non le avrebbero mai dato lo status di repubblica autonoma. Anche in Albania nel 1941, venne fondato il Partito comunista, guidato da Enver Hoxha. Egli ebbe un ruolo molto importante nel coordinamento della resistenza comunista albanese sia contro gli italiani ma soprattutto contro i tedeschi. Grazie a ciò gli venne affidato il comando dell’Esercito di liberazione nazionale. Con l’aiuto materiale dell’Europa e sotto la giuda del partito comunista iugoslavo, il partito comunista albanese consolidò la sua posizione. Con la fine della guerra e la vittoria dell’esercito di liberazione nazionale nel 1945 vennero indette le elezioni e Hoxha, già segretario del Partito comunista, fu eletto capo del governo della nuova Repubblica Albanese. Nel programma del partito i confini dell’Albania rimasero quelli stabiliti nel 1913 senza pronunciarsi su quelli nati durante l’occupazione italiana e la questione del Kosovo venne lasciata nell’ombra. Questi erano segni chiari della politica che avrebbe seguito il partito comunista albanese sotto l’influenza del partito comunista iugoslavo. L’influenza di tale partito convinse, Enver Hoxha che lo spirito indipendentista dei kosovari costituiva un pericoloso ostacolo per l’espansione del comunismo e indebolendo in questo modo il suo potere e la sua popolarità (Dode 2006, pp. 251-253). Nei documenti comunisti non furono mai trovate le parole “strategia nazionale” che comprendesse anche il Kosovo e il principio di autodeterminazione (Detrez 2004, p. 42). Come previsto il 31 Gennaio 1946 fu approvata la Costituzione jugoslava dove veniva confermata la struttura federale proposta a Jajce. Essa era formata dalle sei Repubbliche paritarie e in più dalla Provincia autonoma della Vojvodina e dalla Regione autonoma del Kosovo all’interno della Repubblica di Serbia. Solo Serbia, Macedonia, Croazia e Slovenia furono riconosciute come nazioni costituenti della Jugoslavia, mentre gli Slavi musulmani ottennero questo status solo negli anni Settanta. Gli Albanesi, gli Ungheresi e gli altri popoli che vivevano all’interno dei confini jugoslavi vennero riconosciuti come nazionalità, fatto che gli proibiva la costituzione della propria Repubblica. È importante a questo punto chiarire qual fosse la differenza tra nazione o na cije/na rodi e nazionalità o na ciona lsnoti/na rodnosti . Con il termine nazione si riconoscevano quelle popolazioni dove la loro patria era all’interno dei confini della Iugoslavia come i bosniaci, croati, sloveni, serbi, macedoni e montenegrini. Essi potevano avere lo status di Repubblica e venivano considerate come nazioni costituenti. Invece, con il termine nazionalità venivano considerate le popolazioni la cui patria si trovava all’esterno dei confini della federazione, come gli albanesi e gli ungheresi. Esse non avevano il diritto di avere la propria repubblica ma dovevano accettare lo status di provincia sotto il potere della Repubblica 62 Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo della Serbia (Detrez 2004, p. 45). Questa decisione svelò da subito le intenzioni della politica iugoslava, essa non solo non mantenne le promesse fatte agli Albanesi del Kosovo durante la guerra antifascista, ma gli lasciò in una situazione che somigliava alle decisioni del 1878 e 1913. Il territorio kosovaro subì presto una ulteriore spartizione tra Macedonia, Serbia e Montenegro. La città di Scopje capitale del vila jet di Kosovo venne data alla Macedonia. Questa spartizione fu fatta in modo da poter diminuire il numero degli albanesi aventi diritti perché solo gli albanesi che rimasero sotto la provincia autonoma del Kosovo venivano applicati i diritti dettati dalla costituzione del 1946. Invece, la popolazione albanese divisa tra le diverse repubbliche fu ridotta a minoranza ed in questo modo era soggetta alla legislazione di quest’ultime. Così, si poteva evitare la loro unione e di conseguenza diminuiva la probabilità di rivolte. Tutto questo venne fatto senza consultare la parte albanese. Il dopoguerra non migliorò la situazione per il Kosovo. L’educazione, le scuole costruite durante la seconda guerra mondiale non furono chiuse ma il governo diminuì i fondi per mantenerle. In questo modo l’insegnamento della lingua albanese venne eliminato lentamente e la stessa cosa successe anche per le altre materia e tra esse la storia. Milan Kundera (1981), scrisse: “il primo passo per liquidare un popolo è cancellare la sua memoria. Distruggerne i libri, la cultura, la storia”. Possiamo ammettere che i serbi erano sulla buona strada non riconoscendo nessuno status alla lingua albanese. La popolazione albanese cominciò a essere maltrattata dalla polizia e divenne soggetto di discriminazione in tutti gli aspetti della vita. Molte persone furono imprigionate, specialmente gli intellettuali. Quelli che venivano arrestati non potevano avere un avvocato e venivano giudicati a vari anni di prigione, divenendo soggetti a varie umiliazioni e numerose torture. Per non parlare dell’emigrazione forzata di duecentomila persone che dovettero spostarsi in Turchia. In questo contesto i giornali non facevano che parlare della numerosa crescita degli albanesi del Kosovo. La loro propaganda dimenticava che in quella zona la presenza degli slavi non superava il 15% della popolazione nel 1913, invece nel 1950 questa era triplicata. Dopo la prima guerra mondiale il numero dei kosovari era quasi uguale al numero degli albanesi rimasti nei territori dell’Albania, invece nel 1960, a causa della politica sciovinista e del vecchio fenomeno dell’immigrazione venne diminuito drasticamente. Nell’anno 1966, il partito comunista serbo si trovò diviso al suo interno. Questa circostanza portò delle novità per quanto riguarda le condizioni dei kosovari. Tito ammise che i diritti dei kosovari erano stati violati in modo arbitrario e che il responsabile di questa infrazione e dei crimini che ebbero seguito fu Aleksander Rankovic, ministro degli interni insieme ai suoi agenti (Detrez 2004, p. 43). Con il suo allontanamento ebbe seguito l’adozione di nuove misure più liberali per i kosovari. La revisione della costituzione nell’anno 1969, portò diritti eguali per i kosovari come per gli altri gruppi etnici, ma escluse per la millesima volta la possibilità di formare una repubblica autonoma. Il Kosovo e la Vojvodina vennero identificate come “comunità sociali e politiche”. Ciò significava che il Kosovo era ormai un’entità federativa legittima e poteva esercitare le proprie competenze come le altre repubbliche. Il fatto che si potesse mostrare la propria bandiera e che nella nuova Università di Pristina le lezioni si tenessero in entrambe le lingue (serbo-croato e albanese) testimoniò l’importanza dei 63 n.17 / 2007 diritti che questa nuova costituzione aveva portato. Gli albanesi dimostrarono grande fermento nel produrre nuovi giornali e riviste e intrapresero varie ricerche nella lingua albanese. Malgrado il fatto che i professori fossero sottopagati l’università di Pristina crebbe rapidamente diventando la terza università della Iugoslavia. Apparentemente questa situazione sembrava perfetta, ma nella realtà i circoli conservatori serbi continuavano la repressione del progresso dell’educazione e della cultura creata in Kosovo. La polizia iugoslava continuava ad arrestare kosovari e nelle prigioni iugoslave trovavi più kosovari che iugoslavi e tra questi molti scrittori e poeti. La costituzione del 1974, rimasta in vigore fino alla disgregazione della federazione della Jugoslavia nel 1991, cambiò la situazione ampliando ulteriormente i diritti della popolazione in Kosovo. Il primo articolo di questo documento affermava che le province, anche se facenti parte della Repubblica Serba, erano rappresentate ai livelli federativi. Di conseguenza il Kosovo ottenne i diritti, quasi, di uno Stato: si fondò la banca nazionale e ottenne il diritto di intrattenere relazioni a livello internazionale anche se solo entro i confini delle leggi predisposte dalla federazione. Il Kosovo aveva i propri rappresentanti in parlamento, nel governo presidenziale e anche nei tribunali, come le altre repubbliche. Questa costituzione segnò la storia del Kosovo nonostante non possedesse il diritto di staccarsi dalla Repubblica serba, diritto che valeva solo per le repubbliche e non per le province, le quali non potevano scegliere il proprio status. Ma non mancarono le reazioni dei nazionalisti serbi che consideravano tale costituzione come discriminante nei loro confronti, reazione che alterò i rapporti interetnici tra i Serbi e gli Albanesi della Regione. Gli intellettuali albanesi non venivano rispettati dalla classe politica serba, anzi, nella maggior parte delle volte quelli che offendevano gli albanesi, lontani dall’essere criticati venivano lodati e esaltati dall’opinione pubblica dando in questo modo, luogo alla creazione di forti nazionalismi, che ponevano come obiettivo l’umiliazione degli albanesi in modo da proibirli di essere orgogliosi della loro identità. La conseguenza fu una proposta di revisione che riguardava specificamente il potere delle province autonome. Tito non accettò tale proposta e riuscì a mantenere unito il paese anche se all’interno fervevano molti sentimenti nazionalisti che furono soppressi con la forza. Tuttavia, la situazione iniziò a cambiare dopo la sua morte nel 1980, quando apparve chiara sia la crisi del modello politico, sia il fallimento del progetto nazionale. Il nazionalismo, ricomparso già in Slovenia e Croazia, si diffuse in tutte le regioni della Federazione, portando in poco tempo ad una crisi irreversibile. Quando le guerre non finiscono più L’11 Marzo del 1981, gli studenti dell’Università di Pristina invasero le strade della capitale kosovara, denunciando le loro condizioni di vita e la qualità delle mense universitarie. L’arresto da parte della polizia serba di alcuni studenti comportò nuove manifestazioni dove si chiedeva la liberazione dei colleghi incarcerati. In poco tempo la dimostrazione si espanse velocemente investendo altri temi politici e coinvolgendo la massa della popolazione. Per la prima volta i manifestanti chiesero lo status di piena repubblica per il Kosovo. Le forze dell’ordine intervennero in modo brutale e incivile sulla popolazione che manifestava in modo 64 Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo pacifico. Il 2 aprile a Pristina fu proclamato lo stato d’assedio che portò i carri armati per le strade di Pristina. Tutto ciò non fermò la protesta degli albanesi che si intensificarono ulteriormente provocando un bilancio pesantissimo. Non si è mai saputo esattamente il numero delle vittima, alcune fonti parlano di centinaia altri di migliaia. La polizia rimase ancora in Kosovo anche se lo stato d’assedio finì e la conseguenza fu un’ondata di arresti e processi giudiziari. Viene spontaneo in questo momento pensare alle raccomandazioni, fatte nel memorandum dal Vaso Cubrilovic come queste: “i conflitti devono essere prepa ra ti e incora ggia ti …a ttribuendo a loro ra gioni economiche” e poi “reprimerli sa nguinosa mente nella ma niera più effica ce….il ruolo della polizia dovrà essere di estrema importa nza ” (Cubrilovic 1937)24. Il parallelismo tra le sue raccomandazioni e quello che successe nel 1981 in Kosovo è impressionante. Dopo la soppressione sanguinosa delle manifestazioni e la morte di centinaia di connazionali, i kosovari furono privati, pian piano, della loro relativa libertà garantita da Tito nel 1974. Questa volta il target della repressione furono gli intellettuali: scrittori, poeti, studenti e specialmente professori dell’università di Pristina, perché con le loro ricerche intensive nel campo dell’albanologia rilevarono fatti storici veri che mettevano in luce l’origine dei kosovari, dimostrando che non erano una popolazione estranea ma avevano le loro radici li in quei territori. Oltre ad essere licenziati, la maggior parte di essi, furono imprigionati senza un processo legale. Nelle prigioni quasi il 50% degli incarcerati erano kosovari che diventarono oggetto di maltrattamenti. Per la prima volta l’Albania reagì durante il regime comunista, denunciando l’accaduto in uno dei giornali del paese, esprimendo la sua solidarietà agli albanesi del Kosovo, interrompendo definitivamente i legami con la Iugoslavia. Oltre alla violenza, le persecuzioni e il maltrattamento, i serbi diedero inizio alla propaganda razzista. Usando la libertà di stampa seguita dopo la morte di Tito, gli intellettuali serbi pubblicarono scritti prodotti da studi pseudoscentifici, dove si parlava della mentalità arretrata dei kosovari, della violenza da loro prodotta, atti che avevano come scopo la pulizia etnica e lo spostamento dei serbi dal Kosovo. In particolare, sui giornali comparvero articoli che cercavano di denigrare gli albanesi, esemplare fu il caso Martinovic25 sul quale venne pubblicato un libro di 485 pagine e vennero vendute 50000 copie cosa che dimostrava la forma isterica che stava assumendo la campagna denigratoria serba contro gli albanesi. Per non parlare poi della questione dello spostamento dei serbi dal Kosovo che veniva denunciata da loro come genocidio. Nessuno ragionò sulle ragioni vere e proprie dell’allontanamento dei serbi dal Kosovo che era la conseguenza della difficile situazione sociale e della crisi economica post-Tito che colpì la Iugoslavia cosa che portò uno spostamento dalle regioni povere verso quelle più ricche. Le librarie furono riempite con libri di storia nuovi, con delle aggiunte nazionalistiche e razziste come quelli di Batakovic, Bogdanovic, Cosic26. In questi documenti si presentava una Serbia gravemente limitata a causa delle due province autonome che godevano di più libertà rispetto a quello che meritavano, si affermava inoltre che in Kosovo era in corso dal 1981 una guerra aperta e totale contro i serbi, vittime di un genocidio da parte degli albanesi. Nei testi si chiedevano riforme democratiche per la stabilizzazione dello stato di diritto che avrebbe potuto proteggere i diritti di tutti. In questo modo essi esigevano la limitazione 24 Citato in Juka (1984) dove vengono riportati pezzi molto ampi dell’articolo (The expulsion of the Albanians) dello storico serbo Vaso Cubrilovic pubblicato nel marzo 1937. 25 Il primo maggio 1985 venne ricoverato all’ospedale di Pristina, Dorde Martinovic, con una bottiglia rotta infilata nell’ano che secondo lui era stata opera di alcuni albanesi mascherati. 26 Erano conosciuti con il nome Francuska 7 secondo l’indirizzo dove si trovavano per discutere e redigere petizioni diretti al governo della Iugoslavia. Due di essi erano i più conosciuti: La Petizione dei duecento intellettuali serbi diretta al governo Iugoslavo, 21 gennaio 1986 e il Memorandum della Accademia delle Scienze e dell’arte della Serbia dal quale sono stati pubblicati solo due frammenti il 24 e il 25 settembre 1986. 65 n.17 / 2007 27 Santo protettore dei serbi. 66 o come vedremo la sospensione dell’autonomia del Kosovo. Questi libri pubblicati dalla Accademia delle Scienze della Serbia formarono le basi teoriche alla politica nazionalistica che verrà adottata in Kosovo. La persona che usò questo nazionalismo per la propria scalata verso il potere fu Slobodan Milosevic. Infatti, con il suo avvento al potere, la situazione peggiorò ulteriormente, perché incentivò ancora di più la crescita del sentimento nazionalistico serbo alimentato dalla creazione della “Grande Serbia” e il Kosovo in questo caso costituì uno dei nodi principali di tale politica. Infatti, il mito del Kosovo come terra d’origine da recuperare alla totale sovranità di Belgrado, riaccese l’orgoglio nazionalista e il desiderio di riconquista della “terra santa” ovvero la memoria comune. La “riconquista” diventò l’elemento centrale del nazionalismo serbo. Inoltre, salito al potere il nuovo leader rifiuto il sistema federale come responsabile della debolezza economica della Serbia rispetto alle repubbliche del nord. Nel 1989, l’Assemblea della Serbia preparò una serie di emendamenti alla costituzione al fine di limitare le competenze del Kosovo e che avrebbero dato alla Serbia il pieno controllo sulla polizia, sulla giustizia, sulla protezione territoriale, l’educazione e la lingua ecc. Emendamenti che non furono adottati dal parlamento kosovaro posto davanti ad una riduzione delle libertà del popolo kosovaro. Ricominciarono le proteste contro queste proposte legislative che si concretizzarono in diversi scioperi dei minatori e in sospensioni dal lavoro in varie fabbriche, a cui Miloscevic rispose dichiarando lo stato d’assedio per la seconda volta dal 1981. Cominciò una lunga fase di arresti con l’accusa di azioni controrivoluzionarie che per la maggio parte vennero sanzionate con la pena di morte. Il Parlamento kosovaro fu messo di fronte ad una scelta difficile: adottare gli emendamenti o porre sotto un governo militare il Kosovo. Il 23 marzo 1989 l’assemblea provinciale del Kosovo si riunì in circostanze anomale, circondata da carri armati e blindati, dove forze di sicurezza e funzionari del partito comunista serbo, parteciparono alla votazione. In questo modo fu ottenuta l’approvazione dal parlamento di Pristina, necessaria per approvare gli emendamenti costituzionali che avrebbero tolto ogni reale autonomia al Kosovo. Agli occhi della popolazione serba sembrò che il Kosovo aveva deciso autonomamente di limitare la propria autonomia tramite un processo democratico. La ratifica finale degli emendamenti fu poi votata il 28 marzo a Belgrado: da questo momento il Kosovo venne governato de fa cto da Belgrado. Iniziarono così le proteste e gli scioperi dei kosovari che coinvolsero tutti i gruppi sociali e contemporaneamente iniziarono gli arresti di massa, la violenza e gli omicidi senza limiti. La costituzione serba dell’anno 1990 vietò l’utilizzo della lingua albanese in tutte le scuole e nell’Università di Pristina che venne trasformata nella Scuola di studi superiori Sveti Sava27. Gli albanesi non poterono più vendere oppure comprare beni immobiliari senza l’autorizzazione delle autorità serbe. A tutte le istituzioni albanesi venne tolto ogni genere di potere e l’Assemblea del Kosovo perse ogni diritto di votare i nuovi emendamenti alla nuova Costituzione della Serbia. Tanti albanesi furono licenziati soprattutto il personale ospedaliero perché aiutavano di nascosto le persone che avevano subito la violenza serba. Allo stesso tempo venne chiusa l’Accademia delle Belle Arti Albanese. Il parlamento serbo aveva come punto fondamentale del suo programma l’uniformazione di tutte le scuole in Kosovo, le quali furono obbligate ad usare come lingua solo il Serbo, per annientare così ogni diritto degli albanesi e di conseguenza l’essere albanesi. Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo Questa politica arbitraria seguita dai serbi, riducendo i diritti agli albanesi in Kosovo e trattandoli come cittadini inferiori di fronte ai cittadini serbi, alimentò un continuo sentimento di rivolta. Il 2 luglio del 1990, l’Assemblea del Kosovo dichiarò quest’ultimo un’entità indipendente con diritti uguali a livello federativo. Come risultato le autorità serbe soppressero sia l’Assemblea che il governo del Kosovo, eliminando così le ultime speranze di autonomia. Tuttavia i membri dell’Assemblea si riunirono di nuovo in segreto nella città di Kacanik, il 7 di settembre del 1990, e approvarono la “Costituzione della Repubblica del Kosovo”, si sancì che la legge serba sarebbe valsa solo se non avesse violato le disposizioni della costituzione albanese. La reazione serba fu la solita: arresti, persecuzioni e omicidi. Un anno dopo, l’Assemblea organizzò un referendum, il quale confermò la sovranità e l’indipendenza della “Repubblica del Kosovo”. Il 26 maggio 1992, i kosovari svolsero elezioni parlamentari e presidenziali che portarono alla creazione delle istituzioni del governo e del parlamento e il capo del partito La Lega Democratica del Kosovo, Ibrahim Rugova, fu eletto presidente della Repubblica. In uno dei suoi discorsi egli affermò: “Rima nere soggetto a lla Serbia non è una soluzione. La Iugosla via è sta ta fra ntuma ta e a ssieme a essa la possibilità che noi possia mo dipendere da essa ” (AA. VV. 1996, p. 122). Il Kosovo non fu mai riconosciuto come stato da parte dei membri della comunità europea e quella internazionale, l’unico Stato a riconoscere il Kosovo fu l’Albania. I kosovari boicottarono le elezioni serbe e non vollero partecipare alla vita politica serba perché avrebbe significato giustificare il diritto dei serbi sul Kosovo. Essi pensavano che un incontro tra i governi sarebbe stato possibile solo in un terreno neutrale al di fuori dei confini. Questa proposta kosovara venne rifiutata dai serbi, perché sarebbe sembrato un riconoscimento dello Stato kosovaro da parte serba. Nonostante ciò il governo del Kosovo continuava ad operare anche di fronte alle grandi difficoltà organizzative: vennero aperte scuole nella lingua albanese utilizzando come edifici le abitazioni della popolazione e allo stesso tempo continuarono le proteste per la riapertura delle scuole in Kosovo. Di conseguenza il capo di governo serbo Panic invitò Rugova a discutere della soluzione del problema delle scuole. Con la presenza delle delegazioni straniere essi si incontrarono a Pristina e dall’incontro uscirono risultati modesti ma anche questi non vennero applicate, perché Miloscevic avvisò subito Panic che non era di sua competenza la risoluzione delle questioni interni alla Serbia. Un sistema sanitario provvisorio venne creato con i finanziamenti provenienti dagli emigrati kosovari che sostenevano il loro paese dall’estero. Questo stato parallelo creato da Rugova e la sua strategia politica pacifica che puntava al riconoscimento della Repubblica del Kosovo come entità indipendente, non durò molto. Di fronte alle atrocità che i serbi commettevano in Kosovo ogni giorno, questa strategia fallì, costringendo molti kosovari che ancora credevano nell’indipendenza, a sostenere i gruppi che proponevano politiche radicali. Case distrutte, scuole, ospedali, case editrici che non potevano più lavorare, tutti i funzionari dello stato che sostenevano la causa dell’indipendenza del Kosovo furono licenziati, i serbi cominciarono a trasferirsi in Kosovo per scacciare la popolazione albanese. Oltre a questa violenza e il terrore della politica di Milosevic esistevano 67 n.17 / 2007 altre ragioni che portarono i kosovari a sostenere questi gruppi. In questo periodo Slovenia e Croazia raggiunsero l’indipendenza e non seguirono una politica difensiva anzi il conflitto aperto con la Serbia fu la modalità seguita da questi nuovi stati. Così in breve tempo l’opinione degli albanesi cambiò, convincendosi che anche per il Kosovo, la via migliore sarebbe stato il conflitto armato. Il 14 dicembre 1995, Izetbegovic, Miloscevic, Tudman stipularono il Trattato di Pace in Bosnia – Erzegovina dove la Comunità Europea assieme agli Stati Uniti imposero la soluzione finale per l’ex Jugoslavia, senza però menzionare in nessun momento la soluzione per il Kosovo. Gli albanesi del Kosovo si sentirono di conseguenza ignorati e abbandonati e non ebbero nessun riconoscimento per la loro resistenza pacifica. Inoltre, la fuga di 200000 serbi dalla Krajina, a causa dell’esercito croato, fece capire che i serbi potevano essere sconfitti. La politica della resistenza pacifica, seguita dagli albanesi, lasciò posto agli attacchi armati. Inizialmente furono attacchi sporadici ma presto la situazione cambiò. Nel 1997, un gruppo di guerriglieri, che si definì con il nome U.C.K (Ushtria Clirimare e Kosoves) fece degli attentati armati alle stazioni di polizia serba. Il loro obbiettivo era la liberazione del Kosovo anche con la guerra. I serbi reagirono inviando le forze militari pesanti in Kosovo, le quali realizzarono omicidi di massa senza alcuna distinzione tra gente armata e popolazione civile. Il territorio del Kosovo subì forti sconvolgimenti demografici, intensificatisi alla fine degli anni Novanta a causa della “pulizia etnica” serba. Essi devastarono villaggi interi, uccidendo tutti i componenti dei villaggi, senza risparmiare donne e bambini. Soprattutto nei villaggi della Drenica il numero delle vittime fu altissimo, 80 morti e tra questi 12 bambini e 14 donne. Per tutto l’anno 1997 e quello successivo si susseguirono massacri senza mai interrompersi, Decan, Pej, Racak ecc. Le esecuzioni di civili e la evacuazione di interi villaggi provocò massicci esodi di profughi verso i paesi limitrofi e verso l’Europa, soprattutto Italia, Germania e Turchia. Il numero aumentava con l’aumentare dei massacri. Il conflitto che andava sempre più accentuandosi e il rischio che il conflitto nel Kosovo si espandesse nel resto dei Balcani, mobilitò la diplomazia internazionale: nel marzo 1998 si riunì a Londra il Gruppo di contatto – istituito per vigilare sulla pace nell’ex Iugoslavia e formato da Stati Uniti, Russia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia – che decisero (con il parere contrario della Russia) di imporre alla Serbia sanzioni economiche e l’embargo di armi, minacciando un intervento militare diretto nel Kosovo se la Serbia non avesse accettato il ritiro delle proprie forze di polizia e l’avvio di un negoziato di pace con i rappresentanti albanesi. Nel maggio 1998 gli Stati Uniti inviarono a Belgrado il mediatore Richard Holbrooke – già intervenuto negli accordi di Dayton che conclusero la guerra civile iugoslava – con l’incarico di favorire le trattative tra le parti in conflitto. Nel settembre dello stesso anno, il Consiglio di sicurezza dell’ONU votò la risoluzione 1199 finalizzata al cessate il fuoco, ammonendo il governo di Belgrado, nel contempo la NATO avviò i preparativi per un intervento militare diretto. In ottobre si aprì il primo tavolo di negoziati, che si conclusero con la firma di un accordo per il cessate il fuoco e per il ritiro delle truppe serbe dalla regione, a garanzia dell’attuazione dell’accordo di pace furono inviati nel Kosovo più di 2000 osservatori dell’OSCE. La palese violazione dell’accordo nei mesi seguenti, con il ripetersi degli scontri, 68 Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo degli esodi di popolazione e le stragi di civili albanesi da parte delle milizie serbe, costrinse la diplomazia internazionale, a richiamare le parti in conflitto ad un incontro, che si svolse dal 6-23 di febbraio del 1999 nel castello di Rambouillet, nei pressi di Parigi sotto la sorveglianza del Gruppo di Contatto e con la partecipazione delle delegazioni serbe e albanesi. Il piano formulato dal Gruppo di contatto prevedeva la concessione di un’ampia autonomia al Kosovo nel rispetto della sovranità serba sulla provincia, il disarmo dell’UÇK e il dispiegamento di una forza multinazionale di pace sotto l’egida della NATO che garantisse il rispetto dell’accordo politico. Il Kosovo da quel momento avrebbe potuto intrattenere relazioni internazionali, nonostante fosse un’ entità sottostatale. Lo status del paese era da considerarsi una via tra una provincia autonoma ed una repubblica parte della RFJ. Nonostante la comunità internazionale face una grande pressione affinché i kosovari e serbi rispettassero il trattato di Rambouillet, nessuna delle parti fu soddisfatta, poiché entrambe rivendicavano le proprie pretese. Dopo forti pressioni diplomatiche, la delegazione albanese decise di firmare il trattato, mentre quella serba rifiutò nonostante il rischio di azioni militari da parte dei Paesi della NATO nei suoi confronti. Infatti, dal 24 marzo fino il 10 giugno 1999 la NATO intraprese una serie di bombardamenti sul tutto il territorio della Iugoslavia. Dopo 78 giorni di bombardamenti, fu raggiunto un accordo che prevedeva: la cessazione dei raid aerei della NATO, il simultaneo ritiro delle forze serbe dal Kosovo e il dispiegamento di una forza internazionale di pace (KFOR) composta di truppe dei paesi membri della NATO e della Russia (per un totale di 50.000 uomini). Così, la Repubblica Federale Iugoslava, accettò le condizioni proposte dai paesi del G-8 e il Consiglio di Sicurezza istituì la risoluzione 1244 nel giugno del 1999 intesa ad autorizzare l’intervento della forza di pace per permettere ai profughi di far ritorno in patria che solo in Albania, nel 1999 erano già 100000. Questa risoluzione segnò la fine del conflitto armato e pose il Kosovo sotto l’amministrazione dell’ONU28. La ratifica del Trattato di Rambouillet, siglata il 3 giugno 1999 da parte dell’Assemblea della Serbia a Kumanova, produsse la creazione di un’Amministrazione Temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo (UMNIK) come parte civile internazionale, mettendo al primo posto l’obiettivo di creare una amministrazione a d interim sotto la quale il popolo del Kosovo potesse godere di una sostanziale autonomia all’interno della Repubblica Federale Iugoslava. Allo stesso tempo si decise che sarebbe stata compito della parte civile internazionale il controllo dello sviluppo delle istituzioni democratiche provvisorie di autogoverno. Inoltre vennero stabilite una serie di funzioni specifiche ordinate in quattro “pilastri” ciascuno dei quali venne assegnato ad una organizzazione internazionale. L’amministrazione civile fu assegnata alle Nazioni Unite, mentre dell’institution building venne incaricata l’OSCE. L’UNHCR condusse il rientro dei rifugiati, degli sfollati e la fornitura degli aiuti umanitari invece l’Unione europea gestì la ricostruzione economica del paese. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite poneva come priorità il rispetto dell’integrità territoriale e la sovranità della Repubblica Federale Jugoslava sul Kosovo e l’avvio della realizzazione di una reale autonomia e di una efficace autoamministrazione. Fu chiesto all’amministrazione civile provvisoria guidata dall’UNMIK di assolvere i compiti per la loro attuazione. Svolgere le funzioni 28 Per maggiori informazioni si veda United Nations Security Council, Resolution 1244, 10 June 1999. 69 n.17 / 2007 29 Si veda UNMIK, Constitutional Framework. Constitutional Framework for provisional selfgovernment, UNMIK/REG/2001/9 – 15 MAY 2001. 70 amministrative civili di base era la funzione principale richiesta all’UNMIK per promuovere l’instaurazione di forme di autonomia e autogoverno sostanziali. Tra i suoi compiti figurava la facilitazione del processo politico che avrebbe portato alla determinazione del futuro status del Kosovo, la coordinazione dell’assistenza umanitaria fornita dalle varie agenzie internazionali e la ricostruzione delle infrastrutture fondamentali. Sotto la sua competenza vi era il mantenimento dell’ordine e della legalità, la promozione dei diritti umani e assicurazione del libero e sicuro ritorno di tutti i rifugiati e sfollati alle proprie case in Kosovo (Muharremaj 2006). Il passo successivo fu il graduale trasferimento delle responsabilità dalla comunità internazionale agli organi amministrativi kosovari per la creazione delle istituzioni statali temporanee del Kosovo, come previsto dalla Risoluzione 1244. Il regolamento 2001/9 dell’UMNIK pose le basi per il trasferimento delle responsabilità alle istituzioni temporanee per l’auto-governo. In sostanza, l’UNMIK trasferì alle neonate istituzioni di autogoverno solamente alcune funzioni amministrative (e non politiche), non trasferendo così la propria autorità. Questo fu un passaggio importante perché sottolineava come i poteri tipici di uno stato sovrano fossero ancora nelle mani dell’amministrazione internazionale. Questo documento pose le basi per la creazione di una costituzione provvisoria anche se l’uso del termine Costituzione venne rifiutato dall’UMNIK che precisa, “Constitutiona l Fra mework for Provisiona l Self-Government”. Esso rappresenta un documento di grandissima importanza, nel quale venne dichiarato che il Kosovo è “una entità sotto a mministra zione interna ziona le che, con il suo popolo, ha ca ra tteristiche storiche, lega li, cultura li e linguistiche uniche”, a ggiungendo che è “un territorio indiviso sul qua le le Istituzioni Provvisorie di Auto-Governo devono esercita re le loro responsa bilità ” 29. Quale status per il Kosovo? Diversamente da quello che successe in Bosnia con gli accordi di Dayton, in Kosovo non fu possibile trovare una soluzione definitiva per il suo status. La risoluzione 1244 affidò il compito di creare le premesse per la definizione dello status all’Amministrazione Internazionale che elaborò la teoria degli “sta nda rds before sta tus”. Ovvero la possibilità di dialogare sullo status sarebbe potuta iniziare solo quando la società civile e le istituzioni kosovare avessero raggiunto gli standards di democraticità richiesti dall’Amministrazione Internazionale. Il 10 dicembre del 2003, l’UNMIK presentò il documento intitolato “Sta nda rds for Kosovo”, in cui furono elencati gli obiettivi da raggiungere. La creazione di istituzioni provvisorie liberamente, onestamente e democraticamente elette, che governino in modo imparziale, trasparente e responsabile e che possono rappresentare i bisogni di tutte le comunità era l’obiettivo principale che il documento proponeva. Inoltre, esso poneva la condizione che anche gli sfollati e i rifugiati fossero inclusi nel processo elettorale. Particolare attenzione viene dedicata ai media e alla società civile per la creazione di un sistema pluralistico di media privati ed indipendenti, controllati da una autorità regolatrice indipendente. Il documento impone la formazione di una società in cui qualsiasi forma di incoraggiamento all’odio interetnico sia condannata dal mondo politico, dai media e dalla stessa autorità. Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo Per quanto riguarda il secondo obiettivo veniva richiesta la messa in atto di una sola struttura legale e di una effettiva politica di imposizione della legge. In sostanza un sistema in cui la polizia , il potere giudiziario e il sistema penale possono agire imparzialmente e nel pieno rispetto dei diritti umani, creando un sistema di giustizia uguale per tutti e da tutti ugualmente accessibile. La libertà di movimento invece, prevedeva il diritto per tutti gli individui di qualsiasi etnia di viaggiare, lavorare e vivere in sicurezza e in assenza di minacce o di paura di attacchi, maltrattamenti o intimidazioni. Un altro aspetto importante era quello del libero uso della propria lingua ovunque in Kosovo, nonché il dovere delle istituzioni di emanare documenti in tutte le lingue ufficiali. Per quel che concerneva gli sfollati e rifugiati che abbiano il desiderio di ritornare, essi dovranno essere in grado di farlo in condizioni di sicurezza e di dignità e dovranno poter essere in grado di partecipare pienamente alla vita politica, economica e sociale del Kosovo. Inoltre venne creata una organizzazione civile di emergenza in caso di calamità: Kosovo Protection Corps. Lo sviluppo di un’economia di mercato competitiva e sostenibile era uno dei punti cardine del documento che prevedeva la sua messa in atto ed l’implementazione, ponendo come obbiettivo finale il raggiungimento degli sta nda rds economici europei. Per incoraggiare il ritorno di tutte le comunità etniche il testo precisava un’onesta applicazione del diritto di proprietà che richiede la messa in atto di una legislazione effettiva e di meccanismi efficaci di risoluzione delle dispute sulla proprietà. L’aspetto più importare e allo stesso tempo più difficile da realizzare era e rimane la costruzione di un duplice dialogo costruttivo e continuo. Oltre al dialogo tra le istituzioni provvisorie di autogoverno e Belgrado sulle tematiche concrete, era indispensabile la creazione di un Kosovo come “attore attivo” nella cooperazione e nei rapporti tra le regioni30. Oggi il Kosovo ha raggiunto alcuni degli sta nda rds sopraelencati, ma il sogno di un Kosovo pacifico e multietnico è ancora lontano dall’essere realizzato. La popolazione albanese si è stancata di aspettare la decisione dell’amministrazione internazionale, incapace di risolvere il problema dello status. Infatti, sono passati otto anni e la soluzione dello status non è ancora pronta. Le conferenze tenutesi in questi anni hanno proposto delle soluzioni ogni volta respinte dall’intervento di veti dimostrando la debolezza della diplomazia internazionale basata ancora sui rapporti di forza. Questa stasi ha influenzato negativamente i rapporti tra le due etnie mantenendo ancora vivi i vecchi rancori. Anche se il dialogo ha avuto inizio le due etnie con a fianco i loro storici alleati non si discostano dalle loro posizioni. Da una parte i Serbi decisi a non perdere l’integrità territoriale e dall’altra i kosovari che reclamano la loro indipendenza. La convergenza delle due posizioni totalmente contrarie aspetta alla comunità internazionale, un compito molto complesso ma il mantenimento dello status quo non è una soluzione e non accontenta nessuna delle parti né gli albanesi e né i serbi. L’ultima soluzione proposta non soddisfa ancora nessuna delle due posizioni ma dà la possibilità alle due etnie di iniziare a voltare pagine lasciando alle spalle secoli di guerre, sperando che un Kosovo multietnico non rimanga un’utopia. 30 UNMIK, Standards for Kosovo, UNMIK/PR/1078, 10 December 2003 71 n.17 / 2007 Bibliografia Letteratura albanese: AA VV. (2003) Historia e popullit shqipta r (tr. It. Storia del popolo albanese), Toena, Tirana; AA VV. (1996) Pa qe e pa perfundua r (tr. It. Pace non raggiunta), Shtepia e librit, Tirana. Academy of Sciences of Albania (1998), Pla tform for the Solution of the Na tiona l Alba nia n Question , Tirana; Biberaj E. (2001) Shqiperia ne tra nzicion: Rruga e veshtire drejt Demokra cise (tr.it L’Albania in transizione: La difficile strada verso la Democrazia ), Ora; Ceka N, Korkuti M. (1998) Arkeologjia (tr.it Archeologia), shblu, Tirana; Cela M. (2002) Mes Kosoves dhe Epirit (tr.it Tra il Kosovo e l’Epiro), Uegen; Celmeta M. (2001), E drejta per vetvendosje e shqipeta reve te kosoves (tr.it. Il diritto di autodeterminazione degli albanesi del Kosovo), Flesh; Detrez R. (2004) Kosova – Lufta e shtyre (Kosovo – La guerra rimandata), Skanderbeg books; Dode L. (2006) Kosova ne qendrimet e Enver Hoxhes (tr.it. Il Kosovo e l’atteggiamento di Enver Hoxha), Medaur; D’Angély R. (1998), Enigma , (tr.it. L’enigma),Toena; Elezi M. (1999) Kosova midis politikes dhe rea lpolitikes (tr.it. Il Kosovo tra la politica e la realpolitica), Botimpex; Gjecovi Xh, (1998) Shteti shqipta r dhe ceshtja e Kosoves (tr.it. Lo Stato albanese e la questione del Kosovo), Botimpex; Gjeorgjevic S. (2004) Deshmi mbi Kosoven (tr.it. Testimonianza sul Kosovo), EuroRilindja; Hadri A. (2003) Ma redheniet shqipta re-jugoslla ve” (Le relazioni tra Albania e Iugoslavia), Tirane, Seksioni i shkencave shoqerore; Kadare I. (2004) Poshterimi ne Ba llka n (tr.it. L’umiliazione nei Balcani), Onufri; Kadare I. (2006) Identiteti europia n i shqipta reve (tr.it. L’identità europea degli albanesi), Onufri; Faik Konica. (1897) Alba nia , n. 2; Malltezi L, Ndreci P. (1996) Ma redheniet shqipta re-jugoslla ve 1945-1948 (tr.it. Le relazioni iugoslavo-albanesi 1945-1948), Tirane, Drejtoria e pergjithshme e arkivave; Mero B.(1998) Shqiperia dhe lufta ne Kosovo (tr.it L’Albania e la guerra del Kosovo), Koha; Muhaj A. (2000) Kosova : rruga e na tyrshme drejt pa va rsise – Zhvillimet politike ne vitet 1989-1999 (tr.it. Il Kosovo: la strada verso l’indipendenza – lo sviluppo politico negli anni 1989-1999), Albagen; Muharremaj E. (2006) Sta tusi ligjor i Kosoves nen a dministrimin e Kombeve te Ba shkua ra (tr.it. Lo status normativo del Kosovo sotto l’amministrazione delle Nazioni Unite), Mirgeeralb; Pasini C. S. (2004) Lufta e Kosoves 1999 (tr.it. La guerra del Kosovo 1999), Geer; Qosja R. (1999) Pa qja e pergja kshme (tr.it. Pace sanguinosa), Toena; Qosja R. (1990) Populli i nda lua r (Popolo proibito), Mega Medium; Shaban S. (1998) Kosova ne Gjeopolitike (tr.it. Il Kosovo nella geopolitica), Dritero; 72 Blerina Brami Rassegna critica della letteratura albanese sul Kosovo Sokoli A. (2001) Kosova dia log (tr.it. Kosovo Dialogo), Toena; Udovicki J, Ridgeway J. (1998) Ma nkthi etnik i Jugoslla vise (tr.it. L’ansia etnica della Jugoslavia), albin, Tirana; Vasa Pashko. (1989) Vepra , vol. I, (tr.it. Opere), Rilindja, Prishtinë; Verli M. (2006) Nga Kosova per Kosoven (tr.it. Dal Kosovo per il Kosovo), Botimpex; Letteratura in altre lingue: Bogdanovic D. (1986) The Kosovo question pa st a nd present, Knijia o Kosovu: Serbian Academy of Sciences and Arts; Conte F. (1991), Gli Sla vi. Le civiltà dell’Europa centra le e orienta le, Einaudi, Torino; Fisher H.A.L. (1973), Storia d’Europa , volume I, Laterza; Halbwachs Maurice. (1997), I qua dri socia li della memoria , Ipermedium, Napoli&Los Angeles; Hannah Arendt. (1989), Origini del tota lita rismo, Edizioni di Comunità, Milano; Jr. Fine, V.A. John. (1982), The Ea rly Modern Ba lka ns: A Critica l Survey from the Sixth to the la te Twelfth Century, University of Michigan Press; Juka S. Sophie (1984), The Alba nia ns in Yugosla via in light of historica l documents, edited in New York; Juka S. Sophie. (1992), Tha t wa s Yugosla via , Juka Publishing Co. Inc, Hamburg; Kundera M. (1981), The Book of La ugher a nd Forgetting, Knopf, New York; Malcolm N. (1998), Storia del Kosovo, Bompiani, Milano; Malcolm N. (2000), Storia della Bosnia . Da lle origini a i giorni nostri , Bompiani, Milano; Pirjevec J. (2001), Le guerre Jugosla ve 1991-1999, Einaudi ,Torino; Srbljanovic B. (2000), Dia rio da Belgra do, Baldini & Castoldi; Tylor, E.B. (1985-1988) Alle origini della cultura , Edizioni dell’Ateneo, Roma; UNMIK, Constitutional Framework. Constitutional Framework for provisional self-government, UNMIK/REG/2001/9 – 15 MAY 2001; UNMIK, Standards for Kosovo, UNMIK/PR/1078, 10 December 2003; UNMIK, Kosovo Standards Implementation Plan, 31 March 2004; UNMIK, Working Group On Local Government, Framework for the Reform of Local Self-Government in Kosovo, 19 July 2004; United Nations Security Council, Resolution 1244, 10 June 1999. [email protected] 73 Federica Dallan Rassegna critica della letteratura internazionale sul Kosovo: lettura in chiave identitaria del contesto socio-politico kosovaro Focus: Kosovo 1 Un segnale di indeterminatezza socio-politica è dato dal fatto che l’incertezza relativa allo status futuro si riproduce anche a livello di applicazione del regime dei visti. Nei primi tre anni che seguono il conflitto del 1999, infatti, solamente un ristretto numero di stati riconosce i documenti di viaggio UNMIK, a testimonianza di come la mancanza di un chiaro assetto politico comporta per il popolo insediato in Kosovo difficoltà di spostamento all’esterno della provincia. Per un maggiore approfondimento di tale questione, si veda ICG (ICG 2005). 2 Si veda Unscr, Resolution 1244 (1999), New York: UNSCR, S/RES/1244 (1999), 10 June. 3 Risulta comunque necessario porre in evidenza alcune considerazioni rispetto alla risoluzione 1244: quest’ultima, infatti, prevede “substantial autonomy and meaningful self-administration for Kosovo” ma conferma “the commitment of all Member States to the sovereignty and territorial 74 Oggi numerose sono le prospettive analitiche attraverso le quali il contesto socio-politico caratterizzante il Kosovo viene indagato e approfondito: le definizioni che lo contraddistinguono sono molteplici (protettorato internazionale, quasi-stato, stato fuori legge…) e ciò indica il suo essere in transizione e in un limbo dai contorni indefiniti. A testimonianza dell’indeterminatezza politico-istituzionale1 che lo rappresenta, basti pensare all’esistenza di una discrepanza tra il Kosovo così come definito giuridicamente e il Kosovo così come si presenta in una dimensione reale. Infatti, se si considera come riferimento la risoluzione 1244 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 10 giugno 1999, a conclusione dello scontro bellico scoppiato nel marzo dello stesso anno, si afferma l’impegno degli Stati membri verso il mantenimento della sovranità e dell’integrità della Repubblica Federale della Jugoslavia2. Dunque, stando al testo prima citato3, il Kosovo è ancora parte integrante della Serbia ma se si abbandona la dimensione giuridica e ci si affaccia al contesto reale, alcune voci accademiche considerano oggi il territorio come protettorato internazionale, di fatto staccato dallo stato serbo. Basti pensare a chi, come Dusan Janjic, direttore del Forum per le relazioni etniche di Belgrado, dichiari che il Kosovo sia già di per sé un’entità separata e dunque non si profila la necessità per tale area e per il popolo in essa insediato di ricercare uno status indipendente poiché questo esiste in una dimensione contingente.4 Questa breve parentesi iniziale mira semplicemente a mettere in luce alcune precisazioni di tipo scientifico poiché, proprio in riferimento a tale contesto, non emergono risposte univoche e immagini chiare e nitide, tanto che l’indagine qui di seguito riportata risulta, nella sua totalità, percorsa da flussi in opposizione, da valutazioni che danno vita a interpretazioni bi-direzionali, comportando un continuo ribaltamento e ripensamento del quadro identitario. Ciò risulta particolarmente evidente se si richiama l’interrogativo che attraversa il presente lavoro, legato al tentativo di comprendere il panorama delle identità caratterizzanti la provincia, attraverso una riflessione circa il carattere mono o multi-etnico della stessa. Dunque, l’analisi che qui si propone poggia su una logica scientifica per così dire duale in quanto, proprio per evitare di produrre un’indagine approssimativa e poco attenta alla molteplicità di prospettive analitiche a disposizione con cui “affrontare” il Kosovo, si cerca di presentare, nella sua globalità, un sistema caratterizzato da immagini dissonanti e da percorsi spesso antitetici. Il desiderio di effettuare un lavoro il più aderente possibile alla varietà del contesto ter- Federica Dallan Rassegna critica della letteratura internazionale sul kosovo ritoriale di riferimento, si evidenzia nel tentare di focalizzare l’attenzione non solo su percorsi univoci d’indagine ma nel cercare sempre di creare disequilibri e mettere sotto una lente d’analisi critica le teorie descritte. A seguito di simili puntualizzazioni, si tratta ora di sottolineare come qui l’obiettivo ultimo sia legato alla volontà di produrre una sorta di diagnosi del contesto socio-politico di riferimento, in vista di una maggiore comprensione delle diverse modalità d’intervento che si profilano in relazione alla definizione di uno status per la provincia. In altre parole, ci si chiede se il Kosovo si presenta oggi come una realtà composita e variegata o, al contrario, si delinea come territorio caratterizzato da una conformazione identitaria dicotomica e polarizzata? La risposta a tale interrogativo permette di effettuare un’analisi posizionandosi su diversi livelli di riflessione: a) approfondimento dell’andamento dei processi di identificazione, in particolare attraverso un dialogo tra dimensione religiosa e dimensione etno-nazionalista; b) valutazione dell’esistenza di reali forme di coesistenza e di cooperazione tra i diversi gruppi, che ci permettano quindi di capire se si possa effettivamente parlare di realtà “mosaicata” in Kosovo; c) comprensione dei tentativi di ridefinizione in chiave monoetnica del quadro delle identità in Kosovo, percorso che porterà a valutare se le categorie d’appartenenza sono così rigide e di difficile superamento o al contrario sia possibile intravedere forme di mobilità e fluidità che trascendono le diverse affiliazioni del singolo. Ciò sarà supportato da un approfondimento circa i processi volti alla creazione di spazi territoriali sulla base di appartenenze identitarie nazionali. 1.1. Premessa di lavoro: ripristino del concetto di identità Prima di dare avvio all’analisi socio-politica legata alla valutazione dell’andamento dei processi di maturazione delle identità in Kosovo, risulta utile sottolineare alcune considerazioni, in linea con presunte obiezioni che potrebbero essere mosse alla base scientifica da cui trae spunto il presente lavoro. Ciò che a prima vista si potrebbe rilevare, in maniera critica, rispetto all’indagine qui proposta, è il carattere ambiguo e fonte di conflittualità politica assunto dal concetto di identità, la cui mera evocazione spesso rimanda a visioni del mondo etnocentriche o all’esistenza di crociate ideologiche contro gli “altri” (Cerutti 2002, p. 23). Perché, dunque, a motivo dell’esistenza di simili rischi analitici, si decide di effettuare un approfondimento del contesto kosovaro, partendo proprio da un fra mework concettuale che pone l’appartenenza identitaria come variabile centrale? Per poter rispondere a tale quesito, risulta necessario scardinare le immagini peggiorative del valore dell’identità, prima evidenziate, rifacendosi a due livelli di approfondimento: a) processo di integrazione europea e conseguente delegittimazione delle politiche d’identità, soprattutto nella loro accezione nazionale; b) valorizzazione, nel dialogo dicotomico tra ragione e identità, della prima dimensione sulla seconda. In riferimento al primo ordine di considerazioni, è doveroso mettere in luce come il percorso unificatore europeo, fin dalla sua esplicazione iniziale, si lega ad una riformulazione delle identità nazionali e, proprio in virtù di definire un quadro identitario più ampio, gli stati-nazione gradualmente si svuotano di significato. L’assunto per cui l’esistenza delle identità nazionali debba essere sgreto- integrity of the Federal Republic of Yugoslavia”. In realtà, l’aver sancito l’inviolabilità dei confini dello stato serbo, configurabile come elemento che può bloccare il processo di avanzamento nella definizione di uno status futuro, è stato interpretato non sempre nel senso di un impedimento del tentativo di rafforzare la separazione del Kosovo. Infatti, la risoluzione 1244, dopo aver dichiarato l’impegno a conservare i confini esistenti, rimanda all’Atto finale di Helsinki e all’Annesso 2 della risoluzione stessa. Il primo sancisce “equal recognition of a state’s right to sovereignty and territorial integrity” ma anche “minority people’s right to self-determination”. Anche l’Annesso 2 inserisce il rispetto dei confini della FRY all’interno di un contesto che favorisca “interim political framework agreement providing for substantial self-government of Kosovo”. Da ciò ne deriva che rientra nel mandato legale dell’UNMIK il trasferimento di autorità al governo provvisorio in Kosovo (Bugajski, Hitchner, Williams 2003). 4 Si tratta di dichiarazioni rilasciate a seguito di un’intervista in cui Janjic, uno dei maggiori esperti serbi di Kosovo, traccia alcune considerazioni circa l’odierna situazione della provincia. Per una versione integrale dell’intervista, si veda Zanoni L. (2006), Il Kosovo alla deriva, www.osservatoriobalcani.org. 75 n.17 / 2007 lata, a favore di progetti integrativi, si pone sullo stesso piano di una chiusura, che si registra a livello accademico, circa la problematica della nazione, dei nazionalismi e delle politiche d’identità, definiti come elementi legati a contesti politici ormai superati. In particolare, una simile marginalizzazione scientifica rispetto a tali concetti viene sottolineata, da un lato, dal paradigma liberale, che considera la nazionalità come variabile incompatibile con il pluralismo culturale, in quanto l’esistenza di una società caratterizzata dal dominio di una nazione, comporta non solo la difficoltà di garantire uguale rispetto alla varietà di tradizioni in essa presenti ma anche lo sgretolamento della competizione e dello scambio che da tale diversità scaturisce (Miller 2000, p. 33). Dall’altro, si tratta del paradigma marxista che, considerando la dimensione economica e l’appartenenza di classe come elementi prioritari di identificazione, riduce in un contesto d’analisi secondario la portata del ba ckground culturale su cui poggia l’identità dei singoli. Nel periodo 1945-1989, i problemi legati all’identity e alle politiche su di essa poggianti, sono presenti ma non assumono mai una configurazione prioritaria nell’agenda politica; un simile confinamento secondario dell’identità, però, soprattutto in seguito alla dissoluzione del mondo bipolare e all’emergere di istanze etno-nazionaliste nell’Europa centro-orientale, subisce un forte scossone che comporta un ripensamento del ruolo stesso delle appartenenze identitarie. Paradossalmente, è proprio il progetto sopranazionale europeo, sorto come tentativo di superamento della centralità delle identità territoriali che, nel suo percorso attuale di riconfigurazione della propria anima, spinge verso un ripensamento dell’importanza dell’identity, contribuendo a ridare vitalità al dibattito. Oggi, infatti, gli studi europei, finora caratterizzati da una focalizzazione sugli aspetti meramente economico-finanziari del processo di integrazione, si stanno indirizzando verso un percorso analitico volto a indagare la questione dell’identità politico-culturale dell’Europa. Quest’ultima, soprattutto a motivo dell’attuale fase di allargamento, non può mostrarsi indifferente rispetto al rapporto esistente tra le ampie identità collettive, soprattutto nazionali, presenti al proprio interno, e l’emergente identità europea. Dunque, la nuova e approfondita riflessione che l’Unione Europea sta compiendo su se stessa, in virtù della ricerca di valori altri rispetto a quelli meramente economici, che contribuiscano a rendere la sua esistenza più pregna di significato, non fa altro che ripristinare la centralità di un concetto, quale l’identità, per lungo tempo considerato ai margini della policy a genda e degli studi accademici. Il secondo ordine di considerazioni, in grado di spiegare il motivo per cui facili si profilerebbero le critiche ad un lavoro poggiante su rielaborazioni del concetto di identità, è legato all’esistenza di un’interpretazione riduttiva circa la portata, in termini di razionalità, delle appartenenze identitarie. L’attenzione qui viene posta sull’indagine della relazione esistente tra rea son e identity (Schöpflin 2000) e sul ruolo di entrambi nella definizione del potere politico. Entrambi si presentano come autentici, nel senso di essere in grado di conferire significato e dare valore alla politics ma ciò che si profila, nel dibattito scientifico, è la considerazione che essi si configurino reciprocamente esclusivi e che l’identità, vista legata al prodursi di azioni distruttive, quali la pulizia etnica, sia da bandire come elemento in grado di produrre legittimità politica. In realtà, nel momento in cui ci si interroga sulla presunta irrazionalità delle appartenenze identitarie, ciò che emerge non è tanto la loro natura illogica e ambigua, quanto la loro capacità di produrre significati in riferimento al politica l power . Coloro che enfatizzano il 76 Federica Dallan Rassegna critica della letteratura internazionale sul kosovo ruolo della ragione, per il fatto che essa è in grado di impedire che la dimensione del potere si delinei come arbitraria, fonte di disordine e priva di a ccounta bility, devono considerare come anche l’identità abbia, in questo senso, un ruolo primario: essa, infatti, conferisce al singolo un senso di sicurezza in quanto lo rende consapevole di appartenere ad una comunità poggiante su legami solidaristici, evitando che esso si senta isolato e che dunque si sleghi dal contesto politico. E’ inimmaginabile prevedere l’esistenza di politics senza comunità e, quindi, di esseri umani slegati da appartenenze comunitarie, poiché la mancanza o l’eliminazione dell’identità, comporta l’emergere di situazioni di anomia, perdita di significato e, in ultima analisi, di instabilità politica. Lo stesso Sen (Sen 2006), nell’interrogarsi sulla relazione esistente tra violenza e identità, fornisce un quadro d’analisi che contribuisce a rimettere in evidenza il ruolo non distruttivo delle appartenenze collettive. Ciò che spinge all’attuale cla sh of civila za tion non è tanto l’identità in sé ma la sua manipolazione in senso riduttivo ed esclusivizzante. La presunzione che gli individui possano essere categorizzati basandosi su un’unica appartenenza, normalmente religiosa o culturale, rappresenta proprio la maggiore fonte di conflitto, tanto che all’origine dello scoppio della violenza tra gruppi in opposizione, vi è proprio l’illusione che l’identità sia univoca e che sia data senza che alla base vi sia una possibilità di scelta da parte del singolo. Inconsapevolmente, il riduzionismo che si produce a livello accademico, contribuisce a rendere complessa l’opera di superamento del verificarsi di forme di conflitto poiché, fino a quando gli individui verranno inseriti in “piccole scatole”, la miniaturizzazione che ne consegue continuerà a rafforzare visioni eccessivamente ristrette dell’identità stessa. Proprio in linea con il pensiero di Sen, si inserisce una valutazione teorica del concetto di identità, che qui viene brevemente delineata, in quanto considerata base scientifica in grado di proporre una lettura innovativa non solo dell’appartenenza identitaria ma, di riflesso, anche del Kosovo stesso. A tal proposito, si adotterà una prospettiva d’indagine che, configurando l’identità come una sorta di legame sociale che unisce un individuo ad una specifica categoria, giunge ad affermare come questa possa subire variazioni non solo in relazione allo spazio e al tempo ma anche in virtù dell’accettazione o contestazione da parte dei membri stessi della comunità o al contrario di chi rispetto alla collettività si presenta come outsider . Il concetto di identità a cui si farà spesso riferimento nel proseguo del lavoro si inserisce in una corrente di pensiero5 che mira a valorizzare la natura processuale dei legami identitari, mettendo in luce come questi spesso si presentino fluidi e modificabili (Duijzings 2000). 1.2. Applicazione del concetto di identità processuale al Kosovo 5 Ci si riferisce al concetto di identità “congiunturale” proposto da James Clifford. A tal proposito, si veda Duijzings (2000). 6 Da un primo sguardo sembrerebbe che l’attuale antagonismo serbo-albanese che caratterizza la provincia sia legato ad odi antichi da sempre presenti nell’area e per tale motivo di difficile risoluzione; tale immagine, di un’origine ancestrale del conflitto, sembra trovare conferma se confrontata con la realtà della Bosnia-Herzegovina. Infatti, nel contesto bosniaco, serbi, croati e musulmani sono popoli slavi che parlano la stessa lingua e perciò l’aspetto principale di differenziazione risulta essere l’appartenenza confessionale. Al contrario, in Kosovo, serbi e albanesi si distinguono non solo per motivi religiosi (e ciò rimanda all’antagonismo Ortodossia-Islam) ma anche per ragioni di lingua6, tanto da Esistono approcci all’etnicità che conferiscono alla lingua un ruolo primario nel processo di unificazione delle collettività umane; alla base vi è la considerazione che una variabile primaria nella costituzione di un gruppo etnico sia la comunicazione, l’intellegibilità e la comprensione reciproca. 77 n.17 / 2007 far sembrare tali divisioni più “genuinamente” etniche e da far presumere l’esistenza di premesse reali, oggettive, di conflittualità politica. Una simile visione risulta confermata dagli eventi bellici più recenti che hanno portato a leggere la complessa realtà kosovara in termini dicotomici ed esclusivamente etnici ma se l’intento è quello di fornire una lettura più corretta possibile, si ritiene indispensabile condurre un’analisi volta alla comprensione se simili visioni di separatezza si delineano come aderenti al reale o meno. 7 Duijzings preferisce a tale proposito parlare non tanto di sistema quanto di forma di governo indiretto attraverso il supporto delle autorità ecclesiastiche locali (Duijzings 2000, p. 28). 78 1.2.1. Processi di identifica zione religiosa Applicare il concetto di identità in divenire rimanda al discorso teorico di Duijzings dove il Kosovo viene dipinto come zona caratterizzata dalla presenza di molteplici e fluide appartenenze identitarie (ethnic sha tter zone, zona di frantumazione etnica), a motivo della sua integrazione, per cinque secoli, nello stato ottomano, il quale contribuisce a preservare una notevole diversità di gruppi etnici (Duijzings 2000). Lo stesso Malcolm considera fuorvianti e del tutto false le affermazioni che descrivono lo stato ottomano come elemento di distruzione delle fiorenti culture nazionali, di colonizzazione di vaste aree dei Balcani, attraverso l’insediamento di coloni turchi, e di oppressione nei confronti delle Chiese cristiane locali (Malcolm 1999, p. 126). A detta di Dérens, simili affermazioni sembrerebbero una provocazione, in netto contrasto con i consueti approcci ideologici che tendono a giudicare in maniera fortemente negativa la presenza della Sublime Porta nei Balcani, evidenziandone l’arretratezza e il declino interno (Dérens 2001). Sicuramente la conquista militare ottomana è accompagnata da uccisioni, saccheggi, distruzioni di monasteri e chiese ma considerare l’intera dominazione di Istanbul in termini di violenza, governo arbitrario o introduzione di pratiche barbariche quali la schiavitù, la tortura e la mutilazione, rappresenta una lettura storica errata e anacronistica. Infatti, nei primi anni, almeno fino alla fine del XVI secolo, il sistema ottomano risulta essere ben regolato e strutturato al proprio interno: le colonizzazioni di massa sono pressoché inesistenti come del tutto rara è la conversione forzata all’Islam, per non parlare poi della schiavitù, pratica registrata anche sotto i precedenti stati cristiani. L’emergere di giudizi del tutto negativi circa l’operato di Istanbul nella penisola balcanica è legato al fatto che gli ultimi secoli di dominazione ottomana vedono un inasprimento delle condizioni di vita della popolazione assoggettata e un declino politico interno ed è proprio l’immagine finale di caos e di instabilità che prevale. Una simile valutazione storica è tra l’altro comprensibile se inserita nel clima generale anti-ottomano che circonda le guerre di liberazione del XIX secolo. In ogni caso, risulta necessario scardinare visioni storiche semplicistiche e mettere in luce come, inizialmente, Istanbul dia grande prova di abilità amministrativa e organizzativa poiché riesce a gestire un impero così vasto, associando una forma di governo militarista e assolutista ad una politica interna che concede ampia autonomia culturale alle popolazioni conquistate. Anche a motivo della mancanza di mezzi tecnologici e istituzionali per integrare e uniformare i popoli sottomessi, viene avviato un sistema di decentramento amministrativo (noto come sistema7 del millet) che permette alle diverse comunità religiose, anche alle più piccole, di auto-governarsi, a patto però che queste riconoscano fedeltà al sovrano e rispettino gli obblighi tributari. L’elemento primo su cui si fonda il millet risulta essere l’appartenenza religiosa e ciò spiega come tale sistema di decentramento porti alla creazione di comunità anche non contigue dal punto Federica Dallan Rassegna critica della letteratura internazionale sul kosovo di vista territoriale poiché l’aspetto fondante non è la presenza stabile di un gruppo all’interno di una specifica realtà geografica bensì la fede professata. A riprova della priorità assunta dall’elemento confessionale, basti pensare come, accanto al millet ortodosso, istituito per primo, nel 1454, esiste un millet armeno ed entrambi si pongono come le comunità religiose più estese, soprattutto se rapportate al millet ebraico. Il millet “latino” viene stabilito in un periodo di tempo successivo, sottoforma di concessione alla popolazione di fede cattolica dell’Albania settentrionale; quest’ultima viene inoltre posta sotto la protezione dell’imperatore asburgico e il primo accordo tra Vienna e Istanbul viene siglato nel luglio del 1615. L’impero ottomano viene governato sulla base dei precetti islamici e, a motivo di questi, le principali linee di divisione tra i gruppi risultano essere non tanto etno- linguistiche quanto confessionali; basti pensare come il millet, configurando una netta separazione tra le diverse collettività religiose, stabilisce regole di condotta specifiche in merito, ad esempio, al tipo di vestiario che è permesso indossare a ebrei e cristiani. Dunque, inizialmente i principi su cui poggia il governo di Istanbul permettono alle diverse comunità religiose la conservazione della propria individualità etnica e la protezione contro processi di assimilazione o eliminazione, in quanto il modello ottomano di governa nce gravita attorno alla religione e non alla nazionalità. In questo quadro si inserisce la riproposta da parte di Duijzings del concetto di regimi religiosi; tale espressione poggia su una visione della religione e della politica non come settori completamente separati ma al contrario si tenta di valorizzare il loro legame intimo, assegnando una funzionalità politica alla religione. I regimi religiosi, infatti, si presentano come “a formalised and institutionalised constellation of human interdependencies of variable strenght, which is legitimised by religious ideas and propagated by religious specialist”(Duijzings 2000, p. 27). Il sistema del millet rappresenta dunque un buon esempio di regime religioso, poiché la dimensione confessionale viene in un certo senso formalizzata e istituzionalizzata in quanto risulta essere il collante politico in grado di far coesistere una pluralità di appartenenze identitarie. Se ora si cerca di passare ad un livello più strettamente politico, e dunque si considerano i rapporti di forza che si sviluppano non solo nel contesto del millet ma anche tra quest’ultimo e il governo di Istanbul, è utile sottolineare come l’autorità ecclesiastica, guida politica e giuridica all’interno delle singole comunità, rappresenti il punto di contatto tra i sudditi e lo Stato. I capi religiosi locali, infatti, essendo visibili e affidabili per entrambe le parti, popolo e potere centrale, garantiscono stabilità nelle relazioni tra centro e periferia ed un clima di tranquillità e di convivenza pacifica. In aggiunta, il fatto che la dirigenza ottomana non si occupi direttamente dell’andamento del millet, delegando ai vertici ecclesiastici ogni contatto con i sudditi, contribuisce a creare delle aree del tutto autonome dove le organizzazioni religiose svolgono senza interferenze esterne compiti che oltrepassano la sfera prettamente spirituale. Esemplificativo del grado di autonomia concesso, è il mantenimento delle tradizioni giuridiche locali o addirittura l’integrazione di alcune norme consuetudinarie nei codici giuridici ottomani delle singole province. L’apertura politico-amministrativa e la tolleranza religiosa musulmana si manifestano inoltre attraverso l’afflusso di un gran numero di ebrei, soprattutto sefarditi di lingua ladina, espulsi dalla Spagna verso la fine del XV secolo. Da questa cornice risulta, quindi, come le formazioni religiose rappresentino il maggior veicolo nei processi di identificazione che interessano i popo- 79 n.17 / 2007 8 I cristiani, oltre ai normali obblighi tributari, subiscono una tassazione aggiuntiva sul prodotto dell’attività terriera e familiare e su tutti i possedimenti personali. Inoltre, esiste una speciale tassa che colpisce i maschi cristiani, concepita in sostituzione al servizio militare, richiesto al contrario ai musulmani. 9 La “leva dei fanciulli” (nota come devširme, ossia raccolta) se da un lato rappresenta uno dei rari esempi iniziali di conversione forzata all’Islam, dall’altro si configura come la principale forma di mobilità sociale verso l’alto nel primo sistema ottomano, poiché permette ai ragazzi raya di entrare a far parte della classe ahskeri. In aggiunta, tale sistema di reclutamento viene considerato uno degli elementi che contribuiscono a fare della classe di governo ottomana un amalgama etnico di tutti i popoli assoggettati (Malcolm 1999). 80 li assoggettati alla Sublime Porta, e l’importanza assunta dalla confessionalità nei primi tempi di dominazione ottomana, contribuisce a spiegare come l’identità etnica nei Balcani poggi molto sull’affiliazione religiosa. La politica seguita dal governo ottomano in relazione al mosaico identitario che lo compone, spesso comporta una valutazione del suo operato in termini positivi, in quanto viene considerata come esempio di tolleranza, armonia e convivenza pacifica tra le diverse culture. Per poter comprendere se simili immagini di coesistenza senza frizioni sono effettivamente applicabili al contesto del millet, risulta necessario avanzare alcuni quesiti: si tratta di reali forme di pluralismo e di multiculturalità, tanto da far configurare l’impianto ottomano come esempio di successo nel tentativo di far dialogare in maniera pacifica i popoli assoggettati? In realtà, il clima di relativa tolleranza finora messo in evidenza, viene in parte sgretolato se si considera come, dal punto di vista della stratificazione sociale, esistano delle distinzioni, che rimandano alle categorie d’appartenenza religiose e comportano dei trattamenti differenziati per la componente non musulmana. Tale situazione di disuguaglianza è definita dal geografo francese Michel Roux “pluralismo gerarchizzato” (Duijzings 2000, p. 28) a motivo del fatto che, nonostante il variegato patrimonio culturale locale venga preservato, elementi di disequilibrio sono presenti nel contesto del millet. Se da un punto di vista amministrativo la componente prima su cui poggia l’intero sistema ottomano risulta essere la religione, dal punto di vista del governo di Istanbul, la ragion d’essere dell’impero poggia più che altro sull’espansione militare; da ciò ne deriva un assetto sociale che vede l’esistenza di due gruppi distinti: coloro che finanziano le guerre e coloro che al contrario le combattono. I primi, noti con il nome di ra ya , sono i sudditi che pagano le tasse mentre i secondi, gli a shkeri , sono non solo i soldati ma anche tutti coloro che esercitano un potere sulla base di una delega del sovrano, come i giudici, gli impiegati e lo stesso clero musulmano. E’ necessario comunque precisare come inizialmente tale differenziazione trascenda l’identità religiosa poiché, sebbene nelle fasi successive di governo ottomano il termine ra ya venga utilizzato per indicare esclusivamente i contadini cristiani, il suo significato originale è molto più ampio, tanto da comprendere anche contadini musulmani. Inoltre va considerato come non tutti i sudditi cristiani vengano impiegati nelle proprietà feudali come braccianti, in quanto esistono categorie privilegiate, come gli artigiani che fabbricano armi per l’esercito, i falconieri che allevano gli uccelli per il sultano e i signori locali, i soldati pagati e i minatori, che beneficiano di particolari esenzioni fiscali. In ogni caso, aldilà delle precisazioni prima evidenziate, gradualmente emerge una composizione sociale che ricalca l’appartenenza religiosa e fa sì che ai musulmani venga conferito uno status più elevato; ciò è testimoniato dal fatto che vengono loro concesse ampie agevolazioni, come l’esenzione dai pagamenti tributari, o comunque sgravi fiscali, e il diritto a portare armi. I cristiani, al contrario, oltre agli obblighi in termini di tassazione8, sono tenuti ogni sette anni, o più spesso nei periodi di guerra frequente, a cedere un fanciullo sano, il quale verrà trasferito a Istanbul dove verrà educato nella fede islamica e verrà istruito a parlare turco, con l’obiettivo ultimo di addestrarlo nel corpo militare dei Giannizzeri o di inserirlo nell’amministrazione ottomana9. Simili trattamenti differenziati in riferimento all’appartenenza religiosa aiutano a comprendere un fenomeno che accompagna i primi anni di dominazione ottomana, la crescita e la diffusione della cultura islamica. Malcolm, nell’interrogarsi Federica Dallan Rassegna critica della letteratura internazionale sul kosovo sui motivi ultimi che stanno alla base di queste conversioni, si rifà a ragioni di carattere pratico, in quanto abbandonare la religione cristiana significa soprattutto riduzione del carico fiscale e, in particolare per gli schiavi, si ha la possibilità di uscire dalla condizione di schiavitù e divenire contadini liberi. Se Malcolm sottolinea come inizialmente i casi di conversione forzata all’Islam siano pressoché nulli (Malcolm 1999), Vickers si dichiara di tesi opposte: proprio la politica di tassazione ottomana viene considerata una misura strategica volta a incoraggiare la conversione della popolazione cristiana, presente soprattutto nelle fasce occidentali dell’impero (Vickers 1998, p. 23). A tale proposito risulta utile precisare come i cattolici siano più soggetti alla persecuzione ottomana rispetto agli ortodossi10, in quanto legati ad un potere considerato straniero, il papato romano, tra l’altro quest’ultimo visto come nemico in grado di fomentare gli animi dei propri fedeli e di dar vita ad un attacco in nome del Cattolicesimo. Tale considerazione risulta essere inoltre il presupposto di un altro tipo di trasformazione dell’identità religiosa: proprio a motivo del minor grado di tolleranza riservato alla popolazione cattolica, quest’ultima in alcuni casi, come avviene ad esempio in Montenegro, preferisce convertirsi all’Ortodossia piuttosto che all’Islam. Ad ulteriore conferma di quanto sostenuto nella fase d’esordio del presente lavoro, ossia che le identità di gruppo non debbano considerarsi come date nel tempo e nello spazio ma al contrario esistono molte “ambiguità” in questo senso, basti ricordare l’esistenza di forme di conversione incomplete, dove l’incompletezza è data dal mantenimento di elementi legati alla religione abbandonata e dal loro coesistere con aspetti del nuovo credo abbracciato. Tale fenomeno si lega soprattutto all’identità di genere poiché esistono in Kosovo famiglie estese biconfessionali dove alcuni membri, soprattutto uomini, si convertono all’Islam mentre mogli e figlie rimangono cristiane. Simili processi di identificazione religiosa interconnessi con l’identità di genere sono legati al tentativo di veder migliorate le proprie condizioni di vita: in questo caso, l’esistenza di una tassa pro capite (cizye) imposta solamente agli uomini non musulmani, fa sì che si producano conversioni soprattutto tra la popolazione maschile. Altro fenomeno da evidenziare, in linea con l’affermazione di quanto labili e poco stabili siano le identità collettive, in questo caso quelle religiose, è dato dall’esistenza di comunità cristiane che si comportano esternamente come musulmane, salvo poi mantenere privatamente la propria fedeltà al cattolicesimo. Simili manifestazioni religiose, note con il nome di criptocristianesimo, si legano presumibilmente alla divisione tra uomini e donne cui si è fatto riferimento prima. Nella società ottomana, infatti, accade spesso che gli uomini che professano la fede musulmana ma sposano donne cristiane, permettono che le figlie vengano educate al Cristianesimo; ciò garantisce la conservazione della religione cristiana in forma privata, domestica, anche per diverse generazioni. Dunque, con donne in famiglia ufficialmente cristiane, i preti possono entrare nelle case e somministrare in segreto i sacramenti anche agli uomini, nonostante quest’ultimi si siano convertiti all’Islam. Un ulteriore elemento in grado di spiegare i meccanismi alla base di tali fenomeni può essere di tipo sociale, in quanto il criptocristianesimo si sviluppa soprattutto nei villaggi poiché in ambito urbano vi è un maggior grado di controllo da parte del clero musulmano. Va comunque sottolineato come il motore primo che contribuisce all’emergere di forme di appartenenza confessionale così ambigue è dato dalla collaborazione del clero locale il quale si presta alla somministrazione di sacramenti cristiani anche a coloro che 10 Le chiese ortodosse serba, bulgara e greca sono viste con minor sospetto in quanto si trovano tutte nel territorio dell’impero ottomano. 81 n.17 / 2007 si sono convertiti alla religione musulmana. Dalla trattazione dei processi di identificazione religiosa che si producono a seguito della conquista ottomana e del conseguente sviluppo della religione islamica nella penisola balcanica, ciò che si considera fondamentale sottolineare è, in primo luogo, come prima evidenziato, la necessità di andare oltre immagini riduttive circa la presenza della Sublime Porta nei Balcani, dipinta spesso come intollerante e distruttiva delle fiorenti culture locali. D’altro canto, però, risulta doveroso superare visioni eccessivamente ottimistiche circa l’operato di Istanbul e cogliere elementi di stratificazione e divisione sociale gerarchica, aspetti che la precedente analisi ha cercato di far emergere. In secondo luogo, si ritiene utile sottolineare, proprio in chiusura della trattazione relativa ai processi di identificazione religiosa, come il sistema del millet si caratterizzi per una non contemplazione dell’appartenenza etnica quale elemento fondante di divisione sociale e di governo amministrativo. Dunque, tale considerazione fa emergere un quesito: come mai, l’identità etnica, fattore estraneo alla politica ottomana di gestione dei propri territori balcanici, si configura successivamente come elemento prioritario di definizione dei gruppi? 11 “Controrivoluzione” è un’espressione che emerge a partire dal 1981, quando una manifestazione degli studenti dell’università di Priština, scontenti per le pessime condizioni di vita e di studio, provoca l’intervento delle forze dell’ordine serbe e la dichiarazione dello stato d’emergenza. 82 1.2.2. Da ll’identità religiosa a ll’identità etno-na ziona le Il comune modo di considerare gli avvenimenti più recenti che hanno contraddistinto l’assetto politico-sociale del Kosovo, poggia sull’idea che esistano conflitti etnici, risultato del profilarsi di violenti odi, da sempre presenti tra le popolazioni che hanno insediato questa regione. Malcolm (Malcolm 1999) ci mette in guardia da letture così semplicistiche, così come Duijzings (2000), il quale sottolinea come le divisioni legate all’etnia non sempre hanno caratterizzato le collettività presenti nella provincia. Al contrario, molti dei conflitti e delle ostilità che oggi permeano la società kosovara corrono lungo binari “altri” rispetto a quelli etnici. Basti pensare come, nel corso del XVIII secolo, la principale linea di distinzione vede da un lato i proprietari terrieri albanesi e dall’altro il resto della popolazione, in una perenne condizione di insicurezza esistenziale, vissuta indipendentemente dal ba ckground religioso ed etnico. Inoltre, se si considera la vita quotidiana e i contesti più strettamente locali, linee di divisione non etniche emergono, legate ad esempio all’appartenenza di clan, alla fedeltà tribale, all’opposizione urbano-rurale o al genere. Infine, se ci si affaccia ad eventi più recenti, un altro tipo di differenziazione può essere messo in luce, legato a divisioni politiche o ideologiche: si tratta del contrasto che segna la vita politica del Kosovo a partire dagli anni ’80 e che vede scontrarsi da un lato i comunisti e dall’altro i “controrivoluzionari”11. Con queste premesse, che dipingono un contesto dove l’etnia non risulta essere inizialmente una categoria concettuale atta a produrre divisioni di gruppo così marcate, l’intento risulta essere ora quello di capire come emergano differenziazioni che al contrario si rifanno all’etnicità. In particolare, se si considerano i processi di identificazione religiosa precedentemente evidenziati, i quali hanno messo in luce come, nei primi anni di dominio ottomano, il principale elemento di configurazione dell’identità collettiva sia l’appartenenza religiosa, emerge un interrogativo: come mai la religione perde i propri connotati di elemento primo di definizione identitaria? Sono molteplici gli aspetti da evidenziare se si desidera comprendere al meglio il passaggio dall’appartenenza confessionale all’etnia nella definizione delle identità, poiché diversi sono i cambiamenti socio-politici che intervengono a modifi- Federica Dallan Rassegna critica della letteratura internazionale sul kosovo ca degli assetti interni dell’impero ottomano. In primo luogo, è necessario sottolineare l’emergere di un graduale declino che inizia a far vacillare la presenza della Sublime Porta nei Balcani, già a partire dalla fine del XVI secolo. L’elemento scatenante è rappresentato dalla costante esigenza di espansione territoriale dell’impero stesso che, per sostenere le proprie campagne militari, costringe la popolazione conquistata a sopportare oneri tributari sempre più pesanti. Ciò va a colpire soprattutto la componente cristiana, che vede peggiorare le proprie condizioni di vita, non solo a motivo di un innalzamento del livello di tassazione, ma anche in seguito alle guerre che l’impero ottomano intraprende contro le potenze cristiane12 le quali hanno come conseguenza un irrigidimento della politica adottata nei confronti dei sudditi non musulmani. E’ proprio a partire da simili avvenimenti che emergono forme di conversione religiosa forzata: ne dà testimonianza Vickers, che rifacendosi alla pesante sconfitta ottomana subita alle porte di Vienna nel 168313, sottolinea il delinearsi di un periodo di forti pressioni, esemplificato dalla deportazione di centinaia di cattolici dall’Albania settentrionale alle piane della Serbia, dove la maggior parte viene obbligata ad abbandonare la propria religione e ad abbracciare l’Islam. Come reagisce la popolazione locale a simili cambiamenti interni? Da un lato vi è chi decide di lasciare le terre d’origine, scelta testimoniata dal verificarsi di un’ondata di emigrazione serba dal Kosovo nel 1735-1739; anche la componente albanese si orienta verso l’abbandono della regione, spostandosi soprattutto verso l’Italia, la Grecia e lungo la costa dalmata. Al contrario, vi è chi decide di rimanere ma sceglie la via della ribellione; a questo proposito emerge un interrogativo: le rivolte locali che si producono possono essere considerate forme embrionali di lotta di liberazione nazionale? Malcolm sostiene che, nonostante gli storici serbi e albanesi abbiano in passato cercato di catalogare queste azioni ribelli come nazionali forme di emancipazione, non tutte possono essere ricondotte all’interno di questa categoria. Vi sono infatti alcune sommosse che effettivamente mirano a liberarsi del dominio ottomano14 mentre altre sono configurabili più che altro come tentativi di protesta contro il sistema di tassazione o contro funzionari locali particolarmente oppressivi, senza che si profili però alcun intento di erosione del potere centrale (Malcolm 1999). Dunque, quando si può effettivamente parlare di rivendicazioni nazionali? A tal proposito, risulta interessante sottolineare come lo stesso sistema del millet paradossalmente contribuisca a far emergere istanze prenazionaliste. Infatti, l’iniziale tolleranza ottomana, manifestata non solo attraverso il mantenimento delle comunità religiose locali in un clima di relativa autonomia ma anche dal fatto che ai cristiani convertiti vengono concesse molte opportunità di impiego nelle cariche amministrative più elevate15, garantisce la conservazione del variegato mosaico etno-linguistico dell’impero. In realtà, se da un lato l’assetto politico-amministrativo del millet, mantenendo integre le specificità etniche e religiose locali, favorisce l’emergere di rivendicazioni nazionaliste, dall’altro bisogna rifarsi a variabili esterne al contesto balcanico nel momento in cui si tenta di capire il percorso seguito nella formazione delle identità nazionali. Basti pensare come sarà proprio l’intensificarsi dei contatti con l’Europa occidentale e centrale a portare trasformazioni nell’impero ottomano: si assiste, verso la metà del XIX secolo, alla graduale ma sempre più intensa diffusione delle idee dell’illuminismo prima, e del romanticismo poi, tra i rappresentanti della borghesia ortodossa locale. Ne consegue una rottura del precedente rapporto di equilibrio creatosi con l’aristocra- 12 Ne sono esempio la guerra tra Vienna e Istanbul del 1593-1606 e la campagna militare condotta dall’impero ottomano contro Venezia per la conquista di Creta. 13 Vickers presenta altri esempi di eventi bellici che contribuiscono a modificare l’assetto politico ottomano: la scontro militare con la Russia, conclusosi nel 1711, il rinnovo delle ostilità con Venezia nel 1715 e lo scoppio di una nuova guerra con l’Austria nel 1716 (Vickers 1998, p. 29). 14 Malcolm si rifà in questo caso all’organizzazione di complotti da parte degli arcivescovi cattolici; in riferimento all’esempio specifico della rivolta che si sviluppa nella città di Bar, in Montenegro, e ad altri progetti politici volti a destabilizzare il governo ottomano, si veda Malcolm (1999). 15 Il numero elevato di pascià, generali, visir e gran visir di origine albanese viene spesso interpretato come segno della fedeltà e della collaborazione del popolo albanese nei confronti della Sublime Porta (Benedikter 1999, p. 29). In realtà, ritengo che ciò sia dovuto più semplicemente alle grandi opportunità politiche offerte dal governo di Istanbul ai cristiani convertiti ed essendo quest’ultimi soprattutto di origine albanese, ne consegue la loro presenza cospicua nel settore amministrativo-militare ottomano, sicuramente maggiore rispetto a quella serba. 83 n.17 / 2007 16 Il sistema di decentramento amministrativo e istituzionale del millet funziona fino alla metà del XIX secolo, quando riforme in senso più accentratore, note con il nome di Tanzīmāt, ne minano le basi. Proprio per ridare vitalità ad un impero in declino, scosso da ribellioni indipendentiste interne e da pressioni espansionistiche esterne, a partire dal regno del sultano Mahmud II (18081839), vengono introdotte alcune riforme volte a modernizzare lo stato. Particolarmente liberalizzanti si profilano le misure che proclamano uguali diritti per tutti i sudditi, indipendentemente dalla religione professata, o la dichiarazione del 1844 secondo cui i convertiti musulmani dal cristianesimo desiderosi di ritornare alla fede cristiana non rischiano la pena di morte. Simili previsioni, accompagnate anche dall’introduzione della circoscrizione obbligatoria, spingono molti albanesi a recuperare la fede cattolica; in ogni caso, tali processi di trasformazione dell’identità religiosa incontrano in Kosovo forti opposizioni da parte dei circoli ottomani più conservatori (Vickers 1998). 84 zia militare e amministrativa ottomana poiché sarà proprio la crescita di una nuova élite commerciale e di una classe di intellettuali secolarizzati a portare, insieme ai mercanti cristiani, alla richiesta di una profonda riforma del sistema del millet16. Nascono, dapprima come gruppi elitari, poi aumentando la base d’appoggio tra la popolazione, movimenti nazionali che, richiamandosi ad un passato medievale nazionale, rivendicano un diritto all’autogoverno e un territorio esclusivo su cui esercitare simili prerogative giuridiche. Gradualmente si fanno quindi spazio meccanismi di auto-percezione collettiva legati all’esistenza di confini etnici e nazionali ma le nuove identità che ne scaturiscono risultano essere da subito segnate dalla specificità politico-istituzionale che caratterizza la penisola balcanica, portandola a differenziarsi dal contesto europeo occidentale. Come sostiene infatti Fornaro, la particolare configurazione del millet, poggiante sull’intermediazione e l’interposizione dell’autorità religiosa nel rapporto suddito-Stato, impedisce che nei popoli balcanici si sviluppi quella cultura dell’identificazione tra cittadini e Stato (che significa senso del dovere nei confronti delle istituzioni, lealtà verso il potere centrale, volontà di difesa di un bene comune ecc.) presente al contrario nel processo di formazione del cosiddetto “spirito di patria” in Occidente. La singolarità dei processi di identificazione nazionale che coinvolgono i popoli balcanici viene inoltre alla luce se si richiama il concetto di nazionalismo tribale propugnato da Hannah Arendt. Vi sono infatti alcuni contesti geografici come la Russia zarista, l’Austria-Ungheria o i Balcani, dove il continuo cambiamento delle frontiere attraverso i secoli e la persistenza di processi migratori interni, impediscono di creare un terreno fertile per la realizzazione della trinità popolo, territorio e Stato. A differenza degli stati occidentali, i quali possono vantare l’esistenza di un passato coloniale e di un popolo che ha maturato quel senso di patriottismo e di identificazione nello Stato di sui si parlava prima, qui l’aver convissuto per anni all’interno di un sistema, come quello del millet, produce, oltre ad un carente se non addirittura assente senso dello Stato, un netto predominio delle élites locali ed un’intolleranza nei confronti degli elementi esterni alla propria comunità religiosa. A questo proposito si può addirittura giungere ad un giudizio negativo circa l’operato del millet in quanto tale sistema, nell’opposizione concettuale che vede contrapposti nazione territoriale e nazione diasporica, porta al prevalere della seconda tipologia. A differenza della prima, che riconosce come membri di una specifica comunità nazionale tutti coloro che sono insediati all’interno di un dato territorio, contemplando quindi una situazione di inclusione e di riconoscimento delle minoranze, la seconda nozione esprime un senso d’appartenenza che potremmo indicare come aggressivo ed esclusivo in quanto considera l’etnia, la religione, la lingua e non l’insediamento territoriale, l’elemento primo di inserimento degli individui nella comunità. Finché la nazione diasporica rimane ancorata al ristretto spaziorete del millet, i problemi di convivenza tutto sommato non si pongono ma quando si pretende di fuoriuscire da queste realtà anguste e di edificare Stati territoriali o passare da situazioni di autogoverno su base locale alla costruzione di realtà politiche fondate sul principio dell’appropriazione esclusiva di un territorio, allora emergono situazioni di conflittualità. L’idea di stato–nazione, dunque, una volta sradicata dal suo contesto originario di diffusione, l’Europa occidentale, finisce per snaturarsi poiché mal si concilia con la tradizione dei popoli balcanici. Simili considerazioni si pongono in linea con la tesi sostenuta da Prévélakis in base alla quale l’avvento della modernità nei Balcani, verificatosi in Federica Dallan Rassegna critica della letteratura internazionale sul kosovo modo sempre più frequente a partire dalla fine del XVIII secolo, se da un lato comporta effetti positivi, quali il progresso tecnologico e l’uscita dall’emarginazione, in ultima analisi produce lacerazioni e antagonismi fino ad allora poco conosciuti (Fornaro 2001). Questa situazione di frattura, conseguenza dell’emergere di nazionalismi e rivendicazioni indipendentiste, si delinea con maggior chiarezza se si considera il Kosovo; la regione, infatti, si trova contesa tra un impero ottomano in declino da un lato, e uno Stato serbo indipendente17 dall’altro, a conferma della sua immagine di zona di frontiera, evidenziata in apertura al lavoro. I confini tra i due stati vengono stabiliti al Congresso di Berlino del 1878, evento che vede per la prima volta la comparsa di “carte etnografiche”, a testimonianza del timore delle grandi potenze e dei dirigenti balcanici di ridefinire il nuovo assetto territoriale, emerso in seguito alla decomposizione dell’impero ottomano, sulla base di criteri etnici. A motivo dell’indeterminatezza e dell’ambiguità che caratterizza le identità nazionali sviluppatesi nei Balcani, come prima messo in luce, il tentativo di far coincidere spazio etnico e spazio territoriale statale comporta un’ulteriore esplosione degli antagonismi politici. Ne è prova il Kosovo che, a seguito delle decisioni maturate a Berlino, per la prima volta nella sua storia vede profilarsi nette divisioni etniche al suo interno, tanto che il dualismo religioso IslamCristianesimo che fino ad allora lo aveva caratterizzato, si trasforma, assumendo i connotati di una divisione etno-nazionalista, quella tra serbi e albanesi. 1.2.3. Forme di coesistenza e coopera zione: esperienze rea li di sca mbio o meri a rtifici teorico-a cca demici? Se da un lato l’identità nazionale diventa, a partire dal XIX secolo, discorso imperante, tanto da rappresentare ancora oggi elemento primario a cui ci si rifà se si guarda al Kosovo, dall’altro, però, la distanza e la nettezza dei confini che il processo di identificazione nazionale porta con sé, vengono meno, se si considera l’esistenza di momenti di cooperazione e condivisione tra i gruppi. Forme di contatto e dunque di sfumatura dei confini identitari si manifestano soprattutto se ci si affaccia ad una dimensione locale, ed è proprio Duijzings che, indagando il microcosmo etnico e religioso kosovaro, testimonia la presenza di contatti tra le collettività. Il punto da cui partire è considerare l’esistenza di discrepanze tra il discorso sostenuto dai nazionalismi e dai poteri statali che li incarnano, che spinge verso la fissità e l’impenetrabilità dei confini, e la pratica quotidiana registrata soprattutto nelle aree di frontiera come il Kosovo, dove, al contrario, prevalgono spesso momenti di interscambio piuttosto che di divisione (Duijzings 2000). Oggi sembra inimmaginabile ma vi sono state, in un passato più o meno recente, forme di contatto tra i gruppi che hanno popolato queste terre e simili esempi di coesistenza ci portano ad essere cauti nell’analizzare il Kosovo solo in termini di conflitto e separazioni. Anche in altre zone di frontiera, come l’Albania settentrionale e le zone montagnose del Montenegro meridionale, si sono verificati casi di superamento dei confini identitari, tanto da far parlare di osmosi etnica; infatti, gli abitanti delle montagne montenegrine al confine con l’Albania, condividono molti caratteri, quali le leggi tradizionali, i costumi, l’organizzazione sociale, con i loro vicini malësor18 albanesi. Nei secoli passati si sono creati legami forti tra i due gruppi, quali le alleanze in tempo di guerra, i matrimoni misti o la condivisione di leggende legate ad antenati comuni. Simili forme di contatto hanno portato a pensare che alcuni clan montenegrini siano in realtà emanazione di fami- 17 In relazione alla formazione di uno Stato serbo indipendente, si veda Malcolm (1999). 18 Malësor è l’espressione con cui si indicano le genti albanesi insediate nella zona montagnosa dell’Albania nord-orientale, al confine con il Kosovo. Il nome deriva dal fatto che l’intero complesso montuoso viene definito Malësi, cioè altopiano. 85 n.17 / 2007 19 Per una descrizione più esaustiva del pellegrinaggio in questione, si veda Duijzings (2000). 20 Per maggiori dettagli, si veda Duijzings (2000, p. 72). 86 glie albanesi e, sullo stesso piano, alcuni clan albanesi abbiano antenati slavi. Ritornando al Kosovo, casi di superamento dei confini etno-religiosi si profilano innanzitutto in campo bellico poiché esistono, nella storia, esempi di lotta comune serbo-albanese. Ne è prova il fatto che la stessa battaglia della Piana dei Merli del 1389, evento che dà origine a rivendicazioni territoriali sul Kosovo da parte serba, in aperta opposizione alle pretese nazionali albanesi, vede la presenza di alleanze tra i due popoli. Inoltre, risulta doveroso aggiungere come queste compaiano non solo a motivo dell’esistenza di un obiettivo comune, quale l’impedire un’avanzata ottomana, ma anche sul fronte opposto e quindi in funzione antiserba, si configurano coalizioni volte a combattere il principe Lazar e il suo esercito. Forme di lotta comune compaiono anche nei periodi successivi: basti pensare come l’invasione austriaca in Kosovo, verificatasi nel 1689, vede non solo serbi ma anche albanesi, agire a sostegno dell’esercito asburgico per sovvertire l’impero ottomano. Ancora, una successiva rivolta a supporto di un’altra invasione austriaca che si produce nel 1737, coinvolge anche un gruppo misto slavoalbanese, proveniente dalle zone di montagna dell’Albania settentrionale e del Montenegro, la cui costituzione è motivata dal fatto che già esistevano, tra i due popoli, forme di condivisione di alcune caratteristiche, come messo precedentemente in evidenza. La dimensione in cui si delineano le forme più interessanti, in quanto variegate e composite, di condivisione e superamento dei contrasti tra le collettività, è la religione popolare dove, fino a pochi anni fa, si sono registrate pratiche quali i pellegrinaggi misti o l’adorazione degli stessi santi, che hanno visto amalgamati musulmani e cristiani di differenti appartenenze etniche. A titolo esemplificativo, basti pensare ai pellegrinaggi verso il santuario serbo-ortodosso situato nel piccolo villaggio serbo-albanese di Zočište, nei pressi di Orahovac19; qui, almeno fino alla fine degli anni ’80, molti albanesi musulmani della zona hanno celebrato, in prossimità dell’edificio, il sa bor , festività religiosa che ha luogo il 14 luglio. In aggiunta, bisogna ricordare che proprio in riferimento a tale area, si sono configurate nel corso della storia altre forme di condivisione religiosa: ci si sta riferendo alla pratica di istituire la figura del guardiano20 (vojvod) dei monasteri serbo-ortodossi. La particolarità sta nel fatto che tale funzione è stata spesso svolta dai potenti clan albanesi di fede musulmana che, ponendo uno dei propri membri a guardia degli edifici monastici, hanno fornito un supporto alla popolazione serba contro attacchi esterni, tra l’altro spesso di natura albanese. Dunque, le differenze confessionali non hanno impedito lo svolgimento di questo ruolo ereditario, grazie al quale si è spesso evitato la distruzione dei monasteri serbo-ortodossi, soprattutto nei tempi di guerra. Se Duijzings rappresenta un supporto teorico essenziale nell’intento di delineare forme di condivisione religiosa tra le genti in Kosovo, Malcolm riporta anch’esso momenti di contatto tra le comunità kosovare ma il suo apporto si inserisce in una prospettiva storica meno recente e maggiormente legata all’interazione tra Islam, Cattolicesimo e Ortodossia (Malcolm 1999). In effetti, se si focalizza l’attenzione sul rapporto esistente tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa serba in Kosovo, emergono sicuramente forme di competizione ma affiorano anche momenti di mescolanza di riti e credenze, soprattutto nel campo della religione popolare. Questo sincretismo, visibile già in precedenza con l’esempio di Zočište, trova una spiegazione nel fatto che, per le genti del luogo, la funzione principale della religione è spesso quasi magica, in quanto permette di combat- Federica Dallan Rassegna critica della letteratura internazionale sul kosovo tere il male, le malattie ed avere buoni raccolti. Se si pensa ai pellegrinaggi, i motivi che portano collettività differenti verso gli stessi luoghi religiosi, sono di natura universale, quali la ricerca della salute, del benessere e della felicità per sé e per i propri famigliari, elementi, quindi, che trascendono le diverse appartenenze etno-religiose. E’ normale, dunque, che nelle aree dove sono presenti due o più confessioni, la gente approfitti dell’esistenza di molteplici forme di protezione, attingendo elementi di rimedio anche da fedi diverse dalla propria. Il sincretismo aiuta inoltre a comprendere il fenomeno della conversione all’Islam, di cui si è dato testimonianza in apertura del mio lavoro: riprendendo quanto detto in precedenza, se inizialmente l’abbracciare la religione musulmana rappresenta un atto volontario, allora come mai i cattolici non decidono di passare all’ortodossia, conservando in questo modo la propria cristianità? E’ vero che la ragione prima sta nella volontà di ottenere vantaggi economici ma parte della risposta va proprio ricercata nell’esistenza di pratiche religiose sincretiste; infatti, in virtù della presenza di così tanti rituali condivisi, la gente non nota differenze così nette tra la Cristianità e l’Islam. A conclusione dell’approfondimento qui proposto, ritorna l’interrogativo prima evidenziato: l’immagine di coesistenza che sin qui si è voluto mettere in luce rappresenta una sorta di sforzo accademico di proiettare nei confronti del Kosovo assetti di convivenza e condivisione che in realtà non esistono21? Per poter far fronte ad un simile quesito si ritiene indispensabile evidenziare come la descrizione di forme di cooperazione tra i popoli del Kosovo, anche se si delinea esperienza reale di interscambio e di mobilità delle identità d’appartenenza, risulta un artificio teorico se si modifica la prospettiva analitica d’intervento; infatti, ci si affaccia alla dimensione delle politiche di regolazione del conflitto etnico, si può vedere come queste spesso si profilano poggianti su logiche omogeneizzanti. Esse, dunque, oltre a far perdere di valore le esistenti forme di contatto, anche se minime e strettamente circoscritte, fanno sì che nell’osservatore esterno e nell’analista si radichino visioni riduttive, legate a letture strettamente duali, statiche e di divisione binaria delle identità in Kosovo, impedendo di ampliare l’orizzonte d’indagine. Proprio in riferimento allo sviluppo di politiche omogeneizzanti, si ritiene utile ora, approfondire i meccanismi che si pongono alla base di simili interventi regolativi. Innanzitutto, è necessario considerare che l’utilizzo della violenza si configura come strategia che ha accompagnato uno specifico percorso storico: la creazione degli stati-nazione. Basti pensare, infatti, come l’emergere di un’esistenza identitaria unica ed esclusiva sia uno dei requisiti essenziali su cui si fonda lo stato e, nel tentativo di forgiare appartenenze nazionali, si assiste allo sviluppo di percorsi di omogeneizzazione, volti a scardinare assetti politici al contrario caratterizzati dalla presenza di molteplici collettività. I moderni stati-nazione, attraverso la standardizzazione del linguaggio, l’introduzione di un sistema educativo uniforme, la creazione di un mercato del lavoro nazionale contribuiscono a forgiare identità univoche, nonostante l’esistenza di un panorama d’appartenenze variegato e composito. Nel percorso verso la costruzione di identità solide e di confini impenetrabili, la violenza si pone come atto in grado di realizzare un triplice intento: in primo luogo, come prima sottolineato, rappresenta spesso un motore alla base dei processi di na tion-building, soprattutto se legata alla conquista territoriale e al desiderio di modificare l’assetto demografico, eliminando elementi che minacciano la costruzione dello stato stesso. In secondo luogo, 21 L’affermazione secondo cui la focalizzazione su scenari di condivisione si delinea come mero artificio accademico è condivisa da Blumi che rivolge un’analisi critica alla pratica dei pellegrinaggi condivisi proposta da Duijzings, mettendo in luce soprattutto difetti di carattere metodologico (Blumi 2000, p. 128). A ciò si aggiunge una revisione critica rispetto al tentativo ossessivo di Malcolm di ricercare quei rari momenti storici di lotta comune serbo-albanese (Djilas 1998). 87 n.17 / 2007 cerca di favorire delle trasformazioni identitarie, costringendo i singoli a ridefinire le proprie appartenenze, decostruendo le proprie identità primarie e stabilendo affiliazioni esclusive, fisse, cancellando quindi il ricordo di solidarietà e di condivisione precedenti. Infine, si giunge forse alla considerazione più innovativa rispetto alle politiche di regolazione del conflitto che fanno uso della violenza: quest’ultima, infatti, nella sua capacità di creare nuovi assetti e nuove identità, si inserisce nella dimensione di una profezia che si auto adempie in quanto è in grado di rendere reali i costrutti ideologici (nazionalisti) che stanno alla base della sua pratica. In breve, sembra che la violenza, soprattutto in riferimento al contesto balcanico, si configuri non tanto come il risultato dell’esistenza di divisioni etniche così profonde e insanabili ma si delinei più che altro come mezzo attraverso il quale immagini di impossibile convivenza si producono nella dimensione contingente (Duijzings 2000). Anche Fornaro ricorda che la violenza non è un aspetto insito nell’esperienza balcanica ma si configura come elemento legato ai processi di identificazione nazionale e dunque come fattore importato dall’Europa occidentale. Se, infatti ci si interroga sulla presunta conflittualità endemica del popolo balcanico, si può evincere come proiettare un’immagine di dramma connaturato alle genti che vivono nell’area, rappresenta una considerazione storicamente inesatta e fuorviante. Si tratta infatti di un’esperienza relativamente recente, dal momento che esplode con tutta la sua intensità in concomitanza con l’emergere delle istanze nazionaliste nel corso del XIX secolo (Fornaro 2001). Se ora ci si affaccia al panorama kosovaro, si può notare come il margine di manipolazione e di intervento omogeneizzante da parte dello stato sia molto ampio a causa della sua particolare configurazione di territorio di frontiera. E’ da premettere che esiste una sorta di proporzionalità diretta tra la longevità del processo di formazione dello stato-nazione e la flessibilità e fluidità delle appartenenze identitarie. Infatti, dove le istanze nazionaliste si presentano come di più antica apparizione, come nel caso del contesto occidentale europeo, la coscienza dell’esistenza di un unico tipo di appartenenza è molto più radicata rispetto a società periferiche, dove le affiliazioni sono più fluide e differenziate. A ciò va aggiunto il fatto che spesso l’insicurezza esistenziale si presenta come elemento ulteriore in grado di favorire la mutabilità delle identità di gruppo. Il Kosovo, a tal proposito, si configura come esempio emblematico in quanto si caratterizza per essere una società periferica, povera, frantumata da conflitti interni, dove la maggior parte della popolazione rurale vive in una situazione quotidiana di lotta per la sopravvivenza. Proprio perché le condizioni di vita si presentano dure e altamente competitive, gli individui cercano rifugio nella famiglia, la cui struttura estesa e patriarcale garantisce non solo sostentamento ma anche protezione da minacce esterne. E’ chiaro, quindi, che l’enfatizzazione del legame di clan comporta l’emergere di una società atomizzata, dove il radicamento nella famiglia e la sfiducia nutrita nei confronti degli elementi non appartenenti alla propria cerchia, impediscono di ricreare, anche nei contesti che oltrepassano la dimensione famigliare, forme di solidarietà così strette. Dunque, l’eccessiva frammentazione e la conseguente mancanza di qualsiasi forma di integrazione sociale ed economica tra clan, rappresenta un ostacolo alla formazione di identificazioni più stabili e più ampie, contribuendo a creare identità fluide e facilmente malleabili. In un simile contesto di mutabilità dei confini, la pratica di rendere l’assetto etno-demografico meno complesso e maggiormente omogeneo, si 88 Federica Dallan Rassegna critica della letteratura internazionale sul kosovo presenta proprio come tentativo di ridurre le ambiguità e le ambivalenze identitarie. Il conflitto, dunque, mette in moto dei meccanismi che semplificano la complessità sociale, assorbendo le identità plurime all’interno delle categorie etniche principali, attraverso forme di assimilazione o, in maniera più acuta, per mezzo di espulsione o eliminazione delle cosiddette anomalie. Proprio in relazione ai meccanismi omogeneizzanti che spingono allo sgretolamento e alla perdita di significato di quel concetto di identità processuale e fluida di cui si è parlato precedentemente, in quanto comportano un irrigidimento delle categorie e dei confini d’appartenenza, sembra interessante comprendere come il discorso sulla malleabilità dei processi di identificazione si ponga rispetto alla pretesa di creare nuove na tiona l identities, percorso che oggi sta interessando direttamente il Kosovo. Si sceglie di approfondire tale dimensione posizionandosi su due livelli d’indagine: 1) elaborazione critica del concetto di autodeterminazione dei popoli; 2) analisi della validità delle pretese di forgiare nuove identità nazionali. 1.3. Principio di autodeterminazione dei popoli e sviluppo delle identità nazionali In relazione all’affermazione secondo cui la declinazione concreta del principio di autodeterminazione dei popoli si attua attraverso la creazione di stati-nazione, può essere posta sotto una lente analitica critica. E’ da premettere, innanzitutto, che l’autodeterminazione si presenta in una triplice configurazione: inizialmente si sviluppa come diritto concesso ai popoli colonizzati di creare un proprio stato durante il periodo di decolonizzazione; è proprio in tali termini che tale principio viene delineato nella Carta delle Nazioni Unite e in numerose fonti di diritto internazionale; il secondo significato, in linea con le richieste secessioniste, si rifà alla volontà delle minoranze all’interno di uno stato di staccarsi e di configurarsi come entità politica autonoma o, comunque, di unirsi ad una già esistente; infine, l’autodeterminazione contempla anche situazioni in cui esistono gruppi etnici e culturali che, sebbene non avanzino pretese secessioniste, dichiarano il desiderio di veder tutelati alcuni diritti collettivi. Naturalmente, queste tre categorie sono interconnesse: basti pensare al contesto kosovaro, che si presenta, da questo punto di vista, un ottimo laboratorio d’analisi. Si registra, infatti, in relazione al caso studio qui riportato, una configurazione a spirale, dove, inizialmente, vi è uno stato, la Jugoslavia prima e la Serbia poi, che, a motivo di una presunta negazione dei diritti di alcune minoranze etniche, porta quest’ultime a cercare di delinearsi come entità politica separata, in virtù della protezione della propria identità e la conseguente secessione albanese che ne scaturirebbe, potrebbe comportare, in ultima analisi, l’emergere di un’ulteriore assetto dove si riproporrebbe una situazione di mancata tutela dei diritti, questa volta della minoranza serba. Una simile precisazione permette già di porre in evidenza alcune lacune alla base degli appelli al principio di autodeterminazione, considerato come soluzione pratica alla multietnicità; infatti, l’aver ampliato il suo significato, porta a concludere come la sua piena realizzazione darebbe adito a rivendicazioni all’infinito, creando non solo effetti destabilizzanti ma comportando l’emergere di un circolo vizioso in cui facile si profilerebbe l’uso delle armi come proposta risolutiva. 89 n.17 / 2007 22 Tra i progetti sopranazionali che interessano l’area, si citano l’idea del letterato croato Ljudevic Gaj (1809-1872) di costituire una “Grande Illiria”, entità politica che avrebbe unito tutti gli slavi del sud, dall’Adriatico al Mar Nero. In aggiunta, si richiama la proposta di costituire una confederazione bulgaro-jugoslava, idea sviluppata dopo il primo conflitto mondiale dal leader contadino bulgaro Aleksander Srambolijski, ma venuta meno a causa di un colpo di stato militare che pone fine al suo governo e ai suoi progetti federativi (Fornaro 2001, p. 34). 90 Altra critica alle rivendicazioni poggianti sull’esplicazione in termini etno-nazionalisti del diritto all’autodeterminazione, è data dall’interconnessione esistente tra stato e popolo. Il concetto di autodeterminazione si basa sull’assunto che i popoli stessi siano da considerare titolari di specifici diritti e, come effetto di ciò, risulta necessario creare delle istituzioni a d hoc, diverse da quelle modellate per i singoli e lo stato. Il problema sorge per il fatto che, a differenza di quanto avviene per l’entità statale, la quale si presenta con confini specifici e con un sistema legislativo che la rende di facile definizione e riconoscimento, qualsiasi atto di classificazione dei popoli poggia su considerazioni soggettive e dunque dà adito a interpretazioni arbitrarie circa la sua natura. L’esistenza di questa discrepanza fa sì che lo stato spesso non si configuri come entità in grado di soddisfare le esigenze di un popolo proprio perché non esiste, in una dimensione contingente, una corrispondenza tra le due variabili e l’idea di ridefinire un territorio in vista di farlo aderire ad un popolo risulta impensabile (Archibugi 2003). Se da un lato vi è il riconoscimento del concetto di auto-determinazione, poiché oggi vi è un consenso circa il fatto che non debbano intervenire fattori esogeni nella definizione di ciò che è meglio per un popolo, dall’altro, però, identificare quest’ultimo come soggetto giuridico non implica necessariamente riconoscergli la sovranità e quindi favorirne la costituzione come stato. Il diritto all’autodeterminazione prevede che una comunità possa scegliere il quadro politico che difende meglio i propri interessi ma non vi sono elementi in grado di dimostrare che la migliore struttura istituzionale per rispondere a simili aspirazioni sia uno stato fondato su basi etno-nazionali esclusive, nel quadro di territori isolati l’uno dall’altro (Samary 1999). Il discorso sull’autodeterminazione permette di introdurre alcune considerazioni in linea con la precedente elaborazione storica dei processi di identificazione che hanno interessato la penisola balcanica. L’irruzione, nel XIX secolo, del concetto di stato-nazione, comporta l’emergere di rivendicazioni fondate sulla volontà di definire lo spazio attraverso elementi esclusivisti ed assolutizzanti, quali l’omogeneità etnica o la fede religiosa. Proprio quando ci si interroga sulla presunta intrinseca conflittualità interbalcanica, una delle ragioni prime che la caratterizzano è la continua ossessione verso l’edificazione ad ogni costo di Stati nazionali puri, oggi più che mai prodotto di visioni anacronistiche, devianti, riduttive. Il prevalere degli egoismi nazionali ha comportato l’abbandono di qualsiasi progetto di integrazione, cooperazione e di sviluppo equilibrato dell’area, che, nel passato, ha visto una pallida affermazione22 (Fornaro 2001). Dunque, nel momento in cui l’Unione Europea sta portando avanti un progetto innovatore di natura sovranazionale e integrativa, perché insistere ancora sulla frammentazione degli spazi e dei territori in micronazioni? (Thiesse 1999, p. 12). In generale, gli stati balcanici riusciranno a fondare la propria legittimità politica su basi diverse da quelle etnonazionali? E’ possibile uscire da una logica che vede solamente nello stato-nazione l’unico assetto politico risolutivo? (Dérens 2003, p. 17). In realtà, se da un lato, l’analisi di natura essenzialmente storica prodotta nella fase iniziale del lavoro ha visto l’emergere di un giudizio critico circa la tendenza a forgiare identità poggianti su elementi etnici e nazionali, dall’altro, però, si sollevano voci che vedono proprio nel rispetto della nazionalità l’unico percorso possibile per poter realizzare reali forme di solidarietà tra popolazioni. Ripristinare il concetto di appartenenza nazionale, vista come unica variabile in grado di garantire coesione e lealtà tra individui, in aperta opposizione a chi vede Federica Dallan Rassegna critica della letteratura internazionale sul kosovo nell’identità civica e sovranazionale un percorso unificatore possibile, poggia su alcune proposizioni interconnesse. In primo luogo, l’identità nazionale si presenta come elemento costituente l’identità personale, nel senso che se un singolo è chiamato a specificare gli elementi che definiscono la sua natura identitaria, solitamente si rifà alla propria nazionalità. In secondo luogo, le nazioni si presentano come comunità etiche, in grado cioè di delineare un sistema di doveri reciproci tra i membri che le costituiscono e la creazione di simili legami rende del tutto validi gli schemi istituzionali volti ad assegnare specifici benefici solamente a chi ricade all’interno di determinati confini territoriali. Quando si parla di nazione come comunità etica, non si ha in mente il senso di comunità che normalmente caratterizza una collettività unita da solidarietà reciproca ma ci si rifà ad un grado di unità più profondo, che solo l’appartenenza nazionale può garantire. A tal proposito, basti pensare alla sua continuità storica e al fatto che si configura come fattore che permane nel tempo e al quale le generazioni presenti non possono rinunciare (Miller 2000). A motivo di tali affermazioni, si giunge a considerazioni antitetiche rispetto a quelle emerse in precedenza rispetto alla portata riduttiva della nazione: infatti, se da un lato si assiste ad una sua demolizione, in quanto considerata nozione reazionaria, in controtendenza rispetto all’attuale progresso politico che porta al suo superamento, dall’altro, però, il suo configurarsi, in rapporto ad altre forme d’appartenenza, come fonte principale di solidarietà e coesione23, comporta una sua rivalutazione. E’ possibile, in ultima analisi, avanzare delle obiezioni alle tesi difensive della nazionalità? Il contesto balcanico può rappresentare una cornice in grado di testimoniare l’effetto distruttivo e conflittuale delle pretese di forgiare identità nazionali e di appartenenze territoriali esclusive, come sta avvenendo ora in Kosovo, dove le richieste indipendentiste albanesi possono essere viste come poggianti su logiche omogeneizzanti e monoetniche? Per poter comprendere le eventuali conseguenze destabilizzanti dell’applicazione del concetto di nazionalità nel processo di ridefinizione dei confini territoriali, è necessario soffermarsi su una questione: ciò che sta avvenendo in Kosovo deve farci chiedere, in riferimento alla volontà secessionista albanese, se quest’ultima poggia sull’esistenza di una reale identità collettiva divenuta incompatibile con quella nazionale, di cui si fa portatrice la maggioranza serba. Se, proprio in riferimento a tale interrogativo, si configura una situazione di distacco e antagonismo netto tra i due gruppi in lotta, Serbia da una parte e albanesi kosovari dall’altra, tale da rendere solide le tesi secessioniste e indipendentiste, è anche vero, però, che per poter ridefinire i confini sulla base di criteri nazionali, è necessario rispettare alcune condizioni. Non è sufficiente, infatti, il configurarsi di una situazione di incompatibilità identitaria ma è necessario valutare un altro fattore in gioco: il territorio su cui la comunità rivendica la secessione non deve contenere al proprio interno altre minoranze, la cui identità risulti in conflitto con l’eventuale nuova maggioranza che si andrebbe a creare. Ciò sembra un assetto che si potrebbe profilare nel caso kosovaro, in quanto la causa indipendentista, se realizzata, non condurrebbe alla costituzione di uno stato-nazione omogeneo, in virtù della presenza di una minoranza serba, incompatibile con la neonata identità nazionale albanese. Cosa si può dedurre da simili argomentazioni? La rielaborazione critica del principio di autodeterminazione non mira in alcun modo ad un suo sgretolamento ma si pone nella prospettiva di precisare come esso non debba essere considerato meramente in termini secessionisti, soprattutto se esistono assetti territo- 23 Per testimoniare la validità coesiva della nazionalità, basti pensare alle società caratterizzate dalla presenza di un’economia di mercato, la cui centralità comporta l’emergere di una tendenza verso l’atomizzazione sociale, in quanto ogni individuo cerca di massimizzare i propri interessi e quelli del network sociale a cui appartiene. Come conseguenza del prevalere di simili logiche egoiste, risulta difficile trovare consenso circa l’adozione di pratiche redistributive dalle quali i singoli non trovano beneficio diretto. Tali problemi possono essere superati se esiste una solidarietà di larga scala, che fa sentire gli individui parte di una macrocomunità, in grado di produrre, nei singoli, un senso di dovere ad agire a protezione dei propri vicini più svantaggiati (Miller 2000, p. 32). Solamente la nazione può creare un sistema d’appartenenza così ampio e allo stesso tempo così integrativo. 91 n.17 / 2007 riali, come quello kosovaro, dove la sua applicazione comporterebbe effetti destabilizzanti. Ci si sta riferendo, a questo proposito, alle difficoltà che emergerebbero in riferimento alla coesistenza e all’interazione con la componente serba, fattore che, sebbene numericamente minoritario in Kosovo, risulta legato a dinamiche complesse con le quali l’amministrazione internazionale a d interim ha cercato e sta cercando tuttora di dialogare. 1.4. Tentativi da parte dell’UNMIK di preservazione del panorama identitario mosaicato kosovaro 24 Si veda UNSCR, Resolution 1244 (99), New York: UNSCR, S/RES/1244 (1999), 10 June. 92 Costruire uno scenario di convivenza pacifica e di promozione della multietnicità: questa è la premessa sulla quale si inserisce la strategia d’intervento da parte dell’amministrazione internazionale a d interim. Sebbene dalla lettura della risoluzione 1244 non emerga alcun mandato specifico in relazione al dialogo interetnico24, tanto da configurare già una lacuna di partenza, descrivibile in termini di mancanza di linee guida specifiche in tale settore, esistono, in ogni caso, dimensioni di policy in grado di tutelare l’obiettivo multietnico, in virtù del suo presentarsi come elemento di natura intersettoriale. L’assunto su cui poggia l’intervento dell’UNMIK è legato al tentativo di evitare lo sviluppo e il consolidamento di una visione del Kosovo come territorio di un solo popolo, gli albanesi, rafforzando, al contrario, la partecipazione e l’integrazione della componente serba nelle strutture politiche. Si desidera avviare, con la creazione di spazi istituzionali in cui la minoranza serba, e non solo, si senta inserita, un percorso in grado di promuovere la coesione attraverso il graduale sviluppo di un comune senso di identificazione nei confronti della dimensione della politics. La maturazione di interessi ed esperienze condivise, risultato dell’emergere di meccanismi d’appartenenza al sistema politico-istituzionale, è qui considerata come variabile in grado di produrre un senso di unità e garantire forme di interazione tra le parti. Il problema, in relazione al Kosovo, è dato dal fatto che l’eccessiva segregazione e polarizzazione etnica, rafforzatasi nell’ultimo ventennio, limita enormemente il potenziale integrativo del processo di sta te-building, dove con tale espressione si indica l’adozione di una serie di attività quali la creazione di istituzioni politiche, il consolidamento della società civile e l’applicazione di un sistema elettorale efficace, volte a creare un senso di comunità all’interno di una polity. In realtà, sebbene sia assente tra i cittadini la percezione di far parte della stessa cornice istituzionale, si possono configurare, in ogni caso, strutture e policies in grado di facilitare lo sviluppo di un simile senso di coesione (Simonsen 2004, p. 290). Lo spettro delle politiche aventi in sé un potenziale integrativo è molto ampio e copre settori quali la facilitazione del ritorno dei rifugiati, la creazione di un ambiente sicuro in cui le minoranze si sentano protette o l’emergere di una rappresentanza politica che rispecchi le varie componenti etniche. Se ora si cercano di indagare i metodi e le azioni poste in essere dagli attori internazionali in Kosovo nel periodo postbellico, si delinea, proprio in riferimento alle strategie adottate, la possibilità di applicare il metodo di regolazione del conflitto etnico, che McGarry e O’Leary definiscono del consociativismo o “power sharing”. Si tratta di una modalità d’intervento che, per poter trovare realizzazione concreta, necessita il rispetto di alcuni elementi chiave: creazione di grandi coalizioni di governo in cui siano presenti i rappresentanti di tutti i gruppi etnici, introduzione del meccanismo della rappresentanza proporzionale in aree Federica Dallan Rassegna critica della letteratura internazionale sul kosovo quali il pubblico impiego, le istituzioni politiche e l’allocazione dei servizi, la concessione di autonomia e di possibilità di auto-determinazione per le diverse comunità, soprattutto in quelle aree considerate prioritarie per la tutela della propria identità ed infine, la previsione di un diritto di veto per le minoranze (Hoxhaj 2005, p. 25). Avendo a riferimento un simile modello regolativo, si può mettere in luce come l’UNMIK, nel tentativo di preservare il quadro multietnico kosovaro, spesso si sia ispirata ad esso. Di seguito, verranno brevemente elencate alcune misure che, nel loro esplicarsi, ricordano la strategia consociativa; tale presentazione, inoltre, permetterà di valutare quali siano i settori di policy considerati prioritari nella realizzazione dell’obiettivo della coesione interna. Sebbene il mandato su cui poggia l’intervento internazionale in Kosovo non citi esplicitamente la dimensione della convivenza interetnica, l’UNMIK, dopo la campagna aerea della Nato, decide di adottare una strategia d’azione volta a preservare il composito quadro identitario kosovaro. Accanto al profilarsi di opzioni ristrette e catastrofiche, quali il fallimento politico, legato cioè all’abbandono dell’obiettivo della convivenza, o il disastro politico, riferito alla possibilità che si configuri una situazione di guerrilla interna, emerge un’opzione alternativa, poggiante sull’intento di realizzare forme di interazione tra le parti. Prima di addentrarsi nell’analisi delle misure adottate, è utile premettere come sia possibile individuare, tra le politiche pubbliche, una differenziazione che vede, da un lato, quelle inclusive, in grado cioè di produrre processi che accomunino e avvicinino tutti i gruppi etnici presenti all’interno di una polity e, dall’altro, quelle esclusive che, al pari delle prime, si delineano come tentativi di creare coesione ma la variabile distintiva è legata al fatto che esse si sviluppano in relazione ad un unico gruppo, avendo quindi effetti discriminanti e di marginalizzazione rispetto alle altre collettività (Simonsen 2004, p. 290). Esistono in Kosovo delle arene o policies in grado di promuovere identità inclusive e sulle quali l’UNMIK ha indirizzato i propri sforzi: a seguito dello svilupparsi di una sorta di “contro-epurazione etnica” albanese nei mesi successivi al conflitto bellico e, di riflesso, alla poca fiducia nutrita dalla componente serba nei confronti della capacità di protezione da parte della missione internazionale, vengono promosse alcune misure per favorire la partecipazione di tale gruppo alle strutture politico-istituzionali. Nel dicembre 1999, il Rappresentante speciale (SRSG) Bernard Kouchner, lancia l’Agenda per la Coesistenza, documento in cui viene enfatizzato il percorso che l’UNMIK desidera seguire: in virtù della necessità di evitare di dar vita ad assetti socio-politici per i quali la popolazione non è pronta, si decide di ridurre l’obiettivo di intervento, puntando non tanto sull’ambizioso risultato della riconciliazione ma indirizzandosi, come primo step, verso una più moderata coesistenza. A tal proposito, in virtù del tentativo di garantire l’integrazione serba nelle strutture politiche, viene prevista l’adozione di accordi UNMIK-leaders serbi, volti a indicare misure amministrative e nel campo della sicurezza in grado di tutelare tale collettività, in cambio di una sua cooperazione. Tali strategie non si configurano come risolutive in quanto, nell’ottobre 2000, i serbi-kosovari boicottano le elezioni municipali e ciò comporta l’adozione di un secondo livello d’azioni, legato al settore della rappresentanza politica. In riferimento a tale arena, è necessario innanzitutto evidenziare come i partiti politici in Kosovo si caratterizzano per avere una base di supporto e una leadership che rispecchia l’identità etnica e, dunque, una simile connotazione par- 93 n.17 / 2007 25 Si veda UNMIK, Constitutional Framework for provisional selfgovernment, UNMIK/REG/2001/9, 15 May. 26 Per una descrizione della composizione del sistema delle istituzioni provvisorie di autogoverno (PSIG), contenente al proprio interno un’assemblea parlamentare e un esecutivo, costituitisi a seguito delle elezioni politiche del novembre 2001, si veda Hoxhaj (2005, p. 26) e Simonsen (2004). 27 Tale accordo è noto come Common Document, risultato di un negoziato tra il Rappresentante speciale Haekkerup e il ViceMinistro serbo Nebojsa Covic, nonché capo del Coordinating Centre for Kosovo. 94 titica comporta il rischio che le maggioranze al governo non riproducano la composita realtà identitaria della provincia. Una prima azione poggia proprio sulla configurazione di un nuovo sistema istituzionale, in cui, in linea con quanto contenuto nel Constitutiona l Fra mework25, porti alla creazione di strutture politiche in grado di garantire, al proprio interno, spazi di rappresentanza anche per le minoranze.26 Proprio per assicurare la partecipazione serba alle strutture istituzionali, l’UNMIK, attraverso il suo Rappresentante speciale Haekkerup, negozia un accordo27 con il governo serbo in cui si chiede che Belgrado eserciti pressione sui serbi-kosovari, in modo che essi partecipino alle elezioni parlamentari del 2001, obiettivo che riuscirà ad essere realizzato. In realtà, emergono alcuni difetti da questo punto di vista, in quanto l’amministrazione internazionale, scegliendo di rifarsi a Belgrado, contribuisce a rendere la Repubblica serba un fattore chiave nella vita politica kosovara, impedendo di dar voce alla popolazione serba locale (Hoxhaj 2005, p. 24). Altro elemento lacunoso che si desidera mettere in luce è legato alla politica di over-representa tion (Simonsen 2004, p. 299), seguita dall’UNMIK. Non solo in riferimento all’inserimento di un’agenda etnica nel settore legato alla partecipazione politica ma anche in altre dimensioni di policy, si profilano interventi inclusivi, volti a garantire un equilibrio tra le diverse collettività. Basti pensare all’arena legata alla sicurezza interna dove, accanto alla struttura della KPC (Kosovo Protection Corp) che, in quanto mutuata dal precedente Esercito di Liberazione nazionale (KLA), si configura come corpo di polizia eccessivamente legato agli interessi albanesi, esistono organismi più inclusivi. Ne è un esempio il Kosovo Police Service (KPS) che, dal punto di vista dell’integrazione, rappresenta un successo in quanto, al proprio interno, sono compresi non solo albanesi ma anche serbi, rom, turchi e slavi musulmani e ciò rappresenta una prova di come esistono, in molte aree della provincia, pattuglie di polizia etnicamente miste. Ulteriore conferma dell’adozione di strategie consociative, non solo in ambito strettamente politico, è dato dal mercato del lavoro, in cui si è cercato di riprodurre, nel settore impiegatizio amministrativo, un meccanismo che assegni alle minoranze la possibilità di inserimento lavorativo, garantendo un livello minimo di rappresentanza (8-18% del totale dei posti disponibili). A seguito della presentazione di simili misure volte a preservare un quadro multietnico in Kosovo, ci si chiede se la politica poggiante sul modello consociativo possa rappresentare un buon canale per raggiungere forme di interazione. Sicuramente, se l’attenzione viene focalizzata sull’inclusività e sulla ricerca di unità interna, risultano del tutto genuine e colme di significato le strategie adottate dall’UNMIK. Basti pensare alla rappresentanza politica, per la quale ha un senso produrre misure volte a garantire una partecipazione delle minoranze, in modo da evitare che si formino strutture istituzionali monoetniche e totalmente dominate dalla componente albanese. Se, però, si sposta il focus dall’obiettivo dell’equilibrio etnico a quello della creazione di identità civiche, che comportino cioè un superamento delle appartenenze identitarie etniche come tratto sociale distintivo, allora emergono alcune immagini dissonanti. Infatti, se si considera il rapporto tra ethnicity e politics e si sceglie di avviare un processo di de-etnicizzazione della seconda, in virtù della promozione di forme di coesione di tipo civico, non vi è forse il rischio che strategie di “power-sharing” agiscano in senso opposto, ossia rafforzando la dimensione etnica? L’inserimento di un’agenda etnica in settori chiave quali il sistema partitico-elettorale o il sistema impiegati- Federica Dallan Rassegna critica della letteratura internazionale sul kosovo zio si pone forse come sforzo antitetico rispetto al tentativo di ridurre il significato e la portata dell’etnicità? Si chiude questo ultimo scenario proprio con un simile interrogativo, che mette in luce come, per poter realizzare forme di interazione o di mera coesistenza in Kosovo, attraverso lo strumento della governa nce o della modellazione in senso inclusivo delle policies, non è del tutto efficace l’adozione di politiche palesemente e direttamente multietniche. Piuttosto che cercare la realizzazione di forme di compromesso attraverso la creazione di strutture collettiviste ed “etniciste”, che garantirebbero risultati, ma solo in un’ottica di breve termine, risulta necessario spostare l’attenzione verso un approccio che insista maggiormente su principi civici (ICG 2003, p. 17). In realtà, proprio in riferimento ad una simile necessità, risulta indispensabile problematizzare ulteriormente la questione: se, infatti, come prima evidenziato in relazione all’UNMIK, la pratica consociativa contribuisce a delineare il rischio del configurarsi di una sorta di “etnocrazia”, sottolineando il bisogno di poggiare su percorsi identitari legati alla maturazione di istituzioni comuni in grado di produrre coesione, le appartenenze identitarie civiche si presentano anch’esse ambigue e discutibili. Infatti, è necessario sottolineare come il ruolo della sfera simbolica si presenta essenziale nel salvaguardare la stabilità della comunità e, dunque, nel momento in cui ci si interroga sull’esistenza di possibili percorsi identitari coesivi, riservare all’ethnicity una funzione secondaria nei processi di identificazione, rappresenta una sorta di cecità analitica. Questa breve parentesi finale mira solamente a mettere in guardia dall’adozione di ricette risolutive semplicistiche e riduttive, legate alla scelta, nell’opposizione dicotomica tra ethnicity e citizenship, dell’una o dell’altra. Al contrario, per produrre strategie d’intervento adeguate, è necessario far incontrare le due dimensioni; ciò significa operare un connubio tra personale e impersonale, facendo in modo che il singolo sia consapevole del fatto che le procedure istituzionali impersonali e i meccanismi di potere neutrali si configurino come una parte della propria esperienza personale e della propria appartenenza identitaria (Schöpflin 2000, p. 28). Conclusioni L’analisi qui presentata si è posta come tentativo di approfondire la dimensione socio-politico kosovara attraverso le dinamiche che interessano i processi di maturazione delle identità, secondo un quadro teorico che mira ad abbandonare visioni eccessivamente riduttive ed esclusiviste dell’identity. Si è cercato, infatti, di presentare una lettura innovativa del contesto kosovaro, mettendo in luce come l’immagine di un Kosovo percorso da rivalità di remota origine e da conflitti da sempre poggianti sull’esistenza di divisioni etniche, risulta scardinata se si attua un’analisi storica poiché quest’ultima ha messo in luce la presenza di esempi di interazione e di condivisione tra i diversi gruppi. La tesi qui sostenuta, ripresa dal lavoro di Duijzings, è considerare l’area non tanto un territorio caratterizzato dalla configurazione di due società parallele i cui confini risultano perfettamente definiti e dunque di difficile superamento, quanto una singola società “di frontiera” (one single “frontier” society) dove periodi di scontro si sono alternati a periodi di contatto tra le diverse comunità (Duijzings 2000). Per produrre una lettura più corretta possibile, non si possono tralasciare nell’indagine momenti di coesistenza, cooperazione e contatto tra le molteplici collettività. I confini, siano essi considerati in termini territoriali che in termini cognitivi, spes- 95 n.17 / 2007 28 Per una visione dell’andamento dei negoziati, si rimanda al sito www.osservatoriobalcani.org, il quale contiene numerosi articoli circa l’evoluzione del processo negoziale a Vienna. 29 Per una panoramica circa i contenuti della proposta Athisaari, si veda il sito www.osservatoriobalcani.org. 30 Si sta facendo riferimento al fatto che nel febbraio scorso, la discesa in piazza del movimento albanese-kosovaro Vetvendosje, indipendenza, per manifestare il proprio dissenso contro i contenuti della proposta Athisaari, ha comportato una degenerazione della manifestazione che si è conclusa con due morti e numerosi feriti. 96 so sono sfumati nel corso della storia e hanno dato vita a forme di condivisione di numerosi tratti culturali, rendendo le identità fluide, mobili e non definite in modo netto e duraturo. In realtà, una simile immagine innovativa non si presenta come assoluta e ciò è stato sottolineato dalla descrizione della rottura che si produce, soprattutto nel corso del XIX secolo, a causa della penetrazione del concetto di stato-nazione e della sua particolare combinazione con la specificità del contesto politico balcanico. Proprio in relazione al tentativo di definire nuovi spazi, avendo come concetto-chiave di riferimento l’appartenenza nazionale, la valutazione critica della stessa che prima si è proposta, viene qui di seguito ripresa, a motivo della scelta di concludere il lavoro con una riflessione circa il percorso futuro che si profila per il Kosovo. L’anno 2006 doveva essere un momento cruciale per l’area, in quanto, nel febbraio, si sono aperti a Vienna i negoziati28 in vista del tentativo di definire un assetto ancora caratterizzato da indeterminatezza politica. In realtà, ciò che si è prodotto, è stato il profilarsi di una situazione di stallo, in cui non si è riusciti a concretizzare alcuna forma di compromesso o di avvicinamento tra le parti in gioco. Le speranze verso il raggiungimento di una possibile soluzione politica sono state così posposte all’anno successivo, che si è aperto con la presentazione da parte del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite, Marthi Athisaari29, di una bozza risolutiva che dovrebbe garantire la realizzazione di un primo passo verso la ricomposizione delle divergenze. In realtà, ciò che si è realizzato è stata un’ulteriore esacerbazione del conflitto: basti pensare agli avvenimenti che recentemente hanno caratterizzato la provincia30. Ciò riporta ad una considerazione finale: come potranno le genti insediate in Kosovo sviluppare forme d’appartenenza identitaria di tipo coesivo o integrativo, se non hanno ancora uno status politico definitivo? Sicuramente il fatto che attualmente vi sia una situazione di temporeggiamento e di stallo nei negoziati è sintomatico della difficoltà di ricomposizione del dialogo e delle parti ma ciò che si desidera evidenziare è il rischio che il perdurare della provincia in una condizione di limbo, innalzi il livello di insoddisfazione, soprattutto per quella componente albanese più radicata nella causa indipendentista, creando nuove instabilità interne. Quando si parla di innalzamento del livello di insicurezza, ci si rifà alla possibilità che il Kosovo possa cadere, come già avvenuto nel marzo 2004, in una situazione di collasso e di intensificazione dell’uso della violenza, contribuendo a polarizzare ulteriormente il panorama etnico-demografico kosovaro. Rimanendo all’interno del discorso identitario sin qui proposto, esistono, a conclusione delle argomentazioni finora maturate, spiragli di positività futura? Probabilmente, ma ciò sarà tutto da scoprire, essi potranno emergere in relazione alla possibilità di ancoraggio e di avvicinamento della provincia al contesto integrativo europeo. Tale configurazione si potrebbe realizzare, tra l’altro, in un futuro immediato poiché l’andamento dei negoziati prevede che, a seguito dell’adozione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di una nuova risoluzione, in sostituzione della 1244, avvenga una modifica nella composizione internazionale che guida il processo di transizione democratica nella provincia. Infatti, le nuove prospettive d’intervento stabiliscono che sia proprio l’Unione Europea a sostituire le Nazioni Unite nella conduzione dell’amministrazione a d interim in Kosovo. Quale apporto concreto potrebbe dare l’UE al contesto kosovaro? Si configura, a tale proposito, una particolare dimensione in cui l’avvicinamento tra le due entità politiche può produrre nuova linfa vitale per entrambe. L’Unione Europea e il Kosovo, infatti, sono accomunate da un tentativo attuale Federica Dallan Rassegna critica della letteratura internazionale sul kosovo di riconsiderazione della propria identità. Si ricorda che in ambito comunitario si sta assistendo alla maturazione di un percorso di auto-riflessione circa la necessità di dotarsi di un’anima culturale, che rafforzi la coesione interna e garantisca un più elevato livello di avvicinamento dei cittadini europei alle strutture istituzionali, andando oltre la già raggiunta configurazione di un’identità economica e funzionalista. Non solo la comune riflessione circa la propria immagine identitaria può contribuire a generare nuovi impulsi, in un percorso di influenza reciproca e bi-direzionale ma si può assistere anche ad un interscambio interessante tra le due. Se si considera, infatti, l’esistenza di una duplice modalità di maturazione di coesione e integrazione, evidenziando da un lato la possibilità di creare unità attraverso la previsione di comuni meccanismi istituzionali e statali e, dall’altro, la capacità di forgiare identità sulla base di appartenenze etniche, emerge un quadro di interconnessione. L’Unione Europea sta cercando di affrontare una sfida, data dal tentativo di approfondire il processo integrativo focalizzando l’attenzione sulla dimensione simbolica e culturale e, proprio in questo senso, il suo avvicinamento al Kosovo e, più in generale, al contesto europeo balcanico, può fornirle un notevole insegnamento. Infatti, la particolare esperienza europea orientale, legata all’aver seguito percorsi di identificazione poggianti sull’appartenenza etnica e culturale, può aiutare l’UE a superare la soglia della mera identità economica e istituzionale, evidenziando come l’etnicità sia un elemento non trascurabile nel definire le appartenenze identitarie collettive. L’Unione Europea, dal canto suo, può mostrare, in questo caso al Kosovo, come sia possibile non solo dar vita a processi integrativi che oltrepassano il concetto di appartenenza nazionale ad un territorio ma può sottolineare percorsi di identificazione innovativi, slegati dall’etnicità, maggiormente ancorati alle comuni istituzioni e alla maturazione di coesione attraverso identità per così dire civiche e sovra-etniche. Riferimenti bibliografici Archibugi D. (2003), “A critical analysis of the self-determination of peoples: a cosmopolitan perspective”, Constella tion Volume 10, No. 4, pp. 488-505. Benedikter T. (1999), Il dra mma del Kosovo: da ll’origine del conflitto fra serbi e a lba nesi a gli scontri di oggi , Datanews, Roma. Blumi I. (2000), Ger Duijzings. Religion and the politics of identity in Kosovo, Book Reviews, Southea st Europea n Politics, 1 (2), December, pp. 126- 130. Bugajski J., Hitchner R. B., Williams P. (2003), Achieving a fina l sta tus settlement for Kosovo, Centre for Strategic and International Studies, Washington, D.C. Cerutti F., Rudolph E. (2002), Un’a nima per l’Europa . Lessico di un’identità politica , Edizioni ETS, Pisa. Dérens J. A. (2001), Le mosaique kosovare, Le monde diplomatique, N° 564, p. 22. Dérens J. A. (2003), Les « petits peuples » oubliés des Balkans, Le monde diploma tique, N° 592, pp. 16-17. Djilas A. (1998), “Imagining Kosovo: a biased new account fans western confusion”, Foreign Affa irs, Vol. 77, Number 5, September/October, pp. 124-131. Duijzings G. (2000), “Il conflitto nel Kosovo e altre guerre Jugoslave”, in Buttino M., Ercolessi C., Triulzi A., Uomini e a rmi. Costruzioni etniche e violenza politica , L’Ancora del Mediterraneo, Napoli, pp. 25-33. Duijzings G. (2000), “New myths are needed. Reconciliation in Kosovo as an 97 n.17 / 2007 intellectual challenge”, paper presented at the Workshop Post-Kosovo Ba lka ns: Perspectives on Reconcilia tion, orga nized by the Centre for South-Ea st Europea n Studies a nd Na sh Alba nia n Studies Progra mme, London, 18 march. Duijzings G. (2000), Religion a nd the politics of identity in Kosovo, Hurst & Company, London. Fornaro P. (2001), “A proposito del Kosovo. Il peso della storia nel dramma dei popoli balcanici”, in Orteca P., Saija M. (a cura di), La guerra del Kosovo e la questione ba lca nica , Rubbettino Editore, Catanzaro, pp. 27-39. Hoxhaj E. (2005), The politics of ethnic conflict regula tion in Kosovo, Centre for the study of global governance, Discussion paper 39, London. International Crisis Group (2003), Kosovo’s ethnic dilemma : the need for a civic contra ct, Balkans Report N° 143, Priština/Brussels . International Crisis Group (2005), EU visa s a nd the Western Ba lka ns, Europe Report N° 168, Belgrade/Priština/Sarajevo/Skopje/Brussels. Malcolm N. (1999), Storia del Kosovo: da lle origini a i giorni nostri , Bompiani, Milano. Miller D. (2000), Citizenship a nd na tiona l identity, Polity Press, Cambridge. Samary C. (1999), Explosion ou confédération, Le monde diploma tique, N° 542, pp. 10-11. Schöpflin G. (2000), Na tions Identity Power. The new politics of Europe, Hurst & Company, London. Sen A. (2006), Identity a nd violence. The illusion of destiny, W.W. Norton & Company, New York. Simonsen S. G. (2004), “Nation-building as peace-building: racing to define the Kosovar”, Interna tiona l Pea cekeeping, Vol. 11, Nr. 2, pp. 289-311. Thiesse A. M. (1999), La lente invention des identités nationales, Le monde diploma tique, N° 543, pp. 12-13. UNMIK, Constitutiona l Fra mework for provisiona l self-government, UNMIK/REG/2001/9, 15 May. UNSCR, Resolution 1244 (1999), New York: UNSCR, S/RES/1244 (1999), 10 June. Vickers M. (1998), Between Serb a nd Alba nia n: a history of Kosovo, Hurst & Company, London. Zanoni L. (2006), Il Kosovo a lla deriva , www.osservatoriobalcani.org. 98 99 100 Damiano Fanni “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche Focus: Memorie e Kosovo “Non puoi capire cosa significa sentire quella musica dappertutto. Quando c’è il sole e apri le finestre la senti nell’aria…Come possiamo ascoltare musica serba!? È musica allegra, per i giovani e loro l’ascoltano e cantano le parole. A me fa troppo male… capire che quella cultura [dei serbi] conquista tutta l’area e alla fine la “Grande Serbia” passa anche nelle onde della radio dei nostri figli. Povero Danubio… quella non la può fermare nemmeno lui”. Lo sfogo di una collaboratrice del referente croato nel corso di uno dei miei ultimi viaggi nei “Balcani”, riassumeva efficacemente gran parte della considerevole produzione scientifica elaborata attorno alle grandi questioni del nostro presente, europeo ad intensità differenti e, quindi, anche balcanico: il tema dell’identità, dell’invenzione del conflitto inter-etnico, della memoria collettiva e di quella culturale, della ricerca ossessiva della purezza della lingua, delle minoranze, dell’inurbanizzazione… e della musica, della cucina, del nome delle strade, piazze e città da cambiare, dell’eterno dibattito sul “possesso” degli eroi che, a seconda, sono criminali o pazzi oppure, semplicemente, nessuno. Appare evidente che ogni tentativo di delimitare forzatamente il campo d’indagine, con la pretesa di occuparsi di una di queste prospettive, e una sola, è destinato ad aggiunger ben poco a quanto già detto e scritto; viceversa, l’utopia di affrontare un approccio globale, esaustivo ed esauriente che non sacrifichi alcun tema è, appunto, un’utopia che forse potrebbe anche esser utile come indicazione della strada da seguire, ma in altre sedi, con altri spazi e possibilmente in regime di collaborazione. Tuttavia, e giusto per aprire con una contraddizione, tra i temi esposti ve n’è uno che potrebbe trovare ospitalità in tutti gli altri: la memoria ed il ruolo giocato nella configurazione degli eventi storici, politici, economici e sociali dell’area del Sud Est Europa1. E una prima fondata obiezione potrebbe muoversi contro l’oggetto del presente studio, relativamente al rilievo che si vorrebbe attribuire alla memoria in questa regione, quasi come si volesse farla assurgere a chiave di lettura esclusiva, in virtù della sua importanza, adatta a dare una spiegazione alternativa2, univoca e definitiva delle complesse dinamiche che informano l’area. Ma non è così. 1 Sud Est Europa è la dizione ritenuta politicamente corretta rispetto a “Balcani”, come si spiegherà più avanti. Entrambe le forme sono comunque tuttora ugualmente diffuse e nel presente lavoro si continuerà prevalentemente ad usare la seconda. 2 Memoria(e) La memoria è il codice che conferisce senso alla mappa dell’esistenza umana, individuale e collettiva, pur in modi e con percorsi differenti; è il filtro che media la Rispetto ad altre più comuni quali quella che attribuisce la dissoluzione della Jugoslavia alla scomparsa della figura e del carisma di Tito. 101 n.17 / 2007 3 Scrive Jan-Werner Müller “Memory matters. It matters for the simple reason that memory is an anthropological given, since all consciousness is mediated trough it”. 4 E certamente di memoria si è occupato ad es. Henri Bergson, che in “Materia e Memoria” del 1896 si occupa di definire il cervello non quale deposito di ricordi ma dispositivo di attivazione di percezioni passate e selezionate (Bergson 1986, 196 e segg.). L’interesse verso la memoria non è misurabile: dalla trasmissione orale della cultura, al lavoro di trascrizione delle opere da parte degli Amanuensi, agli archivi genealogici dei mormoni in Salt Lake City, con 2,4 milioni di dati di nomi in microfilm. 5 Nell’opera, del 1925, l’Autore anticipa il concetto di “cornice” o frame, prima di Goffman, “Frame Analysis”, del 1974 e di Schön e Rein “Frame Reflection”, del 1994. 102 coscienza3 (Müller 2002, 1) e contribuisce ad attestare che “Il mondo è veramente un’operazione dinamica; solo per mezzo di simboli la mente può trattare con esso ‘come se’ fosse una struttura statica”(Upton 1961, 31-32). Nei Balcani così come in ogni altro contesto. Condividendo un destino comune a numerosi concetti che costituiscono il piano d’azione delle scienze umane, anche per quello di memoria non è disponibile una definizione univoca. Esiste una memoria che aiuta nella preparazione degli esami e nell’acquisto delle provviste; una memoria che accompagna un album fotografico, o un profumo, o un motivo musicale. Esiste una memoria che viene compromessa da gravi patologie neurologiche; una che interessa i creatori di consenso politico. Memorie che persistono e altre che svaniscono, con propria autonomia ed indipendentemente da chi le possiede; memorie del singolo, della collettività, di un’istituzione, di una generazione o di una cultura. Memorie apprese e memorie agite, memorie di un luogo, fisico e/o mentale. L’attenzione per la memoria è sempre stata elevata. Basterebbe far emergere lo stretto legame che forma la coppia ‘memoria-potere’; ma l’interesse per l’aspetto qui affrontato ha inizio principalmente con i lavori di Maurice Halbwacks, sociologo francese formatosi alla scuola di Durkheim. Non è indifferente specificare la natura della formazione di Halbwachs poiché questa combinazione influenzerà l’approccio dell’Autore alle tematiche che qui sono rilevanti. È chiaro che esiste un interesse per la memoria assolutamente antecedente ai lavori di Halbwacks4, tuttavia, l’originalità del suo pensiero risiede nel proporre una memoria sempre e comunque da intendere quale risultato della mediazione dell’individuo con il gruppo, sottraendo la possibilità dell’esistenza di una memoria individuale, autonoma e non riconducibile a quella collettiva. Nell’opera “I quadri sociali della memoria”5, l’Autore individua la dimensione sociale della memoria nell’esistenza di strutture ordinative o categorie a-priori - linguaggio, rappresentazioni sociali dello spazio e del tempo, classificazione - che conferiscono pregnanza al ricordo condizione necessaria affinché venga fissato - e orizzonte, ovvero un significato e una rilevanza sociale del ricordo. Sensibile all’ambiente della sua formazione, Halbwachs tende progressivamente a negare l’esistenza di una memoria individuale specifica e distinta da quella sociale: “(…) i nostri ricordi vivono in noi come ricordi collettivi, e ci sono rammentati dagli altri a nche qua ndo si tra tta di a vvenimenti in cui sia mo sta ti coinvolti solo noi (…). Il fatto è che, in realtà, non siamo mai soli (…) perché ciascuno di noi porta sempre con sé e dentro di sé una quantità di persone distinte” (Halbwachs 2001, 80, corsivi aggiunti). Non solo è necessario un gruppo per la formazione del ricordo di un evento collettivo, es. un evento naturale rilevante, ma la condizione dell’individuo in quanto parte di una formazione sociale condiziona ed influisce anche la formazione di un ricordo che potrebbe altrimenti collocarsi a pieno titolo nel novero dei ricordi biografici e personali. L’“essere parte di” è una condizione necessaria per la riattivazione del ricordo: similmente ai comuni “bei vecchi tempi” che si rievocano in occasione dell’incontro con persone che hanno condiviso parte della loro esistenza insieme, il ricordo si riattiva al momento in cui si rioccupa una posizione di appartenenza, è una ricomposizione alla quale ognuno collabora conferendo al prodotto - il ricordo - la propria personale testimonianza che mantiene intatto ed inalterato il codice genetico del gruppo in cui - e da cui - ha avuto origine: Damiano Fanni “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche “Perché la nostra memoria si aiuti con quella degli altri non basta che questi ci portino le loro testimonianze: bisogna anche che essa non abbia cessato di essere in accordo con le loro memorie e che vi siano abbastanza punti di contatto fra l’una e le altre perché il ricordo che ci viene rievocato possa essere ricostruito su di un fondamento comune” (Halbwachs 2001, 90). Questo è vero, ma pure non lo è. Se non è sufficiente che gli altri ci portino le loro testimonianze, è pur vero che non è indifferente “chi sono” questi altri: l’eventuale accordo dipende, quindi, non tanto dalla permanenza immutata di punti di contatto nelle memorie, quanto soprattutto dalla persistenza dei codici interpretativi per quelle memorie. Ancor meno attendibile è l’idea che per aversi una memoria collettiva è necessario esser stati, e continuare ad essere, parte della medesima società6: è forse questa la conditio sine qua non per “(…) comprendere come un ricordo possa essere contemporaneamente riconosciuto e ricostruito”? In realtà Halbwacks sta sottolineando il problema dell’identità collettiva, prima e oltre a quello della memoria collettiva. Un cittadino israeliano ebreo di Tel Aviv, lo psicologo ebreo che tratta la sindrome dei disordini da stress post-traumatico a Vukovar, in Croazia, Simon Wiesenthal7, non sono parte della stessa società, eppure presumibilmente intercorrono tra loro stretti legami identitari con la comunità ebraica e compartecipano al ricordo dell’Esodo, dell’Olocausto, della Shoah. Si potrebbe aggiungere che nella religione ebraica la filiazione segue la linea della madre8, che la madre è la figura che più incide nella formazione del bambino e nella trasmissione degli elementi che contribuiranno alla creazione dei vincoli di appartenenza alla comunità e alla costituzione dell’identità, in questo caso, ebraica. Proprio Jan Assmann spiega che in ogni cultura è possibile rinvenire una “struttura connettiva” che agisce connettendo una dimensione sociale ad una temporale e che si costituisce sulla base di elementi quali il ricordo, l’identità e la perpetuazione culturale (Assmann 1997, xii). Proseguendo sulla stessa linea, anche la formula “fate questo in memoria di me” che accompagna la celebrazione eucaristica della messa cattolica non elimina i dubbi circa la comunanza degli astanti dell’ultima cena con la comunità di fedeli riuniti in una chiesa di periferia di una qualsiasi città. E tuttavia quella formula induce una curvatura nella dimensione dello spazio e del tempo, annulla le differenze, crea identità, comunità e appartenenza, riattiva i quadri sociali della memoria e agisce nel senso di indurre la compartecipazione dell’individuo alla memoria collettiva. Così pure la cerimonia ebraica del séder , un banchetto che celebra (ricorda) l’esodo del popolo ebraico dall’Egitto e nel quale viene letto ai bambini il libretto dell’Ha gga dá h, una raccolta di canti, aneddoti, storie che si sostanziano in una grande lezione sull’esodo (Assmann 1997, xi-xiii) e che attinge dalla Bibbia passi quali “Lo spiegherai al figlio tuo, in quel giorno, dicendo: ‘È a causa di quel che il Signore fece per me, quando uscii dall’Egitto’”9. Assmann spiega che la cerimonia del séder non è solo una ripetizione di quella dell’anno precedente ma è una evocazione di un evento che ha segnato, segna e segnerà l’identità di appartenenza alla medesima Comunità dell’Esodo, anche per tramite della coerenza rituale della cerimonia. Memoria e identità sono concetti che si svolgono in parallelo e la condivisione - per la memoria - o l’appartenenza - per l’identità - non hanno una valenza temporale e non può risentire dell’“interesse” attuale per una certa tematica10. Così come non si può scegliere cosa ricordare e cosa dimenticare dell’insieme dei ricordi che formano la memoria personale (supposto che ne esista una, autonoma 6 “Bisogna che questa ricostruzione sia fatta a partire da dati o nozioni comuni che si trovano dentro di noi tanto quanto negli altri, perché passano senza sosta da noi a loro e reciprocamente; questo è possibile solo se tutti fanno parte, e continuano a far parte, di una medesima società” (Halbwachs 2001, 91). 7 Sopravvissuto ai campi nazisti, Wiesenthal ha dedicato la sua vita a documentare i crimini dell’Olocausto e ad assicurare alla giustizia i responsabili. 8 Nella versione più comunemente accettata, anche se la questione è tutt’ora oggetto di dibattito: “Nei periodi moderni vi sono stati occasionali contrasti tra la definizione rabbinica e quella del senso comune, per esempio nell’interpretazione data dalla Corte suprema israeliana della “legge del ritorno”, secondo l’opinione di Rabbi John D. Rayner, Union of Liberal & Progressive Synagogues, 1993, consultabile sul sito http://www.levchadash.inf o/?page_id=37 Vedi anche Meyers (1998) a proposito degli Ebrei in Russia. 9 Esodo, 13, 8. In realtà ci sono quattro diverse formulazioni dello stesso concetto che propongono varianti sul pronome personale usato: “vi”, “me”, etc. che definiscono il tipo di relazione che il bambino “sente” prima della lettura e della celebrazione e che definiscono il suo stile nel rapportarsi alla sua comunità. Vedi Assmann. 103 n.17 / 2007 10 Diversamente Halbwacks:“Che m’importa che gli altri siano ancora dominati da un sentimento che un tempo provavo anch’io con loro ma che oggi non provo più?” (2001, p.90) 11 Il riferimento è alla querelle sulle radici giudaico-cristiane da includere nel testo costituzionale dell’Unione Europea. 12 Che è poi la stessa domanda… 104 e separata da quella della collettività), allo stesso modo il coinvolgimento entro la memoria collettiva è sottratto alla libera scelta autonoma. E non può essere imposto.11 Con questo non si vuole sostenere che la memoria collettiva è “qualcosa” che sfugge dal controllo e che si propone come un assolutamente autonomo a cui riferirsi o verso cui tendere. La domanda, qui, che potrebbe orientare il discorso verso scenari fecondi di riflessione non è “cos’è la memoria collettiva” ma, piuttosto, “quale è l’uso che ne viene fatto?”12. L’uso della memoria collettiva risponde all’esigenza di fornire risposte ad una domanda che non è stata formulata 2000 anni fa ma che origina dalle attuali contingenze (Fabietti e Matera 1999, 11), ovvero, la memoria risponde ad un bisogno che è a ttua le. D’altro canto, questo bisogno attuale ha una sua origine nel passato ed è suscettibile di essere interpretato alla luce dei costituenti della memoria collettiva. Prendiamo la questione a partire da un confronto. Memoria individuale e memoria collettiva si intrecciano inesorabilmente, eppure si dispiegano seguendo logiche differenti. Posto che non vi è attendibilità dei ricordi personali, intesa quale completa coincidenza del ricordato – del contenuto del ricordo – con l’evento oggetto dello stesso, va da sé che questa coincidenza non possa aversi neppure per gli elementi costituenti la memoria collettiva. Tuttavia, rispetto a quella individuale quella collettiva è maggiormente esposta ad eventuali interventi di pianificazione. Se assumiamo il vissuto personale e l’elaborazione che di questo l’individuo ne fa e che sono elementi costitutivi del ricordo e quindi della memoria, come in una condizione di “equilibrio endogeno”, vale a dire che la memoria adempie efficacemente al suo ruolo in quanto elaborata sulla base di un set di esigenze proprie del soggetto che la possiede, resta da prendere in considerazione la diversa sorte cui inevitabilmente va incontro la memoria collettiva. Anche questa è il prodotto di una selezione e di una codificazione, anche questa risponde a precise esigenze che in questo caso, però, sono quelle di una collettività e che quindi devono essere interpretate e/o rappresentate da altri. Questa interpretazione genera una condizione di “squilibrio esogeno” in quanto si apre la possibilità che l’individuo singolo possieda un ricordo “diverso”; fatto, questo, che però non incide in alcun caso sull’attendibilità della memoria collettiva la cui esistenza non deve, comunque, ricevere necessariamente una generale sottoscrizione di paternità. Un ricordo lo si “sente” proprio. Dipende dal grado di predisposizione degli individui a credere nella sua esistenza e nella sua legittimità, coerenza, utilità. Elementi che hanno a che fare con la disponibilità di una visione presumibilmente chiara dei bisogni attuali e pure con la capacità di prevederne l’evoluzione. Non sembri fuori luogo il riferimento a John Dewey quando scrive che “Chiodi e tavole non sono, propriamente parlando, i mezzi di una cassetta: sono soltanto i materiali che occorrono per farla” (Dewey 1958, 32). La battaglia di Kosovo-Polje del 1389, i “bogomili” della Bosnia, i monasteri ortodossi del Kosovo, il ponte vecchio di Mostar, l’opera di santo Sava non sono (alcuni dei) mezzi che compongono le memorie collettive dei Balcani, sono piuttosto gli elementi costitutivi che, in quanto orientati verso il soddisfacimento di un bisogno, necessitano per questo di una forma di organizzazione (Dewey 1958, 33) che Dewey chiama “abitudine”, e che così definisce: “(…) noi abbiamo bisogno di una parola che esprima quel genere di attività umana che è influenzata da un’attività precedente, e in questo senso è acquisita; che contenga in se stessa un certo ordinamento o sistemazione di minori elementi di azione; che sia prospettica, di qualità dinamica, pronta a manifestarsi apertamente, e Damiano Fanni “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche che operi in qualche forma attenuata e subordinata anche quando non domini palesemente l’azione: e la parola ‘abitudine’ nel suo senso ordinario si avvicina più di qualsiasi altra a denotare questi fatti” (Dewey 1958, 47). Una “cosa” che non è autonoma, che si acquisisce, che contiene in sé elementi minori o accessori, che sia in costante evoluzione e che riesca a generare correnti profonde non visibili ma per questo non meno determinanti, è una “cosa” che sta immediatamente prima della memoria collettiva: un’a bitudine-memoria collettiva o, se si preferisce, la “matrice” della memoria collettiva13. Così come non tutti faranno una cassetta con i chiodi e le tavole, ma forse un appendiabiti oppure un cavalletto, i materiali costitutivi che diverranno poi mezzi per la formazione di una memoria collettiva nei Balcani - visto l’oggetto di questo studio - hanno necessità di una “predisposizione acquisita a modi determinati di risposta” (Dewey, 1958 49) per poter giungere a quella particolare combinazione dei ricordi che sia incastrabile e/o compatibile con il vissuto individuale di ognuno (che sia balcanico). Stiamo forse sostenendo che nei Balcani gli individui sono naturalmente predisposti all’odio, al rancore, alla vendetta?14 No; e per gli stessi argomenti per i quali Dewey sceglie “abitudine” invece di “attitudine” o “disposizione” (Dewey, 47 e 48). Questi termini fanno riferimento all’esistenza di qualcosa di latente, pronto a divenire manifesto in seguito ad uno stimolo esterno e dopo aver rimosso eventuali “tendenze inibitorie”, esempio, la possibilità dell’uso coercitivo della forza. Disposizione, poi, richiama predisposizione ovvero qualcosa che è “(…) in attesa come se dovesse balzare attraverso una porta aperta”, come l’emersione violenta di una pallina di gomma prima tenuta ferma sul fondo di un contenitore pieno d’acqua. Quella che riteniamo possa intendersi quale “matrice della memoria collettiva”, e che è “abitudine” per Dewey, è esattamente “(…) una particolare sensibilità o accessibilità a certe classi di stimoli, delle predilezioni e avversioni [che restano] costanti(…)” (Dewey 1958, 49). Nel nostro caso, la matrice della memoria collettiva è il principio ordinatore mediante il quale acquisiscono senso e significato gli elementi che verranno a comporre la memoria collettiva. È quella particolare sensibilità contenuta entro il codice genetico-culturale di un popolo, è la traccia mnesica che permane, come nella metafora del “notes magico”, dove da un lato è possibile scrivere illimitate volte sulla pellicola mentre dall’altro tutti i segni restano per sempre incisi sulla tavoletta sottostante15 (Freud 1989, 63-68) e che è possibile ripassare infinite volte ancora. Il premier britannico Winston Churchill diede una descrizione illuminante: “I Balcani producono più storia di quanta ne possono digerire”. La “storia balcanica” ha una connaturata propensione alla ripetizione? Per un’altra “storia balcanica”. L’accusa che Halbwacks muove con decisione alla “presunzione della storia” deriva dalla constatazione che, per necessità, questa tende ad epurare l’elemento umano dal suo svolgimento per cui quel che resta è uno spettatore fuori dal tempo e disumanizzato che sembra “(…) come quel personaggio di un’opera buffa che esclama: ‘oggi comincia la guerra dei cent’anni!’” (Halbwachs 2001, 158). L’attribuzione di rilevanza storica ad un dato avvenimento è sempre un’operazione ex-post che emerge dal “gusto estremo per lo studio dettagliato” (Halbwachs 2001, 160) che porta ad attribuire eguale importanza, nel segno dell’obiettività, a qualsiasi fatto non facendosi carico, così, “(…) del punto di vista di nessuno dei 13 Un efficace panoramica è quella proposta da Yadin Dudai per il quale l’espressione “memoria collettiva” si riferisce a tre entità: un corpo di conoscenze, un attributo e un processo. Il corpo di conoscenze è un tratto caratteristico della cultura degli individui che condividono alcune analogie e che possono prendere parte a diversi gruppi e quindi a diverse memorie collettive sulla base dell’occupazione, del luogo di origine e così via. L’attributo è il riassunto totale e distintivo del passato del gruppo, es. il ricordo di un incidente aereo per i sopravvissuti. Il processo è la dinamica che interconnette l’individuo e il suo gruppo e apre ad una influenza biunivoca, dove il gruppo incide sulle memorie dell’individuo e questi può, in diversa misura, incidere su quelle del gruppo cui appartiene. (Dudai 2002, 51) 14 È proprio questa l’immagine dei Balcani che più incontra consensi, come spiega Maria Todorova che riporta un passo da “Inside Europe” di John Gunter pubblicato nel 1914 e ripubblicato nel 1940 “È un intollerabile affronto alla natura umana e politica che questi piccoli paesi sventurati e infelici della penisola balcanica possano, e lo fanno, avere contrasti tali da provocare guerre mondiali. Circa centocinquantamila giovani americani sono morti a causa di un episodio avvenuto in un fangoso villaggio primitivo, Sarajevo”, mentre Harry de Windt proclamava che “la vita qui [Montenegro] ha un valo- 105 n.17 / 2007 re basso, quanto in Cina e in Giappone”. (Todorova 1997, 199) 15 Il notes magico permette ai segni tracciati sulla pellicola superficiale trasparente di essere cancellati, permettendo di rioperare sulla stessa superficie senza necessariamente cambiare il supporto grafico. I segni sono solo apparentemente cancellati di volta in volta poiché essi rimangono pure impressi sulla superficie sottostante al primo strato di pellicola. Al di sotto di questo strato restano delle tracce, che nel tempo si stratificano e si confondono le une con le altre. Le tracce grafiche vengono paragonate da Freud alle impressioni ricevute dall'esterno che si sono sedimentate al di sotto della soglia cosciente, la pellicola sovrastante prende invece il carattere della coscienza percettiva. La distruzione delle annotazioni già prese in un dato contesto psicologico è solo apparente: le tracce restano ed è per questo che possono essere riportate alla luce. 106 gruppi vivi e reali che esistono, o sono esistiti: per questi, infatti, al contrario, tutti gli avvenimenti, tutti i luoghi e tutti i periodi sono ben lonta ni da ll’a vere la stessa importa nza , poiché non sono vissuti a lla stessa ma niera ” (Halbwachs 2001, 161 corsivi aggiunti). Conferire alla disciplina della storia il compito di dipanare il “groviglio” della memoria balcanica implica la possibilità di sottrarsi alla domanda: Cosa sono, dunque, i Ba lca ni? (Todorova 1997, 268). Se la domanda appare scontata è perché la risposta che notoriamente vi si accompagna è in rima con il senso comune banalmente vigente, ovvero “tutto quello che c’è a Est” dell’Europa (sic), che oggi è già in parte Europa (nel senso di “Unione”), in ogni caso, forse, non sarebbe più nemmeno tanto corretto continuare a chiamarli “Balcani” quanto piuttosto “Sud-Est Europa”, conferendo all’idea di Europa, in perfetta assonanza con l’antropocentrismo vecchia maniera, il compito di definire una parte di mondo in relazione alla posizione occupata rispetto ad un punto fermo e definito (mettendo da parte, e a fatica, l’euroscetticismo dilagante). Per trovare una risposta, poniamo una ulteriore domanda: essi sono Balcani oppure sono visti come Balcani? Tra “vedere come” ed “essere” Balcani corre la stessa relazione che generalmente si individua nella relazione tra “interpretante” e “significato”: semplificando il discorso, “essere Balcani” ha a che fare con il significato, il quale “(…)presuppone che esista un senso dei concetti autonomo e indipendente da coloro che li utilizzano, dai contesti in cui sono utilizzati e dalle teorie con cui si interpretano quei contesti” (Gangemi 1999, 153-160), esaltando così una relazione forte tra l’oggetto, il segno (o nome) e il significato autonomo ed indipendente dell’essere Balcani; “vedere come” ha a che fare con l’interpretante e presuppone “(…) che non esist[a] alcun significato oggettivo (al massimo esiste un significato consolidato dalla e nella tradizione), che tutti i significati sono sempre interpretati da chi li utilizza e che è l’interprete (…) a rivestire di significato i concetti che utilizza perché l’uomo è, per sua natura, un animale simbolico”, dove la relazione forte è quella tra, appunto, l’interpretante e il referente e, dall’altra, l’interpretante e il significante. Pure se non è disponibile, quindi, alcun significato oggettivo, non da meno i Balcani si accompagnano ad un significato consolidato nella tradizione, e basterebbe “Balcani, la polveriera d’Europa”, “i Balcani segnano l’inizio e la fine del secolo con una guerra”, e così via. Essi, quindi, “sono da vvero” Balcani. Questa trasformazione del passato dei Balcani in un presente sempre ricorrente è un’operazione compiuta anche da Rebecca West nel suo studio, datato 1941, Bla ck La mb a nd Grey Fa lcon , in cui chiarisce la ciclicità ricorrente di determinate assunzioni attraverso uno stile espositivo che non è esclusivo di quegli anni: Robert Kaplan osserva che “Avrei preferito perdere il mio passaporto o i soldi invece della mia copia ampiamente sfogliata e annotata di Bla ck La mb a nd Grey Fa lcon ” (Kaplan 2000, 39). E infatti l’influenza del libro della West su Kaplan è manifesta. L’incanto di Rebecca West per i Balcani è il prodotto della percezione di “(…) una terra in cui tutto era [immediatamente] comprensibile”(West 1993, 1), atteggiamento che richiama quella “chiarezza beata” che Roland Barthes individua nel mito, i cui effetti inducono “le cose a significare qualcosa da sole” (Barthes 1972, 142-43). I Balcani di Rebecca West sono un luogo in cui le persone agiscono entro un dramma storico che ha luogo da secoli, un elemento che, secondo l’Autrice, “impreziosisce” in qualche modo gli jugoslavi e consente, in un prolasso di significato, di identificare gli individui che di volta in volta compaiono sul palcoscenico balcanico come gli interpreti della parte del Serbo, del Croato e del Turco entro Damiano Fanni “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche questa “recita a soggetto” che costituisce i Balcani. Così, per la West anche i commensali in un ristorante a Senj erano innanzitutto esponenti di un determinato e determinabile gruppo etnico: quando un cliente ha esternato, gridando, le proprie rimostranze per la “minestra fredda come l’acqua del mare”, la West ha capito che “non stava lamentandosi della minestra. Stava gridando ai Turchi, ai Veneziani, agli Austriaci, ai Francesi ed ai Serbi [nel caso fosse un croato] o ai Croati [in caso fosse un serbo]. È stato un bene che abbia gridato” perché così ha reso giustizia alla memoria dei suoi “antenati [che] sono sopravvissuti perché hanno avuto il potere di gridare, rifiutando la minestra fredda”(West 1993, 128). Ancor oggi, i Balcani tendono ad essere percepiti come straordinariamente trasparenti, così coincidenti con la loro essenza, così prevedibili e ad una dimensione, ovviamente quella balcanica. Per la comprensione del fenomeno attributivo che innesca la “natura balcanica” occorre un’indagine che parta dal nome. C’è un monte che separa la Bulgaria dalla Romania, Aemus per i greci antichi e Ha emus per gli antichi romani che, per un’errata convinzione che ha resistito almeno fino al XVIII secolo, si riteneva fosse parte di una catena montuosa che attraversava l’intera Europa, collegandosi alle catene montuose europee in Croazia (Todorova 1997, 50-52). Sono i turchi a chiamarlo Ba l-ka n , montagna generalmente ricoperta da foreste e difficile da attraversare ed è dal 1827 che il nome Ba lka n iniziò ad essere utilizzato per indicare l’intera penisola, quando, come riporta la Todorova, Robert Walsh si riferì al fatto che i vescovi nei Balcani erano pur sempre greci…(1997, 51). Ne “Immaginando i Balcani”, Todorova traccia la genealogia del “Balcanismo” attraverso un’indagine sui racconti di viaggio di autori occidentali per ripercorrere le modalità con le quali il termine “Balcani” è stato costruito attraverso una connotazione negativa durante gli ultimi tre secoli. Todorova individua tre fasi dello sviluppo del “balcanismo”: I Balcani vennero prima “scoperti” attorno alla fine del XVIII secolo dai viaggiatori occidentali. Benché questi primi resoconti occidentali sui Balcani contenessero alcune inesattezze geografiche, lo stile utilizzato è principalmente classificatorio e descrittivo; Dopo una serie di guerre nei Balcani e con la prima guerra mondiale, i Balcani divengono progressivamente oggetto “(…) di saturazione dell’appellativo geografico con tutti i sottintesi politici, sociali, culturali e ideologici, e dell’inizio dell’uso peggiorativo di ‘Balcani’”(Todorova 1997, 22-23); Oggi il termine “Balcani” è stato quasi completamente dissociato dal referente e i giornalisti e gli accademici utilizzano il costrutto “Balcani” come un potente simbolo collocato convenientemente fuori da qualsiasi contesto spaziale o temporale. “Balcanizzazione” ora indica generalmente la disintegrazione delle nazioni e il possibile innesco di una spirale verso “the tribal, the backward, the primitive, the barbarian” (Todorova 1994; vedi anche Iveković 1995). Questi stereotipi balcanici si sono rinvigoriti nel corso dell’ultima guerra nell’ex Iugoslavia, spesso definita la “guerra nei Balcani” malgrado il fatto che fossero coinvolti soltanto gli stati dell’ex-Jugoslavia e che prima della guerra la Jugoslavia fosse considerata come “la stella brillante” dell’Europa Orientale. Il metodo archeologico di Todorova nello studio dei Balcani e del Balcanismo ha molto in comune con il lavoro di Edward Said e le sue analisi in Orienta lismo. Said argomenta le modalità in cui “(…) la cultura europea ha saputo trattare - e persino creare, in una certa misura – l’Oriente in campo politico, sociologico, militare, ideologico, scientifico e immaginativo (…)” (Said 2002, 13) con i “discorsi” sull’Oriente che lo hanno trasformato in “essenzialmente altro”, attraverso dico- 107 n.17 / 2007 tomie tessute su rappresentazioni stereotipiche funzionali a rinforzare l’immagine dell’Occidente quale civiltà superiore. Todorova dimostra che un simile fenomeno esiste fra i Balcani e l’Europa. Scrive: “Geograficamente inestricabili dall’Europa, benché culturalmente costruiti come ‘l’altro’ al proprio interno, i Balcani (…) sono stati in grado di assorbire un certo numero di frustrazioni poltiche, ideologiche e culturali (…) che derivano da tensioni e contraddizioni proprie di regioni e società esterne ad essi”, e aggiunge: “I Balcani sono serviti da ricettacolo delle caratteristiche negative contro cui è stata costruita un’immagine positiva ed autocompiacente dell’’europeo’ e dell’’occidentale’” (Todorova 1997, 310). L’Autrice sostiene che i Balcani sono una parte di Europa, anche se una parte provinciale o periferica e quindi il balcanismo origina da differenze interne all’Europa: “La mia tesi sostiene che mentre l’orientalismo si occupa della differenza fra (supposti) tipi, il balcanismo affronta le differenze all’interno di un solo tipo” (Todorova 1997, 42), il tipo-Europa, meno propenso ad affrontare le proprie contraddizioni interne di quanto non lo sia a proiettare la sua “metà oscura” sui vicini Balcani. Il nome “Balcani” ha spesso indignato quanti ritenevano ingiusto e scorretto continuare ad indicare un’intera regione con un nome dato dai turchi a un monte di poco conto, e non mancarono i tentativi di de-balcanizzare i Balcani, col chiaro intento di “ripulire” l’immagine del referente per “sdoganare” il significato. Oggi si preferisce, specie istituzionalmente, parlare di Sud-Est-Europa, che suona anche come un auspicio e sprono per il raggiungimento di un obiettivo che dovrebbe contribuire alla risoluzione dei problemi che, notoria mente, attraversano la regione. “Notoriamente”, proprio perché le memorie che hanno avuto un ruolo nei paesi dell’ex-Jugoslavia non sono esclusivamente quelle autoctone: paradossalmente, un qualsiasi discorso sul ruolo e la valenza della memoria - intesa in senso ampio - relativamente ai Balcani non è rilevante solo per la zona in questione se, come in questo caso, l’interesse alla memoria è principalmente legato al ruolo giocato nella preparazione e conduzione del conflitto armato; ma è rilevante pure per tutti quei soggetti che vi hanno preso parte a diverso titolo: le organizzazioni internazionali ed ogni specifica azione a queste riconducibile, le diverse ONG, organizzazioni internazionali di pace e di volontariato italiane, speso nate informalmente e con momenti fondativi che hanno inciso nel senso di cortocircuitare le memorie dei Balcani con quelle sui Balcani: Luca Rastello lo spiega in “La guerra in casa” dove racconta come il coinvolgimento personale, e della sua famiglia, nel conflitto dell’ex-Jugoslavia è stato tale che sua figlia aveva imparato alcune parole “(…) di una lingua che non esiste più, il serbocroato” (Rastello 1998, 3). Più avanti descrive la morte di Sergio Lana, Fabio Moreni e Guido Puletti, pacifisti volontari in missione il 23 maggio 1993 mentre, assieme ad Agostino Zanotti e Christian Penocchio, cercavano di portare a Zavidovići un carico di aiuti e i documenti per l’espatrio di decine di vedove con i loro figli che dovevano essere ospitate a Brescia (Rastello 1998, 142 e segg.). Overla pping Histories sono storie sovrapposte che generano quelle memorie che Banasik e Pennebaker chiamano fla hbulb memories, una mistura nella memoria di circostanze personali ed eventi storici, quando la Storia fa da sottofondo agli “assolo” della vita personale svolgendo la trama delle interconnessioni fra le diverse dimensioni della memoria (Banasik e Pennebaker 1997, 4-5 e 35-40). Non ci si può sottrarre all’incombenza della memoria e non esistono mezzi o strumenti per poter classificare il valore di una memoria; a questo si aggiunge il riconoscimento risolutivo ed immediato delle memorie altrui, il che testimonia le difficoltà presenti nel riconoscimento delle proprie: 108 Damiano Fanni “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche quanti, infatti, all’indomani dello scoppio della guerra che ha coinvolto i paesi dell’ex-Jugoslavia, avranno potuto esimersi dal pensare “un’altra guerra nei Balcani, un’altra scintilla nella polveriera d’Europa”? Tutti coloro che, con la West, “conoscono” la risposta alla domanda posta in apertura dalla Torodova. La memoria non è un contenitore immutato ed indifferente rispetto al contenuto, che attinge costantemente e in modo indefesso dal passato per pianificare il presente, quanto piuttosto il prodotto di un processo che risente dell’azione della matrice della memoria collettiva e che si orienta in relazione alle diverse issues. La “scena primaria” balcanica: tra monasteri, memorandum e fr a mes In psicoanalisi la scena primaria rimanda all’origine delle pulsioni sessuali ma, senza ribadire la congruità della coppia Eros-Tha na tos, in questo caso interessa la parte che evidenzia come le fantasie legate alla scena primaria sono “(…) il prodotto dell’elaborazione e configurazione dell’evento vissuto attuate posteriormente nel ricordo” (Mertens e Haubl, 1996). È chiaro che le disposizioni interne incidono sulla colorazione dell’elaborazione dell’evento e, come visto prima, chiameremo “sensibilità” balcanica, nell’accezione deweiana del termine, tale originale capacità di reazione a determinati stimoli. E questo reintroduce con prepotenza l’umano nella storia. È plausibile pensare che si possano rintracciare nella storia dei Balcani avvenimenti che hanno contribuito alla strutturazione di questa matrice della memoria collettiva, “chiodi e tavole” reinventate che attendono una nuova organizzazione. Quale che sia il materiale storico di queste “scene madri”, tuttavia, esso risulta da un lavoro di selezione e ricostruzione che manca di oggettività, obiettività ed imparzialità, tutti vizi che incideranno sul lavoro storico finale, precludendo un confronto eventuale con le storie di altri paesi, e anche su chi questo lavoro lo fa: “[Lo storico] anche quando scrive la storia del suo paese, si sforza di raccogliere un insieme di fatti che potrà essere posto a fianco di un altro insieme, per esempio alla storia di un altro paese, in modo tale che non vi sia alcuna soluzione di continuità, e che nel quadro complessivo della storia d’Europa si trovi non l’intersezione di più punti di vista nazionali sui fatti, ma piuttosto la serie e la totalità dei fatti così come sono, non per il paese tale o per il gruppo tale, ma indipendentemente da qualunque giudizio di un gruppo” (Halbwachs 2001, 161). Al fine di comporre una “nuova storia” gli elementi che componevano la vecchia vengono selezionati, ristrutturati, enfatizzati, riconfigurati, e pure dimenticati. In questo senso esiste un processo di autenticazione che gli storici compiono nella ricomposizione dei nuovi eventi, al quale se ne affianca uno di de-autenticazione di tutte le altre combinazioni possibili. Dimenticare non è mai un evento accidentale, ma può essere coscientemente indirizzato verso la negazione della cittadinanza ad ogni collezione di eventi alternativa a quella “ufficiale”. Rilevanza e irrilevanza non sono qualità in sé, sono costrutti e, quindi, strategici: i cicli, le ridondanze, i destini ineluttabili, la terra inzuppata di sangue e le torri di teschi non sono certo appropriati per una ricostruzione propriamente storica, eppure sono “Solo [le] parole che volano di bocca in bocca, leggende e canti, nei confini del paese [che] tengono il popolo in vita”16. Parole, leggende, storie al plurale per un’audience composita con differenti sensibilità e una disponibilità ad ascoltare ed impa ra re differente da quella che potrebbe aversi da quanti studia no un manuale di storia. Prendiamo in considerazione le “storie” che seguono. 16 Grundtvig N.F.S. “Budstikke i Høinorden” citato in De Certeau 2001, 195. 109 n.17 / 2007 - Il monastero di Visoki Decani in Kosovo è letteralmente forgiato dalla memoria. Tutti i giovedì i monaci di Visoko Decani si preparano per un rito che consiste nell’aprire il sarcofago dove sono conservate le spoglie mortali di Stefan Decanski che fu re dei Serbi fino al 1331 quando venne ucciso, strangolato, dal figlio Dusan che governò il glorioso impero per soli quattro anni, prima di morire (Judah 1997b, 23). I monaci raccontano che quando vengono esposti i resti di Stefan Decansky in estate, la chiesa si riempie di un dolce profumo di rose. Questo non è importante storicamente, non spiega gli “accordi” di Dayton, nè il bombardamento del ponte di Mostar, l’assedio di Sarajevo, il bombardamento di Belgrado. La domanda è: perché queste informazioni sono ancora oggetto di discussione? Chi le ha selezionate? Chi ha definito rilevante il rito che ancora si celebra dopo quasi sette secoli? Quel rito che sarebbe cessato per sempre senza l’intervento dei militari italiani che durante la guerra lo protessero dagli attacchi della resistenza nazionalista albanese, segnando l’inizio di un sentimento di riconoscenza verso le truppe tricolori “(…) Noi non abbiamo brutte esperienze con loro. Le truppe dell’esercito erano davvero amichevoli ma le ca micie nere erano aggressive” (Judah 1997a, 131). Si sarebbe potuto sentire un commento analogo da un monaco croato? - Più di trentacinque anni dopo la seconda guerra mondiale morì Vitomir Janković, un operaio, probabilmente un custode della città bosniaca di Odzak. La sua fama era nota in città per la sua partecipazione ad un massacro di musulmani nel novembre 1941 ed era stato accusato di aver fornito informazioni sui partigiani qualche mese prima, ragion per cui non godeva della fiducia tra i suoi vicini serbi. In virtù della sua notorietà, la notizia della sua morte si diffuse rapidamente e giunse a Sarajevo mentre vi era in visita Avdo Čelik. Avdo Čelik è il figlio di un musulmano vittima di Janković nel 1941; dopo aver sentito parlare di lui e della sua storia, acquista una cartolina e la invia alla famiglia Janković con una sola frase: “Le mie congratulazioni per Vitomir Janković, morto come un cane”. Questo accadde 10 anni prima che Avdo ricevesse una risposta: “Cordiali Saluti”. Non scrisse altro Mile Janković, figlio di Vitomir, il quale, all’inizio dell’escalation della guerra etnica nell’ex-Jugoslavia, aveva ucciso i cugini di Avdo vicino a Visegrad, gettando poi i loro corpi nel fiume di Drina (Sudetic 1998, 52). Sono storie, queste, che non fanno la Storia e non la cambiano. Sono storie che non dicono nulla, spaccati di micro-realtà che possono ritrovarsi in diversi contesti ed assumere, o venire interpretati, secondo sensi diversi che predispongono a significati diversi. - Durante un’intervista a Sarajevo, un ricercatore italiano presso la facoltà di studi islamici lamentava la mancanza di rielaborazione storica degli eventi che hanno segnato i Balcani: “(…)Qui la storia si fa con “la lista della spesa”. Hai la lista, prendi quello che vuoi, o quello che devi, dipende da cosa devi legittimare in quel momento. Manca una storia condivisa. Ce ne sono tre ma solo una ufficiale, che non considera nessuno in quanto non vi ci riconosce nessuno, ma che funziona finché tutto quello che sta intorno regge (…) Appena qualcosa scricchiola o si ferma allora emergono le vere storie, quelle della gente che va in chiesa o in moschea, che usa l’alfabeto cirillico o quello latino, che si ricorda l’importanza o la necessità di essere diversi. (…) A Sarajevo non c’è un istituto di cultura. Ce ne sono tre. Devi andare in ognuno, sha kera re il contenuto e poi vedere quanto, ed è tanto, è frutto di invenzione. (…) È facilissimo fare la storia, una storia che sia funzionale alla spiegazione di quello che cade oggi e presumibilmente domani. Quando è morto Tito, nessuno ha par- 110 Damiano Fanni “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche lato dello scioglimento della Jugoslavia, nessuno... neanche all’estero. (…) Ricordo che il presidente americano (Clinton) arrivato in Slovenia salutava con gioia “il popolo slovacco”. Slovacchia, Slovenia, Slavonia... che confusione!”. Più avanti, aggiunge: “Una volta sono stato in un quartiere prevalentemente serbo di Sarajevo, ospite di una famiglia che mi spiegava che l’intera loro esistenza si svolge nella Repubblica Srpska a Lukavica, a tre minuti da qua, però dall’altra parte. E loro la mattina escono di casa ‘in apnea’ nella valle e fanno tutto al di là: scuola, lavoro, compere, tutto. E come vanno le cose a Lukavica [qua rtiere serbo a Sa ra jevo]? Come in tutta la Repubblica Srpska, ha problemi enormi: 43% di disoccupazione, miseria e fame, sporcizia e disperazione (…) Ho amici sia serbi che bosniacchi i quali mi consigliano o sconsigliano di visitare un luogo, a seconda che il posto in questione sia in Bosnia o in Repubblica Srpska. Molti serbi a Sarajevo si vergognano anche di passeggiare in centro…“ Innegabilmente questa serie di citazioni ha fatto precipitare il discorso verso toni finora inediti. Probabilmente è l’umano che irrompe quando le storie che nessuno studierà restano a disposizione per essere imparate, raccontate ed ammantate di veri o finti particolari che plasmano la sensibilità incidendo su quella forza “(…) che sia prospettica, di qualità dinamica, pronta a manifestarsi apertamente” che è l’abitudine. La risposta alla crisi della Jugoslavia potrebbe trovarsi in una più precisa definizione della “matrice della memoria collettiva”, anzitutto per esorcizzare gli “Spettri dei Balcani” che solo inseguono la necessità di una spiegazione coerente e logica - e ad uso esterno dai Balcani, talvolta giustificativa nella politica interna - per quanto accaduto. A Sarajevo, Belgrado e Zagabria non ci sono più “spettri” di quanti ve ne siano alla stazione di Bologna, in piazza Fontana o a Manhattan, sul muro di Berlino, in quello di Israele… Si cercherà di esaminare parte della letteratura attorno a questi ed altri fantasmi e sulle strutture della temporalità che hanno consentito “apparizioni” e “sparizioni” spettrali. D’altro canto, come vedremo, l’ex–Jugoslavia non si discosta da una più generale “crisi di memoria” che deve essere contestualizzata più specificamente sul problema dell’immaginazione di un passato collettivo, delimitato nel tempo e nello spazio ma sempre strumento pronto a trasformarsi in “mezzo”. La saga dei “Jankovićs” e “Čeliks” prima citata è parte dell’opera di Chuck Sudetic, per il quale gli eccidi degli anni ‘90 hanno palesato “un culto dei morti, un mondo dove le memorie e le storie per la notte hanno fuso la storia entro il proprio orizzonte” (Sudetic 1998, xxxi). Dal canto suo, l’Autore passa in rassegna un considerevole numero di altri osservatori bene informati per quali “i miti mortali” della nazione serba o croata hanno costituito “la struttura profonda” della tragedia jugoslava. Nel forse più completo resoconto sui serbi, per esempio, Tim Judah rileva la natura seriale di “incendio dei villaggi, massacri e fuga” e struttura le sue descrizioni come una serie di ripetizioni: 1804, 1876-78, 1912-13, 1941-45, 1991-95. Judah insiste sulla forza dei miti collettivi e la vitalità delle memorie del gruppo: con evidente approvazione cita Ljubomir Nenadović, scrittore serbo del diciannovesimo secolo: “Quando parlate con questa gente, avete l’impressione che la battaglia di Kosovo-Polje è avvenuta ieri” (Judah 1997a, 65). Commentatori perspicaci quale Roger Cohen, che segue la saga di numerose famiglie a Sarajevo; Marcus Tanner, che ha condotto studi sulla Croazia; e Robert Kaplan, il cui titolo del libro - Fa nta smi dei Ba lca ni - è un efficace sunto delle sue tesi, sottolineano ampiamente il punto di vista “esterno” secondo il quale persone comuni convivono costantemente nella vita quotidiana con un “viscerale senso del passato”. E anche 111 n.17 / 2007 17 O “eterno ritorno” elemento portante della filosofia di Friedrich Nietzsche. Il ragionamento che sta dietro al concetto di Nietzsche è che dato un tempo infinito, entro un sistema finito ogni combinazione può ripetersi infinite volte. 18 Nezavisna Država Hrvatska, Stato Indipendente Croato, era il nome dello stato che comprendeva la maggior parte della Croazia durante la Seconda Guerra Mondiale. 112 quanto gli osservatori stranieri abbiano utilizzato la chiave di lettura del passato balcanico sempre ricorrente17, così come descritto da Rebecca West. I miti collettivi possono effettivamente modellare le identità sociali, ma non necessariamente in regime di “stimolo-risposta”. Come lo scivolone della West al ristorante potrebbe suggerire, esistono pesanti ostacoli - e tranelli - di fronte al presupposto che gli argomenti storici sono costantemente presenti e immutati entro le vetuste tradizioni collettive: la minestra, talvolta, è semplicemente fredda. Srebrenica è un nome evocativo; non lo sono Bjelovar, 184 serbi uccisi dagli Ustaša croati, 250 a Blagaj, 300 a Glina, 150 a Gacko, 1200 a Grabovac e i 20.000 serbi morti nei mesi estivi dell’anno 1941. Erano anni in cui la morte era un prodotto diffuso; Srebrenica è considerato invece il massacro più grande della storia dopo la seconda guerra mondiale. Non c’è dubbio, commenta Marcus Tanner, che la NDH18 “intendesse sterminare la popolazione serba e non vi è riuscito soltanto perché non disponeva degli strumenti necessari” (Tanner 1997, 153), e se è vero che non si processano le intenzioni, è pur vero che “dopo tutto, i serbi non sarebbero stati manipolati se non ci fosse stato materiale con cui manipolarli”, commenta Tim Judah (1997b). A questa interpretazione debole si potrebbe contrapporre quella forte di Schön e Rein i quali, per gli aspetti che in questa discussione sono rilevanti, spiegano come il materiale per “manipolare” i serbi - ma non solo si è reso disponibile successivamente, piuttosto che essere già pronto, come conseguenza diretta di eventi determinati e determinabili. Partendo dall’assunto che tutte le situazioni che possono ritenersi reali sono per ciò stesso complesse, vaghe, ambigue ed indeterminate, Schön e Rein sostengono che, al fine di conferire un senso ad una situazione, è necessario definire le caratteristiche determinanti e le relazioni che intercorrono tra queste nella situazione in esame, pervenendo così alla costituzione di un “frame”, una cornice che è una struttura di credenza, di percezione e comprensione alla base di una posizione soprattutto politica (Schön e Rein 1994, 23). Al fra me viene affidato il compito di spiegare e si tratta di un “uso attivo” ovvero un uso che discende e dipende direttamente dall’atto della sua creazione. Questi presupposti sono alla base della creazione di una storia - un’altra storia che spiega la prima - e che è il prodotto di una procedura di selezione che viene definita di “na ming a nd fra ming” (Schön e Rein 1994, 26), attuata a partire da una situazione problematica che è vaga, ambigua ed indeterminata, e portata avanti attraverso la selezione e nominazione delle caratteristiche ritenute determinanti e che per questa via divengono ‘le cose’ della storia, ciò di cui la storia tratta. A seguire, ogni storia colloca le caratteristiche che ha selezionato entro il fra me di un contesto specifico. Si tratta di un modus opera ndi che Donald Schön racchiude in due sentenze chiarificatrici “I problemi non sono dati. Essi sono costruiti dagli esseri umani nel tentativo di dare un senso a situazioni complesse e tormentate” (Schön 1993, 144). Le osservazioni di Schön e Rein rendono disponibile una chiave di lettura particolarmente adeguata per il “Memorandum dell’Accademia delle Arti e delle Scienze di Belgrado”, un prodotto dove si coniugano capacità di sintesi, dovizia di particolari, attenzione per il passato e proiezione sul futuro, attendibilità, prestigio e tempismo. Alla voce “memorandum” il dizionario della Garzanti del 1984 riporta quanto segue: “scritto in cui sono ricordati a sommi capi i termini di una questione; libricino di note in cui si segnano le cose da fare giorno per giorno, per non dimenticarsene”. Così, quando venne pubblicato nel settembre 1986 l’intero paese rimase perplesso non tanto per i contenuti, già li viveva, quanto per il fatto che il memorandum aveva ordina- Damiano Fanni “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche to, dato senso ed inedita concretezza al sentire collettivo dell’epoca. Da questo punto di vista il documento è un distillato del malessere serbo del quale l’Accademia ha sentito il dovere morale di rendersi interprete, producendo un documento che fosse da monito e da guida: “Nessuno ha il diritto di chiudere gli occhi davanti a quanto si sta verificando e su quanto potrebbe accadere. In particolare non ha questo diritto l’istituzione scientifica e culturale del popolo serbo”19 e non dello stato serbo. Il documento si concentra sui maggiori problemi che ora necessitano di essere nominati ed inseriti in un fra me - che contenga anche un conseguente ed implicito aspetto normativo -: crescita economica, disoccupazione, relazione con le altre entità della Federazione nei confronti della quale la Serbia viene presentata in regime antagonistico: “(…) il ritardo relativo della Serbia è in primo luogo il risultato di un debole tasso di investimenti per abitante e non di una minore efficienza degli investimenti (…)[che] nel corso dell’ultimo decennio è stata la più elevata in Jugoslavia”. Un popolo virtuoso che fa tanto con poco, che non si è mai tirato indietro davanti ai richiami della Storia ma che è stato guidato da leaders miopi ed inetti: “Le concessioni che molti leaders serbi hanno fatto a spese del loro popolo non sarebbero state accettate storicamente ed eticamente da nessun’altra nazione al mondo, soprattutto perché i serbi non hanno mai, nel corso della loro storia, conquistato e sfruttato altri popoli” dirà Slobodan Milosević20 il 28 giugno del 1989 nel discorso di Kosovo-Polje. Tim Judah (1997a) inserisce nel suo libro una foto scattata quel giorno: alle spalle di Milosević campeggiano due date a caratteri cubitali, 1389-1989. Sembra quindi una finzione narrativa l’inizio del suo discorso quando afferma che “Oggi è difficile dire quale sia la verità storica sulla battaglia del Kosovo e cosa è leggenda. Oggi non è più importante. Oppressi dal dolore e pieni di speranza, i popoli ricordano e dimenticano e, dopo tutto, tutti i popoli del mondo fanno lo stesso”. Ma non tutti i popoli hanno combattuto la battaglia di Kosovo-Polje. Il Memorandum, invece, non fa alcun riferimento al mito: non si parla di “Grande Serbia”, né di Lazar, o di Miloš Obilić21. Consoni al ruolo che ricoprono, sottolineano che l’economia serba fornisce “l’immagine di una economia dipendente e trascurata nel quadro dello spazio jugoslavo”. Le ragioni? Nella passata gestione del “Kominterm autoritario [e nella] giustificazione ideologica dell’opporre la nazione serba ‘oppressiva’ alle altre nazioni ‘oppresse’”. Definito il problema, ergo la soluzione. Le cause individuate si configurano esterne alla Serbia, presuppongono un’interazione monca dove una parte - quella serba - virtuosa, aperta al dialogo, rappresentata da leaders incapaci e costretta a fronteggiare tutte le dinamiche implicite nella dizione “nazione serba oppressiva” si contrappone ad un “altro” generalizzato ed indefinito ma sempre pronto ad ordire un complotto. Come accadde, ad esempio, nell’errata valutazione della situazione economica, quando “un semplice colpo d’occhio agli indicatori di base del livello di sviluppo del 1948 [avrebbe confermato che] la Serbia non aveva goduto di una situazione economica privilegiata nel periodo fra le due guerre”. Ma l’errata valutazione ancora pesa, perché “diventa” la causa selezionata per ordinare la situazione attuale. È innegabile la presenza di un complotto architettato ai danni della Serbia al fine di “inculcare nel popolo serbo un sentimento di colpa che controbilanciasse la sua resistenza al dominio politico ed economico cui veniva sottomesso”. Quest’ultima è una metafora generativa à la Schön: come arriviamo a vedere le cose in modo nuovo? Anche la battaglia di Kosovo-Polje che vide i serbi opporsi all’invasione turca, così come ora li vede opporsi al dominio politico e, come contrappasso dantesco, l’interiorizzazione della colpa conse- 19 Tutte le citazioni che seguono sono tratte dal “memorandum” ove non specificato diversamente. 20 Il testo completo del discorso di Slobodan Milosević è consultabile sul sito www.trepca.net, indirizzo completo nella bibliografia. 21 Mitico eroe serbo che durante la battaglia di Kosovo-Polje del 1389 uccise il sultano turco Murad, vedi Hösch 2005, 73. Noel Malcolm, invece, nutre forti dubbi sulla serbità dell’eroe mitico, avanzando l’ipotesi di discendenza ungheresi o albanesi. Cfr. Malcolm 1999, 104-107 113 n.17 / 2007 guente all’atto. La metafora del sacrificio martirologico di Lazar che rinuncia ad un regno terreno per la conquista ultraterrena non passa per la trama del Memorandum, ovvero, il senso di colpa non ha ragion d’essere perché la resistenza al dominio politico – o all’invasione turca – è elemento di pregio che contraddistingue il popolo serbo, da sempre. Il mito c’è nel Memorandum, è un fra me elaborato in seconda battuta che supporta e conferma quello principale. Notare, peraltro, i tanti riferimenti a caratteristiche della personalità individuale, piuttosto che ad una ipotetica collettiva. Ragionando a contrario, “Non si vede come la mentalità collettiva possa significare qualcosa di più che un costume portato in qualche punto fino al grado di coscienza esplicita ben rilevata, emozionale o intellettuale” (Dewey 1958, 67), anche se esistono riserve sull’accettare un costume collettivo come la rappresentazione diffusa di un costume individuale, in nota Dewey precisa che “(…) i capi di un’organizzazione (…) possono, allo scopo di far trionfare certi progetti, ricorrere deliberatamente a stimoli che spezzera nno la crosta del costume ordina rio e sfreneranno gli impulsi su tale scala da generare una psicologia di folla” (corsivi aggiunti) e prosegue “(…) vaste ondate di emozione travolgono le masse”. Trattando di memoria collettiva, non potremo evitare di parlare delle ‘vaste ondate di emozioni’ proprie delle folle. Che si distinguono dalle reazioni individuali non semplicemente moltiplicando il singolo. Come Gustave Le Bon (1970, 90-98) precisa, la folla tende a “diluire” quelle connotazioni specificatamente umane che caratterizzano l’individuo: analisi, ponderazione, elaborazione di una soluzione, sono fattori che tendono a zero in situazioni di crisi collettiva. È come se si demandasse agli altri parte della responsabilità sul “che fare”, oppure, come se la semplice osservazione del comportamento altrui costituisse un rinforzo circa la congruità delle proprie reazioni. Il conformismo ha una netta rilevanza in queste dinamiche. Rispetto al singolo, la folla si contraddistingue per i seguenti fattori (Delumeau 1979, 26): - influenzabilità; - carattere assoluto dei suoi giudizi; - rapidità della propagazione dei “contagi”; - riduzione del senso personale di responsabilità; - capacità di conversione repentina dell’atteggiamento: una folla acclamante il leader, facilmente si trasforma in una folla inneggiante l’eliminazione fisica della minaccia (del leader). A questi fattori si accompagna la seguente considerazione: mentre le paure collettive appartengono ad un genus che può essere mutuato dagli individui singoli, nel senso che le paure collettive possiedono la “dimensione del singolare”, non è vero che le paure individuali possono integralmente - e contemporaneamente essere collettive. La paura di una catastrofe naturale, di un’invasione, di un’epidemia, di una recessione economica, ad esempio, sono paure bi-dimensionali; la paura delle reazioni del proprio datore di lavoro, la paura della velocità, dei ragni, di essere scoperti in flagranza di infedeltà dal proprio partner, sono esempi dei limitati e personali scenari di paura che, peraltro, possiedono una dimensione temporale ben definita. La paura collettiva va intesa come “l’abitudine posseduta da un gruppo umano di temere questa o quella minaccia, reale o immaginaria” (Delumeau 1979, 26). “Abitudine” non deve intendersi come “tendenza”, anche seguendo Dewey, ma come esposizione a stress emozionali ripetuti, aggressioni psicologiche che hanno desensibilizzato il gruppo umano, che hanno modificato sensibilmente - accor- 114 Damiano Fanni “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche ciandoli - i suoi tempi di reazione alla minaccia, ovvero, l’hanno a bitua to ad aver paura. Il fatto che l’abitudine abbia ad oggetto una minaccia reale o immaginaria, però, contravviene alla definizione di “paura” fornita da Freud, che presuppone la definizione dell’oggetto di cui si ha paura. La sensibilizzazione del gruppo alla minaccia, e l’indefinitezza di questa, trasforma la paura in a ngoscia : uno stato di tensione caratterizzato da inquietudine, ansietà, depressione, sensazioni che vengono originate dalla percezione di un pericolo non conosciuto, non presente, non nominato eppure così “reale”. L’angoscia, a differenza della paura, è prettamente umana: la sua presenza presuppone una memoria collettiva - vissuto - e previsionalità: “(...) l’uomo reagisce a una situazione critica in funzione del suo vissuto anteriore e dei suoi ricordi” (Delumeau 1979, 28). La mancanza di precisi riferimenti oggettivi rende l’angoscia più insopportabile della paura; l’incapacità di individuarne la causa la trasforma in un sentimento di insicurezza globale in cui l’immaginazione svolge una parte di rilievo. “Immaginazione” non come “invenzione”, ma come modalità di recupero di elementi comuni a situazioni ed eventi già vissuti (spesso subìti) dal gruppo sociale, che richiama “evocazione”; elementi che contribuiscono a “completare il quadro” in modo forzoso attraverso simboli - trasfigurazioni - il cui significato è un prodotto culturale comune. Nel fare questo gli individui trasformano il sentimento di angoscia generalizzata ed indefinita - nevrotica - in paure precise di qualcosa o di qualcuno, è sufficiente che sia “ben definito”. E gli accademici di Belgrado, appunto, “scrostano” la patina di angoscia diffusa ed inspiegabile che affigge il popolo serbo e definiscono le cause che normalmente sfuggono all’”uomo della strada”. Il bisogno da soddisfare è quello di ottenere un quadro esaustivo e coerente della situazione, una cristallizzazione discorsiva della Serbia che addomestichi il caos di risentimento e frustrazione dilaganti assieme ad un indefinibile “sentimento di colpa”. Oltre alla possibilità di rispolverare il richiamo al martirologio sopito nel “(…)popolo serbo, costantemente accusato di essere ‘oppressore’, ‘unitarista’, ‘centralista’, ‘poliziotto’, [che] non ha potuto ottenere diritti uguali a quelli di tutti gli altri popoli della Jugoslavia, paese per il quale ha sopportato i maggiori sacrifici”. Ingratitudine, fraintendimenti, etichettamento, e non basta, perché è evidente una “coalizione antiserba” che resiste malgrado il paese abbia “(…) con il suo contributo, aiutato lo sviluppo delle regioni sottosviluppate mentre si assumeva il fardello delle regioni sviluppate (…) la Serbia si è scontrata con l’incomprensione delle une e delle altre”. La foto accanto riproduce forse il dipinto più popolare della Serbia ad opera di Uroš Predić, che fu membro dell’Accademia di Belgrado. Il dipinto fu portato a compimento nel 1919 ed il nome è “la ragazza del Kosovo”. Tiene amorevolmente la testa di Lazar morente e gli porge del vino con una coppa d’oro, sullo sfondo della battaglia di 115 n.17 / 2007 22 Un’altra interpretazione atribuisce alle Quattro lettere il significato di “Sveti Sava - Srpska Slava” ovvero Santo Sava, patrono della Serbia. Ma le notizie non concordano. 116 Kosovo-Polje del 1389. E in Kosovo ci sono i giacimenti minerari più importanti di tutto il Sud Est Europa (Malcolm 1999, 33-34). È interessante notare il senso di beata rassegnazione del viso della ragazza. Sembra l’incarnazione della certezza nell’ineluttabilità del destino, nella necessità del sacrificio perché, come ricorda Tim Judah, “È meglio morire in battaglia che vivere nella vergogna”. Anche nei toni del Memorandum aleggia una sorta di strana rassegnazione, la constatazione distaccata che le cose vanno così com’era prevedibile che andassero. La sindrome dell’incompreso: “La voce di un elettore serbo vale meno di quella dell’elettore di una qualunque delle altre repubbliche o province autonome”, la Vojvodina e il Kosovo. Le quali sono potentemente autonome, nel senso che, pur avendo un numero inferiore di rappresentanti negli organi della federazione, esse “compensavano queste carenze col fatto che, tramite l’Assemblea Repubblicana, possono intervenire negli affari interni della Serbia nel senso stretto del termine [senza province] mentre le loro Assemblee sono del tutto autonome”. Soffre la Serbia a constatare che il grado di autonomia delle province è così elevato che quasi sono repubbliche anch’esse: riconosce che ci sono state forti tendenze separatiste ma queste non avrebbero avuto seguito se “non avessero ottenuto il sostegno morale e politico delle repubbliche nelle quali le tendenze separatiste non sono mai scomparse”. Che dire riguardo al “sostegno morale”? Che man mano che il discorso scende sui particolari, gli stati antropomorfizzati hanno bisogni umani, paure umane, risentimenti, rancori. Ovviamente è una forzatura, ma è indubbio che l’Accademia conoscesse perfettamente le “corde” del Paese: così come questo documento non suscita le stesse riflessioni indipendentemente da chi lo legge, così il richiamo subliminale che è racchiuso in questa precisa sequenza di argomenti era potenzialmente in grado di smuovere esattamente le persone cui era rivolto. Per quelli che non hanno ancora capito, Само Слога Србина Спасава (Sa mo Sloga Srbina Spa sa va ), cioè, “solo l’unità salva i serbi”, è ciò che significano le quattro “C” della croce tradizionale serba22. “Se abbiamo perduto la battaglia fu non solo per la superiorità sociale e militare dell’impero ottomano ma anche per la tragica disunità della leadership dello stato serbo dell’epoca” ricorda e precisa Milosevic. Nel lontano 1389 esattamente come ora, ricordano all’Accademia, “Gli avvenimenti in Kosovo alla fine degli anni sessanta mostrarono a che punto si può arrivare quando l’autonomia viene accresciuta”, forze cospiratrici cercano, “seminando disinformazione, di dividere il popolo serbo in ‘serbi di Serbia’ e ‘serbi al di là del fiume’”. E proseguono con l’accusa di aver aiutato le nuove province autonome a comportarsi come entità federali “(…) dimenticandosi che sono parti costitutive della Repubblica di Serbia”. Sfugge, ma è una svista voluta perché parte integrante del fra me, un’analisi sui motivi per cui i le province autonome si “dimenticano” di essere parte della Serbia. Per il Kosovo sono chiare le spinte autonomiste degli albanesi, per la Vojvodina nell’era avanzata dell’espansione asburgica a sud-est, le famiglie dei magnati austriaci e magiari avevano accumulato una considerevole proprietà latifondista fino al punto che, nel 1945 anno della riforma agraria, il 41% delle terre Jugoslave espropriate appartenevano alla minoranza tedesca presente e fiorente soprattutto in Vojvodina che venne successivamente deportata attraverso rappresaglie e sfollamenti e rimpiazzata da immigrati serbi (Hösch 2005, 205 e 252). Tim Judah precisa che si trattava di circa 350.000 tedeschi sfollati e rimpiazzati da serbi bosniaci e croati (Judah 1997a, 154). Come può la Vojvodina “dimenticare” di esser serba? Ancora, la personificazione delle entità territoriali è stupefacente. In un crescendo di astiosità e dimenticanze stra- Damiano Fanni “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche tegiche incompatibili con il fra me che va costruendo, l’Accademia prepara il colpo finale, l’argomento che pone una pesante ipoteca sull’eroismo e soprattutto sulla memoria di Miloš Obilić che scambiò la sua vita col sultano Murad: “L’espulsione del popolo serbo dal Kosovo è la testimonianza spettacolare della sua sconfitta storica”. A cosa è servito perdere Lazar? Meglio la morte che la vergogna, ma i vivi dovranno vergognarsi fino a quando non capiranno che “il destino del Kosovo resta una questione vitale per il popolo serbo tutto intero”, compresi i figli di quelli che persero in Kosovo per mancanza di unità e che ancora oggi, divisi, assistono impotenti davanti al ripetersi della storia. Basterà la propensione serba al martirio a sopire gli animi? Le forze politiche serbe “organizzate hanno compiuto una rivoluzione in condizioni pressoché impossibili sotto il giogo del nemico più potente del secolo [il Reich]”: l’accento è su “organizzate”. Ora non lo sono più e non capiscono che devono rispondere “a una guerra aperta nel solo modo appropriato: con la difesa risoluta del popolo e del territorio”. Saltato il confine tra pensiero e azione, l’Accademia si erge in una dimensione a-temporale e a-storica e si rivolge alla “sensibilità” del popolo serbo che conosce benissimo, fornendogli il progetto per completare la cassetta di Dewey: chiodi e tavole ce ne sono a sufficienza. Anche fra mes. Ancorati ad un Ricor do Il Memorandum dell’Accademia colpisce per il suo ricercato equilibrio tra emozioni e dati, tra riletture del passato e consegne per il presente. Poggia su una ricostruzione storica ed analitica degli eventi ma tra le maglie scivola quello che abbiamo definito un richiamo subliminale che non è mirato ad un impatto puramente razionale. La materia prima della memoria è il ricordo, e la radice prima del termine “ricordo” è cor -cordis, che indica il cuore, e il cuore ha ragioni che la ragione non conosce, ricorda Blaise Pascal. Difficile mettere in discussione il potere di un ricordo, anche quando questo è falso. Fa lse memories è la dizione inglese per “ricordi apparenti”, detti anche “falsi riconoscimenti”. Ricordare è riconoscere, conoscere di nuovo: nel caso dei ricordi apparenti23, tuttavia, tale riconoscimento è falso e viene percepito come vero dal soggetto in quanto avviene in condizioni di supposta certezza del ricordo, così da ammantarli dell’attributo di veridicità. Una condizione necessaria, ma non sufficiente, per aversi una fa lse memory è la plausibilità del ricordo, ovvero, esso deve “rimare” con l’insieme dei ricordi che costituiscono la memoria. Un ricordo apparente è, quindi, il prodotto di fattori interni ed esterni all’individuo. Tra quelli esterni vi è l’opinione di una figura autorevole, la ripetizione dell’informazione con qualunque mezzo e attraverso qualsiasi forma, la condivisibilità dell’evento “ricordato” con altri soggetti - e che verosimilmente sono esposti ai medesimi stimoli24. Un falso ricordo, quindi, non deve necessariamente essere il prodotto di un singolo a suo uso e consumo, ovvero: nel tranello della memoria (spesso) ci si cade in compagnia. Ciò detto, pur nella sua intrinseca fragilità epistemologica, il ricordo è comunque “nostro”, e quindi l’attendibilità e soprattutto la veridicità – vera o presunta – hanno una rilevanza limitata rispetto alla sua capacità di spiegare, di mettere ordine tra altri eventi – pure questi ricordati – e anche di mantenere quella “condizione di equilibrio” che è il presupposto minimo per conservare una soddisfacente salute mentale. Ora, il ricordo è un segno che tende a restare, ma non come resta la cicatrice di una ferita chi- 23 Vedi voce “ricordi apparenti” in “Dizionario della memoria e del ricordo” op. cit. 24 Scrive Dewey: “Spesso si immagina che le istituzioni, il costume sociale, l’abitudine collettiva, si siano formati per consolidamento delle abitudini individuali. Per la maggior parte dei casi la supposizione è di fatto falsa. In molti casi, i costumi, o le uniformità di abitudine largamente diffuse, esistono perché gli individui si trovano di fronte alla medesima situazione e reagiscono in modo simile” (Dewey 1958, 65). 117 n.17 / 2007 25 Il riferimento è a Hobsbawm nell’introduzione a “L’invenzione della tradizione” (Hobsbawm e Ranger 1987, 3) 26 L’intera opera di Halbwacks richiama l’elemento sensibilità, quale tratto della matrice della memoria collettiva. Per serbare un ricordo, perché la testimonianza non sia un elemento completamente avulso dalla nostra memoria, è necessario che un individuo conservi l’abitudine e la facoltà di pensare e ricordare “(…) in quanto membri del gruppo del quale facevamo parte insieme ai testimoni, cioè ponendoci dal suo punto di vista, e facendo uso di tutte le nozioni comuni ai suoi membri” (Halbwacks 2001, 83) 27 Tra storia e memoria vi è una relazione discorsiva che le congiunge ma, precisa Halbwacks “Fra il viaggiatore e il paese attraversato non ci sarà vero contatto” (Halbwacks 2001, 127). La memoria autobiografica (il viaggiatore) si appoggia a quella storica (il paesaggio) in virtù della sua appartenenza, ma si tratta di una differenza di “densità”, dove la storia è il riassunto sintetico e la memoria un racconto denso e continuo. La storia non è la somma degli accadimenti ma un discorso sulla conoscenza di quanto è accaduto. In questo senso, come disciplina universitaria autonoma dal XVII secolo, la storia si studia e la memoria, in quanto passato “abitato” si impara. Vedi anche “Dizionario della memoria e del ricordo”, op.cit. 118 rurgica: “bruciature”, “ferite”, “scottature”, sono metafore che rinviano anche ad un avvenimento passato, un’esperienza, un ricordo che ha segnato l’esistenza, che ha impresso una svolta, che ha contribuito e contribuisce alla costituzione originale dell’irripetibile unicità dell’essere umano. Percorrendo la metafora, ciò che caratterizza il segno del ricordo, e la memoria nel suo insieme, riguarda la “mobilità dei punti di sutura”, vale a dire, l’apertura del ricordo alla possibilità di essere il prodotto di un’operazione di costruzione e/o ricostruzione o “invenzione”25. La memoria si costituisce in ricordi e questi hanno una propria ed implicita connotazione affettiva e sensibile. La traccia dell’avvenimento passato di cui tratta Halbwacks26, quindi, è ben più ed altro di una semplice constatazione meccanica dell’effettiva datità di un evento, quale potrebbe essere lo spasmodico ricorso a testimonianze ufficiali e/o l’ostinata ricerca di fonti storiche reputate inoppugnabili: è necessario “credere” nel ricordo, “sentirlo” attraverso codici che sono sufficientemente distanti dalla quelli della verità scientifica. Che non potrebbero esserlo nel caso in cui vi fosse una relazione precisa tra memoria e storia. Per avere solo un’idea della relazione27 tra i due fattori, utilizziamo la traduzione inglese del termine “studiare” che scinde i due aspetti in to study e to lea rn : la storia si studia, la memoria si impara. Così come si impara ad andare in bicicletta, e non lo si scorda più, così si studiano i nomi dei sette re di Roma, e li si dimenticano. Non si impara la medicina, la si studia, mentre si impara a cambiare la gomma dell’auto ma non l’io kantiano e anche il significato del séder , il banchetto ebraico, si impara. Un esempio della sovrapposizione tra storia e memoria è il caso di quelle che Banasik e Pennebaker chiamano fla hbulb memories (Banasik e Pennebaker 1997, 4-5 e 35-40), una mistura nella memoria di circostanze personali ed eventi storici, quando la Storia fa da sottofondo agli “assolo” della vita personale svolgendo la trama delle interconnessioni fra le diverse dimensioni della memoria28. L’idea di ciclo storico, come la Todorova ha messo in allerta, è perfettamente sovrapponibile all’immagine dei Balcani. Un ciclo deve avere un inizio. Nella formazione ed esistenza di un ciclo la memoria svolge un suo ruolo duplice, garantendo le condizioni per il suo innesco [memoria come dispositivo] e il suo sostentamento [memoria come riconoscimento d’appartenenza, formazione di identità]. Alcune delle memorie in gioco hanno precisi quanto deformanti punti di contatto con eventi storici, altre sono state forzatamente familiarizzate, altre ancora sono il prodotto dell’elaborazione del mito ma si tratta comunque di ricordi di dolore e di aggressioni (BetEl 2002, 206-222). E cosa importa se si tratta di accadimenti di diversi secoli addietro, se comunque l’effetto di quegli accadimenti ancora influisce e indubbiamente influirà sul futuro nei secoli? “In quale punto della storia dovrebbe iniziare la cronaca del conflitto fra serbi e albanesi per il Kosovo?” si chiede Zerubavel (2005, 11): compatibilmente con la disponibilità degli archeologi e dei finanziatori di continuare a cercare. Almeno fino a quando al carbonio14 non si sostituirà un nuovo metodo per la datazione dell’ultima moneta, dell’ultima iscrizione, dell’ultimo manufatto. Zerubavel chiama “battaglie mnemoniche” tutte le ricostruzioni del passato che, lungi dall’essere oggettive e funzionali per capire chi-ha-iniziato-cosa29, riescono solo a dimostrare che non tutti ricordano allo stesso modo, pur trattandosi degli stessi eventi e che “(…) l’acquisizione delle memorie di un gruppo, e quindi l’identificazione con il suo passato collettivo, fa parte del processo di acquisizione di ogni identità sociale, e far familiarizzare i membri con quel passato è lo sforzo principale di una comunità per assimilarli” (Zerubavel 2005, 14 corsivi aggiunti). Quindi non si tratta di un passato ma di molteplici, uno (solo?) per ciascun gruppo nazionale: i Damiano Fanni “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche croati nel passato dei serbi e dei bosniacchi30; i bosniacchi in quello dei croati e dei serbi; i serbi in quello dei croati, dei bosniacchi e dei kosovari albanesi; i kosovari albanesi in quello dei serbi. Questo incrocio di relazioni evidentemente è solo una ricostruzione ex-post della storia degli eventi e trasferisce la sua artificiosità alla formazione delle memorie dei gruppi nazionali coinvolti. Anche le memorie collettive internazionali giocano un ruolo importante, non solo quelle autoctone. Non è possibile sottrarre l’influenza internazionale dalla modellizzazione dell’ultima guerra balcanica: l’immediato riconoscimento dell’indipendenza della Slovenia nel 1991 ha preparato la scena per quanto è poi avvenuto. Gli accordi di Dayton nel 1995 hanno generato, più che una pace tra i contendenti, una situazione preparatoria di non-guerra “conclusa” nel 1999 con il conflitto in Kosovo. Evidentemente, la guerra non ha portato alla risoluzione dei motivi che l’hanno scatenata e, ammesso che essi fossero riconducibili ai “tipici rancori e odii balcanici”, la non-guerra sembra più che altro un momento di restaurazione della “polveriera balcanica”. [Intermezzo] “Bure ba ruta ” in serbo-croa to-bosnia co significa “La Polveriera ”, è il titolo di un film di Gora n Pa ska ljevic costruito come un schizofrenico puzzle metropolita no vissuto nell’a rco di una sola notte, in una Belgra do sma rrita nella violenza successiva a i conflitti degli a nni ‘90. La scena si gira su un a utobus, dove i pa sseggeri a spetta no pa zientemente che l’a utista finisca il suo ca ffè per pa rtire con 15 minuti di rita rdo. Uno di questi, un ra ga zzo, prende spunto da questo ma lcostume per urla re la sua persona le interpreta zione “Si ricorda signora com’era sotto i turchi?” “Come fa ccio a sa pere com’era sotto i turchi?” “Come fa a sa perlo? Fa cile, ci ha nno domina to per 500 a nni” “È vero, ma non ero na ta a quell’epoca ” “Allora pa rlia mo dei crucchi” “Non me li ricordo proprio i crucchi” “Non ricorda nemmeno quelli? Anche di questa guerra si è dimentica ta , vero? Il problema è questo…nessuno ricorda niente, qui. Mi pa re chia ro che a vete bisogno di un’a ltra guerra ”. Ricordare e dimenticare non sono antitetici ma si confermano vicendevolmente. L’oblio non è la perdita del fatto in sé, il puro accadimento, quanto piuttosto la perdita della rielaborazione che del fatto si è compiuta. Non si ricorda tutto, non si dimentica tutto: così come c’è una selezione e una rielaborazione che consentono all’evento di diventare parte della memoria, così anche l’oblio è selettivo: “Dimmi cosa dimentichi e ti dirò chi sei”, azzarda Marc Augé (2000, 30). I serbi non poterono certo dimenticare “le ragioni” del millenario vittimismo in occasione dell’espulsione e delle uccisioni dei serbo-croati nella regione della Krajina nel 199531; mentre l’immobilismo della scena internazionale durante l’assedio di Sarajevo ha indotto una reazione più solerte [e azzardata] delle forze internazionali in Kosovo. Ciò che forse avvenne per l’uso incondizionato e criminogeno di immagini deformate della storia ebbe un decennio di conflitti per riassestarsi e ri-orientare, ma non dissolvere, l’arsenale immaginifico. Il primo momento di coagulazione della memoria nei Balcani è, ovviamente, la battaglia di Kosovo-Polje del 1389. Nonostante Milosević, come già visto, abbia cercato, non volendolo, di ridimensionarne la portata mitica, in realtà ha solo provveduto a togliere la polvere di 600 anni di storia, attualizzando non la battaglia in sé – chi ha perso, chi ha vinto – quanto il messaggio dell’importanza, vitale per la Serbia, di riconquistare l’unità. Ma c’è anche un messaggio più profondo e totale, quello che profetizza la dissoluzione irreversibile della federazione jugoslava: “Sei secoli dopo, la Serbia eroicamente difende se stessa nel Kosovo, ma difende p. 552-53 e Assmann 1997, 17-20. 28 É l’esempio narrato con maestria nel film, composto da un insieme di ‘corti’ e di cui quello riportato è girato da Sean Penn, dal titolo “11 Settembre 2001”: un uomo anziano, in un appartamento molto buio. Sul letto, riposti con cura infinita, alcuni vestiti di donna, sono quelli di sua moglie. L’intero appartamento è un mausoleo in memoria della compagna di una vita. Ci sono dei fiori ormai appassiti sul davanzale di una finestra che resta comunque in ombra. D’un tratto la stanza si inonda progressivamente di luce intensa, inedita, inaspettata: crollando, una delle due torri lascia passare la luce del sole. 29 “Words of the past became weapons of war” (Bet-El 2002, 206) 30 “Bosniacchi” è la trasposizione italiana del termine inglese “bosniaks” che indica il cittadino di Bosnia-Herzegovina di religione musulmana. 31 Tra il 4 e il 6 agosto 1995 si effettua l’operazione “Tempesta”, in croato Oluja. I croati conquistano la Krajina, costringendo 170.000 serbi alla fuga. Hösch, p.390 119 n.17 / 2007 32 Questa parte del discorso, introvabile altrove, è riportata da Tim Judah 1997a, 29 33 “The here-and-now, which as the model of messianic time, summarizes the entire history of humanity into a monstrous abbreviation” (Benjamin 1999, 246) 120 pure l’Europa. La Serbia fu, in quel tempo, il bastione che difese la cultura europea, la religione e la società in generale (…) Camerati! Voglio dirlo, in primo luogo che dovreste rimanere qui. Questo è il vostro paese, queste sono le vostre case, i vostri campi e i giardini, le vostre memorie… Dovreste restare qui… In caso contrario sareste una vergogna per i vostri antenati e una delusione per i vostri discendenti. Ma non sto dicendo che dovreste stare qui soffrendo e perdurando in una situazione per cui siete insoddisfatti. Al contrario! Tale situazione dovrà cambiare! (…) La Jugoslavia non esiste senza il Kosovo! La Jugoslavia si disintegrerà senza il Kosovo! La Jugoslavia e la Serbia non molleranno il Kosovo!”32 Era la dichiarazione di morte della Jugoslavia. Parole che risuonavano nella piana dei merli con colore intonato per tutti coloro che hanno percepito la minaccia della ripresa dell’antico nazionalismo serbo che ha svolto un ruolo determinante anche nella formazione delle coscienze di quanti, di lì a poco, sarebbero stati coinvolti in un altro “ciclo della storia” balcanica. Come è naturale nel caso di memorie sovrapposte, da quelle parole ognuno ha ritagliato la parte che più lo chiamava in causa. I croati hanno recuperato le immagini di oppressione serba durante le due guerre e nella Jugoslavia di Tito; i musulmani di Bosnia hanno ripensato alla supremazia ottomana fino alla dissoluzione dell’Impero; i kossovari albanesi, probabilmente, non hanno dovuto sforzarsi troppo per ripercorrere la difficile convivenza nella regione, almeno dal diciassettesimo secolo in avanti. Tuttavia, ed è la parte che merita maggiore rilievo, le memorie serbe e croate si sono trovate coincidenti al confronto con la dominazione turca, quando uniti combattevano gli “infedeli”; e i serbi e i musulmani avevano condiviso il regime degli Ustaša e il campo di concentramento di Jasenovac. Tali memorie erano sopravissute agli sforzi della politica di Tito di “cacciare i rancori nel profondo freezer della storia”, senza successo (Glenny 1993, 148). C’erano tutti i motivi per imparare la memoria dei partigiani, degli ustaša, dei musulmani. I motivi che inducevano Tito a surgelare le memorie sono stati, al rovescio, gli stessi che hanno indotto i politici all’indomani della sua morte nel 1980 a “(…)ricorrere deliberatamente a stimoli che spezzeranno la crosta del costume ordinario e sfreneranno gli impulsi(…)”, spiega Dewey. La costituzione degli stati nazionali valeva bene un mito distorto, a discapito della coerenza narrativa, perché era necessario mobilitare gli individui affinché combattessero contro i - o supportati dai - ricordi del cuore. La nuova ricomposizione delle memorie è stata sufficientemente attenta a rimuovere ogni punto in comune, ogni memoria condivisa che avrebbe potuto vanificare lo sforzo. Era necessario buttare giù i ponti, anche fisicamente, enucleare impianti di memoria monolitici e autoreferenziali che potessero, radicalizzandosi e cristallizzandosi, giustificare e legittimare qualsiasi azione sulla base della memoria presente. Per Walter Benjamin il “tempo messianico” è una condizione di simultaneità del passato e del futuro in un presente istantaneo33, e tale situazione pare perfettamente congrua per i Balcani in generale e per i serbi nello specifico. Tim Judah descrive la santificazione del re medioevale Nemanja e la convinzione che i suoi discendenti serbi fossero il “popolo eletto”, nel 1848, assieme all’ondata di nazionalismo che imperversava in Europa, Ilija Garasanin, politico serbo di spicco e il primo a teorizzare un’ideologia nazionale serba, ha scritto: “il nostro presente non sarà senza un legame con il nostro passato, ma realizzerà un tutto collegato, coerente e congruo e questo regno serbo (…) sarà sotto il sacro diritto storico” (Judah 1997a, 58), e gli stessi legami, reali o artefatti del presente con il passato, si ritrovano nei discorsi di Milosevic, nel Memorandum dell’Accademia Damiano Fanni “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche ma tutti, indistintamente, riferiscono ad un passato immutato e immutabile, così come immutati nel presente istantaneo sono i discendenti di quel sangue di eroi, re e santi. Luoghi di memorie per over la pping memor ies La memoria è oggetto di discussioni e decisioni pubbliche progressivamente sempre più frequenti34, naturalmente anche fuori dai Balcani. Il fatto che sia oggetto di discussione è indice innanzitutto di un avvenuto mutamento nell’approccio alla memoria e più precisamente un cambiamento nel modo di pensare il passato: dal rifiuto delle storie ufficiali alla ricerca delle origini, dalla rivendicazione di un passato dimenticato a nuove storie alternative ed un generale rinnovato interesse per stabilire le condizioni necessarie per la “tutela della memoria”, salvandola da un oblio storico percepito costantemente in agguato. I “giorni della memoria” e i musei, le opere architettoniche a tema, le commemorazioni in genere, sono innanzitutto una reazione allo sconforto che deriva da una generale ed indefinita “crisi” della memoria, che implicitamente le vale quanto un esplicito conferimento di importanza. La domanda è se questo revival sia da interpretarsi quale moda, se oggi la memoria svolga un ruolo determinante e se questo sia mutato rispetto al passato. Oppure, se oggi la memoria sia una metafora interpretativa funzionale a mutare il piano del conflitto: in questo caso, eventuali “memorie confliggenti” sono sempre preferibili ad un conflitto agito. Pierre Nora risponde con una esauriente affermazione: “Parliamo così tanto di memoria perché ne è rimasta così poca”35. Il paradosso si spiega dal fatto che l’oggetto delle discussioni non è la memoria, soprattutto perché questa è materia che poco si adatta a discussioni il cui esito non sia più che prevedibile; vale a dire che essa è di per sé politica lly incorrect: la potenza insita nell’affermazione “mi ricordo” e, per i motivi visti prima, ancor più “ci ricordiamo”, la sottrae alla negoziazione perché in gioco non c’è la data della fondazione di Roma ma la stessa materia di cui è formata l’esistenza di società viventi, fondate nel nome di quella memoria di cui si vorrebbe discutere (Nora 1989a, 8). La memoria conquista gli spazi creati da rilevanti - o supposti tali - avvenimenti storici, in un regime di ciò che Nora chiama “accelerazione della storia”, ovvero “uno slittamento sempre più veloce del presente in un passato storico che è andato per sempre, una generale percezione che niente o tutto potrebbe dissolversi - sono indici della rottura di un equilibrio”36 (Nora 1989a 7). Come lo stesso Autore spiega, questa nozione essenzialmente significa che la caratteristica che più contraddistingue il mondo moderno non è la continuità o la permanenza ma il cambiamento. E il cambiamento è sempre più veloce, una precipitazione accelerata di tutte le cose in un passato in veloce ritirata. Significa che viene meno la separazione tra il passato, da una parte, ed il presente con il futuro dall’altra. Nora ricorda che le modalità di relazione al futuro di un gruppo sociale incidono sulla selezione degli elementi del passato che devono, o no, essere mantenuti per essere ricordati. E questa scelta, compiuta nel presente, rappresenta il collegamento delle due dimensioni, passato e futuro. Milosevic nella Piana dei Merli ricordava che “(...)queste sono le vostre case, i vostri campi e i giardini, le vostre memorie… Dovreste restare qui… In caso contrario sareste una vergogna per i vostri antenati e una delusione per i vostri discendenti(...)”. La certezza di potersi rapportare con entrambe le dimensioni temporali è falsa ed il presente, che era appena futuro ed è già storia, ci pone davanti alla responsabilità di sce- 34 Con legge n. 56 del 4 maggio 2007 (pubblicata nella G.U. - serie generale - n. 103 del 5 maggio 2007), il Parlamento Italiano ha riconosciuto il 9 maggio, anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, quale “Giorno della memoria”, al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno ed internazionale, e delle stragi di tale matrice. Il “Giorno del ricordo”, invece, è stato istituito con legge n. 92 del 30 marzo 2004 “(…)al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. 35 Nora, Pierre “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire” che costituisce l’introduzione all’opera in sette volumi, riedita poi in tre tomi “Les Lieux de mémoire”, a cura di Pierre Nora, preparati tra il 1983 e il 1994. Paris : Quarto Gallimard, 1997 36 “An increasingly rapid slippage of the present into a historical past that is gone for good, a general perception that anything and everything may disappear-these indicate a rupture of equilibrium”. 121 n.17 / 2007 gliere quello che dovremmo consegnare ai posteri sulla base sia dell’idea che vorremmo avessero di noi, sia dall’idea che noi, già ora, abbiamo del futuro. Così (Nora b), poiché non possiamo anticipare che cosa i nostri discendenti dovranno conoscere di noi per capire loro stessi, accumuliamo ogni traccia possa testimoniare cosa siamo ora e, facendolo, condensiamo entro spazi finiti le possibilità del divenire. Sparendo la teleologia della storia, di un fine noto, avanza un urgente “dovere di ricordarsi”, un approccio più meccanico all’eredità da lasciare che si propone come “perdita”: per questo determiniamo la memoria che costituirà l’eredità ai posteri in termini “quantitativi” in modo da lasciargli in eredità ciò che noi abbiamo perduto: la memoria. Tale “accelerazione della storia” annulla qualsiasi comunione con il passato che viene sostituita con una relazione impostata sulle tracce via via recuperate, analizzate, classificate. È la memoria degli archivi, dei rinvenimenti archeologici, dello studio dei documenti. Porta all’istituzione di “giorni della memoria” sulla base di nuove analisi storiografiche di eventi passati, alla conseguente sovrapposizione coincidente di storia e memoria e, soprattutto, conferisce alla storia il mandato di ricostruire la memoria. Seguendo questa linea, la formazione della memoria avviene sulla base degli eventuali sviluppi della conoscenza storica la quale, in quanto strumento e non fine, consente il costante reperimento di elementi utili all’emersione della memoria dei diversi gruppi che compongono la collettività, i quali si individuano sulla base di una memoria che è stata storicamente prodotta. Si tratta di memorie in cerca di cittadinanza all’interno di collettività che non riconoscerebbero loro questo diritto in mancanza di elementi storici che ne stabiliscano il fondamento. Per Nora, questi trends di emancipazione sono da interpretarsi quali movimenti di “decolonizzazione” della memoria che può essere “internazionale”, delle società che sono/sono state sotto regime coloniale, con l’accesso alla coscienza storica e la riabilitazione o la fabbricazione di memorie; “domestica” per le rivendicazioni della memoria di gruppi minoritari religiosi, di genere, province che chiedono il riconoscimento dell’autonomia e che tramite l’affermazione della loro memoria, che è in realtà storia, rivendicano il diritto al riconoscimento del particolarismo; “ideologica” che riunisce le esigenze di ripristino della memoria di quanti hanno subito gli effetti di un regime totalitario (Nora b). La novità di questo revival della memoria è ben espressa dal nuovo equilibrio di relazione tra storia e memoria. La storia è al servizio delle autorità pubbliche, studiosi e gruppi di ricerca specializzati ai quali è demandato il compito di dare forma al sentire collettivo di una nazione e fornire, anche inconsapevolmente, le direttive per uniformare le identità individuali a quella collettiva. Storia e memoria si scambiano di posto e le rispettive sfere d’influenza, la storia della collettività e la memoria dell’individuo, vedono depotenziati i rispettivi confini. Ma la memoria non può aspirare allo status scientifico proprio della storia, e tale esigenza è ben espressa entro i “musei della memoria”, dove c’è molta storia e poca memoria. E non è indifferente riflettere su cosa potrebbe accadere se si dovesse conferire alla storia il compito di svolgere integralmente il ruolo della memoria. Ad esempio, cosa comporterebbe sostituire la memoria della Shoah con la storia del popolo ebraico nella Germania nazista? Quei luoghi, quelle foto, quegli elenchi di nomi, quelle perfette ricostruzioni ambientali con le “docce”, le catene, le cancellate, il filo spinato, non sono forse il tentativo di accesso alla memoria collettiva passando attraverso i canoni dell’evidenza storica? A quale necessità si sta dando risposta? Quale tipo di “sensibilità” o 122 Damiano Fanni “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche abitudine si vorrebbe ri-attivare, in che modo incidere sulla formazione della matrice della memoria collettiva via storia? E cosa accadrebbe se scomparisse contemporaneamente ogni minimo riferimento storico, ogni evidenza, ogni prova storicamente fondata? Quali pericoli si nascondono dietro l’illusione che una sia sicuramente scienza, l’altra semplicemente tradizione? Si dice che l’obiettivo pedagogico da raggiungere è che tali orrori non accadano mai più ed è una constatazione desolante quella che sottolinea che tali orrori siano tuttora presenti anche se “quel” particolare orrore, in “quel” modo preciso e determinato logicamente non accadrà mai più, con o senza musei, con o senza giorni della memoria. Perché il patrimonio della memoria collettiva della Shoah, se esiste e se è disponibile, non può essere attivato, o non agisce, come deterrente reale contro ogni evento analogo? Inoltre, investire un luogo fisico della responsabilità di conservare e riprodurre memoria può interpretarsi come un disinventimento collettivo di responsabilità: in quanto costrutto, la memoria collettiva coincide con l’erogazione di un servizio da attuarsi esclusivamente entro i luoghi preposti per i diversi Lieux de mémoire. Nora individua due modelli d’organizzazione della memoria. Il primo consiste nel riciclaggio ossessivo del passato. Ciascun evento commemorativo è prova che il passato ha smesso di avere un significato univoco e che un presente ricoperto di consapevolezza relativamente alla propria storia apre anche alla possibilità di numerose versioni alternative del passato. Correlato al primo, il secondo modello tiene conto della fine del monopolio della storia da parte degli storici. Non esiste più una sola interpretazione esclusiva del passato ma ognuna di queste deve confrontarsi con i media, con i giudici e i testimoni, con i legislatori. Da questa negoziazione potrebbe emergere, ad esempio, l’esistenza di differenze sostanziali tra la lingua serba, croata e bosniaca. Oggi è plausibile, ma nell’ex-Jugoslavia veniva parlata una lingua slava del sud, solitamente chiamata “serbo-croato” o “croato-serbo”. Nel diciannovesimo secolo, i dialetti molto simili del serbo-croato sono stati standardizzati in una singola lingua ufficiale. È dei Principati Danubiani l’iniziativa di adottare i caratteri latini per le pubblicazioni ufficiali, nel 1860 a cui seguì l’opera dei riformatori linguistici dell’area serbo-croata. Infrangendo le barriere linguistiche regionali e confessionali esistenti, si preferì adottare, come futuro veicolo delle comuni tradizioni letterarie, il volgare parlato dalla maggioranza, cioè la variante jeka vica del dialetto ŝtoka vo; per la fonetica si adottò il principio ‘una lettera per ogni suono’ (Hösch 2005, 158), al fine di dimostrare la “unicità” dello jugoslavo e della nazione slava del sud soprattutto nei confronti dei “diversi nemici” (tedeschi, ungheresi, turchi). Oggi i “nemici” sono gli albanesi, i serbi, i croati, gli sloveni, i bosniacchi, anche i montenegrini: nemici potenziali, certo, ma dietro l’inflessione sbagliata, dietro un’esitazione linguistica si misura lo spazio creato dalla precipitazione della storia recente in un passato che lascia emergere la purezza della lingua come valore irrinunciabile, anche se “artificiale”. La rivendicazione storica dell’identità si trasforma inevitabilmente in esclusione depurazione - di tutto quanto ritenuto ad essa non pertinente. Quindi si selezionano simboli e narrazioni che modellano la memoria collettiva e l’identità culturale e che provengono da un assortimento ra ndom di oggetti ed eventi ereditati. Negli spazi comuni - virtuali e geografici - gli eventi, i confini ed i monumenti, i riti collettivi, le celebrazioni pubbliche, le immagini, i suoni, la musica (“Non puoi ca pire cosa significa sentire quella musica da ppertutto”), i testi e anche alcuni film, la radio e le trasmissioni televisive, sono investiti di importanza simbolica. Si 123 n.17 / 2007 trasformano in ciò che Nora ha chiamato “lieux de mémoire”, i luoghi della memoria intorno ai quali memorie comuni ed identità interrelate sono tessute, consolidate e comunicate. I lieux de mémoire sono il segno del dissolvimento del milieux de mémoire, ambienti, spazi di memoria. La società civile non trova più spazi per raccontarsi, dove imparare e far imparare la memoria, dove raccontare e raccontarsi che a Sarajevo nel 1984 ci sono state le Olimpiadi e c’era una squadra, una bandiera, una lingua: la coesione della memoria cede il passo ad un lavoro consa pevole e scientifico di ricostruzione storica. I luoghi della memoria emergono dalla realizzazione che non esiste nulla che possa essere inteso quale memoria spontanea, ragion per cui si creano archivi, si programmano anniversari, si organizzano celebrazioni (Nora 1989a, 12). E in situazione di pluralismo, ad ogni particolare dovrebbe essere garantito eguale spazio, ma nell’ex-Jugoslavia non è così: le memorie ufficiali vengono consegnate ai posteri successivamente ad un’attenta selezione. Queste produzioni volute, decise e pianificate, evocano un passato “sterilizzato”, incapace di creare legami percorribili ed autentici e generatore di immagini virtuali che fungono da succedaneo per l’immaginazione. L’eco del ricordo si dissolve davanti al presente disincantato e “i luoghi della memoria restano come conchiglie sulla spiaggia dopo il ritiro del mare della memoria vivente” (Nora 1989a, 12). Nora non chiarisce il momento in cui sarebbe avvenuta questa frattura, ma dalle metafore usate si nota che il riferimento è all’inizio della rivoluzione industriale e ai movimenti di urbanizzazione delle masse dalla campagna, quindi presumibilmente nella prima metà del diciannovesimo secolo. Non sono mancati i critici alle tesi di Nora, soprattutto per quanto concerne il riferimento ad un passato della memoria inteso quale corpo unico, immodificato ed originale attraverso il quale, per differenza, leggere le memorie contraffate generate dalle pratiche della storia. Tuttavia, gran parte dell’impianto di Nora è valido anche perché rintracciabile in diverse forme lungo tutta la tradizione di pensiero del diciannovesimo e ventesimo secolo. Il tempo dell’esperienza si è contratto al punto quasi di dissolversi, quando i vissuti e le esperienze, personali e collettivi, vengono costantemente presentificati. Oggi, “inventare” e “possedere” una memoria risultano essere necessità sociali imprescindibili, acutizzate anche dal sentimento della sua mancanza: il desiderio di qualcosa trae origine, infatti, dal sentimento della perdita. Nessuno avrebbe permesso che la città di Mostar, in Bosnia-Herzegovina, perdesse il suo vecchio ponte, lo Sta ri Most in serbo-croato-bosniaco, il ponte sul fiume Neretva. In realtà l’ha perso il 9 novembre del 1993, durante il conflitto, ad opera delle milizie croate. Il ponte divenne presto un’ossessione per l’opinione pubblica internazionale tanto che venne deciso che sarebbe stato ricostruito “dov’era e com’era”: restava implicita la terza variabile “cos’era”, ovvio, un ponte. Cosa si vuole consegnare ai posteri decidendo per la sua ricostruzione? “Non mi piace il nuovo ‘ponte vecchio’”, affermava con disinvoltura uno dei collaboratori dell’Agenzia di democrazia locale di Mostar, perché “quella Mostar non c’è più e questo ponte non è ‘quel’ ponte”. Evidentemente l’opinione differiva da quella diffusa fuori dalla Bosnia. Due antitetiche modalità di produzione e gestione della memoria collettiva non si incontravano sul “ponte vecchio” che nelle intenzioni doveva rappresentare simbolicamente il dialogo, l’unione della città - ora nettamente divisa in una parte bosniacca e in una croata - e dei popoli. Il “ponte che unisce” era diventato, nel 2004, anno della riapertura, un luogo della memoria, dove questa si cristallizza e si nasconde, dove la coscienza di una rottura con il pas- 124 Damiano Fanni “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche sato si lega alla certezza di uno strappo nella memoria tale da porre il problema di incarnarla in un luogo in cui, si presume, persiste un senso di continuità storica (Nora 1989a, 1). Il ponte di Mostar era questo luogo e l’Unesco, conferendogli lo status di patrimonio dell’umanità, ha soddisfatto un bisogno che è della comunità internazionale più che di quella locale. Il ponte che il turista attraversa con meraviglia e incanto, recuperando dalla memoria quante più immagini gli è possibile della guerra dell’ex-Jugoslavia, non è lo stesso ponte che attraversa il mostarino. Il ponte è diverso perché lo sono i significati di cui dovrebbe essere, e sicuramente è, il simbolo. Una delle caratteristiche connaturate al luogo della memoria è che dovrebbe, almeno in via teorica, produrre lo stesso “tipo” di memoria indistintamente per tutti. Ma la memoria non si studia. Le motivazioni dell’introduzione del ponte di Mostar nella lista dei beni patrimonio culturale dell’umanità è la seguente: “Con la ‘rinascita’ del Vecchio Ponte e delle zone adiacenti, il potere ed il significato simbolici della città di Mostar - quali simboli universali ed eccezionali di coesistenza delle comunità appartenenti a differenti background culturali, etnici e religiosi - sono stati rinforzati e consolidati, sottolineando così gli sforzi illimitati della solidarietà umana per la pace e l’intensa cooperazione di fronte alle immani catastrofi.” Certo, non è “la minestra fredda” di Rebecca West, eppure dietro questa motivazione si agitano ancora gli “spettri dei Balcani” dei quali l’Europa ha sempre procurato di fornire una solerte regia. È quindi un elemento che “stona” l’iscrizione a vernice nera su un sasso posto alle due estremità del ponte: “Don’t forget ’93”? Eric Hobsbawm definisce “tradizione inventata” le pratiche dotate di natura anche simbolica che intendono favorire l’affermazione di valori e norme di comportamento dei quali è implicita la continuità con il passato (Hobsbawm, Eric J. 3-17). La comunità internazionale intendeva affidare al ponte il compito di “ricordare” l’importanza dell’unione, il valore della contiguità e il rispetto delle differenze là dove serbi e croati hanno sempre e solo visto il simbolo di un passato ottomano combattuto, ingombrante e disdicevole. Come spiega Nora, i luoghi della memoria sono una risposta alla mancanza di milieux de mémoire, ambienti o spazi di memoria. Il ponte assieme alla città di Mostar hanno perduto entrambi lo spazio d’esistenza in divenire nella memoria collettiva per riscoprirsi parti di uno spazio storicamente sclerotizzato e anche ricostruito, finalizzato al favorire la resurrezione di un passato mitico di convivenza fraterna tra diversi, da una parte, e dall’altra corroborare le tesi che interpretano i conflitti balcanici come l’eccezione attribuibile al cadenzato sonno della ragione. Lo stesso dicasi per il centro storico di Sarajevo, la Bascarsija. Tutto ricostruito, tutto com’era. Eppure è ora che ci sono zone della città, come il quartiere Lukavica a prevalenza serba, che hanno iniziato ad auto-affermarsi “Srpsko Sarajevo”, Sarajevo Serbo; è ora che si vedono diverse bandiere nazionali dei diversi quartieri a segnare confini immaginari37. Halbwachs suggerisce che l’apparente staticità dell’ambiente esterno, fatto di cose e oggetti, contribuisce a garantire una sensazione irrinunciabile di stabilità, quiete, permanenza (Halbwachs 2001, 215), ma è una considerazione che non tiene conto del fatto che la memoria, a differenza della storia, ha a che fare con le pratiche. E nelle pratiche è l’uso che rileva, quando la creatività e l’inventiva dell’uomo comune, reinventa, creandola e appropriandosene, la totalità del quotidiano. La memoria è un ri-uso della storia in una combinazione creatrice che sovverte i limiti della storiografia in quanto scienza, aprendo alla possibilità, come per Charlie Chaplin38, di fare cose inedite attraverso tattiche attinte da un repertorio contenuto nella matri- 37 Ma che comunque sono anche amministrativi in quanto la linea che separa la Bosnia dalla Repubblica Srpska passa dentro la città: “A casa ho la cucina in Bosnia e il salotto nella Repubblica”, commentava divertita un’intervistata di Sarajevo. 38 Il riferimento è a De Certeau “È così che Charlie Chaplin moltiplica le possibilità del suo bastoncino: fa altre cose con lo stesso oggetto e oltrepassa i limiti che le determinazioni di quest’ultimo fissavano al suo utilizzo” (2001, 152) 125 n.17 / 2007 ce della memoria collettiva. La scritta “Don’t forget ’93” è la ri-appropriazione del ponte, è la sconfessione del luogo della memoria, è la prova che nei Balcani non bisogna che tutto cambi perché nulla cambi; piuttosto, bisogna che tutto torni com’era perché tutto cambi. La quantità di memorie balcaniche è tale che solo con fatica riescono a ricavarsi uno spazio autonomo ed esclusivo d’esistenza. E quale memoria indipendente ed autonoma per i milioni di nati dal 12% di matrimoni misti nel 1988, milioni di persone nate che ora hanno vent’anni e si sentono “jugoslavi”? (Iveković 1995, 141). La risposta al bisogno principale, quello della creazione-costituzione e riconoscimento di un’identità esclusiva cozza con l’impossibilità oggettiva - ma sarebbe più corretto definirla storica - di individuare le linee di demarcazione delle diverse memorie le quali, ormai divenute overla pping memories, pericolosamente giungono a render conto anche delle storie degli “altri”. È dalla constatazione dell’imperante contaminazione che occorre ripartire, piuttosto che investire la storia del compito di forgiare una memoria a d hoc, pura, originale, e ricostruita. Forzare il ragionamento fino ad affermare che diverse memorie divise garantiscono una coesistenza civile immune da conflitti significa non considerare la natura viva della memoria che resiste nelle pratiche, nelle narrazioni, nella vita della comunità e finché questa potrà raccontarsi. La sensazione, che potrebbe costituire il naturale prosieguo di tanti discorsi qui appena abbozzati, è che la consapevolezza dell’esistenza di una corrente profonda di memoria collettivamente riconosciuta nei Balcani sia una certezza che trova ampi spazi di consenso all’interno della società civile, molto meno tra le istituzioni politiche; aiuta il riferimento a Mary Douglas quando scrive “Perché una convenzione si trasformi in un’istituzione sociale legittima è necessaria una parallela convenzione cognitiva che la sostenga” e se questa convenzione è istituzionalizzata essa darà ragione di sé facendo riferimento “(…) alla posizione dei pianeti nel cielo o al modo in cui le piante, gli animali o gli esseri umani si comportano naturalmente” (Douglas 1990, 82-83). Ci sono elementi che inducono a pensare che nei Balcani ancora debba avvenire il salto che trasforma le memorie collettive in una convenzione istituzionalizzata; la memoria dei e nei Balcani è ancora un marasma indefinito di memorie sovrapposte suscettibile di ricevere nuove forme e connotazioni e significati inediti e questo, che corrisponde al suo maggior pregio, è anche ciò che più la avvicina ad un capitale che diverrà indisponibile nel momento in cui contribuirà a fondare un’identità nazionale definita. Come già sta accadendo. Sarà possibile, e come, garantire spazi d’esistenza delle memorie alternative - antagoniste - delle minoranze più o meno rappresentate entro tutti gli stati balcanici, evitando che per questo debbano ricorrere alle rispettive memorie di riferimento (degli stati nazionali)? 126 Damiano Fanni “Don’t forget”: ricordi e memorie balcaniche Rifer imenti bibliogr a fici Accademia serba delle scienze e delle arti (1986), “Memorandum dell’Accade-mia serba delle scienze e delle arti”, in Limes, n° 1-2/1993, pp. 233-245 Assmann, Jan (1997), La memoria cultura le. Scrittura , ricordo e identità politica nelle gra ndi civiltà a ntiche, Torino, Einaudi. Augé, Marc (2000), Le forme dell’oblio, Milano, Il Saggiatore. Banasik, Becky L. e James W. Pennebaker (1997), On the crea tion a nd ma intena nce of collective memories: history a s socia l psychology in Pennebaker, James W. et al. (1997), a cura di, Collective Memory of Politica l Events, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates. Barthes, Roland (1972), Mythologies, New York, Hill and Wang. Benjamin, Walter (1999), Theses on the Philosophy of History, in Walter Benjamin, Illumina tions, London, Pimlico. Bergson, Henri (1986), Ma teria e memoria . Sa ggio sulla rela zione tra il corpo e lo spirito in “Opere 1889-1896”, Milano, Mondadori. Bet-El, Ilana R. (2002), Unima gined communities: the power of memory a nd the conflict in the former Yugosla via in Müller, Jan-Werner (2002), Memory a nd Power in Post-Wa r Europe: Studies in the presence of the Pa st, Cambridge, Cambridge University Press. Boothe, Brigitte (2002), Scena Prima ria , voce del dizionario di Pethes e Ruchatz (2002) Cohen, Roger (1998), Hea rts Grown Bruta l: Sa ga s of Sa ra jevo, New York, Random House. De Certeau, Michel (2001), L’invenzione del Quotidia no, Roma, Edizioni Lavoro. Delumeau, Jean (1979), La pa ura in Occidente - secoli XIV-XVIII, Torino, SEI. Dewey, John (1958), Na tura e condotta dell’uomo, Firenze, La Nuova Italia. Douglas, Mary (1990), Come pensa no le istituzioni , Bologna, il Mulino. Dudai, Yadin (2002), Memory from A to Z, New York, Oxford University Press Fabietti, Ugo e Vincenzo Matera (1999), Memorie e identità . Simboli e stra tegie del ricordo, Roma, Meltemi. Freud, Sigmund (1989), Nota sul notes ma gico, in Sigmund Freud, Opere, Torino, Bollati Boringhieri, Vol.X. Gangemi, Giuseppe (1999), Metodologia e Democra zia . La comunica zione a ttra verso meta fore, concetti e forme a rgomenta tive, Milano, Giuffrè. Glenny, Misha (1993), The Fa ll of Yugosla via : The third Ba lka n wa r , New York, Penguin Books. Grundtvig N.F.S. Budstikke i Høinorden in De Certeau, Michel (2001), L’invenzione del Quotidia no, Roma, Edizioni Lavoro. Halbwachs, Maurice (1997), I qua dri socia li della memoria (ed. or. 1925), Napoli, Ipermedium. Halbwachs, Maurice (2001) La memoria collettiva , Milano, Edizioni Unicopli. Hobsbawm, Eric J. (1994), Introduzione, in Hobsbawm e Ranger, L’invenzione della tra dizione, Torino, Einaudi. Hösch, Edgar (2005), Storia dei pa esi ba lca nici , Torino, Einaudi. Iveković, Rada (1995), La ba lca nizza zione della ra gione, Roma, ManifestoLibri. Judah, Tim (1997a), The Serbs. History, Myth a nd the destruction of Yugosla via , Yale University Press. Judah, Tim (1997b), “The Serbs: The Sweet and Rotten Smell of History”, in 127 n.17 / 2007 Da eda lus, Volume: 126, fascicolo 3. Kaplan, Robert D. (2000), Gli spettri dei Ba lca ni. Un via ggio a ttra verso la storia , Milano, Rizzoli. Le Bon, Gustave (1970), Psicologia delle folle, Milano, Longanesi. Malcolm, Noel (1999), Storia del Kosovo. Dalle origini ai giorni nostri , Milano, RCS. Mertens e Haubl (1996), Der Psychoa na lytiker a ls Archä ologe, Stuttgart, citato in Brigitte Boothe, voce “Scena Primaria” in Pethes, Nicolas e Jens Ruchatz, Diziona rio della Memoria e del Ricordo, Paravia Bruno Mondatori Editore, 2002 Meyers, Nechemia (1998) “How Jewish a State?”, in World a nd I, Volume: 13, Issue: 5, May Milošević, Slobodan (1989) “Milosevic’s Speech Kosovo Field”, 28 June 1989, consultabile all’indirizzo: http://www.trepca.net/english/2006/serbian_memorandum_1986/slobodan_milosevics_speech_in_kosovo_polje_24_april_1989.html Müller, Jan-Werner (2002), a cura di, Memory a nd Power in Post-Wa r Europe: Studies in the presence of the Pa st, Cambridge, Cambridge University Press. Nora, Pierre, (1989a) “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire” in Representa tions, n.26, The Regents of the University of California, Spring. Nora, Pierre (1989b) The Tida l Wa ve of Memory, paper pubblicato sul sito internet http://www.project-syndicate.org/commentary/nora1 Pethes, Nicolas e Jens Ruchatz (2002), a cura di, Diziona rio della Memoria e del Ricordo, Paravia Bruno Mondatori Editore. Rastello, Luca (1998), La guerra in ca sa , Torino, Einaudi. Said, Edward D. (2002), Orienta lismo. L’imma gine europea dell’Oriente, Milano, Feltrinelli. Schön, Donald A. (1993), Genera tive meta phor: A perspective on problem-setting in socia l policy in Andrew Ortony (1993), a cura di, Meta phor a nd Thought, Cambridge, Cambridge University Press. Schön, Donald A. e Martin Rein (1994), Fra me Reflection: Towa rd the Resolution of Intra cta ble Policy Controversies, New York, Basic Books. Sudetic, Chuck (1998), Blood a nd Vengea nce: One Fa mily’s Story of the Wa r in Bosnia , New York, W. W. Norton. Tanner, Marcus (1997), Croa tia : A Na tion Forged in Wa r , Yale University Press, YaleNotaBene Book 2001 Todorova, Maria (1997), Imma gina ndo i Ba lca ni , Lecce, Argo. Todorova, Maria (1994), “The Balkans: From Discovery to Invention”, in Sla vic Review n.53 Summer. Upton, Albert (1961), Design for Thinking, Pacific, Palo Alto, CA. Citato in Weick, Karl E. (1997), Senso e Significa to nell’Orga nizza zione, Milano, Raffaello Cortina. West, Rebecca (1993), Bla ck La mb a nd Grey Fa lcon , Edinburgh, Canongate Zerubavel, Eviatar (2005), Ma ppe del Tempo, Bologna, Il Mulino. [email protected] 128
Scaricare