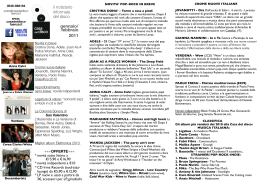SENTIRE A SCOLTARE o n l i n e m u s i c magazine DICEMBRE N.14 Boards Of Canada Calla Klaus Schulze Red Crayola Mi And L’au Babyshambles Stranglers Silver Jews sentireascoltare il diritto di rimanere in silenzio in copertina Silver Jews il diritto di rimanere in silenzio SentireAscoltare online music magazine Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05 Editore Edoardo Bridda Direttore responsabile Ivano Rebustini Provider NGI S.p.A. Copyright © 2005 Edoardo Bridda. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale, in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare sommario 4 News 8 Speciali Boards Of C a n a d a , K l a u s S c h u l z e , Silver Jews , C a l l a . . . 34 Recensioni 61 65DaysOfS t a t i c . T h e B o y L e a s t L i k e l y To, Kate B u s h , M i A n d L’ a u , K r a f t w e r k , Kill The Vu l t u r e s , B a b y s h a m b l e s … 6 1 Dal vivo Interferenz e 2 0 0 5 , A n i m a l C o l l e c t i v e , Ardecore, G o ! Te a m , N i n a N a s t a s i a . . . 65 Rubriche 8 We Are De m o S i x R e d C a r p e t s , D e vocka… Classic Re d C r a y o l a , P a v e m e n t , Orange Ju i c e , R . E . M . , I c e b u r n Note a mar g i n e T h e S t r a n g l e r s Cinema W i m We n d e r s - L’ a n i m a d e l Blues, L’ar c o , T h e D e s c e n t , I F r a t e l l i Grimm, Bro k e n F l o w e r s Cose dell’a l t r o m o n d o J e n n i f e r D e l a n o sui Tubi Direttore Edoardo Bridda Direttore responsabile Ivano Rebustini Coordinamento 34 Antonio Puglia Stefano Solventi Staff Valentina Cassano Daniele Follero Teresa Greco Hanno collaborato Gianni Avella, Marco Braggion, Michele Casella, Antonello Comunale, Andrea Erra, Andreas Flevin, Lorenzo Filipaz, Paolo Grava (aka Neon Eater), Manfredi Lamartina, Martino Lorusso, Carlo Pastore, Giulio Pasquali, Marina Pierri, Michele Saran, Michele Vaccari, Fabrizio Zampighi Guida spirituale Adriano Trauber (1966-2004) Grafica Paola Squizzato, Squp, Edoardo Bridda 67 sentireascoltare news a cura di Daniele Follero Dopo un periodo di allontanamento dal mercato discografico ufficiale Prince ritorna sui binari delle major firmando per la Universal-Motown, per la quale è stato già distribuito il prim o s i n g o l o ( Te A m o C o r a z o n ) , p e r o r a s c a r i c a b i l e s o l o d a l l a rete… Secondo un conteggio che la rivista Billboard pubblica ogni fine anno, il gruppo che ha guadagnato di più in tour nel 2005 sono stati gli U2, con un incasso di circa 260 milioni di dollari per un totale di 90 concerti, doppiando gli Eagles, piazzatisi s e c o n d i c o n u n o s c a r t o d i q u a s i 1 5 0 m i l i o n i d i d o l l a r i ( 11 7 m i lioni incassati in 77 date). Seguono nella lista dei primi cinque Prince Neil Diamond, Kenny Chesney e Paul McCartney… Comincia a prendere forma il prossimo album degli Audioslave, successore di Out Of Exile. La band ha registrato già due brani e sta lavorando su un’altra ventina insieme al produttore Brendan O’Brien che in precedenza aveva già lavorato con Soundgarden e Rage Against The Machine… La Memphis Recording Service , etichetta indipendente entrata in possesso delle matrici originarie del primo singolo di Elvis Presley, lo ha ristampato in vinile e senza l’effetto di eco aggiunto nelle registrazioni della RCA. Il 45 giri That’s All Right è compreso in un cofanetto che include anche un dvd e un libro illustrato… I Depeche Mode hanno confermato la loro presenza alla prossima edizione del festival di Benicassim, alla sua undicesima e d i z i o n e e c h e s i t e r r à n e l l a c i t t a d i n a v i c i n a a Va l e n c i a t r a i l 20 e il 23 giugno 2006… I New Order stanno lavorando a nuovo materiale per la colonna di Control, il film biografico di Anton Corbijn sulla vita di Ian Curtis. Il bassista della band Peter Hook in un’intervista al New Musical Express si è detto entusiasta dell’operazione: “E’ una grande idea quella di far fare ai Joy Division la colonna sonora per un film sui Joy Division. Non ci era mai capitato di farlo, in passato”… I l p r o s s i m o 1 5 d i g e n n a i o i N e w Yo r k D o l l s e n t r e r a n n o i n s t u d i o con Jack Douglas (che ha già lavorato con John Lennon, Aeros m i t h e g l i s t e s s i N e w Yo r k D o l l s ) p e r r e g i s t r a r e i l n u o v o a l b u m sentireascoltare dopo la reunion della band. Il lavoro in studio più recente della band di David Johansen r i s a l e a l 1 9 7 4 ( To o M u c h To o Soon)… Bob Dylan si mette a fare il DJ! A marzo gramma partirà un radiofonico pro- gestito da lui, che andrà in onda sulla radio satellitare americana P a r t i r à d a N e w Yo r k i l 1 4 f e b braio il tour mondiale di Cat Power, che il mese successivo approderà in Europa… Alex James, attualmente im- pegnato con i Wigwam, ha annunciato il ritorno sulle scene Blur. dei James, Damon Blur XM Network… lavorando pazione di membri di R.E.M. e duro per riuscire a finire entro Wilco. Ai compagni di Michael la prossima estate il loro ulti- Stipe, Peter Buck e Bill Rei- mo album. Sarà il terzo della flin si sono aggiunti anche al- loro carriera e seguirà il for- tri ospiti, tra cui John Moen e t u n a t o C h u t e s To o N a r r o w d e l Colin Meloy dei Decembrists, 2004… John Wesley Harding e Kelly Gli Shins stanno H o g a n . L’ a l b u m è p r e v i s t o p e r Albarn e Dave Rowntree sono Gli Status Quo hanno cancel- pronti a rientrare in studio già lato tutte le date del loro tour a partire da questo mese. Già nel Regno Unito a causa di un Gli Arcade Fire ripartono da ultimato invece, Love Travels problema di salute del chitar- una chiesa. Il chitarrista Tim At Illegal Speed, il nuovo la- rista Rick Parfitt a cui è stato Kingsbury voro della diagnosticato un non precisa- New band Graham Coxon, del qua- to male alla laringe. Le date band ha di recente acquistato le si sa già la data di pubbli- non saranno recuperate… una chiesa sconsacrata a sud dell’ex cazione. chitarrista Uscirà prossimo per il la 13 marzo il 7 febbraio… ha Musical dichiarato Express che al la di Montreal, che verrà adibi- Parlophone Dopo una battaglia durata cin- ta a studio per registrare (a e sarà preceduto dal singolo que anni il CBGB’s, storico lo- partire Standing On My Own Again, in cale newyorchese, ha annun- il nuovo album previsto per il vendita dal 27 di febbraio… ciato la definitiva chiusura per 2006… già da questo mese) il 31 di ottobre del 2006. Hilly 8 dicembre. A 25 anni dalla Kristal, gestore del locale, è Confermata Lennon molti riuscito a strappare un accor- vo album solista di David Gil- ne hanno approfittato per ren- do che posticipa la chiusura mour per il 6 marzo. On An dere tributo all’ex baronetto di dello stabile di poco più di un Island è il primo album solista Liverpool, assassinato a New anno (la chiusura era prevista del chitarrista dei Pink Floyd Yo r k n e l 1 9 8 0 . I M e r c u r y R e v, per il 31 agosto 2005), e ha dai dal anche morte di John palco dello Shepherd’s nuo- Face del volerlo lontanissimo 1984, terzo del- riaprire in un altro luogo. Le la sua carriera in solitudine. God, terminata in un’apoteosi ricerche sono ancora in alto Tra gli ospiti dell’album ci sa- di commossi applausi, mentre mare, ma spunta qualche ipo- ranno gli U2, da Civic Center di Har- tesi: Hoboken, C r o s b y. I l d i s c o s a r à s e g u i t o tford (Connecticut), oltre alla nel New Jersey o addirittura da un tour europeo che par- già collaudata Instant Karma, L a s Ve g a s ! . . . tirà il 10 Marzo da Dortmund, Empire hanno Time Square, di di About del suonato Bush annunciato tempi l’uscita si sono cimentati in una personalissima gian Wood… cover di Norwe- Graham Nash e David in Germania, per approdare in The Gun Album del collettivo I t a l i a i l 2 4 e 2 5 m a r z o a l Te a - The Minus 5 vedrà la parteci- tro degli Arcimboldi di Milano sentireascoltare e all’auditorium Parco della Musica di Roma il 26… Potrebbero riunirsi gli Smiths? Per ora l’idea piace molto solo all’ex bassista Andy Rourke, anche se qualcuno scommetterebbe di aver visto Morrissey e Johnny Marr cenare insieme… L’ i d e a s a r e b b e r i f o r m a r e l a s t o r i c a b a n d i n g l e s e i n o c c a s i o n e di un concerto benefico che lo stesso Rourke sta organizzando a Manchester per il prossimo 28 gennaio. All’appello hanno già r i s p o s t o C h a r l a t a n s , P e t e r H o o k d e i N e w O r d e r, B a d l y D r a w n Arcade Fire Boy e Mani degli Stone Roses… L’ e x N i r v a n a C h r i s N o v o s e l i c s t a p e n s a n d o s e r i a m e n t e d i e n trare in politica. Dopo aver manifestato dichiaratamente le sue idee politiche nel libro Of Grunge And Government, il bassista ha di recente preso parte al dibattito sulla riforma elettorale di Prince Edward Island, una provincia del Canada. Fa sul serio o si fa solo un po’ di pubblicità? Intanto l’altro superstite della band più famosa del grunge, Dave Grohl ha declinato cortesemente l’offerta di prendere parte al cast del film King Kong di Peter Jackson nel ruolo di Satana… S i n g o l a r e u s c i t a p e r l a D r a g C i t y. S i t r a t t a d i M r. J e w s , u n 7 ’ ’ attribuito ai Silver Palace, dietro cui si cela la tanto attesa e fantomatica collaborazione tra David Berman dei Silver Jews e Will Oldham. Sfortunatamente (ma poi mica tanto) si tratta solo di uno scherzo di quei mattacchioni dell’etichetta di Chicago: due finte interviste in cui Oldham e Berman rispondono alle domande attraverso clip dalle loro canzoni... P a r e c h e l ’ u l t i m o a l b u m d e g l i Ye a h Ye a h Ye a h s s i a u n c o n c e p t il cui tema principale è il gatto della cantante Karen O. Il trio ha già terminato le registrazioni e il disco dovrebbe essere pronto per marzo 2006, probabilmente seguito da un ep con il resto del materiale… I Rolling Stones suoneranno al prossimo Super Bowl, che si terrà a Detroit il prossimo 5 febbraio. Saranno in buona (!) c o m p a g n i a : P a u l M c C a r t n e y, B r i t n e y S p e a r s , A e r o s m i t h , B e y o n c e , K i d R o c k e N e l l y. L a b a n d d i M i c k J a g g e r e K e i t h R i c h a r d s ha anche annunciato le date ufficiali del prossimo tour europeo, che partirà da Barcellona il 27 maggio. Unica data italiana, il 22 giugno al San Siro di Milano… A Brooklyn, dal 18 novembre al 18 dicembre, la Brooklyn Fire Proof Art Gallery ospita la mostra Series 4: vi partecipano, tra gli altri, David Berman dei Silver Jews, Pall Jenkins dei Black Heart Procession, Jason Molina dei Magnolia Electric Co.e Archer Prewitt. La mostra è dedicata alle opere d’arte visuale di alcuni dei migliori musicisti di area indie-rock, e ad idearla e’ stato John Darnielle, il leader degli statunitensi Mountain Goats… sentireascoltare In periodo di reunion (dai Pink Floyd agli Who) almeno c’è qualcuno, come Paul Weller, che si tiene alla larga da operazioni nostalgiche. “Riformare i Jam sarebbe come fare un del triste cabaret” ha detto l’ex leader degli Style Council alla rivista Uncut… I Goldfrapp e i Placebo si sono uniti ai Prodigy per rivestire il ruolo di headliner nella prossima edizione del festival dell’Iso- I Black Sabbath e i Sex Pistols saranno le prossime band inglesi a entrare nella Rock’n’Roll Hall Of Fame, onore confe- Paul Weller la di Wight… rito dall’industria del disco americano a band particolarmente “meritevoli” (secondo una giuria di discografici), il cui album d’esordio abbia compiuto almeno il venticinquesimo anno di età… Nonostante gli sforzi del mercato discografico e l’appoggio delle istituzioni, il file sharing “illegale” supera ancora di parecchio quello “legale” (sui due aggettivi ci sarebbe da discutere..). Secondo una ricerca della Jupiter i pirati del download sono più del triplo di chi scarica musica pagando… Nuovo album per i Pet Shop Boys. Prodotto da Trevor Horn, non se ne conosce ancora il nome, ma dovrebbe uscire ad aprile… Glenn Hughes, in passato bassista e (sporadicamente) cantante dei Deep Purple comincerà a gennaio le registrazioni per un nuovo album con la collaborazione dei due Red Hot Chili Peppers John Frusciante e Chad Smith… E ’ m o r t o To n y M e e h a n , b a t t e r i s t a e f o n d a t o r e d e g l i S h a d o w s , famosa band britannica, ultima a raggiungere un grande successo nel Regno Unito prima dei Beatles (Apache, nel 1960 rimase prima in classifica per 6 settimane)… sentireascoltare speciale Boards Of Canada Da qualche parte …vicino a Inverness, Scozia di Edoardo Bridda La discografia dei Boards Of Canada non è che un mosaico di un’unica trama, la sottile grana psichedelica di un unico streaming audiovisivo girato in Super8. Ogni brano, ogni album è rappresentativo (e sostituibile) di un’unica idea musicale, esattamente quel modello che li ha resi così influenti per la scena elettronica e l’hip-hop, la stessa visione d’immagini in suoni che li accompagna fin dalla loro infanzia. Mike Sandison e Marcus Eoin hanno circa sette anni quando iniziano a comporre musica assieme. Lo negano tutt’ora fino alla morte, ma sono sangue dello stesso sangue e la loro casa, allora come oggi, è piena di giocattoli. Pianoforti e chitarre sono facili da trovare quanto i toys sotto il letto e, naturalmente, non mancano né un registratore con il puntino rosso talmente sbiadito da non essere più riconoscibile, né, al suo interno, un’altrettanto macinata cassetta BASF grigia con la banda bordeaux. La vita dei fratelli scorre pacifica tra tv e campetto quando, tra il 1979 e il 1980, in seguito a un profittevole impegno lavorativo sentireascoltare del padre che lavora nel campo dell’edilizia, si trasferiscono per un anno a Alberta, in Canada. Troppo giovani per andare al cinema e senza alcun amico, decidono di passare il tempo davanti allo schermo e a furia di zapping, tra una p u n t a t a d e L’ u o m o d a s e i m i l i o n i d i d o l l a r i e una del Muppet Show , una trasmissione colpisce la loro attenzione, l’unica peraltro a non essere svanita nella trasvolata: è il National Film Board of Canada (noto anche come National Film Board), un format divulgato dall’organizzazione statale omonima per promuove le risorse naturali del Paese la cui colonna so- nora, interamente suonata ai sintetizzatori, è (come la pellicola stessa) di quella pasta tipica degli anni Settanta. S o n o r i t à a b a s e d i Ta n g e r i n e D r e a m , Va n g e l i s e J e a n M i chel Jarre e immagini girate in super8 di sagome montane e boschive riempiono così le ore più mortifere del palinsesto televisivo, una noia mortale che per Mike e Marcus è fascino puro. Completamente stregati e di ritorno con la famiglia a Edimburgo, il passo dalla fantasia alla pratica è breve: diciott’anni di vita totali, trascorrono le giornate per le strade e i cam- bedroom artist di lì a venire) non mancano di certo. Mike e Marcus comprano un secondo registratore con il quale incidere il risultato della riproduzione ottenuta con quello già presente in casa; da una base aggiungono, di volta in volta, un arpeggio di chitarra, un tocco di pianoforte, uno spezzone di audio televisivo e così via, fino a che il registrato, zeppo di fruscii e gracchi, è più vicino all’estetica dell’Industrial di casa Throbbin’ Gristle che all’ambient music di teutonica memoria, ma tant’è. È il principio di una flebile figura Boards Of Canada, un pi a caccia di location e situazioni da catturare. Assieme a loro, un gruppuscolo d’amici, assistenti cameramen e aiuto regia; infine, da soli e at home, le primissime agognate sonorizzazioni. miraggio che sembra destinato a dissolversi con la tempesta adolescenziale dietro l’angolo, l’High School. I mezzi tecnologici all’epoca scarseggiano, manca un multitraccia, indispensabile apparecchio per mescolare le piste audio, ma gli escamotage (peraltro tipici di molti I templari dell’Hexagon Sun. Le primissime produzioni. Ebollizione e curiosità caratterizzano il periodo scolastico; per i fratelli è tempo di separarsi e interrompere il sodalizio musicale per coltivare progetti diversi: Marcus (come da manuale) si fa cat- turare dal gruppo thrash metal di turno, mentre il fratello forma una band strumentale che fa largo uso di synth, tapes e percussioni. Il distacco non dura che un paio d’anni: sfogato a sufficienza, Marcus è pronto per rientrare come bassista nella band del fratello maggiore che, nel frattempo, si è specializzato nel musicare i filmati di un collettivo di cui è promotore. Caratterizzati da streaming in Super8, fotografie ad alto tasso psichedelico e sonorità elettroniche soffuse e stranianti, le prime installazioni, a cui collaborano un numero variabile di giovani artisti locali (che supera abbondantemente la dozzina), sono centrate sulla rappresentazione della nostalgia, del ricordo e della perdita. Probabilmente, sono flussi di coscienza di quella Generation E in dopo(s)ballo, che stava promuovendo una potente alternativa alla tradizione dopolavorista inglese basata sui consueti pub a rit- sentireascoltare mo rock (e hair metal), ma soprattutto costituiscono un terreno di grande creatività per i ragazzi che sono anche dei veri pionieri nella loro scuola. Ma se tante idee e spine attaccate sono il sale della creatività, è anche vero che dinamiche e pressioni di gruppo, possono generare le più nefaste entropie e così, separato tra spinte minimaliste, pulsioni punk e tendenze hip hop, il collettivo, almeno per la sezione musicale, si riduce a tre membri, ovvero Mike, Marcus e Chris, gli apostoli più convinti del sintetico. to fanciullesco, caratteristico del loro sound maturo, è solo un miraggio, o tutt’alpiù, una carta nel mazzo. Le tracklist, infatti, si caratterizzano per involuti solipsismi tastieristici nella più tediata vena del Va n g e l i s ( e p i ù i n d i e t r o d e l l a kosmische musik tedesca) con qualche sprazzo dell’Aphex Tw i n di Selected Ambient Works Vol.1 (Warp, novembre 1992) o degli Autechre di Incunabula (Warp, novembre 1993) a far da corredo. Come dire: produzioni altamente trascurabili che, più che ben sperare, fanno temere per il peggio. Mentre Richard D. James infi- mesi dalla pubblicazione di Artificial Intelligence (la famosa geografia di talenti mappata dalla Warp nel 1993), Mike e Marcus contano ancora i grani del rosario. Noncuranti della scena IDM che si sta articolando attorno a loro, pubblicano Hooper Bay (Music 70, 1994), una raccolta di sghembe e interlocutorie elegie in punta di piedi dedicate a un villaggio esquimese chiamato Naparagamiut. Un’operazione simile a quella compiuta – con le dovute proporzioni s’intende – dai Residents in Eskimo che culmina nei negli otto minuti di Noa- Pervasi da chissà quale credo, cristiano nei contenuti ma decisamente ortodosso nella forma, i tre iniziano una lunga gavetta di registrazioni e performance live all’insegna della multimedialità e dell’autoproduzione. Organizzano una kermesse ambient rave - Red Moon sotto il nome di Hexagon Sun, un appuntamento estivo annuale organizzato assieme a alcuni fedelissimi nella campagna scozzese (che pare si tenga tutt’ora) e iniziano a incidere le prime produzioni per l’audience locale tramite un’etichetta personale chiamata Music70. Tra il 1987 e il 1993 si susseguono quattro cassette: Catalogue 3 (1987, il terzo di due volumi mai pubblicati), Acid Memories (1989), Closes Volume 1 (1993) e Play By Numbers (1994), tuttavia l’aspet- lava le prime ficcanti produzioni e quei diavolacci elettronici autori di Amber si piazzavano come primi della classe seguiti a ruota dai più ammiccanti Black Dog (poi Plaid e Balil), i Boards Of Canada, a fronte di scarse abilità sampledelicoritmiche e persistente chiodo fisso per mood ambientali, brancolano tra le alghe come ranocchi nello stagno. Del resto, non possono competere né con il piglio ipnagogico del capellone della Cornovaglia, né fregiarsi dei climax tecnocratici dei mancuniani, limiti che paiono già confinare un flebile sound a un’altrettanto ristretta cerchia di amici e tak, una suggestiva sequenza per xilofoni persi nella notte siderale. Benché la cassetta pare figlia del classico brancolare senza meta di color che son sospesi, in verità rappresenta un passaggio del testimone: l’anno successivo è la volta di Boc Maxima (Music70, cassetta, 1995), una collezione che evidenzia sia una sintonizzazione con la scena elettronica inglese e, specialmente, una piccola grande svolta. Tra sequenze oniriche (Wildlife Analisys), primi manifes t i ( E v e r y t h i n g Yo u D o I s A Balloon), qualche accattivante settaggio di drum machine (Chinook), nonché un pizzico di old skool Hip-Hop (nlogax), la raccolta sigla alcuni brani che finiranno dritti nel debutto Music Has The Right To C h i l d r e n , u n f r u t t o c h e i l c o n c i s o e m i r a t o Tw o i s m ( M u - 10 sentireascoltare conoscenti. Sixtyniner – Il periodo Skam Records Nel 1994, l’anno domini dell’uscita del secondo volume ambient di James e parecchi sic 70, 1995) cercherà di approfondire. Una strada è dunque intrapresa, in quest’ultima autoproduzione brani come Sixtyniner, Smokes Quantity e l’emblematica traccia omonima costituiscono a pieno titolo una prima sintesi del BOC sound adulto, un mondo sonoro in bilico costante tra mood ambientali (i synth sibillini) e sinistre latitudini sottopelle (la riproduzione di vecchi nastri), breakbeat angelici (il risciacquo primordiale) e sottili melodie psichedeliche (l’abbandono della mente). Bontà che è già buon pane per Sean Booth de- la quale diventano highliners, e con l’aiuto di Booth, Mike e Marcus prendono parte agli happening elettronici che contano: suonano a Londra assieme a Pan(a)sonic e Autechre (luglio 1996) e al festival di Phoenix (luglio 1997), ampliando così gli orizzonti fuori dell’Isola. Partecipano infine alla serie di 12’’ Mask, realizzata grazie una partnership tra la Skam Records e la bavarese Musik Aus Strom, con due tracce che s’avventurano in percorsi molto distanti da quelli intrapresi sinora. Tra questi, se Korona (su Mask 100) è una trascurabile traccia Amniotiche verità, avvistamenti di fanciulli sott’acqua – La maturità 1 9 9 8 . L’ a n n o z e r o . L’ e n t r a t a nella scuderia più rinomata dell’IDM coincide con la realizzazione di un lunghissimo M u s i c H a s T h e R i g h t To C h i ldren, che vede la luce il 20 aprile del 1998. Nel panorama anglosassone, l’album, uscito grazie a una joint venture tra Skam e Warp Records, si colloca come un tardo tassello ambientale dell’ideologia dell’etichetta di Sheffield, eppure dimostra di possedere la potenza simbolica di un obelisco materializ- gli Autechre, che dagli headquarters della mancuniana Skam Records telefona personalmente al duo, sancendo così la fine della prima parte di una gavetta durata quasi dieci anni. Eppure, se una porta si è aperta, i difetti di forma non mancano: molte sono le soluzioni prese maldestramente a prestito dai compagni d’etichetta (come accade per le linee autechriane di Oirectine o i breakbeat rubati a AFX di Basefree), troppe a dir il vero. Debolezze che l’eppì Hi Score (Skam, dicembre 1996), uscito di lì a poco e con tracce già presenti in Boc Maxima, non fa che confermare (Chinook). Per dei Boards Of Canada ben poco inclini ad avvilirsi in studio di registrazione, del resto è il momento di suonare dal vivo e giocare su varie piazze. Agganciati alla Skam, per techno à la Moby periodo Go! (1991), con i nostri a far da c u s t o d i d e l l a m e m o r i a d i Tw i n P e a k s , Tr a p p e d ( d i C o l o n e l Abrams) risulta invero curiosa per una complicata ragnatela di roland, synth angolari, trivelle ritmiche e fraseggi soul. La traccia coincide con il debutto dei Boards come remixer e, contemporaneamente, il varo di una nuova ragione, Hell Interface, un side-project che se farà il paio (anche qualitativamente parlando) con l’analogo progetto degli Autechre (Gescom), costituisce, se non altro, il segnale più evidente della maturazione di Mike e Marcus sotto l’aspetto tecnico. Caratteristica che va certamente annoverata tra gli elementi essenziali di un debutto in grande stile, che è già nell’aria: nel febbraio del 1998 i fratelli firmano per la Warp. zatosi d’emblée nella campagna inglese. È un lavoro che sublima anni di ricerche, un compatto e coerente flusso di coscienza di ricordi della pre-adolescenza, una sintesi di mito e sottesi presagi, d’incanto e di rarefazioni temporali. Compreso il potenziale di un mondo immaginifico, della savana amniotica e delle maree al crepuscolo, i Boards Of Canada siglano così l’apice - tutt’ora insuperato - di una personale poetica. Remissaggi di brani già app a r s i s u B o c M a x i m a , Tw o i sm e Hi Scores si combinano a altri di una sofisticazione inedita; accanto alle trame lineari (seppur off-pitch) delle migliori produzioni del passato, si manifestano complessi intrecci di voci e vocine, sussurri e dialoghi televisivi strappati al tempo, masse li- s e n t i r e a s c o l t a r e 11 quide che vengono egregiamente scandite una varietà di riff spezzati, dentelli metallici e fruscii cosmici. Evidenze di un lavoro timbrico che si riconduce all’alveo di un’ennesima spettacolare mutazione del tessuto dell’Hip Hop che dopo esser passato nell’acceleratore di particelle Jungle e nella narcosi del Trip-hop, trasfigura in senso angelico, onirico e ultraterreno. Alex Paterson aveva dimostrato come non ci fosse nessuna differenza di vedute tra gli hippies e i Ravers, Aphex Tw i n i n s e g n a t o c o m e s i p o t e va essere compositori classici prendendo a prestito le mac- stesso anno), stupendo l’uomo con due dignitosi inediti (Happy Cycling e quel ragarock per guerre stellari chiamato Xyz) e una sorprendente versione up-tempo di Aquarius (gioiello taglia e cuci sampledelico di funky e voci di bambini) (6.8/10), il debutto riceve consensi crescenti fino a trionfare nelle classifiche di fine anno di NME, The Wire, Jockey Slut, DJ Magazine. Grazie a un contratto con la M a t a d o r, l ’ a l b u m è d i s t r i b u i t o negli USA (settembre 1998) e con l’hype in forte crescita, nel febbraio successivo, è nuovamente nelle indipendent chart inglesi, dove rimane a Star sotto il nome di Hell Interface, e il più discreto make up per Mira Calix (Sandsings), ritornano nei negozi nel novembre del 2000 con In A Beautiful Place Out In The Country (Warp, novembre 2000). chine very cheap dell’Hip-Hop (e smontando e rimontando sintetizzatori), gli Autechre azzerato lo scarto linguistico tra i murales e le microchirurgie ritmiche, dunque i fratelli scozzesi scovano uno stargate evocativo e personale in un’infanzia tra Edimburgo, il Canada naturalistico dei documentari e il pianeta Marte del “c’è l’acqua sottosotto” e dei marziani verde fluo. (7.6/10) alte quote per parecchie settimane. Il successo è inarrestabile: in quegli stessi mesi, la popolare rivista NME inserisce i Boards Of Canada nel gotha neo psichedelico assieme a Mercury Rev e Beta Band e da lì ha luogo l’ennesimo bagno di folla al Warp Records 10th Birthday Party (con Autechre, S q u a r e p u s h e r, Aphex Tw i n e Mira Calix) e al lighthous e p r e s s o i l Ta m i g i a L o n d r a (con, oltre i consueti, anche Plaid e Prefuse 73). gelico/onirico stream of consciousness, il duo valica le pareti del subconscio approdando agli umori della riflessione adulta. In questo senso, se il pop - naturalmente dilatato - della marittima Kid F o r To d a y ( c o n t r a c c e d i P a n American) rappresenta un evidente segnale, è la traccia omonima l’effigie dello scarto tematico. Nei mesi successivi alla pubblicazione, mentre gli scozzes i r e m i s s a n o Ve g e t a r i a n S o u p degli allora famosi Meat Beat Manifesto (inserendo forzatamente carillon, vocine e spett r i d i Ta n g e r i n e l d u b - t e c h n o robotico del gruppo che pare non digerire bene l’intrusione) e partecipano alle session di John Peel (primo giugno 1998, pubblicazione su cd per la Warp nell’ottobre dello 12 sentireascoltare Tr e m e n d o u s Vo l c a n i c E x p l o sions Some Time Occur. Una geografia d’ambienti psichici e mentali Occorreranno due anni per far smaltire il boom mediatico ai fratelli scozzesi, che dopo un p e s s i m o r e m i x d i M i d a s To u c h del gruppo two-step Midnight L’ e p p ì , solo apparentemente un’ovazione alla natura e ai filmini del National Board, rappresenta un celato concept sulla strage di Mount Carmel a W a c o , i n Te x a s , d o v e f u r o n o uccisi dall’FBI 75 appartenenti della setta Branch Davidian. Per Mike e Marcus, lungi dal dare una svolta dark-ambient alla loro carriera, è uno spartiacque importante: dall’an- Tra vocalizzi vocoderati à la Daft Punk, un tipico Tum Tum Cha dell’Hip Hop e un sottile sinfonismo à la Badalamenti (sotto forma di pennellate di synth che sanno di organi funebri), il brano bilancia perfettamente un format mai così riconoscibile - pop come non lo è mai stato - eppur vivo e per nulla parco delle caratteristiche misteriose degli esordi. Appetibilità che non sfuggirà né ai fan sempre più numerosi del gruppo, né al mercato dell a t e l e f o n i a . Te l e c o m I t a l i a , quell’anno, commissionerà la sonorizzazione di un spot ai Boards Of Canada che per l’occasione ripropongono Sixt e e n d a Tw o i s m . ( 7 . 1 / 1 0 ) Di questa ulteriore maturazione farà tesoro Geogaddi (Warp / Self, febbraio 2002), secondo album sulla lunga distanza e caleidoscopio di ventitrè spaccati tra natura e contemplazione sull’esistenza, altrettanti tasselli del BOC pensiero sottoposti a sottili strategie oblique. Asciugato il volume acquatico del precedente lavoro, forata l’ovatta alinea, e usciti dal liquido amniotico della piscina di Cocoon (e da quello non meno mesmerico del festival A l l To m o r r o w ’ s P a r t i e s d e l 2001), i fratelli scozzesi disegnano una variegata geografia d’ambienti fisici e mentali che si traduce nei giochi timbrici sulle voci, di ragazzi e ragazze, prese dalla radio come d a l l a t v, d ’ i n d i v i d u i s c i o l t i i n un’avvolgente pasta ritmica che, di volta in volta, assume le fragranze del soul-pop (Music Is Math, 1959) come dell ’ e t n i c a ( S u n s h i n e R e c o r d e r, Opening The Mouth), del downtempo sincopato (Gyroscope) come dell’aria orchestrata e s y n t h - e t i c a ( Yo u C o u l d F e e l The Sky), del carillon sfasato (Dawn Chorus) come della piece concreta di field recording ( A I s To B A s B I s To C , T h e Devil Is In The Details, Diving Station). Il tutto condito, per la gioia di Scientology (nonché dei fanatici che credono alla cabalistica attorno alla morte di McCartney), di una serie di riferimenti alla matematica e allo spazio (Alpha And Omega, Music Is Math, A I s To B A s B I s To C , 1 9 5 9 … ) , sequenze e congetture avallate dai Nostri che rincarano la dose tirando in ballo persino la sequenza di Fibonacci. Ben lontano dall’incarnare le vesti di belzebù (ma sicura- mente pronto a vendergli l’anima, come dire, Devil Is In The Details), il secondogenito di casa, ancor oggi venerato dai fan occultisti (alcuni di loro tenutari di website in tutto e per tutto simili a quelli che raccontano la “vera” storia dei Beatles), è un prova frammentaria, con sicuramente alcuni momenti poco incisivi, ma pienamente riuscita. È, in definitiva, una mappa d’immagini di chi ha vissuto a sufficienza per evocare il passato, anche il più remoto, con la giusta pacatezza e il proverbiale distacco. E proprio come le voci dell’infanzia di Music Has The R i g h t To C h i l d r e n s o n o c r e sciute e con esse è maturato un diverso modo d’osservarle. (7.1/10) A Beautiful Day Out In The C o u n t r y, f o r r e a l ? Se occorrono ben tre anni per dare un successore a Geog a d d y, p e r M i k e e M a r c u s l e pause da un long playing e l’altro non hanno mai costituito un problema. Da anni sono richiesti come remixer e, anche questa volta, trascorrono il tempo al bancone dello studio di registrazione. Nel 2004 rifanno lo smalto a Boom Bip con Last Walk Around Mirror Lake, un lavoro d’ordinanza che non lascia alcuna scia dietro di sé, ma quando pare che la tv li stia assopendo, i fratelli sbucano dal lago di Lockness con due tra i migliori lifting di sempre: Dead Dogs Tw o p e r i c L O U D D E A D e B r o ken Drum per Beck. E con il prima a fregiarsi di una astuta siringata di A Day In The Life dei Beatles con il fantasma di Beck dietro l’angolo, e il secondo a reinventare lo stesso Hansen come avremmo sempre voluto sentirlo in Guero (Beck stesso dichiarerà “è il miglior remix che ho mai commissionato”) ogni dubbio sulla forma dei Boards Of Canada è sciolto mentre crescono le attese per una nuova fatica che si preannuncia calibrata nei suoni e fors’anche ricca d’innovazioni. Campfire Headphase (Warp / Self, 17 ottobre 2005), con la copertina caratterizzata da una figura sbavata e consumata come se la pellicola si fosse macchiata di un qualche liquido fosforescente poi sbiadito, non conferma le aspettative che i remix avevano paventato, tuttavia introduce una piccola grande novità, le chitarre. Mike e Marcus hanno passato gli ultimi due anni a provare e riprovare riff e arpeggi alla sei corde, ripensando il sound alla luce di uno strumento appeso al muro dai tempi del l i c e o . L’ a l b u m è u n a r i s p o sta ai loro quesiti ma anche una riapertura all’acustico come alle esterne, agli spazi bucolici dove le linee melodiche costeggiano i flussi della coscienza delle speranze più che delle reminiscenze, delle immagini dei volti che ancora devono venire al mondo, piuttosto che quelli c h e n o n c i s o n o p i ù . L’ i n i z i a le Chromakey Dreamcoat, tra un grezzo arpeggio di chitarra r e g i s t r a t o a l D AT e p o i m e s s o in loop, l’avvicendarsi delle consuete aperture acquatiche e un drumming maggiormente live rispetto agli standard, è il principio di un nuovo corso. Pur con qualche cassetta di scrosci ancora sotto il letto, il file canadese riapre sereno e senza teoremi matematici: Satellite Anthem Icarus è indietronica di marca 2004 senza troppi taglia e cuci, una melodia affogata nel gelato di una psichedelia per sbuffi angelici e vocoder di pannacotta. Niente più off-ptich spinti (tastiere opportunamente stonate) o bambini alieni (alienati) in apnea, la paternità di Marcus sembra aver portato un certo buonismo nelle melodie geogaddiche, armonizzazioni che nella sovraffollata glass a d i P e a c o c k Ta i l d e n o t a n o maggior produzione, e qual- s e n t i r e a s c o l t a r e 13 14 sentireascoltare interviste Klaus Schulze Quando il rock si liberò delle chitarre e diventò “cosmico” di Daniele Follero Quasi sessant’anni e una carriera più che trentennale. Dalla nascita dei Tangerine Dream e degli Ash Ra Tempel all’era dell’informatica musicale, passando per le incertezze degli anni’80. Piaccia o no, Klaus Schulze ha occupato di prepotenza un posto nella storia della musica. SentireAscoltare intervista in esclusiva il padre della Cosmische Musik. Schulze durante una performance a Linz nel 1980 che dubbio. Si respirano momenti convincenti, come nella cinematica Dayvan Cowboy (in crescendo avvolgente), o nelle pennellate blu di Oscar See Thorugh Red Eye (che sembra rinfocolare la fiamma umorale d i u n a K i d F o r To d a y ) ; t u t t a via, da altre parti (84 Pontiac Dream e Hey Saturnday Sun), in cotanta spazialità sonora, l’aria che tira è quella patinata - ahinoi - della new age. E se a quattordici anni dal debutto chill-out degli Orb, il leit motiv è sempre il medesimo - How Was The Sky When W e W e r e Yo u n g ? - , i l l a v o r o più lineare, massimalista e arrangiato dei nostri è anche il più debole: perso il lato s c u r o d e l l a f o r z a ( Te a r s F r o m The Compound Eye), Campfire Headphase guadagna in colore ma in definitiva perde in carenatura. Per vie diverse, ma nello stesso incrocio d’interrogativi, l’album porta con sé alcune delle perplessità del popolare fake che, per un po’ di tempo, molti hanno pensato essere l’album originale. Se il falso denotava incertezza ma grande passione per un sound comunque stagionato, l’autentico pur compatto, straordinariamente rifinito e proiettato verso il presente (la folktronica è uno dei piatti forti dell’indie attuale), manca di quella filigrana invisibile, di quel brivido sottopelle, che caratterizzava piccoli capolavori quali In A Beautiful Place O u t I n T h e C o u n t r y, A q u a r i u s (versione Peel Sessions) o Sixtyten. (6.0/10) Trentacinque anni fa usciva Let It Be e si concludeva l’avventura dei Beatles, che aveva rivoluzionato il rock in tutto e per tutto, anzi, forse lo aveva inventato. Contemporaneamente veniva dato alle stampe Electronic Meditation e si preparava un nuovo cambiamento epocale per la storia della popular music: cominciava la carriera di Klaus Schulze e dei Ta n g e r i n e D r e a m e p r e n d e v a i l via quel radicalismo elettronico che sconvolse non poco chi ancora viveva con l’idea che il rock fosse inscindibile dall’idea di fare musica con chi- tarra, basso e batteria. Corrieri Cosmici Te d e s c h i : così vennero definiti quei musicisti che un giorno decisero di fare tabula rasa di tutte le esperienze musicali che li avevano formati e cominciarono a manipolare i suoni con sintetizzatori analogici e moog, che divennero in seguito il segno distintivo di quella generazione. Ma la Cosmische Musik non nasceva dal nulla. Il fascino di certe esperienze “colte” (le esperienze minimaliste di L a M o n t e Yo u n g , R i l e y, G l a s s e Reich) e la psichedelia; le esperienze con le droghe allucinogene e il senso di “espansione” della mente che alla fine degli anni sessanta aveva influito fortemente anche sulle pratiche del fare musica, si univa a un vertiginoso sviluppo delle tecnologie e alla diffusione degli strumenti di manipolazione e sinterizzazione dei suoni. In questo clima, che apriva le porte al decennio più sperimentale del rock, la Germania, confermando il suo secolare approccio filosofico-spirituale alla musica, dimostrava che rock e avanguardia non erano poi vocaboli così antitetici tra loro. Il kraut rock, al di là del nome buffo, rappresentava al meglio la via tedesca alla popular music, accostando Stockhausen, i Pink Floyd e R i c h a r d Wa g n e r. Klaus Schulze, insieme a Edg a r d F r o e s e d e i Ta n g e r i n e Dream e Florian Fricke dei Popol Vuh può essere considerato tra i fondatori di questa “scuola”, che raggiunse, dopo un periodo di rodaggio, il suo apice creativo attorno alla metà degli anni ’70, quando gli esperimenti dei primi anni cominciarono a prendere forma e a riempirsi di contenuto, per poi cadere in una sorta di manierismo alla fine del decennio e scavarsi la fossa negli anni’80. L’ i n t r o d u z i o n e d i t e m i r i c o n o scibili al posto degli interminabili tappeti sonori, le ritmiche quasi dance che sostituiscono le atmosfere a-temporali e oniriche, sono il segno di una trasformazione inesorabile, piegata alle logiche di un mercato in forte espansione. La lunga carriera di Schulze è testimone di tutti questi cambiamenti: dai capolavori degli esordi Irrlichte Cyborg ai capitomboli di Body Love e Aphrica, fino alle mastodontiche operazioni degli ultimi anni (i 50 cd di musica inedita di The Ultimate Edition) il musicista berlinese non si è mai fermato, dimostrando oltre a un’incredibile prolificità, anche una grande consapevolezza dei propri mezzi artistici e un’ottima qualità compositiva. Manuel Gottsching (Ash Ra Te m p e l ) , B i l l L a s w e l l e S t e v e Winwood sono solo alcuni dei personaggi con cui il Nostro ha collaborato. E poi, ve li ricordate gli Alphaville, icona del pop anni’80? Era lui il coproduttore del progetto. Quel berlinese venuto dallo spazio - Intervista a Klaus Schulze Piaccia o no, Klaus Schulze è entrato di diritto nella storia della musica e avere l’opportunità di fare quattro chiacchiere con lui mi eccita e mi disorienta allo stesso tempo. Il rischio di perdermi nella storia ultra-trentennale di questo giovane sessantenne, la paura di sentirmi troppo piccolo di fronte a un colosso della musica, sono pensieri che inevitabilmente mi pervadono. Poi squilla il telefono: “Salve, sono Klaus Schulze, vorrei parlare con Daniele Follero”. Per un attimo sprofondo in una situazione assolutamente surreale. Poi tiro il fiato: “salve Klaus, sono io…” Sono passati più di trent’anni dalla nascita della Cosmische Musik. Cosa pensi sia rimasto di quegli esperimenti nella musica elettronica di oggi? Penso soprattutto al “sequencing”, quella sorta di maniera ipnotica di mettere in sequenza i suoni e l’approccio sperimentale nell’intervenire suoi suoni. Oggi le manipolazioni avvengono a qualsiasi livello, noi all’epoca non avevamo le a t t r e z z a t u r e ( c o m p u t e r, r y t h m machines) che è possibile utilizzare oggi. Ciò che oggi rimane di quelle esperienze penso sia anche un certo “feeling” nell’approccio alla materia musicale. Quali pensi siano state, in- vece, le debolezze della “musica cosmica”? Beh, ce ne sono molte! (ride). Penso soprattutto alla maniera un po’ caotica di fare musica che ci contraddistingueva. Allora, (mi riferisco in particolare ai miei esordi i n s i e m e a i Ta n g e r i n e D r e a m con Electronic Meditation) più che fare musica si stava provando a sperimentare nuove sonorità. Per questo spesso venivano fuori cose caotiche e, a volte, anche un bel po’ noiose. Stavamo iniziando in quel momento, non avevamo mai fatto cose del genere e non conoscevamo ancora il risultato che avremmo ottenuto. Mancando una tradizione non potevamo prendere spunto da esperienze simili. E’ attorno al 1974 che la cosmische musik arriva ad acquisire consapevolezza dei propri mezzi espressivi e raggiunge quasi la perfezione. Era anche un problema di forma, di struttura? Più che di forma, direi che c’era soprattutto un problema “drammaturgico”. Non sapevamo ancora come organizzare composizioni così lunghe. All’inizio stavamo esplorando nuovi strumenti, non eravamo consapevoli del risultato e quello che ci interessava era il puro effetto. Restavamo sorpresi perfino dall’atto stesso di girare la manopola di un Synth. Ma è la stessa situazione che ha vissuto la techno ai suoi esordi: oggi si ricerca la sofisticazione mentre prima i musicisti cercavano nuovi mondi sonori, avevano le attrezzature a disposizione e gli bastava questo. E’un po’ come quando i bambini vengono a contatto con qualcosa di nuovo e non sanno cosa aspettarsi. Molti ritengono Irrlicht il tuo miglior lavoro di sempre. Ti ha mai preoccupato l’idea di non riuscire a ripetere quello straordinario capolavoro? Assolutamente no, anzi, mi sentireascoltare 15 Schulze in una versione di cera... sorprende un po’che la gente pensi questo. Quando penso ai miei lavori precedenti li considero sempre nel contesto in cui sono stati creati e questo mi permette di giudicarli in maniera più oggettiva possibile. In un disco come Irrlicht oggi non posso evitare di scorgere tanti punti deboli, non lo rifarei, ma sono ancora convinto che all’epoca avesse la sua ragion d’essere. Al principio degli anni ‘70 le possibilità, gli strumenti, erano limitati rispetto ad oggi e questo fa onore a quel disco, per quanto lo renda assolutamente irripetibile. Cosa ricordi delle session in studio per il primo album deg l i A s h R a Te m p e l ? E’ stata veramente una specie di jam-session “fricchettona” (la risata scappa a entrambi). 16 sentireascoltare Era la prima volta che provavamo in uno studio di registrazione professionale e non avevamo la benché minima idea di come si lavorasse in uno studio. Eravamo abituati a suonare dal vivo. Ci guardammo in faccia e ci dicemmo: “ok, proviamo!”. Poi il tecnico ci ha fermato: “bene adesso ripetete la prima parte”. E poi ancora e ancora… E’stato davvero disorientante per noi lavorare in quel modo. In ogni caso noi, fuori dallo studio, abbiamo poi registrato in presa diretta lo stesso materiale, consegnando il nastro al produttore, che si è preoccupato del mixaggio. Cosa diresti della collaborazione con Manuel Gottsching? E’ sempre fantastico lavorare con lui. Cosa pensi dei suoi Cosmic Jokers? Non mi piace quella roba, penso siano stupidaggini. E’ musica piena di droghe, non mi interessa affatto.. Credi che le esperienze con le droghe possano avere qualche importanza nella composizione musicale? Dipende. Quando abbiamo cominciato, le esperienze con le droghe erano abbastanza importanti per noi, perché sentivamo la necessità di uscire dalla realtà, di superare i confini. In più, venivamo da un’educazione tradizionale (non solo musicale): eravamo normali musicisti che suonavano la batteria, la chitarra e il basso. Per abbandonare questa “normalità” pensavamo che anche l’uso di droghe avesse la sua importanza. Nel momento in cui, però, si riesce a uscire da questa dimensione è importante usare il proprio potere senza farsi troppo “aiutare”. Con un uso reiterato le droghe perdono di senso, come nel caso dei Cosmic Jokers: ognuno suona per conto suo, senza pensare a cosa stanno facendo gli altri. Non penso sia un buon esempio di musica, questo. 1970: Electronic Meditation c o n i Ta n g e r i n e D r e a m p u ò essere considerato l’inizio della carriera sia tua che loro. Come consideri la storia musicale di quella band? Hai ancora qualcosa da condividere con loro, musicalmente parlando? P e n s o c h e l a s t o r i a d e i Ta n g e rine Dream abbia subito rapidi cambiamenti già dopo qualche anno dagli esordi, soprattutto dovuti a vari cambi di formazione. E’ stato negli anni ’80, però, che le nostre strade si sono separate inesorabilmente: io all’epoca ero ancora interessato a composizioni lunghe e di ampio respiro mentre i Ta n g e r i n e D r e a m h a n n o c o minciato a interessarsi al mercato musicale americano e alle musiche da film e i loro dischi sono diventati inevitabilmente più “commerciali”. In America devi seguire determinate regole e questo a me non interessa per niente. Non ho mai voluto suonare in America e anche per questo la mia musica ha avuto successo in Europa e non negli U.S.A. Gottsching ha affidato uno dei suoi capolavori, E2-E4, allo Zeitkratzer Ensemble. Hai mai pensato di far eseguire un tuo lavoro per orchestra (Irrlicht, per esempio) a un ensemble orchestrale? Ve r a m e n t e n o . I m i e i l a v o r i sono molto basati sul sound complessivo, che costruisco in studio e non penso sia particolarmente interessante farli eseguire da altri, come se fossero messi in partitura. Pensi che esista qualche relazione tra la musica classica (o “colta” che dir si voglia) e il rock? N o . L’ u n i c a c a r a t t e r i s t i c a c h e hanno in comune questi due ambiti è quella di appartenere in maniera molto generica alla categoria “musica”. Il rock è una musica concepita per il corpo, laddove la musica cosiddetta “classica” appartiene alla sfera mentale, non solo in senso intellettualistico. Beh, però i valzer di Johann Strass nascono per il ballo, quindi per il corpo… Già, ma per vecchi corpi (gran risata)… E’ stato davvero importante Richard Wagner per la tua musica? Certo! E’uno dei primi musicisti a comporre in senso multimediale. Il suo concetto di opera totale (può piacere o no) riusciva a mettere insieme straordinariamente diversi mezzi espressivi. Trovo straordinario anche il suo modo di comporre alcune parti vocali, specialmente quelle femminili: mi fanno veramente accapponare la pelle! C’è un particolare aspetto della musica di Wagner che ti interessa? Quel particolare modo di costruire le melodie che viene normalmente chiamato Leitmotiv e che stravolge il concetto di tema che si trova fino a Beethoven. Il Leitmotiv è una melodia, ma non è “concreta” e questo lo rende particolarmente misterioso. Pensi che i 50 cd di The Ultimate Edition possano davvero aggiungere qualcosa alla tua discografia, o sono solo un feticcio per fan e collezionisti? Penso che siano come una sorta di diario di venti e più anni di carriera. I fan sono sempre alla ricerca di esecuzioni dal vivo o comunque in presa diretta e questo mi sembra un buon modo di venirgli incontro con materiale inedito. E’importante per avere un quadro più completo della mia produzione musicale, ma non può sostituire la discografia ufficiale. Diciamo pure che più che di una raccolta si tratta di un complemento alla mia discografia. Tu h a i l a v o r a t o c o n m e t o d i d i registrazione e produzione del suono sia analogici sia digitali e questo dualismo è ben rappresentato in tutta la tua produzione. Segui qualche criterio estetico nella scelta di suoni analogici o digitali quando componi? Dipende molto dalla musica che sto componendo in quel preciso momento e dal suono di cui ho bisogno. Non mi interessa molto se sia creato in analogico o digitale. Oggi, ad esempio, lavoro molto con i software, anche per una questione di praticità. Cosa pensi della New Age? E’ solo una moda? E’orribile! Dolce ed esoterica, ma di un esoterismo molto “americano”. C’è gente che pensa che per rilassarsi e calmarsi ha bisogno di ascoltare quella roba. Ma è una stupidaggine! C’è molta musica, in questo senso, molto più “new age”, ma che non è considerata tale. Cosa pensi di etichette tedesche di musica elettronica come Monika Records, Staubgold, Sonig e di band come i Mouse On Mars? Ah, li trovo molto divertenti! E anche interessanti. Si può dire che rappresentano la terza generazione di musicisti elettronici tedeschi. Trovo molti di questi lavori troppo commerciali per me, ma ci sono alcune idee da non sottovalutare. Cosa diresti del tuo ultimo album, Moonlake, uscito da poco? Oh, è molto bello! (ride) Non c’è molto da dire in proposito, visto che è stato composto nello stato emozionale in cui ho sempre registrati i miei dischi, quindi per me è un disco del tutto normale, anche se mi piace particolarmente perché è l’ultimo: mi affeziono sempre di più all’ultimo album che incido, nel momento in cui lo faccio! Un’ultima domanda. Dopo anni di intensa attività artistica, c’è ancora musica nel futuro di Klaus Schulze? Hai qualche progetto? Al momento no, perché sono ancora convalescente dopo un periodo in cui sono stato poco bene. Per ora non ho programmi, ma appena starò meglio rimetterò piede nel mio studio di per registrare qualcosa, magari un nuovo album o qualcosa del genere. Ad ogni modo spero che ci sia ancora musica nel futuro di Klaus Schulze e, soprattutto… buona musica. sentireascoltare 17 monografia Silver Jews Il diritto di rimanere in silenzio di Antonio Puglia Tra lo-fi, folk, alt. country e quintali di poesia sgangherata, la carriera della (non) band dell’ultimo anti-eroe indie, David Berman (non) Strana creatura, i Silver Jews di David Berman. Un’entità sfuggente, atipica anche per la loro culla, quel bizzarro e sono emerse personalità forti come Will Oldham, Stephen Malkmus, Beck; gente che, partita imboccando percorsi alternativi a quelli tradizionali del music business (quando non decisamente in rottura con essi), col passare del tempo si è “arresa” all’idea di carriera, anche con successo. In questo contesto, David Ber- che, anche se saltuariamente, lo obbliga a stare sotto i rif l e t t o r i . N o n è u n a r o c k s t a r, f i guriamoci. Non è un hobo nato c o m e i l P r i n c e B i l l y. N o n è u n eroe indie come Malkmus, né un loser eccellente come Lou B a r l o w. L o p o t r e m m o p i u t t o sto chiamare poeta, e a volte anche lui ama definirsi così; nel 1999 ha pubblicato una frastagliato universo lo-fi che nei primi ’90 vide fiorire Royal Trux, Palace, Sebadoh e mille altri. Un panorama musicale improbabile, da cui tuttavia man (o più brevemente DCB) resta un’eccezione. Non è certo uno a cui piace stare al centro dell’attenzione, anzi. Eppure ha scelto un mestiere raccolta di scritti (Actual Air) e si è detto che per un certo periodo abbia anche insegnato letteratura americana; nessuna meraviglia che invece di “Sono il tiro che mia madre ha giocato al mondo; diciassette dottori non sono riusciti a decidere se dovessi fare parte del gioco o meno” (Send In The Clouds – 1998) 18 sentireascoltare andare in giro a promuovere i dischi preferisca dedicarsi ai reading. Eppure per lui la musica è sempre stata una cosa seria, quasi un’esigenza vitale: basta buttare un occhio ai suoi testi ironici e poeticissimi, buffi e profondi al tempo stesso, per rendersene conto. Questi paradossi non devono stupire: sin dagli inizi, la storia dei Silver Jews si è basata sugli sforzi, apparentemente opposti e inconciliabili, di passare inosservati e al contempo di affermare la propria esistenza. Basti pensare che Berman ha speso metà degli anni ’90 tentando di spiegare che i Silver Jews non erano un side project dei Pavement, e nonostante ciò, buona parte della notorietà della band è dipesa proprio da questo beffardo equivoco. In effetti, era ancora il 1989 quando tre studenti dell’Università della Virginia misero su una band informale chiamata Ectoslavia; trasferitisi a N e w Yo r k , B e r m a n , S t e p h e n Malkmus e Bob Nastanovich continuarono a improvvisare canzoni nell’appartamento che dividevano, registrandole con mezzi di fortuna dopo lunghe giornate di lavoro (i primi due come guardiani in un museo, il terzo come autista di un bus navetta): erano nati i Silver Jews, a quello stadio niente più che un gioco tra amici. Una concezione di band che negli anni non è poi cambiata tanto: nonostante il crescente interesse intorno a Berman a causa della Pavement-connection, i Joos sono sempre rimasti una piccola famiglia, intima e riservata. Un approccio più professionale, l’aiuto di preziosi collaboratori e un’ispirazione sempre più vivida hanno solo contribuito ad elevare esponenzialmente la qualità dei dischi, senza influire sull’atteggiamento di Berman nei confronti dello show-biz. Pur mantenendo un basso pro- filo, i Silver Jews hanno finito per mostrare tutta l’urgenza di comunicare la propria esistenza, e questo perché sono stati anzitutto la finestra da cui il loro creatore si è affacciato per raccontare il mondo. Un mondo in cui “gli alberi hanno la silhouette di Abramo Lincoln”, “gli uccelli della Virginia volano in tre come le coriste”, “i professori di latino puzzano sempre di piscio”, “i treni attraversano il mare” e “i vestiti di velluto servono a far scorrere via la pioggia”. A partire dal 1996 con The Natural Bridge, Berman ha messo a punto una poetica personalissima, una weltanschauung densa di riflessioni immaginifiche sulla realtà circostante, su rapporti interpersonali, sull’amore, sulla vita e sulla morte; il tutto condito da uno humour surreale, sardonico e beffardo, che nella maggior parte dei casi cela un profondo disagio esistenziale (si è saputo che DCB è stato un aspirante suicida). In altre parole le canzoni dei Silver Jews ci forniscono un ritratto unico dell’uomo, delle esperienze e dei luoghi in cui è vissuto, con spaccati singolari della provincia americana di fine millennio (Virginia, Te x a s , K e n t u c k y , Te n n e s s e e ) . Oggi, parte della poesia forse si è persa: abbiamo un Berman sposato, ottimista, non più depresso, che ha addirittura trovato il piacere di suonare “loud” abbandonando in parte le sonnolente cadenze country folk. “Fino a Bright Flight - 2001 - avevo concepito i miei dischi come lettere d’addio, adesso vivo per il presente” (da un’intervista a Blow Up #90, novembre 2005). Un presente in cui, siamo sicuri, David continuerà a fare dischi come ha sempre fatto, e chissà, forse si arrenderà anche lui all’idea di carriera… riservandosi comunque il diritto di rimanere in silenzio. Don’t talk to me about work – Due chiacchiere con David Berman Domanda ovvia ma inevitabile: cosa hai fatto negli ultimi quattro anni? L’ u l t i m o d i s c o ( B r i g h t F l i g h t ) è uscito nell’ottobre del 2001. Mi sono sposato nell’ottobre 2002. Tutti i miei album precedenti sono usciti in ottobre. Perché? Da giovane ho letto questo passaggio di Nietzche ed mi è sempre rimasto in testa (letteralmente: “it became one of the sentences spraypainted on the dry bone walls of my m i n d ” n d r. ) “ P e r i m i e i l e t t o ri più selezionati vorrei dire qualcosa anche su ciò che voglio veramente dalla musica. Deve essere piacevole e intensa, come un pomeriggio di ottobre. Deve essere unica, lasciva e tenera, e come una donna raffinata ed elegante, piena di malizia e grazia…” (dall’Ecce Homo). I n a s t r i d i Ta n g l e w o o d N u m bers si sono miracolosamente salvati dall’incendio che l’estate scorsa ha distrutto gli Easley-McCain studios di Memphis. Credi nel Fato? E’ un po’ infelice credere che tutto ciò che fai è deciso dal Fato. A volte succedono cose che ti danno la possibilità di dire “questo doveva accadere”, e in un contesto creativo ciò può essere piuttosto demoralizzante: “Se questo doveva accadere come posso dire di essere completamente padrone di ciò che faccio?”. E’ come attaccare se stessi. La prima cosa che viene fuor i d a l l ’ a s c o l t o d i Ta n g l e w o o d Numbers è che oggi i Silver Jews suonano più “rock” che mai. E’ dipeso dai musicisti con cui hai lavorato stavolta o da influenze particolari? Penso dipenda dalla musica che ho ascoltato in macchina durante il 2004. Ho ricominciato a sentire musica ad alto volume, il mio stile di guida è diventato più aggressivo e spietato e mi sono reso con- s e n t i r e a s c o l t a r e 19 to che lentamente, col tempo, ero diventato insensibile alla capacità che ha la musica di suscitare grandi ondate di emozioni. Così ho suonato a tutto volume Jo Jo Gunne, Bloodrock, UFO e Hairy Chapter (tutte band hard rock anni’70, ndr). Ho anche ascoltato un po’ del rap che proviene da “Cashville”: Haystak a n d A l l - S t a r n o w. R e s p e c t . Tu t t o q u e s t o s u o n a p r o p r i o come una sorta di nuovo iniz i o p e r t e . Tu t t a v i a , s a p r e s t i trovarmi dei punti in comune tra questo disco e il precedente, Bright Flight? Soltanto ovvietà, come il nome dell’autore e la sequenzialità. Penso che tw#s più che altro si faccia notare per l’assenza di legami con il suo predecessore. Com’è stato lavorare di nuovo con Bob Nastanovich (ex percussionista dei Pavement, ndr)? Non abbiamo sue notizie da un bel po’. Come se la passa? Bob ha scelto di fare una vita tranquilla. Il suo sorriso allegro e il modo in cui spazza industriosamente la strada gli hanno fatto guadagnare il rispetto di tutta la comunità in cui vive, ed è piuttosto frequente che un mercante indaffarato si fermi e offra a Bob un nichelino scintillante, che “mister Bob” (lo chiamano così) lascia cadere con orgoglio nelle tasche con un gran battito di ciglia. Nelle nuove canzoni Stephen (Malkmus) non canta, si limita a suonare la chitarra. E’ come se fosse un “semplice” musicista nella band, anche se il suo stile resta sempre in primo piano. E’ ancora un partner speciale per te? Sì. Mi piace pensare alla nostra relazione come quella tra quarterback e ricevitore nel football americano. Ci deve essere una certa intesa tra i giocatori perché riescano i lanci lunghi, ed è un po’ quello che ci succede in studio. 20 sentireascoltare Sotto la sigla Silver Jews sono passati tanti musicisti diversi. Oltre a quelli con cui hai già lavorato, ci sono dei musicisti con cui ti piacerebbe collaborare in futuro? Mi piace molto il gruppo che abbiamo adesso. Forse dovrei richiamare i ragazzi di The Natural Bridge… Comunque il nostro roster è questo. Non ho intenzione di rimpiazzare nessuno all’interno di questa organizzazione. Che musica hai ascoltato negli ultimi mesi? Il nuovo disco di Bobby Bare S r. s u D u a l t o n e ( T h e M o o n Was Blue, gennaio 2005) è un documento impressionante, e quando ti trovi davanti alla g r a n d e z z a d i Va n L e a r R o s e di Loretta Lynn (Interscope, 2004) e delle ultime cose pubblicate da Johnny Cash ti rendi finalmente conto che, quand o s e i c o u n t r y, è u n a c o s a c h e ti porti fin dentro la tomba. Avremo mai la possibilità di leggere Actual Air anche in Europa? La traduzione avviene quando qualcuno dell’altra lingua lo decide. Non posso impedire a nessuno di tradurre le mie poesie, come potrei? Una squadra speciale di Nobel che sgombera uno squat olandese? E’ una domanda interessante. In una recente intervista, quando ti è stato chiesto cosa pensassi delle poesie d i J e f f Tw e e d y e B i l l y C o r gan, hai detto che loro erano musicisti professionisti ancora prima di essere scrittori professionisti. Ti consideri più uno scrittore professionista o un musicista professionista? E cosa significa “professionista” per te, in ogni caso? Penso a me stesso come un “portatore di significato” (significance provider). E’ un termine che ho sentito dire a Grant Morrison durante una conferenza. Penso che “pro- fessionista” sia un termine comune che indica “ciò che fai nella vita”. La storia dei Silver Jews è sempre stata strettamente legata alle vicende della tua vita, alle tue scelte, come una sorta di tua questione privata. Arriverà il momento in cui la band prenderà il controllo e diventerà un business? La band assumerà tanto controllo quanto il mondo è disposto a darne (decliniamo ogni responsabilità circa l’igiene urbana e cose del genere). Gli ultimi eventi nella selezione naturale hanno dimostrato che la mutazione chiamata “business” è diventata un adattamento necessario, e così, anche se con riluttanza… - Significa che finalmente vi metterete a fare concerti? (Come da copione, David non risponde a questa domanda, ndr). Dai vostri esordi c’è stato sicuramente un cambiamento - diremmo una crescita nella storia dei Silver Jews. Quando ti sei accorto che la band poteva essere qualcosa di diverso da tre amici che registrano canzoni in un appartamento? Nel 1996 The Natural Bridge è arrivato al diciassettesimo posto nella classifica degli album dell’anno del Melody M a k e r. A q u e l t e m p o l a c o s a mi ha mandato fuori di testa. Guardando indietro, qual è il tuo disco preferito dei Jews? Probabilmente Crooked Rain, Crooked Rain. Dicci qualcosa che non hai ancora fatto e qualcosa che vorresti fare in futuro. Vo g l i o s o l o c h e c i s i a u n f u t u ro. Non voglio che questa vita finisca. Prologo: Canzoni da un appartamento (1991/ 1992) Le prime uscite a nome Silver Jews sono esattamente quello che Berman, Malkmus e Nastanovich promettono sin dall’inizio: tre amici che strimpellano allegramente in una stanza, niente di più, niente di meno. Nel 1993 la Drag City (guidata dal lungimirante e coraggioso Dan Koretsky) tiene a battesimo la “band” dando alle stampe l’EP Dime Map Of The Reef, seguito dall’ineffabile 7” The Silver Jews & Nico (questo edito dalla Chunk Records), fino al mini The Arizona Record. Si tratta per lo più di registrazioni in bassissima fedeltà risalenti al biennio ‘91/92, periodo in cui due terzi del gruppo erano alle prese con Slanted & Enchanted. Il paragone con le coeve produzioni dei Pavement è, appunto, inevitabile: se il grado di amatorialità ed insana incoscienza è all’incirca lo stesso (tanto che a volte è difficile distinguere trai due gruppi, vedi The War In Apartment 1812), dalle parti dei Jews l’approccio compositivo è ancora più frammentario e aleatorio: non canzoni, piuttosto ritornelli abbozzati, spesso improvvisati sul momento; la poetica visionaria e assurda di Berman è ancora tutta da venire, così come la vena pop di Malkmus (che sboccia altrove), mentre Nastanovich conferisce quel grado di simpatica amatorialità al tutto. Tra le prime apparizioni del demenziale jingle jangle malkmusiano (Canada, Sabellion Rebellion, Jackson Nightz) e del tetro solipsismo di Berman (Walnut Falcon), in questa messe sgangherata si possono trovare comunque episodi esplicativi come l a d i v e r t e n t e p a r o d i a j a z z d i O l d N e w Yo r k , S e c r e t K n o w l e d g e o f The Backroads (in multiproprietà con i Pavement, che la suoneranno in una Peel Session) e la psichedelia spacey di Bar Scene From Star Wars. Da notare che a questo stadio Malkmus e Nastanovich erano nascosti dietro gli alias Hazel Figurine e Bobby N. Come se ci si potesse sbagliare.. Starlite Walker (Drag City / Domino, 1994) “In ventisette anni ho bevuto cinquantamila birre / che si inf r a n g o n o c o n t r o d i m e c o m e i l m a r e c o n t r o u n m o l o ” ( Tr a i n s Across The Sea) Dopo le prove generali degli Ep, il primo vero album dei Silver Jews esce nell’autunno del 1994. La stagione del lo-fi sembra ormai agli sgoccioli: Beck è in heavy rotation su Mtv e gli stessi Pavement, i re della scena, hanno cominciato a prendere le distanze dal movimento con Crooked Rain, Crooked Rain. Accompagnato dai soliti Malkmus e Nastanovich (più il loro nuovo batterista Steve West, a rendere ancora più pesante la “sudditanza”), Berman entra nei leggendari Easley-McCain di Memphis per uscirne con quel mucchio di canzoni che form a n o S t a r l i t e Wa l k e r. C a n z o n i c o u n t r y - f o l k p e r l a p r e c i s i o n e , ripassate attraverso la tipica dis-grazia dei sodali; anche se lo stile di scrittura rivendica una sua indipendenza, l’associazione col gruppo di Stockton è ancora inevitabile: si vedano le sconclusionatezze strumentali in The Moon Is The Number 18, l’andamento alla Fall di Pan American Blues o il gigioneggiare imperterrito dei coretti in Living Waters, per non parlare dello stile vocale di David, ancora influenzato dall’amico Stephen. Nonostante ciò, i Silver Jews cominciano a rivelare un’identità più certa: lo dimostra Trains Across The Sea, la prima composizione memorabile di DCB, che inaugura qui la sua poetica surreale, e New Orleans, il prototipo delle ballate crepuscolari di lì a venire. E andando avanti, è proprio un bell’ascoltare: A d v i c e To T h e G r a d u a t e , T i d e To T h e O c e a n s ( e n t r a m b e c o n il leader dei Pavement ben in evidenza), Rebel Jew sono tutti episodi melodicamente ineccepibili (alla voce Beatles vs. sentireascoltare 21 Ve l v e t U n d e r g r o u n d ) , v e n a t i d i u n f a s c i n o r u r a l e c h e r i c h i a m a i primissimi R.e.m. di dieci anni prima (anche nella grafica di copertina), passati attraverso l’estetica amatoriale e naif dei propri tempi. Oggi si può pensare a questo disco come a un’appendice in chiave folk di quel piccolo capolavoro che è Crooked Rain, Crooked Rain o, più semplicemente, uno dei segreti meglio custoditi del suo periodo. (7.3/10) The Natural Bridge (Drag City / Domino, 1996) “No, non voglio morire davvero / Voglio solo morire nei tuoi o c c h i ” ( H o w To R e n t A R o o m ) Se Starlite Walker aveva mostrato cosa fossero i Silver Jews in un “vero” studio per un “vero” disco, The Natural Bridge va anche oltre. A buon diritto, è lecito credere che Berman si fosse ampiamente stufato delle continue associazioni del suo progetto con i Pavement, e così, approfittando dei sempre più frequenti impegni dei compari, scrive un pugno di ballad con quei pochi accordi che conosce, ci butta dentro quintali di poesia sgangherata e ispiratissima, le arrangia al volo e le registra c o n a l t r i q u a t t r o m u s i c i s t i s e m i - s c o n o s c i u t i ( M a t t H u n t e r, R i a n M u r p h y, P e y t o n P i n k e r t o n , M i c h a e l D e m i n g ) . N e v i e n e f u o r i u n o stile musicale che, per quanto classico e ortodosso rispetto alla sregolatezza del passato, consente al Nostro di dedicarsi al meglio alla scrittura. Il risultato è il più bel disco di Berman come autore e compositore. È qui che troviamo il prototipo della ballata à la Silver J e w s , H o w To R e n t a R o o m : g i r o a r m o n i c o s e m p l i c i s s i m o , d o l e n t e c a d e n z a c o u n t r y, v o c e s t r a s c i c a t a s e m p r e s u l f i l o d e l l a stonatura e un verso che ti colpisce a primo ascolto (“No, I don’t really wanna die / I only wanna die in your eyes”); un incipit folgorante, che sarà una caratteristica costante dei dischi successivi dei Joos. Per il resto, The Natural Bridge è un lavoro straordinariamente compatto, che da un lato paga il dovuto dazio alle colonne portanti del songwriting folk (lo spirito di Dylan aleggia inevitabilmente su quasi tutte le tracc e , c o s ì c o m e q u e l l o d i N e i l Yo u n g - I n s i d e T h e G o l d e n D a y s O f M i s s i n g Yo u – o a n c h e d e i p r i m i R . e . m . – D a l l a s ) , d a l l ’ a l t r o crea atmosfere dense di un minimalismo teso e spettrale (quasi post, come in Ballad Of Reverend War Character), per un esito analogo a quello coevo dell’amico Will Oldham e i suoi Palace. Su tutto, l’inconfondibile stile lirico di Berman, che rende queste elementari country songs dei deliziosi quadretti densi di un esistenzialismo disincantato, colmi di uno humour sardonico e amarissimo (vedi la drammaticità di Frontier Index, la filosofia naif di Black And Brown Shoes, la toccante sincerità di Pretty Eyes). Insomma, un album talmente riuscito che il suo esterrefatto autore lo vedrà scalare le classifiche indie di fine anno. E’ uff i c i a l e : S i l v e r J e w s a r e h e r e t o s t a y. ( 8 . 0 / 1 0 ) American Water (Drag City/ Domino, ottobre 1998) “Nel 1984 fui ricoverato per essermi avvicinato alla perfezione / Dopo aver cazzeggiato in giro per l’Europa, hanno dovuto ricredersi” (Random Rules) Per il successore di Natural Bridge, DCB inverte parzialmente la rotta: convoca nuovi musicisti (Tim Barnes, l’ex Royal Trux Mike Fellows, Chris Stroffolino) e, sorpresa, richiama in squadra l’amico Stephen. Un ritorno al passato? Quasi: la nuova 22 sentireascoltare formula dei Jews, per quanto riporti in azione la coppia Malkmus-Berman, risente inevitabilmente delle esperienze maturate d a i d u e n e l p o s t - S t a r l i t e Wa l k e r. I l p r i m o , r e d u c e d a l l a p r o gressiva “normalizzazione” dei Pavement, comincia a sentire bisogno di respirare aria nuova; il secondo, ormai sicuro delle proprie capacità di autore e interprete, non teme più il confronto con la “grande madre” di Stockton e sceglie di avvalersi di un partner musicale d’eccezione. A dirla tutta, nell’ideale rincorsa Silver Jews / Pavement, stavolta il risultato si ribalta. American Water non solo rivela la completa maturazione del progetto di Berman come entità a sé stante, ma mostra un valore aggiunto anche rispetto al gruppo di Malkmus. Se la calligrafia è quella già incontrata in Natural Bridge (Random Rules, classica album opener che si avvale di un arrangiamento strepitoso con sfumature alla Oldham, o la crepuscolare We Are Real), Stephen s’inserisce tra le pieghe, con la voce e ancor più con la chitarra (protagonista assoluta nella strumentale Night Society e in Like Like The The Death), mettendo in luce tutte le potenzialità di un tandem formidabile. In certi episodi inevitabilmente l’orecchio riporta ai tardi Pavement (vedi l’incedere ubriaco di Federal Dust, o Blue Arrangements, che pare fare il verso alla Something beatlesiana), ma in più di uno è facile riscontrare una freschezza, una realizzazione che manca agli ultimi lavori di Malkmus e soci (su tutti la strepitosa People). Non sarà un caso se lo stesso Stephen r e s t e r à a l l a l u n g a d e l u s o d a l “ s u o ” Te r r o r T w i l i g h t ( r e a l i z z a t o poco dopo questo disco) perché “non era altrettanto ispirato come American Water”; e ascoltando Send InThe Clouds, Smit h & J o n e s F o r e v e r, B u c k i n g h a m R a b b i t e T h e W i l d K i n d n e s s viene proprio voglia di dargli ragione: neanche da solista riuscirà a trovare un socio come DCB. Il quale a sua volta mette da parte il cupo esistenzialismo del disco precedente in favore di un beffardo nonsense, che alleggerisce i toni senza perdere in profondità (le già citate We Are Real, Random Rules e Send In the Clouds, tutte dei classici bermaniani): l’ulteriore pregio di un album che ancora oggi è uno dei picchi del cantautorato indie pop. (7.7/10) Bright Flight (Drag City / Domino, ottobre 2001) “Andremo a vivere a Nashville, e lì farò carriera / scrivendo canzoni tristi per poi essere pagato in base alle l a c r i m e ” ( Te n n e s s e e ) Aria di cambiamenti in casa Silver Jews. La Pavement connection è ormai un ricordo sbiadito (Malkmus ha appena iniziato l’avventura solista con i Jicks), così come gli anni del lo-fi e d e l l e s c o r r i b a n d e i n d i e t r a L o u i s v i l l e , D a l l a s , N e w Yo r k e i l N e w J e r s e y. D C B s i è t r a s f e r i t o n e l l a c i t t à d e i s u o i s o g n i , quella Nashville che per lui rappresenta un porto ideale, non solo da un punto di vista musicale: nel suo futuro prossimo, d o p o l ’ a ff e r m a z i o n e c o m e s c r i t t o r e c o n A c t u a l A i r, c ’ è a n c h e i l matrimonio e una vita più o meno stabile. Insomma, si chiude una stagione. Il Nostro se ne rende pienamente conto e scrive quello che potremmo chiamare il disco “definitivo” dei Silver Jews; nel senso che Bright Flight, in maniera più o meno conscia, conclude quel ciclo che si era aperto con Starlite Walker e aveva visto la partecipazione alterna degli amici Pavement. Per l’occasione, Berman lascia ancora una volta Stephen a c a s a e r e c l u t a p r o f e s s i o n i s t i c o m e i d u e L a m b c h o p To n y C r o w e Paul Niehaus e Cassie Marret, cantante country-punk destinata sentireascoltare 23 a diventare la sua compagna di vita. Il processo di maturazione è dunque completo: la tetra desolazione di Natural Bridge e la frizzante ironia di American Water vengono qui metabolizzate e cristallizzate nell’ideale dimensione del tipico Nashville sound; una scelta che, per quanto convenzionale, definisce inequivocabilmente l’essenza “classica” del songwriting strampalato di DCB. Non è quindi un caso che la veste tradizionale calzi a pennello a queste composizioni, in assoluto tra le più ispirate del Nostro: dall’ironica riflessione sulla creazione e sulla morte di Slow Education (“When God was young, he made the wind and the sun / and since then, it’s been a slow education”), allo sguardo sornione verso il futuro d i Te n n e s s e e ( “ M a r r y m e , l e a v e K e n t u c k y , c o m e t o Te n n e s s e e ” ) ritroviamo l’intero universo di Berman, il quale adesso guarda alla vita con cauto ottimismo, senza rinunciare a quel disincantato sarcasmo che lo ha sempre accompagnato. E se I Remember Me e Horseleg Swastikas sono tipiche ballad country da “scazzo sul divano” (I’m drunk on a couch in Nashville /… I’m like a rabbit freezing on a star), a far da contraltare ci pensano l’honky tonk sbarazzino di Let’s Not And Say We Did (con Cassie al controcanto) e il buffo numero da c l o s i n g t i m e F r i d a y N i g h t F e v e r, m e n t r e i n Ti m e W i l l B r e a k T h e World e nella strumentale Transylvania Blues fa capolino un inedito mood desertico à la Giant Sand / Calexico. La malinconica Death Of An Heir Of Sorrows (I wish I had a thousand bucks / I wish I was the Royal Trux) è l’epitaffio che chiude idealmente un album che sa tanto di lettera d’addio. Dopo Bright Flight, sarà tutt’altra musica. (7.5/10) Tanglewood Numbers (Drag City / Domino, 18 ottobre 2005) “Dov’è la busta di carta che avvolge il liquore / nel caso in cui dovessi aver bisogno di vomitare”(Punks In The Beerlight) Quattro anni: una gestazione insolitamente lunga per un disco dei Silver Jews. Da quel poco che ci è dato sapere, nel frattempo David Berman si è felicemente sposato con Cassie Marret, mettendo da parte la musica per dedicarsi ai suoi amati reading (nonché alla trasposizione sulle scene di Actual Air); soltanto a fine del 2004 ha cominciato a raccogliere le idee per l’atteso ritorno della sua creatura, radunando tra gli altri vecchi amici come Stephen Malkmus, Bob Nastanovich e Will Oldham. Dopo alcune peripezie in fase di post produzione - si è persino vociferato che il master fosse andato perso nell’incendio che a inizio estate ha distrutto gli storici Easley-McCain Studios di M e m p h i s - e c c o f i n a l m e n t e Ta n g l e w o o d N u m b e r s , u n a s o r t a di nuovo inizio per il progetto di DCB, soprattutto alla luce dell’alone di ineluttabile “morte annunciata” che avvolgeva il precedente Bright Flight. E se ovviamente non possiamo che rallegrarci del fatto che (ipse dixit) “i Silver Jews esisteranno finché almeno due di noi continueranno a camminare su questa terra”, è subito evidente che ci troviamo di fronte a un gruppo sostanzialmente diverso da quello che conoscevamo, e ciò non dipende soltanto dai mus i c i s t i c o i n v o l t i . L’ i n i z i a l e P u n k s I n t h e B e e r l i g h t m e t t e s u b i t o le carte in tavola: David Berman ha scoperto il gusto di suonare ad alto volume, dedicandosi a una scrittura prettamente rock: echi di Paisley Underground, aperture seventies, chitarre capricciose e ruvide, scrittura agile come non mai; dello stesso tenore le successive Sometimes a Pony Gets Depressed (con un Malkmus mai tanto velvettiano) e K-Hole. Gli arrangiamenti rimangono chiaramente votati al country (vedi il banjo o gli 24 sentireascoltare efficaci inserti di violino di Paz Lechantin), così come lo stile lirico del Nostro, sempre pungente e surreale (“Where does an animal sleep when the round is wet?”); ma in generale sono i toni ad inasprirsi e ad assumere diverse sfumature; perfino la gamma vocale di David risulta più varia, grazie anche all’efficace controcanto della moglie in più occasioni. Alla lunga il disco soffre un po’ degli ospiti illustri, ma non potrebbe essere altrimenti: come in precedenza, Nastanovich, Malkmus e un redivivo Steve West ai tamburi tingono di Pavem e n t e p i s o d i c o m e H o w C a n I L o v e Yo u I f Yo u W o n ’ t L i e D o w n ( a m a r c o r d d i S t a r l i t e Wa l k e r ) , T h e P o o r, T h e F a i r & T h e G o o d e Farmer ’s Hotel (entrambe infiorettate da un Malkmus in stato di grazia); dal canto loro Sleeping Is The Only Love e I’m Gett i n g B a c k I n t o G e t t i n g B a c k I n t o Yo u ( c o n u n o s q u i s i t o c a m e o d i B o b b y B a r e J r. ) s o n o b a l l a t e c h e c i r e s t i t u i s c o n o i l B e r m a n di un tempo, anche se la conclusiva There Is A Place mette definitivamente in chiaro che il passato è solo un ricordo. Forse resta un po’ di rimpianto da parte nostra, ma, come ci ha detto l o s t e s s o D C B : “ Vo g l i o s o l o c h e c i s i a u n f u t u r o . N o n v o g l i o c h e questa vita finisca”. E a noi tutto sommato va benissimo così. (6.6/10) sentireascoltare 25 monografia Calla Dalla canzone alla sperimentazione, andata e ritorno di Lorenzo Filipaz Anima darkwave in un corpo slowcore. Il percorso di una band che dopo aver viaggiato per grandi praterie sonore ritorna al songwriting, fra frontiera e mura urbane… I Calla sono la fusione di due nuclei compiutasi nello spazio che intercorre fra una dimensione domestica, volta al paes a g g i o r u r a l e ( Te x a s ) , e q u e l la urbana e cosmopolita per a n t o n o m a s i a d i N e w Yo r k . S u queste coordinate psicogeografiche si sviluppa l’identità sonora del gruppo. In principio, a.d. 1992, ci sono i Fallen Vlods: duo elettro-acustico indirizzato ver- 26 sentireascoltare so la sperimentazione sotto la guida di Sean A. Donovan, subito titolari di una label – la EachHundreds – dedita ai suoni di frontiera. Accanto a loro sorge poco dopo (’93) The F a c t o r y P r e s s , d i A u r e l i o Va l le e Peter Gannon, sbilanciati invece verso un rock ad alto contenuto “sabbioso” (il loro unico album The Smoky Ends Of A Burnt Out Day - uscito postumo nel ’98 per la ND vedeva Kid Congo Powers e M a t t Ve r t a - R a y a l l a p r o d u z i o ne, ndr), minimo comun denominatore delle due esperienze il percussionista, batterista, nonché electronic programmer Wa y n e B . M a g r u d e r. Entrambi i progetti ebbero orig i n e i n Te x a s : i F a c t o r y P r e s s a Denton, quasi contemporaneamente ai Bedhead (di Dallas, poche miglia più a sud, ndr), e i Fallen Vlods ad Austin, in una scena che di lì a a poco vide sorgere gruppi come A m e r i c a n A n a l o g S e t , A n d Yo u Will Know Us By The Trail Of Dead e poi Explosions In T h e S k y. M a a m b e d u e i g r u p p i mossero ben presto verso New Yo r k , d o v e s i d i s s o l s e r o g r o s somodo nel ’96. Nella Grande Mela i nostri protagonisti trascorsero un lasso di tempo seguitando per le loro rispett i v e s t r a d e ; c o s ì m e n t r e Va l l e transitò per gruppi garage e r o c k a b i l l y, D o n o v a n p r o s e g u ì la sua formazione classica organizzando le Simultaneity Series per trenta musicisti, collaborando col S.E.M. En- Sul finire del ’97 decisero in fine di riunire le forze (Gannon fiancheggiava il gruppo senza prendervi parte a pieno titolo) spinti dalle motivazion i p i ù d i s p a r a t e : m e n t r e Va l le (chitarra, voce) aspirava a fondere “un suono vintage con influenze moderne” rientrando nell’alveo di un songrwriting “altro” che guardava a To m W a i t s c o m e a i J e s u s A n d Mary Chain passando per Lee Hazelwood, Donovan (basso) si interessava alla “manipolazione del timbro attraverso lo spazio” incarnando l’anima più trico” guidato dal basso di Donovan e dai sample industriali d i M a g r u d e r. I l d i s c o - r e g i strato nel ’98 - uscì nel ’99, giusto in tempo per rientrare nel novero dei dischi più suggestivi e fascinosi degli anni ’90, forte della totale libertà concessagli dalla belga Sub Rosa, l’etichetta che forse più di ogni altra si è dimostrata in sintonia con l’anima dei tre. semble di Petr Kortik e diven- sperimentale tando animatore degli eventi organizzati al Guggenheim, al Lincoln Center e alla Carnegie Hall (per le sue più che eccellenti partecipazioni rimandiam o a l s i t o d e l l a Yo u n g G o d ) . Magruder invece divenne rinomato sessionman on-stage p e r W i n d s o r F o r t h e D e r b y, Robert Hampson (Loop, Main) e Bowery Electric con i quali registrò il loro secondo album B e a t ( K r a n k y, 1 9 9 6 ) . gruppo. Magruder invece (batteria), ambendo ad “integrare elettronica, triggers e samples in un formato rock” si poneva come ideale medium fra i due compagni, avvicinando in parte il gruppo al post-rock e alla glitch. Il loro self-titled debut si presenta come la risultante sorprendentemente esatta di queste tre linee: frammenti soffocati di ballata drop-out si perdono in un suono “volume- sertica con quella cosmica, non potè non scatenare l’infa- all’interno del Quel suono fatto di lontani echi industriali proiettati in una dimensione dilatata, fusione della suggestione de- tuazione di uno come Michael Gira che mise immediatamente i Calla sotto contratto per l a s u a Yo u n g G o d . M a q u a l cosa nel frattempo era cambiato, la dimensione live con la quale si ritrovarono a confronto dopo il debutto alterò il perfetto equilibrio del disco: erano pur sempre un gruppo rock - per quanto di frontiera - e il rock dal vivo necessi- sentireascoltare 27 ta di un frontman, ruolo che quasi immancabilmente spetta al vocalist. Gira, intuendo le potenzialità compositive di Va l l e , s p i n s e n e l l a s u a d i r e zione completando l’opera. C o s ì i n S c a v e n g e r s ( Yo u n g God, 2001) le chitarre finirono in primo piano e inevitabilmente riemersero i retaggi della scena texana, Bedhead in testa, anche se decisamente superati grazie al carico di charme cosmico-desertico che i Calla si portavano appresso e alla loro totale estraneità dalle pastoie emo. La cesura con l’esperienza precedente non era infatti ancora così netta e l’apporto di Donovan e Magruder si rese ancora determinante a conferire al disco quell’immaginifico allure dei grandi spazi nonché gli accenti sperimentali collusi – quantomeno stilisticamente - con l’elettronica downtempo. A riprova della vitalità di questa duplice attitudine i Calla offrirono i loro repertorio in pasto ai remix di amici e non in Custom (Quatermass, 2001), dall’altro lato, spinti dalla critica - specialmente europea (in quanto è a questa che la produzione li spingeva a rivolgersi) - che li voleva eredi di Badalamenti, Morricone e delle grande colonne sonore da “panoramica”, iniziarono a prestare i loro brani ai commenti sonori di cortometraggi, incamminandosi su una strada che li porterà a far parte della soundtrack The Manchurian Candidate di Jonathan Demme (2004) e a partecipare attivamente alla colonna sonora del film Satellite (2004). Rinfocolarono intanto i progetti collettivi, i Fallen Vlods si ripresentarono come Crumbles Recovery (EachHundreds, 2000), Wayne Magruder avviò il progetto personale tenEcke e il “fiancheggiatore” Gannon fondò i Murcov con Daphne Gere (sua futura moglie). I particolari interessi sperimentali dei vari membri 28 sentireascoltare si dirottarono quindi su queste valvole di sfogo lasciand o a Va l l e i l c a m p o l i b e r o . N e c o n s e g u ì u n d i s c o , Te l e v i s e , uscito per i tipi della Quatermass nel 2003 (etichetta diversa ad ogni disco, a testimonianza di un continuo desiderio di cambiar pelle) che presenta un mood nuovamente rivoluzionato. Sulla falsariga di Fear Of Fireflies, ballata che lasciava intravedere un grande songwriting, Va l l e s c r i s s e u n a m a n c i a t a d i canzoni decisamente più standardizzate rispetto alla precedente produzione, con un suono meno elaborato ma dotate di una comunicativa indubbia - S t r a n g l e r e Te l e v i s e d s u t u t te - figlia più della darkwave urbana che dello slowcore rurale. Inevitabilmente il loro pubblico s’ingrossò guadagnando al gruppo un successo inedito ma fruttando anche un equivoco: la loro nuova lettera pervasa dall’affascinant e v o c e d i Va l l e , s o s p e s a f r a torpore erotico e disperazione autocompiaciuta, unita alla frequentazione della nascente next big thing della Grande Mela, gli Interpol, avvicinò pericolosamente i Calla ad un pubblico estraneo a quello abituale, molto più attento a l l ’ h y p e ( t r a s f o r m a n d o Va l l e quasi in un idolo per ragazze) e quindi molto impaziente, poco propenso alla lente seduzioni in punta di voce. Ne derivarono gig confusionarie, laddove la loro musica (anche in questa nuova veste) necessitava di silenzio e attenzione, come testimonia l’EP acustico uscito in tiratura limitata nello stesso anno. Forse anche per adattarsi a questo nuovo pubblico Gannon entrò nel gruppo in pianta stabile a partire dal 2 0 0 4 e Va l l e i n i z i ò a s c r i v e r e pezzi sempre più wave e semp r e m e n o s l o w, f i n o a l l ’ a b b a n dono di Donovan quest’anno che ha deciso di proseguire nello sviluppo dei suoi interessi in ambito sperimentale al di fuori della band. Con il presente Collisions uscito per la prestigiosa Beggar ’s Banquet e recensito su S A 11 - e c o n l a n u o v a f o r m a z i o n e Va l l e - M a g r u d e r - G a n n o n , ritornano in pratica gli originari Factory Press, completando idealmente un ciclo che li riconsegna nuovamente alla canzone dopo averli trasportati per grandi praterie sonore… Self-Titled (Sub Rosa, 1999) Il debutto dei Calla è una pietra scura, incrostata di polvere, sabbia e detriti da lavorazione industriale. Suoni dolcemente introversi, sperduti in labirinti di triggers al ritmo martellante di percussioni autarchiche programmate, fra i quali a volte sbuca una voce larvale a intonare sommesse giaculatorie private. Disco per le ore piccole, nelle dichiarazioni degli stessi musicisti, giocato su quella tenue luce che non si spegne mai neanche a notte fonda, che impasta residui di subconscio con pezzetti di realtà cruda e livida. L’ e n g i n e e r i n g è a ff a r e d i S e a n D o n o v a n , a l l i e v o i d e a l e d i Stockhausen e Feldman, con il supporto sporadico di Magruder ed – esternamente – di Peter Mavrogeorgis. Il suono è una questione interna al gruppo quindi, un suono che va ben oltre una semplicistica bassa fedeltà, soffermandosi aleatoriamente sull’imperfezione a dargli volume e anima, forte di una consolidata esperienza avanguardistica che lambisce appena i moduli del rock (principalmente nel velluto darkwave della song più tradizionale del lotto, Trinidad, e nel chiaro omaggio a Waits, Custom Car Crash), includendo altresì accenti mai banali da soundtrack non solo occidentale (Juneci suggerisce il nome d i Te i j i I t o ) . U n g r a n l a v o r o d i s p e r i m e n t a z i o n e s u l l e m a s s e sonore, quasi studi da Dolby Surround, nell’accostare echi incredibilmente lontani (di basso) a rumori incredibilmente vicini (i triggers) per delineare grandi spazialità attraverso il suono. Un Midwest dell’anima fatto di non-luoghi notturni (Elsewhere) dove ogni tanto si vede spuntare l’aurora (Only Drowning Men). (8.0/10) Scavengers (Young God, 2001) La dimensione concertistica è sempre stata conflittuale per i Calla. Il loro primo repertorio fatto di sfumature di suono e di crepuscoli di canzoni, perfettamente a suo agio nel catalogo “di frontiera” Sub Rosa, trovava non poca difficoltà nella mess a i n s c e n a d a l v i v o c o n s t r u m e n t a z i o n e t r a d i z i o n a l e . L’ a s s e t t o è cambiato di conseguenza, concretizzandosi nel ritorno alle chitarre e a batteria e basso non programmati, con il patrocinio di Mr Gira in cabina di produzione. Mutamento che si dispiega in tutta la sua portata fin dalla prima canzone: Fear Of Fireflies (un instant-classic del loro repertorio live) colpisce immediatamente nel mostrarsi come l’inattesa trasposizione della loro peculiare ricerca sonora nelle strutture tradizionali della ballata, così come Tijerina (forse il loro apice di carriera) traspone nella scienza del riff la loro sperimentazione “spaziale” giocata sul contrasto lontano/vicino. La prima parte del disco fino a The Swarm punta direttamente e deliberatamente al cuore dell’ascoltatore con il canto stras c i c a t o , m a o r a m o l t o p i ù c h i a r o , d i A u r e l i o Va l l e e c o l s u o particolare modo di intrecciarsi alle chitarre e alla “polvere di suono”. Molti ne hanno parlato come di rockabilly dilatato e screpolato (sicuramente i Gun Club e i Leaving Trains più rilassati non saranno del tutto alieni ai Nostri) ma la voce e le par o l e d i Va l l e , p i ù c h e r i f l e t t e r e l ’ e p i c a d e l W e s t , s i r i a l l a c c i a n o più volentieri alla desolazione post-paisley di Kendra Smith, Mazzy Star e affiliati (fino a Codeine, Galaxie 500 e i conterranei Bedhead soprattutto), e nondimeno all’estetica malinconica e torbida – sottilmente vampiresca – dell’UK post-new wave: dai fratelli Reid dei Jesus And Mary Chain, a Neil Hailstead e M y B l o o d y Va l e n t i n e . M a n t e n e n d o s e m p r e t o n a l i t à f i o c h e , a l l e sentireascoltare 29 volte vigorose ma mai violente, delicate ma dal retrogusto ferino, come mani sul corpo di un amante perduto e immaginario. Purtroppo l’ultima parte dell’album scade nella prolissità e in episodi dozzinali, facendo perdere qualche punto al disco altrimenti all’altezza dell’esordio – per quanto molto differente. In questo senso meglio l’edizione americana, con la breve A Fondness For Crawling e la bella cover di Promenade degli U2, rispetto a quella europea con la buona ma prescindibile cover di Dear Mary della Steve Miller Band e con gli insostenibili dodici minuti di Subterrain. (7.8/10) alla prima versione e (7.5/10) alla seconda. Intermezzo #1: Remixes Poco dopo l’uscita di Scavengers, la Quatermass licenzia un album di remix intitolato Custom: i primi pezzi non sono proprio esaltanti con i loro lunghi prolegomeni elettronici (totalmente fuori luogo) nei quali indulgono persino gli stessi Calla nel loro auto-remix iniziale; tantomeno pregevole si direbbe l’int e r v e n t o d e i Ta r w a t e r s u u n m a t e r i a l e d e l i c a t o c o m e T i j e r i n a . In generale il repertorio dei Calla viene qui totalmente defraudato di tutta la suggestione sonora di cui è intriso, trasformato in un mucchio di scheletri impersonali e freddi. Gli episodi migliori sono quelli dove il remixer accosta i brani minori a ritmi inconsueti (Metrotech, Datach’i) o dove il suono rimane grossomodo inalterato per quanto crashato (Couch nel remix n°2 di Fear Of Fireflies). In conclusione Custom si dimostra un prodotto ovviabile addirittura per i completisti, alla luce anche dell’estraneità dei Calla dal risultato finale (non a caso il materiale più interessante sono le due tracce live che concludono la versione cd). I Calla a loro volta si dilettano nell’arte del remix con risultati forse discutibili, ma testimoniando ancora una volta il loro interesse negli aspetti più tecnici della produzione del suono. A subire il loro trattamento sono i gruppi più affini per spirito: Windsor For The Derby e PSI Performer nel 2001, e Silva e Couch (ai quali restituiscono il “favore”)nel 2002. Da segnalare nel 2001 anche l’inizio della pubblicazione di cd-r promozionali con brevi registrazioni live: Performance NYTX (EacherHundreds; 2001) rivanga la doppia anima “geografica” del gruppo, con l ’ a c c o s t a m e n t o d i d u e p e r f o r m a n c e , u n a a N e w Yo r k e l ’ a l t r a i n Te x a s . Cominciano anche le risposte concrete alla loro tanto decantata attitutine cinematografica. Alcuni loro brani vengono utilizzati per il commento sonoro di due corti: Freunde The Whiz K i d s d i J a n K r ü g e r ( 2 0 0 1 ) e B u l l e t I n T h e B r a i n d i D a v i d Vo n Acken (2002). 30 sentireascoltare Calla / Walkmen Split CD (Troubleman; novembre 2002) Dopo Scavengers qualcosa stava cambiando nella politica dei Calla, lo si evinceva principalmente dalle frequentazioni: se prima si facevano accompagnare da artisti come Flux Information Science - dal chiaro background orientato verso “altri-suoni” – ora si presentavano a braccetto con gente come Interpol e Walkmen, intraprendendo una strada che li porterà a comparire n e l l a c o m p i l a t i o n Ye s N e w Yo r k ( V i c e ; G i u g n o 2 0 0 3 ) a c c a n t o a tipi come Strokes, Radio 4, Rapture, LCD Soundsystem… Non proprio il loro contesto più congeniale, quantomeno all’epoca dell’uscita di questo split. I Walkmen sono infatti ben lontani dal competere con i Calla, con la loro formula piacevole ma piuttosto mediocre, tutta orientata verso gli U2 appena appena restaurati. Il nostro gruppo invece propone qui in anteprima Don’t Hold Yo u r B r e a t h , u n o d e i f u t u r i c l a s s i c i d e l l o r o n u o v o a l b u m d a l caratteristico andamento a respiro affannoso, desolante ma avv o l g e n t e . Ve r o m o t i v o d ’ i n t e r e s s e p e r q u e s t o c d è l ’ a l t r a t r a c c i a , M o t h e r S k y, u n p e z z o d e i C a n i l q u a l e – o l t r e a d i l l u s t r a re meglio, come ogni cover per loro esplicita ammissione, il mosaico di influenze dei Calla – lancia un ulteriore rimando all’amico e mentore Robert Hampson che con i suoi Loop già ne aveva proposto una versione quasi quindici anni prima. Ma i l p r e s e n t e b r a n o , p e r q u a n t o Va l l e r i e s c a a c a m u f f a r s i i n m o d o convincente da Damo Suzuki, viene scippato ai legittimi proprietari per diventare una delle distintive tinte della tavolozza Calla. Per la precisione, un’evoluzione del loro tipico andamento minaccioso, dapprima mutuato dal piglio a la Waits in b r a n i c o m e C u s t o m C a r C r a s h e S l u m C r e e p e r. ( 6 . 7 / 1 0 ) Televise (Quartermass/Arena Rock, 2003) E’ probabile - e, ci tengo a rimarcarlo, dico probabile - che la qualità dei dischi dei Calla sia decresciuta in valore a partire dall’omonimo esordio. Il loro secondo cd - Scavengers - subiva forse troppo le intrusioni in sede di regia del grande “guru” Michael Gira; esso segnava però una svolta nelle strategie sonore del gruppo definendosi come iniziale tappa d’avvicinamento ai metodi della forma canzone più involuta e concettuale (sebbene non poi così distante dal solipsismo creativo degli esordi). Te l e v i s e c o n d u c e f i n a l m e n t e t u t t i i f a n s d e l g r u p p o t e x a n o a d una visione compiutamente “pop” del complesso mondo poetico dei Calla, solitaria e traumatica terra di nessuno interiore. L a v o c e d i A u r e l i o Va l l e m e d i a , i n S t r a n g l e r ( l ’ o p e n i n g t r a c k ) , il Robert Smith dei medi ‘80 - gli album psichedelici dei Cure o se preferite, Wish - con certe appena più tarde malinconie pop d a s h o e g a z e r s ( v e d i p r i m i R i d e ) . L’ i n f l u e n z a d e i J o y D i v i s i o n e di quella quiet disperation anglosassone così profondamente loro (nella ultima svolta “pop”, soprattutto) sembra essere ancora determinante per i nostri. Ed è ciò che accade in Pete the K i l l e r, p a g i n a p r e g n a d ’ u n a ff l a t o l i r i c o d e p r e s s o e m e l a n c o l i co dove persino certe dilatazioni psicotrope alla Spiritualized trovano posto. Altrove aleggiano gli umori più acidi delle lisergie anni ‘60: Customized - complice l’uso dell’echoplex - abusa d’effetti stranianti (ad imitazione dei nastri “rovesciati” di tanta psichedelia britannica sixties) e li integra perfettamente in una sorta di talking song per l’era del post trip hop. Stupenda è anche s e n t i r e a s c o l t a r e 31 Quick as it comes, vicina - nell’incipit maggiormente - alle svenevolezze della Hope Sandoval solista. E forse, almeno in questo caso, non sarebbe scorretto parlare di dream pop iperdepresso. A u r e l i o Va l l e , Wa y n e B . M a g r u d e r e S e a n D o n o v a n h a n n o s a p u to far loro l’ “espressionismo” dark dei Joy Division costruendo, su tali presupposti armonici, una forma sonora tanto austera quanto comunicativa (in tal senso, fra i suoi capolavori, il disco annovera la coda strumentale di Carrera). C h i u d o n o i l l a v o r o d u e p e r l e d e l c a l i b r o d i Te l e v i s e d e S u r f a c e Scratch: esercizio d’incalzante e mobilissimo hard rock evoluto ed emotivo la prima (con inflessioni, anche qui, psichedeliche); dolce e tremula ballata sospesa fra luce ed ombra la seconda. Non estranea ad eventi di pathos intenso e rattenuto alla Big S t a r, l ’ a r t e d e i C a l l a c o n s i s t e s e m p r e p i ù n e l m e d i a r e g l i s t i l i pop depressivi degli ‘80 dark con quelli sixties psichedelici. Il gruppo tiene perciò pienamente fede a ciò che promise quando ancora si chiamava Factory Press. (7.0/10) (Massimo Padalino) Intermezzo #2: Singles, demos & live recordings P o c o p r i m a d e l l ’ u s c i t a d i Te l e v i s e d v i e n e p u b b l i c a t o l ’ I n s o u n d To u r S u p p o r t N o . 2 2 ( 2 0 0 2 ) , r a c c o l t a d i l i v e p e r f o r m a n c e s n o n particolarmente eccezionali, inframezzate da “cartoline audio” di vari luoghi che la band ha toccato durante la tourneé europea del 2000 (tra i quali pure una da Cagliari e una da Sassari - n o n s a p p i a m o m o l t o d e l l e e v e n t u a l i o r i g i n i i t a l i a n e d i Va l l e ma curiosamente Calla in sardo e spagnolo hanno lo stesso significato: stare zitti. ndr), niente più che brevi istantanee di baldorie, scherzi, scazzi. Uno dei motivi della nostra menz i o n e s o n o l e c o v e r, L o n g L o n g L o n g d i G e o r g e H a r r i s o n e H a r v e s t M o o n d i N e i l Yo u n g : l a p r i m a - n e l l a v e s t e i n c u i è q u i presentata - fa sobbalzare intravedendovi i Calla trenta anni prima della loro formazione, la seconda è rimarchevole perché illustra una ahinoi abituale situazione concertistica del gruppo, incorniciata com’è dal cicaleccio indifferente del pubblico; colpisce però il modo in cui i Calla si trovino a proprio agio in questa atmosfera, quasi il brusìo fosse un sound effect per arricchire il pezzo di alienazione. Maggior motivo d’interesse sono comunque le quattro tracce demo che aprono il disco – A s t r a l , M o n u m e n t , D o n ’ t H o l d Yo u r B r e a t h , P e t e T h e K i l l e r – non solo come anteprima dell’album. Con la registrazione leggermente imperfetta, la voce non in autotune, i riverberi dissonanti, la strutturazione delle canzoni più studiata (con la dialettica basso-chitarra decisamente più ficcante) e le tipiche bave di suono del gruppo - senza quindi la robusta produzione sottilmente mainstream-oriented di Chris Zane – le canzoni si rivelano qui essere decisamente all’altezza se non superiori al repertorio di Scavengers, peccato. La ricerca di comunicativa – specie in Europa - da parte del gruppo si evidenzia anche con l’inedito ricorso ai singoli e ai videoclip (pubblicati solo in Inghilterra), che escono al seguito d e l l e c a n z o n i p i ù r a d i o - f r i e n d l y d e l l o t t o : S t r a n g l e r e Te l e v i sed. Lo Strangler EP emerge particolarmente perché sul “lato B” presenta due straordinari live-medley registrati per la BBC, S l u m C r e e p e r / L o v e O f I v a h e Te l e v i s e d / M o t h e r S k y , s p e c i e in quest’ultimo caso notevole per il vigore dell’interpretazione, p e r i l s e t t a g g i o e l ’ i n t e r p l a y. R a g g u a r d e v o l e a n c h e u n a d e l l e b - s i d e s d e l Te l e v i s e d E P : T r i n i d a d c o n i n c o d a l a s o r p r e n d e n t e - 32 sentireascoltare mente squillante cover di I Shall Be Released di Dylan. Continua la pubblicazione di cd-r live promozionali, come i due Miscellaneous EP usciti in tiratura limitata di 200 copie numerate (2003; il secondo registrato in radio a Milano e dal vivo a Biella). Buoni tutti e due - certamente superiori alle registrazioni per il disco Insound – ma chiaramente destinati ai collezionisti. Entrambi sono peraltro segnati dal finale remix di Mayzelle da parte di Mr Hampson / Main – ancora lui! – una distesa ambient popolata da microbi di beats e sinewaves nel complesso moderatamente pallosa. Altra storia per l’Acoustic EP uscito in 250 copie (sempre nel 2 0 0 3 ) c h e p r e s e n t a Va l l e s o l i s t a i n t e n t o a t o r n i r e p r e z i o s e e suadenti alternate takes dei loro successi con in più splendenti c o v e r ( f o r s e l e m i g l i o r i a n o m e C a l l a ) d i W a i t s ( Ye s t e r d a y I s Here), Springsteen (State Trooper) ed Echo & The Bunnymen (Ocean Rain). Prosegue pure l’attività profilmica e dopo la partecipazione al corto Kairos di Shanti Thakur (2003) e dopo aver prestato Traff i c S o u n d a C i n d e r d r i f t d i A n d r e w W. F l o r e s ( 2 0 0 3 ) e A s t r a l a l remake di The Manchurian Candidate di Demme (2004), scrivono per la prima volta dei pezzi su commissione per Satellite di Jeff Winner (2004). Questo lavoro frutterà il cd-r Collisionworks (300 copie – esaurite) che oltre a presentare in anteprima il nuovo cavallo di battaglia It Dawned On Me – poi incluso in Collisions – sfodera quattro abbozzi strumentali piuttosto a n o n i m i , b e n l o n t a n i d a l l e s u g g e s t i o n i d i u n a Ta r a n t u l a , p i ù un “demolition remix” dell’imminente album. Insomma proprio quando le virtù cinematografiche della loro musica iniziano ad ottenere un riconoscimento professionale, le loro facoltà “descrittive” sembrano andare in pensione… Determinante, molto probabilmente, la progressiva perdita di interesse nel progetto di Donovan, il più impegnato nella definizione “spaziale” del suono che lascia il gruppo agli inizi del 2005. I Calla sono stati poi interpellati per il film Ben And Holly (Kurt H a a s , 2 0 0 4 ) m e n t r e A u r e l i o Va l l e h a s c r i t t o d e l l e l i b e r e i m provvisazioni per Egoshooter (Becker & Schwabe, 2004), film tedesco che vede anche la partecipazione della leggenda rock Nikki Sudden. Nell’autunno 2005 arrica Collisions ( v e d i r e c e n s i o n e s u S A 11 ) . s e n t i r e a s c o l t a r e 33 recensioni Mi and L’Au S/t (Young God Records / Goodfellas, 22 novembre 2005) Nel cuore di cemento di Brooklyn (NYC) Michael Gira e l a s u a Yo u n g G o d R e c o r d s h a n n o r i t a g l i a t o u n q u a d r a t o naturale che non sfugge alle stagioni, ma permane in una sorta di epoca inattuale che, pure, è calata completamente nel presente e nei suoi fermenti. Creatore di un paradosso temporale quasi senza precedenti, l’ex Swan gestisce questo parco giochi dell’alt.folk tirando fuori dalla terra, di volta in volta, germogli come Banhart, A k r o n / F a m i l y e M i a n d L’ A u p e r p o i v e d e r l i c r e s c e r e e maturare sotto i suoi occhi. Primaverile il primo, autunnali i secondi, il duo composto da Mira e Laurence (lui francese e lei finlandese) è stato invece capace di scrivere un disco dalla qualità decisamente invernale. Le canzoni dell’ album, Self-Titled, sono intarsiate nel ghiaccio e nella neve. Sono state scritte in un casolare nei boschi finlandesi, dove la coppia si è ritirata a vivere e comporre in solitudine, nutrendosi di frugalità e amore. Gli arrangiamenti rispecchiano a dovere il loro stile di vita e la poetica quasi esistenziale che ne deriva, congelati, come sono, nei fraseggi in punta di piedi di una chitarra, di alcuni archi, e, soprattutto, di due voci che intrecciano versi soffici sulle parole degli strumenti eloq u e n t i . N e l l a b a i t a n o r d i c a d i M i a n d L’ A u n o n è c o n c e s s o a l c u n o s p a z i o a l l ’ e c c e s s o , alle emozioni forti, ai colpi di testa: la tracklist scorre omogenea, sognante; i brani, tutti bellissimi, non soffrono di frammentarietà né di intensità alterna - piuttosto compongono insieme, uno dopo l’altro, in parata, un intarsio monocromatico (bianco) ed intenso. Mai come in questa sede è difficile privilegiare alcuni episodi sonori rispetto ad altri: sicuramente danze sottili come I’ve Been Watching, Nude oppure Boxer meritano una breve menzione, eppure anch’essi vanno catturati e goduti nella dimensione totale di un lavoro che, senza esagerare, suona suggestivo, evocativo e potente come poche altre uscite del 2005. Mira e Laurence, una di quelle piante che il freddo denuda per rendere quasi più maestose, hanno conquistato un angolo luminoso nel piccolo impero di Gira. Le etic h e t t e l a s c i a n o i l t e m p o c h e t r o v a n o : c h e s i t r a t t i d i p r e - w a r, d i w e i r d o d i f r e a k - f o l k non è importante; i giorni e le notti reinventati dal duo, come quelli di diamante della m u s a Va s h t i B u n y a n , r o m p o n o l e r e g o l e i n c l e m e n t i d e l t e m p o . ( 7 . 7 / 1 0 ) Marina Pierri sentireascoltare 34 3EEM – Essence of 3EEM (Smallvoices, 2005) A due anni dalla loro ufficiale nascita i torinesi 3EEM si presentano finalmente al pubblico. Un disco non certo di facile impatto, complesso, dispersivo a volte, ma interessante, non c’è che dire. Il verde pisello della sobria copertina poco dice sulla ricchezza di contenuti che la musica di questo trio dimostra già a un primo ascolto di possedere. Le differenti esperienze musicali dei singoli membri sono testimoni della promiscuità m e s s a i n g i o c o . Va l e r i o Z u c ca (aka Abstract Q) e Fabrizio Buzzoni, rispettivamente agli electronics e alla chitarra crescono musicalmente negli anni ’80 con la band crossover Nasty Nurses, influenzata da F a i t h N o M o r e e N a k e d C i t y. Zucca passerà attraverso le esperienze più diverse, dalla psichedelia dei Disoriente, al duo jungle-ambient Abstract Quadrant, attivo anche in ambito cinematografico. Ai due si aggiunge la chitarra elettrica di Danilo Corgnati, passato per varie punk band cittadine per approdare al grunge dei Mayflowers and Mantras, con gruppi di riferimento come Nirvana e Screaming Trees. Il risultato di questa commistione, Essence Of 3EEM, sta però al rock come gli Scorn di Mick Harris stanno ai Napalm Death (cioè, molto, ma molto poco). Sonorità elettroniche molto tendenti all’ambient (a volte ricordano gli Orbital) si mescolano alla chitarra e al sax con un approccio che richiama un modo di produrre e un sound tipicamente laswelliani (Reverse). Ma in questo disco non è difficile riconoscere anche echi di cosmiche musik che aleggiano tra i bran i : n o n s o l o Ta n g e r i n e D r e a m , ma anche spunti di kraut rock. Come nel caso della conclusiva 24 Apes, ventiquattro minuti di deliri cosmico-elet- tronici, schizzetti psichedelici e ritmiche cangianti, che passano dall’ambient-dub al trip hop. Su questi paesaggi sonori i fraseggi di sax e gli arpeggi di chitarra disegnano figure che si mimetizzano nei suoni elettronici creando impasti timbrici affascinanti. Nella grandiosa costruzione trovano spazio anche sprazzi di pseudo rythm’n’blues (In The Beginning It Was An Accordion) e di uno strano free jazz mescolato alla techno (Kinfu). Un’altra bella sorpresa nostrana in questo 2005 piacevolmente “italiano”. (7.5/10) Daniele Follero 65 Daysofstatic - One Time For All Time (Monotreme/ Ghost, 2005) Il nuovo album dei 65 Daysofstatic conferma ancora una volta la bontà di un progetto in grado di ridisegnare le coordinate della musica moderna. L’ i n i z i a l e D r o v e T h r o u g h G h o s t s To G e t H e r e è u n m a n i f e sto programmatico d’intenti: atmosfera in crescendo, tastiere che cantano di dolcezza e malinconia e ritmi che sembrano sempre sul punto di esplodere. Ma è solo un antipasto della furia che verrà. Il pezzo successivo, se possibile, inasprisce ancora di più tutti gli elementi presenti nella traccia d’apertura, cercando di segnare una sottile linea di demarcazione che separa il passato recente dal qui e ora del nuovo lavoro. La già vigorosa batteria di Await Rescue, infatti, viene dopata ulteriormente dai violentissimi innesti drum’n’bass, potenziando così la riuscita di un brano che aveva comunque dalla sua il privilegio delle note più emotive mai sentite in queste latitudini sonore. W e l c o m e To T h e T i m e s è i n vece il prototipo del post-rock più tradizionale, grazie a un arrangiamento maggiormente “suonato” rispetto agli al- tri episodi, ma non per questo meno coinvolgente. I 65daysofstatic agiscono in un territorio che li vede signori e padroni incontrastati, come d’altronde aveva notat o p r o p r i o J o h n P e e l . L’ u n i c o – piccolo – appunto che si può muovere alla band è di non aver innovato abbastanza il proprio suono, limitandosi ad estremizzare le formule che hanno caratterizzato il precedente The Fall Of Math. Ma la materia trattata è comunque ottima e abbondante, e basterebbero i cinque minuti dell’aggressiva 65 Doesn’t U n d e r s t a n d Yo u p e r e s a l t a r e ed esaltarsi con una band incredibile, cui manca solo la parola per riuscire finalmente a conquistare il mondo. E non è detto che un giorno non sarà così. (7.5/10) Manfredi Lamartina AA.VV. - This Bird Has Flown: A 40th Anniversary Tribute To The Beatles’ Rubber Soul (Razor & Tie, 25 ottobre 2005) Il 3 Dicembre 1965 usciva Rubber Soul, il famoso “album della svolta” dei Beatles. Nel quarantesimo anniversario la Razor & Tie pubblica uno speciale tributo in cui protagonisti dell’indie (o quasi) interpretano ossequiosamente l’intera scaletta del disco. Viene subito da pensare: l’ennesimo omaggio ai Fab Four di cui forse si poteva anche fare a meno? Dubbio più che legittimo, a cui si somma la doverosa cautela - da parte di chi ascolta e talvolta anche da parte di chi suona - con cui ci si appresta a questo tipo di operazioni. Va quindi preventivamente detto che This Bird Has Flown nulla aggiunge all’originale né a quanto si sapesse già dei soggetti implicati, quindi non va oltre la semplice - e tiepida - idea del tributo; chiarito questo punto, il dischetto è l’occasione per misurare sia il grado di “beatlesianità” sentireascoltare 35 delle personalità coinvolte nel progetto, sia le doti mimetiche dei più coraggiosi del lotto. Alla categoria fan ossequiosi appartengono The D o n n a s , R h e t t M i l l e r e Yo n d e r Mountain String Band, che rileggono i brani assegnati con un piglio tra il didascalico e il filologico che tuttavia regge bene l’ascolto; tra i più spericolati citiamo il buon Sufjan Stevens, che offre di gran lunga la prova migliore trasfigurando a modo suo (cioè tingendola di folk pop psichedelico / garage) l’originariamente innocua What Goes On, e gli immarcescibili Cowboy Junkies, che rendono Run For Yo u r L i f e b l u e s , s p o r c a e c a t tiva come l’avrebbe voluta Lou Reed. Deludono un po’ i Fiery Furnaces, dalla cui temeraria Norwegian Wood in salsa California ‘67 ci si aspettava qualcosa di più, e ancor di più i L o w, c o n u n a N o w h e r e M a n – ahinoi – piuttosto scialba; palma della discordia alla Mic h e l l e r e g g a e d i B e n H a r p e r, seguita a ruota dalla If I Needed Someone lounge di Nellie M c K a y, c h e c i s a r e m m o v o l e n tieri risparmiati. (5.0/10) tura incisiva e appassionata che pure ci si aspetterebbe. Se le influenze più palesi a monte sono ristrette al circolo Molina-Oldham ed alle loro innumerevoli trasformazioni onomastico/sonore, a valle vengono in mente nomi valenti e più “recenti” come gli Zephyrs, cui si accostano facilmente per delicatezza e dolcezza della sezione vocale e ritmica. Le pretese sono poche e questo va probabilmente a vantaggio della band, ma la pena espressa in toni volutamente low-key di pezzi come Blood And Marrow o Fathers And Sons non colpisce veramente il segno, scivolando, piuttosto, lieve e un tantino annacquata per i canali auditivi. E se in altre zone della tracklist sicuramente i pianoforti o la voce strascicata di Olof Gidlof fanno egregiamente la loro parte (molto belle For All The Marbles, Over The Trenches o Heart Tremor), è pur vero che al di là di una certa, innegabile, qualità di fondo, le sensazioni suscitate complessivamente dall’ascolto di This Is Where Our Hearts Collide sono tiepide. (6.0/10) Antonio Puglia Marina Pierri Amandine - This Is Where Our Hearts Collide (Fat Cat / Wide, 19 settembre 2005) L’ o t t i m a etichetta inglese Fat Cat - la stessa dell’ultim a Va s h t i B u n y a n e d e g l i A n i mal Collective, per intenderci - propone da diversi anni uno dei migliori roster tendenzialmente alt.folk in circolazione e fa per questo da autentico marchio di garanzia. E’ comprensibile dunque che davanti alla sua ultima creatura, This Is Where Our Hearts Collide degli illustri sconosciuti svedesi Amandine, ci si metta all’ascolto con fiducia e impazienza. Le aspettative però vengono leggermente deluse. Il chamber pop/folk del debutto del quartetto, per quanto piacevole o gradevole, manca spesso e volentieri della scrit- 36 sentireascoltare Bachi da Pietra – Tornare nella terra (Wallace / Audioglobe, 2005) Musica strana quella dei Bachi da Pietra: parte al rallentatore e ti prende alle spalle senza nemmeno che tu te ne accorga. Violenta, benché contenuta nei volumi, capace di instillare un’inquietudine sfocata e di imporre all’ascoltatore un viaggio che parte dalla terra e scava nell’anima, nel fango dei ricordi, nelle profondità del cuore. Una musica che sceglie come idioma ufficiale un blues primordiale appena elettrificato e che ne estremizza il fluire rendendolo monocromatico, ossessivo, lento e inesorabile, simile a un sussurro sorpreso dal male di vivere. Titolari del progetto sono quel Bruno Dorella di cui ormai a fatica si seguono le vicissitudini artistiche tanto sono numerose – ex Wolfango, ora Ronin, Ovo, nonché primo cittadino dell’etichetta Bar La Muerte – e Giambeppe Succi, per dieci anni colonna portante dei Madrigali Magri. Una collaborazione che sa di artigianale e mirato, almeno nei suoni, dal momento che il motore del gruppo risiede esclusivamente nella batteria del primo e nella chitarra del secondo. Del resto non serve altro, dal momento che l’obiettivo è quello di veicolare una musica umorale e diretta, avvolgente ma minimale, strutturata su un cantato appena accennato e una chitarra che dal blues riprende attitudine più che grammatica: sei corde che rilasciano sprazzi di inquietudine – Solare – o che magari cedono ad un battere di rullante anoressico - Aprile D.C. – e ad atmosfere ipnotiche (Primavera del sangue). Tra riff quasi improvvisati e a piatti che vibrano nel vuoto si inerpicano i testi di Succi, poesie angoscianti e carnali che raccontano di esistenze fallite, illusioni svanite, vita e morte, spaccati di un’etica della disperazione figlia di brumosi scenari autunnali e giornate senza sole. Tra i cattivi maestri del gruppo inevitabile citare l’ex Bad Seeds Hugo Race, profeta tutt’ora insuperato di certo blues ruvido ed oscuro, anche se ad alcune derive di impianto jazzistico dell’australiano, i Bachi da Pietra preferiscono secchezze formali reiterate e assenze strumentali. (6.7 / 10) Fabrizio Zampighi Blown Paper Bags - Arm Your Cameras (Suiteside / Goodfellas, 2005) Sette pezzi per 23 minuti, refrattari alle etichette: fin dal brano di apertura, Blown Manifesto (titolo programmatico), siamo spinti in un frullatore che miscela riff brevi e nervosi, sonorità analogiche (con abbondante uso di Moog e Korg), cori urlati, groove veloci, estetica lo-fi (per impacchettare il tutto). Genovesi, formatisi nel 2004, i Blown Paper Bags hanno alle spalle variegate esperienze e partecipazioni con gruppi della loro città; non solo: pur essendo alla prima pubblicazione - Arm Yo u r C a m e r a s è i l l o r o e s o r dio per la Suiteside -, vantano già alcune apparizioni sul palco con gruppi come El Guapo, Experimental Dental School, Mae Shi, JohnWayne Shot Me, Karate, Xiu Xiu. Political Dance (il brano più lungo) è caratterizzato da un suono tipicamente analogico usato per i riff che sono la carta d’identità del pezzo. E se Panda Gang porta in primo piano un coro ritmato, sostituito nel finale da un secco riff di chitarra, nel pezzo successivo (Spell Athlete!) siamo di nuovo all’ascolto di differenti, brevi spunti ritmici e melodici accostati per dare forma a una composizione che ipnotizza. European Secret Service e P a s s M y Ta p e ( t o D F A ) s e guono la linea del brano precedente, mentre una nuova sorpresa arriva dal pezzo che chiude il cd (Double Dragon On The Dancefloor), animato da uno spirito funky con cui si scontra una chitarra che fa rimbalzare poche note psichedeliche. Si prova una specie di spaesamento di fronte ai continui cambi di direzione e all’assenza di una struttura riconoscibile (difficile parlare di canzone), una sensazione riconducibile all’attitudine punk/hip-hop che i Blown Paper Bag mettono in campo nell’assemblare il materiale sonoro. Allo stesso tempo, la presenza di sonorità e suoni così diversi regala appigli e punti di riferimento a ogni possibile diverso fruitore (purché abbia la pazienza di aspettare che arrivi il suo turno). Il giudizio è positivo: sia i pezzi brevi, sia quelli più lunghi trasmettono le tanto attese “good vibrations”; sarà interessante ascoltare i Blown dal vivo e alla prova del secondo lavoro in studio. M e r i t a u n c e n n o l a c o v e r, c h e permette di comprendere a quali “cameras” faccia riferimento il titolo dell’album: la figura ritratta è un mix del Balilla che iniziò una rivolta lanciando un sasso contro l’armata austriaca (Genova, 1746) e del contestatore che scagliò il cavalletto della macchina fotografica contro Berlusconi verso la fine del 2004. Anche questo è un Blown Manifesto. (6.7/10) Andrea Erra Françoiz Breut - Une Saison Volée (Bella Union / Tot Ou Tard, 2005) U n e S a i s o n Vo l é e , u n a s t a gione rubata o potremmo dire, per esprimere meglio il senso di questo nuovo album di Françoiz Breut, una stagione “presa in prestito”. Certamente il fascino di queste 15 tracce è rappresentato da numerosi rimandi al passato, sia nelle melodie, sia negli strumenti utilizzati. Quando parlo di passato alludo soprattutto ad una sorta di velo creato dal tempo, una sovrapposizione di texture che dà spessore alle composizioni, rendendole morbide ma compatte, e ispirando un certo senso di accoglienza e sicurezza. Le stagioni da cui si attinge non sono solo identificabili con una lontananza temporale, ma anche territoriale, linguistica ed infine umorale. I sentimenti - talvolta melanconici, talvolta energici - percorrono l’album come se si trattasse di un pezzo di terra segnato da vari confini e soggetto ai cambiamenti del giorno e della notte, come un microcosmo dove ogni canzone porta con sé il senso ambiguo delle frontier e . U n e S a i s o n Vo l é e è i l t e r z o album della cantante francese, attiva già dalla metà degli anni Novanta, dopo esperienze professionali e private in continua evoluzione (l’esordio con Dominique A., Calexico, Kat Onoma). Françoiz si affida alla scrittura di molteplici autori e arrangiatori, che compongono per lei brani originali e rivisitazioni di classici, come la bellissima interpretazione, trascinata ed ipnotica, di La Premiere Bonheur Du Jour , resa all’epoca famosa d a F r a n ç o i s e H a r d y. L’ e s t r e m a v a r i e t à d i c o l l a boratori, molti dei quali non nuovi alla voce di Françoiz, ha portato ad una analoga diversità di suoni, di scritture e di lingue utilizzate. Sono infatti presenti nell’album brani in francese come in inglese, spagnolo e italiano, tutti accomunati da quel suo modo particolarissimo di cantare, che rende irrilevante qualsiasi diversità - per così dire - spazio temporale. Grazie al suo utilizzo della voce, quasi fosse uno strumento, anzi uno “strumento per parlare”, il senso delle frasi che canta ne guadagna, rimanendo comunque secondario al loro suono. Françoiz, oltre che cantante, è una eccellente disegnatrice con un taglio quasi infantile; al disegno si dedica quanto, se non forse più che alla musica, ed è per questo che le sue capacità evocative, sviluppate con l’attività di illustratrice, sono sempre molto evidenti nelle sue interpretazioni canore. Infatti, pur non essendo autrice dei brani che canta, Françoiz li interpreta proprio come se fosse farina del suo sacco, con la disinvoltura ed il coinvolgimento propri di chi parla di qualcosa di personale. Sembrerebbe che persino il tono della sua voce sia mutuato dall’esercizio di raccontare favole (illustrate da lei) sentireascoltare 37 recensioni Babyshambles Down In Albion (Rough Trade / Self, 2005) Maledetti londinesi! Quelli che se li metti davanti alla telecamera per la prima volta già ballano e cantano c o m e c o n s u m a t e s t a r. Q u e l l i c h e f a n n o d i s p e r a r e i p a r rucchieri che è quarant’anni che, come automi, eseguono lo stesso taglio. Quelli che anarchici oggi (e neopsichedelici domani) si vendono al primo discografico per un tozzo di pane dopodomani. Quelli che chiamano i sanitari al singolare. Quelli che, in definitiva, working class e ignoranti come capre, dal campetto dietro casa te la menano e te la suonano masticando corde e suonando bacon, triturando pelli e percuotendo polli. C’era un aspetto che rendeva i Libertines accattivanti e odiosi allo stesso tempo: la capacità di tradurre la lascivia del punk in storie di vita sconclusionate eppur abilmente giocate sul filo di una ubriacante e sonnolenta strada pop. Qualunquismi e ritornelli buttati là nel più ruffiano e trasandato dei modi, che convergevano verso uno stile che acciuffava per i capelli la sguattera dell’avanspettacolo per farla roteare in una confusione di sberle e carezze, di rattoppi di spilla e biasciar di caramella. P e t e D o h e r t y, p o s t - s c a r a m u c c e c o n B a r a t , p o s t - b a c i o g a y c o n E l t o n J o h n , p o s t - s e s s o e droga con Kate Moss, riparte proprio da queste coordinate tracciando la strada dei Babyshambles verso il raccordo chiamato Exile On Main Street e incarnando così, anche musicalmente, il personaggio mediatico che s’è costruito negli ultimi mesi. Da questi presupposti il menù viene da sé: fatto salvo un manipolo di brani maggiormente convenzionali strofa ritornello (8 Dead Boys su tutti), il resto sono canzoni abbozzate, bassi profili urbani (Back From The Dead), umori da post-sbronza, anthem senza eiaculazione (Fuck Forever), serenate Mersey Beat (What Katy Did Next), amati ‘50, fisarmoniche dylaniane (Loyalty Song) e (persino …ma non ci stupiamo per nulla) reggae chitarra/voce scritti in carcere (Pentonville). Con tutto ciò, tanto punk infilzato qua e la come un porcello allo spiedo e un inseguir canovacci mai scritti per chitarre, bassi e batterie. In cabina di regia Mick Jones lavora in background e miracoleggia in superficie, lasciando che il ragazzone incarni il legno betulla della marionetta, scambiando sorrisi con l’ottimo chitarrista Patrick Walden e tendendo sempre i brandelli del giornale ben appiccicati. Il risultato? È elementare …piacevolmente qui e ora punk. (6.8/10) Edoardo Bridda sentireascoltare 38 al suo unico rende le sue figlio. Questo interpretazioni intime e suadenti. Une Saison Vo l é e è u n a l b u m c h e , p u r f a cendo affidamento a strategie largamente collaudate nella musica che va dagli anni ’50 agli anni ’70, si mette in gioco nel tentativo di trascinare nel presente uno spirito assopito, nel rischio di mettere faccia a faccia diversi modi di pensare la musica e, infine, nell’osare l’azzeramento di quel tabù territoriale che sono i confini geografici. Françoiz Breut è aldilà di tutto questo, e ad indicarlo è proprio il trasporto della sua interpretazione (vedi le bellissime La Certitude e Km 83), che trascina in un lunghissimo viaggio a mezz’aria senza trovare ostacoli. Non è casuale che il suo talento - e quello delle persone di cui si circonda - abbia ormai abbattuto il limite della Francia, per andare ad incantare un altro continente grazie alla recente tournèe in Arizona, America, Te r r a . ( 7 . 0 / 1 0 ) Andreas Flevin Thomas Brinkmann - Lucky Hands (Max Ernst / Audioglobe, novembre 2005) Il nome di Brinkmann è di quelli che m’intrigano. Ok, non sono un fan né del genere né della persona. E, a dirla tutta, gli entusiasmi suscitati qualche anno fa (1999) da Klick - con le sue “variations” su “locked grooves” e scratch di saporiti vinili seventies da consumarsi caldi e tirati sul dancefloor - non è che li abbia proprio condivisi. Tuttavia, quell’attitudine alla ricerca, alla sperimentazione sul materiale tecnico e sonoro (ad esempio escogitando un turntable con un pick-up per canale), mi sembra come minimo meritevole di curiosità e rispetto. Si aggiunga poi che questo Lucky Hands è preceduto dalla fama di lavoro più accomodante e meno dance- oriented, ed ecco perché non ho potuto fare a meno di metterci il naso. Riscoprendo innanzitutto il gusto di: alzare il volume. Sì, perché il suono si definisce chiaro, essenziale, nel segno di pulsazioni ritmiche asciutte e una parsimoniosa successione di espedienti, riuscendo ipnotico e scoppiettante, algebrico ma organico, con quell’aria da imitazione robotica in differita dalla cuspide settanta/ottanta. Prima che possiate pensare a Rockets e David Zed(mea culpa), sintonizzatevi senz’altro sulla pulsazione dritta infestata di droni birboni e clash ferrosi di Jacknot, oppure sui l i q u o r i s p a c e y d i T h i r t y, o m e glio ancora sui Kraftwerk versione popcorn e virus funk dell’iniziale Drops. E’ un fare sul serio giocando, o viceversa. É una danza intelligente, una strategia di scherzi molto competenti, marchiati di sorprendente autoironia (come q u a n d o c i t a S u n s h i n e O f Yo u r Love nella stolida Work) e intuizioni genialoidi (come gli Smiths immersi in brume Dep e c h e M o d e d i T h e M o r e Yo u Ignore Me, The Closer I Get). Il buon Thomas si cimenta anche in un reading flemmatico, molto tedesco, nel funk industrial-minimale di Maschine, ma se c’è da cantare è meglio affidarsi a TBA (al secolo Tusia Beridze), brava a gestire ad esempio il languore alieno in quella specie di narcosi reggae che risponde al nome di Margins. Ci sono anche dei riempitivi, certo, specie nella seconda metà del programma (il giochicchiare ozioso di Bd a y, l e s c o n t a t e z z e d a n c e d i C Black R – che pure parte in sella ad un bel funk colloso), e non sembra poi quella gran cosa il sample di Django Reinhard avvolto da sottili ma impellenti percussioni nella conclusiva Charleston (da un’idea di Marco “Tuscania” Palmieri). Però, tirate le somme, è un disco autorevole e di- vertente, senza che un aspetto soverchi mai l’altro, anzi stemperandosi in un equilibrio affascinante. (6.7/10) Stefano Solventi Daniele Brusaschetto – Mezza Luna Piena (Bar La Muerte / Bosco Rec. / Audioglobe, 2005) Qualcuno lo definisce il Battiato del 2000, qualche altro lo riconduce direttamente a certa scena post-industrial. Paragoni scomodi, non c’è che dire. Ma Daniele Brusaschetto non è uno sprovveduto, assolutamente. Dieci anni sulle scene, una carriera discografica cominciata nel 1997 con Bellies/ Pance (che si avvale dell’aiuto di etichette come Snowdonia ed RRR Records) e proseguita sotto il segno delle collaborazioni. Nel 2001 si siede alla batteria Bruno Dorella (Ovo, Ronin e Bachi da Pietra) e di lì a poco seguiranno tour in Europa e Stati Uniti. Si spiega così l’interesse di un’etichetta come Bar La Muerte, poco avvezza ad arruolare cantautori. Ma forse è proprio l’etichetta “cantautore”, e quello che essa comporta a livello musicale, che sta stretta a B r u s a s c h e t t o . L’ a t t e n z i o n e per il sound va di pari passo con l’interesse per i testi, pungenti, complessi e quasi mai banali. Se qualche confronto può essere fatto con il cantante catanese è proprio nella costruzione delle liriche e delle melodie vocali: uso di vocaboli in apparenza poco “musicali” e parti cantate che si trascinano al limite della declamazione e che, però, nel risultato finale si avvicinano più allo stile di Cristiano Godano dei Marlene Kuntz che a quello dell’autore di Fetus e L’ E r a D e l C i n g h i a l e B i a n co. Daniele non è il classico cantautore pseudo-romantico-sentimental-esistenzialista s e n t i r e a s c o l t a r e 39 che imbraccia dylanianamente la chitarra e canta, magari arricchendo il tutto con qualche arrangiamento di contorno. La musica rappresenta un lavoro fondamentale nelle sue canzoni e si sente: grande attenzione ai suoni elettronici e alle atmosfere ambient (la strumentale conclusiva Stella stellina); tentativi riusciti di immersione nell’electro (Ciao bellissima, In limitato contorno, strani incroci tra Subsonica e Kraftwerk); momenti più pop (Vita sulla terra) ed echi di Nine Inch Nails (Stupido ma sincero, Criptico) si alternano all’intimismo di Bandieralvento. Mezza Luna Piena, quinto album della sua carriera da solista, si gioca un bel po’ di j o l l y, a v v i a n d o u n p e r c o r s o verso un moderato sperimentalismo che potrebbe ancora dare buoni frutti e che, se non altro, lo accosta a quell’alveo di musicisti e label nostrane (l’elenco sarebbe lunghissimo) che sta reinventando la musica italiana. (7.5/10) Daniele Follero The Chap – Ham (Lo Recordings , 20 giugno 2005 ) Te n e n d o p r e s e n t e l ’ a l l u v i o n e continua e incessante di nuove uscite discografiche, sarebbe un vero peccato lasciarsi sfuggire questo secondo disco dei Chap, soprattutto in virtù del fatto che Ham ha tutte le sue cose al posto giusto: arrangiamenti variegati, melodie frizzanti, umore divertito, citazionismo post moderno e una sciccosa supponenza che si manifesta in tutta la sua coolness già dalla tigre mascherata in copertina. I quattro londinesi (Claire Hope, Johannes von Weizsäck e r, P a n o s G h i k a s a n d K e i t h Duncan) sono gli evidenti continuatori di una corposa tradizione, che partendo dai Beach Boys, e continuando con g r u p p i c o m e B l u r, B e t a B a n d , Supergrass, ecc. ha lavorato 40 sentireascoltare sulle “good vibrations” della pop rock music, senza dimenticare il lato più riflessivo e melanconico, quindi senza diventare goliardici ed effimeri. Da parte loro, i quattro ci mettono gli ormai inevitabili ed enciclopedici riferimenti musicali. Uno stile che è un raffinato amalgama di tanti elementi passati, e che sballotta il disco da un estremo all’altro, sempre operando però su una base che è essenzialmente elettro rock. Il tessuto elettronico non è mai invadente, le trame glitch mai fini a se stesse e sempre alla ricerca di un dialogo con l e c h i t a r r e ( A u t o W h e r e To , I Am Oozing Emotion), altre volte la ritmica è ironicamente dance (Woop Woop e Long Distance Loving) mentre non mancano i momenti più rock, dove pulsazioni elettro e chitarra distorta trasportano i Chap dalle parti degli El Guapo (Now Woel, Arts Centre). Il pregio maggiore del disco è proprio quello della varietà, il suo alternare momenti frenetic i a l l a Ta l k i n g H e a d s ( B a b y I ’ m Hurt’n) ad altri di languida ed accorata introspezione (Woop, The Premier At Last, Clissold Park). Il sipario si chiude con una presa in giro di Emerson L a k e A n d P a l m e r, c h e è a n c h e una manifestazione di intenti: “Modernisation is what we’re about / Without warning you’ll suddenly run out and cry / Goodbye” (7.0/10) Antonello Comunale Dirty Three - Cinder (Touch & Go / Wide, novembre 2005) I soliti Dirty Three, quel loro manifestarsi come una catastrofe in corso, densi e volatili, impalpabili e immanenti. In Cinder – il loro settimo album lungo - si avverte però l’intenzione di mettere a punto il meccanismo, di fare un passo significativo verso una specie di “pienezza essenziale”: sembra in effetti il disco di una band che sfoglia il proprio ventaglio espressivo sapendo di non poter aggiungervi altro, quindi ci medita sopra, mette il freno agli eccessi, spoglia il suono, lo riempie di tremori e memorie, allestendo un programma (fin troppo) lungo, ipnotico e narcotico, quasi ti volesse accompagnare in un sonno che sogna la feroce insensatezza del quotidiano. Le canzoni sono quasi sempre naturalmente - mute, frames più o meno brevi pasturati a folk crudo, dall’asciuttezza affilata. Canzoni in cui può capitare che barbagli melodici (la mesta Michele, la soffice Dream evie) gravitino tra dolcezza e malanimo, tra calore e sgomento, nell’agile e austero svolgersi di timbri e dinamiche. Ma ogni indizio di calore e/o conforto è destinato ad infrangersi in un vasto disegno di desolazione: le chitarre covano minacce postfolk, il drumming possiede una calligrafia secca e vibrante, il piano palpita in territori perlopiù dimessi ( la toccante Last dance), il violino o la viola si aggirano con misurata ma sempre accesa apprensione. Spuntano a tratti mandolini, chitarre Calexico (nel wes t e r n m a l f e r m o d i To o s o o n , too late), chitarre “sitareggianti” e cornamuse (gli strani incroci arabo/irlandesi di Doris), c’è anche gradita ospite la voce inconfondibile di Chan “Cat Power” Marshall (quella setosa dissolutezza) nella laconica Great waves: ma sono scosse che servono vieppiù a sottolineare il senso di irreversibile afflizione, perché poi torni a confrontarti con quelle ballad amarognole ( la dimessa It happened, la strugg e n t e E m b e r, l a s b i g o t t i t a I n fall), tra le tensioni oblique e le rumbe diafane (Ever since), tra blues radenti e ombrosi (i rigurgiti On the beach di Sad Jexy), in un buio attonito e spettrale (quella Rain on che rimanda al Jason Molina più desolato). Più interessante sembrano le ibridazioni stilistico/atmosferiche tentate nella già citata Doris e nella title track (giapponeseria western tra sbuffi di violino e frinire di chitarre), o la disarticolazione ritmica che fa somigliare She passed trough ad una marionetta The Books. Soprattutto per questi ultimi episodi il disco è meritevole di attenzione, ma nel complesso mi sento di definirlo un lavoro di transizione, prima di ogni altra cosa utile ad Ellis e compagni per mappare intenzioni, sviluppi, possibilità. Pure se, ne sono certo, farà la gioia dei non pochi fans dello sporco trio. (6.4/10) Stefano Solventi Dungen - Ta Det Lugnt (Memphis Industries-Cooperative Music / V2) Gustav Ejstes, polistrumentista e figlio ribelle di una famiglia di musicisti classici, è attivo da ormai quattro anni . Nel 2001 esordiva con un album omonimo al quale ha fatto seguito Stadsvandringar (2002), prodotto da un’etichetta personale, la Subliminal Sounds, sotto l’egida dell’amico Stef a n K é r y . C o n Ta D e t L u g n t , l a one man band dello svedese - che canta il linguaggio del rock nella lingua madre - è finalmente in grado di segnare il colpaccio. Un album folgorante fin dall’iniziale e garagista Panda (lungo chorus spaccacuore, batteria rimbombante, organetti crepitanti, chitarre cosmiche in jamming acido), dove non mancano il power folk (Festival) e il jazz (quello spacey di Lejonet & Kulan e quello un po’ Canterbury di Ta D e t L u g n t ) , l ’ a c i d r o c k d a l le volute vertiginose à la Can ( O m D u Vo r e E n Va k t h u n d , Bortglömd) e quello più caciarone che vuol anche dire hard r o c k ( Ta D e t L u g n t ) . I n f i n e , i n tanta prog attitude c’è, e non poteva non esserci, un tour de force a base di barocchismi e agganci alla tradizione svedese chiamato Du E För Fin För Mig un pentolone per spezie Lennon “I Am the Walrus”, melodie per saghe nordiche e bolge chitarristiche rockadeliche anni ’70. Di Dungen colpisce soprattutto l’alchimia tra scrittura sciolta (al limite dell’ingenuità) e surreali aperture folk come acid-rock, un linguaggio che si avvale di una stratosferica produzione, dinamica e magmatica …proprio come se i settanta tutti pelle e parrucconi si riavvolgessero nei sessanta dei cugini hippie illuminati, con gli Hell’s Angels ancora fuori dalla porta. (6.9/10) Michele Saran Earth - Hex: Or Printing in the Infernal Method (Southern Lord / Wide, 20 settembre 2005) Anno dei ritorni, grandi e piccoli, questo 2005. Alla fine è tornato pure lui, ‘Sua Drone-ità’ Dylan Carlson, dopo le varie avvisaglie in forma di (scarsissime) registrazioni live. Si cianciava piuttosto del penultimo Pentastar (SubPop, 1996), quel suo istillare dubbi circa il possibile proseguo creativo degli Earth, ma pure caparbio nello spostare i registri - tramite ponti mobili verso generi collegati - nella direzione del fascino atmosferico, più che nei magmi monolitici di suoni scavanti. La smentita/conferma di tali dubbi è dunque arrivata con il suo ultimo parto, Hex e relativo sottotitolo (già da qui qualche affinità col predecessore), secondo tributo sui generis da parte del chitarrista-compositore. Diciamolo subito, perché la storia è palese: se Pentastar era un permeato dal pensiero della psichedelia acid/ stoner-derivata, Hex si rifugia in atmosfere desertico-sergioleonesche, texarcane, vagamente hard-southern. Accanto al duo portante chitarra (ovviamente Carlson, anche al banjo)-batteria (di nuovo Adrienne Davies), anche basso (John Schuller), pedal steel, trombone e campane tubolari (Steve Moore) fanno la loro parte. Questa filologia roots sfoggia tutta la sua solennità all’ascolto delle quattro dilatazioni strumentali di media durata (7 minuti e rotti a testa), in cui fraseggi melodici di chitarra scurissima sono plasmati come dal vento che soffia in lande desolate (The Dire and Ever Circling Wolves), suddivisi in sorta di strofa e chorus (Lens of Unrectified Night, Land of Other Order), o parti d’inizio-chiusa e variazione centrale, insieme a visioni Gelb-iane spartite con buon equilibrio tra gli strumenti di corredo (An Inquest Concern i n g Te e t h ) . E poi i quadri di breve durata. Mirage, l’incipit, attacca ampio tra colpi solenni di chitarra e vento tutt’intorno, The Dry Lake, il più ambizioso, è un’oasi color pece di musique concrete ambientale, in cui sembrano far comparsa indefinita fantasmi antichi (invocazioni acute, note sparse, nitriti in lontananza). In Left in the Desert, altro intermezzo ventoso, fa apparire il miraggio dello stesso Carlson - quello del tempo che fu -, attraverso un esile feedback e sbatacchiamenti di campanacci. Come dei Bardo Pond a imitare i Calexico, passando per il vaglio Sabbath-iano, e con la direzione artistica dei Codeine. E’ il disco (il quinto) più esplicito di Carlson, e non il più diretto: forme ben salde, un po’ telefonate, crosta melodica (arida nel migliore dei casi) insistita fino ai fasti della pura scenografia, anche se d’innegabile buon gusto, e con un tatto western drammatizzato che evita qualche luogo c o m u n e d i t r o p p o . L’ a r t w o r k centrato - è a cura di Stephen sentireascoltare 41 recensioni Kate Bush Aerial (Emi, 2005) Altopiano di Ukok, regione degli Altai, tra la Mongolia e la Cina. Tremila metri di altitudine, l’aria è sottile. Nel sarcofago di epoca scizia, perfettamente conservato in una bolla di ghiaccio, riposa il corpo di una donna giovane e bella, vissuta duemila e cinquecento anni fa. La Principessa dei Ghiacci. Ma la vera scoperta è un’altra: le mani bianche e affusolate stringono un pacchettino quadrato. (…) L’ a r c h e o l o g o s i e d e i n p o l t r o n a d a v a n t i a l c a m i n o a c c e so, nel ballon c’è un dito di Armagnac. Non ha detto a nessuno di quel pacchettino. Ascolta. Il fuoco scalda, scalda l’Armagnac, ma l’aria comincia a farsi sottile, come sull’altopiano di Ukok, regione degli Altai, tra la Mongolia e la Cina, tremila metri di altitudine. Tutto è perfetto. Troppo. La voce algida. Il pianoforte essenziale. La batteria (quanto l’avranno studiato, quel primo colpo?). Le raffinate orchestrazioni. Anche gli uccellini sono comandati a bacchetta: l’archeologo, che si è versato un altro dito di Armagnac e ha cominciato a ridere da solo, pensa, o forse lo sta dicendo ad alta voce, che di solito un animal collective non è così disciplinato. Adesso anche la principessa sta ridacchiando, ma forse è colpa o merito dell’Armagnac, e se non è così, poteva decidersi prima, non aspettare la fine del secondo cd. (…) L’ a r c h e o l o g o s i s v e g l i a d a v a n t i a l c a m i n o . S p e n t o . A l l a b o t t i g l i a d i A r m a g n a c . Vu o ta. La funzione “repeat” lo riporta alla realtà. Legge gli appunti presi la sera prima: “Dovevo essere ubriaco”. Ascolta. King Of The Mountain (chi sarà mai? il padre della Principessa? suo marito?) alla fine è una palla. Bertie (sembra che il principino si chiamasse così) è folk e Rinascimento, cerchio e botte, ma almeno l’amor di madre scioglie il ghiaccio. E rotto il ghiaccio, come suol dirsi, le cose migliorano, grazie anche alla cenerentola Mrs. Bartolozzi, incantata dalla lavatrice (l’archeologo è a sua volta incantato dalla voce e dal pianoforte, un incanto che si ripresenterà, ridestandolo da un breve pisolino, nella Coral Room). In casi come questi il vecchio Pioneer a doppio caricamento (pure lui un pezzo di archeologia) è l’ideale, e senza soluzione di continuità si scivola dal pianoforte agli uccellini in fila per sei col resto di due del Prelude: “Che disciplina, cazzo!”, si ripete l’archeologo prima di riaddormentarsi. Lo ridesta un ritmo sostenuto (finalmente) e latineggiante, la voce della Principessa è appoggiata da quella pure principesca di u n u o m o ( g l i s e m b r a d i r i c o n o s c e r e M r. G a r y B r o o k e r, i l l e a d e r d e i P r o c o l H a r u m , g i à dispensatore qui e là di piccole magie d’Hammond): al ritmo sostenuto e latineggiante di Sunset, l’archeologo balla come un orso con le dita nel miele, si ricorda una certa Babooshka e sorride. Non riderà più verso la fine, quando la noia l’assale e la nostalgia gli fa desiderare Wuthering Heights. Ma qui le cime non sono tempestose, solo freddo e ghiaccio: la Principessa gli ha giocato un brutto scherzo. (6.5/10) Ivano Rebustini sentireascoltare 42 O ’ M a l l e y. ( 6 . 2 / 1 0 ) Michele Saran Field Music - Self Titled (Memphis Industries /Cooperative, agosto 2005) Cosa combinano assieme i new wavers Peter Brewis e Barry H y d e d e i F u t u r e h e a d s , To m English dei Maximo Park assieme a alcuni amici del nord est nel covo della Memphis Industries (quella che ha recent e m e n t e p r o d o t t o G o ! Te a m e Dungen)? Quanti pensano a un gruppo post-emul o neo-neo-neo-psichedelico, saranno probabilmente delusi poiché i ragazzi, appendendo giacche e cravatte al muro, hanno deciso di trarre ispirazione proprio da quel che i punk e i wavers originari avevano odiato di più: la terra di mezzo del prog con il vezzo della melodia perfetta. Per la serie niente sesso siamo inglesi, via trascuratezza e pressappochismo, e dentro la Great English Tradition pescando trote Genesis e merluzzi Caravan, riavvolgendo il mulinello fino ai salmoni Beatles con la zampa. Un biglietto da visita che lo scorso giugno prendeva il nome di Shorter S h o r t e r, t i p i c a m a r c e t t a a l l ’ i n glese, e assieme, il classico espediente per farcire strofe e ritornelli con gli arrangiamenti più disparati tra i quali, tra archi e citazioni multiple, quelli di Abbey Road e del buon Peter Gabriel dei vecchi tempi della genesi. Ma se in brani come If Only The Moon Were Up (cambi funabolici di tempo, chitarrine country swing, pianoforte da English Garden), Pieces (ancor più matematico rincorrere scampoli di stili e accordature vocali) e soprattutto in Luck Is A Fine Thing e 17, l’omaggio Foxtrot si fa sperticato, i falsetti del cantante già amato dai Tv On The Radio, non sono i soli a dominare il platt e r. C u r i o s o e f r e s c o i l r i c h i a - mo alle influenze sopraccitate alla luce della consueta tradizione wave, noto punto di partenza anche per i Field Music c h e , a l l a n e v r a s t e n i a Ta l k i n g Heads (giusto per citare un gruppo a caso), preferiscono intelligentemente (come direbbe Gordon Sumner) il melody making dei cristallini XTC. E tutto ciò si traduce in acidi lattiginosi, anfetamine di Drums And Wires, chitarrine tirate eppure tutt’altro che ringhiose, riff di piano come p i a c e r e b b e r o a To n y B a n k s , sofisticazioni leziose che tentano di sublimare le carte del prog e del pop inglesi, manna che quasi giunge con Like W h e n Yo u M e e t S o m e o n e E l s e dove il bilanciamento tra melodia e arrangiamento manca di un soffio il miracolo. L’ a l b u m s t u p i s c e s o p r a t t u t t o nella prima tornata di brani dove i fasti, anche tra vaudeville The Kinks, paiono quelli delle migliori annate; eppure la mandibola si ricompone quando tanta perfezione formale va a collimare con la stucchevolezza, come accade con le pallottole a salve di Y o u ’ r e S o P r e t t y e G o t To G e t The Nerve (con ritornelli ripetuti all’infinito), che frenano gli entusiasmi e rendono al contempo più agile l’inquadramento generale del lavoro. È un discreto esercizio di stile il lavoro dei Field Music… cert o c h e a l m e n o u n a T i m e Ta b l e ce la potevano regalare. Per le canzoni è ancora presto. (6.5/10) Edoardo Bridda Gaudi & Antonio Testa - Continuum (em:t records, 2005) Paesaggi sonori in continuo divenire, sonorità elettroniche (analogiche e digitali) che incontrano strumenti tradizionali, ritmi ipnotici e trascinanti. Continuum è questo e molto di più: è uno sguardo intelligente (ma che non si compiace di sé) e a 360 gradi sulle possibilità che offre la musica “globalizzata”. In linea con la produzione ambient-elettronica della em:t records, Continuum ci offre tutto il bagaglio dei suoi autori: il dub (chi ricorda gli esordi ragamuffin di Gaudì?) e la sapienza combinatoria del Dj-remixer (Gaudì ha lavorato per artisti come Lamd, 1 Giant Leap, Simple Minds e Ojos De Bruio), tessiture ambient (caratteristiche della produzione musicale di A n t o n i o Te s t a ) . Va l o r e a g g i u n t o è l a r i c e r c a d i suoni etnici, con l’utilizzo di strumenti tipici di tradizioni musicali lontane da quella occidentale (dove si incontrano il percorso già evidente nelle precedenti produzioni di Gaudì e quello di etnomusicologo d i Te s t a ) . F o n d a m e n t a l e p e r l a buona riuscita del disco è poi la riconoscibilità dell’apporto dei due compositori, dei loro gusti e delle loro competenze all’interno di tutti i pezzi che compongono il cd: ogni traccia ha così una sua fisionomia ben riconoscibile e ci propone nuovi spunti e nuovi orizzonti. I brani sono in realtà due sequenze (la prima composta dalle tracce da 1 a 5, la sec o n d a d a 7 a 11 ) d i v i s e d a l l a traccia 6 (non a caso intitolata Interlude). Prologue - Helictite Labyrinth presenta subito il mondo che stiamo per esplorare: un suono lontano appena percebile - in loop (il Labyrinth del titolo) è la base (anche ritmica) su cui si innestano rumori e suoni evocativi di paesaggi lontani e sconosciuti, preludio a Deimos’ Prophecy che ci offre i primi spunti dub. Con Night Watch le cadenze reggae prendono il sopravvento insieme a una colorazione rumoristica, ma Dawn Cliffs II Risveglio delle pietre ci riporta di colpo a un’atmosfera sognante di echi, in cui si ritagliano un posto brevi spunti martellanti, che nella seconda parte del pezzo lasciano il campo a un sentireascoltare 43 recensioni Fursaxa Lepidoptera (ATP Recordings/Goodfellas, 26 luglio 2005) Prima o poi si dovrà dare ai Bardo Pond il credito che gli spetta, se non altro perché hanno fatto da ponte tra le diverse istanze psichedeliche dei primi anni ‘90 e la contemporanea ondata wild-folk. A questo giro, i fratelli Gibbons prendono sotto la propria ala protettiva u n a c o n c i t t a d i n a d i P h i l a d e l p h i a , Ta r a B u r k e , i n a r t e Fursaxa, già sponsorizzata da Kawabata Makoto (Acid M o t h e r s Te m p l e ) e T h u r s t o n M o o r e ( c h e h a d i s t r i b u i t o uno dei suoi dischi con la Ecstatic Peace). Lepidoptera non si allontana dai lavori precedenti, ma si muove con più agilità tra le fitte trame di una folk music alterata, disturbata, costantemente erosa da elementi lisergici. Quella di Fursaxa è una musica che può attrarre e respingere in egual misura e che, se da un lato poggia le sue fondamenta nella tradizione folk, mira continuamente ad affrancarsene. Una Va s h t i B u n y a n c h e r a g g i u n t a S k y e p r o s e g u e e n o n t o r n a p i ù i n d i e t r o , f i n o a d a r r i v a r e in estasi ai deserti dell’anima e alle cicatrici interiori di Nico. Questa è un po’ la sua condanna artistica, quella di non poter andare oltre Marble Index, ma stiamo parlando, comunque, di traguardi notevoli. In sede produttiva, lei e i fratelli Gibbons non hanno la creatività di John Cale, ma usano bene le loro carte. L’ o r g a n o d e l l ’ i n i z i a l e F r e e d o m e i l f l a u t o a l l a H a n g i n g R o c k d i P u r p l e F a n t a s y a l l e s t i s c o n o s u b i t o u n a s c e n o g r a f i a s u g g e s t i v a , s o l e n n e e d i l a t a t a . L e s u c c e s s i v e Ve l a d a , Karma e Pyrachanta sono i tipici madrigali in cui si è specializzata la Burke, a metà tra il panteismo religioso della Kendra Smith post Opal e l’umore decadente e ieratico dei canti di Hildegard von Bingen (una delle influenze maggiori per sua stessa ammissione). Neon Lights espande ulteriormente questa prassi e riverbera ipnoticamente le parti vocali, mentre in Poppy Opera sono le chitarre ad essere trattate come materiale da modulare progressivamente, fino a quando non rimane che un ronzio ad accompagnare il canto solitario. Tutto il disco ha l’umore solenne dei canti medievali ed è costruito con pochi tocchi strumentali: Russian Snow Queen fa fede solo ad un tappeto di farfisa, mentre gli o t t o m i n u t i d i Ty r a n n y s o n o s c a n d i t i p r i n c i p a l m e n t e d a l l e n o t e r e i t e r a t e d e l l ’ o r g a n o , a cui si aggiungono flauto e ovattate percussioni tribali nel crescendo finale. Si chiude il sipario nella conclusiva Una De Gato, che affoga tutto nel chitarrismo noise dei Gibbons. In sintesi, un disco solenne e ammaliante al tempo stesso, che migliora ulteriormente lo standard della ballata psichedelica, vero trademark di Fursaxa. Un’opera notevole, soprattutto per gli amanti del genere. (7.3/10) Antonello Comunale sentireascoltare 44 unico riff. Micro-Evolution è il continuo mutare timbrico di un riff e dell’accompagnamento di batteria (quasi un gioco in stile minimalista). Interlude chiude la prima parte di questa sequenza/suite con un tappeto sonoro sospeso, a cui si contrappone la precisione ritmica di Dub Hypnosis, con cui si apre la seconda sequenza. Bass Instinct tiene fede al suo nome grazie al riff di basso che sostiene tutta la traccia e porta all’ascolto di Space-Mind Continuum; No Escape ripropone la cifra stilistica di Micro-Evolution. Epilogue - After The Plunge chiude la seconda sequenza: come nel brano di apertura, un suono e una voce evocativi di mondi lontani fanno da base a una variegata tavolozza di suoni/rumori, che conducono alla fine di questo viaggio musicale. Un cd da ascoltare comodamente seduti in poltrona, a occhi chiusi, ma con l’immaginazione pronta a offrirci paesaggi magici, oppure da vivere lasciando vibrare il corpo al ritmo pulsante del dub, o ancora ad alto volume fino a saturare l’ambiente con la ricchezza dei suoni. (7.5/10) Andrea Erra Gravenhurst - Fires In Distant Buildings (Warp / Self, 28 ottobre 2005) N i c k Ta l b o t , l e a d e r d e l t r i o Gravenhurst, sarebbe un ragazzo qualunque se non fosse per un certo indiscutibile talento di alt-folker e per un’insana attrazione verso il lato oscuro dei sentimenti umani. Non gli si può negare di avere una poetica molto precisa, un insieme di temi privilegiati e sviluppati sul filo del rasoio di una affettività/sensibilità morbosa e irrisolta. La sua discografia è minuta, ma di valore: dapprima, meno c h e v e n t e n n e , Ta l b o t f o n d a una piccola casa discografica (la Silent Age Records) a Bri- stol, città da cui proviene. Nel 2003 fa uscire il suo primo lavoro, Flashlight Seasons. Un anno dopo, ingaggiato dalla illustre Warp Records nonostante una sostanziale divergenza di genere rispetto al roster dell’etichetta, pubblica uno stupendo Ep noir-folk, che va sotto il nome di Blackholes In The Sand e che gli vale una certa attenzione. All’alba della terza ed ultima uscita dei Gravehurst, Fires In Distant Buildings, la scrittura di Nick non appare sostanzialmente modificata rispetto agli album precedenti. È solida, intensa, grandguignolesca e dolente come e più di sempre. Al centro del mondo della band e del suo giovane leader ci sono ancora una volta le circostanze scomode dello stupro, dell’assassinio, del suicidio: argomenti tabù che avvolgono nel buio tutti e tre i dischi, facendo di canzoni d’eccezione come la cover di Diane degli Hüsker Dü oppure le autografe Emily o Blackholes In The Sand (tutte presenti nell’omonimo eppì) delle autentiche “murder ballads” tra Nick Cave e Nick Drake, art i s t i c o n c u i Ta l b o t c o n d i v i d e , evidentemente, più del nome di battesimo. Le nuove Nicole e Cities Beneath The Sea, l’autolesionista Animals o la e c c e l l e n t e T h e Ve l v e t C e l l quest’ultima appena meno folk del solito - non suonano meno minacciose. N i c k Ta l b o t è u n ’ a r t i s t a e c l e t tico del calibro di Arrington de Dionyso, che pure per molti versi ricorda, e dando tempo al tempo si farà certamente notare per personalità e doti compositive. Per il momento, contratto per Warp nonostante, l’occhialuto fondatore dei Gravenhurst rimanda allo stereotipo del ragazzo seduto nella propria classe, dietro il proprio banco; quell’adolescente cupo che disegna teste mozzate mentre l’insegnante è voltata verso la lavagna, quello ingaggiato senza esitazioni nella triplice lotta contro i suoi ormoni, i suoi fantasmi ed il mondo torbido e sbagliato. Non è sicuro che ci piacerà vederlo risolversi, venire a patti con la sua paura, diventare adulto. Perciò, per ora, non resta che godere delle sue prolifiche storture. (7.2/10) Marina Pierri Hello Daylight – Gemma (Acid Soxx, 2006) Bella scoperta gli Hello Daylight, non solo per i sostenitori accaniti delle mescolanze stilistiche, gli amanti del non-genere o i figli legittimi del meltin’ pot, ma soprattutto per chi, della cosiddetta musica “alternativa”, apprezza la creatività, il coraggio e la voglia di spingersi oltre i facili confini espressivi della moda stagionale. Che ci crediate e meno, pur frutto – e sembra quasi un paradosso dirlo – di continui rifacimenti, Gemma racchiude in sé quello che un album indie dovrebbe sempre possedere: personalità, identità e autenticità. È così allora che linee melodiche sottratte all’universo effimero dei New Romantic si fondono all’elettronica nordica e al crooning (April Come), psichedelia morbida e chitarre acustiche costituiscono il giusto background sonoro agli echi Spiritualized (Soft Medea), e un ribollire ritmico inarrestabile e un ripetersi tematico al sintetizzatore rendono Big Mistake uno dei passaggi obbligati di tutto il pacchetto. Il resto del programma scorre che è un piacere, tra drum ’n’ bass frenetici e parti vocali dai corposi sapori espansivi – Mr Nowhere Song, Winters Ta l e - i n f e r m i t à e l e t t r o n i c h e di matrice Blues Explosion e vie di fuga a metà strada tra Notwist e Ian Curtis – Nation a l G a l l e r y, G y p s y L i k e Yo u partiture à la Bjork da tastiera Bontempi e musiche corali dal sentireascoltare 45 vago sapore rétro (The Inmate Song, Urethra). Tutto il materiale è condito da campionamenti salva-spazio, distese di rumori di fondo, coloriture melodiche inaspettate e, dulcis in fundo, una ghost track che nei quattro minuti di durata si diverte a giocherellare tra piacevoli mutazioni stilistiche (una fertilità creativa generalizzata confermata anche dalla traccia video Cuore di cane allegata al cd). Se volessimo cercare un possibile contraltare stilistico a Gemma lo troveremmo probabilmente in Days Before The D a y d e i m a r c h i g i a n i Yu p p i e Flu, un’opera figlia della stessa stratificazione e complessità di questo secondo episodio a nome Hello Daylight. (7.3/10) Fabrizio Zampighi I Refuse It! – Cronache del Videotopo (Wide, 2005) 1982: in Italia esplode il fenomeno dell’hardcore, che mette in gioco, estremizzandoli, gli ultimi scampoli di un punk che ormai, dopo aver rivoluzionato il rock, lasciava il posto al gran calderone della new wave. Nell’hardcore lo spirito punk sembra rinnovare il suo potere alternativo dando i suoi ultimi colpi di coda. L’ I t a l i a in questo contesto vive anni di rivalsa, tira fuori gli “attributi” che aveva tenuto nascosti negli anni precedenti e gode della la sua stagione punk più autentica, tanto che si può parlare senza indugio di “scena”, anzi di “scene italiane”, che ruotano attorno al fenomeno dei centri sociali autogestiti, spesso di m a t r i c e a n a r c h i c a . A To r i n o i Negazione, i Randagi , i Contropotere a Napoli: rappresentano solo alcuni esempi di stretto legame tra band e centri sociali, una regola più che un’eccezione all’epoca. Un periodo, quello dei primi anni Ottanta, di forti estremismi, premessa al piccolo boom di 46 sentireascoltare fine decennio: l’eroina impera, il punk ha fatto terra bruciata di ideologie e ricerca musicale, il nichilismo del no future comincia a lasciare il posto a un anarchismo tanto estremo quanto ingenuo, a cui si accosta un esistenzialismo post-adolescenziale che esaurirà in pochi anni la sua carica propulsiva, per trasformarsi in qualcos’ altro. Emblematico il caso di Neffa, ex batterista dei Negazione, ma sono molti i protagonisti della scena hardcore-punk italiana che dalla fine del decennio in poi sono naufragati verso ambiti molto diversi dal loro background. Il reggae e l’hip hop sono risultati i generi di approdo più diffusi. I n q u e s t a s t o r i a a n c h e l a To scana ha avuto il suo ruolo. La “scena” toscana, per circa un lustro ha ruotato attorno al Granducato Hardcore, gruppo di band hardcore più o meno ortodosse (CCM, Ward o g s , P u t r i d F e v e r, Tr a u m a tic, Juggernaut e altri) tra cui spiccavano, per fantasia e un approccio per niente straight edge, gli I Refuse It! Difficile rinchiudere musicalmente Stefano Bettini e compagni nelle griglie dell’hardcore, tanto è variegato il loro sound, in cui confluiscono accenni di funk, spigolature post-punk e ritmi sincopati che quasi preludono alla no wave. Un’esperienza durata quattro anni, dal 1983 al 1987, che rischiava di rimanere nelle mani di pochi collezionisti o amanti del genere, che di quell’epoca hanno conservato i feticci. La Wide, grazie all’indubbio interesse del suo fondatore, Sandro Favilli, ex bassista del gruppo, ripubblica, in Cronache dal Videotopo, tutta la discografia del gruppo toscano, dagli esordi su cassetta ai vari (pochi) 7 e 12 pollici e i brani sparsi. Il punk dissacrante di Mira il tuo popolo; le registrazioni incerte e grezze di Nuove dal fronte; gli esperimenti con lingue improbabili come il russo (Chocu Umeret) o idiomi inventati (Hit’N’Run Attack), l’hc più canonico di Agguato e Fuggi fuggi; le composizioni più articolate dell’ultimo periodo della band (Cronache del Videotopo, Questo è l’Inferno…questa è Eleusi, la bellissima Paradiso Zero). Tutta racchiusa in 25 brani la storia di una band che ha saputo con arditezza introdurre sax, tastiere, piffero e armonica in un genere assolutamente allergico alla sperimentazione. Che gli esperimenti non vadano sempre a buon fine, beh…è da metterlo in conto. Un (8.0/10) pieno all’operazione, che restituisce un pezzo di storia della musica che rischiava di finire definitivamente nel dimenticatoio. La band non va oltre una seppur piena sufficienza. Daniele Follero Jackson And His Computer Band – Smash (Warp / Universal, novembre 2005) La contaminazione e decostruzione del suono techno da parte della Warp e di poche altre e t i c h e t t e ( R a s t e r - N o t o n , D FA ) continua senza sosta. Rinnovare il beat più antisperimentale della storia (ossia l’odioso quattro quarti della cassa) non è (stata) impresa facile. Se da un lato si costruiscono mondi sonori minimalisti e alienanti (vedi ad esempio gli Autechre), dall’altro si tenta di importare nel suono electro una contaminazione massimalista che attinge da varie culture musicali o da altri mondi sonori (vedi la deriva concreta dell’ultimo Herbert o dei Matmos). In quest’ultimo magma si tuffa a capofitto un parigino di 26 anni: Jackson Forgeaud. Educato a suon di folk e blues dalla madre cantante (Paula Moore, che compare in ben quattro tracce dell’album), l’enfant prodige riesce a mescolare la sensibilità melodi- ca del suo retroterra francese (già compagno di studio di M r. O i z o e r e m i x a t o r e d i M 8 3 e Air) con le più recenti sonorità electro. Il disco è un miscuglio divertito e divertente di brevi samples vocali à la Daft Punk (Utopia, Rock On), di electro hip-hop apocalittico e minimale (con l’aiuto di Mike Ladd in TV Dogs), un improbabile mix tra Coldcut e Boards Of Canada (Hard Tits), un accenno a ritmi anni novanta semiDepeche Mode incrociati con b r e v i a l l u s i o n i i n d u s t r i a l ( Te e n Beat Ocean), una ripresa visionaria del jazz piùsbilenco d i q u e l p a z z o d i A m o n To b i n (in Tropical Metal), una sonorizzazione di una partita a qualche videogame (Moto) e un omaggio al padre di tutto il r o a s t e r Wa r p : A p h e x Tw i n ( i n Radio Caca). La prima prova della Computer Band risulta essere un inevitabile contenitore di contraddizioni che riflettono lo stato dell’elettronica contemporanea: lo smarrimento davanti alla troppa informazione. Il pregio del disco sta nella sua (non ancora completa) capacità di organizzare il caos. Un buon punto di partenza su cui (de)costruire il futuro. (7.6/10) Marco Braggion Kraftwerk - Minimum Maximum (Emi / Astralwerks, giugno / dicembre 2005) In un periodo in cui le reunion illustri sono la norma piuttosto che l’eccezione, quello dei Kraftwerk è stato sicuramente uno dei ritorni più graditi degli ultimi due anni. Dopo dischi e apparizioni pubbliche somministrate con il contagocce nei passati tre lustri, R a l f H u t t e r, F l o r i a n S c h n e i der e compagni sono tornati i n g r a n d e s t i l e p r i m a c o n To u r De France – Soundtracks, poi con un tour mondiale che, a partire dal 2004, ha toccato una quindicina di Paesi (tra cui l’Italia per due volte). Ed ecco quindi puntuale Minimum Maximum, due cd e un dvd che immortalano le più di due ore di spettacolo dei simbionti di Düsseldorf. Operazione nostalgia? Nient’affatto. In tempi in cui è diventato normale vedere simultaneamente in azione Pixies, Slint, Pink Floyd, Gang Of Four e Cream in una sorta di azzeramento temporale, i Kraftwerk hanno saputo fare la differenza, offrendo quella che è sì una celebrazione, ma non una semplice istantanea del bel tempo che fu. Nell’epoca in cui l’I-pod ha preso il posto del pocket calc u l a t o r, i m e n m a c h i n e s o n o hic et nunc, apparentemente immutabili, statici eppure immersi nella dinamicità dei nostri giorni. Da sempre pionieri della multimedialità, hanno allestito uno show accuratissimo (di cui si può godere ogni dettaglio nel bellissimo dvd), in cui il repertorio trentennale risulta eccezionalmente coeso in virtù di efficaci ripartizioni tematiche (si veda tutta la parte dedicata a Computer World) e di sapienti accostamenti (la sequenza micidiale Autobahn / The Model / Neon Lights / Radioactivity / Trans Europe Express); e così brani anche distanti tra loro nel tempo sono riportati in una dimensione inedita, un universo automatico fatto di autostrade, ferrovie, corse in bicicletta, luci al neon, calcolatrici, cifre digitali. Insomma, un doppio live che vale più di qualsiasi best of. Il merito di questo nuovo successo non va ricercato tanto nell’indiscutibile abilità dei Nostri in fase di mix e rielaborazione, quanto nell’eccezionale dote che ha reso immortali i loro capolavori: il saper permeare romanticamente ogni opera di un’estetica precisa, che ne definisse forma, sostanza e identità. In Minimum Maximum i mae- stri dell’elettronica raccontano sostanzialmente sé stessi, mostrando come la loro musica sintetica riesca ancora a suonare fresca e attuale nell’era automatizzata che stiamo vivendo. D’altronde, se i Kraftwerk oggi vengono omaggiati persino da insospettabili come U2 (che hanno ripreso Neon Lights) e C o l d p l a y ( l a c u i Ta l k h a r i p o r tato in auge il riff di Computer Love) ci sarà anche un perché. (7.8/10) Antonio Puglia Daniel Lanois - Belladonna (Anti / Alternative Distribution Alliance, 12 luglio 2005) La carriera del Lanois produttore è delle più avvincenti e storicizzate. La lasciamo a chi di dovere. Il Lanois compositore-interprete, meno noto e forse un po’ bistrattato, ha saputo dare alla luce piccoli tesori dal valore autentico. Dapprima (Acadie - Opal, 1989) bozzettista sonoro alle prese con stili e prestiti tradizional-popolari, ma pure rimescolati col fare dello stilista astratto, non lontano da certe obliquità Brian Eno ; poi cantautore maggiormente ligio alle convenzioni, ma parimenti emozionale, quasi combattivo (For The Beauty Of Wynona - Wa r n e r, 1 9 9 3 ) . I n f i n e p e r f o r mer di tenerezze in forma di ballad-cocktail (Shine - Anti, 2003). Con un’inconsueta pausa di soli due anni, il Nostro si ripropone poeta ambientale, stavolta tutto strumentale, con un album discretamente i m p r e c i s o . D u s t y, a d e s e m p i o , è una semplicissima vignetta per sola chitarra, mentre Panorama è un inno di steel guitar tra vibrati impercettibili, Sketches rotea placida tra mugugni di chitarra, batteria mareggiante e synth ovattati, e Flametop Green propone un onirismo sensuale e dolente Durutti Column, con docile accompagnamento di piano. sentireascoltare 47 recensioni Kill The Vultures Self Titled (Jib Door, 2005) Un altro disco che rivoluzionerà l’hip-hop, un’altra band che mette in discussione la stabilità della musica afroa m e r i c a n a c o n t e m p o r a n e a . L’ e s o r d i o d e i K i l l T h e Vu l t u res non scende a compromessi, e fa ancora una volta storcere il naso ai puristi (ma ce ne sono ancora??). Questa volta non sono i bianchi a sradicare la musica “nera”, a naturalizzarla, come è stato per i cLOUDDEAD. I quattro musicisti americani mettono in campo un meticciato musicale che fonde jazz, rock e hip-hop radicale partendo da un rapping inconfondibilmente black. Fiati, percussioni, contrabbasso e poca elettronica: la fisicità del sound davisiano incontra ancora una volta il ghetto e si riscopre assolutamente in continuità con la contemporaneità afro-americana, stupenda attualizzazione di una storia lunga un secolo, cominciata nel mitico quartiere di Storyville, a New Orleans e proseguita con una impressionante soluzione di continuità fino ai giorni nostri. Campionamenti, ma anche musica suonata. E’ questa la linfa vitale dei diretti eredi d i J o h n C o l t r a n e e d e i P u b l i c E n e m y, d e l f r e e j a z z e d i J a m e s B r o w n . Poco più di trenta minuti che bastano a far gridare al miracolo e tracciano la nuova strada della black music e non solo. La litania di Good Intentions basterebbe da sola a testimoniare le volontà programmatiche dei Kill The Vultures: un contrabbasso minimale sullo sfondo, flebili suoni di tromba che contrappuntano un rapping insolito, appena accennato, quasi recitato e una batteria che fa da sfondo più che da sostegno ritmico. Roba da fare arrossire t u t t o i l W u Ta n g K l a n ! La stessa struttura si ripete in The Vultures, ma in maniera ancora più insistente, claustrofobica, mentre in 7-8-9 compare addirittura una chitarra distorta e la batteria s e m b r a s c i m m i o t t a r e g l i S t o o g e s . L’ i m p a t t o è s e m p r e v i o l e n t i s s i m o , u n s e n s o d i v u o to pervade ogni brano come a voler evidenziare una dimensione percussiva (fisica, ancora una volta), che se ne sbatte dei “riempimenti” tipicamente pop. Una musica che è sempre, anche e soprattutto politica, alla faccia dell’intrattenimento. Il pianoforte di Beasts Of Burden, con il suo andamento darkeggiante mette quasi i brividi e richiama alla mente addirittura sprazzi di sound 4AD. Niente appare superfluo in questo disco, tutto ha il suo perché, come succede per tutta quella musica che prima o poi passerà alla storia. (8.0/10) Daniele Follero sentireascoltare 48 Difficile dire dove Lanois voglia andare a parare, stavolta. Di sicuro l’unisono tra vibrafono, tastiere e gorgheggio catatonico di Oaxaca (ancora Eno dietro l’angolo) non aiuta molto, e nemmeno la svolta mariachi della parte centrale Agave. Così come non aiutano i riempitivi (Desert Rose), le pallide imitazioni di Frittke (The Deadly Nightshade) e di F r i s e l l ( Te l c o ) , l e i n c u r s i o n i nello ska (Frozen). Nemmeno la chiusa, l’ambient aeriforme c o n f l a n g e r o f f u s c a n t e d i To dos Santos riesce ad aggiungere alcunché al già poco. Con il piano di Brad Mehldau e la batteria da Brian Blade (già in Shine), è la meno convincente dimostrazione delle potenzialità di Lanois. C’è la sua tipica cura professionale, e una dosata cornice strumentale, ma l’album in sé si basa su un vignettismo davvero monotono e incompiuto, per di più triviale nell’uso delle stereofonie e degli effetti sul suono e altamente volatile nella consistenza delle composizioni. Da perdersi, senza il rischio di non tornare. (5.1/10) Michele Saran Macromeo – s/t (Aiuola Dischi, dicembre 2005) Tutto è così semplice: Bologna, un’amicizia fruttuosa, un’etichetta pregevole e, soprattutto, un ragazzo con delle buone idee supportate da un certo talento. Così si potrebbero descrivere brevemente le circostanze che hanno reso possibile il debutto su Aiuola Dischi di Michele Stefani, alias Macromeo. Supportato e prodotto dalle teste calde di Riotmaker (leggasi - gli Amari) e registrato in casa, il self-titled in questione è una buona via di mezzo tra produzione fine e verve D I Y: e ff e t t i v i n t a g e c h e v a n no dal delicato al volutamente invadente, forma-canzone a 360°, motivi ultrapop nella veste rigorosamente naif di tra- dizione Aiuola, testi italiani ora divertenti, ora un pochino commoventi. Del resto, come nel caso del vicino Grand Master Mogol, forse l’aspetto più interessante di questo piccolo lavoro d’esordio è proprio l’intimità della scrittura, che ingrandisce, con la lente di una sensibilità volutamente esibita, le insicurezze che si ritrovano in Tutto è così semplice e Tutto Inutile. Anche se a dir la verità verrebbe quasi da dire a Macromeo che non è stato affatto tutto inutile, perchè se queste canzoni tonde e sincere nascono dai suoi otto volanti emotivi come tutto lascia credere, allora è valsa la pena di sfidare certe altezze (6.5/10) Marina Pierri The Mass – Perfect Picture Of Wisdom & Boldness (Monotreme, 2005) La Monotreme si conferma etichetta interessante e da seguire nelle sue incursioni ed escursioni, soprattutto in ambito metal, dove con la parola metal si comincia a intendere un linguaggio compositivo e non più un genere. Nulla dei Mass fa pensare al manierismo metallaro che pure non cessa di circolare. Eppure Perfect Picture Of Wisdom & Boldness è un album intriso di metal dall’inizio alla fine: rocciosi riff di chitarre, abbondanza di effetti di compressione e distorsione, batteria veloce e “pesante”, voce roca. E’ la combinazione di questi elementi che allontana molto i Mass dal genere “metal”. Un approccio che rigetta sia i semplici schemi formali del black e del death, sia i vuoti virtuosismi kitsch alla Dream T h e a t e r, reinterpretando il progressive nella sua versione più dura. Gli impasti timbrici che derivano da un attento e preciso inserimento dei fiati hanno lo stesso senso che avevano nei Rolling Stones dei primi ’70 e cioè quello di dare più groove: sembrerà strano, ma il sax di Matt Waters riesce a dialogare benissimo con la chitarra di To m O ’ D o n n e l l , t a n t o d a e n trare perfettamente nell’amalgama metallico. Una band al livello dei migliori Cynic, che sfodera un ventaglio di influenze che va dai C r a d l e O f F i l t h a i Vo i v o d , p a s sando per i Metallica di fine ’ 8 0 e l o s t o n e r. N i e n t e d i r i v o luzionario dunque, ma quando tra i suoni imponenti di Cloven Head si ascolta il sax per la prima volta l’effetto è piacevolmente spiazzante. Brani lunghissimi (quasi tutti appena sotto i dieci minuti) ognuno dei quali è un concentrato di episodi musicali che confluiscono l’uno nell’altro: momenti di calma che ricordan o i To r t o i s e e g l i S l i n t ( M e d i tation On The Some Carcass) si alternano a violente scariche in stile black norvegese modello Dimmu Borgir (Little Climbers Of Nifelheim). Il tutto strutturato, manco a dirlo, con tempi dispari e frequenti cambi di tempo, guidati dalla b a t t e r i a d i Ty l e r C o x . Troppo poco estremi per interessare ad artisti d’avanguardia tipo Zorn, troppo estremi per chi non mastica metal. Forse non hanno davanti la più facile delle carriere, ma di sicuro meritano notorietà. (7.5/10) Daniele Follero Mazarin - We’re Already There (Bella Union-Cooperative Music / V2, 2005) Te r z o c a p i t o l o p e r M a z a r i n e c’è da giurare che la mente del suo ideatore, quel Quantin Stoltzfus che militava nelle fila drone-psych dei philadelphiani Azusa Plane (in qualità di batterista), abbia finalmente trovato quel che cercava. Con questo We’re Already There, uscito dopo una lung a p a u s a d i r i f l e s s i o n e ( A Ta l l Ta l e S t o r y l i n e r i s a l e a l 2 0 0 1 ) , sentireascoltare 49 il cantautore insegue, ancora una volta, il personale percorso dreampop d’ascendenza electro-psichedelica occupandosi per la prima volta dell’intero ciclo creativo/produttivo. Ne esce un album compatto e coeso, studiato in ogni particolare, dalla vena lo-fi che non disdegna il Big Beat, soprattutto: aritmeticamente (?) e lisergicamente pop. Brani strumentali come Schroed(er) / I n g e r, t u t t o s u o n e t t i d l i n d l o n oscillanti, e sezione ritmica gelatinosa, esprimono gracilità melodica in appassionanti quadrature armoniche, mentre Kenyan Heat Wave (ManitobaCaribou ringrazia), pungolano il retrò tra tastierini lounge e spartani ritmi cadenzati. L’ a n i m a d e l c a n t a u t o r e e m e r g e prorompente in Another One G o e s B y, m i s c e l l a n e a e l e c t r o lo-fi, negli incensi electro di T h e N e w A m e r i c a n A p a t h y, n e l rieccheggio Apples In Ster e o d i A t 1 2 To 6 . n e l g a r a g e beat con coda psichedelica di I ’ l l S e e Yo u I n T h e E v e n i n g , e nella Elephant6-oriented Louise (con Jeff Mangum in palmo di mano). Manca forse un pizzico di personalità nella scrittura …ma che signorilità nelle citazioni e che produzione popadelica! (6.3/10) Michele Saran Milaus - JJJ (Black Candy, novembre 2005) Domanda: come fare del buon indie rock nell’anno del signore 2005 (quasi 2006)? Risposta: pagando pegno con passione. Un esempio? JJJ dei Milaus. Non so se i cinque ragazzi valtellinesi saranno d’accordo, ma in questo loro terzo lavoro mi sembrano emergere tanto i pregi quanto i limiti di una situazione – non la loro in particolare, ma in generale - senza sbocco per quanto piacevole, coinvolgente seppure formattata su idee già piuttosto logore. Intendiamoci, si tratta di un buon disco. Che trasuda entusiasmo nudo 50 sentireascoltare e crudo, capace di presentarsi affilato e beffardello in So beautiful, di regalare buone intuizioni come gli stranianti pigolii sintetici e il violoncello grattugia-ombre nello scazzo pavementiano di Attitude to the funny things, di sbandierare un’ispirazione struggente come nell’indolenzita Traffic (cantata col sottile abbandono del miglior Corgan), scuotendosi con un’energia talmente ben meditata da sembrare grezza, come nel blues-funk nervoso di It’s a miracle!!!, con quei cigolii di violino, il clarinetto diabolico e il finale innodico/distorto. Tuttavia, non puoi fare a meno di avvertire la stanchezza “estetica” della formula, ad esempio degli spigoli ritmici & chitarre radenti à la June of ‘44 nell’iniziale She’s back (cantata con elegante doglianza Polvo), o del siparietto dEUS di As I used to be, o della misteriosa enf a s i To r t o i s e n e l f o s c o c a r i l lon di It’s coming (dove Fabio Magistrali allestisce rumori da poltergeist sotto sedativo). Tutte soluzioni valide e funzionali, certo, sulle quali però persiste un senso d’arredo modulare, di lezione imparata e (ben) applicata, in ragione del quale finisci per ascoltare con quel po’ di distacco che gambizza il trasporto nella culla. Con tutto ciò, non può passare sotto silenzio il modo in cui la cassa in quattro Rapture-style di Searching in all love songs sdilinquisca in una lunga dissolvenza sanguigna, fino ad incarnare un toccante intimismo soul. O come la title track congedi l’ascoltatore stemperando onirici sdrucciolamenti Flaming Lips e accorati crepuscoli Wilco. Insomma, bravi son bravi, i Milaus. Se sapranno smarcarsi dalle predilezioni e puntare dritti a se stessi, potranno aspirare ad una qualche forma di grandezza. (6.8/10) Stefano Solventi Mr. Bizarro & The Higway Experience - Hello Hell (Midfinger, 2005) C’è questa band che è davvero interessante. Più che altro è l’ennesima, intrigante incarnazione del rock ‘n’ roll. Di un certo gusto d’oggi, quello che ripesca elementi della vecchia roba grezza dei Settanta con piglio amorevole e incazzat o , i n s o m m a : i l Ve c c h i o N u o v o Rock. A modo loro. Si chiaman o M r. B i z a r r o & T h e H i g h w a y Experience, un nome che non significa niente, ma che fa la sua porca figura. Spieghiamoci. Il batterista è quello che oggi ha sostituito Dario Perissuti negli One Dimensional Man. Perciò ci siamo con il tiro. Ma non basta. Sono praticamente la versione aggiornata dei Queen Of The Stone Age, o forse il superamento in chiave easy stoner degli International Noise C o n s p i r a c y, o a n c o r a i l n o i s e core dei già citati ODM, privato del nichilismo assassino del cantante Pierpaolo Capovilla e mischiato alla carnalità assassina degli Ikara Colt. O, più semplicemente, i Mr Bizarro & The Highway Experience, post-stoner-indie-glam-rock d a Ve n e z i a . È come se questi cinque trasferissero all’istrionismo un suono core lisergico, mantenendone intatta la fisicità. Anzi, accentuandola, erigendola quasi a importante cifra della matrice stilistica. Non c’è assenza che si contempli: ogni nota è presa in mano e lavorata alla massima intensità; le strutture sono semplici, eppure non c’è niente che risulti sotto tono, tutti in fila compatti a passo di marcia verso una dimensione musicale che mischia - in una sintesi strabordante, ma lucida - l’eccesso della fisicità. E allora scopami di qui e prendimi di là e alla fine ci sono queste canzoni che ti gonfiano il cervello e fanno esplodere le vene, tanta è la voglia di mangiarsele dal vivo in una fantastica cornice, dove tutti siano in mezzo alla bolgia a scatenarsi come leoni appena liberati dalla gabbia. Mi sbaglierò, ma con i Bizarro e il loro Hello Hell è tornato quello che da queste parti mancava da un po’. Lo spettacolo. E visto che è interamente scaricabile, gratis, da m i d f i n g e r. n e t , n o n r e s t a c h e cliccare senza sensi di colpa. Spettacolare! (7.2/10) Carlo Pastore Nada e Massimo Zamboni - L’apertura (EDEL, novembre 2005) Ta n t o s o r p r e n d e n t e e b e l l o f u i l tour imbastito da Nada e Zamboni la scorsa stagione, che certo meritava una testimonianza discografica. Naturalm e n t e m a n c a a q u e s t o L’ a p e r tura la “presenza” scenica della cantante toscana, corpo da bambola tenera e sciroccata, logora e sensuale, folle e bambina, bella di vita ormai sbrigliata, irrecuperabile. Se volete, una Marianne Faithful nostrana, e senza paura di esagerare. Zamboni invece, penso lo sappiate, sul palco è uno inversamente proporzionale alla densità di quello che suona: se solo potesse, se ne starebbe volentieri dietro le quinte a ordire i suoi incubi e i suoi stupori sonici. Ma a noi sta bene così, e a Nada credo pure, visto come le sue canzoni – sette su undici in scaletta – si giovano di quelle rifrazioni sintetiche, di quell’ululato “interiore” di chitarra, dei ruggiti e degli ologrammi. Interferenze estetiche che ben si sposano con la poetica da “malanima”, traslandola su un piano di allarmante attualità. Più che emblematiche in questo senso Chiedimi quello che vuoi e Tutto l’amore che mi manca, dove l’asprezza accorata della cantautrice trova carburante e comburente nei bassi turgidi, nelle trame ra- denti e scabre di tastiere e chitarre, oppure – soprattutto – quando nella conclusiva Le mie madri la teatralità si consuma visionaria e febbricitante tra robotici tribalismi e pulsazioni motorizzate. I pezzi firmati Zamboni a loro volta guadagnano in fisicità, s’inclinano blues con fare ombroso e acido (Da solo), masticano punk la desolante afflizione (Ultimo volo America, che nell’originale era allucinata profezia), sottolineano l’ebbrezza sofferta della questione (Miccia prende fuoco, con breve intro - recitato dallo stesso chitarrista - che rafforza i sospetti di “dedica nascosta” al Ferretti). Resta da dire di quella Trafitto che, d a b u o n f a n t a s m a C C C P, è uno schiaffo teso e cupo, mitigato però da una certa dose di saggezza, l’invettiva resa più vulnerabile e passionale da una Nada ben calata nella parte (di alter-ego di Zamboni, come un tempo Ferretti). Bel disco in definitiva. Ben registrato, ben suonato, ben interpretato. (7.1/10) Stefano Solventi Need New Body – Where’s Black Ben? (5 Rue Christine / Wide, 2005) I Need New Body al terzo album incarnano come non mai il loro nomen-omen: necessitano di un nuovo corpo ma tentennano indecisi nella scelta, trasformandosi più o meno deliberatamente in spiritelli dispettosi che possiedono ora uno ora un altro cadavere, senza mai trovare appagamento. Unico tratto comune a spuntare da tutti i pezzi di Where’s Black Pen i folti baffi di Frank Zappa, a sostituire le jam kraut-psych del primo disco (più vicino alla precedente esperienza Bent Leg Fatima) e ad ulteriore evoluzione degli spunti melodici e dell’ampliamento a nuovi stili (come il bluegrass e l’electro) che già s’affastellavano in UFO (File13, 2003). Ma la schizofrenia si estende qui anche alla scelta dello stile parodistico, ora cercando di far coincidere Zappa con Beck ( Brite Tha’ Day , So St Rx), ora abbandonandosi ad un comedy-punk idealmente compreso fra Minutemen, Fugazi ed Edie Sedgwick ed El Guapo sul fronte più moderno ( M a g i c K i n g d o m , To t a l l y P o s Paas , Mouthbreaker ), ora gigionegiando in un easy-bop tipo versione faceta di Sun Ra (Inner Gift, Badoosh+Seagull War=Die) ora cazzeggiando fra recuperi post-electroclash in odor di Juan MacLean (e ci verrebbe da citare i nostrani Faresoldi), fino a puntare a brevi centrifughe parossistiche à la Oneida (Pax-N-Half, Juvie Girlz/Ghost Of Bistro/ Hairfunny ). Ne risulta un confusionario e generalistico zapping fra generi incongrui, impressione sollecitata anche dalla brevità dei brani e dalla mania dello stacchetto. Un pasticcio che nel complesso lascia un po’ l’amaro in bocca dopo le passate improvvisazioni “incredibly strange psych” ma anche a fronte di alcuni episodi veramente riusciti nel sincretismo fra capra e cavoli, perle di un linguaggio nuovo che installa strutture rock e country su scheletri di suoneria da cellulare come Eskimo (ricordare i Residents è pleonastico). Con questo pot-pourri i Need New Body sembrano aggiornare lo spirito zappiano all’epoca dell’emul-rock, a meno che non si siano trasformati a loro volta in un’emulazione di Zappa. Misteriose scatole cinesi della ripetizione post-postmoderna che di sicuro non ci faranno perdere il sonno alla notte. (6.3/10) Lorenzo Filipaz One Starving Day - Broken Wings Lead Arms To The Sun (Planaria Recordings, novembre 2005) Da un po’ di tempo stiamo assi- sentireascoltare 51 recensioni Shout Out Louds Howl Howl Gaff Gaff (Capitol / Budfox, settembre 2005) A volte succede il miracolo: un semplice disco indiepop, per lo più influenzato da un certo numero di altri dischi indiepop, ti parla. Ti mette all’angolo, ti afferra, ti fa ballare. E quando ha finito di scuoterti, di riempirti, sembra quasi chiederti di investigare la sua algebra sonora solo apparentemente decifrabile, di comprendere il suo teorema. E’ così che, armati di pazienza, curiosità e costanza si penetra in Howl Howl Gaff Gaff, il lavoro di debutto degli svedesi Shout Out Louds. Un lavoro molto più intenso, pregnante e significativo di quanto ci potrebbe aspettare. E’ vero, le canzoni di questo disco (che è un disco, come si dice, “di canzoni”) non sono particolarmente differenti quanto a forma e sostanza dai momenti più tondi ed efficaci di certa discografia di Bright Eyes, dagli anthems casalinghi dei Lucksmiths o dalle nenie sincopate dei Belle & Sebastian; ma dopo avere saltato per mesi su pastiches d’ecc e z i o n e c o m e 1 0 0 ° , Ve r y L o u d o P l e a s e , P l e a s e , P l e a s e , f r a m m e n t i c o l o r a t i p e r f e t t a mente colorati e compiuti, ci si accorge di avere realmente a che fare con i pezzi di un puzzle. Dunque, sembra quasi necessario tirare ancora una volta fuori la vecchia, abusata ma sempre affascinante etichetta di “concept album”: sciogliendo il rebus composto dal nome della band, il nome del disco – un non-sense quasi onomatopeic o - e d i t e s t i t a n t o d e i p e z z i g i à c i t a t i ( Ve r y L o u d è i l r a c c o n t o d i u n a r e l a z i o n e t r a una persona che parla troppo ed una che è decisamente stanca di parlare) quanto di There’s Nothing (“there are words that never should be said, but there’s nothing I can do about it ‘cause the words are always in my head”) oppure la programmatica Oh, Sweetheart (“whatever I said, I didn’t mean it; whatever I said, I take it back”) viene fuori una piccola opera sulla non-comunicazione, o piuttosto sulla non-comunicabilità. In altre parole, è come se il disco intero degli Shout Out Louds fosse un cubo di Rubik che confonde e ricompone nient’altro che la sensazione spiacevole di voler davvero gridare a squarciagola quello che si prova - anche se ogni volta viene fuori non meno sconnesso e confuso di un qualsiasi howl howl gaff gaff. (7.2/10) Marina Pierri sentireascoltare 52 stendo alle evoluzioni di molti gruppi che partendo dall’hardcore, emanano la loro musica verso lidi che si possono definire progressive-rock. Il passato recente, con l’affermarsi di gente come Cave-in e Isis e Pelican , sembra voler dire questo e i nostrani One Starving Day vogliono confermare la “tendenza” (anche se è giusto ricordare che i il gruppo nasce ben prima dell’affermarsi del genere), registrando un disco di progressive-core, ma non temano i puristi: non stiamo parlando di pirotecniche frasi in controtempo, febbrili e spastiche (quelle lasciamole a i M a r s Vo l t a … ) , m a d i m u s i ca che dal progressive prende l’ estetica della suite (quindi brani lunghi e multiformi) e certe partiture elettroniche che ammiccano, omaggiano il prog cosmico dei primissimi anni ’70 dei più primitivi Ash R a Te m p e l , i Ta n g e r i n e D r e a m “meditativo-elettronici” ed Amon Duul I/II. Questi i suoni che un ascolto attento suggerisce, poiché - occorre dirlo - la prima impressione che suscita Broken W i n g s L e a d A r m s To T h e S u n è di un incontro / scontro tra Neuroris e Godspeed Yo u ! Black Emperor (gente comunque non lontana dal prog..), post-rockismo d’antan (A Minor Forest), nuova scuola hard-core statunitense (Isis in testa) e disperazione Swansiana. Ma al di là dei riferimenti stilistici, un disco è prima di tutto un’esperienza, e quella dei OSD è esperienza sonora allo stato puro: il gruppo di Pasquale Foresti (ideatore del progetto nel lontano 1997) emana dolore e oppressione, estasi psichedelica corrosa dalla sofferenza, un mantrico urlo liberatorio in crescendo doom-neurisis-iano ( Leave), trafitto da violini gotici (l’eccezionale apertura di Black Star Aeon ), trialismi sciamanici (Secret Heart) visioni nebbiose della Chicago post (Fate Drainer) e rintocchi di piano gravi come un dolore solenne (Silver Star Domain). La fine di qualcosa che amavamo, il presagire sofferente delle conseguenze: un telo nero chiude lo scenario. Tutto questo è qui, in questi solchi trafitti dal dolore. (7.0/10) Gianni Avella The Psychic Paramount – Gamelan Into The Mink Supernatural (No Quarter / Goodfellas, 19 settembre 2005 ) Forse qualcuno ricorderà una band sconosciuta, chiamata Psychic Paramount, che tre anni fa fece alcune date in Italia, di supporto a gente come Suicide e Dat Politics. La band in questione si presenta alla sua prima uscita ufficiale solo quest’anno, con questo Gamelan Into The Mink Supernatural, un disco che si prende con ferocia il proprio spazio tra i migliori debutti dell’anno. P r o v e n i e n t i d a N e w Yo r k , s o n o in qualche modo la continuazione degli indimenticati Laddio Bolocko, band di culto della scena math rock anni ’90, che vanta almeno un disco imprescindibile come Strange Warnings. Chiusa quell’esperienza, il chitarrista Drew St. Ivany e il bassista Ben Armstrong decidono di mettersi in proprio. Per il tour di tre anni fa reclutano come batterista l ’ e x N m p e r i g n , Ta t s u y a N a k a tani, trovando poi la line-up d e f i n i t i v a c o n J e f f C o n a w a y, già nei Sabers (band con un disco su Neurot). Il risultato finale è un’enfatizzazione spregiudicata degli elementi più ritmici e rumorosi dei Laddio Bolocko, che lascia perdere del tutto le componenti jazz, per un accelerazione continua, stordente, maniacale, che non dà respiro. Nonostante questo, la musica dei newyorkesi, almeno concettualmente, è più vicina al prog e allo space rock, che non al noise delle band su Load (Lightning Bolt, Noxagt, Sightings), anche se qualche inevitabile punto in comune si può facilmente rintracciare. Il brano d’apertura, Megatherion, tasta il terreno sommergendo la melodia, sotto una nebulosa di distorsioni mandate in reverse, in una maniera non dissimile dai My B l o o d y Va l e n t i n e . Ma è solo l’introduzione, perché il brano successivo, Para5, incalza con veemenza attraverso un furibondo tappeto percussivo e una chitarra in primo piano che parla gli argomenti classici dell’hard anni ’70, dai Blue Cheer agli Mc5. Echoh Air è solo un oasi di calma apparente, con minacciose mareggiate di feedback chitarristico che preparono l’excursus di X-Visitations, un brano degli Hawkwind brutal i z z a t o d a i B o r e d o m s . L’ i n t e ro canovaccio del disco viene riassunto nella conclusiva title track, che parte quieta e ragionata come se uscisse dalle mani dei King Crimson, per poi andare rapidamente a perdersi in una tempesta di distorsioni da cui non si esce che con le orecchie a pezzi. Gli Psychic Paramount sono encomiabili. Portano tutti gli strumenti alla pazzia e fanno rumore per il puro piacere di farlo, ma facendo bene attenzione a non perdere le tracce di un ipotetico discorso melodico. La colonna sonora ideale per le prossime Guerre Stellari. (7.3/10) Antonello Comunale Psycho Sun – Silly Things (Urtovox / Audioglobe, 2005) L’ i m m a g i n a r i o c h e p r e n d e c o r po tra queste tredici canzoni degli Psycho Sun è lo stesso di un famoso videoclip che qualche anno fa spopolava tra l e f r e q u e n z e d i M t v. E r a u n brano dei Something Corporate, in cui la band suonava il più classico dei giri rock in quattro quarti all’interno della sentireascoltare 53 scuola dei sogni, composta da professori fessi e polverosi, fighe da capogiro e libri che finivano immancabilmente sulla testa del secchione quattrocchi-brofoloso-magrolino. Un grande party rock’n’roll in cui si celebrava la felicità di essere adolescenti in un mondo di plastica che, diciamo la verità, sa come far divertire i propri abitanti. I suoni di Silly Things sembrano affacciarsi sulla scena indie italiana con lo stesso senso di meraviglia descritto in precedenza, con in più la necessaria voglia di cazzeggio che il rock certe volte richiede per potersi esprimere nel migliore dei modi. Considerando poi il ritardo perfetto con cui si presentano – un disco garage-pop-rock che arriva quando la spinta propulsiva degli ex Libertines sembra presagire un imminente arresto per mancanza di carburante – saremmo quasi tentati di gridare al capolavoro. Perché gli Psycho Sun mostrano una buona vena compositiva che riesce ad incastrarsi nella testa, come ogni canzone pop degna di questo nome. D’altronde il lato più orecchiabile del gruppo è quello che dà i risultati migliori. Time è una zattera che si inoltra in un ambiente fatto di melodie dolcissime che poi esplodono in una cascata di chitarre dis t o r t e . A b o u t Yo u r M a n s e m bra un bel reperto che proviene dagli anni Settanta. Ben And Cicely è il pezzo più bello della raccolta, in grado presagire un futuro di tutto rispetto per la band pugliese. Quando invece il ritmo accelera gli Psycho Sun si limitano a urla e schitarrate come un gruppo punk qualsiasi, senza deludere i fan del genere ma senza neanche colpire chi cerca qualcosa di più di un semplice “one-two-three-four”. Ma Silly Things suona comunque discretamente fresco e soprattutto sincero. E poi è 54 sentireascoltare difficile non premiare la faccia tosta di un gruppo disposto a copiare col sorriso sulle labbra il leggendario arpeggio di W i s h Yo u W e r e H e r e d e i P i n k Floyd (nel brano Something Is Happening) nell’anno della storica reunion. Stiano però tranquilli i fan di Roger Waters: a parte l’introduzione, il resto del pezzo vaga in situazioni che non hanno nulla a che fare con il complesso inglese. (6.5/10) Manfredi Lamartina The Raveonettes – Pretty In Black (Columbia / The Orchard, 2005) Genuino. E’ questo ciò che pensi ad ogni singolo ascolto di Pretty In Black, ultimo lavoro del duo danese (ormai con f i s s a r e s i d e n z a a N e w Yo r k ) formato da Sune Rose Wagner e Sharin Foo. Il nuovo e secondo album dei Raveonettes si lascia in parte alle spalle le sonorità garage di Chain Gang Of Love del 2003 (espansione di Whip It On EP datato 2002) per andare a pescare direttamente dal miglior rock originario targato anni ’50. Alla base di questo cambiamento non c’è una rivoluzione (i tratti somatico-stilistici della band sono sempre quelli), ma una più ambiziosa ricerca del suono e la missione - più estetica che sostanziale, si veda anche la copertina in stile fifties- di ripercorrere a ritroso la storia del rock fino agli albori. “Genuino” in tal senso. Canzoni come Here Comes Mary e R e d Ta n s e m b r a n o a r r i v a r e d i rettamente dal 1957 senza accusare “il colpo” di un gap di oltre 40 anni; giungono a noi pulite, lineari e fresche. E’ proprio Sune a evidenziare il distacco dai lavori precedenti: “Ho realizzato che per la gente deve esser stato difficile ascoltare album di un’ora circa basato su tre accordi in un’unica chiave”. Conclude Sharin: “Dovevamo fare qualcosa di nuovo, di diverso per questo album, per noi stessi e la nostra sanità”. Più chiari di così! Per Pretty in Black The Raveonettes hanno detto no a distorsioni e riverberi, lasciando molto più spazio alla vena cantautorale del frontman e sostituendo a hit radiofoniche delle ballad che riescono a scomodare i nomi più celebri del panorama rock e folk a stellestrisce. E’ il caso della traccia che chiude l’album If I W a s Yo u n g , c h e q u a s i c o m muove nella sua candida rassegnazione (and all I have is memories of a life / I once held dear-and all the lights are out tonight / oh how I wish I wasn’t here) e di The Heavens, che sembra un pezzo scritto e musicato direttamente da Re Elvis in persona. Un’altra prova è la schiera di guest star che hanno collaborato all’album. E’ doveroso iniziare la lista da Moe Tucker d e i Ve l v e t U n d e r g r o u n d , c h e suona la batteria in diverse c a n z o n i , t r a l e q u a l i Yo u S a y Yo u L i e e O d e T h e H e a v e n s ; v i è poi Martin Rev direttamente dai Suicide per apportare la sua decennale saggezza e competenza in Uncertain Times, e compare addirittura l ’ a t t e m p a t a R o n n i e S p e c t o r, v o c e d i O d e To L . A . P e r l a c o ver di My Boyfriend’s Back i Nostri si sono avvalsi direttamente di Richard Gottehrer - tra l’altro produttore dell’album - per ridar lustro ad una gemma della musica degli anni sessanta a ben 42 anni di distanza. Te c h n i c o l o r : q u e s t o è i n d u b biamente l’aggettivo più appropriato per definire Pretty In Black; dopo il Black & White style dei lavori precedenti Sune e Sharin confezionano un album stilisticamente impeccabile, ricercato, compiendo un triplo salto mortale in avanti. (7.5/10) M i c h e l e Va c c a r i Rogue Wave - Descended Like Vultures (Sub Pop / Audioglobe, 21 novembre 2005) Impossibile parlare di una band come i Rogue Wave senza involontariamente citare quegli Shins venuti a galla a fine 2 0 0 3 c o n l ’ o t t i m o C h u t e s To Narrow , sia per ragioni strettamente pratiche - entrambi incidono per la Sub Pop - sia per le evidenti affinità di stile che accomunano i due gruppi. Un amore per un pop a colori e con la P maiuscola, che se per questi ultimi significa intessere musica della porta accanto, di inclinazione pressoché acustica e tutto sommato piuttosto contenuta nei toni, per i Nostri vuol dire giocare con dinamiche ampie e suoni eterei, chitarre fuzzeggianti ed echoes espansivi. Chi conosce la band, di Descended Like Vultures parla, forse non a torto, come una via di mezzo tra i Fleetwood M a c , N e i l Yo u n g e i M y B l o o d y Va l e n t i n e , a n c h e s e s i n t e t i z zare in due parole una formula musicale dallo spettro stilistico tanto ampio ci pare piuttosto riduttivo. Meglio sarebbe affrontare i brani del disco uno ad uno, lasciandosi magari cullare dalla ritmica pacata e le stilettate in distorsione di Bird On The Wire, ondeggiando il capo al refrain rubato ai R.E.M. di Publish My Love, scivolando tra i rapidi arpeggi di chitarra e i coretti lisergici di Catform. L’ o p e r a r a c c o g l i e s p u n t i d i ottima qualità, equamente distribuiti tra ballate suadenti e r i p a r t e n z e q u a s i s h o e g a z e r, parentesi acustiche e pop magniloquente, melodie che talvolta richiamano le malincon i e d e l g i à c i t a t o N e i l Yo u n g (come nel caso di Medicine Ball ) o che mostrano di apprezzare la lezione dei Mojave 3 (California). Quella del secondo episodio a nome Rogue Wave è una molteplicità di aromi dal fascino immediato e persistente, un vissuto musicale che potrebbe apparire persino pretenzioso, non fosse sorretto da un consistente lavoro di produzione, pregevoli doti compositive e una forte autocoscienza. Un’ autocoscienza che permette ai quattro musicisti americani di concepire con chitarra, basso, sintetizzatore, wurlitzer e batteria un’idea di pop a metà strada tra college radio e sonorità indie, richiami al grunge più melodico e velleità psichedeliche.(6.9/10) Fabrizio Zampighi Shooting At Unarmed Man - Soon There Will Be Shooting At Unarmed Men (Too Pure/ Self, 2005) In un momento in cui etichettare una band come perfetto esempio di indie rock potrebbe portare a seri abbassamenti delle vendite, gli Shooting At Unarmed Man scelgono volontariamente di impelagarsi in un suono fra il lo-fi dei Pavement ed il punk dei M c L u s k y. E d i n f a t t i i l t e r z e t t o intestatario del progetto vede affiancati Jon Chapple, Simon Alexander e Steve Morgan, tutti decisi a rendere sbilenchi e ubriachi i brani inclusi nel loro album d’esordio. Tra una ballata un po’ stonata, qualche urletto da live esagitato e chitarrine oblique che hanno fatto la fortuna delle band statunitense di metà anni novanta, il disco scorre bene senza riuscire ad esaltare né annichilire; ma per superare una semplice sufficienza, gli Shooting At Unarmed Man avrebbero davvero bisogno di sconvolgere radicalmente la loro musica. (5.0/10) Michele Casella Carlo Spera & - Sto correndo 2005 ) Stereonoise (Videoradio, Progetto coraggioso quello di Carlo Spera & Stereonoise, stando a quanto riportato sul l o r o S i t o U ff i c i a l e : “ L’ i d e a è quella di dare un nuovo contri- buto alla musica italiana fondendo influenze musicali che vanno dal Jazz al Blues, dall’elettronica anni ’80 alle nuove tendenze del techno pop e dell’improvvisazione elettronica, dal rock progressivo alla psichedelia, fino ad arrivare alla canzone d’autore”. Alcuni di questi elementi li troviamo nelle 15 tracce di Sto correndo:breakbeats e spunti elettronici incontrano il suono jazz della tromba di Mario Massa, la voce di Carlo Spera offre brevi melodie (a volte quasi dei recitati), mentre al chitarrista Maurizio Marzo spetta il compito di agganciare le sonorità progressive, funky e rock. La produzione è buona: suoni puliti e sempre ben bilanciati permettono di apprezzare i diversi apporti rintracciabili nelle singole tracce; la cura e la brillantezza del suono conferiscono al tutto una patina pop. Certo l’idea che sta alla base del lavoro è coraggiosa, ma non facile da mettere in pratica senza rischi che, in questo caso, si traducono in una mancanza di originalità (nei testi e negli apporti della voce) e in una sensazione di “già sentito” dovuta al ripetersi di alcune sonorità elettroniche. Tutto funziona meglio nei brani più veloci e in quelli più curati nelle sonorità, nei momenti in cui interviene la voce della tromba o la chitarra ad animare il sound. A scapito del lavoro va anche la sua lunghezza totale e quella dei singoli brani: meglio sarebbe stato concentrarsi su un numero minore di tracce più brevi, ampliando la timbrica usata. Insomma un’opera prima che lancia una bella sfida senza riuscire a vincerla del tutto; l’obbiettivo – arduo – di unire tutti gli elementi musicali che dovrebbero creare il suono degli Stereonoise viene perseguito senza provare fino in sentireascoltare 55 fondo a sperimentare. Per chi volesse farsi un’idea sul sito è posssibile ascoltare alcuni mp3. (6.2/10) Andrea Erra Starsailor – On The Outside (Emi, 17 ottobre 2005) A quattro anni dal debutto, il momento magico degli Starsailor è ormai un ricordo, anche se Walsh e amici hanno assaporato il successo anche oltreoceano grazie al singolone s p e c t o r i a n o F o u r To T h e F l o o r . Il terzo disco della band di Wigan viene così registrato a Los Angeles con Rob Schnapf (co-produttore, tra gli altri, di Elliott Smith), con l’intenzione dichiarata di dare una sterzata al loro percorso. Dopo le afflizioni folk di Love Is Here e le ambizioni produttive di S i l e n c e I s E a s y, g l i S t a r s a i l o r cercano di reinventarsi come rock band, inasprendo i toni e cercando un mordente che latitava dalla loro musica. In The Crossfire sfoggia da subito un suono corposo e aggressivo; un brano con una certa personalità (non a caso è il singolo apripista), ma attenzione, gli ingredienti sono comunque quelli noti: liriche tormentate, rabbia adolescenziale (alla Creep) e piglio da melodramma (“I don’t see myself when I look in the mirror / I see what I should be”). Un vestito nuovo per la solita cerimonia, in pratica; non basta rivestire di psichedelia le solite ballatone o cavalcate, magari mettendoci dentro un po’ di groove, si rischia solo di fare ulteriori danni, come nello pseudo-grunge di Faith Hope Love o nello psych di marca Six By Seven / Spiritualized Way Back Home (con bello sfoggio di artifici di produzione vecchi di una decina d’anni); vanno un po’ meglio In My Blood, Get Out While Y o u C a n e K e e p U s To g e t h e r (prima di scivolare pericolosamente dalle parti della Pride degli U2), che rispolverano lo 56 sentireascoltare spleen buckleyano degli esordi, ma è un film già visto. Le vibrazioni soul di I Don’t Know e White Light finiscono per risultare quantomeno piacevoli, ma non si può aggiustare un giocattolo già rotto. Almeno, non stavolta. (4.0/10) Antonio Puglia Velma - La Pointe Farinet, 2949 m. (Monopsone / Wide, ottobre 2005) Coloro che hanno apprezzato i t r e a l b u m l i c e n z i a t i d a i Ve l m a dal ’97 al 2003, e in genere tutti gli inveterati amanti del trip-hop, non faranno fatica ad innamorarsi di questo La Pointe Farinet, 2949 m. Non un passo indietro, non un cedimento rispetto ai dettami del genere – le trame apocalittiche, l’angoscia oppiacea, la voce aliena e monocorde. Nessun timore di obsolescenza, anzi. C’è un più deciso lavoro sulla fibra sintetica, che crepita e sfrigola, spampana farragini e vapori fiabeschi, mastica una tensione corrosiva popolando di graffi western i margini delle canzoni (piuttosto azzeccata la scelta del guru electro Locust - al s e c o l o M a r k Va n H o e n - a l l a produzione). Un impasto frastagliato che non si affronta a cuor leggero, che non ha alcuna intenzione di affrancarsi (di affrancarti) dalla consapevolezza d’un mondo tragico. E che tuttavia abbaglia con quei cromatismi densi, seducendo col folto sovrapporsi di trasparenze androidi e brume industrial. Non è solo questo. E’ che la compagine di Losanna assorbe tutto ciò che confina con la propria premessa poetico/ estetica al modo di una spugna radioattiva, che sia il tipico torpore angoscioso circ a T h o m Yo r k e ( t r a i f r u s c i i sintetici e le pelli spazzolate di Sleeping Underwater), che siano certe cosmiche alienazioni Air (quelli più krauti in N o R i s k To B e Ta k e n e q u e l l i delle vergine suicidi in 100% Sure), che siano quei vamp plastici modello Art of Noise e quei coretti da Beta Band sotto anestesia (nell’iniziale 32 Offices). E tutto si tiene, pesantemente, febbrilmente, ma in fondo con naturalezza. Se meritano poi un minimo di rilievo la presenza di Dälek in Vo i c e s O f T h e E t h e r ( i n s i d i o samente post-electro) e la curiosa cover di Metropolis dei Motorhead (sempre in chiave Air-Massive Attack), va invece ben rimarcata la stupenda coppia finale Private Perfection e Run, la prima una lunga processione di cineserie e grugniti, arpeggi ripescati dai Radiohead periodo The Bends e folate The Edge, la seconda una sorprendente, fragile bossa per chitarra acustica, voce e piano, il pathos che si coagula come in certi languidi disarmi dEUS. Bravi quindi i Ve l m a , a b b a s t a n z a c o c c i u t i d a coinvolgere, magari non sorprendenti però intensi. Credibili anacoreti del trip-hop. (6.8/10) Stafano Solventi Martha Wainwright – Self Titled (V2, 2005) Dici Wainwright e pensi Rufus. Dici “sorella di Rufus” e pensi che non sarà mai al livello del fratello. D’altronde è sempre la solita storia. Per un artista è dura resistere al peso delle influenze musicali, che ogni anno fanno più vittime del virus dei polli. Figuriamoci se poi le lunghe ombre dei paragoni scomodi te le ritrovi addirittura dentro casa. Difficile quindi che la più piccola della famiglia Wainwright possa sfuggire al gioco al massacro del “chi ricorda che cosa”. Ta n t o p i ù c h e q u e l c o g n o m e è universalmente riconosciuto come garanzia di qualità. Il problema, però, è che questo disco di Martha Wainwright soffre delle aspettative che inevitabilmente ha generato. Ti immagini brani talmente recensioni The Boy Least Likely To The Best Party Ever (Too Young To Die, 2005) Prendete due ragazzi provenienti dalla annoiata provincia inglese, fate pure che siano appassionati del pop stralunato e casalingo delle indie britanniche degli ’80 (C86, Sarah, Postcard), metteteci anche un bel debole per classici della letteratura per l’infanzia come Winnie The Pooh. Fatto? Ok, ora chiudeteli in una stanza con gli strumenti più disparati (xilofoni, banjo, percussioni, armoniche etc), spruzzate nell’aria molecole di spensieratezza e giocosità (anche LSD va benissimo), e avrete T h e B e s t P a r t y E v e r, i l v o s t r o d i s c o d i i n d i e p o p f a t t o in casa. No, non è una puntata di Art Attack, ma ci somiglia parecchio. Già , perché ai nostri Pete Hobbs e Jof Owen da Wendover in Buckinghamshire, in arte The Boy Least L i k e l y To , d i c e r t o n o n d i f e t t a n o f a n t a s i a , c r e a t i v i t à e u n a s a n a a t t i t u d i n e l u d i c a . U s c i t o s o l t a n t o i n U K p e r l a l o r o To o Y o u n g To o D i e , q u e s t o d e b u t t o n o n h a a n c o r a avuto una distribuzione vera e propria, ma è già un piccolo fenomeno che ha fatto drizzare le orecchie ai più attenti seguaci del pop indipendente, e non è difficile capire il perché. A partire dall’artwork fino ai titoli dei brani, viene evocato tutto un immaginario che va dai racconti per bambini agli Smiths, dalle festicciole a scuola a i c u l t i p o p - d a - c a m e r e t t a Va s e l i n e s e P a s t e l s , d a l l o z u c c h e r o f i l a t o e p a l l o n c i n i a i viaggi spaziali di Barrett, in una girandola di stili, melodie e arrangiamenti eccentrici il giusto, ma mai sopra le righe. Ecco quindi snocciolate una dopo l’altra - come le m&m’s - canzoncine che trattano, con candore infantile misto a humour quasi demenziale, la perdita dell’innocenza, la paura di crescere (Fur Soft As Fur), perfino della morte (Sleeping With A Gun Under My Pillow), tutto però affrontato con una certa vena surreale, in chiave giocosa e vagamente psichedelica. Almeno metà di queste canzoni, in un mondo ideale, sarebbero dei singoli perfetti: vedi Monsters (un incubo infantile come l’avrebbero visto dieci anni fa i Folk Implosion), o Paper Cuts (che singolo in effetti lo è davvero, e giustamente), o le scintille Go Betweens di Be Gentle With Me e il ritornello-tormentone I’m Glad I Hitched My A p p l e W a g o n To Y o u r S t a r ( s c i o c c a , c a r a m e l l o s a e i r r e s i s t i b i l e c o m e u n a s i g l a d e i cartoni), per poi ritrovare in I See Spiders When I Close My Eyes quella naiveté mista all’ironia agrodolce di Morrissey - come altro definireste un verso come: “I’d love to go to S.Francisco, but I’m too afraid to fly” - che si poteva incontrare nei Belle & Sebastian di un tempo (evocati esplicitamente anche in Hugging My Grudge e The B a t t l e O f T h e B o y L e a s t L i k e l y To ) . Insomma, uno di quei dischetti che nasce per pochi intimi (alla Tigermilk, per intenderci), da cui, chissà, potrebbe scaturire prima o poi un universo a parte. Semplicemente delizioso. Occhio al livello del diabete, però. (7.2/10) Antonio Puglia sentireascoltare 57 belli da farti male ma ti ritrovi un pugno di pezzi che vagano nel deja-vu folk-pop. Senti il bisogno di esplorare nuove prospettive e nuovi significati della parola “emotività” ma dallo stereo esce soltanto una bella voce. Vuoi riscoprire un suono che sappia essere fedele cronista dei tuoi stati d’animo ma poi ti rimangono semplici giri di chitarra acustica tra le mani. Ad esempio, Bloody Motherfucking Asshole – una specie di Bella stronza al maschile – sembra la solita filippica anti-fidanzato declinata al tempo del folk. The M a k e r, d i c o n t r o , è p i ù s o b r i a nelle sonorità, e proprio per questo ha un esito migliore. Il risultato, alla fine, è una mezza delusione. Soprattutto perché l’autrice dimostra a volte – sarebbe stupido non riconoscerlo – di avere comunque ereditato il gene Wainwright, come nel caso della deliziosa tenerezza di These Flowers. Solo che, presa dalla furia di mettere sul fuoco quanta più carne possibile, non è riuscita a mantenere ferma la barra sull’obiettivo di sempre: emozionare. Diluire quindi in sessanta minuti il proprio talento non è una mossa raccomandabile, specie quando le atmosfere dei pezzi si assomigliano pericolosamente. È come voler fare una cena per venti persone solo con un po’ di zuppa. Se allunghiamo il brodo con acqua abbondante magari riusciamo a garantire venti porzioni uguali, ma difficilmente i nostri ospiti ne apprezzeranno lo sforzo. Se invece avesse giocato di sottrazione l’album ne avrebbe tratto giovamento. Così non è stato, e, benché la sufficienza sia raggiunta, si prospetta purtroppo una sconfitta – seppur di misura – non solo nel confronto col fratello (presente in Bring Back My Heart, una delle canzoni migliori del lotto), ma anche con altre cantautrici che negli ultimi tempi 58 sentireascoltare hanno colpito come e più di quanto abbia fatto Martha. Il riferimento è per Liz Janes e Hanne Hukkelberg, che senza la stessa copertura mediatica garantita alla Wainwright hanno saputo – loro sì – emozionare e coinvolgere.(6.0/10) Manfredi Lamartina We Are Scientists - With Love And Squalor (Virgin / Emi, 17 ottobre 2005) Insomma, ai We Are Scientists, prodotto mediatico confezionato alla perfezione a partire dalla bella presenza dei componenti fino alla leziosità dell’artwork, non manca niente per vendere, e bene se n’è accorta l’industria vera e propria, dal momento che il debutt o d e l l a b a n d è m a j o r, Vi r g i n , per la precisione. (5.8/10) Marina Pierri A quest’ora dovremmo essere stanchi delle band come i We Are Scientists. La fabbrica di NME e del circuito pseudo punkfunk anglo-americano continua a sfornare pacchetti sonori analoghi in tutto e per tutto a With Love And Squalor da almeno due anni - se pensiamo che l’ A.D di gene- White Hassle – Your Language (Fargo / Self, 2005) re è stato il 2003 con l’uscita di Echoes dei Rapture, lavoro che si è fatto seguire da una schiera praticamente infinita di epigoni. Proporne una lista è pleonastico, ma tanto per fare qualche nome: Moving Units, Editors, Killers, Chikinki ed in tutta probabilità un’altra quindicina di formazioni di ventenni agguerriti di cui si è già persa traccia e memoria. Date queste premesse, il giudizio deve slittare dal numero - indiscutibilmente alto - di prodotti per lo più appetibili che cavalcano l’onda fortunata del post-punk, alla qualità. Il trio di Brooklyn, NYC (ma và?), non propone assolutamente niente di nuovo. Le canzoni sono dinamiche, piacevoli, ben prodotte, del tutto integrate nel “movimento” di cui rispettano con tanta puntigliosità i requisiti. Gli arrangiamenti sono squisitamente analogici, M T V- f r i e n d l y, catchy come in Cash-Cow; il cantato scimiotta spesso, in maniera peraltro piacevole, gli Hot Hot Heat, come in Worth The Wait; i testi sono universali e qua e là molto ben scritti - In Action e This Scene Is Dead su tutti. tradizionale; ma da qui a considerarlo - come fa qualcuno - un brutto disco ce ne passa. Perché il nuovo episodio a nome White Hassle è tutto fuorché brutto, nonostante proponga musica alla good old boys e non aggiunga molto in termini di ricerca ad un genere ormai legato al mondo dei ricordi; palesi senza vergogna gli evidenti antecedenti stilistici e dichiari apertamente le proprie infatuazioni. Merito delle potenzialità melodiche e dell’immediatezza dei brani, di una tendenza ad occuparsi di poche cose ma nel modo giusto, del suo destreggiarsi abilmente tra i richiami estetici più evidenti e quelli meno noti. Tra i primi il country e il blues, spina dorsale nonché minimo comune denominatore del disco mentre nella seconda categoria rientrano il Beck di Odelay e i Modern Lovers del disco d’esordio. E’ proprio questo, forse, il valore aggiunto dei White Hassle, il saper fondere armoniosamente suoni tradizionali e elementi musicali più recenti, approccio classico alla melodia e toni irriverenti, nell’ottica di una proposta Yo u r L a n g u a g e n o n s a r à f o r s e un capolavoro di originalità e coraggio, non avrà magari la fortuna di rientrare nella top ten di fine anno e con ogni probabilità non muoverà a stupore gli ascoltatori più scafati con il suo roots-rock piuttosto recensioni Wilco Kicking Television: Live in Chicago (Nonesuch, novembre 2005) Questo doppio live dei Wilco ha tutta l’aria di voler chiarire a critica e fans lo stato dell’arte della band. Scossa da importanti cambi di formazione – alle chitarre ci sono Nels Cline e Pat Sansone, mentre Mikael Jorgensen si occupa di pianoforte e tastiere – e più ancora dalla svolta “poetica” ed estetica (nel segno dell’eredità lasciata da “prezzemolo” O’Rourke) degli ultimi due lavori, Tw e e d y e s o c i s e m b r a n o a v e r d e f i n i t i v a m e n t e e s a u r i t o l’aura no depression di antica memoria Uncle Tupelo. Si r i f l e t t o n o a n z i s e m p r e p i ù n e i t r a v a g l i e s i s t e n z i a l i d e l l e a d e r, i l c u i l a c o n i c o i n t i m i smo conserva vivaddio quel taglio genuino e visionario, quella delicatezza fragile e o m b r o s a c h e s a f a r s i c a r i c o d i i s t a n z e “ e p o c a l i ” s e n z a i n c i a m p a r e n e l l a r e t o r i c a . Ve r o e proprio manifesto di questo disagio, Ashes Of American Flags è uno dei pezzi cardine del live act, con la chitarra come una crepa nel cuore, l’onirico languore delle tastiere, tutto un sogno seventies trafitto dal mesto, struggente assolo di chitarra. Quanto al resto, sappiate che su ventitrè pezzi in scaletta soltanto sei non fanno p a r t e d e l d i t t i c o Ya n k e e H o t e l F o x t r o t / A G h o s t I s B o r n : s e n o n s i t r a t t a d i u n ’ a b i u r a delle vecchie cose, le somiglia abbastanza. A parte questo, occorre dire che le tracce sono rese con trasporto e professionalità, riarrangiando quel poco che occorre, talora concedendo qualche preziosismo sonico (la misteriosa luminosità del synth ad i n t r o d u r r e I A m T r y i n g To B r e a k Y o u r H e a r t o l e b r u m e i n d u s t r i a l n o i s e d a c u i s o r g e Wishful Thinking), irrobustendo le trame come da copione (ad esempio la divertita ebbrezza country-funk di I’m the man who loves you e l’intrigante vaudeville di Hummingbird). Si dimostrano abili i Wilco – ma non è una sorpresa - sia quando c’è da mordere il freno (la dolente tenerezza di Via Chicago, la fragranza minstrel folk - r i s p o l v e r a t a d a M e r m a i d A v e n u e - d i O n e B y o n e e A i r l i n e To H e a v e n ) s i a q u a n d o va sbrigliata l’elettricità (la chitarra che divora spazio emotivo in coda a Muzzle of b e e s , l ’ a r t p u n k p a r o s s i s t i c o d i K i c k i n g Te l e v i s i o n ) . M e g l i o a n c o r a s e q u e s t o c a p i t a nel volgere della stessa canzone, come nella delicatezza melò di At least that’s what you said, squadernata in un crescendo elettrico esplosivo. Il canzoniere è di tutto rispetto, ti molla una carezza e un ceffone, un ceffone e una carezza, così fino a quella Comment - cover di Charles Wright – che chiude in una luce sì speranzosa ma in cuor proprio dimessa. Forse troppo. Già, perché qui sta forse l’unico rischio ravvisabile nell’entità Wilco: che in quel disarmo si esauriscano e alla lunga ci esauriscano, che da loro non ci si possa attendere altro che l’ennesima variazione della stessa accorata disanima. Ma è un rischio che vale la pena correre. (7.1/10) Stefano Solventi sentireascoltare 59 musicale varia, orecchiabile e mai noiosa. A dimostrarlo gli ammiccamenti alla Nashville tutta stivali e cappelloni di H a l f w a y d o n e W i t h T h e To u r , l’armonica blues di Vo d k a Ta l k i n ’ – u n a s o r t a d i v i a d i mezzo tra il già citato Beck e la Not Fade Away dei Rolling Stones , i toni semiseri e s c r a t c h a n t i d i Yo u r L a n g u a g e e Yo u ’ d B e S u r p r i s e d - J o nathan Richman impegnato a giocare con mixer e piatti , la dolcezza malinconica di ballate come Neon, Not The Night, il Bob Dylan più ritmico di Sweet Eloise. Una raccolta di brani che forse non farà dei newyorkesi la next big thing di turno o degli idoli stagionali del popolo indie ma che crediamo riveli una band capace di confezionare musica coinvolgente e gradevole, fatta con pochi mezzi ma inaspettatamente lucida. (6.3/10) Fabrizio Zampighi Wooden Wand And The Vanishing Voice – Buck Dharma (5Rue Christine/Goodfellas, 13 Settembre 2005 ) Il 2005 è stato un anno cruciale per James Thot, in arte Wooden Wand. La chiusura della P o l y a m o r y, l’etichetta che nell’ormai lontano 1996 allestì in modo spartano con To v a h O ’ R o u r k e ( m o g l i e d i John Olson dei Wolf Eyes e motore creativo dei Dead Machines), ha coinciso quest’anno con il passaggio a 5Rue Christine. Un po’ come andare ad incidere per una major per uno cresciuto a cassette e CDRs. In aggiunta a questo, ci sono state una serie di ristampe, che hanno reso la reperibilità di alcuni dischi (Xiao in particolare) qualcosa di meno avventuroso. Molti hanno parlato di freefolk, ma più che imparentati a free-formers come No Neck Blues Band o Sunburned Hand Of The Man, Wooden Wand And t h e Va n i s h i n g Vo i c e s e m b r a n o 60 sentireascoltare più interessati a proseguire la stagione acida degli anni ’60, virandola verso un gotico americano sudista che li differenzia dagli altri. Il sogno lisergico dei Jefferson Airplane e dei Grateful Dead affogato nelle paludi blues e gospel di New Orleans. Buck Dharma è il primo lavoro ad avere una distribuzione degna di questo nome e come biglietto da visita non potrebbe essere più riuscito. E’ in pratica un riassunto delle puntate precedenti, che assembla un’ora scarsa di musica onirica e visionaria (1). Parte con Hideous Whisker & His Woman, uno strumentale trattenuto e abbozzato, che non sa decidersi se farsi canzone o improvvisazione per poi immergersi, con Rot On, nei loro tipici corridoi a base di chitarre riverberate. Il mantra acido di Risen From The Ashes è un po’ la continuazione della magnifica Cariboe Christ In The G r e a t Vo i d p r e s e n t e s u X i a o . La voce di Satya Sai Baba declama carismatica su un tappeto di chitarre wah wah che pur non avendo la stessa magia di Jerry Garcia, lo prend o n o a m o d e l l o . L’ o n i r i s m o del disco non viene mai meno, anche nelle successive Satya Sai Scupetty Plays “Reverse Jam Band” e Steven The Harvester Presides O’er The Din Of The-The Cups che evocano gli incubi ambientali dei Pink Floyd di Ummagumma. Owl Fowl ha un finale da rituale pagano, che fa venire in mente la collaborazione tra Michael Gira e Dan Matz, mentre I Am The One I Am & He Is the Caretaker Of My Heart è un po’ la loro White Rabbit, con Satya Sai Baba, impegnata a recitare la parte di uno stravolto incrocio tra Grace Slick e Ella Fitzgerald. Chiudono il disco due gemme nere: il folk apocalittico di Spear Of Destiny e la misteriosa e cerimoniale Wicked World che scioglie Bob Dylan nell’acido e ne fa danzare lo scheletro su percussioni voodoo. La musica di Wooden Wand And t h e Va n i s h i n g Vo i c e t r a s f o r m a il sogno hippie in un bad tripping, facendo più di qualche riferimento agli archetipi della musica americana. Adesso che hanno una distribuzione migliore, potrebbero anche essere il passo successivo agli Animal Collective e ai gruppi s u Yo u n g G o d R e c o r d s , m a s i sa… nemo propheta in patria. (7.8/10) Antonello Comunale Yo La Tengo - Prisoners Of Love: A Smattering Of Scintillating Senescent Songs 19852003 (Beggars Banquet – Matador / Self, 22 marzo 2005) Ammirati quest’estate al festival Frequenze Disturbate di U r b i n o , g l i Y o L a Te n g o p o s so essere considerati i portabandiera del rock alternativo americano. Alla soglia del ventennio di carriera i coniugi Ira Kaplan e Georgia Hublay danno alle stampe su Matador una raccolta che tenta di ricostruire la storia del loro progetto attraverso una quarantina di pezzi (la versione limitata contiene un terzo CD di outtakes), impresa come sempre ardua, a maggior ragione per una band che non ha mai avuto cadute di tono e crisi creative e nella cui produzione non è facile individuare degli hit single. Si va dal suono velvettiano di Shaker al velluto sonico di From A Motel 6, dalla sognant e l o w - f i s o n g D i d I Te l l Y o u alla soffice The Summer (pezzo uscito come unico originale nella raccolta di cover Fakebook). Al tourbillon estatico d i f e e d b a c k d i B a r n a b y, H a r dly Working si contrappone la gemma acustica Stockholm Syndrome, arricchita dal falsetto del bassista James McN e w . G l i Y o L a Te n g o h a n n o esplorato ogni anfratto della musica indie senza cadere nella banalità, assimilando spesso il suono del momento per darne un’interpretazione personale e sperimentale. M e m o r a b i l i N u c l e a r Wa r, c o v e r d i S u n R a u s c i t a i n i z i a l m e n t e i n q u a t t r o v e r s i o n i d i ff e r e n t i , l ’ o r g a n o d i A u t u m n S w e a t e r ( c h e a p p a r e i n u n r e m i x d i K e v i n S h i e l d s ) e B l u e L i n e S w i n g e r, c a m a leontica suite ricca di cacofonie e riverberi, inno al rumore che chiudeva Electr-O-Pura. Un album da procurarsi se si ha premura di gustare in un sol boccone l’evoluzione della band dal 1986 a oggi, da affiancare magari a Human Amusements At Hourly Rates dei Guided By Vo i c e s ( c h e c o n i N o s t r i e i S e b a d o h f o r m a n o l a “ s a c r a t r i a d e d e l l ’ i n d i e r o c k ” ) . F o r s e m e g l i o mettersi a caccia dei singoli dischi in offerta o usati. Io consiglio di iniziare a scoprirli attraverso l’esordio Ride The Tiger o I Can Hear The Heart Beating As One, senza fretta.(6.0/10) Paolo Grava Animal Collective dal vivo Animal Collective - Circolo degli Artisti, Roma (3 novembre 2005) Curiosità, impazienza, euforia. Queste le sensazioni dominanti, stasera. La più sorniona e animalesca band psichedelica del momento inaugura il passaggio in Italia proprio qui, nella Capitale. Parliamo di quattro storti personaggi di casa a Brooklyn (o più o meno sparsi per il mondo), di quattro selvaggi ragazzi bianchi che per la prima volta si ritrovano sul palco tutti insieme, di quattro figure primitive, dai tratti sfocati, senza maschere e travestimenti (come molti, in realtà, si aspettano): gli Animal Collective. Introdotti da un prescindibile Geoff Farina in versione so- sentireascoltare 61 litaria e acustica (con conseguente evasione del pubblico verso l’esterno) e dal comizio musical-politico degli Evens di Ian Mckay ed Amy Farina, tra il rispetto per l’uomo Fugazi e l’insofferenza per certi discorsi propagandistici (“Shut up and play!”, grida una ragazza di Chicago dal fondo della sala), i Nostri s’impossessano del palco e dell’attenzione di tutti i presenti con il loro folk ancestrale, con le loro cavalcate lungo savane sterminate di giochi di voci, intrecci psichedelici, furore ritmico, in un continuum che non prevede interruzioni di sorta (se non in un paio di occasioni, ma giusto perché l’aria inizia a mancare). Lo sciamano Geologist, con la sua luce da minatore sulla fronte - insieme vezzo e necessità -, è alla guida di una trance che snocciola tutto l’ultimo Feels, dall’iniziale Banshee Beat alla scorribanda rumorista di The Purple Bottle, fino alla convulsa Grass, senza dimenticare alcuni classici d i S u n g To n g s ( L e a f H o u s e , We Tigers). Il set è assieme rinascita collettiva e esperienza catartica, luminescente impasto di suoni e visioni che i Nostri, animati da una pulsione vitale che pare inesauribile, articolano in una trama che lascia ampi margini all’improvvisazione. Un approccio liberatorio e ossessivo, che tuttavia - soprattutto nei cambi di tempo e nei rilasci lisergici (ne è testimonianza più compiuta la tappa bolognese il giorno seguente) - lascia intravedere una certa asprezza, ovvero, il prezzo da pagare per un praticantato live latitante. Il bilancio è comunque positivo per gli Animali delle voci e delle vociaccie, delle chitarre e distorsori: ci mostrano l’anticamera di un mondo che appartiene all’essere umano, ma di cui non possiede ormai alcun ricordo. La natura 62 sentireascoltare e la modernità come vorremmo coesistessero sempre. Gran t a l e n t o . L’ e s p e r i e n z a a r r i v e rà. Va l e n t i n a C a s s a n o e E d o a r d o Bridda Inteferenze 2005 – New Arts festival (1 / 2 / 3 settembre 2005 – San Martino Valle Caudina) Sarà la formula gratuita, sarà la stupenda cornice di un paes e c o m e S a n M a r t i n o Va l l e Caudina, va da sé che il festival di new-arts Interferenze cresce anno dopo anno. Giunta ormai alla terza edizione, la manifestazione, che si è svolta in diverse location ubicate nel suggestivo scenario dell’area dell’exMulino (zona Capofiume), anche quest’ anno promette e conferma un cast d’eccezione, sia per la sezione audio che installazioni, video, conferenze, workshop, software art. Se la presenza dell’artista russo Alexei Shulgin, coadiuvato da Alessandro Ludovico di Neural, è il fiore all’occhiello dell’area tematica dedicata alle software-arts, e la nutritissima area dedicata ai vari tipi di installazioni (dove svetta la presenza del collettivo milanese di architetti, designers, media artists Limiteazero con l’opera Min_mod e dell’artista finlandese Kati Åberg con la video-installazione Emotions in Man) è come sempre campo che convoglia fascino e curiosità, il clou delle tre serate sono le performance live, che tra luci ed ombre riscaldano l’infreddolito pubblico per un assaggio anticipato dell’inverno (campano-elettronico) che verrà. La defezione forzata Nous (ovvero Marco Messina e Meg) permette al duo partenopeo Frame di dilungarsi in una ottima performance, guastata però da qualche piccolo contrattempo tecnico che ne vieta una finale degno. Problemi che fortunatamente lasciano il campo all’incubo Lynch-iano della norvegese Maja Ratkje e del collega (per la parte visual) Hc Gilje: un susseguirsi di umori calmo/nervosi violentati da power-elettronics e voce trattata alle macchine. Il secondo giorno si apre con la serietà di Mass (Mario Masullo) e lo stato di grazia di Populous , ma il bello arriva con trio all-female Midaircondo, una sorta di Laurie Anderson al cubo che dopo l’eccellente presenza al Sonar di Barcellona deliziano i presenti con una variegata formula tra acustico (vedi la presenza dei fiati), elettronico ed intrecci vocali à la Bjork aneroide. Al solito impeccabile e sospeso tra groove minimal/metropolitani il set di Jan Jelinek , che apre ideologicamente quello che si è rivelato il valore aggiunto dell’intera sezione live del festival: la prima assoluta del progetto Initials BB, sigla dietro la quale si celano Thomas Brinkmann e Natalie Beridze (aka Tba). Peccato però che il buon Thomas, protagonista unico del set con la graziosa Natalie relegata alla mera presenza scenica, scambi la cittadina campana per la riviera romagnola, sciorinando due ore di manieristica techno che sì rapisce il pubblico ma non allontana l’idea di pochezza complessiva (cafona secondo molti) del tedesco in veste live. D’altronde Brinkmann è cosi, prendere o lasciare! Deludenti le pose anni ’80 degli Slow Motion ed ineccepibile il dj set Ilic, che chiude ed archivia l’ennesimo successo di un festival la cui crescita esponenziale lo pone tra i più riusciti dello stivale. Gianni Avella Ardecore - Bronson (Ravenna, 23 novembre 2005) Ardecore non è semplicemente una passeggera quanto temporanea infatuazione per la tradizione degli stornelli romani, di una Roma povera ma piena d’orgoglio, quella dei reietti, dei dimenticati, dei colpevoli di troppo amore. Dalla puntigliosa operazione di rinnovamento – tutti i brani in scaletta appartengono alla tradizione musicale capitolina - nascono struggenti episodi di denuncia sociale – Come te posso amà -, suite dilatate a ff o l l a n o i l D e t o u r, u n m i n u scolo cineclub nel cuore di Roma. Un’unica sala con settanta posti a sedere, il resto in piedi, tutti in attesa della luminescenza vocale di Nina Nastasia. Ed eccola sbucare dal camerino e attraversare il corridoio di gente,che l’accoglie con un applauso scrosciante. Una sedia e un mi- una voce – quella di Giampaolo Felici - che strappa il cuore in mille pezzettini. che sfiorano territori jazz – la straziante Lupo de ’ fiume arrangiamenti quasi bandistici (La Popolana). Al centro musicisti capaci di trovarsi a memoria, dal piglio sicuro e la solida presenza on stage, padroni di un background stilistico che parte dal folk del De Andrè meno etnico e arriva a toccare mondi a prima vista irraggiungibili come quello degli spirituals. crofono, questo è il suo palco. Minuta e vestita di nero, senza quella tipica treccia sul capo, ma con la fluente chioma corvino sciolta sulle spalle, che le incornicia il viso diafano. Timidamente imbraccia la sua chitarra. Nina Nastasia come del resto non rappresenta un revival nobile e edulcorato di certo folk rionale tutto gnocchi e fettuccine. Ardecore è sinonimo di blues, musica dell’anima, impatto emotivo totale e destabilizzante, mediato tutt’al più da qualche strumento contrabbasso, chitarra, sassofono, xilofono, fisarmonica batteria - e da Questa l’impressione dopo averli ascoltati al Bronson di Ravenna. Una band compatta, dalla performance live intensa e senza fronzoli, capace di raccontare l’’essere umano declamandone le solitudini, le insicurezze, le tensioni religiose, il coraggio di continuare a vivere anche nei momenti più difficili. Storie di disperazione, storie di umili e lavoratori, canzoni d’amore strazianti, vibranti spezzoni di scenari popolari. Murder Ballads le definirebbe il buon Nick Cave, che sottolineano un universo di riferimento parte integrante Fabrizio Zampighi Nina Nastasia - Cineclub Detour, Roma (11 dicembre 2005) Non arrivano a un centinaio i fortunati che, in una fredda e umida domenica di dicembre, Questa sera è sola: lei, la sua voce, la sua musica. Con un sorriso appena abbozzato, ammette di suonare per la prima volta in un cinema. Location insolita, vero, ma perfetta per serbare e custodire germogli di un’incantevole fulgore come Dogs (Socialist, 1999, r i s t a m p a To u c h & G o / W i d e , giugno 2004), The Blackened A i r ( To u c h & G o / W i d e , a p r i l e 2 0 0 2 ) e R u n To R u i n ( To u c h & sentireascoltare 63 Go / Wide, giugno 2003). Tre piccoli, riservati album tenuti in piedi da pochi e semplici elementi (una chitarra, un pianoforte, un violino), che in questa occasione poggiano esclusivamente sulla morbidezza del suo canto, sulla linearità e sobrietà di cui è maestra. Brani come Stormy Weather e Judy’s In The Sandbox sono zucchero filato di folk fumoso c h e s i s c i o g l i e i n b o c c a , To o Much In Between è un veleno di mestizia che si mescola al s a n g u e d e l l a v i t a , Yo u , H e r And Me è una marcia sussurrata che si gonfia di dolore, Regrets è un vellutato sfarfallio jazzistico per sola chitarra, con un falsetto che si libra in aria e bruscamente si piega su se stesso, lama tagliente e affilata che infilza il cuore. Angelica nella sua oscurità, la sua grazia ha intorpidito gli occhi di tutti, infondendo un calore di cui si sentiva il bisogno. E dopo poco più di un’ora, Nina si dilegua così com’è stata accolta: veloce e discreta, tra gli applausi del pubblico. Va l e n t i n a C a s s a n o The Go! Team, Locanda Atlantide, Roma (3 dicembre 2005) Una scossa di chiassoso entusiasmo arriva finalmente a scuotere il Bel Paese, in un inverno gelido che ancora si stropiccia gli occhi e si stiracchia le ossa. Dopo la languida pacatezza dream pop di Her S p a c e H o l i d a y, o v v e r o M a r c Bianchi (un godibile intrattenimento di chitarra minimale, semplici beat elettronici e loop di archi), fischio di trombe e largo ai sei giovanissimi di Brighton, Regno Unito. Sorridenti e colorati, interscambiabili agli strumenti come le f i g u r i n e P a n i n i , i G o ! Te a m s i lanciano in una corsa a perdifiato nel guazzabuglio dell’ a l b u m d i d e b u t t o ( T h u n d e r, Lighting, Strike), trascinando con loro un pubblico - nume- 64 sentireascoltare roso e ben disposto - preso letteralmente d’assalto. Non risparmiano le energie, non lesinano un solo brano (da Panther Dash a Bottle Racket), esaltati come sono da quel diavolo nero di Ninja MC al microfono, che sembra avere polmoni d’acciaio, tanto si dimena frenetica nel suo completino da ragazza pon pon. E non è un caso che sia riuscita a strappare in più di un’occasione un timido coro dalle ugole dei presenti, frastornati da un’ora di hip hop sgangherato, con ben due batterie a tenere un ritmo spasmodico e incalzante, ché rimanere fermi e impassibili é pura utopia (Ladyflash e Junior Kickstart gli apici). Un’invasione di allegria e buon umore, con conseguente e visibile soddisfazione di tutti, ma se proprio vogliamo fargli le pulci allora diciamo pure dei volumi troppo alti della strumentazione, del suono - certo a sorpresa - saturo e potente delle chitarre, quasi una voglia di strafare che ha penalizzato non poco le voci (valore aggiunto nel disco). Colpa del fonico o meno, i l c o l l e g e p a r t y d e i G o ! Te a m funziona, devono solo macinare un po’ di strada insieme. Va l e n t i n a C a s s a n o we are demo a cura di Stefano Solventi Capita spesso che i demo siano pervasi da una smaccata, flagrante voglia di emulazione. E’ naturale. Anzi, per molti versi è un percorso opport u n o . Ta n t o , a n c h e n e l l ’ i p o t e s i estrema di un tasso imitativo da cover band, resterà sempre una differenza, non solo qualitativa (e mica per forza alla meno) ma anche sostanziale. Proprio quello scarto è il terreno (vergine?) dove piantare – volendo e se esistono - i semi della propria singolarità. Prendete i Six Red Carpets, ad esempio. Non fanno mistero di guardare al rock - senza neanche troppe pretese alternative - di Radiohead e Smashing Pumpkins, condito aggiungo io da un essenziale turgore White Stripes e da bave dark-psych vagamente Placebo. Ne risultano le tre tracce di Upon, A Ring, che confermano questa programmatica sudditanza, bazzicando però brumosi territori wave (l’angolosa veemenza della title track, tra vampe elettriche e aspersioni apocalittiche The Bends), irrisolte tensioni lo-fi (l’indolenza Pavement, gli arpeggi pixiani, la psych avariata di Love Amphetamine) e una verve fiabesca e pazzoide di stampo Elf Power (la levigata drammaticità, le allucinazioni liquide dei synth e la percussività radente della conclusiva A n i w a y ) . Vo g l i o d i r e , l ’ i n e v i t a bile tributo da pagare ai propri modelli/idoli non è – non deve essere sentito come – un limite. Non necessariamente, a l m e n o . Va v i s s u t o c o m e v i e ne, una tappa prima di qualcos’altro. I Six Red Carpets sembrano averlo capito bene. Unico appunto, la voce: lascia intravedere capacità considerevoli (una fibra irrequieta & indolenzita), ma occhio alla pronuncia. Oppure – perché no? - si faccia un pensierino a l l ’ i t a l i a n o . Vo t o : 6 . 5 / 1 0 Potremmo fare considerazioni analoghe anche per i Devocka. Anzi, di più. Questo quartetto da Ferrara - due anni di vita che stanno fruttando l’imminente debutto in lungo - mi fa pervenire un ep omonimo con cinque tracce toste, wave ghignante su cui imperversa il recitato aspro di F a b i o I g o r To s i . F a n n o p e n s a re a una versione adrenalinica dei Diaframma più bruschi (la wave marziale di Gracili istanti, decorata di arpeggi e incandescenze Echo & the Bunnymen) oppure ad un Giorgio Canali colto da feroce rigurgito CCCP (il noise al guinzaglio, i sussulti dell’invettiva, il basso stolido dell’iniziale Controllo). Devocka rimanda all’atroce Alex di Arancia Meccanica, perché in tal modo l’ineffabile drugo usava chiamare le ragazze-pollastrelle da spiumare. Ragione sociale che ben s’accorda con la parossistica crudezza di Insane (l’unico brano in inglese, dove Dead Kennedys, Killing Joke e Richard Hell sembrano un conato solo) e coi singulti marziali di Nota uniforme, sorta di noise-punk come lo avrebbe potuto intendere un Jim Morrison. In entrambe balenano squarci di angosciosa pensosità, che prendono forma di sardonica ballata in Marzo, tra incendi di corde e basso effettato, una bella voce femminile al controcanto e quel chorus che a dirla tutta tradisce ovvietà folk come certi spompi Modena City Ramblers. Sono lanciati, hanno una bella personalità, insomma ci credono. Vo t o : 6 . 9 / 1 0 Proseguiamo il discorso coi Te n i a , i l c u i e p P a r e t i d i l a n a potete liberamente scaricare dal loro sito (vedi nella sezione link) con tanto di copertina ad alta risoluzione. Tre pezzi intensi che mirano al bersaglio del blues psych italico, ovverosia secondo le rivisitazioni romantiche, languide, inquiete, veementi, nevrotiche che ne hanno dato Afterhours e Marlene Kuntz. Naturalmente la situazione è un po’ più complessa, c’è da fare i conti con quello scarto, quella peculiarità irriducibile di cui dicevamo, ciò che in fondo rende interessante la questione. Detto infatti che Polistirolo è scossone post-punk solcato da una bella vena noir e ossuta giga di chitarre, nella ballata Dossi artificiali il tipico andamento Marlene sembra sfaldarsi tra il piglio art-rock delle corde (che sembrano sfuggire al corpo stesso della canzone) e quel bridge che spalanca irose acidità, peccato solo che la melodia non brilli anzi rischi di somigliare ad un sentireascoltare 65 l e m m e c a n t i l e n a r e Ve r d e n a . Gioiellino stilistico è quindi Ancora sotto vetro, plausibile anello di congiunzione tra la compagine di Agnelli e i migliori Tiromancino, e se non ci credete beccatevi la disinvolta convivenza tra spossatezza reggae e liquori soul-rock, tra quei vocalizzi parossistici e il caracollare opalino degli umori seventies. Confesso di aspettarmi molto da loro. Vo t o : 7 . 1 / 1 0 Completiamo il quartetto con una svolta decisa. Il progetto Electro Plastic Box – moniker di Robert Nava, manipolatore di tastiere e batterie sintetiche – sboccia con disarmante anti-tempismo rispetto allo tsunami electroclash di qualche stagione fa. Tuttavia, quel cocciuto solipsismo che rischia di esserne il principale difetto è in qualche modo la sua salvezza, sfociando in una cifra espressiva efficace, essenziale, senza sbrodolamenti. Al buon Robert insomma interessa di più consumare un rito ludico/meditativo attorno alle possibilità residue del genere che non inchinarsi al tal guru o al talaltro santone. Ok, a volte sembra un po’ gli Ya z o o i n v e n a d i f a n f a l u c h e , un Moroder teutonizzato, dei Visage marziali (si veda Fish & Chips), altrove dei Kraftwerk formato videogame, un Hancock electro che spande arzigogoli e singulti (Electric Potato). Ma l’impronta più profonda la imprime quell’impasto di ammiccamenti e minacce, ghigni e spernacchiamenti, crepitii e vapori che struttura la breve Pop-Corn Chips (uno sfarfallio fuori fase, una tranqui-dance aeriforme) e la conclusiva Electro Plastic Box, funk sforbiciato da minutaglie sintetiche, inturgidito da un groove gommoso che ne fa esperienza quasi tattile, da bambino nella stanza dei gioc h i . Vo g l i a d i s t u p o r e e i n s i dia, frammenti di rappresentazione che smazzano l’astratto 66 sentireascoltare e il concreto, l’uno sempre più nel corpo dell’altro. E’ troppo presto (il progetto nasce solo l’estate scorsa) e troppo poco per giudicare, ma quel che s ’ i n t r a v e d e è b u o n o . Vo t o : 6.7/10 classic Red Crayola La Parabola del Signore dei Pastelli di Martino Lorusso Autentico e incompreso iniziatore della psichedelia americana negli anni ’60, figura di spicco del post punk inglese, spirito guida dell’intellighenzia post rock di Chicago, Mayo Thompson è uno dei personaggi più illuminanti e trasversali della storia del rock . Una lunga storia quella dei Red Crayola, raccontata dal suo stesso ideatore con passione e lungimiranza. «Mi stai chiedendo se il rock mi abbia salvato la vita o semplicemente me l’abbia resa più semplice e interessante?… beh, fondamentalmente penso che non ci sia differenza tra le due cose!» (Mayo Thompson) Confrontandolo alla mastodontica mole di produzione artistica - laddove per “arte” si intenda la costante ricerca di un prodotto sperimentale e all’avanguardia, pertanto di complessa e a tratti ostica fruizione -, Mayo Thompson si presenta come un personaggio alquanto presente a sé stesso, dotato di un aplomb discreto e minimale, raffinato nell’aspetto, assolutamente cordiale nel modo di offrire la sua comunicazione all’altro… una comunicazione calda, piacevole, spunto di interessanti flashback che abbracciano, in una visione grandangolare, oltre trentacinque anni di onorata carriera. Stupisce più d’ogni altra cosa l’umiltà con la quale Mayo, mente affascinante, instancabilmente volta ad un costante superamento delle dimensioni già esplorate (per ripartire sentireascoltare 67 con slancio ugualmente denso d’energia e carico di stimoli verso nuove mete), si pone nei confronti dell’interlocutore, che senza accorgersene si ritrova perfettamente a proprio agio e libero da ogni timore reverenziale di sorta. Una dote che rende ancor più apprezzabile una figura la cui sola spinta vitale, mai esauritasi, come dimostra l’immane attività, sarebbe bastata per emergere tra molti, destinati a differenti esiti: dall’elementare dispendio d’energie, a un’irrazionale ed inconsapevole autodistruzione, entrambi estremi di una condizione d’artista forse non più padrone di sé, in balia dell’esterno o della sua stessa personalità, in una sperimentazione decostruttiva, la cui fine viene scritta in anticipo. Rivoluzione trasparente: i primi indelebili solchi tracciati nell’arabile terra del rock, tra attitudine freak e avanguardia Difficile pensare a un gruppo che abbia incarnato ed espresso così perfettamente l’idea di “psichedelia” come i Red Crayola, pur senza definirsi pretenziosamente psichedelico, per il semplice fatto di suonare fuori tono, servirsi di insoliti ammenicoli in guisa di strumenti o seguire una ferrea dieta di sostanze in grado di aprire le porte della percezione. La band di Mayo Thompson, il solo elemento stabile di un nucleo (originariamente formato anche dal bassista Frederick Barthelme e dal batterista Steve Cunningham) che ha mutato incessantemente forma per quasi quattro decenni e intorno al quale ha ruotato un collettivo di oltre cento musicisti, è stata senza dubbio una delle realtà più originali emerse dall’America dei tardi anni ’60; a suo modo unica, al più avvicinabile per peculiarità stilistica, carica innovati- 68 sentireascoltare va/rivoluzionaria/dissacrante e - duole dirlo - scarsa considerazione tra i contemporan e i , a n o m i q u a l i Ve l v e t U n derground, Captain Beefheart, Frank Zappa, dai quali tuttavia il texano ha sempre preso le distanze. «In realtà non ci siamo mai considerati parte dell’underground o della controcultura di cui loro erano i fieri portavoce, non volevamo essere catalogati, eravamo dei cani sciolti e del resto anche la gente ci percepiva divesamente… come autentici “weirdos”, tipi davvero strani… a differenza di chi era “professionalmente freak”, tipo Zappa». D’altra parte è indubbio come l’esperienza dei Crayola si sia dispiegata lungo traiettorie parallele a quelle tracciate dai suddetti personaggi, condividendone anche aspetti musicali, incarnando la medesima aura mitologica, muovendosi con lo stesso spirito precursore di tempi & mo(n)di musicali, pur senza mai intersecarle. Forse anche per il nomadismo fisico (e intellettuale) di Thompson, mai del tutto a suo agio in un continente, quello americano, incapace di dare gli stessi input e stimoli culturali di un Europa sicuramente più vicina alla sua sensibilità artistica; né autenticamente in grado, d’altra parte, di recepire un output così in anticipo rispetto ai tempi e alle realtà coeve, perfino quelle legate all’etichetta che ha messo sul mercato i primi due straordinari lavori della band. La presenza dei pastelli rossi nel roster dell’International Artists di Lelan Rogers, infatti, appare quanto meno singolare se si confronta la loro proposta musicale con quella degli altri gruppi che hanno inciso per la storica label texana - a cominciare dai 13th Floor Elevators - certamente più legati a un retroterra garage rock, a “form(ul)e tipicamente stone- siane/beatlesiane”, meno disposti a un’effettiva manipolazione della materia sonora. Caratteristiche chiaramente riscontrabili nella musica dei Crayola, autentici pionieri nel rivoluzionare la struttura stessa della canzone rock sin dalle fondamenta, dilatando lo spazio della composizione, scardinando la sequenza strofa-ritornello-bridge-strofa in favore di soluzioni meno costrittive, includendo suoni realizzati da chiunque e con qualunque strumento/oggetto/metodo. «Non penso che i Red Crayola abbiano distrutto qualcosa o screditato qualcuno… abbiamo semplicemente utilizzato i linguaggi musicali esistenti, del resto nessuno ci ha chiesto di inventare nulla; la musica è un “fatto materiale” e non c’è modo di decostruire, scomporre un fatto materiale… abbiamo manipolato gli idiomi e giocato con le forme ma il nostro scopo non era certamente quello di distruggere». Concettualmente simile alle Mother ’s Auxiliary di Zappa, la Familiar Ugly dei texani è una banda sconfinata di personaggi - per inciso non solo musicisti - costruita intorno a uno zoccolo duro, costantemente in progress e destinata a svolgere i compiti più disparati, dal semplice lavoro manuale alle scorribande rumoristiche sul palco. «Se si presentava la possibilità la Familiar Ugly si esibiva, rivelandosi per quello che era: io dicevo “andiamo ragazzi facciamo un po’ di rumore!” e nessuno si tirava indietro. Abbiamo cominciato come una sorta di progetto aperto perché ci sembrava il modo migliore per avere la massima libertà espressiva. Le alternative non avrebbero funzionato e non erano da prendere in considerazione per me». Esemplificative dell’attitudine realmente psichedelica della band, le free form freak-out del primo epocale The Parable of Arable Land (IA, 1967) sono magma ribollente di vibrazioni cacofoniche che investono l’ascoltatore, spesso con violenza inaudita, e dal quale spontaneamente emerge il suono “organizzato” delle canzoni. Similmente a una scultura liberata dal blocco di marmo grezzo che l’avvinghia, la musica si aggrega e prende vita dall’energia primigenia del rumore, per poi esserne nuovamente risucchiata in un progressivo frantumarsi dei legami che ne reggevano la costruzione razionale/armonica. A distinguere l’approccio dei Red Crayola da quello di altre bande psichedeliche dell’epoca è proprio l’importanza & il ruolo attribuiti al fattore rumore, allorché da semplice contorno/ contrasto o intermezzo, diviene esso stesso elemento centrale della composizione, all’interno del quale si fanno largo faticosamente strutture canoniche e tonali. Eppure è un elemento mai sopito del tutto, che attende felino sullo sfondo per tirare la zampata al momento più opportuno e inaspettato. Altro tratto distintivo è la disposizione dei pastelli alla contaminazione e apertura verso linguaggi altri dalla musica pop(ular): il filo che lega talune intuizioni con i poemi elettronici di Edgar Va r e s e e l a m u s i c a a l e a t o r i a d i John Cage è tutt’altro che sottile e trascurabile (si ascoltino per esempio la free form freak out che segue Pink Stainless Ta i l e l a s t o r i c a I o n i s a t i o n del parigino), né va sminuito chiamando in causa il rigore scientifico e l’approccio sistemico di quei pionieri della sperimentazione: ci troviamo chiaramente di fronte a contesti, background e percorsi formativi distanti anni luce e dunque non direttamente confrontabili. Enfatizzare però l’aspetto dissacrante del’opera, ergendolo a valore assoluto della stessa vorrebbe dire adombrare la bellezza di sei canzoni altrettanto eccentriche ed emozionanti: a cominciare dall’incalzante Hurricane Fighter Plane, propulsa da tre note di basso ripetute e percussioni squinternate, agitata da un pulviscolo vorticoso di rumorini in cui galleggia un organo liquido in stile Wright (sarebbe interessante sapere, tra Pink Floyd e Red Crayola, chi abbia influenzato l’altro). E non si finirà mai di tessere l’elogio di Transparent Radiation, anthem lisergico il cui potenziale psichedelico sarà messo in luce e (di)spiegato - vent’anni dopo - nella cover degli inglesi Spacemen 3 (splendida come l’album che la contiene: Perfect Prescription, Glass 1987). Si tratta probabilmente del brano più importante di tutta la psichedelia americana, di cui sono presenti alcuni dei tratti archetipici: chitarre in reverse, voci/strumenti e rumori che viaggiano in libertà da un canale all’altro, sottoposti a frequenti alterazioni di tono/ timbro/volume, un’armonica chiesastica che giunge a toccare l’empireo. Sembrano animate dallo stesso spirito dionisiaco le progressioni nevrotiche di War Sucks, veemente invettiva contro la g u e r r a , e P i n k S t a i n l e s s Ta i l , in cui si consuma il rito orgiastico tra suono & rumore, in un continuo, animalesco e liberatorio (com)penetrarsi dei due elementi. La title track, sinfonia cacofonica di clangori, stridii, fischi, urla, voci fuori campo, strumenti struprati selvaggiamente e chi più ne ha più ne metta è il preludio al rilascio tensionale che sancisce/scandisce il ritorno dal viaggio, Former Reflections Enduring Doubt, epifanica presa di coscienza del cambiamento. «Eravamo per- sentireascoltare 69 fettamente consapevoli che stavamo cambiando le cose, che stavamo creando una musica diversa dal blues revival… per carità, non ho nulla contro il blues, lo adoravo anche io quando ho iniziato ma non avevo nessuna intenzione di suonarlo, volevo creare qualcosa di mai udito prima» Le benedizioni non bastano: dai viaggi nella California di John Fahey al naufragio commerciale dell’influente God Bless L’ a t t i v i t à c o n c e r t i s t i c a d e l c o l lettivo si divide tra concorsi per band emergenti e festival di nicchia, tra cui vanno citati i trip californiani dell’Angry A r t s a l Ve n i c e P a v i l i o n e d e l Berkley Folk Festival (entrambi risalenti all’estate del 1967), le cui sconvolgenti performance sono immortalate nel doppio album Live 1 9 6 7 ( D r a g C i t y, 1 9 9 8 ) . N e l secondo disco compare anche una lunga e ipnotica jam con J o h n F a h e y, u n o d e i p o c h i a r tisti realmente apprezzati dal gruppo. «Non ci piaceva nulla di quello che si sentiva in giro all’epoca, detto francamente. Restammo molto delusi dal primo album dei Grateful Dead da cui ci aspettavamo qualcosa di nuovo… quando andammo in California, l’unica musica che volevamo ascoltare era quella di John Fahey e ci proposero di incontrarlo per lavorarci insieme, fu fantastico! Registrammo un doppio album con lui a Berkley… la International Artists venne a sapere la cosa e si impuntò per averlo prima del nostro rit o r n o i n Te x a s . C o n m o l t a r i luttanza lo spedimmo e - non si sa come - l’etichetta perse i m a s t e r, c o n n o s t r o g r a n d e rammarico…» Se qualcuno, compresi i discografici della IA, può attendersi una normalizzazione del suono dopo un esordio così bizzarro, chiaramente si sbaglia 70 sentireascoltare di grosso: il successivo Coconut Hotel si avventura lungo sentieri ancor più impervi, al punto di essere categoricamente rifiutato dall’etichetta texana, per andare alle stampe solo trent’anni più tardi (nel 1 9 9 5 ) , g r a z i e a l l a D r a g C i t y. L’ a l b u m è u n c a m p i o n a r i o d i stranezze, dai famigerati onesecond pieces ai monologhi di feedback, passando per quadretti concréti, escursioni folkpsych per chitarre acustiche e improvvisazioni al pianoforte. «Un pezzo di un secondo è il più compresso istante che si può ottenere da una composizione coerente: un suono, due suoni, quattrocentomila o infiniti suoni concentrati nell’arco di un secondo - che è una microporzione del brano. Ve n n e r o f u o r i d a l l a n o s t r a a m mirazione per Cage e la sua opera… evidentemente c’era ancora qualcosa da fare in quella direzione; i one-secondpieces pongono anche delle domande all’artista: “messi all’inizio del disco fungono da introduzione alla prima canzone, posti dopo la prima canzone rappresentano la sua conclusione o l’annuncio della seconda?” oppure “quanto silenzio devo lasciare prima e dopo i pezzi?”. Se pure questi dettagli possono sembrare banali, oltre alla struttura interna, modificano la percezione dell’opera… certo, dietro di loro c’è un concetto ma io ho sempre creduto che “la musica è l’idea”» Chiamando in causa la musica delle Accademie, i Red Crayola si chiedono, come altri complessi rock dell’epoca - si pensi a Zappa o ai Pink Floyd di Ummagumma -, se sia possibile (e attraverso quali dinamiche) applicare alla musica pop le pregevoli intuizioni maturate negli ambienti colti. Se gli esiti non sempre corrispondono a quelli auspicati e spesso le sperimentazioni restano fini a sé stesse, tal- volta le idee si concretizzano in composizioni inaudite. Accade di frequente nel successivo God Bless The Red Krayola And All Who Sail With It (IA, 1968), realizzato dopo la dipartita di Barthelme a cui s u b e n t r a i l v a l i d i s s i m o To m m y S m i t h . L’ a l b u m r a c c o g l i e v e n ti brevi affreschi dalle tinte variegate e profetiche ma ben lontane dall’apocalisse della parabola - spostandosi il fuoco sulla forma canzone, di cui vengono esplorate possibilità & confini. Senza voler nulla togliere all’unicità dell’esordio, God Bless riesce ad essere ancor più antesignano e influente per le generazioni future, pur non configurandosi come progetto organico e u n i t a r i o . P r o g r e s s i o n i j a z z y, ritmiche spezzate o ipnotiche, coretti sgangherati, chitarrine sghembe, numeri da cabaret, pastiche dada, continui cambi di registro… in queste tracce così slegate possiamo trovare i semi di tante esperienze a venire: dal kraut rock alla new wave, dal post rock al cantautorato lo-fi. «Molti ravvisano in God Bless delle somiglianze tra i Red Crayola e la scena rock tedesca degli anni ’70. In realtà noi abbiamo iniziato a suonare prima dei Faust, dei Can e di altri gruppi krautrock… non conoscevamo né ascoltavamo quella musica. Sicuramente esiste una relazione tra noi e loro ma ritengo sia puramente casuale, abbia a che fare con le idee che si trovano alla base dell’espressione musicale piuttosto che con il modo di realizzarle e suonare. Ci sono diverse cose che ci separano da loro… prendiamo i Can, li trovo sicuramente meravigliosi ma alcune loro composizioni sono costruite su una nota di basso ripetuta all’infinito, è un concetto estremo e interessante che può rivelarsi utile ma a volte può essere anche limitante, quel tipo di cose personalmente mi andavano strette» Com’è consuetudine nella storia della musica, le grandi rivoluzioni spesso passano inosservate agli occhi dei contemporanei, per essere comprese nella loro reale portata solo a distanza di anni; e nella statistica che raccoglie i gruppi dissolti dall’insuccesso commerciale figurano anche i Red Crayola. Mayo Thompson però è un tipo che non si piega facilmente e due anni dopo lo ritroviamo in sala prove con l’intento di incidere il suo primo album solista, questa volta circondato da un nugolo di artisti appartenenti proprio a quella polverosa tradizione musicale con cui i Crayola avevano giocato al tiro al piattello nei primi due dischi: la leggenda di Houston Frank Davis, Roger D r. R o c k e t R o m a n o e l a s u a band, e altri personaggi del giro country/blues. Tuttavia C o r k y ’ s D e b t To H i s F a t h e r , prodotto dalla piccola e prematuramente fallita Te x a s Revolution, non giunge nei negozi prima della fine degli anni ’80, quando la label inglese Glass si adopera per la sua pubblicazione. Ristampato dalla Drag City nel ’95, Corky’s resta l’album più accessibile di Thompson, alternando morbide canzoni d’amore velate di psichedelia a blues elettrici e pianismi boogie da locale fumoso. Gli slogan del soldato: dall’incontro con l’arte concettuale inglese alla traversata dell’Oceano, inseguendo la nuova onda Mente straordinariamente ricettiva e animata da una curiosità sconfinata, il texano entra in contatto proprio in quegli anni con un gruppo di artisti concettuali londinesi a t t i v i a n c h e a N e w Yo r k , g l i Art & Language. Dalla collaborazione nascono svariati progetti (non solo musicali) tra cui Corrected Slogans (Music Language, 1976), un’opera di meta-musica che lascia convergere l’eclettismo stilistico di Mayo con l’ideologia pro- fessata dal collettivo, in un confronto dialettico che si articola lungo venti scarne composizioni, ciascuna arrangiata per voce(/ i) & uno strumento. I testi, cantati tanto da soprano quanto da amatori poco intonati, scanditi a mo’ di filastrocca o recitati alla maniera di spoken word, fanno riferimento a tematiche di natura filosofica, politica e sociologica. «In genere io mi occupavo della musica e loro scrivevano le lyrics… con gli Art & Language ci interrogavamo su questioni interessanti tipo: “chi è il musicista”, “cos’è la musica” e soprattutto “quando… è la musica”, in quale momento avviene l’atto creativo». La necessità di interagire in maniera più diretta con i nuovi collaboratori spinge il texano a volare oltreoceano per sbarcare nella vivacissima Londra, dove nel 1978 con il batterista Jesse Chamberlain riforma i Red Crayola. In quel momento la metropoli vive nel fermento sollevato dalla nuova sentireascoltare 71 onda: la rivoluzione punk ha cambiato il modo di approcciarsi all’esperienza artistica, percepire l’atto creativo e comunicare con il pubblico; è uno sconvolgimento che ha già imboccato la via del tramonto ma le cui conseguenze sono destinate a protrarsi negli anni a venire: l’idea del “tutti possono farlo” ha indotto molti ragazzi a concepire la musica come forma di espressione & prosecuzione del proprio Sé, e aperto le porte a un’invasione di gruppi dalle sonorità spesso divergenti, eppure guidati da un comune sentire. Proprio nel periodo di crescita esponenziale della new wave, Thompson inizia a frequentare alcuni musicisti inglesi per poi entrare in contatto con la Radar Records di A n d r e w L a u d e r, c h e - i r o n i a della sorte - ha appena ristampato i primi due lavori della band per il mercato britannico, probabilmente riconoscendo in essi i prodromi di quanto sta creando l’esuberante scena nazionale. «A proposito del rapporto con gli artisti della new wave… più che una comunione di idee si trattava di un comune “sentire”. David Thomas ne è la testimonianza diretta… erano molte di più le cose su cui eravamo in disaccordo di quelle su cui la pensavamo alla stessa maniera. Posso identificare delle categorie o delle caratteristiche filosofiche descrittivamente accurate da applicare alla musica punk che è una “chiesa larga”: ci sono diversi tipi di punk, dai Sex Pistols, a un estremo, ai Desperate Bycycles, all’altro… e nel mezzo un’intera gamma di artisti new wave. Autedeterminazione, spirito d’iniziativa, autoproduzione, quindi un’ attitudine “do it yourself” […] all’epoca importava molto l’idea di ciò che la gente stesse facendo, di cosa fosse buono, bello e virtuoso… in definitiva di cosa valesse la 72 sentireascoltare pena fare. Quel modo di essere aveva a che fare con il “dire di no”, o il “dire di sì a qualcos’altro”, con l’idea di “alternativo”… ci si chiedeva cosa permettesse all’artista la scelta di un’alternativa al comune sentire/agire. Allo stesso tempo esistevano delle difficoltà e tutta una serie di problematiche legate al punk, che tirava in gioco l’identità sociale, sessuale, ecc… ma all’epoca io ero fuori da tutto questo, non appartenevo a nessuna comunità di quella chiesa. Svolgevo delle attività, avevo dei progetti, e in essi è possibile individuare ciò che dividevo con quelle persone… che ovviamente non erano tenute ad avere i miei stessi punti di vista: ero americano, di un’altra generazione, avevo dieci anni più di loro, valori differenti, un modo diverso di apprendere e fare le cose…. dovevamo solo suonare e se c’era il giusto feeling tra di noi, accadeva qualcosa di unico e irripetibile ma le cose potevano anche non funzionare». S o l d i e r Ta l k ( R a d a r , 1 9 7 9 ) è l’opera più a fuoco di questa seconda fase dei Red Crayola, esala l’afflato psichedelico in favore di un’urgenza espressiva di i(n)spirazione punk, sostenuta da ospiti del calibro della sassofonista Lora Logic (X-Ray Spex, Essential Logic) e dei Pere Ubu - quasi al completo. Lo spettacolo messo in scena è una nevrosi che brucia progressivamente ogni sinapsi, tra ritmi forsennati e sconnessi, tagliati a fette da chitarre affilatissime (On the Brink, Conspiration Oath, la splendida X), marcette da sagra dei funghi allucinogeni (march no.12 e no.14), isteriche copule progpunk (Letter-Bomb) e jam improvvisate da reduci di guerra i m p a z z i t i ( S o l d i e r Ta l k , D i s c i pline). Il cambio di ritmo alla fine di An Opposition Spokes- man, che in una manciata di secondi, da free-jazz si fa kraut-motoristico per detonare in un’esplosione punk finale, da solo vale l’acquisto dell’album. Materiale infiammabile: dall’esperienza di produttore per l a R o u g h Tr a d e a l l e c o l l a b o razioni con la scena free-jazz tedesca La congiuntura è favorevole perché Thompson possa mettersi in gioco anche su altri fronti: parallelamente all’esperienza Crayola, il Signore dei Pastelli intraprende una frenetica attività di produttore per la storica Rough Trade, che gli procurerà non poche soddisfazioni. I migliori dischi del post-punk britannico pubblicati dall’etichetta inglese tra il ’78 e l’81 accrediteranno il texano al banco di regia: Monochrome Set, Stiff Little Fingers, Raincoats, The F a l l , C a b a r e t Vo l t a i r e , J a m e s “ B l o o d ” U l m e r, B l u e O r c h i d s , Scritti Politti. «Cercavo di carpire il sound naturale di un gruppo ed evidenziarne i tratti distintivi, se potevo fornire una prospettiva in grado di indirizzare i musicisti nelle proprie scelte lo facevo, anche se il mio lavoro consisteva principalmente nell’assicurarmi che quella musica finisse su nastro. Sono orgoglioso di tutti i dischi e gli artisti che ho prodotto, dagli Stiff Little Fingers di Inflammable Material alle Raincoats, da Mark E. Smith & T h e F a l l a i C a b a r e t Vo l t a i r e di Nag Nag Nag. Rimasi un po’ deluso da Lawrence Hayward dei Felt, gli missai il disco ma lo rifiutò perché riteneva che la sua voce non fosse sufficientemente in primo piano e quindi fui costretto a rifare il mix… in generale il suo comportamento da popstar mi lasciò piuttosto perplesso perché non lo immaginavo così, ma il disco era il suo e naturalmente dovevo adeguarmi! C’è solo un album la cui produzi- one è stata assolutamente deludente per me ed è quello dei The Chills, perché fondamentalmente a loro il disco non piaceva, non erano felici di suonarlo ma lo produssi ugualmente… finito il missaggio praticamente fuggii dallo studio, il giorno dopo ero già f u o r i c i t t à ! Ve r s o l a f i n e d e g l i anni ’80 le cose si erano fatte troppo complicate e non ero più in grado di stare al banco di produzione, gli studi si iniziavano a riempire di strumenti sempre più complessi, macchinari che automatizzavano molti processi, enormi computer… in realtà amo indiscriminatamente tutti i mezzi di produzione e le tecnologie disponibili e se si presenta l’opportunità di utilizzarne una non mi tiro Trade, 1981), sorta di rivisitazione pop degli Slogans, e Black Snakes (Rec Rec / Pure Freude, 1983), che sposta le coordinate verso ritmi più f u n k y, q u a s i a ’ l a M a t e r i a l . E’ un periodo quanto mai prolifico per Thompson che con Ravenstine e il ritrovato Jesse Chamberlain sforna un altro mini album, Three Songs On A T r i p To T h e U n i t e d S t a t e s A n d Bismarkstrasse, 50 (Reccomended / Pure Freude, 1983), inciso in Germania - sua nuova dimora - e comprendente versioni live di brani estratti d a S o l d i e r Ta l k e d a i l a v o r i realizzati con Baldwin & soci; oltre a tre nuovi pezzi, tra cui è opportuno segnalare quantomeno l’inedita vena darkwave di Caribbean Postcard. indietro ma io ero legato a un’altra idea di produttore, anche più “romantica”, se così si può dire…» Sempre attivo all’interno della Rough Trade come produttore, il texano indossa con perfetto aplomb anche l’abito del manager: sarà proprio lui a presentare il “regista delle libertà” Derek Jarman agli Smiths, pubblicandone i primi video. Le nuove frequentazioni tedesche si collocano anche nel giro avant jazz, vecchio pallino di Mayo, risolv e n d o s i n e l l ’ a l b u m M a l e f a c t o r, Ade (Glass, 1989), cui prende parte tra gli altri il maestro dell’improvvisazione Rüdiger Carl (COWWS Quintet).Prova esemplare di eclettismo & capacità di rielaborazione, la raccolta è un pregevole tentativo di contaminare idiomi ben distanti (& distinti), come acc a d e i n E x p r e s s e F r a n z Vo n Assisi, stralunate canzoncine scandite da balbettii robotici di clarinetto, trombone e batteria. Altre perle sono custodite nel blues devitalizzato di Baby Jesus Frog e nella marcetta demente per psicopatici in libera uscita Blue Jeans; piuttosto insolite ma altrettanto degne d’attenzione le manipolazioni elettroniche incise sull’altra facciata del lp (effetti, tape loop…). «Malefactor è essenzialmente un Con alcuni artisti new wave sorge un’affinità destinata a sfociare spontaneamente in un rendez-vous con i Crayola: è il caso di Gina Birch (Raincoats) e Epic Soundtracks (Swell Maps), che dopo aver suonato in Microchips & Fish(*1979) - primo 12” della Rough Trade - diventeranno membri effettivi della band. Il lato A dell’EP è un ballabile strapazzato da chitarre atonali, sorta di punk-funk ante litteram dai toni raccapriccianti (al punto da indurre il compianto John Peel ad azzardare previsioni infauste sulle sorti dell’etichetta!). Le incursioni nei territori della danza postmoderna continuano con il singolo Born in Flames(*1981), synth pop mandato in orbita dagli acuti anfetaminici di Lora Logic, subito eletto ad anthem da discoteca alternativa. Si arricchisce di nuova linfa anche l’esperienza con i teorici dell’Art & Language, grazie agli album Kangaroo? (Rough lavoro di studio… oltre al pittore Albert Oehlen era coinvolto un musicista free-jazz, Rüdiger Carl… suonò delle linee di clarinetto su un tape recorder e noi le manipolammo, rigirandole e rivoltandole da capo a piedi così da poterle utilizzare in diverse tracce. Eravamo molto soddisfatti del risultato finale… fu anche la prima volta che utilizzai delle drum machine al posto della batteria» La gente è pronta: dall’avventura con la scena avant rock di Chicago alle fatiche dell’ultimo entusiasmante tour mondiale Lasciato lo zampino in altri dischi dell’intellighenzia germanica, all’inizio degli anni ’90 il fondatore dei Crayola pone termine alle sue peregrinazioni europee per fare ritorno in patria, mosso dalla ricerca di nuovi stimoli e forse subodorando aria di cambiamento. La nuova destinazione non è esattamente l’arido Sud che gli ha dato i natali bensì svariate miglia più a nord - la ventosa Chicago, il cui sfaccettato sottobosco musicale sta iniziando proprio allora a parlare una lingua comune e acquistare una sorta di unità d’ intenti che indurrà la stampa specializzata a definire una “scena” locale. A trainare il carrozzone post rock chicagoano, una serie di personaggi dall’indubbio talento, curiosi divoratori di ogni musica possibile, animati da uno spirito D . I . Y. d i a s c e n d e n z a p u n k m a di ben più larghe vedute, tra cui il chitarrista/produttore Steve Albini, John McEntire (batterista/percussionista dal tocco inconfondibile), il jolly Jim O’Rourke e il compagno di merende David Grubbs. Proprio quest’ultimo, da sempre grande estimatore dei pastelli (per i quali nutre la stessa riverenza che un musicista può avere nei confronti di chi lo ha indotto a imbracciare per sentireascoltare 73 la prima volta lo strumento), introduce Thompson nel giro. «Non li conoscevo ma avevo ascoltato alcuni dei loro dischi, con David Grubbs avevo un amico in comune che mi chiese di produrre un album degli Squirrel Bait ma all’epoca ero in Inghilterra e la cosa non si fece. Un giorno David mi chiamò al telefono, si presentò e mi chiese se potevamo vederci per fare quattro chiacchiere; quando lo incontrai a Chicago ci fu subito una grande affinità tra noi e lo stesso accadde con McEntire e gli altri… anche perché loro conoscevano bene la nostra musica e io apprezzavo molto il fatto che fossero intenzionati a creare qualcosa di nuovo. Registrai un demo con sei canzoni che David fece ascoltare ai tipi della Drag Cirty» La storica label indipendente non esita a prendersi l’onere (e l’onore) di ristampare buona parte del materiale inciso dal texano, oltre a dargli la possibilità di ritornare in studio. La prima nuova uscita sulla lunga distanza è l’omonimo The Red Krayola(DC, 1994), che annovera tra i credits anche i l t a l e n t o d e l l a s e i c o r d e To m Wa t s o n ( S l o v e n l y, O v e r p a s s ) e l’artista visuale Stephen Prin a . L’ a r i a c h e t i r a t r a q u e s t e diciassette tracce (tutte sotto i tre minuti) è frizzante, pregna di tensione (positiva) e vivace quanto quella che si respira negli incontri improvvisati - a casa, in studio, nei club - tra i musicisti coinvolti… amici prima di tutto, ragazzi a cui piace bere una birra, attaccare gli amplificatori e tirare fuori l’anima dai loro strumenti. E’ un clima rilassato & fecondo - a suo modo simile a quello dei lontani & utopici anni ’60 -, che tira fuori il lato più creativo di Thompson, ben percepibile nella lucentezza accecante di episodi come Book Of Words - irresistibile nel suo (s)rotolarsi umorale 74 sentireascoltare tra coretti e chitarrine pruriginose -, l’arrembante People Get Ready (The Train’s Not Coming), il raga trasfigurato di I Knew It, e 101st, di cui entusiasma l’interplay voce/ chitarre/batteria. La scrittura resta a fuoco anche quando i toni si fanno più dimessi: in P e s s i m i s t r y, c h e i m p l o d e p r o prio sul punto di prendere il volo, nelle sinistre (Why) I’m So Blasé e The Big Macumba, nella sonnolenza oppiacea di S u d d e n l y. Il successivo mini Amor & Language (DC, 1995) riunisce una pletora di ospiti illustri tra cui il leggendario George Hurley (Minutemen, fIREHOSE), subito reclutato come nuovo batterista della band. Trattatello di morbida psichedelia, l’album smussa molti spigoli & asperità del suono Krayola, preferendogli superfici più levigate che utilizzano materiali tradizionali, dal folk al country-blues. Spostando l’accento sulla melodia, in un confronto dialettico con il ritmo, che possa generare forme/ strutture allo stesso tempo ricercate & fruibili, Hazel (DC, 1996) è la naturale prosecuzione del discorso intrapreso due anni prima, la vetta più alta raggiunta dal texano d a i t e m p i d i S o l d i e r Ta l k ; u n cammeo avant-pop che mostra ancora una volta come Thompson sappia recepire gli input più disparati senza cadere nella facile (e comoda) tentazione di adattarvisi, riproponendoli pedissequamente, quanto piuttosto manipolandoli, rigirandoli tra le dita e premendoli nella formina della sua spiccata personalità. Tipico esempio ne è la gemma dell’album, Duke Of Newcastle, un reggae trasfigurato che narra la marcia di un soldato cristiano: della musica in levare resta solo l’afflato corale, bianca è invece la leggerezza delle voci. I duetti con Grubbs sprigionano incanto ad ogni nota e hanno l’aria del passaggio di consegne dal maestro all’allievo: alla levità wyattiana di I’m So Blasé fanno da contraltare il folk magmatico di Larking e gli incastri chitarristici di Another Song, Another Satan. Il tocco dell’intellighenzia chicagoana si sente particolarmente nelle reiterazioni di Duck & Cover e nelle distorsioni posthardcore di GAO, altro vertice dell’album, come pure nell’umorale alt.country di Falls (commovente l’assolo finale di banjo) e nella cameristica We Feel Fine. Il rumorismo post rock trova infine un punto di contatto con l’attitudine psichedelica di Thompson nell’elettronica cheap di Boogie e in Father Abrahm, moderna free form freak-out che fornisce anche l’assist per il lavoro seguente. Ultimo tassello del trittico su D r a g C i t y, F i n g e r p a i n t i n g ( D C , 1999) è una via di mezzo tra un divertissment e un tentativo di misurarsi con il passato, nella fattispecie provando a disseppellire lo scheletro del leggendario The Parable Of Arable Land per impiantargli un corpo nuovo e ricamarci intorno un abito altrettanto stravagante. Naturalmente questa volta il campionario di suoni & rumorini viene generato (anche) da mezzi più moderni e teconologici - a partire da una drum machine che appare/scompare dal mix in maniera più o meno casuale -, oltre ad essere in parte estrapolato da vecchie registrazioni. «Ci chiedevamo: “è possibile ripetere la struttura di Parable ora? In che modo possiamo approcciarci a quel materiale sonoro in questo momento e quali possono essere gli effetti su di noi e sull’ascoltatore?” Avevamo dei pezzi non utilizzati in Parable, dato che all’epoca la IA ci aveva chiesto solo sei delle dieci canzoni che avevamo scritto, e quindi recuperammo i restanti per farne uso in Fin- gerpainting. La cosa curiosa è che quei brani avevano una struttura piuttosto semplice, basata su tre accordi, anche perché all’epoca le nostre capacità tecniche erano piuttosto limitate… è chiaro che rispetto a Parable cambiavano sostanzialmente le condizioni produttive ma noi abbiamo sempre puntato a lavorare con le migliori tecnologie disponibili, e non per feticismo… Steve Albini è uno fissato per la tecnologia [ride], un lunatico dell’analogico - Dio lo benedica! è un uomo straordinario -, lui usa valvole, microfoni vecchio stile e tutto un armamentario di strumenti vintage. E’ un piacere collaborarci, è un gentiluomo… conosci il disco A m o r & L a n g u a g e ? L’ h a m i s sato lui, l’unico motivo per cui non ho voluto che comparisse nei credits è perché aspettavo quel giorno da una vita e così gli ho semplicemente detto “grazie”! [ride]» Anche nel maelstrom cacofonico di Fingerpainting si (ri)compongono pseudo-canzoni, dai titoli spesso strampalati tipo Sow With an Abbess’s Bonnet Is Sitting on Four Rock-Objects and Singing oppure Out of a Trombone That Is Divided Lengthways by a Partition of Gold Sou, la lunga suite che chiude l’album. Curioso notare l’affinità di alcuni brani (Bed Medicine, Te a r s F o r E x a m p l e ) c o n i d e liri metropolitani dei primi Suicide e dei Can più acidi, d’altra parte in queste tracce il cerchio si chiude: i Red Crayola che nella loro opera pioneristica hanno inlfuenzato dapprima i krautrocker e di riflesso i complessi new wave più radicali, entrambi ispirazioni dirette per le eminenze grige del post rock, infine recuperano le proprie origini in un percorso a ritroso compiuto proprio al fianco della loro ultima discendenza generazionale, quella rappresentata da Grubbs & soci. Tra singoli, apparizioni come ospite in svariati dischi e compilation, due nuove produzioni - il mini Blues Hollers & Hellos (DC, 2000) e la colonna sonora Japan in Paris in L.A. (DC, 2004) - e la raccolta Singles(DC, 2004), la carriera di Thompson approda all’oggi, a questo 2005 segnato da una mai così frenetica attività concertistica che ha toccato gli USA, l’Europa - con un’indimenticabile parentesi italiana - e il Giappone. Una carriera, durata quasi quattro lustri, senza essere il benchè minimo intaccata dalla polvere dell’oblio, né minata dall’insidia del deja vu e dell’inaridimento; piuttosto tesa al continuo sperimentare, rimescolare, ribollire che diviene testimonianza tangibile di ciò che potenzialmente un essere umano produca, utilizzando in modo costruttivo la sua facoltà razionale, partendo da presupposti animati da uno spirito conoscitivo così puro da rendere anche l’assunzione di incentivi sintetici, miccia positiva, piuttosto che pericolo estemporaneo o latente. «Ci considerano tutti un gruppo d’avanguardia, in effetti forse lo siamo stati, visto che avevamo delle teorie, dei progetti, un programma ma ora in America non esistono più le condizioni perché ci sia l’avanguardia, forse in Europa sono ancora presenti ma da noi l’avanguardia è diventata “ufficiale” negli anni ’60 e a mano a mano che diveniva pubblica io smettevo di pensare in quei termini… ho prodotto degli album destinati a persone che naturalmente avevano bisogno di dare un nome alle cose, di etichettarle, catalogarle e così è accaduto. A volte i nomi erano adeguati alla nostra proposta musicale altre volte no… ho anche iniziato a pensare che un giorno avrei dovuto rac- contare la vera storia di quel periodo, ma sapevo che anche se lo avessi fatto nessuno mi avrebbe creduto e avrei suscitato solo ilarità, e ad ogni modo dubito che queste informazioni potrebbero mai interessare a qualcuno… non ho mai pensato che la musica potesse rivoluzionare il mondo, le implicazioni sociali del suonare rock’n’roll restano legate alla “grande famiglia” del rock’n’roll… so già quale sarà la prossima domanda: mi chiederai se il rock abbia almeno salvato la mia vita o quantomeno me l’abbia resa più interessante… beh, la risposta è affermativa e fondamentalmente penso che non ci sia differenza tra le due cose!» (si ringrazia Mimma Schirosi per la preziosa collaborazione) sentireascoltare 75 note a margine a cura di Giulio Pasquali The Stranglers Anni Bui Gli anni bui degli Stranglers, ovvero l’oscurità nella quale è piombato negli ultimi 15 anni uno dei gruppi di spicco del punk/new wave, dopo cambi di formazione e alterne vicende che ne hanno segnato irrimediabilmente la storia. “Bui”, in un certo senso, gli Stranglers lo sono sempre stati. Già agli esordi, secondo i testimoni dei loro primi concerti, “emanavano dal palco un senso di minaccia”, che negli anni darà vita a un curriculum fatto di risse, incidenti, date annullate e pubbliche prese furono anche arrestati, vedi Nice In Nice, da Dreamtime). Il nero entrerà di prepotenza nel loro immaginario (diventando tra l’altro il colore unico dei loro abiti) col terzo album, Black And White (1978), e con il brano Meninblack, dal successivo The Raven (1980), riose che secondo la leggenda urbana rapiscono le persone e le fanno sparire per conto del governo. O degli extraterrestri, secondo la versione accettata dal gruppo, che all’argomento dedicherà il successivo The Gospel According To T h e M e n i n b l a c k ( 1 9 8 1 ) i l di posizione di consiglieri comunali, degno dei Sex Pistols (storici, tra gli altri, i disordini all’università di Edimburgo, a Lisbona e a Nizza, dove che darà loro un soprannome che si porteranno dietro a lungo, sebbene in realtà la canzone parlasse degli “uomini in nero” americani, figure miste- quale, con i cognomi dei musicisti cambiati in “in black” nei credits, consacrerà il soprannome. 76 sentireascoltare Ma non è in questo senso che parliamo di anni “bui”: vogliamo parlare dell’oscurità nella quale è piombato negli ultimi 15 anni uno dei gruppi di spicco del punk/new wave che negli anni ‘80 aveva ottenuto, sebbene a fasi alterne, alcuni buoni successi commerciali. A parte la notizia di qualche mese fa sul Mucchio Selvaggio che annunciava un ritorno in grande stile da tempo immemore, dal ‘ 90 in poi pochissime sono state le notizie a proposito del gruppo. Il che è piuttosto strano, se si considerano i burrascosi esordi, costellati non solo dagli incidenti durante i concerti, ma anche da un gran numero di scandali e polemiche di varia natura. Turbini che hanno messo più volte a repentaglio la carriera del gruppo la cui musica, nata in epoca punk, in realtà si allargava tanto nel passato, con le tastiere doorsiane di Greenfield e l’ariosità sixties, quanto nel presente, con la grinta punk e lo spirito oltraggioso dei testi; e pure nel futuro, in quanto già si intravedevano strutture complesse ed un grado di elaborazione che proiettava il punk oltre se stesso, verso la New Wave (se questa parola, dopo esser finita a designare sia i Pere Ubu che i Duran Duran, ha ancora un senso). Un passaggio questo, che la musica inglese dell’epoca dovrà in parte proprio al loro The Raven (1979), uno dei capolavori della band, che abbandona alcuni dei marchi di fabbrica della prima fase (organetto doorsiano, basso esplosivo, voce grottesca e beffarda), a favore di un suono maggiormente articolato. Ma dicevamo del 1990: un anno centrale nella storia del gruppo, non solo per l’uscita del decimo album in studio, 10 per l’appunto (per inciso, peggior disco fino a quel pun- to della loro carriera, proprio come il precedente Dreamtime), e per l’abbandono del cantante e chitarrista Hugh Cornwell (che lascia all’indomani del concerto inciso sull’album Saturday Night, Sunday Morning), ma soprattutto perché si colloca esattamente nel mezzo della storia della band, dall’organico “classico”, al giorno d’oggi. La stranezza della storia degli Stranglers sta nel diverso peso che hanno avuto certi anni rispetto ad altri. Fatti salvi i primi tre anni della gavetta, l’incontro tra Hugh Cornwell e Jet Black (batteria), e il contratto discografico, i dischi “storici”, sono stati incisi nell’arco di cinque anni, dal 1977 al 1981: Rat- tus Norvegicus (1977), No More Heroes (1977), Black And White(1978), The Raven (1979), The Gospel According To T h e M e n i n b l a c k ( 1 9 8 1 ) , e La Folie (1981); poi, nel 1982, il cambio di casa discografica, otto anni di relativa tranquillità (a parte le liti interne, in particolare le tensioni tra Cornwell e il bassista Jean Jacques Burnell) fatta di pop (i tuttavia ancora belli Feline del 1983 e Aural Sculpture del 1984) e infine la caduta plateale dei succedanei Dreamtime (1986) e 10 (un disco studiato a tavolino per sbancare gli USA che si traduce in un fiasco totale). I primi 15 anni della band formano già una carriera fatta e finita, eppure ve ne sono altrettanti dalla sostituzione di sentireascoltare 77 Hugh Cornwell con Paul Roberts alla voce e John Ellis alla chitarra, non certo da applauso. Con la nuova formazione gli Stranglers inaugurano nel 1992, la terza generazione con In The Night, un album che sembrerebbe possedere le carte giuste fin dal titolo (letto dopo il nome del gruppo risultava “Stranglers In The Night”), che non lesina un a s s o i n a p e r t u r a ( T i m e To D i e , un western con base dance ai livelli dei vecchi Stranglers), non facendosi mancare nemmeno il (disgustoso) “ratto norvegese” del primo album. Tuttavia i difetti sono dietro l’angolo: il canto di Roberts, tra alti e bassi, non possiede il carisma di Cornwell, anzi, oltre a Ian Mc Culloch degli Echo & the Bunnymen, tocca p e r s i n o l e c o r d e d i To n y H a d ley degli Spandau Ballet (!)… stilisticamente e a livello di produzione, il platter avvicenda certo pop anni ‘80 e suoni mainstream (per esempio nelle distorsioni delle chitarre), canzoni non proprio incisive, che nelle tronfie Heaven Or Hell e Grand Canyon raggiungono picchi in negativo assoluti (si ascoltino versi “seri” quali “guardo i giornali e non credo a ciò che leggo” , o“Grand Canyon, lo spazio tra di noi mi spezzerà il cuore”). Altri brani, come Laug h i n g A t T h e R a i n , T h i s To w n e Southern Mountain prodotti diversamente avrebbero avuto 78 sentireascoltare qualche chance in più. Never See si salva ma il problema è un altro: se in passato era difficile catalogare lo stile dei Nostri, ora la difficoltà maggiore è trovare in loro la personalità. Tra il 1994 e il 1995, in piena esplosione brit-pop, il nome Stranglers torna a far parlare i media: una delle varie “big things” della stampa inglese è un gruppo quasi completamente femminile, le Elastica, il quale prima racconta in un’intervista di essersi formato grazie a un annuncio (sullo stesso giornale) nel quale si cercavano “appassionati di Stranglers e Wire”, e poi pub- blica due canzoni plagiando le stesse band. Nessun dubbio: il giro di basso di Waking Up è identico al riff di No More Heroes (nemmeno la più ignota, perché non Peaches, a quel punto?), e anche il tribunale ne è convinto: obbliga le giovani a corrispondere alle band scopiazzate parte dei guadagni dei brani. In qualche modo, gli Stranglers tornano in classifica… Il 1995 è anche l’anno dell’abbandono temporaneo di Jet Black, che rientrerà dopo l’album About Time (dello stesso anno, e il relativo tour). Il disco trova i favori della critica, tuttavia è una raccolta di brani mediocri. Al solito l’iniziale Golden Boy (Gianni Rivera non c’entra nulla...), un rock nel più classico Stranglers style, conferma la tradizione anni ‘90: il primo brano è sempre il migliore. Da ricordare il singolo Lies And Deception, un valzer delicato dal ritornello easy considerato un piccolo classico di q u e s t i a n n i , e P a r a d i s e R o w, che ricorda i Doors come non mai. Per il resto, le solite canzoncine, con l’eccezione di She Gave It All e Lucky Finger la cui debolezza compositiva è compensata dalla buona performance strumentale. Due anni dopo, è la volta di Written In Red (1997), che da un lato presenta i soliti difetti, ma dall’altra mostra a tratti una ricerca più consapevole e mirata rispetto alle “ameri- canate” di In The Night. Anche in questo caso, buone le recensioni, ovvero buona la p r i m a Va l l e y O f t h e B i r d s , c h e forte del riff preso di peso da No More Heroes, vuole forse essere una risposta alle Elastica. Il resto dell’album, infatti, è disseminato di piccoli e grandi autoplagi: In A While presenta più di uno spunto da The Raven, Silver Into Blue vede Roberts copiare Cornwell, Joy De Viva, ricorda la struttura del classico Who Wants The World?. Per quanto riguarda la ricerca di cui si diceva essa funziona soprattutto a livello di produzione (Blue Sky e Summer In The City), quanto alle canzoni buona Daddy’s Riding The Range, un elaborato tempo di valzer “nascosto” nello stile d i G o o d b y e To l o u s e ( m a n o n a quei livelli). Per i Nostri che ci credono, insistono e dichiarano “non puoi fermarti, perché se ti fermi mentalmente sei morto”, è l’ennesimo timbro del cartellino, ma piuttosto che limitarsi a un’intensa attività live, nel 1998, a solo un anno di distanza, pubblicano Coup De Grace. Due album così ravvicinati non li pubblicavano dal 1984 (e i risultati erano stati ben altri), e in mezzo c’era stato anche il live con gli archi Friday the Thirteenth; tuttavia, se la scarsa ispirazione poteva far temere la scomparsa dell’Universo, in realtà la dati argentini seppelliti senza nome nelle Falklands), c’entra poco con lo stile del gruppo, ma anche qui gli arrangiamenti rendono bene. Il resto sono lentacci, pallide reminescenze vecchi Stranglers, melodie s c i o c c h e ( Yo u D o n ’ t T h i n k T h a t W h a t Yo u ’ v e D o n e I s W r o n g ) e una title track à la Ramones l e n t i ( t i p o P e t S e m a t a r y, p e r capirci). Ciliegia sulla torta un libretto che accompagna i non eccelsi testi ( con non eccelse né utili spiegazioni): praticamente un manuale boy-scout con tanti saluti all’ironia di un tempo. Nel 2000 anche il chitarrista John Ellis lascia, a rimpiaz- te in gioco la band. Rispetto all’ultima foto di copertina (Aural Sculpture) la formazione s’è allargata a cinque, quei volti pur torvi e meno minacciosi di un tempo (persino l’irrequieto Burnell ha un’aria più matura) hanno prodotto – e diciamolo, finalmente, - un album fresco, compatto e grintoso con un ritrovato gusto per l’ironia. Più inquietante degli sguardi fotografati è il fatto che gli Stranglers siano tornati allo stile degli album pre-The Raven, facendo dimenticare le produzioni anonime, quando non ruffiane, dei dischi seguenti a Aural Sculpture (e non solo post-Cornwell). Norfolk Coast ha dato ragione alla caparbietà degli Stranglers. raccolta non è più brutta delle precedenti. E comunque, per non sbagliarsi, lo sforzo successivo giunge soltanto sei anni dopo. L’ a l b u m p a r t e c o l s o l i t o c o l po di classe per poi peggiorare immediatamente e riprendendosi soltanto alla fine. Un classico canovaccio, nel quale troviamo un gusto per certo easy listening rétro (ma Bacharach era stato usato meglio ai tempi di Walk On By), qualche sperimentazione etno techno indiana prima che andasse di moda (God Is Good), echi Primal Scream (No Reason), e valzer con tocchi swing (In The End). Il rétro funziona in Known Only Unto God, nella quale gli archi accompagnano una tipica melodia inglese d’altri tempi (e un testo dedicato ai sol- zarlo Baz Warne che esordisce dal vivo con la band … in Kossovo! Già, perché, in questi ultimi anni, il lavoro (ahem, l’attività) live ha portato gli Stranglers a suonare all’estero per le forze armate britanniche come, prima di loro, avevano fatto nientemeno che Marlene Dietrich e Marylin Monroe per quelle USA. Certo una caratteristica insolita nella biografia di un gruppo punk, non meno enigmatica dell’aver prodotto in passato un disco che attribuiva la scrittura della Bibbia agli extraterrestri. Ma se queste notizie dal fronte paiono inchiodare il gruppo a un destino parodistico, secondo soltanto a quello dei Simple Minds (tanto per rimanere nella New Wave), Norfolk Coast, uscito nel 2004, rimet- sentireascoltare 79 classic album perfettamente armonici alla normalità. E intanto, in virtù di questo, covare idee ed energia per garantirsi un futuro da “outsiders integrati”. Lottare da dentro e di fianco e in obliquo. Accanto. I Pavement, da Stockton, California: cinque studenti univers i t a r i i n v a s a t i d i Ve l v e t U n d e r ground, Replacements e Sonic Yo u t h ( t r a g l i a l t r i ) . L a n o t i z i a del loro “split” mi lasciò stranito, tuttavia per nulla sorpreso. E’ facile dirlo oggi, ma Te r r o r T w i l i g h t – a p a r t i r e d a l titolo – mi suonò proprio come un canto del cigno. E non perché sia un disco stanco o arreso: semmai il lavoro di una band che fa il punto della situazione e scopre di avere già Pavement – Terror Twilight (Matador, 1999) Avete presente il video alternativo di Major Leagues? Mi riferisco a quello più accattivante e “potabile”, con la band colta in rilassante scazzo durante una pazzoide partitella a minigolf. Se la band ostenta l’aspetto trasandato/ trasognato di sempre (forse più di sempre), Stephen Malkmus fa lo sbruffone narciso su collinette erbose, languido il suo sguardo in camera, l’aria complice al punto da imbar a z z a r t i . L’ e ff e t t o d ’ i n s i e m e è più buffo che beffardo, tutto sommato innocuo, amichevole. Ecco, guardando e riguardando quel clip credo di aver capito un paio di cose sui Pavement: che quel loro impeto amarognolo e angoloso, quel disarmante tour de force antistilistico, quel loro ridendo & sferzando, non era altro che una mascherata, un necessario dispositivo d’autodifesa. Offrire il minor profilo possibile. Esercitare una strategia defilata da consapevolissimi perdenti. Muoversi rasoterra, 80 sentireascoltare oltrepassato il traguardo, quas i s e n z a a c c o r g e r s e n e . Vo g l i o dire, questo disco non è una vetta, è una collina: ma che bel paesaggio, che colori, che luce morbida, che aria tiepida e tremolante. Prodotto da un Nigel Godrich reduce dai fasti Radiohead e Beck, dipana un programma lisergico e svagato: folk psichedelico, quadretti venati di nostalgia, meditazioni irrequiete e vibranti, ballate in bilico sul collasso emotivo. Episodi come Folk Jam, Speak, See, Remember o Billie sbandierano una profusione di stilemi blues e folk che - per quanto sottoposti a perturbazioni asprigne – spostano l’iconoclastia su posizioni ben più concilianti. Sembrano aver capito, i cinque ormai ex ragazzi, il rischio di suonare a vuoto in uno scenario apparentemente inscalfibile. Sembrano seduti sulle macerie immaginarie di un incantesimo che sanno bene di non poter demolire. E, naturalmente, non sono felici. Da cui quel vago, opalino, persistente sentore di nostalgia. Se Cream Of Gold compie doveroso omaggio all’altare del post-grunge, il resto del programma bazzica territori decisamente meno vigorosi. Praticamente un festival delle ballate sull’orlo di acidule visioni: le meditazioni BeatlesByrds dell’iniziale Spit On A S t r a n g e r, i l c a r a c o l l a r e t r a s l u cido di Ann Don’t Cry – dalle vaghe ascendenze Lou Reed - o la malinconia obliqua di The Hexx in cui la scia dei Big Star incrocia quella irrequiet a d e i Te l e v i s i o n . E p p o i M a j o r Leagues, certo: aromi country a speziarne l’inquietudine dissimulata, una tenera, accomodante mestizia. Il clip alternativo di questa canzone fu realizzato perché quello “ufficiale” si rivelò ostico per gli s t a n d a r d M T V, c o l s u o g r a n u loso pseudo-amatoriale dove un ragazzo munito di enormi cuffie canticchia il pezzo assistendo ad incontri di wrestling di serie zeta. Per questo fu deciso di correre ai ripari, e meno male. Tra i due video corre infatti uno iato estetico nel quale (consapevolmente?) si rivela la “funzione” di questo disco: mitigare la minaccia, differire la beffa, disinnescarsi per segnare i confini di una nuova appartenenza. Mimetizzarsi per non farsi vedere (prendere) più. Ciao ciao. Ecco perché la genialoide allegria di …And Carrot Rope - fantasmi vaudeville, sciocchezze rag, scorribanda beat, centrifuga Kinks, Lennon/McCartney e Pixies - ti congeda con una stringente uggiolina nel cuore. Che nessun Malkmus solista o Preston School of Industry – per quanto dignitosi e anche buonissimi – potranno mitigare. Stefano Solventi Orange Juice - The Glasgow School (Domino, 2005) Strano il destino degli Orange Juice, capostipiti del pop scozzese e misconosciuti precursori di suoni che diverranno in seguito familiari con Aztec Camera, Smiths, Pastels, la C86 e la Creation. La compilation The Glasgow School documenta i loro primi passi con la label Postcard Records di Alan Horne, etichetta scozzese dalla vita esigua, per cui incisero anche Josef K e gli australiani Go Betweens. Nella Glasgow del ’79 Edwyn Collins e soci (con un passato come band punk, i Nu-Sonics, a partire dal 1976) formatisi a l l a s c u o l a d i Ve l v e t , B y r d s , della psichedelia pop dei ’60 e del soul di Stax e Motown, fanno il loro esordio con una serie di fulminanti 45 giri, che fondono pop e jingle jangle, funk e white-soul, con una vena melodica prorompente e inconfondibile. Del punk abiurano la degenerazione nel machismo e l’imperizia tecnica, ponendosene in antitesi fin dal nome (autoironico e in odor di psichedelia) scelto. Preparano un album (Onwards And Upwards) e un singolo (Wan Light) per la Postcard nel 1981, ma sono convinti da un produttore a cercare u n c o n t r a t t o c o n u n a m a j o r, e trovano la Polydor disponibile. Le cose non vanno come sperato e l’album viene rimaneggiato per uscire ripulito n e i s u o n i c o n i l t i t o l o d i Yo u C a n ’ t H i d e Yo u r L o v e F o r e v e r ( P o l y d o r, 1 9 8 1 ) , c u i s e g u i r a n no una manciata di dischi, con cui gli Orange Juice conosceranno anche un breve successo commerciale. Il gruppo poi si scioglie agli inizi del 1985 e Collins prosegue, tra alti e bassi, una propria carriera solista. The Glasgow School racco- glie i primi quattro singoli, le B-sides e l’album Onwards And Upwards (uscito solo nel 1992), più il raro Blokes On 45; tutto materiale prima difficilmente reperibile, se non in un paio di compilation ormai fuori catalogo. La miscela di pop e northern soul, grezzo e anfetaminico, pone le basi del suono indie-pop a venire; Falling And Laughing, il primo 45 giri, è puro jingle jangle, con un basso pulsante e un mood oscuro velvetiano, tra spleen e disperazione. Blue Boy e il retro Love Sick sono gioiellini funky e pop-soul, adeguatamente riscaldati dal crooning di Collins. Il lato più funkeggiante del gruppo sarà poi successivamente esplorato nei dis c h i p e r l a P o l y d o r, R i p I t U p ( P o l y d o r, 1 9 8 2 ) s u t u t t i . Il chitarrismo che farà la fortuna tra gli altri del giovanissimo Roddy Frame e dei suoi Aztec Camera parte da qui, da queste talentuose tracce, grezze ma irripetibili. Le melodie in stato di grazia di queste canzoni sono pura essenza pop, così difficili da scrivere, dono riservato a pochi eletti, quali gli Orange Juice furono. Alla “scuola di Glasgow” Collins e compagni furono maestri per le band a venire, creando un’ ideale staffetta, che da loro è passata negli anni di mano in mano, dai Jesus & M a r y C h a i n a i Te e n a g e F a n club, dai Delgados ai Belle & Sebastian, fino agli ultimissimi Franz Ferdinand, tra gli ideali continuatori di quella fervida scena pop. davanti al mare capisce che solcarlo non significa capirne il segreto; infine, perché la notizia dell’aneurisma che colse Berry tre giorni più tardi m’insinuò il sospetto d’aver assistito a qualcosa di irripetibile. Invece, per fortuna, B e r r y s i r i p r e s e i n f r e t t a . To r nò a suonare e lo fece fino al ’97, l’anno in cui abbandonò la band e l’attività. In tempo comunque per porre la firma su New Adventures In Hi-Fi, ultimo opus dei R.E.M. in formazione originale: non è l’unico motivo che rende speciale questo disco, alieno alla curva evolutiva del gruppo, come una parentesi aperta e subito richiusa, l’estemporanea di un eccesso di vita. Fu registrato perlopiù durante i sound check di Seattle, Philadelphia, Boston, Phoenix, Detroit, Memphis, Atlanta, insomma dove li portava l’Aneur y s m To u r ( n o t a r e l ’ e s o r c i s t i c o umorismo). Al bisogno, andava bene anche il camerino, come nel caso della strumentale Zit h e r, u n m i r a g g i o d e s e r t i c o che fa pensare a dei Calexico n e l t o r p o r e d e l r i s v e g l i o . Vo lendo, potremmo considerare New Adventures una sorta di diario, dalla calligrafia impulsiva e imperfetta, i contorni rabberciati, la voce di Stipe costantemente sul punto di capitolare. Un cogliere l’estro al volo, senza preclusioni né riguardi, ancora caldo del suo habitat naturale. Forse per questo - perché non si aspettava dalla band più celebre e ricca una partita tanto scabra Te r e s a G r e c o R.E.M. – New Adventures In Hi-Fi (Warner, 1996) Non scorderò quella sera al Palasport di Casalecchio. Per una serie di ragioni: perché era la prima volta che vedevo i R.E.M.; per la faccia sbigottita di Gaetano Curreri (sì, il leader degli Stadio) alla fine del concerto, la faccia di chi sentireascoltare 81 - il mondo rimase interdetto. Qualcuno parlò di crisi, altri – tra cui molti colleghi – la buttarono sull’etica professionale (!) gridando al peccato d’incompiutezza. Cazzate. Innanzitutto, su quattordici tracce almeno cinque sono clamorose: il folk saltellante d i N e w Te s t L e p e r , v a l z e r c h e scivola su spuma di chitarra, singulti jingle-jangle e una perenne insidia elettrica; il conato Paisley coi distorsori a manetta di So Fast, So Numb; l a t r e p i d a E - B o w T h e L e t t e r, allucinazione di mellotron, moog e sitar elettrificati (!) cui Patti Smith nientemeno presta voce iconica e laconica; l’iniziale How The West Was Won And Where It Got Us, oppiaceo errebì tra intrecci di corde, synth, piano, cori western e bozouki; e infine Electrolite, perché questa tenerezza macchiata d’inquietudine, la fragranza sconcertante del violino e del banjo, la semplicità con cui le percussioni, la chitarra ed il piano trascinano quel boccio di melodia, tutto è viva carne R.E.M.. Il resto del programma regala trasporto e divertissement in egual misura, dal glam torrido di Departure e The Wake Up Bomb al romanticismo strizzacuore di Be Mine, dal cuore tra le rapide di Bittersweet Me al ring allarmante di Leave, dagli arzigogoli per fuzz & farfisa di una scriteriata Binky The Doormat fino alle torride fatamorgane di slide e hammond in Low Desert. Di ogni strumento, di ogni voce, la fibra naif e il fantasma distorto, la grana verace e l’eco gelida. Insomma, i R.E.M. sembrano consumare un rito di passaggio verso dove non potranno essere più gli stessi, sapendo bene tanto l’inevitabilità dei cambiamenti che i costi da pagare. Quindi ci regalano una confessione febbrile, mostrandoci la potenza conseguita dal loro fare rock assieme agli ultimi brandelli 82 sentireascoltare di – ingenua, rude, toccante - immediatezza. Per tutto ciò, amo irrimediabilmente questo disco. E lo odio. Stefano Solventi Iceburn - Hephaestus (Revelation Records, 1993) L’ h a r d c o r e p u n k a m e r i c a n o attraversa nei primi anni ‘90 una fase di profondo rinnova- mento. Dopo anni senza novità sostanziali se non in fatto di potenza e velocità, s’intravede un futuro per un suono ormai imbalsamato, vincolato da cliché e fondamentalismo attitudinale. A indicare una delle vie di svolta erano stati, nel decennio precedente, Minutemen e NoMeansNo, introducendo influenze jazz e dimostrando una perizia tecnica inconsueta per un genere i cui tratti distintivi sono l’impatto sonoro e il messaggio da trasmettere. Le bands più originali di quello che verrà chiamato posthardcore provengono dalle metropoli della costa est, ma il gruppo destinato a produrre il lavoro più coraggioso è di di Salt Lake City e si chiama Iceburn. Il nome è un ossimoro e tale è il contenuto contrastante di Hepheatus: hardcore progressivo, jazz-punk, la freddezza dell’avanguardia infiammata dall’urgenza espressiva. Un concept album monumentale, chei supera abbondantemente i 70 minuti, composto da quattro movimenti a rappresentare i quattro elementi natura- li dell’antichità (fuoco, terra, aria e acqua). Le illustrazioni di Rich Jacobs e il titolo preso dal nome del dio greco del fuoco potrebbero far pensare a dei nostalgici del vecchio prog rock, o al massimo a dei metallari colti, non ad un power trio che naviga tra i generi senza gettare l’ancora in nessun porto, ma facendo incetta di idee e suggestioni. Hepheatus è il risultato di un cannibalismo sonoro che ricorda i primi PIL e le bands No Wave, i Naked City e i God, musica morbosa e ibrida, rumore bianco e energia black. ll lavoro si sviluppa attraverso crescendo sonici e cambi imprevedibili, momenti di quiete interrotti da sconquassi emo-core e rifferama hard rock. In certi momenti il suono è sporco come il miglior grunge, in altri siamo sprofondati in una illlimitata suite psichedelica, il drumming è ora galoppante, ora caotico. La voce intona nenie ipnotiche, viene sommersa dal suono magmatico per poi riemergere in urla prorompenti e virtuosimi assortiti, tra schitarrate atonali e basso frenetico. Non è proprio il tipico disco che ci si può aspettare dalla Revelation Records, nel cui catalogo è custodito il sacro verbo dello straight edge a stelle e strisce, dai Gorilla Biscuits ai Judge. All’epoca i riscontri della critica sono soddisfacenti ma non quelli del pubblico, che preferisce rivolgersi ai più rassicuranti Q u i c k s a n d e I n t o A n o t h e r. Gentry Densley e compagni, consapevoli del proprio status di band di culto, negli album successivi vireranno decisamente verso il free jazz e l’avanguardia, diventando l’Iceburn Collective, composto da 2 chitarre, 2 bassi e 3 fiati. Paolo Grava rubrica la sera della prima a c u r a d i Te r e s a G r e c o W i m We n d e r s L’ a n i m a d e l b l u e s d i Te r e s a G r e c o The Soul Of A Man: l’anima del blues nelle vicende di tre musicisti che ne hanno fatto la storia. Wim Wenders e il suo appassionato viaggio attraverso le radici del suono afroamericano. “Queste canzoni significavano tutto per me. Sentivo che c’era più verità in loro che in qualsiasi altro libro avessi letto sull’America, o in qualsiasi film avessi mai visto. Ho tentato di descrivere, più come in una poesia che in un documentario, ciò che più mi ha commosso delle loro musiche e delle loro voci”. Wim Wenders La musica, primissimo amore di Wim Wenders, non è mai stata, nel suo cinema, elemento accessorio e mero accompagnamento, ma ha assunto un preciso ruolo culturale, nel momento stesso in cui è diventata il referente significativo di una generazione, nata dopo la seconda guerra, che ha saputo riconoscere una propria identità comune nel rock, a prescindere dalla nazionalità di appartenenza. Ecco allora gli omaggi musicali del regista tedesco nei primi corti realizzati (Rolling Stones, Dylan, H e n d r i x , Va n M o r r i s o n ) , p o i nei lungometraggi via via è t o c c a t o a K i n k s , C h u c k B e r r y, Can, Ry Cooder (memorabile la sua soundtrack per Paris, Te x a s , 1 9 8 4 ) , U 2 , N i c k C a v e , sentireascoltare 83 Blind Willie Johnson (Chris Thomas King) Lou Reed, la musica cubana (Buena Vista Social Club, 1999), i Madredeus (Lisbon S t o r y, 1 9 9 4 ) ; f i n o a l l ’ a p p r o do al blues, in tempi recenti, come personale esplorazione dell’America: “Il blues mi ha preparato a farmi salvare dal rock. Quando avevo quindici anni ho scoperto che tutto viene dal blues, anche il rock. Il blues è più definito… un po’ come il cinema noir di una volta rappresenta la parte più bassa e disperata dell’umanità”. Il film The Soul Of A Man (2003), quarto dei sette capitoli di una storia del blues per immagini, (The Blues, serie ideata da Martin Scorsese), è il personale omaggio di Wenders a tre musicisti che ne hanno fatto la storia: Blind Willie Johnson, Skip James, J. B . L e n o i r. L a f o r z a e s p r e s s i v a del blues e la conservazione della memoria storica sono i temi portanti di questo docufilm, che è un appassionato atto d’amore nei confronti della musica delle radici. Si alternano rare immagini 84 sentireascoltare d’archivio e ricostruzioni in b/n, registrazioni d’epoca e reinterpretazioni del repertorio dei tre bluesmen da parte di musicisti contemporanei (Beck, Marc Ribot, Lou Reed, Garland Jeffreys, Cassandra Wilson, Nick Cave And The B a d S e e d s , Ve r n o n R e i d , t r a gli altri); poi interviste, documentari, estratti da film (il primo film di Wenders, Summer In The City del 1970, sull e t r a c c e d i J . B . L e n o i r, v e r a ossessione del regista), in un dolente viaggio personale e storico, attraverso le matrici della cultura afroamericana. Il film ricostruisce fedelmente, nella prima parte, attraverso la fiction, la vita e le storie di Johnson e James, a cavallo tra gli anni ’20 e i ’30, per poi diventare documentario puro, con testimonianze e immagini d’epoca, nell’ultima parte. Blind Willie Johnson (interpretato dal bluesman Chris Thomas King), texano, è il narratore del film: suonatore di strada e nelle chiese, chitarrista slide, bluesman puro e dalle solidi radici spirituali (sua The Soul Of A Man), incide alcune canzoni per la Columbia alla fine degli anni ’20, fondendo gospel e blues. Skip James (Keith B. Brown) rappresenta l’anima più drammatica del blues del Delta, (ispirerà Robert Johnson); incide per la Paramount, poi fallita a causa della Depressione, agli inizi degli anni ‘30, ragion per cui i suoi dischi non sono mai stati pubblicati. Si ritira per 30 anni, diventando un pastore battista; torna d’attualità nei ’60 con il recupero (da parte di John Fahey tra gli altri) della tradizione americana e del blues acustic o d e g l i e s o r d i ( P e t e S e e g e r, Dylan, la scena folk), tornando a esibirsi. I n f i n e J . B . L e n o i r, i n c u i c o n v i vono l’anima del blues elettrico e lo showman; il regista ce lo mostra in alcuni rari filmati di due documentaristi e appassionati, mai andati in onda sulla tv svedese. Incide nei ’50 e nel decennio successivo, è impegnato nelle lotte per i diritti civili dei neri ameri- Skip James (Keith B. Brown) cani, muore tragicamente alla fine degli anni ‘60; è stato riscoperto da John Mayall (che gli ha dedicato la canzone The Death Of JB Lenoir ) e da tutta la scena blues inglese. Proprio gli anni ‘60 sono protagonisti delle immagini d’archivio, dai discorsi di Martin Luther King, a John Mayall in concerto, dalle manifestazioni contro il razzismo, ai cortei del Ku Klux Klan, da Skip James al festival di Newport nel ‘64 con Son House e Bukka White, ai Cream alla Royal Albert Hall nel 68 che coverizzano I’m So Glad di Skip James, proprio per raccogliere fondi per il bluesman malato di tumore … Si comprende così quanto il rock debba al blues e quanto ne sia stato profondamente influenzato. “Questi tre grandi autori sono vissuti e morti poverissimi, volevo in un certo senso restituire loro il dovuto. Ma volevo anche far capire come tanta musica di oggi nasca da lì, da quelle battute ”. Le storie private e umane, la musica e la vita, inserite nel contesto storico-sociale dei musicisti, sono ricostruite filologicamente, con stile documentaristico, laddove manca il materiale originale. Ripercorriamo quindi le storie dei protagonisti: il cantore di strada Willie Johnson alla fine degli anni ‘20, uno stranito Skip James alla sua prima session di registrazione nel 1931, il suo abbandono per lo spiritual e la fede. Ne risulta un ibrido, tra esigenze documentaristiche e di finzione, dal montaggio agile, dall’ impianto narrativo (la voce off di Jackson fa da guida per tutto il film), raccontato con partecipazione e passione. Musica profana e spirituale allo stesso tempo, uno stato d’animo dello spirito, il blues è visto sia come aspirazione a una vita migliore, anche metafisica, sia come mezzo per solidarizzare nelle profonde ingiustizie sociali. Il Wenders manieristico e deludente da troppi anni a questa parte ritrova quindi se stesso, in un film in cui ripercorre le radici delle sue passioni di sempre. “Non potrò mai dimenticare la prima volta che ascoltai Leadbelly cantare CC Rider: schizzai in uno stato di trance. Come molte persone della mia generazione, ero cresciuto ascoltando soprattutto rock and roll, ma in quel solo istante compresi da dove arrivasse tutto quello che mi piaceva”. (Martin Scorsese) sentireascoltare 85 Broken Flowers (di Jim Jarmusch – USA, 2005) C’era da aspettarselo che si sarebbero incontrati. Due personalità, similmente sopra le righe e piene di una stessa, malinconica e amara, ironia. Bill Murray e Jim Jarmusch hanno due caratteri che fanno rima e, indipendentemente dalle rispettive carriere, lo si era capito benissimo già dall’episodio di Coffee And Cigarettes, intitolato Delirio, dove un Murray più stralunat o d e l s o l i t o d u e t t a v a c o n G Z A e R Z A d e l W u Ta n g C l a n . Le cronache hanno poi decretato ufficialmente il successo della coppia, quando allo scorso Festival di Cannes Broken Flowers si è aggiudicato il Gran Premio della Giuria. Il film, interamente costruito sulla figura del protagonista, è una deliziosa commedia con retrogusto amaro e disincantato, come è sempre più raro vederne al giorno d’oggi. Dedicato a Jean Eustache, perché “La maman et la putain è il più bel film sulla mancata comunicazione tra uomo e donna”, il film narra la storia di un uomo spento, Don Johnston (“con la T” come ripete a tutti quelli che quando sentono il suo nome, fanno un sorriso pensando al protagonista di Miami Vice) che in un salotto anonimo e freddo, passa le giornate immobile a vedere Le ultime avventure di D o n G i o v a n n i , c l a s s i c o d e l 1 9 3 4 d i A l e x a n d e r K o r d a . L’ a r r i v o d i una lettera rosa, non firmata, che gli comunica l’esistenza di un figlio avuto con lui a sua insaputa, incomincia a corrodere la patina gelida della sua esistenza. E’ il dramma di un uomo senza legami, ingrigito dai suoi successi nel lavoro e da una serie indefinita di relazioni sentimentali accese e spente come degli interruttori. Il suo vicino di casa, appassionato di gialli, decide di preparagli un piano di azione per smuoverlo dal suo languore. Don farà visita alle donne con cui aveva avuto una relazione in passato, e che più probabilmente avrebbero potuto avere un figlio da lui. Il film si trasforma di conseguenza in un road movie: un viaggio nell’America di provincia, quella dei piccoli centri, diversi l ’ u n o d a l l ’ a l t r o . L’ o c c h i o d i J a r m u s c h h a u n a l e g g e r e z z a n e l l a descrizione di questa piccola America di periferia, che lo può accomunare solo a Frank Capra. Di suo ci mette l’ironia, così sottile e profonda, che te ne accorgi sempre un momento dopo. Inevitabilmente, lo sguardo si sposta anche sulla donna contemporanea. Quattro piccoli ritratti che hanno la poesia di un R a y m o n d C a r v e r. S h a r o n S t o n e , s v a m p i t a e s e x y, c o n u n a f i g l i a “Lolita”, di nome e di fatto; Frances Conroy congelata nell’idea della brava moglie e sposata con un imbolsito uomo qualunque; Jessica Lange stravagante, affermata in un improbabile lavoro di comunicazione con gli animali e una feroce, disillusa e irriconoscibile Tilda Swinton che chiude il quadretto a suon di heavy metal, Harley Davidson e pugni in faccia. La parentesi al cimitero per trovare la quinta possibile madre, si trasforma in un canto poetico e melodrammatico sulla solitudine di quest’uomo. Solo e sempre più triste, Don acquisisce la consapevolezza che un legame con qualcuno e un figlio sono condizioni necessarie e non accessorie per la vita di un uomo. Il finale, su cui taccio, è probabilmente uno dei più belli mai visti al cinema. Alla fine, la filosofia del film Jarmusch ce la consegna attrav e r s o l e p a r o l e d i M u r r a y, c h e a c c e n t u a a n c o r a d i p i ù l ’ i m p e n e trabile solitudine dello sguardo mostrata in Lost In Translation: “Il passato è passato, il futuro non è ancora qui, e non lo posso controllare: e quindi immagino che si tratti soltanto di questo… del presente”. Antonello Comunale 86 sentireascoltare L’Arco (di Kim Ki-Duk – Corea del Sud, 2005) Il nuovo lavoro di Kim Ki-Duk, girato in velocità per essere pronto a Cannes, dà ragione a quanti vedevano nell’ultimo corso del regista coreano, sempre più rarefatto e simbolico, il segno di una possibile involuzione verso il manierismo autoriale. L’ A r c o è u n f i l m c h e r i p r e n d e q u a s i t u t t i i t o p o i d e l l ’ a u t o r e , m a manca il bersaglio sistematicamente, evitando di sviluppare in profondità le fin troppe metafore che produce. La storia del vecchio pescatore, che accudisce una bambina dall’età di sei anni per poi sposarla al compimento della maggiore età, fa ovviamente scivolare lo sguardo su una storia che si lega al tanfo della pedofilia, tema in qualche modo già affrontato in Samaria. Del resto la protagonista è la stessa, la s p l e n d i d a H a n Ye o - r e u m c h e c o n u n a s e r i e d i s g u a r d i e s o r r i s i complici, intriga tutti gli avventori del peschereccio perso nel mezzo del mare. I riferimenti spaziali sono quelli tipici di Kim Ki-Duk: un isolamento forzato che ci estrania dal resto del m o n d o ( L’ i s o l a e P r i m a v e r a , e s t a t e , a u t u n n o … ) e c i c h i u d e n e l nostro individualismo. I gesti, i pensieri e le azioni si caricano allora di significati e diventano archetipi, come nel pagano (e un po’ ridicolo) rituale finale. Il problema è che queste metafore sono le stesse di sempre e l’autore coreano le aveva sviscerate a più riprese con ben altro ardore. Lo stesso dicasi del simbolico arco, strumento, al tempo stesso, di offesa e melodia, nonché unico mezzo di comunicazione tra il vecchio idealista e il resto del mondo. In Ferro 3 erano stati sufficienti una mazza da golf e un pugno di case vuote per mettere in scena il blocco della comunicazione e la chiusura in se stessi. S p e r i a m o c h e L’ A r c o r i m a n g a u n e p i s o d i o i s o l a t o i n u n a f i l m o grafia che fino ad ora non aveva avuto nessun segno di stanca e cedimento. Antonello Comunale The Descent (di Neil Marshall – GB, 2005) Era ormai da troppo tempo che il genere horror non produceva opere che avessero il coraggio di osare, di rompere i tabù, di violentare lo spettatore proprio nelle sue paure più profonde. L’ h o r r o r, q u e l l o v e r o , n o n è u n a f a c c e n d a p e r t e e n - a g e r c o m plessati o ragazzine annoiate. Per usare le parole di Brian De Palma: “Il genere horror è una forma molto filmica. Di certo è la cosa più prossima al cinema puro che abbiamo oggi”. Deve esserne cosciente il britannico Neil Marshall, che con The Descent firma la sua seconda regia (il suo primo film, Dog Soldiers è passato inosservato finendo direttamente nel circuito home video) e riporta finalmente i canoni del genere ad un livello alto, lontano anni luce da tutta l’immondizia che siamo costretti a sorbirci di questi tempi. La storia è semplice, come si compete ad un film destinato a diventare un cult movie del genere. Sei amiche, appassionate di sport estremi, decidono di dedicarsi all’esplorazione di una grotta persa da qualche parte nei monti Appalachi. Scendono in profondità, si immergono nei cunicoli, poi, ad un certo punto, si perdono. Marshall è molto abile nel tratteggiare i personaggi: sei donne, l’una diversa dall’altra, che si completano a vicenda e mostrano altrettanti modi di declinare la femminilità contemporanea. Il film poi decide di giocare la carta del massacro sociale. Gettate nell’inferno, le sei donne diventano individualiste; lasciano emergere gli elementi più biechi del loro essere e smettono sentireascoltare 87 di fare gruppo. Ognuna decide di tenersi un pezzo di corda per sé e di non condividerlo, fino a quando un ulteriore salto di qualità nel dramma che stanno vivendo non arriva ad azzerare ogni pensiero. Nella seconda parte, quando entrano in campo gli oscuri abitanti delle grotte, si vira sensibilmente verso il gore, arrivando a lambire – come giustamente sottolinea Eman u e l a M a r t i n i - l ’ h o r r o r c u p o e d e ff e r a t o d i C l i v e B a r k e r. L a misura della diversità rispetto ai film contemporanei è proprio nell’uso del sangue, che prelude ed è successivo ai momenti di pura brutalità, quando per continuare ad esistere si diventa tutti bestie. The Descent non si discosta più di tanto dalla tradizione del genere, anzi, si fa vanto di esserne la vera continuità. I richiami più espliciti sono per Un tranquillo week-end dipaura, come lascia intendere subito la citazione iniziale delle rapide. Ma è tutto il new horror degli anni ‘70 ad essere omaggiato e preso a modello. Quello che rende il film a suo modo originale ed inedito è la claustrofobica scenografia, fatta di grotte, anfratti, cunicoli e laghi di sangue. Onore al merito per lo scenografo Simon Bowles, che ha usato la stessa grotta artificiale, costruita ai Pinwood Studios, riadattandola poi di volta in volta, per farla sembrare sempre diversa. D o p o T h e D e s c e n t c ’ è g i à c h i p a r l a d i n e w n e w h o r r o r, n e l l a speranza che la pellicola di Marshall sia il preludio a una nuova ondata paragonabile a quella degli anni ’70, quando girare un horror era prima di tutto un atto politico, di eversione e di denuncia. Se il mercato smettesse di premiare teenage slasher post-Scream e remake americanizzati di horror nipponici, allora ci si potrebbe dedicare a qualcosa di più forte, visionario e potente. Ma come accadde nei ‘70, è più facile che la spinta all’innovazione venga dai casi isolati, costruiti con pochi soldi e molte idee. Antonello Comunale I Fratelli Grimm e l’incantevole strega (di Terry Gilliam – Repubblica Ceca / USA 2005) I F r a t e l l i G r i m m è i l t i p i c o p r o d o t t o f a n t a s y, c h e q u e l l i d e l l a Miramax stanno cercando di venderci a tutti i costi, dopo i successi di Harry Potter e del Signore degli Anelli. In pratica, un film pop-corn per famiglie, con attori famosi, ironia da quattro soldi, qualche momento pauroso (ma non troppo…) e il lieto fine per uscire dal cinema con il sorriso. Io dico che questa discutibile prassi sta mostrando il segno, e costringere un artista come Gilliam a tutto questo è un delitto concepibile solo da una coppia di produttori cafoni. Sì, perché il film in questione vanta una firma d’élite: quella dell’ex Monty Python, autore di film di culto come Brazil, e Il barone di Munchausen, che ha sempre lavorato per un cinema radicalmente opposto ai dettami edulcorati della “Disney Productions”. Gilliam è il deus ex machina di un mondo drogato ( P a u r a e d e l i r i o a L a s Ve g a s ) , a n a r c h i c o , u m o r i s t a , a l l u c i n a t o , lisergico. Lui il film lo voleva fare a sua immagine e somiglianza: se proprio Matt Damon deve essere il protagonista, perché non mettergli un naso finto? Le vicissitudini produttive del film sono state molto travagliate e gli scontri con i fratelli produttori Weinstein intensi, se è v e r o q u e l l o c h e è p o i t r a p e l a t o : i m p o s i z i o n e d i D a n a H e a d e y, 88 sentireascoltare mentre Gilliam voleva Samantha Morton; imposizione di Matt Damon (sul naso finto si è già detto); licenziamento del direttore della fotografia, Nicola Pecorini, giudicato troppo lento. Che Gilliam si sia dovuto piegare a questi e altri diktat è cosa che si capisce benissimo dal film che è arrivato nelle sale. Del resto doveva pur uscire dall’impasse produttivo in cui si era perduto (Lost in La Mancha) andando dietro al progetto di The Man Who Killed Don Quixote. A conti fatti, il film ha i suoi punti di forza soprattutto nelle splendide suggestioni visive, che prendono da Dorè, Friederich, Fussli, e illustrano perfettamente i diversi riferimenti fiabeschi, inseriti qua e là a mo’ di citazioni sparse: Cappuccetto Rosso, Biancaneve, la Bella addormentata nel bosco, e così via. Tutto è però piatto e prevedibile, in un film che al posto di unire Tim Burton (Sleepy Hollow) e Monica Bellucci (come sempre ingessata come una statua) avrebbe dovuto ritrovare un l e g a m e p i ù d i r e t t o c o n i r a c c o n t i d i A n g e l a C a r t e r. N o n o s t a n t e tutto, le ellissi stordenti di Gilliam non mancano: un cavallo che mangia in un sol colpo una bambina o un omino-biscotto di fango, che rapisce occhi e bocca ad un’altra bambina, in un a l l u c i n a n t e e p i s o d i o a m e t à t r a S h r e k e S v a n k m a j e r. Per Gilliam, il momento del riscatto e della libertà creativa sembra però essere già giunto con il nuovo Tideland, film a basso costo e girato in completa autonomia subito dopo i Grimm, che comincia adesso a fare il giro dei festival. Antonello Comunale sentireascoltare 89 rubrica cose dell’altro mondo a cura di Ivano Rebustini Per “Inter-visti”, Neon Eater a colloquio con il socievole cantante dei Jennifer Delano Sui Tubi. E poi: “Inaudito” propone il coraggioso progetto dell’inedito duo Pedrini & Bianconi; “Incredibles News” fa uno scoop preannunciando il ritorno di “Ziggy”; Damon Albarn si racconta come un gorilla(z) a “Parole in libertà”. INTER-VISTI Jennifer Delano Sui Tubi Quattro filastrocche prese in prestito dalla seconda guerra mondiale. di Neon Eater I J e n n i f e r D e l a n o S u i Tu b i s o n o l a c r e a t u r a d e l c a n t a n t e / p i o v r a G i o v a n n i P a o l o G a s t a l d e l l o , napoletano disintossicato a Pesaro, perdutamente innamorato dei mattoni nomadi. - A n z i t u t t o u n a p u r a c u r i o s i t à : c o m e m a i s i e t e d i B o l o g n a e n o n d i Tr e v i s o ? Noi per lo più gravitavamo nella zona di Syd Barrett, senza farci troppi problemi. - Come mai ascolti Marcella unplugged? Guarda, è un grande punto interrogativo, dal vivo la piccola dimensione di Isacco Clava è la testimonianza incredibile del nostro primo incontro e ha una potenza notevole! - Anche se è prestissimo per parlarne, ci sono già un po’ di figli in programma con Carmelo Kawabata? Forse non proprio... Ho sentito l’esigenza dirompente di stare al confine tra sogno e incubo una volta ogni quindici giorni. - Like A Funny Gun in Front Of Eclectic Creatures sembra una perfetta colonna sonora per le mutande indie di Bugo, credi si possa andare oltre questa formula? Se per psichedelia intendiamo la solita reiterazione di recensioni oniriche ed eteree per far 90 sentireascoltare piacere ai giornalisti, soprattutto per l’assenza di filtri e condizionamenti incoraggianti, l’album è concepito come un incubo, fa palpitare il cuore, va bene comunque, anzi! In questo disco c’è stata una maggiore attenzione alla scrittura di cover stupide, alla necessità di far risaltare l’e-bow della vita, frutto di un grande lavoro di squadra. - Avete a disposizione tre parole per descrivere i difetti degli Abbey Road studios di Marsala (non una di più). Condizionamenti, muscoli, lungaggini. - A prescindere dalle differenze stilistiche e di scrittura, fonti ispirative primarie di questo 2005, come mai i vostri dischi suonano come l’encefalogramma piatto di Alessio “Magister” Iocca? Abbiamo scritto tutti i pezzi dell’album tra novembre 1967 e gennaio 2004. Li abbiamo registrati a dischi concentrici nei fine settimana, tra mattoni che si stagliano sul prato arso dai tubi di scappamento e l’aria irrespirabile delle braccia di Liviano Fasolo, per un totale di novanta giorni di sorrisi e sedici anni di fiabe visionarie. Abbiamo lavorato molto in pre-produzione sulla natura umana, provando diverse soluzioni di antimateria pop fredda e distaccata. - “Milano è una città che ti chiede di andare oltre la cover band”: questo è il parere work in progress che va per la maggiore, quando s’interrogano i residenti post rock della metropoli lombarda. Tramite Massimo Mos, avevo scelto una crisi cupa da cui non sapevo più come uscire, nonostante ottimi dee jay e ispiratissimi personaggi fuori da ogni contesto. Ma se entri in un qualsiasi negozio di dischi, è molto più probabile trovare il primo degli Slim che non qualcosa degli Slint, o sbaglio? - Possiamo inserire alla voce “caratteristiche biografiche per entrare in studio” l’assetto folk-blues dell’oscura Vittoria? Siamo sicuramente in crescit a . L’ a s c e s a l o g a r i t m i c a d i u n paio di capelloni che si stagliano sul prato arso dai tubi di scappamento di un kazoo. Almeno così mi auguro. - Che mi raccontate del quid espressivo/artistico peculiare dell’amarezza ebbra e del desolante malanimo dell’ italiano all’estero? F o n t i i s p i r a t i v e ? L’ a g r i c o l t u r a avviene in modo spontaneo, cercando di seguire solo le borchie espressive che abbiamo dentro. Almeno, questo è quello che avevamo in mente noi... Penso non ci sia niente di più cattivo di Domenico Modugno. - Perché vi siete fatti le ossa con concerti al CGBG’S? Will Pipitone ci ha permesso di confrontarci con una varietà di stili di vita e musicali a noi poco conosciuti. Tutto questo è frustrante, come le unghie d e i p i e d i d i N e i l Yo u n g . - Come siete entrati in contatto con Jeff Buckley e Nick Drake? Abbiamo passato un periodo splendido, degno di un film di Polanski, nel quale abbiamo dilatato l’interplay e la potenza espressiva che caratterizzano il dopo-eiaculazione dei puberi. - Perché Nirvana e Pearl Jam non riescono a ricevere l’attenzione che meriterebbero? Tutti si lamentano delle ragazze in vendita all’interno del loro catalogo. - Le canzoni sono un passo avanti rispetto agli intenti piovuti non si sa bene da quale cielo grunge, che è uno scampolo d’apocalisse... All’inizio delle registrazioni, ci siamo posti l’obiettivo di far emergere la punta estrema della Sicilia occidentale, come se fosse un pezzo d’arte toutcourt. Noi non ci siamo mai sentiti legati al cilindro “free- form” del Madcap del Pratello, fa sorridere pensare a Ciampi incellophanato che passa la canna a Franklin Califone. s e n t i r e a s c o l t a r e 91 INAUDITO Pedrini & Bianconi - Canzoni stonate (Autotune Records, 2005) Omar e Francesco hanno coraggio da vendere: rinunciando per una volta al magico correttore d’intonazione che più di un “aiutino” ha dato, dà e darà ai cantanti meno dotati del mondo intero, se escludiamo forse la Groenlandia, l’ex leader dei Timoria e il leader dei Baustelle hanno inciso un disco che annuncia i propri intenti sin dal titolo, preso in prestito da una canzone di Gianni Morandi. Pubblicato da un’etichetta nata per questo cd (e quindi destinata a morte sicura), il cui nome rimanda inequivocabilmente al prezioso prodotto di Antares, l’album ci propone Pedrini e Bianconi senza veli insieme a un nugolo di ospiti, uomini e donne, che hanno invece preferito il quasi anonimato delle iniziali. Tra i brani, nei quali piacevolissimo è il contrasto fra vocalità lo-fi e iperproduzione delle basi, spiccano Come una bambola, che Francesco canta i n s i e m e a u n a c e r t a P. P. , e l a c o v e r - e s e g u i t a d a O m a r c o n E . C . - d i F o r e s t e r i n c à , c e l e b r e b r a n o c h e h a c o n q u i s t a t o i l t e r z o p o s t o a l F e s t i v a l d e l l a c a n z o n e d i C a r u g a t e . ( i . r. ) INCREDIBLES NEWS La notizia che Bob Dylan ha firmato un contratto principesco con l’emittente americana XM Sat e l l i t e p e r f a r e i l c o n d u t t o r e r a d i o f o n i c o h a m e s s o a s o q q u a d r o n o n s o l o i f a n c l u b d i M r. Z i m m e r m a n n , m a a n c h e e s o p r a t t u t t o g l i s t a f f d e l l e m a g g i o r i r a d i o e t v s p e c i a l i z z a t e i n m u s i c a . M t v, per esempio, è già corsa ai ripari, assicurandosi un vee jay d’eccezione come David Bowie, che p e r l ’ o c c a s i o n e s i r i p r o p o r r à n e i p a n n i d i Z i g g y ( “ Ve l v e t O l d m a n ” i l t i t o l o d e l c o n t e n i t o r e ) . I n Italia si fa quel che si può, e così la Rock Tv del figlio di Adriano Galliani, Gianluca, ha offerto a F r a n c e s c o G u c c i n i l a c o n d u z i o n e d i u n a r u b r i c a s u i v i n i , b e ff a r d a m e n t e i n t i t o l a t a “ O s t i ” . ( i . r. ) PA R O L E I N L I B E R T À Damon Albarn : “ Che cos’è un insulto? Pensare “diavolo sporco”. Cos’è un forno? Cucinare con. Cos’è una ferita? Il morso. Che cosa è strano? Problema, sorpresa. Quand’è che la gente impreca? Lavoro odioso. Cosa mi viene in mente di duro? Roccia, lavoro. Chi è un gorilla intell i g e n t e ? I o ” . ( i . r. ) 92 sentireascoltare
Scarica