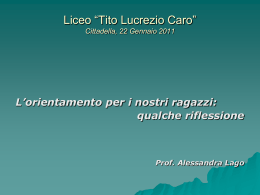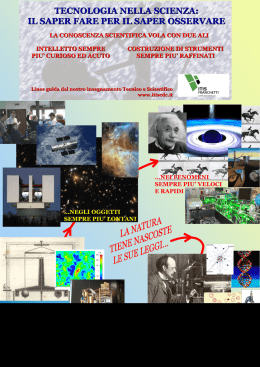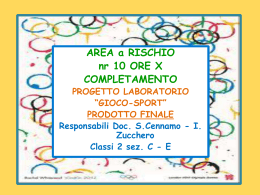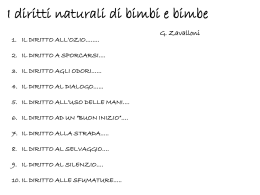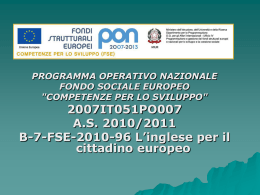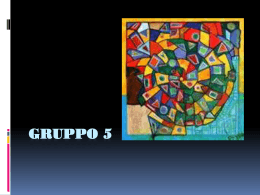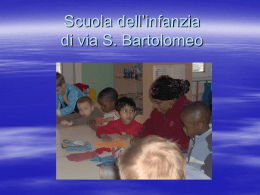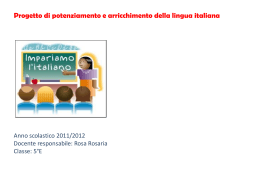Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Istituto d’Istruzione Superiore “Severi-Correnti” 02-318112/1 02-33100578 IIS Severi-Correnti via Alcuino 4 - 20149 Milano codice fiscale 97504620150 [email protected] [email protected] SITO WEB: www.severi.org codice ministeriale Istituto principale MIIS07200D Istituto associato IPIA ”C.Correnti” MIRI072015 Istituto associato Liceo Scientifico “F.Severi” MIPS07201X PROGRAMMAZIONE DI CLASSE CLASSE: 2 MAT Anno scolastico 2015 – 2016 LINEE GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA : 1. OBIETTIVI EDUCATIVI 2. OBIETTIVI DIDATTICI – COGNITIVI 3. METODI E STRUMENTI 4. CONTENUTI DI CIASCUNA DISCIPLINA (cfr allegati dei docenti) 5. ATTIVITA’ COMUNI (recupero e sostegno, percorsi pluri/interdisciplinari, viaggi d’istruzione, visite guidate ) 6. VERIFICHE (numero e tipologia) E CRITERI DI VALUTAZIONE 7. MODALITA’ DI INFORMAZIONE E CONFRONTO CON LE FAMIGLIE 1. OBIETTIVI EDUCATIVI Il C. di C. ritiene fondamentale sostenere un atteggiamento dialogante con gli studenti al fine di permettere la costruzione di un clima sereno e favorevole all’apprendimento, alla crescita culturale, civile, sociale equilibrata degli studenti e alla costruzione di rapporti di fiducia e di rispetto reciproci. A tal fine si considera basilare l’osservanza di alcune regole comportamentali: - rispetto dell’orario di entrata a scuola e inizio lezioni al termine degli intervalli; - comportamento corretto e responsabile durante il cambio dell’ora di lezione o in assenza - puntualità nel giustificare le assenze e i ritardi. - rispetto delle scadenze - rispetto delle strutture e degli arredi , delle attrezzature e degli spazi della collettività, del materiale scolastico di ogni singolo alunno. dell’insegnante Il C.di C. chiede, inoltre, diligenza e puntualità nel consegnare a casa avvisi e circolari. E’ fondamentale inoltre che ogni alunno si impegni ad: - acquisire o migliorare capacità di attenzione , concentrazione e autocontrollo sia verbale sia gestuale. - sviluppare relazioni sociali equilibrate e responsabili - riconoscere i ruoli di chi opera nella scuola rispettandone il lavoro. Naturalmente su tutto è di fondamentale importanza il rapporto costante e continuo con le famiglie 2. OBIETTIVI DIDATTICI – COGNITIVI Didattici-cognitivi conoscenze Uso consapevole del linguaggio specifico delle singole discipline Capacità di comprendere, rielaborare ed applicare i contenuti di ogni disciplina abilità Consolidamento delle capacità di organizzazione logica dei concetti Miglioramento progressivo del proprio metodo di studio Uso autonomo dei diversi strumenti didattici Sviluppo delle capacità di esporre e comunicare verbalmente e per iscritto in modo chiaro ed efficace competenze 3. METODI E STRUMENTI Ogni docente : Insegnerà ad ogni alunno a organizzare e pianificare il proprio lavoro attraverso il controllo del materiale, dei compiti assegnati e lo svolgimento di verifiche e test - Favorirà la partecipazione attiva, ma consapevole e ordinata - Presterà attenzione al dialogo tra studenti e tra docente e allievo in modo da favorire il raggiungimento degli obiettivi comportamentali, cognitivi e formativi. IL C.di C. terrà un comportamento coerente e comune per il raggiungimento degli obiettivi indicati. Lezione frontale x X X X X X Lezione partecipata X x X X X X x x elettronica tecnol. dell’nformaz. e comunicaz. Scienze della terra Religione Cattolica Tecnologia e tecn. di rapp. grafiche Educaz. Fisica Laboratorio tecn. Ed esercitaz. Elettrotecn. Chimica diritto Matematica fisica Inglese Strumento utilizzato Storia Itaiano Metodi di lavoro applicati X X X X x X Problem solving X Metodo induttivo x Lavoro di gruppo Discussione guidata X x x X x x x x X X x x x Simulazione Prove fisiche x 4. CONTENUTI DI CIASCUNA DISCIPLINA (cfr allegato 1) Le programmazioni di ciascuna disciplina saranno disponibili sul sito dell’IIS Severi-Correnti all’indirizzo: http://www.severi.org/ Le stesse potranno essere richieste in formato cartaceo direttamente in segreteria didattica. Di seguito verranno illustrati gli obiettivi minimi di ciascuna materia. Prof. Calvio Michele Disciplina Italiano 1. Finalità educative La padronanza della lingua italiana, intesa come capacità di ricezione e produzione scritta e orale, è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione che è possibilità di esprimersi, avere relazioni con gli altri, far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, interagire adeguatamente in pluralità di situazioni comunicative. Il percorso di conoscenza della storia e degli elementi basi della costituzione italiana sono inoltre passi fondamentali verso l’esercizio pieno della cittadinanza. 2. Obiettivi disciplinari Riconoscere le caratteristiche strutturali e linguistiche di alcuni tipi di testo Saper leggere testi riconoscendone alcuni elementi caratterizzanti Saper operare sintesi Saper analizzare le tipologie testuali narrative e poetiche Essere in grado di distinguere e analizzare le seguenti tipologie di testo: Mito, fiaba Racconto Romanzo Gli elementi del linguaggio poetico: Cogliere gli elementi fondamentali della poesia Decodificare il contenuto di un testo poetico attraverso i simboli, i messaggi e i temi Individuare le tematiche principali e secondarie Conoscere le tecniche di esecuzione per parafrasare e commentare un testo Incontro con gli autori Saper elaborare testi scritti diversificati Saper operare sintesi 3. Obiettivi minimi Riconoscere le caratteristiche strutturali e linguistiche almeno dei tipi di testo più semplici Saper leggere testi riconoscendone alcuni elementi caratterizzanti Saper operare sintesi semplici Saper analizzare le tipologie testuali narrative e poetiche più semplici Essere in grado di distinguere e analizzare almeno una delle seguenti tipologie di testo: Mito, fiaba Racconto Romanzo Gli elementi del linguaggio poetico: Cogliere gli elementi fondamentali della poesia Individuare le tematiche principali Conoscere le tecniche di esecuzione per parafrasare e commentare un testo semplice Incontro con gli autori Saper elaborare testi scritti descrittivi Saper operare sintesi 4. Contenuti COMPETENZA Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in varicontesti ABILITA’ Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico. Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: ortografia morfologia sintassi della proposizione lessico. COMPETENZE Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario ABILITA’ Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi; Leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti dalle letteratura italiana e straniera. Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello altrui. Strutture essenziali dei testi narrativi e poetici Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana, europea e di altri paesi, inclusa quella scientifica e tecnica Il mito (1) Versi, rime strofe : cenni (2.1) Significato e figure retoriche: cenni (2.2) L’analisi del testo poetico: cenni (2.3) Un esempio di poesia d’amore Un esempio di poesia della natura Incontri con l’autore: esempi di poesia italiana dell’Ottocento COMPETENZA Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi ABILITA’ Utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio appunti, scalette,mappe. Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare ipertesti, ecc. Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione; varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai contesti comunicativi Modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, titolare, parafrasare, relazionare. Prof: Michele Calvio Materia: Storia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Finalità educative Far assumere agli alunni la coscienza di vivere in una società in evoluzione (rapporti fra passato, presente, futuro). Aiutarli a riconoscere i rapporti fondamentali su cui si basa una società, un gruppo sociale. Aiutarli ad acquisire un metodo utile per l’indagine della realtà umana (raccolta dati, analisi, selezione delle informazioni, concatenazione, sintesi. Recuperare la memoria del passato Orientarsi nella complessità del presente Sollecitare la riflessione, attraverso lo studio del passato, sulle problematiche della realtà presente. Riconoscere la peculiarità dell’indagine storica. Riconoscere i valori autonomi delle diverse civiltà e culture Permettere agli alunni di ampliare i loro orizzonti culturali nella difesa dell’identità personale. 3. Obiettivi disciplinari Gli obiettivi disciplinari si riassumono nelle seguenti COMPETENZE BASE da ottenere: 1.Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica (attraverso il confronto tra epoche) e sincronica (attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali) 2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente I singoli e specifici obiettivi disciplinari sono i seguenti: 1. sa collocare i fatti in ordine temporale 2. li colloca nella linea del tempo 3. sa leggere e costruire tabelle sinottiche e grafici 4. sa riferire e collocare nello spazio i fenomeni analizzati 5. si esprime in modo corretto. 6. é in grado di sostenere un argomento dei contenuti forniti 7. Impiega in modo appropriato il manuale 4. Obiettivi minimi. 1, 2, 3; 6; 7 5. Contenuti Metodo di lavoro Organizzazione del lavoro in classe e a casa Presentazione del piano di lavoro e del manuale con letture mirate alla comprensione del testo Suddivisione e classificazione delle informazioni in principali e secondarie Criteri di cronologia e sistemi di datazione Lettura di carte geografiche, tematiche, tabelle, grafici e documenti Le fonti storiche rapporti causa-effetto Obiettivi: sa utilizzare il manuale sa schematizzare e gerarchizzare le informazioni conosce i sistemi di datazione , utilizzare e costruire cronologie, distinguere le fonti primarie dalle secondarie distingue i vari tipi di grafici e saperli costruire saper individuare i diversi tipi di cause e le relative conseguenze sa prendere appunti Apogeo e caduta dell’Impero Romano Nascita e diffusione del Cristianesimo L’Alto Medioevo Regni romano-barbarici Bizantini, Longobardi, Franchi La civiltà araba L’età feudale Carlo Magno ed il Sacro Romano Impero Il Sacro Romano Impero Germanico Le invasioni Ungare e Saracene Lo Scisma d’Oriente La società feudale La formazione della civiltà cinese Cittadinanza e Costituzione Le forme di governo Liberismo e socialismo Uno sguardo sull’attualità: lettura di brani tratti da Gomorra di Roberto Saviano Docente: Emanuela Zuffellato Disciplina: Lingua inglese Standard minimi: comprensione globale di testi orali e scritti, comprensione delle informazioni esplicite di testi orali e scritti, produzione di semplici testi orali e scritti che dimostrino la conoscenza sufficiente delle strutture di base, delle nozioni e funzioni affrontate nel biennio. Al termine del biennio, lo studente dovrebbe aver acquisito una competenza comunicativa tale da permettergli di: comprendere espressioni di uso quotidiano, esprimersi su argomenti di carattere quotidiano. Produrre semplici testi (riassunti, lettere informali, schede), saper formulare e rispondere a questionari completare open-dialogues e costruire dialoghi su traccia. ASSE DEI LINGUAGGI/MATEMATICO/SCIENTIFICO-TECNOLOGICO/STORICO SOCIALE Utilizzare la lingua straniera per interazioni quotidiane in modo sempre più autonomo, (con gradualità nel primo biennio). Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia) e sugli usi linguistici (funzioni, registro linguistico) anche in un’ottica contrastiva con la lingua italiana. Conoscenza ed approfondimento della cultura e dei costumi del paese straniero. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA sviluppabili nell’ambito della disciplina Saper comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico), mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. Acquisire ed interpretare l’informazione criticamente nei diversi ambiti, attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità, distinguendo fatti e opinioni. ELENCO MODULI Module 3: From Unit 9 to Unit 12 UF 1: Conoscenze Past simple regular and irregular verbs (all forms). Interrogative pronoun: How long?. Present simple: future (timetables). Past simple regular and irregular verbs (all forms). It takes. Subject/object questions: Who? What? Sequencers ( First, then, next…), every/some/any/no compounds. Abilità Talking about the Past, talking about holidays, using public transport; talking about the Past. UF 2: Conoscenze Whose and possessive pronouns, imperative. Prepositions of place and movement. Comparative adjectives, superlative adjectives, is/are wearing. Modulo 4: From Unit 13 to Unit 16 UF 1: Conoscenze Be going to: future intentions. Present continuous: future arrangements. Future time expressions (next week, in two days’ time…). Be going to vs. Present continuous vs. Present simple. Be going to: predictions based on present evidence. What’s he like? vs. What does she like?. Qualifiers: not enough, a little bit, fairly, pretty. too. Abilità Asking about possession, asking for and giving directions. Making comparisons and expressing preferences. Shopping for clothes, describing clothes. Abilità Talking about future intentions. Making and talking about arrangements. Describing personality. Talking about the weather. Making sure predictions. UF 2: Conoscenze Present perfect: ever /never, been / gone, recently. Present perfect vs. Past simple. Agreeing and Disagreeing, So have I/ Neither have I./Oh. I did./Oh I didn’t. Present perfect: just/already/yet. I’ll…, and Shall I/we…?, offers. Will: spontaneous decisions. Abilità Talking about experiences, comparing experiences. Making offers of help and accepting/refusing offers. Talking about recent events. Docente: Mascherpa Disciplina: Matematica Fi na l i tà ed uc at i v e Pr om uo v e re l e f ac ol t à in tu i t i ve e lo g ic he E duc ar e a i pr oc es s i d i as tr a zi o n e e d i f orm a zi on e de i c o nc e t ti Es erc it are a l r ag i o na m ento i nd u tt i v o e d e du tt i v o S v i lu p par e e p o te n zi ar e l e c ap ac it à d i a na l is i e d i s i nt es i. O b ie tt i v i d i a p pr e n d i m ento - S ol l ec it ar e l’ es pr es s i on e at tr a v er s o u n l i ng ua g g io s em pr e p iù c hi aro , c orre tt o , pr ec is o e r i go ros o a v va l e nd os i d i s tr um en t i q u al i a d es em p io s im bo l i e r a p pr es e nt a zi o n i gr af ic h e . - G u id ar e a l l ’a n al is i e a l l a s i nt es i ed uc an d o a d u n a pro gr es s i va c h iar if ic a zi o n e d ei c onc e tt i, a l ric o n os c im en t o d i a na l o gi e i n s i t ua zi o n i d i vers e p er g i un g er e a d u na v is i o ne un i tar i a s u a lc u n i c o nc e tt i c e n tra l i. - G u id ar e a l la c ap ac it à d i am pl i ar e i c onc e tt i e a l l’ us o d i m od e l l i. O b ie tt i v i s p ec if ic i d e l l’ i ns e g nam en t o ne l s ec on d o a nn o: - A ppr of o n di r e e am pl ia r e l e pr op r i e tà d e i n u m eri - Ca lc o lar e c o n l e pr o pr i et à d el l e p ot e n ze - Es eg u ir e r a pi d am ent e i c a lc ol i - Ut i l i z zar e c o ns ap e v ol m ente il l in g ua g g io d e l l e l et ter e - Ris o l v ere eq u a zi o n i e pr o b l em i c o n l e e q ua zi on i - Ris o l v ere e d is c u te r e eq u a zi o n i l et te ra l i - O p erar e c o n s e gm ent i e a ng o l i - A pp l ic are i c r i ter i d i c on gr u en za d e i tri a n go l i, i l c r it er i o d i p ara l l e li s m o e l e pr opr i et à d e i qu a dr i la ter i - A pp l ic are le pr o pr i et à de g l i a ng o l i n ei po l i go n i per de t erm in are le am pi e z ze de g l i an g o l i i n s em pl ic i f ig ur e - c a lc o l ar e l a pr o b a bi l i t à d i s em pl ic i e v en t i, a pp l ic an d o i t eo rem i f o nd am en ta l i Testo adottato Fragni – Botta – Colombo – Ciceri MATEMATICA IN PRATICA vol.2 Ed. CEDAMscuola OBIETTIVI CONTENUTI Monomi Definizioni Operazioni tra monomi M.C.D e m.c.m. di monomi OBIETTVI MINIMI PERIODO Settembre Ottobre Polinomi MODULO 0 RIPASSO Definizioni Operazioni tra polinomi Prodotti notevoli Divisione di polinomi Teoremi del resto e di Ruffini Regola di Ruffini MODULO 2 EQUAZIONI DI PRIMO GRADO MODULO 1 CALCOLO LETTERALE SAPERE Cos’è un’espressione algebrica Cosa significa scomporre in fattori SAPER FARE Fattorizzare un polinomio Calcolare MCD e mcm fra polinomi Semplificare una frazione algebrica Eseguire operazioni con le frazioni algebriche SAPERE Che cos’è un’equazione Classificare un’equazione Che cos’è l’insieme delle soluzioni di un’equazione Che cos’è un’equazione determinata, un’equazione impossibile, un’identità Quali sono i principi di equivalenza per le equazioni Equazioni equivalenti Scomposizione di un polinomio in fattori Saper scomporre in fattori primi semplici Novembre polinomi con l’uso dei prodotti notevoli MCD e mcm tra polinomi Frazioni algebriche e loro semplificazione Saper semplificare una frazione algebrica Saper eseguire le operazioni con le Riduzioni di frazioni algebriche al mcd frazioni algebriche Operazioni tra frazioni algebriche Equazioni lineari Identità Generalità sulle equazioni Principi di equivalenza Risoluzione di equazioni razionali numeriche intere Equazioni frazionarie Saper risolvere semplici equazioni di primo grado intere e frazionarie Dicembre MODULO 3 SISTEMI LINEARI MODULO 4 L’INSIEME DEI NUMERI REALI E I RADICALI OBIETTIVI SAPER FARE Risolvere un’equazione di primo grado in una incognita Risolvere un’equazione fratta e discutere i risultati in relazione al dominio Risolvere una disequazione SAPERE La definizione di un sistema Il significato di sistema determinato, indeterminato, impossibile Il significato di soluzione di un sistema SAPER FARE Discutere un sistema Risolvere sistemi lineari di n equazioni in n incognite con i metodi di sostituzione, Cramer SAPERE Definire R e indicarne le caratteristiche Definire la radice n-esima nell’insieme dei numeri reali Enunciare le principali proprietà dei radicali Definire le potenze con esponente razionale ed elencarne le proprietà SAPER FARE Rappresentare sulla retta un numero reale Approssimare un numero reale Semplificare un radicale Eseguire semplici operazioni con i radicali Razionalizzare il denominatore di una frazione Trasformare radicali in potenze con esponente razionale e viceversa CONTENUTI Sistemi lineari Generalità Principi di equivalenza Discussione di un sistema lineare di due equazioni in due incognite Matrici e determinanti Risoluzione di un sistema di n equazioni in n incognite con i metodi di sostituzione e Cramer OBIETTVI MINIMI PERIODO Saper risolvere semplici sistemi di primo Gennaio grado utilizzando il metodo di sostituzione Febbraio o quello di Cramer Calcolo con i radicali Febbraio Riduzione allo stesso indice e Saper eseguire le seguenti operazioni semplificazione con i radicali: Prodotto, quoziente, elevamento a semplificare, moltiplicare, dividere, potenza ed estrazione di radice di radicali trasportare fattori dentro e fuori il segno di radice, elevare a potenza, sommare Trasporto dentro e fuori dal segno di radice Somma di radiceli ed espressioni irrazionali Razionalizzazioni Potenze con esponente razionale MODULO 5 EQUAZIONI DI SECONDO GRADO OBIETTIVI SAPERE Riconoscere le equazioni algebriche di secondo grado scritte in forma normale Riconoscere le equazioni di secondo grado spurie, pure, complete Dire quando un’equazione di secondo grado è risolubile o impossibile Discutere la risolubilità nell’insieme dei numeri reali di un’equazione di secondo grado attraverso il suo discriminante Scrivere le formule che legano la somma e il prodotto delle soluzioni di un’equazione di secondo grado con i suoi coefficienti Scrivere la formula per fattorizzare in R un trinomio di secondo grado SAPER FARE risolvere equazioni di secondo grado in R risolvere in R equazioni di secondo grado fratte scrivere un’equazione di secondo grado di soluzioni assegnate trovare due numeri reali di cui sono noti somma e prodotto fattorizzare in R un trinomio di secondo grado CONTENUTI OBIETTVI MINIMI PERIODO Equazioni di secondo grado Generalità Risoluzione di equazioni di secondo grado incomplete e complete Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado Scomposizione del trinomio di secondo grado Saper risolvere semplici equazioni di secondo grado intere e fratte Marzo MODULO 6 DISEQUAZIONI OBIETTIVI SAPERE Definire una disequazione i concetti di intervallo e di insieme delle soluzioni di una disequazione i principi di equivalenza delle disequazioni OBIETTVI MINIMI Saper risolvere disequazioni numeriche intere PERIODO Aprile calcolare la probabilità di semplici eventi, applicando i teoremi fondamentali Maggio SAPER FARE risolvere disequazioni numeriche di primo grado risolvere disequazioni fratte e altri tipi di disequazioni riconducibili al primo grado SAPERE illustrare le definizioni di probabilità secondo l’approccio teorico, frequentista e soggettivo illustrare gli assiomi del calcolo delle probabilità e il principio fondamentale del calcolo combinatorio enunciare i primi teoremi di calcolo della probabilità descrivere i concetti di probabilità condizionata e di eventi indipendenti SAPER FARE MODULO 7 PROBABILITÀ CONTENUTI Principi di equivalenza delle disequazioni Risoluzione delle disequazioni di 1° grado Disequazioni frazionarie Disequazioni di grado superiore al primo calcolare la probabilità di semplici eventi, applicando i teoremi fondamentali risolvere problemi di conteggio utilizzando diagrammi ad albero o il principio fondamentale del calcolo combinatorio riconoscere eventi indipendenti Eventi certi, impossibili e casuali Spazio delle probabilità Definizione classica di probabilità Proprietà additiva della probabilità Eventi indipendenti e teorema del prodotto Legge empirica del caso OBIETTIVI SAPERE CONTENUTI OBIETTVI MINIMI Dare la definizione di poligoni equivalenti e conoscere i teoremi di equivalenza Definire l’area di un poligono e conoscere le formule per calcolare le aree dei principali poligoni Conoscere il procedimento per ricavare la misura della lunghezza della circonferenza e dell’area del cerchio Enunciare e dimostrare il teorema di Pitagora Enunciare il teorema di Talete ed alcuni suoi corollari Definire la similitudine fra poligoni Enunciare i criteri di similitudine per i triangoli Area di figure piane Equivalenza ed equiscomponibilità Aree dei poligoni Dare la definizione di poligoni equivalenti Definire e calcolare l’area di un poligono Enunciare e applicare il teorema di Pitagora Enunciare il teorema di Talete Enunciare e applicare i teoremi di Euclide Definire la similitudine tra poligoni MODULO GEOMETRIA SAPER FARE - Riconoscere poligoni equivalenti - Calcolare l’area di un poligono - Applicare il teorema di Pitagora per calcolare lunghezze - applicare il teorema di Talete - scrivere proporzioni fra i lati corrispondenti di due poligoni simili - applicare le relazioni fra lati, perimetri e aree di poligoni simili Similitudine Proporzionalità tra segmenti Corrispondenza parallela di Talete Teorema di Talete La relazione di similitudine Triangoli simili Criteri di similitudine dei triangoli Proprietà dei triangoli simili Teoremi di Euclide Teorema di Pitagora PERIODO da Ottobre a Maggio Circonferenza e cerchio Circonferenza e cerchio Corde, angoli al centro, archi e settori Posizione reciproche tra rette e circonferenze Posizioni reciproche di due circonferenze Angoli alla circonferenza e angoli al centro Poligoni inscritti e circoscritti; poligoni regolari Misura della circonferenza Area del cerchio Materia: Chimica Prof: Laura Candiani OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Gli studenti dovranno raggiungere gli obiettivi sotto elencati, riportati dalla Società chimica Italiana, Divisione didattica, definiti secondo la tassonomia di Bloom: OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI abilità di richiamare informazioni abilità di costruire schemi di risoluzione di un problema abilità di classificare ed elaborare informazioni chimiche (dati, grafici) abilità di applicare concetti appresi in precedenza per formulare ipotesi su situazioni inconsuete capacità di ripetere e commentare, in forma scritta e orale, argomenti riguardanti la chimica elementare consapevolezza del ruolo che la chimica riveste tra le altre discipline e nella società OBIETTIVI COGNITIVI conoscenza dei termini conoscenza dei fatti conoscenza dei principi e delle regole abilità nell’uso di metodi e procedimenti capacità di effettuare trasformazioni OBIETTIVI SPECIFICI: standard minimi in termini di conoscenze e di abilità usare i termini tecnici e scientifici in modo appropriato ripetere le definizioni e riconoscerle tra una serie di definizioni date usare correttamente le unità di misura del S.I. per le grandezze esaminate comprendere il testo di un problema avvalersi delle regole matematiche e dei principi fisici elementari per al risoluzione di problemi chimici osservare un fenomeno e rilevare dati classificare i dati in base al valore letto e riportarli in grafico e trovare le relazioni esistenti tra questi fare collegamenti tra diverse discipline fare trasformazioni sui contenuti (concreto/ astratto - verbale/simbolico particolare/generale) OBIETTIVI TRASVERSALI rispetto delle scadenze sia per lo studio che per l’esecuzione dei compiti assegnati rispetto delle regole stabilite nell’ambito scolastico acquisizione e utilizzo appropriato della terminologia specifica CONTENUTI I contenuti delle unità didattiche coincideranno con quelli dei sotto elencati capitoli del libro di testo in adozione, inoltre potranno essere trattati eventuali altri argomenti specifici concordati in sede di programmazione pluridisciplinare. Primo trimestre pentamestre 1. La materia: proprietà, trasformazioni, suddivisione della materia. Soluzioni : proprietà e concentrazioni % 2. Composti ed elementi - Nomenclatura IUPAC 3. La mole / entro dicembre 1. Struttura atomica e periodicità / entro febbraio 2. Struttura delle molecole e legami chimici intramolecolari 3. Legami intermolecolari / entro marzo 4. Cinetica chimica 5. Aspetti energetici delle reazioni / entro aprile 6. Equilibrio chimico 7. Reazioni acido-base e concetto di pH 8. Reazioni di ossido-riduzione / entro fine a.s. Materia: Scienze integrate (scienze della terra e biologia) Prof. Anna Romano FINALITÀ DELLA DISCIPLINA Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. OBIETTIVI GENERALI DISCIPLINARI Acquisire conoscenze e concetti relativi ai contenuti affrontati. Consolidamento di un efficace metodo di studio. Capacità di utilizzo dei libri di testo anche per la parte iconografica (figure, tabelle, grafici, fotografie ecc.). Acquisire e saper utilizzare il lessico specifico della disciplina. Comprendere il libro di testo e letture scientifiche. Descrivere ed interpretare un fenomeno in modo chiaro e logico. Capacità di lettura e comprensione adeguata di testi tecnico-scientifici. Acquisizione di maggiore autonomia d'organizzazione del lavoro e rispetto dei tempi scolastici Acquisire la capacità di ristrutturare correttamente le conoscenze già in possesso OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI Comprensione e la conoscenza di base dei contenuti Organizzazione semplice ma logica dei contenuti L’interesse per le tematiche scientifiche Graduale acquisizione di sufficienti capacità espositive utilizzando il linguaggio propri della materia. Comprende le cause fondamentali dei fenomeni naturali anche in riferimento alla propria esperienza Comprende i rapporti di causa effetto tra semplici eventi e fenomeni OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI (vedere programmazione di classe) COMPETENZE ABILITA’ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto Comprendere il diverso significato biologico della mitosi e della meiosi Saper definire il significato di: corredo cromosomico diploide ed aploide, cromosomi omologhi. Comprendere l’importanza della prevenzione per la lotta ai tumori. Comprendere la causa di alcune aneuploidie e saperle descrivere. Descrivere i vari livelli dell’organizzazione strutturale gerarchica del corpo umano. Descrivere le caratteristiche distintive e le relative funzioni dei diversi tipi di tessuti corporei. Riconosce la struttura e la funzione di alcuni apparati del corpo umano. Comprendere l’importanza di una sana e corretta alimentazione per il buon funzionamento non solo dell’apparato digerente ma dell’intero organismo. Comprendere l’importanza delle articolazioni in merito alla capacità di movimento. Descrivere la circolazione cardiaca evidenziando il ruolo delle valvole durante la diastole e la sistole. Collegare il trasporto di ossigeno da parte dell’emoglobina con le pressioni parziali di questo gas nei tessuti e nei capillari degli alveoli polmonari. Individuare la posizione del cervello, del midollo allungato, del cervelletto, dei nervi cranici e di quelli spinali. Saper riconoscere ed evitare situazioni rischiose per la salute CONOSCENZE La riproduzione cellulare Ciclo cellulare Cromosomi omologhi, diploidia e aploidia Mitosi e meiosi Controllo della mitosi e tumori Malattie genetiche dovute a errori durante la meiosi. Organizzazione gerarchica del corpo umano. I tessuti del corpo umano Apparato riproduttore. Malattie sessualmente trasmissibili Contraccezione. Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente. Educazione alimentare. Apparato respiratorio. Apparato escretore. Sistema circolatorio. Sistema linfatico. Sistema locomotore. Sistema endocrino. Sistema nervoso. Alcool ed effetti sulla salute, tabagismo e danni da fumo al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate Saper descrivere l’interno della Terra. Saper descrivere le strutture continentali e quelle oceaniche. Saper classificare le rocce in base alla loro origine Confrontare i principali tipi di eruzioni e correlarle con i diversi edifici vulcanici e con le componenti di un magma, il loro ruolo nel meccanismo eruttivo e i prodotti dell’attività vulcanica Saper individuare nella tettonica delle placche la teoria unificante dei fenomeni geologici. Definizione dei contenuti U.D. 1 La riproduzione cellulare Ripasso acidi nucleici Divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti Ciclo cellulare Mitosi e citodieresi Controllo della mitosi e tumori U.D.2 Meiosi e riproduzione sessuata Meiosi e ciclo vitale Fasi della meiosi Meiosi nella specie umana Gametogenesi Errori nel processo meiotico Malattie genetiche dovute a errori durante la meiosi U.D. 3 Organizzazione gerarchica del corpo umano I tessuti: epiteliale, connettivo, nervoso, muscolare Organi, apparati e sistemi U.D. 4 Il sistema riproduttore Apparato riproduttore maschile Apparato riproduttore femminile Malattie sessualmente trasmissibili Contraccezione U.D. 5 Apparato locomotore Sistema scheletrico Principali muscoli della testa, tronco e arti U.D. 6 La digestione Materiali e dinamica della Terra solida La struttura interna della Terra. Strutture continentali e strutture oceaniche. I minerali. Le rocce: classificazione e ciclo litogenetico. I fenomeni sismici I fenomeni vulcanici Il movimento delle placche ed i fenomeni tettonici ad esso associati (sismici e vulcanici) Anatomia generale dell’apparato digerente Digestione, assorbimento ed eliminazione Regolazione del glucosio ematico Educazione alimentare U.D.7 La respirazione Anatomia dell’apparato respiratorio umano La meccanica respiratoria Trasporto e scambio di gas: ruolo dell’emoglobina U.D. 8 La circolazione Il sangue: plasma, globuli rossi, globuli bianchi, piastrine I vasi sanguigni: arterie, vene, capillari Anatomia e fisiologia del cuore umano La pressione sanguigna Il sistema linfatico U.D.9 L’escrezione Anatomia dell’apparato escretore La formazione dell’urina La regolazione dell’equilibrio idrico e salino U.D. 10 I sistemi di controllo dell’organismo nervoso Il sistema nervoso: SNC e SNP Cenni di origine, propagazione dell’impulso nervoso e trasmissione sinaptica Il sistema endocrino U.D. 11 Struttura e materiali della Terra La struttura interna della Terra. La superficie terrestre Caratteri generali dei minerali Tipi di magma Classificazione delle rocce Ciclo delle rocce U.D. 12 I fenomeni vulcanici. Struttura dei vulcani I prodotti vulcanici Tipi di eruzione Vulcanismo secondario Rischio vulcanico, previsione e prevenzione Vulcanismo in Italia U.D. 13 I terremoti. Teoria del ritorno elastico Le onde sismiche Le cause dei terremoti e la loro distribuzione Scala Mercalli e scala Richter Rischio sismico, previsione e prevenzione Sismicità in Italia Materia: Tecnologia e tecnica di rappresentazione grafica Prof. D. RAPISARDA METROLOGIA Misura e misurazione, calcolo della media e della deviazione standard, errore nella misura ed incertezza, accuratezza e precisione di uno strumento QUOTATURA Norme e casi di quotatura corretta ed errata. Quotatura dimensionale RUGOSITA’ Tipi di rugosità e simbologia TOLLERANZE DIMENSIONALI Accoppiamenti, imprecisioni, albero-foro. Sistema ISO delle tolleranze. Tolleranze geometriche LE VISTE IN SEZIONE Campitura e classificazione dei diversi tipi di sezione ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO Alberi, perni, cuscinetti, chiavette, linguette, conicità LA TRASMISSIONE DEL MOTO Ruote di frizione e ruote dentate, innesti, giunti, cinghie INFORMATICA APPLICATA AL DISEGNO Comandi CAD Matera: Fisica Prof. R. Colombo 1. Finalità educative - Saper osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà. Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 2. Obiettivi disciplinari - Saper leggere correttamente una legge fisica e saperla interpretare. Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. Saper riconoscere i vari tipi di proporzionalità esistenti tra grandezze fisiche che compaiono nella stessa legge. Saper rielaborare i contenuti teorici al fine di risolvere gli esercizi proposti. 3. Obiettivi minimi Gli studenti dovranno saper esporre con sufficiente chiarezza i concetti basilari trattati in teoria ed inoltre dovranno essere in grado di risolvere semplici esercizi di immediata applicazione delle formule. 4. Contenuti Il calore e le sue trasformazioni. La temperatura. La scala Celsius. La dilatazione termica lineare nei solidi. Il comportamento dei gas. Prima legge di Gay-Lussac. Seconda legge di Gay-Lussac. Legge di Boyle. Il calore. Calore e lavoro. Capacità termica e calore specifico. Legge fondamentale della calorimetria. Elettrostatica. Struttura atomica dei corpi ed elettrizzazione. La carica elettrica. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. La corrente elettrica. La differenza di potenziale. La corrente elettrica. La resistenza elettrica. La prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo. L’elettromagnetismo. Il campo magnetico. I poli magnetici. Le proprietà dei magneti. Le linee del campo magnetico. Confronto tra campo elettrico e campo magnetico. Valore del campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente. Campo magnetico in un solenoide. Materia: Giuridico-economiche Prof.ssa Graziano Paola 2.Finalità educative Lo studio delle discipline giuridico economiche ha lo scopo di trasmettere agli studenti il senso del rispetto delle regole e della loro doverosa operatività all’interno di una comunità. Il principio di legalità, se compreso, implica l’osservanza delle norme giuridiche e delle regole economiche, basi e fondamento di una cittadinanza matura, corretta e consapevole. 3. Obiettivi disciplinari Gli studenti alla fine della seconda, dovranno essere in grado di: Individuare e rielaborare gli argomenti ed i temi studiati; Utilizzare adeguatamente i termini e delle locuzioni giuridiche ed economiche apprese; Consolidare nell’esperienza quotidiana le nozioni studiate 4.Obiettivi minimi Gli studenti alla fine della seconda, dovranno essere in grado di conoscere e saper spiegare i seguenti argomenti: Economia Il mercato e le sue regole Il concetto di moneta La ricchezza nazionale I concetti di sviluppo e sottosviluppo Diritto I principi fondamentali della nostra Costituzione Composizione, funzioni e modalità di funzionamento degli organi costituzionali 5.Contenuti 1° quadrimestre Lo Stato: forme di stato e di governo Caratteri e principi della Costituzione Diritti e doveri dei cittadini Gli organi costituzionali 2° quadrimestre La domanda, l’offerta e le diverse forme di mercato La moneta: tipologie Il sistema bancario Lo sviluppo economico nazionale ed internazionale Materia LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI Prof. SASSERA MAURIZIO 2) apprendere il comportamento da tenere nei reparti di lavoro -le norme da rispettare 3) conoscere e rispettare le norme antinfortunistiche specifiche-saper realizzare la lavorazione seguendo il disegno quotato-conoscere i diversi tipi di saldatura su metalli-sapere il funzionamento delle principali macchine utensili 4) norme infortunistiche-dal disegno al pezzo finito 5) le principali macchine utensili-il funzionamento del tornio parallelo e quali lavorazioni si possono eseguire -i vari tipi di saldatura-elettrica e a cannello-la brasatura i dispositivi di protezione individuali previsti per l'officina macchine utensili e per il laboratorio di saldatura -le norme antinfortunistiche specifiche per i reparti dove operare dimostrazione uso saldatrice a filo continuo illustrazione della fresa,limatrice, rettifica presenti in officina lavorazione al tornio su disegno assegnato con sfacciatura-fori ad intestare-tornitura cilindrica-gole-zigrinatura saldatura elettrica-cordoni su piastra-unione di due piastre in piano-piastre a 90° 6) lezioni frontali e lavorazioni pratiche nelle officine 7) verifiche scritte e valutazioni periodiche dei lavori effettuati Materia: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione Prof. C. ALI’ OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA Conoscere la differenza tra segnale analogico e segnale digitale. Conoscere le fasi che permettono di passare da un segnale analogico ad un segnale digitale e viceversa. Conoscere in cosa consiste la compressione di un file audio. Conoscere i file compressi con perdite e senza perdita. Conoscere come vengono codificate le immagini digitali. Conoscere il concetto di algoritmo. Saper ricavare , per un dato problema, il relativo diagramma di flusso. Riconoscere i comandi di excel. Utilizzare gli strumenti di excel nelle diverse situazioni: per costruire grafici, e come foglio di calcolo. Saper creare un semplice database. Saper inserire, modificare e cancellare dati in una tabella. Saper ordinare, cercare e filtrare i dati in una tabella. Conoscere la differenza tra un testo ed un ipertesto. Conoscere la funzione dei link. Saper costruire la mappa concettuale di un ipertesto. Segnali analogici e segnali digitali.(differenza tra i due tipi di segnali) MODULO 1: I SUONI DIGITALI (ottobre) procedimenti per la digitalizzazione del suono riproduzione di un suono digitale campionamento del suono (frequenza di campionamento, risoluzione, bitrate) memorizzazione del suono MODULO 2: I FILE AUDIO E LA LORO COMPRESSIONE (novembre) dimensione dei file audio (file wave) formati audio compressi con perdita formati audio compressi senza perdita file midi MODULO 3: LE IMMAGINI DIGITALI:(dicembre) codifica delle immagini digitali immagini bitmap e vettoriali la dimensione delle immagini e la compressione risoluzione e profondità del colore MODULO 4: GLI ALGORITMI E I LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE:(gennaio) il calcolatore, i problemi, i programmi e i linguaggi di programmazione i problemi e la loro risoluzione analisi e comprensione del problema l’algoritmo dall’algoritmo al codice macchina MODULO 5: IL FOGLIO ELETTRONICO: EXCEL (febbraio) Le aree applicative dei fogli elettronici valori, formule e funzioni. Riferimenti assoluti e relativi Impostare valori, formule e funzioni in una cella con excel MODULO 6: LE BASI DI DATI (marzo) Le tabelle di dati Chiavi primarie e indici Tipi di relazione fra tabelle Le caratteristiche delle maschere video MODULO 7: IPERTESTI E MULTIMEDIALITA’ (aprile maggio) La struttura di ipertesti e ipermedia La navigazione in un ipermedia I sistemi per la codifica di immagini, suoni e filmati Gli strumenti hardware e software per i sistemi multimediali Materia: I.R.C. Prof.ssa Maria Emanuela Lucchin Finalità La progettazione qui proposta vuole tener conto dei motivi offerti dalle ricorrenze civili ed ecclesiali, considerandole opportunità per l’organizzazione di un itinerario di IRC centrato sulla persona chiamata a costruire il futuro, per sé e per tutti (identità/diversità, progetto di vita, responsabilità e partecipazione, speranza, pace e giustizia) ed aperta al confronto con la proposta cristiana per la vita. La programmazione annuale è articolata nell’indicazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze (alla fine del primo biennio, poiché rientrante nell’obbligo di istruzione e della conclusione del percorso di studi) e nella sequenza delle unità di lavoro ciascuna costituita da abilità, conoscenze e indicazioni didattiche sulla strategia e/o sul mezzo da privilegiare. Obiettivi minimi generali Si rimanda agli obiettivi formativi trasversali comuni a cui i docenti danno la loro piena adesione. Obiettivi cognitivi Considerate l’attenzione, la partecipazione e il contributo al dialogo educativo, la sufficienza sarà raggiunta quando lo studente sarà in grado di: Accostare il fatto religioso con più consapevolezza, affrontando un giudizio personale sulla fenomenologia religiosa (personale e sociale) Saper evidenziare i tratti fondamentali di Dio come creatore e di Dio come salvatore nella persona di Gesù Cristo Contenuti: Monoteismo ebraico e giudaismo I luoghi della storia La religione Ebraica Ripasso argomenti trattati il 1° anno Ebraismo e cristianesimo: una radice comune La formazione del testo biblico Antico Testamento tra oralità e scrittura La geografia della Palestina Dai Patriarchi la nuovo esodo (Babilonia e la diaspora) Il profetismo Origini e diffusione Le credenze fondamentali Il libro sacro Il culto,i luoghi e le feste religiose L’idea della morte e dell’aldilà Gesù di Nazareth Le radici culturali europee Storia ebraica post-biblica Contesto storico,culturale,politico e religioso della Palestina di Gesù Gesù di Nazareth: un personaggio storico le fonti pagane e cristiane i vangeli apocrifi Gli appellativi di Cristo Attività missionaria Il monachesimo La Chiesa in decadenza Chiesa d’occidente e d’oriente Il rinnovamento La riforma protestante e la riforma cattolica Materia: Scienze motorie Prof. Carminati Carlo Augusto 1 Obiettivi disciplinari - Favorire l’armonico sviluppo psico-fisico dell’allievo agendo sull’area corporea e motoria Rendere cosciente l’allievo della propria corporeità, sia come padronanza corporea che come capacità relazionale Favorire la socializzazione, il senso di responsabilità, lo spirito do collaborazione Facilitare l’acquisizione di una cultura dell’attività motoria e sportiva Educare alla pratica corretta del movimento 2 Obiettivi minimi - Conoscere e controllare il proprio corpo Sviluppare e coordinare gli schemi motori di base Conoscere ed effettuare i fondamentali individuali e di squadra delle principali discipline sportive Conoscere a livello teorico i principali effetti che l’attività fisica produce a livello fisiologico Partecipare alle attività proposte in maniera attiva, dimostrando interesse ed impegno - 5. 3 Contenuti Esercizi di coordinazione dinamica generale Esercizi di coordinazione segmentaria Esercizi per l’incremento della velocità di base Esercizi per l’incremento della resistenza organica e muscolare Esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolare Esercizi di potenziamento degli arti sup., inf., addome Fondamentali individuali e di squadra di volley-basket-uni hockey-ultimate-calcetto Test motori Nozioni sulla prevenzione degli infortuni (stretching e riscaldamento) Lezioni teoriche riguardanti: a) apparato scheletrico b) apparato muscolare c) educazione alla salute d) regolamenti degli sport di squadra ATTIVITA’ COMUNI (recupero e sostegno, percorsi pluri/interdisciplinari, terza area, stage e/o viaggi Materia, modalità e tempi degli interventi di recupero Il C.d.C. approva la partecipazione della classe, in base alle necessità, alle seguenti attività di recupero, che potranno essere proposte compatibilmente con le disponibilità economiche della scuola: corsi di recupero pomeridiani, sportello “Help”, eventuale recupero in itinere che verrà valutato da ogni docente in base alle necessità. In base alle proposte della Commissione Salute, dei Dipartimenti di materia e dei singoli docenti, il C.d.C. approva la partecipazione della classe a: Educhange, dal 28/10 al 7/12 , tre ore di conversazione in inglese a settimana, per sei settimane, sul tema sella “security” . Con la possibilità di una visita a San Patrignano (indicativamente a novembre) o in alternativa alla comunità Exodus a Lambrate Uscita naturalistica (periodo primavera), l’eventuale uscita è subordinata al comportamento tenuto dalla classe nel corso dell’anno scolastico Tra le attività sportive si segnalano: Tornei di pallavolo Gruppo sportivo di pallavolo maschile e femminile 6. VERIFICHE (numero e tipologia) E CRITERI DI VALUTAZIONE Interrogazione lunga x X X X Interrogazione breve X x X X Tema o problema X X X X X x X X X X x x X Prove di laboratorio Griglia di osservazione x Questionario x X X X X Relazione - Grafico X Esercizi x x x x x x x x NUMERO MINIMO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE PER TRIMESTRE/PENTAMESTRE MATERIA S/G O Italiano 2/3 2/3 P MATERIA S/G O Storia 2/3 2/3 P Cattolica Elettrotecn. elettronica tecnol. dell’nformaz. e comunicaz. Religione Tecnologia e tecn. di rapp. grafiche Educaz. Fisica Diritto Chimica Sc. Della terra Matematica Ffisica Inglese Storia Italiano Strumento utilizzato Laboratorio tecn. Ed esercitaz. STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione) Inglese 2 2 Fisica Matematica 2/3 2 Laboratorio tecn. ed esercitazioni Sc. Della terra 2/3 Chimica 2/3 Diritto 2 Educazione Fisica 1/1 2/2 2 2/3 Tecnologia e tecn. di rapp. grafiche Religione cattolica Elettrotecn. elettronica tecnol. dell’nformaz. e comunicaz. 2 1 2 2 3 CRITERI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE La valutazione non si baserà solo sui tradizionali strumenti di verifica, ma anche sulla partecipazione, sull’impegno e sull’interesse dimostrati (domande, contributi, osservazioni). In particolare, in sede di valutazione finale si terrà conto dei dati emersi dalle prove scritte ed orali, della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno, dell’acquisizione di un metodo di studio funzionale, del profitto conseguito rispetto ai livelli di partenza. DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 10 9 L’alunno ha raggiunto gli obiettivi in modo eccellente: ha una visione globale dei problemi e li affronta con mentalità interdisciplinare, sa valutare criticamente e apportare contributi personali L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi in modo ottimale: ha una visione globale dei problemi, sa valutare criticamente e apportare contributi personali. 8 L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi in modo completo: sa collegare tra loro gli argomenti, li rielabora e li applica anche a situazioni non note. 7 L’alunno ha raggiunto gli obiettivi: conosce in modo preciso e comprende gli argomenti proposti, li collega, e li rielabora applicandoli a situazioni note. 6 L’alunno ha raggiunto gli obiettivi essenziali: conosce e comprende gli argomenti, applica in situazioni note le regole e comunica correttamente. 5 L’alunno ha parzialmente raggiunto gli obiettivi: conosce e comprende gli argomenti, ma li applica con difficoltà anche in situazioni note. L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi: conosce in modo frammentario gli argomenti, commette gravi 4 errori nelle applicazioni e nella comunicazione. L’alunno non ha raggiunto nessun obiettivo: non conosce argomenti, applicazioni e terminologia basilari. 3 2/1 L’alunno non ha raggiunto alcun obiettivo e rifiuta, totalmente di partecipare alle attività. 7 MODALITÀ DI INFORMAZIONE E CONFRONTO CON LE FAMIGLIE Gli strumenti di comunicazione e confronto tra i docenti e le famiglie sono: Il libretto dello studente (che lo studente è tenuto a portare sempre con sé) Le informazioni/comunicazioni che studenti e genitori possono ricevere consultando il servizio costantemente aggiornato dai docenti Le pagelle di fine trimestre e pentamestre I colloqui individuali I consigli di classe aperti ai genitori Il ricevimento individuale dei genitori (26 Gennaio 2016, 12aprile 2016) L’incontro con i genitori degli alunni con sospensione del giudizio (16 giugno 2016) Mastercom della scuola (registro elettronico), Il docente coordinatore Carlo Carminati
Scarica