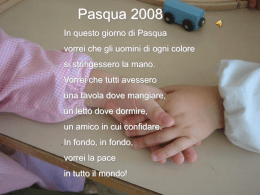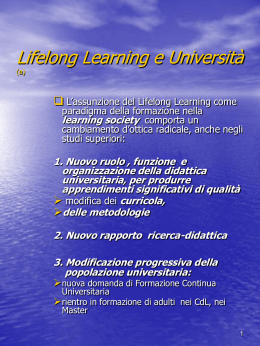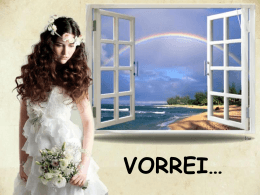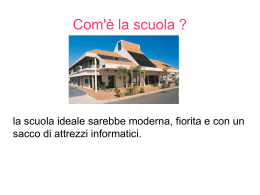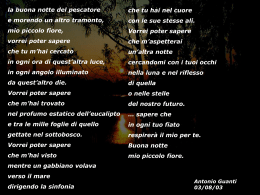Pier Giovanni Bresciani Professore a contratto Università di Genova e Università di Bologna Studio Méta & associati DAL TRAINING AL LEARNING Un nuovo paradigma per la gestione delle risorse umane Relazione al convegno ‘Le politiche per le risorse umane in Europa’ Trento, 13-14 dicembre 2005 In corso di pubblicazione su Professionalità, n.93, 2006 Nel mio intervento vorrei presentare alcune considerazioni che costituiscono il necessario sviluppo della riflessione proposta da Rullani in apertura del seminario, e più diffusamente argomentata nell’ambito del recente volume del quale è co-autore, significativamente intitolato ‘Il capitalismo personale’: dove vengono quindi coniugati ‘programmaticamente’, a partire dal titolo, aspetti della struttura socioeconomica (il capitalismo) con aspetti riferiti alla individualità dei soggetti che in tale struttura si trovano ad operare, dandole forma e contribuendo dialetticamente a determinarla (personale). Si tratta, a ben vedere, di una analogia con ciò che sta avvenendo in questa fase di preparazione del nuovo periodo di programmazione dei Fondi Strutturali UE per il periodo 2007-2013: in tale ambito, infatti, si sta sviluppando una dialettica consistente (che in qualche caso assume la forma del conflitto di potere, quando non del conflitto per la sopravvivenza) tra le ragioni dello sviluppo produttivo, socio-economico e territoriale da un lato e le ragioni dello sviluppo individuale dei diversi tipi di soggetti autori ed attori di tale sviluppo dall’altro (imprenditori, dirigenti, lavoratori occupati, lavoratori ‘flessibili’ e lavoratori ‘precari’, inoccupati, etc.). Questa dialettica ha assunto la forma del confronto anche aspro tra esigenze dello sviluppo dell’economia del territorio ed esigenze dello sviluppo delle ‘risorse umane’; tra FESR e FSE; tra economisti, statistici, ingegneri, geologi, architetti da un lato e psicologi, pedagogisti e formatori dall’altro; tra ‘scienze hard’ e ‘scienze soft’. Tutto questo è comprensibile, ma vorrei fare osservare come in realtà ci troviamo, proprio in forza del ‘vincolo’ rappresentato dall’ormai certo ridimensionamento del flusso di risorse comunitarie sulle quali il nostro Paese potrà contare (in particolare in alcune regioni) alle soglie di una storica occasione per il necessario ripensamento del rapporto tra queste due istanze, tra questi due approcci, tra queste due strategie di intervento. Non c’è dubbio infatti che la abbondanza di risorse finanziarie nel periodo di programmazione che si sta concludendo abbia favorito (insieme al consolidamento di esperienze e modelli di intervento appropriati ed innovativi, che costituiscono un prezioso patrimonio da valorizzare in prospettiva) anche forme di auto-referenzialità della formazione, e di schizofrenia tra questa e i processi economici e di sviluppo reali con i quali dovrebbe invece ‘andare insieme’. La tesi che vorrei sostenere è che è essenziale in prospettiva superare questa auto-referenzialità, ma che nello stesso tempo occorre non cadere nella tentazione (che mi appare presente in questo avvio di dibattito e confronto) di sostituire ad essa una altra auto-referenzialità di segno opposto (quella della economia dello sviluppo) che costituirebbe soltanto una ‘illusione di alternative’ e non contribuirebbe a superare i limiti che le analisi più attente hanno consentito di riscontrare in molti degli approcci fino ad ora adottati nel nostro Paese quando si sono affrontati i problemi della formazione e dello sviluppo del risorse umane. Se affermo queste cose, è anche perché, nelle fasi preliminari di discussione che accompagnano ad esempio la elaborazione del QSN (il Quadro Strategico Nazionale) mi pare si possano cogliere con chiarezza le tracce del rischio al quale mi riferisco. Intendo dire che quando dalla impostazione ‘strutturale’ che l’approccio socio-economico (alimentato dagli opportuni dati statistici) propone ed ‘impone’ quale framework per la definizione delle strategie di in intervento, si passa alla definizione delle linee di indirizzo che sul piano delle azioni di formazione dovrebbero costituirne nello stesso tempo il complemento e lo strumento di concretizzazione, si avverte chiaramente uno iato, che mi pare riconducibile proprio alla mancanza di ‘cultura formativa’ e di esperienza specifica a tale riguardo; cultura ed esperienza che in tutti questi anni (se pure, come indicato, incorrendo non di rado in un limite di autoreferenzilità) il ‘mondo della formazione’ ha invece potuto e saputo consolidare, e che è in grado di consegnare come ‘patrimonio’ al nuovo periodo di programmazione. A questo punto, quindi, quello che occorre non è tanto ‘cambiare registro’ nel senso manicheo e banale di passare da una presunta autosufficienza della formazione ad una presunta autosufficienza dello sviluppo, quanto piuttosto cogliere l’occasione storica di integrazione effettiva tra queste due prospettive, che la nuova fase di programmazione presenta come opportunità (ed io aggiungo: come necessità ai fini dell’efficacia). Ciò sarà tanto più possibile quanto più il confronto si possa sviluppare a partire da alcuni assunti di base che occorrerebbe condividere, poiché da essi deriva un certo ‘modo di inquadrare’ i problemi e le sfide che lo scenario propone, e quindi di individuare soluzioni. Sinteticamente, nella economia di questo breve intervento, vorrei richiamare soltanto per titoli alcuni di tali assunti di base. Il primo assunto è che alla fine di qualsiasi ‘filiera’ (produttiva o formativa) ‘le cose le fanno le persone’: che lavorano, intraprendono e che scelgono se, come, quanto, quando, e dove farlo: certo, le persone fanno questo nei limiti che sono ad esse dati; ma anche in quelli che sono in grado di ridefinire e modificare. Il secondo assunto è che se è così, allora occorre chiedersi che cosa fa sì che le persone ‘facciano quello che fanno’: e la risposta che non tarderemo a darci è che questo ‘che cosa’ è dato (insieme ed in maniera indissolubile) da un lato dalla ‘cultura’, dalle conoscenze e dalle competenze delle persone; e dall’altro lato dalle ‘condizioni’ (in senso lato ‘hard’ e ‘soft’) in cui le persone si trovano ad operare, e dalle ‘risorse a disposizione’ che esse si trovano ad avere o che sono in grado di acquisire e mobilitare. Come si può osservare ciò significa che è nell’intreccio indissolubile di interventi sulle risorse umane (FSE) ed interventi sugli assetti strutturali e sulle risorse del territorio (FESR) che può essere identificata la ‘strada maestra’ per fare fronte alle sfide del futuro con maggiori chance rispetto a ciò che si è riusciti a fare fino ad ora. Un elemento particolarmente interessante è che nel tentativo di definire quali siano le dimensioni dell’agire individuale che maggiormente sono in grado di ‘spiegare’ i comportamenti effettivi delle persone (e quindi anche il loro modo di lavorare professionalmente, di ‘fare management’, e di ‘fare impresa’), è proprio un economista come Rullani, e non il ‘solito’ psicologo o pedagogista umanista, a riconoscere la assoluta centralità di elementi quali le motivazioni, gli interessi, i valori, le emozioni, le attribuzioni di senso, le intenzioni ed i progetti di vita; pena il non avere sufficienti categorie esplicative di ciò che osserviamo come comportamento effettivo sul mercato del lavoro e nel territorio. Il terzo assunto che va condiviso è che nello scenario del lifelong learning e del lifewide learning cambiano radicalmente le politiche di intervento in grado di supportare gli individui e le imprese a sostenere il cambiamento (come dirò in seguito: non solo formazione iniziale; non solo apprendimento ‘formale’; etc.) ma soprattutto cambia il modo di concepire la formazione, per come l’abbiamo conosciuta in questi anni, perché essa si rivela con assoluta evidenza come soltanto uno degli strumenti (in prospettiva, forse, non necessariamente il più importante) mediante il quale è possibile sviluppare apprendimento nelle persone e nei contesti di lavoro. In altre parole, stiamo assistendo da qualche anno a quel ‘cambiamento di focus’ dal training al learning la cui conseguenza sul piano operativo consiste nella differenziazione delle modalità di sviluppo dell’apprendimento e nella relativizzazione della ‘modalità formativa’ tradizionale (i corsi in aula). È interessante osservare come da tutto questo, un poco paradossalmente, vengano fatte discendere politiche di intervento volte a valorizzare essenzialmente proprio la formazione ‘tradizionale’. Come ho altrove osservato, infatti, se analizziamo le tipologie di intervento ‘raccomandate’ in una prospettiva di lifelong learning possiamo verificare che si tratta in realtà pressoché esclusivamente di interventi di formazione, come se quindi lifelong learning significasse in realtà lifelong training. D’altra parte, mentre si afferma questo, contemporaneamente si afferma che ‘la formazione non basta’, e da questo proposito si fa riferimento ad una gamma più ampia di strumenti e politiche (in una logica di workfare; di capacity building; etc.) ed alle tante e diverse ‘azioni di accompagnamento’ integrative della formazione che in questi anni (proprio grazie al FSE) hanno arricchito il panorama delle soluzioni disponibili per favorire l’apprendimento e lo sviluppo di conoscenze e competenze: l’analisi in ingresso per la personalizzazione dei percorsi; il riconoscimento dei crediti; il tutorato e l’accompagnamento; l’orientamento in ingresso e in itinere; il bilancio di competenze; la certificazione; l’alternanza tra contesto della formazione e luogo di lavoro; etc. Se quindi cerchiamo di riordinare l’insieme delle suggestioni che il dibattito ha fatto emergere in questi anni per affrontare con successo la sfida del lifelong learning e del lifewide learning, potremmo schematicamente osservare che la soluzione al problema dell’apprendimento (il learning come differenziale competitivo per le persone, per le imprese, per i territori, per i Paese: come anche proposto da Rullani nel suo intervento) è così esprimibile: da un lato ‘più formazione’ (magari demand-side e individualizzata, secondo una sollecitazione che Rullani fa propria, ma che è ben presente nel dibattito di questi anni); e ‘più azioni di accompagnamento’ in grado di integrare la formazione ‘tradizionale’ (ed anche qui Rullani, evocando ad esempio l’esigenza di certificazione, si colloca in realtà in sintonia con un dibattito specifico che già da diversi anni ha posto questo tema all’attenzione dei decisori). In ogni caso, ciò che emerge secondo l’impostazione prevalente è che l’effetto/risultato ‘apprendimento’ viene considerato essenzialmente come un portato dei curriculi formativi formali, in questo modo rischiando di depotenziare il senso di quella vera e propria ‘rivoluzione copernicana’ che consiste nel mette il learning (e non il training, che è solo uno degli strumenti per perseguirlo) al centro dell’attenzione e delle politiche. Oltre alla formazione tradizionale ‘arricchita’ dalle azioni integrative (FAD, project work, action learning, e quelle già in precedenza indicate) almeno altre tre direzioni di intervento possono qui sinteticamente essere richiamate. La prima consiste nella costruzione di progetti reali di innovazione e cambiamento organizzativo/produttivo (a livello aziendale e/o territoriale) nei quali intenzionalmente la gestione dei processi di implementazione ‘tenga insieme’ gli aspetti di intervento organizzativo e gli aspetti di apprendimento. La seconda consiste nella costruzione di una ‘via italiana’ al WPL (workplace learning: un tipo di approccio per il quale in altri Paesi siamo già ai dispositivi ‘di terza generazione’) magari a partire dalla valorizzazione dello spazio che in tale direzione può essere identificato nella nuova filiera dell’apprendistato professionalizzante (senza sottovalutarne i rischi; ma senza farsene paralizzare). La terza consiste nella diffusione di forme e consulenza di supervisione ad individui e a gruppi di lavoro nell’ambito dei contesti organizzativi reali: pervenendo, sotto questo profilo, anche ad una razionalizzazione di quella ampia e forse già eccessivamente variegata tipologie di esperienze che viene a volte impropriamente aggregata sotto l’unica etichetta di coaching. Ma se si vuole andare oltre, ed elaborare in funzione della futura programmazione una sorta di ‘catalogo’ degli interventi e delle misure di ‘sistema’ necessari per favorire lo sviluppo dei tipi di esperienze che ho finora delineato (raccogliendo e sintetizzando anche quanto emerso nel dibattito di questo seminario) allora è possibile proporre il seguente catalogo: a) ridurre (fino ad eliminare, si afferma con l’ottimismo della volontà) le persistenti barriere che ancora si frappongono all’accesso alle opportunità di apprendimento (barriere hard come gli orari di lavoro, la mancanza di servizi di conciliazione, le risorse economiche necessarie; e barriere soft come la mancanza di informazione, di competenze-chiave per l’accesso, di fiducia e di autostima, di supporto, etc) b) massimizzare le opportunità di apprendimento, diversificandone i luoghi ed i tempi (self learning; workplace learning; training) c) garantire le infrastrutture necessarie per la fruizione del ‘diritto individuale all’apprendimento’: congedi formativi; servizi di conciliazione; personalizzazione anche tramite i voucher; gamma di offerta ampia d) supportare e accompagnare gli individui nel processo di apprendimento: prima, mediante l’informazione, l’orientamento e la consulenza; e durante, mediante la ricostruzione dell’esperienza, la riflessione, il supporto alla meta-cognizione e) diversificare gli interventi: per target, per ciclo di vita individuale, per ciclo di vita aziendale, per territorio f) integrare gli interventi di formazione e per l’apprendimento nelle politiche di sviluppo aziendale, settoriale e territoriale g) sviluppare e diversificare le metodologie per il training e per learning, valorizzando le esperienze, le buone pratiche ed i modelli di intervento consolidati nel precedente periodo di programmazione del FSE h) riconoscere i crediti, e certificare le competenze (libretto formativo; validazione delle esperienze; Europass; etc.) i) creare ‘convenienza’ all’investimento in apprendimento, sia per gli individui sia per le imprese (certificando; offrendo servizi di conciliazione; mediante un sistema di voucher; magari innovando le modalità di influenzare la propensione al risparmio, come è avvenuto in altri Paesi non solo europei con la formula dei conti correnti finalizzati –es. ILA IDA, ILDA, a seconda delle finalità e dei Paesi- nei quali l’ente pubblico versa un contributo per incentivare il cofinanzimento individuale) j) definire modalità di riconoscimento economico e di rendicontazione amministrativa per le ‘nuove’ forme di learning che le rendano praticabili e ‘competitive’ (dal punto di vista dei soggetti che devono programmarle/progettarle) rispetto alle modalità ‘tradizionali’ di fare formazione. Occorre dunque creare nelle persone e nelle imprese una ‘disposizione all’apprendimento’: e questo può essere fatto dai soggetti pubblici di programmazione mediante una ‘ecologia’ di infrastrutture e dispositivi che possa orientare i comportamenti in una direzione che sia insieme ‘etica’ e ‘conveniente’.
Scarica