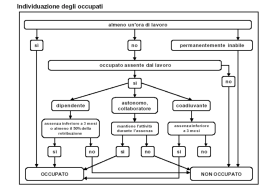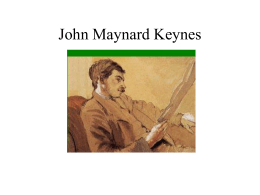LEZIONE 1. GRANDE DEPRESSIONE, IMPERIALISMO, ROTTURA EQUILIBRI 1.1. Il periodo 1873-1913 La fase liberoscambista di apertura dei mercati internazionali e di affermazione del gold standard, che è anche una fase di notevole stabilità politica, apertasi con l’abolizione delle Corn Laws in Gran Bretagna viene ad esaurimento a partire dai primi anni ’70 sotto i colpi di quella che viene comunemente definita come la “grande depressione”. Al proposito vanno subito precisate due cose: che c’è un’altra “grande depressione” nella storia degli ultimi due secoli ed è quella iniziata nel 1929 negli Stati Uniti e dilagata nel mondo negli anni ‘30. bisogna sempre evitare di confondere i due fenomeni. che questa crisi appare ai contemporanei molto grave e profonda dopo decenni di crescita ininterrotta e di clamorosi successi dell’industria, della tecnologia e della finanza, ma in realtà non è tale da compromettere gravemente l’espansione dell’industria e del capitalismo, come invece avverrà per quella degli anni ’30 del Novecento. Più in generale possiamo dire la fase che copre il quarantennio dal 1873 al 1913 è una fase contrassegnata da cinque fenomeni, alcuni dei quali già abbiamo avuto modo di vedere in dettaglio l’emergere di nuove potenze industriali (Germania e Stati Uniti, soprattutto) per certi versi in grado di insidiare il primato britannico, fenomeno che abbiamo già analizzato alcuni decisivi cambiamenti nella produzione, nel commercio, nell’organizzazione d’impresa e in campo finanziario e in particolare il compimento della rivoluzione dei trasporti e la seconda rivoluzione industriale, fenomeni che pure abbiamo già visto una fase di inedito e preoccupante blocco della crescita tra il 1873 e il 1896 seguito da una fase di recupero durata fino allo scoppio della prima guerra mondiale (il periodo 1873-96 è appunto quello definito della “grande depressione”) il ritorno, in seguito a questa fase depressiva, di politiche protezionistiche che sostituiscono progressivamente le politiche liberoscambiste impostesi dopo il trattato commerciale anglo-francese Cobden-Chevalier del 1860 il trasferimento della competizione economica in campo militare e soprattutto fuori del territorio europeo, cioè una nuova fase del colonialismo che prende il nome di “imperialismo” Questi sono i principali fenomeni economici che contraddistinguono i quattro decenni che precedono la Prima guerra mondiale e che contribuiscono tra l’altro al suo scatenamento. Parleremo qui nel dettaglio di questi fenomeni ad eccezione di quelli che abbiamo già avuto modo di trattare in precedenza. 1.2. Il crescere della competizione politica ed economica La Gran Bretagna - come sappiamo - non aveva potuto impedire che altri paesi si industrializzassero e da un certo punto in poi si era anzi giovata della loro industrializzazione per divenire un grande esportatore anche di materie prime, di semilavorati, di macchinari e di capitali. Allo stesso modo essa non fu in grado di impedire che alcune tra le nazioni emergenti divenissero dei temibili concorrenti sia sotto il profilo produttivo che sotto quello finanziario. Vale la pena ripetere che sul piano commerciale e degli investimenti esteri la Gran Bretagna restò di gran lunga la maggiore potenza mondiale sino al 1914, ma già dagli anni ‘60-’70 cominciò ad apparire chiaro che su mercati specifici, in settori economici particolari e in aree particolari gli inglesi non soltanto perdevano terreno ma erano costretti a subire l’iniziativa altrui. Con la seconda metà del secolo si entra insomma in una fase in cui prende rapidamente piede una competizione piuttosto accesa per la conquista dei mercati internazionali di materie prime, di capitali e di prodotti manifatturieri. Questa competizione sempre più aspra, si svolge anche sul piano dei simboli nazionali delle ideologie e della forza militare, mette rapidamente in discussione il liberoscambismo affermatosi negli anni ‘60 e spinge vari paesi già prima della Grande depressione a considerare la possibilità di proteggere e di sostenere attraverso finanziamenti diretti o innalzamento di dazi le proprie industrie nazionali. In realtà il successo del liberoscambismo non solo non fu mai completo ma si limitò a una breve stagione, tra il 1850-60 e il 1875 circa, quando la massima apertura dei mercati non solo fu facilmente realizzabile, ma risultò conveniente sia per i paesi già industrializzati che per quelli in via di industrializzazione e per quelli esportatori di materie prime. Da un certo punto in poi, al contrario, non fu più né facile né conveniente per tutti tenere basse le tariffe doganali. Molti paesi che stavano iniziando a sviluppare un’industria nazionale, che erano in forte crescita e che iniziavano ad essere in grado di sostituire i manufatti e i macchinari importati dai paesi più sviluppati con manufatti e macchinari prodotti in patria, ritennero pian piano che fossero possibili e anzi necessarie alcune misure di protezione delle proprie manifatture. Quando si manifestò la Grande depressione queste tendenze furono rafforzate dalla convinzione - ingiustificata - che il miglior modo di proteggersi dalla crisi fosse quella di elevare le tariffe. 1.3. La Grande depressione e il ritorno del protezionismo L’evento che fece precipitare la crisi dell’equilibrio internazionale creatosi a partire dal 1830 fu infatti la cosiddetta “grande depressione”. sui caratteri di questa crisi economica di lungo periodo si è scritto molto e si è soprattutto fatto notare che essa non riuscì in effetti a fermare la crescita economica nè l’innovazione tecnologica, ma ebbe l’effetto soprattutto di “raffreddare” la crescita stessa, di rallentarne il ritmo. Nonostante ciò si trattava della prima crisi di una certa gravità e di una certa durata che coinvolgeva la nuova struttura dell’economia internazionale e questo impressionò molto i contemporanei, tanto più che essa si svolgeva contemporaneamente al primo grande slancio del movimento socialista, del quale abbiamo parlato alla nascita di una vera competizione tra paesi industrializzati a una drammatica redistribuzione del potere tra i paesi “inseguitori”, con l’evidente declino della Francia e il rapido emergere di Germania e Stati Uniti Se gli effetti della crisi sulle strutture economiche erano insomma abbastanza pesanti, molto di più lo erano sullo spirito degli osservatori. La crisi, che - ripeto - iniziò nel 1873 e si prolungò per oltre un ventennio fino al 1896, si manifestò soprattutto con un calo dei prezzi generalizzato e di conseguenza con rallentamento delle attività economiche, profitti in calo e disoccupazione. Le ragioni principali della crisi pare siano individuabili in tre fattori che operarono indipendentemente tra loro ma in parallelo: una temporanea contrazione della produzione di oro. di fronte a scambi in forte crescita e a un sistema monetario che vincolava l’emissione di moneta alla quantità effettive di oro posseduto dalle banche centrali l’insufficienza di oro si traduceva in un aumento del valore delle monete e in una conseguente diminuzione del prezzo effettivo delle merci. tutto ciò durò fino alla scoperta delle nuove miniere d’oro del Transvaal (Sudafrica), negli anni ’90. la riduzione del costo dei trasporti derivante dalla rapida diffusione della ferrovia e, a partire dagli anni ’60, dal trionfo delle navi a vapore con scafo in acciaio. la discesa dei noli era dovuta alla maggiore capacità di trasporto, alla concorrenza sempre maggiore e al costo via via minore dei mezzi di trasporto realizzati con le nuove tecnologie. a questo punto il peso dei prezzi di trasporto sulle merci diminuirono rapidamente e in misura assai notevole. grazie all’apertura dei mercati, crescita della concorrenza. ad esempio, nuovi paesi con enormi risorse agrarie come gli Stati Uniti, la Russia, l’Argentina, l’Australia e la Nuova Zelanda iniziarono a gettare sul mercato mondiale enormi quantità di derrate e di materie prime a basso prezzo (grano, lana, cotone e carni) che misero in crisi le agricolture tradizionali di molti paesi. lo stesso accadde verso la fine del secolo con i prodotti manifatturieri, soprattutto tedeschi e americani, che invasero i mercati di tutto il mondo sostituendo sia una buona parte di quelli inglesi sia soprattutto quelli artigianali o protoindustriali prodotti localmente. l’impatto più violento fu tuttavia quello in campo agricolo, in cui la formidabile produzione americana esportata per oltre un quarto mise in difficoltà le cerealicolture dell’europa intera. La combinazione di questi tre fattori provocò appunto una rapida discesa dei prezzi, che erano stati in ascesa ininterrottamente dal 1850 al 1873. La discesa dei prezzi non fu uniforme nel tempo ed ebbe effetti diversi a seconda dei settori e soprattutto dei paesi; ci furono brevi riprese e soprattutto ci furono paesi che riuscirono a conquistare nuove posizioni di mercato, a continuare la propria crescita e a limitare i danni della depressione, soprattutto Stati Uniti e Germania. Inoltre, come abbiamo già visto, questo quarto di secolo fu proprio quello in cui si verificarono profondi mutamenti tecnologici e di organizzazione del lavoro, e il grosso della seconda rivoluzione industriale si verificò proprio in questa fase. Tutto questo, però, noi lo sappiamo bene oggi: i contemporanei, ripeto, vissero la crisi come un grande trauma e un momento di grande incertezza per il futuro dopo una lunga fase di impressionante crescita. Di fronte alla discesa dei prezzi (soprattutto dei prezzi agricoli), che di per sé non era un indice di crisi, e alle sue gravi conseguenze (picchi di crisi occupazionale e calo costante dei redditi agricoli) imprese e governi cercarono di correre ai ripari con linee di politica economica piuttosto simili ristrutturazioni produttive (la Danimarca e l’Olanda si convertirono ad esempio dalla produzione cerealicola alle produzioni carnee e lattierocasearie di pregio destinate all’esportazione soprattutto in Gran Bretagna, oppure passaggio nel Mezzogiorno d’Italia a colture arboree specializzate per l’esportazione) elevamento delle tariffe doganali per alcuni tra i paesi più forti, adozione o accentuazione di politiche estere di tipo coloniale e imperiale il che non risolse in realtà i problemi, ma anzi contribuì a rallentare la crescita degli scambi e iniziò a creare una serie di frizioni economiche e politiche che sarebbero sfociate nella prima guerra mondiale Il periodo 1873-1896 appare quindi come un primo periodo di incertezze e di contraddizioni dopo un quarantennio di crescita gloriosa e ininterrotta dell’economia. I contemporanei lo vivono con ansia e con aggressività e compiono una serie di scelte che si riveleranno anche molto negative. D’altra parte si tratta di un periodo in cui la crescita continua, con innovazioni assai importanti sia nel campo del cambiamento tecnologico e organizzativo dell’economia sia nella redistribuzione del potere economico e politico a livello mondiale. Col 1896 si apre invece una nuova fase di crescita destinata ad interrompersi bruscamente solo con lo scoppio della prima guerra mondiale, nel 1914. 1.4. Colonialismo e imperialismo Per comprendere bene come si arriva alla guerra, che ha effetti economici profondissimi sulla storia dell’economia mondiale del Novecento, bisogna tenere presenti anzitutto alcune delle cose che abbiamo già analizzato: il declino (relativo) della Gran Bretagna il parallelo emergere di nuove potenze industriali (e in particolare Germania e Stati Uniti) la fase di recessione che inizia nel 1873 e che rende la competizione economica internazionale più aspra riducendo i margini di profitto e accrescendo la ricerca di mercati nuovi e sicuri la maggiore interconnessione delle economie delle varie aree del pianeta grazie alla rivoluzione dei trasporti La nascita di un nuovo grande stato al centro dell’Europa (la Germania) nel 1870 crea inoltre nuovi equilibri politici estremamente delicati che possono saltare con maggiore facilità che in passato. Il capolavoro del cancelliere tedesco Bismarck, nel corso degli anni ‘70, sta nella creazione di un complesso equilibrio diplomatico europeo sostanzialmente stabile volto in sostanza a impedire la vendetta dei francesi, battuti militarmente nel 1870 dalla Prussia. Le alleanze che si vengono così a creare bloccano per molti anni la conflittualità sul continente e generano una lunga fase di pace europea, dal 1870 al 1913, anche se la competizione economica nello stesso periodo aumenta fortemente, sia sul piano produttivo che sul piano finanziario e su quello commerciale. Questa competizione, che all’interno del continente europeo veniva limitata dalla politica delle alleanze, esplose al di fuori dei suoi confini alimentata dall’affermarsi di un forte sentimento nazionalista in tutte le potenze industriali. Nell’ultimo quarto dell’Ottocento si diffuse infatti una cultura politica estremamente aggressiva ed espansionistica che non risparmiò alcun paese europeo e che fu una delle cause principali dello scoppio della grande guerra. In un clima di crescente competizione economica, di grande accumulazione di profitti che andavano necessariamente investiti e di scelte protezionistiche causate dalla Grande depressione i governi di tutti i paesi industrializzati si convinsero che era indispensabile seguire politiche di riarmo e di conquista di spazi “protetti” dai quali trarre materie prime e nei quali esportare e investire senza l’intralcio dei concorrenti. Questi spazi “protetti” potevano prendere la duplice forma di colonie (sottoposte al diretto controllo politico-militare della madrepatria) oppure di “zone d’influenza”, cioè aree geografiche formalmente indipendenti ma che erano in sostanza sotto il controllo politico di una o più nazioni occidentali. Tra il 1875 e il 1914 fu soprattutto l’Africa intera a trasformarsi in colonia dei vari paesi europei mentre i grandi stati asiatici (Cina e Giappone) rimasero formalmente indipendenti ma vennero sottoposti a trattati commerciali o militari vessatori da parte delle varie potenze occidentali, trattati che ne limitavano l’autonomia e che sancivano il controllo delle loro varie aree da parte di questo o quel paese o da più paesi congiuntamente. L’ondata di spedizioni militari e di fondazioni di colonie avvenuta a partire dal 1875 circa giunse nel giro di pochi anni a coinvolgere tutta l’Africa, dove si installarono anzitutto gli inglesi (Egitto e Sudafrica ma anche Sudan, Kenya e Uganda), poi i francesi, i belgi, i tedeschi e infine (e con grandissima fatica) anche gli italiani. In più occasioni queste spedizioni, effettuate spesso molto velocemente per occupare tutto l’occupabile, finirono con lo scontrarsi e col creare dei gravissimi incidenti diplomatici. Diverso fu il caso dell’America Latina e dell’Asia. Nella prima finirono con lo stabilire un controllo informale complessivo gli Stati Uniti cacciando definitivamente gli Spagnoli da Cuba nel 1898. Con questa guerra l’America Latina divenne definitivamente una sorta di appendice economico-politica degli Stati Uniti, definita non a caso “giardino di casa” degli Stati Uniti. A questo proposito va in ogni caso osservato che il progetto (mai seriamente rimesso in discussione) di fare dell’America Latina un’appendice degli Stati Uniti era molto più antico, risalendo alla cosiddetta “dottrina di Monroe”, elaborata sin dagli anni ’20 dell’Ottocento. Per l’Asia il discorso fu necessariamente molto più complesso in quanto si trattava anzitutto di una realtà molto più ampia e articolata erano in campo contemporaneamente tutti i paesi industrializzati (o quasi) e soprattutto esistevano in questo continenti stati politicamente deboli ma molto popolati, di grande tradizione e non facilmente occupabili, come Cina e Giappone. In diverse aree esistevano antiche colonie europee (la più importante e vasta di tutte era l’India) e nuove ne furono impiantate (dalla Francia in Indocina dal 1867, dagli Stati Uniti nelle Filippine nel 1898) ma il grosso lavoro fu nel rendere Cina e Giappone delle zone di influenza condivise. Se la modernizzazione accelerata del Giappone sul modello europeo sottrasse questo paese al giogo politico-militare europeo e ne fece una potenza con ambizioni egemoniche sull’intera area asiatica la Cina cadde sempre più sotto il controllo congiunto delle potenze occidentali (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Austria, ma anche Portogallo, Russia, Giappone e Italia) che pur riconoscendo l’autorità politica imperiale tenevano saldamente nelle loro mani gran parte dei commerci cinesi. Ciò causò una serie di aspre rivolte represse nel sangue - la più importante quella dei Boxer, nel 1899-1901 - e la fine dell’impero, rovesciato da un movimento indipendentista repubblicano nel 1912.Questo movimento non riuscì tuttavia a eliminare né a ridurre la presenza economico-militare delle potenze occidentali che durò fino al 1945. 1.5. Dal 1896 una fase di poderosa crescita con contraddizioni Abbiamo visto come la terza parte dell’Ottocento sia un periodo contraddittorio per l’economia mondiale. Un periodo di grandi innovazioni tecnologiche e produttive e di straordinaria espansione quantitativa e spaziale del capitalismo occidentale ma al tempo stesso un periodo di caduta dei prezzi, di incertezza, di ritorno al protezionismo e soprattutto di competizione crescente tra potenze economiche e politiche vecchie e nuove. A partire dal 1896 un po’ in tutto il mondo si osservano i segni di una notevole ripresa dei ritmi della crescita e degli scambi internazionali, cosicchè il ventennio circa che precede la prima guerra mondiale viene definito la belle epoque sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico. A questa nuova grande fase di prosperità contribuisce grandemente la maturazione di tutte le novità di cui abbiamo parlato la scorsa settimana: le nuove forme di energia e di trasporto, le nuove forme di credito, il sorgere della grande impresa, etc. Come abbiamo già osservato è in questi anni, tra le altre cose, che l’Italia compie il suo salto definitivo verso l’industrializzazione, sia grazie alla congiuntura favorevole, sia grazie ai governi progressisti succedutisi al tentativo di destra di Francesco Crispi. 1.6. Verso la guerra Quando anche questa corsa a conquistare territori da controllare politicamente ed economicamente ebbe fine perché non c’era quasi più nulla da conquistare o da mettere vantaggiosamente sotto controllo, gli equilibri politico-diplomatici si fecero sempre più delicati in quanto diversi paesi “nuovi” - ormai diventati molto potenti economicamente - iniziarono a pensare come rosicchiare spazi ulteriori agli avversari più grandi e soprattutto alla Gran Bretagna. Fu così che a partire dalla metà degli anni 1890 le crisi tra i paesi imperialisti e i conflitti locali si moltiplicarono fino a diventare sempre meno gestibili. Da un certo momento in poi alcune potenze industriali (la Germania anzitutto) si attrezzarono per dare uno sbocco bellico alla loro competizione economica, ritenendo oltretutto che la guerra potesse essere combattuta come le guerre dell’Ottocento, in pochi mesi e con poche battaglie. Ma saranno proprio tutte le trasformazioni tecnologiche ed economiche che abbiamo visto nelle scorse lezioni a rendere la nuova guerra tra le grandi potenze una cosa mai vista in passato. LEZIONE 2. LA CRISI DI FINE SECOLO E LO SCOPPIO DELLA GUERRA 2.1. L’esplosione delle contraddizioni: la guerra Sappiamo, lo abbiamo già visto, come la prima guerra mondiale sia il frutto: del progressivo acuirsi dei contrasti tra le potenze economiche nuove e vecchie sia sul piano del controllo territoriale planetario sia sul piano del controllo di risorse e mercati del precipitare di crisi diplomatiche europee tenute a lungo sotto controllo ma sempre più difficoltose da gestire di calcoli sostanzialmente sbagliati sulla durata e le dimensioni della guerra, per “mancanza di abitudine” Alla guerra giunse infatti sulla base di una incapacità di gestire questa contrapposizione in modo diplomatico di una sottovalutazione della dimensione effettiva che avrebbe potuto prendere la guerra stessa della considerazione, conseguente, che la guerra era diventata inevitabile ma che non sarebbe poi stata una grande catastrofe Si scivolò così per passi successivi in un conflitto che in realtà nessuno aveva effettivamente voluto in quelle dimensioni. I calcoli riguardanti una guerra rapida e “locale”, come erano state tutte le guerre ottocesche dopo il 1820 si rivelarono insomma del tutto erronei e il conflitto finì con l’avere una serie di caratteristiche nuove alle quali gli stati non erano preparati e dovettero adattarsi: la lunga durata la necessità di disporre di una quantità colossale di materie prime e di attrezzature tecnologicamente avanzate la necessità di trovare una grande quantità di fonti di credito per finanziare la guerra la necessità di controllare scenari geografici nuovi in modo nuovo: i mari, le colonie, l’aria, le aree capaci di fornire risorse, con una guerra ormai non più locale Più in generale, la novità principale della nuova guerra fu il suo carattere di “guerra totale: a differenza delle guerre ottocentesche, che avevano in genere obiettivi limitati e si risolvevano in tempi non lunghissimi grazie a qualche forma di compromesso, la prima guerra mondiale fu una guerra totale, illimitata, che poteva solo essere interamente vinta o interamente perduta. Sentiamo come definisce la “guerra totale” un importante storico inglese, Eric Hobsbawm: Perché, dunque, la prima guerra mondiale fu condotta dalle potenze che guidavano i due schieramenti come un giuoco all’ultima mossa, cioè come una guerra che poteva essere o totalmente vinta o interamente perduta? La ragione fu che questa guerra, diversamente dalle guerre precedenti, che erano condotte per obiettivi limitati e specifici, aveva come posta scopi illimitati. Nell’Età degli imperi, la politica e l’economia si erano fuse. La rivalità politica internazionale si modellava sulla crescita e sulla competizione economiche, ma la caratteristica di questi processi era appunto la loro illimitatezza. Le “frontiere naturali” della Standard Oil, della Deutsche Bank o della De Beers Diamond Corporation erano i limiti estremi del globo, o piuttosto i limiti della loro capacità di espansione. Più concretamente per i due principali contendenti, Germania e Gran Bretagna, l’unico limite doveva essere costituito dal cielo, poiché la Germania voleva una posizione di predominio politico e marittimo mondiale pari a quella britannica, che avrebbe perciò automaticamente relegato a un rango la potenza inglese già in declino. Nel 1900, al culmine dell’Età imperiale e imperialistica, sia la pretesa tedesca a una posizione unica nel mondo («Lo spirito tedesco rigenererà il mondo», come allora si diceva) sia la resistenza inglese e francese, che erano ancora innegabilmente «grandi potenze» in un mondo eurocentrico, permanevano intatte. Sulla carta era senza dubbio possibile un compromesso su alcuni obiettivi bellici che entrambe le parti, con ottica megalomane, formularono non appena scoppiò il conflitto, ma in pratica il solo obiettivo che contasse era la vittoria totale: ciò che nella seconda guerra mondiale venne definito «resa incondizionata». Era un obiettivo assurdo e autolesionistico che condusse alla rovina vinti e vincitori. Gli sconfitti furono trascinati nella rivoluzione, mentre i vincitori conobbero la bancarotta e il dissanguamento di ogni energia. 2.2. La guerra: chi e quando. Il suo impatto immediato La guerra giunse alla fine di un rimescolamento delle alleanze che aveva visto formarsi due blocchi sul territorio europeo: Francia, Gran Bretagna e Russia (Triplice Intesa) contro Germania e impero Austro-Ungarico (Triplice Alleanza). Alcuni paesi intervennero successivamente: l’Italia (1915) e gli Stati Uniti (1917), facendo pendere decisamente la bilancia in favore della Triplice intesa. Alla fine, in ogni caso, vennero coinvolti nel conflitto 28 paesi per un complesso di 65 milioni individui mobilitati. Alla fine, in ogni caso, vennero coinvolti nel conflitto 28 paesi per un complesso di 65 milioni individui mobilitati. La guerra, inoltre, che sarebbe dovuta durare pochi mesi durò invece quattro lunghi anni, fece 8,6 milioni di morti e oltre 20 milioni feriti tra i militari più 6 milioni di civili uccisi nei teatri di guerra e altre decine milioni uccisi per conseguenze indiretta della guerra (massacri etnici, la “spagnola”), a fronte dei “soli” 5,5 milioni di morti di tutti i conflitti ottocenteschi e richiese una quantità colossale di risorse: nei cinque anni di guerra 7/9 volte il Pnl dei paesi belligeranti e 3 volte il Pnl mondiale Le enormi risorse destinate a sostenere l’enorme sforzo bellico, risorse che andavano per tutti i paesi infinitamente al di là delle riserve auree e molto al di là anche della propria capacità finanziaria e produttiva, poterono essere approntate sul fronte finanziario grazie a una serie di misure quali: imposizione di tasse più ampie che in passato e a volte nuove (imposta sul reddito in Francia, ad es.; tasse sui profitti di guerra) aumento del debito pubblico: buoni del tesoro di vario genere, in grande quantità; emissione di prestiti all’estero, soprattutto da parte dei paesi dell’Intesa, che poterono giovarsi dell’ampia capacità finanziaria sia degli Stati Uniti che, in misura minore, della Gran Bretagna; aumento della circolazione monetaria, sganciando l’emissione di cartamoneta dalle riserve auree, quindi adottando universalmente il corso forzoso. Questo sforzo, sopportato soprattutto da Germania, Francia, Gran Bretagna, Russia, Italia e Impero Austro-ungarico, generò una forte esposizione debitoria di questi paesi e provocò una redistribuzione delle risorse monetarie e una forte inflazione in quasi tutti i paesi, dovuta agli alti prezzi, agli alti salari e all’accresciuta circolazione. La forte inflazione derivante dagli eventi bellici danneggiò fortemente, spesso portandoli alla rovina, i redditieri i creditori i percettori di reddito fisso di molti paesi europei. Molta dell’instabilità politica del dopoguerra fu dovuta alle milioni di persone rovinate o quantomeno duramente colpite dall’inflazione. 2.3. L’economia di guerra e la nuova centralità dello stato L’intera economia dei principali paesi belligeranti fu piegata alla necessità di alimentare adeguatamente questa colossale e inedita macchina di guerra; l’alternativa era la sconfitta. Ciò fu fatto ristrutturando il funzionamento stesso dell’apparato produttivo nazionale mediante la cosiddetta “economia di guerra”. Con qualche variazione nazionale, si trattò in ogni caso ovunque di: calmierare i prezzi dei generi di prima necessità razionando tali beni mediante la requisizione e la distribuzione mediante tesseramento chiudere la borsa garantendo comunque che la crisi di liquidità conseguente non danneggiasse l’economia e non provocasse una corsa al ritiro dei depositi bancari ridisegnare scopi e funzionamento del sistema dei trasporti, dedicandolo in gran parte alla movimentazione delle truppe e del materiale bellico garantire la produzione manifatturiera, e in particolare quella bellica, nonostante l’assenza di centinaia di migliaia di lavoratori mediante la precettazione di giovani, donne, prigionieri di guerra, lavoratori stranieri creare dipartimenti ministeriali appositi incaricati di: a) verificare la consistenza delle scorte; b) effettuare le requisizioni necessarie alla produzione bellica; c) attivare le produzioni di beni sostitutivi rispetto a quelli che non si aveva a disposizione; d) ripartire i materiali tra i vari settori e imprese; e) indicare le imprese sottoposte agli obblighi di mobilitazione bellica. Questo sforzo di direzione dell’economia da parte dello stato trasformò profondamente i rapporti tra stato, operatori economici e lavoratori e risultò fondamentale: per vincere la guerra per “abituare” all’idea di uno stato dirigista I risultati di tutto ciò si sarebbero visti bene soltanto in seguito, con la crisi degli anni ’30. In questi anni si sperimentarono le tecniche di gestione dell’economia nazionale che si sarebbero poi perfezionate a partire dagli anni ’30. 2.4. Una pace irragionevole: il trattato di Versailles La guerra si concluse nel 1918 e nel 1919 si svolse a Versailles la conferenza di pace. Tra le varie opzioni possibili prevalse quella di punire duramente le potenze vinte smembrandole in stati più piccoli, imponendo condizioni militari molto dure e soprattutto imponendo alla Germania un risarcimento monetario molto forte, le cosiddette “riparazioni di guerra” che avevano la caratteristica irrazionale e perversa di essere: decise unilateralmente anno per anno senza scadenza temporale Le scelte adottate nei trattati di pace non facevano che inasprire e rendere pericolosamente instabile la situazione e furono in buona parte alla base di forti disagi sociali nei paesi vinti ma anche, alla lunga, nei paesi vincitori di radicalizzazioni dagli effetti politici catastrofici di conflittualità internazionali destinate a sfociare nel giro di relativamente pochi anni in un nuovo conflitto mondiale Questa idea - insomma - di piegare, umiliare e ridurre all’impotenza le potenze dell’Europa centrale fu condannata duramente dal capo della delegazione britannica, l’economista John Maynard Keynes, che per protesta si dimise e pubblicò un libretto intitolato Le conseguenze economiche della pace, nel quale metteva in guardia rispetto ai pericoli che questi provvedimenti avrebbero generato per l’economia mondiale. Cogli anni le previsioni di Keynes si rivelarono ampiamente centrate. 2.5. Le conseguenze: le difficoltà della riconversione Finita la guerra molti paesi devono affrontare difficili problemi di riconversione dei propri apparati economici, almeno in tre sensi: ritorno a un controllo privato delle imprese riconversione della produzione bellica in produzione civile fine dei grandi privilegi riservati alle imprese strategiche per il conseguimento della vittoria (in Italia ad es.) Si trattò di uno sforzo niente affatto semplice, di lunga durata e che in alcuni paesi come l’Italia - si trascinò per tutti gli anni ‘20. 2.6. Le conseguenze: la marginalizzazione della Germania Ma nel complesso la grande novità del dopoguerra, la sua conseguenza più profonda e duratura fu la riconfigurazione degli equilibri economici e politici internazionali. Alla vigilia della guerra, lo abbiamo visto più volte, la situazione era la seguente: il mercato finanziario mondiale (servizi finanziari, investimenti esteri, prestiti, divise) era assolutamente dominato dalla Gran Bretagna e dalla sterlina, la principale potenza prestatrice, la sede delle borse fondamentali e la detentrice della moneta di riferimento. la Gran Bretagna disponeva anche del controllo militare delle rotte oceaniche e dell’egemonia militare sul mondo; a livello industriale la Germania e gli Stati Uniti erano ormai potenze in grado di rivaleggiare, sia in quantità prodotte che in livello tecnologico, con la gran bretagna sui mercati mondiali; altre potenze economiche capitaliste, molto diverse tra loro, avevano ormai una dimensione tale da permettersi un’espansione politica e finanziaria di area o anche planetaria: la Francia, il Belgio, l’Italia, la Russia, il Giappone. La guerra fa tre cose: crea grossi problemi di inflazione interna ai paesi che hanno fatto la guerra crea grossi problemi di ricostruzione del quadro di equilibri che aveva permesso lo sviluppo del commercio internazionale nei decenni precedenti la guerra rimescola tutta la gerarchia economico-politica: modifica infatti in modo irreversibile i rapporti tra maggiori paesi industrializzati La prima conseguenza è la temporanea scomparsa della Germania dal numero delle potenze mondiali. Abbiamo visto le condizioni insostenibili e miopi poste dalle potenze vincitrici, le riparazioni di guerra e la sottrazione dell’Alsazia e la Lorena. Tutte misure che favoriscono lo svilupparsi di una eccezionale fiammata inflazionista e che mettono in ginocchio la Germania nel corso dei primi anni Venti, creano un enorme disagio tra la popolazione, generano una forte instabilità politica che, al pari dell’Italia, porta alla crescita di movimenti autoritari di estrema destra e che fanno nascere un grande desiderio di rivalsa, culturale, politica ed economica, sulla quale faranno poi leva i nazisti. 2.7. Le conseguenze: perdita di peso della Gran Bretagna ed egemonia mondiale statunitense Per quel che riguarda gli equilibri di potere economici e politici mondiali la conseguenza più rilevante del conflitto è, come abbiamo detto più volte, il passaggio della posizione di comando dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti. La Gran Bretagna si indebita fortemente per sostenere il peso della guerra e deve ripiegare su rapporti privilegiati con il Commonwealth. Inoltre il fatto di essere coinvolta direttamente nel conflitto sin dall’inizio l’ha costretta a concentrare il proprio sforzo produttivo in campo bellico, trascurando la produzione per l’esportazione, il che determina una perdita di mercati e di relazioni commerciali. Gli Stati Uniti sono invece i grandi beneficiari della guerra e ne approfittano per trasferire anche sul piano politico e finanziario la superiorità sulla Gran Bretagna raggiunta prima della guerra sia sul piano tecnologico che dei volumi produttivi. Essi passano anzitutto da paese debitore non solo a paese creditore, ma a maggior paese creditore del mondo, prendendo decisamente il posto della Gran Bretagna. Gli Stati Uniti, unica delle grandi potenze industriale non coinvolta da subito e pesantemente nelle operazioni belliche, si erano avvantaggiati rifornendo i paesi in guerra di manufatti, materie prime, generi alimentari, servizi di trasporto etc. effettuando prestiti Nel corso della guerra “il dollaro si affianca alla sterlina come valuta di riferimento e New York entra in concorrenza con Londra come mercato finanziario di importanza mondiale”. Il 1919 viene insomma considerato da molti come l’anno in cui, simbolicamente, il titolo di “cuore” dell’economia mondiale (ricordate Braudel) si trasferisce da Londra a New York, dove rimane tuttora. 2.8. Le conseguenze: gli effetti sui paesi terzi e la frammentazione dello spazio economico europeo L’ampiezza della guerra, che fu tra l’altro il primo conflitto in cui i paesi di quasi tutti i continenti furono in modo o nell’altro coinvolti, fece in modo che le sue conseguenze si avvertissero anche molto lontano dall’area dello scontro. Il Giappone, ad esempio, si giovò fortemente della diminuita pressione da parte degli europei in Asia per proseguire la sua politica espansionistica sia in campo militare (colonie tedesche, cina) sia in campo economico (esportazioni industriali in Europa, America Latina, Stati Uniti), fino a divenire anch’esso, finalmente, un paese creditore. Non molto diversa fu, almeno sotto il profilo economico, la sorte di un’altra area fortemente coinvolta nel conflitto, l’America Latina, che anche grazie a massicci investimenti statunitensi vide aumentare notevolmente le proprie esportazioni, il proprio tessuto industriale e quindi la propria integrazione con i mercati internazionali. Al contrario, le decisioni prese a Versailles di punire i paesi vinti attraverso una riduzione delle loro superfici territoriali portò a una notevole frammentazione dell’Europa centrale, frammentazione che - unita all’autoesclusione dell’Unione Sovietica dal circuito economico capitalista e dallo scorporamento dell’Impero Ottomano - portò alla contrazione degli scambi internazionali. 2.9. Le conseguenze: la nascita dell’Unione Sovietica La seconda conseguenza della guerra è una profonda crisi interna in Russia che determina la crisi del regime zarista e l’affermazione di forze rivoluzionarie. Dopo un periodo di passaggio nel quale si confrontano varie ipotesi di uscita dal vecchio regime ancora in parte feudale, riescono a conquistare il potere i bolscevichi, cioè i comunisti, che fondano una federazione di stati sovietici (l’Urss, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) che tenta per la prima volta nella storia un esperimento di economia non di mercato, non capitalista, basata sulla proprietà collettiva (attraverso la mediazione dello stato) dei mezzi di produzione. Si tratta di una novità storica di enorme importanza, tra l’altro in un paese estesissimo, di grande prestigio internazionale e a diretto contatto con la culla del capitalismo, cioè con l’Europa. Dal 1917 e per oltre settanta anni l’Unione Sovietica e poi gli altri paesi comunisti saranno quindi “sganciati” dal sistema mondiale capitalista, tenteranno di sperimentare (con maggiore o minore successo) forme di economie non di mercato e costituiranno un potente richiamo, un modello e una speranza per centinaia di milioni di lavoratori, di diseredati e di oppressi di tutto il mondo. LEZIONE 3. LA RIVOLUZIONE RUSSA E L’UNIONE SOVIETICA 3.1. Le premesse della rivoluzione Facciamo un rapido ripasso delle radici ottocentesche della rivoluzione russa: le modificazioni della composizione di classe con l’industrializzazione gli antagonismi di classe nella prima metà dell’ottocento e il socialismo utopistico l’internazionale socialista, le sue correnti, marx e il marxismo l’emergere della “questione sociale”, dei partiti socialisti (riformisti e non) e delle varie risposte, tra cui il riconoscimento dei sindacati e la loro crescita la prima guerra mondiale e i suoi effetti sui movimenti socialisti la questione della rivoluzione nei paesi arretrati o nei paesi avanzati il paradosso russo: la rivoluzione in un paese arretrato 3.2. Dall’impero russo degli zar alla fine della Nep sovietica, 1913-28 3.2.1. La Russia degli zar alla vigilia della prima guerra mondiale, ovvero il punto di partenza economico All’inizio del ‘900, infatti, la Russia era decisamente un paese ritardatario. Nonostante un rapido processo di industrializzazione avviatosi verso il 1880, al 1913 il PNL reale per abitante (quello totale era ovviamente piuttosto alto, visti i 161 milioni di abitanti) era meno di un terzo degli Usa, circa metà di Francia e Germania e quasi sicuramente al di sotto di Italia e Spagna. Idem dicasi per l’industrializzazione, dove a fronte di un quarto posto assoluto se si guardava alla produzione industriale procapite era piazzata invece al 15-18° posto, dopo Italia e Spagna anche se prima di paesi balcanici come la Serbia e la Romania. Nel complesso si trattava comunque di un paese con una dieta monocorde (soprattutto cereali) ma ampiamente sufficiente, che aveva oltretutto un settore di latifondo capace di esportare circa un quinto della produzione nazionale complessiva di cereali. Socialmente si trattava di un paese abbastanza contraddittorio: un servaggio appena finito (con molto ritardo); una stragrande prevalenza di contadini poveri (80%), tecnologicamente arretrati e in crisi (il declino dell’allevamento); tassi di alfabetizzazione molto bassi; alta mortalità infantile; sull’altro versante una frequenza universitaria piuttosto alta e un’intellettualità di primissimo ordine, che aveva segnato la cultura europea dell’Ottocento. Inoltre a partire dagli anni a cavallo tra Otto e Novecento sembra iniziare una fortissima crescita demografica, simile a quella dei paesi del Terzo Mondo di oggi, che implica (a fronte di una crescita economica piuttosto lenta) una progressiva riduzione della produzione sia industriale che agricola procapite negli anni precedenti la guerra. Ricordiamo inoltre che nel 1905 si verifica un imponente moto rivoluzionario, in coincidenza tra l’altro con la sconfitta nella guerra col Giappone, moto che apre la strada a delle riforme sia istituzionali che economiche. Nonostante tale moto il gruppo dirigente del paese resta nelle mani dello Zar e di una nobiltà profondamente arretrata, che non vuole e non riesce a fare le riforme necessarie. Questa sarà una delle cause principali degli avvenimenti del 1917. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, insomma, la Russia è un paese pieno di profonde contraddizioni che si butta nella mischia col peso del suo vasto impero ma con un livello tecnologico-militare infinitamente più basso della Germania. 3.2.2. Il comunismo di guerra, 1917-21 È anche a causa di questa arretratezza che verso il 1917 l’esercito dello zar non riesce a contenere l’avanzata delle truppe degli imperi centrali (Germania e AustriaUngheria) che penetrano in profondità nel territorio russo. A questo punto, nel febbraio del 1917, avviene un primo moto rivoluzionario che abbatte lo zar e successivamente, nel mese di ottobre, si impone la parte più radicale dello schieramento rivoluzionario, cioè il Partito Comunista guidato da Lenin, che conquista il potere, firma una pace separata con i tedeschi e avvia una trasformazione profonda delle istituzioni, dell’economia e delle strutture sociali del paese. I PROVVEDIMENTI RIVOLUZIONARI IN ECONOMIA I comunisti russi non sono dei riformisti. Sono dei seguaci abbastanza puri della teoria di Marx e intendono rovesciare completamente le strutture economiche e sociali del paese. Già nell’ottobre del 1917 viene adottata una serie di misure che riguardano tutti i settori della vita economica. I primi provvedimenti riguardarono il settore più importante in assoluto, l’agricoltura. Nonostante l’abolizione della servitù del 1861, il latifondo continuava di gran lungo a dominare e i grandissimi proprietari detenevano ancora il 60% delle terre. La riforma agraria previde la confisca delle proprietà senza indennizzo e l’acquisizione da parte dello stato sia dei terreni che del bestiame. Lo stato, inoltre, si preoccupava di prelevare una parte del prodotto per soddisfare le esigenze di sussistenza della popolazione non agricola, quella urbana in particolare. In campo industriale furono requisite le fabbriche, che vennero affidate agli operai. Siccome molti dirigenti erano fuggiti e mancava un’elaborazione teorica forte sul da farsi (a differenza delle analisi critiche, che erano molto raffinate) si fece fronte alla penuria di tecnici e manager creando un organismo tecnico centrale, il “Consiglio superiore dell’economia nazionale” (Vesencha), un organismo che doveva coordinare tutto il settore industriale e poi avrebbe avuto un ruolo decisivo nella pianificazione. In campo finanziario il sistema creditizio fu nazionalizzato, espropriati gli azionisti e cancellati unilateralmente i debiti con l’estero. Idem dicasi per commercio e distribuzione. LE LORO CONSEGUENZE Il bilancio di questi provvedimenti, tra la fine del 1917 e i primi del 1921, apparve presto disastroso ed era aggravato: dai problemi causati dalla smobilitazione delle truppe che avevano combattuto nella Grande Guerra dalla guerra civile che, appoggiata dai governi inglese, francese, statunitense e giapponese, oppose i rivoluzionari e i controrivoluzionari almeno fino alla metà del 1920 con propaggini fino al 1922 dal blocco commerciale e istituzionale operato dai governi occidentali anche mediante la creazione del “cordone sanitario” In campo agricolo la riforma del 1918 costituì il primo di una lunga serie di fallimenti nel settore, fallimenti ripetutisi sistematicamente fino alla fine del regime socialista, perché i contadini erano contrari sia ai prelievi forzati sia al fatto che le terre non erano divenute di loro diretta proprietà. Il nuovo sistema, oltretutto, rompeva la vecchia tradizione autarchica delle campagne: prima il 70% dei cereali destinati al mercato provenivano dal latifondo e solo il 30% veniva dalle piccole produzioni, il che significa che la stragrande maggioranza dei contadini si ritrovò a versare una parte molto maggiore del proprio prodotto al mercato di quanto non facesse in passato. La prima conseguenza fu una notevole riduzione dei terreni coltivati e una prima grande carestia nel 1918, poi una penuria nel 1920 (nonostante l’eliminazione dell’esporto) e quindi una carestia ancora più grave nel 1921. Nel 1920 la produzione agricola era dimezzata rispetto a quella dell’anteguerra. In campo industriale i problemi, aggravati dalle grandi difficoltà della riconversione e dalla perdita delle relazioni commerciali e finanziarie con l’estero, causarono una riduzione delle attività a un sesto-un ottavo rispetto all’anteguerra. Per il governo dei soviet il bilancio all’inizio del 1921 era militarmente positivo ma economicamente catastrofico, con rivolte diffuse sia per motivi alimentari che per motivi politici. Di qui la decisione di modificare la linea di politica economica adottata fino a quel momento. 3.2.3. Il socialismo LA NEP, 1921-28 Questi provvedimenti vennero definiti con la sigla di Nuova politica economica (Nep), e costituirono in sostanza il ristabilimento provvisorio di un settore capitalistico accanto a un settore socialista del quale si cerca di migliorare il funzionamento. Il carattere “provvisorio” è un elemento importante, in quanto l’obiettivo, a più o meno lungo termine, è l’instaurazione di una società a economia comunista. (Paul Bairoch) Si trattò in buona sostanza di: abolizione delle requisizioni in agricoltura e sostituzione con una tassa fissa della metà circa rispetto ai prelievi precedenti ritorno alla proprietà privata della terra, diritto di successione compreso privatizzazione delle imprese di meno di 20 operai (circa il 12% del settore), autorizzate a vendere liberamente libertà d’impresa ricorso a tecnici stranieri, a capitali stranieri (che non arrivarono causa inaffidabilità) e a imprese straniere (che comunque rimasero 70, lo 0,6% della produzione industriale) riorganizzazione del settore industriale pubblico mediante cartelli, profitto come metro e liberalizzazione privatizzazione del commercio interno: con la soglia dei 20 dipendenti, il 90% della distribuzione tornò in mani private. riforma monetaria, con varie vicissitudini (vedi bairoch, p. 1078) Rimase piena prerogativa del governo la gestione del commercio estero, comunque ridotto ai minimi termini (esporto 15% del 1912, importo 1%) che si cercò di rilanciare mediante accordi. La Nep andò sostanzialmente a buon fine, consentendo il ritorno alla normalità nell’arco di cinque anni. Nel 1928 la produzione industriale era tornata nel complesso ai livelli del 1913, senza ancora privilegiare l’industria pesante e quindi con consumi individuali non intaccati. Nel settore elettrico, privilegiato da Lenin, il rapporto 1913-28 era 4,5 anche se a livello internazionale tale progressione non era gran che (consumi individuali sotto quelli spagnoli). In agricoltura si iniziò con la terrificante carestia del 1921 (riduzione coltivi+siccità) che uccise 5 milioni di persone, concentrate in gran parte nelle maggiori città e si tornò ai livelli anteguerra nel 1925-26. Nonostante ciò si manifestò sin da allora un limite grave che avrebbe poi pesato su tutta la storia dell’agricoltura sovietica: la cattiva organizzazione dello stoccaggio e del trasporto dei prodotti alimentari. Il commercio estero conobbe una ripresa notevole anche se a partire da livelli minimi, cosicché nel 1928 era ancora la metà circa del 1913. A livello sociale le cose erano più articolate. La liberalizzazione introdusse il ritorno di una certa quantità di disoccupazione (1,6 ml di persone, probabilmente il 10% della manodopera industriale), ma furono introdotte una serie di importanti misure di tutela dei lavoratori che fecero in breve dell’Urss il paese più avanzato del mondo in tale campo: otto ore (1922) sicurezza sociale (malattia) indennità di disoccupazione ferie pagate (1922, prime al mondo) 3.3. La pianificazione 3.3.1. Introduzione Con Stalin (che elimina Trockij nel 1927 e assume pieni poteri nel 1929) la Nep viene progressivamente abbandonata, anche se ufficialmente celebrata ancora nel 1931. L’apogeo della Nep è probabilmente nel 1925, il settore privato comincia a declinare nel 1926, nel 1927 vengono adottati i primi provvedimenti in senso contrario, nel 1929 si entra di fatto in una fase diversa. I due principali elementi di innovazione sono: abolizione del settore agricolo privato pianificazione 3.3.2. La fine della Nep e la pianificazione “integrale” Il primo campo in cui la Nep viene ridimensionata è quello dell’agricoltura. Già dal 1927 viene dichiarata la necessità di collettivizzare l’agricoltura. Nel 1928, a seguito di una carestia, viene deciso di requisire un certo quantitativo di cereali. Alla metà del 1929 parte la collettivizzazione delle terre mediante i kolkhoz (aziende collettive) e la deportazione (altrove o in campi) dei kulaki, i grandi proprietari terrieri. Nei kolkhoz la terra appartiene allo stato, ma ai contadini viene concesso di avere dei piccoli appezzamenti per sé. Al 1930 il 43% delle terre è collettivizzato e nel 1933 l’83%; nel 1936 la collettivizzazione è completata. I risultati immediati della collettivizzazione della terra sono da una parte milioni di morti, di morte violenta o di stenti, e da un’altra parte un crollo della produzione agricola e del bestiame. Al contempo lo stato mise a disposizione mezzi ingenti per potenziare il settore agricolo, considerato la base fondamentale per l’industrializzazione: nel 1936 l’Urss disponeva di 2/3 dei trattori europei (450.000) e consumava l’11% dei fertilizzanti del continente (3% nel 1913). Meno traumatico fu il ritorno a un pieno controllo statale sull’industria, che era rimasta in larghissima parte statale anche durante la Nep. I problemi per l’industria furono sul fronte della pianificazione e del coordinamento intersettoriale. Notevolmente complesso fu il ritorno allo stato del commercio al dettaglio. La fine della Nep segnò anche l’inizio del sindacalismo di stato e la fine di qualsiasi potere da parte dei lavoratori, sia a livello centrale che a livello di fabbrica. La fine della Nep coincise con la nascita della pianificazione. Una novità storica assoluta, senza precedenti, avviata con il piano quinquennale 1928-32. I piani furono, per l’esattezza: 1928-32 1. 1933-37 2. 1938-42 (interrotto nel 1941 per la guerra) 3. 1946-50 4. 1951-55 5. 1956-60 (sostituito nel 1958 dal nuovo piano settennale) 6. 1959-65 7. 1966-70 8. 1971-75 9. 1976-80 10. 1981-85 11. 1986-90 (l’ultimo, interrotto nel 1987) I dodici piani possono essere suddivisi in tre fasi: pianificazione integrale (1929-58) riforme (1959-64) ritorno all’ortodossia (1964-1987) 3.3.3. Il bilancio della pianificazione integrale, 1928-58 Due obiettivi fondamentali della pianificazione erano l’industrializzazione e il raggiungimento di standard europeo-ocidentali. Vediamo come andò. L’industrializzazione fu un successo indubbio. Al 1958 l’industria sovietica era pari al 26-28% di quella, nel frattempo cresciutissima, degli Usa mentre nel 1913 era il 15-17 e nel 1928 il 10-12. Un limite particolarmente evidente di questa crescita sta nello squilibrio tra industria pesante e industria dei beni di consumo: laddove assai sostenuta è la crescita della produzione di acciaio e di energia elettrica, ad esempio, i prodotti tessili, le automobili, gli elettrodomestici restano generi estremamente scarsi, mentre un poco meglio va sul fronte delle abitazioni, anche se non si riesce a far fronte adeguatamente alla domanda. Su un altro fronte resta notevole il fatto che in tutto questo periodo non si verificano fenomeni tipici invece del campo capitalista come il crollo della produzione oppure le crisi di disoccupazione (forme di sottocupazione incluse…). Altri aspetti rilevanti e caratteristici, il notevole livello di inefficienza e di sprechi rispetto all’Occidente e, sempre rispetto all’Occidente, l’alto livello della spesa destinata alla difesa. Sul fronte agricolo a fronte di un buon bilancio per quanto riguarda i cereali, che nel periodo crebbero del 70% rispetto a una crescita della popolazione del 40%, ci fu una crescita debole per tutti gli altri prodotti: carne, prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura. Nel 1958 si consumava decisamente più carne che nel 1928, ma forse non più che nel 1913: 90 gr. procapite contro i 180 gr. europei e i 250 gr. americani. Calcolare la crescita, più tradizionalmente, in termini di Pil non è facile a causa dell’imprecisione delle stime sovietiche ma per il periodo 1928-58 si può […] ritenere che, complessivamente, la pianificazione abbia consentito all’Urss di colmare parte del suo ritardo e di dotarsi più rapidamente dell’Occidente di una base industriale. (Paul Bairoch) Tra i principali insuccessi vanno citati anzitutto i tremendi prezzi umani degli anni ’20 e ’30 e la debole espansione del settore dei beni di consumo, ma va messo nel conto il tremendo periodo staliniano che si estende dal 1926 fino al 1953 che si porta sulle spalle la responsabilità di diverse decine di milioni di morti (40, forse di cui ½ assassinati). Sul piano sociale al contrario vanno annoverati parecchi importanti successi: una distribuzione meno sperequata del reddito, sia a livello sociale che a livello territoriale un progresso estremamente rapido di istruzione e medicina assenza di disoccupazione, nonostante la sottoccupazione livello culturale molto alto e diffuso, nonostante le gravissime limitazioni alla libertà di espressione bassi livelli di criminalità, tossicodipendenza e prostituzione, o quantomeno più bassi che in occidente (discorso a parte l’alcolismo) LEZIONE 4. GLI ANNI ’20; LA CRISI ECONOMICA NEGLI STATI UNITI 4.1. Il dopoguerra e gli anni ‘20 4.1.1. Le evitabili eredità della Grande Guerra Un cataclisma come la grande guerra, dunque, doveva inevitabilmente portare con sé una serie di modificazioni traumatiche negli equilibri economici e sociali. Ciò di cui soltanto pochi si resero conto all’epoca era che le scelte adottate nei trattati di pace (Versailles, come abbiamo visto) non facevano che inasprire e rendere pericolosamente instabile la situazione. Esse furono in buona parte alla base di forti disagi sociali di radicalizzazioni dagli effetti politici catastrofici di conflittualità internazionali destinate a sfociare nel giro di soli venti anni in un nuovo conflitto mondiale Per questo si è parlato non solo di “conseguenze della guerra” ma anche di “conseguenze della pace”, non meno importanti, per pace intendendo proprio i trattati firmati alla fine della guerra. 4.1.2. La follia della “resa incondizionata” e le sue conseguenze Sulla carta era senza dubbio possibile un compromesso su alcuni obiettivi bellici che entrambe le parti, con ottica megalomane, formularono non appena scoppiò il conflitto, ma in pratica il solo obiettivo che contasse era la vittoria totale: ciò che nella seconda guerra mondiale venne definito “resa incondizionata”. Era un obiettivo assurdo e autolesionistico che condusse alla rovina vinti e vincitori. Gli sconfitti furono trascinati nella rivoluzione, mentre i vincitori conobbero la bancarotta e il dissanguamento di ogni energia. (…) La Gran Bretagna non fu più la stessa dopo il 1918, perché aveva rovinato la propria economia, conducendo una guerra al di là delle proprie risorse. Inoltre la vittoria totale, ratificata da una pace punitiva, imposta dai vincitori, distrusse quelle poche possibilità che ancora esistevano di restaurare un ordine che fosse, anche vagamente, simile a quello dell’Europa liberale e borghese, come l’economista John Maynard Keynes immediatamente riconobbe. Senza reintegrare la Germania nell’economia europea, senza cioè riconoscere e accettare il peso economico di quel paese, non poteva esserci alcuna stabilità. Ma reinserire la Germania era l’ultimo pensiero di coloro che avevano combattuto per eliminarla. (Eric Hobsbawm) I trattati di pace, quindi, piuttosto che risolvere i problemi li resero quasi iresolubili. Essi contribuirono grandemente ad alimentare soprattutto due problemi: il crescente nazionalismo economico l’instabilità monetaria e finanziaria 4.1.3. L’umiliazione della Germania Al di là delle ridistribuzioni di territori tra paesi vincitori e vinti, l’aspetto più rilevante dei trattati era l’umiliazione e la punizione della Germania. Oltre alle ingenti confische le venivano imposte delle imprecisate “riparazioni” sul cui ammontare non si trovò accordo ma che avrebbero dovuto essere mostruose. Keynes: abbandono delle trattative e pamphlet Le conseguenze economiche della pace. 4.1.4. Disordini monetari e finanziari: debiti di guerra e riparazioni I disordini monetari e finanziari degli anni ’20 sarebbero stati infatti strettamente collegati al problema dei crediti di guerra e della infelice questione delle “riparazioni”, decisa nei trattati di pace. Vediamo più da vicino il punto di partenza: primi prestatori all’inizio della guerra, gli inglesi, poi gli americani debito di guerra interalleato al 1918 20 mld $ la metà di questi prestati dagli Usa 7,5 mld prestati dalla Gran Bretagna (che aveva però circa 4 mld $ di debiti con gli Usa) 2,5 mld prestati dalla Francia (che però aveva altrettanti debiti) Tutti speravano senza dirlo apertamente che questa enorme massa di debiti sarebbe stata condonata con la fine della guerra, ma gli Stati Uniti non ne vollero sapere, più attenti ai fatti loro che agli equilibri globali, gettando gli Alleati nella disperazione. Questi ultimi decisero allora di risolvere spremendo la Germania, pur continuando a sperare (invano) di poter far tabula rasa sia dei debiti che delle riparazioni, anche perché nonostante lo strizzamento criminale e insostenibile della Germania essi non ce la facevano comunque a restituire i soldi perché il paese era economicamente paralizzato proprio a causa delle sanzioni alleate. Insomma, un circolo vizioso. 4.1.5. Sminuzzamento territoriale e chiusura economica Un’altra conseguenza profondamente negativa per l’economia fu lo sminuzzamento dell’Europa centrale in un gran numero di piccoli stati cosicché viene a finire un’importante area di libero scambio. Tra questi staterelli (come più in generale tra tutti gli stati, con tutti i casini di confine etc.) si arrivò in seguito ad una forte chiusura che produsse una notevole contrazione dei commerci. 4.2. I traumi dei primi anni ’20: la stagnazione del commercio internazionale e l’inflazione 4.2.1. Nazionalismo economico (Unione Sovietica, Regno Unito, Stati Uniti) e conseguenze del neo-mercantilismo: il crollo del commercio e la stagnazione Ma non furono soltanto i neo-staterelli a chiudersi: la Russia rivoluzionaria com’è ovvio lo fece ma lo fecero anche la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. la Gran Bretagna mise dazi, tariffe e restrizioni e contemporaneamente sussidiò le proprie imprese per favorire le esportazioni; inoltre ridiscusse molti accordi eliminando la clausola della nazione più favorita, che sappiamo quanto importante etc. gli Usa, inoltre, alzano ulteriormente le proprie già alte tariffe e così continueranno a fare negli anni ‘20. Ogni stato faceva insomma il possibile per proteggere la propria economia contro le minacce provenienti dall’esterno, vale a dire contro l’economia mondiale che era chiaramente in grande difficoltà. Le conseguenze di queste chiusure reciproche furono il ristagno del commercio mondiale, che prima della guerra era sempre cresciuto, e il crollo del commercio estero dei paesi europei che solo nel 1929, e per breve tempo, raggiungerà i livelli dell’anteguerra. Il nazionalismo economico, infatti, invece di proteggere e rilanciare le economie nazionali nella gran parte dei casi non fece che deprimere i livelli di produzione e di reddito. 4.2.2. La tempesta sulle monete del centro-est Europa (1920-23), rovina di milioni di salariati e risparmiatori e strada spianata al fascismo Un altro fenomeno che contribuì a rendere tragici, almeno per alcuni paesi, gli anni dell’immediato dopoguerra fu l’inflazione, un fenomeno quasi sconosciuto nel corso dell’Ottocento, e al quale abbiamo fatto già cenno quando abbiamo parlato delle conseguenze della guerra. Gli anglosassoni, il Giappone e i paesi neutrali riuscirono infatti a riportare le loro economie ai cambi monetari stabili, al regime aureo tra il 1922 e il 1926 ma i paesi vinti e quelli che avevano vinto a costi troppo alti, cioè quelli dell’area centro ed esteuropea, conobbero un crollo spettacolare dei loro sistemi monetari. A metà 1922, il marco iniziò a collassare a causa della pressione eccessiva e i risarcimenti di guerra furono addirittura sospesi. In risposta, nel gennaio 1923 belgi e francesi occuparono militarmente la Ruhr per sfruttarne direttamente la produzione, e il governo tedesco per aiutare i propri concittadini sfruttati emise una gran quantità di cartamoneta, provvedimento che avviò un processo inflazionistico pauroso. A novembre 1923 con un dollaro si potevano ottenere 4,2 trilioni di marchi. L’inflazione si trasmise all’Austria e ai suoi ex domini, quindi alla Francia, travolta dalla sua stessa scelta di occupare la Ruhr (5 franchi per dollaro nel 1914, 40 franchi per dollaro al massimo della crisi, 25 franchi per dollaro alla stabilizzazione nel 1926). Era la crisi, come previsto da Keynes. I francesi lasciarono la Ruhr, i pagamenti furono diminuiti, partì un prestito per la Germania (il prestito Dawes, 200 ml $, in prevalenza Usa più una serie di altri prestiti locali) per ricostruire il paese e permettergli di pagare i debiti. 4.3. L’apparente ripresa degli anni ‘20 4.3.1. Apparente prosperità Nonostante tutto ciò buone performances delle economie occidentali tra 1924 e 1929. In particolare gli Stati Uniti, la Germania e la Francia, attraversarono un periodo di prosperità. Tuttavia le basi di questa prosperità erano oscurate e persino rese fragili da una serie di debolezze strutturali: per la Germania, l’eccessiva dipendenza dai capitali americani per la ripresa per gli Stati Uniti, una agricoltura in crisi di sovrapproduzione dopo l’ubriacatura della guerra e una domanda che non teneva il passo della capacità produttiva per la Gran Bretagna, una eccessiva dipendenza dal commercio internazionale e una obsolescenza dell’apparato industriale che la resero molto esposta alla perdita di centralità finanziaria e commerciale che abbiamo visto prima 4.4. Il manifestarsi della crisi 4.4.1. L’inatteso tracollo del ’29 Nonostante l’apparente fase di tranquillità successiva al 1926 verso la fine degli anni ’20 una crisi ciclica era prevista tanto dagli economisti borghesi (eccetto gli operatori di borsa) quanto dai rivoluzionari di sinistra sia a causa degli squilibri detti, sia per la consapevolezza dell’esistenza dei cicli. Ciò che stupì fu la sua estensione e la sua profondità, del tutto inattese. 4.4.2. La meccanica della crisi La Grande depressione partì nell’ottobre del 1929 con un colossale crack di borsa da dove meno ce lo si aspettava: dagli Stati Uniti, che sembravano (e in parte sicuramente erano) il paese economicamente più forte e in buona salute del mondo. Come mai? All’uscita dalla guerra, gli Usa si presentavano, come in parte già sappiamo: passati da debitori a creditori con mercati nuovi strappati ai produttori europei con una bilancia commerciale in ricco attivo Grande slancio, quindi, grandi affari, grandi aspettative: in apparenza un’età dell’oro alle porte per tutti. Sull’onda di questo ottimismo diffuso, dall’estate 1928 disinvestimento nei titoli stranieri (tedeschi soprattutto) e investimenti crescenti sul mercato azionario di New York. Si verificava insomma un gigantesco boom speculativo proprio in corrispondenza (a partire dal 1929) di due fenomeni molto gravi e preoccupanti: una profondissima crisi europea legata proprio ai disinvestimenti Usa un rallentamento della stessa crescita produttiva statunitense Di qui l’esplosione della bolla speculativa. LEZIONE 5. LA CRISI NEL MONDO, LE CAUSE E LE PRIME RISPOSTE 5.1. La diffusione della crisi a livello internazionale 5.1.1. La meccanica della diffusione Con l’esplosione della bolla speculativa improvvisamente tutti iniziarono contemporaneamente a disinvestire, a svendere, a cercare di salvare qualcosa e continuarono fino a tutto il 1930 devastando intere fortune, equilibri finanziari nazionali interni ed esteri. Un gigantesco tentativo di aprire i cordoni del credito e soprattutto del credito al consumo per stimolare la fiducia e la crescita si rivelò troppo tardivo e coinvolse un gran numero di banche in fallimenti a catena che aumentarono ulteriormente la sfiducia collettiva e la spirale della crisi. Nel 1930 i mercati si stabilizzarono ma i prezzi continuarono a scendere investendo infine anche i paesi produttori di materie prime come Australia e Argentina. All’inizio del 1931 il commercio estero statunitense rappresentava 65% di quello di due anni prima. Nel maggio 1931 il panico si diffuse dapprima in Austria poi in tutta l’Europa centrale e orientale, Germania compresa, causando disinvestimenti massicci e fallimenti bancari. Il 20 giugno 1931 gli Usa dichiararono la moratoria di un anno sui pagamenti di debiti e riparazioni ma a quel punto era inutile: in quanto il panico si diffuse anche in Gran Bretagna, dove furono sospesi i pagamenti in oro. Tra il settembre 1931 e l’aprile del 1932 ben 24 paesi abbandonarono la parità aurea, mentre quelli che vi rimanevano legati sospendevano i pagamenti. In assenza di un sistema internazionale concordato, i valori delle valute oscillarono incontrollabilmente spinti dalle variazioni dell’offerta e della domanda, e influenzati dalle fughe di capitali e dagli eccessi del nazionalismo economico che si riflettevano in variazioni tariffarie di ritorsione. Gli scambi internazionali caddero drasticamente tra il 1929 e il 1932, inducendo analoghe, ma meno drastiche, contrazioni della produzione manifatturiera, dell’occupazione e del reddito procapite. 5.1.2. Una valutazione complessiva Con la crisi del 1929, insomma: si giunse assai vicino al tracollo dell’economia mondiale capitalistica, che parve in preda a un circolo vizioso nel quale ogni indice economico in ribasso (a eccezione del livello di disoccupazione, che si innalzò toccando punte astronomiche) accentuava il calo di tutti gli altri. una forte recessione dell’economia industriale nordamericana si diffuse ben presto nell’altro cuore industriale del mondo, la Germania. ci fu una crisi della produzione sia di materie prime sia di generi alimentari di prima necessità allorchè i prezzi di queste merci, non più sorretti come in precedenza dalla formazione di ingenti scorte, scesero in caduta libera. questo fatto gettò nella crisi le economie dei paesi il cui commercio internazionale dipendeva in grandissima parte dall’esportazione di prodotti di prima necessità. in breve, la depressione divenne mondiale. 5.2. Le cause della depressione Un fenomeno così ampio e catastrofico ha colpito subito l’immaginazione di tutti e ha costituito un problema interpretativo tanto urgente quanto complesso. Bisognava capire come e perché tutto ciò era potuto avvenire. La cosa era resa difficile dalla grande quantità di fattori in gioco, ma col passare del tempo gli studiosi hanno finito col concordare su alcuni punti di fondo. 5.2.1. Le cause principali della crisi radici Grande Guerra della crisi: indebolimento europeo e spirale perversa debito-riparazioni-debito. si noti come il circolo vizioso riparazioni di guerra-restituzione del debito-nuovo debito portò nel 1929 a creare il primo organismo di coordinamento economico mondiale, la Banca degli Accordi Internazionali, con sede a Basilea, tuttora esistente. radici Usa della crisi: capire gli Usa per capire la crisi. la grande crescita con la guerra (1913 = 33% della prod. mondiale vs 34% di Gran Bretagna+Francia+Germania; 1929 = 42% vs 28%), il passaggio dalla posizione debitoria a quella creditoria, soprattutto nei confronti degli europei, prima nazione esportatrice, prima nazione importatrice. domanda insufficiente. altra causa il fallimento nel generare una domanda in grado di provocare un’espansione durevole. negli stessi Usa c’erano settori stagnanti o in declino negli stessi anni del boom. La dinamica era: salari in ritardo rispetto alla crescita > profitti spropositati, sovradimensionati > domanda non al passo con la produttività > sovrapproduzione e speculazione > crollo. eccessiva dipendenza di Alleati e Germania dal prestito americano. il circolo vizioso debito-riparazioni-debito portò negli anni ’20 sia gli Alleati che la Germania a dipendere in modo massiccio dalla finanza statunitense, in posizione di estrema debolezza. quando i risparmiatori americani si sganciarono dal finanziamento dell’economia europea, fu il caos Stati Uniti: onori senza oneri. un’altra causa di destabilizzazione era l’ormai consolidato predominio statunitense su tutti gli aspetti dell’economia internazionale senza il senso di responsabilità che ne doveva conseguire 5.2.2. Altri fattori che pesarono diminuzione della quantità di denaro disponibile nelle economie industriali la depressione agricola la dipendenza dei paesi del terzo mondo da mercati instabili per i loro prodotti una scarsità o cattiva distribuzione delle risorse auree 5.2.3. Cause della gravità e durata della crisi Tutti d’accordo, in ogni caso, sul perché la crisi fu così devastante e perché durò cosi a lungo: dopo la guerra la Gran Bretagna non poteva più sostenere il suo ruolo guida dell’economia mondiale (sbocchi per tutte le merci, massicci investimenti esteri che equilibravano le bilance dei pagamenti altrui, fedeltà al regime aureo, etc.) la cosa non fu chiara fino al 1931 quando la cosa fu chiara gli Usa si rifiutarono tuttavia di prendersi le proprie responsabilità, sempre assunte in precedenza dalla Gran Bretagna, verso la stabilizzazione dell’economia monetaria internazionale (maggiore apertura e disponibilità a farsi carico degli squilibri) 5.3. Gli insegnamenti e il senso della Grande depressione La Grande Depressione fu un tornante fondamentale per la storia, anche non economica, del Novecento. Vale la pena soffermarsi un poco a riflettere sul suo peso e sul suo significato in generale, facendo - grazie all’analisi di Hobsbawm - tre osservazioni. 5.3.1. L’inedito impatto spaziale della crisi La prima guerra mondiale devastò solo alcune parti del vecchio mondo, principalmente in Europa. La rivoluzione mondiale, l’aspetto più vistoso del crollo della civiltà borghese ottocentesca, ebbe una diffusione più vasta: dal Messico alla Cina e, sotto forma di movimenti di liberazione coloniale, dal Maghreb all’Indonesia. Tuttavia, sarebbe stato facilissimo trovare aree del mondo che non furono toccate né dalla guerra né dalla rivoluzione, segnatamente gli Stati Uniti d’America come pure larghe regioni dell’Africa coloniale subsahariana. E tuttavia alla prima guerra mondiale seguì il crollo economico che ebbe davvero estensione mondiale, perché riguardò tutti quegli uomini e quelle donne la cui esistenza era impigliata in qualche modo nei meccanismi impersonali del mercato capitalistico. Infatti proprio gli Usa, così fieri di se stessi, lungi dall’essere un porto sicuro, al riparo dalle tempeste economiche che sconvolgevano continenti meno fortunati, divennero l’epicentro di quello che fu il più grande terremoto mondiale che sia mai stato misurato sulla scala Richter degli storici dell’economia. (Hobsbawm) 5.3.2. Il suo peso storico Senza il crollo dell’economia mondiale tra le due guerre, inoltre, non ci sarebbe sicuramente stato nessun Hitler e quasi certamente non ci sarebbe stato nessun Roosevelt. è altresì molto improbabile che il sistema sovietico sarebbe stato considerato come una seria alternativa economica al capitalismo mondiale. Le conseguenze della crisi economica nel mondo extraeuropeo e nei paesi non occidentali, di cui abbiamo dato conto altrove, furono enormi. In breve il mondo nella seconda metà del ventesimo secolo risulta incomprensibile se non si capisce che impatto abbia avuto il tracollo economico. 5.3.4. L’arresto dell’integrazione internazionale (migrazioni, commercio, etc.) nel periodo 1920-48 Anche se nella vita della maggioranza degli uomini e delle donne le mutazioni economiche, culminate nella Grande crisi del 1929-33, ebbero effetti sconvolgenti, la crescita economica durante questi decenni non si interruppe. Semplicemente rallentò. Se qualche marziano avesse osservato la curva dei movimenti economici da una distanza così lontana da non consentirgli di notare le brusche fluttuazioni che gli esseri umani avevano sperimentato sulla terra, egli avrebbe concluso che l’economia del pianeta aveva senza dubbio continuato ad espandersi. Almeno sotto un aspetto questa espansione non si era però verificata: il processo di mondializzazione dell’economia si era arrestato tra le due guerre: deciso riflusso delle migrazioni, degli investimenti esteri, del commercio internazionale. 5.4. Gli orrori della depressione 5.4.1. La devastazione dei settori stipendiati, disoccupazione tra il 22 e il 44% (1932-3) e non risolutività della ripresa dopo il 1933 eccetto la Germania Per coloro che non avevano né controllo né accesso ai mezzi di produzione (a meno che non potessero tornare a casa dalla propria famiglia contadina), cioè per gli uomini e le donne salariati e stipendiati, la principale conseguenza della crisi fu la disoccupazione, che si diffuse su una scala senza precedenti e per una durata che nessuno si era mai aspettato. All’acme della crisi (1932-33) da un minimo del 22-23% in Gran Bretagna e Belgio al 44% della Germania. Né la ripresa fu particolarmente risolutiva. “L’unico paese che ebbe successo nell’eliminare la disoccupazione fu la Germania nazista tra il 1933 e il 1938. Da tempo immemorabile non si verificava una catastrofe economica di tale portata nella vita delle classi lavoratrici”. E senza ammortizzatori sociali di nessun genere. Anche se i prezzi alimentari erano calati e chi era occupato poteva comprare meglio ciò non riguardava la grande massa che il lavoro non lo trovava e viveva questa crisi profonda, cupa e di lungo periodo. “Non c’è da sorprendersi pertanto che la disoccupazione venisse percepita come una ferita profonda e potenzialmente mortale inferta al corpo politico”. 5.5. Tra crisi e progressi sovietici, capitalismo in crisi 5.5.1. Gli effetti politici della crisi in rapida sintesi fine delle speranze di “ritorno al ‘13” profondissima crisi della vulgata teorica e delle pratiche del liberismo tre strade aperte: comunismo, fascismo e compromesso tra capitalismo e socialdemocrazia il comunismo non praticato, di fatto: l’Urss rimane sola e la depressione penalizza anzi soprattutto le sinistre, sia per la debolezza occupazionale di fronte alla disoccupazione sia per l’idiozia settaria dei terzinternazionalisti. sinistra in ginocchio nel mondo nei primi anni ’30 notevole successo del fascismo (rimarchevoli quello tedesco e quello giapponese, soprattutto per i loro esiti futuri) per quanto riguarda il compromesso (soggettivo e teorico, d’amore e d’interesse) tra capitalismo e socialdemocrazia esso viene anticipato nel 1933 dalle elezioni presidenziali statunitensi e poi si diffonde massicciamente a partire dal 1936 per divenire, come vedremo, il segno politico del dopoguerra fino alla metà degli anni ‘70 un’instabilità politica planetaria: nelle colonie disagio profondo per i prezzi e crescita di antimperialismo 5.5.2. Mondo economico e politico nel pallone sui rimedi. Il rimedio più ovvio (il protezionismo) finiva col neutralizzare la più potente molla della crescita, cioè il commercio estero Anche se il prezzo più pesante della crisi fu pagato dalle masse popolari, essa mise non meno nei guai le élite. Piuttosto curiosamente il senso di disorientamento e di catastrofe prodotto dalla Grande crisi fu forse maggiore tra gli imprenditori, gli economisti e i politici di quanto lo fu tra le masse. La disoccupazione di massa e il crollo dei prezzi agricoli colpirono duramente la popolazione, che però non aveva dubbi sul fatto che si potesse trovare qualche soluzione politica - sulla destra o sulla sinistra - a queste ingiustizie inattese, nella misura in cui la povera gente potesse mai aspettarsi di veder soddisfatti i propri bisogni. Era invece proprio l’assenza di ogni soluzione entro la cornice della vecchia economia liberale che poneva in drammatico imbarazzo i responsabili della politica economica. Dal loro punto di vista, per fronteggiare crisi repentine e di breve periodo essi dovevano minare le basi di una prosperità economica mondiale nel lungo periodo. (Eric Hobsbawm) In un’epoca di contrazione del commercio mondiale, i governi non sembravano avere infatti altra strada che quella di difendersi dalle burrasche internazionali mediante dazi e tariffe sempre più alte “ben sapendo che questo significava lo smantellamento del sistema mondiale di commercio multilaterale sul quale, secondo il loro stesso giudizio, doveva fondarsi la prosperità mondiale”. 5.6. Il ritorno della mano pubblica 5.6.1. Fine del liberismo classico Fu crisi profonda, quindi, del liberismo economico. In vari modi e varie forme: abbandono generalizzato del sistema aureo (Gran Bretagna, Can, Scania e Usa nel 1931-2; Belgio, Olanda e Francia, dopo il 1936) adozione o innalzamento di dazi e tariffe ovunque (persino in Gran Bretagna, dal 1931) incentivi pubblici ai settori produttivi più esposti (agricoltura in particolare) con sostegno dei prezzi, acquisto delle eccedenze e politiche di set aside priorità del sociale sull’economico per evitare casini politici gravi, radicalizzazioni politiche di piena occupazione 5.6.2. Il caso del New Deal Marzo 1933, quando Roosevelt entra in carica: 15 milioni di disoccupati (50% della forza lavoro) banche in ginocchio rivolta sociale crimine diffuso Con Roosevelt, a partire dai primi tre mesi di presidenza, un massiccio apparato di provvedimenti legislativi in tutti i campi: agricoltura banche moneta mercato dei titoli lavoro sicurezza sociale sanità abitazioni trasporti comunicazioni risorse naturali L’intervento forse più importante fu nel campo dell’industria (National Industrial Recovery Act) con un ente pubblico di supervisione sulla concorrenza leale tra le imprese fatta con il consenso e la partecipazione delle imprese. Si trattava di “un sistema di pianificazione economica privata (“autogoverno industriale”), con supervisione governativa per salvaguardare l’interesse pubblico e garantire il diritto del mondo del lavoro di organizzarsi e contrattare collettivamente”. Una roba in linea teorica molto simile al sistema corporativo, ma senza la costrizione e l’elemento truffaldino. I LIMITI DEL NEW DEAL La corte suprema diede frequentemente addosso a Roosevelt e ai suoi provvedimenti, abrogandone parecchi. Nel complesso in ogni caso il risanamento industriale non fu gran cosa. Dal 1937 nuova fase di recessione senza comunque pieno impiego. Per quanto insomma il New Deal funzionasse discretamente, esso non servì necessariamente meglio al risanamento di quanto fecero altri. 5.6.3. Adozione generalizzata del keynesismo Il New Deal fu tuttavia il primo esempio di politiche che poi saranno adottate largamente dagli anni ’30 e soprattutto nel dopoguerra. Dopo la guerra, infatti, l’obiettivo della piena occupazione, cioè l’eliminazione della disoccupazione di massa, divenne il cardine della politica economica nei paesi di capitalismo riformato in senso democratico. Il più celebre profeta e pioniere di questa politica, sebbene non il solo, fu l’economista britannico John Maynard Keynes (1883-1946). L’argomento avanzato da Keynes per sostenere i benefici della eliminazione di una permanente disoccupazione di massa era sia politico sia economico. Keynes e i kenesiani ritenevano correttamente che la domanda generata dai redditi dei lavoratori occupati avrebbe avuto un effetto stimolante sulle economie depresse. Tuttavia la ragione per cui venne data priorità urgente a questo metodo di incremento della domanda - il governo inglese si impegnò in tale politica anche prima della fine della seconda guerra mondiale - fu che si riteneva la disoccupazione di massa un fenomeno politicamente e socialmente esplosivo, come in effetti si era dimostrato durante la crisi”. 5.6.4. Altre risposte Il New Deal, ripeto, è importante non per il suo successo, che fu solo parziale, anche se accompagnato da una persistente mitologia, ma perché prefigurò con qualche anno di anticipo le soluzioni poi adottate da molti dopo il 1936 e pressoché ovunque dopo la fine della guerra. Ma la miscela di opere pubbliche sostegno alla domanda e coordinamento cooperativo della produzione in un contesto di libertà d’impresa, di democrazia e di conflitto regolato fu per qualche anno una risposta isolata. Altri provarono a dare risposte almeno parzialmente diverse. 5.6.5. La Francia Uscita sfatta dalla guerra iniziò a ricostituirsi con i soldi delle riparazioni, ma questa fonte si dimostrò presto inaffidabile. A quel punto, nel 1926, si decise: una stretta fiscale svalutazioni drastiche e tagli alla spesa pubblica La soluzione funzionò abbastanza bene, ma a pagare ciò furono i percettori di rendite e i lavoratori il che creò instabilità sociali notevoli. In ogni caso la svalutazione provocò effetti benefici e ritardò l’insorgere degli effetti della crisi. Essa fu meno grave che altrove ma più lunga, dal 1931 avanzato al 1936. Mentre la ripresa stava avviandosi, nel 1939, scoppiò la guerra. 5.6.6. L’Italia fascista Molte furono in questi anni di instabilità le formule nuove politico-economiche. Mussolini s’inventò, per poter dire che la sua era una rivoluzione vera, lo stato corporativo, una sorta di antitesi del capitalismo e del socialismo. La proprietà privata era mantenuta ma lavoro e capitale si sottomettevano entrambi al supremo interesse dello stato nazionale. Dodici associazioni di settore (le “corporazioni”) decidevano di prezzi salari condizioni di lavoro e previdenza sociale In realtà questa cosa fu una struttura non cooperativa né tanto meno democratica, un fifity-fifty tra padronato e una burocrazia autoritaria e corrotta a danno dei lavoratori, cui tutti i diritti venivano di fatto negati, e dei consumatori. Nonostante un’imponente serie di salvataggi industriali e un ampio piano di lavori pubblici e di riarmo la depressione colpì l’Italia molto duramente. Un sostanziale fallimento, dunque. Ma su questo torneremo. 5.6.7. La Germania Meglio di tutti, tra i paesi più duramente toccati dalla crisi, andarono i tedeschi, che risanarono completamente (da sei milioni di disoccupati nel 1933 alla piena occupazione nel 1939). La formula fu “opere pubbliche + riarmo”. Sia ai lavoratori che ai padroni fu negata la parola e la decisione fu tutta politica, anche se ai padroni fu lasciata la proprietà. Un altro strumento capitale fu l’autarchia: autosufficienza alimentare e di materie prime controllo rigido sui cambi controlli finanziari complessi e rigorosi scambi con un’area circostante (a oriente) sulla base di una sorta di baratto 5.7. Una ripresa lenta e oscillante 5.7.1. La lenta ripresa A partire dal 1933, in ogni caso, la fase più cupa della bufera passa, sia in Europa che negli Stati Uniti. Alcuni performano bene (Germania, Giappone, Svezia), ma la crescita complessiva resta appannata. Delude, in sostanza, anche il New Deal. Il mondo resta imprigionato in una spirale di instabilità e di stagnazione, anche a causa del bailamme finanziario. 5.7.2. Conferenza di Losanna e fallimento della conferenza mondiale monetaria Una buona mano a mantenere il caos la dava infatti la mancanza di coordinamento finanziario tra stati. Nel giugno 1932 conferenza di Losanna per concordare cosa fare dopo la fine della moratoria: si azzera tutto o no? Gli Usa continuavano a dire che riparazioni tedesche e debiti alleati non erano interdipendenti, per cui l’accordo non ci fu, ma non pertanto l’azzeramento ci fu di fatto. L’anno dopo, per la Conferenza monetaria mondiale della Società delle Nazioni a Londra, l’odg era: ripristino del regime aureo riduzione di tariffe e contingenti forme di cooperazione internazionale Gli Usa erano quelli a dover dire l’ultima parola, in quanto potenza leader, ma Roosevelt appena eletto si sganciò per lanciare un piano di forte sostegno alla traballante economia interna, piano che comprendeva persino l’abbandono del sistema aureo, e l’accordo non si fece. Ognuno continuò ad andare per conto suo, tentando di salvare il salvabile. LEZIONE 6. LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 6.1. Verso la nuova guerra 6.1.1. Come nasce la guerra Forse la seconda guerra mondiale poteva essere evitata o almeno differita, se l’economia prebellica fosse stata restaurata come un sistema globale di crescita e di espansione. Invece, dopo che a metà degli anni ’20 sembrò che l’economia mondiale si fosse lasciata alle spalle le distruzioni della guerra e del dopoguerra, essa sprofondò nella più grande e drammatica crisi mai conosciuta dall’avvento della rivoluzione industriale. E questo fatto condusse al potere sia in Germania che in Giappone le forze politiche del militarismo e dell’estrema destra, impegnate a infrangere deliberatamente lo status quo attraverso lo scontro, se necessario di carattere militare, piuttosto che a trasformarlo gradualmente con la negoziazione pacifica. Da quel momento in poi una nuova guerra mondiale non solo era prevedibile, ma veniva prevista ripetutamente. Le generazioni che divennero adulte negli anni ’30 se l’aspettavano. (Eric Hobsbawm) Sia la Germania che il Giappone sono infatti impegnati sin dagli anni ’30 in forti politiche di espansione territoriale, nel caso tedesco finalizzate anche a una guerra “risolutiva”. La conquista di uno “spazio vitale” ad Est per la nazione tedesca e per la razza ariana infatti faceva parte del programma hitleriano sin dagli anni ’20, come pure la neutralizzazione del “nemico storico”, la Francia. A partire dal 1936 tutta l’economia tedesca viene consapevolmente indirizzata alla preparazione di una nuova guerra che si dovrà svolgere contemporaneamente contro la Francia e contro l’Unione Sovietica, dopo aver annesso l’Austria. Questa “economia di guerra in tempo di pace” azzera la disoccupazione, fa ripartire definitivamente l’industria, ma destina nel 1936 il 28% della ricchezza nazionale al riarmo (vs 7-8% di F e Uk e 1% degli USA). Nel 1937 i piani di guerra sono pronti, contando anche sulla determinazione della Gran Bretagna a non intervenire: il piano è annettere Austria e Cecoslovacchia, cosa che avviene regolarmente nel 1938. Di lì in poi la guerra precipita, con il chiaro obiettivo di invadere la Francia, neutralizzare la Gran Bretagna, sconfiggere l’Unione Sovietica dando vita a un ampio impero tedesco insediato soprattutto in Europa orientale e servito da stati indipendenti ma alleati o satelliti su tutto il continente. LA GUERRA inizia nel settembre 1939 con Germania contro Francia e Gran Bretagna; nel giugno 1940, parallelamente all’invasione della Francia da parte di Hitler, interviene l’Italia a fianco della Germania; nel giugno 1941 l’Unione Sovietica fu coinvolta nel conflitto, essendo stata invasa dalla Germania; nel dicembre 1941 il Giappone (che già dal 1937 ha invaso la Cina) attacca gli Stati Uniti affiancandosi così a Germania e Italia; gli Stati Uniti a loro volta intervengono a fianco dei paesi alleati Ciò vuol dire, tuttavia, che con gli Stati Uniti in conflitto e l’Unione Sovietica che nelle stesse settimane è riuscita a fermare le truppe tedesche, la guerra è decisa in favore degli alleati. Siamo all’inizio del 1942: ci vorranno altri tre anni e mezzo perché finisca, anni assolutamente non meno duri di quelli precedenti. La guerra finirà infatti tra la tarda primavera e l’estate del 1945, tra aprile e settembre. La guerra fu mondiale da un punto di vista territoriale in quanto fu combattuta su tutto il continente europeo, salvo la penisola iberica, e in quasi tutto il bacino del Mediterraneo in varie parti dell’Africa, ma soprattutto nella parte Nord del continente in buona parte dell’Asia, dalla Cina fino ai confini dell’India E coinvolse decine di paesi, ove viveva quasi tutto il genere umano. Solo pochi ne rimasero del tutto fuori. In questo senso fu sicuramente una guerra più tragica di quella precedente, anche se non fu vissuta come una cesura altrettanto grande. Anche questa guerra fu gravida di conseguenze. 6.1.2. Aspetti economici della Seconda Guerra Mondiale La prima conseguenza furono i danni e le perdite umane. Se nella prima guerra mondiale morirono tra i 14 e i 16 milioni di persone, nella seconda ne morirono assai più del doppio: tra i 37 e i 44 milioni. Su 92 milioni di combattenti, ne morirono circa 17 (il doppio che nella Grande Guerra), ma questo significa anche che il grosso delle perdite fu di civili: 20-27 milioni contro i 6-7 della guerra precedente, 3-4 volte di più. Vediamo il grafico. I dati sui morti, a noi utili anche per ricordare l’aspetto umanamente tragico della vicenda, ci parlano anche dell’immenso potere di devastazione economica del conflitto: danni catastrofici e infinitamente più alti, da tutti i punti di vista, materiale e umano, della guerra precedente. i bombardamenti distrussero città, infrastrutture, industrie di gran parte dei paesi coinvolti. le sole spese militari ammontarono a oltre mille miliardi di dollari ai prezzi dell’epoca. Come nel caso precedente, chi rimase immune da problemi economicoinfrastrutturali furono ancora una volta gli Usa, che ne uscirono ancor più rafforzati e influenti. Inoltre la guerra implicò la guerra economica, cioè i blocchi reciproci, il danneggiamento dei flussi commerciali, l’utilizzo della forza lavoro e delle risorse dei paesi occupati. L’economia di guerra, inoltre, fu nuovamente un modelli ideale di intervento dello stato, cosa che rafforzò le tendenze interventiste impostesi già negli anni ’30. 6.2. Le conseguenze della guerra Le conseguenze materiali e culturali più importanti della guerra furono: distruzione di reti infrastrutturali, agricoltura e patrimonio abitativo di gran parte di Europa e Giappone: tutto da rifare modificazioni territoriali: divisione della Germania, nascita dei due blocchi. ulteriore rafforzamento politico ed economico USA, retroterra produttivo dello sforzo bellico alleato, che si tramuta in una schiacciante superiorità degli stessi USA in campo produttivo e finanziario espansione dell’area dei paesi socialisti, soprattutto in conseguenza del patto di Yalta accresciuta capacità produttiva in settori fondamentali dell’industria rafforzamento della cultura dirigista e di piano potente timore di ripetere i numerosi errori diplomatici e di politica economica degli anni del dopoguerra Di conseguenza, le quattro scelte fatte in ordine sparso o più sovente cooperativamente: non ripetere gli errori di Versailles: la ricostruzione dell'Europa e il miracolo finirla con instabilità dei cambi e protezionismo: un nuovo sistema finanziario e commerciale internazionale (con relativo impegno usa nel promuovere la liberalizzazione degli scambi internazionali) finirla con mercati interni asfittici e rischi sociali: il keynesismo (intervento statale nell’economia per sostenere l’occupazione e la domanda) finirla con un sistema coloniale costoso, inefficiente, destabilizzante Ma di questo domani. LEZIONE 7. LA CONFERENZA DI BRETTON WOODS E IL NUOVO ORDINE ECONOMICO INTERNAZIONALE 7.1. La necessità di una nuova architettura economica internazionale Come vi ho detto, la prima grande novità rispetto ai decenni precedenti fu la creazione di un clima di forte cooperazione politica ed economica. Questa cooperazione fu voluta, progettata e sviluppata in modo consapevole e tenace e diede eccellenti frutti. Usciti dalla seconda guerra mondiale con la consapevolezza, ormai, degli errori fatti a partire dal 1919 e condannati da subito da Keynes si impostò una politica per molti versi opposta a quella adottata dopo la Grande Guerra. Invece di perseguitare i paesi vinti, anche se effettivamente responsabili del conflitto, si decise di contribuire alla loro ricostruzione mettendo tra l’altro in piedi un efficiente sistema di relazioni internazionali cooperative. 7.2. Le relazioni internazionali a livello mondiale: un quadro di forte cooperazione a guida Usa 7.2.1. I tremendi anni Trenta e i virtuosi anni Cinquanta Si rinunciò in tal modo alla politica che come abbiamo visto era stata prevalente negli anni 1920 e 1930 di scaricare la crisi sui propri vicini svalutando la propria moneta e adottando politiche protezioniste. Si accolsero al contrario gli inviti di Keynes ad adottare un sistema di relazioni internazionali vincolante, ordinato e cooperativo. 7.2.2. Gli accordi di Bretton Woods il riallineamento delle monete Sappiamo di come i tentativi fatti in piena crisi, a Losanna nel 1932 e a Londra nel 1933, per tornare a un regime di cambi stabile ridurre le tariffe trovare forme di cooperazione internazionale naufragarono per l’indisponibilità di quello che era ormai il paese guida, gli Usa, di farsi carico di una leadership autorevole. Nel corso della guerra apparve chiaro: che era necessario un nuovo quadro di norme a livello mondiale che tali norme dovevano avere un carattere di indirizzo forte che gli Stati Uniti dovevano avere un ruolo centrale nel sistema. Già nell’agosto1941 Churchill e Roosevelt, i responsabili delle due maggiori potenze finanziarie mondiali, il vecchio e il nuovo perno dell’economia mondiale, avevano firmato la Carta Atlantica, un impegno a “ripristinare un sistema mondiale di scambi multilaterali in luogo del bilateralismo degli anni ‘30”. L’architettura di tale sistema fu concordata dalle potenze alleate già durante la guerra, in una riunione tra le delegazioni dei 44 paesi alleati che si tenne nel luglio 1944 nella località statunitense di Bretton Woods, da cui quegli accordi hanno preso il nome. Qui venne discusso un piano basato su tre priorità: un accordo per il riallineamento delle monete attorno a un nuovo standard; la creazione di istituzioni cooperative che garantissero la stabilità monetaria internazionale; un accordo internazionale sul commercio. Tutti i convenuti erano d’accordo sulla necessità di costruire un accordo di lungo periodo attorno a un nuovo ordine economico e monetario internazionale che evitasse i gravissimi squilibri verificatisi tra le due guerre mediante una cooperazione attiva. Il conflitto era attorno a come realizzare tecnicamente il nuovo sistema, perché da ciò dipendevano parecchie conseguenze importanti. Nel corso delle trattative si confrontarono quindi le posizioni della potenza “uscente”, la Gran Bretagna, la cui delegazione era guidata da Keynes, e di quella “emergente”, gli Stati Uniti, la cui delegazione era guidata da Harry White: il progetto americano era basato sul ritorno al regime aureo che di fatto avrebbe reso il dollaro la moneta universale essendo gli Usa i possessori della maggior parte delle riserve auree mondiali; il piano inglese era basato al contrario sull’ipotesi di una moneta di conto mondiale regolata da una superbanca centrale. Dati i rapporti di forza internazionale (militari, economici e finanziari) prevalse la proposta statunitense. L’Unione Sovietica, che riteneva politicamente rischioso e limitante agganciarsi al dollaro e che poteva oltretutto permettersi il lusso di non aderire, non firmò infatti l’accordo, entrato in vigore nel dicembre dell’anno successivo. Il nuovo sistema monetario, dunque, era basato sulla convertibilità delle monete in dollari e sulla stabilità dei cambi, garantiti dal Fmi. Il sistema si reggeva inoltre sulla istituzione di due agenzie sovranazionali: il Fondo Monetario Internazionale (Fmi/Imf) e la Banca per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Birs), meglio nota come Banca Mondiale (Bm/Wb). 7.2.3. Il Fondo monetario internazionale La prima di tali agenzie (il Fmi) era finalizzata a: assicurare la stabilità dei cambi utilizzando le risorse messe a disposizione dai membri, allargare il commercio internazionale mediante la fondazione di un sistema multilaterale dei pagamenti e la eliminazione delle restrizioni sui cambi che ostacolavano il commercio mondiale e operare per garantire la difesa dell’occupazione. Il compito principale del Fondo si è tuttavia rivelato col tempo essere il primo, quello della stabilità dei cambi: fissata la parità di ciascun paese, i paesi si impegnavano a garantire che le oscillazioni delle loro monete non superassero certe soglie e il Fondo si impegnava (come si impegna ancor oggi) a fornire dei prestiti ai paesi con problemi di solvibilità che avrebbero potuto destabilizzare il sistema. Quindi nel corso degli anni il Fmi ha abbandonato la difesa dell’occupazione e lo sviluppo del commercio per divenire il garante del rigore monetario e finanziario. L’abbandono dell’occupazione si è fatta sentire poco fino alla metà degli anni 1970 perché l’occupazione è riuscita a crescere autonomamente. Indubbio, invece il successo per quel che riguarda gli altri due obiettivi, pure estremamente importanti: la stabilità dei cambi e l’ampliamento del commercio internazionale, anche se in questo secondo caso altre istituzioni specifiche hanno affiancato l’opera del FMI. 7.2.4. La Banca mondiale Essa è stata pensata (e resta ancora in gran parte) un istituto internazionale di credito mobiliare con un capitale anch’esso costituito da versamenti dei paesi membri e soprattutto degli Stati Uniti volto a finanziare la ricostruzione dei paesi danneggiati dalla guerra promuovere gli investimenti esteri garantendo il prestito oppure partecipando direttamente agli investimenti concedere prestiti a fini produttivi per il finanziamento di progetti di interesse generale che non trovassero finanziatori, soprattutto nelle aree più arretrate, per favorirne la modernizzazione e lo sviluppo A distanza di mezzo secolo la Banca è oggetto di dure critiche in quanto essa ha sostanzialmente fallito il suo compito: le disparità tra i paesi del Nord e del Sud del mondo invece di ridursi si sono ampliate e continuano ad ampliarsi. 7.2.5. Il commercio: dall’Organizzazione internazionale del commercio (Ito) all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) attraverso il Gatt Un altro organismo che avrebbe dovuto completare il quadro degli enti finanziari mondiali era l’Organizzazione Internazionale del Commercio che non vide però la luce. Al suo posto, nel 1947, entrò in funzione un accordo multilaterale (non più bilaterale, quindi) per il commercio, il Gatt, che si andò via via perfezionando fino al 1994 quando fu definitivamente sostituito dall’Omc. Questi organismi, volti a garantire trasparenza e agibilità al commercio estero (estensione della clausola della nazione più favorita, giù le tariffe, giù i contingenti, consultazioni reciproche preventive), si sono venuti orientando in direzione sempre più radicalmente liberoscambista, secondo i desideri statunitensi di sempre dopo il 1945 e secondo l’evoluzione transnazionale delle imprese manifatturiere, soprattutto a partire dagli anni ‘60. 7.2.6. Un bilancio Nonostante a cinquant’anni di distanza il giudizio che si incomincia a dare dell’operato di Banca Mondiale, Fmi, Gatt/Omc sia sempre più velato di perplessità se non di aperta critica, soprattutto per gli effetti sociali e redistributivi dei loro interventi, l’operato di questi organismi ha sicuramente, soprattutto dalla seconda metà degli anni ‘50, contribuito a stimolare intensamente gli scambi internazionali e la crescita almeno delle economie più avanzate, evitando le drammatiche secche provocate dal caos finanziario e dal protezionismo dei decenni precedenti. 7.2.7. 1971: fine della convertibilità del dollaro e dell’ ordine economico a stelle e strisce Questa fase inizia ad esaurirsi già prima della crisi petrolifera del 1973, quando nell’agosto del 1971 il presidente americano Nixon decide di abolire la convertibilità del dollaro in oro in quanto i dollari in circolazione eccedevano ormai di gran lunga la disponibilità di oro presente nelle casse statunitensi. Finiva con la decisione di Nixon un periodo in cui gli Stati Uniti avevano svolto un ruolo fondamentale nel favorire lo sviluppo economico mondiale sia contribuendo alla crescita degli altri paesi industrializzati sia contribuendo a mantenere la stabilità dei cambi. Non era stata una cosa ovvia, in quanto come sappiamo nonostante gli Usa fossero usciti dominatori dalla prima guerra mondiale fino al 1944 essi avevano continuato a una politica sostanzialmente isolazionista, rifiutandosi di svolgere un ruolo da potenza leader e mettendo anzi in opera politiche di forte competizione verso tutti gli altri paesi. 7.2.8. Il piano Marshall e gli aiuti all’economia europea Nel secondo dopoguerra le scelte furono radicalmente diverse anche perché il nuovo conflitto aveva ulteriormente rafforzato il paese rispetto alle altre potenze industriali e la conferenza di Bretton Woods aveva mostrato la nuova volontà di protagonismo e di cooperazione del governo Usa. Per quanto la responsabilità della Germania nello scatenare la guerra sia questa volta innegabile, gli Stati Uniti evitano con cura di ripiombare nella spirale debiti di guerrariparazioni. Tale scelta è del tutto evidente nella decisione statunitense di concedere una serie di tornate di aiuti sia direttamente sia attraverso organismi internazionali di fatto controllati da loro: dapprima si tratta di aiuti di emergenza per far fronte all’enorme necessità di cibo e medicinali che attanaglia l’Europa (1944-45); successivamente sono prestiti in dollari (1946-47) che però non riescono a stimolare a sufficienza il rilancio dell’economia europea e la ricostruzione in quanto la liberalizzazione dei prezzi dei beni statunitensi mette in crisi le possibilità di acquisto europee; finché non parte, tra il 1947-48 un colossale piano di aiuti finanziari e materiali destinato a durare fino al 1952 grazie al quale le economie europee, salvo Spagna e Urss, riceveranno il corrispondente di 13 miliardi di dollari. Questo fu il Piano Marshall col quale gli Usa misero a disposizione delle economie europee circa il 2% del proprio reddito tra il 1948 e il 1950. Il piano Marshall era un gesto di notevole generosità, sia in assoluto sia rapportato all’isolazionismo di prima della guerra, ma tutt’altro che disinteressato: diede sbocchi all’industria americana favorendo le esportazioni statunitensi rafforzò l’egemonia politica statunitense sul blocco capitalista, legando indissolubilmente i paesi aiutati agli Stati Uniti Ciononostante il suo ruolo nella ricostruzione e nel rilancio dell’Europa fu molto importante offrendo agli europei la possibilità di acquistare merci di importanza strategica per i consumi pubblici e per la ricostruzione e l’ammodernamento dell’apparato produttivo come fu estremamente importante nel consolidare l’adozione di politiche economiche nazionali coerenti tra loro e utili alla crescita economica e l’impostazione cooperativa che ha dominato fino ad oggi, permettendo, tra l’altro, agli europei di costituire le prime embrionali forme di organizzazione continentale (Marshall, nel luglio 1947, aveva infatti condizionato l’avvio del piano a una richiesta congiunta di aiuto da parte dei paesi europei). Ma su questo torneremo. Gli Usa infine si impegnarono a reintegrare la Germania nell’economia europea, vincendo le resistenze degli altri paesi del continente, mediante un organismo sovranazionale di ripartizione degli aiuti al quale chiamarono a partecipare il paese sconfitto. 7.3. La cooperazione economica in Europa e nelle altre aree del mondo Una importante conferma di questo nuovo clima nei rapporti internazionali si ebbe, come ho appena accennato, con la creazione di una serie di organismi economici sovranazionali a partire dall’immediato dopoguerra: nel 1948 nacque l’organizzazione per la cooperazione economica europea (Oece), nata per distribuire i fondi americani dell’Erp (European Recovery Program) e poi trasformatasi nel 1961 nell’Ocse, club dei paesi industrializzati; nel 1950 la stessa Oece fu un elemento di grande stimolo per la creazione dell’Unione europea dei pagamenti (Uep) che svolse all’interno dell’Europa le funzioni che avrebbero dovuto svolgere più tardi Bm e Fmi a livello mondiale, una volta divenuti pienamente efficienti; nel 1957, analogamente, fu stipulato il Trattato di Roma che avviava il processo di unificazione economica dell’Europa che negli anni è andato molto avanti fino a giungere all’attuale Unione Europea, con la sua moneta unica e le sue politiche comuni. Il Trattato era stato preparato da una serie di organizzazioni istituite a partire dal 1950, coinvolgendo sei paesi europei, e si sarebbe sviluppato nei decenni seguenti coinvolgendo altri paesi e rendendo sempre più ampi e vincolanti gli accordi. Al momento attuale manca solo l’unificazione politica, ed è di estremo interesse notare, rispetto alle cose che abbiamo detto durante il corso, che questa unificazione politico-economica avviene tra paesi la cui conflittualità reciproca è stata alla base di due guerre mondiali. 7.4. Rilancio e sviluppo delle esportazioni e del commercio internazionale Questa serie di provvedimenti si rivelò straordinariamente favorevole per lo sviluppo europeo per il complesso dei paesi occidentali e soprattutto per la crescita degli scambi internazionali, considerati la chiave di volta della crescita (gli scambi esteri dell’Italia crebbero di ben 15 volte nel periodo considerato). Alcuni studiosi hanno addirittura ritenuto che il commercio internazionale sia stato il motore primo della grande crescita dei paesi europei e di quelli dell’estremo oriente in questo periodo secondo la dinamica crescita dell’export redditi aggiuntivi consumi crescenti aumento conseguente della produzione e dell’occupazione Tutto questo è sicuramente vero ma non basta a spiegare la crescita, in quanto anche altri fattori incisero. Alla creazione delle istituzioni internazionali e al potenziamento delle relazioni commerciali internazionali, pur elementi importantissimi, si aggiunsero altri importanti elementi. in Europa un sistema di pagamenti con finanziamento dei deficit dei creditori mediante l’attivo dei debitori, usato con cautela ma che riuscì ad evitare che si riproducessro gli squilibri nei pagamenti tipici dei ‘20-30; agevolò la progressiva apertura delle economie industrializzate europee; permise di estendere i pagamenti ai paesi che utilizzavano la sterlina, attraverso la mediazione britannica nel mondo le spese militari estere e i prestiti americani (prima solo pubblici, poi anche privati) aiutarono a colmare il dollar gap e a far funzionare il sistema senza intoppi l’aumento degli scambi internazionali fu accompagnato e rafforzato da una profonda trasformazione qualitativa degli scambi stessi: dallo schema, prevalente nell’Ottocento, materie prime vs manufatti si passò alla prevalenza dello schema manufatti contro manufatti, con relativo mutamento della ripartizione regionale degli scambi, con forte crescita soprattutto degli scambi interni all’Europa, ove iniziarono ad operare forme di mercato comune locale, come Efta e Mec a livello mondiale non si riuscì a creare l’Omc (almeno fino all’Uruguay Round del 1994) ma a partire dal 1949 gli scambi furono lentamente liberalizzati mediante il Gatt. Questa liberalizzazione fu voluta soprattutto dagli Usa, desiderosi di aprire sbocchi per le proprie produzioni cresciute enormemente durante il conflitto a tutto ciò si aggiunsero numerose unioni doganali e commerciali d’area (Europa, America Latina, Asia, paesi socialisti) La crescita economica, infatti, generalizzò anche l’interesse per una maggiore integrazione delle economie a livello regionale perché così si superavano i limiti di mercati nazionali troppo ristretti si potevano realizzare economie di scala si potevano specializzare le produzioni si potevano applicare tecniche più moderne ed efficaci con vantaggi in termini di costo, di posizioni di mercato, di profitti si poteva quindi accelerare lo sviluppo di imprese, di settori produttivi o addirittura dell’intero sistema. LEZIONE 8. LA GUERRA FREDDA E I BLOCCHI CONTRAPPOSTI 8.1. Le economie collettivistiche e la sfida al mercato La tendenza degli Stati Uniti e dei paesi capitalisti, soprattutto europei, a ribaltare l’impostazione punitiva e isolazionista tipica del primo dopoguerra in favore di politiche di integrazione e di cooperazione aveva essenzialmente tre scopi, due che abbiamo già illustrato e uno che illustreremo ora: evitare gli squilibri finanziari internazionali favorire la crescita dell’economia mediante la crescita del commercio internazionale rispondere alla sfida sovietica compattando il fronte capitalista e garantendogli forza e prestigio Non dobbiamo dimenticare infatti due circostanze. Primo: se la seconda guerra mondiale da un lato aveva costituito un sacrificio enorme per l’URSS sia dal punto di vista materiale che umano (10 milioni di morti, tra civili e militari) il suo svolgimento aveva portato il paese a rivestire un ruolo decisivo nella vittoria alleata con la possibilità, riconosciuta col trattato di Yalta del febbraio 1945, di estendere la propria area di influenza su Cecoslovacchia, Germania orientale, Romania, Bulgaria, Ungheria e Polonia (la Jugoslavia aveva maggiore autonomia). Era evidente che il comunismo, per quasi trent’anni rimasto confinato alla sola Unione Sovietica, avrebbe subito una notevole espansione territoriale. E quindi sarebbe divenuto ancor più influente e pericoloso, anche perché la sua potenza militare era ora la più imponente sul suolo europeo. Secondo: i buoni risultati economici della pianificazione (almeno in campo industriale e occultando stragi e fallimenti agricoli) facevano dell’URSS per milioni di lavoratori di tutto il mondo un modello di società per il quale valeva la pena di battersi e per molte altre persone un modello comunque prestigioso, anche se non auspicabile a causa del suo carattere autoritario. Dopo la seconda guerra mondiale, insomma, il comunismo si stava diffondendo e soprattutto acquisiva sempre più prestigio anche nei paesi capitalisti. Di qui due sfide parallele e complementari. Per le borghesie di tutto il mondo si trattava di impedire l’ulteriore espansione del modello socialista, che minacciava direttamente la loro esistenza. Per le potenze occidentali, e gli Stati Uniti in primo luogo, si trattava di evitare che la potenza sovietica (che ambiva a controllare rigidamente i paesi posti sotto la propria influenza) si espandesse a danno proprio e delle proprie sfere di influenza. Dopo la collaborazione 1941-1945, già dal 1946 inizia di conseguenza uno scontro tra Unione Sovietica e potenze occidentali che viene definito già dal 1947 come “guerra fredda”, una guerra mai combattuta direttamente sui campi di battaglia tra le due superpotenze e i loro alleati ma che ha segnato la storia del Novecento fino alla dissoluzione dell’Unione Sovietica e del blocco dei paesi dell’Est nel 1989. Un conflitto per la supremazia mondiale al tempo stesso: tra due superpotenze tradizionali tra due modelli di società e di economica, uno di mercato e uno collettivista Vediamo i passaggi successivi dell’espansione territoriale dei paesi socialisti: tra il 1917 e il 1945, quindi, l’Urss è isolata tra il 1946 e il 1949 circa ad essa si aggiungono, per amore o per forza, 8 stati dell’Europa orientale e balcanica fino a costituire la “cortina di ferro”. ad essi si aggiunge nel 1948 la Corea del Nord. nel 1949, dopo una guerra durata oltre dieci anni interrotta solo per combattere gli invasori giapponesi, l’esercito di Mao sconfigge i nazionalisti di Chiang Kai Shek e fa della Cina il più popoloso paese socialista del mondo nel 1954 il movimento di liberazione Viet Minh sconfigge le truppe francesi e le trattative portano alla nascita della repubblica popolare del Nord Vietnam. nel 1959, anche in questo caso dopo anni di guerriglia, Fidel Castro abbatte il governo di Anastasio Somoza e avvia un esperimento nazionalista a Cuba che a causa dell’ostilità americana si tramuterà in breve tempo in uno stato socialista, l’unico mai edificato nel continente americano, sempre rigidamente sotto il controllo statunitense. All’inizio degli anni ’60, quindi, i paesi controllati da regimi comunisti che fanno direttamente capo all’Unione Sovietica sono diversi, in qualche caso molto popolosi e non più solo in Europa ma anche in Asia e in America Latina. Inoltre molti paesi non controllati dall’Unione Sovietica hanno regimi che si dichiarano volentieri socialisti e sono in eccellenti rapporti con l’Urss stessa. Tra gli altri l’India, l’Egitto e altri paesi arabi in molti paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina sono in corso per tutti gli anni ’60 e ’70 guerriglie di tipo antimperialista, legate o meno all’Urss, che a volte raggiungono il successo e infine in alcuni paesi i partiti di sinistra, compreso quello comunista legato all’Urss, riescono a vincere le elezioni. è il caso ad esempio del Cile, dove però il governo democraticamente eletto viene abbattuto da un colpo di stato guidato dagli Stati Uniti. Oggi che tutto questo è finito (la Cina non è più un paese socialista e Cuba è un caso fortemente isolato) è difficile anche solo dare l’idea di tutto questo, ma appena fino a quindici anni fa questa contrapposizione tra due blocchi è stato il fenomeno politico più importante a livello mondiale, per ben 45 anni e ha influito sulle vite di miliardi di persone in tutto il mondo: nei paesi socialisti, in quelli capitalisti ma anche in quelli che non facevano parte dei due blocchi. Sotto il profilo più propriamente economico la progressiva espansione dei regimi comunisti o che comunque si ispiravano al socialismo ha significato essenzialmente tre cose: l’adozione di un modello socio-economico statalista, collettivista ed egalitarista in molti paesi di tutti i continenti almeno fino alla metà degli anni ’70 la presenza di un modello di organizzazione della vita economica alternativo al capitalismo dotato di prestigio e attrattività la creazione di due grandi aree di scambio: una, più ampia, propria dei paesi capitalisti e una dei paesi socialisti, molto segregate Quest’ultimo fatto non ha impedito nel corso dei decenni, nonostante enormi ostacoli, a molti paesi del terzo mondo di commerciare e di stabilire accordi sia coi paesi socialisti che con quelli a capitalismo industriale, né ha impedito talvolta a questi ultimi di fare ottimi affari con i paesi di osservanza sovietica e viceversa: il caso del grano americano in Urss, le auto Fiat pure in Urss, eccetera. Resta il fatto tuttavia che il grosso del commercio e degli spostamenti di popolazione avvenivano principalmente all’interno di ciascuna area, con severe limitazioni. Anzitutto nello spostamento di persone. 8.2. Il fallimento dell’Urss e le ambiguità della Cina 8.2.1. Urss e paesi dell’Est La guerra fredda si è conclusa con una sconfitta del nucleo fondamentale del mondo socialista, l’Unione Sovietica, che non ha perso sul campo ma è piuttosto implosa politicamente ed economicamente trascinando nel proprio fallimento e nella propria sconfitta nel giro di pochi anni, dopo il 1989, tutti i paesi dell’Est europeo. Per semplificare al massimo si può dire che le economie collettivistiche dell’Est europeo sono franate nel passaggio dalla fase dell’industria pesante alla fase dell’uso delle risorse per il consumo, dalla produzione estensiva a quella qualitativa a più alta efficienza. Sono state incapaci cioè di compiere questo cruciale passaggio dotandosi di istituzioni più idonee a rispondere ai mutamenti della tecnica e dei bisogni dei consumatori attraverso il piano o attraverso l’innesto di elementi di mercato nel piano. Muovendo da livelli molto bassi (circa un quinto del prodotto pro capite americano), la produzione nell’Urss si era accresciuta più rapidamente di quella negli Usa dal 1928 al 1939 (86 contro 9%), e ancora dal 1950 al 1973 (200 contro 140%). La sfida economica sembrava, allora, lanciata con successo: molti, anche in “Occidente”, pensarono che l’economia pianificata avesse una capacità di crescita persino superiore a quella dell’economia di mercato. Ma nel 1973-90 lo sviluppo dell’Urss discese al di sotto di quello americano (30 contro 55%). In termini di produttività (produzione per ora lavorata) l’Urss aveva accorciato le distanze dal 24 al 28% del livello Usa nel 1950-73; il divario tuttavia si riaprì in modo drammatico nel ventennio successivo (19% del livello Usa nel 1992). Anche se con il concorso di altri fattori, è stata questa inefficienza dinamica la causa determinante della disintegrazione istituzionale e del crollo economico del blocco dell’Europa dell’Est dalla fine degli anni ottanta. Successivamente il ritorno, o il cammino, verso l’economia di mercato si è dimostrato più arduo del previsto nelle economie ex pianificate dell’Europa dell’Est, nonostante gli aiuti esterni e le forti terapie, d’urto o gradualiste, attuate per ristrutturarle. 8.2.2. La Cina Se l’Unione Sovietica e il blocco di paesi socialisti dell’Europa Orientale sono collassati quasi improvvisamente e senza colpo ferire, le cose sono andate e stanno però andando molto diversamente in Cina, dove ancor oggi il regime si dichiara socialista ed è in ogni caso erede a tutti gli effetti di quello instaurato nel 1949. Prima di discuterne brevemente va notato che sin dai primi anni ’60 il regime di Mao Tze Tung aveva ritenuto opportuno sottrarsi al diretto controllo dell’Unione Sovietica e avviare un percorso del tutto autonomo, persino in contrapposizione con Mosca. Questo è uno dei motivi che, tra l’altro, spiega come mai la Cina non sia stata coinvolta nel crollo dell’Urss. Ma ci sono altri motivi importanti. Tra la vittoria dei comunisti guidati da Mao Dzedong (1950) alla fine degli anni settanta la Cina aveva raddoppiato il prodotto pro capite. L’ha raddoppiato di nuovo per una popolazione salita in meno di cinquant’anni da 546 a 1200 milioni!- dal 1984 a oggi: dopo le riforme liberalizzatrici del mercato introdotte sotto la direzione di Deng Xiaoping la crescita della produzione è stata rapidissima, dell’8% l’anno. Nel 1820, nonostante la sua arretratezza, quella cinese era la maggiore economia del globo, con quasi un terzo del prodotto mondiale (5% il Regno Unito). Era poi precipitata, sino a un minimo del 6% negli anni 1950-60. Oggi è risalita al secondo posto (13%) subito dopo gli Usa (20%), il cui peso relativo è diminuito. Attualmente la Repubblica Popolare Cinese è uno stato autoritario governato da un partito unico che si definisce comunista e che dirige con mano piuttosto ferrea l’economia nazionale. La novità è che non si tratta più da molti anni di uno stato socialista in senso classico, per almeno due motivi: la libera impresa non è soltanto tollerata come soggetto marginale (come avveniva nella NEP) bensì considerata come un fondamentale motore di sviluppo e attivamente stimolata e aiutata l’uguaglianza tra cittadini e aree non è più considerata un obiettivo strategico per il paese. Questa svolta data almeno dall’inizio degli anni ’80, quando il potere passa nelle mani di un dirigente, Deng Hsiao Ping, convinto della necessità di modernizzare l’economia del paese per accelerare la crescita e si rivela un successo sia politico che economico. Dal punto di vista politico il regime sopravvive senza traumi al crollo del blocco sovietico, mentre dal punto di vista economico l’impetuosa crescita consente alla Cina di posizionarsi finalmente tra i grandi protagonisti dell’economia mondiale. Un processo ancora pienamente in corso. Sul piano sociale, al contrario, i costi sono molto alti: nessuna liberalizzazione dal punto di vista della democrazia e dei diritti civili e peggioramento delle condizioni di vita per centinaia di milioni di persone, con disparità sociali in rapida crescita. 8.3. La decolonizzazione e il terzo mondo Una delle caratteristiche marcanti dei primi decenni del dopoguerra, e in particolare gli anni tra il 1945 e il 1975, è la fine del sistema coloniale (dominato da Gran Bretagna, Francia, Belgio, Portogallo, Spagna e Italia: gli Usa non hanno mai avuto colonie vere e proprie), nato nel Cinquecento e straordinariamente ampliatosi, come sappiamo, nei decenni precedenti la prima guerra mondiale. 8.3.1. I significati del colonialismo Come abbiamo già visto lo scorso anno, la tendenza a creare colonie aveva principalmente tre significati: il significato simbolico. più un sovrano o una nazione possedevano territori esterni alla madre-patria, maggiore era considerata la loro potenza e il loro prestigio. questo aspetto venne enfatizzato ancora di più a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, con l’emergere delle ideologie nazionaliste il significato strategico. la competizione per la supremazia in determinate aree o per la supremazia in generale, o anche solo per garantirsi una sopravvivenza sicura contro vicini aggressivi o potenzialmente tali, prevedeva da sempre la conquista di territori esterni, il controllo di vie di comunicazione, eccetera. il significato economico. il controllo delle rotte commerciali e di aree esterne alla madre patria serviva per rendere possibile: a) l’acquisizione di materie prime a buon mercato (senza intermediazioni di alcun genere: dogane, royalties, imprenditori stranieri, legislazioni restrittive, etc); b) il libero sbocco alle proprie merci; c) l’investimento di capitali soprattutto nelle campo delle infrastrutture senza dover subire concorrenza Il modello era: I paesi dipendenti dovevano pagare l’importazione dei manufatti delle industrie dei colonizzatori vendendo i loro prodotti primari. Questa era stata la base dell’economia mondiale dominata dagli inglesi nel periodo anteriore al 1914. (Eric Hobsbawm) Si trattava di una vera e propria divisione internazionale del lavoro, rimasta peraltro più o meno intatta, salvo l’eccezione sovietica, fino agli anni ’70 del Novecento. 8.3.2. La fine del colonialismo dentro la crisi europea e dentro la guerra fredda Già la prima guerra mondiale e poi la grande crisi avevano segnato la fine di alcuni imperi (Germania e Turchia) ma soprattutto avviato una crisi abbastanza profonda nel sistema (indipendenza o semi-indipendenza di Irlanda, Egitto; crescente peso e influenza dei movimenti di liberazione). La fine del mondo coloniale avviene tuttavia mediante il progressivo smantellamento delle colonie tra 1947 e 1975, sia mediante campagne militari vinte dai movimenti di liberazione (esempio tipico: Vietnam anni ‘50), sia mediante abbandoni volontari (esempio tipico: India 1947). Tale smantellamento fu causato da molti fattori convergenti, ove più ove meno importanti e diversamente miscelati. Fattori legati alla situazione dei paesi possessori di colonie: debolezza geo-politica delle forze imperiali e coloniali (Gran Bretagna e Francia soprattutto) causata dagli esorbitanti costi della guerra calcoli più precisi sul rapporto economico costi-benefici del sistema coloniale rispetto alla molto maggiore efficienza dei metodi di controllo basati sulla dipendenza politica finanziaria e tecnologica Fattori legati all’evoluzione dei paesi colonizzati: visione, durante la guerra, della possibile caducità del governo coloniale, in precedenza ritenuto molto solido forza crescente dei movimenti di liberazione e consapevolezza del potenziale destabilizzante di colonie riottose in un mondo sempre più ravvicinato Fattori legati al contesto mondiale: influenza dei paesi comunisti su tali movimenti e rischio di turbare l’equilibrio della guerra fredda con “passaggi” all’altro campo estraneità (quando non ostilità, variamente motivata) delle due nuove superpotenze al colonialismo tradizionale Non trascurabili fattori culturali: forza crescente del pensiero progressista e umanista sia nei paesi imperiali ed ex-imperiali che in quelli colonizzati (il caso dell’ONU. spiegare come e qualmente e cosa) di contro, inarrestabile declino dell’idea di prestigio nazionale associato al possesso di colonie 8.3.3. Le tappe fondamentali della decolonizzazione e la stagione del non allineamento LA DECOLONIZZAZIONE Le basi della grande ondata di decolonizzazione si pongono subito dopo la guerra, nella seconda metà degli anni ’40: smantellamento dell’impero per eccellenza, quello britannico, lento e contrastato ma inarrestabile, a partire dalla colonia più antica (tre secoli) e importante: l’India (1947) dichiarazione dei diritti dell’uomo (1948), cui farà seguito, nel 1960, la condanna ufficiale del colonialismo da parte dell’ONU. Alla fine degli anni ’50, decolonizzata del tutto l’Asia, fallito il tentativo anglofrancese di ribadire la propria presenza nei paesi arabi, si fece definitivamente strada l’idea di abbandonare definitivamente un sistema ormai insostenibile da ogni punto di vista. Solo i portoghesi, sotto l’antiquata dittatura fascita di Salazar, continuò a mantenere i propri possedimenti, perché la sua economia metropolitana, arretrata, politicamente isolata e marginalizzata, non gli permetteva di adottare la soluzione neocolonialista. Il Portogallo aveva bisogno di sfruttare le risorse africane delle colonie, e poiché la sua economia non era competitiva, poteva farlo solo attraverso un controllo diretto. (Hobsbawm) Alla fine, in ogni caso, a metà anni ’60 Parigi, Londra e Bruxelles decisero che la concessione spontanea dell’indipendenza formale e il mantenimento di fatto della dipendenza economica e culturale erano preferibili a lunghe lotte che con molta probabilità sarebbero terminate con la conquista dell’indipendenza da parte delle colonie e con l’insediamento di regimi di sinistra. (Hobsbawm) Col 1970 l’età degli imperi era praticamente finita, nonostante qualche coda fino ai primi anni ’80. La decolonizzazione e la rivoluzione trasformarono vistosamente la mappa politica del pianeta. In Asia il numero degli stati indipendenti, riconosciuti a livello internazionale, si quintuplicò. In Africa, dove nel 1939 c’era un solo stato indipendente, dopo la decolonizzazione ce ne furono una cinquantina. Perfino nelle Americhe, dove la decolonizzazione dell’inizio dell’Ottocento si era lasciata alle spalle in America latina circa venti repubbliche, un’altra dozzina se ne aggiunsero dopo la decolonizzazione novecentesca. Il fatto importante riguardo a questi nuovi stati non era però il loro numero, quanto l’enorme peso e la crescente pressione demografica che essi collettivamente esercitavano. (Hobsbawm) Tutto ciò creava un problema e forniva un’opportunità politica notevole. IL NON ALLINEAMENTO E’ importante a tal proposito osservare quindi come già dal 1955 molti grandi paesi ex-coloniali (India, Pakistan, Indonesia, Egitto) lanciano, assieme alla Jugoslavia e alla Cina, un progetto politico-economico di collaborazione tra paesi che non fanno parte del mondo industrializzato, né quindi dell’area capitalista né di quella socialista. Questi paesi si daranno infatti anche il nome di “non allineati”. I fini di questo gruppo di paesi, riunitisi nel 1955 a Bandung (Indonesia) e successivamente in altre sedi sono appoggio al processo di decolonizzazione sostegno ai processi di sviluppo economico di tipo moderno nei paesi excoloniali e non-occidentali in genere. costruzione e rafforzamento di un campo autonomo a livello mondiale in grado di costituire un’alternativa politica ai due blocchi costruzione di una cooperazione pacifica Nord-Sud per lo sviluppo economico e sociale L’esperienza del non-allineamento fu forte negli anni ’60 e nonostante fosse molto composita finì spesso con l’intrecciarsi con le lotte di liberazione e antimperialiste di quegli anni. In seguito, a partire dagli anni ‘70 la progressiva crisi interna, di prestigio e di egemonia dell’Urss (che era stato interlocutore politico privilegiato dei non allineati) la rinnovata egemonia occidentale e soprattutto USA in termini di interlocuzione economica il mordente ideale sempre minore la crescente divaricazione economica tra i vari protagonisti del non allineamento portarono, molto prima della fine dello scontro tra i due blocchi, al tramonto del non allineamento. 8.4. Nord e sud oggi: un universo non omogeneo Il panorama del Sud del mondo (tutti salvo Europa, Usa-Canada, Giappone, Urss e satelliti) si è infatti andato rapidamente divaricando a partire dagli anni ’60: mentre molti paesi (praticamente tutta l’Africa, ad es) non sono riusciti a modernizzare le proprie economie e a uscire dalla spirale della dipendenza, alcuni grandi paesi del Terzo mondo come Brasile, Messico e successivamente Cina e soprattutto alcuni dinamici paesi estremo orientali (i dragoni asiatici) hanno saputo imboccare vie di industrializzazione che hanno mutato il volto delle proprie economie, pur non senza contrasti e problemi. A ciò si aggiunga l’ascesa dei paesi petroliferi, molto diversi tra loro, ma tutti beneficiati dalla presenza della materia prima energetica oggi cruciale e dalla loro crescente capacità di venderla non sottocosto. 8.5. La conferma della dipendenza, con nuovi strumenti Nonostante questi casi fortunati uno dei grandi fallimenti dell’economia del Novecento, come vedremo, è stato nella sfida alla povertà e alla diseguaglianza: le disparità di ricchezza tra la parte più ricca del mondo e quella più povera dopo la seconda guerra mondiale invece di diminuire sono aumentate. La decolonizzazione e il terzomondismo hanno contribuito relativamente poco al riequilibrio dei rapporti di forza economici tra i paesi industrializzatisi nell’Ottocento e gli altri paesi del mondo. Come vedremo, alla base di questo problema ci sono molte cause, ma trattando di colonialismo e di decolonializzazione non possiamo trascurare due fatti: il retaggio coloniale è stato drammatico, in termine di spoliazione, di arretratezza, di deficit democratico, e tarda a colmarsi se non in forme subalterne. la concessione dell’indipendenza a gran parte delle colonie è stata effettuata con l’intenzione di continuare a mantenere il modello di dominazione precedente in altre forme, sia dal punto di vista politico sia da quello economico. Quello cioè che è stato definito il neo-colonialismo: un dominio non più basato sul controllo politico-militare diretto ma su un’ampia gamma di forme di pressione e di condizionamento, sia politico che economico. Una questione complessa e attualisssima sulla quale dovremo tornare. 9. I TRENTA RUGGENTI: LA CRESCITA Con la fine della Seconda Guerra Mondiale si chiude una lunga parentesi (durata trent’anni) di instabilità economica, di conflitti armati tra grandi potenze economiche e di stagnazione o depressione economica. L’epoca che inizia col 1945, che viene a maturazione verso il 1948-50 e che si conclude verso il 1973 ha caratteristiche opposte rispetto alla precedente: è piuttosto stabile sotto il profilo economico è contraddistinta da conflitti anche tragici ma prevalentemente periferici è sotto il segno di una crescita mai vista, fortissima nel primo trentennio e poi più lenta è caratterizzata da un profilo marcatamente progressista sotto il profilo economico sociale In questa lezione ci occupiamo principalmente della questione della crescita. 9.1. La crescita nel Novecento Il primo aspetto di questo periodo, come vi ho già accennato, è la rapidità della crescita economica, a ritmi estremamente elevati. Osserviamo prima un quadro generale del Novecento e poi un altro dei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale. Nel Novecento, secondo i dati quantitativi disponibili, lo sviluppo economico la toccato i massimi ritmi. A livello mondiale mai è risultata tanto rapida, come tra l’inizio e la fine del secolo, la crescita media annua di tre fondamentali variabili socio-economiche: la produttività, o prodotto pro capite (1,5%, rispetto a 0,8 dell’Ottocento); la popolazione (1,4%, rispetto a 0,5); la produzione di beni e servizi (2,9%, rispetto a 1,3). Per comprendere meglio la portata di questa crescita è opportuno paragonarla con i secoli precedenti.Le stime statistiche di cui si dispone - pur se molto incerte - danno saggi annui di variazione del reddito prò capite nelle diverse aree del globo molto più bassi, compresi fra lo 0,2 e lo 0% annuo, dal 1500 al 1800. Nella stessa Inghilterra avviata alla prima rivoluzione industriale l'aumento della produzione prò capite non superò, nell'intero Settecento, lo 0,3° o annuo (0,8 il prodotto, 0,5 la popolazione). Per quel che riguarda i dati demografici possiamo dire che la durata media della vita, cioè l'aspettativa di vita delle persone, si è innalzata nel!'insieme dei paesi industriali da meno di 40 anni nel 1820 a circa 50 nel 1900. a 77 nell'ultimo decennio del XX secolo; nel complesso dei paesi arretrati, pur con un'alta variabilità, essa superava alla fine del secolo i 60 anni; è di 67 anni nel mondo intero, per una popolazione giunta a 5.5 miliardi di persone. Per quanto riguarda infine un altro indicatore estremamente importante, quello del commercio intemazionale, si può osservare che gli scambi di merci fra paesi che nell'Ottocento erano già passati dall'I al 7° o del prodotto mondiale passano nel corso del Novecento al 15%. E tutto questo a fronte di una fortissima crescita complessiva della produzione, come abbiamo appena visto. Se questi sono i dati per l’intero Novecento, quelli del periodo successivo al 1945 sono ancora più impressionanti. 9.2. L’età dell’oro 9.2.1. 1950-1973: un ventennio di sviluppo tumultuoso Dal 1950 circa al 1973, infatti, (guerra arabo-israeliana + crisi petrolifera) una crescita straordinaria dell’economia mondiale, a ritmi inediti. Per questo è stata detta “l’età dell’oro”. Un’età dell’oro per finanze e imprese, ma finalmente un’età dell’oro anche per lavoratori e lavoratrici di tutti i settori e di tutto il mondo ma soprattutto per quelli europei. Un’età dell’oro che si infrange nel 1973 contro alcune contraddizioni sorte nel frattempo come il peso eccessivo sostenuto dagli Stati Uniti per svolgere il suo ruolo di statoguida dei paesi a economia capitalista l’incapacità di alcune aree di far fruttare razionalmente gli investimenti internazionali l’instabilità finanziaria creata da una massa crescente di dollari fuori da ogni controllo pubblico il rincaro del petrolio e la crescente difficoltà a gestire un forte settore pubblico in presenza di stagnazione economica. Ciò nonostante la seconda metà del Novecento sta tuttora sotto il segno di questa prodigiosa e relativamente pacifica crescita e degli ampi dividendi che ha saputo distribuire a centinaia di milioni di esseri umani. Grazie al nuovo quadro istituzionale che regolava i flussi commerciali e finanziari internazionali evitando crisi nel regolare svolgimento dei pagamenti internazionali fu il commercio internazionale innanzi tutto a crescere: paesi ocse +8.2% annuo pro capite nel 1950-73 paesi non sviluppati 4.5% Corea e Taiwan 17.7% e 12.9% il tutto facendo aumentare la % degli scambi sul pil dei paesi europei industrializzati e contribuendo alla continuità della crescita Un quadro opposto, quindi, a quello del periodo 1918-1939 e, in primo luogo tra il 1950 e il 1973 una crescita mai vista di tutti gli indicatori, non limitata quindi agli scambi internazionali ma estendentesi a: scambi internazionali, pil produzione manifatturiera investimenti occupazione reddito Una crescita omogeneamente diffusa in tutto il mondo, anche se con ritmi diversi a seconda delle aree (pezzi di Asia più forti di tutti, poi l’Europa dell’Ocse, quindi gli Usa). Il massimo della crescita in Europa, più che negli Stati Uniti e in Giappone. 9.2.2. L’eccezionale performance dell’economia europea Cominciamo con qualche dato tra il 1950 e il 1973 il reddito a disposizione di ciascun cittadino europeo è cresciuto del 4,1% l’anno (tasso medio annuo di crescita del pil), dato assolutamente inedito e irripetuto. Nel corso del Novecento la media è stata dell’1,9% medio annuo. Tale crescita, che riguardò i 15 Ue più la Svizzera fu inoltre superiore a quella di altre aree: nello stesso periodo a livello mondiale la crescita annua fu del 2,9%. 9.2.3. Il recupero nei confronti degli Stati Uniti Per quanto riguarda l’Italia il tasso è stato del 5%, inferiore all’8% del Giappone ma più che doppio del dato Usa (2,4%). Dato europeo e dato italiano mostrano un altro aspetto interessante del dopoguerra: il fatto che l’Europa e alcuni paesi estremo-orientali in questo periodo hanno recuperato parecchio del terreno che dalla Prima Guerra Mondiale li aveva separati dagli Stati Uniti. Probabilmente anche questo ampio divario consolidatosi tra il 1914 e il 1949 contribuì al dispiegarsi dell’età dell’oro europea e giapponese. 9.2.4. Stabilità monetaria, bassa inflazione, alta occupazione La forte crescita del Pnl è il primo e più evidente degli indicatori di eccellente salute dell’economia in questi anni. Ce ne sono altri, altrettanto importanti e strettamente collegati ad esso. Un’altra caratteristica notevole del periodo è stata la il basso livello dell’inflazione, sul 4% annuo in media. Un’inflazione alta rispetto alla situazione attuale ma molto bassa sia alle fiammate inflattive dei periodi tra le due guerre e soprattutto più bassa che negli anni immediatamente seguenti, profondamente segnati dal rialzo dei prezzi avvenuto dopo la crisi petrolifera del 1973. Anche un’altra piaga del periodo tra le due guerre oggi di ritorno, la disoccupazione, in questo periodo si ridusse ai minimi termini: in media il 2% o anche meno, anche se in questo caso l’Italia non era nella media avendo circa un 5,5%, soprattutto imputabile agli ultimi anni del periodo. 9.2.5. Un’onda lunga senza cicli Terza caratteristica positiva del periodo, è la caratterizzazione ciclica. Non soltanto tutto il periodo può essere considerato come parte di un unico ciclo espansivo lungo ma ha avuto la caratteristica abbastanza anomala di non contenere oscillazioni brevi. Un unico ciclo positivo lungo senza cicli brevi all’interno, insomma. 9.2.6. Buon andamento del debito pubblico e redistribuzione dei redditi Quarta caratteristica, il basso indebitamento pubblico di tutti i paesi industrializzati, anche in questo caso molto più basso che nei decenni precedenti e di quelli successivi. Questo squilibrio largamente accettabile tra entrate e uscite dello stato nonostante il notevole allargamento della spesa per istruzione, sanità e assistenza sociale è stato uno degli aspetti più caratterizzanti del periodo come pure la riduzione della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi. In Europa, in particolare (e a differenza degli Usa), le distanze tra ricchi e poveri in questo periodo si ridussero sia per il passaggio di molti agricoltori ormai impoveriti a lavori meglio retribuiti sia per l’efficacia dell’azione redistributiva dello stato sociale (pensioni, lavori, varie forme di assistenza) e della sua pressione fiscale Il tutto frutto sia del clima progressista sia delle lotte di quegli anni. Il “miracolo” (o anche “boom”) economico quindi fu contraddistinto da alcuni caratteri molto evidenti e in qualche misura inediti, soprattutto nella loro compresenza: crescita della ricchezza alta occupazione stabilità monetaria riduzione delle diseguaglianze economiche A cosa si dovè imputare questo periodo eccezionalmente positivo per i paesi occidentali? Anche in questo caso abbiamo una serie di trasformazioni di lunga durata che investono tutto il Novecento (sia pure tra oscillazioni molto forti) e alcune trasformazioni più peculiari del dopoguerra. Partiamo dalle prime. 9.3. L’agricoltura come serbatoio di manodopera e la diffusione in Europa del fordismo 9.3.1. Quattro fattori di sviluppo Le condizioni economiche, politiche e sociali, prevalenti negli anni cinquanta e sessanta all’interno di numerosi paesi europei, sono state considerate come particolarmente favorevoli all’avvio prima e al rafforzamento poi dell’età dell’oro. Tra gli altri fattori, quattro sembrano avere attratto maggiormente l’attenzione degli studiosi: la grande disponibilità di manodopera a basso costo per l’industria, resa possibile dall’esodo agricolo; il notevole divario tecnologico esistente tra i paesi europei e il leader mondiale, gli Stati Uniti, che ha consentito ai primi di realizzare elevati investimenti ed elevati aumenti di produttività seguendo la “semplice” strategia di importare il modello americano e di recuperare il ritardo accumulato; gli effetti benefici, su diversi piani, del crescente coinvolgimento dello Stato nelle attività economiche, in seguito all’affermarsi dell’impostazione antiliberista di Keynes; l’attenuazione del potere dei gruppi di interesse che ha permesso alla crescita economica di incontrare minori resistenze sociali e di divenire, al contrario, un fattore di consenso sociale. 9.3.2. L’esodo dal settore agricolo L’esodo di lavoratori dal settore agricolo verso quello industriale ha rappresentato uno dei segni distintivi di questo periodo. Grazie all’emigrazione, la crescente domanda di forza lavoro proveniente dal settore industriale ha potuto essere soddisfatta dal serbatoio rappresentato dall’a gricoltura. Nel settore agricolo era presente una quota molto rilevante di manodopera ridondante e l’assenza di opportunità alternative di impiego aveva obbligato molti giovani a restare nel settore agricolo anche se il loro contributo produttivo risultava praticamente nullo. Per conseguenza, la riduzione dell’occupazione nel settore non determinò cali nella produzione agricola; le famiglie agricole videro perciò aumentare il proprio reddito complessivo in seguito all’emigrazione di qualcuno dei loro membri verso il Nord industriale, nonostante i bassi salari guadagnati da questi ultimi. In breve, “l’eccesso di occupazione” nell’agricoltura - che spesso significava povertà - ha reso accettabile, e talvolta conveniente, per molti uomini del Sud la scelta dell’emigrazione. L’eccesso era di dimensioni tali che il lavoro a basso costo disponibile per le imprese industriali sembrava essere “illimitato”. Solo dopo molti anni hanno iniziato a manifestarsi, sul mercato del lavoro, quelle tensioni che, nel nostro paese, hanno preceduto l’alta conflittualità dell’autunno caldo del 1969. Per più di un decennio la crescita industriale non ha trovato, grazie all’agricoltura, ostacoli significativi nella disponibilità e nel costo del lavoro. L’età dell’oro è, dunque, anche il periodo del definitivo declino dell’agricoltura come settore principale dal punto di vista occupazionale, a vantaggio dell’industria e, successivamente, dei servizi. 9.3.3. Investimenti e consumi: il modello “fordista” in Europa La crescita dell’industria è stata favorita, oltre che dall’eccezionale andamento delle esportazioni, ricordato in precedenza, dall’elevata dinamica degli investimenti produttivi realizzati dalle imprese e dalla forte espansione della spesa per consumi da parte delle famiglie. Nell’età dell’oro, i paesi europei imboccano con decisione la strada del “fordismo”, cioè di un modello produttivo e sociale basato sulle imprese di grandi dimensioni e sui consumi di massa di prodotti largamente standardizzati. Il modello “fordista” si era affermato oltreoceano già nel secondo decennio del secolo; a permetteme il successo fu la possibilità di utilizzare gli sviluppi tecnologici per realizzare un circolo virtuoso tra produzione, costi, prezzi e domanda: la “catena di montaggio”, simbolo produttivo del fordismo, assicurava una forte riduzione dei costi unitari al crescere delle quantità prodotte; d’altro canto, la riduzione dei costi permetteva di praticare prezzi contenuti e ciò favoriva l’assorbimento da parte del mercato delle grandi quantità prodotte. Il fordismo, che ha consentito anche agli operai di accedere ai consumi di massa, ha rappresentato il modello dominante fino alla seconda metà degli anni settanta, quando ha iniziato a perdere decisamente terreno nei confronti del modello “giapponese” o toyotista e dei sistemi di imprese di più piccole dimensioni, come i “distretti industriali” Italiani, la cui caratteristica è la forte integrazione tra molte imprese che sono localizzate in un’area geografica ristretta e che risultano specializzate in una determinata attività produttiva. Tali modelli alternativi consentono, complessivamente, una flessibilità maggiore e sono, quindi, in grado di assicurare risultati migliori in un ambiente caratterizzato da una maggiore mutevolezza dei mercati e da una crescente rigidità istituzionale e sociale. 9.3.4. Ritardo e recupero Alla fine degli anni quaranta, dopo circa tre decenni di fordismo e dopo la o guerra, gli Stati Uniti godevano nei confronti dei paesi europei di un vantaggio tecnologico rilevantissimo e probabilmente senza precedenti. Il prodotto pro capite in Europa era, nel 1950, solo di pochissimo superiore alla metà del prodotto pro capite negli Stati Uniti. L’importazione del modello fordista avvenne in modo massiccio durante l’età dell’oro e nel 1973 il prodotto pro capite europeo era divenuto’ pari a quasi tre quarti di quello statunitense. Questo prodigioso balzo in avanti ha indotto molti studiosi a considerare il ritardo tecnologico iniziale dei paesi europei e il conseguente rapido processo di recupero (catching up) il fattore più importante nella spiegazione dell’età dell’oro. Ma non basta: l’importanza di altri elementi non può, dunque, essere sottovalutata: l’ampia disponibilità e al ridotto costo di lavoratori con basse qualifiche l’offerta abbondante di manodopera con adeguata formazione professionale la presenza di un clima nel complesso favorevole alla realizzazione degli investimenti produttivi il mutato ruolo economico dello Stato, che ha svolto un ruolo importante oltre che da altri punti di vista - nel fornire agli imprenditori quelle garanzie di stabilità che sono, molto spesso, decisive per l’attività di investimento. 9.3.5. La crescita nel Terzo Mondo Questa fase vide l’estendersi della crescita economica anche a diversi paesi sottosviluppati grazie soprattutto a: commercio internazionale flussi turistici prestiti (soprattutto di stati e di agenzie) Grandi speranze furono alimentate in questo periodo anche dalla decolonizzazione ma raramente questa riuscì a tramutarsi in precondizione di sviluppo in quanto le economie di questi paesi rimasero in prevalenza dipendenti dai paesi sviluppati e non riuscirono ad andare molto oltre il loro tradizionale ruolo di fornitrici di derrate e risorse minerarie. Inoltre una parte assai consistenti degli aiuti vennero usati per: comprarci armi arricchire le borghesie compradore sviluppare i centri urbani e non per sviluppare le infrastrutture. Una parziale eccezione fu costituita da alcuni paesi di ispirazione socialista, i cui piani non riuscirono comunque a dare risultati di grande rilievo, anche per la frequente ostilità dei paesi sviluppati. LEZIONE 10. I TRENTA RUGGENTI: INTERVENTO DELLO STATO E WELFARE 10.1. Le politiche economiche keynesiane Il primo aspetto caratterizzante del periodo 1945-1973 è la crescita. Il secondo è il successo pressochè universale del nuovo ruolo dello Stato. Nell’età dell’oro tutti i paesi occidentali, compresi quelli gestiti da conservatori, adottano infatti le indicazioni rooseveltiane e keynesiane: nazionalizzazione dei settori strategici per la vita economica nazionale e per lo sviluppo pianificazione (o programmazione) economica politiche di piena occupazione politiche di espansione della domanda di massa di beni di consumo politiche di tutela e di assistenza sociale Vi ho già accennato che queste scelte hanno diverse motivazioni: convinzione che un’espansione della domanda interna possa stimolare la crescita sfiducia diffusa nelle capacità del mercato autoregolato di espandersi regolarmente da sé necessità di dare una risposta culturale alla sfida sovietica e a quella dei movimenti operai dei paesi occidentali abitudine all’economia di guerra dopo due conflitti mondiali obbligo di non ridare fiato alla mina vagante della disoccupazione umanitarismo antifascista Il tutto fece passare, sempre nei paesi Ocse, la quota della spesa pubblica sul Pil dal 27% del 1950 al 37% del 1973, con un aumento particolarmente forte nei settori della sicurezza sociale, dell’istruzione e della salute. Quel che conta, in ogni caso, è che queste politiche funzionano egregiamente: per molti anni la disoccupazione viene ridotta un po’ dappertutto su percentuali che si aggirano sul 3-4% (contro quella banda 22-45% che avevamo visto negli anni ‘30) una forte domanda di beni di consumo stimola il commercio internazionale e l’ammodernamento tecnologico di molti apparati produttivi nazionali il forte potenziale eversivo dei movimenti socialista e comunista viene disinnescato non più tanto per via repressiva ma mediante una estensione dei consumi e dei servizi pubblici e una partecipazione delle formazioni politiche di sinistra alla decisione politica Ma andiamo più in profondità nel cercare di descrivere il rapporto tra età dell’oro e politiche keynesiane. 10.1.1. Le deficienze del mercato Come vi ho accennato, negli anni dell’età dell’oro lo Stato, principalmente sulla base delle indicazioni fornite dall’opera di Keynes, ha ridefinito i propri compiti in campo economico e ha assunto un ruolo decisamente più interventista. L’esperienza negativa della Grande Depressione era stata da molti considerata una convincente dimostrazione dei difetti dell’economia capitalistica di mercato: da un lato, essa poteva imboccare la strada di una crisi tanto repentina quanto devastante; dall’altro, una volta toccato il fondo, essa non mostrava di possedere forze sufficienti per risollevarsi da sola. Il persistere, in molti paesi occidentali, durante gli anni trenta e fino allo scoppio del secondo conflitto mondiale, di bassi livelli di attività economica ed elevati tassi di disoccupazione sembra giustificare quest’ultima affermazione. Benché studiosi di ispirazione liberista (come Friedman e Hayek) abbiano attribuito la gravità della crisi ad alcuni errori delle autorità politiche, e in particolare di quelle preposte alla gestione della moneta, l’interpretazione prevalente della Grande Depressione è stata quella di tipo keynesiano, basata sulle deficienze del mercato. Con le sue opere di maggiore spessore teorico e con i suoi efficaci interventi divulgativi, Keynes riuscì a conquistare consensi alla tesi che illaissez faire, se mai lo fosse stato, non costituiva più la migliore forma di politica economica. Il governo aveva, al contrario, importanti funzioni da svolgere e ciò non allo scopo di sostituire il piano al mercato - com’era invece tipico dei sistemi economici socialisti, ben poco attraenti per il “liberale” Keynes - ma per permettere all’economia di mercato di funzionare meglio e di conseguire una più desiderabile combinazione di crescita economica e di eguaglianza nei redditi e nelle ricchezze. 10.1.2. Le politiche pubbliche e il sostegno all’occupazione Il segno più evidente che le teorie di Keynes si erano ormai affermate è, probabilmente, costituito dall’inclusione, tra gli obiettivi economici dei governi, di un elevato livello di occupazione. Alcuni documenti ufficiali americani, redatti negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, contengono, infatti, una novità straordinaria per i paesi di tradizione liberista: la politica economica non ha soltanto il compito consolidato di prevenire l’inflazione, ma deve essere diretta anche a sostenere l’occupazione. Tutto ciò non avrebbe potuto essere affermato se fosse rimasta intatta la fiducia nelle capacità del mercato di “fare da solo”. L’aspirazione keynesiana era, dunque, quella di integrare economia di mercato e intervento pubblico - generando la cosiddetta “economia mista” - in modo da assicurare permanenti elevati livelli di occupazione - che richiedono una sostenuta crescita economica - e una distribuzione meno diseguale nei redditi e nelle ricchezze. L’età dell’oro europea, come si è detto, ha avuto proprio questi caratteri; le politiche economiche keynesiane hanno certamente contribuito al raggiungimento di questo risultato. 10.1.3. Il primo canale dell’intervento pubblico: la funzione anticiclica I canali attraverso i quali si è manifestata la presenza dello Stato nell’economia sono stati molteplici e i diversi paesi vi hanno fatto ricorso in modi diversi. Il primo canale è quello delle politiche di stabilizzazione del reddito. Utilizzando la spesa pubblica le aliquote delle imposte nonché gli strumenti monetari (come il tasso di sconto, ovvero il costo che le banche sopportano per finanziarsi presso la banca centrale) i governi di molti paesi hanno perseguito l’obiettivo di ridurre le oscillazioni nella produzione, “raffreddando” l’economia nelle fasi di spontanea espansione e, al contrario, stimolandola nelle fasi di rallentamento. Si è già ricordato che tra le caratteristiche dell’età dell’oro vi è l’attenuazione dell’andamento ciclico dell’economia; questo risultato può essere ascritto alla consapevole gestione delle politiche di stabilizzazione. Un effetto indiretto, ma molto importante, della stabilizzazione è stato, probabilmente, quello di creare un clima più favore vole agli investimenti: la ragionevole aspettativa che l’economia - grazie all’implicito impegno assunto dai governi - non sarebbe scivolata in una recessione ha fatto sì che gli imprenditori guardassero con maggiore fiducia al futuro e non si lasciassero scoraggiare dal rischio che sempre accompagna l’attività di investimento. 10.1.4. Il secondo canale: le imprese pubbliche. Loro pregi e difetti Il secondo canale delle politiche economiche è quello della produzione pubblica di beni e servizi destinati al mercato. In alcuni paesi la diffusione delle imprese i pubbliche è stata molto ampia. In Italia, attraverso l’innovativo sistema delle “partecipazioni statali” articolato nei grandi contenitori rappresentati dall’Iri (Istituto per la ricostruzione industriale) dall’Eni (Ente nazionale indrocarburi) e dall’Efim (Ente per il finanziamento dell’industria manifatturiera), la presenza pubblica nel tessuto produttivo si è progressivamente estesa. Inizialmente limitata a settori strategici, quali l’energia, la difesa e la siderurgia e giustificata da ragioni di efficienza economica, questa presenza ha finito per riguardare - anche in conseguenza di operazioni di salvataggio di molte imprese private in difficoltà - quasi ogni tipo di attività economica. Il successivo assoggettamento del management di queste imprese a mere logiche di potere ha reso inevitabili quelle pessime performances che, a partire dalla seconda metà degli anni settanta, hanno fornito validi argomenti ai sostenitori delle più radicali politiche di privatizzazione. Questa negativa evoluzione non deve comunque indurre a dimenticare che le imprese pubbliche hanno svolto, nella prima fase dell’età dell’oro, un ruolo importante per la realizzazione di finalità positive, quali lo sviluppo di alcuni settori strategici e l’allocazione di rilevanti investimenti nelle aree economicamente arretrate. 10.1.5. Il terzo canale: le politiche di welfare Il terzo canale dell’interventismo in campo economico è rappresentato dalle politiche di redistribuzione del reddito e di difesa dei più deboli e degli svantaggiati. In questo ambito ricade il welfare state inteso in senso proprio. In estrema sintesi, si può affermare che alla base del welfare state vi è l’idea che l’individuo non debba sopportare tutti i rischi ai quali può venire esposto nel corso della propria esistenza; al contrario, si ritiene che molti di questi rischi possano ricadere sulla collettività. Utilizzando il sistema fiscale come fonte di finanziamento, i governi forniscono servizi o trasferiscono redditi in modo da prevenire o mitigare le conseguenze negative della disoccupazione, dell’invalidità, della vecchiaia, delle malattie e così via. 10.1.6. Il modello liberale e quello universalistico L’espansione del welfare state durante l’età dell’oro è stata, in Europa, molto marcata: la spesa sociale complessiva, come quota del reddito dei paesi europei, è passata da circa il 25% a circa il 45%. Le modalità di attuazione dei welfare state sono, però, risultate diverse da paese a paese e riflettono un insieme di fattori culturali e istituzionali: i rischi coperti le modalità di finanziamento i criteri sulla base dei quali viene stabilito il diritto a beneficiare dei servizi del welfare state costituiscono le principali ragioni delle differenze. Con riferimento a tali elementi si usa distinguere il modello liberale, tipico degli Stati Uniti, da quello universalistico, modellato sulle idee di Lord Beveridge - uno dei grandi architetti del welfare state - e da quello socialdemocratico o corporativo, caratteristico della Germania occidentale. Il welfare state liberale ha, normalmente, carattere residuale; esso è costruito, cioè, sul presupposto che lo Stato debba intervenire solo in con dizioni estreme e nel caso in cui sia insufficiente l’azione di altre istituzioni, come la famiglia o la carità privata. La differenza principale, anche se non la sola, tra welfare state universalistico inizialmente adottato dal sistema sanitario inglese e corporativo si riferisce, invece, al criterio adottato per stabilire chi abbia diritto a ricevere i servizi erogati dallo Stato: nel primo tutti i cittadini (tanto è vero che si parla di diritti di cittadinanza sociale), nel secondo soltanto coloro che, in vario grado, contribuiscono a finanziarne il costo. Queste differenze possono contribuire a spiegare il diverso andamento nella distribuzione dei redditi in Europa e negli Stati Uniti, durante l’età dell’oro, nettamente più favorevole all’eguaglianza nel Vecchio Continente. Non possono, tuttavia, nutrirsi dubbi sul fatto che negli anni che qui vengono esaminati tutti i sistemi di welfare state hanno contribuito a elevare il tenore di vita dei più svantaggiati e a permettere, anche attraverso il sistema scolastico, una maggiore mobilità verso l’alto. 10.2. Lo Stato sociale da Bismark agli anni ’30 del Novecento 10.2.1. Introduzione Tra i fatti sociali di importanza primaria verificatisi nella seconda metà del XX secolo, rientra a pieno titolo la realizzazione, pressoché in tutti i paesi del mondo sviluppato occidentale, dello Stato sociale. Realizzazione facilitata dalla crescita economica rapida verificatasi in questo periodo; crescita che, contrariamente a quella del XIX secolo, ha comportato una convergenza dei livelli di vita dei diversi paesi. Per definire il fenomeno si impiegano espressioni diverse, in ogni caso il riferimento principale è all’espressione inglese Welfare State, spesso solo parzialmente tradotta come “Stato di Welfare” o anche semplicemente welfare (“benessere”). Va infine osservato che, spesso, non si tratta di definizioni del tutto avalutative, come per esempio quando si parla di “Stato assistenziale”. In ogni caso, l’espressione Welfare State rimanda storicamente a quello che si suole chiamare “Piano Beveridge”, dal nome di William Beveridge, presidente della commissione governativa istituita nel giugno 1942, in piena guerra, e incaricata di procedere all’elaborazione di un piano complessivo in materia di sicurezza sociale. Piano reso pubblico nel novembre 1942. Sulla sua scorta fu creato il ministero della sicurezza sociale e votata una serie di leggi (tra maggio e luglio 1946) per impulso del Labour Party che, in seguito alla grande vittoria elettorale del luglio 1945, aveva sostituito il governo di coalizione di guerra formatosi nel maggio 1940. Il sistema venne definito un programma di sicurezza sociale “dalla culla alla tomba” (cradle-to-grave). Ovviamente, l’idea di un sistema generale di sicurezza sociale non nasce con il Piano Beveridge; del resto, lo stesso Regno Unito si era dotato, sin dal 1925, di un sistema sociale piuttosto elaborato. Come ha scritto Peter Flora, nell’introduzione all’ampia storia dello stato sociale nell’Europa occidentale di cui è il curatore (1986): “Lo stato sociale moderno è un’invenzione europea, al pari dello Stato-nazione, della democrazia di massa e del capitalismo industriale. Nato in risposta ai problemi creati dall’industrializzazione capitalistica, è un portato della lotta democratica delle classi e si è mosso sulle tracce dello Stato-nazione”. Se si trascurano gli antecedenti di prima della rivoluzione industriale - dalla Bibbia alle Poor Laws, per limitarsi a quelli più noti -, si può ritenere che lo Stato sociale abbia la sua origine nelle riforme bismarckiane degli anni 1883-89. (Paul Bairoch) 10.2.2. Le nuove conquiste sociali: dalle acquisizioni del primo dopoguerra al Fronte popolare, dal miglioramento del trattamento pensionistico alle ferie retribuite La prima guerra mondiale ha convogliato in una duplice direzione i risultati dell’ascesa del socialismo ottocentesco: da un lato la nascita del regime socialista sorto dalla rivoluzione russa da un altro lato “in Occidente, la pressione sindacale, in qualche modo agevolata dalla paura del comunismo, comporta l’emanazione di una serie di provvedimenti legislativi che mitigano gli aspetti negativi del capitalismo” A ciò si aggiunge la crisi del 1929 “che ha fatto per così dire da base all’assunzione di nuovi provvedimenti di carattere sociale e al miglioramento di quelli esistenti”. L’alto livello di disoccupazione richiese un cambio di indirizzo, determinato soprattutto dalle indicazioni keynesiane. Prima del 1914, oltretutto, qualche forma (molto blanda) di sostegno ai disoccupati era fornito solo da Danimarca, Norvegia e Regno Unito e già dopo la fine della guerra le cose iniziarono lentamente a cambiare. 10.2.3. Il Regno Unito, in attesa del Piano Beveridge: Keynes e alcune misure sociali di carattere limitato Tra le due guerre il Regno Unito non si segnalò per particolare avanzatezza nel settore sociale. Nonostante alcune assicurazioni ottenute nel corso della Grande Guerra, sindacati e movimento operaio non riuscirono a ottenere quasi nulla nel corso degli anni 1920, salvo qualche ritocco piuttosto marginale al sistema pensionistico del 1908 e al sussidio di disoccupazione del 1911. Il grosso dell’assistenza rimaneva demandato alle antiche Poor Laws, peraltro non di competenza statale, bensì municipale. Gli stessi anni, d’altro canto, furono contraddistinti da una forte conflittualiltà sociale e dal primo governo del Labour (gennaio-novembre 1924). Il segno fondamentale di questo decennio è la coppia disoccupazione elevata-politiche liberiste, per cui non è sorprendente che sia stato inglese Lord Keynes, che “pur avendo tentato di salvaguardare il carattere liberale dell’economia, si mostrò favorevole all’intervento dello Stato inteso a garantire la piena occupazione mediante una politica fiscale e monetaria atta a favorire la propensione al consumo”. 10.2.4. La Francia: la svolta del Fronte popolare In Francia e Germania, più flagellate dalla guerra, si adottano sin dal 1919 politiche sociali più radicali. In Francia la guerra aveva profondamente diviso il fronte dei lavoratori, diminuendone la capacità contrattuale, il che ritardò di molti anni (1928) l’effettiva applicazione della legge del 1921 su cassa malattia e maternità. Gli anni successivi sono invece caratterizzati da due passaggi importanti: le leggi del 1932 sugli assegni familiari (i primi dopo l’esempio neozelandese del 1926) e i provvedimenti del Fronte Popolare, a partire dal 1936. Dopo una serie di scioperi il governo di Léon Blum firma nel giugno 1936 gli “accordi di Matignon” che comprendono: aumenti salariali riduzione della settimana lavorativa a 40 ore due settimane di ferie retribuite per tutti un notevole ampliamento degli accordi sindacali mentre la normativa contro la disoccupazione rimane ferma ai provvedimenti migliorativi del 1914. Il punto forte dei provvedimenti è in ogni caso quello sulle ferie retribuite generalizzate. 10.3. Dalla fine della seconda Guerra Mondiale all’apogeo dello Stato sociale (1975-83) Dopo la guerra lo spettro del comunismo impazzava: conquiste territoriali, partiti operai fortissimi e “minacciosi”. Inoltre grande crescita economica che permetteva di mettere a disposizione risorse per la sicurezza sociale. Ma le misure del dopoguerra dipesero da provvedimenti concordati e pianificati spesso (Uk, B, F) in piena guerra, per sostenere il morale del popolo impegnato nello sforzo bellico: La seconda guerra mondiale fu, al pari della prima, una guerra totale. E questo tipo di conflitti comporta delle conseguenze sociali più rilevanti rispetto ai conflitti precedenti. I motivi che spingono a ritenere che le guerre totali tendono a sollecitare progressi in campo sociali sono duplici. Da una parte, c’è il fatto che determinano un avvicinamento tra le classi sociali, nell’esercito come nell’ambito dei responsabili della politica. D’altra parte, al fine di stabilire la pace sociale necessaria a sostenere il grande sforzo industriale richiesto da questo tipo di guerre, i governi promettono in genere vantaggi sociali una volta terminate le ostilità. Questo tipo di promesse sono state particolarmente importanti nel Regno Unito. (Bairoch) 10.3.1. Il Regno Unito: da William Beveridge a Margaret Tatcher L’economista William Beveridge (1879-1963) iniziò a interessarsi all’inizio del secolo di disoccupazione e pubblicò nel 1909 un primo rapporto sulla disoccupazione. Direttore per un ventennio circa (1919-1937) della London School, fu incaricato nel 1942 di progettare un nuovo sistema di sicurezza sociale, prendendo in parte spunto da quello già adottato negli anni 1920 in Nuova Zelanda. Gli obiettivi del piano erano sostanzialmente due: il conseguimento della piena occupazione la sconfitta di indigenza, malattia, ignoranza, dipendenza, degrado e abitazioni malsane I principi base, in larga parte innovativi rispetto alla tradizione bismarckiana, erano quattro (le “tre u” soprattutto): universalità (un sistema di garanzie sociali estese all’intera popolazione e non soltanto agli operai) unicità (un solo servizione deve gestire tutto) uniformità (aiuti indipendenti dal livello del reddito) lo stato sociale doveva essere finanziato col gettito fiscale, controllato dal Parlamento e gestito dallo Stato La grande vittoria laburista del luglio 1945 accelerò l’applicazione del piano, anche se erano già stati introdotti gli assegni familiari e l’estensione della scolarità obbligatoria. Del 1946 viene votata la legislazione sugli infortuni sul lavoro e il National Health Service. Il sistema viene completato nel 1948 con le misure relative a anzianità, reversibilità e disoccupazione. Accanto a queste misure sociali il governo laburista avviò un piano di nazionalizzazioni (banca centrale, miniere di carbone, siderurgia) e di estensione dei diritti civili non mancando, tra il 1951 e il 1977, di migliorare progressivamente il sistema di welfare. La spesa per la sicurezza sociale, rimasta tra il 1950 e il 1960 attorno al 10% della spesa complessiva dello Stato, passa dal 1960 al 1983 al 20,4%. Il “ritorno indietro” inizia nel 1980 (la Tatcher è al governo dall’anno precedente) con la restrizione dell’indicizzazioni delle pensioni ai soli prezzi e non più anche all’andamento dei salari e a partire dal 1982 la spesa per l’assistenza inizia a stagnare per regredire dal 1987 in poi. 10.3.2. Diffusione territoriale dello Stato sociale Il Belgio adotta già durante l’occupazione tedesca un piano clandestino di riforme sociali approvato da tutte le forze politiche e sociali clandestine, nel 1944. Questo sarà poi la base delle riforme del dopoguerra. In Francia il governo di unità nazionale dei liberatori adotta ancor prima che in Gran Bretagna, e cioè nell’ottobre 1944, una serie di misure molto avanzate sia in campo sociale che per quanto riguarda le nazionalizzazioni (miniere di carbone, elettricità, banche e marina mercantile). Anche i paesi scandinavi (eccetto la Svezia) e l’Irlanda adottano già negli anni 1940 provvedimenti simili a quelli inglesi mentre sistemi simili verranno adottati dopo il 1960 in Canada, in Grecia, Spagna e Portogallo. A quell’epoca rimanevano al 5% della spesa pubblica soltanto Svizzera., Giappone, Grecia e Spagna. LEZIONE 11. MODIFICAZIONI STRUTTURALI DELL’ECONOMIA NEL NOVECENTO 11.1. Trasformazioni radicali delle fonti e degli usi delle risorse Il Novecento è stato il secolo della più rapida, radicale trasformazione nelle fonti e negli usi delle risorse economiche. mutamento della ripartizione delle attività economiche: l’agricoltura ha perso rapidamente peso rispetto all’industria, principalmente produttrice di manufatti, prima, e rispetto al terziario, produttore di servizi pubblici e privati, poi. Negli stessi paesi più avanzati la quota della forza lavoro complessiva addetta all’agricoltura era del 40% e oltre - ben oltre - nel 1820, del 20-60%, a seconda del grado di industrializzazione dell’economia, nel 1900. Alla fine del Novecento in questi paesi (dove è praticamente sparita la figura del contadino) essa non supera di media il 5%; è inferiore al 50% nel mondo. Nel complesso delle economie avanzate la maggior parte della forza lavoro (65%) è addetta al terziario. I “colletti bianchi”, gli impiegati, sono di gran lunga più numerosi dei “colletti blu”, gli operai. La quota dei consumi privati superava ancora nel 1820 1’80% del prodotto in Francia e nella stessa Gran Bretagna; sullo scorcio finale del XIX secolo era scesa al di sotto di questi livelli nella media dei paesi industriali; oggi è attorno al 60% in queste economie, al 70 altrove. nel 1820 la maggioranza delle persone era analfabeta; attualmente, nelle stesse nazioni a più basso reddito, la maggioranza di chi ha più di 15 anni non lo è più. Nei paesi ad alto reddito gli anni di istruzione delle persone con età compresa fra i 15 e i 64 anni sono saliti da non più di due nel 1820, a 5-8 nel 1900, a 12-18 oggi. modificazione della struttura dei consumi e innalzamento del livello di vita: l’autoconsumo, tipico della società contadina, è divenuto consumo di massa di merci, rese familiari dalla pubblicità e vendute nel mercato. corrispondentemente, è aumentato il peso relativo dei consumi pubblici e degli investimenti (rispettivamente, al 16 e al 20% del prodotto nei paesi più avanzati): la spesa statale e gli investimenti delle imprese in impianti, scorte, macchinari sono divenuti quantitativamente più importanti. incremento conseguente del consumo di energia e delle materie prime e, di conseguenza, deficit del mondo sviluppato e crescita dell’export del Terzo Mondo modificazioni della struttura e del funzionamento delle imprese la scienza si è trasformata in tecnologia sistematicamente rivolta e applicata alla produzione. 11.2. La struttura delle attività: la fine dei contadini e la crescita del terziario Due possibili modi di misurare il peso dei settori: la quota sulla produzione totale e la quota degli attivi. Il secondo è in qualche misura meno incerto. 11.2.1. La fine dei contadini Fenomeno ben chiaro agli inizi degli anni 1980 ma incubato nella perdita di peso relativo dell’agricoltura fra le due guerre. “Peso relativo”: il settore continua ad essere estremamente influente e ad espandersi, in realtà, in termini assoluti, ma il numero assoluto di agricoltori inizia a diminuire. Tre fasi, infatti, nei paesi industrializzati: fino alla rivoluzione industriale aumento della popolazione -> aumento proporzionale dei contadini dopo la rivoluzione industriale aumento assoluto dei contadini (1800 = 24,7 ml; 1910 = 41,1 ml; 1930 = 41,5 ml) ma loro flessione in termini relativi (sotto il 50% già alla vigilia della Grande Guerra, pur con notevole dispersione, dal 15 al 70 a seconda dei casi fino al 78% “tradizionale” della Russia1) a partire dal 1930 circa, con una forte accelerazione dopo il 1950, flessione in termini assoluti (al 1995 20 ml di agricoltori) Al 1995 si era sul 5% (4,5 senza Sudafrica e Iugoslavia) a causa soprattutto della “terza rivoluzione agricola”. Al 1990 nei paesi sviluppati meno avanzati si era comunque tra il 15 e il 25% (Gr, P, E) e il 2-3% (B, Usa, Uk). Questi ultimi sono peraltro paesi autosufficienti se non ampiamente esportatori, come gli Usa (che possono nutrire il 230% della propria popolazione). Stessa dinamica, un poco ritardata, per i paesi dell’Est europeo. 11.2.2. Occupazione nell’industria: una progressione ininterrotta sino agli anni 1970 Fenomeno verificatosi in sostanza nell’Ottocento, raggiungendo il suo massimo attorno al 1965 con il 38% (31% nel 1910 e 29% nel 1995). All’interno di questa relativa stabilità due cambiamenti radicali: la diminuzione, nel corso del Novecento, del peso relativo delle produzioni tradizionali (tessile etc) e l’emergere impetuoso di settori nuovi (automobili, chimica, elettricità, elettronica) a partire dal 1970, la deindustrializzazione soprattutto in Europa a causa dei manufatti a basso costo provenienti dai dragoni asiatici e dal Terzo Mondo 1 stima standard delle società tradizionali: primario 75-85%; secondario 8-12; servizi 8-12. in generale 11.2.3. Crescita del terziario A fronte di questi mutamenti, il peso preponderante assunto dal terziario, che supera il 50% attorno al 1967-69. Al 1995 siamo attorno al 66% e in nessuno dei paesi occidentali è comunque al di sotto del 60% (un po’ diverso il caso dei paesi dell’Est, ancor oggi in media sotto il 45%, tra l’altro perché a lungo ritenuto “parassitario”). All’interno del terziario comunque, notevoli cambiamenti: notevole diminuzione del personale di servizio domestico aumento nel campo dei servizi finanziari e nella distribuzione 11.3. Grandi mutamenti nella struttura del consumo A partire dai primi del Novecento, analisi del “bilancio familiare” (Aus, Sf, D, Usa tra il 1902 e il 1910) sulla scia degli studi di metà ottocento di Le Play. Poi si è continuato e si sono potuti fare raffronti per il resto del secolo. 11.3.1. Marginalizzazione dell’alimentazione Diversi fattori (sia legati alle modificazioni strutturali dell’economia, sia alla psicologia, sia alla cultura locale in senso lato, sia alla tecnologia) influiscono sulle modifiche delle scelte di consumo e non le rendono perfettamente sincrone. In ogni caso ovunque è calato potentemente il peso relativo dell’alimentazione, ancora al 50% attorno al 1914 (Usa=33; P=66) e stimabile al 18% alla metà degli anni 1990, pur con un certo grado di dispersione. 11.3.2. La crescita delle altre spese Le spese non alimentari sono salite dunque dal 50 all’82% tra il 1913 e il 1990, alcune rimanendo pressoché invariate (affitti sul 17% e abbigliamento sul 10%), altre crescendo sensibilmente (mobili, elettrodomestici, trasporti 14%, divertimenti e spettacoli, cure mediche). Il livello di alcune di queste spese dipende in ogni caso dal sistema di welfare: negli Usa il sanitario incide per il 17%, in Scandinavia per il 2-3%. 11.4. Dall’eccedenza energetica alla dipendenza del Terzo Mondo in fatto di energia e materie prime L’idea di una forte dipendenza energetica del mondo sviluppato occidentale è talmente radicata che si ha talvolta difficoltà a prendere atto della sua autosufficienza energetica sino all’inizio degli anni 1950. In effetti, la storia dell’energia, come in pratica di quella di tutte le materie merci che pesano più di una tonnellata per metro cubo, è la storia del passaggio da un sistema di autoconsumo locale pressoché assoluto agli scambi internazionali. Passaggio che ha potuto avere luogo soltanto dopo la forte diminuzione dei costi di trasporto verificatisi intorno alla metà del XIX secolo. (Paul Bairoch) 11.5. Il progresso tecnico: la terza rivoluzione industriale 11.5.1. Introduzione A partire dagli anni del secondo dopoguerra una terza ondata di innovazioni, soprattutto nei campi dell’elettronica e delle telecomunicazioni (cioè in quello che viene definito il settore delle tecnologie dell’informazione) e, negli anni più recenti, delle biotecnologie La caratteristica del primo gruppo di queste tecnologie (ma in parte anche delle seconde) è la loro flessibilità, il loro carattere pervasivo, il fatto cioè che sono utilizzabili in quasi tutti i settori produttivi: telecomunicazioni, produzione di beni e servizi, eccetera. 11.5.2. Il calcolatore elettronico e il settore delle telecomunicazioni Al cuore di questa fase stanno l’invenzione del calcolatore elettronico e la diffusione dell’automazione. Il primo calcolatore elettronico (Usa 1946) era a valvole, di grandissime dimensioni, e servì al solito per fini bellici (calcoli balistici) ma presto vennero gli utilizzi produttivi (guida degli utensili di precisione). Dagli anni ’50 le dimensioni dei calcolatori si ridussero sempre di più grazie all’invenzione del transistor rendendoli adatti per una serie sempre più varia di applicazioni, militari e civili, dal calcolo al controllo dei processi di produzione. Per un lungo periodo le operazioni guidate dal computer venivano assistite da schede cartacee perforate contenenti le istruzioni che i macchinari dovevano eseguire. La terza generazione di computer si basava sulla sostituzione dei transistor con i circuiti integrati, un insieme di elementi posti su un blocco unico, miniaturizzato e senza saldature. L’ulteriore riduzione di dimensioni e il miglioramento delle prestazioni ampliarono ulteriormente la gamma di applicazioni dei computer fino a renderli utilizzabili dall’utente privato finale, a casa, com’è da vent’anni a questa parte. Altre caratteristiche rilevanti di questi ultimi computer sono la capacità di far girare contemporaneamente più programmi su una stessa macchina e di lavorare per più utenti, cosa fondamentale oggi. La rivoluzione informatica è andata di pari passo e si è intrecciata con quella delle comunicazioni: il radar, tra le due guerre; l’evoluzione di radiofonia e televisione grazie all’utilizzo dei transistor e poi dei circuiti integrati; infine gli apparecchi radioriceventi satellitari dalla fine degli anni ’60 che hanno raggiunto la loro maturità negli ultimissimi anni. 11.5.3. Gli altri settori: chimica, metallurgia, aeronautica e nucleare Per quanto riguarda gli altri settori nel secondo dopoguerra va detto anzitutto del “sorpasso” del petrolio sul carbone in quanto a consumi ma anche della crescente importanza dei derivati del petrolio nelle varie applicazioni chimiche. Nasce così la chimica organica: i vari composti provenienti dalla sintesi del petrolio sono destinati a diventare sempre più importanti. Sempre per quanto riguarda il settore chimico va ricordato anzitutto che di questo periodo sono anche gli antibiotici, prima di tutti la penicillina. Sperimentata nel 1941, per qualche anno non si riuscì a trovare il modo di produrla industrialmente. Questo risultato fu ottenuto immediatamente dopo la fine della guerra. Questo è anche il periodo della definitiva affermazione delle fibre artificiali non solo nel settore tessile ma anche come conduttori elettrici e materia di base per materiali resistenti. Altra importantissima (ed estremamente controversa) innovazione del dopoguerra è l’utilizzo dell’energia nucleare. Sperimentata per la prima volta durante la seconda guerra mondiale per fini militari e utilizzata contro la popolazione civile giapponese, trova successivamente utilizzo non solo in campo militare (decine di migliaia di testate nucleari per fortuna mai utilizzate eccezion fatta per gli esperimenti, sotterranei e nell’atmosfera) ma anche in campo civile. Per un certo periodo si è pensato che l’energia atomica, per certi aspetti più pulita del carbone e del petrolio, potesse essere davvero l’energia del futuro ma a partire dagli anni ’70 essa è stata progressivamente abbandonata sia per i costi eccessivi sia per la sua insicurezza intrinseca (incidenti di Three Mile Island e Cernobyl + scorie radioattive). Altro settore di grande espansione e con innovazioni rilevanti è il trasporto aereo, con l’invenzione del motore a reazione che consente velocità molto maggiori che in passato. Anche qui per un periodo si sono sognati grandi aerei da trasporto supersonici come il Concorde, anche se l’orientamento maggioritario è stato quello a costruire velivoli di grande capienza anche se meno veloci. Ultimo settore, del tutto nuovo, è quello aerospaziale cioè del volo al di sopra dell’atmosfera. Nato anch’esso in ambito militare (artiglieria a grandissima gittata mediante lancio di razzi) ha poi avuto sviluppi sia militari (razzi balistici) che civili. In quest’ultimo campo si è battuta a lungo la strada (relativamente poco interessante, nonostante la spettacolarità) della ricerca interplanetaria (nel 1969, la luna) fino a privilegiare, di recente, la tecnologia dei satelliti stazionari, fondamentali per le telecomunicazioni, l’informazione, la rilevazione elettronica del territorio. 11.6. Gli effetti sull’occupazione Il fattore più importante sia della crescita sia della trasformazione è stato il progresso tecnico. Esso ha investito l’intera economia del mondo, financo nelle aree più povere e arretrate. I suoi effetti sono stati pervasivi nelle economie di mercato dotate delle capacità imprenditive e delle istituzioni più idonee a promuoverlo, valorizzarlo, governarlo. Il progresso tecnico ha interagito con il mutare dei consumi nel determinare un processo continuo di creazione-distruzione di posti di lavoro. A mano a mano che la stessa quantità di prodotto poteva essere ottenuta con meno lavoro, divenuto più efficiente, i posti di lavoro venivano distrutti nei settori che producevano beni e servizi la cui domanda diminuiva, mentre venivano creati nei settori in espansione, più dinamici. L’effetto netto sull’occupazione è risultato non di rado negativo. La disoccupazione è stata massima negli anni trenta, con punte del 25% negli Stati Uniti e in Germania, dove peraltro contribuì all’avvento al potere del nazismo hitleriano (cfr. le lezioni XIV e XV). È stata minima negli anni sessanta, allorché scese sino al 23%, un livello praticamente di pieno impiego (cfr. la lezione XVIII). Il XX secolo si chiude con 35 milioni di disoccupati nei paesi industriali, 1’8% delle forze di lavoro (11% e più nell’Unione europea). Il XXI secolo si apre con la questione del lavoro di nuovo al centro dell’attenzione, in particolare nell’Europa continentale. 11.7. L’innovazione programmata Tornando al progresso tecnologico possiamo osservare come, sostituendosi alla Gran Bretagna, nel Novecento gli Stati Uniti sono stati il capofila, ancor più dinamico, dell’avanzamento tecnologico. Il Giappone a sua volta è stato, dopo la seconda guerra mondiale, l’imitatore creativo di maggior successo. Inoltre, e più in generale, nell’Ottocento l’innovazione tecnologica era per lo più dovuta a inventori individuali e a imprese piccole; nel Novecento essa si è estesa alle grandi imprese che investono nella ricerca e ai governi; insomma non è più casuale, ma scaturisce da un impegno programmato. Le telecomunicazioni legate all’elaborazione dei dati con i calcolatori elettronici rappresentano l’ultima ondata innovativa, con le prospettive più interessanti per gli investimenti, per lo sviluppo della produzione, per l’occupazione, diretta o indotta. In conseguenza del progresso tecnologico, infatti, nel corso del Novecento il numero delle ore lavorate pro capite è tendenzialmente diminuito: nel complesso dei paesi industriali la diminuzione è stata del 40%, da 2700 a 1600 ore annue per lavoratore. La flessione è stata più rapida che nel corso dell’Ottocento, allorché, negli Stati Uniti ad esempio, il calo fu del 1520%, rispetto al 20-30% in questo secolo. La quantità di capitale per addetto è notevolmente cresciuta, dotando ciascun lavoratore di strumenti produttivi più numerosi e soprattutto più efficienti: ha rappresentato il veicolo attraverso cui il progresso tecnico è stato applicato al miglioramento della produttività . L’efficienza è stata inoltre notevolmente favorita dalla più alta qualità delle risorse umane e dai cambiamenti nell’organizzazione interna delle fabbriche, degli uffici, delle unità produttive. 11.8. Le mutazioni delle imprese Cinque grandi aspetti: un avvicinamento già tra le due guerre tra il modello gestionale americano e quelli europei, poi una vera e propria rivoluzione nel campo dell’organizzazione del lavoro il passaggio dal fordismotaylorismo, invalso dagli anni 1910 alla fine degli anni 1960, quando si passa ai circoli di qualità e similia la multinazionalizzazione delle imprese le ondate di fusioni/acquisizioni a partire dai 1980 la dinamica nazionalizzazioni-privatizzazioni 11.8.1. La gestione delle grandi imprese Il “modello americano” (con struttura a divisione multipla, gerarchizzata e coordinata: cfr. 12.4.d) era già applicato nella seconda metà dell’Ottocento, si generalizza alla fine del secolo e con la crisi del 1920-21 si espande ulteriormente. La Germania iniziò ad adottare queste innovazioni tecniche già all’inizio del Novecento (Siemens, ad es.), ma esse si generalizzano in Europa e in Giappone soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sarà proprio il Giappone ad adottare tecniche gestionali ancor più innovative in vari campi nel corso degli anni 1960. DAL “DOWNSIZING”’ ALLA “HORIZONTAL CORPORATION” Dai primi anni 1980 una risposta alla deindustrializzazione e alla maggiore instabilità generatasi dopo il 1973 è costituita dal “downsizing”, cioè dalla riduzione di dimensioni delle imprese. Non si tratta solo di ridurre il numero di dipendenti ma anche di adottare metodi di gestione diversi da quelli adottati in una fase di crescita come la precedente. Il fenomeno non riguarda solo l’impresa manifatturiera, ma anche i trasporti, la finanza e la pubblica amministrazione. Tra il 1980 e il 1993 negli Usa le 500 principali imprese manifatturiere passano così da 20 a 15 ml di dipendenti (1960, il 20% dei salariati; 1990, il 10%). Il taglio riguarda soprattutto le grandi imprese, mentre la crescita del terziario riguarda soprattutto piccole imprese: si ha così l’inversione di una tendenza secolare, dal grande al piccolo piuttosto che dal piccolo al grande. Studi effettuati all’inizio degli anni 1990 hanno mostrato come le ristrutturazioni non avevano contribuito un gran che a migliorare la produttività delle imprese (chi rimaneva si sentiva bombardato più o meno come chi era stato cacciato), anche se il benefico effetto sui profitti ha suggerito di effettuare tagli sia in fase di congiuntura sfavorevole che in fase di congiuntura favorevole, rendendo il downsizing permanente. Gli aspetti negativi del downsizing hanno indotto ad adottare un’altra tecnica, quella della horizontal corporation. Si trattava in sostanza di: abolire le gerarchie organizzare su tre assi l’impresa: creazione di nuovi prodotti; produzione e vendita; assistenza alla clientela Il tutto ruotando attorno a un insieme di principi tra cui: livellamento delle gerarchie e eliminazione di attività che non creano valore aggiunto impiego di équipe autonome soddisfazione della clientela come criterio per eccellenza delle prestazioni modificazione delle remunerazioni per favorire le équipe che ottengono i risultati migliori massimizzazione dei contatti del personale sia con i fornitori che con la clientela informazione e formazione di tutto il personale Tutto questo pastone tecnocratico è stato adottato in diverse multinazionali soprattutto giapponesi e americane e soprattutto dell’alta tecnologia. 11.8.2. L’organizzazione del lavoro: dal fordismo ai circoli di qualità Il taylorismo e il fordismo erano stati adottati negli Usa già nei primi anni 1910 (cfr. 12.4.f) e si erano diffusi durante la guerra. In Europa anche tali principi arriveranno dopo il 1945, anche se una variante era stata elaborata anche in Urss, lo stachanovismo (qui illustrato). Il sistema avrà il suo periodo d’oro in Occidente tra il 1945 e la fine degli anni 1960. LA CRISI DEL FORDISMO E LE NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO La crisi del fordismo viene generata sia dall’ostilità della classe operaia, dalla diminuzione del capitale d’impresa e dal fatto che la parte strettamente produttiva è divenuta via via meno centrale e preponderante. A partire da queste considerazioni viene elaborata una organizzazione del lavoro basata sulla flessibilità e sull’ampliamento e arricchimento delle mansioni dei lavoratori. “Si tratta in sostanza di un modo di lavorare che combina le mansioni produttive propriamente dette col controllo di qualità dei pezzi prodotti e la regolazione delle macchine”. Il primo campo di applicazione di queste modalità (caratterizzata anche dal just in time e dall’automazione) è l’impresa automobilistica, mentre il taylorismo resta imperante nelle piccole e medie imprese. I pionieri, sin dal 1950, sono i giapponesi della Toyota, ma nel 1974 la Volvo fa un ulteriore passo in avanti abolendo la catena di montaggio e adottando piccole équipe di lavoro volontarie (5-10 persone) cui compete l’intero ciclo e il controllo di qualità. La qualità diviene peraltro sempre più centrale per la conquista dei mercati “difficili” e viene introdotto il concetto di “controllo totale della qualità”. L’applicazione della flessibilità, delle isole e della qualità totale conoscono una diffusione notevole ma non universale e non mancano di suscitare critiche. Oltretutto si tratta di modificazioni che si accompagnano (e accompagnano) un decremento continuo di occupati nella grande impresa manifatturiera occidentale. 12. CRISI, REAZIONE, FINE DEI BLOCCHI 12.1. Il cambio delle egemonie economiche: Inghilterra, Usa, Germania e Giappone A parte la sfida tra paesi capitalisti, guidati anche militarmente dagli Usa, e paesi socialisti, guidati almento fino a metà degli anni ’60 dall’Unione Sovietica, nel Novecento gli equilibri del potere mondiale sono mutati almeno quattro volte: dalla prevalenza inglese ottocentesca e d’inizio Novecento si è passati al dominio pieno, ancorché contrastato, degli Usa e più di recente alla riassunzione di un ruolo importante, economico se non ancora politico, da parte della Germania e del Giappone, usciti sconfitti dall’ultima guerra alla recente ascesa della Cina, che sta trascinando con sé anche paesi asiatici che al pari di lei erano rimasti fuori dalla crescita degli anni ’60 e ’70, come ad esempio l’India L’economia mondiale non solo non è più imperniata su Londra, come nell’Ottocento, ma non è nemmeno più eurocentrica. Le esportazioni dell’Europa occidentale rappresentavano più della metà di quelle mondiali nel 1870, e ancora nel 1913; oggi superano di poco il 40%. Le troppe incertezze nella costituzione di una organica economia europea, che in teoria avrebbe già da tempo potuto competere con gli altri giganti economici degli anni 70 e 80 ma non è riuscita a farlo, si trovano oggi a costituire un freno proprio nel momento in cui la comparsa di nuovi competitori mondiali estremamente attivi come Cina e India sta mandando rapidamente in frantumi in quadro tripolare EuropaGiappone-Cina. Al di là della tematica - cruciale e dagli enormi effetti futuri - della nuova ripartizione del potere economico a livello mondiale, vediamo rapidamente cosa è successo dopo la fine dell’età dell’oro, quali sono stati i principali mutamenti dell’economia mondiale e quali sono le altre grandi problematiche aperte. 12.2. Apogeo e crisi del welfare state Il consenso attorno alle politiche sociali e, più in generale, all’intervento pubblico nell’economia era ampio e convinto. Lo dimostra anche il fatto che la già ricordata espansione della spesa sociale non generò tensioni significative nel bilancio dello Stato: i cittadini accettarono di pagare imposte crescenti cosicché le entrate dello Stato tennero sostanzialmente il passo delle uscite. Gli spaventosi debiti pubblici appartengono a un periodo successivo e, del resto, di “crisi fiscale dello Stato” si cominciò a parlare - soprattutto da parte di studiosi di formazione marxista, come O’Connor quando l’età dell’oro era già tramontata. Per lungo tempo ha prevalso, alimentato da campagne di stampa molto attive, un giudizio fortemente negativo sul welfare state. Negli anni sessanta, la fiducia nell’intervento pubblico era molto alta e dominava la convinzione che esso potesse servire le ragioni della crescita e quelle dell’equità. Tra i motivi di questo cambiamento di giudizio vi sono gli abusi cui, in molti paesi, il welfare state ha progressivamente dato origine, i privilegi ingiustificati che esso ha garantito e le perduranti distorsioni che può avere introdotto nel funzionamento dei mercati. 12.3. Il declino dell’età dell’oro 12.3.1. I limiti all’intervento statale L’accresciuto intervento dello Stato si scontrò, alla lunga, con il progressivo rafforzamento del big business e in particolare delle multinazionali, soprattutto statunitensi. Queste “organizzano infatti i propri cicli di produzione su scala mondiale, approfittando dell’abbattimento dei costi di trasporto e della facilità di comunicazione, per migliorare le condizioni di accesso ai mercati sfruttare con vantaggio la disponibilità di risorse aggirare limitazioni e ostacoli eventualmente posti dalle amministrazioni statali”. Ciò favorì l’integrazione dei mercati nazionali ma anche “l’indipendenza di scelta dei gruppi che controllavano le grandi imprese multinazionali e il loro potere di pressione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, delle società e delle economie locali”. 12.3.2. Il ritorno dell’inflazione Fino ai primi sessanta prezzi in crescita lieve grazie a abbondanza di risorse sottoutilizzate e consistenti incrementi di produttività Inoltre, nonostante i ritmi diversi da un’economia all’altra, costante compatibilità con i limiti fissati a Bretton Woods. Dalla seconda metà degli anni sessanta, invece, crescita dei prezzi più rapida nel momento in cui alcuni paesi sfiorarono la piena occupazione e altri rivelarono strozzature nelle infrastrutture e nei servizi Attorno al 1973 una forte ventata inflazionistica e notevoli squilibri nel sistema internazionale dei pagamenti, difficilmente sanabili. A partire dal deficit della bilancia dei pagamenti americana che dal 1958 cominciò ad andare in passivo (e ci andò sempre di più col passare del tempo) mentre altri paesi (D soprattutto) avevano avanzi consistenti. Gli americani speravano di rilanciare la ripresa senza svalutare, bensì costringendo gli altri a rivalutare ma non ci riuscirono. Al contempo si presentavano altri due problemi: le riserve erano in quantità sempre minore rispetto agli scambi e alle passività finanziarie internazionali (pompate dalle attività delle multinazionali e dal mercato degli eurodollari, liberi di circolare come pareva loro) le riserve erano sempre più costituite da dollari (a causa del deficit della bilancia usa e dal valore troppo basso dell’oro) Le cose non andarono a carte quarantotto a causa della supremazia economica america e a successive correzioni nella gestione dei cambi, ma nel 1971 Nixon sganciò il dollaro e avviò “un’esperienza di limitata fluttuazione della parità di cambio”. Non essendo sufficiente tutto ciò, soprattutto rispetto all’enorme forza del marco e delle monete europee ad esso connesse, nell’estate del 1972 si adottò una “fluttuazione manovrata delle valute”, nonostante l’opposizione dei paesi europei che volevano un minimo di controlli. In questo contesto i paesi Opec decisero di “riallineare” il loro import-export (danneggiato dall’inflazione dei paesi industriali e dalla svalutazione del dollaro) quadruplicando il prezzo del petrolio. 12.4. L’ultimo ventennio 12.4.1. La crescita perde colpi La libertà di movimento dei capitali e le dimensioni delle operazioni internazionali introducevano “importanti conseguenze per la politica macroeconomica” in quanto “anche politiche moderatamente espansive potevano determinare una crisi dei pagamenti”. A ciò si aggiunse il crescente ritorno di popolarità del liberismo (stato minimo, anche per fronteggiare la crisi fiscale dello stato della seconda metà degli anni settanta). Il rincaro dei prezzi petroliferi contribuì alla crescita dell’inflazione nei paesi importatori di petrolio e danneggiò severamente la loro bilancia dei pagamenti imponendo un ridimensionamento delle importazioni: l’incremento delle importazioni medie annue dei paesi Ocse scese dall’8,7 al 3,4 per cento: fu così che il rallentamento delle economie industrializzate venne trasmesso internazionalmente. Ciò non implicò l’abbandono del libero scambio di merci (salvo l’agricoltura) ma solo alcune (inefficaci) misure di limitazione della libera circolazione dei capitali. La libertà di movimento dei capitali e le dimensioni delle operazioni internazionali introducevano “importanti conseguenze per la politica macroeconomica” in quanto “anche politiche moderatamente espansive potevano determinare una crisi dei pagamenti”. A ciò si aggiunse il crescente ritorno di popolarità del liberismo (stato minimo, anche per fronteggiare la crisi fiscale dello stato della seconda metà degli anni settanta). Il rincaro dei prezzi petroliferi contribuì alla crescita dell’inflazione nei paesi importatori di petrolio e danneggiò severamente la loro bilancia dei pagamenti imponendo un ridimensionamento delle importazioni: l’incremento delle importazioni medie annue dei paesi Ocse scese dall’8,7 al 3,4 per cento: fu così che il rallentamento delle economie industrializzate venne trasmesso internazionalmente. Ciò non implicò l’abbandono del libero scambio di merci (salvo l’agricoltura) ma solo alcune (inefficaci) misure di limitazione della libera circolazione dei capitali. 12.4.2. Le contromisure L’impatto deflazionistico dell’aumento dei prezzi del petrolio fu riassorbito: facendo redistribuire i surplus finanziari dei paesi petroliferi (acquisto di armi, investimenti al Nord e prestiti ai flesciati dagli aumenti) mediante una complessa azione diplomatica volta a contenere le fluttuazioni dei cambi e l’incalzare dell’inflazione procedendo a una riorganizzazione degli apparati industriali per contenere i costi: downsizing, esternalizzazione, trasferimento delle produzioni, innovazioni tecnologiche del ciclo In alcune aree le cose ebbero un decorso differente: per un po’ i paesi latinoamericani giocarono con il loro petrolio e con il fatto di essere da sempre indifferenti ai cambi fluttuanti e inflazione e fecero politiche espansive godendo di grandi prestiti bancari del nord che altrimenti non sapevano come investire il loro danaro. Così andarono avanti indebitandosi paurosamente tra il 1973 e il 1982, al contrario degli asiatici che crebbero rapidamente e abbastanza “bene” senza contrarre troppi debiti, anzi cercando di starne alla larga il più possibile. Questo indebitamento a un certo punto andò a cozzare contro l’aumento dei tassi di interessi Usa decisi per attirare risorse sui titoli di stato: a quel punto fu la crisi finanziaria, e delle più dure. La risposta fu il consolidamento dei debiti da parte delle banche commerciali su suggerimento del Fmi, ma in cambio di piani di aggiustamento lacrime e sangue, ben peggiori di quelli degli anni ’30. Il mercato finanziario è stato salvato da questa decisione di lasciar lasciar portare il peso del debito estero all’America Latina; e sono state salvate le grandi banche commerciali in cambio di una drastica riduzione dei Pil del paesi debitori, aggravata dal peggioramento dei termini di scambio. Investimenti e importazioni di questi paesi caddero drammaticamente per oltre un decennio. L’operazione rovesciava le linee di politica economica applicate dopo la seconda guerra mondiale perché sacrificava deliberatamente le possibilità di sviluppo economico in nome della solvibilità. 12.4.3. Ritorno al “classico” Anche nei sistemi economici industrializzati si assiste a partire dagli anni ’70 ad una inversione di tendenza nel campo delle politiche economiche: La piena occupazione non appare più desiderabile, mentre diventano più importanti il blocco dell’inflazione e il deficit della bilancia dei pagamenti. (…) Si afferma una nuova ortodossia nella politica economica, ispirata a orientamenti restrittivi e nutrita di un’ideologia fortemente liberista, che continua ad imporsi anche quando le spinte inflazionistiche paiono vinte e le economie mostrano i segni della recessione, quando la disoccupazione ha assunto proporzioni drammatiche e i deficit delle bilance dei pagamenti sono stati trasformati in attivi. In relazione a questa politica economica restrittiva e liberista pare inevitabile il ridimensionamento del potenziale di crescita delle economie più industrializzate. L’incremento di produttività era stato in media del 4.5 per cento annuo nel 1950-73, contro l’1.9 per cento fra 1913 e 1950. Dopo il 1973 (e fino al 1986) il tasso è del 2.2 per cento. Il grande incremento realizzato fra il 1950 e il 1973 era il risultato di una situazione unica: lo stimolo legato alla ricostruzione postbellica, quello derivante dall’apertura al commercio estero e dal largo trasferimento di lavoratori dalla campagna all’industria. Inoltre i paesi europei e il Giappone ammodernarono il loro stock di capitale, avvicinandosi al limite superiore delle tecnologie disponibili. Una volta raggiunti questi risultati, i paesi dell’Ocse non possono più trarre beneficio dal fenomeno di rincorsa nei confronti dell’economia più avanzata e il rendimento degli investimenti risulta inferiore rispetto al passato. Il rallentamento che si verifica lascia inutilizzate delle risorse e in primo luogo crea disoccupazione: quella media dell’Ocse, nel 1973, era il 2.6 per cento della forza lavoro; nel 1983 era salita al 7.8 per cento, mentre il rallentamento degli investimenti potrebbe segnalare una capacità produttiva in eccesso. (Paul Bairoch) 12.5. Fine del socialismo reale 12.5.1. Da Perestrojka e Glasnost all’abbandono del comunismo, 198791 Lo smantellamento dello stato sociale fu reso agevolato dall’indebolimento delle sinistre e dei sindacati dei paesi capitalisti dovuto a vari fattori, ma anche e soprattutto dalla crisi delle economie socialiste, che si concluse con un vero e proprio tracollo, politico ed economico, tra la metà degli anni 80 e l’inizio degli anni 90. Tra Breznev e Gorbacev (10.1982-3.1985) si apre un periodo incerto, in cui innovatori e conservatori si contendono il campo. Dal 1986 iniziano le riforme anche in campo economico. Il piano 1986-90 era improntato a principi di maggiore flessibilità rispetto al passato, tendeva al miglioramento della qualità dei prodotti, ma tutte queste innovazioni vennero superate presto da una serie di misure che rendevano vuoto il piano: autorizzazione di un settore semiprivato nel commercio, nell’artigianato e nei servizi autonomia assai più ampia alle imprese che possono fare piani aziendali e scegliersi clienti e fornitori autorizzazioni a joint ventures con imprese occidentali (prima volta dopo la Nep) autorizzazione al licenziamento del personale e salari fissati dalla imprese riforma del sistema bancario privatizzazione delle terre e legalizzazione della trasmissione per via ereditaria Nel frattempo tuttavia il sistema inizia a dare segni di cedimento: tra il 1989 e il 1990 ad una ancora debolissima crescita del Pil e dei salari fa seguito un crollo verticale di entrambi e una inedita fiammata inflazionistica. Gorbacev tenta di rappeciare con una serie di riforme che vorrebbero accelerare il passaggio all’economia di mercato, “consigliate” dal professore di Harvard Jeffrey Sachs ma nel 1991 si ha un vero e proprio crollo dell’economia che determina anche la fine dell’esperienza stessa di Gorbacev. 12.5.2. Dall’allentamento alla fine del Comecon Dopo il 1971 le politiche dei vari paesi iniziarono a divergere sempre più da quelle dell’Urss o desiderate dall’Urss, anche “grazie” ai pur falliti tentativi di riforma interna avviati in Ungheria nel 1956 e in Cecoslovacchia nel 1968. Un segno di tale allentamento sta nella riduzione della quota di commercio interno all’area, dal 60% del 1970 al 49% del 1989. Curiosamente, però, fu più l’Urss a beneficiare dell’apertura in quanto paese esportatore di materie prime che non i paesi esportatori di prodotti manufatti come la Cecoslovacchia. L’allentamento fu perseguito anche grazie al permesso di stipula di trattati economici bilaterali con paesi non del Comecon. Tra il 1989-90 l’organizzazione collassa e nel 1991 viene concordemente abolita. 12.5.3. Il crollo economico nei primi anni della transizione al “capitalismo”: 1989-95 Una caduta imprevista e impreviste anche le modalità della transizione. Modalità peraltro diverse da paese a paese, da area a area. Il crollo della produzione complessiva è iniziato nell’Europa dell’Est ma ha avuto gli effetti più gravi e duraturi nell’ex Urss. Gli anni più difficili sono stati il 1991-92, mentre pare che fuori dall’ex Urss verso il 1994-95 inizia una fase di ripresa. In ogni caso il livello complessivo del Pnl dei paesi dell’Est nel 1995 è pari al 60% del 1989, a popolazione invariata e con una crescita sostanziale della sperequazione dei redditi e della povertà diffusa. Lo smantellamento del Comecon ha privato le industrie dei paesi membri degli sbocchi reciproci. La cosa ha avuto dimensioni drammatiche nel caso dell’ex Ddr. Anche i mercati locali hanno subito notevoli contrazioni a causa dell’effetto congiunto della perdita di potere d’acquisto interno e dell’afflusso di prodotti occidentali (migliori e spesso meno cari: l’abbigliamento e le automobili, ad esempio). Tra il 1990 e il 1994 la produzione industriale cala al ritmo del 15% annuo, cosicché al 1994 si è all’incirca alla metà del 1990. I regressi più forti in Bulgaria e Romania, quelli minori in Ungheria e Polonia. In campo agricolo, una situazione migliore. Nonostante andamenti diversi da zona a zona e un andamento generalmente negativo, si è su cali molto minori che in campo industriale: si va dal catastrofico andamento bulgaro (-40%) a quello polacco di appena il -3%, aiutato probabilmente dal carattere prevalentemente privato della proprietà. Con l’economia di mercato si manifesta subito la disoccupazione, soprattutto in Polonia (la prima e quella più alta, col 15% nel 1995) mentre nell’ex Urss si manifesta più a rilento e in modo meno drammatico (almeno stando alle statistiche ufficiali, che sono però molto controverse). Stessa storia per un’altra sconosciuta del vecchio regime, l’inflazione: arrivata subito in Polonia e Ungheria, sintomo delle riforme in atto, e si diffonde ad altri paesi colpendo con particolare forza la federazione russa. Fenomeni inflattivi, oltretutto, estremamente violenti (dalla Cecoslovacchia per 3 alla Russa per 7.500). Netta diminuzione delle esportazioni fino al 1993. Il totale (ex Ddr esclusa) cala da un indice 100 a 86 tra il 1989 al 1993, pur in un quadro internazionale di continua espansione del commercio internazionale (stesso periodo 100-137). I paesi più colpiti: Bulgaria, Romania ed ex Urss. Il crollo del commercio estero degli ex paesi comunisti è largamente determinato dalla notevole riduzione dell’interscambio. Si è passati da percentuali vicine al 60% nei primi decenni del dopoguerra al 36% alla vigilia del crollo del comunismo, per attestarsi poco sopra il 20% nel 1995. E poiché il valore delle esportazioni totali è diminuito, anche l’ammontare degli scambi interregionali è diminuito di circa un quarto tra il 1988 e il 1995. Come abbiamo già segnalato, gli ex paesi comunisti hanno smesso di approvvigionarsi presso i loro ex partner e sono andati alla ricerca, in Occidente, di prodotti di qualità migliore. 12.6. Una globalizzazione in chiaroscuro 12.6.1. Due tendenze: globalizzazione e finanziarizzazione GLOBALIZZAZIONE Un altro fenomeno tipico degli ultimi decenni è quello della cosiddetta globalizzazione. Alcuni tratti. la scala su cui si svolgono i traffici, si dispiega la concorrenza, si attuano le strategie delle imprese è infatti sempre più una scala planetaria. la rapidità dei trasporti e delle comunicazioni costituisce il presupposto di questa “economia globale”. i dazi doganali, dai livelli massimi toccati negli anni trenta (pari al 20% del valore delle importazioni), sono attualmente sui minimi del secolo (2%). i movimenti internazionali dei capitali sono quasi totalmente liberi, e intensi. La consistenza dei mezzi finanziari investiti all’estero da imprese e individui residenti nei principali paesi industriali ammontava nel 1995 a circa 10.000 miliardi di dollari, dieci volte quanto l’Italia produce in un anno. più della metà del commercio mondiale fa capo a grandi imprese multinazionali, il fatturato da queste prodotto negli stabilimenti all’estero supera addirittura il valore annuo degli scambi internazionali di beni e servizi (6000 miliardi di dollari, un quinto del prodotto annuo del mondo intero). anche la mobilità internazionale del lavoro, i flussi migratori, sono cospicui. FINANZIARIZZAZIONE La crescita della finanza internazionale, lo spessore e l’integrazione del mercato mondiale dei capitali sono stati il riflesso di un’espansione straordinariamente veloce delle attività bancarie e dei mercati mobiliari all’interno stesso delle principali economie. Il rapporto fra i cespiti monetari (banconote, depositi, crediti, titoli obbligazionari e azionari) e il valore del capitale fisico (gli impianti, le macchine, le infrastrutture) era pari a circa 0,6 in queste economie alla fine dell’Ottocento. Oggi tale rapporto - che costituisce una buona misura dello sviluppo quantitativo della finanza - è molto più elevato: 2,5 nel Regno Unito 1,5 negli Stati Uniti, superiore a 1 anche in Giappone, Francia, Germania, Italia. La finanziarizzazione è stata favorita dal rifiuto di regolare su basi nuove un settore (quello bancario e finanziario) sempre più complesso, pericoloso e in continua evoluzione ma anche da un progressivo e robusto smantellamento delle stesse regolamentazione adottate negli anni 30 dopo la grande crisi. La crisi odierna, partita anch’essa dagli Stati Uniti ma trasmessasi presto a tutto il mondo, deriva in gran parte da questa assenza di controlli efficaci, che ha permesso al settore bancario di giocare in modo estremamente cinico e irresponsabile su fenomeni economici gravi e patologici, come l’indebitamento delle famiglie americane, le bolle edilizie o i deficit pubblici di alcuni stati, amplificandone le conseguenze. 12.6.2. Il degrado ambientale ECONOMIA E AMBIENTE: IL DIBATTITO SUI LIMITI DELLA CRESCITA L’elevata crescita economica degli anni dell’età dell’oro ha avuto effetti rilevanti e non desiderabili sull’ambiente: la pressione sulle risorse naturali, sia esauribili che rinnovabili, si è intensificata; le minacce all’ecosfera sono divenute più visibili; il problema dell’inquinamento si è fatto più acuto. Negli anni successivi, fenomeni transnazionali se non globali quali l’effetto serra, il buco nell’ozono, le piogge acide hanno conquistato l’attenzione dei governi occidentali e hanno costituito l’oggetto di una serie di accordi internazionali diretti, almeno nelle intenzioni, a prevenirne l’aggravamento. Questi sviluppi negativi hanno certamente iniziato a manifestarsi nell’età dell’oro ma dei problemi ambientali si iniziò a discutere soltanto quando il periodo volgeva al termine: il dibattito sui “limiti della crescita” decollò in seguito alla pubblicazione, nel 1972, di un rapporto commissionato dal “Club di Roma”. Secondo tale rapporto la continuazione del trend di crescita avrebbe portato entro poche decine di anni all’esaurimento di risorse naturali di primaria importanza; inoltre, si paventava il rischio che la crescita della popolazione procedesse a un ritmo troppo elevato rispetto a quello della produzione alimentare e si prospettava, con riferimento a un più lungo orizzonte temporale, la possibilità che i danni arrecati all’ambiente mettessero in pericolo la sopravvivenza stessa dell ‘uomo sul pianeta. Riprendendo tematiche ben note, come quella malthusiana della scarsità alimentare e mostrando una scarsa fiducia nella capacità della tecnologia di dare risposte adeguate almeno ad alcuni dei maggiori problemi, il rapporto - e le posizioni che ad esso si sono ispirate - solleva questioni che non riguardano in modo particolare l’età dell’oro perché invitano a interrogarsi sulla razionalità e la lungimiranza dello sviluppo capitalistico. La letteratura sui “limiti della crescita” - pur con i suoi eccessi di pessimismo costituisce, in effetti, una potente messa in guardia contro i pericoli della corsa al massimo benessere materiale e solleva questioni di grande rilevanza etica come quella relativa alla responsabilità delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future. In effetti, alcuni economisti avevano già sottolineato - in piena età dell’oro - come la crescita economica sostenuta possa dare luogo a una serie di costi non immediatamente visibili, a iniziare da quelli ambientali, che dovrebbero comunque figurare con segno negativo nella contabilità dei risultati economici. DANNI IRREVERSIBILI ALL’AMBIENTE Nell’età dell’oro la coscienza ambientalista era certamente meno sviluppata di quanto non sia oggi ed è anzi probabile che la facilità con cui si accumulavano redditi e ricchezze abbia indotto in molti l’impressione che sarebbe stato possibile pagare qualsiasi costo, qualora se ne fosse presentata la necessità. In altri termini, il facile benessere economico può avere ostacolato la formazione di una responsabile cultura dell’ambiente e se oggi, malgrado il gran parlare di sviluppo sostenibile, pochi sono disposti a compiere rinunce a favore dell’ambiente una parte della responsabilità può essere imputata alle facili illusioni, dure a morire, nate nell’età dell’oro. A riprova di quanto affermato si consideri che l’età dell’oro ha, in alcuni paesi e in alcune aree geografiche, impresso un segno indelebile al territorio e inflitto danni irreversibili all’ambiente. L’esempio più evidente è quello relativo ai numerosi scempi edilizi consumati in molte zone del nostro paese, spesso in nome di un malinteso diritto alla casa. Avere permesso simili devastazioni non ha certamente contribuito a diffondere una solida e responsabile cultura ambientale, che è parte essenziale della più generale cultura civica. LEZIONE 13. HARVEY 1. INTRODUZIONE A BREVE STORIA DEL NEOLIBERISMO I 13.1. Introduzione: un biennio di svolta . il biennio tra il 1978 e il 1980 punto di svolta rivoluzionario nella storia sociale ed economica del mondo. con quattro epicentri: 1978: Teng Hsiao-ping imposta la liberalizzazione di un’economia governata da comunisti in un paese che ospitava un quinto della popolazione mondiale. grazie a ciò la Cina, nell’arco di due decenni, si sarebbe trasformata da paese arretrato e chiuso in se stesso a centro aperto del dinamismo capitalista, caratterizzato da tassi di crescita talmente sostenuti da non avere confronti nella storia. 1979: negli Usa Paul Volcker assumeva, nel luglio 1979, la guida della Federal Reserve e, nel giro di pochi mesi, modificava radicalmente la politica monetaria. Di lì in avanti la Fed avrebbe condotto la lotta all’inflazione senza alcun riguardo per le conseguenze (in particolare per la disoccupazione). 1979: in Gran Bretagna Margaret Thatcher viene eletta primo ministro con il mandato di porre un freno al potere dei sindacati e mettere fine alla deprimente stagnazione inflazionistica che aveva soffocato il paese nel decennio precedente. 1980: Ronald Reagan viene eletto presidente degli Stati Uniti e avvia il paese verso una rivitalizzazione dell’economia fondata da un lato sul sostegno alle manovre compiute da Volcker alla Fed e dall’altro sulla sua personale miscela di politiche finalizzate a contenere i sindacati, a deregolamentare l’industria, l’agricoltura e lo sfruttamento delle risorse, e a liberare le potenzialità della finanza a livello nazionale e sullo scenario mondiale . tutto ciò non fu casuale ma frutto di una lunga preparazione e maturazione. . è importante dunque cercare di capire grazie a quali strumenti e attraverso quali percorsi la nuova configurazione economica abbia sostituito la precedente. 13.2. Il neoliberismo, dalla marginalità al trionfo . si è trattato anzitutto dell’affermazione di una visione dell’economia e della società diverse da quelle dominanti nei decenni precedenti: Volcker, Reagan, Thatcher e Teng Hsiao-ping hanno tutti adottato argomenti minoritari diffusi da tempo e li hanno resi maggioritari. . si tratta in particolare del “neoliberismo”, una dottrina fatta uscire dall’ombra di una relativa oscurità e trasformata nel principio guida della teoria e della pratica economica . di questa dottrina appunto parla il libro di Harvey. . i capisaldi di tale dottrina sono i seguenti: il benessere dell’uomo può essere perseguito al meglio liberando le risorse e le capacità imprenditoriali dell’individuo all’interno di una struttura istituzionale caratterizzata da forti diritti di proprietà privata, liberi mercati e libero scambio Il ruolo dello stato è quello di creare e preservare una struttura istituzionale idonea a queste pratiche Lo stato deve garantire, per esempio, la qualità e l’integrità del denaro; deve predisporre le strutture e le funzioni militari, difensive, poliziesche e legali necessarie per garantire il diritto alla proprietà privata e assicurare, ove necessario con la forza, il corretto funzionamento dei mercati. Inoltre, laddove i mercati non esistono (in settori come l’amministrazione del territorio, le risorse idriche, l’istruzione, l’assistenza sanitaria, la sicurezza sociale o l’inquinamento ambientale), devono essere creati, se necessario tramite l’intervento dello stato al di là di questi compiti, lo stato non dovrebbe avventurarsi: Gli interventi statali nei mercati (una volta creati) devono mantenersi sempre a un livello minimo, perché secondo la teoria neoliberista lo stato non può in alcun modo disporre di informazioni sufficienti per interpretare i segnali del mercato (i prezzi), e perché in ogni caso potenti gruppi di interesse distorcerebbero e influenzerebbero in modo indebito, a proprio beneficio, tali interventi (in particolar modo nelle democrazie). . il neoliberismo ha iniziato la sua marcia trionfale dalla metà degli anni Settanta, ha preso il sopravvento nel biennio 1978-80 e ha finito col condizionare le politiche dei governi di quasi tutto il mondo: del Nord, del Sud, capitalisti, ex socialisti, etc. . i sostenitori della svolta neoliberista occupano oggi posizioni molto influenti nell’istruzione (università e molti think-tanks), nei media, nei consigli di amministrazione delle grandi aziende e nelle istituzioni finanziarie, in strutture chiave dello stato (ministeri del Tesoro, banche centrali) e anche in quelle istituzioni internazionali, come il Fondo monetario internazionale (FMI), la Banca mondiale e l’Organizzazione mondiale per il commercio (WTO), che regolano la finanza e gli scambi globali. . il discorso proposto dal neoliberismo è, in breve divenuto dominante, e la sua influenza talmente pervasiva da costituire parte integrante del modo in cui molti di noi comunemente interpretano, vivono e comprendono il mondo. 13.3. Il rovescio della medaglia il neoliberismo ha distrutto strutture e poteri istituzionali preesistenti (al punto da minacciare le forme tradizionali di sovranità statale), forme consolidate di divisione del lavoro, di relazioni sociali, di welfare, di assetti tecnologici, di stili di vita e di pensiero, di attività riproduttive, di attaccamento alla propria terra e di atteggiamenti affettivi fatto dello scambio di mercato «un’etica in sé, capace di fungere da guida di tutte le azioni umane e di sostituire tutte le convinzioni etiche coltivate in precedenza» sostenuto che il bene sociale può essere massimizzato intensificando la portata e la frequenza delle transazioni commerciali, e tentato di ricondurre tutte le azioni umane nell’ambito del mercato. tutto ciò ha condotto a una compressione fortissima nello spazio e nel tempo delle transazioni commerciali in quanto più è vasta l’estensione geografica e più è breve il termine dei contratti commerciali, meglio è. Le conseguenze culturali del trionfo di tale etica del mercato sono innumerevoli e di vasta portata. LEZIONE 14. HARVEY 2. LA TEORIA DEL NEOLIBERISMO 14.1. Introduzione 14.1.1. La libertà neoliberista e lo stato neoliberista: definizioni . per poter dominare pienamente il potere politico ha necessità di imporre un apparato concettuale, un modo di vedere il mondo che venga percepito dalla maggioranza della popolazione come ovvio, naturale, indiscutibile. . l’apparato concettuale neoliberista ha come suoi fondamenti due valori: la dignità umana e la libertà individuale, minacciati dal fascismo, dal comunismo e da tutte quelle forme di intervento statale che sostituiscono al libero arbitrio degli individui le decisioni collettive. . si tratta sicuramente di valori forti e attraenti, non solo negli Stati Uniti: a livello mondiale essi sono stati alla base di movimenti importanti del Novecento. . la concezione di libertà propria del neoliberismo è però molto specifica e ristretta, contrastante con altre concezioni: la libertà individuale è infatti un bene reso possibile anzitutto dalla libertà di mercato e di scambio e che deve essere garantito dall’apparato statale. . un apparato statale con caratteri anch’esso specifici, in quanto deve avere “come obiettivo fondamentale quello di garantire le condizioni ottimali per una redditizia accumulazione di capitale da parte degli investitori nazionali e stranieri”. . un apparato di questo genere, con queste caratteristiche e finalità viene definito da Harvey “stato neoliberista” e secondo lo stesso Harvey “le libertà che [esso] incarna riflettono gli interessi dei detentori della proprietà privata, delle imprese commerciali, delle multinazionali e dei capitali finanziari. 14.1.2. Il primo esperimento: Cile 1973 . il primo esperimento di stato neoliberista fu quello cileno successivo al golpe militare del 1973 appoggiato dalle elite economiche nazionale e dalle multinazionali americane col sostegno della Cia e del dipartimento di stato. . soffocata nel sangue la democrazia, “liberalizzato” il lavoro, smantellati i sindacati era necessario capire come rilanciare l’economia in un periodo di crisi internazionale. . la tradizionale strategia sudamericana era stata la sostituzione delle importazioni (sostegno alle imprese nazionali e dazi) aveva funzionato poco e non appariva praticabile. . si affidò il compito di individuare una strada nuova a un gruppo di economisti di Chicago, i quali imposero un modello che aveva come cardini: la revoca delle nazionalizzazioni la privatizzazione dei beni pubblici la liberalizzazione dello sfruttamento delle risorse naturali la privatizzazione della previdenza sociale l’agevolazione degli investimenti esteri e del libero scambio la piena libertà di esportare i profitti per le società estere il privilegiamento delle esportazioni sulla sostituzione delle importazioni . il modello consentì forti crescite per qualche anno e poi crollò anch’esso nel 1982 con la crisi del debito latinoamericano. . tale modello anticipò in forma sperimentale le politiche adottate pochi anni dopo, all’inizio degli anni ’80 da Margareth Thatcher in Gran Bretagna e da Ronald Reagan negli Stati Uniti. 14.1.3. Ma una genesi solo di rado violenta . se in Cile (come in Iraq trent’anni dopo) lo stato neoliberista è stato creato con la violenza e con l’attiva partecipazione statunitense, la sua diffusione mondiale è avvenuta soprattutto per via pacifica e in casi diversissimi tra loro, anche molto lontani dall’influenza americana, come per esempio in Cina. . la domanda è, dunque: “perché si è verificata tale svolta e quali forze l’hanno resa dominante all’interno del capitalismo mondiale?” 14.2. Perché la svolta 14.2.1. L’embedded liberalism . sappiamo ormai bene cos’è stato il keynesismo (o “compromesso socialdemocratico” o “embedded capitalism”): un “compromesso di classe tra capitale e lavoro”, una “commistione di stato, mercato e istituzioni democratiche che assicurasse la pace, l’allargamento della partecipazione, il benessere e la stabilità”. . quella che prevalse nel mondo capitalista fu insomma l’idea che lo stato dovesse porsi come obiettivi la piena occupazione, la crescita economica e il benessere dei cittadini e che il potere statale dovesse agire liberamente accanto ai meccanismi di mercato, se necessario addirittura sostituendosi a essi, al fine di conseguire tali obiettivi. . questo implicò che il liberalismo venisse irregimentato: intorno ai processi di mercato e alle attività imprenditoriali e aziendali esistesse una trama di restrizioni sociali e politiche e un contesto di regolamentazioni che a volte limitavano, ma in altri casi orientavano, la strategia economica e industriale. […] [al contrario] il progetto neoliberista mira a svincolare il capitale da queste limitazioni. 14.2.2. E la sua crisi . all’inizio degli anni ’60 questo modello cominciò a mostrare delle debolezze: ritorno della disoccupazione, stagnazione e aumento dell’inflazione. questa crisi strutturale, durata quasi tutti gli anni ’70 ridusse sensibilmente le entrate nel momento stesso in cui le spese statali continuavano a crescere a causa degli impegni dei governi e delle lotte sindacali e per i diritti. fu la crisi fiscale, di cui abbiamo parlato. . a ciò si aggiungeva la fine del sistema monetario di Bretton Woods con i conseguenti problemi di instabilità dei cambi. . apparve chiaro a un certo punto che l’“embedded liberalism” andava superato e si cercavano nuove soluzioni. . per un periodo una soluzione che apparve avere molte possibilità di realizzazione fu quella dell’ “estensione del controllo dello stato e la regolazione dell’economia tramite strategie corporative”, magari contenendo consensualmente le pretese delle classi popolari. ma questa radicalizzazione del keynesismo si dimostrò però “incompatibile con le necessità di accumulazione del capitale”. . a questo punto il il dibattito si polarizzò fra i fautori della socialdemocrazia e della pianificazione centralizzata e gli interessi di coloro che si preoccupavano di liberare il potere delle aziende e dell’attività economica e di ristabilire le libertà di mercato: o andare oltreil keynesismo, oppure tornare indietro rispetto ad esso. 14.2.3. Il prevalere della tendenza a un ritorno al capitalismo non regolato . nella seconda metà degli anni ’70 si profilò la vittoria dei secondi. si trattava concretamente di capire “come ricreare le condizioni per la ripresa di un’efficace accumulazione di capitale”. . il neoliberalismo, così come sperimentato in Cile, era in quel momento una risposta tra le altre possibili ma divenne a un certo punto “la” risposta, anche se ci vollero un po’ di anni per darne una definizione standardizzata (il “Washington consensus”). . il rovesciamento definitivo è avvenuto nella seconda metà degli anni ’90, quando due leader di partiti ex-keynesiani, Clinton e Blair, avrebbero potuto ben dire “oggi siamo tutti liberisti” laddove vent’anni prima un presidente di destra come Nixon aveva effettivamente detto “oggi siamo tutti keynesiani”. 14.2.4. Un’evoluzione non necessitata né lineare verso il predominio neoliberista, ma con una caratteristica di fondo condivisa . nonostante il processo che ha portato al trionfo del neoliberismo sia stato dunque un processo non lineare ma fatto di differenze tra le diverse situazioni nazionali e con esiti diversi ha avuto un elemento comune a tutti i casi: la neoliberalizzazione è stata fin dall’inizio un progetto mirante alla restaurazione del potere di classe. ovunque essa ha portato a una vertiginosa crescita dei redditi della parte più ricca della popolazione e una stagnazione se non un regresso dei redditi della gran parte della popolazione”. la ricchezza nazionale si è enormemente concentrata ai vertici della scala sociale e la forbice tra i redditi più alti e quelli più bassi si è allargata in modo formidabile. [vedere figure 1.3 e 1.4 del testo completo] . conclude Harvey È possibile quindi interpretare la neoliberalizzazione come un progetto utopico finalizzato a una riorganizzazione del capitalismo internazionale, oppure come un progetto politico per ristabilire le condizioni necessarie all’accumulazione di capitale e ripristinare il potere delle élite economiche. Nelle pagine che seguono sosterrò che ha prevalso nei fatti il secondo di questi obiettivi. La neoliberalizzazione non è stata molto efficace nel determinare una ripresa dell’accumulazione di capitale a livello globale, però è riuscita in misura considerevole a ripristinare - o in alcuni casi, come in Russia e Cina, a creare - il potere di un’élite economica. L’utopismo teorico delle argomentazioni neoliberiste ha funzionato in primo luogo come sistema di giustificazione e legittimazione di tutto ciò che doveva servire a raggiungere questo scopo. I dati suggeriscono inoltre che quando i principi neoliberisti si scontrano con la necessità di ripristinare o sostenere le élite dominanti, vengono abbandonati oppure talmente distorti da risultare irriconoscibili. Ciò non rappresenta una negazione del potere delle idee di produrre cambiamenti storico-geografici, ma indica senz’altro l’esistenza di una tensione creativa tra il potere delle idee neoliberiste e le pratiche diffuse di neoliberalizzazione che hanno trasformato il modo in cui negli ultimi trent’anni ha operato il capitalismo globale. 14.3. L’ascesa della teoria neoliberista 14.3.1. Le origini oscure del neoliberismo . noi oggi siamo di fronte a un tale trionfo della dottrina neoliberista, divenuta un’insieme di verità naturali, indiscutibili nei discorsi di quasi tutti i politici, i giornalisti, gli economisti che sorprende lo scoprire che gli inizi del neoliberismo sono oscuri e marginali e rimangono a lungo sotto traccia, come una specie di dottrina minoritaria per una setta di pochi eletti. . il neoliberismo nasce infatti nel 1947 in un ristrettissimo club di pensatori radicalmente contrari all’idea keynesiana, dominante a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, della necessità di controllare il ciclo economico mediante opportuni provvedimenti pubblici ed erano ancor più contrari all’idea della pianificazione pubblica dell’economia. . a loro avviso le decisioni dello stato erano destinate a peccare di parzialità politica a causa dell’influenza esercitata da gruppi di interesse ed erano necessariamente destinate a dimostrarsi errate in quanto le informazioni detenute dallo stato medesimo non erano in grado di competere con quelle offerte dai segnali del mercato. . questo impianto teorico aveva già in sé alcune contraddizioni cui se ne sono aggiunte altre al momento dell’applicazione pratica della dottrina, come vedremo, ma ciò non ha impedito la sua affermazione. . il gruppo di Mont Pélerin iniziò un lungo lavoro sotterraneo di alleanze, di elaborazione teorica e di proselitismo condotto grazie al generoso sostegno di diversi “miliardari e dirigenti d’azienda contrari a qualsiasi forma d’intervento e regolazione da parte dello stato come pure dall’internazionalismo”. 14.3.2. Anni settanta, il neoliberismo alla conquista del potere, fino alla coppia tatcher-reagan . nonostante il movimento rimase marginale fino agli anni ’70 quando riuscì a conquistare il centro della scena sia nel mondo della stampa e della politica, sia in quello delle università e della teoria economica. non a caso due fondatori della Società di Mont Pélerin, Hayek e Friedman, ottennero il premio Nobel per l’economia nel 1974 e nel 1976. . già negli anni ’70, quindi, la teoria e le ricette neoliberiste iniziarono a influenzare la politica, ma l’inizio della loro vera ascesa iniziò nel 1979 quando negli Usa e in Gran Bretagna trionfarono un presidente, Ronald Reagan, e un primo ministro, Margaret Tatcher, ormai convintamente neoliberisti. . la Tatcher iniziò immediatamente, infatti, a demolire con estrema risolutezza tutti i pilastri dello stato socialdemocratico: mise in discussione alla radice il potere di contrattazione dei sindacati attaccò “tutte le forme di solidarietà sociale che ostacolavano la flessibilità competitiva” (amministrazioni municipali, associazioni di professionisti) cercò di smantellare più welfare state possibile privatizzò le imprese pubbliche ridusse le tasse incoraggiò l’iniziativa imprenditoriale rendendola più agevole il che attirò cospicui investimenti stranieri, soprattutto giapponesi. . questa guerra all’ultimo sangue contro lo stato socialdemocratico si basò anche sulla diffusione di una visione estremamente radicale del mondo che ebbe grande risonanza. . fu lei a dire “there is no alternative”, non c’è alternativa, intendendo che tutto quanto stava facendo era l’unica cosa possibile e ragionevole da fare e non una precisa scelta politica. . fu lei a dire “non esiste la società, esistono solo gli individui”, intendendo che “tutte le forme di solidarietà sociale dovevano scomparire a favore dell’individualismo, della proprietà privata, della responsabilità individuale e dei valori familiari”. . la svolta neoliberista negli Stati Uniti invece implicò politiche monetariste (di per sé non neoliberiste, anche se di rottura rispetto al keynesismo) + politiche governative nel campo dei rapporti sindacali, del welfare, dell’intervento pubblico in economia. . tale svolta fu infatti incarnata a partire dal 1980 dalla presidenza di Ronald Reagan negli Stati Uniti, che riconfermò Volcker e le sue politiche monetariste ma di suo vi aggiunse deregolamentazioni tagli fiscali tagli ai bilanci attacchi ai sindacati attacchi alle categorie professionali . inoltre nominò a capo delle agenzie statali per l’ambiente, il lavoro e la sanità dei veri e propri smantellatori; deregolamentò interi settori in modo tale da renderli più profittevoli per le grandi compagnie; diede agevolazioni fiscali a chi investisse in stati tradizionalmente privi di sindacato, indebolendo in tal modo il tessuto produttivo di quelli a forte insediamento sindacale, permise e incoraggiò la delocalizzazione all’estero delle imprese americane innescando così vasti processi di deindustrializzazione e di impoverimento. . a livello fiscale: “le imposizioni fiscali per le aziende furono drasticamente ridotte e la tassa sulle persone fisiche, per la fascia di reddito più alta fu portata dal 70 al 28%, nell’ambito di quello che fu definito il più grande taglio fiscale della storia”. . tutto ciò era pensato per condurre ed effettivamente condusse a “un processo di trasformazione profonda in direzione di una maggiore sperequazione e di una restaurazione del potere economico delle classi alte”. 14.3.3. La planetarizzazione del neoliberismo: il debito e le politiche di aggiustamento strutturale . ma oltre alla svolta monetaria e alle drastiche politiche neoliberiste di Tatcher e Reagan vi fu un altro elemento che contribuì a favorire il trionfo neoliberista, le politiche di “aggiustamento strutturale”, derivate dal piazzamento presso i paesi del terzo mondo dell’enorme quantità di petrodollari che gli Usa avevano costretto i paesi arabi a depositare nelle proprie banche dopo il 1973 e che non era conveniente investire all’interno. . dalla metà degli anni Settanta la situazione debitoria di molti paesi del terzo mondo verso le banche Usa divenne drammatica e il rischio dell’insolvenza altissimo. . il governo Reagan pensò bene di approfittarne imponendo attraverso l’FMI stesso e la Banca mondiale delle misure di salvataggio in cambio di “riforme istituzionali come tagli alle spese dello stato sociale, leggi sul lavoro più flessibili, privatizzazioni. nacque così l’aggiustamento strutturale”, un formidabile e semplice veicolo per imporre le politiche neoliberiste a livello internazionale, vero pilastro della neoliberalizzazione del mondo. . l’effetto è stato un massiccio trasferimento di risorse e di profitti dal sud del mondo verso le banche e le imprese del nord del mondo. anzi, dirò di più: “La restaurazione del potere dell’élite economica, o dei ceti elevati, negli Stati Uniti e in altri paesi a capitalismo avanzato si è basata soprattutto sui surplus prelevati dal resto del mondo attraverso i flussi internazionali e le pratiche di aggiustamento strutturale”. 14.4. La prospettiva della libertà . concludendo (e ritornando alla discussione iniziale sulla libertà “speciale” dei neoliberisti) Harvey aggiunge, ricordando l’analisi di Karl Polanyi: L’idea di libertà «degenera così in un mero patrocinio della libera impresa», che significa «piena libertà per coloro che non hanno bisogno di veder crescere i propri redditi, il proprio tempo libero e la propria sicurezza, e una vera e propria carenza di libertà per la gente che invano potrebbe cercare di far uso dei propri diritti democratici per trovare protezione dal potere di quanti detengono le proprietà». Ma se, come sempre accade, «non è possibile una società in cui non siano presenti il potere e la costrizione, e neppure un mondo in cui la forza non abbia una funzione», allora l’unico modo in cui questa visione utopica liberale potrà essere sostenuta è con la forza, la violenza e l’autoritarismo. L’utopismo liberale o neoliberista è condannato, nella concezione di Polanyi, a essere frustrato dall’autoritarismo, se non dal fascismo vero e proprio. [...] Trent’anni di libertà neoliberiste, dopo tutto, non hanno solo restaurato il potere di [50] una classe capitalistica assai ben definita: hanno anche prodotto immense concentrazioni di potere aziendale nei campi dell’energia, dei media, dei prodotti farmaceutici, dei trasporti e del commercio al dettaglio (si pensi al caso della Wal-Mart). La libertà del i mercato, che secondo i proclami di Bush sarebbe il vertice delle aspirazioni umane, si rivela un comodo strumento per diffondere in modo indiscriminato il potere monopolistico aziendale e la Coca-Cola. Grazie a un’influenza spropositata sui media e sulla politica, questa classe (Rupert Murdoch e Fox News in testa) ha l’incentivo e il potere per persuaderci che stiamo meglio in un regime di libertà neoliberista. LEZIONE 15. HARVEY 3. IL CONSENSO AL NEOLIBERISMO E COME È STATO COSTRUITO 15.1. costruire il consenso 15.1.1. Il problema della creazione del consenso e la costruzione di un senso comune . abbiamo detto che una politica economica finalizzata alla redistribuzione del potere e della ricchezza verso le classi alte in qualche caso è stata imposta con la violenza, ma nella maggior parte dei casi è passata per via democratica, attraverso il consenso della maggior parte degli elettori. . come è potuto avvenire tutto questo? chi ha costruito, insomma, il neoliberismo, chi lo ha imposto? . in Cile e in Argentina , lo abbiamo detto, un colpo di stato borghesia locale-Stati Uniti ma in Gran Bretagna e negli Stati Uniti non era possibile fare la stessa cosa: bisognava necessariamente creare un consenso tale da garantire una vittoria elettorale sicura. . per creare un consenso di tale portata era necessario costruire un “senso comune”, cioè un senso condiviso da molti, non razionale, ragionato, bensì fondato su un’intensa opera di convincimento capace di creare dei veri e propri pregiudizi. insomma, delle visioni del mondo molto semplici, molto solide, scarsamente attaccabili dal ragionamento e che suscitano immediatamente il consenso. per gli americani, ad esempio, la parola “libertà” suscita subito una reazione positiva, a prescindere dal contenuto. . come si è detto il consenso neoliberista si è costituito utilizzando diversi strumenti. gli slogan della Mont Pélerin Society sono stati veicolati nel corso di una lunga marcia inziata nel 1947 attraverso i ricchi think tank, segmenti importanti dei mezzi di comunicazione di massa, cattedre universitarie, chiese, associazioni professionali. . da qui sono penetrati e hanno conquistato i partiti politici e infine sono divenuti slogan, ideologie di stato. . è evidente che questa conquista del consenso non è stata realizzata dichiarando apertamente che si intendeva ricostruire il potere economico di una ristretta élite perché ciò non avrebbe potuto funzionare. 15.1.2. La scissione del libertarismo dalla giustizia sociale nei movimenti dei sessanta . un elemento molto importante della costruzione del consenso al neoliberismo è stata l’esperienza quotidiana, cioè il modo in cui le persone percepiscono se stessi e la propria vita di tutti i giorni. . bisogna a questo punto ricordare che gli anni Sessanta erano stati attraversati in tutto il mondo da grandi movimenti che rivendicavano contemporaneamente maggiori libertà personali e maggiore giustizia sociale. ciò che apparve presto evidente fu che queste due rivendicazioni potevano non essere del tutto compatibili, potevano confliggere tra loro in quanto, spiega Harvey, “il perseguimento della giustizia sociale presuppone solidarietà sociali e una propensione a sublimare le esigenze, i bisogni e i desideri individuali nell’ambito di una lotta più generale, per esempio per l’uguaglianza sociale o la giustizia ambientale”. . con la sua enfasi sulla libertà individuale il neoliberismo fu appunto in grado di sollecitare e di esaltare la forte spinta libertaria degli anni Sessanta e di utilizzarla ai propri fini dopo averla separata dalla spinta verso la giustizia sociale. . il desiderio di libertà e di liberazione che così fortemente contraddistingueva i movimenti degli anni ’60 e induceva a lottare contro l’autoritarismo dello stato e l’oppressione dell’impresa capitalista ha insomma fatto passare in secondo piano la necessità di disciplina, di solidarietà e di sacrificio che la lotta contro l’ingiustizia sociale impone. 15.2. Il caso degli Stati Uniti 15.2.1. La battaglia delle idee come battaglia collettiva degli imprenditori usa . gli imprenditori americani, a partire dai primi anni ’70 e con alla testa la Camera di Commercio, iniziarono un’operazione di compattamento interno, di pressione sul parlamento e di convincimento dell’opinione pubblica. . chi lanciò la campagna pose subito anche il problema dell’utilizzo a questo fine delle strutture dello stato. pur ostile a un’estensione dei compiti dello stato, egli pensava che le imprese dovevano “coltivare assiduamente” i rapporti con lo stato e usarlo quando necessario in modo “aggressivo e determinato” al fine di riformulare il senso comune in senso neoliberista. . ma in che modo? 15.2.2. Il caso statunitense 1. l’esperimento newyorkese . un esempio di un buon modo di utilizzare il potere dello stato per allargare l’influenza del neoliberismo fu il caso della crisi fiscale della città di New York già alla metà degli anni ’70. . già negli anni ’60 la metropoli era in crisi di deindustrializzazione e le zone centrali erano fortemente impoverite. covava molta frustrazione e della rivolta sociale. si pensò di rispondere dando più lavoro e più assistenza grazie alla disponibilità di fondi federali. . il taglio di questi fondi o di una parte di essi sotto l’amministrazione del presidente Nixon condusse a un grave squilibrio tra spese e introiti fiscali. . per un po’ le istituzioni finanziarie accettarono di colmare il divario tra entrate e uscite, ma da un certo momento in poi le banche, con in testa la potente Citibank decisero di mandare coscientemente la città alla bancarotta per poi assumere direttamente il controllo del bilancio cittadino. . una volta fatto questo, esse decisero che gli introiti dovevano anzitutto ripagare i creditori, poi con quanto rimaneva si sarebbe pensato al resto. ciò significò, d’improvviso: messa sotto controllo dei sindacati municipali congelamento dei salari tagli al pubblico impiego tagli ai servizi sociali servizi fino ad allora gratuiti, ora a pagamento obbligo per i sindacati di investire i propri fondi pensione in obbligazioni della città . questi provvedimenti avevano tutta l’aria di un colpo di stato da parte delle istituzioni , finanziarie contro il governo democraticamente eletto della città di New York; ed ebbe la stessa efficacia di quello precedentemente compiuto in Cile. Nel bel mezzo di una crisi fiscale, la ricchezza fu ridistribuita alle classi alte. La crisi di New York fu, sostiene Zevin, sintomatica di una «emergente strategia di disinflazione accompagnata a una ridistribuzione regressiva di redditi, ricchezza e potere». Fu «una battaglia iniziale, forse decisiva, di una nuova guerra», che aveva lo scopo di «dimostrare agli altri che ciò che stava accadendo a NewYork poteva accadere, e in alcuni casi sarebbe poi di fatto accaduto, anche a loro». . il lucido obiettivo del colpo di mano era quello di avviare in una metropoli importante e prestigiosa a livello mondiale come New York un radicale esperimento di ritorno a politiche e soprattutto a rapporti economici e sociali pre-rooseveltiani, prekeynesiani. il segretario al tesoro del presidente Ford dichiarò ad esempio che le condizioni per salvare la città avrebbero dovuto essere “così punitive, l’esperienza complessiva così penosa che nessuna città, nessuna parte politica sarebbe mai stata tentata di percorrere la stessa strada”, cioè di continuare a fare politiche di tipo keynesiano. . New York divenne così l’epicentro della neoliberalizzazione della cultura e una delle città simbolo del neoliberismo medesimo: “Nel frattempo i banchieri d’investimento ricostruivano l’economia della città intorno alle attività finanziarie, a quelle ausiliarie come i servizi legali e i media e al consumismo differenziato”. . conclusione: come il Cile, ma molto più e soprattutto molto meglio del Cile, la New York della metà degli anni fu un grande laboratorio di sperimentazione delle politiche neoliberali. anzi, per essere più precisi: 15.2.3. Il caso statunitense 2. la neoliberalizzazione del partito repubblicano e la creazione di una solida base elettorale: l’alleanza con la destra cristiana fondamentalista . le iniziative della Camera di Commercio erano una svolta per il capitalismo statunitense: da imprese che facevano pressione individualmente su singole questioni a una potente organizzazione corporativa che si poneva degli obiettivi politici generali. . ma questo non era ancora sufficiente: serviva uno strumento politico ancor più potente ed efficiente. lo strumento individuato fu il partito repubblicano, che fu convinto ad adottare la dottrina neoliberista e i cui candidati vennero ampiamente finanziati grazie a nuove leggi elettorali. . il tutto mentre i democratici rimanevano perplessi, tra una base tradizionalmente keynesiana e il timore di perdere l’appoggio delle imprese, ora convertitesi al neoliberismo. . convinti i vertici repubblicani, si trattava di creare una salda base elettorale che introiettasse i principi e gli slogan neoliberisti. . un passo importante per far ciò fu l’alleanza con la destra cristiana, che dal 1978 aveva anch’essa iniziato a organizzarsi politicamente. . la destra cristiana aveva la sua base nei dei lavoratori bianchi convinti di essere vittime di un’ingiustizia morale dovuta al fatto che questa classe viveva: in condizioni di insicurezza economica cronica e si sentiva esclusa da molti dei benefici distribuiti attraverso i provvedimenti in favore delle minoranze e altri programmi statali. questi erano stati convinti a mobilitarsi sulla base di un misto di nazionalismo, di religiosità molto rigida, di omofobia, di razzismo e di antifemminismo. li si era insomma convinti che il loro problema non era costituito dal capitalismo e dalla neoliberalizzazione della cultura, ma dai keynesiani che avevano abusato del potere statale per avvantaggiare gruppi specifici (i neri, le donne, gli ambientalisti ecc.). insomma si era riusciti a mobilitare le loro paure e il loro disagio per farli pensare e votare contro i loro stessi interessi. e con notevole successo. . a questo punto il Partito repubblicano poteva mobilitare ingenti risorse finanziarie e chiamare la sua base popolare a votare contro i propri interessi materiali per motivi culturali e religiosi, mentre il Partito democratico non poteva permettersi di pensare alle necessità materiali della sua base popolare tradizionale (per esempio a un sistema nazionale di assistenza sanitaria) per paura di intaccare gli interessi della classe capitalista. Data l’asimmetria, l’egemonia politica del Partito repubblicano divenne più salda 15.2.4. Il caso statunitense 3. il neoliberismo al governo e all’opera . una volta al potere con Reagan, dal 1980, i neoliberisti iniziarono a eliminare progressivamente le regolamentazioni in campo industriale, ambientale, del lavoro, della sanità, del consumo qualche volta in modo diretto, abrogando i regolamenti, più spesso mediante tagli di bilancio che impedivano l’applicazione dei regolamenti oppure incaricando della loro applicazione personaggi che avevano in compito reale di boicottarli. . oltre alle deregolamentazioni molte delle altre cose attivamente realizzate da Reagan le abbiamo già incontrate e le incontreremo sistematicamente in seguito, in altri periodi e in altri paesi come la detassazione delle società e dei redditi e dei patrimoni più alti, la cessione di beni pubblici a prezzi stracciati o a titolo gratuito, l’attacco al potere dei sindacati e ai diritti sindacali, con vari mezzi, per ottenere manodopera più docile e salari più bassi oppure, in casi estremi, per ottenere piena libertà di chiudere e delocalizzare nei paesi poveri. 15.2.5. Il caso statunitense 4. una teoria economica in soccorso e a giustificazione dei provvedimenti neoliberisti . tutti o quasi tutti questi erano provvedimenti che rompevano con una lunga e gloriosa tradizione e infliggevano sofferenze sociali profonde. . a maggior ragione, quindi, era necessario provare a giustificarli e fare in modo che tali giustificazioni divenissero condivise dal maggior numero di cittadini possibile, magari come teorie “naturali” non discutibili. . i concetti economici del neoliberismo furono una miscela di varie teorie che condividevano però l’idea di base che “l’intervento del governo rappresentava il problema e non la soluzione e che una politica monetaria stabile e tagli fiscali radicali per le fasce più alte avrebbero prodotto un’economia più sana”. . queste idee furono accolte pienamente da importanti giornali, furono propagandate con molti libri pubblicati e promossi attivamente grazie al denaro dei think tank, furono adottate e rilanciate in molte importanti scuole di gestione aziendale come quelle delle università di Stanford e Harvard. è importante osservare che agli inizi degli anni ’90 gran parte dei dipartimenti di economia delle maggiori università americane aveva adottato la visione neoliberista dell’economia: in vent’anni, insomma l’egemonia della teoria economica keynesiana era stata quasi completamente scalzata dall’egemonia di una teoria opposta. 15.2.6. Il caso statunitense 5. morale “Durante gli anni settanta l’ala politica del settore privato della nazione” scrive Edsall “mise in atto una delle più imponenti campagne per la conquista del potere che si siano registrate nella storia recente”. All’inizio degli anni ottanta “aveva raggiunto un livello di influenza e di potere che si avvicinava a quello del boom degli anni venti”. E nel 2000 aveva già usato quel potere per riportare la sua quota della ricchezza e del reddito nazionale a livelli che non si vedevano dagli anni venti. 15.3. Il caso della Gran Bretagna 15.3.1. Il caso britannico 1. gb e usa a confronto . il caso britannico è importante sia perché è contemporaneo a quello statunitense, sia perché anche la Gran Bretagna ha avuto un ruolo importante nella diffusione mondiale del neoliberismo. . il caso inglese è interessante anche perché è piuttosto diverso da quello americano. . qui il welfare e l’intervento pubblico in economia erano anzitutto molto più estesi e robusti. . sappiamo che grazie al Piano Beveridge e ai governi laburisti che si erano succeduti dopo la guerra molte imprese erano state nazionalizzate, si era creato uno stato sociale molto ramificato ed efficace e i sindacati godevano di un grande potere. 15.3.2. Il caso britannico 2. i germi dell’indebolimento del keynesismo e il flagello della stagflazione . anche qui le correnti ostili alle politiche keynesiane erano tutto sommato marginali. . ma qui la cultura giovanile pop degli anni Sessanta sviluppò un rigetto tale verso le forme di potere costituito (aristocratico e borghese, ma anche sindacale) e verso la politica organizzata che diede senza volerlo un grande aiuto a coloro che volevano diminuire l’influenza dei partiti e dei sindacati sulla vita pubblica, anche in nome di ideali tutt’altro che aperti e libertari. . l’esponente politico che portò al successo il neoliberismo - e che è anzi considerato uno dei leaders storici del neoliberismo a livello mondiale - fu Margaret Thatcher, che vinse le elezioni nel 1979 con un programma estremamente radicale e aggressivo e riuscì in gran parte - ma non del tutto - a realizzarlo nel corso dei dieci anni successivi. 15.3.3. Il caso britannico 3. il flagello della stagflazione . vista la solidità, anche in termini di consensi e di tradizione, dell’impostazione keynesiana britannica “il fenomeno Thatcher non sarebbe nato, e certo non avrebbe avuto successo, senza la grave crisi dell’accumulazione di capitale durante gli anni settanta”. . a metà anni ’70 l’inedita combinazione di stagnazione e inflazione rendeva sempre più difficile il compito di sostenere adeguatamente le imprese pubbliche e di mantenere alti i salari dei loro dipendenti. ciò scatenò forti proteste sindacali che fecero cadere nel 1974 il governo conservatore e che nel 1978 provocò un’imponente ondata di scioperi del settore pubblico con una coda di grandi disagi collettivi. . in questa drammatica situazione il tradizionale appoggio popolare a lavoratori e sindacati si ridusse sensibilmente e la Thatcher, con un programma di attacco frontale al sindacato del settore pubblico, riuscì facilmente a vincere le elezioni nel 1979. 15.3.4. il caso britannico 4. la mannaia antisindacale e antilaburista della tatcher . al pari di Reagan negli Stati Uniti, la Thatcher avviò un programma di indebolimento del potere sindacale; parallelamente, la scelta di favorire un innalzamento dei tassi d’interesse ebbe come conseguenza un’ondata di disoccupazione che indebolì ulteriormente tutti i sindacati - quando c’è molta disoccupazione i sindacati sono in genere deboli e quando arriva la disoccupazione spesso chi viene scacciato dal posto di lavoro sono proprio i lavoratori più sindacalizzati. . con una serie di manovre congiunte la Thatcher smantellò grandi pezzi di industria nazionalizzata - e con essa i suoi sindacati - favorendo l’ingresso nel Regno Unito di imprese straniere. . nel giro di tre anni, il Regno Unito si trasformò in un paese di salari relativamente bassi con una forza lavoro molto arrendevole rispetto al resto d’Europa. Quando la Thatcher lasciò la sua carica […] aveva sradicato l’inflazione, piegato i sindacati, domato i lavoratori e costruito progressivamente il consenso della classe media alle sue politiche. . naturalmente la Thatcher di privatizzare tutte le imprese pubbliche, magari svendendole, e si impegnò in un attacco altrettanto duro contro lo stato sociale, il welfare. 15.3.5. il caso britannico 4. il limite: un welfare non semplice da corrodere . qui le cose non le andarono altrettanto bene. programma thatcheriano di smantellamento dell’intervento pubblico nel campo dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria, dei servizi sociali, della burocrazia statale e del sistema giudiziario si infranse contro diverse tenaci resistenze, sia tra gli avversari ma anche tra gli alleati: “per gli inglesi - dice Harvey -c’erano dei limiti alla liberalizzazione generalizzata”. 15.3.6. il caso britannico 5. comunque, cambiamenti economico- istituzionali dalle conseguenze profonde . questo fallimento (relativo) non vuol dire che la Thatcher non sia riuscita a cambiare il volto culturale e politico della società britannica. . essa ha anzitutto governato per dieci anni propugnando apertamente una versione estrema del neoliberismo (“non esiste la società ma solo individui”; “non c’è alternativa” i suoi slogan preferiti, ben più radicali e consapevoli di quelli americani) riuscendo a indebolire e a rendere marginale da un lato tutto il mondo solidale della classe lavoratrice inglese trasformandone gran parte in classe media consumatrice individualizzata e passiva; da un altro lato ha favorito l’ascesa di un nuovo ceto di potere legato alla finanza internazionale che non sempre coincideva con il vecchio potere aristocratico. 15.3.7. il caso statunitense e quello britannico: riassumendo “Reagan e la Thatcher colsero le opportunità che si erano presentate negli anni precedenti (dal Cile a New York) e si posero alla testa di una classe decisa a ripristinare il proprio potere. Il loro punto di forza è consistito nel creare un’eredità e una tradizione in grado di condizionare i politici successivi, imponendo loro una serie di costrizioni cui non potevano sottrarsi facilmente. Quelli che sono venuti dopo, come Clinton e Blair, hanno potuto fare poco altro, se non continuare l’opera di neoliberalizzazione, che a loro piacesse o no”. LEZIONE 16. HARVEY 4. LO STATO NEOLIBERISTA 16.1. introduzione . come sappiamo, secondo la dottrina neoliberista lo stato deve ridurre al minimo il suo intervento, soprattutto in economia. . ciononostante - come pure sappiamo già - il rapporto tra neoliberismo e stato non è solo un rapporto di ostilità, ma anche un rapporto di collaborazione, a volte molto stretta il che determina una contraddizione tra la teoria neoliberista e la sua pratica concreta. . inoltre la pratica (cioè i numerosi esempi nazionali presentati nei capitoli 4 e 5 che noi saltiamo) dimostra che ci sono casi molto diversi tra loro, il che fa pensare che il neoliberismo possa essere un fenomeno in parte instabile e contraddittorio. 16.2. lo stato liberista in teoria 16.2.1. lo stato neoliberista: i suoi compiti . esiste anzitutto una teoria neoliberista di cosa dovrebbe essere e fare lo stato. . secondo la teoria neoliberista lo stato dovrebbe favorire: a) il diritto individuale alla proprietà privata b) il primato della legalità c) l’istituzione di mercati in grado di funzionare liberamente d) il libero scambio. . la struttura legale privilegiata è quella degli obblighi contrattuali liberamente negoziati nel mercato tra individui giuridici . il principale compito dello stato è di proteggere a tutti i costi e se necessario con la violenza a) tali contratti b) i diritti individuali, alla libertà d’azione, di espressione e di scelta c) la libertà delle imprese commerciali e delle grandi aziende di operare all’interno della struttura istituzionale di liberi mercati e libero scambio. . così facendo - secondo la teoria - lo stato incoraggia le imprese a investire, a fare innovazione tecnologica, ad aumentare in tal modo la produttività, cosa che a sua volta garantisce la crescita della ricchezza e quindi un livello di vita più alto per tutti, non solo per gli imprenditori. . in questa forma specifica il neoliberismo non è più solo una teoria economia o una opzione di politica economica tra le tante, ma diviene una ricetta di arricchimento generalizzato non discutibile, una grande promessa per tutta l’umanità priva di alternative credibili. 16.2.2. lo stato neoliberista e la privatizzazione . un altro compito fondamentale dello stato neoliberista è quello della privatizzazione: . secondo i neoliberisti, la privatizzazione e la deregolamentazione, combinate con la competizione accrescono l’efficienza e la produttività, migliorano la qualità e riducono i costi, sia direttamente. presso il consumatore, perché prodotti e servizi costano meno, sia indirettamente, per via della riduzione del peso fiscale. 16.2.3. lo stato neoliberista e i suoi risvolti culturali sulla vita dei singoli individui . un altro effetto dello stato neoliberista si dispiega nella sfera mentale, culturale: una volta garantita la libertà personale e individuale nel mercato, ciascun individuo è ritenuto infatti responsabile delle proprie azioni e del proprio benessere, e può essere chiamato. a risponderne. […] Il successo o l’insuccesso individuale vengono così sempre più interpretati in termini di doti imprenditoriali o di fallimenti personali invece di essere attribuite il qualche caratteristica (magari perversa) del sistema. 16.2.4. stato neoliberista contro democrazia? . si badi però che l’enfasi sulla libertà non vuol dire un’accettazione piena e convinta della democrazia, come ci si potrebbe attendere in quanto il “governo basato sulla regola della maggioranza è visto come una minaccia potenziale ai diritti individuali e alle libertà costituzionali; i neoliberisti tendono quindi a favorire l’egemonia degli esperti e delle élite. esiste una netta preferenza per l’esercizio del governo tramite decreti esecutivi e decisioni giudiziarie, piuttosto che tramite il processo decisionale democratico e parlamentare”. 16.3. Tensioni e contraddizioni . ma la teoria neoliberista nasconde anche vere e proprie contraddizioni che rendono estremamente difficoltoso, se non impossibile realizzare uno stato neoliberista del tutto coerente con la dottrina del movimento. . Harvey ne elenca qui quattro, ma io mi soffermo solo sull’ultima di esse, che si ricollega a quanto appena detto sul contrasto tra neoliberismo e democrazia. . l’individualismo possessivo può entrare in contraddizione col diffuso desiderio delle persone di organizzarsi e di scegliere liberamente. ciò crea spesso delle situazioni a loro volta contraddittorie. . Harvey scrive infatti che i neoliberisti devono imporre limitazioni sostanziali al governo democratico e affidarsi, soprattutto per certe decisioni cruciali, a istituzioni non democratiche e non tenute a rendere conto dei propri atti (come l’FMI) col risultato paradossale di massicci interventi dello stato e un governo affidato alle élite e agli «esperti» in un mondo in cui lo stato non dovrebbe essere interventista. […] Di fronte a movimenti sociali che chiedono interventi collettivi, quindi, lo stato neoliberista è costretto a intervenire, a volte in modo repressivo, negando così proprio quella libertà che dovrebbe difendere. 16.4. Lo stato liberista nella pratica . tutte queste contraddizioni interne alla teoria rendono dunque difficile dare una definizione precisa e univoca dello stato neoliberista e realizzarlo concretamente. . ma a rendere ancora più difficile questa impresa sta il fatto che: . esiste anche un grandissimo numero di altre divergenze tra la teoria e le sue applicazioni. . l’evoluzione del processo di neoliberalizzazione ha costretto i neoliberisti stessi a introdurre notevoli aggiustamenti da un posto all’altro e da un periodo all’altro. . nonostante una definizione precisa e univoca dello stato neoliberista sia dunque impossibile, si possono comunque individuare alcuni elementi ricorrenti, alcune situazioni in cui “nelle quali la pratica tradisce sistematicamente la teoria” e in particolare quella parte della teoria che cerca di accreditare le politiche neoliberiste come uniche vere garanti del massimo di benessere collettivo. . ciò accade per esempio quando tipico stato neoliberista tende a schierarsi a favore di un clima propizio all’attività economica e contro i diritti collettivi (e la qualità della vita) dei lavoratori, oppure contro la capacità dell’ambiente di rigenerarsi. . oppure accade quando, in caso di conflitto, gli stati neoliberisti tendono ad anteporre l’integrità del sistema finanziario e la solvibilità delle istituzioni finanziarie al benessere della popolazione o alla qualità dell’ambiente. . o ancora quando la neoliberalizzazione deve operare in ambienti in cui il keynesismo è molto solido e possono realizzarsi soltanto in parte. . il settore in cui la pratica contraddice più sistematicamente la teoria neoliberista è però quello del capitale e delle istituzioni finanziarie. questo è un punto di estrema importanza e soprattutto profondamente attuale . dice Harvey: Normalmente gli stati neoliberisti favoriscono la crescita dell’influenza delle istituzioni finanziarie attraverso la deregolamentazione, ma oltre a ciò fin troppo spesso arrivano a garantire a qualsiasi costo l’integrità e la solvibilità delle istituzioni finanziarie. Questo impegno deriva in parte […] dal fatto che si ci affida al monetarismo come elemento fondamentale della politica statale, e l’integrità e validità del denaro è cruciale per una simile politica. Ma questo paradossalmente significa che lo stato neoliberista non può tollerare nessuna grave inadempienza finanziaria anche quando sono state le stesse istituzioni finanziarie a prendere decisioni sbagliate. Lo stato deve farsi avanti e sostituire il denaro «cattivo» con il proprio denaro, che si suppone «buono», e questo spiega la pressione sulle banche centrali perché tengano viva la fiducia nella validità del denaro dello stato. Il potere statale è spesso stato usato per togliere dai guai aziende o evitare fallimenti commerciali. […] L’FMI di fatto copre, per quanto gli è possibile, i rischi e le incertezze nei mercati finanziari internazionali. Questa prassi è difficile da giustificare secondo la teoria neoliberista, visto che in linea di principio gli investitori dovrebbero essere responsabili dei loro errori. […] Questa prassi - dare la priorità alle esigenze delle banche e delle istituzioni finanziarie penalizzando i livelli di vita del paese debitore - era già stata messa alla prova durante la crisi debitoria della città di New York. Nel contesto internazionale ciò significava ricavare surplus dalle popolazioni povere del Terzo Mondo per ripagare i banchieri internazionali. . gli stati più ricchi, insomma difendono gli interessi delle proprie banche quando queste “risucchiano i surplus provenienti da altre aree” e ciò consolida ancor più la tendenza alla concentrazione di potere nelle mani dei detentori della ricchezza finanziaria. . ciò dimostra bene come l’utilizzo delle strategie neoliberiste attraverso i poteri dello stato serva molto più a concentrare potere che non a far funzionare correttamente l’economia. se infatti in questi casi i principi neoliberisti venissero rispettati sarebbe punito con gravi perdite chi presta danaro in modo incauto e non chi lo prende a prestito, mentre in questo caso avviene esattamente il contrario: è lo stato che fa sì che chi presta il denaro sia sempre al sicuro, qualsiasi cosa faccia, anche la più sconsiderata e perfino delinquenziale. . ci sono naturalmente dei limiti alla possibilità di spremere i debitori, per cui una strategia che è necessario a volte adottare è quella della parziale cancellazione del debito nella speranza di recuperare qualcosain cambio delle politiche di “aggiustamento strutturale”, che abbiamo già visto. . di queste politiche hanno fatto parte in modo sistematico delle ristrutturazioni del mercato del lavoro finalizzate: a) ridurre le retribuzioni dei lavoratori b) accrescere l’insicurezza riguardo alla stabilità del posto di lavoro c) eliminare numerosi benefici tradizionalmente associati al posto d) eliminare gran parte delle garanzie tradizionalmente associate al lavoro. . questa flessibilizzazione e precarizzazione estrema del lavoro e il progressivo abbattimento del welfare hanno come effetto congiunto di esporre “strati sempre più vasti della popolazione all’impoverimento”. 16.4.1. la modificazione della governance . per poter imporre efficacemente cambiamenti economici, sociali e culturali di questa portata è stato necessario modificare la natura della decisione politica, sostanzialmente in senso meno democratico, magari attraverso il meccanismo delle partnership pubblico-privato: non sono solo più le istituzioni pubbliche, democraticamente elette, a decidere bensì dei circoli formati in parte da eletti, in parte da tecnici e in parte da imprenditori . in conseguenza di questa trasformazione lo stato produce leggi e strutture normative che avvantaggiano le aziende, e in alcuni casi interessi specifici come quelli legati all’energia, alla produzione farmaceutica, alle imprese agricole. In molti casi di partnership tra pubblico e privato, in particolare a livello municipale, lo stato si assume buona parte dei rischi mentre il settore privato ricava gran parte dei profitti. Se necessario, poi, lo stato neoliberista ricorre a leggi coercitive e a tattiche poliziesche (norme contro i picchettaggi, per esempio) per disperdere o reprimere le forme collettive di opposizione alle grandi aziende. . anche in questo caso ci troviamo di fronte a una contraddizione evidente tra pratica dello stato neoliberista e teoria neoliberista in quanto non viene rispettata, anzi viene calpestata la pretesa eguaglianza di partenza tra i vari soggetti economici. . il neoliberismo - insomma - non rende irrilevante lo stato, ma piuttosto lo ridisegna . possiamo inoltre concludere che il liberismo sia una forma politica instabile e transitoria anzitutto a causa della contraddizione sempre più evidente tra scopi dichiarati (benessere di tutti) e risultati effettivi (restaurazione del potere di classe). . a questo proposito si deve aggiungere che lo scollamento di teoria e prassi si nutre anche di altre cinque contraddizioni minori: 1. lo stato stia in disparte e al tempo stesso lo stato intervenga per “creare il clima favorevole”. 2. la proclamazione di ideali di libertà individuale va di pari passo con l’autoritarismo nell’imposizione del mercato. 3. l’individualismo irresponsabile degli attori risulta cruciale per preservare l’integrità del sistema finanziario ma al tempo stesso produce volatilità speculativa, scandali finanziari e instabilità cronica. 4. si esalta la competizione ma si creano nei fatti poteri sempre più oligopolistici se non monopolistici 5. a livello di costumi, di mentalità, di abitudini presso la gente comune la spinta verso la libertà di mercato e la trasformazione di ogni cosa in merce può facilmente impazzire e produrre incoerenza sociale. 16.5. La risposta neoconservatrice . tutte le difficoltà e le contraddizioni sinora evidenziate fanno pensare, ripeto, che lo stato neoliberista sia intrinsecamente instabile e destinato ad essere prima o poi superato. . come potrebbero fare, però, le classi dirigenti attuali a superarlo senza modificare i rapporti di potere così faticosamente conquistati? . quella neoconservatrice è una risposta che al 2005, al momento della stesura del libro, sembrava molto praticata, ma che in effetti si è dimostrata anch’essa fragile in quanto negli anni seguenti è stata abbandonata in alcuni dei paesi dove si era affermata, primo fra tutti gli USA. . in cosa consisteva e in cosa consiste ancora tale risposta? . quella neoconservatrice è una visione che non coincide del tutto con quella neoliberista. . esse concordano su: a) potere alle grandi aziende; b) restaurazione del potere di classe; c) sfiducia nella democrazia; d) governo delle élite; e) libertà di mercato. . ma discordano totalmente dai neoliberisti sull’enfasi posta sulla priorità degli interessi individuali e sul disinteresse per qualsiasi forma di morale collettiva. . ma i neoconservatori discordano dai neoliberisti riguardo alla priorità degli interessi individuali e al disinteresse per qualsiasi forma di morale collettiva e propugnano quindi: a) l’ordine sociale come argine al caos degli interessi individuali; b) una morale esasperata come collante sociale per mantenere lo stato forte. . con loro si torna a una centralità dello stato come monopolio della forza e come grande dispiegamento poliziesco, sia interno che internazionale. . per loro il consenso deve essere costruito non tanto attorno a dogmi economici ma a un complesso coerente di valori morali, quelli - per la precisione - che dagli anni Settanta in poi hanno fatto leva sui sentimenti dei ceti operai bianchi scontenti: nazionalismo culturale, virtù morale, cristianesimo di un certo tipo evangelico, famiglia e diritto alla vita, e sull’opposizione ai nuovi movimenti sociali come il femminismo, i diritti degli omosessuali, la tutela dei diritti delle minoranze e l’ambientalismo. . negli Stati Uniti questo compattamento ha funzionato, ha modificato radicalmente l’identità politica del Partito Repubblicano e ha garantito le vittorie di Reagan prima e di Bush padre e figlio poi. ancor oggi il nucleo più forte di opposizione a Obama è costituito dai cosiddetti “tea party” che sono una forma molto estrema di neoconservatorismo. . ma ciò è avvenuto anche altrove: in Italia il moralismo nazionalista, omofobo, antifemminista, razzista è stato efficacemente coltivato sia dagli ex missini, sia dai berlusconiani, sia soprattutto dai leghisti. anche se con minor coerenza, estremismo e reale efficacia che negli Stati Uniti. . tutto questo, però, introduce ulteriori contraddizioni interne e ulteriori incoerenze nel già contraddittorio impianto neoliberista e ulteriori tensioni tra la teoria e la pratica di governo. LEZIONE 17 HARVEY 5. FORZE E FLUSSI . analizzati questi casi nazionali [cioè del capitolo 4, che abbiamo omesso] appare che l’irregolarità nello sviluppo dovrebbe quindi essere dovuta a: a) diversificazione, innovazione, competizione (a volte di tipo monopolistico) tra modelli di governance b) imposizioni di qualche potenza egemonica esterna . ma se si guarda meglio si vedono altri fattori ancora, alcuni veri ma un po’ banali: il legame tra l’efficacia delle idee neoliberiste (ritenuta particolarmente forte nei casi della Gran Bretagna e del Cile), la necessità di rispondere a crisi finanziarie di vario genere (come in Messico e nella Corea del Sud) e un approccio più pragmatico alle riforme dell’apparato statale (come in Francia e in Cina) per migliorare la posizione competitiva nel mercato globale . mentre quasi nessuna attenzione viene dedicata ad altri fattori o ipotesi: che le idee dominanti possano essere quelle di una classe dominante [pur esistendo] prove evidenti che attestano interventi pesanti da parte degli interessi delle élite economiche e finanziarie nella formazione di idee e ideologie, tramite investimenti nei think-tanks, formazione di tecnocrati e controllo dei media; la possibilità [inoltre] che le crisi finanziarie possano essere provocate da offensive del capitale, fughe di capitale o speculazioni finanziarie, o che certe crisi finanziarie vengano architettate proprio per facilitare l’accumulazione tramite esproprio, [ipotesi che] viene liquidata come troppo macchinosa, anche di fronte agli innumerevoli segnali che fanno sospettare attacchi speculativi coordinati contro questa o quella valuta. le condizioni del contesto e gli assetti istituzionali, che variano molto i mutamenti dei rapporti tra le classi in uno specifico stato costituiscono pure un fattore determinante: ad esempio indebolire (come in Gran Bretagna e negli Stati Uniti), scavalcare (come in Svezia) o distruggere violentemente (come in Cile) il potere sindacale è una precondizione necessaria alla neoliberalizzazione ancora: la neoliberalizzazione spesso è stata una conseguenza dell’aumento del potere, dell’autonomia e della coesione di imprese e aziende e della loro capacità di esercitare, in quanto classe, sollecitazioni sul potere dello stato: uesta capacità viene esercitata generalmente in modo diretto, tramite istituzioni finanziarie, comportamenti del mercato, attacchi del capitale o fughe del capitale, ma anche indiretto, influenzando le elezioni, utilizzando le lobby, la corruzione e le tangenti oppure, in modo ancor più sottile, attraverso il controllo del potere delle idee in campo economico. Questa capacità viene esercitata generalmente in modo diretto, tramite istituzioni finanziarie, comportamenti del mercato, attacchi del capitale o fughe del capitale, ma anche indiretto, influenzando le elezioni, utilizzando le lobby, la corruzione e le tangenti oppure, in modo ancor più sottile, attraverso il controllo del potere delle idee in campo economico. il successo culturale e psicologico della neoliberalizzazione è variato a seconda di quanto è radicata la fiducia nelle forme di solidarietà sociale e nell’importanza delle tradizioni di responsabilità sociale collettiva. oppure la complessa interazione che si verifica tra tra dinamiche interne e forze esterne o considerazioni geopolitiche contingenti . ma la cosa che si è presentata in modo assolutamente regolare in tutti i casi è stata un’altra: “la tendenza universale ad aumentare la disuguaglianza sociale e ad esporre gli elementi meno fortunati, in qualsiasi società ai venti gelidi dell’austerità e a un’emarginazione crescente. Se a una tendenza del genere si è in qualche caso posto rimedio grazie a politiche sociali, all’altra estremità dello spettro sociale gli effetti sono stati davvero spettacolari. Le incredibili concentrazioni di ricchezza e di potere che esistono adesso ai livelli più alti del capitalismo non si vedevano dagli anni venti. Il flusso dei tributi verso i maggiori centri finanziari del mondo è stato stupefacente. Quello che però è ancora più stupefacente è l’abitudine a trattare tutto questo come un semplice effetto collaterale della neoliberalizzazione. La sola idea che questo aspetto possa invece costituire proprio l’elemento sostanziale a cui puntava la neoliberalizzazione fin dall’inizio - la sola idea che esista questa possibilità - appare inaccettabile. La teoria neoliberista ha dato prova di molto talento presentandosi con una maschera di benevolenza, con parole altisonanti come libertà, indipendenza, scelte e diritti, nascondendo le amare realtà della restaurazione del puro e semplice potere di classe, a livello locale oltre che transnazionale, ma in particolare nei principali centri finanziari del capitalismo globale”. LEZIONE 18 HARVEY 6. IN CONCRETO: IL NEOLIBERISMO ALLA PROVA 18.1. Introduzione . negli anni precedenti la scrittura del libro, dal 2001 in poi, il mondo ha attraversato una fase di recessione piuttosto grave, anche se quasi insignificante rispetto alla crisi che stiamo attraversando ormai da quattro anni senza vedere una via d’uscita. . le due potenze ormai dominanti, Usa e Cina, hanno risposto a questa crisi in modo abbastanza sorprendente, riciclando delle politiche di tipo keynesiano mentre sventolavano convintamente la bandiera neoliberista: “gli Stati Uniti hanno fatto ricorso in modo pesante al deficit per finanziare campagne militari e consumi, mentre la Cina ha finanziato a debito, con prestiti bancari improduttivi, grandi investimenti infrastrutturali e investimenti di capitale fisso”. . il neoliberismo ha insomma, alla fin fine, è sembrato fallire e ha dovuto persino mettere mano a politiche che ha sempre detestato e cercato di far dimenticare per sempre. . osservando questo fallimento: a) alcuni hanno detto che la neoliberalizzazione non è che un esempio di teoria sbagliata finita fuori controllo; b) altri che essa costituisce un caso di attuazione insensata di una falsa utopia. . harvey ritiene invece che la volontà di far funzionare in modo equilibrato ed efficace il capitalismo e la volontà di restaurare o ricostituire il potere della classe dominante sono in realtà in aperta contraddizione tra loro e che i gruppi dirigenti neoliberisti preferiscono portare le crisi economiche alle estreme conseguenze pur di conservare i loro privilegi. . harvey aggiunge anzi che le crisi stesse vengono in alcuni casi viste da questi gruppi dirigenti come occasioni per consolidare il loro potere. . citiamo direttamente harvey, che si sta riferendo alle crisi storiche del 1873 e del 1929: le classi più alte, insistendo sulla natura inviolabile dei loro diritti di proprietà, allora preferirono scardinare il sistema, piuttosto che rinunciare a qualcuno dei loro privilegi e poteri. Così facendo non erano dimentiche dei loro interessi, perché quando assumono l’assetto più appropriato alla situazione possono, come abili curatori fallimentari, trarre vantaggio da un crollo, mentre noi rimaniamo atrocemente intrappolati nel bel mezzo del diluvio. […] . la conclusione è molto netta e ha un sapore anche un po’ sorprendente: le classi dominanti raramente cedono volontariamente, se mai lo fanno, una parte del loro potere, e non vedo per quale ragione si debba credere che lo farebbero in questo caso. paradossalmente, un movimento socialdemocratico della classe lavoratrice, se forte e potente, è in posizione migliore per riscattare il capitalismo di quanto non lo sia lo stesso potere della classe capitalista 18.2. I risultati del neoliberismo 18.2.1. una pletora di insuccessi . per capire meglio quanto appena scritto e per sottoporlo a verifica vediamo se la neoliberalizzazione costituisca o meno una soluzione per i problemi che minacciano il capitalismo stesso. . la neoliberalizzazione anzitutto non è riuscita a stimolare l’accumulazione di capitale: i tassi di crescita globale aggregata che erano del 3,5% negli anni Sessanta e del 2,4% ancora negli anni Settanta sono scesi all’1,4 e all’1,1% negli anni Ottanta e Novanta . [vedere figura 6 p. 177] . le uniche aree che sono andate veramente bene in questi decenni sono quelle estremo-orientali, dall’India alla Cina, neoliberiste in modo piuttosto anomalo. . male, complessivamente, anche altri indicatori: lavoro nero e precario in aumento molto forte livelli di salute, aspettativa di vita, mortalità infantile spesso in regresso . il confronto, inoltre, tra due paesi in qualche misura simili che hanno conosciuto forme opposte di neoliberalizzazione, una limitata e “morbida” e una radicale, come la Svezia e la Gran Bretagna, mostra i risultati economici complessivamente molto più positivi della prima. 18.2.2. l’illusione ottica del successo generalizzato . se questo è vero, perché si è diffusa questa percezione che non ci fossero alternative, che la neoliberalizzazione è stata un successo? . per due ragioni. . la prima ragione è data dalla distribuzione irregolare nel tempo della neoliberalizzazione ha permesso successi a scacchiera, ora qui ora lì, che hanno offuscato il fatto che nel complesso non stava funzionando un gran che . la seconda ragione è data dal fatto che la neoliberalizzazione ha avvantaggiato in modo spettacolare le classi alte, sia quelle vecchie sia quelle nuove, create dalla neoliberalizzazione medesima. dato che i mezzi di comunicazione di massa sono nella stragrande maggioranza o nella quasi totalità in mano a queste classi essi hanno ricevuto il mandato di costruire un vero e proprio mito dell’indispensabilità delle misure neoliberiste e della loro necessaria efficacia. come spiega Harvey: Si è voluto sostenere che una crescente disuguaglianza sociale all’interno di un territorio era condizione necessaria per incoraggiare quel rischio imprenditoriale e quell’innovazione che potevano accrescere la forza competitiva e stimolare la crescita. Se tra gli esponenti delle classi più basse le condizioni di vita si deterioravano, era perché non riuscivano, in genere per ragioni personali e culturali, a potenziare il proprio capitale umano (tramite l’istruzione, l’acquisizione di un’etica protestante del lavoro, l’adattamento alla disciplina e alla flessibilità del lavoro e così via). Certi problemi nascevano, in breve, a causa della mancanza di forza competitiva o per via di carenze personali, culturali e politiche. In un mondo di darwinismo neoliberista, si diceva, solo i più adatti avrebbero potuto e dovuto sopravvivere! 18.2.3. i soli tre veri successi . alcuni mutamenti in realtà ci sono stati e anche spettacolari, e si sono concentrati soprattutto in due settori: finanza e tecnologie informative . una gran quantità di ricchezza e di posti di lavoro si è creata nell’ambito delle attività finanziarie, ad esempio, ma in effetti si può discutere della reale produttività di tutto ciò in quanto “gran parte dell’attività finanziaria si concentra solo sulla finanza. Non si fa altro che andare alla ricerca di profitti speculativi […] e in questo modo si crea una grande quantità di ricchezza fittizia”. . una crescita prodigiosa c’è stata anche nel campo delle tecnologie dell’informazione, passata dal 25% degli investimenti complessivi nel 1970 al 45% del 2000. dopo aver pensato a lungo che ciò stava dando vita a un’economia dell’informazione ci si è resi conto che tutto ciò ha rappresentato un’infelice deviazione del corso di cambiamento tecnologico, che si è allontanato da produzione e infrastrutture per andare incontro a quella finanziarizzazione orientata al mercato che era il marchio di fabbrica della neoliberalizzazione. La tecnologia dell’informazione è la tecnologia preferita del neoliberismo: è molto più utile per l’attività speculativa e per massimizzare il numero dei contratti a breve termine che per migliorare la produzione […] le infrastrutture materiali e sociali di base. . a parte i successi in questi due specifici settori, il campo nel quale si può senz’altro dire che la neoliberalizzazione ha funzionato meglio è stato non tanto quello della generazione di nuova ricchezza bensì quello della sua redistribuzione, dal basso verso l’alto, cioè dai poveri ai ricchi. 18.2.4. l’accumulazione tramite esproprio . questo è avvenuto attraverso quella che harvey chiama l’accumulazione tramite esproprio. . l’accumulazione ha operato anzitutto attraverso la prosecuzione di antiche “pratiche di accumulazione” primitive (Marx) realizzate col decisivo contributo dello stato: la conversione di varie forme di diritti di proprietà (comune, collettiva, dello stato ecc.) in diritti di proprietà esclusivamente privati (il caso più spettacolare è quello della Cina); la soppressione dei diritti alle proprietà comuni; la trasformazione in merce della manodopera e la soppressione delle forme alternative (indigene) di produzione e consumo; i processi coloniali, neocoloniali e imperiali di appropriazione di risorse (incluse quelle naturali); la monetizzazione dello scambio e della tassazione, in particolare della terra; la tratta di schiavi (che continua, particolarmente nell’industria del sesso); l’usura, il debito nazionale e, più sconvolgente che mai, l’uso del sistema di credito come strumento radicale di accumulazione tramite esproprio . cui se ne sono aggiunte quattro nuove: privatizzazione e mercificazione. si è trattato di trasformare in risorsa aziendale, di mercificare e di privatizzare risorse finora pubbliche. lo scopo primario di queste operazioni è stato di aprire nuovi campi all’accumulazione di capitale in ambiti finora esclusi da considerazioni di possibile profitto: i servizi pubblici di ogni tipo (acqua, telecomunicazioni, assistenza sanitaria, pensioni), le istituzioni pubbliche (università, laboratori di ricerca, prigioni) e persino le attività belliche (i contractors operanti in Iraq). con i cosiddetti accordi TRIPS (Trade-Related Intellectual Property Rights) l’OMC definisce come proprietà privata i materiali genetici, il plasma seminale e ogni genere di altri prodotti naturali. “spesso per imporre con la forza questi processi viene usato il potere dello stato, anche contro la volontà popolare. La cancellazione delle strutture di regolamentazione concepite per proteggere la forza lavoro e l’ambiente dal degrado ha comportato la perdita di diritti. Il trasferimento nell’ambito privato dei diritti di proprietà comune ottenuti attraverso anni di dura lotta di classe (il diritto a una pensione statale, al welfare, all’assistenza sanitaria nazionale) è stato una delle strategie di esproprio più riuscite, e spesso è stato ottenuto contro la volontà politica generale della popolazione”. importante la conclusione: “tutti questi processi non sono stati altro che il trasferimento di risorse dal campo del pubblico e del popolare a quello del privato e del privilegio di classe”. finanziarizzazione. “La forte ondata di finanziarizzazione iniziata dopo il 1980 è stata contrassegnata da uno stile speculativo e predatorio. Il giro d’affari giornaliero totale delle transazioni finanziarie sui mercati internazionali, che nel 1983 ammontava a 2,3 miliardi di dollari, era salito a 130 miliardi di dollari nel 2001. I 40.000 miliardi di dollari di giro d’affari annuale del 2001 vanno messi a confronto con gli 800 miliardi di dollari che secondo le stime sarebbero necessari per alimentare il flusso degli scambi internazionali e degli investimenti produttivi. La deregolamentazione ha consentito al sistema finanziario di diventare uno dei principali centri di attività ridistributiva, grazie a speculazioni, saccheggi, frodi e furti. La promozione di titoli azionari, i piani truffaldini, la distruzione tramite inflazione di attività strutturate, il frazionamento di attività aziendali tramite fusioni e acquisizioni, la promozione di titoli di debito a livelli che riducevano intere popolazioni, anche in paesi a capitalismo avanzato, in condizioni di schiavitù debitoria, per non parlare delle frodi aziendali, dell’esproprio di ricchezze (le razzie dei fondi pensioni e la loro decimazione, attraverso crolli azionari e aziendali) tramite manipolazione del credito e del capitale azionario: tutti questi sono divenuti aspetti centrali del sistema finanziario capitalista”. gestione e manipolazione delle crisi. al di là dei meccanismi finanziari singoli, “c’è un processo più profondo che comporta lo scatto della «trappola debitoria», strumento primario di accumulazione tramite esproprio. La creazione, la gestione e la manipolazione delle crisi sullo scenario mondiale si è evoluta in un’arte sottile di ridistribuzione intenzionale di ricchezze dai paesi poveri a quelli ricchi. […] Le crisi debitorie di singoli paesi, non comuni durante gli anni sessanta, sono divenute molto frequenti negli anni ottanta e novanta. Nessun paese o quasi in via di sviluppo è stato risparmiato e in alcuni casi, come in America Latina, crisi del genere sono divenute endemiche. Queste crisi debitorie sono state orchestrate, gestite e controllate allo scopo di razionalizzare il sistema e di ridistribuire ricchezze. Dal 1980, è stato calcolato, l’equivalente di oltre cinquanta piani Marshall (cioè più di 4.600 miliardi di dollari) è stato inviato dalle popolazioni della periferia del mondo ai loro creditori al centro. […] Esiste il pericolo, però, che le crisi possano finire fuori controllo e divenire generalizzate, oppure che scoppino rivolte contro il sistema che le crea. Una delle funzioni più importanti degli interventi dello stato e delle istituzioni internazionali è quella di controllare che crisi e svalutazioni seguano modalità che consentano il manifestarsi di accumulazione tramite esproprio senza che s’inneschi un crollo generale o una rivolta popolare (come è accaduto in Indonesia e in Argentina). Il programma di aggiustamento strutturale gestito dal complesso Wall-Street-Tesoro-FMI si occupa del primo, mentre è compito dell’apparato comprador dello stato (sostenuto dall’aiuto militare dei poteri imperiali) nel paese che è stato razziato assicurare che non si verifichi la seconda”. ridistribuzioni dello stato. “Lo stato, una volta neoliberalizzato, diventa un primo agente delle politiche ridistributive, invertendo quel flusso dalle classi più alte a quelle più basse che si veri-ficava all’epoca dell’embedded liberalism. Lo fa in primo luogo cercando di mettere in atto piani di privatizzazione e tagli di quelle spese statali che sostengono il salario sociale. […]Inoltre lo stato neoliberista ridistribuisce ricchezze e introiti attraverso revisioni delle normative fiscali che vanno a beneficio dei [188] profitti sugli investimenti e non dei redditi o dei salari, la promozione di elementi regressivi nella normativa fiscale (come le tasse sulle vendite), l’imposizione di canoni di utilizzo (ora molto diffusi nella Cina rurale) e disponendo una grande varietà di sussidi ed esenzioni fiscali per le aziende. Negli Stati Uniti il livello dell’imposizione fiscale alle aziende è diminuito in modo costante e la rielezione di Bush è stata accolta con grande soddisfazione dai leader delle grandi società, in previsione di ulteriori riduzioni dei loro oneri fiscali”. 18.3. Mercificazione di tutto. . “Presumere che i mercati e i segnali del mercato possano determinare nel modo migliore tutte le decisioni di stanziamento significa [189] affermare che ogni cosa può in linea di principio essere trattata come una merce. La mercificazione presuppone che esistano diritti di proprietà su processi, cose e relazioni sociali, che si possa attribuire loro un prezzo e che possano essere scambiati in base a contratti legali. Si presuppone che il mercato operi come una guida giusta - un’etica - per tutte le azioni umane”. […] . “La mercificazione di sessualità, cultura, storia, patrimonio ereditario, della natura come spettacolo o come forma di terapia del riposo; il ricavo di rendite monopolistiche dall’originalità, dall’autenticità e dall’unicità (delle opere d’arte, per esempio): tutto questo equivale a dare un prezzo a cose che non sono mai state prodotte come merci”. . “La neoliberalizzazione ha senza dubbio ampliato i limiti della mercificazione e allargato di molto l’area in cui vigono i contratti legali. In genere celebra (come buona parte della teoria postmoderna) l’effimero e il contratto a breve termine; il matrimonio, per esempio, è inteso come un accordo contrattuale a breve termine, invece che come un legame sacro e inviolabile”. . “Ma qui sono in ballo questioni ben più serie che il mero tentativo di tutelare qualche oggetto di pregio, qualche particolare rituale o qualche attraente angolino di vita sociale dal calcolo monetario e dal contratto a breve termine. Questo perché al cuore della teoria liberale e neoliberista c’è la necessità di costruire mercati coerenti per i terreni, la manodopera e il denaro, e questi, come ha notato Karl Polanyi, «non sono ovviamente delle merci. [...] La descrizione del lavoro, della terra e della moneta come merce è interamente fittizia». Anche se il capitalismo non può funzionare senza queste finzioni, produce un danno indescrivibile quando evita di prendere atto delle realtà complesse che ci sono dietro”. . “La neoliberalizzazione cerca di strappare le coperture protettive consentite e in certi casi promosse dall’embedded liberalism. L’attacco generale contro il mondo del lavoro ha due punte. Il potere dei sindacati e di altre istituzioni della classe lavoratrice viene stroncato o smantellato all’interno di un certo stato (con la violenza, se necessario). Vengono creati mercati del lavoro flessibili. Il ritiro dello stato dagli impegni del welfare e i cambiamenti [192] indotti dalla tecnologia nelle strutture del lavoro, che rendono ridondanti ampi settori della manodopera, completano il dominio del capitale sul lavoro all’interno del mercato. Il lavoratore individualizzato e relativamente privo di potere si trova così ad affrontare un mercato del lavoro in cui per consuetudine vengono offerti solo contratti a breve termine. La sicurezza della permanenza sul lavoro diviene un fenomeno del passato (nelle università la Thatcher l’ha abolita, per esempio). Un «sistema di responsabilità personale» (quanto era accorto il linguaggio di Teng!) si sostituisce alle protezioni sociali (pensioni, assistenza sanitaria, tutela contro gli infortuni) che precedentemente erano un obbligo per i datori di lavoro come per lo stato. Gli individui devono invece acquistare prodotti sul mercato che vende forme di protezione sociale. La sicurezza individuale è dunque un problema di scelta individuale legata alla possibilità di permettersi prodotti finanziari inseriti in mercati finanziari pieni di rischi. La seconda punta dell’attacco comporta trasformazioni nelle coordinate spaziali e temporali del mercato del lavoro. I risultati che si possono ottenere con la «corsa verso il fondo» alla ricerca delle riserve di manodopera più economiche e più docili sono fin troppi, ma la mobilità geografica del capitale consente di esercitare il dominio su una manodopera globale che ha una mobilità geografica limitata. Le forze lavoro imprigionate abbondano, perché l’immigrazione è limitata”. . “La neoliberalizzazione ha trasformato il modo in cui si posizionano la forza lavoro, le donne e i gruppi indigeni nell’ordine sociale, sottolineando il fatto che il lavoro è una materia prima come qualsiasi altra. Privata della copertura protettiva di istituzioni democratiche incisive e minacciata da ogni genere di trasferimenti geografici, una manodopera usa e getta si volge inevitabilmente verso altre forme istituzionali grazie a cui costruire solidarietà sociali ed esprimere una volontà collettiva. Proliferano realtà di ogni tipo, dalle gang e dai cartelli criminali alle reti di narcotraffico, dai boss delle minimafie e delle favelas fino alle organizzazioni di comunità di base e non governative, ai culti secolari e alle sette religiose. Ecco quali sono le forme sociali alternative che riempiono il vuoto che si apre mentre i poteri dello stato, i partiti politici e le altre forme istituzionali vengono attivamente smantellati o semplicemente perdono la propria valenza in quanto centri di ricerca collettiva e di legami sociali”. 18.4. I degradi ambientali . “L’imposizione di una logica contrattuale a breve termine all’utilizzo delle risorse ambientali ha conseguenze disastrose. Fortunatamente su questo tema all’interno del campo neoliberista le concezioni sono in qualche modo differenti”. . “Le politiche dello stato neoliberista rispetto all’ambiente sono di conseguenza geograficamente discontinue e temporalmente instabili”. . “Ciononostante, il bilancio complessivo delle conseguenze neoliberalizzazione sull’ambiente è quasi certamente negativo”. della . “La neoliberalizzazione ha un primato piuttosto triste, quando si considera lo sfruttamento delle risorse naturali. Le ragioni non sono difficili da cogliere. La preferenza per i rapporti contrattuali di breve durata spinge tutti i produttori a ricavare quanto più possono finché dura il contratto. Anche se contratti e opzioni possono essere rinnovati, l’incertezza permane sempre, perché esiste la possibilità che si trovino altre fonti. L’orizzonte temporale più lungo possibile per lo sfruttamento delle risorse naturali è quello del tasso di sconto (cioè circa venticinque anni), ma attualmente gran parte dei contratti è molto più breve. In genere si ritiene che l’impoverimento sia lineare, mentre adesso è evidente [199] che molti sistemi ecologici crollano improvvisamente, una volta che è stato raggiunto un livello massimo oltre il quale la capacità di riproduzione naturale non è più garantita”. . “L’insistenza neoliberista a favore della privatizzazione rende difficile giungere a qualsiasi accordo globale sui princìpi di gestione delle foreste per proteggere habitat preziosi e biodiversità, particolarmente nelle foreste pluviali tropicali”. . “Ma l’impatto dei programmi di aggiustamento strutturale amministrati dall’FMI ha avuto esiti ancora peggiori. Imporre l’austerità significa mettere i paesi più poveri nella condizione di avere meno soldi per la gestione delle foreste. E in più c’è la sollecitazione a privatizzare le foreste e consentirne lo sfruttamento alle società di legname straniere con contratti a breve termine. Spinti a guadagnare valuta straniera per ripagare i propri debiti, questi paesi sono esposti alla tentazione di acconsentire a un regime di massimo sfruttamento nel breve termine”. 18.5. Sui diritti . “La neoliberalizzazione ha generato al proprio interno una vasta cultura d’opposizione, la quale tende, tuttavia, ad accettare molte delle proposizioni che sono alla base del neoliberismo, concentrandosi invece su alcune contraddizioni interne. Ha a cuore, per esempio, le questioni relative a diritti e libertà individuali e le contrappone all’autoritarismo e all’esercizio spesso arbitrario del potere politico, economico e di classe; affronta la retorica neoliberista di un aumento generalizzato del benessere e accusa il processo di neoliberalizzazione di aver fallito proprio su questo terreno. Si consideri, per esempio, il primo, significativo paragrafo di un documento che rappresenta la quintessenza del neoliberismo, l’accordo WTO. Eccone lo scopo: “Innalzamento degli standard di vita, piena occupazione con un volume alto e sempre crescente di redditi reali e di domanda effettiva, un’espansione della produzione di, e degli scambi in, beni e servizi, mentre [i paesi] consentono l’uso ottimale delle risorse mondiali in armonia con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, allo scopo sia di proteggere e preservare l’ambiente sia di rendere più efficaci gli strumenti per farlo in modo coerente con le loro rispettive necessità e interessi a differenti livelli di sviluppo economico”. . “Pie speranze di questo genere si ritrovano nelle dichiarazioni della Banca mondiale («la riduzione della povertà è il nostro scopo primario»). Nulla di tutto ciò si concilia con le pratiche che attualmente sostengono la restaurazione o la creazione del potere di classe né con i risultati in termini di impoverimento e degrado ambientale. . “La svolta neoliberista è stata accompagnata dalla nascita di gruppi di sostegno e di ONG, così come dal dibattito sui diritti in generale; tali strutture sono aumentate in modo spettacolare più o meno a partire dal 1980. In molti casi le ONG hanno occupato il vuoto lasciato dello stato nel campo dei provvedimenti dl natura sociale. Si compie così un processo che corrisponde a una privatizzazione da parte delle ONG. In alcuni casi ciò ha contribuito ad accelerare ulteriormente il ritiro dello stato dai provvedimenti sociali”. . “Ma c’è un’altra ragione per cui questa cultura d’opposizione ha acquistato una simile forza trainante in anni recenti. L’accumulazione tramite esproprio comporta un complesso di pratiche molto diverse, dall’accumulazione all’aumento del lavoro salariato nell’industria e nell’agricoltura. Quest’ultimo aspetto, che ha dominato i processi di accumulazione di capitale negli anni cinquanta e sessanta, ha dato avvio a una cultura d’opposizione (del tipo di quella radicata nei sindacati e nei partiti politici della classe lavoratrice) che ha prodotto embedded liberalism. L’esproprio, d’altra parte, è frammentato e particolare: una privatizzazione qui, un degrado ambientale lì, una crisi finanziaria di indebitamento da qualche altra parte. È difficile opporsi a tutta questa specificità e particolarità senza fare appello a principi universali. L’esproprio comporta la perdita di diritti; di qui la svolta verso una retorica [203] universalistica dei diritti e della dignità umana, delle pratiche ecologiche sostenibili, dei diritti ambientali e così via, come base di una politica di opposizione unitaria. Questo richiamo all’universalismo dei diritti è un’arma a doppio taglio. Può essere in effetti usato in vista di obiettivi progressisti. […] Però la limitatezza degli obiettivi di molti discorsi sui diritti umani (nel caso di Amnesty la concentrazione esclusiva, fino a tempi recenti, sui diritti civili e politici invece che su quelli economici) rende fin troppo facile assorbire queste battaglie all’interno della struttura neoliberista”. . “Ma i diritti alla proprietà privata non sono gli unici che abbiamo a disposizione. Anche la concezione liberale, espressa nella [207] Carta dell’ONU, include diritti come la libertà di espressione e di parola, il diritto all’istruzione e alla sicurezza economica, o a organizzarsi in sindacato. Applicare questi diritti significa sfidare il neoliberismo; rendere primari questi diritti derivati e trasformare in diritti derivati quelli primari alla proprietà privata e al profitto costituirebbe una profonda rivoluzione delle pratiche politico-economiche. Vi sono altri diritti, del tutto diversi, a cui potremmo ispirarci: l’accesso alle risorse globali comuni o la sicurezza alimentare, per esempio”.
Scaricare