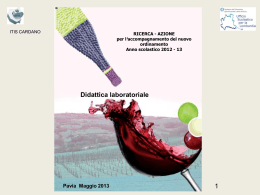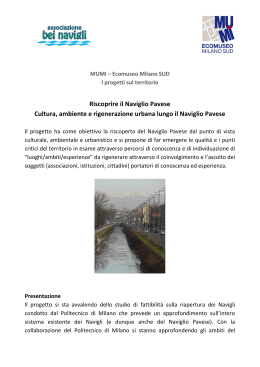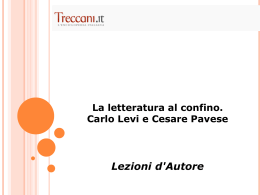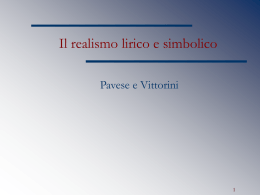Inserto della rIvIsta ComunItàItalIana - sotto l’egIda deI dIpartImentI dI ItalIano delle unIversItà pubblIChe brasIlIane Suplemento da Revista Comunità Italiana. Não pode ser vendido separadamente. ano VII - numero 61 Per Pavese dopo cento anni Gennaio / 2005 2 gennaio / 2009 Istituto Italiano di Cultura Editora Comunità Rio de Janeiro - Brasil www.comunitaitaliana.com [email protected] Direttore responsabile Pietro Petraglia Coordinatori Fabio Pierangeli Direttori Roberto Mosena e Serena Maffìa Grafico Alberto Carvalho Copertina Riproduzione ComItato dI redaZIone Anna Palma; Annita Gullo (UFRJ); Arcangelo Carrera; Cristiana Cocco (UFF); Cristiane Magalhães; Doris Natia Cavallari (USP); Ernesto Livorni (Wisconsin-Madison); Esman Dias (UFPE); Fabio Andrade (UFPE); Fabrizio Fassio; Flora De Paoli Faria (UFRJ); Francesca Papi; Giovanni Zambito; Giuzy D’Alconzo; Hilário Antonio Amaral (UNESP); Katia d’Errico; Laura Pacelli; Livia Apa (Istituto Orientale di Napoli); Maria Lizete dos Santos (UFRJ); Maria Pace Chiavari (IIC-RJ); Mauricio Santana Dias (UFF); Paola Micheli (Siena); Paolo Spedicato (UFES); Sonia Cristina Reis (UFRJ); Wander Melo Miranda (UFMG) ComItato edItorIale Affonso Romano de Sant’Anna; Alberto Asor Rosa; Beatriz Resende; Dacia Maraini; Elsa Savino; Everardo Norões; Floriano Martins; Francesco Alberoni; Giacomo Marramao; Giovanni Meo Zilio; Giulia Lanciani; Leda Papaleo Ruffo; Luciana Stegagno Picchio; Maria Helena Kühner; Marina Colasanti; Pietro Petraglia; Rubens Piovano; Sergio Michele; Victor Mateus gruppo dI traduZIonI Antonella Genna; NUPLITT - Núcleo de pesquisa em literatura e tradução da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina): Andréia Guerini, Cláudia Borges de Faveri, Marie-Hèlene C. Torres, Mauri Furlan, Walter Carlos Costa e Werner Heidermann. I mattini passano chiari daVerrà la morte e avrà i tuoi occhi 30 marzo 1950 I mattini passano chiari e deserti. Così i tuoi occhi s’aprivano un tempo. Il mattino trascorreva lento, era un gorgo d’immobile luce. Taceva. Tu viva tacevi; le cose Vivevano sotto i tuoi occhi (non pena non febbre non ombra) Come un mare al mattino, chiaro Dove sei tu, luce, è il mattino. Tu eri la vita e le cose. In te desti respiravamo Sotto il cielo che è ancora in noi. rICerCa non pena non febbre allora, Federico Bertolazzi; Nello Avella; Rino Caputo; Università Roma II “Tor Vergata” non quest’ombra greve del giorno esemplarI anterIorI affollato e diverso O luce, chiarezza lontana, respiro Redazione e Amministrazione Rua Marquês de Caxias, 31 Centro - Niterói - RJ - 24030-050 Tel/Fax: (55+21) 2722-0181 / 2719-1468 Mosaico italiano è aperto ai contributi e alle ricerche di studiosi ed esperti brasiliani, italiani e stranieri. I collaboratori esprimono, nella massima libertà, personali opinioni che non riflettono necessariamente il pensiero della direzione. sI rIngraZIano ABPI, ACIB, Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, UFBA, UFF, UFRJ, IIC, USP. stampatore Editora Comunità Ltda. ISSN 1676-3220 2 Cesare Pavese affannoso, rivolgi gli occhi immobili e chiari su noi. E’ buio il mattino che passa senza la luce dei tuoi occhi/ Gennaio / 2005 3 Pavese cent’anni A cento anni esatti dalla nascita, avvenuta su quelle che rimarranno le sue colline, fonte primaria di ispirazione, nelle Langhe a Santo Stefano Belbo, il 9 settembre 1908, ancora di recente, l’autorevole italianista e critico militante, Giulio Ferroni, in preparazione di un convegno romano alla Casa delle Letterature per i cento anni dalla nascita nel marzo del 2008, testimoniava della necessità di leggere Cesare Pavese allontanandosi da un effetto bruciante e annichilente del primo impatto dell’adolescenza e della giovinezza. Personalità di diverse generazioni, confessavano della difficoltà di confrontarsi con quello scrittore, furiosamente legato alle ansie di una età trascorsa, a domande a cui, con rude maturità, si è dovuto rispondere una volta per tutte, oltrepassandole. Si tratta di evitare, insomma, un possibile terremoto interiore. Nel frattempo, abbattute ostilità varie, da Moravia agli integralisti di partito, studi ed edizioni accurate donano a Pavese il profilo che gli spetta, quello di un classico del Novecento per lo stile, la lingua, l’inconfondibile voce narrativa e poetica, per il lavoro editoriale e di traduttore. Si pensi all’edizioni curata dal compianto Marziano Guglielminetti e da Mariarosa Masoero, A cura di Mosaico dei Romanzi e Racconti per la prestigiosa Pleiade Einaudi, alla monumentale bibliografia della critica, a cura di Luisella Mesiano, Cesare Pavese di carta e di parole, Edizioni dell’Orso. Rileggere oggi Pavese e le sue biografie, da quella storica di Lajolo Il vizio assurdo, riedito da Daniela Piazza editrice in Torino, a cura della figlia Laurana, costruito sulle testimonianze degli amici, su materiali allora sconosciuti, provenienti dal famoso “baule” conservato dalla sorella Maria fino a quella più recente di Lorenzo Mondo, edita da Rizzoli, Quell’antico ragazzo, ci pone di fronte a quelle domande radicali al centro dell’esperienza artistica, civile, umana, intellettuale di Cesare Pavese: ci conduce a rileggerlo nella estrema complessità del “classico” si pensi almeno alla Casa in collina (la guerra civile osservata da un intellettuale incapace di prendere le armi) e La luna e i falò, appunto, con le sue grandezze e le sue fragilità, capace di affrontare nodi come ispirazione, destino, pienezza, felicità, amore assoluto nelle vicende di personaggi quotidiani e nelle asprezze del diario. Se è necessario considerare la letterarietà classica di Pavese, altrettanto necessario non ridurlo al silenzio dell’erudizione (elementi del resto, che si sposano “naturalmente” in studi seri: basti citare i lavori di Anco Marzio Mutterle tra cui Le bacche di Leucò). La tensione centrale del suo compitodi scrittore rimane il tentativo di unire in un unico stile narrativo veloce, spezzato, ritmico sul modello della letteratura americana il piglio vivacemente e furbescamente realistico alla profondità dei sensi del mito, come archetipo necessario e tragico, con cui leggere anche l’esperienza contemporanea, in particolare il dramma della guerra: «Parlare con la gente, bisogna, capirli, sapere quel che ognuno vuole. Tutti vogliono qualcosa nella vita, vogliono fare qualcosa che non sanno mai bene. Ebbene, in questa voglia c’è Dio», afferma Pieretto nel XIV capitolo del Diavolo sulle colline. E Poli, nel XX«Ti fanno paura le parole? Dagli il nome che vuoi. Io chiamo Dio l’assoluta libertà e certezza. Non mi chiedo se Dio esiste: mi basta esser libero, certo e felice, come Lui». “Voglia”, come ben sa il lettore di Pavese, chiama 3 Gennaio / 2005 4 fragilità, leggerezza, vizio, inadattamento ai ritmi della città, del lavoro adulto, della maturità. Rosetta, in Tra donne sole, ne muore, proprio davanti a quelle radici lontane, immemori e dimenticate, dentro all’effimero tenero della ricerca di successo («il curioso era stata l’idea di affittare uno studio da pittore, farci portare una poltrona, nient’altro, e morire così davanti alla finestra che guardava Superga»): «e si chiedevano come può darsi che chi come Rosetta ha tanto bisogno di vivere, voglia morire. Qualcuno diceva che il suicidio andrebbe proibito». Per ragioni storiche ed individuali la “storia” di Pavese descrive lo sradicamento esistenziale che diverrà poi epocale (la pasoliniana scomparsa delle lucciole) da quei valori di sanità contadina e naturale rappresentati, con il vigore del comunista contadino dal Nuto de La luna e i falò, struggente romanzo di un impossibile ritorno al paese dell’infanzia e del mito, che si chiude, come si apriva la intensa e breve stagione dello scrittore, con una ascesa sulla collina, appreso al Cugino, nella splendida lirica di Lavorare stanca, le poesie racconto dell’esordio pavesiano, Mari del sud. Proprio il salire sulla collina accompagnati da una guida o in solitudine diviene l’immagine centrale si una ricerca esistenziale e stilistica. Forse lì, come per Esiodo, abita l’inafferrabile dea della Memoria Nel frammento dedicato ad Odisseo, nei Dialoghi con Leucò, il libro più caro a Pavese, in cui lo scrittore attraverso il linguaggio noto del mito greco insegue gli archetipi fondanti dell’esistenza uma- 4 na, L’isola, si legge: «Quello che cerco l’ho nel cuore come te». L’amore come assoluto, la potenza ammaliatrice del vizio, la ricerca della carità umana, la scoperta delle radici contadine e di esserne lontano, l’attesa della gloria e lo scoprirla effimera, restano i punti essenziali della esperienza artistica di Pavese, riassunti tutti in quella ricerca delle libertà testimoniata fedelmente, fino alla morte, da Pavese come scrive Davide Lajolo. «Questa ansia di libertà che si esprime nelle opere di Pavese spiega ancor meglio la ragione per cui giovani e giovanissimi ripercorrono tuttora i suoi scritti e vogliono riandare al suo tempo, anche oggi che tante cose sono mutate e le delusioni patite da Pavese, fino al gesto irreparabile, sono accresciute», scriveva Davide Lajolo presentando il lavoro per la Rizzoli ventiquattro anni dopo la prima edizione. L’ansia della “durata” si descrive in mille modi, da quelle romantiche posizioni adolescenziale, alle motivate descrizioni dei giovani della Bella estate, che gli valse, nel 1950, prima della morte suicida, la notte tra il 27 e il 28 agosto, in quella che sembra essere una ribellione al tempo scandito dalla società borghese, in Pieretto, Poli, Rosetta, nel tentativo di prolungare il divertimento oltre il limite simbolico della giornata, avvertito da Pavese fin dalle lettere giovanili all’amico Sturani, insieme alla baluginante volontà di restare oltre il tempo assegnato attraverso l’arte. «C’è in me- sono le celebri parole di Pavese all’amico biografo- almeno tanto egoi- smo quanta generosità, e c’è sempre esitazione tra fedeltà e tradimento. Forse soltanto il mago di Vesime potrebbe scoprirmi tutto. Nessuno sa: io non mi confesso né ai preti, né agli amici, anzi, appena m’accorgo che un amico mi sta entrando dentro, lo abbandono. Ed abbandono le donne, quelle che tu chiami materne, appena mi illudo che mi vogliono bene. Sono sempre alla disperata ricerca di quella che non me ne ha voluto e non me ne vorrà». E proprio questa percezione si abbraccia con lo studio del mito, con i suoi potenti dialoghetti. Da un parte Odisseo dell’Isola, la “cara speranza” (la vita e la morte) di Mnemosine, dall’altra lo schiacciamento, la Belva donna, i sacrifici umani, la palude Boibeide, la belluina cattiveria dell’uomo esplosa nella guerra civile.. A questa inquieta ferita della ricerca di un amore assoluto, per ogni istante, Pavese opponeva (sentendosene escluso) la dura, laica (a mio modo di vedere religiosissima) speranza dalla terra, dalla tradizione, dalla bellezza del lavoro ben fatto, durissimo, nella lotta per migliorarne le condizioni, traducendola, da buon piemontese, nello scrupoloso lavoro editoriale, imponente, di traduttore, di direttore di collana (quella viola che con De Martino istituisce il fondamento degli studi etnologici e antropologici nella chiusa Italia del dopoguerra) e nel mestiere di scrittore. La ricercata maturità espressa in sintesi nell’ esergo della Luna e i falò: «man must endure / his going hence e’ en as his coming hither. / Ripeness is all. Gennaio / 2005 5 Pavese a Maria Bellonci A cura della redazione di Mosaico Pubblichiamo alcune lettere, depositate alla Biblioteca Nazionale di Roma, di Pavese a Maria Bellonci, la scrittrice nota per il suo salotto di Amici della Domenica da cui prende le mosse, nel 1949, quello che ancora oggi resta il più ambito e celebre premio letterario, Lo Strega. Pavese lo ottiene con la Bella estate nel 1950. La relativa tranquillità e la sottile ironia ci rimandano alle foto del Premio e stridono con le pagine di Diario commentate nell’articolo seguente, dove lo scrittore,, dolorosamente, contesta il desiderio di gloria accarezzato negli anni giovanili, accusando l’inconsistenza, di fronte all’inquieta angosciosa che sorride da sola, al termine di ogni sentimento d’amore e di bellezza. Le lettere riferiscono soprattutto delle vicende del Premio Salento e testimoniano una fiduciosa amicizia con la Bellonci, il cui salotto romano è stato, in generale assai critico con Pavese. 24 agosto 1947 via Lamarmora 35 Gentile signora, credo di esser / stato degno della sua fiducia. Ho scritto a […]una splendida lettera dove elogiavo lui, la Puglia, il Reame, tutto il Sud. E va bene. Adesso ho il premio. A proposito, sa che per contratto le 200.000 ₤ andranno a Giulio Einaudi e non a me? E’ un sacrificio che ho dovuto fargli per indurlo a stampare I dialoghi, anch’essi sotto la stessa clausola. Inoltre né dal Compagno né dai Dialoghi prendo un soldo di percentuale. Ho o no il diritto di sostenere che gli scrittori devono essere disinteressati? Si figuri se non ho piacere che il Compagno peregrini fra le case bianche e cubiche del Sud. Lei dimentica che sono stato un anno confinato (1935 - 36) in Calabria, dove neppure mancano albanesi e greci, e qui contrassi amicizia e piansi a lungo in riva al mare. Presto anzi stamperò un libro dove racconto questa storia. Ma la cosa più bella e di cui ringrazio Lei e i suoi colleghi con tutto il cuore, è il trionfo del Compagno davanti agli ottimati e al clero del card. Ruffo. Questi sono Colpi. Cordialmente suo Cesare Pavese 5 Gennaio / 2005 6 [1947] 3 sett. (su carta intestata Einaudi) Gentile Signora, io sono stato buono, ma Indraccolo no. Gli ho scritto un verso autografo, ma lui niente. Insomma, i famosi soldi non si sono visti. Scrivo a lei, caso mai sapesse precisarmi l’indirizzo di questo benedetto premio, onde fulminare come sono uso. Capirà in che pasticcio sono. Se non ricevo i soldi, Einaudi è capace di credere che li ho tenuti io - e così farei la doppia figura del poverino e del birbante. Ah ma perché esistono premi letterari? La saluto, intanto, caramente e mi scuso, ancora una volta suo Pavese 24 mercol. [marzo 1948] Cara Signora, le sono grato di quanto mi scrive per il mio protetto. Si chiama avv. March. David Invrea, abita in Corso Stati Uniti 39, e il suo telefono è il 42712. Io credo che se avrà buone notizie da dargli, farà bene a telefonargli nella notte dall’8 al 9. Credo che, se sarà il caso, verrà senz’altro a Roma. Dovevo sempre rispondere alla Sua cara lettera di gennaio, dove mi parlava dei miei libri. Sono confuso di tanto interesse. Inutile dire che tutte le mie simpatie vanno ai Dialoghi e, come certi padri snaturati, vorrei che si dicesse male del Compagno per esaltare l’altro e l’altro soltanto. Del premio Strega non so nulla, ma non credo che Einaudi sia per fare la minima difficoltà. Ricordi comunque, che se le mancano libri-omaggio per i giudici li può chiedere liberamente in via Uff. del Vicaro 49. Tutto sommato, è più spiccio Mi auguro di vederla presto, cara Signora, e le faccio molti auguri. Suo Cesare Pavese 22 aprile 48 Torino via Lamarmora 35 Gentile Signora, ho avuto il Suo ultimo biglietto e la ringrazio di tutto ciò che ha fatto e fa per il mio protetto. Visto che ci siamo, e che i rimandi lo hanno un poco allarmato, le pregherei di esser tanto buona di telefonargli o telefonargli qualcosa non appena deciso, qualunque sia l’esito. Questo infelice non esce più la sera per attendere notizie del premio, e ciò da quindici giorni. Probabilmente, in maggio farò una scappata a Roma e sarò lieto di venirla a salutare. Suo Cesare Pavese 6 Gennaio / 2005 7 4 agosto Torino [1948] La ringrazio del Suo fulmineo biglietto. Al premio come Lei sa non tenevo gran che, ma molto invece al benvolere e al ricordo degli amici. Ma vorrei che questo ricordo potesse manifestarsi in modi meno pubblici. Che cos’ha di comune l’autore col suo libro? Io credo ben poco. La ringrazio anche della Candidatura Strega. Mi pare che così come andò, il pr. Str. Sia andato bene, peccato però che adesso il Salento abbia per sempre distrutto la mia verginità. Le sarò grato se vorrà ringraziare per me tutti quei giudici che mi hanno favorito e che se capitassero sotto mano. Non dubito che ciò avverrà, in quanto leggo e sento che corso Liegi è diventato una vera sala d’asp[etto] d’Immortali. Augurando d’avere al più presto occasione d’incontrarla la ossequio e la prego di salutarmi Suo marito. Cordialmente Cesare Pavese 9 giugno [1950] Gentile Signora, i giornali non mi hanno annunciato niente. Bisogna anche dire che non li leggo. Me ne ha detto qualcosa Carlo Levi e poi per telegramma (!!) di Muscetta. E va bene. Vedremo anche questa. Le sue lusinghiere parole mi fanno arrossire. Visto che è tanto buona, veda di tenermi divertito a suo tempo. Penso che votandosi il 24 si farà la festa domenica 25, o no? Comunque, non vedo come sarà possibile essere divertito in tempo per partire dopo la votazione. A lei il problema. Io intanto la ringrazio ancora e sono il suo devoto Cesare Pavese 7 Gennaio / 2005 8 «E poi?». Ritorno a Pavese «P er me la collina resta tuttora un paese d’infanzia, di falò e di scappate, di giochi». (La casa in collina XXIII e ultimo capitolo). Un «paese d’infanzia», quasi che Cesare Pavese aves- 8 Fabio Pierangeli se lasciato lì il «cuore», e volesse andarlo a riprendere. «Il cuore di ciascuno di noi è attesa di una felicità vera, e vera vuol dire che corrisponde al cuore. È attesa di un compimento, per sempre. “Forse qualcuno ci ha mai promes- so qualcosa? E allora perché aspettiamo?” scriveva Cesare Pavese nei suoi diari. Perché aspettiamo? Se il cuore aspetta, vuol dire che Qualcuno ci ha promesso qualcosa. È grande cosa questa promessa per ogni uomo». Pavese trova un’immagine suggestiva e vera per descrivere l’attesa originaria: «Ma tutti i pazzi, i maledetti, i criminosi sono stati bambini, hanno giocato come te, hanno creduto che qualcosa di bello li aspettasse». (Il mestiere di vivere, 9 dicembre 1945). Anguilla, protagonista de La luna e i falò, ritorna al paese d’infanzia dopo aver fatto fortuna in America per vedere se veramente «qualcosa di bello» lo attende dopo tutti quegli anni in giro per il mondo. Prima ancora, in limine all’opera di Pavese, nella lirica I mari del sud, il cugino si stabilisce, taciturno, in quel piccolo borgo di collina da dove era partito, dopo aver visto le isole più belle del Gennaio / 2005 mondo. Sono il primo e l’ultimo dei personaggi di Pavese che come tanti altri salgono la collina e si girano a osservare il tempo che è passato. Nessuna esperienza fuori dal «paese d’infanzia» è stata sufficiente a riempire il desiderio di felicità del cuore. Il paese, la collina, rimette davanti quella promessa, il «cuore», che ora sembra la più grande illusione. Rileggiamo per intero la frase accennata precedentemente, Il mestiere di vivere, 27 novembre 1945: «Come è grande il pensiero che veramente nulla a noi è dovuto. Qualcuno ci ha mai promesso qualcosa? E allora perché attendiamo? Eppure è semplice. Quando non si resiste più, si muore. E voilà». «E voilà». Nel Mestiere di vivere sono moltissime le espressioni di questo tipo tra l’ironico e il tragico, tra la speranza e lo scetticismo anche cattivo, rabbioso. E poi?, E con questo? Ebbene? le più usate. Ogni avvenimento importante («il mio più alto trionfo») segna un limite, non raggiunge mai la pienezza sperata. Costringe a dire E poi? o Valeva la pena? espressione analoga che troviamo ripetutamente nei romanzi e nelle poesie. Ecco un’altra espressione del diario, 18 dicembre 1937, che sembra preludere, per lucida profezia, alle marmoree sentenze delle ultime due annate: «C’è una cosa più triste che fallire i propri ideali: esserci riusciti». Quando Pavese raggiunge i propri ideali, per lo meno professionalmente, nel successo dei suoi libri e con la vittoria al Premio Strega nel 9 Cinquanta, troviamo le formule consorelle a «E voilà» ed «E poi?» che, grilli parlanti, ricordano la verità inflessibile della formula del ‘37. Anche un amore intensissimo lascia, a posteriori, questa tragica consapevolezza, dopo aver illuso di scalare i gradini del successo. Pavese è ben consapevole di gettarsi in ogni nuova avventura, «tagliando i ponti dietro le spalle», senza rete di protezione. Dopo l’ennesimo fallimento sessuale scrive: «Il dolore più atroce è sapere che il dolore passerà. Adesso è facile umiliarsi. E poi?» (Il mestiere di vivere, 27 novembre 1945). Nel solito consuntivo dell’annata, in data 1 gennaio 1946, ecco annunciarsi l’oscillazione tipica di queste ultime annate; la sete di gloria e la distruzione rabbiosa di questa nella consapevolezza di non saperla godere, di aspettare sempre altro, altrove. Come in uno specchio, un altro motivo ricorrente corre tra due diversi magnetismi: sei solo e ne sei orgoglioso, (il mito dello stoicismo) eppure hai un disperato bisogno degli altri, del loro consenso. La formula questa volta è «Ebbene?»: « Sei felice? si, sei felice. Hai la forza, hai il genio, hai da fare. Sei solo. Hai due volte sfiorato il suicidio quest’anno. Tutti ti ammirano, ti complimentano, ti ballano intorno. Ebbene? Non hai mai combattuto, ricordalo. Non combatterai mai. Conti qualcosa per qualcuno?». Nel consuntivo del 1948, questa volta affidato al 31 dicembre di quell’anno e non ai primi giorni del nuovo, come più consueto, sembra presen- tarsi come un dio indurito e celebre, che ha raggiunto i suoi ideali artistici e professionali. Ma il brano è complesso, di una sincerità spietata. Vale la pena di riprodurlo per intero: «Anno serissimo, di definitivo e sicuro lavoro, di acquisita posizione tecnica e materiale. Due romanzi. Altro in gestazione. Dittatore editoriale. Riconosciuto da tutti come un grand’uomo e uomo buono. Da tutti? Non so. Difficilmente andrai più in là. Non credere che tutto ciò sia molto. Non ci speravi in passato e ti stupisce. Ci sei giunto cercando soltanto di lavorare bene e di voglia. Continua, pronto all’idea che i frutti saranno magari domani di cenere. Non deve importartene. Così soltanto espierai la buona fortuna e te ne mostrerai degno». Un programma per non «ricaderci» che Pavese smentirà a volte, ma che saprà dignitosamente portare alle estreme conseguenze: cenere. C’è qualcosa di religioso in questa posizione, paganamente tragica e fatalista, cristianamente in cerca di una giusta posizione verso il mistero che dona e toglie la vita. Il 19 gennaio la formula «ebbene?» segue l’orgoglio di fronte al fioccare delle recensioni positive per Prima che il gallo canti, ripassando le smanie dei vent’anni, l’età in cui si desiderava la gloria, con rabbia e nostalgia: «[...] Sognavi altro a vent’anni? Ebbene? Non dirò “tutto qui e adesso?”. Sapevo quel che volevo e so quel che vale ora che l’ho». Fedele al modello piemontese e langarolo del lavoratore taciturno e tosto, si impone di 9 Gennaio / 2005 10 ritornare al lavoro, come se non fosse niente, «domani darò dentro, come ieri». Nell’estate il relativo equilibrio tra ambizione, senso di aver raggiunto una meta, consapevolezza di non saper che farsene si incrina di nuovo, preludio di stagione finale breve e vorticosa, con ascensioni affettive e gioie creative direttamente proporzionali alle depressioni. Il 22 giugno: «[...] Probabilmente è la tua stagione più intensa, e comincia a corrompersi - tant’è vero che te ne accorgi. Che cosa scopriremo di nuovo cioè, che cosa vivremo, per poi scoprirlo quando comincerà a puzzare? Verra la fine. E allora?» Pavese espone la ben nota demarcazione tra il vivere comune e quella speciale condanna all’intelligenza (alla creatività, con punte depressive quando questa non 10 è percepita presente) che è il marchio dei grandi autori tragici. La formula «E poi?» cosi grammaticalmente banale, crea lo iato, la frattura tra l’uomo «pacifico» e l’artista insoddisfatto: «C’è gente che questa maturità, questa efficienza, questa ricca misura, non l’ha mai provata. Che cosa sanno della vita? La vita non è che questo. E poi? La felicità della pesca, del grappolo d’uva. Chi gli chiede più in là? Sono e basta». In autunno, si accorge di essere entrato in un giro egotistico da cui difficilmente si rialzerà. Come una gabbia, con il sentimento di struttivo e in cerca di oltre dell’«E poi?» a costruirne, per così dire, le sbarre. 30 settembre: «Non hai più intimità. Meglio, la tua intimità è oggettiva, è il lavoro (bozze, lettere, capitoli, sedute) che fai. Ciò è pauroso. Non hai più esitazioni, paure, stupori esistenziali. Ti vai prosciugando. Dove sono le angosce, gli urli, gli amori dei 18-30 anni? Tutto quanto adoperi fu accumulato allora. E poi? Che si farà?». 16 ottobre: «Esiste qualcuno oltre a te? Non parli che di te e del tuo lavoro. Siamo tornati a una posizione infantile di prima di scoprire il mondo (adolescenza), quando si era se stessi e il proprio gioco e nient’altro. Qualcosa si chiude. E poi?». Di questo ritorno all’infanzia, però, si gode. In modo unico in questi mesi. Nella stessa giornata appunta di aver finalmente trovato il titolo presentito da sedici anni, il racconto del paese, lo scavare la memoria ancestrale: La luna e i falò. Gennaio / 2005 E ancora si accorge di essere definitivamente in gabbia, tra due sentimenti già altrove delineati: la depressione dell’inconsistenza e la febbrile e potente onnipotenza della creazione che riporta alla luce il segreto interiore custodito nei gesti dell’infanzia/adolescenza, attraverso il ritmo della parola: «Quante volte in queste ultime note hai scritto E poi? Cominciamo a essere in gabbia, no?» Nel mestiere di scrittore l’illusione che il «proprio ideale» soddisfi l’attesa del cuore può essere più estenuante e lunga, quando l’invenzione di mitologie letterarie, di personaggi, di fantasie, rialzano stupendamente la qualità del gioco. Ma «l’ardente sazietà», si è visto più volte, in una sorta di progressivo ictus, è pericolosissima. Più si tocca con mano, più si discende di colpo. L’identico meccanismo per la gloria letteraria. Quando vince il premio Strega, il massimo riconoscimento mondano per uno scrittore, scrive il 22 giugno 1950, non rinuncia alla solita formula: «È una beatitudine. Indubbio. Ma quante volte la godrò ancora? E poi? Questo viaggio ha l’aria di essere per essere il mio massimo trionfo. Premio mondano, D che mi parlerà - tutto il dolce senza l’amaro. E poi? e poi?» E poi? Si ha solo voglia di tornare. Ma dove? A chi chiedere perdono del tempo dissipato in cose «inutili»? La domanda sul cuore si esprime così nelle ultime, brucianti, pagine del diario, in quell’agosto di cinquant’anni fa. Un punto interrogativo al confine del tempo, del pro- 11 prio tempo, verso un «dopo» che non c’è, è il nulla: «Non importano i nomi. Sono altro che nomi di fortuna, nomi casuali - se non quelli, altri? Resta che ora so qual è il mio più alto trionfo - e a questo trionfo manca la carne, manca il sangue, manca la vita» (Il mestiere di vivere, 17 agosto 1950). La carne, il sangue, la vita: la felicità e la pienezza del cuore. Il paese è proprio il luogo dove si intuisce, perduta, questa pienezza «Di tutto quanto, della Mora, di quella vita di noialtri, che cosa resta? Per tanti anni mi era bastata una ventata di tiglio, la sera, e mi sentivo un altro, mi sentivo davvero io, non sapevo nemmeno bene perché».(La luna e i falò cap.XXVI). Pavese alla fine della sua carriera di scrittore, dando fondo alle immagine più care, setacciando i suoi ricordi più intimi, inventa nella Luna e i falò, la figura di un bastardo che cerca il suo paese e non lo ritroverà mai. Cerca il suo cuore e non lo troverà più. Senza padre né madre. Il meccanismo del E poi? sorprende ancora. Anguilla ha fatto fortuna in America può avere tutte le donne del mondo, ha visto paesi, sterminate praterie, eppure non gli basta: «Valeva la pena esser venuto? Dove potevo ancora andare? Buttarmi dal molo? [...] Ma dove andare? Ero arrivato in capo al mondo, sull’ultima costa, e ne avevo abbastanza. Allora cominciai a pensare che potevo ripassare le montagne». Ma «nulla resiste all’andare del tempo», predice Calipso ad Ulisse nel dialogo L’isola, dai commentatori con- siderato, con tutta evidenza, la sintesi «mitologica» del romanzo della piena maturità. Anche per Ulisse si tratta di accettare un orizzonte molto più modesto di quello che avverte nella speranza di tornare alla sua Itaca. Calipso già sa tutto quello che Anguilla dovrà scoprire, una volta ripassate le montagne e l’Oceano: «Calipso: Il passato non torna. nulla regge all’andare del tempo. Tu che hai visto l’Oceano, i mostri e l’Eliso, potrai ancora riconoscere le case, le tue case? Odisseo: Tu stessa hai detto che porta l’isola in me. Calipso: Oh mutata, perduta, un silenzio[...] Con te nessuno potrà condividerla. Le case saranno come il viso di un vecchio. Le tue parole avranno un senso altro dal loro». Nel bellissimo finale, Calipso ripete quasi alla lettera una frase del King Lear, che sarà posta in esergo a La luna e i falò: accettare l’istante è l’unica saggezza. Ulisse capisce. È un attimo. Immagino che in quel momento, prima di rispondere, possa sorridere: «Quello che cerco l’ho nel cuore, come te». È grande cosa questo sorriso. «Grande cosa è quello che ci è promesso». Chi sa se a Cesare Pavese, in quell’agosto di cinquant’anni fa, sia tornato alla mente dal punto lontano, e vicinissimo, della sua disperazione il «cuore» di questa attesa. Ha scritto pietà al volto per lui sconosciuto della misericordia, prima di aggiungervi, nell’impossibilità del pianto, la consueta formula del «non esiste»: «Scrivo: o Tu, abbi pietà. E poi?». (Il mestiere di vivere,18 agosto 1950). 11 Gennaio / 2005 12 Pavese tra donne sole I talo Calvino aveva appena ventisei anni, ma già poteva prendere in giro l’amico più grande: «E la cosa che scombussola di più – scrive per lettera a Pavese – è quella donna-cavallo pelosa, con la voce cavernosa e l’alito che sa di pipa, che parla in prima persona e fin da principio si capisce che sei tu con la parrucca e i seni finti che dici: Ecco, una donna sul serio dovrebb’esser 12 Paolo Di Paolo così». Il personaggio di cui parla il giovane Calvino è Clelia, l’io narrante del romanzo Tra donne sole, che Pavese pubblica nel 1949 insieme a Il diavolo sulle colline e La bella estate. Clelia è alla fine della giovinezza, vive sola. «Arrivai a Torino sotto l’ultima neve di gennaio, come succede ai saltimbanchi e ai venditori di torrone» – l’aria cruda le morde le gambe, allora pensa alla primavera «nella penombra dei portici». Pavese aveva molto a cuore Tra donne sole: lo pensava come il «gran romanzo» della scoperta di sé, e del fondo tragico e vano del mondo cittadino. Rileggendo anni dopo quel libro su cui si era trovato a scherzare, Calvino conclude che in Clelia, nella sua fierezza amara, c’è tutto Pavese, e che perciò risulta «il personaggio più bello d’uno scrittore che non credeva nei personaggi». Ma com’è, per uno scrittore uomo, sondare il segreto delle cose attraverso un corpo femminile? Com’è, insomma, questo Pavese-Clelia? Donna dai gesti bruschi, le frasi corte, che tagliano (a volte si pente di averle pronunciate), sacrifica sé stessa a un’idea concreta, laboriosa dell’esistenza («la smania di far da sola, di bastarmi»). Frequenta ragazze più giovani e più lievi, che – a lei pare – si buttano via. Pratica il loro mondo ma con un senso di ripulsa. Sembra pronta a stornare lo sguardo da ciò che dell’esistenza si rivela più sporco, brutale – e però continua a seguire tutto con la coda dell’occhio (restandone turbata, sebbene paia dire, con tono burbero, «so già». «So già», ricorda Natalia Ginzburg, era una delle frasi di Pavese). Sentenzia: «Sporco può essere tutto, è questione d’intenderci, ma allora anche sognare di notte, anche andare in automobile… Ieri la Nene vomitava»; «La vita è lunga. Il mondo non l’hanno fatto gli innamorati. Ogni mattino è un altro giorno». Clelia non si scopre, resta un passo indietro. Osserva le altre – Mariella, Momina – che si lasciano andare, si avventurano, si abbandonano, sanno la verità («è la vita che è sporca») ma Gennaio / 2005 non si sottraggono. Poi magari piangono. Oppure, come Rosetta, si uccidono: «Nel salone arioso, sotto il grande lampadario, sembrava un ricevimento, e si chiedevano come può darsi che chi come Rosetta ha tanto bisogno di vivere, voglia morire. Qualcuno diceva che il suicidio andrebbe proibito». Aveva già tentato di avvelenarsi. Non per amore, dice Momina: «“Lei fa la vita che ho fatto io, che fanno tutte… Sappiamo bene cos’è il cazzo” (…) “Fa succedere dei grossi guai. Sarebbe meglio se non ci fosse”. “Può darsi. Ma a me mancherebbe. A te no? Figùrati. Tutti carini e dignitosi, tutti per bene. Più nessuno sarebbe costretto a uscire dalla sua tana, a mostrarsi com’è, brutto e porco com’è. Come faresti a conoscere gli uomini?”». Le donne che non sono Clelia hanno coraggio di spogliarsi, di stare nude anche dopo aver scoperto che la vita non è nuda, che invece è disonesta, sleale: per quel segreto torbido, «morboso» che da sempre cova, di cui fa avvertire il peso senza mai svelarne la natura. Il disgusto, o la rabbia, derivano dalla coscienza di quel peso, che pure non riesce a privare il corpo di vitalità, di slancio. Le donne che non sono Clelia sono calde e corrono, hanno paura però restano («il vecchio s’era tolta la cinghia e picchiava Gisella come fosse una scarpa. Ma Gisella non scappava», Paesi tuoi, 1941); dicono, delle loro ferite, fa male ancora, sì, ma solo «se fai forte». Le donne sopportano. Sanno che «i maschi non sono cattivi ma scemi». Le donne che non sono Clelia piangono. Come Ginia nella Bella estate, dopo essersi spogliata per Guido, il pittore che ama. Tutto il bello è finito, pensa. Come l’estate. «In 13 certi momenti, per le strade, Ginia si fermava perché di colpo sentiva persino il profumo delle sere d’estate, e i colori e i rumori e l’ombra dei platani. Ci pensava in mezzo al fango e alla neve, e si fermava sugli angoli col desiderio in gola». Quindi si lascia condurre, si abbandona di nuovo. Le donne che non sono Clelia sono quelle di cui Pavese si innamora. Le descrive sempre mosso da uno strano turbamento, che non è soltanto erotico. C’è sì la carica sensuale («la bocca ch’era tutta una voglia e i capelli negli occhi»), ma c’è pure lo strazio: di qualcosa che in fondo si teme, perché inafferrabile, oscuro. «Guido – si legge nella Bella estate – diceva della collina che voleva fare, e che aveva in mente di trattarla come una donna distesa con le poppe al sole, e darle il fluido e il sapore che sanno le donne». Così pure Berto di Paesi tuoi è quasi ossessionato dalla visione della collinaccia-mammella, «tutta rotonda sulle coste e col ciuffo di piante che la chiazzava in punta». Il fluido e il sapore che sanno le donne Pavese ha provato a raccontarlo anche quando si traveste da Clelia e guarda le altre. Se ne avverte tutta l’attrazione e il fastidio, di uomo deluso. Al nono capitolo di Tra donne sole, Momina domanda a Clelia se desidera avere figli. «Chi fa figli – disse fissando il bicchiere, – accetta la vita. Tu l’accetti la vita?». «Se uno vive l’accetta, no? I figli non cambiano la questione». Clelia qui stranamente non sentenzia, e per una volta attende conferma: se uno vive l’accetta, no? Sta in questo interrogativo il ritorno di Pavese a sé stesso: nel suo non poter accordarsi a Momina – a quell’idea di vita, a quel sapore, a quel fluido. 13 Gennaio / 2005 14 Non c’è più tempo, l’ultimo romanzo di Sergio Givone Dante Maffìa S ergio Givone insegna Estetica all’Università di Firenze. Molti suoi libri sono studi fondamentali, per esempio Disincanto del mondo e pensiero tragico, Storia del nulla e Il bibliotecario di Leibniz. E’ sicuramente una delle personalità più in vista della cultura europea, un punto di riferimento. Ha scritto anche opere di narrativa. Nel 1998 Favola delle cose ultime e nel 2002 Nel nome di un dio barbaro, dimostrando immediatamente di saper convertire la sua scrittura saggistica in scrittura narrativa e renderla ancora più leggera, accattivante, coinvolgente. Accadde lo stessa cosa per il suo romanzo più recente, Non c’è più tempo, uscito in questi giorni con Einaudi, come gli altri precedenti. Una invenzione al limite del paradosso, eppure vera oltre ogni dire, favola di una realtà che spesso si consuma in noi come sogno sfuggente e che è invece parte essenziale di un percorso che tutti dovremmo compiere per riuscire ad entrare nel vivo di problematiche alle quali passiamo accanto quasi senza accorgercene. La storia si svolge a Firenze, una Firenze ritratta a 14 puntasecca da chi la conosce dall’interno, dalla parte del popolo, da chi la vive come una sorgente di luce e di ombre che si accapigliano di continuo senza trovare mai la sintesi. La sera del 2 ottobre 1981 Venturino Filisdei, professore di architettura ma adesso in pensione perché finito sulla sedie a rotelle a seguito di una disgrazia, viene condotto in un luogo irreale e Gennaio / 2005 a un tempo massicciamente reale dalla sua badante che egli chiama Capra. Ci si reca perché ha ricevuto una telefonata in cui gli si diceva che avrebbe potuto incontrare un figlio mai conosciuto. Non sembra essere curioso e interessato e alla fine lo è. Si fa accompagnare e nel buio cominciano a tessersi vicende che sembrano nascere dai sussulti delle ombre, dal groviglio intricato di allucinazioni che si susseguono con colpi teatrali davvero strabilianti. Venturino vive una lunga notte infinita davanti a se stesso, alla pioggia, all’abbaiare insistente di un cane, alla tentazione di conoscere e non conoscere, di farla finita o di scoprire il motivo vero per cui ha accettato l’appuntamento. Ha a che fare con personaggi buffi con il piglio e le movenze delle marionette e che invece interpretano una parte seria, quella di terroristi che però cercano una sorta di giustificazione al loro operato, che vivono una loro fede delusi e chiusi in una deriva di rituali. Givone ha la mano felice nel rappresentarli col loro carattere svagato, con i vezzi che accompagnano sempre i giovani impegnati in azioni più grandi di loro. Il terrorismo così viene visto in tutta la sua truculenza e anche in tutta la sua effimera baldanza e insipienza che è offesa all’utopia.. Eppure non risulta un atto di accusa, ma semplicemente un dato di verità che si scioglie all’alba., quando la luce rischiara il luogo, l’Antica Manifattura Tabacchi, già convento di Sant’Orsola. Il testo è cosparso di enigmi che via via sembrano sciogliersi e che invece si 15 caricano di maggiori nodi, di più diffuse allusioni. E’ certo che “il destino di quei luoghi era segnato. Ne avrebbero ricavato piazzali per auto. O rimesse, casengoli,, tettoie presto destinate a trasformarsi in abitazioni”. Osservazioni simili ci spiegano il motivo per cui il protagonista debba essere un architetto, perché in effetti è sul luogo che si giocano le coordinate del mistero e si coagulano i fitti riferimenti del gruppo terrorista. Il luogo è il simbolo di ciò che può essere e non è, di ciò che si progetta e poi si sfalda nella luce. E’ una possibilità e una parvenza, la ricusazione di una sacralità con l’illusione che altra sacralità possa sopperire. Lo svolgimento degli avvenimenti dura meno di dodici ore. Una sfida al tempo impiegato da Joyce e da Broch per raccontarci di Mister Bloom e di Virgilio? O semplicemente la necessaria consistenza del buio che serve a Givone per avvolgere idee e avvenimenti, sensazioni e azioni in un’atmosfera ovattata dentro la quale fluiscono meglio e più agevolmente le “marionette” di turno? Non si dimentichi che “Una teoria dell’architetto è che il luogo decide degli eventi anche più profondamente del tempo” e che “Se l’invisibile che esiste sta in cielo, sottoterra sta l’invisibile che esiste”. Dunque Filisdei a suo modo filosofeggia e in questo filosofeggiare si contorce e ne pensa di tutti i colori, mentre la banda sfila e si propone in varia maniera, compreso quel figlio che finalmente conosce e che ha una fisionomia sfuggente. Del resto lo hanno soprannominato Riseverzi, come dice Givone, riso e cavolo, anzi riso e verza. A proposito di nomi, Givone non li ha attribuiti a caso, a cominciare da Venturino Filisdei. E poi Max Penitenti, Confiteor, Dolores Entierro, Quisqualis, Feuer… nomi improbabili, nient’altro che nomi? O invece “doppio speculare” di una condizione umana che si dibatte nelle incertezze e cerca una giustificazione alle azioni? Il ricorso al “contino di Recanati” e poi al Petrarca crea una alternativa alle teorie, mi verrebbe da dire deliranti, del gruppo dei terroristi che stanno sospesi sul burrone a due passi dalla chiesa di Sant’Orsola, ma si tratta di poesia, cioè di roba inutile, che non attirerebbe mai chi pensa di cambiare il mondo, le sorti degli uomini. Allora le scene si susseguono sempre più tese e proiettate su un teatro che non riesce a liberarsi dalle finzioni per diventare vita che si apre ad altra vita, sviluppo di eventi che non siano soltanto il crogiolo di elucubrazioni attorno a cui sembra di poter giocare il destino dell’universo. Givone riesce a portarci dentro le coscienze di ognuno dei protagonisti e ne sa ricavare momenti storici che vanno al di là di ognuno di loro, perché rappresentano ognuno una posizione chiara, un modo di essere nei confronti del potere. Ma perché come protagonista viene scelto un paraplegico? Perché appare Capra che subito dopo averlo accompagnato deve tornare a casa? Capra è ancora la parvenza della tenerezza e della vita, poi prende dominio il sogno, il non tempo, il pulviscolo notturno che rende 15 Gennaio / 2005 16 inconsistente ogni cosa, dalle voci ai pensieri, dalle azioni ai rumori di sottofondo che cadenzano la mancanza del tempo. Givone ha saputo realizzare uno scenario di autentica rarefazione, dove esistono soltanto le ragioni dell’imponderabile, dei sussulti, dei presagi, della malattia del nulla. Chi è in effetti Filisdei? Il provocatore che deve mettere a nudo gli scalmanati di turno? La loro coscienza? Il loro fallimento? Probabilmente tutte queste cose insieme. In effetti egli non ha nulla di più e nulla di meno degli altri che gli stanno attorno, che parlano di morte, di condanne, di assoluzioni come se fossero officianti di una messa di non si sa bene quale religione. Comunque nel suo allucinato pensare e nel suo intorbidarsi nelle ossessioni che escono dalla sua anima e dalla sua mente come fuochi fatui Venturino mostra di aver preso conoscenza che il mondo è diventato una cloaca massima mefitica e impazzita. Ogni uomo è sospeso al burrone lì davanti, ogni uomo è tentato di perdersi, anche lui, tanto non c’è un prima né un dopo, non c’è più un fine per cui combattere. Neppure quello di un figlio? Già, un figlio : “Lei ha un figlio! Lei, il principe della negazione, il signore del nulla, il maestro della fine, lei, lei ha fatto un figlio. Roba da non credere”. Il figlio, avuto con Maria, la sordomuta, non colma il suo vuoto, la sconfinata materia del grigiore inconsistente. Anche “Alla luce della fiammella il volto del ragazzo è apparso all’uomo in sedia a rotelle come il volto di un altro. Tanto più vicino e 16 intimo, ora che l’identità vera è svelata. Eppure estraneo. E in fondo ostile, ignoto”. Ma al di là della bellezza delle pagine ricche addirittura di aforismi che restano nel lettore con forza e tengono la scrittura tesa in un’aura etica forte e calibrata, e al di là dell’eleganza espressiva che è propria di Givone che riesce perfino a mutuare una lingua di quegli anni non disdegnando neppure vocaboli forse ormai desueti ma che allora erano in voga (“aggalla”, “sgrigliorare”, “casipola”, “manfano”, “sfruculiare”, “manfruito”, “acciocchito”, “abbrica”, “misirizzi”), il romanzo è un affresco di epoca dettagliato e connotato dal flusso di idee che circolavano negli anni settanta e ottanta in una Italia che vide opposte fazioni ideologicamente impegnate in una guerra proprio “senza tempo”. È’ sempre stato quasi impossibile riuscire a scrivere un romanzo di idee, di politica, di storia insieme, un romanzo complesso che sappia contemperare la psicologia dei protagonisti, il loro rapporto con gli altri, con la società, con il mondo. Molti narratori hanno tentato di realizzarlo ma con scarsi risultati, se si escludono alcuni grandi maestri. Sergio Givone invece ci riesce, perché non si preoccupa di mettere in primo piano la storia, la politica, la sociologia, ma la poesia e l’umano, servendosi di quella “tenerezza della memoria” a cui fa cenno nelle prime pagine. Non solo, egli affida ad elementi apparentemente inessenziali la struttura narrativa in modo che il lettore si appropria della storia indirettamente, come se si trovasse per caso in quel “punto cieco di Firenze”. Così diventano legittimi incubi e dubbi, parvenze e risonanze lontane, progetti di vita e di morte. Venturino ormai è il nulla personificato e può assistere indenne e indifferente a ciò che sta accadendo. Non è neppure più protagonista, a un certo punto, ma una delle tante pedine di quella storia senza storie che si dipana come un suono di tamburo che man mano si affievolisce. Il terrore sovrasta, ma qual è il fine di questo terrore che ha mani flaccide e lunghe che si muovono circolarmente? Ecco dunque che il terrore genera dal suo stesso corpo altro terrore e la morte appare sempre più vicina, sempre più pronta a mischiarsi nella notte di sinistri bagliori. Non sa, Venturino, che c’è qualcosa peggiore della morte stessa e che è in agguato. Potrebbe fuggire, poteva non essere andato a questo strano appuntamento. Ma c’è andato, ed ha potuto assistere allo sfacelo di un progetto, di un sogno che, ahimé, “Non significa più nulla”. Sergio Givone ha scritto un romanzo indimenticabile per la forza del dettato che non cede mai agli ammiccamenti romanzeschi tout court, un romanzo soprattutto su Firenze (“E sopra e intorno e fuori di lì, Firenze. Che mai come in questo momento gli appare imperscrutabile. Eppure è stata oggetto d’amore – un amore infinito, il suo. Ma che cosa ha amato di questa sua città? Tutto. Tutto ciò di cui essa è fatta. Le sue pietre. La sua luce. Perché sono pietre di luce, le pietre di Firenze. Pietra serena è pietra di luna. Pietra Gennaio / 2005 forte è pietra di sole. Anche la luce è pietra. Ah, la luce di Firenze! Che un più profondo buio partorisce, allo scopo di ritirarsi nei suoi antri, sparire alla vista ed essere quel che è: buio, invincibile buio, eterno buio”. Sembra di leggere una pagina di Tommaso Campanella tratta dalla Metafisica o Dal senso delle cose e della magia e si comprende perché Givone si serva di tracce e motivi esoterici per farci assistere all’apoteosi del dissolvimento che poteva essere evitato soltanto se i brigatisti avessero pensato che “i giornali del giorno dopo” avrebbero dato all’accaduto scarso risalto. Viene da domandarsi se Venturino non sia anche una sorta di Amleto contemporaneo che analizza innanzi tutto, come ha notato Ivan Turgenev a proposito dell’opera di Shakespeare, e subito però si chiude nel più bieco egoismo. Egli non ama nessuno, non è capace di guardare fuori di se stesso, di affacciarsi alla verità, qualunque possa essere. Eppure Venturino dovrebbe sapere, e dovrebbero 17 saperlo anche i terroristi, che “La vita è lotta”, una vecchia verità di tutti i tempi, come ci ricorda Johan Huizinga, ne La crisi della civiltà. Invece alla lotta ha rinunciato, dimenticando anche che “Due culture si giustappongono sempre, due gruppi, due collettività parlano due famiglie di lingue” (Michel Serres) e che quindi non ci può essere punto di contatto teorico, e che il solo momento di saldatura potrebbe avvenire se non si scambiasse il buio con la luce. Ma l’argomento è vasto e complesso e non è il caso di aggiungere altro alle parole di un Givone che ha saputo rendere anche le idee leggere e cariche di suggestioni narrative. Pregio, questo, raro tra i narratori soprattutto italiani. Insomma, non si leggeva da tempo un romanzo così denso di accensioni, di riferimenti occultati e resi fluidi, di tensioni che hanno il sapore a volte kafkiano e a volte di certe atmosfere francesi degli anni quaranta cinquanta. “C’è stato un tempo in cui abbiamo ucciso per uno scopo. Lo esigeva la giustizia proletaria. Semplicemente la giustizia aveva bisogno di noi… Poi, è vero, c’è stato un tempo in cui abbiamo ucciso senza scopo… Ora lei vorrebbe sapere che tempo è questo… Questo è il tempo in cui il compagno uccide il compagno, il fratello uccide il fratello. Per amore”. Givone ha affrontato un tema che non era facile rendere narrativamente, che presenta di per sé infinite ambiguità e col rischio di fare un romanzo di idee pesante e slegato dalle percezioni storiche. La sua consapevolezza e la sua attenzione costante sia alla struttura e sia al dialogo e al linguaggio gi hanno permesso di rendere le azioni convincenti e significative anche quando si sono avvicinate all’assurdo e al surreale. Infatti si avverte qualche nota lontana del teatro di Beckett, quell’attesa senza attesa che rende le parole stesse qualcosa di stupidamente sublime, di riccamente irrilevante. 17 Gennaio / 2005 18 Perche’ la vita non muore Giovanna Scarsi Giovanna Scarsi è Preside Liceo Tasso di Salerno “T. Tasso” Salerno Fondatrice e Presidente “Martedì Letterari” dal 1981, docente letteratura artistica Università e critico letterario- collaboratrice Studium Roma dal 1979, conferenziere istituti italiani di cultura ed università autrice 23 volumi 800/900, specialista sul rapporto fra le arti. Pubblichiamo il suo intervento al convegno organizzato dal Liceo sulla figura della Fallaci e che ha coinvolto tutta la città. A rrivederci, Oriana non addio, perché la vita non muore. Piccola, minuta, fragile: tailleur grigio fumo, il cappello nero celato su due bande, accuratamente scrinate, di capelli scuri sulle spalle, orecchini di perle bianche; il volto intenso e mobile col solo ornamento delle tue “ medaglie”, alcune rughe ai lati degli occhi e della bocca, gli occhi dal taglio esotico smeraldo: eri tutta nello sguardo vivido, tagliente che mi avvolse e coinvolse come sapevi fare solo tu: prepotente, aggressiva, provocatrice ma capace di squarci di tenerezza con i pochi fortunati cui sapevi che entravano nel cerchio magico della tua simpatia. Così quella sera, l’una di fronte all’altra, in quel contesto di autorevoli personaggi maschi e maschilisti “ fottuti”. “ Chi credevi di trovare, piccola?”. Sono tutta qui: alta 1,56, peso 43 Kg” e la piccola “ di rimando, intimidita,: “Signora io sono alta 1,58 e peso 45 Kg ma senza i suoi tacchi”. 18 Erano gli anni delle battaglie laiche e laiciste sul divorzio, l’aborto etc. Una signora all’antica o un’antica signora nella sua elegante casa in via Prati a Firenze dove parlò di “ Un Uomo” che avremmo dovu- to presentare a Salerno in un martedì letterario con l’assenso eccezionale di Lei, schiva a cose pubbliche ed altro: fra oggetti antichi, quadri e mobili antichi, ritratti, piccole cose anche ma su ciascuna impressa una ve- Gennaio / 2005 stigia del passato: l’unica certezza concreta per Oriana – il Futuro un’ipotesi: senza il passato non c’è il futuro come senza memoria non c’è civiltà. La Memoria - gridava nei giorni di pericolo per la sua Firenze - causa la presenza dei No Global, è la vera forza della Civiltà. Sentii di trovarmi davanti ad una persona speciale, una vera donna, capace di una percezione del Reale, speciale, fondata sull’intuito della ragione ma anche su quello del cuore, pur sempre filtrato dalla mente. Intransigente e dura prima con se stessa, aliena dal compromesso, era fiera della sua indipendenza pagata sulle sue spalle e della dignità con cui era ostinatamente sfuggita ad ogni irregimentazione in congrega politica letteraria accademica che sia, in nome della sua Religione della libertà che le dava il coraggio e l’orgoglio della Verità. Atea-cristiana fino all’ultimo, visse con coerenza le sue convinzioni; il suo ultimo saluto fu alla cupola del Brunelleschi nella sua Firenze, sublimò nell’Assoluto dell’Arte la sua ricerca dell’Assoluto, religiosa più del credo storico che rifiutò. Che ella rifiutò fino all’ultimo. Se ne andò insieme a Suor Leonella, a significare per caso, come coraggio, verità, amore, avvicinino vite diverse ma parallele perchè accomunate dagli stessi ideali: la Verità e l’Amore. San Francesco, il Santo della carità, era il suo amuleto, Papa Benedetto il suo riferimento di rispetto pur nella sua laicità, convinta, qual era, della forza della tradizione per l’opera svolta dalla Chiesa nella storia. 19 Vero è che Oriana era e fu fino a l’ultimo se stessa : un Io “ipertrofico” che si nutriva di contrasti irriducibili: elegante e cinica, aggressiva e tenera, forte e fragile, colta e popolare, il tutto si dissolveva in quell’energia esplosiva, il vero prodigio di una vitalità eccezionale che si sprigionava tutta nel fascino della sua affabulazione e della sua gestualità, comprese le sfuriate proverbiali quando parlava. Parlava come scriveva: tutti tacciono, rapiti nel vortice della sua incisività ed immediatezza di comunicazione. Oriana era se stessa anche nell’abbigliamento: quella in tailleur era la seconda Oriana. Ai nostri tempi, fece moda il mito dell’esile ragazza: elmetto, tuta, scarponi, la prima donna soldato nella guerra dove essere donna non solo è inutile, ma è dannoso. Già bambina, a nove anni, faceva da staffetta nella resistenza con la bici, nascondendo i messaggi dentro le treccine, accanto al padre Edoardo che fu il suo mito: lo stesso ebbe il coraggio di darle uno schiaffo perché in quelle circostanze una bimba non deve piangere. Vennero poi le guerre storiche di cui lei fu testimone attiva: del Vietnam, Libano etc. dove la morte la sperimentò di persona, accanto al suo compagno fotografo,Gianfranco Moroldo con cui maturò un rapporto di intesa profonda nella collaborazione fervida: testimoniavano entrambi, lei con la forza della scrittura, lui con la forza dell’immagine, a leggere e interpretare i fatti. A Città del Messico, ferita, fu creduta per qualche momento morta. Erano i tempi in cui Oriana in pubblico porta- va i jeans e i capelli lunghi, quando noi portavamo la minigonna ed i capelli cotonati e le Signore ingioiellate usavano raffinati e costosi maquillages. Ancora ricordo la lite con la Cederna, allora sulla cresta dell’onda: la signora incipriata ed ingioiellata rinfacciò ad Oriana che faceva la populista vivendo in una casa di ventidue stanze. Ad un’attricetta Sabrina Guzzanti, che si fece trovare sotto la cupola del Brunelleschi, vestita come lei, nelle giornate del forum fiorentino, irridendo il cancro e la chiamò guerrafondaia, Oriana: “ Giovanotta, al cancro non si irride. Circa la guerra io non l’ho vista a cinema ma l’ho vissuta per dare a lei e ai suoi compari la libertà di cui godete”. Essere donna è affascinante, è un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non finisce mai”. La sua testimonianza è storia per cui ognuna di noi le deve gratitudine. Invece, le donne le furono nemiche, eccetto quelle vere e grandi come la Loren, Magnani, la Rossellini, la Madre Tosca che le raccomandava di scrivere facile perché capissero gli altri. La invidiavano, anche se - come la sorella Paola più volte ha affermato - quel successo così sudato era fonte di infelicità “ Mi sento come l’ultima medusa nell’oceano deserto:”; la sua solitudine era la sua grandezza. Non furono capiti i suoi discreti appelli di amore, i suoi affetti furono rari ma intensi e schivi; invece fu odiata dalle donne, lottata dai colleghi maschi che oggi mutano in elogi quegli stessi difetti, perché se li avessero avuti loro non sarebbero diventati direttori di giornali. 19 Gennaio / 2005 20 Ed il telefono tace e non solo per la volontà di Oriana che non apriva la posta dall’Italia ma per una voluta avversione dei suoi concorrenti che così scaricavano con gli improperi e le calunnie i loro complessi di inferiorità. Qualche donna tentò anche di imitarla ma il modello restò inattingibile. Invece, l’America la osannava ( laurea honoris causa, premio al coraggio ecc….): nei paesi dove la donna vale meno di un cammeo divenne un mito ed un idolo. Concludeva la fila degli esuli grandi del’900, innalzando l’esilio a categoria etica di libertà come i maestri del passato. Vero è che senza Pasolini prima e senza Fallaci dopo, non ci sarebbe stato il dibattito di contestazione storica.” Ho sempre pagato per dire quello che dico ed essere quella che sono”. Una persona che dice “ pane al pane vino al vino,” che butta in faccia la verità, che non si piega ai ricatti e imposizioni. Una persona libera: “tutta la mia vita professionale è stata un crucifige, ogni mio libro, articolo reportage”. Un novello Padre Turoldo, cattolico del dissenso, che per altre strade, testimoniò per lo stesso obiettivo: la Verità e l’Amore. Verità ed Amore anche nel dramma del cancro, “il drago” per Turoldo, per Oriana “ l’alieno” con cui manteneva colloquio di sfida ogni giorno. “ Ritenevo prima dovuto tutto: ho apprezzato il sole e il mare, il miracolo della vita…. Perbacco qui si muore, bisogna mettersi subito al lavoro”! Attinse dall’alieno che dominò sempre con il cervello, la forza di inizia- 20 re il romanzo segregandosi per anni nella sua villetta a New York, cercando la verità, interrogando ed interrogandosi. Un percorso di fatiche estenuanti, ma lei sola, sfinita ma ostinata e lucida scriveva indefessamente: un lavoro il più faticoso ma che fu la sua forza e la sua terapia. Ma il mondo intero la conosceva e l’ammirava attraverso quella lettera tradotta in tutte le lingue che fu strumentalizzata addirittura nelle battaglie abortiste delle femministe che detestavano Oriana con la stessa visceralità con lui lei le detestava. Quel libretto, invece, è il canto della vita che si leva da un’anima ferita dal dramma della maternità mancata, fra dolori e lacrime. “ Uno muore due volte quando muore senza lasciare un figlio. Non c’entra la creatività; i figli di carta sono altra cosa e non valgono a sostituire quelli veri”. “Stanotte ho saputo che c’eri: goccia di vita scappata dal nulla” ; “ spero che tu non abbia mai urlato l’atroce bestemmia: perché sono nato ? Spero che tu abbia concluso che ne valeva la pena: a costo di soffrire, di morire….. Ma altrove nascono mille, centomila bambini e mamme di futuri bambini. La vita non ha bisogno né di te né di me. Tu sei morto. Ora muoio anch’io. Ma non conta, perché la vita non muore.” Un inno alla vita come un inno all’Amore alla Piaf “ Un uomo” il suo uomo, l’unico che un suo collega miserabile disse che era lei, Oriana! Non poteva esserci vituperio maggiore per un romanzo che ha consacrato un eroe nazionale e non un amore ma l’Amore come lei lo intese e lo visse,” un’amicizia, un’intesa non per passione fisica”. Un Assoluto, quell’Assoluto si chiamava Alekos Panagulis. Chi era e quale la verità della storia al di sopra dei contingente della cronaca? Oriana detestava il gossip ed andava dritto per la sua storia. In suo rispetto anch’io tralascio i dettagli, talvolta disgustosi, delle cronache di allora di quanti, soprattutto le donne, non sapevano né potevano levarsi a tanta altezza. La verità la consacra il libro e la consegna alla storia: Oriana ha così compiuto la sua missione di giornalista testimone della storia secondo la volontà di Alekos che le aveva affidato questo compito che solo lei poteva assolvere avendo in custodia i documenti che lui gli aveva consegnato. Salvare Alekos dall’oblio, affidarlo alla memoria dell’immaginario collettivo, consacrare l’Assoluto dell’Amore e con esso quei valori per cui insieme avevano lottato: la Verità, la libertà, il coraggio della lotta contro la tirannide, non solo quella politica ma quella della miseria del quotidiano, dell’ignoranza e della stupidità. L’eroe nazionale nasce con un “Uomo” : i suoi funerali del cinque Maggio 1976 descritti in pagine di alto pathos ne sono la testimonianza. Alekos aveva lottato contro la dittatura militare in Grecia con ostinazione e coraggio che rasentò il fanatismo. Dopo l’attentato a Papadopulos fu incarcerato, torturato e condannato a morte. Oriana l’incontrò all’uscita del carcere e fu amore a prima vista, un’inte- Gennaio / 2005 sa di amicizia, una sintonia immediata etico-estetica, fondata sulla fede in valori comuni soprattutto la libertà nella lotta contro il potere, la verità , il coraggio, i sensi giocarono l’ultimo ruolo. Perciò durò al di là delle distanze, al di sopra dei gossip e delle tempeste furiose con poche tregue nonostante i dodici anni in più di Oriana. Lui beveva e delirava, era violento ed ostinato, lei era sempre pronta a perdonarlo e proteggerlo, era il suo approdo. Ad ogni interruzione e promessa di rottura , di nuovo si cercavano fino a quel cinque Maggio in cui si erano dati appuntamento ad Atene e lei vi si recò d’urgenza per il suoi funerali, chiamata mentre svolgeva una conferenza. Fu l’appuntamento con la morte apparentemente avvenuta per incidente d’auto ma di fatto determinata da un attentato politico al deputato Panagu- 21 lis; che Oriana aveva creato lei: fra vicissitudini numerose Oriana l’innalzò a simbolo di eroe poeta nazionale della Grecia, svelando tutta la verità su quei documenti che solo lei possedeva. Una storia che è anche l’espressione della saggezza del poeta che si batte contro i mulini a vento, dolorosa sì ma anche ilare e gioiosa. “ Ti amo ora, ti amerò sempre:” è la scritta sul cuscino di rose bianche. La divina di Manattan non è più uscita dal suo riserbo ma ha continuato a controllare dal suo limbo di aristocratica solitudine come dalla torre di un osservatorio, il mondo intero: intervistando i potenti del mondo, condannando e facendosi condannare, lanciando anatema contro tutto e tutti , ma sempre fedele a se stessa, alla sua passione di vivere e di soffrire. Il simbolo era quell’amore di donna indomabile che fu domata solo dalla vitalità travolgente di un uomo forse non bello che fu travolto da una donna bella non so, ma che dominava e dava fastidio, anche per la sua età maggiore, per la classe, per lo stile, il fascino dell’intelligenza e della parola. “ La bellezza non basta in un rapporto se non si ha nulla da offrire se non il monotono “ facciamo all’amore”, che suona alla fine attentato alla libertà”. “ L’amore al suo sbocciare è una festa di verde , al suo appassire un mucchio di foglie marce”. Ma senza quell’amore non ci sarebbero stati né la “Lettera a un bambino mai nato” - vero o falsa la storia di quel calcio nè “ un Uomo”. Ancora una storia di donne capaci di sublimare il sacrificio di una vita nell’arte. Prima di lei Eleonora Duse che anche l’America scoprì ed acclamò. Così l’amore non muore perché la vita non muore. 21 Gennaio / 2005 22 Una vita alla radio Marco Tesei “P er ogni cosa ci sono due parole, una che ingrandisce e una che rimpicciolisce”. Lo diceva Robert L. Stevenson nel “Signore di Ballantrae.” Come dire che le parole vanno usate con cautela, con quella accortezza semantica che non conduca a fraintendimenti, dubbie interpretazioni, ambigui segnali. Qualchesecolo prima, Pindaro affermava che “le parole hanno vita più lunga che i fatti”. E’ una 22 (ideatore e conduttore di Radio Games, Rai RadioUno, domenica mattina) frase che fa riflettere soprattutto se, come spesso accade ed è giusto che accada, ci chiediamo quanto sia valida oggi una simile affermazione. Una cosa è certa. Pindaro contraddice la celebre: “verba volant, scripta manent”. E’ vero, il suo riferimento non è ad una pagina scritta quanto ad un’azione, un insieme di comportamenti o una sequenza( parola usata in senso strettamente cinematografico) di atteggiamenti dalla cui somma si deduce appunto “un fatto”. Non si riferisce alla pagi- na scritta ma quello che a noi interessa, coinvolti e spesso travolti dalle tecnologie che cambiano ogni 24 ore, come una prescrizione medica: una pasticca , una volta al giorno o al dì( in alcune ricette c’è scritto ancora “dì ”), è capire, per essere consapevoli, se “le parole hanno vita più lunga dei fatti”. Capire per essere consapevoli con la stessa differenza che esiste in latino tra “quaero e “peto” (cioè chiedere per sapere e chiedere per ottenere). In questo caso, noi vogliamo sapere, in quanto le parole sono il nostro pane Gennaio / 2005 quotidiano, le parole servono a incantarci, a convincerci, a distrarci, a coinvolgerci……a ingannarci.……….Insomma, è l’uso della parola che conta, non la parola in sé: il significante non il significato. Perché un giornalista radiofonico si deve preoccupare di queste cose? Quando Pindaro faceva quell’ affermazione non soltanto radio e televisione sarebbero state( se fossero apparse all’improvviso) una terribile maledizione di Zeus come i tornadi o un’eclissi di sole per le popolazioni primitive; ma anche una rivoluzione impossibile. Troppi passaggi logici, troppe fasi evolutive saltate per pensare di non trovarsi di fronte a mostri distruttivi. “Ogni cosa a suo tempo”, dunque: è sempre un sano proverbio popolare. Oggi che radio e televisione hanno cambiato la nostra vita e che internet, telefonia mobile, e-mail, la stanno ulteriormente cambiando e ancora lo faranno al di là di noi e malgrado noi, quella frase di Pindaro non va più bene. Oggi, la parola si accavalla con un’altra, sfugge, si intreccia e si confonde con il mezzo che la diffonde, il senso della realtà è cambiato, quindi è cambiata la sua percezione. In fondo, viviamo producendo un’infinità di discorsi, articoli, reportagès televisivi e radiofonici, libri di tutti i generi che, guarda caso, sono un insieme di parole ma spesso l’esito complessivo è quello di un ammassarsi multiforme e difforme, precario e provvisorio( che poi ha “quasi” lo stesso significato). Insomma, è il trionfo del “tutto e il contrario di tutto”. Meglio i fatti, caro Pindaro, meglio i fatti.“Io credo soltanto nella 23 parola. La parola ferisce, la parola convince, la parola placa. Questo, per me, è il senso dello scrivere”(E. Flaiano). La parola. L’intellettuale di Pescara, molto citato per le sue antinomie dialettiche, per i suoi sillogismi “alla rovescia”, per quell’ ironia dove il senso del tragico diventa una lotta contro “l’illogicità della vita”, un trionfo del paradosso come schermo di altre verità, rappresenta un modo di intendere il reale che si insinua nella nostra sensibilità di lettori: gli ascoltatori della radio dovrebbero essere come i lettori di Flaiano. Un sorriso consapevole li dovrebbe sempre accompagnare. -“L’italiano è una lingua parlata dai doppiatori”. Ancora Flaiano, che aveva spesso come bersaglio proprio l’italiano. Un altro paradosso ma che confina con la verità. La nostra lingua diventa vera soltanto quando la parlano i doppiatori: una lingua retorica, costruita, tradotta da un’altra lingua; una lingua quasi “solitaria” perché gli italiani non la conoscono se non attraverso i mass-media e il cinema. Gli italiani conoscono non la lingua che parlano ma quella che ascoltano attraverso televisione, radio, cinema. La radio che faccio io Chi parla alla radio dovrebbe avere dentro di sè umiltà ed entusiasmo. Innanzitutto, mantenere il senso delle proporzioni ma prima di tutto dei ruoli. Vale a dire: parlo alla radio non per soddisfare un latente esibizionismo con tendenze narcisistiche, ma per rivolgermi a chi ascolta, tanto più che al di là di sondaggi, ricerche di mercato, studi di ogni genere, l’ascoltatore resta sempre un mistero. L’entusiasmo aiuta a rinnovarsi anche quando si crede di essere “veri professionisti”. E poi fa bene: evita un virus terribile che può catturare anche chi ha un microfono davanti: LA NOIA! All’inizio di questo scritto, vi ho doverosamente intrattenuto su alcuni aspetti tecnici che si riferiscono alla conoscenza del mezzo. Questo ha implicato una serie di descrizioni specifiche che servono a capire di che cosa si sta parlando. Sono elementi propedeutici che, se necessari per chi vuole fare il dentista( quelli per i dentisti, ovviamente) devono per necessità essere appresi anche per i giornalisti della radio. Tutto è utile e a volte anche geniale (è il caso di Gadda). Ma come leggevo anni fa in un manuale di antropologia culturale, esiste il ruolo e “l’interpretazione del ruolo”. Vale a dire ciò che si deve sapere per essere e ciò che si deve essere per sapere. Insomma, la radio potenzialmente offre a chi si mette una cuffia sulle orecchie e un microfono davanti, una vasta gamma di modalità espressive. Questo dipende dalla personalità, dalla professionalità e dal talento. E’ una parola impegnativa( e ripensando a Pindaro me ne assumo la responsabilità) ma anche la radio ha persone di talento e quando le ascolti te ne accorgi. Io cerco sempre di parlare con la massima disinvoltura, senza un testo precostituito, con appunti di massima, una scaletta essenziale, stringata e un buon dosaggio di improvvisazione. Va tenuto presente che mi occupo di programmi culturali e non di conduzione di Giornali Radio. In quest’ul- 23 Gennaio / 2005 24 timo caso, è necessaria una maggiore “compostezza”, un certo distacco dalle notizie ma non freddezza e nemmeno asetticità (ma senza troppa partecipazione). E’ più facile farsi tagliare a pezzi in una scatola con lame di metallo che penetrano da tutti i lati? Certamente sì, anche perché in quel caso c’è il trucco e quando sei al microfono i trucchi non ci sono, non ci possono essere. Dal momento che, dopo tante PAROLE, qualcuno potrebbe rimanere quanto meno dubbioso, ecco due esempi concreti del mio modo di intendere la radioIl primo si riferisce ad una conduzione del GR1 cultura del 1997 proprio sulla lingua italiana. Buona giornata…… .”oh, parole, quanti delitti si commettono in vostro nome!” A dirlo è Eugene Ionesco e c’è da crederlo, il drammaturgo di origine romena sapeva quel che diceva. E noi oggi proprio di parole parleremo, non sappiamo quanto compromettenti o delittuose per riprendere Ionesco ma sicuramente parole ricorrenti, di largo uso………andando a scovare la loro data di nascita. Questo tra poco, dopo la rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani che, come ogni lunedì, arriva dall’estero. Tocca al nostro corrispondente da Londra. “Le parole false non sono soltanto male in se stesso, ma anche contagiano l’anima. “ Non l’abbiamo detto noi ma Platone. Ebbene, persi in un mare di parole, avvolti nuoda vocaboli vecchi e nuo vi, dietro l’uso di modi di quotidire, tra linguaggio quoti diano e scritto, parlato, ririferito, tramandato, ri proposto, cancellato, posrecuperato, non pos torsiamo che dire: tor nare all’origine delle parole non è soltan soltanto curiosità fine a se stessa ma anche un percorso culturale, un percorso an ancora da esplorare e decifrare per conoscere, in una volta sola, le tante piccole storie che for formano la Storia. La radio di domani Non mi avventurerò in previ previsioni troppo compromettenti sul futuro della radio. Ma ci sono dei segnali che fanno ben sperare. Quando nacque la televisione, si disse che la radio sarebbe morta. E’ successo altre volte con il proliferare dei canali televi televi- 24 sivi, con la pay TV. Internet avrebbe dovuto affossarla. Persino gli SMS( è ancora sto cercando di capire perché) ma è stato detto. In realtà, la radio, come dimostrano i dati di ascolto è sempre più nel cuore della gente. Radiouno Rai occupa il primo posto di questa classifica seguita da altre emittenti che hanno scelto ciascuna la loro modalità di espressione. Pochi sanno che Jean Tardieu, annoverato come uno dei più interessanti drammaturghi dell’assurdo, lavorava alla radio francese. Ebbene, non c’è nessun mezzo di comunicazione che permetta di dimostrare quello che si è come la radio. La radio è crudele. Ti fa capire subito chi è valido e chi lo è un po’ meno. Ma non basta. La radio consente una spinta alla creatività. Le idee si “accucciano” dentro la radio, la radio le cova come una chioccia e le fa nascere, crescere, maturare. Il supporto telematico è oggi di grande importanza per la radio.Il sito di RadioRai è un supporto essenziale per informare e indirizzare lo spettatore e l’ascoltatore. Oggi un programma radiofonico ha molte vite: attraverso l’apparecchio radio ma anche sul web, può essere scaricato, ci sono, in molti casi, i numeri verdi, gli SMS, la comunicazione diventa quasi “interattiva”, nel senso che si moltiplicano i canali del comunicare.Anche per queste nuove realtà, il linguaggio delle radio cambia. Lo fa discretamente, ma avviene.Le tecnologie, invece che affossarla, le hanno offerta un’altra grande opportunità di esistere come e meglio di prima. Non lasciamoci sfuggire una simile occasione. Gennaio / 2005 25 Nel mondo delle volta al nuovo mondo si rivolse. Anche lei camminava ora per quelle strade prima tanto desiderate, ma non erano più larghe e vuote come prima le aveva viste o forse solo immaginate. Ora in tanti si guidava Greta cresceva turbata, un po’arrabbiata e amareggiata, ma col tempo la rabbia se ne andò e la delusione cominciò. La delusione per aver creduto in quello che aveva ingenuamente veduto, ma che in fondo non era mai esistito né accaduto. Un giorno però Greta inciampò nelle reti dell’amore. Lui e lei di nuovo racchiusi in una bolla di sapone, a rivivere la favola che da bambini li cullava. Si potevano stringere, baciare, intrecciare. Si potevano amare e lo fecero più volte. e il rischio c’era sempre che qualcuno ti acciaccava. Pochi erano i boschetti, spesso i poveri alberelli erano più simili a fragili stecchetti. Non più verdi le città, ma grigie e buie senza speranza per la luce della felicità. Il mare c’era, ma era oscuro, benzina e smog lo rendevano poco puro. Succedeva che se sbagliavi non la pagavi, che se nella vita tu vincevi era perché qualcuno lo conoscevi, se eri importante, ma un furfante non avevi come gli altri la pena più umiliante. Il clima era dunque di tristezza e di amarezza, quello che la gente prova quando nel suo mondo non c’è sole, non c’è amore e non c’è vera giustizia. Ma la felicità di quell’amore consumato tutto aveva rovinato perché la bolla aveva scoppiato e i due amanti separato. Così Greta tornava sulla terra a vivere l’amarezza di quel dolore e di quell’età che avanzava e maturava. Ora non ci credeva più, nemmeno all’amore, nemmeno ai sentimenti del suo cuore. E quando capitava che l’emozione di nuovo forte per qualcuno la stregava… no, non si avvicinava, a mezz’aria come da bimba restava. Perché da grandi tante volte era ancora bello restare fra le nuvole del cielo, e dalle favole cullati, coccolati, rassicurati, anche se purtroppo tristemente o felicemente ingannati. bolle di sapone G Apologo-favola di Marzia Consalvi reta era piccola e serena, viveva in una bolla di sapone adagiata su leggeri fiocchi di cotone e a mezz’aria si cullava senza mai salire troppo in alto perché era lì che si raffreddava l’aria, il suo cuore le gelava e la vista le annebbiava. Preferiva quindi rimanere a quell’altezza, tanto alta quanto bassa da preservare la mitezza mai avuta ad altra altezza. E da lì guardava il mondo che le appariva come un grande e armonioso tondo: il mare blu, ovunque cristallino, proteggeva ogni suo piccolo e grande pesciolino. Foreste verdi, ovunque fitte, ospitavano specie varie e mai estinte. Per le strade lunghe, ovunque grandi, si camminava in tanti, ma in pochi si guidava perché a nessuno il cammino affaticava e il tempo ritardava. Sani e forti si nasceva e col cibo del buon orto si cresceva. Se sbagliavi la pagavi, se nella vita tu vincevi era perché qualcosa la valevi, se eri giusto e meritevole ti aspettava il posto più lodevole. Se eri importante, ma un furfante meritavi come gli altri la pena più umiliante. Il clima era dunque di letizia, quello che la gente prova quando nel suo mondo c’è sole, amore e vera giustizia. Ma Greta cresceva e la sua bolla di sapone la premeva e la stringeva. E così in un solo puff, un giorno la bolla si dissolse e Greta per la prima 25 Francesco Alberoni L Torniamo ad esser quelli che inventarono la Vespa a crisi economica finirà quando le nostre imprese creeranno prodotti più adatti alla nostra epoca e a prezzi concorrenziali. Oggi molti di questi prodotti esistono già in forma di prototipi lasciati in un cassetto. La gente vorrà acquistare auto promiscue a benzina, a metano o ad elettricità, villette o case in condomini alimentati con energia solare, spostarsi in una rete metropolitana sotterranea capillare, usare treni ad alta velocità. Occorrono poi desalinizzatori per le regioni aride, trasporti di merci su rotaia, scuole più complete e più moderne, una sanità con metodi e tecniche che evitino i paurosi ritardi odierni. Molti pensano che per raggiungere questo risultato si debba rivoluzionare il nostro tessuto produttivo. Nient’affatto. L’innovazione sorge proprio nei distretti che hanno già cultura industriale, tradizione, dove esistono centinaia di imprese che cercano, sperimentano, hanno rapporti con tutto il mondo e percepiscono subito i bisogni emergenti. Il nostro Paese ha molte di queste aree. Alcune nate per iniziativa di un uomo o di una famiglia come Agnelli a Torino, Marzotto a Valdagno, Ferrari a Modena. Altre generate da una collettività 26 come il Parmigiano Reggiano, l’oreficeria a Valenza Po o le ceramiche a Sassuolo. Spesso sono tradizioni antichissime, antiche sensibilità ed antichi saperi che hanno fruttificato nel tempo arricchendosi di tecnologie cresciute insieme al prodotto. E che sono pronti a sbocciare di nuovo. Si dice che l’Italia non ha ricerca e sviluppo. Non è vero. Queste comunità di imprese, più numerosi centri universitari o postuniversitari di altissimo valore— per esempio i Politecnici di Milano e Torino, l’Istituto del Restauro a Firenze, Sant’Anna di Pisa, Telespazio, il Centro Nazionale di Fisica Nucleare — costituiscono altrettanti laboratori di ricerca avanzata proiettati sul mondo, patrimoni preziosi che dobbiamo conservare e alimentare. Guai a tagliare loro le radici, sarebbe una perdita incolmabile che nessun apporto tecnologico astratto potrebbe più colmare. In questa crisi le misure finanziarie sono insufficienti. La ripresa verrà quando inventeremo prodotti adatti alle esigenze del presente e del futuro. L’Italia del dopoguerra ha saputo farlo, pensiamo solo all’invenzione della Vespa, della Lambretta, della Cinquecento, della plastica. E’ l’entusiasmo, la voglia di vivere, di fare, di riuscire che crea. 27 SoLuZIoNI Sudoku Sudoku
Scaricare