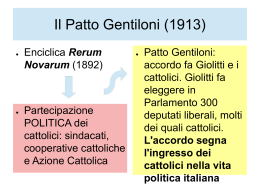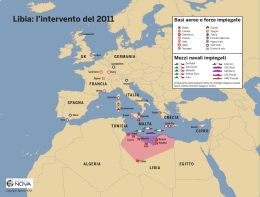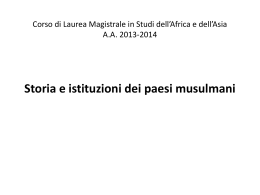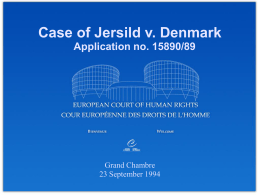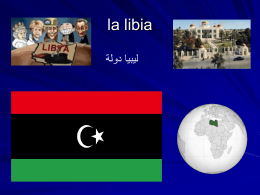www.ildirittoamministrativo.it Rivista giuridica Registrata presso il Tribunale di Catania ISSN 2039-6937 OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE FEBBRAIO 2012 A cura di Luca SALAMONE (www.lucasalamone.it) T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 8 febbraio 2012, n. 157 (In tema di natura provata della strada e uso della stessa). Con la pronuncia in rassegna il giudice amministrativo ha evidenziato che risulta ammessa la natura privata di una data strada allorché non emerga l’assenza dei dovuti e necessari accertamenti in ordine alla sussistenza di un eventuale uso pubblico pregresso della stessa, nonché in ordine alla concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di pubblica utilità. Ed infatti, non può desumersi l’uso pubblico di una strada dal fatto che il passaggio venga esercitato nell’interesse di un gruppo limitato di soggetti, quali proprietari di immobili confinanti con la strada in questione, dovendo invero essere dimostrato che la stessa sia al servizio, in modo continuativo, della generalità indifferenziata dei cittadini uti cives e non uti singuli. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 684 (In tema di ritiro del libretto a personale marittimo e riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo). Con la pronuncia in rassegna il giudice amministrativo di appello ha stabilito che il danno provocato ad un marittimo dal mancato imbarco conseguente al ritiro del libretto di navigazione protrattosi nel tempo per una visita di controllo è in astratto riconducibile al comportamento della cassa di previdenza marittima che aveva disposto la visita medica biennale oppure al comportamento della commissione medica di primo grado, dipendente dall’ex Ministero della marina mercantile (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), che ha, poi, proceduto all’accertamento sanitario, incorrendo in vari ritardi nel corso della sua esecuzione. Ne consegue, in quest’ultima ipotesi, il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria rispetto alla relativa controversia, devoluta alla cognizione del giudice amministrativo (annulla con rinvio della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I bis, n. 68/2011). Corte Europea Diritti dell’Uomo, sez. Grande, sentenza 23 febbraio 2012 (In tema di respingimenti dei migranti clandestini in mare e violazione della CEDU). Con l’importante pronuncia in rassegna, la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo (CEDU) ha condannato l’Italia per i respingimenti di immigrati clandestini verso la Libia. La questione decisa dalla CEDU concerne il famoso caso “Hirsi Jamaa e altri contro l’Italia” risalente al 2009 e relativo ad un gruppo di immigrati provenienti dalla Libia intercettati, in corso di navigazione, dalle autorità militari italiane e rimpatriati dalle stesse nel Paese africano. Nel dettaglio, la pronuncia trae origine dal ricorso di 24 profughi, 11 somali e 13 eritrei, in merito agli avvenimenti accaduti nel corso della notte tra il 6 e 7 maggio 2009, quando tre grosse imbarcazioni provenienti dalla Libia vennero intercettate da unità militari italiane in acque internazionali, a 35 miglia a sud di Lampedusa (in zona di ricerca e soccorso di competenza maltese, non già italiana, ma Malta nella fattispecie si è rifiutata di intervenire). A bordo delle imbarcazioni fermate si trovavano circa 200 persone, originarie della Somalia e dell’Eritrea, tra cui alcune donne incinte e molti bambini. Tutti i migranti furono trasbordati su altre imbarcazioni militari italiane e, da queste, riaccompagnati in Libia contro la loro volontà, senza essere informati sulla loro effettiva destinazione e senza avere avuto la possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale in Italia. Il caso è giunto davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo il 26 maggio del 2009 e il 15 febbraio del 2011 è stato trasferito alla Grande Chambre. Sono stati autorizzati ad intervenire come terza parte nella procedura, tra gli altri, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e le organizzazioni non governative Human Rights Watch e Amnesty International. La linea difensiva del governo italiano è stata piuttosto articolata e si è basata su diversi argomenti. In via pregiudiziale, si contestava la correttezza formale dell’atto di procura firmato dai ricorrenti in favore del gruppo di avvocati che li rappresentava e il fatto che questi potessero essere identificati effettivamente come vittime della presunta violazione. Sul punto si evidenzia che, in un caso analogo trattato dalla Corte europea dei diritti umani nel 2010 (Hussun and Others v. Italy, nos. 10171/05, 10601/05, 11593/05 and 17165/05, 19 January 2010), la mancanza di firme autentiche sull’atto che autorizzava i legali a trattare la causa e di ulteriori contatti tra i legali stessi e i loro presunti clienti era stato il fondamento per la decisione di cancellare dal ruolo il ricorso. Nonostante la difesa, tuttavia, la sentenza della Corte ha riconosciuto l’autenticità delle firme e l’esistenza di effettivi contatti – benché soltanto telefonici o tramite e-mail – tra gli avvocati e le persone vittime dell’operato dello Stato, il persistere del loro interesse a continuare a causa e la loro identità di vittime della condotta contestata. La seconda eccezione, di carattere pregiudiziale, opposta dallo Stato italiano riguardava il difetto di giurisdizione in forza del quale l’attività posta in essere dalle autorità italiane, essendo avvenuta in acque internazionali, non è stata compiuta in un luogo posto sotto la giurisdizione dello Stato italiano; inoltre le autorità italiane che hanno tratto in salvo i profughi africani avrebbero compiuto un’operazione di salvataggio in mare e non un’operazione di polizia, di conseguenza, la giurisdizione della Corte europea dovrebbe essere esclusa. Sul punto tuttavia la Corte ha giudicato che l’Italia, nel caso in specie, stava esercitando la sua giurisdizione quando successivamente ha trasferito su una nave le persone intercettate respingendole verso la Libia. Inoltre, la Corte non ha ritenuto accettabile tale argomentazione affermando che lo stesso codice della navigazione italiano, oltre che il diritto internazionale, riconoscono che anche sulla nave militare in alto mare si applica la giurisdizione dello Stato della bandiera. Ne consegue, ad avviso della Corte europea, che non è possibile aggirare la regola invocando il fatto che nella fattispecie si sia trattato di un’operazione di salvataggio e non di polizia. In ogni caso, ad adbundantiam, ad avviso della CEDU tra il momento in cui i profughi sono stati accolti a bordo delle navi italiane e quello, temporalmente successivo, in cui gli stessi sono stati consegnati alle autorità libiche a Tripoli, le autorità italiane hanno esercitato su di essi un controllo de facto che impegna la responsabilità dello Stato italiano per qualunque violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione europea (a sostegno di tale tesi è citata la sentenza Medvedyev and Others v. France ([GC], no. 3394/03, 29 March 2010). Superate le eccezioni preliminari, la Corte ha passato al vaglio le diverse censure mosse nei confronti dello Stato italiano, ossia: la violazione dell’art. 3 della CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti, in altre parole i trattamenti inumani); dell’art. 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive); dell’art. 13 CEDU, da solo ed in connessione con gli artt. 3 e 4 del Protocollo n. 4 CEDU del 1963, essendo mancato un rimedio adeguato, che avrebbe permesso un esame dei reclami dei migranti. Quindi, entrando nel merito, secondo i giudici di Strasburgo nel caso esaminato si configura la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, che sanziona i trattamenti degradanti e la tortura, in quanto i profughi “furono esposti al rischio di maltrattamenti in Libia” nonché a quello di “venire rimpatriati in Somalia ed Eritrea”. Sullo specifico argomento lo Stato italiano aveva sostenuto che la Libia avrebbe dovuto considerarsi un “luogo sicuro”, contestando l’accusa di aver violato l’art. 3 della Convenzione e affermando, da un lato, che la Libia non era, all’epoca, uno Stato che presentasse evidenti rischi di maltrattamento ai danni dei profughi rimpatriati, avendo tra l’altro ratificato una serie di convenzioni sui diritti umani (ma non la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati); dall’altro che nessuno dei profughi soccorsi aveva espresso una chiara volontà di chiedere asilo politico in Italia. Entrambi i suddetti argomenti sono stati rigettati dalla CEDU. In particolare, la Corte ha escluso che gli impegni sottoscritti da Italia e Libia per il contrasto dell’immigrazione clandestina e del traffico di persone potessero escludere o limitare l’applicabilità delle norme internazionali di tutela dei diritti umani (la Corte cita l’Accordo italo-libico di amicizia, partnership e cooperazione del 30 agosto 2008 e l’Accordo di cooperazione tra l’Italia e Libia del 29 dicembre 2007, emendato da un Protocollo del 4 febbraio 2009: è in particolare quest’ultimo protocollo che fa esplicito riferimento all’impegno congiunto di rimpatriare gli immigrati intercettati in mare). La Corte ha osservato inoltre che non solo a bordo delle navi non vi erano interpreti o consulenti legali che potessero agevolare la presentazione di domande di asilo, ma che secondo le testimonianze ai profughi veniva fatto credere che la destinazione del trasferimento offerto dalle navi italiane fosse l’Italia. Ad avviso della Corte quindi nel respingere gli immigrati verso la Libia, tutti potenzialmente dei richiedenti asilo, l’Italia ha certamente violato l’art. 3 poiché, secondo i rapporti elaborati dagli Stati, ONG e agenzie internazionali, il trattamento riservato dalla Libia agli immigrati clandestini, compresi i richiedenti asilo, è ampiamente al di sotto dello standard accettabile, concretizzandosi in una detenzione arbitraria in condizioni estremamente dure, in particolare per le donne (sullo specifico la pronuncia fa rinvio per questi argomenti al precedente fissato da M.S.S. v. Belgium and Greece [GC], no. 30696/09, § 223, 21 January 2011). Inoltre, ad avviso della Corte europea, nel caso in esame vi era l’alta probabilità che i potenziali richiedenti asilo fossero rimpatriati nel Paese d’origine in cui temevano persecuzioni. La Corte cita a sostegno delle proprie conclusioni diverse norme, a conferma di quanto il principio del non refoulement sia radicato nel diritto internazionale vigente (tra cui, oltre all’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, anche l’art. 19 della Carta dei diritti fondamentale dell’Unione Europea) e non possa in alcun modo essere aggirato, tanto meno qualificando i respingimenti come azioni di soccorso in mare o come operazioni tese a stroncare il traffico di persone e i reati ad esso collegati. Ancora, la Corte ha condannato l’Italia per aver violato anche l’articolo 4 del Protocollo n. 4 CEDU del 1963 che proibisce le espulsioni collettive (ed è appena la seconda volta che ciò avviene nella storia della Corte; la prima con riferimento all’applicazione in acque internazionali). Sullo specifico punto l’Italia aveva contestato che la norma fosse applicabile, in quanto la fattispecie dell’espulsione è diversa da quella del respingimento (c.d. non refoulement), perché presuppone che vi sia stato l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, negando quindi che l’art. 4 del Protocollo CEDU potesse essere richiamato per censurare un’azione espulsiva condotta in acque internazionali, ossia prima che sia avvenuto l’ingresso dei clandestini nel territorio italiano. Invece, richiamando al propria giurisprudenza, la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 4 del Protocollo n. 4 al caso di stranieri che non si trovano sul territorio nazionale, bensì in alto mare, ricorrendo ad un’interpretazione teleologica e funzionale della CEDU, conforme alla propria giurisprudenza e alla Convenzione di Ginevra sul diritto dei Trattati, che si fonda su un significato ampio di “giurisdizione” esercitata dallo Stato ai sensi dell’art. 1 della CEDU. Sullo specifico punto, infatti, la Corte ha osservato che il divieto di espulsioni collettive si applica anche alle violazioni del principio di non refoulement, in quanto lo Stato esercitando il refoulement degli stranieri esercita un potere pubblico e sovrano e quindi esercita la propria giurisdizione sulle persone (che ne sono quindi “soggette” ai sensi dell’art. 1 CEDU), impedendo loro di sbarcare sullo coste nazionali, con conseguente assunzione di responsabilità sulle misure adottate. Inoltre, il termine “espulsione” usato nell’art. 4 del Protocollo 4, si deve interpretare estensivamente in modo da non lasciare scoperta un’ipotesi di tale rilevanza. Infine, la Corte europea ha altresì rilevato la violazione dell’articolo 13 che riconosce il diritto ad un rimedio effettivo davanti alle autorità nazionali (ad esempio dando la possibilità di fare ricorso su casi di questo genere), nella fattispecie non garantito, in quanto la possibilità per i ricorrenti, una volta riportati in Libia, di presentare un reclamo in sede civile o penale contro le autorità italiane per violazione dei loro diritti, appariva puramente teorica e comunque non idonea a tutelare gli individui rispetto ad una violazione particolarmente grave come quella che comporta il subire tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Invero, la sorte dei migranti fu piuttosto dura: vennero condotti in carcere a Misurata e a Tripoli, dove rimasero a lungo in condizioni disumane1. Alcuni migranti furono rintracciati e assistiti in Libia dal Centro 1 Le condizioni di vita in Libia dei migranti respinti il 6 maggio 2009 sono state drammatiche. La maggior parte di essi è stata reclusa per molti mesi nei centri di detenzione libici ove ha subito violenze e abusi di ogni genere. La maggior parte dei ricorrenti sono stati registrati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e in Libia hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato sotto mandato UNHCR. Dopo lo scoppio del conflitto in Libia, i ricorrenti che si trovavano ancora a Tripoli, ed erano stati nel frattempo liberati dai centri di detenzione, sono stati vittime di rappresaglie sia da parte delle milizie fedeli al regime sia da parte degli insorti e sono stati costretti a nascondersi per alcune settimane senza acqua ne cibo. Dopo l’inizio dei bombardamenti NATO, alcuni ricorrenti sono scappati in Tunisia, altri hanno tentato nuovamente di imbarcarsi verso l’Europa, di nuovo Un ricorrente è riuscito a lasciare nuovamente la Libia alla volta di Malta, dove ha richiesto e ottenuto protezione. Due ricorrenti sono, invece, deceduti nel tentativo di raggiungere nuovamente l’Italia a bordo di un’imbarcazione di fortuna. Un ricorrente è riuscito a fuggire in Israele, mentre un altro è ritornato in Etiopia. Italiano Rifugiati e presentarono ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Alla luce dei principi espressi dalla Corte, in buona sostanza, gli Stati che intercettano persone al di là delle acque territoriali non possono operare in un vuoto giuridico; la violazione di diritti fondamentali nella fattispecie impegna il governo italiano sia a verificare che le autorità del paese verso cui gli stranieri sono respinti , li trattino in modo conforme alla CEDU e non li rimpatrino nei paesi di origine, sia a fare tutto il possibile per prevenire il verificarsi di situazioni simili in avvenire. Dunque, l’applicazione delle norme del diritto internazionale dei diritti umani in mare aperto, compreso il principio di non respingimento, richiede agli Stati di esercitare la loro giurisdizione sulle imbarcazioni e sulle persone intercettate, in un modo che sia coerente con tali norme. Questa importante sentenza conferma quindi che gli obblighi che gli Stati hanno assunto con la CEDU non si fermano con i loro confini geografici. Gli Stati perciò non possono abdicare ai loro principi, ai loro valori e al loro impegno nella protezione dei diritti umani facendo fuori dei loro confini quello che non sarebbe consentito nei loro territori. Quanto sopra, non riguarda solo la proibizione di respingimento diretto o indiretto, ma una più vasta gamma di diritti, quali la protezione dalle espulsioni collettive e il diritto delle persone intercettate di ricorrere contro la decisione di rinviarle nel paese di partenza. La sentenza si conclude con un importante monito per tutti i Paesi europei ai principi in materia “The words of Justice Blackmun are so inspiring that they should not be forgotten. Refugees attempting to escape Africa do not claim a right of admission to Europe. They demand only that Europe, the cradle of human rights idealism and the birthplace of the rule of law, cease closing its doors to people in despair who have fled from arbitrariness and brutality. That is a very modest plea, vindicated by the European Convention on Human Rights. We should not close our ears to it”. Sulla base di testimonianze, si teme che altri ricorrenti abbiano perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Italia via mare. Al riguardo, si deve ricordare che secondo le stime dell’UNHCR sarebbero circa 1.500 i migranti ad aver perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Italia via mare nel 2011. Con la sentenza in rassegna la Corte europea ha altresì stabilito che l’Italia dovrà versare un risarcimento per il danno non patrimoniale subito di 15 mila euro oltre le spese processuali. La sentenza in rassegna appare dunque una radicale messa in discussione delle politiche sui respingimenti in mare, soprattutto nell’ambito dell’accordo bilaterale tra l’Italia e la Libia, e obbligo lo Stato italiano ad adottare (in conformità con l’art. 46 CEDU) misure di carattere generale, attraverso idonei atti normativi in materia2. 2 Per approfondimenti sul tema dell’immigrazione clandestina via mare, e sui respingimenti via mare in generale, si rinvia a L. SALAMONE, La disciplina giuridica dell’immigrazione clandestina via mare, nel diritto interno, europeo ed internazionale.
Scaricare