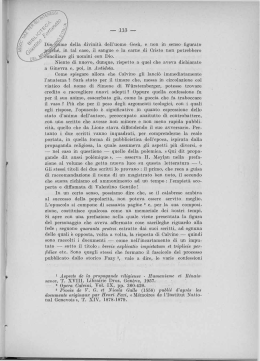Vite precarie, solitudini e crucci ministeriali • La scuola s’è desta... • Come si diventa Silvio • La generazione 2.0 e la scuola • Apprendimento della Storia. A macchie o lineare? • Vincente o perdente? • Non si deve sapere • Risorgimento • La nota di Limina: verso il regime o una idiozia? • Spigolature europee • Energia: da merce a bene comune • Codirossi e pesci rossi • Ascoltando Roberto Piumini • Orwell • Il verosimile e l’interessante • In memoria di uno scrittore ignoto • TEXT Gli ultimi giovani o il colore delle passioni Calvino e l’educazione SETTEMBRE 2010 tema nuova serie numero 78 - SETTEMBRE 2010 (3. 2010) • Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, DCB (Como) • 8 euro idee per l’educazione costruirel’uguaglianzaliberareledifferenze NUMERO 78 settembre 2010 EDIT 3 Vite precarie, solitudini e crucci ministeriali • CELESTE GROSSI 4 La scuola s’è desta... • COSIMO SCARINZI PRE TEMA CINQUE LEZIONI SU CALVINO E L’EDUCAZIONE 6 Lezioni invisibili • STEFANO VITALE 8A che serve la letteratura • MARIO BARENGHI 11 La leggerezza • DUCCIO DEMETRIO 13 Cronache di Altroquando • GIUSEPPE PANELLA 15 Le città invisibili dei bambini • PATRIZIA BORTOLINI 16Il Marchionne Sergio della Puzza • ANDREA BAGNI 17 Calvino e la Rete • EDOARDO CHIANURA IDEE PER L’EDUCAZIONE 19 21 23 24 26 27 28 Come si diventa Silvio • RAFFAELE MANTEGAZZA La generazione 2.0 e la scuola • EDOARDO CHIANURA Apprendimento della Storia. A macchie o lineare? • PATRIZIA BORTOLINI ESPERIENZE NARRATE Vincente o perdente? • ANNA DI PAOLA NUOVI ARRIVI Non si deve sapere • LIDIA GARGIULO NOTE IN CONDOTTA Risorgimento • ANDREA BAGNI LE LEGGI La nota di Limina: verso il regime o una idiozia? • CORRADO MAUCERI MAPPAMONDO 29 L’ERBA DEL VICINO Spigolature europee • PINO Patroncini DE RERUM NATURA 32 34 Energia: da merce a bene comune • MARIO AGOSTINELLI Mente locale Codirossi e pesci rossi • Laura Scarino MODI E MEDIA 36 37 38 39 40 42 Ascoltando Roberto Piumini • STEFANO VITALE RILETTURE Orwell • CESARE PIANCIOLA SCRIPT Il verosimile e l’interessante • MARIA LETIZIA GROSSI Il libro • PAOLO CHIAPPE Humus ANNI VERDI In memoria di uno scrittore ignoto • STEFANO VITALE TEXT Redazione via Magenta 13, 22100 Como tel. 031.4491529 [email protected] www.ecolenet.it Maurizio Disoteo, Marisa Notarnicola, Cesare Pianciola, Andrea Rosso, Gianpaolo Rosso, Giovanni Spena, Filippo Trasatti, Stefano Vitale Direttrice responsabile Celeste Grossi Collaboratori Giovanna Alborghetti, Monica Andreucci, Guido Armellini, Antonella Baldi, Marta Baiardi, Antonia Barone, Gabriele Barrera, Annita Benassi, Giorgio Bini, William Bonapace, Franco Calvetti, Andrea Canevaro, Vicedirettore Andrea Bagni Redattori Bianca Dacomo Annoni, Francesca Capelli, Paolo Chiappe, 43 Gli ultimi giovani o il colore delle passioni • ENRICO DONAGGIO 48 Trend • LORENZO SANCHEZ Minny Cavallone, Edoardo Chianura, Angelo Chiattella, Rosalba Conserva, Vita Cosentino, Marina Di Bartolomeo, Lella Di Marco, Mauro Doglio, Lidia Gargiulo, Maria Letizia Grossi, Toni Gullusci, Monica Lanfranco, Mariateresa Lietti, Marco Lorenzini, Franco Lorenzoni, Francesca Manna, Raffaele Mantegazza, Corrado Mauceri, Cristina Meirelles, Alberto Melis, Luciana Mella, Bruno Moretto, Giorgio Nebbia, Filippo Nibbi, Enrico Norelli, Laura Operti, Carlo Ottino, Giuseppe Panella, Pino Patroncini, Vito Pileggi, Nevia Plavsic, Gaspare Polizzi, Rinaldo Rizzi, Marcello Sala, Nanni Salio, Antonia Sani, Laura Scarino, Cosimo Scarinzi, Maria Antonietta Selvaggio, Angelo Semeraro, Scipione Semeraro, Rezio Sisini, Monica Specchia, Marcello Vigli Grafica e impaginazione Natura e comunicazione Como (Andrea Rosso con Marco Bracchi) Abbonamenti Attivazione immediata: tel. 031.268425, [email protected] Abbonamento annuale: (4 numeri + 1 anno della lettera telematica e-mail): 45 euro. Sostenitore: 70 euro. Abbonamento telematico: (invio via mail in formato pdf di 4 numeri + 1 anno della lettera telematica e-mail): 20 euro. Versamenti sul conto corrente postale n. 25362252 intestato a Associazione Idee per l’educazione, via Anzani 9, 22100 Como. Registrazione Tribunale di Como n. 1/2001 del 10 gennaio 2001 Stampa Fotocomp snc via Varesina 3, 22075 Lurate Caccivio (Como) tel. 031 494454 Proprietà della testata Associazione Idee per l’educazione. Sede legale: via Anzani 9, 22100 Como Consiglio di amministrazione Bianca Dacomo Annoni (vice presidente), Andrea Rosso, Gianpaolo Rosso, Filippo Trasatti (presidente), Stefano Vitale edit costruirel’uguaglianzaliberareledifferenze Vite precarie, solitudini e crucci ministeriali CELESTE GROSSI L’ assistente tecnico precario Giacomo Russo − prima di essere ricoverato in ospedale a causa dello sciopero della fame attuato come forma di protesta contro le politiche del governo sul sistema d’istruzione, dell’università e della ricerca pubblica − ha dichiarato: «Questa non è la battaglia dei precari della scuola, è la battaglia della scuola per il futuro del Paese». Speriamo che la scuola e il Paese lo ascoltino. Solo quando le lavoratrici e i lavoratori più tutelati si renderanno conto che i diritti o sono di tutti o non sono di nessuno e che la perdita di garanzie democratiche si estende a macchia d’olio e rapidamente, si realizzeranno mobilitazioni unitarie visibili oltre la cerchia degli addetti ai lavori e per questo capaci di svelare che le questioni sollevate dai precari della scuola sono di rilievo generale e non possono essere liquidate come “rivendicazioni corporative”. Solo allora in Italia si capirà che l’investimento in istruzione «non è un problema economico, ma il problema economico prioritario», come ha detto degli Stati Uniti Barack Obama. È proprio la solitudine che accompagna le lotte dei precari a rendere possibile l’atteggiamento sprezzante della ministra Gelmini (che fino ad oggi, 1 settembre, ha rifiutato di incontrare i partecipanti alla mobilitazione) e del governo Tremonti-Berlusconi. Per ora i finiani, impegnati in questioni di bottega, tacciono. Ma come potranno continuare a ignorare le proteste di quello che soprattutto a Sud è stato il loro bacino elettorale? In questa situazione assai difficile per la vita di lavoratrici e lavoratori, di milioni di studenti, delle loro famiglie e di tutti le cittadine e i cittadini italiani, con o senza figli, interessati al luogo dove la società educa se stessa, la ministra dell’Istruzione il 20 agosto si è permessa di dichiarare: «Non vedo difficoltà per quanto riguarda l’apertura dell’anno scolastico, in modo particolare nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, la scuola media, perché da quest’anno non ci sono particolari innovazioni o particolari modifiche». A parte più ripetizioni dell’aggettivo “particolare” in tre righe, meno male che l’ha usato per circoscrivere la sua considerazione alle elementari e alle medie. Perché a sentire chi ha partecipato ai collegi dei docenti del primo settembre la secondaria di secondo grado è nel caos per l’entrata in vigore della riforma. E non è bastata a diradare la confusione la scarna circolare ministeriale (30 agosto 2010, n. 76) sulle “Misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – Anno scolastico 2010-2011”. Di tutt’altro tenore sono le dichiarazioni dei precari della scuola. Caterina Altamura − che si autodefinisce deportata al Nord, dove ha lavorato lo scorso anno, dopo 14 di insegnamento a Palermo − ha detto: «Oggi voglio dire con forza a Tremonti, alla Gelmini, al mio Presidente del Consiglio e ai numerosissimi parlamentari siciliani che le cose devono cambiare! Che non permetteremo la morte né nostra né della nostra scuola pubblica! Che non permetteremo che la mafia approfitti della disperazione di tanta gente! Che la scuola pubblica sia di serie B e che i soldi pubblici vengano dati alle private! Che anche al Sud deve essere garantito il tempo pieno! Che non mi farò trattare come spazzatura!». Ancora più drammatiche le parole pronunciate, dopo alcuni giorni di sciopero della fame, da Pietro di Grusa: «Da qui me ne andrò con un lavoro oppure morto». Pietro è collaboratore scolastico precario da 25 anni. Venticinque anni, più o meno l’età di tanti giovani laureati disoccupati che non riusciranno a lavorare neppure come precari, se gli insegnanti “anziani” non riusciranno ad andare in pensione. Allo sciopero della fame partecipano anche molti insegnanti di sostegno tra i più colpiti dai tagli. A Bergamo, nel profondo Nord, rispetto all’anno scolastico precedente sono 99 quelli in meno (a fronte di 142 iscritti con handicap in più); a Messina, nel profondo Sud, 149 alunni che nel 2009/2010 hanno usufruito del sostegno non lo avranno per la diminuzione di 86 docenti. Con buona pace della Corte Costituzionale che il 22 febbraio 2010 ha prescritto l’obbligatorietà della copertura di eventuali ore aggiuntive o posti di sostegno a fronte delle richieste presentate da parte delle famiglie e certificate dalle Asl. Sulla questione è intervenuta anche la ministra per le Pari opportunità, Mara Carfagna: «Ho un cruccio che è insieme un desiderio: vorrei tanto migliorare le condizioni dei disabili: con le loro famiglie, vivono spesso situazioni non facili, per non dire drammatiche. Sono certa che riusciremo a fare qualcosa per aiutarli». La coerenza non è più una virtù. pre La scuola s’è desta... La ricaduta sulla scuola della manovra economica del governo e soprattutto l’abolizione degli scatti di anzianità hanno avuto una conseguenza “educativa” sulla categoria: la massiccia partecipazione allo sciopero del 14/15 giugno (inattesa anche dai promotori). Il comportamento del governo dalla fine di giugno in poi potrebbe essere interpretato come una risposta alla mobilitazione intrecciata alla necessità di non bruciare i rapporti con i sindacati “moderati”. Ma cosa cambia realmente? Assai poco: il governo destina o promette di destinare il 30% di quanto risparmiato tagliando gli organici alle retribuzioni cosa che dovrebbe permettere, il condizionale è d’obbligo, la salvaguardia dei gradoni COSIMO SCARINZI I n preparazione dello sciopero del 14/15 giugno si tiene presso il Liceo Scientifico Gobetti di Torino un’assemblea per informare le colleghe ed i colleghi delle ragioni e degli obiettivi dello sciopero stesso. Di norma le assemblee in questo periodo vanno deserte, i colleghi e le colleghe sono chini su compiti e registri e non hanno tempo. Per di più, la sera precedente, ho sentito la nostra delegata rsu che non mi è sembrata particolarmente vispa. Infine, è noto che i licei, poco conta se classici o scientifici, sono il settore della secondaria superiore meno colpiti dalla manovra sugli organici. Vado quindi a tenere l’assemblea aspettandomi una presenza numericamente limitata e un’attitudine poco vivace. Con mio stupore la sala è piena e, soprattutto, i presenti si école numero 78 pagina 4 limitano più che altro a chiedere informazioni tecniche sulla conduzione dello sciopero che hanno già deciso di fare in massa organizzando la solidarietà da parte di chi non potrà farlo perché non in servizio nei confronti degli scioperanti. Tutto fila liscio oltre misura. Peraltro a Torino è nato un coordinamento delle rsu di istituto che allarga notevolmente l’area di aggregazione rispetto al pur generoso impegno dei sindacati di base, il numero di scuole che aderisce allo sciopero è cresciuto in misura notevolissima, in diversi istituti si tengono iniziative di informazione, feste, occupazioni et similia. Cosa cambia rispetto a giugno Questo dopo che nel 2009 la scuola ha vi- sto una passività pressoché assoluta dopo la fine rapida e traumatica del movimento “No Gelmini” sviluppatosi nell’autunno del 2008. Che cosa ha determinato questa rapida modificazione del comportamento collettivo della categoria? Con ogni evidenza non è stato solo, né principalmente, il massiccio taglio degli organici visto appunto che è bastato, il 30 ottobre 2008 che Cisl - Uil - Snals e Gilda si accordassero con il governo per addormentare il movimento. La novità è stata la ricaduta sulla scuola della manovra economica del governo. Riassumo qual era l’impatto previsto a giugno: 1. Salto del contratto 2010-2012. È ben Collaboratori scolastici -753 Assistenti amministrativi e tecnici -978 Direttori dei servizi generali e amministrativi -2081 vero che da molto tempo i contratti si sono ridotti ad una sorta di scala mobile assai imperfetta ma, anche tenendo conto di questo dato, il salto del contratto comporta una riduzione ulteriore media delle retribuzioni del 5,9% (quanto previsto dall’indice IPCA) e, di conseguenza, sempre in media, di più di 1.500 euro netti nel triennio. 2. Fatto ancora più rilevante, il congelamento degli stipendi al 2009 e l’abolizione degli scatti di anzianità (vedi tabella). Questa disposizione avrebbe colpito nell’immediato 254.000 docenti ed Ata che sarebbero passati di gradone nei prossimi tre anni ma riguardava tutti visto che il congelamento degli scatti di anzianità avrebbe continuato ad operare. Considerando che i gradoni sono ormai l’unica forma effettiva di incremento delle retribuzioni a fronte del carattere miserevole dei contratti, il blocco dei gradoni ha avuto un effetto notevolissimo sul comune sentire della categoria e, in particolare, proprio di quella fascia di insegnanti anziani che si erano ormai messi l’anima in pace per lo stato della scuola pubblica e che non sono direttamente troppo colpiti dal taglio degli organici anche perché meno esposti di altri al rischio del sovrannumero. 3. Il congelamento degli stipendi determina inoltre automaticamente una riduzione delle pensioni che sarebbe andato dai 50 euro netti per le retribuzioni più basse ai 100 euro netti per quelle più alte. In particolare sarebbe stato colpito chi, essendo restato in servizio in questi anni nell’aspettativa dell’aumento, se lo vedrà sottratto. Ancora una volta, si era previsto di colpire seccamente proprio la vecchia guardia, quella la cui retribuzioni sarebbero state più colpite 4. Come ciliegina sulla torta, vengono dimezzate le risorse per la formazione del personale che si riducono, per il 2011, a circa 5 euro per lavoratore e si dimezzano anche le risorse per le visite di istruzione all’estero che, a questo punto, divengono nei fatti pressoché impossibili. Ritengo che una manovra del genere abbia avuto delle conseguenze, mi si permetta il termine, educative. Nel corso del 2009, infatti, si era determinata una situazione, dal punto di vista dell’iniziativa politica e sindacale, difficilissima. La divisione del fronte sindacale, infatti, si incrociava con una spaventosa divisione interna alla categoria. I precari dopo le agitazioni dell’autunno 2009 erano tornati al consueto ripiegamento nella ricerca di soluzioni individuali e molti colleghi di ruolo, magari dopo aver votato mozioni di solidarietà ai precari e di condanna della politica scolastica del governo, avevano accettato cattedre superiori alle 18 ore. Per di più era, ed è, forte la tensione fra precari delle re- Docenti scuola dell’infanzia ed elementari -1495 Docenti diplomati della secondaria Docenti scuola secondaria di I grado -1644 -1730 gioni del Nord e precari di quelle del Sud visto che questi ultimi, costretti a migrare, concorrono con quelli del Nord (sovente essi stessi meridionali) nella spartizione di una torta sempre più modesta. Vale, a questo punto, la pena di riflettere sul, provvisorio, esito della vicenda e sulle ragioni di questo esito. Due ipotesi, almeno, sono possibili e, forse, una spiegazione attendibile può integrarle entrambe: nonostante il Ministro Gelmini abbia sostenuto, mentendo per la gola, che lo sciopero del 14/15 giugno fosse fallito, in realtà vi è stata un’adesione che ha dimostrato che la tensione nella categoria è andata crescendo. Il comportamento del governo dalla fine di giugno in poi potrebbe essere interpretato come una risposta alla mobilitazione; la Cisl (lo Snals, la UilL e la Gilda a mio avviso, come l’intendenza, seguono) ha la necessità di dimostrare ai settori della categoria che rappresenta ed organizza che la linea del dialogo sempre e comunque paga e porta a dei risultati concreti a fronte di una presunta inutilità della mobilitazione e ha posto il governo di fronte alla necessità di non bruciare i rapporti con i sindacati “moderati” pagando qualche prezzo a questa stessa necessità. Per parte mia, ritengo che non vi sia poi molta contraddizione fra le due spiegazioni. È, infatti, evidente che il governo è indotto ad “accontentare” i sindacati amici, anche se non solo, dalla consapevolezza che vi sia una reale tensione fra i lavoratori e che è bene non screditarli se vuole tenere sotto controllo la situazione. Su la Repubblica del 26 giugno leggiamo infatti: «Marcia indietro del governo sul blocco degli scatti stipendiali degli insegnanti? Sembra proprio di sì. Lo ha annunciato, durante un incontro con i sindacati della scuola, lo stesso ministro dell’Economia, Giulio Tremonti». «Una quota dei risparmi provenienti dal blocco nella scuola, destinata al miglioramento delle scuole e al personale − ha annunciato Tremonti − può essere destinata ai docenti. [...] All’incontro erano presenti Cisl e Uil scuola, Gilda degli insegnanti e Snals che da tempo pressano per una soluzione al problema. [...] L’azione di un sindacato − dichiara Francesco Scrima, leader della Cisl scuola − si giudica dai risultati che produce: l’impegno assunto dal Governo di modificare la manovra finanziaria in modo da rendere possibile il mantenimento delle progressioni di anzianità previste dal contratto scuola vigente dimostra che la Cisl, percorrendo in piena autonomia la via del confronto e del negoziato, ha fatto la scelta giusta e ha agito bene». Gli impegni presi da Tremonti In pratica la manovra è stata emendata an- Docenti laureati scuola secondaria di II grado -1990 che se l’emendamento si limita, usiamo la definizione Cisl a rendere meno prescrittiva la manovra, la stessa Cisl in un recente comunicato afferma: «Se il testo di legge è necessariamente vago, non lo sono gli impegni assunti dal Governo, nella persona dello stesso Ministro dell’Economia: fin d’ora l’obiettivo della nostra attenzione e della nostra iniziativa è che a tali impegni sia data puntuale e coerente attuazione». Ma qual’è l’impegno preso da Tremonti? Semplicemente, citiamo sempre la Cisl «destinare alle retribuzioni del personale le risorse di cui all’articolo 8 comma 14 (il 30% delle economie realizzate con la riduzione degli organici). Nella versione originaria del decreto, esse erano indirizzate ad altri scopi, puntualmente elencati nella relazione tecnica allegata al decreto (crediti delle scuole, supplenze, spese di funzionamento)». In altre parole, il governo destina o promette di destinare il 30% di quanto risparmiato tagliando gli organici alle retribuzioni cosa che dovrebbe permettere, uso il condizionale per correttezza, la salvaguardia dei gradoni. Non c’è che dire, un bell’esempio di solidarietà dei lavoratori. info Pubblica amministrazione. Discriminazioni «La decisione assunta dalla Commissione europea di inviare all’Italia una richiesta formale di far cessare la discriminazione nei confronti di candidati a posti nella pubblica amministrazione nella provincia di Bolzano perché lesiva della libera circolazione dei lavoratori dovrebbe mettere finalmente una pietra tombale sui propositi di alcune forze politiche di introdurre nel nostro ordinamento concorsi legati al “requisito della territorialità”. […] La richiesta di un certificato specifico rilasciato dalla stessa amministrazione provinciale e il riconoscimento di una precedenza ai candidati che risiedono nella stessa provincia da almeno due anni non solo è discriminatorio nei confronti dei cittadini di altre nazionalità dell’UE, ma anche dei nostri connazionali non residenti nella provincia di Bolzano». Francesco Greco, presidente dell’Associazione nazionale docenti. école numero 78 pagina 5 TEMA cinque lezioni su Calvino e l'educazione Lezioni invisibili Italo Calvino e l’educazione STEFANO VITALE A 25 anni dalla morte Italo Calvino continua a proporci la sua “lezione invisibile”: così presente, così puntuale ed acuto, così provocatorio. La sua lezione è talmente viva da non riguardare solo i territori specifici della letteratura. Calvino è entrato nella nostra cultura così profondamente da riguardare da vicino anche il mondo dell’educazione. Non solo perché molti dei suoi testi narrativi sono dei “classici” nella scuola, ma perché sono le sue riflessioni a proporre dei costanti valori di confronto e di riferimento critico per le azioni formative e culturali. Il 18 e 19 marzo 2010, i Cemea, col patrocinio della Città di Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte e la collaborazione del Circolo dei Lettori di Torino hanno proposto una originale riflessione su Italo Calvino. Nel convegno si è ripartiti dalle “Lezioni Americane” così ricche di esplicite indicazioni per l’educazione e la pedagogia e, come detto, per la nostra intera cultura. È stato chiesto ad alcuni studiosi di proporre una loro “lezione” a partire dalle diverse parole chiave del libro di Calvino e di riflettere sui legami tra Calvino e l’educazione, tra la “lezione” di Calvino ed i problemi del nostro tempo. Hanno risposto all’appello Francesco Remotti, Gabriele Lolli, Duccio Demetrio, Rosalba Conserva, Paolo Mottana, Mario Barenghi, Francesco Ciafaloni (un resoconto completo del convegno sarà pubblicato in un quaderno a cura dei Cemea del Piemonte). Per noi di école questo “tema” è l’occasione per allargare il discorso ad altri in questa continua riflessione sui temi della cultura, della scuola e della formazione. Perché Italo Calvino? C’è un’idea della formazione che è riduzionista, esclusivamente centrata sui problemi tecnici e curriculari. E c’è una formazione che vuole esprimere una visione più ampia delle cose. La nostra visione della formazione, della cultura dell’educazione è ampia, attenta alla complessità, all’interdisciplinarietà. Noi non rinchiudiamo la formazione negli angusti spazi del riduzionismo didatticista e Calvino risponde a questa nostra idea. Italo Calvino è entrato profondamente nella nostra vita culturale ed è quindi un riferimento per l’educazione. Non si dimentichi, poi, che Calvino ha dedicato una certa attenzione sia formale che sostanziale proprio agli aspetti educativi della letteratura. Le fiabe popolari, i romanzi come Marcovaldo, Il Barone Rampante, Il Visconte Dimezzato; Il Cavaliere Inesistente sono dei classici della scuola e della letteratura e dunque per noi tutti, insegnanti ed educatori, degli strumenti di lavoro quotidiano. Ma c’è di più. In romanzi come Il Castello dei destini incrociati egli sviluppa una compiuta teoria del pensiero narrativo che si ricollega ad autori più specialistici come Jerom Bruner e Howard Gardner: «ogni racconto corre incontro ad un altro racconto in una logica dell’intrecciarsi simultaneo di diversi fattori e punti di vista» (p. 41). Ecco, il tema del école numero 78 pagina 6 Illustrare Calvino Filip Zagorski Le cosmicomiche “punto di vista”: una delle chiavi di lettura del romanzo Palomar dove Calvino dice che per guardare il mondo occorre un punto di vista e che per guardare se stesso il mondo ha bisogno degli occhi e degli occhiali del signor Palomar. La capacità di porre domande non banali su di sé e sul mondo è condizionata dall’inclusione dell’osservatore nel mondo che si osserva. Questo è un concetto molto rilevante sul piano educativo e ricollega Calvino alle moderne teorie della complessità (Von Foester, Maturana e Varela, Bateson). Nel titolo del convegno, “Lezioni Invisibili”, c’è naturalmente un riferimento alle Città Invisibil. Ma l’aggettivo invisibili lo utilizziamo in due sensi: in primo luogo nel senso che i valori, le qualità di cui Calvino parla nelle “Lezioni Americane” sembrano essere invisibili nell’attuale società italiana dominata da illegalità, abusi di potere, manipolazioni mediatiche, dalle volgarità della cultura e della politica, dal razzismo dilagante. Eugenio Scalfari in un articolo del 3 settembre 2009 (L’Espresso), riprendendo un altro articolo di Antonio Scurati del 23 agosto 2009 (La Stampa) sosteneva l’idea che leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità si sono trasformate in superficialità, pressappochismo, pedanteria, esibizione, trasformismo e, aggiungo io, indifferenza e ripiegamento egoistico. Insomma un Calvino “a rovescio”, annegato in una banalizzazione dei valori davvero preoccupante Ma sono “invisibili” anche in un altro senso: in modo sotterraneo continuano ad operare ad essere, presenti come “idee regolative” (proprio nel senso morale kantiano) che possono sia orientare l’azione educativa e civile sia servire da chiave di lettura per la letteratura. C’è in Calvino una capacità di anticipare i tempi leggendo criticamente il presente che conferisce ai suoi testi, specialmente alle “Lezioni Americane”, una valenza utopica molto significativa ancorata comunque concretamente alla realtà sociale, culturale, antropologia del suo tempo e del nostro. Italo Calvino moriva 25 anni fa e il suo ultimo libro, Lezioni Americane, ha avuto ed ha un valore profetico, almeno per noi. Il titolo in inglese è Six memos for the next millenium. La traduzione di “memos” è proposta, appunto, promemoria. Insomma qualcosa di semplice, informale. Un titolo davvero calviniano, pieno di understatement. Eppure Calvino era uno scrittore che affidava alla letteratura un compito importante: «la mia fiducia nel futuro della letteratura consiste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare con i suoi mezzi specifici», così si legge nell’introduzione alle Lezioni Americane. Non c’è dubbio che Calvino ponesse il suo focus sulla letteratura che per essere “educativa” doveva appunto essere letteratura e non porsi certo dei compiti pedagogici. Eppure le sue riflessioni sulla leggerezza, la rapidità, l’esattezza, la molteplicità, vanno ben oltre la semplice riflessione letteraria. Nel testo, poi, vi sono diretti ed indiretti riferimenti molto utili per chi come noi si occupa di educazione e di cultura in generale. Proprio perché l’attenzione di Calvino per i testi non è mai svincolata dai contesti. Pertanto noi oggi vogliamo rileggere le Lezioni Americane usandole come “pre-testo” per ragionare sui legami tra letteratura ed educazione, tra Calvino e la cultura dell’educazione dentro la quale la letteratura gioca un suo ruolo specifico, coi suoi strumenti specifici così come l’educazione partecipa ai processi culturali e sociali coi suoi strumenti specifici. In questo senso riteniamo importante collegare “l’impulso-Calvino” con una “lettura-rilettura-traduzione” personale, in un gioco calviniano di specchi, labirinti, destini incrociati che ciascuno di noi può continuare a fare nel proprio contesto di lavoro, specie se è educativo e culturale. D’altra parte Calvino diceva che «la funzione della letteratura e la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto diverso, non ottundendo bensì esaltando la differenza». La funzione della letteratura è di stendere ponti, d’altra parte uno dei miti preferiti da Calvino era quello di mercurio, tipica figura di mediazione, portatore di messaggi. «Io penso che siamo sempre alla caccia di qualcosa di nascosto o di solo potenziale o ipotetico, di cui seguiamo le tracce che affiorano sulla superficie del suolo». Calvino qui disegna la funzione della letteratura ma anche, per noi, dell’educazione. Noi crediamo che la dignità della scuola, dell’educazione, della formazione passi attraverso l’idea di costruire un’esperienza culturale più ampia che sostenga l’emancipazione delle persone e dei loro orizzonti, una dimensione che valorizzi la pluralità dell’esperienza e della conoscenza. école numero 78 pagina 7 A che serve la letteratura La letteratura può esercitare una funzione educativa solo se non si prefigge di farlo. Lo scrittore che tramite la letteratura si proponga di fare opera principalmente, direttamente, educativa non fa buona letteratura: né buona pedagogia. La letteratura deve in primo luogo funzionare in quanto letteratura, iuxta propria principia MARIO BARENGHI * C on la parola “letteratura” mi riferirò alla letteratura d’invenzione: che rappresenta un settore importantissimo e probabilmente centrale della produzione letteraria, ma è ben lungi dall’esaurirla. Che cosa si aspettano i lettori dalla letteratura? Che cosa cercano nelle opere letterarie? O, più semplicemente: Perché si legge? Su questo vorrei richiamare un piccolo episodio avvenuto più di vent’anni fa. A quell’epoca collaboravo con la rivista di Goffredo Fofi, Linea d’ombra, che aveva sede a Milano. Una volta, chiacchierando di non ricordo più quale argomento, capitammo su questo semplice quanto fondamentale quesito. Perché si legge? Perché leggiamo? «Leggo − disse Goffredo − perché io sono io». Per una frazione di secondo pensai che si trattasse di una risposta tautologica, del tipo “leggo perché sono un lettore”: e non sarebbe stata affatto una frase priva di senso (l’interesse per la lettura dipende da fattori soggettivi e imponderabili, o cose del genere). Ma mi sbagliavo; e infatti Goffredo proseguì: «... perché sono io e non un altro. Perché sono un uomo e non una donna. Perché ho cinquant’anni, e non ottanta o novanta o quindici. Perché sono un essere umano e non un animale...». Sto citando a memoria; non mi pare che l’elenco fosse molto più lungo di così. Tuttavia non sarebbe difficile continuare. Perché vivo qui e non altrove; perché vivo in quest’epoca, e non cent’anni fa, o duemila; perché ho avuto certe esperienze e non altre; perché, infine, vivere significa scegliere, ogni scelta implica rinunce, e dunque il cammino che noi percorriamo è fatto anche delle tante alternative escluse, dietro ognuna delle quali c’è una vita possibile. Leggere consente di aprire spiragli su alcune di queste possibilità, evadendo temporaneamente dalla nostra identità effettiva. Il termine “evadere” non gode generalmente di buona fama. “Letteratura di evasione” è una qualifica, anche quando non sprezzante école numero 78 pagina 8 o liquidatoria, certamente limitativa. Senza discutere questo assunto, vorrei sottolineare però che evadere è un’aspirazione quanto mai legittima per chi si senta in prigione; tutto dipende, semmai, da quanto giustificato è quel sentimento. E comunque, la letteratura (guai a dimenticarselo) serve anche a divertirsi. A distrarsi: a svagarsi. Tutte le varianti sinonimiche contengono l’idea di “volgersi altrove”, distogliendo la mente dallo stato presente delle cose. Il principio è tutt’altro che banale. Una delle qualità della letteratura – «poche, ma insostituibili», come diceva Calvino nel Midollo del leone – è di sottrarci ai limiti e ai condizionamenti della realtà. Su questo orizzonte prendono forma anche le proiezioni utopiche: ben oltre, quindi, l’effimero diversivo di un passatempo. L’immaginazione La letteratura consente di estendere il campo dell’esperienza attraverso l’esercizio dell’immaginazione. L’immaginazione ci proietta oltre i confini dell’io, permettendoci di assaporare, di esperire e (per dir così) di esplorare virtualmente stati d’animo, turbamenti, affezioni, trasporti, modi d’essere e di sentire che non corrispondono alle nostre condizioni o inclinazioni reali, e a volte ne sono lontanissimi. Così la nostra vita si moltiplica: grazie alla lettura ci è offerta l’opportunità di vivere più vite in una. Gli studiosi che si sono occupati di teoria della lettura non hanno mancato di segnalare un’ambigua parentela tra l’esperienza della lettura e la fantasticheria. In entrambi i casi si cerca sollievo, consolazione o sollazzo (gli ultimi due termini derivano dalla medesima radice, con un interessante slittamento semantico dall’idea di conforto a quella di piacere) – si cerca, dicevo, un ristoro nella dimensione dell’immaginario. Ma il fantasticare è un’attività tanto facilmente appagante, quanto insidiosa. La coscienza ne trae talvolta beneficio, talaltra no: il rischio è di offuscare o smarrire il contatto con il reale, perdendosi tra le nuvole o costruendosi mondi paralleli. La differenza, naturalmente, è che le opere letterarie non sono chimere o sogni ad occhi aperti. Hanno la consistenza e l’oggettività di un discorso: sono testi, tessuti di parole, dove l’invenzione più sbrigliata si deve comunque misurare con le esigenze di una comunicazione intersoggettiva. Chi può negare, d’altronde, che anche l’attività della lettura può produrre effetti deleteri? La rappresentazione letteraria si è occupata largamente di questo tema. La storia del romanzo moderno inizia con le avventure di un “cattivo lettore”, don Quijote; ma potremmo ricordare anche Emma Bovary, o il Gian dei Brughi del Barone rampante. Lasciarsi rapire dalle invenzioni letterarie è pericoloso: il piacere di leggere è suscettibile di indurre una sorta di trasognata, ipnotica malìa, che a sua volta può degenerare in allucinazione o delirio. Altro che ristoro: anziché arricchirsi o corroborarsi l’ego s’indebolisce. Il facile appagamento è scontato da guasti e scompensi profondi, che possono portare alle conseguenze più rovinose. Quali, dunque, le condizioni perché la lettura non produca questi effetti negativi? Il più autorevole studioso di teoria della lettura, Vittorio Spinazzola, parla di un equilibrio fra “divertimento” e “ricreazione”, cioè tra il momento centrifugo dell’uscita da sé e il momento centripeto del ritorno a sé. Leggere significa proiettarsi oltre i confini del proprio io, identificarsi con figure d’invenzione, fingersi partecipi di mondi immaginari; ma significa anche saper recuperare la propria identità, confrontando la propria esperienza con gli esempi e i modelli forniti dalla finzione letteraria. Potremmo dire, in breve, che il buon lettore è colui che riesce ad attivare un dialogo tra la realtà empirica e la realtà fittizia, tra il mondo della vita vissuta e i mondi possibili della letteratura: e così facendo espande, approfondisce, sviluppa la propria comprensione delle cose e la propria conoscenza di sé. Vorrei soffermarmi su due fenomeni, in particolare. Il primo è l’invenzione dei personaggi. I personaggi letterari consentono – come ha scritto Giacomo Debenedetti – di “battezzare” le grandi congiunture esistenziali: di rendere evidenti delle situazioni esemplari, che – una volta narrate o messe in scena – divengono conoscibili, riconoscibili, identificabili. Al livello più elementare questa funzione si esplica nella trasformazione di nomi propri in nomi comuni. Sono i casi di Tartufo e Perpetua, di Sosia e don Giovanni, di Anfitrione, di Gradasso: per via antonomastica, la letteratura rimedia all’inopia verborum della lingua e incrementa il catalogo dei tipi umani con una suggestiva serie di figure. Com’è noto la lessicalizzazione può riguardare anche la categoria degli aggettivi (erculeo, faustiano, amletico, pantagruelico, rocambolesco) e in qualche caso coinvolge i nomi degli scrittori (boccaccesco, orwelliano, kafkiano). Ma va da sé che la dimensione più rilevante è l’esperienza soggettiva del singolo lettore: che potrà specchiarsi in questo o quell’aspetto del carattere o della storia di Elizabeth Bennett, di Anna Karenina, di Gertrude, di Rastignac, di Marlow, di Swann, di Zeno, di Josef K. E di Quinto Anfossi, di Cosimo Piovasco di Rondò, di Pin; perfino (perché no?) di Qfwfq. Quello che la letteratura offre, in buona sostanza, è un repertorio personificato di modelli di esperienza; e i personaggi costituiscono un vocabolario che rende più variegato e preciso il nostro discorso sul mondo. La forma e l’esperienza Il secondo fenomeno consiste nella compiutezza della forma, e perciò nella potenziale compiutezza di senso, propria della rappresentazione letteraria. Questo aspetto è ben espresso in una brillante battuta di Groucho Marx: «Piuttosto che vivere, preferisco guardare un film o leggere un romanzo: lì almeno c’è una trama». La nostra esperienza empirica è composta da un flusso ininterrotto e disordinato di avvenimenti, atti, parole, incontri, sensazioni, stati d’animo, che è facile percepire come insignificanti e confusi. Una delle ragioni principali è che a noi sfuggono completamente i termini della nostra vita, la nascita e la morte; possiamo solo in via congetturale avanzare ipotesi su quanto gli antefatti abbiano determinato il nostro destino, e non ci è concesso di valutare a posteriori esiti e ripercussioni del nostro operato. E naturalmente i giorni e gli anni, i minuti e le ore passano per noi senza tornare indietro: del passato non resta che un labile, instabile insieme di tracce memoriali, che non necessariamente (anzi, quasi mai) compongono un insieme organico o coeso. «Le cose sono davvero ciò che sembrano essere − ha scritto un’antropologa danese, Kirsten Hastrup −: caotiche, paradossali e inesaustive». Un’opera letteraria, invece, ha un inizio e una fine; comprende un numero limitato di personaggi e di eventi; li oggettiva in un tessuto verbale che possiamo percorrere e ripercorrere a nostro piacimento; li designa una volta per tutte, attribuendo agli uni e agli altri maggiore o minore rilie- Illustrare Calvino DOMENICO GNOLI IL BARONE RAMPANTE vo. Tutto questo ci permette di interpretare le vicende narrate, di discuterle e di dar loro un senso. Un senso che, beninteso, non necessariamente sarà univoco o definitivo. Al contrario: un’opera è per definizione aperta a letture sempre nuove, perché sempre nuovo è il quadro esistenziale sullo sfondo del quale viene letta. Ma la compiutezza della forma consente, volta per volta, l’imputazione di significati: dai quali potrà poi discendere un po’ di luce anche su quell’opaco guazzabuglio, su quel futile e affannoso tramestio, che nella maggior parte dei casi rischia di apparire la vita vissuta – almeno finché non ci si impegni a ragionarci su. Ecco: la letteratura è il modo più “divertente” (ma non il meno serio, né il meno fruttuoso) di cominciare a ragionarci su. Dopo aver evocato la figura del cattivo lettore, conviene ora richiamare alla mente l’immagine di un “buon” lettore. Nel capitolo VIII di Se una notte d’inverno un viaggiatore l’alter ego di Calvino, Silas Flannery, riassume in una frase il funzionamento virtuoso della lettura: «Dai lettori m’aspetto che leggano nei miei libri qualcosa che io non sapevo, ma posso aspettarmelo solo da quelli che s’aspettano di leggere qualcosa che non sapevano loro». Lettura, dunque, come dialogo, interazione cooperativa, costruzione di senso. Ecco le condizioni perché la letteratura possa assolvere anche a una funzione educativa. Ma tutto questo può avvenire solo se il lettore assume nei riguardi del testo l’atteggiamento appropriato. Un atteggiamento in cui curiosità esplorativa e disponibilità alla fascinazione, riflessione ed empatia, spontaneità ingenua e controllo critico, incanto e raziocinio riescano a equilibrarsi vicendevolmente. Il buon lettore è colui che concilia da un lato l’impulso a identificarsi immediatamente con le figure e le situazioni immaginarie evocate dall’opera, dall’altro la capacità di mediarle, considerandole come termini di un’interrogazione. Quali domande sollecitano sulla mia visione del mondo, sulle mie idee, sulla mia esperienza vissuta? quali risposte? La scuola cosa fa? E qui si pone un altro ordine di problemi. Nel processo di formazione del lettore interviene, inevitabilmente, la scuola. Purtroppo l’insegnamento scolastico della letteratura tende spesso a relegare l’allievo in una posizione passiva. Anziché incoraggiarlo a indagare e interrogare l’opera, gli si chiede di riconoscere nell’opera ciò che altri vi ha già école numero 78 pagina 9 Illustrare Calvino EMANUELE LUZZATI IL PRINCIPE GRANCHIO trovato prima di lui. Il sintomo più vistoso di questa perversione educativa è costituito dalle tante edizioni commentate in cui il commento fagocita il testo, sovraccaricandolo di una torva pletora di discorsi secondari. Sul testo, degradato a pretesto didattico, pullula una vegetazione parassitaria di considerazioni storiche, linguistiche, ideologiche, sociologiche, narratologiche. Non c’è più spazio per porre domande: le risposte sono già tutte lì. O peggio, ci sono le domande, tante domande: alle quali bisogna rispondere (dalla 1 alla 5, per lunedì prossimo), e s’intende che la risposta giusta è una sola. Così, velato, offuscato, occultato dagli apparati critici, nonché affaticato e sgualcito dall’accumulo di domande forzose, il testo perde ogni freschezza. Non si presta più ad alcun dialogo: diviene l’oggetto di un compito ingrato ed esoso, inservibile ad altro che a ottenere un voto. Il fatto è che non si dà apprendimento vero, quanto a capacità di lettura, se non si lascia uno spazio adeguato all’interpretazione spontanea, ingenua, genuina dell’allievo. E questo comporta dei rischi (immagino che ci sia un’intera letteratura sul rischio pedagogico). Proponendo un testo, l’insegnante non dovrebbe affrettarsi a spiegarlo. Dovrebbe aspettare l’autonoma reazione degli allievi; e costruire la spiegazione su (o meglio, a partire da) quella reazione, in modo da coinvolgere gli allievi non come passivi destinatari terminali di un allotrio esercizio interpretativo, ma come protagonisti di una ricerca. Naturalmente, così facendo, si accetta anche di correre il rischio di una reazione inadeguata. Non tanto perché “sbagliata” (non è questo il discorso), quanto perché troppo tiepida o distratta. E naturalmente esiste anche la possibilità che la proposta cada, almeno in apparenza, nel vuoto. Silenzio: nessuna risposta, zero feedback. Chiunque abbia insegnato lo sa: sono momenti difficili. Ma la posta in gioco è alta. L’alternativa è tra affrettarsi a colmare il vuoto, iniziando a sciorinare nozioni precostituite. ancorché corrette (e non necessariamente pedantesche: possono essere perfino brillanti), ovvero seguire un’altra strada. E cercare così – per dirla in una parola – di restituire alla letteratura una funzione. Educativa, anche. Tempo fa mi sono imbattuto in una massima di W.H. Auden: «Un vero libro non è quello che noi leggiamo, ma quello che legge noi». Forse questo è l’obiettivo principale che si dovrebbe porre chi si trova a insegnare letteratura – in qualunque luogo, a qualunque livello. Persuadere chi ascolta che in un’opera letteraria si possono trovare molte cose: cose divertenti, affascinanti, istruttive. E a volte, anche, quando meno ce lo aspettiamo, una pagina della nostra autobiografia. * Direttore del Dipartimento di Scienze umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università di Milano Bicocca. école numero 78 pagina 10 La leggerezza «La spinta a scrivere è sempre legata alla mancanza di qualcosa che si vorrebbe conoscere e possedere, qualcosa che ci sfugge. Credo che sempre scriviamo di qualcosa che non sappiamo: scriviamo per rendere possibile al mondo non scritto di esprimersi attraverso di noi.» (Italo Calvino) DUCCIO DEMETRIO * E logio della pesantezza Leggero è ciò che ha poco peso, il cui contrario rimanda a quanto, invece, per i sensi o nel pensiero, nell’ animo, si presenta pesante, greve, soffocante. Tale levità può riguardare il cibo, il sonno, gli sforzi, un senso intimo di benessere e felicità. E inoltre, i nostri modi di essere: in amore, nel lavoro, nei rapporti con le persone. La parola deriva infatti dal latino parlato leviarium, dal più colto levis: indicante anche quanto si presenta sottile, delicato, dolce, tenue. Che la leggerezza come qualità non solo delle cose, ma anche delle nostre azioni, dei pensieri, dei gesti, sia da considerarsi sempre un aspetto positivo della vita, auspicabile e gradito, è però questione tutta da discutere. Le metafore possibili che al termine possiamo associare, non v’è dubbio, parrebbero evocare piume, angeli, tessuti impalpabili, “amori ridicoli” (parafrasando il titolo di un romanzo di Milan Kundera), minuti gradevoli ed estatici. Ci avvaliamo di riferimenti simbolici o materiali alla leggerezza quando le situazioni e gli istanti non si presentano provvisti di alcuni attributi usuali assegnati alla pesantezza: stanchezza, insopportabilità, monotonia, noia, difficoltà, problematicità… Eppure, anche la leggerezza qualche tratto non proprio positivo sembra possederlo. Quando ci riconduciamo, più che ai momenti personali e interiori (in cui ci sentiamo ad esempio “leggeri come l’aria” o intenti a bere un vino giovane, ad osservare le movenze di un adolescente di ambo i sessi), invece al mondo delle relazioni umane. La leggerezza, in questi frangenti, rinvia a significati di tono morale o psicologico. Entra in gioco la categoria del giudizio. Quando, ben lungi dal restituirci momenti di godimento e spensieratezza, un simile stato viene attribuito, a torto o a ragione, a persone, affetti, modi di stabilire relazioni che definiamo “leggeri”. Superficiali, inaffidabili, incostanti. Una battuta di spirito introduce la leggerezza in molti momenti opprimenti della nostra quotidianità, ma se l’autore o l’autrice non fanno che avvalersi di spiritosaggini, la loro leggerezza è indice di stupidità incapacità di comprendere che non è proprio il momento propizio. In amore, la leggerezza è una grande qualità. Ma donne o maschi “troppo leggeri”, a seconda delle aspettative più meno serie che abbiamo nei loro confronti, a seconda delle circostanze della vita, ci irritano, indispongono, fanno soffrire. Per tali ragioni, la positività della leggerezza (quando non nuoce e possa degenerare nei suoi contrari) va ricondotta ad alcune circostanze soltanto e non a tutte indistintamente. Nessuna parola è esente dall’alterarsi nel suo contrario: nulla è soltanto positivo o negativo. Pertanto dovremmo anche occuparci dei pregi della pesantezza, qualche volta: alias della serietà, della fatica, di certe regole, di una certa disciplina. Ogni intento, seppur lodevole e generoso, di affannarsi per rendere pertanto pedagogica la leggerezza, potrebbe finire col farcela odiare. Per sua natura l’educazione non può essere soltanto leggera e spensierata. Sottrarre peso alla scrittura Italo Calvino, non a caso, scelse di dedicare il primo saggio ad una leggerezza che gli stava particolarmente a cuore: il suo obiettivo dichiarato, come ritroviamo più volte nelle Lezioni, fu quello di «sottrarre peso alla struttura del racconto, al linguaggio». E questa levità ritrova allora nelle opere di Ovidio, Lucrezio, Leopardi, Montale… Per Calvino la leggerezza è scrittura capace di suscitare una pensosità sempre limpida. Egli fu nemico dichiarato della «opacità, dell’oscurità, dell’inerzia del mondo», tratti peculiari della pesantezza sia del vivere che dello scrivere. Per lui rintracciabili1 negli effetti dello sguardo della Medusa, che pietrificava, appesantiva, chiunque la guardasse. Soltanto l’eroe alato Perseo, protetto dall’inafferrabile Ermes, poté infatti sconfiggerla. Imparare a guardare le cose con uno sguardo non sempre uguale significa evitare che divengano troppo pesanti; scri- vere con leggerezza non significa scrivere di cose futili. Anche la tragicità dell’esistenza può essere raccontata con uno stile leggero. Come la conoscenza del mondo diviene (in Lucrezio) dissoluzione della sua compattezza – oggi diremmo decostruzione, approccio analitico – anche la letteratura, la creazione poetica, sono in grado di muoversi allo stesso modo quando vanno mostrando l’invisibile nelle cose visibili, riuscendo a smaterializzare la fisicità talvolta insopportabile della vita. Rendere leggero un testo è dissolverne la compattezza. Scrivere leggermente è far sì che la scrittura sia in grado di ridare forme leggere a quanto va narrando. Leggerezza per Calvino è la gravità, ne è il segreto, dice. Quando scrivere è superare la vaghezza, mostrando che si può essere leggeri come «l’uccello e non come la piuma»2. Allora quello che scriviamo se riusciamo a farlo “levitare” assumerà tutt’altro senso e tono, affidato alla dinamicità che un’arte leggera dello scrivere deve riuscire a infondere nei contenuti. La scrittura letteraria che crea parole (“pulviscoli” e combinazioni infinite tra di esse) in continua cangianza e metamorfosi per raccontare il mondo, non ha bisogno di avvalersi mai di questa parola. Un esempio lo ritroviamo nel Cavaliere inesistente3, quando nella figura di Agilulfo ci vuole mostrare che l’eccesso di leggerezza conduce alla vacuità, alla scomparsa di ogni forma. Come non avanzare dunque qualche dubbio sulla possibilità di educare sempre e comunque con leggerezza il prossimo nostro e noi stessi. Occorre allora declinare la parola e chiedersi che cosa possiamo intendere per: educare leggermente, educazione leggera, educazione leggiadra, educazione alla leggerezza. Nella prima possibilità equivarrebbe a educare poco o nulla, ad essere presenti astenendosi da insistenze, provocazioni, muoversi senza invasività e quel tanto che basta per influenzare l’altro; nel secondo l’educazione si presenterebbe all’insegna della futilità, dell’enfasi tributata all’effimero del carpe diem, della inconsistenza, della assenza di incisività e école numero 78 pagina 11 Illustrare Calvino RUGGERO ASNAGHO MARCOVALDO quindi incapace di generare cambiamenti; nel terzo, l’educazione leggiadra, non può che ricondursi alla giocosità, alla frivolezza, alla cura estetica dei contesti in cui si attua l’educazione. Infine un’educazione alla leggerezza nel senso autentico del termine, sembra suggerirci ancora Calvino, vorrebbe dire sottrarre peso pedagogico, non esagerare con cure e preoccupazioni eccessive, non essere opachi e cioè ambigui. Scrivere di sé con leggerezza La lezione sulla leggerezza ci offre dei consigli preziosi, quando senza ambire a diventare scrittori famosi, si utilizzi la scrittura per raccontarsi. Il rischio di ogni autobiografia è difatti quello di indulgere nella pesantezza dello stile, specie quando la vita ritrovata e riscoperta di episodi, eventi, incontri “pesanti” ce ne abbia riservati non pochi. Seguendo le indicazioni dello scrittore potremmo avanzare qualche raccomandazione pertanto allo scrittore principiante. Occorre ripercorrere la propria storia affrontando la pesantezza di quanto abbiamo vissuto con maggiore ironia; con un’attenzione alla complicazione degli eventi, a quel poco o tanto di enigmatico, di inconcluso, che abbiamo prima vissuto e che poi con lo scrivere si tratta di riprodurre. La tecnica, sempre suggerita da Calvino, deve mostrarsi in grado di non far inciampare mai il lettore in qualcosa che gli richieda un appesantimento del suo atto di leggere. Occorre rendere le figure, che via via appaiono alla memoria, quasi fragili bozzetti. Poiché il ricordare è per sua natura un’operazione che sottrae peso alle immagini realmente incontrate. I corpi dei luoghi e delle persone devono risultare precisi ma al contempo diafani, come i personaggi che Calvino creò, città comprese da lui non a caso chiamate con nomi degni di organismo viventi. Occorre scrivere sorvolando i luoghi che abbiamo attraversato con rapidità, evitando eccessive descrizioni. E sarà bene raccontarsi, con uno sguardo al passato, avendo ben presente il disegno esistenziale che solo guardandosi alle spalle si profila senza renderlo troppo didascalico e pedante. Soprattutto occorrerà rendere leggero l’io narrante, scevro da giudizi al fine di non pietrificare quanto si è vissuto e il lettore. Al quale va proposto di seguire lo stratagemma di Perseo che vinse la Medusa evitando di guardarla direttamente negli occhi. Scrivere di sé, della propria storia, è ritrovarla come in uno specchio, precisa ma tremula, come attraversata da una brezza che come tale non potrà che essere leggera, radente, fremente. * Docente di Filosofia dell’educazione, Università di Milano Bicocca. NOTE 1. I. Calvino, Lezioni americane, Garzanti, Milano, p. 6. 2. Occorre leggere la prima lezione in interazione continua con quella dedicata all’“Esattezza” dove Calvino ci ricorda che il linguaggio preciso riesce a creare immagini nitide, incisive, icastiche: leggére appunto (op.cit. pp. 55 - 78). 3. I. Calvino, Il cavaliere inesistente, Einaudi, Torino p. 95. école numero 78 pagina 12 Cronache di Altroquando Italo Calvino e la leggerezza del fantastico GIUSEPPE PANELLA «È la forza immaginativa o creativa della nostra mente che ha prodotto tutto ciò che noi chiamiamo cultura e civiltà. È la capacità di trasformare un mondo fisico subumano in un mondo dalla forma e dal significato umani, in un mondo non di rocce e d’alberi, ma di città e di giardini, non ambiente ma home. […] È un dato dell’esperienza che il mondo nel quale viviamo è un mondo creato in larga misura dall’umana immaginazione. Fa parte del riconoscimento della realtà da parte del buon senso il fatto che ci deve essere una norma al di sopra del buon senso con potere di veto sul buon senso stesso» (Northrop Frye, Favole d’identità. Studi di mitologia poetica) U na vocazione per il fantastico: elogio della leggerezza Fin dal principio tutta l’opera narrativa di Italo Calvino si è posta sotto il segno del fantastico1. Anche Il sentiero dei nidi di ragno del 1947, salutato all’inizio come una sorta di recupero e di ringiovanimento della tradizione del neorealismo letterario, era, in realtà, un tentativo perfettamente riuscito di coniugare una certa tradizione italiana di scrittura improntata al realismo (in particolare, in quel romanzo, era l’influsso di Nievo e delle sue Confessioni di un italiano a prevalere) con l’accensione fantastica delle impressioni di un ragazzino, Pin, che ha all’incirca dieci anni ed è orfano di padre e di madre. Ambientato in Liguria all’epoca della Resistenza, il romanzo di Calvino contiene tutta una serie di suggestioni legate al mondo del fantastico tutt’altro che ortodosse rispetto all’atteggiamento letterario fino ad allora invalso rispetto alla lotta di liberazione partigiana e alla sua dimensione “più che eroica” (il Fenoglio dei Ventitré giorni della città di Alba e del Partigiano Johnny era, all’epoca, ancora di là da venire). Del suo essere o meno scrittore del fantastico, lo stesso Calvino dirà anni dopo (rispondendo il 15 agosto 1970 a un’inchiesta di Le Monde avviata proprio in relazione all’uscita del saggio di Todorov già citato) che: «Il fantastico dell’Ottocento, prodotto raffinato dello spirito romantico, è entrato presto nella letteratura popolare (Poe scriveva per i giornali). Nel Novecento è un uso intellettuale (e non più emozionale) del fantastico che s’impone: come gioco, ironia, ammicco, e anche come meditazione sugli incubi o i desideri nascosti dell’uomo contemporaneo. Lascio ai critici il compito di situare i miei romanzi e racconti all’interno (o all’esterno) d’una classificazione del fantastico. Al centro della narrazione per me non è la spiegazione d’un fatto straordinario2, bensì l’ordine che questo fatto straordinario sviluppa in sé e attorno a sé, il disegno, la simmetria, la rete d’immagini che si depositano intorno ad esso come nella formazione di un cristallo»3. Del fantastico e della sua capacità di espressione che andava al di là della possibile riproduzione del reale, Calvino apprezzava soprattutto la leggerezza e la visibilità. Nella prima delle Norton Lectures del 1986 che sarebbero poi confluite nelle cosiddette Lezioni americane4, il fantastico e la fantascienza hanno dei numi tutelari (uno fra tutti è il Cyrano de Bergerac dell’Altro mondo che narra dei suoi fantastici viaggi sul Sole e sulla Luna5) che ne garantiscono, appunto, la levità narrativa e la non-pesantezza espressiva. La leggerezza, per Calvino, era la capacità di mostrare attraverso immagini poetiche e ritmate da una scansione il più possibile libera da pesantezze e indugi il corso del presente in proiezione futura. Tale forma di rifiuto dell’alienazione del presente in nome della capacità di realizzare una maggiore fluidità della vita a venire attraverso l’opera letteraria è presente fin da subito nella sua poetica di autore del fantastico. Nelle prime pagine della “lezione americana” dedicata alla leggerezza, infatti, scriverà con acutezza e rimpianto: «Quando ho iniziato la mia attività, il dovere di rappresentare il nostro tempo era l’imperativo categorico d’ogni giovane scrittore. Pieno di buona volontà, cercavo d’immedesimarmi nell’energia spietata che muove la storia del nostro secolo, nelle sue vicende collettive e individuali. Cercavo di cogliere una sintonia tra il movimentato spettacolo del mondo, ora drammatico ora grottesco, e il ritmo interiore picaresco e avventuroso che mi spingeva a scrivere. Presto mi sono accorto che tra i fatti della vita che avrebbero dovuto essere la mia materia prima e l’agilità scattante e tagliente che volevo animasse la mia scrittura c’era un divario che mi costava sempre più sforzo superare. Forse stavo scoprendo solo allora la pesantezza, l’inerzia, l’opacità del mondo: qualità che s’attaccano subito alla scrittura, se non si trova il modo di sfuggirle. In certi momenti mi sembrava che il mondo stesse diventando tutto di pietra: una lenta pietrificazione più o meno avanzata a seconda delle persone e dei luoghi, ma che non risparmiava nessun aspetto della vita»6. Il modo migliore che Calvino troverà per sfuggire alla “pietrificazione del presente” e salvarsi da essa sarà scrivere storie di fantascienza che nessuno avrebbe potuto prendere sul serio sul fronte del realismo. Nascono le Cosmicomiche (1965), nel tentativo leopardiano di coniugare scienza e letteratura. La scrittura di anticipazione come visibilità del futuro prossimo venturo Il libro, tradotto in inglese nel 1968, avrà una notevole fortuna anche in America (come quasi tutte le altre sue opere) ed entrerà nella rosa del prestigioso Premio Nebula per quell’anno. Calvino, tuttavia, vincerà quel premio creato per la fantascienza d’autore solo nel 1975 con la traduzione delle Città invisibili (The Invisibile Cities). Il successo delle Cosmicomiche fu tale che lo scrittore ligure scrisse e pubblicò nel 1967 una sua continuazione dal titolo Ti con zero dove venivano alternate storie del futuro prossimo con pastiche letterari (diventerà famosa la sua riscrittura del Conte di Montecristo in parte ripresa da I fiori blu di Raymond Queneau che in quel periodo egli stava traducendo). Il personaggio principale delle Cosmicomiche, un essere labile dal fantomatico nome di Qfwfq, (evidentemente un palindromo), deve forse il suo nome alla seconda legge della termodinamica di Sadi Carnot per cui sostituendo = con la f di f (or) si ottiene Q=W=Q, il che descrive una pompa di calore. Ogni sua narrazione si basa su un fatto scientifico relativo alla costituzione del mondo e al suo rapporto con lo spazio e gli altri pianeti e prende la forma di un monologo in cui il vecchio Qfwfq mescola la narrazione dell’evento con le sue vicende personali ricordate spesso in maniera confusa e surreale. In Tutto in un punto, ad esempio, una serie di personaggi “inesistenti” convivono tutti in un punto solo e solo il Big Bang primordiale riuscirà a liberarli dall’indistinzione in cui sono. In La distanza della Luna, insieme alla descrizione del rapporto tra la Terra e il suo satellite, viene raccontato l’innamoramento della signora Vhd Vhd per il cugino sordo del narratore che, però, è attirato dalla Luna e non da questa donna (cui, invece, Qfwfq tiene molto). La donna e il cugino sordo approfittano dell’avvicinarsi della Luna per salirci su con una scaletta ma qui, nonostante la situazione favorevole, i due non si comunicano i loro sentimenti perché école numero 78 pagina 13 l’uomo preferisce rimanere in solitudine con la Luna e quindi, quando dovranno ritornare sulla Terra, nulla sarà avvenuto. Data la proliferazione di situazioni basata sulla dimensione puramente immaginativa, è chiaro come per Calvino la fantascienza rappresenti la visibilità della parola nell’epoca della presa di possesso dell’immagine nell’ambito dei processi culturali creativi. «Diciamo che diversi elementi concorrono a formare la parte visuale dell’immaginazione letteraria: l’osservazione diretta del mondo reale, la trasfigurazione fantasmatica e onirica, il mondo figurativo trasmesso dalla cultura ai suoi vari livelli, e un processo d’astrazione, condensazione e interiorizzazione dell’esperienza sensibile, d’importanza decisiva tanto nella visualizzazione quanto nella verbalizzazione del pensiero. […] Sarà possibile la letteratura fantastica nel Duemila, in una crescente inflazione d’immagini prefabbricate? Le vie che vediamo aperte fin da ora possono essere due. Riciclare le immagini usate in un nuovo contesto che ne cambi il significato. Il post-modernism può essere considerato la tendenza a fare un uso ironico dell’immaginario dei mass media, oppure a immettere il gusto del meraviglioso ereditato dalla tradizione letteraria in meccanismi narrativi che ne accentuino l’estraneazione. Oppure fare il vuoto per ripartire da zero. Samuel Beckett ha ottenuto i risultati più straordinari riducendo al minimo elementi visuali e linguaggio, come in un mondo dopo la fine del mondo»7. Su questa domanda fondamentale per il destino della letteratura che verrà, si chiude la carriera di scrittore di Italo Calvino. NOTE 1. Il termine fantastico che può essere ovviamente utilizzato e considerato sotto molte e diverse angolature sia teoriche che fattuali viene qui ripreso nei suoi significati primari da un celebre saggio di T. Todorov, La letteratura fantastica. Definizione e grammatica di un genere letterario, traduzione italiana di E. Klersy Imberciadori, Garzanti, Milano 1983. Ma, per il valore della riflessione che aggiungono allo studio di un problema tanto controverso, non si possono trascurare sia il saggio di L. Vax, La natura del fantastico, traduzione italiana di E. Cocanari, Theoria, Roma - Napoli 1987, che quello di R. Runcini intitolato Enigmi del Fantastico, con un’introduzione di C. Bordoni, Solfanelli, Chieti 2007. 2. Come avviene nei romanzi e racconti analizzati da Todorov. 3. I. Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Mondadori, Milano 1995, p. 261. 4. Pubblicate postume da Garzanti di Milano nel 1988, sono state poi ristampate con lo stesso titolo presso Mondadori nel 1993. 5. «Straordinario scrittore, Cyrano, che meriterebbe d’essere più ricordato, e non solo come primo vero precursore della fantascienza, ma per le sue qualità intellettuali e poetiche. Seguace del sensismo di Gassendi e dell’astronomia di Copernico, ma soprattutto nutrito della “filosofia naturale” del Rinascimento italiano – Cardano, Bruno, Campanella – Cyrano è il primo poeta dell’atomismo nelle letterature moderne. In pagine la cui ironia non fa velo a una vera commozione cosmica, Cyrano celebra l’unità di tutte le cose, inanimate o animate, la combinatoria di figure elementari che determina la varietà delle forme viventi, e soprattutto egli rende il senso della precarietà dei processi che le hanno create: cioè quanto poco è mancato perché l’uomo non fosse l’uomo, e la vita la vita, e il mondo un mondo» (I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio. 6. I. Calvino, Lezioni americane, pp. 7 - 8. 7. I. Calvino, Lezioni americane, pp. 106 - 107. école numero 78 pagina 14 Illustrare Calvino MARIA ENRICA AGOTINELLI IL BARONE RAMPANTE Le città invisibili dei bambini Da tempo sembra stia avvenendo una lunga e velata transizione della scuola e del sapere verso la decostruzione di una capacità critica e di approfondimento della conoscenza umana, come se qualcuno si fosse accorto che tutta la conoscenza divulgata facesse traballare la costruzione sociale come la conosciamo. Non solo, una mediocre formazione intellettuale, fin dall’infanzia, tende a rendere omogenei verso il basso i saperi e l’apprendimento PATRIZIA BORTOLINI * N ella scuola primaria si assiste da anni a quella che può essere definita la “banalizzazione” della cultura dei bambini e delle bambine. Per capire cosa significa basta vedere i libri di testo proposti: immagini di orsetti, paperelle, pupazzetti, testi banali spesso privati, sino in quinta, di qualsiasi difficoltà linguistica. Dietro questa evoluzione sta l’idea che “il mondo dei bambini” sia altro da quello degli adulti, nel senso che assomigli ad una specie di Disneyland, che i bambini non abbiano pensiero astratto e senso del tempo e quindi non siano in grado di capire, che il “loro” linguaggio sia diverso e che quindi si debba parlare in modo più “semplice” adattandolo, cioè impoverendolo. Se poi accostiamo questo linguaggio a quello televisivo, spesso ordinario e volgare, possiamo trarne le dovute conseguenze. Questo non è lo spazio né il luogo per approfondire questi argomenti, ma vorrei offrire una riflessione attraverso una esperienza didattica. La genialità dell’infanzia Lo spunto teorico che da anni mi sostiene in questo approccio attiene agli studi di Lev Vigotskij, in particolare a quelli sulla formazione del pensiero attraverso il linguaggio, dell’influenza sociale e del condizionamento storico che entrambi subiscono. In questa epoca, uno dei compiti degli insegnanti deve essere quello di ampliare le conoscenze e il lessico dei bambini ed anche la loro capacità, infinita e troppo spesso frustrata, di pensare e di immaginare. Proprio recentemente ho ritrovato in una citazione di Margherite Yourcenar il senso di questa modalità di lavoro: parlando del fatto che il padre le leggeva in inglese i Ricordi di Marco Aurelio, dice «La nostra epoca ignora e nega troppo la genialità dell’infanzia». Qua- le migliore proposta di uno scrittore come Calvino, che fa della relazione tra parola ed immaginazione, dell’intreccio di mondi immaginari e di realtà, il punto del suo lavoro? Molti ritengono che la lettura di Calvino in una scuola primaria sia precoce perché i bambini non sono in grado di decodificare un testo così complesso. Prima di tutto non tutti i testi di Calvino sono “difficili”, molti sono stati scritti proprio per i bambini e poi non si deve avere paura di proporre “stimoli alti” e magari anche precoci: quanti sono i libri che si leggono ad età diverse trovandovi nuovi spunti e risonanze via via che si stratificano nelle nostre menti. Nella mia esperienza la proposta di testi complessi e di alto livello letterario risulta, invece, di un fascino incredibile, è come se i bambini ne cogliessero spontaneamente la bellezza. Nelle Città invisibili è la struttura stessa, in forma di narrazione-fiaba, che li incanta fin dal primo momento e le letture interpretative che i bambini riescono a farne sono spesso ben più profonde ed immediate di quelle di molti adulti, mediate da approcci culturali non sempre felici. Dal punto di vista didattico sono stati presentati e letti insieme alcuni brani tra quelli che potessero sfociare in una riproduzione/ rappresentazione grafica. Questo consente di analizzare insieme il testo e di condividerne la comprensione a partire dalla lettura che ne fanno i bambini. Ne emergono riflessioni significative su diversi aspetti e piani di lettura: la forma “città”, cosa intendiamo e perché la città ha per noi questo significato, le diverse forme di città nella storia e nelle culture, le similitudini e le differenze; il rapporto con “l’altro”; l’importanza della narrazione; il senso del “viaggiare”, l’incontro con codici, culture, lingue diverse... Questo percorso sprona la loro fantasia e quando viene chiesto di creare una loro città invisibile, dapprima raccontandola e poi riproducendola concretamente attraverso installazioni realizzate con materiali di recupero, emergono realizzazioni degne della mente fantasiosa e creativa di Calvino. Un mondo si apre attraverso gli occhi dei bambini, che, molto più di noi, se ben guidati sanno cogliere la meraviglia della molteplicità del mondo e Calvino è sempre un’ottima guida. * Insegnante di scuola primaria, Milano. Illustrare Calvino SERGIO MASALA LA DISTANZA DALLA LUNA école numero 78 pagina 15 Il Marchionne Sergio della Puzza Inizio giugno, fine anno scolastico, ultimi argomenti da rivedere del programma: Italo Calvino e la società industriale, il boom economico. Fabbriche, smog, città inquinate invisibili e vite pure. Per i famigerati “percorsi personali” che cercano di intrecciare diverse discipline intorno a un argomento – e gli intrecci a volte avvengono intorno a nessi strampalatissimi – alcuni racconti di Calvino mi sembra vadano bene. Perlomeno sono sul tema e sono brevi, insomma si possono leggere davvero. In classe facciamo La gallina di reparto e L’avventura di due sposi ANDREA BAGNI G iugno, Italia, 2010. Si parla di lavoro e si parla di Sud. Pomigliano d’Arco. La Fiat vuole riportarci la produzione della Panda, già trasferita in Polonia. Un gesto eroico, contro la storia, dicono in Confindustria. Cosa si può fare di più per il paese. Però per poter riportare la produzione automobilistica in Italia (e addirittura al Sud) bisogna che le cose funzionino come devono funzionare nella globalizzazione. Come vasi comunicanti, è stato scritto su repubblica. Si deve lavorare come nell’Est europeo. La concorrenza è concorrenza e la razionalità economica ha la sua logica. Mica è ideologia. E neanche poesia, per quanto nella proposta di accordo – bizzarro accordo: prendere o lasciare – si parli di metrica del lavoro. Si chiede di lavorare tutti i giorni su tre turni, con la pausa mensa dopo le otto ore; ritmi tempi e metodi misurati come una volta ma adesso dettati dal computer – che cancelli una volta per tutte gli sprechi (gabinetti, pensieri e respiri), che asciughi il processo produttivo. È il World Class Manufacturing (Wcm). Si parla di sanzioni disciplinari per chi sciopera e indice lo sciopero, di riduzione di stipendio per chi si ammala in periodi di malattie sospette. In classe leggiamo di operai ex contadini che cercano di attirare la gallina che il guardiano ha portato in fabbrica: sarebbe una vittoria farle fare le uova per loro invece che per il capo. Vittoria simbolica. Storia di leggerezza ed ironia ma di spessore politico niente male. Operai che hanno dovuto adattare le loro menti alle macchine. Aumentate perché lavorando bene dimostravano che era possibile aumentarle. Adesso devono parlare e pensare a ritmo sincopato. «Se a mag... (alza la leva!)... gio mio figlio sposa la figlia di quel barbagianni... (ora accompagna il pezécole numero 78 pagina 16 zo sotto il tornio!) sgomberiamo la stanza grande... (e facendo i due passi:) ... così gli sposi la domenica restando a letto insieme fino a tardi vedranno dalla finestra le montagne... (ed ora abbassa quella leva là!) e io e la mia vecchia ci arrangiamo nella stanza piccola... (metti a posto quei pezzi!)... tanto noi anche se dalla finestra vediamo il gasometro non fa differenza». Convivere con l’invasione produttiva della vita, restando altro negli interstizi, nei vuoti in cui tessere un filo di libertà. I ritmi dell’industria 1954 modellano la sintassi ma non cancellano il discorso. Che li incorpora. In Calvino ci salvano, in un certo senso, le figure retoriche. Metonimie, spostamenti, sostituzioni di contatti. Dislocazioni di senso. Metafore della liberazione. A Pomigliano chiedono la fine di ogni alterità. Dal lavoro deve sparire la possibilità stessa dell’ironia. Sarebbe distanza. Bisogna invece essere servi, nel corpo nell’anima, e riconoscenti di esserlo. Di non essere disoccupati. L’ironia è dignità. E la leggerezza di Calvino è un’antropologia non rassegnata, da consegnare al secolo scorso. A Pomigliano Marchionne l’illuminato si riduce a Giovannino della Puzza. Quello incapace di un lavoro ben fatto, che fa la spia stazionando fisso nei cessi per ascoltare i discorsi privati dei dipendenti. Quella gallina deve portare messaggi segreti. Strategie di sabotaggio. Sarà perquisita, sotto le ali in particolare – uno dei sorveglianti è un ex militare e conosce le tecniche della guerriglia. A Pomigliano la Fiat potrebbe chiamare quelli che sono stati a Genova per il G8. Si tratta sempre di bonificare il terreno dai diritti costituzionali. Calvino alla fine resta, con la sua malinconia così nitida e ironica, uno che ci crede nella razionalità. In un’altra razionalità: umana relazionale spiazzante metaforica. Come un cartello a Parigi: la lucidité est révolutionnaire. Di questi tempi moderni e post-moderni, cioè neofeudali e iper-tayloristici (ma non più fordisti: niente cinque dollari al giorno, niente potere d’acquisto da sostenere – alla domanda ci pensino derivati e fondi spazzatura) questa fiducia nella possibilità di una resistenza razionale mi sembra che faccia bene all’anima. Per i corpi rimane la strepitosa metonimia dei due sposi avventurosi nel racconto del 1958. Lei si sveglia la mattina per andare in fabbrica, lui ritorna dal turno di notte. Lei sente dal suo abbraccio col giaccone nero di pelle se fuori fa caldo o freddo, se c’è umido o il sole. Il tatto racconta, come una sinestesia narrativa. La città esterna, il suo movimento e il suo tempo, entrano dentro. Nello spazio intimo. Arturo e Elide si toccano come per sbaglio in bagno per lavarsi, in direzioni opposte del tempo. Poi lui quando lei esce si mette a letto. Dalla sua parte è freddo. Da quella di lei è rimasto il calore del suo corpo. Assente. Turni di fabbrica, ritmi di vita, intermittenze del cuore. Vai a spiegarlo ai mega dirigenti illuminati mondiali. Starà dalla pare di lei, Arturo. La sera Elide allunga la mano dalla parte di lui e la sente fredda. Capisce ovviamente. Sorride. Dev’essere come un abbraccio. L’amore dei corpi attraverso il ricordo caldo della loro impronta. Il contatto per mancanza. A Pomigliano niente più sabati e chissà le domeniche. Niente abbracci fuori turno. Prepararsi alla resistenza umana. All’amore al tempo della metrica del lavoro. Metrica nera di lavoro servile. Amore avventuroso e ribelle. Calvino e la Rete Quando nel 1985 Italo Calvino si apprestava a scrivere le Lezioni americane, nel mondo di Internet venivano assegnati i domini nazionali: .it per l’Italia, .de per la Germania, .fr per la Francia, ecc… Quindi, probabilmente, Calvino non era a conoscenza delle potenzialità che la Rete andava implementando. Eppure le aveva immaginate se, nel preparare le sei conferenze, la sua idea era quella di presentare appunti utili per orientarsi in quelle trasformazioni che apparivano davanti ai suoi occhi, come riportato nello stesso sottotitolo del libro: “sei proposte per il prossimo millennio” Illustrare Calvino SHANNON MAY LE COSMICOMICHE EDOARDO CHIANURA L e proposte, pur mirando a qualità appartenenti alla letteratura, ad una attenta lettura riguardano “valori” che dovrebbero informare non soltanto l’attività degli scrittori, ma ogni aspetto del nostro vivere quotidiano: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza (conferenza che Calvino non fece in tempo a scrivere, per la prematura scomparsa). Il tentativo che voglio proporre, peraltro già operato in anni passati da autori come Alessandro Lucchini (http://www.magiadellascrittura.it) e Luisa Carrada (http://www.mestierediscrivere.com), è quello di accostare alcune considerazioni tra le sei proposte riportate nel libro e il modo di “stare in rete” o quantomeno come dovrebbe essere secondo i valori calviniani. Leggerezza: quando come informatici pensiamo a questo valore è immediato l’accostamento al software, rispetto alla pesantezza dell’hardware. Ma se ci accostiamo ad Internet è nel flusso comunicativo, alle modalità di scambio e creazione delle informazioni, che ritroviamo la leggerezza proposta da Calvino. Quel continuo saltare da un albero all’altro del “Barone rampante” che «si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l’abbandono al caso». Una scrittura leggera che non vuole essere frivolezza, che non è riduzione a pillole, ma leggerezza di linguaggio che sappia coniugare quantità (immagini, paragrafi, parole e stili) a qualità (sintesi, dinamica e densità di informazioni). Un requisito necessario per l’usabilità dei contenuti in rete (http://www.fcomolli.it/ bs_nielsen.htm), o meglio della semplicità nella loro fruizione. Rapidità: sempre più il nostro modo di vivere ci chiede di essere rapidi e nel web ciò si traduce in richieste di assalto nella ricerca e creazione di informazioni e di associazioni fra un contenuto, un pensiero e un’idea. Ma la celebrazione che Calvino fa della rapidi- école numero 78 pagina 17 Illustrare Calvino SERGIO TOFANO MARCOVALDO tà non esclude l’attenzione al suo valore opposto, quell’“affrettati lentamente” che, nella congestione attuale di contenuti brevi, semplici e concentrati, richiede a monte una “paziente ricerca”. Esattezza: attraverso questo “valore” Calvino ci chiede che ogni progetto sia “ben definito e ben calcolato” non solo per ciò che riguarda la sua struttura (di navigazione), ma nell’affidabilità delle fonti, nella sua correttezza e chiarezza espressiva. Visibilità: sappiamo bene quanto sia fondamentale per la rete la visibilità per potere esistere, perché puoi benissimo scrivere, aggiornare, aggiungere, ma se poi non ti “vede” nessuno? O peggio ancora, se tutto ciò che “metti in vista” è illeggibile? Quindi mai dimenticare «il potere di mettere a fuoco visioni» attraverso un linguaggio visivo che sia gravido di immagini, colori, caratteri, strutture rigorose e disposizioni. Molteplicità: «in Internet c’è tutto» è ciò che spesso ci sentiamo ripetere ed in effetti da ogni parola, immagine può eplodere una marea di nuove direzioni informative e comunicative (uno-ad-uno, uno-a-molti, molti-a-molti) quindi la richiesta di un modo di proporsi sempre diverso in un viaggio che «se potesse continuare e svilupparsi in ogni direzione arriverebbe ad abbracciare l’intero universo». Coerenza: seppur questa lezione non è stata scritta, in essa troviamo l’epilogo delle precedenti. Quel bisogno di connessione tra libertà, qualità, aggiornamento, affidabilità che non sta solo al livello del contenuto, ma anche nel modo di proporlo e che fa di un medium così potente come la Rete un luogo non-luogo in cui pochi sono i punti fermi, ma molti quelli di riflessione e di indagine. Quindi un mondo a cui dobbiamo essere preparati e da cui nulla può essere agguantato e dato per scontato una volta per tutte. école numero 78 pagina 18 idEE per l’educazione PEDAGOGIE I dispositivi per la formazione di un nuovo italiano Come si diventa Silvio RAFFAELE MANTEGAZZA C he importanza hanno l’ascesa e il potere di Silvio Berlusconi per un pedagogista? Che cosa gli insegnano dal punto di vista professionale di esperto dei processi educativi? A mio parere, moltissimo. Non c’è stata forse in Italia nel Dopoguerra una forma di potere più pedagogica di quella instaurata da Berlusconi negli ultimi anni; nemmeno il potere democristiano, forse nemmeno il fascismo erano così fortemente caratterizzati in senso educativo. Ma non nel senso banale di prendere il potere per esercitare attraverso di esso una serie di azioni educative sul popolo italiano; al contrario: quello che è accaduto è che il popolo italiano, o la gran parte di esso, è stato educato, costruito, strutturato in modo tale da non percepire (proprio a livello di fenomenologia della percezione; non vedere, non udire, non assaporare) i continui strappi al tessuto democratico che Berlusconi ha attuato; Silvio Berlusconi (e non Forza Italia, il “Polo”; il Popolo delle Libertà: proprio Silvio Berlusconi) è il risultato di una serie di pratiche pedagogiche di potere, viene a valle e non a monte dell’applicazione di dispositivi pedagogici; è un prodotto e non un presupposto. I fans e gli elettori di Berlusconi (due termini assolutamente interscambiabili) erano école numero 78 pagina 19 ra è stupido, che chi rispetta le leggi è un idiota, costituisce l’anima di molti processi formativi. Lo sport (l’ammirazione per il simulatore – dal goal di mano di Maradona agli scudetti truccati di Moggi –, per il baro, in fin dei conti anche per il dopato almeno “finché non si fa beccare”), il mondo del lavoro (tutto l’universo del sommerso, il senso di stupidità che si prova quando si richiede una ricevuta fiscale), purtroppo anche la scuola («ci sarebbe l’insufficienza, il provvedimento disciplinare, l’obbligo di frequenza, ma via, cosa volete che sia, azzeriamo tutto») sono esempi dell’applicazione di un’idea di lungo corso: le regole sono rigorose solamente per gli ultimi e gli esclusi (la galera per un grammo di hascisc trovato in tasca a un immigrato), mentre per i ricchi e i potenti non rispettarle è un dovere (la segreta ammirazione per chi ha evaso il fisco per milioni); da anni ci sembra che in ambito educativo chi chiede che le regole siano rispettate sia considerato un sadico, un fascista oppure un moralista. E anche da sinistra ci viene continuamente ricordato che le regole sono di destra, sono cattive, sono camicie di Nesso. L’annientamento dell’aspetto positivo della regola, il non dire più che le regole servono perché siano tutelati gli ultimi e gli esclusi, il dimenticare che esiste un rigore del rivoluzionario, una regola per il ribelle, una rigorosa etica della contestazione: tutto ciò ha spianato la strada a chi ha fatto del disprezzo delle regole una piattaforma politica e dell’irrisione verso chi le rispetta uno slogan di eccezionale forza propagandistica. pronti, come scatole vuote, a votare lui o qualsiasi altro soggetto avesse le sue caratteristiche, ben prima della famigerata “discesa in campo”. Se Berlusconi non ci fosse stato lo si sarebbe inventato perché ormai le pratiche pedagogiche avevano preparato il vuoto da riempire con questo tipo di soggettività. Le strategie messe in atto a livello sociale diffuso per ottenere questo consenso – per ottenere i soggetti umani che garantiscono questo consenso –, i dispositivi di questa che Pasolini aveva già iniziato a definire “mutazione antropologica” sono quanto di più interessante per chi studia le pratiche di formazione umana. Anzi, non si vede di che cosa altro dovrebbe interessarsi oggi la pedagogia, non solo in Italia. Ci sembra che questo meccanismo pedagogico di creazione dei soggetti “berlusconizzabili” punti su alcuni capisaldi dei quali iniziamo da questo numero l’analisi1. Il disprezzo per le regole Al di là degli eccessi quasi patologici degli ultimissimi anni, l’idea che una regola sia unicamente un vincolo che ostacola qualsiasi forma di attività umana non è certo nuova. Di più, l’idea che le regole possono essere aggirate, anzi che chi non le aggi- école numero 78 pagina 20 La generalizzazione dell’arroganza «Lei non sa chi sono io!», una frase che sembrerebbe propria di un problematico “carattere italiano” (che non si sa bene che cosa sia ma che anche Renato Mannheimer sembra riproporre in uno sconcertante questionario2), è invece il risultato di un lungo processo educativo. La comparsa di Vittorio Sgarbi sulle TV italiane (grazie, occorre ricordarlo, a Maurizio Costanzo) ha incarnato il principio secondo il quale chi grida, chi insulta, chi riesce a sottrarre all’avversario anche il diritto alla replica ha ragione. Ma si tratta di un principio già presente nel tessuto sociale, da quando i processi educativi hanno smesso di educare all’argomentazione razionale e hanno contribuito a educare alla prepotenza, all’arroganza, alla prevaricazione. L’insegnante, l’allenatore, il capo scout che tollerano episodi che vanno sotto il disgustoso nome di “nonnismo” quando non si trasformano essi stessi in piccoli ducetti che non sanno dire altro che «si fa così perché lo dico io» hanno preparato il terreno per un’Italia nella quale il vecchio detto brianzolo per cui «chi grida di più porta a casa la vacca» ha assunto una declinazione positiva: che bravi sono quelli che riempiono le stalle di vacche conquistate con la violenza verbale! In senso politico, il risultato è la feticizzazione della maggioranza; sono i voti – i milioni di voti – a sostituire i muscoli, e ad essere a loro volta sostenuti dalle parole urlate che portano nuovi voti, e così via in una spirale che ha contagiato anche il centrosinistra (non si spiegherebbe la sconcertante arroganza di Grillo, Santoro, Annunziata, Cacciari, Bresso, Penati e tanti, tantissimi altri e altre): il bullismo istituzionale portato a sistema da Berlusconi, per cui la maggioranza ha sempre ragione perché ha i voti che sono il corrispettivo dei muscoli del bullo, è stato reso possibile dall’abitudine ad accettare la legge del più forte, che i ragazzi e le ragazze hanno visto e vedono applicata quasi ovunque da adulti che non sanno discutere, sanno solamente urlare. La svalutazione delle ritualità Una educazione che ha buttato dalla finestra tutto quanto era rito, svalutando ogni momento alto a livello istituzionale, credendo davvero che l’abito non faccia il monaco, che le dimensioni rituali siano solamente fronzoli e perdita di tempo, una educazione siffatta ha preparato il terreno per la distruzione delle istituzioni e il loro svuotamento di senso. Silvio Berlusconi che invece di presentarsi al Parlamento riceve i suoi ministri a villa San Martino o in tribuna a San Siro è poi così differente – fenomenologicamente – dall’insegnante che interroga i ragazzi in pizzeria, dal docente universitario che esamina gli studenti a casa sua, tra il ragù e i letti da rifare? La critica sessantottina alle istituzioni, alle loro rigidità e ieraticità (una critica sacrosanta, rigorosa e realmente anti-istituzionale) è stata convertita nella parodia di se stessa: svuotando di senso le istituzioni, ridicolizzandole, considerandole solo inutili orpelli si è indebolito anche il senso della loro possibile critica: che cosa c’è mai da criticare in un potere che oramai è parodistico e ridicolizzato? Come direbbe Max Horkheimer, come si fa a spezzare le Dodici Tavole se queste ormai sono marce fradice? Il risultato è stato immediato: in questa nuova forma di potere nel quale “siamo tutti amici”, non esistono differenze di potere (anche perché non esistono più elementi visibili che le segnalano, dalle cattedre alle cattedrali, dagli scranni ai Palazzi del Potere: l’unico elemento di distinzione del potente sono i soldi, ma tutti con un po’ di fortuna e di disprezzo delle regole potremmo farne a vagonate). In questo potere che si nasconde per meglio manifestarsi, si è inserito il Presidente Amico, apparentato strettamente al Professore Amico, al Padre Amico, all’Assessore Amico, al Confessore Amico: siamo tutti amici e tutti uguali in un potere che si nasconde e che cela i propri meccanismi, non più controbilanciati dalle ritualità istituzionali che, come aveva già mostrato Adorno, se rischiano di opprimere il soggetto al tempo stesso si pongono come poli per la sua possibile ribellione; oggi, c’è solo una dolce, mielosa, amichevole oppressione. NOTE 1. Lanalisi di Raffaele Mantegazza su “Come si diventa Silvio” proseguirà sui prossimi numeri di école. 2. Cfr. www.ispo.it/forms/f01/ Ringrazio la mia studentessa Silvia Angiolini per la segnalazione. INTERVISTA Fin tanto che le tecnologie verranno discusse solo per dimostrarne o il loro aspetto ludico o il loro aspetto critico non sarà possibile soffermarsi a fare una riflessione più costruttiva su quali potrebbero essere i vantaggi, su quali sono gli scenari positivi che esistono: scuole che fanno formazione online, scuole che attraverso i gruppi fanno discussione, scuole che fanno sostegno ai ragazzi ospedalizzati e tanto altro ancora. Oggi si sta assistendo ad un imborghesimento della rete. La rete che diventa spazio per quei pochi che hanno tanto tempo da dedicare ad essa e anche risorse culturali da spendere. Noi, nativi analogici, cosa possiamo fare a scuola per mettere tutti in condizioni di pari opportunità? Intervista a Barbara Bruschi, docente di Tecnologie didattiche presso l’Università di Torino La generazione 2.0 e la scuola EDOARDO CHIANURA G enerazione 2.0, homo sapiens digitale1, nativi digitali2, di cosa stiamo realmente parlando, di possibilità in più rispetto al passato o di nuovi modi di essere? L’etichetta generazione digitale è stata coniata da Mark Prensky che per primo ha parlato di “nativi digitali3” andando ad individuare quei soggetti che, essendo nati dopo gli anni ’80, presentavano tipologie di fruizione dei media tali da modificare il proprio sistema cognitivo grazie all’uso delle tecnologie. Per Prensky le nuove generazioni imparano in maniera diversa perché sono strutturalmente diverse. In tutto questo vedo una serie di problemi. Parlare di generazione mettendo insieme i ragazzini di tre anni a quelli che ormai ne hanno quasi trenta, è un forte limite. Forse può valere oggi per chi ha tra i 12 e i 16 anni, ma non vale per chi invece ne ha 25 e ancor meno per chi ne ha 30. Apporre delle etichette così ampie non ci è utile, serve solo a dare un’aurea di mistero a queste nuove situazioni senza dirci nulla di concreto. Chiunque di noi abbia un’esperienza di scuola, di formazione, sa benissimo che non solo non esiste un’intera generazione digitale, ma non esistono nemmeno delle intere classi di ragazzi digitali. Uno dei maggiori problemi è appunto quello del digital devide4 all’interno della stessa classe, in cui troviamo ragazzini dotati di tutte le tecnologie, che navigano in rete, che hanno accesso al mondo digitale, accanto a ragazzini della stessa età che, pur condividendo lo stesso percorso formativo, tale accesso non hanno per questioni familiari, per scelte educative ed altro ancora. Perciò ci troviamo di fronte ad almeno due tipi di soggetti che presentano delle caratteristiche molto diverse sul piano digitale. E poi non sono nemmeno tanto convinta che esista tutta questa digitalizzazione, o meglio che esista questa cosiddetta competenza digitale. Attenti a distinguere ciò che può essere un impiego strumentale e quasi primitivo delle tecnologie da quello che può essere un impiego funzionale e costruttivo: un conto è se io uso le tecnologie per cercare il film al cinema o semplicemente per comunicare, altro è se faccio delle tecnologie un ambiente di conoscenza, di studio, di lavoro, di discussione civile, cioè se c’è dietro a questo “fare” una costruzione di contenuti. Creare tutte queste aspettative, nei con- fronti della generazione digitale (in alcuni saggi, si sbandiera che «ci salveranno i nativi digitali»5; che «l’unica speranza che abbiamo è che i nativi digitali ci caccino fuori dal mondo digitale per farla finalmente da padroni») mi sembra una visione un po’ miope perché continua a mettere l’accento sul valore della tecnologia in quanto tale, ma la tecnologia non serve a nulla se dietro non ha dei modelli culturali forti. Noi adulti, docenti, educatori, genitori che ruolo possiamo svolgere? Certo l’esistenza di nativi digitali con il loro approccio culturale alla rete porterà delle novità. Ma la meta-competenza che hanno gli adulti è una questione di metodo, di storicizzazione degli approcci, di esperienza su come si comunica, su che cosa si comunica, su come si costruisce la comunicazione, sullo stesso “stare al mondo”. A me sembra che ogni tanto ci si dimentichi che lo “stare in rete” riguarda lo “stare al mondo”. Non è un universo parallelo in cui spariscono le regole e c’è tutto da re-inventare. Penso che sia fondamentale partire dai principi che muovono lo stare in società, lo stare nelle organizzazioni sociali reali per poi declinarne delle situazioni in rete école numero 78 pagina 21 che significa comunque avere delle norme, avere delle regole, avere degli orientamenti. Cioè diventare cittadini6 nel vero senso del termine, anche in rete. Ma il discrimine non mi sembra la differenza nelle modalità del fare tra un nativo digitale e un immigrato digitale – per esempio l’immigrato digitale scrive in silenzio, mentre il nativo lo fa con l’MP3 nelle orecchie, il telefonino in una mano e l’altra sulla tastiera. Indubbiamente tutto ciò mette in crisi la scuola, la formazione e l’educazione, nel senso che si dice: «Guardate che i nativi digitali sono diversi, imparano in maniera diversa, hanno bisogno di cose diverse, e la scuola non si adegua!” Dunque: crisi!. Appunto la scuola: non c’è il rischio che ci si arrocchi su posizioni autoreferenziali, incapace di adeguarsi ai cambiamenti esterni? Ma la scuola non deve adeguarsi! La scuola deve sviluppare dei ragionamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi per cui nasce – spazio della formazione, spazio della socializzazione – ed ha una sua identità forte. Bisogna sottolineare questo ruolo forte della scuola, declinato anche secondo le nuove esigenze digitali. I nuovi bisogni educativi si devono esprimere nei termini di alfabetizzazione per il 21° secolo e non di scuola che deve adattarsi alle realtà che stanno fuori. Il gioco è molto rischioso perché si arriva a dire, a volte, che «siccome tutti i ragazzi sono su internet, allora bisogna a tutti i costi usare internet nella scuola». No! Si andrà ad usare internet per quelle attività per cui può servire. La scuola deve chiedersi in primis quali sono i nuovi bisogni di queste generazioni e poi, sulla base di questi nuovi bisogni, mettere in atto degli interventi educativi e formativi funzionali. Che non annullano la sua identità di scuola, di luogo della socializzazione, dell’educazione e della partecipazione. Altrimenti da una parte non si capisce più perché andare a scuola, se poi tutto si fa dovunque, dall’altra ci diremmo che non esistono più competenze necessarie per agire in maniera funzionale al di fuori della scuola. Ci spieghi meglio questo concetto di impiego costruttivo ed efficace della rete? Un esempio che faccio sempre a lezione è che si è perso il senso della documentazione. Le persone non si documentano più! Le persone cercano informazioni in rete, che è qualcosa di molto diverso. Paradossalmente siamo nella “società della conoscenza”, ma il valore della conoscenza è sempre minore. Che differenza c’è tra quello che io leggo in qualsiasi blog e quello che viene pubblicato in una rivista scientifica? Per l’utente medio nessuna! Con l’aggravante che l’utente medio non arriva alla rivista scientifica, ma arriva a qualunque blog e quella diventa la conoscenza. E ciò è molto grave in quanto se da una parte dà spazio a una serie di problemi scientifici, dall’altra dà anche spazio a una brutta credenza: che il lavoro école numero 78 pagina 22 intellettuale e la scienza, tutto sommato, siano qualcosa che può essere fatto e raggiunto da tutti con il semplice uso delle nuove tecnologie; arrivando a sovrapporre senso comune e sapere scientifico in maniera estremamente deleteria. La scuola dov’è rispetto ad un incontro con le tecnologie? Quale funzione può ancora svolgere per le giovani generazioni? Il ruolo della scuola diventa innanzitutto un ruolo di formazione, un ruolo di educazione. In cui l’educazione è intesa come prospettiva di soggetti in grado di gestire in maniera corretta, efficace e costruttiva il loro “stare” nelle diverse realtà. Ricordando che ci sono dei limiti. Ricordando che ci sono delle norme. Ricordando che, prima di tutto, ci sono le “persone”. La scuola ha questo vantaggio, cioè quello di parlare alle persone e di mettere le persone nella stessa condizione e di proporre a tutte la stessa condizione e non pensare che siano più importanti le tecnologie o lo stare nella tecnologia. Quello che conta sono le persone e come queste riescono a stare nel mondo e non nei “paradisi digitali”. In questo momento la scuola ha un dovere che è quello di interrogarsi su quali sono i nuovi bisogni educativi, iniziando a comprendere veramente “che cos’è la rete”. Oggi la rete è un mito. C’è veramente di tutto, si dice di tutto, si pensa di tutto. Tutto è quasi lecito. Mentre sarebbe interessante una re-definizione di un concetto di spazio di rete, dei ruoli, delle dimensioni della rete. Altra questione è che gli studenti hanno bisogno di acquisire le competenze che poi saranno richieste nel mondo professionale − usare gli strumenti per svolgere le professioni − e nella società − saper accedere agli strumenti che consentono in qualche maniera la costruzione di decisioni. Il mio timore è che oggi, in questo mito della conoscenza del sapere diffuso, non si ha molto chiaro quale ruolo svolge e che posizione occupa la rete nella possibilità di partecipazione civile. Cosa può fare la scuola per allargare questa consapevolezza nell’uso della rete? Bisognerà smetterla di far credere che le tecnologie possano essere un’alternativa. In una realtà come la nostra, in cui comunque le tecnologie costituiscono un nucleo forte, anche talvolta di “sviluppo sostenibile”, non possiamo permettere a nessuno di dire «questo non mi riguarda». È un po’ come se oggi qualcuno pensasse che non mi riguarda che le persone debbano saper leggere e scrivere. Oggi lo diamo per scontato, solo qualche decina di anni fa non lo era affatto. E ora con le tecnologie stiamo vivendo lo stesso passaggio. Per cui è utile iniziare a farlo con le nuove generazioni. Per altro bisognerà iniziare a pensare che, se è pur vero che la scuola non deve adeguarsi per non essere poi costretta ad adattarsi a richieste esterne, deve trasformarsi in motore di innovazione. Cioè dobbiamo chiederci non solo quali sono i nuovi biso- gni, ma anche come si costruiscono le risposte. Quindi dobbiamo chiederci come si costruisce la risposta formativa del XXI secolo. Secondo me, non certo continuando a studiare solo sui libri, non certo dicendo non facciamo più le ricerche perché tanto copiate in rete, non certo dicendo il tema in terza media deve essere scritto a mano perché non va scritto al computer, ma capendo che sempre di più oggi gli strumenti sono entrati nel vissuto di ciascuno e che certe competenze diventano fondamentali, non alternative. Qui ci scontriamo con dato di fatto. Purtroppo ci sono delle indicazioni di metodo e di intervento che devono arrivare dall’alto, da un punto di vista del riconoscimento formale di ciò che sta in rete. L’unica soluzione è quella di una vera politica del digitale. Non c’è il rischio che l’uso dei media (tv, slide, internet) possa ricadere in un utilizzo strumentale, invece che costruttivo? Le tecnologie possono essere viste in tre modi. Possono essere degli strumenti, dei mezzi o dei linguaggi. Se sono dei linguaggi bisogna imparare ad usarli nelle diverse situazioni, nel senso che ciascuno deve chiedersi quali linguaggi sono a disposizione nell’ambito della propria disciplina. Non negiamolo, noi continuiamo a scrivere, leggere e parlare. Abbiamo grosse difficoltà a ricorrere ad altre forme di linguaggio. C’è stata nella storia dell’insegnamento un’evoluzione nei modi di fare didattica. Perché allora oggi dobbiamo alzare muri solo perché la trasformazione passa attraverso le tecnologie? L’altra questione riguarda la consapevolezza nel produrre. Consapevolezza che ahimè talvolta manca (quanto, a volte, viene pubblicato su YouTube ce lo conferma). Ma bisogna anche dire che è possibile trovare esempi di produzione da parte dei giovani, che lasciano davvero a bocca aperta perché sono la materializzazione di quello che la MediaEducation va perorando da quasi 50 anni: la multimedialità intesa come l’espressione della creatività attraverso linguaggi alternativi. E in questo senso penso che funzioni un buon sodalizio tra quelle che sono le metaconoscenze, anche procedurali, degli insegnanti, degli adulti e le conoscenze, le competenze – talvolta più di tipo tecnico – che possiedono le nuove generazioni, unitamente anche alla cultura e alla creatività giovanile in quanto tale. NOTE 1. Mark Prensky, “H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom”, Journal of Online Education, Volume 5, Issue 3, February/March 2009, in http://tinyurl.com/cj6pyd. 2. Punto Informatico (2006), Seoul s’interroga sui nativi digitali, http://tinyurl.com/d95zrm. 3. Mark Prensky, Mamma non rompere STO IMPARANDO!, Edizioni Multiplayer.it, Terni 2008. 4. Per un maggior approfondimento http:// it.wikipedia.org/wiki/Digital_divide 5. Palfrey John, Gasser Urs, Nati con la rete. La prima generazione cresciuta su Internet. Istruzioni per l’uso, BUR-Rizzoli, Milano 2009. 6. A. Radicchi, Abitare l’utopia oggi: la città digitale, ejour-fup.unifi.it/index.php/mac/article/ view/2286/2206. STORIA Sono passati anni da quando le Indicazioni Nazionali hanno modificato i curricoli di Storia per la scuola dell’obbligo, ma il dibattito, i dubbi e le sperimentazioni relative all’insegnamento ed alla didattica di questa disciplina non accennano a fermarsi. Soprattutto nella primaria Apprendimento della storia: a macchie o lineare? PATRIZIA BORTOLINI * C stiene Nico Hirtt. E aggiunge: «L’idea secondo cui l’apprendimento passerebbe essenzialmente per la pratica non è più completamente vera quando si tratti di saperi complessi». E c’è anche una questione di pari opportunità: nelle famiglie con alti livelli culturali le possibilità per le bambine e i bambini di entrare in contatto con conoscenze storiche, attraverso viaggi, trasmissioni televisive, mostre, ecc. sono frequenti, mentre nelle famiglie culturalmente più svantaggiate queste esperienze sono assai limitate. Sapere e saper fare L’intento della Commissione di voler andare oltre «la tradizionale separatezza tra gli studi orientati al “sapere” e quelli orientati al “saper fare”», e ritiene che non si possa parlare di competenza solo a proposito di una dimensione strettamente operativa e/o professionale, pone le basi per la costruzione di un percorso scolastico fortemente differenziato tra coloro che hanno accesso ai “saperi” e coloro che potranno limitarsi al “saper fare”. Il termine competenza è portatore di un pensiero tutt’altro che democratico, deriva da competere, parola poco accomunabile con sapere. «L’approccio per competenze costituisce un abbandono del sapere», so- Capaci di capire Come realizzare una didattica che renda capaci bambini e bambine di ricercare, di dubitare, di costruire un proprio pensiero? Come questi cittadini del presente dalla possibilità di discernere tra letture diverse degli accadimenti riusciranno ad acquisire capacità di lettura della realtà nella quale vivranno in futuro? Bambine e bambini sono capaci di “capire” anche concetti astratti. Lo dimostra la domanda di una bambina di sette anni: «Ma allora noi viviamo nella Storia?». Certo fino agli 11 anni la fase è quella delle operazioni concrete, ma ciò non significa che bambine e bambini piccoli non siano in grado di avere un pensiero, e non siano in grado di studiare Storia. Poco interesse hanno per loro i fatti storici trasmessi in modo nozionistico, ma quanto li coinvolge, invece, la Storia costruita sulle narrazioni, tramite ricerche sulle fonti, attraverso un approccio antropologico? È evidente che i concetti, la metodologia, le tematiche, la didattica proposta a bambini fino agli 11 anni sono diversi e di diverso spessore rispetto a quelli proposti a giovani tra gli 11 e i 14 anni. Sono età diverse nelle quali si apprende in modo diverso, con he ne sarà di quei ragazzi e ragazze, e sono molti, che abbandonando la scuola prima della fine delle superiori, della storia del ‘900 avranno un unico assaggio, forse, in terza media? Il curricolo verticale della storia nella scuola dell’obbligo introdotto dalla Commissione De Mauro è stato un intervento, meritevole per la necessaria continuità curricolare, ma lascia pensare più ad un frettoloso taglio (per esempio, nella scuola primaria la proposta prevede di fermarsi all’Impero romano d’Occidente) che ad una approfondita riflessione sull’apprendimento e sulla didattica. entusiasmi e sensibilità diversi. Ma ciò che si interiorizza in termini di apprendimento nella fase della scuola primaria è decisamente più permanente di molto di quello che segue. È sui primi apprendimenti che poggeranno le conoscenze successive dal momento che l’apprendimento avviene per connessioni. Perché i bambini della scuola primaria si appassionano tanto alla storia, mentre nella scuola secondaria di primo grado c’è una grave disaffezione per la disciplina che non aiuterà a conoscere i periodi storici che sono stati espunti dal curricolo della primaria? Chi si preoccupa di evitare lo studio “ripetuto” della storia non ha frequentato scuole primarie negli ultimi decenni, o ha conosciuto quelle sbagliate (in molte classi della scuola primaria vi sono insegnanti che hanno continuato ad applicare un metodo nozionistico, basato esclusivamente sui libri di testo, eliminando la storia successiva all’Impero romano). Sono molte le insegnanti che hanno avviato programmazioni alternative, talvolta fin troppo articolate, tanto che l’unico percorso possibile per recuperare una ininterrotta linea del tempo pare costituito dal collegamento con quella parte di Indicazioni che promuovono la conoscenza storica legata al territorio. Ma questa tendenza potrebbe svilire in un localismo miope, scollegato dagli avvenimenti mondiali. Resta il dubbio che l’apprendimento “a macchie”, in grado di mettere in discussione la pratica di un percorso di educazione alla storia esclusivamente lineare, sia adatto alla scuola primaria dove è necessario costruire le prime mappature temporali degli avvenimenti, secondo un ordine, quello della linea del tempo. * Insegnante di scuola primaria. école numero 78 pagina 23 esperienze narrate Vincente o perdente? Il percorso “Chi vince e chi perde”, proposto in una classe prima di scuola media, si è posto come obiettivo quello di entrare nei meccanismi mentali del “vincere” e del “perdere”. In ogni momento tutti noi, adulti e ragazzi, siamo sollecitati da una modalità di vita che porta alla vittoria. Ma cosa vuol dire “vincere” e “perdere” nella nostra vita quotidiana? E come viene affrontato questo tema nei libri per ragazzi? Il percorso vuole condurre i ragazzi a una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie possibilità e dei propri limiti, potenzialità e limitazioni che possono creare, nel rapporto con gli altri, situazioni vincenti o perdenti. La discussione, il confronto, la lettura di alcuni testi di narrativa si sono rivelati molto utili per affrontare questa tematica apparentemente semplice e scontata, ma che permette di scendere nel profondo, e di riflettere sui veri valori della vita ANNA DI PAOLA C on gli allievi della mia classe, una prima media nella “Norberto Bobbio” (ex Baretti) di Torino, ho affrontato il tema Vincere e perdere. Chi vince e chi perde, sviluppandolo non solo nella letteratura per ragazzi, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Nell’immaginario collettivo il perdente è timido, insicuro, debole, goffo, poco intelligente... per questo è disprezzato da tutti. Il vincente, invece, è di bella presenza, coraggioso, forte, sicuro, saggio, generoso e intelligente... per questo è stimato dagli altri. Attraverso le letture svolte in classe, i ragazzi hanno constatato che nelle fiabe è molto semplice individuare vincitori e perdenti. Il perdente è di solito il nemico, l’antagonista, il malvagio; il vincitore è spesso l’eroe, buono, generoso, altruista, e coraggioso che trionfa sempre sul male. «E tutti vissero felici e contenti»: così terminano sempre le fiabe. In esse l’eroe ha le stesse caratteristiche del cavaliere medioevale che incarnava i valori e le virtù della lealtà, della generosità, della fedeltà, del coraggio, della difesa dei più deboli... Nella vita di tutti i giorni, invece, questa divisione non è mai così netta: viviamo situazioni in cui siamo vincenti, e altre in cui ci sentiamo perdenti. Basta “scomporre” in école numero 78 pagina 24 tanti momenti la nostra giornata per renderci conto di quante piccole vittorie e di quante piccole sconfitte siamo protagonisti. Così gli uomini non si possono distinguere nettamente in due categorie, vincenti e perdenti: chi vince non vince sempre, e chi perde non è in assoluto sempre perdente. Guidandoli nella discussione e invitandoli al confronto, ragazze e ragazzi si sono resi conto che “vincere” significa raggiungere un obiettivo, crescere nel modo migliore, aprirsi all’accoglienza degli altri e al dialogo, vuol dire affrontare paure e ansie, imparare dai propri errori, accettare con serenità le proprie sconfitte per impegnarsi a migliorare: una sconfitta, se considerata come occasione di riflessione e di crescita, può trasformarsi in vittoria. Non è stato semplice far capire che lasciarsi trascinare da esempi negativi, reagire a una provocazione, demordere alla prima difficoltà, chiudersi nel pregiudizio e nell’egoismo, sono tutte azioni che creano le condizioni per una sconfitta. Nonostante le evidenti difficoltà, credo che, in una società come la nostra che vive una situazione di “emergenza educativa”, sia compito prioritario e irrinunciabile di noi educatori-insegnanti condurre i giovani a riflettere su questi temi, e a discutere insieme sulle loro azioni, sui loro atteggiamenti se ci accorgiamo che questi li renderanno presto persone perdenti. Paura dell’altro Molto apprezzate sono state le letture dei testi di Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare e di Armir Greder, L’isola. Due testi del tutto diversi, agli antipodi, che i ragazzi hanno voluto mettere a confronto: nel primo tutti i personaggi risultano vincenti, nel secondo tutti sono perdenti. Ne L’isola di Armir Greder, lo straniero protagonista che approda su un’isola, in cerca di cibo e riparo, è un perdente per il suo status etnico: semplicemente perché straniero, è escluso, è reietto, viene emarginato, ed è perdente fino alla fine, fino alla morte. Ma anche gli abitanti che sembrano vincitori perché “hanno risolto il loro problema”, e cioè si sono liberati del diverso, in realtà sono perdenti anch’essi, perché si sono “chiusi” nella loro isola, nei loro pregiudizi, hanno eretto alte mura che li escludono dal resto del mondo e dagli altri. Sono perdenti perché si sono preclusi la possibilità di conoscere altri, diversi da loro; hanno negato a se stessi la preziosa opportunità di allargare le proprie conoscenze e i propri orizzonti. Hanno visto nell’altro un nemico: senza neppure conoscerlo, lo hanno emarginato perché non era come loro: «Lo condussero alla parte disabitata dell’isola, in una stalla che normalmente era destinata alle capre, e che da lungo tempo nessuno usava più. [...] Poi sprangarono la porta della stalla e tornarono alla loro vita, quella di tutti i giorni, continuando a comportarsi come se nulla fosse successo». Senza neppure conoscerlo lo hanno giudicato come colui che ruba il lavoro e il cibo: «Era già abbastanza difficile così: non era possibile occuparsi anche degli altri. Sta a vedere che chiunque arriva… Quell’uomo non era di lì. Era uno straniero. Doveva andarsene [...]». L’ignoto genera paura. E alla paura gli isolani hanno fatto fronte con la violenza, macchiandosi di un crimine orrendo: hanno tolto la vita a un altro essere umano. Non solo: essi continueranno a vivere nella paura di trovarsi di fronte qualcuno che è diverso da loro e di cui sbarazzarsi, e solo nell’isolamento crederanno di stare al sicuro: «Costruirono un muro altissimo tutt’intorno all’isola: aveva delle torri da cui si poteva sorvegliare il mare giorno e notte. Poi uccisero i gabbiani e i cormorani che passavano in volo: perché nessuno potesse sapere, là fuori, dell’esistenza dell’isola». Dal “branco” una sola voce cerca di farsi strada e tenta di farsi sentire. È quella del pescatore dell’isola che, immedesimandosi nello straniero, propone a tutti di aiutarlo; egli potrebbe essere vincente, ma è dominato dagli altri: è un “vincente dominato”, pertanto debole e sconfitto. Anche la sua barca verrà bruciata: lui, che meriterebbe di vincere, purtroppo, in questa situazione, perde. È quanto succede a volte nella vita. L’analisi della figura del pescatore ha permesso ai ragazzi di allargare il discorso e di riflettere anche sull’importanza, in questa fase delicata della loro vita, in cui ciascuno comincia a costruire la propria personalità, di credere fino in fondo nelle proprie idee e di lottare per esse, se riteniamo che esse esprimano valori irrinunciabili: la riflessione collettiva ha reso i ragazzi più consapevoli dell’importanza di affermare la propria individualità, rifiutando l’omologazione che schiaccia e offende l’identità, i pensieri e gli ideali del singolo. Rispetto della diversità Abbiamo poi affrontato il tema della diversità in una dimensione fiabesca, quale quella presentata nel romanzo di Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare... Gli abitanti del porto, i gatti del porto di Amburgo, sanno che la gabbianella è diversa da loro: è lei la “straniera” che è approdata “sull’isola-balcone” di Gatto Zorba. Gatto Zorba e i suoi amici non conoscono le abitudini e le caratteristiche di questo nuovo arrivato, ma di fronte all’ignoto, collaborano tra loro, per conoscere meglio un essere diverso da loro, a cui danno anche un nome, Fortunata. Rispettando la sua diversità, incoraggiano la gabbianella e la aiutano a trovare la strada della sua vita, andando ben oltre le evidenti differenze fisiche, al punto che Fortunata si sente una di loro, e perfettamente integrata nel gruppo. “Integrazione” è l’esatto contrario di “emarginazione”. E nell’integrazione l’esteriorità e l’apparenza non hanno alcun significato; ciò che conta è scendere nel profondo di ciascun essere, per coglierne e apprezzarne l’intima e preziosa originalità: «Sei una gabbiana. [...] Ti vo- gliamo tutti bene, Fortunata. E ti vogliamo bene perché sei una gabbiana, una bella gabbiana. Non ti abbiamo contraddetto quando ti abbiamo sentito stridere che eri un gatto, perché ci lusinga che tu voglia essere come noi, ma sei diversa e ci piace che tu sia diversa... Ti vogliamo gabbiana. Sentiamo che anche tu ci vuoi bene, che siamo i tuoi amici, la tua famiglia, ed è bene tu sappia che con te abbiamo imparato qualcosa che ci riempie di orgoglio: abbiamo imparato ad apprezzare, a rispettare e ad amare un essere diverso. È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci hai aiutato a farlo. Sei una gabbiana e devi seguire il tuo destino di gabbiana. Devi volare. Quando ci riuscirai, Fortunata, ti assicuro che sari felice, e allora i tuoi sentimenti verso di noi e i nostri verso di te saranno più intensi e più belli, perché sarà l’affetto tra esseri completamente diversi». Il confronto dei due testi ha condotto i ragazzi a cogliere il significato profondo del tema “vincere e perdere” nella vita di tutti i giorni. Quando nelle nostre azioni quotidiane, ci apriamo al dialogo, alla collaborazione e al rispetto creiamo sicuramente situazioni vincenti; quando lottiamo per un obiettivo, superando con coraggio difficoltà o paure, o quando accettiamo con serenità le nostre sconfitte e impariamo dai nostri stessi errori, siamo vincenti. La chiusura, l’egoismo, il pregiudizio, la violenza sono veicoli di sconfitta: se cediamo a questi disvalori diventiamo perdenti, poiché perdiamo l’occasione di costruire il nostro futuro, e di fare, nel nostro piccolo, qualcosa di buono per migliorare la nostra società. Il libro di classe Il lavoro è continuato con l’ elaborazione di un breve articolo giornalistico che evidenziasse le riflessioni più importanti emerse, per poi sfociare nella realizzazione “artigianale” di un libro, per il quale i ragazzi hanno lavorato con carta, cartoncini, forbici, colla e, naturalmente, creatività. È proprio nel Laboratorio di Creatività che i nuclei fondamentali riassunti nell’articolo si sono trasformati in un vero e proprio libro dal titolo Le immagini e le parole della vittoria e della sconfitta. Esso è stato diviso in quattro sezioni, ben evidenziate dalla scelta dei colori dei cartoncini che costituiscono le pagine del libro stesso: vincenti e perdenti nelle fiabe, nel romanzo di Sepulveda, nel testo di Greder, e anche in alcune pagine bellissime di Ben Jelloun, Il razzismo spiegato a mia figlia, testo che sempre riesce a commuovermi e che ritengo debba essere un vademecum prezioso per ogni educatore: «Con la cultura si impara a vivere insieme; si impara soprattutto che non siamo soli al mondo, che esistono altri popoli e altre tradizioni, altri modi di vivere che sono altrettanto validi dei nostri. [...] Quando tornerai a scuola guarda bene tutti i tuoi compagni e noterai che sono tutti diversi tra loro, e questa differenza è una bella cosa. È una buona occasione per l’umanità. Questi scolari vengono da orizzonti diversi, sono capaci di darti cose che non hai, come tu puoi dargli info L’Italia vista da Suthida «Invece di lamentarvi, siate orgogliosi di sapere che abbiamo scelto il vostro Paese perché è migliore, siate generosi ad accoglierci con un po’ di allegria, siate misericordiosi ad aiutarci a vivere con normalità nel vostro Paese, siate pazienti e insegnateci la vostra lingua, la vostra cultura e le vostre tradizioni, siate curiosi di conoscerci meglio, ma soprattutto siate coraggiosi di ammettere che gli stranieri vi sono di aiuto, vi servono e vi arricchiscono giorno dopo giorno». Queste parole sono tratte da uno scritto di Suthida, una ragazzina di origine tailandese che ha frequentato la terza media in una scuola comasca. Il suo tema d’esame, incentrato sul significato dell’emigrazione, ha colpito ed emozionato la dirigente scolastica che ha pensato di inviarlo ad alcuni giornali. Nei primi giorni di luglio, il quotidiano la Repubblica lo ha riportato in prima pagina col titolo: “Tema: l’Italia vista da una bimba immigrata”. Un bel segnale. Ragazze che, nonostante i problemi che vivono quotidianamente, sono in grado di esprimere con chiarezza, lucidità e poesia forti emozioni e idee profonde; di una scuola che, in mezzo a tutte le difficoltà, sa riconoscere, valorizzare e far crescere autonomia di giudizio e capacità espressive; di una stampa, non sempre distratta, che sa accorgersi di cosa è importante e sa ascoltare e dare spazio alle voci vere anche in mezzo a tanto frastuono quotidiano; di persone che, in un mondo sempre più disumanizzato, sanno ancora battersi per valori profondi quali la solidarietà e l’accoglienza. [MARIATERESA LIETTI] qualcosa che loro non conoscono. Il miscuglio è un arricchimento reciproco». I ragazzi hanno disegnato, ritagliato, scelto e trascritto passi significativi dei testi letti, curandone anche la veste grafica. Il lavoro di ognuno è stato fondamentale per la realizzazione di un obiettivo comune (creare il loro primo libro di classe), e l’impegno di ciascuno e la collaborazione sono stati tali da creare una situazione in cui tutti si sono sentiti vincenti. Anche la dedica scritta in epigrafe è estremamente significativa, ed esprime il significato ultimo del tema “vincere e perdere”: chi perde spezza e distrugge; chi vince costruisce. E i ragazzi hanno voluto dedicare questa loro fatica «A tutti coloro che vogliono costruire» rappresentando questo messaggio attraverso il semplice ma significativo disegno di tanti mattoncini sparsi qua e là su un tappeto erboso, pronti per essere cementati uno sull’altro per costruire il “muretto della vita” di ogni ragazzo, un muretto solido e sicuro, perché ha come fondamenta quei veri valori che fanno di ogni individuo una persona vincente. école numero 78 pagina 25 nuovi arrivi Non si deve sapere LIDIA GARGIULO «V erresti a leggere qualcosa nella mia scuola, una mattina?». Mi aveva chiesto Cristina dopo una serata a casa di amici e io avevo detto sì. è sì ogni volta che posso entrare in una scuola, le facce di bambini o adolescenti o ragazzi in crescita sono un mistero che non smette mai di meravigliarmi e commuovermi. Una mattinata piena di chiasso e di attenzione, con quella capacità di fare insieme cose che la vita adulta insegna a separare, con la mente espansa e imprendibile, faticosa se pensiamo “disciplina” ma vitale e divertente se ci prende curiosità e partecipazione. Maestra, maestra, chiamano, e la maestra “vera” li informa che non sono maestra, che sono… «Sono maestra di ragazzi grandi, anche voi sarete grandi». «Allora veniamo da te». «Va bene, vi aspetto». «E adesso te ne vai? Non ci vediamo più?». Ci siamo visti, invece, siamo rimasti insieme in un progetto di lettura e sceneggiatura di un testo letterario. Avevo trovato nei miei scaffali le Novelline di Guido Gozzano, una si intitolava “Nonsò”. Il nostro programma prevedeva visite alla Biblioteca Comunale del loro quartiere sulla Casilina, la lettura del racconto e la teatralizzazione. Il progetto, chiaro e lineare, a contatto con le teste e gli organismi di 7-8 anni si rivelò un’avventura. Il libretto passò di mano in mano con interruzioni che facevano perdere il filo − «Posso andare al bagno?». «Ho sete». «Posso prendere il panino? − e scambi di pizzichi e pugni, e l’ansia delle maestre che imponevano calma trasmettendo nervosismo. Un esercizio continuo di mediazione fra i loro tempi liquidi e i nostri tempi strutturati. Il più recalcitrante all’ordine era Pino, un bel bambino dagli grandi occhi neri che a tratti capiva più degli altri e a tratti voleva uscire, si alzava, giocava da solo con qualcosa, disturbava o voleva cambiare discorso. «Mi annoio», disse una volta, come cercando aria. «Ma tu vuoi recitare o no?». «Sì». «E come reciti se non sai la trama?». «Non la voglio sapere». «Allora non vuoi recitare». «Va bene, voglio recitare, sto fermo». Chissà se è meglio sapere o non sapere le nascoste piaghe di coloro che incontriamo, se è meglio non toccare i loro tic, squilibri e stranezze quando non siamo in grado di guardare quello che c’è dietro. Cristina mi disse che era una bambino “disturbato”. «Disturbato?». E allora seppi che Pino era “disturbato” a causa di un trauma, si era saputo che il padre «pensa un po’ il padre, lo portava con sé e lo abusava, lo passava agli amici, questo per anni, pensa». «Chi se n’è accorto? Come l’hai saputo?». «C’è stata una denuncia, è stata la mamma di Samuele, quello lì, il bambino rumeno, il padre lavorava col padre di Pino e un giorno il padre di Pino portò “a giocare” anche Samuele, Samuele però non si fidò, dovette sentire qualcosa di strano, bambini come lui maturano presto; quando vide troppi grandi e solo loro due bambini, ebbe paura e scappò via, lo disse alla sua mamma. È stata coraggiosa la mamma di Samuele, adesso il padre di Pino è indagato. Ci siamo preoccupati del bambino, abbiamo chiamato la mamma, ma invece di ringraziarci che le aprivamo gli occhi ha fatto una scenata, ha detto che son cose che non ci riguardano, che i rumeni sono bugiardi e delinquenti, che non è vero niente e guai se ci immischiamo ancora, loro sono persone perbene. Chissà a casa che cos’è successo veramente, se lei ha taciuto perché non ha creduto, o perché ha paura del marito, o il marito l’ha proprio minacciata. Capisci, non possiamo fare niente pur sapendo questa cosa orribile. Abbiamo fatto venire una psicologa per un colloquio col bambino ma non è stato facile, Pino si è chiuso e non ha parla- école numero 78 pagina 26 to, non ha voluto dire niente e la mamma è tornata per dirci che ci denunciava se non ci facevamo i fatti nostri. Con la psicologa lui non ha parlato». «Che poteva dire, lui non può né chiamare né giudicare quello che gli è successo, per lui può essere come mangiare qualcosa che non piace, o andare a scuola invece di giocare, può vedere che non è bello ma può anche pensare che si fa così, che fa parte della vita… Che ne sa, un bambino, se una cosa è normale o anormale … Il delitto di uomini come il padre non è solo l’abuso ma la confusione che lasciano in chi subisce». E dunque si comincia: «La favola la conosciamo tutti, scegliamoci la parte, ognuno un personaggio, scriviamo cosa dice il principe, cosa dice il mercante di cavalli, cosa dice il maggiordomo, la principessa…». Pino vuole fare Nonsò, colloquia con tutti i personaggi e dice le parole giuste, è spiritoso e pronto, e dunque Pino è Nonsò. Gli altri costruiscono tutti la loro parte e insieme, nel disordine che a poco a poco si sistema e prende corpo, si fa sempre più chiara la rappresentazione. Per la Principessa, ovvio, ci sono state più candidature ma alla fine siamo tutti d’accordo che Luisa sa la parte meglio di tutte e in più con quel suo visetto di principessina in incognito è perfetta nel ruolo. Quando siamo a metà e la cosa comincia a prender corpo, un giorno Pino non c’è. «Non importa − dico −, ripassiamo lo stesso, adesso lo faccio io Nonsò». «No, non viene più, non vuole recitare». «Lo posso fare io». Lo posso fare io». Lo posso fare io». Chiaro che tutti vorrebbero, ma dov’è Pino? Il giorno dopo è a scuola, al telefono Cristina mi dice che la mamma non vuole, così gli ha detto il bambino; ma quando qualche giorno dopo vado per le prove, lui mi viene vicino: «Lo voglio fare». «Ti piace?». «Sì». «Te le ricordi le parole?». «Sì». «Mi dispiace per gli aspiranti principi ma qui c’è Pino, il primo Principe». Tutto a posto, riprendiamo. Il giorno della recita: le maestre hanno ottenuto la sala del cinema parrocchiale, palco e spazio a volontà, e un bel cortile per il rinfresco all’aperto offerto dalle mamme. Dal palco le maestre salutano e parlano del loro lavoro, dell’impegno dei bambini, del mio contributo. Tra il pubblico in prima fila la Principessina: non sarà la Principessa, dieci giorni fa ha avuto un attacco di appendicite, è stata operata e non è potuta venire a scuola, è stata sostituita. La faccio venire sul palco: «Questa bambina è Luisa, doveva essere la Principessa, alle prove era molto brava, ma si è ammalata e abbiamo dovuto sostituirla. Noi le facciamo un applauso perché ci fa piacere che sia guarita e festeggi la fine della scuola assieme a noi». La recita va avanti come tutte le recite dei bambini, nell’ansia controllata dei grandi e nella miracolosa trance dei piccoli che ricordano senza sforzo, che sono diventati quello che hanno imparato a sembrare. Pino controlla lucidamente tutta la scena e una volta corregge ad alta voce una battuta al compagno che si era confuso, dal pubblico risate e applauso. Tutto bene, tra omaggi di fiori a noi e complimenti ai bambini, poi tutti fuori a bere, mangiare, chiacchierare. «Dov’è Nonsò?». «Dov’é…». «È andato via». «Quando? Perché? È stato così bravo…». «La mamma lo ha portato via. Di corsa». Ecco Samuele: «Maestra, è stato bello. miracoloso, come allo stadio». «È venuta la tua mamma? Dov’è, dov’è la mamma?». Eccola, la piccola donna stinta dalle mani indurite di fatica, ma con le idee chiare di donna coraggiosa: «Bello tutto, mio bambino contento. Lui nato qui, italiano, noi venuti prima di essere Europa. Adesso tutti europei». Penso all’altra, quella che per vergogna delle chiacchiere ha sottratto il suo bambino ai complimenti; non ha capito che la piccola gloria di Nonsò sarebbe stata balsamo per le ferite del bimbo e per l’orgoglio di una mamma. note in condotta Risorgimento ANDREA BAGNI C he palle il Risorgimento − mi sembra già di sentirli i miei studenti. Quelli peraltro che mi sono più simpatici. Cavour, Garibaldi, Mazzini, Carlo Alberto: tutta retorica nazionale e patriottica. Obbedisco, il Re a cavallo Garibaldi pure, gli sguardi fieri, le parole solenni. Tutti in ginocchio davanti agli eroi nazionali, il grido di dolore eccetera. Impossibile combinare qualcosa di buono con questa roba. Però il concetto di nazione è diventato complicato da maneggiare oggi, e questo forse lo rende interessante. Chiaro che molti studenti non si pongono nemmeno il problema, lo considerano semplicemente un sinonimo di stato: nazione italiana – stato italiano, più o meno ci siamo. I dizionari dei sinonimi e dei contrari aiutano a fare casino. Ma ci sono stati slittamenti significativi nella storia recente e anche il concetto di nazione è abbastanza mutato. Anche nella sensibilità diffusa dei ragazzi e delle ragazze. Era decisamente positivo quando ho fatto la scuola io per esempio, nettamente separato dalle ideologie aggressive: indipendenza nazionale, appartenenza al popolo, risorgimento, libertà. Era anche diritto sacrosanto alla autodeterminazione. Anti-imperialismo. Poi, anche per i giovani di oggi, l’Europa dall’89 in poi, il disfacimento della ex Jugoslavia e dell’URSS, hanno mostrato che le cose sono più complicate. Si è cominciato a parlare di pulizia etnica. Guerra civile e stupri. Fare partorire alla straniera un figlio del proprio sangue. La vittoria. Insomma si è conosciuta la versione orrendamente maschile di certe lotte per l’indipendenza nazionale. Indipendenza dalla sfera dell’umano. Chiusura nella propria comunità di sangue – il sangue degli altri. Anche l’autodeterminazione dei popoli non è uscita benissimo dalla fine del Novecento: è diventata frammentazione, chiusura, esclusione, incapacità di convivere fra diversi e diverse. Nazionalismo senza cittadinanza politica. Peraltro il federalismo, che era stata una grande invenzione per stare insieme riconoscendo le differenze, è diventato oggi una maniera per separarsi, tenendosi stretti i propri soldi da individualisti proprietari, padroni in casa nostra. Il nido di Pascoli, con il filo spinato intorno e guardie giurate alla siepe. Adesso però la Lega prende spavaldamente in giro il tricolore in nome della “Padania” e del Dio Po, e diventa per certi versi tutto ancora più complicato. Ai mondiali quasi toccava fare il tifo per la nazionale di Lippi – quello che Io non devo spiegare nulla a nessuno, non devo rendere conto a chicchessia. Un altro padrone a casa sua. Quello andato a Sanremo a sponsorizzare Pupo e il Principe, “Italia amore mio”. Eppure il concetto di nazione, in questo disastro di comunitarismi egoistici e stati forti confusionali, mi pare che possa diventare utile. A patto di riuscire a utilizzarlo in un senso tutto politico, né sabaudo né leghista – come ha scritto Paolo Cacciari. Un po’ in quest’ottica per la fine di ottobre è stata lanciata l’idea di una Teano due. Centocinquant’anni di storia italiana non da celebrare retoricamente ma da ripensare dalle radici. Proprio dalle radici. Come storia di un paese mancato. Di una nazione mai veramente nata. Potrebbe essere l’occasione per portare sulla scena un’altra Italia, che non coincide e non si riconosce nello stato e nella patria con le iniziali maiuscole. Una nazione fatta di tessuto politico, di relazioni civili, di solidarietà e apertura al mondo. Aperture non turistiche né di sfruttamento in sotto-lavori di sotto-uomini: meri passaggi di merci, il volto vero della retorica delle radici religiose. Quell’altra Italia vive nel mondo dell’associazionismo, del volontariato, dell’economia alternativa, del consumo equo e solidale. L’Italia dei beni comuni, né privati né burocratici. L’Italia della scuola anche. Nei quattro giorni dell’incontro a Teano questa rete solidale dovrebbe circondare e accompagnare sindaci e istituzioni locali. Essere l’Italia delle relazioni ravvicinate, umane. Della cittadinanza. Una nazione fatta di cittadini e cittadine, di un’identità definita politicamente e di democrazia praticata. Semplicemente tutti coloro che sono soggetti alle leggi e alle norme sono anche soggetti politici, hanno diritto di partecipare alle decisioni. Perché li riguardano e ci riguardano; perché ci sono sul territorio, vivono, lavorano, esistono, costruiscono relazioni. Fanno parte del tessuto sociale. Non sono figli di un dio minore, non perché si debba essere buoni con i poveri ma perché non c’è nessun dio, nessun suolo sacro, di cui essere figli o figliastri. È l’appartenere allo spazio pubblico, orizzontale interpersonale democratico, che conta. Il dialogo con la collettività di cui si è parte semplicemente per il fatto di esserci. Allora la nazione può essere un tessuto fluido di relazioni in un certo senso “artificiali” − nel senso bello del termine: artificiali perché effettivamente e integralmente politiche. Opera umana collettiva. Inclusiva e accogliente perché aperta. Per definizione. Di questo forse si può fare scuola. info Spese militari e tagli sociali La scuola pubblica è un bene comune, così come lo sono la cultura, la ricerca, la sanità, l’acqua, l’ambiente e la pace. Il governo usa la crisi economica come alibi per tagliare le spese sociali, smantellare i servizi pubblici e i diritti primari garantiti dalla Costituzione, mentre continua ad investire in spese militari e armamenti. Le cifre possono apparire aride, ma parlano da sole. La spesa militare italiana è aumentata del 21% dal 2006 al 2008 con un ulteriore incremento attorno al 7% nel 2009. L’Italia si colloca al 10° posto mondiale come spesa militare e al 6° posto come spesa militare pro-capite (dati SIPRI sul 2009) con un ammontare di circa 30 miliardi di euro all’anno. Più di una pesante finanziaria, pagata ogni anno con denaro pubblico. L’industria militare va a gonfie vele e non conosce crisi. Nel 2009 le esportazioni di armi italiane sono aumentate del 61%, un vero record, con lauti guadagni anche per le banche che fanno transazioni in armi (“banche armate”). L’Italia continua ad acquistare nuovi sistemi d’arma. È confermato l’acquisto di 131 caccia bombardieri F35 con una spesa di 15 miliardi entro il 2016. Contro la legge Balilla Bella educazione! Si tagliano i fondi alla scuola e all’università e s’investe sulla formazione militare dei giovani. Approfittando della manovra finanziaria, il governo ha deciso di stanziare ben 20 milioni di euro per organizzare corsi di formazione delle Forze Armate per i giovani. Il progetto era già contenuto in un disegno di legge in discussione al Senato ma con un emendamento alla finanziaria si fa prima. L’idea del governo è semplice: invitiamo i giovani per tre settimane in caserma, gli facciamo indossare per la prima volta la divisa e gli spieghiamo quanto sia bello far parte delle Forze Armate e andare in missione in giro per il mondo. In questo modo riusciremo a selezionare nuovi volontari per l’arruolamento, ad “assicurare nuova linfa e continuità d’azione” alle associazioni combattentistiche e d’arma e, alla peggio, a promuovere un po’ di sana cultura militare. Se ci sono 20 milioni per la formazione dei giovani, pretendiamo che siano spesi per educare veramente alla cittadinanza e alla Costituzione ovvero alla pace e ai diritti umani, alla legalità e alla giustizia. Per aderire all’appello inviare mail all’indirizzo: [email protected]. Tavola della Pace (via della Viola, 1, 06122 Perugia, tel. 075 5736890, fax 075.5739337, [email protected]. www.perlapace.it. Senza Chance Dopo dodici anni, il progetto Chance, quello ideato e realizzato dai maestri di strada napoletani per dare un’altra possibilità ai più umili che la scuola spesso umilia, che è riuscito a impegnare maestre e maestri, mamme e ragazzi altrimenti votati all’emarginazione, chiude, soffocato da tagli di risorse e ostacoli di natura politica. Videointervista a Cesare Moreno all’url http://www.youtube.com/ watch?v=Fyz3nBRwLDw. école numero 78 pagina 27 le leggi La nota di Limina: verso il regime o una idiozia? Con una nota del 27 aprile scorso, indirizzata ai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, il Direttore Generale dell’USR dell’Emilia Romagna, richiamando il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto 28 novembre 2000), dopo il rituale ossequio alla libertà di manifestazione del pensiero, ricorda che detto codice stabilisce che i dipendenti pubblici devono astenersi «da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’amministrazione» e devono tenere «informato il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa» CORRADO MAUCERI za, non essendo una legge (è un decreto ministeriale), è inapplicabile. È pacifico pertanto che i dipendenti pubblici, ed in primo luogo i docenti, debbano conformare la loro condotta al dovere costituzionale di «servire esclusivamente la Nazione», il che non vuol certo dire servire il ministro o il presidente del Consiglio, ma svolgere al meglio la propria funzione, quindi anche esprimere giudizi critici e formulare proposte in merito alla politica scolastica. Allo stesso modo «evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione» non può precludere il diritto alla critica del ministro o del Governo che, per incapacità e calcolo politico, con la loro politica devastante mettono in pericolo il ruolo istituzionale della scuola. Il personale docente proprio per la “tipicità della funzione educativa” non solo ha il diritto sancito dall’articolo 21 della Costituzione di criticare in ogni modo la politica del Governo, ma ha anche il dovere sia perché con il proprio comportamento deve “educare” gli alunni al rispetto dei propri diritti (e doveri) senza condizionamenti, sia perché ha il diritto-dovere di dare il proprio contributo, anche con critiche e proteste, a una scuola di qualità per tutti e tutte. Il lavoratore, pubblico o privato che sia, mantiene anche nel luogo di lavoro il suo pieno diritto di cittadinanza; la “sovranità appartiene al popolo” che non può essere imbavagliato per compiacere i ministri. Attenzione ai Limina che cominciano ad essere numerosi e pericolosi, grazie anche alle ambiguità dei Governi centro-sinistra. Testimoni del Novecento Un gruppo di studenti medi e universitari di Trento da anni si incontra per costruire una memoria del Novecento. L’esperienza, iniziata nel 2006 con un’intervista a collettiva a Kapuscinski (diventata un libro nel 2007), è proseguita con Sedie vuote, un dialogo sugli anni di piombo con i parenti delle vittime CELESTE GROSSI L imina aggiunge anche che «è improprio indirizzare alle alte autorità politiche o amministrative diverse dal loro diretto riferimento gerarchico documenti, appelli o richieste». Senza dubbio la nota è una idiozia perché un funzionario che voglia reprimere il diritto alla critica e mettere il “bavaglio” agli insegnanti non lo manifesta con un “editto” che viola in modo plateale la Costituzione e soprattutto il buon senso. È però un segnale del clima politico di una maggioranza debole ma arrogante che tende a tacitare ogni voce fuori dal coro. Leggi approvate a colpi di voti di fiducia, il “bavaglio” alla stampa, attacchi all’indipendenza della magistratura, al diritto di sciopero ed al potere contrattuale sono tutti interventi che conducono ad uno stesso progetto: aziendalizzare la società sul modello di Pomigliano, cioè andare verso un regime. L’articolo 21 della Costituzione (che fino a prova contraria è la legge fondamentale del nostro Paese) afferma la libertà di tutti/e di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo senza alcuna limitazione di categorie di cittadini e senza alcuna forma di controllo preventivo (che durante il fascismo si chiamava censura). Limina nella sua nota si fa scudo del codice di comportamento (Governo Amato e Ministro Bassanini), ma è fin troppo evidente nessun codice può limitare i diritti sanciti nella Costituzione; se un codice contrasta in modo insanabile con i principi costituzionali è illegittimo per violazione e di conseguen- école numero 78 pagina 28 Nell’ottobre del 2006 Ryszard Kapuscinski fu invitato a Bolzano dal Centro per la Pace. In quella occasione un gruppo di studenti di Trento, liceali ed universitari che avevano letto e discusso i suoi libri guidati dal loro insegnante, Alberto Conci, lo incontrarono per porgli una serie di domande sui grandi eventi del Novecento che il reporter aveva raccontato − dalla decolonizzazione africana allo sgretolamento dell’impero sovietico, dalle dittature latinoamericane alle guerre, dal risveglio dei fondamentalismi alla globalizzazione, dall’incontro-scontro tra le culture alle disuguaglianze, dalla rivoluzione alla vita quotidiana di quella parte degli abitanti del pianeta ignorati dai media, dal dominio di internet alla poesia... − e per sentire da lui quali fossero le caratteristiche di un buon giornalista. «Il cinico − secondo il reporter polacco, apprezzato in tutto il mondo − non può essere un giornalista. Solo le persone buone, solo coloro che si compromettono con la vita degli altri, possono raccontare quello che gli altri vivono, le loro sofferenze, le loro gioie, i loro sogni. Il sentimento che dovrebbe muovere un buon giornalista si chiama empatia». Nel gennaio successivo Kapuscinski morì e l’intervista pubblica raccolta all’Università di Bolzano da Paolo Rumiz e il dialogo che ebbe con gli studenti furono considerati da sua moglie Alicja una sorta di testamento morale perché lo scrittore le aveva detto che quell’incontro con i giovani era stato «uno dei più belli della sua vita». Dalle iniziative di quei giorni sono nati un libro Ho dato voce ai poveri. Dialogo con i giovani, curato dal giornalista Francesco Comina, da Alberto Conci e da Paolo Grigolli, e il dvd Ryszard Kapuscinski, l’ultimo viaggio, editi dalla casa editrice Il Margine (libro + dvd euro 19,50). L’entusiasmo per l’esperienza vissuta insieme ha fatto decidere agli studenti e ad Alberto Conci di continuare ad incontrarsi per discutere di storia contemporanea e, dopo la lettura del libro di Mario Calabresi, Spingendo la notte più in là, di costituire un gruppo di lavoro di una trentina di persone per approfondire «le vicende dolorose e complesse degli anni Settanta». Il percorso, che ha impegnato i ragazzi tutte le domeniche per un anno intero, ha portato alla pubblicazione di Sedie vuote. Gli anni di piombo: dalla parte delle vittime. Il libro, curato da Alberto Conci, Paolo Grigolli, Natalina Mosna (Editrice Il Margine pp. 344 + 16 a colori, euro 17), contiene le testimonianze di dieci parenti di vittime − Mario Calabresi, Benedetta Tobagi, Silvia Giralucci, Manlio Milani, Giovanni Ricci, Alfredo Bazoli, Agnese Moro, Giovanni Bachelet, Vittorio Bosio, Sabina Rossa − «che a causa della violenza hanno dovuto convivere con la presenza di una sedia vuota nella loro casa» e si chiude con un contributo di Gian Carlo Caselli. Nei dialoghi si trovano frammenti della memoria di chi ha avuto un parente ucciso dalla violenza politica o dalle stragi (Brescia e Bologna), ma anche riflessioni su questioni cruciali della storia recente della nostra democrazia, fondamentali per la memoria collettiva. Il testo offre inoltre interessanti spunti sul metodo di lavoro, attraverso il quale i giovani sono stati protagonisti di un percorso di studio, della gestione dei dialoghi, e infine della costruzione del libro. M l’erba del vicino appamondo L’attacco concentrico che i governi europei stanno sferrando alle pubbliche amministrazioni (scuola compresa) come vettore principale per una possibile uscita dalla crisi è favorito dall’isolamento delle categorie pubbliche rispetto all’opinione pubblica. I cittadini europei sono stati convinti da anni di propaganda liberista, che il pubblico impiego si sia dato alla bella vita e che i servizi pubblici siano inefficienti Spigolature europee PINO PATRONCINI M anifestazione continentale 29 settembre. Non è solo il titolo di una vecchia e famosa canzone dell’Equipe 84. Adesso è una data che potrebbe anche divenire storica. È la data in cui la CES - Confederazione Europea dei Sindacati ha deciso di indire una manifestazione continentale contro la crisi. Ma sarebbe meglio dire contro le misure che per la crisi i governi europei stanno mettendo in atto Pur non nascondendosi le difficoltà esistenti in Italia (Cisl e Uil pur facendo parte della CES non paiono molto convinte) sarebbe un errore che i sindacati italiani prendessero questa data come una pura scadenza burocratica, come spesso capita alle scadenze della CES: le ultime manifestazioni europee, quel- la di Bruxelles contro la Bolkestein e quella di Lubiana lo scorso anno, hanno visto solo l’impegno degli apparati o, nel secondo caso, solo delle sedi friulane. Stavolta la posta in gioco è più alta. Alcuni paesi europei più colpiti stanno dimostrando questa consapevolezza: i sindacati di Spagna e Grecia hanno deciso di indire in questa giornata uno sciopero generale. La stessa individuazione di una data precisa è piombata come una bomba sul Social Forum di Istanbul (1-14 luglio) che non ha potuto fare a meno di misurarsi con essa, per alcuni con sconcerto e per altri prendendola come un’ancora di salvezza: il periodo che precederà e che seguirà questa data è stato alla fine individuato come il periodo clou in cui intensificare le azioni e le iniziative in ogni paese. Il forum di Istanbul, pur avendo rin- novato parecchi miracoli, tra cui quello del far risuonare nella centrale piazza Taksim un comizio nella vietatissima lingua kurda, non è stato entusiasmante: appena tremila partecipanti al forum e qualche migliaio in più alla manifestazione. E la sessione più grossa, a parte le assemblee finali, è stata probabilmente proprio quella sulla crisi organizzata con la segreteria della CES. Tutto ciò dà un po’ il senso delle difficoltà che attraversano i movimenti e non solo. Ma il 29 settembre è importante per un’altra ragione. Si tratta di una reazione ancorché tardiva a una serie di fenomeni trasversali che costituiscono la risposta alla crisi che i governi europei danno. Fenomeni che sembrano da noi sottovalutati. Tra questi vi è l’attacco concentrico che i governi europei stan- école numero 78 pagina 29 no sferrando allo stato sociale come vettore principale per una possibile uscita dalla crisi. Un attacco che riguarda soprattutto i sistemi previdenziali e le pubbliche amministrazioni, e tra queste la scuola. Orbene vi sono certamente governi (come Spagna, Grecia, Portogallo) che pensano anche ad altre misure (come qualche tassazione in più sui redditi più alti) e altri che invece puntano solo ai tagli nella Pubblica Amministrazione (come l’Italia e la Germania). Ma vi è anche chi taglia meno (la Germania taglia 10.000 milioni contro i nostri 24.000!) e in modo più oculato (la Germania risparmia la ricerca pubblica che viene anzi finanziata di più). Ma tutti, nessuno escluso, mettono mano a tagli pesanti nella pubblica amministrazione, scuola compresa, approfittando anche di un isolamento altrettanto trasversale delle categorie pubbliche rispetto all’opinione pubblica. E qui emerge uno dei problemi più grossi: fare breccia nell’immaginario collettivo dei cittadini europei, convinti da anni di propaganda liberista, che il pubblico impiego si sia dato alla bella vita e, come dicono Berlusconi e Gelmini, che in questi anni abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. È una litania che abbiamo sentito e risentito anche in Italia, dopo che il “tutto va bene madama la marchesa” ha mostrato la corda. Ad essa torna utile la tradizionale diffidenza verso le inefficienze dei servizi pubblici ravvivata dalla propaganda populista di Brunetta contro i “fannulloni”, che fa perdere di vista i costi risparmiati in questi anni alle famiglie che invece ora ricadranno direttamente sulle loro spalle. Fa parte di questa propaganda populista l’idea che i servizi pubblici, in particolare quelli italiani, siano pletorici. In realtà non è così: se si guarda all’Europa vi è certo chi ha meno lavoratori pubblici dell’Italia, ma nella maggior parte degli altri paesi i lavoratori pubblici sono di più. L’Europa si potrebbe dividere in 3 fasce: una fascia che ha un alto numero di dipendenti pubblici in rapporto alla popolazione (1 ogni 8-12 cittadini), una fascia che ne ha pochissimi (1 ogni 30-100 cittadini) e una fascia intermedia (1 ogni 15-20 cittadini). Appartengono alla prima fascia il Belgio, la Francia, il Portogallo, i paesi scandinavi di forte tradizione socialdemocratica (Svezia, Finlandia), alcuni paesi ex socialisti che hanno mantenuto lo stato forte (Polonia, Ungheria, Lettonia, Slovenia) e alcune excolonie britanniche (Irlanda, Malta e Cipro) che hanno ereditato il modello inglese keynesiano e pretatcheriano. Appartengono alla seconda fascia invece la Gran Bretagna posttatcheriana, la Grecia e i rimanenti paesi ex socialisti che a differenza dei primi hanno radicalmente smantellato lo stato (Slovacchia, Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca, Lituania, Estonia). L’Italia − con un dipendente pubblico ogni 17,32 abitanti − sta nel bel mezzo della fascia di mezzo insieme a Germania, Olanda, Austria, Spagna e Lussemburgo. Senza nulla togliere alle storture del nostro servizio pubblico, questi dati andrebbero resi noti per smontare una campagna che si è fatta vieppiù forsennata e per dimostrare che uno stato moderno non può fare a meno école numero 78 pagina 30 di un pubblico impiego ricco e forte. Infatti del circa mezzo miliardo di europei, oltre 350 mila fanno affidamento su organizzazioni pubbliche pari alle nostre o addirittura molto più consistenti e dei paesi più popolosi solo la Gran Bretagna fa affidamento su un sistema che prevede un dipendente pubblico ogni 29,25 abitanti. La Grecia stessa − pur accusata di essere la causa della crisi (ma anche di falsare i dati) −, con un dipendente ogni 30,28 abitanti, avrebbe un rapporto persino migliore (o peggiore, secondo i punti di vista) della Gran Bretagna. Germania: fuga dal federalismo Se il Social Forum di Istanbul non è stato tra i più riusciti, merita però attenzione l’arrivo in forze ai lavori del sindacato tedesco dell’educazione GEW, che aveva tenuto finora un profilo più defilato. Probabilmente è merito del grosso movimento degli studenti che, soprattutto nel 2008-09 ha smosso le università tedesche, austriache e svizzere (in questi ultimi due paesi si riversano numerosi studenti tedeschi esclusi dal numero chiuso delle loro università). La botta di movimentismo si era già vista a dicembre nell’assemblea paneuropea di Varsavia, dove la GEW insieme al sindacato austriaco GOeD si era fatta promotrice di una mozione, sottoscritta anche dai sindacati italiani, che sostanzialmente diceva: non basta dare soldi alla banche per fronteggiare la crisi, bisogna darli anche alle scuole. E non è finita lì. Mentre da noi si parla di federalismo anche scolastico il Der Spiegel a metà luglio è uscito con un lungo reportage intitolato “Fuga dal federalismo”. In sostanza ne emerge una situazione squinternata della scuola tedesca tradizionalmente amministrata dai Laender, dove vigono almeno 4 o 5 sistemi scolastici diversi. Infatti il tradizionale sistema a tre uscite dalla scuola elementare tedesca (a 10 anni!), con la scuola liceale (Gymnasium), tecnica (Realschule) e professionale (Hauptschule), quinquennali e rigidamente attribuite secondo i risultati finali, è rimasto tale solo nelle due regioni meridionali della Baviera e del Baden-Wurttenberg. Altrove si è aggiunta una Gesamstschule unitaria. Nella ex DDR invece è rimasto in vigore un modello binario costituito dal Gymnasium e da una Sekundarschule. Questo modello ha contagiato alcuni Laender dell’Ovest come Brema, Amburgo e lo Schleswig-Holstein. Nello stesso tempo anche all’Est in alcune regioni alle due scuole si è aggiunta la Gesamtschule unitaria. E quest’ultimo modello ha contagiato anche alcune regioni dell’Ovest come la Saar e la Renania-Palatinato. Come se non bastasse Berlino, Amburgo e il Brandeburgo hanno deciso di portare la scuola primaria da 4 a 6 anni e posticipare così la scelta degli indirizzi. Risultato: è complicato passare da un Laend all’altro. Ma a volte è anche ricercato, come succede nelle località dell’Assia vicine al confine con la Turingia perché capita che la selezione (e quindi il passaggio all’ambito Gymnasium) sia più pesante in una regione che nell’altra. Gioca infatti a favore dei tradizionalisti la qualità del loro insegnamento (Baviera e Baden sono in testa alle classifiche PISA, mentre in coda sono prevalentemente i laender ex DDR e quelli delle grandi città), ma gioca a loro sfavore la selettività (in Ba- viera il 32% degli alunni vengono ammessi al Gymnasium contro medie superiori al 40% nella ex DDR). Il Consiglio dei ministri regionali tedeschi dell’educazione, corrispettivo federale del nostro MIUR, sta pensando seriamente di uniformare il tutto. La repubblica dei ricercatori A proposito di fannulloni e del mistificatorio utilizzo che per converso si fa, in chiave del tutto competitiva, del concetto di merito giunge a fagiolo un lungo reportage a puntate apparso sulle pagine estive di Le Monde dal titolo “Nel paese dei fisici” dedicato al CERN, il prestigioso laboratorio ginevrino dove si sperimenta la collisione delle particelle atomiche e che viene visto come una vera e propria repubblica dei ricercatori. Una repubblica sui generis, non solo per il grado di extraterritorialità di cui il laboratorio sembra godere, ma soprattutto per la vita che vi si svolge all’interno. Una vita che coinvolge circa 3.000 ricercatori in fisica delle particelle in un modello organizzativo fondato su una forte democrazia partecipativa coerente con un lavoro di ricerca che è frutto non più di individuali menti eccelse, come in passato, ma sempre più e sempre più intensamente di elaborazioni collettive fatte di confronti, riunioni, corrispondenze elettroniche ecc. ecc. Un modello che di per sé bandisce gli individualismi e riduce la competizione al pur necessario “conflitto” tra le equipe, a quella ricerca dell’errore altrui da cui scaturisce il controllo sull’esattezza del lavoro dell’altro. In cui sarà difficile per le prossime scoperte (il bosone di Higgs?) persino attribuire un premio Nobel, il quale per sua natura non può che dar luogo a tre ex aequo mentre qui sono tremila le persone che firmano “ex aequo” ogni ricerca, dagli ingegneri che hanno studiato progettato e costruito i rilevatori ai ricercatori che hanno analizzato le collisioni, fino a quello che magari non ha scoperto niente e ha passato il suo tempo a giocare a Tetris al computer. Una repubblica di ricercatori la cui sopravvivenza richiede finanziamenti, per cui chi non paga è fuori. Che richiede che ognuno metta in campo le sue qualità migliori: le tante risorse umane degli americani, le capacità di intesa tra università degli europei. Dove vivono insieme americani e iraniani, israeliani e arabi, russi e georgiani. Una repubblica dove non si va a tempo e dove la via può portare altrove rispetto alle intenzioni, come è successo col web che nato per la comunicazione tra scienziati si è trasformato nel potente mezzo di comunicazione che tutti oggi conosciamo e su cui corrono anche i fantasmi che le stesse ricerche generano, come la paura del “buco nero” scatenata proprio sul web alla vigilia del primo esperimento di collisione. Ricerca libera dunque, partecipata, non competitiva, sostenuta finanziariamente e magari anche disinteressata. Proprio quello che dovrebbero leggere il rettore della Sapienza che accusa i ricercatori di non scoprire nulla, le Gelmini che vuole merito individuale e competizione, Brunetta sempre a caccia di fannulloni, Tremonti che taglia le risorse e Berlusconi che monetarizza tutto. Sud Africa: la libertà in cambio della verità Raccontare la verità - Sud Africa 1996/98 la Commissione per la verità e la riconciliazione (Mimesis edizioni, giugno 2010, pp. 344, euro 22), a cura di Danilo Franchi Un testo assai adatto all’uso in classe per affrontare la storia recente del Sud Africa − un paese di cui si è parlato molto all’inizio dell’estate per aver ospitato i mondiali di calcio −, ma anche per discutere in chiave originale di diritti umani, di risoluzione pacifica dei conflitti, di lotta al razzismo, di ascolto dell’altro. Il testo, ricco di schede, fotografie e testimonianze di aguzzini e vittime dell’apartheid, presenta il complicato percorso, primo nella storia, della Commissione per la verità e la riconciliazione del Sud Africa voluta, nel 1995, da Nelson Mandela, presidente che per il suo nuovo paese scelse di rifiutare la vendetta e di proporre invece che castigo e odio, verità e riconciliazione. «La Truth and Reconciliation Commission non fa giustizia ma verità» (Mandela); fu istituita «come meccanismo per gestire le ingiustizie del passato: perché altrimenti quelle stesse ingiustizie avrebbero continuato ad affliggere il nuovo governo e a minacciare le fragili strutture della nuova democrazia del Sud Africa», ha affermato Desmond Tutu, l’arcivescovo anglicano che l’ha presieduta. L’autore, Danilo Franchi, insieme a Laura Miani, sul medesimo argomento aveva già pubblicato La verità non ha colore (Comedit 2000, pp. 272, 2002, recensito sul numero di ottobre 2003 di école), che ha fornito la contestualizzazione storica e alcuni elementi fondamentali per l’impianto della pièce teatrale La notte dell’Ubuntu (Editore Centro Saveriano Animazione Missionaria, 2004, 12.50 euro) che Marisa Veroni ha realizzato su proposta della rivista Missione Oggi. Celeste Grossi Congo: decolonizzare l’immaginazione Patrizia Politelli, Di notte si vede ancora di più, Manni, 2010, pp. 104, euro 12 «Ad un certo punto ho sentito il bisogno di raccontare questa esperienza che era stata particolarmente intensa, ricchissima di emozioni e di riflessioni, di sorprese e rivelazioni», dice del suo libro Patrizia Politelli. L’esperienza è quella di un viaggio in Congo per tenere a Kenge un corso di formazione alle donne indigene. Il libro è un invito a «decolonizzare l’immaginazione», ad avvicinarsi ad altre persone, luoghi, culture, con curiosità e rispetto, a non vedere solo gli altri come diversi, ma percepire anche se stessi come tali rispetto agli altri. «Se avvicini le persone e non i luoghi comuni, ti si presentano in tutta la loro ricchezza e nelle loro sfaccettature, così come anche tu, che puoi essere amabile o irritante a seconda delle situazioni e degli interlocutori». L’autrice raccontata con passione gli incontri, «le bambine e i ragazzini che mi hanno accompagnato e mi hanno svelato molte verità», le profonde relazioni con le donne indigene che con coraggio e inventiva, sempre con speranza, affrontano le gravi difficoltà quotidiane − dalla violenza dei militari sbandati allo sminamento, dalla povertà, soprattutto delle numerose vedove, alla carenza di trasporti… −, la sapienza della vecchiaia e dell’infanzia, la natura sorprendente, i canti. Politelli riesce a comunicare usando il corpo (sguardi, sorrisi, abbracci, carezze), ma per imparare almeno qualche parola di kikongo partecipa ad alcune lezioni di alfabetizzazione insieme ad altre donne che cercano di imparare a leggere e scrivere, convinte che questo le aiuterà ad avere un futuro migliore. La narrazione è affettuosa, ma non edulcorata; sempre accompagnata dalle sensazioni vissute. «Il libro che ne esce è molto lontano da quello che mi proponevo. Ma aderisce perfettamente alle impressioni e alle parole che scorrevano sulle labbra e nella testa mentre ero lì». Le istantanee che l’autrice ci propone, senza nascondere spiazzamenti e diffidenze, suscitano domande, emozioni e riflessioni. CELESTE GROSSI info Da Gaza alla Cisgiordania La Ong israeliana Gisha ha pubblicato un gioco on-line per svelare le difficoltà che i palestinesi della Striscia di Gaza incontrano per raggiungere la Cisgiordania: http://it.peacereporter.net/articolo/22702/ Percorso+a+ostacoli. école numero 78 pagina 31 de rerum natura Energia È tempo di ragionare, anche a scuola, sull’estensione del concetto di bene comune ad una merce per eccellenza, per cui si combattono guerre e si colonializzano immensi territori: l’energia, sia proveniente da fonti fossili che da fonti naturali. La formazione è un terreno essenziale per la costruzione di un altro modello energetico, partecipato, equo e democratico, non più alimentato dai combustibili fossili e dal nucleare, ma basato sul risparmio dell’energia e sull’uso distribuito e sostenibile delle risorse rinnovabili Da merce a bene comune MARIO AGOSTINELLI * N el 2005 l’assemblea del Forum Sociale di Porto Alegre ha innalzato le questioni energetiche al rango di priorità per “un mondo diverso possibile”. Era già avvenuto cinque anni prima per l’acqua, con una intuizione che ha portato allo sviluppo di una azione politica dei paesi del Sud del mondo tesa a rivalutare in modo convergente i diritti della natura e quelli dell’umanità, capovolgendo il paradigma capitalistico-industriale che riduceva l’ambiente e la vita a serbatoio da sfruttare come merce e bene di natura economica. Proprio a partire dall’acqua si è arrivati in questi anni più recenti ad un conflitto nuovo, che porta ad un cambio di cultura e al ristabilimento della priorità della vita sull’economia. La recente risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU école numero 78 pagina 32 a favore della proclamazione dell’acqua come diritto dell’umanità ne è testimonianza. Io penso che sia ora venuto il tempo di ragionare sull’estensione del concetto di bene comune ad una merce per eccellenza, per cui si combattono guerre e si colonializzano immensi territori: l’energia, sia proveniente da fonti fossili che da fonti naturali. Democrazia territoriale La chiave di questo passaggio sta nel ritenere che il cambio di paradigma dalle fonti fossili alle rinnovabili sia indispensabile per il rilancio di una azione locale-globale che rimetta al centro la democrazia territoriale, la salvaguardia dei cicli naturali, il lavoro. Abbandonando l’approccio tradizionale dell’era del petrolio, che finiva per collocare l’energia nello spazio della geopolitica e delle guerre e promuovendo con le fonti solari la nascita di una politica della biosfera, contigua alla cultura della pace e dei beni comuni, si opererebbe una svolta culturale e politica di enorme portata. L’energia diffusa nei processi naturali e sottratta dalle mani delle grandi multinazionali diventa così, anche e soprattutto, possibilità di vita e di lotta alla povertà, proprio mentre gli effetti di consumi spropositati in poche zone del pianeta, indotti dal sistema capitalistico e dall’accaparramento del petrolio, del gas e del carbone, continuano a mettere in discussione non solo l’uguaglianza tra individui, ma la sopravvivenza della specie. Questa percezione, ormai patrimonio delle nuove generazioni, richiede di riposizionare il sistema sociale e produttivo rispetto alla fonte solare e di rivalorizzare il tempo biologico e riproduttivo. Non si tratta tanto e soltanto di scelte tecnologiche compatibili con l’ambiente, ma anche di assetti sociali e di decisioni democratiche di produzione, consumo e relazioni nelle comunità, nel territorio e nel rapporto armonico con la natura. Questa idea completamente nuova dell’energia come possibilità e occasione di ordinare coscientemente e in maniera condivisa i rapporti sociali, il sistema tecnologico caratteristico di una civiltà, le possibilità di benessere universale, gli equilibri vitali dei sistemi ecologici, rappresenta un salto anche nella pratica politica e scientifica a cui nessun sistema, neanche quelli di ispirazione socialista e egualitaria, era ed è preparato. Un mondo diverso è cioè possibile se l’azione dei popoli saprà costruire un altro modello energetico, partecipato, equo e democratico, non più alimentato dai combustibili fossili e dal nucleare, ma basato sul risparmio dell’energia e sull’uso distribuito e sostenibile delle risorse rinnovabili. Nessuno può pensare una imposizione dall’alto: occorre una estensione della democrazia e della partecipazione, lasciando agli abitanti di un territorio il diritto di decidere se e come sfruttare le risorse energetiche di cui la loro terra è ricca. La conseguente necessaria riduzione delle merci e della quantità materiale dei prodotti, comporta anche un ridimensionamento della civiltà manifatturiera industriale, con problemi inediti per l’occupazione. Le merci da produrre d’ora in avanti dovrebbero sottostare a criteri di utilità e desiderabilità sociale e la diffusione di nuovi prodotti così concepiti richiederebbe un riassetto complessivo delle relazioni, la familiarizzazione con l’idea di uno sviluppo sobrio, un potenziamento dei servizi, una sottrazione dei beni comuni alla logica mercantile, una diversa ripartizione tra tempo di lavoro ridotto e tempo di vita, una espansione degli impieghi qualificati. Argomenti formidabili per una estensione anche dei diritti del lavoro e della democrazia sindacale. Alternative al “rinascimento nucleare” Ma veniamo a noi, per misurarci con una azione del governo che va esattamente in direzione opposta. Berlusconi e Scajola, Confindustria e ENEL, Veronesi e Chicco Testa vorrebbero convincere il popolo cui apparteniamo del “rinascimento nucleare”, secondo loro, necessario all’Italia. Non sappiamo se dopodomani questo governo ci sarà ancora, ma con la spinta all’atomo dovremo farci i conti, perché l’opzione del nucleare civile ha origine anche nel gioco internazionale della potenza, che ci coinvolge nelle missioni militari all’estero, sulle rotte delle risorse energetiche del pianeta. Il monopolio mediatico di chi vuole convincere la gente comune è all’opera per un piano di centrali addirittura di 13.000 Megawatt, a partire dai quattro reattori EPR da 1.600 Megawatt ciascuno, concordati con la Francia per un costo complessivo di oltre 30 miliardi di euro. Insistono perché fanno parte di un passato e di un sistema di potere che vorrebbero continuare ad imporci, proprio quando siamo in presenza di alternative praticabili. Si tratta della riduzione dei consumi, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, sostenute e favorite da soluzioni scientifiche d’avanguardia, dalla realizzazione di filiere industriali che offrono buona occupazione in un periodo di crisi e dalla diffusione di esperienze locali che valorizzano il territorio, consumano meno natura e non lasciano scorie ineliminabili per le future generazioni. In fondo, il potere che rilancia il sistema centralizzato dei grandi impianti come i reattori atomici e persegue un controllo militare della società, vuole assicurare il comando e il controllo dell’economia nelle mani di pochi e contrastare l’idea di democrazia partecipata necessaria a costruire il nostro futuro. Un futuro che metta al centro vita, giustizia sociale, relazioni comunitarie e virtuose con la natura, valorizzazione dell’interculturalità e della creatività, sovranità popolare. Per queste ragioni è stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare a sostegno del risparmio energetico e della diffusione delle rinnovabili, che invito a prendere in considerazione ed a sostenere sottoscrivendola e proponendola alla firma dei cittadi- ni. Opporsi al nucleare significa ripensare e ripensarci, rompere il quadro statico che vorrebbero imporci per rispondere alla crisi con le stesse ricette che l’hanno provocata. Ripensare il nostro stile di vita e di consumo perché il pianeta è unico e condiviso e l’energia è questione sociale, dato che nel sistema in vigore si bruciano risorse di tutti, si inquina l’aria che tutti respiriamo e si consuma suolo di madre terra. Non lasciare scorie pericolose è necessario alla sopravvivenza dei nostri figli e nipoti ed alla tranquillità del presente. Non sprecare è intelligente. Costruire case autosufficienti è intelligente. Ridurre i consumi è lungimirante e non segno di miseria. Costruire una società in cui la generazione di energia è distribuita e non esistono centri di potere che “comandano” i flussi di energia equivale a corresponsabilizzare le comunità territoriali e a promuovere da subito centinaia di migliaia di posti di lavoro di indubbia utilità sociale. Inoltre, l’energia di fonte naturale necessaria può essere integrata con gli altri beni comuni come il cibo, la terra e l’acqua. Antinucleari, allora, ma, contemporaneamente, in lotta per un modello alternativo da costruire insieme, fondato sul passaggio dalle fonti fossili e nucleari alle rinnovabili per una società di pace. Il Forum dell’acqua pubblica può farci da modello con la sua campagna referendaria unitaria, capace di mettere insieme nell’operatività reti ed organizzazioni sì distinte, ma ad un tempo assolutamente convinte che ricercare punti di convergenza ed incrociare i percorsi costituisca una condizione imprescindibile per contare tutti di più e portare a casa risultati che vanno in direzione delle nostre speranze di alternativa. * Portavoce del Contratto mondiale per l’energia e il clima, saggista, autore con Pierattilio Tronconi del recente L’energia felice. Dalla geopolitica alla biosfera, edizioni Socialmente, 2009. école numero 78 pagina 33 mente locale Codirossi e pesci rossi LAURA SCARINO A vere Francesco come guida all’interno del complesso monumentale delle Terme di Traiano, sede di una parte del Museo nazionale romano oltre che degli uffici della Soprintendenza, è stata un’avventura ricca di molte soddisfazioni. Prima di tutto quella di essere di nuovo in sua compagnia dopo quasi quarant’anni, e cioè dalla fine dei nostri avventurosi studi al liceo Mamiani di Roma. In aggiunta, quella di vedere da dentro (e non più da fuori!) l’infilata dei piccoli cortili, ognuno allietato da rigogliosi alberi di arancio, che si affacciano sul lato del Convento verso via Cernaia. Ho potuto così finalmente esplorare i giardini dal piano terra, e scoprire piccole fontane appoggiate sul muro di cinta, invisibili a chi guarda da sopra, e invece di cogliere le arance, che sono commestibili, sì, ma amare, seguire Francesco alla scoperta di un albero di mandarini – seminascosto tra mucchi di reperti marmorei –, dal quale egli ha colto alcuni frutti dolci e profumatissimi che abbiamo allegramente mangiato insieme. Accompagnati da una persistente scia di aroma di mandarino, abbiamo poi risalito scalette, percorso corridoi, infilato porte e siamo sbucati infine nel grande, bellissimo chiostro del convento di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, risistemato da Michelangelo, letteralmente pieno zeppo di statue, busti, lapidi, capitelli, sarcofaghi in tutti i suoi lati e nelle aiuole (del resto, chi altri, se non la Soprintendenza archeologica di Roma, potrebbe averne così tanti in custodia?). E, al centro del chiostro, ecco il cipresso di Michelangelo. Alla sua ombra e sotto un cielo glorioso, accanto alla fontana dei delfini, ci siamo finalmente fermati a conversare. Anche questo chiostro è uno dei luoghi magici di Roma: il rumore del traffico ne è miracolosamente escluso e vi si sentono, chiarissimi, i rintocchi della campana del- la chiesa accanto. Il luogo porta con sé la bellezza di molti secoli, composta con sapienza da uno dei pochi Grandi che hanno saputo attraversare il tempo fino a noi con il loro solo nome. Il cipresso, che Michelangelo ha probabilmente visto e amato, ha un tronco possente e cavo, quasi minerale, della compattezza e del colore della pietra, bello da accarezzare. Un solo ramo, ancora vivo, sale vittorioso verso il cielo. Ma nel buio, tra i suoi piedi, una piccola palma di san Pietro occhieggia speranzosa... C’erano merli e altri uccelli in questo cortile, spiega Francesco, oggi scacciati dai troppi gatti che hanno su di loro il vantaggio di mangiare a sbafo e senza troppa fatica. Passano tuttora i gabbiani. E mi racconta di quella volta che, spaventando involontariamente col suo passaggio un gabbiano, trovò sulla ghiaia un pesce rosso appena estratto dalla fontana, che poté così rituffarsi sano e salvo dentro l’acqua. Con occhio esperto, Francesco ha osservato ancora, dal suo studio che si affaccia sul chiostro, lodolai che cacciano arditamente storni, e ancora gabbiani, ingordi e infidi, che, facendo finta di volare insieme a loro, se ne ingoiano a sorpresa qualcuno ogni tanto. Prima di uscire dal chiostro, un piccolo volatile si è fermato sulle tegole del tetto degli uffici di fronte a noi. «Guarda, una ballerina!», ho buttato là io. «Ma no – ha precisato lui – è un codirosso, al più un codirosso spazzacamino!». E l’uccellino, alzandosi veloce in volo, gli ha dato immediata e indiscutibile ragione, mostrando maliziosamente un piccolo ventaglio rosso proprio al posto della coda. Speria- école numero 78 pagina 34 info mo che Francesco abbia ancora la pazienza di insegnarmi, come fece a suo tempo per le rondini, i rondoni e i balestrucci, a riconoscere i codirossi dai pesci rossi e dagli spazzacamini... Da leggere Gerald Durrell, La mia famiglia e altri animali, Adelphi, Milano 1975. Constantinos Kavafis, “Aspettando i barbari”, da: Settantacinque poesie, a cura di Nelo Risi e Margherita Dalmati, Einaudi, Torino 1992. Per un’ecologia della mente A 30 anni dalla morte di Gregory Bateson (19041980), a 20 dalla fondazione del Circolo Bateson, a 30 anni dalla fondazione di Legambiente, il Circolo Bateson, Legambiente e il Dipartimento di Biologia dell’Università Tor Vergata organizzano il 6 novembre 2010 (Roma, Aula Magna del Rettorato dell’Università Roma Tre, via Ostiense 161, di fronte alla Basilica di san Paolo) il convegno “Per un’ecologia della mente”. L’iniziativa, rivolta anche a chi conosce poco o niente affatto il pensiero e la vita di Bateson, sarà incentrata sul documentario An Ecology of Mind, che verrà presentato dall’autrice, Nora Bateson figlia di Gregory, e proiettato a Roma in anteprima mondiale. Informazioni www.circolobateson.it; iscrizioni [email protected] Da ascoltare Gustav Mahler, “La predica ai pesci di Sant’Antonio da Padova”, canto per voce e orchestra (o pianoforte) da Il corno magico del fanciullo, 1899. Pink Floyd, “Summer 68”, da Atom Hearth Mother, 1970. Nicola Campogrande, “Sebastiano danza con Michelangelo”, da Musica per Sebastiano del Piombo, 2008. Da preparare Spremuta di mandarini. Procuratevi un bel po’ di mandarini (dove, decidete voi; la via più facile è quella che vi porterà dal vostro fruttivendolo di fiducia), tagliateli a metà in senso equatoriale, spremeteli cercando di eliminare tutti i semi e passando il succo ottenuto attraverso un colino da tè se non ci sarete riusciti. Raccogliete il succo in una caraffa di vetro (meglio se cristallo) e servitelo in piccoli calici graziosi a persone selezionate (dopo tutta la fatica che vi è costato prepararlo, mica vorrete rischiare di offrilo al primo che vi capita?!). L’acqua diritto umano Qui sotto: Fabio Mauroner Il cipresso di Michelangelo, Rome 1913, Washington, Smithsonian American Art Museum. Nella pagina a lato: in alto, un codirosso spazzacamino (Phoenicurus ocruros) e uno scorcio del Museo Nazionale Romano. L’Onu ha approvato una mozione promossa dal governo boliviano per dichiarare l’accesso all’acqua diritto umano fondamentale. Nessuno ha votato contro. Quarantuno paesi si sono astenuti, tra cui gli Stati uniti e diversi paesi europei. Il testo non è giuridicamente vincolante, ma è una vittoria per i movimenti globali di difesa dei beni comuni. http://www.carta.org/ campagne/beni+comuni/acqua/19782 Educazione alimentare Dall’Arancia alla Zucchina, il libro di Silvia Camatta, illustrato da Chiara D’Agostino (Edicolors edizioni, www. edicolors.com, [email protected], Genova 2010, pp. 34, 9.90 euro), attraverso filastrocche e indovinelli presenta ai piccoli lettori frutta e verdure, le loro proprietà alimentari e le loro provenienze. Ringraziamenti Naturalmente a Francesco, per avermi accompagnata nella sua “tana” e aver conservato ancora, stratificato nella sua vita di oggi, il ragazzo pestifero e adorabile che è stato ai tempi del liceo. Avvertenze Se vorrete visitare il cipresso di Michelangelo e il bellissimo chiostro nel quale è piantato evitate di andare a disturbare di nuovo Francesco, che ha davvero molto da fare. Entrate piuttosto dalle Terme di Diocleziano (l’ingresso è in via Enrico de Nicola 79). Le Terme fanno parte del Museo nazionale romano; biglietto unico valido 3 giorni per 4 siti – Palazzo Massimo, Palazzo Altemps, Crypta Balbi, Terme di Diocleziano – intero euro 7, ridotto euro 3,50 per i cittadini dell’Unione Europea tra i 18 e i 24 anni e per i docenti dell’Unione Europea, gratuito per i cittadini della Unione Europea sotto i 18 e sopra i 65 anni. Orari: tutti i giorni dalle 9 alle 19,45 79. La biglietteria chiude alle 18,45); casomai, una volta arrivati nel chiostro, se vorrete salutarlo fategli un piccolo cenno con la mano o, meglio ancora, imitate il verso del codirosso (oppure un gorgheggio di merlo, notissimo anche ai meno esperti). Non provate a rifare il richiamo del pesce rosso perché, come molti altri pesci, è inesorabilmente muto. école numero 78 pagina 35 modi e media Poesia in gioco Incontro Roberto Piumini il 30 novembre 2009 ad Asti, nel quadro dell’attività di formazione organizzata per il Comune dall’associazione maestri cattolici. Il titolo è “Parole e non solo… tra memoria e immaginazione: i diversi linguaggi del comunicare”. Piumini è qui per introdurre il laboratorio sulla poesia che poi io dovrò condurre con gli insegnanti. La sua figura è imponente, emana simpatia quest’uomo con la barba che racconta storie ed attacca subito diretto «i poeti fanno poesia, non parlano di poesia». Eppure siamo qui e proviamo a dire qualcosa Ascoltando Roberto Piumini STEFANO VITALE L a parola calda Per prima cosa la parola espressiva nasce nella relazione materna della e con la lingua. L’espressività viene prima, per così dire, della scelta poetica, è legata ad un colloquio intimo che è tipico dell’oralità. La parola ha una sua materialità che nel tempo si perde ma che possiamo ritrovare nel momento in cui cerchiamo la parola “giusta”, la parola “calda”, école numero 78 pagina 36 non solo adatta, ma giusta per dire quel che sentiamo. E la parola può essere allora forte o sottile, dipende: dalla parola e da noi. Fin da bambini, senza sforzo, abbiamo la capacità di giocare con le parole. Esse hanno una identità sonora, prima di tutto. L’infanzia è l’età dell’eco, della risonanza che è scoperta continua nell’immediatezza dell’uso e del ragiona- Piumini si mette a leggere alcune sue poesie per sostenere e dimostrare le sue tesi. È un momento affascinante: la voce del poeta dà corpo alle parole. Il tempo passa veloce tra metafore, allitterazioni, sinestesie, onomatopee, giochi di parole, non sense pieni di senso: siamo su un ottovolante di parole dove ritmo e fantasia sostengono la lingua nella ricerca di nuovi significati. Poi Piumini si ferma e noi con lui e conclude: «occorre nella poesia essere semplici ma non banali: così le storie per i bambini vivono più a lungo e sono più vive». Chissà cosa resterà di tutto questo nella scuola che sta arrivando… Per altre informazioni: www.robertopiumini.it Orwell George Orwell, Omaggio alla Catalogna, traduzione di Riccardo Duranti, Oscar Mondadori, Milano 2002, pp. XII259, euro 9 riletture mento. Purtroppo, nel tempo, questa capacità si indebolisce: è una forma di competenza dei significati che viene dispersa. A volte le cose capitano per caso: mio figlio una volta usò il verbo “scintinnare”. Era riferito ad un suono che però aveva una sua visibilità. Ecco: mettere insieme parole e suoni diversi è giocare con le parole restituendo alla lingua un suo spessore creativo ed espressivo. Ci sono parole non troppo bene definite che colgono la realtà meglio di una definizione “corretta”. Quante volte gli insegnanti non si accorgono che negli errori si nascondono delle soluzioni nuove, inattese. Nella scuola ci dovrebbe essere il tempo ed il modo per fare resistere quelle che io chiamo parole “calde”. Dobbiamo organizzare una “strategia di resistenza della parola”, prima di lasciare che il “vocabolario”, che pure è importante, abbia tutto il potere. La commistione di diversi linguaggi è altrettanto importante per favorire una maggiore apertura, una capacità di combinazione, di spostamento del punto di vista che è la base della vera creatività. I giochi con le parole, i giochi delle parole (si pensi al contributo di Gianni Rodari) sono essenziali nell’acquisizione della lingua e la poesia gioca un ruolo essenziale. La “parola-musica”, la fonologia stessa, la sonorità delle parole sono elementi su cui giocare. Pensate a come viene sfruttata questa risorsa nei momenti rituali, corali: c’è un impatto “religioso” nelle parole. La parola è come un giocattolo al servizio del linguaggio e la poesia, con le sue regole, le sue possibilità sonore, ritmiche, immaginative e di apprendimento (per esempio, penso sia importante imparare le poesie a memoria), partecipa a questo “gioco”. La poesia ha una funzione importante: di protezione della forma. La rima, il ritmo, la sequenza, le regole metriche, ecc. sono tutti strumenti per “dare forma” al piacere di usare le parole. Ecco perché è importante leggere le poesie ad alta voce ai bambini. Molti poeti “istituzionali” sono noiosi, leggono male, usano un brutto tono e forse fa parte del codice poetico nostrano apparire come “lirici ripiegati”. La poesia, invece, ci obbliga a «mettere la voce», perchè una poesia racconta sempre una storia, ha una dimensione narrativa che va offerta e colta. Fare corsi di dizione può servire, ma l’importante è il piacere di aggiungere espressività alla voce per comunicare, per creare una comunità che comunica. La poesia ha delle sue caratteristiche: ha una corporeità, non solo si riferisce a cose concrete, ma le parole hanno una loro fisicità; vive nel gioco perché si può ragionare per immagini, dire quello che si vuole dentro ad una forma; è una narrazione perché racconta sempre qualcosa. CESARE PIANCIOLA O maggio alla Catalogna – straordinario racconto a caldo dell’esperienza di volontario nella guerra di Spagna, nei primi sei mesi del 1937 sul fronte aragonese, dove Orwell fu gravemente ferito – uscì a Londra nell’aprile del 1938, dopo che l’editore abituale dello scrittore l’aveva rifiutato temendo di indebolire l’unità delle forze antifasciste. Molte pagine del libro sono infatti la testimonianza diretta dei metodi terroristici messi in atto dal partito comunista staliniano contro gli anarchici e contro i “trozkisti” del POUM, un piccolo partito della sinistra marxista alle cui formazioni militari Orwell si trovò quasi casualmente aggregato al suo arrivo in Spagna nel dicembre 1936. Nel maggio 1937 gli anarchici, appoggiati dal POUM, avevano respinto il tentativo della polizia di sloggiarli dal palazzo delle telecomunicazioni che controllavano dall’inizio della guerra e ne erano seguite barricate e scontri. I comunisti orchestrarono una campagna contro i “trozkisti” accusati, in linea con i contemporanei processi di Mosca, di essere agenti dei fascisti; a giugno il POUM fu messo fuori legge e i suoi militanti incarcerati e processati (il segretario generale Andreu Nin fu portato a Madrid e assassinato). Dopo giorni angosciosi di latitanza Orwell e sua moglie riuscirono fortunosamente a passare il confine francese e a tornare in Inghilterra. Per non interrompere la narrazione, nelle attuali edizioni del libro, su precise indicazioni date da Orwell per future ristampe, i capitoli di analisi delle forze politiche e di documentazione delle lacerazioni interne al campo repubblicano sono diventati due appendici finali. L’esperienza spagnola fu centrale nella biografia dello scrittore, che prima si era immerso, traendone inchieste avvincenti, nel mondo dei derelitti di Parigi e di Londra e in quello dei minatori inglesi: «Sentivo di dover sottrarmi non soltanto all’imperialismo ma ad ogni forma del dominio dell’uomo sull’uomo» (La strada di Wigan Pier, 1937). In Spagna trovò intensi rapporti di fraternità (di cui è simbolo il miliziano italiano che lo accoglie al suo arrivo) e un entusiasmante abbozzo di società egualitaria (cap. VII), già insidiata, nelle retrovie del fronte, dal ripristino delle gerarchie sociali e politiche (nel cap. VIII ci sono belle pagine sul ritorno a Barcellona e sul mutamento della città). Ebbe anche l’esperienza di un montante “fascismo di sinistra” ma non abbandonò la speranza, come scrisse nel 1938, in «un movimento che sia genuinamente rivoluzionario […], ma che non perda di vista, come hanno fatto il comunismo e il fascismo, i valori essenziali della democrazia»1. Omaggio alla Catalogna, – secondo Italo Calvino – tra «i libri che racchiudono l’esperienza del secolo […] è nel numero degli indispensabili». Da leggere e da rileggere. NOTA 1. Notevole il recente saggio di Pietro Costa, «Ho tentato di dire la verità»: George Orwell e l’universo totalitario” in F. Sbarberi (a cura di), La forza dei bisogni e le ragioni della libertà. Il comunismo nella riflessione liberale e democratica del Novecento, Diabasis, Reggio Emilia 2008. école numero 78 pagina 37 script Il verosimile e l’interessante Anche questa volta ci occupiamo della scrittura per il teatro MARIA LETIZIA GROSSI D info Teatro dell’Oppresso Sono aperte le iscrizioni al 9° corso di Formazione Base nel Teatro dell’Oppresso come Coscientizzazione che inizierà a fine ottobre e si concluderà a giugno 2011. Per informazioni: [email protected], http:// www.giollicoop.it. i tutti gli elementi drammaturgici: tema, ambientazione, trama, struttura, personaggi, dialoghi, tempi teatrali, i dialoghi sono non diremo i più importanti, ma quelli che più immediatamente vengono percepiti dagli spettatori e quelli che richiedono a chi scrive – e anche a chi recita – maggiore perizia nel dosaggio. Stanley Kubrick, nientemeno, diceva al grande Jack Nicholson, nientemeno, girando un film molto teatrale come Shining, che alcune scene da lui interpretate ai primi ciack erano «naturali ma non interessanti». I dialoghi Qui sta il paradosso dei dialoghi teatrali. Non sfuggono alla necessità generale di tutti i dialoghi, narrativi, cinematografici e drammaturgici, di essere credibili. Quindi al bisogno per il drammaturgo di conoscere intimamente i personaggi, di convivere con loro, di entrare nelle loro scarpe e nella loro testa, prima di calarli sulla scena, di averli perfettamente definiti nel pensiero in ogni aspetto, anche se, per la famosa regola della metonimia, non tutto sarà detto, anzi qualche particolare significativo, indiziario, servirà a rappresentare l’intero. Nei dialoghi si deve sentire la voce di ciascuno, diversa e riconoscibile. Però, come abbiamo visto nella puntata precedente (pubblicata sul numero 77 di école, giugno 2010), il teatro è un luogo fortemente concreto e anche fortemente simbolico, qui le parole dei personaggi devono inseguire non solo la verosimiglianza, ma anche l’efficacia drammaturgica. Significa che possono essere un po’ più cariche rispetto a quelle della narrativa e delle sceneggiature filmiche, senza mai cedere al birignao o al tono costantemente declamatorio, che ha un effetto falso. Ma non solo, la cosa più importante è che tutti gli elementi drammaturgici siano in stretto rapporto, i personaggi parlano con la loro voce e nel contempo si fanno interpreti dell’idea o delle idee portanti della pièce, che, proprio perché passano attraverso i personaggi, sfuggono all’effetto che sceglie il drammaturgo, non l’inverso. Il tema In classe si può cominciare con un brain storming per definire un tema che tocchi profondamente ragazze e ragazzi. Diamo per scontato che abbiamo già lavorato sull’ambientazione. Affidiamo un personaggio a ciascun aspirante drammaturgo, vivrà con lui, capirà qual è il suo problema e il suo desiderio – come in ogni racconto, la vicenda e la trama nascono da un inghippo da risolvere o da un desiderio da inseguire: l’evento dinamico. Ognuno imparerà le parole “vere” del personaggio, quelle più “giuste” per la situazione che si trova a vivere e per le peripezie fisiche e psichiche che deve affrontare. Imparerà anche a muoversi con lui. I gesti sono importantissimi per definire i personaggi. Essi compiono le grandi azioni, connesse col tema e con la trama, ma anche piccole azioni, movimenti particolari, un modo di camminare, di incespicare, di tossire, di ridere, di piangere. Tutti questi piccoli movimenti caratterizzanti (nel senso che disegnano un carattere) saranno indicati nelle didascalie. Diamoci tempo all’inizio, proviamo, lavoriamo su diversi pia- école numero 78 pagina 38 ni. Poi facciamo incontrare e scontrare i personaggi e i loro dialoghi. Qui entra in scena un altro elemento importantissimo, i tempi dei personaggi, l’entrata e uscita di scena, l’attacco delle battute, anche questi indicati nelle didascalie. Via via che le battute si scrivono, ci renderemo conto che il centro di gravità, che è già nel tema, sarà affiancato, nello svolgimento della trama, da altri elementi trasformabili, capaci di dare svolte alla storia, temi secondari possono affiancarsi. La struttura e il tempo Dopo un po’ di lavoro, dovremo tornare a riflettere su quello che sta venendo fuori e leggervi una struttura. Per iniziare, sempre meglio far riferimento, sia pur con molta libertà, a quella classica, tripartita (come già indicato nella Poetica di Aristotele): impostazione, peripezie col climax, scioglimento, perché è la più semplice, la più naturale. A teatro a questa struttura di base si sovrappongono altre partizioni più visibili: gli atti. Essi corrispondono ai vari momenti dello svolgimento della vicenda, tecnicamente segnano i cambi di scena. Cinque nel teatro greco, nelle pièce del teatro contemporaneo tendono a diminuire, fino, spesso, a uno solo. Per una struttura coerente e fluida è importante tenere sempre il tema come linea guida. Il tempo teatrale, a parte ogni possibile segmentazione, è malleabile, alterno, va dalla dilatazione nelle scene madri, alla contrazione estrema, poiché l’altro suggerimento di Aristotele, l’unità di luogo, di tempo e di azione, che consentiva uno svolgimento in tempo reale, è stato abbandonato già dall’epoca elisabettiana. Il teatro dei nostri giorni ama giocare col tempo ed è consapevole che sul palcoscenico i minuti, i giorni, i secoli, hanno un’altra durata. il libro Un’enciclopedia della scuola enciclopedica Nicola D’Amico e Zanichelli ci presentano sulla scuola italiana un’opera voluminosa, Storia e storie della scuola italiana. Dalle origini ai giorni nostri, che sta tra il repertorio e il manuale storico e vuole essere testo di riferimento per vari tipi di utenti: pedagogisti, candidati a concorsi, studenti delle facoltà di formazione, pubblicisti a cui fornisce anche aneddoti, e che mira a un posto sullo scaffale di ogni dirigente scolastico Paolo Chiappe Nicola D’Amico, Storia e storie della scuola italiana, Zanichelli, Bologna 2010, pp. XVI - 800, 59 euro L e parti introduttive sulla storia italiana in ogni sezione sono frutto di compilazione e si dilungano con attenzione a equilibrare nella quantità i temi cari a destra e sinistra, laici e cattolici. Lo sconfinamento ambizioso dall’argomento specifico dipende appunto anche dalla scelta di fare un manuale utile per varie materie di concorso. In assenza di una chiave interpretativa, sia della storia generale che di quella scolastica, affiora il difetto di una proliferazione di dettagli che rendono il libro poco studiabile, difetto oggi frequente nei manuali, il che dovrebbe essere un problema per chi auspica un ritorno alla serietà degli studi. La tendenza alla proliferazione quantitativa tipica della scuola di oggi si riflette dunque nella forma stessa di questo libro. La resa dei diversi periodi risulta disomogenea per quantità e taglio: si va da una asettica ma precisa ricostruzione della parabola di Gentile a belle schede sulla scuola attiva; da una ampia ricostruzione del fondamentale “caso Zanzara”, a un accorato elogio di Giovanni Leone illustre giurista perseguitato dagli studenti. Minuziosa la ricostruzione delle metamorfosi dello pseudo-mandarinale esame di stato. Certi accostamenti sono un po’ incongrui e rivelano un lavoro di tipo giornalistico, per esempio la trattazione della Toscana dove si salta dal tumulto dei Ciompi alla dinastia lorenese (p. 34). Il riassunto dell’enciclica Rerum Novarum (pp. 143 – 144) la edulcora in modo di fatto funzionale agli interessi sempre attuali della Chiesa. Il linguaggio a tratti vecchiotto rivela forse collazioni di testi non ben digeriti: si trova perfino una “vindice politica” di Vittorio Emanuele I (p. 46). La cifra riconoscibile dell’autore sta in alcune battute amene sparse nel testo e nei titoli. Il tono da libro di alta cultura di certe parti lascia il posto in altre a uno stile didascalico, compreso l’uso del grassetto per liste di concetti da memorizzare: si veda, per esempio, la trattazione dell’editoria per ragazzi all’inizio del secolo passato (p. 133). Il lavoro redazionale non ha evitato, forse per una qualche fretta di raggiungere il mercato, una certa quantità di piccoli errori, talvolta anche nelle date, che spero saranno corretti nelle edizioni successive. In un’opera sulla scuola traslitterare la parola greca come skolè e non come scholè è piuttosto stonato (p. 2). Il nome di battesimo di Giosue Carducci è scritto sempre con l’accento. Il ministro Coppino nella stessa pagina è fatto morire nel 1901 o nel 1905. Nasce il sospetto di una strisciante wikipedizzazione dei metodi zanichelliani. Che ci sia la vendetta di qualche oscuro precario malpagato dietro a queste piccole imprecisioni? Un po’ più fastidioso è trovarsi di fronte a sinossi quasi apologetiche come quella a pagina 8 sulle istituzioni educative cristiane che mette insieme alto medioevo e controriforma, saltando la scolastica e ignorando la lezione del grande Philippe Ariès, o a una scheda sulle scuole militari italiane che le presenta tout court come scuole di eccellenza e che ha tutta l’aria di essere stata scaricata direttamente dai siti internet di tali rispettabili istituzioni. Un sotterraneo patriottismo del libro forse ha influito anche su alcuni dettagli, come per esempio la cauta vaghezza con cui nella relativa e pur ricca scheda biografica si accenna al processo a don Milani. La parte dedicata al fascismo è comunque forse la migliore di tutto il libro ed è quasi un testo a sé. Avvalora la tesi discutibile di una differenza di fondo tra Gentile e il regime, però fornisce al lettore ampio materiale per farsi la propria idea. Ma il contributo specifico del volume, e in questo aspetto il dilungarsi del testo è un merito, è quello della storia e cronaca degli ordinamenti scolastici. Non soltanto le grandi leggi, ma le ordinanze e le note e direttive ministeriali di centocinquant’anni sono riassunte senza mai arretrare di fronte alla aridità del linguaggio e alla ripetitività di certi temi. Quale giudizio sulle storie di scuola italiana si ricavi poi dalla lettura distesa e continuativa di questa esposizione, credo che dipenda dalle esperienze precedenti del lettore. A me ha confermato l’impressione che la scuola, compresa proprio quella privata, ha sofferto e soffre di una asfissiante colonizzazione normativa e gerarchica a cui hanno dato il proprio contributo con intenzioni diverse sia le destre che le sinistre. La storia sociale della scuola è presente anche con una notevole attenzione alla condizione degli insegnanti e soprattutto delle maestre e dei maestri nella prima parte del volume, mentre si esaurisce nella fase dedicata al post-Sessantotto in cui non sono in sostanza nemmeno toccati i temi chiave della condizione degli intellettuali né la situazione del mercato del lavoro nella globalizzazione, poco le vicende sindacali e direi per nulla il tema decisivo del rapporto tra cultura del libro e nuovi media e internet. L’attenzione alla cultura di massa arriva infatti solo fino a Mike Bongiorno. Nella parte finale emergono alcune un po’ sbrigative apologie, per esempio della legge sulla parità scolastica, con una sorta di storicismo da compromesso storico postumo. Per un giovane lettore di oggi è come minimo fuorviante leggere che la parità avrebbe archiviato il «vieto laicismo risorgimentale»: come se non fossero mai esistiti il Concordato e l’insegnamento di religione cattolica, del resto trattati in questo stesso volume. Ci sarebbe molto da osservare sul modo sbrigativo con cui scioperi e occupazioni degli studenti degli ultimi anni sono considerati semplici danni alla pubblica istruzione: ognuno ha diritto di pensarla come vuole, ma non di spacciare le proprie opinioni come fatti. Il volume di Nicola D’Amico obbedisce abbastanza alla regola che l’influenza dei pregiudizi o se si vuole delle preferenze dell’autore si faccia sentire tanto più, quanto più la trattazione si avvicina alla contemporaneità. E le preferenze di Nicola D’Amico sembrano quelle adatte ad alimentare la coscienza di sé di un tipico dirigente scolastico in carriera, ben istruito, centrista e sensibile al politically correct, ma pronto a collaborare con qualsiasi governo della seconda e terza repubblica. Perché la scuola italiana da Casati (1859) in poi è roba dei governi e questo libro lo mostra in modo inequivocabile. école numero 78 pagina 39 LIBRI Franca D’Agostini, Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico, Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp. 257, euro 15 Q P atrizia Aldrovandi e Francesca Boari (francesca_boari@ libero.it) sono entrambe di Ferrara. Patrizia è la madre di Federico Aldrovandi, il ragazzo ferrarese trovato morto col corpo sfigurato all’alba del 25 settembre 2005 nei pressi dell’ippodromo. Francesca ha scritto Il prezzo del riscatto, la sua opera prima, pubblicata nel 2008. Le due donne non si conoscono, ma Patrizia – come lei stessa comunica nell’ultima pagina di Aldro – era rimasta colpita dai colloqui-monologo dei personaggi di Francesca, non molto distanti da quei monologhi senza inizio e senza fine in cui lei da quel maledetto 25 settembre sprofondava. Dal loro incontro nasce Aldro. «La consegna di questi ricordi alla collettività è un grande regalo a Federico» sono le ultime parole con cui Patrizia si congeda da Francesca e dal libro. Aldro si presenta subito come un grande affresco del dolore, e in questo senso è un “romanzo” e non una cronaca: per i sentimenti che vi sono rappresentati, tutti riconducibili al comune denominatore di un dolore che viene percepito come «condizione inamovibile» che muta l’esistenza delle persone. «Ha cercato di scappare. Di non farsi prendere… Quando lo hanno immobilizzato, ammanettato a pancia in giù non ha più avuto la forza di respirare... Lo hanno lasciato lì sulla strada. Cinque ore. Poi lo hanno portato all’obitorio. E solo allora sono venuti ad avvisarci. Perché?» si legge nella lettera di Patrizia. Mutata è l’esistenza di Stefano, il fratello minore di Federico, che vive con l’inconsapevolezza della sua età il dramma che ha colpito la sua famiglia. Piange nella stanza col letto mai disfatto del fratello, ma avrebbe voglia anche di altre cose... Tace il padre, Lino, che non trova le parole. E l’avvocato che abbraccia con determinazione la ricerca di verità della famiglia Aldrovandi è anche lui oppresso da un dolore quotidiano: cure mediche hanno alterato forse irrimediabilmente la salute della moglie… Cause diverse… Che relazione col perdono? Al centro dell’affresco è Patrizia, la “madre coraggio” in cerca della verità, che non è voler scoprire il perché, ma voler scoprire come si sono svolti i fatti, quei fatti che le hanno distrutto il figlio, che versioni di comodo hanno teso a screditare. L’elegia intreccia struggente dialogo e ricordi… Gli anni della scuola elementare, le maestre, il campetto dei giochi pomeridiani dopo la scuola... Poi gli anni dell’adolescenza, la comunicazione più rara e difficile, il distacco inevitabile. Responsabilità, colpe? Sono le ossessioni dello stesso avvocato, alle prese nel suo dolore con una figlia adolescente che sente sfuggire inesorabilmente al rapporto protettivo e spontaneo dell’età della fanciullezza. Tra le pagine più efficaci, gli interventi diretti di Federico, nel suo ultimo sabato di vita; tutto è percepito in una prospettiva già deformata dalla separazione che “sa” imminente. “Lo sa”, ma agli occhi di tutti (e anche di se stesso) si comporta come sempre... Lo ritroviamo all’ippodromo, in quella sua alba tragica, le paure di fronte ai poliziotti, grigi, senza volto come emersi dalla nebbia: si sente strano, non ha con sé i documenti e ha paura che una denuncia non gli consenta di ottenere l’ambita patente... Poi, nel silenzio della notte, con la madre: «Appiccicati a me, fiatami dentro, lenisci quella macchia scura che m’hanno lasciato sul petto, restituiscimi la voce che mi hanno tolto, gli occhi che mi hanno chiuso, la vita che mi hanno preso...». Il legame forte degli anni dell’infanzia riaffiora intatto, consolatorio. Il libro si conclude con l’esito della vicenda giudiziaria, che il 6 luglio 2009 vede condannati in pri- humus uesto prezioso libro mi ha ricordato certi libri settecenteschi degli autori clandestini che nascondevano dietro ad analisi apparentemente svagate un altro obiettivo, solitamente di critica radicale del potere. Mutatis muntandis, l’autrice, che insegna Filosofia della Scienza al Politecnico di Torino e Analisi del discorso politico all’Università del Piemonte Orientale, ci regala un brillante e chiaro manuale di teoria dell’argomentazione dietro al quale si palesa una critica del contesto pubblico e politico in Italia. Il libro è così anche un’analisi della politica oggi quale luogo della “costruzione” delle “false coscienze” si sarebbe detto in altri tempi. E l’analisi si completa con l’invito di ritrovare una forma di libertà, di uso libero e consapevole del pensiero. L’ipotesi dell’autrice è di rivitalizzare il senso della verità attraverso la consapevolezza delle regole del dibattito pubblico, analizzando le manipolazioni, le fallacie del modo di argomentare. La verità, aspro e problematico concetto filosofico, è qui una sorta di ipotesi di lavoro, un’idea relativa che viene sostenuta da un metodo, da una disciplina. Il decadere della pratica argomentativa oggi (si pensi agli estenuanti dibattiti televisivi, alle dichiarazioni contraddittorie dei politici, specie di centro-destra ed il libro è puntuale nel riportare frasi e citazioni tratte da trasmissioni tv e giornali) ha bloccato la dinamica politica stessa nonché della costruzione di un pensiero dell’opinione pubblica appiattendola su alcuni schemi, per altro errati o mistificanti, che riducono la possibilità di intervenire lucidamente nella “cosa pubblica” da parte dei cittadini. L’idea di D’Agostino è che gli italiani non siano affatto stupidi quando seguono certi slogan sconclusionati di leader come Berlusconi, ma pensa che vi sia in giro troppa superficialità ed ignoranza che hanno avvelenato l’orizzonte del dialogo e della dialettica. La metafora fondamentale è quella del “pozzo avvelenato”: così si chiama la procedura di delegittimazione che investe tutto ciò che una persona afferma. Lo spazio pubblico è saturo di cattivi argomenti, specie nel pensiero post-ideologico, che avvelenano appunto sistematicamente la verità. Quanto più s’impara a valutare gli argomenti e distinguere le fallacie argomentative dei politici e delle persone pubbliche in genere, tanto più sarà possibile essere meno manipolati. La fiducia nella filosofia, nella dialettica e nell’intelligenza umana è il filo del libro. Non è detto che sia sufficiente, tutto questo, ma in un mondo in cui i “trascendentali” si sono alleggeriti da qualche parte si deve cominciare. Ed anche gli insegnanti e gli educatori dovrebbero leggere e studiare il libro per meglio capire il mondo in cui viviamo, migliorare se stessi per l’esercizio della professione, lottare contro il potere dell’ignoranza e della distrazione. Come diceva Nanni Moretti nel film Palombella Rossa: «Chi parla male, pensa male». Stefano Vitale LIBRI Francesca Boari, Aldro, edizioni Corbo 2009, pp. 139, euro 16 école numero 78 pagina 40 mo grado i quattro agenti di polizia che all’alba del 25 settembre infierirono sul corpo di Federico. Grande eco ha avuto il libro a Ferrara. Poi, su Aldro scende il silenzio: introvabile nelle librerie cittadine. I quattro poliziotti condannati a tre anni e mezzo di reclusione hanno presentato l’appello in Tribunale… Antonia Sani GRAPHIC NOVEL Zeina Abirached , Mi ricordo Beirut Edizioni Beccogiallo, collezione “Cronaca estera”, pp. 96, 2010, euro 12.90 (http://www. beccogiallo.it) Z humus eina Abirached, che ora vive a Parigi, racconta con ironia i momenti drammatici vissuti in Libano da bambina e la “normalità“ della guerra: il fratellino che colleziona schegge di granate inesplose, i blackout che interrompono i cartoni animati trasmessi in TV, lo zaino sempre pronto accanto al letto con le cose preziose da portare con sé in caso di fuga (poche foto, una torcia, l’agenda, Tintin, il walkman, una cassetta dei Beatles, una matita, le batterie, un peluche), gli spostamenti in auto con tutto il necessario per sopravvivere fuori casa (acqua, tramezzini, cuscini…), il parabrezza che non si ripara più, perché si romperebbe nuovamente, il giradischi a tutto volume per coprire il rumore delle bombe. Con Mi ricordo Beirut Zeina Abirached prosegue un percorso iniziato con Il gioco delle rondini e probabilmente non ancora concluso, dal momento che l’autrice afferma: «Chissà che un giorno non decida di raccontare il mio arrivo in Francia nel 2004 e il mio attuale rapporto con il Libano». Abirached intreccia la propria storia con quella del suo paese, intervalla ricordi e «non ricordo», paure e tentativi di vivere, come una qualsiasi bambina, la quotidianità. Ma filastrocche, giochi, balli, ore davanti alla tv sono intercalati a scontri sulla strada verso la scuola, pullman bruciati, barricate, fughe dai bombardamenti. Quasi sempre si riesce a sorridere, anche se amaramente. Non nelle pagine conclusive: un forte temporale che riporta Abirached, adulta, dalla realtà di Parigi alle bombe di Beirut negli anni dell’infanzia e anche alla dolorosa preoccupazione per il Libano e per i suoi familiari lontani durante l’attacco israeliano dell’estate del 2006. Un fumetto prezioso per avvicinare ragazze e ragazzi alla storia contemporanea di un paese affacciato sul nostro stesso mare. Celeste Grossi titola Histoire de l’ouvrier e non è certo casuale il fatto che il brano di Stravinsky racconti (con una recitazione cantata sulla musica che Daniele Sepe trasforma in un rap) di un soldato che cede il suo violino (la sua anima) al diavolo in cambio di ricchezze. I brani che si succedono nel Cd fanno riferimento a diversi generi e stili: dalla musica classica al jazz, dal rap alla musica popolare, al rock d’avanguardia. Spesso un genere si innesta nell’altro, con continui rimandi e richiami. Si passa quindi dal Meckie Messer di Weill a Luglio, agosto, settembre (nero) degli Area; da Campagna dei Napoli Centrale a brani popolari messicani e greci. Ovviamente i pezzi sono rielaborati, trasformati, contaminati con grande intelligenza e sono lo spunto per riflessioni dissacratorie su tematiche quali l’immigrazione (i fatti di Rosarno sono raccontati con l’alternanza di testi in arabo e dialetto cantati da Marzouk Mejri e Auli Kokko sulla musica di Campagna), il contrasto tra generazioni, l’economia, il mercato e le speculazioni finanziarie, le guerre, i luoghi comuni della sinistra, Gaza e la Palestina, i problemi di Napoli e Scampia. Le tematiche, riprese dal dibattito sulla “bacheca” di Daniele su Facebook (cui il titolo del cd allude ironicamente), sono trattate in modo tagliente, così come dura e dissacratoria è la musica. Non c’è nessuna concessione al compromesso, alla conciliazione, alla retorica; nessuna consolatoria soluzione. C’è invece una graffiante ironia, molta cattiveria che si oppone al “buonismo” imperante e la riproposizione della durezza dello scontro di classe. Al consueto gruppo di musicisti con cui collabora da tempo Daniele Sepe, si aggiungono Tony Esposito, Sandro Oliva e il rapper napoletano Shaone: gruppo composito che dà vita a un cd interessante anche se “scomodo” e sicuramente fuori dagli schemi. MARIATERESA LIETTI MUSICA Daniele Sepe, Fessbuk, Il manifesto Cd, 2010, euro 12 I l Cd, dopo la nota pernacchia di Alberto Sordi ai lavoratori, comincia con la citazione dell’Histoire du soldat di Stravinsky. Citazione musicale, ma anche riferimento letterario visto che il primo pezzo si in- VIDEO-INCHIESTA La Pelle delle periferie P uò essere richiesto gratuitamente alla redazione di école [[email protected]; il trailer del filmato può essere scaricato dal sito di école www.ecolenet.it] il video di interviste a nuovi cittadini italiani realizzato da alcuni allievi dell’Its “Hertz” della periferia di Roma. Storie di immigrazione “ordinarie” e intense per l’immediatezza della relazione che si sviluppa quando una scuola multietnica esamina la realtà multietnica del proprio territorio. Pelle racconta l’integrazione di tre studenti (un rifugiato politico proveniente dal Ruanda, un ragazzo del Congo arrivato a Roma, dopo un anno passato a Padova, un giovane brasiliano adottato all’età di cinque anni da genitori italiani). I racconti di vita si intrecciano con episodi del film-inchiesta Per strade diverse. Il film è stato realizzato dagli studenti del laboratorio video, inizialmente riservato a studenti immigrati e poi aperto anche ad altri su loro richiesta, condotto dal regista Ernesto Caprio. La video-inchiesta Pelle (35 minuti) − da un’idea di Ernesto Caprio realizzata da Tresor Ntumba Betu, Gabriele Biancucci, Andrei Bogdan Grigorescu, Marco Ceccarelli, Francesco Fratarcangeli, Jiuru Jean Hilaire, Alek Musu, Martin Simeonov dell’Itis Hertz di Roma − è stata realizzata con il contributo della Provincia di Roma, Unità di progetto, Ufficio metropolitano per la scuola. école numero 78 pagina 41 STEFANO VITALE I anni verdi In memoria di uno scrittore ignoto l 2010 non è solo l’anno di Gianni Rodari. Dovrebbe essere anche l’anno di Silvio D’Arzo che nasceva a Reggio Emilia il 6 febbraio 1920 da Rosalinda Comparoni, originaria della montagna reggiana, e da padre rimasto ignoto per l’anagrafe. Ed oggi egli è ignoto a molti lettori. Come scrivono su www.literary.it: «La sbandata esterofila che i ragazzi italiani hanno preso a cominciare dagli anni Cinquanta per colpa degli editori (è più sicuro ristampare successi stranieri comprovati che ricercare talenti in patria) ha causato una generale ignoranza sui nostri autori, che persiste tuttoggi. Tra coloro ai quali questa politica culturale dopoguerra ha portato più sfortuna c’è indubbiamente Silvio D’Arzo, nome di penna di Ezio Comparoni: la figura più pura di intellettuale che abbia avuto l’Italia del nostro tempo». Tutte le sue opere sono riunite oggi nel volume Opere edito da MUP (Monte Università Parma editore, http://www. mupeditore.it/) nel 2003 e molte informazioni sui suoi libri sono reperibili on line (www.istitutodarzo. it). Maschere è un volumetto che raccoglie sette racconti: segna il precoce esordio di Comparoni, edito nel 1935 a soli 15 anni. Il ricorso allo pseudonimo (qui solo parziale: Raffaele C.) fa pensare a Pessoa, con invenzioni diverse (Andrea Colli, Sandro Nedi o Nadi, ecc.). Ezio Comparoni superò l’esame di maturità classica a soli sedici anni: lo preparò Giuseppe Zonta, maestro ed autore di opere di critica letteraria, come L’anima dell’Ottocento e la Storia della Letteratura Italiana. Anche l’esperienza poetica di Ezio Comparoni fu precoce: nel 1935 esce il volume Luci e penombre. All’Università di Bologna, incontrò docenti come Calcaterra, Funaioli e Longhi, e si laureò in Lettere ventunenne. Faceva tutto velocemente, voracemente, forse. Il romanzo Buon Corsiero, già elaborato come Ragazzo in città nel 1939 (Garzanti rifiutava la pubblicazione), fu respinto dagli editori anche nel 1942 insieme a L’Osteria dei ricordi e L’uomo che camminava per le strade. Tipico racconto di formazione, esprime un forte e poetico senso di “diversità e provvisorietà” come capitava in quegli anni anche a Cesare Pavese. All’insegna del Buon Corsiero viene pubblicato da Vallecchi nel 1942 e narra dell’intrusione di un fantastico diavolo-funambolo fra gli ospiti e i servitori di una settecentesca locanda. Inserito dalla critica nell’ambito del realismo magico, piacque per la sua leggerezza ed ironia. Ad esso è legata la fama dello pseudonimo Silvio D’Arzo. Nel 1940 co- école numero 78 pagina 42 minciava ad insegnare e a scrivere racconti per ragazzi (“Una storia così”, “Nostro lunedì”) e saggi critici. Nel 1947 insegna nelle scuole superiori di Reggio Emilia e prende corpo il romanzo Casa d’altri. Ma già alla fine del 1951 s’ammala e nei primi mesi del 1952 muore all’età di 32 anni. Bompiani (Emilio Cecchi che lo elogia ma non lo avalla) e Einaudi (Cesare Pavese) rifiutano la pubblicazione di Casa d’altri, bocciata in seguito anche da Vallecchi: «un racconto perfetto» (a detta post mortem di Eugenio Montale sulle pagine del Corriere della Sera). Il titolo Casa d’altri viene dall’osservazione che riporta D’Arzo nella “Prefazione” al romanzo che aveva in progetto, Nostro lunedì di Ignoto del XX secolo: il mondo non è casa tua. Ma D’Arzo scrive anche racconti bellissimi per ragazzi: Il pinguino senza frac, Tobby in prigione, Penny Wirton e sua madre (reperibili anche da Einaudi). Il primo fu scritto tra il 1947 ed il 1949 ed ha una evidente dimensione autobiografica. Il racconto funziona come metafora liberatoria dalle ossessioni per le condizioni di emarginazione e indigenza vissute dall’autore. La storia del pinguino Limpo è ancora un racconto di formazione: le tappe del distacco dai genitori, delle difficoltà del mondo segnano l’itinerario del pinguino. D’Arzo non è mai patetico o lacrimoso: ciò che lo anima è un senso di giustizia sociale che assume espressamente la natura della polemica sociale. Il pinguino è povero, così povero da non poter andare a scuola e da non potersi comprare un frac ma non demorde mai. Simile è l’impianto narrativo di Tobby in prigione, ambientato in una tribù di castori costretti alla cattività nelle gabbie d’allevamento e Penny Wirton, ambientato nell’Inghilterra dei primi del settecento dove il protagonista è un ragazzo alla ricerca di un padre mai conosciuto. Stevenson, Twain, Wilder, Conrad, Kipling sono i suoi diretti e luminosi riferimenti e ciò basti a proteggere D’Arzo da ogni critica di “facile populismo”. D’Arzo aveva una coscienza politica di scrittore autentico non ripiegato su se stesso, certo sostenuto dalla riflessione autobiografica. I suoi personaggi sono in cerca di qualcosa di essenziale per la loro vita, “qualcosa che manca” ma che cercano. Come la dignità che ci sta sfuggendo di mano in un mondo narrativo troppo popolato da maghi e streghe, troppo chiuso su computer e cellulari, che sta dimenticando il vasto mondo del guardare oltre quel che siamo accompagnando ragazzi nella costruzione della loro personalità più profonda. TEXT Gli ultimi giovani o il colore delle passioni Parlare dei giovani e delle loro passioni – per gli adulti – significa in primis parlare anche di se stessi. Un’occasione per misurare lo scarto tra cosa si è diventati e chi si pretenderebbe di essere. Guardarsi allo specchio, riflessi in parole e giudizi su chi dovrebbe starci più a cuore. E di norma non riconoscersi, perché troppo cambiati. Una massima di saggezza, una regola aurea per mettere a fuoco il soggetto osservato: non si devono giudicare gli altri per quello che fanno, ma per quello che fanno quando gliene si offre l’occasione. Si può, forse si deve, parlare male dei giovani e delle loro passioni latitanti e mediocri, a patto di prenderli sul serio ENRICO DONAGGIO * «Ho dimenticato la perla che i miei genitori mi avevano mandato a cercare. La pesantezza del loro cibo mi ha fatto cadere in un sonno profondo». [Da Inno della perla. Atti apocrifi di Tommaso] N on servono convegni o studi dottissimi per disperare dei giovani italiani e di certe loro passioni. Molto meno sembra bastare. Pochi passi la notte, in qualsiasi piazza di metropoli o provincia, mostrano le migliori energie del nostro tempo consumarsi in un infinito happy hour, ultimo emblema di una nuova tristezza. Poche bracciate in internet, nei siti di self-help adolescenziale, afferrano messaggi in bottiglia dentro a un mare di squali ignoranti: «Domanda incerta. Tema sulle passioni dei giovani… mi aiutate? mi serve qlk input x svolgere qst tema, la traccia è: quali sono le passioni ke akkomunano i ragazzi di oggi?? 10 pnt assikurati!!!! kome poxo iniziare?? // te li elenco… il tema però te lo fai tu… allora: pc, amici, tv, musica, fumo, alcol, sport, divertirsi, avere vestiti firmati … possono bastare?»1. Brilla un lampo inedito nello sguardo che condanna un materiale umano così sconfortante per qualsivoglia intervento educativo? In fondo, verrebbe da dire, è sempre andata così. La geremiade generazionale rappresenta un logoro luogo comune per ogni pedagogo con velleità di critico della cultura. Se onesta, tuttavia, questa lamentela sul fatto che la carne frolla sia per definizione più tonica e vitale di quella fresca, include sempre una chiamata di correo. Un esempio, tra i molti: «I figli che vediamo intorno a noi sono figli “puniti”: “puniti”, intanto, dalla loro infelicità, e poi, in école numero 78 pagina 43 TEXT futuro, chissà da che cosa, da quali ecatombi… Ma sono figli “puniti” per le nostre colpe, cioè per le colpe dei padri»2. Un verdetto che consente di stipulare alcune utili clausole di metodo per chi voglia a frontare il tema. Anzitutto l’assunto più ovvio e rimosso: parlare dei giovani e delle loro passioni – per degli adulti – significa in primis parlare anche di se stessi. Un’occasione per misurare lo scarto tra cosa si è diventati e chi si pretenderebbe di essere. Guardarsi allo specchio, riflessi in parole e giudizi su chi dovrebbe starci più a cuore. E di norma non riconoscersi, perché troppo cambiati. Quindi una massima di saggezza, una regola aurea per mettere a fuoco il soggetto osservato: non si devono giudicare gli altri per quello che fanno, ma per quello che fanno quando gliene si offre l’occasione. Si può, forse si deve, parlare male dei giovani e delle loro passioni latitanti e mediocri, a patto di prenderli sul serio. Non attraverso atti d’amore indulgente, ma nemmeno con retoriche o scommesse al ribasso; quid pro quo, una confusione di ruoli e valori che mira a toglierli di mezzo, liquidarli – simbolicamente, e non solo – senza pagare il prezzo, andando preliminarmente assolti. école numero 78 pagina 44 Energie più fresche «I figli che ci circondano, specialmente i più giovani, gli adolescenti, sono quasi tutti dei mostri. Il loro aspetto fisico è quasi terrorizzante, e quando non è terrorizzante, è fastidiosamente infelice. Orribili pelami, capigliature caricaturali, carnagioni pallide, occhi spenti. Sono maschere di qualche iniziazione barbarica. Oppure, sono maschere di una integrazione diligente e incosciente, che non fa pietà». Il paesaggio antropologico degli anni Sessanta e Settanta dipinto da Pasolini; uno squarcio blasfemo nello sfondo mitologico e valoriale entro cui si incastona e legittima la condanna di tutte le generazioni successive. Quelli del Sessantotto e del Settantasette: per sé e per tutti la prima e ultima meglio gioventù; i detentori esclusivi di passioni accese, quelle che oggi sarebbero ridotte in cenere. La più castrante delle favole che troppi genitori hanno raccontato – ai figli e a se stessi – prima di mettersi a tavola e a letto per qualche decennio. Ma la premessa di questa foto di gruppo, inclemente e appassionata, risulta decisiva: «Ho osservato a lungo in questi ultimi anni, questi figli. Alla fine, il mio giudizio, per quanto esso sembri anche a me stesso ingiusto e impietoso, è di condanna. Ho cercato molto di capire, di fingere di non capire, di contare sulle eccezioni, di sperare in qualche cambiamento, di considerare storicamente, cioè fuori dai soggettivi giudizi di male e di bene, la loro realtà. Ma è stato inutile». Quanti oggi potrebbero ripetere in buona fede queste parole? L’immonda gerontocrazia italiana ha mai cercato di capire quei «bamboccioni» che, in modo schizofrenico e secondo le convenienze, fustiga e ingozza? Ha mai sperato in un effettivo cambiamento di quella condizione di minorità cronica, confortevole e umiliante, offrendole qualche occasione di grandezza ed emancipazione? O ha preferito liquidare il problema con un bacio alla nuca, dolcissimo italico crimine? Incurante di cosa comporti per una società rinunciare all’apporto delle sue energie più fresche. E del fatto, eclatante e decisivo, che sono proprio gli adulti a incarnare oggi il materiale umano in cui tutte le passioni paiono davvero spente. Tranne naturalmente quelle onnipotenti ed egolatriche riversate non tanto sui giovani, ma su quella loro versione, povera e impoverita, che sono i “figli”. Stelle polari e buchi neri di una nazione sterile – in Italia, da tempo, nascono più imprese che bambini – che sulla propria carne reca inciso a sangue il motto “tengo famiglia!”. Insomma: biasimare i giovani perché vivono a passioni spente significa sostenere che li si vorrebbe capaci di stare al mondo con una convinzione e una progettualità, una partecipazione e un entusiasmo che noi siamo i primi a non avere. Un dato che collima con il paesaggio emotivo tratteggiato dalle diagnosi epocali oggi più in voga: un coacervo di pazienza (la capacità di sopportare il dolore senza reagire, uno dei tratti più straordinari dell’Italia postmoderna), rassegnazione (riflesso del dogma che qualunque azione politica sia per definizione destinata al naufragio) e di tanta ottima noia. Cosa chiedere di più, in fondo, quando tutti i bisogni materiali sono soddisfatti? E, al contempo, non sembra esserci nulla per cui valga la pena mettere a repentaglio quel che si è ottenuto. Niente per cui lottare o soffrire. Questo il crampo passionale delle democrazie opulente. Lo scenario da «fine della storia» descritto nel più snobbato dei libri recenti. Meglio di così si muore, la vita è tutta qui. Il dogma di Fukuyama: «Noi possiamo anche immaginarci un domani molto peggiore dell’oggi… Ma non possiamo raffigurarci un mondo che sia essenzialmente diverso dall’attuale, e nello stesso tempo migliore»3. Il desiderio di desiderare la vita Cosa si è fatto per rendere consapevoli i giovani di questo scenario? Per tutelarli dall’avanzata di un deserto emotivo dove fioriscono gli “ultimi uomini”, consumatori sazi e famelici, programmaticamente ed eternamente immaturi4. Uno dei grandi meriti della cultura di sinistra è stato lo smascheramento, la critica, la decostruzione delle Il gradiente termico delle passioni Le passioni sono sempre accese; non si spengono, si trasformano. Mai proprietà privata, perché sature di storia, società e politica. Il singolo individuo, il pulviscolo di atomi irrelati e autistici che affolla le piazze e diserta – almeno emotivamente – le scuole è illusione prospettica. Soggetti al tempo, i giovani sono punto di cristallizzazione di contrapposte dinamiche. Attivi e passivi, plasmano e vengono plasmati (impossibile non pagare un tributo al proprio tempo, che forma e deforma). Il vuoto non esiste in natura, nemmeno in società. Quel che percepiamo come assenza di pressione atmosferica cela il volto dell’ovvio o del fatale. Non si avverte perché sembra naturale o invincibile. Uno strapotere a cui adattarsi o soccombere. Le passioni posseggono un gradiente termico e cromatico. Dall’incandescenza al gelo, passando per infiniti gradi intermedi. Dal rosso al nero, attraverso le tiepide sfumature del grigio7. Rosse e calde le passioni suscitate dalle aspettative di mutamenti profondi, dalla speranza in uomini e mondi nuovi, per cui lottare, sacrificarsi, al limite morire. Un amore per il mondo che allarga la vita, predispone al dono di sé in vista del futuro. Misurati esclusivamente con questo metro i giovani di oggi non sono più tali, smarriscono i segni particolari del loro identikit: sono conservazione, non avanguardia; pazienza, non impazienza; adattamento, non conflitto; presente, non futuro. Nessuna ribellione, piuttosto un’astrusa forma di saggezza che attende di essere decifrata. Se elette a unica lente per mettere a fuoco il capitale emotivo del presente, le passioni rosse restituiscono un paesaggio arido e spoglio, un presente da cui ogni emozione è fuggita. Una distesa di ghiaccio su cui i giovani glissano e sfuggono a ogni presa. Lo spettro passionale contemporaneo conosce però altre tinte; meno gradevoli a uno sguardo gettato da sinistra, ma più brucianti che mai. Intanto le passioni grigie, agglutinate in un’indifferenza sui generis. Frutto non di un’assenza di coinvolgimento, ma di un disgusto che ha rinunciato persino a concedere al mondo l’onore della rabbia. Non l’effetto di un vuoto o di un’assenza di desideri, ma il frutto di un lavoro emotivo intenso. Necessario per schermare il dolore verso una vita sociale incapace di fornire occasioni e lotte di una qualche grandezza. Per pazientare, non per rassegnarsi. Questa indifferenza testimonia una capacità di sopportare, non rinunciando, en attendant, a scavarsi un rifugio, una nicchia di vivibilità e soddisfazione che consenta anche di amare il mondo, non soltanto di adattarsi a esso o rifiutarlo. Quindi le passioni nere, più accese e roventi che mai. Quelle del mito, della legge e dell’ordine, dell’eccezione che si staglia sulla mediocrità diffusa. Aneliti di grandezza che riescono a trionfare solo in forma livida e asfittica: il rancore, il risentimento dei penultimi a danno degli ultimi. Chi sa parlare a queste passioni, oggi in Italia conquista i giovani e il potere8. Capirle significa esplorare un continente sempre più ignoto a quello sguardo nostalgico e frettoloso che descrive i giovani come apatici e integrati. TEXT illusioni, al fine di sprigionare le migliori energie del presente. Ma questo atteggiamento e i suoi effetti oggi hanno perso credibilità e fascino, almeno tra i giovani. Lo ha colto molto bene Domenico Starnone, regalando a una studentessa un giudizio sugli adulti italiani a cui dovrebbe essere dedicato più di un convegno: «Quello che sanno delle cose della vita non gli serve a niente, e non li fa neppure essere felici: qualsiasi cosa sia, ciò che hanno capito non gli ha cambiato il modo di stare al mondo»5. In palio, per ambo i fronti di questa stranissima guerra fredda, vi è qualcosa di simile a una passione del presente. La capacità di reinventare scampoli di felicità e amore per un mondo che, a tutta prima, ingenera solo indifferenza o apatico disgusto. Servirebbe una cultura nuova, diversa, che unisse un vecchio tratto virtuoso – defatalizzare il mondo e la vita, privarli del loro carattere di inesorabile destino – a un tratto non tanto edificante, quanto entusiasmante: il desiderio di desiderare la vita6. Sarebbe questa una strategia promettente per smontare l’alibi consolatorio dell’«epoca delle passioni tristi» e proporre intuizioni educative benedette da una freschezza nuova, tutta da inventare. Contro il trionfo di una mestizia ipocritamente coinvogliata sui giovani bisognerebbe da un lato valorizzare il senso di liberazione da ideali pedagogico-politici che a lungo hanno imposto all’esistere un orizzonte di ulteriorità frustrante, abbinato a una condanna talvolta spietata della sua imperfezione; gustarsi il piacere per prospettive di vita finalmente adeguate alle proporzioni del singolo e delle sue effettive possibilità. Dall’altro, si tratterebbe di decifrare un senso di perdita e angustia, uno strano pessimismo che si fatica a organizzare. Sensazioni divergenti radicate nella percezione che la vita oggi è tutta qui: un godimento del presente che non intende sacrificarne un attimo sull’altare di un domani possibile; una felicità esile che non può però essere ridotta soltanto alla magnifica ossessione di una me generation innamorata del proprio ombelico. La diagnosi «la vita è tutta qui» risulta infatti ambigua, capace di suscitare il realismo dell’adattamento cinico o apatico, ma anche l’impazienza dell’hic et nunc, la consapevolezza del «se non ora, quando?». école numero 78 pagina 45 TEXT Il paesaggio poltitico e pedagogico delle destre «Pasquale aveva una rabbia, ma una rabbia impossibile da cacciare fuori. Eppure la soddisfazione è un diritto, se esiste un merito questo dev’essere riconosciuto. Sentiva in fondo, in qualche parte del fegato o dello stomaco, di aver fatto un ottimo lavoro e voleva poterlo dire. Sapeva di meritarsi qualcos’altro. Ma non gli era stato detto niente. Se n’era accorto per caso, per errore. Una rabbia fine a se stessa, che spunta carica di ragioni ma di queste non può far nulla… Quando tutto ciò che è possibile è stato fatto, quando talento, bravura, maestria, impegno, vengono fusi in un’azione, in una prassi, quando tutto questo non serve a mutare nulla, allora viene la voglia di stendersi a pancia sotto sul nulla, nel nulla. Sparire lentamente, farsi passare i minuti sopra, affondarci dentro come fossero sabbie mobili. Smettere di fare qualsiasi cosa. E tirare, tirare a respirare. Nient’altro»9. Tra letteratura e fiction, una storia che illumina, nel suo congiungere infimo e sublime, vicende assai più diffuse e ordinarie. E che insegna qualcosa d’importante: esiste un nesso profondo, originario, tra la rabbia, la stima di sé e la capacità di nutrire la più rossa delle passioni: la speranza nella lotta per un mondo migliore per tutti. Non si tratta di sentimenti intimi, idiosincratici. Quando si concretizzano in prassi, quando divengono società, posseggono anche un preziosissimo momento politico che ne fa sintomi o verdetti sul mondo. Noi pensiamo di valere qualcosa e quando il nostro valore non viene riconosciuto ci adiriamo. Quando la nostra dignità viene offesa perché non dispone delle condizioni per realizzarsi, quando veniamo privati – da un’istanza anonima, dallo stato delle cose, prima ancora che da un individuo con un nome e un cognome – della nostra chance di fare qualcosa di grande, allora ci indigniamo. Come se esistesse un senso innato dell’ingiustizia. E sentiamo il bisogno di reagire, di indirizzare la nostra energia ferita verso qualcuno o qualcosa, di colpire il responsabile. Se il colpo può cambiare la situazione che ha generato l’ira, allora questa reazione dissoda il terreno su cui può crescere speranza sociale10. Se il colpo non muta nulla, se non si sa a chi assestarlo (a se stessi o a qualcun altro), insieme a chi sferrarlo, allora non restano che rancore e abbandono. Solitudine, talora disperata, talora avvolta nelle vesti più presentabili del cinismo, dell’indifferenza, del disincanto. Oggi è probabile che un giovane di nome Pasquale troverebbe sulla sponda destra del paesaggio politico e pedagogico qualcuno capace di parlare alla sua rabbia; di darle carne da colpire. Quella dello straniero di turno, secondo un copione trito ma efficace. A urgere sono dunque un pensiero e una pedagogia che svolgano la funzione di contravveleno alla disperazione di Pasquale. Che non lo lascino solo, nel senso più letterale del termine. Attraverso la messa a punto di una batteria di concetti, pratiche e narrazioni che consentano di sciogliere quella frustrazione, di non farla pietrificare; di conferirle dignità, associandola a quella della maggior parte degli esseri umani. Entro un orizzonte di passioni condivise. Capaci di articolare la rabbia provocata dallo spregio, di dare un senso e una causa all’umiliazione, evitando di farne un destino inevitabile, individuale e anonimo. école numero 78 pagina 46 Le passioni spente sono dunque meno numerose e intense di quanto potrebbe sembrare. Solo a uno sguardo frettoloso, nostalgico e complice i giovani paiono comportarsi come gli «ultimi uomini» di cui parlano molte diagnosi epocali: tutte le contraddizioni risolte, tutti i bisogni soddisfatti, una felicità piccola e meschina da consumare giorno dopo giorno. Reduci da nessuna battaglia, proprio come i loro genitori. Ma è difficile immaginare che si potrà essere a lungo giovani e adulti in questo modo. Perderemo – abbiamo già perduto – una o due generazioni. Nelle città italiane del futuro ci saranno forse strade o piazze intitolate, oltre che ai ragazzi del 1899, a quelli del 1989: i figli della nostra felicità. Dopo di che, senza di noi, comincerà una storia nuova, tutta da scrivere. NOTE 1. http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081118063143AAHM1l7. 2. P.P. Pasolini, “I giovani infelici”, in Lettere luterane, Einaudi, Torino 1976, pp. 5-12, da cui si prendono questa e le citazioni che seguono. 3. F. Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, Rizzoli 2007, pp. 67-68. 4. Cfr. F.M. Cataluccio, Immaturità. La malattia del nostro tempo, Torino, Einaudi 2004; J. Savage, L’invenzione dei giovani, Feltrinelli, Milano, 2009; B.R. Barber, Consumati. Da cittadini a clienti, Einaudi, Torino, 2010. 5. D. Starnone, Solo se interrogato, Feltrinelli, Milano 1995, p. 7. 6. Questo è il meglio che si può estrarre dalla melassa greco-nietzscheana in cui Umberto Galimberti annega le sue lucide diagnosi e le sue prognosi affabulatorie. Cfr. ad esempio L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2007. 7. Cfr. R. Bodei, “Il rosso, il nero, il grigio. Il colore delle moderne passioni politiche”, in S. Vegetti Finzi (a cura di), Storia delle passioni, Laterza, Roma-Bari, 1995, pp. 315-355. 8. Cfr. A. Bonomi, Il rancore. Alle radici del malessere del Nord, Milano, Feltrinelli 2008. Più in generale S. Tomelleri, La società del risentimento, Roma, Meltemi 2004. 9. R. Saviano, Gomorra, Milano, Mondadori 2006, pp. 45-46. 10. Cfr. P. Sloterdijk, Ira e tempo, Roma, Meltemi 2007. abb. L’abbonamento all’edizione su carta costa 45 euro (sostenitore da 70 euro) e dà diritto a quattro numeri della rivista e a é-mail, la lettera mensile di école. L’abbonamento telematico costa 20 euro e prevede l’invio via mail nel formato pdf di quattro numeri della rivista e di un anno di é-mail. 2010 Conto corrente postale n. 25362252 intestato a Associazione Idee per l’educazione, via Anzani 9, 22100 Como o inviando allo stesso indirizzo un assegno non trasferibile. Redazione: [email protected], www.ecolenet.it Abbonamenti: [email protected] Attivazione immediata: tel. 031.268425 école numero 78 pagina 47 trend la crisi? tutta colpa dei poveri, che non fanno più un sacco di debiti per riempirsi di cose inutili FINANCIAL TIMEs école numero 78 pagina 48
Scaricare
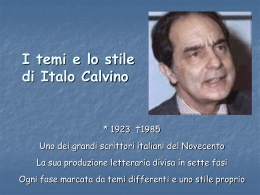
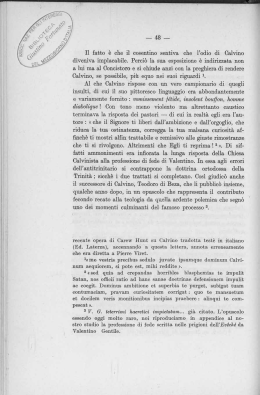
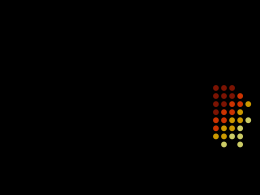

![Italo Calvino [h]](http://s2.diazilla.com/store/data/000054582_1-6f09ede360492035ba514f55116a45aa-260x520.png)