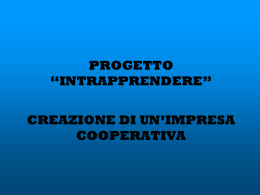Economia e gestione dell’impresa cooperativa Prof. Alberto Guenzi Economia e gestione dell’impresa cooperativa Obiettivi: fornire agli studenti delle LM strumenti di analisi per comprendere l’importanza e i caratteri dell’impresa cooperativa nel sistema economico italiano. Programma: decisamente interdisciplinare, svilupperà i seguenti contenuti: 1) Storia della cooperazione (docente e coordinatore: prof. Guenzi). 2) Finanza dell’impresa cooperativa, le banche cooperative (d&c: prof. Tagliavini). Economia e gestione dell’impresa cooperativa 3) Finanza dell’impresa cooperativa, le assicurazioni cooperative (d&c: prof. Tagliavini). 4) Accounting dell’impresa cooperativa (d&c: prof. Azzali). 5) Bilancio sociale dell’impresa cooperativa (d&c: prof. Azzali). 6) Economia e Marketing della cooperazione di consumo (d&c: prof. Lugli). 7) Partecipazione dei soci alla gestione della cooperativa e governance (d&c: prof.ssa Luceri). Economia e gestione dell’impresa cooperativa 8) Economia e gestione dell’impresa cooperativa nell’edilizia (d&c: prof. Sabbadin). 9) Economia e gestione dell’impresa cooperativa nei servizi (d&c: prof. Sabbadin). 10) Disciplina della cooperazione e del lavoro cooperativo (d&c: prof. Angiello). Per ciascun nucleo tematico saranno somministrati materiali didattici relativi agli aspetti teorici. Economia e gestione dell’impresa cooperativa Modalità didattiche e di accertamento Il corso è organizzato in forma intensiva (10 giornate di lezione). La giornata prevede 6 ore di lezione: nella mattinata (9-13) si svilupperanno gli aspetti teorici mentre nel pomeriggio (14-16) il testimone presenterà il caso di studio che poi sarà discusso con il docente. Le 10 giornate di lezione saranno distribuite nei due periodi del primo semestre con frequenza settimanale. Economia e gestione dell’impresa cooperativa Modalità didattiche e di accertamento Per l’accertamento è prevista una prova scritta, che consiste in 30 domande semichiuse e relative a tre dei 10 moduli in cui si articola il contenuto del corso. Il Corso prevede l’attribuzione di 10 CFU. Il Corso offre, inoltre, ai migliori studenti la possibilità di effettuare stage nelle imprese cooperative, al fine di approfondire anche a livello operativo questa forma di organizzazione aziendale. La cooperazione Profilo storico generale M. FORNASARI – V. ZAMAGNI, Il movimento cooperativo in Italia. Un profilo storico-economico (1854-1992), Firenze, Vallecchi, 1997. Modelli europei - Inghilterra La fine dell’età dell’oro. Le condizioni dei lavoratori. I probi pionieri di Rochedale (coop. di consumo). L’azienda modello di Owen: primo esempio applicativo Il settore del consumo resta l’asse portante del caso inglese. Modelli europei - Francia Saint-Simon promotore della cooperazione tra produttori. Fourier e il Falansterio. Blanc e gli ateliers nationaux. Il movimento delle Coop operaie cresce a dismisura dal 1893 e si dota di: (a) Coop di consumo; (b) Coop agricole. Modelli europei - Germania (1) Patria del credito cooperativo. Il primo caso (Anhausen 1840): spazio circoscritto, responsabilità illimitata, clienti solo soci. Il modello Raiffesen si diffonde con caratteri moderni (1876: viene fondato l’istituto centrale). Modelli europei - Germania (2) Il modello Hesse: ispirazione laica e liberale, dava più spazio alla concorrenza e meno all’imtervento statale. Le banche popolari: il credito cooperativo nelle città. Modello aperto, società per azioni. Un ruolo minoritario per la cooperazione di consumo. Modelli europei - Danimarca Un nuovo tipo di cooperativa: la latteria sociale. La valorizzazione del capitale umano. Altre forme. Il caso Italia (origini) Dopo l’Unità. Frattura tra società “mazziniane” e società “moderate”. Le società come fenomeno urbano. Il ritardo del Sud. Il caso Italia (pionieri) Matrice mazziniana: libera associazione tra produttori, alleanza capitale-lavoro. Viganò, La fratellanza umana (1873). Luzzati e la cooperazione di credito. 1864: Banca Popolare di Lodi. Rabbeno: dalla cooperazione come sistema all’impresa cooperativa. Rinascita e sviluppo Dalle ceneri di ENFC risorsero CCI (Confedera- zione Coperativa italiana, ispirazione cattolica) e poi LNCM (Lega di ispirazione socialista) . Dentro la Lega il crescente collateralismo col PCI portò nel 1952 alla fuoriuscita della componente laica e riformista (repubblicani e socialdemocratici) a costituire AGCI. Molto più tardi (1975) nacque la quarta centrale UNC (Unione nazionale delle cooperative). Le visioni di sistema (Lega) L’economia nazionale come modello tripartito. Allo Stato materie prime, energia, infrastrutture; al privato manifattura; alla cooperazione agricoltura e agroindustria, edilizia, GDO. In questo quadro scelta verso la competizione e verso la gestione manageriale, grande imprese. Le visioni di sistema (CCI) Modello difensivo. Ricorso allo Stato. Il consolidamento delle piccole imprese (agricole, artigiane…). La valorizzazione del risparmio (banche popolari e cassa rurali). Il ruolo delle centrali Rappresentanza. Assistenza tecnica. Controllo della associate. Promozione e coordinamento. Legge Basevi (1947) L’art. 45 della Costituzione. 1947 nuova legge. Una testa e un voto; limiti su controllo quote; inclusione obbligatoria; cessione quote solo autorizzata; variabilità del capitale. Requisiti: contenimento dividendo all’interesse legale sul capitale effettivo, riserve indivisibili. Vantaggi: esenzione fiscale da reddito e da imposte locali. Il problema del finanziamento Collegata alla legge l’istituzione di Coopercredito (in BNL) per finanziare l’intero sistema coop. Poi le centrali sviluppano prprie iniziative. Lega fonda Fincooper (1969), poi BANEC (1987) e FINEC. CCI prima contava sulla retre interna, poi Fondosviluppo (1992). AGCI prima Fincopra e dal 2007 Banca AGCI. Ulteriori interventi legislativi e legge del 1992 Divaricazione tra banche popolari e casse rurali e artigiane. Le prime escono dal sistema coop. Legge 1971: promozione dell’impresa coop con incentivi fiscali (interventi ad hoc su edilizia e consumo). Legge Marcora (1985): il caso CFI (centrali e sindacati). Ulteriori interventi legislativi e legge del 1992 Imprenditoria giovanile (1985). 1991: cooperative sociali. Legge del 1992: soci sovventori, azioni al portatore. La cooperazione nell’economia italiana del Secondo dopoguerra Andamento ciclico e anticiclico. Negli anni ’70 diffusione al Sud. La cooperazione organizzata (60% sul totale). Commento a Tab. 6-3. Tab. 6.3. Cooperative (UL) per settori (1992). Settore UL Agricoltura 15 011 49 769 3,3 Ind. Manifatturiera 6771 53 892 8.0 Edilizia 6656 43 807 6,6 Consumo e comm. 9177 51 054 5,6 Trasporti 4342 54 613 12,6 Credito e finanza 5758 55 057 9,6 Servizi a imprese 8115 35 311 4,4 Servizi privati diversi 12 012 75 965 6,3 Consorzi di cooperative 10 198 10 198 2,9 78 060 448 668 5,7 Totale Occupati Occupati x UL Cooperazione agricola Riforma agraria. Contratti di conduzione, allevamento cooperativo, servizi al settore. Trasformazione dei prodotti agricoli (vino, olio, latte, carni, grano. I consorzi: ANCA e AICA 1947 (Lega). Iniziative di settore UNIBON (carni), GIV (vino), CONERPO (ortofrutta). Settore della pesca. Distribuzione Forma tradizionale e forma avanzata. GDO nella Lega: Coop Italia, CONAD. GDO in CCI. Credito e assicurazioni Fino al 2000 continuità con il passato. Riorganizzazione delle banche popolari. Casse rurali: elemento fondante. Assicurazioni: piccole imprese nella CCI, UNIPOL in Lega. Produzione e lavoro Imprese manifatturiere: grande sviluppo dopo Legge Marcora (1983). Coop di costruzione. Colossi. Coop culturali e dei servizi. Cooperazione abitativa Proprietà divisibile e indivisibile. Nel dopoguerra forte spinta. Quadro frammentario. Cooperazione sociale Innovazione degli anni ’80. (nuove esigenze e nuovo ideale del welfare). Legge 1991 (prestatori, fruitori, volontari). Nuovo modello di cooperazione. La cooperazione La cooperazione italiana La cooperazione nella storia d’Italia Le origini ideali (seconda metà del XIX secolo). Le cooperative laiche e liberali (ispirazione mazziniana). Le cooperative d’ispirazione socialista. La cooperative di ispirazione cattolica. Le forme organizzative Distribuzione territoriale. Le organizzazioni di coordinamento (locali, di settore, nazionali). Nel lungo periodo i caratteri originari sopravvivono. Tra fascismo e ricostruzione ENFC (1926) si occupa soprattutto di cooperazione agricola. Dopo la Liberazione rinascono le tre centrali “storiche”: Legacoop, Confcooperative 1945, poi AGCI 1952, molto più tardi UNCI (1975). Art. 45. Profilo di una crescita La crescita del secondo dopoguerra deriva da: - aumento nel settore terziario; - aumento degli occupati per impresa; - la geografia della crescita premia i territori tradizionali (Emilia, Trentino) ma anche le nuove aree (Puglia, Sardegna). Le grandi imprese cooperative Tra 1971 e 2001 le imprese con almeno 500 addetti passano da 28 a 121. Tabella 7. Tabella 8. Tabella 9. Un caso di studio. Modelli di crescita (Legacoop) Il trend a partire dagli anni ’70. Dualismo dimensionale. Anni ’80: crescita della singola impresa, Fine secolo: crescita dei network di imprese. Il successo nel large retail Modernizzazione, (supermercati e ipermercati). La concorrenza col privato. Il mdello organizzativo. Altri settori trainanti Le costruzioni. Servizi. Agroindustria. Credito. Il modello di governance Tabella 10. Il successo deriva anche dal quadro normativo: da Giolitti a fine secolo XX.
Scarica