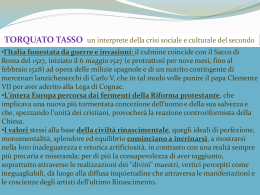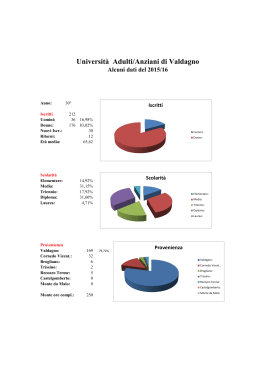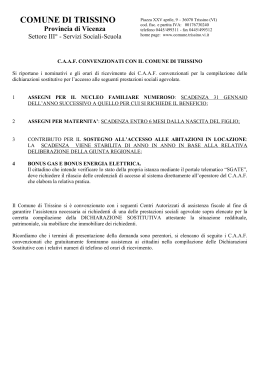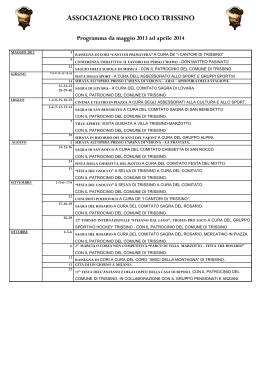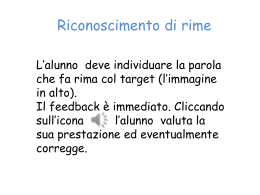UNIVERSITÀ DI PISA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Dottorato in Memoria Culturale
Il poema epico rinascimentale e l’«Iliade»:
dal Trissino al Tasso
Relatore:
Prof. Guido Paduano
Candidato:
Federico Di Santo
Correlatori:
Prof. Guido Baldassarri
Prof. Riccardo Bruscagli
Anno Accademico 2011/2012
1
2
Tesi di dottorato
Il poema epico rinascimentale e l’«Iliade»:
dal Trissino al Tasso
1. INTRODUZIONE
2. IL ROMANZO - Il romanzesco dall’Italia alla Gerusalemme
3. LA STORIA - La scelta dell’epica storica e il rapporto con le fonti
storiografiche
3.1. Storia e fonti storiche nella Gerusalemme del Tasso
3.2. Appendice: Schema dei contatti più rilevanti tra la Gerusalemme
liberata e la Cronaca di Guglielmo di Tiro
3.3. L’Italia del Trissino e la Guerra gotica di Procopio di Cesarea
4. L’EPOS - Il modulo epico dell’eroe necessario in Trissino:
4.1. Contesa e ritiro
4.2. Devastazione
4.3. Ritorno – marginalizzazione della vendetta
5. LA PIETÀ - Compassione per i nemici e ideologia: Omero e Virgilio
conciliabili
6. LO STILE - Questioni stilistiche del poema epico rinascimentale:
6.1. L’endecasillabo sciolto dell’Italia
6.1.1. La proposta del Trissino
6.1.2. Giudizio sull’endecasillabo sciolto come “verso eroico”
6.1.3. Il senso della rima: sua funzione storica a livello di codice (“langue”)
6.1.4. Il senso della rima: sua funzione testuale a livello di espressione (“parole”)
6.1.5. Appendice 1: Breve storia degli studi critici sulla rima
6.1.6. Appendice 2: Per una semiotica della rima (seguendo un suggerimento di Barthes)
6.1.7. Appendice 3: Un caso esemplare: la sestina lirica
6.2. Tentativi di formularità in Trissino
7. L’IMITATIO - L’imitatio rinascimentale e l’Iliade: trattatistica e prassi poetica
7.1. Pregiudizi dell’estetica moderna verso la mimesis
7.2. Sull’etimologia di mimesis
7.3. Il concetto di mimesis in Platone e Aristotele
7.4. L’imitatio rinascimentale e i suoi rapporti con la mimesis
7.5. Imitatio macrostrutturale e traduzione
7.6. Per un contributo al ripensamento in termini semiotici dei fondamenti
della mimesis
8. APPENDICI:
8.1. Schema strutturale dell’Italia liberata
8.2. Prospetto dei materiali omerici della Conquistata
8.3. Schema delle principali modifiche strutturali dalla Liberata alla
Conquistata
8.4. Prospetto dei principali contatti fra i poemi di Trissino e Tasso
9. BIBLIOGRAFIA
3
5
13
53
53
79
85
105
129
145
179
199
239
239
239
243
245
249
257
263
273
279
297
297
303
316
323
340
356
375
379
385
387
389
391
4
La lotta tra ciò che è vecchio, permanente, persistente, e ciò che si sviluppa, si
forma e si trasforma, è sempre la stessa. Ogni forma di ordine finisce col
generare pedanteria; per liberarsi da questa si distrugge quello e passa un po’ di
tempo finché ci si rende conto che bisogna ristabilire l’ordine. Classicismo e
romanticismo…
J. W. GOETHE, Massime e riflessioni, n. 346
Ora poiché la poesia, come tutte le cose di questo mondo, a forza d’uso si
snerva, che rimedio ci troverà questo nostro tempo scopritore e ritrovatore?
Stimo che acciocch’ella mantenga sempre quell’efficacia che proviene dalla
novità, bisogni mutar foggia di quando in quando, e come adesso, in luogo
dell’antica, buona per li pedanti, e disadatta al tempo nostro, abbiamo la
romantica, così quando questa sarà tanto o quanto appassita, se ne debba
mettere in sua vece un’altra, e dopo un’altra, e così di mano in mano.
G. LEOPARDI, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica
W. A. MOZART, Don Giovanni, II, XIII
5
6
1. INTRODUZIONE
Ond’è che io estimo, che sarebbe giustissima cosa ne
andassero i poemi giudicati, non dal povero critico cui in sua
vita non venne forse mai fatto di cavar dalla penna venefica
un verso solo, ma da grandi poeti.
T. TASSO, lettera a Sperone Speroni (ed. Guasti, n. 1561)
La resistenza di fondo del fenomeno artistico alla spiegazione razionale – relativa
tanto alla singolarità dell’opera di fronte al giudizio critico, quanto all’arte in astratto
rispetto alla teoresi estetica – è ormai una vulgata. Ciò non inficia, tuttavia, la
sostanziale validità di tale affermazione. Piuttosto, non mi pare sempre chiaro che tale
resistenza non dipende dalla complessità delle strutture che l’arte produce, bensì dalla
sua irriducibilità al pensiero razionale. Che ciò sia soltanto un modo per eludere una
spiegazione che pure dev’esserci, anche quando non si riesca a raggiungerla, non è altro
che un esito particolare di quello che è senza dubbio il più grande pregiudizio della
storia del pensiero occidentale, originariamente sorto con il nome di aletheia: una verità
immanente al mondo, che risiede, celata, nelle cose, e su cui si fonda la possibilità della
conoscenza come suo disvelamento, scoperta, messa in luce, che la postula persino
quando il pensiero scettico, nel sostenerne l’irraggiungibilità, implicitamente ne
riafferma l’esistenza in un altrove semplicemente precluso al soggetto conoscente. Nella
nostra epoca di esasperato razionalismo dovuto al predominio della cultura scientifica,
proprio dall’esito in tal senso estremo della psicanalisi – che ha inteso spiegare
scientificamente persino quell’ambito per definizione antitetico alla possibilità di
razionalizzazione che è la struttura della soggettività stessa – è invece emersa
paradossalmente, con Freud e più ancora con Matte Blanco, la presa di coscienza che il
fenomeno del senso non si esaurisce affatto in quello del senso logico.
Mettendo da parte la questione teorica dell’arte in generale, ciò mi pare
dimostrabile nel rapporto ermeneutico che la critica istituisce con la singola opera nella
sua individualità sulla base di una semplice considerazione: qualunque sia il principio o
la pluralità di principi a cui vengano ricondotti l’interpretazione e di conseguenza il
valore di un’opera, sarà sempre ipotizzabile la realizzazione di un’altra opera che,
soddisfacendo appieno tali principi, sia tuttavia disastrosa nella sua effettiva riuscita
artistica. Detto altrimenti, se la prova che fonda la validità del pensiero logico è la
7
resistenza alla falsificazione, l’opera d’arte è per definizione falsificabile (se si può
usare questo termine) proprio nel suo principium individuationis costituito dal valore
estetico: in ciò l’arte mostra di essere costitutivamente estranea alla possibilità della
spiegazione esaustiva. Ciò dipende dal fatto che mentre la razionalità cerca delle
relazioni di senso pregresse, che la precedono, che si danno già nell’oggetto (o almeno
così essa presume), l’arte invece crea delle strutture di senso prima inesistenti: l’una deduce, l’altra pro-duce; l’una è noesis, l’altra poiesis. Naturalmente una tale
considerazione non implica affatto che la critica sia superflua, a patto che non si ponga
come spiegazione dell’opera, ma solo come sua interpretazione (con l’ulteriore
precisazione, per nulla scontata, che le interpretazioni non sono affatto tutte egualmente
ammissibili, ma sono fortemente limitate dallo specifico contenuto del messaggio).
Da questa alterità radicale fra pensiero razionale e arte nasce anche il problema
con cui quest’ultima deve confrontarsi continuamente, senza interruzione: il problema
della poiesis appunto, della produzione di un oggetto significante (l’opera) in cui tutto è
frutto di scelta, persino ciò che è casuale (se non altro perché vi è incluso). In questo, la
differenza fra i due ambiti appare in tutta evidenza: nel pensiero razionale ciò che conta
è il (presunto) contenuto di verità, l’idea di fondo, in cui sola risiede il valore
dell’operazione; in arte, invece, la dimensione di pensiero che precede e realizza l’opera
è sempre inessenziale: tutto dipende dalla realizzazione concreta, dalla messa-in-opera
delle idee astratte che pure presiedono al processo compositivo. Questo genera
l’opposizione speculare per cui se un pensiero è valido indipendentemente dalla sua
specifica formulazione, poiché tutto e solo ciò che conta è il contenuto, un’opera d’arte
ha valore unicamente in rapporto alla sua concreta realizzazione (è questo il senso della
celebre funzione poetica di Jakobson), e in una certa misura persino indipendentemente
dal pensiero progettuale da cui origina.
Il presente studio verte in massima parte su un caso clamoroso ed esemplare a
riguardo. Com’è stato giustamente notato, l’Italia liberata dai Goti di Gian Giorgio
Trissino ha per così dire conseguito l’immortalità letteraria, ironicamente, in virtù non
del suo valore ma del suo disvalore, divenendo quanto nessun’altra opera paradigma
neppure della cattiva riuscita, ma del disastro. Il raro dispiacere della lettura integrale di
quest’opera monumentale conferma senz’altro il giudizio di valore vulgato. Non
conferma affatto, invece, il complesso delle motivazioni con cui è stato argomentato.
Anzi, rivela al contrario come questo poema illeggibile risulti tale in virtù della sua
realizzazione poetica – pessima – e niente affatto, invece, nella progettualità che vi si
8
scorge a monte e che alla prassi poetica presiede. Questa divaricazione estrema e direi
quasi schizofrenica fra idea poetica e valore dell’opera ne ha determinato, di riflesso, un
sostanziale fraintendimento critico pur nella piena condivisibilità del giudizio.
Il metadiscorso critico, che abbiamo detto essere costitutivamente inadeguato a
cogliere l’essenza del suo oggetto di studio, proprio per questo opera di necessità un
trasferimento di tale oggetto dalla sostanza dell’opera alla struttura che vi si individua
(qualunque essa sia), in un complessivo slittamento dalla cosa alla rappresentazione
concettuale della cosa che viene eletta ad esserne, arbitrariamente, l’equivalente. Ma se
questa metaforicità è una critica che si può muovere in generale alla possibilità stessa
del linguaggio, come notoriamente è stato fatto1, quando il discorso verte nello specifico
sull’opera d’arte non la si può più mettere fra parentesi con la stessa disinvoltura,
semplicemente alzando le spalle e dicendo: “così è, pazienza”. Lo impedisce proprio la
jakobsoniana funzione poetica del linguaggio dell’arte, troppo spesso semplificata nella
sua autoreferenzialità, quando è invece ben più di questo. Anche il linguaggio verbale,
infatti, sa benissimo essere autoreferenziale, e questo non gli impedisce di produrre dei
metadiscorsi perfettamente adeguati come la linguistica e la filosofia del linguaggio
(l’unico problema sarebbe limitato al caso particolarissimo delle cosiddette antinomie,
ossia le autofalsificazioni: ma a mio parere neppure queste sono problematiche): il
punto è che il linguaggio è strumentale, e come ogni strumento ha la sua essenza fuori
di sé, nella sua finalità. L’arte, invece, ha la sua essenza (non semplicemente la sua
referenza, come crede lo strutturalismo, massime quello francese) in se stessa, nel suo
essere opera, ossia insieme creazione e cosa2. Obliterare la sua “cosalità” (la Dingheit
heideggeriana) riducendo l’arte alla sola dimensione di messaggio (e dunque alla sua
autoreferenzialità) – come fa costitutivamente la critica e in maniera esasperata la
tradizione strutturalista – equivale a perdere esattamente la sua essenza. Tale essenza si
svela – parzialmente – solo nella fruizione, che ci mette in presenza dell’opera-cosa,
oltre che dell’opera-messaggio (ossia della mera forma dell’opera).
Il discorso critico, dunque, limitandosi alla dimensione di messaggio dell’opera,
parla non dell’opera in sé ma di un’immagine dell’opera, di una forma, che è in qualche
modo il corrispettivo a posteriori (anche se non certo l’equivalente) di ciò che la
progettualità immanente all’atto creativo è a priori. Senza ridursi a ricostruzione delle
1
Cfr. NIETZSCHE, F., Su verità e menzogna in senso extramorale (e tutto ciò che ne consegue).
Per questa distinzione faccio riferimento a HEIDEGGER, M., L’origine dell’opera d’arte, in Holzwege.
Sentieri erranti nella selva, Milano, Bompiani, 2002 (1950), in particolare alla prima sezione La cosa e
l’opera, pp. 9-32.
2
9
“intenzioni” dell’autore, la critica adempie pertanto a un compito utilissimo, quello di
permettere di approfondire e comprendere meglio tale dimensione progettuale e cioè
semiotica, di messaggio, gettandovi una luce funzionale ad una più profonda e
consapevole fruizione (che è l’unica forma di rapporto proprio con l’opera d’arte; ogni
altra è in un certo modo un suo “stupro”, compreso lo stupro sommo e sacrosanto
dell’artista che si serve dell’opera altrui per la creazione di un’opera nuova).
Ciò detto, lo scivolamento “metaforico” dall’essenza dell’opera alla sua
dimensione progettuale permane nella sua problematicità, che emerge in maniera
prepotente quando, come per il poema del Trissino, il passaggio fra le strutture
progettuali dell’opera e la loro effettiva messa-in-opera nella prassi poetica segna uno
scarto netto. L’esito di questa situazione, certamente rara in questa forma esasperata, è
che paradossalmente il giudizio di valore negativo si è riverberato, in modo arbitrario,
sull’analisi delle strutture e della progettualità ricostruibile dietro l’opera attraverso le
quali, soltanto, esso poteva venire argomentato. Tutte le strategie significative nuove e
autonome e le idee poetiche elaborate dall’autore sono state annientate e ridotte
all’insignificanza per motivare il disastro della concreta realizzazione poetica, in una
sorta di grande olocausto agli altari della spiegazione esauriente. Un’opera che avanza
un’altissima pretesa, quella di fornire il corrispettivo moderno dei massimi capolavori
dell’epica classica e in fondo di tutta la letteratura occidentale, e dunque a tale pretesa
tenta di conformarsi in un immane lavoro ventennale che produce un poema in
ventisette libri, viene ridotta complessivamente all’insignificanza: ogni strategia
testuale, ogni scelta, ogni intuizione poetica è a priori un errore rovinoso, una cantonata.
Non c’è altro modo per motivare un totale disastro che considerare disastrose la totalità
delle scelte che esso mette in atto.
A un’analisi più approfondita e scevra del pregiudizio che fa coincidere
progettualità e giudizio di valore – analisi che il presente studio si propone di fornire –
questo sbrigativo criterio ermeneutico si rivela in tutta la sua inadeguatezza. Riemerge
così il quadro inaspettato di un progetto poetico di grande portata e nel complesso di
notevole interesse nell’ideare soluzioni spesso valide, innovative, talvolta persino
geniali. Il disconoscimento complessivo di tutta questa grande operazione letteraria,
d’altra parte, pesa sulla ricostruzione storico-letteraria molto più gravemente di quanto
si potrebbe credere per il fatto di aver prodotto, come suo ovvio corollario, la
sostanziale neutralizzazione dell’influenza trissiniana sul capolavoro del Tasso, ridotta
complessivamente al contatto superficiale e alla categoria rassicurante dell’antimodello
10
(diligentemente suffragata attraverso una notissima pagina critica tassiana). I risultati
più clamorosi della riconsiderazione del progetto soggiacente all’Italia liberata rivelano
invece come il rapporto modellizzante che lega il Tasso al Trissino sia addirittura
determinante per la poetica tassiana, non soltanto all’altezza della Gerusalemme
conquistata – fatto ovvio –, ma decisamente già all’altezza della Liberata.
La parte più cospicua e centrale di questo studio si articola dunque in un’analisi di
alcuni nuclei essenziali della poetica trissiniana emergenti dall’esame diretto del testo
dell’Italia liberata, che superi il consueto livello di una rapida scorsa generale alla
trama e del riferimento a un paio di affermazioni teoriche dell’autore considerate
impropriamente suppletive di una seria analisi testuale. Il primo capitolo verte sulla
presenza, a contaminare l’impianto epico, del romanzesco, aspetto per eccellenza
rimosso dalla vulgata critica proprio in quanto di specifica spettanza tassiana come
argomento principe del giudizio di valore sulla Liberata: tanto maggiore è qui la
rimozione, tanto più clamoroso si rivela il debito tassiano a livello non banalmente
quantitativo ma propriamente strutturale. Il secondo capitolo affronta, sul duplice
versante della Gerusalemme tassiana e dell’Italia trissiniana, l’argomento del rapporto
con la storia e le fonti storiografiche, inspiegabilmente trascurato dalla critica pur
nell’evidente problematicità posta da un genere di intertestualità molto particolare,
quella che un testo con finalità artistiche instaura con testi eminentemente
documentaristici. Nucleo portante della tesi è poi il terzo capitolo, quello in cui si
affronta, in una prospettiva comparatistica costantemente rivola al testo, il complessivo
rapporto modellizzante con l’Iliade omerica, accusa prima e capitale a motivare,
tradizionalmente, la stroncatura in sede di giudizio; anche in questo caso, le strategie di
riuso del modello si rivelano molto più complesse del presunto annullamento in termini
di copia, influenzando nel profondo la struttura della non solo della Conquistata, ma già
della Liberata. Segue l’esame di un aspetto spesso banalizzato della Gerusalemme
conquistata, il poema che costituisce l’esito ultimo (quantomeno cinquecentesco) della
linea epica “integrale” inaugurata dal Trissino: l’atteggiamento del Tasso verso i pagani
entro il contesto dell’inasprimento ideologico in senso controriformistico che
caratterizza la riscrittura del poema; questo aspetto si rivela anche il luogo privilegiato
di un possibile recupero virgiliano a contaminare la generale esclusività del modello
omerico. Dalle questioni tematiche e macrostrutturali, il capitolo successivo passa poi
ad affrontare due questioni stilistiche di grande rilievo: l’innovazione trissiniana
dell’endecasillabo sciolto, destinata a influenzare molto la storia della metrica, non solo
11
italiana, costituisce il punto di partenza per osservazioni teoriche generali sul senso e sul
valore della rima, un istituto millenario della poesia occidentale ancor oggi
incomprensibilmente banalizzato in mero artificio tecnico insignificante e persino
d’intralcio alla libertà espressiva; l’immane tentativo di riprodurre nell’Italia il grande
apparato della formularità omerica – intesa giustamente, all’opposto che nell’omeristica
moderna, come fatto eminentemente stilistico – fornisce poi la base di una
riconsiderazione critica di tale fenomeno come presunto argomento probante l’oralità
dei poemi omerici. L’ultimo, ampio capitolo, infine, risponde a un problema di estetica
sollevato dal genere decisamente anomalo di imitatio “integrale” e tendenzialmente
esclusiva del modello iliadico praticata nell’Italia liberata così come mezzo secolo
dopo, su quell’esempio esempio, nella Gerusalemme conquistata: viene proposta
dunque una riconsiderazione generale del concetto cardine dell’estetica occidentale, la
mimesis/imitatio, da una prospettiva che, pur ripercorrendo alcuni momenti
fondamentali della millenaria diacronia di questo concetto (a partire da una proposta per
l’etimologia del termine mimesis, a tutt’oggi considerata sconosciuta dalla linguistica
storica), intende proporsi come uno studio di estetica teorica piuttosto che di storia
dell’estetica. L’approccio estetico-filosofico, che esula di norma dalla critica letteraria,
mi è parso imprescindibile, in questo caso, per cercare di far luce su una categoria così
vasta e dalle implicazioni a tal punto determinanti da rendere del tutto insufficiente, in
rapporto ad essa, qualsiasi forma di specialismo.
12
2. IL ROMANZO
Il romanzesco dall’Italia alla Gerusalemme
Possiamo dare avvio a questo studio sui precedenti epici del Tasso e in particolare
sul Trissino partendo, anziché dalla componente propriamente epica, da quella che la
critica ha sempre considerato, giustamente, come la sua controparte entro l’impianto
narrativo: il romanzesco. Non è necessario ricordare, come cosa notissima e
ampiamente studiata (in particolare da Sergio Zatti3), quanto questa dialettica fra epos e
romanzo sia centrale in entrambi i capolavori della poesia narrativa cinquecentesca,
l’Orlando furioso e la Gerusalemme liberata, naturalmente secondo equilibri in qualche
modo speculari per cui potremmo definire il primo, per brevità, un romanzo con
rilevanti elementi epici e la seconda un poema epico con ampie concessioni al
romanzesco. Ma se il peso di queste componenti nei due poemi è stato delineato in
maniera molto approfondita ed efficace a livello testuale e potremmo dire sincronico,
non altrettanta chiarezza è stata fatta sulla linea di derivazione di tali componenti entro
il quadro della tradizione letteraria, ossia sul livello intertestuale e diacronico: il
presente studio è nel suo complesso, in fondo, nient’altro che un contributo a colmare
tale lacuna. Certamente la netta tendenza della critica moderna a limitare il campo di
indagine specialistica a singole letterature (intese nel senso di letterature scritte in una
certa lingua)4 e in genere, anzi, a singoli periodi di una letteratura ha fatto sì che, in
rapporto al capolavoro tassiano, l’aspetto romanzesco sia stato complessivamente
approfondito nella sua diacronia senz’altro meglio di quello epico: il primo, infatti, può
essere trattato in maniera già soddisfacente entro i confini della letteratura italiana in cui
ha la sua origine più diretta (i cantari, Boccaccio, Boiardo, Ariosto ecc.), tutt’al più con
il completamento di qualche incursione nel campo – limitrofo e spesso frequentato
3
Mi riferisco soprattutto ai suoi fortunati volumi L’uniforme cristiano e il multiforme pagano. Saggio
sulla “Gerusalemme Liberata”, il Saggiatore, Milano, 1983 e Il “Furioso” fra epos e romanzo, PaciniFazzi, Lucca, 1990.
4
Sull’argomento cfr. PADUANO, G., Lo studio della letteratura europea, in «L’asino d’oro», IV, 8
(novembre 1993), pp. 155-67.
13
dall’italianistica – della filologia romanza5, mentre il secondo, quello epico, non può
essere studiato se non in un’ottica intertestuale e comparatistica, in quanto la letteratura
italiana prima del Cinquecento manca di un vero e proprio genere epico e le radici della
rinascita quattro-conquecentesca dell’epica affondano quasi esclusivamente nelle
letterature classiche, latina e poi anche greca (con la riscoperta di Omero). Non a caso il
presente studio si incentra essenzialmente sulla componente epica, come lacuna più
grave e più urgente da affrontare. Tuttavia anche per la componente romanzesca l’ovvia
prevalenza di uno studio sincronico entro il testo rispetto alla diacronia delle sua
derivazioni intertestuali ha portato a delle semplificazioni talvolta piuttosto drastiche: i
capolavori dell’Ariosto e del Tasso, al più con qualche parziale concessione al Boiardo,
sono stati letti come il luogo di un’innovativa e riuscitissima mescolanza di epos e
romanzo, mentre le altre opere minori che quelle hanno oscurato sono state collocate
con facilità interamente entro l’una o l’altra linea. Eppure bisognerebbe tener presente
come molti degli autori di quel periodo frequentassero, seppur in varia misura, entrambi
gli ambiti: l’Alamanni, ad esempio, scrisse sia un romanzo (Girone il cortese) che un
poema epico (l’Avarchide), Bernardo Tasso modificò l’impianto complessivo del suo
Amadigi da un ambito all’altro, suo figlio Torquato scrisse in età giovanile un poema
cavalleresco, il Rinaldo. Persino per Ariosto, l’autore del romanzo cavalleresco per
eccellenza, è stata avanzata l’ipotesi che intendesse scrivere un poema epico
encomiastico in terza rima su Obizzo d’Este, l’Obizzeide, di cui un capitolo presente
nelle sue rime sarebbe il primo abbozzo in seguito abbandonato 6 . Nonostante ciò,
nell’immagine vulgata le opere minori non hanno lo spessore e l’originalità per
partecipare di questa dialettica fra epos e romanzo, né d’altra parte lo scarso interesse
che suscitano richiede approfondimenti ulteriori, e dunque vengono ascritti senza mezzi
termini a una precisa categoria che intende esaurire il loro significato.
5
Per comprendere queste origini in maniera soddisfacente non è certo indispensabile risalire al romanzo
antico, anche se il rapporto è certamente importante e resta per molti versi decisamente oscuro: l’indagine
in questo campo risulta tanto più difficoltosa in quanto già il romanzo antico costituisce di per sé un
ambito molto problematico dal punto di vista filologico e storico-letterario (questione dell’origine,
esiguità della tradizione testuale che ha cancellato gran parte di una produzione probabilmente molto più
vasta della decina di romanzi sopravvissuti fra le due letterature, rapporti fra romanzo greco e latino ecc.):
si veda a riguardo, ad esempio, il volume di GRAVERINI, L. – KEULEN, W. – BARCHIESI, A., Il romanzo
antico. Forme, testi, problemi, Roma, Carocci, 2006. Sarebbe comunque senz’altro auspicabile,
nonostante le difficoltà, chiarire meglio il rapporto che lega il romanzo antico con quello medievale, cosa
che risulterebbe di grande utilità per autori come ad esempio Boccaccio, che mostra indirettamente una
conoscenza delle forme tipiche del romanzo greco – naturalmente mediato dalla tradizione romanzesca
medievale – non solo nei suoi romanzi ma anche in alcune novelle del Decameron.
6
Cfr. JOSSA, S., Un’alternativa all’“Orlando furioso”: l’esperimento dell’Obizzeide, «Schifanoia», 26-27
(2004), p. 203-209.
14
Questo avviene senz’altro per l’Italia liberata da’ Goti del Trissino. Questo
poema monumentale, che già ai tempi del giovane Tasso nessuno leggeva più, è
diventato nell’idea corrente l’esempio per eccellenza della linea epica, la negazione
stessa del romanzesco. Lettura più che giustificata se si pensa alle intenzioni
complessive del Trissino, il quale presenta la sua operazione come contraria rispetto a
quella compiuta qualche decennio prima dall’Ariosto: in uno degli excursus profetici
sulla storia futura inseriti nell’Italia, ad esempio, l’autore ricorda appunto, con un certo
disprezzo neppure troppo dissimulato, l’Ariosto / col Furioso suo, che piace al vulgo
(It., XXIV). Palese è l’intenzione del poeta vicentino di riportare in vita, con questa sua
opera, il genere del poema epico classico opposto al genere “deviato” del romanzo
cavalleresco moderno che aveva in Ariosto il suo campione, perfettamente in parallelo
all’operazione tentata per la tragedia da lui stesso, anni prima, con la Sofonisba. In tal
senso è stata dunque recepita dalla critica, giustamente, la complessiva funzione storicoletteraria dell’Italia: essendo stata subito estromessa dal canone, anzi, quest’opera è
stata ridotta ed eguagliata in toto a tale funzione storica, come se non fosse nient’altro
che questo. Naturalmente in casi simili è quasi impossibile evitare una semplificazione,
e forse, nella misura in cui l’opera ci interessa non in sé ma unicamente in relazione alla
funzione storica che ha svolto, è anche legittimo avallare una simile semplificazione e
accontentarsi di essa. Il problema si pone quando ci si accorge che l’opera non è più
riducibile alla sua mera funzione storica; e questo può accadere, io credo,
essenzialmente in due casi: quando l’autore e l’opera specifica vengono rivalutati – e
decisamente non è questo il caso del Trissino – oppure quando ci si rende conto di
un’influenza di tale opera sulla produzione di un autore che invece nel canone un posto
ce l’ha. Se poi l’autore in questione è Torquato Tasso, che non ha semplicemente un
posto nel canone ma che è uno dei massimi poeti della letteratura occidentale, e se
l’opera influenzata è il suo poema sulla riconquista di Gerusalemme che è uno dei più
grandi capolavori di sempre, allora si impone la necessità di riesumare quell’opera
estromessa dal canone e valutare approfonditamente la portata e il significato della sua
influenza su un autore e su un capolavoro di tale importanza. Quello che era ridotto a
mera funzione storica torna ad essere a tutti gli effetti un rapporto che non ha più nulla
di generico, di riducibile a categorie semplificanti per brevità: torna ad essere a pieno
titolo un rapporto fra testi, fra due testi specifici, un rapporto intertestuale, e come tale
deve essere analizzato. Il che significa, detto in altri termini: l’analisi deve coinvolgere a
tutti gli effetti il testo dell’opera estromessa dal canone, non più la sua immagine
15
vulgata. E tale testo, se non si vuole falsare l’indagine, deve essere analizzato certo in
relazione agli aspetti che ci interessano per l’influenza sull’autore maggiore, ma
comunque innanzitutto e preventivamente in se stesso, nelle dinamiche e strutture sue
proprie, per operare il confronto solo a posteriori, evitando dunque il più possibile di
ridurlo a una lettura in controluce rispetto all’altra opera, a una conferma tautologica di
quanto ci si aspettava da esso.
Non c’è dubbio, se il Trissino svolge la funzione di campione della tendenza epica
e come tale è riconosciuto nei Discorsi dell’arte poetica del Tasso che presiedono alla
stesura della Gerusalemme Liberata, che gli elementi di maggior rilevanza nella sua
influenza sul Tasso riguarderanno la componente propriamente epica delle dinamiche
testuali e narrative. Eppure proprio questa identificazione del Trissino con l’epica tout
court significa senz’altro che se si è avuta una semplificazione delle dinamiche testuali
dell’Italia liberata a tale funzione storico-letteraria, l’aspetto su cui la semplificazione si
sarà abbattuta nel modo più drastico, fino a poterlo obliterare del tutto, sarà proprio
l’eventuale presenza del romanzesco. Una tale semplificazione nella vulgata critica è
senza dubbio molto risalente nella storia degli studi: un vecchio contributo d’inizio
Novecento, improntato alla scuola storica e al celebre lavoro di Rajna e a quelli sulle
fonti della Liberata, lamenta già allora come «nel poema trissiniano il lato cavalleresco,
trascurato quasi affatto dalla critica, è di una importanza capitale» 7 , proponendosi
dunque di indagarne in tale direzione le fonti. Che l’importanza di questo aspetto sia
addirittura capitale è forse eccessivo, ma certamente l’individuazione di questa tendenza
nella storia della critica conferma senz’altro come anche gli studi più recenti siano stati
influenzati da questa vulgata che, quando non le oblitera del tutto, sminuisce
drasticamente la presenza e la funzione del romanzo nell’Italia liberata, con ciò
banalizzando e dunque in parte fraintendendo il rapporto che con essa intrattiene la
Gerusalemme tassiana.
Leggendo il poema del Trissino ci si accorge che le cose stanno precisamente in
questo modo: una componente romanzesca non è affatto assente nell’Italia, a differenza
dell’immagine vulgata che se ne dà, e la critica più recente, che ha mostrato un certo pur
minimo interesse rinnovato per l’opera, concretizzatosi in qualche contributo a riguardo,
non ha mancato di rilevarlo8. Tuttavia questi validi ma pur sempre pionieristici studi
7
CAPALBO, F., Le fonti cavalleresche dell’Italia liberata da’ Goti di Giangiorgio Trissino, Cosenza, La
lotta, 1906, p. 7.
8
Gli studi principali sul poema del Trissino sono: QUONDAM, A., La poesia duplicata. Imitazione e
scrittura nell’esperienza del Trissino, in Atti del Convegno di Studi su Giangiorgio Trissino, a cura di
POZZA, N., Vicenza, 1980, pp. 67-109; ZATTI, S., L’ombra del Tasso. Epica e romanzo nel Cinquecento,
16
sull’argomento non hanno essi neppure reso pienamente conto della portata e della
funzione del romanzesco nel poema del Trissino, talvolta imputabile forse, oltre alla
suddetta vulgata critica, anche a una lettura non integrale dell’opera, che può aver
parzialmente distorto la percezione di questo aspetto considerato marginale.
Lo studio più risalente fra quelli recenti, l’articolo di Quondam, che intende
fornire un primo quadro complessivo dell’opera improntato ad una chiara valutazione
critica (« Imitazione di Omero in termini di remake, duplicazione fedele, restituzione
totale […], gigantesca macchina di riproduzione, che copia tutto senza lasciar nulla,
senza troncare né diminuire l’originale […], duplicazione in scala 1 : 1 »9), non tace
affatto la presenza del romanzesco, ma la riduce essenzialmente alla categoria del
meraviglioso e soprattutto le toglie ogni significato banalizzandola, in parallelo a quanto
fa per l’omerismo, a mera citazione priva di significato:
Cavalieri che attraversano vittoriosi gli incanti e le fatagioni, che superano le prove e le venture
cui sono sottoposti sempre in termini di dispendio (gratuito anche nell’economia della « favola »), solo
per enunciare la propria condizione, affermare se stessi in quanto cavalieri. […]
Draghi, fate, giganti […], negromanti: tutto il repertorio del favoloso, del meraviglioso, del
magico, viene da Trissino recuperato, citato, tradotto sull’impianto omerico della « favola », riformulato a
partire dalla sua presenza dominante. […]
Sull’asse dell’Idea-Omero, insomma, il Trissino innesta le altre tradizioni del romanzo occidentale
medievale. […] Il rapporto con la tradizione narrativa si presenta in termini di assoluta omogeneità con
quello del Trissino istituito nei confronti della tradizione lirica, almeno per quanto riguarda l’assunzione
dell’intero suo percorso sul piano del presente, senza discriminanti gerarchiche, né d’ordine linguistico né
geografico. Tutta la tradizione narrativa, dunque.
Solo che questo rapporto non si fonda più soltanto sull’istituto della citazione, come nelle Rime,
ma si organizza in termini di ri-scrittura, di tra-duzione di codici diversi, e di diversa funzionalità,
sull’asse primario costituito dall’Idea-Omero. Un rapporto di spostamento, dunque, di sistemi discorsivi
(retorici, figurativi e ideologici) sulla macrostruttura omerica. Con una fortissima accentuazione del
pastiche e del collage, con effetti vistosi d’interferenza linguistica e sovraccarico iconografico: l’Italia
liberata dai Gotti intende proporre una summa narratologica, che riproduca l’intera gamma delle forme
praticate dalla tradizione, la ripercorra tutta, ne costituisca l’inventario, il catalogo. A scala 1 : 1.10
La presenza del romanzesco, dunque, pur quantitativamente non trascurabile, è
ridotta a citazione fuori posto, a elemento gratuito, privo di senso: dal punto di vista
funzionale, che poi è quello sostanziale, essa è nullificata.
Milano, Bruno Mondadori, 1996 (cap. 3, L’imperialismo epico del Trissino, pp. 59-110); ID., Tasso
lettore del Trissino, in Torquato Tasso e la cultura estense. Atti del Convegno, Ferrara 10-13 Dicembre
1995, a cura di VENTURI, G., Firenze, Olschki 1999, vol. I, pp. 597-613; GIGANTE, C., «Azioni
formidabili e misericordiose». L’esperimento epico del Trissino, in «Filologia e Critica», XXIII (1998),
pp. 44-71. Sul rapporto con la tradizione epica e cavalleresca si veda anche il recente GIGANTE, C., Epica
e romanzo in Trissino, in La tradizione epica e cavalleresca in Italia (XII-XVI sec.), a cura di GIGANTE,
C. e PALUMBO, G., Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2010, pp. 291-320.
9
QUONDAM, A., cit., p. 90. I corsivi (non) lasciar nulla e troncare né diminuire sono desunti da un passo
appena citato della Poetica del Trissino: citati tuttavia tendenziosamente, in quanto lì si limitano a riferirsi
all’aspetto stilistico dell’enargia omerica che descrivono, e non si riferiscono affatto all’imitazione
omerica in toto.
10
Ibid., pp. 96-99.
17
Più approfondita la successiva lettura proposta nei suoi due contributi sul poema
del Trissino da Sergio Zatti, soprattutto per il fatto di chiamare direttamente in causa il
rapporto con Tasso, che per converso, però, come abbiamo detto, può anche allo stesso
tempo deformare parzialmente alcuni aspetti esaminati. Più che risolversi in una
panoramica complessiva dell’Italia, l’esame condotto da Zatti si focalizza
intelligentemente sui nodi di rilievo funzionale e strutturale (ideologie contrapposte,
struttura aperta o chiusa, topoi epici, elementi romanzeschi, meraviglioso cristiano ecc.),
messi a confronto con il diverso utilizzo che ne farà Tasso. Anche Zatti parla del
romanzesco in Trissino in termini di esclusione o marginalizzazione11, con l’evidente
intenzione di marcare tutta la distanza rispetto all’uso del romanzesco nella Liberata:
Naturalmente non manca del tutto al Trissino un’idea di variatio e di possibile apertura allo spazio
romanzesco. […] Tuttavia l’assoluto controllo testuale esercitato dalla norma omerico-aristotelica fa sì
che anche il canonico “turbamento dell’impresa” non nasca mai dinamicamente da un principio realmente
antagonistico (trame diaboliche o tentazioni femminili), ma da interventi dell’autorità stessa che ha
promosso l’impresa, e mira ad appropriarsi anche dello spazio della propria negazione. Data la fissità
della norma epica, non c’è modo di relativizzarne l’assolutismo ideologico, di creare cioè un punto di
vista eccentrico rispetto all’asse imposto dalla prospettiva imperialistica della “conquista”, che costituisce
il principio ordinatore del testo. Consapevole dei meccanismi e delle esigenze dell’epica, Trissino si
propone di « dare disturbo all’ordinata impresa » (XXVI, 743), ma il “disviamento” dell’eroe achilleico
Corsamonte per le arti fallaci della maga Acratia, che rappresenta l’episodio più clamoroso di abbandono
della giusta causa in cerca d’“altra ventura”, si risolve in un paio di canti e non costituisce una vera
possibile alternativa ideologica al mondo dei valori costituiti: l’evasione romanzesca, che presuppone il
dipartirsi dalla via segnata dell’eroe in preda alle passioni cieche e basse, resta un’occasione mancata nel
racconto monologico del Trissino. E se è pur vero che il romanzo è presente nell’Italia molto più di
quanto lo concedano le posizioni teoriche dell’autore, esso tuttavia svolge generalmente una pura
funzione retorica di “variatio” e non già di vera drammatizzazione dell’intrigo. Al contrario, per la
Gerusalemme si può dire che…12
A parte qualche imprecisione su cui torneremo più avanti, notiamo rispetto a
Quondam un approfondimento del livello di indagine, che non si limita più a
individuare gli elementi romanzeschi ma si interroga essenzialmente sulla validità e sul
senso del contributo da essi fornito alle dinamiche testuali. Il bilancio finale sul
romanzesco risulta comunque sostanzialmente omogeneo a quello di Quondam: non sia
parla più di “citazione”, in un periodo in cui ormai la categoria critica dell’intertestualità
è del tutto sdoganata anche in Italia, ma di “variatio”, eppure la svalutazione del ruolo e
del significato del romanzesco ne costituiscono di fatto una negazione, una riduzione al
grado zero: un presenza irrilevante, assimilabile in tutto ad un’assenza.
11
12
ZATTI, S., L’ombra del Tasso, cit., p. 93.
Ibid., pp. 96-97.
18
Quanto allo studio di Gigante del 199813, esso approfondisce alcuni singoli aspetti
del poema del Trissino condividendo in pieno la posizione di Quondam quanto al
giudizio sull’opera e all’inconsistenza dell’esperimento di “duplicazione” operato sul
poema omerico. Riguardo al romanzesco, lo studioso corregge alcune affermazioni
imprecise o forse troppo generiche di Zatti14, ma poi non trae da ciò alcuna effettiva
conclusione e anzi, limitandosi ad accennare en passant alla compresenza in
Corsamonte di “cromosomi” romanzeschi ed epici e all’episodio della maga Acratia,
trascura del tutto di trattare ulteriormente tale aspetto, presumibilmente ritenendo che in
proposito fosse già stato detto abbastanza da Quondam e Zatti. Più matura e
condivisibile è invece la prospettiva proposta dallo studioso nel recentissimo contributo
sulla compresenza di tradizione epica e cavalleresca in Trissino15.
Un ultimo, recente contributo sull’argomento, senz’altro di minore spessore
critico, è stato proposto da Alessandro Corrieri16: secondo un frequente vizio degli studi
in ambito rinascimentalista, egli imposta la sua analisi del rapporto fra il Trissino e i
precedenti cavallereschi su un confronto condotto a livello del solo sistema dei
personaggi (Belisario, Nicandra, Corsamonte), trascurando così proprio il punto
essenziale, ossia il fatto che la dialettica cinquecentesca fra i generi epico e romanzesco
riguarda innanzitutto le strutture narrative e solo secondariamente – per altro in maniera
ben poco diretta e lineare – la caratterizzazione dei personaggi e dei valori che essi
rappresentano. Questa impostazione rende necessariamente il quadro così delineato
piuttosto superficiale e generico, interessato più a alla dimensione ideologica che non a
quella narrativa e più propriamente letteraria. Il risultato paradossale è che il
personaggio di Corsamonte, di cui pure en passant si riconosce nell’Achille omerico il
modello principale (argomento su cui torneremo ampiamente nel capitolo sul rapporto
del Trissino con Omero), viene al contempo accomunato a Nicandra nel rappresentare
con la propria morte, secondo una formulazione mutuata da Jossa, l’“uccisione
simbolica del romanzo” 17 . Condotta soltanto in termini di sistema di personaggi,
l’analisi si risolve in una pura contraddizione: in che modo la morte del personaggio
modellato su Achille può rappresentare la morte simbolica del romanzo? Sarebbe più
13
GIGANTE, C., «Azioni formidabili e misericordiose», cit.
Ibid., nota n. 70 a p. 58. Le questioni trattate saranno approfonditamente discusse più avanti.
15
GIGANTE, C., Epica e romanzo in Trissino, cit.
16
CORRIERI, A., Rivisitazioni cavalleresche ne “L’Italia liberata da’ Gotthi” di Giangiorgio Trissino,
«Schifanoia», 34-35, 2008, pp. 183-192.
17
JOSSA, S., La fondazione di un genere. Il poema eroico tra Ariosto e Tasso, Carocci, Roma, 2002, p.
151. L’idea è condivisa anche da JAVITCH, D., Lo spettro del romanzo nella teoria sull’epica del
sedicesimo secolo, «Rinascimento» (43), 2003, pp. 159-176.
14
19
opportuno, evitando certi simbolismi narratologici peraltro piuttosto superati – in
particolari quando danno esiti paradossali –, considerare l’opposizione fra generi
narrativi da un punto di vista appunto narrativo, potendo così riconoscere senza
forzature che il personaggio di Corsamonte si rende protagonista di alcune vicende
romanzesche così come anche del principale nucleo di derivazione omerica del poema
trissiniano.
Da questo breve excursus dei pochi contributi critici sull’argomento emerge la
volontà di dare un’immagine dell’Italia liberata complessivamente sovrapponibile e
coerente con la vulgata, o se si vuole con la funzione storico-letteraria da essa ricoperta
di rappresentare la linea dell’epica integrale nel Cinquecento. Declassare, nell’atto
stesso di rilevarla, la presenza del romanzesco a mera citazione, variatio superficiale,
banalmente disorganica rispetto al quadro generale in cui si colloca, vuol dire in fondo
rassicurare sul carattere monologico dell’opera, confermare all’analisi critica che gli
apparenti disturbi da cui sembrerebbe essere messo in dubbio il carattere aproblematico
e innocuo dell’opera, la sua totale mancanza di spessore, non sono appunto nient’altro
che tali: disturbi irrilevanti, incrinature solo superficiali, di cui si può perfettamente non
tener conto. Se il Trissino deve rappresentare l’epica più arcigna e intransigente,
lontanissima tanto dalla brillante leggerezza dell’Ariosto quanto dalla sofferta e
tormentata profondità del Tasso, allora non devono trasparire mezze misure,
compresenze dialettiche, compromessi: meno che mai con il romanzo, il controgenere
per eccellenza dell’epica nella teoresi rinascimentale. Ecco allora che se alla lettura il
romanzesco compare, a meno di non volersi assumere la responsabilità di far saltare un
tassello importante in quello schema di opposizione epos-romanzo in base al quale
precipuamente interpretiamo la poesia narrativa rinascimentale, e peggio ancora lasciar
partecipare altre opere di quella compresenza dialettica fra queste due polarità che ci
fornisce la principale categoria di giudizio per distinguere i due capolavori del secolo
dallo sfondo insignificante delle opere non canoniche (il che significa: mandare in crisi
la nostra possibilità di argomentarne il giudizio di valore), la soluzione più ovvia e
immediata per mantenere la coerenza dello schema critico è di negare non la presenza
ma la funzionalità del romanzesco, in modo da renderlo egualmente inoffensivo. Come
le matematiche rispetto ai loro assiomi, la critica deve sempre preoccuparsi di restare
coerente con le categorie su cui sceglie di fondare i propri giudizi, anche quando questo
comporta qualche accomodamento marginale o forzatura (cosa che tra l’altro, secondo
20
alcuni, avviene di necessità), come può essere appunto negare valore a ciò di cui non si
può negare la presenza.
Beninteso, i giudizi di Quondam e Zatti sul romanzesco in Trissino non sono
affatto privi validità o di punti d’appoggio: sono semplicemente orientati, nel primo
caso dall’immagine vulgata, nel secondo dal dato (ovvio) della netta superiorità di
Tasso. E se questa direzione seguendo la quale è condotta l’analisi genera qualche
semplificazione eccessiva, ciò non sarebbe gran danno finché ci si limita al Trissino in
sé; ma nel momento in cui si considera la sua influenza sul Tasso, si rischia invece di
far dire ai testi ciò che vogliamo sentirci dire, leggervi una mera conferma delle nostre
ipotesi: un’analisi semplificata o banalizzante dell’ipotesto si risolve necessariamente
anche in una comprensione più limitata del testo successivo che ci interessa. In limine
ad uno studio del rapporto fra questi due autori quanto alla componente epica delle loro
opere, sarà utile approfondire, pertanto, anche il rapporto che eventualmente li lega
riguardo al romanzesco come controparte necessaria a quella e alla sua piena
comprensione entro la dialettica narrativa. Ripercorriamo dunque più nel dettaglio i
principali episodi ed elementi di carattere romanzesco nell’Italia cercando di evitare,
per quanto possibile, un giudizio preconcetto e traendo le conclusioni dell’analisi solo
ex post.
Dopo i primi due libri di matrice marcatamente epica (innesco dell’impresa
attraverso il consiglio di guerra e successivo catalogo dell’esercito), che costituiscono
una sorta di grande prologo all’opera senza però avviare propriamente l’azione, si apre
subito un altro spazio narrativo di diversi canti la cui funzione è, nel complesso,
palesemente sospensiva: serve a ritardare l’innesco dell’impresa epica vera e propria,
quasi a voler entrare nel vivo dell’argomento solo per gradi, attraverso un accostamento
progressivo. Un tipo di organizzazione testuale in generale, naturalmente, molto
frequente in qualsiasi tipologia di testo narrativo o drammatico, ma nella fattispecie –
nella specifica struttura che qui assume – ripresa complessivamente proprio da Tasso
per il proprio poema epico: anche nella Liberata (e poi nella Conquistata) l’azione
bellica vera e propria ha inizio relativamente tardi ed è variamente rinviata attraverso
elementi narrativi di altro genere (in particolare l’arrivo di Armida). Approfondiremo
nel corso dell’analisi questi rapporti più nel dettaglio: per ora basti notare l’affinità
complessiva e niente affatto scontata dei primi libri dei poemi di Trissino e Tasso
quanto alla comune funzione di ritardare l’avvio dell’impresa epica. Funzione ritardante
che dagli studi sappiamo bene essere il luogo deputato del romanzesco.
21
Il primo elemento di questa “falsa partenza”, nell’Italia liberata, è in realtà quello
in apparenza meno marcatamente romanzesco, almeno per quello che si intende in
genere con la categoria di romanzesco in relazione al poema rinascimentale (storie di
cavalieri erranti, donzelle, incanti ecc., ossia il romanzo cavalleresco): esso narra della
vicenda amorosa di Giustino e Sofia, eredi di Giustiniano e Teodora nell’Impero
d’Oriente. Si tratta del terzo libro del poema, interamente dedicato al racconto di questa
vicenda amorosa e in sé concluso e fortemente indipendente dal resto della trama: un
vero e proprio episodio autonomo di cui la guerra viene a costituire soltanto lo sfondo e
il contesto, e i cui protagonisti non avranno più alcun ruolo nei successivi sviluppi della
trama. Non si può fare a meno di pensare, naturalmente, al tormentatissimo episodio di
Olindo e Sofronia in Tasso, la cui marcata indipendenza e quasi estraneità alla trama
(fatto salvo il geniale collegamento di servire da presentazione del grande personaggio
di Clorinda e persino prefigurazione del suo destino di conversione) è da subito uno dei
principali bersagli della critica coeva sin dalla revisione romana e finirà per essere
eliminato e sostituito nella Conquistata. Pur nella comunanza del tema amoroso in
forma di episodio concluso, la narrazione trissiniana ha però tutt’altro carattere e
soprattutto tutt’altra ascendenza letteraria e per così dire di genere. Su di esso ha scritto
qualche buona pagina Gigante nel suo articolo già citato, individuando in particolare i
principali influssi omerici (iliadici e stavolta, cosa senz’altro inconsueta, anche
odissiaci)18; condivido in sostanza la sua breve analisi, ma credo che sia necessario fare
almeno una importante precisazione generale, cui lo studioso accenna soltanto molto
alla lontana e in modo dubitativo.
Stavolta, paradossalmente, gli elementi di matrice epica che la critica è solita
trascurare vengono individuati con precisione proprio quando invece sono meno
essenziali degli elementi non epici nel delineare la funzione complessiva dell’episodio
entro il quadro dell’opera. È verissimo che l’innamoramento di Sofia dipende
strettamente da quello di Didone in Eneide IV e della Medea di Apollonio Rodio, e che
il naufragio di Giustino riprende molto da vicino quello di Odisseo. Il dato
fondamentale, però, in questo caso è un altro, è la struttura complessiva dell’intero
episodio. Come si vede già solo dai luoghi letterari che fungono da modello, c’è sì un
richiamo a testi della tradizione epica, ma a luoghi senz’altro particolari e in un certo
senso anomali dal punto di vista di genere, almeno nella loro ricezione moderna: la linea
Apollonio – Eneide IV, rifacendosi soprattutto a celebri modelli tragici, è notoriamente
18
GIGANTE, C., «Azioni formidabili e misericordiose», cit., p. 65-71.
22
anomala e innovativa rispetto alla tradizione epica nel dare rilievo protagonistico al
personaggio femminile e centralità alla tematica amorosa; l’Odissea, a sua volta, in tutta
la storia della sua ricezione moderna ma in particolare proprio nella cultura
rinascimentale, è sempre stata interpretata come archetipo romanzesco in opposizione al
paradigma propriamente epico fornito dall’Iliade.
Ma al di là di questi modelli epici “anomali” (la cui anomalia, naturalmente, sta
tutta nella diversa ricezione rinascimentale dei due poemi omerici e nei paradigmi di
genere che ad essi sono stati sovrapposti nel tempo), l’impianto narrativo dell’episodio
nel suo complesso ci dice forse di più dei singoli ipotesti di volta in volta ripresi nelle
varie scene in cui esso si articola. Gigante accenna molto timidamente, en passant, il
riferimento al romanzo greco, e unicamente in relazione al lieto fine per cui i due
protagonisti scampano alla morte. In realtà l’intero episodio narrato presenta nel suo
complesso, in maniera molto evidente, la tipica struttura fondamentale del romanzo
greco 19 : 1) innamoramento iniziale dei due bellissimi e giovani protagonisti; 2)
separazione attraverso peripezie, costituite in gran parte da disavventure di viaggio per
mare; 3) ricongiungimento e matrimonio. Questo modello di plot, che trova
probabilmente il suo archetipo nella Commedia Nuova greca e, sviluppato in forma
narrativa dal romanzo greco, ameno per come noi lo conosciamo, costituisce un’intera
linea di sviluppo della tradizione romanzesca nei secoli fino alla modernità20 (si pensi ai
Promessi sposi), vede anche un’importante fase della sua storia nella sua ricezione
medievale e in particolare, entro il contesto italiano, in Boccaccio: non solo,
ovviamente, nei suoi romanzi in prosa e versi, ma anche e soprattutto nella
rielaborazione in forma novellistica nel Decameron. Alcune novelle, come quelle di
Cimone, in parte quella di Madonna Beritola, ma soprattutto, seppure in forma parodica
e rovesciata, quella di Alatiel, presentano un chiaro rapporto con questo schema
narrativo di ascendenza greca. E non bisogna dimenticare, poi, che proprio nel
Rinascimento i romanzi greci vengono riscoperti, tradotti e diffusi nella cultura europea,
influenzando fortemente tanto il genere pastorale quanto il romanzo barocco.
Ma a parte la disponibilità, più o meno mediata, di tale modello di trama
romanzesca nella prima metà del Cinquecento, l’aspetto più interessante è forse proprio
il carattere marcatamente episodico di questo libro III dell’Italia, che tanto lo avvicina
19
Sul romanzo antico (greco e latino) cfr. almeno FUSILLO, M., Il romanzo antico: polifonia ed eros,
Venezia, Marsilio, 1989; GRAVERINI L., KEULEN W., BARCHIESI A., Il romanzo antico. Forme, testi,
problemi, Roma, Carocci, 2006; DOODY, M., La vera storia del romanzo, Palermo, Sellerio, 2009 (1996).
20
Sull’argomento cfr. i celebre saggi di BACHTIN, M., La parola nel romanzo e Le forme del tempo e del
cronotopo nel romanzo, entrambi in ID., Estetica e romanzo, Einaudi, Torino, 2001 (1975).
23
per funzione a quello tassiano di Olindo e Sofronia. Esso presenta un carattere
fortemente romanzesco, più ancora che nella sua trama da romanzo greco contaminata
di elementi di varia derivazione epica, proprio nella sua strutturazione narrativa entro la
trama del poema. Se infatti il carattere diversivo di ciò che si definisce un “episodio” è
un tratto tipico del romanzo cavalleresco di matrice arturiana, è pur vero che quella
tipologia di episodi riguarda per lo più i personaggi principali del poema, come mostra
in tutta evidenza il suo esito ultimo e parodistico del Don Chisciotte: l’episodio è la
singola avventura, la vicenda in sé conclusa che càpita al protagonista o ad altra figura
di primo piano e che, venendosi a sommare per iterazione a un numero indefinito di
vicende affini ma sempre nuove, struttura la trama in quella sequenza additiva e
potenzialmente sempre aperta tipica del romance. In questo caso, invece, i protagonisti
della vicenda sono non soltanto secondari, ma del tutto estranei al resto della trama: la
vicenda di Giustino e Sofia si svolge interamente nell’arco del terzo libro ad essi
dedicato. Questa tipologia strutturale, ancor più che al mero carattere episodico di tipo
cavalleresco, di cui vedremo fra breve altri esempi, sembra rimandare piuttosto ad
un’altra struttura tipicamente inglobata del romanzo: la novella. È indubbio che la
novella interna al romanzo, in senso tecnico, sin dal romanzo antico e poi attraverso la
mediazione di Boccaccio 21 in quello cavalleresco si caratterizza per essere una
narrazione di secondo grado, un racconto nel racconto22, cosa che in questo caso non si
verifica: tuttavia tanto la struttura interna dell’episodio quanto la sua funzione
nell’economia complessiva del poema è molto simile a quella di una novella nel
risultare una storia nella storia, una digressione del tutto slegata dalla trama principale
(nel caso di Giustino e Sofia manca anche un qualsiasi legame di ordine paradigmatico
con il resto del poema: legame che invece è tipico della novella romanzesca, da Apuleio
ad Ariosto), che narra una breve vicenda autonoma e in sé conclusa come diversione e
intrattenimento volto a generare varietà nel racconto, tanto che si potrebbe benissimo
adattare ad essa l’indicazione ariostesca di «canto, che senza esso / può star l’istoria e
non sarà men chiara» posta a introdurre la novella di Astolfo e Iocondo23. Tutto ciò che
manca a questo terzo libro perché lo si possa dire una novella è insomma l’elemento
21
Sul rapporto di Boccaccio in particolare con Apuleio (mentre Petronio gli era naturalmente
sconosciuto), cfr. FEDELI, P., Modelli classici della novella italiana, in La novella italiana. Atti del
convegno di Caprarola, 19-24 settembre 1988, Roma, Salerno editrice, tomo I, pp. 303-336.
22
Cfr. FRANCESCHETTI, A., La novella nei poemi del Boiardo e dell’Ariosto, in La novella italiana, cit.
pp.805-840, che individua come una delle due caratteristiche fondamentali per definire la novella entro la
narrativa cavalleresca la seguente: «sono in qualche modo narrazioni di un personaggio ad un altro, non si
tratta cioè dell’autore, reale o immaginario canterino, che racconta una vicenda» (p. 819).
23
Fur., XXVIII, 2, vv. 1-2.
24
“tecnico” di essere narrazione di secondo grado: scelta senz’altro dipendente
dall’influenza dell’episodio virgiliano di Didone e dalla volontà di una nobilitazione in
senso epico. Quanto a struttura e funzione diversiva, tuttavia, esso presenta senz’altro
dei forti legami sia con il genere novellistico in quanto tale (la strutturazione della
novella come genere letterario, d’altronde, quale che sia la sua origine, non dipende
naturalmente dall’essere o meno narrazione di secondo grado, come dimostra proprio
nei secoli XV e XVI la diffusione della cosiddetta novella “spicciolata” 24 , ossia
composta come narrazione autonoma e indipendente da una cornice o dalla collocazione
in una raccolta), sia con il suo inserimento sistematico entro il poema narrativo, dovuto
essenzialmente a Boiardo25.
All’aspetto della varietà entro il poema epico, d’altra parte, il Trissino non mancò
affatto di riconoscere una funzione di un certo rilievo nella struttura narrativa, in netto
contrasto con l’immagine di narrazione monolitica trasmessa dalla vulgata critica. Egli
lo sottolinea espressamente in apertura della Sesta divisione della sua Poetica, parlando
della maggiore ampiezza testuale del poema epico rispetto alla tragedia26:
La qual grandezza ancora, oltra che lo fa parer più magnifico, è utile a far variamente mutare gli
animi degli auditori et a farvi introdurre dissimili episodii, ché ’l simile tosto sazia.
L’ampiezza testuale permette e anzi richiede secondo il Trissino l’introduzione di
episodi di carattere diversivo, in ottemperanza a quel principio di variatio che,
rappresentato in modo paradigmatico da Ariosto, si vorrebbe invece assente o irrilevante
nell’autore che la storiografia critica ha eletto, non senza forzature, a suo opposto
speculare, radicalizzando in maniera senz’altro eccessiva e fuorviante un’opposizione
risalente, ma con tutt’altre sfumature, al Tasso teorico27. Senza dubbio, invece, è proprio
24
Sulla novella “spicciolata” cfr.: MARTELLI, M., Considerazioni sulla tradizione della novella
spicciolata, in La novella italiana, cit. tomo I, pp. 215-44; MAURIELLO, A., Dalla novella spicciolata al
romanzo. I percorsi della novellistica fiorentina nel secolo XVI, Napoli, Liguori, 2001.
25
FRANCESCHETTI, A., La novella, cit., p. 817: «il primo autore a far uso in maniera estensiva di questa
componente [la novella] nella struttura narrativa del poema cavalleresco è proprio il Boiardo».
26
TRISSINO, G. G., Poetica (V-VI), in Trattati di retorica e di poetica del Cinquecento, a cura di
WEINBERG, B., vol. II, Bari, Laterza, p. 47.
27
TASSO, T., Discorsi dell’arte poetica, II: « Non era peraventura cosí necessaria questa varietà a’ tempi
di Virgilio e d’Omero, essendo gli uomini di quel secolo di gusto non cosí isvogliato: però non tanto
v’attesero, benché maggiore nondimeno in Virgilio che in Omero si ritrovi. Necessariissima era a’ nostri
tempi; e perciò dovea il Trissino co’ sapori di questa varietà condire il suo poema, se voleva che da questi
gusti sí delicati non fosse schivato: e se non tentò d’introdurlavi, o non conobbe il bisogno, o il disperò
come impossibile. Io, per me, e necessaria nel poema eroico la stimo, e possibile a conseguire ». Questo
stringato giudizio del Tasso, che ha senz’altro molto influenzato la vulgata critica sul Trissino, sembra
sostanzialmente negare la presenza di qualsiasi principio di variatio nell’Italia liberata; certamente
l’atteggiamento del Tasso critico è qui molto diverso da quello che mostrerà il Tasso poeta nella Liberata,
25
questo il principio ispiratore della variatio che porta il Trissino ad introdurre l’episodio
novellistico-romanzesco costituito da questo libro III, così come pure i successivi
episodi digressivi di carattere più specificamente cavalleresco ai quali verremo fra poco.
E d’altra parte leggendo il poema del Trissino nella sua interezza si nota chiaramente
l’intenzione, benché non molto ben riuscita, di strutturare il procedere della narrazione
su una costante alternanza di modelli e forme narrative differenti, ora epici, ora
romanzeschi, ora più marcatamente storiografici, ora basati sul tale topos, ora sul tal
altro, in modo tale da conferire sia una certa unità narrativamente compiuta ai singoli
libri (come nella tradizione epica classica e in opposizione al romanzo), sia al contempo
una certa costante varietà di modi del racconto nell’arco complessivo del poema28.
Ecco allora che l’episodio di Giustino e Sofia si presenta nel complesso come una
digressione di stampo novellistico – pur non essendo tecnicamente una novella –
esemplata sulla tipologia boccacciana della novella in forma di romanzo greco: questo
modello, tuttavia, per essere convenientemente inserito non più in un contesto
romanzesco come quello del Furioso, ma nel contesto epico del poema eroico rifondato,
subisce una complessiva nobilitazione proprio attraverso la contaminazione con una
serie di modelli epici appropriati, anomali rispetto all’idea corrente del genere epico
astratto (sostanzialmente corrispondente, possiamo dire, al modello iliadico filtrato
dall’interpretazione dell’aristotelismo rinascimentale) e non a caso più vicini invece alla
polarità romanzesca, novellistica e di argomento amorosa. Se dunque l’innamoramento
reciproco di Giustino e Sofia, che sviluppa il punto di partenza della trama da romanzo
greco, segue tuttavia il duplice modello epico della Medea di Apollonio e della Didone
virgiliana (i due ipotesti sono chiaramente compresenti e non alternativi, come è stato
detto 29 ), di cui riprende tra l’altro alcune similitudini centrali (cerva ferita, pensiero
dove appunto egli desume ampiamente dal Trissino prima di tutto proprio gli elementi di variatio
romanzesca presenti nel suo poema.
28
Per dare un’idea di tale ricerca della varietà narrativa, fornisco un breve elenco della schematica
tipologia complessiva (che per brevità tace le molte contaminazioni e gli elementi minoritari) a cui si
possa ricondurre ogni singolo canto dell’Italia liberata: I. epico – II. topos epico (catalogo) – III.
novellistico/romanzesco – IV. romanzesco – V. romanzesco – VI. romanzesco – VII. epico/storico – VIII.
storico – IX. topos epico (catabasi) – X. storico – XI. epico, poi romanzesco – XII. epico – XIII. topos
epico (“doloneia”) – XIV. topos epico (ambasceria) – XV. epico – XVI. storico, poi romanzesco – XVII.
topos epico del duello, poi storico – XVIII. epico (sconfitta) – XIX. epico (“doloneia” e fine dell’ira) –
XX. topos epico (grande aristia) – XXI. topos epico (duello fra i due eroi principali) – XXII. romanzesco
– XXIII. topos epico (giochi funebri) – XXIV. topos epico-romanzesco (ekphrasis sulla storia futura) –
XXV. storico e romanzesco – XXVI. storico e romanzesco – XXVII. epico.
29
SEGANTI, P., Il Trissino attinge al secchio di Apollonio Rodio, «Italian Studies», XXXIII (1978), pp.
72-76 (cui si rimanda per le corrispondenze più dettagliate con Apollonio) sostiene, sulla base di alcuni
indizi di maggiore vicinanza testuale, che il poeta greco sia vero modello qui imitato; un simile
atteggiamento ancora legato ad una ricerca filologica delle fonti appare oggi senz’altro superato: è
26
mutevole come luce rifranta da un catino d’acqua), il tormento della donna all’insorgere
della passione amorosa e il colloquio in forma di confidenza affettuosa con la sorella, la
scena successiva – dopo la partenza per mare dell’esercito guidato da Belisario –
rielabora la DiÕj ¢p£th di Iliade XIV facendone protagonisti Giustiniano e Teodora,
pur epurandola dell’elemento centrale dell’inganno e riducendola a una pura scena di
seduzione coniugale. Ma il ritorno di Giustino, richiamato subito dopo la partenza per
sposare Sofia, si trasforma in un naufragio secondo lo schema romanzesco (non
immemore del naufragio di Rinaldo in Furioso XLI, ma forse anche di quello di Alatiel
nella parodia di romanzo greco di Decameron II, 7)30: il naufragio, tuttavia, viene a sua
volta puntualmente nobilitato in quanto topos che la tradizione romanzesca condivide
anche di quella epica; se la funzione narrativa è quella del romanzo greco, l’ipotesto che
viene direttamente imitato è però il naufragio di Odisseo in Odissea V, vv. 282 e sgg.,
di cui sono ripresi in particolare il monologo del protagonista che, sul punto di
annegare, rimpiange di non essere morto combattendo e l’intervento salvifico della
divinità (puntualmente convertita in angelo). Ecco gli evidenti contatti nel monologo:
TRISSINO, Italia, III:
O come ha detto il ver questo nocchiero
Che tosto in mar sarebbe aspra tempesta;
Eccola giunta e mena tal furore
Ch’io non vedo con gli occhi altro che morte.
O felici color che pongon freno
Ai lor disiri o fortunati quelli
Che saran morti dalle man de Goti
Nel por la bella Ausonia in libertade
Questi avran gloria eterna e fian sepolti
Dalle pietose man dei loro amici
Ed io rimarrò morto in mezzo all’onde
Senza sepolcro aver se non dai pesci
E morrò nella mia fiorita etade
Quando teneva in man tutta la speme
Dei maggior ben ch io disiasse al mondo
OMERO, Odissea, V, vv. 299-312:
ê moi ™gë deilÒj, t… nÚ moi m»kista gšnhtai;
de…dw m¾ d¾ p£nta qe¦ nhmertša eἶpen,
¼ m' œfat' ™n pÒntJ, prˆn patr…da ga‹an ƒkšsqai,
¥lge' ¢napl»sein· t¦ dὲ d¾ nàn p£nta tele‹tai.
o†oisin nefšessi peristšfei oÙranÕn eÙrÝn
ZeÚj, ™t£raxe dὲ pÒnton, ™pispšrcousi d' ¥ellai
panto…wn ¢nšmwn· nàn moi sîj a„pÝj Ôleqroj.
trˆj m£karej Danaoˆ kaˆ tetr£kij, o‰ tÒt' Ôlonto
Tro…V ™n eÙre…V, c£rin 'Atre dVsi fšrontej.
æj d¾ ™gè g' Ôfelon qanšein kaˆ pÒtmon ™pispe‹n
½mati tù Óte moi ple‹stoi calk»rea doàra
Trîej ™pšrriyan perˆ Phleίwni qanÒnti.
tî k' œlacon kteršwn, ka… meu klšoj Ãgon 'Acaio…·
nàn dš me leugalšJ qan£tJ e†marto ¡lînai."
Naturalmente non manca di esercitare il suo peso anche la più celebre ripresa del
medesimo passo odissiaco, la tempesta che apre l’Eneide con le parole di Enea a loro
volta apertamente modellate su quelle di Odisseo (Aen. I, vv. 92-101):
evidente che i due modelli, tanto più di fronte a un luogo virgiliano che è fra i più celebri della letteratura
occidentale, sono compresenti e sovrapposti.
30
L’impazienza a partire di Giustino nonostante le avverse condizioni del mare e il parere contrario dei
marinai ricorda a sua volta dei luoghi della tradizione cavalleresca: la partenza di Rinaldo per l’Inghilterra
in ARIOSTO, Fur. II, 28, vv. 1-4 (« Contra la voluntà d’ogni nocchiero, / pel gran desir che di tornare avea,
/ entrò nel mar ch’era turbato e fiero / e gran procella minacciar parea ») e quella di Rodomonte per la
Francia in Boiardo, Inn. II, VI, 6-7, cui tra l’altro segue puntualmente la tempesta in mare. Anche di
questo topos l’ascendenza è tuttavia classica, risalendo al Cesare di LUCANO che sfida il mare nonostante
il parere contrario del nocchiero Amiclate e i numerosi segnali di tempesta imminente (Fars. V, 532
sgg.).
27
Extemplo Aeneae solvuntur frigore membra:
ingemit, et duplicis tendens ad sidera palmas
talia voce refert: “O terque quaterque beati,
quis ante ora patrum Troiae sub moenibus altis
contigit oppetere! O Danaum fortissime gentis
Tydide! Mene Iliacis occumbere campis
non potuisse, tuaque animam hanc effundere dextra,
saevus ubi Aeacidae telo iacet Hector, ubi ingens
Sarpedon, ubi tot Simois correpta sub undis
scuta virum galeasque et fortia corpora volvit?”
Particolarità, forse un poco ridicola, di questo naufragio trissiniano è che conduce
il naufrago a destinazione: Giustino viene trovato privo di sensi sulla riva del mare
proprio nei pressi del palazzo imperiale dove era diretto, dando luogo così a un doppio
tentativo di suicidio che sembra una parodia ante litteram del finale di Romeo e
Giulietta, capovolto in un lieto fine anch’esso piuttosto ridicolo in cui al posto del
groviglio dei contrattempi shakespeariani troviamo un perfetto tempismo che evita la
tragedia: lei lo crede morto e, lamentandosi con accenti petrarcheschi31, si avvelena; lui
recupera i sensi e credendo morta lei corre nella stanza dell’amata pronto a togliersi la
vita, ma la trova risanata, giusto in tempo, dall’antidoto del medico di corte. Questa
somiglianza nel finale mi porta a ipotizzare un’influenza dei vari modelli italiani della
tragedia shakespeariana, non a caso notoriamente novellistici; in particolare, La
Giulietta di Luigi Da Porto, tra l’altro vicentino come il Trissino e suo contemporaneo,
può aver suggerito il contrattempo nell’avvelenamento per la presunta morte della
persona amata: è senz’altro molto verosimile che la novella, pubblicata nel 1531 e poi di
nuovo nel ’39 (ma si sa che il Bembo, amico del Da Porto, la lesse già nel 1524), fosse
conosciuta dal Trissino e sia stata da lui ripresa nello snodo conclusivo, per quanto volto
in lieto fine32. Un aspetto, questo, che avvalora l’ipotesi di un’impostazione novellistica
dell’episodio.
31
“… E tu pur vivi? / Tu pur ardisci di guardare il sole, / sendo stata cagion del suo morire?”, cfr.
PETRARCA, RFV 292, v. 9: «Et io pur vivo, onde mi dolgo e sdegno», in combinazione con uno stilema
per cui cfr. anche EURIPIDE, Medea, vv. 1327-8: kaˆ taàta dr£sas' ¼liÒn te prosblšpeij / kaˆ
ga‹an, œrgon tl©sa dussebšstaton; Lo stilema sarà ripreso da TASSO, con ben altri effetti, per
Tancredi uccisore di Clorinda, Lib. XII, 75, vv. 1-2: «Io vivo? io spiro ancora? e gli odiosi / rai miro
ancor di questo infausto die?».
32
Entrambe le versioni si leggono oggi in Novellieri del Cinquecento, a cura di GUGLIELMINETTI, M.,
Milano-Napoli, Ricciardi, tomo I, 1972, pp. 239-288 (su cui cfr. GUGLIELMINETTI, M., Amore e morte:
Giulietta e Romeo di Luigi Da porto, in «Leggiadre donne…». Novella e racconto breve in Italia, a cura
di BRUNI, F., Venezia, Marsilio, 2000, pp. 69-84). A differenza che in Shakespeare, Giulietta qui si
risveglia prima che Romeo muoia del veleno già ingerito, dando luogo così ad ampie lamentazioni dei
due sfortunati amanti; infine, dopo la morte di lui, Giulietta non ricorre al pugnale ma muore, non troppo
verosimilmente, d’apnea: «deliberando di non più vivere, raccolto assé il fiato e alquanto tenutolo, e
poscia con un gran grido fuori mandandolo, sopra ’l morto corpo morta si rese» (p. 282). A confermare il
rapporto Da Porto-Trissino non mancano alcune corrispondenze testuali, come l’autoaccusa di Sofia or
28
Come si vede già da questo rapido excursus, l’intero canto si pone come una
diversione ispirata al criterio romanzesco della varietà, dopo i primi due libri
pesantemente insistiti su toni epici monotoni e quasi arcigni (consiglio di guerra,
prodigio, catalogo dell’esercito ecc.); la funzione digressiva di natura romanzesca
traccia uno schema narrativo da novella ispirata a una trama di amore e peripezie da
romanzo greco, ma poi un tale modello, per poter essere assunto nel contesto epico alto,
deve essere nobilitato attraverso un’effettiva realizzazione testuale che ricorre
costantemente a modelli epici sentiti come particolarmente affini al romanzesco e con
esso conciliabili. Per quanto l’esito effettivo non risulti certo entusiasmante,
l’operazione condotta dal Trissino è senz’altro complessa e meditata nella mescolanza
di generi e di modelli, nel tentativo di creare quella che potremmo definire una
digressione epica di natura novellistica, che riprenda la funzione ritardante all’inizio
dell’opera di Eneide IV coniugandola con quella più recente e attuale delle novelle
boiardesche e ariostesche. La pecca principale, a livello narrativo, è che l’episodio
appare drasticamente slegato dalla trama del poema, avendo il suo solo, inconsistente
legame con essa nell’essere contemporaneo alla partenza dell’esercito: un errore contro
il quale Trissino avrebbe dovuto trovare un chiaro avvertimento nella sua attenta lettura
della Poetica aristotelica33. L’errore non è imputabile naturalmente ad Ariosto e alla
tradizione cavalleresca, che fondano sul procedere digressivo l’intera struttura narrativa
(tanto nella diegesi di primo grado, attraverso la pluralità di trame in entrelacement,
quanto in quella di secondo grado, attraverso le novelle). Ma anche in una struttura di
impostazione epica, esso non sarà ripetuto da Tasso nel compiere un’operazione molto
ora ricordata: «Il tuo caro Giustino a morte è giunto / per venirti a trovare; e tu pur vivi? / Tu pur ardisci
di guardare il sole, senso stata cagion del suo morire? / Lassa, non fia mai ver ch’io resti viva, / senza ’l
diletto mio caro consorte», cfr. Da Porto: «Dunque nella mia presenza e per mia cagione dovete, signor
mio, morire? E il cielo concederà che dopo voi, benché poco, io viva? Misera me, almeno a voi la mia
vita potessi donare, e sola morire!» e poi ancora: «Se voi per la mia finta morte morite, che debb’io per la
vostra non finta fare?».
33
ARISTOTELE, Poetica, 1451a, 30-36: cr¾ oân, kaq£per kaˆ ™n ta‹j ¥llaij mimhtika‹j ¹ m…a
m…mhsij ˜nÒj ™stin, oÛtw kaˆ tÕn màqon, ™peˆ pr£xewj m…mhs…j ™sti, mi©j te eἰnai kaˆ taÚthj
Ólhj, kaˆ t¦ mšrh sunest£nai tîn pragm£twn oÛtwj éste metatiqemšnou tinÕj mšrouj À
¢fairoumšnou diafšresqai kaˆ kine‹sqai tÕ Ólon· Ö g¦r prosÕn À m¾ prosÕn mhdὲn poie‹
™p…dhlon, oÙdὲn mÒrion toà Ólou ™st…n (trad. da ARISTOTELE, Poetica, traduzione e introduzione di
PADUANO, G., Roma-Bari, Laterza, 1998, da cui sono tratte tutte le successive traduzioni dello stesso
testo: « Come dunque, nelle altre imitazioni, è imitazione unitaria quella di un solo oggetto, così anche la
trama, essendo imitazione di un’azione. dev’esserlo di una sola e intera, e le parti che la compongono
devono essere collegate in modo tale che, cambiando o togliendo una parte, l’intero risulti alterato e
sconnesso: infatti quello che, presente o assente, non produce conseguenze evidenti, non è parte
dell’intero »). 1451b, 33-36: tîn dὲ ¡plîn mÚqwn kaˆ pr£xewn aƒ ™peisodièdeij e„sˆn ce…ristai·
lšgw d' ™peisodièdh màqon ™n ú t¦ ™peisÒdia met' ¥llhla oÜt' e„kÕj oÜt' ¢n£gkh εἰnai (trad.: «
Fra le trame e le azioni semplici, quelle episodiche sono le peggiori: per episodica intendo una trama in
cui gli episodi si susseguono l’uno all’altro senza verosimiglianza né necessità »).
29
simile a questa con l’episodio di Olindo e Sofronia34, in cui il rapporto con la trama –
nonostante i dubbi dell’autore 35 – è perfettamente garantito a livello paradigmatico
dall’intervento di Clorinda, che funge anche, eccellentemente, da entrata in scena e
presentazione del personaggio. La successiva soppressione dell’episodio tassiano nella
Gerusalemme conquistata mostra inoltre come l’inasprimento in senso epico che
presiede alla riscrittura del poema non coincida necessariamente con un riavvicinamento
al Trissino: per l’aspetto ora esaminato, la Liberata appare senz’altro più vicina della
Conquistata alla struttura dell’Italia.
Ma la presenza del romanzesco nell’Italia liberata si spinge in realtà ben oltre la
sua presenza ambigua e ibridata con altri generi di questa prima diversione, e chiama
ampiamente in causa, dopo il romanzo antico e la tradizione novellistica, proprio quel
moderno romanzo cavalleresco di cui nella vulgata critica il poema trissiniano
costituirebbe l’antitesi stessa. Recentemente solo Claudio Gigante, rivedendo
parzialmente e approfondendo l’analisi del suo precedente contributo sul Trissino,
afferma chiaramente la necessità di correggere tale vulgata e riconoscere senza più
pregiudizi la reale potata della presenza del romanzesco nell’Italia. Egli scrive
chiaramente36:
…l’Italia liberata, che indubbiamente segue per molti episodi la traccia storica di Procopio di
Cesarea proponendo nel contempo imbarazzanti parafrasi dell’Iliade, assorbe pure nella sua trama una
quantità considerevole di spunti «romanzeschi» che derivano spesso proprio da quel Furioso che era
destinato, secondo Trissino, a essere apprezzato soltanto dal «vulgo».
[…]
Ma Trissino non si limita a ciò [riprodurre l’Iliade], e attinge a piene mani da quella stessa
tradizione «romanzesca» che ufficialmente ha ripudiato…
Poi, proponendo un rapido excursus degli episodi di natura romanzesca presenti in
tutto l’arco del poema, egli nota, dopo la menzione di quegli stessi elementi che stiamo
ora analizzando e dei successivi rapporti ancor più stretti con la tradizione cavalleresca
che vedremo fra breve37:
34
Come nota DE SANCTIS, La letteratura italiana nel secolo XIX, vol. II, La scuola liberale e la scuola
democratica, Napoli, Morano, 1902, parlando appunto della tradizione novellistica: « In mezzo alla
narrazione generale è qualche episodio commovente, la novella antica introdotta nella tela. Il Tasso stesso
che voleva fare un poema serio come l’Iliade e l’Eneide, ve le ha messe [le novelle]. Che cosa è infatti
Olindo e Sofronia? » (p. 18).
35
Cfr. TASSO, Lettere, n. 532, A Lorenzo Malpiglio: « Fra le cose che debbono esser mutate è l’episodio
di Sofronia, ch’è nel secondo canto, come già mi consigliarono il Sig. Flamminio vostro e ’l Sig. Barga,
uomini dottissimi » (ed. Guasti).
36
GIGANTE, C., Epica e romanzo in Trissino, cit. p. 301 e 312.
37
Ibid., p. 315.
30
Quasi un quarto del poema è passato senza che alcun avvenimento della guerra imperiale contro i
Goti sia stato narrato: niente male, per un’opera che ha la reputazione di essere aristotelicamente unitaria
e troppo schiacciata sulla storia…
Non c’è dubbio che la revisione della vulgata prospettata da questa posizione vada
nella giusta direzione e debba essere approfondita, benché implichi, ben al di là di un
riesame dell’opera trissiniana che può interessare solo a pochi specialisti, una parziale
ridefinizione in senso di maggiore complessità dell’intero quadro dell’epica
rinascimentale e del tradizionale rapporto fra Ariosto e Tasso. La contrapposizione
frontale fra epos e romanzo, che pure affonda senz’altro le sue radici nel dibattito critico
cinquecentesco, è meno marcata di quanto non si creda, e non sono soltanto i due autori
principali del secolo a proporre, seppure con diversi equilibri, un efficace compromesso
fra le due polarità di genere: persino il Trissino, che si vorrebbe rappresentante di una
linea epica “pura”, a un esame più attento del suo poema risulta partecipare senz’altro a
pieno titolo di simili soluzioni di compromesso, anticipando molto da vicino, e spesso
anzi suggerendogliele, alcune celeberrime soluzioni strutturali e narrative adottate dal
Tasso. L’opposizione fra Ariosto e Trissino come rappresentanti per antonomasia di
romanzo ed epos rinascimentali, canonizzata dalla celebre pagina del Tasso critico, va
senz’altro smussata non solo riconoscendo l’ampia presenza epica nel primo (dato
critico del tutto acquisito), ma anche riconoscendo senza pregiudizi quella del
romanzesco nel secondo.
Dopo lo sbarco dell’esercito di Belisario a Brindisi e la resa del tutto pacifica
della città (con una clamorosa alterazione del dato storico, che testimonia invece uno
sbarco in Sicilia e di lì la risalita della penisola), con la seconda parte del IV libro,
quando l’impresa epica a stento ha trovato niente più che il suo avvio, irrompe nel
poema la componente cavalleresca. Si presenta a questo punto, anzi, di un topos
cavalleresco quant’altri mai: l’arrivo presso il luogo dove sono radunati i cavalieri (in
genere la corte) di una fanciulla bellissima scortata da un aiutante, la quale narra le sue
sventure e invoca l’aiuto dei cavalieri, innescando così una serie di avventure. Il topos si
ritrova in alcuni dei più celebri romanzi della tradizione arturiana, come in Guiron le
Courtois e nella Tavola ritonda, ma naturalmente ha il suo precedente più importante
nel Boiardo 38 . L’arrivo alla corte di Carlo Magno di Angelica scortata dal fratello
38
I precedenti romanzeschi dell’arrivo di Angelica nell’Innamorato sono individuati nei lavori di critica
delle fonti primonovecenteschi: RAZZOLI, G., Per le fonti dell’Orlando innamorato di Matteo Maria
Boiardo: Parte 1a. I primi trenta canti del poema, Editore Albrighi, Segati e C., 1901, pp. 6-9; BERTONI,
G., Nuovi studi su M. M. Boiardo, Zanichelli, Bologna, 1904. Come riassume BRUSCAGLI nel suo
commento all’Innamorato, Torino, Einaudi, 1995 (p. 13, nota all’ottava 21 del primo canto), «La scena
31
Argalia, che apre l’Innamorato con un discorso mendace della bellissima principessa
del Cataio, e la conseguente sfida, “truccata” grazie alla stessa lancia incantata che si
ritroverà poi nel Furioso, il cui l’esito è di allontanare dalla corte i due cavalieri più
forti, Orlando e Ranaldo (esattamente come avverrà di nuovo all’inizio del poema
ariostesco), viene ripreso molto da vicino dal Trissino nella sezione iniziale del suo
poema: la bellissima donzella incantatrice si chiama qui di Ligridonia (nome parlante di
etimo greco, allegorico come quasi tutti quelli dei personaggi romanzeschi trissiniani), e
come Angelica è dotata di un anello magico e similmente narra ai cavalieri di Belisario
un racconto mendace di un inesistente sopruso subito, in modo tale da allontanarli
dall’accampamento verso di una sfida di carattere del tutto cavalleresco; i cavalieri,
come di prammatica, la seguono in buon numero e sono condotti presso un fonte
incantato, dove si svolge la sfida con Faulo, complice di lei, il quale li fa prigionieri
vincendoli uno ad uno in duello grazie ad una lancia incantata, perfettamente parallela a
quella di Argalia nell’Innamorato. Come si vede, il testo boiardesco è ripreso molto da
vicino nella sua struttura narrativa, ma con l’intento primario di mutuare attraverso di
esso un celebre topos d’innesco delle avventure della tradizione cavalleresca. Sarà
inviato a liberare i compagni Corsamonte, che tuttavia finirà per innamorarsi di
Ligridonia e seguirla anziché contrastare il suo progetto. Al di là dell’ampio spazio
testuale di questa prima ventura cavalleresca
e dei suoi spiccati rapporti con la
tradizione arturiana e con Boiardo, ciò che qui importa soprattutto è l’evidente esito di
una simile sovrapposizione di un topos cavalleresco ad una trama epica: la sua ripresa
nella Gerusalemme liberata per l’arrivo di Armida al campo crociato nel canto IV.
Naturalmente l’ascendenza trissiniana dell’episodio della Liberata da cui «quasi da
fonte, derivano quasi tutti gli episodi», come lo stesso Tasso nota esponendo la “favola
della Gerusalemme”39, è nota alla critica, ma il rilievo di questo contatto tende ad essere
sempre sminuito, come fosse marginale: in realtà invece questo episodio dell’Italia è
senza dubbio il precedente più importante e privilegiato non solo dell’episodio tassiano
in sé, ma soprattutto proprio della sua funzione narrativa entro la struttura del poema. I
precedenti cavallereschi del topos, infatti, mostrano come esso in un contesto
romanzesco valga semplicemente da innesco ad una serie di venture da cui originano le
dell’arrivo di Angelica e della sua proposta (ott. 27-28) ricorda quella analoga del Guiron le Courtois, in
cui una donzella accompagnata da un gigante sfida i cavalieri riuniti alla corte di Artù per Pentecoste;
simile situazione nella Tavola Ritonda, in cui Escorducarla, scortata dal fratello Lasancis, a cui ha donato
una lancia fatata, si propone di fare prigionieri tutti i cavalieri di Artù e di arderne il palazzo».
39
L’argomento del poema è notoriamente esposto dal Tasso in una lettera del 27 luglio 1576 a Orazio
Capponi.
32
trame episodiche e aperte di cui sono protagonisti i cavalieri, ossia in fondo la materia
stessa di quel genere narrativo; lo stesso avviene anche in un altro precedente
dell’episodio molto rilevante per Tasso, quello presente nell’Amadigi di suo padre
Bernardo Tasso40. Nel capolavoro di Torquato Tasso, invece, esso vale piuttosto a dare
avvio alla devianza romanzesca che si oppone, a partire dal concilio infernale, al telos
epico rappresentato e quasi incarnato da Goffredo, sottraendo i cavalieri principali
all’impresa cristiana per consegnarli alla spinta centrifuga dell’erranza cavalleresca e
della ventura: aspetto giustamente centrale nella critica tassiana ed eccellentemente
approfondito soprattutto dai noti studi di Sergio Zatti 41 . Ad essere invece rimasto
sempre nell’ombra è il fatto che proprio questa straordinaria rifunzionalizzazione
tassiana del romanzesco entro una struttura narrativa epica, tale da generare una
tensione di forze narrative da cui origini lo sviluppo della trama, permettendo al
contempo di far coesistere le attrattive del romanzo con il rigore dell’epica filtrata
attraverso la lettura dell’aristotelismo rinascimentale, è a tutti gli effetti un’intuizione
del Trissino. È proprio il presunto campione dell’epica più rigida e intransigente a
mettere apertamente in relazione le esigenze strutturali della trama nel suo sviluppo con
le due opposte tradizioni generiche di epos e romanzo, attribuendo al genere
romanzesco la funzione diversiva e sospensiva di una trama principale unitaria di
stampo marcatamente epico. Certamente una simile funzionalizzazione del genere
letterario a fini strutturali è ravvisabile in nuce già in Ariosto e per certi versi anche in
Boiardo, ma in quei casi si tratta di opere prettamente romanzesche con una pluralità di
trame parallele, di cui quella bellica di matrice epica non è che una fra le altre, e non
informa affatto di sé la trama dell’intero poema, come invece avviene nei poemi epici
del Trissino e poi, sul suo esempio, del Tasso.
La trama epico-storica della guerra contro i Goti, dunque, subisce a questo punto
dell’Italia un primo grande arresto attraverso la digressione romanzesca che origina
dall’arrivo al campo di Ligridonia (che poi prosegue occupando per intero anche tutto il
libro seguente, il quinto), perfettamente in parallelo con quanto avviene in Tasso. I
cavalieri fatti prigionieri da Ligridonia, Corsamonte compreso, si trovano infatti in un
giardino incantato con tanto di fontane che inducono all’oblio del valore, dove
40
BERNARDO TASSO, Amadigi, XVI, 43 sgg., dove Oriana, figlia del re di Polonia, fa la sua comparsa alla
corte alla presenza di Amadigi; un cavaliere che la accompagna narra allora la sua storia che, seppure non
mendace, è molto vicina a quella narrata da Armida, con cui condivide l’argomento centrale del regno
usurpato. Per una rassegna dei precedenti a disposizione di Torquato Tasso per tale topos, cfr. V.
VIVALDI, Sulle fonti della Gerusalemme liberata, Catanzaro, Caliò, 1893, pp. 156 sgg.
41
ZATTI, S., L’uniforme cristiano e il multiforme pagano. Saggio sulla Gerusalemme liberata, Milano, Il
Saggiatore, 1983; ID., L’ombra del Tasso, cit.
33
trascorrono il loro tempo fra piaceri e diletti, immemori della loro vita passata. Di
nuovo un topos fra i più celebri della tradizione arturiana, quello del giardino incantato,
variante funzionalmente affine dell’altro topos del palazzo incantato: entrambi ricorrono
più volte in Boiardo e Ariosto, ma risalgono alla tradizione del romanzo cortese. Come
si sa, il topos del luogo dove vengono magicamente trattenuti i cavalieri (giardino o
palazzo che sia) è sfruttato anche come punto di raccordo fra le varie trame in
entrelacement, che subiscono un comune momento d’arresto trasformandosi in una vera
e propria empasse narrativa che dev’essere superata grazie a un intervento esterno di un
personaggio con la funzione di “aiutante”, come avviene col dissolvimento del palazzo
di Atlante ad opera di Astolfo (Furioso, XII, 16 sgg.). Ma per la versione che ricorre in
particolare al giardino incantato, che si incrocia anche con la lunga tradizione del locus
amoenus, i più diretti precedenti del Trissino sono quelli di Dragontina prima e di
Falerina poi nell’Innamorato (I, XIV, 35 sgg. e II, IV, 20 sgg.) e quello descritto
nell’isola di Alcina nel Furioso (VI, 20-25): in essi cavalieri e dame sono prigionieri
dell’incantatrice di turno, finché il giardino (in genere con annesso palazzo) non viene
dissolto per opera rispettivamente di Angelica, Orlando e Melissa. Naturalmente
l’archetipo di una simile struttura narrativa risale già all’episodio odissiaco di Circe, che
forse non manca di esercitare una sua influenza, ma paradossalmente il contatto più
stretto è però proprio con l’autore per eccellenza considerato l’antitesi del Trissino,
quell’Ariosto che, ben più marcatamente di quanto avvenga nella tradizione precedente,
sovrappone all’intera ventura di Ruggero nell’isola di Alcina forse la più celebre
narrazione allegorica rinascimentale. Trissino infatti, qui come altrove nel poema,
arriverà a generalizzare tale abbinamento fra digressione cavalleresca e allegoria, quasi
a legittimare l’ampia presenza di quell’elemento anomalo in un’ottica aristotelica
attraverso la semantizzazione nobilitante di un insegnamento morale. In parallelo a
quanto avviene in Ariosto, i nomi allegorici rimandano scopertamente a una lettura
“sotto il velame” dell’intero episodio, che oltre a un corteggio di figure allegoriche
secondarie vede contrapposte le due incantatrici maligne simboleggianti il vizio
(Ligridonia e Acratia, ossia secondo l’etimo greco, λυγρὰ ἡδονή, il “piacere funesto,
rovinoso” e ἀκράτεια, l’“incontinenza”, l’incapacità a dominarsi) alla loro prigioniera
simboleggiante la virtù (Areta, ossia appunto ἀρετή, “virtù, valore”) 42 : evidente la
ripresa della contrapposizione fra Alcina e Logistilla nel Furioso.
42
Per un’interpretazione complessiva delle allegorie di Italia liberata V, cfr. GALLO, V., Paradigmi etici
dell’eroico e riuso mitologico nel V libro dell’‘Italia’ di Trissino, in «Giornale Storico della Letteratura
Italiana», a. CXXI 2004, vol. CLXXXI, fasc. 595, pp. 373-414.
34
Ciò che più importa in tutto questo è di nuovo l’influenza che il Trissino eserciterà
sul Tasso. Spiccate sono le corrispondenze di singoli elementi, ma ancor più rilevante è
anche qui l’affinità nella rifunzionalizzazione del topos romanzesco in vista di una più
ampia strutturazione narrativa. Si può allora ravvisare nella novità di una coppia di
aiutanti-liberatori, Traiano e Achille, che si sostituisce al liberatore singolo (Angelica,
Orlando, Melissa ecc.), il precedente più diretto di Carlo e Ubaldo della Liberata 43
insieme a una successiva coppia di emissari di Belisario che incontreremo più avanti
nello stesso poema trissiniano; anche la figura che li istruisce, l’angelo Palladio, che
ripete la funzione di Ermes nell’episodio di Circe, ha un carattere sacrale senz’altro più
vicino alla figura sapienziale del tassiano mago d’Ascalona di quanto non lo siano i
personaggi prettamente cavallereschi che svolgono la stessa funzione in Boiardo o
Ariosto; persino l’abbinamento fra il palazzo dell’incantatrice e il motivo dell’ekphrasis
pittorica il cui tema mette en abîme l’allegoria dell’episodio (esempi di lussuria in
Trissino, uomini soggiogati da donne in Tasso) è ulteriore motivo d’affinità. E se tutta
la splendida sezione finale dell’abbandono di Armida – straordinaria riscrittura di una
fortunatissima tipologia di scena che va da Euripide e Apollonio, passando naturalmente
per Catullo e Virgilio, fino ad arrivare all’Ariosto dell’episodio di Olimpia – manca di
un corrispettivo nell’Italia, che qui invece si mantiene più vicina al modello ariostesco
nella
finale
rivelazione
della
metaforica
deformità
come
autentica
natura
dell’incantatrice (attraverso la comune ripresa della “femina balba” di Purgatorio XIX),
la riscrittura del poema porta il Tasso, nella Conquistata, a riavvicinarsi al Trissino nel
dare ad Armida una punizione definitiva che la vedrà scomparire in quel punto dal
poema, legata definitivamente a una rupe «co’ nodi d’adamante e di topazio» di
petrarchesca memoria (Triumphus Pudicitie, v. 122)44.
43
Ancor più stretto si farà il rapporto nella successiva Gerusalemme conquistata, dove fra Ruperto e
Araldo (la nuova versione di Carlo e Ubaldo), il primo dei due sarà proprio l’amico fraterno del grande
eroe da salvare, modellato sul Patroclo omerico, esattamente come nell’Italia del Trissino è Achille,
amico fraterno di Corsamonte.
44
Su tale riscrittura dalla Liberata alla Conquistata si veda RESIDORI, M., Armida e Proteo. Un percorso
tra Gerusalemme Liberata e Conquistata, «Italique», II, 1999, pp. 113-42, che giustamente nota
l’analogia con la “proteiforme” fine di Ligridonia e Acratia nell’Italia liberata: « Quando si vider prese
quelle maghe, / Mutorsi in acqua, per voler fuggire,/ E quasi che li’ uscir fuor de le braccia; / Pur le
ritenner fortemente; e poi / Volsersi in foco, e in paventose serpi, /Volsersi in fumo, in nube, in tigre, e in
orse, / Né mai però lascionle i buon guerrieri. / Ond’elle, visto che ’l cangiar figura / Non le giovava, ne la
prima forma /Tornaro, e tutte liete si voltaro / Adolci prieghi, a parolette, e ciance; /Ma parimente fur
gettate al vento; / Che la virtù del cielo havea sì chiuse / Le orecchie a quei Baron, che non sentiro / La
forza, e ’l suon de i lor soavi accenti». Sui precedenti di tale scena si veda GALLO, V., Paradigmi etici
dell’eroico e riuso mitologico nel V libro dell’«Italia» di Trissino, «Giornale Storico della Letteratura
Italiana», CXXI 2004, vol. CLXXXI, fasc. 595, pp. 373-414 (in particolare la sezione intitolata
Proteimorfismo, pp. 390-392). Ampiamente illustrata, nell’articolo di Residori, è la caratterizzazione
proteiforme di Armida nel passaggio dal primo poema alla sua riscrittura.
35
Ma al di là di queste corrispondenze fra particolari, il vero punto di contatto fra
Trissino e Tasso sta nell’uso che viene fatto di questo episodio topico della letteratura
cavalleresca a fini strutturali di tutt’altro genere rispetto alla precedente tradizione
romanzesca. Lì infatti la prigionia di numerosi cavalieri ad opera della figura più o
meno marcatamente antagonistica dell’incantatore o incantatrice, il cui esito ultimo sarà
la ridanciana parodia di Don Chisciotte ricondotto a casa in gabbia dalla sua “seconda
uscita”, resta sostanzialmente un episodio fra i tanti in cui si snodano le molteplici
trame. Ariosto, in questo caso, è di nuovo il tramite per una rifunzionalizzazione in
senso più ampio quando fa del palazzo di Atlante, assieme alla pazzia di Orlando, il
centro del suo poema: nodo in cui si incrociano, momentaneamente, molteplici trame
dell’opera, come abbiamo già accennato esso diventa anche l’empasse narrativo il cui
superamento permetterà di far convergere gradualmente i personaggi principali verso il
grande finale guerresco ed epico. Tuttavia la natura ancora eminentemente romanzesca
del Furioso non permette di attribuire a tale episodio un ruolo radicalmente opposto al
consueto meccanismo narrativo della ventura. In Trissino, invece, viene introdotta
senz’altro questa novità di fondo, che sarà ripresa nella sua sostanza da Tasso: i
cavalieri fatti prigionieri dall’incantatrice (Ligridonia, Armida), e in particolar modo
l’eroe principale (Corsamonte, Rinaldo), sono sottratti al loro ruolo epico di strumenti di
una missione collettiva e assiologicamente superiore alla avventure individuali,
caratterizzando il ricorso al genere romanzesco come polarmente opposto – dal punto di
vista narrativo e strutturale come da quello valoriale – alla trama principale di natura
spiccatamente epica. Ecco che allora, alla fine di questa lunga ventura durata ben un
canto e mezzo, per circa 1500 versi, uno dei cavalieri potrà concludere esplicitamente,
evidenziando il ruolo strutturale dell’episodio:
Ritorneremo a Belisario il grande,
che forse accusa la tardanza nostra.
Ancor più chiaramente, al ritorno dei cavalieri al campo, dopo aver ascoltato il
racconto della loro vicenda, Belisario asserisce:
Valorosi e leggiadri alti Baroni,
Noi loderemo il Re de l’universo,
Che v’ha tornati con vittoria al campo
Fuor di tanti perigli e tanti inganni.
Dapoi fia ben, che proseguiam la guerra,
che’l differir ne l’ordinate imprese,
36
spesso è un venen, ch’atterra ogni ventura45.
Si vede bene come simili formulazioni contro la diversione e l’erranza, e
ovviamente tutto il nuovo impianto narrativo e strutturale ad esse soggiacente, siano
l’immediato presupposto, ad esempio, dell’iniziale diniego di Goffredo alla richiesta di
Armida nella Liberata (IV, 68):
Ma se queste sue gregge e queste oppresse
mura non torniam prima in libertade,
giusto non è, con iscemar le genti,
che di nostra vittoria il corso allenti.
o della sua preoccupazione accorgendosi della furtiva partenza di molti a seguito
della bellissima donna (V, 85):
Ma già ne lo schiarir de l’aer bruno
s’era del lor partir Goffredo accorto,
e la mente, indovina de’ lor danni,
d’alcun futuro mal par che s’affanni.
Lo stretto rapporto che lega il Tasso al Trissino, ben al di là di una mera “fonte”
secondaria di qualche sparuto episodio da relegare in nota in un commento, si gioca
innanzitutto su tali soluzioni strutturali di primaria importanza nei rispettivi poemi. Ma
ciò risulta ancora più evidente subito dopo nel testo dell’Italia liberata, dove il rapporto
con Tasso si fa ancor più stretto. I cavalieri hanno appena fatto in tempo a ritornare al
campo presso Brindisi dopo la loro erranza cavalleresca che il meccanismo narrativo si
ripete, anche se i suoi esiti saranno ora molto diversi: di nuovo arriva al campo una
bellissima donzella, stavolta di nome Elpidia (libro VI), che narra a Belisario e agli altri
cavalieri la sua triste storia (stavolta, però, non mendace): ella è la principessa di
Taranto, cui il padre è stato ucciso e il regno sottratto; pertanto ella chiede aiuto ai
cavalieri di Belisario e promette di concedersi in sposa a quello a cui il capitano voglia
destinarla. Come al solito, tutti i baroni si accendono d’amore per lei, suscitando
speranze e gelosie reciproche. L’affinità con l’arrivo di Armida al campo crociato non
potrebbe essere più forte, e non necessita di ulteriori chiarimenti. Il topos della donzella
che arriva alla corte e racconta la sua triste storia è presentato nella parte iniziale
45
Da notare tra l’altro, in questo passo, l’uso del verbo “differire”, esprimente una funzione tipicamente
romanzesca (come nota ZATTI, Il Furioso fra epos e romanzo, cit., pp. 24-26) e il capovolgimento
dell’uso del termine “ventura” in contesti cavallereschi: da avventura individuale il termine passa qui a
designare, all’opposto, la fortuna epica e militare che è esattamente opposta all’erranza cavalleresca.
37
dell’Italia liberata due volte di seguito a breve distanza, ma con diversa connotazione
morale, poiché in questo secondo caso non si tratta di un’incantatrice menzognera e
malintenzionata, ma di un’autentica principessa infelice e defraudata del suo regno,
secondo un’altra variazione dello stesso motivo.
La sovrapposizione in Armida di entrambi i modelli consecutivi di Ligridonia ed
Elpidia si fa ancora più evidente se guardiamo allo sviluppo della vicenda: l’invidia
reciproca suscitata fra i pretendenti accende in particolare un contrasto fra Corsamonte e
Aquilino, entrambi innamorati più di tutti gli altri, che si rivela senza dubbio il
principale antecedente dello scontro fra Rinaldo e Gernando nella Liberata; è vero che lì
Rinaldo, il corrispettivo di Corsamonte, non viene alla lite per amore di Armida, ma ciò
accade soltanto perché c’è un passaggio in più consistente nella nomina del successore
di Dudone: il motivo del contrasto, dipendente dal comportamento di Eustazio, è
comunque immediata conseguenza dell’arrivo della bella maga e della discordia che ella
porta con sé nel campo crociato. Le due scene risultano molto simili anche nel loro
svolgersi, con gli alterchi collerici fra Corsamonte e Aquilino in parallelo a quello fra
Rinaldo e Gernando 46. Esattamente come nella Liberata, l’esito ultimo del contrasto
interno all’esercito che origina in questo punto sarà l’allontanamento dalla guerra
dell’eroe più forte (Corsamonte, Rinaldo). La differenza sta invece nel fatto che la vera
e propria lite è in Trissino differita di alcuni libri dall’intervento pacificatore del vecchio
Paulo (modellato sul Nestore iliadico): per sua proposta, Elpidia andrà in moglie al
guerriero che dimostrerà maggior valore in combattimento. Ancora una volta, a
differenza del Tasso, il Trissino riprende un elemento di ascendenza cavalleresca: lo
stesso che apre l’Orlando furioso con la promessa di Carlo di concedere in sposa
Angelica a chi fra Orlando e Rinaldo si mostrerà più valoroso nel combattere i mori,
promessa a sua volta risalente naturalmente all’Innamorato (II, XXIII, 15-16). Questo
stratagemma narrativo permette al Trissino di “sospendere” il potenziale diversivo e
centrifugo implicito nella funzione narrativa della contesa per Elpidia, dando spazio alla
prima grande sezione epica dell’assedio di Napoli (libro VII): in quella battaglia
daranno dunque prova del loro valore sia Aquilino sia, soprattutto, Corsamonte, che da
solo entra nelle mura di Napoli, assumendo in questo caso i tratti dell’eroe persino
troppo ardimentoso e tracotante che ha i suoi principali precedenti nel Turno di Eneide
IX e nel Rodomonte dell’assedio di Parigi (Fur. XVI). In tal modo, insomma, la
46
Il parallelismo si farà ancor più spiccato, anche attraverso la mediazione omerica, nella
Conquistata, con l’ampliamento del dialogo fra i due contendenti e il tentativo di intervento pacificatore
da parte del vecchio saggio Giovanni, parallelo a quello di Paulo in Trissino (cfr. Nestore).
38
funzione sospensiva del romanzo viene a sua volta ad essere sospesa per dar luogo,
momentaneamente, all’elemento epico.
Ma l’assedio di Napoli, che da solo corrisponderebbe all’intera materia narrata nel
poema tassiano, non è che la prima fase della guerra narrata nell’Italia liberata. Dopo
altri due libri (VIII e IX) in cui l’azione bellica è di nuovo sospesa, ma stavolta senza
ricorrere al romanzesco (il libro VIII narra infatti gli avvenimenti storici
dell’incoronazione di Vitige a re dei Goti, in sostituzione dell’imbelle e pauroso
Teodato, e del suo matrimonio con Amata, mentre il libro IX ripercorre il topos epico
della catabasi con il viaggio di Belisario a Cassino, dove un eremita emulo della Sibilla
Cumana lo conduce in uno speco in cui egli avrà la visione dei grandi uomini del
passato e del futuro, compresa la sorte dell’Impero fino al sedicesimo secolo), l’esercito
muove infine a Roma, che si consegna spontaneamente a Belisario.
Ma proprio a questo punto, prima che l’azione bellica ricominci nella lunga
sezione centrale del poema dei combattimenti per la città di Roma, capovolgendo come
in Eneide IX il rapporto fra assedianti e assediati, la contesa fra Aquilino e Corsamonte
per la bella Elpidia torna ad accendersi (libro XI) e libera tutto il potenziale diversivo
che cinque canti prima era rimasto latente e sospeso, innescando la ben più grave e
rilevante contesa fra Corsamonte e Belisario, parallela a quella fra Rinaldo e Goffredo.
A questo punto si inserisce dunque il primo grande nucleo narrativo di derivazione
omerica, di cui ci occuperemo nel capitolo ad esso relativo; per ora basti notare come
sull’elemento cavalleresco della contesa fra due forti cavalieri per una bella donna, che
il re o il capitano tentano di volgere a favore dell’impresa bellica promettendola in sposa
a chi si dimostrerà più valoroso, si innesta il modello epico per eccellenza della contesa
fra Achille e Agamennone in Iliade I, che qui dà luogo a quella fra Corsamonte e
Belisario: un abbinamento che sarà ripreso puntualmente dal Tasso nell’innestarsi sulla
contesa di Rinaldo con Gernando di quella, meno cruenta ma ben più grave, fra il primo
e il capitano Goffredo.
Ciò che qui ci interessa anticipare è che, della contesa iliadica fra Achille e
Agamennone, il Trissino non desume solo le forme rappresentative esteriori in una
servile imitazione la cui unica motivazione sia l’omaggio al grande modello, come
troppo facilmente si pretende di affermare per questo rapporto fondante dell’Italia
liberata con Omero: egli ne individua e desume, al contrario, proprio la funzione
narrativa fondamentale entro la struttura dell’Iliade, quel modulo narrativo che la
39
moderna omeristica ha individuato nello schema “withdrawal-devastation-return” 47 e
che, da un punto di vista strutturale, risponde a una funzione sospensiva del procedere
verso il telos epico del tutto omologa (seppure certamente in un registro più elevato) a
quella di cui abbiamo più volte visto rivestito l’elemento romanzesco. Anzi, il ritiro del
guerriero “necessario” al compimento dell’impresa, che sarà così importante in Tasso,
ha senz’alcun dubbio il primo e più importante modello proprio in questa fondamentale
struttura iliadica, per cui la œrij fra Achille e Agamennone è l’archetipo della discordia
portata da Armida e della contesa fra Rinaldo e Goffredo, e come ben si vede il Trissino
ne è per il Tasso, ancora una volta, il principale mediatore.
Ma il rapporto fra Trissino e Tasso si spinge oltre questo punto, venendo a
interessare il vero nucleo essenziale della struttura narrativa dei rispettivi poemi. Se
infatti Aquilino, a differenza del Gernando tassiano, non viene ucciso da Corsamonte
(corrispettivo di Rinaldo) perché i due vengono divisi per tempo dai compagni, il suo
ferimento tuttavia non manca di suscitare lo sdegno di Belisario, perfettamente parallelo
a quello di Goffredo: l’effetto comune ai due poemi sarà dunque, come si è detto, la
contesa fra il capitano dell’esercito e il suo guerriero più forte, che porterà
all’allontanamento di quest’ultimo. Ma l’aspetto senz’altro più importante di questo
strettissimo rapporto fra l’Italia e la Liberata è la modalità in cui si attua questo ritiro
del guerriero “necessario” e il codice narrativo che di nuovo chiama in causa.
Corsamonte rimarca in un monologo fra sé e sé l’ingratitudine e la crudeltà del capitano
nei suoi confronti, esattamente come farà Rinaldo sfogandosi con Tancredi:
TRISSINO, Italia, XI:
Che l’empio Capitan può ben vietarmi
Che sposa non mi sia, ma non può tormi
Ch io non l’osservi sempre e sempre adori.
Ben fu troppo crudel la sua sentenza,
E troppo ingiusta a non voler ch ell’abbia
Per suo consorte un uom che le talenti,
E voler che Aquilin governi ’1 tutto.
TASSO, Liberata, V, 43:
Ma s’a i meriti miei questa mercede
Goffredo rende e vuol impregionarme
pur com’io fosse un uom del vulgo, e crede
a carcere plebeo legato trarme,
venga egli o mandi, io terrò fermo il piede.
Poi decide, come Rinaldo su consiglio di Tancredi, di allontanarsi dal campo e
ritirarsi dal combattimento; e il vero nucleo profondo del rapporto fra Trissino e Tasso
di cui dicevamo sta proprio qui, nella scelta – centrale negli equilibri della Liberata –
che Rinaldo compie riproponendo esattamente il modello, qui non più privilegiato ma
davvero unico, del Corsamonte trissiniano: entrambi gli eroi, già precedentemente
caratterizzati come militari che pure conservano ampi tratti del cavaliere errante di
47
LORD., A. B., The Singer of Tales, Cambridge, MA, Harvard Univ. Press, 1960, trad. ital.: Il cantore di
storie, Lecce, Argo, 2005.
40
ascendenza arturiana 48 , esautorati dal loro compito epico e dall’impresa collettiva si
rivolgono senz’altro alla ricerca della gloria personale, attraverso una vera e propria
regressione a cavalieri erranti in cerca di “venture” di sapore decisamente arturiano:
TRISSINO, Italia, XI:
Deh non star, Corsamonte, in questo campo
Ove non si dà premio a la virtute
Ma procacciati pur d’altra ventura
Perciò che quel Baron che cerca onore,
Non dee mai dimorar sotto ’1 governo
D’un capitan volubile et ingiusto.
TASSO, Liberata, V, 52:
Parte, e porta un desio d’eterna ed alma
gloria ch’a nobil core è sferza e sprone;
a magnanime imprese intent’ha l'alma,
ed insolite cose oprar dispone:
gir fra i nemici, ivi o cipresso o palma
acquistar per la fede ond'è campione,
scorrer l’Egitto, e penetrar sin dove
fuor d'incognito fonte il Nilo move.
Come si vede, la scelta di Rinaldo dipende direttamente da quella, identica, di
Corsamonte. Entrambi i guerrieri “necessari”, dopo la contesa con il capo dell’esercito
che li spinge al ritiro dalla guerra, si danno all’erranza cavalleresca, sovrapponendo in
tal modo al motivo iliadico del ritiro di Achille quello antiepico della ventura di tipo
romanzesco, in una decisiva risemantizzazione del modello omerico che, se ha senza
dubbio in Tasso, di gran lunga, la sua realizzazione di maggior pregio, nasce tuttavia da
un’idea del Trissino. È il poeta vicentino a concepire sia la ripresa funzionale del nucleo
narrativo centrale dell’Iliade, sia la sovrapposizione ad esso del codice romanzesco,
sviluppando in maniera compiuta e strutturante quell’opposizione assiologica e
narrativa fra impresa bellica e ventura cavalleresca che era solo più genericamente
suggerita dai poemi di Boiardo e Ariosto, e facendone invece il nucleo portante
dell’opera. Tasso riprenderà questa stessa strutturazione fondamentale e ne farà a sua
volta il baricentro del delicatissimo equilibrio della Liberata, portandola a un esito
decisamente più perfezionato e di ben altro valore, ma bisogna riconoscere senza mezzi
termini che non ne è lui l’ideatore.
Giova sottolineare che ciò, naturalmente, non depone affatto a sfavore del Tasso
né intacca minimamente il giudizio di valore sul suo capolavoro: se oggi riconoscere
rapporti intertestuali non ci porta più a sminuire, grossolanamente, il “merito”
dell’autore come faceva Rajna nella Conclusione delle sue Fonti dell’Orlando furioso49,
48
Sul rapporto del personaggio tassiano di Rinaldo con la tradizione cavalleresca, evidente sin dal nome,
cfr. SHERBERG, M., Rinaldo. Character and Intertext in Ariosto and Tasso, Saratoga, Anma Libri, 1993.
Sugli elementi cavallereschi nel personaggio di Corsamonte, cfr. JOSSA, S., La fondazione di un genere. Il
poema eroico tra Ariosto e Tasso, Roma, Carocci, 2002, cap. 4: L’uccisione del romanzo (pp. 139-155):
ne condivido l’analisi ma non la metaforica e semplificante conclusione – che seguendo alla lontana H.
Bloom fa quello che potremmo chiamare “psicologia dei generi letterari” – dell’uccisione del romanzo
come premessa all’affermazione dell’epos eroico.
49
Cfr. p. 610 (ed. 1900, ristampa del 1975): «Sicché per il merito d’uno scrittore non è nient’affatto
indifferente, secondo me, che abbia trovato egli stesso, o che abbia preso da altri la materia» o p. 612:
41
permangono comunque ancora molti pregiudizi più o meno latenti su un rapporto diretto
fra originalità e giudizio di valore; ma se un tale rapporto, figlio di un’estetica
romantico-avanguardistica, comincia forse a rivelare di non essere il criterio di giudizio
più adatto neppure per le opere che di quella stessa prospettiva estetica sono l’esito,
meno che mai lo è per opere del Rinascimento maturo, che vede nell’imitazione di
modelli precedenti – antichi e moderni – il cardine stesso del suo straordinario progetto
culturale ad artistico. Se dunque la critica ha in fondo sempre assecondato la tendenza a
sminuire e quasi occultare l’apporto del Trissino al poema tassiano, grazie al comodo
lasciapassare di un giudizio di valore incontestabilmente negativo, ciò forse è dipeso in
parte, magari in modo non del tutto consapevole, proprio da un tale pregiudizio che
sembrava inficiare il valore della Liberata nel riconoscere che essa, pur
perfezionandole, inglobava in sé, proprio fra le sue strutture profonde e fondamentali,
elementi niente affatto originali e per di più desunti in buona parte da un’opera
unanimemente – e giustissimamente – considerata di gran lunga ad essa inferiore. Forse
i tempi sono maturi per superare un tale sottaciuto imbarazzo e riconoscere che, se
anche alcuni nodi fondamentali e celebratissimi della struttura della Liberata non sono
affatto originali, ma desunti a piene mani dal malriuscito poema trissiniano, ciò non
inficia il valore dell’opera più di quanto riconoscere che il verso «conosco i segni de
l’antica fiamma» non è in effetti dantesco ne sminuisca il pregio o la genialità entro il
suo nuovo contesto.
Proprio come sarà per Rinaldo, dunque, il ritiro dal combattimento di matrice
achilleica viene declinato già per Corsamonte in senso decisamente romanzesco: egli si
mette in viaggio insieme al fraterno amico Achille 50 (il suo Patroclo) finché non
giungono ad un’abbazia, dove l’abate – in qualità di “destinatore” dell’impresa, in
termini greimasiani – suggerisce a Corsamonte un modo per recuperare l’amata Elpidia.
Si tratta appunto di una ventura cavalleresca quant’altre mai, anzi di stampo prettamente
arturiano, che dispiega in pompa magna tutto l’apparato del meraviglioso romanzesco:
egli deve uccidere un drago, carpendo il segreto di come lo si manda a morte dalla ninfa
che ne è custode, cavargli il fiele e cospargerne gli occhi della cieca fata Plutina, che in
tal modo riacquisterebbe la vista, così da esaudire qualunque cosa egli desideri; non
«Quindi, per parte mia, conchiudo, che se Messer Lodovico avesse inventato da sé il moltissimo che ebbe
da altri, alla corona della sua gloria se ne aggiungerebbe più che una foglia d’alloro».
50
Qui c’è un contatto testuale fra la partenza di Corsamonte e Achille e quella di Rinaldo che, proprio
nella sua insignificanza, mostra quanto Tasso stia imitando da vicino il testo del Trissino: « egli tutti
ringrazia e seco prende / sol duo scudieri, e su ’l cavallo ascende » (Lib., V, 51, vv.7-8); « E ratti s’avviar
verso la porta, / avendo seco dui famigli soli » (Italia, XI).
42
manca naturalmente il solito libro magico che fa da manuale d’istruzioni all’impresa. Di
nuovo il romanzesco è legittimato dalla lettura allegorica che gli è sovraimposta:
all’allegoria centrale per cui Plutina (da πλοῦτος, “ricchezza”) rappresenta la ricchezza
cieca nel suo distribuirsi51 fanno da contorno una lunga serie di allegorie secondarie,
fino a formare un piccolo catalogo allegorico nel corteggio della potente fata52. Vero è
che tale ventura rimane in sospeso nella sua prima fase, con Corsamonte e Achille
presso la corte della fata, e la seconda parte – la vera e propria impresa arturiana
dell’uccisione del drago – non avrà mai luogo: ma in fondo tale incompiutezza, oltre ad
avere una sua giustificazione di superficie a livello allegorico (per cui la ricchezza resta
di fatto cieca com’è), assolve così anche alla sua funzione narrativa di diversione e
sospensione del progredire verso il telos epico. E d’altra parte anche qui la soluzione
tassiana non sarà molto diversa nella sostanza, ma solo nel valore: ciò che qui serve non
è la ventura vittoriosa del romanzo, celebrazione del cavaliere che prelude soltanto ad
una nuova ventura in una catena potenzialmente aperta, quanto piuttosto la ventura
come empasse narrativo, in cui la trama dell’eroe ritiratosi dal combattimento, dopo
un’erranza avventurosa, finisca per arrestarsi e giungere a un punto morto,
specularmente parallelo a quello dell’impresa epica che non può giungere a compimento
senza di lui. Una ventura, insomma, del tipo di quella che abbiamo visto prima del
giardino o del palazzo incantato in cui i cavalieri restano prigionieri. Il che è appunto
quanto avviene in Tasso, dove la ventura di Rinaldo, raccontata in gran parte
indirettamente dal Mago d’Ascalona a Carlo e Ubaldo (Lib., XIV, 50-70), finisce per
diventare esattamente un punto morto in cui la ventura di Rinaldo subisce un arresto
presso il giardino di Armida alle isole Fortunate fino alla sua richiamata da parte dei due
emissari di Goffredo. Precisamente quanto avviene anche a Corsamonte nel poema del
Trissino, la cui vicenda resta in sospeso presso la dimora della fata Plutina; lì nel libro
XIV egli riceverà l’ambasceria di Traiano e Ciro – modellata su Iliade IX e anch’essa
ripresa dal Tasso, insieme alla precedente missione di Traiano e Achille per la
liberazione da Ligridonia, per il viaggio di Carlo e Ubaldo –, i quali lo pregheranno di
tornare a combattere all’assedio di Roma, dove Belisario e i suoi versano i gravi
difficoltà proprio per la sua assenza. A differenza di Rinaldo, e come invece fa Achille,
51
L’allegoria si fa del tutto scoperta, molto banalmente, quando Corsamonte le chiede conferma della sua
identità: «Siete voi quell’altissima Plutina, / Che tanto è disiata da le genti?» (Italia, XI).
52
«Ma sopra tutte l’altre con diletto / E con gran tenerezza gli abbracciaro / Basilia e Stratigea che aveano
il primo / Grado che dar si soglia in quella corte / Eran con esse Eulalia e Dorotea / E dopo lor venian da
lunge alquanto / Arpagia con Calunnia e Colachia / E Demetria e Geopona e Liea / Pimenia Emporia con
Trapezia vile / Et altre donne pallide e deformi / Che mai non s accostaro a quei signori» (Italia, XI).
43
Corsamonte rifiuterà momentaneamente, restando ancora in attesa di compiere la
ventura della fata Plutina. A farlo tornare a combattere, lasciando perdere il compimento
dell’impresa romanzesca della fata, sarà invece – nel libro XIX, dopo ben nove libri di
sua assenza dal combattimento –
la notizia del rapimento di Elpidia ad opera di
Turrismondo e Argalto, due dei guerrieri principali della parte dei Goti: a differenza che
in Tasso, ma in perfetto parallelo con l’Iliade, come vedremo meglio nel capitolo
relativo, la riconciliazione con il capo dell’esercito e con l’impresa epico-militare
avverrà soltanto per una sovrapposizione di scopi fra le ragioni belliche della collettività
e quelle private di natura prettamente affettiva (il salvataggio di Elpidia come in Omero
l’uccisione di Patroclo).
Questa rassegna dei più importanti episodi di carattere prettamente romanzesco
mostra già in tutta evidenza non solo quanto sia rilevante – tanto dal punto di vista
quantitativo, quanto da quello strutturale – l’apporto del codice romanzesco entro il
poema epico del Trissino, ma anche e soprattutto quanto stretta e persino determinante
appaia l’influenza che esso esercitò sul poema tassiano, contribuendo in maniera
davvero decisiva alla creazione di quell’ambiguo equilibrio oppositivo fra epos e
romanzo da cui discende gran parte del fascino e della bellezza della Liberata. Le
strutture fondamentali del recupero del romanzesco in Tasso, quelle legate
principalmente al personaggio di Rinaldo, che per buona parte del poema incarna, per
così dire, il provvisorio “regresso” al codice romanzesco in opposizione al ruolo epico
di Goffredo, risultano a un’analisi attenta e dettagliata desunte in massima parte proprio
dal poema trissiniano. Naturalmente nell’effettiva realizzazione poetica di questo
fondamentale impianto strutturale c’è fra i due autori una differenza abissale, ma come
si è detto il giudizio di valore non deve interferire con il riconoscimento di un debito
che può essere, come in questo caso, molto profondo e persino determinante. Bisogna
dunque evitare di sminuire la portata di questo rapporto, come fanno Quondam e anche
Zatti nei contributi ricordati in apertura del capitolo, riconoscendo che invece esso non
solo è decisamente molto esteso, ma influenza profondamente proprio le strutture
portanti del poema tassiano che Zatti stesso ha magistralmente contribuito a mettere in
luce.
Ovviamente la superiorità di valore del Tasso non si gioca soltanto a livello di
dizione e di elaborazione poetica del testo – dove pure lo scarto risulta davvero massimo
–, ma riguarda comprensibilmente anche l’efficacia nell’organizzazione narrativa degli
elementi di derivazione romanzesca che siamo venuti fin qui esaminando: d’altronde il
44
Tasso dimostra una capacità di controllo della strutture narrative e dei loro equilibri che
certo non è inferiore alle sue straordinarie doti poetiche, e non bisogna dimenticare che
la principale critica che egli mosse all’Italia liberata concerne, non a caso, proprio
questo livello dell’opera. L’effettivo risultato nell’uso degli elementi romanzeschi e
della loro rifunzionalizzazione in contesto epico, insomma, nonostante i forti contatti, è
anch’esso molto superiore in Tasso. Nell’Italia, infatti, vediamo che gli episodi
romanzeschi da una parte interrompono l’azione epica in modo troppo vistoso, senza
fondersi affatto nella mirabile unità di tono pur nella varietà che invece caratterizza la
Liberata, e dall’altra mostrano un carattere piuttosto ripetitivo sia nell’insistenza
costante sul monotono pedale dell’allegoria, sia soprattutto nell’evidente duplicazione
delle due diversioni cavalleresche principali di Ligridonia e poi di Elpidia, che ripetono,
per di più a breve distanza, lo stesso topos della fanciulla bellissima che giunge al
campo a chiedere soccorso: proprio tale duplicazione, infatti, viene eliminata dal Tasso
sovrapponendo e fondendo i due modelli sull’unico episodio di Armida, che come si è
visto è profondamente debitore dell’uno e dell’altro precedente trissiniano.
Ma proprio la giustissima critica del Tasso ci mostra in tutta chiarezza che l’errore
strutturale del Trissino quanto al suo uso del codice romanzesco origina da tutt’altra
parte, ossia precisamente da ciò che il Tasso, con grande acutezza, gli rimproverava: la
scelta di una materia storica troppo ampia per essere davvero unitaria. Egli scrive nel
primo libro dei Discorsi dell’arte poetica:
E questo medesimo si può notare nel Trissino, il qual volle che fosse soggetto del suo poema tutta
la spedizione di Belisario contra a i Goti: e perciò è molte fiate piú digiuno ed arido, ch’a poeta non si
converrebbe; ché, s’una parte solamente, e la piú nobil di quella impresa, avesse tolta a descrivere, per
aventura piú ornato e piú vago di belle invenzioni sarebbe riuscito.
Il carattere difettoso e inefficace del pur ampio ricorso al romanzesco nell’Italia
dipendente infatti precipuamente, nel suo carattere ripetitivo, dal costituirsi a livello
strutturale come variazione episodica alla componente epico-storica comunque
predominante. Ma a ben guardare tale difetto non è affatto intrinseco all’uso che il poeta
vicentino fa del romanzesco. Piuttosto, è proprio la pluralità e la sequenza di imprese
belliche scollegate e di diversi teatri successivi di guerra, come vedremo meglio nel
capitolo sulle fonti storiche del Trissino, a far sì che anche la diversione dalla trama
epico-bellica principale non possa essere unitaria e coerente, e questo appunto
semplicemente perché non è unitaria neppure quella: di fronte ad una moltiplicazione
45
delle imprese belliche e dei teatri dell’azione devono necessariamente essere
moltiplicate anche le devianze digressive che ne dilazionano il compimento. L’errore,
dunque, risale alla definizione della troppo ampia e ripetitiva trama principale: la
ripetizione delle diversioni non ne è che l’inevitabile riflesso. Anzi, posto questo errore
di base perfettamente individuato dal Tasso, la gestione della pluralità di diversioni che
ne risulta è in effetti gestita anche piuttosto intelligentemente dal Trissino, evitando una
mera ripetizione della diversione romanzesca e traendo piuttosto dall’Iliade, in vera e
propria variatio della funzione diversiva, la possibilità di una diversione di natura epica:
quella su cui si fonda tutta la prima parte del poema omerico, dalla lite fra Achille e
Agamennone fino alla riconciliazione in seguito alla morte di Patroclo (Iliade I-XIX).
Un aspetto che spesso sfugge, infatti, a certe semplificazione ravvisabili a volte negli
studi di italianistica è che, se è vero che il romanzesco tende nettamente a caratterizzarsi
come genere per eccellenza aperto e tendente alla diversione, è altrettanto vero che
anche il genere epico, che talvolta viene troppo facilmente identificato con la struttura
chiusa e teleologica, è a sua volta dotato di mezzi propri per generare diversioni e
dilazioni del compimento dell’impresa a cui la trama è volta: l’Iliade è interamente
strutturata appunto su un meccanismo di questo tipo, per cui oltre due terzi della sua
trama non sono altro che la dilazione del ritorno di Achille e dell’uccisione di Ettore che
prefigura e di fatto sancisce la fine di Troia. Il Trissino, in modo molto intelligente, si
accorge perfettamente di questa potenzialità diversiva insita nel genere epico e,
desumendola dall’Iliade, la affianca e intreccia nel suo poema con quella costituita dalla
devianza romanzesca. Se poi il risultato sarà poco efficace se non per certi versi
difettoso, ciò è anche comprensibile data la novità dell’operazione compiuta,
sostanzialmente senza precedenti nella letteratura volgare: il Tasso non avrà che da
giovarsi di tutto questo, correggendo gli errori del suo predecessore e perfezionando col
suo genio una serie di intelligenti suggerimenti che egli vedeva attuati nel poema del
Trissino e che sono molto più rilevanti, per capire le strutture della Liberata, delle molte
opere teoriche rinascimentali sulla poesia narrativa su cui ben più volentieri tende a
soffermarsi la critica rinascimentalista.
L’errore più vistoso del ricorso al romanzesco in Trissino, dunque, risulta così
paradossalmente rovesciato rispetto a quello che tradizionalmente gli viene attribuito:
non è la carenza dell’elemento romanzesco ad essere difettosa, quanto piuttosto il suo
eccessivo proliferare in episodi autonomi e slegati, che non sanno comporre la loro
ripetitiva pluralità in un complesso unitario e coerente, e questo proprio perché plurale e
46
disgregata è già l’eccessivamente ampia materia epica cui devono fare da controparte e
contrappeso. Gli episodi romanzeschi più importanti di Ligridonia e di Elpidia sono di
fatto del tutto slegati e autonomi l’uno dall’altro, così come lo sono dalla vicenda di
Giustino e Sofia e dalle altre due o tre diversioni successive cui ora faremo un rapido
cenno: il tentativo trissiniano di creare un “meraviglioso cristiano” semplicemente
travestendo in forma cristiana le divinità classiche col mutarle in angeli ora favorevoli
ora contrari all’impresa si rivela totalmente insufficiente a dare alle tendenze
centrifughe del romanzesco quella unità che invece Tasso, proprio partendo da tale
carenza del suo predecessore, saprà magistralmente ottenere grazie al concilio infernale
da cui ogni episodio diversivo scaturisce “quasi da fonte” 53.
Dall’analisi condotta, dunque, si può notare che in effetti entrambi i grandi nuclei
narrativi bellici precedenti la presa di Ravenna che conclude l’impresa, ossia l’assedio
di Napoli e la lunga sezione centrale degli scontri di Roma, hanno ciascuno la propria
diversione narrativa: quella di Ligridonia nel primo caso, che sottraendo i cavalieri
appena dopo lo sbarco a Brindisi ritarda la marcia su Napoli, e quella di Elpidia nel
secondo, che invece allontana da Roma il guerriero “necessario” Corsamonte
rifunzionalizzando un modulo iliadico cui si sovrappone un’erranza cavalleresca. Si
vede bene, dunque, che la ripetitività del modulo diversivo, pur variamente declinato,
dipende appunto dalla mancata unità narrativa dell’azione epico-bellica e non è altro che
una diretta conseguenza di quella. Proprio l’individuazione di questo difetto ha
permesso al Tasso di non ripeterlo, ma al tempo stesso di desumere a piene mani quanto
di buono e di utile c’era nelle strutture narrative elaborate dal poeta vicentino.
Tuttavia, se i due grandi nuclei romanzeschi dell’Italia che abbiamo ora
analizzato sono certamente i più rilevanti, soprattutto dal punto di vista strutturale,
ulteriori episodi ed altri elementi di carattere romanzesco sono presenti anche in diversi
altri luoghi successivi del poema. In particolare, nella sezione finale dei combattimenti
presso Roma dopo il ritorno di Corsamonte, tutto il tranello escogitato dal traditore
Burgenzo per trarlo a morte (libro XXII) dipende chiaramente dal modello del traditore
di ascendenza romanzesca (seppure attraverso la linea carolingia delle chansons) del
tipo di Gano di Maganza o del Pinabello del Furioso, naturalmente contaminato e
nobilitato in senso epico classico, come di consueto, con la figura virgiliana di Sinone
(Eneide II); anche il cordoglio di Elpidia per la morte di Corsamonte (libri XXII-XXIII)
53
Sul “meraviglioso cristiano” in Tasso, cfr. BALDASSARRI, G., «Inferno» e «Cielo». Tipologia e funzione
del «meraviglioso» nella “Liberata”, Roma, Bulzoni, 1977.
47
mostra ampi contatti con la fine di Fiordiligi dopo la morte del suo Brandimarte alla fine
del Furioso. Nell’ultima parte del poema, poi, quando che il teatro dell’azione di guerra
si sposta nel nord Italia, la serie di scontri molto dispersivi dal punto di vista narrativo
che precedono l’assedio di Ravenna è a sua volta contrappuntata da due venture di tipo
cavalleresco, quella del viaggio allegorico di Mundello54, inviato a Milano a prendere
possesso della città (libro XXV), e l’impresa di Achille e Traiano per disincantare il
sacello della Madonna miracolosamente trasferito a Loreto, novello Palladio da cui
dipende la possibilità di conquistare l’Italia (libro XXVI). Di nuovo si vede chiaramente
come il romanzesco intenda assolvere alla funzione di variatio della materia bellica di
cui abbiamo detto all’inizio del capitolo.
Sulla ventura di Achille e Traiano bisogna di nuovo notare un contatto con una
delle strutture narrative portanti e più straordinarie della Liberata. Seguendo le
indicazione di un angelo, i due guerrieri inviati da Belisario combattono contro due
mostri allegorici, Ambizio e Avario, sconfiggendo i quali ottengono la liberazione
dall’incantesimo del sacello della Madonna, dal cui disincanto dipende direttamente la
possibilità che l’Italia sia conquistata. Benché dunque questo episodio non mostri a
livello testuale dei palesi contatti col Tasso, e riprenda invece abbastanza da vicino il
simile scontro del Rinaldo ariostesco col mostro anch’esso teriomorfo e allegorico della
Gelosia in Furioso XLII, 46 sgg., ciò nonostante la sua funzione entro la struttura del
poema viene palesemente ripresa nella Liberata: si tratta tuttavia di una corrispondenza
ravvisabile soltanto a livello funzionale e strutturale, che pertanto, mancando di evidenti
legami testuali espliciti con un testo peraltro così poco conosciuto anche dalla critica
come il poema trissiniano, è passata sotto silenzio. Evidente è che il mito del Palladio
che preserva Troia dalla conquista, ricordato nel discorso mendace di Sinone all’inizio
della “Ilioupersis” di Eneide II (ai vv. 162 sgg.), viene ripreso e radicalmente rielaborato
dal Tasso per un nodo cruciale nella trama del suo poema, l’incanto della selva di Saron
da parte del mago Ismeno, che impedisce la costruzione delle macchine da guerra e
dunque, indirettamente, la presa di Gerusalemme; il testo della Liberata, tuttavia,
trattando il topos della selva, mostra fittissimi contatti testuali – ampiamente evidenziati
sin dalla critica delle fonti di epoca positivista – non certo col Trissino, ma semmai con
la lunga tradizione di quel topos: Virgilio, Lucano, Dante, l’Ariosto del Furioso e dei
54
Di nuovo vediamo qui in scena tutti gli elementi del romanzo a dare forma allegorica al mito platonico
(dal Simposio) di Eros (da Trissino filologicamente tradotto “Bramante”) figlio di Poros e Penia, che
nell’allegoria diventa un fanciullo figlio di due giganti.
48
Cinque canti55, solo per citare i principali. Eppure tutti questi modelli sono sì molto
presenti nella costruzione interna dell’episodio tassiano, ma non condividono con esso
la funzione strutturale entro la trama del poema di ostacolo sovrannaturale che
impedisce il compimento di un telos epico già ormai volto verso la conclusione56.
Anche qui emerge chiaramente come sia di nuovo il Trissino, a livello strutturale,
il mediatore più diretto di questa ripresa da cui nasce uno degli elementi simbolici più
celebri e fortunati del poema tassiano. Proprio questo episodio dell’Italia liberata,
infatti, recupera il mito classico dell’oggetto sacro che preserva la città dalla conquista
trasformandolo in un’impresa di registro prettamente cavalleresco consistente nella
vittoria che si deve ottenere, col valore guerriero, su un incantesimo dal cui
scioglimento dipende il compimento della guerra. Ed è esattamente questa
rielaborazione in senso cavalleresco del mito del Palladio come empasse da superare per
portare a termine l’assedio che il Tasso riprende palesemente dal Trissino, facendone un
nodo strutturale della trama. Come sempre, nell’ereditare dal Trissino questa radicale
rielaborazione del mito classico, il Tasso al contempo la fa diventare qualcosa di
infinitamente più interessante e riuscito attraverso alcune geniali modifiche: 1) la
straordinaria declinazione psicologica anziché allegorica dell’incantesimo in questione;
2) la reiterazione dei tentativi di disincanto per cui al fallimento degli altri cavalieri e
segnatamente di Tancredi (canto XIII) segue invece la riuscita di Rinaldo (canto XVIII);
3) la congiunzione di questo motivo di ascendenza classica dell’impedimento “magico”
con l’altro impedimento, più specificamente iliadico, costituito dall’assenza dell’eroe
“necessario” (le due funzioni, che in Trissino restano del tutto divise fra questo episodio
e la vicenda di Corsamonte, vengono infatti a coincidere nel personaggio di Rinaldo,
guerriero “necessario” proprio in quanto unico a poter disincantare la selva).
Vediamo dunque che i due principali nuclei romanzeschi della Liberata che
svolgono una funzione strutturante la trama dell’intero poema, ossia il ruolo svolto da
Armida e la selva incantata di Saron, sono desunti, proprio nella loro funzione
strutturale, essenzialmente dal poema del Trissino. Si vede bene, allora, che l’Italia,
55
VIRGILIO, Aen. III, 22 sgg.; VIRGILIO, Aen. VI, 179 sgg.; LUCANO, Phars. III, 399 sgg.; DANTE, Inf.
XIII, 22 sgg.; ARIOSTO, Fur. VI, 26 sgg.; ARIOSTO, Cinque canti, II, 101 sgg.
56
Vero è che in Lucano, modello principale della selva tassiana, l’episodio della selva costituisce un
momentaneo impedimento alle operazioni militari dell’esercito cesariano contro Marsiglia, così come
nella ripresa Ariostesca dei Cinque Canti, dove la selva incantata della maga Medea deve essere abbattuta
dall’esercito di Carlo Magno per poter giungere ad assediare Praga. In entrambe le opere, tuttavia, il topos
si risolve in un breve episodio in sé concluso che non ricopre minimamente la funzione strutturale che
vediamo nel poema tassiano: non si tratta affatto, cioè, di un impedimento alla conclusione dell’impresa
epica (e del poema), ma solo di un intoppo iniziale e del tutto transitorio. Lì inoltre si tratta di episodi
collettivi che riguarda tutto l’esercito e non di una ventura individuale, benché reiterata, com’è invece in
Tasso.
49
lungi dal negare sostanzialmente il romanzesco come vorrebbe la vulgata, non solo ne fa
un ampio uso, ma soprattutto ne fa un uso eminentemente funzionale alla trama epica
del poema che sarà ripreso molto da vicino dal Tasso, e senza il quale l’intera struttura
della Liberata non sarebbe stata concepibile.
Persino il finale stesso dell’opera, momento epico per eccellenza, è nell’Italia
ampiamente contaminato di romanzesco nella trasformazione del duello risolutore finale
di ascendenza virgiliana in un duello collettivo di dieci contro dieci (libro XXVII), con
evidente influsso del triplice duello di Lipadusa che conclude la trama guerresca del
Furioso nonché del duello risolutore appunto di dieci contro dieci prospettato, ma poi
senza compimento, nel terzo dei Cinque canti ariosteschi. Né mancano numerosi altri
elementi romanzeschi di minore rilievo sparsi qua e là nel corso del poema: il diavolo
Rinfagor evocato dal mago Filodemo57, giganti vari, ekphraseis che tengono presenti
tanti i precedenti classici quanto quelli cavallereschi58 ecc.; persino il tanto disprezzato
“meraviglioso cristiano” del Trissino, goffo fin quasi al ridicolo rispetto all’eccellente
soluzione tassiana di cui pure, ancora una volta, è il precedente più prossimo,
sovrappone certamente l’impianto mitologico classico al Dio cristiano e alle gerarchie
angeliche, ma in questo sviluppa, generalizzandolo all’intero impianto del poema, un
suggerimento presente senz’altro nella tradizione cavalleresca, come ad esempio nella
lunga missione dell’arcangelo Michele per intercessione di Dio in Furioso XIV.
In conclusione di questo riesame della presenza del codice romanzesco nell’Italia
liberata possiamo dunque affermare, correggendo decisamente una drastica
semplificazione della vulgata critica, che:
1) Il romanzesco è ampiamente presente, già solo in un senso banalmente
quantitativo, nel poema trissiniano, e seppure certamente subordinato all’elemento
epico-storico, riveste comunque senz’altro una posizione di primo piano. Almeno
cinque ampie sezioni narrative, come abbiamo visto, pur nella disparità del loro peso
57
Italia XIII. Lo spirito infernale è evocato dal mago Filodemo (corrispettivo del tassiano mago di
Ascalona) per sapere dove sia Corsamonte (cfr. Rinaldo) e poterlo così far richiamare da Traiano e Ciro
(cfr. Carlo e Ubaldo). La scena riprende la simile evocazione degli spiriti compiuta dalla maga Melissa
nell’illustrare a Bradamante la sua progenie in Furioso III, 21 sgg, ma una certa insistenza su elementi
macabri non manca di richiamare anche il celebre episodio lucaneo di necromanzia (Fars. VI, 570 sgg.):
di nuovo l’elemento romanzesco e contaminato e nobilitato con quello epico classico.
58
Si veda in particolare la lunga ekphrasis delle sale affrescate con il futuro che la Sibilla mostra a
Narsete in Italia XXIV, basata sull’evidente modello ariostesco delle pitture profetiche di Merlino nella
rocca di Tristano (Furioso XXXIII). Sull’ekphrasis nei poemi rinascimentali cfr. BALDASSARRI, G., Ut
Pictura pöesis. Cicli figurativi nei poemi epici e cavallereschi in PAPAGNO, A., QUONDAM, A., (a cura di),
La corte e lo spazio. Ferrara Estense, Roma, 1982, pp.605-635; BRUSCAGLI, R., L’ecfrasi dinastica nel
poema eroico del Rinascimento, in Ecfrasi. Modelli ed esempi fra Medioevo e Rinascimento, a cura di
VENTURI, G., FARNETTI, M., Roma, Bulzoni, 2005.
50
negli equilibri del poema, rivelano un carattere marcatamente romanzesco: la ventura di
Ligridonia, l’arrivo di Elpidia, le trame di Burgenzo che portano alla morte di
Corsamonte, la ventura di Mundello e la ventura di Achille e Traiano. A queste si
possono aggiungere senz’altro l’episodio di Giustino e Sofia, che però rimanda piuttosto
al romanzo greco, e anche due digressioni che occupano ciascuna un intero libero e che,
pur fortemente contaminate con i due topoi classici della catabasi epica e della visione
sul modello del Somnium Scipionis ciceroniano, mostrano forti contatti con la ricezione
di tali topoi nella tradizione romanzesca (in particolare Ariosto): la “visione” di
Belisario e l’episodio di Narsete dalla Sibilla con l’ekphrasis pittorica.
2) Tale presenza del romanzesco non è affatto gratuita e strutturalmente
irrilevante, ma tutt’al contrario, soprattutto per i due grandi episodi di Ligridonia e di
Elpidia, non solo risponde a una esigenza di variatio nella materia del poema vivamente
avvertita dall’autore, ma soprattutto – è questo l’aspetto più rilevante – è gravata di una
fondamentale funzione strutturale entro gli equilibri narrativi del poema: associare
costantemente il codice romanzesco e il suo carattere di spinta centrifuga alla necessità
di una diversione dal compimento del telos epico e di una dilazione di tale compimento
da cui origini e si sviluppi gran parte della trama stessa dell’opera. Bisogna riconoscere
senza mezzi termini che tale ricorso generalizzato al romanzesco in funzione
subordinata e alternativa alla trama epica principale, ma comunque sulla base di una sua
complessiva e costante semantizzazione a livello strutturale, costituisce una dei
principali debiti – forse in assoluto il più rilevante – della Gerusalemme liberata nei
confronti dell’Italia liberata del Trissino: che poi l’effettiva realizzazione tassiana di
questo principio strutturale risulti nettamente superiore è tutt’altra questione – peraltro
ovvia –, che non deve portare a sminuire il riconoscimento di tale debito in tutta la sua
portata, né a obliterare o nascondere la sostanziale paternità trissiniana di questa
eccellente idea.
3) Un simile riconoscimento non sminuisce in alcun modo il valore del
capolavoro del Tasso: al contrario, oltre a rendere pienamente conto di un fondamentale
rapporto storico-letterario che la vulgata critica ha sostanzialmente oscurato, rivela
come un poeta di tale livello non abbia avuto nessuna remora a desumere (criticamente)
da un’opera precedente – e persino di scarso valore artistico – tutto ciò che poteva
risultare utile e produttivo per l’unico fine davvero rilevante di dare la miglior forma
possibile alle strutture e alle strategie significative della propria creazione, secondo quel
principio fondante del classicismo rinascimentale che l’estetica moderna – cresciuta
51
all’ombra di Hegel e del pensiero romantico e poi di quello avanguardistico/modernista
– ha saputo sostanzialmente solo sminuire a livello teorico banalizzando in senso
ingenuo il principio dell’imitatio59.
Ma lo specifico utilizzo del romanzesco che lega strettamente il Tasso al Trissino,
per quanto piuttosto eclatante, non è affatto il solo punto di contatto rilevante in questo
rapporto misconosciuto e sminuito: altri importantissimi aspetti di questo legame, non
meno trascurati, sono la scelta della materia storica (e di conseguenza il rapporto con le
fonti storiografiche) e la riscoperta dell’Iliade omerica e il rapporto modellizzante che
ne discende, che nella riscrittura che porta dalla Liberata alla Conquistata subisce un
forte ripensamento in senso accentuativo, a sua volta mediato da una ulteriore
rivalutazione dell’operazione compiuta dal Trissino, come vedremo nei prossimi
capitoli.
59
Tale atteggiamento è già implicitamente ravvisabile nell’estetica hegeliana nello sviluppo dialettico
costituito dai tre momenti dell’arte simbolica, classica e romantica, e in fondo anche affermato
esplicitamente: «Tuttavia vi è qualcosa di più alto che la bella apparenza dello spirito nella sua immediata
forma sensibile [quella appunto dell’arte classica], pur se creata dallo spirito come a lui adeguata. Infatti
questa unione, che si realizza nell’elemento dell’esteriorità e quindi fa della realtà sensibile l’esistenza
appropriata, contrasta a sua volta con il vero concetto dello spirito, e dalla sua conciliazione nel corporeo
lo risospinge a se stesso, alla conciliazione di sé in se stesso [nell’arte romantica]» «Questa elevazione
dello spirito a sé, con cui egli acquista in se stesso la sua oggettività, che dovrebbe altrimenti cercare
nell’esteriore e nel sensibile dell’esistenza, e con cui si sente e sa in questa unità con sé, costituisce il
principio dell’arte romantica. Si lega direttamente a ciò la determinazione necessaria che, per quest’ultima
fase dell’arte, la bellezza dell’ideale classico, e quindi la bellezza nella sua forma più propria e nel suo
contenuto più appropriato, non è più la cosa ultima» (HEGEL, G. W. F., Estetica, Torino, Einaudi, 1997, p.
582: parte seconda, sezione terza, Introduzione. Del romantico in generale). La svalutazione solo parziale
e implicita si fa esplicita nell’estetica di Adorno, ad esempio nella Critica del classicismo (ADORNO, T.
W., Teoria estetica, Torino, Einaudi, 2009 [1970], pp. 215-218) o nelle pagine sulla categoria di
originalità: « È universalmente noto che la categoria dell’originalità non ha esercitato alcuna autorità
prima dell’epoca del genio. Del fatto che nel XVII e nel primo XVIII secolo i compositori riutilizzassero
nelle proprie opere interi complessi tratti sia da opere proprie sia da opere altrui, oppure che pittori e
architetti affidassero i propri abbozzi all’esecuzione dei discepoli, è facile abusare per giustificare ciò che
è aspecifico e fatto con lo stampo. Tuttavia ciò dimostra che in altri tempi non si è riflettuto criticamente
sull’originalità, non già che niente del genere fosse presente nelle opere d’arte » (ibid. p. 230, corsivo
mio).
52
3. LA STORIA
La scelta dell’epica storica e il rapporto con le fonti storiografiche
3.1. Storia e fonti storiche nella Gerusalemme del Tasso
Se si dovesse individuare l’aspetto fondamentale e più immediatamente evidente
che differenzia in maniera radicale i due massimi capolavori della poesia rinascimentale
italiana, potrebbero sussistere pochi dubbi: ciò che distingue immediatamente la natura
romanzesca dell’Orlando furioso da quella decisamente più epica della Gerusalemme
liberata del Tasso, dando origine a quelle notissime differenze di genere e di tono su cui
tanto si è scritto, è senz’altro il carattere storico della materia scelta dal poeta sorrentino
in aperta opposizione alla sbrigliata invenzione fantastica, alla finzione spesso anche
esibita della “favole” del suo grande predecessore. Eppure, scorrendo le bibliografie, si
nota l’assenza quasi totale di studi specifici complessivi sulle fonti storiche del poema
tassiano e sul trattamento effettivo che ad esse l’autore riserva nella composizione
dell’opera. Naturalmente i repertori di fonti, i commenti e numerosi contributi critici
non mancano di citare le fonti storiografiche da cui singoli episodi del poema derivano,
ma si tratta sempre di cenni occasionali, asistematici; manca invece una ricostruzione
generale e soprattutto critica che fornisca un quadro del tipo di rapporto che il poema
“storico” del Tasso stabilisce con le fonti storiografiche da cui desume la materia della
narrazione, chiarendo sia le modalità di questo peculiare rapporto intertestuale con testi
di natura non prettamente letteraria, sia soprattutto il peso effettivo che tali fonti hanno
nel testo della Gerusalemme, entro la celebre e programmatica dialettica tra vero e
verosimile, ossia tra fatti storici e finzione poetica.
In un approccio alla questione delle fonti storiche del poema tassiano è d’obbligo
partire dalla domanda sulle motivazioni culturali e prettamente poetiche della scelta
tassiana: perché la materia storica come argomento del poema? Domanda non solo
legittima, ma anche doverosa e tutt’altro che banale, se si tiene presente che il rapporto
53
tra la materia storica e il genere epico – genere che il classicismo rinascimentale intende
rifondare entro l’ambito del suo grande recupero dell’antichità greco-latina – è un
rapporto che innanzitutto non ha affatto carattere di necessità, e per di più appare anzi
una linea senz’altro minoritaria nell’epica antica cui il dibattito cinquecentesco e il
Tasso guardano come modello di riferimento privilegiato. La risposta alla domanda,
tuttavia, pur chiamando in causa questioni di grande importanza e complessità, è
relativamente facile da trovare: si tratta infatti di un dato di poetica fra i più rilevanti e
discussi entro il dibattito letterario cinquecentesco, su cui il Tasso stesso è intervenuto
diverse volte nei propri scritti teorici, consegnando le sue posizioni entro tale dibattito,
messe poi a frutto nell’effettiva prassi poetica, a ben note pagine critiche, molto chiare
ed esplicite a riguardo. Volendo prendere la questione molto alla lontana, cosa tuttavia
utile per collocarla entro il suo quadro culturale di riferimento, bisogna partire da quello
che è il concetto cardine dell’estetica classicistica del Rinascimento, il concetto di
imitatio; chiunque abbia anche una vaga idea del dibattito culturale e della produzione
artistica dell’epoca sa bene di quale centralità esso goda: non è necessario – né sarebbe
possibile in questa sede – approfondire una questione di tale rilievo. Sarà sufficiente
ricordare come sotto tale definizione venissero compresi e quasi fusi insieme due
concetti che alla nostra prospettiva moderna e postromantica appaiono ben distinti se
non antitetici: l’imitazione della natura, ossia della bellezza e dell’ordine del reale, del
mondo, e l’imitazione dell’arte, ossia dei modelli illustri, dei classici, essenzialmente
degli antichi (ma anche di quei “moderni” già divenuti classici, primo fra tutti,
naturalmente, Petrarca)60. Ma nell’estetica classicista il binomio natura e arte per lo più
non era sentito, come appare a noi, in termini di un’opposizione fra naturale e artificiale,
bensì come una continuità ben più armoniosa e quasi consequenziale: essendo l’arte
concepita nel suo complesso come imitazione della natura, in un quadro in cui l’agire
dell’uomo non si situa in conflitto con la natura, come nella concezione moderna, ma in
una molto meno conflittuale continuità con essa, ne consegue che imitazione di arte e
natura siano concepibili come un processo omogeneo, analogo, assimilabile, per quanto
distinguibile sulla base di un diverso grado di allontanamento da un modello pur sempre
comune – secondo un concetto, in ultima analisi, derivato dalla mimesis platonica con i
suoi successivi gradi di allontanamento delle copie (naturalmente anche attraverso la
mediazione di Aristotele e dell’aristotelismo). Entro queste generalissime coordinate
culturali si inserisce anche la questione della materia del poema epico. Se l’arte è
60
Sulla questione cfr. infra, cap. 7, L’IMITATIO - L’imitatio rinascimentale e l’Iliade: trattatistica e prassi
poetica.
54
concepita come imitazione della natura, del reale, dunque di ciò che è vero, ne consegue
che la materia che deve fornire il soggetto al poema epico deve essere vera, il che
significa appunto storica: contro il trionfo della fictio celebrato dal romanzo
cavalleresco, l’estetica classicistica dell’imitatio – soprattutto nella fase aristotelica che
si impone a partire anni ’30-’40 del Cinquecento – rivendica con vigore la funzione
conoscitiva della poesia, la sua dimensione veritativa, di cui la verità della materia
narrata si pone subito come immediato corollario. Il poema epico deve dunque imitare
le imprese dei grandi uomini. Naturalmente, sulla scorta di Aristotele, non si manca di
distinguere in sede teorica tra storiografia e poesia, ponendo così la distinzione tra vero
storico e verosimile poetico: il margine di libertà inventiva che così si concede alla
poesia risiede nel poter narrare non necessariamente ciò che è effettivamente accaduto,
ma anche ciò che sarebbe potuto accadere, ciò che non contraddice il vero né appare
implausibile e bizzarro a chi legge: ossia ciò che è, appunto, verosimile61. Questo è il
dibattito teorico adombrato nel proemio della Liberata nella celebre espressione
s’intesso fregi al ver (I, 2, v. 7), con cui l’autore invoca un’indulgenza della Musa verso
la fictio poetica apparentemente facile da ottenere e quasi scontata (poi rivelatasi, in
realtà, soprattutto nella cosiddetta revisione romana, un aspetto ben più problematico di
quanto il Tasso non si aspettasse).
Possiamo a questo punto rileggere su questo argomento una celebre pagina dai
Discorsi dell’arte poetica del giovane Tasso, l’opera teorica in cui sono esposti i
principi di poetica seguiti nella composizione della Gerusalemme liberata: si tratta del
passo più rilevante, significativo ed esauriente, a questo riguardo, tra i diversi suoi testi
teorici che trattano dell’argomento.
La materia, che argomento può ancora comodamente chiamarsi, o si finge, e allora par che il poeta abbia
parte non solo nella scelta, ma nella invenzione ancora, o si toglie dall'istorie. Ma molto meglio è, a mio giudicio, che
dall'istoria si prenda, perché, dovendo l'epico cercare in ogni parte il verisimile (presupongo questo come principio
notissimo), non è verisimile ch'una azione illustre, quali sono quelle del poema eroico, non sia stata scritta e passata
alla memoria de' posteri con l'aiuto d'alcuna istoria. I successi grandi non possono esser incogniti; e ove non siano
ricevuti in iscrittura, da questo solo argomentano gli uomini la loro falsità; e falsi stimandoli, non consentono così
facilmente d'essere or mossi ad ira, or a terrore, or a pietà, d'esser or allegrati, or contristati, or sospesi, or rapiti, e in
somma non attendono con quella espettazione e con quel diletto i successi delle cose, come farebbono se que'
61
Cfr. ARISTOTELE, Poetica, 9 (1451a, 36-b, 6): FanerÕn dὲ ™k tîn e„rhmšnwn kaˆ Óti oÙ tÕ t¦
genÒmena lšgein, toàto poihtoà œrgon ™st…n, ¢ll' oŒa ¨n gšnoito kaˆ t¦ dunat¦ kat¦ tÕ e„kÕj À
tÕ ¢nagka‹on. Ð g¦r ƒstorikÕj kaˆ Ð poiht¾j oÙ tù À œmmetra lšgein À ¥metra diafšrousin (e‡h
g¦r ¨n t¦ `HrodÒtou e„j mštra teqÁnai kaˆ oÙdὲn Âtton ¨n e‡h ƒstor…a tij met¦ mštrou À ¥neu
mštrwn)· ¢ll¦ toÚtJ diafšrei, tù tÕn mὲn t¦ genÒmena lšgein, tÕn dὲ oŒa ¨n gšnoito (Trad.: « Da
quanto si è detto risulta chiaro che compito del poeta non è dire ciò che è avvenuto ma ciò che potrebbe
avvenire, vale a dire ciò che è possibile secondo verosimiglianza e necessità. Lo storico e il poeta non
differiscono tra loro per il fatto di esprimersi in versi o in prosa – si potrebbero mettere in versi le storie di
Erodoto, e in versi come in prosa resterebbero comunque storia –, ma differiscono in quanto uno dice le
cose accadute e l’altro quelle che potrebbero accadere »).
55
medesimi successi, o in tutto o in parte, veri stimassero. Per questo, dovendo il poeta con la sembianza della verità
ingannare i lettori, e non solo persuader loro che le cose da lui trattate sian vere, ma sottoporle in guisa a i lor sensi
che credano non di leggerle, ma di esser presenti e di vederle e di udirle, è necessitato di guadagnarsi nell'animo loro
questa opinion di verità; il che facilmente con l'auttorità della istoria li verrà fatto. Parlo di quei poeti che imitano le
azioni illustri, quali sono e 'l tragico e l'epico, peroché al comico, che d'azioni ignobili e popolaresche è imitatore,
lecito è sempre che si finga a sua voglia l'argomento, non repugnando al verisimile che dell'azioni private alcuna
contezza non s'abbia fra gli uomini, ancora che della medesima città sono abitatori. E se ben leggiamo nella Poetica
d'Aristotele che le favole finte sogliono piacere al popolo per la novità loro, qual fu tra gli antichi il Fior d'Agatone, e
tra noi altri le favole eroiche del Boiardo e dell'Ariosto, e le tragiche d'alcuni più moderni, non dobbiamo però
lasciarci persuadere che favola alcuna finta in poema nobile sia degna di molta commendazione, come per la ragione
tolta dal verisimile s'è provato, e con molte altre ragioni da altri è stato concluso; oltre le quali tutte si può dire che la
novità del poema non consiste principalmente in questo, cioè che la materia sia finta e non più udita, ma consiste
nella novità del nodo e dello scioglimento della favola. Fu l'argomento di Tieste, di Medea, di Edippo da varii antichi
trattato, ma, variamente tessendolo, di commune proprio e di vecchio novo il facevano; sì che novo sarà quel poema
in cui nova sarà la testura de i nodi, nove le soluzioni, novi gli episodii che per entro vi saranno traposti, ancorachè la
materia sia notissima e da altri prima trattata; e all'incontra novo non potrà dirsi quel poema in cui finte sian le
persone e finto l'argomento, quando però il poeta l'avviluppi e distrighi in quel modo che da altri prima sia stato
annodato e disciolto; e tale per avventura è alcuna moderna tragedia, in cui la materia e i nomi son finti, ma 'l groppo
è così tessuto e così snodato come presso gli antichi Greci si ritrova, sì che non vi è né l'auttorità che porta seco
l'istoria, né la novità che par che rechi la finzione.
Deve dunque l'argomento del poema epico esser tolto dall'istorie; ma l'istoria o è di religione tenuta falsa da
noi, o di religione che vera crediamo, quale è oggi la cristiana e fu già l'ebrea. Né giudico che l'azioni de' gentili ci
porgano comodo soggetto onde perfetto poema epico se ne formi, perché in que' tali poemi o vogliamo ricorrer talora
alle deità che da' gentili erano adorate, o non vogliamo ricorrervi; se non vi ricorriamo mai, viene a mancarvi il
meraviglioso, se vi ricorriamo, resta privo il poema in quella parte del verisimile. Poco dilettevole è veramente quel
poema che non ha seco quelle maraviglie che tanto movono non solo l'animo de gli ignoranti, ma de' giudiziosi
ancora: parlo di quelli anelli, di quelli scudi incantati, di que' corsieri volanti, di quelle navi converse in ninfe, di
quelle larve che fra' combattenti si tramettono, e d'altre cose sì fatte; delle quali, quasi di sapori, deve giudizioso
scrittore condire il suo poema, perché con esse invita e alletta il gusto de gli uomini vulgari, non solo senza fastidio,
ma con sodisfazione ancora de' più intendenti. Ma non potendo questi miracoli esser operati da virtù naturale, è
necessario ch'alla virtù sopranaturale ci rivolgiamo; e rivolgendoci alle deità de' gentili, subito cessa il verisimile,
perché non può esser verisimile a gli uomini nostri quello ch'è da lor tenuto non solo falso, ma impossibile; ma
impossibil è che dal potere di quelli idoli vani e senza soggetto, che non sono e non furon mai, procedano cose che di
tanto la natura e l'umanità trapassino. E quanto quel meraviglioso (se pur merita tal nome) che portan seco i Giovi e
gli Apolli e gli altri numi de' gentili sia non solo lontano da ogni verisimile, ma freddo e insipido e di nissuna virtù,
ciascuno di mediocre giudicio se ne potrà facilmente avvedere leggendo que' poemi che sono fondati sovra la falsità
dell'antica religione.
Solo la materia storica, dunque, potrà garantire nel complesso quell’impressione
di verosimiglianza sul lettore moderno che è considerata fondamentale perché si
inneschi appieno quel rapporto di partecipazione emozionale che genera, come il Tasso
stesso dirà altrove, compassione (eleos) e purgazione (katharsis), ossia le funzioni
proprie dell’arte secondo un’estetica di stampo aristotelico62. Come si vede dal passo, la
62
Da notare la circolarità di questo primo argomento del Tasso: la verosimiglianza della materia narrata è
garantita sufficientemente solo dalla sua effettiva verità storica; come dire: il possibile si dimostra
senz’altro tale solo quando è effettivamente reale. L’argomento, pur presentato come un’opinione del
poeta (a mio giudicio), è in realtà ripreso dalla Poetica di Aristotele, ma con una notevole forzatura:
1451b, 16-19: a‡tion d' Óti piqanÒn ™sti tÕ dunatÒn· t¦ mὲn oân m¾ genÒmena oÜpw pisteÚomen
e„nai dunat£, t¦ dὲ genÒmena fanerÕn Óti dunat£· oÙ g¦r ¨n ™gšneto, e„ Ãn ¢dÚnata (trad.: « La
causa di ciò è che il possibile è già di per sé credibile; di ciò che non è avvenuto noi non abbiamo ancora
fiducia che sia possibile, mentre di ciò che è avvenuto è sempre chiaro che era possibile: se non fosse
stato possibile non sarebbe avvenuto »). In realtà Aristotele non intende affatto sostenere, con questo, che
la realtà (storica) sia argomento preferibile per la poesia, e anzi contrappone notoriamente lo storico al
poeta proprio distinguendo la materia da loro trattata, rispettivamente, in t¦ genÒmena (gli eventi
accaduti) e oŒa ¨n gšnoito (le cose quali potrebbero accadere), senza mancare di sottolineare la
superiorità del secondo nella celebre frase per cui filosofèteron kaˆ spoudaiÒteron po…hsij
ƒstor…aj ™st…n· ¹ mὲn g¦r po…hsij m©llon t¦ kaqÒlou, ¹ d' ƒstor…a t¦ kaq' ›kaston lšgei
(1451b, 6-8, trad.: « la poesia è più filosofica e più seria della storia, poiché la poesia si occupa piuttosto
dell’universale, mentre la storia racconta i particolari »).
56
materia propriamente mitologica, che nell’epica classica è senz’altro la materia epica
per eccellenza, è scartata in virtù dell’alterità culturale fra il mondo de’ gentili e il
presente mondo cristiano: alterità sulla base della quale, soprattutto per quanto concerne
l’intervento delle divinità pagane, il moderno lettore avrebbe immediatamente
un’impressione di falsità tale da compromettere irrimediabilmente la verosimiglianza e
dunque anche l’immedesimazione emotiva63. Ne consegue che la scelta più logica sia
allora quella di una grande impresa cristiana, per ciò stesso immediatamente posta sotto
le insegne del vero non solo storico ma anche religioso. Ciò permetterà di recuperare,
poi, anche la dimensione del meraviglioso, sentita come propria del genere epico e ad
esso indispensabile, riconducendola appunto entro la dimensione cristiana: la celebre
soluzione tassiana del meraviglioso cristiano consiste proprio nel lasciare spazio anche a
63
La questione del verosimile e del suo rapporto con il concetto di e„kÒj nella Poetica di Aristotele (si
noti che la parola greca non evoca in nessun modo l’idea di “verità” come fa invece il termine di origine
latina) è piuttosto complessa per poter essere approfondita in questa sede: sarà utile tuttavia tener presente
che Aristotele parla di verosimiglianza per lo più in senso molto ristretto e concreto, in relazione ad una
rappresentazione dell’azione che risulti efficace e priva di elementi improbabili o tali da suscitare
incredulità; nel dibattito Cinquecentesco e in particolare in Tasso, invece, la questione si complica
venendo a coinvolgere la ben più ampia questione culturale della verità religiosa cristiana. Il cristianesimo
si fonda su un atto di fede in una verità di cui non si ha alcuna prova nell’esperienza e che anzi per
definizione la trascende: è vero esattamente ciò che non è verosimile; non a caso, strumento per
eccellenza della fede cristiana, sin dal Vangelo, è il miracolo (o meglio: la testimonianza del miracolo),
ossia l’evento per definizione non verosimile ma pur dato per vero. Anche per Aristotele, certamente, può
ben capitare che si verifichino eventi non verosimili (1456a, 24-25: œstin dὲ toàto kaˆ e„kÕj ésper
'Ag£qwn lšgei, e„kÕj g¦r g…nesqai poll¦ kaˆ par¦ tÕ e„kÒj, trad.: « questo è verosimile perché,
come dice Agatone, è verosimile che accadano molte cose inverosimili », e ancora in 1461b), ma questa è
per lui l’eccezione, mentre per la cultura cristiana è il fondamento stesso di una verità ultima inattingibile
ai sensi. La prospettiva di partenza è dunque in qualche modo rovesciata tra il realismo aristotelico e il
trascendentalismo cristiano: il concetto di verosimiglianza non può prescindere da un cambiamento tanto
radicale del concetto di verità. Non a caso il Tasso pone la questione esattamente in termini di storia
culturale: ciò che per gli antichi era verosimile, per i cristiani non lo è, e viceversa. D’altronde, una simile
argomentazione poggia a sua volta su altri passi della Poetica di Aristotele in cui la presenza
dell’impossibile e del meraviglioso è ammessa purché non generi un’impressione di inverosimiglianza,
ma sia al contrario accettata dall’opinione comune: 1460a: proaire‹sqa… te de‹ ¢dÚnata e„kÒta
m©llon À dunat¦ ¢p…qana· toÚj te lÒgouj m¾ sun…stasqai ™k merîn ¢lÒgwn, ¢ll¦ m£lista mὲn
mhdὲn œcein ¥logon, e„ dὲ m», œxw toà muqeÚmatoj, ésper O„d…pouj tÕ m¾ e„dšnai pîj Ð L£ioj
¢pšqanen, ¢ll¦ m¾ ™n tù dr£mati, ésper ™n 'Hlšktrv oƒ t¦ PÚqia ¢paggšllontej À ™n Muso‹j
Ð ¥fwnoj ™k Tegšaj e„j t¾n Mus…an ¼kwn (trad.: « Si deve preferire l’impossibile verosimile al
possibile incredibile, e non comporre le storie con parti irrazionali, o almeno lasciarle fuori dalla trama,
come nel caso di Edipo il fatto che ignorasse come era morto Laio, e non nel dramma [ossia nella
rappresentazione scenica] come nell’Elettra quelli che raccontano i giochi pitici o nei Misii il muto che
da Tegea arriva in Misia »); 1461b: Ólwj dὲ tÕ ¢dÚnaton mὲn prÕj t¾n po…hsin À prÕj tÕ bšltion À
prÕj t¾n dÒxan de‹ ¢n£gein. prÒj te g¦r t¾n po…hsin aƒretèteron piqanÕn ¢dÚnaton À ¢p…qanon
kaˆ dunatÒn· * * toioÚtouj einai oŒon Zeàxij œgrafen, ¢ll¦ bšltion· tÕ g¦r par£deigma de‹
Øperšcein. prÕj ¤ fasin t¥loga· oÛtw te kaˆ Óti potὲ oÙk ¥logÒn ™stin· e„kÕj g¦r kaˆ par¦ tÕ
e„kÕj g…nesqai (trad.: « In generale bisogna ricondurre l’impossibile alla poesia, o al meglio, o
all’opinione comune. Nei confronti della poesia è preferibile un impossibile credibile a un possibile
incredibile […] quali li dipinse Zeusi, ma in meglio: infatti il modello deve essere superiore. Rispetto a
quello che chiamano l’irrazionale, si deve rispondere a questo modo, e anche che talvolta non si tratta di
irrazionale, perché è verosimile anche che accada l’inverosimile »).
Sul rapporto tra verità e finzione nella poetica tassiana, cfr. C. SCARPATI – E. BELLINI, Il vero e il falso dei
poeti. Tasso, Tesauro, Pallavicino, Muratori, Milano, Vita e pensiero, 1990, p. 35-71.
57
quanto sarebbe di per sé inverosimile – tanto in rapporto all’intervento divino dell’epica
classica quanto agli incanti dei romanzi cavallereschi – attraverso l’espediente di porlo
sotto la tutela di una verosimiglianza ben più alta e autorevole di quella storica, ossia
quella della religione cristiana: così il magico può essere giustificato come diabolico, il
miracoloso come intervento divino. Se dunque la materia storica garantisce la
verosimiglianza dell’opera e la sua conformità al principio di imitazione della natura e
della verità, nella fattispecie delle imprese di grandi uomini, la soluzione del
meraviglioso cristiano consente di preservare, ponendoli sotto l’egida dell’indubitabile
verità religiosa, anche quegli elementi sovrannaturali fondamentali alla mitopoiesi, alla
trasformazione dei meri dati storici in impresa di carattere mitico appropriata alla poesia
epica. Alla soluzione del meraviglioso cristiano si aggiungerà anche quella “tarda”
dell’allegoria religiosa, che permetterà al poeta di inserire ulteriori elementi non storici
ma di finzione senza però compromettere la verosimiglianza, e anzi rafforzandola
ulteriormente attraverso una più profonda verità teologica: se tale soluzione era nata
quasi come un espediente sovraimposto di peso al testo già scritto del poema per
agevolare la “revisione romana”, nella successiva rielaborazione dell’opera intitolata
Gerusalemme conquistata (1593) l’originario espediente diviene una delle linee portanti
della riscrittura e soprattutto dei numerosi ampliamenti del poema riformato. Nella
riscrittura del poema che porterà alla Gerusalemme conquistata, dunque, emerge un
complessivo riavvicinamento alla poetica del “vero”: da una parte con una più stretta
aderenza alle fonti storiche64, dall’altro con un ampio utilizzo dell’allegoria, che è in
grado di ricondurre anche la finzione che dalla storia si discosta sotto le insegne del
“vero”65.
Oltre a tutto questo, altri elementi fondamentali alla mitopoiesi della storia
secondo l’analisi tassiana sono innanzitutto una certa distanza temporale, che collochi
l’evento lontano dalla trivialità del contemporaneo, in un passato sufficientemente
remoto da poter essere mitizzato, e poi anche un certo legame attualizzante con il
presente, che cioè conferisca al passato un carattere fondativo del presente, come
nell’Eneide virgiliana. La convergenza di queste motivazioni di natura essenzialmente
64
Cfr. ad esempio Guidicio sovra la Gerusalemme riformata, 17, 19-20: «Io, ne la riforma della mia
favola, cercai di farla più simile al vero che non era prima, conformandomi in molte cose con l’istorie».
65
Cfr. Giudicio, cit. «A me ancora dovrebbe esser conceduto che fra l'istorie di Guglielmo arcivescovo di
Tiro, e di Roberto Monaco, e di Paolo Emilio, e degli altri scrittori, i quali cedono a Mosè d'autorità e di
gran lunga son inferiori, abbia avuto ardire di mescolar alcune favole o allegorie; le quali, benchè paiano
false o finte ne' particolari, sono vere nondimeno, avendosi riguardo a l'universale, ed a l'idea in cui rimira
il poeta: e per questa cagione la poesia, come afferma Aristotile, ha molto più del filosofico che non ha
l'istoria».
58
estetica portano ragionevolmente alla scelta della prima crociata come materia del
poema: si tratta di un’impresa storica, ben documentata, di carattere fortemente
cristiano, lontana nel tempo ma non troppo da scomparire dalla memoria collettiva, e
soprattutto attuale nella contrapposizione con il mondo musulmano più che mai viva al
tempo di Tasso66.
Decisivo per la scelta tassiana della materia storica è, dunque, il coevo dibattito
sul poema eroico. Tuttavia bisogna ricordare che, accanto alla teoria, ha avuto senz’altro
un peso determinante per questa scelta anche un precedente poetico, un’opera, che a
quel dibattito è peraltro precedente, seppure di poco: mi riferisco all’Italia liberata da’
Goti del Trissino. Quasi sempre la critica tassiana ha trascurato di analizzare il rapporto
della Gerusalemme con questo suo importante precedente, confondendo il giudizio di
valore sull’opera – negativo non solo per i moderni, ma già per il Tasso – con la sua
influenza storico-letteraria: i due aspetti, invece, non sono necessariamente
corrispondenti. Un’opera di un predecessore giudicata negativamente può innanzitutto
essere un paradigma negativo, un esempio di scelte da evitare, e pertanto può influire in
maniera anche rilevante proprio come anti-modello; ma è possibile anche un caso più
sottile: quello di un’opera di cui si condividono nel complesso le scelte teoriche, di
poetica, salvo poi prendere le distanze dalla loro effettiva realizzazione poetica, che non
ne è mai semplicemente una conseguenza diretta e tanto meno necessaria. Quest’ultimo
è appunto, a mio parere, il caso del rapporto di Tasso dei confronti di Trissino: egli
valuta negativamente l’Italia quanto all’effettivo risultato artistico, al giudizio di valore,
ma quanto alle scelte generali di poetica egli è per molti aspetti vicinissimo al Trissino e
da lui influenzato in modo decisivo; anche quando ne critica le scelte particolari, non si
tratta quasi mai di un rifiuto netto, ma semmai di un tentativo di miglioramento, una
“correzione del tiro” che presuppone, al contrario, un’accettazione complessiva di una
proposta giudicata solo mal realizzata. Un esempio clamoroso è proprio quello del
meraviglioso cristiano, una delle soluzioni più note e più riuscite del Tasso: quando la
critica – raramente – lo raffronta al meraviglioso in Trissino, per lo più è solo in vista di
una poco produttiva celebrazione delle scelte tassiane a fronte di quelle aberranti e
talvolta persino ridicole dell’Italia liberata; eppure si manca quasi sempre di notare che
quelle tanto apprezzate correzioni del Tasso presuppongono l’Italia come il modello
senz’altro più vicino e più influente. E un simile discorso si può fare anche per la
questione della materia storica che qui ci interessa. Se tale scelta tassiana è senz’altro
66
Su questo argomento, cfr. F. CARDINI, Torquato Tasso e la crociata , in Torquato Tasso e la cultura
estense , a cura di G. VENTURI, Firenze, Olschki, 1999, vol. II, pp. 615-624.
59
coerente e motivata, come abbiamo visto, sul piano della teoria letteraria, ancor più
rilevante è l’influsso dell’opera del Trissino. Sin dai Discorsi dell’arte poetica, la
contrapposizione fra l’Orlando furioso letto e ammirato da tutti e destinato all’eternità
letteraria e invece l’Italia liberata già obsoleta quindici anni dopo la sua pubblicazione
adombra una contrapposizione invece molto meno netta e più problematica fra romanzo
ed epica eroica: nella stesura della Liberata, queste due opere costituiranno i due
principali modelli moderni dell’una e dell’altra tendenza, notoriamente compresenti in
quella grande formazione di compromesso che il capolavoro tassiano è innanzitutto a
livello di genere. Quanto alla scelta di una grande impresa collettiva di guerra, dunque,
Tasso segue senz’altro il modello trissiniano contro quello ariostesco della ventura
cavalleresca, che recupera nel suo poema solo secondariamente, caratterizzandolo come
errore, devianza, ritardo al compiersi dell’azione principale. La grande impresa storica,
militare, collettiva, l’azione una di molti – come la definisce Tasso –, è senz’altro uno
dei debiti più rilevanti verso l’ambiguo precedente del Trissino, le cui soluzioni sono
accettate in pieno contro la varietà di azioni e di trame del romanzo. Naturalmente,
anche qui il tiro è corretto: al carattere eminentemente politico dell’impresa capitanata
da Belisario e del suo rapporto con l’attualità italiana e con le idee filoimperiali
dell’autore subentra la natura essenzialmente religiosa dell’impresa guidata da
Goffredo, volta a liberare, più ancora che la città Gerusalemme, il sepolcro di Cristo –
come da proemio (I, 1, v. 2); l’altra differenza, stavolta dovuta a un’esplicita critica
rivolta al poeta vicentino, è che la narrazione non si estende come nell’Italia alla totalità
di una campagna militare pluriennale, con un effetto necessariamente dispersivo, ma si
concentra – come nell’Iliade – sulla sola fase conclusiva o comunque decisiva per la
sorte dell’impresa, con effetto, per così dire, di esserne sineddoche, pars pro toto67. Ma
al di là di queste divergenze subordinate, quel che più conta è l’assoluta continuità nella
scelta e nell’impostazione complessiva della materia del poema basata sull’azione “una
di molti”, da cui discendono tutta una serie di ulteriori elementi di continuità, come ad
esempio – solo per ricordare i principali – la questione del rapporto con le fonti storiche
e del margine di libertà lasciato alla finzione, il protagonismo del capitano militare
67
L’argomento del Tasso contro il Trissino è direttamente desunto da ARISTOTELE, Poetica, 1459a, : diÕ
ésper e‡pomen ½dh kaˆ taÚtV qespšsioj ¨n fane…h “Omhroj par¦ toÝj ¥llouj, tù mhdὲ tÕn
pÒlemon ka…per œconta ¢rc¾n kaˆ tšloj ™piceirÁsai poie‹n Ólon· l…an g¦r ¨n mšgaj kaˆ oÙk
eÙsÚnoptoj œmellen œsesqai Ð màqoj, À tù megšqei metri£zonta katapeplegmšnon tÍ poikil…v
(trad.: « Perciò, come abbiamo detto, anche in questo Omero appare prodigioso rispetto agli altri, per non
aver cercato di rappresentare interamente la guerra di Troia, anche se essa aveva un inizio e una fine. La
trama sarebbe risultata o eccessiva, da non potersi abbracciare con lo sguardo, o, se contenuta nelle
dimensioni, troppo intricata per varietà »).
60
Belisario/Goffredo, il problema di questo protagonismo conteso dalla presenza di un
eroe “necessario” (Corsamonte/Rinaldo), il meraviglioso cristiano come luogo di
conciliazione fra la teleologia narrativa, di ascendenza classica, dell’epos e la teleologia
ideologica della moderna religione cristiana.
Chiariti dunque questi due punti di riferimento fondamentali – il dibattito teorico e
il precedente trissiniano – per la scelta della materia storica e in particolare dell’impresa
cristiana della prima crociata, cerchiamo di analizzare più nello specifico il rapporto
effettivo che la Gerusalemme intrattiene con le sue fonti storiche. Naturalmente in
questa sede la questione non potrà che essere impostata a livello molto generale, dal
momento che per ambire ad una qualche forma di esaustività richiederebbe un’analisi
del rapporto fra episodi del poema e loro fonti storiografiche, se non complessiva,
quanto meno condotta approfonditamente su vasta scala. Sarà bene innanzitutto
spendere due parole, preliminarmente, sulla natura del rapporto con le fonti. Si tratta a
tutti gli effetti di un rapporto di tipo intertestuale, ossia di un testo che si costituisce, in
una qualche misura e a un qualche livello (dalla singola iunctura fino alla struttura
complessiva dell’opera), sulla base di un ipotesto, di un precedente testo di derivazione,
inglobandone alcuni elementi riconoscibili nella forma di una loro presenza nel nuovo
testo. Questo è anche, senz’altro, il caso di un’opera storiografica utilizzata come fonte
di un testo prettamente letterario. Tuttavia la finalità essenzialmente o principalmente
documentaria di un simile testo-fonte rende tale rapporto intertestuale sensibilmente
diverso da quello con cui si è soliti confrontarsi nello studio dell’intertestualità
letteraria, che considera innanzitutto il rapporto con testi affini, di natura propriamente
artistica. Possiamo dire anzi, in un certo senso, che la modalità del rapporto sia nei due
casi quasi opposta: la critica intertestuale ci insegna come il rapporto con un ipotesto
letterario, giocato quasi sempre su una ripresa della parole poetica e dunque anche del
testo, si fondi su un’immancabile risemantizzazione del testo ripreso, seppure in
maniera più o meno marcata secondo i casi, tanto che se tale risemantizzazione manca o
è solo superficiale e inconsistente dà subito l’impressione di povertà inventiva, di
maniera, di carenza di spessore letterario (esattamente al contrario della sua forma
ottimale, in cui la risonanza letteraria implica una valorizzazione e un ampliamento di
senso). Il rapporto con un ipotesto storiografico, invece, guarda essenzialmente non alla
parole del testo ma solo al suo livello contenutistico, e pertanto esige all’opposto un
atteggiamento filologico, di aderenza ai contenuti, di rispetto scrupoloso di quella che
non è solo finzione letteraria ma realtà storica; ogni allontanamento dalla verità storica
61
dell’ipotesto è dunque sentito in un certo senso, all’opposto della consueta prassi
letteraria, come una violazione cui indulgere con parsimonia e di cui bisogna persino
giustificarsi, tanto più in una poetica del vero e del verosimile come quella tassiana:
come ricordavamo prima dal proemio della Liberata: O Musa, […] / … tu perdona /
s’intesso fregi al ver, s’adorno in parte / d’altri diletti, che de’ tuoi, le carte. Alterare la
finzione, insomma, produce nient’altro che nuova finzione, mentre alterare il vero
storico produce invece una sua vera e propria falsificazione. Ma naturalmente sono
proprio questi fregi intessuti al vero che ci interessano, poiché – come in qualsiasi
rapporto con un modello – le differenze sullo sfondo delle identità ci permettono di
delineare la nuova strategia di significati. Inoltre il rapporto con le fonti storiche, che
forniscono la materia narrativa, si presenterà complessivamente come una sorta di
riscrittura estensiva, in cui pertanto le differenze consisteranno, ben più che in una
variazione o modifica di quanto è narrato nell’ipotesto, in una selezione di ciò che
interessa ad un nuovo testo di tutt’altra natura, che ha finalità non più documentaristiche
e meramente informative, o tutt’al più apologetiche, bensì eminentemente artistiche:
uno spunto suggestivo, icastico o magari capace di evocare risonanze letterarie può
essere nettamente privilegiato rispetto a intere pagine rilevanti ma difficilmente
trasformabili da narrazione storica in poesia narrativa. Sarebbe dunque senz’altro
auspicabile un’analisi che valuti complessivamente e criticamente quali aspetti delle
fonti storiche sono trascurati o del tutto obliterati, quali invece privilegiati, quali infine
privi di ogni riscontro: in questa sede sarà possibile, com’è ovvio, solo un rapido
excursus a titolo per lo più esemplificativo.
Venendo ai testi effettivi delle fonti della Gerusalemme tassiana sulla prima
crociata, essi sono essenzialmente tre68: la Cronaca di Guglielmo di Tiro, nota anche col
titolo di Belli Sacri Historia o ancora di Historia rerum in partibus transmarinis
gestarum 69 , che è la fonte principale, poi la Historia Hierosolymitana di Roberto
68
Nel cap. 5 di V. VIVALDI, Prolegomeni ad uno studio completo sulle fonti della Gerusalemme liberata
(Da quali cronisti della prima crociata il Tasso attinse per il suo lavoro), p. 81, lo studioso ne ricorda
cinque: «Nelle sue lettere il Tasso ricorda cinque cronisti della prima crociata, da lui letti; e do in
parentesi le indicazioni delle lettere, nelle quali si fa menzione di essi, perchè queste indicazioni non sono
molto esatte e compiute nel lavoro del Ferrazzi. Questi cronisti sono: Guglielmo arcivescovo di Tiro
(25,28, 29, 47, 60, 82, 532, 707, 1378); Paolo Emilio (47,82,532, 707); Roberto Monaco (52, 82); l’abate
Urspergense (57) e Procoldo conte di Rochese (25, 60, 82). Nel Giudizio sovra la Conquistata il poeta
però non ricorda che i tre primi soli cronisti; ma dà ad intendere di averne letti altri».
69
GUILLAUME DE TYR, Chronique, édition critique par R. B. C. HUYGENS, Turnholti (Corpus
Christianorum), 1986 (ed. princeps col titolo Belli sacri historia, Basilea, 1549; trad. italiana di GIUSEPPE
HOROLOGGI, col titolo Historia della guerra sacra di Gerusalemme, Venezia, Valgrisi, 1562; la cronaca
di Guglielmo di Tiro non fu letta invece dal Tasso, almeno durante la composizione della Liberata, nella
versione volgare del De bello a Christianis contra barbaros gesto pro Christi Sepulchro et Iudaea
recuperandis libri IIII di BENEDETTO ACCOLTI IL VECCHIO redatta da FRANCESCO BALDELLI col titolo Le
62
Monaco (o Robertus Remensis) 70 e il De rebus gestis francorum di Paolo Emilio
Veronese71. Naturalmente sappiamo essere questi i testi di cui si servì principalmente il
Tasso, piuttosto che altri in teoria pur disponibili72, dalla frequente menzione che ne fa
l’autore stesso nei suoi numerosi scritti teorici, dai trattati alle lettere. Non mi risulta,
tuttavia, che sia stato condotto un esame accurato su quali fonti storiche sulla prima
crociata fossero effettivamente disponibili al Tasso e quali egli abbia sicuramente o
verosimilmente consultato: in una lettera egli afferma di aver letto «molte istorie del
passaggio d’oltramare», il che lascia supporre che siano più delle tre suddette che
menziona più spesso nei suoi scritti teorici: non sappiamo però con maggior precisione
quali siano le altre.
Il testo di Roberto Monaco, che narra solo della prima crociata (1095-99), è il più
antico dei tre, essendo l’autore coevo agli eventi e avendo partecipato quasi certamente
al concilio di Clermont (1095) da cui nacque l’iniziativa della spedizione; tuttavia il
testo è piuttosto breve e la sezione dedicata all’assedio di Gerusalemme, nel libro IX, è
estremamente sintetica. Il testo di Guglielmo di Tiro, invece, pur successivo di poco
meno di un secolo agli avvenimenti, è molto più ampio e dettagliato, anche perché
l’autore visse nei luoghi della crociata, ricoprendo la carica di arcivescovo di Tiro, e
poté dunque avere accesso a fonti più ampie e precise: all’assedio di Gerusalemme è
dedicato l’intero libro ottavo, che annovera 24 capitoli e costituisce la fonte storica
principale per la Gerusalemme Liberata. Molto posteriore invece è il De rebus gestis
francorum di Paolo Emilio Veronese, umanista vissuto tra quindicesimo e sedicesimo
secolo, storico di corte nella Parigi di Luigi XII, per cui scrisse la grande opera
storiografica di cui la vicenda della prima crociata, che rielabora naturalmente fonti
storiografiche precedenti, è solo una sezione molto circoscritta entro una grande
ricostruzione della storia francese.
guerre fate da’ cristiani contra barbari per la recuperazione del Sepolcro di Cristo e della Giudea,
Venezia, 1543).
70
ROBERTUS REMENSIS (MONACHUS), Historia Hierosolymitana, Venetiis, Bernardinus de Vitalibus,
1532 (trad. italiana col titolo Historia di Roberto Monaco della guerra fatta da Principi Christiani contra
Saracini per l’acquisto di Terra Santa, tradotta per F. BALDELLI, Fiorenza, Torrentino, 1552).
71
PAULI AEMYLII VERONENSIS HISTORICI CLARISSIMI De rebus gestis Francorum, Parisiis, 1555, pp. 170171 (ed. princeps: Parigi, 1539; trad. italiana col titolo Historia delle cose di Francia […] recate ora a
punto dalla Latina in questa nostra lingua, Venezia, Tramezzino, 1559.
72
Cfr. ad esempio una lettera del 1587 (ed. Guasti, n. 813), dunque di diversi anni successiva alla
pubblicazione della Liberata: «Confesso il vero: ho lette molte istorie del passaggio d’oltramare; ma non
avea letto Benedetto Accolti; e non l’ho letto ancora, da poi che me l’ha mandato a donare». L’opera a cui
il Tasso fa riferimento è il De bello a Christianis contra Barbaros gesto pro Christi sepulchro et Judaea
recuperandis di BENEDETTO ACCOLTI IL VECCHIO.
63
Cerchiamo ora di delineare rapidamente un quadro generale della presenza nel
testo della Liberata della fonte principale, la Cronaca di Guglielmo di Tiro: essa sola è
più che sufficiente a dare un’idea complessiva dell’incidenza del dato storico nella
trama del poema; le altre fonti sono senz’altro secondarie rispetto ad essa e solo
raramente, per episodi per lo più marginali, forniscono spunti che siano del tutto assenti
in Guglielmo di Tiro. Inoltre, dato che si tratta di un’analisi mai affrontata in maniera
complessiva e approfondita, è meglio evitare di complicare il quadro considerando
anche le altre fonti storiche, tanto più che un primo bilancio complessivo non ne sarebbe
nella sostanza modificato. Per facilitare l’analisi ho tracciato un primo, sintetico schema
della presenza della Cronaca di Guglielmo di Tiro nella Gerusalemme liberata (v. pag.
21 e sgg.): naturalmente tale schema non ha alcuna pretesa di esaustività, ma si limita a
registrare i contatti fondamentali a livello narrativo, ossia gli spunti che hanno generato
scene o episodi interi nel poema o anche elementi più circoscritti ma dotati di forte
valore simbolico: per dirla in termini strutturalisti, gli elementi più importanti tanto
sull’asse sintagmetico quanto su quello paradigmatico. Ho tralasciando invece i
frequenti dettagli secondari desunti dal testo storiografico, meno rilevanti, sui quali avrà
senso tornare solo dopo aver studiato a fondo il quadro complessivo.
Partiamo dalla considerazione più ovvia: scorrendo lo schema, si nota
immediatamente che i punti del testo dove è maggiore la presenza della fonte
storiografica sono quelli di natura epica, e in particolare prettamente bellica, mentre le
sezioni più romanzesche se ne discostano maggiormente se non del tutto. I canti dov’è
preminente se non assoluto il carattere romanzesco, come il quarto, con il concilio
infernale e l’arrivo di Armida al campo cristiano, o il grande blocco dei canti 14, 15 e
16, con il viaggio prodigioso di Carlo e Ubaldo per recuperare Rinaldo prigioniero di
Armida, sono naturalmente del tutto privi di rapporto con le fonti storiografiche sulla
crociata, essendo completamente frutto dell’invenzione dell’autore. I canti, invece, dove
maggiore è il contatto con le fonti storiografiche sono quelli che narrano delle due
battaglie principali: l’unidicesimo, con il primo assalto – fallito – a Gerusalemme, che
segue in maniera piuttosto fedele il testo dell’ottavo libro della Cronaca nei capitoli 11
(processione al monte Oliveto) e 13 (battaglia vera e propria, interrotta dal
sopraggiungere della notte), e poi i tre canti finali, con l’assalto decisivo alla città e la
quasi contemporanea battaglia con l’esercito egiziano giunto in soccorso dei pagani di
Gerusalemme, che segue essenzialmente i capitoli dal 15 al 21. Tuttavia, quanto a
quant’ultima grande sezione finale, possiamo subito fare una considerazione meno
64
ovvia e più interessante sul modo tenuto da Tasso nel rapportarsi alla storia: il
sopraggiungere dell’esercito egiziano in soccorso di Gerusalemme e la grande battaglia
con i crociati che si svolge nell’ultimo libro del poema risultano da un trattamento
molto libero delle fonti storiche, che indulge senza troppe preoccupazioni ad un
anacronismo di diversi mesi. Come lo stesso Tasso scrive, infatti, nella lettera
contenente anche la Favola della Gerusalemme,
I fatti sono aggranditi da me, ma per altro passarono così: la gran giornata fra gli Egizii ed i
Cristiani parimente: ben è vero che seguì alquanti mesi dopo l’espugnazione di Gerusalemme, ed alquante
miglia più lontano; ma queste piccole differenze del luogo e del tempo, da qual poeta sono considerate?
La battaglia contro l’esercito egiziano è sì un fatto storico, narrato da Guglielmo
di Tiro nel nono libro, ma si svolse alcuni mesi più tardi rispetto all’assedio di
Gerusalemme, quando ormai la città era da tempo in mano dei cristiani, e per di più non
già nei pressi di Gerusalemme bensì ad Ascalona. Si tratta naturalmente, come queste
poche righe chiariscono perfettamente, della libertà del poeta rispetto allo storico, che
può indulgere anche ad anacronismi e deformazioni tanto vistose del dato storico purché
rientrino appieno, come in questo caso, nell’ambito del verosimile. Questo ci porta
dunque a una considerazione forse non così ovvia: il verosimile di cui parla il Tasso
teorico, ad esempio nella pagina dei Discorsi dell’arte poetica citata in apertura, non è
necessariamente l’invenzione verosimile, che narra ciò che la verità storica tace, ma può
benissimo essere anche una vera e propria falsificazione a fini poetici del dato storico
nel suo complesso.
Quanto alle motivazioni specifiche che portano il Tasso a questa macroscopica
manipolazione del dato storico, in assenza di una loro esplicitazione da parte dell’autore
nei suoi scritti teorici possiamo soltanto provare a ipotizzarle. Nel contraddire il dato
storico, è verosimile che la motivazione sia dunque prettamente letteraria: è evidente,
d’altronde, che in un’opera che resta pur sempre opera di finzione le esigenze letterarie
sono sempre prioritarie rispetto a quelle di verosimiglianza (come d’altronde mostra la
stessa concezione tassiana del meraviglioso cristiano, ossia di una palese violazione del
principio
di
verosimiglianza
che
deve
essere
ricondotta
ad
esso
soltanto
secondariamente, attraverso una giustificazione della sua presenza: il vero nucleo di
interesse è e resta proprio questa presenza anomala e contraddittoria). Riflettendo da
questo punto di vista, appare innegabile che l’arrivo dell’esercito egiziano intende
essere strutturalmente funzionale alla creazione di un finale letterariamente adeguato.
Ma allora bisogna chiedersi perché non bastasse a questo scopo la sola battaglia sul
65
fronte di Gerusalemme, da sentire l’esigenza di duplicarla anche su un secondo fronte.
Dobbiamo partire dal presupposto che, come sempre in un testo letterario di alto livello,
una duplicazione di qualsiasi tipo non è mai veramente tale, non è mai banalmente
tautologica o ridondante, ma acquisisce sempre un significato suo proprio, autonomo,
parzialmente nuovo rispetto all’elemento che sembra duplicare. Qual è dunque la
differenza della battaglia con gli egiziani rispetto al fronte “interno” di Gerusalemme?
Quali differenti strategie letterarie innesca? A ben guardare, si tratta di due generi di
battaglia affatto diversi: da un lato una battaglia di assedio, dall’altro una in campo
aperto. E se non sono certo le differenze di tecnica militare e la loro rappresentazione ad
interessare il poeta, allora la differenza che lo interessa, come dicevamo, è
eminentemente letteraria: non si tarderà ad accorgersi, seguendo questo ragionamento,
che i referenti letterari a cui queste due modalità di battaglia rimandano sono anch’essi
ben distinti e condotti secondo diverse modalità narrative. Letterariamente parlando,
insomma, la grande battaglia in campo aperto rimanda a tutt’altri modelli rispetto alla
battaglia d’assedio ed è senz’altro la forma più canonica di battaglia nella poesia epica:
la stessa Iliade, archetipo di ogni epica di guerra, pur narrando di un assedio, in effetti
presenta solo battaglie in campo aperto, essendo la presa di Troia fatto esterno
all’orizzonte narrativo del poema e soltanto alluso. La tipologia secondaria della
battaglia d’assedio, invece, rimanda semmai alla Ilioupersis dell’Eneide nel II libro e
all’assedio portato da Turno al campo troiano nel IX libro (modello tra l’altro della
celebre irruzione di Rodomonte in Parigi nel Furioso, al rodomontata per antonomasia),
le quali si svolgono secondo modalità del tutto diverse, che danno poco spazio alla
figura propriamente eroica e alla sua modalità di rappresentazione per eccellenza, il
duello, lasciando spazio piuttosto all’oltracotanza, all’eccesso di violenza, alla
sopraffazione unilaterale. D’altronde si vede bene che la situazione impari presupposta
da un assedio è di per se stessa eccezionale e inadatta (per entrambe le parti coinvolte)
alla rappresentazione del valore guerresco individuale emergente dallo sfondo
collettivo, fondamento delle forme di rappresentazione di ogni epica bellica. Sulla base
di tali considerazioni non sarà dunque difficile individuare, anche con una certa dose di
sicurezza, proprio questa diversità nelle modalità di rappresentazione prettamente
letterarie come motivazione dell’anacronismo messo in atto dal Tasso: egli intendeva
verosimilmente ampliare le possibilità rappresentative della grande battaglia posta a
conclusione del poema da quelle della forma secondaria e atipica della battaglia
d’assedio a quelle della ben più ricca e canonica battagli in campo aperto; non a caso,
66
l’esito più evidente che questa scelta permette è di dar luogo ai due grandi duelli finali
fra Tancredi e Argante e fra Rinaldo e Solimano (quest’ultimo, non a caso, con uno
stratagemma deve essere appunto condotto dall’autore fuori dalla città assediata in cui
pure si trova proprio per adempiere alla sua funzione narrativa del grande duello eroico
cui è destinato, e che nell’assedio non potrebbe avere spazio), oltre a garantire
secondariamente anche possibilità ulteriori come la conclusione proto-melodrammatica
della vicenda di Rinaldo e Armida.
Possiamo a questo punto fare un breve cenno all’evoluzione del rapporto con le
fonti storiche nella fase di riscrittura del poema che porta dalla Liberata alla
Conquistata: uno dei tratti caratteristici dell’inasprimento in senso epico del poema
riformato è senz’altro la maggiore presenza del dato storico rispetto al dato
d’invenzione, probabilmente anche sulla scorta della rivalutazione del Trissino. Nella
Conquistata si hanno infatti almeno due grandi sezioni in più che mostrano una stretta
aderenza al dato storico: la prima con l’introduzione di una terza grande battaglia, quella
presso Ioppe, desunta dal capitolo 9 dell’ottavo libro della Cronaca di Guglielmo di
Tiro, che nella Liberata era stato quasi del tutto trascurato; la seconda con la
sostituzione dell’episodio di Olindo e Sofronia con una lunga ekphrasis che descrive un
padiglione istoriato su cui sono rappresentati gli anni precedenti della spedizione dei
crociati: attraverso questo espediente tipicamente rinascimentale, che vale di norma a
proiettare la storia entro la finzione poetica, Tasso concilia la scelta originaria di
limitare la narrazione – in polemica con il Trissino – alla sola fase finale dell’impresa
con la volontà di rendere conto con maggiore precisione ed esaustività del dato storico.
Tornando alla Liberata, per andare oltre l’ovvia corrispondenza fra storia e
narrazione bellica in opposizione al romanzesco, è bene notare la modalità in cui tale
corrispondenza è effettivamente messa in atto nella prassi poetica: nel convertire la
narrazione storiografica in poesia narrativa, Tasso mette continuamente in atto un
processo essenziale al carattere letterario del testo rispetto all’interesse meramente
documentario della fonte storica: l’attribuzione dell’azione anonima o collettiva al
singolo personaggio che ne diviene protagonista. La presenza di un sistema di
personaggi è infatti una funzione del testo imprescindibile per l’opera letteraria di
carattere narrativo, e deve trasformare in un complesso pienamente sviluppato e
coerente i pochi spunti in tal senso del testo storiografico. In Guglielmo di Tiro i pochi
che tra le fila dei crociati si rendono realmente protagonisti di qualche azione, almeno
nel libro ottavo che narra l’assedio di Gerusalemme, sono il capitano Goffredo,
67
Raimondo e Tancredi: gli altri si riducono a una mera serie di nomi. Evidente quanto sia
diverso l’equilibro fra azioni belliche e personaggi che le compiono nella Liberata: in
particolare, bisogna sottolineare l’invenzione del personaggio di Rinaldo, che
dall’essere solo un nome citato fra gli uomini al seguito di Tancredi diviene addirittura
co-protagonista del poema accanto a Goffredo. Si crea così quella situazione di
sostanziale doppio protagonismo della Liberata, tanto problematico agli occhi del
Tasso, per cui l’ambiguità di genere dell’opera che oscilla fra epos e romanzo si riflette
nei due protagonisti di Goffredo e Rinaldo, rappresentanti rispettivamente dell’una e
dell’altra tendenza, in maniera tale che – semplificando – l’uno sia essenzialmente il
protagonista delle vicende storiche, l’altro di quelle d’invenzione. Quanto ai pagani, poi,
personaggi individualizzati sono pressoché del tutto assenti nella fonte storiografica:
solo la figura di Solimano è realmente presente nella Cronaca, ma anch’essa sottoposta
da Tasso ad un adattamento molto libero, poiché in Guglielmo di Tiro se ne parla nel
terzo libro e non certo in relazione all’assedio di Gerusalemme, dove è trasportata
arbitrariamente dal poeta; tutti gli altri campioni pagani, per non parlare naturalmente di
Armida, sono personaggi totalmente d’invenzione tassiana.
Per fare qualche esempio di questa prassi di filtrare costantemente l’azione
attraverso la funzione letteraria del protagonismo, si consideri ad esempio la battaglia
del canto 11: quella che in Guglielmo di Tiro (VIII, 11) è una narrazione del tutto
generica e collettiva, qui vede al centro dell’interesse narrativo il protagonista Goffredo,
che scende in campo armato da fante, poi viene ferito da una freccia e infine, guarito
miracolosamente, torna in campo (tutto naturalmente sul modello di Eneide XII);
similmente, l’episodio della colomba messaggera narrato in questo caso da Paolo
Emilio viene ad avere come protagonista Goffredo, e così pure la visione delle milizie
celesti e delle anime beate dei compagni caduti che vengono in soccorso dei crociati nel
canto 18, che in Guglielmo di Tiro era invece una visione collettiva e non del solo
capitano. Inoltre avviene anche, talvolta, che gli equilibri interni al sistema dei
personaggi inducano l’autore ad attribuire una certa azione ad un personaggio diverso
da quello cui è attribuita nella fonte storiografica: così, ad esempio, il primo a scalare le
mura di Gerusalemme non è più l’anonimo Leotoldo di Roberto Monaco e neppure il
Goffredo di Guglielmo di Tiro bensì, significativamente, Rinaldo: il cavaliere
richiamato a causa della sua fatale necessità per prendere Gerusalemme non potrebbe
68
dimostrarla in maniera più evidente73; lo stesso si può dire per l’attribuzione ancora al
personaggio d’invenzione Rinaldo di un’azione – l’assalto al tempio di Salomone dove
si è rifugiata una parte della popolazione di Gerusalemme, nel canto 19 – che nella
Cronaca è attribuita invece, stavolta, a Tancredi (VIII, 20). Funzione non dissimile
hanno anche i duelli, che trasformano lo scontro collettivo fra le due parti in uno scontro
fra due personaggi: la monotonia e povertà icastica dell’azione collettiva dello storico
acquista così molto maggiore enargeia, diventa passibile di approfondimento
psicologico e di identificazione emotiva e soprattutto permette di instaurare un dialogo
intertestuale con i grandi modelli della tradizione epica classica, in primo luogo Omero
e Virgilio.
Un ultimo caso celebre e più complesso: l’episodio di Olindo e Sofronia. La fonte
è nel primo libro di Guglielmo di Tiro, capitolo 5, dove si narra di un giovane cristiano
che, per evitare la persecuzione di tutti i cristiani a seguito di un atto sacrilego a loro
ingiustamente imputato, pur essendo innocente si offre come capro espiatorio
dichiarandosi colpevole e salvando tutti gli altri col proprio supplizio. La finalità
puramente apologetica dell’episodio nella cronaca storica, dove esso intende dimostrare
la necessità improrogabile della crociata di fronte alla difficile condizione dei fedeli e
dei pellegrini a Gerusalemme, si arricchisce nello splendido episodio tassiano, grazie
alla duplicazione del personaggio protagonista, di un fine gioco psicologico e di
un’ambiguità di fondo tra fede religiosa e passione amorosa. La diversità di esito,
inoltre, che nella Liberata sostituisce il lieto fine matrimoniale all’effettivo compiersi
del supplizio nella fonte storiografica, costituisce anche il vero, forte legame che
l’episodio intrattiene con la trama del poema: quello di introdurre il personaggio di
Clorinda fornendone subito un’esauriente caratterizzazione psicologica – che va dalla
nobiltà d’animo che la distingue da tanti altri pagani alla latente simpatia per i cristiani
che prelude sin d’ora alla sua stessa vicenda di conversione – emergente in filigrana
dall’azione stessa e non da un ritratto autonomo propinato ad hoc dall’autore (alla
maniera manzoniana, insomma).
Tutte queste modifiche hanno naturalmente un unico movente di fondo: quello di
dare spessore letterario e poetico alla narrazione storica, di per sé estranea a simili
finalità. Ciò porta il poeta anche a privilegiare quegli elementi della testimonianza
storica che sembrano meglio passibili di un’elaborazione letteraria, quand’anche si
trattasse solo di brevi spunti. Così ad esempio il rapido cenno alla foresta dove i crociati
73
Su questa modifica rispetto alla fonte storica, cfr. DI BENEDETTO, V., Gerusalemme liberata XVIII: fra
storia e invenzione con postilla sul Manzoni, «Belfagor» 42, 1987, pp. 570-80.
69
si recano a prendere il legname necessario a costruire le macchine d’assedio dà origine a
uno degli episodi simbolici centrali del poema, quello della selva incantata di Saron, con
tutte le sue risonanze romanzesche ma al contempo anche virgiliane, lucanee, dantesche.
Per converso, intere sezioni giudicate poco interessanti o ripetitive nella sostanza
possono essere liquidate nonostante l’importanza che rivestono nelle fonti
storiografiche: così, ad esempio, gli scontri svoltisi vicino al mare presso Ioppe, cui
nella Cronaca è dedicato l’intero capitolo 9 dell’ottavo libro, sono del tutto trascurati
nella Liberata perché evidentemente giudicati ripetitivi rispetto alle altre grandi scene di
battaglia; nella Conquistata, invece, saranno recuperati integralmente (andando a
formare il principale ampliamento del nuovo poema rispetto al vecchio) non solo per
maggiore aderenza alla verità storica, ma soprattutto poiché lì divengono strettamente
funzionali al progetto di omerizzazione del poema, per il quale era necessaria una
ulteriore grande battaglia in cui i cristiani fossero sul punto di essere sconfitti e
annientati così da poter innescare la dinamica iliadica di compassione e intervento
dell’eroe protagonista (cfr. Iliade 15-16).
Possiamo a questo punto passare ad una considerazione meno generale ma allo
stesso tempo più interessante e inaspettata. Scorrendo il pur sommario schema che ho
fornito, ci si accorge che fra gli episodi suggeriti da un qualche spunto delle fonti
storiografiche non sono pochi quelli di carattere soprannaturale. La visione che
Goffredo ha durante l’assalto decisivo a Gerusalemme, come abbiamo già ricordato, è
desunta dai testi di Guglielmo di Tiro e di Roberto Monaco, che la riportano entrambi,
con la solita differenza che lì non è attribuita solo al singolo personaggio ma
genericamente alla collettività. Il primo elemento, ossia la visione delle milizie celesti
che combattono al fianco dei crociati contro le forze infernali, rielabora uno spunto
simile di Guglielmo di Tiro, che menziona appunto come “segno divino” la discesa dal
monte Oliveto di un soldato vestito di armi splendenti ad animare i crociati nell’assalto
(l’episodio sarà poi ripreso con maggiore fedeltà nella Conquistata, XXIII, 34-36, dove
si parla appunto di un cavalier lucente); ancor più vicino all’episodio della Liberata è
Roberto Monaco, che nel capitolo 13 del settimo libro parla del soccorso di un intero
esercito celeste (albatorum militum innumerabilis exercitus visus est de montibus
descendere, quorum signiferi et duces esse dicuntur Georgius, Mauricius…). Il secondo
elemento della visione, ossia il riconoscimento, fra questi aiuti celesti, delle anime di
alcuni crociati morti prima della presa di Gerusalemme, è desunto anch’esso – per
“contaminazione” – da un passo successivo di Guglielmo di Tiro, che narra di come a
70
molti cristiani, una volta conquistata la città, apparvero l’anima di del vescovo di
Poggio (Puys) Ademaro, morto presso Antiochia, e di altri compagni d’arme morti nel
corso della crociata (che naturalmente in Tasso diventano al solito personaggi ben
precisi e noti al lettore: Ugone e Dudone). Ancor più clamorosa è la derivazione dalla
Cronaca – seppure con il solito riadattamento cronologico al momento dell’assedio di
Gerusalemme di un evento precedente – della pioggia inviata da Dio (canto 13) per
placare la siccità e instaurare quel “novello ordine di cose” che segna la svolta decisiva
nella trama del poema: anche nello storiografo (VI, 19) si attribuisce a quella pioggia un
carattere decisamente soprannaturale, in grado di rinfrancare l’animo e restituire le forze
ai crociati avviliti dalle difficoltà dell’impresa. Quello che è senz’altro il più
significativo ricorso al “meraviglioso cristiano” nel poema del Tasso, il momento
simbolico più rilevante dell’opera tanto sul piano paradigmatico quanto su quello
sintagmatico per esplicita ammissione dello stesso autore (poiché segna il
“rivolgimento”, la katastrophé nella trama, ossia il passaggio dal differimento e
dall’erranza al compimento del telos epico) non è un elemento di invenzione ma uno
spunto derivato dalla storiografia. Ma se in fondo non stupisce eccessivamente trovare
simili interventi divini in un testo redatto da un vescovo del dodicesimo secolo, tanto
più se tratta di un evento di storia cristiana per eccellenza come la crociata, certamente è
più inaspettato scoprire che persino le arti magiche e diaboliche, controparte infernale
dell’intervento celeste, considerate naturalmente come l’elemento più romanzesco e più
lontano dalla poetica del verosimile di tutto il poema tassiano, hanno in realtà anch’esse
il loro appiglio nella storiografia: la morte del mago Ismeno, schiacciato dal masso
lanciato da una delle macchine d’assedio mentre sta cercando di fermarla con le sue arti
magiche, è tratta alla lettera da Guglielmo di Tiro, VIII, 15, con l’unica differenza
inessenziale che lì si tratta di due streghe (duas… maleficas):
Contra quam [machinam] cum nulla arte possent proficere, duas adduxerunt maleficas, ut eam
fascinarent et magicis carminibus redderent impotentem; quae dum suis praestigiis instarent super
murum, et incantationibus, repente ex eadem machina molaris immissus utramque illarum cum tribus
puellis, quae illarum gressum fuerant comitatae, obtrivit, et excussis animabus, de muro inferius dejecit
exanimes.
Proprio in questo accenno alla magia che egli trova nel principale storico della
prima crociata, il Tasso vede la giustificazione o se si vuole l’appiglio che avalla
l’inserimento della magia diabolica dei pagani senza venir meno alla verosimiglianza
storica: come infatti egli scrive in una lettera, è proprio la menzione della magia in
questo passo della Cronaca a legittimare, dal suo punto di vista, il ben più ampio ricorso
71
che egli ne fa in tutto il poema (a partire naturalmente dall’invenzione del tutto
romanzesca del personaggio di Armida).
Il numero e la frequenza di tutti questi spunti soprannaturali e magici, in questi
casi non frutto della fantasia del Tasso ma desunti dalla più autorevole e dettagliata
fonte storica dell’opera, deve indurci anche a riconsiderare questo aspetto in relazione al
rapporto tra storia e invenzione, tra vero e verosimile nella poetica tassiana. Nel
complesso, infatti, il vero storico è per il Tasso la materia propria del poema epico,
come abbia visto, mentre il verosimile è il margine d’invenzione lasciato al poeta, con
l’unico vincolo di essere plausibile e dunque non in contraddizione con la realtà storica;
il verosimile dunque comprende tanto il duello di ascendenza classica di cui non c’è
traccia nelle fonti quanto, a maggior ragione, l’invenzione romanzesca; l’unico vero
problema che si pone al Tasso è la giustificazione in tal senso di quegli elementi magici
e soprannaturali che a lui apparivano come elementi imprescindibili del poema e utili ad
allettare il gusto isvogliato del pubblico: per risolvere il problema che essi creano alla
verosimiglianza egli riprende e rielabora dal Trissino, correggendola sensibilmente, la
soluzione del “meraviglioso cristiano” o appunto, con un significativo ossimoro,
“meraviglioso verosimile”. La sostanza di tale soluzione sta, come abbiamo accennato
all’inizio, nel recuperare alla verosimiglianza quegli elementi dell’epica classica e
soprattutto del romanzo cavalleresco che ormai apparivano decisamente inverosimili
ponendoli sotto l’egida della religione cristiana, e in tal modo conferendo ad essi una
dimensione veritativa ancor più autorevole di quella storica. Con la fondamentale
novità, rispetto al Trissino, che all’aiuto del cielo si contrappone anche l’inferno, con
una parallela funzione antagonistica. Ma come abbiamo visto, tanto il meraviglioso
celeste quanto la magia pagana e infernale hanno alcuni appigli molto rilevanti anche
nella cronaca storica: in tal modo proprio il meraviglioso, in apparenza più
problematico, risulta poi invece doppiamente fondato, come verità al contempo storica e
religiosa.
Per concludere questo quadro generale sulla maniera in cui Tasso si rapporta con
le fonti storiografiche, analizziamo infine più da vicino il testo di un celebre episodio
confrontandolo con il passo di Guglielmo di Tiro da cui è desunto, per comprendere
meglio come tale rapporto di rielaborazione sia condotto dal poeta sul piano anche
prettamente testuale oltre che su quello strutturale. La morte di Sveno, principe dei
72
Danesi74, è narrata nella Cronaca in un breve capitolo (n. 20) del quarto libro: il testo di
una manciata di righe si trasforma nella Liberata in un episodio che si distende su
quaranta ottave. A proposito di esso, in una lettera Tasso afferma di essersi discostato
«o nulla o poco» dagli storici, ma a ben guardare le cose non stanno esattamente in
questi termini. Senza che la sostanza della narrazione storica sia alterata, il poeta la
riscrive arricchendola di numerosi elementi narrativi e simbolici, nonché di risonanze
letterarie, che ne fanno qualcosa di totalmente altro pur nella complessiva fedeltà alla
fonte. Innanzitutto assistiamo anche qui a quella libertà di rielaborazione della storia che
abbiamo già visto riuscire piuttosto facile e aproblematica per il poeta: l’evento,
risalente al 1098, è posticipato di un anno per risultare contemporaneo all’assedio di
Gerusalemme, modificando anche il luogo dove esso si svolse in modo da avvicinarlo
anche geograficamente ai luoghi del poema. Un’altra differenza narrativa poi salta
subito all’occhio: il generico rumor quidam cui in Guglielmo di Tiro è affidata la
notizia della morte del principe danese si trasforma in Tasso nel racconto di un
personaggio preciso, Carlo, unico sopravvissuto alla strage e messaggero che si fa
carico di narrarla; l’espediente letterario e quasi teatrale del racconto di secondo grado
permette così di venare l’intera vicenda di un’aura di patetismo tragico nelle parole di
chi ha visto con i propri occhi. Ma l’introduzione del personaggio di Carlo è
fondamentale anche per collegare la morte di Sveno, attraverso la vicenda della
consegna della spada, alla necessità fatale di Rinaldo, per tanti versi suo alter ego, in
vista del compimento dell’impresa crociata; tale rapporto narrativo è chiarito sin
dall’esordio del canto, segnalato esplicitamente dagli spiriti infernali che temono la
richiamata di Rinaldo:
Questi, narrando del suo duce ardito
e de' compagni a i Franchi il caso fero,
paleserà gran cose; onde è periglio
che si richiami di Bertoldo il figlio.
In tal modo, l’intero episodio è letto alla luce di questo rapporto narrativo con il
peso dell’assenza di Rinaldo dal campo crociato (desunta dal protagonismo in absentia
di Achille per gran parte dell’Iliade). Il racconto di Carlo inizia con una ripresa quasi
letterale: Sveno, del re de’ Dani unico figlio, cfr. Danorum regis filius, Sueno nomine, e
74
Sull’episodio di Sveno, cfr. fra l’altro BOLZONI, L., La memoria dell’eroe («Gerusalemme Liberata»,
canto VIII), in Torquato Tasso e la cultura estense. Atti del Convegno, Ferrara 10-13 Dicembre 1995, a
cura di VENTURI, G., Firenze, Olschki 1999, vol. I, pp. 67-97; PIGNATTI, F., La morte di Sveno
("Gerusalemme liberata", VIII, 5-40) e la tradizione epico-cavalleresca medievale, «Giornale storico
della letteratura italiana», 178 (2001), pp. 363-403.
73
nella prima ottava sembra seguire il testo storiografico nella breve descrizione delle
virtù del principe, ma poi subito se ne distacca introducendo il duplice tema del suo
desiderio di gloria terrena, come emulo della fama di Rinaldo, e soprattutto di gloria
celeste, che preannuncia la sua caratterizzazione come martire.
e sentia in parte
sdegno e vergogna di sua fama oscura,
già di Rinaldo il nome in ogni parte
con gloria udendo in verdi anni matura;
ma piú ch'altra cagione, il mosse il zelo
non del terren ma de l'onor del Cielo.
Il viaggio per raggiungere i crociati è di nuovo seguito abbastanza fedelmente, con
qualche diretta ripresa testuale (come 8, v. 5: il cammin volse / a la città che sede è de
l’impero. / Qui il greco Augusto in sua magion l’accolse, cfr. pervenerat
Constantinopolim, ubi ab imperatore satis honeste tractatus fuerat), ma subito vediamo
emergere la prospettiva privilegiata di Sveno, che diventa protagonista indiscusso del
racconto: immancabile, la tendenza al protagonismo che abbiamo già sottolineato porta
a rileggere il fatto collettivo della strage in termini di impresa fortemente
individualizzata; il mero dato oggettivo del ritardo dei Danesi rispetto al resto
dell’esercito crociato viene filtrato attraverso la prospettiva soggettiva della psicologia
del principe e della sua impazienza a raggiungere i crociati:
Hic de regno patris tardior egressus, plurimum acceleraverat, ut se praecedentibus cum omni suo
comitatu adjungeret legionibus…
Precipitò dunque gli indugi…
Questo parlare al giovenetto fianco
del fero Sveno è stimolo sí forte,
ch'ogn'ora un lustro pargli infra pagani
rotar il ferro e insanguinar le mani.
Tale è la focalizzazione sulla prospettiva del protagonista che i propositi di gloria
o martirio che il suo animo vagheggia trovano espressione in un’intera ottava di suo
discorso diretto (15). La vocazione al martirio del giovane principe viene poi
definitivamente chiarita da una modifica non irrilevante rispetto alla fonte: se in
Guglielmo di Tiro le schiere danesi sono colte alla sprovvista e impreparate, clam et de
nocte, anche per la noncuranza del principe, in Tasso invece Sveno ordina al contrario
che i suoi dormano armati in previsione dello scontro:
74
et minus provide se haberet aliquantulum, irruentibus super eum clam et de nocte Turcorum
ingentibus copiis, in ipsis castris gladio perempti sunt.
Vuol ch'armato ognun giaccia, e non depone
ei medesmo gli arnesi o la lorica.
Questa lieve variazione toglie alla strage subita dai cristiani tutto il suo carattere
di imprevisto e di agguato proditorio che aveva nella fonte storiografica per subire una
complessiva risemantizzazione: la strage è la conseguenza di una scelta quasi volontaria
da parte di Sveno, una scelta consapevole di morte e di martirio per la causa cristiana.
Nello scontro che segue, Sveno pur nell’oscurità della notte si distingue combattendo,
un dato che di nuovo, nello storico, era genericamente riferito semmai alle schiere
danesi nel loro complesso:
…sed tamen diu et viriliter resistentes, ne gratis animas viderentur impendisse, cruentam post se
hostibus reliquerunt victoriam.
Pur sí fra gli altri Sveno alza la fronte
ch'agevol cosa è che veder si possa,
e nel buio le prove anco son conte
a chi vi mira, e l'incredibil possa.
Di sangue un rio, d'uomini uccisi un monte
d'ogni intorno gli fanno argine e fossa;
e dovunque ne va, sembra che porte
lo spavento ne gli occhi, e in man la morte.
Infine, all’apparire dell’alba che palesa la strage delle schiere danesi, le ultime
parole del principe prima di gettarsi fra i nemici coraggiosamente e persino lieto della
morte confermano perentoriamente la sua scelta del martirio di cui nella fonte storica
non c’è la minima traccia:
“Seguiam” ne grida “que' compagni forti
ch'al Ciel lunge da i laghi averni e stigi
n'han segnati co 'l sangue alti vestigi.”
Disse, e lieto (credo io) de la vicina
morte cosí nel cor come al sembiante,
incontra alla barbarica ruina
portonne il petto intrepido e costante.
A questo punto tuttavia la narrazione dell’episodio in Guglielmo di Tiro si
conclude, mentre Tasso fa seguire alla morte del principe una lunga appendice
d’invenzione vissuta in prima persona dal narratore Carlo, dove il poeta ricorre
massicciamente al meraviglioso cristiano per coronare il martirio di una forte aura di
sacralità. Carlo, miracolosamente guarito dalle ferite da un eremita che si imbatte in lui,
75
trova fra i corpi quello del suo principe che viene per lui illuminato dal soprannaturale
raggio di luce di una stella: alla fedeltà alla fonte storica si sostituisce ora l’invenzione
letteraria, con una palese memoria dell’episodio ariostesco di Cloridano e Medoro, ai
quali la luce della luna rivela il luogo dove giace il corpo del loro giovane principe
Dardinello. A questo punto Carlo assiste al prodigio, di cui naturalmente non c’è traccia
nel testo storiografico, di un sontuoso sepolcro che sorge per volontà divina intorno al
corpo di Sveno, a sancire senza intermediazioni il conseguimento della gloria celeste cui
il principe ambiva.
In questo capitolo si è cercato di fornire un primo abbozzo per una ricostruzione
complessiva del rapporto fra la Gerusalemme liberata e le sue fonti storiografiche,
questione senz’altro centrale nella poetica tassiana che tuttavia non ha finora ricevuto
quell’approfondimento critico che pure senz’altro meriterebbe. Quello che è emerso già
da questo primo approccio alla questione è che tale rapporto con le fonti storiche ha un
margine di libertà davvero molto ampio, tanto al livello strutturale complessivo quanto a
livello testuale per quegli episodi che sono direttamente tratti dalle cronache, come la
morte di Sveno. Sarebbe decisamente auspicabile uno studio approfondito di una
questione tanto importante, che non solo tracci un quadro possibilmente esaustivo della
presenza delle fonti storiche principali e anche secondarie nel testo della Gerusalemme,
ma che soprattutto, da tale punto di partenza, analizzi la prassi poetica di Tasso in
relazione a questa particolarissima forma di intertestualità, ricerchi delle strategie di
significato dietro le modalità di rielaborazione del dato storico e cerchi poi anche di
metterle in relazione con le teorie estetiche dell’epoca e soprattutto con le posizioni
esposte dall’autore nei suoi testi teorici. Senz’altro utile sarebbe anche, per rendersi
pienamente consapevoli di tale libertà di rielaborazione e invenzione, un confronto con
il parallelo rapporto con la sua fonte storiografica, ossia la Guerra gotica di Procopio di
Cesarea, dell’Italia del Trissino, che per Tasso costituisce senza dubbio il modello più
diretto quanto al rapporto con le fonti per l’epica storica (si cercherà di fornirne le linee
principali nel prossimo capitolo). Leggendo il poema del Trissino, infatti, si ha
continuamente la fastidiosa impressione – senz’altro ben più che per Lucano, bersaglio
per eccellenza di questo genere di critica – di avere a che fare con una versificazione di
prosa storiografica: impressione che è invece quanto di più estraneo al capolavoro
tassiano. Simili analisi potrebbero dare contributi di grande rilievo alla conoscenza della
poetica e dell’opera del Tasso, anche ben al di là della questione specifica della
trattazione. Se i punti di partenza, ossia la sostanziale coincidenza tra vicende belliche e
76
storiografia da una parte, episodi cavallereschi e libera invenzione dall’altra, sono
complessivamente piuttosto scontati, l’approfondimento della questione può certamente
chiarire aspetti molto meno ovvi di un quadro senza dubbio ben più complesso di una
simile schematizzazione di comodo, come abbiamo visto ad esempio per la questione
del meraviglioso verosimile e dei suoi inaspettati appigli storiografici.
77
78
3.2. Schema dei contatti più rilevanti tra la Gerusalemme liberata
e la Cronaca di Guglielmo di Tiro:
GUGLIELMO DI TIRO, Historia belli sacri
Gerusalemme liberata
Canto 1
- prologo in Cielo
- elezione di Goffredo a capitano
- rassegna dell’esercito crociato
- I, 17:
Titulus: Nomina principum qui de regno Francorum
et Teutonicorum iter assumpserunt.
- marcia verso Gerusalemme
- timori di Aladino, che fa intorbidare le
fonti
Canto 2
- VIII, 4:
Porro cives, praecognito nostrorum adventu, ora
fontium et cisternarum quae in circuitu urbis erant,
usque ad quinque vel sex milliaria, ut populus siti
fatigatus, ab urbis obsidione desisteret, obstruxerant:
unde postmodum in ejus obsidione, infinitas molestias
noster passus est exercitus, sicut in sequentibus
dicetur.
e pensa di cacciare i cristiani da
Gerusalemme
- VII, 23:
- episodio di Olindo e Sofronia
- I, 5 (ispirato a):
titulus: Hierosolymitae viris fortibus, armis et
victualibus, urbem communiunt diligenter. Cives
fideles ex plurima parte extra urbem projiciunt.
Quidam civis ex infidelibus nostros odio persequens
insatiabili, vir perfidus et nequam, ut eis aliquid ad
mortem moliretur, morticinum canis clam projecit in
atrium templi, in cujus munditia conservanda, ejus
custodes et universa civitas omnem impendebant
sollicitudinem. Mane facto, qui orationis gratia
accesserunt ad templum, reperientes immundum
cadaver et fetens, pene ad insaniam versi, universam
urbem repleverunt clamoribus. Concurrit subito
populus universus, et omnes asserunt pro constanti,
Christianos hoc fecisse. Quid plura? Decernitur
interitus universis, et tam piaculare flagitium morte
piandum judicatur. Fideles porro de sua confidentes
innocentia, mortem pro Christo parati erant subire.
Dumque adessent spiculatores eductis gladiis ut
populum interimerent, obtulit se adolescens plenus
spiritu, dicens: Periculosum est, fratres, si ita perit
omnis haec ecclesia. Expedit magis ut unus moriatur
pro populo, et non tota gens pereat. Concedite mihi,
ut mei habeatis annuam in benedictione memoriam,
et generi meo honor in perpetuum debitus
conservetur; ego vero, auctore Domino, hanc a vobis
stragem depello. Susceperunt igitur gratanter
verbum, et quod ille petierat, ultro concedunt. Et ut in
Ramis palmarum ad perennem ejus memoriam,
contribules ejus olivam, quae Domini nostri Jesu
Christi significativa est, introducant in civitatem, in
processione solemni, confirmant. Quo facto,
praedictus adolescens primatibus se offert civitatis,
reum se confitetur, et omnes alios astruit innocentes.
Quod audientes judices, aliis absolutis, illum gladio
exposuerunt. Et ita pro fratribus animam ponens,
cum pietate dormitionem accepit, optimam in Domino
habens repositam gratiam.
…Così al publico fato il capo altero
Offerse, e’l volse in sé sola raccòrre…
79
- ambasceria di Alete e Argante
- IV, 24:
titulus: Aegyptius calipha nuntios dirigit ad principes,
foedus postulans, et eorum gratiam sibi conciliare
quaerens.
- VII, 19:
titulus: Nuntii, qui a nostris principibus missi fuerant
in Aegyptum, revertuntur.
Per idem tempus legati nostri qui, invitantibus
Aegyptiis, qui ad obsidionem Antiochenam missi a
calipha Aegyptio venerant, ut praemisimus,
descenderant in Aegyptum, post annum quo tam
violenter quam dolose detenti fuerant, ad principes,
qui eos miserant, sunt reversi; venerantque cum eis
Aegyptiorum principis legati, verba deferentes
multum ab his quae prius attulerant, dissimilia. Cum
enim multa prius obtinere laborassent precum
instantia, ut nostrorum principum contra insolentiam
Turcorum et Persarum haberent gratiam et auxilium;
nunc mutato cantico, pro summo beneficio se
arbitrabantur nostris indulgere, si Hierosolymam
ducentos aut trecentos simul permitteret inermes
accedere et completis orationibus redire incolumes.
Quod verbum nostri principes pro ludibrio habentes,
praedictos nuntios redire compulerunt, significantes
quod non secundum propositas conditiones
particulatim illuc accederet exercitus; sed junctis
agminibus Hierosolymam proficiscerentur unanimes,
regno ejus periculum illaturi.
(- cfr. anche ROBERTO MONACO, V, 1-2)
Canto 3
- arrivo a Gerusalemme e primi scontri
- VII, 24:
titulus: Proficiscens exercitus Hierosolymam
pervenit; sed interim excitatur tumultus, in quo
cadunt nonnulli de hostibus.
…Unde progressi pusillum, e vicino urbem sanctam
contemplantes, cum gemitu et suspiriis prae gaudio
fusis spirituali, pedites, et nudis ex plurima parte
vestigiis, coepto ferventius insistentes itineri, subito
ante urbem constiterunt, castra circumponentes eo
ordine, quo a majoribus principibus singulis
designabatur.
(- cfr. anche ROBERTO MONACO, IX, 1)
- teikhoskopia di Erminia
- incontro fra Clorinda e Tancredi
- morte di Dudone
- descrizione di Gerusalemme (55 sgg.):
Canto 4
Canto 5
Canto 6
Canto 7
- VIII, 3-4:
Gierusalem sovra duo colli è posta…
…Ma fuor la terra intorno è nuda d’erba,
e di fontane sterile e di rivi.
Sita est autem in montibus duobus…
…Est autem locus, in quo civitas sita est, aridus et
inaquosus, rivos, fontes ac flumina non habens
penitus.
- accampamento cristiano
- VIII, 5:
- esequie di Dudone
- legname per le macchine da guerra
- VIII, 6:
titulus: …et quo ordine castra sunt locata.
- concilio infernale
- Idraote e Armida
- arrivo di Armida al campo cristiano
- uccisione di Gernando e partenza di
Rinaldo
- elezione dei dieci campioni di Armida
- furto delle vettovaglie: prospettiva della
fame
- duello fra Tancredi e Argante
- uscita notturna di Erminia da
Gerusalemme
- fuga di Erminia tra i pastori
- Tancredi imprigionato nel castello
80
titulus: …in silvas descendunt, traves deferunt,
erigunt machinas.
- VIII, 9:
titulus: classis Ianuensium apud Ioppen applicat;
mittuntur de exercitu qui eos ad obsidionem
deducant, patiuntur in itinere qui missi fuerant
hostium insidias.
Canto 8
incantato di Armida
- duello fra Argante e Raimondo
- racconto della morte di Sveno
- IV, 20:
- armi insanguinate di Rinaldo
- sommossa fomentata da Argillano
Canto 9
Canto 10
Canto 11
- Solimano in battaglia; poi Clorinda e
Argante
- intervanto dell’arcangelo Michele contro
le forze infernali
- arrivo dei cavalieri liberati dal castello di
Armida e vittoria dei cristiani
- fuga di Solimano e suo ritorno a
Gerusalemme
- consiglio di guerra dei pagani (Aladino,
Argante, Orcano, Solimano)
- racconto dei cavalieri liberati da Rinaldo
e profezia dell’Eremita
- processione al monte Oliveto
titulus: Suenno Danorum regis filius exercitum
subsequens, cum suis copiis juxta urbem Finiminis a
Turcis interficitur.
(- scontri dei crociati con Solimano in III,
3 sgg., ben prima dell’assedio di
Gerusalemme)
- VIII, 11:
titulus: indicuntur populo litanie, in montem Oliveti
ascendit universus populus.
- Goffredo in battaglia come fante:
rimprovero di Raimondo
- battaglia
- VIII, 13:
titulus: impugnatur civitas et vehementissimus hinc
inde fit conflictus. sed nox interposita litem dirimit.
Canto 12
Canto 13
- ferimento di Goffredo e sua guarigione
miracolosa
- la notte interrompe la battaglia
- sortita notturna di Clorinda e Argante;
incendio della macchina d’assedio
- duello fra Tancredi e Clorinda
- battesimo e morte di Clorinda
- tormento di Tancredi
- Ismeno incanta la selva di Saron
- tentativi vani di penetrarvi da parte di
Alcasto e poi Tancredi
- profezia dell’Eremita sulla fatalità di
Rinaldo
- siccità
- VIII, 7:
Titulus: siti populus fatigatur; dumque aquas
quaerunt longe positas, et reliqua vitae necessaria,
ab hostibus perimuntur frequenter.
(- cfr. anche ROBERTO MONACO, IX, 3)
- pioggia mandata da Dio: “novello ordine
di cose”
- VI, 19 (ben prima
Gerusalemme):
dell’arrivo
a
ros quidam suavissimus immissus de supernis,
modicus, sed gratissimus, super nostrum exercitum
descendit ita placidus, ut quasi in eo benedictionem
et gratiam suam videretur Dominus infudisse.
Quicunque enim eo imbre coelitus immisso
conspersus est, ita plenam mentis et corporis,
suscepit hilaritatem et integritatem sospitatis,
tanquam nihil laboris, nihil molestiae tota illa
expeditione passus esset.
Canto 14
Canto 15
- sogno di Goffredo
- Carlo e Ubaldo inviati a richiamare
Rinaldo
- mago di Ascalona e suo racconto delle
vicende occorse a Rinaldo
- viaggio di Carlo e Ubaldo sulla nave
prodigiosa della Fortuna
81
Canto 16
Canto 17
Canto 18
- arrivo all’isola di Armida: ostacoli
- descrizione del palazzo di Armida
- rinsavimento di Rinaldo
- suo abbandono di Armida
- rassegna dell’esercito egiziano
- Armida si unisce agli egiziani
- Rinaldo e il mago di Ascalona: scudo
istoriato con la progenie estense
- ritorno di Rinaldo al campo
- Rinaldo accolto da Goffredo e
rimproverato dall’Eremita
- purificazione di Rinaldo sul monte
Oliveto
- Rinaldo vince gli incanti della selva
- costruzione di nuove macchine d’assedio
- prodigio della colombra
- Rinaldo (non Goffredo) sale per primo
sulle mura di Gerusalemme (78-79):
e [Rinaldo] sale il muro e 'l signoreggia, e 'l rende
sgombro e securo a chi diretro ascende.
Ed egli stesso a l'ultimo germano
del pio Buglion, ch'è di cadere in forse,
stesa la vincitrice amica mano,
di salirne secondo aita porse.
- VIII, 10:
titulus: qui in classe advenerant ad exercitum se
conferunt et in erigendis machinis plurimas prestant
commoditates.
(- da PAOLO EMILIO VERONESE, II)
- VIII, 18:
Ponte igitur sic ordinato, primus omnium vir inclytus
et illustris dux Godefridus, reliquos ut subsequantur
exhortans, cum fratre suo Eustachio urbem ingressus
est; quem continuo subsecuti sunt Ludolfus et
Gislebertus uterini fratres.
(- cfr. anche ROBERTO MONACO, IX, 7,
dove il primo a salire sulle mura è invece
un certo Leotoldo)
- morte di Ismeno
- VIII, 15:
Contra quam [machinam] cum nulla arte possent
proficere, duas adduxerunt maleficas, ut eam
fascinarent et magicis carminibus redderent
impotentem; quae dum suis praestigiis instarent
super murum, et incantationibus, repente ex eadem
machina molaris immissus utramque illarum cum
tribus puellis, quae illarum gressum fuerant
comitatae, obtrivit, et excussis animabus, de muro
inferius dejecit exanimes.
- visione miracolosa di Goffredo:
visione delle milizie celesti
(ma per maggiore aderenza cfr.
Gerusalemme conquistata, XXIII, 34-36:
- VIII, 16:
Poi fu veduto un cavalier lucente
scender da' poggi solitari ed ermi…)
Nam de monte Oliveti miles quidam, qui tamen
postea non comparuit, splendidum et refulgentem
ventilando clypeum, signum dabat nostris legionibus,
ut redirent in id ipsum et congressionem iterarent.
Quo signo exhilaratus animo dux Godefridus, qui
cum fratre suo Eustachio, in superiori castelli nostri
coenaculo ad urbem impugnandam et ad cautius
tuendum aedificium erat constitutus, populum et
majores coepit ingentibus revocare clamoribus.
(- cfr. anche ROBERTO MONACO, V, 13)
e poi visione dei compagni caduti:
- VIII, 22 (dopo la presa di Gerusalemme):
Mira di quei che fur campion di Cristo
l'anime fatte in Cielo or cittadine,
che pugnan teco e di sí alto acquisto
si trovan teco al glorioso fine.
Là 've ondeggiar la polve e 'l fumo misto
vedi e di rotte moli alte ruine,
tra quella folta nebbia Ugon combatte
e de le torri i fondamenti abbatte.
Ecco poi là Dudon, che l'alta porta
Aquilonar con ferro e fiamma assale:
ministra l'arme a i combattenti, essorta
ch'altrui su monti, e drizza e tien le scale.
Quel ch'è su 'l colle, e 'l sacro abito porta
e la corona a i crin sacerdotale,
è il pastore Ademaro, alma felice:
vedi ch'ancor vi segna e benedice.
82
Ea die dominus Ademarus, vir virtutum et immortalis
memoriae,
Podiensis episcopus,
qui apud
Antiochiam, ut praediximus, vita decesserat, a multis
in sancta visus est civitate, ita ut multi viri
venerabiles et fide digni eum super civitatis murum,
primum omnium ascendisse et caeteros animasse ad
ingressum, oculis corporeis se vidisse constanter
assererent: et postmodum plurimis, loca venerabilia
circumeuntibus, eadem die manifestus apparuit.
Aliique quam plures, qui in toto itinere divinis
obsequiis mancipati, piam in Christo dormitionem
acceperant, in eadem civitate apparuerunt multis,
loca sancta cum aliis ingredientes. In quo manifeste
dabatur intelligi, quia, etsi vita decessissent
temporali, ad aeternam vocati beatitudinem, non sunt
fraudati a desiderio suo.
(- cfr. anche ROBERTO MONACO, V, 16)
- i crociati entrano in Gerusalemme
- VIII, 18:
titulus: …urbs capitur, porta aperitur et noster
introducitur exercitus.
Canto 19
- ripresa del duello tra Argante e Tancredi
- morte di Argante, Tancredi ferito
- Rinaldo (non Tancredi) al tempio di
Salomone
- Solimano alla rocca di David
- VIII, 20:
titulus: cives in atrium templi se conferunt, Tancredus
eos illuc persequitur: fit strages innumera et sanguis
ibidem funditur infinitus.
- VIII, 19:
…unde, relictis turribus et muro, ad diversa fugientes
loca, saluti propriae consulere satagebant. Hi,
quoniam praesidium civitatis in vicino constitutum
erat, ex parte plurima se in arcem contulerunt.
- la notte interrompe l’assalto
- Vafrino mandato a spiare l’esercito
egiziano:
Vide [Vafrino] tende infinite e ventillanti
stendardi…
…che fra sé disse: “Qui l'Africa tutta
translata viene e qui l'Asia è condutta”
Canto 20
- Erminia cura Tancredi
- arrivo dell’esercito egiziano a
Gerusalemme
- IX, 12 (per le notizie sull’esercito
egiziano):
De hostium vero numero nullus poterat habere
certitudinem; nam et infinita erat eorum multitudo et
singulis diebus incrementi aliquid eorum accedebat
viribus. Sic igitur obtenta sine contradictore praeda,
quae prae nimia multitudine numerum excedebat,
noctem illam ibi transegerunt gaudentes…
- IX, 10:
Per idem tempus, urbe recens capta, dum adhuc
principes, qui eam divino mancipaverant cultui,
nondum essent divisi abinvicem, rumor insonuit, et
vere sic erat, quod princeps Aegyptius, inter
Orientales potentissimus, ex universis regionibus
suae ditioni subjectis militares convocaverat copias
et exercitus collegerat infinitos, indigne ferens quod
populus barbarus, de ultimis egressus terrarum
finibus, in regnum suum introierat, et provinciam
imperio suo subditam, occupaverat violenter.
Vocatoque ad se militiae suae principe Elafdalio, qui
alio nomine dicebatur Emireus, praecipit ut
universum Aegypti robur, et omnes imperii vires
colligens, in Syriam ascendat; et populum
praesumptuosum deleat de superficie terrae, ita ut
non memoretur nomen illius ultra.
- rispettivi discorsi di Goffredo e di
Emireno
- battaglia
- Gidippe e Odoardo
- Altamoro
- fallito attentato a Goffredo
- Rinaldo incontra Armida
- Solimano si lancia in battaglia:
Raimondo e Tancredi prendono la rocca di
David
- morte di Gidippe e Odoardo
- Rinaldo uccide Solimano
- Rinaldo insegue Armida: riconciliazione
- Goffredo uccide Emireno e fa
prigioniero Altamoro
- Goffredo scioglie il voto al Santo
Sepolcro
83
- IX, 12:
titulus: committitur prelium et nostris divinitus
confertur victoria.
- VIII, 24 (dopo la vittoria cristiana):
Interea vero pars hostium ea quae in arce David, a
facie gladii fugiens se contulerat, videntes quod
urbem universam sibi populus noster vindicaverat et
quod ipsi diutius obsidionem tolerare non possent,
petita et impetrata a domino comite Tolosano
fiducia… arcem ei resignaverunt.
- VIII, 21:
titulus: urbe composita sedatur tumultus et armis
depositis orationis gratia loca circueunt venerabilia,
diem agentes sollempnem.
(- cfr. anche ROBERTO MONACO, IX, 9)
84
3.3. L’Italia del Trissino e la Guerra gotica di Procopio di
Cesarea
Il precedente costituito dall’Italia del Trissino gioca un ruolo chiave per la
comprensione di alcune fondamentali scelte strutturali del poema tassiano, in un
rapporto di derivazione sminuito, trascurato e nel complesso drasticamente sottovalutato
per l’interferenza su di esso del giudizio di valore, che invece, in realtà, è in sé ben poco
pertinente alla questione. Senza le sperimentazioni e gli errori del Trissino a battere la
strada, la Gerusalemme liberata non sarebbe probabilmente quel capolavoro che è. La
critica rinascimentalista ha ricondotto molto approfonditamente, e anzi forse persino in
maniera troppo marcata, le soluzioni elaborate dal Tasso per la Liberata al dibattito
teorico coevo sull’epica e più in generale sulla letteratura, trascurando quasi del tutto,
invece, il debito non più teorico ma di prassi poetica con il tanto vituperato poema
dell’autore vicentino; in questo modo, il quadro che ne risulta è fortemente sbilanciato e
forse persino deformato, rinnegando in sostanza uno degli ipotesti fondamentali del
capolavoro tassiano a tutto vantaggio di un dibattito teorico che, pur toccando spesso le
medesime questioni di poetica, visibilmente non è omogeneo a un rapporto di
derivazione letteraria, e dunque non può sostituirsi ad esso, come nel complesso è
avvenuto. Il Trissino viene citato per lo più solo in relazione alla celebre pagina dei
Discorsi dell’arte poetica in cui è raffrontato ad Ariosto, o tutt’al più additato come
l’incapace sullo sfondo del cui fallimento far emergere il genio tassiano. Proprio quella
pagina teorica, invece, avrebbe dovuto ammonire su un simile atteggiamento, poiché
dietro il giudizio di valore propone chiaramente Ariosto e Trissino come i due modelli
dell’incipiente produzione poetica tassiana: che poi il Trissino sia giudicato inferiore,
com’è naturale, o persino individuato come antimodello, poco importa: ciò non nega né
sminuisce in nessun modo la presenza del rapporto; d’altronde anche Ariosto, in quel
passo, seppure per altri aspetti, è in parte evidentemente considerato a sua volta un
antimodello. In un’operazione come quella messa in atto dal Tasso, acquisizioni e
rifiuti, ossia in fondo affinità e differenze, sono atteggiamenti sempre indeterminati e
compresenti, e soprattutto in una qualche misura, se non certo assimilabili fra loro, per
85
lo meno omogenei nel definire la nuova produzione letteraria in relazione ad opere
precedenti prese come punti di riferimento, in positivo o in negativo che sia. Il rapporto
con un antimodello, insomma, non è affatto nullo e irrilevante (dunque implicitamente
trascurabile) ma, ben altrimenti, è un rapporto in negativo, che talvolta può assumere
una funzione modellizzante forte, persino più influente e pervasiva di quella esercitata
da un modello positivo ed esplicitamente imitato: si pensi al fitto rapporto di Lucano
con il suo antimodello virgiliano. Quella pagina dei Discorsi dell’arte poetica mostra
chiaramente, dunque, non tanto l’ovvia preminenza riconosciuta all’Ariosto in relazione
a un giudizio di valore – mera banalità –, quanto piuttosto l’individuazione di Ariosto e
Trissino – entrambi – come i due termini di confronto privilegiati in rapporto ai quali si
definisce la poetica dell’autore che di lì a poco presiederà alla composizione della
Liberata. Ma se il rapporto con Ariosto è stato sempre frequentatissimo fino a diventare
un luogo comune della critica, tanto che ad esso sono intitolate alcune delle più note
monografie su Tasso e l’epica rinascimentale, al rapporto col Trissino sono stati dedicati
non più di qualche breve pagina en passant e pochissimi contributi specifici, per forza
di cose complessivi e dunque piuttosto sommari75.
Fra i molti aspetti, soprattutto strutturali, coinvolti in questo rapporto
disconosciuto dalla critica, uno dei più rilevanti è, insieme alla necessità di una
ridefinizione degli equilibri fra epos e romanzo, il rapporto con le fonti storiche da cui è
desunta la materia narrata nei due poemi76. Come si è detto, la differenza più ovvia e
75
I principali contributi sul Trissino sono: BARILLI, R., Modernità del Trissino, «Studi Italiani», IX, 2
(1997), pp. 27-59; GIGANTE, C., «Azioni formidabili e misericordiose». L’esperimento epico del
Trissino, «Filologia e Critica», XXIII, I (1998), pp. 44-71 [poi col titolo Un’interpretazione dell’“Italia
liberata dai Goti”, in ID., Esperienze di filologia cinquecentesca. Salviati, Mazzoni, Trissino, Costo, Il
Bargeo, Tasso, Roma, Salerno, 2003, pp. 46-79]; GIGANTE, C., Epica e romanzo in Trissino, in La
tradizione epica e cavalleresca in Italia (XII-XVI sec.), a cura di GIGANTE, C. e Palumbo, G., Bruxelles,
P.I.E. Peter Lang, 2010, pp. 291-320.ZATTI, S., Tasso lettore del Trissino, in Torquato Tasso e la
cultura estense. Atti del Convegno internazionale (Ferrara, 10-13 dicembre 1995), a cura di VENTURI, G.,
Firenze, Olsckhi, II, pp. 597-612 [poi rielaborato col titolo L’imperialismo epico del Trissino, in ZATTI,
S.., L’ombra del Tasso. Epica e romanzo nel Cinquecento, Milano, Mondadori, 1996, pp. 56-110];
BARILLI, R., Il difficile percorso del poema moderno dal Trissino al Tasso, in Tasso, Tiziano e i pittori
del «parlar disgiunto». Un laboratorio fra le arti sorelle, «Schifanoia», numero monografico, 20-21,
2001, pp. 123-131; QUONDAM, A., La poesia duplicata. Imitazione e scrittura nell’esperienza del
Trissino, in Atti del Convegno di Studi su Giangiorgio Trissino, Vicenza, Accademia Olimpica, 31
marzo-1 aprile 1979, a cura di Neri Pozza, Vicenza, Neri Pozza, 1980, pp. 67-10; V. GALLO, Paradigmi
etici dell’eroico e riuso mitologico nel V libro dell’«Italia» di Trissino, in «Giornale Storico della
Letteratura Italiana», a. CXXI 2004, vol. CLXXXI, fasc. 595, pp. 373-414.
76
Gli unici contributi recenti che affrontino l’argomento sono quelli di GIGANTE, C., «Azioni
formidabili e misericordiose», cit., pp. 49-56, e Epica e romanzo in Trissino, cit., dove si fanno
considerazioni nel complesso condivisibili su tale questione; AURIGEMMA, M., Il tema della storia e il
gusto della nuova scienza politica nel teatro e nell’epos del primo Cinquecento, «Annali della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata», III-IV (1970), pp. 135-159 si limita invece a qualche
generica considerazione sul rapporto con la situazione storica contemporanea al Trissino, e non affronta
affatto il rapporto con le fonti storiografiche della materia narrata. Alcune osservazioni sul rapporto fra
86
macroscopica dell’epica tassiana rispetto al romanzo ariostesco è proprio la novità del
ricorso alla materia storica: novità riconducibile essenzialmente al poema del Trissino.
Bisogna sempre tener presente, infatti, che l’operazione compiuta da Trissino nell’Italia
liberata è assolutamente nuova e priva di precedenti moderni in volgare non solo, in
generale, nel suo tentativo propriamente epico, ma anche nel basare complessivamente
la trama di un’opera prettamente letteraria e non storiografica (un’opera poetica,
insomma) su una vicenda storica trattata come tale, secondo verosimiglianza (che,
com’è ovvio, è qualcosa di radicalmente diverso dall’uso del tutto occasionale di
elementi storici fantasiosi e leggendari nei precedenti romanzi in versi e in prosa):
l’unico vero precedente relativamente “recente” di qualche rilievo, ma comunque non in
poesia volgare, è l’Africa di Petrarca; per il resto i modelli di una simile operazione, che
fonda un’epica storica in volgare, sono in effetti tutti classici. L’estetica classicista del
Trissino si palesa pienamente, attraverso scelte senz’altro originali, non solo nel
recupero dell’epica, ma anche nel recupero della materia storica come fonte di un’opera
letteraria con finalità eminentemente artistiche. In questo, il Tasso lo seguirà
palesemente; ma non si tratta soltanto di una scelta generica della materia storica:
proprio la novità di tale operazione trissiniana nel panorama moderno fa si che essa
fosse l’unico punto di riferimento in tal senso non solo come generica indicazione di
poetica, ma anche nell’effettiva prassi poetica del Tasso, per cui, come vedremo, il
rapporto fra i due autori si spinge molto al di là della semplice scelta complessiva
dell’epica storica, influendo continuamente proprio sulle modalità effettive del
trattamento della materia storica e delle fonti storiografiche, in modo tale da risolversi
spesso in un marcato rapporto intertestuale che sconfina ben oltre la ripresa di una
complessiva scelta di poetica. Un’influenza, naturalmente, sottoposta senz’altro a una
serrata critica da parte del grande poeta sorrentino, come vedremo meglio nelle
prossime pagine, ma non per questo meno pervasiva e influente.
Posta questa affinità complessiva, una ovvia differenza tra Trissino e Tasso nel
rapportarsi alla materia storica e alle modalità di rappresentazione letteraria, tuttavia, sta
nel trattamento poetico della fondamentale categoria critica della verosimiglianza77. In
Trissino e la sua fonte storiografica si trovano in vecchi studi ottocenteschi: CIAMPOLINI, E., Un poema
eroico nella prima metà del Cinquecento. Studio di storia letteraria, Lucca, R. Liceo Machiavelli, 1881,
pp. 61-116 e ERMINI, F., L’Italia liberata di G. Trissino. Contributo alla storia dell’epopea italiana,
Roma, Tip. Ed. Romana, 1895, p. 25-92.
77
Qualche considerazione sulla categoria del verosimile in Trissino si trova in BARILLI, R., Modernità del
Trissino, p. 47 e, con maggiore approfondimento, in C. GIGANTE, «Azioni formidabili e misericordiose»,
cit., pp. 51 e sgg. Neppure Gigante, tuttavia, coglie appieno la mistificazione di fondo della posizione di
Aristotele (v. infra), pur evidente nella stessa traduzione, da lui citata, che il Trissino fa delle espressioni
87
tale senso va tenuto presente che l’Italia è scritta nel ventennio ’27-’47, ossia
essenzialmente prima del grande dibattito sulla poesia epica (in cui la questione del
verosimile gioca notoriamente un ruolo fondamentale), mentre il poema del Tasso,
elaborato essenzialmente nel decennio ’65-’75 e pubblicato nell’81, è invece in gran
parte successivo a quel dibattito e per ciò stesso concepito a partire da una condizione di
maggiore consapevolezza critica. Il Trissino affronta pertanto la questione della
verosimiglianza soltanto sulla base del testo di Aristotele, mentre il Tasso legge e
interpreta Aristotele anche sulla base di quel vasto dibattito teorico, di grande rilievo,
oltre che per la comprensione “filologica” del primo trattato di teoria della letteratura78,
anche per misurare la sua pertinenza con la realtà letteraria contemporanea (e in
particolare con il romanzo e il Furioso ariostesco). In termini generali, il dibattito è
basato sulla questione del verosimile per com’è affrontata nelle pagine della Poetica
aristotelica, con il celebre confronto tra poesia e storiografia (capitolo 9). Ma per come
si sviluppa entro tale dibattito, il termine finisce per diventare di fatto piuttosto
ambiguo: mentre per lo storiografo la categoria di verosimiglianza costituisce infatti il
limite delle sue possibilità, ossia il massimo margine di libertà che egli può concedersi
senza sconfinare nella falsificazione, per il letterato il verosimile indica invece anche la
possibilità – in un certo senso opposta – di oltrepassare ampiamente quel limite, cosa in
cui risiede la libertà inventiva propria della letteratura che abbia finalità prettamente
artistiche. Se dunque già per Tucidide (e in parte persino sin da Erodoto) la
verosimiglianza è un criterio di veridicità, di attendibilità, di ricostruzione affidabile di
ciò che è effettivamente accaduto anche là dove la documentazione è carente (non a
caso, nella celebre pagina tucididea, la verosimiglianza è contrapposta proprio al diletto
dell’opera d’arte) 79 , in poesia avviene esattamente l’opposto: per verosimiglianza si
aristoteliche nella dedicatoria a Carlo V: se lo storico riferisce «come furon fatte le cose» (cfr. t¦
genÒmena del passo dell Poetica), l’espressione oŒa ¨n gšnoito riferita alla materia trattata dal poeta non
significa affatto «come si devevano fare», secondo la traduzione trissiniana, ma invece – cosa del tutto
diversa – «quali potrebbero (o sarebbero potute) accadere».
78
Il primo commento rinascimentale alla Poetica di Aristotele, quello del Robortello, è del 1548: proprio
l’anno di pubblicazione della seconda e ultima parte dell’Italia liberata.
79
TUCIDIDE, Storie, 1, 22, 2: t¦ d' œrga tîn pracqšntwn ™n tù polšmJ oÙk ™k toà paratucÒntoj
punqanÒmenoj ºx…wsa gr£fein, oÙd' æj ™moˆ ™dÒkei, ¢ll' oŒj te aÙtÕj parÁn kaˆ par¦ tîn
¥llwn Óson dunatÕn ¢kribe…v perˆ ˜k£stou ™pexelqèn. ™pipÒnwj de hØr…sketo, diÒti oƒ
parÒntej to‹j œrgoij ˜k£stoij oÙ taÙt¦ perˆ tîn aÙtîn œlegon, ¢ll' æj ˜katšrwn tij eÙno…aj À
mn»mhj œcoi. kaˆ ™j men ¢krÒasin ‡swj tÕ m¾ muqîdej aÙtîn ¢terpšsteron fane‹tai. Trad.: « Ho
ritenuto mio dovere descrivere le azioni compiute in questa guerra non sulla base di elementi
d'informazione ricevuti dal primo che incontrassi per via; né come paresse a me, con un'approssimazione
arbitraria, ma analizzando con infinita cura e precisione, naturalmente nei confini del possibile, ogni
particolare dei fatti cui avessi di persona assistito, o che altri mi avessero riportato. La boriosa e
complessa indagine: poiché le memorie di quanti intervennero in una stessa azione, non coincidono mai
sulle medesime circostanze e sfumature di quella. Da qui resoconti diversi, a seconda della individuale
88
intende il margine di libertà che è concesso all’invenzione del poeta, alla creazione, alla
possibilità di discostarsi da ciò che è successo veramente.
Rispetto a tale questione, il Trissino – probabilmente sia per mancanza di spessore
poetico, sia per la sua anteriorità al dibattito teorico – si dimostra molto meno scaltrito
del Tasso: il suo rapporto con le fonti, nell’atteggiamento complessivo, risulta
decisamente più vicino a quello di uno storico, con ovvi effetti rovinosi sull’opera.
Leggendo l’Italia, si ha continuamente l’impressione che l’autore abbia innanzitutto
voluto dar conto dei fatti storici, come suo primo e fondamentale oggetto d’interesse, e
solo in subordine creare delle strategie di significato nell’opera: egli confonde
complessivamente la verosimiglianza richiesta allo storiografo, volta a “restaurare” il
vero, con la verosimiglianza poetica, aperta invece alla finzione. Chiaramente, l’errore
deriva dal fraintendimento di Aristotele e del concetto di e„kÒj, che pure sulla questione
è invece piuttosto chiaro, come appare dalla distinzione fatta nel celebre passo 1451b, 45: ¢ll¦ toÚtJ diafšrei, tù tÕn men [lo storico] t¦ genÒmena lšgein, tÕn de [il
poeta] oŒa ¨n gšnoito80, e ancor più chiaramente in 1451b, 30-32: k¨n ¥ra sumbÍ
genÒmena poie‹n, oÙqen Âtton poiht»j ™sti· tîn g¦r genomšnwn œnia oÙden
kwlÚei toiaàta eἶnai oŒa ¨n e„kÕj genšsqai [kaˆ dunat¦ genšsqai], kaq' Ö
™ke‹noj aÙtîn poiht»j ™stin81. Se lo storiografo riporta i fatti così come avvennero,
nella loro contingenza, il poeta invece, anche quando si rapporta con dei fatti realmente
avvenuti e non soltanto possibili, non si limita a ripercorrerli, ma li seleziona e li
rielabora in modo da desumere da essi le proprie strategie di significato: in questo senso
è ugualmente poiht»j anche chi tratta di cose effettivamente avvenute. Un concetto,
questo, che a noi può forse oggi sembrare ovvio, abituati come siamo all’estetica
romanzesca della fiction, ma che nel primo Cinquecento lo era senz’altro molto meno,
soprattutto nel rapportarsi con una materia di tipo storico: non deve dunque
meravigliare se il Trissino, che pure conosce molto bene il testo aristotelico, ignora o
non comprende adeguatamente queste fondamentali precisazioni di teoria letteraria,
attribuendo alla verità storica una schiacciante preminenza sulla rielaborazione poetica,
in evidente contraddizione non solo con il più elementare istinto letterario, ma anche
con la stessa posizione di Aristotele. Non bisogna dimenticare, a questo riguardo, che
capacità di ricordo o delle soggettive propensioni. Il tono severo della mia storia, mai indulgente al
fiabesco, suonerà forse scabro all'orecchio ».
80
Trad.: « ma [lo storico e il poeta] differiscono in quanto uno dice le cose accadute e l’altro quelle che
[lett. quali] potrebbero accadere ».
81
Trad.: « Se gli capita di rappresentare fatti avvenuti, , è ugualmente poeta: niente impedisce infatti che
tra i fatti avvenuti ce ne siano alcuni che è verosimile avvengano, e secondo una tale verosimiglianza ne è
lui il creatore ».
89
Trissino non solo è uno dei primi letterati rinascimentali a rifarsi al testo del grande
filosofo antico, ma lo fa essenzialmente sulla base della sua personale conoscenza della
lingua greca e di un rapporto diretto col testo originale, senza l’ausilio di commenti, che
sono posteriori alla sua attività poetica e speculativa: dato il suo carattere decisamente
pionieristico, l’operazione interpretativa risulta perciò inevitabilmente aperta al rischio
di fraintendimenti. Il Tasso, invece, nella lettura della Poetica di Aristotele, potrà
giovarsi di tutti commenti scritti dal Robortello in poi, i quali, se certo non garantiscono
necessariamente una comprensione adeguata di un testo ancora oggi molto discusso, per
lo meno permettono di evitare delle ingenuità e dei fraintendimenti clamorosi su
questioni decisive.
Giustissima, dunque, la critica più rilevante che il Tasso muove al Trissino,
proprio sulla scorta di Aristotele:
E questo medesimo si può notare nel Trissino, il qual volle che fosse soggetto del suo poema tutta
la spedizione di Belisario contra a i Goti: e perciò è molte fiate piú digiuno ed arido, ch'a poeta non si
converrebbe; ché, s'una parte solamente, e la piú nobil di quella impresa, avesse tolta a descrivere, per
aventura piú ornato e piú vago di belle invenzioni sarebbe riuscito. Ciascuno in somma, che materia
troppo ampia si propone, è costretto d'allungare il poema oltre il convenevol termine (la qual soverchia
lunghezza sarebbe forse ne l'Innamorato e nel Furioso, chi questi due libri, distinti di titolo e d'autore,
quasi un solo poema considerasse, come in effetto sono); o almeno è sforzato di lassare gli episodi e gli
altri ornamenti, i quali sono al poeta necessariissimi. Meraviglioso fu in questa parte il giudizio d'Omero:
il quale avendo propostasi materia assai breve, quella accresciuta d'episodi, e ricca d'ogni altra maniera
d'ornamento, a lodevole e conveniente grandezza ridusse.
(Discorsi dell’arte poetica, I)
Evidente la derivazione aristotelica dell’osservazione (Poetica, 1459a, 31-36)82:
diÕ ésper e‡pomen ½dh kaˆ taÚtV qespšsioj ¨n fane…h “Omhroj par¦ toÝj ¥llouj, tù
mhde tÕn pÒlemon ka…per œconta ¢rc¾n kaˆ tšloj ™piceirÁsai poie‹n Ólon· l…an g¦r ¨n mšgaj
kaˆ oÙk eÙsÚnoptoj œmellen œsesqai Ð màqoj, À tù megšqei metri£zonta katapeplegmšnon tÍ
poikil…v. nàn d' en mšroj ¢polabën ™peisod…oij kšcrhtai aÙtîn pollo‹j, oŒon neîn katalÒgJ
kaˆ ¥lloij ™peisod…oij [dˆs] dialamb£nei t¾n po…hsin83.
Curiosamente, questo passo non era solo ben noto al Trissino, ma da lui persino
direttamente ripreso – secondo una pratica costante nell’elaborazione di quel testo –
all’inizio della Sesta divisione della sua Poetica [24v]:
82
Cfr. anche 1451a, dove tuttavia il riferimento più esplicito è all’Odissea.
Trad.: « Perciò, come abbiamo detto, anche in questo Omero appare prodigioso rispetto agli altri, per
non avere cercato di rappresentare interamente la guerra di Troia, anche se essa aveva un inizio e una
fine. La trama sarebbe risultata o eccessiva, da non potersi abbracciare con lo sguardo, o, se contenuta
nelle dimensioni, troppo intricata per varietà. Prendendone invece una parte, ha fatto uso di molti episodi,
come il catalogo delle navi e altri che fanno procedere il poema ».
83
90
E però ancora in questo appare Omero essere stato più d’ogni altro meraviglioso, per non si aver
posto a scrivere tutta la guerra troiana, quantunque ella avesse principio, mezzo e fine. Perciò che sarebbe
stato poema et azione di immensa grandezza, tale che non si sarebbe mai potuto insieme tutto ben
comprendere sì come ora si fa essendo di grandezza mediocre e mescolata di molta varietà. E però egli,
pigliando una particella di essa guerra, la adornò di molti episodi, com’è il catalogo delle navi…
Peccato che di questa acuta osservazione aristotelica, che egli fa mostra di
condividere nella teoria, non si sia poi ricordato nella composizione dell’Italia. O
meglio: egli la tiene sì presente, ma mostra di non averne compreso nella sostanza il
senso. Ciò di cui il filosofo sta parlando non è tanto la dimensione testuale dell’opera
(se non secondariamente), quanto piuttosto la sua struttura interna: l’importante non è
solo l’ampiezza della narrazione in sé, come Trissino mostra di intendere, bensì
innanzitutto la selezione di una materia della narrazione che, anche quando tratti t¦
genÒmena, le cose avvenute e non soltanto possibili, individui in essa delle relazioni
dotate di senso fra gli eventi narrati, e non solo delle sequenze di eventi slegati e privi di
relazioni reciproche (che non siano quelle relazioni solo apparenti e superficiali di un
certo intervallo di tempo arbitrariamente segmentato o di un protagonista unico per la
pluralità di vicende). L’effetto di questo fraintendimento ha un esito che sarebbe quasi
ridicolo se non fosse disastroso: per attenersi all’auctoritas senza aver realmente
compreso il vero senso della norma a cui si attiene, il Trissino la interpreta come una
sorta di invito a limitare la materia dal punto di vista quantitativo e così, anziché mettere
in versi l’intera Guerra gotica di Procopio di Cesarea84, la sua fonte storiografica, si
limita a narrarne la metà (!): due libri su quattro totali, per una guerra che si articola in
due fasi distinte e in sé concluse85. Che poi questa metà copra un arco temporale di
cinque anni e una campagna militare che spazia per tutta la penisola italiana, cambiando
continuamente teatro dell’azione in una serie di imprese belliche sostanzialmente
autonome ed estremamente ripetitive, questo non gli crea alcun problema, poiché la
lettera del precetto aristotelico sembra rispettata. La sequenza di eventi narrati,
insomma, attenendosi complessivamente alla fonte storiografica anziché a esigenze
specificamente letterarie di creazione di senso, finisce per ridursi a una teoria di vicende
slegate che, prive di ogni relazione necessaria a dar loro coesione, sacrificano
l’individuazione di chiare strategie di senso al rispetto della contingenza del dato
storico: sacrificano insomma l’essenziale all’inessenziale, l’universale al particolare, la
“letterarietà” alle vicende narrate, come nell’ipotetico esempio aristotelico della vita di
84
PROCOPIO DI CESAREA, La guerra gotica, I-IV, in Le guerre persiana, vandalica, gotica, a cura di
CRAVERI, M.,introduzione di Pontani, F. M., Einaudi, Torino 1977, pp. 339-766.
85
La guerra gotica, I-II, pp. 339-529.
91
Alcibiade86. A garantire l’unità della narrazione non è evidentemente il suo costituirsi
come totalità unitaria, ma piuttosto l’essere costituita da parti che siano realmente in una
relazione significativa fra di loro (1451a, 33-36):
... kaˆ t¦ mšrh sunest£nai tîn pragm£twn oÛtwj éste metatiqemšnou tinÕj mšrouj À
¢fairoumšnou diafšresqai kaˆ kine‹sqai tÕ Ólon: Ö g¦r prosÕn À m¾ prosÕn mhden poie‹
™p…dhlon, oÙden mÒrion toà Ólou ™st…n87.
Paradossalmente, proprio l’osservazione volta a sancire la celebre unità d’azione è
quella che, fraintesa, finisce per compromettere de facto precisamente l’unità
complessiva del poema del Trissino. Tasso saprà benissimo far tesoro di questo
clamoroso errore, tanto in sede teorica – come abbia visto – quanto soprattutto
nell’elaborazione del proprio poema. Viene da chiedersi se, in mancanza del Trissino a
battere la strada, il Tasso avrebbe saputo trarre le stesse conseguenze dal solo dibattito
teorico sulla poesia epica, o se invece tale errore non sia stato fondamentale proprio
come esempio negativo nella prassi poetica, individuabile nella concretezza di un’opera
letteraria con ben altra evidenza che non in trattazioni astratte e generali88.
Per chiarire meglio questa fondamentale differenza riguardo alla materia dei due
poemi e la sua effettiva portata, sarà utile dare un breve sguardo complessivo alle
vicende storiche trattate dal Trissino in parallelo al testo di Procopio. Fornisco qui uno
schema essenziale dei più importanti nuclei narrativi dell’Italia liberata in parallelo ai
rispettivi capitoli della Guerra gotica di Procopio, in un rapporto di derivazione che,
come si vede, copre decisamente la gran parte della trama del poema:
86
ARISTOTELE, Poetica, 1451b, 8-11: œstin dὲ kaqÒlou mšn, tù po…J t¦ po‹a ¥tta sumba…nei lšgein
À pr£ttein kat¦ tÕ e„kÕj À tÕ ¢nagka‹on, oá stoc£zetai ¹ po…hsij ÑnÒmata ™pitiqemšnh· tÕ dὲ
kaq' ›kaston, t… 'Alkibi£dhj œpraxen À t… œpaqen (trad.: « Appartiene all’universale il fatto che a
qualcuno capiti di dire o di fare certe cose secondo verosimiglianza o necessità, e a questo mira la poesia,
aggiungendo successivamente i nomi; appartiene invece al particolare dire cosa ha fatto o cosa è capitato
ad Alcibiade ».
87
Trad.: «… e le parti che la compongono devono essere collegate in modo tale che, cambiando o
togliendo una parte, l’intero risulti alterato e sconnesso: infatti quello che, presente o assente, non produce
conseguenze evidenti, non è parte dell’intero ».
88
Nota giustamente a riguardo BARILLI, R., Modernità del Trissino, cit. – un articolo la cui tesi di fondo
non è tuttavia minimamente condivisibile –: «I numerosi limiti che si devono riconoscere, pur a
malincuore, nell’esperimento del Trissino trovano riscatto se si pensa che aprono la strada a quello
tassiano, consentendogli di evitare i medesimi errori, e di giungere più sicuro alla meta». Ma se questo è,
in termini generali, un dato in effetti da tempo acquisito dalla vulgata critica, ciò che invece non è stato
fatto se non molto superficialmente è analizzare nel dettaglio l’effettiva portata del rapporto di poetica e
soprattutto dei fitti legami intertestuali che legano il poema del Tasso a quello del Trissino: ad uno studio
più approfondito, essi si rivelano molto più marcati di quanto non si ammetta in genere, fino potersi dire
anzi davvero determinanti.
92
TRISSINO
Nuclei narrativi:
PROCOPIO
libro 7
- Assedio di Napoli
I, 8-10
libri 10-21
- Resa di Roma e assedio dei Goti a Roma
I, 14 - II, 10
libro 22
- Morte di Corsamonte
II, 1
libro 24
- Arrivo di Narsete con i soccorsi
II, 13
libri 25-26
- Resa di Milano e occupazione di altre città (Osmo, Rimini ecc.)
II, 7-27
libro 27
- Presa di Ravenna
II, 28-30
Come si evince chiaramente già dal quadro complessivo dell’opera, la narrazione
integrale della spedizione di Belisario comporta una serie di imprese successive e prive
di nessi strutturali a collegarle, al di là del loro mero susseguirsi cronologico a scandire
l’intera progressione della guerra (cosa che appunto, come spiega già Aristotele, non
costituisce un rapporto dotato di senso); il risultato inevitabile è che, dal punto di vista
narrativo, l’azione non solo non è unitaria, ma la pluralità di vicende in cui si articola
appare necessariamente sconnessa da un punto di vista letterario, priva di legami di
consequenzialità logico-narrativa e attenta solo a rispettare la contingenza, di per sé non
significante, della serie di fatti storici. L’assedio di Napoli, che è il primo contatto forte
con la fonte storiografica, è svolto compiutamente nell’arco di un libro del poema, come
un episodio che appare perfettamente circoscritto e narrativamente indipendente da tutto
il resto: se lo si eliminasse, sulla struttura narrativa dell’opera non si avvertirebbero
conseguenze; esso da solo, d’altra parte, corrisponde all’incirca a ciò che costituisce la
materia dell’intero poema tassiano. Tutto il grande blocco successivo dei libri che
narrano l’assedio portato dai Goti a Belisario e il suo esercito chiusi dentro Roma, da
loro precedentemente occupata, si estende poi, in maniera ipertrofica, ad occupare la
maggior parte del poema, semplicemente perché esattamente lo stesso avviene in
Procopio: mentre però questo ha senso nel testo storiografico, poiché si tratta di una fase
della guerra lunga e densa di avvenimenti, a differenza del precedente assedio di Napoli
che si risolve in pochi giorni attraverso un semplice stratagemma militare, nel testo
prettamente letterario ciò non può che risultare complessivamente come una sorta di
ripetizione ampliata – con un mero ribaltamento dei ruoli di assediato e assediante –
della medesima situazione narrativa incontrata subito prima. Per non parlare del vero e
proprio disastro narrativo dei libri 25-26, dove il Trissino, per seguire il doveroso elenco
che il testo storiografico fa della serie di città che, più o meno pacificamente, si
arrendono a Belisario, si perde in una narrazione che procede inevitabilmente in modo
del tutto disorganico e desultorio. Quando nel libro finale si arriva alla presa di
Ravenna, la situazione narrativa dell’assedio di una città è ormai svuotata di ogni
93
possibilità di senso, e la variazione del grande duello collettivo finale non basta a
riscattare la conclusione dell’opera e a conferirle il debito rilievo strutturale e
semantico. È evidente che da un quadro del genere non poteva risultare nulla che
somigliasse non che ad un’azione unica, ma neppure ad un’azione plurale ma comunque
unitaria: la materia storica è semplicemente ripercorsa, nel complesso, per com’è
presentata dalla fonte, senza un adeguato processo di selezione e semantizzazione delle
sequenze narrative. Fra gli episodi narrati, insomma, manca decisamente il legame
kat¦ tÕ ¢nagka‹on 89 , “secondo necessità”, di Aristotele. Nulla a che vedere,
naturalmente, con la straordinaria struttura narrativa del poema tassiano, in cui
l’attenzione per il legame della parte per il tutto diventa per il poeta quasi un maniacale
(si pensi soltanto ai tormentosi dubbi sull’episodio di Olindo e Sofronia, che pure
mostra invece dei legami rilevanti con la narrazione complessiva, benché giocati
sull’asse paradigmatico piuttosto che su quello sintagmatico).
Ma se il rapporto con le fonti in Trissino e in Tasso è senz’altro molto diverso, ciò
dipende non solo dalla ben diversa capacità di rielaborazione poetica dei due autori e
dalle rispettive convinzioni teoriche sulla questione: già le fonti storiografiche sono di
per sé ben diverse. Tasso ha sì una fonte principale, Guglielmo di Tiro, ma fa uso anche
di diverse altre fonti secondarie90; Trissino invece – per lo meno quanto alla materia
storica su cui si basa l’impresa narrata nel poema – utilizza essenzialmente un’unica
fonte, la Guerra gotica di Procopio di Cesarea, che è un testo di valore storico-letterario
molto maggiore rispetto alle fonti del Tasso, e soprattutto è un testo ben più elaborato e
di gran lunga più ampio e dettagliato: per dare un’idea della differenza, la fonte
principale di Tasso è approssimativamente di circa 30 pagine, quella del Trissino di
circa 200 pagine91. È vero che si tratta in entrambi i casi di una selezione di parte di un
testo storiografico più ampio, ma l’estensione della parte selezionata mostra una
sproporzione che presuppone dietro di sé una radicale differenza metodologica: Tasso si
limita a un breve libro della Cronaca di Guglielmo di Tiro (l’ottavo) su un’opera ne
annovera ventitré, mentre Trissino, come abbiamo visto, elegge a materia del suo poema
addirittura metà della Guerra gotica di Procopio (due libri su quattro); Tasso narra un
singolo assedio, escludendo tutte le tappe precedenti del percorso bellico così come le
89
1451a, 13 e altrove.
Per una trattazione più specifica della questione si veda il capitolo Storia e fonti storiche nella
Gerusalemme del Tasso.
91
Mi riferisco solo a quella parte del testo di Procopio che narra gli eventi del poema del Trissino, ossia i
primi due libri della Guerra gotica (così come per la Cronaca di Guglielmo di Tiro mi riferisco solo al
libro ottavo, quello che narra l’assedio di Gerusalemme).
90
94
vicende politico-militari successive alla conquista, mentre Trissino narra per intero tutta
la prima fase, in sé conclusa, della guerra contro i Goti92.
Non si tratta, tuttavia, solo di una questione di quantità di vicende narrate: anche
la qualità della fonte storiografica porta senz’altro già di per sé a delle differenze
notevoli. Come si è detto, la cronaca medievale cui ricorre il Tasso è un testo molto
essenziale, asciutto, poco elaborato, mentre l’opera di Procopio ambisce ad essere una
grande opera storiografica di stampo classico, per cui narra, con tutt’altro livello di
elaborazione, grandi strategie politiche e militare di ben più ampio respiro rispetto al
carattere decisamente più concreto della tattica seguita nell’espugnare Gerusalemme; il
testo sulla prima crociata non si discosta mai da una narrazione essenziale, scarna,
minimale, se non per inserire frequenti considerazioni ideologiche in difesa dei cristiani
e contro i musulmani, mentre il testo dello storico bizantino è intessuto di discorsi diretti
molto finemente elaborati, di excursus di vario genere, caratterizzazioni psicologiche
approfondite e coerenti, secondo la migliore tradizione della storiografia classica. Un
dato di partenza che, apparentemente, sembrerebbe essere più favorevole al Trissino nel
disporre di un testo-fonte decisamente superiore: bisogna invece ritenere, a mio parere,
che la cosa stia all’incirca in termini opposti. Pur con tutte le dovute differenze, un
parallelo utile per farsi un’idea della situazione potrebbe essere forse, anche per
l’eterogeneità fra testo-fonte e testo risultante, il rapporto che l’opera lirica intrattiene
con il libretto: senza volersi addentrare affatto in una questione estremamente
problematica e discussa quant’altre mai addirittura sin da prima della nascita effettiva
del melodramma, si può tuttavia ragionevolmente sostenere che, se è vero che un cattivo
libretto va senz’altro a scapito anche della musica, come notavano fra i tanti Beethoven
o Wagner, è altrettanto vero, d’altra parte, che un libretto che avesse di per se stesso un
grande valore letterario autonomo non potrebbe essere se non controproducente ai fini
della drammaturgia musicale nel soverchiare inevitabilmente lo spazio creativo della
musica, relegandola a una funzione ancillare. In modo non poi così diverso, una fonte
storiografica di alto livello letterario, proprio a causa del suo grado elevato di autonoma
elaborazione del testo – quella che gli studi classici, seguendo una fortunata espressione
di Norden, chiamano “prosa d’arte” –, può benissimo avere un effetto soffocante sulle
possibilità creative di un testo poetico da essa complessivamente derivato:
92
Sul problema dell’estensione temporale della “favola” del poema epico nella teoria letteraria
rinascimentale, cfr. CHEMELLO, A., Tempo circolare vs tempo lineare. La codificazione del “tempo
epico” nel Cinquecento, in BALDASSARRI, G., a cura di, “Quasi un picciolo mondo”. Tentativi di
codificazione del genere epico nel Cinquecento, Milano, Unicopli, 1982 (in particolare sezione 2.1.
Estensione temporale della favola, p. 64 sgg.).
95
inconveniente che invece non si verifica, naturalmente, se il testo-fonte ha una
dimensione meramente documentaria. L’esito limite è il seguente (si tratta della lettera
che Belisario scrive a Giustiniano per chiedere rinforzi, nelle due versioni del poeta e
dello storico):
TRISSINO, Italia, X:
O sacrosanto imperator del mondo
noi siam venuti ne l’Esperia antica
come ci comandaste, ed abbiam preso
il bel Brandizio ne la prima giunta,
d’indi prendemmo Napoli per forza,
e dopo quello, la città di Roma
con altre terre molte a noi s’è resa;
onde bisogno ci è tenervi dentro
assai soldati per presidio loro,
e per questa cagion la nostra gente
s’è sminuita ed è rimasa poca.
Or intendendo, come il re dei Goti
vien con duegento milia eletti fanti,
e trentamilia cavalieri armati
a ritrovarci a Roma, ove noi semo,
dubito assai di qualche alto disconcio;
ed io per me con questa poca gente
non ardirei di contrappormi a tanti,
e star fuor de la terra a la campagna,
e saria la ruina de l’impresa.
E però pregherò la vostra altezza,
che non ci manchi di novel soccorso,
tal che possiam tener questa cittade,
che se per caso ella ci fosse tolta,
voi perdereste poi l’Italia tutta;
onde oltre il danno de le nostre morti
a voi ne seguiria vergogna eterna.
PROCOPIO, Guerra gotica, I, 24:
Siamo venuti in Italia, come tu hai ordinato, e abbiamo
conquistato gran parte del suo territorio e preso anche
possesso di Roma, cacciando i barbari che vi si trovavano, il
cui comandante, Leuderi, ti ho recentemente spedito. Ma è
successo che, avendo dovuto stanziare un gran numero di
soldati sia in Sicilia che in Italia a guardia delle piazzeforti
che eravamo riusciti ad espugnare, il nostro esercito si è
ridotto a cinquemilauomini. Invece i nemici ci sono venuti
contro raccolti in un’armata di centocinquantamila uomini. E
a tutta prima, essendo usciti per renderci conto delle loro
forze, lungo il fiume Tevere, siamo stati costretti contro la
nostra intenzione a venire alle armi con essi, e per poco non è
accaduto che venissimo seppelliti da una pioggia di
giavellotti. Poi, quando i barbari hanno cominciato
adattaccare le mura con tutto il loro esercito prendendo di
mira ognipunto della cinta con vari tipi di macchine da
guerra, c’è mancato poco che la città venisse presa al primo
assalto e noi fossimo fatti prigionieri, se non avesse voluto
salvarci il destino. [...]. . Tuttavia non posso passar sotto
silenzio anche una cosa che ho il dovere di chiederti e tu hai
il dovere di fare […]. Fammi dunque spedire armi e soldati in
numero tale che d’ora innanzi ci sia possibile, in questa
guerra, fronteggiare il nemico con forze pari. […] Considera
invece questo, o imperatore: se adesso i barbari ci
sconfiggessero, noi saremmo espulsi dall’Italia, che ti
appartiene, perdendo anche l’esercito, e naturalmente
ricadrebbe su di noi il biasimo per la nostra condotta.
Le principali modifiche apportate dal Trissino rispetto al testo di Procopio sono: la
variazione di un paio di toponimi; il significativo incremento dei soldati nemici da
centocinquantamila a duecentomila; la reticenza su una poco decorosa scaramuccia
militare; un tono più opportunamente cortese nell’avanzare la richiesta all’imperatore. Il
livello di rielaborazione, insomma, è propriamente ridicolo: il passo del Trissino non è
altro che una fedelissima versificazione della fonte storiografica, una sua traduzione
letterale; anzi, in qualche punto viene operata persino una certa semplificazione, tanto
che nel complesso finisce per avere una maggior elaborazione letteraria il testo dello
storico rispetto a quello del poeta. Come si vede, il fraintendimento del concetto
aristotelico di verosimiglianza, unito all’elegante elaborazione letteraria già presente in
Procopio, finiscono per soffocare totalmente l’istanza creativa nel testo che dovrebbe
essere poetico, riducendolo a traduzione di prosa storica. Né si tratta di un caso isolato:
una simile condotta nella scrittura è decisamente la norma nel testo trissiniano.
96
Per dare un’idea più chiara di una prassi che non è affatto occasionale ma si rivela
la norma nella composizione del poema, cito qualche altro esempio (la scelta è del tutto
casuale). Questo è il passo che narra l’irrompere dell’esercito di Belisario in Napoli:
TRISSINO, Italia, VII:
Ma i feroci soldati, avendo morti
Prima color, che si trovar con l’arme,
entravan dentro a le superbe stanze;
e chi spogliava l’onorate mense,
e i ricchi letti, e chi rompea le casse,
traendo fuor le prezïose robe,
le vaghe gemme, e i belli argenti e gli ori,
e le portavan via con gran rapina.
Altri menava le infelici donne
Per forza seco, e le fanciulle oneste
Tolean di braccio a le dolenti madri;
che le faceano compagnia col pianto.
PROCOPIO, Guerra gotica, I, 10:
Da questo momento, posseduti tutti da una grande rabbia, […]
si diedero ad ammazzare chiunque si parasse loro davanti,
senza rispetto per l’età, e introducendosi nelle case portavano
via come prigionieri donne e bambini e facevano preda di tutti
gli oggetti di valore.
L’unica variazione, a parte l’aggiunta di una scarna aggettivazione convenzionale,
è lo sviluppo in una breve serie di immagini dei beni sottratti nel saccheggio, secondo
quel concetto travisato e banalizzato di ἐνάργεια che il Trissino ravvisa nello stile
omerico su suggerimento di Aristotele e del trattato Sullo stile tradizionalmente
attribuito a Demetrio Falereo (prima che la filologia moderna smentisse definitivamente
questa attribuzione presente nella stessa tradizione manoscritta)93.
Ecco con quali parole Belisario ferma poco dopo la strage:
TRISSINO, Italia, VII:
Gentil soldati, e cavalieri adorni,
poi, che ’l Motore eterno de le stelle
ci dà tanta vittoria e tanto onore,
che presa avemo una città per forza, che
inespugnabil si tenea da tutti;
è buon, che noi con la clemenza nostra
ci mostriam degni del divino aiuto;
e non cerchiamo sradicare il seme
di questa afflitta, e sfortunata gente.[…]
Però, fratelli miei, ponete freno
PROCOPIO, Guerra gotica, I, 10:
Poiché Dio ci ha concesso di vincere e di ottenere il massimo di
gloria mettendo nelle nostre mani una città mai prima
espugnata, è necessario che non ci mostriamo indegni della sua
grazia, ma che diamo prova, trattando con generosità i vinti, di
averli assoggettati con giustizia. Desistete dunque dal
perseguitare i Napoletani con odio implacabile, facendo
continuare la violenza contro di loro anche oltre i limiti della
guerra armata…
A tanto sangue, e a tant’aspra ruina…
Il campionario potrebbe estendersi alla maggior parte dell’ Italia liberata: non
solo la trama nel complesso ripete per lo più in modo pedissequo lo svolgersi delle
vicende per come sono esposte nella fonte storica, ma persino la lettera del testo segue
da vicino, per ampi tratti, il testo di Procopio, finendo di continuo per esserne
93
ARISTOTELE, Poetica, 1455a, 22 e sgg.; DEMETRIO RETORE (PSEUDO-DEMETRIO FALEREO), Perˆ
˜rmhneiaj (De elocutione), citato da Trissino nell’epistola dedicatoria a Carlo V dell’Italia liberata
proprio a questo riguardo: «… e descrivendo assai particularità di vestimenti, di armature, di palagi, di
castramentazioni, e di altre cose perciò che, come dice Demetrio Falareo, la enargia, che è la efficace
rappresentazione, si fa col dire diligentemente ogni particularità de le azioni, e non vi lasciar nulla…».
97
sostanzialmente una traduzione. E persino dove la fonte non è seguita direttamente,
l’autore mantiene comunque in modo molto uniforme questo medesimo tono prosastico
e arido, cosicché sembra di continuare a leggere una mera versificazione di prosa
storiografica anche dove in effetti non è così.
L’Italia
liberata,
insomma,
intrattiene
un
rapporto
complessivo
di
modellizzazione, ossia un rapporto intertestuale condotto a livello strutturale e su vasta
scala, non già con un testo poetico o comunque prettamente artistico da cui desumere
strategie significative da risemantizzare secondo affinità e differenze (come fa ad
esempio l’Eneide con i poemi omerici), bensì con un’opera storiografica, la cui materia
storica non può essere adatta alla letteratura se presa semplicemente così com’è, senza
una radicale operazione di selezione e risemantizzazione. Come afferma giustamente
Zatti 94 , la critica da sempre avanzata al poema storico di Lucano, quella di essere
storiografia in versi, è insomma decisamente adatta – e anzi senz’altro ben più adatta –
al tentativo epico del Trissino. Inutile dire che in Tasso, invece, anche là dove le fonti
storiche sono seguite più da vicino, un fenomeno simile è assolutamente impensabile, e
l’invenzione poetica pervade costantemente il testo, dalle microstrutture stilistiche al
complesso della trama e dell’intreccio.
In realtà, tuttavia, se è vero che il quadro complessivo è sostanzialmente questo,
bisogna comunque riconoscere che anche il Trissino, come poi farà pur con ben altri
risultati il Tasso, rielabora talvolta la fonte storiografica con grande libertà 95 : sarà
proprio lui, anzi, a suggerire le modalità principali di tale rielaborazione al poeta
sorrentino, in quanto suo unico precedente diretto a livello di prassi poetica in
un’operazione di tal genere.
In primo luogo, appare evidentissimo nell’Italia liberata l’inserimento di elementi
prettamente letterari del tutto assenti nella fonte storiografica: un margine di libertà
inventiva che in fondo appariva “lecito” al Trissino di nuovo in quanto sancito da
Aristotele, il quale appunto notava come l’unità dei poemi omerici non fosse affatto
danneggiata ma al contrario arricchita dalla presenza di “episodi” dotati di una certa
autonomia, purché intrattenessero comunque un rapporto forte con il complesso della
trama 96 . A livello più specificamente letterario, l’articolarsi di una trama unitaria in
episodi non autonomi ma comunque circoscritti e in sé conclusi è un fatto
94
ZATTI, S., Tasso lettore del Trissino, cit., p. 600.
Un’osservazione di questo tipo è presente in C. GIGANTE, «Azioni formidabili e misericordiose», pp.
53-56: peccato che le buone osservazioni a riguardo non siano poi ricondotte all’uso delle fonti storiche in
Tasso.
96
Poetica, 1459a, citato sopra.
95
98
strutturalmente molto evidente nell’epica classica, sia nell’Iliade (tanto da dare origine a
un intero filone di studi di omeristica, quello cosiddetto “analitico”) sia di riflesso, e
forse in misura ancora maggiore (anche per l’influenza “anomala” dell’Odissea e di
Apollonio Rodio), nell’Eneide: il quarto libro è solo il caso più celebre e più
straordinario. Avallata sulla base di questa duplice autorizzazione teorica e poetica,
nell’Italia del Trissino l’invenzione di parti “non storiche” si attua poi essenzialmente
sul duplice filo del romanzo e dell’epica classica. Quanto al primo, si tratta soprattutto
del grande blocco “cavalleresco” iniziale dei canti di Acratia e Ligridonia, ma anche di
spunti successivi meno estesi ma comunque rilevanti. L’invenzione di natura
prettamente epica, invece, ha senz’altro il suo nucleo principale nella trama che eleva a
co-protagonista di Corsamonte: figura del tutto marginale in Procopio – seppur
senz’altro meno che Rinaldo nelle fonti storiche del Tasso, dove si tratta
sostanzialmente solo di un nome, un guerriero del seguito di Tancredi menzionato in
modo del tutto occasionale –, questo scita semibarbaro appartenente alla guardia
personale di Belisario è elevato da protagonista di un episodio di audacia dissennata che
lo porta alla morte, brevemente ricordato dallo storiografo, a figura modellata
sull’Achille omerico per permettere l’inserimento nell’Italia del nucleo centrale della
trama iliadica. Persino la funzione che queste polarità di genere rappresenteranno nella
struttura della Gerusalemme del Tasso, dove il romanzo si caratterizzerà, notoriamente,
come errore e diversione e l’epos, al contrario, come teleologia al contempo ideologica
e narrativa, sono già chiaramente utilizzate in questo senso – seppure in modo senz’altro
molto più goffo – già nel poema del Trissino. Tanto per l’analisi degli elementi
d’invenzione romanzesca quanto per quelli di natura epica e la loro funzionalizzazione
si rimanda ai rispettivi capitoli di questo studio: qui basti notare come entrambe queste
tendenze siano già chiaramente delineate in Trissino come le due possibili vie di
allontanamento dal vero storico praticabili nel contesto della nuova poesia epica
rifondata sulla scorta degli autori classici e di Aristotele. Bisogna riconoscere che in ciò
Tasso seguirà Trissino davvero molto da vicino, seppur migliorando nettamente l’esito
nella prassi poetica: tanto l’idea della materia storica come argomento del poema,
quanto le due vie di fuga da essa costituite dalla finzione romanzesca e da quella epica
sono tutti elementi che il Tasso non elabora affatto autonomamente, ma li desume in
modo molto evidente e diretto proprio dal poema del Trissino, in un rapporto di
derivazione di cui la critica, come abbiamo detto, ha sempre sminuito drasticamente la
portata.
99
In secondo luogo, un’ulteriore libertà nel trattamento della materia storica
ravvisabile nel poema tassiano è riconducibile innanzitutto all’esempio del Trissino.
Nelle parti “storiche” tratte da Procopio – che costituiscono comunque decisamente la
maggior parte del testo – l’autore si concede delle modifiche che stravolgono in assoluta
libertà il dato storico, forse persino in maniera più evidente e clamorosa di quanto non
avvenga in Tasso, dove d’altronde l’impresa è molto più circoscritta e unitaria, e dunque
meno passibile di modifiche vistose. Nella Liberata la diversità più macroscopica, come
si è visto, è costituita dall’arrivo dell’esercito egiziano in contemporanea alla presa della
città, con un forte anacronismo. In Trissino già l’inizio dell’impresa è totalmente
modificato rispetto a come si svolse effettivamente: lo sbarco in Sicilia e la conquista
dell’isola, per poi risalire verso Napoli (Guerra gotica, I, 5 e 8), sono sostituiti da uno
sbarco a Brindisi che non sembra avere alcun appiglio con la realtà dei fatti narrati da
Procopio e anzi la modifica stravolgendola in modo evidente (Italia, libri 4-6). Anche
questo genere di libertà rispetto alla fonte storica, che non si limita semplicemente a
sospenderla attraverso l’inserimento di elementi di invenzione più o meno verosimili,
ma giunge fino a falsificarla apertamente – seppure non tanto da comprometterne
l’attendibilità complessiva –, è un ulteriore debito che il Tasso mostra prima di tutto nei
confronti del Trissino. Ancora una volta, la ripresa di un’idea strutturale trova però una
realizzazione molto migliore nel grande poeta che non nel mediocre: se l’anacronismo
nell’arrivo dell’esercito egiziano nella Liberata può essere ricondotto a una motivazione
prettamente letteraria, per altro molto ben riuscita (si veda a riguardo il capitolo sulle
fonti storiche del Tasso), lo stravolgimento di tutto il segmento iniziale dell’impresa di
Belisario fino all’arrivo a Napoli sembra decisamente meno giustificato. Forse si spiega,
in parte, con il fatto di voler evitare all’inizio una narrazione molto dispersiva e
disorganica nella progressiva conquista delle città principali dell’isola (errore per altro
puntualmente commesso poi alla fine dell’opera, come si è visto, nei libri 25-26);
d’altronde questa sarebbe una spiegazione solo in negativo, che evita un errore ma non
costruisce una vera strategia di significato attraverso lo stravolgimento del dato storico,
come avviene invece per l’esercito egiziano in Tasso. Un esempio ulteriore, che proprio
come in Tasso riguarda la conclusione del poema, è costituito dal duello tra Vitige e
Belisario: esso si svolse in realtà nel mezzo della guerra, mentre dal Trissino viene
spostato cronologicamente molto più avanti a risolvere l’assedio di Ravenna e con esso
l’intero conflitto, per garantire al poema un grande duello epico finale sulla scorta tanto
dell’Eneide quanto del duello “collettivo” di Lipadusa nel Furioso. In questo caso, la
100
manipolazione nella sequenza cronologica degli eventi appare molto più sensata proprio
perché mossa da un intento prettamente letterario (garantire, come nell’esempio della
Liberata, un’adeguata conclusione epica); l’effettivo esito è però comunque malriuscito
perché, a parte l’ipertrofia numerica dei partecipanti al duello collettivo, la variante del
duello risolutore non basta a riscattare la ripetitività della situazione narrativa
dell’assedio, riproposta l’ennesima volta per Ravenna, e soprattutto non chiama in causa
un vero coinvolgimento personale ed emotivo dei partecipanti al duello, elemento
cardine di questa tipologia narrativa (dall’odio mortale di Achille, al turbamento di Enea
alla vista del balteo di Pallante, fino alle soluzioni straordinarie del Tasso già per
Tancredi e Clorinda e poi per Tancredi-Argante e Solimano-Rinaldo, solo per ricordarne
alcuni dei più celebri).
Molto meno evidente è invece, in Trissino, una pratica costante nel poema
tassiano: attribuire al singolo personaggio, momentaneamente elevato a protagonista di
un’impresa, quella che nella fonte storica è azione collettiva o anonima. La quantità
sovrabbondante di vicende narrate nell’Italia e la ricchezza di dettagli e personaggi
dell’ampio testo di Procopio fanno sì che raramente il Trissino senta la necessità di
trasformare la contingenza del dato storico in quella particolare funzione di senso del
testo letterario che è il personaggio; di nuovo, il valore e l’accuratezza della fonte
storica, anziché a vantaggio, riesce ad ostacolo della creazione poetica nelle mani
dell’autore mediocre.
Per concludere, possiamo riassumere il quadro delineato in queste pagine dicendo
che il Tasso desume in maniera molto diretta e massiccia dal poema del Trissino alcuni
aspetti fondamentali del rapporto con la storia: sia la scelta complessiva della materia
storica e del suo trattamento condotto sulla linea generale della verosimiglianza in
opposizione al romanzo, sia anche le modalità principali che permettono, all’opposto, il
recupero di un ampio margine di libertà inventiva che si muova in un ambito
prettamente letterario (secondo le due linee del romanzo, appunto, e poi dell’epica). Se
c’è una differenza sostanziale negli esiti, essa dipenderà allora non tanto dalle scelte
strutturali in sé, che invece mostrano un’affinità molto più marcata di quanto la critica
abbia ammesso finora, bensì dalle concrete capacità di realizzazione artistica dei due
autori, e in particolar modo dall’intuizione consapevole o istintiva nel grande poeta di
quale sia la realizzazione adatta a creare strategie di senso coerenti e significative in
un’ottica essenzialmente letteraria. La differenza decisiva, a questo proposito, sta nel
fatto che l’aderenza alla fonte storica, là dove costituisce la base del racconto (e come
101
abbiamo detto è così per la gran parte del testo del poema trissiniano), si fa davvero
molto stretta e persino soffocante, decisamente più che in Tasso. Questo a causa di un
fraintendimento di Aristotele, ma anche della netta diversità, è bene ripeterlo, delle fonti
storiche dei due autori: la brevità e l’asciuttezza della cronaca medievale di Guglielmo
di Tiro ha fortunatamente lasciato al Tasso un grandissimo margine di libertà inventiva
su come condurre il récit del suo poema; il testo di Procopio, invece, ha pretese
letterarie di tenore molto più alto, collocandosi nella tradizione della storiografia
classica (il fatto più evidente sono i grandi discorsi, retoricamente molto elaborati,
sull’esempio della grande storiografia antica: in Guglielmo di Tiro non ce n’è traccia), il
che in un certo senso finisce per castrare la libertà inventiva di fronte a una fonte così
ricca, ampia ed elaborata. Il valore della fonte storiografica, insomma, è stato senz’altro
una sfortuna per il Trissino. Un esempio eclatante, come abbiamo visto en passant, è
l’assedio di Napoli: leggendo Procopio e poi Trissino, si vede che il poeta vicentino non
riesce che a fornire una accuratissima e fedelissima “versificazione” del testo
storiografico, che segue da vicino persino nei discorsi dei personaggi. Ma si tratta in
effetti di una condotta generalizzata, che si fa ora più ora meno mancata, ma informa di
sé l’intero poema. In Tasso non avviene quasi mai nulla di simile, e anche là dove la
fonte storica è seguita più da vicino, il grande poeta non perde mai di vista la finalità
precipuamente letteraria della sua creazione e la necessità improrogabile di ideare quelle
autonome strategie di significato tutte interne a dinamiche prettamente artistiche che,
indipendentemente dalla maggiore o minore novità d’invenzione della materia – e
persino, aggiungerei, del linguaggio poetico in cui questa viene sviluppata –,
costituiscono la vera originalità dell’opera d’arte97.
La diversità radicale nell’atteggiamento tassiano quanto al rapporto con le fonti
storiche emerge in tutta chiarezza da questo breve passo tratto da una delle cosiddette
Lettere poetiche (n. 15, A Scipione Gonzaga), dove la situazione appare perfettamente
rovesciata rispetto al modus operandi del Trissino: la storia non ha più alcuna
preminenza soverchiante sull’invenzione poetica, ma si riduce al rango di una “qualche
similitudine” e di una generica “aria” di verosimiglianza storica che deve promanare
dalla narrazione del poema:
La descrittione del caldo non so se possa essere reputata soverchia, ma io ce la voglio perché il
mio umore è fisso in questo: cioè che nel poema bisogna lasciare alcune note dell’istoria, quasi vestigi in
cui l’uomo, leggendo, riconosca qualche similitudine dell’istoria; e che il poeta sia simile al pittore che
ritrae un uomo: con tutto che gli voglia dare maggior grandezza e proporzione di membra e maggior
97
Cfr. ARISTOTELE, Poetica, 1451b, 23-32.
102
vaghezza di colori e di abiti, gli lascia però alquanto della sua aria. Per questo amo introdurvi la
fame…».
Così come il pittore varia secondo una sua propria idea l’aspetto di un soggetto
che ritrae, ma senza in questo stravolgere la sua “aria” – straordinaria intuizione, tra
l’altro, dei limiti di una concezione realistica della pittura cinquecentesca –, allo stesso
modo il poeta – conformemente all’osservazione aristotelica – rielabora secondo il
proprio progetto e la propria strategia significativa, risemantizzandole, le relazioni di
senso ravvisabili nella vicenda che narra.
103
104
4. L’EPOS
Il modulo epico dell’eroe necessario in Trissino
In quella colossale operazione di recupero della cultura e delle letterature
classiche su cui si fonda l’età umanistico-rinascimentale, se la latinità riscoperta
mantiene sempre il ruolo centrale e dominante, la novità più radicale e straordinaria per
l’Occidente ancora indirettamente latino attraverso la mediazione cristiana è però
senz’altro il progressivo recupero della lingua e della letteratura greca, tanto come
origine e fondamento imprescindibile della cultura europea, quanto come modello della
sua stessa rinascita. A differenza di una latinità che nel complesso, quanto ai suoi testi,
continua dunque ad essere tràdita e almeno potenzialmente accessibile anche nel
Medioevo, sin dal Trecento comincia a farsi avvertire fortemente, fra i letterati più colti,
l’esigenza di recuperare l’accessibilità a una letteratura greca che è invece
completamente perduta per l’Occidente (salvo attraverso alcune rare traduzioni latine,
per lo più di testi filosofici): esigenza che, con la vistosa ma piuttosto isolata
anticipazione del Poliziano, troverà il suo pieno coronamento soltanto nel corso del
Cinquecento. Com’è noto, i due grandi testi che saranno gli indiscussi protagonisti di
questo recupero della grecità letteraria sono la Poetica aristotelica e l’Iliade. E se il
primo grande trattato di teoria della letteratura verrà a ricoprire un ruolo centrale, a
partire dalla metà del secolo, appunto nel dibattito teorico e soprattutto nella rinascita
dei grandi generi letterari antichi, la riscoperta dell’Iliade (e naturalmente dell’Odissea,
che tuttavia resta ancora in gran parte nell’ombra nel quadro della cultura
cinquecentesca) è probabilmente l’evento più atteso e straordinario di tutta quella
immane operazione archeologica e filologica messa in atto dal nostro Rinascimento:
l’Occidente recupera alla possibilità di lettura il “principe dei poeti”, la perduta opera
“prima” e fondativa della sua stessa letteratura, l’ignoto vertice del suo stesso canone.
Per avere idea di quanto fosse stato atteso il recupero di Omero basti ricordare
l’indiscusso primo posto che gli assegna, pur in absentia e sulla sola base
105
dell’auctoritas della tradizione, il quarto canto dell’Inferno98, o l’attesa trepidante di
Petrarca e Boccaccio di poter leggere l’Iliade nella pur pedestre traduzione in prosa
latina di Leonzio Pilato 99 , o ancora la bramosia quasi vorace con cui il padre
dell’Umanesimo imita, in alcuni dei suoi versi più celebri, quello che è per lui uno dei
pochissimi barlumi che lasciano intravedere il testo omerico attraverso la traduzione in
una coppia di esametri ciceroniani, mostrando in tutta evidenza quanto a Petrarca
apparissero preziose anche solo le briciole più infinitesimali di quel tesoro perduto100:
½toi Ö k¦p ped…on tÕ 'Al»ϊon oἱoj ¢l©to
Ön qumÕn katšdwn, p£ton ¢nqrèpwn ¢lee…nwn·
(Iliade, VI, vv. 201-202)
qui miser in campis merens errabat Aleis (v.l.: alienis)
ipse suum cor edens, hominum vestigia vitans.
(CIC. Tusc. III, 63)
Solo et pensoso i più deserti campi
vo mesurando a passi tardi et lenti,
et gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio human l’arena stampi.
(RVF 35, vv. 1-4)
Quando tuttavia il testo greco dell’Iliade viene progressivamente restituito alla
cultura Occidentale attraverso la princeps fiorentina del 1488 di Demetrio Calcòndila e
poi diffuso dalle tre aldine del 1504, 1517 e 1521, e a più riprese tradotto prima
parzialmente e poi interamente in latino (particolarmente rilevanti le traduzione di
Lorenzo Valla, proseguita da Francesco Aretino, e poi di Andrea Divo) e infine anche in
volgare, l’impatto che il più illustre recupero operato dalla filologia umanistica ha sulla
98
Inf. IV, vv. 86-88: « Mira colui con quella spada in mano, / che vien dinanzi ai tre sì come sire: // quelli
è Omero poeta sovrano ».
99
Sulla traduzioni omeriche di Leonzio Pilato cfr. PERTUSI, A, Leonzio Pilato fra Petrarca e Boccaccio.
Le sue versioni omeriche negli autografi di Venezia e la cultura greca del primo Umanesimo, VeneziaRoma, 1964 (rist. Firenze, 1980). Più in generale sulle prime traduzioni omeriche cfr. FABBRI, R., Sulle
traduzioni latine umanistiche da Omero, in Posthomerica, I, Tradizioni omeriche dall’Antichità al
Rinascimento, a cura di MONTANARI, F. e PITTALUGA, S., Genova, 1997, pp. 99-124.
100
La conoscenza della traduzione ciceroniana da parte del Petrarca e dunque la conseguente certezza del
rapporto intertestuale sono rese indubitabili dalla citazione dei due esametri latini nel Secretum, III: «
Cogita nunc ex quo mentem tuam pestis illa corripuit; quam repente, totus in gemitum versus, eo
miseriarum pervenisti ut funesta cum voluptate lacrimis ac suspiriis pascereris; cum tibi noctes insomnes
et pernox in ore dilecte nomen; cum rerum omnium contemptus viteque odium et desiderium mortis;
tristis et amor solitudinis atque hominum fuga; ut de te non minus proprie quam de Bellorophonte illud
homericum dici posset:
qui miser in campis merens errabat alienis
ipse suum cor edens, hominum vestigia vitans ».
La varia lectio “alienis” riportata al posto di “Alieis” dal testo letto dal Petrarca, benché evidente
corruttela del testo latino, ha probabilmente influito sui celebri versi del Canzoniere, dando origine, con
lieve scarto semantico, al nesso “deserti campi”.
106
produzione poetica dell’epoca è forse ben più limitato e tormentato di quel che ci si
sarebbe potuti aspettare da così grandi aspettative.
L’influenza più marcata è naturalmente quella esercitata sulla poesia narrativa, ma
diverse concause contribuiscono a renderla sin dal principio problematica e quasi
difficoltosa, tanto da suscitare delle resistenze talvolta persino molto dure entro la
comunità letteraria rinascimentale. Innanzitutto lo stile stesso dei poemi omerici, le loro
strutture narrative e soprattutto la lontana cultura arcaica che in essi trova
rappresentazione, con il suo sistema di valori aggressivi, personalistici e per tanti versi
primitivi, così lontani dall’umanesimo di stampo cristiano ma anche dalla romanità
altamente civilizzata adombrata nei grandi modelli latini, appaiono per tanti versi
distanti, talvolta fino all’estraneità, sia in una prospettiva prettamente estetica che in una
prospettiva culturale in senso più ampio. L’immane lavoro filologico dell’omeristica,
che in secoli di studi ci ha permesso, pur attraverso un percorso accidentato e
ipertrofico, di colmare sufficientemente tale moderna percezione di alterità estetica e
culturale così da poter fruire appieno e senza più perplessità di tali capolavori – in una
progressiva chiarificazione del quadro che possiamo dire sufficientemente completa
solo con il superamento dei tentativi, ancora pienamente in auge nell’Ottocento, di
smembrare l’unità dei poemi, e poi con i fondamentali studi novecenteschi sulla
formularità, che fanno luce su una questione stilistica prima sostanzialmente incompresa
–, è ancora interamente di là da venire. La ricezione rinascimentale di Omero non può
che essere molto lontana non solo, naturalmente, dalla nostra, ma anche da quella coeva,
ben più agevole e piana, di autori latini da lungo tempo familiari come un Virgilio o un
Ovidio, e persino di altri riscoperti autori greci, come i tragici.
A questa difficoltà di fondo – che poi, se vogliamo, è quella che si articolerà nel
complesso viluppo di problemi della futura questione omerica – si sommano almeno
altri due importanti fattori.
Da una parte, il supporto teorico fornito dalla riscoperta Poetica aristotelica, se
certamente contribuisce in modo determinante a leggere Omero inquadrandone le
strutture fondamentali entro il genere epico, allo stesso tempo però complica
ulteriormente la già difficoltosa ricezione: i problemi ermeneutici posti dallo stesso testo
aristotelico, la brevità e parzialità della sua trattazione dell’epica rispetto a quella della
tragedia, la sua interpretazione spesso troppo rigidamente normativa (il cui esito più
paradossale è il sostanziale accantonamento dell’Odissea, che sembra violare in
apparenza tanti “principi” ivi sanciti) sollevano una serie di perplessità, critiche e
107
incomprensioni nei confronti dei poemi omerici, interpretati quasi soltanto alla luce di
un Aristotele a sua volta interpretato, per forza di cose, in maniera provvisoria e non di
rado opinabile e semplicistica. Il rapporto col testo poetico, insomma, è complicato
dalla sua lettura sempre mediata dall’unico e imprescindibile testo critico in cui se ne
cerca la chiave interpretativa esauriente.
Dall’altra parte, il campo della poesia narrativa in cui l’Iliade fa la sua entrata
trionfale come modello del poema epico “regolare” – secondo una interpretazione
senz’altro arbitraria di Aristotele, che semmai la propone ripetutamente come modello
di eccellenza – non è affatto sgombro e dunque aperto a un’agevole ricezione di tale
antica tradizione epica, ma proprio in quegli anni, tra fine Quattrocento e primo
Cinquecento, vede l’indiscusso trionfo di un genere letterario decisamente altro rispetto
ad essa, quel romanzo cavalleresco che, pur nobilitato da Boiardo e Ariosto attraverso la
parziale contaminazione con la tradizione latina e in particolare, naturalmente, con
modelli epici come Virgilio, mostra tuttavia un’autonoma origine romanza e delle
strutture sue proprie, per tanti versi radicalmente alternative a quelle dell’epica classica.
E se la coesistenza del romanzo cavalleresco con i modelli epici latini era stata
sostanzialmente “pacifica” e persino feconda attraverso i suddetti fortunati tentativi di
contaminazione, non altrettanto si può dire con la comparsa dei riscoperti poemi omerici
e in particolare dell’Iliade “poema epico regolare”: l’impatto risulta decisamente
frontale, oppositivo, traumatico, contribuendo in maniera determinante alla nascita della
grande querelle che contrappone i due generi tanto nella discussione teorica quanto
nella prassi poetica, e che travalica senz’altro i confini di un interesse volto alla mera
ricostruzione storico-culturale nell’essere presupposto imprescindibile di quel
capolavoro della letteratura universale che è la Gerusalemme liberata, che quel dibattito
al tempo stesso trascende e utilizza – conciliandone le opposte polarità – nella maniera
più fruttuosa.
Esito di questa ricezione fortemente problematica, senz’altro divergente dalle
aspettative e se vogliamo persino deludente, è, oltre alla già ricordata sostanziale
“rimozione” dell’Odissea, il costituirsi della diretta influenza iliadica sulla produzione
di poesia narrativa in una linea minoritaria e fortemente osteggiata, fino al punto di
vedere i suoi esiti perentoriamente esclusi, da allora in poi, non solo da ogni canone, ma
anche
da
qualsiasi
possibilità
di
riabilitazione
parziale,
foss’anche
solo
documentaristica, in una vera damnatio memoriae che conosce pochi termini di
confronto tanto drastici e clamorosi. Dei tre poemi che in maniera più evidente pongono
108
al centro della propria poetica l’imitatio iliadica, uno, l’Avarchide di Luigi Alamanni
(composta fra il 1548 e il 1554, ma pubblicata solo postuma nel 1570), è senz’altro
trascurabile sia quanto a valore poetico, sia quanto a influenza storico-letteraria,
pressoché nulla: è pur vero che il Tasso, durante la sua detenzione al S. Anna, più volte
la ricorda fra le molte opere di cui chiede che gli siano inviate copie per la lettura e lo
studio (già solo per questo sarebbe utile un esame più approfondito del suo eventuale,
per quanto esiguo, influsso sulla produzione tassiana: d’altronde sin dalla sua
contaminazione strutturale fra il modello romanzesco del Lancelot e la trama iliadica
essa mostra una strutturale contaminazione fra generi letterari affine tanto alla Liberata
quanto alla Conquistata); tuttavia è proprio il Tasso stesso a darci la misura di un
interesse senz’altro molto scarso quando la definisce perentoriamente «anzi traduzione,
che novo poema» (nella celebre lettera a Orazio Capponi, ed. Guasti, n. 82, la stessa
che contiene la “favola della Gerusalemme”)101. Di ben altro rilievo, non tanto a livello
artistico, quanto per la sua influenza storica innanzitutto – ma non solo – sul Tasso, è il
precedente poema del Trissino, l’Italia liberata dai Goti, composta nell’arco di circa un
ventennio e pubblicata in due parti nel 1547-48. Come ci è già capitato di rilevare, la
sua trascuratissima eppure determinante influenza già sulla Gerusalemme liberata, per
non parlare poi dell’influenza ancor più marcata sulla sua riscrittura che è la
Conquistata, ne fanno un oggetto di studio degno di un’attenzione molto maggiore di
quella, decisamente scarsa, dedicatale finora dalla critica. E proprio la riscrittura del
capolavoro tassiano, quella Gerusalemme conquistata che, per il sommarsi del
pregiudizio antiomerico a quello che deriva dal suo statuto di riscrittura (della Liberata),
ha subito una svalutazione e una denigrazione forse prive di paragoni fra le grandi opere
di autori di tale levatura, dalle quali soltanto negli ultimi anni ci si sta faticosamente
affrancando in vista di un giudizio più equo, è l’ultimo dei tre poemi più rappresentativi
di questa linea marcatamente omerizzante ostracizzata dalla nostra letteratura. A tal
punto questa linea di poetica che collega Italia liberata, Avarchide e Gerusalemme
conquistata è stata osteggiata, da non ricevere quasi per nulla neppure la consueta
attenzione per lo meno bibliografica che si suole riservare, sotto le insegne dello
storicismo e dello specialismo, agli autori e alle opere minori.
101
Una parziale riabilitazione, pur nella sostanziale continuità del giudizio, si legge nei successivi
Discorsi del poema eroico, II: «E s'io non sono errato, è soggetta a questa opposizione l'Avarchide,
poema epico de l'Alamanno, perché, quantunque la favola non sia nota, è quell'istessa de l'Iliade d'Omero;
laonde non merita gran lode ne l'invenzione, e resta ancora privata di quella autorità che suol essere ne
l'istorie o ne la fama; non se ne vede nondimeno alcun'altra meglio tessuta e, per mio giudizio, è la più
perfetta che si legga in questa lingua».
109
Quale che sia il giudizio che si vuole dare su questa produzione epica
rinascimentale di stampo marcatamente omerizzante, proprio il diretto coinvolgimento
in essa del poema di Torquato Tasso sulla conquista di Gerusalemme ne fa invece una
questione critica di primo piano, e questo non solo in relazione alla riscrittura della
Conquistata, notoriamente portata avanti Iliade alla mano: già sulla Liberata l’influenza
di questa linea omerizzante risulta assolutamente decisiva, più ancora che per la pur
avvertibile diretta influenza dell’Iliade – all’epoca letta e postillata dall’autore solo in
traduzione latina – soprattutto attraverso la fondamentale mediazione del Trissino (e
forse anche, ma come si è detto senz’altro in misura molto minore, dell’Alamanni, il cui
poema fu pubblicato d’altronde solo nel ’70). Di matrice iliadica, in particolare, è il
nodo centrale della struttura della Liberata: la contesa fra Goffredo e Rinaldo da cui
origina in massima parte la tanto celebrata opposizione funzionale fra una linea epica e
una romanzesca su cui si fondano gli equilibri del poema. È vero che questa principale
lacerazione all’interno del campo crociato è pur sempre posta, come ogni elemento
diversivo che ritarda il compimento dell’impresa epica, sotto il segno del meraviglioso
infernale, originando indirettamente dall’arrivo di Armida e dall’ulteriore intervento
dello spirito maligno che aizza Gernando contro Rinaldo; tuttavia la specifica
dimensione che essa prende, quella di un conflitto di insubordinazione fra il capo
dell’esercito e il suo guerriero più forte, non solo non è più conseguenza diretta e
necessaria di quegli elementi di meraviglioso demoniaco (che ne sono semmai solo
l’innesco) poiché dipende essenzialmente dal reciproco e libero atteggiamento dei due
contendenti l’uno nei confronti dell’altro, ma anche e soprattutto perché viene in ogni
caso ad assumere una dimensione del tutto esorbitante dalla sua stessa causa d’innesco,
arrivando ad informare di sé l’intera struttura del poema (a differenza delle altre forme
di diversione, come gli incanti della selva o la sedizione di Argillano, tutte, per quanto
ben connesse alla trama principale e ad essa funzionali, sostanzialmente episodiche).
Ma se il riconoscimento dell’origine iliadica di questo conflitto strutturante la Liberata,
modellato su quello fra Agamennone e Achille soprattutto attraverso la mediazione
trissiniana, è un dato piuttosto ovvio e acquisito dalla critica sin dalle pagine
autoesegetiche del Tasso stesso, l’approfondimento di questo macroscopico rapporto
intertestuale – centrale nella definizione degli equilibri dell’opera in senso epico – ha di
fatto risentito negativamente delle generale tendenza critica a trascurare lo studio
dell’influenza omerica sulla poesia rinascimentale 102 . Carenza tanto più paradossale,
102
Il debito tassiano verso la contesa iliadica fra Achille e Agamennone è stato quasi completamente
110
poi, quando si prende in considerazione la riscrittura della Conquistata, che con il testo
omerico si rapporta in modo massiccio non più principalmente attraverso il tramite del
Trissino, ma anche e prima di tutto direttamente103.
La grave carenza nello studio dell’influenza omerica sulla poesia rinascimentale,
sul Tasso e persino nell’analisi delle opere apertamente omerizzanti ora ricordate è un
fatto fin troppo evidente nella critica rinascimentalista, per quanto le sue cause siano
facilmente comprensibili. Un simile studio richiede sia una buona familiarità con il testo
iliadico (e dunque con la lingua greca), sia una sufficiente conoscenza complessiva, per
lo meno a livello generale, della sterminata bibliografia prodotta dagli studi della
moderna omeristica e delle sue acquisizioni più rilevanti: due aspetti che esulano
entrambi dalle consuete competenze richieste all’italianistica. Inoltre, la natura stessa di
un’imitatio pervasiva del testo iliadico – qual è quella mostrata dai poemi di tale linea
omerizzante – richiede in modo imprescindibile un’analisi svolta in una prospettiva
prettamente comparatistica, che conduca fra il testo e il suo modello un costante
confronto innanzitutto a livello testuale: ma nonostante la categoria critica
dell’intertestualità sia ormai un’acquisizione del tutto sdoganata e diffusa, una simile
prospettiva comparatistica, che pure tanto spesso dovrebbe esserne corollario, risulta
ancora decisamente minoritaria e persino osteggiata dallo specialismo settoriale proprio
degli studi accademici, in particolare dalla radicata tendenza a studiare singole
letterature delimitate su base linguistica 104 . Dopo il pionieristico contributo di
Baldassarri del 1982105, che sembrava dover aprire la strada a una tale prospettiva di
ricerca sull’influenza rinascimentale di Omero, gli studi ulteriori in quella direzione
sono stati molto scarsi e comunque di poco valore: anziché proseguire per una via
certamente difficile, ma rilevante e fruttuosa, la tendenza è stata quella di rimandare al
lavoro di Baldassarri quasi come a un contributo esaustivo sull’argomento, quando
invece – come lo studioso stesso d’altra parte afferma chiaramente – si tratta tutt’al
trascurato dalla critica: qualche osservazione in proposito, putroppo senza un adeguato approfondimento,
si legge in RUGGIERO, R., “Il Ricco Edificio”. Arte Allusiva nella «Gerusalemme Liberata». Firenze,
Olschki, 2005 (in particolare Introduzione, pp. v-xxii e cap. I, Rinaldo irato: esempi di influenza omerica,
pp. 1-27; l’Introduzione, col titolo «Aemulatio in imitando». Omero nella Gerusalemme liberata, è stata
pubblicata anche nel volume Contrafactum: copia, imitazione, falso. Atti del XXXII Convegno
interuniversitario, Bressanone-Brixen, 8-11 luglio 2004, a cura di PERON, G., ANDREOSE, A.).
103
Sul rapporto fra la Conquistata e l’Iliade, cfr. l’ampia sezione su Omero in RESIDORI, M., L’idea del
poema, cit., con le cui tesi sullo specifico argomento sono, personalmente, in disaccordo, e il mio articolo
di recentissima pubblicazione La “Patrocleia” di Ruperto nella Gerusalemme conquistata: il modello
omerico e la riscrittura del poema tassiano, «Maia» 63.2 (2011), pp. 330-365 (tratto dalla mia tesi di
laurea, interamente dedicata all’argomento).
104
Sulla questione cfr. PADUANO, G., Lo studio della letteratura europea, cit.
105
BALDASSARRI, G., Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa del poema rinascimentale e tradizione
omerica, Roma, Bulzoni, 1982.
111
contrario di un primo sondaggio condotto su campioni e argomenti senz’altro importanti
ma pure molto circoscritti rispetto all’ampiezza complessiva della questione, che
travalica ampiamente le possibilità di una singola monografia: uno studio che intendeva,
semmai, lungi dal pretendere esaustività, a dare avvio a un ambito di analisi ancora in
massima parte da approfondire. I criteri del decoro e del verosimile, giustamente
individuati da Baldassarri come due importanti categorie di varianza rispetto al modello
omerico, secondo quando è ampiamente testimoniato, d’altronde, dalla produzione
teorica dell’epoca che si rifà anche in questo ad Aristotele106, hanno finito per essere
spesso travisati come uniche questioni chiamate in causa nel trattare l’argomento, quasi
fossero esaustive nel dare ragione del rapporto intrattenuto dalla poesia rinascimentale
con l’Iliade. Un utilizzo di tipo strutturale e funzionale di Omero, in seguito, non è stato
soltanto svalutato, ma quasi neppure sospettato: come se tale forma di imitatio
strutturale e pervasiva fosse l’ingiustificato e ingiustificabile postulato di quella
produzione poetica, e non ci fosse che da valutarne i criteri di correzione operanti nel
metterlo in atto (e tutt’al più gli esiti rovinosi cui dava luogo). Come ho già notato
altrove, in questo errore di fondo mi pare incorrere senz’altro l’unico tentativo di analisi
di una certa ampiezza tentato per questo trascurato settore degli studi, la sezione
dedicata al riuso di Omero nella monografia di Residori sulla Conquistata:
l’omerizzazione è lì a priori presupposta come mero ossequio al modello illustre,
riducendola a un confronto in partenza limitato al “carattere” (l’ethos aristotelico) e al
“decoro”, che dunque non si pone neppure la domanda se gli ampi elementi desunti
dall’Iliade abbiano una funzione strutturale e intendano comporsi in una strategia di
106
Sul decoro, in gran parte connesso anche alla questione del carattere (ethos) e corrispondente
all’harmótton aristotelico, cfr. il capitolo relativo della Poetica, 1454a, 17 sgg.: Perˆ dὲ t¦ ½qh tšttar£
™stin ïn de‹ stoc£zesqai, n mὲn kaˆ prîton, Ópwj crhst¦ Ï. […] deÚteron dὲ tÕ ¡rmÒttonta·
œstin g¦r ¢ndre…an mὲn tÕ Ãqoj, ¢ll' oÙc ¡rmÒtton gunaikˆ oÛtwj ¢ndre…an À dein¾n eἶnai. (trad:
« A proposito dei caratteri, quattro sono le cose a cui bisogna mirare. La prima è che siano buoni […] La
seconda che siano adatti: è possibile avere un carattere coraggioso, ma che l’abbia particolarmente
coraggioso o formidabile una donna, non è adatto » E ancora, poco oltre, 1454b, 8 sgg.: ™peˆ dὲ m…mhs…j
™stin ¹ tragJd…a beltiÒnwn À ¹me‹j, de‹ mime‹sqai toÝj ¢gaqoÝj e„konogr£fouj· kaˆ g¦r ™ke‹noi
¢podidÒntej t¾n „d…an morf¾n Ðmo…ouj poioàntej kall…ouj gr£fousin (trad.: « E poiché la tragedia
è imitazione di persone migliori di noi, occorre imitare i buoni ritrattisti, i quali proprio riproducendo la
fisionomia specifica e facendo somiglianti i loro modelli li dipingono migliori [lett. più belli]»). Sul
verosimile, di cui si parla ripetutamente, cfr. in particolare il celebre passo 1451a-b: FanerÕn dὲ ™k tîn
e„rhmšnwn kaˆ Óti oÙ tÕ t¦ genÒmena lšgein, toàto poihtoà œrgon ™st…n, ¢ll' oŒa ¨n gšnoito kaˆ
t¦ dunat¦ kat¦ tÕ e„kÕj À tÕ ¢nagka‹on. Ð g¦r ƒstorikÕj kaˆ Ð poiht¾j oÙ tù À œmmetra lšgein
À ¥metra diafšrousin (e‡h g¦r ¨n t¦ `HrodÒtou e„j mštra teqÁnai kaˆ oÙdὲn Âtton ¨n e‡h
ƒstor…a tij met¦ mštrou À ¥neu mštrwn)· ¢ll¦ toÚtJ diafšrei, tù tÕn mὲn t¦ genÒmena lšgein,
tÕn dὲ oŒa ¨n gšnoito (trad.: « Da quanto si è detto risulta chiaro che compito del poeta non è dire ciò
che è avvenuto ma ciò che potrebbe avvenire, vale a dire ciò che è possibile secondo verosimiglianza e
necessità. Lo storico e il poeta non differiscono tra loro per il fatto di esprimersi in versi o in prosa – si
potrebbero mettere in versi le storie di Erodoto, e in versi come in prosa resterebbero comunque storia –,
ma differiscono in quanto uno dice le cose accadute e l’altro quelle che potrebbero accadere »).
112
senso: dovunque l’imitatio omerica altera le strutture della Liberata, vuol dire
semplicemente che le rovina e le distrugge. Ma simili tentativi, per quanto forse poco
condivisibili, sono tuttavia apprezzabili se raffrontati al consueto disinteresse e alla
generale trascuratezza di fronte alla presenza di Omero nella produzione poetica
rinascimentale, che nel migliore dei casi si limita ad essere segnalata senza ulteriori
considerazioni, nel peggiore del tutto ignorata e persino travisata. Basti l’esempio,
clamoroso, di un caso in cui in uno studio critico si presenta come affermazione
paradigmatica dell’ideologia aristocratica cinquecentesca dell’Italia del Trissino un
passo che invece – naturalmente senza che ciò sia minimamente notato – è traduzione
letterale di un passo omerico appena meno riconoscibile di quelli più vulgati, il dialogo
fra Sarpedone e Glauco in Iliade XII107:
L’etica dell’Italia liberata prevede chiaramente un’eccellenza, una ‘nobiltà’ fondata sul valore dei
combattenti, su un valore, per giunta, continualmente da dimostrare ai sottoposti come garanzia e giustizia
della gerarchia sociale. Credo che in questo senso si possano interpretare come programmatiche le parole
che Totila rivolge a Tejo nel libro XV:
Tejo, tu sai di che supremo onore
siamo onorati nelle terre nostre,
che ci aman con timor, come un lor Dio.
Ma non è giusto, che i primieri luoghi
abbiamo e nelle piazze, e ne i conviti,
se nelle guerre ancor non siamo i primi
[ecc.]
Chi ha una qualche familiarità con l’epica greca arcaica nota immediatamente che
i valori a cui lo studioso fa riferimento, più che trissiniani o cinquecenteschi, sono
esattamente quelli dell’aristocrazia guerriera iliadica, e che il testo ha ben poco di
originale tanto nei concetti quanto nell’espressione:
Glaàke t… À d¾ nîϊ tetim»mesqa m£lista
›drV te kršas…n te „dὲ ple…oij dep£essin
™n Luk…V, p£ntej dὲ qeoÝj ìj e„sorÒwsi,
kaˆ tšmenoj nεmÒmesqa mšga X£nqoio par' Ôcqaj
kalÕn futalιÁj kaˆ ¢roÚrhj purofÒroio;
të nàn cr¾ Lυk…oisi mšta prètoisin ™Òntaj
˜st£men ºdὲ m£chj kauste…rhj ¢ntibolÁsai
[ecc.]108
107
DE MASI, M., L’errore di Belisario, Corsamonte, Achille, «Studi Italiani», XV, 1 (2003), p. 13.
Iliade, XII, 310 sgg.: « Glauco, perché in Licia ci riveriscono / dandoci il posto d’onore, carne e coppe
ripiene, /e tutti ci considerano come dèi, / e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto, / ricco
di piantagioni d’alberi e di terreni coltivi? / Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila / e affrontare la
battaglia bruciante… »
108
113
Nella scarsa ma crescente attenzione ad essa dedicata, insomma, ciò che è
drasticamente mancato a questa poesia narrativa omerizzante è paradossalmente proprio
lo studio della sua costitutiva componente omerica. E finché si tratta dell’insignificante
poema dell’Alamanni, potremmo benissimo farcene una ragione; già la presenza del
Trissino, che pur non essendo certo un grande poeta fu senz’altro uno dei letterati più in
vista del suo tempo (come testimonia soprattutto il rilievo della sua posizione nella
questione primocinquecentesca della lingua poetica italiana), diventa più ingombrante;
ma il diretto coinvolgimento del capolavoro tassiano in tutta la sua travagliata
evoluzione, come ho già detto, avrebbe dovuto da tempo restituire alla questione la sua
importanza critica di primo piano.
In questo capitolo, dunque, cercherò di contribuire a colmare tale grave carenza
degli studi. Già in precedenza mi sono occupato di approfondire il rapporto con Omero
per quanto riguarda il versante della Gerusalemme conquistata tassiana109, ravvisando
alla base della forte omerizzazione a cui è sottoposta la precedente versione del poema
una complessa rete di motivazioni strettamente funzionali ad una revisione
assolutamente consapevole e motivata – a prescindere dal giudizio che se ne voglia dare
– dei suoi equilibri strutturali: lungi dall’essere gratuito e mosso da uno sterile e
autolesionistico appiattimento della Gerusalemme sull’Iliade, secondo la vulgata
riaffermata dalle conclusioni di Residori, tale rapporto si è rivelato ben altrimenti
fondato innanzitutto da una prospettiva prettamente letteraria e poetica. Un altro aspetto
emerso in tutta chiarezza, ma che in quella sede non poteva essere adeguatamente
approfondito, è come alla base di una simile operazione di riscrittura agisca anche una
complessiva rivalutazione di quella poetica trissiniana che pure era stata già
decisamente influente – ben più di quanto non si ammetta di solito – sin dalla
composizione della Liberata. Lo studio del rapporto del Trissino con Omero, dunque, si
prefigura senz’altro come il principale tassello mancante, come il passo successivo da
compiere per far luce sia sulla tanto vituperata linea omerizzante della poesia
rinascimentale, sia soprattutto sul capolavoro tassiano in tutto l’arco della sua
evoluzione; un ulteriore aspetto di primaria importanza, già parzialmente emerso per la
Conquistata e a sua volta assolutamente degno di attenzione, è inoltre il contributo che
una simile linea poetica – fondata su un rapporto tanto pervasivo con un modello
classico da non conoscere forse alcun termine di paragone in qualsiasi altro ambito di
109
Dell’argomento trattano la mia tesi di laurea specialistica, La «Gerusalemme Conquistata» e
l’«Iliade». Il modello omerico nella riscrittura del poema tassiano, Pisa, Anno Accademico 2007/2008, e
nell’articolo da tratto da un suo capitolo, La “Patrocleia” di Ruperto nella Gerusalemme conquistata, cit.
114
produzione poetica dell’epoca – fornisce per una migliore e più completa comprensione
del quadro generale del principio cardine dell’estetica rinascimentale, l’imitatio.
Procedendo dunque ad un esame dell’utilizzo che il poema trissiniano fa di
Omero, volto ad individuarne non la facies superficiale ma i principali nodi strutturali e
le loro motivazioni, cercheremo su questa base di esaminare poi l’influenza che una
simile operazione intertestuale e le soluzioni cui ha dato luogo hanno esercitato sulla
Liberata e anche sulla Conquistata, tanto negli equilibri strutturali originari quanto nelle
modifiche che intervengono a ridefinirli nella riscrittura. Naturalmente, data anche la
complessità di un simile studio che coinvolge le intricate relazioni fra ben quattro poemi
di grande estensione (Iliade, Italia liberata, Gerusalemme liberata e Gerusalemme
conquistata), presuppongo il mio suddetto lavoro precedente sul rapporto fra la
Conquistata e l’Iliade, alle cui conclusioni – lì ampiamente discusse – non potrò che
rinviare attraverso rapidi e sintetici riferimenti.
Venendo dunque allo specifico della questione relativamente al poema trissiniano,
sarà utile un breve riesame dei risultati raggiunti a riguardo dai pochi studi critici
sull’argomento. A parte la recentissima monografia di Vitale 110 , la quale tuttavia si
occupa del rapporto con Omero limitatamente all’aspetto linguistico-stilistico – che non
è invece ciò che qui ci interessa primariamente –, i pochi contributi recenti sul Trissino
non trattano la questione che, com’era prevedibile, in maniera marginale.
L’articolo di Quondam 111 , che pone le basi di una nuova, sia pur limitata,
attenzione critica all’Italia liberata e al suo ruolo storico-letterario, si limita ad
affermare l’assoluta mancanza di originalità dell’autore rispetto al suo venerato modello
omerico, fornendo l’immagine di un poema esplicitamente definito, con un termine
cinematografico dalle implicazioni perentorie, un “remake”:
Imitazione di Omero in termini di remake, duplicazione fedele, restituzione totale: l’Italia liberata
dai Gotti si organizza come gigantesca macchina da riproduzione, che copia tutto senza lasciar nulla,
senza troncare né diminuire l’originale (non è forse l’Idea riproducibile?), senza tentare una riduzione in
scala minore, una miniaturizzazione del suo essere copioso e largo. Questa duplicazione in scala 1:1 e in
tempo reale dell’originale omerico produce, però, un formidabile «effetto copia», un sovraccarico proprio
della sua «copiosità» e «larghezza», un’accentuazione vistosa delle sue proporzioni: in termini di
colossal. La ricerca ossessiva del massimo di verità finisce per produrre il massimo di falsificazione, per
svelare la presenza della macchina, del suo artificio: questo Omero in xerocopia non è che un simulacro,
un Omero in cartapesta.112
110
VITALE, M., L’Omerida italico: Gian Giorgio Trissino: appunti sulla lingua dell’“Italia liberata da’
Gotthi”, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2011.
111
QUONDAM, A., La poesia duplicata, cit.
112
Ibid., p. 90.
115
Una simile analisi, se certamente inquadra bene il problema estetico posto dalla
pervasività dell’omerismo trissiniano (d’altra parte Quondam si è molto occupato delle
questioni poste dall’estetica rinascimentale e in particolare di quella, capitale,
dell’imitatio113), tuttavia dà della questione un quadro generale decisamente distorto: la
struttura complessiva dell’Italia non è affatto una mera duplicazione della struttura
iliadica, com’è invece l’Avarchide dell’Alamanni nel sopra ricordato giudizio tassiano;
se il debito strutturale verso Omero è senz’altro ingente, gli elementi desunti sono
variamente ricombinati e rielaborati in vista di un’elaborazione complessiva della trama
indubbiamente autonoma, secondo l’esempio dell’Eneide virgiliana (nonostante lo
scarto incolmabile nei risultati). L’Italia liberata non è affatto un “remake”, e ci
interessa, soprattutto in vista del suo influsso sul Tasso, precisamente per questo.
Non molto dissimile, per quanto meno estremizzata, è l’idea complessiva del
rapporto Trissino-Omero che emerge dagli interventi di Zatti 114 , interessati piuttosto
all’aspetto di teoria letteraria e soprattutto al confronto con Tasso (ottimo, tuttavia, è il
riconoscimento di un tentativo trissiniano di imitare stilisticamente la formularità
omerica, su cui torneremo); non condivido del tutto invece la critica metodologica
mossagli da Gigante, per cui studiare un autore alla luce di un altro sarebbe
filologicamente poco corretto115: è giustissimo il rilievo che bisogna studiare Trissino
autonomamente, per non deformare l’analisi ricorrendo a categorie critiche desunte di
peso dallo studio di un altro autore – un difetto da cui effettivamente lo studio di Zatti
forse non è sempre immune –, ma al contempo è innegabile che Trissino, ben più che
per una autonoma ricostruzione storico-letteraria della sua scarsa personalità poetica, ci
interessa innanzitutto in relazione alla sua grande influenza sul massimo autore del
secondo Cinquecento: se dunque non bisogna studiare Trissino attraverso Tasso, lo si
può benissimo studiare, tuttavia, per Tasso. Proprio una prospettiva di tal genere anima,
d’altra parte, il presente studio, che pur studiando Trissino in modo del tutto
113
Cfr. soprattutto il volume antologico di alcuni dei principali testi umanistico-rinascimentali sulle
grandi questioni di poetica dell’epoca: QUONDAM, A., (a cura di), Rinascimento e Classicismo. Materiali
per l’analisi del sistema culturale di Antico regime, Roma, Bulzoni, 1999.
114
ZATTI, S., Tasso lettore del Trissino, cit. e ID., L’ombra del Tasso, cit.
115
GIGANTE, C., Epica e romanzo in Trissino, cit. p. 302: «Una simile lettura, che tradisce qua e là una
conoscenza sommaria del testo, nasce da una particolare prospettiva storica: Zatti legge l’Italia
utilizzando come parametro di riferimento la Gerusalemme del Tasso. Che sarebbe come interpretare il
Werther alla luce dei risultati dell’Ortis». Si potrebbe ulteriormente notare che una simile prospettiva “a
ritroso” non è poi così paradossale, se si pensa che un’opera successiva è sempre anche un’interpretazione
del suo modello e dunque può benissimo fornire delle indicazioni critiche utili allo studio di quello: ciò
che bisogna evitare, semmai, è di considerare esaustiva una tale prospettiva e di leggere
complessivamente l’ipotesto come una sorta di figura profetica e imperfetta del capolavoro di là da
venire.
116
indipendente, guarda ai risultati così raggiunti essenzialmente in vista di una questione
incomparabilmente più importante, la loro ripercussione sulla Gerusalemme tassiana.
Una qualche attenzione al fondamentale nodo narrativo desunto dal conflitto fra
Achille e Agamennone è invece presente, seppure en passant, nei due contributi di
Gigante116, il più recente dei quali fornisce senza dubbio il bilancio più equilibrato del
poema, se non altro dimostrandone un’attenta lettura integrale. Ma se i principali punti
di contatto con Omero sono menzionati, non si va poi al di là di questo nell’analisi:
inevitabile, dunque, la solita conclusione per cui le divergenze più macroscopiche
rispetto al modello non sono se non «stravaganze arbitrarie che invece di esprimere in
qualche modo un desiderio di trasgressione verso la legge imposta dal Modello, si
rivelano come ulteriori sintomi dell’“ansia” trissiniana di emulazione dell’archetipo,
dello smarrimento di un poeta che ha messo in moto una folle, “gigantesca macchina da
riproduzione”, diventata, fatalmente, ingovernabile»
117
: l’identico pregiudizio,
insomma, – elevato a conclusione in assenza di una vera analisi – che abbiamo visto già
in Quondam, dal quale d’altronde sono tratte le citazioni virgolettate.
Ancor meno si può trovare qualcosa riguardo alla nostra questione in altri studi
che pure, marginalmente, la toccano. Il saggio di Jossa 118 , che pur trattando più in
generale del poema narrativo fra Ariosto e Tasso torna costantemente sul Trissino,
chiama in causa l’Iliade come modello del genere epico da rifondare, ma poi non riserva
alcun approfondimento testuale alla questione, che è accennata solo nei soliti termini di
teoria letteraria dell’epoca; decisamente fuorviante nella sua parzialità è anzi, come
abbiamo già avuto modo di notare, l’idea della vicenda di Corsamonte, l’eroe modellato
sull’Achille
omerico,
come
rappresentazione
simbolica
dell’
“uccisione
del
romanzo”119. Del tutto generico, nonostante il titolo promettente, il breve articolo di
Musacchio 120 , che ha il carattere di un breve compendio di osservazioni meramente
teoriche tutte quante sostanzialmente già note
(unità d’azione, costume, decoro,
enargeia): la questione del rapporto con il testo omerico e con le sue strutture è anche
qui totalmente ignorata. Per concludere la breve rassegna, nell’articolo di De Masi121,
che pure sulla scorta di quanto fa Bruscagli per la Liberata individua un nucleo
116
GIGANTE, C., «Azioni formidabili e misericordiose», cit.; ID., Epica e romanzo in Trissino, cit.
«Azioni formidabili e misericordiose», cit., pp. 61-62; il passo è ripreso alla lettera, a testimoniare il
giudizio immutato sulla questione, nel successivo articolo Epica e romanzo in Trissino, cit., pp. 311-312.
118
JOSSA, S., La fondazione di un genere. Il poema eroico tra Ariosto e Tasso, Roma, Carocci, 2002.
119
Ibid., p. 139-155.
120
MUSACCHIO, E., Il poema epico ad una svolta: Trissino tra modello omerico e modello virgiliano,
«Italica» 80 (2003), pp. 334-352.
121
DE MASI, M., L’errore di Belisario…, cit.
117
117
narrativo/paradigmatico di evidenti implicazioni iliadiche122, come abbiamo già visto
Omero non è chiamato in causa neppure nei soliti termini generici, e neanche di fronte a
questioni che proprio con l’Iliade hanno massimamente a che fare123.
In breve, non solo l’ingente e programmatico debito trissiniano verso Omero è
stato piuttosto meramente affermato e denigrato che non studiato effettivamente, ma
l’immagine vulgata che traspare da contributi critici (che spesso tradiscono una lettura
parziale e frettolosa del pesante e farraginoso poema) è semplificata in maniera così
drastica da risultare del tutto deformante. La questione fondamentale se i continui debiti
siano guidati da finalità strutturali, ed eventualmente quali, è stata completamente
ignorata, lasciando passare l’idea pregiudiziale che un’imitazione estensiva e strutturale
non possa che essere priva di ogni senso e valore. Un pregiudizio moderno di cui invece
ci si dovrebbe liberare preventivamente a qualsiasi analisi sull’arte e la letteratura
preromantiche, come dimostrano non già opere di minor conto, bensì – solo per
ricordare esempi clamorosi – il teatro comico latino, l’Eneide, Romeo e Giulietta. Il
poema del Trissino, in realtà, non agisce in maniera sostanzialmente diversa da tanti
capolavori della tradizione occidentale nel rapportarsi con dei modelli privilegiati in
maniera estensiva e strutturale: semmai, i risultati a cui perviene sono scarsi per il poco
spessore poetico dell’autore e per alcuni macroscopici errori di impostazione dell’opera
che non dipendono direttamente dall’incidenza “quantitativa” dell’imitatio. A riprova di
questo sta proprio il fatto che sin dalla Liberata il Tasso si serve a piene mani del
Trissino, precisamente per desumerne quanto c’era di valido nelle strutture nuove e
autonome dell’Italia: se l’autore vicentino non avesse saputo, come non seppe
l’Alamanni, creare strategie significative originali, il suo grande successore lo avrebbe
piuttosto ignorato che non ripreso in modo tanto cospicuo, rifacendosi semmai
direttamente e senza mediazioni al testo iliadico stesso.
Prima di venire all’analisi effettiva sarà utile però ancora qualche precisazione
metodologica sui criteri d’indagine che converrà seguire. Innanzitutto, la necessaria
impostazione prettamente comparatistica cui ho già accennato si baserà proprio su quel
costante confronto condotto a livello testuale tra Italia liberta e Iliade che la critica ha
122
BRUSCAGLI, R., L’errore di Goffredo (G.L. XI), «Studi Tassiani», 40-41 (1992-1993), pp. 207-232
(ristampato in ID., Studi cavallereschi, Firenze, Società Editrice fiorentina, 2003, pp. 167-198).
123
Tanto meno il rapporto con Omero è affrontato in altri articoli sul Trissino che trattano piuttosto di
questioni diverse: BARILLI, R., Modernità del Trissino, cit.; ID., Il difficile percorso del poema moderno
dal Trissino al Tasso, cit.; CORRIERI, A., Rivisitazioni cavalleresche ne “L’Italia liberata da’ Gotthi” di
Giangiorgio Trissino, cit.; V. GALLO, Paradigmi etici dell’eroico e riuso mitologico nel V libro
dell’«Italia» di Trissino, in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», a. CXXI 2004, vol. CLXXXI,
fasc. 595, pp. 373-414.
118
sempre totalmente ignorato, limitandosi ad evidenziare i punti di contatto a livello così
generico che a stento se ne poteva trarre qualche conclusione sulle strutture dell’opera e
le strategie del riuso. In questo modo si eviterà anche il frequentissimo errore
metodologico di fornire un’analisi dell’opera condotta non sul testo dell’opera stessa,
bensì sulla poetica che alla sua composizione presiede, desunta dagli scritti teorici
dell’autore o persino di altri: l’oggetto principale di studio, insomma, non deve essere
l’epistola dedicatoria del poema a Carlo V in quanto presenta ed espone per sommi capi
la poetica seguita nell’Italia, e neppure le ben più ampie considerazioni sulla poesia
epica che il Trissino espone nella quinta e sesta divisione della sua Poetica, bensì – a
differenza di quanto è stato fatto quasi sempre – il testo del poema. Si eviterà così di
trasferire di peso le considerazioni teoriche all’effettiva produzione poetica, in
un’operazione critica assolutamente indebita e controproducente (nel migliore dei casi
tautologica, nel peggiore e più frequente del tutto deformante), e si potranno piuttosto
analizzare direttamente e senza preconcetti, da una prospettiva più neutra e oggettiva, le
effettive dinamiche testuali. Ciò naturalmente non esclude affatto il riferimento alle
dichiarazioni teoriche, senz’altro rilevanti, quando esso risulti utile e necessario:
l’importante è che l’analisi non muova da tali dichiarazioni come suo presupposto, da
verificare a posteriori – nel migliore dei casi – con qualche sparuto esempio testuale
selezionato ad hoc e dunque certamente parziale e tendenzioso (magari del tutto
involontariamente), ma al contrario veda nella teoria solo l’occasionale raffronto di
un’indagine autonoma in quanto autonomo è il suo oggetto. È ben facile, partendo dalla
dichiarazione trissiniana di aver preso Omero «per duce e per Idea» e di averlo seguito
«imitando e adorando le sue pedate»124, dedurne con troppa disinvoltura che l’Italia è
una mera duplicazione del suo modello e pertanto non è necessario indagare oltre:
sarebbe bene ricordare che simili espressioni, che parafrasano Stazio125, non sono altro
che l’esplicitazione topica della comune e condivisa estetica dell’imitatio, che quando
prende a modello in maniera altrettanto esclusiva Virgilio, Cicerone o Petrarca non
meraviglia e non scandalizza mai nessuno; anzi, Petrarca stesso, che di quella estetica è
il grande iniziatore e primo teorico dopo l’età classica, attribuisce giustamente il
medesimo atteggiamento a Virgilio proprio nei confronti di Omero, la cui mancata
124
Le citazioni sono tratte dalla dedica dell’Italia liberata a Carlo V.
STAZIO, Tebaide, XII, vv. 816-17: viue, precor; nec tu divinam Aeneida tempta, / sed longe sequere et
vestigia semper adora.
125
119
esplicitazione nell’Eneide alla maniera della Tebaide è da lui spiegata solo con il fatto
che l’autore non poté ultimarla e sottoporla a revisione126.
Solo in un secondo momento, evidenziati di volta in volta i termini del rapporto
Trissino-Omero, i risultati saranno costantemente raffrontati con l’eventuale riuso che
ne faccia il Tasso nei due distinti momenti di composizione della Liberata e di
rielaborazione che porta, oltre quindici anni dopo, alla Conquistata (com’è noto, il
primo poema era sostanzialmente già ultimato nel 1575, quando viene sottoposto alla
cosiddetta “revisione romana”, e pubblicato nel 1581, mentre la sua riscrittura è
pubblicata nel 1593). Come ho detto, nel far questo mi baserò in buona parte sui miei
precedenti studi tassiani cui non potrò che rimandare in maniera molto sintetica. Quanto
invece al versante omerico, se per il Tasso la questione di come egli lo leggesse nei vari
periodi di composizione della sua opera, se solo in traduzione o anche in lingua
originale, ha spesso fornito alla critica il pretesto per evitare il diretto confronto col testo
greco, per il Trissino questo alibi non sussiste più: il letterato vicentino conosceva assai
bene la lingua greca e la composizione del suo poema presuppone continuamente il
testo dell’Iliade in lingua originale; con quello dobbiamo dunque rapportarci anche noi.
Non riusciranno neppure inutili, quando pertinenti, dei riferimenti anche alle
acquisizioni della moderna omeristica, che anzi ci aiutano senz’altro a interpretare le
strutture e le dinamiche interne del testo preso a modello, senza che ciò distorca in alcun
modo la prospettiva d’analisi in senso anacronistico: uno studio del rapporto di Trissino
e Tasso con Omero non deve affatto adeguare e ridurre la nostra prospettiva di indagine
all’idea che essi avevano del grande autore antico da poco riscoperto, ma al contrario,
pur senza chiamare in causa questioni prettamente filologiche successive e non
pertinenti, deve giovarsi di tutte le acquisizioni esegetiche che, nella consapevolezza
della loro diacronia, possano risultare utili e produttive127.
126
PETRARCA, Familiares, XXIV, 12 (Responsio ad epystolam magnam multaque continentem
sub Homeri poete missam nomine et apud Inferos datam), par. 23-26: «Nempe ille [Vergilius]
Theocritum in Bucolicis ducem nactus, in Georgicis Hesiodum, quemque suis locis inseruit. ‘Et cur’
inquies, ‘tertium in heroyco carmine ducem habens, nulla eius operis in parte me [Homerum] posuit?’.
Posuisset, michi crede, mitissimus verecundissimusque mortalium, quodque de illo scriptum scimus,
“omni probatus vita”, nisi mors impia vetuisset. […] Quod sic esse, vicino et simili conicies ab exemplo:
nam ut te ille sic illum imitatus est Statius Pampinius, cuius supra mentio incidit, vir preter ingenii
laudem insigni morum urbanitate conspicuus; nec tamen ingenue ducem suum nisi in fine poetici itineris
recognovit; licet enim alio quodam loco se stilo “inferiorem” secretius designasset, illic tamen bona fide
totum grati animi debitum benemerite persolvit Eneydi. Si et hunc mors igitur prevenisset, ut te Virgilius
sic iste Virgilium siluisset».
127
Sulla questione, in termini teorici generali, cfr. ad es. GADAMER, H. G., Verità e metodo, Milano,
Bompiani, 2010 (1960), p. 454: «A tutta prima sembra un ragionevole canone ermeneutico il principio
secondo cui non bisogna mettere nel testo nulla che l’autore o il lettore originario non potessero
effettivamente avere in mente. Tuttavia, tale canone si può applicare veramente solo in casi estremi. I testi
120
Naturalmente ciò che ci interessa più da vicino sono le strutture portanti della
narrazione e il loro valore funzionale nella costruzione della trama, secondo la linea di
derivazione Omero-Trissino-Tasso, mentre l’aspetto stilistico e di dizione non sarà qui
preso in considerazione, pur senza per questo escludere qualche considerazione
occasionale (d’altra parte sullo stile del Trissino e la sua dizione omerizzante
disponiamo dell’ampia ricognizione, già ricordata, di Vitale 128 ). Ciò non vuol dire,
tuttavia, che l’analisi debba essere condotta solo guardando alla trama in generale e in
astratto, com’è avvenuto di necessità nei pochi e brevi studi precedenti; al contrario,
l’individuazione delle macrostrutture e delle loro funzioni non può mai prescindere dal
continuo rapporto diretto con il testo, dal quale soltanto, infatti, esse sono definite e
individuate in maniera adeguata e non riduttiva o semplificante. Solo dal diretto
confronto con il testo, e anzi spesso dal confronto fra testi, possono emergere in modo
esauriente le strategie significative messe in atto dall’opera e la fitta relazione di identità
e differenze con il testo modello da cui emergono i significati nuovi e autonomi
dell’opera derivata. E se dunque le identità con l’ipotesto non devono essere
aprioristicamente svuotate di ogni senso nel loro essere qualcosa di già detto altrove,
mera ripetizione insignificante, né liquidate semplicemente come conformi all’estetica
dell’imitatio, magari travisata e ipertrofica, le differenze restano comunque – dalla
variatio microtestuale appena percettibile fino alle più ampie rielaborazioni strutturali –
la principale forma di indicazione da cui dedurre, in filigrana, i significati nuovi del
testo “secondo” e derivato. In quest’ottica, dunque, da una parte le identità generano un
loro apporto di significato sia nell’operare una selezione di un elemento specifico e a
sua volta significativo dell’ipotesto, sia nel mettere in atto una sua ricollocazione entro
un nuovo contesto da cui esso desume necessariamente, in qualche misura, un senso
nuovo; dall’altra le differenze, in maniera ben più ovvia, esprimono un senso nuovo
proprio nel significativo elemento di divergenza che introducono rispetto al testo
d’origine.
non vogliono infatti essere compresi come espressioni della soggettività dell’autore. Il senso di un testo
non può dunque delimitarsi su questa base. Tuttavia non è solo problematica la limitazione del senso del
testo in base agli “effettivi” pensieri dell’autore. Anche quando si cerca di determinare il senso di un testo
in maniera obiettiva, intendendolo come un discorso che si rivolge ai suoi contemporanei e mettendolo in
rapporto con il lettore originario, come voleva Schleiermacher, non si va oltre una delimitazione
accidentale del senso. Anche il concetto di discorso che si rivolge ai contemporanei ha una validità critica
limitata. […] In tal modo il riferimento al lettore originario, come il riferimento all’intenzione dell’autore,
appare come un canone storico-ermeneutico piuttosto rozzo, che non è in grado di delimitare
effettivamente l’orizzonte di significato di un testo».
128
VITALE, M., L’omerida italico, cit.
121
Sarà bene precisare, per finire e venire all’analisi, che l’attenzione dedicata in
questa sede al poema del Trissino non intende minimamente coincidere con una sua
riabilitazione, neppure parziale. Siamo abituati oggi a pensare che l’approfondimento
critico dedicato ad un autore sia sostanzialmente proporzionale al valore della sua
produzione, e ciò in termini generali è senz’altro vero e condivisibile; tuttavia, c’è anche
un altro criterio, secondario, che può determinare delle rilevanti divergenze dal primo:
l’influenza storico-letteraria. Influenza letteraria e giudizio di valore sono infatti due
aspetti che non necessariamente coincidono: un autore successivo può trovare l’opera di
un suo predecessore eccellente quanto al valore ma al contempo poco consonante con la
propria poetica o la specifica strada intrapresa, e dunque poco produttiva nell’apporto
fornito alla sua propria produzione; al contrario, egli può individuare e desumere
proficuamente molti aspetti utili per la propria opera letteraria da un altro autore la cui
opera gli paia, in sé, di scarso valore.
Proprio questo, io credo, è il caso del Tasso in rapporto ai suoi più immediati
predecessori, Ariosto e Trissino, i due autori che avevano proposto due soluzioni
nettamente divergenti per il poema narrativo e a cui il poeta sorrentino più
frequentemente fa riferimento nei suoi scritti teorici. Egli vede benissimo
l’incomparabile distanza di valore fra i loro poemi, ma al tempo stesso, nell’elaborare le
proprie scelte di poetica, bisogna riconoscere senza più reticenze e falsi pudori che è
influenzato senza alcun dubbio più dal secondo. Proprio tale influenza, come ho già
detto, è il motivo di un interesse critico verso il poema del Trissino che appare
indubbiamente esorbitante dal suo effettivo valore letterario. Da quest’ultimo punto di
vista il giudizio della tradizione critica è pienamente condivisibile e non abbisogna di
altra correzione se non forse chiarire meglio lo scarto che passa, nel Trissino, fra teoria
e prassi poetica: se egli, accanto ad alcune clamorose cantonate, ha incontestabilmente
anche delle ottime idee (quelle che in gran parte costituiranno il repertorio di
derivazione del Tasso), l’effettiva attuazione poetica risulta poi quasi sempre inadeguata
e talvolta spesso persino disastrosa. L’Italia liberata, insomma, sta benissimo là dove è
sempre stata: decisamente fuori dal canone, a impolverarsi nei recessi di qualche
biblioteca. È senz’altro un poema illeggibile: se lo si legge, non è certo per suo merito
ma per tutt’altri motivi.
Ripercorriamo dunque il nucleo narrativo portante che Trissino, seguito in ciò da
vicino dal Tasso (pur con notevoli differenze fra le due versioni del suo poema),
riprende dall’Iliade: il modulo dell’eroe necessario, ossia del guerriero il cui intervento
122
è fatalmente indispensabile al compimento dell’impresa epica. Sull’argomento costituito
da questo paradigma narrativo è stato scritto molto, soprattutto dall’omeristica:
attraverso il metodo della comparazione con altre tradizioni letterarie – in origine quella
slava, secondo la strada intrapresa da Parry e Lord 129 , poi anche altre – lo schema
fondamentale è stato individuato,
“withdrawal–devastation–return”,
nella sequenza dei tre nuclei funzionali di
ossia
1)
ritiro
dell’eroe
necessario
dal
combattimento, 2) devastazione che ne consegue in guerra per lo schieramento a cui egli
appartiene e 3) suo ritorno a risolvere la situazione di crisi determinatasi.
Gli studi comparatistici, in particolare quelli di orientamento oralista (ma anche
quella particolare forma di comparazione in absentia che è la cosiddetta neoanalisi130),
sono arrivati a ravvisare questo modulo narrativo non solo altrove nella stessa tradizione
dell’epica greca arcaica (di cui Omero, ricordiamo, è l’epigono), ma anche in tradizioni
decisamente diverse e lontane da quella greca, fino a individuarne un archetipo
narrativo indoeuropeo e persino antropologico 131 . Ciò che qui ci interessa nello
specifico, tuttavia, è proprio l’aspetto iliadico di questo modulo narrativo senz’altro
molto più ampio, come lo stesso Tasso, limitatamente alla letteratura classica, sapeva
bene132 . L’altro ovvio termine di confronto oltre ad Achille entro la mitologia e la
129
Il metodo comparatistico intrapreso da Parry nel suo incompiuto studio Ćor Huso: A Study of
Southslavic Song, in PARRY, M., The Making of the Homeric Verse: The collected Papers of Milman
Parry, edited by PARRY, A., Oxford, Clarendon Press, 1971, pp. 437-464 viene proseguito,
sviluppandolo in una direzione più marcatamente tematica che evidenzia in tutta chiarezza il modulo di
“withdrawal–devastation–return” nei poemi omerici, dal suo assistente LORD, A. B., The Singer of Tales,
Cambridge (Mass.), 1960 (trad. it. Il cantore di storie, Lecce, Argo, 2005); Lord stesso approfondirà
ampiamente l’argomento, individuando il medesimo modulo narrativo, ad esempio, nel poema
anglosassone Beowulf (Interlocking Mythic Patterns in Beowulf, in Old English Literature in Context:
Ten Essays, ed. NILES, J. D., London and Totowa, N.J.: Boydell & Brewer and Rowman & Littlefield, pp.
137-142, 178).
130
Per un quadro generale sulla neoanalisi, cfr. WILLCOCK, M. M., “Neoanalysis” In A New Companion
to Homer. Ed. by POWELL, B. and MORRIS, I., Leiden, Brill, 1997, pp. 174-89. Fra i contributi più noti
sull’argomento cfr. già PESTALOZZI, H., Die Achilleis als Quelle der Ilias. Zurich, Rentsch, 1945, ma
soprattutto KAKRIDIS, J. T., Homeric Researches. Lund, C. W. K. Gleerup, 1949 (che ne è considerato il
vero iniziatore) e KULLMANN., W., Die Quellen der Ilias. Hermes Einzelschriften, 14, Wiesbaden,
Steiner, 1960.
131
Cfr. LORD, L. M. Withdrawal and Return: An Epic Story Pattern in the Homeric Hymn to Demeter and
in the Homeric Poems, «Classical Journal», 1967 (62), pp. 241-48.; NAGY, G., The Best of the Achaeans:
Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, Baltimore, Johns Hopkins University Press,1979, pp. 72
sgg.; EDWARDS, M., Homer: Poet of the Iliad. Baltimore, Johns Hopkins University Press.1987, 61 sgg.;
NAGLER, M. N., Spontaneity and Tradition: A Study in the Oral Art of Homer, Berkeley and Los Angeles,
University of California Press,1974, pp. 131 sgg.; più in generale, cfr. Eliade, M., The Myth of the Eternal
Return: Cosmos and History. Princeton, Princeton University Press, 1971. La neoanalisi, per parte sua, ha
più volte preso in considerazione in particolare la somiglianza paradigmatica e strutturale fra la trama
dell’Iliade e la vicenda di Meleagro in essa raccontata (si può dire quasi en abîme), che sono appunto due
realizzazioni del medesimo modulo narrativo di “withdrawal-devastation-return”: cfr. ad es. KAKRIDIS, J.
T., Homeric Researches, cit., pp. 11-42 e 127-48.
132
Cfr. TASSO, Lettere, ed. Guasti, n. 51 (1576), p. 125 (A Scipione Gonzaga): «[…] sì che si potrà
raccogliere da alcun mio verso ch’altrettanto fosse necessario a l’impresa Goffredo, quanto Rinaldo; ma
l’uno era necessario come capitano, l’altro come esecutore. Né questa necessità di due è cosa nova ,
123
letteratura greche, che è naturalmente Filottete, mostra in tutta evidenza una rilevante
specificità della forma che il modulo prende nell’Iliade: nella tragedia sofoclea
l’allontanamento dell’eroe dall’impresa bellica dipende da un caso fortuito, il morso di
un serpente, ed è per di più decretato appunto dalla collettività dei compagni d’armi,
sancita dall’ordine degli Atridi e dall’esecuzione di Odisseo, contro la volontà dell’eroe
(che è abbandonato sull’isola di Lemno a tradimento133); quanto all’Achille omerico,
invece, l’allontanamento dipende specificamente da un conflitto con l’autorità
(Agamennone) da cui deriva una scelta autonoma e volontaria dell’eroe, che si ritira
proprio in conseguenza di tale conflitto e del trattamento disonorevole ricevuto. Vero è
che Filottete, al pari Achille, sviluppa un radicato odio in particolare contro i vertici
della gerarchia bellica achea, ma tale odio è conseguenza del suo abbandono forzato
della spedizione troiana134, non già la sua causa, com’è invece per Achille. Come si
vede, dunque, carattere distintivo e specifico del ricorso al modulo dell’eroe necessario
per come esso viene utilizzato nell’Iliade (in parallelo a quanto avviene per la vicenda
di Meleagro narrata nell’ambasceria di Iliade IX come exemplum e monito all’eroe
irato) è appunto il suo innesco di natura apertamente conflittuale, originante da un
contrasto interno fra il capo militare e il guerriero più forte.
Proprio questo carattere conflittuale è assolutamente centrale tanto nella ripresa
trissiniana quanto in quella tassiana, appunto in quanto mediata dal Trissino: il conflitto
interno al medesimo schieramento bellico viene desunto come elemento portante e
imprescindibile, e variamente reinterpretato fondendolo indissolubilmente con le
rispettive specificità dei nuovi poemi rinascimentali. E se in Omero il conflitto si
svolgeva tutto all’interno di un universo valoriale condiviso, che è anzi in sostanza la
vera causa del conflitto proprio in quanto origina dalla violazione di tali valori
condivisi, indiscutibili e perfino identitari, al contrario sia in Trissino che, sul suo
esempio, in Tasso il conflitto prende invece una dimensione specificamente esorbitante
perchè a l’espugnazion di Troia erano necessari Pirro e Filottete. Onde nel Filottete di Sofocle
dimandando Neottolemo ad Ulisse: Come dici tu, che Filottete sia necessario a quest’espugnazione? non
son io colui ch’ha da distrugger Troia? – risponde Ulisse: Né tu puoi distruggerla senza lui, né egli senza
te».
133
SOFOCLE, Filottete, 271-275: TÒt' ¥smeno… m' æj eἶdon ™k polloà s£lou / eÛdont' ™p' ¢ktÁj ™n
kathrefe‹ pštrJ, / ·£kh proqšntej bai¦ ka… ti kaˆ bor©j / lipÒntej õconq', oŒa fwtˆ dusmÒrJ /
™pwfšlhma smikrÒn· oŒ' aÙto‹j tÚcoi (trad.: « Quel giorno! Fu festa, per loro, vedermi dormire in
seguito al gran navigare, sulla scogliera, in un buco di roccia: se ne andarono, lasciandomi due stracci,
della carne cruda. Ristoro da poco, proprio per uno segnato da un dio. L’auguro a loro! »).
134
Cfr. ad es. SOFOCLE, Filottete, vv. 314-316: Toiaàt' 'Atre‹da… m' ¼ t' 'Odussšwj b…a, / ð pa‹,
dedr£kas', oŒ' 'OlÚmpioi qeoˆ / do‹šn pot' aÙto‹j ¢nt…poin' ™moà paqe‹n (trad.: «Vedi, ragazzo gli
Atridi m’hanno fatto questo, e quell’Odisseo, il forte! Figlio, lo facciano a loro un regalo così gli dèi
olimpi, male che mi ripaghi del male! »).
124
proprio dai valori condivisi e, in breve, dall’ideologia: il capo e il guerriero necessario
non sono più, semplicemente, prevaricatore e parte lesa come Agamennone e Achille,
ma divengono, dal momento dell’insorgere del conflitto, i portatori e in parte addirittura
i rappresentanti di due sistemi valoriali contrapposti e irriducibili. Come è stato
sottolineato ampiamente per Tasso e solo sporadicamente per Trissino (che invece è il
vero ideatore di questa radicale novità rispetto a Omero), le due parti in causa nel
conflitto vengono a rappresentare l’una l’ideologia bellica collettiva, epica,
dell’assoggettamento dell’individualità e dell’emotività alla causa comune, l’altra
invece l’ideologia cavalleresca più individualistica, di matrice arturiana, romanzesca,
responsabile di un auto-allontanamento dalla guerra che non può non configurarsi –
indipendentemente dalla fondatezza delle sue motivazioni – come un sostanziale
tradimento de facto della causa e dell’ideologia ad essa soggiacente. Non è forse
superfluo ricordare che sono del tutto assenti nell’Iliade non solo, naturalmente, la
contrapposizione valoriale (e tanto più quella di genere letterario che ne è matrice) fra il
capo e il guerriero necessario, ma persino una qualsiasi alterità culturale o ideologica fra
i due schieramenti bellici contrapposti. Perentoriamente ribadita da Achille irato è la
motivazione del tutto privata – dunque né collettiva, né tanto meno ideologica –
presupposta dalla spedizione greca contro i troiani, verso i quali egli non ha
personalmente alcuno specifico motivo di rancore:
oÙ g¦r ™gë Trèwn ›nek' ½luqon a„cmht£wn
deàro machsÒmenoj, ™peˆ oÜ t… moi a‡tio… e„sin·
oÙ g¦r pèpot' ™m¦j boàj ½lasan oÙδὲ mὲn †ppouj,
oÙdš pot' ™n Fq…V ™ribèlaki bwtiane…rV
karpÕn ™dhl»sant', ™peˆ Ã m£la poll¦ metaxÝ
oÜre£ te skiÒenta q£lass£ te ºc»essa·
(Iliade, I, vv. 153-156)135
Benché subordinato all’anax andron Agamemnon nelle gerarchie della spedizione
militare, Achille non è affatto un suo suddito ma un suo pari, che gli obbedisce soltanto
in virtù di un accordo circostanziato e circoscritto alla singola situazione al quale egli
aderisce per sua volontà, e da cui per sua volontà può parimenti ritirarsi. Non si può dire
certo lo stesso né per il Rinaldo della Gerusalemme tassiana né per il suo predecessore,
il Corsamonte dell’Italia liberata: il primo deve un’obbedienza incondizionata,
attraverso il capo militare che la rappresenta, a una causa ideologica che non tollera
135
Trad.: « Non sono venuto qui a causa dei guerrieri troiani, / per combatterli; non mi hanno fatto niente
di male, / non mi hanno portato via le vacche e neanche i cavalli, / non hanno distrutto i raccolti della
fertile Ftia, / madre d’eroi – tanti monti ombrosi ci sono in mezzo, / e il mare rumoreggiante ».
125
compromessi, quella della fede religiosa; il secondo è subordinato al capo militare
Belisario in quanto rappresentante e vicario dell’imperatore Giustiniano, cui deve
l’obbedienza di un suddito – benché principe degli Sciti – al proprio sovrano, secondo
un’ideologia imperiale che è l’aspetto tematico su cui più si è insistito nella scarna
attenzione critica rivolta al poema trissiniano136. Se dunque Achille, ritirandosi, non è
certamente colpevole di nulla 137 (sarà accusata, peraltro genericamente di crudeltà,
soltanto la sua ostinazione di fronte alla sventura dei suoi), non si può dire lo stesso né
di Corsamonte né di Rinaldo, che nel ritirarsi dal combattimento rinnegano i rispettivi
sistemi valoriali di riferimento ideologici e collettivi – la causa cristiana e l’ideologia
imperiale – in nome di un’alterità individualistica con essa inconciliabile. La colpa sarà
scontata da entrambi: dal primo direttamente, con il pentimento religioso sancito dal
rituale di espiazione impostogli dall’Eremita; dal secondo indirettamente – entro gli
equilibri strutturali dell’opera – con la morte a cui l’autore lo destina, esito del perdurare
della sua deviante causa privata (l’amore per Elpidia) anche dopo la reintegrazione
nell’esercito.
Già questo principale nucleo derivato dall’Iliade mostra dunque, a un primo
livello generalissimo, sia un’affinità di fondo col modello proprio nel suo costituirsi,
anche nei poemi del Trissino e del Tasso, come uno degli assi portanti della struttura
complessiva di quelle opere, ereditandone innanzitutto la funzione di conflitto interno
all’esercito da cui dipendono le sorti della guerra, sia anche una clamorosa divergenza e
innovazione, consistente nella risemantizzazione di tale conflitto in termini di
un’opposizione ideologica cui si sovrappone un’ulteriore opposizione fra generi letterari
che la veicolano e la rappresentano (epos vs romanzo).
Un’ultima precisazione su questo punto prima di venire al testo: abbiamo
ampiamente evidenziato, nel capitolo sul romanzesco in Trissino, come l’Italia non
soltanto conceda al romanzesco ampio spazio e una rilevantissima funzione strutturale
136
Cfr. soprattutto ZATTI, S., L’ombra del Tasso, cit., capp. 3.2, La contestazione “politica” del romanzo
e 3.3, Un’utopia restauratrice, pp. 73-87.
137
Esplicita la sanzione di Fenice nell’ambasceria ad Achille, Iliade IX, vv. 515-523: e„ mὲn g¦r m¾
dîra fšroi t¦ d' Ôpisq' Ñnom£zoi / 'Atreΐdhj, ¢ll' a„ὲn ™pizafelîj calepa…noi, / oÙk ¨n œgwgš
se mÁnin ¢porr…yanta kelo…mhn / 'Arge…oisin ¢munšmenai catšous… per œmphj· / nàn d' ¤ma t'
aÙt…ka poll¦ dido‹ t¦ d' Ôpisqen Øpšsth, / ¥ndraj δὲ l…ssesqai ™piprošhken ¢r…stouj /
krin£menoj kat¦ laÕn 'AcaiϊkÒn, o† te soˆ aÙtù / f…ltatoi 'Arge…wn· tîn m¾ sÚ ge màqon
™lšgxVj / mhδὲ pÒdaj· prˆn d' oÜ ti nemesshtÕn kecolîsqai. (Trad.: « Se il figlio di Atreo non ti
portasse dei doni, / se non ne promettesse altri, ma sempre avesse ira e furia, / non io ti consiglierei di
deporre la collera / e di aiutare i Greci, benché ne abbiano tanto bisogno. / Ma ti dà molte cose subito, ed
altre per il futuro / te ne promette, ed ha scelto per supplicarti i migliori / dell’esercito acheo, quelli che
anche a te sono / i più cari fra i Greci: non disprezzare la loro / venuta e la loro parola. Fin qui la tua ira /
non meritava biasimo »).
126
che il Tasso saprà cogliere e riprendere, ma anche come questa rifunzionalizzazione del
romanzo entro un contesto epico sia mediata appunto dalla ripresa del modulo dell’eroe
necessario dall’Iliade. La vulgata critica ci ha portati a ritenere che l’introduzione del
romanzo nell’epos attraverso la contesa di matrice iliadica fra Rinaldo e Goffredo, a
veicolare un’opposizione narrativa ma al contempo anche ideologica, sia geniale
intuizione tassiana. Al contrario, non si crede di fare minimamente torto alla grandezza
del Tasso, liberando il giudizio sul suo capolavoro dai pregiudizi dell’estetica romantica
del genio e dell’originalità, nel riconoscere che l’ideatore di questa contaminazione
generica e delle sue implicazioni ideologiche è senz’altro il Trissino. Merito del Tasso è
non l’inconsistente pregio dell’heuretés, non suo, ma quello vero e sostanziale del
poietés, che come già Aristotele ci insegna è tale anche quando non inventa ciò che pure
crea138. L’idea, insomma, non è tassiana, ma è il Tasso e non certo il Trissino a farne un
capolavoro.
Ripercorriamo dunque le tre fasi in cui il modulo narrativo di “withdrawal–
devastation–return” si articola, cercando di evidenziare in opposizione a Omero –
secondo la metodologia sopra esposta – le specifiche strategie significative nuove messe
in atto dal Trissino, e poi anche la loro successiva influenza nell’ulteriore ripresa e
rielaborazione del Tasso.
138
ARTISTOTELE, Poetica, 1451b, 29-32: k¨n ¥ra sumbÍ genÒmena poie‹n, oÙqὲn Âtton poiht»j ™sti·
tîn g¦r genomšnwn œnia oÙd n kwlÚei toiaàta eἶnai oŒa ¨n e„kÕj genšsqai [kaˆ dunat¦
genšsqai], kaq' Ö ™ke‹noj aÙtîn poiht»j ™stin (trad.: « Se gli capita di rappresentare fatti avvenuti, è
ugualmente poeta: niente impedisce infatti che tra i fatti avvenuti ce ne siano alcuni che è verosimile che
avvengano, e secondo una tale verosimiglianza ne è lui il creatore »). Il passo naturalmente si riferisce
alla diversa questione della creazione di trame originali o meno, ma nel distinguere radicalmente fra
invenzione di una vicenda narrata e creazione di legami strutturali che soli costituiscono la vera
specificità della letteratura può essere esteso anche a ciò che qui ci rigarda: quando la ripresa di un
elemento strutturale è funzionale alla creazione di una nuova struttura autonoma, che seleziona
quell’elemento e lo riutilizza in vista dei propri specifici equilibri narrativi, siamo certamente di fronte a
un fenomeno di creazione poetica.
127
128
4.1. Contesa e ritiro
Indicata già nel proemio come argomento del poema, la contesa fra Agamennone
e Achille (v. 6: ἐρίσαντε) e la conseguente ira di quest’ultimo (v. 1, mῆνιν) trova
immediata rappresentazione in apertura dell’opera: subito dopo il breve compendio
dell’immediato antefatto (la mancata restituzione di Criseide e la peste scatenata da
Apollo), la vera e propria diegesis inizia con la scena della contesa, che si estende per
buona parte del primo libro. Non così, naturalmente, nei poemi del Trissino e poi del
Tasso, dove essa costituisce sì il nucleo portante della trama, ma non più l’argomento
centrale (com’è invece nell’Iliade, almeno fino all’ “incidente” della morte di Patroclo).
Potremmo dire, per brevità, che Omero narra l’ira di Achille e dunque, di riflesso, anche
le sue conseguenze sulla guerra troiana, mentre Trissino e Tasso narrano piuttosto
un’impresa bellica (rispettivamente nella sua interezza e nel suo segmento conclusivo e
“sineddotico”) fortemente condizionata dalla contesa fra il capo dell’esercito e il suo più
forte campione. Da tale inversione assiologica fra guerra e contesa entro la struttura
narrativa e naturalmente anche ideologica dipende la riduzione dell’estensione entro il
poema del modulo di “withdrawal-devastation-return”: se nell’Iliade esso domina la
trama dal primo libro al diciannovesimo (quando avviene la riconciliazione), ma in
fondo arriva a comprendere l’intero poema se si considerano la vendetta di Patroclo e la
morte di Ettore (“figura” della sconfitta troiana) come realizzazione dell’ultima fase del
modulo (il ritorno dell’eroe), nell’Italia liberata la contesa fra Corsamonte e Belisario
ha origine solo nel libro 11 per concludersi nel 19 (o nel 21, se si considera
parallelamente anche l’aristia di Corsamonte e l’uccisione di Turrismondo in duello),
che sui 27 libri complessivi sono una parte cospicua e centrale, ma decisamente
inferiore alla totalità; in Tasso, l’estensione è similmente circoscritta ai canti 5-17 sui 20
della Liberata e ai libri 6-22 su 24 della Conquistata. Quello che nell’Iliade era
l’argomento del poema diviene insomma soltanto il nucleo principale ma non esaustivo
di un argomento nuovo e più ampio, la guerra. Ne consegue anche, almeno nelle
intenzioni, un rovesciamento nella funzione protagonistica: se il protagonismo di
Achille non gli è certo conteso da Agamennone ma semmai dal capo della parte
129
avversa, Ettore139, i due autori rinascimentali fanno del capo dell’esercito – corrispettivo
dunque di Agamennone – il loro protagonista, destinando Corsamonte e Rinaldo –
corrispettivi di Achille – al ruolo di co-protagonisti. Certamente poi l’effettivo risultato
diverge in entrambi da tale intenzione iniziale, in quanto l’identificazione emotiva si
orienta senza dubbio molto più sui due guerrieri che sui rispettivi capitani, dando
origine a un’incertezza per questa cardinale funzione testuale che, se in Trissino è solo
controproducente nel peggiorare la situazione di un Belisario già quasi impermeabile a
ogni autentico moto emozionale, in Tasso finirà invece, paradossalmente, per dare
origine a un’ambiguità inedita e ricca di fascino. In ogni caso, il ritardo nell’inizio della
contesa determina già un’evidente diversità rispetto all’Iliade, premettendo a quella una
serie di vicende che, già solo con la loro presenza, ne modificano necessariamente
l’impatto narrativo e il senso.
In Trissino, in particolare, Corsamonte ha già in precedenza subito la vicenda
paradigmatica di Ligridonia (libri IV-V), nella quale egli, incaricato insieme a Triaiano
e Achille di liberare i compagni d’arme fatti prigionieri, finisce per innamorarsi a sua
volta di Ligridonia ed essere fatto lui stesso suo prigioniero. Un traviamento dalla causa
bellica collettiva per una debolezza emotiva e privata che in tutta evidenza – tanto più
data la natura marcatamente allegorica e moralizzante dell’episodio – non può mancare
ripercuotersi anche sulla successiva contesa con Belisario: di nuovo la causa è infatti
l’amore per una donna, Elpidia, e di nuovo da una simile motivazione privata, di
mancato dominio razionale sulla propria emozionalità, discende l’allontanamento
dell’eroe dal campo e dalla causa collettiva. Già solo questo antefatto, con l’evidente
iterazione che comporta a livello narrativo e valoriale, getta su Corsamonte un’ombra,
se non negativa, quanto meno di debolezza e incapacità a dominarsi (ricordiamo i nomi
parlanti di Ligridonia e Acratia, che appunto sottolineano allegoricamente l’edonismo
colpevole e l’intemperanza), in contrapposizione all’abnegazione e alla completa
dedizione all’impresa dimostrate da Belisario (una caratterizzazione a cui il Goffredo
tassiano deve moltissimo).
D’altra parte il motivo iliadico della contesa originata da una donna subisce una
radicale rielaborazione – verso la quale di nuovo il debito tassiano è più che ingente –
che rende l’insubordinazione di Corsamonte decisamente meno giustificabile di quella
di Achille. Com’è noto, Agamennone, già resosi colpevole con la sua superba
139
Per la giusta difesa del protagonismo di Achille di fronte alla vulgata preferenza accordata ad Ettore,
cfr. PADUANO, G., Le scelte di Achille, in OMERO, Iliade, Torino, Einaudi-Gallimard, 1997, pp. IX-XLIX,
rielaborato ed ampliato in ID., La nascita dell’eroe, BUR, Milano, 2008, in particolare pp. 113 sgg.
130
ostinazione di aver causato la pestilenza diffusa da Apollo, somma colpa a colpa nel
recare affronto, per ripagarsi dell’improrogabile restituzione di Criseide, all’innocente
Achille, estraneo alla vicenda se non per aver giustamente difeso Calcante che si
limitava a rendere manifesto il volere del dio: l’offesa consiste notoriamente nel
sottrarre all’eroe la sua Briseide, precedentemente assegnatagli come gέra~, il premio
derivante dalla spartizione del bottino di guerra che entro il quadro sociale
dell’aristocrazia guerriera sancisce, sin dal nome 140 , l’onore che la collettività,
assegnandolo, riconosce a chi lo riceve. Senza negare una certa importanza anche al
rapporto emotivo che traspare in filigrana fra Achille e Briseide, è ovvio oggi per noi
che il vero motivo scatenante la reazione furiosa dell’eroe alla prevaricazione risiede
dunque nella violazione del suo onore e di conseguenza, in una “civiltà della vergogna”
com’è quella iliadica, della sua stessa identità sociale, com’è d’altronde esplicitamente
riconosciuto, in seguito, nel sunto della questione fornito dall’eroe stesso nel
lamentarsene con la madre Teti:
à g£r m' 'Atreΐdhj eÙrÝ kre…wn 'Agamšmnwn
ºt…mhsen· ˜lën g¦r œcei gšraj aÙtÕj ¢poÚraj
(Il. I, vv. 355-356)141
Certamente questa situazione, chiarita dalla moderna omeristica ma che pure, in
parte, è intuibile anche solo dalla lettura, non era altrettanto chiara al lettore
cinquecentesco, che di conseguenza tendeva ad esagerare l’aspetto della contesa per una
donna, quindi implicitamente amorosa o comunque legata al possesso sessuale: senza
dubbio anche da questa matrice, che si incontra con il rilievo accordato alla tematica
amorosa e con la sua funzione diversiva nella poesia narrativa da Apollonio Rodio e
Virgilio fino al poema cavalleresco, origina la rilevante modifica alla causa scatenante
la contesa nella ripresa trissiniana del motivo iliadico. Elpidia, lontana discendente della
Briseide omerica, non è certo più possesso di Corsamonte e tanto meno premio
derivante dalla spartizione del bottino: è la principessa di Taranto di cui il cavaliere,
come molti altri con lui, si innamora, tanto da volerla in sposa:
Ma sopra tutti Corsamonte il fero
di lei s’accese, e la volea per moglie;
140
Il sostantivo condivide la stessa radice dei termini esprimenti l’idea di vecchiaia e «désigne
originellement la part d’honneur reservé au γέρων, mais le terme est devenu de bonne heure indépendent»
(Chantraine, P., Dictionnaire étymologique de la langue grecque, s. v. γέρας).
141
Trad.: « Il figlio di Atreo, il potente Agamennone, / mi ha offeso, mi ha tolto il mio premio, e se lo
tiene».
131
né il feroce Aquilin da l’altra parte
avea per lei d’amor men caldo il petto.
E così aveano Achil, Traiano e Ciro,
e tutti gli altri principi e signori,
che si trovar nel padiglione a udirla.
(Italia, VI)
L’antefatto della contesa con Belisario, dunque, consiste in una precedente
contesa amorosa, nata nel libro VI per aggiudicarsi la mano di Elpidia, alla quale
Belisario è affatto estraneo, essendo (come sarà Goffredo con Armida) uno dei pochi
che sappia resistere al suo fascino. Di fronte all’insistenza di Corsamonte Aquilino,
l’altro pretendente principale, risponde irritato:
Io son parato, Corsamonte altero,
d’essere il primo che combatta teco,
per questa nobilissima signora;
che ancora agli occhi miei le donne belle
paiono belle, e so cercar d’averle;
che la mia lancia e la mia spada punge
come la tua, sì che non ho paura
né di te, né d’altro uom che monti in sella.
(Italia, VI)
Se fosse per l’irruento Corsamonte, non si tarderebbe ad impugnare le spade:
Questo diss’egli; e Corsamonte tutto
si rodea dento di disdegno e d’ira,
e gli occhi suoi parean di fiamma ardente.
Poi disse: A che più star? vegniamo a l’arme,
proviam con esse chi è di noi più forte.
(Italia, VI)
Ma l’intervento del vecchio Paulo, affine per funzione a quello di Nestore a
tentare una mediazione fra Achille e Agamennone durante la contesa (Iliade, I), pur
senza contatti testuali evidenti, riesce a mettere momentaneamente a tacere la questione;
entrambi i due vecchi saggi, in particolare, sottolineano l’inopportunità dei contrasti
interni da cui potrebbe derivare soltanto il vantaggio del comune nemico:
Certo questo parlar non fu mai buono,
per ciò che non è ben fra noi medesmi
far così acerbe e sanguinose pruove,
le quai son da serbar contra i nimici.
(Italia, VI)
ð pÒpoi à mšga pšnqoj 'Acaiδa ga‹an ƒk£nei·
à ken ghq»sai Pr…amoj Pri£moiÒ tε pa‹dej
¥lloi te Trîej mšga kεn keχaro…ato qumù
e„ sfîϊn t£de p£nta puqo…ato marnamšnoiϊn,
o‰ perˆ mὲn boul¾n Danaîn, perˆ d᾿ ™stὲ m£cesqai.
(Iliade, I, vv. 254-258)142
142
Trad.: ««Ahimè, un grande lutto colpisce la terra di Grecia, / e saranno contenti Priamo e i figli di
Priamo, / e grande piacere ne avranno anche gli altri Troiani, / se sapranno che voi due siete in lite, / voi
che siete i primi nel consiglio dei Greci e in battaglia ».
132
La mediazione ha momentaneamente successo e le parti in causa accettano che
Elpidia sia assegnata in moglie a chi darà prove di maggior valore nel combattere contro
i Goti. Un motivo che, come abbiamo già visto, non ha più nulla a che fare con l’Iliade,
ma rimanda piuttosto alla tradizione cavalleresca (ad es. Angelica promessa in sposa,
all’inizio del Furioso, a chi fra Orlando e Rinaldo si dimostrerà più valoroso nella
battaglia contro i Mori).
Ma la scena ha anche un’altra funzione secondaria: sancire, dandogli adeguata
rappresentazione narrativa, il vincolo d’amicizia che legherà Corsamonte ad Achille, il
quale – con una scelta onomastica forse non troppo felice, ma pur significativa nel
segnalare, entro il rapporto di derivazione, una contaminazione di funzioni – è
nell’Italia il suo “Patroclo”. Egli qui, pur innamorato al pari degli altri, rinuncia
apertamente a ogni sua pretesa su Elpidia per affetto e devozione verso Corsamonte, ma
sottolineando al contempo la preminenza della causa bellica sull’emotività individuale:
…non voglio risparmiar fatica alcuna
per acquistar tant'onorato pregio;
e se per caso il ciel me ne fa degno,
ché certo mi sarà il maggior contento
ch'i' avesse mai, né ch'io potesse avere,
vorrò dar la mia sorte a Corsamonte,
poi che è sì vago e cupido d'averla:
ché sempre amato l'ho come fratello,
ed ho più cari i suoi piaceri onesti
e 'l suo verace ben che 'l mio medesmo.
(Italia, VI)
Tale gesto rinsalda e rende inviolabile la pregressa amicizia, ma ribadendo
ulteriormente al contempo – in una delle innumerevoli e insostenibili gnomai
disseminate nel poema, per un fraintendimento di Aristotele143 – la colpa deviante del
cedere alla passione amorosa, stavolta nelle parole dello stesso Corsamonte:
Però mi sforzerò non esser vinto
da te di questo sì cortese affetto:
143
Sulla γνµη il punto di riferimento per Trissino è ARISTOTELE, Retorica, 1394 a, 19 sgg. Trissino tratta
dell’argomento, proponendo una simile classificazione tipologica delle “gnomi” o “sentenzie” nella
Quinta divisione della sua Poetica, cit., p. 38 [20v]. Il fraintendimento del Trissino risiede da una parte
nell’uso abnorme che egli fa di questo antichissimo stilema poetico, tempestandone i discorsi diretti così
come la narrazione non appena si presenti la minima occsaione di inserire una conclusione sentenziosa,
dall’altra nella loro banalizzazione spesso persino estrema, che si riduce a sancire la correttezza di una
situazione contingente riconducendola al senso comune e alla norma generale di comportamento. Il suo
stesso esempio citato nel suddetto passo della Poetica rende bene l’idea del carattere lapalissiano, spesso
fino al ridicolo, delle sue “gnomi” (evocando a noi, tra l’altro, grottesche risonanze di storia politica
recente): Non deve mai dormir tutta la notte / quel che siede al governo de le genti.
133
ché chi si lascia vincere in amore
è di cuor basso, e di natura ingrata.
Così diss'egli, e da quel giorno inanzi
furo i più cari e i più leali amici
che si trovasser mai sopra la terra.
(Italia, VI)
In questo modo, dunque, mentre si dà al vincolo di amicizia tra Corsamonte e
Achille una rappresentazione che in Omero è invece, per Achille e Patroclo, molto più
esile prima che la morte del secondo la porti perentoriamente in primo piano, viene allo
stesso tempo anche delineato il diverso comportamento dei due verso la devianza
amorosa, il cui esito – conseguenza narrativa di una questione assiologica – sarà il
clamoroso rovesciamento della loro sorte rispetto all’Iliade: Corsamonte, corrispettivo
di Achille, morirà in un agguato proditorio appunto nel tentativo di liberare, al di fuori
da ogni contesto bellico, l’amata Elpidia, mentre sarà Achille, corrispettivo di Patroclo,
a sopravvivergli e vendicarlo (come appunto l’Achille omerico), non avendo ceduto alla
devianza individualistica dalla causa bellica. Invertendo la precedente corrispondenza
alla coppia di personaggi iliadici, l’assiologia positiva di cui l’amico fraterno si fa
portatore evidenziando la colpevole intemperanza dell’eroe principale motiva la
contaminazione nella derivazione dai personaggi iliadici operata da Trissino,
esplicitandola goffamente nell’ambiguità onomastica.
Ma lo scontro fra Corsamonte e Aquilino che qui è stato momentaneamente eluso,
restando però latente144, riemergerà in tutto il suo potenziale distruttivo cinque libri più
avanti, dopo la battaglia in cui Napoli viene conquistata (libro VII) e che dovrebbe aver
fornito la prova per decidere dell’assegnazione di Elpidia in moglie al più valoroso. È
solo a questo punto, nel libro XI, dopo il primo grande canto di battaglia del poema, che
il modulo iliadico dell’ira di Achille verso Agamennone trova il suo vero innesco, con
la contesa fra Corsamonte e Belisario. Nella presa di Napoli Corsamonte ha certamente
dato la maggior prova di valore fra tutti, permettendo di prendere la rocca della città, e
si è per di più conquistato il favore di Elpidia stessa uccidendo tra l’altro, in quella
battaglia, l’assassino del padre di lei e così vendicandola: la donna gli dimostra il suo
amore ricamando per lui e inviandogli una sopravveste non immemore, forse, di quella
che Fiordiligi cuce per Brandimarte prima del triplice duello di Lipadusa alla fine del
Furioso (XLI, 32). Già Belisario, che a differenza di Agamennone per Achille ha grande
affetto per Corsamonte, è propenso ad accondiscendere alle nozze assegnandogli
144
Il mediatore stesso che ha permesso la conciliazione, il “venerando Paulo”, lo nota immediatamente
(Italia, VI): «Il vecchio Paulo, poi che pur vedea / l'ira che Corsamonte avea nel petto / e la natura acerba
di Aquilino, / sì dubitava assai che queste cose /parturissero ancor qualche disconcio ».
134
Elpidia, quando Aquilino fa notare che, secondo i patti, l’assegnazione doveva seguire
alla battaglia contro l’esercito dei Goti, mentre fino ad ora lo scontro li ha visti
contrapposti semmai ai cittadini partenopei e all’esigua guarnigione gota posta a
presidio della città. Le parole arroganti e il gesto provocatorio, quasi un cavillo
avvocatesco, non possono che riportare alla luce il contrasto sopito soltanto cinque libri
prima:
Ma se dicesse alcun che Corsamonte
fece gran prove in Napoli, e che uccise
con le sue proprie mani il fier Tebaldo
facendo la vendetta di Galeso,
e che per questo è da preporlo a tutti;
rispondo lui che è ver che quel barone
non è privo di ardire e di fortezza,
ma non però mi sopravanza tanto
che mi facesse ritirare un passo.
Ei non ha più di me le man di fuoco
né il cuor di ferro, anzi noi siamo equali
di nobiltà, di grado e di fortezza:
né differenti siam molto di etade…
(Italia, XI)
Corsamonte, naturalmente, si adira con Aquilino, e la situazione getta Belisario
nell’incertezza sul da farsi. Alla fine il “capitanio”, arbitro della questione, si pronuncia
apparentemente a favore di Aquilino, che in fondo esige solo il rispetto dei patti
pregressi, nonostante il reciproco consenso di Corsamonte ed Elpidia a sposarsi; la sua
vera intenzione, che egli nasconde per evitare contrasti fra i suoi campioni, è però
segretamente favorevole a Corsamonte:
Così parlò quel capitanio eccelso;
ma ben firmato avea dentr'al suo cuore
di dir secretamente a Corsamonte
che a lui si dava l'onorata sposa,
e poi pregarlo di tener celata
questa promessa sua, per non privare
gli altri baroni ancor di quella speme;
e così volea dire anco a Favenzo:
ma la fortuna al suo pensier s'oppose…
(Italia, XI)
Appare evidente quanto il Tasso sia debitore nei confronti di questo innesco della
contesa fra capo dell’esercito e guerriero “necessario”, non diretto, ma mediato da un
precedente scontro fra commilitoni, a differenza di quanto avviene in Omero, dove lo
scontro fra Achille e Agamennone non è similmente mediato, ma sostanzialmente
diretto (ben poco a che fare ha infatti con l’impari contrasto fra Agamennone e
135
l’indovino Calcante, poi difeso da Achille: in quel caso non c’è un vero scontro fra i
due, ma solo un atto di prevaricazione sacrilega dell’Atride nei confronti di un sacerdote
di Apollo, che si limita a rendere noto il volere del dio): anche nella Gerusalemme,
infatti, la contesa fra Belisario e Rinaldo è conseguenza della precedente contesa fra
Rinaldo e Gernando (pur motivata lì da una questione d’onore e non più da una donna
contesa). Ancor più che Omero, all’epoca letto da Tasso solo in traduzione latina (come
ci è testimoniato da una copia dell’Iliade postillata dal poeta sorrentino), il punto di
riferimento principale dell’imitazione tassiana è dunque appunto il presente episodio del
Trissino. Proprio il segreto favore di Belisario per Corsamonte lascia un’evidente traccia
nella prima redazione del poema tassiano, quella risalente verosimilmente al 1565-66145:
in una breve scena successivamente eliminata, Ubaldo (il futuro Rinaldo), dopo
l’uccisione di Ernando (Gernando), ferisce mortalmente anche uno dei compagni di lui
venuti assieme ai «ministri di giustizia» per «farlo prigion»; nonostante questo ulteriore
aggravamento della colpa, al loro ritorno Goffredo, pur fingendo indignazione, in cuor
suo si rallegra del fatto che essi non siano stati in grado di eseguire l’ordine che lui, suo
malgrado, si era visto stato costretto a dare (con una dissimulazione al limite
dell’ipocrisia impensabile per il personaggio della redazione definitiva della Liberata, e
ben più vicina all’atteggiamento di Belisario nell’Italia del Trissino che non
all’archetipo omerico):
Fra vergogna e timor mesti e confusi
riportan quelli il cavaliero ucciso.
Goffredo, ancor che con rampogne accusi
la lor viltade e mostri irato il viso,
gode tacito in sé che sì delusi
tornati sian dal lor fallace aviso.
Ama l’invitto Ubaldo, e la severa
legge esseguire in lui molesto gli era.
L’irruenza di Corsamonte, tuttavia, previene il segreto proposito di Belisario a suo
favore, facendo precipitare la situazione e dando luogo allo scontro d’armi con
Aquilino:
perciò che Corsamonte, avendo udite
quelle parole, disse entr'al suo cuore:
Il capitan vuol pur ch'i' abbia pazienza,
ma non la voglio aver, perch'ella è cibo
145
I canti V (IV nel ms.), IX e XII di questa prima redazione sono riportati in appendice nell’edizione
della Liberata a cura di CARETTI, L., e furono pubblicati per la prima volta da Ignazio Angelini nel 1877,
da un manoscritto di cui Caretti non riesce più a rintracciare l’originale.
136
d'animi vili e di persone inerti;
e prima vuo' morir che mai lasciare
ad Acquilin quest'onorata donna.
E così detto dentr'a la sua mente,
avolse la sua vesta al braccio manco
e pose mano a l'affilato brando,
e ratto s'aventò verso Acquilino,
il quale anch'ei prese la spada in mano;
presela Bocco e presela Massenzo
e Mundello e Catullo e 'l bel Lucillo,
e tutti foro intorno a Corsamonte.
Nello scontro Corsamonte ferisce Aquilino – benché non mortalmente, come
invece farà Rinaldo con Gernando – prima che i due contendenti siano separati. Il grave
gesto di aperta insubordinazione, per di più avvenuto alla presenza del capitano e
vicario dell’imperatore (a differenza di quanto accade in Tasso), non può che portare
allo sdegno del capitano stesso e al suo dovere di punire l’irruento guerriero. La
punizione consiste precisamente nel capovolgere il favore iniziale e negare al solo
Corsamonte la mano di Elpidia: il parallelismo con la sottrazione di Briseide ad Achille
è palese, ma tuttavia solo parziale. Innanzitutto, infatti, in Trissino si tratta non di una
prevaricazione del tutto arbitraria – che anzi colpisce un gesto dell’eroe, quello di
proteggere il diritto di parola del sacerdote, che rientra senz’altro nella categoria
positiva dell’eÙsέbeia –, ma è l’improrogabile castigo dovuto a una colpa palese e
incontestabile, per quanto causata da motivazioni non infondate; inoltre, il tema
amoroso, secondario e marginale nell’Iliade rispetto alla sottrazione del γέρας, balza qui
perentoriamente in primo piano, con tutte le sue connotazioni assiologiche negative
evocate dal precedente dell’episodio allegorico di Ligridonia e Acratia e dalle parole di
Achille e Corsamonte stesso che abbiamo appena ricordato.
La centralità del tema amoroso come elemento negativo e inibitorio contrapposto
al necessario compiersi del telos epico, si richiama naturalmente a un’importante
tradizione epica, ma stavolta non iliadica: Calipso e Circe nell’Odissea, Medea in
Apollonio, Didone nell’Eneide, fino ad arrivare alle incantatrici dei romanzi (l’Alcina
ariostesca in primis). È tuttavia idea originale del Trissino legare la connotazione
negativa e impediente dell’eros al motivo iliadico della contesa fra Achille e
Agamennone e al modulo del guerriero necessario. Se ne gioverà naturalmente il Tasso,
che riprodurrà lo stesso legame tra la funzione di disturbo all’impresa operata da
Armida e l’allontanamento di Rinaldo dal campo: questo prima indirettamente nella
scena parallela a quella che stiamo analizzando, dove la contesa fra Rinaldo e Gernando
è istigata dall’innamoramento non di Rinaldo stesso ma di Eustazio, e poi anche
137
direttamente nell’ozio amoroso di Rinaldo prigioniero di Armida e dimentico della
causa crociata. Come abbiamo già notato, Armida verrà a unificare in sé la diversa
caratterizzazione, pur nella simile funzione deviante, di Ligridonia e di Elpidia in
Trissino, riducendo a unità quella che nell’Italia risulta un’evidente duplicazione
strutturale che, pur non essendo mera ripetizione, è comunque senz’altro
sovrabbondante: dalla prima il personaggio tassiano desume il carattere doloso e
malevolo del suo intervento, dalla seconda il sincero innamoramento reciproco che la
lega, dopo l’odio iniziale, al campione dell’esercito, e che darà luogo a quel capolavoro
dell’estetica dell’imitatio che è il XVI canto della Liberata.
A causa della netta la differenza situazionale rispetto all’Iliade, così come della
radicale diversità di caratterizzazione dei due personaggi coinvolti nella contesa, i
rapporti con la grande scena iniziale della lite fra Achille e Agamennone, che si estende
per circa duecento esametri, si riduce in Trissino a una manciata di versi, che non
presentano tra l’altro evidenti rapporti testuali con Omero. L’autore vicentino elimina
anzi qualsiasi esplicita lite fra Belisario e Corsamonte: il capitano, infatti, sdegnato dal
comportamento dell’altro, si limita ad enunciare la sua condanna, sottolineandone
peraltro la scarsa severità in confronto alla gravità del gesto compiuto:
Ma Belisario con feroce aspetto
si volse inverso Corsamonte e disse:
«Baron, superbo e senz'alcun rispetto,
non ti vuo' dar la pena che tu merti
per questo error, da cui non è mancato
di por tutto l'essercito in scompiglio,
che ben è noto a tutto quanto il stuolo
ch'esser devrebbe l'ultimo supplizio:
ma sol ti vuo' punir con questa nota,
ch'io ti trarrò del numero di quelli
che deggian prender l'onorata moglie
ch'ha in dote il principato di Tarento».
(Italia, XI)
Corsamonte, di fronte alla condanna, non apre neppure bocca, e si limita a
ritirarsi, con la coda fra le gambe:
Quando il gran duca udì queste parole,
restò tutto confuso entr'al suo petto;
e poi si dipartì tacito e mesto
col cuor pensoso e gli occhi a terra fissi,
e 'n compagnia del suo fedele Achille
con passi lenti andò verso l'albergo.
(Italia, XI)
138
Non potrebbe apparire maggiore la differenza rispetto all’ira minacciosa con cui
Achille, dopo l’intervento di Atena e la rassegnazione ad obbedire alla prevaricazione di
Agamennone, prospetta la sua sanguinaria reazione di fronte a ulteriori prevaricazioni
che in realtà nessuno ha neppure immaginato di compiere:
¥llo dš toi ™ršw, sÝ d᾿ ™nˆ fresˆ b£lleo sÍsi·
cersˆ mὲn oÜ toi œgwge mac»somai e†neka koÚrhj
oÜte soˆ oÜtš tJ ¥llJ, ™pe… m' ¢fšlesqš ge dÒntej·
tîn d' ¥llwn ¤ mo… ™sti qoÍ par¦ nhῒ mela…nV
tîn oÙk ¥n ti fšroij ¢nelën ¢škontoj ™me‹o·
e„ d᾿ ¥ge m¾n pe…rhsai †na gnèwsi kaˆ oŒde·
aἶy£ toi aŒma kelainÕn ™rw»sei perˆ dour….
(Iliade, I, 297-303)146
Serba invece traccia evidente della minaccia dell’eroe iliadico il punto
corrispettivo della Liberata, nelle parole di Rinaldo:
Ma s'a i meriti miei questa mercede
Goffredo rende e vuol impregionarme
pur com'io fosse un uom del vulgo, e crede
a carcere plebeo legato trarme,
venga egli o mandi, io terrò fermo il piede.
Giudici fian tra noi la sorte e l'arme:
fera tragedia vuol che s'appresenti
per lor diporto a le nemiche genti.
(Liberata, V, 43)
Soltanto a questo punto, dopo la breve contesa fra Belisario e Corsamonte (se pure
le si può dare questo nome), la ripresa soltanto funzionale della scena d’apertura iliadica
– per di più con tutte le rilevanti divergenze che abbiamo evidenziato – si trasforma in
una ripresa anche testuale. Segue infatti la scena del lamento di Corsamonte alla
presenza dell’amico Achille, modellata ben più da vicino sul lamento di Achille con la
madre Teti subito dopo la lite con Agamennone. Dapprima il guerriero, parlando fra sé e
sé, prende la risoluzione di abbandonare il campo in cerca d’altra ventura, in perfetto
parallelismo con quanto farà anche il Rinaldo tassiano:
Ben fu tropo crudel la sua sentenza
e troppo ingiusta, a non voler ch'ell'abbia
per suo consorte un uom che le talenti,
e voler che Acquilin governi 'l tutto.
Deh non star Corsamonte in questo campo
ove non si dà premio a la virtute,
146
Trad.: « E mettiti bene in testa quello che dico: / per la ragazza non combatterò con te, né con altri; /
voi me l’avete data e voi la togliete. / Ma di tutto il resto che è mio presso la nave rapida, / non prenderai
nulla contro la mia volontà. / Provaci dunque, e lo sapranno anche questi: / subito sangue nero sprizzerà
intorno alla mia lancia ».
139
ma proccàcciati pur d'altra ventura!
Perciò che quel baron che cerca onore
non dee mai dimorar sotto 'l governo
d'un capitan volubile ed ingiusto.
(Italia, XI)
Parte, e porta un desio d'eterna ed alma
gloria ch'a nobil core è sferza e sprone;
a magnanime imprese intent'ha l'alma,
ed insolite cose oprar dispone:
ir fra i nemici, ivi o cipresso o palma
acquistar per la fede ond'è campione,
scorrer l'Egitto, e penetrar sin dove
fuor d'incognito fonte il Nilo move.
(Liberata, V, 52)
Mentre Corsamonte si sta già armando per partire, sopraggiunge l’amico Achille,
dando luogo a una scena che costituisce il tramite e potremmo dire la versione
intermedia fra il lamento dell’Achille omerico con Teti dopo la contesa con
Agamennone e il discorso di Tancredi a Rinaldo prima della sua partenza dal campo:
Vi sopragiunse l'onorato Achille,
e disse a lui parlando este parole:
Diletto mio fratel, che cosa è questa?
Io veggio apparecchiati al dipartire
senza far motto al tuo fedele Achille
che t'ama e caro t'ha più che se stesso?
Parla, non mel celar; fa ch'ancor io
conosca la cagion del tuo vïaggio;
che come non sta ben dar fede a tutti,
così sta mal non si fidar di alcuno.
Questo diss'egli; e Corsamonte a lui:
A che debbio ridir quel che m'offende
s'e' t'è palese, e se vedesti il tutto?
Ma se ti cal di me, come son certo,
monta a cavallo, e dipartianci insieme
da questa gente perfida ed ingrata,
che arà bisogno ancor del nostro aiuto
quando da i Gotti fia cacciata e vinta:
alor mi cercheran ne i lor sermoni,
dannando seco la vergogna e l'onta
che mi fan ora, e chiamerammi indarno.
Così parlaro, e s'accordaron tosto
quei dui summi baroni al dipartirsi.
(Italia, XI)
karpal…mwj d' ¢nšdu poliÁj ¡lÕj ºät' Ñm…clh,
ka… ·a p£roiq' aÙto‹o kaqšzeto d£kru cšontoj,
ceir… tš min katšrexen œpoj t' œfat' œk t' ÑnÒmaze·
tšknon t… kla…eij; t… dš se fršnaj †keto pšnqoj;
™xaÚda, m¾ keàqe nÒJ, †na e‡domen ¥mfw.
T¾n dὲ barÝ sten£cwn prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj·
οἶsqa· t… ½ toi taàta „du…V p£nt' ¢goreÚw;
[…]
tîn nàn min mn»sasa paršzeo kaˆ laβὲ goÚnwn
a‡ kšn pwj ™qšlVsin ™pˆ Trèessin ¢rÁxai,
toÝj dὲ kat¦ prÚmnaj te kaˆ ¢mf' ¤la œlsai 'AcaioÝj
kteinomšnouj, †na p£ntej ™paÚrwntai basilÁoj,
gnù dὲ kaˆ 'Atre dhj eÙrÝ kre…wn 'Agamšmnwn
¿n ¥thn Ó t' ¥riston 'Acaiîn oÙdὲn œtisen.
(Iliade, I, vv. 359-412)147
147
Trad.: « Subito emerse dal mare bianco, come la nebbia, / e si sedette accanto a lui che piangeva, / lo
accarezzò con la mano, e gli disse: / “Figlio mio, perché piangi? Quale pena ti ha invaso il cuore? / Parla,
non nasconderla dentro di te, anch’io la voglio sapere”. / Le rispose, profondamente gemendo, il veloce
Achille: / «Lo sai; perché dirtelo se sai già tutto? […] Ricordagli questo, e siedigli accanto e abbracciagli
le ginocchia, / pregandolo di prestare aiuto ai Troiani / e ricacciare i Greci verso le navi ed in mare, /
facendone strage, perché se lo godano tutti il loro re, / e capisca il figlio di Atreo, il potente Agamennone,
/ la sua colpa, di non avere onorato il migliore dei Greci ».
140
Al lamento dell’eroe omerico con la dea madre si sostituisce quello con il
compagno d’armi e più intimo amico: il Tasso riprenderla la stessa sostituzione,
introducendo l’ulteriore modifica di porre in secondo piano anche la recriminazione
verso il comportamento del capitano in favore degli accorti consigli che Tancredi
dispensa a Rinaldo. Traccia di un ulteriore riavvicinamento al Trissino si avrà poi nella
riscrittura della Conquistata (VI, 81-84), dove Ruperto – il fraterno amico di cui l’eroe è
qui dotato sull’esempio dell’Achille trissiniano e del Patroclo omerico – vorrebbe unirsi
all’esilio del compagno, ma la sua proposta è cortesemente rifiutata dall’interessato:
Ruperto, d’altronde, è destinato infatti ad essere in seguito il protagonista della
richiamata dell’eroe al campo, sostituendosi al Carlo della Liberata.
Lungi dall’essere una mera “copia” di Omero, la scena trissiniana della contesa fra
Corsamonte e Belisario mostra di rielaborare il suo ipotesto con notevole autonomia,
riducendo peraltro i contatti testuali davvero evidenti a pochi punti circoscritti su un
episodio che occupa sostanzialmente un libro intero; ma quel che più conta è che
introduce delle divergenze notevoli rispetto alla situazione iliadica, che saranno seguite
molto da vicino dal Tasso per la parallela contesa fra Rinaldo e Goffredo. In particolare,
a differenza dell’Achille omerico, che è solo vittima di una prevaricazione da imputare
interamente ad Agamennone, tanto il Corsamonte dell’Italia quanto il Rinaldo della
Liberata si rendono responsabili di una grave colpa, l’uno violando apertamente
l’ordine e la maestà di colui che rappresenta l’imperatore, l’altro addirittura versando
sangue cristiano. Naturalmente, entrambi hanno delle parziali giustificazioni e
attenuanti, tali da permettere loro di percepirsi come parte offesa e di ritirarsi dal
combattimento, innescando così il modulo narrativo dell’eroe necessario. Ma tale
colpevolezza che tanto li differenzia da Achille ha, come abbiamo accennato delle
rilevanti conseguenze strutturali, poiché conferisce in entrambi i casi una dimensione
ideologica ad un conflitto che, nell’ipotesto iliadico, aveva invece una dimensione
soltanto emotiva, svolgendosi interamente all’interno di valori egualmente condivisi
dalle due parti contendenti. Il modulo dell’eroe necessario non è introdotto come mero
ossequio al modello illustre, ma è strumentale all’introduzione nella trama – oltre che di
un fondamentale impedimento diversivo del telos epico – di una polarizzazione di valori
a livello ideologico: in Trissino l’ideologia imperiale opposta alle deviazioni
individualistiche, legate in particolare alla tematica erotica; in Tasso un simile
individualismo, vittima della debolezza di fronte all’amore, si contrappone invece
(chiaramente con ben altri esiti artistici) all’ideologia collettiva della causa cristiana.
141
Nella rielaborazione di Omero non manca, certo, il dato della correzione del
“costume”, ma il suo peso non dev’essere troppo ingigantito: le motivazioni che
guidano la riscrittura sono innanzitutto di ordine strutturale, volte ad introdurre
divergenze del tutto autonome negli sviluppi successivi della contesa e nel loro influsso
determinante sull’intero corso della trama, come vedremo ora. Il Tasso, ad esempio, nel
suo Giudicio sovra la Gerusalemme riformata148 afferma esplicitamente:
da me fu schivato il soverchio de l’ira di Riccardo, come si dee schivare ne la musica il sovrano, o
altra voce, che da l’altre discordando, sola quasi si faccia sentire ed empia di strepito gli orecchi degli
ascoltanti [Giudicio, II, p. 131]
Un simile intervento correttivo è chiaramente ravvisabile sia nella Gerusalemme,
sia nell’Italia liberata, ma come abbiamo visto il suo intento primario non è tutelare la
maestà del capitano ed evitare gli eccessi di Achille in Corsamonte o Rinaldo/Riccardo,
bensì, tutt’al contrario, gravare i due guerrieri di una colpevolezza ideologicamente
connotata di cui l’eroe omerico è del tutto scevro. D’altronde, sarebbe bene ricordare
che sull’importanza del carattere e del costume, che gli studi rinascimentalisti tendono
senz’altro a sopravvalutare, guardando spesso più alla teoria letteraria cinquecentesca
che non alla corrispettiva prassi poetica, proprio la Poetica di Aristotele che costituisce
il punto di riferimento della questione, in un’osservazione sulla tragedia come di
consueto estendibile all’epica, è perentoriamente chiara nel negare la preminenza
dell’ethos sulla trama e la struttura narrativa dell’opera (1450a, 16-33):
¹ g¦r tragJd…a m…mhs…j ™stin oÙk ¢nqrèpwn ¢ll¦ pr£xewn kaˆ b…ou [kaˆ eÙdaimon…a kaˆ
kakodaimon…a ™n pr£xei ™st…n, kaˆ tÕ tšloj pr©x…j tij ™st…n, oÙ poiÒthj· e„sˆn dὲ kat¦ mὲn t¦
½qh poio… tinej, kat¦ dὲ t¦j pr£xeij eÙda…monej À toÙnant…on]· oÜkoun Ópwj t¦ ½qh mim»swntai
pr£ttousin, ¢ll¦ t¦ ½qh sumperilamb£nousin di¦ t¦j pr£xeij· éste t¦ pr£gmata kaˆ Ð màqoj
tšloj tÁj tragJd…aj, tÕ dὲ tšloj mšgiston ¡p£ntwn. œti ¥neu mὲn pr£xewj oÙk ¨n gšnoito
tragJd…a, ¥neu dὲ ºqîn gšnoit' ¥n· aƒ g¦r tîn nšwn tîn ple…stwn ¢»qeij tragJd…ai e„s…n, kaˆ
Ólwj poihtaˆ polloˆ toioàtoi, oŒon kaˆ tîn grafšwn Zeàxij prÕj PolÚgnwton pšponqen· Ð mὲn
g¦r PolÚgnwtoj ¢gaqÕj ºqogr£foj, ¹ dὲ ZeÚxidoj graf¾ oÙdὲn œcei Ãqoj. œti ™£n tij ™fexÁj qÍ
·»seij ºqik¦j kaˆ lšxei kaˆ diano…v eâ pepoihmšnaj, oÙ poi»sei Ö Ãn tÁj tragJd…aj œrgon, ¢ll¦
polÝ m©llon ¹ katadeestšroij toÚtoij kecrhmšnh tragJd…a, œcousa d màqon kaˆ sÚstasin
pragm£twn149.
148
TASSO, T., Giudicio sovra la Gerusalemme riformata, a cura di GIGANTE, C., Roma, Salerno editrice,
2000.
149
Trad.: « Perché la tragedia non è imitazione di uomini, ma di azioni e di vita. Non si agisce dunque per
imitare i caratteri, ma si assumono i caratteri in dipendenza delle azioni, di modo che gli eventi e la trama
sono il fine della tragedia, e il fine è la cosa determinante. Inoltre senza azione non può esservi tragedia,
mentre senza caratteri potrebbe: in effetti le tragedie di molti poeti più recenti sono senza caratteri: ci
sono molti poetti di questo tipo, che si trovano nella stessa posizione di Zeusi rispetto a Polignoto:
Polignoto infatti è un buon pittore di caratteri, mentre la pittura di Zeusi ne è totalmente priva. Anche se si
mettono in bell’ordine discorsi morali, ben costruiti nella dizione e nel pensiero, con ciò non si realizza
l’effetto della tragedia; molto più lo realizza una tragedia carente sotto questi aspetti, ma che possiede una
trama e una sistemazione degli eventi ».
142
La centralità della nuova (rispetto a Omero) colpevolezza dell’eroe nei confronti
del capo dell’esercito piuttosto che della correzione del “costume” si fa del tutto
evidente – come ho mostrato altrove – nel passaggio dalla Liberata alla Conquistata: in
un importante riavvicinamento al Trissino e ad Omero, lo scontro diretto fra Riccardo e
Goffredo, che nella prima versione del poema era accuratamente evitato, lì torna ad aver
luogo, accentuando decisamente il grado di colpevolezza dell’eroe nei confronti del
capitano e di ciò che egli rappresenta; in questo modo, si rendono possibili una serie di
rilevantissime modifiche strutturali, che interessano il modulo dell’eroe necessario nel
suo complesso e dunque, di riflesso, l’intera trama dell’opera.
143
144
4.2. Devastazione
Nel capitolo sul romanzesco abbiamo già messo ampiamente in luce la
connessione ordita dal Trissino, e poi ripresa dal Tasso, tra la fase di assenza dell’eroe,
in cui la sua fatale necessità al compimento dell’impresa si fa avvertire fino all’estremo
dal suo schieramento attraverso la devastazione che esso subisce a causa della sua
assenza, e l’inserimento nella trama dell’elemento diversivo di natura narrativa e
strutturale ma al contempo anche ideologica. Come vedremo, tuttavia, l’elemento di
diversione così introdotto non va identificato integralmente con il romanzesco, come la
critica tassiana ci ha abituati a ritenere con una semplificazione forse troppo rigida: la
tradizione epica già antica possiede essa stessa degli elementi diversivi suoi propri che
differiscono il compimento del telos, e che con il romanzesco non hanno niente a che
fare, ma rivelano appunto un carattere a tutti gli effetti epico (tanto da essere diventati
spesso, dopo Omero, dei veri e propri topoi della poesia epica). Il Trissino, nella fase di
“devastazione” durante l’assenza di Corsamonte dal campo di battaglia, si serve appunto
di entrambi i generi di diversione narrativa, sia quelli di natura romanzesca che quelli di
natura epica. Su questi ultimi, che pure hanno senz’altro un ruolo preminente,
torneremo fra poco: per ora soffermiamoci ancora brevemente su quelli di natura
romanzesca, che costituiscono naturalmente l’aspetto più interessante per l’influenza sul
capolavoro tassiano.
Fatto notissimo è la piena consapevolezza con cui il Tasso asserve il riuso del
modulo iliadico dell’eroe necessario all’introduzione del “diletto” romanzesco, secondo
quanto è esplicitamente testimoniato negli scritti teorici nel poeta, come ad esempio in
una lettera a Silvio Antoniano, uno dei revisori romani:
Stimo bene all’incontro di non essermi senza alcun pericolo dilungato nelle vestigie degli antichi
in quello che giudiziosamente è avvertito da Vostra Signoria, cioè nel conceder troppo a Rinaldo. E certo
io ho sempre dubbitato che così sia: pur io m’indussi a far tanto principale questa seconda persona, non
solo per quell’artificio cortigiano il quale è sì conosciuto da lei; ma ancora perché volendo io servire al
gusto de gli uomini presenti, cupido molto dell’aura populare, né contento di scrivere ai pochissimi,
quando ancora tra quelli fosse Platone, non sapea come altramente introdurre nel mio poema quella
145
varietà e vaghezza di cose, la quale non è da lor ritrovata ne’ poemi antichi: che se Rinaldo non fosse
all’impresa necessario, oziosi mi parrebbon tutti quelli episodi ove di lui si ragiona.150
Naturalmente la “varietà e vaghezza di cose” che non si ritrova nei “poemi
antichi” è senza alcun dubbio possibile l’elemento romanzesco, la cui introduzione nel
poema è strutturalmente collegata dall’autore alla figura di Rinaldo e dunque al modulo
dell’eroe necessario a lui connesso. Decisamente meno noto è invece che tale relazione
fra la trama epica e la necessità strutturale della variatio soddisfatta attraverso
l’introduzione di episodi diversivi è in effetti non solo praticata nel suo poema, ma
anche esplicitamente teorizzata nella sua Poetica proprio dal Trissino, che di norma
invece è considerato il campione negativo della narrazione monolitica dove ogni
possibilità di varietà narrativa è sacrificata ad una (presunta) ortodossia aristotelica; al
contrario, come abbiamo già visto nel capitolo sul romanzesco, egli scrive nella Sesta
divisione della sua Poetica:
Vero è che lo eroico ha molte cose proprie e particolari più della tragedia da aggrandire la sua
grandezza. […] La qual grandezza ancora, oltra che lo fa parer più magnifico, è utile a far variamente
mutare gli animi degli auditori et a farvi introdurre dissimili episodii, ché ’l simile tosto sazia.
Non solo dunque la diversione episodica, prima di Tasso e mostrandogli la strada,
è teorizzata e praticata dal Trissino, prendendo naturalmente come forma privilegiata
(ma non esclusiva) quella del romanzesco, ma da questo passo si capisce chiaramente
come essa risalga proprio ad una poco nota osservazione di Aristotele stesso nella
Poetica (oscurata dalla vulgata semplificante riguardo all’unità d’azione), che il
Trissino riprende traducendo pressoché alla lettera l’intero passo dal testo greco:
Diafšrei dὲ kat£ te tÁj sust£sewj tÕ mÁkoj ¹ ™popoi…a kaˆ tÕ mštron. toà mὲn oân m»kouj Óroj
ƒkanÕj Ð e„rhmšnoj· dÚnasqai g¦r de‹ sunor©sqai t¾n ¢rc¾n kaˆ tÕ tšloj. e‡h d' ¨n toàto, e„
tîn mὲn ¢rca…wn ™l£ttouj aƒ sust£seij eἶen, prÕj dὲ tÕ plÁqoj tragJdiîn tîn e„j m…an
¢krÒasin tiqemšnwn par»koien. œcei dὲ prÕj tÕ ™pekte…nesqai tÕ mšgeqoj polÚ ti ¹ ™popoi…a
‡dion di¦ tÕ ™n mὲn tÍ tragJd…v m¾ ™ndšcesqai ¤ma prattÒmena poll¦ mšrh mime‹sqai ¢ll¦ tÕ
™pˆ tÁj skhnÁj kaˆ tîn Øpokritîn mšroj mÒnon· ™n dὲ tÍ ™popoi…v di¦ tÕ di»ghsin eἶnai œsti
poll¦ mšrh ¤ma poie‹n perainÒmena, Øf' ïn o„ke…wn Ôntwn aÜxetai Ð toà poi»matoj Ôgkoj. éste
toàt' œcei tÕ ¢gaqÕn e„j megalopršpeian kaˆ tÕ metab£llein tÕn ¢koÚonta kaˆ ™peisodioàn
¢nomo…oij ™peisod…oij· tÕ g¦r Ómoion tacÝ plhroàn ™kp…ptein poie‹ t¦j tragJd…aj151.
150
T. TASSO, Lettere poetiche, a cura di C. MOLINARI, Parma, Guanda, 1995, lettera XXXVIII, pp. 358-59.
Poetica, 1459b, 17-31, trad.: « Peraltro l’epica si differenzia per la lunghezza della composizione e per
il metro. per la lunghezza sarà sufficiente ricordare il limite che si è detto prima: si deve poter abbracciare
insieme l’inizio e la fine. Ciò è possibile se le composizioni sono più brevi di quelle antiche, e
paragonabili al numero di tragedie che si danno in un’unica recita. Ma, per quanto riguarda le dimensioni,
l’epica presenta la peculiarità che, mentre nella tragedia non si possono imitare contemporaneamente più
parti, ma solo quella messa in scena e recitata dagli attori, l’epica, per il fatto di essere una narrazione,
può rappresentare contemporaneamente più parti: esse, se appropriate, accrescono la dignità dell’opera, la
151
146
Inserire diversioni episodiche a variare l’ampia estensione della trama epica,
dunque, è una necessità specifica del genere narrativo perfettamente riconosciuta da
Aristotele, peraltro sull’esempio dell’Iliade omerica152: a differenza della tragedia, che
necessità di una struttura più compatta, l’epica può e anzi deve contenere degli elementi
episodici e diversivi a generare varietà entro una narrazione di ampio respiro, che
altrimenti sfocerebbe facilmente nella monotonia. L’unità d’azione, spesso banalizzata
dall’opinione vulgata – talvolta già nella critica rinascimentale – in una condanna senza
appello di qualsiasi diversione da un intreccio costituito da un’unica vicenda, è in realtà
un concetto molto più fine di quanto solitamente si creda: essa infatti richiede, piuttosto,
dei legami logico-narrativi forti fra gli eventi narrati in successione, il cui rapporto sia
necessario, dunque affine a un’implicazione di causa ed effetto, rifiutando gli
accostamenti gratuiti e debolmente collegati (ad esempio sulla sola base dell’identità del
protagonista o della mera contemporaneità)153. Fatto salvo il rispetto di questo principio
generale comune al teatro e all’epica, quest’ultima non solo tollera, ma anzi esige come
apporto valorizzante e persino necessario, date le sue maggiori dimensioni testuali, il
ricorso alla diversione episodica e persino a una pluralità di vicende portate avanti in
contemporanea nella narrazione.
Proprio sulla scorta di Aristotele, dunque, il Trissino ammette a livello teorico
nella sua Poetica e a livello di prassi nel suo poema questa necessità, senza che la
concessione all’episodio sia dunque in alcun modo sentita come una violazione del
principio aristotelico dell’unità d’azione, con il quale semmai deve convivere e
conciliarsi in un equilibrio tale da non comprometterla: la diversione episodica,
insomma, è necessaria, ma, al contempo, deve essere motivata dal punto di vista logiconarrativo. Lo specifico carattere di tali episodi diversivi sarà poi, nell’intelligente scelta
del Trissino, in buona parte anche romanzesco, come abbiamo avuto modo di rilevare
ampiamente.
Ma l’aspetto più importante di questa intuizione è che il mezzo individuato per
motivare a livello strutturale la necessaria introduzione della varietà romanzesca è, in
gran parte, precisamente il modulo epico di derivazione iliadica di cui ci stiamo
quale ne ricava un vantaggio in termini di grandiosità e per il fatto di mutare il sentimento dello
spettatore, accumulando episodi diversi. L’uniformità, infatti, sazia rapidamente e fa cadere le tragedie ».
152
ARISTOTELE, Poetica, 1459a, 35-37 (parlando di Omero e della struttura della trama dell’Iliade): nàn
d' ἓn mšroj ¢polabën ™peisod…oij kšcrhtai aÙtîn pollo‹j, oŒon neîn katalÒgJ kaˆ ¥lloij
™peisod…oij [dˆs] dialamb£nei t¾n po…hsin (trad.: « Prendendone invece una parte [della guerra di
troia], ha fatto uso di molti episodi, come il catalogo delle navi e altri che fanno procedere il poema »).
153
ARISTOTELE, Poetica, 1451a, 17 sgg.
147
occupando: come abbiamo visto, è appunto il romanzesco arrivo di Elpidia a causare
indirettamente la contesa fra Belisario e Corsamonte, in seguito alla quale l’eroe
necessario si ritira per rendersi protagonista della ancor più romanzesca ventura della
fata Plutina. Se infatti il ritiro di Achille nell’Iliade si svolgeva nel segno dell’inazione,
per cui l’eroe irato si ritirava presso la sua nave perseguendo l’unico scopo negativo di
non combattere più per l’ingrato Agamennone, il Trissino ha l’intuizione geniale – cui
tuttavia solo il Tasso saprà dare adeguata realizzazione nella prassi poetica – di
rovesciare di segno questo elemento in azione, ma in un’azione decisamente autre
rispetto all’impresa epica, rendendo protagonista Corsamonte di un’erranza cavalleresca
che è il solo vero e diretto precedente dell’erranza perfettamente parallela di Rinaldo
dopo la contesa con Goffredo. Non sussiste più quel double bind per cui « da un lato la
necessità di salvaguardare il proprio onore impone ad Achille di ritirarsi dalla guerra,
dall’altro è solo la guerra, come mostra il suo epiteto kudianeira, la sede della gloria
»154: la tradizione cavalleresca fa sì che la guerra non sia più, per l’eroe moderno, la
sede esclusiva della gloria, che può essere conseguita anche attraverso la via alternativa
e individualistica dell’erranza cavalleresca e dell’impresa solitaria di carattere arturiano.
L’impiego strutturale di questa alternativa è una geniale intuizione trissiniana, soltanto
suggerita dall’opposizione guerra/erranza cavalleresca della precedente tradizione
romanzesca; pur indebolendo la lacerante situazione psicologica dell’Achille omerico,
essa permette, in compenso, la contaminazione strutturalmente motivata delle due
tradizione generiche epica e romanzesca: sarà tuttavia solo il Tasso a sfruttare al meglio
quest’intuizione non sua, cui la Liberata deve tanta parte del suo valore artistico.
Con questa rilevantissima modifica, dunque, il Trissino fa sì che il modulo epico
dell’eroe necessario, senza per questo perdere affatto il suo carattere epico e omerico,
diventi veicolo privilegiato dell’introduzione della varietà romanzesca nel poema.
Evidente l’influenza, fortissima, sui nuclei fondamentali del poema tassiano, come
abbiamo già avuto modo di rilevare: l’arrivo di Armida al campo è perfettamente
parallelo a quello di Elpidia (contaminandolo anche con quello precedente di
Ligridonia), e ne condivide in particolare la funzione cardine di essere indirettamente
causa della contesa fra Rinaldo e Goffredo, innescata dagli intempestivi e insinceri
consigli dell’innamorato Eustazio (Liberata, V, 8 sgg.), così come in Trissino dipende
dalla rivalità amorosa fra Corsamonte e Aquilino; l’erranza romanzesca di Rinaldo che
ne consegue, volgendo in azione l’inazione dell’Achille omerico irato, è poi evidente
154
PADUANO, G., Le scelte di Achille, cit., p. XXIX.
148
ripresa di quella di Corsamonte, con il suo arrivo all’abbazia e la ventura della fata
Plutina.
Tuttavia la parte più cospicua dell’elemento diversivo nel quale trova
rappresentazione la fase di “devastazione” è, in Trissino, senz’altro quella di marca
epica. La critica tassiana, invece, focalizzando l’attenzione quasi esclusivamente
sull’opposizione epos-romanzo in termini di chiusura-diversione – cosa peraltro
giustissima – ha forse sottovalutato però il peso degli elementi diversivi di ascendenza
epica presenti nella Liberata, in gran parte inseriti appunto sull’esempio del Trissino.
Vediamo dunque brevemente quali sono nell’Italia liberata questi elementi epici di
impedimento al compiersi del telos durante il periodo di assenza dell’eroe necessario,
per poi considerare anche per questo aspetto l’influsso sul Tasso.
Subito dopo la partenza di Corsamonte e la ventura della fata Plutina, che resta in
sospeso, segue nell’Italia un intero libro di battaglia (il XII) fortemente omerizzante
nello stile, nel quale l’assenza dell’eroe si fa immediatamente avvertire in tutta la sua
gravità. Si tratta, in effetti, del primo vero scontro fra l’esercito di Belisario e quello dei
Goti, poiché la precedente battaglia di Napoli viene combattuta piuttosto contro i
cittadini della città; non a caso, è ripresa la similitudine con cui nell’Iliade iniziano gli
scontri fra Greci e Troiani narrati nel poema, dopo la violazione dei patti (il passo da
cui, come abbiamo notato altrove, trae origine l’opposizione tassiana fra uniforme
cristiano e multiforme pagano):
Ma come fan le pecorelle, uscite
fuor de le ricche stalle d'un pastore
che n'abbia molti numerosi greggi,
che sempre van gridando verso i paschi
e dan risposta a i lor diletti agnelli
che vengon dietro, o son dentr'a le mandre;
così quei Gotti al trappassar del ponte
givan gridando, e con diverse voci
davan risposta a gli altri lor compagni
ch'erano a dietro o sopra l'altra ripa.
(Italia, XII)
Trîej d', éj t' Ôϊej polup£monoj ¢ndrÕj ™n aÙlÍ
mur…ai ˜st»kasin ¢melgÒmenai g£la leukÕn
¢zhc j memaku‹ai ¢koÚousai Ôpa ¢rnîn,
ìj Trèwn ¢lalhtÕj ¢n¦ stratÕn eÙrÝn Ñrèrei·
oÙ g¦r p£ntwn Ãen ÐmÕj qrÒoj oÙd' ‡a gÁruj,
¢ll¦ glîssa mšmikto, polÚklhtoi d' œsan ¥ndrej.
(Iliade, IV, vv. 433-438)155
Il primo a trovare la morte negli scontri è un giovane, figlio del “perfido
Agolante”, che cade « come un olmo novel, ch’el vento sbarbi », con un genere di
similitudine frequente in Omero; similmente omerico è anche il riferimento al dolore
che la morte del figlio in battaglia arrecherà al genitore (motivo che trova la sua
155
Trad.: « I Troiani invece, come stanno affollate le pecore / nel cortile di un uomo ricco per essere
munte del bianco latte, / e belano senza tregua sentendo la voce dei loro agnelli, / così si levava nel vasto
campo il loro grido di guerra; / non avevano la stessa voce e la stessa lingua, / ma lingue mescolate, di
genti di vari paesi ».
149
massima espressione nel rapporto speculare Ettore-Priamo e Achille-Peleo nel libro
XXIV), qui tuttavia filtrato – non senza una qualche memoria della morte di Lauso e
Mezenzio in Eneide X – attraverso un celebre luogo dantesco:
Quando Argolante intese che 'l figliuolo
stat'era il primo morto da i romani,
fremea co i denti e si traea la barba,
poi facea con le man le fiche al cielo
dicendo: Togli, Iddio, che puoi più farmi?
(Italia, XII)
Al fine de le sue parole il ladro
le mani alzò con amendue le fiche,
gridando: «Togli, Dio, ch'a te le squadro!».
(Inferno, XXV, 1-3)
La serie di uccisioni che seguono è scritta, come di norma in Trissino, in pieno
stile omerizzante. Molto evidente, in particolare, è la ripresa del cosiddetto “grisly
realism” omerico:
e lo colpì nel mezzo de la panza,
d'un fiero colpo, e poi tirando l'asta
gli venner le budella in su l'arcione…
(Italia, XII)
™k d' ¥ra p©sai
cÚnto camaˆ col£dej, tÕn d skÒtoj Ôsse k£luye.
(Iliade, IV, 525-526)156
perché 'l ferro crudel se n'andò dentro
per l'occhio manco e per la nuca uscio,
ond'egli andò subitamente a morte
e cadde giù del suo cavallo in terra.
(Italia, XII)
il colpo passò dentro, ond'ei piegossi
verso le groppe, e la spietata punta
giunse a la bocca e poi d'indi al cervello,
tal che l'asta il portò giù del destriero;
e ne l'aria pendea come una lepre
che tolga il villanel denanzi a i cani
e se la rechi allegramente a casa
in cima il spontoncel che porta in spalla.
(Italia, XII)
Omerico è anche l’inserimento di una breve storia del personaggio-comparsa
prima della sua morte per mano di un personaggio di maggiore levatura:
156
Trad.: « le viscere / si rovesciarono a terra e il buio gli velò gli occhi ».
150
Asfalto, di Tachimoro figliuolo
e nipote di Vitige, che nacque
su la ripa del Ren presso a Pontecchio:
quivi egli avea gran numero d'armenti
grassi, e gran copia di feraci campi;
ma per vedere il zio venne a Ravenna,
ch'era creato nuovo re de i Gotti,
e di sua compagnia partissi quindi
et andò seco a por l'assedio a Roma.
(Italia, XII)
così come lo stilema che introduce una serie di uccisioni di guerrieri minori
(androktasia), che riprende il verso formulare iliadico ”Enqa t…na prîton t…na d'
Ûstaton ™xen£rix[en] (Il., V, 703 = XI, 729 = XVI, 962)157:
Vergini Muse, or mi donate aiuto,
ditemi chi fu il primo, e chi ’l secondo,
che venner contra Belisario armati.
(Italia, XII)
”Espete nàn moi Moàsai 'OlÚmpia dèmat' œcousai
Ój tij d¾ prîtoj 'Agamšmnonoj ¢nt…on Ãlqen
À aÙtîn Trèwn º kleitîn ™pikoÚrwn.
(Iliade, XI, 218-220)158
Ma chi fu, Muse, il primo, e chi ’l secondo
ch’allor Fileno saettando uccise?
(Italia, XII)
o ancora i brevi dettagli di carattere tipico e in genere formulare a descrivere il
momento della morte:
Ond’ei lasciò la briglia, e gli occhi adorni
furon d’oscure tenebre coperti
(Italia, XII)
[tÕn dὲ] skÒtoj Ôsse k£luye
(Iliade, 12x)159
…ond’ei cadde morto
giù dal cavallo, e si distese al piano
e co i denti mordea l’erba sanguigna.
(Italia, XII)
prhnšej ™n kon…Vsin Ñd¦x lazo…ato ga‹an.
(Iliade, II, v. 418 e affini)160
157
Trad.: « Chi per primo, chi per ultimo uccisero…? ».
Trad.: « Ditemi adesso Muse, che abitate l’Olimpo, / chi per primo si fece incontro ad Agamennone /
fra i Troiani ed i loro illustri alleati ».
159
Trad.: « il buio gli velò gli occhi ».
160
Trad.: « stesi nella polvere mordano la terra coi denti ».
158
151
per non parlare, naturalmente, delle numerose similitudini tratte dal mondo
animale, su cui torneremo fra breve, a dare forza rappresentativa a singoli momenti del
combattimento.
Tutti questi stilemi omerici accuratamente imitati dal Trissino saranno a loro volta
studiati e ripresi in maniera molto simile dal Tasso nella riscrittura omerizzante del suo
poema, la Gerusalemme conquistata. Anche lì verrà ripreso il “grisly realism” omerico:
Il Britanno signor con l'asta lunga
ferí costui sotto il sinistro orecchio,
e fe' sentir quanto sia grave e punga,
poi la svelse con l'alma al corpo vecchio.
(G. C., XVIII, 27, 1-4)
tÒn d' uƒÕj Telamînoj Øp' oÜatoj œgcei makrù
nÚx', ™k d' œspasen œgcoj
(Il., XIII, 177-78)161
Talvolta la derivazione di simili particolari corporali e macabri è effettuata, nel
dettato tassiano, attraverso la mediazione di celeberrime espressioni dantesche, in
particolare delle Malebolge, come abbiamo visto appunto in Trissino:
e sotto il duro scudo aperse l'imo
ventre, e ciò ch'ascondea il tristo sacco
(G. C., XVIII, 57, 3-4)
Tra le gambe pendevan le minugia;
la corata pareva e 'l tristo sacco
che merda fa di quel che si trangugia.
(Inf., XVIII, 25-27)
E d'arme saettate a' corpi, a' vólti,
parte lasciò l'orribil segno impresso,
parte ancor, fissa in terra, ingorda sembra
del fèro pasto di sanguigne membra.
(G. C., XVIII, 81, 4-8)
La bocca sollevò dal fiero pasto
quel peccator, forbendola a' capelli
del capo ch'elli avea di retro guasto.
(Inf., XXXIII, 1-3)
¢pÕ neurÁfi d' Ñistoˆ
qrùskon: poll¦ de doàra qrasei£wn ¢pÕ ceirîn
¥lla men ™n croˆ p»gnut' ¢rhiqÒwn a„zhîn,
poll¦ de kaˆ messhgÝ p£roj crÒa leukÕn ™paure‹n
™n ga…V †stanto lilaiÒmena croÕj «sai.
(Il., XV, 313-17)162
161
Trad.: « il figlio di Telamone lo colpì con la lunga lancia / sotto l’orecchio, e ritrasse la lancia ».
152
E Rodoan sotto il piloso mento
a Cimosco il Frison gran lancia affisse;
mentre a parlar, piú ch'a ferire intento,
volea: 'Compagni', dir: ma nulla disse:
perché insieme col sangue uscía, qual vento,
per la piaga lo spirto ond'egli visse:
e fece un mormorar dolente e roco,
pur come stride umido legno al foco.
(G. C., XVIII, 42)
Come d'un stizzo verde ch'arso sia
da l'un de' capi, che da l'altro geme
e cigola per vento che va via
(Inf., XIII, 40-42)
Anche la formulare immagine omerica del guerriero che morendo stringe la terra
col pugno è arricchita nel Tasso dall’aggettivo “lordo”, tipicamente dantesco e basso (6
occorrenze nella Commedia):
Quegli prendea con la sinistra palma
la lorda terra, anzi 'l fuggir de l'alma.
(G. C., XVIII, 43, 7-8)
Ö d' ™n kon…Vsi pesën ›le ga‹an ¢gostù
(Il., XIII, 508 ecc. – 5x)163
La ricerca tassiana per le scene di battaglia di una langue poetica di registro serio
e alto, pur tanto lontana dalla sciatta mediocrità dello sciolto trissiniano, spesso trova
comunque nel precedente dell’Italia l’esempio sia delle modalità di ripresa dello stile
omerico, sia la sua resa filtrata talvolta attraverso il recupero di certi forti tratti
espressivi del Dante di registro basso e comico, senza generare in questo la minima
incongruenza stilistica164.
162
Trad.: « le frecce balzavano / dagli archi, e molte lance scagliate da mani ardite, / alcune si piantavano
nel corpo dei giovani, / altre si piantavano in terra a metà strada / prima di toccare la bianca pelle, avide di
saziarsi di carne ».
163
Trad.: « piombò nella polvere, stringendo la terra col pugno ».
164
Vale la pena di ricordare a questo proposito un passo delle Lettere poetiche relativo alle difficoltà di
ottenere uno stile alto nella lingua toscana (lettera XLVII, pp. 452-53): «Della umile [forma, nel senso di
stile] è propria passion, per così dire, la purità; della mediocre, l’ornamento. Ma s’egli [il magnifico
dicitor toscano, ossia il poeta eroico italiano, che deve scrivere in stile alto] per sua natura è più vicino
alla mediocre che non all’umile, perché non servirsi degli aiuti vicini e conformi, più tosto che de’ lontani
e difformi? L’Ariosto, Dante, e ’l Petrarca ne’ Trionfi, molte volte serpono; e questo è il maggior vizio
che possa commetter l’eroico: e parlo dell’Ariosto e di Dante, non quando passan nel vizio contiguo
all’umiltà, ch’è la bassezza, ma quando usano questa umiltà, che per se stessa non è biasmevole, fuor di
luogo». Nei casi citati il poeta sta per l’appunto riprendendo tratti dello stile umile del Dante comico e
grottesco dell’Inferno, ma con la chiara intenzione di farlo in maniera limitata e soprattutto non «fuor di
luogo», bensì proprio là dove l’Iliade, pur nella sua coerenza di modello per eccellenza dell’eroico e del
suo stile alto, ne lascia l’occasione e quasi lo suggerisce.
153
Un tratto dello stile omerico ripreso, sull’esempio del Trissino, anche dal Tasso
della Conquistata è quello di costruire l’identità del personaggio altrimenti sconosciuto,
che compare solo in funzione della sua uccisione, tramite una breve “biografia”165, una
sua storia, che attraverso l’evocazione degli affetti familiari mira ad avere un effetto
emozionale, patetico, dando un margine di varietà alla brutale materialità delle
uccisioni:
Né giá venne a cercare o spoglia ostile
in nobil guerra o glorïosa fama;
ma nobil moglie e stirpe alta e gentile,
che la figlia del re sospira ed ama.
E d'illustrar la sua progenie umíle,
e le nuove ricchezze altero ei brama;
oro scoprendo e gemme ancora occulte,
pria del sepolto padre a lui sepulte.
Ma fèra morte al suo desio s'oppose,
ed a le nozze ond'egli era sí vago,
ch'a lui Roberto il ferro in seno ascose,
e fe' di nero sangue in terra un lago.
(G. C., 37, 4-8 e 38)
pšfne g¦r 'OqruonÁa KabhsÒqen œndon ™Ònta,
Ój ·a nšon polšmoio met¦ klšοj e„lhloÚqei,
Étee de Pri£moio qugatrîn e„dοj ¢r…sthn
Kass£ndrhn ¢n£ednon, Øpšscεto de mšga œrgon,
™k Tro…hj ¢škontaj ¢pωsšmen uŒaj 'Acaiîn.
tù d' Ð gšrwn Pr…amoj ØpÒ t' œsceto kaˆ katšneuse
dwsšmenai: Ö dὲ m£rnaq' Øposces…Vsi piq»saj.
'IdomeneÝj d' aÙto‹o titÚsketo dοurˆ faeinù,
kaˆ b£len Ûyi bib£nta tucèn: οÙd' ½rkese qèrhx
c£lkeoj, Ön foršeske, mšsV d' ™n gαstšri pÁxe.
(Il., XIII, 363-72)166
Mira ad un effetto patetico anche l’anticipazione del destino di morte del
personaggio, come per Norandino, sul modello omerico di Asio:
Né devea riveder le mura eccelse
d'Elia sublime, e del palagio adorno,
ch'egli ebbe ingombro, e proprio albergo felse,
e 'nvano avea sperato un bel ritorno;
ch'atro di guerra turbo il cinse e svelse,
come sterpar veggiamo abete od orno;
e cadde ove il trafisse orribil asta,
qual uom ch'indarno al suo destin contrasta.
(G. C., XVII, 96)
165
B. FENIK, Typical Battle Scenes... cit., pp. 150 sgg.
Trad.: « Uccise Otrioneo, giunto in città da Cabeso, / che era venuto da poco alla notizia di guerra, / e
chiedeva la più bella delle figlie di Priamo, / Cassandra, senza doni, ma promettendo una grande impresa:
/ cacciare loro malgrado gli Achei dalla Troade. / Il vecchio Priamo acconsentì e gli promise / Cassandra,
e lui combatteva fidando nella promessa. / Ma Idomeneo lo prese di mira con la lancia splendente / e lo
colpì mentre avanzava superbamente: la corazza di bronzo / che portava non fermò il colpo e la lancia si
piantò nel ventre ».
166
154
n»pioj, oÙd' ¥r' œmelle kak¦j ØpÕ kÁraj ¢lÚxaj
†ppoisin kaˆ Ôcesfin ¢gallÒmenoj par¦ nhîn
¨y ¢ponost»sein protˆ ”Ilion ºnemÒessan:
prÒsqen g£r min mo‹ra dusènumoj ¢mfek£luyen
œgcei 'IdomenÁoj ¢gauoà Deukal…dao.
(Il., XII, 113-17)167
Frequente in Omero è anche il vanto, non di rado in forma di scherno, rivolto
all’avversario colpito mortalmente, come in questo caso:
E disse rampognando: - Or va', racconta
quel che tra noi si faccia al re d'Inferno,
e come l'uomo in guerra a l'uom s'affronta,
e narra ivi di me nel lago Averno. Cosí a la fèra morte oltraggio ed onta
aggiungea per vendetta e per ischerno;
perché giá il falso messaggier deluse
i nostri duci, e vera pace escluse.
(G. C., XVIII, 58)
Poulud£maj d' œkpaglon ™peÚxato makrÕn ¢äsaj:
oÙ m¦n aât' Ñ…w megaqÚmou Panqo…dao
ceirÕj ¥po stibarÁj ¤lion phdÁsai ¥konta,
¢ll£ tij 'Arge…wn kÒmise cro…, ka… min Ñ…w
aÙtù skhptÒmenon kat…men dÒmon ”Aidoj e‡sw.
•Wj œfat', 'Arge…oisi d' ¥coj gšnet' eÙxamšnoio
(Il., XIV, 453-58)168
Ma per il tono siamo forse più vicini all’uccisione di Cebrione nella “Patrocleia”:
tÕn d' ™pikertomšwn prosšfhj PatrÒkleej ƒppeà:
í pÒpoi à m£l' ™lafrÕj ¢n»r, æj ·e‹a kubist´.
e„ d» pou kaˆ pÒntJ ™n „cquÒenti gšnoito,
polloÝj ¨n koršseien ¢n¾r Óde t»qea difîn
nhÕj ¢poqróskwn, e„ kaˆ duspšmfeloj e‡h,
æj nàn ™n ped…J ™x †ppwn ·e‹a kubist´.
à ·a kaˆ ™n Trèessi kubisthtÁrej œasin.
(Il., XVI, 744-750)169
Oltre al vanto rivolto al nemico, frequenti sono i discorsi rivolti anche ai propri
compagni, talvolta nella forma del consiglio 170 ; il seguente esempio nella forma si
richiama palesemente alle parole rivolte da Polidamante a Ettore:
167
Trad.: « Sciocco, non era destinato a sfuggire alle nere / dee della morte, a tornare dalle navi, superbo /
dei cavalli e del carro, a Ilio ventosa: / prima lo avvolse il destino funesto / per mano di Idomeneo, il
nobile figlio di Deucalione ».
168
Trad.: « Allora Polidamante si vantò superbamente, gridando: / “Non mi pare che dalla forte mano del
figlio / di Pantoo sia partito un colpo a vuoto; / qualcuno dei Greci la porta via nel suo corpo, e io credo /
che appoggiandosi ad essa scenderà all’Ade”. / Così disse, e i Greci si addolorarono del suo vanto ».
169
Trad.: « E tu così lo schernisti, Patroclo cavaliere: / “Come è agile l’uomo e come volteggia bene! /
Se andasse sul mare pescoso a cercare molluschi, / nutrirebbe a sazietà molti uomini / gettandosi dalla
nave, anche nel mare in tempesta, / come adesso volteggia nella pianura gettandosi dal suo carro. / Ci
sono acrobati anche fra i Troiani” ».
155
Or mentre del tumulto il ciel risuona,
e che dal muro ognun rifugge e scampa,
al gran Roberto Goldemar ragiona:
- Giá dentro il muro 'l fier nemico accampa,
e giá, prese le porte, aspra corona
d'orribil guerra a te d'intorno avvampa:
giá per le navi son divisi e sparsi
Egizi e Siri, e non potran ritrarsi.
Noi dobbiam tosto farlo, insieme accolti
i piú forti di questo o d'altro stuolo;
pria che siam presi in mezzo, e 'ntorno avvolti
d'empi nemici, in mal securo suolo;
ché pochi e stanchi, incontra i fèri e molti
fuor de la ròcca avrian di morte il duolo;
ma se colá potrem ritrarci in alto,
sosterrem de le turbe il nuovo assalto. Cosí diss'ei: né spiacque il suo consiglio
al magnanimo cor del gran Roberto;
(G. C., XVIII, 12, 13 e 14, 1-2)
d¾ tÒte Poulud£maj qrasÝn “Ektora e„pe parast£j:
“Ektor t' ºd' ¥lloi Trèwn ¢goˆ ºd' ™pikoÚrwn
¢fradšwj di¦ t£fron ™laÚnomen çkšaj †ppouj:
[...]
•Wj f£to Poulud£maj, ¤de d' “Ektori màqoj ¢p»mwn
(Il., XII, 60-80)171
oppure, più spesso, nella forma dell’esortazione a combattere172,
ma pur conforta i suoi con alte voci,
e gli fa co 'l suo esempio ancor feroci.
- O Turchi in guerra forti, o popol fido,
o voi che giá solcaste i salsi flutti,
per me passando a sí remoto lido,
dove lieta fortuna or v'ha condutti:
durate meco, e 'n quel giá vecchio nido,
i ladroni del mare or fian distrutti:
né lungo tempo sosterran la forza
nostra, e di tutti noi, se piú si sforza. Cosí parlava; e 'n ragionando, accese
di ciascuno de' suoi gli spirti e 'l core,
a dimostrar ne l'onorate imprese,
quanto avesser di forza e di valore.
(G. C., XVIII, 21, 7-8, 22 e 23, 1-4)
½ãsen de diaprÚsion Trèessi gegwnèj:
Trîej kaˆ LÚkioi kaˆ D£rdanoi ¢gcimachtaˆ
170
B. FENIK, Typical Battle Scenes... cit. a proposito dell’elemento tipico del consiglio e del suo schema
tradizionale parla di “advice pattern” (vedi p. 50).
171
Trad.: « Allora Polidamante si accostò al forte Ettore e disse: / “Ettore e voi altri capi dei Troiani e
degli alleati, / sbagliamo a voler passare il muro coi nostri cavalli; […] Così disse Polidamante, ed
Ettore approvò il suo prudente consiglio ».
172
B. FENIK, cit., p. 48 ecc.
156
parmšnet': oÜ toi dhrÕn ™me sc»sousin 'Acaioˆ
kaˆ m£la purghdÕn sfšaj aÙtoÝj ¢rtÚnantej,
¢ll' Ñ…w c£ssontai Øp' œgceoj, e„ ™teÒn me
ðrse qeîn êristoj, ™r…gdoupoj pÒsij “Hrhj.
•Wj e„pën Ôtrune mšnoj kaˆ qumÕn ˜k£stou.
(Il., XIII, 149-155)173
o ancora del rimprovero174, come in questo esempio di vera e propria traduzione:
E rivolto al fratel, cui stanca e doma
tenere e gravi membra il grave peso,
e come sian quell'arme ingiusta soma,
è in rimirar l'altrui fatiche inteso,
una e due volte rampognando il noma:
- Celebin, Celebin, chi n'ha difeso?
Or tu sano ed io infermo ancor viviamo?
ove son gli altri ch'io sospiro e bramo?
tÕn de t£c' eáre m£chj ™p' ¢rister¦ dakruošsshj
d‹on 'Alšxandron `Elšnhj pÒsin ºãkÒmoio
qarsÚnonq' ˜t£rouj kaˆ ™potrÚnonta m£cesqai,
¢gcoà d' ƒst£menoj prosšfh a„scro‹j ™pšessi:
Ove Alfansor, ove Ismael rimase?
la forza di Sanguigno ove lasciasti?
come tornare a le dolenti case,
senza il tuo Norandino anco pensasti?
Manca a la reggia omai sostegno e base,
per vari sanguinosi empi contrasti:
e dal sommo Sion vacilla e trema,
e minaccia ruina a noi suprema. -
poà toi DhifobÒj te b…h q' `Elšnoio ¥naktoj
'Asi£dhj t' 'Ad£maj ºd' ”Asioj `Urt£kou uƒÒj;
poà dš toi 'OqruoneÚj;
Disse; e da l'animoso alto fanciullo
tal risposta il feroce incontra udia:
- Altra volta fu, Argante, il mio trastullo
cessar da l'arme e soggiornar tra via;
nessun riposo oggi ritrovo, e nullo
spazio da respirar, come solia;
ma te difesi e 'l nostro onore e 'l regno,
tutto 'l dí armato, e son di biasmo indegno.
TÕn d' aâte prosšeipen 'Alšxandroj qeoeid»j:
I compagni che cerchi, invido fato
a la nostra vittoria estinti invola,
fuor che Sanguigno, il qual partí piagato
nel primo assalto e piú non fe' parola;
me, del fratello e non d'onor privato,
questo sol che m'avanza, oggi consola:
e per seguirti, a la persona stanca,
con prontissimi spirti, ardir non manca.
Dunque dove comandi, o vengo o vado,
non fia ch'in me virtute invan s'attenda,
e pugnerò quanto la forza, e 'l grado
ch'io sostegno fra gli altri, oggi si stenda.
Oltra le forze, ancor se fosse a grado,
non lece; or fa ch'il tuo volere intenda. Cosí dice egli; e placar può nel core
del suo fratello il disdegnoso ardore.
DÚspari e„doj ¥riste gunaimanej ºperopeut¦
nàn êleto p©sa kat' ¥krhj
”Ilioj a„pein»: nàn toi sîj a„pÝj Ôleqroj.
“Ektor ™pe… toi qumÕj ¢na…tion a„ti£asqai,
¥llote d» pote m©llon ™rwÁsai polšmoio
mšllw, ™peˆ oÙd' ™me p£mpan ¢n£lkida ge…nato m»thr:
™x oá g¦r par¦ nhusˆ m£chn ½geiraj ˜ta…rwn,
™k toà d' ™nq£d' ™Òntej Ðmilšomen Danao‹si
nwlemšwj:
›taroi de katšktaqen oÞj sÝ metall´j.
o‡w DhifobÒj te b…h q' `Elšnoio ¥naktoj
o‡cesqon, makrÍsi tetummšnw ™gce…Vsin
¢mfotšrw kat¦ ce‹ra: fÒnon d' ½mune Kron…wn.
nàn d' ¥rc' ÓppV se krad…h qumÒj te keleÚei:
¹me‹j d' ™mmemaîtej ¤m' ˜yÒmeq', oÙdš t… fhmi
¢lkÁj deu»sesqai, Ósh dÚnam…j ge p£resti.
p¦r dÚnamin d' oÙk œsti kaˆ ™ssÚmenon polem…zein.
•Wj e„pën paršpeisen ¢delfeioà fršnaj ¼rwj:
173
Trad.: « Allora gridò forte, per farsi sentire dai Troiani: / “Troiani, Lici, Dardani bellicosi, / restate al
mio fianco! I Greci non riusciranno a fermarci / a lungo anche stringendosi in schiere compatte come / un
muro; credo che cederanno alla mia lancia, se è vero / che mi ha spinto il dio più forte, lo sposo tonante di
Era”. / Così dicendo ridestava il furore e il coraggio di ognuno ».
174
B. FENIK, cit., individua anche in questo caso uno schema tipico, che chiama “rebuke pattern” (vedi
pp. 26 sgg.).
157
E l'uno e l'altro ove piú avvampa e ferve
la battaglia si spinge in mezzo a l'armi;
(G. C., XVIII, 97-102, 1-2)
b¦n d' ‡men œnqa m£lista m£ch kaˆ fÚlopij Ãen
(Il., XIII, 765-789)175
Naturalmente si potrebbero fare molti altri esempi di simili elementi “tipici” che il
Tasso della Conquistata, sulla scorta del Trissino, riprende da Omero, come il
fallimento del colpo che però va ad uccidere accidentalmente l’auriga o lo scudiero del
bersaglio predestinato (G. C., XVIII, 103, cfr. Il., XV, 429 sgg. ecc.), o il motivo della
vendetta di un fratello appena ucciso (G. C., XVIII, 61, 1-2). Una trattazione a parte
meriterebbero poi le similitudini, che in Omero si mostrano al contempo come un
repertorio di immagini tradizionali176 ma anche come uno dei luoghi privilegiati in cui
maggiore è la libertà di innovare rispetto a questa tradizione; qui la superiorità del
grande poeta rispetto al suo mediocre predecessore vicentino si fa evidentissima pur
nell’imitazione serrata dello stile omerico: le frequentissime similitudini del Trissino177,
pur complessivamente omogenee al repertorio iliadico e spesso da esso tradotte, sono
uno degli aspetti più poveri di poesia dell’Italia, nel loro continuo ricorrere quasi
unicamente nella funzione banalizzante di chiarificazione rappresentativa e visuale o più
raramente auditiva (dietro una simile prassi sta un concetto frainteso e semplificato
dell’ἐνάργεια omerica, che il Trissino desume soprattutto da Demetrio Retore – pseudo
Demetrio Falereo – secondo quanto è ampiamente testimoniato nella sua Poetica):
E come il can che seguita il leone
o 'l selvatico porco entr'a la selva,
che si confida ne i veloci piedi
e gli va dietro picicando l'anche,
e poi che morse l'ha, si volge e guarda
la fiera, acciò ch'ei non riceva oltraggio;
175
Trad.: « Trovò invece, a sinistra della battaglia crudele, / l’illustre Paride, sposo di Elena dai bei
capelli, / che incoraggiava e spronava i compagni a combattere; / gli si accostò e gli disse parole
ingiuriose: / “Paride disgraziato, bellimbusto, donnaiolo, / seduttore, dov’è Deifobo, dov’è il forte Eleno,
/ Adamante figlio di Asio e Asio figlio di Irtaco? Dov’è Otrioneo? Troia tutta precipita / dalle
fondamenta; adesso per te è sicuro l’abisso di morte”. / Gli rispose Paride, simile a un dio: / “Ettore, la tua
ira ti fa accusare un innocente: / altre volte forse ho abbandonato la lotta, / ma non del tutto vile mi ha
partorito la madre. / Da quando hai risvegliato l’assalto troiano alle navi, / da quel momento noi tutti ci
scontriamo coi Greci / incessantemente; e sono morti i compagni che cerchi. / Solamente Deifobo e il
forte Eleno / si sono ritirati, feriti entrambi / da lunghe lance nel braccio: Zeus li ha sottratti alla morte. /
Ora comanda come ti consigliano l’animo e il cuore; / noi ti seguiremo con grande slancio e ti dico / che
non mancheremo di coraggio, finché avremo forza. / Oltre le proprie forze non può combattere neanche il
più ardito”. / Così dicendo, l’eroe persuase l’animo di suo fratello; / andarono insieme dov’era più aspra
la battaglia e la mischia ».
176
Sul carattere tradizionale delle similitudini omeriche, vedi: W. C. SCOTT, The oral nature of the
Homeric simile, Princeton, Princeton Univ., 1964; J. C. HOGAN, The oral nature of the Homeric simile,
Cornell Univ. Ithaca, 1966. Sull’argomento delle similitudini omeriche in generale, vedi C. MOULTON,
Similes in the Homeric Poems, Hypomnemata 49, Göttingen, 1977.
177
Per un catalogo delle similitudini nell’Italia liberata, cfr. VITALE, M., L’omerida italico, cit., pp. 4457.
158
così facea quel Turrismondo altero
nel seguitare i cavalier romani.
(Italia, XII)
Vale la pena di ricordare, a proposito di questa povertà espressiva solo
superficialmente simile a Omero, un’illuminante intuizione tassiana su cui torneremo
più avanti parlando della rima:
Considerisi, oltra ciò, che l’instrumento del poeta eroico latino e greco è il verso essametro, il qual
per se stesso senza altro aiuto basta a sollevar lo stile: ma ’l nostro endecasillabo non è tale; e
la rima ricerca e porta di sua natura l’ornamento, più che non fa il verso latino e greco.
Il Tasso, appunto, non incorre nello stesso errore, credendo di poter
semplicemente trasportare di peso la dizione omerica nell’endecasillabo italiano, e
ricorre a tutti gli “ornamenti” necessari alla versificazione romanza. Fra i numerosi casi
di ripresa tassiana della similitudine iliadica insieme al suo contesto di riferimento, in
particolare, segnalo soltanto uno splendido esempio di emulazione con il passo relativo
al crollo del muro di difesa, dove appare evidente quella competizione con il modello
che tanto rilievo ha nella poetica rinascimentale dell’imitazione, e dove si può ben
misurare la distanza dalla banalità del dettato trissiniano:
Il muro ancora ivi cadea repente,
il muro, ch'in piú mesi a poco a poco
fatto crescea da faticosa gente,
alto riparo al ben guardato loco:
or percosso, al furor del gran tridente,
simigliò di fanciullo opra da gioco,
ch'ei fa d'umida arena appresso l'onde,
e poi co' piè la guasta e la confonde.
(G. C., XVIII, 88)
prÕ d' 'ApÒllwn
a„g…d' œcwn ™r…timon: œreipe de te‹coj 'Acaiîn
·e‹a m£l', æj Óte tij y£maqon p£ij ¥gci qal£sshj,
Ój t' ™peˆ oân poi»sV ¢qÚrmata nhpišVsin
¨y aâtij sunšceue posˆn kaˆ cersˆn ¢qÚrwn.
(Il., XV, 360-64)178
Ma tornando al Trissino, dall’Iliade è mutuato non solo lo stile della narrazione di
battaglia, ma anche la struttura complessiva del libro XII dell’Italia liberata, che
rielabora in particolare alcuni momenti salienti della grande battaglia che giunge fino
alle navi di Iliade XI-XV: l’esortazione e il diretto intervento dell’angelo Gradivo in
favore dei Goti, in parallelo all’aiuto di Poseidone agli Achei (Iliade, XIII, vv. 10 sgg.),
178
Trad.: « Attraverso di esso i Troiani si rovesciarono a schiere e davanti / a loro Apollo, con l’egida
sacra, abbatté il muro / facilmente, come sulla riva del mare fa con la sabbia / un bambino che, dopo aver
costruito per gioco un castello, / di nuovo lo rovescia coi piedi e con le mani per gioco ».
159
poi l’ordine divino di ritirarsi riferito da Iridio all’angelo Palladio, favorevole invece ai
Romani, parallelo a quello di Zeus riferito a Poseidone da Iride (Iliade, XIII, vv. 345
sgg.), poi ancora l’angelo che prima di ritirarsi toglie il velo agli occhi di Belisario
permettendogli di vedere il favore divino momentaneamente accordato ai Goti, così
come Atena toglie agli occhi dei Greci la nube che li offusca, permettendo loro di
vedere chiaramente l’infuriare di Ettore e dei Troiani ormai presso le navi (ma il passo è
contaminato con l’altro luogo di Iliade V in cui Atena permette a Diomede di
distinguere i mortali dagli dei, così da non opporsi a questi ultimi):
ma levò prima a Belisario il velo
che la carne mortale avanti gli occhi
gli avea disteso, ond'impediti alquanto
non conosceano i messaggier celesti:
e questo gli levò perché potesse
vederli meglio, e non opporsi a loro.
(Italia, XII)
to‹si d' ¢p' Ñfqalmîn nšfoj ¢clÚoj ðsen 'Aq»nh
qespšsion· m£la dš sfi fÒwj gšnet' ¢mfotšrwqen
ºmὲn prÕj nhîn kaˆ Ðmoi ou polšmoio.
(Iliade, XV, vv. 668-670)179
¢clÝn d' aâ toi ¢p' Ñfqalmîn ›lon ¿ prˆn ™pÁen,
Ôfr' eâ gignèskVj ºmὲn qeÕn ºdὲ kaˆ ¥ndra.
të nàn a‡ ke qeÕj peirèmenoj ™nq£d' †khtai
m» ti sÚ g' ¢qan£toisi qeo‹j ¢ntikrÝ m£cesqai
to‹j ¥lloij· ¢t¦r e‡ ke DiÕj qug£thr 'Afrod…th
œlqVs' ™j pÒlemon, t»n g' oÙt£men Ñxšϊ calkù.
(Iliade, V, 128-132)180
Il risultato è che Belisario e i suoi sono respinti fin sotto le mura di Roma e
costretti infine a riparare dentro la città, capovolgendo il rapporto tra offesa e difesa,
così come avviene nell’Iliade quando in assenza di Achille, capovolgendo il rapporto
fra assedianti e assediati, gli Achei finiscono a doversi ritirare oltre il muro difensivo
per poi essere respinti fino alle navi: lo stesso momentaneo rovesciamento di ruoli è
ripreso anche da Virgilio in Eneide IX, quando durante l’assenza di Enea
l’accampamento dei suoi è assediato dall’esercito guidato da Turno. Già un solo libro
dopo il ritiro di Corsamonte dal combattimento, condensando all’estremo una situazione
che nell’Iliade, invece, si determina progressivamente nell’arco ben più ampio di tutta la
prima metà del poema e oltre, l’assenza dell’eroe necessario pesa a tal punto sulle sorti
179
Trad.: « Allora Atena tolse loro dagli occhi / la nube prodigiosa, di nebbia, e fu fatta luce / da ambo le
parti, sulle navi e sulla feroce battaglia ».
180
Trad.: « e ti ho tolto la nebbia che prima stava sopra i tuoi occhi, / perché tu conosca bene uomini e
dèi. / E tu, se un dio venisse qui a provocarti, / con gli altri immortali non combattere mai / faccia a
faccia, ma se la figlia di Zeus Afrodite / scende in battaglia, colpiscila col bronzo acuto».
160
della guerra da mettere in forse l’esito dell’intera impresa, minacciando la disfatta
dell’esercito di Belisario.
La crisi così determinatasi porta, come nell’Iliade, all’innesco di due paralleli
tentativi di soluzione (libri XIII-XIV): da una parte, l’invio di un’ambasceria da parte di
Belisario per richiamare indietro Corsamonte, parallela a quella per richiamare Achille
in Iliade IX; dall’altra, la ripresa della “Doloneia”, la spedizione notturna di Ulisse e
Diomede, che intercettano e uccidono la spia troiana Dolone e poi fanno strage
nell’accampamento degli alleati dei troiani. Naturalmente non possiamo ora seguire da
vicino tutta questa mole di materiali iliadici: sull’ambasceria torneremo brevemente più
avanti, quando tratteremo della questione del ritorno di Corsamonte a combattere; sulla
ripresa della “Doloneia” basti qualche breve stralcio a dare idea del livello di aderenza,
costantemente giocato sul filo della traduzione, con l’ipotesto iliadico. Come Ettore in
Iliade X, il re dei Goti Vitige propone di mandare una spia nel campo nemico:
buon è che noi mandiam qualcun de i nostri
a Roma per veder quel che si fanno:
se pongon guardie intorno la cittade
o se smarriti da le nostre forze
fanno tra lor consiglio di fuggirsi
e lasciar vòta la città di Roma.
Io poscia a quel ch'averà cuor d'andarvi
darò il più bel corsier ch'io tenga in stalla
con molti doni prezïosi appresso;
e se per caso non potesse intrare
dentr'a le mura e le serrate porte,
cerchi di far spavento a quelle genti
che saran poste a guardia de la terra
con parole superbe e con minaccie:
(Italia, XII)
t…j kšn moi tÒde œrgon ØposcÒmenoj telšseie
dèrJ œpi meg£lJ; misqÕj dš oƒ ¥rkioj œstai.
dèsw g¦r d…frÒn te dÚw t' ™riaÚcenaj †ppouj
o† ken ¥ristoi œwsi qoÍj ™pˆ nhusˆn 'Acaiîn
Ój t…j ke tla…h, oŒ t' aÙtù kàdoj ¥roito,
nhîn çkupÒrwn scedÕn ™lqšmen, œk te puqšsqai
º ful£ssontai nÁej qoaˆ æj tÕ p£roj per,
à ½dh ce…ressin Øf' ¹metšrVsi damšntej
fÚxin bouleÚousi met¦ sf…sin, oÙd' ™qšlousi
nÚkta fulassšmenai, kam£tJ ¢dhkÒtej a„nù.
(Iliade, X, vv. 303-312)181
e così come Dolone alzava la posta chiedendo niente meno che i cavalli e il carro
di Achille, il suo quasi omonimo Frodino pretende come compenso per la rischiosa
missione il cavallo e l’armatura di Belisario:
Signore, il cuor mi dà d'andare a Roma
e di far tutto quel che voi dicete,
se mi giurate sopra il vostro petto
di darmi il bel corsier ch'aveva sotto
ne la battaglia Belisario il grande;
e darmi ancora l'armatura fina,
“Ektor œm' ÑtrÚnei krad…h kaˆ qumÕj ¢g»nwr
nhîn çkupÒrwn scedÕn ™lqšmen œk te puqšsqai.
¢ll' ¥ge moi tÕ skÁptron ¢n£sceo, ka… moi Ômosson
à m n toÝj †ppouj te kaˆ ¤rmata poik…la calkù
dwsšmen, o‰ foršousin ¢mÚmona Phle wna,
soˆ d' ™gë oÙc ¤lioj skopÕj œssomai oÙd' ¢pÕ dÒxhj·
tÒfra g¦r ™j stratÕn e mi diamper j Ôfr' ¨n †kwmai
nÁ' 'Agamemnonšhn, Óqi pou mšllousin ¥ristoi
181
Trad.: « Chi si impegna a compiere per me quest’impresa / per un grande premio? Avrà un compenso
sicuro: / darò un carro e due cavalli superbi, / i migliori che sono nella flotta greca, / a chi ardirà, e ne avrà
grande gloria, / di andare vicino alle navi e informarsi / se sono custodite come in passato, / oppure,
finalmente domati dalle nostre mani, / meditano tra loro la fuga e non vogliono / vegliare la notte, sfiniti
dalla tremenda stanchezza ».
161
dal capo a i piè, che si trovava intorno.
(Italia, XII)
boul¦j bouleÚein À feugšmen º m£cesqai.
(Iliade, X, vv. 319-327)182
Come Dolone da Ulisse e Diomede, egli sarà poi intercettato e inseguito da
Lucillo e Tibullo, sentinelle presso una porta di Roma, per essere da loro interrogato
con la promessa di aver salva la vita:
A cui rispose il provido Lucillo:
Piglia ardimento, e non pensar di morte;
ma dimmi prima qual cagion ti mosse
a venirci a trovar con tanto ardire
per l'oscuro silenzio de la notte
quando la gente si riposa e dorme,
e dir quell'aspre ingiurie al popol nostro.
Fu parola del re che te 'l comise
o pur è nato fuor de la tua testa?
(Italia, XII)
TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh polÚmhtij 'OdusseÚj:
q£rsei, mhdš t… toi q£natoj kataqÚmioj œstw.
¢ll' ¥ge moi tÒde e„p kaˆ ¢trekšwj kat£lexon:
pÍ d¾ oÛtwj ™pˆ nÁaj ¢pÕ stratoà œrceai oŒoj
nÚkta di' Ñrfna…hn, Óte q' eÛdousi brotoˆ ¥lloi;
½ tina sul»swn nekÚwn katateqnhètwn;
à s' “Ektwr prošhke diaskopi©sqai ›kasta
nÁaj œpi glafur£j; Ã s' aÙtÕn qumÕj ¢nÁke;
(Iliade, X, vv. 383-389)183
Qui interviene tuttavia il “miglioramento del costume” a modificare la ripresa
tanto fedele: se Ulisse, dopo la confessione di Dolone, viene meno alla parola data e lo
uccide, i due soldati di Belisario risparmiano la vita alla spia, rispettando quanto gli
hanno garantito poco prima. Segue, sempre con lo stesso grado di aderenza al testo
omerico, la strage notturna compiuta dai due guerrieri nel campo dei Goti: è ripresa la
similitudine del leone – trasformato in un lupo – che fa strage di pecore (Iliade, X, vv.
485-486), come pure l’uccisione di Reso – che prende il nome di Urtado – e il furto
conclusivo dei cavalli.
L’episodio non manca di influire già sul Tasso della Liberata per la sortita
notturna di Argante e Clorinda, ma sarà tenuto presente ancor più da vicino nella
Conquistata, dove l’episodio di Vafrino è ampliato appunto con una vera e propria
“Doloneia”, in cui la spia dei crociati, prima di giungere al campo nemico, intercetta e
uccide una spia inviata a loro volta dai pagani.
Nel libro successivo, il XIV, dopo il fallimento dell’ambasceria a Corsamonte su
cui torneremo fra breve, è ripreso dal secondo libro dell’Iliade un nuovo momento
diversivo di marca epica, l’episodio di Tersite: la rivolta contro Belisario fomentata da
182
Trad.: « Ettore, il mio cuore e il mio nobile animo / mi spinge ad andare alle navi e ad informarmi; /
ma alza lo scettro e giurami che mi darai / i cavalli e il carro adorno di bronzo / che portano adesso il
grande figlio di Peleo, / e farò per te la spia, non invano e non a sproposito. / Andrò dritto nel campo
greco, fino a trovare / la nave di Agamennone, dove penso che i capi / tengano consiglio, se fuggire o
combattere ».
183
Trad.: « Così gli rispose l’accorto Odisseo: / “Coraggio, non devi avere la morte nell’anima, / ma
dimmi piuttosto e parla sinceramente: /dove vai solo, lontano dal campo, verso le navi / nella notte buia,
quando gli altri uomini dormono? / Forse per spogliare qualcuno dei soldati caduti? / O Ettore ti ha
mandato a spiare tutto ciò che succede / alle navi? Oppure vi ti ha spinto il tuo cuore?”».
162
Anticalo a causa della scarsezza di provviste costituirà, di nuovo, il tramite della ripresa
omerica e il precedente più diretto della simile rivolta aizzata da Argillano. In Trissino
l’episodio iliadico è ripercorso fedelmente e pressoché tradotto, tanto nella descrizione
fisica di Anticalo/Tersite
Questi era il più brutt'uom che fosse in Roma,
guercio e sottil di gambe, e le sue spalle
gobbe pareano quasi arco del petto,
ch'era ristretto e concavo nel mezzo;
e sopra quelle avea la testa acuta
conspersa di capelli corti e rari,
con una faccia lenticchiosa e magra.
(Italia, XIV)
a‡scistoj d ¢n¾r ØpÕ ”Ilion Ãlqe:
folkÕj œhn, cwlÕj d' ›teron pÒda. të dš oƒ êmw
kurtë ™pˆ stÁqoj sunocwkÒte.
aÙt¦r Ûperqe
foxÕj œhn kefal»n, yedn¾ d' ™pen»noqe l£cnh.
(Iliade, II, vv. 216-219)184
quanto nel suo discorso, con l’accusa di avidità rivolta al capo dell’esercito, il
biasimo alla prona obbedienza all’autorità rivolto, con un disonorevole femminile, alle
«misere Romane, non Romani» (Il. II, v. 235: ð pšponej k£k' ™lšgce' 'Acaiΐdej
oÙkšt' 'Acaioˆ) e il riferimento all’offesa inflitta a Corsamonte/Achille:
ch'han privo Corsamonte de la moglie,
ch'era il miglior guerrier che fosse in campo;
ond'ei partissi, e ci ha lasciati in preda
più de gli amici assai che de i nimici.
Ma quei fu troppo buon, ch'alora forse
areste fatto a noi l'ultimo danno.
(Italia, XIV)
Öj kaˆ nàn 'AcilÁa ›o mšg' ¢me…nona fîta
ºt…mhsen. ˜lën g¦r œcei gšraj aÙtÕj ¢poÚraj.
¢ll¦ m£l' oÙk 'AcilÁϊ cÒloj fres…n, ¢ll¦ meq»mwn·
à g¦r ¨n 'Atre dh nàn Ûstata lwb»saio.
(Iliade, II, vv. 239-242)185
e infine nella punizione inflittagli da Traiano/Ulisse che lo colpisce con lo scettro,
suscitando il riso generale:
Così disse Traiano, e poi menolli
col scettro suo che si trovava in mano
sopra la schena e su le curve spalle;
ond'ei piegossi, e gli cadder da gli occhi
lagrime salse, e sotto l'empia ferza
le battiture acerbe si gonfiaro:
et ei dolente risguardando intorno
si nettava la faccia con un piglio
che mosse riso a tutta quella gente,
quantunque fosse sconsolata e mesta.
(Italia, XIV)
•Wj ¥r' œfh, sk»ptrJ dὲ met£frenon ºdὲ kaˆ êmw
plÁxen. Ö d' „dnèqh, qalerÕn dš oƒ œkpese d£kru.
smîdix d' aƒmatÒessa metafršnou ™xupanšsth
sk»ptrou Ûpo crusšou. Ö d' ¥r' ›zeto t£rbhsšn te,
¢lg»saj d' ¢cre‹on „dën ¢pomÒrxato d£kru.
o‰ dὲ kaˆ ¢cnÚmeno… per ™p' aÙtù ¹dÝ gšlassan.
(Iliade, II, vv. 265-270)186
184
Trad.: « Era il più brutto tra i Greci venuti a Troia: / si trascinava zoppo ad un piede, le spalle curve /
rientranti sul petto; sopra, la testa / era appuntita e coperta da rada peluria ».
185
Trad.: « lui che anche adesso ha offeso Achille, un guerriero / molto migliore di lui, gli ha tolto il suo
premio, e se lo tiene. / Ma Achille è conciliante, non ha rabbia nel cuore; / altrimenti, figlio di Atreo, per
l’ultima volta avresti offeso ».
186
Trad.: « Così disse, e lo colpì con lo scettro sul dorso / e sulle spalle – Tersite si piegò e gli cadde una
lacrima, / e una piaga si produsse sul dorso al colpo / dello scettro dorato; sedette impaurito e dolorante, /
e con uno sguardo attonito si asciugò il pianto. A ciò gli altri sorrisero, per quanto afflitti ».
163
La rielaborazione tassiana della rivolta capeggiata da Argillano sarà invece molto
più libera e autonoma, e meglio saldata con il resto della narrazione nel suo
collegamento sia al meraviglioso demoniaco tramite il sogno ingannatore della furia
Aletto, sia al precedente ritrovamento delle armi insanguinate di Rinaldo; ciò
nonostante, appare innegabile che lo spunto di una sedizione interna al campo in un
momento di crisi e di un’accusa rivolta esplicitamente al capo dell’esercito risalgono
senz’altro ad Omero attraverso il consueto tramite trissiniano, trattando la sedizione
interna come un vero e proprio topos epico: mentre nell’Iliade l’episodio precede di
gran lunga la crisi dell’esercito acheo, in Trissino e sulla sua scorta il Tasso lo
ricollocano entrambi nel pieno della crisi militare.
Il libro XV narra poi l’assedio di Roma, dov’è asserragliato l’esercito di Belisario,
da parte dell’esercito dei Goti, replicando una situazione bellica rovesciata rispetto ai
ruoli dell’intera guerra che, pur debitrice dell’affine rovesciamento iliadico quando i
Troiani si spingono al muro e poi alle navi, replica soprattutto l’assedio al campo
troiano da parte di Turno in Eneide IX: di ascendenza virgiliana è in particolare il
personaggio dell’amazzone Nicandra, plasmato a imitazione di Camilla e che costituirà
uno dei precedenti più rilevanti della Clorinda tassiana. Ciò nonostante, lo stile continua
ad essere prevalentemente omerizzante, e vengono inoltre riutilizzati e variamente
ricombinati materiali iliadici, come ad esempio l’esortazione di Totila a Teio (ricordata
in apertura del capitolo) che traduce quella di Sarpedone a Glauco in Iliade XII.
In questa lunga sezione “romana” del poema, l’unico libro a non avere
direttamente a che fare con strutture iliadiche è il XVI, dove la distruzione delle
macchine da assedio abbandonate dai Goti sarà, insieme alle fonti storiche, lo spunto
della ben più rilevante vicenda affine nel poema tassiano.
Ma già con il XVII libro torna in primo piano l’esempio iliadico di elementi
diversivi di matrice epica attraverso il topos del duello concordato, esemplato su quello
fra Ettore e Aiace in Iliade VII e ancora una volta tramite per il simile duello tassiano
fra Tancredi e Argante (Liberata VI, Conquistata VII). Come al solito, il Trissino segue
Omero molto più da vicino di quanto farà Tasso, che invece – pur dagli stessi
presupposti narrativi della sfida, della scelta dello sfidante e del conseguente duello
avulso dallo scontro collettivo, interrotto dal sopraggiungere dell’oscurità – elabora un
episodio in gran parte autonomo, soprattutto nello splendido intermezzo lirico della
visione di Clorinda e poi nella opposta caratterizzazione psicologia dei duellanti
164
emergente dalla dimensione schermistica e decisamente cinquecentesca della “singolar
tenzone”. Nell’Italia troviamo invece la consueta fedeltà continuamente sconfinante
nella traduzione, dall’innesco “celeste” del duello, al timore degli avversari a rispondere
alla sfida, fino allo sdegno di Belisario che, al pari di Menelao, si propone lui stesso
come avversario:
Ma dopo questo ancor ciascun si tacque,
perch'avean tema d'accettar l'invito
e gli parea vergogna il rifiutarlo.
Allor levossi il capitanio eccelso
e disse con disdegno e con dolore:
O cavalieri arditi a le minaccie
e pegri e lenti ad essequire i fatti,
veramente Romane e non Romani:
questa vi sarà pur vergogna eterna,
a non risponder nulla ad un guerriero
che solo ardisca a disfidarci tutti.
Non sarà questo no, non sarà questo:
datemi l'arme, ch'io vuo' gire al campo
e combatter con lui senza dimora;
sia la vittoria poi dove al ciel piaccia.
(Italia, XVII)
•Wj œfaq', oƒ d' ¥ra p£ntej ¢k¾n ™gšnonto siwpÍ:
a‡desqen mὲn ¢n»nasqai, de‹san d' Øpodšcqai:
Ñyὲ dὲ d¾ Menšlaoj ¢n…stato kaˆ metšeipe
ne…kei Ñneid…zwn, mšga dὲ stenac…zeto qumù:
ê moi ¢peilhtÁrej 'Acai dej oÙkšt' 'Acaio…:
à mὲn d¾ lèbh t£de g' œssetai a„nÒqen a„nîj
e„ m» tij Danaîn nàn “Ektoroj ¢nt…oj eἶsin.
¢ll' Øme‹j mὲn p£ntej Ûdwr kaˆ ga‹a gšnoisqe
¼menoi aâqi ›kastoi ¢k»rioi ¢kleὲj aÜtwj:
tùde d' ™gën aÙtÕj qwr»xomai· aÙt¦r Ûperqe
n…khj pe…rat' œcontai ™n ¢qan£toisi qeo‹siν.
(Iliade, VII, vv. 92-102)187
Come Menelao dal vecchio Nestore, così qui Belisario è distolto da un simile
proposito che metterebbe a rischio l’intera impresa attraverso un lungo discorso del
“venerando Paulo”: un parallelo racconto del suo giovanile ardire in combattimento
risveglia lo spirito guerriero negli altri eroi:
O summo Re de le sustanze eterne,
foss'io di quella età com'era quando
noi combatemmo là press'al Ticino
col forte re de gli Eruli Odoacro…
(Italia, XVII)
aŠ g¦r Zeà te p£ter kaˆ 'Aqhna…h kaˆ ”Apollon
¹bùm' æj Ót' ™p' çkurÒJ Kel£donti m£conto
¢grÒmenoi PÚlio… te kaˆ 'Ark£dej ™gces…mwroi
Fei©j p¦r te…cessin 'Iard£nou ¢mfˆ ·šeqra...
(Iliade, VII, vv. 132-135)188
Alla fine viene scelto Aquilino, e segue un duello anch’esso molto simile a quello
iliadico; degno di rilievo, in particolare, è il breve dialogo fra i due contendenti in cui
viene ricordata la connessione fra gli elementi diversivi che stiamo ricordando e
l’assenza dell’eroe necessario, che – in parallelo a quanto avviene per l’Achille omerico
– tende ad incombere costantemente sulla narrazione pur in absentia:
187
Trad.: « Così disse, e tutti rimasero muti, in silenzio, / vergognandosi di rifiutare e temendo / di
accettare, finché si alzò Menelao rimbrottandoli / con aspre parole e gemendo in cuor suo: / “Ahimè,
millantatori, Achee e non più Achei, / questa sarà un’infamia più infame di tutte, / se nessuno dei Greci
affronterà Ettore. / Possiate tutti diventare acqua e terra, / voi che restate seduti senza coraggio né onore. /
Io dunque mi armerò contro di lui, giacché la sorte / della vittoria sta in alto presso gli dèi immortali” ».
188
Trad.: « Magari, Zeus padre, ed Atena, ed Apollo, / fossi giovane come quando presso il Celadonte / si
radunarono per combattere i Pilî e gli Arcadi bellicosi, / sotto le mura di Feia, sulle rive del fiume
Giardano… ».
165
…e disse minacciando este parole:
Turrismondo or saprai da solo a solo
come son fatti i principi romani,
se ben non c'è il feroce Corsamonte;
perciò che senza lui molti ci sono
che potran contraporsi a la tua forza.
A cui rispose Turrismondo altero:
Valoroso Acquilin, mastro di guerra,
non mi tentar come fanciullo o come
femina d'arme e di milizia ignara,
ch'esperto son anch'io ne le battaglie
e so ferire e uccidere i nimici
e so ben maneggiar la lancia e 'l scudo
con la sinistra mano e con la destra,
e so combattere a cavallo e a piedi.
Guàrdati adunque, ch'io non vuo' ferirti
nascosamente, e schiva questo colpo.
(Italia, XVII)
stÁ ·a m£l' “Ektoroj ™ggÚj, ¢peil»saj dὲ proshÚda·
“Ektor nàn mὲn d¾ s£fa e‡seai o„Òqen oἶoj
oŒoi kaˆ Danao‹sin ¢ristÁej metšasi
kaˆ met' 'AcillÁa ·hx»nora qumolšonta.
¢ll' Ö mὲν ™n n»essi korwn…si pontopÒroisi
ke‹t' ¢pomhn…saj 'Agamšmnoni poimšni laîn·
¹me‹j d' e„mὲn to‹oi o‰ ¨n sšqen ¢nti£saimen
kaˆ polšej· ¢ll' ¥rce m£chj ºdὲ ptolšmoio.
TÕn d' aâte prosšeipe mšgaj koruqa…oloj “Ektwr·
Aἶan diogenὲj Telamènie ko…rane laîn
m» t… meu ºäte paidÕj ¢fauroà peir»tize
º gunaikÒj, ¿ oÙk oἶden polem»ϊa œrga.
aÙt¦r ™gën eâ o da m£caj t' ¢ndroktas…aj te·
o d' ™pˆ dexi£, oἶd' ™p' ¢rister¦ nwmÁsai bîn
¢zalšhn, tÒ moi œsti talaÚrinon polem…zein·
o da d' ™paΐxai mÒqon †ppwn çkei£wn·
o da d' ™nˆ stad…V dh J mšlpesqai ”Arhϊ.
¢ll' oÙ g£r s' ™qšlw balšein toioàton ™Ònta
l£qrV ÑpipeÚsaj, ¢ll' ¢mfadÒn, a‡ ke tÚcwmi.
(Iliade, VII, vv. 225-243)189
Simile, poi, anche l’interruzione per il sopraggiungere della notte e il reciproco
scambio di doni fra i due contendenti.
Infine, l’ultimo libro di questa ampia fase di “devastazione”, prima che
Corsamonte torni a combattere rovesciando le sorti della guerra, è il XVIII: qui la crisi
dell’esercito di Belisario raggiunge il suo apice con il ferimento di Belisario stesso e la
morte di tre dei suoi guerrieri fra i più forti, Aquilino, Agrippa e l’amazzone Nicandra.
La situazione, naturalmente, replica la crisi dell’esercito acheo nei libri XI-XVI
dell’Iliade, che era stata già parzialmente ripresa, soprattutto nel libro XII dell’Italia,
riguardo alle sorti generali della battaglia, e ora viene di nuovo ripresa, con ulteriore
aggravamento, rispetto ai singoli guerrieri principali dell’esercito imperiale bizantino.
Gli scontri si aprono con un’ampia aristia di Belisario che rielabora piuttosto da
vicino quella di Agamennone in Iliade XI. D’altronde il libro incomincia, come quello
iliadico, con la parallela vestizione delle armi da parte del capo dell’esercito 190 ,
improntata alla più fedele e particolareggiata ἐνάργεια di stampo omerico:
189
Trad.: « si accostò ad Ettore e disse vantandosi: / “Ettore, ora saprai chiaramente, da solo a solo, / quali
campioni vi sono ancora tra i Greci / dopo il vittorioso Achille cuor di leone. / È vero che lui rimane
presso le navi, / irato con Agamennone, capo d’eserciti; / ma restiamo noi, anche in molti, capaci / di
affrontarti: comincia dunque il duello”. / Gli rispose Ettore, l’eroe dall’elmo splendente: / “Illustre Aiace
figlio di Telamone, capo d’eserciti, / non provocarmi, come se fossi un ragazzetto, / o una donna, che non
conosce i fatti di guerra. / Io conosco bene le battaglie e i massacri, / so muovere a destra ed a sinistra la
pelle / disseccata che mi fa scudo nel combattimento, / e so assaltare nella mischia i carri veloci / e
danzare nel corpo a corpo per Ares feroce. / Ma uno come te non voglio colpirlo / cogliendolo di sorpresa,
ma apertamente, se posso”».
190
Sulla tipicità della scena omerica di vestizione delle armi, cfr. almeno ARMSTRONG, J. L., The Arming
Motive in the Iliad, AJPh 19 (1958), pp. 337-54, il primo contributo a individuare esplicitamente il nesso
fra gli elementi tradizionali a livello di dizione (la formularità parryana) e gli elementi tradizionali a
livello tematico.
166
Belisario dapoi con alta voce
comandò che ciascun prendesse l'arme;
ed egli armossi: e prima i sproni d'oro
si pose e le schiniere, e poi le arnise
tutte di ferro lucido e dorate
mirabilmente là presso al genocchio;
e sopra l'assettato suo gipone
si pose i fiancaletti, e poi si cinse
a i stretti fianchi la sicura falda,
d'una maglia finissima d'acciale,
che solamente ne le parti estreme
aveva un fregio di magliette d'oro.
Poi sopra queste pose la corazza
che 'l gran Giustinïan gli aveva donata
quando 'l mandò in Italia a liberarla:
questa fu prima d'Atila feroce,
e Zelibe donolla al buon Giustino
quando con lui fé lega contra i Persi,
la qual fu poi cagion de la sua morte.
Questo era tutta di sì fino acciale
che nol potea signar taglio di spada,
e risplendea come brunito argento:
questa avea dui serpenti intorn'al collo
d'oro e di smalti varïati in modo
ch'esser parean la figlia di Taumante
quando nel cielo appar dopo la pioggia,
e ne l'estremo lembo un fregio d'oro
la scorrea tutta con mirabil arte.
Poi fece porsi i braccialetti in braccio,
fregiati d'oro anch'ei presso a la mano:
indi gli fu vestito un bel saggione
di brocato gentil, cargo di perle
rotonde e grosse e di bianchezza immensa.
Da poi si cinse l'onorata spada,
col manico di prasma e 'l fodro d'oro,
e 'l pugnaletto avea da l'altro fianco,
guarnito anch'esso di mirabiol gemme.
Fecisi anco allacciare i gran spalazzi
fregiati d'oro, e prese i guanti in mano,
e la celata si fé porre in testa
di gemme adorna e di purpuree penne.
(Italia, XVII)
'Atreΐdhj d' ™bÒhsen „dὲ zènnusqai ¥nwgen
'Arge…ouj· ™n d' aÙtÕj ™dÚseto nèropa calkÒn.
knhm‹daj mὲn prîta perˆ kn»mVsin œqhke
kal¦j ¢rguršoisin ™pisfur…oij ¢raru…aj·
deÚteron aâ qèrhka perˆ st»qessin œdune,
tÒn potš oƒ KinÚrhj dîke xein»ϊon eἶnai.
peÚqeto g¦r KÚpron dὲ mšga klšoj oÛnek' 'Acaioˆ
™j Tro…hn n»essin ¢napleÚsesqai œmellon·
toÜnek£ oƒ tÕn dîke carizÒmenoj basilÁϊ.
toà d' ½toi dška oἶmoi œsan mšlanoj ku£noio,
dèdeka dὲ cruso‹o kaˆ e‡kosi kassitšroio·
ku£neoi dὲ dr£kontej Ñrwršcato protˆ deir¾n
tre‹j ˜k£terq' ‡rissin ™oikÒtej, ¤j te Kron…wn
™n nšfeϊ st»rixe, tšraj merÒpwn ¢nqrèpwn.
¢mfˆ d' ¥r' êmoisin b£leto x…foj· ™n dš oƒ Âloi
crÚseioi p£mfainon, ¢t¦r perˆ kouleÕn Ãen
¢rgÚreon crusšoisin ¢ort»ressin ¢rhrÒj.
¨n d' ›let' ¢mfibrÒthn poluda…dalon ¢sp…da qoàrin
kal»n, ¿n pšri mὲn kÚkloi dška c£lkeoi Ãsan,
™n dš oƒ Ñmfaloˆ Ãsan ™ε…kosi kassitšroio
leuko…, ™n dὲ mšsoisin œhn mšlanoj ku£noio.
tÍ d' ™pˆ mὲn Gorgë blosurîpij ™stef£nwto
deinÕn derkomšnh, perˆ dὲ De‹mÒj te FÒboj te.
tÁj d' ™x ¢rgÚreoj telamën Ãn· aÙt¦r ™p' aÙtoà
ku£neoj ™lšlikto dr£kwn, kefalaˆ dš oƒ Ãsan
tre‹j ¢mfistrefšej ˜nÕj aÙcšnoj ™kpefuu‹ai.
kratˆ d' ™p' ¢mf…falon kunšhn qšto tetraf£lhron
†ppourin· deinÕn dὲ lÒfoj kaqÚperqen œneuen.
e†leto d' ¥lkima doàre dÚw kekoruqmšna calkù
Ñxša· tÁle dὲ calkÕj ¢p' aÙtÒfin oÙranÕn e‡sw
l£mp'· ™pˆ d' ™gdoÚphsan 'Aqhna…h te kaˆ “Hrh
timîsai basilÁa polucrÚsoio Muk»nhj.
(Iliade, XI, vv. 15-46)191
191
Trad.: « Il figlio di Atreo gridò, ordinò ai Greci di cingere / le armi ed egli stesso indossò il bronzo
lucente. / Per prima cosa mise alle gambe le belle gambiere / rafforzate da cavigliere d’argento; / poi
indossò sopra il petto la corazza che un tempo / gli diede Cinira come dono ospitale, / avendo saputo a
Cipro la grande notizia che i Greci / stavano per andare a Troia per nave, / e gliela diede per fargli cosa
gradita: / aveva dieci fasce di smalto nero, / dodici d’oro e venti fasce di stagno, / e serpenti di smalto si
tendevano verso il collo, / tre da ogni lato, simili agli arcobaleni che il figlio di Crono / colloca nelle
nuvole come segnale per gli uomini. / Poi mise attorno alle spalle la spada, lucente / di borchie d’oro – il
fodero era d’argento, / connesso con ganci dorati; poi sollevò il grande scudo, / robusto, riccamente
adorno, / bellissimo, attorno a cui c’erano dieci cerchi di bronzoe al centro venti borchie bianche di stagno
/ e una al mezzo di smalto nero; di sopra / faceva corona la Gorgone dal volto agghiacciante, / dallo
sguardo tremendo, e vicino il Terrore e la Disfatta. / Il balteo era d’argento e sopra di esso / si stendeva un
serpente di smalto, che aveva tre teste / intrecciate tra loro sopra un unico collo. / Sulla testa mise l’elmo
con due cimieri e quattro creste / e la coda equina: sopra ondeggiava terribilmente il pennacchio. / Prese
due lance robuste, con la punta di bronzo, / acute; da lontano splendeva il bronzo / fino al cielo. Era ed
Atena uonarono, / rendendo onore al re di Micene dorata ».
167
Dopo una lunga serie di gesta in cui il capitano, esponendosi al pericolo di vita in
qualità di guerriero, contravviene così all’accorto consiglio datogli altrove (libro XVII)
dal vecchio Paulo, secondo cui il capitano non deve esporsi personalmente in battaglia
mettendo a rischio, assieme alla propria vita, l’intera impresa 192 , questo errore di
Belisario da lui sarà scontato con il suo ferimento ad una mano, che lo costringerà,
esattamente come Agamennone, a porre fine alla sua aristia e ritirarsi dalla battaglia: di
nuovo la traduzione si fa qui pressoché letterale, riprendendo persino l’identica
similitudine delle doglie:
il qual non ebbe impedimento alcuno
da la ferita sua mentre era calda;
ma come la nettò, cessando il sangue,
sentì nel corpo suo dolori amari
simili a quei d'una leggiadra donna
che si ritruovi esser vicina al parto,
che doglia sopra doglia ognor la ingombra;
così i dolori acuti un sopra l'altro
nel capitanio eccelso si destaro,
tal che deliberossi andare in Roma
per medicarsi, e disse al buon Narsete:
Signore illustre e di valore immenso,
io vuo' lasciarvi il pondo de la guerra
e di espugnare i valli u' son ridotti
i nostri timidissimi nimici,
ch'io non posso più stare a la campagna,
tanto dolor mi fa questa mia piaga:
però voglio ridurmi entr'a le mura
per trovar, s'io potrò, qualche rimedio.
(Italia, XVII)
AÙt¦r Ö tîn ¥llwn ™pepwle‹to st…caj ¢ndrîn
œgceϊ t' ¥or… te meg£lois… te cermad…oisin,
Ôfr£ oƒ aŒm' œti qermÕn ¢n»noqen ™x çteilÁj.
aÙt¦r ™peˆ tÕ mὲn ›lkoj ™tšrseto, paÚsato d' aŒma,
Ñxe‹ai d' ÑdÚnai dànon mšnoj 'Atreϊdao.
æj d' Ót' ¨n çd…nousan œcV bšloj ÑxÝ guna‹ka
drimÚ, tÒ te proϊe‹si mogostÒkoi E„le…quiai
“Hrhj qugatšrej pikr¦j çd‹naj œcousai,
ìj Ñxe‹' ÑdÚnai dànon mšnoj 'Atreϊdao.
™j d…fron d' ¢nÒrouse, kaˆ ¹niÒcJ ™pštelle
nhusˆn œpi glafurÍsin ™launšmen· ½cqeto g¦r kÁr.
½ãsen dὲ diaprÚsion Danao‹si gegwnèj·
ð f…loi 'Arge…wn ¹g»torej ºdὲ mšdontej
Øme‹j mὲn nàn nhusˆn ¢mÚnete pontopÒroisi
fÚlopin ¢rgalšhn, ™peˆ oÙk ™mὲ mht…eta ZeÝj
e‡ase Trèessi panhmšrion polem…zein.
(Iliade, XI, vv. 264-279)193
Ispirandosi a un saggio di Bruscagli194, Marco De Masi195 individua l’errore di
Belisario nel negare Elpidia in sposa a Corsamonte, esigendo dai suoi sottoposti la
stessa dedizione totalizzante alla causa bellica che egli chiede a se stesso: come
abbiamo visto, enunciata in questi termini la questione appare quantomeno troppo
drasticamente semplificata, e torneremo su di essa fra breve; per ora ci interessa notare
192
Signor, non tocca a voi questa battaglia: / perché tra i sommi capitani sempre / l'audace ha manco
laude che 'l sicuro. / S'a questa vi sfidasse il re de' Gotti, / forse non vi direi che non v'andassi: /
quantunque il capitanio che governa / non deggia mai combatter, se non quando / forza è salvare o
inanimar le genti.
193
Trad.: « Ma lui ancora attaccava file di uomini / con la spada e la lancia e con grandi pietre, / finché
dalla ferita gli usciva sangue ancora caldo. / Ma quando il sangue cessò e si stagnò la ferita, / dolori acuti
invasero il figlio di Atreo. / Come una partoriente è colpita dallo strale acuto, / che scoccano le Ilizie, dee
della nascita, / figlie di Era, portatrici di doglie acute, / così i dolori invasero il figlio di Atreo. / Saltò sul
carro e ordinò al suo auriga / di guidarlo alle navi: era affranto nel cuore. / E però ancora gridò per farsi
sentire dai Greci: / “Amici miei, capi e guide dei Greci, / ora dovete difendere dal terribile assalto / le
nostre navi, perché il saggio Zeus non mi concede / di lottare contro i Troiani per tutto il giorno” ».
194
BRUSCAGLI, R., L’errore di Goffredo (G.L. XI), «Studi Tassiani», 40-41 (1992-1993), pp. 207-232
(ristampato in ID., Studi cavallereschi, Firenze, Società Editrice fiorentina, 2003, pp. 167-198).
195
DE MASI, M., L’errore di Belisario, Corsamonte, Achille, cit.
168
come Belisario commetta anche un errore perfettamente parallelo a quello che Bruscagli
individua per Goffredo in Liberata XI, ossia subordinare a una questione privata di
onore e di fede personale la causa bellica collettiva. Tale errore, come si vede, è una
risemantizzazione di un elemento desunto dall’Iliade: anche lì, infatti, lo sconsiderato
esporsi di Agamennone in combattimento e il suo conseguente ferimento costituiscono
l’innesco del successivo ferimento degli altri grandi eroi Achei che porta fino alla
disperata situazione del libro XV e alla morte di Patroclo nel XVI. L’avventatezza del
capo dell’esercito appare tanto più evidente per la risonanza della precedente accusa di
non prendere parte attiva agli scontri rivoltagli Achille e, rispettivamente, delle parole
con cui Agamennone prospetta, nell’eventualità della morte di Menelao, l’indecorosa
fine dell’intera impresa di guerra:
oÜtš pot' ™j pÒlemon ¤ma laù qwrhcqÁnai
oÜte lÒcon d' „šnai sÝn ¢rist»essin 'Acaiîn
tštlhkaj qumù· tÕ dš toi k¾r e‡detai eἶnai.
(Iliade, I, 226-228)196
¢ll£ moi a„nÕn ¥coj sšqen œssetai ð Menšlae
a‡ ke q£nVj kaˆ pÒtmon ¢napl»sVj biÒtoio.
ka… ken ™lšgcistoj polud…yion ”Argoj ƒko…mhn·
aÙt…ka g¦r mn»sontai 'Acaioˆ patr…doj a‡hj·
k¦d dš ken eÙcwl¾n Pri£mJ kaˆ Trwsˆ l…poimen
'Arge…hn `Elšnhn· sšo d' Ñstša pÚsei ¥roura
keimšnou ™n Tro…V ¢teleut»tJ ™pˆ œrgJ.
(Iliade, IV, 169-175)197
Il Trissino riprende, condensandola nell’arco di un solo libro, l’identica
successione per cui dal rischioso intervento del capitano e dal suo ferimento deriva la
sconfitta dei principali guerrieri della sua parte, privata momentaneamente della guida,
che culmina appunto nella fedele ripresa della morte di Patroclo. La stessa idea di
matrice iliadica sarà ripresa, attraverso il consueto tramite del Trissino, anche appunto
per il ferimento di Goffredo in Liberata XI, con la conseguente vanificazione di quel
primo tentativo di assalto a Gerusalemme.
Uscito di scena il capitano, seguono tre ampie scene di cui si rendono
protagonisti,
con
esito
funesto,
alcuni
fra
i
principali
eroi
dell’esercito
momentaneamente privo di guida: si ha appunto l’impressione che l’assenza di un
coordinamento unitario e generale degli scontri lasci emergere l’azione individuale
196
Trad.: « tu non hai mai avuto il coraggio di armarti / per la guerra assieme ai tuoi uomini, né di andare
in agguato / coi migliori dei Greci: questo ti sembra la morte ».
197
Trad.: «Ma per te, Menelao, avrò atroce dolore / se tu muori, compiendo il destino della tua vita; /
tornerei infamato all’arida terra di Argo: / subito infatti gli Achei desidereranno tornare in patria, / e
lasceremo in trofeo a Priamo e ai Troiani / Elena argiva, e la terra consumerà le tue ossa / giacenti a Troia,
per un’impresa incompiuta ».
169
troppo arrischiata e quasi priva di controllo: l’assenza rispettivamente di Belisario e di
Goffredo, con la loro autorità capace di unificare i rispettivi eserciti in un corpo unitario
e coeso (l’uniforme cristiano di cui parla Zatti), fa sì che riemergano immediatamente,
con tutta la loro carica distruttiva, le tendenze centrifughe ed individualistiche mosse
dall’ambizione personale.
Dei tre eroi che si arrischiano l’uno dopo l’altro in un’iniziativa anarchica e
pericolosa, il primo è Aquilino, il responsabile dell’allontanamento di Corsamonte dal
campo. Egli non teme di contrapporsi da solo a una moltitudine di nemici e poi di
rotolarsi in un fosso con Turrismondo, il più feroce dei Goti, in un uno scontro che
ricorda alla lontana quello fra Ruggero e Rodomonte nel finale del Furioso: l’azione
troppo indulgente al pericolo si conclude con la morte di Aquilino per mano di
Turrismondo. La morte di uno dei campioni principali di Belisario getta nello sconforto
tutta la sua parte e dà avvio al prevalere dei Goti.
Dopo di lui, la scena passa a Nicandra. Così come il personaggio nel suo
complesso, la morte di Nicandra mostra qualche contatto con l’episodio virgiliano della
morte di Camilla in Eneide XI, seppure in maniera piuttosto generica, mentre la sua
fonte diretta è piuttosto la morte di Pentesilea per mano di Achille narrata in Quinto
Smirneo, noto al rinascimento italiano come Quinto Calabro198. L’ampliamento patetico
e amoroso per cui Turrismondo, ignaro di essersi vendicato su una donna di un forte
colpo da lei poco prima infertogli, al trarle l’elmo dalla testa piange la sua morte e quasi
se ne innamora, è uno dei pochi luoghi trissiniani esplicitamente riconosciuti dalla
critica tassiana come fonti della Liberata (nonostante la serie di derivazioni fittissime e
spesso strutturali che stiamo evidenziando): è ben noto come da questo passo, peraltro
contaminato con un altro luogo anch’esso trissiniano, origini l’episodio forse più
celebre e celebrato dell’intera Gerusalemme, la morte di Clorinda:
…e prima le cavò l'elmo di testa,
ch'avea tre belle gemme per cimiero,
un rubino, un diamante ed un zafiro:
ma come vide ch'era una fanciulla
di vago aspetto e di beltà suprema,
che già s'impallidiva per la morte
ed essalava gli ultimi suspiri,
d'amore e di pietà tanto s'accese
198
Il manoscritto (H: Hydruntinus, oggi perduto) dei suoi Posthomerica fu riscoperto nei pressi di Otranto
(per questo fu detto “Calabro”) dal cardinal Bessarione dopo il 1452; il testo era noto al rinascimento
italiano – spesso anche il Tasso cita l’autore nei trattati e nelle lettere – sin dall’editio princeps aldina del
1504 (lo stesso anno della prima aldina dell’Iliade), recante il titolo Quinti Calabri derelictorum ab
Homero libri XIV. Venetiis: in aedibus Aldi. Cfr. in proposito VIAN, F., Histoire de la tradition
manuscrite de Quintus de Smyrne, Presses universitaires de France, Paris, 1959.
170
che disse suspirando este parole:
Ahi, miserabil vergine, tu muori
per man di chi vorrìa tenerti in vita,
e che t'aiuteria col proprio sangue.
Ma poi ch'è corso il mal contra mia voglia
per non saper chi m'avea fatto oltraggio,
rendoti l'elmo e le tue lucid'arme
e 'l tuo cavallo, e ti rimando a i tuoi.
E detto questo, volse dare un baso
con gli occhi ruggiadosi a quella estinta,
poi suspirando rimontò a cavallo.
(Italia, XVIII)
onde Bisandro, che giacea tra loro
e che spirava ancora, aperse gli occhi;
di che s'avvide Rodorico, e disse:
Bisandro; ed ei rispose; O fratel caro,
porgime un poco d'acqua anzi ch'io muora.
E Rodorico andò correndo al fiume;
poi la celata si cavò di testa
e l'empì d'acqua liquida, e portolla
a quel maschino, e glie ne diede a bere:
onde per essa ristorossi tanto
che ritornolli l'intelletto e i sensi.
(Italia, XIII)
Poco quindi lontan nel sen del monte
scaturia mormorando un picciol rio.
Egli v'accorse e l'elmo empié nel fonte,
e tornò mesto al grande ufficio e pio.
Tremar sentí la man, mentre la fronte
non conosciuta ancor sciolse e scoprio.
La vide, la conobbe, e restò senza
e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza!
Non morí già, ché sue virtuti accolse
tutte in quel punto e in guardia al cor le mise,
e premendo il suo affanno a dar si volse
vita con l'acqua a chi co 'l ferro uccise.
Mentre egli il suon de' sacri detti sciolse,
colei di gioia trasmutossi, e rise;
e in atto di morir lieto e vivace,
dir parea: “S'apre il cielo; io vado in pace.”
(G. L., XII, 67-68)
Molto meno nota è invece l’influenza della scena di Quinto Smirneo,
Posthomerica, I, in cui è narrata la morte di Pentesilea, l’amazzone di cui Achille si
innamora al momento di spogliarla delle armi dopo averla uccisa: i commenti alla
Liberata, compreso quello recente e molto ricco di Franco Tomasi, evidenziano il nesso
del celebre luogo tassiano con il modello trissiniano e quello virgiliano, ma sembrano
ignorare del tutto che il precedente più diretto della morte di Nicandra nel Trissino non
è la tanto Camilla virgiliana quanto piuttosto la Pentesilea di Quinto Smirneo (il quale,
171
semmai, era stato a sua volta influenzato dal grande poeta latino199). Dal poeta greco
d’età imperiale è ripreso infatti il dettaglio dell’uccisore che toglie l’elmo all’amazzone
da lui uccisa (v. 657), come pure l’innamoramento che ne consegue alla vista della
bellezza di lei (vv. 666 sgg.) e soprattutto il rammarico per averle tolto la vita (v. 671
sgg.): tutti aspetti completamente assenti dalla scena virgiliana. Risulta evidente come
Quinto Smirneo sia la fonte diretta della scena dal Trissino e, attraverso il suo tramite,
anche fonte indiretta della celeberrima scena tassiana:
•Wj e„pën mel…hn ™xe…ruse Phlšoj uƒÕj
çkšoj ™x †ppoio kaˆ a„nÁj Penqesile…hj·
¥mfw d' ¢spa…reskon Øf' ἓν dÒru dVwqšntej.
'Amfˆ dš oƒ krαtÕj kÒrun e†leto marma…rousan
ºel…ou ¢kt‹sιn ¢l…gkion À DiÕj a‡glV·
tÁj dὲ kaˆ ™n kon…Vsi kaˆ a†mati pepthu…hj
™xef£nh ™ratÍsin Øp' ÑfrÚsi kal¦ prÒswpa
ka… per ¢poktamšnhj. O‰ d', æj ‡don, ¢mfišpontej
'Arge‹oi q£mbhsan, ™peˆ mak£ressin ™ókei.
Ke‹to g¦r ™n teÚcessi kat¦ cqonÕj ºÚt' ¢teir¾j
”Artemij Øpnèousa DiÕj tškoj, eâte k£mVsi
gu‹a kat' oÜrea makr¦ qooÝj b£llousa lšontaj·
aÙt¾ g£r min œteuxe kaˆ ™n fqimšnoisin ¢ght¾n
KÚprij ™ustšfanoj krateroà par£koitij ”Arhoj,
Ôfr£ ti kaˆ PhlÁoj ¢mÚmonoj uŒ' ¢kac»sV.
Polloˆ d' eÙcetÒwnto kat' o„k…a nost»santej
to…hj <tÁsd'> ¢lÒcoio par¦ lecšessin „aàsai.
Kaˆ d' 'AcileÝj ¢l…aston ˜ù ™nete…reto qumù,
oÛnek£ min katšpefne kaˆ oÙk ¥ge d‹an ¥koitin
Fq…hn e„j eÜpwlon, ™peˆ mšgeqÒj te kaˆ eἶdoj
œplet' ¢mèmhtÒj te kaˆ ¢qan£tVsin Ðmo…h.
(Posthomerica, I, vv. 654-674)200
D’altronde già il colpo di lancia con cui Pentesilea è ferita da Achille deriva
chiaramente anche da questa scena oltre che dal colpo inferto da Arrunte a Camilla,
l’unico citato dai commenti a Tasso:
199
Sui contatti testuali fra la morte di Camilla e quella di Pentesilea in Quinto Smirneo, cfr. GÄRTNER, U.,
Quintus Smyrnaeus und die Aeneis. Zur Nachwirkung Vergils in der griechischen Literatur der
Kaiserzeit, Zetemata 123, Beck, München, 2005, pp. 63-65.
200
QUINTUS SMYRNAEUS, The fall of Troy, with an English translation by WAY, A. S., Cambridge
(Mass.), Harvard University Press - London, Heinemann, 1955; trad.: « So spake he, and his ashen spear
the son of Peleus drew from that swift horse, and from Penthesileia in death’s agony. Then steed and rider
gasped their lives away slain by one spear. Now from her her haed he plucked the helmet spendourflashing like the beams of the great sun, or Zeus’ own glory-light. Then, there as fallen in dust and blood
she lay, rose, like the breaking of the dawn, to view ’Neath dainty-pencilled brows a lovely face, lovely in
death. The Argives thronged around, and all they saw and marvelled, for she seemed like an Immortal. In
her armour there upon the earth she lay, and seemed the Child of Zeus, the tireless Huntress Artemis
aleeping, what time her feet forwearied are with following lions with her flying shafts over the hills farstretching. She was made a wonder of beauty even in her death by Aphrodite glorious-crowned, the Bride
of the strong War-god, to the end that he, the son of noble Peleus, might be pierced with the sharp arrow
of repentant love. The warriors gazed, and in their hearts they prayed that fair and sweet like her their
wives might seem, laid on the bed of love, when home they won. Yae, and Achilles’ very heart was
wrung with love’s remorse to have slain a thing so sweet, who might have borne her home, his queenly
bride, to chariot-glorious Phthia; for she was flawless, a very daughter of the Gods, divinely tall, and most
divinely fair ».
172
Hasta sub exsertam donec perlata papillam
haesit virgineumque alte bibit acta cruorem.
(Eneide, XI, 803-804)
Aἶya d' Øpὲr mazo‹o daΐfrona Penqes…leian
oÜtase dexitero‹o, mšlan dš οƒ œrreen aŒma
™ssumšnwj. •H d' eἶqar Øpekl£sqh melšessin,
™k d' œbalεn ceirÕj pšlekun mšgan: ¢mfˆ dš oƒ nÝx
ÑfqalmoÝj ½clυse kaˆ ™j fršna dàsan ¢n‹ai.
(Posthomerica, I, vv. 594-598)201
…e pose in resta una possente lancia
e gli percosse acerbamente il petto
sotto la poppa manca, e trappassollo:
onde la stese moribunda al piano.
(Italia, XVIII)
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta
che vi s'immerge e 'l sangue avido beve;
e la veste, che d'or vago trapunta
le mammelle stringea tenera e leve,
l'empie d'un caldo fiume. Ella già sente
morirsi, e 'l piè le manca egro e languente.
(G. L., XII, 64, vv. 3-8)
Ma il contatto più importante è naturalmente l’innamoramento, assente in Virgilio
e desunto invece da Quinto Smirneo: la variazione introdotta dal Trissino per cui
Turrismondo non sa di avere di fronte a sé una donna, a differenza di Achille, che lo sa
ma non l’ha ancora vista in volto, è chiaramente all’origine dell’inconsapevolezza di
Tancredi di fronte a Clorinda armata e coperta in viso dall’elmo. Lo sbrigativo
compianto sul corpo di lei da parte del Turrismondo trissiniano, desunto da Quinto
Smirneo e assente in Virgilio, è straordinariamente ampliato in Tasso – elevandolo a
ben altro livello artistico – nel lamento e nel luttuoso tormento di Tancredi: tormento
che riemergerà poi, con una trovata geniale, in quel formidabile luogo letterario del
ritorno del represso che è la selva incantata di Saron 202 . D’altronde, i fitti contatti
testuali non sempre riconducibili alla mediazione virgiliana o a quella trissiniana,
lasciano pensare che anche il Tasso conoscesse in traduzione il poema di Quinto
Smirneo 203 , che d’altronde egli, come ho detto, cita diverse volte nei suoi scritti.
Naturalmente non è questa la sede adatta, ma non sarebbe affatto superflua una più
201
Trad.: « The red blood leapt forth, as a fountain wells, and all at once fainted the strength of
Penthesileia’s limbs; dropped the great battle-axe from her nerveless hand; a mist of darkness overveiled
her eyes, and anguish thrilled her soul ».
202
Sul ritorno del represso in letteratura, naturalmente, è d’obbligo il rimando a ORLANDO, F., Per una
teoria freudiana della letteratura, Torino, Einaudi, 1973.
203
Già al 1539 risale la prima traduzione latina di Quinto Smirneo: Quinti Calabri Derelictorum ab
Homero libri quatuordecim, JODOCO VELARAEO interprete. Coluthi Thebani Raptus Helene eodem
interprete. Editio prima. Antverpiae apud Io. Steelesium, 1539 (cfr. VIAN, F. Recherches sur les
Posthomerica de Quintus de Smyrne, Klincksieck, 1959, p. 8)
173
generale ricognizione dell’influsso di Quinto Smirneo su Trissino e Tasso: l’epigono
omerico della tarda antichità, in particolare, sembrerebbe fra l’altro aver fornito un
esempio alternativo a Virgilio delle modalità dell’imitazione dell’Iliade probabilmente
tenuto presente da Trissino e forse anche dal Tasso della Conquistata.
Come la morte di Nicandra è preceduta, secondo la prassi omerica per gli eroi di
maggior riguardo, da un’androktasia da lei compiuta a celebrarne il valore in limine
vitae (come d’altronde in Quinto Smirneo per Pentesilea), così avviene anche per la
successiva morte di Agrippa, che invece riprende molto da vicino la morte di Patroclo in
Iliade XVI: al termine della sua pur breve aristia, il guerriero è colpito in sequenza da
tre diversi avversari, così come Patroclo; anche il dialogo di Agrippa morente con
l’uccisore Turrismondo riprende da vicino quello fra Patroclo ed Ettore:
ma quando vide lui cadere a terra,
li disse allegro tai parole acerbe:
Malvagio traditor, tu sei pur morto.
tu ti credevi abbandonando i Gotti
e seguendo i Romani avere il scettro
senz'alcun dubio de la nostra gente:
né ti pensavi poi che Turrismondo,
ch'è il miglior uom che si ritruovi in terra,
dovesse far del suo fallir vendetta.
Or giaci, e pasci gli avoltori e i cani
de le tue triste e scelerate membra,
ché Corsamonte non daratti aiuto.
Così disse il superbo, e quel meschino,
ch'avea la morte già vicina a i denti,
rispose: Tu non già, ma la mia stella,
Turrismondo crudel, m'ha posto al fine.
E non sei stato il primo anco a ferirmi,
ma la fraude di dui t'ha fatto il terzo.
Or io ti dico, e chiudilo nel cuore,
che Corsamonte ancor fra pochi giorni
ti darà morte sopra questi campi.
Così diss'egli, e l'alma uscì di fuori
e se n'andò gemendo a l'altra vita,
che gli increscea ne suoi più florid'anni
abbandonare il mondo e la sua donna.
Ma poi gli disse Turrismondo altiero
queste parole ancora, essendo morto:
Tu potrai ben predir la morte mia,
ingrato cavalier, come a te pare,
la quale a me verrà quand'al ciel piaccia:
ma tu però non tornerai più vivo.
ka… oƒ ™peucÒmenoj œpea pterÒenta proshÚda·
P£trokl' Ã pou œfhsqa pÒlin keraϊxšmen ¡m»n,
Trwϊ£daj dὲ guna‹kaj ™leÚqeron Ãmar ¢poÚraj
¥xein ™n n»essi f…lhn ™j patr…da ga‹an
n»pie· t£wn dὲ prÒsq' “Ektoroj çkšej †ppoi
possˆn Ñrwršcatai polem…zein· œgceϊ d' aÙtÕj
Trwsˆ filoptolšmoisi metapršpw, Ó sfin ¢mÚnw
Ãmar ¢nagka‹on· s dš t' ™nq£de gàpej œdontai.
« de…l', oÙdš toi ™sqlÕj ™ën cra…smhsen 'AcilleÚj,
Ój poÚ toi m£la poll¦ mšnwn ™petšllet' „Ònti·
m» moi prˆn „šnai PatrÒkleεj ƒppokšleuqe
nÁaj œpi glafur¦j prˆn “Ektοroj ¢ndrofÒnoio
aƒmatÒenta citîna perˆ st»qessi da xai.
éj poÚ se prosšfh, soˆ d fršnaj ¥froni pe‹qe.
TÕn d' Ñligodranšwn prosšfhj PatrÒkleej ƒppeà·
½dh nàn “Ektor meg£l' eÜceo· soˆ g¦r œdwke
n…khn ZeÝj Kron…dhj kaˆ 'ApÒllwn, o† me d£massan
·hid…wj· aÙtoˆ g¦r ¢p' êmwn teÚce' ›lonto.
toioàtoi d' e‡ pšr moi ™e…kosin ¢ntebÒlhsan,
p£ntšj k' aÙtÒq' Ôlonto ™mù ØpÕ dourˆ damšntej.
¢ll£ me mo‹r' Ñlo¾ kaˆ Lhtoàj œktanen uƒÒj,
¢ndrîn d' EÜforboj· sÝ dš me tr…toj ™xenar…zeij.
¥llo dš toi ™ršw, sÝ d' ™nˆ fresˆ b£lleo sÍsin·
oÜ qhn oÙd' aÙtÕj dhrÕn bšV, ¢ll£ toi ½dh
¥gci paršsthken q£natoj kaˆ mo‹ra kratai¾
cersˆ damšnt' 'AcilÁoj ¢mÚmonoj A„ak…dao.
•Wj ¥ra min e„pÒnta tšloj qan£toio k£luye·
yuc¾ d' ™k ·eqšwn ptamšnh ”Aϊdoj dὲ beb»kei
Ön pÒtmon goÒwsa lipoàs' ¢ndrotÁta kaˆ ¼bhn.
tÕn kaˆ teqnhîta prοshÚda fa…dimoj “Ektwr·
PatrÒkleij t… nÚ moi mαnteÚeai a„pÝn Ôleqron;
t…j d' οἶd' e‡ k' 'AcileÝj Qštidoj p£ϊj ºãkÒmoio
fq»V ™mù ØpÕ dourˆ tupeˆj ¢pÕ qυmÕn Ñlšssai;
(Iliade, XVI, vv. 829-861)204
204
Trad.: «e vantandosi gli si rivolse con queste parole: / “Patroclo, tu pensavi di distruggere la mia città, /
di togliere la libertà alle donne troiane / e portarle sulle navi alla tua patria. Sciocco! / In loro difesa i
veloci cavalli di Ettore / si slanciano al combattimento, ed io mi distinguo / con la lancia tra i bellicosi
Troiani, e così li proteggo / dal giorno fatale – tu, sarai cibo per gli avvoltoi. / Sciagurato, non ti è servito
Achille, per valoroso che sia, / che certo, restando e mandandoti, ti disse molte parole: / ‘Non mi tornare,
Patroclo, abile nel guidare i cavalli, /alle navi, prima d’avere lacerato sul petto / la veste sanguinante di
Ettore, sterminatore’. / Così certo ti disse, e, sciocco che sei, persuase il tuo cuore”. / E tu, senza più
forze, gli rispondesti, Patroclo cavaliere: / “Ora puoi vantarti, Ettore, perché ti ha dato vittoria / Zeus,
174
E chi sa ch'io non mandi Corsamonte
ancora a farti compagnia sotterra,
prima ch'io giunga a quello estremo passo?
(Italia, XVII)
La ripresa tanto fedele di uno dei luoghi di maggior pathos nell’Iliade – la morte
del compagno fraterno di Achille che determina la svolta più radicale nell’emotività del
protagonista e dunque nell’intero poema – è il punto culminante di una strategia di
ripresa e rielaborazione dell’ampia fase di “devastazione” dell’Iliade che appare
senz’altro molto meditata e non priva di intelligenza e creatività. Particolarmente
evidenti sono due aspetti di tale libera rielaborazione: 1) la costante ricombinazione di
elementi di varia provenienza a creare una successione di eventi complessivamente
nuova e autonoma, seppure funzionalmente affine a quella iliadica; 2) la nuova strategia
per cui l’assenza dell’eroe necessario si fa avvertire immediatamente in tutta la sua
gravità subito dopo il suo ritiro – a differenza di quanto avviene nell’Iliade, dove gli
scontri iniziano con la netta supremazia degli Achei nella portentosa aristia di Diomede,
per arrivare a una vero vantaggio dei Troiani solo nel libro VIII e a una situazione
davvero disperata per gli Achei, infine, solo nel libro XV 205 –, mentre l’evoluzione
narrativa è ottenuta non più attraverso la “peripezia” da una situazione positiva a una
negativa, bensì tramite quella che potremmo considerare una “focalizzazione” dalla crisi
della situazione bellica generale del libro XII alla conclusiva disfatta dei singoli eroi
principali di fronte all’imperversare di Turrismondo/Ettore nel libro XVIII.
È senz’altro ammirevole – per quanto poco riuscito – anche il tentativo di
generare varietà all’interno di un ampio blocco del poema di natura quasi
esclusivamente epica e bellica, ricombinando elementi iliadici molto variegati
(ambasceria, Doloneia, duello concordato, scene di battaglia ecc.) e trattandoli dunque
figlio di Crono, ed Apollo, che mi hanno vinto / facilmente: loro mi hanno tolto dalle spalle le armi. / Se
venti uomini come te mi fossero venuti a fronte, / tutti sarebbero qui periti, vinti dalla mia lancia; / ma il
destino funesto e il figlio di Leto mi hanno ucciso, / e tra gli uomini Euforbo; tu arrivi, terzo, a
spogliarmi. / E mettiti bene in testa quello che dico: / neanche tu vivrai molto, perché già incombe / su te
vicina la morte ed il feroce destino / per mano del grandissimo Achille, nipote di Eaco”. / Mentre così
diceva, la morte lo avvolse, / l’anima lasciò le membra e volò nell’Ade, / piangendo il suo destino,
lasciando la forza e la giovinezza. / E a lui già morto disse lo splendido Ettore: / “Patroclo, perché mi
profetizzi l’abisso di morte? / Chissà se Achille, il figlio di Teti dai bei capelli / colpito dalla mia lancia
non mi preceda a morire?” ».
205
Cfr. a questo proposito DI BENEDETTO, V., Nel laboratorio di Omero, cit., p. 211-212: « Più volte
capita nel corso della narrazione dei combattimenti che l’interesse del narratore si concentri intorno a un
singolo guerriero, i cui successi vengono messi in evidenza in una particolare zona del testo (si parla a
questo proposito di un’aristia). In questo modo il narratore sollecita un procedimento di
immedesimazione dell’ascoltatore volta per volta con un nuovo “divo”; e nello stesso tempo attraverso le
varie aristie dei guerrieri greci Omero intendeva evitare il rischio principale che incombeva sul racconto,
dopo la promessa fatta da Zeus a Theti, e cioè che si determinasse una sequenza ripetitiva di vittorie dei
Troiabu e di Ettore in particolare ».
175
come topoi epici: non a caso la parallela fase di assenza di Rinaldo dal campo crociato
nella Liberata rivela, ad un’attenta analisi, un debito complessivo verso l’Italia molto
maggiore di quanto non si ammetta solitamente, per cui il poema del Trissino svolge
costantemente – come abbiamo visto – una fondamentale funzione di mediazione nella
ripresa dell’Iliade. Uno sintetico schema dei principali elementi epici di diversione dal
compimento dell’impresa ad articolare la fase di “devastazione” (ossia gli “episodi”, per
usare il termine aristotelico) può essere utile per riassumere con chiarezza la portata del
rapporto e della costante funzione di filtro svolta dal poema del Trissino: all’altezza
della Liberata, d’altronde, il testo omerico è raramente ripreso dal Tasso in modo
diretto, e quasi sempre, invece, attraverso la mediazione dell’Italia, sia in quanto
esempio di selezione e ripresa di elementi omerici da imitare proficuamente, sia come
effettivo tramite della ripresa testuale:
Iliade
Italia liberata
Gerusalemme
duello concordato
VII. Ettore e Aiace
XVII. Turrismondo e Aquilino
VI. Tancredi e Argante
sedizione interna
II. Tersite
XIV. Anticalo
VIII. Argillano
doloneia
X. Ulisse e Diomede
XIII. Lucillo e Tibullo
(XII. Clorinda e Argante)
XIX. Mundello e Traiano
Conquistata, XVI. Vafrino
XIII-XIV. Traiano e Ciro
XV-XVI. Carlo e Ubaldo
ambasceria
IX. Fenice, Aiace e
Ulisse
Conquistata, XII-XIII.
Ruperto e Araldo
aristia del capo
XI. Agamennone
XVIII. Belisario
XI. Goffredo
(manca: da Eneide XI)
XVIII. Nicandra
XII. Clorinda
dell’esericito e
suo ferimento
morte della
vergine guerriera
La netta superiorità del Tasso si misura piuttosto, oltre che costantemente nel
dettato poetico (che è poi il vero livello in cui si misura il valore artistico: come dice
Borges, influenzato dallo strutturalismo, un’opera letteraria consta in fondo della serie
di parole che la compongono206), anche nella geniale intuizione di venire incontro al
“gusto isvogliato” del moderno lettore di romanzi inserendo elementi romanzeschi ad
arricchire di fascino, varietà ed interesse narrativo anche questa ampia fase epica di
206
Cfr. BORGES, J. L., Il falso problema del conte Ugolino (dai Saggi danteschi), in Tutte le opere,
Mondadori, I Meridiani, 1985, vol. 2, p. 1278: «Il detto “Un libro consiste nelle parole che lo
compongono” corre il rischio di sembrare un assioma insipido. Tuttavia, tutti propendiamo a credere che
c’è una forma separabile dalla struttura e che dieci minuti di dialogo con Henry James ci rivelerebbero il
“vero” tema di Giro di vite. Penso che questo non sia vero; penso che Dante non sapesse di Ugolino
molto più di quello che riferiscono le sue terzine».
176
“devastazione”: nella dicotomia epos-romanzo per com’è concepita dal Trissino, infatti,
il Tasso introduce qui un proficuo e felice elemento di asimmetria, che, lungi dal
generare incongruenze, risolleva invece dalla monotonia questa lunga fase epica privata
del suo principale protagonista. Se infatti l’eccellenza di Omero, come nota Aristotele a
un altro proposito207, è in grado di risollevare anche aspetti che nell’opera di un autore
di minor levatura sarebbero senz’altro deprecabili, non si può certo dire altrettanto del
Trissino: pur più che dimezzatο per estensione rispetto al suo corrispettivo nell’Iliade, il
lungo assedio di Roma che si svolge in assenza di Corsamonte riesce, alla lettura, di una
monotonia e di una povertà poetica senza pari, che a livello di valore sono quanto di più
distante dalle due grandi giornate di guerra che danno rappresentazione al precipitare
della guerra per gli Achei in assenza di Achille. L’eccellente idea trissiniana di
rifunzionalizzare la contesa fra capo dell’esercito ed eroe necessario in termini di
contrapposizione ideologica e generica fra epos e romanzo non è sufficiente a sopperire
in qualche modo alla disparità di valore rispetto all’ipotesto: la troppo netta
contrapposizione fra la diversione romanzesca del solo Corsamonte e le numerose
diversioni di matrice epica pertinenti invece a Belisario e al resto dell’esercito risultano
quantitativamente sproporzionate per garantire un’adeguata presenza del “diletto”
romanzescoin quell’ampia sezione dell’opera.
Il Tasso saprà invece rimediare perfettamente a questa carenza sfumando la
contrapposizione fra generi letterari, e inserendo continuamente le principali attrattive
del romanzo (amori, incanti, digressioni pastorali ecc.) anche fra le vicende che danno
rappresentazione alla fase di “devastazione” nel campo crociato, senza limitarle al solo
Rinaldo (che pure resta senz’altro il protagonista di tale tendenza narrativa). Così, il
duello concordato fra Tancredi e Argante è ingentilito dalla visione estatica di Clorinda
e poi genera indirettamente la vicenda pastorale di Erminia, che a sua volta innesca la
romanzesca prigionia di Tancredi al castello di Armida; la necessità del tutto epica delle
macchine da assedio dà luogo alle suggestioni quanto mai romanzesche della selva di
Saron; l’ambasceria si trasforma in un viaggio fantastico e avventuroso in un giardino
incantato all’altro capo del mondo, ecc. Tale è la presenza del romanzesco che il Tasso
207
ARISTOTELE, Poetica, 1460a, 35 sgg.: ¨n dὲ qÍ kaˆ fa…nhtai eÙlogwtšrwj ™ndšcesqai kaˆ
¥topon ™peˆ kaˆ t¦ ™n 'Odusse…v ¥loga t¦ perˆ t¾n œkqesin æj oÙk ¨n Ãn ¢nekt¦ dÁlon ¨n
gšnoito, e„ aÙt¦ faàloj poiht¾j poi»seie· nàn dὲ to‹j ¥lloij ¢gaqo‹j Ð poiht¾j ¢fan…zei
¹dÚnwn tÕ ¥topon. tÍ dὲ lšxei de‹ diapone‹n ™n to‹j ¢rgo‹j mšresin kaˆ m»te ºqiko‹j m»te
dianohtiko‹j· ¢pokrÚptei g¦r p£lin ¹ l…an lampr¦ lšxij t£ te ½qh kaˆ t¦j diano…aj (trad.: «
Anche nell’Odissea è irrazionale la scena dello sbarco, ed è chiaro che se l’avesse composta un poeta
mediocre sarebbe inaccettabile. Ma invece Omero con i suoi altri pregi elimina e rende piacevole
l’assurdo. Nelle parti inerti, prive di carattere e di pensiero, bisogna lavorare sulla dizione; il linguaggio
brillante, infatti, nasconde carattere e pensiero »).
177
stesso avrà timore di aver troppo insistito su quel registro a eccessivo scapito di quello
epico, com’è testimoniato nelle cosiddette Lettere poetiche relative alla “revisione
romana”: la riscrittura messa in atto con la Conquistata trova la sua motivazione
fondamentale proprio nel tentativo di correggere tale sproporzione, riequilibrando le
ampie concessioni al romanzesco attraverso l’introduzione di un nuovo grande nucleo
epico di battaglia, in cui a quella che è solo una mancata vittoria dei crociati privi di
Rinaldo in Liberata XI si sostituisca invece, nel poema riscritto, una vera e propria
pesante sconfitta, attraverso l’introduzione degli scontri presso Joppe; in tal modo,
inoltre, la necessità di Riccardo (il nuovo Rinaldo) si fa avvertire in tutta la sua gravità
anche sul piano propriamente militare ed epico, e non più solo in relazione alla missione
romanzesca (in cui il ruolo “fatale” di Rinaldo/Riccardo è peraltro del tutto arbitrario) di
vincere gli incanti della selva. L’esempio di tale ripensamento che, senza togliere quasi
nulla degli elementi romanzeschi già presenti nella Liberata, aggiunge però molti nuovi
elementi epici alla fase di “devastazione”, è costituito naturalmente proprio dal poema
del Trissino e in particolare appunto dalla complessa rielaborazione della fase di
“devastazione” dell’Iliade che abbiamo appena analizzato.
178
4.3. Ritorno – marginalizzazione della vendetta
Nelle precedenti sezioni di questo capitolo abbiamo evidenziato come la ripresa
del modulo iliadico dell’eroe necessario sia condotta dal Trissino con un ampio margine
di libertà e rielaborazione a livello strutturale, venendo a costituire un punto di
riferimento fondamentale per il Tasso sia della Liberata che, a maggior ragione, della
Conquistata: in particolare, nella contesa iniziale abbiamo visto come la colpevolezza
del comportamento di Corsamonte sia notevolmente accentuata rispetto all’Achille
omerico, mentre nell’ampia sezione di devastazione durante il ritiro dell’eroe gli
episodi, pur massima parte desunti dall’Iliade, sono ricombinati in una struttura
completamente nuova. Tuttavia è nell’ultima fase del modulo, quella del ritorno
dell’eroe necessario, che le divergenze dall’ipotesto si fanno più notevoli, portando le
premesse già parzialmente divergenti ad un esito ormai molto lontano dalla trama
iliadica e per certi versi rovesciato. Ciò non stupisce, poiché è chiaro che nel poema del
Trissino Corsamonte, così come sarà per il Rinaldo tassiano, non può assurgere al ruolo
di protagonista che Achille ricopre nell’Iliade: la preminenza dell’eroe deve restare
subordinata all’impresa militare che è il vero argomento del poema e all’ideologia
imperiale, incarnata da Belisario, che essa presuppone.
Abbiamo già notato come il soggetto dell’Italia liberata e quello della
Gerusalemme tassiana differiscano radicalmente da quello iliadico nel narrare non più la
vicenda eminentemente individuale ed emotiva di un protagonista la quale si rifletta
sull’impresa militare in cui si inscrive, ma appunto l’impresa militare stessa. Ciò
comporta anche, come corollario, una definizione del tutto diversa della questione del
protagonismo in queste opere: se, come scrive Guido Paduano riguardo al più celebre
problema dell’omeristica, «la presenza nel poema di un protagonista, e la relazione di
interdipendenza tra la struttura del poema e la rappresentazione dell’universo emotivo di
questo protagonista» costituiscono «la motivazione perentoria dell’unità dell’Iliade»208,
non si può dire certo altrettanto per i poemi del Trissino e del Tasso, dove, proprio in
conseguenza della difformità evidenziata nella scelta del soggetto della narrazione, il
208
PADUANO, G. Le scelte di Achille, cit., pp. X-XI.
179
capo dell’esercito (corrispettivo di Agamennone) tende ad assurgere al ruolo
protagonistico, relegando invece l’eroe necessario (corrispettivo di Achille) al ruolo di
co-protagonista. Una scelta in realtà di ben difficile realizzazione proprio per lo stesso
motivo che ci porta ad individuare senz’altro in Achille il protagonista dell’Iliade: la
sostanziale assenza di un vero coinvolgimento emotivo profondo del protagonista
prescelto con le vicende narrate nella trama del poema, di cui egli appare l’obbediente
esecutore più che il diretto interessato. D’altronde, se a contendere in qualche modo il
ruolo di protagonista ad Achille è Ettore e non certo Agamennone, ciò dipende dal ben
diverso coinvolgimento emotivo di chi difende la propria patria e la propria gente
rispetto a chi invece mette in atto una guerra di aggressione, in cui il massimo rischio è
la disfatta militare e il fallimento dell’impresa: la celeberrima scena di Ettore e
Andromaca alle porte Scee ne è la sanzione più evidente. Il capo dell’esercito che
conduce una guerra di aggressione è dunque un personaggio, anche nell’epica, ben
difficile da trasformare in protagonista dell’opera, proprio per l’assenza di un autentico
orizzonte soggettivo ed emozionale che inneschi l’identificazione emotiva e si leghi in
una imprescindibile relazione di interdipendenza con la struttura complessiva della
trama. La solidarietà presupposta nei suoi confronti in quanto personaggio portatore
dell’ideologia positiva non è affatto sufficiente, naturalmente, a sopperire a una tale
mancanza (come si sa anche da altissimi esempi letterari, il ruolo protagonistico può
benissimo identificarsi con un’ideologia identificata senz’altro come negativa
nell’opera). Di qui il sostanziale doppio protagonismo che emerge di fatto – in una
parziale divergenza dagli intenti programmatici – nel poema del Trissino e, sul suo
esempio, in quello del Tasso: Corsamonte e Rinaldo vengono affiancati come
protagonisti dell’identificazione emotiva a Belisario e Goffredo, portatori dell’ideologia
positiva ed esecutori del telos epico. Una situazione senz’altro problematica, che se in
Tasso – al di là della difficoltà progettuale – darà esito a una splendida ambiguità per
questa fondamentale funzione testuale, in Trissino ha invece un esito rovinoso per la
struttura complessiva del poema: Belisario, mero esecutore del progetto militare
dell’imperatore, è continuamente presente in scena, ma non per questo riesce a risultare
protagonista dell’opera; Corsamonte viene invece escluso da questa possibilità nella
maniera più drastica e perentoria possibile dall’autore, che lo fa morire molto prima
della fine del poema (nel libro XXII sui XXVII complessivi), cercando così di
riaffermare in modo artificiale e forzato la preminenza di Belisario. L’esito risulta
rovinoso perché in questo modo il poema finisce per non avere affatto un protagonista,
180
o se si vuole due protagonisti entrambi inadeguati non già al compimento dell’impresa
narrata, ma piuttosto proprio alla funzione testuale richiesta al protagonismo. Una
situazione da cui scaturisce una vera e propria disgregazione della narrazione, priva un
suo autentico baricentro emozionale e per questo pericolosamente vicina a una mera
versificazione della storiografia, secondo il rischio paventato già da Aristotele (Poetica,
cap. 9, 1451a, 36 sgg.). Se invece il Tasso lamenterà in sede teorica la difficoltà a
preservare Goffredo nel ruolo protagonistico di fronte a Rinaldo, ciò avviene proprio
perché il grande poeta, a differenza del mediocre, non riesce a sacrificare le esigenze
della poesia a quelle dell’ideologia neppure quando è razionalmente convinto di volerlo
fare.
Proprio il drastico tentativo di riabilitare l’improbabile protagonismo di Belisario
attraverso la rimozione di Corsamonte con la sua morte implica la prima, clamorosa
divergenza dall’Iliade relativa al ritorno dell’eroe irato: come abbiamo visto, il
materiale omerico concernente la morte di Patroclo (Iliade XVI) è riutilizzato soltanto
in minima parte in relazione ad un personaggio, Agrippa, la cui morte ha la mera
funzione di scandire – dopo il ferimento di Belisario e la morte di Aquilino e Nicandra –
il definitivo precipitare della situazione militare dell’esercito di Giustiniano. La morte di
Patroclo invece, ben oltre questa stessa funzione, ricopre nell’Iliade quella decisamente
più importante di sconvolgere radicalmente l’universo emotivo del protagonista Achille
e, di conseguenza, rovesciare l’esito della trama del poema. In Trissino la funzione
emotiva di questa morte è invece relegata al lutto personale di Cillenia, moglie di
Agrippa: personaggio del tutto secondario (versione “epica” della Fiordiligi ariostesca),
che dunque non innesca neppure lontanamente le conseguenze strutturali della morte di
Patroclo nell’Iliade. Che il materiale della “Patrocleia” sia utilizzato per una funzione
narrativa secondaria e un personaggio non certo di primo piano è reso possibile appunto
dall’esito che il Trissino intende dare alla vicenda di Corsamonte: il suo legame di
amicizia fraterna con l’Achille dell’Italia che riprende il rapporto dell’Achille omerico
con Patroclo avrà infatti un esito rovesciato rispetto a quello dell’ipotesto, poiché, come
abbiamo detto, a morire sarà Corsamonte, ossia appunto il corrispettivo di Achille e non
di Patroclo.
In tal modo, viene sostanzialmente rimosso il grande nucleo emozionale della
vendetta che nell’Iliade si sostituisce come orizzonte totalizzante, nell’emozionalità di
Achille e dunque in tutta la parte finale della trama, all’odio verso Agamennone. Il
rovesciamento di ruoli fra ucciso e suo vendicatore, d’altronde, non può in nessun modo
181
tradursi in un mero rovesciamento delle rispettive funzioni narrative: il carattere
totalizzante del nuovo nucleo emotivo della vendetta non può certo essere trasferito dal
ruolo protagonistico al personaggio secondario, proprio per il venir meno del
personaggio oggetto di identificazione emotiva (il protagonista, appunto) che sola
potrebbe veicolarlo. Dal punto di vista narrativo, insomma, la “vendetta del
protagonista” è cosa radicalmente diversa e in nessun modo parallela o anche solo
confrontabile a seconda che il genitivo sia da intendersi come soggettivo oppure
oggettivo. L’ovvia conseguenza di ciò è che la vendetta per la morte di Corsamonte
delegata al suo amico Achille (il suo Patroclo) si consuma in una manciata di versi,
pressoché insignificanti nel loro peso narrativo. L’eroe viene infatti ucciso
proditoriamente dopo che, grazie al suo intervento, i Goti si stanno ormai ritirando da
Roma, in un agguato di sapore romanzesco ordito a suo danno dal traditore Burgenzo
(versione “epica” del Gano di Maganza della tradizione cavalleresca). La sua morte,
spettacolarmente iperbolica, ricorda quella del gigante Encelado sotterrato da Atena
scagliandogli sopra la Sicilia (com’è esplicitato nel testo), forse anche quella del
Sansone biblico e quella di Orlando a Roncisvalle, non senza un tratto finale vagamente
dantesco:
…così parea quel Corsamonte audace
e ben da tutto il stuol s'aria difeso
se quei ch'eran di fuor co i picchi in mano,
e che più di quattr'ore avean piccato
intorno ai fondamenti de la torre,
non la facean cader sopra il suo capo;
e nel cader che fece ancora accolse
Turbone e Baricardo a Fuligante,
dui cugini di Teio, un di Bisandro,
con più di novecento altre persone:
ma questo parve nulla al re de' Gotti,
poi che 'l suo gran nimico era sott'essa.
Le genti, come vider quella torre
caduta sopra l'animoso duca,
mandarono un cridor fin a le stelle:
e così morto fu quel gran guerriero
con danno estremo de l'Italia afflitta.
Poi non fu Gotto alcun che non pigliasse
legnami o sassi e no i gettasse sopra
la gran ruina e le cadute pietre:
quasi temendo ancor che quindi uscisse
e tutti quanti gli mandasse a morte;
così gettando ognun materia molta
crebbe su quella piazzia un alto monte,
non minor del Testaccio, e non men grave
di quel che 'l grande Encelado ricuopre.
(Italia, XXII)
182
Se 'l pastor di Cosenza, che a la caccia
di me fu messo per Clemente allora,
avesse in Dio ben letta questa faccia,
l'ossa del corpo mio sarieno ancora
in co del ponte presso a Benevento,
sotto la guardia de la grave mora.
(DANTE, Purg., II, 124-129)
Immediatamente dopo, i due traditori responsabili della morte dell’eroe, Burgenzo
e Doletto, vengono intercettati e catturati dal tardivo soccorso di Belisario e i suoi. Il
corpo dell’eroe è quindi facilmente recuperato e dunque sepolto, con grandi onori, dopo
il lamento di Elpidia. Già all’inizio del libro successivo (XXIII), appena qualche
centinaio di versi dopo la sua morte, l’anima di Corsamonte appare in sogno al suo fido
Achille esigendo vendetta, così come ad un altro Achille appariva l’ombra di Patroclo
avanzando, a vendetta già compiuta, la richiesta della sepoltura:
…ed in quel tempo l'anima gli apparve
di Corsamonte, con la sua sembianza,
con la persona sua, con la sua voce,
co i suoi begli occhi e con le solite arme:
e poi fermossi appresso a la sua testa
e disse a lui queste parole tali:
Tu dormi, Achille, e m'hai posto in oblio,
né cura prendi de la mia vendetta.
Quel traditor che con astuti inganni
tradimmi, e mi condusse entr'al castello
ove fui morto da la gente gotta
che ruinormi una gran torre adosso,
vive; e se non sarà da voi depresso
libererassi ancor con le sue fraudi,
con danno espresso de le nostre genti:
però provedi a quest'aspro periglio.
Dammi la man, che tu mi fai pietate,
che starai senza me molt'anni in terra;
né più saran communi i pensier nostri
né più l'un l'altro si darem consiglio:
ché la morte crudel da te mi parte
con strada lunga, adamantina ed aspra.
Non ti scordar di me, che pur siam vissi
da i tener'anni in su come fratelli,
anzi come in dui corpi un'alma sola;
però come a fratel ti raccomando,
Ãlqe d' ™pˆ yuc¾ PatroklÁoj deilo‹o
p£nt' aÙtù mšgeqÒj te kaˆ Ômmata k£l' ™ ku‹a
kaˆ fwn»n, kaˆ to‹a perˆ cro e†mata ›sto·
stÁ d' ¥r' Øp r kefalÁj ka… min prÕj màqon œeipen·
eÛdeij, aÙt¦r ™me‹o lelasmšnoj œpleu 'Acilleà.
oÙ mšn meu zèontoj ¢k»deij, ¢ll¦ qanÒntoj·
q£ptš me Ótti t£cista pÚlaj 'A dao per»sw.
tÁlš me e‡rgousi yucaˆ e‡dwla kamÒntwn,
oÙdš mš pw m…sgesqai Øp r potamo‹o ™îsin,
¢ll' aÜtwj ¢l£lhmai ¢n' eÙrupul j ”AŽ doj dî.
ka… moi dÕj t¾n ce‹r'· ÑlofÚromai, oÙ g¦r œt' aâtij
n…somai ™x 'A dao, ™p»n me purÕj lel£chte.
oÙ m n g¦r zwo… ge f…lwn ¢p£neuqen ˜ta…rwn
boul¦j ˜zÒmenoi bouleÚsomen, ¢ll' ™m m n k¾r
¢mfšcane stuger», ¼ per l£ce gignÒmenÒn per·
kaˆ d soˆ aÙtù mo‹ra, qeo‹j ™pie…kel' 'Acilleà,
te…cei Ûpo Trèwn eÙhfenšwn ¢polšsqai.
¥llo dš toi ™ršw kaˆ ™f»somai a‡ ke p…qhai·
m¾ ™m¦ sîn ¢p£neuqe tiq»menai Ñstš' 'Acilleà,
¢ll' Ðmoà æj ™tr£fhmen ™n Ømetšroisi dÒmoisin,
eâtš me tutqÕn ™Ònta Meno…tioj ™x 'OpÒentoj
½gagen Ømšteron d' ¢ndroktas…hj Ûpo lugrÁj,
½mati tù Óte pa‹da katšktanon 'Amfid£mantoj
n»pioj oÙk ™qšlwn ¢mf' ¢strag£loisi colwqe…j·
œnq£ me dex£menoj ™n dèmasin ƒppÒta PhleÝj
œtrafš t' ™ndukšwj kaˆ sÕn qer£pont' ÑnÒmhnen·
ìj d kaˆ Ñstša nîŽ n Ðm¾ sorÕj ¢mfikalÚptoi
crÚseoj ¢mfiforeÚj, tÒn toi pÒre pÒtnia m»thr.
(Iliade, XXIII, vv. 65-92)209
209
Trad.: «Ed ecco gli venne in sogno l’ombra del povero Patroclo, / in tutto uguale a lui nella figura,
negli occhi / bellissimi, nella voce e vestiva le stesse vesti. / Stette sopra la sua testa e gli disse: / “Tu
dormi, Achille, e ti dimentichi di me: da vivo / non mi trascuravi, mi trascuri morto. / Seppelliscimi al più
presto, e io passerò le porte dell’Ade, / da cui mi escludono le anime, i simulacri dei morti, / e non mi
permettono che mi mescoli a loro oltre il fiume: / vago così intorno alla casa dell’Ade dalle ampie porte. /
Ti prego, dammi la mano: non tornerò più / dall’Ade, quando mi avrete concesso l’onore del fuoco. Mai
più terremo consiglio da vivi, in disparte / dai cari compagni, giacché mi ha colto il destino / odioso che
ebbi in sorte nascendo. / E anche il tuo destino, Achille pari agli dèi, / è quello di morire sotto le mura dei
ricchi / Troiani. Un’altra cosa ti dico e ti chiedo, se vuoi darmi ascolto: / non mettere le mie ossa separate
dalle tue, Achille, / mettile insieme, come insieme crescemmo nella vostra casa, / da quando Menezio mi
condusse da Opunte, ancora piccolo, / a motivo di un doloroso omicidio, il giorno che uccisi, / ahimè
183
o come a un altro me, la donna nostra
e la nostra memoria e 'l nostro onore.
(Italia, XXIII)
Di tutto il grande tema iliadico della vendetta, che dal libro XVIII fino alla
conclusione domina incontrastato la parte conclusiva dell’Iliade, non può che essere
ripreso il solo segmento finale e meno significativo dal punto di vista narrativo, poiché,
come abbiamo detto, l’identificazione emotiva che il dolore e l’odio totalizzante verso
Ettore presuppongono con il protagonista del poema omerico non può essere trasferita
al personaggio secondario, nonostante la continuità onomastica fra il personaggio
omerico e quello trissiniano intenda denunciare proprio la continuità della funzione.
Essendo i traditori già in mano di Belisario, dopo il sogno Achille non deve far altro che
recarsi dal capitano e richiedere la loro consegna per vendicare l’amico morto: saranno
prontamente consegnati e sottoposti, ancora vivi, al medesimo strazio cui Achille
sottopone il corpo di Ettore già morto. Quella «sostituzione vertiginosa e istantanea» per
cui «dove c’era il conflitto con Agamennone l’annuncio della morte di Patroclo induce
il conflitto insanabile con Ettore»210, sostituendo così alla menis proemiale il nuovo e
deviante tema della vendetta, non lascia nell’Italia liberata che questa esile traccia,
niente più che un omaggio al mancato protagonista che l’autore gli accorda nel
momento in cui decide di far uscire prematuramente di scena (pur rispettando in questo
la fonte storiografica 211 ) per lasciare spazio al personaggio portatore dell’ideologia,
Belisario. Ben altrimenti efficace, per quanto non priva di difficoltà egregiamente
dissimulate, sarà la soluzione tassiana della Liberata212, così come di tutt’altro rilievo e
sciocco, il figlio di Anfidamante, / senza volerlo, adirato per una partita di astragali. / Mi accolse nella sua
casa Peleo, abile nel guidare i cavalli, / mi allevò con ogni cura e mi nominò tuo scudiero. / Così vorrei
che una sola urna accogliesse / le nostre ossa, quella d’oro che ti diede tua madre” ».
210
PADUANO, G., Le scelte di Achille, cit. p. XXV, poi ID., La nascita dell’eroe, cit. p. 34.
211
Cfr. PROCOPIO, Guerra gotica, II, 1: « Pochi giorni più tardi, in un’altra battaglia, Corsamanti fu
colpito alla gamba sinistra. […] Essendo un barbaro non poteva sopportare pazientemente quella
inattività, ma continuava a imprecare, giurando che ben tosto l’avrebbe fatta pagar cara ai Goti per il
colpo datogli alla gamba. Infatti, non molto tempo dopo, ormai ristabilito, un giorno che durante il pranzo
si era come al solito ubriacato, decise di partire da solo contro i nemici a vendicarsi della ferita ricevuta.
[…] Appena lo videro, a tutta prima lo credettero un disertore che veniva alla loro volta, ma quando egli
fu vicino e mise mano all’arco, non riuscendo a comprendere chi fosse, venti nemici accorsero verso di
lui. Egli però li respinse senza difficoltà e si diede poi a camminare tranquillamente avanti e indietro,
senza fuggire nemmeno quando parecchi altri Goti si diressero contro di lui. Ma i Romani, che lo
vedevano dall’alto delle torrette continuare a lottare, circondato da quella massa di Goti, pensarono che si
trattasse di un pazzo, non avendo ancora riconosciuto che era Corsamanti. Alla fine, dopo aver dato
straordinarie prove di un indomito coraggio, egli si trovò attorniato da un intero esercito di nemici, e pagò
le conseguenze del suo folle ardimento ».
212
Mi sono occupato della questione nella mia tesi di laurea, La «Gerusalemme Conquistata» e
l’«Iliade». Il modello omerico nella riscrittura del poema tassiano, cit., nel capitolo 2.4 La richiamata e
il ritorno di Riccardo. Lì notavo come il problema del doppio protagonismo all’altezza della Liberata
fosse risolto non, come vuole MARTINELLI, A., La demiurgia della scrittura poetica, Firenze, Olschki,
1983, pp. 112 sgg., «scindendo in due l’“eroe” principale: la mente e la mano, la virtù ideale e la virtù
184
spessore sarà la ripresa della “Patrocleia” iliadica nella Conquistata, quando le soluzioni
strutturali escogitate nella versione giovanile del poema non appariranno più
soddisfacenti all’autore.
È questo, senza alcun dubbio, il più rovinoso errore strutturale del poema
trissiniano, che abbandona gli ultimi cinque libri, privi ormai del solo personaggio che
poteva ambire ad avere un autentico ruolo protagonistico, alla totale disgregazione
narrativa. Già i giochi funebri per Corsamonte, paralleli a quelli per Patroclo nell’Iliade
e per Anchise nell’Eneide, perdono clamorosamente la loro risonanza emotiva nel non
essere più espressione ritualizzata e sociale del dolore del protagonista; i tre libri
successivi (XXIV-XXVI) si perdono completamente in vicende politico-militari che
ormai non ruotano più attorno ad alcun baricentro, rendendo conto soltanto di fatti
storiografici privi di qualsiasi nesso narrativo plausibile (l’arrivo di Narsete e la lunga
ekphrasis allegorico-profetica di cui egli si fa spettatore; la consegna di Milano a
Belisario; la ventura allegorica di Mundello di cui abbiamo parlato nel capitolo sul
romanzesco; l’inutile discesa in Italia del re di Francia Tiberto; l’occupazione o la resa
di altre città; la ventura allegorica di Achille e Traiano). La battaglia conclusiva presso
Ravenna dell’ultimo libro del poema – che da sola corrisponde alla materia dell’intero
poema tassiano – si trasforma infine in un duello multiplo di dieci contro dieci in cui la
dimensione collettiva di matrice ariostesca (triplice duello di Lipadusa del Furioso e
duello di dieci contro dieci prospettato, senza compimento, nei Cinque Canti), anziché
conferire un carattere grandioso al finale, in cui far emergere il ruolo di Belisario,
tradisce piuttosto l’assenza di un vero eroe protagonista capace di decidere da solo, in
duello, le sorti della guerra (come fa implicitamente l’Achille omerico ed esplicitamente
l’Enea virgiliano).
operativa» né «grazie all’ideazione del paragone dell’esercito crociato con le varie membra del corpo
umano», bensì introducendo lo stratagemma per cui Rinaldo è, fatalmente, il solo a poter vincere gli
incanti della selva (con un arbitrio abilmente dissimulato): in tal modo la necessità bellica di Rinaldo è
motivata non più direttamente da una grave sconfitta cristiana, che il Tasso voleva evitare per motivi
ideologici, ma indirettamente dal bisogno di legname con cui costruire le macchina a loro volta necessarie
alla guerra; il modulo omerico dell’eroe “necessario” è così coniugato, inoltre, con l’altro modulo del
“novello ordin di cose” dovuto all’intervento divino: il legame presenta tuttavia una certa debolezza
poiché dipende dalla mera sovrapposizione cronologica del sogno di Goffredo, in cui si palesa la volontà
divina di richiamare Rinaldo, e la pioggia che dà inizio alla “peripezia” (nel progetto originario,
d’altronde, tale sovrapposizione non aveva luogo). Le imperfezioni di questa soluzione portarono il poeta
a scardinare l’intero meccanismo nella Conquistata e ripensarlo attraverso un riavvicinamento all’Iliade:
l’introduzione di una nuova, grave sconfitta dei crociati (che nella Liberata mancava) motiva la necessità
improrogabile dell’eroe su un piano strettamente bellico, e non più attraverso lo stratagemma della selva
incantata, che permane conservando principalmente i suoi significati simbolici. A consentire il ritorno
dell’eroe è il sovrapporsi della gravità della crisi bellica alla morte di Ruperto e al tema della vendetta, di
cui ho trattato nel mio recente articolo La “Patrocleia” di Ruperto nella Gerusalemme conquistata, cit.
185
La drastica marginalizzazione del tema della vendetta, che da totalizzante diviene
quasi irrilevante, e l’inversione di ruoli nella coppia corrispettiva ad Achille e Patroclo –
oltre a costituire i due punti di maggiore e più rovinosa originalità del Trissino rispetto a
Omero – comportano anche un radicale cambiamento nelle motivazioni che inducono
l’eroe irato a tornare a combattere. Essendo Corsamonte destinato alla morte ben entro i
limiti della trama, anziché al di là di essi come Achille, e prima del suo fraterno
compagno anziché dopo di lui, la sostituzione della vendetta all’ira verso il capo
dell’esercito non può costituire più la motivazione del suo ritorno a combattere.
Al pari dell’Achille omerico, d’altronde, Corsamonte appare piuttosto fermo nel
proposito di non desistere dall’ira nei confronti del capo dell’esercito che gli ha fatto un
torto per lui irreparabile. Come abbiamo visto, la necessità dell’eroe si fa avvertire in
tutta la sua gravità già nel libro successivo al suo ritiro, condensando in qualche
centinaio di versi una situazione a cui nell’Iliade si arriva nell’arco di un terzo del
poema. Di fronte alla crisi militare, Belisario non tarda ad ammettere il proprio errore,
in un rovesciamento di prospettive troppo repentino e poco motivato rispetto
all’evidente, seppur parziale, colpevolezza di Corsamonte, che come abbiamo visto lo
distingue dalla mera prevaricazione subita dall’Achille omerico. Su esempio del Nestore
omerico, è il vecchio Paulo a proporre di richiamare Corsamonte di fronte alla
stringente difficoltà militare, suggerendo una riparazione sociale che possa placare il
suo sdegno (Il. IX, vv. 112-113: frazèmesq' éj kšn min ¢ress£menoi pep…qwmen /
dèrois…n t' ¢gano‹sin œpess… te meilic…oisi213, cfr. Italia, XIII: « Adunque il mio
consiglio è di placarlo / con doni eletti e con parole dolci »); come Nestore, Paulo
biasima la condotta tenuta dal capitano al momento della contesa con Corsamonte sulla
base di una motivazione prettamente morale che assume la consueta dimensione
gnomica:
Elpidia il dimandava per marito,
e di ragion non si devea negarle
quando v'era il consenso de le parti;
ma voi primieramente gliel negaste,
da poi, cedendo a la magnanim'ira
nata dal suo fallir, che senza dubbio
fu molto grave, lo privaste ancora
de la speranza di poter più averla.
Voi sapete, signor, come l'amore
constringe più le menti de i mortali,
e più le gira, che l'argento e l'oro;
ond'ei, d'amor sospinto e dal disdegno,
subitamente s'è partito quinci
213
Trad.: « pensiamo a come possiamo persuaderlo e placarlo / con doni amabili e con parole gentili ».
186
e ci ha lasciati, e cerca altra ventura.
(Italia, XIII)
Belisario ammette l’errore morale e quasi giuridico che gli viene rimproverato
(opporsi al “consenso de le parti” in un matrimonio), senza tuttavia risparmiarsi di
ribadire implicitamente la propria superiorità etica proclamando l’insensatezza
dell’abbandono alla passione amorosa, negli accenti tipici della satira contro le donne:
Veramente, signor, senza menzogna
avete raccontato il nostro errore:
ch'alor certo fallai, né vuo' negarlo,
quando non diedi Elpidia a Corsamonte.
Ben la dovea promettere a Favenzo
e non gli dar materia di fallire,
ch'amor può troppo ne le nostre menti;
or poscia ch'ei fallì, cedendo a l'ira,
voglio non solamente perdonarli,
ma gli vuo' dare Elpidia per consorte,
poi che l'ama e disia; ché 'l prender moglie
è un mal che suol desiderar la gente:
e quel che si dispone a tòr mogliera
camina per la strada del pentirsi,
per ciò che l'uom ch'ha donna è sempre servo.
(Italia, XIII)
Né la considerazione, in bocca all’integerrimo e apatico Belisario, sarebbe poi
così fuori luogo se lo svilimento dell’emozionalità amorosa a mera convenienza sociale
non si intravedesse poi anche nelle parole rivolte dallo stesso Corsamonte ai tre
ambasciatori inviati a offrigli i molti doni del capitano e la mano di Elpidia in cambio
del suo ritorno a combattere (libro XIV):
…spero d'avere Elpidia per consorte
ancor che Belisario me la vieti:
ben che più tosto io voglio star senz'ella
che conoserla mai da le sue mani.
e poco dopo rincara la dose:
Io voglio andare a dimorar tra i Sciti
nel mio paese, e col mio padre antico:
e quivi menerò la cara moglie
s'io la racquisto, o prenderonne un'altra;
ché non mi mancherà donna ch'io voglia
in quelle parti, con suprema dote.
187
Vero è che si tratta anche qui di traduzione dalle parole di Achille riguardo a
Briseide nell’ambasceria di Iliade IX214, ma lì l’affettività se non l’amore per la donna è
tema subordinato a quello dell’onore violato, mentre nel Trissino una simile
dichiarazione appare tanto più fuori luogo in quanto il tema dell’amore assurge ad un
ruolo di primo piano tanto in funzione dell’ideologia, quanto dell’influenza tematica
della tradizione romanzesca. E la razionalizzazione sociale dell’emozionalità non è
certo un procedimento molto proficuo a livello poetico se si intenda conferire grande
rilievo alla tematica amorosa215: una poesia della ragione e del pensiero esiste senz’altro
e può assurgere a livelli altissimi, come ci mostra perentoriamente Dante, ma nel nostro
caso non si tratta certo di questo; la diffusissima razionalizzazione dell’emotività che
qui come altrove è una costante del poema trissiniano – esempio del secolare
pregiudizio dell’emozione intesa negativamente come irrazionalità – si riduce sempre a
una mera riaffermazione delle convenzioni sociali a scapito dell’infinitizzazione e l’alogicità (o piuttosto bi-logicità, nei termini di Matte Blanco) dell’universo emozionale,
così da portare a un esito che è per definizione l’esatto opposto di ogni autentica
espressione poetica. Ancor più paradossale sembra questa banalizzazione sociale del
dato emozionale se si pensa che proprio nella scena iliadica corrispettiva l’affettività di
Achille verso Briseide, per quanto sempre subordinata alla questione dell’onore violato
e ad essa in parte strumentale, emerge invece nella sua ammissione più esplicita ed
esorbitante dall’essere lei preda di guerra (douriktht»):
à moànoi filšous' ¢lÒcouj merÒpwn ¢nqrèpwn
'Atreΐdai; ™peˆ Ój tιj ¢n¾r ¢gaqÕj kaˆ ™cšfrwn
214
Cfr. Iliade, IX, vv. 393-397: Àn g¦r d» me saîsi qeoˆ kaˆ o‡kad' †kwmai, / PhleÚj q»n moi
œpeita guna‹k£ ge m£ssetai aÙtÒj. / pollaˆ 'Acaiΐdej e„sˆn ¢n' `Ell£da te Fq…hn te / koàrai
¢rist»wn, o† te ptol…eqra ·Úontai, / t£wn ¼n k' ™qšlwmi f…lhn poi»som' ¥koitin (Trad.: « Se gli
dèi mi salvano e tornerò alla mia patria, / Peleo stesso mi procurerà una moglie. Ci sono / tante donne
achee a Ftia e per l’Ellade, / figlie di principi che difendono la loro terra; / quella che sceglierò tra queste
sarà la mia sposa »).
215
Viene in mente l’argomentazione e contrario con cui MATTE BLANCO, I., L’inconscio come insiemi
infiniti. Saggio sulla bi-logica, Torino, Einaudi, 1981 (1975) introduce l’estensione del ricorso alla
categoria matematica di insieme infinito, prima applicata all’inconscio, anche all’emozionalità (p. 204):
«Possiamo iniziare con la considerazione di un’emozione intensa, come l’essere innamorati. L’esperienza
quotidiana mostra che una persona innamorata idealizza la persona amata; sebbene razionalmente possa
pensare cose diverse, resta il fatto che, in quanto innamorata, la persona amata le appare come il massimo
della perfezione e di ciò che è desiderabile. Ciò può essere in netto contrasto con l’effettiva realtà;
l’espressione “l’amore è cieco” si riferisce proprio a questo aspetto. D’altra parte l’amore è sentito come
qualcosa che supera il tempo, qualcosa che durerà per l’eternità anche se si può essere perfettamente
consapevoli della transitorietà del sentimento. Trascende anche lo spazio e la distanza. Se coniamo una
frase che apertamente nega o contraddice tutte queste proprietà, possiamo renderci maggiormente conto
di come esse siano parte integrale dell’emozione di amore. Una frase potrebbe essere questa: “ Il mio
amore per te dura solo un periodo limitato di tempo ed esiste solo mentre sono vicino a te. Ti amo per
certe qualità limitate che mi attraggono verso di te”. Certamente nessuno penserà che ciò corrisponde a
quel che realmente sente una persona innamorata ».
188
t¾n aÙtoà filšei kaˆ k»detai, æj kaˆ ™gë t¾n
™k qumoà f…leon douriktht»n per ™oàsan.
(Iliade, IX, vv. 340-343)216
In ogni caso, il motivo per cui Corsamonte rifiuta di tornare di fronte alla richiesta
di quest’ambasceria (che sarà, come si è visto, lo spunto principale del viaggio
romanzesco di Carlo e Ubaldo in Tasso) è ancora la questione dell’onore violato e del
sopruso subito da parte di Belisario nel togliergli Elpidia, in questo caso perfettamente
in parallelo con la situazione iliadica corrispettiva. Dalla caratterizzazione di Achille
resta, in questo caso, qualche traccia dell’infinitizzazione emotiva dell’odio, il cui
carattere apparentemente insanabile è sancito con lo stesso rifiuto iperbolico dei doni e
della donna proposti come riparazione che venivano offerti anche all’eroe omerico:
Dunque da me non speri alcuno aiuto,
e lasci d'offerirmi i suoi gran doni
che voi m'avete numerati, ch'io
non li voglio accettar, se ben mi desse
tutto 'l tesor che mai potesse Roma
e che or possiede il correttor del mondo:
ché non è dono il dono del nimico
né reca utilità, ma porta danno.
(Italia, XIV)
™cqr¦ dš moi toà dîra, t…w dš min ™n karÕj a‡sV.
oÙd' e‡ moi dek£kij te kaˆ e„kos£kij tÒsa do…h
Óss£ tš oƒ nàn œsti, kaˆ e‡ poqen ¥lla gšnoito,
oÙd' Ós' ™j 'OrcomenÕn potin…setai, oÙd' Ósa Q»baj
A„gupt…aj, Óqi ple‹sta dÒmoij ™n kt»mata ke‹tai,
a† q' ˜katÒmpulo… e„si, dihkÒsioi d' ¢n' ˜k£staj
¢nšrej ™xoicneàsi sÝn †ppoisin kaˆ Ôcesfin·
oÙd' e‡ moi tÒsa do…h Ósa y£maqÒj te kÒnij te,
oÙdš ken ïj œti qumÕn ™mÕn pe…sei' 'Agamšmnwn
pr…n g' ¢pÕ p©san ™moˆ dÒmenai qumalgša lèbhn.
(Iliade, IX, vv. 378-387)217
E qualche traccia ne resta anche nell’ammorbidirsi della posizione di Corsamonte
in seguito alla richiesta del suo amico Achille (l’Achille trissiniano, il Patroclo della
situazione), che gli strappa la concessione del ritorno in campo qualora a pregarlo, una
volta compiuta l’impresa romanzesca della fata Plutina, fosse la stessa Elpidia:
Fratel, più caro a me che la mia vita,
veggio ch'hai detto drittamente il vero.
Ma tant'è l'ira che m'abbonda al cuore
quando mi tornan quelle ingiurie a mente
che mi fece Aquilino e i suoi compagni,
e che trattommi Belisario il grande
com'io fosse il più vil di tutto 'l campo,
che non posso scordarle o porvi meta.
Pur vuo' pensarvi, e non negare il tutto
A
an diogenὲj Telamènie ko…rane laîn
p£nt£ t… moi kat¦ qumÕn ™e…sao muq»sasqai·
¢ll£ moi o„d£nεtai krad…h cÒlJ ÐppÒte ke…nwn
mn»somai éj m' ¢sÚfhlon ™n 'Arge…oisin œrexen
'Atreΐdhj æj e‡ tin' ¢t…mhton metan£sthn.
¢ll' Øme‹j œrcesqe kaˆ ¢ggel…hn ¢pÒfasqe·
oÙ g¦r prˆn pοlšmoio med»somai aƒmatÒentoj
pr…n g' uƒÕn Pri£moio daΐfronoj “Ektora d‹on
MurmidÒnwn ™p… tε klis…aj kaˆ nÁaj ƒkšsqai
kte…nont' 'Arge…ouj, kat£ te smàxai purˆ nÁaj.
216
Trad.: « Ma sono i soli fra tutti gli uomini ad amare le loro compagne /i figli di Atreo? Ogni uomo che
sia buono e saggio / ama la sua e si prende cura di lei, ed io pure / l’amavo di cuore, benché fosse preda di
guerra ».
217
Trad.: « Odiosi mi sono i suoi doni, e lui lo calcolo niente. / Neanche se mi donasse dieci e venti volte
di più di quanto / ora possiede, o se altre ricchezze da qualche altra parte / gli venissero, quante
affluiscono ad Orcomeno o a Tebe / Egizia, dove nelle case ci sono grandi tesori, / e la città ha cento
porte, e passano per ognuna di esse /duecento soldati coi loro cavalli e i carri, / se mi desse tanto quant’è
la sabbia o la polvere, / neanche così potrebbe persuadere il mio cuore Agamennone, / prima d’avere
scontata tutta l’offesa che affligge il mio cuore ».
189
a i miei diletti principi e fratelli.
Direte adunque al capitanio vostro
ad a gli altri baron che v'han mandati
che quando passerà per queste parti
la bella principessa di Tarento
mi farà motto, ed io, s'arò guarita
l'onorata Plutina de la vista,
venirò seco a la città di Roma.
(Italia, XIV)
¢mfˆ dš toi tÍ ™mÍ klis…V kaˆ nhῒ mela…nV
“Ektora kaˆ memaîta m£chj sc»sesqai Ñΐw.
(Iliade, IX, vv. 644-655)218
Ne resta solo qualche traccia, dico, perché poi in effetti il Trissino non coglie né
riprende l’aspetto più straordinario della vicenda emozionale di Achille, la sostituzione
repentina di un sentimento totalizzante, l’odio, con un altro parimenti totalizzante, il
dolore per Patroclo, che spazza letteralmente via il precedente, tanto da rendere
superflue e persino fastidiose le compensazioni materiali e simboliche della
reintegrazione sociale e del ripristino del suo onore. La motivazione del ritorno di
Corsamonte a combattere, dopo il rifiuto pur provvisorio opposto all’ambasceria, sarà
infatti di tutt’altra natura rispetto al desiderio di vendetta di Achille, seppur parimenti
individuale: dipenderà ancora, coerentemente alla tematizzazione dell’eros e alla
caratterizzazione del personaggio di Corsamonte, dall’amore di lui per Elpidia.
In seguito alla richiesta dell’eroe agli ambasciatori, infatti, Belisario manda a
chiamare a Roma la bella principessa, sperando così di ottenere il ritorno del guerriero;
il traditore Burgenzo, tuttavia, informato della questione, organizza in combutta con i
Goti il rapimento di lei (libro XIX), per poi usarla come esca nell’ulteriore trappola che
porterà alla proditoria morte dell’eroe. Del rapimento si rende autore, tra l’altro,
Turrismondo, il campione dei Goti in larga misura corrispettivo all’Ettore omerico che
eredita così, dal principe troiano, una colpevolezza nei confronti del massimo eroe della
parte avversa parallela a quella per l’uccisione di Patroclo. A motivare il ritorno
dell’eroe “necessario” è dunque come nell’Iliade un fatto accidentale, ma in questo caso
declinato in direzione decisamente romanzesca, nonostante il precedente epico
autorizzante del rapimento di Elena: il topos arturiano quant’altri mai della donna amata
rapita e poi liberata dal cavaliere errante (il cui principale archetipo è naturalmente il
rapimento di Ginevra nel Lancelot). Alla notizia del rapimento, Corsamonte non indugia
a deporre l’ira nei confronti di Belisario e ad abbandonare incompiuta la ventura
218
Trad.: « Illustre Aiace figlio di Telamone, capo d’eserciti, / mi pare che tu abbia detto bene tutto quello
che hai detto. / Ma a me si gonfia il cuore di collera quando ricordo / come il figlio di Atreo mi ha offeso
in mezzo agli Achei, / come se fossi un profugo disonorato. / Ma voi andate e riferite così l’ambasciata: /
non penserò alla guerra sanguinosa fintanto / che il figlio del saggio Priamo, il nobile Ettore, / non sia
arrivato fino alle navi e alle tende dei miei Mirmidoni, / uccidendo i Greci, e non abbia distrutto col fuoco
le loro navi. / Accanto alla mia tenda, alla mia nave nera, / credo che Ettore si fermerà, per quanto
smanioso di lotta ».
190
romanzesca di cui si era reso protagonista per prestare soccorso alla donna amata.
Tuttavia la razionalizzazione svilente che abbiamo visto soffocare ogni spinta verso
l’infinitizzazione emotiva nell’amore di Corsamonte per Elpidia – in un parallelismo del
tutto fuori luogo con la Briseide omerica – rende tale motivazione decisamente inadatta
ad annullare improvvisamente, come accade con il dolore per la morte di Patroclo, il
precedente conflitto con il capo dell’esercito, fino a spingere il guerriero a biasimare la
sua stessa ostinazione nell’ira, indiretta causa del nefasto effetto:
Fratel mio caro, l'empia mia durezza
m'ha indotto in questo sì crudele affanno.
Or voglio andare a liberar costei,
s'io vi dovesse ben lasciar la vita:
ch'avendo posta in me la sua speranza
non voglio mai ch'abbia sperato indarno.
Andiamo adunque, e non perdiam più tempo.
(Italia, XIX)
Del tutto svuotata della sua vertiginosa profondità emozionale, di cui conserva
solo la dimensione esteriore di sostituzione, è in questo modo la reazione disperata di
Achille alla notizia della morte di Patroclo, che si propaga intorno ai presenti e arriva a
prospettare l’ipotesi del suicidio:
•Wj f£to, tÕn d' ¥ceoj nefšlh ™k£luye mšlaina·
¢mfotšrVsi dὲ cersˆn ˜lën kÒnin a„qalÒessan
ceÚato k¦k kefalÁj, car…en d' Éscune prÒswpon·
nektaršJ dὲ citîni mšlain' ¢mf…zane tšfrh.
aÙtÕj d' ™n kon…Vsi mšgaj megalwstˆ tanusqeˆj
ke‹to, f…lVsi dὲ cersˆ kÒmhn Éscune daΐzwn.
dmJaˆ d' §j 'AcileÝj lhssato P£troklÒj te
qumÕn ¢khcšmenai meg£l' ‡acon, ™k dὲ qÚraze
œdramon ¢mf' 'AcilÁa dafrona, cersˆ dὲ p©sai
st»qea pepl»gonto, lÚqen d' ØpÕ gu‹a ˜k£sthj.
'Ant…locoj d' ˜tšrwqen ÑdÚreto d£krua le…bwn
ce‹raj œcwn 'AcilÁoj· Ö d' œstene kud£limon kÁr·
de…die g¦r m¾ laimÕn ¢pam»seie sid»rJ.
(Iliade, XVIII, vv. 22-34)219
Di nuovo nel momento cruciale emerge chiara la disparità fra l’autore mediocre e
il grande poeta pur nel contesto di un’imitazione serrata del medesimo ipotesto: a
differenza della sostituzione con una motivazione amorosa razionalizzata e svilita
219
Trad.: « Così disse, e una nera nube d’angoscia lo avvolse: / con ambedue le mani prese la polvere
arsa, / la rovesciò sul capo, sporcando lo splendido viso, / e sulla veste fragrante cadde la cenere. / Lui
stesso, grande, disteso in mezzo alla polvere, / giaceva, e con le mani si sfigurava strappando i capelli. /
Le schiave che Achille aveva predato con Patroclo, / afflitte nel cuore, gridavano, e accorrevano fuori /
intorno al valoroso Achille, e con le mani / tutte si percuotevano il petto, e si scioglievano a tutte le
membra. / Dall’altra parte Antiloco gemeva e versava lacrime, / tenendo le mani di Achille che piangeva
nel nobile cuore: / temeva che si tagliasse col ferro la gola ».
191
proposta dal Trissino, nella Gerusalemme conquistata il Tasso coglie e rielabora da
Omero proprio l’aspetto più poetico del dolore totalizzante di Riccardo di fronte alla
morte di Ruperto (il suo Patroclo) come motivazione del suo ritorno a combattere, a
sostituire con una scelta volontaria e autonoma di ritorno il passivo “salvataggio” di
Rinaldo nella Liberata:
Cosí disse Belprato; e 'l seno e 'l viso
tutto d'amare lagrime s'asperse;
ma di Riccardo, a quel dolente avviso,
nube atra di dolor gli occhi coperse,
e cadde in su lo scoglio ov'era assiso,
e la cetra gittando in mar sommerse;
e l'armonia rivolse in mesti accenti:
pianger seco pareano 'l mare e i venti.
Flebil concento a l'arenosa sponda
facean, senza mostrar gli usati orgogli.
'Ruperto' l'erta rupe, e l'aura e l'onda
rispondean pur 'Ruperto' a' suoi cordogli;
par che la cetra al nome ancor risponda,
percossa e ripercossa a' duri scogli:
mormoravano gli antri oscuri e foschi
a quel suon tenebroso, e i seggi e i boschi.
(G. C., XXI, 25-26)
Ancor più esplicita la ripresa dell’infinitizzazione emotiva nel successivo lamento
dell’eroe con la madre Lucia, modellato su quello di Achille con Teti all’inizio di Iliade
XVIII:
Cosí diss'ella; e con dolenti note:
- Non conobbi (ei rispose) il male e 'l danno,
quando i' gemea con lagrimose gote
de la morte paterna il primo affanno;
ma questo colpo in guisa 'l cor percuote,
ch'a pianto eterno il mio dolor condanno.
Conosco, ahi lasso, la prevista piaga,
ma di sempre languir l 'alma s'appaga.
Sempre dorrommi; e sempre amore e sdegno
mi roderan quest'alma afflitta ed egra.
Dove era l'ardir mio, l'onor, l'ingegno,
quando egli cadde, e la mia forza integra?
Non potria d'Asia, e d'Orïente il regno,
darmi del suo morir vendetta allegra,
ch'io devea ritenerlo e seco armarme:
ei morí col mio nome, o pur con l'arme.
(G.C., XXI, 36-37)
192
Affine il carattere totalizzante del dolore di Achille per Patroclo220: termine di
confronto per questo elemento, ancor più vicino che la scena di Il. XVIII (che pure è il
modello della scena nel suo complesso) è il momento in cui per Achille, anche dopo
l’impossibile consolazione della vendetta su Ettore, l’eternità del ricordo implica
l’eternità del dolore:
P£trokloj: toà d' oÙk ™pil»somai, Ôfr' ¨n œgwge
zwo‹sin metšw ka… moi f…la goÚnat' ÑrèrV:
e„ de qanÒntwn per katal»qont' e„n 'Aidao
aÙt¦r ™gë kaˆ ke‹qi f…lou memn»som' ˜ta…rou.
(Il., XXII, 387-390)221
Comune è anche il confronto in termini quantitativi con un lutto che colpisca nel
cuore degli affetti familiari, dove anzi la cautela di Achille in rapporto a un evento solo
l’ipotetico cede addirittura di fronte all’esplicita inferiorità di un dolore già esperito nel
caso di Riccardo:
oÙ men g£r ti kakèteron ¥llo p£qoimi,
oÙd' e‡ ken toà patrÕj ¢pofqimšnoio puqo…mhn,
Ój pou nàn Fq…hfi tšren kat¦ d£kruon e‡bei
c»tei toioàd' uŒoj: Ö d' ¢llodapù ™nˆ d»mJ
e†neka · igedanÁj `Elšnhj Trwsˆn polem…zw:
ºe tÕn Öj SkÚrJ moi œni tršfetai f…loj uƒÒj,
e‡ pou œti zèei ge NeoptÒlemoj qeoeid»j.
(Il., XIX, 321-327)222
Anche il problema di conciliare tale motivazione intima e privata del ritorno
dell’eroe necessario con le ragioni dell’ideologia – problema che in Omero non sussiste
e che il Trissino di fatto non risolve – viene intelligentemente superato nella
Conquistata attraverso una sovrapposizione temporale fra l’ambasceria inviatagli da
Goffredo (cfr. Iliade IX) e l’annuncio dell’uccisione di Ruperto (cfr. Iliade XVIII): una
coincidenza che non ha nulla di pretestuoso, ma che, se vogliamo, è l’equivalente volto
ad un esito positivo della serie di contrattempi funesti che innescano l’esito tragico in
Romeo e Giulietta223.
220
Sulla questione cfr. G. PADUANO, Le scelte di Achille, cit., pp. IX-XLIX.
Trad.: « Patroclo, ed io di lui non mi scorderò mai, fino a quando / sarò tra i vivi e le mie ginocchia si
muovono; / e se nell’Ade si scordano i morti, anche là / io sempre mi ricorderò del caro compagno ».
222
Trad.: « non potrei soffrire sciagura più grande / neanche se sapessi che è morto mio padre / – che
forse adesso a Ftia versa lacrime per la lontananza / di suo figlio, di me che combatto in un paese
straniero / per Elena maledetta contro i Troiani – / o mio figlio, che viene allevato a Sciro, / se pure è
ancor vivo Neottolemo pari agli dèi ».
223
Ho trattato la questione di tale sovrapposizione temporale dell’ambasceria e dell’annuncio della morte
di Ruperto nel mio articolo la La “Patrocleia” di Ruperto nella Gerusalemme conquistata, cit., pp. 339341.
221
193
Il Trissino, invece, riprende da Omero solo la funzione strutturale della
riconciliazione fra Corsamonte e Belisario, senza conferirle un adeguato fondamento
emotivo e poetico nella rappresentazione dell’amore di Corsamonte per Elpidia, che
pure, adeguatamente sviluppato, avrebbe certamente potuto fornirlo: ma il Trissino è
purtroppo
costantemente
impegnato
a
subordinare
la
rappresentazione
dell’emozionalità, che è in fondo il proprium della poesia, alle esigenze dell’ideologia e
di un moralismo tanto esemplare quanto prono alla riaffermazione dei valori
convenzionali e culturalmente dominanti. L’unica rilevante modifica rispetto alla
riconciliazione fra Achille e Agamennone in Iliade XIX si limita alla “correzione del
costume” su cui tanto insiste la teoria letteraria rinascimentale: a differenza dell’eroe
omerico, in ottemperanza all’ideologia imperiale, Corsamonte torna a sottomettersi
autonomamente e in maniera del tutto esplicita all’autorità di Belisario:
e Corsamonte allor parlando disse:
«Illustre capitanio de le genti,
ben conosch'io che saria stato il meglio,
non sol per noi, ma per l'Italia tutta,
non esser nata la discordia nostra;
ma poi ch'è morto quel che ne fu causa,
del cui morir però molto mi duole,
ch'egli era un uom di smisurato ardire
e di forza maggiore assai che senno:
or ch'egli è morto, e quella donna è presa,
per cui son stati questi acerbi mali,
depongo l'ira, e vengo a sottopormi
al vostro eccellentissimo governo […]»
(Italia, XIX)
Achille invece depone l’ira, ma senza fare alcun cenno ad una sua subordinazione
ad Agamennone, che in precedenza ha contestato d’altronde sia de facto, ritirandosi, che
de iure:
¢ll¦ t¦ mὲn protetÚcqai ™£somen ¢cnÚmeno… per
qumÕn ™nˆ st»qessi f…lon dam£santej ¢n£gkV·
nàn d' ½toi mὲn ™gë paÚw cÒlon, oÙdš t… me cr¾
¢skelšwj a„eˆ meneainšmen·
(Iliade, XIX, vv. 65-68)224
Sostanzialmente affine a quella di Agamennone, fino al consueto livello rasente la
traduzione, è invece la risposta di Belisario, benché meno drastica nel suo mea culpa in
relazione a una colpevolezza, come abbiamo visto, certo minore, così come
224
Trad.: « Ma lasciamo stare il passato, per quanto afflitti, / e secondo necessità vinciamo il cuore nel
petto. / Io smetto la mia collera, giacché non devo / restare continuamente irato ».
194
perfettamente paralleli sono anche i ricchi doni con cui il capitano sancisce la
riconciliazione:
Io dirò, Corsamonte, quel che ho detto
più volte a questi cari miei fratelli:
non si può mai fuggir quel che 'l Ciel vuole
né per consiglio uman né per fatiche,
ch'indi dipendon l'opre de i mortali.
Il Ciel fu quello, il Ciel, che così volse
ch'io vi privasse di sì cara donna
contra la buona mia primiera voglia:
ch'alor certo pensai dentr'al mio petto
di voler darvi Elpidia per mogliera,
e volea sol che s'induggiasse alquanto;
ma non so come il Ciel privommi in tutto
di quel fermo voler ch'avea nel cuore.
Or poi che voi, non risguardando a questo,
vi siete ritornato a darci aiuto,
anch'io voglio onorarvi, e darvi i doni
che vi promesser già Traiano e Ciro;
ma non v'incresca d'aspettare alquanto,
ch'io gli farò portare in questo loco.
(Italia, XIX)
ð f…loi ¼rwej Danaoˆ qer£pontej ”Arhoj
˜staÒtoj mὲn kalÕn ¢koÚein, oÙdὲ œoiken
Øbb£llein· calepÕn g¦r ™pistamšnJ per ™Ònti.
¢ndrîn d' ™n pollù Ðm£dJ pîj kšn tij ¢koÚsai
À e‡poi; bl£betai dὲ ligÚj per ™ën ¢gorht»j.
PhleΐdV mὲn ™gën ™nde…xomai· aÙt¦r oƒ ¥lloi
sÚnqesq' 'Arge‹oi, màqÒn t' eâ gnîte ›kastoj.
poll£ki d» mοi toàton 'Acaioˆ màqon œeipon
ka… tš me neike…eskon· ™gë d' oÙk a‡tiÒj e„mi,
¢ll¦ ZeÝj kaˆ Mo‹ra kaˆ ºerofo‹tij 'ErinÚj,
o† tš moi e„n ¢gorÍ fresˆn œmbalon ¥griοn ¥thn,
½mati tù Ót' 'AcillÁoj gšraj aÙtÕj ¢phÚrwn.
¢ll¦ t… ken ·šxaimi; qeÕj di¦ p£nta teleut´.
[…]
ìj kaˆ ™gèn, Óte d' aâte mšgaj koruqa…oloj “Ektwr
'Arge…ouj Ñlškesken ™pˆ prumnÍsi nšessin,
oÙ dun£mhn lelaqšsq' ”Athj Î prîton ¢£sqhn.
¢ll' ™peˆ ¢as£mhn ka… meu fršnaj ™xšleto ZeÚj,
¨y ™qšlw ¢ršsai, dÒmena… t' ¢pere…si' ¥poina·
¢ll' Ôrseu pÒlemon dὲ kaˆ ¥llouj Ôrnuqi laoÚj.
dîra d' ™gën Óde p£nta parascšmen Óss£ toi ™lqën
cqizÕj ™nˆ klis…Vsin Øpšsceto d‹oj 'OdusseÚj.
e„ d' ™qšleij, ™p…meinon ™peigÒmenÒj per ”Arhoj,
dîra dš toi qer£pοntej ™mÁj par¦ nhÕj ˜lÒntej
o‡sous', Ôfra ‡dhai Ó toi menoeikša dèsw.
(Iliade, XIX, vv. 78-144)225
Più sottile ma ben altrimenti rilevante è una variazione in apparenza appena
percettibile nella risposta dell’eroe che ha appena deposto la sua ira:
Illustre capitan gloria del mondo,
a voi starà il mandarmi i vostri doni
o 'l tenerli apo voi quanto vi piaccia,
che sempre mi saran giocondi e cari.
Or mi par tempo di trattar la guerra
e gir contra i nimici a la campagna:
(Italia, XIX)
'Atredh kÚdiste ¥nax ¢ndrîn 'Ag£memnon
dîra mὲn a‡ k' ™qšlVsqa parascšmen, æj ™pieikšj,
½ t' ™cšmen par¦ so…· nàn dὲ mnhsèmeqa c£rmhj
αἶya m£l'· oÙ g¦r cr¾ klotopeÚein ™nq£d' ™Òntaj
oÙdὲ diatr…bein· œti g¦r mšga œrgon ¥rekton·
(Iliade, XIX, vv. 146-150)226
225
Trad.: «Amici miei, eroi greci, scudieri di Ares, / è bello stare a sentire un uomo che si alza a parlare, /
e non è bene interromperlo: è fastidioso anche per un esperto. / Tra molto rumore di uomini chi mai
potrebbe / ascoltare o parlare? Anche un buon oratore ne è danneggiato. / Voglio spiegarmi con il figlio di
Peleo, ma voi altri Greci / ascoltatemi, e ognuno intenda le mie parole. / Spesso i Greci facevano questo
discorso, / e mi biasimavano, ma non io sono colpevole, / piuttosto Zeus e la Moira e l’Erinni che si
muove nell’ombra, / i quali nell’assemblea mi misero in cuore la colpa selvaggia, / il giorno che tolsi ad
Achille il suo premio. / Ma che potevo fare? È il dio che compie ogni cosa / […] Così anch’io, quando il
grande Ettore, l’eroe dall’elmo splendente, / sterminava i Greci accanto alle poppe delle navi, / non
potevo dimenticare la Colpa che mi ha accecato. / Ma poiché sono stato accecato e Zeus mi ha tolto / la
ragione, adesso voglio compiacerti e darti un compenso infinito. / Tu gettati nella battaglia e sprona gli
altri guerrieri; / io ti darò tutti i doni che ieri, venendo / nella tua tenda, ti ha promesso l’illustre Odisseo. /
Se vuoi aspetta, per quanto desideroso di guerra, / e gli scudieri prenderanno i doni dalla mia nave e li
porteranno / a te, che tu veda come ti soddisferanno ».
226
Trad.: «Gloriosissimo figlio di Atreo, Agamennone capo d’eserciti, / i doni se vuoi consegnali, come è
giusto, oppure / trattienili presso di te. Adesso pensiamo alla guerra, / subito: non restiamo qui a
chiacchierare, perdendo / il nostro tempo. Una grande opera resta da fare ».
195
Di nuovo la “correzione del costume” che ingentilisce nel verso «che sempre mi
saran giocondi e cari» l’indifferenza di Achille al risarcimento di Agamennone quando
ormai il suo unico pensiero è la vendetta contro Ettore, riesce a rovinare in questa
minima espressione di cortesia l’aspetto totalizzante del dolore per Patroclo che non
lascia più alcuno spazio all’odio per Agamennone: è in questa mancanza di sensibilità
per l’essenza della poesia, continuamente disseminata nel testo e nella dizione
dell’Italia, che si misura la mediocrità del Trissino, non già nelle sue preventive scelte
strutturali che invece, pur indulgendo ampiamente a errori macroscopici, talvolta
tuttavia, come abbiamo spesso messo in luce, escogitano delle soluzioni ottime e in
qualche caso persino geniali di cui il Tasso saprà fare tesoro.
Dopo l’inopportuno intervallo di un nuovo duello concordato che si conclude con
la violazione dei patti da parte dell’arciere Ablavio (i materiali rielaborati sono infatti
forzatamente desunti dal segmento iniziale della trama iliadica, libri III e IV: duello fra
Paride e Menelao e violazione dei patti da parte di Pandaro), segue la grandiosa aristia
di Corsamonte, rielaborazione di quella di Achille in Iliade XX-XXII, di cui riprende
fra l’altro la duplice articolazione in una strage collettiva al limite del soprannaturale e il
duello in cui l’eroe uccide il più forte guerriero della parte avversa, Turrismondo/Ettore.
Il carattere necessario dell’eroe trova qui dunque adeguata rappresentazione sul piano
bellico, sull’esempio dell’Iliade, rovesciando grazie al intervento di Corsamonte l’esito
dell’assedio di Roma e di conseguenza dell’intera guerra. Una soluzione che il Tasso,
come abbiamo visto, eviterà all’altezza della Liberata, sostituendola con lo stratagemma
romanzesco della predestinazione del solo Rinaldo a vincere gli incanti della selva, per
poi recuperare la “necessità” dell’eroe al piano prettamente bellico nell’altrettanto
straordinaria aristia di Riccardo aggiunta nei libri finali della Conquistata (XXIIXXIV).
Assolta la sua funzione narrativa di guerriero determinante per le sorti del
conflitto, Corsamonte può poi morire nel libro successivo (il XXII) nel compiersi della
trappola ordita da Burgenzo/Gano. La sua morte interna alla trama – a differenza di
quella di Achille, solo profetizzata come imminente – appare anzi quasi come la
punizione sancita dall’ideologia dell’autore contro l’intemperanza dell’eroe di fronte
alle passioni della collera e dell’amore, evidenziata sin dall’inizio del poema nel suo
cedere alle allegoriche lusinghe di Ligridonia e Acratia: quell’intemperanza da cui
Belisario è invece immune e che gli fa meritare la sua inconcludente preminenza nel
196
narrato che pure non riesce a tradursi, come abbiamo visto, in un vero protagonismo.
Corsamonte invece cade appunto vittima della sua passione amorosa, in quanto l’esca
con cui è attirato nell’imboscata in cui troverà la sua morte rolandiana è appunto la falsa
informazione riguardo al luogo dove Elpidia è tenuta prigioniera. Come dire: anche
dopo il suo reintegro nell’esercito e la sua rinnovata adesione alla causa collettiva,
coronata dalla grandiosa aristia, egli non si è del tutto redento dalle sue pulsioni
individualistiche e cavalleresche, ma si caccia senza pensarci due volte in una rischiosa
ventura arturiana di salvataggio della donna prigioniera dei nemici. La sua morte
sanziona a livello narrativo – in modo decisamente ingenuo e banalmente ideologico –
la sua condanna per l’incompleto adeguamento all’istanza epico-imperialistica. Il Tasso,
di nuovo, eviterà accuratamente l’errore, garantendo al suo eroe, oltre alla sanzione
sociale del reintegro militare, anche il suo pieno soddisfacimento conclusivo
dell’istanza ideologica cristiana attraverso la scena – peraltro poeticamente straordinaria
– del rituale di purificazione al monte Oliveto, che gli permette dunque di evitare la
tanto drastica e tanto rovinosa esclusione dal finale collettivo per cui opta invece il
Trissino.
197
198
5. LA PIETÀ
Compassione per i nemici e ideologia: Omero e Virgilio
conciliabili
Il tratto più palesemente virgiliano della Gerusalemme liberata, anche al di là dei
pur abbondanti rapporti di derivazione diretta di singoli episodi, è probabilmente
quell’identificazione emotiva con il mondo degli antagonisti al telos epico che,
recuperata entro il nuovo quadro ideologico del poema cristiano, genera quel sistema di
opposizioni polari complesso e ambiguo, ma al contempo coerente e solidale, di cui
l’intero poema si alimenta e si sostanzia, e che sta all’origine di tante critiche ad esso
mosse da numerosi letterati contemporanei e al tempo stesso dell’immediato, grande
successo di pubblico che ne ha determinato la rapida canonizzazione. Anche la critica
ha in seguito riconosciuto tale sistema di opposizioni e di ambiguità come effettivo
fondamento delle strutture dell’opera e del suo stesso valore artistico, soprattutto
attraverso la celebre formulazione carettiana del bifrontismo tassiano 227 e il suo
approfondimento nell’ormai classico contributo di Zatti 228 . È emerso con chiarezza
come la contrapposizione epica e bellica tra pagani e cristiani sia ben più di un semplice
dato narrativo, e risulti strettamente connessa a tutta una serie di parallele opposizioni a
livello ideologico, strutturale, poetico che emergono costantemente nel testo e vengono
a costituirne l’impianto e le dinamiche di maggior rilievo (per ricordare le principali:
epos vs romanzo, uniformità vs multiformità, cielo vs inferno, capitano vs compagni
erranti, controriforma vs umanesimo laico). L’ambigua e velata identificazione emotiva
con il mondo pagano, condannato naturalmente a livello ideologico, fa sì che questa
serie di opposizioni entro cui si bilanciano gli equilibri della Liberata si presti molto
bene ad essere letta in termini freudiani di formazione di compromesso fra un’istanza
ideologica repressiva e un’istanza deviante repressa.
227
CARETTI, L., Ariosto e Tasso, Torino, Einaudi, 1977.
ZATTI, S., L’uniforme cristiano e il multiforme pagano. Saggio sulla “Gerusalemme Liberata”,
Milano, 1983.
228
199
La riscrittura del poema che porta alla Gerusalemme conquistata viene a
modificare, talvolta anche in maniera decisiva, tali equilibri. L’aspetto investito dal
cambiamento più perentorio è senz’altro il rapporto fra codice epico e codice
romanzesco, che, senza negare il secondo, si volge tuttavia decisamente a vantaggio del
primo, in particolare tramite le ampie aggiunte di carattere bellico nei libri finali. Ma
anche il rapporto tra la dimensione ideologica e l’identificazione emotiva subisce delle
alterazioni significative rispetto alla precedente versione del poema. Che nella
Conquistata si verifichi un inasprimento ideologico in senso più marcatamente
controriformistico appare indubbio ed è divenuto anzi uno dei più frequenti luoghi
comuni della critica: sia le pressioni sociali e culturali di quegli anni di forte reazione,
sia l’intima crisi spirituale del poeta uscito dalla dura reclusione al Sant’Anna non
mancarono certo di lasciare un’evidente impronta sulla rielaborazione dell’opera.
L’ideologia contempla ora più esplicitamente il ricorso alla violenza – pienamente
giustificata, e anzi pia e devota – per la causa cristiana ai danni degli infedeli (cfr. già
nel proemio: e correr fece il mar di sangue misto); si radicalizza la condanna ideologica
che investe i pagani, dei quali si evidenzia più insistentemente l’empietà, spesso netta e
senza appello; più palesemente improntata all’esemplarità e alla devozione alla causa
cristiana diviene, per converso, la caratterizzazione dei crociati (salvo poi rivelare dietro
questa superficie, a uno sguardo più acuto, anche nuove incrinature, come quelle
evidenziate da Godard per Goffredo229). Ciò nonostante nella riscrittura assistiamo, con
un apparente paradosso, anche ad un concomitante movimento in direzione contraria,
nel senso di un’accentuazione della compassione per i nemici pagani rispetto a quanto
non fosse già nella Liberata, e questo non può mancare di apparire in netto contrasto
con l’inasprimento della condanna che invece li investe sul piano ideologico. Tale
accresciuta simpatia verso i pagani potrà anche considerarsi ricercata – secondo quanto
pare avvenire per ogni genere di intervento che modifichi la sacralità del testo
canonizzato – in modo maldestro e poco riuscito, tramite un arido e stanco ricorso a
modelli classici neppure ben armonizzati col vecchio contesto, secondo una poetica
dell’imitazione estremizzata e priva di ispirazione tipica dell’ultimo Tasso: nondimeno,
non si può non riconoscere questa accresciuta identificazione come una tendenza
innegabile e piuttosto evidente nella riscrittura del poema, il cui senso richiede di essere
chiarito proprio in rapporto all’irrigidimento ideologico apparentemente del tutto
incongruente con essa.
229
GODARD, A., Du “Capitano” au “Cavalier sovrano”. Godefroi de Bouillon dans la «Jérusalem
Conquise», in AA. VV. Réécritures, III, Université de la Sorbonne Nouvelle, Parigi, 1987, pp. 205-264.
200
Nel rinnovato interesse critico emerso negli ultimi anni per la Gerusalemme
conquistata, lo studio dei cambiamenti che investono il mondo pagano ha ricevuto una
certa attenzione e prodotto un buon numero di contributi, per lo più di volta in volta
limitati al singolo personaggio230. Ne emerge un quadro, in confronto a tanti altri aspetti
della riscrittura ben più trascurati (in primo luogo le ampie sezioni nuove fortemente
omerizzanti), già sufficientemente preciso e approfondito, ma in parte ancora viziato dai
pregiudizi tipici con cui si affronta da sempre il testo del poema riformato. In
particolare, due tendenze più generali hanno anche in questo caso impedito di cogliere
appieno il senso complessivo degli interventi di modifica.
Il primo è la netta e aprioristica svalutazione della nuova forma di imitazione forte
ed estensiva dei modelli (essenzialmente l’Iliade) propria della riscrittura del poema:
banalizzata in un mero ossequio del modello e nel conseguente appiattimento su di esso,
ad esempio ricorrendo alla categoria di imitazione “sacramentale” elaborata da Thomas
M. Greene 231 , essa viene in ciò stesso implicitamente considerata aproblematica e
superficiale e pertanto del tutto accantonata come non degna di considerazione.
Atteggiamento tanto più paradossale se si considera che proprio le sezioni dove
maggiore risulta la distanza e la novità rispetto alla Liberata hanno finito così per essere
quelle più drasticamente trascurate (il che significa in una certa misura travisare
sicuramente, in partenza, il senso complessivo della riscrittura del poema). Anche la
trattazione di alcuni fondamentali mutamenti nell’ambito pagano e nelle vicende degli
antagonisti principali, che come vedremo dipendono in larga misura da un nuovo
rapporto con i modelli classici, è stata non si vuol dire compromessa, ma certamente
comunque viziata da un tale atteggiamento.
230
BOILLET, D., Clorinde, de la «Jérusalem délivrée» à la «Jérusalem Conquise», Revue des Etudes
Italiennes 42 (1996), pp. 7-53; DELLA TERZA, D., Armida dalla «Liberata» alla «Conquistata». Genesi ed
evoluzione del personaggio, in ID., a cura di, Dal Rinaldo alla Gerusalemme: il testo, la favola, Sorrento,
1997, pp. 257-271; FOLTRAN, D., Dalla «Liberata» alla «Conquistata». Intertestualità virgiliana e
omerica nel personaggio di Argante, Studi Tassiani, 55-56 (1992-93), pp. 89-134; MOLINARI, C., Erminia
e Nicea: metamorfosi tassiane, in DE ROBERTIS, D. e GAVAZZENI, F., a cura di, Operosa parva. Studi
offerti a Gianni Antonini, Verona, Edizioni Valdonega, 1996, pp. 189-196; OLINI, L., Dalla
«Gerusalemme Terrena» alla «Gerusalemme Celeste»: Rinaldo e Armida vs Armida e Riccardo, Studi
Tassiani, 33 (1985), pp. 69-87; PICCO, G., «Or s’indora or verdeggia». Il ritratto femminile dalla
«Liberata» alla «Conquistata», Firenze, Le Lettere, 1996; i capitoli Il passato di Armida, Armida
imprigionata e Armida e Proteo in RESIDORI, M., L’idea del poema. Studio sulla Gerusalemme
Conquistata di Torquato Tasso, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2004. Uno studio complessivo
sull’evoluzione mondo pagano nella riscrittura è invece quello proposto da BORRELLI, C., Il mondo
pagano della «Liberata» alla «Conquistata»: varianti tematiche e linguistiche, in EAD. Su Tasso e il
tassismo tra Cinquecento e Ottocento, Napoli, L’orientale, 2001, pp. 7-41.
231
Così RESIDORI, M., L’idea del poema, cit., pp. 179-80: il testo cui fa riferimento è GREENE, T. M., The
Light in Troy. Imitation and Discovery in Renaissance Poetry, Yale, University Press, 1982.
201
Il secondo pregiudizio, non meno frequente, è quello per cui l’innegabile
inasprimento ideologico viene estremizzato fino a farne una dimensione univoca e
totalizzante di lettura, in cui il fascino ambiguo che promana dalla Liberata si
perderebbe irrimediabilmente in un manicheismo arcigno e monocorde dove la
dimensione letteraria risulta soffocata dall’ortodossia controriformistica. Anche in
questo caso è chiaro che se si parte dal presupposto che nella Conquistata l’ideologia
sommerga e cancelli in partenza ogni altro aspetto più propriamente poetico, tale
atteggiamento porterà a non svolgere se non superficialmente quell’analisi delle
dinamiche letterarie al termine della quale soltanto tali aspetti potrebbero emergere. Va
da sé che la ridefinizione del mondo pagano, ovvio bersaglio principale dell’inasprirsi
dell’ideologia cattolica, non potrà che essere almeno in parte travisata e banalizzata da
una simile petizione di principio, per cui si vede nel testo solo ciò che ci si aspetta di
trovarvi.
Caso emblematico, per il rilievo del personaggio e per la modifica clamorosa cui
la sua vicenda viene sottoposta nella riscrittura, è quello di Armida: proprio la sua
emblematicità, il cui senso è apparentemente immediato e palese, può essere utile a
mostrare come una simile lettura prevenuta riesca a cogliere in maniera soltanto parziale
le motivazioni che inducono a interventi anche drastici, deformandone inevitabilmente
il significato complessivo. A parte diverse modifiche non irrilevanti ma tutto sommato
marginali, il vero grande cambiamento che non può mancare di stupire concerne il
destino cui la maga va incontro nelle due versioni del poema. Dopo il suo abbandono
iper-virgiliano da parte di un Rinaldo richiamato, esattamente come Enea, ai suoi doveri
“epici”, nella Liberata Armida torna in scena, e da protagonista, nell’ultimo canto, in
quel capolavoro di poesia sentimentale e patetica che è l’episodio finale del suo
ricongiungimento con l’uomo amato: un episodio breve e intensissimo, indelebile nella
memoria di ogni lettore, pericolosamente giocato sul filo dell’eccesso e della ridondanza
senza mai cadere oltre la misura, e che tanto contribuisce alla varietà romanzesca – e per
certi versi quasi ariostesca – del grande affresco di battaglia conclusivo, rivelando al
contempo una sensibilità affatto nuova che apre al melodramma ormai prossimo alla
nascita, non a caso così spesso sensibile al fascino della figura di Armida. Grande è il
cambiamento che essa subisce in questo suo ritorno nel finale corale, eppure
perfettamente coerente con la parabola che da aggreditrice la trasforma in vittima e
quindi in supplice inascoltata, fino alla sua completa sottomissione che, attraverso la
celebre parafrasi mariana (Ecco l’ancilla tua), adombra la conversione sotto il segno
202
dell’amore ritrovato (con parallelismo rovesciato rispetto a Clorinda, la cui conversione
discendeva invece da un amore mancato e alla fine sublimato in pura spiritualità).
Questo memorabile e significativo episodio è rimosso nella Conquistata, dove
non ha più luogo alcuna riconciliazione tra Armida e Riccardo (il Rinaldo della
precedente versione del poema), e la vicenda della maga termina drasticamente al
momento della liberazione del campione cristiano da parte di Ruperto e Araldo (i
corrispettivi di Carlo e Ubaldo della Liberata): in una breve aggiunta di carattere
fortemente allegorico al termine dell’intatta separazione virgiliana, i due liberatori
legano la maga ad una rupe con una catena di diamante e topazio, simbolo – tratto dal
Triumpus Pudicitiae petrarchesco – della vittoria di senno e virtù sugli inganni
dell’amore profano:
Ma de l’ascose insidie uscito Araldo,
la cauta man gli avvolse entro a' capelli;
torcendo il viso al viso umido e caldo,
ed a’ preghi, di fede ancor rubelli:
e con quel laccio sí tenace e saldo
legò le braccia e i piè fugaci e snelli
co’ nodi d’adamante e di topazio;
né fece altra di lei vendetta o strazio.
Ma la zona, onde intorno andò recinta,
con la severa man le ha tolto, e disse:
- Tu starai qui su questa pietra avvinta
a contemplar le stelle erranti e fisse,
sin che la mole tua bugiarda e finta
disfaccia, e segua ciò che il Ciel prescrisse:
ché non ti lega violenza o forza,
ma ’l senno e la virtú, cui nulla sforza. –
(G. C., XIII, 70-71)
Ell’avea in dosso, il dì, candida gonna,
lo scudo in man che mal vide Medusa.
D'un bel dïaspro er’ ivi una colonna,
a la qual d’una in mezzo Lete infusa
catena di diamante e di topazio,
che s'usò fra le donne, oggi non s’usa,
legarlo vidi, e farne quello strazio
che bastò ben a mille altre vendette;
ed io per me ne fui contento e sazio.
(T. P., vv. 118-126)
Facile e direi quasi immediata alla lettura è l’interpretazione in chiave ideologica
del taglio della riconciliazione finale tra i due amanti, non a caso interpretata
unanimemente dalla critica come soffocamento della istanze poetiche di fronte ad una
condanna morale che ormai non conosce più ambiguità né vie di scampo, in un aut aut
che per privilegiare l’esemplarità e l’allegoria va decisamente a scapito del risultato
203
artistico. Interpretazione non solo del tutto legittima, ma portata in piena evidenza dalle
strategie testuali stesse e giustamente messa in parallelo dalla critica con l’eliminazione
dell’ultimo incontro fra Erminia e Tancredi ferito nel XIX canto della Liberata, come a
ribadire una più rigida alterità di fondo tra i due campi contrapposti. Tuttavia, una
simile lettura che si esaurisce nel dato ideologico non fa altro che limitarsi a trovare nel
testo, come dicevamo, ciò che in partenza ci si aspetta di trovarvi, senza spingersi oltre e
chiedersi se ad un’analisi più approfondita possano emergere elementi ulteriori e magari
inaspettati, tali da modificare anche nettamente il quadro apparentemente più ovvio che
si mostra già ad un primo sguardo. In una delle Lettere poetiche (la n. XXI, indirizzata a
Scipione Gonzaga), citata solo en passant da qualche critico, il Tasso affronta appunto
la questione della presenza di Armida nell’ultimo canto del poema (corsivi miei):
L’argomento che Vostra Signoria dimanda non potrei ora mandarlo senza molto mio discommodo:
mi basterà solo, dunque, che si consideri se quello accompagnare l’attione d’Armida con l’attione
principale, quasi sino al fine, potrà dare altrui noia e far parere ch’io abbia presa Armida per soggetto
principale e ch’io riguardi in lei, non solo in quanto distorna i cristiani e ritiene Rinaldo, ma anco prima
e per sè. Se questo non offende, del rimanente parmi quasi essere o sicuro o risoluto, come l’ho scritto per
l’altre mie: ma se questo noiasse, si potrebbe rimovere quella riconciliazione fra lei e Rinaldo, ch’è
nell’ultimo canto, e fornire nella sua fuga; perochè in tutti gli altri luoghi dove di lei si parla, dopo il
sestodecimo, non se ne parla se non brevissimamente e sempre per accidente.
Già nel 1575, all’altezza della cosiddetta “revisione romana”, anni prima
dell’edizione Bonnà della Liberata, l’autore prospettava la possibilità di rimuovere
quell’episodio, ma la motivazione addotta non è affatto ideologica, bensì prettamente
poetica e strutturale (si badi invece che proprio nelle Lettere poetiche, quando entrano in
gioco interferenze ideologiche, spesso direttamente collegate alla censura dell’autorità
ecclesiastica, il poeta non si fa alcuno scrupolo a parlarne a chiare lettere, come per la
vexata quaestio della magia entro il poema cristiano). Il vero problema, per Tasso, sta
nel dubbio che la ripresa della vicenda di Armida alla fine del poema rischi di dare
troppo rilievo a quella che dev’essere invece solo una diversione, un impedimento che
ritarda il compiersi del telos epico, e finisca per elevare la figura della maga a un ruolo
autonomo e concorrenziale verso quello protagonistico; d’altronde è noto quanto il
poeta fosse tormentato da simili questioni strutturali, se è vero che una delle sue costanti
preoccupazioni – fortunatamente, potremmo dire, non del tutto realizzata – era quella di
arginare il rischio di un doppio protagonismo per l’ingombrante presenza di Rinaldo
accanto a Goffredo.
Riesaminando la questione da questa prospettiva, subito la soppressione
dell’episodio nella Conquistata acquista innanzitutto un altro senso, che non nega il
204
ruolo dell’ideologia ma ne ridimensiona senz’altro il peso. Tra le tante e pervasive
modifiche che investono il poema ad ogni livello, per cui si può parlare a pieno titolo di
riscrittura, la più rilevante è senz’alcun dubbio la ridefinizione complessiva del
protagonismo di Rinaldo/Riccardo sulla base di quello di Achille nell’Iliade, nonostante
questo aspetto sia stato decisamente trascurato dalla critica rispetto alla sua importanza
decisiva, e spesso ampiamente frainteso; l’elemento cardine attorno al quale si
costituisce tale ridefinizione del protagonismo è l’introduzione ex novo della vicenda di
Ruperto, esemplata su quella omerica di Patroclo, a generare nel poema un nucleo
emotivo precedentemente assente, a tal punto totalizzante per Riccardo da improntare su
di sé, anche se non quanto nell’Iliade, tutta la seconda parte del poema. Se dunque nella
Liberata la diversione dal compimento del telos epico della quale Rinaldo è
protagonista e paradigma si incentra sull’unico nucleo narrativo romanzesco della
vicenda di Armida, nella Conquistata a questo primo nucleo diversivo se ne aggiunge
un secondo, marcatamente epico, dovuto al radicalizzarsi della contesa con Goffredo e
risolto dalla tragica vicenda di Ruperto. È evidente, allora, che il taglio della
riconciliazione finale tra Armida e il campione cristiano va imputato essenzialmente
proprio a questo nuovo grande nucleo omerizzante che la critica sembra troppo spesso
ignorare: se già all’epoca della “revisione romana” l’opportunità dell’episodio appariva
dubbia per ragioni strutturali, proprio l’interposizione del nuovo nucleo emozionale
della “Patrocleia” di Ruperto risolve senz’altro la questione, rendendo impraticabile la
ripresa del filo di Armida a tale distanza non solo testuale (che comunque nella
Conquistata risulta notevolmente accresciuta: non più quattro canti ma ben undici), ma
soprattutto narrativa ed emotiva. La presenza di Riccardo nella battaglia finale, come
vedremo, sarà ovviamente incentrata sul tema della vendetta di Ruperto sul suo uccisore
Solimano, e non può più avere spazio per il ritrovato affetto nei confronti di Armida. Se
nel finale il necessario e definitivo imporsi della causa cristiana sopra ogni
particolarismo impedisce, dopo la penitenza di Riccardo e la sua reintegrazione nella
collettività, che al tema della vendetta sia lasciata altro che una pallida ombra della
dimensione totalizzante che esso aveva nell’aristia di Achille, cui pure in qualche
misura Tasso si ispira, tuttavia certo non c’è più spazio per la riconciliazione con
Armida: il poco che lo zelo cristiano collettivo e concorde ancora concede al
particolarismo e all’interiorità dell’individuo non può che essere dominato dal pensiero
dell’amico morto, che nella sua assolutizzazione emotiva ha da tempo sottratto ogni
posto all’affettività che lo legava ad Armida. Un caso esemplare in cui l’ideologia
205
sembrava essere palesemente il movente unico e pienamente soddisfacente per spiegare
gli interventi di riscrittura si è dunque rivelato dipendere innanzitutto, ad uno sguardo
appena più ampio e meno prevenuto, da tutt’altre motivazioni, ossia la necessità di
sacrificare la bella pagina alla coerenza strutturale: l’ideologia, l’intento allegorico,
l’esemplarità morale sono senz’altro compresenti, ma solo come corollari di un
obiettivo fondamentale che invece si è rivelato essere eminentemente letterario.
Nell’intento di tornare in una prospettiva più generale sull’evoluzione del mondo
pagano dalla Liberata alla Conquistata per cercare di fare qualche passo avanti rispetto
ai risultati finora raggiunti dalla critica sarà bene, dunque, sulla base dell’esempio
fornito, tener conto innanzitutto del fatto che il dato ideologico ha senz’altro il suo
rilievo, ma non va sopravvalutato, per evitare di banalizzare il senso della riscrittura e
leggervi un appiattimento monosemico che risulta forse, piuttosto, da una proiezione di
limiti imputabili all’interpretazione. L’immagine complessiva del mondo pagano nella
Conquistata per come risulta delineata dalla critica appare fortemente sbilanciata su tale
aspetto ideologico, il cui inasprimento è visto in partenza come negazione
dell’identificazione emotiva con i nemici, senza neppure che ci sia il bisogno di andare
realmente ad analizzare il testo in maniera approfondita per verificare tale supposizione:
Clara Borrelli, ad esempio, nel fornire l’unico contributo che affronti nel complesso il
tema del mondo pagano, parla espressamente di scene e situazioni che « saranno
“censurate” nella Conquistata, per cancellare l’impressione […] che egli [il poeta]
partecipi emotivamente alle vicende umane e militari degli infedeli, tanto da far parlare i
critici di una sua complicità con il nemico » 232 ; Matteo Residori, nella breve ma
aggiornata presentazione complessiva della Conquistata inserita nella sua monografia
introduttiva al Tasso, riassume lapidariamente un tale orientamento critico
sostanzialmente unanime affermando: « La chiarezza assiologica del poema esclude
infatti la compassione, e a maggior ragione l’ambiguità di sentimenti. Il registro degli
affetti non è assente dalla Conquistata, ma si limita ormai a una poesia del lutto
iperbolica e rituale, secondo il modello omerico»233. Per misurare quanto una simile
immagine vulgata sia parziale e in ciò travisi le intenzioni dell’autore nella riscrittura,
basta confrontarla con le affermazioni del Tasso stesso a tale riguardo nel Giudicio
sovra la «Gerusalemme riformata», l’opera di autocommento che si accompagna alla
nuova versione del poema; è vero che si tratta di un’opera preventivamente apologetica,
le cui indicazioni devono essere costantemente verificate tramite il riscontro nel testo
232
233
BORRELLI, C., Il mondo pagano della «Liberata» alla «Conquistata», cit., p. 30.
RESIDORI, M., Tasso. Profili di storia letteraria, Bologna, Il mulino, 2009, p. 126.
206
per valutare l’eventuale discrepanza tra la teorizzazione e i risultati effettivi, e tuttavia
non si può mancare di notare come l’interpretazione che il poeta stesso propone sia
quasi opposta a quella emersa dall’analisi critica: egli scrive infatti:
ne la difesa della patria e de la sua fede Argante è similissimo ad Ettore, e per questo meritevole
de le lagrime e de’ lamenti della moglie e de la madre e de l’altre donne saracine; le quali, essendo
innocenti, bench’infedeli, possono muover gran compassione; e là dove la persona di Argante prima non
era miserabile, ora è divenuta miserabilissima, perchè di soldato straniero e mercenario è divenuto
figliuolo di re e di regina cristiana, e principe natural di quella città, difensor del padre, amator della
moglie, e costante nella difesa e nella fede; e però quella pietà che si niega alla legge, si può conceder a
la natura ed a l’umanità.
Se dunque di norma è vero che « le persone scelerate non sogliono mover
compassione de le loro infelicità », tuttavia
si può dubitare se nel poema eroico il poeta possa o debba muover compassione per l’infortunio di
persona scelerata, perché da quella di Mezenzio e di Lauso la ricerca Virgilio.
Tasso conclude infine sull’argomento in maniera molto chiara:
volendo io far la favola affettuosa, ho cercato di muover la compassione ancora da’ nemici,
stimando ch’a’ cavalieri cristiani si convenga la pietà usata ancora ne’ barbari e negl’infedeli: laonde non
debbo meritar biasimo perch’io abbia voluto in tutt’i modi e da tutte le persone la misericordia.
[…]
In questo modo, come ho detto, nella perturbazione, che è la terza parte della favola, ho ricercata
la compassione da’ Principi Infedeli e da’ Fedeli, sì come Omero la cercò da’ Greci e da’ Barbari ; ma
più da’ Fedeli, e più che da tutte le altre persone e da gli altri avvenimenti, da la morte di Ruperto d’Ansa,
laudata e lagrimata poeticamente quanto ho giudicato esser conveniente.
Si vede bene come l’autore non solo ribadisca frequentemente e senza la minima
ambiguità di aver « cercato di muover la compassione ancora da’ nemici », ma nel caso
di Argante affermi anche a chiare lettere che il livello di partecipazione emotiva e di
identificazione è persino decisamente accresciuto nella Conquistata rispetto a quanto
non fosse nella Liberata. Le ultime pagine del Giudicio, d’altra parte, sono interamente
finalizzate a spiegare, attraverso un’ampia serie di riferimenti filosofici, quale debba
essere il ruolo « de la commiserazione e de la purgazione de gli affetti »234 nell’epopea:
seguendo la tradizione aristotelica della catarsi, contro la concezione « di Platone e de
gli Academici, e de gli Stoici, e de gli Epicurei, i quali, come ne l’altre cose siano molto
discordi, paiono concordarsi in quel ch’appertiene a la vacuità de gli affetti ed a la
tranquillità de gli animi »235, la rappresentazione delle passioni nell’opera è connessa
234
235
Giudicio…, cit., p. 165.
Ibid., p. 166.
207
all’influsso positivo che essa può avere sull’animo dello spettatore o del lettore
“purgandolo” dagli eccessi che quelle passioni producono nel suo animo, cosa che per il
Tasso può avvenire sia tramite la rappresentazione delle « contrarie qualità », sia tramite
« l’eccesso de le simili qualità », « sì come nel corpo non solamente contraria
contrariis curantur, ma, per giudicio d’Ippocrate ancora, similia similibus curantur »236.
L’argomentazione, sviluppata per diverse pagine, è interamente finalizzata a giustificare
proprio quel coinvolgimento nella partecipazione emotiva anche dei pagani oltre che dei
cristiani al quale la critica sembra negare del tutto un ruolo nella Conquistata, o
quantomeno svalutarlo fortemente: l’autore, insomma, sente di dover difendere le sue
scelte di poetica in relazione alla presenza e anzi all’accresciuto peso, rispetto alla
Liberata, proprio di quell’aspetto di cui la critica, all’opposto, gli rimprovera la perdita
a tutto vantaggio dell’ideologia. Certo non stupisce che sia questa la prospettiva
dell’autore, nel quadro della sua poetica classica del miscere utile dulci riletta alla luce
della morale cristiana. Ma appunto da una simile prospettiva la presunta mancanza o
drastica riduzione dell’identificazione emotiva con il nemico pagano non avrebbe
affatto costituito problema né richiesto una preventiva giustificazione, proprio in quanto
immediatamente coerente con il movente morale, con l’utile: se il Tasso sente di dover
giustificare questo aspetto, ciò significa che a suo giudizio le tante critiche di ordine
morale mosse a questo fondamentale aspetto della Liberata si sarebbero ripresentate tal
quali per la Conquistata, in quanto nella riscrittura, lungi dal piegare le proprie scelte di
poetica a simili pressioni, non soltanto egli non mette affatto a tacere la compassione
per i nemici sconfitti, ma ritiene anzi di averne persino accentuato il peso rispetto alla
precedente versione del poema, a tal punto da sentirsi in dovere di elaborare
esplicitamente una sorta di piccola teoria estetica dell’identificazione con quanto è
oggetto di netta condanna morale.
Veniamo dunque a valutare, nell’analisi effettiva del testo, a quali modifiche
complessive è soggetta la rappresentazione del mondo pagano e quale possa essere la
loro incidenza nel modificare le strategie di significazione del testo nel passaggio
dall’una all’altra redazione del poema. Ad uno sguardo complessivo, l’aspetto che
subito salta agli occhi è la notevole modifica della caratterizzazione del mondo pagano
in termini di multiformità, disgregazione e discordia che soprattutto Sergio Zatti ha
contribuito a mettere nella giusta evidenza, collocandolo in un quadro coerente di
significazione nel poema. Sarà bene chiarire subito che questo aspetto, tanto importante
236
Ibid., p. 172.
208
nel sistema della Liberata, non è affatto negato o desemantizzato nella Conquistata; mi
sembra più giusto dire che esso è ridefinito, e in vista di finalità poetiche prima ancora
che ideologiche. La caratterizzazione del campo pagano in termini di varietà discorde e
tendente alla dispersione permane, ma per lo più sul versante collettivo e prettamente
militare, come nella descrizione dell’esercito egiziano prima agli occhi di Vafrino e poi
al suo arrivo presso Gerusalemme e all’inizio dello scontro: simili elementi restano nel
nuovo testo sostanzialmente invariati e conservano intatta l’insistenza. Non mancano,
anzi, anche passi riscritti o nuovi che introducono il tema anche laddove mancava nella
Liberata, come il momento in cui i crociati vedono arrivare di lontano l’immenso
esercito egiziano:
Conquistata:
Liberata:
Non sbigottisce a la terribil vista
de' magnanimi Franchi il cor feroce,
mentre l'oste, di turba orribil mista,
e varia d'armi e d'abiti e di voce,
si fa lor piú vicina, e spazio acquista
incontra 'l monte ove s'alzò la croce,
quando ebbe del tiranno empio d'inferno
la sanguigna vittoria il Re superno.
Ben s’avisaro i Franchi onde de l'ire
l'impeto novo e 'l minacciar procede,
e miran d'alta parte; ed apparire
il poderoso campo indi si vede.
Ma s'è dubbioso a' nuovi rischi e teme
de l'incerta fortuna 'l volgo afflitto,
il fior de' cavalieri accolto insieme
con giovanile ardire al duce invitto:
'Dá (grida) il segno di battaglia', e freme,
non avendo timor d'Asia, o d'Egitto,
perché da nere arene e d'alte selve
armino i mostri e le possenti belve.
(G.C., XIX, 7-8)
Súbito avampa il generoso ardire
in que' petti feroci e pugna chiede.
La gioventute altera accolta insieme:
"Dà" grida "il segno, invitto duce," e freme.
(G.L., XX, 3)
Sarà utile precisare en passant – cosa che non mi pare sia stata notata – come la
matrice della contrapposizione tra uniformità dell’esercito cristiano e multiformità di
quello pagano origini, forse inaspettatamente, da uno spunto omerico. È noto come
nell’Iliade la contrapposizione fra Greci e Troiani sia meramente militare e non
ideologica o culturale, come in Tasso: eppure proprio nel momento iniziale degli
scontri, dopo la violazione dei patti, viene sottolineata appunto l’unità linguisticoculturale dei Greci contrapposta alla multiformità dei Troiani e dei loro vari alleati
d’Asia:
ìj tÒt' ™passÚterai Danaîn k…nunto f£laggej
nwlemšwj pÒlemon dš· kšleue d oŒsin ›kastoj
¹gemÒnwn· o‰ d' ¥lloi ¢k¾n ‡san, oÙdš ke fa…hj
tÒsson laÕn ›pesqai œcont' ™n st»qesin aÙd»n,
sigÍ deidiÒtej shm£ntoraj· ¢mfˆ d p©si
209
teÚcea poik…l' œlampe, t¦ eƒmšnoi ™sticÒwnto.
Trîej d', éj t' Ôϊej polup£monoj ¢ndrÕj ™n aÙlÍ
mur…ai ˜st»kasin ¢melgÒmenai g£la leukÕn
¢zhc j memaku‹ai ¢koÚousai Ôpa ¢rnîn,
ìj Trèwn ¢lalhtÕj ¢n¦ stratÕn eÙrÝn Ñrèrei·
oÙ g¦r p£ntwn Ãen ÐmÕj qrÒoj oÙd' ‡a gÁruj,
¢ll¦ glîssa mšmikto, polÚklhtoi d' œsan ¥ndrej.
(Iliade, IV, 427-438)237
Appare evidente come i passi tassiani appena citati, così come altri luoghi affini
ampiamente illustrati da Zatti nel primo capitolo del suo saggio sull’argomento 238 ,
traggano ispirazione da questo luogo omerico.
Se dunque questa caratterizzazione multiforme dell’esercito pagano ripresa
dall’affine multiformità di Troiani e alleati nell’Iliade resta sostanzialmente immutata
nel passaggio alla Conquistata, ad essere radicalmente modificato, invece, è il mondo
pagano sul suo versante interno, ossia in quanto comunità, in quanto collettività sociale
costretta ad affrontare le avversità della guerra e dell’assedio e destinata fatalmente alla
sconfitta. Se nella Liberata il tratto dell’esilio o comunque dell’isolamento e
dell’individualismo caratterizzava i pagani anche oltre l’aspetto strettamente militare,
soprattutto nelle due grandi figure di Argante e Solimano, la riscrittura ripensa
totalmente questo aspetto, e lo fa ancora una volta – almeno nel complesso ‒ sulla base
del nuovo grande modello dell’Iliade omerica: proprio come lì avveniva per i Troiani, il
popolo di Gerusalemme nella Conquistata diventa una vera comunità, unita e solidale al
suo interno, i cui capi sono trasformati in un gruppo familiare sull’esempio della
famiglia di Priamo in Omero. Questo risultato è ottenuto innanzitutto trasformando
Argante, da personaggio senza passato e senza una vera patria qual era, in figlio del re
di Gerusalemme Ducalto (il precedente Aladino) e riplasmandolo in parte sull’Ettore
omerico. Anche Solimano, pur restando l’esule privato del regno dai crociati, diviene
ora padre di Nicea, che è il nuovo nome di Erminia, e del giovane Amoralto. Altri
personaggi secondari introdotti nella riscrittura contribuiscono poi a completare questo
nuovo quadro di una comunità unita nella difesa della patria e nei legami familiari. Tale
omerizzazione del mondo pagano, tuttavia, non determina un continuo stravolgimento
237
Trad.: « così le schiere dei Greci, una dopo l’altra muovevano / impartiva ordini; gli altri marciavano
in silenzio e mai avresti detto / che tanti uomini, possedendo una voce, / avanzassero in silenzio per
rispetto dei loro capi; attorno ad ognuno / scintillavano le armi adorne che portavano in marcia. / I Troiani
invece, come stanno affollate le pecore / nel cortile di un uomo ricco per essere munte del bianco latte, / e
belano senza tregua sentendo la voce dei loro agnelli, / così si levava nel vasto campo il loro grido di
guerra; / non avevano la stessa voce e la stessa lingua, / ma lingue mescolate, di genti di vari paesi ».
238
Cfr. ad esempio la descrizione dell’esercito egiziano visto dagli occhi di Vafrino (Lib., XIX, 58):
«Vide tende infinite e ventillanti / stendardi in cima azzurri e persi e gialli, / e tante udí lingue discordi e
tanti / timpani e corni e barbari metalli / e voci di cameli e d'elefanti, / tra 'l nitrir de' magnanimi cavalli, /
che fra sé disse: “Qui l'Africa tutta / translata viene e qui l'Asia è condutta.”»
210
nella figura e nelle vicende dei principali antagonisti dei crociati, ma si concentra
soprattutto in alcune grandi scene fortemente riscritte o inserite ex novo sul modello di
alcuni celebri momenti iliadici. Tale pratica ha subito, com’è facile immaginare, un
giudizio doppiamente negativo da parte della critica: le nuove scene fortemente
omerizzanti sono state svalutate, come sempre, considerandole nulla più che traduzioni
e appiattimenti sull’Iliade secondo la nuova prassi dell’imitazione “sacramentale”, che
si limita ad omaggiare il grande modello privandosi di ogni possibilità di significazione
sua propria; gli inserti iliadici, poi, che naturalmente vanno a modificare la
caratterizzazione dei personaggi, sono stati considerati inconciliabili con gli elementi
preesistenti della Liberata, con cui non potrebbero armonizzarsi, determinando
nient’altro che delle stonature.
Il caso più sistematico di omerizzazione è senz’altro quello di Argante nel suo
essere riplasmato sulla figura di Ettore. Cerchiamo di analizzare le principali modifiche
cui va incontro nella riscrittura andando oltre i pregiudizi verso il ricorso al modello
iliadico e confrontandoci direttamente con il testo, per cercare di capire quali possano
essere le strategie di significato messe in atto da tale nuova pratica. A parte una serie di
scene prettamente belliche nei libri finali del poema, in cui Argante ripete spesso l’agire
di Ettore negli scontri al muro e poi alle navi nell’Iliade, le grandi scene dalle quali la
vicenda e la caratterizzazione del campione pagano risultano fortemente modificate
rispetto alla Liberata sono il suo ultimo commiato dalla moglie, basato sul celeberrimo
incontro alle porte Scee di Iliade VI, e dopo la sua morte il compianto del corpo da parte
delle donne pagane, che dell’Iliade riprende la conclusione. Come si vede, si tratta di
due scene fortemente patetiche, dalla cui sola scelta emerge con chiarezza la coerenza
dell’intervento della riscrittura con il proposito di « muover la compassione ancora da’
nemici » espresso nel Giudicio.
L’ultimo incontro di Argante con sua moglie, che conformemente alla sua
funzione ha il nome parlante di Lugeria, da lugeo, è collocato nel XXII libro, all’inizio
della lunga sequenza bellica finale dell’assalto cristiano a Gerusalemme. Dopo la
riconciliazione di Goffredo e Riccardo e la purificazione penitenziale di quest’ultimo ha
inizio la prima sequenza dell’aristia di Riccardo, ad imitazione di quella di Achille; di
fronte all’infuriare del campione crociato tornato a combattere, Argante sente di dover
scendere in campo ad affrontarlo, sia per il suo onore (G. C., XXII, 50, vv. 7-8: « ned al
proprio fratel lasciarla [la gloria] agogna / e teme in altrui laude onta e vergogna »), sia
soprattutto per proteggere gli affetti e la patria di cui sa di essere il principale difensore:
211
Non ritrovava intanto o pace, o posa,
l'alma inquïeta del feroce Argante;
ma del fin de la guerra ancor pensosa,
mille forme d'orrore avea davante:
il rischio de' fratei, l'etá gravosa
del vecchio padre ed, anzi il fin, tremante:
i preghi de la moglie, e i teneri anni
del figlio, il proprio onore, e i lunghi affanni.
(G.C., XXII, 49)
Ma la moglie Lugeria, intuendo il suo proposito, gli si fa incontro con le ancelle e
il figlio per cercare di distoglierlo e trattenerlo dentro le mura. In undici ottave viene
così incastonata la scena che ripercorre fedelmente l’addio di Ettore ad Andromaca,
secondo la tecnica di imitazione “integrale”, al limite della traduzione, cui spesso Tasso
ricorre nella riscrittura del poema quando riprende delle scene del nuovo modello
iliadico. Come in Omero, l’attenzione del poeta si sofferma per prima cosa
sull’immagine del figlio bambino, nella cui figura è in qualche modo preannunciata e
racchiusa insieme la commovente e quasi inaspettata conflittualità che in questa scena si
genera tra valori sociali di difesa della patria e affetti familiari, solitamente invece del
tutto omogenei e quasi assimilabili per la parte degli assediati:
Una di lor portava in braccio il figlio
che poco anzi lasciato avea la culla,
e pargoleggia ancor nel gran periglio,
e de l'altrui dolor sa poco o nulla:
bello era come rosa o fresco giglio;
e spesso del gran padre il duol trastulla,
che Giordano il chiamò: le genti dome
Salmansar il dicean con regio nome.
(G.C., XIX, 52)
All’inconfondibile particolare omerico del doppio nome, in cui subito la
dimensione privata e affettiva viene ad essere distinta da quella collettiva e sociale, fa
da contrappeso la nota tutta tassiana, assente nel modello, della spensierata
inconsapevolezza infantile della sofferenza, sulla quale si innesta la dolente preghiera
della moglie, vicinissima al dettato iliadico:
Tacito rimirando il fèro padre,
come soleva, al pargoletto arrise.
Piangeva appresso la dolente madre:
e presa quella man che tanti ancise,
e spesse volte a le nemiche squadre
de la vittoria alto sentier precise,
disse: - Questa virtú che gli altri affida,
signor mio caro, a morte alfin ti guida.
212
Abbi pietá del tuo figliuol diletto
che non conosce la miseria umana,
e di me, dal paterno e caro aspetto,
e da la patria mia tanto lontana,
che lascerai nel mal securo letto,
vedova sconsolata in terra estrana,
la qual, priva di te, vorrei la morte,
pria che di real sangue indegna sorte.
Piú caro mi sarebbe andar sotterra,
lasciando tante mie serve meschine,
che, senza te, di lacrimosa guerra
veder cattiva il giá temuto fine;
e rimaner ne l'infelice terra
fra morti e dolorose alte ruine:
né fuor che la tua vita altro convene
a tanti affanni miei conforto e spene.
Tu marito, tu padre e tu fratello,
di tua presenza al mio timor soccorri.
Non so qual di lá su fiamma o flagello
strugge le squadre ove tu incauto accorri.
Deh! Noi tutte difendi e 'l fido ostello,
tra queste integre ancora eccelse torri,
e raccogli la turba anco smarrita:
forse ne salverá maggiore aita. (G.C., XIX, 53-56)
Annunciata dal gesto omerico del prendere la mano del marito, che però Tasso
ricollega subito alla coerente e niente affatto incompatibile ferocia in guerra («man che
tanti ancise » ecc.), la contrapposizione generata di fronte al rischio di morte fra ambito
sociale e familiare si profila con chiarezza sin dai primi due versi di discorso diretto:
l’espressione fq…sei se tÕ sÕn mšnoj si sdoppia in una più esplicita antitesi per cui
quel rischio che per gli altri è salvezza, per il nucleo familiare ristretto non può che
essere pericolo estremo di distruzione e immagine di morte. L’insistenza sulle proprie
sventure, sfoltita del troppo particolareggiato ricordo della morte di Eezione, dei fratelli
e della madre, inadatto al nuovo contesto, conserva tuttavia il nucleo fondamentale
dell’argomentazione di Andromaca: la sovrapposizione alla propria immagine disforica
di esule di quella, ancor più negativa, di vedova, in una somma necessariamente
corrispondente alla definitiva disperazione che si traduce in una figura di morte (« più
caro mi sarebbe andar sotterra »). Naturale conseguenza di una tale condizione risulta
dunque, nell’essere la vedovanza ancora ineffettuale, la valorizzazione del solo rapporto
affettivo superstite in qualità di moglie/madre, sintetizzato da Andromaca nel distico
forse più celebre dell’Iliade e puntualmente ripreso da Tasso: « Tu marito, tu padre e tu
fratello ». Non c’è probabilmente immagine poetica che più possa rappresentare in
modo più chiaro ed evidente l’emozionalità totalizzante, la logica simmetrica di Matte
213
Blanco in cui nell’inconscio e nell’emotività l’individuo e la classe di un insieme si
sovrappongono e si equivalgono, e l’intera sfera dei rapporti affettivi è sostituita dal
singolo rapporto totalizzante. La forza straordinaria e singolare di questa immagine sta
poi nell’estendere il dominio dell’emozione fino ad informare di sé lo stesso principio di
realtà: l’effettiva, reale perdita di ogni altro affetto nella distruzione della patria e
nell’esilio finisce per essere, dal punto di vista poetico, conseguenza e corollario, e non
già causa, di questa emozione senza limite, e l’esclusione di Andromaca/Lugeria da
ogni altro rapporto affettivo se non con il marito appare come la proiezione
dell’esclusività e totalità di quello.
Non viene ripresa, invece, la prima delle due risposte di Ettore, in cui l’eroe
troiano ricorda il principio della civiltà di vergogna per cui non può sottrarsi al
combattimento e mostra di conoscere il destino segnato della città, di cui compatisce più
di ogni altra la sorte di schiavitù che spetterà alla moglie. È sufficiente, per lo scopo che
Tasso persegue, la seconda risposta, che oblia ogni contesto sociale per lasciare spazio
solo alla magra ma sola possibile consolazione dell’ineluttabilità del destino:
Cosí diss'ella; e 'l cavalier turbato:
- Non t'affligga, mia cara, amata cura,
de la mia fine e del mio dubbio stato,
oltra modo (dicea) doglia, o paura:
ch'io non andrò pria che 'l prefigga il fato,
per man de' miei nemici a morte oscura;
ma contra il ciel non ha riparo e schermo
il vile, o 'l forte, e 'l mio destino è fermo.
Torna dunque a l'albergo, o mia fedele;
e de l'ancille tue pensier or prendi,
ed a' lavori pur di bianche tele,
o pur di seta e d'òr, pudica attendi.
Noi cura avrem de la tenzon crudele,
uomini usati in guerra a' casi orrendi;
io piú d'ogni altro, che produsse, e pasce
la sacra terra che nudrimmi in fasce. (G.C., XIX, 57-58)
L’anticipazione della seconda risposta permette poi al Tasso di posporre come
elemento finale della scena, e con essa del libro, il rivolgersi dell’attenzione di nuovo
verso il bambino, in una chiusa che rimanda circolarmente all’immagine iniziale:
Cosí alla donna il cavalier rispose:
a baciare 'l figliuolo indi è rivolto,
ma de l'armi lucenti e spaventose
quel rimirando il fèro padre avvolto,
fuggí 'l paterno aspetto e 'n seno ascose
de la bella nudrice il capo e 'l volto;
214
onde la cara madre ed egli insieme
ridon di lui che semplicetto il teme.
Ei discoperto giá de l'elmo il viso,
tra le braccia il bambin lusinga e molce;
e de la bocca il desiato riso
bacia, che rende il travagliar piú dolce:
e poi che da sé l'ebbe alfin diviso,
prega, in vece di lui che il mondo folce,
falso profeta: onde nel ciel dispersi
fûro i suoi preghi, a la giustizia avversi.
- Dammi, spirto di Dio, che viva e cresca
questo mio figlio, e che di me sia degno:
degno de gli avi antichi anco riesca,
che ne l'Asia acquistârsi imperio e regno:
e co 'l tuo nome e co 'l valor accresca
questo, a cui son difesa, anzi sostegno:
e spoglie di nemici in guerra morti
sanguigne, e gloria a la sua madre apporti. Cosí pregò di sua fortuna in forse,
ma di vano sperar gonfiato e pieno;
ed a la cara madre il figlio porse,
che l'accogliea ne l'odorato seno.
Poscia al maggior periglio il passo ei torse,
al suo feroce ardir lentando il freno:
ed uscí per la porta a l'acque opposta,
ond'ebbe il nome in su l'altera costa.
(G. C., XIX, 59-62)
Attraverso la ripresa della tenera reazione del figlio alla vista del padre armato, la
compassione verso la coppia si volge nell’anticlimax del sorriso, in modo da lasciare
così spazio – stavolta sì – all’ideologia: la preghiera di Ettore agli dei per il futuro di
Astianatte è l’occasione perfetta per ricordare, attraverso una parallela preghiera al loro
“falso” dio, che Argante e suoi sono pur sempre degli infedeli, e che la partecipazione
umana alla loro sofferenza nulla toglie alla condanna religiosa. Se dunque la ripresa di
un’altra preghiera omerica, quella di Achille/Riccardo nel lasciar andare a combattere
Patroclo/Ruperto con le sue armi, poteva non essere esaudita dal dio cristiano in
relazione alla richiesta di gran lunga più importante – far tornare vivo il compagno –
soltanto a costo di essere interamente ridotta alla sua dimensione psicologica, il mancato
adempimento stavolta può ben essere conservato in tutta la sua dimensione
esplicitamente religiosa proprio in quanto si tratta, questa volta, della parte pagana e del
suo “falso profeta”: tanto basta perché i « preghi » siano « a la giustizia avversi », e
dunque, come ovvia e naturale conseguenza, « nel ciel dispersi ». Difficile immaginare
un modo migliore per inserire il dato ideologico, quasi d’obbligo di fronte a un tale
livello di identificazione emotiva con i pagani, senza nulla togliere alla profondità e alla
sincerità di quella. Si vede bene, in questo caso, come la simpatia verso il nemico non si
215
consumi affatto, nella Conquistata, ad un livello superficiale, in un omaggio a certa
grande tradizione letteraria ormai soffocato da un’ideologia troppo repressiva:
esattamente all’opposto, il vero nucleo di interesse, quello emotivo, si assicura il suo
spazio e la sua stessa possibilità di espressione attraverso il lasciapassare di una
sbrigativa condanna ideologica, adombrata senza compromettere minimamente
l’immedesimazione, e anzi addirittura potenziandola grazie allo strumento tipicamente
epico e omerico dell’analessi che anticipa, gettando sul presente una luce patetica, il
destino di sconfitta e di morte, come appunto nel caso della preghiera di Achille per la
vita di
Patroclo. D’altra parte, se è vero che ogni negazione è al contempo
un’accettazione, un lasciare spazio ed espressione a ciò che si intende negare239, sarà
bene notare che in questo caso, nel sottolinearne l’ineffettualità, viene dedicata un’intera
ottava all’esplicita formulazione in discorso diretto di una preghiera pagana, cosa ben
difficile da rintracciare, ad esempio, in un poema cavalleresco in cui l’ideologia
cristiana risulti alleggerita, almeno in apparenza, dall’irrealismo ironico quando non
esplicitamente farsesco di tanti personaggi e situazioni, salvo poi riemergere sferzante e
inaspettata (si pensi a certi proemi di canto del Furioso). Dopo un’identificazione
emotiva del tutto esplicita e nobilitata dal modello illustre, persino la presa di distanza
ideologica finisce dunque per dar voce all’ideologia che pretende di negare e soffocare:
nonostante le connotazioni negative che lo circondano (falso profeta; preghi a la
giustizia avversi; di vano sperar gonfiato e pieno), il discorso diretto della preghiera non
può che smentire la distanza ideologica nell’umana partecipazione ad un desiderio che
risulta in tutta evidenza giustissimo e naturalissimo, quello di un padre che spera nella
felicità del figlio. Come potrebbe essere ingiusto che egli chieda che suo figlio « viva e
cresca », che « sia degno » di lui, che possa accrescere col suo valore « imperio e regno
» dei suoi avi? Tali parole, con la loro semplice presenza, negano la loro stessa
negazione, lasciando spazio alla constatazione, piena di humanitas e lontanissima dalla
repressione controriformistica che qui parrebbe affermarsi, che la preghiera dell’altro,
del nemico, dell’infedele non è poi diversa da quella dei “nostri”, dei “cristiani”, da
quella di qualsiasi uomo proprio in quanto uomo, al di là di ogni differenza culturale o
religiosa.
239
Cfr. a riguardo ORLANDO, F., Per una teoria freudiana della letteratura, cit., pp. 210 sgg., che cita a
questo proposito BENVENISTE: « La caratteristica della negazione linguistica è che essa può annullare solo
quanto è enunciato, che deve formulare esplicitamente quanto vuole sopprimere e che un giudizio di nonesistenza ha anche necessariamente lo status formale di un giudizio di esistenza. La negazione è quindi in
primo luogo accettazione » (p. 214).
216
Colmando la distanza testuale che separa i due episodi nell’Iliade, al commiato
dalla moglie nella Conquistata segue dopo poche decine di ottave la morte di Argante
per mano di Tancredi. La scena resta sostanzialmente la stessa, se non per le consuete
modifiche secondarie, per lo più al dettato, cui l’intero testo del poema è sottoposto
nella riscrittura. L’attenzione della critica si è soffermata soprattutto sulla soppressione
del breve dialogo d’intonazione vagamente virgiliana240 precedente il duello:
Qui si fermano entrambi, e pur sospeso
volgeasi Argante a la cittade afflitta.
Vede Tancredi che 'l pagan difeso
non è di scudo, e 'l suo lontano ei gitta.
Poscia lui dice: "Or qual pensier t'ha preso?
pensi ch'è giunta l'ora a te prescritta?
S'antivedendo ciò timido stai,
è 'l tuo timore intempestivo omai."
"Penso" risponde "a la città del regno
di Giudea antichissima regina,
che vinta or cade, e indarno esser sostegno
io procurai de la fatal ruina,
e ch'è poca vendetta al mio disdegno
il capo tuo che 'l Cielo or mi destina."
Tacque, e incontra si van con gran risguardo,
ché ben conosce l'un l'altro gagliardo.
(G. L., XIX, 9-10)
Più che a far sparire dal personaggio « ogni sfumatura di titanismo »241 o a portare
« alle estreme conseguenze la divisione ideologica tra i “nostri” (X,10) e il “volgo al
ciel rubello” (XXXIII, 32) » ‒ non è ben chiaro con quale relazione con queste due
ottave ‒ « in nome forse di un più rigido manicheismo »242, mi pare più verosimile
pensare che la modifica sia dettata appunto dalla presenza ravvicinata della nuova scena
di commiato alla moglie e dalla più generale ridefinizione del personaggio come parte
di un nucleo familiare: è naturale che l’Argante della Liberata, il feroce straniero « che
ripone / ne la spada sua legge e sua ragione » (G.L., II, 59, vv. 7-8), provi « disdegno »
nel constatare di non essere stato in grado di impedire la caduta della città e sia subito
pronto a volgerlo in vanto aggressivo e sprezzante (10, vv. 5-6); altrettanto
comprensibile che un simile orgoglio ferito appaia fuori luogo nel nuovo contesto, dove
semmai gli ultimi pensieri del guerriero, nella disfatta, andrebbero piuttosto alla moglie,
alla famiglia lasciata in balia del nemico: cosa che in effetti avviene immediatamente
240
Certamente eccessivo è, come fa Caretti nel suo commento alla Liberata, citare VIRGILIO, Eneide, II,
290-92 come rapporto intertestuale diretto.
241
FOLTRAN, D., cit., p. 132.
242
BORRELLI, C., cit. p. 17.
217
prima dell’incontro con Tancredi, dove si dice che Argante « nulla di sé, de la consorte
ei teme, / che di lasciar solinga ha gran vergogna ». In ogni caso, una simile modifica
risulta niente più che una correzione marginale se si considera che la scena della morte
del guerriero pagano resta nel complesso pressoché invariata, e ricercare in un simile
dettaglio, per quanto non irrilevante, una chiave di lettura dell’intera scena se non del
personaggio è una sovrainterpretazione. A voler notare il peso dell’ideologia cristiana in
questo episodio sarebbe più opportuno guardarne semmai il segmento finale, dove
Tancredi, ormai prossimo a prevalere, offre al pagano la resa proclamando vincitore non
più se stesso ma il « vero Dio », in un’esortazione al pentimento in extremis da
Convitato di pietra avant la lettre:
- Cedimi, uom forte, e riconoscer voglia,
non la vittorïosa alta fortuna,
ma 'l vero Dio: che piú onorata spoglia
acquistar non potrai sotto la luna. (G. C., XXIII, 100, vv. 1-4)
- Cedimi, uom forte, o riconoscer voglia
me per tuo vincitore o la fortuna;
né ricerco da te trionfo o spoglia,
né mi riserbo in te ragione alcuna. (G. L., XIX, 21, vv. 1-4)
Il residuo di onore cavalleresco ancora ben presente nella prima versione è del
tutto sacrificato, nella seconda, al compiersi della volontà di Dio, sottraendo ogni valore
all’iniziativa individuale in una più ferrea coerenza con quella ritrovata unità dei crociati
nel segno della missione cristiana già ben ravvisabile, come da proemio, nella
Liberata
243
. Una tale cancellazione dell’individualismo cavalleresco prosegue
d’altronde nella ottave successive, in alcune minime ma mirate modifiche volte, dopo il
richiamo a Turno nelle parole « Usa la sorte tua », ad allontanare la memoria della
ariostesca morte di Rodomonte, che a quell’ideale laico e cortese è ancora legata: entro
tale ridefinizione ideologica, la mancata resa di Argante genera in Tancredi non più l’ira
verso l’ingrato sconfitto che, come Rodomonte, tenta ancora di ferire « di furto »244, ma
piuttosto un turbamento di fronte alla perseveranza nel non volersi pentire e convertire:
243
Cfr. ZATTI, S., cit.
Tra gli elementi rimossi nella riscrittura, le affinità più marcata del testo della Liberata con il Furioso
sono il tentativo di colpire l’avversario ormai vincitore « di furto », l’esplicitazione della parte del corpo a
cui mira il colpo a tradimento (rispettivamente « su ’l tallone » e « sotto le rene »), le minacce verbali del
guerriero morente (minacciando come bestemmiando) riconvertite nella Conquistata in un aspetto
minaccioso del volto; la stessa accusa di fellonia, nelle parole del Tancredi della Liberata, è
implicitamente derivata dal finale del Furioso, così come l’ira di fronte all’offerta di resa rifiutata in un
ultimo attacco proditorio. Tutti questi particolari ariosteschi sono eliminati nella riscrittura del poema
244
218
Conquistata:
Liberata:
- Renditi,- grida, e gli fa nuove offerte,
senza noiarlo, il vincitor cortese.
Ma quegli, non risorto anco, piagarlo
tenta di nuovo colpo e potria farlo.
"Renditi" grida, e gli fa nove offerte,
senza noiarlo, il vincitor cortese.
Quegli di furto intanto il ferro caccia
e su 'l tallone il fiede, indi il minaccia.
Turbossi allora il pio guerriero e disse:
- Giusta pietate è il non usarla or teco. Poi la spada gli fisse, e la rifisse
per la visiera al giá latrante e cieco.
Moriva Argante, e tal moria qual visse;
l'alma fuggía di Pluto al nero speco;
ma ne la morta e spaventosa faccia
piú terribil la morte ancor minaccia.
(G.C., XXIII, 104-105)
Infuriossi allor Tancredi, e disse:
"Cosí abusi, fellon, la pietà mia?"
poi la spada gli fisse e gli rifisse
ne la visiera, ove accertò la via.
Moriva Argante, e tal moria qual visse:
minacciava morendo e non languia.
Superbi, formidabili e feroci
gli ultimi moti fur, l'ultime voci.
(G.L., XIX, 25-26)
per cui il conclusivo « Giusta pietate è il non usarla teco » di Tancredi (G. C.,
XXXIII, 105, v. 2) ‒ tanto diverso dal precedente « Così abusi, fellon, la pietà mia? »
(G. L., XIX, 26, v. 2) ‒ suona ormai piuttosto come irrevocabile sanzione della
condanna ultraterrena. Ah, tempo più non v’è.
Morto Argante, il corpo viene restituito ai pagani « perché riceva alfin gli usati
onori » (G. C., XXIII, 117, v.2). È qui inserita la seconda nuova scena desunta
dall’Iliade, il compianto delle donne sul corpo del guerriero caduto, parallelo a quello
per Ettore che chiude il poema omerico. Vale la pena notare, en passant, che questa
nuova scena di « compassione » per i pagani è separata da quella della morte di Argante
da dieci ottave in cui la narrazione torna per un attimo a focalizzarsi sui conquistatori
crociati, che hanno appena espugnato Gerusalemme: di nuovo vediamo dunque
riemergere puntualmente la dimensione ideologica, nella lode a Pietro l’eremita, nella
purificazione della « città macchiata e lorda » (tanto in senso proprio che figurato, per
cui devono essere di nuovo ornati « i sacri tempî a Dio) e soprattutto nel discorso di
Goffredo. Quest’ultimo è ripreso dalla Liberata, ma con una significativa modifica
finale:
Conquistata:
Liberata:
Ite, e curate quei c'han fatto acquisto
di questo regno a voi col sangue loro,
ché non conviensi a' cavalier di Cristo
il desio di vendetta e di tesoro.
Troppo, ahi! troppo di male oggi s'è visto,
e fatto preda abbiam d'argento e d'oro.
Ite, e curate quei c'han fatto acquisto
di questa patria a noi co 'l sangue loro.
Ciò piú conviensi a i cavalier di Cristo,
che desio di vendetta o di tesoro.
Troppo, ahi! troppo di strage oggi s'è visto,
troppa in alcuni avidità de l'oro;
tassiano: è conservata soltanto l’affinità più evidente, almeno dal punto di vista visivo, ossia il colpo
mortale reiterato attraverso la visiera.
219
Membrate ch'oggi è il sesto e sacro giorno,
ch'il re sofferse, onde Satán ha scorno. (G.C., XXIII, 115)
rapir piú oltra, e incrudelir i' vieto.
Or divulghin le trombe il mio divieto."
(G.L., XIX, 52)
Nelle parole del Buglione la « strage » della Liberata, che pure nel poema
riformato il lettore ha visto e vedrà ancora rappresentata in tutta la sua nuova, feroce
ἐnάrgeia desunta da Omero, si trasforma in un « male » più generico e
deresponsabilizzato, l’« avidità de l’oro » si edulcora nell’ovvia normalità della
semplice « preda » di guerra, i riferimenti ancor più espliciti, nel primo poema, al «
rapir » e « incrudelir » sono del tutto censurati e sostituiti con un più devoto ‒ e
petrarchesco ‒ richiamo alle sofferenze di Cristo, molto vicino al celeberrimo sonetto
Padre del ciel, RVF 62 (« Membrate ch’oggi è il sesto e sacro giorno, ch’il re sofferse
», cfr. « Rammenta lor come oggi fusti in croce »; « onde Satán ha scorno », cfr. « il
mio duro adversario se ne scorni »).
Solo dopo questo ulteriore, breve controcanto ideologico alle sofferenze dei vinti
può riprendere la nuova strategia omerizzante di identificazione emotiva con i pagani
nell’ampia scena del compianto che chiude il penultimo libro, come nell’Iliade chiudeva
il poema. Al contrario di quel che sembra emergere dal quadro complessivo tracciato
dalla critica, insomma, in quest’ampia sezione del finale del poema l’identificazione
emotiva con i pagani risulta senza dubbio il vero nucleo di interesse, entro cui sono
inseriti rapide concessioni all’ideologia controriformistica – tra l’altro essenzialmente
limitate all’esaltazione della vittoria cristiana e niente affatto miranti ad una
caratterizzazione negativa degli sconfitti ‒ il cui effetto è quello di rafforzare e far
risaltare per contrasto proprio la compassione per i vinti.
Come nell’ipotesto iliadico, il compianto collettivo sul corpo di Argante è
scandito dai tre lamenti di Lugeria/Andromaca, Funebrina/Ecuba e Nicea/Elena, cui fa
eco il pianto delle altre donne. Come di consueto in questo genere di operazioni nella
Conquistata l’aderenza al modello è forte e spesso rasenta la traduzione, ma rispetto alla
precedente imitazione del commiato alle porte Scee mostra un trattamento più libero,
sviluppandosi a tratti in maniera più autonoma. Già le parole di Lugeria, partendo da
un’aderenza stretta, amplificano poi in un’intera ottava un suggerimento di due soli
versi iliadici, tornano quindi a seguire il testo omerico da vicino e infine prendono di
nuovo una strada propria, per tornare alla traduzione solo nel distico finale:
Ma come vede il suo marito anciso,
a cui pudico il petto anco riserba,
spargendo il pianto sovra il morto viso,
tÍsin d' 'Androm£ch leukèlenoj Ãrce gÒoio
“Ektoroj ¢ndrofÒnoio k£rh met¦ cersˆn œcousa·
220
bacia la faccia ancor fèra e superba:
- Fosti, giovine ancor, da me diviso
(dice), caro signor, per morte acerba;
e lasci me co 'l tuo piú caro pegno,
vedova e serva, e presa al giogo indegno.
«ner ¢p' a„înoj nšoj êleo, k¦d dš me c»rhn
le…peij ™n meg£roisi·
Ne la tenera etate è il figlio ancora,
che generammo al lagrimoso duolo,
tu ed io infelici; e piú m'accora
ch'in grande stirpe e quasi estremo, e solo
non vedrá gli anni in cui virtú s'onora,
né l'alta fama tua, che spazii a volo,
né de l'avo il bel regno, o regio nome
lieto il fará tra vinte genti e dome.
p£ϊj d' œti n»pioj aÜtwj
Ön tškomen sÚ t' ™gè te dus£mmoroi, oÙdš min o‡w
¼bhn †xesqai· prˆn g¦r pÒlij Âde kat' ¥krhj
pšrsetai· Ã g¦r Ôlwlaj ™p…skopoj, Ój tš min aÙt¾n
·Úskeu, œcej d' ¢lÒcouj kedn¦j kaˆ n»pia tškna,
a‰ d» toi t£ca nhusˆn Ñc»sontai glafurÍsi,
kaˆ mὲn ™gë met¦ tÍsi·
Ma di tua madre, o figlio, a' lidi estrani
seguirai su le navi il duro caso:
ed in atto servil Franchi, o Romani,
ne' regni inchinerai del nero Occaso,
anzi signor superbo: o se rimani,
spietata pena avrai d'esser rimaso,
da gran torre rotato o d'alte rupi,
a pascer di tue membra i corvi, o i lupi.
Fèri nemici irati al debil figlio,
misero Argante, anzi 'l morir lasciasti;
al vecchio genitor morte od esiglio,
a l'orba madre ignudi membri, e guasti:
e senza fine a me lutto e periglio,
e pensieri d'amor dolenti e casti:
né prima ebbi da te baci, o parole,
ond'io, piangendo, il mio dolor console. (G.C., XXIII, vv. 118-121)
sÝ d' aâ tškoj À ™moˆ aÙtÍ
›yeai, œnq£ ken œrga ¢eikša ™rg£zoio
¢qleÚwn prÕ ¥naktoj ¢meil…cou,
½ tij 'Acaiîn
·…yei ceirÕj ˜lën ¢pÕ pÚrgou lugrÕn Ôleqron
cwÒmenoj, ú d» pou ¢delfeÕn œktanen “Ektwr
À patšr' º kaˆ uƒÒn, ™peˆ m£la polloˆ 'Acaiîn
“Ektoroj ™n pal£mVsin Ñd¦x ›lon ¥speton oâdaj.
oÙ g¦r me…licoj œske pat¾r teÕj ™n daῒ lugrÍ·
të ka… min laoˆ mὲn ÑdÚrontai kat¦ ¥stu,
¢rhtÕn dὲ tokeàsi gÒon kaˆ pšnqoj œqhkaj
“Ektor· ™moˆ dὲ m£lista lele…yetai ¥lgea lugr£.
oÙ g£r moi qnÇskwn lecšwn ™k ce‹raj Ôrexaj,
oÙdš t… moi eἶpej pukinÕn œpoj, oá tš ken a„eˆ
memnÇmhn nÚkt£j te kaˆ ½mata d£kru cšousa.
(Il., XXIV, vv. 723-745)245
Ad essere amplificato rispetto alle parole di Andromaca è soprattutto il
riferimento al figlio ancora « ne la tenera etade »: all’apostrofe già iliadica in cui si
prefigura per lui l’alternativa tra due mali, servitù o morte violenta, viene fatta
corrispondere un’insistenza, assente nel modello, sul futuro felice inesorabilmente
negato dalla morte del padre e difensore, in una esibita contrapposizione tra effettualità
negativa ed ineffettualità positiva che non può non evocare la preghiera inesaudita di
Argante per il figlio nella scena del commiato, data anche la vicinanza delle due scene.
245
Trad.: « E fra di loro diede inizio al compianto Andromaca dalle candide braccia, / tenendo fra le mani
il capo di Ettore sterminatore: / “Mio sposo, te ne vai giovane dalla vita e mi lasci / vedova nella tua casa
con questo figlio ancora bambino, / che abbiamo generato io e te, entrambi infelici, e non credo / che
arriverà alla giovinezza: la città prima / verrà tutta distrutta perché sei morto tu, il suo difensore, / tu che
la proteggevi e difendevi le spose devote e i bambini. / Loro presto se ne andranno sopra le navi, e io con
loro; tu, figlio mio, seguirai / me dove dovrai sopportare fatiche indegne, / al servizio di un padrone
inclemente, oppure un Acheo / ti afferrerà per un braccio e ti scaglierà da una torre, orribile fine!, / irato,
perché Ettore forse gli ha ucciso un fratello / o il padre o un figlio, giacché moltissimi Greci / morsero la
terra infinita per mano di Ettore. / Non era dolce tuo padre nella mischia feroce. / Per questo lo piangono
gli uomini per la città: / hai dato lutto e dolore atroce ai tuoi genitori, / Ettore, ma soprattutto a me hai
lasciato amara pena. / Non mi hai teso morendo le braccia dal letto, / non mi hai detto una saggia parola
che io potessi / ricordare sempre, notte e giorno, piangendo” ».
221
Il richiamo intratestuale riprende punto per punto e volge in negativo le precedenti
richieste del padre al « falso profeta » (« che di me sia degno » → « non vedrà gli anni
in cui virtú s'onora »; « degno de gli avi antichi anco riesca, / che ne l'Asia acquistârsi
imperio e regno / e co 'l tuo nome e co 'l valor accresca / questo [regno] » → « né de
l'avo il bel regno, o regio nome / lieto il fará tra vinte genti e dome »): in tal modo
sviluppa lo spunto del testo greco « οὐδὲ µιν ὄιω / ἥbην ἵξεσθαι » trasformandolo in
un’enfasi sul tema virgiliano della guerra che nega il futuro a chi, giovane, dovrebbe
invece averlo ancora tutto davanti a sé (tema del tutto estraneo alla poesia omerica, dove
la sola declinazione conosciuta della morte giovane è quella della belle mort eroica che
sottrae alla vecchiaia e preserva idealmente la giovinezza nel κλέος). Un vero e proprio
threnos nel threnos, in cui la morte del padre equivale ipso facto alla morte del figlio e
dunque piangere l’uno vuol significa piangere l’altro; nell’ultima ottava la figura di
morte si estende poi ‒ in un’ulteriore innovazione tassiana ‒ all’intero ambito degli
affetti familiari, proiettando sulla classe la privazione dolorosa dell’individuo che come
per Andromaca era il centro totalizzante dell’affettività: di nuovo, il confronto razionale
con il principio di realtà (il venir meno del principale difensore che implica prigionia o
morte per gli altri) viene a corrispondere, amplificandola, alla logica simmetrica
dell’emozionalità.
Una simile svolta verso il pathos virgiliano della guerra come negazione del
futuro non solo accresce l’identificazione con gli sconfitti, palese finalità di queste
nuove scene, ma rispetto alla Liberata problematizza ulteriormente la violenza della pur
devota aggressione crociata: la strage e la brutalità che abbiamo visto censurate nelle
parole di Goffredo riemergono qui con la massima evidenza nella stridente antitesi –
tassiana – fra il rimpianto elegiaco di quello che avrebbe potuto essere e l’orrore di
quello che sarà. La violenta aggressione dissimulata dal condottiero crociato dietro un
devoto riferimento cristologico trova qui piena espressione nella voce di chi lo subisce,
nell’immagine terribile del bambino scagliato dalla torre, il cui orrore è persino
moltiplicato da un probabile richiamo alla protasi iliadica in quel « pascer di tue
membra i corvi, o i lupi ».
Al lamento della moglie segue, come nell’Iliade, quello della madre. La non
pertinenza al nuovo contesto dei due motivi toccati da Ecuba ‒ l’intatta conservazione
del corpo di Ettore per opera divina, tanto da sembrare ucciso dalle “miti frecce di
Apollo”, ossia morto di morte naturale, e la vanità della vendetta di Achille in termini di
compensazione del dolore per Patroclo (non Argante bensì Solimano è l’uccisore di
222
Ruperto) ‒ portano qui Tasso a distanziarsi del tutto dal modello: l’unico vero contatto è
il verso « ch’eri di tutti i figli a me più caro » (cfr. Il., XXIV, v. 748: Ἕκτορ· ἐµῷ θυµῷ
πάντων πολὺ φίλτατε παίδων); per il resto sono sviluppati temi diversi, la difesa della
patria e la ripresa dell’immagine topica di Ecuba come paradigma di sventura (e più
precisamente, come Creso, della volubilità della fortuna):
- Argante, nessun duolo egual soffersi
pari a quel che per te m'aggrava e preme:
ch'eri di tutti i figli a me piú caro,
di cui mi priva empio destino avaro.
D'animo, di valor, di fatti egregi,
tutti vincesti, e di reale aspetto;
da' soldani onorato e d'alti regi,
spaventoso a' nemici, a' tuoi diletto.
Difendesti la patria, e palme e fregi
n'avesti, or n'hai trafitto il viso e 'l petto:
e col tuo regno cadi, ond'io presaga,
sento al dolente cor prevista piaga.
Del mio senil consiglio a te non calse,
o del materno duolo, o del cordoglio;
ma contra 'l ciel giammai non vale o valse
terrena forza o pur terreno orgoglio:
o mondane grandezze incerte e false!
per gran prosperitá vie piú mi doglio,
fra superbe, nemiche, irate squadre,
misera vecchia, serva ed orba madre. –
(G. C., XXIII, 122-124)
Basti notare come il verso « spaventoso a’ nemici, a’ tuoi diletto » sembri
riassumere nella giustapposizione dei due emistichi il senso della ridefinizione del
personaggio di Argante nella riscrittura: alla ferocia dello « straniero » della Liberata si
accompagna la nuova affettività di un personaggio che non è più un escluso. Alla critica
che ritiene i due aspetti inconciliabili e contraddittori fino a parlare apertamente di
stonature si può rispondere per brevità, senza il bisogno di rimarcare ancora come simili
giudizi negativi siano niente più che l’ingenua espressione del fastidio di fronte a
modifiche che investono la sacralità del personaggio canonizzato, che tale duplicità in
realtà perfettamente coerente è una vistosa caratteristica proprio di quell’Ettore omerico
cui la vulgata accorda invece la simpatia del lettore a scapito di Achille.
Terza ed ultima a prendere la parola è Nicea (l’Erminia della Liberata), già
assimilata ad Elena nella Teichoscopia del VII libro più di quanto non fosse nel
corrispettivo episodio della Liberata. Venuti meno il suo incontro con Vafrino prima e
Tancredi poi, dopo la sua sortita notturna per amore essa non trova rifugio al campo
egiziano ma torna a Gerusalemme, dove partecipa al lutto per Argante. Anche qui
223
l’argomento di Elena, frutto della sua esclusione addolcita dalla mitezza di Ettore nei
suoi confronti, è del tutto inapplicabile al poema tassiano, cosicché il distacco dal
dettato omerico risulta ora totale:
- Tu giaci, Argante; Argante, oimè, sei morto:
o arti mie fallaci, o falsa spene!
A cui piú l'erbe omai raccoglio e porto
da l'ime valli e da l'inculte arene?
Non ti spero veder mai piú risorto,
per mia pietosa cura. A cui s'attiene
piú questa vita mia noiosa e schiva,
nel duro esiglio e di sostegno or priva?
Deh chi m'affida, ahi lassa, e mi consola
nel caso estremo e ne l'orribil fine?
Chi il padre amato e 'l mio fratel m'invola,
giá morti? o fèra morte avranno alfine?
Sola io non sono al mio dolor; ma sola
veggio, dopo la prima, altre ruine,
altri incendi, altre morti: e grave e stanca,
quest'alma al nuovo duol languisce e manca. –
(G. C., XXIII, 126-127)
Così come per la soppressione della riconciliazione tra Armida e Rinaldo, anche
nel caso di Nicea/Erminia il mancato episodio della cura di Tancredi ferito dopo il
duello con Argante segna sì di fatto, rispetto alla Liberata, una maggiore inconciliabilità
fra cristiani e pagani anche sul fronte amoroso, ma il movente ideologico è pur sempre
subalterno all’inventio poetica: anziché iterare il desiderio premuroso di soccorrere
Tancredi, che ha già trovato posto nella prima parte del poema, Tasso preferisce qui far
riconvergere il motivo sulla nuova strategia complessiva di accrescere l’identificazione
emotiva con il dolore dei pagani, sostituendo le cure efficaci praticate da Erminia a
Tancredi con le cure mancate di Nicea ad Argante. Su questo si innesta l’altro motivo,
virgiliano, del vivere per la seconda volta il capitolare della propria città al nemico:
dopo la prima, cade per mano cristiana anche questa seconda patria della donna esiliata,
costretta a vedere di nuovo « altre ruine, / altri incendi, altre morti », così come Anchise
che non vuole sopravvivere per la seconda volta alla distruzione della sua città:
Me si caelicolae voluissent ducere vitam
has mihi servassent sedes. Satis una superque
vidimus excidia et captae superavimus urbi.
(Aen., II, vv. 641-43)
Queste nuove scene omerizzanti inserite nella Conquistata rispondono dunque
perfettamente alla finalità dichiarata dall’autore nel Giudicio: l’analisi del testo
224
conferma come lo stretto rapporto di derivazione dall’Iliade, parallelamente alle grandi
modifiche nel campo cristiano che avvicinano l’ira di Riccardo a quella di Achille e
inseriscono ex novo la vicenda di Ruperto a imitazione di quella di Patroclo, non intenda
affatto essere un omaggio vuoto o un pedissequo adeguamento al modello eccellente,
ma risulti strettamente funzionale a creare delle strategie di significato ben precise e
coerenti. Così come in quel caso le modifiche miravano a compensare la componente
romanzesca della prima metà del poema con l’introduzione di un nuovo nucleo
emozionale più marcatamente epico, creando in tal modo nuovi equilibri strutturali, che
talvolta correggessero persino alcune debolezze, pur ben dissimulate, nel congegno
narrativo della Liberata, parimenti, in questo caso, dal modello iliadico è desunta la
ridefinizione del mondo pagano in termini di comunità che, seppur ancora multiforme e
disorganica sul piano prettamente bellico, trova tuttavia una sua nuova unità sociale e
affettiva al suo interno. Tale ridefinizione è strettamente funzionale ad accrescere
decisamente rispetto alla Liberata l’identificazione emotiva con i pagani proprio nel
momento in cui comincia a profilarsi con chiarezza la loro condizione di vinti, ossia
proprio quando sta trionfando definitivamente l’ideologia cristiana, nella ritrovata unità
che porterà al compimento del telos epico della vittoria sugli infedeli e della liberazione
del Santo Sepolcro. L’inasprirsi del manicheismo ideologico nella Conquistata non
corrisponde ipso facto ad una rappresentazione più intransigente e ad una svalutazione
più netta degli infedeli, come sembra emergere da alcune analisi critiche soltanto
sommarie: essa trova espressione, semmai, nel nuovo impianto biblico, dottrinale e
allegorico che costituisce l’altro grande nucleo della riscrittura dopo l’omerizzazione e
celebra il suo trionfo nell’ampliamento del sogno di Goffredo in una grande visione
allegorica che viene ad occupare un intero canto. La netta condanna religiosa e morale
che investe i pagani, invece, non svilisce affatto la loro statura poetica, ma al contrario
la accresce in un sentimento di humanitas di fronte alla sofferenza ancor più forte che
nella Liberata, purché lo si sappia leggere e sentire nella sua mediazione attraverso il
modello iliadico.
Proprio quest’ultima è la vera difficoltà che si incontra nell’analisi e nella
valutazione della riscrittura. L’estetica di matrice romantica che ancora pervade la
nostra concezione dell’arte stabilisce un’equivalenza di fondo tra valore artistico e
originalità: la grandezza di un’opera sta innanzitutto nella sua capacità di aprire nuove
strade, di deviare dalla tradizione e dalla norma acquisita per creare forme, strutture,
strategie di senso che non si esauriscano nelle convenzioni ma contribuiscano a
225
modificarle. Tale è l’orizzonte di aspettativa con cui ci si confronta non solo con l’arte
del nostro tempo, ma anche con quella del passato. Nel far questo, tuttavia, spesso non
si tiene nel minimo conto il fatto che una simile concezione estetica è storicamente data,
e come tale spesso molto lontana dalle concezioni estetiche del passato. Non meraviglia
che, ad un simile metro, il rapporto di massiccia derivazione dall’Iliade operato da
Tasso nella Conquistata non possa che risultare un paradigma di negatività, un errore
ovvio e autoevidente con cui non vale neppure la pena di confrontarsi. Riscrivere
un’intera scena trasformandola in gran parte in una traduzione da un’altra opera risulta
necessariamente un’operazione banale, negativa, persino autolesionistica. Eppure si
dovrebbe considerare che proprio la tradizione classica, e in particolare quella latina –
con cui la letteratura cinquecentesca si colloca in palese continuità –, non solo era
estranea ad una simile visione, ma anzi ci ha lasciato grandi capolavori proprio nel
campo della traduzione poetica: basti pensare al teatro di Plauto e Terenzio, o alle
traduzioni di Saffo e Callimaco inserite nel Liber catulliano accanto ai componimenti
“originali” e in perfetta sintonia e coerenza con quelli. La letteratura latina, anzi, si
presenta sin dalle origine come una letteratura “di secondo grado”, e persino il suo
massimo capolavoro – l’Eneide ‒ si fonda su un rapporto pervasivo a ogni livello con i
due poemi omerici, non solo nella struttura e nella definizione delle sue – diversissime –
strategie di senso, ma spesso anche nelle singole scene e persino nel dettato e nella
dizione. In questo sta anche il classicismo dell’operazione tassiana, in quanto relazione
metastorica con un modello di eccellenza poetica lontano nel tempo, ma capace di
fornire un repertorio coerente di derivazione funzionale alla rinascita di un genere
“morto”, il poema epico eroico, in contrapposizione al genere “vivo” del romanzo
cavalleresco.
Per valutare tale operazione tassiana in maniera non pregiudiziale bisognerebbe
saper colmare una simile distanza estetica senza volgere automaticamente in un giudizio
negativo; bisognerebbe essere in grado di compiere il passo ulteriore che, dopo
l’evolversi del concetto negativo di plagio in quello neutro di fonte e poi in quello
positivo – in quanto capace di creare senso – di rapporto intertestuale, sappia estendere
al passo o alla scena quello che non ci fa più meraviglia per il singolo verso, e che anzi
siamo oggi in grado di apprezzare come un apporto ulteriore di significato e non come
un furto.
Se dunque la Gerusalemme liberata trovava in Virgilio il modello privilegiato da
cui far emergere significati nuovi, in particolare per creare quella sua peculiare
226
ambiguità di modi verso il nemico pagano che ne è in qualche modo la cifra, la
Conquistata lo trova invece, attraverso un rapporto ancor più marcato, in un riscoperto
Omero. L’Iliade diviene l’opera da cui, attraverso la coerenza di una derivazione quasi
esclusiva (almeno per le sezioni nuove), si desume la coerenza di forme e temi
costituenti un genere letterario, quello epico, che si intende riportare in vita.
L’esclusività del modello è garanzia della salvaguardia della derivazione di un sistema
coerente in un’operazione artificiale come quella di riportare in vita un genere letterario
la cui tradizione si era interrotta con il Medioevo, secondo una pratica che è alla base
del classicismo rinascimentale.
Non stupisce, dunque, che sia desunta dall’Iliade tanto la rielaborazione in senso
maggiormente epico del campo cristiano con l’ira di Riccardo e la vicenda di Ruperto,
quanto la ridefinizione del campo pagano in termini di comunità legata da vincoli
affettivi e come tale atta a suscitare maggiore identificazione emotiva pur in
concomitanza ad una più netta condanna ideologica. Eppure l’esclusività della
derivazione complessiva può occasionalmente aprirsi a singoli rapporti con altre opere
della tradizione alla condizione, apparentemente ovvia, in realtà molto delicata nella
prassi, che essi non vengano a determinare delle incongruenze, ossia quando tali
rapporti si dimostrino coerenti non già con il modello originario (l’Iliade), ma con l’uso
che se ne fa nella nuova opera.
Tale è appunto il caso dell’Eneide. Essa non solo è coerente già con il sostrato
costituito dalla Liberata, complessivamente conservato nella riscrittura, ma lo è
soprattutto in quell’aspetto della compassione per i vinti in relazione al quale la
Conquistata si colloca in piena continuità, come abbiamo visto, con l’impianto
virgiliano della Liberata. Non è affatto casuale che, delle numerose sezioni rielaborate o
introdotte ex novo nella riscrittura secondo la nuova pratica di imitazione “integrale”,
l’unica a non essere desunta dall’Iliade si collochi proprio entro la rielaborazione del
versante pagano in termini di accresciuta compassione. Le scene iliadiche riprese in
relazione alla morte di Argante sono attentamente selezionate per collocarsi in
continuità con il tema virgiliano della guerra vista anche dagli occhi degli sconfitti, e
sono in fondo le sole nell’Iliade – insieme all’incontro finale di Priamo e Achille – a
tematizzare palesemente la sofferenza della parte che risulterà sconfitta (e che già lo è di
fatto con la morte di Ettore), prestandosi perciò come adeguate ad essere risemantizzate
per veicolare un tema virgiliano e decisamente poco omerico; e d’altra parte già nelle
nuove scene omerizzanti analizzate abbiamo visto infiltrarsi diverse volte qualche
227
significativo elemento virgiliano. Questa è la premessa perché nel quadro
dell’omerizzazione abbia una sua coerenza la rielaborazione di un episodio ‒ la morte di
Solimano ‒ condotta attraverso la derivazione da quello, celeberrimo, della morte di
Mezenzio e Lauso nell’Eneide.
Proprio in vista di tale modifica, anche Solimano, al pari di Argante, viene inserito
in un quadro di relazioni familiari e affettive che sacrificano la caratterizzazione di
personaggio “solitario” alla finalità virgiliana di accrescere la compassione per i vinti
soprattutto nel tratto conclusivo del poema (senza che ciò comporti poi una
rielaborazione complessiva della sua figura al di là di questo aspetto): egli diviene padre
di Nicea/Erminia, sfruttando la comune sorte di sovrani esiliati come tratto unificante, e
soprattutto del giovane Amoralto, che per la prima volta combatte, al fianco del padre.
L’affetto che lega il feroce Solimano ad Amoralto ha avuto una sua rapida ma efficace
rappresentazione già al momento in cui il guerriero entra a Gerusalemme grazie
all’aiuto del mago Ismeno, il quale, per convincerlo ad accettare il suo aiuto,
all’argomentazione bellica della Liberata (G. L., X, 12, v. 7-8: « difenderai la terra insin
che giunga / l’oste d’Egitto a rinovar la pugna ») aggiunge quella più rilevante
dell’affetto reciproco tra padre e figlio:
difendendo a gli amici il nobil regno,
a te medesmo il tuo piú caro pegno.
Amoralto dich'io, che senza oltraggio
di rea fortuna o pur di fato avverso,
con gli Arabi forní dubbio vïaggio,
e di notte v'entrò per l'aer perso.
Quivi salvo il vedrai co 'l novo raggio;
ed or per te sospira, al ciel converso,
e dice: «Senza lui la vita è nulla;
ch'or foss'io morto al latte ed a la culla».
(G. C., XI, 19-20)
Il legame è ribadito, poco dopo, al momento del ricongiungimento dei due, dopo
l’accoglienza riservata dal re di Gerusalemme al forte soccorritore:
Cosí parlava a Soliman Ducalto,
di pensier, di fastidi e d'anni pieno;
quando inchinollo il nobile Amoralto,
come predetto avea l'antico Ismeno:
ch'arme ancor non vestí per fèro assalto,
e 'l suo gran padre lo si strinse al seno,
baciando gli occhi e la serena fronte,
degna d'imperio, e le fattezze conte.
(G. C., XI, 72)
228
Ma il momento in cui questo nuovo rapporto affettivo mette effettivamente in atto
il suo potenziale di significazione è, come si è detto, il segmento finale della morte di
Solimano. Nella Liberata questo snodo fondamentale e conclusivo si sviluppava in sole
quattro ottave, dove di fronte all’impeto spaventoso di Rinaldo il prevedibile duello si
trasforma in una vera e propria esecuzione; in tale concisione, unico elemento tematico
resta, obliterata anche la vendetta di Sveno, la paralizzante incapacità a reagire del
Soldano, mediata dalla similitudine virgiliana che traduce l’irresolutezza di Turno (e
indirettamente di Ettore: cfr. Il., XXII, 199-201) di fronte alla morte:
Come vede talor torbidi sogni
ne' brevi sonni suoi l'egro o l'insano,
pargli ch'al corso avidamente agogni
stender le membra, e che s'affanni invano,
ché ne' maggiori sforzi a' suoi bisogni
non corrisponde il piè stanco e la mano,
scioglier talor la lingua e parlar vòle,
ma non seguon la voce o le parole;
Ac velut in somnis, oculos ubi languida pressit
nocte quies, nequiquam avidos extendere cursus
velle videmur et in mediis conatibus aegri
succidimus; non lingua valet, non corpore notae
sufficiunt vires
cosí allora il Soldan vorria rapire
pur se stesso a l'assalto e se ne sforza,
ma non conosce in sé le solite ire,
né sé conosce a la scemata forza.
(G. L., XX, 105-106)
sic Turno, quacumque viam virtute petivit,
successum dea dira negat. Tum pectore sensus
vertuntur varii; Rutulos aspectat et urbem
cunctaturque metu letumque instare tremescit,
nec quo se eripiat, nec qua vi tendat in hostem,
nec currus usquam videt aurigamve sororem.
(Aen., XII, 908-18)
nec vox aut verba sequuntur:
La scena, totalmente riscritta, nella Conquistata si distende su venti ottave, come
una conclusione probabilmente sentita dal Tasso più confacente alla parabola di uno
degli antagonisti principali del suo poema, tanto più nel nuovo contesto più
marcatamente epico. In apertura è immediatamente ricordato il tema della vendetta,
assente nell’episodio virgiliano: è vero che l’inusitata furia in battaglia di Enea che
riuscirà fatale a Lauso e Mezenzio è scatenata dall’uccisione di Pallante, ma i due non
ne sono responsabili e il tema della vendetta avrà il suo compimento solo nel colpo
mortale a Turno con cui il poema si chiude. Su Solimano, invece, pesa proprio la colpa
di Ettore e Turno, quella di aver ucciso il compagno più caro all’eroe protagonista,
Ruperto:
Ma rosseggiar parea di ferro e d'ostro,
crollando il fier soldano orrida lancia
innanzi a tutti; e qual tartareo mostro
minacciava superbo Italia e Francia:
e 'l figlio tinto ancor del sangue nostro,
sotto l'elmo non suo la molle guancia
giovinetto copriva; e gir solingo
229
non temerebbe in periglioso arringo.
Ma gli vide Riccardo, e quasi a volo
il rapido Circino ei mosse e 'l punse,
per vendicarsi omai del fèro stuolo
che la sua amata compagnia disgiunse:
il soldán giá sentia l'estremo duolo
annunzïarsi al cor quand'egli aggiunse;
pur gli si volse incontra e 'l ferro ei vibra,
e ne le forze sue si fonda e libra.
L’elmo non suo che Amoralto indossa richiama, con sinistra reticenza, il momento
in cui il giovane si è impadronito delle spoglie di Ruperto dopo la sua uccisione per
mano del padre:
Ma di quell'auree spoglie altero e lieto
corre Amoralto a la gentil rapina,
ch'al suo valore omai, senza divieto,
quella gloria quel giorno il ciel destina
(G. C., XIX, 104, vv. 1-4)
Un dettaglio che richiama quello del balteo di Pallante come oggetto tangibile che
rammenta e quasi ipostatizza la necessità di vendetta: non ne condivide, tuttavia, il
rilievo che nell’Eneide ne fa l’immagine conclusiva del poema e quasi simbolica di quel
conflitto inconciliabile tra dover essere e volontà, tra pietas e humanitas, tra sofferenza
e necessità storica che sta al centro non solo della concezione della guerra, ma
dell’intera poetica virgiliana. Nella scene della morte di Solimano, invece, come già
nella Liberata era del tutto tralasciato il motivo della vendetta di Sveno, così nella
Conquistata la vendetta di Ruperto passa del tutto in secondo piano in confronto al
rilievo che la corrispondente vendetta di Patroclo riveste nella morte di Ettore: l’unico
altro cenno che se ne fa è molto velato e per di più espresso per bocca non di Riccardo
ma di Solimano, quando decide di affrontare l’avversario e di far « pago e sazio » il «
lungo odio immortal d’infesto duce » (G. C., XXIV, 97, vv. 3-4). Quell’emozione
totalizzante per la morte di Ruperto che ha rimodellato intorno a sé l’intero assetto del
poema deve necessariamente cedere qui, per il crociato Riccardo ormai redento e
reintegrato, di fronte all’imporsi dell’uniformità e concordia nell’ideologia cristiana che
sta ormai celebrando il suo trionfo; lo spazio poetico che essa lascia libero può essere
allora tutto occupato dall’identificazione emotiva con la parte sconfitta, nel palese
accrescimento della simpatia per Solimano, rispetto alla Liberata, ottenuto mediante la
nuova intertestualità virgiliana del rimando a Lauso e Mezenzio. Ancora una volta,
come già per la morte di Argante, vediamo come l’accrescimento della repressione
230
ideologica nella riscrittura non vada affatto a censurare l’ambigua simpatia verso il
nemico nell’imporsi di una monosemica condanna morale, come spesso sembra
emergere dalle analisi critiche, ma si addensi tutta sulla parte crociata che di
quell’ideologia è portatrice, lasciando così maggiore – e non minore – possibilità di
espressione al represso costituito dall’identificazione emotiva con il mondo pagano. In
termini freudiani, quanto maggiore è l’istanza repressiva, tanto più forte sarà il
riemergere del represso in quella formazione di compromesso cui l’opera d’arte è nelle
sue dinamiche fondamentali assimilabile.
Dopo lo sbrigativo cenno iniziale alla vendetta, la scena si sviluppa in
un’aderenza stretta al modello eneadico, ancor più di quanto non lo fossero le
“traduzioni” omeriche relative ad Argante: tanto più significative appariranno, allora, le
poche differenze emergenti dal confronto. Le parole con cui Solimano si slancia
coraggiosamente contro Riccardo sono le stesse di Mezenzio nel suo primo scontro con
Enea:
- E 'n vece di mio nume, a me sia (disse)
questa mia destra, o figlio, e questo ferro
che tanti altri nemici ancor trafisse,
ché sol fidando in mia virtú non erro:
e mal grado di stelle erranti e fisse,
s'oggi questo crudel con l'asta afferro,
tu mi sarai trofeo di nuove spoglie. Cosí parlando, ogni sua forza accoglie.
(G. L., XXIV, 88)
'dextra mihi deus et telum, quod missile libro,
nunc adsint!
voveo praedonis corpore raptis
indutum spoliis ipsum te, Lause, tropaeum
Aeneae.' dixit, stridentemque eminus hastam
iecit.
(Aen., X, 773-77)
Al rapido cedere del padre di fronte al più forte nemico viene arditamente in
soccorso, come in Virgilio, il giovane figlio, suscitando l’entusiasta reazione dei suoi:
A la man che s'innalza e fèra piaga
porta di novo a quelle membra inferme,
sottentra il figlio e lor difende e guarda,
e 'l nemico furor sostiene e tarda.
Proripuit iuvenis seseque immiscuit armis,
iamque adsurgentis dextra plagamque ferentis
Aeneae subiit mucronem ipsumque morando
sustinuit;
Mentre cede al nemico il re feroce,
dal forte scudo del figliuol difeso,
i barbari innalzando orribil voce,
l'arme lanciâro in lui ch'è nulla offeso:
né di ferri né d'aste il furor nuoce
a que' doni celesti o 'l grave peso:
ei ne lo scudo si ricopre e serra,
e la nube sostien d'orrida guerra.
(G. L., XXIV, 88)
socii magno clamore sequuntur,
dum genitor nati parma protectus abiret,
telaque coniciunt perturbantque eminus hostem
missilibus.
furit Aeneas tectusque tenet se.
(Aen., X, 796-802)
La successiva similitudine virgiliana che rappresenta la facilità con cui Enea e
Riccardo si riparano dietro lo scudo dalla “grandine” di colpi scagliati dalla massa dei
231
nemici è tradotta, con una splendida operazione di classicismo “sperimentale”,
attraverso la mediazione della più leopardiana fra le canzoni petrarchesche, RVF 50 (Ne
la stagion che ’l ciel rapido inchina), a sua volta intessuta di memorie virgiliane:
Sí come allor che ruinosa a basso
la grandine dal ciel risuona e scende,
e per fuggir, con frettoloso passo,
l'avaro zappator l'arme riprende:
fugge ogni altro da' campi, e d'alto sasso
nel curvo seno il peregrino attende,
o' n ben securo albergo, il caldo raggio
ch'il richiami al suo lungo aspro vïaggio
(G. C., XXIV, 91)
ac velut effusa si quando grandine nimbi
praecipitant, omnis campis diffugit arator
omnis et agricola, et tuta latet arce viator
aut amnis ripis aut alti fornice saxi,
dum pluit in terris, ut possint sole reducto
exercere diem: sic obrutus undique telis
Aeneas nubem belli, dum detonet omnis,
sustinet
(Aen., X, 803-810)
La compresenza dell’agricola, del viator e dell’immagine del sole nel passo
dell’Eneide non possono sfuggire alla memoria di quella straordinaria canzone, che
tematizza il volgere del sole al tramonto come momento di quiete cui contrapporre –
secondo un frequente topos virgiliano e poi romanzo – la sofferenza amorosa del poeta,
e che vede protagonisti delle prime due strofe precisamente la stanca vecchierella
pellegrina (v. 5) e l’avaro zappador (v. 18). Intorno alla citazione letterale dell’intero
verso 18 (« l’avaro zappador l’arme riprende ») si affollano altri elementi tratti dalla
canzone (« frettoloso passo » → v. 6: « raddoppia i passi, et più et più s’affretta »; «
lungo aspro viaggio » → v. 11: « la noia e ’l mal de la passata via »; « il caldo raggio »
→ v. 15: « come ’l sol volge le ’nfiammate rote » e anche v. 29: « quando vede ’l pastor
calare i raggi »), in una sorta di sunto del testo petrarchesco a mediare la traduzione
virgiliana entro il volgere di un’ottava. Di fronte a una ripresa così densa e palese da
potersi dire quasi una mise en abîme, non sarà fuori luogo notare come il rimando
complessivo alla canzone petrarchesca evochi le dinamiche stesse di quel testo: la
corrispondenza dell’imperturbabilità di Riccardo con la quiete delle figure evocate da
Petrarca rimarca allora, nella paradigmatica alterità di quelle rispetto allo stato disforico
dell’io poetico – contrapposizione leopardianamente strutturale, iterata in ogni strofa ‒,
anche una non identificazione a livello emotivo. Consapevole o inconscia che sia, tale
corrispondenza fa di una simile operazione sperimentale –
mediare un rapporto
intertestuale strettissimo attraverso un altro ancora più stretto ‒ non un mero
divertissement erudito, ma anche un veicolo di significati sul piano paradigmatico
veicolati dalle risonanze letterarie che innesca. Le nuove armi celesti che rendono
invulnerabile Riccardo fanno anche di lui, nel finale del poema, quasi un’emanazione
dell’ideologia controriformistica adombrata nel trionfo crociato, di fronte alla quale
232
l’identificazione emotiva si indirizza quasi naturalmente, come in questo caso, con la
parte avversa degli sconfitti che a tale trionfo ideologico soccombono.
L’aderenza strettissima al dettato virgiliano prosegue nelle parole di Riccardo
che, come Enea, cerca di dissuadere il ragazzo dall’impari confronto e nel successivo
colpo mortale che gli infligge:
e 'l giovine, ch'incontro aver sí duro
non si credea, minaccia, anzi spaventa:
- Dove ruini, o di morir securo?
La tua virtute oltr' il poter s'avventa.
Falsa pietá ti sforza o pur t'inganna
nel punto estremo; e 'l troppo ardir condanna. Ma giá l'avara Parca il filo incide
di lui ch'il suo valor non tenne a freno;
e il ferro micidial fiammeggia e stride
sovra 'l dorato scudo, e 'l coglie appieno:
e per mezzo il fanciullo apre e divide,
insin che tutto a lui s'asconde in seno,
e gli empie il grembo di purpureo sangue:
mesta l'alma abbandona il corpo esangue.
(G. C., XXIV, 92-93)
et Lausum increpitat Lausoque minatur:
'quo moriture ruis maioraque viribus audes?
fallit te incautum pietas tua.' nec minus ille
exsultat demens, saevae iamque altius irae
Dardanio surgunt ductori,
extremaque Lauso
Parcae fila legunt.
Validum namque exigit ensem
per medium Aeneas iuvenem totumque recondit;
transiit et parmam mucro, levia arma minacis,
et tunicam molli mater quam neverat auro,
implevitque sinum sanguis; tum vita per auras
concessit maesta ad Manis corpusque reliquit.
(Aen., X, 810-820)
Quasi impercettibile, il cambiamento da « pietas tua… fallit » alla ben diversa
forma attributiva « falsa pietà » è invece tanto più notevole in quanto perfettamente
parallelo ai « preghi a la giustizia avversi » di Argante per suo figlio, dei quali si è già
detto: preghiere e aspetto filiale parimenti condannati semplicemente in quanto
espressione della parte avversa, che la prospettiva ideologica – qui veicolata dalle parole
di Riccardo – condanna a priori, ma che la dimensione letteraria del testo riscatta nella
semplice presenza autoevidente della rappresentazione e rovescia nell’identificazione
emotiva. E tanto più paradossali, le parole di Riccardo, nel loro evocare inevitabilmente,
quasi volgendola in una colpa, esattamente la stessa sconsideratezza che ha portato alla
morte proprio il suo Ruperto, dimentico della raccomandazione di non affrontare
Solimano:
Cosí diss'egli; e parte al cor profondo
di tai parole il buon Ruperto inscrisse:
parte obliò, ch'il suo valor secondo
non stimò ad altro che d'Europa uscisse,
trattone lui che par non ebbe al mondo
d'intrepida virtú, mentr' egli visse:
felice pria con poche spade e lance;
ma non librò l'ardir con giusta lance.
(G. C., XVIII, 129)
Parte del suo signore oblia l'impero,
233
ch'egli guerra non faccia e sol rispinga,
e del soldán, ch'è si possente e fèro,
schivi l'incontro, ove s'avanzi e spinga:
tanto nel petto giovinile altero
può di gloria immortal dolce lusinga,
o quasi forza è pur d'eterna luce
questo nobil desio ch'a morte induce.
(G. C., XIX, 69)
Si comprende allora perché l’aderenza al dettato virgiliano si interrompa subito
dopo nella soppressione delle parole di Enea sul corpo di Lauso morto e del gesto,
derivato da quello di Achille con il corpo di Ettore alla presenza di Priamo (Il., XXIV,
589), di sollevare con sollecitudine il cadavere per renderlo agli onori funebri: la
commozione del sentimento paterno che si impone sull’alterità militare sarebbe stata
coerente, certo, con il patetismo che Tasso ricerca attraverso Virgilio, ma avrebbe
coinvolto nell’identificazione anche Riccardo, in quella partecipazione alla sofferenza in
cui la guerra nell’Eneide accomuna vinti e vincitori. Nella prospettiva tassiana, che
polarizza questa opposizione nella sua attualizzazione storica, anziché smussarla e quasi
annullarla nella fusione da cui avrà origine la grandezza di Roma, la vittoria di Riccardo
è di per sé giusta in quanto espressione della volontà di Dio, come quella del nuovo
Tancredi che tentava redimere Argante in punto di morte; essa non abbisogna di
mostrare una pietà ulteriore, umana, oltre a quella perfetta e compiuta del realizzare il
volere divino. Ulteriore prova, dunque, che qui emerge ex silentio dalla comparazione
con l’ipotesto, di come l’inasprimento ideologico della Conquistata non vada affatto a
negare il fascino e la simpatia verso il mondo pagano, risolvendo il “bifrontismo
tassiano” in una ortodossia monosemica, ma all’opposto, catalizzando nel finale i fattori
ideologici sulla parte cristiana, lasci maggiore spazio all’ambiguità dell’identificazione
con l’altra parte.
Dopo questo significativo taglio, la narrazione prosegue ‒ sempre al consueto
livello di “traduzione” ‒ spostandosi su Solimano che, come Mezenzio, si cura in
disparte e intuisce subito l’accaduto dalle grida dei suoi. Perfettamente paralleli anche il
disperato lamento per la propria salvezza costata la vita al figlio, culminante nella
risoluzione di morire piuttosto che sopravvivergli, e le parole addolorate e sprezzanti
con cui si rivolge a Riccardo nell’affrontarlo di nuovo. Rispettivamente:
- Tanto di viver dunque avea diletto,
o figlio, senza te, ch'io pur soffersi
ch'in mia vece esponessi al ferro il petto,
e la mia prole al mio destino offersi?
Da queste piaghe tue salute aspetto,
'Tantane me tenuit vivendi, nate, voluptas,
ut pro me hostili paterer succedere dextrae,
quem genui?
Tuane haec genitor per vulnera servor
234
vivo per la tua morte? O cieli avversi!
Or l'esiglio è infelice, or giunto il colpo
è troppo addentro e 'l mio timor n'incolpo.
Ch'io piú tosto deveva al fèro strazio
espor la vita che miseria adduce
e servitute alfine: e pago e sazio
far lungo odio immortal d'infesto duce.
Or io cerco al morir piú lungo spazio?
Né lascio il mondo e l'odïosa luce?
Ma lascerolla. (G. C., XXIV, 96-97)
morte tua vivens? Heu, nunc misero mihi demum
exilium246 infelix, nunc alte vulnus adactum!
Idem ego, nate, tuum maculavi crimine nomen,
pulsus ob invidiam solio sceptrisque paternis.
Debueram patriae poenas odiisque meorum:
omnis per mortis animam sontem ipse dedissem!
Nunc vivo
neque adhuc homines lucemque relinquo.
Sed linquam.'
(Aen., X, 846-856)
- Crudelissimo (dice), in qual periglio
vuoi spaventarmi, or che mi hai tolto il figlio?
'Quid me erepto, saevissime, nato
terres? Haec via sola fuit qua perdere posses:
Non pavento il morir, non pena o scempio,
non Dio nel ciel che mi condanna a torto,
e mi fa di miseria al mondo esempio.
Lascia, ch'io qui ritorno ad esser morto
e del mio sangue il mio difetto adempio;
ma questi doni anzi il morir ti porto. (G. C., XXIV, 100-101)
nec mortem horremus
nec divum parcimus ulli.
Desine, nam venio moriturus
et haec tibi porto
dona prius.'
(Aen., X, 878-882)
In tale modo è messo in pratica il principio, spiegato poi in sede teorica nel
Giudicio, secondo cui
Le persone scelerate non soglion muover compassione della loro infelicità […] Ma si può dubitare
se nel poema eroico il poeta possa o debba muover compassione per l'infortunio di persona scelerata,
perchè da quella di Mezenzio e di Lauso la ricerca Virgilio. […]
Comunque sia, Mezenzio, per lo disprezzo degli Dei, e per la crudeltà odioso, muove compassione
appresso Virgilio. […]
Ma dirò più tosto, che la persona di Mezenzio si considera come correlativa a quella del figliuolo,
perciò che de' relativi non si può considerar l'uno senza l'altro: laonde, essendo Lauso pietoso ,
Mezenzio, che gli è padre, e padre amorevole, partecipa in qualche modo di quel merito, e della pietà ch'è
nel figliuolo: e quantunque la persona di Mezenzio per se stessa non possa muover la commiserazione,
congiunta a quella di Lauso può muoverla. […]
In questa istessa guisa muove pietà Solimano con la sua morte; e si può considerare non come
imperator de' Turchi, ma come principe valoroso, e padre di valoroso e di pietoso figliuolo; perchè
Amoralto, e Solimano istesso, quantunque fosser privi delle virtù teologiche, non erano senza le virtù
naturali e quelle de' costumi: e l'uno in più luoghi è descritto forte ed intrepido cavaliere; dell'altro si
legge particolarmente:
Ma 'l buon figliuolo, a cui pietà perfetta
negò sua dispietata iniqua legge.
Se dunque in Amoralto era alcuna colpa, la colpa è rigittata nel legislatore; usando il poeta quella
che da' retori è detta translatio criminis; ed in questa guisa la sua persona è attissima a muover la pietà: e
perchè oltre a tutte l'altre azioni è lodevolissima la difesa che fa il figliuolo del padre, per la quale
s'espone a la morte, laudevolissima è la morte di Lauso, e con molta laude degna di molta compassione: è
degna similmente di laude e di pietà la morte d'Amoralto, che ad imitazione di Virgilio è descritta: merita
ancora laude l'azione di Mezenzio, e quella di Solimano nel cercar vendetta del figliuolo, per la quale non
246
Al v. 848 riporto nel testo virgiliano la lezione exilium, che evidentemente Tasso leggeva; tràdita è
anche, e preferita da molti editori moderni, la lezione exitium (MRg1).
235
ricusano d'esporsi di nuovo a certissimo pericolo della morte; e per questa medesima cagione la morte è
affettuosissima, ed atta a muover la misericordia.
La translatio criminis di cui Tasso parla, aggirando con un prestito giuridico la
carenza terminologica e teorica, altro non è se non l’individuazione della componente
ideologica passibile di astrazione dalle dinamiche del testo letterario in sé (« la colpa è
rigettata sul legislatore »), e colta nella sua contrapposizione irrisolta con
l’identificazione emotiva (« muover la pietà »). Ridurre il peso della prima, non già
negandola ma deviando altrove la sua incidenza sui meccanismi testuali, significa
lasciare maggior spazio alla seconda, proprio come abbiamo visto in queste nuove scene
della Conquistata. Dando diretta espressione alla condanna ideologica, come nella
preghiera inesaudita di Argante per il figlio, o convogliandola su quei personaggi, come
Tancredi e Riccardo, che possono farsene rappresentanti (per lo meno nella contingenza
del contesto specifico), l’immedesimazione con la parte avversa può ben risultare non
soffocata ma al contrario accresciuta. Così avviene per Solimano grazie alla nuova
presenza di Amoralto e al vincolo affettivo che essa genera, in opposizione
all’improrogabile giustizia della sua uccisione per mano del campione crociato. Nella
conclusione del poema, dove trova compimento il telos epico dell’affermazione
cristiana, non c’è più spazio per accomunare virgilianamente vincitori e vinti sotto il
comune segno della sofferenza, da cui far nascere la futura unità di Roma e del popolo
italico: l’ideologia controriformistica impone che la divaricazione sia netta, che la piena
vittoria dei crociati ‒ non più conquistata a costo della negazione di sé e della propria
individualità, sacrificata per intero alla missione, come quella di Enea ‒ obliteri nel
trionfo persino quel dolore totalizzante per Ruperto di cui nel finale non può quasi
restare traccia; in ciò permette anche, per converso, che l’emozionalità garante della
simpatia e dell’identificazione sia rivolta nel suo complesso verso quei pagani che sono
‒ e non possono che essere ‒ i soli sconfitti.
In questa luce va letta anche la modifica che interviene nel segmento finale della
scena, secondo una pratica frequente in Tasso per questo genere di imitazione
“integrale”, dove la significanza propria dell’elemento conclusivo non può mancare di
ribadire la discrepanza di senso che, attraverso la filigrana delle differenze, emerge
sempre da questo genere di “traduzioni”. Dopo lo scontro che sembra ripetersi identico
in ogni gesto, quasi a rimarcare il grado zero di significazione dell’azione fisica, e dopo
l’identico vanto minaccioso del vincitore sul nemico ancora vivo, le ultime parole di
Solimano rivelano una sottile ma rilevante diversità da quelle di Mezenzio:
236
- Che rimproveri a me, nemico acerbo?
quasi la morte sia vergogna o scorno.
Nulla colpa è il morire; e non riserbo
questa misera vita ad altro giorno.
Né tu del sangue giovinil superbo,
altra co 'l mio figliuol, di spoglie adorno,
pietá qui patteggiasti;- e piú non disse;
ma 'l colpo attese ond'altri il cor trafisse.
(G. C., XXIV, 105)
Hostis amare, quid increpitas mortemque minaris?
Nullum in caede nefas; nec sic ad proelia veni;
nec tecum meus haec pepigit mihi foedera Lausus.
[…]
Haec loquitur, iuguloque haut inscius accipit ensem,
undantique animam diffundit in arma cruore.
(Aen., X, 900-908)
Il riferimento di Mezenzio alla non colpevolezza di Enea nell’ucciderlo, vista
semplicemente come conformità alle dinamiche della guerra, uguali per entrambe le
parti, ed equivalente ad una mancata richiesta di essere risparmiato, si trasforma nella
Conquistata in una opposta rivendicazione della dignità del soccombere, sottratta ad
ogni assiologia bellica. Resta solo l’immagine della sofferenza, in tutta la sua
unilateralità, amplificata dal conferire tutto il rilievo della conclusione (a differenza che
in Virgilio) al ricordo dolente del figlio appena ucciso: il rovesciamento del soggetto,
per cui non aver fatto alcun patto non è più il giovane ucciso (« Lausus ») ma l’uccisore
(« tu »: Riccardo), chiude la scena volgendo il senso del verso virgiliano dal ribadire
l’accettazione della morte implicita nel combattere in una chiara espressione della
crudeltà mediante la quale la cristianità celebra il suo aggressivo trionfo.
237
238
6. LO STILE
Questioni stilistiche del poema epico rinascimentale
6.1. L’endecasillabo sciolto dell’Italia
Marry, I cannot show it in rhyme; I have tried: I can find out
no rhyme to ‘lady’ but ‘baby’, an innocent rhyme; for
‘scorn’, ‘horn’, a hard rhyme; for ‘school’, ‘fool’, a babbling
rhyme; very ominous endings: no, I was not born under a
rhyming planet, nor I cannot woo in festival terms.
W. SHAKESPEARE, Much Ado About Nothig, V, 2
1. La proposta del Trissino
Entro il quadro dell’aristotelismo e del classicismo rinascimentali, le questioni di
metrica hanno un peso senz’altro molto rilevante, data la radicale diversità della metrica
moderna da quella antica: l’intento di rifondare generi classici come la tragedia, la
commedia e l’epica va incontro al problema imprescindibile di trovare una forma
metrica adeguata a tali generi e in particolare il più possibile efficace nel rendere al
meglio, in metrica italiana, le corrispettive forme metriche antiche. Se dunque i tentativi
di metrica barbara, ossia di riprodurre la metrica classica in lingua volgare, restano
sperimentazioni occasionali senza seguito – come quella dell’Alberti – e la natura
accentuativa della metrica italiana è di fatto universalmente accettata in quanto
connaturata alla lingua e desunta da una tradizione ormai consolidata (per quanto, a
livello teorico, si tenti spesso di assimilare gli schemi accentuativi dei versi italiani agli
schemi metrici classici), non altrettanto si può dire per la differenza più vistosa (non a
caso eponima) dei rhythmi volgari rispetto ai metra latini e greci: la rima. In fondo,
tanto la metrica quantitativa quanto quella accentuativa rispondono, seppur in maniera
molto diversa, alla stessa finalità di conferire al discorso un andamento ritmico
riconoscibile e ripetibile; la rima, invece, appare come un artificio non solo del tutto
nuovo e peculiare delle lingue volgari (seppure di eredità mediolatina), ma soprattutto
volto ad assolvere ad una funzione strutturante assolutamente priva di qualsiasi parallelo
nella metrica classica. I versi della tradizione romanza, dunque, non sono mai realmente
messi in discussione, mentre l’istituto della rima suscita nel Cinquecento un dibattito
piuttosto ampio riguardo a diverse questioni, la principale delle quali è se la rima debba
239
essere accettata o meno in una letteratura italiana che ormai aspira alla dignità delle
letterature classiche.
Proprio negli anni del classicismo di stampo aristotelico si presenta alla letteratura
volgare, tanto nella teoria quanto nella prassi poetica, la questione dei versi sciolti247,
ossia appunto della rinuncia all’istituto della rima in vista di un riavvicinamento alla
metrica classica. L’ambito in cui il verso sciolto avrà maggiore fortuna – affermandovisi
come una delle forme canoniche – sarà senz’altro quello teatrale, dove esso sembra
molto adatto a rendere il fluire del discorso parlato in modo abbastanza simile al
trimetro/senario giambico, ma naturalmente la questione riguarderà anche – seppure con
esiti decisamente meno fortunati – la poesia epica.
Tanto per la tragedia quanto per l’epica – tralasciando alcuni dubbi precedenti
trecenteschi, storicamente irrilevanti 248 – la novità viene proposta per primo dal
Trissino 249 , con l’esempio rispettivamente della Sofonisba e poi dell’Italia liberata,
composte appunto in versi sciolti; tali proposte avanzate dal letterato vicentino nella
prassi poetica attraverso queste due opere sono inoltre suffragate dalla giustificazione
teorica di una simile scelta fornita in sede teorica. In particolare, nella Sesta divisione
della sua Poetica, dopo aver ribadito, con Aristotele, che l’esametro è il verso che
meglio si adatta alla poesia epica250 e dopo aver ricordato la soluzione dantesca della
terza rima e quella verosimilmente boccaccesca dell’ottava, consegnata poi alla
tradizione romanzesca di Pulci, Boiardo e Ariosto, il Trissino prende le distanze da
entrambe le soluzioni in favore dell’endecasillabo sciolto come verso che meglio si
adatta a fare le veci dell’esametro epico:
Io poscia, volendo scrivere in questa lingua la nostra Italia liberata da’ Gotti, la quale è materia
d’arme, ho voluto lasciare le terze rime che trovò Dante e parimente le ottave trovate dal Boccaccio.
247
Per una buona ricostruzione del dibattito cinquecentesco sui versi sciolti in sede teorica cfr..
STEADMAN, J. M., Verse without Rime: Sixteenth-Century Italian Defences of Versi Sciolti, in Italica, 41
(1964), pp. 384-402; specificamente sull’epica, cfr. anche il datato e piuttosto sintetico articolo di
WILLIAMS, R., Metrical Form of the Epic, as discussed by Sixteenth-Century Critics, « Modern Language
Notes », 36 (1921), pp. 449-457 ma soprattutto l’ottimo articolo di BORSETTO, L., Tra normalizzazione e
sperimentazione: appunti sulla questione del verso, in BALDASSARRI, G., a cura di, “Quasi un picciolo
mondo”. Tentativi di codificazione del genere epico nel Cinquecento, Milano, Unicopli, 1982, che
fornisce un esauriente excursus storico del dibattito relativo alla forma metrica appropriata all’epica in
volgare dai dialoghi Della poetica del Daniello (1536) fino al Tasso.
248
A proposito di tali precedenti – dubbi o comunque privi della coscienza storica di un’innovazione
metrica, ad esempio perché puramente effetto di una perdita delle rime in traduzione – cfr. SANSONE, G.
E., Per la storia dell’endecasillabo sciolto, « Convivium », 1948, pp. 895-901.
249
In commedia il primo a ricorrere al verso sciolto fu notoriamente l’Ariosto con i suoi endecasillabi
sdruccioli: dopo i primi tentativi in prosa, la sua prima commedia in versi, il Negromante, fu abbozzata
nel 1509, terminata nel 1520, riscritta e rappresentata nel 1528. La Sofonisba del Trissino è invece
composta nel 1514-15 e pubblicata nel 1524.
250
ARISTOTELE, Poetica, 1459b, 31 sgg.
240
Perciò che non mi pareano atte a materia continuata, sì per lo accordare spesso le desinenze dalle quali
nasce una certa uniformità di figure, sì eziandio perché in esse si convien sempre avere relazione da dui
versi a dui versi, o ver da tre a tre, o da quattro a quattro, o da otto a otto, e simili; la qual cosa è
totalmente contraria alla continuazione della materia e concatenazione dei sensi e delle construzioni. E
però levai di accordare le desinenze e ritenni il verso, cioè lo endecasillabo, per non essere in questa
lingua altra sorte di versi che siano più atti a materia continuata né migliori di quelli, essendo lo
endecasillabo (come dice Dante) superiore a tutti gli altri versi di questa lingua, sì di occupazione di
tempo come di capacità di sentenzie, di vocaboli, e di construzioni. […] Et in questa tale qualità di versi
siamo stati imitati da molti, e diconli versi sciolti per essere liberi dal convenire accordare le ultime
desinenzie, laonde sono attissimi a tutti e poemi dragmatici. Questo adunque sarà il verso che secondo il
parer mio allo eroico si conviene.
L’argomento avanzato dal Trissino per rifiutare la rima in poesia epica, dunque,
verte sulla concezione classica di tale genere poetico come carmen continuum: se gli
esametri dell’epica greca e latina sono del tutto irrelati tra loro dal punto di vista
metrico, l’endecasillabo rimato, al contrario, individua necessariamente una struttura
strofica che segmenta e articola il fluire dei versi in maniera totalmente contraria alla
continuazione della materia e concatenazione dei sensi e delle construzioni, il che è
chiaramente un aspetto fondamentale per la poesia narrativa. Inoltre la rima è
immediatamente collegata all’effetto di dolcezza e vaghezza, e dunque senz’altro adatta
alla poesia lirica e anche alle parti liriche della poesia drammatica, i cori251, mentre
proprio per questo stesso motivo è controproducente al conseguimento dello stile alto e
magnifico dell’epica, sentito come ben lontano, in quanto più austero ed elevato, dalla
dolcezza lirica. In quanto innovazione medievale e, almeno in origine, popolaresca, essa
non può che essere guardata con sospetto dai sostenitori più intransigenti – come
appunto il Trissino – di un ritorno al classicismo antico, e di conseguenza rifiutata per
quei generi – teatro ed epica eroica opposta al romanzo – che si intendevano rifondare
modellandoli sugli esempi antichi con la maggiore fedeltà possibile.
Ma se il verso sciolto ebbe un ampio successo nel teatro rinascimentale, come
abbiamo detto, non altrettanto si può dire per il suo impiego in poesia epica, dove, pur
non mancando chi approvava la scelta del Trissino 252 , l’ottava continuò ad essere
senz’altro la forma metrica più fortunata non solo tra i fautori del romanzo, ma anche tra
251
TRISSINO, Poetica: « Ben è vero, che ne i Cori de le Tragedie , e de le Commedie, e ne le materie, che
trattano di amore, e di laudi, ove la dolcezza, e la vaghezza specialmente vi si richiede, esse rime con le
sue regole non sono da schivare, ma vi si denno ricevere, et abbracciare, per esser membra principali di
essa vaghezza, e dolcezza ».
252
Fra gli altri si possono ricordare, ad esempio, MUZIO, Tre libri di lettere in rime sciolte: « Più sono atti
à la lira che à la tromba / i ternari e le stanze » e ancora: « Et è la mia sentenza, che l’imprese / alte e
superbe senza suon di rima / debbian trattarsi », e anche lo stesso CASTELVETRO, Poetica d’Aristotele
vulgarizzata, e sposta. Per Lodovico Castelvetro, il quale nel commentare il passo sopra citato di
Aristotele sull’esametro non manca di puntualizzare che il verso eroico « dee essere tessuto con una
catena, che non sia spezzata, ma continuata » e poi che « tale è la catena del verso heroico della lingua
greca e della latina, ma non già tale la catena dell’ottava rima della lingua volgare trovata, come si crede,
da Giovanni Boccaccio ».
241
i sostenitori del poema eroico di ispirazione classica. La critica principale che fu rivolta
alla scelta del Trissino riguardo all’epica già dai suoi contemporanei – tralasciando
quella banalizzante della difficoltà della rima per un testo molto esteso253 – si ricollega
proprio al successo che il verso sciolto aveva avuto invece nel teatro: già lo stesso
Trissino infatti, nella prefazione alla sua Sofonisba, spiegava perché la rima fosse
inadatta alla tragedia sulla base di un argomento del tutto diverso da quello portato per
l’epica, ossia che l’artificialità di tale pratica contrasta non solo con la mimesi del
linguaggio parlato, ma soprattutto con l’espressione spontanea del dolore e con il pathos
aristotelico:
… ed il dolore manda fuori non pensate parole, onde la rima, che pensamento dimostra, è
veramente alla compassione contraria254.
Ma se il verso sciolto è particolarmente adatto alla stilizzazione artistica del
linguaggio parlato sulla scena e all’espressione spontanea dell’emotività del
personaggio teatrale, proprio questa sua qualità lo rende invece decisamente inadatto
allo stile alto e ricercato della poesia epica: come scrive Giraldi nel Discorso intorno al
Comporre dei Romanzi, i versi sciolti sono “convenevolissimi alla scena” per il fatto
che risultano
liberi e sciolti da ogni pensamento, e pareano nati per lo parlare comune. […] E (per dir il parer
mio) tengo molto torto il giudizio di coloro [leggi: Trissino], ch’hanno trasportati questi versi dalla scena
alle materie grandi, alle quali se mancano le rime, manca tutto quello che dee far riuscire grato tutto il
componimento.
253
Cfr. SPERONE SPERONI, Sommarii e Fragmenti di Lezioni in difesa della Canace recitate nella
Accademia degli elevati in Padova: « Certo non conclude ciò altro, salvo che per essere essi poco
esercitati nel far versi, l’obbligazione della rima, non sapendo esse liberarnela, li spaventò ».
254
Scrive a proposito BARILLI, R., Modernità del Trissino, «Studi Italiani», IX, 2 (1997), pp. 27-59: «
Riflessione straordinaria, veramente inaugurale di una psicologia “moderna”, pronta a contestare dalle
radici l’arma di mediazione fornita per lunga abitudine dalle parole, dallo strumento della retorica » (p.
39). Tale riflessione del Trissino, in effetti, limitatamente all’ambito teatrale, sarà ampiamente condivisa,
e non manca di acutezza. Anche in questo caso, tuttavia, sarebbe opportuno fare una precisazione: in
realtà non è tanto la spontaneità nell’espressione del dolore a risultare ostacolata dalla rima, quanto
piuttosto la sua espressione scenica, ossia il suo essere parte di una rappresentazione drammatica
attualizzata sotto gli occhi dello spettatore: certamente si converrà che la rima non è d’ostacolo
all’espressione del dolore per i dannati della Commedia dantesca, ad esempio, dove si è fuori da un
contesto drammatico. Riguardo alla questione della spontaneità sollevata dall’affermazione del Trissino
bisognerebbe tener presente che in contesti di mimesis letteraria la metrica – e in particolare la rima –
rientra senz’altro fra gli elementi per i quali è richiesta al fruitore la “sospensione dell’incredulità”:
l’artificio metrico pertiene unicamente al livello della dizione, non a quello della rappresentazione (così
come il canto nell’opera, salvo momentanee ed autoevidenti eccezioni). Che l’incisione di Medoro nella
grotta da cui origina la pazzia di Orlando, pur essendo in arabo, sia riportata nel testo del Furioso in
un’ottava di endecasillabi italiani non crea naturalmente nessuna difficoltà. Qualche difficoltà in più sorge
appunto nel teatro, dove l’attualizzazione del testo nella recitazione inevitabilmente porta i due livelli ad
avvicinarsi e interferire.
242
e ancora:
Ma debbono esser questi versi sciolti in tutto dalle rime nelle commedie; ché i versi con le rime
sono più lontani dal parlare di ogni dì, di tutti gli altri, portando con loro maggior pensamento che gli altri
non fanno.
Proprio la forte artificialità della rima, insomma, che la rende inadatta alla mimesi
della parola parlata nel teatro, la rende per converso maggiormente adatta del verso
sciolto al genere epico e al suo stile elevato, ricercato, per definizione lontanissimo dalla
lingua parlata che invece il teatro intende sempre, in qualche misura, imitare. La
corrispondenza tra esametro ed endecasillabo sciolto che il Trissino proponeva come
l’approssimazione migliore e più filologica del verso eroico appare invece al Giraldi
un’approssimazione solo apparente, inappropriata proprio in relazione all’aspetto più
importante, ossia la corrispondenza al livello stilistico del testo255.
2. Giudizio sull’endecasillabo sciolto come “verso eroico”
Oggi possiamo dire, ex post, che la soluzione metrico-stilistica elaborata dal Tasso
per il suo capolavoro ha dato ragione senz’altro ragione ai sostenitori della rima contro
il Trissino. La splendida soluzione della Liberata di una nobilitazione dell’ottava
cavalleresca verso un linguaggio epico-lirico di stampo petrarchesco ha mostrato
perentoriamente come la dolcezza e la vaghezza della rima, artificio eminentemente
lirico, non sia affatto incompatibile né con la materia dell’epica, né tanto meno con il
suo stile alto e con la sua ricerca della continuità narrativa. Anche il carattere
popolareggiante e ironico dell’ottava, ancora così vivo nella medietas stilistica del
Furioso, non era affatto connaturato a quella forma metrica: in particolare il distico
finale, luogo per eccellenza dell’ammiccamento ironico dell’Ariosto a causa del sapore
popolareggiante della rima baciata, poteva perdere totalmente tale carattere di
leggerezza facendosi al contrario costantemente, come in Tasso, il punto di
innalzamento del tono, della gnome morale o esistenziale di stampo petrarchesco: versi
ariosteschi come
255
La posizione di Giraldi fu anticipata già dal DANIELLO nei suoi dialoghi Della poetica del 1536
(pubblicati in WEINBERG, B., Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, Bari, Laterza, 1970, vol. I,
pp. 229-318), dove per la prima volta è posta esplicitamente la “questione metrica” del poema eroico in
volgare: «A me pare che non solamente non si debba quel verso eroico chiamare che è senza rima, ma né
verso ancora, e specialmente essendo la rima un’armonia che il verso volgare ha in più che il latino».
243
che nei calci tal possa avea il cavallo
ch’avria spezzato un monte di metallo.
oppure quelli dell’uscita di scena di Angelica dal poema “gambe all’aria”
levò legambe et uscì de l’arcione
e si trovò riversa sul sabbione.
lasciano il posto, in Tasso, a espressioni sempre sorvegliatissime e spesso austere,
attente a soffocare ogni spinta alla leggerezza di tono e all’ironia cui la rima baciata
sembrerebbe invogliare:
ché nel mondo mutabile e leggero
costanza è spesso il varïar pensiero.
Ne gode e superbisce. Oh nostra folle
mente ch’ogn’aura di fortuna estolle!
Anche nella Conquistata, dove il Tasso si riavvicina per tanti aspetti alle proposte
del Trissino, la complessiva revisione stilistica sul testo del precedente poema mostra
come l’ottava, nonostante la rima e la struttura strofica, possa corrispondere anche
all’idea di uno stile epico ancor più elevato e austero, più lontano della Liberata dalla
dolcezza lirica petrarchesca in favore della pienezza e magnificenza dell’espressione
(esattamente secondo i propositi dello stesso Trissino).
Probabilmente quella dell’endecasillabo sciolto per l’Italia liberata non è stata
una scelta felice, per quanto abbia comunque avuto anche fra grandi autori un certo
seguito (dal Tasso del poema Il mondo creato, a Milton, fino ad arrivare a Parini). Ma
entro la poesia epica rinascimentale l’abbandono della rima si è rivelato senza dubbio
una proposta fallimentare. Se il poema del Trissino è sempre apparso arido, impoetico,
troppo vicino alla prosa, tanto da lasciare costantemente, alla lettura, l’impressione di
una mera versificazione di un testo storiografico, questo in buona parte si deve, forse,
proprio alla mancanza della rima e del suo contributo all’elaborazione stilisticoespressiva del testo.
Senza dubbio si può dire, infatti, che il semplice endecasillabo, senza rima e senza
strutture strofiche, non è affatto sufficiente a fare le veci dell’esametro greco e latino: la
brevità del verso moderno rispetto a quello classico, la molto maggiore semplicità della
sua strutturazione interna, la varietà decisamente minore di sequenze ritmiche possibili
244
in una metrica accentuativa rispetto ad una metrica quantitativa fanno sì che il proposito
di far semplicemente corrispondere i due versi a livello funzionale rimanga decisamente
una pura velleità, una pretesa azzardata e troppo fiduciosa. Quando il Trissino, nel passo
sopra citato della sua Poetica concernente i pregi dell’endecasillabo, come molto spesso
avviene nell’opera nel suo complesso riprende e riscrive e anzi quasi traduce
Aristotele 256 , mostra chiaramente di voler presentare l’endecasillabo come l’esatto
corrispondente moderno dell’esametro antico; ma il suo aristotelismo e il suo
classicismo, a differenza che per il Tasso, sono troppo spesso acritici: l’auctoritas del
passato è a priori superiore, senza neppure che ci sia bisogno di verificarne la
compatibilità con il presente. Se i grandi autori classici mostrano nell’uso l’eccellenza
dell’esametro e Aristotele la sancisce in sede teorica, tanto basta per dover senz’altro
cercarne il corrispettivo moderno (l’endecasillabo): una volta individuatolo, ogni
ulteriore elemento di diversità (la rima) risulta superfluo, sovrabbondante, ingiustificato,
e pertanto deve essere rifiutato senza neppure chiedersi se abbia un suo senso.
3. Il senso della rima: sua funzione storica a livello di codice (“langue”)
Cerchiamo dunque di approfondire la questione di quale sia il senso della rima in
poesia, per poi valutare con maggiore consapevolezza perché al proposta trissiniana
risulti fallimentare. La critica avanzata dal Giraldi all’utilizzo dell’endecasillabo sciolto
nell’epica, alla quale abbiamo accennato sopra, coglie en passant un aspetto molto
importante per la questione della rima, pur senza poi trarne tutte le conseguenze.
Quando si parla di rima, tanto nei dibattiti antichi quanto nell’approccio moderno,
difficilmente ci si pone la domanda fondamentale, ossia quale sia il senso della rima, a
che cosa essa serva257. Ci si rapporta a questo artificio peculiare della poesia moderna
256
TRISSINO, Poetica: «… e ritenni il verso, cioè lo endecasillabo, per non essere in questa lingua altra
sorte di versi che siano più atti a materia continuata né migliori di quello, essendo lo endecasillabo (come
dice Dante) superiore a tutti gli altri versi di questa lingua, sì di occupazione di tempo come di capacità
di sentenzie, di vocaboli e di construzioni»; cfr. ARISTOTELE, Poetica, 1459b, 31 sgg.: tÕ g¦r ¹rwikÕn
stasimètaton kaˆ Ñgkwdšstaton tîn mštrwn ™st…n (diÕ kaˆ glèttaj kaˆ metafor¦j dšcetai
m£lista· peritt¾ g¦r kaˆ ¹ dihghmatik¾ m…mhsij tîn ¥llwn).
257
Per qualche riferimento essenziale alla questione specifica della rima, cfr. F. FLORA, La rima nella
poesia italiana, in Taverna del Parnaso, Roma, Tumminelli, 1943; F. SARRI, Perché la rima, Vallecchi,
Firenze, 1955; PARODI, E. G., La rima e i vocaboli in rima nella « Divina commedia » in Lingua e
letterature, a cura di FOLENA, G.,Venezia, 1957, vol. II, pp. 208-218; FUBINI, M., Metrica e poesia:
lezioni sulle forme metriche italiane, Feltrinelli, Milano 1962 (sulla rima v. pp. 70 sgg.); BIGI, E., La rima
del Petrarca, in La cultura del Poliziano e altri studi umanistici, Pisa, 1967, pp.30-40; VALENTINI, A., La
rima, la forma, la struttura, Bulzoni, Roma, 1971; MENICHETTI, A., Metrica italiana (sezione 7: La rima,
pp.508-590), Antenore, Padova, 1993.
245
semplicemente in una prospettiva storicistica, filologica, come un elemento che è
intervenuto da un certo momento storico in poi ed va semplicemente interpretato come
un carattere peculiare di una certa tradizione letteraria: ci si rapporta ad essa come a un
fatto, non come a uno stilema dotato di senso. Molto di rado, insomma, ci si interroga su
quale sia sua funzione258. Questa è appunto anche la prospettiva del Trissino: egli rifiuta
la rima nell’epica come elemento anticlassico, storicamente legato alla lirica medievale,
e per lo stesso motivo, invece, la accetta e ne analizza schemi e funzionamento nei
minimi dettagli trattando di poesia lirica (nella Terza divisione della Poetica), ma non si
interroga mai sulla sua funzione in se stessa, a livello teorico, a prescindere dall’uso che
ne fa storicamente la tradizione romanza. D’altra parte anche oggi, in un’epoca che
ormai ha da tempo complessivamente rifiutato la rima – almeno nel suo uso sistematico
– come un orpello inscindibilmente legato alla tradizione e al vecchio, tale rifiuto
dipende molto più dalla storia della rima e dal tipo di estetica in cui essa si inscrive che
non da un’analisi critica della sua funzione nel testo. Certamente gli studi critici e i
trattati di metrica dei nostri giorni elencano una serie di funzioni della rima, ma si tratta
quasi sempre di funzioni secondarie e potremmo dire accidentali, che non giungono alla
sostanza della questione e non danno ragione della presenza della rima259.
Per chiarire meglio la questione, torniamo al dibattito rinascimentale e alle
osservazioni del Giraldi: nel sottolineare quanto l’endecasillabo sciolto sia
“convenevole” al teatro per la sua vicinanza al parlato, parafrasando una considerazione
di Aristotele sul trimetro giambico260, egli osserva:
… non è alcuno per basso ed ignorante ch’egli sia che scrivendo lettere famigliari non cada (non
sapendo ciò che si faccia) in qualche verso sciolto, tanto è ella famigliare questa sorte di versi al parlare,
ed allo scrivere di ogni dì, e tanto lontana dall’armonioso e soave del verso convenevole all’eroico.
In un altro suo trattato, il Discorso intorno al comporre delle Commedie e delle
Tragedie, egli esprime di nuovo lo stesso concetto:
258
Per un breve excursus degli studi critici sulla rima si veda l’appendice alla fine del capitolo presente:
Breve storia degli studi critici sulla rima.
259
Le funzioni che più di frequente si attribuiscono alla rima sono: 1) demarcativa: favorire la percezione
della divisione in versi; 2) strutturante: determinare le strutture strofiche; 3) associativa: associare tra le
parole in rima (dunque anche i loro significati) sulla base della parziale identità di suoni; 4) sintattica:
modificare l’ordine sintattico dell’espressione; 5) fonica: influire sull’espressione a livello fonico, del
significante (come l’allitterazione o l’omoteleuto). Come si vede, più che essere funzioni che danno
ragione della rima ne sono semmai delle conseguenze, ossia gli effetti che la sua presenza genera sul
testo.
260
Cfr. ARISTOTELE, Poetica, 1459a, 11: ™n dὲ to‹j „ambe…oij di¦ tÕ Óti m£lista lšxin mime‹sqai
taàta ¡rmÒttei tîn Ñnom£twn Ósoij k¨n ™n lÒgoij tij cr»saito (trad.: « ai giambi, che imitano
moltissimo la conversazione, si adattano le parole che si userebbero nel discorso).
246
[Sulla scena] debbono esser i lor ragionamenti così simili al parlar famigliare che paia che
altrimenti non si ragionerebbe tra amici e domestici, se di tali cose si avesse a parlare, tra quali non cade
uno sdrucciolo ogni giorno una volta. Ma bene ce ne cadono infiniti di quelli d’undici sillabe. E però mi
pare che questi siano quelli nei quali si debba comporre lodevolmente l’una e l’altra favola, facendo quelli
della commedia simili a ragionamenti popolareschi, e quelli della tragedia a grandi e reali.
e in un passo già citato aggiunge che « i versi con le rime sono più lontani dal
parlare di ogni dì, di tutti gli altri, portando con loro maggior pensamento che gli altri
non fanno ». Ora, a parte il dibattito specifico sulla forma metrica più appropriata al
teatro e all’epica, queste osservazioni sono interessanti proprio riguardo alla rima in
generale, a livello teorico: Giraldi coglie infatti un aspetto fondamentale della rima,
ossia il suo alto livello di artificialità, la sua nettissima lontananza dalla lingua d’uso261;
e tale lontananza implica un maggior pensamento, ossia una maggiore complessità a
livello compositivo che si riflette poi in una maggiore portata di pensiero, di significato.
Come avviene in ogni sistema semiotico (tale è anche la lingua poetica italiana), ogni
elemento di complicazione che viene introdotto nel sistema non è mai fine a se stesso,
ma – tanto più se viene poi recepito come un elemento di codice – serve ad aumentare le
possibilità di significazione. La difficoltà, il complicarsi del linguaggio non sono
ostacoli alla significazione – per lo meno fino ad una certa soglia di “saturazione” –, ma
sono al contrario suoi veicoli. Per fare un parallelo musicale, il progressivo complicarsi
dell’armonia nella musica occidentale attraverso la graduale introduzione di nuovi
accordi
dissonanti
autonomi
(quella
che
Schönberg
chiamava
progressiva
“emancipazione della dissonanza”) vale a garantire maggiori possibilità espressive al
compositore, non certo a rendere più difficoltoso il processo creativo. Così anche
l’istituto della rima, se fosse stato solo un orpello stilistico e non avesse avuto la sua
ragion d’essere, sarebbe stato abbandonato ben prima della rivoluzione romantica e
forse, anzi, non si sarebbe mai affermato. Se invece si è affermato, è perché, come dice
Giraldi, porta con sé maggior pensamento, ossia: ha un senso.
Ma qual è dunque il senso della rima? Per approfondire la questione saltiamo in
avanti al momento iniziale della sua crisi definitiva. Scrive Leopardi nello Zibaldone:
Ne’ versi rimati, per quanto la rima paia spontanea, e sia lungi dal parere stiracchiata, possiamo
dire per esperienza di chi compone, che il concetto è mezzo del poeta, mezzo della rima, e talvolta un
261
Scrive ancora il Giraldi nel Discorso intorno al comporre dei romanzi: «la rima è tutto quel dolce, e
quel soave armonioso che possono avere i nostri versi. E tolta la rima dal verso se ne rimane egli tanto
simile all’orazione soluta che non par verso, tanto egli è senza grazia, senza dolcezza e senza dignità
eroica. E però non conviene egli al poema che molta grazia e molta dignità ricerca: le quali cose non si
possono trovare in verso che più s’assomigli al parlare d’ogni dì».
247
terzo di quello, e due di questa, talvolta tutto della sola rima. Ma ben pochi son quelli che appartengono
interamente al solo poeta, quantunque non paiano stentati, anzi nati dalla cosa.
(13 Ottobre 1821.)
Posta in questi termini, l’osservazione di Leopardi sembra notare un difetto della
rima, il suo sottrarre libertà d’espressione al poeta. Ma leggiamo questa osservazione in
termini semiotici: che cosa si dice in effetti in queste poche righe? Si dice che, per
quanto concerne la rima, il sistema semiotico dell’italiano letterario (la langue)
condiziona e vincola l’effettiva possibilità espressiva (la parole): il che significa
semplicemente che ne garantisce ed incrementa le possibilità di significazione, ossia
assolve alla funzione propria del codice. Così ad esempio, nel linguaggio naturale, la
limitazione della libertà di associare in serie le parole (sintassi) permette un aumento
delle possibilità di significazione, mentre un’ipotetica libertà assoluta nell’associare le
parole senza alcun vincolo che la limiti equivale alla totale assenza di significazione. O
per fare di nuovo un parallelo musicale: il fatto che nel linguaggio tonale alcune
successioni di accordi siano permesse ed altre no fa sì che le prime siano dotate di senso
e costituiscano la base dell’armonia, il che semplicemente non potrebbe avvenire se
qualsiasi successione fosse egualmente permessa (su questo punto, in sostanza, verte la
critica strutturalista di Lévi-Strauss alla musica atonale e al presunto strutturalismo
musicale dei postweberniani 262 ). Con la rima avviene qualcosa di molto simile.
Chiunque abbia anche solo una vaga idea tanto della metrica classica quanto di quella
moderna sa bene quanto il sistema antico fosse più complesso e più ricco di quello
elaborato in seno alla cultura romanza, per il semplice fatto che la prosodia quantitativa
del latino e del greco permetteva sequenze e combinazioni ritmiche molto più numerose
e varie della prosodia accentuativa delle lingue romanze. Il nuovo sistema metrico
romanzo è in sé estremamente più povero di quello classico: la stessa tradizione alta
della poesia italiana – a partire già da Dante, ma poi in maniera definitiva con Petrarca –
limita le sue possibilità metriche a due soli tipi di verso (seppure passibili di una certa
varietà interna). Un sistema così povero dal punto di vista strettamente metrico non
garantisce in sé quel tasso minimo di artificialità necessario ad un sistema metrico per
marcare la differenziazione “tecnica” tra poesia e prosa: tale differenza sarebbe
sottodeterminata. La rima interviene appunto a colmare questa mancanza: quello che è
già in origine un artificio connesso alla perdita della quantità vocalica e dunque sillabica
nel latino medievale viene recepito ed ulteriormente elaborato dalla poesia romanza,
262
LÉVI-STRAUSS, C., Il crudo e il cotto, il Saggiatore, Milano, 1980 (1964), p. 40 e sgg.
248
anche nella sua tradizione più alta, come un elemento fondamentale alla progressiva
costituzione di una metrica autonoma, completa, soddisfacente. Quel tasso di
artificialità necessario a distinguere compiutamente e in modo netto la prosa dalla
poesia era venuto meno con le innumerevoli possibilità della metrica quantitativa: la
rima, storicamente, ha avuto proprio il compito di tornare a complicare il quadro, ad
innalzare il tasso di artificialità del discorso ritmico rispetto a quello della lingua d’uso.
Se al parlante italiano, come nota Giraldi, capita spesso di formulare involontariamente
sequenze metricamente equivalenti all’endecasillabo (cosa che avviene molto più
raramente nella metrica classica: chi potrebbe mai pensare che l’esametro con cui
iniziano gli Annales di Tacito sia casuale?), questo significa che la distinzione tra prosa
e verso è troppo poco marcata dalla mera struttura metrica, persino da quella del verso
più illustre263. La rima torna a innalzare nuovamente il livello di artificialità del discorso
poetico e a distinguerlo più nettamente dalla prosa. Come scrive Giraldi: « i versi con le
rime sono più lontani dal parlare di ogni dì, di tutti gli altri». In questo senso si spiega la
sonorità decisamente arida, povera e prosastica dell’endecasillabo sciolto dell’Italia
liberata, che lascia continuamente l’impressione di somigliare ad una versificazione,
appena più ritmata, di una prosa storiografica. Nello sbarazzarsi con facilità della rima
soltanto sulla base una presunto recupero delle forme classiche, il Trissino mostra di
non aver riflettuto adeguatamente su questo punto, sul senso che la rima ha avuto
storicamente nello sviluppo della metrica romanza.
4. Il senso della rima: sua funzione testuale a livello di espressione (“parole”)
Ma c’è anche un altro aspetto del problema. Quella di incrementare il livello di
artificialità e stilizzazione del discorso poetico rispetto alla prosa è una funzione storica
della rima inerente al sistema metrico, ossia la lingua letteraria intesa come codice.
Tuttavia, se la rima ha davvero una sua ragion d’essere, un senso, deve averlo non solo
nella lingua poetica ma anche, costantemente, nell’effettiva prassi poetica, nella
composizione dei singoli componimenti, come funzione non più solo del sistema ma
263
All’origine dell’argomento, giustissimo, c’è di nuovo un passo di ARISTOTELE, Poetica, 1449a, 24 e
sgg.: aÙt¾ ¹ fÚsij tÕ o„ke‹on mštron eáre· m£lista g¦r lektikÕn tîn mštrwn tÕ „ambe‹Òn ™stin·
shme‹on dὲ toÚtou, ple‹sta g¦r „ambe‹a lšgomen ™n tÍ dialšktJ tÍ prÕj ¢ll»louj, ˜x£metra dὲ
Ñlig£kij kaˆ ™kba…nontej tÁj lektikÁj ¡rmon…aj (trad.: « Il giambo è infatti il metro più colloquiale,
come prova il fatto che nella nostra conversazione ci capita di fare molti giambi e pochi esametri, e solo
quando ci si allontana dal ritmo discorsivo »).
249
anche del testo: ossia come funzione non solo della langue ma anche della parole
poetica. In effetti le funzioni individuate in genere dai moderni trattati di metrica,
menzionate sopra in nota, sono appunti funzioni testuali della rima; tuttavia si tratta di
effetti sul testo più che di funzioni che davvero rendano conto della costante presenza
della rima nel testo: ne descrivono le conseguenze più che spiegarne la motivazione, la
ragion d’essere. Per indagare meglio anche questo aspetto, anch’esso del tutto trascurato
dal Trissino (che parla soltanto genericamente di dolcezza e vaghezza conferite dalla
rima all’espressione poetica), possiamo di nuovo ricorrere al passo citato dello
Zibaldone leopardiano. Sottolineando la forte artificialità della rima, il poeta di Recanati
nota che il concetto, ossia il pensiero poetico veicolato dai versi, è spesso in gran parte
vincolato dalla scelta delle parole-rima. Per precisare meglio, potremmo dire che quanto
più la rima è rara (ossia quanto minore è il numero di parole-rima che offre come
possibilità di scelta), tanto più l’espressione del pensiero sarà condizionata dal minor
numero di alternative. All’opposto, la rima altamente ricorsiva è quasi sempre una rima
desinenziale
264
, e per ciò stesso facilmente percepita come banale (dunque
“stiracchiata”, “stentata”, come dice Leopardi): dunque richiede comunque una certa
ricercatezza pur nella facilità, per evitare le soluzioni più semplici e banali. Questo
significa in sostanza una cosa molto rilevante, che è appunto ciò che sta dicendo
Leopardi: la rima condiziona fortemente l’immaginario. Tutto sta nel decidere come
debba intendersi questo condizionamento, se come una mera limitazione della
possibilità espressiva del poeta o al contrario, in una prospettiva più moderna e
semiotica, come una complicazione della langue che nel limitare le possibilità della
parole al tempo stesso incrementa il suo livello di significazione. Naturalmente nella
prospettiva romantica della dissoluzione delle regole tradizionali in favore della
spontaneità espressiva individuale il punto di vista non poteva che essere il primo; oggi,
tuttavia, dopo lo sviluppo della semiotica, possiamo forse capire meglio il senso del
secondo. Analizziamo dunque, brevemente, questo secondo punto di vista. In che modo
agisce la rima nel testo, in fondo? Essa agisce costringendo il poeta ad inserire a fine
verso una parola scelta entro un gruppo ristretto di parole, individuato sulla base di un
criterio casuale in quanto connesso alla sola struttura fonica – arbitraria – dei
significanti. La parola talvolta potrà anche essere pienamente pertinente al pensiero
poetico che l’autore sta formulando, ma questo è il caso più fortunato e relativamente
raro. Più spesso, una volta scelta una delle parole-rima (non necessariamente la prima
264
La rima detta in genere sincategorematica o categoriale: ad es. la serie dolcezza, asprezza, bellezza
ecc.
250
nell’ordine), la pertinenza delle successive al discorso non potrà che essere solo parziale
e qualche volta minima: questo porta inevitabilmente, e anzi costringe, ad elaborare
maggiormente l’espressione per esprimere il pensiero poetico, in modo tale da
adeguarlo a contenere quella parola in sé non immediatamente pertinente. Questo, come
dicevamo, comporta delle conseguenze a livello di immaginario. Da una parte la libertà
espressiva è limitata, poiché il poeta è costretto ad inserire una parola scelta fra poche.
Dall’altra però tale limitazione, costringendo ad adeguare il pensiero alla presenza di
quella parola, ha un effetto del tutto opposto, ossia di costringere a maggior
pensamento, come dice Giraldi, al ricorso ad un immaginario più vasto e ricercato,
spesso metaforico. La semplice presenza della rima, insomma, determina sempre un
aumento di quello che Francesco Orlando chiama tasso di figuralità 265 . Quanto più
l’inserimento nel contesto di una data parola-rima risulta difficoltoso, tanto più il poeta
deve ingegnarsi per inserirla nel suo discorso, e questo comporta subito uno slittamento
del discorso verso la metafora, verso l’immagine ricercata, non letterale, poetica, dando
così un notevole impulso al tasso di figuralità del testo. In questo senso, dunque, la rima
vale non già ad ostacolare, ma al contrario ad incrementare lo specifico del testo poetico
in opposizione alla prosa e in particolare alla prosa non letteraria 266 . In alcuni casi
questo fenomeno è evidentissimo, come ad esempio in Dante:
… quando incontrammo d’anime una schiera
che venìan lungo l’argine, e ciascuna
265
ORLANDO, F., Per una teoria freudiana della letteratura, cit. (p. 59 sgg.).
In termini semiotici questo significa che la rima è un fenomeno di “ipercodifica”, e come tale crea un
“sottocodice”; tale sottocodice si afferma entro il codice (la lingua poetica) proprio perché riesce,
funziona, ha un senso, serve ad aumentare le possibilità di significazione. Non mi risulta che sia mai stato
tentato un serio approccio semiotico alla questione della rima, nonostante il suggerimento lanciato da
BARTHES, R., Elementi di semiologia, Einaudi, Torino, 2002 (1964), p. 72, e dunque le considerazioni sul
suo senso risultano quasi sempre molto vaghe; l’articolo di SHAPIRO, M., Sémiotique de la rime, «
Poétique » 20 (1974), pp. 501-519 si limita a proporre un approccio semiotico – per altro assai discutibile
– della mera struttura fonica della rima, senza affrontare minimamente la questione del suo senso. In
effetti il fenomeno della rima si presterebbe invece ad essere analizzato proficuamente da una prospettiva
semiotica proprio per il fatto di essere un sottocodice della lingua poetica, che in quanto tale veicola
sempre, in qualche misura, dei significati suoi propri: se nella Commedia la parola “Cristo” rima solo con
se stessa e se in Gozzano “Nietzsche” rima con “camicie”, è evidente che il significato di tali
accostamenti è veicolato unicamente dalla rima, dal fatto di coinvolgere parole-rima. Si tratta della
cosiddetta funzione “associativa” della rima, che in misura più o meno marcata agisce sempre, anche
quando il senso dell’associazione non è così evidente come nei due esempi ricordati: essa può essere
appunto la base di una semiotica della rima intesa come fenomeno di significazione. Il “lessico” dei
paradigmi di rime (tutte le parole-rima associate per classi di rima) più le regole di “sintassi” della rima
(ossia gli schemi metrici: terzina, ottava ecc.) costituirebbero il (sotto)codice, la langue; l’effettiva serie di
parole-rima di volta in volta scelte dal poeta (il “sintagma”) costituirebbe la parole; il significato della
rima intesa come segno dipenderebbe dal rapporto dei significati delle parole-rima fra loro (es. Nietzschecamicie), mentre il suo senso dipenderebbe dal loro rapporto con il contesto (i versi in questione, ma
anche l’intero componimento di Gozzano), e così via. Le considerazioni a riguardo sono sviluppate nelle
appendici 2 e 3 al presente capitolo.
266
251
ci riguardava come suol da sera
guardare uno altro sotto nuova luna;
e sì ver noi aguzzavan le ciglia
come ’l vecchio sartor fa ne la cruna.
(Inf., XV, vv. 16-21)
Da una parola comune e denotativa, “ciascuna”, il grande poeta sa cercare
nell’angusto bacino delle rime in -una due parole-rima, “luna” e “cruna”, ognuna delle
quali fa germinare nella sua fantasia un’immagine analogica di straordinaria forza
icastica, tale da far scivolare verso la figuralità un evento narrativo concretissimo –
l’imbattersi in una nuova schiera di anime – che è fra l’altro senza dubbio il più
ricorrente e il più consueto del poema, trasfigurando tale consuetudine e concretezza in
qualcosa di unico, originalissimo e assolutamente individuale attraverso due similitudini
straordinariamente realistiche e del tutto imprevedibili: non c’è dubbio che entrambe le
similitudini originano dalla scelta della parola-rima, sono suggerite da essa, ma allo
stesso tempo tale vincolo dovuto alla rima, anziché essere una limitazione alla libera
espressione, è tutt’al contrario la poca favilla da cui seconda la gran fiamma della
vertiginosa invenzione dantesca.
Quasi rovesciato negli esiti e molto meno evidente, ma solo perché dissimulato
dietro il cesello della “sprezzatura” ante litteram propria del suo stile, è lo stesso
fenomeno in Petrarca, dove, coerentemente con le differenze di poetica rispetto al
grande predecessore, esso intende sempre far apparire naturalissima e quasi spontanea
l’immagine che pure tante volte è ispirata o comunque almeno condizionata dalla rima:
L’ombra che cade da quel’humil colle,
ove favilla il mio soave foco,
ove ’l gran lauro fu picciola verga,
crescendo mentr’io parlo, agli occhi tolle
la dolce vista del beato loco,
ove ’l mio cor co la sua donna alberga.
(RVF 188, vv. 9-14)
Al pari che nel passo dantesco, seppure in maniera molto meno appariscente e
icastica, anche le immagini coinvolte nella sirima di questo celebre sonetto originano
tutte, si può dire, dalle coppie di parole-rima scelte dal poeta, senza che questo sia
affatto un limite all’espressione: al contrario, si tratta di un elemento che contribuisce in
maniera fondamentale a stimolarla ed arricchirla, ad incrementare il suo livello di
significazione.
Ora, basta prendere un qualsiasi passo dell’Italia liberata per rendersi conto della
differenza: beninteso, della differenza non tanto di valore – scontata rispetto ai due
252
massimi autori della letteratura italiana – quanto di figuralità e di poeticità opposta alla
prosaicità. Prendiamo ad esempio un attacco di canto (luogo in genere soggetto a
maggiore elaborazione poetica):
Come divisa fu l’immensa preda,
Costanzo se n’andò verso l’albergo
del sommo capitanio de le genti,
per dirli tutto quel che s’era fatto.
E quivi lo trovò con Aldigieri,
che discorrea le cose della guerra;
Onde Costanzo a lui parlando disse…
Senz’altro è ravvisabile in questi versi la volontà – purtroppo malriuscita – di
imitare lo stile narrativo dell’epica classica e in particolare di Omero; ma l’esito a cui
porta l’incontro fra questo proposito e l’utilizzo dell’endecasillabo sciolto è di abbattere
il livello di figuralità del testo fino a farlo diventare una sorta di prosa che, di quando in
quando, si perita di andare a capo: il ritmo del solo metro senza la rima è decisamente
troppo blando, e chi non avesse familiarità con l’andamento dell’endecasillabo
all’ascolto forse non si accorgerebbe neppure, sentendo leggere questo passo, che non si
tratta di prosa 267 . In sette versi, inoltre, l’aggettivazione è minimale e di repertorio
(fraintendendo il senso della formularità omerica in una sorta di banalizzazione dei nessi
aggettivali) e non c’è traccia di discorso che non sia letterale e denotativo. Prendiamo
un altro passo, stavolta un discorso diretto:
Illustre capitan, che sì gran stuolo
condotto avete intorno a queste mura
per oppugnarle e torci la cittade;
veramente ci par che abbiate torto,
a darci danno alcun, perciò che mai
da noi non riceveste alcuna offesa.
Poi dentro avemo il gran presidio Goto,
ch' ha il fren in mano, e la custodia insieme
de la cittade ; onde non ci è permesso,
dar questa terra a voi contra lor voglia.
Eglino ancor, quando sen venner quivi
per custodirla, dietro a sé lasciaro
ne la man del suo re le care mogli,
la roba, i figli ; onde non posson darvi
questa città, senza tradir sé stessi.
Ma se a dir lice apertamente il vero,
267
Riguardo a questo aspetto, riferendosi nella fattispecie alla Sofonisba, ma in generale allo stile proprio
del poeta vicentino, RENATO BARILLI, nel suo articolo dal titolo Modernità del Trissino, cit., parla di «
prosasticità di cui l’Autore è capace, una virtù che viceversa commentatori antichi e recenti insistono ad
opporgli come vizio, come limite », aggiungendo in nota, con un ostentato stupore che lascia stupiti, che «
tra questi critici compare perfino il Tasso » (p. 44). Non si vede davvero in che senso la prosasticità possa
essere una “virtù” in poesia, tanto più in un contesto di classicismo piuttosto lontano da certe consapevoli
poetiche novecentesche di poesia prosastica (ad es. Pavese).
253
i’ vi dirò, signor, quel ch' a me pare.
Il venir contra noi con tanta gente
non fu salubre, ed ottimo consiglio.
Che dovevate andar di lungo a Roma…
Lo stile estremamente prosastico e povero è lo stesso del passo precedente; né si
tratta di casi eccezionali: il tono dell’opera è questo per tutti i 27 canti che la
compongono. Ma in questo secondo caso – come in molti altri, in effetti – possiamo
spiegare meglio l’origine di questa estrema prosaicità e al contempo darne più
chiaramente la misura riportando il passo della guerra gotica di Procopio di Cesarea da
cui il discorso è derivato:
« Non agisci rettamente, o generale, movendo guerra a noi, cittadini romani, che non ti abbiamo
fatto nulla di male e per di più viviamo in una piccola città, avendo su di noi un presidio di barbari, che ci
domina senza lasciare alcuna possibilità di liberarcene, anche se lo volessimo. Anzi, ai soldati che sono
qui di guarnigione è toccato di dover consegnare moglie e figli e tutti i loro averi nelle mani di Teodato,
prima di venire a presidiarci; perciò, se essi venissero a patti con voi, consegnerebbero nelle vostre mani
non solo la città, ma se stessi. Quindi, a voler dire schiettamente la verità, senza troppe reticenze, non
avete preso una decisione vantaggiosa per voi, movendo contro di noi. Se invece conquisterete Roma… »
Come si vede, il passo del Trissino non ha soltanto il sapore di una versificazione
della fonte storiografica: lo è, in tutto e per tutto. La prosa di Procopio è semplicemente
volta in endecasillabi sciolti, per il resto non ci sono quasi cambiamenti: le stesse frasi,
gli stessi argomenti, esposti per giunta nello stesso ordine, senza la minima aggiunta e
soprattutto senza che si avverta la minima necessità di dare una qualche elaborazione
figurale al testo. E questo esito, chiaramente rovinoso per la riuscita estetica del poema,
è indotto o per lo meno ampiamente favorito proprio dal verso sciolto: la rima,
costringendo ad inserire parole più o meno estranee al discorso letterale, avrebbe
necessariamente portato ad un certo livello di figuralità, impedendo che il proposito di
dare una veste italiana all’esametro classico finisse per svilirsi in una prosa appena
ritmata, quasi del tutto priva di tratti poetici. Viene da chiedersi come un aristotelico
quale il Trissino abbia potuto non avvedersi di come questo suo tentativo di riportare in
vita il verso eroico andava in senso del tutto opposto non solo alla natura dell’esametro
classico, ma anche alle osservazioni di Aristotele a riguardo, il quale nota proprio come
l’esametro sia invece il verso che maggiormente si presta ad accogliere elementi
figurali268.
268
Cfr. il passo già citato di ARISTOTELE, Poetica, 1459b, 31 sgg.: tÕ g¦r ¹rwikÕn stasimètaton kaˆ
Ñgkwdšstaton tîn mštrwn ™st…n (diÕ kaˆ glèttaj kaˆ metafor¦j dšcetai m£lista· peritt¾ g¦r
kaˆ ¹ dihghmatik¾ m…mhsij tîn ¥llwn). Trad.: « Il verso eroico è tra tutti i metri il più composto e
solenne, e per questo è in grado di ospitare al meglio glosse e metafore ». Va ricordato, per di più, che
254
Come sempre, il Tasso saprà fare tesoro degli errori del suo predecessore e
rifiuterà la proposta dell’endecasillabo sciolto nell’epica, tanto nella Liberata quanto
nella sua riscrittura che è la Conquistata. Scelta naturalmente operata in piena
consapevolezza, come dimostra un breve passo di una delle cosiddette Lettere poetiche,
indirizzata a Scipione Gonzaga (n. 47):
Considerisi, oltra ciò, che l’instrumento del poeta eroico latino e greco è il verso essametro, il qual
per se stesso senza altro aiuto basta a sollevar lo stile: ma ’l nostro endecasillabo non è tale; e
la rima ricerca e porta di sua natura l’ornamento, più che non fa il verso latino e greco.
In questa breve frase sono riassunte, seppur in un cenno rapidissimo, proprio le
due funzioni fondamentali della rima che abbiamo esposto in queste pagine: quella
“storica” (a livello di langue poetica) di sopperire alla carenza di stilizzazione della
metrica romanza rispetto alla metrica classica e quella “figurale” (a livello di parole) di
favorire l’elaborazione retorica e lo sviluppo dell’immaginario (la rima ricerca e porta
di sua natura l’ornamento).
Vero è che il Tasso sperimentò la proposta trissiniana in una sua opera minore, il
Mondo creato, che pure si ricollega a un più consolidato filone di poesia didascalica in
versi sciolti che non propriamente alla poesia narrativa, epica. Ma basta ricordarne il
raffinatissimo incipit per misurare la distanza abissale che la medesima forma metrica,
nelle mani di un grande poeta, produce rispetto alla prosaicità vacua del verso sciolto
trissiniano:
Padre del cielo, e tu del Padre eterno
eterno Figlio, e non creata prole,
de l'immutabil mente unico parto,
divina imago, al tuo divino essempio
eguale, e lume pur di lume ardente;
e tu, che d'ambo spiri e d'ambo splendi,
o di gemina luce acceso Spirto,
che sei pur sacro lume e sacra fiamma,
quasi lucido rivo in chiaro fonte,
e vera imago ancor di vera imago,
in cui se stesso il primo essempio agguaglia
(se dir conviensi), e triplicato Sole,
che l'alme accendi e i puri ingegni illustri;
santo don, santo messo e santo nodo,
che tre sante Persone in un congiungi,
Dio non solingo, in cui s'aduna il tutto,
che 'n varie parti poi si scema e sparge;
nella Poetica Aristotele intende per “metafora” qualcosa di decisamente più ampio della figura retorica
cui ci riferiamo oggi, in senso stretto, con questo nome (1457a, 31 sgg.). All’importanza dell’espressione
figurata in poesia Aristotele dedica anche un intero capitolo dell’opera (il n. 22, 1458a, 18 sgg.), che il
Trissino non manca di riprendere e sviluppare in un piccolo trattato di retorica entro la sua Poetica.
255
termine d'infinito alto consiglio
e de l'ordine suo divino Amore…
Come si vede, il Tasso non ha necessariamente bisogno della rima per mantenere
un adeguato livello di elaborazione figurale e poetica. Il Trissino, invece, non si
dimostra in grado di “camminare solo sulle sue gambe”, senza l’aiuto della rima a
“costringerlo” ad essere poetico, per così dire: basta leggere qualcuna delle sue Rime per
rendersi subito conto di come la semplice presenza di quell’artificio, pur senza
garantire, naturalmente, risultati straordinari, basta di per sé a risollevare il livello
stilistico dall’insostenibile trascuratezza della versificazione epica ad una fattura di
qualità media, tutt’altro che disprezzabile e non priva di soluzioni originali ed efficaci,
nell’eclettismo antibembesco della sua produzione lirica, come notava anche Croce269.
La rima, insomma, lungi dall’essere un ostacolo alla creatività, è al contrario un potente
strumento al servizio di quella; ma appunto in quanto strumento è utile ma non
indispensabile, come dimostrano già Parini e soprattutto Leopardi, senza dover
scomodare il Novecento. Tuttavia dimostrano anche che, quantomeno nei secoli della
tradizione, se per essere grandi poeti non è certo necessaria la rima, per abbandonare la
rima è necessario essere grandi poeti.
269
Cfr. CROCE, B., Poeti e scrittori del pieno e del tardo Rinascimento, I, Bari, Laterza, 1945, pp. 302309: « Nel poema non c'è nulla di nulla: non vi si coglie alcun tratto felice, alcun moto di affetto, alcun
pensiero notevole, come invece accade nelle rime dello stesso autore, che era tutt'altro che privo di
finezza e gentilezza, e nella Sofonisba, e persino in qualche tratto della commedia dei Simillimi ». Sulla
produzione lirica del Trissino cfr.: QUONDAM, A., La poesia duplicata. Imitazione e scrittura
nell’esperienza del Trissino, in Atti del Convegno di Studi su Giangiorgio Trissino, Neri Pozza, Vicenza,
1979, pp. 67-109; QUONDAM, A., Introduzione a G. G. Trissino, Rime 1529, a cura di ID., Neri Pozza,
Vicenza, 1981.
256
5. Appendice 1:
Breve storia degli studi critici sulla rima
A livello generale – se si vuole di teoria della letteratura –, nonostante
l’imponenza del fenomeno, la rima è stata studiata molto poco e in maniera disorganica,
e i risultati ottenuti sono, nel complesso, poco soddisfacenti. Ancor oggi, la definizione
che si fornisce della rima la liquida quasi sempre in una mera descrizione della sua
dimensione fonica, per passare subito a una classificazione tipologica. Nel migliore dei
casi, si fornisce in aggiunta un elenco delle sue funzioni nel testo poetico (demarcativa,
strutturante, associativa, sintattica, fonica); ma non sarà difficile accorgersi di come
anche questo succinto catalogo di funzioni non sia affatto in grado di rendere conto del
fenomeno millenario e fortunatissimo della rima nel suo complesso: tali funzioni
costituiscono gli effetti che la presenza della rima può generare nel testo e non già la sua
ragion d’essere, la sua motivazione generale, il suo “perché”. Gli studi critici
sull’argomento hanno fornito, insomma, solo delle spiegazioni parziali, asistematiche,
valide unicamente per certi casi e non per altri, non di rado anche contrastanti fra loro,
senza saper dare ancora una spiegazione complessiva ed esauriente del fenomeno che
davvero renda ragione della sua straordinaria fortuna.
Possiamo dunque ripercorrere brevemente la storia recente di tali acquisizioni
critiche per valutarne i risultati conseguiti e le carenze tuttora riscontrabili.
Naturalmente della rima si parla sin dalle sue origini e, in Italia, almeno a partire dai più
antichi trattati di argomento metrico, quelli di Dante e Antonio Da Tempo (ma alcune
importanti indicazioni sono già nel Tresor di Brunetto Latini); riguardo alla questione
dei suoi pregi e difetti e della sua appropriatezza ai diversi generi poetici si discute di
frequente fra letterati dal Cinquecento in poi, o almeno vi si fa spesso qualche cenno.
Ma per tracciare un quadro complessivo degli studi più recenti di carattere scientifico,
possiamo partire dai primi decenni del Novecento per arrivare, in due parole, ai giorni
nostri. Originariamente, certo anche in relazione agli sviluppi della fonetica, si ha una
concezione eminentemente fonica della rima, coerente, in fondo, con la definizione
comunemente accettata: il caso più rappresentativo è LANZ (1931), che spiega la rima in
rapporto al ritorno delle frequenze sonore dei suoni vocalici. Un decisivo passo avanti è
compiuto dai formalisti russi nel mettere in relazione questa struttura fonica con
l’organizzazione ritmica del testo (ZHIRMUNSKIJ, TOMAŠEVKIJ ecc.), in particolare con
la funzione di marcare la fine del verso. Quando si tenta di andare oltre la dimensione
257
fonica o ritmica, però, l’approccio è quasi sempre “impressionistico”, generico, poco
pregnante: si parla di musicalità, di arazionalità della rima e altre simili categorie
(FLORA, CLARK, SARRI, FUBINI ecc.) 270 . Successivamente, a partire da WIMSATT e
JAKOBSON e poi più recentemente con LOTMAN271 si afferma una visione più matura e
capace di arrivare a cogliere la vera portata del fenomeno, con la concezione semantica
della rima: la rima non è solo un fenomeno fonico o un elemento di organizzazione
ritmica, ma genera anche delle interferenze fra le parole rimanti al livello del significato
(JAKOBSON e LOTMAN sostengono che la rima abbia sempre un significato, mentre altri,
ad es. BERTINETTO272, sono più cauti: pur senza negare spessore semantico alla rima, lo
270
FLORA (1938) è il più indicativo: «la calamita delle rime, la magnetica virtù degli echi risponde a una
armonia cosmica» (p. 27), oppure «Spesso la rima fu nella poesia il senso figurato della danza, come è
sempre la traduzione vocale di una melodia» (p. 28). CLARK (1946) considera ancora la rima come una
difficoltà il cui superamento dimostra l’arte del poeta: «I do not deny the difficulty of composition in
rhyme: I only assert the triumph when the difficulty is surmounted, the real beauty of the
accomplishment, and its seeming inevitability. Omnia praeclara difficilia»; si limita poi ad analizzare,
seppur in decine di pagine, l’appropriatezza della rima ai vari generi letterari e registri stilistici. SARRI
(1955) spiega la rima come fenomeno di scansione ritmica del testo poetico in parallelo alla cadenza in
una frase musicale: «Ora, se consideriamo la formola tic-tac come l’equivalente dei due emistichi del
verso, di cui il secondo serva di corrispondenza o di risposta ritmica, o della successione di due versi,
oppure di una serie ripetuta di un accoppio di versi, il fenomeno della rima avrà in ciò, se non
c’inganniamo, la sua prima ed essenziale ragion di essere, ed ancora la sua spiegazione. Ma eziandio il
suo valore, perché identificandosi così con la cadenza musicale, fenomeno per eccellenza allitterativo,
sarà da considerarsi, analogamente a questa, come la somma dei valori ritmici e sonori del verso e per
conseguenza anche della strofa, e quale centro di attrazione tonale degli stessi valori» (pp. 134-135).
FUBINI (1966): «In realtà con la rima, per quello che essa sembra avere di irrazionale, noi non abbiamo se
non una manifestazione della arazionalità della lingua che segue leggi che la ragione non conosce : tutta
la lingua è qualcosa di differente dalla ragione».
271
WIMSATT (1944): Constatando, in polemica con Lanz, che «il mero ritorno alla vocale tonica
(l’accordo o gamma tonale caratteristica di una vocale) non produce in genere altra emozione che la noia»
(p. 198), egli sostiene una opposta concezione semantica: «Si ammette comunemente che la rima abbia
nella struttura metrica questa funzione di legare. Ma dove c’è bisogno di legare, deve esserci anche
qualche differenza o separazione tra le cose che devono essere legate. Se sono già affini, è superfluo
sottolinearlo con l’espediente della rima. Possiamo dunque dire che quanto maggiore è la differenza di
significato tra le parole-rima, tanto più efficace e appropriato sarà l’effetto di legatura» (p. 196).
JAKOBSON (1960): «La rima implica necessariamente una relazione semantica fra le unità che rimano fra
loro (“compagni di rima”, rhyme-fellows, secondo la terminologia di Hopkins)» e ancora: «Qualunque sia
il rapporto fra il suono e il senso nelle diverse tecniche della rima, le due sferere sono implicate
necessariamente. Dopo le penetranti osservazioni di Wimsatt sull’importanza semantica della rima, e
dopo i notevoli studi recentemente condotti sui sistemi ritmici slavi, lo studioso di poetica difficilmente
può sostenere l’idea che le rime hanno soltanto una vaga funzione semantica». LOTMAN (1970): «Il
fenomeno della struttura del verso, in ultima analisi, risulta sempre un fenomeno di significato. Questo è
particolarmente chiaro nell’esempio della rima» (p. 146); egli ne fornisce dunque una nuova e più
completa definizione: «la rima è una coincidenza sonora di parole o di loro parti, con marcata non
coincidenza di significato, relativamente alla posizione nell’unita ritmica. Questa definizione abbraccia
anche la rima tautologica, perché a differenza dal discorso colloquiale, il linguaggio poetico non conosce
una ripetizione semantica assoluta» (p. 151). Molto intelligente anche l’osservazione per cui «la natura di
questa binarietà [della rima] è tale che essa include l’identità e la contrapposizione dei concetti che la
costituiscono. […] La rima si attua in una formula estremamente significativa per l’arte: “questo e
contemporaneamente non questo”».
272
BERTINETTO: «Si può dare il caso che in un certo testo la rima postuli l’esistenza di tutta una fitta
trama di rapporti semantici; mentre in un altro testo tali rapporti possono essere assenti, senza
minimamente pregiudicare con ciò il volto del fenomeno dal punto di vista della sua individuazione» (p.
53); più precisamente: «un fenomeno come la rima […] si definisce qualitativamente sulla base delle sue
258
ritengono un fenomeno non generalizzato ma solo occasionale; torneremo più avanti
sulla questione). In realtà l’individuazione di tale funzione semantica della rima, che
negli studi si fa risalire in genere a Wimsatt e Jakobson, è in effetti già pienamente
esplicitata prima di loro almeno da TYNJANOV273, che ne fornisce un’analisi ampiamente
sviluppata vent’anni prima. Tuttavia è solo con Wimsatt e Jakobson, forse anche per
l’autorità di quest’ultimo e della sua teoria della comunicazione letteraria, che la
concezione semantica della rima diventa dagli anni ’60 in poi un’acquisizione
generalizzata, e quasi tutti gli studiosi successivi fanno riferimento ad essa, pur
assegnandole di volta in volta un diverso rilievo in funzione delle loro tesi specifiche:
possiamo ricordare, in questa direzione, almeno i rilevanti studi di CHATMAN, LEVIN e
COHEN274. Recentemente, infine, si va affermando la tendenza a sottolineare – talvolta,
forse, in modo eccessivo e con troppa facilità – le implicazioni intertestuali della rima,
seguendo, almeno in Italia, un suggerimento di SEGRE (che parla di “vischiosità” dei
caratteristiche generali e delle sue proprietà strutturali (che costituiscono, in un certo senso, le condizioni
minime di accertamento del fenomeno stesso); mentre tutti i tratti che ne specificano la fisionomia entro
un particolare contesto non istituiscono differenze di tipo qualitativo tra le varie opere, bensì differenze
meramente quantitative» (p. 56).
273
TYNJANOV (1924): dopo giuste considerazioni sulle implicazioni ritmiche della rima («Nella rima, in
quanto fattore del ritmo, si possono rilevare due momenti: un momento progressivo (il primo elemento
rimato) e un momento regressivo (il secondo elemento rimato). La rima si determina, a simiglianza del
metro, come risultante di un’anticipazione dinamica progressiva e di una dinamica soluzione regressiva»,
p. 41), viene ampiamente analizzata l’interferenza semantica fra le parole in rima: «Così la presenza di
nessi ritmici stabili comporta una deformazione semantica principalmente del primo membro, […] mentre
il secondo membro risulta semanticamente poco toccato (e di conseguenza anche meno intensamente
emergente). Mentre in una rima in cui l’effetto di progressione si manifesti con tutta la sua forza, tale
effetto di progressione sottolinea anzitutto il secondo membro rimante: e tanto più forte, per il confronto
che tra entrambi i membri si stabilisce, è l’effetto che da ciò deriva (momento regressivo). E da questo
confronto il gruppo risulta tanto più deformato quanto più grande è in esso la differenza dei due membri
rimanti» (p. 144); «L’importanza dell’elemento del confronto, nell’equiparazione, induce a considerare la
rima alla stregua di una comparazione di genere particolare […]. La sua importanza come leva semantica
di grande forza è fuori discussione» (p. 149); egli discute dunque l’uso comico della rima, i rischi delle
associazioni scontate e la prevedibilità della rima e persino la sua connessione con la teoria dell’immagine
in poesia.
274
COHEN (1966), per accettando pienamente la concezione semantica della rima («la sua vera funzione
non appare se non è messa in relazione col senso», p. 97), insiste su un punto abbastanza condivisibile ma
piuttosto sterile: la rima come antinorma del linguaggio corrente, che contribuisce a caratterizzare la
poesia come antiprosa: è una concezione senz’altro riduttiva. CHATMAN (1960) parte dal presupposto che
«The function of rhyme in English verse is primarily metrical, that is, to help mark line endings» Ma
subito, rifacendosi a Wimsatt, ammette la sua dimensione semantica: «Sometimes, however, it may also
have a quasi-lexical function. […] In its lexical function, rhyme, like metaphor or epithet, limits meaning
by asking us to consider suddenly the connection of two things whose sound shapes happen to be
resemblant» (p. 153). Interessante la concezione per cui il significato dei termini in rima emergerebbe
tramite una delimitazione del confronto in maniera simile alla metafora: «the rhyme actually may provide
information by limiting the possibilities of interpretation, just as the vehicle of a metaphor forces us to
limit the possible interpretations of the tenor (“not all x’s, or the whole of x but only those x’s or parts of x
which resemble the vehicle y in some important respects”)». LEVIN (1962), considerndo la rima, secondo
la sua tesi, come uno dei possibili casi di coupling del linguaggio poetico, sostiene che essa non ha
necessariamente implicazioni semantiche: «the devices of rhyme, alliteration, etc. are entirely satisfied by
phonic equivalence; semantic equivalence in such couplings is gratuitous»; «To be sure, rhyming words
may frequently be found to be semantically equivalent, but the phenomenon does not seem to occur very
often with the other conventional devices [i.e. alliteration, assonance]».
259
rimanti)275: si vedano in tal senso i contributi di ANTONELLI, PULSONI, AFRIBO, PUNZI276
ecc. Prospettiva interessantissima: la posizione particolarmente rilevata in clausola di
verso e lo spessore “materico” conferito alla dimensione sonora della parola
dall’artificio fonico rendono la parola in rima di per sé altamente memorabile. Peccato
che poi, più che studiare il potenziale di allusività della rima, cosa che si rivelerebbe
verosimilmente molto produttiva e stimolante, si tende invece ad analizzare, al
contrario, i sistemi di rime, la loro convenzionalità, ciò che già Tytjanov, quasi un
secolo fa, chiamava “associazioni scontate”, tali da implicare una “funzione
suggeritiva” della rima 277 , per cui il primo membro lascia presagire il secondo:
un’intertestualità, per così dire, in negativo anziché in positivo, un fatto di langue, di
codice, anziché di parole. Non stupisce che il risultato a cui si arriva sub specie metrica
sia poi una mera conferma di tesi spesso – mi si lasci dire – piuttosto scontate, come
l’originalità pur antitetica di Dante e Petrarca rispetto alla tradizione Duecentesca.
Gli aspetti della rima maggiormente evidenziati dagli studi specialistici sono,
dunque, quello fonico, quello ritmico, quello semantico e quello intertestuale. Ma già
per quello ritmico l’analisi è in genere molto carente, limitando la funzione della rima a
marcare la fine di verso, in modo da isolare e individuare l’unità ritmica; essa è invece
molto più di questo, è un fattore organico al sistema metrico stesso: ritmo e rima sono
inscindibilmente legati nell’età della tradizione come elementi omogenei e
interdipendenti pur nella loro diversità, per cui analizzare la struttura ritmica di un verso
rimato senza tener conto della rima significa trascurare un fattore determinante per la
stessa organizzazione ritmica del discorso, alterando i risultati. La rima, infatti, modifica
e quasi determina l’ordo verborum; ma poiché nella metrica accentuativa il ritmo del
verso dipende dagli accenti delle parole, modificare l’ordine delle parole significa
275
SEGRE, C., Esperienze ariostesche, Pisa, 1966, pp. 51-83: il riuso intertestuale di un rimante
significativo di un predecessore porterebbe naturalmente a recuperare l’intera serie rimica.
276
ANTONELLI (1998): «La ripetizione per ri-uso [delle rime] è la condizione normale, il “codice”
addirittura, della poesia italiana (ma non solo) fino a Petrarca, e oltre. […] Una volta scelta una rima vi
sono alcuni lemmi che costituiscono più o meno conscia-mente, per il lettore (e l’autore) medievale (ma
non solo), un vero e proprio “orizzonte d’attesa”» (p. 148); «La persistenza di rime, costellazioni rimiche
e serie rimiche, i rimandi, le citazioni e le allusioni intertestuali stanno lì a dimostrare con ogni evidenza
che gli autori in genere iniziavano proprio dalla selezione delle rime e dei rimanti e che talvolta, per i più
diversi motivi, tali scelte erano perfino obbligate» (p. 150). AFRIBO (2002): «Credo che una rima per
essere un segnale intertestuale ideale debba essere così: essere difficile e perciò tendenzialmente a tiratura
limitata. Difficile perché la sua desinenza è difficile, e perciò difficile sarà per il poeta trovare parole che
finiscano in quel modo, e perciò i rimanti relativi si conteranno sulle dita di una mano»; buona
osservazione: peccato che studi poi il Duecento, che è invece un secolo di rime facili, categoriali. PUNZI
(2001): «Le serie rimiche divengono così la chiave di lettura dei rapporti intertestuali […]. Nella
Commedia, organizzata anche sul piano macrostrutturale in maniera da creare precisi collegamenti
interni, le serie rimiche rappresentano una componente importante del tessuto memoriale dell’opera» (p.
273).
277
TYNJANOV, cit., pp. 138-142.
260
influenzare in modo determinante la sequenza ritmica degli accenti. Lo studio della
metrica volgare, pertanto, non dovrebbe mai limitarsi al ritmo prescindendo dalla rima,
come troppo spesso accade nei contributi specialistici: sarebbe senz’altro opportuno
colmare tale sbilanciamento degli studi verso i fattori ritmici a scapito della rima e
tornare a congiungere sistematicamente questi due aspetti nell’analisi. Ma se la rima è
indispensabile al ritmo della poesia tradizionale, essa è anche molto più di questo, dal
momento che coinvolge le parole, che per di più sono parole poetiche, dunque gravate
di connotazioni e altre implicazioni testuali molto maggiori rispetto ai semplici segni
linguistici. La rima appare insomma, nel complesso, un grande fenomeno che ancora
reclama, negli studi specialistici sull’argomento, una sua spiegazione complessiva e
organica, che non la banalizzi come un mero fatto ma al contrario la consideri come una
struttura di senso: partendo dal giudizio avanzato in questo capitolo sulla proposta
trissiniana dell’endecasillabo sciolto, si è tentato di fornire una prima spiegazione
generale di questo fenomeno tanto rilevante eppure tanto trascurato.
261
262
6. Appendice 2:
Per una semiotica della rima (seguendo un suggerimento di Barthes)
Abbiamo visto come il fenomeno storico-letterario della rima abbia nel complesso
una sua ragion d’essere entro il codice della lingua poetica sia in rapporto all’evoluzione
storica del codice stesso, con il passaggio alla metrica accentuativa, sia in rapporto
all’effettiva produzione di testi che tale codice permette, stimolando in essi un più
elevato tasso di figuralità. Ma con l’affermarsi, a partire da Wimsatt e Jakobson (con il
precedente di Tytjanov) della concezione semantica della rima, emerge chiaramente la
coscienza di una funzione che le specifiche serie rimiche presenti in un dato
componimento poetico svolgono anche a livello del contesto particolare in cui di volta
in volta compaiono: quella di fornire un loro specifico apporto di significato. La rima,
insomma, ha un suo senso non solo come fenomeno di codice (langue), ma anche come
specifico elemento di espressione (parole). La funzione figurale di cui abbiamo parlato,
infatti, agisce sì a livello di espressione, di parole, ma è comunque un dato presupposto
a livello estensivo dal codice, su tutti i testi che esso produce, indistintamente. La
funzione semantica, invece, agisce a livello microstrutturale in ciascun testo,
contribuendo al suo specifico messaggio in maniera circostanziata.
La rima, come si accennava nell’introduzione, non è un fenomeno fonico se non
secondariamente, occasionalmente; essa è innanzitutto un fenomeno metrico che però
ha delle implicazioni semantiche: è un fenomeno metrico-semantico. Si tratta cioè di un
unicum nel panorama della metrica, di uno straordinario ibrido che collega in uno stesso
artificio tecnico la dimensione metrica e la dimensione semantica, aggiogando insieme
ritmo e significato, cosa di cui non conosco alcun altro caso paragonabile: limitatamente
a questo aspetto il fenomeno più vicino potrebbe essere forse la formularità omerica, in
quanto tecnica di versificazione che implica tuttavia un’evidente apporto semantico, ma
in quel caso non si tratta stricto sensu di un fenomeno metrico. Proprio questo
straordinario carattere trasversale della rima, questa sua “verticalità”, che coinvolge
insieme diversi livelli del testo, fa sì che una prospettiva semiotica risulti
particolarmente utile ad analizzarlo, permettendo al contempo di distinguere fra questi
livelli ma anche di comprenderne le interazioni. Impostare l’analisi di questo ulteriore
livello su base puramente semantica, parlando in modo generico di significato, porta
infatti a dei frequenti fraintendimenti: sarà più utile, per capire adeguatamente certi
aspetti, impostare l’analisi in una prospettiva più specificamente semiotica. Se infatti la
263
rima veicola un significato, ciò vuol dire che essa è un segno, e in quanto tale ricade
nell’abito d’analisi della semiotica. Non mi risulta che sia mai stato tentato un serio
approccio di questo tipo alla questione della rima 278 , nonostante un suggerimento
lanciato da Roland Barthes in Elementi di Semiologia (1964); indicando alcuni possibili
spunti di sviluppo per la nascente disciplina semiotica, egli scrive:
«Un’altra importante direzione da esplorare è la rima. Essa forma una sfera associativa al livello
del suono, cioè dei significanti: ci sono dei paradigmi di rime; in rapporto a questi paradigmi, il discorso
rimato è evidentemente costituito da un frammento di sistema esteso in sintagma. La rima coinciderebbe
insomma con una trasgressione della legge di distanza del sintagma-sistema (legge di Trnka), e
corrisponderebbe a una tensione volontaria fra l’affine e dissimile, a una specie di scandalo strutturale»
(p. 72).
Questo breve schizzo, tuttavia, traccia un’analisi semiologica della rima dal punto
di vista del linguaggio verbale, del codice, e non una autonoma semiotica della rima,
costruita sul suo proprio livello, in quanto sottocodice di quella lingua. In effetti il
fenomeno della rima si presta invece ad essere analizzato proficuamente da una
prospettiva semiotica proprio per il fatto di essere un sottocodice della lingua poetica,
che in quanto tale veicola, in qualche misura, dei significati suoi propri; detto altrimenti,
esso ha un altro livello di significazione rispetto a quello del linguaggio, che
contribuisce ad arricchire: se nella Commedia la parola “Cristo” rima solo con se
stessa 279 e se in Gozzano “Nietzsche” rima con “camicie” 280 , è evidente che il
significato di tali accostamenti è veicolato unicamente dalla rima, dal fatto di
coinvolgere parole in rima piuttosto che parole qualsiasi (si tratta della cosiddetta
funzione “associativa” della rima). Una simile prospettiva semiotica, allora, aiuterà a
uscire definitivamente dai giudizi fumosi e impressionistici sulla “musicalità” della rima
e simili, ma a prendere al contempo le distanze anche da eccessi di analisi statistiche cui
i metricisti indulgono con troppa facilità, credendo di spiegare il fenomeno col
trasformarlo nella confortante precisione del numero, quando l’importante è invece la
funzione, il senso; in questo modo, inoltre, si eviterà il frequente errore di confondere il
senso delle parole con il senso del fenomeno della rima, i quali interagiscono
costantemente proprio in virtù del loro svolgersi su due piani distinti. Delineare una
278
L’articolo di SHAPIRO, M., Sémiotique de la rime, « Poétique » 20 (1974), pp. 501-519 si limita a
proporre un approccio semiotico – per altro assai discutibile – della mera struttura fonica della rima, senza
affrontare minimamente la questione del suo senso, dunque affronta tutt’altra questione da quella trattata
qui. BERTINETTO, cit., parla di una dimensione semiologica della rima, ma poi non sviluppa ulteriormente
la questione.
279
Par. XII, 71-75; XIV, 104-108; XIX, 104-108; XXXII, 83-87.
280
GOZZANO, La signorina Felicita, 308-311.
264
semiotica della rima comporterà pertanto di chiarire le diverse funzioni che pertengono
alla rima in quanto segno e dunque, essenzialmente, precisare la relativa terminologia e
le sue implicazioni.
Il significante genera molte confusioni perché apparentemente coincide con quello
linguistico: in realtà il significante della rima non è la struttura fonica in sé, ma la
percezione dell’identità nella struttura fonica fra parole che concludono versi successivi
o relativamente vicini. Anche a livello di significante, dunque, rima e parola non
coincidono affatto 281 . La definizione che ancor oggi si dà comunemente della rima
(MENICHETTI, Metrica italiana, p. 506: «la rima fra due o più parole è l’omofonia (cioè
l’identità del suono) delle loro vocali toniche e, nello stesso ordine, di tutti i suoni,
vocalici e consonantici, che eventualmente le seguono») è in effetti soltanto la
definizione del suo significante. Sarebbe come dire che le parole di una lingua sono una
sequenza di suoni: non che ciò sia di per sé errato, ma è senz’altro gravemente
incompleto, mancando di notare proprio l’elemento essenziale (il significato). Ma
riconoscere che la struttura fonica della rima non è altro che il suo significante ci
permette anche una riflessione ulteriore, cui abbiamo accennato sopra in nota. Quello
che è forse il più grande seguace della proposta trissiniana dell’endecasillabo sciolto,
Milton, nel suo Paradise Lost rifiuta la rima anche per «the jingling sound of like
endings, a fault avoided by the learned Ancients both in Poetry and all good
Oratory»282. In verità questo effetto fonico cantilenante è realmente sfruttato dalla rima
soltanto occasionalmente: la rima come istituto richiede al lettore/ascoltatore una sorta
di “sospensione dell’incredulità” proprio in rapporto alla struttura fonica della rima, che
c’è ma è come se non ci fosse. Allo stesso modo, nel linguaggio verbale noi non
prestiamo attenzione alla dimensione sonora in sé dei suoni articolati da chi parla, ma
solo ai significati che quei suoni veicolano. L’identità di suoni della rima, insomma,
pertiene unicamente al livello della dizione, del messaggio in senso jakobsoniano, non
già a quello della rappresentazione, del contenuto, esattamente come il canto nel
melodramma. La funzione fonica della rima può essere poi recuperata occasionalmente,
281
Per la precisione, nella terminologia di Hjemslev, esse condividono la sostanza dell’espressione (i
suoni) ma differiscono quanto alla forma dell’espressione (che in un caso è data dall’opposizione
distintiva tra fonemi, nell’altro dalla percezione dell’identità di suono a partire dall’ultima vocale tonica
del verso). Proprio l’interferenza a livello di sostanza dell’espressione spiega anche, tendenzialmente, le
inesattezze nell’omofonia della rima nelle varie lingue: se l’opposizione fonematica è debole e poco
produttiva o si sta perdendo nella lingua, anche la rima tenderà ad ignorarla: in italiano, ad esempio, le
opposizioni ò/ó ed è/é sono produttive solo in sede tonica, dunque la rima finisce per ignorarle (anche per
ragioni storiche: nel siciliano che è alle origini della nostra poesia in rima l’opposizione è del tutto
assente); lo stesso tende ad avvenire per le opposizioni s/ṣ e z/ẓ (scempie e doppie), molto poco
produttive e destinate a perdersi nella percezione di molti parlanti.
282
MILTON, J., The Verse of Paradise Lost, 1668.
265
quando è funzionale alla rappresentazione, proprio al modo stesso che il canto, di
nuovo, quando nel melodramma diviene occasionalmente realtà scenica (ad es. la
canzonetta del Don Giovanni o l’aria “Voi che sapete” nelle Nozze di Figaro): così
avviene con le rime aspre e chiocce di Inferno XXXII, o quelle sibilanti di Inferno XIII
o anche, sebbene in modo meno marcato e più generalizzato, nella musicalità e dolcezza
che la rima petrarchesca consegna alla tradizione italiana in rapporto a un certo registro
stilistico e tematico. Ma in generale la stilizzazione artistica richiede per convenzione
che gli elementi stilizzati, nel momento della fruizione, siano riferiti al testo e non alla
sua dimensione rappresentativa, salvo rifunzionalizzazioni sempre e solo occasionali.
Ovviamente ciò non vuol dire che il livello fonico della rima non abbia importanza, ma
solo che esso non è fondamentale proprio in quanto è sistematico: la rima, insomma,
non è una figura di suono come l’allitterazione o l’onomatopea, se non quando è
intenzionalmente trattata come tale. Torna ad essere sempre una figura di suono solo
dopo la crisi novecentesca della rima, quando tornando ad essere occasionale non può
più presupporre l’atteggiamento “sospensivo” imprescindibilmente legato alla sua
sistematicità di convenzione. La rima, dunque, non è affatto una folle forma di
fonosimbolismo generalizzato ed elevato a sistema: provare fastidio di fronte al
«jingling sound» della rima, insomma, equivale all’insofferenza per la convenzione
strutturante del melodramma per cui i personaggi in scena si esprimono sempre
cantando283.
Veniamo ora all’aspetto su cui maggiormente hanno insistito i migliori contributi
recenti sulla rima. Il significato della rima è dato dall’interferenza dei significati delle
parole in rima, dei rimanti (o eventualmente di espressioni costituite da più parole
283
D’altronde la pertinentizzazione che l’arte mette sempre in opera di elementi materiali che al di fuori
di essa appaiono non semantizzati è un fatto noto, accennato già in ARISTOTELE, Poetica, 1448b, 15 sgg.:
di¦ g¦r toàto ca…rousi t¦j e„kÒnaj Ðrîntej, Óti sumba…nei qewroàntaj manq£nein kaˆ
sullog…zesqai t… ›kaston, oŒon Óti oátoj ™ke‹noj· ™peˆ ™¦n m¾ tÚcV proewrakèj, oÙc Î m…mhma
poi»sei t¾n ¹don¾n ¢ll¦ di¦ t¾n ¢pergas…an À t¾n croi¦n À di¦ toiaÚthn tin¦ ¥llhn a„t…an
(trad.: « Si gode dunque a vedere le immagini perché contemplandole si impara e si ragiona su ogni
punto, per esempio che una certa figura è il tale. Se poi quell’immagine capita di non averla mai vista
prima, allora non procurerà piacere in quanto imitazione, ma per la sua fattura, il colore o qualche altro
motivo del genere »). Il moderno approccio semiotico al fenomeno artistico, poi, riconosce questo aspetto
come uno degli elementi costitutivi della semiosi estetica in generale: scrive a proposito U. ECO, Trattato
di semiotica generale, cit.: « Ora, nel godimento estetico, tale materia riveste una importante funzione, e
ciò accade non al di là delle proprietà semiotiche del testo estetico, ma proprio perché la materia è stata
resa SEMIOTICAMENTE RILEVANTE. La materia del segnale diventa, nel testo estetico, luogo di una
ULTERIORE SEGMENTAZIONE […] Ciò significa che anche quei tratti individuali delle occorrenze concrete
che il normale discorso semiotico non prende in considerazione, qui assumono importanza semiotica: la
materia della sostanza diventa un aspetto della forma dell’espressione» (p. 333). La rima è evidentemente
un simile caso di semantizzazione della materia sonora in poesia: la ripetizione di suoni finali che in prosa
si evita come cacofonica e nel linguaggio ordinario risulta unicamente ridicola, non avendo che una
dimensione materiale, in poesia invece, divenendo un fatto generalizzato, viene sistematicamente
semantizzata nei modi che che stiamo esaminando nel presente studio.
266
lessicalizzate o comunque fortemente legate nell’avere un denotatum unico: ad es.
Spirito Santo ≠ santo). Alla rima tautologica Cristo : Cristo è chiaramente possibile
attribuire un significato eufemistico e sacrale legato al fatto di nominare in sede rimica
il nome del Dio-uomo della religione cristiana; similmente, l’accostamento Nietzsche :
camicie appare dissacrante proprio perché fa interferire i significati delle due parole
unicamente in quanto messi in relazione dal fatto di rimare: se le due parole non fossero
in rima non ci sarebbe nulla di dissacrante, non ci sarebbe, cioè, il significato veicolato
dalla rima. La definizione comunemente accettata della rima ignora del tutto questo
aspetto
fondamentale:
giustamente
dunque
Lotman
propone
di
ridefinirla
approssimativamente nei seguenti termini: «la rima è una coincidenza sonora di parole o
di loro parti, con marcata non coincidenza di significato, relativamente alla posizione
dell’unità ritmica» (pp. 150-151). Anche qui, come già per il significante, non si dovrà
confondere dunque il significato delle singole parole in rima in quanto segni linguistici
con il significato della rima, ossia dell’accostamento di quelle parole in rima. Questo ci
porta ad affrontare due questioni, entrambe già autorevolmente discusse. La prima è se
la rima, come sostiene Jakobson, abbia sempre un significato, oppure se ce l’abbia
soltanto occasionalmente. Ognuno ha infatti esperienza del fatto che spesso la rima
mette in relazione parole il cui accostamento è molto poco significativo: è evidente che
la rima cielo : ne lo / punto (Par. XI, 13-15) significa in sé poco o nulla dato che uno
dei rimanti è fortemente desemantizzato, ma si limita ad ottemperare all’obbligo
generalizzato della rima. Per questo Bertinetto, ad esempio, conclude prudentemente:
«si può dare il caso che in un certo testo la rima postuli l’esistenza di tutta una fitta
trama di rapporti semantici; mentre in un altro testo tali rapporti possono essere assenti,
senza minimamente pregiudicare con ciò il volto del fenomeno dal punto di vista della
sua individuazione» (p. 53). Tuttavia non si può neppure dire che abbiano del tutto torto
Jakobson o Lotman nel sostenere che la rima ha sempre un significato, poiché senz’altro
«tutto ciò che è strutturale-significante nell’arte viene semantizzato» (LOTMAN, p. 155).
La questione, anzi, è anche più generalizzata proprio nell’essere una questione generale
di semiotica: riconoscere che un certo ordine di elementi, come ad esempio la rima, ha
talvolta un significato implica necessariamente riconoscere che ha sempre, in qualche
misura, un significato. Non si danno sistemi semiotici i cui segni possano
occasionalmente non avere significato: sarebbe come dire, per fare il solito esempio
linguistico, che il linguaggio verbale possa di quando in quando tollerare
nell’espressione parole senza significato, significanti puri, mentre un significante senza
267
significato non può esistere affatto (il significante è tale soltanto in virtù del suo farsi
veicolo di un significato: si tratta della nota questione dell’unità del segno). Possiamo
dunque concludere, di nuovo grazie ad una prospettiva prettamente semiotica, che
proprio l’indubbia possibilità di attribuire in certi casi una dimensione semantica
all’artificio stilistico della rima genera sempre in chi legge, in qualche misura,
un’aspettativa di significato, almeno fintanto che essa fa sistema: proprio la sua
sistematicità, per implicare un significato talvolta, deve implicarlo in qualche misura
sempre. Il sistema-rima, insomma, porta all’esito paradossale di attribuire un qualche
significato “accidentale” anche a ciò che non intendeva averlo nelle intenzioni
dell’autore: la rima cielo : ne lo risulta strana, insolita, eccezionale proprio perché ci
porta ad attribuire un qualche rilievo semantico alla sequenza “ne lo” che in se stessa
non ce l’ha. Anzi, la rima può continuare ad avere un significato pieno anche nel
Novecento proprio perché “viene dopo”, perché rimanda ad un sistema (pur superato),
perché insomma presuppone una tradizione alle sue spalle, a differenza dell’omoteleuto
classico che, “venendo prima” della rima come sistema, non genera affatto la stessa
aspettativa di significato284.
Veniamo alla seconda questione. Se è vero che l’artificio della rima genera un suo
proprio significato, è molto interessante capire quale sia il rapporto che lega le parole in
rima a generarlo (la situazione è riassunta in BERTINETTO): per Hopkins tra i rimanti
deve avvenire un confronto per somiglianza o dissimiglianza di significato; per
Jakobson tale rapporto, invece, è di tipo metaforico oppure metonimico; per Cohen,
metaforico; per Chatman il tipo di relazione semantica non è specificato; per Wimsatt
invece è essenzialmente antitetico (come lo era per Tytjanov). Innanzitutto, però,
bisogna chiarire preliminarmente una questione su cui un po’ tutti fanno confusione: il
significato della rima in sé dipende unicamente dall’accostamento dalle parole coinvolte
in rima e non dal loro rapporto con il contesto (il verso, la frase, il componimento ecc.):
il significato sacrale della rima Cristo : Cristo o quello dissacrante dell’esempio di
Gozzano può essere intuito anche da chi non abbia letto i passi in cui esse compaiono.
Qui la prospettiva semiotica si rivela di nuovo molto utile: nel suo costituire un
sottocodice, ossia una semiotica connotativa (secondo l’espressione di Hjelmslev), il
sistema della rima crea dei significati ambigui e imprecisi, benché effettivi (si tratta
della cosiddetta “ambiguità” del segno), poiché i suoi significati non sono lessicalizzati
284
Sulla “rima” nella poesia classica cfr. GUGGENHEIMER, E., Rhyme Effects and Rhyming Figures: A
Comparative Study of Sound Repetitions in the Classics with Emphasis on Latin Poetry, The Hague-Paris,
Mouton, 1972.
268
dal codice ma intuiti di volta in volta dal fruitore. Tale genere di attribuzione di
significato (abduzione) avviene cioè per ipocodifica285. Proprio per questo, il rapporto
semantico che lega le parole in rima non avviene sulla base di uno schema complessivo,
ma è intuito caso per caso sulla base delle possibili interazioni fra le parole coinvolte
dato il loro semplice accostamento. Sta insomma all’interprete azzardare il possibile
significato dell’accostamento (in questo aspetto, ossia limitatamente al procedimento
interpretativo, sta l’affinità con la metafora non convenzionale). L’accostamento c(u)ore
: amore, allora, sarà interpretato in senso metonimico perché quella è la relazione ovvia
che si stabilisce fra queste due parole; l’accostamento Cristo : Cristo avrà valore
eufemistico e sacrale proprio nel suo essere riconosciuta come identità, da cui si può
inferire il significato che il nome del Dio-uomo non può essere “contaminato”
dall’accostamento con qualsiasi altra cosa, al confronto necessariamente triviale e
svilente; Nietzsche : camicie avrà un opposto significato in virtù dell’antitesi e della
differenza di ambito fra i due termini coinvolti, per cui sarà interpretato come un
accostamento dissacrante ma al contempo amaramente ironico; l’accostamento dolcezza
: amarezza sarà letto a sua volta come un’antitesi oppure un ossimoro, ma stavolta
senza nessuna risonanza ironica; riso : paradiso sarà un accostamento metaforico, e così
via286. In breve, il sistema-rima codifica l’esistenza di una relazione tra i rimanti, ma
non codifica il tipo di relazione che fra essi si stabilisce, lasciandone l’individuazione
caso per caso all’interpretazione di chi legge (il che non vuol dire che tale
interpretazione sia poi arbitraria, ma soltanto che è demandata all’“azzardo”
dell’interprete, condotto sulla solida base del significato delle parole e delle loro limitate
interazioni possibili). Ciò non toglie che in certi contesti fortemente convenzionali,
come è stato evidenziato per la poesia italiana del Duecento, i significati attribuibili alle
serie rimiche finiscano per essere provvisoriamente codificati, ossia lessicalizzati,
proprio in quanto ripetitivi, secondo lo stesso processo per cui dalla metafora si passa
alla sua forma lessicalizzata, la catacresi.
Veniamo infine alla questione del senso della rima. I significati che abbiamo
individuato per le serie rimiche, essendo attribuibili ad ogni serie indipendentemente dal
suo impiego effettivo, restano per così dire “in sospeso” finché non vengono a interagire
285
ECO, U., Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano, 2008 [1975], p. 191:« l’ipocodifica può
essere definita come l’operazione per cui in assenza di regole precise, porzioni macroscopiche di certi
testi sono provvisoriamente assunte come unità pertinenti di un codice in formazione, capaci di veicolare
porzioni vaghe ma effettive di contenuto, anche se le regole combinatorie che permettono l’articolazione
analitica di tali porzioni espressive rimangono ignote ».
286
Si noti che qui si sta parlando della relazione semantica fra le parole in rima, non più – come si è fatto
prima – dello slittamento figurale generato dalla singola parola in rima nel suo essere inserita nel testo.
269
con il contesto specifico in cui sono collocate. Allo stesso modo la parola “Dio”, ad
esempio, ha soltanto un significato potenziale (o meglio, una serie di significati: quelli
lessicalizzati nel vocabolario), ma non esprime un pensiero compiuto, ossia non ha in se
stessa un senso: lo acquisisce solo quando viene collocata in frasi come “Dio esiste” o
“Dio non esiste” (che infatti hanno senso opposto). Ugualmente, il senso della rima
dipenderà dal rapporto del suo significato con il contesto: il verso, innanzitutto, ma
anche la frase, la strofa, l’intero componimento, talvolta persino l’opera nel complesso.
Anche sistemi di rime quasi obbligati oppure molto convenzionali e ripetitivi come
quelli del Duecento italiano, se anche hanno sempre lo stesso significato come serie,
cambiano però senso nell’incontrarsi col contesto, da cui nascono tutte le possibilità di
significazione e di originalità. La concezione semantica della rima parla indistintamente
di “significato” della rima tanto per l’interferenza che si genera fra le parole in rima
quanto per il loro rapporto con il contesto: ciò, tuttavia, è decisamente fuorviante perché
impedisce di analizzare adeguatamente il rapporto reciproco che si instaura tra il livello
linguistico del significato e l’apporto in tal senso del sistema-rima, dunque tra il codice
e uno dei suoi sottocodici. Il significato di un segno, infatti, che è una proprietà
intrinseca al segno stesso una volta che esso è posto come tale, è qualcosa di
radicalmente distinto dal suo senso, che invece dipende dall’uso effettivo che se ne fa,
in rapporto al contesto e all’intenzione soggiacente all’espressione (“produzione
segnica”) 287 . Per tornare alla rima e al solito esempio dantesco, il significato
eufemistico, sacrale e persino metafisico che è possibile attribuire a priori alla rima
tautologica Cristo : Cristo ha di volta in volta un suo senso nei tre passi in cui occorre e
più in generale nel contesto del poema sacro; la serie rimica sempre dantesca tristo :
Cristo : malacquisto nel terzo sonetto della contesa con Forese (Rime, 28) ha invece,
evidentemente, un significato opposto, dissacrante e quasi blasfemo. Entrambe le serie,
tuttavia, hanno un senso, per quanto antitetico, entro il loro contesto: il rimante Cristo
acquista il suo senso dal rispettivo rapporto con un verso come ma chi prende sua croce
e segue Cristo (Par. XIV, 106) oppure che gli appartien quanto Giosepp’a Cristo
(Rime, 28, 11), una doppia bestemmia che, neppure troppo implicitamente, dà del
cornuto al primo e del bastardo al secondo; le due serie rimiche, a loro volta, sono
287
Purtroppo in ambito semantico e semiotico c’è ancora molta imprecisione, non solo terminologica,
nell’uso delle categorie di significato e senso, risalente almeno al celebre scritto di FREGE Über Sinn und
Bedeutung, «Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik», 100 (trad. it. in Logica e aritmetica,
Torino, Boringhieri, 1965). Per il concetto di senso di un segno, come qualcosa di nettamente distinto dal
suo significato, si fa qui riferimento soprattutto alla concezione di Prieto: «L’influence que l’émetteur
essaie d’exercer sur le récepteur en produisant un signal [= un segno] n’est autre chose que ce qu’on
appelle le sens de se signal» (PRIETO, Pertinence et pratique. Essai de semiologie, p. 24).
270
coerenti con i contesti in cui si inseriscono e soprattutto contribuiscono, con un loro
proprio apporto di senso, alle due diverse e opposte strategie significative che i rispettivi
testi mettono in atto. Come si vede, la serie rimica blasfema della contesa non potrebbe
stare nel contesto alto e sacrale del Paradiso e viceversa, proprio perché il significato
della serie non avrebbe senso in rapporto al contesto.
È sufficiente a delineare la natura semiotica della rima aver distinto i piani
fondamentali del significante, del significato e del senso, la cui confusione ha spesso
portato a fraintendimenti, imprecisioni, incomprensioni. L’indagine del sistema
semiotico della rima potrebbe continuare individuando il suo lessico (tutti i paradigmi di
rime, ossia l’insieme delle parole che rimano in una certa lingua, come possibilità
virtuali di significato), la sua sintassi (gli schemi codificati delle rime: baciata, alternata,
incrociata, terzina, ottava ecc.), l’effettivo sintagma che essa produce (le serie rimiche
attualizzate nel testo) e così via, ma significherebbe soltanto complicare inutilmente il
discorso nel rapportarsi a un sistema che in effetti, poi, è molto poco codificato, essendo
soltanto un sottocodice di un codice molto più ampio e complesso, la lingua poetica.
Basti notare, per concludere, che anche la terminologia tecnica della rima risulta spesso
carente o molto confusa proprio perché non se ne è mai individuata la parziale
autonomia di (sotto)sistema semiotico; in particolare, è lampante come manchi la
possibilità di distinguere chiaramente tra il livello del codice e quello dell’espressione,
ossia della rima come fatto di langue oppure di parole: il termine “rimante”, ad
esempio, si riferisce alla parola “vita” del primo verso della Commedia in opposizione
soltanto a “smarrita” o a tutte le altre parole italiane che rimano in -ita? Ma
naturalmente la terminologia è solo un fatto secondario: ciò che importa è riconoscere
come la rima si sia strutturata in un sistema coerente e articolato sempre in rapporto a un
senso, e mai come puro artificio tecnico autoreferenziale. Essa pertanto non può essere
liquidata come un orpello insensato della tradizione o come un artificio la cui unica
dimensione sia la constatazione della sua realtà storica.
271
272
7. Appendice 3:
Un caso esemplare: la sestina lirica
La sestina lirica è un esempio eccellente per capire come un’analisi meramente
semantica della rima sia insufficiente, ma sia invece necessaria una sua analisi
complessiva in una prospettiva semiotica. In quanto forma metrica, infatti, essa
costituisce una fenomeno-limite della rima: la sua parola-rima, istituzionalizzando e
generalizzando la rima tautologica (o univoca), si priva del tutto della dimensione
semantica: se come abbiamo visto la rima Cristo : Cristo nella Commedia ha un
significato molto pregnante, sacrale e persino filosofico, proprio perché occasionale, in
quanto inserita in un contesto dove la rima tautologica è ovviamente del tutto
eccezionale, la rima costante di una parola con se stessa nella sestina non può che
perdere ogni significato, proprio per il suo generalizzarsi. Che significato si può
attribuire alle serie rimiche vento : vento : vento… o luna : luna : luna…?
Evidentemente nessuno: avrà un significato la parola in quanto segno linguistico, ma la
rima in sé, in quanto ripetizione di quella parola a fine di verso, non ha alcun
significato. Questo però non vuol dire, tuttavia, che la sestina diventi un mero esercizio
di abilità tecnica, di difficoltà, come spesso la si considera: essa infatti, pur non avendo,
in quanto rima, un suo significato, conserva tuttavia un senso, ossia un rapporto
motivato con il contesto, innanzitutto quello del verso, ma anche quello della strofa e
dell’intero componimento.
Ma qual è dunque questo rapporto? Qual è l’effetto che l’impiego della parolarima genera sul contesto, qual è il suo apporto? Esso è proprio quella che abbiamo visto
essere la funzione essenziale della rima, la sua vera ragion d’essere: quella figurale. Se
la rima non ha più significato in sé, ma recupera soltanto un senso in rapporto al
contesto, ecco che all’annullarsi della sua dimensione semantica corrisponde un
proporzionale emergere della sua funzione figurale, che deve a questo punto garantire
essa sola un senso, senza più l’ausilio di un significato. La variazione determinata dalla
parola-rima nelle sue occorrenze nelle diverse strofe della sestina, infatti, non è una
variazione semantica, come potrebbe sembrare, ma una variazione figurale: vengono
sfruttati nella massima pienezza non i significati della parola, ma le sue potenzialità
figurali, i suoi significati connotativi: ora letterale, ora metaforico, ora in una
similitudine, ora metonimia ecc. Il senso della parola-rima dipende unicamente
dall’attrito con il contesto, che pertanto esaspera la natura eminentemente figurale della
273
rima. La sestina, insomma, istituzionalizza l’uso della parola in tutto il suo peso di
parola poetica; potremmo dire che istituzionalizza la polisemia, ma non la polisemia
lessicale, da vocabolario (le parole-rima della sestina sono in genere delle più semplici e
dal significato tendenzialmente univoco), bensì la polisemia figurale: la medesima
parola deve essere sfruttata in tutta la pienezza delle sue potenziali connotazioni,
guardata contemporaneamente da tutte le prospettive poetiche, in una sorta di sintesi
“cubista” del suo potenziale figurale.
A riprova di una simile interpretazione si possono portare due argomenti a mio
parere probanti. In primo luogo, la sestina lirica (salvo rare eccezioni) limita il ricorso
ai soli sostantivi per la parola-rima. Questo, di nuovo, non è affatto un vincolo di
difficoltà, ma una convenzione che acquista chiaramente un senso in relazione
all’interpretazione semiotica e figurale qui avanzata: il sostantivo è infatti la parte del
discorso che per eccellenza si presta alla metafora, all’elaborazione figurale, all’uso
connotativo; l’aggettivo, ad esempio, essendo per lo più già di per sé connotativo,
difficilmente permette una sua ulteriore connotazione; il verbo, invece, ha in genere
minore duttilità all’uso figurale, spesso tra l’altro già lessicalizzato e dunque
poeticamente più banale, meno produttivo (si pensi ad esempio al verbo “volare” nella
sua comune connotazione di “affrettarsi”, priva di qualsiasi spessore, a fronte del
sostantivo “volo” nel folle volo dell’Ulisse dantesco, che a quella connotazione più
ovvia assomma almeno anche quella conoscitiva di “volo della conoscenza”, non senza
contrapporsi a livello tematico all’opposto volo che porterà Dante alla salvezza e alla
visione di Dio…). La scelta cade sul sostantivo, dunque, proprio perché è la sola parte
del discorso che certamente, assurgendo a parola-tema, può garantire sei diverse
declinazioni figurali di una stessa parola. Questo, naturalmente, implica anche che la
scelta delle parole-rima debba essere molto accurata proprio per trovare dei sostantivi
ricchi di potenziali risonanze figurali.
In secondo luogo, c’è un’ulteriore proibizione, legata alla precedente, che di
nuovo si spiega soltanto in rapporto alla figuralità della rima: la sestina evita
sistematicamente la rima equivoca (ossia la rima semantica per eccellenza, quella dove
varia il significato senza che vari il significante della parola), che pure sembrerebbe una
ovvia risorsa della parola-rima (come avviene sistematicamente, ad esempio, nel sonetto
RVF 18, tutto giocato su rime equivoche) se il suo senso fosse quello di una difficoltà
da superare dimostrando abilità tecnica; come parola-rima, insomma, “morte” sarà
sempre sostantivo e mai participio, “sole” a sua volta non sarà mai aggettivo, secondo
274
un’aequivocatio pur frequente, altrove, nel Canzoniere petrarchesco, ecc. Ciò avviene
appunto perché la rima equivoca immediatamente darebbe un significato alla rima,
coinvolgendo due diversi significati lessicali in interferenza, mentre la sestina è appunto
il grado zero della dimensione semantica della rima, è la rima senza significato, dove
ciò che interessa è solo la sua portata figurale: la portata figurale di una sola parola, di
una solo denotatum, e non di due parole omofone (una delle quali risulterebbe dunque,
per così dire, fuori tema). Consentire la rima equivoca significherebbe, cioè, tornando
ad implicare la funzione semantica, incrinare proprio la scelta su cui si fonda la forma
della sestina, quella di usare la rima soltanto nella sua portata figurale, riducendola
dunque a parola-rima.
Prendiamo ad esempio la celebre sestina di Petrarca Giovene donna sotto un verde
lauro (RVF 30) e ripercorriamo la variatio figurale a cui è sottoposta la parola-rima
“lauro”. Nella prima strofa essa ha valore letterale, denotativo, designando la pianta alla
cui ombra Laura siede (ma naturalmente evoca già tutto il sistema di connotazioni nel
contesto dell’opera, nell’essere la parola tematica per eccellenza del Canzoniere):
Giovene donna sotto un verde lauro
vidi più bianca et più fredda che neve.
Nella seconda strofa la parola-rima genera un adynaton, che sottolinea la
persistenza dei pensieri d’amore attraverso la qualità dell’alloro di essere una pianta
sempreverde:
Allor saranno i miei pensieri a riva
che foglia verde non si trovi in lauro.
Nella terza è usata metaforicamente, designando la donna amata in quanto oggetto
di desiderio, e pertanto torna quasi a ridursi a senhal:
seguirò l’ombra di quel dolce lauro
per lo più ardente sole e per la neve,
fin che l’ultimo dì chiuda quest’occhi.
Nella quarta strofa, continuando a designare la donna ma stavolta nel suo negarsi
all’amore, acquista una dimensione più propriamente allegorica, circondata com’è da
altri elementi affini:
onde procede lagrimosa riva,
275
ch’Amor conduce a pie’ del duro lauro
ch’à i rami di diamante, et d’òr le chiome.
Da notare, in quest’ultimo caso, oltre alla compresenza dell’altra immagine
laurana dell’auro/oro, la duplice contaminazione nell’ultimo verso tra denotazione e
connotazione: i rami del lauro, come spesso in Petrarca, sono qui anche metafora delle
braccia di Laura, mentre subito dopo le fronde della pianta sono espresse con il termine
“chiome”, ossia una metafora nella metafora il cui livello connotativo –
l’antropomorfizzazione del lauro – torna a ribaltarsi e a corrispondere alla denotazione –
la donna – della metafora/allegoria complessiva in cui essa è inserita (salvo poi
accompagnarsi all’ulteriore metafora dell’oro, denotativa entro l’allegoria del lauro,
connotativa invece in quanto metafora dei capelli biondi della donna). Siamo qui
davvero al limite delle potenzialità del linguaggio figurato.
Nella strofa successiva della sestina il “lauro” è ancora la donna, ma è anche, per
metonimia, il legno della pianta; accompagnandosi all’aggettivo “vivo”, infatti, genera
di nuovo un’interferenza tra denotazione e connotazione, tra donna e pianta di alloro:
l’idolo mio, scolpito in vivo lauro
dove per di più l’essere un idolo, un’immagine scolpita, avvicina la metafora della
donna ad un vero e proprio emblema di se stessa.
Nella sesta strofa il “lauro” non indica più la donna ma torna ad essere a tutti gli
effetti un simbolo, che designa la poesia e in particolare la memoria perpetuata dal canto
per far forse pietà venir negli occhi
di tal che nascerà dopo mill’anni
se tanto viver po’ ben cólto lauro,
senza dimenticare anche qui il gioco di interferenza fra letterale e metaforico che,
rivitalizzando la metafora “morta” del “coltivare la poesia”, la volge anche nel suo
senso originario di “coltivare” una pianta, quella appunto dell’alloro.
Nella
tornata,
infine,
la
tendenziale
proibizione
dell’aequivocatio
è
eccezionalmente sospesa in virtù del peso tematico della parola “lauro” nel Canzoniere,
per poter essere sottoposta al consueto gioco fonico di rilettura che la reinterpreta come
articolo più sostantivo, trasformandolo nell’altra immagine laurana dell’oro dei capelli
biondi: significativamente, però, ciò accade appunto quando la parola non è più in sede
276
di rima ma a inizio verso, dove non genera più interferenza semantica con le altre
parole-rima:
L’auro e i topacii al sol sopra la neve
vincon le bionde chiome presso agli occhi
che menan gli anni miei sì tosto a riva.
Riassumendo, la parola-rima “lauro” genera nell’immaginario del poeta le
seguenti variazioni figurali: nell’ordine, significato letterale, adynaton, senhal,
allegoria, metafora/metonimia, simbolo della poesia e infine paronomasia in una
posizione che desemantizza la sua portata semantica. Naturalmente l’esempio è
particolarmente evidente nel coinvolgere una parola di grande importanza tematica
nell’opera, ma il procedimento è lo stesso per qualsiasi parola-rima di una sestina. Nella
sestina doppia RVF 332, le parole-rima scelte si rivelano tanto produttive da consentire
non solo 6 variazioni figurali ma ben 12: il verso et doppiando ’l dolor, doppia lo stile
indica dunque non la difficoltà tecnica, ma appunto il rapporto tra la realtà emozionale e
il suo esito poetico, la trasfigurazione figurale del linguaggio – così evidente ed
esasperata nella forma della sestina – che la media (stile). La sestina lirica dimostra
dunque: 1) come la funzione figurale della rima sia la sua vera funzione fondamentale,
ciò che le garantisce il suo senso, poiché emerge in tutta evidenza proprio quando la
rima perde ogni spessore semantico; 2) come una prospettiva semiotica, e non
meramente semantica, sia fondamentale per capire appropriatamente la portata della
rima, evitando di confondere il suo apporto con quello dovuto invece alla dimensione
semantica del linguaggio.
277
278
6.2. Tentativi di formularità in Trissino
Il sottotitolo della celebre tesi di Milman Parry L’Épithète traditionelle dans
Homère288, il contributo critico che maggiormente ha influenzato gli studi di omeristica
del secolo scorso, gettando le basi dell’immane dibattito novecentesco sull’oralità,
recita: Essai sur un problème de style homérique. Con la progressiva affermazione della
Oral Theory soprattutto in area anglosassone, lo studio della formularità è stato inteso
sempre più nel senso di una possibile soluzione della cosiddetta “questione omerica”,
ossia come una questione prettamente filologica volta a far luce sul più celebre e annoso
“giallo” della storia della letteratura, quello sulla storicità della figura autoriale di
Omero e sulle modalità di formazione del testo dei due grandi poemi che la tradizione
attribuisce a tale figura per come oggi li leggiamo: si è andata progressivamente e
volutamente dimenticando, in sostanza, la parola che nel sottotitolo di Parry designava
con chiarezza il tipo di approccio e l’ambito di analisi nella prospettiva originaria dello
studioso americano. Si è insomma gradualmente trasformata in una questione
eminentemente filologica – già a partire dai successivi Studies dello stesso Parry289 e poi
dal contributo del suo collaboratore e continuatore A. B. Lord290 – quella che in origine
intendeva essere prima di tutto una questione di stilistica. Oggi, quando si sta ormai
superando la prospettiva oralistica, almeno nella sua concezione più rigorosa, possiamo
forse ipotizzare e auspicare un recupero dello studio critico di formularità e dizione
omerica alla stilistica, dove tali fenomeni testuali siano studiati per se stessi, nella loro
propria e legittima dimensione estetica e letteraria, anziché essere sviliti in argomenti
finalizzati a sostenere delle tesi ad essi estranee291. D’altronde, storia della filologia a
parte, in una tale prospettiva si è mossa da sempre, di necessità, la ricezione letteraria
288
Les Belles Lettres, Paris, 1928, trad. ingl. in The Making of the Homeric Verse: The collected Papers
of Milman Parry, edited by ADAM PARRY, Oxford, Clarendon Press, 1971, pp. 1-190.
289
Studies in the Epic Technique of Oral Verse-Making. I. Homer and Homeric Style. II. The Homeric
Language as the Language of an Oral Poetry, in The Making of the Homeric Verse cit., pp. 266-324 e
325-364.
290
The Singer of Tales, Cambridge, MA, Harvard Univ. Press, 1960, trad. ital.: Il cantore di storie, Lecce,
Argo, 2005.
291
In tal senso muove, in maniera forse fin troppo audace nel liquidare l’oralismo, V. DI BENEDETTO, Nel
laboratorio di Omero, Torino, Einaudi, 1994.
279
dei poemi omerici: imitatissimi non solo nell’antichità, ma anche – almeno in Occidente
– dal Rinascimento in poi fino ai nostri giorni, essi sono stati considerati dagli autori
successivi semplicemente nella loro dimensione testuale, l’unica realmente pertinente
alla prassi letteraria e al suo confrontarsi con la tradizione. Sin dall’antichità, insomma,
si è creata una netta discrepanza fra la prospettiva adottata dagli studi critici, che
ponendo al centro del loro dibattito la questione omerica hanno sempre sancito una
problematica alterità di Iliade e Odissea rispetto a tutta la letteratura successiva, e l’uso
che dei poemi omerici ha fatto, invece, proprio quella stessa letteratura successiva, che
al contrario li ha trattati esattamente come qualsiasi altro testo, ossia come un corpo
organico, unitario e del tutto aproblematico nella sua realtà testuale 292 . E questo
rapporto in un certo senso schizofrenico, che fa di Omero al contempo il massimo
autore della letteratura occidentale e un autore inesistente, non ha mancato di esercitare
effetti negativi e deformanti sullo studio non solo dei poemi omerici in se stessi, ma
appunto anche della loro influenza letteraria su autori successivi; un caso clamoroso fra
tutti: gli studi critici sull’Eneide virgiliana, opera integralmente concepita su un
rapporto pervasivo e talvolta capillare con i poemi omerici, prescindono puntualmente
da questi due imprescindibili ipotesti, in particolare proprio sul versante stilistico e sulla
formularità come tratto di stile epico 293 . Proprio la formularità, invece, essendo
immediatamente identificabile alla lettura come un aspetto imponente dello stile
omerico, con l’affermazione di Omero come modello epico per eccellenza spesso è stata
di fatto recepita, a livello letterario, come un tratto tipico dello stile epico tout court.
Analizzarla soltanto come un fatto (un espediente di mnemotecnica legato a contesti di
oralità) anziché come un elemento stilistico dotato di senso a livello testuale (e dunque
di una pertinenza in primo luogo estetica) porta inevitabilmente – oltre che forse a non
comprendere la vera essenza di un fenomeno che, pur legato in origine all’oralità, resta
nondimeno un fenomeno stilistico – a trascurare o travisare la sua influenza sullo stile di
autori successivi che imitano Omero non solo negli elementi strutturali e narrativi ma
anche a livello di dizione.
292
Vale la pena di ricordare la presunta eccezione del finale delle Argonautiche di Apollonio Rodio, dove,
secondo alcuni, il letterato che è al contempo filologo farebbe terminare il suo poema con un richiamo al
verso odissiaco (XXIII, 296) con cui il poema omerico si concluderebbe secondo una dubbia tradizione
alessandrina, quasi ad affermare tramite il mezzo della letteratura una tale tesi filologica; in realtà la
debolezza del presunto richiamo intertestuale prova appunto l’opposto, ossia che la questione critica qui
tenta arbitrariamente di accampare i suoi diritti al di là del lecito, in un ambito letterario che in realtà con
le sue tesi ha ben poco a che fare.
293
Fra i pochissimi studi della formularità in Virgilio, cfr. MOSKALEW, W., Formular language and
poetic design in the Aeneid, Leiden, Brill, 1982.
280
Uno di questi imitatori è senz’altro Gian Giorgio Trissino. Anzi, al di fuori della
produzione letteraria greca antica di stampo marcatamente omerizzante, egli è senza
dubbio uno degli imitatori più aderenti al modello non soltanto, come abbiamo visto,
nelle macrostrutture narrative, ma anche a livello stilistico, in un rapporto che egli
d’altronde afferma esplicitamente tanto nel poema, quanto negli scritti teorici. Basta
leggere qualche manciata di versi tratti da qualunque luogo dell’Italia liberata per
notare immediatamente l’evidente alterità stilistica rispetto alla tradizione letteraria
italiana. La dizione del poema è complessivamente plasmata, come e forse ancor più
che le strutture narrative, su quella omerica: i risultati in questo caso sono davvero
disastrosi, molto più di quanto non avvenga a livello strutturale, dove invece alcune
geniali intuizioni – pur mal realizzate e frammiste a tanti clamorosi errori – aprono
senz’altro la strada al capolavoro tassiano. Ma anche in questo ambito l’inedito rapporto
con Omero intuisce nello stile iliadico, con un’acutezza talvolta davvero sorprendente,
alcuni aspetti fondamentali che l’omeristica metterà adeguatamente in luce solo secoli
dopo.
Un caso clamoroso, a metà fra la stilistica e il topos narrativo (ma piuttosto
distinto dai grandi e notissimi topoi epici di tradizione millenaria), sono le cosiddette
“scene tipiche”, di cui l’omeristica sembra essersi a stento accorta prima che alcuni noti
contributi le portassero all’attenzione degli studiosi294: ben prima di loro, il Trissino
mostra di averne perfettamente individuato le forme principali, imitandole proprio nella
loro tipicità e ricorsività. Forse ancora più sorprendente agli occhi dell’omerista apparirà
la consapevolezza da lui dimostrata, su suggerimento di Aristotele, della varietà di
componenti linguistiche che contribuiscono a formare la lingua letteraria artificiale e
mista dell’epica greca arcaica, tanto che egli ne imiterà la mescolanza di elementi
dialettali di provenienza diversa (in prevalenza ionici, eolici e arcadici, ma non solo)
contaminando in maniera parallela elementi dei vari dialetti italiani, d’altronde in
perfetta coerenza con la sua celebre (e perdente) proposta antibembesca di una lingua
letteraria cortigiana che fosse una koiné risultante dalle principali varietà regionali di
italiano colto. Quasi sorprendenti le sue parole a riguardo nella Prima divisione della
sua Poetica, scritte in un epoca che naturalmente non poteva avere neppure
lontanamente le nostre conoscenze di dialettologia greca per una lingua che era stata da
pochi decenni riscoperta:
294
Mi riferisco in particolare a AREND, W., Die typischen Scenen bei Homer, Problemata, 7, Berlin, 1933
e, per la specifica scena della vestizione delle armi, ARMSTRONG, J. L., The Arming Motive in the Iliad,
AJPh 19 (1958), pp. 337-54.
281
Ma le parole che sono in uso e non se ritruovano ne gli autori, avegna che sempre fosse licito, e
sempre sarà, ponere ne’ suoi scritti qualunque parola che sia da l’uso presente accettata e signata, non di
meno è buono considerarle in due modi: l’uno è che o sono comuni a tutte le lingue o particulari di una;
l’altro, che o sono proprie o trasportate; e se sono comuni a tutte le lingue, si ponno sicuramente usare,
siano di che lingua si voglia; come è “nosco” et “adarsi”, verbo che vuol dire accorgersi, le quali sono
parole lombarde, e così de l’altre; e queste specialmente stanno bene ad usarsi ne lo eroico, nel quale la
varietà di lingue, come dice Aristotele, si ricerca…295
Ma in uno studio così attento del modello omerico e in un’aderenza tanto stretta
non poteva mancare di essere individuato e imitato – in quanto fatto stilistico, come
dicevo – quel fenomeno distintivo e pervasivo della dizione omerica che è la
formularità. Su questo aspetto, già acutamente osservato da Zatti296, disponiamo oggi
anche del recentissimo repertorio di Vitale sull’omerismo stilistico e più in generale
sulla lingua dell’Italia liberata 297 . Come è avvenuto anche per la Gerusalemme
conquistata, l’aspetto stilistico è stato decisamente meglio studiato che non quello
strutturale, data anche la maggiore facilità dell’analisi, tanto più con gli odierni
strumenti di ricerca informatici. Ciò nonostante, è forse utile qualche ulteriore
precisazione sull’argomento.
Sin dallo studio di Parry citato sopra da cui origina l’oralistica, è chiara la
distinzione fra la formularità omerica per così dire “autentica”, espressione di uno stile
“tradizionale” connesso all’oralità, e la formularità “imitata” e “stilizzata” di autori
successivi che con l’oralità non hanno più nulla a che vedere, come Apollonio Rodio e
Virgilio. Il grande merito della studioso, com’è noto, è di aver intuito la stretta
correlazione in Omero tra formularità ed esigenze metriche, riconducendo poi questo
rapporto – soprattutto nella sua coerenza interna (economia) e imponenza quantitativa
(estensione) – ad uno stile “tradizionale”, che in seguito sarà collegato in maniera più
295
L’osservazione dipende dalla considerazione di ARISTOTELE sulle “glosse” (prestiti da altri dialetti)
nella sezione linguistica e stilistica della Poetica (capp. 20-22) e da 1459b, 34-36: tÕ g¦r ¹rwikÕn
stasimètaton kaˆ Ñgkwdšstaton tîn mštrwn ™st…n (diÕ kaˆ glèttaj kaˆ metafor¦j dšcetai
m£lista· peritt¾ g¦r kaˆ ¹ dihghmatik¾ m…mhsij tîn ¥llwn).
296
Cfr. ZATTI, S., L’imperialismo epico del Trissino, in L’ombra del Tasso, cit. pp. 108-109: « Il discorso
appena concluso sulla similitudine chiama in causa un’ultima considerazione sull’altra marca tipicamente
omerica dell’Italia, quell’iterazione di formule discorsive e descrittive rituali che è stata oggetto del
fastidio di molti lettori e, in particolar modo, bersaglio delle famose, feroci beffe di Croce. Tuttavia, se si
accetta per paradosso di rovesciare l’impostazione crociana, allora potrebbe persino scaturirne il miglior
elogio per il Trissino, proprio per la sua intuizione di un’epica omerica “formulare” ».
297
VITALE, M., L’omerida italico, cit. L’autore si era già occupato della lingua poetica tassiana nella sua
monografia VITALE, M., L’officina linguistica del Tasso epico. La “Gerusalemme Liberata”, «Il Filarete.
Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano» 246, 2 voll.
Milano, 2007.
282
esplicita alle necessità di un contesto di composizione orale298. Il ricorso massiccio a
formule fisse e tendenzialmente prive di doppioni per la stessa sede metrica (il
cosiddetto principio di “economia”) e la disponibilità di formule a coprire un’ampia
gamma di esigenze sintattiche (principio di estensione) si spiega soltanto in relazione
alle necessità di una versificazione orale e almeno in parte improvvisata. Tale necessità,
in contesti di scrittura che non presuppongono più quello stile “tradizionale”, viene
meno, e così anche i sistemi di formule costruiti artificialmente quando non sono più
funzionali alla composizione orale tradiscono perentoriamente, nella scarsa estensione e
nell’incoerenza nell’uso, la loro origine imitativa e “contraffatta”. Naturalmente
l’imitazione trissiniana della formularità omerica rientra in questa seconda categoria,
anche se nel suo saggio Vitale non sembra tener presente la distinzione, lasciando
trasparire un concetto di formula forse troppo generico ed esteso rispetto a quello
originario omerico (pur variamente ampliato e riadattato dopo Parry): spesso infatti,
nelle sue liste tematiche, egli annovera come formule delle espressioni prive di diretti
paralleli se non nel contenuto stereotipo; sarebbe bene chiarire che invece una formula è
tale innanzitutto nell’identità totale o almeno parziale delle parole di cui si compone,
nel caso limite persino nonostante una diversità di contenuto, come in Omero per p…oni
d»mJ (“terra feconda”) e p…oni dhmù (“grasso abbondante”), trattate come una stessa
formula. La formula, insomma, non è il concetto convenzionale e topico, ma
l’espressione convenzionale e ripetitiva di un tale concetto. Non ha dunque molto senso
considerare formulare un’espressione come Italia, XV, vv. 932-933: « Aiutatemi, Muse,
a dir chi foro / i primi ch’egli uccise, e chi i postremi », essendo essa priva di paralleli
nell’Italia (formulare è semmai nell’Iliade da cui è tradotta299). Così anche le formule
per indicare lo spuntare dell’aurora, uno dei tratti più vistosi e celebri della formularità
omerica, mostrano una implacabile necessità di variazione nell’espressione dell’idea
stereotipata che è esattamente l’opposto del concetto di formularità. Ecco qualcuno
degli esempi forniti da Vitale:
La bella Aurora, che ci rende il giorno
fatto avea bianco tutto l’oriente
Poi, come apparve fuor la bella Aurora
coronata di rose in vesta d’oro
298
Questo a partire dai due Studies in the Epic Tecnique of Oral Verse-Making del 1930 e 1932,
ripubblicati in The making of the Homeric Verse, cit.; cfr. in particolare n. I, Homer and Homeric Style,
sez. 6, The traditional oral style, pp. 314-324.
299
”Enqa t…na prîton t…na d' Ûstaton ™xen£rix[en] (3 occorrenze).
283
La bella Aurora con le aurate chiome
rimenava a’ mortali il giorno, e ’l sole
L’elenco continua per un’intera pagina. Ma la varietà degli gli esempi iliadici
riportati in nota da Vitale 300 non sono certo prova della formularità di queste
espressioni, ma al contrario della loro non formularità: l’idea è la stessa, ma espressa
sempre con parole diverse. E gli esempi omerici riportati sono appunto i casi in cui
l’idea dell’aurora trova espressione in maniera non formulare ma più libera, mentre la
formula tradizionale per esprimere lo stesso concetto in Omero è il celebre verso ’Hmoj
d ºrigšneia f£nh ·odod£ktuloj 'Hèj (19 occorrenze perfettamente identiche nella
sola Odissea, 3 occorrenze – di cui una variata – nell’Iliade).
Ancora più clamoroso il caso dei versi che introducono il discorso diretto, che in
Omero notoriamente hanno un grado di ricorsività elevatissimo, tanto da essere stati
definiti dagli oralisti “punteggiatura tradizionale”301: per dare un’idea, la forma base
generica per introdurre la risposta alle parole altrui, TÕn [tὴn] d ¢pameibÒmenoj[-h]
prosšfh + formula epiteto-nome dopo la cesura eftemimere, ricorre identica 50 volte
soltanto con la relativa formula per Odisseo, polÚmhtij 'OdusseÚj (e naturalmente è
applicabile quasi ad ogni altro personaggio) 302 . Le corrispettive formule nel poema
trissiniano sono invece costantemente variate, tanto che la loro diligente catalogazione
in Vitale, scevra di qualsiasi commento, si estende su ben sei fitte pagine303.
Ciò nonostante, il rilievo quantitativo di quanto può essere considerato
propriamente formulare è senz’altro ingente per trattarsi di un caso di formularità
stilizzata e artificiale. Ovviamente nessuno si aspetta che siano rispettati i principi
parryani di economia ed estensione, il cui rigore è stato d’altronde decisamente
ridimensionato dagli studi successivi304; eppure il concorso dell’intelligente intuizione
trissiniana e della sua imitazione stilistica “pedantesca” (in senso proprio) fa sì che
alcuni micro-sistemi formulari si ricreino davvero, presentando in qualche caso un
livello di “economicità” sorprendente per un’opera che con l’oralità non ha il benché
minimo rapporto (neppure quello di lontana memoria di certe formule orali canterine di
300
Op. cit., p. 22, n. 8.
Così ad es. in FOLEY, J. M., Homer’s traditional art, Pennsylvania State University Press, 1999.
302
Cfr. PARRY, M., The Traditional Epithet in Homer, cit., p. 15.
303
VITALE, op. cit., pp. 29-34.
304
Questo sin dalla prima grande fase di risonanza degli studi parryani, ad es. nello studio di
HAINSWORTH, J. B., The Flexibility of the Homeric Formula, Oxford, Clarendon Press, 1968, fino ad
arrivare al netto ridimensionamento del principio di economia nel recente, seppur criticato, FRIEDRICH,
R., Formular economy in Homer. The poetics of the breaches, Hermes: Zeitschrift für klassische
Philologie. Einzelschriften, Stuttgart, Steiner, 2007.
301
284
cui ancora serba traccia il poema ariostesco 305 , nella sua forma definitiva del ’32
contemporaneo alla stesura del poema trissiniano). Si veda in particolare la tendenza
alla formula fissa epiteto-nome in clausola, che è appunto l’argomento della celebre tesi
parryana: nonostante la radicale alterità non solo di lingua e metro, ma persino di
sistema metrico (quantitativo vs accentuativo), la netta tendenza all’individuazione della
clausola come luogo di massima memorabilità entro il verso si rivela un dato
sovraculturale e si vorrebbe dire quasi universale nel garantire la traducibilità di un
simile fenomeno fra sistemi metrici tanto diversi quali quello greco antico e quello
italiano. D’altronde, la “traducibilità” della bipartizione dell’esametro in due formule
giustapposte – solitamente la prima verbale e la seconda del tipo nome-epiteto – è
assicurata dalla parallela bipartizione dell’endecasillabo italiano nei due emistichi che lo
compongono. Una situazione certamente favorevole, che tuttavia il Trissino ha saputo
intelligentemente cogliere e sfruttare al meglio, in questo caso, per il suo tentativo di
imitazione e stilizzazione dello stile formulare omerico (persino nella cosiddetta
“declinabilità” della formula):
Ma poi, com’ ebbe il capitanio eccelso
Cosi fé’ noto il capitanio eccelso
Cosi diss’ egli, e ’l capitanio eccelso
Allora disse il capitanio eccelso:
Il padiglion del capitanio eccelso
La carta in mano al capitanio eccelso
E dopo quella il capitanio eccelso
Come fu nota al capitanio eccelso
A ritrovare il capitanio eccelso
Non dubitate, o capitanio eccelso
(ecc.)
to‹si d' ¢nist£menoj metšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj·
tÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj·
tÕn d' ¥r' ØpÒdra „dën prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj·
t¾n d barÝ sten£cwn prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj·
diogen¾j PhlÁoj uƒÕj pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj·
të kaˆ deiknÚmenoj prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj·
e den, Ót' ™x ”Idhj ¥gagen pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj.
305
Cfr. fra l’altro CABANI, M. C., Le forme del cantare epico-cavalleresco, Lucca, 1988; EAD. Costanti
ariostesche. Tecniche di ripresa e memoria interna nell' "Orlando Furioso", Pisa, Scuola Normale
Superiore, 1990.
285
tÕn d mšg' Ñcq»saj prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj·
oÞj ™pˆ PatrÒklJ pšfnen pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj·
(ecc.)
È pur vero che il massiccio tentativo di imitazione della formularità finisce spesso
per contribuire in modo nefasto alla banalizzazione della dizione, che è senz’altro uno
degli aspetti peggiori del poema trissiniano. D’altronde, come abbiamo già visto per la
pretesa di rendere l’esametro greco con l’endecasillabo sciolto, il verso italiano si rivela
uno spazio metrico troppo angusto anche per riprodurre la grande ricchezza e varietà del
vasto repertorio formulare dell’epica greca arcaica. Epiteti formulari di due o persino tre
parole oltre il nome che accompagnano o anche i tanto caratteristici aggettivi composti
non sono neppure immaginabili nel breve volgere di un emistichio dell’estensione di
quinario o di un settenario; e con essi si perde necessariamente anche tutta quella
straordinaria ricchezza espressiva omerica (ora cristallizzata in una formula secolare,
ora rielaborata più liberamente dal poeta in base alle specifiche esigenze testuali306) che
ha spesso uno straordinario valore evocativo nell’essere quasi un allusivo racconto nel
racconto, capace persino di evocare in due parole la storia di un personaggio (come
πολύτλας, ma forse anche l’enigmatico πόδας ὠκύς), o più spesso le sue doti più
rilevanti sul piano fisico o intellettuale
(πολύµητιj, boὴn ἀgaqόj), le peculiarità
distintive del suo aspetto fisico (γλαυκῶπις, λευκώλενος) ecc. Una grande ricchezza
stilistica che, pur avendo origine essenzialmente dalla tradizione e non nell’autonoma
invenzione del singolo autore, non per questo diventa un elemento stereotipo svilente,
ma costituisce semmai un valido contributo fornito della langue tradizionale alla parole
del poeta, che non ne sminuisca l’originalità ma al contrario valorizza il testo e
amplifica le possibilità espressive, non altrimenti che il riconoscimento in Mozart di una
cellula melodica desunta dalla scuola napoletana o da C. P. E. Bach. Naturalmente di
tutto questo può restare ben poco nella brevità dell’endecasillabo italiano e nella
capacità inventiva di un autore non certo brillante. E allora l’imitazione della
formularità omerica finisce in Trissino per ridursi, complessivamente, ad una colossale
banalizzazione del nesso aggettivale, che riesce a desumere da Omero solo l’equivalente
dei cosiddetti epiteti generici, ossia la parte meno interessante della formularità, mentre
non può ricreare nulla di lontanamente simile agli straordinari epiteti distintivi, quelli
306
Sulla libertà creativa emergente dai poemi omerici nell’impiego del repertorio tradizionale di formule
e sulle sue implicazioni intertestuali per il rapporto dell’Odissea con l’Iliade – aspetti sempre
misconosciuti dai fautori più intransigenti dell’oralismo – cfr. DI BENEDETTO, V., Nel laboratorio di
Omero, Torino, Einaudi, 1994.
286
più belli e spesso giustamente celebri307. Ecco allora che in Trissino non si legge altro
che: l’onorato Achille, l’onorata Areta, l’onorato Magno, il callido Trαiano, il buon
Traiano, il callido Narsete, il cortese Achille, il buon Achille, Corsamonte acerbo,
Corsamonte il fiero, Corsamonte ardito… Non che in Omero non ci sia qualcosa di
simile: c’è tuttavia anche molto altro, ed è proprio ciò che il metro italiano non consente
e che il singolo autore non può ricreare da solo, privo com’è di una secolare tradizione
narrativa capace di compendiare i tratti più caratteristici dei suoi singoli personaggi in
epiteti che alludono a secoli di narrazioni. Evidente anche la distanza da Virgilio, che ad
esempio nel nesso pius Aeneas – solo apparentemente generico – arriva a ipostatizzare il
conflitto tematico portante dell’intero poema.
Tuttavia bisogna senz’altro riconoscere che il meccanismo imitativo imbastito
anche in questo ulteriore colossale ambito d’imitazione, se pure i suoi risultati artistici
sono deboli e spesso disastrosi, è almeno quantitativamente impressionante, oltre a
muovere – come già altre volte abbiamo avuto modo di rilevare – da un’idea tutt’altro
che banale cui segue purtroppo una realizzazione inadeguata. Misurarne l’effettiva
estensione richiederebbe un’indagine approfondita che sicuramente non vale la pena di
intraprendere per una tale opera: il repertorio di Vitale, benché in realtà poco attento ai
meccanismi specifici della formularità, è decisamente più che sufficiente; già dalla sola
lettura dell’Italia liberata, tuttavia, si ha l’impressione di un’incidenza quantitativa del
materiale “formulare” davvero impressionante per un’opera interamente concepita e
scritta “a tavolino” da un singolo autore: un’incidenza verosimilmente molto maggiore,
ad esempio, di quella di un Virgilio, che pure a sua volta intende riprodurre spesso la
formularità omerica individuandola come tratto stilistico epico.
Naturalmente non è possibile farne qui un’analisi complessiva, ma un esempio
rilevante può essere di grande utilità per comprendere non solo le dimensioni del
fenomeno, ma soprattutto i suoi meccanismi di funzionamento. In questo il Trissino
mostra una capacità di penetrare lo specifico fenomeno della formularità omerica che
appare decisamente sorprendente, non solo nella quasi profetica analisi palesemente
presupposta dalle modalità stesse della sua imitazione, ma anche nel contributo che ne
può venire a una più generale questione di stilistica della poesia epica.
Nel secondo capitolo della sua tesi principale, Parry propone, come termine di
confronto da cui far emergere per contrasto le specificità dello stile omerico
307
Nella definizione di PARRY, M., The Traditional Epithet, cit., p. 64, un epiteto è detto «generic» se
«can be used to describe any god or any hero», mantre è detto «distinctive» se invece «can be used for
only one god or one hero».
287
“tradizionale”, una breve analisi dei principali sistemi formulari rintracciabili nei poemi
di due autori “non tradizionali”, Apollonio Rodio e Virgilio 308 . Ne risulta una netta
sproporzione rispetto a Omero sia nel rapporto fra elementi formulari (come nome più
epiteto) e non formulari (nome senza epiteto), sia nel rispetto di estensione ed economia
dei sistemi formulari: Parry porta questa diversità come prova dell’alterità radicale fra
stile “tradizionale” e “non tradizionale”, in un’opposizione che in seguito sarà
reinterpretata nei termini di oralità vs scrittura. Possiamo allora condurre una breve
analisi dello stesso tipo sul poema trissiniano, per misurarne da un campione
particolarmente rilevante il livello di formularità e di vicinanza allo stile omerico. E
come Parry sceglie i sistemi di formule nome-epiteto per i nomi dei rispettivi
protagonisti in Apollonio e Virgilio, così noi possiamo analizzare in parallelo il sistema
costruito dal poema vicentino per il suo (presunto) protagonista, Belisario.
Nell’Italia liberata il termine capitano/capitanio è fortemente specializzato per
designare Belisario, soprattutto nella forma capitanio (su 331 occorrenze di questa
forma, ben 316 sono riferite a Belisario: le eccezioni sono soltanto 15), ed è anzi persino
più frequente del nome proprio Belisario (306 occorrenze). Su di esso è costruito un
imponente sistema formulare che, ovviamente, non è desunto direttamente da Omero
attraverso una mera traduzione, ma è creato autonomamente dal Trissino, plasmandolo a
imitazione non tanto di formule omeriche precise ma in generale dello stile formulare.
Consideriamo ora solo la forma capitanio, che d’altronde è anche di gran lunga la
più frequente (331 occorrenze contro soltanto 95 delle forme capitano/capitan); riporto
un breve sunto dell’analisi che ho condotto sul sistema formulare costruito dal Trissino
su questo termine:
A) capitanio:
331 occorrenze, di cui:
316 riferite direttamente a Belisario (solo 15 non riferite a lui):
- capitanio eccelso:113 occorrenze (tutte in clausola eccetto 9)
- eccelso capitanio:17 occorrenze (comprese 2 occorrenze di eccelso
capitan)
- capitanio eletto:15 occorrenze
- gran capitanio: 16 occorrenze (tutte a partire dalla 3a sede)
- illustre capitanio: 22 occorrenze (tutte a inizio verso), di cui:
308
PARRY, M. The Making…, cit., pp. 24-36.
288
- illustre capitanio de le genti: 16 occorrenze
- illustre capitanio de i Romani: 4 occorrenze
- invitto capitanio: 5 occorrenze
- sommo capitanio: 1 occorrenza
Totale per capitanio: 185 occorrenze con epiteto ornamentale; 131 senza epiteto
(o molto raramente con aggettivo non ornamentale)
B) capitano: 21 occorrenze riferite a Belisario
C) capitan: 68 occorrenze riferite a Belisario (su 74 totali)
- gran capitan:17 occorrenze
- invitto capitan (capitanio): 7 occorrenze
- illustre capitan: 17 occorrenze
(seguito da: mastro di guerra, 4x; luce del mondo, 8x):
Delle 316 occorrenze della forma capitanio riferite a Belisario, soltanto 131 sono
prive di epiteto o presentano (cosa peraltro estremamente rara, quasi assente) un
aggettivo strettamente legato al contesto (ossia non “ornamentale”, come ardito o
accorto strettamente legati al contesto, entrambi una sola volta; ho considerato come
prive di epiteto, naturalmente, anche forme come vostro, nostro), mentre ben 185 sono
accompagnate da un epiteto ornamentale. Ciò senza considerare, per di più, che fra le
occorrenze senza epiteto ho calcolato anche un’espressione pur chiaramente formulare
come capitanio de le genti quando priva di un aggettivo ad accompagnarla. Già solo
questo dato macroscopico si rivela non solo assolutamente confrontabile con quanto
avviene in Omero, dove ad esempio il nome ᾿Οδυσ(σ)εύς compare 334 volte
accompagnato da un epiteto e 343 volte senza, ma mostra addirittura una tendenza
all’epiteto ornamentale ancor più marcata di quanto non avvenga in Omero: Trissino,
insomma, si rivela in questo più omerizzante di Omero. Ricordiamo, per dare idea della
clamorosa sproporzione, le stime fornite da Parry stesso per Apollonio Rodio e Virgilio
ad evidenziare il loro divario da uno stile “tradizionale”: nel primo, per Giasone si
hanno 3 casi con epiteto contro 38 senza (e 5 con contro 59 senza nella forma
patronimica Αἰσονίδης); nel secondo, per Enea 62 occorrenze con epiteto contro 172
senza. Nella sproporzione già soltanto quantitativa fra Omero da una parte e Apollonio e
289
Virgilio dall’altra, Trissino si colloca dunque senz’altro nettamente dalla parte di
Omero, e anzi lo supera nel rapporto fra forme con epiteto e forme prive di epiteto.
Quanto alla forma capitano, nella versione non tronca (21 occorrenze) essa mostra
chiaramente la tendenza ad essere usata senza epiteto (una sola eccezione), mentre nella
forma tronca (68 occorrenze riferite a Belisario) mostra di nuovo una sostanziale
bipartizione fra forme con epiteto ornamentale (35 occorrenze) e senza epiteto o
(raramente) con epiteto contestualizzato (33 occorrenze). Anche considerando la somma
di tutte e tre le forme capitanio, capitano e capitan, abbiamo in totale un rapporto
sostanzialmente paritario fra le forme con epiteto ornamentale (220) e quelle che ne
sono prive (185): anche così il rapporto eguaglia e ancora supera lievemente il dato
omerico, mentre il rapporto in Apollonio e Virgilio è incomparabilmente sbilanciato
verso gli elementi non formulari (in una proporzione di circa 7:1).
Ma ben oltre questo dato generale, possiamo riscontrare anche un vero e proprio
sistema formulare per Belisario, dotato di un’estensione e un’economia assolutamente
paragonabili con Omero. Fra le 185 occorrenze di capitanio con epiteto ornamentale, la
formula capitanio eccelso emerge in assoluta prevalenza: ben 113 occorrenze (più altre
17 nella forma invertita eccelso capitanio) contro soltanto 55 di tutte le altre formule
sommate insieme. L’altra formula equivalente, che occupa la stessa posizione metrica in
clausola (dunque in un “doppione” del tipo qe¦ leukèlenoj “Hrh e boîpij pÒtnia
“Hrh), che è capitanio eletto, ricorre soltanto 15 volte. Si nota inoltre una totale
specializzazione dell’altra formula illustre capitanio (22 occorrenze) per il solo caso
vocativo e per la diversa sede metrica di inizio verso: non compare mai altrove nel
verso. Si badi che la posizione metrica della formula non è affatto obbligata, poiché
teoricamente potrebbe perfettamente trovare posto nell’endecasillabo anche in altri due
luoghi, dalla 3a sede alla 9a e dalla 5a alla 11a (rispettivamente, in due esempi
dimostrativi artificiali, assenti dal poema: *a lui l’illustre capitanio disse e rispose
*rispose a lui l’illustre capitanio): in queste altre sedi possibili, invece, non compare,
mai. La specializzazione per il vocativo, a sua volta, non era naturalmente affatto
obbligata anche lasciando la formula a inizio verso: sarebbe bastato premetterle
l’articolo per farne un nominativo o le preposizioni a, d’(i), da per i casi obliqui (pur
perdendo così l’articolo che in molte occasioni è ovviamente imprescindibile): ciò
nonostante, essa compare sempre e solo al vocativo. L’altra formula equivalente nella
stessa sede metrica, invitto capitanio, compare invece solo 5 volte (contro 22 di illustre
capitanio), e non mostra la stessa specializzazione per il vocativo. L’ulteriore formula
290
gran capitanio (16 occorrenze) è a sua volta specializzata, senza alcuna eccezione, per
la posizione metrica dalla 3a alla 7a sede. Ma anche la formula principale per Belisario,
capitanio eccelso, mostra una fortissima tendenza alla specializzazione per una sede
metrica, di nuovo, niente affatto obbligata: di 131 occorrenze, soltanto 9 non sono in
clausola. Questo dato è davvero sorprendente nel dimostrare da parte di Trissino una
sostanziale comprensione, nel tentativo di riprodurlo, del rapporto tendenzialmente
esclusivo, in Omero, fra la specifica formula e una precisa sede metrica: un rapporto fra
formula e convenienza metrica che alla moderna omeristica non è veramente chiaro se
non a partire da Parry (solo parzialmente anticipato dai suoi precursori ottocenteschi,
Ellendt e Düntzer 309 ). La forma invertita eccelso capitanio, invece, pur molto meno
frequente (15 occorrenze, più altre 2 nella forma tronca eccelso capitan), mostra una
maggiore mobilità, adattando la formula principale alle diverse collocazioni di inizio
verso e di 3a sede: non altrimenti in Omero, come dimostra Haisworth 310 , alla
tendenziale corrispondenza sancita da Parry tra formula e sede metrica fissa si
accompagna un numero minoritario di modificazioni della formula stessa (spostamento,
separazione degli elementi, inversione ecc.) che la adattano talvolta a sedi metriche
diverse.
Si potrebbe obiettare che l’analisi è falsata dal fatto di considerare solo il termine
capitano/capitanio ed escludere invece dal computo il nome proprio Belisario, che
evidentemente esprime la stessa “idea essenziale”, nelle parole di Parry311. In questo
caso il conteggio è molto più rapido perché sul nome proprio di Belisario il Trissino
costruisce un’unica formula, Belisario il grande. Ebbene, il rapporto fra le occorrenze
totali del nome (304) e le occorrenze di questa formula con l’epiteto (146) è di nuovo lo
stesso, la metà, con un dato perfettamente omogeneo a quello visto per il termine
capitano/capitanio e quantitativamente equivalente a quanto avviene in Omero.
L’esempio che abbiamo analizzato del sistema di formule nome-epiteto per
Belisario porta dunque a delle conclusioni di grande interesse. Da una parte, sul
versante specificamente trissiniano, esso presuppone dietro di sé, come abbiamo detto,
un’analisi della formularità omerica di una precisione impressionante, i cui soli termini
di paragone sono gli studi scientifici specialistici condotti soltanto secoli dopo – peraltro
309
ELLENDT, J.-E., Über den Einfluss des Metrum auf Wortbildung und Wortverbindung, Könisberg,
1861; DÜNTZER, H., Homerische Abhandlungen, Leipzig, 1872. Per la discussione delle loro tesi, cfr.
PARRY, M., The Making…, cit., pp. 124 e sgg. e passim.
310
HAINSWORTH, J. B., The Flexibility of the Homeric Formula, cit.
311
La nota definizione parryana della formula, in seguito variamente estesa e rimaneggiata, recita: « The
formula can be defined as an expression regularly used, under the same metrical conditions, to express an
essential idea » (PARRY, M., The Making…, cit., p. 13).
291
con grande ritardo per una questione tanto rilevante – dall’omeristica. Se poi la bellezza
“tradizionale” (espressione che all’estetica moderna può apparire quasi ossimorica)
della formularità omerica si volge inevitabilmente in una mera banalizzazione del nesso
aggettivale, ciò dipende sia dalla mediocrità dell’autore che dalle scarse possibilità della
metrica accentuativa: questo non toglie tuttavia che dietro di essa non ci sia soltanto
un’analisi straordinariamente approfondita, come pure giustamente intuisce, anche in
assenza di un’analisi specifica come quella qui condotta, Sergio Zatti:
…allora potrebbe persino scaturirne il miglior elogio per il Trissino, proprio per la sua intuizione
di un’epica omericamente “formulare”. In ciò il critico geniale riscatta i fallimenti dell’artista, anzi ne è in
qualche modo l’espressione più conseguente.
C’è anche un’altra geniale intuizione, l’idea della possibilità di imitare lo stile
omerico nella poesia moderna, cosa di cui si accorse, con la consueta finezza, il
Tasso312:
…l’Italia liberata del Trissino; del quale io fo molta stima , perchè egli fu il primo che ci diede
alcuna luce del modo del poetare tenuto da’ greci, ed arricchì questa lingua di nobilissimi componimenti.
Se l’effettivo risultato nella prassi poetica trissinana fu decisamente deludente, ciò
tuttavia non inficia di per sé l’intuizione, l’idea teorica che presiede alla composizione.
E lo stesso si può dire anche per l’assenza di qualsiasi seguito a questo suo tentativo
stilistico nella successiva letteratura italiana: come ci insegna Nietzsche, la storia non è
in nessun ambito (e meno che mai in ambito artistico) un adeguato metro di giudizio,
risolvendosi spesso solo in un’apologia di ciò che è avvenuto e in una mera
celebrazione del principio di realtà313.
Ma ben al di là della sua pertinenza al giudizio sul poema trissiniano, il risultato
della analisi qui condotta ha delle conseguenze di ben altro tenore che travalicano
decisamente l’importanza di un autore minore. Esso infatti dimostra perentoriamente
come un poeta che scrive può senz’altro simulare, per imitazione stilistica, un sistema
formulare assolutamente paragonabile – quantitativamente e qualitativamente – con
quello omerico, e ciò senza la benché minima connessione con l’oralità e con la
necessità di improvvisare e dunque semplificare la versificazione: Trissino non solo
312
Lettere, ed. Guasti, n. 211 (A Orazio Lombardelli), corsivo mio.
Cfr. NIETZSCHE, F., Sull’utilità e il danno della storia per la vita, Milano, Adelphi, 2009, pp. 71-72: «
(Hegel) ha instillato nelle generazioni da lui lievitate quell’ammirazione di fronte alla “potenza della
storia”, che praticamente si trasforma a ogni istante in nuda ammirazione del successo e conduce
all’idolatria del fatto ».
313
292
impiega vent’anni per scrivere l’Italia liberata, trovandosi dunque a comporre in una
condizione piuttosto lontana dalla “fretta” dell’improvvisazione, ma oltre a ciò, come ho
detto, concepisce un’opera che va direttamente dallo scrittoio dell’autore alla stampa,
non intrattendendo più alcun rapporto neppure residuale con performances orali come
ne intrattiene ancora, senz’altro, Ariosto, che invece non solo si rapporta con la
tradizione canterina orale testimoniata dai cantari (seppure in maniera ironica e
stilizzata), ma legge il suo poema a corte, in una situazione di ricezione orale di un testo
scritto che si suole definire “auralità” (naturalmente a ciò si affianca poi anche la
ricezione scritta della stampa). Nonostante l’assenza di qualsiasi connessione anche
remota con oralità o anche solo auralità, la sola imitazione stilistica è dunque sufficiente
al Trissino per creare sistemi formulari che mostrano ampi tratti di sovrapponibilità con
il funzionamento della formularità omerica. Se Parry, insomma, avesse scelto non
Apollonio e Virgilio, ma Trissino come termine di confronto per Omero, analizzando il
sistemi di formule per Belisario anziché quelli per Giasone o Enea, la sua tesi di una
connessione necessaria fra il rispetto dei principi di estensione ed economia e la
tradizionalità e dunque l’oralità dello stile sarebbe stata smentita sul nascere.
Questa considerazione, a mio avviso, ha dunque delle rilevanti implicazioni
proprio riguardo a Omero. Se Trissino, scrivendo e mettendo in atto un’operazione iperletteraria e artificiale quant’altre mai, è in grado di ricreare una formularità
quantitativamente raffrontabile con quella di Iliade e Odissea, che dire allora di Omero
stesso? Il testo dei poemi omerici dovrebbe forse richiedere ancora un diretto rapporto
con l’oralità – con una produzione orale, intendo –, se quello stile formulare che
dovrebbe costituire la prova dell’oralità può essere riprodotto artificialmente,
nell’essenza del suo funzionamento e nella sua incidenza quantitativa, da un autore di
secoli successivo, isolato, distante non solo dall’epica greca arcaica ma persino dalla sua
stessa tradizione poetica, per di più mediocre, e che soprattutto crea la sua opera
totalmente per iscritto? Il presupposto fondante dell’oralistica più intransigente – quella
che vede nella formularità e più in generale nei tanti fenomeni di ripetizione, non solo
espressiva, ravvisabili nei poemi omerici una prova della composizione orale di quei
testi (poi variamente affidati solo in seguito alla scrittura o almeno alla dettatura) – mi
pare minata alla base dall’evidenza ravvisabile nel poema del Trissino. Se può fare
qualcosa di simile un mediocre poeta che compone per iscritto, simulando uno stile del
tutto estraneo ai suoi tempi, tanto più l’autore di Iliade e Odissea potrà allora ricorrere a
uno stile formulare che gli è ben altrimenti vicino e affine senza che ciò implichi in
293
nessun modo l’oralità della composizione di quei testi. La formularità, insomma, tanto
nella sua accezione ristretta quanto in quella più ampia dei tanti fenomeni di ripetizione
di elementi standardizzati, prova senza alcun dubbio l’oralità dello stile, ma non prova
affatto l’oralità dei testi composti in quello stile. Uno stile, infatti, è tale innanzitutto in
quanto passibile di imitazione, simulazione, ripresa: serve appunto a comporre “in
stile”, e anzi l’essenza stessa del concetto di stile implica la replicabilità e l’imitazione
da parte di chi decida di aderire a quel determinato stile. E questo è vero per uno stile
orale così come che per uno stile scritto, seppure attraverso modalità certamente diverse.
Anche lo stile orale può essere imitato e continuato persino dopo l’avvento non solo
della scrittura in sé come ritrovato tecnico, ma anche della prassi compositiva scritta:
un’opera composta per iscritto può benissimo imitare lo stile orale. Scrive giustamente a
proposito Vincenzo Di Benedetto:
Ma una volta constatata l’ineffettualità del nesso tra alta frequenza della ripetizione e oralità,
bisogna andare alla radice del problema. Non si vede infatti per quale ragione si debba collegare la
questione dell’alta frequenza delle ripetizioni in Omero alla contrapposizione tra composizione orale e
non orale. Non c’è un motivo valido perché la tendenza alla ripetizione che c’è nei poemi omerici non
debba essere considerata come tutte le altre tendenze formali che si affermano in una certa epoca e/o in
certi ambienti e poi tendono ad atrofizzarsi o scompaiono del tutto. Tutta la storia della letteratura (e in
generale delle arti) è fatta di fenomeni di questo genere.
Dire che lo stile formulare dell’epica greca arcaiaca – che naturalmente non è
artificiale come quello del Trissino – origina dalle necessità della composizione orale,
com’è innegabile, non porta con sé alcuna implicazione sulle modalità di composizione
di Iliade e Odissea. Tali poemi possono essere stati benissimo composti per iscritto e in
maniera unitaria da un autore nel senso proprio del termine (come d’altronde lo sono
Esiodo e i lirici più antichi, attivi sostanzialmente nello stesso periodo a cui risalgono i
poemi omerici o immediatamente dopo) che tuttavia, pur componendo ormai per
iscritto, abbia continuato a comporre nello stile della sua tradizione letteraria, quello
dell’epica greca arcaica. E questo non per una scelta “arcaizzante” – se si può usare
questo termine per Omero –, ma semplicemente perché quello era lo stile poetico che
egli aveva a disposizione, era lo stile del suo tempo, era il suo stile.
Nella storia della letteratura, i cambiamenti riguardanti le modalità pratiche di
composizione e diffusione dei testi influenzano certamente i processi creativi, ma tale
influenza non va sopravvalutata. E comunque sarà opportuno ricordare, tra l’altro, che
l’Iliade menziona un esplicito e perentorio riferimento a ciò che non può essere
interpretato se non come un testo scritto: mi riferisco naturalmente alla tavoletta piegata
294
recante su di sé dei σήµατα che, nel racconto di Glauco314, Bellerofonte porta al re di
Licia da parte del sovrano di Argo: esattamente come l’Amleto shakespeariano, l’eroe è
incaricato di farsi lui stesso portatore inconsapevole del messaggio che decreta la sua
morte:
pšmpe dš min Luk…hn dš, pÒren d' Ó ge s»mata lugr¦
gr£yaj ™n p…naki ptuktù qumofqÒra poll£,
de‹xai d' ºnègein ú penqerù Ôfr' ¢pÒloito.
(Iliade, VI, vv. 168-170)315
Le spiegazioni avanzate dagli oralisti per conciliare questo riferimento con le loro
teorie non sono che un arrampicarsi sugli specchi. Fuorvianti sono la questione (peraltro
ovvia) che il verbo gr£fw non implichi di per sé la scrittura o quella riguardo alla storia
materiale dell’uso di tavolette ripiegabili per scrivere: è evidente che la tavoletta qui
risulta piegata (e implicitamente sigillata, esattamente come la lettera dell’Amleto)
semplicemente perché il portatore non possa leggerla, dal momento che decreta la sua
morte. Poco rilevanti sono anche le ipotesi su quale tipo di scrittura sia implicato, se
quella alfabetica o la lineare B micenea o altra316. Ciò che conta è invece la natura del
messaggio, un messaggio il cui contenuto è sostanzialmente “uccidi il portatore di
questo messaggio”: dunque un enunciato autoreferenziale, metalinguistico, formalmente
assai vicino a quella ricca classe di paradossi sul tipo del mentitore (“questa frase è
falsa”, “non obbedire a quest’ordine” ecc.) che per la loro complessità hanno messo in
crisi per qualche millenio i fondamenti della semantica, e tanto più continuano a farlo
dopo Russel, Gödel e Tarski. Ora: un contenuto di tale complessità può essere veicolato
da altro se non dalla scrittura nel senso più proprio e ristretto del termine? E allora se
l’Iliade menziona al suo interno l’uso della scrittura, peraltro a un tale livello di
314
Iliade, VI, vv. 152 sgg.
Trad.: «ma lo mandò in Licia e gli diede una tavoletta piegata / con su scritti segni funesti, parole
capaci di dare morte, / e gli ordinò di mostrarla al suocero, che lo uccidesse ».
316
La questione è compendiata in The Iliad: A Commentary, general director KIRK, G. S., volume II:
books 5-8, KIRK, G. S., Cambridge, 1990, ad loc.: «The s»mata lugr¦ could be any kind of messagebearing signs, not necessarily pictograms (s»mata lugr¦ οἷον οὖν ἐγχαράξας εἴδωλα, Aristarchus
(Arn/A)) or Linear B symbols; and grάyaj, though its literal meaning is “scratching” (as in Homeric
references to wounds), which would suit clay tablets well enough, would also fit writing on a wooden
diptych coated on its inner sides with wax. The balance may be tipped towards alphabetic writing by the
“folded tablet” itself, something probably not unknown to the Mycenaean world (see G. F. Bass, National
Geographic, Dec. 1987, 73of. on the Ka; wreck) but far more familiar from Assyrian reliefs and in
developed uses of the alphabet, cf. L. H. Jeffery in Wace and Stubbings, Companion 555, who thought
Phoenician prototypes unlikely. W. Burkert (in R. Hägg, ed., The Greek Renaissance of the Eighth
Century B.C., Stockholm 1983, 52ff.), gives a useful bibliography and opts for the Phoenician-Greek
δέλτος as prototype, assigning the present reference to it (together with the alphabetic s»mata, the
Potiphar's-wife theme and the Chimaera), to as late as the early 7th cent. B.C. See further A. Heubeck,
Arch. Hom., x 141ff.»
315
295
complessità semantica, come si può pensare che non presupponga la scrittura come
mezzo della sua stessa composizione? L’assurdo equivale a qualcosa come leggere in un
manoscritto medievale un riferimento alla stampa.
Con l’avvento della scrittura alfabetica in Grecia e la conseguente modificazione
delle modalità di composizione dei testi letterari, non è affatto necessario supporre
l’immediato abbandono, in quanto non più motivato, di uno stile compositivo
originatosi in un contesto di oralità. Al contrario, è invece naturale supporre il perdurare
di quello stile per una fase di transizione, proprio per il suo essere uno stile letterario e
non il mero effetto meccanico di una necessità compositiva. D’altronde, il minuetto di
una partita di Bach o di una sinfonia di Mozart, per il fatto di conservare a tutti gli
effetti la struttura e l’andamento di un genere compositivo che originariamente
accompagnava una danza, dovrebbe forse presupporre il perdurare di una simile prassi
esecutiva?
Allo stesso modo, se senza avere notizie sull’autore si applicassero all’Italia
liberata i criteri che gli oralisti applicano ai poemi omerici per trarne conclusioni
parallele, Trissino ne risulterebbe al di là di ogni dubbio un bardo semi-letterato.
296
7. L’IMITATIO
L’imitatio rinascimentale e l’Iliade: trattatistica e prassi poetica
Con il termine «l’antistorico» designo la forza e l’arte di poter
dimenticare e di rinchiudersi in un orizzonte limitato;
«sovrastoriche» chiamo le potenze che distolgono lo sguardo dal
divenire, volgendolo a ciò che dà all’esistenza il carattere dell’eterno
e dell’immutabile, all’arte e alla religione. La scienza […] in quella
forza, in queste potenze vede potenze e forze avverse: essa reputa
infatti vera e giusta, ossia una considerazione scientifica, solo la
considerazione delle cose che vede dappertutto un divenuto, un
elemento storico, e in nessun luogo un ente, un eterno.
F. NIETZSCHE, Sull’utilità e il danno della storia per la vita
7.1. Pregiudizi dell’estetica moderna verso la mimesis
È oggi per noi un fatto del tutto scontato che non esista alcuna possibilità di
espressione artistica che prescinda da un linguaggio artistico pregresso, se non nella
forma del primitivismo e della naïveté. Persino la più drastica rottura con la tradizione
precedente che la storia delle arti occidentali ricordi, l’Avanguardia novecentesca,
presuppone la tradizione stessa che pure rifiuta spesso in maniera ben più marcata di
quanto non ammetta, e d’altra parte si costituisce rapidamente in una serie di linguaggi
nuovi e alternativi in cui la produzione dei singoli autori si inserisce. La pratica di
qualunque forma d’arte necessita sempre di un preventivo periodo di apprendistato in
cui l’autore forma la possibilità di una propria parole sullo sfondo di una langue con cui
egli familiarizza e che, per quanto poi se ne distacchi, magari fino al totale rifiuto, per
intraprendere una strada autonoma, resta sempre il presupposto imprescindibile della
sua parole poetica. Allo stesso tempo, tuttavia, la sensibilità moderna è nettamente
propensa a ritenere che il proprium dell’arte consista precisamente nell’allontanamento
e nello scarto dalla tradizione pur presupposta in vista della creazione di un proprio
linguaggio autonomo, identitario, nuovo: chi si appropria senza sostanziali innovazioni
del linguaggio altrui è nient’altro che manierista, servile imitatore, artigiano più che
artista, autore di una produzione che, quand’anche fosse di pregio, è però senza valore.
Con le parole di Leopardi:
297
Ma il fatto sta che in materia di letteratura o di arti, basta accorgersi dell’imitazione, per metter
quell’opera infinitamente al di sotto del modello, e che in questo caso, come in molti altri, la fama non ha
tanto riguardo al merito assoluto ed intrinseco dell’opera, quanto alla circostanza dello scrittore o
dell’artefice. Laonde, o imitatori qualunque vi siate, disperate affatto di arrivare all’immortalità, quando
bene le vostre copie valessero effettivamente molto più dell’originale.317
Un doppio movimento in direzioni radicalmente divergenti anima così il cuore
stesso dell’estetica moderna e, di riflesso, della critica: da una parte, la categoria critica
di intertestualità, di matrice semiotica e dunque linguistica, ci insegna che l’arte è a tutti
gli effetti una forma di linguaggio – in senso non genericamente metaforico, ma
assolutamente proprio e specifico – e come tale desume le sue stesse possibilità di
espressione dalla preesistenza di un codice da cui non può prescindere per significare;
dall’altra, la categoria dell’originalità come irrinunciabile fondamento del giudizio di
valore afferma che un’opera che non si discosti sensibilmente da quel linguaggio da
essa pur presupposto, e anzi non intervenga a modificarlo con la sua stessa presenza,
non è da considerarsi affatto opera d’arte. Certo, si potrà dire che il bisogno di
originalità è contemplato e persino strutturale entro la prospettiva intertestuale in quanto
un’espressione implica sempre, foss’anche in misura infinitesimale, un mutamento del
codice, così come l’uso effettivo del linguaggio è la causa stessa del mutamento
linguistico; si potrà dire, del pari, che l’originalità a sua volta non pretende certo di
essere totale, ma presuppone come cosa pacifica e aproblematica una certa componente
di elementi codificati e convenzionali anche all’interno dell’opera originale, che segni il
perdurare di un rapporto con la tradizione: basti ricordare come Anton Webern – il
compositore da cui origina e prende il nome la più significativa produzione di musica
“colta” del secondo Novecento, rappresentante di uno dei punti di più estremi toccati
dello sperimentalismo avanguardistico (al confronto Pollock è un paesaggista) – almeno
nella sua fase più tarda considerasse la musica dodecafonica come lo sviluppo storico
diretto e quasi naturale del precedente sistema tonale. È innegabile, tuttavia, nonostante
la possibilità di compresenza e compromesso, come questi due principi estetici siano di
fatto opposti e producano un atteggiamento quasi schizofrenico, per cui da una parte il
“già detto” o il “già fatto” determina e costituisce il valore artistico, dall’altra ne
costituisce la svalutazione. Per quanto nella prassi artistica come in quella interpretativa
le due tendenze risultino di fatto assolutamente conciliabili, i principi estetici che le
animano sono però apertamente contraddittori.
317
Zibaldone, 1 luglio 1820.
298
A ben guardare, la duplicità dei criteri di giudizio che così emerge, se analizzata
in una prospettiva storica, origina dalla sostanziale stratificazione di due concezioni
estetiche distinte e per tanti versi contrapposte: una è l’estetica propria della tradizione,
fondata sul principio della mimesis-imitatio, di cui in fondo la categoria critica
dell’intertestualità fornisce una reinterpretazione in chiave moderna e “scientifica” (non
a caso in stretta correlazione con la semiotica, un’altra disciplina che mostra una matrice
greca spesso strettamente correlata alla teoria mimetica), condividendone la centralità
riconosciuta nel discorso artistico alla “parola del passato”; l’altra è l’estetica di matrice
romantica, ancora decisamente predominante nella nostra sensibilità attraverso la
mediazione dell’avanguardia e del modernismo, che invece con la tradizione ha rotto
nel porre al centro dell’esperienza artistica il continuo bisogno del nuovo e
dell’originale, originariamente legato alla categoria tardosettecentesca del genio. Se la
prima concezione affonda le sue radici nell’arte e nel pensiero della Grecia antica, e a
partire soprattutto da Platone e Aristotele 318 – seppure in maniera sin da allora
decisamente non univoca e omogenea – ha ricevuto una formulazione di stampo
eminentemente filosofico, rimasta in sostanza conforme a quell’impostazione anche
nella sua moderna ripresa umanistico-rinascimentale, la seconda invece, pur essendo
certamente legata a doppio filo con la filosofia romantica, ha poi ricevuto un’ampia e
solida elaborazione teorica nell’ambito delle moderne Scienze dello Spirito e in
particolare nella recente disciplina che si occupa di fornire una spiegazione e
sistemazione
dell’esperienza
scientifica
artistica,
(nel
senso
l’estetica.
tedesco
di
Semplificando
Wissenschaft,
all’estremo
naturalmente)
una
situazione
ovviamente di grande complessità, il risultato è che noi oggi percepiamo l’estetica della
tradizione come qualcosa di formulato in maniera più debole, non scientifica e semmai
irrimediabilmente legata a un pensiero antico che in quell’ambito ci pare ingenuo,
primigenio, prescientifico, e dunque, in breve, superato: l’estetica dell’originalità ci
appare come una fondamentale acquisizione moderna sostanzialmente sconosciuta alla
tradizione preromantica, priva di un’autentica e autonoma scienza estetica, per cui la
318
Ancora precedente è la teoria musicale, già certamente mimetica, di Damone, verso la quale tanto
Platone quanto Aristotele mostrano un cospicuo debito. Ma i primi riferimenti alla teoria mimetica
dell’arte risalgono già a Democrito, cfr. fr. 154 DK: gelo‹oi d' ‡swj ™smὲn ™pˆ tîi manq£nein t¦ zîia
semnÚnontej, ïn Ð D. ¢pofa…nei maqht¦j ™n to‹j meg…stoij gegonÒtaj ¹m©j· ¢r£cnhj ™n
ØfantikÁi kaˆ ¢kestikÁi, celidÒnoj ™n o„kodom…ai, kaˆ tîn ligurîn, kÚknou kaˆ ¢hdÒnoj, ™n
çidÁi kat¦ m…mhsin (Trad.: « Noi siamo siamo discretamente ridicoli quando celebriamo le bestie come
modelli per la nostra capacità di imparare, arrivando sino al punto di Democrito che dichiara che: noi
siamo stati discepoli delle bestie nelle arti più importanti: del ragno nel tessere e nel rammendare, della
colomba nel costruire le case e degli uccelli canterini, del cigno e dell’usignolo, nel canto, mediante
l’imitazione », da PLUTARCH., De sollert. an., 20).
299
nostra comprensione del fenomeno artistico appare oggi decisamente più profonda e
penetrante, fondata su un sapere solido, analitico, scientifico. Significativa la
testimonianza di Adorno nella sua Teoria estetica:
A causa del momento del non già esistito, il geniale è stato congiunto al concetto di originalità:
“genio originale”. È universalmente noto che la categoria dell’originalità non ha esercitato alcuna autorità
prima dell’epoca del genio. Del fatto che nel XVII e nel primo XVIII secolo i compositori riutilizzassero
nelle proprie opere interi complessi tratti sia da opere proprie sia da opere altrui, oppure che i pittori e
architetti affidassero i propri abbozzi all’esecuzione dei discepoli, è facile abusare per giustificare ciò che
è aspecifico e fatto con lo stampo, e per denunciare la libertà soggettiva. Tuttavia ciò dimostra che in altri
tempi non si è riflettuto criticamente sull’originalità, non già che niente del genere fosse presente nelle
opere d’arte; basta uno sguardo alla differenza tra Bach e i suoi contemporanei.319
In questo caso, dunque, la coscienza storica viene in nostro soccorso
rassicurandoci in questo modo sulla questione: in passato l’importanza capitale
dell’originalità semplicemente non è stata pensata in modo adeguato, come noi moderni
abbiamo invece saputo fare; nel rapportarci all’arte del passato, che tanto spesso ignora
clamorosamente questo criterio di ordine superiore, basterà ricordare che l’arte stessa,
con i suoi principi, è fenomeno eminentemente storico e come tale va compresa e
interpretata: se l’arte del passato non risponde ai nostri principi teorici, ciò si spiega
proprio nel suo appartenere al passato e rispondere alle esigenze di allora320. Eppure il
problema non è forse di così semplice soluzione, se appena ammettiamo che la
prospettiva storicistica non è necessariamente la spiegazione di ogni fenomeno, ma a
sua volta una prospettiva storicamente determinata e dunque a sua volta sottoponibile a
critica. Possiamo guardare, allora, alla formulazione del problema posto specificamente
per la poesia da Leopardi, proprio negli anni dell’impatto europeo dell’estetica
romantica:
Ora come sarà disdetto ai poeti il cantare nella forma di Omero e di Pindaro e in breve degli
antichi, finattantoché gli antichi diletteranno?
319
ADORNO, T. W., Teoria estetica, Torino, Einaudi, 2009 [1970], p. 230 (corsivo mio). Per una
ricostruzione della reinterpretazione adorniana della mimesis, con particolare riferimento alla Dialettica
dell’illuminismo di HORKEIMER-ADORNO e alla Teoria estetica di ADORNO, cfr. CAHN, M., Subversive
Mimesis: Theodore W. Adorno and the modern impasse of critique, in SPARIOSU, M., a cura di, Mimesis
in Contemporary Theory: An Interdisciplinary Approach, Philadelphia, John Benjamin’s Publishing
Company, 1984, vol. I, pp. 27-64.
320
L’impostazione storicizzante del fenomeno artistico come fondamento stesso dell’estetica risale
essenzialmente all’idealismo tedesco e in particolare all’estetica hegeliana, dove accanto alla critica del
concetto di imitazione (HEGEL, W. F., Estetica, cit., p. 51 sgg.) si ha, conseguentemente, una netta
affermazione dell’originalità dell’opera d’arte come principio fondamentale (ibid., p. 331 sgg.).
300
Naturalmente non è questa la sede per un così ampio dibattito su questioni tanto
generali e rilevanti; basterà qui aver individuato la problematicità ancora
sostanzialmente irrisolta e solitamente ignorata di un simile problema. Ciò che ci
interessa ora è fare quel tanto di autocritica che ci permetta di guardare al passato non
con la consueta superiorità del moderno progressismo scientifico, ma da un prospettiva
un po’ meno parziale e orientata: bisogna quanto meno ammettere la possibilità che
l’estetica moderna non sia senz’altro superiore a priori a quella antica solo per aver
studiato il problema dell’arte in un’ottica scientifica, e che per contro l’estetica della
tradizione possa essere, forse, ben più profonda e meditata della banalizzazione con cui
si è soliti liquidarla.
Sarebbe utilissima, per una valutazione più obiettiva, una breve Begriffsgeschichte
del categoria della mimesis-imitatio nella sua specifica relazione all’arte, ma
naturalmente l’ampiezza del problema e la sterminata bibliografia critica sull’argomento
ce lo impediscono321. Quello che tuttavia è possibile rilevare è come gli studi più recenti
321
Sui concetti di mimesis e imitatio (evito volutamente di distinguerli) si veda: ADORNO, T. W., Teoria
estetica, Torino, Einaudi, 2009 [1970]; BLOCK, H. M., The concept of imitation in modern criticism, in
JOST, F., (ed.), Actes du IVe Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée, Parigi,
Mouton, 1964, pp. 704-720; BOMPAIRE, J. Filosofia e mimesis, «Studi di Estetica» 7/8 (1993), pp. 27-39,
trad. it. del cap. II di Id., Lucien écrivain. Imitation et création, Paris, De Boccard, 1958; COMPAGNON,
A., Il demone della teoria. Letteratura e senso comune, Einaudi, Torino 2000 (in particolare cap. 3, Il
mondo, pp. 100-148); ELSE, G. F., “Imitation” in the Fifth Century, «Classical Philology» 53 (1958), pp.
73-90; GREENE, T. M., The Light in Troy. Imitation and Discovery in Renaissance Poetry, Yale,
University Press, 1982; HALLIWELL, S., L’estetica della mimesis. Testi antichi e problemi moderni,
Palermo, Aesthetica edizioni, 2009 (ed. or. Princeton, 2002); HEGEL, G. W. F., Estetica, Einaudi, Torino,
1997; HORKEIMER, M., – ADORNO, T. W., Dialettica dell’illuminismo, Torino, Einaudi, 1997 (1944);
KOLLER, H., Die Mimesis in der Antike. Nachahmung, Darstellung, Ausdruck, Berna, Francke, 1954
(trad. it. parziale: La mimesis nell’antichità, «Studi di estetica», serie III, anno XXII, fasc. 1, 1993, pp.
13-26); Mimesis, «Studi di estetica», III serie, 7/8 (1993); MCLAUGHLIN, M. L., Literary Imitation in the
Italian Renaissance, Oxford, 1983; MELBERG, A., Theories of Mimesis, Cambridge, 1995; MOSS, A.,
Literary imitation in the sixteenth century: writers and readers, Latin and French, in The Cambridge
History of Literary Criticism, a cura di NORTON, G. P., vol. III, The Renaissance, Cambridge, University
Press, 1999, pp. 107-118; Poetiche della mimesis, «Studi di estetica», III serie, 10 (1994); PIGMAN, G. W,
Versions of Imitation in the Renaissance, «Renaissance Quarterly» 3 (1980), pp. 1-32; QUONDAM, A., (a
cura di), Rinascimento e Classicismo. Materiali per l’analisi del sistema culturale di Antico regime,
Roma, Bulzoni, 1999; SPARIOSU, M., La mimesis nella teoria contemporanea: un approccio
interdisciplinare, «Studi di estetica», 7/8 (1993), pp. 73-104 (tr. ital. dell’Introduzione a ID., a cura di,
Mimesis in Contemporary Theory. An Interdisciplinary Approach, Philadelphia, John Benjamin’s
Publishing Company, 1984); SPARIOSU, M., Mimesis in Contemporary Theory: An Interdisciplinary
Approach, Philadelphia, John Benjamin’s Publishing Company, 1984; SMITH, A. J., Theory and Practice
in Renaissance Theory: Two Kinds of Imitation, «Bulletin of the John Rylands Library» 47 (1964), pp.
212-43; TATARKIEWICZ, W., Storia dell’estetica, Einaudi, Torino 1979-1980 (1970); TATARKIEWICZ, W.,
Storia di sei Idee. L’Arte, il Bello, la Forma, la Creatività, l’Imitazione, l’Esperienza Estetica, Aestetica
edizioni, Palermo, 1993 (1975); ULIVI, V. F., L’imitazione nella poetica del Rinascimento, Milano,
Marzorati, 1959; VASOLI, C., L’estetica dell’Umanesimo e del Rinascimento, in AA.VV., Momenti e
problemi di storia dell’estetica. Parte prima: dall’antichità classica al barocco, Milano, Marzorati, 1983,
pp. 326-433 (in particolare Il problema dell’imitazione, pp. 345-354 e La poetica aristotelica e le dispute
cinquecentesche sulla poesia, pp. 376-390); VERNANT, J.-P., Nascita di immagini, in ID., Nascita di
301
sulla questione, guardando spesso al di là della pur ampia produzione teorica
rinascimentale sull’argomento, mostrino l’inequivocabile tendenza a ridimensionare la
banalizzazione di quella teoresi e a recuperare una complessità originaria spesso
fraintesa e travisata. Se infatti persino la corrispondenza del termine mimesis con la
traduzione “imitazione” è stata messa in discussione, a favore di termini come
“rappresentazione” o anche altri (“modellizzazione”, “simulazione” ecc.), nonostante la
corrispondenza appaia del tutto piana e aproblematica tanto per la latinità classica
quanto per l’età umanistico-rinascimentale322 (è stata anche avanzata l’idea di un poco
probabile etimo comune ai due termini323), ciò dipende da un progressivo slittamento
semantico del termine “imitazione” tanto accentuato da trasformare l’originaria
connotazione positiva in una attuale connotazione decisamente negativa e svilente,
denunciando, in una traduzione divenuta quasi inservibile, la radicale alterazione del
concetto originario, fino all’esito estremo che la distorce nel concetto di “copia” 324 .
Tuttavia gli studi sulla mimesis antica e quelli sull’imitatio rinascimentale, nonostante
l’evidente continuità della teoria, mostrano una netta tendenza a limitarsi ai rispettivi
ambiti scientifici senza approfondire adeguatamente il rapporto della teoria
rinascimentale con quella antica, come fosse qualcosa di ovvio. Cerchiamo dunque di
approfondire questo trascurato collegamento, evidenziando al contempo le principali
specificità della ripresa rinascimentale, adeguatamente comprensibili, io credo, solo alla
immagini e altri scritti su religione, storia, ragione, Milano, Il Saggiatore, 1982, pp. 119-152.WEINBERG,
B., A History of the literary Criticism in the Renaissance Italy, Chicago, University Press, 1961;
WEINBERG, B., L’imitation au XVIe et au XVIIe siècles, in JOST, F., (ed.), Actes du IVe Congrès de
l’Association Internationale de Littérature Comparée, Parigi, Mouton, 1964, pp. 697-703.
I pricipali testi del dibattito rinascimentale sull’imitatio sono leggibili in WEINBERG, B., a cura di, Trattati
di retorica e di poetica del Cinquecento, Bari, Laterza, 1970; alcuni dei testi più rilevanti sono stati
ripubblicati e tradotti in QUONDAM, A., (a cura di), Rinascimento e Classicismo, cit. Per una bibliografia
più competa si rimanda a HALLIWELL, S., L’estetica della mimesis, cit.
322
La corrispondenza non è affatto inficiata dalla presenza della categoria accessoria di aemulatio, che
anzi è subordinata all’estetica dell’imitatio e definisce, a differenza di quella, non il processo in sé (che
resta appunto il medesimo) quanto l’atteggiamento con cui esso viene messo in atto.
323
Sull’etimologia di mimesis cfr. infra., sez. 7.2.
324
Del tutto compiuto appare questo slittamento concettuale quando l’estetica romantica e l’idealismo
tedesco muovono la critica al concetto di imitazione che avrebbe portato al suo superamento: cfr. HEGEL,
W. F., Estetica, cit., pp. 51-52 (Il principio dell’imitazione della natura): «Secondo questo punto di vista,
il fine essenziale dell’arte è costituito dall’imitazione, intesa come abilità a riprodurre forme naturali quali
esse sono, in maniera interamente corrispondente, e il buon esito di questa raffigurazione corrispondente
alla natura deve dare pieno soddisfacimento». Da un simile punto di partenza, che le seguenti pagine
intendono contribuire a dimostrare radicalmente infondanto, non può che discendere la critica ovvia e
verrebbe da dire quasi di buon senso spicciolo – che resta ancora oggi la principale critica vulgata
all’imitazione – secondo cui «tale ripetizione può essere nel contempo considerata come una fatica
supeflua, giacché quel che quadri, rappresentazioni teatrali, ecc., manifestano imitando per es., bestie,
paesaggi, eventi umani, noi lo abbiamo già nel nostro giardino o nella nostra casa, o in casi capitati a
nostri conoscenti vicini e lontani».
302
luce di un raffronto con la teoresi antica da cui derivano. Per farlo, risaliamo molto
indietro, fino a riconsiderare l’etimologia stessa della parola greca mimesis.
7.2. Sull’etimologia di mimesis
…the apparition comes. I knew your father.
These hands are not more like.
W. SHAKESPEARE, Hamlet, I.2
Non di rado si può riscontrare una tendenza a sminuire il contributo che
l’etimologia può dare alla ricostruzione della storia dei concetti. Personalmente, sono
convinto invece del contrario, per un motivo che mi pare di primaria rilevanza.
Acquisizione definitiva della filosofia del linguaggio, dell’ermeneutica e della semiotica
novecentesche è il riconoscimento che il linguaggio non è semplicemente un prodotto
storico del mondo, ma contribuisce in maniera determinante a creare quel mondo che ad
esso ricorre, a definire la totalità degli oggetti esperiti nell’esistenza in una specifica
configurazione storica. Non è insomma l’oggetto a richiedere un significato ad esso
corrispondente che si realizzi nel linguaggio, alla maniera di una nomenclatura, ma
all’opposto è il significato a istituire l’oggetto che designa, individuandolo come parte
specifica entro la totalità dell’Ente-mondo. Per comprendere adeguatamente l’essenza
storica di un oggetto reale (materiale o meno che sia) è dunque indispensabile una
riflessione critica sulla storicità del significato che lo individua. E se questo è vero per i
più banali oggetti materiali della vita quotidiana, tanto più è vero per i concetti, la cui
adeguata comprensione è sempre subordinata a una riflessione critica sulla loro storia,
dunque sul loro significato nella diacronia della sua evoluzione.
Errore fin troppo comune è allora crede che un’adeguata ricostruzione
dell’oggetto (denotatum) sia sufficiente a definirne, di riflesso, il significato. Il
significato di un oggetto è infatti individuato in maniera irriducibilmente complessa dal
concorso di due fattori inscindibili: quelli che la semiotica chiama intensione ed
estensione, ossia rispettivamente l’individuazione di una serie di proprietà pertinenti nel
descrivere e circoscrivere l’oggetto (type) e invece la classe di tutti gli enti reali (le
occorrenze, tokens) ad esso corrispondenti, che tali proprietà realizzano. Ma se nel
lavoro di ricostruzione storico-culturale la delimitazione dell’estensione di un concetto è
relativamente facile da restituire sulla base delle testimonianze testuali, non si può certo
dire lo stesso dell’intensione. Troppo spesso infatti si tende a considerare l’intensione
come una funzione dell’estensione, e questo è senza dubbio errato e fonte di
fraintendimento. Non basta infatti individuare quali siano gli oggetti reali (referenti) a
303
cui un significato si riferisce per individuare immediatamente le proprietà comuni a
questi oggetti che il significato individua e veicola: anzi, proprio la presunzione di saper
individuare senz’altro tali proprietà deducendole dalla classe dei membri che le
realizzano – operazione che sarà necessariamente condizionata dalla storicità delle
proprie conoscenze – genera il rischio del fraintendimento, poiché saremo sempre
portati, in qualche misura, a interpretare il passato secondo le categorie del nostro
presente e a credere che le proprietà attribuite in passato a una classe di oggetti siano le
stesse che a quella classe attribuiremmo oggi noi. Il che poi non è altro, in fondo, che il
problema del circolo ermeneutico: ciò che deve essere spiegato è al tempo stesso il
fondamento della spiegazione325.
In che modo ci soccorre dunque, di fronte a tale difficoltà, la ricostruzione
dell’etimologia? Essa risulta di grande aiuto proprio perché ci permette di far luce
sull’intensione del significato. Leggendo un testo del passato, il più delle volte siamo
semplicemente portati a individuare una corrispondenza fra i significati lì implicati e
significati attuali che noi ad essi associamo: il che già comporta senza dubbio una certa
misura di fraintendimento; ma anche quando notiamo una discrepanza nell’uso di un
significato, ciò di cui in genere ci accorgiamo è solo la discrepanza nell’estensione: un
certo termine o concetto è riferito a un oggetto al quale non ci aspetteremmo che fosse
riferito, e come conseguenza procediamo, con l’aiuto del contesto, ad estendere il
significato per ipotesi (in un processo che in semiotica prende il nome di ipocodifica) in
maniera tale da poter abbracciare anche quell’oggetto. Un accomodamento provvisorio
e ipotetico ci permette così di comprende a sufficienza. Un italiano d’oggi che, ignaro di
latino, legga il verso dantesco O insensata cura de’ mortali, scartando l’attuale
accezione più comune della parola cura come non pertinente, saprà forse adattarne in
maniera soddisfacente il significato sulla base della considerazione di usi ancora vivi
nella lingua come “aver cura di”, “curarsi di”, “cura dei beni” ecc.; ma anche se saprà
tradurre mentalmente il termine con un più moderno “interessi”, avrà probabilmente
soddisfatto la necessità di modifica richiesta da una difficoltà estensionale, ma,
eguagliando così un concetto ad un altro da esso diverso, perderà e dimenticherà
irrimediabilmente alcune specificità intensionali del termine “cura” rispetto al termine
“interesse”, come ad esempio la connotazione di affannosa difficoltà di cui il secondo è
esente. Se l’uso specifico e il contesto non avessero evidenziato una discrepanza
nell’estensione, il significato non sarebbe stato ripensato affatto, e il fraintendimento si
325
Cfr. naturalmente GADAMER, H. G., Verità e metodo, cit.
304
sarebbe infiltrato inavvertitamente nell’interpretazione; ma anche quando una difficoltà
segnala la discrepanza, la misura della correzione è per così dire cucita addosso alla sola
incongruenza estensionale: sistemata quella, non è ulteriormente necessario interrogarsi
sull’intensione, che può benissimo restarsene nell’ombra almeno fino alla prossima
incongruenza. Se a una modificazione storica dell’intensione (che poi è in realtà il
significato vero e proprio) non segue immediatamente una chiara modifica
dell’estensione, il mutamento intensionale può restare del tutto insospettato, generando
così un fraintendimento che resta totalmente inavvertito.
Ora, la linguistica storica ci insegna che, qualunque sia la causa o l’entità del
mutamento linguistico, esiste sempre un legame associativo fra il vecchio e il nuovo
significato, in una catena che, per quanto ingenti o rapide siano le modifiche nella
diacronia, preserva comunque una continuità di fondo. L’etimologia, individuando su
base comparativa una forma originaria, ricostruisce allora non solo il significante, ma
anche appunto un significato originario, per quanto in una forma artificiale e generica:
in questo modo ci permette di avere un’idea complessiva delle modificazioni
diacroniche, quasi in una visione generale “dall’alto”, cosicché misurando le
oscillazioni
del
significato
nel
tempo
possiamo
distinguere
l’essenziale
dall’inessenziale, ciò che nel significato tende a permanere in quanto idea fondamentale
alla base di una parola o una radice e ciò che invece è accessorio, secondario,
contingente, non direttamente connesso all’essenza del significato: una distinzione
importantissima per ricostruire adeguatamente la storia dei concetti, che non può essere
in nessun modo desunta dallo stadio sincronico del significato. Come potremmo dal
solo italiano desumere che l’opposizione fra bianco e candido, che per noi connota il
secondo di un’idea di purezza confinante con l’ingenuità, deriva e si spiega alla luce di
un’originaria connotazione di brillantezza e luminosità, se non risalendo a un etimo che
accomuna il colore del metallo fuso al nome indiano antico della luna?
Per questo motivo ritengo che sia utile non solo tracciare a grandi linee una
connessione fra la categoria rinascimentale dell’imitatio e il concetto greco di mimesis,
in una traduzione che sin dal passaggio alla cultura latina implica, già solo in quanto
traduzione, lo scalino di un’ineliminabile imperfezione nella corrispondenza, ma anche
cercare di fare chiarezza, per quanto possibile, sulle ipotesi di etimologia per la parola
greca: in questo modo, arrivando a dei risultati che siano attendibili, saremo in grado di
avere un’idea del concetto di fondo espresso dalla parola greca e dunque anche di
delinearne forse con più precisione l’essenza del significato, e così misurare meglio –
305
senza naturalmente voler ripercorrere l’intera diacronia di uno dei concetti portanti non
solo dell’estetica ma della cultura occidentale – il progressivo scarto da esso che si
accumula nel tempo.
Allo stato attuale degli studi si tende a ritenere che l’etimologia della parola
mimesis sia oscura e sostanzialmente ignota326, tanto da ipotizzare che sia un termine di
sostrato pregreco. Pura fantasia sembrerebbe l’etimo comune a mimesis e imitatio
ipotizzato quasi a orecchio nel vecchio Vocabolario etimologico della lingua italiana di
OTTORINO PIANIGIANI (e di recente anche in MANIERI, A., L’immagine poetica nella
teoria degli antichi, 1998) sulla base di una presunta radice me- “misurare” ravvisabile
in lat. i-mi-tor, gr. mī-mē-sis: sembra evidente infatti che la radice greca non sia mebensì è mīm-, ravvisabile in µῖµος, da cui deriverebbero il denominativo µιµ-έ-οµαι e, da
quest’ultimo, il deverbativo µίµ-η-σις (e d’altronde la radice di misurare non è mebensì met-), mentre imitor è probabilmente il frequentativo di una radice im- comune a
imago (ERNOUT-MEILLET, Dictionnaire etymologique de la langue latine, s. v. imago).
Più interessante l’ipotesi avanzata da SCHULZE, Kleine Schriften, p. 53, di un legame
della radice greca con il sanscrito māyā (termine reso celebre in occidente da
Schopenauer); ad essa tuttavia CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue
grecque, s. v. µῖµος, si dichiara contrario, presumo in quanto la connessione appare
difficilmente giustificabile sul piano fonetico (ma- ≠ mim-). La riconsiderazione
dell’estensione semantica della parola indiana, tuttavia, mostra effettivamente dei
contatti “seducenti”: i principali significati del termine sanscrito secondo il MONIERWILLIAMS, Sanskrit-English Dictionary sono infatti: 1) art, wisdom, extraordinary or
supernatural power (only in the earlier language); 2) illusion, unreality, deception,
fraud, trick, sorcery; 3) witchcraft magic; 4) an unreal or illusory image, phantom,
apparition (esp. false , unreal , illusory); 5) duplicity. Viene allora da chiedersi se non
sia ipotizzabile per l’originario termine µῖµος una diversa partizione che individui una
radice mī- cui si aggiunga il suffisso -µος (sul tipo θῦ-µος, εἰκασ-µς ecc.), come
Schulze stesso sembra suggerire proponendo un raffronto con la forma secondaria τῖµος dalla stessa radice di τιµή. Proprio in sanscrito si trova allora un’altra radice che
326
Così ancora il recentissimo HALLIWELL, S., L’estetica della mimesis. cit., p. 24: « L’etimologia dei
termini greci composti sulla radice mim- non è ricostruibile con certezza e non ci è quindi di alcun aiuto
(anche ammettendo che l’etimologia sia davvero utile alla storia dei concetti) » e nota 42 a p. 327, sulla
scorta di KOLLER, H., Die Mimesis in der Antike, cit. e CHANTRAINE, P., Dictionnaire étymologique de la
langue grecque, Paris, Klincksieck, 1968, s.v. µῖµος, i quali non forniscono alcuna etimologia. Così anche
BOISACQ, E., Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 1950 (p. 638: « Étym. obscure ») e il
recente BREEKS, R., Etymological dictionary of Greek, 2009 (p. 955: « There is no etymology, and PreGreek origin is quite possible »).
306
mostra un’alternanza mā-/mī- il cui significato di base è “misurare” (cfr. greco mέtron,
lat. mētior), ma che significa anche secondo il MONIER-WILLIAMS “to prepare, arrange,
fashion, form, build, make” e “to show, display, exibit”. L’esempio da un inno ad Agni
del Ṛg-Veda riportato dal dizionario è interessantissimo (Ṛg-Veda, III, 29, 11): parlando
delle varie forme che il dio assume, si dice infatti:
tánūnápād ucyate gárbha āsuró nárāsháṁso bhavati yád vijāyate
mātaríshvā yád ámimīta mātári vātasya sárgo abhavat sárīmaṅi.
As Germ Celestial he is called Tanūnapāt, and Narāśaṁsa born diffused in varied shape.
Formed in his Mother he is Mātariśvan; he hath, in his course, become the rapid flight of wind
(trad.: Griffith).
Per la forma ámimīta (cfr. gr. ἐµιµεῖτο) il MONIER-WILLIAMS traduce: “he
displayed or developed himself”: un significato che nella diatesi media vale insomma
“mostrarsi nella forma di”, “assumere l’aspetto di” (come fosse “misurarsi su qualcosa o
qualcuno”), in questo caso la forma della madre. D’altronde dalla stessa radice
sembrerebbe derivare il sostantivo māyā “immagine illusoria” cui rinvia Schulze, come
pure l’aggettivo māya, che significa sia “measuring” che “creating illusions”, detto di
Vishṅu (una formazione che sembrerebbe piuttosto simile, con altro suffisso, al gr.
µῖµος). Non avendo sufficienti competenze glottologiche per una questione tanto
specifica, non so dire se questo rapporto sia eventualmente ravvisabile solo nella radice
mī- di µῖµος o se sia ipotizzabile un più diretto rapporto con l’indiano anche nella forma
verbale µιµέοµαι raffrontabile con la parallela forma media con raddoppiamento mímīte
(Classe VI ātmanepada) e con la forma vedica ed epica raddoppiata mimāti (immagino
tuttavia che la quantità lunga dello iota nella radice greca escluda senz’altro che essa
possa serbare in sé la traccia di un’antica forma con raddoppiamento parallela al
sanscrito). In ogni caso, il parallelo di una radice che presenta il grado zero mīassociato al significato di “mostrarsi”, “assumere l’aspetto di” mi pare molto rilevante
come possibile etimo di µίµησις.
A dire il vero, tuttavia, la radice indiana mā-/mī- sembra contaminare due diverse
radici indoeuropee: l’antico indiano infatti subisce un mutamento fonetico generalizzato
per cui i suoni a, e, o indoeuropei confluiscono tutti in a. La radice sscr. mā- “misurare”
presuppone un i.e. *mē-/met (cfr. lat. mētior, gr. µέτρον), mentre la radice mā“immagine illusoria” di māyā presuppone invece un i.e. *mā-. Guardando più in
generale all’indoeuropeo, per questa seconda radice i. e. mā- esiste un’evidenza a mio
parere probante per l’etimologia del termine greco: POKORNY, J., Indogermanisches
307
Etymologisches Wörterbuch, 1959, propone le seguenti corrispondenze (senza tuttavia
sospettare il rapporto con µῖµος, anche perché non conosceva ancora la teoria delle
laringali che spiega l’apofonia indoeuropea):
Ai. māyā `Verwandlung, Truggestalt, Betrug, Illusion' (oder zu 3. mē-?);
gr. µηνύω, dor. µᾱνύω `zeige an, verrate' aus *µά̄-νῡ-µι `winke mit der Hand'; s-Erweiterung
µαίοµαι `berühre, untersuche', Fut. µάσσοµαι, ἐπι-µαστος `berührt' = `befleckt', µαστήρ, µαστρός `Sucher,
Nachforscher', µαστροπός `Kuppler', µάστις, µάστιξ `Peitsche, Geißel'; t-Erweiterung µάτη `Verfehlung'
(*mə-tā), µάτην, dor. -ᾱν `vergeblich', µάταιος `eitel, nichtig';
lit. móju, móti `mit der Hand winken, ein Zeichen geben', lett. mãju, mãt ds., mâdît `mit der
Hand winken', mâditiês `Gaukelei treiben', mâdži `Gaukelbilder'; mit s-Erweiterung lit. mãsinti `locken',
mosúoti `schwenken, schwingen', mostagúoti ds., mósterėti, móstelėti `winken';
slav. *majǫ, *majati (an Stelle von *mati nach dem balt.-slav. Präteritalstamm *māi̯ ā-) in abg.
na-majǫ, -majati `zuwinken', po-mavati, -manǫti ds., russ. na-májatь `durch Zeichen anzeigen, betrügen',
mit Formans -mo-: serb. mâmīm, mámiti `locken'; mit Formans -no-: russ. mańú, mańítь `anlocken,
täuschen' (aus dem Slav. stammen lit. mõnai Pl. `Zauberei', lett. mãnít `betrügen'); mit Formans -rā-:
russ.-ksl. mara `Gemütsbewegung', poln. mara `Täuschung', usw.; s-Erweiterung in: ksl. machaju,
machati `ventilare', usw.; t-Erweiterung in: aserb. matam, matati `anlocken', čech. mátati `als Gespenst
spuken', usw.
Una radice che insomma indica come significato generale “fare gesti”, in
particolare gesti furtivi e ingannevoli, da cui può evolvere il significato di “ingannare,
adescare” (in origine appunto attraverso la gestualità), come anche quello di “mostrarsi
con apparenza illusoria” (ad es. fantasma, visione) ma anche “fare gesti magici,
incantare”. Palese è la vicinanza semantica con le principali accezioni del sscr. māyā
menzionate sopra. Viene in mente allora anche una parola latina per la quale l’ERNOUTMEILLET non fornisce un’etimologia: mānes (con suffisso in nasale), il cui senso è
palesemente “spirito del morto che appare, si manifesta con aspetto illusorio”327, che è
appunto uno dei significati di māyā (continuato anche in alcune lingue moderne come il
verbo ceco mátati); una forma latina secondaria, mānia, māniola, testimonia addirittura
l’idea di fantoccio artefatto, simulacro, spauracchio, rappresentazione finta (ficta
quaedam ex farina in hominum figuras, quia turpes fiant)328, in un perfetto parallelo per
327
Viene da chiedersi allora se addirittura il lat. mānus, “mano”, non debba essere a sua volta connesso
(di nuovo con infisso in nasale) a questa stessa radice mā-, nell’altra accezione di “fare gesti, indicare”,
come significato indicante per metonimia la parte del corpo che per eccellenza serve a fare gesti (così
come il dito in latino come in greco prende il nome dall’indicare: digitus, dάktulo~ < i.e. *deik-,
“indicare”).
328
FESTUS, De verborum significatione: « Manias Aelius Stilo dicit ficta quaedam ex farina in hominum
figuras, quia turpes fiant, quas alii maniolas appellent. Manias autem, quas nutrices minitentur parvulis
308
la parola greca 329 . Forse ci si potrebbe addirittura chiedere se persino imāgo – una
parola che ci interessa molto, in quanto legata a imitor e dunque centrale nella storia
della mimesis – non sia a sua volta connessa, più che con la radice im- priva di paralleli
proposta dall’ERNOUT-MEILLET, con questa radice *ma- attraverso l’aggiunta di un
prefisso i- (forse da in-? 330 ) e un suffisso in velare 331 : imago infatti significa
“rappresentazione visiva”, ma anche appunto “spirito del morto che appare”,
“apparizione in sogno”, nonché (come vedremo più avanti in greco) “eco, immagine
sonora” (in un significato che non è necessariamente derivato in via metaforica
dall’immagine visiva, ma potrebbe derivare parallelamente appunto dall’idea di finzione
e rappresentazione di un aspetto, visivo come sonoro)332.
Il parallelo dai Ṛg-Veda della forma verbale dal significato “mostrarsi sotto
l’aspetto di” risulta allora palesemente connessa con questa radice (i. e. *mā-) piuttosto
che con quella di “misurare” (i. e. *mē-): il sanscrito tuttavia non le distingue più a
livello fonetico (dal momento che il suono e confluisce in modo generalizzato nel suono
a) e dunque finisce per contaminarle. L’alternanza mā-/mī- si spiega supponendo (cfr.
ad es. Schulze, cit.) una radice indoeuropea con apofonia *ma∂-/m∂ (cfr. da∂-/d∂“dare”, dhe∂-/dh∂- “porre” ecc.): com’è regolare, in antico indiano ∂ allunga la vocale
precedente (*ma∂- > mā-) e dà invece esito -i- fra consonanti (l’allungamento di i in ī,
anch’esso del tutto regolare, si spiega come analogia sulla forma in ā). In greco l’esito
µῖ-µος è perfettamente coerente con l’evidenza in altre lingue indoeuropee (il serbo
testimonia tra l’altro lo stesso suffisso -mo), derivando dunque da una forma *m∂-mos:
lo ῑ sarebbe esito dello ∂ della radice al grado zero, e la quantità vocalica lunga risulta
parallela ad altre forme con una simile alternanza, come πῶσις / πῑνω (< *po∂-/p∂-). Le
successive forme µιµέοµαι e µίµησις, chiaramente secondarie, si formerebbero
naturalmente sulla radice del sostantivo originario reinterpretata come mīm-,
comprendendo, in una nuova segmentazione, l’infisso in nasale.
Se questo rapporto è esatto – ma mi sembra difficilmente dubitabile – l’idea di
fondo (l’intensione) della famiglia µῖµος, µιµέοµαι, µίµησις sarebbe connessa non tanto
pueris, esse larvas, id est manes deos deasque, quod aut ab inferis ad superos emanant, aut Mania est
eorum avia materve. Sunt enim utriusque opinionis auctores ».
329
Cfr. l’uso di µµηµα nel senso di εἴδωλον in ESCHILO, Theoroi , fr. 78a Radt, v. infra.
330
Forse l’antico accento protosillabico potrebbe aver impedito il raddoppiamento di m, riemerso
nell’italiano immagine.
331
D’altronde che l’elemento propriamente suffissale sia -go piuttosto che -ago sembra confermato
dall’uso dello stesso suffisso preceduto da vocale i anziché a: imago, propago, ecc., ma anche origo,
vertigo ecc.
332
Cfr. ad es. LUCR. De rerum natura, IV, 570-71: «pars solidis adlisa locis reiecta sonorem / reddit et
inter dum frustratur imagine verbi ».
309
con l’idea di “immagine”, come intende Schulze, quanto proprio con l’idea di imitare
l’aspetto, in particolare attraverso la gestualità, imitare la forma esteriore e sensibile,
in un processo di cui è sottolineato tuttavia il carattere artificiale e illusorio, persino
ingannevole. Come si vede, un significato perfettamente coerente con µῖµος: un
simulatore attraverso la gestualità di una realtà illusoria, di finzione. Da questa base si
sviluppa successivamente nei due termini derivati, con perfetta coerenza, l’idea più
generica di “imitare”, mentre il sostantivo µῖµος rimane sempre più strettamente legato
all’idea originaria della finzione attraverso la gestualità. L’idea della somiglianza o della
copia di un’immagine visibile, invece, non sarebbe affatto coinvolta direttamente, ma
soltanto di riflesso, come ovvio corollario del simulare l’aspetto altrui. Persino il caso
limite dell’immagine dellο specchio, che tramite Platone diventerà uno dei simboli –
fraintesi – della mimesis, è mimesis in quanto immagine irreale e illusoria, non in
quanto immagine speculare e fedele (peraltro in perfetta coerenza con l’uso della parola
nel celeberrimo passo dell Repubblica, dove le immagini allo specchio sono φαινόµενα
opposte a ντα τ ἀληθείᾳ). D’altronde, come è stato sottolineato, le più antiche
occorrenze sia di µῖµος che di µιµέοµαι rivelano un rapporto particolarmente stretto con
l’imitazione sonora e la danza più che con quella visiva. Vediamone qualcuna.
In Eschilo, Edoni, fr. 57 Radt Gentili, µῖµος è riferito alla produzione di un suono
terribile, che ricorda a un cupo muggito: la realtà illusoria qui simulata è dunque non
un’immagine visiva ma un suono:
taurÒfqoggoi d' Øpomukîntai poqὲn ™x ¢fanoàj
foberoˆ m‹moi· tump£nou d' e„kën ésq' Øpoga…ou brontÁj fšretai barutarb»s'.333
Nell’inno omerico Ad Apollo, vv. 162-164, un coro di ragazze riproduce le voci
degli uomini di cui l’inno che intonano ricorda le gesta, e lo fanno con tanta fedeltà che
“ognuno direbbe d’essere lui stesso a parlare”; in questo caso, se nello specifico la
simulazione concerne un suono, siamo anche in un contesto di danza che coinvolge al
contempo anche la gestualità:
p£ntwn d' ¢nqrèpwn fwn¦j kaˆ krembaliastÝn
333
Trad.: « Spaventosi mimoi dalla voce di toro muggiscono da un qualche luogo nascosto alla vista:
l’immagine di un timpano, come un tuono sotterraneo, ne è riportata » (traduzione mia). Il termine mimoi
è stato qui inteso da Koller nel senso di “attori” di un dramma cultuale dionisiaco; Else contesta tale
interpretazione e intende invece “imitazioni”; per Halliwell si tratterebbe, più audacemente, di «una
metafora, in cui i suoni dei timpani sarebbero caratterizzati o personificati quasi come attori drammatici»:
sulla questione cfr. HALLIWELL, S., L’estetica della mimesis, cit, pp. 24-25.
310
mime‹sq' ‡sasin· fa…h dš ken aÙtÕj ›kastoj
fqšggesq'· oÛtw sfin kal¾ sun£rhren ¢oid».334
Ma anche il frammento dei Theoroi di Eschilo, 78a Radt (anch’esso fra le prime
attestazioni della parola), dove si fa evidentemente riferimento ad un µῖµος come ad una
riproduzione visiva, dopo aver sancito la somiglianza visiva subito chiama in causa
anche la voce: come a dire che per fare di quell’immagine un µῖµος vero e proprio, del
tutto completo, manca proprio la voce, come un aspetto necessario ad una mimesis
davvero compiuta (un topos che arriverà all’aneddoto leggendario della martellata di
Michelangelo sul ginocchio del Mosè e alla “Muta” di Raffaello):
<SAT.> […] ¥qrhson, e‡ t[ij e]‡kel[on
e‡dwlon e
nai toàt' ™mÁi morfÁi plšon
<™re‹ pot' À tÁi KÚpridi>
tÕ Daid£lou me[…]mhma· fwnÁj de‹ mÒnon.335
Non a caso tutta la teoresi greca sulla mimesis coinvolgerà sempre come un
aspetto di primo piano, da Damone in poi, la musica. Cosa che a noi moderni appare di
primo acchito ben strana, proprio perché tendiamo a leggere quella categoria
concettuale come “imitazione di una somiglianza visiva”, “realismo rappresentativo”336:
idea da cui con ogni evidenza esula il concetto greco di musica come µίµησις dell’ἦqoς,
cioè imitazione di un’attitudine caratteriale ed emozionale, un aspetto per definizione
appartenente all’interiorità e non certo alla realtà esterna e percepibile del mondo.
L’emozione e l’attitudine caratteriale non hanno certo un aspetto che si possa raffigurare
nello stesso senso di un oggetto attraverso la pittura o anche di un’azione attraverso le
parole. Eppure Aristotele, in un noto passo della Politica sulla musica, non esita a
parlare a riguardo di Ðmoièmata fra la percezione acustica, seppur culturalizzata nella
forma di ritmi e armonie, e le disposizioni caratteriali ed emotive (Politica, 1340a, 18
sgg.):
334
Trad.: « Di tutti gli uomini le voci e gli accenti / sanno imitare: ognuno direbbe d’essere lui stesso a
parlare, / tanto bene si adegua il loro canto armonioso » (Inni omerici, a cura di CÀSSOLA, F., Fondazione
Lorenzo Valla, Mondadori, 2006 [1975]).
335
Trad.: « SATIRO: […] Considera se uno non direbbe (dirà) che questo sia un simulacro più somigliante
al mio aspetto che non ad Afrodite la sua rappresentazione (mimema) fatta da Dedalo! Gli manca solo la
voce » (traduzione mia).
336
Sul carattere decisamente rivelatore di questa nostra radicale difficoltà ad intendere la musica come
mimesis cfr. KOLLER, H., Die mimesis in der Antike, cit.: « Per ciò che riguarda l’uso tecnico di mimesis,
dobbiamo prestare attenzione all’annotazione di un esimio conoscitore della terminologia scientifica, E.
Frank: “In contrasto con la concezione moderna, per i Greci la musica è l’arte propriamente mimetica”.
Dobbiamo chiederci ora su che cosa si fondi questa differenza rispetto alla nostra concezione. O il nostro
rapporto con la musica è divenuto qualcosa di completamente diverso, oppure, il che è più verosimile, il
significato di µίµησις è completamente diverso per i Greci che per noi ».
311
œsti dὲ Ðmoièmata m£lista par¦ t¦j ¢lhqin¦j fÚseij ™n to‹j ruqmo‹j kaˆ to‹j mšlesin
ÑrgÁj kaˆ praÒthtoj, œti d' ¢ndre…aj kaˆ swfrosÚnhj kaˆ p£ntwn tîn ™nant…wn toÚtοij kaˆ tîn
¥llwn ºqîn.337
Di nuovo emerge come il termine sia tradotto in modo inadeguato dalla nostra
categoria di “somiglianza”, irrimediabilmente compromessa con l’aspetto visivo o
comunque percettivo, implicando piuttosto quella che oggi chiameremmo una
“corrispondenza”: la homoiotes tra suoni e attitudini emotive non implica infatti,
naturalmente, alcuna somiglianza che cada sotto i cinque sensi, ma semmai una
corrispondenza fra la naturale disposizione emotiva di fronte alla realtà e la sua
simulazione o riproduzione attraverso il medium sonoro:
Ð d' ™n to‹j Ðmo…oij ™qismÕj toà lupe‹sqai kaˆ ca…rein ™ggÚj ™sti tù prÕj t¾n ¢l»qeian tÕn
aÙtÕn œcein trÒpon.338
Anzi, a tal punto questa corrispondenza equivale alla ri-produzione artificiale di
un processo naturale, a ciò che in inglese si direbbe un “re-enactment”, e non certo alla
“copia” di una percezione sensibile, che, per quanto concerne nello specifico la µίµησις
dell’ἦqoς, tutte le altre forme di mimesis risultano addirittura imperfette e manchevoli in
confronto alla musica, che limitatamente a questo aspetto risulta invece, addirittura, la
più mimetica di tutte: se il tatto e il gusto sono del tutto inefficaci in tal senso, persino la
rappresentazione visiva – ciò che a noi appare il paradigma stesso della somiglianza
imitativa – presenta rispetto alla musica una possibilità di corrispondenza soltanto
imperfetta, limitata e parziale con l’ἦqoς:
sumbšbhke dὲ tîn a„sqhtîn ™n mὲn to‹j ¥lloij mhdὲn Øp£rcein Ðmo…wma to‹j ½qesin, oŒon ™n to‹j
¡pto‹j kaˆ to‹j geusto‹j, ¢ll' ™n to‹j Ðrato‹j ºršma (sc»mata g¦r œsti toiaàta, ¢ll' ™pˆ
mikrÒn, kaˆ <oÙ> p£ntej tÁj toiaÚthj a„sq»sewj koinwnoàsin· œti dὲ oÙk œsti taàta Ðmoièmata
tîn ºqîn, ¢ll¦ shme‹a m©llon t¦ gignÒmena sc»mata kaˆ crèmata tîn ºqîn, kaˆ taàt' ™stˆn
™p…shma ™n to‹j p£qesin.339
337
Trad. (C. A. Viano): « Ma ritmi e melodie possono raffigurare con un alto grado di somiglianza al
modello naturale ira e mansuetudine, ma anche coraggio e temperanza e tutti i loro contrari, e in genere
tutti gli altri tratti del carattere ».
338
Trad.: « E la tendenza ad addolorarci o rallegrarci che proviamo dinanzi alle imitazioni è affine alla
nostra reazione di fronte alla situazione reale ».
339
Trad.: « Ma gli oggetti degli altri sensi non hanno alcuna somiglianza con i caratteri come nel caso del
gusto e del tatto; negli oggetti della vista questa proprietà c’è fino a un certo grado. Le figure hanno una
possibilità raffigurativa dei caratteri solo limitata e non tutti posseggono la facoltà sensibile con cui si
apprezzano. Inoltre esse non sono vere e proprie raffigurazioni dei caratteri ma, in quanto costituite di
disegno e colori, che sono sintomi di emozioni, piuttosto segni di essi ».
312
In una intuizione che, come giustamente è stato notato, anticipa il segno iconico
peirceano, Aristotele misura la manchevolezza mimetica della rappresentazione
figurativa rispetto alla musica, per quanto concerne l’ἦqoς, proprio riconoscendo che
l’“icona” è solo un segno, un shme‹on di ciò che rappresenta a livello di ἦqoς, mentre la
musica innesca una corrispondenza non semplicemente allusiva e indiretta, ma effettiva
e diretta, un “re-enactment” appunto, un “suscitare” l’emozione anziché indicarla:
™n δὲ to‹j mšlesin aÙto‹j œsti mim»mata tîn ºqîn (kaˆ toàt' ™stˆ fanerÒn· eÙqÝj g¦r ¹ tîn
¡rmoniîn dišsthke fÚsij, éste ¢koÚontaj ¥llwj diat…qesqai kaˆ m¾ tÕn aÙtÕn œcein trÒpon
prÕj ˜k£sthn aÙtîn, ¢ll¦ prÕj mὲn ™n…aj Ñdurtikwtšrwj kaˆ sunesthkÒtwj m©llon, oŒon prÕj
t¾n mixoludistˆ kaloumšnhn, prÕj dὲ t¦j malakwtšrwj t¾n di£noian, oŒon prÕj t¦j ¢neimšnaj,
mšswj dὲ kaˆ kaqesthkÒtwj m£lista prÕj ˜tšran, oŒon doke‹ poie‹n ¹ dwristˆ mÒnh tîn
340
¡rmoniîn, ™nqousiastikoÝj d' ¹ frugist……).
In breve: l’“icona” si limita a “stare per” ἦqoς, come si dice nella moderna
semiotica, ossia a rimandare ad esso in un rinvio concettuale mediato dal
riconoscimento di una somiglianza percettiva, si limita insomma ad esserne segno; la
musica invece suscita direttamente l’ἦqoς nell’animo di chi ascolta, non si limita a
rappresentarlo, a simboleggiarlo, ad imitarne l’apparenza in maniera più o meno
somigliante e riconoscibile: essa non ne copia la forma percettiva divenendone un
simulacro, ma lo ri-produce nella sua effettiva realtà, seppure in modo artificiale.
Naturalmente la questione specifica, che poi rimarrà sempre al centro del dibattito
occidentale sulla musica, qui non ci riguarda; ciò che ora ci interessa è invece che
questo processo non già di rappresentazione, allusione o copia, ma di ri-produzione non
solo è mimesis a tutti gli effetti, ma lo è addirittura in grado superiore a ogni altra forma
di mimesis.
Come in tante altre questioni moderne di semiotica e di estetica, la musica è di
fondamentale importanza anche per comprendere più adeguatamente la categoria della
mimesis. Proprio il fatto che la musica costituisca per le teorie antiche un fatto di
mimesis pacifico e perfettamente organico alla categoria ci dà la misura di quanto la
vulgata di una mimesis intesa come realismo imitativo sia fuorviante. Per noi moderni è
infatti piuttosto ovvio che se le altre arti rivelano sempre in un certo grado un rapporto
con un mondo reale rappresentato, la musica invece è senz’altro fra tutte quella più
340
Trad.: « Le melodie hanno invece in se stesse la possibilità di imitare i costumi. Questo è evidente.
Infatti intanto la natura delle armonie è varia, sicché ascoltandole ci disponiamo in modo diverso di fronte
a ognuna di esse: di fronte ad alcune ci sentiamo presi da dolore e da raccoglimento, come quando si
tratta dell’armonia chiamata mixolidia; altre più rilassate inducono pensieri morbidi; l’armonia dorica
sembra invece l’unica che ispiri compostezza e moderazione, mentre dalla frigia deriva l’entusiasmo ».
313
“pura” e “astratta”. Se invece per gli antichi era del tutto aproblematico che la musica
fosse un fenomeno di mimesis, ad era anzi la mimesis per eccellenza (si ricordi che la
teoria mimetica musicale di Damone precede e influenza Platone e Aristotele), ciò
dipende appunto dal fatto che tale categoria con il realismo rappresentativo e con ciò
che oggi intendiamo quando specifichiamo che una rappresentazione è “mimetica” non
aveva nulla a che fare. Mimetica, nel senso originario, non è dunque solo la musica che
allude, simulandoli, a suoni del mondo reale, come nella Primavera di Vivaldi o nel
Temporale (terzo movimento) della Sesta sinfonia di Beethoven, ma tutta la musica, o
almeno tutta quella parte decisamente maggioritaria della musica che intende avere una
dimensione emozionale.
Quanto abbiamo appena esaminato attraverso l’etimologia e l’applicazione della
categoria mimetica alla musica chiarisce molto bene, a mio avviso, che è proprio nel
processo di “ri-produzione”, di “ri-messa in opera” che in generale la mimesis consiste
(indipendentemente dal fatto che sia mimesis di ἤqh o di altro), e non nella produzione
di copie più o meno somiglianti ad un modello reale: al contrario, l’etimologia
evidenzia palesemente il carattere illusorio, di finzione, di simulazione, connesso con la
magia, l’apparizione fantasmatica, l’inganno 341 . L’equivoco nasce solo quando il
processo di “ri-produzione” concerne nella fattispecie l’aspetto visivo di una forma
esteriore, poiché in quel caso la riproduzione dell’aspetto comporta la riproduzione di
una somiglianza percettiva, come nel frammento dei Theoroi di Eschilo; ma questo è
soltanto un caso particolare di mimesis, in cui la somiglianza percettiva dipende in
maniera contingente dalla specifica natura dell’oggetto della mimesis, e non
dall’essenza di tale processo, che invece, come abbiamo visto, concerne senz’altro
anche il suscitare una condizione emozionale parallela alla realtà e non meramente
simbolica e allusiva ad essa. Ciò che è fondamentale sottolineare, allora, è che
l’equivoco sul significato della mimesis è un equivoco del tutto moderno: a qualunque
ambito il termine fosse riferito (musicale, coreutico, poetico, figurativo ecc.) ed entro
qualunque teoria specifica, esso non implicava per il parlante greco l’idea di “copiare
l’immagine o l’aspetto in maniera fedele”, ma semmai l’idea di “simulare un aspetto
illusorio e artificiale”.
341
Nota è la correlazione platonica fra arte e incantesimo (γοητεία), espressa ad es. in Repubblica, 602, d,
2-4: una concezione che all’epoca di Platone era in realtà vulgata, già espressa in precedenza dai
Pitagorici e da Gorgia. Il rapporto fra l’attitudine mimetica e la magia, d’altronde, è stato spesso messo in
evidenza soprattutto dall’antropologia e dalla sociologia: a tali acquisizioni fanno riferimento
HORKHEIMER e ADORNO nella Dialettica dell’illuminismo parlando della mimesis (p. 23, ed. Einaudi,
dove citano HUBERT, H. – MAUSS, M., Teoria generale della magia).
314
Ma a riprova di questo significato fondamentale della categoria della mimesis,
perfettamente conforme all’etimologia proposta, ancora più clamoroso è il caso del fr.
107a Maehler di Pindaro:
PelαsgÕn †ppon À kÚna
'Amυkl£ian ¢gwn…J
™lεlizÒmenoj podˆ mimšo kampÚlon mšloj dièkwn342
Qui la mimesis realizza nella danza la simulazione del movimento di vari animali:
l’idea originaria ravvisata nell’etimologia diviene stavolta davvero evidentissima nel
significato di “simulare l’aspetto altrui attraverso la gestualità”, dunque non già
assumendone l’immagine statica nella maniera il più possibile somigliante, ma
riproducendone l’apparenza attraverso un processo in divenire, che colga e ripeta alcuni
tratti pertinenti di un movimento peculiare (in questo caso animale), tanto da permettere
il riconoscimento del modello. L’idea di fondo, di nuovo, non è dunque la somiglianza
ad un’immagine, ma la ri-produzione di un processo: una particolare forma di
movimento. Come si vede, qui è ancora molto forte il contatto con il significato
originario di rappresentazione gestuale che µῖµος, a differenza dei suoi derivati,
conserverà sempre343.
Per riassumere, la ricostruzione etimologica proposta, che estende il raffronto con
māyā proposto da Schulze – attraverso un eccellente parallelo dai Ṛg-Veda – a un più
342
Trad.: « Imita il cavallo Pelasgico o il cane Amicleo volteggiando su piede competitivo, seguendo la
sinuosa melodia (la curva del canto) » (traduzione mia).
343
L’etimologia proposta rende conto dunque anche della connessione originaria – ma lì certo
sopravvalutata – della mimesis con la danza e con la ritualità che è la tesi fondamentale di KOLLER, H.,
Die Mimesis in der Antike, cit.: « L’osservazione che µῖµος e tutti i concetti da esso derivati siano
originariamente proprio solo della sfera del culto, e precisamente del culto orgiastico, come il fatto che,
nonostante l’applicabilità metrica, essi non compaiano nella prima lingua letteraria, e non offrano
connessioni con le lingue indogermaniche, ci porta alla supposizione che µῖµος indichi l’attore e la
maschera del dramma cultuale dionisiaco. Indipendentemente dal tentativo di spigazione, è certo che
µιµεῖσθαι indica una rappresentazione danzata e che da qui si sono sviluppati i suoi successivi impieghi »
(p. 17 della trad. it. su Studi di estetica, 1993). L’individuazione di connessioni con una radice
indoeuropea ci ha portato a correggere decisamente non solo la supposizione, decisamente azzardata, del
significato di µῖµος come termine tecnico della rappresentazione rituale, ma anche ciò che a Koller
sembrava una certezza, l’originarietà della connessione con la danza. La comparazione indoeuropea ci
porta invece a spiegare l’applicazione del termine alla danza come un caso particolare della sua più
generale connessione con la gestualità ingannevole e illusoria, che è il vero significato della radice. Ciò
dimostra anche, tra l’altro, l’importanza della ricostruzione etimologica dei concetti e gli errori
interpretativi cui si va incontro se si prescinde da un tale approccio. L’originario collegamento greco con
la danza (smentito dal ben più antico termine sanscrito e dalla comparazione linguistica) risulta
esattamente dall’errore di metodo chiarito in apertura del capitolo: Koller desume il significato solo
dall’estensione del termine, apparentemente limitato alla danza nelle sue attestazioni più antiche, e ne
deduce un significato erroneo desunto meramente da tale uso e anzi su di esso “accomodato”; egli non
prende in considerazione il fatto che l’intensione – che come si è visto rimanda invece alla ri-produzione
finta e ingannevole dell’aspetto attraverso la gestualità – può adattarsi al concetto di danza senza
dipendere direttamente da esso, e ciò anche quando le sue (peraltro scarse) attestazioni originarie siano
limitate a quell’uso estensionale.
315
ampio quadro indoeuropeo, correggendone profondamente anche il significato
ricostruito, evidenzia come la radice greca di mimesis in origine non esprima in sé
alcuna idea di somiglianza, ma semmai al contrario un’idea di illusione, di finzione,
particolarmente connessa – almeno in origine – con una gestualità che la simula
attraverso un attivo processo di ri-produzione, e interferisce senz’altro non con la sfera
della natura, ma al contrario con quella della magia e del soprannaturale. La
somiglianza è solo un’idea accessoria, secondaria: ogni finzione, per riuscire ad
ingannare, deve soddisfare un certo grado di somiglianza, che tuttavia non è espressa di
per sé dall’etimo, ma implicata soltanto come corollario logico proprio dal carattere di
finzione e illusorietà. Mimesis significa dunque: ri-produrre in un processo illusorio e
artificiale un modello reale simulato. Come si vede, siamo lontanissimi dalla vulgata
che interpreta la mimesis come specchio fedele della natura e che permette ad Auerbach
di intitolare ad essa un saggio sul realismo in letteratura 344 . La mimesis è proprio
l’opposto: è l’irrealismo della rappresentazione, e la teoria su di essa fondata è una
teoria dell’irrealismo, una teoria della finzione artistica. Le idee che ad essa si
avvicinano di più sono la gestualità illusoria, la simulazione, la visione illusoria di una
realtà apparente e fantasmatica.
3. Il concetto di mimesis in Platone e Aristotele
Considerando i principali studi più recenti sull’argomento, mi pare di poter
affermare che soprattutto l’idea vulgata, ancora del tutto diffusa, di un’imitazione tanto
più perfetta quanto maggiore è il grado di somiglianza con il modello e con la natura sta
cominciando a rivelarsi non solo una banalizzazione, ma in gran parte proprio un
travisamento 345 . L’etimologia qui proposta mi pare rafforzare decisamente questa
convinzione, non perché la teoria estetica non possa marcare uno scarto semantico
344
Per una critica alla concezione auerbachiana della mimesis, comprensibilmente conforme alla vulgata
otto-novecentesca del termine, cfr. GEBAUER, G. - WULF, C., La mimesis in Auerbach, «Stuadi di
estetica», 7/8 (1993), pp. 129-140 (ed. orig. in Mimesis. Kultur-Kunst-Gesellschaft, Rowohlts
Enzyklopädie, Hamburg, 1992, pp. 18-26).
345
Cfr. già KOLLER, H., Die Mimesis in der Antike, cit., ma più di recente soprattutto l’ampio saggio di
HALLIWELL, S., L’estetica della mimesis, cit., la cui tesi fondamentale è che il concetto di mimesis non sia
affatto univoco o riducibile ad una concezione unitaria nella diacronia della sua millenaria storia: « Uno
dei miei assunti principali è infatti che la mimesis sia un concetto intrinsecamente ambiguo e bivalente.
[…] Pur entro una schematica e tuttavia istruttiva dicotomia, si può dire che questa varietà della teoria e
dell’atteggiamento mimetico comportino una differenza tra il modello di una rappresentazione artistica
che “riflette il mondo” (lo “specchio” ne è stato un comune ma talvolta poco chiaro emblema metaforico)
e la concezione di una rappresentazione artistica che invece “simula (o crea) il mondo” » (p. 28).
316
nell’acquisizione di un termine d’uso comune (cosa che anzi senz’altro avviene: direi
piuttosto che l’influenza è reciproca), ma perché, come ho cercato di chiarire prima, se
rispetto al nostro modo di intendere la categoria della mimesis c’è non solo uno scarto
estensionale ma anche un ulteriore scarto intensionale, quest’ultimo può benissimo
passare inosservato ai nostri occhi, poiché non riguarda l’aspetto macroscopico
dell’individuazione di ciò di cui si sta parlando, ma la ben più sottile sfumatura di quale
aspetto si sta mettendo in evidenza di quell’oggetto del discorso 346 . Nelle originarie
formulazioni di Platone e Aristotele è piuttosto evidente, d’altronde, che il grado di
somiglianza con l’originale non è affatto il presupposto della mimesis. Molto chiaro a
riguardo è un celebre passo del Cratilo (432 b-d):
SW. […] «r' ¨n dÚo pr£gmata e‡h toi£de, oŒon KratÚloj kaˆ KratÚlou e„kèn, e‡ tij qeîn m¾
mÒnon tÕ sÕn crîma kaˆ scÁma ¢peik£seien ésper oƒ zwgr£foi, ¢ll¦ kaˆ t¦ ™ntÕj p£nta
toiaàta poi»seien oŒ£per t¦ s£, kaˆ malakÒthtaj kaˆ qermÒthtaj t¦j aÙt¦j ¢podo…h, kaˆ
k…nhsin kaˆ yuc¾n kaˆ frÒnhsin o†aper ¹ par¦ soˆ ™nqe…h aÙto‹j, kaˆ ˜nˆ lÒgJ p£nta ¤per sÝ
œceij, toiaàta ›tera katast»seien plhs…on sou; pÒteron KratÚloj ¨n kaˆ e„kën KratÚlou tÒt'
e‡h tÕ toioàton, À dÚo KratÚloi;
KR. DÚo œmoige dokoàsin, ð Sèkratej, KratÚloi.
SW. `Or´j oân, ð f…le, Óti ¥llhn cr¾ e„kÒnoj ÑrqÒthta zhte‹n kaˆ ïn nund¾ ™lšgomen, kaˆ
oÙk ¢nagk£zein, ™£n ti ¢pÍ À prosÍ, mhkšti aÙt¾n e„kÒna eἶnai; À oÙk a„sq£nV Ósou ™ndšousin
aƒ e„kÒnej t¦ aÙt¦ œcein ™ke…noij ïn e„kÒnej e„s…n;
KR. ”Egwge.
SW. Gelo‹a goàn, ð KratÚle, ØpÕ tîn Ñnom£twn p£qoi ¨n ™ke‹na ïn ÑnÒmat£ ™stin t¦
ÑnÒmata, e„ p£nta pantacÍ aÙto‹j Ðmoiwqe…h. ditt¦ g¦r ¥n pou p£nta gšnoito, kaˆ oÙk ¨n œcoi
aÙtîn e„pe‹n <oÙdeˆj> oÙdšteron ÐpÒterÒn ™sti tÕ mὲn aÙtÒ, tÕ δὲ Ônoma.
KR. 'AlhqÁ lšgeij347.
La mimesis prodotta tanto dalle immagini quanto dalle parole non mira affatto alla
maggior somiglianza possibile, al fedele rispecchiamento del reale, alla produzione di
copie o duplicati, il cui risultato paradossale (ditt¦ g¦r ¥n pou p£nta gšnoito) è
esplicitamente considerato niente meno che ridicolo (gelo‹a) sin da questa prima
346
Tanto più il fraintendimento può passare inosservato, naturalmente, se i concetti sono come nel nostro
caso contigui: l’idea di simulazione dell’aspetto altrui, che implica una certa somiglianza a veicolare
l’inganno, può benissimo confondersi, in maniera generalizzata, con l’idea della riproduzione di una
somiglianza che tenda alla perfetta identità come caso limite.
347
Trad.: « SOCRATE: […] Potrebbero dunque essere due cose queste, poniamo, Cratilo e l'immagine di
Cratilo, se un dio non solo rappresentasse il tuo colore e il tuo aspetto come i pittori, ma rendesse anche
tutto quello che si trova nell'intimo, come il tuo e poi riproducesse le tue morbidezze e gli stessi colori e il
movimento e l'anima e il pensiero vi iscrivesse all'interno come sono in te, e in una parola tutto quello che
tu hai, questa e altre cose ponesse vicino a te? E tutto questo allora sarebbe Cratilo, o l'immagine di
Cratilo, oppure due Cratili? CRATILO: A mio parere, Socrate, due Cratili. SO: Tu capisci dunque, amico,
che occorre ricercare un'altra correttezza di immagine rispetto alle considerazioni che dicevamo poco fa, e
non considerare necessario che se qualcosa manchi o sia in eccesso, questa non sia più immagine. O non
ti rendi conto di quanto le immagini siano lontane dall'avere le stesse cose che hanno quelle di cui sono le
immagini? CR: Sì. SO: E sarebbe proprio ridicolo, Cratilo, quello che a causa dei nomi potrebbe toccare
alle cose delle quali i nomi sono i nomi, se i nomi fossero in tutto simili a esse. Tutte le cose dunque
assumerebbero un duplice aspetto, e nessuno avrebbe più la possibilità di dire di alcuna di esse, quale è la
cosa stessa e quale il nome. CR: Dici la verità ».
317
formulazione platonica. E anche la Poetica di Aristotele, il testo che sarà sempre
considerato il fondamento di ogni teoria della mimesis nell’arte, è in effetti piuttosto
chiaro: se la mimesis implica certamente la somiglianza (homoiotes), non è certo il
grado di somiglianza a definirne il livello di perfezione e compiutezza; anzi, proprio il
grado di diversità rispetto al modello imitato è addirittura il presupposto stesso della
teoria aristotelica dei generi letterari come delle modalità di rappresentazione dell’arte
figurativa (1448a 1-18):
'Epeˆ d mimoàntai oƒ mimoÚmenoi pr£ttontaj, ¢n£gkh d toÚtouj À spouda…ouj À faÚlouj
eἶnai (t¦ g¦r ½qh scedÕn ¢eˆ toÚtoij ¢kolouqe‹ mÒnoij, kak…v g¦r kaˆ ¢retÍ t¦ ½qh diafšrousi
p£ntej), ½toi belt…onaj À kaq' ¹m©j À ce…ronaj À kaˆ toioÚtouj, ésper oƒ grafe‹j· PolÚgnwtoj
mn g¦r kre…ttouj, PaÚswn d ce…rouj, DionÚsioj d Ðmo…ouj e‡kazen. dÁlon d Óti kaˆ tîn
lecqeisîn ˜k£sth mim»sewn ›xei taÚtaj t¦j diafor¦j kaˆ œstai ˜tšra tù ›tera mime‹sqai
toàton tÕn trÒpon. kaˆ g¦r ™n Ñrc»sei kaˆ aÙl»sei kaˆ kiqar…sei œsti genšsqai taÚtaj t¦j
¢nomoiÒthtaj, kaˆ [tÕ] perˆ toÝj lÒgouj d kaˆ t¾n yilometr…an, oŒon “Omhroj mn belt…ouj,
Kleofîn d Ðmo…ouj, `Hg»mwn d Ð Q£sioj <Ð> t¦j parJd…aj poi»saj prîtoj kaˆ Nikoc£rhj Ð
t¾n Deili£da ce…rouj· Ðmo…wj d kaˆ perˆ toÝj diqur£mbouj kaˆ perˆ toÝj nÒmouj, ésper g©s
KÚklwpaj TimÒqeoj kaˆ FilÒxenoj mim»saito ¥n tij. ™n aÙtÍ d tÍ diafor´ kaˆ ¹ tragJd…a
prÕj t¾n kwmJd…an dišsthken· ¹ mn g¦r ce…rouj ¹ d belt…ouj mime‹sqai boÚletai tîn nàn348.
E se si è spesso detto che il senso del termine mimesis è forse reso meglio, oggi,
se tradotto con “rappresentazione” più che con “imitazione”349, forse la stessa categoria
348
Trad.: « Poiché chi imita, imita persone in azione, queste non possono che essere o serie o dappoco (i
caratteri seguono quasi sempre solo questi due tipi, perché gli uomini, per quanto riguarda il carattere, si
distinguono per vizio o per virtù), persone cioè o migliori di noi, o peggiori di noi, o come noi (così anche
i pittori: Polignoto li rappresentava migliori, Pausone peggiori, Dionisio simili). È chiaro dunque che
ognuna delle suddette imitazioni presenterà queste differenze e si distinguerò per il fatto di imitare in
questo senso oggetti diversi. Anche nella danza, nell’auletica e nella citaristica si possono avere queste
differenze, come nella prosa e nella poesia senza canto: così Omero rappresenta gli uomini migliori,
Cleofonte simili, Egemone di Taso, che fu il primo a scrivere parodie, e Nicocare, l’autore della Viliade,
peggiori. Lo stesso avviene nei ditirambi e nei nomi, come […] i Ciclopi di Timoteo e di Filosseno.
Proprio questa è la differenza tra tragedia e commedia: la commedia vuole rappresentare gli uomini
peggiori, la tragedia migliori che nella realtà attuale ».
349
Cfr. HALLIWELL, S., L’estetica della mimesis, cit., p. 22-24: « L’ostacolo più grande frapposto a una
puntuale comprensione delle molteplici varianti dell’esperienza mimetica, antica e moderna, viene
dall’alone negativo che circonda la più usuale (e deplorevole) traduzione del termine mimesis con il
termine imitazione (e con i suoi equivalenti nelle altre lingue moderne). […] Per questa ragione soltanto
[la possibilità che non sia sempre implicato un “originale”] la traduzione di mimesis con “imitazione” si
dimostra inaffidabile anche per la maggior parte delle prime occorrenze del termine e dei suoi correlati.
Riesce invece più utile ammettere che, già da una fase antica, la mimesis, applicata alla poesia, alle arti
visive, alla musica, alla danza etc., rimonta al concetto (o alla famiglia concettuale) della
rappresentazione ». Ma sulla questione cfr. anche la giusta osservazione di PADUANO, G., Introduzione ad
ARISTOTELE, Poetica, Bari, Laterza, 1998, p. X: « Per questo qualcuno ha proposto per il termine greco
mimesis, che ricopre uno spettro comunque più ampio, una versione diversa ed esente da ogni ombra
derogatoria quale “rappresntazione”; ma, a parte il fatto che un simile scarto rispetto a una classicità
canonica e inveterata produrrebbe uno stridente effetto di anacronismo, non sono sicuro che proprio
“imitazione” non garantisca meglio lo stretto rapporto tra letteratura e vita, e dunque l’autenticità che
dall’una ricade sull’altra ». Naturalmente la questione della traduzione più adatta non interferisce con
l’indipendente bisogno di approfondire il senso del concetto, al di là di una terminologia sempre di
necessità imperfetta. La progressiva sostituzione del termine “rappresenazione” al tradizionale termine
“imitazione” (imitation > representation; Nachahmung > Darstellung ecc.) risale all’estetica romantica e
alla sua connessione radicale dell’arte con l’immaginazione e l’individualità interiore, come ricorda ad es.
318
della homoiotes differisce in maniera piuttosto significativa – sia per intensione che per
estensione – dalla nostra idea della “somiglianza”, rivelandosi spesso più vicino alla
nostra categoria di “corrispondenza” 350 , che individua un rapporto biunivoco e
funzionale fra elementi di ambiti diversi senza presupporne necessariamente affinità
“esteriori” e formali che da tale rapporto prescindano: la parziale incongruenza della
traduzione si può notare già in un passo della stessa Poetica, relativa appunto al senso
della mimesis, 1454b, 8-12: ™peˆ dὲ m…mhs…j ™stin ¹ tragJd…a beltiÒnwn À ¹me‹j,
de‹ mime‹sqai toÝj ¢gaqoÝj e„konogr£fouj· kaˆ g¦r ™ke‹noi ¢podidÒntej t¾n
„d…an morf¾n Ðmo…ouj poioàntej kall…ouj gr£fousin 351 , dove appunto l’essere
homoios non è minimamente contraddittorio con l’essere kallion, “più bello”, e dunque
appunto dissimile.
Se ciò non bastasse, uno dei concetti fondamentali della mimesis delle azioni
umane che nella teoria letteraria di Aristotele sta alla base della letteratura è
precisamente la constatazione, in opposizione al senso comune, che la riproduzione del
reale e di eventi così come sono – ciò che fa lo storico, ad esempio – non è affatto
mimesis e dunque neppure letteratura, poiché 1) non opera, nel reale, una selezione di
elementi individuati come significativi, e non invece meramente accaduti e dunque solo
contingenti, e 2) non determina una loro conseguente ri-strutturazione complessiva
secondo i criteri di verosimiglianza e necessità, ossia secondo una legame forte di senso
costruito da colui che, proprio in virtù di tale operazione, prende il nome di poietes
(creatore). Celebri i passi in cui questi principi, più volte ribaditi, sono esposti nella
maniera più estesa (Poetica, 1451a, 30 sgg):
cr¾ oân, kaq£per kaˆ ™n ta‹j ¥llaij mimhtika‹j ¹ m…a m…mhsij ˜nÒj ™stin, oÛtw kaˆ tÕn
màqon, ™peˆ pr£xewj m…mhs…j ™sti, mi©j te e nai kaˆ taÚthj Ólhj, kaˆ t¦ mšrh sunest£nai tîn
pragm£twn oÛtwj éste metatiqemšnou tinÕj mšrouj À ¢fairoumšnou diafšresqai kaˆ kine‹sqai
tÕ Ólon· Ö g¦r prosÕn À m¾ prosÕn mhd n poie‹ ™p…dhlon, oÙdὲn mÒrion toà Ólou ™st…n.
FanerÕn δὲ ™k tîn e„rhmšnwn kaˆ Óti oÙ tÕ t¦ genÒmena lšgein, toàto poihtoà œrgon
™st…n, ¢ll' oŒa ¨n gšnoito kaˆ t¦ dunat¦ kat¦ tÕ e„kÕj À tÕ ¢nagka‹on. Ð g¦r ƒstorikÕj kaˆ Ð
BLOCK, H. M., The concept of imitation in modern criticism, in Actes du IVe Congrès de l'Association
Internationale de Littérature Comparée, ed. Jost, F., The Hague, Mouton, 1966, pp. 717-718. È utile
tener presente, però, che già in età rinascimentale FRACASTORO, nel Naugerius (1555), 6.6, propone
esattamente la stessa duplicità terminologica: «scis enim Poeticam a Platone et Aristotele imitatoriam
artem vocari, nihil autem refert, sive imitari, sive repraesentare dicamus».
350
Homoios, a differenza del nostro “simile”, indica fra l’altro anche il permanere della stessa cosa nel
tempo (dunque l’essere corrispondente, non certo simile, a se stesso), la conformità a una certa categoria
o la corrispondenza di cose fra loro, la corrispondenza in grado sociale, persino in matematica il prodotto
di due fattori uguali (dunque certo non somiglianti, ma corrispondenti l’uno all’altro).
351
Trad.: « E poiché la tragedia è imitazione di persone migliori di noi, occorre imitare i buoni ritrattisti, i
quali proprio riproducendo la fisionomia specifica e facendo somiglianti i loro modelli li dipingono
migliori ».
319
poiht¾j oÙ tù À œmmetra lšgein À ¥metra diafšrousin (e‡h g¦r ¨n t¦ `HrodÒtou e„j mštra
teqÁnai kaˆ oÙdὲn Âtton ¨n e‡h ƒstor…a tij met¦ mštrou À ¥neu mštrwn)· ¢ll¦ toÚtJ diafšrei,
tù tÕn mὲn t¦ genÒmena lšgein, tÕn dὲ oŒa ¨n gšnoito. diÕ kaˆ filosofèteron kaˆ spoudaiÒteron
po…hsij ƒstor…aj ™st…n· ¹ mὲn g¦r po…hsij m©llon t¦ kaqÒlou, ¹ d' ƒstor…a t¦ kaq' ›kaston
lšgei. œstin dὲ kaqÒlou mšn, tù po…J t¦ po‹a ¥tta sumba…nei lšgein À pr£ttein kat¦ tÕ e„kÕj À
tÕ ¢nagka‹on, oá stoc£zetai ¹ po…hsij ÑnÒmata ™pitiqemšnh· tÕ dὲ kaq' ›kaston, t… 'Alkibi£dhj
œpraxen À t… œpaqen.
[…]
dÁlon oân ™k toÚtwn Óti tÕn poiht¾n m©llon tîn mÚqwn eἶnai de‹ poiht¾n À tîn mštrwn, ÓsJ
poiht¾j kat¦ t¾n m…mhs…n ™stin, mime‹tai dὲ t¦j pr£xeij. k¨n ¥ra sumbÍ genÒmena poie‹n, oÙqὲn
Âtton poiht»j ™sti· tîn g¦r genomšnwn œnia oÙdὲn kwlÚei toiaàta eἶnai oŒa ¨n e„kÕj genšsqai
[kaˆ dunat¦ genšsqai], kaq' Ö ™ke‹noj aÙtîn poiht»j ™stin352.
L’essenza della mimesis, insomma, ben più che nella riproduzione di una
somiglianza rispetto a un modello, consiste invece nel “ri-mettere in opera”,
ricollocandoli a formare una nuova struttura di senso, elementi selezionati e desunti (in
quanto pertinenti) da un oggetto-modello, o se volgiamo da un repertorio, naturale o
artificiale che sia. La mimesis è nella sua essenza poiesis: il poeta poiht¾j kat¦ t¾n
m…mhs…n ™stin, ossia è creatore non già nonostante la mimesis, ma precisamente in virtù
della mimesis. Che poi il prodotto della mimesis intrattenga anche delle relazioni di
somiglianza con il modello, naturalmente, non è affatto escluso, anzi: è il corollario
stesso di questo presupposto, in quanto, affinché possa darsi l’individuazione di questa
corrispondenza o relazione funzionale fra elementi del modello ed elementi della sua
rappresentazione o ri-produzione, è necessario appunto un qualche criterio preventivo di
individuazione della corrispondenza e del riconoscimento che tale relazione istituisce.
Ma d’altra parte l’individuazione della somiglianza, come è stato dimostrato in diversi
ambiti di studio, non è una capacità naturale, innata, obiettiva, ma una competenza che
si acquisisce culturalmente: essa necessita insomma che siano stabiliti, per via
convenzionale, dei criteri in qualche misura sempre arbitrari sulla cui base la
352
Trad.: « Come dunque, nelle altre imitazioni, è imitazione unitaria quella di un solo oggetto, così
anche la trama, essendo imitazione di un’azione, deve esserlo di una sola e intera, e le parti che la
compongono devono essere collegate in modo tale che, cambiando o togliendo una parte, l’intero risulti
alterato e sconneso: infatti quello che, presente o assente, non produce conseguenze evidenti, non è parte
dell’intero.
Da quanto si è detto risulta chiaro che compito del poeta non è dire ciò che è avvenuto ma ciò che
potrebbe avvenire, vale a dire ciò che è possibile secondo verosimiglianza o necessità. Lo storico e il
poeta non differiscono tra loro per il fatto di esprimersi in versi o in prosa – ma si potrebbe mettere in
versi le storie di Erodoto, e in versi come in prosa resterebbero comunque storia –, ma differiscono in
quanto uno dice le cose accadute e l’altro quelle che potrebbero accadere. Per questo motivo la poesia è
più filosofica e più seria della storia, perché la poesia si occupa piuttosto dell’universale, mentre la storia
racconta i particolari. Appartiene all’universale il fatto che a qualcuno capiti di dire o di fare certe cose
secondo verosimiglianza o necessità, e a questo mira la poesia, aggiungendo successivamente i nomi;
appartiene invece al particolare dire cosa ha fatto o cosa è capitato ad Alcibiade.
[…]
È chiaro dunque che il poeta deve essere creatore di trame piuttosto che di versi, perché è poeta in quanto
imita, e imita le azioni. Se gli capita di rappresentare fatti avvenuti, è ugualmente poeta: niente impedisce
infatti che tra i fatti avvenuti ce ne siano alcuni che è verosimile che avvengano, e secondo una tale
verosimiglianza ne è lui il creatore ».
320
somiglianza possa essere individuata, selezionandone i tratti pertinenti353. Il che è, in
fondo, ciò che presuppone il passo del Cratilo citato sopra, quando viene messo in
evidenza quanto sia marcata la diversità fra l’immagine e l’oggetto che essa rappresenta
(À oÙk a„sq£nV Ósou ™ndšousin aƒ e„kÒnej t¦ aÙt¦ œcein ™ke…noij ïn e„kÒnej
e„s…n;): l’immagine seleziona – arbitrariamente – solo alcuni tratti culturalmente
considerati pertinenti al riconoscimento della somiglianza, mentre ne esclude altri come
non pertinenti; la scultura ne seleziona altri decisamente diversi; una descrizione fatta a
parole ne seleziona altri ancora ecc. Non è dunque la scelta del criterio di somiglianza in
sé a determinare il fatto di essere o meno in presenza di una mimesis, ma soltanto la
riconducibilità (non la somiglianza) dei tratti pertinentizzati ad un modello dato e
individuabile, dalla cui preesistenza gli elementi rielaborati nella mimesis traggono il
loro significato per ristrutturarlo in un’autonoma strategia di senso: in assenza del
modello, dunque, ciò che manca di essenziale non è né il riconoscimento di una
somiglianza, né l’oggetto da cui desumere una (presunta) bellezza pregressa – secondo
dei travisamenti frequentissimi –, bensì il repertorio dal quale desumere il senso degli
elementi ri-messi in opera nella mimesis, senza il quale l’oggetto mimetico da essa
prodotto (mimema) risulterà appunto privo di senso e dunque di una possibilità adeguata
di lettura. Molto eloquente, a proposito, un altro passo della Poetica, 1448b, 15 sgg.:
di¦ g¦r toàto ca…rousi t¦j e„kÒnaj Ðrîntej, Óti sumba…nei qewroàntaj manq£nein kaˆ
sullog…zesqai t… ›kaston, oŒon Óti oátoj ™ke‹noj· ™peˆ ™¦n m¾ tÚcV proewrakèj, oÙc Î m…mhma
poi»sei t¾n ¹don¾n ¢ll¦ di¦ t¾n ¢pergas…an À t¾n croi¦n À di¦ toiaÚthn tin¦ ¥llhn a„t…an354.
353
Proprio da tale carattere “culturale” piuttosto che innato del riconoscimento della somiglianza muove
la celebre critica di ECO all’iconiscmo peirceano nel suo Trattato di semiotica generale, Milano,
Bompiani, 2008 (1975), cap. 3.5, pp. 256-284. A tale critica si dovrebbe rispondere, io credo, che sia pure
il riconoscimento di una somiglianza un dato culturale, non per questo esso cessa di essere la modalità in
cui quella specifica categoria di segni si istituisce: quei segni (iconici) sono segni in virtù
dell’individuazione di un forma che precede (e istituisce) il loro statuto di segni, essendo una forma
autonomamente individuabile nella realtà appunto in virtù di un riconoscimento: il riconoscimento di
quella forma che mi permette cioè di individuare un uomo o un cane in carne ed ossa (token) come
appartenente alla categoria astratta di uomo o cane (type) nell’esperienza del mondo prima ancora che
nella riproduzione figurativa (immagine dipinta o fotografia di un uomo o un cane). Il segno verbale
“cane”, invece, presenta una forma (la forma dell’espressione, ossia una precisa strutturazione della
materia dell’espressione – la dimensione sonora – di cui si compone) che non esiste in nessun modo nel
reale preventivamente alla sua istituzione arbitraria in quanto segno: quella forma è istituita solo al
momento dell’istituzione arbitraria del segno (aniconico, dunque). L’arbitrarietà del segno iconico,
inoltre, è del tutto preservata proprio in virtù della culturalizzazione delle specifiche pratiche
rappresentative. L’iconismo è dunque una categoria del tutto legittima: su di essa poggia il processo della
mimesis, che appunto si fonda non sul grado di somiglianza, ma semplicemente sul riconoscimento di cui
abbiamo parlato, che permette di ricondurre un segno a un referente reale preventivamente alla
comprensione del suo significato (che anzi veicola).
354
Trad.: « Si gode dunque a vedere le immagini perché contemplandole si impara e si ragiona su ogni
punto, per esempio che una certa figura è il tale. Se poi quell’immagine capita di non averla mai vista
prima, allora non procurerà piacere in quanto imitazione, ma per la sua fattura, il colore o qualche altro
motivo del genere ».
321
In assenza della pregressa conoscenza del modello (™¦n m¾ tÚcV proewrakèj),
l’oggetto prodotto potrà anche procurare piacere (poi»sei t¾n ¹don¾n), ma non in
quanto prodotto della mimesis (oÙc Î m…mhma) – naturalmente il riferimento alle
immagini è qui solo un caso particolare, portato come esemplificazione, di un fenomeno
concernente la mimesis in ogni sua forma. Un passo che, fra l’altro, sembra quasi
anticipare le teorie antimimetiche novecentesche, riconoscendo che la mimesis non è la
sola possibile modalità di suscitare il piacere della fruizione artistica, che può anche
dipendere dai materiali in sé (le forme e i colori puri dell’astrattismo, i suoni valorizzati
nella loro mera dimensione acustica della cosiddetta musica concreta ecc.). Cosa fra
l’altro niente affatto esclusa ma semmai solo inglobata e subordinata ad altri principi
nell’arte mimetica, come ben saprà chi, ad esempio, al Louvre si è stupito della
straordinaria tonalità di grigio che fa da sfondo al ritratto del Castiglione di Raffaello:
l’approccio semiotico al fenomeno artistico, d’altronde, riconosce questo aspetto come
uno degli elementi costitutivi della semiosi estetica in generale355.
Ecco allora che trova una sua spiegazione del tutto organica al resto del
ragionamento anche un passo – immediatamente precedente – che talvolta la critica ha
considerato estraneo e non direttamente pertinente alla teoria della mimesis
aristotelica356 (Poetica, 1448b, 5-9):
tÒ te g¦r mime‹sqai sÚmfuton to‹j ¢nqrèpoij ™k pa…dwn ™stˆ kaˆ toÚtJ diafšrousi tîn
¥llwn zówn Óti mimhtikètatÒn ™sti kaˆ t¦j maq»seij poie‹tai di¦ mim»sewj t¦j prètaj, kaˆ tÕ
ca…rein to‹j mim»masi p£ntaj357.
La mimesis di cui qui si parla come fondamento della capacità umana di
apprendimento non è un processo sostanzialmente diverso dalla mimesis artistica e ad
355
Cfr. ECO, U, Trattato di semiotica generale, cit., capp. 3.7.3, La manipolazione del continuum e 3.7.4,
L’ipocodifica estetica: l’espressione, pp. 332-336 («Ora, nel godimento estetico, tale materia riveste una
importante funzione, e ciò accade non al di là delle proprietà semiotiche del testo estetico, ma proprio
perché la materia è stata resa SEMIOTICAMENTE RILEVANTE. La materia del segnale diventa, nel testo
estetico, luogo di una ULTERIORE SEGMENTAZIONE […] Ciò significa che anche quei tratti individuali delle
occorrenze concrete che il normale discorso semiotico non prende in considerazione, qui assumono
importanza semiotica: la materia della sostanza diventa un aspetto della forma dell’espressione», p. 333).
356
Cfr. HALLIWELL, S., L’estetica della mimesis, cit., p. 138: «La più ampia applicazione della mimesis (o
dei vocaboli consimili) a forme non artistiche di comportamento umano o animale, ma talvolta anche a
oggetti inanimati, ne illumina il valore anche per le pratiche e per i prodotti dell’arte – con un’eccezione
principale: il nesso tra le finzioni giocose dei bambini e la mimesis artistica, che Aristotele stabilisce nel
capitolo IV della Poetica »; la questione è poi ripresa a p. 160, dove si conclude: « Qui non emerge alcun
elemento per cancellare le enormi differenze tra il giuoco dei bambini e, poniamo, una tragedia di Sofocle
o un affresco di Polignoto ».
357
Trad.: « L’imitare è congenito fin dall’infanzia all’uomo, che si differenzia dagli altri animali proprio
perché è il più portato a imitare, e attraverso l’imitazione si procura le prime conoscenze; dalle imitazioni
tutti ricavano piacere ».
322
essa estraneo: è anzi esattamente lo stesso processo di ri-produzione, di ri-messa in
opera di tratti pertinenti desunti da un modello imitato, che in questo passo potrebbe
riferirsi verosimilmente all’agire degli adulti e in particolare dei genitori (ma anche al
gioco), dal quale appunto il bambino individua gradualmente degli elementi pertinenti
come dotati di senso e li ri-produce a sua volta. Come ben si vede, il superlativo
mimhtikètaton non implica affatto la capacità umana di produrre una somiglianza in
sommo grado rispetto al modello, dunque qualcosa di fedele il più possibile
all’originale, ma di essere capace più che ogni altro animale di innescare questo
processo di ri-messa in opera, di rielaborazione di strutture dotate di senso.
Interpretata in questo modo, la mimesis appare qualcosa di decisamente meno
banale della vulgata che intorno ad essa hanno costruito nel tempo – certamente anche
per un mancato approfondimento della questione – i suoi detrattori. Essa appare invece
un processo che penetra molto a fondo il senso stesso dell’arte e che mostra, senza voler
per questo eccedere in forzature anacronistiche, non pochi punti di contatto con una
teoria semiotica dell’arte (d’altra parte la semiotica, come la gran parte degli ambiti del
sapere su cui ancora oggi riflettiamo, origina appunto dal pensiero greco antico, e
spesso collide con la discussione sulla mimesis, come nel passo del Cratilo citato
prima). La teoria della mimesis, infatti, sembra sostanzialmente trattare il rapporto fra
modello e oggetto prodotto dalla mimesis (mimema) alla stregua di un rapporto fra
codice ed espressione: l’opera d’arte mimetica, insomma, presuppone il proprio
modello non come fonte da cui trarre una bellezza riflessa attraverso la somiglianza, ma
come codice – di volta in volta nuovamente posto e stabilito – su cui fondare il senso di
un’espressione estetica autonoma, in quanto originata non già dal modello bensì dal
processo della sua ri-messa in opera (la mimesis, appunto).
4. L’imitatio rinascimentale e i suoi rapporti con la mimesis
Senza voler ripercorrere le pur rilevanti tappe intermedie (dalle filosofie
ellenistiche, al neoplatonismo, alla fondamentale tappa dalla latinità, fino problema
costituito dal Medioevo), saltiamo ora al momento della grande ripresa della mimesis
come cardine e fondamento dell’estetica nell’età umanistico-rinascimentale. Ciò che ci
interessa qui, infatti, non è tanto ripercorrere la storia dell’estetica della mimesis, quanto
ricollegare ad essa – cosa che negli studi di italianistica si evita puntualmente – la
323
concezione rinascimentale dell’imitatio: in questo modo, si presume, sarà possibile
evidenziare meglio tanto i suoi rapporti quanto le differenze con la concezione antica e
dunque le sue specificità, al fine di contribuire ad un chiarimento e ad una valutazione
più obiettiva di questa estetica che alla modernità, nonostante il pieno riconoscimento
dell’eccellenza dei risultati conseguiti nella prassi artistica che ne consegue, risulta
spesso estranea fino all’idiosincrasia.
Notoriamente, a impostare la ripresa della teoria mimetica come fondamento di
una nuova estetica della “rinascita” fu colui che può essere per tanti versi considerato il
padre dell’umanesimo, Petrarca. Com’è ovvio, non mancano già prima segnali di questa
rinascita dell’imitazione, come testimonia perentoriamente già Dante non solo, a livello
di prassi poetica, nel suo rapporto creativo di stampo proto-umanistico con i classici
latini, ma anche in alcuni luoghi della Commedia da cui traspare in modo palese una
concezione dell’arte che con la teoria mimetica ha molto a che fare. Più ancora che
alcuni celeberrimi passi in cui la concezione medievale degli auctores comincia a
volgersi esplicitamente in una più moderna visione del rapporto letterario con i classici
(ed es. Inf. I, vv. 85-87: « Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore, / tu se’ solo colui da cu’
io tolsi / lo bello stilo che m’ha fatto onore » o Purg. XXI, 97-99: « de l’Eneïda dico, la
qual mamma / fummi, e fummi nutrice, poetando: / sanz’ essa non fermai peso di
dramma », o anche in sede teorica: De vulgari eloquentia, II, 4 358 ), mi sembrano
significative le due grandi ekphraseis del primo girone di Purgatorio, dove comincia a
riemergere in modo evidente fino al paradosso una concezione dell’arte come
imitazione che corrisponde alla superiorità di Giotto rispetto a Cimabue (Purg. XI, 9496). I rilievi marmorei dei canti X e XII, confrontandosi con la tradizione classica
dell’ekphrasis, vecchia quanto la letteratura occidentale, ne desumono anche il
riferimento alla teoria mimetica, evidenziandone anzi il nodo più rilevante attraverso
una finzione paradossale: le opere d’arte qui descritte non sono semplicemente
“imitazioni” della natura ma, essendone artefice Dio stesso, potremmo dirle piuttosto
“sorelle” della natura e ad essa parallele:
Colui che mai non vide cosa nova
358
« Revisentes igitur ea que dicta sunt, recolimus nos eos qui vulgariter versificantur plerunque vocasse
poetas: quod procul dubio rationabiliter eructare presumpsimus, quia prorsus poete sunt, si poesim recte
consideremus: que nichil aliud est quam fictio rethorica musicaque poita. Differunt tamen a magnis
poetis, hoc est regularibus, quia magni sermone et arte regulari poetati sunt, hii vero casu, ut dictum est.
Idcirco accidit ut, quantum illos proximius imitemur , tantum rectius poetemur. Unde nos doctrine operi
intendentes doctrinatas eorum poetrias emulari oportet ». Naturalmente il principale punto di riferimento
teorico su tali questioni è per Dante l’Ars poetica oraziana.
324
produsse esto visibile parlare,
novello a noi perché qui non si trova.
Eppure, nonostante questo grado di parentela orizzontale anziché verticale, non
per questo cessano di essere imitazioni, e anzi della teoria mimetica antica portano
evidenti contrassegni nelle categorie della verosimiglianza (X, 37: dinanzi a noi pareva
sì verace) e del diletto (X, 97: mentr’io mi dilettava di guardare); ma soprattutto è
direttamente chiamato in causa il rapporto con la realtà-modello secondo l’opposizione
di matrice aristotelica fra vero e verosimile:
Qual di pennel fu maestro o di stile
che ritraesse l’ombre e ’ tratti ch’ivi
mirar farieno uno ingegno sottile?
Morti li morti e i vivi parean vivi:
non vide mei di me chi vide il vero,
quant’io calcai, fin che chinato givi.
A parte l’ulteriore riferimento alle categorie, di nuovo di matrice aristotelica, della
meraviglia (mirar; cfr. il thaumaston della Poetica) e della natura eminentemente
intellettuale del piacere estetico in quanto fenomeno di senso (ingegno sottile), evidente
è il rapporto di perfetta corrispondenza fra rappresentazione e modello, fra l’immagine e
il vero, ossia il reale, che lascerebbe supporre un’estetica della somiglianza, per cui
semplicemente quanto più i morti e i vivi sono simili ai morti e ai vivi reali, tanto più
l’opera è eccellente. Supposizione clamorosamente e paradossalmente smentita invece
sin dall’inizio (X, vv. 31-33), quando Dante personaggio vede la parete rocciosa
esser di marmo candido e addorno
d’intagli sì, che non pur Policleto,
ma la natura lì avrebbe scorno.
E se della superiorità artistica di Dio rispetto a Policleto possiamo – sulla fiducia –
farci una ragione, la superiorità della sua purgatoriale opera di finzione rispetto alla
natura stessa da lui creata non è più, come il diluvio biblico, una palinodia del creatore
insoddisfatto della sua creazione, ma qualcosa di radicalmente diverso: è
un’affermazione, attraverso la geniale forma letteraria di un supremo paradosso, del
primato della finzione artistica sul reale, o, per dirla in termini aristotelici, del
verosimile sul vero: cfr. il già citato passo 1454b, 9-12 kaˆ g¦r ™ke‹noi
[e„konogr£foi] ¢podidÒntej t¾n „d…an morf¾n Ðmo…ouj poioàntej kall…ouj
gr£fousin (e naturalmente anche Poetica, capitolo 9). Proprio lo splendido paradosso
325
di un Dio-artista che supera il se stesso creatore (in una sorta di caso limite
dell’aemulatio), così come l’arte ha un implicito primato sul reale, supera,
riprendendola, la concezione medievale del Dio artista e prelude dunque già all’estetica
dell’imitatio rinascimentale compendiata ad esempio, alla morte del suo più illustre
esponente nelle arti figurative, dall’epitaffio del Bembo, col quale il verso dantesco X,
33 mostra un’evidente consonanza:
Ille hic est Raphael timuit quo sospite vinci
rerum magna parens et moriente mori.
(En passant: proprio da Aristotele e dalla teoria della mimesis il primato dell’arte
sul reale e soprattutto lo scarto che essa marca rispetto a quello arriva, portato alle
estreme conseguenze, fino al cuore della massima negazione dell’estetica tradizionale,
l’Avanguardia novecentesca; nel Secondo manifesto del Surrealismo, 1930, si legge ad
esempio: « I surrealisti sostengono che la realtà è brutta per definizione; la bellezza
esiste unicamente in ciò che non è reale. È stato l’uomo a introdurre la bellezza nel
mondo. Per produrre il bello, bisogna allontanarsi il più possibile dalla realtà ». Ben più
di una coincidenza, naturalmente, e alla luce di quanto veniamo dicendo neppure poi
così sorprendente).
Solo con alcuni ben noti testi petrarcheschi, tuttavia, si arriva a una prima vera
teorizzazione di una ripresa consapevole dell’estetica imitativa, desumendo argomenti
tratti soprattutto da Orazio, Seneca, Macrobio. Il complessivo proporsi del nascente
umanesimo come “rinascita”, come una cultura nuova che trae la sua novità,
paradossalmente, proprio dal riscoprire e rivitalizzare l’antico, dall’essere per
definizione, sin dal nome, una cultura derivata e “seconda”, fa sì che la categoria di
imitatio subisca una sorta di netto sdoppiamento, che nella fase antica era rimasto molto
meno marcato: oltre all’imitazione come mimesis del reale, ossia nella terminologia
rinascimentale l’imitazione della natura, si prefigura come un procedimento
generalizzato e dunque autonomamente rilevante anche l’imitazione come ripresa di
modelli letterari precedenti, antichi e poi anche volgari. Un aspetto, questo, che nella
teorizzazione Aristotelica della Poetica è invece pressoché assente, dato che l’interesse
del filosofo è quello di delineare una teoria dei modi di significazione della letteratura e
dunque del suo rapporto col reale più che una teoria della produzione poetica in sé. La
questione non era affatto in ombra invece nella cultura letteraria latina, anch’essa
seconda e “derivata” al pari di quella rinascimentale: proprio dalla riflessione senecana
326
sull’argomento Petrarca desume alcune celebri immagini – in un rapporto che
potremmo definire meta-intertestuale – in cui è da subito chiarito al di là di ogni dubbio
che l’imitazione dei modelli appare una questione ben più attuale e bruciante di quella
filosofica dei modi dell’imitazione del reale nell’arte. La formulazione è ben conosciuta:
non bisogna imitare come scimmie, ma come api che mescolano il nettare di molti e vari
fiori a fare un miele che è altra cosa da quelli:
Utendum igitur ingenio alieno utendumque coloribus, abstinendum verbis; illa enim similitudo
latet, hec eminet; illa poetas facit, hec simias. Standum denique Senece consilio, quod ante Senecam
Flacci erat, ut scribamus scilicet sicut apes mellificant, non servatis floribus sed in favos versis, ut ex
multis et variis unum fiat, idque aliud et melius359.
Al di là della questione, notoriamente centrale nel dibattito letterario dei due
secoli successivi, se debba essere imitato un solo modello eccellente oppure una
pluralità di modelli passibili di contaminazione, ciò che qui più ci riguarda è come la
diversità del risultato dal modello letterario di derivazione sia da subito un aspetto
centrale e decisivo, su cui la rinascente teoria dell’imitatio si fonda, forse anche in
un’implicita polemica con la più prona aderenza dimostrata dalla concezione medievale
delle auctoritates; è comunque rilevante che si senta il bisogno di sottolineare questa
differenza dal modello come qualcosa di non scontato e dunque, implicitamente, almeno
in teoria non imprescindibile.
Ancora più interessante l’altra immagine dell’imitatio dell’arte che deve implicare
sì una somiglianza, ma tale da non essere affatto tendente alla duplicazione, bensì affine
semmai a quella passante fra il volto del padre e del figlio:
Curandum imitatori ut quod scribit simile non idem sit, eamque similitudinem talem esse oportere
[…] qualis filii ad patrem. [12] In quibus cum magna sepe diversitas sit membrorum, umbra quedam et
quem pictores nostri aerem vocant, qui in vultu inque oculis maxime cernitur, similitudinem illam facit,
que statim viso filio, patris in memoriam nos reducat, cum tamen si res ad mensuram redeat, omnia sint
diversa; sed est ibi nescio quid occultum quod hanc habeat vim. [13] Sic et nobis providendum ut cum
simile aliquid sit, multa sint dissimilia, et id ipsum simile lateat ne deprehendi possit nisi tacita mentis
indagine, ut intelligi simile queat potiusquam dici360.
359
Cfr. SENECA, Lettere morali a Lucilio, 84, 3 e 5: « quidquid lectione collectum est stilus redigat in
corpus. Apes, ut aiunt, debemus imitari, quae vagantur et flores ad mel faciendum idoneos carpunt,
deinde quidquid attulere disponunt ac per favos digerunt et, ut Vergilius noster ait,
liquentia mella
stipant et dulci distendunt nectare cellas.
[…] Sed ne ad aliud quam de quo agitur abducar, nos quoque has apes debemus imitari et quaecumque ex
diversa lectione congessimus separare melius enim distincta servantur, deinde adhibita ingenii nostri cura
et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere, ut etiam si apparuerit unde sumptum sit,
aliud tamen esse quam unde sumptum est appareat ».
360
Cfr. SENECA, Lettere morali a Lucilio, 84, 8: « Etiam si cuius in te comparebit similitudo quem
admiratio tibi altius fixerit, similem esse te volo quomodo filium… […] “Quid ergo? non intellegetur
cuius imiteris orationem? cuius argumentationem? cuius sententias?” Puto aliquando ne intellegi quidem
327
Ognuno di essi ha la sua propria identità, il suo proprio aspetto, eppure il figlio ha
un’ “aria”, un non so che di affine e insieme diverso, che ricorda il genitore. Addirittura
Petrarca arriva a teorizzare un certo discostamento, in questo, persino dalla pratica, che
pure riconosce benissimo negli antichi, di desumere ampi elementi di dizione e persino
tradurre dal modello, proponendo dunque un’imitatio preoccupata appunto di essere
meno aderente ai modelli di quanto spesso non avvenga negli stessi amati classici, come
si legge nel passo citato sopra:
Utendum igitur ingenio alieno utendumque coloribus, abstinendum verbis.
[…]
Etsi enim mille passim talia in poetis sint, ubi scilicet alter alterius verbis usus est, michi tamen
nichil operosius in scribendo nichilque difficilius se offert, quam et mei ipsius et multo maxime
precedentium vitare vestigia.
Parzialmente
problematico,
almeno
al
livello
di
teorizzazione,
risulta
inevitabilmente il rapporto di Virgilio con Omero: riguardo a questo capitale modello di
imitatio nei classici a loro volta imitati, viene ricordata in altri due passi la
giustificazione attribuita da Macrobio a Virgilio stesso, secondo cui non è opera da poco
riuscire a “sottrarre la clava a Ercole” (Familiares, XXII, 2, 27 e XXIV, 12, 19):
[27] Etsi enim non me lateat quosdam veterum Virgiliumque ante alios versus innumeros non
modo e greco in latinum versos, ubi abstulisse clavam Herculi gloriatur, sed, ut erat, ex alienis in suum
opus transtulisse, non ignorantia quidem ulla, que in tot tantisque rebus hinc illinc ereptis fingi nequit,
neque furandi quantum intelligitur, sed certandi animo, tamen aut plus illi licentie fuit, aut mens alia;
certe ego, si res adigat, alieno sciens uti patiar, non comi; siquid adversus hec ab ignorante peccabitur, fac
sentiam: agnosco libens bonam fidem et usurpata restituo.
Profecto equidem que de illius imitatione dixisti, non vera modo sed vulgo etiam nota sunt, et
multa alia que — verecundia dicam an modestia? — siluisti; que tamen ex ordine ipsis in Saturnalibus
scripta sunt, quamvis hoc loco ille suus iocus innotuerit; cui cum obiceretur ab emulis quod versus tibi
tuos eriperet, magnarum virium esse respondit auferre clavam Herculi; nec sim dubius quin latentem
salem ioci huius intelligas.
Si badi che l’aderenza non letterale al modello non dipende qui in nessun modo
dalla percezione di un’alterità culturale o di una differenza di sensibilità storica che
debbano essere improrogabilmente affermate, secondo quanto sarà in seguito affermato,
ad esempio, nel Ciceronianus di Erasmo: l’atteggiamento è e resta, per dirla in termini
nietzscheani, perfettamente antistorico e metastorico, come nel complesso l’intera
concezione rinascimentale della cultura che da qui prende le mosse (la stessa
posse, si magni vir ingenii omnibus quae ex quo voluit exemplari traxit formam suam inpressit, ut in
unitatem illa competant ».
328
storiografia umanistica nata proprio con Petrarca, pur essendo alla base di quella
moderna, condivide senz’altro questo atteggiamento nel rapportarsi allo studio degli
eventi passati cercandovi non strutture di senso che spieghino e dunque riaffermino lo
stato delle cose – in una complessiva accettazione e persino agiografia del principio di
realtà – bensì l’esemplarità dei viri illustres e delle res gestae su cui plasmare
metastoricamente, sulla base di una libera scelta critica e volontaria, il presente361). Ciò
che qui invece si sta delineando è quella che oggi potremmo chiamare una vera e
propria teoria dell’intertestualità: si tratta insomma di una questione non culturale e
storicizzante, ma tutta interna alla teoria della letteratura e dunque, semmai, universale,
la cui problema centrale, insomma, non è il rapporto con i modelli letterari “oggi”, ma il
rapporto con i modelli tout court. Quello che a Petrarca interessa non è affatto
l’affermazione di un’alterità storica dall’antico (che in lui tende ormai a restringersi
chiaramente alla sola sfera religiosa), quanto la rivendicazione dell’autonomia stilistica
e dell’individualità personale emergente in controluce sullo sfondo dell’imitatio dei
modelli letterari (Familiares, XXII, 2, 20-21):
[20] Quid ergo? Sum quem priorum semitam, sed non semper aliena vestigia sequi iuvet; sum qui
aliorum scriptis non furtim sed precario uti velim in tempore, sed dum liceat, meis malim; sum quem
similitudo delectet, non identitas, et similitudo ipsa quoque non nimia, in qua sequacis lux ingenii
emineat, non cecitas non paupertas; sum qui satius rear duce caruisse quam cogi per omnia ducem sequi.
[21] Nolo ducem qui me vinciat sed precedat; sint cum duce oculi, sit iudicium, sit libertas; non prohibear
ubi velim pedem ponere et preterire aliqua et inaccessa tentare; et breviorem sive ita fert animus,
planiorem callem sequi et properare et subsistere et divertere liceat et reverti.
È interessante notare come questa teorizzazione sia parzialmente smentita,
rivelando il permanere di un’ambiguità di fondo nel rapporto, dal suo originarsi come
riflessione su una prassi poetica dell’autore stesso che a tale teorizzazione si rivela non
del tutto omogenea: in un caso si tratta infatti di un’autocorrezione volta ad eliminare o
quantomeno celare un’inconsapevole reminiscenza virgiliana nel Bucolicum carmen, in
un altro dell’immediata smentita del principio teorico appena enunciato che il suo
brillante copista-allievo Giovanni Malpaghini fa notare al maestro Petrarca portandogli
a esempio proprio un altro passo della medesima sua opera, di fronte alla quale la
reazione del maestro è uno stupore non privo di un certo imbarazzo nel riconoscere la
reminiscenza inconsapevole (« Obstupui; sensi enim, illo loquente, quod me scribente
non senseram, finem esse virgiliani versus sexto divini operis »).
361
Su tale concezione e uso della storia come monumentum nel Rinascimento, si veda la seconda
Inattuale di NIETZSCHE, F., Sull’utilità e il danno della storia per la vita, cit., che vale più di qualsiasi
ricostruzione filologica e storiografica della questione.
329
Come dunque nella teoria aristotelica la mimesis non era affatto una copia del
reale, ma la produzione di quella che oggi potremmo chiamare una “struttura” – il testo
letterario così come l’immagine dipinta e persino la musica – che dal reale desumeva
per selezione soltanto gli elementi da reinserire in una significazione autonoma e nuova,
allo stesso modo anche l’imitatio dei modelli letterari deve secondo Petrarca desumere
solo ciò che serve ad una struttura di significazione parimenti nuova e autonoma,
mostrando anzi, nel dover evitare, per quanto possibile, la mera duplicare delle parole
dell’ipotesto a favore di una loro rielaborazione più libera, un più specifico parallelismo
con la natura non duplicante ma selettiva e intesa alla rielaborazione della mimesis del
reale nella teoria antica, come abbiamo visto in tutta chiarezza nel passo citato dal
Cratilo.
Ma a questo punto possiamo rilevare anche una più sottile divergenza proprio
nell’analogia pittorica proposta, stavolta in maniera antitetica, dalla originaria teoresi
greca antica e da Petrarca. Se come abbiamo visto la pittura è tanto per Platone quanto
per Aristotele un parallelo perfettamente legittimo, fino ad essere chiarificante, della
mimesis in letteratura, in quanto è mimesis esattamente al pari della letteratura e
attraverso procedimenti distinti ma paralleli e omologhi, per Petrarca invece la
somiglianza fra immagine e oggetto rappresentato arriva invece a diventare
significativamente, ancora una volta sull’esempio latino di Seneca, paradigma negativo,
esempio di ciò che la poesia non deve essere; abbiamo già citato sopra, parzialmente, il
passo (Familiares, XXIII, 19, 11):
Curandum imitatori ut quod scribit simile non idem sit, eamque similitudinem talem esse
oportere, non qualis est imaginis ad eum cuius imago est, que quo similior eo maior laus artificis…362
Questo scarto, si badi, non riguarda solo una similitudine esplicativa che dunque
sfiora soltanto marginalmente la nostra questione; investe invece proprio la misura di
una scarto intervenuto nel modo di concepire la mimesis in generale, poiché la pittura
non è qualcosa di eterogeneo a cui la mimesis letteraria può essere paragonata solo con
intento esplicativo, ma è a tutti gli effetti essa stessa mimesis: semplicemente, un’altra
forma di mimesis. Né d’altra parte si tratta di una concezione assimilabile a quella
espressa nella celebre similitudine platonica della specchio, che ha carattere
362
Cfr. SENECA, Lettere morali a Lucilio, 84, 8: « Etiam si cuius in te comparebit similitudo quem
admiratio tibi altius fixerit, similem esse te volo quomodo filium, non quomodo imaginem: imago res
mortua est. ».
330
provocatorio ed è volta ad introdurre una complessiva svalutazione della mimesis e della
poesia da una prospettiva politico-morale che appare quantomai estranea a Petrarca.
Vediamo qui chiaramente quanto la categoria di mimesis si sia modificata, anche
attraverso la mediazione latina, fino a quella dell’imitatio petrarchesca, pur senza
stravolgersi radicalmente: per Petrarca il concetto di imitazione implica davvero,
innanzitutto, l’idea del copiare una somiglianza esteriore, che è dunque tanto “più
imitativa” quanto più simile al modello; per Aristotele, invece, abbiamo visto che il
criterio di valutazione di un’opera pittorica non soggiace nella sua somiglianza al
modello, del quale può liberamente essere più bello e persino più brutto, e d’altronde
l’uomo è per lui animale mimhtikètaton proprio in quanto sa “imitare” non nella
maniera più fedele, ma al contrario in maniera più intelligente e selettiva rispetto agli
altri animali (come potrebbe essere appunto la scimmia petrarchesca). Né si dovrà
imputare questa divergenza alla diversità reale, storica, fra pittura antica e protorinascimentale: essa non è certo tanto marcata nella sua estetica da giustificare
addirittura un rovesciamento di fondo nella prospettiva, e d’altronde la pittura di Giotto
o Altichiero non era certo più legata a canoni di realismo di quanto non fosse – per quel
che sappiamo dalle testimonianze indirette – quella dei grandi pittori greci antichi noti
ad Aristotele. La differenza, invece, sta proprio in un parziale slittamento semantico del
concetto di imitazione, che ormai sembra coinvolgere più direttamente la categoria di
somiglianza ad un’immagine esteriore, allontanandosi ormai in maniera sensibile da un
aspetto che abbiamo visto essere centrale invece nella teoresi antica, ossia la natura
eminentemente “processuale” della mimesis; amplificando una concezione latina
dell’imitatio già discoste da quella originaria greca, Petrarca – e dunque tanto più
l’umanesimo a lui successivo – marca già un lieve ma pur sensibile avvicinamento
all’odierna concezione svilente dell’imitazione (d’altronde proprio in una simile
funzione svilente va il raffronto proposto da Petrarca).
D’altronde, tutto il grande dibattito rinascimentale sull’imitatio mostra una
macroscopica deviazione rispetto a quello greco antico sulla mimesis su cui sarà utile
soffermarci ancora: come abbiamo visto, la mimesis antica si propone come una teoria
generale della prassi artistica e delle sue modalità di significazione emergenti dal
rapporto referenziale con il reale; l’imitatio umanistica pone decisamente in secondo
piano questo aspetto originario a tutto vantaggio della questione – sostanzialmente
estranea all’originario dibattito filosofico greco – del rapporto che la prassi artistica
deve intrattenere non tanto con il reale quanto con la precedente tradizione artistica, che
331
assume una fortissima funzione modellizzante 363 . Come scrive Tatarkiewicz, il più
importante storico dell’estetica: « Inoltre tale tesi [l’imitatio come fondamento dell’arte]
finisce per assumere un significato diverso da quello originario: nel Rinascimento non si
tratta tanto di imitare la natura (sotto l’influenza del platonismo ciò diventa un elemento
di secondaria importanza), quanto di imitare modelli perfetti e cioè antichi » 364 .
Naturalmente il Rinascimento non manca di interrogarsi riguardo alla questione del
rapporto dell’arte con il reale e del senso della rappresentazione che essa mette in atto: i
due approcci fondamentali alla questione sono non a caso quello neo-platonista risalente
soprattutto a Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola e poi, a partire dalla
progressiva riscoperta della Poetica a metà del Cinquecento, quello neo-aristotelico.
Tuttavia, considerando nel complesso il grande dibattito sull’imitatio e le molte
trattazioni specifiche sull’argomento che esso produce, si nota senz’altro che il vero
nucleo della questione è quello del rapporto con i modelli letterari e non con il reale:
spesso i numerosi scritti sul tema dell’imitatio – soprattutto prima che il rinnovato
interesse per la Poetica di Aristotele riporti in primo piano la questione del rapporto fra
arte e realtà – ignorano del tutto la questione originaria della mimesis, oppure la toccano
solo marginalmente, mentre il vero argomento di discussione è evidentemente il
rapporto imitativo con la precedente tradizione letteraria, tanto che in genarale, quando
si parla di imitatio, si intende automaticamente imitazione dei modelli letterari 365 .
Anche quando l’aristotelismo comincia a riproporre una più attenta riflessione
sull’originaria questione del rapporto fra arte e realtà, tuttavia, l’impostazione platonica
di fondo permane comunque nella tendenza, comune a tutto il Rinascimento, ad una
concezione idealizzante tanto del bello artistico quanto del bello di natura, per cui anche
363
Spesso si manca di distinguere adeguatamente – sia nel dibattito rinascimentale, sia anche in quello
critico moderno – fra le due categorie radicalmente distinte della mimesis in senso generale e filosofico e
la mimesis come teoria generale della prassi artistica, la quale a sua volta va distinta nei due aspetti di
imitazione del reale (o della natura) e imitazione dei modelli artistici. Si veda a riguardo BOMPAIRE, J.
Filosofia e mimesis, «Studi di Estetica» 7/8 (1993), pp. 27-39, trad. it. del cap. II di Id., Lucien écrivain.
Imitation et création, Paris, De Boccard, 1958.
364
TATARKIEWICZ, W., Storia dell’estetica, Einaudi, Torino 1979-1980 (ed. orig.: 1970), vol. III
(L’estetica moderna), p. 108. La reciproca implicazione delle due accezioni fondamentali dell’imitatio è
ribadita con la dovuta chiarezza da MOSS, A., Literary imitation in the sixteenth century: writers and
readers, Latin and French, in The Cambridge History of Literary Criticism, a cura di NORTON, G. P., vol.
III, The Renaissance, Cambridge, University Press, 1999, pp. 107-118: « Renaissance concepts of the
relationship between artistically composed language and the true nature of things are usually bound
almost inextricably with the presupposition that the genesis of literary composition lies in rhetoric and in
the imitation of model authors » (p. 107).
365
Cfr. TATARKIEWICZ, W., Storia dell’estetica, cit., vol. III, pp. 108-109: «Per esprimere la nuova idea
[ossia l’imitatio dei modelli antichi] viene usato ancora l’antico termine di imitatio, ma questo concetto
fondamentale per la teoria dell’arte comincia ad assumere un significato diverso da quello precedente»:
come esempio, lo studioso cita la definizione dell’imitatio di Pico: «nihil est aliud imitari nisi alieni styli
similitudinem transferre in tua scripta».
332
le riflessioni scaturite più o meno direttamente dal confronto con il testo dello Stagirita
contaminano sempre, in qualche misura, le due tendenze366.
Senza dubbio l’anello intermedio di questo complessivo slittamento è costituito
essenzialmente dalla teoria sull’imitatio nella cultura latina. Con essa, infatti, il
Rinascimento condivide un’affine condizione di letteratura “seconda” nel suo
complesso: come quella latina nasceva e si sviluppava in tutto il suo corso nella
modalità di una sua complessiva modellizzazione su quella greca (tanto che, secondo la
notissima affermazione di Quintiliano, solo il genere tutto sommato minore della satira
risultava di autonoma origine latina), così la letteratura umanistico-rinascimentale
avverte in maniera acutissima e perfino esasperata il suo complessivo rapporto di
dipendenza da entrambe le letterature classiche. Proprio questa generalissima affinità di
condizione permette, sin da Petrarca, di riprendere e sviluppare come questione centrale
quella già latina dell’imitazione dei modelli letterari piuttosto che il rapporto tra arte e
realtà rappresentata. L’urgenza della questione, d’altronde, è inizialmente anzitutto
linguistica e verrebbe quasi da dire “pratica”, riguardando soprattutto la produzione
letteraria umanistica in lingua latina: la necessità di recuperare la padronanza di una
lingua che non è più quella degli autori che pure di essa intendono servirsi comporta che
il recupero di tale competenza non possa darsi se non attraverso l’imitazione molto
aderente degli autori latini presi a modello. Da questa esigenza originaria – che pure
perdura per tutto l’umanesimo latino – la questione viene trasportata poi anche alla
produzione in volgare nel grande dibattito che vedrà imporsi la proposta del Bembo,
mentre al contempo si allarga anche al più generale rapporto stilistico e infine strutturale
e poetico con i modelli.
Tale estensione del concetto di imitatio dall’aspetto linguistico e microstrutturale
fino ad un rapporto letterario “a tutto tondo” articola il dibattito in una serie di più
specifiche questioni, ben note, di cui le principali sono: 1) se si debba imitare un solo
modello letterario, quello eccellente nel proprio ambito, oppure una pluralità di modelli,
da rielaborare in maniera più eclettica e personale (che è senz’altro la questione più
rilevante e più dibattuta, dalla disputa fra Poliziano e Cortesi, a quella fra Bembo e Pico,
366
Cfr. ad es. VASOLI, C., L’estetica dell’Umanesimo e del Rinascimento, in AA.VV., Momenti e
problemi di storia dell’estetica. Parte prima: dall’antichità classica al barocco, Milano, Marzorati, 1983,
sez. La poetica aristotelica e le dispute cinquecentesche sulla poesia, p. 381: «Ma mentre la disputa tra il
Poliziano e il Cortese si era svolta essenzialmente intorno ai motivi dell’ “imitatio” ciceroniana intesa
come rapporto ad un esemplare tecnicamente perfetto, e la polemica Bembo-Pico si era mossa nell’ambito
platonico della ricerca di un “tipo” o “canone ideale” di Bellezza e di grazia, la lettura della Poetica pone
adesso invece in primo piano il problema dell’imitazione della realtà, come effettiva e diretta
rappresentazione della vita, in perenne dialettica con l’esigenza sempre vitale dell’imitazione dei
classici».
333
all’intervento di Erasmo e alla risposta di Giulio Camillo Delminio, fino al confronto fra
Giraldi e Calcagnini e oltre); 2) se l’imitazione debba mirare alla fedeltà al modello o
piuttosto rielaborarlo in modo autonomo mirando a superarlo, secondo la sottocategoria
imitativa dell’aemulatio; 3) se l’imitazione debba essere riconoscibile e letterale o
invece dissimulata, secondo il precetto per cui ars est celare artem; 4) fino a che punto
possa spingersi l’imitazione per non compromettere l’originalità della nuova opera
riducendola a plagio; 5) se l’imitazione sia un fatto meramente stilistico-letterario o se
sia costitutivamente condizionata dal mutamento storico-culturale (e in particolare
dall’alterità cristiana rispetto alle culture classiche); 6) se si debba privilegiare
l’imitazione dei modelli letterari concreti oppure – soprattutto a partire dall’imporsi
dell’aristotelismo – seguire piuttosto un modello teorico (formato per lo più seguendo o
ripensando le indicazioni della Poetica di Aristotele) in base al quale riadattare e
correggere gli effettivi modelli letterari.
Non ci addentreremo in nessuna di tali questioni: esse, d’altra parte, pur coprendo
in massima parte le questioni dibattute nei contributi teorici dell’epoca, non sono
immediatamente pertinenti al nostro argomento, che è piuttosto l’estetica della
mimesis/imitatio considerata appunto in quanto teoria estetica generale, al di là degli
specifici problemi di poetica cui ha dato luogo storicamente e che la presuppongono
tutti in egual modo. D’altronde anche la questione principale se si debba imitare il solo
modello eccellente per ogni ambito (Cicerone, Virgilio, Petrarca ecc.) o una pluralità di
modelli non mette mai in nessun modo in discussione il principio d’imitazione in quanto
tale, che è condiviso da tutti: basti pensare alla fittissima tessitura intertestuale che
soggiace alle Stanze del Poliziano, che pure, nel dibattito col Cortesi, fu uno dei più
netti assertori della libertà espressiva individuale di fronte ai modelli da imitare: « Non
exprimis, inquit aliquis, Ciceronem. Quid tum? Non enim sum Cicero. Me tamen, ut
opinor, exprimo »; ancora più esplicito Erasmo, che pur riprendendo esplicitamente la
posizione di Poliziano e pur proponendo la più radicale critica all’atteggiamento
anacronistico e antistorico, quantomeno nei suoi esisti più estremi e ottusi, afferma però
in tutta chiarezza: « Amplector imitationem, sed quae adiuvet naturam, non violet; quae
corrigat illius dotes, non obruat: probo imitationem, sed ad exemplum ingenio tuo
congruens, aut certe non repugnans » 367 . Similmente, l’opposizione fra imitazione
pedissequa ed aemulatio che rivendichi maggiore libertà di rielaborazione e volontà di
“gareggiare” col modello presuppone in entrambi i casi il medesimo principio estetico
367
ERASMO, Il Ciceroniano o dello stile migliore, Brescia, La Scuola Editrice, 1965, p. 290.
334
fondamentale, divergendo poi solo riguardo ai modi della sua applicazione nella prassi
letteraria:
l’enfasi
senz’altro
eccessiva
e
schematica
sulla
contrapposizione
imitatio/aemulatio è in gran parte imputabile alla prospettiva che sulla questione ha dato
soprattutto certa influente critica americana – da Weinberg, a Pigman, a Greene – la cui
analisi è ancora fortemente condizionata e persino deformata dal latente pregiudizio
antimimetico dell’estetica postromantica dell’originalità (dalla loro prospettiva, in
sostanza, il principio anti-originale dell’imitatio si salva dalla condanna grazie al
“cavallo di Troia” dell’originalità che in esso si insinua attraverso la sottocategoria
dell’aemulatio). Persino le rare proposte di autori meno usuali o addirittura eccentrici
rispetto ai modelli canonici, come l’Apuleio proposto da Beroaldo o l’anti-canone
trissiniano opposto a quello bembesco, non mettono mai in questione l’idea di imitatio
di modelli letterari come pratica fondante la prassi artistica. Le varie proposte e le
divergenze anche radicali che articolano questo fitto dibattito teorico vertono
esclusivamente sulle modalità secondo cui l’imitatio deve essere praticata, dando luogo
fra l’altro a un’ampia topica di similitudini di ascendenza già classica ad illustrarle in
via metaforica (api, somiglianza padre-figlio, digestione, scimmia ecc., divenute veri
luoghi comuni – ancor più che della teoresi rinascimentale – dei moderni studi
sull’argomento), ma non mettono mai in questione il principio estetico generale
dell’imitatio; né d’altra parte si interrogano approfonditamente sulla sua validità, che
sarà sottoposta a critica complessiva (non troppo felicemente) soltanto dall’estetica
romantica368: la riflessione sull’imitatio da un punto di vista estetico-filosofico proposta
dal Rinascimento si appoggia in massima parte alla rilfessione antica sulla questione,
mostrando un grado di rielaborazione che si limita, al più, a un eclettismo di fondo tra le
due concezioni dominanti, platonica e aristotelica.
L’estetica dell’imitatio, che l’età umanistico-rinascimentale impone alla tradizione
europea per i tre secoli successivi, nonostante il tanto ampio dibattito teorico sui modi
dell’imitazione rimane insomma in massima parte – secondo la categoria di
368
Basti ricordare la critica radicale all’estetica e alla poesia romantiche con cui, negli anni della loro
diffusione europea, LEOPARDI reagisce ad esse nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica,
riaffermando perentoriamente l’estetica dell’imitatio come unica via autenticamente moderna della poesia
proprio – potremmo dire – per la sua inattualità: un’inattualità che si rivelerà non come arretratezza ma
come anticipo sui tempi, all’opposto della “moda” romantica (il termine è leopardiano), nell’influenzare
profondamente, soprattutto tramite Nietzsche, alcuni degli esiti più profondi del pensiero filosofico ottonovecentesco di impostazione nichilista ed esistenzialista. Sulla critica leopardiana all’estetica antiimitativa del Romanticismo, cfr. l’efficace ricostruzione di GUGLIELMI, G., Leopardi e le poetiche
romantiche, «Studi di estetica», 10 (1994), pp. 9-39.
335
Tatarkiewicz – una questione di “estetica implicita”369: essa è molto più spesso data per
scontata che non discussa criticamente nel suo fondamento estetico-filosofico, e anche
quando ciò avviene la discussione non perviene a novità sostanziali rispetto alla
posizione platonica e aristotelica, se non tutt’al più nella forma di una loro – non sempre
pacifica – contaminazione.
La mancanza di un’adeguata riflessione filosofica sull’estetica dell’imitatio –
quella che, come abbiamo visto in apertura, Adorno rimproverava alla tradizione – è in
fondo imputabile, per l’età umanistico-rinascimentale, oltre che alla più generale
assenza di una riflessione filosofica profonda veramente originale e autonoma, anche e
soprattutto all’imporsi, a partire dall’Accademia Fiorentina, di un orientamento
platonista di fondo nel concepire il rapporto tra arte e “natura”: prospettiva che,
rifiutando evidentemente la svalutazione della mimesis nella Repubblica di Platone e
rivelandosi pertanto fortemente in debito – sin da Marsilio Ficino – anche con Plotino,
continua a perdurare sempre, nella forma della concezione idealizzante della natura o
comunque dell’imitazione che la rende conforme all’ideale, anche quando come punto
di riferimento principale dell’estetica si impone piuttosto Aristotele. A prescindere dalle
singole posizioni specifiche – in una questione centrale dell’estetica quattrocinquecentesca che d’altronde travalica ampiamente la letteratura per trovare anzi nelle
369
Per il concetto, cfr. TATARKIEWICZ, W., Storia dell’estetica, cit., vol. I, pp. 10-11, par. 2 (Storia
dell’estetica implicita ed esplicita): « Se lo storico dell’estetica dovesse desumere il suo materiale
unicamente dagli studiosi di estetica, non sarebbe in grado di fornire un quadro completo di ciò che fu in
passato il pensiero sull’arte e sul bello. Egli dovrà attingere informazioni anche dagli artisti, senza
trascurare ciò che ha trovato espressione, non nelle opere dotte, me nelle concezioni dominanti e nella vox
populi ». A ciò sarebbe utile aggiungere qualche ulteriore precisazione, particolarmente utile per l’estetica
rinascimentale: 1) quando un autore – come ad es. il Tasso – esplicita le sue concezioni estetiche, ciò non
significa che la sua prassi poetica ne sia poi il risultato necessario e conseguente, ma può divergere anche
sensibilmente dalle posizioni teoriche (per altro dagli autori sempre trattate in modo parziale e
asistematico); 2) anche quando in un’opera teorica si discute di poetica chiamando in causa principi
estetici, ciò non vuol dire che di quei principi siano esplicitati i presupposti estetico-filosofici, che anzi
spesso restano impliciti e dati per scontati: ciò è evidente nel dibattito rinascimentale sull’imitatio nel suo
complesso, che discute molto più della poetica dell’imitatio che non dell’estetica dell’imitatio (un
esempio lampante è la Poetica del Trissino, che naturalmente tratta a più riprese della poetica
dell’imitazione del modelli letterari come prassi artistica, ma quando tocca en passant i presupposti
estetici dell’imitatio si limita a tradurre alla lettera Aristotele: ossia, non mostra un pensiero autonomo a
riguardo. TRISSINO, Poetica, Quinta divisione, 5: « Lo imitare è naturale dell’uomo da fanciullo insuso
[…]. Che l’imitare poi ci sia più naturale si può chiaramente comprendere, essendo l’uomo più di ogni
altro animale imitatore e nascendo il suo primo imparare dalla imitazione, onde i fanciulli che sono più
imitatori degli altri riescono di ingegno maggiori. E poi ognuno della imitazione comunemente s’allegra,
come per lo effetto istesso si può vedere. Perciò che quelle cose che con dispiacere veggiamo, come sono
fiere, serpi, corpi morti e simili, le loro imagini però con diletto riguardiamo, massimamente quando sono
con diligenza ritratte », cfr. ARISTOTELE, Poetica, 1448b, 5-10: tÒ te g¦r mιme‹sqai sÚmfuton to‹j
¢nqrèpoij ™k pa…dwn ™stˆ kaˆ toÚtJ diafšrousi tîn ¥llwn zówn Óti mιmhtikètatÒn ™sti kaˆ
t¦j maq»seij poie‹tai di¦ mim»sewj t¦j prètaj, kaˆ tÕ ca…rein to‹j mim»masi p£ntaj. shme‹on
dὲ toÚtou tÕ sumba‹non ™pˆ tîn œrgwn, trad.: « L’imitare è congenito fin dall’infanzia all’uomo, che si
differenzia dagli altri animali proprio perché è il più portato a imitare, e attraverso l’imitazione si procura
le prime conoscenze; dalle imitazioni tutti ricavano piacere »).
336
arti figurative il suo punto di riferimento primario –, risulta evidente che se il reale (la
“natura”) appare già di per sé gravato di connotazione estetica nella forma di una
partecipazione ontologica alla bellezza ideale, tanto più nell’ottica cristiana che intende
il reale come natura naturata dalla natura naturans divina, ne consegue senz’altro che
il valore estetico dell’opera d’arte può essere direttamente desunto e quasi attinto dalla
sua mera riproduzione. Questo – si badi – è solo il supporto teorico e filosofico fornito
come giustificazione di una prassi artististica che, pur fortemente influenzata da tale
concezione, origina da un’esigenza creativa autonoma nella sua vera essenza: il
platonismo ficiniano, nonostante la sua influenza determinante sulla Weltanschauung
rinascimentale, non è che la “nottola di Minerva” di un atteggiamento culturale e
artistico che affonda le sue radici nel grande Trecento italiano: in Dante e Petrarca, in
Giotto e Altichiero.
In questa prospettiva, l’imitazione dei grandi modelli artistici antichi (in
letteratura come nelle arti figurative) si spiega allora secondariamente con l’idea che gli
antichi siano stati i più eccellenti imitatori della natura: imitandoli, si ottiene dunque il
duplice conseguimento di imitare tramite loro la natura stessa e di imitarla, come essi
seppero fare, nel modo migliore. Anche questo, in fondo, è un argomento debole e
sostanzialmente pretestuoso nel voler giustificare a livello teorico l’universale pratica
della ripresa dell’antico: fra l’altro, si tratta di un perfetto ribaltamento della celebre
condanna della mimesis artistica nel decimo libro della Repubblica di Platone – ben
poco congeniale, naturalmente, allo stesso platonismo rinascimentale –, che
notoriamente svaluta e condanna l’arte e la poesia in relazione al loro valore conoscitivo
proprio in quanto imitazione di un’imitazione, distante dunque tre gradi di
allontanamento dalla verità dell’idea 370 . L’argomento rinascimentale arriverà, pur
radicalmente ripensato, fino a Leopardi, il quale vedrà ancora negli antichi gli imitatori
spontanei e quasi ingenui di una natura con cui sono ancora pienamente in contatto
diretto e in armonica comunione, a differenza della moderna civiltà scientifica e
industrializzata che ha perso irrimediabilmente tale contatto e pertanto può e deve
370
PLATONE, Repubblica, 597e, 3-8: Eἶen, Ãn d' ™gè· tÕn toà tr…tou ¥ra genn»matoj ¢pÕ tÁj fÚsewj
mimht¾n kale‹j; P£nu mὲn oân, œfh. Toàt' ¥ra œstai kaˆ Ð tragJdopoiÒj, e‡per mimht»j ™sti,
tr…toj tij ¢pÕ basilšwj kaˆ tÁj ¢lhqe…aj pefukèj, kaˆ p£ntej oƒ ¥lloi mimhta…. (trad.: « “E sia”
dissi io: “chiami imitatore l’autore dei prodotti di terza generazione, a partire dalla natura?” “Certo” disse.
“Questo sarà dunque anche il posto del poeta tragico, se appunto è un imitatore – per natura terzo a partire
dal re [il dio generatore] e dalla verità – e di tutti gli altri imitatori.” ») La conclusione del ragionamento è
dunque, Ibid., 601b, 9: Ð toà e„dèlou poiht»j, Ð mimht»j, famšn, toà mὲn Ôntoj oÙdὲn ™pαΐei, toà dὲ
fainomšnou· oÙc oÛtwj; Na…. (trad.: « l’artefice del simulacro, l’imitatore, sosteniamo, non conosce
nulla della realtà ma solo l’apparenza »).
337
recuperarlo nella poesia, paradossalmente, proprio attraverso la mediazione costituita
dall’imitazione della poesia antica371.
Nonostante la loro fortuna storica, la debolezza teorica di tali argomenti filosofici
con cui sono giustificate l’imitazione della natura e dell’arte antica costituisce senz’altro
una delle più gravi carenze della riflessione estetica rinascimentale, che ha fornito il
miglior pretesto alle successive critiche otto-novecentesche: malgrado alcuni spunti
isolati, siamo infatti ancor lontani dalla netta e consapevole distinzione teorica fra il
“bello artistico” e il “bello di natura”, su cui non a caso si fonderà la nascita della
moderna estetica filosofica come disciplina autonoma nella seconda meta del
Settecento, in particolare attraverso il capitale contributo kantiano. Venendo meno la
concezione oggettivata della bello di ascendenza platonica a vantaggio della sua
concezione soggettiva (in senso prettamente filosofico, naturalmente), il fondamento
stesso di una bellezza artistica desunta da quella naturale – non importa se essa stessa
idealizzata o soltanto intesa come mezzo per risalire all’ideale – non poteva che venir
meno.
La mancanza di un riflessione critica adeguata a livello teorico, tuttavia, non
implica la superficialità di quella concezione estetica, che la moderna vulgata di
impostazione anti-mimetica banalizza spesso con facilità nel concetto svilente di copia
(tanto rispetto al reale quanto, a maggior ragione, rispetto ai modelli artistici),
evidenziando cioè nel concetto stesso di imitazione una mancanza di riflessione sulla
categoria eminentemente moderna dell’originalità dell’opera d’arte (che si impone alla
cultura europea solo a partire l’estetica romantica ed hegeliana372). Come abbiamo visto,
invece, e come d’altronde sta gradualmente emergendo in tutta chiarezza nel rinnovato
interesse critico per quello che è probabilmente il concetto cardine dell’estetica
occidentale, la categoria di mimesis/imitatio intesa come copia di un modello, pur non
del tutto estranea alla tradizione mimetica, costituisce un fraintendimento radicale non
solo del suo senso originario, ma anche della sua storia (ossia di ciò che permane
371
LEOPARDI, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: « Ora da tutto questo e dalle altre
cose che si son dette, agevolmente si comprende che la poesia dovette essere agli antichi oltremisura più
facile e spontanea che non può essere presentemente a nessuno, e che a' tempi nostri per imitare poetando
la natura vergine e primitiva, e parlare il linguaggio della natura (lo dirò con dolore della condizione
nostra, con disprezzo delle risa dei romantici) è pressochè necessario lo studio lungo e profondo de' poeti
antichi. Imperocché non basta ora al poeta che sappia imitar la natura; bisogna che la sappia trovare, non
solamente aguzzando gli occhi per iscorgere quello che mentre abbiamo tuttora presente, non sogliamo
vedere, impediti dall'uso, la quale è stata sempre necessarissima opera del poeta, ma rimovendo gli
oggetti che la occultano, e scoprendola, e diseppellendo e spostando e nettando dalla mota
dell'incivilimento e della corruzione umana quei celesti esemplari che si assume di ritrarre ».
372
Si veda a riguardo, in particolare, HEGEL, W. F., Estetica, cit., Parte prima, Capitolo terzo, sez. C. 3,
Maniera, stile ed originalità, pp. 327 sgg.
338
costante attraverso le modificazioni): fraintendimento che corrisponde, in effetti, solo al
segmento più recente della diacronia del suo sviluppo, ed ha molto più a che fare con la
speculazione teorica e filosofica che non con la prassi artistica, ossia con l’effettiva
realizzazione della mimesis nella poiesis.
Basti pensare, nella fase finale di tale millenario sviluppo concettuale, alla strenua
difesa dell’imitazione in entrambe le sue accezioni (rappresentativa e intertestuale) nel
già citato Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica di Leopardi, dove
l’autore reagisce all’attacco portato dal Romanticismo all’estetica della tradizione che
avrebbe condotto poi al definitivo superamento di quella: appare evidente come
l’obiettivo polemico lì non sia tanto la poesia romantica, verso cui pure non manca
qualche strale, quanto piuttosto – anche se in gran parte indirettamente – l’aggressione
dell’autonomia della creazione poetica da parte di una nuova concezione filosofica
totalizzante che, attraverso quella sua branca che è l’estetica, intende “addomesticare”
l’arte integrandola nel proprio sistema di pensiero e dunque subordinandola ad esso. Il
Romanticismo, soprattutto nel suo fondamento filosofico dell’idealismo, impone alla
modernità l’idea che l’arte, in quanto manifestazione del processo storico del mondo, è
e deve essere storica (tutta la Parte seconda dell’Estetica hegeliana, d’altronde,
cos’altro è se non una grande “fenomenologia dello Spirito” nell’arte?), il che significa
che deve essere moderna, adeguata alla sua epoca, da cui d’altronde non può
prescindere: ancora oggi, per l’alleanza fra modernismo dell’arte e storicismo della
critica, questo rimane assolutamente un dogma incontestabile di qualsiasi approccio al
fenomeno artistico, nonostante il postmodernismo ne abbia in parte (con l’asistematicità
che gli è propria) superato alcuni presupposti. A una tale concezione Leopardi risponde,
paradossalmente, che la poesia proprio per essere moderna deve essere antica,
smascherando con l’intuizione del grande poeta, forse in modo neppure del tutto
consapevole, il vizio dell’imposizione filosofica dello storicismo sull’arte espresso nella
citazione menzionata in apertura: tutto ciò che nell’arte è storico è sempre inessenziale,
estraneo alla specificità del discorso artistico nella sua autentica sostanza; per
confrontarsi con i rivolgimenti culturali, sociali e antropologici della modernità – con la
cultura scientifica, l’ideologia del progresso, la società della produzione e del mercato: i
temi oggetto della stira più esplicita nella Palinodia al marchese Gino Capponi, ironica
sin dal titolo – l’arte non deve scendere a compromessi con tale nuova realtà, ma al
contrario riaffermare perentoriamente la propria specificità e universalità, di cui
339
l’imitazione degli autori antichi, mediando quella della natura, diviene uno strumento
quanto mai indispensabile:
Che andiamo noi cercando bellezze eterne e immutabili? Qualunque cosa non si muta, qualunque
dura sempre, non fa per la poesia: questa vuol cose caduche, cose che si rinnuovino, cose che passino:
abbia anch'ella le sue mode, diventi leggera per esser sempre gagliarda; duri ciascuna foggia quanto può
durare una moda: nella fama de' poeti non fo variazione: duri a un di presso quanto dura presentemente:
spero che si potranno stampare i giornaletti a posta, colle mostre di ciascheduna poesia che andrà
venendo in usanza, come adesso si stampano quelli delle altre mode colle loro figurine373.
Non stupisce allora che il più grande teorico novecentesco della storicità dell’arte,
il filosofo Adorno, abbia speso la massima parte delle sue energie in campo estetico in
rapporto al problema della musica. Se infatti in letteratura, come in fondo in tutte le
altre arti, l’estetica fondata sullo storicismo potrà sempre fare appello ai contenuti, la
musica si sottrae evidentemente a questa possibilità: essa appare alla modernità come
l’arte antimimetica par excellence (mentre, come abbiamo visto, per l’antichità era
perfettamente all’opposto l’arte mimetica par excellence), l’arte che per definizione non
rappresenta il reale e dunque meno che mai contenuti e realtà storicamente determinate.
Tracciare un qualche legame tra una partitura e una Weltanschauung che l’avrebbe
determinata è una possibilità quasi impraticabile e comunque sempre estremamente
esile e generica. Di qui l’urgenza di recuperare la musica all’ortodossia filosofica dello
storicismo,
postulando
un
rapporto
diretto
e
persino
necessario,
mediato
dall’impostazione sociologica, fra il “torto storico” della società capitalista massificata e
la diacronia del linguaggio musicale374.
5. Imitatio macrostrutturale e traduzione
Torniamo ora brevemente alla pertinentizzazione del discorso fin qui svolto sulla
mimesis/imitatio alla linea epica “integrale” che lega Trissino, Alamanni e Tasso. Tanto
all’Italia liberata quanto alla Gerusalemme conquistata, fra le molte altre critiche, viene
373
LEOPARDI, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica.
Mi riferisco naturalmente, in primo luogo, a ADORNO, T. W., Filosofia della musica moderna, Torino,
Einaudi, 2002 (1949), che d’altronde si ricollega esplicitamente a Hegel e in particolare alla sua
concezione dell’originalità nell’arte (sin dalle tre citazioni in epigrafe alle tre sezioni del saggio); cfr. ad
es. p. 25: «Alla musica avanzata non resta altro che persistere nel proprio indurimento, senza concessioni
a quell’elemento umano che, là dove continua ad esercitare le sue lusinghe, essa riconosce come
maschera dell’inumanità. La verità di quella musica appare esaltata in quanto essa smentisce, mediante
un’organizzata vuotezza di significato, il senso della società organizzata che essa ripudia, piuttosto che
per il fatto di essere di per se stessa capace di un significato positivo». Tale posizione è peraltro
perfettamente coerenti con quelle più generali della Teoria estetica del filosofo.
374
340
mossa la critica prima e capitale, che sussume quasi tutte le altre, di essere opere dove
qualsiasi ricerca di originalità è sacrificata in toto all’adeguamento imitativo al modello
eccellente, l’Iliade omerica. Adeguamento descritto appunto, tanto in passato quanto, a
maggior ragione, dalla critica anche più recente, in termini di copia, duplicazione fedele
e integrale, appiattimento sul modello, “remake”. Paradossalmente, proprio questa è la
critica che il Tasso stesso, quando sta già maturando il suo ulteriore riavvicinamento al
poema trissiniano con la Gerusalemme conquistata, muove al poema dell’altro
rappresentante di questa linea epica “integrale” di cui ci siamo occupati, Alamanni,
liquidando la sua Avarchide per essere « anzi traduzione, che novo poema ». Già solo
questa consapevolezza, mostrando che il rischio sul fronte dell’originalità era
perfettamente chiaro al poeta, dovrebbe garantire l’operazione di riscrittura tassiana (e
di riflesso anche la sua rivalutazione del Trissino) da tale genere di accusa.
Credo che l’analisi del poema trissiniano e della sua influenza sul Tasso condotta
in questo studio, così come quella da me precedentemente condotta sulla Conquistata,
abbia contribuito a mettere ampiamente in luce la portata degli elementi originali e
persino fortemente innovativi dell’Italia liberata – sul triplice livello del rapporto con la
tradizione epica, con quella romanzesca e con la materia storica –, nonché il suo
rapporto assolutamente libero e creativo (seppur complessivamente malriuscito) con
Omero. Se è innegabile che la quantità di materiale desunto dalla tradizione e in
particolare dall’Iliade è decisamente ingente, abbiamo evidenziato come esso sia
costantemente selezionato e riutilizzato in vista della creazione di nuove e indipendenti
strategie di senso, spesso del tutto divergenti dal modello e complessivamente coerenti
con un progetto autonomo: lo scarso valore artistico del risultato è poi questione diversa
e, in parte, indipendente, nell’essere lo scarto fra l’idea poetica e l’effettiva poiesis il
vero banco di prova dell’arte.
D’altra parte, però, proprio la forma specifica di imitatio praticata, con vari esiti,
dai tre autori della linea epica “integrale” che abbiamo individuato – un’imitatio
estensiva e tendenzialmente esclusiva del modello iliadico, tale da permeare la nuova
opera a tutti i livelli, da quello microstrutturale e stilistico fino alle macrostrutture e alla
trama nel suo complesso – a causa del suo carattere apparentemente esorbitante dalle
consuete pratiche imitative necessita di una sua specifica spiegazione entro il quadro
generale dell’estetica della mimesis, che si è qui tentato di contribuire a liberare dei
pregiudizi ad essa sovrapposti dalla successiva concezione estetica, ancor oggi
dominante nonostante il suo evidente indebolimento intervenuto con il postmodernismo
341
filosofico e artistico. Si tratta insomma di una pratica dell’imitazione che appare
peculiare e perfino anomala rispetto allo stesso contesto rinascimentale prima di tutto
per il suo peso anche meramente quantitativo entro le opere considerate: intere scene del
Trissino o del Tasso della Conquistata appaiono modellate su corrispettive scene
iliadiche, ampi passi anche di decine di versi risultano essere traduzione poco meno che
letterale da Omero, nuclei narrativi portanti della struttura della trama sono mutuati
dall’Iliade. Come si spiega un tale modo di procedere, prassi costante in quelle opere?
Come si inscrive nella concezione rinascimentale dell’imitatio? Come possiamo dare
ragione, pur senza estendere arbitrariamente su tale fenomeno la nostra concezione
postromantica dell’originalità, di una pratica che sembra però contravvenire anche al
concetto più debole e se vogliamo metastorico, magari persino ingenuo, di opera nuova
e originale semplicemente in quanto altra da una precedente (concetto d’altronde ben
chiaro già al dibattito rinascimentale, ed evidente appunto nel citato giudizio tassiano
sull’Alamanni)?
La categoria critica relativamente recente di intertestualità, mediata anche dalla
pratica del commento scientifico, ci ha abituati a guardare alla ripresa di elementi
microstrutturali di altri testi (nessi, citazioni, reminiscenze, allusioni, “tessere” ecc.)
come a un fatto costitutivo del fenomeno letterario in generale e poetico in particolare,
comprendendolo finalmente appieno nel riconoscerlo come apportatore di senso e
dunque tale non da impoverire il testo, ma tutt’al contrario da arricchirlo attraverso le
risonanze, al contempo evocative e significanti, di testi precedenti. Ci ha abituati
senz’altro meno, invece, a valutare in maniera corrispondente quei rapporti fra testi che
travalicano la dizione, il tassello, la ripresa puntuale quasi sempre veicolata a livello
verbale, arrivando a coinvolgere elementi macrostrutturali come scene, episodi e a
maggior ragione nuclei narrativi fondamentali nella strutturazione della trama nel suo
complesso. Proprio a questa residua difficoltà, io credo, è in gran parte imputabile la
condanna aprioristica (in quanto avulsa da una seria analisi critica e spesso anche dalla
lettura) e senza appello di questo genere di intertestualità “macrostrutturale”, quella che
porta a bollare un’opera come copia e remake perché anziché imitare in filigrana imita
nella struttura complessiva, macroscopica: una nostra difficoltà ermeneutica, dunque,
proiettata senza la minima cautela critica sui prodotti di un’estetica evidentemente altra.
Di fronte a questo tipo di rapporto intertestuale, insomma, i nostri strumenti critici non
si sono ancora giovati appieno della categoria di intertestualità, e il nostro atteggiamento
non appare poi così lontano da quello, vistosamente acritico, che portava Rajna a
342
svalutare il Furioso a causa del pullulare di “fonti” in esso rintracciate. Se poi al
rapporto macrostrutturale si abbina persino, con frequenza sistematica, anche la ripresa
testuale a livello di dizione, sfociando spesso nella quasi traduzione, allora la condanna
è del tutto scontata in partenza.
Ma forse questo non è l’atteggiamento migliore per comprendere. Piuttosto, in
ambito estetico (e anzi in qualsiasi ambito), prima di proporre un giudizio critico su un
qualsiasi oggetto di analisi bisognerebbe preventivamente raggiungere, innanzitutto, un
elevato grado di autocoscienza, per giudicare, prima ancora che ciò che si intende
giudicare, i propri metri di giudizio, che come l’ermeneutica filosofica ci insegna sono
costitutivamente, in qualche misura, pregiudiziali (pur riconoscendo che il pregiudizio
non è necessariamente sbagliato in quanto tale). E tanto più tali pregiudizi sono grandi e
fondanti il nostro giudizio, tanto meno – proprio per questo – li riconosciamo e siamo
propensi a sottoporli ad autocritica.
In fondo il modo di procedere di Trissino e del Tasso, soprattutto il Tasso della
Conquistata, in rapporto al testo omerico, non è poi così diverso da quello che essi
potevano riscontrare nell’Eneide virgiliana, dove al rapporto strutturale con i poemi
omerici si associa spesso la tendenza alla libera traduzione di ampi passi dell’ipotesto.
Anzi, l’intera operazione che essi compiono si propone chiaramente come qualcosa di
omologo all’operazione compiuta un millennio e mezzo prima da Virgilio nel
rimodellare complessivamente il genere letterario dell’epica, anziché sulla tradizionale
epica annalistica latina (che pure naturalmente non è obliterata, come possiamo
constatare già dagli scarsi frammenti che abbiamo di Ennio), piuttosto sui due poemi
omerici, ben più lontani nella lingua, nel tempo, nella tradizione letteraria. Già Petrarca,
pur arrivando a stento a leggere una provvisoria traduzione latina di Omero, grazie
anche alla testimonianza di Macrobio sapeva misurare l’ingente debito di Virgilio verso
Omero, che ancor oggi dagli studi specifici del settore è forse più affermato in termini
generali che non studiato con il dovuto approfondimento. Tanto più, allora, il rapporto
pervasivo e strutturante con Iliade e Odissea appare in tutta la sua evidenza come
criterio fondante del poema virgiliano agli occhi di Trissino e Tasso, che naturalmente
conoscono altrettanto bene i massimi capolavori sia dell’epica greca arcaica che di
quella latina.
Né d’altronde si deve pensare che tale uso estensivo della libera traduzione
artistica in associazione alla ripresa strutturale sia una pratica esclusiva della linea epica
“integrale” che stiamo considerando. Sicuramente nei testi poetici dell’umanesimo
343
latino si trovano dei precedenti per una simile modalità di imitatio, d’altronde a sua
volta esemplata sul genere di rapporto intrattenuto da svariate tipologie di testi della
latinità con i loro modelli greci; ma già nel Tasso stesso della Liberata, ben prima del
riavvicinamento alla poetica trissiniana all’altezza della riscrittura del poema, si può
occasionalmente individuare un simile modo di procedere nella creazione poetica: la
celebre descrizione del giardino di Armida, ad esempio, nel rifunzionalizzare il topos
romanzesco del giardino incantato, risale all’origine della fortunatissima tradizione del
locus amoenus, e nell’operare questa ripresa funzionale la accompagna alla traduzione
piuttosto fedele del testo dell’Odissea in cui è descritto il cortile della reggia di Alcinoo
al momento in cui Odisseo, come Carlo e Ubaldo, lo attraversa:
Co' fiori eterni eterno il frutto dura,
e mentre spunta l'un, l'altro matura.
Nel tronco istesso e tra l'istessa foglia
sovra il nascente fico invecchia il fico;
pendono a un ramo, un con dorata spoglia,
l'altro con verde, il novo e 'l pomo antico;
lussureggiante serpe alto e germoglia
la torta vite ov'è più l'orto aprico:
qui l'uva ha in fiori acerba, e qui d'or l'have
e di piropo e già di nèttar grave.
(G. L., XVI, 10-11)
t£wn oÜ pote karpÕj ¢pÒllutai oÙd' ¢pole…pei
ce…matoj oÙdὲ qšreuj, ™pet»sioj· ¢ll¦ m£l' a„eˆ
zefur…h pne…ousa t¦ mὲn fÚei, ¥lla dὲ pšssei.
Ôgcnh ™p' ÔgcnV ghr£skei, mÁlon d' ™pˆ m»lJ,
aÙt¦r ™pˆ stafulÍ staful», sàkon d' ™pˆ sÚkJ.
œnqa dš oƒ polÚkarpoj ¢lJ¾ ™rr…zwtai,
tÁj ›teron mšn q' eƒlÒpedon leurù ™nˆ cèrJ
tšrsetai ºel…J, ˜tšraj d' ¥ra te trugÒwsin,
¥llaj dὲ trapšousi· p£roiqe dš t' Ômfakšj e„sin
¥nqoj ¢fie‹sai, ›terai d' Øpoperk£zousin.
œnqa dὲ kosmhtaˆ prasiaˆ par¦ ne…aton Ôrcon
panto‹ai pefÚasin, ™phetanÕn ganÒwsai.
(Odissea., VII, 117-128)375
L’aderenza all’ipotesto è molto forte, ma allo stesso tempo l’eccellenza poetica dà
luogo ad un passo totalmente originale nell’espressione – nel senso di nuovo e altro
rispetto al modello – nonostante una dipendenza tanto stretta: ecco che le medesime
immagini al contempo permangono e vengono ricreate ex novo; la mimesis/imitatio del
modello letterario si rivela autenticamente tale proprio in quanto si fa di nuovo, al
contempo, poiesis. Vediamo in particolare quanto contribuisca all’essenza radicalmente
originale dell’imitatio artistica – tradizionalmente accusata, dalla vulgata antimimetica,
di essere l’antitesi stessa dell’originalità – la straordinaria forza figurale,
precedentemente evidenziata, della rima, che in mano a un grande poeta diventa lo
strumento di un perfetto equilibrio tra un’aderenza al pensiero poetico tanto poco
deformante da potersi permettere il livello di fedeltà di una traduzione e, al contempo,
una libertà immaginifica e inventiva tale da ricreare da capo, come fosse un’immagine
375
Trad.: « Mai il loro frutto marcisce o finisce, / né inverno né estate: è perenne . Sempre / lo Zefiro gli
uni fa crescere, gli altri matura soffiando. / Invecchia sulla pera la pera, sulla mela la mela, / sul grappolo
il grappolo, il fico sul fico. / È piantata lì la sua vigna ricca di frutti: / una parte, esposta ai raggi su un
aperto terreno, / è seccata dal sole; le altre uve invece le colgono, / altre ancora le pigiano. Davanti sono
grappoli acerbi, che gettano il fiore e altri che imbrunano » (OMERO, Odissea, traduzione di PRIVITERA,
G. A., Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, 1981).
344
nuova ideata autonomamente dal poeta imitatore, l’immagine che è invece
rigorosamente mutuata dal testo imitato: i parallelismi del testo odissiaco, di un
geometrico e granitico arcaismo, spoglio di qualsiasi ornamento o plasticità (Ôgcnh ™p'
ÔgcnV ghr£skei, mÁlon d' ™pˆ m»lJ, / aÙt¦r ™pˆ stafulÍ staful», sàkon d' ™pˆ
sÚkJ), si stemperano e addolciscono in una variatio figurale nel testo tassiano: così, il
prodigio innaturale del perpetuo sovrapporsi del frutto acerbo a quello maturo dapprima
si espande nel “particolareggiare” realistico e denotativo – quasi come uno zoom di
stupore – dal tronco alla foglia, poi la medesima immagine viene rideclinata nel traslato
e più evocativo spoglia (non immemore, d’altronde, dell’eco di un celebre luogo
dantesco, Inf. III, vv. 112-114: « Come d’autunno si levan le foglie / l’una appresso de
l’altra, fin che ’l ramo / vede a la terra tutte le sue spoglie »); parallelamente la rima con
il letterale termine fico rompe il parallelismo omerico fra sostantivi nel nesso aggettivale
pomo antico, per poi tornare mirabilmente alla traduzione letterale con ov’è più l’orto
aprico (leurù ™nˆ cèrJ, dove leurς significa luogo piano e dunque aperto, esposto:
esattamente l’italiano “aprico”), mentre l’altra rima trasforma il “mette radici” del greco
(™rr…zwtai) in germoglia; nel distico conclusivo, infine, la forma arcaica e latineggiante
have permette, attraverso l’aggettivo grave, di dilatare Øpoperk£zousin (“si
scuriscono, maturano”) in una splendida perifrasi tutta di termini traslati (or e piropo a
rendere l’aspetto coloristico, nettar a richiamare l’allusione alla vendemmia presente nel
testo greco due versi prima).
È proprio questo il livello di fedeltà al dettato omerico niente affatto in contrasto
con la rielaborazione creativa che sarà molto più frequente, sull’esempio trissiniano,
nella Conquistata, da cui è tratta la seguente similitudine, che marca il cambiamento
provocato sull’andamento della battaglia dall’arrivo sul campo dei rinforzi. Il
comparatum sviluppa la stessa immagine presente nell’Iliade, e dall’eccellente
traduzione letterale dei primi due versi muove verso una maggiore libertà nei particolari
del seguente ampliamento descrittivo, che trasferisce il tratto del “fulmine” dalla
divinità – alla quale non è più pertinente, avendo frattanto il cielo cambiato padrone – al
monte, che dal fulmine viene colpito, designato dal termine traslato fronte; la
conseguente modificazione della descrizione in senso più lugubre permette di variare in
maniera più sostanziale il comparandum: l’immagine positiva del riprendere fiato dalla
guerra, prima auspicata da Patroclo ad Achille con le parole di Nestore (Ñl…gh dš t'
¢n£pneusij polšmoio, Il, XVI, 43 = Il, XI, 801), è rovesciata a rimarcare,
cristianamente, l’orrore della guerra:
345
Qual dal sommo talor d'eccelso monte
l'orride nubi il re del ciel disgombra,
e scopre in lui la fulminata fronte,
e i tronchi i quai lasciâro i rami e l'ombra,
e i nudi gioghi, e 'l conturbato fonte,
e tutto ciò ch'una ruina ingombra:
tal ne l'aria serena è quivi apparso
orror di morte, e foco, e sangue sparso.
(G. C., XVIII, 149)
æj d' Ót' ¢f' ØyhlÁj korufÁj Ôreoj meg£loio
kin»sV pukin¾n nefšlhn sterophgeršta ZeÚj,
œk t' œfanen p©sai skopiaˆ kaˆ prèonej ¥kroi
kaˆ n£pai, oÙranÒqen d' ¥r' Øperr£gh ¥spetoj a„q»r,
ìj Danaoˆ nhîn men ¢pws£menoi d»ion pàr
tutqÕn ¢nšpneusan, polšmou d' oÙ g…gnet' ™rw»
(Il., XVI, 297-302)376
In questo caso persino l’elemento che genera la variazione – che poi qui non è
altro che il tertium comparationis – viene desunto dall’originale e rifunzionalizzato; il
risultato che ne deriva, però, arriva a coinvolgere addirittura le differenze di natura
culturale e ideologica che separano il poema cristiano dall’epica greca arcaica. Sembra
quasi di essere di fronte a una sfida alla massima ripresa possibile di elementi del
modello pur nella loro completa ri-creazione in qualcosa che, al di là della somiglianza,
risulta poi altro, nuovo, autonomo nel suo significato: ossia appunto quella che abbiamo
visto essere l’essenza della mimesis.
Tale livello di aderenza all’ipotesto omerico, costante nelle parti aggiunte ex novo
nella Conquistata, è in tutta evidenza un procedimento mediato dal poema del Trissino,
dove un simile rapporto di traduzione del modello è, come abbiamo riscontrato
ampiamente soprattutto nel quarto capitolo, molto frequente. Eppure proprio
l’innovazione metrica dell’endecasillabo sciolto si rivela, anche in questo,
assolutamente nefasta: al venir meno della rima, viene meno anche la spinta
all’elaborazione figurale e immaginifica che negli esempi tassiani anima la traduzione
emancipandola dalla fedeltà rigorosa e rendendola autenticamente mimesis, ossia
appunto nuova e autentica poesis di ciò che pure era già prima. La prosaicità dello
sciolto trissiniano, priva di qualsiasi slancio verso l’elaborazione figurale, finisce in
genere per scadere in una traduzione fedele e letterale nell’accezione moderna del
concetto, senza che la blanda ritmica del solo endecasillabo basti a riscattare la qualità
della creazione poetica.
Emerge qui di nuovo, in tutta evidenza, il valore figurale, immaginifico, creativo
della rima nella diametrale opposizione di funzioni fra la traduzione in senso proprio,
quella fedele e “filologica”, tipicamente moderna, e invece la traduzione creativa,
artistica, tradizionalmente designata in latino dal verbo vortere, che alla luce di quanto
376
Trad.: «Come quando dall’alta cima di una montagna / Zeus fulminante rimuove una nuvola spessa – /
appaiono tutte le cime e i picchi / e le valli, dall’alto si apre il cielo infinito – / così i Greci, avendo
respinto il fuoco dalle loro navi, / ebbero un po’ di respiro, ma la lotta non ebbe soste ».
346
abbiamo detto potremmo definire ancora più propriamente – senza timore di sminuirne
l’aspetto creativo, ma anzi appunto sottolineandolo nel modo più pertinente –
traduzione “mimetica”377.
Il valido articolo di Luciana Borsetto sulla questione del verso nel Rinascimento
italiano 378 , confrontando brani di traduzione virgiliana negli sciolti del Caro e nella
versione in ottave del Dolce (l’Enea), nota intelligentemente l’inadeguatezza dell’ottava
alla prima funzione di traduzione fedele proprio per la presenza della rima, che porta di
necessità al surplus, all’aggiunta sovrabbondante che per forza di cose eccede il testo di
partenza semplicemente « per fare la rima » (p. 117). Si può forse ipotizzare che proprio
la logorante difficoltà che origina dalla coercizione esercitata dalla rima contro
l’espressione letterale, precisa, adeguata che una traduzione (nell’accezione moderna
del termine) esige abbia influito in qualche misura sul giudizio parzialmente negativo e
quasi infastidito di Leopardi sulla rima ricordato a suo tempo379, e quindi forse anche
sulla quasi completa liquidazione della rima nei Canti (almeno della rima come istituto,
come norma): il grande poeta si era infatti a lungo cimentato, in particolare, nella più
volte rimaneggiata traduzione della Batracomiomachia pseudo-omerica, dove la scelta
della sestina narrativa (rimata) come struttura strofica per la traduzione porta, in un
progressivo cedere alle “costrizioni” della rima, ad un graduale scivolamento dalla
traduzione fedele alla riscrittura nelle tre versione successive, che quasi “tracimerà”
nell’invenzione creativa dei Paralipomeni380.
377
La bibliografia sulla pratica della traduzione e sulle sue svariate tipologie e finalità è piuttosto ampia;
per la distinzione fra traduzione in senso moderno e traduzione letteraria mi limito a rimandare a
MOUNIN, G., Teoria e storia della traduzione, Torino, Einaudi, 1965; Alcini, L., Storia e teoria della
traduzione letteraria in Italia, vol. I, Perugia, Guerra, 1998; PADUANO, G., Tradurre, in LAVAGETTO, M., a
cura di, Il testo letterario: Istruzioni per l’uso, Roma – Bari, Laterza, 1996.
378
BORSETTO, L., Tra normalizzazione e sperimentazione: appunti sulla questione del verso, cit., p. 115
sgg (La “maniera” del verso nella pratica).
379
Il problema dipende per Leopardi dal fatto che « il concetto è mezzo del poeta, mezzo della rima, e
talvolta un terzo di quello, e due di questa, talvolta tutto della sola rima »; per la discussione della
questione, cfr. supra, 6.1.3.
380
La traduzione e i Paralipomeni sono leggibili nell’edizione LEOPARDI, G., Batracomiomachia e
Paralipomeni, a cura e con saggio di Fornaro, P., Torino, Dall’Orso, 1999 (2007). A mostrare la creativa
infedeltà cui la rima costringe basti l’esempio delle prime tre sestine: 'ArcÒmenoj prῶtον Mousῶν
corÕn ™x `Elikînoj / ™lqe‹n e„j ™mÕn Ãtor ™peÚcomai e†nek᾿ ¢oidÁj· / ¿n nšon ™n dšltoisin ™mo‹j
™pˆ goÚnasi qÁka, / dÁrin ¢peires…hn, polemÒklonon œrgon ”Arhoj, / eÙcÒmenoj merÒpessin ™j
oÜata p©si balšsqai / pîj mÚej ™n batr£coisin ¢risteÚsantej œbhsan, / ghgenšwn ¢ndrîn
mimoÚmenoi œrga Gig£ntwn, / æj lÒgoj ™n qnhto‹sin œhn· to…hn d' œcen ¢rc»n. Trad.: « Mentre a
novo m’accingo arduo lavoro, / o Muse, voi da l’Eliconie cime / scendete a me ch’il vostro aiuto
imploro: / datemi vago stil, carme sublime: / antica lite io canto, opre lontane, / la Battaglia de’ topi e de
le rane. // Su le ginocchia ho le mie carte; or fate / che nota a ogni mortal sia l'opra mia, / che salva giunga
alla più tarda etate / per vostro dono, e che di quanto fio / che su le carte a voi sacrale io scriva / la fama
sempre e la memoria viva. // I nati già dal suol vasti giganti / di que' topi imitò la razza audace: / di nobil
foco accesi, ira spiranti / vennero al campo; e se non è mendace / il grido ch'oggi ancor va per la terra, /
questo l'origin fu di quella guerra ». D’altronde la correlazione fra rima e rielaborazione creativa è
347
Tuttavia appunto per questo, possiamo aggiungere, la rima risulta all’opposto non
un ostacolo ma una straordinaria risorsa, come si è visto, per la creazione poetica e per
quel suo caso specifico ma non esorbitante che è la traduzione artistica, autonoma o
inserita, come nel nostro caso, entro opere di più ampio respiro. Se di fronte
all’obiettivo di rendere fedelmente la lettera e lo spirito di un testo in un’altra lingua, in
un’operazione essenzialmente filologica e interpretativa, l’impiego della rima – con la
sua tendenza incoercibile alla libertà associativa e persino all’arbitrio – costituisce
meramente un ostacolo, quando l’obiettivo sia invece quello radicalmente altro della
creazione artistica anche una pratica apparentemente e superficialmente affine alla
precedente nell’essere di fatto una forma di traduzione viene all’opposto vivificata e
animata dal ricorso alla rima, che proprio per la medesima incoercibile tendenza alla
figuralità e all’invenzione viene, in questo secondo caso, ad essere pienamente in
sintonia con le finalità e i modi dell’operazione messa in atto. L’obbligo di tradurre, in
questo caso, assume sostanzialmente la funzione di “materia resistente” al processo
formativo della creazione dall’impatto con la quale sorge lo specifico della poiesis: la
stessa funzione di resistenza materiale messa in atto dalla rima, dai vincoli formali
“chiusi”, dalle difficoltà tecniche del “naturalismo” figurativo in arte, dai mille obblighi
armonici e strutturali del classicismo musicale.
Ciò costituisce anche un eccellente esempio concreto, a livello di dizione, delle
potenzialità creative insite nel concetto di mimesis/imitatio che abbiamo tentato di
delineare: nel caso specifico, del potenziale mimetico insito nella traduzione artistica e
nell’impiego della rima. Luciana Borsetto, discutendo delle traduzioni del Caro e del
Dolce, utilizza la terminologia relativa alla mimesis nel senso della corrente vulgata che
la intende come rappresentazione fedele e copia del modello: « Se l’esercizio della
funzione poetica è assegnato alle ottave e il rigore della mimesi narrativa, invece, allo
sciolto…» 381 (corsivo mio). Come si vede, la concezione svilente otto-novecentesca
esplicitata in conclusione al Discorso sopra la Batracomiomachia: « Il Dolce e Giovanni da Falgano si
servirono dell'ottava rima, ma per le difficoltà che porta seco questo metro, le quali probabilmente mi
avrebbono obbligato a comporre piuttosto che tradurre, o a servirmi di rime stiracchiate che io abborro
come nemiche capitali della bellezza della poesia, e del piacere dei lettori, lo abbandonai, e scelsi le
sestine endecasillabe, dei vantaggi delle quali, dopo l'uso felicissimo che hanno fatto di loro parecchi
poeti, e singolarmente l'Ab. Casti, non può più dubitarsi. Tradussi non letteralmente, come il Lavagnoli,
ma per tradussi, e fui ben lontano dal fare un nuovo poema, come Andrea del Sarto. Cercai d'investirmi
dei pensieri del poeta greco, di rendermeli propri, e di dar così una traduzione che avesse qualche aspetto
di opera originale, e non obbligasse il lettore a ricordarsi ad ogni tratto che il poema, che leggea, era stato
scritto in greco molti secoli prima. Volli che le espressioni del mio autore, prima di passare dall'originale
nelle mie carte, si fermassero alquanto nella mia mente, e conservando tutto il sapor greco, ricevessero
l'andamento italiano, e fossero poste in versi non duri e in rime che potessero sembrare spontanee ».
381
BORSETTO, L., cit., p. 115.
348
della mimesis come riproduzione rigorosa mirante alla somiglianza e alla fedeltà porta
ad un esito esattamente rovesciato rispetto alla prospettiva proposta in queste pagine, in
conseguenza alla quale, al contrario, la traduzione “fedele”, la trasposizione che sia
potenzialmente copia esatta (pur concretamente impossibile) di un dato testo in un’altra
lingua, quella cui la rima è ostacolo impediente e non mezzo creativo, risulta appunto
un’operazione non mimetica proprio a causa della sua intrinseca aspirazione alla
fedeltà; l’istanza propriamente mimetica risulta essere, invece, quella della traduzione
artistica, creativa, che anche quando è estremamente fedele come nei due casi proposti
non ha tale fedeltà come suo obiettivo primario: tale fedeltà è meramente strumentale
alla creazione di qualcosa di nuovo, di autenticamente originale, nel senso migliore e
meno ideologico del termine.
In questo senso, la mimesis consiste in un processo che smembra e scardina gli
elementi costitutivi del modello – naturale o artistico che sia – per rielaborarli
trattandoli alla stregua di elementi creati autonomamente, appunto perché trattati come
materiali di una nuova e indipendente creazione. La mimesis, dunque, secondo un
riavvicinamento concettuale più volte segnalato negli ultimi anni, non è affatto l’antitesi
della poiesis, della creazione, come nell’interpretazione romantica, ma al contrario un
concetto strettamente affine ad essa: potremmo forse dire, addirittura, che essa è in
generale nient’altro che la modalità della poiesis.
D’altronde è piuttosto chiaro che il confine tra l’imitatio intesa come rapporto
intertestuale e la pratica della traduzione, prima dell’idea contemporanea della
traduzione “letterale” ma non “letteraria”, è un confine decisamente fluido: le traduzioni
integrali dei testi classici, soprattutto poetici, sono aperte ad ampi margini di libertà,
nelle forme più varie della cancellazione, dell’aggiunta, della modifica che stravolge,
persino dell’inglobamento nel testo della glossa erudita; per contro, le opere “originali”
sono conteste di frammenti testuali e moduli strutturali desunti a piene mani dai modelli
classici. Pur nella loro ovvia diversità, entrambe queste pratiche rientrano
evidentemente nell’ambito dell’intertestualità in senso lato, per cui giustamente Genette
annovera senz’altro la traduzione fra i casi per cui un certo testo si produce e si
conforma sulla base di testi precedenti382. Altrettanto evidente, tuttavia, che si tratta di
due operazioni radicalmente diverse, nella loro essenza profonda. Come si può dunque
tracciare una demarcazione netta e sicura fra l’istanza interpretativa di un testo, di cui la
traduzione in senso proprio è solo l’esito più letterale e fedele, e l’istanza creativa, per
382
GENETTE, G., Palinsesti. La letteratura al secondo grado, Torino, Eindaudi, 1997 (1982), cap. XLI
sgg., pp. 128 sgg.
349
cui il rapporto con testi precedenti è inteso a creare un testo artistico in qualche misura
originale rispetto a quelli? Mi pare chiaro a questo punto che la linea di demarcazione
non può essere quantitativa: una parafrasi si può allontanare dalla lettera del testo molto
più di quanto non facciano gli esempi di traduzione artistica o “mimetica” che abbiamo
visto. L’unico criterio realmente pertinente resta allora non già il livello di aderenza al
testo modello in se stesso, ma soltanto quella che si potrebbe definire aristotelicamente
la finalità dell’operazione, ossia precisamente il suo essere volta complessivamente a
interpretare il testo d’origine oppure a crearne uno nuovo e autonomo,
indipendentemente dal livello di aderenza testuale al modello. Come scrive Guido
Paduano a proposito della traduzione artistica (la “traduzione-rifacimento”), « abbiamo
dunque a che fare con opere dotate di un disegno perfettamente autonomo, che però si
definisce attraverso la relazione contrastiva con un “modello” »383. Altrimenti detto, il
discrimine risiede nella subordinazione del testo d’origine alla creazione di una nuova e
autonoma strategia di senso nel testo derivato.
Ma ben al di là della questione specifica della traduzione – che pure qui ci
riguardava direttamente solo per la presenza quantitativamente imponente del ricorso
alla traduzione artistica nell’epica rinascimentale di cui ci stiamo occupando –, credo
che questo sia appunto il principium individuationis che permetta di ripensare in
generale, nella loro interdipendenza, le categorie tradizionalmente contrapposte della
mimesis e dell’originalità nell’arte. Per com’è concepito dalla vulgata, l’opposizione è
radicale e quasi antinomica nel consistere la prima nella conformazione a un modello –
asintoticamente tendente al “limite” della copia-duplicato, della fedeltà assoluta – e la
seconda,
all’opposto,
nello
scardinamento
di
un
tale
rapporto
sulla
base
dell’affermazione dell’individualità soggettiva e irripetibile. Opposizione che la
presente analisi non intende semplicemente contribuire a stemperare, secondo una
tendenza peraltro evidente negli studi da diversi decenni a questa parte, ma a ripensare
proprio nella sua essenza, dunque non tanto nella diacronia storica delle sue
innumerevoli variazioni contingenti e passibili di ricostruzione nella loro specificità (già
solo in ambito rinascimentale estremamente numerose e variegate), quanto nel suo
fondamento teorico e filosofico. Possiamo allora individuare l’essenza della mimesis
artistica proprio nella significazione, nel suo essere costitutivamente un fenomeno di
creazione di senso. Il rapporto con il modello (reale o artistico che sia),
progressivamente slittato per opera della spinta della speculazione teorica e filosofica
383
PADUANO, G., Tradurre, cit., pp. 131-151.
350
fino ad una vera e propria ossessione di fedeltà, che deflagra infine nella rottura
liberatoria dell’Avanguardia, si spiega invece unicamente in subordine all’esigenza
primaria ed essenziale della creazione di senso. La storia più recente della millenaria
estetica della mimesis è allora, come sta emergendo con nettezza negli ultimi anni, la
storia di un fraintendimento. Se l’essenza della mimesis consiste non nella fedeltà e
nella copia ma nella creazione autonoma di senso, la sua opposizione romantica
all’originalità (pur implicita e presagita già molto prima, anche nell’età umanisticorinascimentale) in tutta evidenza non può che venir meno. Ma prima di trarre le
conseguenze teoriche ultime di questo lungo ragionamento, tuttavia, torniamo un
momento a concludere, dalla prospettiva ormai delineatasi, sullo specifico problema di
storia della letteratura che ha sollecitato questa lunga riflessione di estetica.
Già confrontandomi con gli studi critici sulla Gerusalemme conquistata avevo
riscontrato chiaramente un insufficiente approfondimento critico del problematico
rapporto imitativo che la riscrittura del capolavoro tassiano instaura su larga scala con
l’Iliade omerica. Anche lo studioso che ha fornito recentemente la più ampia
monografia sulla riscrittura della Gerusalemme, Matteo Residori, il solo a proporre un
approccio più approfondito del rapporto con Omero e a tentare di darne una spiegazione
complessiva384, si limita in realtà a ricollegarsi – come abbiamo già accennato – alla
ricostruzione dell’imitatio fornita dalla critica americana e in particolare all’autore che
ha scritto sull’argomento la trattazione più specifica e approfondita, Thomas M.
Greene385. Quel tipo di approccio critico alla questione, tuttavia, nonostante la validità e
l’approfondimento della ricostruzione storica che propone, appare viziato, nei principi
teorici da cui muove, proprio da un difetto di autocoscienza e dall’implicita e acritica
proiezione dell’estetica antimimetica dell’originalità sull’imitatio rinascimentale. In
particolare, la categoria di imitazione “sacramentale” di Greene, cui Residori ricorre per
spiegare il tipo di imitazione messo in atto dalla Conquistata, è esplicitamente elaborata
per fornire un presupposto teorico al giudizio negativo di quel tipo di imitazione che
appare poco creativa, troppo legata alla duplicazione e alla copia di un modello illustre,
da cui intenderebbe desumere nell’imitazione fedele proprio la sacralità e dunque, di
riflesso, il pregio letterario: evidente la perfetta adeguatezza della spiegazione anche alla
poetica omerizzante dell’Italia del Trissino. A tale forma negativa e svilente di
imitazione si contrapporrebbe in particolare, come polarità opposta, l’imitazione
“eristica”, positiva e valida nel gareggiare col modello e mirare all’emancipazione,
384
385
RESIDORI, M., L’idea del poema, cit.
GREENE, T. M., The Light in Troy. Imitation and Discovery in Renaissance Poetry, cit.
351
persino aggressiva, rispetto ad esso. Nonostante l’apparente adeguatezza di una tale
dicotomia – su cui è impostata la ricostruzione dell’intero saggio di Greene come pure
la posizione, esplicitamente omogenea, di Pigman – al dibattito umanisticorinascimentale sull’opposizione di ascendenza classica fra imitatio e aemulatio e sulla
preferibilità del modello eccellente unico o piuttosto dell’imitazione eclettica, mi pare
evidente, alla luce della ricostruzione proposta in queste pagine, il carattere arbitrario e
anacronistico di una simile analisi: l’imitazione “sacramentale” non è altro che la
categoria in cui collocare quanto la moderna estetica antimimetica rifiuta
perentoriamente, mentre quella “eristica”, complementarmente, è la categoria mediante
la quale piegare la parte residua e accettabile (si direbbe quasi “tollerabile”)
dell’imitatio rinascimentale all’estetica dell’originalità. La dicotomia fra rifiuto e
misinterpretazione che qui agisce in forma latente è, in generale, semplicemente la
modalità tipica con cui un’ideologia dominante assoggetta a sé un precedente sistema
ideologico su cui ha prevalso: macroscopico, in questo senso, l’esempio della secolare
appropriazione della cultura classica da parte di quella cristiana, continuamente
oscillante fra l’anatema e il saccheggio.
Smascherata la fallacia di un simile approccio, come spiegare allora, alla luce
delle considerazioni svolte sulla teoria della mimesis, il carattere macroscopico e
tendente all’esclusività (quantomeno nella sproporzione rispetto al riuso di altri modelli)
del rapporto che la nostra linea epica “integrale” instaura con il modello omerico? Dallo
studio condotto nei precedenti capitoli sul testo del poema trissiniano e sulla sua
influenza sul Tasso credo sia emersa in maniera evidente la motivazione costantemente
funzionale del rapporto imitativo con l’Iliade, soprattutto a livello macrostrutturale. I
nuclei principali della trama iliadica sono dal Trissino selezionati, desunti e
completamente rielaborati – fino a stravolgerne consapevolmente alcuni esiti
fondamentali – in vista della creazione di autonome strategie significative, ossia
strutture di senso senz’altro nuove (e in certi casi radicalmente nuove) rispetto a quelle
del testo omerico. La contaminazione strutturale con il romanzesco, quasi
completamente ignorata dalla vulgata critica, è apparsa d’altronde proprio come una
delle modalità principali di tale risemantizzazione: elemento di fondamentale
importanza per l’influenza determinante, anch’essa disconosciuta, sull’intera diacronia
evolutiva della Gerusalemme tassiana. Sostanzialmente omogenea a questo risultato era
apparsa non a caso, all’analisi da me in precedenza condotta, anche la Gerusalemme
conquistata, vittima di un affine pregiudizio critico verso la sua capacità di creare, nella
352
riscrittura, strategie di senso nuove e autonome, non necessariamente peggiorative,
rispetto alla Liberata: chiaramente evidenziabile ad un’analisi non pregiudiziale era
risultata, anche lì, la rifunzionalizzazione degli altrettanto cospicui materiali omerici,
massicciamente desunti non per ossequio “sacrale” al modello illustre, ma al contrario
in vista della creazione di autonome di strategie significative. Ma se con tale riscrittura
assistiamo senz’altro, proprio in questo genere di pratica imitativa “integrale”, a un
netto riavvicinamento del Tasso alla poetica trissiniana, il peso di questa particolare
modalità di imitazione inaugurata dal Trissino, come credo di aver dimostrato in tutta
evidenza, è capitale e assolutamente determinante, innanzitutto proprio a livello
macrostrutturale, non solo per la Conquistata ma già per composizione stessa della
Liberata, in un rapporto drasticamente sottovalutato e quasi rimosso dalla critica.
Si chiarisce a questo punto anche la connessione fra la ricostruzione qui avanzata
dell’essenza profonda e autentica della mimesis/imitatio e il particolare rapporto
modellizzante di ordine macrostrutturale che l’Italia liberata e la Gerusalemme
conquistata (ma anche più indirettamente, attraverso la mediazione trissiniana, la
Liberata) intrattengono con l’Iliade. Il permanere del pregiudizio negativo verso
un’intertestualità macrostrutturale anziché soltanto microstrutturale ha portato
complessivamente a non scorgere il vero senso di tale operazione di imitatio “integrale”.
Essa risiede evidentemente non nella presunta “sacralità” del modello, ma in una
questione di teoria dei generi letterari. Come nota giustamente Javitch in un suo articolo
sulla nascita della teoria dei generi letterari nel Cinquecento italiano386, la dialettica che
anima nel profondo la produzione letteraria rinascimentale oscilla costantemente fra
l’imitazione dei concreti modelli letterari canonizzati e la modellizzazione teorica
desunta e spesso anche costruita ex novo a partire soprattutto dalle indicazioni della
Poetica di Aristotele: alla teoria aristotelica si ricorreva in particolare (ma questo
argomento di Javitch è forse troppo schematico) quando mancavano dei modelli letterari
che potessero assolvere pienamente alla funzione modellizzante. Piuttosto, entro la
generale volontà di rifondare i generi letterari classici in una letteratura volgare che
ormai, dopo i “nuovi” classici del Trecento, era considerata decisamente degna di
assurgere a un livello di letteratura “alta”, la poesia narrativa costituisce un settore
problematico per l’interferenza di una parallela codificazione generica già in atto, quella
romanzesca, imposta dallo straordinario successo del Furioso. Ciò fa sì che la
codificazione della poesia narrativa diventi decisamente problematica, in questo caso,
386
JAVITCH, D., La nascita della teoria dei generi poetici nel Cinquecento, «Italianistica», XVII, 2
(1998), pp. 177-197.
353
non più per un difetto di codificazione (come per il teatro), ma all’opposto per un suo
eccesso. Accingersi a scrivere narrativa in versi poneva di fronte a un evidente problema
di prassi poetica: come strutturare l’opera? come i romanzi di Boiardo e Ariosto? come
l’epica classica? e in quest’ultimo caso, quale epica classica? Omero, Virgilio o
cos’altro? La scelta trissiniana di Omero come modello è allora naturalmente
influenzata da Aristotele, non tanto per la sua autorità né per la sua proposta di Omero
come paradigma di eccellenza, bensì perché la Poetica fornisce alla prassi artistica uno
schema del modello di genere epico in evidente relazione di teoria-esempio con l’Iliade.
Non si tratta dunque di una questione di autorità, ma di un problema eminentemente
pratico, di prassi poetica. Il Tasso si troverà esattamente di fronte allo stesso problema,
e proprio per questo guarderà al Trissino, come modello di prassi poetica ben più che
come modello di teoria.
Ciò che l’artista richiede all’idea di genere letterario, infatti, è un codice
complessivo di temi e di forme che gli permetta di strutturare la sua opera e al contempo
di far emergere, su quello sfondo di codice, la strategia strutturale nuova e autonoma
della propria opera, che quel modello astratto e convenzionale realizza e innova (come
ogni espressione rispetto alla sua langue). Trissino, allora, non produce affatto un
duplicato astorico e anacronistico dell’Iliade, ma desume da esso, seguendo le scarne
ma illuminanti indicazioni di Aristotele, le strutture che permettano di costruire
un’opera epica e di farla significare sullo sfondo di una tradizione. Da questa ottica il
romanzo si prospetta evidentemente come un controgenere, cioè non un genere
malriuscito o deprecabile, ma come un genere alternativo proprio nelle strutture che
propone, in un’opposizione fondamentalmente dialettica.
Tuttavia quando si intenda, dunque, riportare in vita la struttura complessiva di un
genere letterario “morto” come genere epico classico in alternativa al vivissimo
romanzo, facendo risorgere una tradizione letteraria da tempo interrottasi, si sta
compiendo un’operazione altamente artificiale: bisogna colmare quello iato temporale e
letterario che separa il presente dal passato, che rompe la continuità. Quelle forme e
quei temi di cui si ha bisogno devono essere desunti artificialmente da una tradizione
del passato. Viene a mancare quel diretto confronto con le opere dei propri predecessori
che permette di collocarsi in una continuità, quand’anche fosse per contrapposizione, e
che è indispensabile a ricevere “naturalmente” un patrimonio di materiali dal rapporto
con i quali, in una continua evoluzione, si determina nel tempo un genere letterario. Per
rifondare il poema eroico, dunque, le forme e i temi devono essere desunti
354
artificialmente dalla tradizione epica dell’antichità. Ma allora perché solo Omero,
perché un tipo di imitazione al contempo così esclusiva e così pervasiva?
La risposta è a mio parere appunto nel carattere artificiale dell’operazione: andare
a desumere da opere del passato del materiale che non viene trasmesso naturalmente,
per via di una continuità, è un’operazione difficile e pericolosa. Come avevo già
osservato in precedenza per la Conquistata del Tasso, si rischia di creare un monstrum,
una creatura informe che fa convivere elementi inconciliabili, i quali, per quanto siano
parte di una stessa tradizione di genere, sono però differenziati da una continua
evoluzione: questa evoluzione, benché attraverso una continuità, li trasforma rendendoli
inconciliabili con il sistema delle opere precedenti da cui derivano. L’Enea virgiliano,
insomma, non potrebbe stare nell’Iliade, così come il raffinato apparato metaletterario
del Furioso non potrebbe stare nei cantari toscani. C’è bisogno, per operare una
derivazione artificiale, di un sistema coerente, e non lo si può trovare che in una singola
opera. Cercare di conciliare in sincronia gli elementi di una diacronia sarebbe
impossibile, almeno a livello di struttura complessiva. Per questo per riportare in vita il
genere epico ci si confronta con quel modello che può rappresentarlo appieno, e in
maniera tendente all’esclusività. Imitandolo da vicino, in modo costante e a tutti i
livelli, si cerca di dedurne quella coerenza di forme e temi che costituisce appunto un
genere. La tradizione non più vitale viene a coincidere con l’opera singola: l’Iliade, in
questa prospettiva, è il poema epico, diviene il repertorio coerente di derivazione.
Il problema centrale dell’imitatio rinascimentale, se si debba imitare un singolo
modello eccellente o una pluralità eclettica di modelli, assume un significato del tutto
particolare ed eminentemente pratico quando ci si confronti con una tradizione di
genere non più vitale: un significato totalmente diverso sia dalla questione della
produzione in lingua latina, che pone un problema innanzitutto linguistico e stilistico,
non di genere, sia dall’ambito della lirica volgare, dove la selezione bembesca del
modello eccellente di Petrarca a scapito degli altri opera entro una tradizione di genere,
naturalmente, vivissima. Trissino, invece, vuole evidentemente compiere un’operazione
del tutto diversa, esplicitamente affine a quella – non meno artificiale – compiuta da
Virgilio un millennio e mezzo prima nel rivitalizzare la tradizione omerica in alternativa
all’epos storico della tradizione latina:
Quel che tol l’acqua con sì largo vaso
dal sacro vecchio [Omero], è il buon Virgilio vostro
(Italia, IX, nella grande “visione” della catabasi di Belisario)
355
D’altra parte, come si sa, proprio rispetto al vivo genere lirico il Trissino propone
appunto un’alternativa alla soluzione del Bembo che consiste, al rovescio di quello che
egli fa per il genere “morto” dell’epica, in un canone di modelli plurale ed eclettico.
La mimesis del modello letterario eccellente serve dunque a codificare l’opera nel
suo complesso per permetterle di significare in assenza di una legame di diretta
continuità. La risemantizzazione di Omero nell’Italia è assolutamente evidente anche a
livello macrostrutturale, come credo di aver ampiamente messo in evidenza. L’aspetto
più clamoroso di questa radicale risemantizzazione è proprio la sua attualizzazione e la
sua contaminazione generica che la vulgata critica gli nega del tutto, e che è invece
evidentissima: la contaminazione macrostrutturale proprio con la tradizione vitale del
romanzo, che per essere acquisita deve necessariamente subordinarsi alla più generale
struttura epica: le due strutture, epica e romanzesca, sono evidentemente alternative, nel
complesso; per conciliarle insieme, ed essere dunque antichi e moderni insieme, non si
può che subordinarne funzionalmente l’una all’altra. Il Trissino non solo si rende
perfettamente conto di questo, ma ha la geniale intuizione di realizzare tale
subordinazione funzionale del romanzo alla complessiva struttura epica nel collegarla
alla dimensione ideologica e alla contrapposizione di valori, così da poter caratterizzare
l’epos come struttura e il romanzo come devianza da tale struttura, al duplice livello
narrativo e valoriale. La povertà poetica dell’opera ha poi portato la vulgata critica a
negare questa clamorosa risemantizzazione dell’imitatio macrostrutturale, per
attribuirne tutti i meriti a Tasso. Il grande poeta sorrentino, al contrario, saprà cogliere
questa geniale intuizione trissiniana relativa alla possibilità di strutturare il genere epico
riportato in vita, trattando appunto il poema del Trissino, a sua volta, come oggetto di
mimesis letteraria.
6. Per un contributo al ripensamento in termini semiotici dell’essenza della
mimesis
La noncuranza avviene ai sommi? o quale,
se più de’ carmi, il computar s’ascolta,
ti appresterebbe il lauro un’altra volta?
G. LEOPARDI, Ad Angelo Mai
La storia della mimesis è la storia parallela di un prassi e della sua teoria: della
prassi artistica della creazione attraverso la duplice modalità della rappresentazione del
356
reale e dell’imitazione dei modelli artistici ma anche, accanto ad essa, della teoria
filosofica che tale prassi intende spiegare e valutare (tra l’altro in costante interferenza
con la categoria della mimesis nel più generale senso filosofico-ontologico e, più di
recente, anche nell’accezione antropologica e psicologica, pur già anticipata da
Aristotele nel riconoscimento della mimesis come fondamento della mathesis umana in
Poetica, 1448b, 5-8). Paradossalmente, quando si riflette criticamente sul concetto di
mimesis si tende a limitarsi a trattarlo nel suo versante teorico dimenticando del tutto la
prassi artistica: fenomeno ben strano se appena si riflette sul fatto che tale categoria
permea la storia delle arti prima ancora che la storia dell’estetica, che riflette
sull’argomento solo in conseguenza di quella prassi. Si dirà che però il concetto di
mimesis è un’elaborazione della riflessione filosofica e non della prassi artistica: questo
è senz’altro vero, ma è anche vero che tale riflessione nasce dalla considerazione di un
prassi artistica pregressa e consapevole, anche se non teorizzata: la musica, le arti
figurative, Omero, i tragici ecc. La mimesis è una prassi dell’arte prima (dal duplice
punto di vista storico e logico) di essere una categoria estetica: all’arte essa pertiene
molto più che alla teoria e alla riflessione filosofica.
Eppure quando si discute della mimesis si tende a parlare solo della riflessione
teorica a riguardo, naturalmente dal punto di vista storiografico della innumerevole,
proliferante, incontrollabile pluralità di interpretazioni cui ha dato luogo nella sua
diacronia: la prassi artistica non ne appare che come la ovvia e diretta conseguenza. La
tesi fondamentale del più recente e più approfondito contributo sull’argomento, il
mirabile saggio di Halliwell387, è appunto, per esplicita ammissione, che non esiste un
concetto unico di mimesis, ma piuttosto una pluralità irriducibile di concezioni storiche
diversificate e oscillanti fra i due poli dell’idea di copia fedele e dell’idea di simulazione
o creazione, ossia fra il concetto vulgato di “imitazione” e quello apparentemente più
profondo di “rappresentazione”. Se da una parte questa è in fondo poco più che
un’ovvietà, dall’altra però io credo che ridurre un concetto alla sua diacronia storica
significa sempre falsificarlo nella sua essenza.
Cosa ci interessa, infatti, di un concetto o un’idea? Forse la sua storia, il suo
passato, ciò che di esso non è più, la sua archeologia? Niente affatto: ci interessa al
contrario ciò che di essa vive, ciò che è presente e ci riguarda; nient’altro che questo. La
ricostruzione storica è sempre strumentale alla pertinenza che una questione ha con noi:
quando perde di vista questo obiettivo diventa archivismo, entomologia, insignificanza.
387
HALLIWELL, S., L’estetica della mimesis, cit.
357
Ciò che veramente di un concetto ci interessa è dunque non la sua diacronia, ma la sua
essenza, la sua validità: la ricostruzione della diacronia non è fine a se stessa, ma serve
appunto a penetrare l’essenza. Ha poco senso, allora, perdersi ad esempio nella
ricostruzione delle innumerevoli posizioni specifiche del dibattito rinascimentale
sull’imitatio senza poi trarne delle conclusioni sulla sostanza della questione, e
soprattutto senza gettare neppure uno sguardo all’effettiva produzione artistica.
“Particolareggiare”, perdersi nella differenza e nella specificità, come sappiamo sin dai
tempi di Parmenide, è il modo migliore per non capire.
Riconsiderando criticamente la storia della teoria sulla mimesis nel suo
complesso, allora, una considerazione si impone. Essa parte all’insegna della
svalutazione. Platone, desumendo il concetto di mimesis da precedenti forme di teoria
dell’arte (in particolare dai pitagorici e da Damone), lo reinterpreta radicalmente
facendone il perno di tutto il suo sistema filosofico, ontologico e gnoseologico: la teoria
delle Idee. Lì il concetto di mimesis diventa funzionale e subordinato ai concetti di
conoscenza e di verità: il rapporto di modello e “copia” diventa il fondamento della
teoria del reale, e il percorso che lo ripercorre a ritroso diventa la modalità stessa della
conoscenza. Una categoria desunta dalla riflessione sulla prassi artistica si trasforma
così in una categoria filosofica che con l’arte e la poiesis non ha più alcuna relazione,
ma è subordinata alla ricerca conoscitiva. Ne consegue che, con il ribaltamento della
prospettiva e della funzione, da poetica a veritativa, l’originaria finalità artistica non può
che essere svalutata e condannata proprio perché non risponde alla nuova funzione
conoscitiva richiesta alla mimesis: PÒrrw ¥ra pou toà ¢lhqoàj ¹ mimhtik» ™stin
ka…, æj œoiken, di¦ toàto p£nta ¢perg£zetai, Óti smikrÒn ti ˜k£stou ™f£ptetai,
kaˆ toàto e‡dwlon (Repubblica, 598b, 6-8) 388 . Un procedimento logico che sa di
paralogismo: la rappresentazione artistica è il modello su cui plasmare una teoria della
verità; ciò fatto, ci si rende conto che l’arte non è però un’adeguata teoria della verità;
ergo, l’arte va condannata. Qualcosa di simile avviene nell’esilarante scena finale del IV
atto della Bisbetica domata, quando Petruccio prima costringe Caterina a dire che il sole
è la luna, e poi la rimprovera perché il sole è il sole e non è mica la luna (la gag si ripete
immediatamente
momentaneamente
dopo,
una
ancor
più
“giovane
esilarante,
vergine
in
con
un
vecchio
bocciolo”).
Fuor
che
diventa
di
scherzo,
l’appropriazione filosofica della teoria della mimesis da parte di Platone costituisce
l’atto fondativo di un aggressivo tentativo di subordinazione del fenomeno artistico al
388
Trad.: « La tecnica dell’imitazione è dunque in certo modo lontana dal vero, e, a quanto sembra, riesce
a produrre tutte le cose per questo: coglie una piccola parte di ognuna, e si tratta di un simulacro ».
358
pensiero filosofico che da allora ha percorso l’intera storia della cultura occidentale, e
dura ancora oggi più che mai nelle teorie veritative dell’arte e nell’idea del valore
conoscitivo della poesia, di cui lo scritto heideggeriano L’origine dell’opera d’arte è
solo l’esito più celebre e più raffinato389.
Se riconosciamo dunque che la millenaria riflessione teorica sulla mimesis –
persino quando a intervenire a riguardo siano gli artisti stessi (il Rinascimento italiano è
palesemente l’esito più vistoso di questa costante possibilità) – non spiega
necessariamente l’essenza della questione, ma anzi è in gran parte la storia del suo
fraintendimento e del tentativo – magari inconsapevolmente – aggressivo di spiegarla,
cioè assoggettarla alla sistemazione filosofica del sapere e del reale, allora appare chiaro
che l’essenza della mimesis in quanto principio pertinente alla prassi artistica e non alla
storia del pensiero può benissimo essere in contrasto, persino stridente, con la
teorizzazione estetica che storicamente ha inteso darne conto. D’altra parte, filosofia e
arte muovono da due prospettive sull’esistenza radicalmente opposte e inconciliabili,
nonostante la loro continua interferenza: la prima presuppone – persino quando arriva a
negarla – la preventiva sensatezza dell’esistenza; la seconda origina all’opposto da una
lacerante intuizione – prima ancora che comprensione – del radicale non senso
dell’esistenza sancito dalla limitatezza e dalla mortalità390, a cui la risposta è dunque
costitutivamente emozionale (persino quando pretende di non esserlo): di qui nasce
anche, io credo, il carattere di irriducibile formazione di compromesso fra ideologia,
dunque razionalizzazione, e istanza emozionale evidenziata da Francesco Orlando e
ribadita da Guido Paduano, che rende il linguaggio artistico strutturalmente affine alla
“bi-logicità” matteblanchiana dell’inconscio o, se si vuole, alla condizione esistenziale
dell’essere-nel-mondo. La poesia si mostra spesso perfettamente autocosciente di ciò, da
389
HEIDEGGER, M., L’origine dell’opera d’arte, cit., pp. 5-89. Nota la conclusione per cui « l’arte è un
divenire o accadere della verità» (p. 71); evidente la riaffermazione, seppure totalmente ripensata, della
subordinazione dell’arte alla dimensione veritativa e conoscitiva nel seguente passo: « Questo sapere, che
in quanto volere diventa di casa nella verità dell’opera e solo così resta un sapere, non strappa l’opera dal
suo stare-entro-sé, non la trascina nella cerchia del mero vissuto, e non sottomette l’opera al ruolo di
suscitatrice di esperienze emozionali. Il verecondimento dell’opera non isola l’uomo nelle sue esperienze
vissute, bensì lo irradica nell’appartenenza alla verità storicizzantesi nell’opera, e fonda così, in base alla
retratta relazione con l’inascosità, l’esser-l’uno-per-l’altro e l’esser-l’uno-assieme-all’altro come l’estare
storico dell’Esser-ci » (p. 67). Penetrata la consuetà oscurità del linguaggio heideggeriano (che pure
origina da un’esigenza autentica fino a diventare centrale nel pensiero dell’autore, e che non ha nulla a
che fare con la gergalità saccente e accademica di un Adorno), cosa dice questo passo? Esso nega la
concezione dell’arte come vita e come esperienza, in particolare come esperienza emozionale, per
ricondurla invece a una modalità del sapere come forma storica dell’esistenza, dell’essere dell’uomo nel
mondo.
390
Sulla mortalità come negazione radicale della possibilità di senso dell’esitenza, cfr. la critica di
SARTRE al concetto heideggeriano di essere-per-la-morte (Sein zum Tode) in L’essere e il nulla, Milano, Il
Saggiatore, 2008 (1943), Parte quarta, I. 2, Libertà e fatticità: la situazione, sez. E) La mia morte, pp. 605
sgg.
359
Omero a Leopardi e oltre; piace ricordare la splendida formulazione di Anacreonte (fr.
36 Gentili):
polioˆ mὲn ¹mˆn ½dh
krÒtafoι k£rh te leukÒn,
car…essa d' oÙkšt' ¼bh
p£ra, ghralšoi d' ÑdÒntej,
glukεroà d' oÙkšti pollÕj
biÒtou crÒnoj lšleiptai·
Ormai ho grige le tempie,
canuta la testa: è andata
la giovinezza amabile!
I denti sono smangiati,
più molto tempo non resta
alla dolce vita.
di¦ taàt' ¢nastalÚzw
qam¦ T£rtaron dedoikèj·
'A…dεw g£r ™sti deinÕj
mucÒj, ¢rgalÁ d' ™j aÙtÕn
k£todoj· kaˆ g¦r ˜to‹mon
katab£nti m¾ ¢nabÁnai.
Per questo gemo e molto
Mi spaventa il Tartaro!
Tremendo è l’abisso di Ades,
dura la discesa laggiù:
e per chi vi è disceso
è impossibile rimontare.391
La concezione della mimesis è stata a mio parere vittima di questo costitutivo
conflitto inconciliabile tra filosofia e arte, iniziato sin da Platone e solo parzialmente
ricomposto da Aristotele nella sua sostanziale affermazione di autonomia dell’arte nella
Poetica. La filosofia persegue la conoscenza strumentalmente al tentativo di dare senso
all’esistenza, producendo dunque delle “grandi narrazioni” – per usare la terminologia
di Lyotard – che mirano alla meta asintotica della verità; il pensiero razionalizzante ha
dunque valore esclusivamente quando produce un qualche avanzamento verso la verità,
quando produce “pensiero più pensato”: in altre parole, il pensiero ha valore unicamente
in funzione al suo apporto di novità. Dire il già detto equivale a non dire nulla.
Nell’arte le cose stanno in maniera radicalmente diversa. Essa produce delle opere
in un processo che non è noesis ma poiesis, non pensiero razionale ma creazione,
produzione concreta di un oggetto (l’opera). Solo in questo senso si spiega l’originalità
dell’opera d’arte come individualità irripetibile, che non è in alcun modo inficiata dalla
riproducibilità tecnica di Benjamin (secondo una prospettiva, d’altronde, largamente
smentita dall’arte novecentesca e in particolar modo dal cinema): così, il Don Giovanni
di Mozart è esattamente altrettanto originale rispetto alle Nozze di Figaro quanto
rispetto ad entrambe quei capolavori lo sono la musica di Stravinkij o Schönberg. Ma la
filosofia, nel suo eterno tentativo di razionalizzazione e “addomesticamento” della
concezione esistenziale radicalmente altra dell’arte, riuscì a imporsi con la nascita
dell’estetica scientifica moderna, non a caso sorta in una delle fasi di massimo
razionalismo della storia occidentale con l’Illuminismo, la filosofia kantiana, la
391
Trad. da Lirica monodica. Saffo, Alceo, Anacreonte, Ibico, a cura di di GUIDORIZZI, G., in Lirici greci,
Milano, mondadori, I Classici Collezione, 2007.
360
sistematizzazione enciclopedica e totalizzante dell’Idealismo tedesco. Essa sottopose a
una nuova critica razionalistica il principio della mimesis, assimilando l’alterità dell’arte
alle proprie strutture logiche: il ri-fare il già fatto (o il già esistente) in cui risiede
l’essenza processuale e poietica della mimesis fu così assimilato alla critica in cui
incorre il ri-dire il già detto in filosofia. All’arte si cominciò a richiedere allora un
genere di novità affine a quello che si richiede al pensiero, proprio per renderla in tal
modo omogenea al pensiero e dunque ad esso ricondotta e assoggettata: non più solo la
novità dell’opera rispetto all’opera – quella costitutivamente garantita dalla mimesis,
coma abbiamo visto, anche nel caso di rapporti modellizzanti “forti” –, ma la novità
dell’opera rispetto alla tradizione nel suo complesso. Novità che deve trovare
realizzazione al duplice livello formale del linguaggio e contenutistico dell’attualità
storica e dell’adeguatezza ai tempi. L’idea razionalista del progresso veniva così
proiettata anche sull’arte, conquistando anche l’ambito delle res humanae
costitutivamente idiosincratico a tale concezione. Esito ultimo di tale tendenza è la
teoria dell’estetica avanguadistica di Adorno: « solo ciò che di volta in volta è più
progredito ha la chance di combattere la rovina del tempo »392; nella sua riflessione il
concetto storicizzante dell’originalità raggiunge l’esito estremo, fino ad aggredire il suo
stesso presupposto romantico dell’individualità del genio e trasformarsi in
un’intransigenza assoluta verso qualsiasi altra istanza che non sia quella storicistica:
L’originalità non obbedisce più a ciò a cui la si è associata da quando vi si è riflettuto sopra, al
cosiddetto stile individuale. Mentre nel frattempo la decadenza di quest’ultimo viene lamentata dai
tradizionalisti, che a loro volta difendono in esso beni diventati convenzionali, in opere progredite lo stile
individuale, quasi strappato con l’inganno alle violenze costruttive, assume un’aria di pezza, di
deficienza, almeno di compromesso. Non da ultimo è per questo che la produzione avanzata mira meno
all’originalità della singola creazione che alla produzione di nuovi tipi. L’originalità comincia a
trasformarsi nell’invenzione di questi ultimi. Essa muta qualitativamente in se stessa, senza però per
questo scomparire393.
All’epoca dell’originario attacco all’estetica della mimesis, invece, la reazione del
genio di Leopardi, uno dei pochi spiriti europei ad essere in grado di cogliere l’essenza
profonda della contraddizione, rimase sostanzialmente una campana fuori dal coro: «
Tutto si è perfezionato da Omero in qua, fuori che la poesia ». E ancora (sempre dallo
Zibaldone):
Gridano che la poesia debba esserci contemporanea, cioè adoperare il linguaggio e le idee e
dipingere i costumi, e fors’anche gli accidenti de’ nostri tempi. Onde condannano l’uso delle antiche
392
393
ADORNO, T. W., Teoria estetica, cit., p. 56.
Ibid., p. 231.
361
finzioni, opinioni, costumi, avvenimenti. Puoi vedere la p. 3152. Ma io dico che tutt’altro potrà esser
contemporaneo a questo secolo fuorchè la poesia. Come può il poeta adoperare il linguaggio e seguir le
idee e mostrare i costumi d’una generazione d’uomini per cui la gloria è un fantasma, la libertà la patria
l’amor patrio non esistono, l’amor vero è una fanciullaggine, e insomma le illusioni son tutte svanite, le
passioni, non solo grandi e nobili e belle, ma tutte le passioni estinte? Come può, dico, ciò fare, ed esser
poeta? Un poeta, una poesia, senza illusioni senza passioni, sono termini che reggano in logica? Un poeta
in quanto poeta può egli essere egoista e metafisico? e il nostro secolo non è tale caratteristicamente?
come dunque può il poeta essere caratteristicamente contemporaneo in quanto poeta?
[…]
Perdóno dunque se il poeta moderno segue le cose antiche, se adopra il linguaggio e lo stile e la
maniera antica, se usa eziandio le antiche favole ec., se mostra di accostarsi alle antiche opinioni, se
preferisce gli antichi costumi, usi, avvenimenti, se imprime alla sua poesia un carattere d’altro secolo, se
cerca in somma o di essere, quanto allo spirito e all’indole, o di parere antico. Perdóno se il poeta, se la
poesia moderna non si mostrano, non sono contemporanei a questo secolo, poichè esser contemporaneo a
questo secolo, è, o inchiude essenzialmente, non esser poeta, non esser poesia. Ed ei non si può essere
insieme e non essere. (11. Luglio. 1823.). E non è conveniente a filosofi e ad un secolo filosofo il
richieder cosa impossibile di natura sua, e contraddittoria in se stessa e ne’ suoi propri termini. (12.
Luglio 1823.).
L’imitazione della poesia antica, qui esplicitamente contrapposta ai dettami della
filosofia imperante, è colta in tutta la sua essenza di fenomeno metastorico e, per
reazione al razionalismo, persino antistorico: considerazioni di una meravigliosa
inattualità negli anni di gestazione dell’hegelismo, un’inattualità di cui solo Nietzsche
saprà recepire la grande lezione (nella seconda Inattuale egli muove esplicitamente da
Leopardi). La critica leopardiana è stata infatti sostanzialmente ignorata, allora come in
seguito, dalla riflessione sull’arte, e relegata in secondo piano persino entro il “pensiero
leopardiano” che – all’origine del nichilismo europeo – è stato però offuscato e ridotto a
pagina antologica con la complicità della grandezza dei Canti: lo storicismo, d’altronde,
sa storicizzare qualunque cosa, persino la sua stessa negazione.
Ma dunque? Ammettendo che la storia della teoria mimetica non spieghi
necessariamente il senso della mimesis nell’arte e anzi riveli, sin dalle origini, una certa
tendenza latente a negarlo ed occultarlo – tendenza che la posizione filo-artistica e antiveritativa di Aristotele non basterà a scongiurare –, come si può ripensare l’essenza e il
fondamento della mimesis in maniera più adeguata alla sua prassi anziché alla sua
teoria? Come risalire all’essenza di un fenomeno che la rilfessione filosofica ha finito
per negare e distruggere, anziché spiegarlo nella sua straordinaria, millenaria
produttività?
Le considerazioni proposte in queste pagine ci portano in una direzione, credo,
piuttosto chiara. Come ci insegna Heidegger, la questione dell’essenza è
inscindibilmente legata con quella dell’origine, e allo stesso tempo definita e persino
istituita dal linguaggio che non solo la veicola, ma la pone in essere. La ricostruzione
etimologica del concetto di mimesis e la riconsiderazione, alla luce di quella, delle più
362
antiche attestazioni poetiche e filosofiche della sua famiglia lessicale ci hanno permesso
di affermare che l’essenza della mimesis non risiede affatto nel rapporto di somiglianza
e fedeltà ad un modello, ma al contrario – sin dall’origine – nel sua carattere
processuale, poietico e antirealistico: la mimesis non riproduce e duplica il modello, ma
produce qualcosa di nuovo servendosi strumentalmente del modello. Ciò che essa
produce di nuovo, tanto da rendere ogni opera mimetica radicalmente originale nella sua
individualità, è in sostanza – siamo arrivati ad affermare – il fenomeno della
significazione, del senso.
Ma in cosa consiste questo senso nuovo che si crea nella mimesis? E in che modo
il rapporto con il modello si rende necessario alla sua produzione?
Prima di giugere alla concusione, è necessario un ultimo chiarimento. Il fenomeno
del senso nella sua generalità è stato postulato e studiato dallo strutturalismo e dalla
semiotica. La semiotica, in fondo, si pone appunto come una teoria generale del senso e
della significazione. Tuttavia su di essa grava ancora, a parte una certa deprecabile
tendenza al tecnicismo filo-scientifico di influenza angloamericana, un macroscopico
vizio di fondo, che ostacola il suo carattere generale come pure l’adeguato
riconoscimento, complementare, dei suoi stessi limiti: mi riferisco a quel suo carattere
che si definisce riduttivamente “glottocentrismo”, e che invece è molto più di questo.
L’originario rapporto privilegiato della semiotica con la linguistica (saussuriana), che
ancora oggi sbilancia la sua teoria della significazione nella direzione della teoria del
linguaggio da cui proviene, tradisce un vizio ben più grande di questo rapporto
privilegiato: esso non è altro che la più recente espressione del logocentrismo di matrice
greca della cultura occidentale, nel senso duplice e inscindibile di fiducia pregiudiziale
nel principio logico-razionale per la comprensione della realtà e di fiducia nel
linguaggio logico-verbale come mezzo adeguato ad esprimerlo. Il suo esito semiotico
consiste nella radicata tendenza a limitare e così fraintendere il fenomeno del senso alla
forma particolare del senso logico-razionale mediato istituzionalmente dal linguaggio
verbale (il logos, appunto). Ma come abbiamo detto l’arte si sottrae costitutivamente,
nella sua essenza, a questo principio. Essa non solo si è sempre mostrata radicalmente
irriducibile a qualsiasi tentativo di spiegazione logica della sua essenza, ma addirittura,
come abbiamo detto, origina costitutivamente proprio dalla negazione della validità del
principio logico-razionale: l’inconsistenza della verità che la filosofia ammette solo con
Nietzsche (e che è ancora oggi quanto mai inattuale nello spadroneggiare del
razionalismo scientifico), l’arte la afferma da sempre – in via per forza di cose non
363
logica – nell’essenza della sua stessa prassi. L’arte è una critica nella prassi al principio
del logos. Se dunque vogliamo interrogare l’essenza della mimesis, tradizionale
fondamento della prassi artistica (ossia della poiesis), non possiamo che farlo
riconoscendo preventivamente che il fenomeno del senso studiato dalla semiotica
travalica senz’altro il senso logico-razionale come un suo caso particolare. Alcuni
principi desunti dalla formazione di compromesso freudiana e dalla bi-logica
matteblanchiana credo che, nella loro recente applicazione al fenomeno letterario,
costituiscano proprio per questo una delle più preziose acquisizioni alla riflessione non
solo sulla letteratura ma sull’arte: esse danno conto, senza per questo razionalizzarlo,
appunto del senso non logico costitutivo del fenomeno artistico, tradizionalmente
relegato nel limbo negativo dell’irrazionale, del nescio quid, della spiritualità fumosa e
succube del razionalismo nel credere di fuggirlo gridando la sua alterità.
A questo punto possiamo davvero tirare le conclusioni ultime di questo lungo
ragionamento. Nel proporre una soluzione semiotica del concetto antico di mimesis non
dobbiamo temere l’anacronismo: l’essenza di un concetto può essere irriducibile, come
abbiamo visto, alla sua teoresi storica, e dunque ricorrere a categorie moderne per
spiegarla non è né improprio né antifilologico; l’atteggiamento rigorosamente
filologico, nel ridurre una questione alla sua storicità anziché al suo merito, ossia alla
sua essenza, rischia di risultare eminentemente antifilologico proprio nel tradire
l’essenza di ciò che ricostruisce con acribia.
L’essenza della mimesis dunque è una questione semiotica: l’espressione artistica,
in quanto fenomeno di significazione, necessita di un fondamento pregresso alla sua
possibilità di significare. In questa prospettiva, la funzione del modello (reale o artistico
che sia) è precisamente ed esclusivamente quella di garantire tale fondamento della
significazione.
Il senso che in tale genere di significazione è veicolato, o per dirla in termini
jakobsoniani il messaggio, è idiosincratico a qualsiasi riduzione logico-verbale poiché è
radicalmente altro dalla forma logico-verbale del senso, quella che ha a che fare con il
pensiero razionale e il linguaggio verbale. Si tratta di una dimensione prettamente
estetica del senso che si realizza nella poiesis attraverso la mimesis: una dimensione la
cui autonomia è stata costantemente negata – tanto nella concezione razionalistica
quanto in quella irrazionalistica dell’arte – sulla base del millenario pregiudizio per cui
il senso coincide con la dimensione logico-verbale (il pregiudizio per cui quando
affermiamo che qualcosa “non ha senso” intendiamo senz’altro che non ha senso logico;
364
il pregiudizio per cui non è ben chiaro che cosa intenda io ora parlando di “senso non
logico”, dal momento che tale dimensione non è stata fatta oggetto di analisi adeguate e
dunque non è chiara nella sua individuazione). D’altronde, se all’arte si è continuamente
richiesto di essere razionalmente comprensibile, nessuno chiederebbe mai alla
razionalità di essere artistica: questa asimmetria denuncia, nella forma del paradosso, il
pregiudizio latente. È pur vero che talvolta – essenzialmente in letteratura – tale
dimensione estetica del senso nell’arte si serve strumentalmente del senso logicoverbale, tornando a cooptarlo all’interno del suo messaggio: ma lo riassorbe appunto
come elemento funzionale alla creazione di strategie di senso totalmente estranee, nella
loro essenza, alla dimensione logico-verbale. Il che poi non vuol dire che tale
dimensione subordinata e strumentale non conservi una sua parziale autonomia di
significato, che equivale al contenuto ideologico del messaggio artistico e in particolar
modo letterario (dimensione di cui la musica è invece costitutivamente priva, ragion per
cui è stata spesso considerata – ad esempio da Hegel – la più “pura” delle arti). Ma il
senso di una qualsiasi forma di messaggio si definisce unicamente in base alla sua
finalità e intenzionalità complessiva, cui sono volte tutte le strutture di senso parziali e
subordinate394.
Se allora intendiamo la mimesis come la modalità propria della creazione di senso
estetico (o se vogliamo contenuto o messaggio estetico), allora si ricompone in perfetta
unità anche la tradizionale distinzione tra imitazione della natura e imitazione dell’arte,
considerabili entrambe come due aspetti di uno stesso fenomeno di fondo. Un qualsiasi
processo semiotico, per poter significare (dunque essere dotato di senso), ha bisogno di
un duplice livello di fondamento preventivo: 1) un
CODICE
di riferimento che dia senso
all’espressione (una langue che renda sensata la parole) e 2) una REFERENZIALITÀ, ossia
il fatto che la semiosi implichi dei referenti che la rendano sensata. Ma se il primo tipo
di fondamento è universalmente noto e accettato, il secondo è molto più controverso
poiché sembra avere delle irrisolvibili implicazioni ontologiche, e necessita di un
chiarimento. A mio avviso, infatti, la semiosi implica necessariamente la referenzialità.
Per referente, tuttavia, non intendo un ente reale della cui esistenza la semiosi abbia
bisogno per significare: intendo invece la presupposizione di esistenza di un tale ente,
394
Come ho già ricordato, in ambito semantico e semiotico c’è ancora molta imprecisione, non solo
terminologica, nell’uso delle categorie di significato e senso, risalente almeno al celebre scritto di FREGE
Über Sinn und Bedeutung, «Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik», 100 (trad. it. in
Logica e aritmetica, Torino, Boringhieri, 1965). Per il concetto di senso di un segno, come qualcosa di
nettamente distinto dal suo significato, mi rifaccio qui soprattutto alla concezione di Prieto: «L’influence
que l’émetteur essaie d’exercer sur le récepteur en produisant un signal [= un segno] n’est autre chose que
ce qu’on appelle le sens de se signal» (PRIETO, Pertinence et pratique. Essai de semiologie, p. 24).
365
magari azzardata o persino consapevolmente inattendibile (che naturalmente è cosa del
tutto distinta dal significato)395. Il noto principio semiotico della fallacia referenziale,
per cui ogni semiotica si definisce costitutivamente sulla base della sua falsificabilità,
del suo possibile uso per mentire, oltre ad esemplificare il pregiudizio logocentrico per
cui il senso sarebbe sempre un fatto logico, chiarisce anche che una semiotica, per
definizione, non hai mai implicazioni ontologiche. Tuttavia proprio il fatto che essa
risulti utile per mentire, e non indifferente a tale possibilità, tradisce un’asimmetria di
fondo: per convenzione, ogni semiotica presuppone la verità referenziale dei propri
segni come norma, e la fallacia referenziale (la referenzialità vuota, in cui al segno non
corrisponde alcun ente reale) come eccezione a tale norma 396 . Ciò vuol dire che la
totalità dei segni è gravata di un’ipotesi referenziale, dell’azzardata supposizione di
esistenza di un ente reale che corrisponda al significato veicolato dal segno: la sua
negazione per una minoranza dei segni così prodotti, riconosciuti di fatto come non
esistenti, è poi sempre un passaggio logico successivo e sempre contingente,
determinato caso per caso come smentita circostanziata di un’affermazione generale.
Fatto questo chiarimento, possiamo allora intendere come, nella significazione
messa in atto dalla mimesis, l’imitazione dell’arte altro non è che il
imprescindibile (la tradizione) sullo sfondo del quale ogni singola
CODICE
ESPRESSIONE
(ogni
opera) acquista significato, mentre l’imitazione della natura – che come abbiamo visto
395
Il problema della referenza, com’è noto, è uno dei più discussi della semiotica, poiché (proprio come la
mimesis) viene a coinvolgere la questione della realtà, interferendo dunque con una serie di problemi di
pertinenza ontologica. Banalizzante mi pare tuttavia l’opinione vulgata che il referente sia l’oggetto reale
cui il segno rimanda: è evidente che la semiotica non può avere alcuna implicazione ontologica, meno che
mai nell’affermare l’esistenza di una “cosa in sé” che si sottrae alla conoscenza in generale. Ciò non vuol
dire tuttavia che la questione della pertinenza reale della semiosi esuli dall’ambito della semiotica (così in
sostanza anche ECO, U., Trattato di semiotica generale, cit., pp. 88 sgg.): una qualsiasi forma di
linguaggio (una semiotica) avanza sempre l’ipotesi implicita che il complesso dei segni di cui è costituita
corrisponda a enti reali (ma non necessariamente materiali). Così la matematica postula l’esistenza reale
dei numeri, il linguaggio naturale la postula delle cose ecc.: senza tale implicazione, le semiotiche
sarebbero dei puri formalismi, tra l’altro anche irrealizzabili perché la loro strutturazione non sarebbe
possibile prescindendo dal preventivo incontro con un dato esperienziale che la fondi (l’incontro con le
cose nel mondo, la numerabilità delle cose stesse ecc.). L’inesistenza di alcuni di oggetti specifici è poi
sempre un dato successivo, che si comprende solo postulando preventivamente l’essere della totalità di
quelli: è la negazione circostanziata di un’affermazione generale: l’oggetto dei segni “sirena” e “liocorno”
si qualifica come inesistente soltanto sullo sfondo della complessiva referenzialità del linguaggio; e
d’altronde persino la loro inesistenza è in effetti parziale e secondaria, dal momento che non è possibile
parlare del non essere come composto di una pluralità di oggetti distinti (ossia enti!), poiché ciò che non è
non può neppure avere parti: farlo significa implicitamente affermarne l’esistenza per poi negarla
culturalmente subito dopo. Il referente, allora, altro non è che questa presupposizione azzardata di
esistenza implicita nell’atto stesso di nominare: per questo sostengo che il referente non è l’oggetto reale,
ma solo l’idea dell’esistenza di un tale oggetto. In questa prospettiva, allora, il significato è il contenuto
concettuale veicolato dalla semiosi, il referente è invece l’idea di un ente reale o uno stato del mond
Scaricare