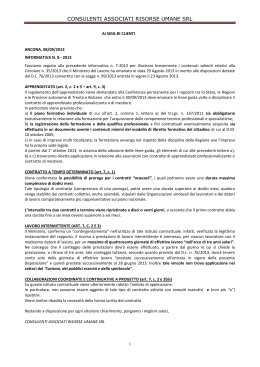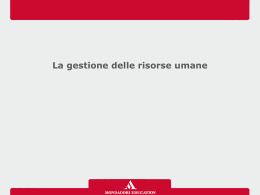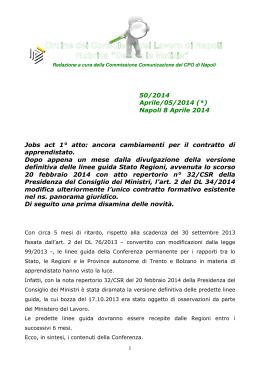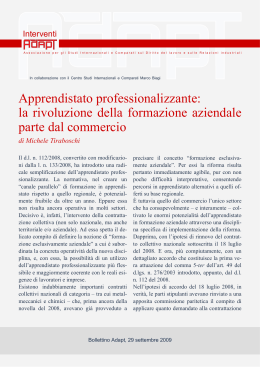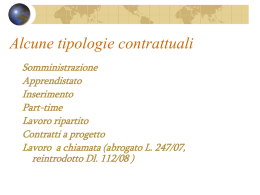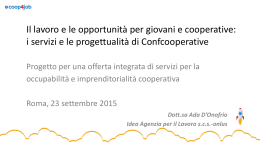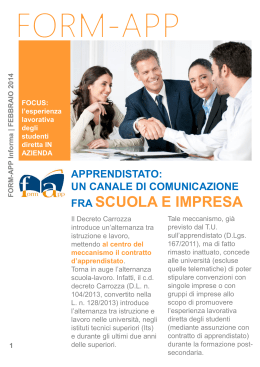CAPITOLO SETTIMO LA NUOVA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO ART. 1, 16°-19° COMMA, ART. 2, 31°-32° COMMA, L. 28 GIUGNO 2012, N. 92 E ART. 2, 2°-3° COMMA, ART. 9, 3° COMMA, D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76 di Lisa Rustico Sommario: 1. Introduzione. – 2. Modifiche del d.l. 76/2013. – 3. Durata minima. – 4. Durata massima (apprendistato professionalizzante). – 5. Periodo di preavviso. – 6. Limiti numerici per gli apprendisti. – 7. Apprendistato in somministrazione. – 8. Percentuale di conferma. – 9. Assicurazione Sociale per l’Impiego. – 10. Contributo per il licenziamento. 1. Introduzione. L’art. 1, l. 92/2012, ai 16° comma ss., introduce puntuali modifiche al d.lg. 14 settembre 2011, n. 167, recante il «Testo unico dell’apprendistato» (Testo Unico), fonte che oggi detta la disciplina organica dell’istituto 1. Un anno dopo, il d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (c.d. pacchetto lavoro) 2 modifica nuovamente il Testo Unico, nell’ambito degli interventi straordinari per favorire l’occupazione giovanile. Il ripetuto intervento del legislatore 1 Cfr. M. Tiraboschi, (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini. Commentario al d.lgs. 14/9/2011, n. 167, e all’art. 11 del d.l. 13/8/2011, n. 138, convertito con modifiche nella l. 14/9/2011, n. 148, Milano, 2011. 2 «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» d.l. 28 giugno 2013, n. 76, approvato, con modifiche, dal Senato il 31 luglio 2013, e convertito in l. 9 agosto 2013, n. 99 (GU n. 196 del 22 agosto 2013). 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 141 17/10/13 6:06 PM 142 II. Il riordino delle tipologie contrattuali sull’apprendistato, a ridosso della riforma del 2011, può essere letto come risposta alla volontà di ampliare le possibilità di applicazione dell’istituto, favorendone un maggiore utilizzo, alla stregua del «contratto prevalente» 3 per i giovani o della «modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro» 4 . Le modifiche del 2013 riguardano soprattutto l’introduzione di passaggi ulteriori per la regolamentazione di alcuni aspetti del contratto, con esclusivo riferimento all’apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere). Il d.l. 76/2013 adotta disposizioni – «derogatorie» del Testo Unico – volte a rendere più certo e omogeneo sul territorio nazionale il quadro di regole per la formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Inoltre, il d.l. 76/2013 chiarisce un aspetto riguardante la successione di contratti in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale a contratti di apprendistato professionalizzante. Sul piano della tecnica normativa, le modifiche, benché veicolate da un decreto legge, rinviano alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, impegnandola nella approvazione di «Linee guida» per la formazione di base e trasversale dei contratti di mestiere, entro il 30 settembre 2013. La l. 92/2012, invece, apportava cambiamenti, in parte immediatamente operativi, alla sostanziale disciplina del contratto di apprendistato, con l’obiettivo di prevenirne l’utilizzo distorto, quale soluzione – scarsamente o per nulla formativa – volta a ridurre il costo del lavoro 5. Al fine di rendere il contratto di apprendistato più fruibile, parallelamente alla modifica di alcune norme di dettaglio (ad esempio, l’allargamento dei limiti del numero di apprendisti impiegabili in ogni azienda), la sostanziale spinta all’apprendistato è giunta indirettamente, per via della restrizione all’utilizzo di strumenti alternativi all’apprendistato, e in una certa misura «concorrenti» rispetto ad esso (i tirocini, i contratti a progetto, le partite Iva, la somministrazione di lavoro), e rendendo alcuni contratti più costosi (in particolare, il contratto a termine e la somministrazione di lavoro). 3 Lo affermava lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel Comunicato Stampa del 27 giugno 2012, pubblicato a seguito dell’approvazione della l. 92/2012. 4 Art. 2, 2° comma, d.l. 76/2013. 5 Per un commento sul quadro complessivo dell’intervento della l. 92/2012 sul Testo Unico dell’Apprendistato, e le relative finalità, cfr. A. Tagliente, Le modifiche all’apprendistato nella legge di riforma del mercato del lavoro, in Bollettino Adapt, 10 settembre 2012, n. 31. Si veda anche P. Salazar, Apprendistato. Formazione e accesso al mondo del lavoro, in Dir. e prat. lav., 2012, n. 40. 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 142 17/10/13 6:06 PM La nuova disciplina dell’apprendistato 143 Le novità della l. 92/2012 riguardano sia modifiche, sia integrazioni, di aspetti sostanziali e procedurali della regolamentazione del contratto di apprendistato; inoltre, mentre alcuni interventi riguardano tutte le tipologie di apprendistato, altri si applicano solo al professionalizzante. Tra le novità si possono ricordare: la reintroduzione di una durata minima per tutti i contratti di apprendistato, l’apposizione di vincoli all’assunzione di nuovi apprendisti, la modifica del limite numerico di apprendisti occupabili in ciascuna azienda, l’ampliamento della tutela previdenziale degli apprendisti, una puntualizzazione sulla disciplina applicabile durante il periodo di preavviso. La tecnica normativa della l. 92/2012 appare diversa da quella adottata nel Testo Unico. Il legislatore del 2011, infatti, rinviava la disciplina di dettaglio «ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» 6 , nel rispetto dei limiti («principi») dettati dall’art. 2, d.lg. 167/2011, che si traducevano in obblighi [lett. b) e l)] e in divieti [lett. a), d) e g)]. La riforma del 2012, invece, affida alla legge il compito di dettare disposizioni puntuali, anche nel merito della disciplina di dettaglio del contratto 7. Tale scelta potrebbe intendersi alla luce della volontà di garantire l’uniformità della regolamentazione dell’istituto; garanzia che, a ben vedere, già il Testo Unico salvaguardava, nella misura in cui rinviava alla contrattazione collettiva – solo di livello nazionale – e ad accordi interconfederali 8 . In ogni caso, a seguito della approvazione della riforma Fornero, è possibile che sorgano dubbi in merito alla chiarezza del rapporto tra legge e contratto, ossia come armonizzare le disposizioni dei contratti intervenuti prima dell’approvazione della l. 92/2012, rispetto alle previsioni della legge stessa. Tra l’altro, mentre alcune delle novità introdotte dalla l. 92/2012 si sono distinte per l’immediata operatività (ad esempio la clausola di stabilizzazione legale degli apprendisti), altre hanno iniziato ad essere operative a 6 Il Testo Unico riapre la possibilità che soltanto due qualsiasi dei sindacati rappresentativi concludano la negoziazione, in quanto, riferendosi alle associazioni sindacali e datoriali, non utilizza la proposizione articolata («dalle associazioni») ma ripropone la formula semplice («da associazioni»). 7 In questo senso, la tecnica normativa della «riforma Fornero» rimanda alla disciplina del contratto di apprendistato prevista dal d.lg. 276/2003, che disponeva precetti immediatamente operativi per le parti. 8 Invero, la versione del Testo Unico approvata in Consiglio dei Ministri nel maggio 2011 faceva riferimento agli accordi stipulati a livello «territoriale o aziendale». 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 143 17/10/13 6:06 PM 144 II. Il riordino delle tipologie contrattuali partire dal 1° gennaio 2013 (come le disposizioni relative ai limiti numerici). Creando una fase di «transizione» da vecchio a nuovo regime, la riforma potrebbe aver contribuito ad alimentare ulteriormente l’incertezza in punto di lettura delle disposizioni contrattuali alla luce delle novità normative. Il prossimo paragrafo è dedicato alle novità introdotte dal d.l. 76/2013 in materia di apprendistato, mentre i successivi illustrano gli aspetti dell’istituto modificati per effetto della l. 92/2012. 2. Modifiche del d.l. 76/2013 Il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, in ragione della «grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i giovani» (1° comma, art. 2), intende «restituire all’apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro» (2° comma, art. 2). È necessario specificare che, nonostante il tenore letterale della norma, il legislatore considera soltanto uno dei tre tipi di apprendistato, ossia quello professionalizzante o contratto di mestiere, di cui all’art. 4 del d.lg. 14 settembre 2011, n. 167, tacendo invece sulla disciplina sostanziale dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e sull’apprendistato di alta formazione e ricerca (artt. 3 e 5 del Testo Unico) 9. Il d.l. 76/2013 dedica all’apprendistato professionalizzante il 2° e 3° comma dell’art. 2. Il 2° comma si propone di rispondere alla necessità di «una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica» prevista dal 3° comma, art. 4, d.lg. 167/2011. Si tratta della formazione, «interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio». Il Testo Unico demandava la disciplina di tale offerta formativa alle singole Regioni, sentite le parti sociali, 9 Eppure, l’importanza di queste due tipologie di apprendistato era stata riconosciuta dal legislatore nel Testo Unico del 2011, che agli artt. 3 e 5 ripropone, seppur modificati, gli analoghi istituti introdotti dagli artt. 48 e 50 del d.lg. 276/2003. Le esperienze di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e di apprendistato di alta formazione e ricerca, tuttavia, sono diffuse ancora oggi in misura limitata, se non marginale, mentre il professionalizzante è la forma tipica di apprendistato (ISFOL, XIII Rapporto di monitoraggio sull’apprendistato, Roma, 2013, 39). A fronte di tale ritardo, anche la riflessione avviata in sede di confronto tra il Ministero del Lavoro e le Regioni nell’estate del 2012 aveva dedicato particolare attenzione a queste tipologie di apprendistato, che risultano scarsamente appetibili e difficilmente attuabili per il mondo imprenditoriale, a confronto con il contratto di mestiere, (si veda il documento programmatico delle Regioni, Apprendistato: attuazione regionale, criticità e proposte di intervento, marzo 2013). 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 144 17/10/13 6:06 PM La nuova disciplina dell’apprendistato 145 senza imporre vincoli di omogeneità. Con il d.l. 76/2013, invece, il legislatore affida alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il compito di adottare – entro il 30 settembre 2013 – delle «linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere». Le linee guida potranno prevedere disposizioni derogatorie del Testo Unico – sempre con esclusivo riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante – rispetto a tre elementi specifici. Il primo, di cui alla lett. a) del comma in esame, restringe l’obbligo di redazione del piano formativo individuale – di cui alla lett. a), 1° comma, art. 2 del d.lg. 167/2011 – alla formazione per l’acquisizione delle competenze professionali e specialistiche 10 . La limitazione dell’obbligo – per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati dal 1° ottobre 2013 – si riferisce soltanto alla compilazione scritta del piano formativo individuale, non già all’assolvimento del complessivo obbligo di formazione. Il Ministero del Lavoro ha chiarito, infatti, che «rimane intatto l’obbligo di svolgimento della formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni» 11. Ciò sarebbe confermato «dalla circostanza secondo cui, per le imprese multi localizzate, va osservata la disciplina “della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale”, disciplina che evidentemente non può che identificarsi in quella concernente l’offerta formativa pubblica». Il secondo elemento sul quale potranno intervenire le linee guida della Conferenza Stato-Regioni è indicato alla lett. b), 2° comma, art. 2 e riguarda «la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita». In deroga al Testo Unico 12 , tale operazione potrà essere eseguita in un documento avente i contenuti minimi del 10 Giova richiamare che la regolamentazione della durata e delle modalità di erogazione di questa componente dell’obbligo formativo è stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale (2° comma, art. 4 del Testo Unico). 11 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 29 agosto 2013, n. 35, d.l. 76/2013 (conv. da l. 99/2013) recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» – indicazioni operative per il personale ispettivo. 12 Il Testo Unico, invece, all’art. 2, 1° comma, lett. g), prevedeva semplicemente che la «registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita» fosse effettuata nel «libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» e non in un documento affine o equivalente. 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 145 17/10/13 6:06 PM 146 II. Il riordino delle tipologie contrattuali modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino». Come chiarito dalla circolare ministeriale n. 35/2013, i «contenuti minimi» sono quelli, già individuati con il d.m. 10 ottobre 2005, che fanno riferimento alle «Competenze acquisite in percorsi di apprendimento», e alle «informazioni personali» del lavoratore (nome e cognome, codice fiscale, ecc.). In via esemplificativa la circolare riporta la relativa tabella contenuta nel Libretto allegato al d.m. 10 ottobre 2005. Il Ministero specifica che «Resta evidentemente salva, anche per i contratti di apprendistato in questione, l’eventuale utilizzo della diversa modulistica adottata dal contratto collettivo applicato (v. ad es. l’accordo interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 18 aprile 2012)». Infine, la lett. c) del 2° comma, dispone che «in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale». Il richiamo a un’unica disciplina si riferisce, evidentemente, all’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, e deve essere principalmente riferito ai contenuti e alla durata della stessa formazione. La circolare 35/2013 del Ministero del Lavoro specifica che «La disposizione va infatti applicata compatibilmente con l’offerta formativa pubblica della Regione dove l’apprendista svolge la propria attività, senza che ciò comporti pertanto un obbligo di frequenza di corsi extra-Regione e quindi maggiori oneri per le imprese» 13 . Il 3° comma, art. 2, d.l. 76/2013 specifica che, nelle more dell’intervento della Conferenza Stato-Regioni, con riferimento alle assunzioni in apprendistato professionalizzante, troveranno diretta applicazione le previsioni di cui alle lett. a), b), c) sopra richiamate. In questa ultima ipotesi, specifica il 3° comma, è comunque «fatta salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all’adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni». Secondo la formulazione originale del decreto legge, l’efficacia delle linee guida avrebbe avuto carattere straordinario e limitato nel tempo, cioè fino al 31 dicembre 2015, e la sua applicazione sarebbe stata confinata alle «microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003»14 . Non riporta tali limiti la versione 13 L’evidente finalità di semplificazione era perseguita già dal Testo Unico, là dove prevedeva – nei termini di una possibilità – che «I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale» (10° comma, art. 7). 14 Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE). 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 146 17/10/13 6:06 PM La nuova disciplina dell’apprendistato 147 definitiva del d.l. 76/2013, approvato, con modifiche, dal Senato il 31 luglio 2013, e convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 99 15. Per effetto della abrogazione del limite temporale, qualora la Conferenza “Stato-Regioni” non dovesse adottare le linee guida entro i termini stabiliti per legge, dal 1° ottobre 2013 le previsioni di cui alle lett. a), b), c), 2° comma, art. 2, d.l. 76/2013 si applicheranno dunque a tutti i contratti di apprendistato professionalizzante, non solo quelli stipulati entro la fine del 2015, da micro, piccole e medie imprese. Oltre alle novità appena descritte, il d.l. 76/2013 interviene su un altro aspetto della disciplina del contratto di apprendistato. Il 3° comma, art. 9 apporta una modifica letterale all’art. 3 del d.lg. 167/2011, aggiungendo il 2° comma bis, in materia di successione di contratti di apprendistato. Il pacchetto lavoro introduce la possibilità di conseguire una qualifica professionale ai fini contrattuali, a seguito della acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale in apprendistato, ex art. 3, d.lg. 167/2011, trasformando il contratto in un apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Questa possibilità è vincolata dal limite massimo di durata complessiva dei due periodi di apprendistato, che non può superare quella individuata dalla contrattazione collettiva. In particolare, per individuare tale limite bisognerà fare riferimento, come specifica il Testo Unico, agli «appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Il Ministero del Lavoro, con la già citata circolare 35/2013, ha poi chiarito che «Tale disposizione può trovare applicazione in relazione ai contratti di apprendistato per la qualifica o diploma professionale in corso alla data di entrata in vigore del d.l. ed il cui periodo formativo non sia ancora scaduto ma esclusivamente nell’ipotesi in cui il contratto collettivo applicato abbia individuato “la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato”». Per concludere, occorre ricordare che «al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età» (1° comma, art. 1), il d.l. 76/2013 ha istituito, in via sperimentale, «un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato», lavoratori 15 L’allegato alla l. 99/2013 specifica che sono soppresse: all’art. 2, 1° comma, le parole «di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015,»; al 2° comma, le parole «per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003»; al 3° comma, al primo periodo, le parole «effettuate dall’entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015,» e «di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015,». 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 147 17/10/13 6:06 PM 148 II. Il riordino delle tipologie contrattuali di età compresa tra i 18 e i 29 anni, i quali rientrino in una delle seguenti condizioni: «a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale» (2° comma, art. 1) 16 . È opportuno chiedersi se tale incentivo si applichi anche in caso di assunzione di giovani con un contratto di apprendistato. Attenendosi al tenore letterale della norma, l’incentivo sembrerebbe doversi applicare anche in questo caso, ovviamente qualora ricorrano i presupposti di legge. La norma, infatti, parla genericamente di assunzioni con contratto a tempo indeterminato ed esclude esplicitamente solo il lavoro domestico [lett. c), 2° comma, art. 1]. L’apprendistato, del resto, è definito letteralmente come «contratto di lavoro a tempo indeterminato» dall’articolo 1 del Testo Unico. Inoltre, la platea di potenziali beneficiari dell’incentivo economico previsto dal d.l. 76/2013 coincide con quella dei soggetti che possono essere assunti in apprendistato – il professionalizzante e quello di alta formazione e ricerca – fatte salve, naturalmente, le condizioni in subordine alle quali è riconosciuto l’incentivo. Tuttavia, sorge il dubbio se tale interpretazione sia da ritenersi corretta. Occorre infatti ricordare che, benché l’apprendistato sia un «contratto di lavoro a tempo indeterminato», al termine della formazione le parti possono esercitare liberamente il recesso, ai sensi dell’art. 2118 c.c., ponendo così fine al vincolo contrattuale [lett. m), 1° comma, art. 2, d.lg. 167/2011]. Il dubbio è motivato anche dall’esistenza di altri e diversi incentivi per le assunzioni di giovani con contratto di apprendistato, di natura retributiva [lett. c), 1° comma, art. 2, d.l. 167/2011], fiscale e contributiva 17. Pertanto, in attesa di un chiarimento di fonte ministeriale o dell’Inps, sembra possibile ipotizzare che l’applicazione dell’incentivo economico per l’assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato di cui all’articolo 1 del d.l. 76/2013 verrà esclusa nel caso di assunzioni in apprendistato 18 . 16 Si rimanda al 3° comma ss., art. 1, d.l. 76/2013 per la disciplina sulle condizioni e sulle modalità di calcolo e di erogazione dell’incentivo economico, Per un commento, si rinvia a E. Massi, Legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76. Le novità in materia di lavoro, 23 agosto 2013. 17 Si rinvia alle note a piè di pagina n. 43 e 44. 18 Di tale avviso sembra messere R. Camera, riferendosi all’incentivo ex art. 1, d.l. 76/2013 quale «forma alternativa» al sostegno delle risorse pubbliche per l’apprendistato; in R. Camera, Apprendistato e incentivo per i giovani tra i 18 ed i 29 anni: norme a confronto, in La lente sul fisco, 17 luglio 2013, n. 315. 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 148 17/10/13 6:06 PM La nuova disciplina dell’apprendistato 149 3. Durata minima. La lett. a), 16° comma, art. 1, l. 92/2012, introduce la «previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi» [lett. a bis), 1° comma, art. 2, d.lg. 167/2011]. La disposizione si intende applicabile a tutte le tipologie di apprendistato previste ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Testo Unico. Fa eccezione, per il solo caso dell’apprendistato professionalizzante, quanto previsto dai contratti collettivi applicati in imprese che conducano attività stagionali (art. 4, 5° comma, d.lg. 167/2011); tali contratti, a norma del Testo Unico, possono infatti prevedere specifiche modalità di svolgimento dell’apprendistato, anche a tempo determinato, purché siano stati sottoscritti, a livello nazionale, da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 19. Il Testo Unico non prevedeva una durata minima per i contratti di apprendistato, benché, per il professionalizzante, all’art. 4, 2° comma, demandasse agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi la possibilità di specificarla. Il Testo Unico si pone in continuità con quanto disposto dal d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal d.l. 112/2008: questo ultimo abrogava l’art. 49, 3° comma, d.lg. 276/2003 che, a sua volta, aveva fissato a due anni la durata minima del rapporto di apprendistato. Pertanto, a partire dal 26 giugno 2008 (data di entrata in vigore del già citato decreto 112/2008, poi convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133) fino all’entrata in vigore della l. 92/2012, è stato possibile assumere apprendisti per periodi di tempo anche inferiori a ventiquattro mesi. Ciò si discosta dalla tradizionale disciplina dell’apprendistato in Italia, là dove la l. 196/1997, prevedendo una durata minima di diciotto mesi, intendeva garantire – a tutti gli apprendisti – un tempo sufficiente per l’apprendimento della professione oggetto del contratto, da maturare attraverso una congrua attività formativa. La ratio della norma che nel 2012 ha reintrodotto la durata minima dell’apprendistato è coerente con la volontà del legislatore di garantire la effettività della finalità formativa del contratto. Questa ultima, come la dottrina ha storicamente osservato 20 , non si limita all’addestramento, ma si realizza in un più complesso percorso di formazione professionale, i cui contenuti non possono essere compressi al di sotto di una soglia minima. La 19 A.M. Nucara e A.G. Candido, L’apprendistato stagionale dopo la riforma, in M. Tiraboschi, (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini. Commentario al d.lgs. 14/9/2011, n. 167, e all’art. 11 del d.l. 13/8/2011, n. 138, convertito con modifiche nella L. 14/9/2011, n. 148, Milano, 2011, 346-366. 20 P.A. Varesi, I contratti di lavoro con finalità formative, Milano, 2001, 119-120. 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 149 17/10/13 6:06 PM 150 II. Il riordino delle tipologie contrattuali norma in commento dovrebbe contribuire a prevenire il rischio che, a fronte delle limitazioni imposte dalla riforma all’utilizzo delle tipologie contrattuali «concorrenti» all’apprendistato, questo diventi un surrogato, economico, dei rapporti a termine. 4. Durata massima (apprendistato professionalizzante). Il 17° comma, art. 1, l. 92/2012, fornisce una precisazione sull’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo delle norme che disciplinano i limiti di durata massima dei contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. L’art. 4, 2° comma, del Testo Unico, rispetto ai suddetti limiti, prevedeva una eccezione per le «figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento», ampliando tali limiti da tre a cinque anni. La nuova formulazione della norma prevede che l’estensione dei limiti di durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante siano previsti «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento». Sul punto era intervenuto il Ministero del lavoro con l’interpello del 26 ottobre 2011, n. 40 21, in risposta al quesito di Confcommercio e Confesercenti che richiedevano chiarimenti in ordine alla durata massima dell’apprendistato professionalizzante, disciplinato dall’art. 4, d.lg. 167/2011. In particolare le due Organizzazioni chiedevano se la durata massima di cinque anni prevista per le figure professionali dell’artigianato potesse riguardare anche «profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato, anche se appartenenti a settori merceologici differenti». Il Ministero rispondeva chiarendo che la disposizione del Testo Unico interessava tutte le figure professionali proprie dell’artigianato, ossia «tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani». In tal senso, l’interpretazione ministeriale estendeva, con criterio di analogia, anche a settori professionali diversi dall’artigianato, la possibilità di stipulare contratti di apprendistato aventi una durata massima pari a cinque anni. Al problema di conflittualità tra l’interpretazione del Ministero del lavoro, che può essere intesa in senso estensivo, e la norma di legge, che può 21 Interpello 26 ottobre 2011, n. 40 (Confcommercio e Confesercenti), Durata massima apprendistato professionalizzante. 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 150 17/10/13 6:06 PM La nuova disciplina dell’apprendistato 151 essere intesa in senso restrittivo, si possono attribuire, almeno, due diverse letture interpretative. La prima individuerebbe coerenza tra la nuova formulazione della legge e l’indirizzo dell’interpello ministeriale. Del resto, alcuni accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali di lavoro non «artigiani» avevano già previsto una durata massima del contratto di apprendistato fino a cinque anni. Ne sono esempi l’Accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel settore terziario, distribuzione, servizi, sottoscritto da Confcommercio-Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, FisascatCisl, Uiltucs-Uil il 24 marzo 2012, e l’accordo interconfederale siglato da CONFINDUSTRIA, Cgil, Cisl e Uil (Accordo interconfederale in materia di apprendistato, 18 aprile 2012) 22 . Secondo una diversa interpretazione 23, la modifica introdotta dal 17° comma, art. 1, l. 92/2012, si riferirebbe esplicitamente alla figura dell’artigiano, puntualmente definita nella l. 443/1985, cosiddetta «legge quadro sull’artigianato» 24, limitando quindi la possibilità di estendere i limiti di durata massima dell’apprendistato professionalizzante oltre le soglie del settore artigiano. A fronte di più e diverse possibili letture della nuova formulazione della legge, si può osservare che questa ultima, invece di chiarire in modo inequivocabile la questione della durata massima dei contratti di apprendistato professionalizzante, ha lasciato aperte più soluzioni interpretative. Per ulteriori elementi di chiarezza si dovranno pertanto attendere, da un lato la reazione dei diversi settori, dall’altro lato, un nuovo, eventuale, più esplicito pronunciamento del Ministero 25. Se tutto ciò si riferisce esclusivamente ai contratti di apprendistato professionalizzante, restano, invece, invariate le norme sulla durata dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e di apprendistato di alta formazione e ricerca. 22 Consultabili nella sezione Contrattazione Collettiva di www.fareapprendistato.it. M. Magnani e M. Tiraboschi, (a cura di), La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, Milano, 2012, 119. 24 La l. 8 agosto 1985, n. 443. 25 In materia di durata della formazione in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, si veda l’Interpello del Ministero del lavoro, 19 ottobre 2012, n. 34 (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro), Apprendistato Professionalizzante. Durata della formazione e previsioni collettive. Cfr. il commento di R. Schiavone, Apprendistato professionalizzante e durata della formazione, in Giust. lav., 2 novembre 2012, n. 43; e la nota di M. Tavella, Durata della formazione nell’apprendistato professionalizzante, in Dir. e prat. lav., 19 novembre 2012, n. 44. 23 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 151 17/10/13 6:06 PM 152 II. Il riordino delle tipologie contrattuali Nel primo caso, la durata del contratto si determina «in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale» (1° comma, art. 3, d.lg. 167/2011). Nel secondo caso, la durata del periodo di apprendistato, per i soli profili che attengono alla formazione, è stabilita dalle Regioni, «in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico» (2° comma, art. 5, d.lg. 167/2011). In assenza di regolamentazioni regionali, la durata del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà specificata, insieme agli altri aspetti, da apposite convenzioni che i singoli datori di lavoro o le loro associazioni possono stipulare con le Università e le altre istituzioni formative o di ricerca sopra menzionate. 5. Periodo di preavviso. La lett. b), 16° comma, art. 1, l. 92/2012, specifica che «nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto apprendistato». La precisazione risponde ai dubbi interpretativi in materia di recesso al termine del periodo di formazione sorti dalla lettura dell’art. 2, 2° comma, lett. m), d.lg. 167/2011. Innovando rispetto al passato, il Testo Unico aveva previsto che il termine di preavviso sarebbe iniziato a decorrere dal termine del periodo di formazione, e dunque non più, come prima, nell’ambito della durata del periodo di formazione. In assenza di specifiche nel testo della legge, si era posto il problema di quale trattamento normativo, retributivo e contributivo applicare durante il periodo di preavviso lavorato, una volta comunicato il recesso: se quello del contratto di apprendistato o quello dell’ordinario rapporto di lavoro, collocandosi temporalmente il recesso al termine del periodo di formazione 26 . La l. 92/2012 ha inteso risolvere tale dubbio relativo alla qualificazione del rapporto di lavoro, precisando che nel 26 Per tale interpretazione propendeva E. Massi, Contratto di apprendistato e preavviso, in La circolare di lavoro e previdenza, n. 43, 7 novembre 2011. 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 152 17/10/13 6:06 PM La nuova disciplina dell’apprendistato 153 periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Il tema del recesso dal contratto di apprendistato è stato oggetto di commento non soltanto rispetto alla questione del preavviso, ma aveva suscitato dibattito già prima della approvazione della l. 92/2012. Il 14 giugno 2012, infatti, il Ministero del lavoro si era pronunciato sul punto, con Interpello 16/2012 27, in risposta a una richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, avente ad oggetto, tra l’altro, il tema del recesso dal contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 2118 c.c. durante il periodo di malattia, infortunio e altre cause di assenza dal lavoro. In quell’occasione il Ministero del lavoro aveva già chiarito che, «il periodo di preavviso di cui all’articolo 2118 del Codice Civile – richiesto dal citato art. 2, comma 1 lett. m) e decorso il quale il rapporto potrà ritenersi risolto – non potrà che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento» 28 . 6. Limiti numerici per gli apprendisti. La l. 92/2012 introduce anche una modifica, nella direzione di un ampliamento, alle norme sul limite massimo del numero di apprendisti in azienda. Prima della riforma, il 3° comma dell’art. 2 del Testo Unico prevedeva che un datore di lavoro potesse assumere un numero massimo di apprendisti in rapporto di uno a uno rispetto alle maestranze specializzate e qualificate da lui stesso assunte. In altre parole, la legge richiedeva la presenza di un lavoratore dipendente qualificato o specializzato per ogni apprendista, con l’implicazione che il numero di apprendisti non avrebbe potuto superare il 100% di tali lavoratori qualificati o specializzati. Nel caso questi ultimi non fossero stati presenti in azienda, o fossero stati meno di tre, l’azienda avrebbe potuto comunque assumere apprendisti, fino a un massimo di tre. Le disposizioni del Testo Unico non si sarebbero applicate alle aziende artigiane, oggetto della normativa di settore, contenuta, sulla questione specifica, dall’art. 4, l. 8 agosto 1985, n. 443 29. 27 Interpello 14 giugno 2012, n. 16 (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro), Richiesta del parere di conformità agli enti bilaterali e recesso dal contratto. 28 Cfr. la nota di A. Casotti, Apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo e iscrizione nelle liste di mobilità, in Dir. e prat. lav., 29 settembre 2012, n. 35. 29 L’art. 4, l. 8 agosto 1985, n. 443, disciplinava i «Limiti dimensionali» delle imprese artigiane, in base a una distinzione per tipi di produzione, ad esempio, prevedendo: «a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 153 17/10/13 6:06 PM 154 II. Il riordino delle tipologie contrattuali Secondo la disciplina dell’apprendistato riformata dalla l. 92/2012, i limiti numerici previsti dal Testo Unico restano invariati nei seguenti tre casi. Primo, per i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti, il rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate e qualificate in servizio continuerà a non poter superare il 100%, come già previsto dal Testo Unico. Secondo, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze «lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre». Terzo, restano escluse dall’applicazione delle norme in questione le imprese artigiane, a cui continuano ad applicarsi le condizioni di maggior favore previste dall’art. 4, l. 8 agosto 1985, n. 443. Le novità riguardano, invece, le imprese che occupano un numero di lavoratori pari o superiore a dieci: in tal caso, ai sensi del 16° comma, lett. c), art. 1 della legge in commento, il rapporto tra il numero di apprendisti e il numero dei lavoratori qualificati, passa dal vecchio uno a uno, a un rapporto di tre a due. In altre parole, secondo il novellato 3° comma, art. 2, d.lg. 167/2011, un datore di lavoro con più di dieci dipendenti potrà assumere un numero complessivo di apprendisti maggiore del numero totale di lavoratori in servizio presso la propria impresa 30 . Le nuove norme sui limiti numerici si applicano esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2013, come specificato dall’art. 1, 18° comma, l. 92/2012. Pertanto, alle assunzioni con decorrenza anteriore a tale data, e cioè fino al 31 dicembre 2012, hanno continuato ad applicarsi i limiti numerici previsti dal Testo Unico sull’apprendistato 31, nella versione antecedente all’entrata in vigore della «riforma Fornero». Dal 1° gennaio 2013, invece, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di nove lavoratori, possono beneficiare dei nuovi limiti, e dunque assumere un numero complessivo massimo di apprendisti «non superiore al rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in numero non superiore a 9 […]; b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5 […]; c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16», ecc. 30 Per la prima volta si ammette che, anche per le imprese non artigiane, il numero di apprendisti possa essere superiore a quello dei lavoratori specializzati. Tale facoltà era concessa alle imprese artigiane, in virtù della peculiarità del settore, tradizionalmente votato all’utilizzo dell’apprendistato. 31 Per inciso, si osservi che i limiti numerici previsti dal Testo Unico dell’Apprendistato sono rimasti invariati rispetto alla disciplina originaria dell’apprendistato, contenuta nella l. 25/1955. 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 154 17/10/13 6:06 PM La nuova disciplina dell’apprendistato 155 servizio». Per gli altri datori di lavoro (quelli con meno di dieci dipendenti, quelli che abbiano in servizio massimo tre o nessun lavoratore qualificato o specializzato, e le imprese artigiane) continuano a valere i limiti numerici previsti dal d.lg. 167/2011. In ogni caso, i nuovi limiti numerici per l’assunzione di apprendisti, sono validi sia nel caso di assunzione diretta, sia nel caso di assunzione indiretta, per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, di cui all’art. 20, d.lg. 276/2003, con un contratto di somministrazione, comunque, a tempo indeterminato. Lo stesso art. 2, 3° comma, come modificato dalla legge in esame, specifica che «è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» (a tal proposito, si veda il paragrafo successivo). Brevemente, si può osservare che le novità introdotte dalla l. 92/2012 in materia di limiti numerici per gli apprendisti sembrano penalizzare le microimprese, ossia quelle aventi fino a nove dipendenti, almeno rispetto alle imprese che occupano un numero di lavoratori pari o superiore a dieci. Per queste ultime, del resto, l’ampliamento delle possibilità di utilizzo – in termini quantitativi – dell’apprendistato, pare essere bilanciato da diversi altri interventi che introducono nuovi limiti e vincoli sulle modalità di applicazione delle norme sull’istituto. In altre parole, se da un lato viene favorita la diffusione dell’apprendistato su una più ampia scala, dall’altro lato, la legge pone dei limiti alle modalità di utilizzo dello strumento, con l’intenzione di eliminare e prevenire gli abusi di legge. 7. Apprendistato in somministrazione. La l. 92/2012 interviene anche in materia di assunzione di giovani con contratto di apprendistato per mezzo della somministrazione di lavoro. In primo luogo, il 17° comma bis, art. 1, integrando con la lett. i bis), il 3° comma, art. 20, d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, amplia la rassegna dei casi in cui è possibile utilizzare la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, facendo cioè esplicito riferimento all’utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato, in tutti i settori produttivi. La norma in commento si limita, in verità, a chiarire quanto già specificato dal Testo Unico dell’Apprendistato, all’art. 2, 3° comma, senza apportare ulteriori novità. In secondo luogo, la lett. c), 16° comma, art. 1 della legge in esame specifica che «è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 155 17/10/13 6:06 PM 156 II. Il riordino delle tipologie contrattuali apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». Invero, già il Testo Unico disponeva chiaramente che gli apprendisti potessero essere assunti «direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», e cioè solo con contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Tuttavia, le stesse parti sociali parevano suggerire una interpretazione differente e alternativa sul punto 32 : sembrava, cioè, che fosse possibile somministrare gli apprendisti in missioni presso più e diversi datori di lavoro, presupponendo quindi la possibilità di usare la somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 20, 4° comma 33 . A fronte della possibile incertezza in materia di apprendistato in somministrazione, la l. 92/2012 ha voluto fare chiarezza, specificando che gli apprendisti possono essere somministrati solo nell’ambito di rapporti di c.d. staff-leasing, ossia somministrazioni a tempo indeterminato. Potrebbe, infine, esserci un altro aspetto, per ora largamente trascurato dagli esperti 34 , rilevante ai fini della comprensione della disciplina dei contratti di apprendistato in somministrazione. La l. 92/2012 ha abrogato l’art. 13, d.lg. 276/2003, recante disposizioni per il supporto e la incentivazione della presa in carico e del reinserimento in azienda di determinate categorie di «lavoratori svantaggiati» 35. L’art. 13, tra le altre cose, ammetteva di derogare al principio di parità di trattamento tra i lavoratori in somministrazione e i lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice, qualora i primi fossero stati coinvolti in percorsi di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, o, come gli apprendisti, in percorsi di formazione. Si porrebbe quindi un potenziale dubbio sulla eventualità che tale intervento 32 Accordo in materia di apprendistato professionalizzante in somministrazione, siglato il 5 aprile 2012 da Assolavoro, Associazione Nazionale Agenzie per il Lavoro, Felsa CISL, Nidil CGIL e Uil Tem.p @. 33 Questa ipotesi sarebbe risultata, almeno secondo una parte del movimento sindacale, illegittima sotto una serie di profili. Primo, per la mancanza di fondamento giuridico, considerato che, come ricordato, il Testo Unico prevedeva esclusivamente l’uso dell’apprendistato nell’ambito di una somministrazione a tempo indeterminato richiamandosi al solo art. 20, 3° comma, d.lg. 276/2003. In secondo luogo, la somministrazione a tempo determinato di apprendisti avrebbe rischiato di pregiudicare la funzione formativa e occupazionale dell’istituto. Si veda a tal proposito il comunicato stampa della NIdiL CGIL del 23 marzo 2012. 34 Sull’apprendistato in somministrazione si vedano i commenti di M. Tiraboschi, L’apprendistato in somministrazione nella legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro: una occasione mancata, in Dir. relaz. ind., 2012, n. 3, e di P. Rausei, Apprendistato in somministrazione. Ambito di applicazione e criticità, in Dir. e prat. lav., 17 novembre 2012, n. 42. 35 Per la definizione di «lavoratori svantaggiati» si veda il regolamento (CE) 800/2008. 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 156 17/10/13 6:06 PM La nuova disciplina dell’apprendistato 157 possa in qualche modo influire sulla possibilità, e sulla opportunità, di somministrare apprendisti. Il dubbio riguarderebbe, in particolare, la possibilità di attribuire agli apprendisti in somministrazione una retribuzione inferiore rispetto ai lavoratori assunti direttamente dall’impresa utilizzatrice, derogando al principio di parità di trattamento di cui sopra. 8. Percentuale di conferma. La lett. d), 16° comma, art. 1, l. 92/2012, vincola l’assunzione di nuovi apprendisti a una clausola di stabilizzazione degli apprendisti precedentemente assunti. All’art. 2 del Testo Unico, dopo il 3° comma, sono aggiunti i 3° comma bis e 3° comma ter. Il primo subordina l’ingresso in azienda di nuovi apprendisti «alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro». Il secondo esclude l’applicazione delle disposizioni di cui al 3° comma bis nei confronti dei «datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità». Il 19° comma dell’art. 1 in commento fissa la suddetta percentuale nella misura del 30% per un periodo di trentasei mesi decorrente dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della l. 92/2012. Pertanto, fino al 17 luglio 2015, alle imprese con più di dieci dipendenti che vogliano assumere apprendisti, sarà richiesto di aver trasformato in contratti di lavoro subordinato di tipo ordinario il 30% dei contratti di apprendistato stipulati nei tre anni precedenti. Dopo il 2015, sarà, invece, necessario aver stabilizzato un apprendista su due, tra quelli la cui fase formativa del contratto sia scaduta nei trentasei mesi precedenti. Nel caso di mancato rispetto delle percentuali di conferma previste dalla legge, il datore di lavoro potrà tuttavia assumere un apprendista in più rispetto a quelli già confermati. Ovvero, nel caso in cui nessuno degli apprendisti precedentemente assunti sia confermato, sarà comunque possibile assumere, in totale, ossia al massimo, un apprendista. La legge specifica che gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di legge, «sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato […] sin alla data di costituzione del rapporto». In ogni caso, al fine di calcolare la percentuale di conferma, non si considerano «i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa», vale a dire i contratti cessati per cause di recesso che prescindono dalla volontà del datore di lavoro. 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 157 17/10/13 6:06 PM 158 II. Il riordino delle tipologie contrattuali Il 18° comma dell’articolo in esame, inoltre, specifica che la disposizione sulla clausola di stabilizzazione si applica alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Fino a tale data hanno trovato esclusiva applicazione le disposizioni previste dall’art. 2, 1° comma, lett. i) del Testo Unico, che affidavano alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere «forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato», entro i limiti numerici dettati dal 3° comma dello stesso articolo. Dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la norma di legge sulla percentuale di conferma, nella misura del 30%, per trentasei mesi; anche dopo tale data, la contrattazione collettiva potrà prevedere eventuali disposizioni recanti regole di maggior favore. Ad ogni modo, si pone il problema della interpretazione del rapporto tra la norma di legge e le norme di contratto; problema rispetto al quale, finora, gli interpreti non sembrano aver raggiunto una posizione condivisa. Sul punto, la circolare del Ministero del lavoro, 18 luglio 2012, n. 18 36 chiarisce che, mentre la clausola di stabilizzazione «legale» si applica con esclusivo riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci lavoratori, le clausole previste dai contratti collettivi non subiscono «alcuna limitazione in funzione dell’organico aziendale». Da una possibile interpretazione letterale della circolare, potrebbe dedursi che, mentre le imprese con dieci o più dipendenti devono ignorare le eventuali clausole di stabilizzazione previste dai contratti collettivi, tali clausole, nella prassi più rigide delle previsioni di legge, si applicano alle imprese con meno di dieci dipendenti. Secondo alcuni 37, ciò potrebbe condurre a esiti paradossali: ad esempio, la clausola di stabilizzazione del contratto del commercio prevede una percentuale pari all’80%; applicando alla lettera la circolare ministeriale, tale percentuale, meno favorevole rispetto a quella fissata per legge (30% fino al 2015, poi 50%), si applicherebbe solo alle micro-imprese. Pare, tuttavia, ragionevole escludere tale soluzione interpretativa, a favore della lettura per cui la clausola introdotta dal legislatore sia da intendersi quale «tutela minima», che i contratti collettivi possono elevare. Ciò sembra ammissibile anche in forza del fatto che la conseguenza del mancato rispetto 36 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 luglio 2012, n. 18, L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro) – Tipologie contrattuali ed altre disposizioni – prime indicazioni operative. 37 E. Carminati e M. Tiraboschi, Il paradosso della clausola legale di stabilizzazione degli apprendisti, in Bollettino Adapt, 19 novembre 2012, n. 41. 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 158 17/10/13 6:06 PM La nuova disciplina dell’apprendistato 159 delle percentuali di conferma sarebbe la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato. La l. 92/2012, a fronte di un ampliamento dei margini – quantitativi – di utilizzo dell’apprendistato, ha reso vincolante la richiesta alle imprese di stabilizzare gli apprendisti al termine del periodo formativo, in vista di maggiori garanzie occupazionali per i giovani, e con l’intenzione di limitare l’abuso del contratto di apprendistato come lungo periodo di prova o come strumento per abbattere il costo del lavoro. La possibilità di vincolare l’assunzione di nuovi apprendisti, invero, era già contemplata nel d.lg. 167/2011, che la affidava alla contrattazione collettiva, all’art. 2, 1° comma, lett. i). Il Testo Unico si limitava a riportare quella che da anni era una prassi consolidata in molti contratti collettivi nazionali di lavoro, fatta eccezione, tra gli altri, per il comparto artigiano, considerato che le imprese di piccole dimensioni, ampiamente diffuse in tale settore, sarebbero state troppo penalizzate da una simile previsione. La l. 92/2012, del resto, ha tenuto conto di questo rischio disponendo che le norme di legge sulla stabilizzazione degli apprendisti valgano solo per le aziende con un numero pari o superiore a dieci dipendenti. 9. Assicurazione Sociale per l’Impiego. Il 2° comma, art. 2, d.lg. 167/2011, dispone le norme in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria per gli apprendisti. Il Testo Unico prevedeva che questi fossero assicurati contro le malattie, contro l’invalidità e la vecchiaia, per la maternità, e che potessero beneficiare degli assegni familiari. In aggiunta a quanto già previsto, introducendo la lett. e bis), 2° comma, art. 2, d.lg. 167/2011, la l. 92/2012 prevede il diritto per gli apprendisti di ricevere la assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) 38 . 38 Questa forma di assicurazione, istituita dalla l. 92/2012, dal 1° gennaio 2013 rappresenterà l’unico strumento di tutela del reddito in caso di disoccupazione totale e involontaria, e sostituisce le indennità di mobilità e di disoccupazione. Più precisamente, l’ASpI sostituisce la indennità di mobilità, quella di disoccupazione speciale edile e quella di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e ridotti, lasciando inalterato il sistema dell’indennità di disoccupazione agricola. Cfr. Inps, circ. del 14 dicembre 2012, n. 140, Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), istituita dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Aspetti di carattere contributivo; in particolare paragrafo 3.3. Sul disegno di legge per la riforma degli ammortizzatori sociali, cfr. M. Cinelli, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del lavoro, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2012, n. 2. 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 159 17/10/13 6:06 PM 160 II. Il riordino delle tipologie contrattuali Come specifica l’art. 2, 36° comma, l. 92/2012, la lett. e bis) è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2013. Ai sensi della norma in commento, oltre alla contribuzione dovuta per le forme di previdenza e assistenza sociale già esistenti 39, i datori di lavoro dovranno versare, per gli apprendisti artigiani e non artigiani, una contribuzione pari all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 40 . La legge specifica che, con riferimento a tale versamento, non operano gli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità 2012 per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 entro il 31 dicembre 2016 41. Sono tuttavia confermate le previsioni relative alle agevolazioni vigenti, ovvero la disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 42 . La circolare 128/2012 dell’Inps 43 è intervenuta per chiarire le forme assicurative e il regime contributivo applicabile agli apprendisti dopo il Testo Unico così come novellato dalla l. 92/2012 e dalla successiva legge sulle misure urgenti per la crescita 44 . La novità assume particolare rilievo in ragione del fatto che la previgente normativa, benché parificasse le tutele di previdenza e assistenza sociale degli apprendisti a quelle dei lavoratori «standard», aveva sempre escluso gli apprendisti dalle misure a tutela della disoccupazione involontaria e quelle 39 Ai sensi della disciplina di cui all’art. 1, 773° comma, l. 27 dicembre 2006, n. 296. L’ASpI è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2013 che, da allora, è applicabile ai nuovi eventi di disoccupazione che occorrano posteriormente a tale data. 41 Ai sensi dell’art. 22, 1° comma, l. 12 novembre 2011, n. 183, «a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo». Cfr. Inail, circ. 24 maggio 2013, n. 27, Apprendistato. Disciplina generale e regime contributivo. Testo unico dell’apprendistato. Legge di stabilità 2012 (l. 183/2011) e Riforma del lavoro (l. 92 /2012). 42 Art. 1, 773° comma, l. 296/2006. Tale disciplina prevede, per le imprese con meno di 10 dipendenti, una aliquota percentuale a carico del datore di lavoro variabile in ragione dell’anzianità dell’apprendista (1,50% per il primo anno, 3% per il secondo, 10% dal terzo), mentre per imprese con dieci o più dipendenti si applica una aliquota fissa (10%). A carico dell’apprendista è prevista una aliquota fissa del 5,84%. 43 Inps, circ. 2 novembre 2012, n. 128, Apprendistato. D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167. (T.U. dell’apprendistato). Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 22. Cfr. P. Rossi, Apprendisti e regime contributivo: i chiarimenti Inps sulle novità, in Giust. lav., 16 novembre 2012, n. 45. 44 L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. 40 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 160 17/10/13 6:06 PM La nuova disciplina dell’apprendistato 161 di integrazione al reddito. Unica eccezione fu l’esperienza delle c.d. «misure anticrisi», introdotte dall’art. 19, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, che aveva riconosciuto anche agli apprendisti la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali (CIG e mobilità in deroga). 10. Contributo per il licenziamento. Il 31° comma dell’art. 2, l. 92/2012, introduce l’obbligo per il datore di lavoro di versare un contributo «in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013» 45. Poiché l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro che, dal primo gennaio 2013 in avanti, licenzi un apprendista, sia durante, sia al termine della fase formativa, dovrà versare una sorta di «contributo per il licenziamento». Lo specifica il 32° comma, là dove dispone che il contributo per il licenziamento sia dovuto anche «per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167». Dopo aver introdotto l’obbligo di versamento, il 31° comma specifica l’ammontare di tale contributo e le relative modalità di calcolo. La somma da versare sarà pari al 50% del trattamento iniziale di Assicurazione Sociale per l’Impiego, per ciascuna delle dodici mensilità di anzianità aziendale nei tre anni precedenti. Al fine del computo dell’anzianità aziendale saranno considerati anche «i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30» 46 . 45 Inps, circ. 23 marzo 2013, n. 44, Legge 92/2012 – Art. 2, comma 31. Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013. Criteri impositivi e modalità operative. Ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI. 46 La «restituzione di cui al comma 30» si riferisce alla restituzione nei limiti delle ultime sei mensilità, del contributo addizionale, di cui ai precedenti 28°, 29° e 30° comma. Tale contributo, a carico del datore di lavoro, e pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, si applica ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Al datore di lavoro è restituito tale contributo in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, dopo il periodo di prova. «La restituzione avviene anche qualora il datore di 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 161 17/10/13 6:06 PM 162 II. Il riordino delle tipologie contrattuali Si osservi che la novità in commento non incide sulla disciplina del rapporto di apprendistato, prevista dal d.lg. 167/2011. Tuttavia, sembra lecito osservare che l’introduzione di questo obbligo rende il recesso dal contratto più gravoso, se non altro in termini di un maggiore costo del lavoro. lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine». 147784_007_LIEBMAN_PART_02_CH_07.indd 162 17/10/13 6:06 PM
Scarica