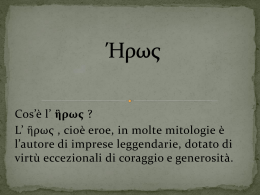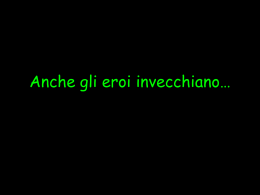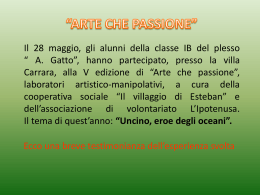Anno 1 Numero 44 - 22.12.2008 Professione d’agnosticismo Editoriale di Gian Maria Tosatti «Felice quella terra che non ha bisogno di eroi» Bertolt Brecht La letteratura e i fumetti ne sono pieni. E ultimamente sono finiti anche sui grandi schermi del cinema americano. Eroi ovunque e supereroi in ogni dove. Non è una novità. D’altra parte ogni forma di racconto nella storia, dall’epica antica a quella medievale, si è fondato sulla figura dell’eroe come simbolo di una forza archetipa o del destino. Ed è così per tutte quelle figure che tale ruolo hanno assunto nella sfera della realtà, prodotti e incarnazioni anch’essi di un sentimento popolare. La differenza essenziale, tuttavia, fra gli eroi della fiction e quelli che come tali sono stati percepiti nella Storia sta nel fatto che i primi sembrano avere una vocazione conservatrice, legata alla protezione ed al mantenimento dello status quo, mentre i secondi, di contro, si presentano come rivoluzionari. Effettivamente i supereroi della storia sono sempre collegabili ad un concetto di cambiamento o addirittura ad una vera e propria rivoluzione. Quella francese partorì la figura di Napoleone, quella fascista partorì la sagoma del faccione di Mussolini, quella bolscevica dipinse l’icona staliniana. E la stessa figura di Adolf Hitler nella sua ascesa fu incarnazione di una delle più grosse rivoluzioni della storia tedesca moderna. A completare il quadro del nostro pantheon contemporaneo possiamo metterci anche Ernesto Che Guevara, la cui faccia su sfondo rosso è diventata bandiera del concetto stesso di Rivoluzione anche al di là dei confini latinoamericani. In un’ipotetico scontro fra titani nell’altra metà campo finirebbero i supereroi di carta, l’Uomo Ragno, Batman, Iron Man, James Bond, The Spirit, per citare solo gli ultimi che hanno attraversato la striscia immobile della carta per finire su quella movimentata della pellicola. Non sono tutti santi, ognuno di loro ha avuto almeno una crisi d’identità, dall’Uomo Ragno (nel suo dualismo con Venom) a Batman e 007 le cui contraddizioni sono state approfondite proprio negli ultimi episodi cinematografici delle rispettive saghe. Eppure tutti loro esprimono con estrema chiarezza un’ideale conservatore, di difesa e protezione dell’esistente, a partire dal loro storico allenatore (è questa la figura che ricopre spesso nell’universo Marvel) Capitan America il cui stesso granitico patriottismo non è stato immune a qualche ripensamento (ne nacque il più grosso scontro di supereroi mai disegnato). E al conservatorismo tendono anche quegli eroi della Storia che oltrepassano la cortina della fiction, uno su tutti (sempre per stare nell’attualità) è il Leonida re di Sparta protagonista della graphic novel 300 (ossia la battaglia delle Termopili secondo Frank Miller). Ma in tutto ciò quel che più appare interessante è che tale distinzione è frutto della percezione che gli uomini hanno della figura eroica. Essenzialmente, osservando tale quadro, si capisce facilmente come la società nella sua produzione di forme comunicative tenga ipoteticamente alla conservazione, alla protezione del proprio equilibrio da attacchi esterni o interni. Tuttavia, nell’intimo spirito della realtà quotidiana, le molteplici contraddizioni del potere e la certa distanza da una società ideale portano alla ricerca spasmodica di una figura forte, di un leader capace di cambiare le cose. D’altra parte è su questa consapevolezza che s’è edificato (e direi anche inceppato) il bipolarismo all’italiana. Ovviamente, infatti, di veri eroi non ce ne sono poi tanti e quando nascono, spesso, non è il momento giusto per loro. Così la voglia di costruire un idolo, realizza spesso aberrazioni, come fu il vitello d’oro degli ebrei o come lo sono state più tardi le molte figure reali che sopra abbiamo elencato. A ben vedere, dunque, l’eroe si dimostra una sorta di astrazione. Per intenderlo si può prendere a prestito Feuerbach dicendo che la debolezza strutturale dell’uomo porta quest’ultimo ad astrarre da sé un’idea di potenza alla quale poi si sottopone quale schiavo. E’ quel che il filosofo pensava di Dio, ma è pur vero che dal mitologico Ercole al marveliano Thor gli eroi sono sempre stati considerati semi-dei ed è ancor più vero che chi assurge al potere gioca spesso a fare l’onnipotente e la sua trama termina spesso in una catarsi tragica. SuperZombie Esce il giorno di Natale “The Spirit”, paladino senza platea di Federico Pontiggia Un ex poliziotto, Denny Colt (Gabriel Macht), tornato dalla morte per combattere il crimine di Central City. E’ lui The Spirit, “omaggio al noir anni ‘40” tratto dal fumetto di Will Eisner, che segna la prima regia in solitaria del fumettaro Frank Miller, dopo quella a quattro mani con Robert Rodriguez per Sin City (in carnet, anche il soggetto di 300). Mostro sacro dei comics, dietro la macchina da presa Miller non rinuncia all’estetica da balloon, avvalendosi di un signor cast: tra gli altri, Samuel L. Jackson, Eva Mendes e Scarlett Johansson. “Spirit è il tipico gentleman. Era innamorato di una donna, Sand Saref (Eva Mendes), che è diventata una formidabile ladra di gioielli. In lui – dichiara Miller - convivono lo spirito del poliziotto, che gli impone di arrestare Sand, e quello dell'innamorato, che vorrebbe salvarla e tenerla per sé”. Questo, eterno, conflitto tra il dovere e il cuore caratterizzava anche il suo Batman a fumetti (Il cavaliere oscuro): “E’ il dilemma nascosto di ogni supereroe. Ma quello che spinge Spirit più di ogni altra cosa è l'ansia di sapere perché non è morto pur essendo morto”, conferma Miller. Se a far il supereroe sono dunque cuore, dovere e conoscenza, nulla è nuovo sul fronte eroico, della serie “fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza…”. Il problema è che la società è cambiata, e questi (super)eroi non fanno più notizia, o almeno non riescono più a mantenere le promesse e le premesse: se per il semiologo Juri M. Lotman l’eroe è il travalicatore di confini – uno per tutti, Ulisse – ebbene sono in pochi oggi ad avere capacità trasgressiva (transgredi, andare oltre) rispetto alla norma. In primis, perché in un’epoca in cui la - supposta - trasgressività edonistica è pane quotidiano, all’eroe manca il gap fondativo, il primo gradino distintivo. Da qui, lo sfalsamento di piani ontologici cui sempre più assistiamo in letteratura e sugli schermi “supereroici”: che sono Hancock, il supereroe alcolizzato di Will Smith, i celebri Incredibili animati, il puzzolente Hellboy di Guillermo Del Toro e molti altri se non supereroi disfunzionali, forse addirittura disabili? Di fronte, al superomismo estetizzante a uso e consumo massmediatico – e massmediale – il supereroe è costretto a mischiare le carte, fare di disabilità virtù, ovvero aprirsi a una debolezza, un vulnus e una colpa che sono espressione piena di una paradossale antieroicità. Il supereroe oggi, anche quello animato e/o formato famiglia, è a due facce, come l’Harvey Dent de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, ovvero uno e bino, bello e scarificato, medio sproporzionato tra l’eroe Batman e la nemesi Joker, ovvero volto spaccato da un manicheismo divenuto impossibile. Al di là degli innegabili meriti di regia e interpretazioni, forse il vero surplus de Il cavaliere oscuro è proprio questa fedeltà etimologica nello stato dell’arte, con un trio (Batman, Joker e Due Facce) demiurgico e identitario: A (Batman), nonA (Joker) e diverso da A (Due Facce). Ed è in questa definizione per diversità che affonda l’attuale, forse definitiva, crisi dell’eroe: se The Spirit di Miller barcolla già nella mancanza di coraggio eidetico, l’asetticità dell’omaggio al noir anni ’40 e l’incapacità emozionale, il suo vero fallimento sta nella riproposizione stucchevole di un eroe che non ha più chi possa ritenerlo tale, ovvero la società contemporanea. E il suo essere un morto non morto, undead, è paradigmatico di ciò che oggi è diventato: uno zombie. Ma al di là dell’incipit e dell’ambientazione, riveduta e corretta al gusto contemporaneo, poco altro resta della struttura testuale di Weiss. La scelta di Felici è di sottrazione, una riscrittura tutta orientata a illuminare il personaggio di Marat, l’eroe rivoluzionario, l’amico del popolo (come veniva chiamato, dal nome del giornale che fondò nel 1789, «L’Ami du peuple»). Scompare invece la figura di De Sade, l’autore, che viene solo evocato nei versi delle attrici (ma è il divin marchese o lo stesso regista?). Scompare cioè l’occhio che è esterno alla rappresentazione pur essendo interno allo spettacolo, ovvero il meccanismo di confronto e di moltiplicazione dei piani di realtà ideato da Weiss nel suo Marat/Sade – con questo binomio, dal film di Peter Brook in poi, sarà chiamata per brevità l’opera del drammaturgo tedesco. Recitare la rivoluzione Un po’ più e un po’ meno del “Marat/Sade” nella versione per sole donne di Andrea Felici di Graziano Graziani Dal palco tre donne si rivolgono al pubblico recitando in versi, avvertendolo dell’inizio della rappresentazione e scusandosi anticipatamente se le attrici scelte per i ruoli non sapranno tenere a mente le battute: in fondo siamo in un manicomio, e per quanto gli intelletti chiamati in causa non manchino di ingegno, si tratta di poco più che una rappresentazione amatoriale. È questo l’inizio – letterale e rimato – del testo di Peter Weiss La persecuzione e l’assassinio di JeanPaul Marat, rappresentati dai filodrammatici dell’ospizio di Charenton, sotto la guida del marchese De Sade. Ed è questo anche l’incipit dello spettacolo diretto da Andrea Felici, FurioMarat, che ha debuttato al teatro Furio Camillo di Roma il 18 dicembre. Se è vero che il panorama artistico romano è un alveo della ricerca dove da tempo si sperimenta una non-recitazione, che trova la sua incisività espressiva nel suo volersi “sgonfia” e antideclamatoria; allora la scelta di tre brave attrici della scena capitolina (Fiora Blasi, Giovanna Conforto e Simona Senzacqua) ben si sposa con la temperatura voluta dallo stesso Weiss, che definiva gli allestimenti teatrali del marchese De Sade nel manicomio di Charenton – istituto dove venivano confinati i soggetti socialmente indesiderati, oltre che i malati di mente veri e propri, in cui il divin marchese fu internato dal 1801 fino alla sua morte – delle rappresentazioni poco più che dilettantesche, “esercizi declamatori nello stile dell’epoca”. Tuttavia, se la rifrazione voluta da Weiss era orientata a interrogare il pubblico – oltre che a mettere a confronto il violento padre della patria francese, il rivoluzionario precursore del socialismo, con il libertino campione dell’individualismo, accusatore della decadenza dell’ancien régime che giunse a sostenere Marat, è vero, ma restando istintivamente diffidente verso ogni forma di totalitarismo – a questo meccanismo, pur smontato, non si sottrae FurioMarat. Se la figura di De Sade si dissolve, allora i rantoli e le invettive del cadente protagonista della rivoluzione, costretto a lunghi bagni per alleviare la dermatosi di cui soffriva, è proprio verso gli spettatori che si indirizzano, pubblico due volte di un opera nell’opera, rifrazione voyeuristica che è la cifra più profonda della società odierna, che alle molteplici crisi che la sovrastano risponde il più delle volte con l’inazione, una società in cui l’individualismo portato alle estreme conseguenze non è più eccezione né provocazione, ma costume diffuso. L’interrogativo che lo spettacolo produce, allora, scaturisce direttamente dal gesto di portare a teatro proprio oggi la figura di Marat e un testo di oltre quarant’anni fa. Un interrogativo che si sofferma sulle macerie della politica cavalcando le parole dell’eroe di una rivoluzione che ha divorato i suoi stessi figli («Abbiamo inventato la rivoluzione, ma non sappiamo ancora come governarla…»), sola figura in grado, pur nel declino fisico e spirituale, di strapparci al torpore dei “ma anche” e di ricordarci che i rischi delle tensioni sociali non si dissolvono nella normalizzazione del dibattito pubblico. «Credete che i ricchi daranno spontaneamente la propria ricchezza agli altri? Non se ne può uscire senza la violenza», urla Marat tra gli spasmi delle convulsioni; ma lo spettro che agita di fronte al suo auditorio non è quello della degenerazione della protesta, quanto della violenza delle pressioni che il dissenso può subire prima che cambi la sua forma. forse ad interrogare una gestione del potere tradizionalmente maschile. Il registro quasi comico, quando non grottesco, del manicomio inscenato dalle tre attrici, che si avvalgono di pochi oggetti continuamente ridefiniti, un appendiabiti e una poltrona pensile, convive con l’universo perturbante che scaturisce dalla danza. Due mondi, due manicomi, divisi da un corridoio di vetro che taglia la scena in diagonale, all’interno del quale si muovono i corpi agonizzanti delle tre internate-danzatrici, che battono ossessivamente il piede, si contorcono su se stesse, o semplicemente si aggirano dietro i riflessi del vetro, dando alla propria presenza una consistenza ectoplasmatica. Due universi che viaggiano su registri quasi opposti, che sembrano procedere su binari paralleli e solo alla fine trasgrediscono le geometrie che li separano. E se questo accostamento di registri, a volte stridente, che non si scioglie in un segno estetico unitario, è forse il nodo meno risolto dello spettacolo, è però in certi momenti anche il suo punto di forza, in grado di far collassare vicendevolmente la tragedia nella farsa, dando vita a un ulteriore rifrazione/confronto che stavolta chiama in causa i termini di una celebre considerazione di Karl Marx sui corsi e ricorsi della storia. Certo non si tratta di una scelta casuale, ma anzi di un interrogativo che è stato alla base del lavoro di ricerca intrapreso lungo le tante bisettrici che attraversano questo testo. Si legge, infatti, nelle note di regia: «La purezza essenziale della danza butoh agisce e reagisce con la teatralità ibrida e stratificata nel tempo e nei generi del bagaglio dell’attore. Possono mondi apparentemente opposti, come l’essenza e la storia, il corpo e la parola, la profondità e la banalità, la sanità e la follia, trovare luoghi di confine dove guardarsi in faccia e magari sovrapporsi? Forse sì, forse no…». La seconda repubblica di Filippo II Estremamente attuale il “Don Carlo” che ha aperto la stagione della Scala di Gian Maria Tosatti FurioMarat è il risultato di un percorso di ricerca intrapreso al Furio Camillo nel 2007, e non a caso di questo luogo non neutro di produzione porta nel titolo il marchio di fabbrica. Un’operazione che sceglie di interrogare il testo (e il suo meccanismo) interrogando anzitutto se stessa: così, accanto alla presenza delle attrici, troviamo l’accostamento di alcuni degli artisti che hanno animato storicamente questo luminoso epicentro della ricerca romana: dal regista Felici, che ne è condirettore artistico, alla formazione Adama, che raccoglie le danzatrici butoh Alessandra Cristiani, Maddalena Gana e Samantha Marenzi. Le figure in scena, tutte femminili, si moltiplicano, andando La Scala non avrebbe potuto aprire con opera più appropriata in questo 2008. Le trame di un intero anno, fino a quelle degli ultimissimi giorni, sembrano intrecciarsi alla vicenda di Don Carlo e della Spagna controriformista. Il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, sul palco del più prestigioso teatro del mondo inizia una rappresentazione cui effettivamente pochi hanno prestato attenzione. Si è molto parlato dei vari accidenti occorsi prima dell’alzata di sipario e sono stati ripresi (quando non direttamente fatti) sui giornali i commenti più imbecilli, cui ha risposto la dignità di Daniele Gatti e degli artisti che sul palcoscenico sono stati sommersi da fischi che avevano la stessa tonalità del grande rumore di fondo che in Italia si produce in ogni piazza mediatica per opera di politicanti urlatori e dame da salotto sdrucito (tale è quella contessa che ha avuto il gusto di dichiararsi “infastidita” dalla stazza del tenore Stuart Neill affermando che a terra «sembrava una balena arenata»). Eppure proprio la figura di Neill è la prima chiave sensibile di un’edizione estremamente efficace di quest’opera che in fondo parla della difficoltà di rispondere alla chiamata eroica. Conoscendo, infatti, la storia spagnola e poi il libretto, vien da dire che non è il tenore ad essere fuori misura, quanto appunto Don Carlo, un ragazzo ventenne cui è chiesto un coraggio che neppure suo padre, l’uomo forse più potente della terra, possiede – quello di difendere il primato imperiale di fronte a quello ecclesiastico facendo cessare le persecuzioni e l’autodafé del popolo fiammingo di confessione calvinista. Eccolo Carlo entrare in scena e poi il suo amico d’infanzia Rodrigo, vero eroe della vicenda. Quest’ultimo elegge l’Infante salvatore degli oppressi dall’Inquisizione. Un auspicio che mostra tutti i suoi limiti già nel primo dialogo fra i due, in cui la mente di Carlo sembra già stremata dal peso delle sue umane passioni. Ancora una volta nel bellissimo duetto “Dio che nell’alma infondere”, giureranno fedeltà alla loro amicizia e alla causa della libertà. E in questa scena è già tutto chiaro quel che in quest’allestimento diventa addirittura cristallino, complice la sensibilità di Neill, capace di rendere con l’ottima voce e la recitazione estremamente credibile la figura di un Carlo perennemente vacillante, perennemente in disequilibrio, un Carlo appunto imprigionato in una figura troppo grande e ingombrante. Lui e Rodrigo (un ottimo Dalibor Jenis) si stringono e sullo sfondo si ripete come in un flashback dell’infanzia quella stessa ritualità di gesti che i due da bambini avevano già fissato preparandosi ad entrare nei rispettivi ruoli di eroi eletti dalla Storia. Basterebbe questa scena, la migliore mai riuscita nella rassegna degli allestimenti di quest’opera, per giudicare la regia di Stéphane Braunschweig come uno strumento affilato tanto da entrare fino in fondo nei risvolti dell’opera. Ed è appunto in questo paragone, fra i due bambini che giurano con sicurezza incrociando le spade di legno e i due adulti in cui l’abbraccio di Rodrigo sembra lasciare senza forze Carlo, che si consuma già l’intera tensione dell’opera verdiana. Davanti a Carlo, si apre la prospettiva della Storia e lui l’osserva quasi impietrito, sentendosi troppo debole e forse troppo distratto per affrontarla. Opposte vacillante volontà dell’Infante, che viene subito disarmata dalla sua stessa isteria per mano dell’amico Rodrigo, le figure del re (un Ferruccio Furlanetto che domina le proprie sfumature meglio di quando esordì nel ruolo con Karajan nell’’86) e del Grande inquisitore, uno di fronte all’altro nel celebre duetto di bassi del terzo atto, sembrano due titani troppo forti perché si possa anche solo respirare sotto il peso della loro ombra. E proprio in questo dialogo tesissimo, diretto e chiaro come una odierna intercettazione telefonica, in cui il testo e la musica danno il meglio di sé, i due rappresentanti del potere decidono (in uno scambio di favori) la castrazione (attraverso la morte di Carlo e Rodrigo) delle nuove generazioni e del “pensiero novator”. L’epilogo è scontato, l’uccisione di Rodrigo che vede ancora una volta Carlo perdere la lucidità e infine la morte dell’Infante, salvato dalle grinfie del padre dalla visione di Carlo V che esce dalla sua tomba per strappare il nipote alla scelleratezza degli uomini, ci porta al lamento ed al silenzio in cui da anni si spengono gli aneliti delle nostre generazioni, schiacciate da un’Italia cupa, in cui le foto dei grandi vecchi sui giornali non differiscono troppo dalla rassegna di opprimenti teste coronate che all’epoca dei fatti si affacciavano dai ritratti sfondo nero. Eh già, dunque, l’epoca dei fatti. Siamo negli anni in cui Dostoevskij scrive la sua versione del Grande Inquisitore, ossia in quel particolare momento della storia in cui per chiunque, per Gesù Cristo stesso, risorto nel racconto russo, trovare un posto nella storia sembra impossibile. E non è per la violenza repressiva dei roghi, quanto appunto per la cappa oscura di superstizione e timore che ha coperto l’occidente per oltre un secolo fino a sembrare un muro di gomma contro cui s’annulla ogni speranza di cambiamento. Visto in questa prospettiva Carlo dunque non può sembrare un egoista quanto un uomo mutilato nell’anima dal proprio tempo, a cui non è rimasto che il cuore e il suo dolore primordiale, l’unico che sia ancora in grado di sentire. Soccomberà allora per l’impossibilità di farsi trovare eroe di fronte alla Storia e soccomberà anche Rodrigo, mente miracolosa, illuminata in un tempo buio, che fino all’ultimo darà la vita nella speranza che l’amico possa spogliare l’autorità che opprime il proprio popolo e dare una nuova speranza a spagnoli e fiamminghi. Così si chiude una delle opere più scure e amare del repertorio verdiano e non solo. In sala i giornalisti raccolgono i commenti del parterre de rois della prima. Molti, fra i più politici, accusano l’allestimento di eccessiva cupezza, dichiarando che in questo momento di crisi ci sarebbe voluto maggiore ottimismo. I giornalisti non si fanno scrupolo di riportarlo nei loro articoli, quasi fosse un’osservazione sensata. E in effetti, la regia di Braunschweig un peccato lo commette. Ambientando l’opera nel suo giusto tempo dimostra di aver confidato nel fatto che il pubblico avesse quel minimo di acume che accecò d’ira e di rimorso re Claudio di fronte al teatro dei comici istruiti da Amleto. Ma è un peccato veniale, perché tale è stato solo il giorno della prima. All’anteprima con gli studenti non è stato lo stesso e neppure gli altri giorni. muro di Berlino e ha infine faticosamente introiettato la nuova dottrina riformista. In un continuo ed esilarante dialogo telefonico con Veltroni, che lo chiama per farsi consigliare sulle strategie comunicative, Zoro fa emergere con folgorante ironia il grande rimpianto della sinistra italiana: l’assenza di un leader. A partire dalla concezione leninista del partito e della sua funzione di avanguardia, il tarlo del militante comunista è sempre stata la linea da seguire, dettata da un capo carismatico, colui che avrebbe guidato le masse rivoluzionarie fino alla terra promessa del socialismo realizzato. Una delle satire più divertenti di questa fede quasi messianica la fa Roberto Benigni in uno dei suoi primi film, Berlinguer ti voglio bene, del 1977, dove l’ossessione di Cioni Mario arriva a fargli attaccare la foto di Enrico Berlinguer, allora segretario del Pci, sulla testa di uno spaventapasseri, per poterci parlare liberamente nei suoi soliloqui in mezzo alla campagna. In una delle scene più divertenti del film Mario, in cantiere coi colleghi, si dice convinto che prima o poi il grande capo darà “il segnale”: andrà in televisione, col suo fare deferente, e poi di colpo dirà “Via!” e sarà finalmente l’inizio della agognata rivoluzione. Cercasi leader disperatamente Dal blog al programma della Dandini l’iperbole veltroniana raccontata da Zoro di Graziano Graziani Barba di qualche giorno, capelli a zero e l’espressione a cavallo tra lo scoramento di chi naviga a vista nella politica di oggi e il sarcasmo un po’ sbruffone e molto romanesco, Zoro si affaccia dal web con le sue disavventure in pillole di un militante del PD, che faticosamente segue le evoluzioni funamboliche ed elettoralmente disastrose del – malgrado tutto – “suo” partito. Nel suo “saltuario di informazione e opinionistica estremamente personale”, Diego Bianchi ha dato vita a una web tv satirica imperniata sul personaggio di Zoro, il suo alter ego mediatico che decripta il linguaggio sempre più edulcorato di politica e tv grazie a una buona dose di romanità e sarcasmo. In Tolleranza Zoro, che ha debuttato su un blog all’indomani della nascita del Partito Democratico e che oggi è un diario settimanale al programma Parla con me, Zoro segue con crescente apprensione l’ennesima mutazione genetica della sinistra, sempre più confusa anche per chi come lui ha avuto un passato da militante comunista, si è dovuto confrontare col crollo del Con uno stile diverso, ma un registro ugualmente iperbolico, Diego Bianchi alias Zoro ironizza sulla fiducia verso il partito (non più comunista, ma comunque “il partito”) e sul suo condottiero, Walter l’americano, che guarda a Obama ma che a differenza del presidente U.S.A. perde le elezioni. E se al telefono con il grande capo e i suoi “dirigenti delle risorse umane” Zoro sprizza ottimismo riformista e moderno lessico da top menager (in una puntata sogna persino di arringare i militanti come Luca Luciani, il manager telecom della gaffe sul “capolavoro di Napoleone a Waterloo”), quando chiama gli amici svela tutti i suoi dubbi sulla linea del segretario e su un partito così edulcorato da non sembrare più così tanto di sinistra… Nell’iperbole di Zoro, il “grande capo” del “grande partito democratico” si rovescia in un uomo ossessionato dall’immagine, ma che nonostante le sue grandi manovre comunicative e politiche alla fin fine non ne azzecca una. E se pian piano si fa strada il sospetto che la strategia politica non sia più tanto chiara, e si sia piuttosto striminzita fino a diventare misera tattica di sopravvivenza; allo stesso modo la figura del grande leader rimpicciolisce, fino a trasformarsi in quella di un capitano che naviga a vista, al quale ci si riferisce con bonaria esasperazione, facendo spallucce. torna il lavoro e la salute per tutti, e trionfa la giustizia (se non quella proletaria, almeno quella ordinaria). Insomma, un finale da vissero tutti felici e contenti. Finché si sta nel mondo delle favole, ci si può pure credere. The Amazing Mr. George Bush Super Shoe Quando una scarpa serve per fare il primo passo in una nuova direzione di Emanuele Giordana Sul suo blog, dedicato agli arabi invisibili Paola Caridi ha scritto che «...tra gli arabi non si parla d'altro. E non sorprende che in Iraq vi siano state manifestazioni in cui si brandivano scarpe come si sarebbero brandite spade. Muntazer al Zaidi, il giornalista iracheno che ha tirato non una, bensì due scarpe a Bush, in una situazione di assoluto controllo da parte delle forze di sicurezza, è ora l'eroe della strada. Di quella strada araba per la quale - citazioni sentite con le mie orecchie ai quattro angoli del mondo arabo negli scorsi sette anni e mezzo - Bush è solo e unicamente un criminale di guerra, nonché il sostenitore di regimi (arabi) non democratici. Muntazer, insomma, ha vendicato l'opinione pubblica araba, contravvenendo - come scrive il libanese Daily Star, al primo dovere di un arabo: l'ospitalità». Per questo l’unico guizzo in grado di smarcarsi dalla disillusione arriva quando D’Alema, ospite da Crozza che gli chiede di commentare la frase di Berlusconi che lo definisce “il più comunista” di tutti, risponde che sì, probabilmente è vero. Qualcosa scatta nella testa di Zoro, che esulta come se avesse segnato la sua squadra del cuore. È il segnale. Se lo fa D’Alema, significa che si può finalmente tornare a dirsi “comunisti”. Significa che tutto è tornato chiaro, e ci si può finalmente disfare dell’armamentario riformista che per tutti questi anni è andato così stretto… Ma è un’esuberanza che dura poco: squilla il telefono, è Walter, e allora tocca dissimulare e dire che è proprio una storiaccia quella di D’Alema che torna a parlare di comunismo… In fondo il vero militante è quello che è fedele alla linea, anche quando non c’è (come cantavano i CCCP). Così si torna a stringere i denti quando si perde in Abruzzo, e ad avere i mal di pancia se arrestano gli esponenti del PD per corruzione. La questione morale sarà anche reale, ma quello che più conta è che fa perdere le elezioni (“La Jervolino non schioda, Bassolino non schioda, Villani non schioda, Bettini non schioda. Più radicati nel territorio di così…”). E allora, visto che sono tempi duri ma che siamo pur sempre sotto Natale, non resta che affidarsi alle favole: quella del Principe Walter, che guida le forze del bene contro il malvagio Cavaliere Silvio. Quando il piccolo principe, sul suo bianco cavallo riformista, sconfigge le forze del male, Se esistono ancora gli eroi è una domanda ricorrente. Muntazer al Zaidi lo è. Sarà ricordato per le scarpe e non forse per i suoi articoli ma alla fine è il coraggio, il coraggio di dirla tutta rischiando, com'è successo, le botte e la galera, che piace all'uomo della strada e non solo araba. Gli eroi son quelli che noi non siamo. Sono il nostro compagno delle elementari che ha difeso quel tale davanti a uno delle medie; sono quella ragazza che disse in faccia al preside che la scuola è nostra; sono quel tipo che ha rinunciato alla promozione perché la gente non si compra; sono quella giovane collega che ha detto al capufficio di tener giù le mani. Son quello, quella, quelli che parlano quando stiamo zitti e dicono le cose al nostro posto. Siamo loro grati, che tirino le scarpe o anche solo una saracca che non abbiamo il coraggio di pronunciare. L'eroe è sempre stato e sempre sarà. Non è solo una necessità dei tempi bui, è il toccasana che ci fa sorridere o piangere, che muove i sentimenti e che, soprattutto, si è esposto quando nessuno aveva il coraggio, la voglia, l'energia per farlo. Il bisogno di eroismo può essere una malattia indotta dall'arma potente della propaganda che innesta miti e valori studiati a tavolino. Ma gli eroi sani son altra cosa. Vengon fuori così quando meno te lo aspetti e forse neppure loro ci avevano poi pensato su. Quel gesto della scarpa non ha fatto solo il giro del mondo dalle nostre parti o nell'area del Mediterraneo-Medio oriente. Se lo sono goduto in mezzo mondo, ché oggi youtube lo vedono anche nelle favelas. E non è morta li. Il giorno dopo Bush era in Afghanistan e i giornalisti afgani lo han preso in giro mostrandogli le scarpe. Non le han tirate, ma quando alla conferenza stampa il funzionario afgano ha detto che al presidente bisognava rivolgersi col titolo di “sua eccellenza”, i giornalisti gli hanno rivolto le domande chiamandolo “Mister Bush”. Erano altrettante scarpe e più difficili da evitare. E' che il gesto dell'eroe, non solo è eroico in sé, nell'atto di tirare la scarpa o, come Enrico Toti, in quello di gettare la stampella contro il nemico (eroismo subito diventato icona della propaganda militare). E' che poi producono, gli eroi sani, un effetto a catena. Smascherano il re e quando il re viene sbeffeggiato allora tutta la corte, e il popolino, finalmente possono farlo. Grazie Muntazer al Zaidi. Più potente di Kruscev alle Nazioni Unite, più esilarante di Wolfowitz che si leva le scarpe alla moschea di Istanbul e rivela i buchi nei calzini, più elegante di una decolleté di Gucci, più magico della favola della scarpina di Cenerentola. L'eroe è eroe quando ci libera liberandosi. Facendoci sognare. E andare a letto felici anche stasera di render liberi i piedi dalle scarpe. la differenza settimanale di cultura on-line su www.differenza.org direttore responsabile Gian Maria Tosatti in redazione Graziano Graziani, Attilio Scarpellini, Mariateresa Surianello. La rivista è finanziata nell'ambito del progetto Scenari Indipendenti, promosso dalla Provincia di Roma in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio.
Scarica