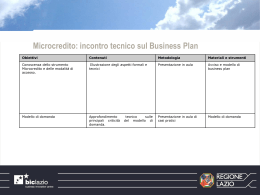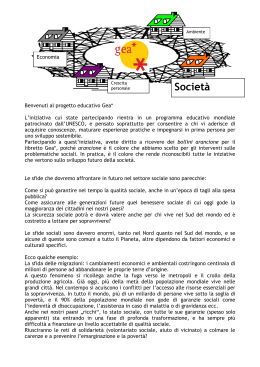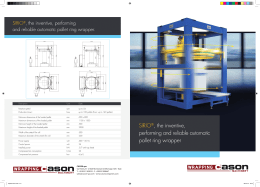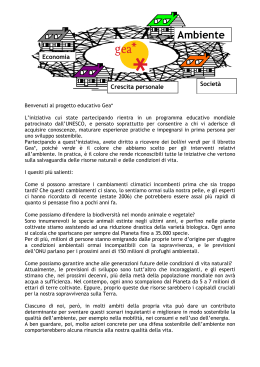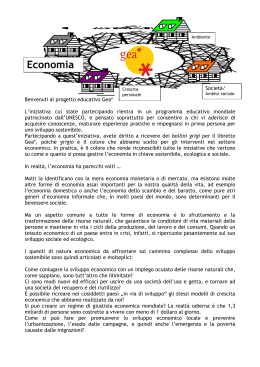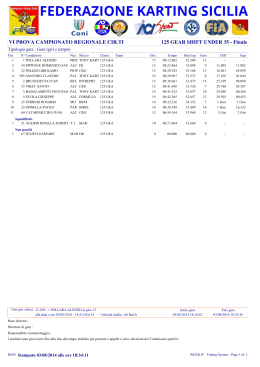A-A- CHILDREN’S CHARITY dossier NUOVA COOPERAZIONE Cinque piste per ripartire Questo è il primo capitolo di un dibattito, che si spera profondo, sulla cooperazione con il sud del mondo. Attività che, assieme alle risorse, sembra aver perduto anche l’interesse dell’opinione pubblica. Ha ancora senso lavorare in questo campo? C’è chi dice sì. Ma con quali mezzi e con quali obiettivi? Questo dossier prova a indicarli. Andrea Camperio Ciani dossier 39-56 dicembre doss2010.indd 39 23-11-2010 9:33:23 Nuova cooperazione Sono tempi duri per la cooperazione internazionale decentrata italiana. Duri e bui. Manca la progettazione. Fa difetto la ricerca. Gli schemi e i paradigmi applicati sono vecchi di decenni: alcuni non funzionano, ma continuano a ripetersi. In un’epoca di continue crisi economiche e finanziarie, l’aiuto al sud del mondo e al suo sviluppo è lasciato nelle mani di volontari mal sostenuti e mal pagati. Ma da questo vicolo cieco si può uscire. Ricominciamo c Q L’autore, con la sua ultima figlia, in Marocco. GEA / E. PELLIZZARI Andrea Camperio Ciani* ueste pagine si concentrano sulla cooperazione internazionale decentrata, cioè quella fatta in collaborazione con le piccole organizzazioni non governative (ong). Non sulla grande cooperazione internazionale fra paesi, regolata dal Fondo monetario internazionale e da accordi commerciali. Nigrizia ha più volte trattato questa seconda cooperazione, mostrando come essa strangoli e impoverisca i paesi più deboli. È emblematico che una delle regioni più ricche e potenti d’Italia, il Veneto, destini solo 800mila euro l’anno a progetti di associazioni e ong di cooperazione, mentre la sola provincia autonoma di Trento ne destini ben 5 milioni. Perché? Semplicemente perché la provincia di Trento è a statuto speciale? Oppure perché vede un po’ più lontano del Veneto? La cooperazione internazionale non è ancora una scienza, purtroppo. Ma lo deve diventare, se vogliamo aumentarne l’efficacia, ridurne gli sprechi, incrementare la partecipazione, il contributo e l’appoggio della società civile, oggi molto scettica al riguardo. La cooperazione del Veneto, con i suoi 800mila euro, co-finanzia circa 20 progetti al 50%, con un processo abbastanza trasparente, basato su un sistema a punti. Lo stesso tipo di progetti (per dimensioni, obiettivi e numero di beneficiari) che la regione finanzia è anche * Presidente e coordinatore scientifico dell’Aps Gea Onlus, Associazione internazionale per lo studio e la conservazione degli ecosistemi. Professore associato di etologia e psicologia evoluzionistica presso la Facoltà di psicologia di Padova, con 13 anni di esperienza d’insegnamento universitario e 25 di esperienza sul campo in progetti ambientali e di ricerca. Oggi dirige e conduce progetti di monitoraggio ambientale e di cooperazione allo sviluppo prevalentemente fra i nomadi del Nord Africa e tra le comunità emarginate del sud-est asiatico. 39-56 dicembre doss2010.indd 40 23-11-2010 9:33:34 Ko Lipeh (Thailandia). Si analizza l’acqua inquinata dei pozzi. volte superiori. Difficile non sospettare che, se la regione Veneto dà il 50 % di poco, forse il ministero, con le sue ong accreditate, spreca il 100% di qualcosa. I finanziamenti del Mae sono accessibili alle sole ong accreditate presso di esso. Ottenere l’accreditamento non è una procedura facile. Qualità e dimensioni non c’entrano: ong piccolissime e sconosciute sono accreditate; altre, ben più operose, no. Solo nel nostro paese si ha la seguente contraddizione: per essere finanziati come associazione “non governativa” si deve essere accreditati da un ministero governativo. BANDI PERVERSI Sprechi e cattive abitudini non si registrano solo in termini di denaro. Spesso c’è anche sciupio di energie e risorse umane. Stanchi di presentare agli enti regionali miseri progetti per la cooperazione Microcredito e cooperazione o così SOWESTIMEAST.FILES.WORDPRESS.COM finanziato dalla divisione cooperazione internazionale del ministero degli affari esteri (Mae). Ma c’è una differenza: quest’ultimo, in media, destina cifre 15-20 GEA / A. CAMPERIO CIANI S ono passati quasi due decenni dalla Conferenza di Rio de Janeiro sull’ambiente (1992), dove si coniò e promosse l’espressione sviluppo sostenibile. Da allora, l’espressione è stata usata e abusata: tutti dicono di sapere cos’è, ma nessuno sa come si realizza. Forse, sviluppo sostenibile è un concetto impossibile ma bello. Quindi, può essere un buon programma di ricerca. La ricerca nel mondo della cooperazione ha prodotto un Nobel: quello dato nel 2006 al bengalese Muhammad Yunus, “il banchiere dei poveri”, per lo sviluppo della sua Grameen Bank e la formalizzazione del concetto di microcredito. Sufia Khatuman prendeva in prestito soldi per costruire sgabelli di bambù, che poi Microcredito in Bangladesh. vendeva. L’esorbitante tasso d’interesse che le veniva richiesto e l’essere costretta a vendere il prodotto alla stessa persona che le prestava il denaro (e al prezzo da questa stabilito) riducevano il guadagno a 2 cent di dollaro per sgabello. Commenta Yunus: «Non potevo accettare che una qualunque persona potesse ricavare tanto poco da un’attività così faticosa e creativa». Tutto ciò di cui Sufia aveva bisogno per uscire dalla sua povertà era il denaro per comperare il bambù: 20 centesimi di dollaro. Yunus scoprì che vi erano altre 42 persone nelle stesse condizioni e decise di prestare quei pochi dollari di tasca sua. Gli studenti che lo assistevano nella ricerca spiegarono a Sufia e alle altre donne che ciò che stavano ricevendo era un credito, e quindi doveva essere restituito. Potevano, però, vendere i loro manufatti a prezzo libero. Nacque così il microcredito, come strumento di sviluppo economico che permette alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione di avere accesso ai servizi finanziari. L’idea ha rivoluzionato il mondo di un’infinità di individui e di comunità povere, sia rurali che urbane. Il microcredito è stato il frutto di una lunga ricerca, di serie sperimentazioni, di profonde verifiche dei risultati e di schiette valutazione dei suoi limiti. Ma quando il microcredito è stato applicato dalla cooperazione internazionale su larga scala, i limiti e i prerequisiti, fortemente sottolineati dal banchiere bengalese, sono stati rapidamente dimenticati. E così, il microcredito, pur avendo avuto successi incontestabili, ha fallito in importanti contesti. dossier 39-56 dicembre doss2010.indd 41 23-11-2010 9:33:42 Nuova cooperazione decentrata e impossibilitati a sottoporne al Mae, ci siamo rivolti al prestigioso Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite (Undp). Ci eravamo imbattuti in un bando che sembrava fatto apposta per noi: Migration4Development (“migrazione in cambio di sviluppo”). Met- teva a disposizione 1 milione di euro per «progetti innovativi, mirati ai migranti, intesi come risorsa e come prospettiva di sviluppo sia per i paesi di origine che per quelli di destinazione». Peccato che la burocrazia del progetto richiedesse un “consorzio” di almeno tre enti del paese GEA / V. PASQUALETTI Volontari presso il gruppo nomade sakai, in Malaysia. europeo e altrettanti del paese di origine dei migranti. Abbiamo associato la nostra piccola ong, Associazione internazionale per lo studio e la conservazione degli ecosistemi (Aps Gea onlus), con il comune di Padova e con un’associazione marocchina che opera nel nostro territorio; in Marocco, abbiamo mobilitato un dipartimento universitario, una grande ong locale e un’associazione di insegnanti. Preciso l’obiettivo: “riciclare” i migranti di ritorno in Marocco, prima con un periodo di formazione a Padova, poi attraverso la loro partecipazione a progetti sociali e di sviluppo, in vista di una loro riqualificazione come “mediatori culturali” e/o “operatori sociali” in patria. Per pianificare ogni cosa, impiegammo tre mesi, con corsi di formazione e incontri di coordinamento fra paese di origine e di destinazione. In Italia spendemmo 3.000 euro; altrettanto spesero (in valuta locale) i nostri partner marocchini. In totale: circa 6.000 euro e sei “mesi uomo” di lavoro, solo per presentare la proposta all’Undp. Dopo molti mesi, la risposta definitiva: «Non avete “meritato” il finanziamento, ma siamo molto fieri della vasta partecipazione al bando». Scoprimmo I rischi del volontario I n una recente ricerca, condotta da un mio laureato, Mattia Garau, si rileva che nei pochi corsi di master e specializzazione in cooperazione internazionale, le materie psicologiche sono solo l’1 o il 2% di quelle trattate. Mentre la psicologia ignora la cooperazione allo sviluppo, le ong che se ne occupano non conoscono le potenzialità e l’utilità dell’approccio psicologico, sia per la riuscita dei progetti sia per i bisogni dei volontari, spesso smarriti. I volontari vanno formati e addestrati a rispondere ai problemi che incontreranno sul campo. Necessitano di stage formativi prima di partire. Durante l’attuazione del progetto, vanno assistiti da persone di esperienza. Concluso il progetto, è bene aiutarli a reinserirsi nella quotidianità della vita in patria. In tutto questo, la psicologia è fondamentale. Molti operatori umanitari, soprattutto se volontari e impiegati in situazioni drammatiche, anche se per breve tempo, possono riportare shock di vario genere. Non è sempre facile cooperare a un progetto di emergenza in situazioni di guerra, fame, carestia o disastro naturale. Noti sono gli esiti patologici di processi stressogeni che colpiscono le persone che esercitano professioni di aiuto, quando non rispondono in maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il lavoro le porta ad assume- re. Oggi, tra i volontari di ritorno, si registrano sindromi da burn out (“bruciarsi”) o da stress post-traumatico o acuto, con conseguenti cadute nell’alcolismo e nella tossicodipendenza. Eppure, molte ong sembrano ignorare tutto questo e continuano a comportarsi come se i volontari da esse impiegati fossero individui invincibili. Delle 32 ong accredidate presso il Mae, 30 hanno risposto al questionario inviato da Garau, ma solo 2 hanno riconosciuto la presenza di problemi psicologici tra i loro volontari e hanno ammesso di averli dovuti assistere a livello psicologico. Queste 30 associazioni, dalla loro fondazione ad oggi, hanno inviato oltre 28.000 operatori a lavorare nei progetti più diversi e rischiosi. Delle due, una: o hanno davvero avuto volontari di ferro, o non si preoccupano di questi problemi riscontrati nei loro volontari. Il volontario è disponibile e generoso, ma va aiutato e inquadrato. Il suo lavoro è fondamentale, utile ed economico, ma dev’essere sostenuto. Questo lavoro di sostegno può essere svolto da un volontario più esperto; più sovente, è necessario un professionista, cioè qualcuno che ha sviluppato competenze specifiche per assistere, inquadrare e sostenere il volontario prima, durante e dopo la realizzazione del progetto. 42/43 39-56 dicembre doss2010.indd 42 23-11-2010 9:33:55 GEA/ M. DELL’AMICO GEA/ M. DELL’AMICO Volontari conducono autorità marocchine a visitare i pozzi abusivi. Volontari intervistano una famiglia berbera. che oltre 500 “consorzi” avevano presentato progetti, di cui solo 10 erano stati giudicati degni di finanziamento: 100.000 euro ciascuno. Facciamo un po’ di conti. Se tutti i 500 consorzi avevano speso, in media, il tempo e il denaro che avevamo speso noi, il totale delle energie e delle finanze usate dalle ong (europee e del sud del mondo) ammontava a 3 milioni di euro e a 3.000 “mesi uomo”. Il sistema di fare spendere 3 milioni di euro per ottenerne 1 – suddiviso tra dieci fortunati – è più perverso di una lotteria. Questa, almeno, serve a finanziare lo stato. Quello spreco, invece, non finanziò nulla: servì solo a impoverire e deludere deboli e fragili ong impegnate nel settore della cooperazione internazionale. Il mio collega Loris Patentini critica questi bandi demenziali, perché incoraggiano la pessima abitudine di alcune ong di farsi improntare, a basso costo, i progetti da “professionisti”, i quali scriBamako (Mali). Ciò che rimane della cooperazione italiana. vono bene ma non conoscono nulla di concreto. Guai, poi, se questi progetti ottengono il finanziamento solo perché ben confezionati e “logici”, ma proposti a totale insaputa dei beneficiari. L’insuccesso è garantito. RICERCA? ASSENTE! Va ribadita la necessità della ricerca nella cooperazione. Non c’è ancora un solo ente finanziatore pronto a sostenere tale ricerca. Invece è necessario confrontare scientificamente i metodi impiegati, valutarne l’efficacia relativa e identificare le cause del fallimento o successo di un progetto. Ad esempio, ci sembra fondamentale sapere quando è opportuno utilizzare una procedura come il microcredito e quando, invece, è più utile usare tecniche di microimpresa. I progetti di ricerca devono essere condotti “sul campo”, per capire cosa davvero funziona, in quali contesti e con quali dinamiche, e soprattutto che risultati possiamo aspettarci. Queste indagini sono la base necessaria per lo sviluppo successivo di progetti su larga scala. Eppure, le università se ne occupano poco. Serve un training professionale degli operatori umanitari (aid workers). Troppo spesso questi sono gettati allo sbaraglio in contesti imprevedibili e altamente delicati, con il rischio che danneggino il tessuto sociale, invece di produrre gli auspicati benefici. Se ci fosse chiesto in quale ambito la ricerca sulla cooperazione dovrebbe essere sviluppata, la nostra risposta è precisa: nella psicologia. La cooperazione è una materia interdisciplinare in cui confluiscono economia, agraria, ingegneria, scienze politiche e sociali (e altre ancora), ma ha come oggetto le persone: il loro modo di pensare, i loro valori, le loro credenze, i loro pregiudizi, le loro illusioni cognitive, le loro dinamiche all’interno della comunità, il loro più o meno forte senso di appartenenza a un gruppo. Questo dovrebbe essere il pane quotidiano della psicologia di comunità, della psicologia sociale e della psicologia evoluzionistica. L’oggetto della cooperazione deve essere approfondito da chi si occupa di persone, di comunità e di processi mentali. Perché i progetti di cooperazione abbiano successo e possano almeno avvicinarsi allo “sviluppo sostenibile”, la nostra esperienza sul campo ci propone una “ricetta”, che si coniuga in cinque concetti: • partecipazione della comunità alla costruzione del progetto; • condivisione della comunità locale con gli obiettivi del progetto; • formazione permanente di chi partecipa al progetto; • basso costo del progetto e volontariato animato da efficaci figure professionali; • auto-implementazione, ovvero il progetto deve mirare ad automantenersi nel tempo. Sono i titoli dei capitoli di questo dossier. DGIANNI.BLOGSPOT.COM dossier 39-56 dicembre doss2010.indd 43 23-11-2010 9:34:07 Nuova cooperazione PARTECIPAZIONE Berberi apicoltori Marocco. Pastore berbero. Come arginare un problema di desertificazione sui monti dell’Atlante (Marocco), dialogando con i pastori nomadi e “rottamando” l’allevamento delle capre. GEA/ M. DELL’AMICO I l concetto di partecipazione può sembrare banale. È chiaro, infatti, che la partecipazione alle azioni di un progetto è importante per tutti. Nelle nostre ricerche, però, abbiamo visto che la questione è molto più complessa. Allo stato attuale, ai progetti che vengono finanziati è richiesta la swot analysis [analisi che evidenzia i punti di forza (strengths) e di debolezza (weaknesses), al fine di fare emergere le opportunità (opportunities) e le minacce (threats) che Marocco. Le capre sono tra le prime cause della desertificazione. Medio Atlante (Marocco). Le scimmie diminuiscono, mentre le capre e i montoni aumentano. GEA / E. FERROELLI derivano dal contesto esterno in cui sono esposte le specifiche realtà settoriali] e il logical framework (inquadramento logico del flusso dei vari passi che il progetto percorre). Le due tecniche sono sofisticate e ben sviluppate e tutte le ong ne GEA / R. SCHEMBRI 44/45 39-56 dicembre doss2010.indd 44 23-11-2010 9:34:14 Marocco. Pastori berberi, di notte, imparano a gestire le api. che vivono sui monti dell’Atlante in Marocco. In entrambi i casi la popolazione ci ha dato informazioni imprevedibili ma essenziali per la riuscita del nostro progetto che né la swot analysis né il logical framework avrebbero mai individuato. ARNIE TRANSUMANTI Il caso dei nomadi berberi è significativo. Dai nostri studi di monitoraggio sulla regione è emerso subito che la causa principale della desertificazione dell’area – un tempo coperta da una ricchissima foresta temperata – era la crescita sconsiderata del pascolo misto, fatto di montoni (90%), pascolati per conto terzi, e di capre (10%), allevate per il proprio sostentamento. I montoni mangiano erba. Le capre, invece, lasciate senza foraggio dai montoni, divorano arbusti, radici ed essenze legnose, al punto da impedire la rigenerazione vegetale. Negli ultimi 30 anni, la foresta s’è ridotta di oltre il 40% e la produttività dei pascoli di oltre l’80%. Il nostro progetto – suggerito da uno studente, Luca Peri – verteva sulla progressiva “rottamazione” delle capre, in cambio di un’attività altrettanto remunerativa. Attraverso una serie di interviste, è emerso che i pastori erano coscienti della progressiva desertificazione, ma, come il resto della popolazione, ne ritenevano responsabili le scimmie, che mangiavano le cortecce degli alberi. Facile da intuire da dove avessero acquisito quest’idea: incolpare le scimmie faceva comodo ai responsabili forestali, che potevano continuare impunemente a concedere permessi di pascolo ai proprietari dei montoni, in cambio di bustarelle. Varie le soluzioni da noi ipotizzate: allevamento di tacchini, produzione di formaggio, mantenimento delle capre nelle stalle, fabbricazione di tappeti… Tutte, però, si scontravano con l’attività quotidiana del pastore, che lo portava lontano dal focolare e gli impediva di occuparsi di qualsiasi nuova attività. Ciò che appariva logico per noi non lo era per loro. Alla fine, grazie soprattutto all’apporto delle famiglie interessate, si è optato per l’apicoltura. Questa attività GEA / F. CORNA fanno uso, perché sono estremamente efficaci a mettere in luce possibili falle logiche in un progetto e permettono ai finanziatori di valutarne l’efficacia logica. La cosa sorprendente è che, benché si tratti di cooperazione (“azione compiuta insieme”), non è previsto alcun aspetto riguardante i beneficiari, la comunità di destinazione del progetto, la loro logica, i loro valori e le loro idee. Quasi che non si debbano attendere contributi “logici” da comunità di analfabeti o primitive. Il fatto è che i progetti sono fatti per loro, devono rimanere a loro, essere nutriti e coltivati da loro, non da noi e dai nostri quadri logici. Comparando sei progetti mirati al miglioramento sanitario in Nigeria, il ricercatore nigeriano Adebiyi Edun ha commentato: «Non basta sostenere il perseguimento del coinvolgimento comunitario, se non si sono adeguatamente presi in considerazione i bisogni della comunità, i suoi punti di forza e le condizioni che permettano a priori di implementare il progetto». Allora, ben venga il logical framework come strumento di miglioramento continuo di un progetto. Ma questo dev’essere assolutamente affiancato da un’azione d’indagine, attraverso interviste preliminari per acquisire informazioni fondamentali su come i membri di una comunità percepiscono il fenomeno che li affligge. Quali ritengono essere le vere cause del fenomeno? Considerano il fenomeno reversibile o irreversibile? Sono pronti a cambiare radicalmente, o s’aspettano soluzioni a breve termine, per poi tornare a una tranquilla quotidianità? Non sempre le soluzioni che noi vorremmo proporre sono compatibili con la loro visione del mondo. Forse questo tipo di analisi non offrirà aspetti logici o razionali. Di certo, però, ci dirà molto su ciò che la comunità crede, su cosa è disposta a fare e su quanto è pronta a proseguire il progetto, una volta avviato. Con una mia allieva di dottorato in scienze sociali presso l’Università Descartes di Parigi, ho sviluppato un “quadro partecipativo” d’indagine sui beneficiari, che poi abbiamo applicato sia in Italia, nel Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, sia presso i nomadi berberi GEA / F. CORNA avrebbe potuto essere svolta dalle donne, che non sarebbero più state costrette a seguire le capre, ma avrebbero potuto rimanere presso la tenda e accudire ai figli. Si trattava solo di studiare il modo di risolvere il problema del trasporto delle arnie durante la transumanza. Un tecnico locale mostrò a noi e a loro come fare. E il progetto partì con 6 beneficiari, 12 arnie (finanziate) e 1 tecnico (sponsorizzato). Oggi, senza successivi finanziamenti, le arnie sono oltre 250 e i beneficiari 30. Quindi, 24 famiglie hanno optato di “rottamare” le capre e dedicarsi all’apicoltura spontaneamente. Il tecnico è ancora chiamato regolarmente per risolvere questo o quel problema, ma oggi è pagato dalle famiglie stesse. I guadagni ottenuti con la vendita del miele superano di gran lunga quelli avuti con l’allevamento delle capre. L’apicoltura non era sembrata del tutto “logica” a noi occidentali; solo una diretta partecipazione delle persone interessate ci ha consentito di attuare un progetto che funziona, perché è piaciuto a loro e ha raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefisso. dossier 39-56 dicembre doss2010.indd 45 23-11-2010 9:34:35 Nuova cooperazione CONDIVISIONE Logico ma inattuabile Spesso i beneficiari di un progetto hanno sistemi culturali e valori di riferimento diversi da quelli dei cooperanti. Ad esempio, sul concetto di prestito. Bisogna tenerne conto e, prima di agire, scambiarsi informazioni. Q uando lo studio minuzioso attuato nel contesto di un “quadro partecipativo” di analisi mette in luce che i beneficiari di un progetto non sono consapevoli delle cause del problema che li affligge, o, pur essendolo, ne attribuiscono le cause al destino inevitabile o al volere di altre entità, la condivisione degli obiettivi viene meno e si crea un distacco – totale o parziale – dal progetto stesso. La maggior parte dei progetti varati dalle ong fallisce, perché i beneficiari non ne condividono gli obiettivi e i prospettati risultati. Capita spesso che i beneficiari partecipino ai progetti perché attratti da temporanei benefici economici o di altro genere, ma rimangono scettici sulla bontà dello scopo prefisso, considerato astratto o perfino puerile. Vengono in mente alcuni piani di assistenza alle ragazze madri e ai loro bambini varati in Bolivia, allo scopo di educare le donne alla fecondità responsabile. Uno studio approfondito fatto da Magela Lusik, una mia dottoranda internazionale, ha mostrato come le beneficiarie di simili programmi sono più che felici di ottenere l’alloggio temporaneo messo a loro disposizione, ma non sono disposte a modificare minimamente la loro condotta riproduttiva. Va da sé che, prima di avviare un progetto, è necessaria una seria opera di sensibilizzazione e conscientizzazione sulle cause del problema. Varie le tecniche usate, per lo più di natura psicologica. Tra di esse primeggiano i focus group, incontri in cui i partecipanti, sotto la guida di un moderatore, ricercano insieme le cause e prospettano soluzioni al problema che li affligge. Ottime anche le interviste partecipative, durante le quali preziose informazioni vengono scambiate tra la comunità interessata e coloro che propongono il progetto. Così facendo, si filtra consapevolezza e si ottiene condivisione. Non si deve mai aver fretta nella fase di sensibilizzazione: se mancano consapevolezza e condivisione, non si deve procedere con il progetto, pena il suo più totale fallimento. SCOGLIO MICROCREDITO La nostra associazione conosce particolarmente bene il fallimento del microcredito sperimentato con i nomadi. Francesco Armellino ha condotto un’analisi sistematica della distribuzione dei successi e dei fallimenti del microcredito relativi a 92 progetti attuati presso popolazioni nomadi e 100 presso grup- pi agricoli. I risultati della ricerca sono eclatanti: l’88% dei progetti di microcredito tentati con i nomadi fallisce; se i beneficiari sono agricoltori, il fallimento è solo del 25%. Perché? I fallimenti registrati con i nomadi non sembrano dovuti all’incapacità delle ong (sono le stesse che ottengono successi con gli agricoltori). La causa va ricercata nella diversità delle due socio-ecologie. I vari aspetti del microcredito (anticipo, utilizzo del finanziamento, restituzione dilazionata, mantenimento dei margini per il reinvestimento…) sono presenti nella socio-ecologia di un agricoltore. Egli fa ciò naturalmente da millenni: la logica creditizia (semina, investimento nella cura delle piante, raccolto, restituzione dei semi, consumo domestico, margine di profitto del raccolto…) gli è familiare. Il nomade, invece, ha valori diversi. Un individuo è bravo se ha il coraggio di spingersi verso nuovi territori e li sa sfruttare al meglio, magari escogitando nuove tecniche per estrarre più risorse possibili. Le sue incredibili flessibilità e capacità sono invidiabili, ma non sono ciò che il microcredito esige. Gli zingari, i pastori berberi o “i nomadi del mare” (come i chao lay della 46/47 39-56 dicembre doss2010.indd 46 23-11-2010 9:34:41 Ko Lipeh (Thailandia). Bambini chao lay. A destra: pescatore chao lay. Ko Surin (Thailandia). Barche dei “nomadi del mare”. Thailandia meridionale, un gruppo pescatore-nomade, immigrato nel Mar delle Andamane circa 5.000 anni or sono, oggi ridotto a circa 1.500 individui che vivono di pesce e molluschi) non contemplano la restituzione, né condividono gli obiettivi di un progetto di microcredito; caso mai lo sfruttano, per poi sparire. La loro necessità di affinare sempre nuove tecniche estrattive delle risorse li rende, invece, soggetti ideali per progetti di “microimpresa”. LA LEZIONE DI SURAT Dal 2005 l’Aps Gea onlus sta lavorando presso la comunità chao lay di Ko Lipeh con un ampio progetto di cooperazione allo sviluppo. Si sono tentate anche iniziative di microcredito con questi nomadi del mare che vivono e lavorano su barche, senza però registrare successi. Abbiamo provato, ad esempio, a comprare una barca da pesca e trasporto tradizionale e offrirla, con un piccolo progetto di microcredito, a Surat, un individuo poverissimo, ma particolarmente sveglio e promettente. Chiare le modalità di restituzione del credito: ogni anno, per 6 anni, avrebbe dovuto consegnarci il ricavato di 5 gior- GEA / F. CORNA nate di lavoro con i turisti. Abbiamo pensato fosse un piano comodo e vantaggioso per lui: ogni anno, avrebbe avuto circa 90 giornate di lavoro con i turisti e 90 di pesca. Ma non c’è stato niente da fare: Surat non riusciva ad accettare l’idea di restituzione. Insisteva: «Se siete miei amici, regalatemi la barca e basta». A nulla sono valse le nostre spiegazioni “logiche” e “finanziarie”, e il progetto non decollò. Un anno dopo, abbiamo incontrato Surat alla guida di una fiammante barca gialla, con la scritta “Taxi 80”. Cos’era successo? Partendo dall’idea che gli avevamo suggerito (cioè di lavorare con i numerosi turisti che visitano le piccole isole, deserte e stupende, che si trovano a sud di Ko Phuket), Surat aveva lavorato tutto l’inverno e si era costruito il suo long tail (tipo di barca), facendosi aiutare dall’intera famiglia. E ora, eccolo lì, con il suo “Taxi 80”, orgoglioso, felice… e senza debiti. Ce l’aveva fatta, senza il nostro microcredito. E ci aveva dato una lezione. L’esempio di Surat si è ripetuto con i berberi e i beduini del deserto e con gli zingari urbani in innumerevoli altri progetti varati in giro per il mondo. La domanda s’impone: perché tanti soldi ven- GEA / A. CAMPERIO CIANI gono tuttora sprecati in progetti di microcredito con beneficiari sbagliati? Semplicemente perché il microcredito è bello e “logico” per noi. L’“inquadramento logico” non fa una grinza e ci pare talmente ovvio che ci sembra assurdo che un “bisognoso” non lo debba accettare. E invece molti non l’accettano. E per una semplice ragione: non lo condividono, punto e basta. GEA/ M. DELL’AMICO GEA / A. CAMPERIO CIANI Ko Lipeh. Costruzione di un long tail. dossier 39-56 dicembre doss2010.indd 47 23-11-2010 9:34:45 Nuova cooperazione FORMAZIONE Sviluppo fa rima con responsabilità Due esempi – sulla fertilità delle donne filippine e algerine di città, di campagna ed emigrate, e sulle condizioni igienico-sanitarie di una comunità thailandese – per comprendere quanto una formazione adeguata e creativa agisca in profondità e trasformi le situazioni. I sta massima cinese rimane tutt’oggi un aforisma semplice ed efficace anche per spiegare l’importanza della formazione nello sviluppo sostenibile. Formazione non è sinonimo di istruzione: è qualche cosa di più fondamentale e necessario. Per istruzione s’intende quell’insieme di nozioni utili per fare carriera, o anche solo per cavarsela nel mondo odierno. La matematica, i calcoli, la geografia, l’economia, la storia… sono, sì, elementi utilissimi per inserirsi nella società, ma spesso non servono a risolvere i problemi della sopravvivenza e della riorganizzazione delle comunità emarginate e povere del sud del mondo. L’istruzione impartita nelle scuole non sempre insegna come riconoscere un’infezione da stafilococco, come proteggersi dalla malaria (malattia che uccide più di tutte le altre), come migliorare le tecniche d’irrigazione, o come ridurre GEA / E. PELLIZZARI l proverbio cinese: “Se uno ti chiede un pesce, insegnagli a pescare”, viene usato per descrivere due opposte concezioni di aiuto: “dare il pesce” allude a un atteggiamento assistenziale nei riguardi di un bisognoso considerato incapace di soddisfazione; “insegnare a pescare” indica una forma di aiuto che considera l’altro un proprio simile in termini di capacità e responsabilità e opera perché queste si sviluppino. Que- Ko Lipeh (Thailandia). Monitoraggio sull’igiene nelle famiglie chao lay. 39-56 dicembre doss2010.indd 48 23-11-2010 9:34:54 ANASANTOSWRITES.COM Filippine. Libera distribuzione di contraccettivi. Ko Lipeh (Thailandia). Scarse condizioni igieniche. In basso: volontari con una famiglia chao lay. GEA / N. SERENA DONNE, POTERE, FERTILITÀ Nei diversi contesti culturali da noi presi in esame, abbiamo notato che la fecondità troppo elevata è un problema ormai improrogabile per lo sviluppo sostenibile. Le donne, rispondendo alle nostre interviste, dichiarano unanimemente che desidererebbero aver avuto GEA / N. SERENA un tasso di fecondità che provoca la sovrappopolazione. Spesso si sente dire che l’istruzione è il miglior mezzo per il controllo delle nascite. La nostra esperienza ci dice che non è propriamente così. È dalla fine degli anni ’80 che, assieme a un team di ricercatori, stiamo studiando la fecondità delle donne filippine immigrate in Italia, comparandola con quella delle loro sorelle restate in patria, con pari istruzione, classe sociale, relazione nuziale, ecc. Abbiamo replicato gli studi con le donne algerine di città e di campagna, e anche con le donne marocchine del Medio Atlante e quelle immigrate in Italia. E abbiamo scoperto che la variabile più importante per ridurre la fecondità è quella che gli inglesi chiamano empowerment, cioè “conferire potere”, “mettere in grado di”, nel senso di favorire l’accrescimento spirituale, politico, sociale ed economico di un individuo o di una comunità, cosi che, sviluppando la fiducia nelle proprie capacità, arrivino a “sentire di avere potere” o “sentire di essere in grado di fare”. Questo comporta l’accesso a risorse e la possibilità di gestirle. meno figli di quanti ne hanno. Per loro, la famiglia ideale è certamente meno numerosa della loro. Cosa più che ovvia, visto che sono loro le prime a pagare i costi di una famiglia “oltre misura”. Molte società in cui operano i volontari sono caratterizzate da “sistemi di genere” patriarcali, che concedono alle donne scarsa voce in capitolo su questioni quali quella del numero dei figli. È l’uomo a decidere. E poco importa che la moglie svolga lavori più pesanti e determinanti il tenore di vita della famiglia, specie in comunità agricole. Si parla di lavoro fisico, non di gestione dei soldi. Questa spetta, di regola, al maschio. Se vuoi intervistare maschi adulti, non devi che recarti al bar o al luogo di ritrovo del villaggio. Molto più difficile è trovare una donna che abbia un momento libero per parlare con te: è sempre impegnata con qualche incombenza. Le nostre analisi ci hanno mostrato che il livello d’istruzione non gioca un ruolo determinante nella fertilità di una donna. Nelle comunità filippine, marocchine e algerine da noi esaminate, abbiamo riscontrato che le donne che, di fatto, riducono il numero dei figli sono quelle che hanno un lavoro fuori della famiglia e percepiscono uno stipendio. Una volta dossier 39-56 dicembre doss2010.indd 49 23-11-2010 9:35:09 diventate padrone della loro economia, la loro fecondità scende rapidamente verso i livelli desiderati. Neppure la migrazione verso la città o un altro paese incide sul numero dei figli quanto il fatto di avere un lavoro e un peso nella famiglia in termini economici. In tutto il mondo, le donne sono le più consapevoli dei pericoli di un’eccessiva crescita demografica. Ma un povero sarà sempre tentato d’investire quantitativamente nei figli, soprattutto là dove il tasso di mortalità infantile è elevato: continuerà a fare figli nella speranza che almeno qualcuno sopravviva e provveda anche ai genitori vecchi. Ma se dai potere alle donne, se concedi loro un ruolo più importante nelle decisioni familiari e le metti in grado di assicurare una sopravvivenza alla prole, automaticamente cominceranno a investire qualitativamente nei figli. In altre parole, se si agevola l’empowerment femminile, si disinnesca la bomba demografica. E senza imposizioni, né campagne odiose di sterilizzazione assistita. Questa verità dovrebbe portare a modificare le politiche internazionali di aiuto alle popolazioni in difficoltà. Quando scoppia un’emergenza alimentare (potremmo pensare alla “Missione Arcobaleno” del 1999 in Albania o ai più recenti interventi umanitari in Somalia, prostrata dalla guerra civile), si commette sempre lo stesso errore: s’inviano gli aiuti, e questi vengono scaricati presso gli aeroporti o i porti, dove costituiscono immensi giacimenti di ricchezza per gli uomini più aggressivi delle fazioni armate e determinati a impossessarsene, per poi venderle, magari in cambio di nuove armi, aumentando così il loro potere. Potere che va a confermare il sistema di genere patriarcale del controllo delle risorse. La cooperazione internazionale, specie quando si esprime nell’invio di aiuti alimentari, dovrebbe seguire strade “altre”: quelle che fanno arrivare gli aiuti alle donne. Non siamo i soli a sostenere questo. Le ricercatrici Francesca Zamperetti e Giovanna Dalla Costa hanno affermato la stessa cosa nel loro studio Microcredito donne e sviluppo. Il caso dell’Eritrea, in cui affrontano le tematiche della microfinanza e la questione di genere, nel tenta- GEA / M. DELL’AMICO Nuova cooperazione Ko Lipeh (Thailandia). Attività formativa di igiene e prevenzione. tivo di gettare luce sul complesso legame che intercorre tra condizioni di vita della donna e nuove modalità di sviluppo. Le risorse che arrivano alle donne, e sono da esse gestite, aiutano le famiglie, aumentano il potere delle donne nel sistema di genere e producono effetti benefici a lungo temine. A questo riguardo, la dice lunga il fatto che i primi progetti di microcredito sostenuti dalla Grameen Bank di Yunus fossero destinati alle donne. CAPIRE E RISOLVERE Cosa c’entra la formazione in tutto questo? Le piccole ong non possono partecipare alla distribuzione degli aiuti su larga scala. L’utilità della loro azione sta nell’aiutare i beneficiari a utilizzare nuove tecniche e nuovi strumenti che consentano di migliorare la loro vita e quella delle loro comunità. Il loro ruolo non deve essere misurato in beni distribuiti, ospedali costruiti, farmaci consegnati e pozzi scavati (come vorrebbero i finanziatori), ma in termini di capacity building, ovvero nel trasferimento di capacità e di tecniche, nel riconoscimento dei sintomi, nell’abilità di prevenzione e nell’identificazione dei rischi. Le persone che versano in situazioni di povertà vanno messe in condizione di identificare i propri problemi e avere gli strumenti per risolverli. Ecco spiegato il ruolo della formazione nella cooperazione internazionale. Questo tipo di formazione non si basa sull’istruzione formale. Spesso ricorre a vie non canoniche, che però risultano essere le migliori – se non le uniche – per dare una risposta alle effettive esigenze della comunità beneficiaria. A volte, l’istruzione formale porta a un impoverimento dei paesi beneficiari. Potrà sembrare sgradevole quanto stiamo per dire, ma lo vogliamo dire. Troppi studenti africani, al costo di enormi sacrifici delle famiglie, raggiungono buoni livelli d’istruzione nel loro paese e poi vengono a completare gli studi nelle nostre università e nelle nostre scuole di dottorato e infine decidono di rimanere per sempre in Occidente, contribuendo così alla fuga dei cervelli migliori dalle loro nazioni. La formazione che i volontari devono proporre non deve condurre a questo esodo di intelligenze, ma a trasferire capacità e tecniche utili alla cultura o al paese che s’intende aiutare. UNA BELLA RECITA Un esempio di formazione informale è quello che abbiamo svolto nella piccola comunità chao lay di Ko Lipeh attraverso il teatro. Da un monitoraggio, condotto dal laureando Nicolò Serena, GEA / M. DELL’AMICO Ko Lipeh. Il teatro formativo entusiasma tutto il villaggio. 50/51 39-56 dicembre doss2010.indd 50 23-11-2010 9:35:19 GEA / E. PELLIZZARI Ko Lipeh. Contenitore d’acqua protetto da zanzariera. Ko Lipeh. Nasce la discarica al centro dell’isola. GEA / N. SERENA GEA / F. CORNA Ko Lipeh. Un bagnetto in acqua pulita. era emerso che uno dei problemi sanitari più rilevanti erano le punture di insetti ai bambini, che causavano infezioni secondarie gravi, soprattutto alle gambe, con invasioni di stafilococchi e conseguenti suppurazioni tanto acute da condizionare la vita del colpito. Le cause apparvero subito evidenti: misere condizioni igienico-sanitarie, mancata protezione dell’acqua dolce nelle cisterne da invasioni di parassiti, assenza di un vero e proprio dispensario. Insomma: spazzatura e acqua infetta dovunque. La soluzione suggerita da Giorgio Festimanni, primario radiologo, 83 anni, oggi medico volontario “senza frontiere”, con una lunga esperienza in Brasile, Rd Congo, Tanzania e Burundi, responsabile del monitoraggio epidemiologico a Ko Lipeh, fu semplice e fattibile: proteggere con economiche zanzariere le cisterne e i contenitori d’acqua e allontanare la spazzatura, creando una piccola discarica al centro dell’isola. Tornati in Italia, stampammo una brochure, alcuni volantini e un libretto per bambini sui problemi dell’igiene e dell’acqua. Dopo un anno di campagna, però, costatammo che, mentre i bambini e i loro maestri avevano apprezzato il nostro lavoro, poco o nulla era arrivato ai genitori in termini di migliore gestione della spazzatura e condizioni igieniche dell’acqua. Il progetto stava fallendo. Prolungate inchieste tramite questionari indirizzati alle donne ci consentirono di raccogliere un ampio spettro di se- GEA / A. CAMPERIO CIANI Ko Lipeh. I pescatori sono disponibili solo di notte per le attività di prevenzione dell’embolia. gnalazioni e di opinioni sulle tecniche da esse usate per mantenere l’igiene e gestire i rifiuti. Le molte risposte raccolte ci diedero la misura del nostro insuccesso: i testi da noi preparati non avevano raggiunto lo scopo. Elena Pellizzari e Niccolò Serena ebbero l’idea di preparare una recita interpretata dai bambini. Era una novità assoluta sull’isola. La rappresentazione mette in scena un bambino sporco e in fin di vita a causa di un’infezione. Ma ecco arrivare altri bambini vestiti da infermieri: lo aiutano, lo puliscono, lo curano, lo rimettono in piedi e gli dicono come fare per non ammalarsi di nuovo: «Le immondizie non vanno tenute sulla barca o presso la casa, ma portate alla discarica. La cisterna dell’acqua potabile va protetta con una zanzariera. E la devi controllare spesso, per vedere che non sia rotta». Tutte le madri e molti padri, rinunciando a una giornata di pesca, parteciparono a quell’evento, allestito sotto una grande tenda sulla spiaggia. Tutti si sentirono coinvolti e partecipi in una storia che non avevano mai ascoltato, raccontata loro con costumi e con scenografie povere, ma teatralmente ingegnose. Dopo alcuni mesi, ripetemmo l’inchiesta tra le mamme. Le informazioni ottenute furono di tutt’altro genere: il messaggio era passato. Oggi, a distanza di 5 anni da quell’iniziativa di informazione informale, se andate a Ko Lipeh troverete che le zanzariere sono ben stese sui contenitori dell’acqua e potrete visitare anche la piccola discarica nel centro dell’isola. Il teatro è arrivato dove libri e volantini avevano fallito. dossier 39-56 dicembre doss2010.indd 51 23-11-2010 9:35:33 Nuova cooperazione BASSO COSTO Basta nababbi della povertà getti. Nell’Aps Gea onlus, per il 75% dei progetti le spese sono interamente coperte dai volontari. Energie, buona volontà, potenzialità e grandi numeri sono evidenti qualità del volontariato per la cooperazione internazionale. L’onestà è un’altra sua grande dote. I progetti che utilizzano volontari sono i meglio attrezzati a condurre operazioni finanziarie trasparenti: l’ultima cosa che un volontario desidera è svolgere un’attività poco chiara dal punto di vista finanziario nei confronti dei beneficiari. VOLONTARI NEL MEDIO ATLANTE Il progetto che l’Aps Gea onlus sta portando avanti da più tempo è il monitoraggio e la difesa dell’ultima grande foresta a nord del Sahara, precisamente nella regione del Medio Atlante in Marocco. Vi siamo impegnati, quasi ininterrottamente, dal 1983, esaminando, anno dopo anno, il processo di desertificazione e le sue cause (sia umane che naturali) e proponendo progetti di mitigazione e salvaguardia dell’ambiente e delle popolazioni nomadi berbere. GEA / M. DELL’AMICO U no studio di Francesca Donato su 75 progetti italiani ha dimostrato che non esiste alcuna correlazione tra il successo e il costo di un progetto, comunque si vogliano calcolare i due fattori. Se per realizzare un progetto in un paese del sud del mondo è necessario aprire sul posto una sede con tanto di ufficio e inviare professionisti per la gestione tecnica ed economica dell’iniziativa, è ovvio che i fondi crescano e che non tutti arrivino a destinazione, cioè ai beneficiari. E che dire della ong che occupa la sede dell’ex ambasciata scandinava a Roma? Nessuna meraviglia, quindi, se la società civile arriva a dire che si fanno ottimi affari con i poveri e che i fondi per la cooperazione servono prevalentemente ad alimentare le nostre aziende e ong. Il volontariato è una risorsa complessa e articolata. C’è un’infinità di organizzazioni di volontariato composte da ingegneri, geologi, formatori, psicologi, architetti, ecc., tutti prevalentemente giovani (tra i 25 e i 36 anni), qualificati e desiderosi di mettersi a disposizione per esperienze più o meno lunghe. È vero che fra i volontari non tutti sono animati dai migliori sentimenti: c’è chi cerca il brivido e chi parte per spirito di avventura. Ma basterebbe una seria azione di filtro per eliminarli. Spesso i volontari sono una risorsa anche finanziaria: se opportunamente motivati, sono disposti a partecipare economicamente alle spese vive dei pro- GEA / M. DELL’AMICO Il mondo della cooperazione decentrata deve far leva prevalentemente su volontari motivati e onesti. I progetti ne traggono giovamento anche sul piano finanziario. Il che non significa rinunciare a figure professionali adeguatamente stipendiate. 52/53 39-56 dicembre doss2010.indd 52 23-11-2010 9:35:43 In senso orario: Marocco. Tenda berbera. Ko Tarutao (Thailandia). Volontari in transect di monitoraggio nella jungla. Marocco. Volontari osservano un’area di foresta devastata dai pastori. GEA / M. DELL’AMICO L’intero progetto è, da sempre e quasi interamente, sostenuto dall’attività e dal finanziamento dei volontari stessi. Reclutati nelle università, questi volontari conducono estenuanti attraversamenti di foreste, per oltre 4.000 km lineari di transect. Un transect è un percorso lungo cui uno registra e conta i casi del fenomeno dello studio; nel nostro caso, rilevando le condizioni della vegetazione e del suolo, la presenza-assenza di pastori e di greggi nelle foreste e la composizio- ne delle greggi stesse. Il monitoraggio è fatto secondo i parametri di un modello d’indicatore biologico basato sulla demografia delle scimmie bertucce in antagonismo alimentare con le greggi. Grande attenzione viene data alle popolazioni. Infinite sono le interviste fatte a nomadi e agricoltori, al fine di rilevare modificazioni nei sistemi di genere, nelle abitudini nuziali, nelle relazioni economiche fra proprietari e pastori (salariati), nei rapporti fra gruppi etnici (arabi e berberi vivono da sempre in velato conflitto). Si misura anche l’impatto che l’islam ha sulle norme e le leggi che regolano gli usi civici dei pascoli e delle terre comuni. Tutti questi dati rilevati sono variabili importanti per misurare il processo di desertificazione. Il progetto ha raggiunto, nel tempo, una tale complessità che è stato necessario frazionarlo, scomporlo e semplificarlo, per consentire ai volontari di portarlo avanti. Sono state sviluppate procedure standard e modalità d’intervento che i volontari da soli non avrebbero mai saputo elaborare: dietro tutto ciò ci sono anni di ricerche, di pubblicazioni scientifiche e progetti pilota riusciti e falliti. Nel tempo, c’è stata una meticolosa attività di collaborazione fra ricercatori marocchini ed europei, assieme all’indispensabile opera dei mediatori culturali, che s’interfacciano negli incontri fra i volontari, che non parlano una parola di berbero, e i pastori, che offrono loro pane caldo e tè di maggiorana in segno di ospitalità. Questi volontari, uomini e donne, non sono partecipanti passivi: elaborano i dati, contribuiscono idee negli incontri di gruppo e nei brain storming quotidiani, suggeriscono e testano soluzioni sempre nuove, fanno rilevamenti diffi- cilissimi sul campo, servendosi di una bussola e una cartina… Si tratta di un lavoro colossale, citato anche nella pagina della scienza del New York Times e menzionato dalla prestigiosa rivista Smithsonian. Si sono raccolte migliaia di dati, che hanno arricchito la ricerca nella lotta alla desertificazione e oggi stanno alla base di molti progetti ideati per mitigarla e anticiparla, alcuni dei quali stanno registrando lo sperato successo. TRASPARENZA La cooperazione decentrata, quindi, pur appoggiandosi sempre di più sul volontariato, deve tuttavia essere in grado di sviluppare figure altamente professionali. Ed è giusto che queste siano pagate, come sono pagati altri operatori sociali (medici, psicologi, assistenti sociali). Conducono una vita piena di rischi e difficoltà, il più delle volte lontano da casa. Le ong non devono vergognarsi di pagare bene i propri professionisti, se effettivamente sono esperti e utili al progetto. Devono solo spiegare e giustificare ogni cosa dettagliatamente. Pagare bene, però, non significa creare “nababbi della povertà”. Difficile, per esempio, giustificare l’operato di quelle ong che hanno realizzato un sito Internet sulla condizione della donna berbera, spendendo 1 milione di euro, per una popolazione prevalentemente analfabeta. In Italia, un volontario abile e onesto l’avrebbe fatto per un millesimo del costo! Il tema del basso costo, quindi, deve far parte della discussione che precede la presentazione di un progetto ai finanziatori. In ogni proposta deve apparire chiara la volontà di contenere i costi, di minimizzarli, e di utilizzare l’impiego di risorse professionali solo se veramente necessarie. In un mondo di risorse limitate, ogni risparmio fatto per un progetto va a vantaggio di altri progetti. La cooperazione internazionale non decollerà mai a livello planetario, se non se ne riducono i costi, eliminando gli sprechi e mostrando che ogni euro speso si traduce in benefici per le persone e le comunità aiutate. dossier 39-56 dicembre doss2010.indd 53 23-11-2010 9:35:59 Nuova cooperazione AUTO-IMPLEMENTAZIONE Con le proprie gambe Ogni progetto di cooperazione deve trovare l’adesione della comunità beneficiaria. Che ne valuta i vantaggi, lo fa proprio e lo porta avanti. Ko Lipeh (Thailandia). All’alba si parte per la pesca. GEA / A. CAMPERIO CIANI I l termine auto-implementazione può sembrare troppo tecnico, ma è la migliore semplificazione operativa del concetto di “sviluppo sostenibile”. La sostenibilità rimane un buon concetto. Applicato a un progetto di sviluppo, sta a indicare che il miglioramento apportato è duraturo e produce ulteriori perfezionamenti all’interno di una comunità. La letteratura sull’argomento è immensa. Le visioni e le posizioni sono le più disparate. Qualcuno ritiene che, a livello globale, lo sviluppo sostenibile non sarà mai raggiunto, fino a quando non sarà disinnescata la “bomba demografica”, in quanto ogni soluzione sostenibile oggi diventerà inevitabilmente insostenibile domani, quando la popolazione sarà maggiore. Ovvio che una piccola ong non può occuparsi di questi immani problemi dai difficili risvolti scientifici, etici e religiosi. Deve, però, in ogni caso, cercare di applicare il concetto di sviluppo sostenibile a ogni suo progetto. E per noi, ogni progetto di questo tipo deve essere “auto-implementante”: il suo scopo, cioè, è quello di avviare una comunità, offrendole strumenti formativi adeguati, verso la costruzione autonoma di azioni atte a raggiungere i risultati e a mantenerli duraturi nel tempo. L’auto-implementazione deve essere un modo di pensare la cooperazione stessa. Per fare questo, è necessario identificare i processi psicologici e sociali che aiutino la comunità assistita a vedere la bontà del progetto, ad aderirvi e a proseguirlo. Realizzare un progetto auto-implementante non è cosa facile. Gli esempi di riuscita sono rarissimi. Alnoor Ebrahim, ricercatore presso la Harvard University’s Hauser Center for Nonprofit Organizations, ne spiega le ragioni: «La valutazione degli aspetti a lungo termine di un progetto viene spesso tralasciata per l’esigenza che i finanziatori hanno di vedere risultati concreti e misurabili in tempi brevi». VEDI ALLA VOCE MICROCREDITO La fretta di vedere risultati è cattiva consigliera. È necessario, invece, avere un’approfondita conoscenza del problema che si vuole affrontare, e questa si ottiene solo con un adeguato monitoraggio o una precisa valutazione degli aspetti che ostacolano lo sviluppo nella comunità (attraverso il quadro partecipativo e la sensibilizzazione-condivisione). L’appoggio entusiastico che una comunità dà al progetto proposto dall’ong e da tutti assunto è fondamentale, ma non basta. Occorre che i beneficiari sappiano usare correttamente gli eventuali sviluppi o apparati tecnici suggeriti, ripararli e anche modificarli, adattandoli a nuove necessità. Un modello auto-implementante deve essere anche appetibile: i beneficiari chiedono di toccare con mano i vantaggi (e non solo economici) che ne derivano. Non costa nulla a loro condividere il “sogno occidentale” di una ong europea o nord-americana; probabilmente 54/55 39-56 dicembre doss2010.indd 54 23-11-2010 9:36:07 lo elogiano e ne auspicano la messa in atto. Ma poi, quando tornano a casa, trovano famiglie affamate e figli da allevare. Se non riscontrano immediati vantaggi economici, sarà difficile averli direttamente e permanentemente coinvolti nel progetto. Quindi, a differenza di un progetto assistenziale in caso d’emergenza, quello auto-implementante non può esistere se non è partecipato e condiviso. Ma non solo: non può esistere se prevede una continua sovvenzione, altrimenti, quando questa termina, anch’esso si ferma. Un progetto auto-implementante può essere assistito solo come “progetto dimostrativo”, al fine di mostrare con i fatti i possibili benefici. Poi, però, va lasciato alla libera scelta e iniziativa della comunità. Un tale progetto è quasi sempre a basso costo. I suoi risultati, però, possono crescere a dismisura. Le banche di credito e risparmio… Sono tutti progetti auto-implementanti, perché qualcuno ha giudicato buona l’idea e oggi le iniziative continuano senza alcuna sovvenzione esterna. Marshall Murphree, l’ideatore dell’approccio eco-stistemico “Campire” (acronimo inglese per Communal Area Management Programme for Indigenous Resources), applicato in Zimbabwe a un noto programma sulla valorizzazione delle risorse locali da parte dei residenti, cita sempre l’esempio geniale e auto-implementante dell’agriturismo in Toscana. Negli anni Ottanta, la campagna toscana stava progressivamente morendo a causa dei magri profitti dell’agricoltura collinare. Qualche genio – a noi sconosciuto – pensò di sfruttare gli alloggi spopolati delle bellissime case coloniche per ospitare un turismo rurale, in cui i visitatori potessero condividere abitudini locali e acquistare prodotti senza passare per la catena de- Il contadino toscano – e il principe decaduto veneto – non sono certo beneficiari del sud del mondo. Ma se l’autoimplementazione funziona in una comunità, perché non dovrebbe funzionare anche in altre? MIELE CONTRO IL DESERTO GEA / M. DELL’AMICO Marocco. Volontarie con bambine berbere. microcredito sono tutte nate come progetti auto-implementanti. Hanno funzionato e oggi c’è un’infinità di piccoli banchieri pronti a fare piccoli crediti. Vari i modelli: banche di villaggio, fondi rotativi comunitari, associazioni di gli intermediari. Sorsero progetti pilota con contributi per ristrutturare gli alloggi, fu varata una legge sulla possibilità di affittare e offrire pranzi con propri prodotti locali… e tutto si è rapidamente auto-implementato. Il nostro progetto di apicoltura presso i berberi del Marocco ha le stesse caratteristiche dell’agriturismo toscano e veneto, anche se i beneficiari sono diversi. È stato il “quadro partecipativo” a confermarci la possibilità di adottare l’apicoltura per quei nomadi. Fu subito chiaro che le donne sarebbero state disponibili. Il nostro progetto si limitò a trovare il modo di trasportare le arnie e insegnare alcune tecniche ai locali. Tecniche che non dovemmo importare dall’estero: un qualunque falegname locale poteva costruire arnie; un pastore più intraprendente poteva ricorrere a un pick-up per trasportarle. Il valore di mercato del miele prodotto risultò subito un vantaggio economico riconosciuto dai beneficiari. I marocchini sono golosi di miele: lo usano in tutti i loro dolci. La produzione di una singola arnia portava nelle tasche dell’apicoltore più soldi di quanto non ne potesse avere con l’allevamento delle capre. E questo avveniva senza incrementare la desertificazione. I soldi messi da noi a disposizione per il progetto dimostrativo finirono subito. Ma in due anni, quel progetto si è autoimplementato, senza bisogno di nuovi finanziamenti esterni. La formazione da noi avviata è continuata, perché i benefici economici sono apparsi allettanti e nuovi fruitori del progetto si sono mostrati disposti ad assumerlo a proprie spese. Oggi, anche se la Regione Veneto ci ha tagliato i fondi, quel progetto continua a crescere sui monti dell’Atlante in Marocco. C’è da giurare che quei berberi si sono perfino dimenticati che l’abbiamo iniziato noi. È la dura legge del contrappasso. Ma non c’è niente di più bello del costatare che una bella idea che hai avuto, sta aiutando una popolazione a condurre una vita più dignitosa. dossier 39-56 dicembre doss2010.indd 55 23-11-2010 9:36:17 Nuova cooperazione CONCLUDENDO Il bene va fatto bene Tre criteri-cardine: smascherare gli abusi, lavorare con i beneficiari, mettere in comune le esperienze. Marocco. Membri della ong Gea. GEA / M. DELL’AMICO M olte parole, alcuni esempi e qualche chiaro suggerimento. Ma la convinzione è di aver semplicemente scalfito il problema. Del resto, il problema di come aiutare efficacemente una comunità del sud del mondo a uscire dalla povertà o a superare un’emergenza rimane tuttora irrisolto. I grandi Stati Uniti sono rimasti al palo nella piccola Haiti colpita dal sisma! Non c’è ancora sufficiente ricerca in questo settore. Pochi gli studi scientifici che comparano i risultati. Sospettiamo una possibile critica: perché abbiamo parlato prevalentemente delle nostre esperienze? La risposta è semplice: le altre non si conoscono. I progetti vengono ideati, presentati, finanziati e condotti, ma mai pubblicati. Solo scarni rapporti di fine progetto, riassunti quasi sempre autoreferenziali e ipocritamente ottimisti. Pochissime le riviste scientifiche in cui i ricercatori possano pubblicare i propri progetti, illustrare le nuove tecniche, confrontare i risultati. Non si fanno convegni per dibattere temi importanti come partecipazione, condivisione, basso costo e autoimplementazione di un progetto. E questo la dice lunga sulla (non) trasparenza della cooperazione internazionale. La cooperazione muove risorse immense e ha risvolti geopolitici e sociali colossali. Eppure pochissimi ricercatori se ne occupano. Anche le ong, responsabili dei propri fallimenti, non avvertono l’esigenza del confronto e della trasparenza. La psicologia – incluse le psicologia sociale e la psicologia di comunità – dovrebbe essere la prima a occuparsi di processi scientifici di cooperazione. Di fatto, però, è l’ultima, se non completamente assente. Nelle stesso tempo, le ong desiderano implementare progetti efficaci, ma non fanno ricerca. La chiave del successo del microcredito è semplice: è stato pensato, studiato e sperimentato, poi è stato reso pubblico con studi scientifici dai suoi ideatori; ci sono stati confronti, critiche costruttive, aggiustamenti, nuovi esperimenti… Il guaio è che i finanziatori non vogliono sentire parlare di progetti dimostrativi, di progetti pilota o di studi sulla cooperazione. Vogliono vedere ospedali, pozzi, dighe, cemento, mattoni... Ai loro occhi, la formazione è teorica, impalpabile. Serve tanta intelligenza per aiutare chi è nel bisogno. Il bene va fatto bene. Occorrono idee nuove: quelle vecchie, se funzionano poco e male, vanno cambiate. Il mondo della cooperazione aspetta ancora il suo Darwin o il suo Galileo, che riscriva la cooperazione e ci spieghi come muoverci e dove andare. Si può solo sperare che arrivi presto. Fino ad allora, però, tre cose sono possibili e doverose: smascherare gli abusi e gli sprechi, a tutti i livelli e in tutte le sedi; ascoltare di più i beneficiari, lavorare con loro, non per loro; confrontare le rispettive esperienze. Ne va del bene della cooperazione internazionale decentrata. 56 39-56 dicembre doss2010.indd 56 23-11-2010 9:36:26
Scaricare