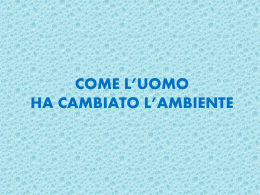Progetto_Paesaggio Rigenerazione, Riqualificazione, Riuso. Il futuro delle città: riqualificazione, rammendo, innesto, riciclo. Renato Bocchi Professore ordinario. Coordinatore del programma di ricerca triennale Re-cycle Italy DELL’IMPORTANZA DELLA VISIONE “UTOPICA” “L’innovazione di rottura nasce dalla visione: la capacità di guardare il mondo e vedere ciò che gli altri non sono in grado di vedere. La costruzione della visione è l’asset più importante e raro del nostro tempo. (…) Ma avere una visione non è ancora sufficiente. (…) L’innovazione richiede che le visioni siano realizzate… Le grandi innovazioni spesso devono affrontare grandi ostacoli (…) La nuova frontiera per comprendere le strade che portano all’innovazione è quindi studiare i meccanismi di costruzione della visione. A questo scopo abbiamo bisogno di nuovi schemi interpretativi, di nuove prospettive. Dobbiamo esplorare le dinamiche intangibili del pensiero, investigare quelle affascinanti capacità che rendono le persone in grado di riconoscere ciò che è nascosto nello specchio che riflette il nostro ruolo nella società. Abbiamo bisogno di comprendere i sogni delle persone, cambiare il mondo da quello ordinario a uno che non c’è ancora. Questo è essenziale se vogliamo vivere in un mondo sostenibile. Una società sostenibile può scaturire solo da visioni che sappiano guardare oltre l’oggi, oltre i problemi immediati” Don Norman e Roberto Verganti, Per costruire una visione servono nuovi contesti, in Il Sole 24 ore, Nòva, n.430, 13 luglio 2014, p.7). Si dice che invecchiando si diventi saggi, che si possegga una visione più pacata, più a tutto tondo e più rasserenata del mondo, e pertanto si possano individuare meglio le strade per comporre i conflitti, per mediare verso un progetto meno rivoluzionario e più concretamente riformista. A me in verità sta succedendo il contrario: fin da giovane ho avuto una vocazione quasi innata per la mediazione e per la composizione delle idee e dei dissidi – insomma per la “moderazione” – ma, invecchiando, pur continuando a credere pervicacemente nelle virtù del dialogo, sempre più mi appare insufficiente operare in termini di composizione e di mediazione e sto invece riscoprendo il valore dell’utopia, della visionarietà, della non-convenzionalità, del rovesciamento di ottica, dello scarto rivelatore e perfino della fuga in avanti, onde rischiarare il quadro della realtà e intravvedere un futuro di qualche speranza. Sarà che ho sempre amato la Grammatica della fantasia di Gianni Rodari e il potere inventivo assolutamente spiazzante e imprevedibile contenuto nelle parole. Sarà che parimenti ho sempre apprezzato la dimensione altrettanto “fantastica” e spiazzante delle invenzioni di design radicale e “surrealista” di Bruno Munari. Di fronte alla radicalità dei fenomeni di mutamento nella società, nelle città, nel pianeta – e ritenendo ormai acquisita, nella cultura architettonico-urbanistica come in quella socio-politica, la volontà e la necessità di non consumare più suolo e di ridurre al massimo lo spreco delle risorse e quindi del patrimonio esistente quale che ne sia la sua qualità intrinseca - mi appaiono così del tutto insufficienti e perfino rischiosi i processi di rimedio, di modificazione debole, di ricucitura, e sempre più sento la necessità di spingere per l’elaborazione di modelli, di visioni, al limite anche di utopie, per un futuro profondamente diverso, per un cambiamento radicale di mentalità e quindi di scenario: pena una decadenza irreversibile e perniciosa. Il che non vuol dire necessariamente sostituire alle terapie dolci la chirurgia (ho un debole per l’omeopatia e l’agopuntura), ma lavorare per autentici processi di metamorfosi, che non si accontentino delle forme trovate, ma le ripensino in modo radicale e creativo. 1 1. VISIONI Ci sono momenti storici (e questo mi par tra quelli) in cui servono figure ed elaborazioni capaci di uno scarto in avanti o di lato, non necessariamente subito comprensibile e praticabile, certamente non-convenzionale. Nell’architettura e nella città del Settecento ha avuto questo ruolo un personaggio come Piranesi, capace di sovvertire regole e geometrie spaziali pur partendo da una cultura antiquaria e lavorando quasi solamente di disegni ed incisioni. Nell’architettura e nella città del primo Novecento forse può leggersi un ruolo simile per un costruttivista rivoluzionario come El Lisitzkij (si pensi anche solo alle sue “staffe per le nuvole” con cui proponeva di ripensare ab-ovo la trigonometria urbana ovvero la struttura di relazioni urbane a grande scala del piano di Mosca), le cui sperimentazioni sono convinto esser state fondamentali fra l’altro per un nume tutelare dell’architettura moderna come Mies van der Rohe. In tempi più recenti una figura come Cedric Price, oggetto lo scorso luglio (grazie a H.U. Obrist) di un nostro workshop Iuav presso il padiglione svizzero della Biennale architettura (cfr. www.ifclause.it), può incarnare un ruolo analogo di visionario innovatore: si pensi anche solo alla sua ipotesi di Fun Palace come attrezzatura urbana socialmente multivalente e continuamente variabile, cui non a caso sono stati debitori i giovani Piano e Rogers del parigino Centre Pompidou. 2. IL RAMMENDO, L’INNESTO, IL RI-CICLO Per questi stessi motivi, pur condividendo in larga parte sia le idealità sia le proposte e i metodi certamente innovativi dell’architettura di Renzo Piano (per l’appunto), trovo difficoltà e diffidenza nel condividere la sua recente parola d’ordine, assurta all’onore delle cronache negli esami di maturità di migliaia di studenti italiani: il rammendo (delle periferie). Mi trovo perfettamente e anzi entusiasticamente d’accordo quando Piano dice: “Siamo tutti nani sulle spalle di un gigante. Il gigante è la nostra cultura umanistica, la nostra capacità di inventare, di cogliere i chiaroscuri, di affrontare i problemi in maniera laterale” – il che corrisponde assai precisamente a quella volontà di vedere le cose secondo uno “scarto” in avanti o laterale che prima io stesso invocavo. Sono meno d’accordo quando Piano dice: “Alle nostre periferie serve un enorme lavoro di rammendo, di riparazione” (cfr. Renzo Piano, Il rammendo delle periferie, in “Il Sole 24 ore”, 26 gennaio 2014). E questo per il motivo che nelle desolanti periferie diffuse di questo paese mi pare ci sia assai poco da rammendare: ago e filo sono strumenti del tutto inadeguati per costruire un patchwork dotato di qualche senso di quel mondo alieno che insistiamo a voler chiamare città. Il rammendo mi pare del tutto insufficiente, anche se sono assolutamente convinto che non si possa e non si debba necessariamente demolire e ricostruire, ma piuttosto “costruire sul costruito” o magari “innestare” per produrre “metamorfosi” – come sostenuto con buone ragioni nella recente Biennale da Cino Zucchi (cfr. Innesti-Grafting, Padiglione Italia, 14° Mostra Internazionale di Architettura, Marsilio, Venezia 2014). Soffermiamoci allora un momento su quanto sostengono da un lato Renzo Piano (nel suo articolo sul rammendo e nella conseguente iniziativa rivolta ai giovani architetti), dall’altro Cino Zucchi (nel padiglione italiano della Biennale veneziana), dall’altro ancora Pippo Ciorra (nella mostra Re-cycle. Strategie per l’architettura, la città e il pianeta, catalogo Electa, Milano 2011, tenutasi al Maxxi di Roma, che è alla base della ricerca nazionale di 11 università italiane che sto coordinando presso l’Iuav di Venezia, dal titolo Re-cycle Italy, cfr. www.recycleitaly.it). Renzo Piano scrive: “sono le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l’energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. C’è bisogno di una gigantesca opera di rammendo e ci vogliono delle idee” E poi aggiunge: “La prima cosa da fare è non costruire nuove periferie. Bisogna che le periferie diventino città ma senza ampliarsi a macchia d’olio, bisogna cucirle e fertilizzarle con delle strutture pubbliche. Si deve mettere un limite alla crescita anche perché diventa economicamente insostenibile portare i trasporti pubblici e raccogliere la spazzatura sempre più lontano. Oggi la crescita anziché esplosiva deve essere implosiva, bisogna completare le ex aree industriali, militari o ferroviarie, c’è un sacco di spazio disponibile. Parlo d’intensificare la città, di costruire sul costruito. In questo senso è importante una green belt come la chiamano gli inglesi, una cintura verde che definisca con chiarezza il confine invalicabile tra la città e la campagna. (…) Un’altra idea guida nel mio progetto con i giovani architetti è quella di portare in periferia un mix di funzioni. La città giusta è quella in cui si dorme, si lavora, si studia, ci si diverte, si fa la spesa. Se si devono costruire nuovi ospedali, meglio farli in periferia, e così per le sale da concerto, i teatri, i musei o le università. Andiamo a fecondare con funzioni catalizzanti questo grande deserto affettivo. Costruire dei luoghi per la gente, dei punti d’incontro, dove si condividono i valori, dove si celebra un rito che si chiama urbanità. Oggi i miei progetti principali sono la riqualificazione di ghetti o periferie urbane, dall’Università di New York a Harlem al polo ospedaliero di Sesto San Giovanni che prevede anche una stazione ferroviaria e del metrò e un grande parco. E se ci sono le funzioni, i ristoranti e i teatri ci devono essere anche i trasporti pubblici. Dobbiamo smetterla di scavare parcheggi. Penso che le città del futuro debbano liberarsi dai giganteschi silos e dai tunnel che portano auto, e sforzarsi di puntare sul trasporto pubblico. Non ho nulla contro l’auto ma ci sono già 2 idee, come il car sharing, per declinare in modo diverso e condiviso il concetto dell’auto. Credo sia la via giusta per un uso più razionale e anche godibile dell’automobile. Servono idee anche per l’adeguamento energetico e funzionale degli edifici esistenti. Si potrebbero ridurre in pochi anni i consumi energetici degli edifici del 70-80 per cento, consolidare le 60mila scuole a rischio sparse per l’Italia. Alle nostre periferie occorre un enorme lavoro di rammendo, di riparazione. Parlo di rammendo, perché lo è veramente da tutti i punti di vista, idrogeologico, sismico, estetico”. Sono d’accordo su quasi tutto: non sprecare altro suolo, densificare, costruire nel e sul costruito, introdurre funzioni miste e armature pubbliche urbane, a cominciare dalle scuole, incentivare il trasporto pubblico e scoraggiare il traffico privato, aumentare il rendimento energetico, riparare i guasti idro-geologici. Ma perché – mi chiedo - parlare di un concetto debole come il rammendo, sulla scia di quella che anni fa Gregotti chiamava la modificazione, richiamandosi al pensiero debole. Mi pare insufficiente e anche un po’ pericoloso, perché accredita l’ipotesi della mitigazione dei danni, della riparazione e dell’aggiustamento, della semplice ricucitura. Insomma pone troppo l’accento sulle tattiche più o meno occasionali e trascura il loro legame con le strategie, con le effettive potenzialità di cambiamento dello sguardo e della visione “laterale o periferica”, e di conseguenza dei nostri stessi comportamenti nell’uso delle città. Per legarsi a un caso concreto che ben conoscete, utilizzo come cartina di tornasole il progetto che Renzo Piano ha realizzato a Trento, facendo seguito al meno noto mio studio-quadro sull’area fluviale, preliminare alla Variante del PRG, redatto nel 2000-01 (cfr. R.B., Il paesaggio come palinsesto, Nicolodi, Rovereto 2006). Va premesso che nel progetto di trasformazione dell’area ex-Michelin purtroppo non è stata mai presa in seria considerazione un’ipotesi di ri-conversione o ri-ciclo dell’esistente (e ciò è vero anche per il ns studio-quadro). Fanno eccezione un paio di progetti presentati al concorso di idee del 2000 (cfr. Area ex-Michelin – Trento, Temi, Trento 2000): ricorderei soprattutto quello del gruppo Wolf-Ceccon, progetto sicuramente interessante e meritevole di seria attenzione, ma scartato a priori dalla commissione giudicatrice perché di fatto non si prestava agli obiettivi del pool di proprietariimprenditori che il concorso aveva bandito – un progetto che indagava sulla convertibilità almeno parziale del sistema modulare di capannoni a shed della vecchia fabbrica e sfruttava le ottime potenzialità di tale sistema modulare nel riconfigurare un tessuto insediativo innovativo e con alti contenuti tecnici di sostenibilità ambientale ed energetica. Insomma un buon esempio di progetto di riciclo architettonico-urbano. Ma forse allora i tempi non erano ancora maturi per tale tipo di proposta. Ciò premesso, il progetto del quartiere più tardi realizzato da Renzo Piano, su principi di totale renewal e certamente non di rammendo, ha certamente il valore, a mio parere, di aver confermato e realizzato alcuni obiettivi-cardine del nostro stesso precedente piano-guida, connessi con la volontà di recuperare un rapporto intenso col fiume e con la continuità del waterfront mediante un parco pubblico, in questo impostando di fatto un processo di ri-ciclo nei confronti non tanto delle vecchie fabbriche ma sicuramente nei confronti del fiume e delle sue sponde e del ruolo urbano che in antico aveva avuto la villa madruzziana delle Albere, proprio nel senso di quel principio di città-paesaggio su cui io stesso avevo fondata la mia idea di ri-sviluppo dell’area lungofiume. Ed infatti il parco fluviale già sta incontrando un largo successo nell’uso da parte dei cittadini, riaprendo fertili rapporti con le attività di svago e sportive che sempre più si concentrano sulle rive e gli argini del fiume. Parimenti il progetto di Piano ha dato corpo all’obiettivo conclamato di rilegare l’area alla città superando la barriera della ferrovia (superamento per fortuna finalmente avviato con il pur banale sottopasso in asse con via Madruzzo e il cimitero e che dovrà continuare con gli ulteriori sottopassi previsti, in barba all’idea a mio giudizio irrealistica e di fatto fuorviante di interramento della ferrovia lanciata invece da J.Busquets nel 2001 – cfr. R.Cerone, a cura di, Joan Busquets. Un progetto europeo per Trento, Nicolodi, Rovereto 2004) e d’altro lato ha dato corpo all’altro importante obiettivo di incrementare l’attrattività e l’armatura urbana di questa parte di città, facendo leva non soltanto sull’esistente villa-museo delle Albere (che attende oggi una opportuna ed efficace ri-destinazione), ma soprattutto sulla creazione dei due nuovi poli culturali a nord e sud dell’area: in particolare con la realizzazione del Museo delle Scienze (MUSE), cui ha arriso un clamoroso successo di pubblico, superiore ad ogni rosea aspettativa, e prossimamente con la nuova Biblioteca Universitaria. In tal modo l’area ex-Michelin sta già fortunatamente diventando quella nuova porta della città di Trento da sud che il nostro piano in certo modo aveva preconizzato e auspicato. E’ questa implicitamente una dimostrazione che il progetto di Renzo Piano – nelle sue caratteristiche migliori, cioè quelle legate alle potenzialità di armatura urbano-territoriale a valenza pubblica (“Andiamo a fecondare con funzioni catalizzanti questo grande deserto affettivo”), ha prodotto davvero un’opera di rifondazione assai incisiva di tutta la parte fluviale della 3 città, che non ha nulla a che vedere con politiche di rammendo o riparazione “deboli” ma ha tutti i crismi per essere un volano di trasformazione virtuosa e profonda delle relazioni urbane. Niente a che fare con un’opera di rammendo: semmai, come verrò a dire più avanti, con un’opera di ri-ciclo urbano-territoriale. (Il punto debole del progetto, a mio avviso, si ritrova semmai in un certo appiattimento della proposta di impianto spaziale del quartiere interno, impostata su caratteri sostanzialmente tradizionali della maglia viaria, pur con una corretta gerarchia di flussi, e su un sistema tipologico a cortina che è certamente innovativo nelle caratteristiche tecnico-prestazionali degli edifici ma assai meno nelle risposte morfologico-urbane, e che per di più ha incontrato un prevedibile fallimento nell’inserirsi nel mercato immobiliare della città in anni di acuta crisi economica e con un’offerta sostanzialmente non competitiva e sproporzionata all’interno di un mercato tutto sommato di dimensioni modeste come può essere quello di una città di piccole dimensioni quale è Trento). Insomma, nel caso delle Albere, mi pare che i caratteri della sistemazione paesaggistica e quelli della “potenza di fuoco” delle grandi attrezzature urbane, collaborando insieme, abbiano costituito la carta vincente per la possibilità che l’intervento costituisse davvero una svolta importante e innovativa nella costruzione della città nuova, in tal senso realizzando di fatto alcuni degli obiettivi-chiave che avevano guidato il già citato nostro studio-quadro del 2000-01, ispirato ai principi della città-paesaggio e della città dei flussi, e quindi ispirato da una volontà di effettivo ripensamento radicale del nuovo ciclo di vita di tutta l’area fluviale. Un’opera di ri-ciclo urbano-territoriale, quella delle Albere, che dovrebbe ispirare allo stesso modo le trasformazioni ancora in attesa preconizzate dal nostro piano-quadro del 2001, in primis quella dell’area ex-Italcementi, dove di nuovo il blitz demolitore di un paio d’anni fa ha sprecato la possibilità - ancora più interessante che nel caso della Michelin - di un effettivo materiale riciclo parziale della vecchia fabbrica, che personalmente auspicavo: operazione di ri-ciclo che si è invece magnificamente realizzata nel caso dell’ipotesi di riconversione dei tunnel sotto il Doss Trento con il progetto di Elisabetta Terragni, non a caso proposto come una delle best practice più stimolanti nella mostra Re-cycle al Maxxi: questo sì un vero e proprio esemplare progetto di ri-ciclo architettonico e urbano, tanto più efficace se si riuscirà a completare come previsto con la completa ri-sistemazione dello spazio urbano antistante a connessione con il vecchio borgo di Piedicastello, con la testa di ponte di San Lorenzo e quindi col fiume stesso, e se addirittura si potrà riproporre il suo rapporto con le falde e la sommità del colle detto Doss Trento. Se guardiamo ora invece alla proposta presentata alla Biennale da Cino Zucchi troviamo certamente una corrispondenza più fedele - a partire dal concetto là proposto come parola-chiave, quello di innesto inteso a generare metamorfosi - nei confronti dei rapporti instaurabili fra tattiche d’intervento architettonico e strategie di trasformazione urbana. Scrive Zucchi: … il pensiero contemporaneo persegue nuovi fini e valori attraverso una metamorfosi delle strutture esistenti. Non adattamenti formali a posteriori del nuovo rispetto all’esistente, ma piuttosto “innesti” capaci di agire con efficacia e sensibilità in contesti urbani stratificati, (…) innestando così gemme di grande modernità negli interstizi che separano gli strati precedenti (delle città). (…) Un “innesto” presuppone una ferita nell’organismo ospite, ma anche una profonda conoscenza della sua fisiologia, e delle conseguenze implicite nella trasformazione di uno stato esistente, spesso illusoriamente vissuto come seconda natura. E’ a questo riguardo molto interessante come Zucchi si richiami esplicitamente al concetto di bricolage utilizzato in antropologia da Claude Levi-Strauss, cui anch’io mi sono altrove spesso riferito ricercando un metodo per affrontare il tema progettuale del riscatto (ri-ciclo) delle aree di scarto e di rifiuto (per il quale ho tirato in ballo le tecniche di bricolage letterario usate da T.S.Eliot nel suo famoso poema The Waste Land, ispirate anch’esse agli studi antropologici – di Frazer in tal caso - e comparabili alle sperimentazioni letterarie anche più innovative di James Joyce nell’Ulisse e nel Finnegan’s Wake, cfr. R.B., “The waste land-scape. Frammenti di pensiero per un’ipotesi di paesaggio come palinsesto”, in : OPEN Papers, Scritti sul paesaggio, ETS, Pisa, 2012). Nella famosa distinzione tra ingegnere e bricoleur operata da Claude Levi-Strauss ne Il pensiero selvaggio – scrive Zucchi - l’ingegnere è colui che possiede un metodo forte ma non ha pregiudizi formali, mentre il bricoleur è colui che manipola forme esistenti per raggiungere obiettivi nuovi: il primo opera mediante concetti, il secondo mediante segni”. E cita al proposito François Jacob (Evoluzione e bricolage, Einaudi, Torino, 1978): “La selezione naturale opera non come un ingegnere ma come un bricoleur, il quale non sa esattamente cosa produrrà, ma che recupera tutto quello che trova in giro (…) il bricoleur si arrangia con gli scarti (…) per molti aspetti questo modo di operare ricorda il processo dell’evoluzione… l’evoluzione costruisce un’ala da una zampa (…) l’evoluzione non crea dal nulla le sue novità. Lavora su ciò che esiste, sia trasformando un vecchio sistema per dargli una funzione nuova, sia combinando diversi sistemi per formarne un altro più complesso”. 4 E’ interessante trovare, nella rassegna di esempi raccolta da Zucchi e dai suoi collaboratori all’interno dell’ultima produzione degli architetti italiani, una serie numerosa di opere realizzate da architetti trentini o alto-atesini, da Fabrizio Barozzi a Markus Scherer, dagli studi ETB e GSMM allo studio MoDus, che sono fra le espressioni più alte della cultura italiana e europea dell’innesto dell’architettura nuova in contesti di pregio sia urbano che paesistico. Ma va detto che siamo qui ancora nel campo di inserimenti su contesti ad alta connotazione e non propriamente all’interno di contesti di periferia o di wasteland: insomma di innesti su piante sostanzialmente sane, che pur vengono rivitalizzate dalla qualità alta dei nuovi interventi. Se ora guardiamo invece alla proposta di Pippo Ciorra che ha lanciato, con la mostra al Maxxi, il termine Re-cycle cui si ispira la nostra attuale ricerca, possiamo andare ancora un po’ più in là, cercando risposte anche e soprattutto per le grandi aree irrisolte dei nostri paesaggi di “periferia”. “La novità postmoderna da sottolineare – afferma Ciorra - è che il riciclaggio – o riciclo che dir si voglia – non è più solo un dispositivo economicamente, politicamente e antropologicamente corretto ma anche una delle forme più sofisticate e attuali della ricerca espressiva degli architetti contemporanei. L’idea che un progetto architettonico o urbano possa fondare la sua identità figurativa sul fatto di essere frutto di un’opera di riciclaggio diventa chiara già con una serie di progetti di autore databili tra la fine degli anni settanta e l’inizio dei novanta. A un estremo del campo di sperimentazione troviamo i capolavori dell’architettura del riciclo concettuale – il Parco de la Villette e la scuola Le Fresnoy di Tschumi e il progetto per Cannaregio di P.Eisenman (…) all’opposto troviamo la versione apparentemente più artigianale e situazionista del riciclo messa in scena da Lacaton e Vassal nel progetto di trasformazione del Palais de Tokyo a Parigi da sonnecchiante museo a teatro della ricerca artistica di avanguardia. (…) Urge quindi una cultura del riciclo che sia tanto audace e infedele quanto il restauro mainstream è attento e (non sempre sinceramente) fedele all’originale, e tanto veloce e indeterminata quanto l’approccio consueto al “riuso” è pedante puntiglioso e burocratico. La strategia del riciclo appare allora come un approccio che consente di tenere insieme memoria e innovazione radicale, realismo e tabula (quasi) rasa. I progetti presentati in mostra propongono tutti di ri-costruire invece di costruire: costruire sopra sotto intorno dentro addosso, con i materiali di scarto, invece che costruire, abitare la rovina invece di costruire, rinaturalizzare invece che riurbanizzare. A partire da questa rete di relazioni il riciclo può finalmente espandersi in direzioni opposte per diventare allo stesso tempo una tattica quotidiana socialmente condivisa e una nuova possibile teoria dell’architettura”. Così Ciorra. Fra i progetti selezionati per la mostra compaiono così sia progetti di riciclo vero e proprio, materialmente inteso, come i progetti tedeschi o olandesi che riutilizzano container o materiali di scarto industriale per ricomporre nuove architetture (ma potremmo aggiungervi i notissimi esperimenti di Shigeru Ban premiato recentemente dal Pritzker) sia progetti di metamorfosi di reperti infrastrutturali preesistenti, come il già citato progetto trentino delle Gallerie o come l’ormai famosissimo progetto della High Line newyorkese di Corner, Diller e Scofidio, che trasfigura un viadotto abbandonato in un parco lineare di grandissimo successo popolare sia ancora progetti di autentica metamorfosi edilizia come è il caso della trasformazione di un bunker da parte di Index Architekten o di Hegger Schleiff, o ancor più della straordinaria esperienza della casa Sortino su progetto di Giuseppina Grasso Cannizzo. 3. LE STRATEGIE DI RI-CICLO Pertanto, tornando al nostro discorso iniziale: pur condividendo la volontà di “cambiare verso” espressa così da Renzo Piano come dagli altri Renzi che vanno oggi per la maggiore, stento a credere che ciò si possa fare senza affermare un cambio radicale nei modi e negli stili di vita e nelle stesse idealità degli Italiani, anche e soprattutto per ciò che attiene ai loro modi di insediarsi nel territorio e di abitare le città o le pseudo-città che lo costellano. Insomma, credo che sia il momento giusto per provare a elaborare nuovi modelli di comportamento e di gestione nelle e delle città e a testare perciò eventualmente perfino le potenzialità coraggiose del pensiero utopico in tal senso, per proiettare nel futuro visioni di ri-fondazione piuttosto che di rammendo, per elaborare nuovi paradigmi piuttosto che ipotesi di pura modificazione dell’esistente o di semplice problem solving, come si usa dire ora (“I comportamenti basati sull'intuizione, sul potere di visione delle persone, vengono spesso stigmatizzati. Questo mito deriva dalla tradizionale cultura d'impresa che punta verso il problem solving più che alla costruzione di una visione. Un approccio di questo genere può risolvere i problemi immediati ma non prepara certo per il futuro” - scrivono Norman & Verganti nell’articolo già citato in apertura). Il che non vuol dire trascurare il potenziale dell’esistente: tutt’altro, piuttosto assumere l’esistente nelle sue potenzialità di risorsa materiale da ri-ciclare e re-inventare radicalmente, a favore di nuovi disegni, per nuovi cicli di vita (che è appunto lo spirito con cui si sviluppa la nostra ricerca Re-cycle Italy). E’ qui, nel voler istituire “nuovi cicli di vita” per i nostri territori, che può soccorrere l’ipotesi ardita di traslare gli strumenti delle scienze e delle tecniche ecologiche nel campo dell’architettura, dell’urbanistica e del paesaggio che è alla base della ns ricerca. 5 Dovremmo indagare quindi i modi con cui possa rifondarsi una struttura di relazioni di senso in quei territori, pur partendo dal “riciclo” di un’eredità materiale e ideale tutt’altro che omogenea e spesso disperatamente “desolata”. Ri-ciclo - così come lo intendiamo – vuol dire proprio questo: è qualcosa di più del recupero, del riuso o della riqualificazione, è più vicino forse al concetto di rigenerazione, perché intende istituire un nuovo ciclo di vita e quindi intende ri-generare e ri-fondare le cose e le relazioni fra le cose, i luoghi e i paesaggi. Per questo motivo ha pochissimo a che vedere con la conservazione e moltissimo a che fare invece con la trasformazione, anche se rifiuta di lavorare sulla tabula rasa, scegliendo di sporcarsi le mani con quello che si trova, che preesiste, non disdegnando l’ibridazione, la stratificazione, il montaggio, la sovrapposizione, la riscrittura e la sovrascrittura –esattamente come Eliot o Joyce lavoravano con i lacerti, letterari e non, per costruire i loro modernissimi capolavori; esattamente come il montaggio del cosiddetto found footage lavora oggi nel re-cycled cinema per costruire nuove narrazioni, secondo nuovi orizzonti di senso (cfr. Marco Bertozzi, Recycled Cinema, Marsilio, Venezia 2013). Non ci basta quindi proclamare la volontà sacrosanta di “non consumare più altri suoli”, ma pensiamo si debbano anche e soprattutto tracciare nuove strategie per ri-ciclare quanto è stato già trasformato e costruito – ricordando quell’aforisma di Marcel Proust che recitava: “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi”. Quindi, di nuovo: saper “vedere” e “costruire” sulla materia di quanto esiste un nuovo disegno delle città, dei paesaggi, dei territori. Questi “nuovi paradigmi” ci sono richiesti dal tempo di crisi in cui siamo immersi, il quale esige imprescindibilmente di cercare un nuovo inizio, una rigenerazione appunto – rendendo insufficiente qualsiasi opera di puro rimedio, di riparazione, di aggiustamento, di modificazione debole. Un esempio abbastanza calzante qui vicino a noi potrebbe essere il progetto di Kengo Kuma e Carlo Ratti per la Manifattura Tabacchi a Rovereto. E’ in tal senso che il concetto di riciclo applicato ai temi dell’architettura, della città e del paesaggio, può passare da puro termine tecnico a parola-chiave, a nuovo paradigma, per cercare rinnovate strategie e rinnovati strumenti (progettuali) per la rigenerazione cui aspiriamo, considerando non solo i materiali di scarto dei processi di trasformazione urbana e territoriale recente (che chiamano in causa temi ormai assai frequentati quali quelli delle aree e delle infrastrutture dismesse, dei wasteland, dei brownfield , etc.; e d’altro lato lo sprawl degli insediamenti diffusi nel territorio, con tutti gli aspetti di spreco ma pure di embodied energy che si portano dietro), ma anche gli stessi lacerti “inerti” delle geografie territoriali preesistenti coinvolte in processi di abbandono, di emarginazione e di rifiuto (quelli che la storica Antonella Tarpino ha giustamente chiamato “spaesati” (cfr. A.Tarpino, Spaesati, Einaudi, Torino 2012) - ovvero i territori fragili, i borghi abbandonati, le venature dei fiumi e delle reti idrografiche, le tracce lasciate in eredità - talvolta più alle comunità che ai luoghi stessi - dai cicli della storia (un riciclo più metaforico, se si vuole, ma altrettanto strategico). Porterò ad esempio della sperimentazione di questi obiettivi e di questi processi alcune mie sperimentazioni in sede didattica, con tutti i limiti che possono avere simili esperimenti. Un processo sperimentale con diverse uscite progettuali tutte improntate all’idea di riciclo urbano si è impostato in un Laboratorio Iuav applicato all’ area industriale parzialmente dismessa della Latteria di Soligo nei colli trevigiani, considerando centrale nel processo di ri-ciclo urbano non solo il parziale recupero dei fabbricati dismessi ma soprattutto la riscoperta dei caratteri fondativi del paesaggio geografico primigenio: il fiume Soligo e la situazione esplicitamente pedemontana dell’insediamento. Si è trattato di una micro-indagine su un processo di ripensamento radicale del tessuto produttivo e insediativo del territorio pedemontano veneto, entrato in una profonda crisi negli ultimi anni, e che Masiero e Bonomi in un fortunato libretto hanno provato a rilanciare col termine di Smart Land (cfr. A.Bonomi, R.Masiero, Dalla Smart City alla Smart Land, Marsilio, Venezia 2014). Scrive Bonomi: “Gli attori che pensano un territorio come rampa di lancio per affrontare la globalizzazione non più soltanto come flussi in entrata, quanto come progetti di andata nel mondo, come globalizzazione in uscita”, ma anche forse – aggiungo io - di un nuovo progetto collettivo territoriale, fondato per l’appunto sul “ri-ciclo” di valori architettonico-urbani e paesaggistici obsoleti e negletti (i fiumi, per esempio, o itinerari di memoria o piccoli borghi e casali o aree naturalistiche più o meno protette) o di risorse abbandonate e dismesse considerate usualmente “disvalori” (i capannoni in disuso o le ferrovie dismesse o alcuni brani delle stesse “periferie diffuse”). Su questa linea si può forse lavorare – abbiamo pensato - in modo di arrestare il consumo di suolo, valorizzando da un lato le possibilità di consolidamento e irrobustimento (nel “carattere”) dei brani dell’insediamento disperso, dei landmarks territoriali e delle maglie o reticoli infrastrutturali che li collegano; dall’altro lato valorizzando le potenzialità connettive e di infrastrutturazione possedute dagli stessi brani del paesaggio non costruito (spazi urbani, spazi agricoli, spazi boscati, 6 corsi d’acqua, alture, e via dicendo), insomma metamorfizzando l’informe patrimonio edilizio-infrastrutturale della città dispersa a favore dei caratteri morfologici del Pedemonte. Con un metodo analogo si è operato in una tesi di laurea (Favaretto-Fulciniti) avente come oggetto il riciclo di una vasta area industriale parzialmente dismessa a Mira, sulla Riviera del Brenta: l’area che era degli stabilimenti Mira Lanza, nel pieno centro della città di Mira e in diretta relazione con il Brenta. Qui, ancor più che nella Latteria di Soligo, non si voleva limitare la portata della trasformazione alla riconversione dell’area, ma sfruttarne il potenziale di ri-fondazione urbana, riconsiderandone le possibili caratteristiche di strutturazione morfologico-urbana. Si sono quindi esplorati una serie di modelli derivati dalle esperienze più paradigmatiche della produzione architettonica contemporanea, testandone i possibili contributi strutturanti nei confronti dell’area ed esplorando tutta la gamma di trasformazioni dalla rinaturalizzazione con la formazione di un parco urbano alla densificazione attraverso tessuti edilizi di assoluta compattezza, per giungere poi ad un masterplan che sapesse re-inglobare i reperti industriali recuperati in una struttura d’impianto urbano completamente ripensata. Un altro esempio di riciclo urbano di un’area industriale dismessa è una recente tesi di laurea sull’area Lanerossi di Schio (Bizzotto-Girolimetto-Moro), in cui i lacerti industriali degli stabilimenti Lanerossi e alcuni tracciati dell’impianto urbano a suo tempo progettato da Caregaro Negrin sono stati assunti come materiali di una completa ri-fondazione della struttura urbana centrale di Schio, con l’esplicita volontà di trasformare il valore identitario di memoria della Lanerossi in un nuovo segnale o landmark urbano, capace di giocare il ruolo di un vero e proprio caposaldo della nuova Schio. Tutti questi esperimenti indagano sulla possibilità di ripensare le tecniche del “progetto urbano” nei termini di una riformulazione aggiornata della manipolazione della “morfologia urbana” a partire dal concetto di ri-ciclo. E’ quanto sto personalmente sperimentando nella didattica, ripescando i miei antichi studi dopo un lungo lavoro svolto in questi anni sui temi del paesaggio (urbano e non solo) e quindi sullo spazio pubblico e aperto della città in un’ottica nonconvenzionale. E questo non certo secondo accenti nostalgici, ma con l’intento di trovare strade innovative, o più semplicemente metodologie, per una risposta meno richiusa sul “particulare” e più capace di incidere (appunto) sulla forma urbana più complessiva, senza per questo dover ricadere nell’ormai improponibile riscoperta di tecniche di radicale renewal urbano. L’esempio forse più esplicito di questa ricerca di metodo, già visibile nella tesi sulla Mira Lanza, è stato un esperimento compiuto con una tesi di laurea (di Nicola Russolo) che mi ha fatto tornare – a distanza di ben quarant’anni – sul campo della mia personale lontana tesi di laurea: la città di Glasgow in Scozia. Il caso di Glasgow è un caso assolutamente paradigmatico di applicazione dei modelli di trasformazione urbana sperimentati dalla cultura degli architetti negli ultimi tre secoli. Il corpo della città di Glasgow è infatti la testimonianza concreta dello stratificarsi di una vicenda secolare di successi e di fallimenti delle idee e dei modelli di costruzione e ricostruzione urbana, e per questo è un caso paradigmatico per la storia del progetto urbano. La tesi di Russolo (e mia) è che quella particolare periferia interna rappresentata a Glasgow dall’antica area dei docks portuali lungo il fiume Clyde possa essere ri-ciclata e ri-generata soltanto se sarà in grado di ritrovare un chiaro principio fondativo e quindi di ripensare la sua morfologia in funzione di un sistema di relazioni ricche e complesse di accessibilità e di collaborazione fra gli oggetti architettonici e d’uso (a volte di grandi firme come Norman Foster o Zaha Hadid) che gradualmente vi si sono insediati in modo purtroppo disordinato e slegato: vere e proprie cattedrali nel deserto. Per rintracciare i possibili principi ri-fondativi o di re-invenzione di questa importante area urbana, desolatamente slegata dalla sua città, la tesi ha messo in moto un processo metodologico che ha comportato l’applicazione sperimentale di una serie di “modelli insediativi” desunti dalla complicata, stratificata e paradigmatica storia di trasformazione della città stessa, sottoponendo l’area a una serie di test di “reazione” all’applicazione di tali modelli più o meno astratti. I vari “modelli” variano da un limite minimo di occupazione dei suoli che prevede la restituzione dell’area alle acque del fiume e delle sue antiche darsene portuali o l’invasione dell’area da parte del vicino parco pittoresco di Kelvingrove ad un limite massimo di occupazione dei suoli che prevede la costruzione di una griglia edificata simile a quella georgiano-vittoriana o il punteggiamento con alte torri alla maniera dell’urbanistica high rise del dopoguerra. Ogni test è valutato secondo i vantaggi e svantaggi in termini di ri-fondazione e re-invenzione dell’area, acquisibili con l’applicazione del singolo “modello, pur conservando integralmente tutti gli oggetti architettonici presenti nell’area stessa. E’ evidente che i singoli “modelli” sperimentati si fondano non soltanto sulla possibile coerenza con i modi storici di costituirsi della morfologia urbana di Glasgow, ma anche sulla verifica delle risposte contenute nell’impostazione “ideologica” di ciascuna di queste proposte, ascrivibili ai mutamenti del pensiero e degli scenari architettonico-urbani fra Settecento e Novecento, e fino all’oggi. 7 La tradizione di forme della città di Glasgow e delle “ideologie architettonico-urbane” che l’hanno via via plasmata e trasformata è assunta quindi come materiale di indagine per un progetto contemporaneo della sua area forse più innovativa e rappresentativa. L’intento programmatico di utilizzo del bagaglio storico come materiale di un progetto trasformativo si può forse correlare a quell’atteggiamento che ManfredoTafuri leggeva nel dibattito e nelle utopie delle “Venezie possibili” a commento della mostra omonima nel 1985: “Tradizione significa a Venezia continuità del ‘tradimento’: esattamente il contrario di ogni vischiosità conservatrice. Ciò che nel perenne ritrovarsi, nella perenne rifondazione, è chiamato a resistere, non è una forma, bensì un modo di essere in relazione” (cfr. Le Venezie possibili. Da Palladio a Le Corbusier, Electa, Milano, 1985). Il nuovo master plan di re-invenzione dell’area dei docks di Glasgow è alla fine proposto da Nicola Russolo come un montaggio ponderato e ibridato di differenti possibili opzioni morfologiche, di un sistema relazionale, appunto, offerto come capace di riannodare l’area alla città e al suo fiume e di ritesserne le relazioni interne, in funzione del suo ruolo centrale nelle attività culturali e commerciali della nuova città del XXI secolo. In tal senso la proposta sperimentale elaborata da Russolo vuole navigare lontano sia da radicali operazioni di renewal (come quelle tutto sommato ancora accarezzate dall’amministrazione urbana di Glasgow, secondo principi piuttosto stantii di new urbanism) sia da operazioni di puro “rammendo” dell’esistente, ma cerca di operare una vera e propria metamorfosi a partire dai materiali “trovati” e dal loro re-innesto e da una loro ricomposizione significante, dotata di una trama solida e comprensibile di relazioni spaziali ed urbane. Forse in tal senso – suggerisce l’esperimento - la morfologia urbana, quale strumento non solo di conoscenza ma anche di progetto, può ancora contribuire a ripensare radicalmente il futuro di una città. 4. LE AZIONI DAL BASSO ovvero RE-ACTION Ma c’è un capitolo della nostra ricerca che apre anche il problema che al tempo della crisi gli strumenti d’intervento progettuale devono essere profondamente rivisti anche in quanto alle tecniche e ai processi di azione del progetto nella società e nel territorio. Non ci si può più affidare semplicemente all’inventiva (visionaria o meno) dell’architetto-demiurgo, e in fondo nemmeno alle nostre capacità di riconfigurare un progetto urbano a partire dall’esistente, ma occorre confrontarsi anche apertamente con i contributi che vengono da un’azione capillare, “dal basso”, nel sociale, più corale e democratica (fatico a usare la parola “partecipativa”), e sfruttarne le potenzialità per aprire quei “nuovi cicli di vita” di cui stiamo parlando, così come lo stesso Renzo Piano pare preannunciare quando si richiama nel suo articolo già citato alla sua vecchia esperienza partecipativa del “laboratorio di quartiere” a Otranto nel 1979. Non è più il tempo evidentemente – dato lo stato delle risorse economiche, e soprattutto di quelle pubbliche - dei grandi disegni di renewal urbano, delle grandi operazioni di ristrutturazione urbanistica, nemmeno forse dei semplici investimenti sulla reinvenzione degli spazi pubblici urbani come hanno tentato in passato città come Barcellona. Occorre probabilmente trovare strategie più sottili di “infiltrazione”, che lavorino più dal basso, fortemente saldate all’azione nei tessuti sociali, trovando anche alleanze con l’azione dell’imprenditoria privata ma soprattutto dell’associazionismo, del volontariato, delle Fondazioni senza scopo di lucro, e che agiscano – se mi si consente di mutuare linguaggi della medicina - più per agopuntura o per riattivazione di meccanismi metabolici, se non addirittura per omeopatia o per scatenamento di infezioni virali “virtuose”, piuttosto che secondo procedure chirurgiche. Il riciclo peraltro è una pratica che nasce proprio, con radici antropologiche, nell’ambito di comportamenti individuali o al massimo di “cultura materiale”. Basti pensare alle pratiche di riciclo nel campo dell’alimentazione, passate nella gastronomia solo dopo una sperimentazione spontanea nella cucina povera, o anche alle pratiche di riciclo nel campo dell’abbigliamento o dell’oggettistica, che derivano di fatto da operazioni “da rigattiere”, con conseguente montaggio dei materiali “trovati”. Torna qui in campo non casualmente il riferimento alle tecniche di bricolage già ricordate. E ciò vale anche per molte esperienze non solo dell’arte povera, ma anche dell’architettura “povera”: si pensi ad operazioni come quelle spesso compiute da architetti quali Shigeru Ban o Kengo Kuma in area giapponese, o quali i Rural Studio negli USA o alle molte esperienze della più o meno giovane architettura olandese, dagli MVRDV fino ai Superuse Studios. Si tratta quindi di movimenti dal basso, su spinte spesso individuali o volontaristiche, che solo gradualmente si trasformano in “campagne a sfondo collettivo”, proponendosi perciò in una dimensione comunitaria e quindi politica, verso l’affermazione di un “bene comune”. E’ proprio questo passaggio da pratiche o tecniche - favorite dai tempi di crisi e dall’aguzzar l’ingegno, ossia la creatività indotta che le crisi comportano – a metodi e strumenti che possono proporsi come “nuovi paradigmi” per imprimere una svolta al lavoro attorno alle trasformazioni delle nostre città e dei nostri territori, quello che ci interessa cercare nel mondo del “riciclo”. Ciò suggerisce di riaprire il dialogo dell’azione progettuale con il tessuto sociale e territoriale, non solo e non tanto in termini di pratiche di partecipazione e concertazione (che spesso si sono rivelate inefficaci e vuote), ma proprio nel senso 8 dell’innesco di “azioni” sperimentali che aprano la strada a un rinnovamento “creativo” delle situazioni urbane e territoriali. E le occasioni per tali “azioni” risiedono spesso oggi nei domini del non-programmato, del temporaneo, dell’emergenziale. Si tratta dunque di capire se da queste occasioni si possano ricavare metodi e pratiche trasferibili su un piano più generale e strategico. “Essere pervasivi, radicali e rigenerativi - scrive Pasquale Persico in Living the other city – Abitare l’altra città, 2012 – deve poter significare nuova capacità di diventare rabdomanti di un territorio che deve trovare sorgenti e risorgenze dimenticate o inattese, ma significa anche credere alla metamorfosi urbana dell’eredità materiale e immateriale che è la città, infrastruttura complessa da riposizionare nell’area vasta”. Stiamo parlando evidentemente di una linea di “progetto” (proiezione in avanti), che accetta di confrontarsi con le trasformazioni, lasciando da parte atteggiamenti puramente difensivi (di pura “protezione”) che non hanno il fiato lungo in un mondo in tale tumultuoso cambiamento. Stiamo parlando non tanto di un disegno finito e visionario di un futuro possibilmente radioso, ma dell’apertura consapevole di un processo di trasformazione “controllata”. Poiché penso nessuno di noi creda più a un progetto blueprint ma piuttosto a un progetto “processuale” che preveda interventi di innesco, di controllo e manutenzione, di adattamento progressivo delle trasformazioni, e che lavori quindi attraverso strategie “narrative”, capaci di mettere in conto le mutazioni e i movimenti, nonché i comportamenti e le percezioni cangianti, fuori da qualsiasi idea di cristallizzazione dei progetti in geometrie “cartesiane”. In questo senso mi pare assolutamente interessante valutare attentamente l’apporto al processo di re-cycling che può venire da esperienze come quelle del gruppo milanese dei TempoRiuso o di giovani architetti associati nel progetto SOSacces, o di altri simili e sempre più diffusi esperimenti di progettazione dal basso (nell’ambito della nostra ricerca vi stanno lavorando per esempio alcuni colleghi reggini – cfr. il quaderno n.9 della collana della ricerca Recycle italy, a cura di A.Paolella, intitolato People meet in the recycled city, Aracne, Roma 2014): tutte esperienze improntate a un largo coinvolgimento nelle trasformazioni non solo delle amministrazioni ma anche della popolazione e dei gruppi di azione popolare e che lavorano su processi graduali e temporanei di trasformazione e riciclo, certamente di minore portata dimensionale ma in grado di innescare strategie più vaste per nuovi cicli di vita urbani. Questa è una importante nuova frontiera che si è ormai aperta per i giovani architetti, in una dimensione professionale (di start-up) largamente inedita, non-convenzionale e “creativa”. Ed è anche probabilmente il futuro delle trasformazioni nelle nostre città, che può giocare la carta delle riconversioni e delle riqualificazioni delle aree abbandonate o dismesse (dalle caserme alle aree industriali) o delle friches residuali come le aree lungo fiumi, infrastrutture, ecc. 5. IL RUOLO DEL PAESAGGIO Dopo quanto fin qui esposto, per finire mi chiedo – dato che ci troviamo qui in una Scuola che si interessa soprattutto dei temi del paesaggio – quale ruolo possa avere il paesaggio in tutti questi processi – sperabilmente virtuosi – di ri-ciclo. Può essere – mi chiedo – che il progetto di paesaggio, aggiornato secondo i concetti piuttosto rivoluzionari impostati dalla Convenzione Europea del Paesaggio, possa costituire parte integrante di questo processo di ri-ciclo? Penso proprio di sì. Già gli accenni ai temi della città-paesaggio su cui si è fondata la mia esperienza di progetto urbano a Trento mi pare possano testimoniare di questo. E in tutte le ricerche progettuali che ho citato il tema del paesaggio ricorre come elementochiave per stabilire nuovi cicli di vita delle città e dei territori esaminati. Forse ancor più esplicita in tal senso è stata la sperimentazione che abbiamo condotto assieme con Emanuela Schir ed altri colleghi sul tema delle cave, dismesse e non, del distretto trentino del porfido o dell’area di Ala-Pilcante. In quello studio (cfr. www.paesaggiotrentino.it) si è voluto indagare e proporre il significato fondativo di una strategia di autentico riciclo territoriale a sfondo paesaggistico che le costellazioni delle cave potrebbero rivestire, cessando di essere segni di degrado paesaggistico e proponendosi invece come occasioni di rilancio e quindi autentiche risorse identitarie di quei territori. Si è trattato di fatto di delineare scenari “preventivi” di paesaggi presenti e futuri, cui possa attribuirsi quel valore identitario che è rivendicato dalla Convenzione Europea del Paesaggio. Ne è discesa la proposta di assumere la presenza diffusa delle cave in alcune enclaves territoriali del Trentino quale risorsa non solo economica ma anche culturale e paesaggistica, nell’ipotesi che la si sappia sfruttare a supporto e arricchimento degli altri valori storico-culturali e geografico-paesaggistici dei medesimi territori, in una prospettiva capace di sottolineare e propagandare un’immagine peculiare del territorio stesso: quasi un suo possibile “marchio d’origine controllata”. Per esempio, il distretto del porfido è una regione peculiare per la geomorfologia fortemente ondulata dall’antica eredità glaciale, ricca di attrazioni turistico-naturalistiche (i numerosi piccoli laghi, i boschi, i numerosi biotopi in zone umide, il fitto reticolo di sentieri e percorsi, equestri, di trekking o di biking, etc.), di scenari agricoli di pregio (in ispecie i vigneti), di testimonianze storico-archeologiche (l’ecomuseo dell’Argentario e le tracce delle antiche miniere di argento), di 9 emergenze storico-architettoniche (ricordiamo anche solo il castello di Fornace, le chiese di Civezzano, San Mauro, Santo Stefano, vari piccoli centri storici), e poi di punti panoramici di notevole fascino. Mettere a sistema il complesso di queste valenze attrattive, sfruttando in termini positivi la specificità connessa all’attività estrattiva del porfido e convertendola da elemento deturpante a risorsa identitaria, non sembra un obiettivo impossibile, se appena si considerano i valori scenografici e le potenzialità “formali o figurative” che i siti estrattivi spesso presentano nel caratterizzare ulteriormente questi paesaggi. La messa in luce delle sequenze spazio-temporali, quindi dei “movimenti” con cui può fruirsi l’ingresso e l’attraversamento dentro il territorio di ogni “costellazione” può diventare la traccia, lo story-board , di un racconto -anzi di uno stratificarsi di racconti – per immagini e per sensazioni percettive, che ne sottolinea i caratteri di “paesaggio”. E’ importante sottolineare che l’“istituzione di nuovi cicli di vita” nei paesaggi estrattivi è per forza di cose basata su strategie “processuali”, e che lavora insieme e in parallelo con gli stessi “cicli della produzione”(dell’attività estrattiva). Insomma il fattore “tempo” è un fattore determinante della strategia, la quale lavora necessariamente sulla base di scenari di paesaggio “preventivi”, che sono obiettivi di breve, medio o lungo termine, a seconda dello stato dei siti e delle attività in corso. Gli strumenti preliminari per definire questa strategia sono in primo luogo la rilevazione dei caratteri formali nei vari punti degli itinerari (variabilità delle sezioni territoriali, morfologia in successione di alture e depressioni derivante dalla formazione geologica e orografica, alternanza di rocce vive e di manti vegetali e boschivi…) e la rilevazione dei caratteri percettivi degli stessi (direttrici e scenari visuali e panoramici, skyline e landmarks, sensazioni di compressione e dilatazione, sonorità degli ambienti, passaggi da sole a ombra, da fresco a caldo, rispecchiamenti sulle superfici lacustri, effetti cromatici, ecc). La strategia delineata ha individuato pertanto come fondamentale la sottolineatura di “luoghi-porta”, capaci di segnalare manifestamente l’ingresso in un territorio peculiare, sfruttando anche i suoi possibili valori “scenografici” e inoltre la sottolineatura di un reticolo complesso e stratificato o intrecciato di itinerari di attraversamento e scoperta del medesimo territorio, capaci di rivelare le peculiarità di cui si è detto. Le cave si sono proposte così come materiali ed occasioni di un progetto di riconfigurazione territoriale complessivo, entro il quale – allo stesso modo prima richiamato per altri tipi di uso temporaneo (il discorso può valere analogamente per le caserme o i siti militari dismessi, per es – cfr. al proposito la ricerca di un altro mio allievo e collaboratore, Alessandro Santarossa, www.primulecaserme.it) – possano collocarsi interventi anche minuti, graduali e temporanei, capaci di accompagnare da vicino nel tempo gli stessi meccanismi della produzione dell’industria estrattiva e la loro graduale dismissione. 10
Scaricare