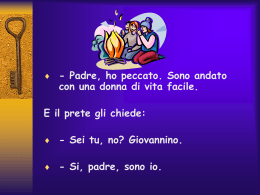Minardi, A. GUARESCHI: STORIA DI UN UOMO COERENTE La biografia inedita dell’autore di “Don Camillo” scritta dal suo più intimo amico da L’Uomo Qualunque, n. 9, marzo 1998 ÷ n. 22, giugno 1998 A novant’anni dalla nascita e a trent’anni dalla morte dello scrittore, ecco le vicende più segrete della sua vita attraverso le note e gli appunti di chi gli fu accanto quotidianamente Guareschi torna sempre a far parlare di sé, anche se molti non vorrebbero. Ad esempio, quando il consiglio comunale di Busseto, senza distinzioni di colore politico, decretò di intitolare al suo nome la piazza di Roncole, il paese dove lo scrittore aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita (quando gli era diventata insopportabile la frenetica vita di Milano) ci fu chi si oppose. Era destino che la generale armonia con la quale era stata presa la decisione del consiglio comunale (avevano votato favorevolmente anche i comunisti) venisse turbata da un vecchio giornalista littorio passato all’intellettualismo conformista imperante. Ma con le sue escandescenze di sapore staraciano contro Guareschi scrittore e uomo, Vittorio Gorresio aveva ottenuto il contrario di ciò che si attendeva: una generale sollevazione dei vecchi lettori di Guareschi che non avevano dimenticato lo scrittore che tante ore felici aveva loro donato. La gente non ha perso la memoria e sono moltissimi quelli che ricordano lo scrittore brillante e umano che più d’ogni altro si è battuto per un’Italia onesta e pulita, il galantuomo inflessibile, il soldato che ha preferito la prigionia nei lager nazisti piuttosto che tradire il giuramento e, ancora, in democrazia ha accettato il carcere per non appellarsi contro una sentenza da lui (e da tanti altri) ritenuta ingiusta. Guareschi era un uomo dai costumi semplici nella vita di ogni giorno ma pieno di fantasia quando prendeva la penna o la matita in mano, i politicanti e i sociologi e si trovava a suo agio solo fra la gente della Bassa Parmense, dove era nato e dove aveva maturato tutto ciò che gli sarebbe servito come scrittore e disegnatore. Va ricordato che fino agli anni ’20 la Bassa Parmense era un mondo chiuso, una specie di Far West con le sue tradizioni, le sue leggi naturali, le consuetudini morali e suoi comportamenti secondo cui l’individuo progrediva con il lavoro, l’intelligenza e la forza di carattere. Guareschi era un uomo della Bassa, tagliato su misura, con la stessa mentalità di autentico agricoltore che deve mandare avanti con spirito pionieristico la sua impresa. Per questo si trovava bene quando parlava con un bergamino per discutere sulla condizione del bestiame, con un capomastro quando c’era da discutere la costruzione di un tetto complicato, con un fabbro quando c’era da intendersi sul come disegnare un cancello che non si “svirgolasse”. Parlava il linguaggio di quella gente e la gente, che pur sentiva per lui il massimo rispetto, si trovava a pieno agio con lui, così semplice e genuino, uno di loro, insomma, che intercalava il discorso con battute polemiche e spiritose nel linguaggio di quel mondo. Lo cercavano, lo stimavano proprio perché era uno di loro. Quando Guareschi, ancora ragazzo, seguì la famiglia a Parma e venne messo al famoso “Convitto Nazionale Maria Luigia” l’impatto fu duro. La sua semplicità di vita avrebbe dovuto allinearsi al conformismo di una società fin troppo sofisticata. Il dramma intimo del giovane fu attenuato dalle nuove amicizie: Pietro Bianchi che divenne poi uno dei più acuti critici di cinema, Cesare Zavattini allora istitutore al “Maria Luigia”, Attilio Bertolucci che già aveva stampato il primo libro di poesie, Erberto Carboni cartellonista di fama europea, Ugo Betti il drammaturgo allora pretore, Atanasio Soldati il maestro dell’astrattismo italiano e, più intimamente, il sottoscritto. Dopo la crisi mondiale del ’29 le traversie economiche travolsero anche suo padre e Guareschi si trovò da un giorno all’altro nella angosciosa necessità di dover pensare a mantenersi. Aveva appena preso la licenza liceale (meritandosi la stella d’oro che il primo della classe aveva il diritto di portare sulla manica destra) e nello stesso tempo diventò istitutore dello stesso “Maria Luigia” prendendo il posto di Zavattini “emigrato” nel frattempo a Milano dove trovò subito posto da Bompiani. Ma con il magro stipendio di istitutore (200 lire al mese) c’era poco da godere e Guareschi dopo qualche mese cercò dell’altro: fece l’elettricista, l’ufficiale di censimento, il cartellonista, lo scenografo, lo xilografo dando anche qualche ripetizione a due lire l’ora; d’estate il portinaio allo zuccherificio “Eridania”. Tra l’altro, lui che non aveva mai visto un motore, riscrisse il “Manuale dell’automobilista” (edito da Hoepli) avendo avuto l’incarico dal vecchio autore che non riusciva a scrivere in una forma adeguata ai nuovi tempi. Furono le prime trecento lire guadagnate con la penna con la penna in due mesi di lavoro. Aveva preso in affitto un solaio nello squallido Borgo del Gelso (60 lire al mese d’affitto), si manteneva a cappuccini e brioche, salvo quando andava a Marore che lo rimpinzava di minestroni. Poi, la svolta fatale, il contatto con la carta stampata: venne assunto come correttore di bozze al Corriere Emiliano che aveva assorbito la pluricentenaria Gazzetta di Parma. Era il 1930. pochi mesi dopo, nel 1931, quando diventai redattore capo di quel giornale, convinsi il direttore Stanis Ruinas a nominarlo capo cronista. E fu allora che la sua fantasia esplose. Scriveva delle cronache inventate perché diceva che la fantasia è più divertente della realtà (in realtà perché era costretto a fare il “giro” di cronaca per il quale si perdeva gran tempo con scarsi risultati). Dunque storie fantastiche ma scritte con una tale abilità che nessuno ebbe mai dubbio che si trattasse di invenzioni. Scriveva un pezzo al giorno, lo portava in redazione e poi spariva fino a sera quando tornava per correggere le bozze. Ed era un correttore con l’occhio infallibile. L’incontro di Giovanni Guareschi con Ennia Pallini (Margherita per chi ha letto il Corrierino delle Famiglie) avvenne in un ambiente e in un’atmosfera tipica di un racconto della “Bassa”, in un tempo in cui Giovannino non poteva pensare a diventare famoso con i suoi racconti che hanno fatto il giro del mondo. Eravamo nel 1933, quando a seguito dei “treni popolari” (lire due andata e ritorno Venezia, Roma, Bari, Firenze, Napoli) anche a Parma si istituirono ogni domenica tram (a vapore ed elettrici di Muggia) che partivano dalla città alle sei del mattino per Fornivo, Marzolara, Montecchio, Langhirano, Busseto e Polesine e tornavano verso mezzanotte. Il Corriere Emiliano - Gazzetta di Parma fu sollecitato a mandare un “inviato speciale” al primo tram popolare che aveva meta Montecchio. Il programma prevedeva gite in libertà, pic-nic e alla sera un gran ballo in piazza, aperto a tutti. Nessun collaboratore se la sentiva di perdere una intera giornata per una scampagnata in mezzo a una folla festaiola. Sola la sera di sabato Guareschi, che era appena stato nominato capo cronista, saputo del ballo decise: “Ci vado io, finalmente avrò da scegliere fra tante ballerine”. E così fu. Però tornò tanto tardi che non si poté pubblicare il servizio che apparve sul giornale con un giorno di ritardo. Il giorno dopo venne in redazione trasformato. Non era più il tipo introverso e timido che tutti conoscevano. Mi venne incontro fresco come una rosa e sorridente: “Una cosa meravigliosa – mi disse – ho conosciuto una ragazza con la quale ho ballato tutta la sera. Inesauribile, spiritosa, bellissima, una rossa piena di pepe. Pensa che mi ha messo a terra per la stanchezza. Quando mi fermavo qualche istante, tutto sudato, per bere una gazzosa, si metteva a ridere dicendo: ‘ Ecco il signorino che ha scarsi muscoli ’. Un bel momento ha voluto che saltassimo su un tavolino di marmo per fare il ‘ ballo del mattonella ’. credevo di non farcela perché sai bene, quando io ballo ce la metto tutta. Ebbene mi obbligò a ballare, sul tavolino, un tango e un foxtrot. A un certo punto la pregai di fermarsi: le promisi che dopo avremmo fatto una mazurca ‘dipinta’. ‘Che mazurca – mi disse – qui ci vuole Jalouise ’. Massacrante, ma ce la feci anche se il ballo finì in modo imprevisto: alle ultime battute il tavolino crollò rovinosamente fracassandosi in mille pezzi e noi facemmo appena in tempo a saltare giù toccando terra in piedi tenendoci per mano. Roba da cinematografo, una gag degna di Stanlio e Olio. La ragazza mi abbracciò e finalmente mi disse che ero in gamba: ‘ altro che signorino ’. mentre mi asciugavo il sudore dalla fronte mi accorsi di una cosa straordinaria: vidi che tutta la gente si era fermata in un gran cerchio per guardarci, tutti silenziosi come se fossero a una prima del ‘Regio’. Alla fine scoppiò un applauso che avrò sempre nelle mie orecchie”. È un episodio che dimostra che Guareschi quando andava al “Gardenia” o nelle balere della “Bassa” aveva lo spirito del cow boy che va al rodeo. Quella ragazza era una barista del “Bar Orientale” di piazza Grande e non l’aveva mai vista prima. Da allora cominciò una storia che durò più di trent’anni. (1 - Continua) Alessandro Minardi Da “L’Uomo qualunque” 12/03/1998 MUSSOLINI IN PERSONA ORDINO’ DI SCARCERARLO Gli anni giovanili dell’apprendistato giornalistico a Parma e la chiamata dell’editore Rizzoli a Milano. La sbronza fatale: arrestato per aver insultato pubblicamente i gerarchi fascisti A Ennia Pallini, la moglie di Guareschi, quando, già madre, parlava della sera del primo incontro con Giovannino, venivano i lucciconi. “Io – diceva – ero stanca di lui, ma non volevo che se ne accorgesse. E pensare che non toccavamo una goccia di vino: andavamo avanti a gazzose, altro che la gioventù di oggi che trova la carica nel whisky”. Ecco perché per parlare compiutamente di Ennia Guareschi è indispensabile averla conosciuta di persona negli anni giovanili. Snella, capelli di fuoco, pronta alla battuta, testarda nelle sue simpatie come nelle antipatie. Squadrava la gente con occhio infallibile e qualificava l’interlocutore a prima vista: un giornalista, in seguito noto critico musicale, secco allampanato e biondastro, indolente e immobile come una statua, era “un soldato del papa”; lo scrittore Giuseppe Marotta che sembrava tanto rude era per lei “delicato come un orologio svizzero”; Carletto Manzoni, uomo di poche parole e ironie silenziose, “aveva dimenticato a casa la lingua”; l’editore Angelo Rizzoli, il “commenda”, “è infaticabile: ma non si stanca di incassare miliardi”. LA SOUBRETTE IN VISTA La stessa costanza, l’identica volontà di non mollare furono gli elementi che sostennero Ennia Guareschi nella vita, senza disperazione nei momenti duri, senza inutili esaltazioni nei momenti felici; e furono tanti gli uni e gli altri: quando a Milano riuscirono finalmente a mettere su casa, quando Giovannino fu deportato in Germania, quando lui conquistò il successo mondiale, quando ci fu il processo De Gasperi seguito dal durissimo carcere in San Francesco, quando ne uscì distrutto, quando dovette abbandonare il suo “Candido”, quando venne colpito dal primo infarto. La signora Ennia tenne sempre duro, continuando il ballo dell’esistenza anche se per tenere su lui non bastavano più le gazzose. E quando la fortissima fibra dell’uomo crollò anche per lei fu la fine. Campò altri quindici anni ma la sua non era più vita. Non era una donna facile da avvicinare. Per lei contavano solo suo marito, i suoi figli, la casa, e il suo problema principale era quello di allontanare i seccatori e i seccatori per lei erano tutti coloro che suonavano al campanello della sua casa. -“Il signor Guareschi non c’è”. -“Quando potrei trovarlo?”. -“Non lo so; sa, va e viene quando vuole”. -“Ma scusi lei non è sua moglie?”. -“Certo, ma questo non significa che io debba dire a uno sconosciuto quando mio marito c’è o non c’è”. Una sola volta fece una eccezione riscattando tutti i “non c’è” che aveva detto per decenni. Accadde allorché si presentò, alla porta della villetta di via Righi dove abitava, Ines Lidelba, famosa soubrette degli anni ’20 e ’30. l’attrice era ancora una magnifica creatura, tale da far impallidire tutte le soubrette degli ultimi 40 anni. Era sposata con un ricco industriale e pur essendo una gran signora faceva una vita piena di semplicità e di modestia. Fece subito colpo sulla signora Ennia prima ancora di qualificarsi. La fece entrare – ed era già molto – e si presentarono. La Lidelba disse che era venuta a conoscere Guareschi ma non voleva disturbare. Le fu risposto che purtroppo Guareschi stava lavorando (era effettivamente in riunione di lavoro con Manzoni e con il sottoscritto) ma certamente avrebbe ricevuto un’ospite così eccezionale. Ci chiamò e cominciò un pomeriggio indimenticabile. Guareschi, che sorrideva sotto i baffi, divertito, lasciò la conversazione alle due donne. Sembrava il dialogo preparato da un gran sceneggiatore. L’attrice raccontava le sue esperienze, la signora Ennia ad ogni nome faceva da contrappunto con battute brillantissime. Guareschi, Manzoni e io eravamo spettatori muti ed estasiati: pareva di assistere ad una commedia esilarante imperniata su due attrici eccezionali. Durò fino alle otto di sera, ora in cui Ines Lidelba si ricordò di avere una cena alle nove. Manzoni e io l’accompagnammo a casa, lei seguitò a parlare della signora Ennia commentando: “Ora capisco molto di più anche di Guareschi”; disse tra l’altro: “Potessi stare una volta, di tanto in tanto, un pomeriggio con la signora Ennia, potrei diventare me stessa, rinascere. Quella è una donna come poche”. Da tempo Giovannino ed Ennia giacciono nel cimitero di Roncole, a quattro - cinque passi l’uno dall’altro; se uno dei due potesse parlare direbbe all’altro: “Dai, bevi una gazzosa e balliamo sulla mattonella”. Due, tre volte all’anno facevamo in collaborazione dei numeri unici umoristici che furono lo sfogatoio per la fantasia di Guareschi. Allora lui scriveva di tutto: raccontini, poesiole, satirucole, sfottò e perfino filastrocche in romanesco. Inoltre disegnava caricature e vignette all’acido solforico; incidendo poi i disegni in linoleum per risparmiare il costo del cliché. Viaggiava con una sgangherata bicicletta da donna che aveva pagato 35 lire. Era uno strano tipo di introverso, scontroso e solitario, ma bastava che incontrasse un amico o un conoscente simpatico per esplodere con tutta la sua cordialità. Molti lo consideravano un uomo di talento ma inevitabilmente destinato a barcamenarsi in provincia, invece lasciò presto Parma. Dapprima per assolvere il servizio di leva. Vestita la divisa venne destinato alla scuola di artiglieria. Esaurito il corso fu a Modena e a Potenza; compiuta la ferma ritornò a Parma per raccogliere le sue carabattole e trasferirsi definitivamente a Milano. L’editore Rizzoli, su segnalazione di Zavattini, l’aveva ingaggiato per un nuovo settimanale umoristico del quale divenne in seguito redattore capo. Questo periodico, costituì un’autentica rottura nell’editoria italiana e incise profondamente nel costume nazionale. Ancora oggi non si può parlare di quegli anni senza tenere conto della funzione che ebbe il Bertoldo nella formazione anticonformista di un paio di generazioni. Durante quegli anni Guareschi – e fino a quando non venne richiamato – non lavorò soltanto per il Bertoldo insieme con Giovanni Mosca, con Metz, Marchesi, Frattini, Manzoni, Molino, Della Zorza, Mondani e gli altri scrittori e disegnatori che si erano raccolti attorno al settimanale di Rizzoli. Scrisse romanzi a puntate, feuilleton divertentissimi per L’Ambrosiano che era il quotidiano del pomeriggio più importante dell’epoca e per la Gazzetta del Popolo, racconti per Novella, Tutto, Lei e L’Illustratore del Popolo, corrispondenze per il Corriere della Sera (fra cui un giro d’Italia turistico in bicicletta). Creava disegni per L’Illustrazione Italiana e per La Stampa di Torino. Non basta: con Mosca ed altri fu autore di due riviste teatrali che ebbero uno strepitoso successo da Milano a Roma, da Torino a Genova. Collaborò anche all’Omnibus di Longanesi e fece conferenze umoristiche in varie città. Ogni tre mesi, con i suoi amici del Bertoldo compilava L’Arcibertoldo, un grosso fascicolo che era un vero godimento: una specie di New Yorker all’italiana. Pubblicò persino con uno pseudonimo (e questo siamo in pochi a saperlo) dei fascicoli settimanali a fumetti per ragazzi, ispirati al gusto nostrano, senza imitare né americani né francesi. Ma non basta ancora: in questo periodo portò a termine anche tre libri, che naturalmente ebbero grande successo (destinato a moltiplicarsi dopo la guerra); “La scoperta di Milano”, “Il destino si chiama Clotilde” e “Il marito in collegio”: da quest’ultima opera venne poi tratta una brillante commedia e anche un film, entrato nei circuiti stranieri. LA TELEFONATA DEL DELATORE Tutto questo era il frutto di un’attività prodigiosa che gli lasciava solo poche ore di sonno. Per questa ragione la sua vita privata non cambiò di molto anche se nel frattempo era stato raggiunto a Milano dalla moglie. L’unico lusso che si permise fu l’acquisto di un’automobile che gli serviva più che altro per fare qualche puntata a Parma. Per il resto tutto continuò come negli anni di onorata miseria: niente svaghi, niente capricci, continuò a farsi le sigarette a mano con il pestilenziale “Trinciato forte” del Monopolio di Stato che sostituiva con qualche “macedonia” o “giubek” quando era inviato in qualche casa. Ma questo era un lusso che gli capitava di rado. Ora dobbiamo spiegare perché Guareschi, esonerato dal servizio militare essendo ritenuto indispensabile al fronte interno, finì con l’essere richiamato. Una sera dell’estate del ’42, dopo una cena a casa di amici dove aveva alzato un po’ il gomito (beveva pochissimo vino salvo quando era amareggiato) tornando a casa cominciò a protestare contro Tizio e contro Caio. Urlava per strada senza ritegno che, mentre suo fratello era nella steppa russa, i gerarchi se ne stavano comodamente a Roma. Fece dei nomi fra cui quello di Ciano. Dietro qualche persiana socchiusa nei pressi di via Ciro Menotti, dove abitava, ci fu qualcuno che l’adocchiò, un capofabbricato zelante e forse invidioso di lui. Sta di fatto che al comando della Milizia arrivò la telefonata del delatore e dopo pochi minuti Guareschi venne arrestato. L’evento destò sensazione perché il personaggio era intanto diventato tale, ben noto, e non soltanto negli ambienti giornalistici. Il giorno dopo Rizzoli mosse mari e monti: senza Guareschi, il Bertoldo non si sarebbe potuto fare. L’editore andò personalmente dal prefetto e dal segretario fede- rale, pregò Aldo Borrelli, direttore del Corriere della Sera, di intervenire presso il generale Galbiati, comandante della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Nulla da fare. Se non fosse stato Guareschi, venne risposto, si sarebbe potuto sorvolare sulle invettive di un ubriaco. Ma con Guareschi, no. In serata Giorgio Pini, caporedattore del Popolo d’Italia e in questo campo braccio destro di Benito Mussolini, durante la consueta telefonata delle ore 20 informò il Duce. Fu soltanto in seguito all’intervento diretto di Mussolini che il giorno dopo Guareschi venne rilasciato. Però il comando della Milizia impose che il giornalista venisse richiamato alle armi. E così fu. (2 – Continua) Alessandro Minardi Da “L’Uomo qualunque” 19/03/1998 GUARESCHI RECITAVA I DEPORTATI PIANGEVANO Lo scrittore, prigioniero in Germania, rifiuta la proposta del feldmaresciallo Kesserling di tornare libero al giornalismo per non tradire il giuramento al re. Suscita speranza e commozione tra i compagni di sventura leggendo loro, la sera del Natale 1944, la fiaba scritta per la neonata figlioletta Carlotta che ancora non conosceva. Il ritorno e l’inizio dell’avventura col nuovo settimanale “Candido” Così, vestita la divisa di sottotenente, si avviò verso la caserma di artiglieria di Alessandria. E qui, dopo l’annuncio dell’avvenuto armistizio con gli angloamericani dato alla radio da Badoglio l’8 settembre 1943, si presentarono i soldati tedeschi per parlamentare. I reparti germanici, fino a ieri alleati e adesso invasori, avrebbero preferito discutere la resa con gli ufficiali proponendo loro di collaborare. Ma quando venne il turno di Guareschi, questi tagliò corto: “Spiacente ma non c’è nulla da discutere. La situazione è chiara e semplice, c’è la faccenda del giuramento che ho prestato al re. E fino a quando il re non me ne libera, non posso prestare altri giuramenti”. Sicché venne prelevato e deportato in Germania. “SE MI AMMAZZANO, NON MUOIO” durante il trasferimento in carro bestiame, a Verona e nei pressi del Brennero, ebbe l’opportunità di scappare. Ma a chi glielo proponeva (il tenente Tassi prima e il capitano Gerolamido dopo, entrambi poi ripresi dagli ex camerati e mai più tornati nelle loro case) replicava: “Fuggire per andare dove? Sia nella Germania sia nell’Italia occupata i tedeschi sono sempre uguali. Ormai la vita sarà difficile per tutti. Il rischio sarà uguale sia qui da noi sia da loro”. La prigionia di Guareschi nel lager tedeschi e polacchi ci Czestochowa, di Sandbostel e Wietzendorf fu dura e in certi periodi durissima tanto che molti dei suoi compagni non resistettero, ma non al punto da intaccare la personalità di Giovannino. Sotto questo aspetto ebbe anzi una ricarica che aumentava la sua testarda volontà anticonformista. Dopo pochi giorni aveva già capito la situazione. La polizia del lager era organizzata e questo imponeva un comportamento pieno di cautele e di astuzie. Così studiò un piano di raffinata resistenza senza mai incappare nelle maglie della stretta sorveglianza dei guardiani. Bisognava fare in modo che questa resistenza – che era una vera e propria “ribellione dolce” – contagiasse i compagni non per com- prometterli ma per incoraggiarli nella speranza. La ferrea sorveglianza, la scarsità e la povertà dell’alimentazione, l’impossibilità di esprimere liberamente i suoi sentimenti indomabili acuirono la sua abilità dialettica. Girava le baracche raccontando favole che in realtà erano sottili satire contro i seguaci di Hitler. E i guardiani tedeschi, che non avvertivano l’insidia celata nelle sue parole, erano felicissimi perché quando parlava Guareschi gli altri prigionieri che l’ascoltavano attentissimi si abbandonavano a un riso contagioso. Ridevano senza ritegno perché era chiaro che non correvano nessun rischio dal momento che anche i guardiani in grado di capire la nostra lingua non comprendevano peraltro le sfumature sottili, le metafore. In realtà, come poi testimoniarono i suoi compagni di sventura (come il giornalista e scrittore Giovanni Ansaldo, il pittore Gastone Novello e il poeta Clemente Rebora) le favole di Guareschi erano un continuo incitamento a resistere, a sopportare e non avere paura nemmeno della Gestapo. Ma a restare, nello stesso tempo, guardinghi e sospettosi per non fornire agli sbirri l’occasione di intervento con trasferimento in un campo di punizione. Nelle parabole di Giovannino non c’erano solo vicende satiriche o umoristiche: c’era un sottofondo umano, profondamente autentico, venato di ottimismo e speranza. La speranza di tornare alla fine in Italia, rivedere i propri cari e rimettersi a lavorare corazzati da una grande esperienza. La volontà e la pazienza avrebbero reso tutti più degni di riconquistarsela libertà. Tutti i suoi compagni di prigionia interrogati dal sottoscritto dopo il loro ritorno alle rispettive famiglie sono stati concordi nel dichiarare che il suo spirito, anche quando gli internati erano ridotti allo stato di abbrutimento a causa delle privazioni, non ebbe mai cedimenti. Spesso essi integravano la brodaglia delle cucine tedesche con bucce di patata e scarti infimi recuperati dalle immondizie e Guareschi allegramente commentava che la Divina Provvidenza non si era dimenticata di loro. Quando il comandante in capo delle forze tedesche in Italia, feldmaresciallo Albert Kesserling, seppe che fino al giorno dell’armistizio si era pubblicato a Milano un periodico – Il Bertoldo – che aveva una forte presa sull’opinione pubblica nazionale, mandò a chiamare l’editore Angelo Rizzoli chiedendo esplicitamente di ridare vita al giornale. Non gli avrebbe fatto mancare nulla. Rizzoli rispose che era impossibile per il fatto che il principale artefice del Bertoldo era internato in Germania. Il feldmaresciallo Kesserling chiese allora il nome di questo personaggio “indispensabile” e telefonò a Berlino dando l’ordine che Guareschi venisse subito liberato. Ma c’era un piccolo ostacolo: Guareschi avrebbe dovuto sottoscrivere una dichiarazione di lealtà nei confronti della Germania. Firma che avrebbe in sostanza annullato il giuramento che egli come ufficiale del Regio esercito italiano aveva prestato al re. Guareschi rifiutò di sottoscrivere questa dichiarazione collaborazionistica. Inutilmente i suoi amici di Milano gli scrissero che la firma non contava niente e che, una volta ritornato in Italia, egli sarebbe stato libero di fare ciò che voleva, essendo protetto da una speciale immunità. A uno di questi amici, Ambrogio Ceroni (era un dirigente della Marelli che divenne capo la guerra direttore della galleria d’arte “Il Milione”) rispose con una lettera di due facciate in cui era scritto per 276 volte “ho ragione io”. Cominciava: “Caro Broglio, ho ragione io…” e finiva “...ho ragione io. Grazie della premura e cordiali saluti, Guareschi”. Così manteneva fede a quanto aveva detto a se stesso in un momento particolarmente critico, mentre molti suoi compagni morivano di patimenti. “No, io qui non muoio neanche se mi ammazzano”, ripeteva a chi cercava di indurlo a collaborare per salvarsi dai pericoli. La sua era una frase apparentemente senza senso, ma che rendeva bene l’idea della sua determinazione. La stessa che mise nel volere riportare in Italia il manoscritto del “Diario clandestino” che andava scrivendo di nascosto durante i lunghi mesi della prigionia e che riuscì a sottrarre alle minuziose ricerche della Gestapo. Non mi sembrò quindi strano, conoscendo io questi e altri particolari, che appena tornato a Milano, dopo la fine della guerra, quando gli espressi la mia preoccupazione per la situazione (era ridotto davvero col fisico stremato) mi guardò serio serio come se stesse meditando sulle mie parole. Alla fine scoppiò in una grande risata esclamando: “Non c’è nulla di preoccupante. L’importante è che sia ritornato con il mio cervello intatto, anzi arricchito da un’esperienza umana che adesso mi permette di valutare il mondo con maggiore sensibilità”. Poi si arrotolò una sigaretta di trinciato forte (per lui una delizia, dopo le privazioni dell’internamento) e concluse: “Oggi vado da Rizzoli e sono certo che riprenderemo subito”. Tutto andò come Giovannino aveva previsto. Rizzoli richiamò nella sede di piazza Carlo Erba, ricostruita a tamburo battente dalle rovine della guerra, l’ex direttore del Bertoldo Giovanni Mosca e riformò una redazione. Quindi iniziò le pubblicazioni Candido, una delle prime voci dell’Italia che persa la guerra non voleva perdere anche la libertà come era accaduto, o stava accadendo, a Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Iugoslavia. Naturalmente Guareschi non poteva accontentarsi di un solo giornale e così cominciò a collaborare anche al Corriere Lombardo (edizione del mattino), alla radio per la rubrica “Chi è il colpevole” con una serie di processi che ebbe uno straordinario successo (la trasmissione andava in onda alle ore 13 di ogni domenica e divenne in breve il clou dei vari programmi). Iniziò anche la collaborazione a vari settimanali, a cominciare da Oggi sul quale apparve, nell’ultima settimana del 1945, il primo racconto di “Don Camillo”. IL SUO PRIMO FILM Guareschi aveva scritto quel racconto destinandolo al suo Candido e lo aveva già passato in tipografia facendolo comporre, come usava allora, in colonne di piombo, pronte per essere messe in pagina. Incontrò peraltro nel corridoio della casa editrice il giovane collega e amico Edilio Rusconi, che era stato pure lui prigioniero dei tedeschi e al quale Rizzoli aveva adesso affidato la direzione del settimanale Oggi, che tornava in edicola dopo essere stato abolito dal regime durante la guerra. Quel giorno del loro incontro casuale disse Rusconi a Guareschi: “Sono nei guai, mi hanno anticipato la chiusura del giornale ma non ho pronto il solito racconto”. Giovannino, sempre disponibile a dare una mano a chi era in difficoltà, replicò seduta stante: “Fatti dare dalla tipografia il piombo del mio testo, per Candido ne preparo immediatamente un altro”. Così fu che il primo, e soltanto quello, “Don Camillo”, serie destinata alla fama mondiale, venne pubblicato da Oggi anziché da Candido. E di nuovo l’attività del vulcanico giornalista-scrittore-vignettista diventò frenetica come negli anni dell’anteguerra. Fra l’altro preparò “La favola di Natale”, una straordinaria satira scritta durante la deportazione in Germania per la figlioletta Carlotta, che ancora non conosceva perché nata dopo il suo internamento. L’aveva letta ai suoi compagni nelle gelide baracche la notte del Natale 1944, destando in ognuno grande commozione. Un lavoro che gli costò grande fatica per i disegni acquerellati, taluni a piena pagina, miniati con grande cura e con soggetti dove il lato patetico si alternava all’umoristico. Ma con tanta, veramente tanta poesia. In quel periodo la tipografia della casa editrice in piena ripresa era oberata di lavoro. Anche Angelo Rizzoli, il “commenda”, si era scatenato e non era in grado di pubblicare subito il volume che Guareschi si era ripromesso di fare apparire per il Natale 1945. così venne smistato all’editore Elmo. Anche questo fu un grande successo. Ed è un vero peccato che il libro non si sia più ristampato. La ragione è che quando Rizzoli chiese al primo editore i diritti di ristampa si sentì rispondere che il materiale, compresi i bellissimi disegni acquerellati e i cliché, erano stati mandati al macero. Poiché i librai continuavano a chiedere ordinazioni di altre copie del volume Guareschi, per accontentare il pubblico, fu costretto a girare l’Italia per leggere “La favola di Natale”, cominciando dall’”Angelicum” di Milano. Nel frattempo Giovannino aveva pubblicato su Candido un drammatico racconto intitolato “Gente così”, che richiamò l’attenzione di un produttore cinematografico. E allora, ecco il “nostro” dedicarsi alla sceneggiatura, alla scelta degli attori, a schizzare scene e costumi, in poche settimane fu girato un film che rimane uno dei primi del filone neorealista, carico di tensione ma profondamente umano ed educativo. Forse per questo (ma anche perché il produttore era fuori dal giro) “Gente così” uscì dalla programmazione dopo poche settimane. L’ostracismo dei cinematografari contro Guareschi cominciò allora, ci volle solo la forza di Angelo Rizzoli, che stimava al massimo il “suo” scrittore, per sostenerlo fino in fondo, riuscendo a battere questo ostracismo con un successo che ripagò Giovannino di tante amarezze. (3 – Continua) Alessandro Minardi Da “L’Uomo qualunque” 26/03/1998 GUARESCHI ACCUSA DE GASPERI DI AVER PUGNALATO SELLA Il giornalista nel 1954 inizia una vivace polemica con i notabili democristiani che avevano costretto il presidente del Consiglio a dimettersi. I retroscena dell’unico e burrascoso incontro con il “trentino prestato all’Italia” Il “caso De Gasperi” esplose nel 1954 quando Giovannino Guareschi, irritato per il siluramento del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Pella, uno dei pochi uomini politici da lui stimati, iniziò su Candido una polemica vivacissima. Il famoso giornalista vignettista-scrittore attribuiva a De Gasperi, leader carismatico della Democrazia cristiana, o comunque al suo entourage, la caduta del capo del governo , azione da lui giudicata deplorevole e dannosa per l’Italia. Guareschi pubblicò tra l’altro una vignetta, subito divenuta famosa, che mostrava Pella pugnalato alle spalle dai colleghi di partito. L’attacco suscitò la rabbiosa reazione della stampa democristiana, ormai dimentica del tutto che chi aveva provocato le forzate dimissioni di Pella era lo stesso gruppo di “amici” DC che in precedenza aveva estromesso lo stesso De Gasperi dalla guida del governo e poi del partito. “NON MI SPORCO LE MANI” FINO AD ALLORA Guareschi s’era limitato a bordate polemiche di carattere politico, senza toccare l’uomo De Gasperi. Era una critica lecita, anche se pepata, dei cedimenti dello statista che per lunghi anni aveva diretto la politica del nostro Paese con metodi che si potrebbero sbrigativamente definire poco italiani, con un mentalità “piuttosto austriaca, con qualche sotterfugio e una certa dose di arroganza”. Guareschi non dimenticava mai l’affermazione fatta da De Gasperi durante un comizio, o comunque a lui attribuita, con la quale il leader veniva definito “un trentino prestato all’Italia”. De Gasperi, osservava polemicamente il direttore di Candido, era stato in gioventù, nel 1911, deputato al Parlamento austriaco della cattolica Unione politica trentina e intransigente avversario di Cesare Battisti, pure deputato a Vienna ma come rappresentante del movimento socialista che in quel periodo si batteva per l’autonomia del Trentino dall’Austria. Scoppiata poi la Grande guerra, Battisti si era arruolato nell’esercito italiano: catturato dagli austriaci, era stato impiccato come traditore insieme con Fabio Filzi. La frase “un trentino prestato all’Italia” assumeva quindi per Guareschi un significato critico. E ancora più critica era, ovviamente, la vignetta della “pugnalata alle spalle” inferta a Pella dagli “amici” di partito. Molti lettori di Candido avvertirono che il direttore andava rivelando un aspetto di De Gasperi considerato fino ad allora tabù. Secondo Guareschi, il leader politico che per vari anni aveva rappresentato l’Italia nel consesso delle Nazioni non era esattamente quello che si era sforzato di apparire. Il giornalista ricordò il suo colloquio avvenuto un paio di anni prima con De Gasperi, quando questi era ancora presidente del Consiglio dei ministri a capo della coalizione di centro. Colloquio avvenuto a Cortemaggiore (Piacenza) su invito dello stesso De Gasperi, presenti Pella, Vanoni, Campilli e altri dignitari democristiani convenuti all’inaugurazione di quel centro petrolifero. Nell’interpretazione critica di Guareschi, Cortemaggiore serviva a Enrico Mattei, potentissimo presidente dell’Ente nazionale idrocarburi, a spacciare come una grande conquista quella che egli considerava una delle più grandi imposture del dopoguerra. La sera prima dell’inaugurazione Guareschi aveva incontrato in un bar a Busseto (Parma) vicino a casa sua tre operai che conosceva bene: sapeva che lavoravano appunto a Cortemaggiore. Dopo averli salutati, chiese loro scherzosamente: “E allora, avete preparato il petrolio per l’inaugurazione di domani?”. Con suo grande stupore si sentì rispondere: “Sì, abbiamo messo un grande serbatoio sotto la pompa. Basterà girare il rubinetto…”. Fu così che il giorno dopo, quando vide De Gasperi girare il volano del (finto) pozzo petrolifero, Guareschi si mise a sghignazzare fra lo stupore dei notabili democristiani presenti. Il liquido verdastro sgorgava davvero e i ministri, invitati da Mattei, andarono a gara a sciacquarsi le mani nel “petrolio” del sottosuolo di Cortemaggiore, anche se in realtà si trattava di greggio proveniente dall’Arabia Saudita. Qualcuno invitò Guareschi a partecipare al rito ma il nostro rifiutò dicendo: “Io non mi sporco le mani”. Ma l’allusione non venne compresa. Quel giorno ero anch’io a Cortemaggiore insieme con Giovannino, che mi aveva affidato la con direzione di Candido. Più tardi, mentre tornavamo a Milano mi disse: “Con quali imbroglioni abbiamo a che fare! Che peccato che non possiamo pubblicare niente. La mia e la tua testimonianza non contano e quei tre operai chiacchieroni, se chiamati a testimoniare, verrebbero messi a tacere facilmente. Per loro, c’è di mezzo il pane”. Ma l’imbroglio del petrolio non era che la premessa di quella giornata indimenticabile. Eravamo al pranzo offerto da Mattei a duemila persone, sotto un capannone grande come una piazza d’armi. Al nostro tavole c’erano fra gli altri il famoso architetto Mazzocchi e il famoso agricoltore Ferdinando Bergamaschi, che aveva una tenuta modello nei pressi di Cortemaggiore. A un certo momento si avvicino a Guareschi un funzio- nario della presidenza del Consiglio, che con molto garbo gli disse che il “presidente lo desiderava al suo tavolo”. Guareschi rimase perplesso e inutilmente si schermì dicendo che doveva trattarsi di un equivoco: “Io non ho chiesto di parlare col presidente e non credo che lui abbia qualcosa da dirmi: ha ben altro a cui pensare”. Il funzionario, imbarazzato, insistette e Guareschi, sia pure controvoglia, andò. Molta gente che aveva assistito alla manovra si alzò in piedi per seguire quello che accadeva. Ma non si vide nulla di strano. Sedutosi Guareschi accanto a De Gasperi questi cominciò a parlare lasciando all’interlocutore solo qualche parentesi, il tempo per tirare il fiato. Nessuno ovviamente sentiva nulla, ma si capiva bene che De Gasperi diceva cose non gradite a Guareschi e che le contestazioni di questi erano ancor meno gradite a De Gasperi. Giovannino ritornò al nostro tavolo scuro in volto. Bevve qualcosa e dopo avere salutato gli amici mi disse: “Andiamo a respirare aria pulita. Qui si soffoca”. LE INGIURIE DI TOGLIATTI In auto, durante il ritorno, sfogò l’amarezza che aveva dipinta in volto. Mi disse che De Gasperi era un uomo intrattabile, lo paragonò ironicamente a “uno sbirro austriaco di Maria Teresa”: sembrava incapace di “digerire” il recente successo elettorale dei monarchici, specialmente a Napoli, dove avevano riportato la maggioranza assoluta dei voti. Per questo motivo il leader gli aveva detto che sarebbe stato durissimo contro tutti i tentativi di opposizione da destra. Temeva che dopo il fallito esperimento dei “qualunquisti” di Giannini prendesse piede un movimento di opinione di destra; osservava che i monarchici si agitavano troppo, temeva perfino una crescita liberale. Sicché avrebbe fatto di tutto per impedire il proliferare di giornali piccoli o grandi che potessero dirottare l’opinione pubblica verso destra. Guareschi gli aveva detto: “Ma non siamo in democrazia, non siamo liberi?”. “Siamo in democrazia e liberissimi” gli aveva risposto De Gasperi fulminando con un gelido sguardo il suo interlocutore. “Ora ho capito tutto – ribatté Guareschi – la ringrazio sinceramente”. È chiaro che dopo questo colloquio Giovannino non avrebbe più potuto vedere De Gasperi come l’aveva visto prima. Il contatto umano gli aveva aperto gli occhi: De Gasperi non era italiano, nel senso che si intende comunemente, era “un trentino prestato all’Italia”, ma un trentino dei tempi di Francesco Giuseppe. Questa la conclusione. Dopo l’incontro di Cortemaggiore i tempi del 1948 si erano improvvisamente allontanati. Quei tempi delle elezioni cruciali che avevano permesso l’esclusione dei socialcomunisti dal governo, quando Guareschi con una generosa quanto veemente polemica aveva messo in guardia tutti gli italiani del “pericolo rosso” contribuendo in maniera determinante, con le sue vignette e con i suoi scritti, con slogan feroci quanto efficaci, a far conquistare alla DC la maggioranza assoluta dei voti in funzione anticomunista. Secondo gli osservatori italiani e stranieri aveva aiutato in modo determinante la DC, ma – e nessuno lo ha mai rilevato – senza esaltare gli uomini democristiani, semplicemente indirizzando i suoi strali senza esclusione di colpi contro i comunisti e socialisti, gli alleati del “fronte popolare”. I meno giovani dei nostri lettori ricorderanno certamente quel manifesto tratto da una vignetta che Guareschi aveva pubblicato su Candido, in cui si vedeva lo scheletro di un prigioniero italiano aggrappato ai reticolati di un lager sovietico con l’indice puntato sul simbolo del “fronte popolare” che gridava alla madre in gramaglie: “Votagli contro anche per me”. Allora Guareschi era esaltato dai democristiani, che gli proposero perfino di candidarsi nelle loro liste, offrendogli un seggio sicuro alla Camera o al Senato, a sua scelta. Non avevano capito che Guareschi non si sarebbe mai intruppato nella DC e in nessun altro partito, ma voleva solo impedire che l’Italia cadesse nelle mai dei comunisti, il che avrebbe permesso alla Russia di prendere il posto degli Stati Uniti nello scacchiere del mediterraneo. Lo aveva ben capito Togliatti che in un comizio a Bologna, non avendo argomenti validi per controbattere le violente bordate di Candido, s’era limitato ad affermare che “Guareschi era tre volte cretino”. Ma adesso, nel 1953, la situazione era cambiata. I democristiani, tramontato il pericolo socialcomunisti, si sentivano padroni dell’Italia e verso Guareschi alla cordialità subentrò l’intolleranza alle sue più frequenti frecciate e l’arroganza verso un uomo che agiva di persona, senza la protezione di un partito. Pian piano nella stampa democristiana Guareschi lasciò il ruolo di valoroso alleato assumendo quello del sovversivo. Non seguiva l’orientamento conformista della stampa democristiana e per ciò veniva considerato un fastidioso piantagrane, messo nel mazzo dei reprobi. “PRIVI DI DIGNITA’ NAZIONALE” In questa situazione Giovannino affrontò in perfetta buonafede e coerenza la polemica in difesa di Pella, quel primo ministro che al profilarsi del pericolo iugoslavo alla frontiera con Trieste non aveva esitato a far schierare due divisioni dell’esercito ai confini della Venezia Giulia. Fu l’unica dimostrazione di dignità dell’Italia che dopo le umiliazioni del trattato di pace aveva dovuto subire tutte le imposizioni dei vincitori. Ma la cosa non era piaciuta ai governanti democristiani che avevano ormai perduto il senso della nazione e raccattavano ogni elemosina con servile soddisfazione. “Non mi lamento per la loro mancanza di generosità”, diceva Guareschi. “Deploro soltanto la loro mancanza di dignità nazionale. Accetterebbero qualunque umiliazione pur di restare al governo”. (4 – continua) Alessandro Minardi da “L’Uomo qualunque” 02/04/1998 «PUBBLICO QUESTE LETTERE A COSTO DI ROVINARMI» Perché Guareschi decide imprudentemente di credere all’autenticità delle due missive, avute tramite uno sconosciuto, con firma attribuita a De Gasperi e con una delle quali il leader DC durante la guerra avrebbe chiesto agli alleati di bombardare Roma. «È mio dovere informare i lettori di “Candido”» Nel 1954 accadde l’evento determinante che portò al tentativo di tappare definitivamente la bocca a Guareschi. Una domenica pomeriggio mentre Giovannino era nella sua casa di via Righi a Milano, tutto solo, intento a preparare gli articoli e le vignette per Candido, che avrebbe dovuto consegnare entro lunedì sera, uno sconosciuto si presentò davanti alla cancellata del giardino premendo il pulsante del campanello. “IL COLPO DI GRAZIA” Quando lavorava, il nostro non voleva essere disturbato per alcuna ragione e perciò disse che non aveva tempo da perdere e invitò l’inaspettato ospite a rivolgersi, se aveva del materiale per Candido, direttamente alla redazione del giornale, l’indomani, in piazza Carlo Erba. Lo sconosciuto replicò che non gli avrebbe fatto perdere un minuto: aveva soltanto il compito di consegnare dei documenti importantissimi da parte di “un gentiluomo veneto” di cui fece il nome, che era quello di un personaggio molto autorevole dell’epoca. Guareschi per tagliare corto aprì la porta convinto che se la sarebbe cavata in pochi minuti, e l’ospite gli consegnò una grande busta. Conteneva le fotocopie di due lettere che risultavano scritte dal leader democristiano Alcide De Gasperi e in seguito autenticate da un notaio svizzero. Questi certificava di essere in possesso degli originali ai quali erano del tutto conformi le fotocopie. C’era anche l’autenticazione della firma del notaio eseguita dal consolato italiano in Locarno. Le missive risalivano al periodo in cui l’Italia era divisa in due in seguito all’invasione alleata della Sicilia e prima della Liberazione di Roma, tra l’estate 1943 e la primavera ’44. Una delle due lettere a firma De Gasperi era indirizzata a un colonnello inglese addetto a un comando alleato di Salerno, e sollecitava il bombardamento della periferia di Roma da parte dell’aviazione angloamericana allo scopo di sollevare l’opinione pubblica contro i tedeschi che volevano a tutti i costi proseguire la guerra richiesta che in quei tempi drammatici poteva risultare per certi aspetti “comprensibile”, se non giustificabile, da parte di uno dei capi dell’antifascismo e della Resistenza italiana che erano in contatto con gli alleati, dai quali ricevevano aiuti e armi fornendo tra l’altro in cambio delle informazioni utili sul piano militare. Questa missiva era scritta a macchina su carta intestata del Vaticano, dove De Gasperi era rimasto nascosto dapprima sino alla fatidica notte del 25 luglio ’43 quando i gerarchi fascisti avevano offerto al re, votando l’ordine del giorno Grandi, il pretesto per sollevare Mussolini dalla guida del governo; e quindi dopo il ritorno al potere del regime in seguito agli avvenimenti successivi all’armistizio dell’8 settembre ’43. L’altra lettera, in data di poco posteriore, era tutta scritta a penna. In essa De Gasperi assicurava il destinatario (s’iniziava con un “Caro amico” che, si disse poi, poteva essere Enrico Mattei, allora tra i capi del Cor- po volontari della libertà alta Italia in rappresentanza della Democrazia cristiana) che “presto si sarebbe avuto da Falerno il colpo di grazia”. Chi poteva aver scritto quella seconda lettera se non l’autore della prima? C’era una logica in tutto questo. Quanti resistenti, antifascisti, agenti d’informazioni, per non parlare di spie – e non solo comunisti e socialisti – avevano chiesto agli alleati di bombardare porti, ferrovie e città (per esempio: Treviso, che non era certamente un obiettivo militare, rasa al suolo in mezza giornata)? Subito dopo la guerra ci fu chi si gloriò di tali imprese e chi pur non facendosene un merito non smentì quando giornali e settimanali rievocavano questi episodi: tra cui quello di cui fu protagonista un famoso tecnico dell’automobile, che essendo membro di un Comitato di liberazione aveva sollecitato il bombardamento dell’Alfa Romeo a Milano per impedire la produzione di materiale bellico destinato alle forze armate della Germania e della Repubblica di Salò. La periferia di Roma non era certo più importante della zona di corso Sempione in piena Milano, dove sorgeva appunto l’“Alfa”. “GALANTUOMO MA PERICOLOSO” Guareschi credette subito e davvero che queste lettere fossero autentiche? La mia risposta non può che essere affermativa. E in effetti ebbe poi l’occasione di rintracciare delle prove, o almeno dei riscontri. Innanzi tutto, la perizia calligrafica che egli fece eseguire da un consulente abituale del Tribunale di Milano. Inoltre delle testimonianze tendenti ad assicurare che una delle lettere era stata trovata indosso a corrieri democristiani usciti dal Vaticano (dove era appunto nascosto De Gasperi) catturati da agenti del servizio di controspionaggio della Repubblica di Salò. Come si vede di fronte a questi fatti c’è poco da parlare di “ingenuità” di Guareschi. Comunque già il giorno successivo all’inaspettata visita, lunedì mattina, Giovannino mi parlò delle lettere, dicendosi deciso a pubblicarle: “Subito, integralmente e con un adeguato commento”. Io gli dissi: “Senti, Nino, lascia perdere, lascia passare qualche tempo e pensaci bene: De Gasperi è ormai politicamente accantonato e una polemica personale contro di lui potrebbe provocare una reazione di solidarietà, dargli nuovo prestigio con l’intervento di quegli stessi dai quali è stato silurato. Cane non mangia cane, come assicura un proverbio volgarotto ma efficace. Tu sei sulla breccia con un esercito di lettori (Candido tirava allora quattrocentomila copie), hai avuto guadagni superiori alle tue stesse aspettative e un successo senza precedenti per uno scrittore italiano. La tua famiglia è tranquilla e unita come poche. Perché vuoi compromettere tutto questo per De Gasperi? Il meno che ti diranno i giornali del regime è che sei un falsario. Che hai offeso la Resistenza, che sei un sovversivo. I più benevoli diranno che sei in buona fede ma scriteriato, galantuomo ma pericoloso”. “IL TA-PUM DEL CECCHINO” Guareschi mi rispose: “Il tuo ragionamento è giusto, anzi giustissimo secondo il buon senso comune. Hai parlato da vero amico, da fratello affezionato, proprio come mi aspettavo. Ma quanto mi hai detto non mi serve: non che sia sbagliato, semplicemente lo ritengo inutile. Anche se questa faccenda mi rovinasse, anche se i miei figli fossero ridotti alla fame e io fossi ridotto a vendere l’ultima sedia, come fece mio padre nel 1929 per onorare la sua firma, io queste lettere le pubblico. E sai perché? Perché sono convintissimo che sono autentiche e che in Italia non c’è nessuno che abbia il coraggio di pubblicarle. Per questo tocca a me. Lo so, si scateneranno tutti, anche se De Gasperi è ormai impopolare. M chi può credere che io possa essere tanto cretino di pubblicare queste lettere se non fossi più che convinto della loro autenticità? Sarò ricoperto di critiche, sbranato vivo? Ciò non significa che questi documenti storici siano falsi. Piuttosto, so di essere un rompiscatole che data la professione che esercita ha criticato e magari preso in giro, messo alla berlina giornalistica troppa gente: politici, scrittori, editori, cinematografari, colleghi senza contare la gente della bassa corte di queste categorie e gli intrallazzatori che hanno interesse a blandire i potenti. Io penso agli italiani per bene, alla gente onesta che è stata imbrogliata da chi ha creato questo regime di balordi”. Ritenni mio dovere insistere nella tesi contraria anche se ero convinto , conoscendolo come le mie tasche, che Giovannino non avrebbe cambiato idea. Infatti nello stesso pomeriggio mi portò l’articolo di fondo intitolato “Il tapum del cecchino”: il rumore caratteristico provocato dal tiratore scelto austriaco che durante la Grande guerra restava appostato e ben nascosto per sparare contro i nostri soldati non appena si sporgevano dalla trincea. In sostanza, Giovannino ribadiva la tesi che la caduta del governo Pella era dovuto a De Gasperi. E per dimostrare il comportamento a suo dire non lineare del “trentino prestato all’Italia” portava a testimonianza le due lettere. Sulle prime non accadde nulla e si pensò che De Gasperi, colpito nel punto più delicato della sua vita politica, preferisse lasciar sgonfiare la cosa per non uscire allo scoperto. Ma ci fu chi agì al suo posto: Enrico Mattei, diventato potente presidente dell’Eni con a disposizione enormi mezzi, giornali, uomini politici e la burocrazia statale. Mattei fece diramare un comunicato in cui si diceva che l’onorevole De Gasperi smentiva di aver mai scritto quelle lettere e sporgeva querela contro Guareschi (ma pare che De Gasperi agli inizi non ne sapesse nulla). Mattei partì, come si dice, alla grande. Per prima cosa si rivolse all’avvocato Giacomo Delitala, penalista e docente universitario tra i più insigni e abili. Ma non per questo Mattei partì alla grande: ma perché Delitala, fino a quel giorno, era stato l’avvocato di fiducia di Guareschi che aveva difeso (inutilmente, però) dall’accusa di diffamazione per aver pubblicato su Candido una vignetta in cui si vedeva il capo dello Stato Luigi Einaudi mentre passava in rassegna uno schieramento di bottiglie del Famoso “Nebiolo” dei vigneti del presidente, anziché di corazzieri. Con allusione al fatto che Einaudi nella sua tenuta agricola produceva anche dell’ottimo vino: e secondo la mentalità di Guareschi non sembrava elegante che l’uomo che rappresentava l’Italia fosse un vignaiolo. Così il presidente dell’Eni prendeva due piccioni con una fava: aveva sottratto a Guareschi il suo difensore di fiducia e procurato a De Gasperi un avvocato di grande prestigio. Eppure Mattei aveva manifestato tante volte la sua simpatia e una grande stima per Guareschi. Dopo le elezioni del ’48, concluse con la sconfitta del “fronte popolare”socialcomunisti, egli aveva dichiarato – come del resto De Gasperi, Andreotti, Pella, Vanoni e altri baroni democristiani – che l’appoggio di Guareschi era stato determinante per la vittoria democristiana. Ancora di recente, non più di due mesi prima della pubblicazione delle lettere di De Gasperi, attraverso il suo capo dell’ufficio stampa, l’ottimo e correttissimo Vero Montebugnoli, mi aveva fatto sapere che aveva intenzione di sdebitarsi per tutto quanto Guareschi aveva fatto nel 1948 per silurare il piano Togliatti e Nenni mirante alla conquista del potere. Voleva regalargli “un quadro d’autore, di un grande autore”. Se Vero Montebugnoli mi legge sono certo che non avrà difficoltà a confermare questo fatto: è un uomo che è sempre stato leale con Mattei e non di meno con la verità, un vero galantuomo. E potrà confermare la mia risposta: “Informa l’onorevole Mattei che Guareschi non si attende riconoscenza e doni da nessuno, anzi si sentirebbe profondamente offeso da un regalo (che ha odore di bustarella) perché quello che ha fatto è semplicemente quello che voleva fare, e non certo per la DC ma per sconfiggere il fronte popolare. Sono certo che respingerebbe qualunque dono spiegandone poi le ragioni pubblicamente su Candido. Il mio consiglio fu ascoltato. MANEGGI E MINACCE Quando raccontai l’episodio a Guareschi ebbi questa risposta: “Hai fatto molto male a sconsigliarlo. Avrei fatto un bellissimo articolo per spiegare con un esempio emblematico come nasce la corruzione in regime democristiano: ti fanno un regalo per poterti legare al carro e chiuderti la bocca. Una bella occasione perduta”. La querela di De Gasperi contro Guareschi scatenò sulla stampa e negli ambienti politici una reazione assai vivace. Solo i pochi fogli di destra (c’era ancora il partito monarchico) si misero dalla parte di Guareschi. Tutti gli altri contro: chi con veleno e cattiveria (i democristiani) chi (socialisti e comunisti) con freddo atteggiamento inquisitorio perché Guareschi aveva osato criticare i “rossi” e la Resistenza. Poi cominciarono i maneggi per inquinare le prove ed intimidire i sostenitori di Guareschi. “Sifar”, Servizi segreti della presidenza del Consiglio e del ministero degli Interni, polizia, carabinieri e Guardia di Finanza furono mobilitati per accertare chi aveva dato le lettere a Guareschi, se esistevano gli originali e dove potevano essere, chi era il “falsario” chi “spingeva” Guareschi. Cominciò così il pellegrinaggio alla redazione di Candido di sedicenti amici che con la scusa di preoccuparsi del destino del popolarissimo scrittore, offrivano consigli strani, dicevano di avere rivelazioni da fare che sarebbero state utili a “Giovannino”. Tutti, insomma, erano curiosi di sapere qualcosa. Una certa mattina, avendo in anticamera tre di questi tipi, feci affiggere alla porta del mio ufficio un cartello con su scritto: “Sappiamo già tutto e non abbiamo nulla da dire. Non si ricevono agenti segreti e informatori clandestini”. Intanto il consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano deliberò una “deplorazione” per l’avvocata Delitala, in quanto, essendo il legale di fiducia di Guareschi, era passato dalla parte avversa. Guareschi scrisse su Candido un sarcastico epigramma che diceva: “Avvocato Delitala, politica e metano, tolgono il fiato all’uomo più sano”. “ma cosa c’entra il metano?”, si chiedeva il lettore. C’entra eccome – faceva capire Guareschi – visto che nello stesso giorno in cui Mattei incaricava Delitala di assumere la difesa del buon nome di De Gasperi, nominava l’insigne penalista alla presidenza della società “Milano Città” distributrice del metano in tutta la Lombardia. (5 – continua) Alessandro Minardi da “L’Uomo qualunque” 09/04/1998 LA CONDANNA DI GUARESCHI INDIGNA MEZZA ITALIA Il processo per diffamazione nei confronti di De Gasperi dura solo un giorno. Respinte tutte le richieste dei difensori. Quasi un’esecuzione sommaria: il tribunale resta in camera di consiglio appena quindici minuti e poi dichiara colpevole l’imputato che rinuncia all’appello. Il popolarissimo giornalista rimarrà in prigione per oltre un anno. Ma perché i giudici, nel frattempo, distruggono le prove? Così si arrivò al processo in un’atmosfera arroventata. Ci fu chi consigliò Guareschi di appigliarsi a qualche espediente per rinviare l’udienza pubblica nella speranza che nel frattempo intervenisse una soluzione extra processuale. Ma Giovannino si oppose nettamente e il dibattimento per direttissima si svolse come fissato. C’era allora a Milano il ben noto procuratore della Repubblica Spagnolo, che sembrava condurre la regia secondo le aspettative del Palazzo e per questo il processo a Guareschi venne istruito a tempo di record. I tempi di un’“esecuzione sommaria”. Ma troppo lungo sarebbe fare la cronaca del dibattimento, riassumiamo i punti essenziali. PERIZIA NEGATA 1° - Nell’udienza del mattino, dopo qualche scaramuccia di carattere procedurale sollevata dall’avvocato Michele Lener, si ebbe subito l’impressione che il tribunale non era disposto a concedere fiato alla discussione. Il pubblico ministero dichiarò che era necessario procedere a una perizia delle due lettere di cui Guareschi era entrato in possesso e di cui attribuiva la paternità a De Gasperi perché non rimanesse alcun dubbio sull’autenticità o falsità. Nell’udienza pomeridiana affermò invece che, essendo già stato ascoltato De Gasperi che respingeva sdegnato di essere autore delle missive (la parte civile trasformata in testimone!) non era più il caso di procedere alla perizia. Le lettere erano giudicate false ma, secondo l’interpretazione della difesa di Guareschi, non si voleva correre il rischio che una perizia dichiarasse il contrario o quanto meno proponesse dubbi. 2° - Nel corso dell’udienza a smentire le voci riportate da certi giornali, secondo cui le lettere pubblicate erano niente altro che abili fotomontaggi ricavati da lettere autentiche, si presentò al presidente del tribunale il notaio svizzero Bruno Stamm, giunto appositamente da Locarno. Questi consegnò gli originali delle lettere con una sua dichiarazione quale testimonianza che le fotocopie consegnate a suo tempo a Guareschi da uno sconosciuto erano identiche agli originali. Questo documento risultava autenticato dal Consolato italiano di Locarno. 3° - I difensori di Guareschi, i famosi avvocati Michele Lener e Vincenzo Porzio, presentarono al tribunale una perizia di parte redatta dal professor Focaccia, abituale collaboratore dello stesso tribunale. Il professionista dopo un esame grafologico particolareggiato, fotografico e chimico, stabiliva l’indiscussa autenticità delle lettere. Ma questa perizia non venne presa in considerazione, nemmeno per dire che era inutile. 4° - Quando il presidente del tribunale lesse la proposta del pubblico ministero di respingere la richiesta di far eseguire una perizia d’ufficio da parte del tribunale, l’avvocato, su istruzione di Guareschi, dichiarò che quella decisione gli impediva di difendere l’imputato. Si tolse la toga, mentre nell’aula calava un silenzio di tomba, disse che non avrebbe più aperto bocca. Così fece e il processo si concluse senza che Guareschi fosse difeso. TESTIMONIANZE RESPINTE 5° - Il legale di De Gasperi, avvocato Giacomo Delitala, pronunciò un’arringa sbrigativa e a un certo punto disse: “Conosco Guareschi, l’ ho difeso in altre cause, è un uomo intelligente e capace di disorientare l’avversario”. Insomma, l’accusa principale che muoveva a Guareschi era di essere “intelligente”, proprio il contrario di quello che dicevano altri e cioè che era un sempliciotto sia pure in buona fede. 6° - Inutilmente la difesa di Guareschi aveva chiesto di ascoltare dei testimoni che avrebbero potuto dimostrare come i servizi segreti per ordini superiori si erano di recente recati a Lugano per offrire 50 milioni (del 1954!) al detentore del carteggio che conteneva tra l’altro le due lettere attribuite a De Gasperi. Nonché altri testimoni che avrebbero spiegato come gli agenti del controspionaggio al soldo della Repubblica di Salò avevano intercettato nel 1944 i corrieri del Vaticano che recavano anche le due lettere scritte del capo democristiano in clandestinità, finite nel carteggio citato e affidate infine in fotocopia a Guareschi. 7° - Alla fine del dibattimento la discussione dei membri del tribunale in camera di consiglio, se mai ci fu, risultò davvero fulminea: giusto il tempo indispensabile per stendere praticamente il dispositivo della sentenza. In tutto quindici minuti, come rilevarono l’indomani i giornali. Prova che il destino di Guareschi era già segnato prima di entrare in aula. Il processo era stato una semplice formalità come la pronuncia della sentenza di condanna: dodici mesi di reclusione. A questi “punti” va subito aggiunta la considerazione che nel periodo successivo al processo e pochi giorni dopo l’entrata di Guareschi in carcere, il tribunale di Milano si riunì alla chetichella ed emise una disposizione che intimava la distruzione dei “corpi di reato”, ovvero le lettere originali consegnate dal notaio Stamm con tanto di autentiche e vidimazioni. E così fu fatto. Ma se erano false perché distruggerle? Non conveniva conservarle per poterne dimostrare in qualunque momento la falsità? Questo provvedimento giudiziario sollevò un putiferio. Molti magistrati e avvocati attraverso giornali che prima erano stati piuttosto scettici nei riguardi di Guareschi cominciavano ora ad avanzare dubbi sullo svolgimento del processo. Ci furono polemiche, però a chi interessava realmente difendere Guareschi, Bastian Contrario che non aveva mai voluto intrupparsi in alcun partito? Sicché l’iter giudiziario andò avanti come voleva il Palazzo. Ma l’opinione pubblica restò convinta che Guareschi era innocente. Migliaia e migliaia di lettere e telegrammi giunti a casa dello scrittore e alla redazione di Candido lo confermarono. “NON ACCETTO COMPROMESSI” Giovannino a me disse: “Il tempo è galantuomo. Il tempo dice la verità. Per questo sono tranquillo. Le mie carte sono in regola perché non sono un baro. Risulterà chiaro, se qualcuno vorrà oggi o domani vedere cosa c’è dietro al polverone attuale, che non sono né un furbastro né un ingenuo. Dovrà ammettere la mia buona fede. D’altra parte è contrastante l’opinione che i giornali cercano di diffondere sul mio conto: furbastro per i miei avversari dichiarati, ingenuo per i miei più benevoli sostenitori. La verità sul caso De Gasperi risulterà chiara anche se nessuno vorrà ammettere che le lettere sono vere, come limpido risulterà il successo dei miei libri e film che ho realizzato senza tenere conto degli interessi di cassetta e senza chiedere benevolenza alla critica dalla quale sono stato sempre e puntualmente ignorato. E ancora più chiara risulterà la mia azione giornalistica ispirata soltanto a sentimenti, a principî della morale naturale, a prescindere dalle ideologie politiche e senza compiacenze o timori verso il potere costituito”. Queste sono considerazioni espresse da Giovannino al sottoscritto la notte prima di entrare in carcere. Inutilmente amici e politici, che si professavano ammiratori di Guareschi, l’avevano scongiurato di interporre appello. Sostenevano che con il tempo, con i rinvii e con i cambiamenti di umori, tutto sarebbe finito nel nulla. Nel senso che lo scrittore sarebbe entrato, anziché in galera, nella lista dei “furbi che non pagano mai per le colpe commesse”. Ma Guareschi non era uomo da compromessi. E lo sapevano bene i suoi lettori che avevano letto su Candido la lettera con la quale toglieva il mandato ai suoi legali, Lener e Porzio, unicamente per impedire loro di interporre appello alla sentenza. Mi diceva: “Non è un colpo di testa. Io non ho il temperamento dell’aspirante martire. Io sono un piccolo borghese, un qualsiasi padre di famiglia che, avendo dei figli, ha dei doveri. Primo dovere: quello di insegnare ai figli il rispetto per la dignità personale”. Mi spiegava ancora: “Se non avessi dei figli potrei infischiarmene, venire a patti, a compromessi. Potrei rinunciare a tutta o una parte della mia dignità. Così non si può. In tutta questa faccenda hanno tenuto conto dell’ ‘alibi morale ’ di De Gasperi e non si è neppure ammesso che possa avere anch’io un ‘alibi morale ’. me lo hanno negato. Hanno negato tutta la mia vita, tutto quello che io ho fatto nella mia vita. Quarantacinque o quarantasei anni di vita pulita, di lavoro onesto non sono un luminoso ‘alibi morale ’? Non si può accettare un sopruso del genere. Se il tuo nemico ti sputa in faccia non puoi ricorrere in appello per ottenere che ti ripulisca la faccia col fazzoletto. Se il mio nemico mi porta via mio figlio, non posso mettermi a patteggiare con lui perché mi restituisca almeno una gamba della mia creatura. M’avete condannato alla prigione? Vado in prigione. Accetto la condanna come accetterei un pugno in faccia: non mi interessa dimostrare che mi è stato dato ingiustamente. Il pugno l' ho preso e nessuno potrà fare sì che non l’abbia preso. No, niente appello. È inutile che insistiate, voi tutti che mi siete davvero amici”. “GIORNALISTI INVIDIOSI” RICORDANDO IL GIORNO DEL PROCESSO EGLI SCRIVEVA AMARAMENTE: “Mi pareva di essere davanti a un tribunale rivoluzionario. Ero seduto all’estremo limite della mia panca, e tutt’attorno a me, e sopra di me, incombevano gli inviati dei giornali: mi sentivo pesare sulle spalle tutto il loro odio, tutto il loro disprezzo. I loro occhi brillavano di gioia infinita: alla fine il nemico era lì, sistemato sulla panca dei delinquenti. Era lì in attesa di essere bollato d’infamia. ‘Hai venduto un milione e mezzo di tuoi libri in Francia?’, essi pensavano. ‘ Bene, adesso sei qui alla nostra mercé ’ ”. E alla fine concludeva: “La mia dignità di uomo, cittadino e giornalista è faccenda mia personale e in tal caso accetto soltanto il consiglio della mia coscienza. Riprenderò la mia vecchia e sbudellata sacca di ‘ prigioniero volontario ’ e mi avvierò tranquillo e sereno in quest’altro lager. Ritroverò il vecchio Giovannino fatto di aria e di sogni e riprenderò, assieme a lui, il viaggio cominciato nel 1943 e interrotto nel 1945. niente di teatrale, niente di drammatico. Tutto semplice e naturale. Per rimanere liberi bisogna, un bel momento, prendere senza esitare la via della prigione”. Come si vede, al momento di entrare in carcere una persona furba o ingenua non avrebbe mai potuto parlare così. Chiunque altro al posto di Giovannino avrebbe trovato mille scuse per restare libero, tanto più che i suoi stessi avversari avevano interesse a facilitare questa soluzione per evitare polemiche. Essere accusati di aver lasciato andare in prigione, per la prima volta, un giornalista libero e non protetto da partiti era una bella responsabilità. Ma per Guareschi, sempre abituato a pagare di persona, in un’Italia dove tutti cercano compromessi, favori e tolleranze, non c’era altro da fare. Era stato condannato e, anche se la condanna era ingiusta, doveva andare in prigione. (6 – continua) Alessandro Minardi da “L’Uomo qualunque” 16/04/1998 DA ALFIERE DELLA LIBERTA’ A PRIGIONIERO DI STATO Guareschi entra in carcere con lo zainetto che usava durante la prigionia nei lager nazisti. L’ambasciatore americano e lo stesso presidente Eisenhower deplorano “la condanna di colui che più e meglio di ogni altro ha fatto sventolare in Italia la bandiera della dignità nazionale”. Ordine da Roma: severità in cella con lo scrittore. Ma tolleranza con i banditi. Così Guareschi in un tiepido, profumato pomeriggio di maggio 1954 entrava in carcere per scontare la recente condanna a 12 mesi di reclusione più altri 8 che gli erano stati inflitti due anni prima, con la condizione, per le sue vignette satiriche nei confronti del capo di Stato Luigi Einaudi. In totale: 20 mesi di galera. Con il suo vecchio zaino di prigioniero di guerra, cimelio del tempo trascorso nei lager nazisti, Giovannino si presentò al carcere di San Francesco di Parma, davanti al quale era atteso da numerose persone, spontaneamente riunite per testimoniare solidarietà al coraggioso giornalista che non voleva sottrarsi alla condanna unicamente per una questione di dignità e di principio. Era tranquillo. Prima di salutarmi, sulla porta del carcere, mi disse: “Cosa vuoi che sia un anno e passa di carcere in Italia, per me che ne ho fatti due nei lager tedeschi. Là è stata dura, qui sarà roba da ridere”. Ma questa volta si sbagliava in pieno. E se ne accorse, come al solito, a sue spese. Era il primo giornalista italiano incarcerato per un reato di opinione e l’emozione risultava grande sia in Italia sia all’estero data la popolarità anche cinematografica del personaggio. Indro Montanelli scrisse sul settimanale Il Borghese di Longanesi che “in quell’occasione l’ambasciatore degli Stati Uniti a Roma Claire Boothe Luce dichiarò: ‘Noi non vediamo e non deploriamo in questo verdetto che la condanna di colui che più e meglio di ogni altro ha fatto sventolare in Italia la bandiera della libertà e della dignità nazionale ’. Frase cui ne fece eco immediatamente un’altra nello stesso senso del presidente americano Ike Eisenhower”. Oltre che negli Stati Uniti, anche in Francia, Inghilterra, Germania, Olanda, la notizia appare per lo più incredibile. SOLIDARIETA’ DALL’ESTERO Ma cosa contavano le opinioni di grandi e piccoli personaggi italiani o stranieri? Per i democristiani che avevano il potere l’importante era che Guareschi fosse stato messo a tacere. E tacque per un anno e mezzo dal momento che all’infuori di due lettere settimanali di carattere familiare, che poteva scrivere per regolamento, non poté mandare nulla al giornale, a quel Candido che era più di ogni altra cosa nel suo cuore. Ma Candido continuò a uscire regolarmente, senza perdere lettori perché Guareschi era settimanalmente presente sia con testi “vecchi” ma poco noti sia con gli articoli che la stampa italiana e straniera andava scrivendo sul suo caso. Per il direttore del carcere di Parma gli ordini di Mario Scelba, già potentissimo ministro degli Interni e ora presidente del Consiglio, erano tassativi: applicazione integrale del regolamento carcerario, cioè nel senso più restrittivo. In proposito Benso Fini, direttore del Corriere Lombardo, scrisse un articolo dal titolo “Guareschi prigioniero di Stato”. Mentre per gli altri detenuti (rapinatori, assassini, stupratori) il regolamento risultava applicato con una certa elasticità, con Guareschi veniva applicato alla lettera, senza la minima deroga, senza eccezioni. Per esempio, secondo il regolamento il detenuto non poteva ricevere cibi cotti all’esterno e Guareschi non ne ricevette mai. Il feroce bandito Pollastri, condannato all’ergastolo per cinque omicidi e diverse rapine, poteva gustare faraone arrosto e lasagne alla bolognese quando lo desiderava, con una sorta di complicità tra cuochi e sorveglianti. A Giovannino, invece, non toccava nemmeno una cotoletta cucinata fuori dalle mura della squallida galera. Furono lunghissimi, terribili i mesi che lo zelante direttore lasciò trascorrere evitando di dimostrare verso Giovannino una parvenza di umana solidarietà. Da vero burocrate egli esercitava un controllo spietato e censurava le lettere senza motivo: quando credeva di capire che sotto una frase, mia e di Guareschi, potesse nascondersi un’allusione qualunque. In casi del genere ricopriva con l’inchiostro di china una frase o addirittura un periodo intero. Poveretto, non sapeva che noialtri due da quasi trent’anni parlavamo in gergo, non per nascondere agli altri i nostri discorsi ma semplicemente perché ci si intendeva più alla svelta. Così, quando Giovannino cominciò a scrivermi da San Francesco il nostro colloquio epistolare continuò con il gergo di prima. Non era basato su uno schema ma su una spontanea consuetudine a vedere le cose con lo stesso occhio. Per esempio, sua moglie era “la contessa”, lui “bondiola” o “il figlio di Teodosio” o “l’uomo dello zuccherificio”; mia moglie era “alba tragica”, Rizzoli “il commenda” o “l’imperatore di Ischia”, Scelba “l’uomo dalle scarpe bianche e nere!, Andreotti “l’amico di Umberto” (non il re ma un conoscente comune), io ero a volte “Baxter”, a volte il “padre della Cicci”. A volte “Marchi-Paelli”, Mattei “il pestifero”, Carletto Manzoni “fil di ferro”. “PEDINATO IN SVIZZERA” Così quando Scelba o chi per lui mobilitò una squadra di fiscalisti specializzati da Rizzoli, il nostro editore, nell’intento di controllare se esistevano indizi di evasione fiscale (ma non trovarono nulla). Io scrissi al carcerato: “l’Uomo dalle scarpe bianche e nere ha mandato i suoi amici a far visita all’Imperatore, che gli ha dato ampia ospitalità. Pare che si siano impegnati molto senza vincere la più piccola coppa”. Era l’epoca dei carteggi segreti, a volte veri e altre volte falsi oppure inesistenti. Mentre io seguivo le tracce del carteggio Mussolini - Churchill con alterne speranze, scrissi: “Quel fesso di Baxter va spesso a gamberi ma ne ha preso solo pochi e piccoli, il che dimostra però che in quella zona ci possono essere anche i più grossi”. Quando andavo a Lugano, Varese, Como, Locarno ero pedinato così come era controllato il mio telefono. Cominciai a seguire gli itinerari più strani e arrivavo alla meta solo quando ero certo di avere seminato i miei pedinatori. Sapevo che i miei spostamenti erano segnalati dagli addetti ai caselli autostradali e dalle guardie di frontiera quindi entravo in Svizzera da Porto Ceresio, dove parcheggiavo la mia automobile per usare quella di un amico svizzero e uscivo da Chiasso per rientrare dal valico di Novazzano. Perciò gli sbirri venivano a sapere che ero stato in Svizzera ma non potevano immaginare dove e con chi mi fossi incontrato. Intendiamoci: in quello che facevo non c’era nulla di illegale. In qualità di direttore responsabile di Candido, succeduto a Giovannino che dopo la condanna non poteva firmare il giornale, conducevo personalmente un’inchiesta che avrebbe potuto avere successo solo se non fosse stata intralciata dagli agenti di servizi segreti mobilitati a seguire le mie mosse e magari convinti di poter scoprire chissà mai quali trame occulte. Così quando telefonavo da Milano sapendo che il mio apparecchio era sotto controllo, dicevo “Sono Giorgio e tu Giorgio come stai? Avverti Giorgio che Giorgio (cioè io) sarà da lui giovedì dopo le due (il che voleva dire due giorni dopo il giovedì)”. Di tutte queste cose informavo sommariamente Guareschi. A lui facevo sapere che quel fesso di Baxter andava a cercare gamberi. Ma lui capiva, come poi mi confermò di persona. JACOBELLI RIMPROVERATO Ho citato questi esempi per rendere l’idea di come potevamo esprimerci liberamente. Il fatto è che il direttore del carcere censurava frasi in gergo che poi trasmetteva a Roma senza sapere cosa volessero dire ma con la speranza che gli agenti dei “servizi” riuscissero a capire qualcosa. Segnalavo anche i particolari più innocenti. Per Natale, il popolare giornalista della Rai Jader Jacobelli, allora collaboratore politico di Candido sotto nome finto, inviò a Guareschi una cartolina con la sua firma pressoché illeggibile. Ebbene, dopo qualche giorno fu chiamato dal presidente Scelba in persona che lo rimproverò di continuare a collaborare al nostro giornale da lui considerato “al bando”. Altre angherie: a Giovannino per varie settimane negarono non solo la macchina per scrivere ma anche un po’ di carta e una matita. Fu in seguito a una campagna stampa scatenata dal Corriere Lombardo, da La Notte, dal Patria e dal Roma di Napoli che a tutti noi uniti riuscì di fargli ottenere l’occorrente per scrivere. Ma nulla di quanto scrisse, tranne le lettere inviate alla moglie e a me, poté uscire. Per la verità ci fu un’eccezione ma si tratta di un caso clandestino. Per un precedente accordo con Rizzoli, Guareschi avrebbe dovuto preparare entro il 1954 la sceneggiatura del secondo film di “Don Camillo”. La produzione era già in movimento bisognava assicurarsi che la sceneggiatura arrivasse in tempo. L’editore andò a Roma per ottenere che Guareschi potesse dedicarsi a questo lavoro. Il nostro ebbe in effetti il permesso di scrivere la sceneggiatura ma il ministero di Grazia e Giustizia gli impose che il testo, una volta finito, venisse consegnato al direttore del carcere e da questi trasmesso al ministero. Alla fine il guardasigilli avrebbe a sua volta consegnato la sceneggiatura a Rizzoli, naturalmente dopo averla esaminata con la lente di ingrandimento e fatto averne copia al presidente Scelba. Messe così le cose c’era da prevedere che passassero dei mesi di attesa. Senza che il direttore fiutasse l’imbroglio, con Guareschi ci intendemmo che quando fosse stato pronto il dattiloscritto lo avrebbe consegnato al direttore del carcere mentre io avrei escogitato il modo di farne uscire una copia. Proprio in quel periodo venne in Italia l’editore tedesco del “Don Camillo”. Io scrissi a Guareschi: “C’è, in Italia, Muller che cerca di ottenere il permesso per avere un colloquio con te. Se viene, affida per recapitarlo a me quel libro ti è tanto piaciuto. Vorrei leggerlo”. Fu così che quando il signor Muller si recò a colloquio con Guareschi si vide consegnare un volumetto della “Bur” (la collezione economica di Rizzoli) con la preghiera di Guareschi: “Lo consegni a Minardi: è un libro molto interessante e sono sicuro che sarà contento di leggerlo”. Il tutto davanti all’agente di custodia che per regolamento assisteva al colloquio. Ma la direzione del carcere sapeva che il signor Muller era un visitatore privilegiato avendo ottenuto il permesso del colloquio dopo lunghissime anticamere a Roma. E l’aveva ottenuto solo dopo l’intervento dell’ambasciatore del suo Paese, che aveva dovuto compiere apposta un “passo” ufficiale presso Scelba. Dopo quel colloquio il signor Muller venne da me e rimase di stucco quando io apersi il libro che gli aveva consegnato Guareschi. La copertina era quella delle “Ultime lettere” di Jacopo Ortis, ma dentro c’erano piegati in quattro con millimetrica precisione i fogli della copia della sceneggiatura del film. Quel giorno stesso il recluso consegnò la copia originale al “superiore” che provvide a spedirla a Roma con un corriere speciale. La conclusione fu che il testo della sceneggiatura arrivò prima sul tavolo di Rizzoli che non su quello del ministro. Trascorsero poi ben tre mesi prima che il ministro si decidesse a far pervenire la sceneggiatura al legittimo proprietario, nella persona dell’editore e produttore cinematografico Angelo Rizzoli. Ma nel frattempo il film era già in avanzato stato di realizzazione. LIBRI PER GLI ALTRI DETENUTI Guareschi pativa soprattutto l’isolamento inumano della galera, al punto che per non sentirsi un verme nelle ore d’aria prese a frequentare qualche “compagno di sventura”. Tra i reclusi c’era qualche brava persona condannata a brevi pene per una cambiale scaduta o per avere ingiuriato un coinquilino molesto. Ma in genere c’erano fior di mascalzoni, che si avvicinavano a Guareschi per spillargli dei soldi con le scuse più bislacche o per circuirlo allo scopo di carpirgli “qualche segreto”. Giovannino era sì un innocente in buonafede, ma non certamente un ingenuo. Sapeva distinguere, anche se talvolta la sua generosità risultava eccessiva. Nelle lettere non di rado mi sollecitava a spedire 50 mila lire (equivalenti all’incirca a un milione di oggi) a un avvocato per fare il ricorso contro la condanna di un detenuto o per aiutare una famiglia priva di ogni sostentamento. Osservando che i detenuti erano immersi nell’ozio ebbe l’idea di organizzare una biblioteca, una vera biblioteca ma soltanto di “roba pulita”. A suo nome sollecitai Rizzoli, Longanesi, Garzanti e mondatori a inviare libri e dopo qualche settimana la biblioteca del carcere di Parma divenne una delle più ricche di tutte le prigioni d’Italia. I detenuti cominciarono a dedicarsi spontaneamente alla lettura e la maggior parte di essi dimenticò il “vuoto ozio del carcerato che induce a cattivi pensieri”. Le visite a quel carcerato speciale che rispondeva al nome di Giovanni Guareschi erano in sostanza regolate da Roma, né il direttore né il giudice di sorveglianza potevano rilasciare permessi al di fuori dell’ambito familiare. Per chiunque ci voleva l’autorizzazione di Roma. Così, per esempio, l’onorevole Cavaliere, socialista, vecchio amico di Guareschi, poté visitarlo quasi subito mentre io che avevo mille ragioni, anche urgenti, di vederlo, essendo l’unico che gli curava gli interessi professionali e familiari, dovetti attendere dieci mesi prima di essere ammesso al colloquio. Soltanto la moglie e i figli andavano a colloquio ogni due o tre settimane. (7 – continua) Alessandro Minardi da “L’Uomo qualunque” 23/04/1998 Appendice alla settima puntata Indro scrive a Giovannino Milano, 29 settembre 1954 Caro Giovannino, I tuoi rappresentanti in terra mi hanno trasmesso il tuo minaccioso messaggio, del quale mi faccio un lunghissimo baffo perché, alla peggio, ritiro fuori la polemica che avemmo due anni fa, ne estraggo gli estremi per una diffamazione e ti faccio appioppare un altro decennio di galera che, alla media di una foruncolosi per semestre, mi libererà per sempre della tua incomoda presenza. Giorni fa ti mandammo una cartolina firmata, oltre che da Longanesi, Tedeschi e me, anche da Kravcenko, e tu forse avrai preso quel nome per uno scherzo. No, non era uno scherzo. Il mio amico Kravcenko è un tuo grande ammiratore e sebbene, scegliendo la libertà, abbia fatto il contrario di te, che hai scelto la prigione, ha tenuto a mandarti un segno della sua simpatia. Aveva il “Don Camillo” in edizione americana dentro la valigia, e bofonchiava che un libro così, lui non sarebbe riuscito a scriverlo mai. Il che è vero di Kravcenko, ma è vero anche di Moravia, di Silone e di Vittoriani: i quali sono soltanto meno sinceri nel riconoscerlo. Caro Giovannino l’inverno ha bussato alle nostre porte con un tornado di vento e la notizia dell’aggravamento della tua pena. Ne ho parlato a lungo con Rosanna e con Minardi e domattina andrò a parlare con Lener, cui voglio mostrare quello che intendo pubblicare sul “Borghese”. Oh, so benissimo che servirà a poco, anzi a nulla. Ma vorrei almeno che tu sentissi, attraverso quelle parole il calore del nostro affetto: unica stufa che, immagino, ti sia consentita in codesto Istituto. Conosco la tua forza, del resto ben collaudata nel lager tedesco. Ma penso che, comunque, ti sarà di qualche conforto la constatazione che c’è nella nostra categoria, chi, pur ogni tanto dissentendo da qualche tua opinione, ti è più amico oggi di ieri e sente la sua sorte idealmente legata a quella tua ed è ben deciso a far blocco con te, fino in fondo. Io son di questi e credo che oramai tu lo sappia. Il giorno che sarai di nuovo libero, troverai molte cose cambiate, caro Giovannino, e non in meglio. Anzi decisamente in peggio. Però noialtri ci vedrai allo stesso posto di prima, solo con qualche capello in meno e qualche ruga in più. Ti scriverò ancora, di quando in quando. Tu non rispondermi. Fammi solo sapere, attraverso Minardi, se hai ricevuto. Ti abbraccio con triplicato affetto il tuo Indro Montanelli IL NATALE NEI LAGER E NEL CARCERE DI PARMA Guareschi, lavoratore instancabile e vulcanico, non osservava mai i riposi festivi tranne la notte della Vigilia: rievochiamo le straordinarie iniziative che architettò in queste ricorrenze, per i compagni di sventura, quando era deportato in Germania e nella prigione della sua città Molte persone ritengono che la vita dello scrittore conceda all’interessato lunghi periodi di vacanza, di dolce far niente: riposo, comunque, relativo, avendo sempre il Nostro la necessità di quieto raccoglimento, di svaghi utili alla meditazione e al recupero delle risorse psicofisiche. Per taluni creativi effettivamente è così, per altri no. È questione di carattere. Per chi ha veramente la testa piena di idee e di programmi non ci possono essere interruzioni o distrazioni; la smania di scavare dentro di sé, per far venire alla luce tutto quello che si ha dentro e poi “buttarlo fuori”, non concede tregua. Guareschi è un esempio, non certo il primo e l’unico, di uno scrittore incapace di vivere secondo lo schema dell’uomo comune. Era nato per scrivere e disegnare, con una continuità e un impegno che escludeva soste, turismo, svaghi e chiacchiere inutili. La sua vita è stata interamente consacrata al fare, tale da risultare alla fine quasi una sola anche se lunga giornata di lavoro. Infatti, dopo l’infanzia e l’adolescenza impegnate allo studio (senza sport, senza ferie, senza scampagnate) dai diciotto anni in poi non ha fatto che scrivere e disegnare; le brevi soste della sua attività erano occupate con svaghi strani e occasionali. Ma non erano poi svaghi, bensì impegni utili a mettere insieme il necessario per campare: portinaio dello zuccherificio di Parma d’estate e, nelle altre stagioni, agente di censimento oppure elettricista. Comunque lavorando e scrivendo Guareschi ha santificato ben poche feste. Per lui la domenica andava bene unicamente perché la considerava come un qualunque altro giorno. Con un’unica, grande eccezione : il Natale. Era l’unica ricorrenza che accettava con profonda convinzione e che riassumeva tutte le feste dell’anno. A chi gli ricordava la necessità di fermarsi per il Capodanno, per l’Epifania, per Pasqua o per Ferragosto, rispondeva: “Ma non abbiamo già fatto Natale?”. «OLTRE IL RETICOLATO» E per quel giorno veramente si impegnava, rinunciando a importanti programmi già fissati o svaghi allettanti. Cominciava a pensarci ai primi di dicembre. Quando vedeva qualcosa di curioso nelle vetrine per rallegrare questa ricorrenza acquistando regali destinati ai propri figli e agli amici, era felice come se avesse risolto un assillante problema. Quindi cominciava a preparare i biglietti d’augurio che non erano quelli banali già stampati: li disegnava, si può dire, su misura del destinatario, spesso patetici e qualche volta ironici, mai banali e nemmeno maliziosi. Arrivava così alla Vigilia avendo fatto molte cose, tranne quella dell’“allestimento” casalingo. Ogni anno sembrava che non riuscisse a mettere a posto il grande tinello per la serata, ma avendo già in testa cosa voleva fare, in un paio d’ore sistemava tutto. Ed era sempre una scena da Natale d’altri tempi: l’ampia sala sfolgorante di luci e colori, il presepe con tutti i personaggi e il paesaggio in ordine, l’albero carico di doni: e poi la cucina con tutti i fornelli in azione: il vino già scelto e, se c’era la neve, un grande pupazzo nell’aia illuminato da un potente faro. Questo per il Natale degli anni, diciamo, tranquilli. Ma durante l’intera sua esistenza ci furono almeno tre Natali amari, passati lontano dalla famiglia, in condizioni tragiche, che per gli altri erano causa di sconforto e disperazione, ma per Guareschi furono ragione di speranza e di fede nell’avvenire. Natale 1943, nel campo tedesco di prigionia di Beniaminowo, in territorio polacco. Mentre gli altri internati si abbattono e si disperano ricordando le case e le famigli lontane, non sapendo come riempire le ore di ozio forzato, Giovannino costruisce un “presepe tascabile”. Ritagliando pezzi di cartone e rimediando il colore grattato dalle scatolette verniciate, mette insieme un micro-presepe, con tutti i personaggi, il paesaggio e la sua brava stella cometa argentata. Dimensioni: centimetri 9 x 12 x 1,5. una volta montato, sembra il modello di un teatrino. La sera della Vigilia invita i compagni di sventura a visitare il suo angolino, dove ha sistemato questo straordinario “presepe del prigioniero”, strappando a tutti un sorriso e qualche attimo di serenità. In una lettera ideale destinata alla moglie, e pubblicata poi nel Diario clandestino, scrive : “Di una sola cosa ti prego: che la sera della Vigilia di Natale si imbandisca la tavola nel modo più lieto possibile. Fai schiodare la cassa delle stoviglie e quella della cristalleria; scegli la tovaglia migliore, quella nuovissima piena di ricami: accendi tutte le lampade, prepara un grosso albero di Natale con tante candeline e il presepe vicino alla finestra, come l’anno scorso… Ho bisogno che tu faccia questo. Il mio pensiero ogni notte varca il reticolato… Ogni notte approfitto del sonno degli altri e mi affido all’aria, trasvolo rapido gli sconfinati silenzi di terre straniere e città sconosciute… Non dire che sono il solito se non mi avventuro lungo le macerie della scala… Cerco un po’ di luce, un po’ di tiepida serenità e invece non trovo che buio e freddo e non posso ravvisare nel buio il volto di mio figlio,e sui laghi e sulle spiagge tutto è spento e abbandonato, tutto è silenzio, e io rinavigo verso il recinto e torno al mio pagliericcio portando il gelo nelle ossa del numero 6865”. «PORTAMI IL PRESEPIO» Sono molti gli ex internati nei lager che ricordano il Natale di Beniaminowo, quando la speranza di uscire vivi da quell’inferno era legata solo alla fantasia e alla tenace volontà di Guareschi. Natale 1944, lager di Sandbostel (Germania). Dopo quasi sedici mesi di prigionia Guareschi è diminuito da 82 a 46 chili. “Sembrava un’acciuga”, mi raccontò un giorno il nostro comune amico e collega Giovanni Ansaldo che era stato in prigionia con Guareschi. “Ma un’acciuga vivacissima anche se costretta in una scatola assieme ad altre acciughe che, pur se vive, sembravano morte”. Il secondo Natale di prigionia era, ovviamente, per gli internati, davvero tragico, per le sofferenze di altri dodici mesi erano ridotti all’estremo limite della resistenza umana. I deportati vinti dai patimenti, morti, non si contavano più e molti sopravvissuti si alzavano dalle cuccette solo il tempo indispensabile alle necessità personali. Anche Guareschi era all’estremo limite, ma con testardaggine emiliana, come scrisse nella prefazione del Diario clandestino, strinse i denti e proclamò: “Non muoio neanche se mi ammazzano”. Figurarsi se un personaggio siffatto poteva essere indifferente al Natale soltanto perché aveva perduto quaranta chili di peso corporeo, soffriva la fame, sentiva i morsi dell’ulcera ed era tormentato dal gelo! Spiega ancora Giovannino: “Non ci siamo rinchiusi nel nostro egoismo. La fame, la sporcizia, il freddo, la malattia, la disperata nostalgia delle nostre mamme e dei nostri figli, il cupo dolore per l’infelicità della nostra terra non ci hanno sconfitti. Non abbiamo dimenticato mai di essere persone civili, uomini con un degno passato alle spalle e un avvenire tutto da inventare”. Così Guareschi, costruito con mezzi di fortuna un rozzo altoparlante, messa insieme una piccola troupe di attori improvvisati e munitili di primitivi strumenti sonori, visita le varie baracche del campo di prigionia per leggere ai suoi compagni, interpretandola, La favola di Natale. Delicato racconto tra il fiabesco e la satira che in seguito, una volta tornato in Italia, potrà dare alle stampe riscotendo enorme successo. Dovevano passare soltanto dieci anni perché, contro tutte le aspettative, Guareschi fosse sottoposto di nuovo all’esperienza del Natale in prigionia. Questa volta resa più amara dal fatto che i suoi carcerieri erano italiani e non stranieri e, specialmente, dalle assurde ragioni per cui era ristretto tra quattro pareti. Ho già accennato al trattamento, duro e spesso inumano, subìto da Giovannino nelle prigioni di San Francesco a Parma. È necessario ricordarlo per comprendere in quali condizioni fisiche Guareschi arrivò al Natale 1954. Nonostante tutto anche allora ritrovò lo spirito del lager: non lasciarsi abbattere e reagire con spirito all’assurdo regolamento che lo costringeva, proprio nella sua terra a celebrare il Natale come se non fosse un cristiano. Nei lager aveva come alleati i suoi compagni di sventura, nel carcere di Parma i suoi lettori che con lettere, telegrammi e cartoline, lo sostenevano con affettuosa solidarietà mai prima d’allora manifestata nei confronti di un carcerato. CONFORTATO DAI SUOI LETTORI Per organizzare il Natale alla sua maniera cominciò i preparativi già alla fine di novembre. Innanzi tutto, scrisse alla moglie: “Per Natale vorrei un rametto di pino da mettere accanto al mio presepe smontabile che avevo fatto in prigionia, cercalo nella valigia del lager. Se non sarà lì, cercalo in qualche cassetto. Trovalo e portamelo al prossimo colloquio. Fa però attenzione, è molto delicato. Mi raccomando, altrimenti con il presepe sfasciato non avrei il Natale che voglio. E come regalo desidero solo mezzo chilogrammo di bicarbonato che mi durerà fino all’Epifania, sono contentissimo che Minardi e famiglia vengano a fare Natale a casa nostra a Roncole, insieme con voi: e ci terrei che tutto si svolgesse nel migliore modo possibile e con la massima allegria. Tutto come prima, insomma”. A me scrisse in data 26 novembre: “Voglio sperare che, per Natale, non abbandonerete la ‘ vedova provvisoria ’ e i suoi ‘semiorfani’. Se avete deciso di non passare il Natale a Roncole, puoi evitare di venire al secondo colloquio. Non ti riceverei! Ti ringrazio in anticipo di aver disciplinatamente accettato l’incarico. È essenziale che tutto funzioni come se fossi presente io. Ho bisogno di una cosa così, come sfondo psicologico per il mio Natale”. Una settimana dopo, lettera datata 3 dicembre, mi precisava un altro desiderio: “Dappoiché Giovanni Poli, la mattina della vigilia, sarà a Roncole assieme ai ‘dipendenti’ per il ritiro del panettone, ti prego di far preparare un panettone speciale di sei o sette chili, una cosa adeguata ai 120 chili di peso corporeo di questo fattore straordinario. Non dire niente a nessuno: lo deve vedere solo quando gli verrà consegnato. Voglio fotografie dell’avvenimento”. Era una richiesta molto difficile da esaudire. Mi informai da pasticceri e fornai. Mai visto un panettone di più di un paio di chili, mi rivolsi allora all’amico Valeri, l’anziano socialista che era uno dei dirigenti della “Motta”, mi confermò che panettoni tanto grandi non erano mai stati fatti anche perché c’era il problema, fino ad allora irrisolto, della cottura del maxi-panettone industriale. Però sollecitò i tecnici che si sentirono stimolati dalla richiesta strana e senza precedenti sicché, alla fine, ebbi un panettone di otto chili, un vero monumento. Va detto che il destinatario del curioso omaggio era uno strano tipo di agricoltore, amico d’infanzia di Guareschi e da qualche anno suo consigliere per l’attività agricola che Giovannino aveva avviato da tempo nella terra natale di Giuseppe Verdi. Altre richiesta: “Ti prego di farmi avere il numero natalizio di Esquire e quello dell’Illustrazione Italiana. Sai che ho una predilezione per le strenne e per le cartoline illustrate”. Tutto funzionò a meraviglia. E nella lettera del 28 dicembre precisava: “Carissimo Alex, ti parlo di giorni ormai lontani, d’un episodio di cronachetta che, per me, è già diventata favola. Ti parlo del Natale del 1954, del più dolce Natale della mia vita. Quel Natale arrivò in San Francesco assieme a un gran numero di lettere, e tutte le lettere dicevano che io ero in prigione, lontano dai miei, e che questo fatto era ben triste e dispiaceva a tante brave persone, ma non riuscivo a soffrire del mio, perché il mio cuore era pieno soltanto di letizia. Mi commossi spesso nel leggere e rileggere quelle lettere ma non pensando a me, bensì pensando alla bontà di chi le aveva scritte. Mi commuoveva profondamente la delicata, umanissima poesia di quelle lettere. Tanta poesia che le mura della mia cella non bastavano a contenerla! Era già notte quando, la Vigilia, io arrivai in fondo al mucchio delle lettere ‘speciali’ e mi accinsi a leggere le tre lettere normali. Allora io pensai: ‘Adesso leggendo queste letterine, io mi rattristerò perché qui non si tratta di amici, ma dei miei figli e della mia vedova provvisoria!’. Ma nella lettera ‘ricamata’ di Albertino niente c’era di triste, e niente di triste era nelle letterina della Carlotta, e la letterina della vedova provvisoria era ilare, addirittura, prima di tirar giù la branda, guardai con orgoglio il mio presepio: che stupenda idea avevo avuto costruendolo smontabile. E come funzionava bene, anche qui, nella cella di San Francesco! Lo guardai con orgoglio perché potevo dire alle ombre leggere che si aggiravano attorno alle baracche dello sfondo: ‘Amici che non tornate, ho mantenuto fede alla parola data. Sono passati tanti anni da quel primo nostro Natale del lager, ma io sono lo stesso Giovannino d’allora!”. CARTOLINE DA TUTTA ITALIA Cito ancora dalle sue lettere di quei giorni: “Che favolosa mattina quella del 25 dicembre 1954! Sole di primavera, colloquio ‘straordinario’. Non occorre che io parli del sole di quella mattina perché lo hai visto anche tu e, pur se la mia spettanza di cielo è – qualitativamente – inferiore alla tua, la qualità è identica. (Mi pare – guardandola dal fondo della fossa del cortile – che il mio scampolo di cielo sia d’un azzurro più intenso del cielo di ‘fuori’. Ma non ne sono sicuro perché ricordo com’era il mio cielo di uomo ‘libero’ e, in verità, quand’ero ‘fuori’, avevo poco tempo per guardarlo attentamente). “Insomma, qualcosa di stupendo. Un Natale mirabilmente, favolosamente sereno come il cielo miracoloso di quella mattina. Credi: con tutti i difetti, con tutte le mie intemperanze verbali io – fatti scrupolosamente i conti di 46 anni di vita – sono un galantuomo. E lo meritavo un Natale così bello, così felice. Io penso a chi – mandandomi in carcere – credeva di ‘punirmi’. Quanto poco contano le ‘decisioni’ degli uomini! “Intanto è cominciato l’ottavo mese di carcere e io mi metto a ridere perché, appiccicata sul muro, davanti a me, c’è la cartolina di Carlotta con la categorica direttiva in rima: ‘forza e coraggio, dopo Natale viene maggio!’”. Nella lettera del 7 gennaio 1955 ritornava sulla festa di Natale: “La mia cella è ancora piena di angioletti: migliaia di angioletti che si sono levati a volo dalle migliaia e migliaia di cartoline natalizie. Il giorno di Natale ne sono giunte esattamente 1.322 e io le ho volute leggere tutte prima di andare a letto. Tutte, una per una, e così mi sono accorto che, sotto il tavolino, non era primavera e mi sono preso un’infreddatura. È stata la più dolce influenza della mia vita. La più gradita. E anche la più nobile. Se ti capita ringrazia coloro che mi hanno scritto, spiega che si trattava sì starnuti, ma che venivano dal cuore. In ogni caso saluta Biagi, Ansaldo, Longanesi, quelli della ‘Patria’, Nutrizio, Fini, Titina De Filippo, Cervi, il generale Messe, l’arcivescovo Montini, Rusconi, Cesco Tommaselli, Gianni Calvi, Giuseppe Marotta, Marchesi, Zincone, direttore del Carlino e il direttore e i redattori del Salzburger Nachrichten. Ringrazia anche Mario Missiroli che mi ha scritto una simpatica lettera in cui, fra l’altro dice: ‘Penso a quel Natale di alcuni anni fa che dovevamo passare insieme, e che, per un contrattempo, andò a vuoto. Io sono fermo a quel grato ricordo ’”. Come si vede un modo tipicamente missiroliano per esprimere molto affettuosamente una solidarietà personale che si sentiva di manifestare esplicitamente. Così anche nel carcere di Parma, nonostante la stretta sorveglianza e il trattamento restrittivo, Guareschi ritrovò lo stesso spirito indomito dei lager.(8 – continua) Alessandro Minardi da “L’Uomo qualunque” 30/04/1998 LA GALERA MI HA DISTRUTTO NON RIESCO PIÙ A CREARE Così Guareschi confessò al direttore di “Candido” che attendeva invano un suo articolo: “Tredici mesi di carcere non sono tredici mesi di vacanza”. Ma l’affetto dei suoi lettori lo aiutò a superare la gravissima crisi. Le costrizioni e l’umiliazione della libertà vigilata Un bel giorno Epoca pubblicò una serie di fotografie di “Guareschi in carcere a Parma”; si trattava di immagini sbiadite e poco chiare, al punto che si parlò di fotomontaggio: vere o meno che fossero, provocarono un inasprimento della sorveglianza nei confronti di Giovannino e in me il desiderio di realizzare un intero servizio dedicato alla vita del “galeotto”. Ma l’impresa risultò tutt’altro che facile. Avevo saputo che in quel periodo si erano iniziati nelle varie celle di San Francesco i lavori per il rifacimento degli impianti idraulici e sanitari. Un’opera importante, che era stata appaltata a una ditta specializzata torinese e che sarebbe durata dei mesi. Mi recai dunque a Torino per parlare con il titolare di quella ditta ed ebbi la sorpresa di sapere che era stato in prigionia con Guareschi. Con lui aveva diviso la miseria e l’angoscia delle baracche dei lager. Non ci fu molto da discutere. Era un uomo massiccio, un piemontese che sembrava squadrato con l’ascia, di poche parole, laureato in ingegneria. Dall’esperienza del lager aveva tratto una morale limpida: l’Italia doveva lavorare con impegno e con onestà sia per riguadagnare fiducia in se stessa sia per riconquistarsi la stima del mondo. Amico affettuoso di Guareschi, aderì subito alla mia proposta. Mi presentò un giovane geometra di sua piena fiducia raccomandandogli di usare prudenza e tatto per realizzare il mio progetto. “Ciò che conta – concluse – è il risultato e lei lo deve raggiungere”. LA SPIDER IN DONO DALLA FIAT Questo geometra era incaricato di dirigere i lavori nel carcere di San Francesco, partì subito per Parma dove lo raggiunsi dopo alcuni giorni. Acquistai un apparecchio fotografico e gli diedi le ultime istruzioni. Da quel momento doveva agire di sua iniziativa cercando di non compromettersi anche per evitare guai a Guareschi, che tra l’altro era all’oscuro di tutto. Il giorno dopo il geometra accompagnato dalle guardie cominciò la visita delle celle per rendersi conto della situazione e dei lavori da fare: giunto in quella di Giovannino spiegò come sarebbe stato costruito l’impianto sanitario che finalmente eliminava il mefitico bugliolo. Precisò quindi che il giorno dopo, alle sedici in punto sarebbe andato a fare un’ispezione sul tetto proprio di fronte alla finestra di questa cella. “Così – concluse – sarò l’unico a vedere Guareschi dietro le sbarre”. Giovannino capì al volo e il giorno dopo, esattamente all’ora stabilita, si avvicinò all’inferriata consentendo al geometra di scattare due fotografie. All’epoca, comunque, dopo lunga meditazione ritenni opportuno non pubblicare queste immagini che avrebbero potuto provocare inchieste e punizioni a carico degli agenti di custodia del tutto innocenti mentre c’era l’assoluta necessità di evitare che ci andasse di mezzo Guareschi. Il suo stato d’animo peggiorava. Le sue giornate erano di una monotonia esasperante. Egli si immalinconì fino alla disperazione quando gli fu in un primo tempo negato il condono di qualche mese di detenzione, misura alla quale aveva diritto avendo già scontato oltre metà della pena mantenendo sempre buona condotta. Era una norma valida per tutti i detenuti ma, sembrava, non per lui. Così dovette restare in carcere ancora una quarantina di giorni. E se venne rilasciato in “libertà vigilata” fu soltanto perché Rizzoli reagì a Roma a tutti i livelli contro la patente ingiustizia. Pare che sia intervenuta una decisione politica ad alto livello legata anche alla nomina di Giovanni Gronchi alla presidenza della Repubblica e alla caduta del governo Scelba. Nel luglio 1955, quando Giovannino uscì dal carcere, benché la liberazione non fosse stata pronunciata ufficialmente c’era una marea di folla. Arrivato a casa trovò nel cortile una fiammante Fiat 1200 spider, significativo dono del senatore Valletta, allora presidente della Fiat e fervente ammiratore di Guareschi. Questi visibilmente commosso disse: “Ringrazierò il senatore Valletta anche se lui non sa che per 205 giorni io non potrò usare la sua automobile”. Gli era stato infatti consegnato un libretto rosso su cui era scritto che come ex detenuto scarcerato “sotto condizione” non poteva allontanarsi dalla sua residenza legale, che aveva stabilito a Roncole di Busseto (Parma), luogo natale di Giuseppe Verdi. Insomma era libero nel senso che non era più nella cella di San Francesco ma non poteva muovere un passo fuori dal comune di Busseto. Inoltre “dalle 23 al levar del sole” non poteva nemmeno uscire di casa. Per andare a Sant’Agata (3 chilometri) o a Cortemaggiore (6 chilometri) doveva chiedere preventivamente il permesso al giudice di sorveglianza. “Tutto considerato – mi diceva – sono nella stessa situazione del mio cane Amleto che può correre soltanto nel cortile ma non uscire quando viene trattenuto dalla catena” PREMIATO DAI LIBRAI A noi pareva che tutte queste limitazioni fossero state studiate apposta, o quasi, per impedire a Guareschi di recarsi a Milano a riprendere la direzione di Candido. Giovannino era scoraggiato e con il cuore pieno di amarezza. L’uomo che aveva dato tante prove di coraggio, di fermezza, di resistenza alle avversità di ogni genere non sembrava più lui. Diceva: “Non conservo odio per nessuno ma debbo riconoscere che non avrei mai immaginato che ci fossero degli italiani così feroci contro un giornalista. Le SS che mi sorvegliavano nei lager tedeschi e polacchi erano degli angeli al confronto”. Dopo qualche settimana il suo carattere forte e testardo si risvegliò: riprese a collaborare a Candido, ma era uno sforzo superiore alle sue condizioni psico-fisiche. Comunque tirò avanti ancora sei anni chiaramente spinto da una sovrumana volontà di non cedere. “Lo faccio – diceva – per dimostrare a me stesso che sono ancora vivo e perché tanta gente mi stimola a non mollare. Tu mi conosci bene: se non lavorerò più, sarà perché sono morto”. Uscito in “libertà” vigilata, dopo oltre tredici mesi di carcere duro, Giovannino era nella condizione di chi deve tornare all’esistenza normale dopo una lunga parentesi straordinaria. Si vedeva che faceva uno sforzo incredibile a parlare con la gente che gli diceva cose che gli risultavano del tutto indifferenti, come dimenticate, perdute nel fondo della memoria. Leggeva i giornali con distacco: in essi non trovava più lo sfondo polemico che in altri momenti mettevano in moto la sua dialettica. Erano passati i tempi in cui una notizia, anche se banale, lo induceva alla satira. Longanesi aveva detto paradossalmente qualche anno prima: “Date una virgola a Guareschi e questi vi fa una tragedia in due battute”. Per fortuna c’era l’ambiente ad agire da antidoto contro la sua depressione: la Bassa con i suoi verdi prati, i pioppi, i contadini, gli artigiani che continuavano nei lavori consueti. Giovannino aveva un senso viscerale della vita della Bassa: quei contadini, quegli artigiani, tutti legati al corso delle stagioni in un impegno umano che ignora l’ozio e che impone a tutti doveri elementari, lo richiamarono alla realtà. La noia e l’indifferenza si attenuarono e così dopo poche settimane riprese a collaborare a Candido. Ma sarebbe meglio dire che accettò di riprendere come si accette un dovere, non già l’impegno volontario. Fu uno sforzo enorme che i lettori non potevano avvertire perché i suoi racconti, i disegni e le vignette che mandava erano brillanti, polemici, divertenti come quelli di “prima”. Alla fine ritrovò il ritmo giusto ma era un fatto puramente tecnico perché la sofferenza interiore si accentuò. Diceva: “È l’unico modo di combattere il male oscuro che mi ha colpito. Non debbo pensarci. Voglio ritornare a lavorare come prima, altrimenti la macchina si blocca per sempre”. Quando ancora era in prigione i librai pontremolesi gli avevano attribuito il “Premio Bancarella” per il “Don Camillo”. La cosa l’aveva colpito per il gesto di non conformismo dei librai della Lunigiana. “Mi spiace per loro – mi diceva – il ‘Bancarella’ è l’unico premio serio, proprio perché è in mano a veri librai indi- pendenti, che basano le loro valutazioni unicamente sulle vendite: vedrai che il regime troverà modo di renderli meno indipendenti. Gli uomini politici non possono permettere che si ripeta un caso del genere”. Una previsione che si verificò puntualmente. L’assegnazione di questo premio fu importante più che per il riconoscimento stesso, per la spinta morale sostenuta da gente che gli scriveva perché riprendesse il ritmo di prima. E Guareschi sentì il dovere di non deludere i suoi lettori che l’avevano seguito per tanti anni. E così ritornarono i racconti di Don Camillo, il Corrierino delle famiglie, i corsivi polemici, gli articoli di fondo, le vignette mordenti, piene di “verve” e di sfottiture. Sembrava tornato quelli di prima, ma dentro di sé sentiva un’immensa amarezza. Dopo alcune settimane ebbe il contraccolpo che tutti noi paventavamo: la crisi covata in carcere risultava aumentata col passaggio alla vita normale. I medici l’avevano previsto. Il 26 luglio 1955 mi inviò un lungo scritto nel quale confessava amaramente le previsioni. Quella mattina avrei dovuto ricevere da lui il solito articolo politico ma al posto di questo mi venne recapitato, da un suo conoscente, incontrato alla stazione di Fidenza, un messaggio personale a me diretto nel quale affermava tra l’altro: “Sono le ore 3 di mattina del 26 luglio 1955. esattamente 24 ore fa io mi sedevo a questo tavolino e incominciavo a cercare un’idea per l’articolo. La sto ancora cercando. E sono pieno di caffè, di bicarbonato, di stenamina e ho fumato una quantità paurosa di sigarette. Mi fa tutto male, ma ciò non serve a niente. I due ‘pezzi’ che ho pubblicato nei numeri scorsi mi sono costati una fatica superiore alle mie forze”. “Io avevo tentato di spiegarvi che non ero in grado di riprendere: data però l’enorme fatica che tu hai sostenuto per tredici mesi, io non ho trovato il coraggio di parlarti francamente. E ho tentato di aiutarti. Ho tentato disperatamente di scrivere qualcosa; il risultato è stato pietoso. E ho la testa vuota. E ho il cuore pieno di noia mortale. Ho tentato di leggere i giornali: mi pareva di leggere giornali di un altro paese. Mi stupivo che i giornali stranieri fossero scritti in italiano. Lo sforzo che debbo sostenere per seguire i discorsi della gente è immenso. Non me ne importa della nuova 1500; dei lavori al podere ‘Bonifica’, la stalla nuova mi dà un senso di nausea. Parlo coi muratori e con gli altri artigiani e continuo a pagare il loro lavoro anche se il loro operato non mi interessa più. Mi pare che ciò faccia parte di una condanna da scontare”. «ORA VOGLIO DIMETTERMI» “Tredici mesi di carcere non sono tredici mesi di vacanza. Sono stanco, terribilmente stanco, adesso io lo sento il peso grave del carcere. Adesso io potrei scrivere ‘ Le mie prigioni ’ ma parlando di Roncole, non di San Francesco. Qui, a casa mia, io mi sento prigioniero. Mi sento terribilmente solo perché mi manca la compagnia di me stesso. Un tempo io ero il mio migliore amico; adesso cerco invano l’amico di un tempo. E mi pesa spaventosamente il fatto che gli altri mi ricordino mentre io mi sono dimenticato di me stesso. Mi guardo attorno e tutto mi sembra appartenga al passato. Tutto questo io te lo posso soltanto scrivere perché soltanto quando scrivo io trovo il coraggio di essere sincero”. “Oggi è la prima volta, nella mia vita di giornalista, che manco ai miei impegni. Credevo che ciò non potesse avvenire mai: e, invece, è avvenuto. Non ho avuto il coraggio di parlare con te, non ho avuto il coraggio di parlare con Andrea (Rizzoli, ndr), non ho avuto il coraggio di parlare col Commenda (l’editore Angelo Rizzoli, ndr). Mi sentivo come un uomo che ha contratto un grosso debito e che, arrivato al momento di pagare, deve confessare: ‘ non posso pagare ’. È un debito che ho non solo con voi ma con tutti coloro che mi hanno seguito nella mia vicenda. E l’altra sera, quando nell’osteria di Viadana ho visto piangere quel vecchio contadino, e l’ ho sentito dirmi che aveva tanto pianto per me, ho provato vergogna di me stesso”. Altre considerazioni amare: “Io abbandono il campo, chiudo bottega. Anche mio padre, quando raggiunse pressappoco la mia età, si mise a letto e vi rimase, quasi ininterrottamente, fino a quando morì. La vita, la lotta avevano perso ogni interesse per lui. Anche per me il ballo è finito”. Ancora: “Sì, il ballo è finito. E anche io continuerò a dire che ho bisogno di pace di solitudine per scrivere romanzi e delle commedie che mai scriverò. Domani manderò una lettera ad Andrea e una al Commenda. Prima ho voluto avvertire te. E prima di spedire la lettera di dimissioni, vorrei parlare con te per non metterti nei guai. Di guai e di noie te ne ho dati fin troppi”. “Quando tu, quasi trent’anni fa, mi incontrasti per la prima volta io stavo attraversando un periodo particolare. Vivevo solitario a Marore, nel freddo, nella miseria e nella malinconia. Di giorno dormivo, di notte disegnavo a lume della lucerna. Poi, ogni tanto, venivo in città, a piedi, di sera, con qualche scarabocchio da mostrare a Carboni. E fu appunto in una di quelle sere, in via Cavour, che tu mi incontrasti. Ero gonfio di tristezza, in quei giorni, e riuscivo a malapena a tollerare la compagnia di me stesso. Adesso sto attraversando un periodo ancora peggiore: perché ho quasi trent’anni di più, perché non ho più voglia di disegnare, perché non ho più nessuna speranza. Perché quello era un duro inizio mentre questa e una dura fine. Tutto quello che posseggo mi disgusta e mi annoia”. “Ma tu avevi bisogno di un articolo non di una crisi! Mi dispiace di non poterti mandare il ‘pezzo’: non ho più niente da dire. Il magazzino è vuoto”. “Tutto finisce all’alba: anche questa lettera, anche la mia carriera di giornalista. Sono le cinque e niente va bene. Non occorre che tu mi porti le graffette per la macchinetta cucitrice: esse non hanno più alcun senso nella mia vita”. SCATTA LA MOLLA DELLA RIPRESA Io conoscevo bene l’uomo e sapevo che quello sfogo messo per iscritto gli era servito per scaricare l’amarezza accumulata. Altre volte aveva fatto così. Si scrollava di dosso i cattivi pensieri e ritornava a lavorare con impegno maggiore. Ma questa volta la crisi era preoccupante perché aggravata dalle sofferenze sopportate in carcere. Sarebbe stato quindi molto più difficile aiutarlo a rimettersi in carreggiata. Andai subito a Roncole e per due giorni girovagammo per la Bassa e sugli Appennini senza meta e, apparentemente, senza scopo. Evitai di parlare di crisi. Evitai di sollecitarlo, di incoraggiarlo perché non volevo dargli l’impressione (ed ero davvero sincero) di volergli strappare un impegno. La soluzione doveva essere naturale a rischio che fosse negativa. Giovannino non doveva essere spinto alla ripresa: doveva decidere senza essere influenzato. Dopo una lunga notte di chiacchiere d’ogni genere con assaggi di vari tipi di lambrusco gli dissi: “Non preoccuparti. I tuoi lettori ti hanno aspettato per più di un anno: aspetteranno ancora qualche settimana. Per il giornale ci arrangeremo. Rizzoli è d’accordo”. Mi guardò con uno sguardo sorpreso: “Tu sai che io non ho mai fatto aspettare nessuno. Odio le attese e le anticamere per me e per gli altri. Salutami il Commenda e digli che nulla cambia”. Dopo cinque giorni aveva ripreso in pieno. Mi mandò il materiale come se nulla fosse accaduto e da quel giorno continuò senza interruzioni per più di sei anni. E per altri sette continuò, quando Candido cessò le pubblicazioni, a collaborare a Oggi (un racconto ogni numero), alla Notte (una vignetta al giorno) e al Borghese (con racconti, vignette e corsivi ogni settimana). (9 – continua) Alessandro Minardi da “L’Uomo qualunque” 07/05/1998 I REGISTI NON VOLEVANO FARE UN FILM ANTICOMUNISTA Guareschi dovette affrontare un’autentica battaglia per impedire che i suoi scritti, dal preciso contenuto sociale e politico, venissero trasformati, nella riduzione cinematografica, in una commedia all’italiana. Il rifiuto di De Sica e il “tradimento” del maestro francese Duvivier Il successo di Guareschi seguitava sia prima sia dopo la dura esperienza del carcere: i suoi libri furono tradotti in una quarantina di lingue (compreso il giapponese, l’ebraico, il groenlandese, il birmano) e i film ricavati dalle sue invenzioni giornalistico - letterarie vennero proiettati in tutto il mondo. Era, dunque, un successo senza precedenti per uno scrittore italiano. Ma a Giovannino interessava relativamente; anzi, egli valutava almeno agli inizi con sospetto ogni proposta di sfruttamento di queste opere per il cinema e per la televisione. “Ho scritto per divertirmi – diceva – non per diventare un impresario”. Ogni giorno ricevette la visita di Cristina Wenthworth, una ricca signora americana, sposata con un industriale aeronautico. La Wenthworth aveva scoperto nei libri di Guareschi “”un edificante messaggio di bontà degno di essere diffuso in tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti”. La signora venne presentata a Guareschi dall’industriale aeronautico Gianni Caproni, era un donna intelligente e molto abile. Dopo un incontro per lei sconcertante, in quanto Guareschi non si sentiva interessato a proposte del genere, la signora Wenthworth ritornò decisa più che mai e per dimostrare la serietà delle sue intenzioni portò a Roncole alcune azioni, già perfettamente stampate, della casa cinematografica che lei stava organizzando per produrre i film di “Don Camillo”. Guareschi ne sarebbe stato il presidente e lei consigliere delegato. Fu un colpo di scena che lasciò Giovannino a bocca aperta: la casa cinematografica si chiamava “Parma Production”. Un colpo da maestro. Ma anche allora menò il can per l’aia e tutto restò in sospeso. Si rimase intesi che la signora Cristina sarebbe tornata dopo qualche settimana certa di poter concludere l’affare. Guareschi aveva quasi dimenticato queste trattative, quando lei stessa mi telefono da San Francisco per avvisare che il giorno dopo sarebbe partita assieme al marito con il loro aereo personale per venire a Milano con il contratto da sottoscrivere. Invece, trascorsi pochi giorni, mi telefonò Gianni Caproni per comunicarmi la triste notizia che l’aereo dei Wenthworth si era inabissato in Atlantico. Guareschi commentò: “Mi dispiace molto perché era una donna intelligente e in gamba, forse sarebbe riuscita a intrappolarmi, a trasformarmi in presidente della ‘ Parma Production ’”. dietro l’apparenza scherzosa, era turbato per la tragedia. Ed ecco, invece, le avventure cinematografiche realizzate davvero. Non tutti sanno che risalgono all’anteguerra. Eravamo alla fine degli anni ’30 e Guareschi lavorava come un ossesso per i giornali, per le riviste teatrali e per i libri. Il suo talento per la satira fu subito intuito da Longanesi, che lo invitò a collaborare al suo Omnibus, il grande padre di tutti i rotocalchi italiani e stranieri di ieri e magari anche di oggi. E così quando Longanesi fece il suo primo e unico film. “Batticuore”, invitò Guareschi a collaborare alla sceneggiatura. Ma Giovannino era per natura solitario e aveva un metodo di operare poco adatto al lavoro di gruppo. Tranne le riunioni di redazione alle quali partecipava con impegno animando le discussioni con battute pirotecniche, era abituato a lavorare in solitudine. Peraltro, partecipando con Giovanni Mosca e con altri umoristi alla stesura dei copioni per un paio di riviste teatrali, si accorse che con un po’ di buona volontà riusciva a collaborare con profitto anche al lavoro di squadra. LA MISSIONE DI RIZZOLI Fu così che, passato il ciclone della guerra, alla prima occasione Guareschi si buttò nel cinema. Letteralmente si buttò perché , sollecitato da un piccolo produttore intelligente ed esperto, mise condizioni che escludevano drasticamente collaboratori al soggetto, alla sceneggiatura e alla scenografia: avrebbe fatto tutto lui. E così fu. Il regista Cerchio, si occupò solo, con scrupolo e diligenza, della regia. Il filo conduttore del film “Gente così” era una storia drammatica e poetica senza rilievi politici. C’erano Vivi Gioi, Adriano Rimordi e Saro Urzi; e c’era Camillo Pilotto nei panni di un prete che si può considerare l’anticipazione di Don Camillo. Pur realizzato con mezzi modestissimi il film riuscì bene e si può ancora considerare un piccolo capolavoro pressoché artigianale. Ma il produttore non era collegato con il circuito della distribuzione e così la pellicola, dopo qualche mese, uscì di scena quasi senza che nessuno se ne accorgesse. Il fatto però era servito a chiarire due cose: convincere Guareschi che poteva dedicarsi anche a quest’arte e richiamare l’attenzione di Angelo Rizzoli sulla possibilità di trasferire nel cinema i racconti di Guareschi, che proprio in quel periodo aveva iniziato la serie di “Don Camillo” dal successo immediato e strepitoso. Sicché Giovannino fu convocato dal suo editore-produttore che gli chiese di cedergli i diritti di riproduzione cinematografica dei racconti. Fu quasi una farsa. Alla richiesta del Commenda lo scrittore rispose che i diritti non erano più suoi, li aveva ceduti tempo addietro a un “Tizio” di Roma per duecentomila lire. Ma chi era costui? Guareschi non ne ricordava il nome. Sapeva soltanto che aveva firmato un foglio di carta da bollo su cui era scritto che cedeva i diritti di riproduzione cinematografica dei due personaggi, Don Camillo e Peppone. Rizzoli era deciso. Voleva ricomprare quei diritti. Fece fare delle ricerche a Roma, promise laute ricompense. Nell’ambiente cinematografico aveva amici e collaboratori espertissimi come De Fonseca, Dandi e Peppino Amato: proprio quest’ultimo riuscì a rintracciare il misterioso personaggio. Era un piccolo trafficante che bordeggiava tra cinema e giornalismo, conosceva l’importanza di Amato ed era convinto che dietro di lui ci fossero i produttori di Hollywood, più che Rizzoli. E così sparò grosso: cinquecento milioni! Dopo una notte di discussioni, con blandizie e minacce di mandare tutto all’aria, Amato concluse l’affare per duecento milioni. Sembrava una pazzia. Eravamo nel 1949 e nessun soggetto cinematografico, almeno in Italia, era mai stato pagato tanto. Ma Rizzoli aveva le idee chiare e puntò a realizzare un film di qualità, non solo di cassetta. C’era però da affrontare il grosso problema del regista. Era il momento del neorealismo italiano e sembrava fin troppo facile intendersi con uno di questi maestri, ma presto si comprese che i nostri registi, tutti o quasi di sinistra, o comunque timorosi di non apparire allineati con l’intellighenzia “rossa”, non avrebbero mai accettato di mettere in satira i comunisti. A cominciare da Vittorio De Sica, che volle rendere pubblico di aver rifiutato un’offerta del genere confidandosi con L’Unità. I maestri di Cinecittà sarebbero stati invece disposti a trasformare il soggetto in una commedia all’italiana travisando completamente il contenuto morale e politico dell’opera originale. Così il Commenda, personaggio in ogni senso straordinario, prese cappello e andò a Parigi a trattare con Julien Duvivier, il grande regista francese famoso fin dagli anni Trenta per aver diretto capolavori quali “Carnet di ballo” o “Il bandito della casbah”. E questi, valutato il soggetto, accettò l’offerta del produttore italiano. «È LUI IL PEPPONE IDEALE» non bisogna peraltro credere che le cose procedessero tanto facilmente. Anche Duvivier era, grosso modo, orientato, come i registi di Cinecittà, a realizzare una specie di sagra paesana sfruttando le trovate umoristiche di Guareschi ma sorvolando sui contenuti morali e politici. In seguito ai discorsi preoccupati di Rizzoli, Giovannino capì la manfrina e dichiarò subito, chiaro e tondo, che non avrebbe mai approvato che si alterasse lo spirito genuino dei suoi racconti. D’altra parte Duvivier non aveva alcuna intenzione di fare un film che avesse riflessi anticomunisti. Intendeva realizzare una specie di “Kermesse eroicomica” padana in cui le trovate umoristiche facevano dimenticare la sostanza politica. Tanto è vero che affidò la parte di Don Camillo, uno dei due protagonisti, all’attor comico, nonché cantante e fantasista, Fernand Contandin in arte Fernandel, che collaborava con lui dal 1937. E Peppone? Agli inizi fu proprio Guareschi. Al primo incontro Duvivier, visti quei baffi e quella faccia, disse esultante: “È lui il Peppone ideale: l’autore è l’attore”. E quando incominciò la lavorazione, Giovannino entro nel “set” nei panni di Peppone. Per la verità, controvoglia. Che Duvivier si fosse sbagliato si accertò la sera stessa quando Guareschi, che pure ci aveva messo la sua buona volontà e con risultati per la verità non scoraggianti, disse che fare l’attore non era il suo mestiere, che era abituato a impiegare il suo tempo in ben altro modo. Perciò rinunciava “senza nemmeno aprire la discussione”. Rizzoli, previdente, aveva già pensato a un ostacolo del genere: un paio di settimane prima aveva fatto avvertire Gino Cervi di non assumere nessun impegno per i prossimi mesi perché c’era in vista qualcosa di importante. Bastò quindi telefonare a Roma e il giorno dopo Gino Cervi arrivò a Brescello dove si riprese a “girare” dal principio. «CERCO DI FARLI RAGIONARE» Ma i guai non erano finiti: anzi, appena cominciati. Guareschi, che seguiva da vicino lo sviluppo dell’opera, si accorse immediatamente che Duvivier eludeva l’impegno politico. Continuando così ne sarebbe derivato un film divertente ma senza “la ragione d’essere” della vicenda, che era essenzialmente politica. Il regista francese a prescindere dalle sue convinzioni o prevenzioni appunto politiche era convinto che le storie di Guareschi fossero pura invenzione di un umorista, che i suoi personaggi fossero immaginari, che le vicende narrate non avessero agganci con la vita di ogni giorno. Mentre Giovannino aveva scelto quei tipi e quei fatti proprio ispirandosi alla Bassa quanto ad altre realtà “provinciali” tipiche del nostro Paese. Duvivier, raffinato e intelligente, dopo avere girato la Bassa per trovare gli scorci scenografici naturali (come aveva imposto Guareschi) cominciò a rendersi conto che figure e fatti descritti dall’opera originale avevano le radici in quella società antica e onesta, di gente tutta d’un pezzo. Si capì che se continuava a pilotare la sceneggiatura sulla farsa era solo per un preciso condizionamento politico: era un uomo di sinistra e schivava tutto ciò che potesse avere anche una remota parvenza di “nostalgia” e di “reazione”. Guareschi mise per iscritto il suo pensiero in proposito in data 15 settembre 1950, dopo lunghe discussioni sulla sceneggiatura di Chabrol (l’uomo di fiducia di Duvivier), facendolo pervenire brevi manu al suo editore-produttore Angelo Rizzoli. Ecco alcuni brani: “Ritengo opportuno mettere sulla carta le osservazioni che io Le ho fatto verbalmente circa la realizzazione del film tratto dal mio volume. I vari racconti che compongono il volume, basati sugli articoli pubblicati da Candido, erano stati scritti seguendo diligentemente la situazione politica del nostro Paese a cominciare dal dicembre del 1946 e (si può ben dire e dimostrare) ognuno di essi rappresentava, in sintesi, l’umore politico degli italiani di settimana in settimana. Pur trattandosi di ‘pezzi’ staccati, esiste in tutta la serie una tesi svolta con estrema cautela e con estrema cura: tesi che risultò valida, come posso dimostrare attraverso lettere di comunisti che mi confessarono di avere in biblioteca, accanto ai volumi di Marx, Lenin e di Stalin, il mio libro; lettere nelle quali i comunisti confessavano di aver fatto ‘ peggio di Peppone ’, che essendo dibattuto fra le esigenze della disciplina del suo partito e le esigenze della sua coscienza di uomo semplice ma fondamentalmente onesto, aveva votato scheda bianca. La tesi dei miei racconti era ed è, in sintesi, questa: far risaltare la differenza sostanziale che esiste tra la massa comunista e l’apparato comunista. Indurre cioè l’uomo della massa a ragionare col suo cervello e con la sua coscienza: fargli capire che le direttive che vengono dal centro possono essere seguite soltanto fino a quando esse non vadano a ledere quelli che sono universalmente riconosciuti come sani e onesti principî. Trasformare l’obbedienza ‘cieca pronta e assoluta ’ in obbedienza ragionata. Le mie rubriche a disegni ‘ Il compagno padre ’ e ‘ Obbedienza cieca pronta e assoluta ’ tendono anch’esse a raggiungere questa finalità. Esse non sono state fatte per divertire i borghesi alle spalle dei comunisti, ma per provocare nei comunisti quella reazione salutare di cui si parlava. Per dimostrare insomma a quanti votano PCI che no si chiede loro la restituzione della tessera del Partito e l’iscrizione all’Associazione delle Figlie di Maria ma soltanto un po’ di ragionamento. “Perché a parte la situazione politica internazionale ben diversa da qualche anno fa che renderebbe questo film, se non uniformato alla mia tesi, un’opera intempestiva, anacronistica, ‘sgasata’ e, quel che è peggio, utile alla propaganda comunista, ripeto che io non potrei mai ammettere che il concetto informatore della serie dei miei racconti venisse comunque falsato. Ciò infatti, mentre sarebbe dannoso genericamente, sarebbe dannosissimo a me personalmente perché mi classificherebbe tra gli incoscienti o tra i fiancheggiatori comunisti. Resti pertanto ben chiaro che (ripeto ad abundantiam) il film deve avere questa tesi: precisare la differenza sostanziale che esiste tra il centro motore comunista (apparato) e la massa (base). “Pertanto: Peppone è un uomo forte, rozzo, violento. È un estremista in politica, come estremisti sono praticamente gli emiliani e i romagnoli. Capace di arrivare, spinto dalla faziosità e dalla disciplina di partito, a offendere anche quelle che sono le leggi umane: ma che, davanti a quelle che sono le leggi esterne, leggi divine, si ferma. Arrivato ad un certo punto, Peppone si trova a vivere tra le direttive del partito e la direttiva della sua coscienza di galantuomo e di cristiano, e alla fine ascolta sempre la voce della sua coscienza”. L’INGANNO SVENTATO “Don Camillo: è uguale, identico a Peppone. Fisicamente e spiritualmente. Paragonando l’estremismo a una medaglia, Peppone è il diritto e Don Camillo è il rovescio della medaglia,due facce della stessa identica realtà. L’azione di Peppone provoca in Don Camillo una reazione di uguale carattere e misura: ma qui (essendo Don Camillo un uomo più preparato ed educato intellettualmente di Peppone) l’intervento della sua coscienza di cristiano onesto e civile (voce di Cristo) lo riporta alla ragione. E alla fine quando Peppone non riesce ad arrivarci da solo perché occorre un ragionamento troppo sottile o perché egli è troppo eccitato dalla polemica, Don Camillo diventa, nei riguardi di Peppone, il portavoce di Cristo e quindi del ragionamento e della coscienza. Peppone non è un cretino: è un uomo ignorante, ma intelligente, forte e passionale: con altre parole, un galantuomo pericoloso. “Don Camillo è solo la bella copia di Peppone e i sistemi che egli usa per riportare Peppone alla ragione sono quelli adatti alla circostanza e al clima forte del paese dove i due vivono: se occorre Don Camillo farà balenare la canna del mitra o sventolerà panche e metterà in moto i colossali pugni. Don Camillo deve essere, per quello che riguarda il suo modo di agire, l’insegnamento positivo della mia storia: davanti alla violenza la borghesia non deve reagire con la viltà e con la violenza, ma con la forza che è una cosa virile, onesta e ragionata. Il film deve essere onesto: non deve ignorare la miseria, l’ingiustizia e l’egoismo: deve dimostrare che, per combattere la miseria, l’ingiustizia e l’egoismo, il sistema usato dai comunisti è completamente sbagliato: non solo, ma con la scusa di eliminare un male ne crea uno infinitamente maggiore”. Questo testo ci illumina sulle intenzioni di Guareschi e fa giustizia di tutte le scemenze scritte dai reggitori di coda dei partiti di sinistra e dai politici che l’ hanno sempre ignorato o considerato un provocatore e un bastian contrario. È la prima e unica volta che Guareschi, in questo scritto finora assolutamente inedito, rivela la ragione che l’aveva spinto a creare i suoi personaggi. Altro che “nostalgico incallito”, “bieco reazionario” o “anticipatore del compromesso storico” come di volta in volta è stato scritto dai suoi avversari politici. Appena iniziata la lavorazione si capì che Duvivier non rinunciava alla sua intenzione. Si sa che il regista, specialmente se molto esperto, può voltare la frittata come vuole senza che nessuno se ne accorga. E Duvivier dopo aver verbalmente accettato tutte le condizioni di Guareschi, all’atto pratico, sul set, manovrava le cose in modo diverso. Guareschi capì subito che dopo tante assicurazioni alla fine si sarebbe trovato davanti a un film non più “suo” ma di Duvivier. Allora ricopiò lo scritto già inviato a Rizzoli e, senza modificare una virgola, lo mandò, l’otto maggio 1951, con ricevuta di ritorno, a Duvivier. Da quel momento non ci furono più discussioni, le cose ritornarono in carreggiata e alla fine Guareschi diede il suo assenso: il film che era uscito non era proprio quello che avrebbe voluto, ma nemmeno quello che il regista francese aveva tentato di fare agli inizi. Ed ebbe la fortuna che sappiamo proprio per questo. (10 – continua) Alessandro Minardi da “L’Uomo qualunque” 14/05/1998 LA SEQUENZA TAGLIATA PER NON IRRITARE IL CREMLINO Guareschi assistendo alla proiezione del quarto film sulle disavventure del sindaco comunista si accorse che era stato omesso l’episodio critico con l’industria dell’Unione Sovietica. “Le sue astronavi solcano vittoriose il cosmo, ma i suoi trattori si guastano appena solcano il terreno”. La rabbia dello scrittore e la rottura con la produzione cinematografica di Rizzoli. I registi si comportavano allo stesso modo: si capiva che tiravano a evitare di fare dei film dai contenuti di grande rilievo politico e sociale. Con le scuse più strane proponevano di sostituire le sequenze in grado di suscitare le proteste dei socialcomunisti con delle varianti da commediola all’italiana, innocue. Un giorno fui convocato da Angelo Rizzoli, presente il figlio Andrea, per esprimere la mia opinione su talune manipolazioni apportate, rispetto all’originale, da certi sceneggiatori romani, su sollecitazione del regista del film, Carmine Gallone. Si trattava di banalità che nulla avevano a che fare con lo spirito di Guareschi e con il soggetto, una “pezza” messa per coprire una battuta che avrebbe dato fastidio ai sindacalisti. Dissi che certamente l’autore non avrebbe accettato la modifica. Andrea Rizzoli affermò testualmente: “Sarebbe come dare da restaurare un Tiziano ad un imbianchino”. Angelo, il Commenda, allora tagliò corto: “Faranno come previsto nella sceneggiatura di Guareschi. Non ne parliamo più”. VOLEVA MILVA CON BANDIERA ROSSA Ma il caso più clamoroso, che portò alla rottura, almeno nel campo cinematografico, si verificò al quarto film. Nella sceneggiatura di Giovannino c’era un episodio, tratto da un racconto che aveva avuto un grande successo. Nel paese di Don Camillo arriva dall’Unione Sovietica un trattore donato dal Cremino alla sezione del PCI del sindaco Peppone, l’antagonista del parroco. Peppone organizza quindi una grande cerimonia per la consegna ufficiale della macchina con l’intervento di importanti gerarchi comunisti. Evento insopportabile per il parroco, che studia una manovra diversiva affinché il raduno si concluda in una farsa tale da far ridere tutto il paese. Di notte entra nell’officina di Peppone e si mette a trafficare col motore. Il giorno dopo, in un mare di bandiere rosse, davanti alla tribuna piena di comunisti in tripudio arriva il trattore pilotato da Peppone. Questi ha al proprio fianco una ragazza avvolta in una bandiera rossa, che secondo le indicazioni di Guareschi avrebbe dovuto essere Milva cantando alternativamente “Bella ciao” e “Bandiera rossa”. Ma, proprio davanti alla tribuna dove c’è l’inviato di Mosca, il trattore comincia a starnutire e di colpo si blocca. Peppone scende scuro in volto e, mentre la ragazza continua a cantare a squarciagola, alza il cofano e si mette a rovistare nel motore. I comunisti che Giovannino definiva “Trinariciuti”, dalla “obbedienza cieca, pronta e assoluta”, applaudono il loro capo e la sua buona volontà. Ma la folla dei paesani comincia a sghignazzare. Alla fine Peppone chiude il cofano, allarga le braccia sconsolato e se ne va. Ritorna dopo pochi istanti con due paia di buoi che trascinano via il famoso trattore, “orgoglio della potente industria sovietica”, come aveva affermato pochi minuti prima il rappresentante del Cremino. Fin dal principio il regista Carmine Gallone, pur essendo un grande estimatore e amico di Guareschi, aveva detto che questa era una sequenza “troppo forte” e che avrebbe suscitato una reazione nei comunisti, forse anche una protesta diplomatica da parte dell’Unione Sovietica. Quella sequenza, insomma, non la voleva. Era il clima di allora, del tempo della guerra fredda. Ma, appena informato, Giovannino replicò che senza la scena in questione il film non si sarebbe fatto. Ci furono discussioni a non finire con la conclusione che la produzione e il regista ingoiarono il rospo e l’episodio venne girato. Si seppe poi che l’insieme di queste sequenze con moltissime comparse era costato ottanta milioni: per i tempi, quasi un patrimonio. Il colpo di scena si ebbe a Busseto quando si proiettò il film in anteprima mondiale. Quella scena non c’era più; di essa non apparve un solo fotogramma. O l’avevano girata “in bianco”, cioè a vuoto, senza pellicola, o era stata tagliata. Non si seppe mai la verità. Guareschi accusò nettamente il colpo: prima che finisse la proiezione si alzò, gridando che era una truffa che non avrebbe potuto sopportare. Piantò in asso le centinaia di invitati, mi fece cenno e ce ne andammo fuori nella notte. “Si vede meglio in questo buio – disse – che là dentro”. Mi ci vollero ore e ore per riuscire a placare la sua rabbia. Comunque Giovannino il giorno dopo scrisse una lettera a Rizzoli affermando di non poter continuare a lavorare per l’editore che, come produttore cinematografico, non era in grado di mantenere la parola. Dava perciò le dimissioni anche da Candido. Non recedette dalla sua decisione nonostante gli affettuosi interventi degli amici più cari e Candido, di cui egli era la colonna portante, alla fine cesserà le pubblicazioni. Anche se, prima, Rizzoli lo offrì gratuitamente a me, che ne ero il direttore, con la speranza che riuscissi a far collaborare nuovamente il mio amico: “È una bandiera che non deve essere ammainata – affermava l’editore – specialmente ora che ci sono tante nubi temporalesche all’orizzonte del mondo politico ed economico”. Ci vollero mesi prima che l’ira di Guareschi sbollisse, ma alla fina l’amicizia fra l’editore e l’autore riprese intatta (o quasi). I due si volevano bene sul serio e si stimavano profondamente. Ma tra loro di film non si parlò mai più. E Guareschi disse di no a tanti altri produttori, anche stranieri, che speravano di prendere il posto di Rizzoli. «L’ULTIMA VOCE LIBERA» Per valutare appieno la personalità dello scrittore è comunque importante conoscere nei dettagli i retroscena della grande rottura. Questa lettera, in data 17 ottobre 1961, fu spedita a Cademario (Lugano). Era indirizzata ad Andrea Rizzoli e per conoscenza al sottoscritto. Guareschi in risposta a una precedente comunicazione di Andrea scriveva tra l’altro: “Le sue parole hanno reso più acuta la mia malinconia. Anch’io ricordo il giorno in cui la grande Milano, che avevo per anni sognato senza speranza, arrivò d’improvviso in quel dimenticato villaggio nell’Appennino modenese in cui prestavo servizio militare. Arrivò anche lei, Andrea, a bordo di una rombante ‘Augusta’ e accompagnato da una segretaria dallo smagliante sorriso. Quel giorno incominciai a vivere la favola che, ora, è finita e, perciò, mi pare ancora più bella e incredibile. L’edificio che avevo costruito faticosamente, pietra su pietra, è crollato e, di esso, non restano che le macerie del sottotenente d’artiglieria che le offrì una delle sue sigarette ‘milit’. Un capitolo della mia vita si chiude e manca la certezza che se ne apra uno nuovo. Non sono solito piangere sul latte versato, però, sia detto fra noi, io non immaginavo che le mie dimissioni avrebbero indotto l’editore a sopprimere Candido. Candido era rimasto spavaldamente sulla breccia durante la mia detenzione nel carcere di Parma. Quando, cioè, qualsiasi editore – che non fosse stato Rizzoli – non avrebbe esitato a sopprimerlo per numerose e valide ragioni, non ultima quella dei guai che questo giornale gli aveva procurato e continuava a procurargli. “Sulla base di questo precedente e considerando la situazione giornalistica attuale (una situazione disperata perché Candido era rimasto l’ultima voce libera e non conformista dell’alta Italia) non fui sfiorato neppure dall’idea che l’editore potesse sopprimere il nostro settimanale. Anche senza la mia collaborazione, Candido poteva benissimo continuare a vivere e a svolgere la sua importante funzione. “Minardi, uomo onesto, coerente, fedelissimo, di idee chiare e di provata competenza ed efficienza professionale, non più imbrigliato dalla ‘linea-Guareschi’ era finalmente in grado di fare il suo Candido, senza falsarne lo spirito e variando il dosaggio e la forma. Candido avrebbe continuato a viaggiare sullo stesso binario, con una locomotiva nuova. Qualora non appena venuto a conoscenza della mia lettera di dimissioni, l’editore mi avesse posto l’aut-aut: ‘ Se lei va via, io sopprimo il giornale ’ logicamente io mi sarei rimangiato la decisione. E ciò sia per non fare il gioco del nemico, sia per la grande riconoscenza che io dovevo a Minardi e ai suoi e miei collaboratori, sia per impedire che la Rizzoli ammainasse una bandiera – mi sia permesso il dirlo – gloriosa. Ma così non è successo e la buccia che doveva far cadere soltanto me ha fatto cadere, invece, uno degli ultimissimi fortini sui quali ancora sventola la bandiera dell’Italia pulita. Milano, scomparso Candido, è ora completamente liberata e conquista l’ambito titolo di ‘ Capitale del conformismo italiano ‘. “Come sono lontani i tempi meravigliosi del ’46-47-48; quando Candido – e questo è grande e indimenticabile merito di Angelo Rizzoli e del figlio Andrea – diceva ciò che nessuno osava dire. Ora Candido tace, eppure i tempi sono peggiori di quelli d’allora, e c’è chi si appresta a innalzare sul pennone di via Civitavecchia la bandiera gialla del conformismo romano (la Rizzoli aveva annunciato l’intenzione di pubblicare nei suoi stabilimenti di via Civitavecchia un nuovo giornale, con lo slogan ‘ Oggi, il quotidiano di domani ’ ma il progetto venne in seguito abbandonato). Qualcosa di molto importante è rimasto nel palazzo di piazza Carlo Erba dov’era la vecchia sede della Casa editrice, qualcosa che non è stato possibile trasferire nel palazzone di via Civitavecchia. Forse si tratta solo dei miei, dei suoi, dei nostri anni migliori”. “LOTTO CON LE UNGHIE E I DENTI” Guareschi proseguiva quindi così il suo lungo sfogo scritto: “Caro Andrea, la sua lettera mi ha commosso e anche un po’ addolorato. Mi sembra ingiusto mettere sul piatto della bilancia Bertoldo; Candido e i 26 anni di lavoro comunque, e, sull’altro, il quarto ‘ Don Camillo ’. mi sembra ingiusto considerare l’episodio di ‘Monsignore’ a sé, distaccandolo da tutto il resto”. “Caro Andrea – seguitava Guareschi – no, non si può dimenticare: dal 1950 (inizi del progetto del primo ‘ Don Camillo ‘) io lotto con le unghie e coi denti per difendere dai cinematografari di suo padre le mie povere creature di carta di cui essi intendono falsare la personalità e lo spirito. Quando si trattò di iniziare la lavorazione del secondo film, ‘ Il ritorno di Don Camillo ‘, dopo lunghe e angosciose discussioni con Julien Duvivier, che era stato anche il regista del primo, non si riusciva a trovare un accordo. Allora io dissi a suo padre: ‘ Duvivier può urlare fin che vuole: nel contratto c’è scritto chiaro e tondo che ogni variazione deve essere fatta d’accordo con me ’. mi fu risposto che il regista francese ignorava l’esistenza di questa clausola in quanto, il contratto da lui firmato, detta clausola – da me fatta inserire nel mio contratto – era stata omessa. E ciò perché Duvivier mai avrebbe accettata simile condizione. Chiunque al mio posto avrebbe, e con centomila buone ragioni, piantata una grossa grana. Io mi limitai a mandare tutti a quel paese e mi ritirai lasciando alla produzione e al regista carta bianca, rinunciando – per non creare guai a suo padre – a far valere il mio diritto. Poi, a film finito, lei mi pregò di tentare di rabberciare un po’ la situazione e io mi sforzai di farlo scrivendo nuovi dialoghi e ricucendo assieme vari episodi secondo una diversa traccia. Vana fatica perché Duvivier rifiutò di modificare il film già finito e ne uscì la squallida pellicola che lei ben ricorda. “La sceneggiatura del terso film, ‘ Don Camillo e l’onorevole Peppone ‘ che io scrissi e poi riscrissi in carcere, mi diede altre amarezze a causa di interpolazioni e contaminazioni inaccettabili: ma non potevo dimenticare quanto – e a qual gravoso prezzo – suo padre m’era stato amico durante la mia disavventura carceraria e così, quando a Busseto mi fu mostrato il film, mi limitai a dire alcune sgradevoli cose al regista Carmine Gallone. ‘ Don Camillo monsignore… ma non troppo ’ è la mia quarta avventura cinematografica con la Ci- neriz. Non è necessario che io ricordi qui il travagliatissimo iter della sceneggiatura. Lei lo conosce meglio di me e mi ha già dato atto della mia tolleranza, della mia pazienza e della mia buona volontà. Lei mi scrive: ‘ Pensi in quante cose il Commenda l’ ha seguito: è vero che lei ha sempre pagato di persona, ma lui non ha mai mutato atteggiamento restando sempre al suo fianco. Anche quando una decisione è stata volutamente presa all’insaputa del Commenda e tale decisione toccava cose, mi permetta, ben più importanti di qualche franse e scena del film ’. ebbene, caro Andrea, siamo sempre alla faccenda della bilancia. Se su uno dei due piatti mettiamo ciò che la pubblicazione di quella famosa lettera (falsamente attribuita a De Gasperi, ndr) costò a suo padre (preoccupazioni, fastidio, danaro) e, sull’altro piatto, i miei tredici mesi di carcere e il danno che la vendetta fiscale mi procurò, le posso dar ragione. La bilancia pende dalla parte di suo padre. Ma sul mio piatto bisogna mettere anche qualcosa d’altro; qualcosa che non può essere calcolato in mesi di carcere o in lire. Il sopruso del processo, la feroce campagna diffamatoria condotta contro di me dalla stampa e l’aver dovuto vivere, per tredici mesi, tra delinquenti della più spregevole specie, trattato alla loro stregua. L’aver dovuto subire per tredici mesi i piccoli grandi soprusi, le piccole e grandi viltà di chi – angariando il carcerato Guareschi – intendeva acquistarsi titoli di merito presso la Superiore Autorità, tutto questo ha inciso profondamente sul mio spirito”. “SONO STANCO DI SUBIRE SOPRUSI” “Angelo Rizzoli alla fine della triste vicenda era sempre Angelo Rizzoli, io, uscendo dal carcere, non ero più Giovannino Guareschi. Né più riuscii a ridiventare il Guareschi che ero. Metta anche questo, sul mio conto, e vedrà che i due piatti si bilanciano. In confidenza: nei confronti di suo padre, ho pagato tutto quello che dovevo pagare. Forse qualcosa di più. Mettendo sul mio piatto la triste vicenda di ‘Monsignore’, la bilancia pende decisamente dalla mia parte. Non si può ridurre tutto al cambiamento di ‘ qualche frase e scena di un film ’. inquadrate nella battaglia difensiva che io combatto contro i cinematografari di suo padre sin dal lontano 1950, queste variazioni e deformazioni acquistano un’importanza che giustifica il mio risentimento. Trascuro le incredibili sciocchezze commesse dalla Cineriz ai danni della mia sceneggiatura e dello spirito del mio racconto. Voglio ricordare soltanto l’arbitraria omissione di un episodio come quello del trattore sovietico. In un mondo allocchito e tremebondo, con gli occhi persi in cielo, dietro alle alchimie cosmiche sovietiche, quell’episodio richiamava l’attenzione della gente sulla terra e sulla misera realtà di un Paese le cui astronavi solcano vittoriose il cosmo, ma i cui trattori non riescono a fare, senza guastarsi, dieci solchi in un campo di grano. Pur avendo io ammorbidita la versione originale, l’episodio conservava la sua importante funzione. Qualsiasi altro episodio poteva essere soppresso: quello no. L’avevo detto ripetutamente e chiaramente. Non poteva essere in nessun caso eliminato perché la sua funzione era quella di richiamare la polemica anticomunista che è alla base della mia attività di giornalista politico e costituisce il nocciolo dei 450 miei racconti di ‘ Mondo Piccolo ’. Togliendo ogni appiglio polemico e anche quell’episodio il racconto di ‘Monsignore’ è risultato snaturato e cambiato in semplice farsa. Così castrato, e presentando un Monsignore così ridicolizzato, questo quarto film di Don Camillo, se possedesse qualche pregio artistico o, almeno, avesse una fotografia decente e non fosse un pasticcio di immagini e di melensaggini, potrebbe essere tranquillamente presentato in Russia col compiaciuto beneplacito della superiore autorità sovietica. In realtà ‘Monsignore’ è un film che mi danneggia enormemente anche sul piano politico perché, falsando lo spirito dei miei personaggi e della loro vicenda, mi presenta come un normale e banale ‘distensivo’. Uno spregevole ‘pacifista’ che, per far divertire i compagni, fa parlare il Cristo con le parole di due ‘puzzoni’ romani. È un film che mi squalifica come sceneggiatore, come scrittore, come umorista e come giornalista politico. “Ed ora mi lasci dire ancora una cosa: non creda che io speri di vincere questa battaglia: ho ragione e, quindi, è pacifico che la perderò. Ma è mio dovere usare ogni mezzo lecito per denunciare il sopruso e per cercare di riabilitarmi agli occhi dei miei amici lettori, che sono pochi, ma mi bastano. Se l’ ho annoiata, mi perdoni, ma le dovevo una spiegazione”. “Con immutata e immutabile amicizia”, concludeva il suo scritto Giovannino Guareschi. Testo lungo, certo: ma dimostra meglio di un intero volume di quale tempre fosse fatto il mio fraterno amico e grandissimo scrittore. (11 – continua) Alessandro Minardi da “L’Uomo qualunque” 21/05/1998 SFERZANTE CON I POLITICI GENEROSO CON GLI UMILI Guareschi era implacabile con la sua satira ma molto altruista. Quando, da ragazzo, salvò un operaio gravemente ferito per un’esplosione. Nel dopoguerra numerosi reduci si avvicendavano nella sua casa ricordando commossi quanto lo scrittore aveva fatto per loro, durante la prigionia in Germania, sfidando il rigore dei guardiani dei lager Nel raccontare la tumultuosa esistenza di Guareschi si rischia di diffondere soltanto l’immagine di un grande scrittore trascurando del tutto quella dell’uomo, che fu grande anche nel suo privato, nella vita di ogni giorno. Episodi significativi, importanti sotto questo profilo, sono pressoché nascosti a causa della sua innata e spesso cronica ritrosia, anche quando sarebbe stato quasi un obbligo verso il pubblico sconfinato dei suoi lettori rendere note certe verità. Non basta parlare dei suoi libri e dei film che ne sono derivati. Della sua personalità non si discute come si fa del suo enorme impegno giornalistico. Impegno che, a detta di uno, quale io sono, che è stato nel giornalismo per 57 anni, è senza paragoni in Italia. Nessuno dei biografi improvvisati parla dell’uomo Guareschi. Continuano a rilanciare l’inventore di due personaggi famosi, Peppone e Don Camillo, senza sforzarsi di vedere come egli era nella realtà e quale fosse il suo autentico profilo umano. Nessuno cerca di vedere cosa c’era dietro l’autore di successo, quali erano la sua personalità, i suoi slanci vitali, le sue amarezze sopportate in solitudine e senza capricci del personaggio che spesso si è sentito incompreso. Per esempio, fra i tanti aspetti importanti è completamente ignorato quello della generosità, componente fondamentale del suo carattere e matrice segreta della sua opera di scrittore. Schivo com’era, ben pochi sanno dei gesti di bontà e solidarietà da grande altruista. Solidarietà che non ha nulla da spartire con quella in cui si riempiono la bocca, ma non il cuore, i nostri uomini politici. Guareschi era un generoso di temperamento, all’insaputa magari degli stessi beneficiati e in qualche caso, addirittura, dei suoi stessi familiari. Ci sono degli episodi edificanti che solo che gli è stato lungamente vicino può conoscere. C’è un aspetto completamente ignorato, ma facilmente riscontrabile nei suoi scritti, un aspetto della generosità di Guareschi assai raro oggi, anche se può sembrare meno importante, che non dovrebbe sfuggire a chi scrive di lui. Generoso verso gli avversari politici e i colleghi giornalisti che lo osteggiavano in tutti i modi e l’attaccavano pubblicamente attribuendogli fatti e intenzioni del tutto gratuiti. A questi rispondeva scherzando, senza mai entrare nelle questioni personali che, per taluni pezzi grossi, sarebbe stato facile denunciare anche con testimonianze e prove incontestabili. La sua polemica era di carattere morale, mai personale, pungente, spesso dura, ma evitava costantemente la rissa personale. Diceva: “La questione non è fra me e Togliatti o fra me e De Gasperi: è fra Togliatti e il popolo italiano, è fra De Gasperi e il popolo italiano. Io mi limito a stare con il popolo italiano, con l’Italia. Se fanno porcherie è all’Italia che ne devono rendere conto, non a me. Io mi limito a difendere la gente come me e il buon nome dell’Italia”. E anche questo è un aspetto della sua generosità. Il primo atto di altruismo, che fu anche di grande coraggio fisico, Giovannino lo compì a diciotto anni quando era ancora ragazzetto isolato e introverso; timido e in un certo senso condizionato dalle cattive condizioni economiche. Infatti la sua famiglia viveva con il magro stipendio della madre, maestra di campagna, che doveva provvedere da sola al bilancio domestico avendo i due figli ancora studenti. Un giorno dell’estate del 1927 Giovannino sulla sua scassata bicicletta da donna stava pedalando da Marore verso Parma, quando, giunto fuori dal paese, avvertì un grande scoppio di provenienza lontana. Continuò a pedalare fino a quando incrociò un’autopompa rossa dei pompieri che andava verso Monticelli. Seppe così che il tremendo rumore era stato causato da una catastrofica esplosione di gas metano verificatasi mentre si stava trivellando un pozzo. Si cercava l’acqua ma ne scaturì un enorme getto di metano e petrolio che distrusse in un battibaleno il cantiere causando varie vittime e feriti. Giovannino invertì la marcia e arrivò sul luogo dell’esplosione mentre i pompieri erano impegnati a spegnere l’incendio che si era propagato tutto intorno e a recuperare i corpi dei morti, a soccorrere i feriti. Uno spettacolo apocalittico. Si avvicinò più che poté e vide il corpo di un giovane operaio avvolto nelle fiamme. Senza pensarci un minuto si avvicinò al disgraziato e riuscì ad afferrargli un piede e a trascinarlo sull’erba, lontano. Si era immerso fino alla cintola nel pantano di petrolio. Poi con l’aiuto di altri che si erano avvicinati, stimolati dal suo aiuto, riuscì a spegnere le fiamme che avvolgevano il ferito consentendo di accertare le sue condizioni, peraltro gravissime. L’infelice spirò. “MA IO LE DEVO LA VITA” Quindi Giovannino perlustrando la zona scorse, a una trentina di metri dal luogo dove era avvenuto lo scoppio, un giovanotto che tentava di muoversi. Nessuno lo aveva notato prima perché i soccorritori non ritenevano che fossero rimaste coinvolte persone a quella distanza: in effetti, il giovane in questione, un meccanico addetto alla trivella, era stato scaraventato lontano dallo spostamento d’aria. Aveva fatto un volo di una trentina di metri. Guareschi si precipitò verso di lui e affondando nel fango vischioso riuscì a caricarsi sulle spalle il ferito ancora cosciente, e a portarlo nei pressi delle autoambulanze. Il poveretto aveva varie fratture e gravi ustioni in tutto il corpo. Fu portato in ospedale e dopo una lunga degenza si salvò. Guareschi di tanto in tanto telefonava per sapere come stava, senza mai dire il suo nome. Questo episodio mi era stato confermato varie volte da Vieri Borrini, figlio maggiore del proprietario di quel terreno sul quale sorse poi la fiorente Monticelli Terme, considerata ancora oggi la più grande fonte italiana di produzione dello jodio. Ebbene, cinque anni più tardi il meccanico salvato da Giovannino venne nella redazione del Corriere Emiliano-Gazzetta di Parma per ringraziare il giornalista. Disse testualmente, in mia presenza: “Lei mi ha salvato la vita. L’altro giorno l’ho visto passare in bicicletta e l’ ho riconosciuto subito. Certe facce non si dimenticano. Ho chiesto a un giovanotto che l’aveva salutata chi era e dove potevo trovarla. Ed eccomi qui. Mi permetta di abbracciarla. I medici mi riferirono allora che avevo perso molto sangue oltre a presentare diverse e gravi ustioni; se non fossi stato soccorso tempestivamente da lei, sarei morto. Il mio debito di riconoscenza nei suoi confronti resterà sempre tale”. Guareschi gli batté una mano sulle spalle e concluse con semplicità: “Lasciamo perdere. La vita lei la deve al Padre Eterno.”. Di questo episodio Giovannino parlava scherzosamente solo quando qualcuno dei tipografi del giornale che era stato presente a quel colloquio lo ricordava. Poi passarono gli anni e nessuno più ne parlò. Soltanto il padre del “miracolato”, che non aveva potuto vedere un granché essendo arrivato sul luogo del disastro molte ore più tardi, rammentava il salvataggio ogni volta arricchendolo di particolari e così trasformando il nostro giornalista in una specie di Superman. Ma dove la generosità di Guareschi si manifestò in modo tale da non potere rimanere nascosta, perché c’erano migliaia di testimoni, fu nei lager tedeschi. Naturalmente si tratta di generosità morale, spirituale, umana, manifestata in modo tale che un cappellano militare, deportato anche lui, ebbe a dire e a scrivere: “Ciò che ha fatto Guareschi di baracca in baracca per confortare i prigionieri vale più di tutto ciò che abbiamo fatto tutti noi cappellani”. “LI COSTRINSE A REAGIRE” Prendiamo a testimone lui stesso nel “Diario clandestino”, quando scrive: “Non ci siamo rinchiusi nel nostro egoismo. La fame, la sporcizia, il freddo, la malattia, la disperata nostalgia delle nostre mamme e dei nostri figli, il cupo dolore per l’infelicità della nostra terra non ci hanno sconfitti. Non abbiamo dimenticato mai di essere uomini civili, con un passato e un avvenire”. E lo confermavano molti reduci dei lager di Sandbostel, Beniaminowo, di Czestochowa e di Wietzendorf, tutti convinti che Guareschi li avesse aiutati in modo determinante a superare la prova tremenda della lunga prigionia in mano nazista. Uomini provenienti da ogni ceto sociale e alcuni dei quali destinati alla notorietà e al prestigio come il pittore Giuseppe Novello, il poeta Roberto Rebora, il giornalista Massimo Alberini. La testimonianza di quest’ultimo riportata dalla Gazzetta di Parma nel 1984 è eloquente: “Guareschi, lo si è detto, fu personaggio di primissimo piano in quei mesi e fece enormemente del bene soprattutto nei confronti di quanti erano disposti, per disperazione o apatia, a rifiutarsi di reagire, persino di ‘sentirsi vivere ’. ebbi per qualche tempo nel posto letto sopra il mio (dormivamo in ‘castelli’ di tre piani) un tale ancora giovane che passava giorni e notti quasi immobile, guardando in aria senza parlare. Proprio per reagire a questa disperazione silenziosa si era organizzata quella attività culturale che Guareschi chiamava Regia Università di Sandbostel: molti corsi, dalle lingue ai calcoli sul cemento armato (per ingegneri e architetti), un giornale parlato (La Campana) e perfino concorsi letterari. Giovannino partecipava a questa attività ma ne preferiva un’altre più diretta. Con un musicista conosciuto in prigionia, Coppola, dotato, grazie a quelle imprevedibili concessioni che i tedeschi, di tanto in tanto, facevano alla “Kultur”, di una fisarmonica, visitava ogni sera una baracca diversa per il Bertoldo parlato: cronaca della vita del campo e dei suoi abitatori. Ma, soprattutto, il Bertoldo si valeva dei ricordi di casa: la moglie Ennia (Margherita nella finzione letteraria), i figli Albertino e, nata mentre Guareschi era in prigionia, la figlia Carlotta. Ma al di fuori di quella tournèe, era quasi impossibile incontrare Guareschi. Se ne stava in baracca, molto silenzioso, con il desiderio di essere lasciato tranquillo”. Nei primi anni del dopoguerra furono decine e decine gli ex internati che andavano a trovarlo a casa unicamente per ringraziarlo di quanto aveva fatto per loro, sfidando la meticolosa e spietata sorveglianza dei guardiani dei lager. (12 – continua) Alessandro Minardi da “L’Uomo qualunque” 28/05/1998 UN PARMIGIANO A PARIGI Guareschi era molto popolare in Francia dove aveva venduto un milione di copie solo col primo libro dedicato al parroco battagliero e la sindaco Peppone. Fu festeggiato durante la “Notte delle Stelle” con Gina Lollobrigida ma in seguito, in occasione della cena in suo onore, rifiutò con disgusto lo champagne e gradì il casalingo lambrusco Pochi fra milioni di lettori e spettatori cinematografici sanno che le radici di Giovannino Guareschi erano integralmente contadine. Tutto il nucleo familiare veniva dalla Bassa parmense e in quella terra sviluppò l’attività per secoli, esclusivamente agricola. Ci fu una sola eccezione: Icilio, prozio del padre, nato a San Secondo, mandato a studiare a Parma, divenne chimico di fama internazionale. Fu autore di una famosa quanto poderosa enciclopedia della chimica, strumento prezioso fin quasi ai giorni nostri. Arrivò ad avere la cattedra universitaria a Torino e, a quanto si sa, non si occupò mai direttamente di agricoltura. Il caso in senso contrario si ripeté con Giovannino che, anche lui mandato a Parma con l’intenzione di farlo diventare avvocato, arrivò all’Università ma divenne giornalista e poi scrittore. La differenza fra i due consiste nel fatto che mentre Icilio non pensava alla campagna, Giovannino aveva la Bassa nel sangue e nel cervello. Senza l’amore segreto della Bassa non avrebbe potuto essere quello che è stato. Non solo nei gusti semplici e schietti ma specialmente nel modo di pensare, tutto personalistico, fantasioso e intransigente come il più reazionario degli agrari. Solo il contatto con la città lo aveva abituato a quello che lui definiva il “gioco delle parti”: nella Bassa faceva il contadino e in città il cittadino. Ma appena poté tornò nella sua campagna. Le infiltrazioni cittadine presto sparirono e, compromessi a parte, accettati per vivere come gli altri, su una cosa non transigeva: il vino. DISSE NO AL QUIRINALE Non era un gran bevitore, anche perché bastavano due bicchieri per renderlo brillante e quattro piuttosto nervoso. Ma quando beveva non rinunciava ai suoi gusti. Vini nostrani, come si dice, di fattoria e qualità limitata ai prodotti parmensi: bianco sauvignon, malvasia secca e pinot; rosso lambrusco. Gli altri vini non lo interessavano. Sarebbe stato come offrire la compagnia di un gatto a che desiderava un cane. Quando finalmente poté avere della terra sua, la prima preoccupazione, dopo aver sistemato la casa dell’affittuario o del mezzadro, era quella di piantare viti. Non un grande vigneto perché non voleva avere il problema dei rivenditori ma soprattutto ma soprattutto due qualità: sauvignon e lambrusco. La sua più grande soddisfazione fu giungere, finalmente, a bere il suo vino, esattamente uguale a quello che avevano prodotto i suoi vecchi e che lui aveva ancora nel palato. Aveva girato in lungo e in largo e chiesto consigli ad agricoltori di fiducia sino ad avere i prodotti tanto desiderati: vini bianchi con non più di sette - otto gradi, rosso al massimo dieci gradi. Per oltre dieci anni festeggiammo insieme, noi due con le rispettive famiglie, la ricorrenza del Natale. La sera della vigilia, a mezzanotte, si stappava la tradizionale bottiglia di “Cordon Rouge” o “Dom Perignon”, la si metteva, ancora piena, fuori, sul prato, senza versarne una goccia, e si stappava un “bianco seco” di produzione Guareschi che aveva un gusto e una delicatezza squisiti. “Altro che champagne”, commentava immancabilmente Giovannino tutto soddisfatto mentre sbocconcellava la “spongata” (pastafrolla con canditi) di Busseto al posto del panettone. E di quel “bianco” poteva berne quanto voleva. Forse per i grandi gourmet e i famosi tastevin sarebbe stata una bestemmia gustare il culatello e il salame di felino con il sauvignon e il tacchino arrosto con un lambrusco spumeggiante. Ma Guareschi era certo di essere nella tradizione perché i suoi vecchi non sapevano nemmeno cosa era lo champagne e del chianti avevano sentito parlare soltanto coloro che avevano fatto il soldato. Infatti fino a quarant’anni fa la Bassa Parmense era una specie di Far-West, dove chi ci viveva rispettava le sue tradizioni. E nessuno cedeva alle allettanti tentazioni provenienti dal mondo esterno. Queste tradizioni erano favorite dal fatto che ogni famiglia si tramandava i costumi dei padri, gente dura, testarda, intransigente, abituata a bastare a se stessa e a non aver bisogno degli altri. Tutto questo era favorito dalla mancanza di influenze esterne come la radio e la televisione. MATRIMONIO IMPOSSIBILE Dopo la vendemmia, che Giovannino affrontava con uno scrupolo straordinario impedendo la raccolta di quei grappoli che non erano perfetti, seguiva la pigiatura e la vinificazione condotte con altrettanto scrupolo. Andava sul bordo dei tini a fiutare e poi diceva ai contadini: “Lo tiriamo giù domani,, alle sei (ore diciotto)”. I contadini restavano perplessi. Qualcuno azzardava: “Ma non è ancora l’ora”. Lui rispondeva: “Oggi no ma domani sì, mancano ventiquattr’ore, sarà tutto perfetto”. Alla svinatura tutti erano d’accordo: il vino era maturo. Ci fu un anno che, dopo la giusta stagionatura nelle botti procedendo all’imbottigliatura decise di aggiungere a ogni bottiglia un bicchierino (non più di due o tre centimetri cubi di cognac – allora si chiamava ancora così -) di “Tenerelli”. Dopo sei mesi scherzosamente lo offriva agli ospiti convinti di bere dell’autentico champagne. Ma subito chiariva: “Di questo champagne si può riempire tutta l’Italia. Ho voluto dimostrare quanto sia facile fare una buona imitazione, ma io preferisco il vino che non assomigli allo champagne”. C’è un episodio curioso e anche importante che non è mai stato riferito. Subito dopo la condanna a dieci mesi di carcere inflitta a Guareschi per un’innocente vignetta che si riferiva al presidente della Repubblica Luigi Einaudi, Giovannino ideò una battuta che affidò a Manzoni per la realizzazione: raffigurava un omino con il bastone tra due schieramenti di bottiglie alte come granatieri. Titolo: “Rivista al Quirinale”. E sul petto delle bottiglie, al posto delle corazze c’erano le etichette con la dicitura: “nebiolo delle tenute del presidente Einaudi”. Infatti il presidente aveva commercializzato il suo vino prodotto a Dogliani con tale slogan. Dopo qualche settimana dalla condanna arrivò alla redazione di Candido un telex del nostro capo dell’ufficio di Roma, il giornalista Massimo Rendina, in seguito diventato uno dei massimi dirigenti della Rai. Diceva il testo: “Minardi, avvisa Guareschi che il presidente Einaudi lo invita a colazione al Quirinale. Lo prega di fissare lui il giorno che preferisce. Si brinderà con barolo d’annata”: mostrai il messaggio a Guareschi, che mi dettò la risposta con un amaro sorriso: “Caro Rendina, avverti il signor presidente che io ho molto da lavorare e non potrò accettare il gentile invito. Digli anche che io brindo solo con il lambrusco”. Ma l’episodio più curioso, e tipicamente guareschiano, in materia di vini, accadde a Parigi quando fu invitato a partecipare alla “Notte delle Stelle”, una manifestazione grandiosa (una specie di Oscar) riservata ai più famosi scrittori e attori di tutto il mondo. Per l’Italia come scrittore venne invitato Guareschi e come attrice la Lollobrigida. Era la consacrazione mondiale della celebrità. Effettivamente in quegli anni Guareschi godeva in Francia di una notorietà molto superiore a quella riservatagli dalla meschina Italia di allora. Basti pensare che il primo libro di Don Camillo e Peppone, nella traduzione francese, aveva superato il milione di copie. Malgrado ciò nello stesso periodo il più famoso settimanale letterario francese – Les Nouvelles litterarie – aveva pubblicato a puntate tutto il libro con i disegni di un famoso pittore. Il film era stato presentato in prima visione contemporaneamente nei cinque cinema più importanti della capitale, a cominciare dal “Gaumont”. Rimase in programma per sei settimane e subito dopo venne proiettato contemporaneamente in una ventina di cinema della periferia parigina. Lorenzo Bocchi, all’epoca corrispondente del Corriere della Sera da Parigi, può testimoniare tutto questo perché per vari giorni fu la guida instancabile, paziente e intelligente di Guareschi. L’episodio di cui volevo parlare e che riguarda il vino, anzi il lambrusco, accadde quando Guareschi venne invitato a cena dalla sua agente letteraria, Madame Arnaud, alla famosa “Tour d’Argent”, la mecca dei ristoranti. Pranzo per principi, il clou fu la famosa “canard à l’orange”. C’era da prevedere che Guareschi si sarebbe rifiutato di toccare quel piatto esotico e invece fece buon viso e riuscì a mandare giù qualche boccone. Ma quando arrivò lo champagne, ritrovò sé stesso. Disse: “Dovete scusarmi ma lo champagne non mi riesce di mandarlo giù. Sapete, io sono abituato ai miei vinelli semplici. Se bevessi questo champagne avrei una sgradevole impressione di questa serata, di cui voglio invece conservare un imperituro ricordo per tutto quanto di squisito mi avete offerto”. Pur di non “contaminarsi” con lo champagne, era riuscito a giustificarsi con un tatto davvero diplomatico. Ma la “Tour d’Argent” era quella che si sa e pochi minuti dopo arrivò un lambrusco di Sorbara veramente eccellente. Sotto l’etichetta c’era stampata una frase in italiano che diceva pressappoco così: “Questo vino è stato prodotto nella zona tipica del lambrusco di Sorbara e vinificato coi metodi tradizionali dei vignaioli emiliani”. Guareschi rimase di sasso. Assaggiò con soddisfazione il vino che giudicò come un “onesto italiano all’estero” e parlò ancora per dire che se alla “Tour d’Argent” si serviva quel lambrusco lui doveva scusarsi per quanto aveva detto dello champagne. Madame Arnaud, con grazia tutta parigina, concluse: “Così abbiamo celebrato il matrimonio fra champagne e lambrusco”. “Matrimonio senza amore”, mormorò Guareschi a fior di labbra in modo che solo io potessi sentirlo. Su questioni di principio era davvero indomabile. Per il vino c’è un altro episodio guareschiano, l’ultimo, che mi riguarda personalmente. Appena uscito dal carcere di Parma Giovannino mi disse che mi avrebbe regalato una biolca di terreno sulla quale avrei dovuto costruire la casa per quando sarei andato in pensione. “Sono quasi trent’anni che ci conosciamo e per almeno quindici abbiamo chiacchierato e lavorato insieme. Se tu sarai in pensione a Bergamo e io alle Roncole come faremo a parlarci? Tu invece dovresti venire qui, farai quel che vorrai, magari scriverai le tue memorie ma almeno potremo vederci e parlare quando vorremmo, come prima. E poi mi darai una mano a fare il Po o qualche numero unico come facevamo negli anni Trenta a Parma. Ma poi, e questa è la cosa più importante, avrai il tuo vino”. Il Po era il giornale che lui sognava di fare una volta andato in pensione. Un giornale di quattro paginette del piccolo formato della Gazzetta di Parma dei primi dell’Ottocento, tutte scritte e disegnate da lui, senza impegni editoriali o di diffusione. Doveva avere una tiratura di due o trecento copie. Si sarebbe finalmente sfogato. L’offerta non era una novità. Già dal carcere di S. Francesco, quando gli scrissi che il suo capomastro “Pirén” m’aveva offerto di acquistare un piccolo fondo proprio a Roncole, Giovannino mi aveva risposto: “Podere Pirén: ti consiglio di comprarlo. Si può trovare di meglio. Per quanto riguarda la terra della tua casa, ricordati che te l’ ho promessa in regalo io. Entro S. Martino dovrei concludere per l’appezzamento Dirimpetto. Inoltre se lo vuoi subito c’è sulla strada asfaltata di Soragna, vicino alla curva, il podere Morelli. Prova ad andare a vedere se ti piace e rispondimi subito”. Una seconda volta, lettera del 20 febbraio, insisteva. “Bene. Se la vuoi, c’è nel podere Morelli la biolca (misura agraria di superficie tipicamente emiliana, varia secondo le zone da 3000 a 6000 metri quadrati, ndr). Costa lire 18 (diciotto) più le spese di trapasso”. IL PEGNO DELL’AMICIZIA Quindi in data 1 marzo 1955 mi scriveva dal carcere: “La biolca: dipende da quando uscirò. Se la mia permanenza qui dovesse protrarsi, bisognerà riparlarne”. Non ero molto convinto della sua offerta peraltro generosa, ma non rifiutai la risposta. Dovevo pensarci su. Di fronte al mio scarso entusiasmo Giovannino tornò alla carica con un argomento che. A suo avviso, avrebbe dovuto convincermi. Altro messaggio: “Pensa che in una biolca oltre alla casa, che ti farai come la vuoi, ci starà anche un po’ di orto e un piccolo vigneto. Ti darò io i consigli adatti a farti produrre un vino come il mio, che ti piace tanto”. Mi ripeté l’offerta per l’ennesima volta anche durante una delle sue ultime visite in casa mia a Bergamo, dove mi ero nel frattempo trasferito come direttore del quotidiano locale. Parlandomi della sua solitudine di “semipensionato” (in realtà seguitava a lavorare moltissimo, collaborando a Oggi, La Notte e Il Borghese) ammise di avvertire la mancanza di un amico col quale confidarsi liberamente. Disse “Presto andrai in pensione, perché non accetti la biolca che ti ho offerto per costruirci sopra la tua bella casetta?”. Ma era un problema, per me, pensare al trasferimento di tutta la famiglia dalla città lombarda alla campagna emiliana. Inoltre le cose di questo mondo vanno come vogliono. Giovannino ci ha lasciato, d’improvviso, nel 1968; non ho nemmeno avuto il tempo di scambiare l’ultimo saluto. (13 – fine) Alessandro Minardi da “L’Uomo qualunque” 04/06/1998 Chi era Minardi Alessandro Minardi, nato a Parma il 24 luglio 1908, iniziò l’attività giornalistica all’età di 17 anni esordendo come cronista alla Gazzetta di Parma. Minardi e Guareschi si erano conosciuti casualmente una sera dell’ottobre 1929 di fronte alla libreria Battei di Parma intenti a commentare i titoli dei libri esposti. Quella sera nasceva una amicizia che durò mezzo secolo. Nel ’32 Guareschi emigrò a Milano approdando alla casa editrice Rizzoli, Minardi rimase a Parma. In quegli anni i due si divertirono a pubblicare numeri unici commissionati dai gruppi universitari fascisti come Bazar che usciva due volte all’anno, La Cometa e un annuario dal titolo Il portone del grano: erano pubblicazioni dove i personaggi politici, gerarchi e non, venivano messi alla berlina. Minardi al fronte e Guareschi in campo di concentramento a Czestochowa. Tornato dal fronte greco, distrutto nel fisico, Minardi venne chiamato come redattore politico all’Arena di Verona, in seguito divenne redattore capo del Corriere della Sera, dirigendo anche un bisettimanale voluto da Mezzasoma, ministro della Cultura, che si chiamava Sveglia, un giornale per i soldati italiani e i loro familiari. Nonostante l’epurazione del 1946, Minardi venne assunto da Giovannino per inventare quello che sarà il settimanale più moderno d’Italia: L’Europeo. Sempre per lo stesso editore Minardi inventò la grafica del Mondo diretto da Pannunzio e di Settimo Giorno. E ancora, una volta al mese impaginava l’Illustrazione Italiana dell’editore Garzanti. Inventò inoltre la grafica del Corriere di Milano e del Corriere Lombardo, quest’ultimo giornale del pomeriggio voluto dal P.o.w. (un organo di informazione dei militari americani). Nel 1951 Guareschi lo chiamò per andare a lavorare con lui al Candido; di quest’ultimo divenne direttore quando Guareschi fu incarcerato, e lo restò fino al settembre del 1961, data che segnò la chiusura della pubblicazione. Appendice alla tredicesima puntata SE GUARESCHI FOSSE VIVO FAREBBE L’OSTE Lettera aperta a un amico del Corriere. Michele Brambilla Caro Brambilla, ho letto il tuo articolo su Guareschi pubblicato dal Corriere il 21 maggio. Mi ha fatto piacere. Come forse non sai, ero con Giovannino in rapporti di filiale amicizia fin da quando, frequentando i miei parenti bussetani, gli facevo visita a Roncole. Del tuo scritto mi ha solo sorpreso, l’attacco, con la geremiade sul Candido che oggi non c’è, che fa rima con “la cultura di destra che non c’è” e via elencando, secondo la vulgata. Vedi, caro Brambilla, se Guareschi fosse ancora vivo farebbe l’oste. Per due ragioni. Primo: la “cultura” autolegittimante della sinistra continuerebbe a considerarlo uno scrittore da 200 parole e un umorista non degno di allacciare i calzari a Benigni. Le cose non sono cambiate da allora: guai a chi non è di sinistra e osa avere successo popolare. Vedi Susanna Tamaro. Secondo: Guareschi sarebbe oggi consapevole che per avere tanti amici uno come lui è meglio che non scriva. Sugli amici di Guareschi potrei comporre un’antologia. Ti farò solo un esempio. A un anno dalla morte dello scrittore scrissi, sul settimanale che dirigevo per Rizzoli, un ricordo dell’amico, parlando della sua intransigenza morale. La copia del giornale era ancora fresca di stampa quando Enzo Biagi, direttore editoriale della Casa, irruppe nel mio ufficio lamentandosi per “l’apologia di un reazionario” che avevo scritto. Oggi Biagi parla di Guareschi come di un fratello di latte. E veniamo al giornale anticonformista “che non c’è”. Se non hai ancora visto il mio non ti faccio colpa: più che un giornale è un samizdat, un foglio clandestino come quelli del dissenso russo. Ma perché? Perché la stampa di regime, a cominciare dal Corriere, ci tratta come ha trattato Guareschi. Tace e ci ghettizza. Quando siamo tornati nelle edicole il tuo giornale ha ignorato la notizia troppo preso com’era a pubblicare due articoli alla settimana per lanciare Liberal e altrettanti per salvare il Manifesto. A metà dicembre dello scorso anno, il Corriere pubblicò, a mo’ di articolo, una lettera del vicedirettore del Manifesto con la quale l’autore spiegava che il Corriere doveva aiutare il foglio comunista, in omaggio alla libertà di stampa. Io allora presi quella lettera e la copiai limitandomi a sostituire il termine Manifesto con quello di Uomo qualunque e ad aggiungere qualche frase ad hoc. Ne venne fuori una lettera esilarante che spedii a De Bortoli, il tuo direttore. Diceva così: “Caro direttore, forse ti sembrerà strano ricevere questo articolo: non usa, infatti, che un giornalista scriva su una testata diversa dalla sua, anche se questi due giornali, a ben guardare, non sono punto concorrenti. Ma la partita che stiamo giocando noi de l’Uomo qualunque va bene al di là delle regole normali. Si tratta di una partita decisiva e – scusa la retorica – di una partita che riguarda la libertà di opinione in questo Paese. La storia è nota: in un Paese dove il 95 per cento dei mezzi di informazione è omologato e dove, secondo un rapporto dell’Unesco, l’attendibilità dei media ci colloca al 41° posto nel mondo, prima del Gambia, ma dopo la Guinea e dove, secondo la Freedom House, si sta uscendo dal gruppo di Stati a piena libertà di stampa, a un giornale come il nostro dovrebbe essere consentita la sopravvivenza, se non altro per la salvaguardia della specie. Le ragioni delle nostre difficoltà sono diverse: non sono i gadget dei grandi quotidiani, non è la crisi specifica della stampa di sinistra, non è la nostra stanchezza, ma è, semmai, la mancanza di visibilità creata, a bella posta, da quei giornali che dedicano tre colonne a uno sciopero dell’Unità, e cinque alla crisi ideologica del Manifesto, e non dedicano una riga quando nasce un giornale nuovo che non è disponibile a entrare nel coro del regime e che, quando fa l’elenco degli intellettuali di sinistra ex laudatori del fascismo, non fa credere ai lettori che quegli intellettuali erano dei segretissimi boicottatori del duce, come sostiene il tuo giornale. Ecco allora la nostra ultima follia: un giornale speciale, abbastanza arrogante per non vendersi al regime. Ecco allora la nostra ultima follia: un giornale speciale, abbastanza arrogante per non vendersi al regime. Ed ecco la trovata: a Natale l’Uomo qualunque uscirà a 3.500 lire, esattamente come le altre settimane, e non a 50 mila come il Manifesto, con un grande punto interrogativo: esiste in questo Paese un sopravvissuto barlume di libertà perché la gente decida di non farsi ulteriormente rincoglionire dalla grande orchestra dei media omologati? È un referendum costoso perché la libertà costa. Eppure non vogliamo soldi, ci basta che, in ossequio al concetto elementare che le notizie non vanno nascoste, anche il tuo giornale avverta i lettori che siamo rinati. Caro direttore, non la faccio tanto lunga, ma dopo averti ringraziato, ho la faccia tosta di chiederti un’ultima cosa. I tuoi lettori sono inconsapevolmente anche i nostri, perché allora non fare uno strappo alle regole del mercato e consentire loro una boccata d’ossigeno? Sarebbe un bel gesto di libertà. Lucio Lami, Direttore de L’Uomo qualunque Ps: Non essendo noi ricchi come i giornali di sinistra non ho un vicedirettore al quale far firmare questa lettera. A questa lettera De Bortoli rispose con un cortese biglietto manoscritto: “Caro Lucio, nel tuo caso preferiremmo farti un’intervista”. Naturalmente l’intervista non c’è mai stata. Il silenzio è dilagato sulla Stampa, su Repubblica, sul Messaggero, su tutta l’orchestra in uniforme. Rimpiango i tempi onesti della contrapposizione quando, all’uscita del mio libro “La scuola del plagio” l’Unità iniziava il suo elzeviro con un tuono: “Leggendo il Lami si comprende da che parte verrà la reazione”. Oggi il regime ha fatto tesoro degli errori del suo predecessore (il fascismo) e non esilia il dissenso a Ventotene. Lo strangola, lo incrementa, lo mura vivo dentro il silenzio assordante dei media al suo servizio. E lo boicotta nelle edicole, lo censura alla Rai. No, caro Brambilla, non sono gli uomini che mancano, né le penne, né la carta. È la libertà che manca, uccisa dal servilismo, dall’omologazione, dal giornalismo addomesticato, dall’autocensura. Guareschi non è stato che il precursore di tante vittime, illustri e non illustri, come ha dimostrato Minardi sul mio giornale. Lucio Lami Bibliografia essenziale di Giovannino Guareschi Archivio Guareschi - «Club dei Ventitré» Via Processione, 160 - I - 43011 Roncole Verdi (PR) Tel. (39) 0524 92495 - fax (39) 0524 91642
Scaricare