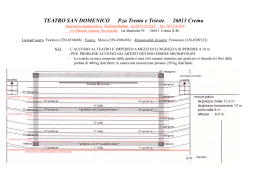Le Martyre de Saint Sébastien von D'Annunzio und Debussy Der unmögliche Mythos der Modernität im (Musik)Theater Vincenzo Borghetti »Jokanaan, deine Stimme ist wie Musik in meinen Ohren«; und weiter »Deine Stimme war ein Weihrauchgefäß, und wenn ich dich ansah, hörte ich geheimnisvolle Musik.« Soweit Salome im libretto der gleichnamigen Oper von Richard Strauss auf einem Text von Oscar Wilde. La voce umana è descritta come suono, come odore, ma non come logos. Le parole di Jokanaan sono affascinanti e incomprensibili come un profumo, sono un suono che genera associazioni ma che non “dice”, non rimanda a niente altro se non a se stesso: »Wir verstehen nie, was er sagt, Prinzessin« dice delle parole di Jokanaan il Zweiter Soldat. Sulla non referenzialità di queste parole c’è un generale accordo sulla terrazza del tetrarca di Palestina. L’episodio costituisce un’epitome delle esperienze del teatro fin de siècle: l’incontro di Salome con Jokanaan ha un forte valore metateatrale, poiché mette in scena il rapporto tra il pubblico e nuove forme teatrali post-, anzi, anti-naturalistiche der Jahrhundertwende, cui, ovviamente Salome stessa appartiene. Salome e Jokanaan non sono due veri interlocutori, essi non dialogano perché lei non lo comprende; Salome è l’ascoltatrice di un atto vocale non linguistico eppure agìto per mezzo del linguaggio. Sostanzialmente Salome è la spettatrice di una performance teatrale modernista in cui la parola non “dice”, eppure riempie la scena, non “dice” ma risuona. Questa scena molto conosciuta può funzionare come introduzione al mio Referat incentrato su un Werk di teatro musicale ai margini del repertorio, per il quale, come per tutto il teatro modernista tra fine XIX e inizio XX secolo il linguaggio nella sua accezione più ampia costituisce un aspetto centrale. Nelle prossime pagine mi occuperò del Martyre de Saint-Sébastien di D’Annunzio e Debussy, un Werk sperimentale, una forma di teatro mista di parola, musica, pittura, danza come se ne videro molte a partire dagli inizi del Novecento. La mia analisi si concentra pertanto su questo Werk nel contesto dell’estetica teatrale dannunziana e in relazione alle esperienze teatrali e musico-teatrali coeve. Inizierò con una sintesi sull’attività teatrale di Gabriele D’Annunzio, premessa fondamentale per comprendere le 1 sue opere più innovative, e mi soffermerò sul Martyre scritto con Claude Debussy come uno degli esiti finali delle sue sperimentazioni drammatiche. Uno dei motivi di maggior interesse musicologico per il teatro di D’Annunzio è la sua “musicalità”. “Musicale” è l’aggettivo di gran lunga più usato nelle recensioni ai suoi spettacoli così come negli studi sul suo teatro. Come agli inizi nel Novecento, non stupisce oggi che “musicale” si addica al teatro di un poeta raffinato e di un romanziere dallo stile “sinfonico”. Anzi, la pertinenza di tale etichetta sembra rafforzata proprio dal successo dei drammi dannunziani come libretti d’opera, alcuni messi in musica più di una volta (si veda sull’hand out l’elenco delle opere teatrali di D’Annunzio e dei libretti da esse ricavati). Tuttavia negli studi su D’Annunzio definire il suo teatro “musicale” è divenuto presto un luogo comune. Si è riconosciuto cioè nel teatro dannunziano un teatro “musicale”, senza sviluppare le premesse della definizione: la categoria “musicale” è rimasta una categoria descrittiva standard senza divenire una categoria analitica. Che cosa significa concretamente “musicale” in relazione al teatro di parola di D’Annunzio. Il suo teatro era musicale solo perché fece ricorso spesso alla Bühnemusik o ci sono altre ragioni più specifiche che giustificano questa deifinizione? Come molte esperienze contemporanee, il teatro di D’Annunzio mette in crisi le convenzioni del dramma borghese. Dopo aver coltivato il romanzo nelle sue forme moderne e introspettive, D’Annunzio approda alla metà degli anni ’90 ad una forma analoga di teatro moderno. Andrea Sperelli protagonista de Il Piacere (Lust) del 1889 è l’esteta che “vive” in una condizione di sensibilità esasperata. D’Annunzio non narra, perché Sperelli non vive, la vita del suo anti-eroe come una «catena di azioni», bensì come una «catena di situazioni», come una serie di metope giustapposte in un fregio di modernissima psicopatia (Hofmannsthal, 1893). Allo stesso modo della narrazione impossibile perché ogni azione è ormai impossibile nel mondo contemporaneo, il dramma dannunziano annulla lo sviluppo. Come Lust finisce esattamente dove comincia, così il suo teatro comunica un senso enorme di inanità, di assenza o di fortissima riduzione dell’azione. I personaggi alla fine sono come all’inizio perché di fatto non accade loro nulla. 2 Fin dall’esordio con la Città morta (1896) il suo teatro rifiuta in modo deciso e programmatico la tranche de vie, e riduce drasticamente la centralità del dialogo, il mezzo principe per costruire il dramma di forma «chiusa» come «vita in divenire». La mancanza di azione si manifesta quindi nell’assenza di un vero processo drammatico costruito mediante il Rededuell: si evita così il susseguirsi di accadimenti che in rapporto causa/effetto permettono di procedere verso una conclusione. L’azione narrabile è ridotta al minimo e non progredisce sulla scena: gli eventi decisivi sono già successi e la scena è occupata dagli affetti dei protagonisti, che verbalizzano le più impercettibili vibrazioni del loro animo. Nel teatro dannunziano il presente scenico non è più in funzione di uno svolgimento teleologicamente orientato che lo attraversa e lo distrugge (di un “prima” necessario presupposto per un “dopo”), bensì un presente scenico dilatato e stagnante. I personaggi non parlano pianificando il futuro o riferendo il passato, ma analizzano se stessi e parlano della situazione in cui si trovano, annullando in tal modo la percezione del dramma come processo. Nel teatro di D’Annunzio i personaggi sono raffigurati in una serie di stati, dove la fissità delle singole scene riflette la mancanza o anche l’inutilità della volontà nella vita moderna, una vita in cui le concatenazioni logiche non ci sono perché non più comprensibili, quindi narrabili e rappresentabili. Il tempo dilatato del teatro dannunziano è un tempo interiore, inerte rispetto alle leggi “esterne” del tempo reale. Visto dall’esterno nel teatro di D’Annunzio è quindi l’attimo che regna. Tale supremazia dell’attimo sul processo è ottenuta costruendo le scene su piccoli avvenimenti privi di rilevanza progettuale ai fini dell’“azione” ma utili solo ad innescare le reazioni emotive dei personaggi. In tal modo dettagli drammaticamente inani costituiscono l’elemento scatenante dello sfogo affettivo dei personaggi che, come un disco rotto, non riescono a staccarsi dalla sensazione di un attimo. Così D’Annunzio nel suo teatro riesce ad estendere l’efficacia di ciò che nel dramma di «forma chiusa» avrebbe avuto una durata trascurabile a svantaggio della vera azione, ridotta in genere ad un rango secondario. L’elemento caratteristico del teatro dannunziano è quindi la discontinuità delle strutture temporali, sbilanciate a vantaggio della contemplazione rispetto all’azione. Il tempo rappresentato (quello dentro la scena) procede a scatti; la sensazione di un decorso temporale lineare conosce lunghi tratti di sospensione. Nei momenti in cui l’attimo 3 domina, l’attimo stesso è bloccato, vissuto intensamente dai personaggi e così prolungato. Il tempo rappresentato perde la sua dimensione oggettiva, si rapprende in un tempo spazializzato, cristallizzato in una serie di quadri non evolutivi. Il risultato è che spessissimo nel teatro dannunziano tempo rappresentato e tempo della rappresentazione (quello della vita fuori dalla scena) non sono coincidenti. Lo sfasamento dei tempi drammatici fuori e dentro la scena conducono il teatro di D’Annunzio ad esiti molto vicini a quelli della drammaturgia operistica. L’opera è la forma di teatro in cui «die musikalisch-szenische Gegenwart ist nicht eine Funktion des dramatischen Verlaufs sondern umgekehrt der Verlauf eine Funktion der Gegenwart, die in sich selbst beruht und beharrt» (Dahlhaus). Come nell’opera, il teatro dannunziano indugia su un presente scenico-musicale drammaticamente inerte ma emotivamente denso. Nel suo teatro, al posto di un processo drammatico teleologicamente orientato sulla scena c’è la rappresentazione dell’interiorità sentimentale dei personaggi. Alla ricerca di un teatro rituale e non naturalista, D’Annunzio riassorbe nel teatro di parola le strutture temporali dell’opera. La possibilità di bloccare ciò che nel teatro di parola tradizionale sarebbe un attimo fuggente o di imporre un tempo rallentato all’azione scenica sono alcuni degli elementi sorprendentemente comuni tra il teatro di D’Annunzio e quello musicale. (si pensi ad un finale rossiniano o ad un’aria per un esempio di tempo bloccato o rallentato). Dico sorpendentemente perché questo tipo di strutture temporali “musicali”sono molto lontane dalle estetiche teatrali tradizionali del dramma classicistico, quel tipo di dramma fondato sull’azione, per il quale la stasi della scena, a differenza dell’opera è forse il pericolo maggiore. D’Annunzio però non è un compositore. Se nell’opera è la presenza della musica a permettere un uso “musicale” delle strutture temporali, D’Annunzio come autore teatrale non ha a disposizione questa risorsa. Come è possibile allora che la mancanza di azione e lo sfasamento dei tempi drammatici vengano ottenuti senza l’ausilio del suono? È possibile con l’unico strumento che il drammaturgo abbia a disposizione: le parole. Come alla nota cantata nell’opera, alla parola “musicale” nel teatro dannunziano è lasciato di riempire i vuoti dell’azione assente, creati dalla divaricazione tra tempo fuori e tempo dentro la scena. Le parole sono lo strumento che D’Annunzio usa per trattenere l’emozione dell’attimo oltre la sua durata reale. Ma si tratta di parole dal valore particolare: non essendo più funzionali a narrare di eventi decisivi per l’azione, le parole 4 “musicali” non producono nuovi contenuti, ma restano ferme su ciò che c’è in scena, espandendo immagini-chiave attraverso figure della variazione (similitudini, metafore). Come in un numero d’opera, pensiero e tempo restano impigliati in una sensazione che le parole “musicali” cercano di trattenere. Sono parole che rivelano nuovi fatti, pertanto sono parole “musicali”, perché la loro presenza è accessoria ad una situazione già evidente dal punto di vista scenico-pantomimico. Le parole del teatro di D’Annnunzio sono quindi una «geheimnisvolle Musik», sono parole che come quelle di Jokanaan ri-suonano riempiendo di sé come «Weihrauch» il quadro della scena. Questa è la caratteristica davvero musicale del suo teatro. L’osmosi tra opera e teatro dannunziano fu intuita già da alcuni critici d’inizio secolo: nel 1902 Hermann Bahr parlava delle sue tragedie come di melodrammi con arie nei punti culminanti. Nel 1899 Georges Hérelle diceva che tragedia di D’Annunzio sarebbe presto diventata un libretto, dove, cito, «le parole hanno un’importanza relativa e la musica stabilisce il contatto tra i personaggi l’uditorio. Ma non è il librettista a scrivere la musica!». Ma le tragedie di D’Annunzio non attendevano nessun completamento esterno; esse nascevano già con tutta la musica necessaria: la parole “musicali” che il poeta vi aveva profuso. Il testo di Hérelle prosegue con una annotazione molto interessante: «Limitandosi a comporre il libretto, Gabriele abbandona ad altri lo spirito stesso della sua arte. È una vera e propria abdicazione. Abdicherà ancora più completamente? I Romani hanno avuto i mimi, dove le parole non contavano più niente e dove il gioco degli attori era tutto. D’Annunzio comporrà dei mimi?». Secondo Hérelle nel ridurre la parola a musica di un presente scenico statico D’Annunzio avrebbe rinunciato alle prerogative stesse dell’autore teatrale. Per Hérelle, il teatro di D’Annunzio sarebbe giunto al mimo, un teatro pre-, anzi, post-verbale in cui l’autore drammatico schizza solo gli scenari di un’azione elementare. Il teatro “musicale” di D’Annunzio sarebbe schliesslich approdato alla disintegrazione del genere teatrale stesso e al consapevole (auto)ammutolimento del poeta drammatico. L’esito di tali premesse non si fecero attendere e D’Annunzio nel giro di pochi anni produsse Le Martyre de Saint-Sébastien (1911) e successivamente La Pisanelle (1913). Scritte su misura per Ida Runbinstein, in stretta collaborazione con musicisti (rispettivamente Claude Debussy e Ildebrando Pizzetti) scenografi e coreografi (le forze dei Ballets russes) il Martyre e La Pisanelle costituiscono il più compiuto progetto di fusione delle arti e di rinnovamento del teatro che D’Annunzio abbia mai realizzato. 5 Significativa per il suo esperimento è già la scelta del soggetto, che condiziona anche quella della forma drammatica. Per il Martyre D’Annunzio si rivolge alla leggenda dei santi e con essa recupera la forma del mistero medievale, quella che sia storicamente sia strutturalmente è ritenuta pertinente alla resa scenica del materiale prescelto. Il ritorno al mito e alle forme primitive della sua drammatizzazione ha in sé poco di archeologico ma è piuttosto l’esito finale della ricerca di quel teatro moderno, paventato da Hérelle come esempio di arte anti-teatrale. La fonte di D’Annunzio per il Martyre è la vita di san Sebastiano della Goldene Legende di Jacopo da Varagine. Come mostrato da Annamaria Andreoli, la Legende non è solo una fonte letteraria, bensì costituisce lo scheletro stesso della seneggiatura del Martyre. D’Annunzio abbozzò direttamente la nuova opera sulla sua copia della traduzione francese della Legende di Teodor de Wyzewa. Secondo i canoni agiografici, le vite dei santi della Legenda, costituiscono un paradigma di narrazione a pannelli: una serie di episodi chiusi, affiancati per accumulazione. D’Annunzio nel Martyre, infatti, non ripropone o ricrea un mito letterariamente intatto, come nel caso della leggenda pseudo-popolare della Figlia di Iorio, la sua tragedia abruzzese del 1904, ma recupera il mito insieme alle forme primitive della sua narrazione. La forma del mistero medievale costituisce la minima mediazione teatrale rispetto a questo tipo di narrazione, forma che permette di conservare nella trasposizione scenica modelli di racconto pre-moderni (quindi innovativi), caratteristici della letteratura delle origini. Come nel teatro medievale preso a modello la musica avrebbe avuto un ruolo essenziale, non solo di accompagnamento accessorio. Materia e forma insieme costituisono il punto di partenza per un allontanamento radicale dalle forme di teatro consuete. Nel caso del Martyre, D’Annunzio è molto esplicito sul suo progetto teatrale. Nell’introduzione del messaggero che apre l’opera l’autore dichiara al pubblico di essere non un poeta teatrale, bensì un artigiano che ha realizzato cinque vetrate consacrate a san Sebastiano sull’esempio dei maestri vetrai delle cattedrali francesi. Gli episodi della vita del santo sono rappresentati in cinque atti (mansions) «par signe et sans paroles», come nelle vetrate gotiche. Significativamente i modelli per quest’opera non sono narrativi, ma sono raffigurazioni pittoriche di una storia. E si tratta di una forma precisa di arte visiva la cui natura non mimetica è esplicita. Nella vetrata l’opera dell’artefice, la saldatura tra scena e scena, è ben visibile e fino ricercata: basandosi 6 su modelli figurativi fondati sul palesamento dell’artificio (le vetrate) D’Annunzio col Martyre concepisce un teatro che rivela la propria natura anti-mimetica e metateatrale. Inoltre come nelle vetrate i punti di fuga sono moltiplicati per il numero delle scene, (ognuna è il centro di se stessa), così anche nel Martyre gli atti e le scene del mistero si affiancano senza direzionalità e senza alcun tentativo di sintesi da parte dell’autore. Il Martyre infatti non è un dramma che si discopre mediante un’azione dialogata, ma è un dramma che presenta una serie di quadri scenici fissi, evidenti nel loro contenuto narrativo già dal punto di vista scenico-pittorico-pantomimico. Con il Martyre D’Annunzio rinuncia in modo radicale alla rappresentazione di un dramma come processo. Nel testo infatti, come nel teatro cristiano medievale, ci sono ripetute esortazioni a vedere l’immagine e ad ascoltare il suono e i canti, non a seguire l’intreccio. Eppure è un testo lunghissimo. Ma nel Martyre le parole sono solo uno degli elementi decorativi che animano i quadri statici: sono parole “nuove” che risuonano, sono parole preziose che si contemplano, parole non necessariamente da “comprendere”. La parola nuova che non dice ma risuona e che con la con la danza si fa visibile costituisce uno dei temi centrali della riflessione teatrale tra Otto e Novecento. O potremmo definirla anche un’ossessione. Salome che perepisce la parola di Jokanaan come una «geheimnisvolle Musik» o un «Weihrauchgefäß» è una delle concretizzazioni di questa nuova parola scenica: la parola autoreferenziale del teatro medernista cui si riconoscono valori comunicativi diversi da quelli usurati dal senso comune. Die Jahrhundertwende propone diverse realizazzione spettacolari di questa crisi del linguaggio tradizionale. Nella Salomè (1893) il dramma giunge al suo culmine e lo celebra senza l’ausilio del testo: uno dei nodi della tragedia è affidato alla danza e alla musica, non è mediato attraverso la parola. Con la sua trasformazione a libretto anche l’opera in questo punto rinuncia al suo linguaggio convenzionale e la seduzione estrema e fatale di Salome è affidata alla danza invece che ad un grande numero cantato come in Aida o in Samson et Dalilah. La ballerina in Salome prende il posto della cantante e la cantante ammutolisce, il linguaggio del corpo prende il sopravvento quando la lingua convenzionale non basta più. «Tanz und schweige!» ordina Elektra a Chrisotemis nell’apice affettivo della tragedia. La presenza strutturale della danza nel Martyre è figlia del Verstummen della parola nel teatro del primo Novecento e della crisi delle forme d’arte narrative e mimetiche dello stesso periodo. Significativamente il Martyre è un’opera intesa per una ballerina: sono il 7 gesto e la musica a rendere visibile quanto nel teatro convenzionale dovrebbe essere mediato dal testo verbale. Nel Martyre D’Annunzio fa un passo avanti rispetto al suo teatro in Italiano, lasciando che la ballerina agisca direttamente sulla musica: i due grandi numeri danzati della partitura, la danza estatica di Sebastiano sui carboni ardenti (I mansion) e la danza della Passione (III mansion) prevedono poche battute di melologo. È questo il «mimo» preconizzato da Hérelle. Ma la sua profezia fu troppo pessimista. Il mimo di D’Annunzio non sarebbe stato un teatro della performance libera. Di “libero”, di “vivo”, di “non codificato” nel Martyre c’è ben poco. La presenza della ballerina e il ricorso all’arte coreutica non traggano in inganno: il dinamismo del movimento è solo un’illusione di azione. Il modernismo europeo fin de sièclevedeva nella danza un’arte statica. Mallarmé scriveva «La donna che danza non è una donna e non danza, la sua arte è una scrittura corporale fatta di segni». Il corpo della ballerina evoca per Mallarmé il geroglifico, un segno “parlante” ma incomprensibile, prezioso ma non discorsivo. La danza per lui è un’arte statica e la ballerina è sostanzialmente un essere non umano, un’apparizione, «morta eppure di carne ed ossa». Con il balletto de-umanizzato i simbolisti pervengono alla trasformazione di un forma-nel-tempo in una forme nello spazio. Così come poesia, dramma e musica divengono sempre più arti figurative il poeta e il compositore teatrali vengono sempre più assimilati a degli artisti “figurativi”. Ida Rubinstein, per cui fu scritto il Martyre, incarnava perfettamente la nuova performer del teatro modernista. Sebbene conosciuta come ballerina, le sue capacità migliori non erano i movimenti, ma pose plastiche e statuarie. Le coreografie fatte di pose stilizzate e formalizzate in cui lei eccelleva e che per lei furono create erano l’esatto opposto dell’arte libera e informale prevista da Hérelle. Al contrario, la sua danza era la quintessenza del modernismo perché disciplinava il corpo, trasformando il movimento in una serie di stati, impedendo così che la danza si traducesse in una rappresentazione mimetica della vita (nel quarto atto del Martyre ella è legata all’albero del martirio dall’inizio alla fine). Ida Rubinstein era l’attrice-attrezzo, l’interprete che trasformava la ballerina in carne ed ossa in una marionetta, completamente controllata dall’autore Il balletto modernista deumanizzando l’uomo conduceva all’assenza della vita dal teatro facendo del gesto-neltempo un segno visivo. Non a caso Adorno criticherà Stravinsky e la sua predilezione per il balletto, dicendo che «Wirklicher Tanz ist, im Gegensatz zur reifer Musik, statische Zeitkunst, ein sich im reise Drehen, Bewegung ohne Fortgang». 8 Per D’Annunzio nel Martyre la musica (verbale o effettiva) e la danza sono i mezzi per la decisiva spazializzazione del dramma, del suo rinunciare al movimento attivo, e quindi alla vita di cui il teatro dovrebbe essere, secondo l’estetica classicistica, una riproduzione. Il nach und nach di una sintassi orientata sulla parola che disvela contenuti, nel Martyre diviene il neben einander di atti verbali o mimici che riempiono uno spazio rinviando soprattutto a se stessi. Il teatro di D’Annunzio produce con il Martyre la sua punta più estrema di modernismo. Ma la sua collaborazione con Debussy non è stata considerata in modo favorevole dalla storiografia. Secondo Boulez il Martyre fu per Debussy «un progetto estetico non coscientemente e pienamente assunto». E il suo giudizio ha a lungo condizionato la ricezione dell’opera. In effetti Debussy lavorò con una fretta a lui sconosciuta, ciononostante non mancò di esprimere il suo apprezzamento per la concezione del Martyre come spettacolo teatrale e cosa più importante portò a termine la partitura, cosa che non si verificò per nessuno degli altri progetti intrapresi. Ma il Martyre fu considerato principalmente un minestrone decadente di cui non valeva la pena di occuparsi se non per salvare la musica di Debussy, per accidente legata ad un testo così lontano dalla sua poetica. Eppure, date le premesse, solo con fatica si può accettare che il Martyre come dramma per immagini in cui le arti-nel-tempo venivano piegate a farsi arti-nello-spazio possa essere un dramma totalmente estraneo alla poetica di Debussy. Analizziamo perché. (Sull’hand out n. ? c’è l’elenco della musica scritta da Debussy e la sua posizione nel mystère di D’Annunzio, sul n. ? tutta la musica originariamente prevista da D’Annunzio). Per le sue caratteristiche il Martyre offriva a Debussy una via d’uscita dall’impasse creativa che gli aveva impedito di trovare una forma teatrale soddisfacente dopo il Pelléas. Nonostante la sua lunghezza, nel Martyre D’Annunzio rinunciava a lunghi processi narrativi: la struttura centrifuga e accumulativa del mito agiografico riproposto attraverso una serie scene anch’essa centrifughe aveva come risultato un dramma in cui la musica avrebbe trovato spazio in forme brevi e ben delimitate. Le forme piccole erano quelle su cui Debussy era concentrato nell’ultimo periodo creativo e ciò era uno dei principali ostacoli alla realizzazione di un dramma musicale dall’arco narrativo lungo, come per la non a caso incompleta Chute de la maison Usher. 9 Il teatro visivo e sonoro di D’Annunzio con la presenza strutturale della danza e di una danzatrice “geroglifica” come Ida Rubinstein permettevano quindi un rapporto tra musica e scena che alla musica di Debussy dovevano essere congeniali. Significativamente da Adorno, fino a Boulez e oltre tutti hanno sottolineato la non-direzionalità e la staticità della musica di Debussy. Secondo Ivanca Stoianova, per esempio, col Martyre Debussy realizza in modo compiuto l’annullamento della «direzionalità dell’esposizione, della teleologia dello sviluppo» pervenendo alla sostituzione del tempo direzionale della musica narrativa con il tempo bloccato. In tal modo, prosegue, Debussy annuncia col Martuyre alcuni esiti compositivi del secondo dopoguerra. Tutte le analisi,però, rinunciando a prendere sul serio il testo dannunziano, hanno mancato di cogliere il perché questa musica sospesa e non teleologica (nicht geziehlt), descritta addirittura come homöostatisch sia stata raggiunta in modo esemplare proprio col Martyre. La risposta è nel testo di D’Annunzio. La non discorsività della parola e della scena dannunziane richiedevano a Debussy una musica anch’essa non discorsiva e non direzionale che sapesse riempire di colore musicale gli spazi bianchi di alcune vetrate predisposte dal poeta. Tanti sono gli esempi per illustrare questa spazializzazione decorativa della musica nel Martyre, ne scelgo uno: il canto della Vièrge Erigone nella seconda mansion. Il canto proviene da una stanza magica chiusa ed è esso stesso musicalmente chiuso nella sua impostazione pentatonica. La voce e l’accompagnamento orchestrale percorrono una serie di cinque suoni Fis E Cis H Gis. Un ostinato pentatonico che sostiene tutto il brano, ipnoticamente ripetuto sempre uguale a se stesso. In tal modo questo il motivo costituisce uno dei diversi “geroglifici musicali” con cui Debussy sonorizza i geroglifici drammatici del poeta e i geroglifici visivi della protagonista. La fissità dell’intonazione è in funzione dell’assenza di azione nel dramma: ma la musica con la sua a-direzionalità riesce a concretizzare d enfatizzare la fissità temporale in modi che il solo testo poetico non realizzerebbe con la stessa efficacia. Non è un caso che la presenza di un musicista non fosse solo accessoria per la realizzazione del Martyre. Col Martyre D’Annunzio e Debussy rispondono alla crisi del linguaggio e all’impossibilità della rappresentazione della vita in movimento del modernismo europeo. «Tanz und schweige!» potrebbe essere il motto di questo progetto, in cui la musica riempie 10 ma non si muove, in cui la danza disegna forme, il gesto sostituisce la scrittura e la parola si cristallizza in suono e gesto. Nel titolo ho parlato di un mito impossibile, quello della modernità nel teatro di inizio secolo. Il Martyre è stato punto di massima tensione di D’Annunzio verso nuove forme di teatro, quelle a cui poteva pervenire un figlio del XIX secolo, troppo attaccato alla parola per sfruttare la crisi del linguaggio come avrebbero fatto le avanguardie degli anni 19201930. Si tratta di un progetto modernista ancora legato alle dimensioni ottocentesche del dramma wagneriano: il Martyre celebra l’inanità dell’azione con l’accumulo, non con la scarnificazione. La tendenza alla frammentazione vi assume proporzioni monumentali, vuole essa stessa essere magniloquente per il trauma dell’ammutolimento ormai irreversibile. Dopo il Martyre e La Pisanelle D’Annunzio poté solo tornare indietro, le due opere erano il non plus ultra nella ricerca di un nuovo tipo di teatro. Significativamente nel 1914 la sua ultima tragedia ritorna da dove era partito: La chèvrefeuille ritorna senza musica e senza danza al mito greco attualizzato della sua prima tragedia Città morta (1896). La sua esperienza teatrale a quel punto si era davvero conclusa. 11
Scarica