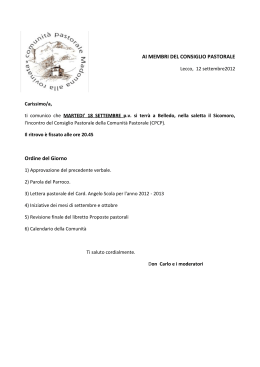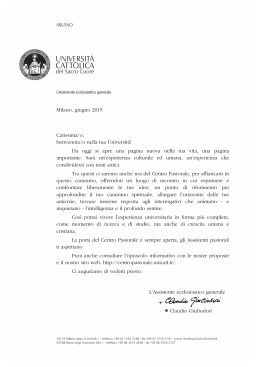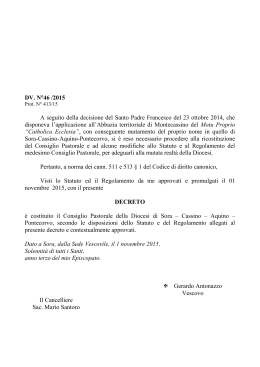1 Cavallino (VE) INCONTRO VESCOVI ED ESPERTI TRIVENETO giovedì 7 gennaio 2010 “Il ministero presbiterale da Presbyterorum ordinis a oggi” 1. Pochi aspetti della teologia e della pastorale sono stati così sollecitati e rivisitati dopo il Vaticano II, come il ministero ordinato e in special modo il presbiterato. Leggere la vicenda recente del presbiterato comporta l’inevitabile incrocio con tutti i nodi teorico-pratici che hanno visto impegnata l’ecclesiologia negli ultimi decenni: dalle relazioni tra pastori e laici al rapporto tra Chiesa e mondo, dal ruolo dei sacramenti alla rilevanza della parola di Dio, dalla dimensione istituzionale a quella carismatica della Chiesa, dalla nozione di spiritualità a quelle di comunione e missione, e così via. Il fatto è che il ministero ordinato, e in particolare il presbiterato, è talmente intrecciato alle pratiche ecclesiali da non potervi essere facilmente isolato. Certo, ogni buona teologia cerca la migliore armonia possibile tra il dato rivelato e l’esperienza vissuta: la fatica e la bellezza della teologia consistono nel percorrere questa tensione feconda tra i dati rivelati e le prassi vissute, nella convinzione che entrambi – sebbene in misura diversa – siano “luoghi teologici”. Interrogando il Vangelo a partire dall’esperienza e l’esperienza a partire dal Vangelo, in una sorta di “circolo virtuoso”, la teologia si mostra davvero un servizio ecclesiale. Se questo intreccio è vero per ogni discorso teologico, lo è ancora di più per un discorso sul presbitero, la cui figura concreta non si costruisce in astratto, ma sempre dentro ad una comunità ecclesiale, dalla quale prende forma e per la quale si pone al servizio. Di fatto, tutte le problematiche, le tensioni, le risorse e le opportunità vissute nella Chiesa postconciliare hanno avuto un contraccolpo sui presbiteri e talvolta li hanno visti protagonisti e iniziatori. Per non perdere e far perdere il filo del discorso, pur correndo il rischio di semplificare troppo la realtà, ho scelto un taglio narrativo: proverò a raccontare, come riesco e come posso, gli snodi principali della vicenda del presbiterato negli ultimi decenni. È evidente che dovrò sacrificare molte questioni anche rilevanti – come il celibato, il sacerdozio alle donne, i tre gradi e i loro rapporti, il sacerdozio dei religiosi, e simili – ma cercherò comunque di segnalare i principali problemi aperti ed alcune opportunità, accompagnando la narrazione con qualche riflessione critica. 2. Prendiamo avvio dal vissuto del presbitero. Non sono in grado di offrire analisi sociologiche, psicologiche o pastorali; propongo piuttosto una lettura della situazione ricavata dall’esperienza diretta, dai documenti del Magistero e da studi di specialisti. Il vissuto, come generalmente accade, è attraversato da luci e ombre, opportunità e fatiche. Lo si potrebbe esprimere con una sola parola? Oggi forse no, ma quarant’anni fa sì: era d’obbligo usare la parola “crisi” e parlare di “crisi di identità del prete”. L’espressione, assente nei testi del Vaticano II e nei primi anni immediatamente postconciliari, venne coniata alla fine degli anni Sessanta e caratterizzò il Sinodo dei vescovi del 1971. Per un ventennio si discusse a fondo su questa “crisi”, cercando di capirne i motivi e di uscirne. Se gli aspetti che colpivano di più l’opinione pubblica erano quelli scandalistici – non pochi preti contestavano e lasciavano rumorosamente il ministero, alcune comunità si opponevano ai loro vescovi, era estesa la richiesta di abolizione del celibato e di estensione 2 del sacerdozio alle donne – i motivi reali e più profondi erano di natura propriamente teologica e riguardavano una domanda radicale: qual è la ragion d’essere del ministero ordinato nella Chiesa? È proprio necessario un sacramento dell’Ordine che dà il carattere o è ipotizzabile che ogni comunità elegga un suo presidente per un certo tempo? Al di sotto quindi delle rivendicazioni ecclesiali, delle crisi psico-affettive, degli atteggiamenti pastorali di dissenso e contestazione, vi erano domande teologiche di tutto rispetto, riguardanti niente meno che la legittimità e la natura stessa del ministero ordinato. 3. Era dunque una “crisi” del sacerdozio paragonabile solo a quella che quattro secoli prima aveva contrapposto Lutero e il Concilio di Trento; in fondo, pur in un contesto diversissimo, si trattava del medesimo problema: Lutero, rifacendosi alla sola Scrittura, aveva negato la legittimità del sacramento dell’Ordine, sostituendo i sacerdoti con dei ministri eletti dalle comunità per la predicazione della parola; e Trento, leggendo la Scrittura attraverso la Tradizione, aveva reagito riaffermando l’esistenza di un sacerdozio ministeriale fondato sull’Ordine e abilitato all’offerta del sacrificio eucaristico e all’assoluzione sacramentale. Se Lutero aveva interpretato teologicamente il ministero in chiave profetica e funzionale, Trento lo imposta in chiave decisamente cultuale e ontologica. Per la verità Trento presenta anche un’altra chiave, quella pastorale: i vescovi e i presbiteri devono plasmarsi sull’immagine del Buon Pastore che offre la vita per il gregge, e su questa base stabilisce l’obbligo di residenza per i vescovi e i parroci; purtroppo però questa visione non compare nei decreti dogmatici, dominati da quella cultuale, ma solo nei decreti giuridici. Nei quattro secoli successivi procedono parallelamente le tre principali concezioni del ministero ordinato: profetica, sacerdotale e pastorale. Il mondo protestante è caratterizzato, con molte sfumature tra le varie confessioni, dal ministero inteso come predicazione della Scrittura; il mondo cattolico è invece connotato da due modelli che convivono nella stessa figura presbiterale: da una parte il sacerdote è configurato ontologicamente a Cristo Sacerdote ed esprime questo suo essere nella celebrazione del sacrificio eucaristico e dei sacramenti; dall’altra egli deve assumere lo stile di Cristo Pastore verso il gregge, spendendo la vita per la Chiesa. Avendo però solo il primo dei due modelli vera e propria dignità dogmatica, il secondo rimaneva affidato alla dedizione generosa del presbitero ma non ne caratterizzava l’essere. 4. Se ora torniamo alla “crisi di identità” del ventennio Settanta-Ottanta, riscontriamo lo stesso aspro confronto tra una visione funzionale e profetica da una parte ed una ontologica e cultuale dall’altra, con la concezione pastorale in sordina. C’era stato però il Vaticano II, che aveva tracciato una dottrina equilibrata del ministero ordinato, coniugando le tre concezioni attraverso lo schema dei tria munera: il ministero ordinato dei vescovi (cf. LG 25-27) e dei presbiteri (cf. LG 28 e PO 4-6) comporta l’annuncio, la celebrazione e la guida pastorale e tutti e tre questi compiti – non solo quello cultuale come per Trento – derivano dal sacramento dell’Ordine. Questo risultato era stato raggiunto dall’ultimo Concilio non come soluzione salomonica per accontentare tutti, ma come esito di una rilettura ampia della Scrittura e della Tradizione a partire dalle istanze poste dalle prassi. Furono soprattutto vescovi africani e asiatici a chiedere insistentemente di allargare la visione cultuale tridentina tenendo conto dell’importanza che ha il ministero dell’annuncio, come primo passo per la diffusione del Vangelo; ad essi si unirono presto alcuni vescovi della Francia, che già da un ventennio era cosciente di essere un “paese di missione”; altri vescovi, specie del Sud Europa, rammentavano però che la dottrina di Trento non si deve contraddire o superare, ma al massimo integrare, e chiedevano che per 3 nessun motivo si mettesse in disparte la visione cultuale ma anzi se ne riaffermasse il primato; altri in varie parti del mondo, nel Nord Europa e specialmente in Germania, chiedevano che anche il modello finora trattato come una cenerentola, quello pastorale, venisse integrato negli elementi essenziali del ministero ordinato. Nessuna delle tre concezioni appariva del resto infondata o arbitraria. Fu facile ad alcuni padri conciliari mostrare che nel Nuovo Testamento il compito fondamentale dei ministri cristiani – dagli apostoli ai loro collaboratori e successori, fino agli altri ministri variamente denominati – è proprio quello di evangelizzare: del resto come avrebbe potuto essere diversamente, nella fase propulsiva della diffusione del cristianesimo? Paolo, che ben presto diventa modello del ministero, si dedica essenzialmente a predicare il Vangelo e solo secondariamente a celebrare i sacramenti e guidare le comunità. Ma anche la concezione cultuale trovava punti di aggancio nel Nuovo Testamento: non tanto in Ebr – testo spesso richiamato nei lavori conciliari, ma di per sé riguardante solo il sacerdozio di Cristo e non quello dei ministri – quanto nella menzione di compiti “sacerdotali” tra i servizi indicati da Gesù ai Dodici e partecipati da questi ad altri soggetti: battezzare, ripetere il rito eucaristico, perdonare i peccati; nelle lettere Pastorali, inoltre, si incontra il gesto di imporre le mani per trasmettere un ministero. La concezione cultuale aveva poi dalla sua quasi diciassette secoli di storia: la sacerdotalizzazione dei ministeri data infatti a partire dal III secolo, con Tertulliano e Cipriano, e si intensifica fino a ricevere il suo sigillo con Tommaso e Trento. Ma anche la sfumatura “sacrale” godeva di una buona tradizione, a partire dal Dialogo sul sacerdozio di Crisostomo, con l’esaltazione dei “tremendi” poteri sacerdotali che Dio non ha dato neppure agli angeli, e dalle opere di Pseudodionigi, con la trasposizione sui ministeri cristiani del modello veterotestamentario della “mediazione sacerdotale”. Infine la concezione pastorale poteva a sua volta rifarsi al Nuovo Testamento, specialmente al testo paradigmatico di Gv 21 nel quale Gesù affida a Pietro il compito di pascere il suo gregge e ai passi nei quali i ministri cristiani sono chiamati “pastori”; e poteva inoltre vantare testi di Agostino e Gregorio Magno. Tutte e tre le concezioni, dunque, appaiono radicate nella Rivelazione: la grande opera del Vaticano II fu quella di mostrare che non si tratta di tre concezioni o tre modelli, ma di tre dimensioni dell’unico ministero ordinato. Le riflessioni dei padri conciliari aiutarono infatti i redattori di LG e PO a leggere con maggiore ampiezza i dati rivelati: anziché collocare, come per lo più si faceva prima, l’origine del sacerdozio ministeriale nel solo evento dell’Ultima Cena, l’hanno ricondotta all’intera missione affidata da Cristo agli apostoli: istruire, annunciare, battezzare, perdonare i peccati, spezzare il pane; anziché fermarsi alla sola visione “sacerdotale” del ministero, rispondente ad un linguaggio praticamente assente nel Nuovo Testamento, hanno adottato la varietà linguistica ad esso più conforme, parlando più di “ministri” che di “sacerdoti” e distinguendo, all’interno dell’Ordine, i vescovi, i presbiteri e i diaconi. 5. Sembrava che il Vaticano II avesse finalmente integrato in maniera ottimale i diversi dati rivelati sul ministero presbiterale, avendone offerto una presentazione missionaria e non più solo cultuale e avendo inserito i riferimenti cristologici (l’azione “in persona Christi Capitis”) in un’ecclesiologia che faceva spazio al sacerdozio battesimale e alla comune missione di tutto il popolo di Dio. Il Concilio aveva potuto in effetti tratteggiare una figura “completa” del ministero presbiterale, perché non era partito da intenti polemici: non dovendo, come Trento, reagire ad una concezione ritenuta opposta a quella cattolica, potè formulare una dottrina piana e serena. Solo che, pochi anni dopo, quella dottrina sembrò insufficiente a fronteggiare la nuova situazione di “crisi”. 4 Il vento di democratizzazione, che percorse il fenomeno del dissenso, per molti fu infatti l’occasione per dichiarare sorpassata la stessa ecclesiologia conciliare. Il Vaticano II aveva raggiunto una felice sintesi fra i tre modelli che per secoli erano stati contrapposti o giustapposti, aveva articolato in maniera soddisfacente i riferimenti cristologici ed ecclesiologici del presbiterato; eppure sei anni dopo la chiusura del Concilio, Paolo VI sentì il bisogno di aggiungere al tema previsto per il Sinodo dei vescovi, “la giustizia nel mondo”, anche un secondo tema, il “sacerdozio ministeriale” appunto. Il clima di contestazione costituì un nuovo scenario nel quale ancora una volta veniva interrogata la Rivelazione, e in maniera – come abbiamo visto – molto radicale. Al Sinodo del 1971 più che le teologie del ministero si confrontarono le ecclesiologie. Da una parte vi era chi domandava di portare a compimento la riforma iniziata dal Vaticano II, prospettando un’interpretazione democratica della Chiesa: H. Küng ad esempio, in un libretto del 1971 dal tiolo Preti: perché?, la definiva comunità di uguaglianza, libertà e fraternità e vi prospettava un ministero puramente funzionale e desacralizzato; sul versante opposto, chi aveva mal digerito l’ecclesiologia conciliare del “popolo di Dio”, reagiva riaffermando quella visione di Chiesa come “corpo di Cristo” che il Concilio aveva accolto ma relativizzato, o addirittura quella post-tridentina di Chiesa come “società perfetta”, che il Vaticano II non aveva di fatto accolto, e vi collocava un sacerdozio inteso come mediazione tra il cielo e la terra (così ad es. Pons, Parente, per certi aspetti Galot, ecc.). Nella prima concezione ecclesiologica, il ministero non è altro che espressione della comunità ed ha la funzione di leadership, coordinando i carismi e presiedendone l’annuncio e le celebrazioni su delega dal basso; nella seconda concezione, al contrario, il ministero nasce dall’alto ed ha la funzione di trasmettere la grazia che da Cristo scende verso la Chiesa; volentieri il sacerdote è qui definito, secondo l’uso preconciliare, “mediatore” e “alter Christus”: due espressioni che il Vaticano II aveva deliberatamente evitato. Il Sinodo del 1971 cerca una via media tra questi due estremi, e – sulle piste del Concilio – evita di cadere in una visione di Chiesa come democrazia o al contrario come monarchia assoluta, proponendo invece una concezione ecclesiologica che, pur tenendo conto delle istanze “dal basso”, riaffermasse la natura teandrica della Chiesa. La Chiesa dipende essenzialmente da Cristo, suo Capo – nel testo sinodale l’idea della Chiesa come corpo di Cristo ha maggiore spazio che in LG – e la coscienza di questa radicale dipendenza è condizione essenziale per la sua vita: se la Chiesa perdesse la consapevolezza di ricevere da Cristo tutto quanto le è necessario per vivere e operare – la parola, i sacramenti, i doni dello Spirito – perderebbe la sua stessa natura di “Chiesa”, cioè comunità radunata dall’alto, corpo di Cristo Capo. Il Sinodo, adottando questa visione ecclesiologica, colloca il sacerdozio ministeriale nel punto d’unione tra la Chiesa e Cristo: come ministero di Cristo Capo della Chiesa, è a servizio della sua edificazione, è uno degli strumenti che la mantiene nella consapevolezza di dipendere dal suo Signore. Ecco dunque, per il Sinodo, la risposta alla crisi d’identità teologica: il ministero ordinato ha come ragion d’essere la testimonianza efficace della priorità della grazia di Cristo, che continua ad edificare il suo corpo che è la Chiesa. Questa sottolineatura cristologica sarà la risposta costante del Magistero postconciliare alla domanda sulla natura teologica del ministero sacerdotale, come dimostra soprattutto Pastores dabo vobis ai nn. 15 e 16. Non possiamo seguire qui lo sviluppo del tema in campo ecumenico, che in quei decenni ha certamente influito anche sul contemporaneo dibattito in casa cattolica. Basterà ricordare il documento BEM (“Battesimo, Eucaristia, Ministero”) approvato a Lima nel 1982, con il lungo lavoro di preparazione e il periodo di recezione. Esso rappresenta un significativo sforzo di far convergere le due diverse linee di cui ho fatto cenno. Né possiamo entrare nella 5 complessa vicenda dei ministeri laicali, che esplodevano proprio nel corso degli anni Settanta, con alcuni contraccolpi sul presbiterato oltre che sul laicato. La discussa espressione “una Chiesa tutta ministeriale” infatti, che dal 1973 in avanti divenne una sorta di slogan, sembrava rendere più ardua la collocazione specifica del presbiterato, indicato dal Vaticano II proprio come “ministero”: se tutto è ministero, qual è l’originalità del “ministero” presbiterale? Ma da un altro punto di vista lo slogan rese un buon servizio ai tre gradi dell’Ordine, favorendo il passaggio dall’espressione “sacerdozio ministeriale” all’espressione “ministero sacerdotale”, recuperando così il sostantivo più aderente alla terminologia neotestamentaria. Non sembra invece che la “Chiesa tutta ministeriale” abbia giovato al laicato, poiché favorì l’impressione che non sia il battesimo a fondare la dignità e la missione del laico, bensì un “ministero” che dovrebbe aggiungersi al battesimo. Negli anni Ottanta il dibattito sulla “crisi di identità” teologica del presbitero fu comunque segnato più che altro dalle tesi di E. Schillebeeckx e dal dibattito attorno al suo volume Per una Chiesa dal volto umano, pubblicato in prima edizione olandese nel 1985 e tradotto l’anno dopo in italiano dalla Queriniana. In maniera ben documentata, il teologo domenicano prese posizione in favore di una concezione meno verticale-cristologica e più ecclesiale-orizzontale dei ministeri ordinati. Il ministero nel Nuovo Testamento è per lui essenzialmente una funzione di guida: “esso non si sviluppò attorno all’eucaristia o alla liturgia, ma attorno all’edificazione apostolica della comunità, mediante la predicazione, l’esortazione e la direzione. Per quante variazioni debbano subire, ministero e guida vanno di pari passo. I ministri sono delle guide, degli animatori e dei modelli di identificazione evangelica per la comunità” (p. 135). Questa connotazione, per Schillebeeckx, si conserva sostanzialmente – pur tra tante sfumature – nel primo millennio, mentre nel secondo si passa ad una deduzione cristologica diretta, relegando la comunità a mera recettrice della grazia che da Cristo le giunge attraverso i ministri. Convinto della superiorità dell’istanza ecclesiologica su quella cristologica, Schillebeckx prospetta per l’oggi la possibilità di una presidenza eucaristica da parte di non-ordinati, quando ciò sia richiesto da particolari necessità: l’eucaristia è infatti un diritto delle comunità cristiane, mentre l’ordinazione non è altro che un servizio a questo diritto; può perciò mancare l’ordinazione, ma non l’eucaristia nella comunità. Le tesi di Schillebeeckx hanno provocato parecchie reazioni, sia sul versante teologico sia su quello magisteriale, ed hanno stimolato l‘approfondimento delle fonti e la ricerca di quell’equilibrio tra le due dimensioni, cristologica ed ecclesiologica che caratterizza parecchi tentativi nella seconda metà degli anni Ottanta, periodo nel quale si incontrano sempre meno posizioni estreme e polemiche, come negli anni Settanta, e sempre maggiori sforzi di sintesi anche ben riusciti, come quelli di Dianich e Greshake. 6. La Pastores dabo vobis, nel 1992 dichiara conclusa la crisi di identità teologica, e dopo quasi due decenni le si può dare sostanzialmente ragione. Un’occhiata alla bibliografia conferma che dopo l’esplosione di studi degli anni Settanta e Ottanta, la teologia del ministero raggiunge negli anni Novanta e in quest’ultimo decennio un certo equilibrio. Non si incontrano normalmente posizioni teologiche estremiste e discussioni aspre sulla natura del presbiterato; vi sono certo posizioni differenti, anche di parecchio: da chi ripropone, con qualche ritocco, il modello cultuale e addirittura sacrale (“prete uomo del sacro”, “sacerdos alter Christus”, ecc.) a chi al contrario prospetta una visione profetica e “di frontiera”, a chi riafferma una concezione pastorale; vi sono dibattiti, riguardanti soprattutto la spiritualità diocesana, i religiosi presbiteri, le relazioni presbiteri-laici e presbiteri-vescovi, ecc. Niente però di paragonabile alla radicalità del dibattito degli anni Settanta e Ottanta. 6 Sembra tuttavia che senza la compagnia della “crisi” i presbiteri non possano vivere. Infatti si è aperto, negli ultimi vent’anni, un altro fronte della “crisi” – quasi un contraccolpo tardivo di quella immediatamente post-conciliare – che si potrebbe indicare come “crisi di identità pastorale”. Questo nuovo fronte non riguarda più le domande radicali sulla ragion d’essere teologica del ministero, ma ruota attorno alla sua configurazione pastorale. Se la prima crisi si può paragonare a un’alta montagna che si staglia sul livello del mare, questa sembra piuttosto un iceberg, emergente dall’acqua solo per un decimo della sua massa: allora il numero elevato di coloro che lasciavano il ministero – unito ad un atteggiamento talvolta provocatorio – faceva notizia e creava un clima acceso, di rabbia da una parte e dolore dall’altra; ora invece il numero di coloro che lasciano il ministero è grazie a Dio più contenuto, la gestione della crisi è più riservata e spesso non sfocia nell’abbandono; rimane tuttavia un clima di sottofondo a volte pesante tra i preti, specialmente giovani, che poco tempo dopo l’ordinazione già sembrano in alcuni casi pastoralmente “rassegnati”. E se la grande maggioranza dei presbiteri continua con entusiasmo a vivere il ministero, fa tuttavia pensare il fatto che in questi decenni diverse diocesi italiane siano state toccate dal fenomeno di preti giovani, anche giovanissimi per ordinazione – talvolta persino un anno o due – che vanno in crisi e magari decidono di lasciare il ministero. Non mi avventuro nell’individuazione delle cause di questa “crisi di identità pastorale”; bisognerebbe senza dubbio cercarle in direzioni diverse, come: la tanto proclamata fragilità psicologica e affettiva del mondo giovanile, più capace forse di slanci generosi e meno di donazione costante; la complessità e frammentarietà della nostra cultura, nella quale è così difficile orientarsi, discernere il bene dal male e mantenersi fedeli al Vangelo; la fatica di alcuni Seminari ad impostare percorsi di formazione che da una parte evitino il ritorno a modelli cultuali e sacrali e dall’altra evitino l’accomodarsi “borghese” ai venti culturali alla moda... Ma a queste tre grandi cause, di tipo rispettivamente psicologico, culturale e pedagogico, penso dobbiamo aggiungerne almeno una quarta, che forse permette di trovare il perno attorno a cui ruota il malessere attuale: ed è una causa precisamente “pastorale”. 7. Sta diventando uno slogan, ma non è infondata, l’affermazione spesso ripetuta che oggi ci troviamo “al guado” nella nostra pastorale: la sponda che stiamo faticosamente e (alcuni) nostalgicamente lasciando era quella della pastorale di conservazione, adeguata forse un tempo a situazioni di sostanziale tenuta dei valori cristiani, ancora presenti nelle varie culture della nostra nazione, anche in quelle più lontane dalla sensibilità ecclesiale. Mentre in Francia, come ricordavo, già durante la seconda guerra mondiale l’opinione pubblica cattolica prese coscienza di essere “in stato di missione”, in Italia questa consapevolezza matura solo negli anni Settanta e si concretizza nel primo progetto decennale della CEI, Evangelizzazione e sacramenti. Non c’è bisogno solo di catechesi, c’è bisogno di ri-annunciare il Vangelo: questa è la doccia fredda che investe negli anni Settanta il cattolicesimo italiano, e lo risveglia dalla dolce illusione di una sostanziale “tenuta” dei valori cristiani. L’insistenza di Giovanni Paolo II sulla “nuova evangelizzazione” è poi divenuta, dall’inizio degli anni Ottanta, motivo conduttore anche delle scelte pastorali italiane. Ma la sponda della “conservazione” evidentemente è difficile da lasciare, perché l’altra, quella che si intravede oltre il guado, è tutt’altro che sicura: appare instabile, malferma, inesplorata, ad alcuni perfino pericolosa. Il timore (giustificato?) di perdere una fascia di fedeli ancorati a certe tradizioni (di tipo ad es. devozionale o popolare), o legati a prestazioni ecclesiastiche (certificati, benedizioni, ecc.), comprese le Messe negli orari più comodi per il fedeli e nei luoghi più impensati e meno frequentati, rende molto difficile l’abbandono della sponda “conservatrice”. L’inevitabile carico di impegni sui presbiteri, spesso concentrati per forza di 7 cose più su problemi amministrativi, logistici e burocratrici, o sulla cosiddetta “sacramentalizzazione”, che sulle attività legate all’annuncio del Vangelo, porta alcuni a spendere le loro migliori energie per la conservazione e la ristrutturazione non solo di edifici e chiese ma anche di tradizioni e usanze. A volte resta poco tempo, troppo poco, per studiare, pregare e dedicarsi alla formazione delle persone. Esiste il concreto rischio di un ritorno pratico alla visione tridentina del presbitero come “uomo del culto”; con questo paradosso: Trento aveva delineato un sacerdozio teologicamente cultuale ma aveva dato origine, anche per l’esempio di grandi pastori come Carlo Borromeo che plasmò l’ideale sacerdotale per secoli, ad un sacerdozio praticamente pastorale; il Vaticano II delinea un presbiterato missionario ma, a causa della mutata situazione pastorale, specialmente del calo di presbiteri, rischia di dare origine ad un presbiterato praticamente cultuale. È un caso emblematico di interazione tra teologia e prassi. Dopo Trento la pratica era più ampia della dogmatica, mentre oggi sembra accada l’inverso: la dogmatica è ampia e missionaria, la pratica sembra essere ristretta e forzatamente cultuale. Tutto questo per parecchi giovani preti, e anche per alcuni non più giovani, è molto pesante. Sembra proprio che alla base di questo nuovo tornante della crisi presbiterale vi sia per lo più una demotivazione pastorale. Come nella crisi teologica, il problema è di nuovo quello dell’identità della Chiesa: là era l’identità teologica appunto, che venne precisata nei termini già accennati; qui è l’identità pastorale, sulla quale si sta tanto discutendo. I presbiteri hanno bisogno non solo di sapere qual è la natura teologica del loro ministero – il che resta sempre fondamentale – ma di sperimentare una Chiesa più agile e missionaria. D’altra parte alcune pubblicazioni teologico-spirituali, come il volume di Marcel Macial La formazione integrale del sacerdote, del 1990, tornano a ragionare sul sacerdozio come “ponte tra il cielo e la terra”, riproponendo questa visione sacrale e cultuale che il Vaticano II aveva superato e integrato in un’ampia visione missionaria. 8. Ma riproporre sic et simpliciter una concezione preconciliare del sacerdozio non sembra la strada giusta per affrontare la “crisi pastorale”, così come non lo fu per affrontare quella teologica. La tentazione è grande, perché a prima vista impostare la formazione seminaristica e permanente su un’identità teologica “verticale”, tornando alla visione del “sacerdos alter Christus”, al presbitero come “uomo del sacro”, alla visione cultuale e sacrale, sembrerebbe la risposta più solida alla crisi. Sarebbe una strada apparentemente sicura, ma in realtà di corto respiro. È comprensibile che di fronte allo smarrimento generale per la complessità culturale di oggi alcuni perseguano semplicemente un “ricompattamento” delle fila, rispondendo ad una cultura frammentaria e debole con alcune idee che appaiono forti e massicce – e dunque che rispuntino anche nei Seminari spinte tradizionaliste e ritualiste, chiuse al dialogo – ma non è giustificabile. La lezione della storia è lì a dirci che la Chiesa ha solo da perdere quando si chiude ermeticamente al mondo e – se non deve certo aprirsi in maniera sconsiderata – è davvero missionaria quando mantiene un dialogo critico, attento a rilevare tutti gli agganci positivi del Vangelo e a proclamarne in compimento in Cristo. Una sindrome dell’assedio – la Chiesa cittadella insidiata – farebbe perdere anche nei seminaristi e nei presbiteri la spinta missionaria. Di fronte alla “crisi pastorale” dei presbiteri, anziché questi sentieri di corto respiro, va imboccata – e grazie a Dio viene per lo più imboccata – la strada di una formazione ampia e capace di rapportarsi alle grandi sfide culturali. E occorre affrontare anche teologicamente i nodi ecclesiali che causano la crisi. È necessario, in altre parole, rivolgersi oggi non tanto al polo cristologico del ministero, ma all’altro riferimento, il polo ecclesiologico. Concretamente infatti l’esperienza di Chiesa che sta alla base della “crisi pastorale” passa per 8 i presbiteri attraverso tre relazioni fondamentali, sulle quali dal Vaticano II in avanti si riflette a fondo, che costituiscono la trama ecclesiale del loro ministero: la relazione con la porzione del popolo di Dio a cui sono inviati (una parrocchia, un ambito pastorale, un’associazione o un movimento), con i confratelli nel presbiterio e, in esso, con il loro vescovo. Nell’attuale “crisi pastorale” è proprio sulla qualità di queste relazioni ecclesiali che si gioca gran parte del ministero. Oggi difficilmente un prete si demotiva per cause teologiche, ossia perché non sa qual è la natura del suo ministero; e neppure si demotiva semplicemente per cause affettive: queste sono in genere, è vero, il detonatore che fa esplodere la crisi, ma non la ragione più profonda; normalmente è per il fatto che nelle relazioni ecclesiali si è aperta una “crepa”, che diventa spontaneo cercare compensazioni, sia sul versante affettivo che su quello dei beni o degli onori. Se la qualità delle relazioni con i laici, gli altri presbiteri e il vescovo è buona, è più difficile che si apra uno spazio per una crisi profonda. Vi saranno sempre tensioni, delusioni, sconfitte – fanno parte della croce del discepolo – ma il modo di affrontarle sarà diverso se invece di sentirsi soli si appartiene ad una comunità. L’appartenenza alla Chiesa diocesana – per dare il nome proprio alla triplice relazione di cui stiamo parlando – diventa elemento irrinunciabile dell’identità non solo teologica ma anche pastorale del presbitero. Non un libero battitore, per quanto animato da generosità e carismi, ma uno consapevole di appartenere alla famiglia che si chiama “diocesi”: una comunità locale con un proprio “volto”, una sua storia, problemi e situazioni peculiari, scelte pastorali specifiche. Giovanni Paolo II nella Pastores dabo vobis n. 31 ha parlato della diocesanità come valore spirituale per il presbitero, il cui ministero consiste nella dedicazione stabile alla Chiesa particolare. Questa è la sua identità pastorale: il prete è un battezzato che accoglie la chiamata a spendersi completamente nel nome di Cristo per la Chiesa locale e, in essa, per la Chiesa universale. Se tutti i presbiteri sono chiamati ad assumere la spiritualità diocesana, servirla e farla crescere, i presbiteri diocesani ne fanno addirittura il perno della loro spiritualità. Altri carismi, provenienti da congregazioni e ordini religiosi, da movimenti e cammini, potranno certo arricchire la spiritualità di un presbitero diocesano, ma non configurarla nella sua struttura, perché essa è già plasmata dall’appartenenza e dedicazione ad una Chiesa locale, nella quale spende le proprie energie per l’annuncio, la celebrazione e l’edificazione del popolo di Dio. 9. Dal Vaticano II in avanti questa dedicazione, con tutte le esigenze che comporta, viene riassunta nell’espressione carità pastorale, contenuta in PO 14, ribadita e sviluppata a fondo in Pastores dabo vobis 21-23 e rilanciata più volte dai vescovi italiani. In particolare questi ultimi, nei loro interventi sul ministero ma anche nella Ratio per la formazione nei seminari (2006), tracciano una figura di presbitero inserito in una trama ricca di relazioni con i laici, gli altri presbiteri e il vescovo. Un prete in grado di ascoltare la comunità per la quale si spende e di responsabilizzare i laici: non è più il tempo dei laici-esecutori e neppure solo dei laicicollaboratori: è il tempo dei laici-corresponsabili. Un prete inserito nel presbiterio, nel quale sia possibile e desiderabile vivere esperienze di comunicazione fraterna e magari anche di vita comunitaria; e in rapporto di collaborazione con i diaconi. Un presbitero in relazione cordiale e sincera con il proprio vescovo, con il quale possa avere momenti di confronto ed al quale possa esprimere il proprio pensiero con schiettezza, anche quando differisce dal suo. È facile indovinare la miriade di problemi pratici legati a questa triplice relazione, che interrogano e stimolano la riflessione teologica. Basti pensare alle difficoltà da parte di alcuni presbiteri a formare laici responsabili superando la mentalità della delega e la difficoltà da parte degli stessi laici, in alcuni casi, a collaborare come veri “responsabili”, cioè non solo in fase esecutiva ma prima ancora nella fase del discernimento e del consiglio; e a questo 9 proposito ci si deve interrogare sulla disaffezione da tempo riscontrabile verso il “Consigli pastorali”, organismi nei quali dal Concilio in avanti si intendeva offrire uno strumento di “discernimento comunitario” e corresponsabilità, e che invece troppo spesso vengono incaricati di risolvere i problemi pastorali, quasi fossero non uno strumento la cui efficacia dipende dall’ecclesiologia sottostante, ma una bacchetta magica che agisce per virtù propria. Basti pensare, ancora, al rapporto oggi abbastanza pacifico ma non ancora del tutto chiarito tra parrocchie e diocesi da una parte e associazioni e movimenti dall’altra. Passando al presbiterio, è agevole e incoraggiante riscontrare i tentativi (incontri, ritiri, settimane di fraternità...) che in tutte le Chiese locali vengono portati avanti per ridare corpo ad un istituto che aveva perso la sua pregnanza sacramentale – “presbiterio” per Ignazio di Antiochia è una grandezza teologica, la “corona del vescovo”, mentre dal Medioevo al Vaticano II è una grandezza architettonica, ossia la parte dell’edificio sacro delimitata dalla balaustra: ma non è facile, come sappiamo, passare da un presbiterato inteso in chiave prevalentemente individuale ad uno inteso in chiave comunitaria, da uno stile presbiterale a uno presbiteriale, dove nessuno si senta detentore del compito che gli è affidato (la mia parrocchia, il mio movimento, il mio centro diocesano), ma si sappia inviato dal vescovo e dal presbiterio in quella realtà, che non è sua ma gli è temporaneamente affidata. La maturazione pratica del “presbiterio” va di pari passo con l’acquisizione di una spiritualità “diocesana”, che faccia avvertire al presbitero l’appartenenza all’intera Chiesa locale e non ad una sola delle sue espressioni (parrocchia, movimento, ambito pastorale). Per citare infine almeno un aspetto connesso alla relazione con il vescovo: oggi, a parte i problemi legati alla diversità di carattere o di impostazione pastorale che un presbitero può avvertire verso il proprio vescovo, vi sono motivi oggettivi che richiedono un ripensamento – in molti casi avviato – di questa relazione; che cos’hanno in comune, ad esempio, l’esercizio della paternità episcopale in una piccola diocesi di poche decine di presbiteri, dove il contatto può essere informale e frequente, con una grande diocesi di centinaia di presbiteri, dove invece inevitabilmente il contatto diventa raro e deve essere programmato? Come far sì che non si perda, nemmeno nelle grandi diocesi, quella relazione umana e calda che è sempre la base per ridurre i pregiudizi e favorire una convinta corresponsabilità? Tanto più che il sovraccarico burocratico che affligge i presbiteri colpisce i vescovi in misura enormemente maggiore. 10. Andiamo rapidamente verso la conclusione. La vicenda postconciliare del presbiterato, appena tratteggiata, ha lasciato emergere il fitto intreccio tra teologie e pratiche: un intreccio necessario e fecondo, se non vogliamo cadere in una sorta di platonismo ministeriale; dobbiamo infatti accettare che il presbiterato non sia dato una volta per tutte, non cada impacchettato dal cielo, ma “divenga” ed evolva nella storia, assuma accenti sempre nuovi, risenta dei contraccolpi delle mutate situazioni sociali e pastorali ed esso stesso le influenzi. Se infatti è Cristo Pastore il soggetto, l’origine e il costante punto di riferimento del ministero, è poi la Chiesa il suo ambito concreto, il suo luogo di crescita e di esercizio: anche la comunità quindi, con le sue relazioni e il suo volto concreto, fa parte dell’identità del ministero e non ne è solamente il vuoto recipiente; è invece il luogo nel quale cresce e prende corpo la “carità pastorale”. L’oscillazione tra la sponda cristologica e quella ecclesiale, come abbiamo notato, ha caratterizzato la teologia del ministero nell’ultimo mezzo secolo; l’immagine del pendolo, che all’inizio del Novecento Schweitzer utilizzò per la ricerca sul Gesù storico, vale anche per la teologia del ministero ordinato: a ridosso del Concilio il pendolo era totalmente spostato verso la sponda cristologica del “sacerdos alter Christus”, del sacerdote mediatore tra il cielo 10 e la terra, del presbitero “sopra” la comunità; il Vaticano II collocò il pendolo al centro, insistendo sulla dimensione ecclesiale del presbiterato, come servizio nella e per la comunità; la contestazione successiva portò il pendolo all’estremo opposto rispetto alla visione preconciliare, assolutizzando la relazione del ministro con la comunità e facendone un semplice coordinatore di carismi senza alcuna consistenza “ontologica” e provocando oscillazioni cultuali e sacrali diametralmente opposte; dal Sinodo del 1971 alla Pastores dabo vobis il Magistero riportò il pendolo verso il centro, spostato però rispetto al Concilio – per reazione al dissenso e alla crisi – verso il versante cristologico, sottolineandolo come “primario” e fondante rispetto a quello ecclesiale; nell’ultimo ventennio, infine, buona parte della riflessione teologica sta cercando di integrare meglio le due dimensioni, evidenziando l’importanza delle relazioni ecclesiali. Il pendolo è però ancora oggi in movimento, perché si riscontrano nella teologia e nella pratica approcci ecclesiologici – e di conseguenza concezioni di ministero – molto diversi. Il problema del ministero, infatti, riguarda direttamente l’ecclesiologia e solo indirettamente la teologia sacramentaria: le diverse pratiche pastorali, ora più aperte al dialogo con il mondo ora più tese a ricompattare le fila dei cristiani – in fondo l’eterna riedizione del dibattito che trent’anni fa contrapponeva i cristiani della presenza a quelli del mediazione – e le diverse ecclesiologie che ne sono alla base, diventano determinanti nella configurazione del ministero presbiterale. Non si giungerà mai a una figura unica e definitiva di presbitero, e non vi si dovrà mai giungere, se è vero che deve plasmarsi sulle esigenze mutevoli della missione ecclesiale nella storia e nella geografia. Se guardiamo anche solo alla Chiesa in Italia, sono oggi numerose le versioni concrete assunte dal ministero presbiterale: convivono legittimamente presbiteri che vivono il ministero in chiave prevalentemente liturgica e sacramentale, con altri che mettono al primo posto la testimonianza della carità nelle situazioni disagiate; presbiteri che si dedicano essenzialmente all’animazione della comunità cristiana e alla pastorale cosiddetta ordinaria, con altri che accolgono le sfide dei “nuovi areopaghi” della cultura e comunicazione, percorrendo le diverse possibilità offerte oggi dai mass media; presbiteri che puntano sulle relazioni interpersonali e si pongono come accompagnatori e guide spirituali, con altri che spendono le loro migliori energie nell’insegnamento della religione, teologia e scienze umane o magari, almeno per certi periodi e in certe situazioni, assumono compiti di supplenza nei campi dell’educazione, promozione umana e professionale o altro. Sono tutte variazioni legittime, dicevo; però alla luce del Vaticano II e degli sviluppi successivi possiamo dire che la diversità non può diventare giustapposizione anarchica – ma deve corrispondere ad alcuni criteri, che fungono anche da linee operative teologico-pastorali per un presbiterato adeguato alle esigenze odierne. Il Vaticano II aveva bene integrato le tre concezioni – cultuale, profetica e pastorale – fondendole in un’unica descrizione del ministero: un primo criterio è la tensione verso l’integrazione dei tre compiti, per cui non si dovrebbe favorire ad esempio un presbiterato unicamente cultuale che, come ho accennato, rappresenta un rischio favorito dal calo numerico dei presbiteri; ma costituisce un rischio anche là dove il presbitero è chiamato unicamente a presiedere l’eucaristia in una comunità, verso la quale non svolge alcun servizio di formazione. Non si dovrebbe neppure favorire, per fare un altro esempio, una scissione tra compito profetico e pastorale; la necessaria specializzazione, per cui non tutti devono fare tutto, non può comunque privare i pastori del tempo necessario per studiare e i predicatori e professori di una significativa immersione pastorale. Il secondo criterio, ispirato ancora ai testi conciliari ma integrato con le successive riflessioni sulla spiritualità diocesana, riguarda le oggettive esigenze della Chiesa locale nella quale il presbitero svolge il suo servizio. La triplice relazione che costituisce l’ossatura della 11 spiritualità del presbitero diocesano – con il popolo di Dio a cui è inviato, con il presbiterio e il vescovo – orienta la configurazione concreta che assume il suo servizio. Non si dà un presbiterato assoluto, “a-topico”, quasi che uno sia programmato “in provetta” per qualsivoglia situazione pastorale e possa configurare il suo ministero allo stesso modo a Brescia, a Bologna o a Pechino. Il ministero assumerà invece il volto della Chiesa locale che serve, respirandone la storia e i problemi, accogliendone le indicazioni pastorali e le priorità missionarie, mettendosi a disposizione del vescovo, inserendosi cordialmente nella trama di relazioni laicali e presbiterali ivi presenti, coltivando specialmente il presbiterio. E tutto ciò vale anche per i presbiteri religiosi e per quelli che provengono da movimenti, cammini e associazioni. Un terzo e ultimo criterio, infine, riguarda i doni naturali e soprannaturali di ciascun presbitero. I due criteri oggettivi appena esposti non possono far dimenticare che ogni presbitero è dotato di attitudini, capacità e carismi peculiari: l’interpretazione concreta del ministero, quindi, deriverà anche da queste singolarità, che – nell’ottica della complementarità delle membra – non può che arricchire l’esperienza ecclesiale. Chi ha particolari doni di parola li metterà a frutto in qualsiasi tipo di ministero, sia esso direttamente pastorale oppure accademico o magari mass-mediatico. O chi ha una sensibilità spiccata per gli ultimi, la trasporterà all’interno di ogni compito gli venga affidato, diventi egli parroco oppure padre spirituale in Seminario. E così via. Quanto più si faranno interagire questi tre criteri, nell’attenzione alle necessità oggettive della Chiesa e ai doni soggettivi dei singoli, tanto più ci si attrezzerà a superare la “crisi pastorale” dei presbiteri e li si aiuterà ad essere nella Chiesa – ecco ciò che deve rimanere fermo, in mezzo a tutte le variazioni – segno della premura di Cristo per gli uomini e con gli uomini del loro tempo. don Erio Castellucci
Scaricare