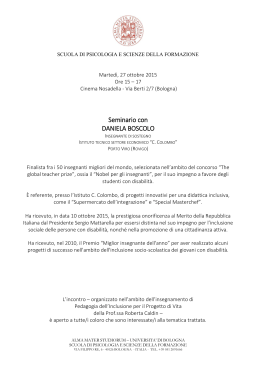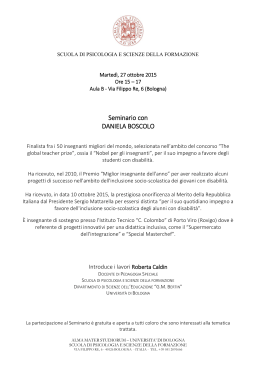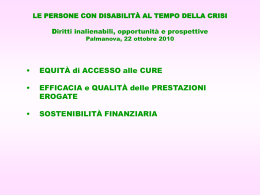i VADEMECUM di LombardiaSociale.it La disabilità è negli occhi di chi la guarda Welfare e società secondo Franco Bomprezzi Questo Vademecum raccoglie articoli e post di Franco Bomprezzi pubblicati su Invisibili di Corriere, Inserto La Lettura del Corriere della sera, Vita.it, Vita Magazine e WelfareOggi. La raccolta è stata progettata e curata da Riccardo Bonacina, Vita.it; i blogger di Invisibili; Cristiano Gori, WelfareOggi e LombardiaSociale.it; Cecilia Guidetti, LombardiaSociale.it; Giovanni Merlo, Ledha. Il blog InVisibili si presenta dal nome: denuncia una condizione nella quale troppo spesso vive chi ha a che fare con una disabilità. L’obiettivo del blog è cambiare questa situazione: innanzitutto parlandone, nel modo più chiaro e sereno possibile. Discutendo idee, proposte, progetti per mettere i disabili in condizione di vivere e confrontarsi alla pari. E nello stesso tempo per offrire alla società le risorse dei disabili. Franco Bomprezzi ha partecipato a Invisibili come blogger e da qui sono tratti alcuni dei post pubblicati nel Vademecum. LEDHA è la Lega per i diritti delle persone con disabilità. È costituita da 10 Coordinamenti territoriali e 16 associazioni a valenza regionale e rappresenta oltre 200 associazioni di persone con disabilità e familiari. Rappresenta in Lombardia la FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap), fa parte del Forum del Terzo Settore Lombardia e aderisce a Exponiamoci. Svolge attività di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità in Lombardia. LombardiaSociale è un progetto, a cura dell’Istituto per la ricerca sociale, di valutazione del welfare sociale in Lombardia, che si concretizza principalmente in un sito web aggiornato regolarmente che raccoglie documenti, informazioni e opinioni riguardo l’andamento delle politiche sociali lombarde. Per preservare la propria indipendenza e allo stesso tempo monitorare con completezza quanto accade nel welfare sociale in Lombardia, il progetto è sostenuto dalle maggiori organizzazioni che si occupano di welfare in Lombardia. VITA è un gruppo editoriale dedicato a sostenibilità nonché un network d’influenza per la costruzione e il sostegno del bene comune. VITA Magazine è grandi interviste, approfondimenti e inchieste; dà spazio ai numeri, alle voci dei protagonisti e degli esperti; indaga i grandi cantieri del welfare e le connessioni tra profit, non profit e istituzioni. Il suo Comitato Editoriale, partecipato da oltre 60 grandi ONP italiane, ne fa il punto di riferimento dell’informazione Social in Europa. Franco Bomprezzi ha curato per diversi anni su vita.it il blog FrancaMente da cui sono tratti alcuni post qui pubblicati. WelfareOggi è un periodico bimestrale del Gruppo Maggioli che offre un’informazione qualificata sulle modalità di erogazione dei servizi e sugli strumenti di programmazione nel nuovo welfare. Politiche, Servizi, Strumenti: i migliori esperti del settore, consulenti, docenti, dirigenti e operatori di IPAB e nuove ASP, di Enti locali, di aziende sanitarie, di cooperative sociali, si confrontano sulle pagine della rivista per capire e discutere le politiche, per diffondere esperienze, buone prassi e forme di gestione dei servizi. Indice Introduzione 3 I diritti difficili Dall’emancipazione della persona alla regressione nell’handicap Origini e conseguenze di una retromarcia culturale L’esercito di riserva dei diritti Cinici e tecnicamente ignoranti Quando l’Inps “aggrava” l’invalidità I mendicanti dei diritti Caro Fontana, 08 14 16 20 22 24 I servizi per la disabilità Includere è più di integrare Stereotipi sulla disabilità – il catalogo è questo. Intervista a Franco Bomprezzi La vita di Rita: in sedia a rotelle, in una casa con sessanta anziani Una foto e lo stigma 27 29 34 37 Lo sguardo sulla società L’eclissi della speranza Azzardo e scommesse, la droga dei più deboli Cara Vita, … Lavorare meglio, lavorare tutti Caro Nicoletti, … Il Corpo dell’amore Siamo belli anche noi 41 43 45 47 49 51 54 Biografia di Franco Bomprezzi 57 2 Introduzione di Riccardo Bonacina, Cristiano Gori, Cecilia Guidetti, Giovanni Merlo e i blogger di InVisibili Franco era divenuto, forse suo malgrado, un grande esperto di "servizi sociali". La presidenza prima della Uildm Nazionale e poi della Ledha, intervallata da una lunga militanza come "portavoce" di fatto dell'intero movimento associativo, lo avevano posto spesso al centro delle analisi e delle riflessioni inerenti i temi del welfare sociale, sia di carattere nazionale che regionale e locale. Il welfare sociale non era però il suo argomento preferito. Franco preferiva offrire il suo punto di vista sul rapporto della società con la disabilità, prendendo spunto da fatti di cronaca e di costume (a volte secondari) per svelare i meccanismi che possono condurre la disabilità nel limbo dell'emarginazione o, al contrario, riportarla al centro dei dibattiti pubblici. La sua militanza lo portava ad occuparsi di invalidità, Isee, politica sanitaria e sociale ma la sua attenzione come giornalista e osservatore si concentrava essenzialmente sul tema della comunicazione, dell'individuazione degli argomenti e dei linguaggi per poter parlare di disabilità, parlando contemporaneamente di tutta la società. Per poter parlare di disabilità in modo che tutti potessero capire, fermarsi anche solo per un secondo a riflettere. Sono quindi relativamente pochi gli articoli di Franco dedicati al tema del welfare sociale. Cristiano Gori ha avuto la bella intuizione di pubblicare i più significativi: perché se Franco parlava poco di servizi sociali, quando lo faceva distillava nelle sue parole la competenza accumulata grazie alla militanza associativa, miscelandola con la sua attenzione a non parlare, come spesso si fa, di un "mondo a parte" ma di una parte del mondo, troppo spesso relegata in un angolo, nel limbo degli addetti ai lavori. Un limbo dove le persone con disabilità spesso non riescono a far uscire la loro voce, il loro punto di vista, la loro critica ad un mondo che non pensa che, per loro, lo spazio di un centro diurno o di una residenza assistita. Le sue parole erano rivolte sia ai decisori, con un forte contributo a contrastare la campagna sui falsi invalidi, ma anche agli operatori senza mai dimenticare ovviamente le persone con disabilità, ancora una volta strappate al velo di silenzio e di invisibilità, grazie al suo sguardo ed alle sue parole. 3 È in questi articoli che Franco ha messo meglio a frutto la sua capacità di osservazione ed il suo sguardo "svelatore", perché nella sua esperienza personale i contatti con questo mondo non sono stati particolarmente significativi. Non parla quindi per "esperienza personale" ma esercitando in pieno il suo ruolo di rappresentante: parola che contiene in sè contemporaneamente il significato di "portavoce" ma anche di colui che "rappresenta", cioè racconta, mette in scena, svela. Franco ci offre le sue parole per porci qualche domanda sul senso delle politiche, sul senso dei benefici, sul senso dei servizi. Domande che avremo bisogno di porci a lungo, se vogliamo contribuire a promuovere, sul serio, il diritto di tutte le persone con disabilità ad essere pienamente parte del mondo, del nostro mondo. Franco era anche un grande costruttore di relazioni, frequentava e faceva incontrare persone con idee, competenze e percorsi assai diversi. Fedeli al suo messaggio di incontro e contaminazione reciproca abbiamo pensato di unire gli sforzi per raccogliere in questo Vademecum alcuni suoi scritti tratti dalle diverse testate delle quali ci occupiamo. Ma è solo l’inizio. Nel prossimo futuro – infatti - vi saranno numerose occasioni per continuare a confrontarci sulle idee di Franco, diversi tra noi ci stanno lavorando. Cosa contiene questo Vademecum Il titolo della raccolta parafrasa una frase di William Shakespeare- “la bellezza è negli occhi di chi la guarda” - ed è stato scelto per comunicare con immediatezza uno dei principali contenuti trasversali agli articoli riportati: parlare di disabilità è parlare del mondo, così come parlando del mondo si può parlare di disabilità. Gli scritti raccolti in questo Vademecum sono stati pubblicati in varie forme e su diverse testate (Vita.it, Vita Magazine, Inserto La Lettura del Corriere della Sera, Invisibili.corriere.it, WelfareOggi) tra il 2011 e il 2014. In questa raccolta sono suddivisi, per facilitare la lettura, in tre sezioni tematiche. La prima sezione è dedicata al tema dei diritti difficili. Negli articoli riportati Franco, discutendo e commentando temi “caldi” nell’area della disabilità (la cosiddetta lotta ai falsi invalidi, il dibattito sulla riduzione delle indennità di accompagnamento) torna e ritorna a parlare di diritti, proponendo riflessioni che riguardano primariamente le persone con disabilità, ma non solo. 4 La caratteristica prima di questi scritti è quella di riuscire a trattare un tema complesso quale quello dei diritti, e della loro effettiva esigibilità nel nostro sistema di welfare, in modo estremamente concreto, senza complicate teorizzazioni ma guardando, in primo luogo, a come le scelte politiche, economiche o amministrative ricadano e portino conseguenze dirette nella vita delle persone. L’universalismo selettivo e i suoi rischi, l’assenza di una definizione di livelli essenziali nel sociale, l’abisso di garanzie di prestazioni tra sociale e sanitario, la frammentazione e scomposizione dei diritti per tipologia di persona e di bisogno (giovani, donne, poveri, anziani, disabili, disoccupati, etc) e la relativa spinta ad una “guerra tra poveri e poverissimi” sempre più feroce, la differenza tra diritti e loro esigibilità, le strategie di riduzione dei costi e le relative ricadute sulla vita e sulla dignità delle persone sono tutti temi che, attraverso il racconto, l’indignazione e, a volte, un po’ di ironia, attraversano queste pagine. La seconda sezione è dedicata al mondo dei servizi per la disabilità. Lo sguardo di Franco sui servizi parte dalla domanda a cui tutte le analisi e le valutazioni di efficacia dei servizi nel sociale (anche non rivolti alla disabilità) dovrebbero rispondere: i servizi consentono oppure no di migliorare l’inclusione delle persone che ne sono beneficiarie? Anche qui l’inclusione non è genericamente richiamata, ma precisamente intesa come “mettere ogni persona con disabilità in condizione di interagire con l’ambiente nel quale vive, di scegliere il proprio progetto di vita, di muoversi liberamente, in casa e fuori, di partecipare alla vita sociale, lavorativa, culturale, sportiva.” Gli scritti riportati in questa sezione richiamano l’importanza dell’interrogarsi circa le caratteristiche di inclusività del lavoro dei servizi, in particolare in quelli rivolti alle persone con disabilità, dove il rischio continuo è quello di una eccessiva preponderanza della visione sanitaria e di una omogeneizzazione di condizioni di vita e di salute, a discapito di un intervento complessivo a favore delle persone e dei loro diversi bisogni e desideri. Il perpetrarsi, anche nel mondo dei servizi e in particolare in quello delle residenze, di una visione spesso stereotipata della disabilità, legata a pregiudizi diffusi e difficili da abbattere e l’importanza di assumere un’ottica inclusiva che non si fermi a una visione compassionevole è raccontata anche attraverso esperienze dirette, che nella loro semplicità riportano chiare evidenze che non si rivolgono agli specialisti e ai tecnici del welfare, ma che sanno parlare a tutti i lettori che incontrano i servizi come beneficiari, familiari o semplicemente come cittadini. 5 La terza sezione è intitolata “lo sguardo sulla società”. Gli articoli riportati qui vogliono essere un piccolo estratto rappresentativo del racconto che Franco ha fatto, negli anni, di quanto accadeva nella società intorno a lui: il tema del lavoro e dell’inclusione lavorativa, l’aggravarsi e il diffondersi di fenomeni come quello delle dipendenze da gioco, l’affermarsi di un clima di dibattito sociale e politico sempre più “fazioso” e poco finalizzato a individuare strategie e soluzioni ai problemi, sono raccontati attraverso osservazioni attente e il richiamo a interventi decisi, di rottura con il modo di porsi delle istituzioni – spesso incerto, sussurrato – proponendo l’idea di perseguire una “direzione del tutto differente di marcia, abbandonando gli automatismi.” Infine, e sempre in questa direzione di costruire e ricostruire visioni complete e concrete di quanto avviene nel mondo, gli ultimi contributi riportano articoli e lettere scritte da Franco ad alcuni amici che ci parlano della responsabilità di narrare e raccontare la disabilità, attraverso la scrittura, ma non solo, per crearne una conoscenza diffusa e reale, sempre focalizzando sulle due parole chiave dei suoi scritti: diritti e inclusione. 6 I diritti difficili 7 WelfareOggi, n° 4 2011 Dall’emancipazione della persona alla regressione nell’handicap Origini e conseguenze di una retromarcia culturale di Franco Bomprezzi In principio fu Tremonti «Sulle Regioni la riduzione è abbastanza consistente. Ma non insostenibile. Si parla di 4, 4.5 miliardi. Beh, lì cosa c’è dietro? Uno dei fenomeni che vi fanno capire perché questo continente e il nostro Paese deve cambiare: le pensioni di invalidità. Questo è un Paese che ha 2 milioni e 7 di invalidi. Su 60 milioni di abitanti, escludendo i giovani e le persone che per definizione non sono così invalidi (salvo incidenti). 2.7 milioni di invalidi pone la questione se un Paese così può essere ancora competitivo». E poi: «L’altra cosa impressionante: non è che abbiamo 2.7 milioni di invalidi, ma che il costo delle pensioni di invalidità è salito a 16 miliardi. Un punto di PIL ogni anno vanno agli invalidi…». Sono le 19 del 26 maggio 2010, conferenza stampa del Ministro Tremonti di presentazione di quella manovra finanziaria. Niente sarà più come prima. Non riusciremo più a ristabilire l’ordine naturale delle cose, perfino il senso di una storia civile e sociale nel nostro Paese. Molte delle tappe successive sono note e ampiamente citate. Mi limito a ricordare l’impresa (fallita) del presidente della Commissione Bilancio del Senato, Azzollni, che era quasi riuscito ad innalzare all’85 per cento la percentuale di invalidità necessaria per ottenere l’assegno di invalidità. Siamo ormai alla fine di giugno dell’annus horribilis 2010. La manifestazione indetta da Fish e Fand a Roma, il 7 luglio, sarà capace di sventare in extremis almeno questa minaccia. Ma le cronache continueranno a cavalcare l’editto tremontiano, senza alcuna riflessione critica sulle cifre, e tantomeno sulla filosofia di fondo.I mesi successivi hanno vistoin una campagna mediatica senza precedenti che va sotto il titolo generale di “lotta ai falsi invalidi”. Un minestrone dove entra di tutto. Servizi televisivi, filmati diffusi su youtube, fatti di cronaca che solo incidentalmente potrebbero essere assimilati a questo ragionamento. I generi che “tirano” maggiormente, accendendo la fantasia popolare e facendo registrare picchi di indi- 8 gnazione, sono alimentati da storie di ciechi che guidano, di paraplegici che si alzano in piedi allo stadio, di pass per invalidi utilizzati in massa (il caso dei calciatori bolognesi1). In realtà prevale la localizzazione meridionale, che aiuta a costruire la convinzione che il fenomeno dei “falsi invalidi” vada di pari passo con il tema del fardello economico del Sud, sulle spalle del Nord produttivo e “onesto”. Il clima mediatico costruito, o comunque alimentato, da notizie scarsamente sorrette da approfondimenti e spiegazioni tecniche (ad esempio su chi ha condotto le indagini: quasi sempre si tratta di corpi di polizia, quasi mai di controllori pubblici dell’Inps2), consente per l’intera seconda parte del 2010 e per i primi mesi del 2011 il consolidamento della prassi dei controlli sulle certificazioni di invalidità. Prima della “lotta ai falsi invalidi” Quali sono le conseguenze per così dire “ideologiche” della “lotta ai falsi invalidi” sul mondo complesso delle persone con disabilità in Italia? Esiste infatti un paradosso originario, una contraddizione perfino semantica, che rende arduo il percorso civile della lunga battaglia sui diritti di cittadinanza. Le persone con disabilità, per vedere riconosciuti e tutelati i propri diritti, sono infatti da sempre costrette a essere “segnate” con lo stigma visibile e socialmente riconosciuto della certificazione di invalidità (simbolicamente sintetizzato 1. In aprile di quest’anno ha suscitato scalpore la notizia delle indagini avviate dalla Procura di Bologna a proposito dell’uso quotidiano da parte di calciatori dell’Ac Bologna di contrassegno per invalidi associato al nome di una collaboratrice disabile della società di calcio, che si è giustificata sostenendo che i calciatori la accompagnavano in centro per aiutarla nelle sue commissioni. A fine agosto si è appurato che il fenomeno dell’abuso dei pass, comprese molte falsificazioni, era assai esteso e consolidato. 2. In linea di massima i controlli a campione effettuati dall’Inps consistono nella convocazione di cittadini che risultano già in possesso di una certificazione di invalidità. I casi di cronaca che spesso accompagnano la vicenda dei cosiddetti “falsi invalidi” sono legati invece a notizie provenienti dagli ambienti della polizia giudiziaria. Un esempio per tutti: il clamoroso arresto a Napoli di 131 persone (Ansa, 22 giugno) avvenne in seguito a indagini della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. In quel caso, ad esempio, venne scoperta un’associazione che falsificava documenti per ottenere pensioni di invalidità. Una truffa in piena regola, dunque, impossibile da smascherare attraverso le visite di controllo, ma solo sulla base delle denunce e delle segnalazioni di comportamenti anomali (i famosi “ciechi che guidano”). 9 dall’omino stilizzato in sedia a rotelle). Senza quel punto di partenza, che nell’infanzia assume il nome di “diagnosi” (rivelando con ciò la stretta correlazione tra gli aspetti medicosanitari e quelli più strettamente socio-assistenziali), il cittadino disabile non può in alcun modo accampare pretese, né di benefici economici, né di prestazioni assistenziali, né di attenzione competente nelle diverse situazioni della vita (scuola, lavoro, mobilità, svago, sport, cultura). Prima della mazzata tremontiana, che indica all’opinione pubblica il peso insopportabile di 2,7 milioni di invalidi civili, la certificazione di invalidità era in qualche modo il compromesso inevitabile per accedere ad un percorso di riconoscimento sociale, di riabilitazione fisica, di inclusione, di valorizzazione delle potenzialità (o “capacità residue”). L’obiettivo ultimo, in buona sostanza, era quello di “superare l’handicap”. Ossia di consentire anche a persone che presentano un deficit fisico, sensoriale o intellettivo, di puntare a un miglioramento dei propri livelli di autonomia, di autosufficienza, di cittadinanza “normale”. Non a caso una delle difficoltà psicologiche maggiori, per i genitori più giovani, era ed è quello di accettare l’idea di una “certificazione” che inevitabilmente avrebbe “targato” il figlio con disabilità in modo definitivo. La legge quadro, la 104 del 1992, da questo punto di vista, pur con la sua incompletezza e genericità di impegni, costituisce un caposaldo di una cultura positiva dei diritti di coloro che allora venivano chiamati “portatori di handicap”. L’evoluzione finale di questa linea ideale è rappresentata dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Potremmo correttamente parlare di una cultura illuminista, positivista, che si allontana dal pietismo e dall’assistenzialismo, ma anche dalla cultura del risarcimento del danno, costruita nei decenni precedenti attorno alle attività e alle imprese delle cosiddette associazioni “storiche”, nate a tutela degli invalidi di guerra, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordi, degli infortunati sul lavoro. Dal punto di vista della spesa sociale, come è stato ampiamente documentato, il flusso di denaro pubblico si è sempre mantenuto al di sotto della media degli altri Paesi europei. Ciò ha consentito di fatto una serie di miglioramenti, di piccoli ma costanti aggiustamenti nel tempo, soprattutto nel campo delle prestazioni socio-sanitarie, ma anche delle agevolazioni fiscali, degli incentivi al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, dell’acquisto di ausili per la mobilità, per l’igiene, per l’istruzione, per la comunicazione. La cultura dei diritti e delle prestazioni è andata, per lungo tempo, di pari passo, in una lunga stagione normativa i cui momenti più alti sono stati sicuramente la legge per l’integrazione scolastica, la legge 68 del ’99 per l’inserimento lavorativo, la legge quadro di riforma dell’assistenza, la 328, che ha compiuto da poco dieci anni (senza mai trovare piena attuazione). 10 Fra contraddizioni e sovrapposizioni, incertezze di interpretazione, criteri a volte estensivi, non si può negare che la qualità della vita, complessiva, delle famiglie e delle persone con disabilità, sia migliorata nel nostro Paese, al punto da consentire la crescita di un movimento associativo basato proprio sulla cultura dei diritti di cittadinanza e sul principio di non discriminazione, fino a quel “niente su di noi senza di noi” che è diventata parola d’ordine internazionale, capace di generare orgoglio, appartenenza, riconoscibilità sociale. Dopo “la lotta ai falsi invalidi” La svolta ideologica determinata dal ministro Tremonti ha profondamente (spero non irrimediabilmente) compromesso questo processo culturale e sociale in atto. Se infatti l’obiettivo è adesso quello di identificare i “veri invalidi”, la loro definizione appare estremamente circoscritta e inquietante. Nell’opinione pubblica si è infatti consolidata la convinzione che i “veri invalidi” sono solo le persone in situazione di “grave bisogno” (economico, fisico, mentale). Persone totalmente “non autosufficienti”, non in grado di svolgere in modo autonomo praticamente nessuna delle funzioni fondamentali dell’esistenza. Solo questo gruppo di cittadini avrebbe diritto “davvero” a provvidenze economiche adeguate, e a servizi di assistenza che invece adesso sarebbero assicurati a una platea troppo vasta. Non è un caso se il Governo decide infatti di inserire, nella legge finanziaria del 2010, nell’ambito di un ridimensionamento contabile del 5 per mille, uno stanziamento cospicuo in favore di una sola specifica categoria di “malati” (torna esplicitamente e ripetutamente in auge il termine “malati”): ossia le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Il tutto senza curarsi del fatto che, a parità di situazione, si trovano anche persone con tetraplegia, persone con esiti di distrofia muscolare, di sclerosi multipla, e via elencando le patologie più invalidanti. Questo provvedimento a sorpresa non viene infatti colto subito nella sua carica dirompente di divisione sociale, di guerra “tra poveri”. Ma il dado è tratto. E dalla fine del 2010 si succedono le segnalazioni pubbliche, prevalentemente da parte dei genitori, ma anche da persone con disabilità “impegnativa”, che fanno a gara nel rappresentare con crudezza di particolari la “gravità” di quello che torna ostentatamente a chiamarsi “handicap”. 11 L’obiettivo generale, dunque, dopo la tempesta tremontiana, sembra essere non più l’emancipazione dalla disabilità3, attraverso percorsi guidati di “presa in carico”, di “riabilitazione”, di “vita indipendente”, ma al contrario l’accettazione dell’ineluttabilità di una “gravità totale”, non rimediabile, accertata una volta per tutte, in modo tale da non perdere il diritto, in tempi così cupi di difficoltà economica del Paese, a quei miseri emolumenti che comunque sono gli unici strumenti a disposizione per sopravvivere. Al di là degli aspetti più dichiaratamente etici, il caso limite di Eluana Englaro diventa – forse involontariamente - il paradigma, il punto di riferimento per dettare la linea dei provvedimenti economici, anche su scala regionale. Le persone in stato vegetativo sono assimilate a persone con disabilità “tout court”, e questa scelta paradossalmente accomuna i fautori dello “stato sociale” e della “solidarietà compassionevole”. Tutti coloro che si emancipano, partendo da situazioni di invalidità certificata al 100%, hanno ora la sensazione di essere “a rischio”, perché la loro acquisita parziale autosufficienza (patente di guida, attività lavorativa, formazione di una famiglia autonoma) potrebbe comportare la perdita di benefici e di agevolazioni, nel quadro di un meccanismo di riforma dell’assistenza, che al momento è una scatola vuota, ma che, nel disegno concettuale elaborato dal “tremontismo”, conduce inevitabilmente al risparmio forzoso di cifre ingentissime. E’ lo scippo finale della speranza, del progetto di vita: è il danno ancora non quantificato di una manovra iniziata il 26 maggio 2010. Verso dove? Un’ultima riflessione è doverosa. Attribuire al solo ministro Giulio Tremonti la responsabilità complessiva, culturale e sociale, di un fenomeno così complesso e multiforme sarebbe 3. Interessante a questo proposito la sorte del cosiddetto “nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi”, che non viene aggiornato da tempo immemorabile (agosto 1999), e dunque non contiene, come ausili appropriati ed efficaci, i principali prodotti tecnologici di ultima generazione. L’utilizzazione di tecnologie compensative e assistive oltre a rappresentare un forte incentivo alla crescente autonomia di molte persone con disabilità fisica e sensoriale permetterebbe anche la crescita di un mercato produttivo nazionale non indifferente, nonché di uno specifico settore di ricerca. Si veda a questo riguardo l’ottima documentazione contenuta nel sito www.portale.siva.it (il portale sulle tecnologie per la disabilità e l’autonomia della Fondazione don Carlo Gnocchi) 12 azzardato e perfino ingiusto. E’ certamente vero che Tremonti (forse anche per una lettura non competente delle cifre della spesa sociale: una lettura “macro” che non teneva conto delle dinamiche della spesa determinate dall’invecchiamento della popolazione e dal conseguente allargamento delle prestazioni di invalidità a una fascia molto più ampia di cittadini rispetto alla effettiva popolazione disabile) ha colto un nervo scoperto, un punto debole, del sistema di welfare italiano costruito negli ultimi decenni. Un sistema farraginoso e burocratico, zeppo di norme e di aggiunte, di piccoli “privilegi” che nel tempo si sono stratificati spesso senza alcuna logica se non quella del soddisfacimento di interessi di lobby (sarebbe doverosa un’analisi precisa delle differenze di trattamento, a parità di situazione di disabilità, fra invalidi civili, non vedenti, non udenti, infortunati sul lavoro, e così via). La monetizzazione dell’handicap, in fin dei conti, fa parte della nostra “storia sociale” mai scritta per davvero, e una possibile rivoluzione culturale (ed economica) non può che passare da una completa revisione dei meccanismi di accertamento dell’invalidità, da una corretta ricognizione dei diritti essenziali delle persone con disabilità, da una seria valutazione dell’appropriatezza e dell’efficacia delle prestazioni. Per invertire la tendenza in atto, che sembra condurre a una nuova “medicalizzazione” ed “estremizzazione” dell’handicap, occorre riempire di contenuti riformatori e positivi la scatola vuota della appena accennata “delega governativa”, che sembra invece destinata a operare solo nella direzione di nuovi tagli ai servizi, forieri di emarginazione e ingiustizia. 13 Blog FrancaMente – Vita.it, 20 ottobre 2013 L’esercito di riserva dei diritti di Franco Bomprezzi Dio è morto, Marx è morto e anche io non mi sento troppo bene. Woody Allen aveva capito perfettamente il problema, tanti anni fa. Fra le mie (scarse) letture marxiane dei tempi universitari ricordo che mi colpiva assai la ragionevolezza della tesi relativa all’esercito di riserva del proletariato. Ossia, in estrema e volgare semplificazione, più persone sono espulse dal mondo del lavoro, più è facile per i padroni, in tempi di crisi, trovare un esercito di riserva pronto a subentrare, ovviamente a condizioni peggiori. L’attuale crisi (economica ma anche morale) sta dimostrando una sorprendente vitalità di questo passaggio ideologico, ma il guaio è che la tesi marxiana si sta estendendo al tema più vasto dei diritti di cittadinanza. Noto con raccapriccio il proliferare di guerre tra poveri, anzi tra poverissimi. La solidarietà è per così dire ormai su linee parallele. Nel senso che ognuno si rende conto che le proprie rivendicazioni (giovani, disoccupati, donne, disabili, persone mature espulse dal lavoro, e così via) potrebbero funzionare meglio se connesse alle altrettanto sacrosante rivendicazioni degli altri. Ma in effetti ognuno parla a se stesso, alla propria platea, a un pubblico da rassicurare e da convincere. Nel frattempo la legge di stabilità sta facendo passare, ad esempio, il primo caso di universalismo selettivo applicato scientificamente alla disabilità, ma puntando su un segmento fragile, quello delle persone che hanno superato i 65 anni di età. Sono tanti, certo, e costano. Dunque, trovare il modo di togliere loro in modo selettivo rispetto al reddito l’accesso all’indennità di accompagnamento è una operazione possibile senza eccessivi danni collaterali. In molti infatti penseranno che il famoso figlio di Agnelli (ma quale?) può benissimo fare a meno dell’indennità di accompagnamento qualora risulti invalido al cento per cento. Il punto è che il riferimento reddituale è ambiguo e furbetto, quarantamila euro lordi l’anno (70 mila se coniugati). In pratica si colpisce tutto il ceto medio dei lavoratori dipendenti che non possono evadere le tasse né eluderle, salvo arrivo in picchiata degli Stukas dell’Agenzia delle Entrate. Tutti gli altri, quelli che possono muoversi liberamente fra redditi in nero ed elusione fiscale, si troveranno dunque doppiamente premiati, perché continueranno a non 14 pagare il dovuto, e potranno accedere senza problemi a questa indennità, che è l’unico, ma proprio l’unico, rimborso risarcitorio forfetario per chi è in condizione di disabilità conclamata. Ecco, l’universalismo selettivo è davvero un concetto micidiale, nel sistema italiano, e non perché in teoria non se ne possa discutere, ma perché in pratica diventa il grimaldello per politiche sociali ingiuste e vessatorie nei confronti di chi non ha né voce né forza per protestare. Il guaio è che questa bella teoria piace molto agli intellettuali del welfare, spesso di sinistra, e si scontra con la realtà concreta delle famiglie. Non si capisce perché un’appendicectomia debba rientrare fra i diritti essenziali alla salute (e quindi universalmente garantita gratis a tutti) mentre una badante per un anziano che soffre di Alzheimer ed è invalido ovviamente al cento per cento, va pagata senza neppure l’aiuto dell’indennità di accompagnamento. Peggio ancora, questo provvedimento, se passerà, aprirà la porta ad una successiva e più ampia applicazione anche al di sotto dei 65 anni di età. Mentre tuttora attendiamo i Lea, i Liveas, e tutto ciò che in qualche modo possa definire in modo inoppugnabile quali prestazioni sociosanitarie siano davvero essenziali per tutti. Se questo è possibile lo si deve forse alla enorme consistenza dell’esercito di riserva dei diritti. Ossia il governo (ma soprattutto i burocrati che preparano i provvedimenti) sanno di poter contare sul silenzio-assenso di una ampia fascia di popolazione che ritiene (magari anche con qualche ragione) di essere ingiustamente penalizzata, dando la colpa proprio a questi “privilegi” delle persone con disabilità. Ecco perché anche io, a questo punto, non mi sento troppo bene. 15 Blog FrancaMente – Vita.it, 8 novembre 2012 Cinici e tecnicamente ignoranti di Franco Bomprezzi Non ce la faccio più. Ero pronto a scrivere, con la massima delicatezza possibile, di un tema complesso, anche dal punto di vista morale, come è quello dell’opportunità o meno di arrivare fino all’arma dello sciopero della fame da parte di coloro, come le persone con sclerosi laterale amiotrofica, che già sono in condizione di grave rischio per la propria esistenza. E poi leggo, fra incredulità e raccapriccio, la notizia che la Commissione Bilancio della Camera (vorrei scriverne qui tutti i nomi, ma mi limito a indicarvi il link dove potete leggerli con tutta calma) ha approvato all’unanimità (sic!) un emendamento alla Legge di Stabilità (altro sic!) che impegna l’Inps (terzo sic!) a 450 mila (quattrocentocinquantamila) controlli ai cittadini con certificazione di invalidità civile, nei prossimi tre anni, per sgominare il fenomeno delle false invalidità. Questo è troppo anche per me. Voglio scendere. Voglio andarmene. Questo Parlamento non è degno di governare il Paese. Lo si è capito da tempo, ma le vicende che seguo da vicino, ossia quelle legate alla sorte delle persone con disabilità e delle loro famiglie, sarebbero la “pistola fumante”, la prova evidente, la conferma anche per i più indulgenti. Proviamo ad andare con ordine, partendo dallo sciopero della fame, ossia dalla bolla mediatica che ha maledettamente complicato la questione del rifinanziamento del fondo per le politiche sociali e il fondo per la non autosufficienza. Un’altra Commissione, quella degli Affari sociali, ha cercato in qualche modo di rimettere ordine e soldi in un campo che era stato smantellato con scientifica e cinica protervia negli ultimi anni, svuotando tutti i fondi a disposizione, vanificando ogni possibile intervento coordinato attorno alle persone, attraverso i trasferimenti alle Regioni e ai Comuni. Inutile dire adesso quali cifre alla fine saranno davvero disponibili e in che modo saranno finalizzate. Ogni giorno il balletto degli emendamenti cambia il quadro di riferimento. E’ ragionevole pensare che in qualche modo ci sarà di nuovo un fondo per le politiche sociali e anche un fondo per la non autosufficienza. Il primo fondo, però, riguarderà molte voci. Il secondo sicuramente risulterà insufficiente a rimettere in pista le leggi che pure ci sono. In questo quadro sconfortante ben si comprende l’angoscia delle famiglie, specie quelle in cui si manifestano le situazioni di maggiore gravità. Da qui nascono le iniziative dei comi16 tati, sganciatisi dal movimento delle grandi associazioni nazionali (anzi, in molte situazioni agendo in aperto dissenso con i metodi seguiti da Fish e Fand). Da qui parte il tam tam, attraverso la rete dei blog e dei social network, che porta alla diffusa scelta dello sciopero della fame. Una patologia in particolare, la sclerosi laterale amiotrofica, conquista la scena mediatica, grazie al carisma di alcune persone e all’efficacia indubbia di un messaggio che in tivù spacca alla grande. Una persona la cui testa funziona ancora benissimo, ma che si può esprimere solo con la sintesi vocale di un computer, ed è attaccata a un ventilatore polmonare, a letto o su una sedia a rotelle, smuoverebbe il cuore anche di un serial killer in pensione. Il messaggio che è passato, anche grazie alla mobilitazione di grandi firme televisive e giornalistiche, è più o meno questo: tirate fuori i soldi per queste persone, non è possibile che non si trovino “poche centinaia di milioni di euro”. Fate finire questa tortura, non la possiamo tollerare. L’equivoco è servito ad ora di cena. L’opinione pubblica giustamente si commuove, prende parte. Attenzione: è tutto vero. Stiamo parlando di situazioni effettivamente gravi, che richiedono un welfare competente e responsabile, nel territorio, con servizi domiciliari, aiuti economici, solidarietà attiva, rispetto dei diritti. Il fatto è che la situazione di gravità non riguarda poche decine, o centinaia, di persone “malate”. E’ la situazione nella quale vivono almeno centocinquantamila persone in Italia, all’interno della più vasta condizione di reale disabilità, magari meno impressionante e grave, che tocca qualche milione di cittadini (mi rifiuto di fare gli elenchi per patologia). Non c’è niente da scoprire, non si dovrebbe arrivare alla commozione, alle lacrime dei ministri (sempre gli stessi). Questo è un grande Paese civile, che ha saputo negli anni passati produrre leggi e sistemi organizzati di gestione dei servizi sociosanitari assolutamente in grado di affrontare, abbastanza bene (si può fare sempre meglio) le situazioni come quelle note a tutti in queste convulse settimane. Adesso si è di fatto scatenata una misera e deplorevole guerra tra poveri e poverissimi. La gara è a chi sta peggio, perché in questa scala dell’orrore i gradini sono ripidi e infiniti. Un baratro che ci fa ripiombare indietro di trent’anni, rispolverando quel solidarismo compassionevole che speravamo sepolto e abbandonato ormai in modo definitivo, in favore di una politica ragionevole basata sull’individuazione corretta dei bisogni coniugata sulla base dei diritti essenziali di cittadinanza e di pari dignità. 17 Ecco perché, al pari di Anffas, ero preoccupato per le implicazioni morali e pratiche di questa strada intrapresa con lo sciopero della fame. Ecco perché sono sempre stato d’accordo con il metodo seguito in silenzio da Fish, la Federazione Italiana per il superamento dell’handicap, con il lavoro assiduo ad esempio di Pietro Vittorio Barbieri e di Carlo Giacobini, che cerca di arginare le fesserie parlamentari, attraverso una fitta e competente documentazione normativa, non limitandosi alla protesta pubblica (che pure c’è stata, e massiccia, il 31 ottobre scorso), ma puntando a proporre soluzioni, a fornire analisi economiche, proiezioni di dati, simulazioni corrette dell’impatto di ogni norma sulla reale situazione del Paese e delle persone con disabilità. Solamente se rimaniamo uniti si vince (forse). La disunione è disastrosa e soprattutto è funzionale alla logica di un Parlamento ormai allo sbando, guidato da un Governo di falsi tecnici (altro che falsi invalidi…). E allora torno ai 450 mila controlli in tre anni. Siamo arrivati alla Stasi de “Le vite degli altri”. E’ una follia senza senso. Come spiega Carlo Giacobini (riporto un passo di una sua splendida nota che ho condiviso stamani su facebook): “Quindi: 800mila controlli dal 2009 al 2012 (già effettuati) + 450 mila controlli fra il 2013 e il 2015. Un milione e 250mila persone controllate. Il che significa che bisogna definire un nuovo campione di persone sospette. Gli invalidi civili sono circa 2 milioni e 200 mila tutti potenzialmente falsi. Dai figuri sospetti, in forza di una legge del 2007, vanno escluse le persone con patologie stabilizzate o ingravescenti. Logica vorrebbe che venissero esclusi anche quelli che sono già stati controllati in precedenza. E sarebbe altrettanto logico escludere dal controllo chi ha ottenuto il verbale dopo il 2007, cioè da quando le verifiche sono diventate una competenza del rigorosissimo INPS. Buon senso vorrebbe che venissero espunti dai sospetti anche gli ultraottentenni che generalmente sono affetti da gravi malattie degenerative, tanto evidenti quanto incontestabili. E gli ultraottantenni rappresentano da soli il 50% dell’universo. Rimane quindi il dubbio inquietante di come INPS costruirà il nuovo campione di 450 mila persone senza violare la legge (ma questo non sembra mai rappresentare una remora per l’Istituto), ma soprattutto per risultare agli occhi dei suoi mandanti politici, come efficace e rigoroso”. E Giacobini dà una risposta a questo dubbio, che io condivido in pieno: si farà in modo di spacciare una sistematica riduzione dei benefici spettanti agli invalidi veri (attraverso ad esempio la riduzione d’ufficio della percentuale di invalidità in precedenza correttamente riconosciuta) come se fosse una vera campagna contro le false invalidità. Il tutto con la conseguenza rovinosa di ricorsi (persi), e di costi per commissioni mediche altissimi, e quindi con un risparmio ridicolo per il bilancio dello Stato, come già è ampiamente documentato per quanto riguarda i controlli sin qui effettuati. 18 Dovrebbero vergognarsi, e andarsene al più presto. Spegnendo la luce per risparmiare. Cinici e tecnicamente ignoranti. E colpevoli i giornalisti che gli vanno dietro come pecore. Troppi e altrettanto ignoranti. 19 Blog InVisibili, 1 luglio 2013 Quando l’Inps “aggrava” l’invalidità di Franco Bomprezzi Avete letto bene. A volte l’Inps “aggrava” l’invalidità delle persone. Ma non nel senso che immaginate: nessun aumento di spesa sociale per pensioni di invalidità o indennità di accompagnamento. Quella che viene aggravata è l’invalidità dei cittadini che devono intraprendere l’iter per la certificazione e si trovano a percorrere un iter tortuoso, spesso un vero gioco dell’oca, tra ritardi, convocazioni doppie, sospensioni delle prestazioni, sorprese e imprevisti. Lo avevamo già scritto pochi giorni fa, commentando le cifre fornite dalla Fish, la Federazione Italiana per il Superamento dell’handicap. Lo confermiamo adesso scorrendo le tabelle della documentatissima indagine realizzata da Cittadinanzattiva e raccontata assai bene da Maria Giovanna Faiella nel canale disabilità di corriere.it . Mi sembra interessante notare come la situazione sia particolarmente critica per un ben preciso segmento di persone: i malati oncologici e le persone affette da malattie rare. Non stiamo parlando dunque davvero di “falsi invalidi”, ma di cittadini (e di parenti) alle prese con una emergenza imprevedibile (un tumore) o con la certezza di una guarigione impossibile (malattie rare croniche e congenite). Ecco, in questi casi lo Stato, e chi ne svolge le funzioni, dovrebbe interpretare il welfare nel migliore dei modi, anche dal punto di vista dei tempi, e dello stile. E invece succede che le persone a volte muoiano prima di vedere riconosciuto il diritto a prestazioni di tipo assistenziale che sono strettamente connesse al presupposto della certificazione di invalidità civile. Fa effetto ad esempio leggere che i medici dell’Inps sono spesso assenti nelle riunioni delle commissioni delle Asl, di cui pure fanno parte in modo determinante, visto che la loro assenza determina spesso la necessità di una seconda visita, con costi e disagi del tutto evidenti ed evitabili. E lo dice la Corte dei Conti, non un’associazione di parte (ammesso e non concesso che le associazioni di tutela delle persone con disabilità possano essere considerate una controparte e non piuttosto un interlocutore importante proprio perché interessate ad evitare sprechi e attribuzioni indebite di denaro pubblico). Naturalmente anche le Asl ci mettono del loro, visto che l’informatizzazione delle pratiche procede a rilento, e dunque 20 vanifica, almeno in parte, l’obiettivo ambizioso dichiarato dall’Inps di utilizzare solo procedure informatiche per snellire la burocrazia e garantire la massima trasparenza. Il punto centrale di questa complessa vicenda è che l’obiettivo dello Stato non dovrebbe essere quello di “risparmiare” su questo tipo di spesa facendo di tutto per scoraggiare i cittadini che si limitano ad esigere un diritto fondamentale, sottoposto giustamente a una severa procedura di controllo. Lo Stato dovrebbe pagare il giusto, e farlo nei tempi corretti, senza ritardi, senza piccole o grandi vessazioni nei confronti dei cittadini. C’era una commissione parlamentare di indagine sui tempi e sulle modalità della certificazione d’invalidità. Forse è il caso che si proceda rapidamente a concludere questo controllo pubblico e adottare poi provvedimenti univoci e chiari, nell’interesse di tutti. Anche perché all’interno dell’Inps – va detto – ci sono persone spesso competenti e appassionate che vivono con crescente disappunto una situazione che comporta, quanto meno, un appannamento dell’immagine di un istituto di fondamentale importanza per la serenità delle famiglie italiane. 21 Blog FrancaMente – Vita.it, 18 settembre 2012 I mendicanti dei diritti di Franco Bomprezzi C’è una nuova violenza nell’aria. Ci riguarda. Tocca un po’ tutti coloro che per necessità o per attenzione abituale si occupano di welfare, di diritti e di servizi. Le cronache quotidiane, le conversazioni private, le storie che conosciamo da vicino, ci raccontano di una progressiva – quasi ineluttabile – questua sociale, pubblica ma anche individuale, per ottenere prestazioni o servizi che fino a ieri consideravamo patrimonio comune, acquisito non solo per legge, ma perché giusto in sé. Non sono uno studioso di economia e neppure di diritto, e dunque avrei bisogno del supporto e della documentazione competente per riempire di sostanza una mia impressione, peraltro forte e netta. Si fa strada un modo di argomentare, del tutto trasversale politicamente e culturalmente, che tende a dare forza e valore a tutte quelle azioni positive che portano comunque a un risparmio, a una minore spesa, a una riduzione dei costi presenti e futuri. Mi direte: è giusto! E’ importante in tempi di crisi puntare al risparmio, alla spesa oculata, al contenimento degli sprechi. Verissimo. Ma è un argomento che andrebbe rigorosamente staccato dal tema dei diritti essenziali. Se un Comune deve tirare la cinghia per i servizi sociali, non è che per questo motivo il diritto all’assistenza domiciliare, all’assistente educativo a scuola, o al trasporto, diminuisca in sé. Il diritto resta inalterato, solo che diventa di fatto non esigibile, almeno non come prima. E qui inizia il calvario delle persone, delle famiglie. Una corsa affannosa a cercare di mantenere in piedi la propria esistenza, la rete dei servizi essenziali attorno ad esempio a una persona con disabilità, o ad un anziano. E’ tutto un chiedere, un fare ricorso, un protestare, un disperarsi, un indignarsi. Una china della quale non si vede la fine, anzi. E’ una forma di violenza, per certi versi inaudita, perché va a toccare la dignità delle persone, la rispettabilità anche sociale delle famiglie in difficoltà. Trovo ad esempio curioso il ragionamento che ho letto di recente in una acuta analisi di Giorgio Fiorentini, a proposito di uno studio che dimostra come le persone con disabilità che fanno sport “costano meno in termini di salute”, perché si ricoverano con minore fre- 22 quenza, e ricorrono meno ai servizi onerosi di riabilitazione funzionale. La conseguenza “morale” è che lo sport non diventa più una libera scelta fra tante, una opportunità da cogliere se lo si desidera o comunque se si hanno le attitudini necessarie. Lo sport diventa “utile economicamente” e quindi va diffuso per questo. Ho letto spesso persone con disabilità argomentare – in assoluta buona fede e con buon senso pratico – che un progetto di vita indipendente, a casa propria o comunque non finendo in servizi residenziali per disabili, è preferibile rispetto alla tradizionale assistenza “perché costa meno”. Il che è sicuramente vero. Ma il punto è che il diritto primario è quello alla vita indipendente. Poi si valuteranno i costi migliori, e il rapporto fra efficacia e convenienza. Nel campo degli ausili per disabili, nel recente convegno per i trent’anni dell’ausilioteca di Bologna, ho sentito più volte una preoccupazione analoga: sappiamo bene che gli ausili, specie quelli tecnologici, sono fondamentale per dare strumenti di vita e di comunicazione alle persone con disabilità. Ma anche qui la “spending review” conduce a forzature pericolose. E’ la cultura del “pressappoco”: un ausilio vale più o meno come l’altro, quindi è “giusto” prescrivere e autorizzare solo quello che costa meno. L’invasione delle carrozzine dall’estremo oriente, tanto per dire, è uno dei frutti avvelenati di questa dissennata convinzione. Basso costo, ma spesso anche infima qualità. Ma a chi interessa? E qui torniamo al tema dei “mendicanti di diritti”. E’ insopportabile una società che nei confronti dei più deboli, e di chi ha bisogno di strumenti appropriati per tutelare i propri diritti di cittadinanza, usi sempre e comunque l’argomento del denaro, e la domanda: “Sì, ma quanto ci costa?”. Che poi diventa, cinicamente: “Ma TU quanto ci costi?”. 23 Vita, aprile 2013 Caro Fontana,… di Franco Bomprezzi Caro Fontana, anzi, caro Alberto. Siamo amici da troppo tempo perché io possa rivolgermi a te per cognome. Abbiamo vissuto insieme, prima nella Uildm, l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, e poi anche assieme alla fondazione Telethon, il grande e lungo viaggio della ricerca italiana per sconfiggere le malattie genetiche. Ricordi? All’inizio, tanti anni fa, Telethon finanziava progetti di ricerca destinati esclusivamente a cercare la cura delle distrofie muscolari. Un obiettivo importante, ma che si scontrò, rapidamente, con la progressiva, dirompente consapevolezza che il mare vasto delle malattie genetiche non consentiva, dal punto di vista morale, ma anche in una corretta posizione di tipo scientifico, di limitarsi egoisticamente a un unico ceppo di mutazioni genetiche. Con un atto lungimirante di enorme generosità (che con grande pudore non è mai stato esibito come motivo di merito) la Uildm decise autonomamente di modificare questo obiettivo, e di consentire la crescita, l’organizzazione, la costruzione autonoma di una Fondazione autorevolissima dal punto di vista scientifico, trasparente nella gestione dei finanziamenti ricevuti dagli italiani, efficiente nei meccanismi di selezione dei progetti meritevoli, attenta a quanto avviene nel mondo, e non solo in Italia. Ti scrivo, caro Alberto, perché soltanto il tuo spirito di servizio poteva condurti ad un dialogo manipolato chiaramente (lo dico da giornalista che conosce i meccanismi del taglio dei servizi televisivi), quasi una trappola delle Iene, che di fatto hanno cercato di mettere sullo stesso piano due realtà del tutto incommensurabili, non solo scientificamente, ma anche eticamente, come Telethon e Stamina, rappresentata dallo psicologo Davide Vannoni. Ho sofferto, e lo sai, vedendo con quanta fatica cercavi di spiegare un concetto elementare, ma che nulla ha a che vedere con la questione di fondo, ossia la validità del metodo Stamina, non comprovata da nessuno. Tu volevi rappresentare, e ci sei riuscito, lo stato d’animo di tutti coloro che vivono sulla propria pelle gli esiti di una malattia genetica. Sai bene come i genitori cerchino, giustamente, di fare qualsiasi cosa pur di lenire le sofferenze e costruire una speranza di guarigione per i propri figli. Ci sono due strade, entrambe comprensibili. Ci sono coloro che comunque ritengono doveroso preservare le proprie creature da tentativi 24 incerti e non validati di cura, nel timore, legittimo, che si possano manifestare complicazioni o successivi danni collaterali, tali da compromettere o vanificare anche i primi, possibili miglioramenti di una cura sperimentale. E ci sono altri che ritengono le cure compassionevoli un tentativo necessario, indipendente persino dalla sua effettiva efficacia, sperando che dal calcolo delle probabilità e dal gioco del destino venga fuori il jolly di una quasi miracolosa guarigione, al di là e indipendentemente dal rispetto delle procedure e dei protocolli scientifici della ricerca. Entrambe le categorie di genitori meritano rispetto, considerazione, compassione, nel senso etimologico del termine. Ma se noi oggi siamo vivi, caro Alberto, lo dobbiamo ai nostri genitori che hanno preservato, come bene primario e inalienabile, il nostro diritto a vivere così come siamo, ben consapevoli delle nostre difficoltà, e del deficit che avrebbe comunque reso difficile il cammino delle nostre vite. Io con l’osteogenesi imperfetta, tu con l’atrofia spinale, e tanti altri con mille difficili nomi di malattie rare e rarissime, quanto, spesso, crudeli. I tempi della ricerca seria sono lunghi. Il primo motto di Telethon era infatti “nella ricerca la speranza”. Lo cambiammo - ricordi? - in un altro, molto più impegnativo: “Nella ricerca la certezza”. E questo patto fra i familiari, le piccole e grandi associazioni delle persone con malattia genetica, e i ricercatori raccolti attorno alle bandiere di Telethon, ha fatto sì che nel nostro Paese, come in Francia e negli Stati Uniti, si arrivasse a risultati inimmaginabili, non solo per la qualità della ricerca finanziata, ma anche per gli esiti nel campo della ricerca clinica, dopo un primo decennio dedicato fondamentalmente alla ricerca di base, quella che interroga e cerca di svelare i meccanismi delle mutazioni cellulari, prima ancora di esplorare il terreno delle possibili terapie. In questo scenario irrompe in qualche modo una sorta di “grillismo” della comunicazione sulle malattie genetiche. Una radicale sfiducia nelle istituzioni di qualunque tipo, l’esaltazione dell’esperienza di base “non competente”, l’eroismo delle mamme, l’uso spregiudicato delle telecamere e delle testimonianze personali, la costruzione di una possibile alternativa taumaturgica, alla quale affidare speranze acritiche. Il tempo, caro Alberto, ci darà le risposte giuste, quelle vere. Per ora io vorrei solo che ogni vita, ogni bambino con malattia genetica, sia rispettata e coltivata come una pianta unica e irripetibile. Con amore, senza mai usarla per altri fini. Ti abbraccio. 25 I servizi per la disabilità 26 Vita Magazine, 8 novembre 2013 Includere è più di integrare di Franco Bomprezzi Forse è la stanchezza. Forse la routine. Forse anche la difficoltà a trovare tempo per riflettere, per pensare e ripensare a quello che si fa, ogni giorno, da anni, per lavoro. All’inizio, certo, anche per passione. Poi, mitridaticamente, la passione cede il passo al mestiere, agli aggiustamenti, alle abitudini che funzionano, a cominciare dalle parole, dai gesti, dal modo di salutare, di accompagnare, di accogliere. Non è facile oggi ragionare su come funzionino, realmente, i servizi sociosanitari destinati a fornire risposte alle persone con disabilità in termini di Inclusione, con la “I” maiuscola, quella che si dovrebbe accompagnare naturalmente alla parola che rappresenta la pietra angolare del castello concettuale attorno al quale si è costruito il complesso ordinatorio e propositivo della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. L’inclusione infatti non è una generica integrazione, e neppure un altrettanto generico servizio dedicato. Inclusione significa mettere ogni persona con disabilità in condizione di interagire con l’ambiente nel quale vive, di scegliere il proprio progetto di vita, di muoversi liberamente, in casa e fuori, di partecipare alla vita sociale, lavorativa, culturale, sportiva. Proprio come tutti. I servizi dovrebbero seriamente ripensare se stessi alla luce di questo faro che illumina la strada e mette in rilievo anche gli ostacoli sul terreno e le tante ombre che rendono il percorso poco sicuro. Non è giusto generalizzare, e neppure citare una Regione o un Comune. Esistono infatti buone prassi disseminate qua e là, frutto delle persone che ci credono, che non si accontentano mai, che si interrogano sui risultati, che chiedono il parere alle famiglie e a chi usufruisce dei servizi. Ma la sensazione evidente a molti è che tanti servizi, nati per liberare energie e potenzialità delle persone con disabilità, nel tempo si siano ingessati, cristallizzati, chiusi in se stessi, magari realizzando cose magnifiche, ma senza raggiungere l’obiettivo dichiarato dell’uscita dal servizio per entrare nella normalità della vita. Penso ai centri diurni, ai servizi di terapia occupazionale, alla stessa assistenza domiciliare, per certi versi vissuta come un badantato ridotto all’osso. Ma è naturalmente nelle residenze che il problema emerge in tutta la sua complessità, sia per la compresenza nelle strutture destinate a ospitare persone con disabilità di soggetti molto diversi, per situazione fisica, sensoriale o intellettiva. Tutti insieme appassionata27 mente, spesso dovendo fare i conti con personale ridotto all’osso, specie per quelle figure che farebbero la differenza, proponendo attività capaci di motivare e di ricostruire le esistenze. Il modello va ripensato, anche quando funziona. E spesso non funziona, nonostante l’ingente impegno di risorse pubbliche e private, perché spesso quelle pubbliche comunque non bastano. Difficile comprendere in questo quadro quanto i responsabili dei servizi destinati alle persone con disabilità, a tutti i livelli, si stiano davvero interrogando in questo lungo periodo di trasformazione non indolore del welfare e delle politiche socio assistenziali, circa le caratteristiche di inclusività del loro lavoro, alla luce della Convenzione Onu e non solo. Non mi pare di cogliere elementi sostanziali di novità culturale, quanto piuttosto, per ora, soprattutto un tentativo di declinare i servizi sulla base delle indicazioni fornite dall’ICF, ossia la classificazione funzionale della disabilità elaborata dall’Oms. C’è sempre, sotto traccia, una visione sanitaria dell’approccio al servizio per le disabilità, che è in netto contrasto con la definizione fornita dalla Convenzione, che insiste giustamente sul concetto di relazione con l’ambiente, con gli ostacoli, con il contesto sociale, culturale ed economico. In questo periodo sono dunque le associazioni delle persone con disabilità, soprattutto a livello di quadri dirigenti, ad aver compiuto un salto di qualità importante, nella definizione degli obiettivi, ma anche nelle modalità di interlocuzione con le istituzioni territoriali, dal Comune alla Regione passando per le Province che continuano a rappresentare, al momento, un riferimento ineludibile su alcuni servizi fondamentali. La Convenzione Onu sta seminando lentamente nelle coscienze il germe del dubbio, del pensiero critico e libero. E penso che fra qualche anno vedremo i frutti di una rivoluzione culturale che ancora cova sotto la cenere dell’esistente. 28 WelfareOggi, n°5 2012 Stereotipi sulla disabilità – il catalogo è questo Intervista a Franco Bomprezzi sui luoghi comuni più diffusi sulla disabilità A cura della redazione di WelfareOggi “Il disabile eterno ragazzo” Questo stereotipo deriva da un ragionamento che nasce e si consolida all’interno delle famiglie specie quando la tutela da parte dei genitori è molto assidua e per certi aspetti necessaria: penso, ad esempio, ad alcune forme di disabilità di tipo intellettivo o motorio tali da comportare la non autosufficienza. L’impossibilità di comunicare in modo autonomo o di muoversi liberamente da soli fa si che i genitori continuino a vedere il proprio figlio con disabilità come un bambino anche a 40 anni e oltre. In questo stereotipo si ritrovano tutti, anche diversi operatori dei servizi che spesso hanno nei confronti delle persone disabili un atteggiamento anche involontariamente paternalistico o amichevole. Si tende, ad esempio, a: dare del “tu” anche quando si conosce appena la persona senza nemmeno porsi il problema se questo le faccia piacere o meno, ad usare un linguaggio infantile, ad enfatizzare anche nel comportamento gesti e situazioni che appartengono all’accudimento della persona quando è in età infantile o adolescenziale. Una persona disabile diventa adulta, esattamente come tutte le persone, dopo lo sviluppo adolescenziale e di conseguenza dovrebbe modificarsi sia il linguaggio che il comportamento. Queste situazioni possono suscitare irritazione o divertimento nelle persone disabili. Io stesso a volte mi sono sentito trattato e considerato come se fossi un ragazzino… questa cosa può farmi anche piacere visto che ho quasi 60 anni, ma ovviamente non è esattamente il massimo. 29 Il disabile è meglio che non si metta in gioco, poi si fa aspettative che non riesce a reali zzare e soffre” Anche questa è una delle situazioni più frequenti specie in una mentalità di tipo assistenziale. La disabilità molto spesso viene connotata in negativo, partendo da un’analisi che applica i criteri diagnostici delle classificazioni che derivano dall’ambito medi- co/sanitario/riabilitativo, cioè della persona disabile si coglie ciò che non c’è o ciò che non funziona: i deficit, la malattia, l’incapacità, l’immobilità. Già all’origine, può succedere che la famiglia e gli operatori che interagiscono con lei tendano a sottolineare sempre lo stato di handicap, non le capacità, le potenzialità, le aspirazioni che hanno a che fare con un progetto di vita. Davanti a questa situazione lo stereotipo del “non mettersi in gioco” è del tutto evidente. Nella logica inclusiva alla quale cerchiamo di fare riferimento, ogni persona dovrebbe essere messa in condizioni di avere progetti, idee a cui tendere per costruire un senso alla propria esistenza, basato sulla piena accettazione della situazione fisica o intellettiva, sensoriale che ha determinato una situazione di disabilità. Per questo è necessario mettersi in relazione con una sfida con l’ambiente, con eventuali altri interlocutori che possono essere di volta in volta la scuola, un ambiente sportivo, culturale, associativo, il lavoro, gli affetti…. tutto quello che è il mondo normale. E’ fondamentale che la persona disabile, come tutti, abbia la possibilità di “mettersi in gioco” anche a rischio di “sbattere la testa contro un muro” e di avere delle delusioni. Uno degli aspetti dell’atteggiamento protettivo di famiglie e di alcuni operatori è la tendenza a fare in modo che la persona disabile non corra rischi emotivi, sia in qualche modo protetta dalla possibilità di rendersi conto drammaticamente della differenza tra sé e gli altri derivante dalla disabilità e che potrebbe pregiudicare la sua serenità. Ora, questo è un rischio che ognuno corre nella propria vita, indipendentemente dalla presenza di una forma di disabilità o meno: ci sono aspirazioni e ambizioni in ognuno di noi che spesso si scontrano con la realtà o con situazioni che non ne consentono la realizzazione. Sono le famose prove della vita dalle quali ognuno può uscire, dopo averle sperimentate, rafforzato e più adulto …. Molto dipende dal carattere personale, dalle abitudini, ma anche dall’ambiente e dalle relazioni sociali e culturali nelle quali si è inseriti. 30 “Il disabile da compatire” Questo stereotipo racchiude un’idea ben precisa, in parte anche vera: la disabilità è una situazione non desiderata, non voluta che ha in qualche maniera rovinato l’esistenza, l’ha indebolita, l’ha resa più fragile. Si pensa che l’empatia, lo stabilire un rapporto di condivisione di un’ipotetica sofferenza da un lato fa star meglio chi opera sul campo e dall’altro vuole essere una forma di solidarietà. Il fatto è che una persona disabile non vuole affrontare la propria disabilità in questo modo, ma vorrebbe esattamente il contrario: superarla, prenderla per quello che è, cioè una delle possibili situazioni della vita, quella che ti è capitata, quella che ti connota, ma che alla fine devi gestire nella migliore modalità possibile. Come dire, la condivisione che passa attraverso il compatire che vuol dire “soffrire insieme” è assai difficile da realizzare per il semplice motivo che in realtà “non si soffre insieme” ed è una forma di non voluta ipocrisia che non aiuta minimamente a migliorare la situazione. La compassione è proprio un sentimento da evitare nel senso che non ce n’é bisogno. C’è invece bisogno di comprensione, di attenzione, di competenza, di amicizia,… . Spesso si crede di provare empatia, mentre al massimo si arriva alla simpatia. “Il disabile è un esempio per tutti, ci dà forza rispetto a come affronta la propria cond izione di malattia” Ci sono due conseguenze rispetto a questo atteggiamento. Una è la convinzione che la disabilità sia una forma di eroismo, di capacità e potenzialità enormi e l’altra è collegata alla parola “disabilità”, diversa abilità, come se essa fosse una scelta e su questa scelta ci fossero delle capacità individuali che siano in qualche maniera determinate proprio dall’handicap. C’è il luogo comune, ad esempio, che i ciechi abbiano una sensibilità maggiore rispetto alle altre persone; in realtà non è detto: sviluppano, ovviamente, meglio gli altri sensi rispetto ad una persona che vede e che atrofizza in parte le altre capacità sensoriali. E’ come per una persona con disabilità motoria: non necessariamente è più intelligente, più capace, più coraggiosa. E’ evidente che ogni persona vive e cerca ragionevolmente di utilizzare al meglio le abilità che è in grado di sviluppare se opportunamente stimolato, orientato, istruito e formato. La disabilità in sé non è una condizione né di superiorità, né di inferiorità, è una condizione di 31 differente esistenza determinata da un deficit il cui peso può essere maggiore o minore a seconda del contesto nel quale si sviluppa. Il problema è che non c’è una cultura inclusiva. Considerare una persona disabile in qualche maniera migliore, superiore o più forte, comporta diversi rischi. Può caricare di una responsabilità eccessiva questa persona alla quale si chiede sempre qualcosa di più o dall’altra parte, paradossalmente, come sta succedendo spesso, può indurre le persone disabili ad affrontare la vita esattamente con questo spirito quasi ipercinetico: cioè sono talmente coinvolte nel meccanismo sociale che si è creato da favorire proprio lo sviluppo di questo stereotipo e da cercare di dimostrare ovunque di essere migliori degli altri e di non essere disabili. Per esempio sento tante volte dire “no, no mio figlio non è una persona disabile, è una persona speciale”: in questo modo si fa torto all’intelligenza di chiunque perché la disabilità non è una malattia della quale vergognarsi, è una condizione oggettiva di cui deve essere tenuto conto per organizzare al meglio il proprio progetto di vita. “Il disabile asessuato” Su questo stereotipo sono stati spesi fiumi di parole. La verità è esattamente il contrario: la persona con disabilità non è asessuata: è un uomo, una donna o può ovviamente anche avere una sessualità differente. Come ognuno, anche il disabile si confronta sul tema dell’amore, degli affetti e della sessualità dopo l’adolescenza e proprio l’impossibilità di avere una normale relazione affettiva o sessuale rappresenta il vero handicap, perché su questo tema rischia di naufragare qualsiasi progetto di vita autonoma e indipendente e in grado di risultare appagante, motivante e positiva. Questo è uno dei temi più delicati da affrontare. Le famiglie fanno fatica in generale a pensare i propri figli come persone che si staccheranno dalla famiglia perché si costruiranno una loro vita affettiva e quindi a maggior ragione quando i propri figli presentano una disabilità, le famiglie mettono in atto atteggiamenti di protezione assoluta e tendono a nascondere, soffocare ed ignorare questo tema oppure a risolverlo con modalità inappropriate e qualche volta perfino non raccontabili … spesso riguardano la disabilità intellettiva, ma non solo. Questo stereotipo contiene uno di quei tabù rispetto al quale soltanto un’educazione alla sessualità e all’affettività può modificare il quadro di riferimento e aiutare a cambiare le cose, ma è un lavoro lungo di generazioni. 32 Non è un aspetto che si può risolvere con facilità se non attraverso le singole situazioni. Esistono per fortuna, rispetto allo stereotipo, tantissime dimostrazioni del contrario e quindi occorre una capacità di raccontare, senza esibizionismo, in maniera semplice e corretta che si può vivere la disabilità e anche la propria sessualità in maniera normale, ovviamente tenendo conto della propria situazione e con grande rispetto della dignità della persona. 33 Blog InVisibili, 5 luglio 2013 La vita di Rita: in sedia a rotelle, in una casa con sessanta anziani di Franco Bomprezzi Si chiama Rita. Non la conosco personalmente. Mi ha scritto una mail incredibile. «Vi racconto brevemente la mia vita – è l’esordio –, vorrei che questo scritto lo leggessero in tanti. Volevo fare un libretto, ma è troppo breve. Mi auguro che succeda qualcosa per me o per i futuri disabili anziani». Sono rimasto colpito, affascinato dalla capacità di questa donna di condensare in poche frasi, scritte con semplicità e qualche errore, una condizione umana vera e profondamente ingiusta, quella delle persone con disabilità che, diventando anziane, vengono private della loro autonomia e libertà, e inserite in strutture per anziani che assomigliano a un ospedale, e neppure lo sono. Provo dunque a restituirvi la sua storia, limitandomi a correggere solo qualche piccolo errore (ma il testo è il suo). Leggetela attentamente. Vi riguarda di sicuro. «Ero una giovane ragazza. Lavoravo, studiavo alla sera ed ero fidanzata, vivevo la vita del momento con l’esuberanza, l’allegria e la pazzia della gioventù, ma tutto finì in una tragica sera d’autunno. Ero in macchina con un amico e successe l’incidente. Fui trasportata in ospedale già in coma e più di là che di qua. Tutto ciò che subii mi è stato solo riferito. Ma la mia fortuna è che ho testa e cuore forti e superai quei brutti momenti. Molti in coma vedono luci e sentono voci, invece io non ricordo nulla, proprio nulla. I mesi e le stagioni passavano. La mia casa era il letto, girai per cure diversi posti, poi approdai a Messina. Io di Milano mi trovavo nel Sud. Doveva essere per pochi mesi e fu invece per parecchi anni. Per un po’ di tempo fui considerata una “novità”, poi fui ben accettata dagli amici coi miei pregi e difetti. Non cammino, ho difficoltà nel parlare. Mi portavano a vedere le bellezze della Sicilia e lo splendido mare. Imparai un po’ di siciliano, ma facevo solo sorridere. Intanto anni e giorni passarono, a volte ero allegra, a volte triste, a volte molto nervosa. Poi le cose cambiarono: negli ultimi anni non mi andava più bene la “casa famiglia” a Messina, decisi di tornare al Nord anche per essere più vicina ai miei, che non erano più ragaz34 zini. Mi sobbarcai trasloco e viaggio da sola, non avevo parenti a Messina per un aiuto. Ero diretta a una “casa famiglia” vicino a Bologna, l’unica che mi accoglieva. Pur avendo i miei problemi, riuscii ad inserirmi e a crearmi una certa indipendenza, col personale avevo un ottimo rapporto di simpatia e amicizia. Ma anche lì, dopo qualche anno, molte cose cambiarono. Era l’annuncio di una catastrofe; infatti andò tutto a catafascio, sorvoliamo sui motivi. Mi trovai nella necessità impellente di trovare una sistemazione per colpa del Comune e della “casa famiglia”. Ero al verde: con quello che avevo in banca pagavo la retta, e l’unica soluzione, ormai, erano i tanto odiati da me “istituti per anziani”. Ecco quindi una disabile anziana ricoverata tra anziani. Fui accolta benissimo: la struttura è tenuta bene, pulita, ordinata. Ma non è adatta a disabili che vogliono essere un po’ indipendenti. Ero troppo abituata a vivere con pochi disabili, ora fra tanta gente mi trovavo – e mi trovo – persa. Mi sono già creata il mio mondo, grazie ai due fratelli titolari che me lo hanno permesso, però la situazione è un po’ dura per me. Qui hanno tutti molto bisogno di assistenza. Sono circa sessanta persone, per cui una che fa da sé (come nel mio caso) a volte mi pare che sia un po’ messa da parte in alcune cose per me importanti. Anche la stessa stanza era molto personale, non come qui che pare la copia di una camera di ospedale e con mobilio poco adatto a una che si muove da sola in carrozzina. Faccio degli esempi pratici: il porta-carta che uso per asciugare le mani, per me seduta in carrozzina, è troppo alto, ci arrivo a fatica. Ma l’altezza è giusta per le operatrici che aiutano le altre ospiti. Qui il dentifricio non c’è, non lo usano, hanno quasi tutte la dentiera. Per il bagno e le lenzuola ha la precedenza chi si sporca di pipì o cacca… Io non ero prevista qui, e ciò ha portato, sia per me che per loro, dei problemi. Alla mattina alle 7 c’è l’alzata con il bidet fatto velocemente: a volte mi pare di essere alle prove delle corse automobilistiche a Maranello. Poi qui quasi tutte portano il pannolone e giustamente a certe ore di notte vanno cambiate. Ho pure problemi di sonno e di odore. Guai se vedono la finestra aperta: le vecchiette hanno freddo, ma io? Sento “odore di vecchio” dappertutto. Coricarmi subito dopo cenato non mi va: per fortuna ho il permesso di stare al computer (in camera) fino quasi alle 21. La mia vicina alle 19.15 circa dorme già, ma mi sveglia di notte, credo perché ho problemi di respiro, non l’ ho ancora capito. Alle 4 o alle 5 di mattina la alzano, dipende dalla flessibilità di chi è di turno di notte. 35 I due titolari cercano in tutti i modi di venirmi incontro, di accontentarmi. Ma hanno da badare ad altre sessanta persone. Li devo ringraziare, si chiamano Cristian e Omar. Ma io per queste comunità numerose ho sempre avuto poca simpatia, l’unica che ho conosciuto era il collegio in cui ero da piccola, quando mia madre morì. Ma ci durai poco, ero e sono un tipo ribelle. Se fai notare qualcosa che non va, dicono che non mi va mai bene niente. E poi mi innervosisce la paura che hanno di star male. Io, pur avendo una certa età, non mi sento “di vetro”, sono ancora piena di energia. So ancora distinguere ciò che posso fare da sola. Questi sono posti per persone che magari non camminano. ma per debolezza o anche perche la testa non è più come sessant’anni prima. Nel mio caso è tutto diverso perché ho vissuto con altri disabili abbastanza giovani, più di me di sicuro. Chi ritiene giusto che le persone disabili siano messe assieme agli anziani venga a rendersi conto! Ora confesso il mio grande desiderio: poter vivere per conto mio con la badante che dovrei pagare con la mia pensione, e non ce la farò mai, e decidere io senza dover chiedere e magari sentirsi dire “Ora non posso”. Per pagare una badante dovrei vincere al lotto o essere figlia di Onassis. Che succederà ora? Io ormai ho 70 anni, ma penso ai disabili futuri». Ecco. Grazie Rita. Le persone con disabilità, per i Servizi Sociali, vengono quasi sempre associate ai servizi per anziani quando compiono 65 anni. Perdono in questo modo il patrimonio della loro autonomia personale, e spesso la dignità. Vivono e sopravvivono, ma su di loro, troppo spesso, si compie un’autentica violenza. Lo hanno scritto con forza, poco tempo fa, la LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) e la Caritas Ambrosiana, in uno studio realizzato assieme al Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Milano [“La persona con disabilità diventa anziana. Riflessioni e proposte per garantire il diritto ad una serena vecchiaia alle persone con disabilità”, N.d.R.]. Una lettura importante, ancor più dopo questo racconto stupendo di Rita. Pensiamoci. 36 Blog FrancaMente – Vita.it, 17 agosto 2011 Una foto e lo stigma di Franco Bomprezzi Osservate bene questa foto. Che cosa vedete? C’è sicuramente una persona in sedia a rotelle, che si gira per parlare con due signori in piedi alle sue spalle. Sullo sfondo altre persone e si capisce che siamo in un luogo pubblico. L’uomo con la cravatta che si china leggermente verso la persona disabile è assai noto. Il signore accanto a lui, che sembra in quel momento spingere la sedia a rotelle, è abbastanza conosciuto. Meno del primo, ma comunque è sicuramente riconoscibile. La persona in sedia a rotelle spicca per essere meno elegante degli altri due, indossa una vistosa polo rossa, denota una pancia purtroppo non indifferente, e si capisce che fa un po’ fatica a parlare con i due in quella posizione non troppo confortevole. Questa foto, pubblicata su Facebook nella pagina “Giuliano Pisapia sindaco x Mi- lano“, fa parte di un album intitolato, in modo asettico: “Ferragosto con i cittadini: Centro Ricreativo Porta del Cuore”. La didascalia di questa immagine è assolutamente stringata e inconfutabile: “Pierfrancesco Majorino, Franco Bomprezzi e Giuliano Pisapia”. Inutile dire che il signore assai noto è Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, la persona abbastanza nota, che sembra spingere la sedia a rotelle, è l’assessore alle politiche sociali, Pierfrancesco Majorino. Il terzo, in sedia a rotelle, sono io. Chi mi conosce sa bene chi sono e che cosa faccio. Ma molti “fans” del sindaco probabilmente no. E così accade che si possano leggere, a corredo di questa foto, alcuni commenti particolarmente significativi. Li riporto (ovviamente non li giudico in alcun modo, mi limito a registrarli): “gesto lodevole..”, “Speriamo non sia solo retorica, tutti i sindaci nelle feste comandate vanno a trovare i meno abbienti…”, “un sindaco a ferragosto insieme ai disabili.…”, “Ke persona umana e sensibile!! Invece di trascorrere il ferragosto in localita’ balneari lo passa in una citta’ accaldata insieme alle persone ke soffrono…”. Ecco fatto. Sono tutti commenti positivi (per il sindaco). Ma so37 no tutti commenti che partono da una convinzione secca, precisa, neppure un attimo di dubbio: il signore in sedia a rotelle nella foto evidentemente è una persona che soffre, è un bisognoso, ed è bello che il sindaco abbia tanta sensibilità umana. Questa foto, con i relativi commenti, secondo me chiarisce in modo esemplare che cosa si intende per pre-giudizio, e per stigma sociale. Io, nell’immaginario collettivo, sono prima di tutto la mia carrozzina. Poi sono sicuramente una persona fragile, debole, sofferente. Solo chi mi conosce direttamente sa bene il motivo per il quale io ero lì, insieme al sindaco e all’assessore. Ero lì perché sono consulente del sindaco e dell’assessore sulle politiche per la disabilità. Ho un ruolo politico, dunque, e di competenza specifica. Ma chi vede la foto, e non sa, arriva immediatamente al giudizio, ed è curioso che questo avvenga in modo così netto in una situazione particolare, che è di pieno apprezzamento per il “gesto” del sindaco. Non ricordo, adesso, che cosa ci stessimo dicendo in quell’istante. Molto probabilmente stavo scherzando con Pisapia a proposito dei tantissimi baci e abbracci che stava ricevendo in quelle ore da parte di anziane signore entusiaste. E Majorino – questo lo ricordo bene – mi stava dicendo, sottovoce: “Ecco, adesso diranno che sto spingendo un disabile….”. Ironia profetica. Con Pierfrancesco su questo punto parliamo assolutamente la stessa lingua e il giovane assessore ha capito perfettamente quanto sia importante far comprendere la dignità e l’autonomia delle persone con disabilità. Io per lui sono un amico e – in piccola misura – un punto di riferimento per confrontare idee e iniziative in un settore così delicato e complesso come quello dei servizi alle persone con disabilità. Del resto in quella bellissima giornata di Ferragosto, trascorsa assieme al sindaco, all’assessore e ai funzionari del Comune, in più di una occasione l’equivoco e il pregiudizio stavano per travolgermi con effetti comici degni di una gag. In una casa di riposo, ad esempio, una balda signora che si riteneva evidentemente al centro delle operazioni organizzative mi ha pregato – dandomi ovviamente del tu – di spostarmi dal centro del corridoio per lasciar passare il sindaco, che sicuramente (così mi tranquillizzava) “si sarebbe fermato a dare un saluto anche a me”. In un centro ricreativo, in un attimo di tranquillità, altri gentilissimi anziani volevano rimpinzarmi di pizzette e di salatini, mentre attendevo che l’assessore terminasse un colloquio un po’ riservato. Non mi offendo mai, non sono permaloso, ma mi limito a osservare e a sorridere. In generale, durante questa prima uscita pubblica, in un ruolo di supporto al sindaco e all’assessore, ho notato quanto sia difficile muoversi con leggerezza e autonomia, in sedia a rotelle, specie quando, per stanchezza o per essere particolarmente veloci negli spostamenti, c’è bisogno di un piccolo aiuto, insomma, di una spinta. Improvvisamente mi sono reso 38 conto di quanto pesi la perdita – sia pure momentanea – di autonomia decisionale. Niente di drammatico, anzi devo ringraziare tutti coloro che mi hanno, di volta in volta, dato una mano: va detto che, ovviamente, abbiamo incontrato nel percorso anche molte piccole barriere, rampe dalle pendenze montanare, gradini maligni, porte strette, passaggi attraverso percorsi secondari (quante cucine e ripostigli si visitano quando ci si muove in sedia a rotelle…). Ultima notazione curiosa: ci siamo spostati, per l’intera giornata, con un radiobus, unico mezzo decisamente accessibile, e comodo per tutti, non solo per me. Anche in questo caso è sfuggita, nei commenti alle foto, la motivazione – banale – di questa scelta, che non aveva alcuna connotazione “politica” ma solo pratica. La morale? Non c’è, o meglio, sarebbe troppo lunga. Mi limito a riflettere: quanta strada ancora dobbiamo percorrere perché lo stigma e il pregiudizio ci abbandonino? “H O W M A N Y R O A D S M U S T A M A N W A L K D O W N , B E F O R E Y O U C A L L H I M A M A N …” (“Blowing in the wind”, Bob Dylan, 1962). 39 Lo sguardo sulla società 40 Blog FrancaMente – Vita.it, 18 novembre 2014 L’eclissi della speranza di Franco Bomprezzi Insomma in qualche modo bisogna reagire. Non riesco, in queste settimane di maggiore presenza a casa, nella lunga e non semplice convalescenza, ad accettare il livello sistematicamente distruttivo di qualsiasi programma televisivo che cerchi di raccontare e affrontare i tanti guai del nostro Paese. I disastri ambientali, le periferie urlanti, le tensioni in piazza, le sceneggiate nelle aule parlamentari, tutto un minestrone indistinto che contribuisce ad alimentare un disagio, una nausea, un rifiuto del presente e del futuro, in una parola, l’eclissi della speranza. Raramente vedo analogo impegno mediatico a cercare chi possa raccontare soluzioni praticabili, anche tecnicamente, per affrontare correttamente uno qualsiasi di questi problemi. Eppure le competenze esistono, dalle università alla rete delle associazioni, dai tecnici onesti (che pure ci sono) ai divulgatori non faziosi. Anche all’interno della politica è evidente che vengono interpellate quasi sempre le persone più aduse alla polemica, all’invettiva, allo sfascio. Il quadro che ne esce è desolante e sicuramente contribuisce a quel degrado della coesione sociale che è un pericolo tremendo per chiunque, da sempre, si batte riformisticamente e banalmente nel tentativo di fare la propria parte per risolvere un pezzetto alla volta. Penso a Milano, squassata dalle acque di Seveso e Lambro, penso a quanto contemporaneamente si sta cercando di fare per migliorare complessivamente l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità o degli anziani. E mi rendo conto che le ripetute esondazioni, con i danni alle linee della metropolitana, con i disagi improvvisi e pesanti, danno la sensazione che tutto sia inutile, che non ci sia niente da fare. Ci scopriamo tutti ignoranti rispetto alle scelte di intervento idrogeologico che dovrebbero essere fatte, rispetto ai tempi, ai finanziamenti, alle soluzioni a breve termine. Eppure non possiamo permetterci il lusso di buttare tutto via, assieme all’acqua sporca. Mai come adesso ci vorrebbe uno scatto d’orgoglio, prepolitico, semplicemente di cittadinanza e di appartenenza, capace di farci riprendere il cammino, in ogni campo. Non è possibile, ragionevolmente, che questo Paese sia completamente a pezzi e soprattutto che la ca41 tastrofe stia avvenendo qui e adesso, negli ultimi mesi. Una mancanza siderale di memoria, un ripetuto e cinico tentativo di buttare tutto in caciara, sperando che alla fine crolli questo sistema ma non sapendo minimamente chi e come potrebbe davvero ricostruire un futuro civile e democratico. Per certi versi sento crescere il desiderio di maniere forti, di scelte autoritarie, di plebisciti che facciano piazza pulita di tutto e di tutti. Come persone impegnate nella comunicazione, nell’informazione di servizio, nel racconto del welfare che cambia, non possiamo chiamarci fuori e lasciare che questo scempio continui indisturbato. A 62 anni voglio continuare a sperare, a vivere, a lottare per fare meglio. E sono certo di non essere il solo. 42 Blog FrancaMente – Vita.it, 30 giugno 2014 Azzardo e scommesse, la droga dei più deboli di Franco Bomprezzi Esco per un attimo dal terreno che frequento maggiormente, anche in questo blog. E mi associo ai tanti appelli che dalle pagine di Vita cercano (con crescente e meritato successo) di arginare un fenomeno mostruoso, soprattutto nel nostro Paese, ovvero la diffusione dell’azzardo legalizzato, in tutte le forme possibili. Non lo chiamo “gioco”, perché è proprio qui l’inganno delle parole, il trucco perverso che spinge tante persone semplici a tentare la fortuna, immaginando che non si tratti di niente di speciale, solamente – appunto – un “gioco”, che si abbina alla speranza di un riscatto economico, di un improvviso rovesciamento delle sorti della propria fragile esistenza. Non passa giorno che Simone Feder non segnali iniziative e non porti l’attenzione, nel blog di Vita.it ma anche attraverso i social network, sui tentativi di apertura di nuove sale che comunque non rispettano neppure i criteri previsti dalle recenti norme (distanza dai luoghi sensibili). Mi pare di aver visto, almeno in Lombardia, una risposta attenta e forte sia a livello della Regione che in molti Comuni, compreso Milano. Ma la sensazione è che si tratti di una guerra di trincea, condotta con pochi mezzi e resa ancor più difficile dallo strapotere mediatico della pubblicità connessa alla promozione delle scommesse. Testimonial di grande popolarità (ci mancava anche Totti) propongono in modo ipocrita e farisaico un uso non smodato delle scommesse, ma la sostanza è chiara: è un invito generalizzato a spendere i propri risparmi tentando la sorte, e cominciando magari con un comportamento che vagamente ricorda l’antico rito della schedina. Ma i tempi del Totocalcio da due colonne, o da sistemino con gli amici al bar, sono morti e sepolti. Ora si comincia con una piccola scommessa e poi si continua a grattare freneticamente, e poi si passa alla slot machine, senza soluzione di continuità. C’è un nesso forte con la disabilità, tema che seguo con maggiore competenza (anche perché mi riguarda direttamente): paradossalmente le sale gioco sono i locali più accessibili del mondo. Mai un gradino all’ingresso, mai una porta stretta. Tutto è concepito in modo tale 43 da consentire a chiunque, non vedenti compresi, la pratica della scommessa e del cosiddetto “gioco”. Non esistono statistiche in materia, ma non credo di sbagliare se immagino molti genitori, magari anziani, alle prese con problemi di economia familiare (quando c’è un figlio disabile i soldi non bastano mai) tentati da questa malattia che si presenta in modo apparentemente innocuo e amichevole. Ma penso che il fenomeno tocchi (non so quanto di striscio) persone con fragilità emotiva e intellettiva, più esposti alle suggestioni, più indifesi degli altri. Non c’è calcolo utilitaristico che tenga. Su questo punto non si può essere morbidi o pronti alla mediazione, magari per incamerare grandi cifre di denaro da investire nel bilancio pubblico (quasi una pseudo giustificazione morale, in stile Robin Hood). Questo è un modello di comunicazione di valori sbagliati che va solo bloccato, frenato, interrotto. In modo duro e chiaro. E la battaglia del movimento “no slot” deve contagiare tutti, e non essere vissuta come una iniziativa circoscritta, o moralistica. Questa è l’unica scommessa da vincere. Tutti insieme. 44 Vita, dicembre 2014 Cara Vita, … di Franco Bomprezzi Cara Vita, vent’anni e sentirli. Ma sentirli bene. In movimento. Ci sono dall’inizio, Riccardo lo sa bene. Ho imparato con la gente di Vita a ragionare largo, profondo, e prima di tutto ad ascoltare, incuriosito, i mondi che si interfacciavano, galassie a volte lontane, che però anno dopo anno si sono cimentate nell’impresa non semplice di uscire dall’orto di casa e condividere competenze, aspirazioni, visioni, esperienze, buone prassi. Il mondo del welfare è cambiato intorno a noi, ma anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo contribuito, con le parole e con le battaglie, con gli approfondimenti e con i servizi dedicati, a cambiare il mondo. Al punto che adesso ci stanno strette molte definizioni, non ci riconosciamo più in un ruolo secondario e sussidiario (nel senso riduttivo che spesso viene usato) e siamo largamente convinti che il cambiamento del quale ha assoluto bisogno questo Paese, ma non solo, passa attraverso la scelta di una direzione del tutto differente di marcia, abbandonando molti automatismi che di fatto mortificano creatività, produttività, sostenibilità, perfino solidarietà. Lo sviluppo sociale ed economico nuovo, la possibilità di creare lavoro, di tornare carichi di speranza verso il futuro, passa attraverso le elaborazioni culturali e progettuali che questo splendido melting pot di Vita ha saputo nel tempo costruire, cementare, rinnovare. Molto ha giocato lo sviluppo della rete, grazie anche al web, con la veloce circolazione delle idee, delle proposte, della documentazione che difficilmente è possibile intercettare sui media generalisti. Ambiente, cooperazione, impresa sociale, attività delle ong, volontariato, associazionismo: altrettante sfide che hanno i volti ben noti di persone che oggi hanno vent’anni di più anche se li portano bene e con disinvoltura, per il semplice motivo che il ricambio generazionale, anche in questo mondo, è difficile e non sempre perché i dirigenti non ce la fanno a lasciare gli incarichi di maggiore responsabilità. Il fatto è che le giovani generazioni sono alle prese con la più impressionante crisi di valori, prima ancora che crisi economica. La nuova sfida di Vita è coniugare l’esperienza, la memoria, la storia, con le speranze, le rabbie, il vitalismo di chi si affaccia adesso al mondo e non lo trova granché attraente. 45 Sarà la nostra capacità di narrazione, di ascolto e di condivisione a fare di Vita per lungo tempo ancora un esempio di housing sociale nel mondo dell’editoria. Andiamo avanti. 46 Blog FrancaMente – Vita.it, 22 settembre 2014 Lavorare meglio, lavorare tutti di Franco Bomprezzi Ancora una volta ho scritto nella mia pagina di facebook una frase sgorgata di getto, dopo ore di telegiornali e di talk show dedicati all’articolo 18: “L’art. 18 fa parte della nostra storia civile, non c’è dubbio. Ma non ho mai visto i sindacati minacciare uno sciopero generale per chiedere l’applicazione della legge 68 del ’99 per il lavoro alle persone con disabilità. O mi sbaglio?” . A giudicare dalla valanga di “mi piace” in poche ore (circa trecento) e di condivisioni sulle bacheche personali di 45 miei “amici” di ogni tipo e tendenza politica, devo dedurne che ho toccato un nervo scoperto e ho espresso un pensiero, in modo credo del tutto civile e rispettoso, che però apre una riflessione più vasta e forse ha bisogno di qualche aggiunta, qui, dove le parole mi vengono con facilità. Il mio rammarico infatti è in sostanza questo: si rischia ancora una volta di non cambiare seriamente il sistema di accesso e di mantenimento del lavoro perché attorno a un simbolo glorioso si concentra una battaglia da Armageddon, che sembra non consentire vie d’uscita. Sgombro subito il campo da qualsiasi dubbio: anche io sono un uomo del Novecento, e ricordo bene con quale orgoglio ho vissuto la fase politica e sociale che ha consentito, nel nostro Paese, il varo dello Statuto dei Lavoratori, in un’epoca differente, complicata e spesso drammatica, ma che vedeva l’economia, l’industria, il Paese in crescita e con l’occupazione a livelli mai più raggiunti. L’articolo 18 fu un punto fermo di un percorso di tutela sostanziale del posto di lavoro, e tuttora, con le limitazioni che ha già ricevuto, ha una sua funzione importante di garanzia contro i soprusi e gli avventurismi. Sono fra coloro che ritengono assurdo e persino inutile concentrarsi su questo punto per decidere se approvare o mandare all’aria il disegno complessivo del Jobs act del governo presieduto da Renzi. Ma se oggi i sindacati vivono il punto più basso di popolarità e di condivisione generale da parte dell’opinione pubblica, anche di sinistra, questo è dovuto anche ad alcune storiche e congenite pigrizie culturali e a precise dimenticanze di impegno e di lotta. Fra queste c’è sicuramente una insufficiente mobilitazione a sostegno della piena applicazione, nel settore pubblico e nel settore privato, della legge 68 del 1999, quella per il collocamento mirato delle persone con disabilità. Una legge frutto di un compromesso, come del resto sempre accade in Italia e non solo in Italia. Ma pur sempre una legge avanzata che avrebbe potuto negli 47 anni seguenti alla sua entrata in vigore contribuire progressivamente alla riduzione della drammatica forbice esistente tra i livelli di disoccupazione generale e i livelli della disoccupazione dei potenziali lavoratori disabili. Ormai si parla di disoccupazione strutturale, con percentuali che superano il 70 per cento. Una causa quasi persa, sia pure con alcune situazioni di eccellenza, e tenendo conto del ruolo prezioso svolto dalle cooperative sociali (specie per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva, doppiamente penalizzati). Le aziende come è ampiamente noto preferiscono quasi sempre pagare una multa piuttosto che assumere una persona con disabilità. Il percorso di ingresso al lavoro passa attraverso la mediazione pubblica, le Province (che sono in fase di sparizione…), le associazioni di tutela, le cooperative, il sistema delle doti. Insomma tutto tranne il tradizionale confronto tra impresa e lavoratori garantito dalla combattività dei sindacati. Sappiamo tutti che è difficile convincere i lavoratori non disabili a battersi per fare largo a persone che, nell’immaginario collettivo, subiscono uno stigma e un pregiudizio pesantissimi. Ma è anche vero che i sindacalisti che si battono seriamente anche per il lavoro delle persone disabili li conosciamo per nome, uno ad uno, regione per regione. E’ difficile dunque immaginare che adesso, da questo mondo tartassato ed emarginato, arrivi una solidarietà attiva per una battaglia di bandiera che nel migliore dei casi viene condivisa soprattutto nel timore che, caduto l’articolo 18, si arrivi di conseguenza a cancellare altre tutele, fino ad arrivare (come già si ipotizza) a eliminare ad esempio l’indennità di accompagnamento. Si tratta insomma di una questione delicata e complessa, nella quale gli stati d’animo, le storie, le delusioni, le speranze, le rabbie accumulate, giocano un ruolo importante, quasi decisivo. Penso che questo sia il momento di concentrarsi seriamente sui contenuti della riforma, cercando casomai di alzarne il livello di inclusione e di tutela sostanziale, costruendo nuove alleanze sociali, con chi oggi si sente escluso dal mondo del lavoro e persino dal precariato. Non è un tema che riguardi solo la disabilità, ovviamente. Ma vorrei che fosse chiaro: l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, quando avviene e funziona, modifica l’ambiente di tutti (dalle barriere fisiche a quelle mentali, dall’organizzazione degli spazi alla flessibilità e idoneità delle mansioni e delle competenze) e lo modifica in meglio. Le aziende pubbliche e private che utilizzano bene e in modo convinto i lavoratori con disabilità fisica, sensoriale o intellettiva, sono aziende migliori, dove il lavoro è un valore anche umano da condividere e supportare ogni giorno. Insomma proviamo a lavorare meglio, e a lavorare tutti. E con questo spirito proviamo anche a smontare le barricate sull’articolo 18. 48 Vita, maggio 2013 Caro Nicoletti, … di Franco Bomprezzi Caro Nicoletti, quante emozioni stai regalando ai lettori che scoprono, pagina dopo pagina, la tua vita con Tommy, quel ragazzone autistico, tuo figlio. “Una notte ho sognato che parlavi” (Mondadori, Strade Blu). Già. Il titolo dice molto, quasi tutto. La tua utopia finale, costruire una città possibile dove le persone con autismo possano vivere liberamente e con i migliori strumenti, tecnici e umani, per declinare un futuro che non sia di angoscia, di abbandono, di impossibilità, per un genitore, di reggere il peso. Mi sono domandato molte volte quale strano destino leghi molti di noi, che usiamo le parole, al tema dell’handicap, della disabilità. Il destino, ad esempio, di Massimiliano Verga, che insegna sociologia dei diritti, all’università. Ed è il papa di Moreno, un bambino divenuto ormai famoso con il nome di “Zigulì”, quella caramellina paragonata alla dimensione del suo cervello: sono diventato amico di Massimiliano, dopo l’iniziale diffidenza per quel suo libro così duro, violento, quasi aggressivo, al limite di apparire disperante. Non era così, era amore. Era desiderio profondo di squarciare il velo di ipocrisia che circonda la disabilità quando prende le forme dell’incomunicabilità. Ora il libro di Verga è addirittura un monologo teatrale, stupendo e potente, realizzato da un ottimo attore come Francesco Colella. L’ho visto a Lissone, a pochi chilometri da Milano. Lunghi interminabili applausi del pubblico. Era già accaduto al teatro di Ringhiera, periferia sud della metropoli. Ma meriterebbe la ribalta dei grandi teatri, perché tutti devono poter vedere, ascoltare, capire. E se ancora questo non avviene, è perché le grandi firme della critica non si spostano in periferia. Ecco, caro Gianluca: ci siamo conosciuti tanto tempo fa, quando ancora la tua era la voce di Golem, su Radio Rai. Mi definii, e ti piacque, il tuo “golem a rotelle”. Fantasmi che si aggirano nell’etere e nel web, parlano la stessa lingua, affrontano il non detto, il non dichiarato. Il mistero delle nostre esistenze, io con le mie rotelle, tu e Massimiliano con due figli che vi cambiano radicalmente la vita. Lo so che non vuoi sentirti dire che era tutto previsto. Anche io mi incavolo quando cercano di convincermi che se “io sono così” forse è giusto, così posso parlare anche per gli altri. Ne avrei fatto a meno, e anche voi due ne avreste fatto volentieri 49 a meno. Ma è andata così. Ce ne siamo fatti una ragione. E a un certo punto delle nostre esistenze abbiamo deciso che non potevamo chiamarci fuori dalle nostre responsabilità. Se è vero che sappiamo usare le parole e le idee, beh, allora ci tocca usarle, senza se e senza ma. E quindi tu, fine esteta, intellettuale colto e multiforme, capace di elucubrazioni radiofoniche tanto insolite quanto intriganti, stai scoprendo la potenza della parola utopica, del racconto esperienziale, della condivisione in rete non tanto delle sofferenze, quanto delle reali condizioni di vita, dalle piccole alle grandi cose che accadono tutti i giorni. Lo fai con leggerezza, e con quella magnifica dote che si chiama “ironia”, che altro non è se non la capacità di vedere la realtà da un altro punto di osservazione, accennando un sorriso là dove normalmente irrompe l’urlo o si scatena il pianto. La rete delle persone che condividono, apprezzano, moltiplicano e rilanciano il messaggio positivo, duro ma pieno di possibili esiti di speranza, si fa di giorno in giorno più grande. E abbiamo scoperto, nella nostra complicità di bloggers che se ne fregano della concorrenza fra gruppi editoriali (tu sulla Stampa e a Radio 24, io su Corriere e Vita), quanto sia bello rilanciare in Rete e amplificare le reciproche riflessioni. Non era mai capitato, che io sappia, che si creasse un’alleanza così forte fra disabilità fisica (la mia) e genitorialità di una disabilità relazionale (la tua e quella di Verga). Lo so che non basta. Lo so che tutto attorno a noi sembra congiurare, che le politiche di welfare sono un insulto all’intelligenza delle famiglie e delle associazioni. Ma vedo con piacere che non ci passa neanche per la testa di mollare, di ritirarci in silenzio. L’importante è che le parole, quelle giuste, continuino a interrogare le coscienze, arrivino a scuotere i palazzi, costringano tutti e ciascuno ad assumersi le responsabilità del vivere in modo solidale, coeso, umano. Tommy, tuo figlio, è un marcantonio alto e robusto, eppure senza la tua costante presenza sarebbe totalmente indifeso. Per quel che vale, caro Nicoletti, sappi che molti figli sarebbero assai orgogliosi di un padre come te. Fa conto che te lo abbia detto Tommy. Magari in sogno. 50 Corriere della Sera – Inserto La Lettura, 23 giugno 2013 Il Corpo dell’amore Affetti e sesso per le persone con disabilità: un diritto che non si esige ma si conquista di Franco Bomprezzi Il ricordo della scoperta affonda nella memoria delle lenzuola candide del mio letto di bambino alle soglie dell’adolescenza, quando all’improvviso mi accorsi di un calore dolcissimo e di una sensazione di piacere inspiegabile e ignota, che partiva in basso e risaliva al cervello, fino a quando le mie mani scoprirono che il mio piccolo membro si era stranamente irrigidito al balenare nella mente di una immagine femminile, che ora è completamente scomparsa e sprofondata nell’oblio. La sessualità si apprende così, all’improvviso, nel volgere di una sera o di un mattino, quando l’adolescenza irrompe e ti trasforma. Il turbamento, certo, nell’uomo come nella donna. Ma un turbamento speciale quando, come nel mio caso, hai ancora il corpo bloccato nell’ingessatura rigida, dal torace alla gamba sinistra, per ricomporre le tante fratture di quella strana malattia genetica delle ossa, che mi ha fatto nascere così, un po’ storto e asimmetrico, fragile e tenace al tempo stesso. Ecco, nell’attimo del primo turgore sessuale ho realizzato anche la mia diversità, mi sono accorto di essere differente, nel fisico, da tutti gli altri. Nel fisico: non nei desideri, non nella mente, non nella volontà. Ma da allora il destino personale rispetto alla ricerca di affetto, e poi di sesso, era segnato indelebilmente. Un piccolo insostituibile rovello si era depositato nel mio cervello e nel mio cuore, portandomi nel tempo a sentimenti altalenanti e confusi, oscillando tra la dolce malinconia e la ricerca comunque di una prova, di una possibilità. Quando si è ragazzi amore e sesso si confondono e si complicano a vicenda, solo il tempo restituirà la dimensione più realistica delle differenze e delle opportunità. Ma non per tutti, non sempre. Perché la disabilità è una condizione umana possibile e diffusa, nelle sue mille forme e bizzarrie del corpo e della mente, ma non per questo accettata e condivisa, anzi spesso rimossa 51 e ammantata di pregiudizi, di uno stigma che si trasforma in barriera e assume le forme del tabù indicibile. Oggi ho superato i sessant’anni e il mondo dovrebbe essere molto cambiato dai tempi della mia normale adolescenza disabile (ma allora neppure le parole mi aiutavano, ché ancora si diceva quasi sempre «poverino» o «invalido», nel migliore dei casi). Ed è vero, se pensiamo alle leggi che favoriscono le cure, la riabilitazione, l’integrazione scolastica, l’inclusione lavorativa, la mobilità personale. Ma si tratta pur sempre di leggi che regolamentano diritti in qualche modo assolutamente esigibili, oggettivi, rispetto ai quali lo scambio di azioni non presuppone e non obbliga alla piena condivisione dell’esistenza, o meglio, del corpo, del proprio aspetto fisico. Inutile dire che io mi sono sempre sentito, dentro di me, assai bello, alto, attraente e seducente. Peccato però che la realtà esteriore urlasse il contrario, e non a caso la prima esperienza, peraltro dolcissima e insperatamente positiva, di sessualità la ebbi attraverso l’incontro a pagamento con una prostituta, alla soglia dei vent’anni. Fu la conferma che in teoria avrei potuto condurre una vita sessuale ed affettiva quasi normale, con qualche piccolo accorgimento tecnico che non mi pare il caso di riferire qui nei dettagli. Il punto vero, e incontrovertibile, è che la sessualità (e di conseguenza l’amore) è un diritto che non si può esigere, non si può imporre. Al massimo si possono cercare delle vie d’uscita, dei compromessi onorevoli e dignitosi (come sta avvenendo, faticosamente, con la battaglia per la creazione della figura dell’assistente sessuale, sulla scia di esperienze significative in molti Paesi europei, come raccontiamo in queste pagine). Ma la strada è tortuosa, complessa, irta di ostacoli di ogni genere. Dopo quell’esperienza unica di sesso «proibito» mi risultò più facile percorrere la strada lineare della ricerca di affetti, di relazioni, che spesso rimanevano comunque amicizia, con il non detto, con quell’ultima ritrosia (magari dettata dal timore della reazione dei genitori) che mi lasciava in uno stato di struggente delusione. Fino a quando incontrai Nadia, una ragazza paraplegica vivacissima, che divenne mia moglie e con lei condivisi 21 anni di vita intensa e assolutamente normale: una malattia imprevedibile me la strappò, quasi dieci anni fa. Ci credevano fratello e sorella. Non capiva la gente come facessimo in due, entrambi in sedia a rotelle, a vivere da soli, liberamente. Era divertente stupire con un bacio, rispondere sorridendo agli sguardi carichi di imbarazzo. 52 Il destino è stato buono con me. Da sei anni vivo una relazione intensa con una donna più giovane, senza alcuna disabilità, che ancora stento a capire perché abbia deciso di condividere la sua esistenza con una persona oggettivamente disabile e un po’ scomoda, come sono io. Ma la chiave di lettura è in fondo la «normalità» di una storia nella quale si vive alla pari, senza indulgere nell’accudimento, anzi. Attorno a me, finalmente, vedo e sento storie più o meno positive di relazioni importanti, ma anche di avventure sessuali effimere. I social network, i siti internet, amplificano le opportunità di incontro, di caduta delle inibizioni e spesso degli alibi che consentono a molti di rinunciare, di scappare, di fronte al rischio di un rifiuto. Ammiro davvero molto le donne con disabilità, capaci di esprimere la propria bellezza attraverso i dettagli, la cura di sé, il fascino, anche quando il corpo tradisce e non rappresenta in modo autentico l’Io che c’è dentro. L’amore, ma anche l’approccio sessuale, parte dallo sguardo, e gli sguardi che toccano le persone disabili spesso feriscono, quasi uccidono. Nella società dell’esaltazione del corpo perfetto è difficile superare la barriera rappresentata da una sedia a rotelle, o da una camminata incerta, o da un modo di parlare rallentato da un deficit o da una spasticità, o dalla cecità. La discriminazione sessuale è evidente, forte, crudele, cinica. Colpisce equamente giovani e meno giovani. Interessante esplorare, ad esempio, la doppia discriminazione che unisce disabilità e omosessualità, maschile e femminile: una realtà che ovviamente esiste, nelle proporzioni analoghe a quelle esistenti e conclamate oggi nella nostra società apparentemente meno omofoba di un tempo. Eppure qui è più difficile, quasi impossibile rivelarsi, fare outing. La frontiera ancora più complessa, e racchiusa spesso nel silenzio muto della famiglia, è la sessualità delle persone con disabilità intellettiva. Assai più numerose e attive sessualmente rispetto a chi, come me, ha un deficit fisico. Solo le madri, a volte, rompono il silenzio e raccontano l’indicibile, come nel blog «InVisibili». Eppure, di fronte all’intero e variegato mondo delle disabilità, la gente continua a ritenere che sessualità e amore non siano un diritto, ma un problema in più per questi «sfortunati». Non li riguarda, non li tocca. Al massimo un’alzata di spalle, un sorriso indulgente, magari una battuta sconveniente. Ma l’amore no… 53 Corriere della Sera – Inserto La Lettura, 24 agosto 2014 Siamo belli anche noi Un reportage fotografico con i disabili al museo di Franco Bomprezzi Bellezze Disarmoniche: il titolo già provoca una certa inquietudine e una presa di distanza. È un libro che raccoglie gli scatti di un grande fotografo italiano, Franco Fontana. Le sue opere sono presenti nei maggiori musei del mondo. A 80 anni l’artista modenese si è cimentato per la prima volta nella sua lunga carriera di scatti con un tema scabroso e raramente esplorato, ossia quello del nesso tra bellezza e disabilità. Lo stimolo è venuto dall’Università di Torino e dalla Fondazione Istituto di ricerca per la comunicazione della disabilità e del disagio, presieduta da Liborio Termine, che hanno ideato un laboratorio artistico dal titolo L’immagine e la visione negata. Ne è nata una sessione di fotografie ambientate nelle sale barocche del Museo di Palazzo Madama, a Torino. Protagonisti consapevoli un certo numero di persone con disabilità, uomini e donne, più o meno giovani. Molti in carrozzina, spesso elettrica. Una persona claudicante, che si muove appoggiandosi a un elegante bastone, una persona più atletica in sedia a rotelle sportiva. Alle pareti i quadri, osservati da un pubblico eterogeneo, ma con l’attenzione del fotografo rivolta a stabilire un nesso fra le opere d’arte e le persone disabili. Ora quel laboratorio è diventato, grazie anche allo sponsor, un libro fotografico importante, destinato a un pubblico appassionato che forse per la prima volta, attraverso questo filtro, si interrogherà su un argomento invisibile e assente dalla scena culturale. Nel volume le fotografie di Fontana sono presentate assieme a una serie di testi e di dettagli. Interessante la ricostruzione del set, raccontata dal regista Michelangelo Dotta: attraverso di lui riusciamo a comprendere l’imbarazzo iniziale, la difficoltà di stabilire una relazione non rigida tra soggetti e autore, il progressivo sciogliersi della tensione, la tecnica scelta dal maestro, il significato a metà tra la performance e la ricerca. Il linguaggio scelto in tutti i testi del libro è volutamente colto, ma risente di una scarsa dimestichezza con la normalità della disabilità. Ripetutamente viene sottolineata la diversità e la disarmonia dei corpi, ma se osserviamo le fotografie scopriamo in realtà persone assai belle, dignitose. Donne di diversa età, ben vesti54 te, truccate, che si muovono agendo sul joystick della carrozzina elettrica, elemento tecnologico che sicuramente ingombra e altera le normali proporzioni delle persone erette che tuttavia non per questo, obiettivamente, si possono definire «disarmoniche». Ho provato, dunque, nella lettura dei testi che affiancano le fotografie, un disagio crescente, mitigato dalla solarità esemplare delle immagini, che rappresentano con esattezza persone «normali», ovvero uomini e donne che stanno esplorando un museo e si accostano con curiosità attenta a opere d’arte di grande valore, proprio come gli altri visitatori non disabili. Ho la sensazione che siano state proprio le carrozzine — tra l’altro caricate di oggetti personali e di capi invernali di abbigliamento, che ne hanno dilatato oltre misura le già notevoli dimensioni — simboli potenti anche nell’immaginario collettivo, e persino stilizzate nelle note ico- ne che garantiscono la possibilità di accedere ai luoghi (dai parcheggi ai servizi igienici), a mettere in imbarazzo e «fuori fuoco» l’intera rappresentazione. È come se la parte afferrasse e divorasse il tutto, persone comprese, togliendo loro identità, e dunque sicuramente bellezza. Una gigantesca e crudele metonimia, fuorviante e gelida. Il fotografo, che probabilmente stava vivendo con difficoltà emotiva l’approccio con un tema insolito, si è dimostrato dunque capace di declinare e sublimare il disagio attraverso la consueta e collaudata abilità artistica, risolvendo in una galleria colorata e divertente la sfida che appariva improponibile o troppo ardua. Per me, che da tanti anni visito musei e gallerie di mezzo mondo muovendomi liberamente in sedia a rotelle, il libro di per sé non rivela nulla di particolarmente inedito. Ne apprezzo l’eleganza, ne comprendo lo sforzo di inclusione culturale, ma ho anche la sensazione che davvero si faccia ancora fatica a uscire dal gioco degli specchi e dei rimandi. Ogni persona è esteticamente irripetibile, e la sua bellezza coincide con la sua identità, con la sua storia individuale. La cultura della disabilità nel corso degli ultimi decenni si è fortemente evoluta uscendo da una rappresentazione spesso pieti- stica oppure legata agli stereotipi della bruttezza estetica. È interessante, nel libro come nella realtà, cogliere invece un dato evidente: ossia la passione per l’arte, il desiderio di vedere da vicino, di conoscere, di possedere con la mente e con il cuore le opere d’arte. Non sempre la collocazione dei quadri, ad esempio, consente a chi è seduto in carrozzina una corretta visione, specie per quanto attiene l’illuminazione, generalmente concepita in funzione di uno spettatore in piedi, a distanza regolabile dalla tela o dalla scultura, per non parlare delle descrizioni e delle didascalie. 55 Non è un caso, ad esempio, che io abbia trovato estremamente apprezzabile la criticatissima collocazione proposta da Ermanno Olmi del Cristo morto di Mantegna nella pinacoteca di Brera. Ho provato infatti un’emozione indicibile nel trovarmi nella situazione ideale, ad altezza di carrozzina, per cogliere non solo la prospettiva del quadro, ma l’impatto drammatico del corpo, che sembra uscire in modo tridimensionale dalla parete per interrogare la mia anima. Molto interesse, invece, sta suscitando il lavoro di chi riesce a rendere fruibili le opere d’arte alle persone cieche (un aggiornato e ricco dossier è consultabile, ad esempio, nel canale cultura di Corriere.it). L’altro aspetto inesplorato, almeno a livello di diffusione generale, è quello della presenza di soggetti con disabilità nelle opere dei grandi artisti del passato. Ci sarebbe invece davvero bisogno di un lavoro sistematico di ricerca e di catalogazione, capace magari di sfociare in una grande esposizione a tema, che sia capace di cogliere l’evoluzione nel tempo e nelle diverse scuole pittoriche e di arti plastiche. Pochi gli esempi celebri, dal nano Sebastian Morra di Diego Velázquez, alle tele di Hieronymus Bosch con la rappresentazione di storpi e reietti. La deformità attira gli artisti, proprio perché nel passato non esisteva il nostro contemporaneo concetto di disabilità, ma solo quello di diversità, inferiorità, mostruosità. È come se l’archetipo di questa impossibilità di rappresentare la disabilità in termini di bellezza abbia attraversato i secoli per giungere intatto fino a noi, e rendere difficile persino oggi cogliere una sostanziale mutazione di ruoli, derivante dalla piena inclusione sociale e culturale di centinaia di migliaia di persone con disabilità fisica, sensoriale, e anche intellettiva. L’ambigua Madonna con Bambino del Mantegna, dove il Bambino ha le fattezze che ricordano in modo sfumato ma non troppo i lineamenti tipici della sindrome di Down è l’indizio che dovrebbe servire per esplorare senza pregiudizi un tema universale: il diritto alla bellezza, e alla rappresentazione estetica anche della disabilità. È forse questo il risultato profondo di una intrigante proposta culturale. Ed è bello sapere che a 80 anni un grande fotografo è in grado di osservare con umiltà un mondo nuovo, un pianeta ancora inesplorato. Benvenuto. 56 Franco Bomprezzi "Giornalista a rotelle, classe 1952, blogger, interista per passione". Così Franco Bomprezzi si presentava sul suo profilo Twitter. Nato a Firenze, il 1º agosto 1952, era affetto fin dalla nascita da osteogenesi imperfetta. Ha iniziato la sua attività giornalistica presso la redazione padovana del Resto del Carlino per poi passare al Mattino di Padova. Nel corso degli anni, ha condotto un'intensa attività giornalistica sui temi della disabilità: ha fondato e diretto alcuni importanti portali d'informazione come Superabile.it e Superando.it; animatore del blog InVIsibili sul Corriere della Sera e autore del blog FrancaMente sul sito di Vita.it. Giornalismo, impegno politico e civile sono stati tre elementi inscindibili nella vita di Franco. Che nel 1978, a soli 26 anni, è entrato a far parte del consiglio comunale di Padova. Ha dedicato grande energia e impegno per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Tra il 1995 e il 2001 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e, dal 1998, quello di presidente nazionale della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare). Dopo aver svolto per molti anni il ruolo di portavoce, nel 2013 Franco ha assunto la presidenza di LEDHA, succedendo a Fulvio Santagostini. Per circa un anno, ha ricoperto il ruolo di delegato del sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, per le Politiche sulla disabilità. Lo scorso giugno era stato nominato consulente di supporto della task force per l'accessibilità di Expo Milano 2015. Nel 2005 la città di Milano gli ha tributato l'Ambrogino d'oro, massima onorificenza civica. Il 3 dicembre 2007 è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Giorgio Napolitano. Ha pubblicato i libri Io sono così e La contea dei ruotanti. 57
Scaricare