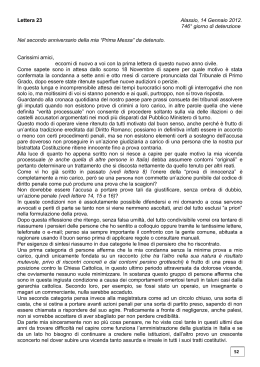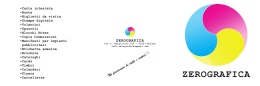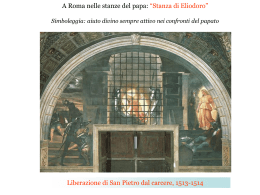AA.VV. Storie e testimonianze dal carcere selezione di testi dal sito http://www.ristretti.it del Centro di Documentazione Due Palazzi di Padova Calomelano Editrice Virtuale ebook numero 2 http://calomelano.it/ebooks I edizione settembre 2009 A cura di calomelano.it Marzo 2009. Si ringrazia Francesco Morelli per la disponibilità a permettere il remix e la redistribuzione dei contenuti. La sintesi è stata necessaria per rendere accessibile uno spaccato dell'abbondante materiale prodotto dai detenuti, ci scusiamo con gli autori che sono rimasti esclusi e invitiamo il lettore a continuare la lettura sul sito di ristretti a cui rimandiamo: http://www.ristretti.it Indice Introduzione...........................................................................................................6 Veronica (Casal del Marmo) - Sono esattamente 801 giorni che sto rinchiusa qui!................................................................................6 Carceri....................................................................................................................7 Marianne - Possiamo mettere a confronto una grande cella per i detenuti con lo scompartimento di un treno? ................................................7 Paola - Una donna italiana in un carcere della Baviera........................9 Paolo Pasimeni - La disperazione del primo impatto con la galera al Circondariale..............................................................................18 Susanna Ronconi - Diario minimo da un altro tempo, ma che non è detto non sia ancora qui, annidato nel tempo presente, pronto a balzar fuori… ......................................................................................20 Sandro Calderoni - Il carcere tra riforme e controriforme..................24 Ion Puica - Ritorno a casa… e rifinisco in galera..............................29 Affetti e sessualità................................................................................................35 Christine - Credo che curare gli affetti sia anche… voler bene a se stessi, perdonarsi, pazientare.........................................................35 Francesco Morelli - Un punto di vista maschile sulle corrispondenze da detenuto a detenuta.....................................................................37 Francesco Morelli - I detenuti e le detenute devono stare separati per ovvi motivi.................................................................................42 Elton Kalica - Vini.......................................................................46 Francesco Morelli - Il sesso in carcere quello che non si dice… e non si fa..............................................................................................57 Tossicodipendenza................................................................................................62 Noemi (Empoli) - Noemi si racconta..............................................62 Paola M. - Dalla tossicodipendenza non si scappa ............................66 Andrea Andriotto - Droga: il brutto arriva quando ti piace lo "sballo" che ti crea ..................................................................................69 Franco Garaffoni - La verità è che amavo la droga ..........................71 Bambini in carcere...............................................................................................74 Le donne della Giudecca - Storia di Emiliana una "detenuta" di tre anni .................................................................................................74 Giuliana - Mamme e bambini in carcere: il "nido" penitenziario della Giudecca....................................................................................77 Stranieri................................................................................................................81 Marianne - Stranieri in depressione, tra avvocati d’ufficio e documenti da firmare senza averne capito una parola.......................................81 Olga - Il mio zio italiano...............................................................84 Francesco Morelli - Stranieri in carcere: diritti teorici e problemi concreti......................................................................................87 Fulvio Santagata - Quando l’immigrazione parlava calabrese..............91 Nabil Tayachi - Mamme italiane e mamme straniere, ma sempre mamme .................................................................................................97 Nicola Sansonna - Quando gli extracomunitari eravamo noi... ........104 Arjan Goga Albania: quando il sogno diventa un incubo ................107 Artur Sognavamo un paio di jeans................................................109 Hamid - Un clandestino in cantina...............................................115 Imed Mejeri - La festa della circoncisione in Tunisia.......................124 Karim Ajili - La paura di tornare a casa a mani vuote......................130 Reinserimento.....................................................................................................134 Francesco Morelli - I lavoratori - detenuti hanno davvero delle tutele? ...............................................................................................134 Francesco Morelli - Lasciate ogni speranza… o voi che uscite...........139 Alessandro Pinti - Perché, una volta usciti dal carcere, la maggior parte di noi torna a commettere reati?..................................................142 Giulia - Ri/Educazione - Re/Inserimento.......................................145 Paola M. - Oggi parto dalla felicità che provo a sentirmi di nuovo una persona libera............................................................................148 Tiziano Fabbian - Un’ordinaria giornata… di carcere......................152 Prostituzione.......................................................................................................159 Lory - Mi chiamo Lory e sono nigeriana ......................................159 Francesco Morelli - Le prostitute straniere, sono schiave o sono "donne povere in cerca di una vita migliore"?...........................................160 Aleksandar Stefanovic - La grande fuga dall’Est ............................164 Omicidi...............................................................................................................168 Graziano Scialpi - Nella testa di un uomo che ha ucciso .................168 Altin Demiri - Se uccidi non puoi essere più lo stesso anche nel chiuso della tua coscienza ....................................................................188 Malavita..............................................................................................................191 Andrea Andriotto - Vita spericolata..............................................191 Claudio e Angelo - Banditi di domani ..........................................196 Enrico Flachi - "Tirare la lima"....................................................200 Salute e salute mentale.......................................................................................203 Francesco Morelli - Matti da slegare... .........................................203 Elton Kalica Dal T.S.O. all’O.P.G...............................................209 Danko Vukomanovic Un delinquente fuori dal comune...................213 Elton Kalica Una piccola storia di "ordinaria" sanità penitenziaria... .215 Infami.................................................................................................................219 Francesco Morelli - Codici di comportamento carcerari... ...............219 Suicidi e autolesionismo.....................................................................................225 Elton Kalica - In carcere è capitato a tanti di essere testimoni di un suicidio ....................................................................................225 Lassad Jlassi - Solitudine che taglia come una lametta.....................230 Il Ciclo Picaresco di Nabil Tayachi....................................................................237 Storia di Nabil, la Tunisia, la Rai ................................................237 Vedi Napoli e poi muori.............................................................240 Un tunisino alla scoperta del profondo nord..................................248 Le peregrinazioni di Nabil in Italia alla ricerca di un lavoro.............258 Nabil e le donne........................................................................265 Continuano le avventure di Nabil, tunisino immigrato in Italia........271 Licenza di questo ebook.....................................................................................278 . Introduzione Veronica (Casal del Marmo) - Sono esattamente 801 giorni che sto rinchiusa qui! Marzo 2003 Chi sono? Chi siete? Il buio fuori non mi permette di riconoscervi, il buio dentro non mi lascia capire chi sono io. Dicono che mi chiamo Veronica, ho 19 anni e, a parte qualche problema, diagnosticato da un paio di psichiatri, beh, a parte questo sono nella norma! C’è chi dice che sono buona, chi dice che sono cattiva… ma io questa sera vi dico che sono solo aria, aria che passa sopra a tutto, sono aria di montagna, a volte lieve e piacevole e poi d’un tratto forte, spietata e assolutamente distruttiva. Potrei anche dirvi che sono solo fuoco, caldo e accogliente e improvvisamente immenso e devastante. Forse sono solo un sogno che spera di non essere più tramutato in incubo. Domani mattina forse sarò un fiore, una pozzanghera, chi può dirlo? La cosa assolutamente certa è che non permetterò mai più, per nessun motivo al mondo, che qualche estraneo entri nei miei segreti e decida quello che sono. È assolutamente impossibile riuscire a capire una persona mettendosi a spiarla da dietro un vetro! lo forse non conosco molte cose di me, ma voglio essere libera di decidere quando capirle e soprattutto libera di decidere se e da chi farmi aiutare! Per ora so solo che sono Veronica, ho 19 anni e vorrei tanto essere solo aria per scappare via… happy freedom. Carceri Marianne - Possiamo mettere a confronto una grande cella per i detenuti con lo scompartimento di un treno? Ovvero: Come Marianne, olandese, detenuta alla Giudecca, descrive l’accoglienza riservata in un paese straniero all’immigrato, che è poi molto simile a come in carcere si accoglie un "nuovo giunto" Agosto 1999 Nello scompartimento sono seduti due passeggeri. Sono diventati quasi intimi, hanno sequestrato gli altri sedili, i tavolini, le reticelle per i bagagli, gli appendiabiti. La porta all’improvviso si apre ed entrano due nuovi viaggiatori. Il loro arrivo non viene molto apprezzato, al contrario si percepisce nell’aria un’avversione evidente all’idea di doversi stringere per liberare i posti occupati. Nel frattempo i viaggiatori che già stanno seduti all’interno si comportano tra di loro, anche se non si conoscono, con evidente solidarietà e sembrano un gruppo compatto di fronte alla gente che è appena entrata loro si sentono sul loro territorio, autoctoni che hanno diritto a tutto il posto, i nuovi viaggiatori sono invece degli intrusi, appena tollerati, ma poi ci sì abitua anche a loro eppure restano "stranieri". Alla stazione successiva la porta dello scompartimento viene aperta da due nuovi viaggiatori. Da questo momento, lo stato dei due entrati prima di loro cambia, poco fa erano intrusi, estranei, adesso improvvisamente sono diventati "autoctoni", appartengono al clan dell’"ordine costituito". Anche loro sono stati "promossi" a proprietari dello scompartimento, con tutti i diritti che ne conseguono, anche loro hanno la sensazione dì dover difendere il "proprio" territorio. Dovrebbero avere un po’ di comprensione per i "novellini", dato che si trovano nella stessa situazione in cui erano loro poco prima, ma non se ne parla neppure: rapida e forte è infatti la smemoratezza. La "parabola" dello scompartimento di treno vale per il carcere, e per il "nuovo giunto" che arriva all’improvviso ad occupare un posto nella cella per sei o otto persone dove cinque o sei detenute si erano sistemate da tempo, appropriandosi di ogni spazio. Tutte, e anche io, si chiedono: come sarà questa "nuova giunta"? si adatterà a noi o porterà ancora più problemi? Ma questo atteggiamento, visto in piccolo per una cella del carcere, è lo stesso che si ritrova in situazioni più importanti, nei paesi dove improvvisamente arrivano gli immigrati stranieri, guardati a vista come "occupanti" del proprio comodo scompartimento. L’Homo Sapiens viene dall’Africa ed è per natura un animale migrante, la migrazione da territori poveri a territori più ricchi esiste da sempre. Eppure noi, che viviamo in un posto "comodo e ricco", non siamo in genere così generosi con i nuovi arrivati. Io in proposito posso solo raccontare qualcosa che riguarda il mio paese d’origine, i Paesi Bassi. Dopo la guerra, negli anni cinquanta è iniziato il rimpatrio di olandesi dalle terre dell’ex impero coloniale (l’attuale Indonesia). Tanti di loro hanno un colore diverso e occhi come nocciole, per questo gli hanno dato il nome di Katjang, cioè arachide, nocciolina. Le loro abitudini erano diverse, la loro cucina troppo aromatica e profumata per il naso degli olandesi. Il tempo però ha attenuato certi contrasti, e gli olandesi hanno finito per accettare in pieno l’uso delle spezie per profumare i loro piatti, i gustosi rysttafels, letteralmente "tavole di riso", un piatto tipico indonesiano, sono diventati una ricetta nazionale dell’Olanda, Poi sono arrivati gli anni ‘60, quando c’era troppo lavoro nel nostro paese, così cominciarono ad emigrare in Olanda turchi e marocchini, e più tardi, una ventina d’anni fa, iniziò l’emigrazione italiana. Gli italiani lavoravano come marmisti, mosaicisti, carpentieri, ristoratori e gelatai. Naturalmente il processo di inserimento non fu senza problemi, e forse agli occhi delle madri olandesi gli italiani, con le loro canzoni e i loro sorrisi, erano troppo seducenti per le loro figlie, ma oggi tante paure sono state sconfitte e la nostra è diventata davvero una società multietnica. Paola - Una donna italiana in un carcere della Baviera Una struttura vecchia di 150 anni, con muri scrostati, celle di "accoglienza" da 8-10 letti con un unico "bagno" Di Paola, settembre 2003 Un’esperienza certamente dura, durissima è stata la mia permanenza in carcere in Germania. Anzi, in Bayern. C’è una premessa da fare: il Bayern è sì in Germania, ma è "Freistaat", Stato Libero. Questo significa che sia le leggi penali che il regime carcerario sono diversi dal resto del paese. Diversi, o, meglio, più severi. Il Bayern crede nel carcere come "punizione", non certo come "rieducazione", o almeno questa è stata la mia impressione, basata sull’esperienza della mia permanenza di due anni e cinque mesi in tre diversi carceri. Il primo anno l’ho trascorso nel carcere di Norimberga. Ero alla mia prima esperienza carceraria, e il ritrovarmi in una struttura vecchia di circa 150 anni, con muri scrostati, celle di "accoglienza" da 8-10 letti con un unico "bagno" (un water e un lavabo vecchi e sporchi, rinchiusi all’interno di un "prefabbricato" di plastica), mi ha suscitato un senso di sporco, di abbandono, che mi ha fatto pensare a certi servizi televisivi visti sulle peggiori strutture italiane. Sì, certo, il problema del sovraffollamento è pressoché inesistente, o, almeno, io non l’ho toccato con mano, ma questo perché il "Land" abbonda di carceri! Il disagio che più ho provato è stata la sensazione di "essere prigioniera" a tutti gli effetti. Lì non si dimentica mai. L’anno del carcere preventivo l’ho speso in una cella "singola", di 4 metri per 2.5, con una finestra posta a filo del soffitto, alto 4 metri, con il WC e il lavabo a mezzo metro dal letto, senza neppure una tenda per "coprirlo", senza corrente elettrica, a parte un neon che rimaneva acceso 16 ore su 24 anche d’estate, con una radiolina a batterie che io, tra le poche fortunate, ho potuto comprarmi, senza acqua calda (alle docce si accedeva in sei persone per volta, tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00, tranne sabato, domenica e festivi), dove si rimaneva aperti, almeno nel mio braccio, dalle 17.00 alle 20.45, più mezz’ora a pranzo per accedere alla mensa. Non esistono sbarre sulle porte, ma solo blindi completamente chiusi, con uno spioncino di modo che gli agenti possano guardare all’interno senza essere visti e che, nella maggior parte dei casi, veniva "oscurato" dalle detenute. Con questo tipo di "porta" quando si è chiusi, e cioè quasi sempre, si è completamente isolati. Ci era concessa un’ora d’aria al giorno Il cibo era scarso e pressoché immangiabile, e per questo, durante i primi tre mesi, ho perso 16 kg. Ho imparato a sopravvivere acquistando dolci e cioccolata e cucinando ogni tanto qualche pastasciutta al pomodoro nel cucinino con due piastre che avevamo nel corridoio, fuori dalla cella. La posta, sia in entrata che in uscita, passava per l’Ufficio del Procuratore, veniva tradotta e letta, e per questo impiegava anche un mese per giungere a destinazione. Per comprendere però la vera essenza del sistema bavarese, devo parlare del carcere definitivo di Aichach, carcere dove sono stata un anno e mezzo. Aichach è un carcere femminile che ospita circa 450 donne, la maggioranza con pene definitive, più, circa, un centinaio di uomini con condanne al di sotto di due anni. È una struttura dei primi anni del ‘900, dove, però, la ristrutturazione è ottima e continua. Il carcere, al primo impatto, è quasi "bello" da vedere. C’è una struttura circolare, al centro, dove è posto un grande ufficio, sempre circolare, tutto di vetro, dove vi è un numero enorme di monitor attraverso i quali si controlla tutto il carcere. Da lì si snodano quattro bracci di quattro piani l’uno (compreso il pianoterra), dove sono posizionate le celle. In ogni cella vi è un interfono con il quale si può comunicare con l’ufficio degli agenti di sezione. Tutto molto ordinato e burocratizzato! Ma veniamo alle regole, molte e ferree Gli orari sono: sveglia alle 6.00, durante la settimana e alle 8.00 il sabato, la domenica e i festivi. Alle 6.00 le celle vengono aperte per un’ora, per dare modo a coloro che lavorano (la maggioranza, visto che il lavoro è obbligatorio per i "definitivi") di prepararsi, di far colazione, di andare in doccia per essere al lavoro alle 7.00. Chi lavora, quando lavora, perché anche lì ci sono problemi di scarsità di "commesse", durante la settimana rimane fuori cella praticamente tutto il giorno, ma si ritrova, nel lungo fine settimana, a dover rimanere quasi sempre chiuso: secondo quanto mi è stato spiegato da un agente, per aver modo di riflettere sui propri "errori"! Arbeit macht frei! Un capitolo a parte è quello del lavoro. Lì è obbligatorio, se ci si rifiuta, la prima punizione è la sospensione del permesso di fare la spesa per tre mesi! Si lavora per 7 ore e mezza tutti i giorni fuorché il venerdì, giorno in cui si lavora 5 ore e mezza. Il salario è di 1 euro e 32 centesimi all’ora (fino al gennaio 2003 era di un euro e venticinque centesimi) per ogni ora effettivamente lavorata. Se ci si assenta, anche solo per dieci minuti, per esempio per andare dal medico o perché si viene chiamati in qualche ufficio, i dieci minuti d’assenza vengono decurtati. Se ti spediscono in cella, perché non c’è lavoro, non pagano. Questo significa che, quando va benissimo (a me non è mai capitato, in un anno e mezzo) si svolgono circa 140 ore di lavoro mensile e si ottiene uno stipendio di circa 190 euro, da cui viene poi tolto il 3.5% per l’assicurazione sul lavoro. Di questa cifra si può utilizzare, per la spesa mensile, una parte pari ai 3/7 del totale, mentre i 4/7 vengono messi in un conto "bloccato" e vengono "liberati" al momento del rilascio (o del trasferimento in un altro paese, come nel mio caso). Se uno ha la TV deve pagare 16 euro mensili per l’affitto dell’apparecchio e il canone La spesa è, appunto, mensile, si fa cioè una sola volta al mese e a volte possono passare anche sei settimane tra una spesa e l’altra. Si può ben capire allora cosa si possa acquistare con circa 60-70 euro, una sola volta al mese. Ma spesso capita che gli euro a disposizione siano molti meno, come mi è successo più di una volta, quando mi sono arrangiata con 40 euro. 40 euro è, poi, la cifra massima di spesa a disposizione di coloro che non lavorano. Da contare che se uno ha la TV deve pagare 16 euro mensili per l’affitto dell’apparecchio e il canone. In cella sono permessi due paia di jeans, che il carcere ti dà al momento del tuo arrivo, sette maglie, quindici paia di slip, sette paia di calzini, una camicia a scacchi, sempre data dal carcere, non più di quattro paia tra scarpe e ciabatte, quattro asciugamani, niente accappatoio, niente lenzuola private, né camicie da notte private. La femminilità, la cura della propria persona, la vanità, non sono "contemplate nel regolamento". Tanti bei soldatini, tutti uguali, senza individualità. Lì c’è un tentativo costante di soffocare la personalità La burocrazia è spaventosa. La cella è piccolissima e singola, con una finestrella da cui si vede solo il cielo e che per aprire e chiudere bisogna salire su di una sedia, (io non sono bassa, sono un metro e settantatre centimetri!), con tazza WC e lavabo attaccati al letto, un tavolino, una sedia, due mobiletti per tenerci la spesa, un armadietto per il vestiario, e questa cella non si può "arredare". Vietato appendere ai muri o ai mobiletti qualche foto o qualcosa di allegro (per non parlare poi di foto un po’ "osé"); c’è un’unica stecca di legno, lunga come il letto, a cui attaccare i propri "ricordi". Non si può tenere in cella troppa posta o troppe foto. Bisogna depositare ogni cosa in magazzino. Tutta la propria vita dev’essere "custodita" in pochi metri quadri. Il non poter consegnare o ricevere pacchi rende impossibile qualsiasi tipo di "contatto" col mondo reale. Non si possono ricevere riviste, a meno che non ci si faccia, da soli, l’abbonamento, il cui costo rende quasi impossibile averne. A me venivano spediti tutti i numeri di Ristretti Orizzonti, ma ne ho letti solo due, che sono riuscita ad avere per l’intercessione di un’agente, l’unica un po’ "umana". La posta, in entrata ed in uscita, viene letta da un’apposita commissione La privacy non esiste! La posta, in entrata ed in uscita, viene letta da un’apposita commissione. Le lettere si devono spedire aperte e si ricevono altrettanto aperte. Non si possono scrivere critiche al carcere o agli agenti, non si può parlare di ciò che succede all’interno del carcere. Io, per scrivere questo, ho atteso di rientrare in Italia. Mi era stato chiesto di mandare qualcosa sulla mia esperienza "tedesca" all’epoca in cui ero lì, ma non mi sono fidata a scrivere nulla: sarebbe stato censurato. Non esistono "discussioni" sulla situazione carceraria: il mondo esterno non sa e non deve sapere Lì non esistono "discussioni" sulla situazione carceraria: il mondo esterno non sa e non deve sapere. Una raccolta di firme, una "riunione" di detenute, una protesta di qualsiasi tipo, vengono punite severamente. I divieti sono "milioni". Non esiste "rieducazione". Non esistono corsi o attività ricreative. Esistono solo il lavoro e la cella. Non c’è palestra (solo una cyclette per 120 persone, circa); c’è un misero corso di computer, a cui possono accedere solo cittadine tedesche in procinto di uscire. Non esiste un corso di Tedesco per stranieri, non esistono volontari che possano entrare; esiste solo un gruppo teatrale, di circa una decina di detenute (su 450!), di lingua tedesca, che organizza due spettacoli all’anno. E poi… c’è la Chiesa. Tutti i giorni si può andare a pregare. Wurstel fritto o una coscia di pollo o tacchino, ma solo due volte al mese Vorrei ora dare un’idea del trattamento che si riserva ai detenuti per quanto concerne il cibo. Innanzitutto parliamo del quantitativo di vitamine settimanale: 300 gr. di frutta, circa due mele piccole, alla settimana; poi, 500 gr. di latte, sempre alla settimana, 250 il martedì e 250 il giovedì, giorni in cui viene consegnata anche la mela. Un pranzo tipo consiste in due cucchiai di riso bollito, un mestolino di salsa rossa, completamente liquida, al gusto di "pomodoro", due o tre foglie di insalata scondita e un medaglione, fritto nella margarina, fatto di pane raffermo, impastato con qualche erba, dove le calorie derivano dai grassi contenuti nella margarina! A volte un pezzo di strudel di mele con salsa al gusto di vaniglia (acqua giallastra), e… basta. Spesso, al posto del riso, patate o insalata di patate (sempre un mestolino), e, nel caso di persone che mangiavano carne, wurstel fritto o una coscia di pollo o tacchino, ma solo due volte al mese! La cena, poi, consegnata intorno alle 16.00, poteva essere 4 o 5 fette di formaggio da toast, oppure 2 uova sode e un formaggino, o un mestolino di pudding annacquato, oppure uno yogurt da 125 grammi. Con un pomodoro della grandezza di una pallina da pingpong, per i vegetariani, e per i non vegetariani c’era quasi sempre… wurst. Cinque o sei fettine di affettato di pasta di wurstel, di gusto indefinito. Poi, una volta alla settimana, 250 gr. di margarina e una volta ogni due settimane 400 gr. di confettura. Sono ancora viva, e, soprattutto, non mi sono "rovinata", ma la mia sopravvivenza è dovuta al fatto che riuscivo a prepararmi e mangiarmi una torta intera ogni due giorni. Sicuramente però ho imparato "l’economia domestica": ogni piano aveva, infatti, una cucina, completa di piccolo frigorifero, quattro piastre elettriche e un forno, a disposizione di, circa, quaranta persone. Con i miei 5060 euro mensili (più tre spese annuali) riuscivo ad acquistare il caffè solubile, il tabacco, le cartine per fumare, il materiale per i dolci, il latte con cui mi preparavo lo yogurt. Poi i prodotti per l’igiene personale, l’olio di oliva e due kg. di carote, unica verdura accessibile e che si manteneva per un mese, fino cioè alla spesa successiva. Posso aggiungere anche che non solo la scarsità era scandalosa, ma anche la qualità. Ho visto persone con problemi allo stomaco, al fegato, all’intestino, per il cibo che ci veniva dato. Naturalmente non si possono acquistare né patate, né succhi di frutta, né frutta sciroppata, per non dare la possibilità ai detenuti di prepararsi bevande alcoliche, che sono severamente vietate e altrettanto severamente punite. Non si può avere neppure un profumo, perché i profumi contengono alcol! Regolamento! Nelle carceri della Baviera è una parola-incubo A proposito di punizioni vorrei, a questo punto, parlare della facilità con cui si prendevano e del tipo di punizioni che venivano inflitte. Lì non si dà confidenza agli agenti, non ci si può arrabbiare, né alzare la voce. Si rischia di essere chiuse in cella, senza possibilità di uscire nelle ore di apertura, per una o due settimane, a discrezione del capo sezione, senza TV. Se poi si viene scoperte alla finestra a parlare con qualcuno del maschile, nelle ore in cui gli uomini sono all’aria, la prima volta si ha la chiusura in cella, la seconda volta c’è il bunker. E qui vorrei spendere due parole sul bunker. È una punizione che decide il direttore per i motivi un po’ più gravi (la recidività a parlare con gli uomini era uno di questi!) come la positività alla droga o all’alcol, o il ritrovamento, da parte degli agenti, di pastiglie prescritte dal medico ma non ingerite quando si doveva (quello che si chiama "accumulo"), o le liti tra detenute, ecc. Il bunker è una cella sotterranea con una grata sul soffitto come finestra. Una cella dove la luce del neon è accesa 24 ore su 24, dove c’è una telecamera, collegata ad un monitor che sta in "Centrale", che spia giorno e notte ciò che la detenuta fa. Compresi i bisogni corporali! In bunker si rimane con la camicia da notte, poiché è l’unico indumento concesso; non si può scrivere né ricevere posta, non si possono avere i colloqui, solo l’ora d’aria da passare in un cortiletto a parte. Questo è il regime di un carcere che sorge a 10-15 km da Dachau, nome che evoca ricordi storicamente "forti" e non piacevoli! Che sia un caso? Un’ultima parte la voglio dedicare alla possibilità che si ha di mantenere i contatti con la famiglia e soprattutto con i figli. I colloqui sono permessi per due ore al mese, mezz’ora alla settimana, oppure un’ora ogni due. Per gli stranieri, naturalmente, neppure se una persona vede i famigliari ogni sei masi è possibile fare più di un’ora di colloquio. Il regolamento! L’incubo del carcere bavarese. Non esistono eccezioni. La sala colloqui è una sola, con tavolini uno vicino all’altro, dove è impossibile parlare con un po’ di "pace". Bambini piccoli che strillano (non esiste una sala per i "colloqui speciali"). Ai colloqui non si può introdurre alcunché. Neppure un biberon o qualche biscottino, nel caso si tratti di bambini piccolissimi che vengono a trovare la madre detenuta. Unica concessione, una volta al mese: chi viene a trovarti può acquistare all’interno del carcere un pacchetto di sigarette e una tavoletta di cioccolato. Una delle ultime regole che ho scoperto (tanto per dare l’esempio della volontà di complicare la vita a noi detenute) è la seguente: non si possono mandare nella medesima busta denaro e francobolli. Sono piccoli esempi di come le "cose semplici" possono diventare "questioni impossibili". Piccoli esempi di come la "burocrazia" può complicare la vita. In Germania più che qui da noi. Legato strettamente al problema dei colloqui, unico momento di "contatto" con la famiglia, c’è quello delle telefonate. Peccato che in Bavaria non c’è il diritto alle telefonate. Solo il "buon cuore" dell’unica assistente sociale mi permetteva di chiamare a casa una volta ogni due mesi circa Solo il "buon cuore" dell’unica assistente sociale, che si occupava di più di 100 persone (compresi i 7-8 bambini del nido), tutte con pene superiori ai 5 anni, e che aveva un ruolo simile (simile per modo di dire) a quello che qui hanno gli educatori, mi permetteva di chiamare a casa una volta ogni due mesi circa. La cosa era a sua discrezione, per cui è successo più di una volta, o perché la signora era in vacanza, o perché aveva una "brutta giornata", che le telefonate saltassero. Ho cercato, a grandi linee, di dare un’idea della situazione carceraria di un paese dell’Unione Europea, nostro vicino, che si ritiene molto più civile dell’Italia. Ho cercato di dare un’idea, attraverso delle cose reali, senza descrivere i sentimenti che può provare una persona in quelle condizioni. Ho cercato di essere obiettiva. Sicuramente non ho esagerato la situazione. Vi sarebbero molte altre cose da descrivere, ma il solo ricordare mi fa male. Ho faticato molto a buttare giù questo pezzo poiché certe esperienze è meglio dimenticarle. È più "salutare". Io ho "retto" perché sono comunque una persona forte, ma, vi assicuro, io sto meglio in carcere in Italia! Paolo Pasimeni - La disperazione del primo impatto con la galera al Circondariale Dicembre 2005 La mia esperienza con il carcere ha avuto inizio con il mio ingresso nella Casa circondariale “Due Palazzi” di Padova nel 2001. Non ero mai stato in carcere prima d’allora e mai avrei pensato di entrarvi, vista la mia totale estraneità a qualsiasi tipo di delinquenza. Mi ricordo il mio ingresso nell’istituto come l’ingresso in un mondo parallelo fatto da cancelli e blindi al posto delle porte, e sbarre al posto delle persiane. Mi ritrovai in una delle celle dell’isolamento in cui fui segregato per qualche tempo per ordine del giudice per le indagini preliminari. Dopo alcuni giorni, iniziai ad andare “all’aria”: un corridoio largo circa due metri e mezzo e lungo una ventina, circondato da cemento e filo spinato. Il regime di alta sorveglianza cessò nel giro di meno di una settimana e venni “declassato” a detenuto comune. Purtroppo però, a causa del sovraffollamento, mi trattennero nel reparto isolamento nonostante l’ordinanza emessa da parte del giudice. Nel frattempo tale reparto iniziò a popolarsi di altri detenuti, tanto da riempire le celle d’isolamento con tre detenuti per cella, cosa, questa, che mi pare entri in conflitto con il significato della parola isolamento. Capii però ben presto come nel mondo in cui ero entrato di logica ve ne fosse ben poca. L’acqua che fuoriusciva dal rubinetto era limacciosa, i sanitari erano fatiscenti e, per di più, non si potevano avere in dotazione i detergenti. Ci si poteva fare una doccia una volta alla settimana, perché l’intero braccio era pressoché sprovvisto di docce. Ben presto alcune persone detenute presso le celle contigue alla mia iniziarono a protestare e non mancarono atti di autolesionismo. Per tranquillizzare gli animi, mi ricordo che venne il comandante e ci disse che nel giro di pochi giorni saremmo stati collocati presso il reparto dei comuni. Nove compressi in una cella da quattro Entrai, quindi, nella cella 25 del secondo blocco della Casa circondariale e all’inizio mi sentii preso dall’angoscia, poiché mi ritrovai in mezzo ad altre otto persone in uno spazio progettato per contenerne quattro. Ero il più giovane e venni accolto positivamente da tutti i componenti della cella. Ma stare in nove in quella stanza così piccola era molto difficile, la convivenza forzata fra persone estranee e con problemi differenti come la tossicodipendenza e/o problemi psichici era spesso causa di discussioni animate. C’é da dire che, però, io fui fortunato a capitare in quella cella, poiché la maggior parte erano delle singole in cui erano stipati tre detenuti che, per tutto l’arco della carcerazione, dovevano condividere gli stessi cinque-sei metri quadrati con annessi sanitari a vista, tavolino e 2 sgabelli. In effetti, il terzo sgabello non aveva senso tenerlo in quelle celle, tre detenuti in piedi non ci potevano fisicamente stare: uno, almeno, doveva rimanere sempre seduto o disteso sul letto! Gli spazi ricreativi erano relegati ad un’ora e mezza al giorno passata in una sala in cui circa 50 persone si trovavano a dividere un tavolo da ping-pong e un calcio balilla. Nemmeno le tre ore di passeggi quotidiane erano tanto meglio. Le arie erano due. Una di queste era un campo da calcio non regolamentare colmo di buche e completamente sprovvisto di tettoia sotto la quale ripararsi in caso di mal tempo. L’altro passeggio era completamente in cemento, grande più o meno quanto un piccolo campo da pallacanestro. Va detto, inoltre, che entrambe le arie erano sprovviste di un bagno e, quindi, si doveva costantemente fare attenzione a non sporcarsi con i “residui organici” altrui. Le condizioni igieniche all’interno dell’istituto, poi, non erano tanto migliori. Aree come la biblioteca erano pressoché inagibili, c’erano nidi di uccelli al suo interno per non parlare dei cumuli di polvere che sovrastavano i libri. Tale area era chiusa, perché il tragitto che portava dalla rotonda alla biblioteca era pericolante; c’erano pezzi di soffitto sul pavimento e le transenne piazzate per i lavori di ristrutturazione rimasero lì per tutto il periodo trascorso da me in quell’istituto. L’impressione che ho avuto dello stato in cui versa la Casa circondariale di Padova è quella di una struttura al collasso, in cui nessun parametro igienico-sanitario può venire rispettato, a scapito della salute dei detenuti, ma anche degli operatori. Mancano i farmaci a causa del sovraffollamento, persino le aspirine sono un lusso e anche un semplice mal di testa può essere un problema serio da risolvere. Susanna Ronconi - Diario minimo da un altro tempo, ma che non è detto non sia ancora qui, annidato nel tempo presente, pronto a balzar fuori… Queste sono le carceri italiane anni ‘70 e ‘80, come escono dalle pagine di un vecchio "diario carcerario", quello di Susanna Ronconi, condannata per terrorismo. Ora Susanna è responsabile del Centro Studi Gruppo Abele, e si occupa con grande competenza di tossicodipendenza e di riduzione del danno. Pubblichiamo queste pagine perché certe realtà del nostro passato è sempre meglio non dimenticarle. Novembre 2001 Le Nuove di Torino, tra gli anni ‘70 e gli ‘80 Il sotterraneo me lo ricordo, c’ero scesa con Liviana e con suor Angela. C’erano vecchi bauli da svuotare, abiti da scena per recite di detenute dei decenni precedenti, prima della riforma. Abiti donati da signore della Torino bene, paillette, seta, frange. Abiti indossati da chissà quali donne: chi c’era prima di noi e prima delle tossiche e prima delle rapinatrici, libere donne degli anni settanta? C’erano le donne semilibere, qui, fino a qualche anno fa, dice suor Angela. Che angoscia, sussurro io. Bello schifo, alla faccia della riforma, dice Liviana. Le celle sono sotto il livello del terreno, una grata piccola e oscurata da polvere, terra e ragnatele fa intravedere il ciglio del cortile di cemento. Un ottocentesco soffitto a volte percorre il lungo corridoio dove si affacciano porte di legno grigio con chiavistelli spropositatamente grandi, e spioncini piccoli. Ovunque buio e umido. Un filo di luce a mezzogiorno, e scalpiccio di pantegane, specie d’estate. Del sotterraneo, me ne aveva parlato Sara, del suo letto di contenzione alle celle delle Nuove, nell’anno della rivolta, il ‘77. Del sorriso del maresciallo, dopo la lotta e le urla e il rifiuto di entrare in cella, nel girare le bende ruvide attorno ai polsi e fissarle al pancaccio. Due giorni e due notti. Lame di sole obliquo e buio e topi e mosche. E le voci delle altre, a chiamare a salutare e fischiare per non farla sentire sola. E le urla delle guardie a farle tacere. Mani legate e corpi esposti al potere totale di un altro e buio intorno pieno di rumori da decifrare senza poter dormire e scalpiccio di topi o di anfibi militari che si avvicinano (perché vengono qui? per fare cosa? cosa accadrà, adesso?) Santa Virdiana - Firenze - Isolamento - 1982 Voci di donne, ora, stemperano la tensione accumulata in caserma tra rumore di passi, porte aperte di scatto, uomini a cerchio sempre attorno, lo sguardo fisso sul mio viso. Il carcere mi accoglie di nuovo nel suo grembo di matrigna, mi nutre di cibo in scodelle di acciaio, mi prepara il letto con lenzuola ruvide, di quelle che durano una vita (…). Il suono femminile tenace delle voci, giù in cortile, e la femminile perversità di accudire un corpo chiuso, mi danno una sorda tranquillità. Le voci delle compagne, in cortile, si fanno più eccitate, rimbalzano sui muri alti del vecchio convento, passano le prime sbarre, e la rete fitta, e le seconde sbarre della piccola finestra. Le riconosco, ad ognuna il suo volto. Alcune mi emozionano. Il mio nome e poi "fuori dall’isolamento", urlato, scandito, cantato. Sensazione calda, sono accudita, ora posso anche piangere un po’. Quasi mi assopisco, vedo la luce trascolorare verso un riflesso dorato, non ho l’orologio, intuisco un pomeriggio d’autunno che si consuma, là fuori. Le donne, nel cortile, non scandiscono più il mio nome né gli slogan per avermi con loro. Percepisco una contrattazione, le loro voci, acute e sovrapposte, si alternano ad una voce, singolare e maschile. Le strisce di sole sul muro, ormai rosate, mi dicono che il pomeriggio volge alla fine. Dovrebbero essere chiuse in cella già da ore. Si rifiutano di rientrare, contrattano ancora. Ho paura di sentire anfibi militari avanzare rabbiosi sul cemento del cortile, mi sento impotente. Mi sento desiderata, anche: impotente e intenerita. Voghera - Massima Sicurezza - 1983 Le divise informi di stoffa ruvida con stampigliato sulla schiena "Trani - 1944" (ma eravamo belle lo stesso, bastardi, Dio se eravamo belle). E quando mettevano brutta musica a tutto volume sparata dagli altoparlanti in tutti i corridoi per impedirci di comunicare tra noi, noi cantavamo più forte, fino a gonfiare le vene del collo. E quando, al momento dell’arrivo, ci mettevano nude in fila e ci facevano fare sei flessioni e poi ci cacciavano a forza sotto le docce calde, per vedere se la vagina, rilassata dal calore, lasciava cadere esplosivi, messaggi cifrati, documenti politici, lettere d’amore clandestine, cacciavamo le lacrime in gola e cercavamo i nostri sguardi più sprezzanti e, perfino, qualche scintillio di ironia. E quando, rivestite delle divise naziste, e calze color militare che scendevano al polpaccio ad ogni passo e scarpe di cartone, incalzate dal fiato sul collo dello sbirro che dava il ritmo dell’apertura dell’infinita teoria dei cancelli blindati ripetendo "muoviti puttana". Sì, anche allora eravamo belle, bastardi, Dio se eravamo belle. Giudecca - Venezia - Isolamento 1988 Il carcere della Giudecca, con il grande portone, mi ingoia insieme alla scorta. Dovrò odiare questo luogo, anche questo luogo: me ne dispiace, è la mia città. Non è così che avrei voluto tornare, non in catene. Non si può stare chiusi, a odiare un luogo che si ama, per cui si muore di nostalgia. Ogni carcere è migliore di questo: il più buio, il più umido, il più duro. Ma qui, resistere alla struggente luce della sera, e alle campane in lontananza, e al dialetto dolce parlato dai carcerieri, e alla voce dei gabbiani. Qui la prigionia è insostenibile. Voci e suoni domestici, la lingua cantilenante, la lingua di mia madre. A sentire sardo e napoletano, almeno, potevo proteggermi con una estraneità; qui, invece, sono avviluppata dalla perversione della familiarità. Tutto qui mi rende inquieta: pochi cancelli, molte suore, la guardia della matricola con le pantofole friulane di velluto e gli occhi chiari, nessuno grida, pavimenti di legno antico. Eppure, i corpi sono chiusi, qui come altrove. È un penale, il carcere del tempo definitivo. Provo, per tutta questa dolcezza, un fremito di ribrezzo e, allo stesso tempo, di fascinazione. Il carcere tutto militare e maschile e duro da cui vengo mi tranquillizza e al contempo mi spaventa, visto da qui. Cosa e chi sto diventando, se addirittura lo rimpiango? Perché sono più salda sulle gambe lì che qui? Le donne qui mangiano insieme, non nelle loro celle, ma in una sala comune. C’è aria di refettorio, di convitto. Ma io ho una cella per me, non posso parlare con nessuna. Sono contenta di stare da sola. Voglio ripensare a tutto il luccicore del mare, allo Stucky che mi ha accolta. Voglio morire di nostalgia, piangere, finalmente non vista. Posso farlo: la cella è molto grande, potrebbe ospitare sei donne, anche di più, con i letti a castello. C’è un angolo, vicino al cesso, che rimane nascosto allo spioncino, fallimento della paranoia del panopticon. Se mi metto lì, posso piangere e pensare non vista. Da quanto non ho il dono dell’invisibilità? Si può fare, qui: sedia e tavolo e letto non sono imbullonati al pavimento, tutto si muove e si sposta, come in una stanza vera. La finestra ha sbarre e rete, lascia intravedere poco del mondo. Però, schiacciando il viso sulle sbarre, a destra, lo sguardo - forzando gli occhi fino a far male arriva ad una cupola chiara, a uno scorcio di tetti, e proprio vicino a me, è appollaiata una coppia di colombi. Sono stanca. Prendo la sedia che mi rende invisibile e apro il mio libro. Sandro Calderoni - Il carcere tra riforme e controriforme Dal 1975 a oggi, un detenuto ripercorre illusioni e delusioni di chi, dal carcere, ha visto alternarsi leggi garantiste a brusche e pesanti chiusure Ottobre 2006 Tempo fa sono venuti a trovarci in redazione, per illustrare la loro proposta di legge di riforma dell’Ordinamento Penitenziario, i magistrati Alessandro Margara e Francesco Maisto. La loro è stata un’esposizione molto ampia e interessante, in cui mi sono sentito personalmente coinvolto soprattutto quando Margara ha ricostruito, con ricchezza di particolari e di riferimenti storici, il complesso succedersi di riforme, mini-riforme e… controriforme che sono state emanate in materia carceraria negli ultimi trent’anni, a partire dall’entrata in vigore dell’Ordinamento Penitenziario del 1975. Questo disorganico e talvolta contraddittorio stratificarsi di leggi e di leggine - e in certi casi di improvvisati provvedimenti “d’emergenza” che poi sono durati anni, ammesso che non siano ancora in vigore - io l’ho vissuto per intero, dal di dentro e sulla mia pelle, perché ero in galera nel ’75, quando fu emanato l’Ordinamento, e in galera ci sono anche adesso, a trent’anni abbondanti di distanza. Credo perciò di poter offrire una testimonianza di parte ma attendibile su quali siano state e continuino a essere le ricadute psicologiche che questi trent’anni di garantismo a corrente alternata hanno prodotto sulla popolazione carceraria, piombandola in uno stato di cronica sfiducia nei confronti di qualsiasi nuovo provvedimento venga annunciato. Mentre Margara ripercorreva con precisione cronologica le varie tappe attraverso cui si è giunti all’attuale normativa sul carcere, dentro di me rivivevo il loro succedersi attraverso le mie personali esperienze, ricordando con chiarezza e ancor viva partecipazione sia le attese che le spinte riformiste avevano sviluppato all’epoca fra noi detenuti, sia – e più ancora, purtroppo – le brucianti delusioni provocate in seguito dall’involversi di quello spirito riformatore in una prassi tutt’altro che garantista, basata perlopiù su provvedimenti emergenziali e sostanzialmente “purgativi”. Il mio stato d’animo, così, quella mattina altalenava in continuazione fra alti e bassi, risvegliando in me sia il ricordo della tanto effimera euforia suscitata dalle “aperture” quanto il profondo senso di frustrazione provocato dalle successive, immancabili “chiusure” di un processo di riforma che, in trent’anni, non ha mai saputo uscire da uno stato di sostanziale precarietà. D’altra parte va detto – e lo stesso Margara l’ha chiaramente ammesso – che all’Ordinamento Penitenziario nel 1975 non si arrivò grazie a un preciso disegno politico riformatore sostenuto da una gran parte della classe politica e dell’opinione pubblica; ci si arrivò, praticamente, per forza maggiore, perché la situazione delle carceri italiane era divenuta insostenibile (istituti fatiscenti e sovraffollati, condizioni igieniche disastrose, evasioni all’ordine del giorno, frequenti e spesso clamorosi episodi di violenza fra detenuti e fra detenuti e agenti) e occorreva assolutamente disinnescare la “bomba” prima che esplodesse. Pressata dagli eventi e dalla preoccupazione dell’opinione pubblica più avveduta, la classe politica dell’epoca seppe tuttavia rispondere a quella sfida con lucidità, emanando una riforma – quella appunto del ’75 – talmente innovativa da porre il nostro paese, che fino allora era stato in materia di legislazione sul carcere uno dei più arretrati d’Europa, un passo avanti rispetto a tutti gli altri. Uscendo dall’angusta logica della repressione fine a se stessa e puntando tutto sui concetti di rieducazione e di recupero sociale, l’Italia concretizzava finalmente in termini di legge quanto, quasi due secoli prima, aveva sostenuto in tema di delitti e relative pene il maggiore dei suoi pensatori illuministi, Cesare Beccaria. Per quanto ben concepita e orientata, una legge però da sola non ce la fa a modificare la realtà. Tanto più se a smentire le sue buone intenzioni, e a renderle impopolari, sopravvengono emergenze politiche e sociali particolarmente gravi, che fanno prevalere la paura sulla ragione. E infatti la riforma del ’75 si impantanò, prima ancora di essere davvero decollata, nell’ondata di allarme sociale provocata dall’impennarsi proprio in quegli anni dell’attività terroristica. Nel rendere impopolari certi benefici che l’Ordinamento Penitenziario aveva appena concesso ai detenuti, come i primi permessi premio, certo concorse anche il fatto che più di uno di noi ne approfittò, dandosi alla fuga e commettendo nuovi reati; è fuor di dubbio, tuttavia, che fu essenzialmente il terrorismo – e il clima di “blindiamoli tutti” che aveva innescato – a svuotare di ogni autentico contenuto innovatore una riforma che, al suo nascere, aveva acceso tante speranze. E infatti non solo fu impresso agli istituti già esistenti un deciso giro di vite, ma vennero anche istituite nuove carceri di “massima sicurezza” in cui, in teoria, avrebbero dovuto essere reclusi soltanto i terroristi, ma che - in pratica - si affollarono ben presto soprattutto di detenuti “comuni”, i quali finirono per essere le vere “cavie da laboratorio” di un modo nuovo, ancor più repressivo, di intendere e di gestire la carcerazione. Stipate in spazi ristretti e stressate da controlli ossessivi, persone che spesso erano già di per sé delle “mine vaganti” esplosero in tutta la loro dirompente aggressività, dando luogo a un’escalation di violenze che finì presto per contagiare anche gli istituti cosiddetti “normali”. L’arrivo della “Gozzini” e poi la “controriforma” del 1991 Questo stato di cose si protrasse fino al 1986, anno in cui fu varata la nuova riforma dell’Ordinamento Penitenziario, meglio nota come legge Gozzini. Ancora una volta la repressione fine a se stessa aveva mostrato la corda, e occorreva raffreddare l’esplosiva situazione carceraria ponendo mano a un insieme di norme capaci di rendere la galera non solo più vivibile, ma più educativa e socialmente utile. La legge Gozzini seppe andare alle radici del malessere carcerario, prefigurando non solo una detenzione più clemente e rispettosa dei fondamentali diritti della persona, ma anche una serie di organici interventi-ponte (permessi “di risocializzazione” e non più solo per gravi motivi familiari, articolo 21, semilibertà, affidamento in prova ai Servizi sociali) finalizzati a promuovere un rientro in società a pena scontata non traumatico, ma graduale e in qualche misura guidato. Noi detenuti vivemmo l’avvento di quella riforma con entusiasmo, perché ci sentivamo finalmente coinvolti in un progetto che ci stimolava a tirare fuori il meglio delle nostre risorse e a guardare al futuro con maggiore serenità. Ma anche in quel caso le molte attese finirono ben presto per essere frustrate da una nuova, grave emergenza (la lotta alla mafia, questa volta), che ebbe l’effetto di indurre un nuovo, brusco retromarcia alla politica carceraria. Nel 1991 venne emanata infatti una legge che stravolgeva completamente lo spirito della Gozzini, escludendo del tutto dai benefici chi si era reso colpevole di alcuni crimini di particolare allarme sociale e prolungando i tempi d’accesso ai benefici medesimi per gli autori di altri, numerosi reati. Non solo l’area dei benefici si restringeva notevolmente (in molti casi addirittura annullandosi), ma si infrangeva di fatto il principio della individualità del trattamento, che era stato uno dei cardini della legge Gozzini. A contare, e a determinare la “qualità” della pena, ora era soltanto il tipo di reato; ragion per cui se disgraziatamente venivi coinvolto anche marginalmente, e con responsabilità personali minime, in uno dei reati che prevedevano l’annientamento dei benefici o l’allungamento dei tempi necessari per potervi accedere, ti ritrovavi – e in effetti ancora ti ritrovi – catapultato nei circuiti chiusi della carcerazione “cieca”, quella che ti taglia fuori dal mondo senza offrirti neppure una finestra di comunicazione con la vita esterna per un lunghissimo periodo, o addirittura fino al termine della pena. Da allora l’Ordinamento Penitenziario ha subito piccole ma costanti modifiche, che hanno finito per allontanarlo ulteriormente dal suo spirito originario, basato appunto sul carattere individuale della pena e del trattamento rieducativo. Ormai si ragiona praticamente soltanto in termini di tipologia di reato, e questo atteggiamento – che non tiene conto della singolarità di ogni persona, delle sue responsabilità ma anche delle sue potenzialità di recupero – viene rinfocolato ogni qual volta un fatto di cronaca particolarmente odioso o efferato scuote l’opinione pubblica, facendo prevalere la furia punitiva sul ragionamento e sull’oggettiva valutazione dei fatti. Il risultato è che le carceri di oggi, salvo rare eccezioni (le cosiddette “isole felici”, che poi davvero felici non sono, ma semmai soltanto “normali”), sono tornate a essere molto simili a quelle che la legge Gozzini si proponeva di “umanizzare”: buona parte dei detenuti non mette infatti il naso fuori fino al giorno della scarcerazione, e sono davvero pochi quelli a cui è concesso imboccare e percorrere con successo i percorsi di progressiva risocializzazione che costituivano il tratto più innovativo di quella riforma. Peggio ancora, sta prevalendo una visione “statistica” del carcere e dei detenuti che vi sono reclusi, come si trattasse non di persone (che hanno sbagliato, ma che non per questo hanno perso la propria umanità) ma di numeri con un segno negativo sempre davanti. Sì, perché i detenuti non hanno volto né personalità, ma costano: e costano maledettamente caro. Oltre che una perdita sociale, costituiscono infatti una costante perdita economica, e ormai sono purtroppo sempre di meno coloro che capiscono (come capì Gozzini, e capiscono ora Margara e Maisto) che l’unico modo per far tornare i conti (o quanto meno per renderli socialmente utili) consiste nel recuperare il maggior numero di detenuti possibile, e non certo nel costruire sempre nuovi e più arcigni recinti in cui ingabbiarli senza speranza. Tornando a quella mattina in cui Margara e Maisto sono venuti in redazione a spiegarci il loro progetto di riforma, ricordo con grande ammirazione la generosità umana e professionale del loro impegno. Ricordo però anche, e mi dispiace dirlo, che il mio entusiasmo era velato da una specie di frustrazione preventiva, perché in questi ultimi trent’anni di vita - buona parte dei quali vissuti dietro le sbarre - ho già visto troppe volte finire in nulla le più buone intenzioni. La mia critica non è volta certamente a Margara e Maisto, sia chiaro: ho infatti il massimo apprezzamento per il loro lavoro, e gli auguro con tutto il cuore di riuscire a condurlo in porto. La mia critica riguarda soltanto la maledetta, sfibrante altalena delle aperture e delle chiusure che si sono succedute nell’arco di questo trentennio, e che ora costringono a essere scettico anche chi, in cuor suo, non vorrebbe essere scettico per niente. Ion Puica - Ritorno a casa… e rifinisco in galera Alcuni anni di detenzione in Italia, l’espulsione a fine pena, appena il tempo di scendere dall’aereo e subito il nuovo arresto testimonianza raccolta da Marino Occhipinti, giugno 2005 Ion è stato uno dei grafici di Ristretti Orizzonti per un paio d’anni. Pochi mesi fa, quando il suo residuo pena è arrivato a meno di un anno, è stato espulso nel suo Paese di origine, la Romania. Mi ero raccomandato che ci facesse sapere le novità: il suo timore, rivelatosi poi fondato, era infatti quello di venire arrestato nuovamente, appena sbarcato dall’aereo che lo avrebbe ricondotto in Patria, per un vecchio conto in sospeso con la giustizia. Nel tal caso, e cioè se fosse arrivata una nuova detenzione, a Ion avevo chiesto di raccontarci come funzionano le carceri in Romania, se è vero che le condizioni sono migliorate, insomma una testimonianza diretta di quella che è la situazione. Detto e fatto, purtroppo. Ora Ion è il nostro “corrispondente estero” per la Romania, e in una lettera ci racconta come funzionano realmente gli istituti di pena nel suo Paese. Almeno quelli che ha “visitato”… Per prima cosa mi voglio scusare perché non vi ho scritto subito quando sono arrivato in Romania. Non lo so se l’avete già saputo, però quando sono arrivato qua mi hanno subito arrestato. Avevo una pendenza vecchia, che spero di riuscire a far “cadere” alla fine di questo mese quando avrò una camera di consiglio per il riconoscimento della pena che ho già scontato in Italia. Se non esco prima, di sicuro alla seconda camera di consiglio sarò fuori, giusto il tempo che dall’Ufficio di Sorveglianza di Padova arrivi la documentazione necessaria. Speriamo bene. Vi ringrazio per la rivista che ho ricevuto. Vedete se c’è la possibilità di continuare a spedirmi anche i prossimi numeri, così mi passo anche un po’ di tempo con i ricordi della redazione. Adesso io mi trovo nel carcere della mia città, Galati. Per i precedenti tre mesi, sono stato in carcere a Bucarest, dove è molto difficile vivere e addirittura sopravvivere. Sono sceso da un albergo a cinque stelle all’inferno delle carceri romene! Anche quello di Padova è un carcere, ma è imparagonabile a ciò che ho trovato nel mio Paese. Quando ero ancora lì in redazione, sulla rivista dell’Amministrazione penitenziaria avevo letto un articolo sulle nostre carceri. Si diceva che gli spagnoli ci avevano aiutati nella ricostruzione degli Istituti detentivi, che quindi venivano presentati come i migliori. Migliori persino di quelli europei, addiritura più vivibili di quelli italiani e tedeschi. Che bello che era quell’articolo dove si diceva che le condizioni detentive in Romania erano migliorate! Non è proprio così, qui si vedono delle cose che per la mente umana sono difficili da credere, però devo dire che dipende molto anche dalla persona che finisce dentro, e cioè se è “conosciuta” oppure no. Attualmente nelle carceri romene si trovano circa 50.000 detenuti contro una capienza di 36.743 posti letto. I problemi non si fermano qui. In ogni cella ci sono circa 20-30 persone ma i letti sono molto meno, quindi, alcune brande vengono occupate… da due persone. Vi sembrerà impossibile ma è così. Nella cella dove mi trovo io siamo in 19 ma i letti sono soltanto 13. I più “abbandonati” e senza famiglia, quelli “che non li cerca nessuno”, finiscono in due nel terzo letto a castello. Emarginati tra gli emarginati, a loro è quasi “vietato” scendere dalla branda: lo spazio non è sufficiente per tutti. Il “blindo” è sempre chiuso, e l’aria entra esclusivamente da una piccola finestra. Sporco e puzza si accumulano, d’altronde la maggior parte delle persone che sono rinchiuse qui fanno del carcere la loro vita, e in queste condizioni perdono qualsiasi stimolo a migliorare la loro esistenza. I colloqui? Qualcosa di inimmaginabile. I bambini piangono disperati perché non possono abbracciare i loro genitori, a causa di un muro divisorio che arriva a mezzo busto. Basta allungare una mano per accarezzare un familiare e scatta un rapporto disciplinare, che naturalmente incide sullo sconto di pena per buona condotta. Per ogni detenuto possono entrare fino a sei-sette familiari, ma le sale colloqui - sporche e puzzolenti all’inverosimile - sono piccole e si deve stare ammassati, perciò si crea una confusione che rende impossibili scambiarsi due parole in modo dignitoso. Il periodo in cui si può uscire all’aria aperta si limita a 15 minuti al giorno, gli alimenti per mangiare sono insufficienti, e quelli che si trovano da acquistare sono scaduti da tempo. Quindi per un detenuto che non ha nessuno è difficile vivere qui dentro, e per andare avanti ha solo un sistema: deve lavare i vestiti e le lenzuola per gli altri per ottenere qualcosa da mangiare. Il pranzo che fornisce il carcere, infatti, non sarebbe sufficiente a sopravvivere per molto tempo: una specie di minestra, così viene chiamata, consistente in un intruglio di acqua bollente dove, ispezionando bene, si può trovare qualche pezzettino di grasso. Questo succede perché la carne, che dovrebbe essere preparata per i detenuti, viene invece venduta sottobanco, da quelli che lavorano in cucina, ai detenuti “vip”. Un carcere in cui i detenuti “vip” hanno tutto, i poveri diavoli nulla I “vip” sono molto influenti e riescono ad avere di tutto, anche cose che difficilmente si può permettere un uomo libero. Naturalmente si tratta di cose illegali. Penso all’affettività, della quale in redazione parlavamo spesso, anche se in questo caso sarebbe più corretto parlare di sessualità. Ad esempio loro, i detenuti “vip”, possono stare in compagnia di una ragazza per due-tre ore in cambio di 100 dollari. Queste ragazze vengono scelte tra le assistenti sanitari che si trovano dentro il carcere, assistenti che esistono solo sulla carta perché, se chiedi qualcosa come ad esempio un’aspirina, gli agenti ti prendono in giro dicendo che non hai niente. Ci sono guardie che fanno la scorta ai detenuti “vip” fino al gabinetto, e per tale servizio prendono due-tre pacchetti di sigarette. Naturalmente, sempre per chi ha soldi in abbondanza, nelle carceri romene ci si può procurare anche la droga, così che il periodo di detenzione possa trascorrere più piacevolmente (dicono loro!). Per un ragazzo giovane che entra in carcere e sfortunatamente non conosce come funziona il sistema detentivo di questo Paese, la vita sarà molto dura. Non appena varcato il portone verrà perquisito in una maniera inimmaginabile, così inizia uno stato di alta tensione fin dal primo istante, che spesso sfocia in atti di autolesionismo. Una volta che la persona viene mandata nella stanza che gli è stata assegnata, viene ricevuta da un detenuto che si chiama “capo cella”. Ogni nuovo arrivato viene sottoposto ad un “interrogatorio” da parte del capo cella e degli altri detenuti più potenti, che vogliono conoscere il motivo della carcerazione e se ci sono familiari disposti… a spedire pacchi. Ogni volta che arriva un pacco, infatti, la metà va consegnata al capo cella. A chi si rifiuta… lascio immaginare le conseguenze, oltre al fatto che del pacco non ricevi più nulla, neppure quella metà che ti sarebbe “gentilmente” stata concessa. Stavo dimenticando di dirvi che il capo cella viene “eletto democraticamente” dagli altri detenuti, naturalmente scegliendo tra le persone più potenti e influenti della stanza. Sicuramente si tratta di un membro della piccola mafia di città dove si trova il carcere, quindi immaginate come sia difficile vivere per una persona di una città diversa. A Bucarest infatti è stata molto dura, ma tutto sommato sono stato quasi “fortunato”: ho trovato un paio di ragazzi di Galati che mi hanno aiutato, abbiamo fatto “muro” e ce la siamo cavata… D’altronde la vita quotidiana qui dentro è organizzata a bande di 4-5 persone, che spadroneggiano fregandosene di quelli che non hanno nulla da mangiare, ed anzi è proprio di loro, dei più deboli, che si approfittano. Non è un caso che quando ho spiegato ai miei attuali compagni come funzionano le carceri italiane mi abbiano preso in giro! Il lavoro interno praticamente non esiste. Solamente chi può uscire a lavorare nei campi e nelle foreste, naturalmente scortato dalle guardie, usufruisce di uno sconto di 4 giorni al mese di buona condotta. Non so se ne valga la pena. Definirli lavori forzati è poco. Li vedo rientrare sfiniti, e siccome poi l’acqua per lavarsi è scarsa e dell’alimentazione vi ho già detto, non si può certamente parlare di lavoro che favorisce il reinserimento nella società. Sapete poi cosa ho trovato di interessante da raccontarvi? Tutti gli stranieri detenuti dell’Unione europea, non appena diventano definitivi, vengono trasferiti in una nuova struttura di Bucarest, il carcere di Rahova. Lì si sta abbastanza bene, infatti ci sono anche parecchi “vip” e detenuti influenti. Credo che questa sia una scelta ben precisa e opportunamente studiata dalle istituzioni del mio Paese: gli stranieri devono avere un trattamento di favore, in modo che oltre confine non si parli male delle carceri romene. Affetti e sessualità Christine - Credo che curare gli affetti sia anche… voler bene a se stessi, perdonarsi, pazientare La testimonianza di Christine arriva dalla casa Circondariale di Rovereto, da un giornale che si chiama Dentro e che esce come inserto di Oltre il muro, la rivista dell’Associazione Provinciale Aiuto Sociale che si occupa di reinserimento e alternative al carcere a Trento. Christine parla di affettività con coraggio: di sesso, di omosessualità, ma anche delle lettere, che per una detenuta, nell’assenza di tutto, spesso sono la vera valvola di sfogo, e poi della necessità di imparare a volersi bene, a riconciliarsi con se stesse per poter vivere meglio anche con gli altri. Di Christine, agosto 2002 Donna… essere donna non è facile, mai! Ancor più quando si è donne detenute. Sono però consapevole che, nonostante tutto, l’altra metà del cielo ci appartiene, a tutte noi donne. Nostro è il suo azzurro sereno, nostra la luce, i colori, ma anche le nubi, la pioggia, il vento, la tempesta perché nostri sono i sentimenti, le emozioni, come nostre sono la sofferenza, il sacrificio, le rinunce… l’amore. Per me, donna e reclusa, l’affettività è tutto questo: un turbine di intense emozioni che può innalzarmi fino al cielo della felicità o sprofondarmi nell’inferno della disperazione. Bisogna ammettere che pur da detenuta mi è possibile non soffocare la mia affettività, avendo la possibilità di periodici colloqui e telefonate che permettono un confronto immediato con i miei sentimenti. La vera valvola di sfogo però sono le lettere: la cosa più bella in assoluto! Infatti non hanno orari, non impedimenti, nessuno può interromperle. A loro puoi affidare tutto, desideri, emozioni, paure, lacrime. Tramite la carta puoi confessare, scoprire, farti scoprire, giocare, litigare, far pace; far compagnia, voler bene, conquistare, amare, soffrire. In una lettera ti puoi raccontare, inventare, fantasticare, immaginare, viaggiare, volare… evadere! Tornar qui e sorridere. Tutto si può in questi fogli di piccola grande libertà. Puoi anche stuzzicare, provocare e ritirarti, buttarti e ripensarci, sedurre, farti sedurre, far l’amore… far sesso… Ah, il sesso! Ecco il punto dolente per noi recluse, credo sia una parte integrante dell’affettività, uno stimolo umano, un desiderio legittimo, ma proprio nel momento in cui, forse, avremmo più bisogno di essere rassicurate anche in questo, ci viene negato. Palliativi ne esistono, eccome, ma palliativi appunto come l’autoerotismo o l’omosessualità. Sull’autoerotismo non voglio soffermarmi, appartiene alla sfera più intima di ciascuna di noi. Dell’omosessualità ne posso accennare per averla osservata, vissuta in terza persona. Ho conosciuto compagne che hanno avuto di queste esperienze, magari solo per bisogno d’amore, di attenzioni, per sentirsi importanti, per poterne parlare, per "provarci", per essere alla moda o per passate delusioni. Anche questa è una piccola libertà, ognuna se consapevole è libera di scegliere come meglio vuol "farsi" la carcerazione, purché il tutto sia nel rispetto delle altre compagne. Quello che non sopporto è la prevaricazione, il volerci provare a forza, questo no, non lo sopporto! E pensare che le donne gay (vere) spesso sono goffe, timide, prevedibili, mi farebbero tenerezza e sorridere se non fosse che in carcere è meglio non attirare mai la loro attenzione perché potrebbero diventare ossessive, appiccicose, morbose, gelose, a volte violente. Roba da rinchiudersi in cella per sfuggire alle loro avance o ancor meglio farsi trasferire di carcere. Invece dovrebbe vigere il rispetto perché il fatto di essere detenute non comporta a priori la rinuncia dei propri valori, della propria dignità, del proprio "vivere", non è per intolleranza o pregiudizio che dico questo, ma per la libera scelta che ognuna deve poter fare. Credo però che l’affettività sia anche… voler bene a se stessi, perdonarsi, pazientare, smettere con il vittimismo, con le lamentele, con la diffidenza ed il sospetto. Accettare finalmente la pena quale logica conseguenza dei nostri sbagli; sono sicura che questo ci aiuterebbe a vivere meglio qui dentro ed a ricostruire il nostro futuro. Personalmente so che pur conoscendo difficoltà, disagi, sofferenze, sacrifici, piccole e grandi rinunce, starò male solo se e quando mi accorgerò di non aver più niente da dare… ma forse anche allora avrò pur sempre un sorriso, una carezza, un ciao per tutti voi. Francesco Morelli - Un punto di vista maschile sulle corrispondenze da detenuto a detenuta "Nel carcere a volte gli uomini imparano a sognare, le donne smettono di sognare… Neanche qui riusciamo ad andare d’accordo…" Gennaio 2001 Da circa un anno e mezzo ho uno scambio di lettere con le donne detenute alla Giudecca. In questo periodo ho conosciuto e dialogato, credo utilmente, con Cristina, Bianca, Marianne, che ora sono tornate in libertà. Attualmente sono in corrispondenza con Giuliana, che si trova in Alta Sicurezza e spera di essere declassificata quanto prima. Dopo aver letto le opinioni delle donne su questo tipo di corrispondenza, la prima tentazione è stata quella di rinunciarci per sempre, ma ho anche considerato che tutte le "relazioni" avute finora sono state positive, quindi che posso ragionevolmente mettere in discussione quello che emerge dal loro articolo. La corrispondenza tra detenuti, in particolare tra persone di sesso differente, richiede buon senso e reciproca onestà, perché duri nel tempo e non degeneri. Bisogna capire, innanzi tutto, che da un altro detenuto non puoi aspettarti l’aiuto che potrebbe darti una persona libera. Bene che vada, puoi ricevere qualche consiglio di natura legale, o sulle migliori strategie di sopravvivenza al carcere, se l’interlocutore ha un po’ d’intelligenza e di esperienza. È difficile sperare in aiuti economici, perché ognuno ha già abbastanza problemi per conto suo, e anche la prospettiva di realizzare progetti in comune è molto remota. Nella corrispondenza, di solito, ci riveliamo (e ci scopriamo) diversi da quella che è la nostra immagine pubblica: magari siamo abituati ad esibire un carattere di ferro, poi abbiamo bisogno di uno spazio segreto in cui sfogare rabbie e frustrazioni, in cui esternare anche il nostro dolore… se troviamo qualcuno disposto ad ascoltarci. Questo accade per le donne come per gli uomini ed il fatto di essere detenuti non credo possa stravolgere certi comportamenti, li rende solo più appariscenti. Il mostrarsi forti, in carcere, è quasi una necessità: serve ad evitare tante piccole (e grandi) sopraffazioni. Ma ciascuno di noi è un leone o una pecora, a seconda delle circostanze, ed è proprio grazie a questa natura "ibrida" che riusciamo a provare qualcosa di più umano, che non sia unicamente il disprezzo verso chi è debole di carattere. Inoltre interviene l’orgoglio, ad impedirci di denunciare le frustrazioni che sperimentiamo ogni giorno. Secondo me, le compagne della Giudecca si sentono più forti ed autosufficienti perché vivono in una comunità di sole donne, dove inevitabilmente sviluppano forme di compensazione all’assenza degli uomini, che sono mitizzati, in senso positivo o, più spesso, negativo: diventano così i molestatori, i violenti, i deboli con la faccia da duri e così via. Accade la stessa cosa qui a Padova, del resto, dove siamo tutti uomini e le donne vengono talvolta facilmente classificate in due categorie: le sante (madri, sorelle, mogli devote) e le puttane (tutte le altre… praticamente). In carcere può succedere anche che gli uomini, che dedicano qualche attenzione in più alle loro compagne, durante i colloqui o tramite la corrispondenza, vengano derisi, considerati privi di carattere; molti sono poi gli uomini che incolpano le donne di essere all’origine delle proprie disgrazie. Sostengono di essersi rovinati nel tentativo di procurarsi i soldi necessari per farsi accettare da qualcuna, oppure per mantenere una relazione dispendiosa, o anche per questioni di gelosia, e la misoginia trapela spesso dai discorsi… naturalmente quando non ci sono donne presenti. Però è sufficiente che nella comunità entri una persona di sesso differente e, di solito, gli atteggiamenti diventano più equilibrati, gli stereotipi (positivi o negativi che siano) vanno in frantumi. Solo vivendo vicino ad una persona puoi valutarne i pregi ed i difetti, farti un’idea di come è realmente e decidere se vale la pena di continuare a frequentarla: il resto è morale da caserma, al maschile o al femminile non fa differenza, e non mi pare né costruttiva né interessante. Le considerazioni delle compagne sulla corrispondenza con gli uomini sono in gran parte esatte, nella loro varietà. Ognuna descrive un diverso aspetto della questione e ve ne sarebbero altri da sottolineare. Per farlo, racconterò quello che succedeva alcuni anni fa (e che probabilmente succede ancora) nel carcere di Bergamo. Quell’Istituto ospita sia uomini che donne, naturalmente in reparti rigorosamente separati. Soltanto il cortile in cui le donne trascorrono le ore d’aria confina con il campo di calcio maschile: tra le due aree c’è un muro altissimo e, sopra il muro, sono fissati dei pannelli metallici che impediscono anche la vista tra le finestre delle rispettive sezioni. Però, dalla cella collocata all’estremità del reparto femminile, è possibile vedere, lontana cinquanta metri, la finestra della cella maschile n° 11 ed in questa cella passano tutti coloro che vogliono salutare la "fidanzata", approfittando del momento concesso alla socialità in sezione. Le donne, che hanno le celle aperte, si danno il cambio all’unica finestra visibile e, pur di scambiare due parole con gli uomini che interessano loro, finiscono con il farsi punire, anche con l’isolamento. Grazie alle presentazioni "a distanza", favorite da qualche amico (o amica) che sta per uscire, è attraverso quel varco che nascono gli amori carcerari, che avvengono le scenate di gelosia e le riconciliazioni. In attesa poi di potersi rivedere, i rapporti si sviluppano attraverso la posta interna, anch’essa scoraggiata in ogni modo dalla direzione, che non può vietarla, ma richiede l’affrancatura delle lettere e impiega tre giorni per farle arrivare da una sezione all’altra. Queste lettere, a volte, sono custodite come reliquie, altre volte vengono lette a tutti gli inquilini della cella (4 o 5), in particolare quando hanno un contenuto più "spinto". È difficile dire chi cominci per primo ad usare un certo linguaggio, se gli uomini o le donne, ma di certo non ci sono troppi imbarazzi nell’invenzione delle immagini più estreme. Non sempre il rapporto è così spregiudicato, naturalmente, anzi sono più frequenti le situazioni in cui i toni ricalcano i duetti di Giulietta e Romeo. L’impressione è di assistere ad un gioco, certamente triste, tuttavia ben accetto da entrambe le parti. Evidentemente, in carcere, la sessualità degenera in fantasie assurde, ossessive, e del resto non ha altro modo di manifestarsi. Solo con il passare del tempo, con la somma degli anni di detenzione e di quelli anagrafici, subentra un progressivo disinteresse, forse più patologico che fisiologico… È evidente che il carcere cambia le persone, ma questo non significa che i cambiamenti debbano necessariamente essere in negativo, oppure una finzione. Tanti detenuti, ad esempio, iniziano a studiare in carcere, leggono e scrivono e fanno cose che, fuori, nemmeno si sarebbero sognati. La mancanza di alternative, evidentemente, ci costringe ad attingere a risorse che prima trascuravamo. Allo stesso modo, scopriamo l’esistenza dei sentimenti proprio quando siamo lontani da un modello di vita nel quale essi sono inflazionati. Le romanticherie, prive di gusto al punto da apparire patetiche, sono il sintomo di un’immaturità sentimentale, prima che estetica. Sono difficili da sopportare eppure andrebbero educate, (non derise) se pensiamo che un sentimento, per quanto espresso in maniera rozza, sia preferibile alla mancanza di sentimenti. Con Svetlana vorrei fare una riflessione in proposito: per quale motivo "correte dietro" agli uomini, fuori dal carcere, se noi siamo distratti ed insensibili? Lo fate per un interesse affettivo o per un interesse materiale? Io penso che lo facciate per entrambe le ragioni, ma soprattutto per la prima, e questo spiegherebbe bene la disillusione che molte di voi mostrano di avere metabolizzato. Le poesie e i fiori disegnati sui biglietti, saranno banali, ma volete forse dirmi che preferite avere mariti e fidanzati infedeli, magari anche duri e distratti, invece di quelli che vi scrivono in versi? Conosco pure io compagni che, quando erano liberi, non si curavano affatto della famiglia ed in carcere si scoprono mariti e padri affettuosi. Se lo siano diventati veramente, si vedrà quando escono. In questo momento non possono fare alcunché di tangibile per le loro donne, quindi per non sentirsi inutili, o per la paura di essere lasciati, si "convertono" al sentimentalismo. Ripensando alle compagne con le quali ho scambiato corrispondenza, ciò che più mi ha impressionato di loro è stata la mancanza di progetti che fossero appena un po’ ambiziosi. Nessuna mi ha scritto di avere in mente una crociera intorno al mondo, di voler fondare una Casa di moda o di volersi candidare al Premio Nobel… come mi è capitato di sentir dire, anche molto seriamente, da alcuni detenuti. Certo, sono sogni, ma forse servirebbero ad affrontare la vita con maggiore entusiasmo. Già abbiamo tanti limiti da rispettare, tante regole da seguire, e dobbiamo anche tarpare la fantasia in nome del "sano" realismo istituzionale!? Faccio riferimento all’istituzione perché credo che questa autocensura sia conseguenza del trattamento cui siamo sottoposti. Rappresenta un elemento negativo, infatti, dichiarare all’educatore, o allo psicologo, di avere progetti di vita differenti dal modello che "pensano" dovremmo adottare dopo l’uscita dal carcere: una casetta, una famigliola, un posticino di lavoro. Sembra che dobbiamo tornare liberi esclusivamente con questi obiettivi, altrimenti potremmo essere "ancora" pericolosi per la società, che spesso ha paura delle persone capaci di sognare. Francesco Morelli - I detenuti e le detenute devono stare separati per ovvi motivi Riflessioni sulla sessualità in carcere e dopo, a partire dallo "strano" incontro di un detenuto della redazione di Ristretti con la redazione femminile della Giudecca L’articolo che segue raccoglie le riflessioni di un detenuto che è entrato in "permesso premio" nell’Istituto Penale Femminile della Giudecca, come volontario che lavora nella nostra redazione. Maggio 2002 Quando rientri da un permesso non hai nessuna voglia di scrivere quello che hai provato. Dopo anni di emozioni controllate gli spunti non mancherebbero ma, uscendo, assieme alla vita libera riscopri il piacere della riservatezza, negato dal carcere. Il traguardo rieducativo, infatti, "impone" che tu sia un libro aperto, che confessi (meglio se davanti a un pubblico) le tue debolezze e i tuoi desideri. In un certo senso non importa se reciti, l’importante è parlare molto, in modo che i vari operatori possano raccogliere elementi per capire se sei sincero o se fai la commedia. Io mi sono adeguato, pur continuando a credere che le "confessioni intime" non dovrebbero essere mai richieste e, a maggior ragione, riguardo ai permessi. Quindi ne parlerò il meno possibile, facendo soltanto delle eccezioni in casi particolari. Questo, mi pare proprio lo sia. Durante l’ultimo permesso sono entrato alla Giudecca, in un carcere femminile! Mi hanno forse scambiato per una donna? Neanche per sogno, ci sono entrato in veste di "volontario": ho consegnato il documento d’identità, depositato gli oggetti personali negli armadietti dei visitatori; in portineria mi hanno perfino chiamato "signore"! Ho potuto incontrare le compagne della redazione veneziana… cosa che sul momento non mi è parsa tanto strana: collaboriamo da quasi tre anni, sia pure a distanza, e di loro conoscevo i nomi e le storie, pur non avendole mai viste di persona. Che si sia trattato di un piccolo evento l’ho capito in seguito, ripensando alle modalità della riunione: nell’ufficio degli educatori, con la porta aperta e alla presenza di quattro volontari veri, cioè persone non detenute. "I detenuti e le detenute devono stare separati, per OVVI MOTIVI", scrivono, in un tema, gli studenti di terza media che abbiamo incontrato lo scorso mese a Limena. I ragazzi riescono a dire, con naturalezza, ciò che gli adulti non osano: bisogna evitare qualsiasi occasione di possibile intimità tra detenuti di sesso diverso. Sarebbe "pericoloso" (oltre che immorale). Del resto, per molte persone è scandaloso pure che i detenuti vogliano avere degli incontri intimi con i propri partner liberi, figurarsi che cosa penserebbero se nelle carceri vi fossero spazi di vita comune tra uomini e donne. Per conto mio, ho percepito subito una notevole affinità con le donne della Giudecca: condividiamo la stessa esperienza e abbiamo, chi più chi meno, gli stessi problemi, nel rapporto con l’esterno, con le rispettive famiglie. Di questo abbiamo parlato ed anche con franchezza. Non intendo, però, fare una cronaca dell’incontro; preferisco approfondire il tema di cui abbiamo discusso "la sessualità vietata ai detenuti", perché penso che su questo argomento si debba lanciare un’iniziativa forte, per uno svecchiamento culturale che chiama necessariamente in gioco anche chi è estraneo ai problemi strettamente carcerari. Sulla nostra strada ci sono due grossi ostacoli: la concezione del sesso come vizio e la sua degradazione a "bene di consumo". La religione ne fa il peccato per eccellenza e il materialismo ce lo fa percepire come un privilegio. Sul primo problema Adriano Sofri ha scritto un articolo, di grande lucidità intellettuale, dal titolo "Il sesso del prigioniero mandrillo". Ne riporto integralmente un brano, che vorrei aver scritto io: "Il sesso è piacere e vizio: è peccato. Dunque, la privazione sessuale non ha bisogno neanche di essere presa in conto nei codici, nominata nei regolamenti, per essere imposta come costitutiva della prigionia. Essa appartiene alla necessaria afflizione: di più, essa è il cuore dell’afflizione. Tutto ciò ha fatto dimenticare che la privazione sessuale è una barbarie che si aggiunge alla privazione della libertà e al dolore: e fa apparire l’ipotesi della possibilità regolata di una relazione sessuale come un cedimento spericolato e lussurioso fatto al piacere, cioè alla peccaminosa superfluità, dell’animale umano in gabbia. Vi si svela il fondo sessuofobico di ogni reclusione e di ogni castigo". Sul secondo aspetto non mi pare vi siano analisi altrettanto precise, ma è sufficiente ricordare la famosa canzone di un altro Adriano, Celentano, "Chi non lavora non fa l’amore", per rendersi conto che il sesso bisogna "meritarselo" e rappresenta pure uno degli strumenti di controllo sociale più efficaci. Quando la religione aveva ancora un peso preponderante nella definizione delle convenzioni, bisognava essere sposati per poter fare del sesso in maniera lecita; oggi bisogna essere "produttivi"… pensate allo sconcerto che suscitano le storie d’amore tra persone disabili, o tra malati di mente. Questo atteggiamento viene giustificato (con una logica un po’ nazista), con il "rischio" che nascano dei bambini a loro volta ammalati, quindi senza un futuro. Ma è soltanto una scusa; nei fatti, in una comunità che si pone come traguardo più alto la produzione (di beni e servizi), io credo che chi è improduttivo rappresenti un peso, un’anomalia da correggere, una "sottospecie" dalla quale è necessario differenziarsi il più possibile. Poiché la vita sessuale è l’elemento che più accomuna tutti gli uomini, a fronte di tante diversità (dalla cultura, alle fattezze, etc.), ecco che il vero spartiacque tra i "normali" e gli "anormali" è il pacifico riconoscimento del diritto alla sessualità per i primi e la negazione dello stesso per i secondi. E non c’è dubbio che noi detenuti apparteniamo alla seconda categoria: per la legge siamo "soggetti socialmente svantaggiati", proprio come per i disabili e i malati di mente. Questo vuol dire che le persone normali faranno il possibile per "aiutarci" e, allo stesso tempo, per ribadire la distanza che c’è tra noi e loro. L’amore in carcere? Quando mai? Al massimo c’è la perversione, lo sfogo animalesco, la prostituzione… In questi mesi ho letto tanti documenti sulla sessualità dei detenuti, dai trattati scientifici ai racconti, a volte deliranti, a volte fortemente ironici degli internati nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario, ma non ho trovato nulla che riguardi il dopo – carcere, quando si presume che la persona rimessa in libertà riprenda una vita "normale", anche sotto il profilo sessuale. Forse si dà per scontato che sia così e, quindi, non c’è nemmeno il bisogno di parlarne… Una risposta certa non ce l’ho, posso soltanto dire che nelle prime uscite in permesso ho scoperto tante altre "disfunzioni", piccole e grandi, che il carcere mi ha provocato: la messa a fuoco della vista è bloccata sui cinque metri, la dimensione della cella, e oltre questa distanza vedo immagini annebbiate; non riesco a orientarmi, a riconoscere le vie e le piazze della città, dopo dieci anni vissuti percorrendo sempre lo stesso corridoio; le notti le passo insonni, perché mi manca la rudezza della branda (i letti veri sono troppo "comodi") e anche il sottofondo di rumori del carcere. È molto difficile sentirsi "normali" quando ti usano per degli esperimenti (saranno di tipo sociale, ma la parte della cavia la fai ugualmente) e forse questo è un motivo in più dei tanti fallimenti sulla strada del reinserimento: tutto è "scientifico", studiato e collaudato. Troppo scientifico e troppo poco umano… a un certo punto senti il bisogno di ribellarti, anche solo per demolire le certezze di quelli che credono di sapere tutto di te. Elton Kalica - Vini Tutte le mattine, dal tavolino del nostro bar preferito, mentre ci prendiamo il caffè, vediamo passare una folla di persone, stiamo a guardare immobili, come fosse un fiume primaverile che scorre, senza soffermarci sulle particolarità, i dislivelli o i ripetuti sbalzi dell’acqua, fintanto che la nostra attenzione viene catturata dal passaggio lento di una foglia caduta da chi sa dove; di un fiore caduto per sbaglio da una mano tremante; di un vecchio ramo che vuole finire i suoi giorni in un paese lontano. Osserviamo sempre ciò che rompe l’uniformità. Gli occhi immersi in qualche pensiero fisso guardano assenti la folla frettolosa, finché non arriva ondeggiando, una donna alta con il passo slanciato e una gonna cortissima e rossa, o un uomo che corre inseguito da qualche pericolo, oppure una creatura strana uscita da chi sa dove e con delle sembianze indefinibili, che solo lui, creatore di se stesso, conosce. Osserviamo con interesse ciò che non è grigio, anche se a volte può essere sgradevole. La moltitudine crea sempre uniformità e da questa inevitabilmente balza fuori il diverso, quello che si fa notare con curiosità e che fissiamo nella nostra mente con mille domande silenziose, supposizioni sciocche, pensieri inadeguati. Allora appoggiamo sul tavolo la tazza di caffè e guardiamo la diversità che si distacca nel panorama dei volti grigi, giacche svolazzanti. Certo che quando dedichiamo un momento di riflessione a qualcosa o qualcuno poi ce ne ricordiamo a lungo: difficilmente si dimentica quel particolare momento che ha richiamato silenziosamente la nostra attenzione. Anche soltanto dedicare pochi pensieri, ci fa sentire creditori, ne prendiamo nota e a volte richiamiamo a nostro piacimento, tutti i dettagli e le sfumature. Tentiamo sempre di riempire i nostri diari, gli armadi, i bagagli e le teste di cose diverse, singolari; in seguito se ci viene chiesto cosa abbiamo fatto durante il primo anno di scuola, non raccontiamo le lunghe ore di studio e le interminabili interrogazioni, ma le sorprese, gli amori, le delusioni, i torti subiti, i rancori scolpiti nella memoria; se ci domandano chi abbiamo visto passare, non rispondiamo di aver visto 235 uomini e 164 donne mentre correvano al lavoro, a scuola, a casa, ma di aver notato una bella gnocca con una minigonna di Gucci; un gangster con la scorta e con un diamante al dito; un pazzo da legare tatuato in testa; un travestito con gli occhi gonfi. Amiamo parlare di ciò che esalta, che travolge. Le moltitudini compatte, a mia sorpresa, le ho trovate anche in carcere, mentre scontavo una pena di sei mesi per aver dato un pugno a mia moglie – veramente i pugni erano stati più di uno ma preferisco dire così a chi me lo chiede. Ce la prendiamo sempre con i muri, le porte, gli armadi, la macchina per i nostri errori o disgrazie, e ce la prendiamo con la moglie per le nostre incapacità e trascuratezze. Entrai nel carcere con delle paure, dei preconcetti e delle idee insinuate dai celebri film di storie terribili. Trovai le stesse scene, i luoghi immaginati, ma non i personaggi che mi sembrava di ricordare e con le loro teorie sull’onore e sulle filosofie di vita. I carcerati, anche se diversi dalla mia immaginazione, si assomigliavano tutti nei loro sguardi scivolosi, a volte persi e remoti e altre volte sagaci; si assomigliavano nelle loro mani bianche e sfuggenti, come se le avessero tenute sempre a mollo, anche quando le dimenavano per aria in discorsi persuasivi; si assomigliavano nei loro corpi appesantiti dalla sedentarietà che schiaccia le ginocchia magre. Sembrava irreale vedere questi denominatori comuni che quasi tutti conservavano con gelosia e che, anche i nuovi giunti prevedevano di assumere: veramente una massa molto compatta nelle sembianze. Ma anche lì, a volte saltava fuori la diversità: un magro psicotico che ripeteva delle frasi precostituite o un piagnucolone che inseguiva i nuovi arrivati raccontando le sue disgrazie e la propria innocenza, oppure l’effeminato con le unghie rosse e il culo grosso. Così, quando gli amici seduti intorno ad un tavolo, mi chiedono di parlare del carcere, richiamo sempre alla memoria quei quattro elementi che uscivano dall’uniformità. Si parla della diversità più facilmente e con più accuratezza perché la normalità si guarda con occhi svagati, mentre ciò che la rompe si osserva con curiosità, e la curiosità fa annotare nella memoria i dettagli, ed era curiosità quella che mi obbligava ad osservare con meraviglia e minuziosità un uomo molto diverso: il suo nome era Vini. Vini fu la prima persona che vidi appena entrai nel penitenziario. La mia cella era di fronte alla sua, quindi spesso oltraggiavo la sua intimità sbirciando la sua vita informe. I primi giorni della mia permanenza in quella cella erano talmente confusi che non mi sono neanche accorto di avere un vicino di cella. Pensavo soltanto a come sarei sopravvissuto per sei mesi in un luogo cosi piccolo e sporco, a cosa mi sarebbe successo, a quello che sarebbe cambiato fuori dopo la mia interminabile assenza. Avevo paura di alzarmi dal letto e camminare, di affacciarmi al cancello e vedere cosa succedeva, di parlare con la guardia e affrontare l’incognito. Poi scattò il meccanismo che la sofferenza impone e le cose cominciarono a diventare familiari: presi confidenza con la televisione – l’unico interlocutore libero – con il lavandino – l’unica cosa veramente necessaria – con il corridoio che univa ventisei celle mescolando un unico, nebuloso insieme di rumori, odori, voci, pianti, risate, che ora neppure ricordo. Più difficile mi fu prendere confidenza con l’idea di vedere la faccia di Vini ogni giorno. Vini era un uomo che si comportava da donna, o usando il gergo del carcere, un frocio perso. In precedenza non avevo conosciuto dei froci, quindi, essendo i miei parametri di giudizio molto inflessibili, inizialmente il mio pregiudizio m’impediva perfino di guardare Vini. Descriverlo è veramente una impresa ardua; spesso vediamo cose, facce, gesti, scene che riusciamo a classificare verbalmente come normali, anormali, felici, infelici, patetici, cinici, e con mille altri aggettivi, ma a volte, proprio per la loro particolarità, ci è difficile anzi impossibile descriverli. Bisogna essere degli psicologi per descrivere i gesti di un uomo mentalmente morboso e Vini era veramente tale. Il suo viso riusciva a cambiare, dietro il suo comando, una quantità di mimiche ed espressioni, e curiosamente, ciò che invece non mutavano erano gli occhi: piccoli e tondi che uscivano come se volessero sfuggire dalle cavità; le due grandi occhiaie rosa che più di stanchezza indicavano benessere, mettevano in risalto le piccole orbite, esageratamente instabili. Inconfondibili erano anche le sue guance, sempre rosa, che si univano in un solo muso rotondo, che perdeva armonia soltanto dal piccolo naso e dallo spacco netto e lungo della bocca, così da fargli assumere le sembianze di una rana, il tutto era inquadrato da dei cappelli ricci, rasati sui lati e lunghi una decina di centimetri sopra la testa. Nella mia cella ogni cinque minuti si sentiva un acuto singhiozzo; siamo abituati a detestare i singhiozzi perché un volta comparsi non spariscono più per lunghi e fastidiosi minuti: Vini invece ne emetteva uno, singolo, tagliente e con il suono femminile che ricordava il singhiozzo di una bambina. Questo strano suono che arrivava in tutte le celle con regolarità aveva ormai abituato le orecchie dei carcerati, ma per me fu sempre un vero tormento. Diventò un incubo a tal punto che finivo per chiudere il blindato e mi coprivo le orecchie con il cuscino. Mentre Vini appoggiava con delicatezza le punta delle dita sul suo immaginario seno e si esibiva con gli occhi chiusi in quel suono acuto e veloce, mi riempivo di odio per questo suo lungo, lento ed interminabile singhiozzo, prodotto da quella brutta bocca da rana; lo guardavo con ripugnanza: diventò una condanna aggiunta. Niente si conserva nel tempo, i colori dei vestiti e dei muri che vanno sbiadendo, le materie che si arricchiscono continuamente di segni e si appiattiscono, le opinioni che mutano i loro colorati indumenti; spesso anche i sentimenti cambiano e le persone odiate finiscono per essere accettate. Mi abituai all’idea di avere un frocio in condominio e, cosa più importante, le mie orecchie si abituarono ai suoi singhiozzi. Credo che anche Vini avesse capito la cessazione delle ostilità; mi salutava con molta gentilezza quando mi affacciavo al cancello per vedere se arrivava la posta, il mangiare oppure le sigarette. In carcere si attende sempre qualcosa e con impazienza: appena ti viene in mente una lettera vai al cancello e vedi se arriva la posta; ti viene in mente un parente e vai a vedere se ti chiamano per qualche colloquio; hai fame e vai al cancello a vedere se arriva il carrello. Cosi, mentre immerso nel pensiero che mi aveva spinto al cancello attendevo il rumore dei passi, immancabile giungeva la voce di Vini: “Ciao Luca!” Lo guardavo sempre con gli occhi di uno che è stato appena svegliato. “Buongiorno, buongiorno Luca, che bel sole oggi” aggiungeva con la massima femminilità nella sua voce. Non ho mai risposto ai suoi saluti, ma non li ho mai ignorati. Mi piaceva fissarlo con durezza senza dire una parola, un po’ per gioco, credo, o forse per comunicargli il mio disappunto; non si sa mai comportarsi con quelli strani, quelli fuori della norma ”Si, si è una bella giornata” rispondeva poi da solo al suo commento, poggiando una mano sull’immaginario petto e facendo risuonare con il suo singhiozzo il corridoio. Ed è stato proprio in questo periodo di “distensione” che accade quello cui non si crederebbe mai di dover assistere finché non ti ci trovi davanti, in modo palpabile e reale. La cella di Vini era tutta di colore rosso, le tende, le lenzuola, la tovaglia, le ciabatte, il grembiule e perfino gli stracci con i quali spolverava ogni mattina. In quel periodo di “distensione”, come ho già detto, avevo accettato l’idea della sua presenza ed avevo cominciato ad osservare i suoi veri gesti e le attività monotone. Lo sbirciavo spesso in quegli ultimi giorni, ma in realtà senza un occhio particolarmente indagatore. Faceva parte della nostra relazione di buoni vicini: ci si diverte sempre a sbirciare i vicini, soprattutto quando ci regalano delle stranezze, e Vini era tutto uno spettacolo che “intratteneva”. Girava per la cella camminando sulle punte dei piedi, la mano penzolava sempre priva di comando, per accentuare la sua femminilità; si legava un asciugamano in testa e cantava una vecchia canzone napoletana: insomma, si credeva una vera donna di casa e si teneva impegnato per tutta la mattina. Con puntualità si fermava, metteva la mano sul petto immaginario e aspirava quel suono da strano singhiozzo. Realizzai che Vini durante gli undici anni della sua spensierata permanenza in quella cella, aveva ripetuto con maniacalità gli stessi passi, gli stessi gesti, la stessa canzone, lo stesso singhiozzo. La sua quotidianità era riassunta in un unico nastro che continuava a girare da undici anni. Dunque, fu proprio in quei giorni ricchi di curiosità che vidi rompersi questa quotidianità. È strano come a volte scopriamo cose che sono state ferme, immobili, immutati da sempre e poi, appena cominciamo ad interessarcene, le vediamo frantumarsi, mutare, distruggersi come se avessero atteso secoli prima di regalare questo cambiamento esclusivamente a noi. Ci si domanda poi se siamo lì, spettatori involontari, richiamati soltanto per assistervi e allora pensiamo che, senza di noi, forse non sarebbe successo niente e tutto avrebbe continuato ad essere uguale per sempre. Ero entrato in carcere da appena un mese per aver picchiato mia moglie e dopo settimane interminabili di rimorsi, inquietudini, pianti, avevo cominciato ad abituarmi allo sporco dei muri, al freddo dei cancelli, alla falsità della gente ed anche a Vini, il mio vicino di cella frocio perso. Era l’ora di socialità e stavo scrivendo una lettera, quando vidi tre detenuti entrare nella cella di Vini. A quell’ora scrivevo sempre delle lettere ed ero sempre seduto verso il cancello, cosicché vedevo tutti i suoi movimenti. Di sera il regolamento del carcere permetteva un paio di ore di socialità tra i detenuti della stessa sezione. Vini non usciva mai dalla cella per fare socialità e in quei pochi giorni di “distensione” non avevo visto nessuno andare da lui. Avevo guardato il mio vicino sempre nella sua viziosa solitudine e ora che c’erano tre uomini con lui mi sentivo nervoso. Appoggiai sul tavolo la penna e mi accesi una sigaretta, si fuma sempre quando ci si trova in nuove e inaspettate circostanze. La cella rosa, una volta l’unico panorama, dove rilassavo il mio sguardo quando si stancava dei pensieri, dove Vini trovava tutto lo spazio necessario per i suoi grotteschi balli, innaturali salti e disturbanti singhiozzi, ora era stata trasformata in un piccolo e incolore quadrato, dove quattro uomini si stringevano oscurandolo. Parlarono e risero per una decina di minuti come dei vecchi amici, loro in piedi e Vini seduto sul suo letto. Nessuno degli ospiti girò la testa per guardare dalla mia parte, ed io, uditore silenzioso, cercavo di cogliere i dialoghi. Poi uno s’avvicinò a Vini, gli mise la mano sui capelli ricci come una lunga ombra obliqua, nascondendo al mio sguardo la sua faccia. Il rosa delle tende penetrò attraverso il braccio teso e la sua schiena gobba, avvolgendo gli occupanti della stanza, silhouettes anonime che ora sono in me presenti solo come memorie sfocate. Forse l’uomo chiedeva a Vini di ballare, di ridere, oppure di baciarlo; forse Vini aveva atteso quell’incontro da tempo, e ora si preparava a ballare, ridere, baciare. La controluce colpisce l’occhio impedendogli di decifrare le sfumature, ma spesso, quando si conoscono i particolari, le sagome diventano eloquenti, i movimenti si traducono in chiare scene e tutto trova il suo senso e il suo posto nella memoria. Così, dopo che i due ospiti si unirono in un’unica ombra, discostandosi dalla scena come un sipario, vidi in controluce la sagoma dell’altro protagonista abbassarsi i pantaloni e avvicinare il braccio, che cadeva sulla testa di Vini, verso la propria nudità. Si chinò verso la sua mano che non si fermò ma cominciò ad ondeggiare avanti e indietro; il braccio, ormai l’unico arto mobile, faceva un lento movimento come se lui si stesse masturbando, poi si staccò dalla testa scura di Vini, rimasta ormai per inerzia l’unica cosa mobile. Mentre il movimento perverso prese velocità, l’ospite levò la mano dietro la testa in segno di abbandono, come se volesse dimostrare ai suoi silenziosi amici, oppure a me, lontano spettatore, il suo godimento per quel fellatio. “Assistiamo spesso a delle stranezze, a volte con piacere, altre volte con disgusto, ci succede comunque di portarle impresse nella memoria per sempre. Durante la mia breve permanenza in carcere fui costretto ad assistere ad una scena che mi fece vomitare, ma nel momento in cui gli amici ancora oggi mi chiedono di parlare del carcere, richiamo sempre alla memoria la storia di Vini.” “Si parla della diversità con più facilità poiché la normalità si guarda con gli occhi immersi in qualche pensiero estraneo, mentre ciò che la rompe si osserva con curiosità, e la curiosità fa annotare i dettagli nella memoria. Ed era curiosità quella che mi obbligava a continuare a guardare la sagoma di quell’uomo che con la testa china parlava ad un altro uomo, forse pazzo, che immaginavo fosse talmente impegnato da non poter rispondere. Non so se sarei rimasto a guardare anche gli altri ospiti che sicuramente attendevano il loro turno, ma accadde che, quando l’ospite fu congedato, e mentre dal buio del muro si staccò un'altra ombra per prendere il suo posto di fronte a Vini immobile, il primo si accorse della mia presenza, reagì senza neanche indossare i pantaloni. Venne al cancello, allungò fuori la mano tirò il blindato, lasciandolo socchiuso. Calò il sipario anche se solo per il primo atto. Tutti abbiamo visto degli omosessuali per strada, in autobus, al lavoro, intendo dire quelli effeminati che si fanno riconoscere, sappiamo che ce ne sono altrettanti in closet, ma oltre ad essere consapevoli della loro perversione non ci soffermiamo ad immaginarli nei loro anormali rapporti. Tra il sapere che una cosa succede e il vederlo, oppure immaginarlo, c’e una grande differenza; almeno questo è ciò che ho pensato quella sera, prima nel vedere in controluce quell’amplesso, e poi quando ho assistito alla drammatica conclusione di quella inconsueta visita dei tre uomini nella cella di Vini. Dopo che l’ombra nuda aveva chiuso il blindato, scappai dalla mia poltrona verso la finestra per prendere un po’ d’aria. Dopo essere andato a farmi un caffè e fumare una sigaretta in bagno, tornai al posto di prima. Ripresi la lettera lasciata a metà e cercai inutilmente di trovare le idee lasciate in qualche angolo che ora la mia mente sconvolta non ritrovava più. In cambio, accesi la televisione come se le sue immagini sconnesse mi dovessero riportare indietro di mezz’ora, per poter cosi, dimenticare le scene ormai radicate. Era come se qualche oscuro mistero cercasse di tenermi concentrato su quell’Ante Prima che non avevo chiesto di vedere, forse era la stessa misteriosa entità che mi aveva spinto di bere e picchiare mia moglie che ora, m’imponeva di essere testimone di ciò che si stava consumando dietro il blindo socchiuso. Stavo pensando di buttarmi sul letto, quando all’improvviso ebbe inizio la seconda parte: Il blindo della cella di Vini si spalancò con forza liberando un urlo lungo e rocco “Aiuto!” Lui si era aggrappato con le mani al cancello e cercava d’infilare la faccia insanguinata tra le sbarre, le labbra spaccate e gonfie non cambiavano il suono che usciva già articolato dai polmoni. Realizzai che fosse nudo soltanto quando una mano strinse i suoi capelli e lo tirò indietro staccando la sua faccia rossa dalle sbarre dove rimasero aggrappate le sue lunghe dita; dopo un secondo, anche le mani mollarono la presa per difendere la faccia dai pugni e dagli schiaffi che la colpivano. Uno degli ospiti poi, indossò in fretta i pantaloni e si affacciò al cancello guardando preoccupato verso il corridoio, in attesa della guardia che arrivò con passo lento e la testa alta. “Ragazzi arriva la guardia” disse, ma l’avviso fermò solo parzialmente il pestaggio: uno andò subito in bagno, mentre l’altro ora controllava l’andatura sempre lenta dell’agente “Minchia! Me che state facendo aa? Fermati ca l’amazzi a cussi! Collega! Venni ca s’acchiapparono arriri chisti ca!” Arrivarono altre due guardie, si posizionarono davanti al cancello e mi oscurarono la visione di Vini raggomitolato che si contorceva tra il sangue, i lividi, i dolori. Ascoltavo però il suo pianto, e la chiave che apriva rumorosamente il cancello per fare uscire i protagonisti dello spettacolo. “Che succediu aa?” “Niente appuntato, Mirco si è arrabbiato con Vini perché, l’ha trovato che barava a carte” “Sì appuntato, gli ho detto che non sopporto i bari, perché lui si era segnato di nuovo le carte da gioco.” “Picchiasti arriri u puipu perché ti rrobbava i caite? Ma a cu u racconti sta minchiata tu aa? Avanti, in cella ca ora viene u ispettura e parla idu cu u puipu! Avanti!”. Ascoltai questo dialogo guardando le schiene delle tre divise, che poi si mossero per accompagnare nelle rispettive celle i protagonisti di questa parte chiaramente già recitata in quello stesso palcoscenico, e che sicuramente sarebbe stata messa in scena nuovamente in futuro. Stavo fissando le tende color rosa, quando Vini si levò da terra e con la testa bassa indossò con velocità i pantaloncini e la canottiera del medesimo colore. Poi appoggiò con delicatezza le punte delle dita sul suo immaginario seno e con gli occhi chiusi singhiozzò con quel solito tono acuto e veloce, si avvicinò al cancello e allungo la mano per tirare il blindo, ma prima di chiuderlo mi guardò per un ultimo momento, come se avesse capito la mia attesa della conclusione di questa storia che mi aveva tenuto con il fiato sospeso per quasi due ore, come se sapesse che io ero stato mandato lì per assistere a quell’evento. “Non è successo niente sai, stavamo giocando a carte e abbiamo litigato, adesso però devo andare, Ciao! Ciao!” Mi parlò con una voce da bambina sbattendo le palpebre, forse in segno d’imbarazzo per il suo aspetto orribile. Aveva un occhio viola, la bocca spaccata e gonfia e dal naso colava del sangue che già si stava coagulando. La maglietta sgualcita era piena di macchie rosse, nere, marrone, e l’aveva messa a rovescio. Siamo abituati a vedere, parlare, toccare persone in condizioni normali, ordinate, pulite. Quando ci imbattiamo in quello diverso, quello che esalta, che stravolge, e che non appartiene alla massa, lo guardiamo con curiosità e diffidenza, ma li notiamo sempre nelle loro vesti migliori – una bella gnocca con una minigonna di Gucci, un gangster con la scorta e con il diamante al dito, un pazzo da legare tatuato in testa, un travestito con gli occhi gonfi ma coerente nella sua metamorfosi – così odiamo, aborriamo, accettiamo, sogniamo, amiamo quello che è peculiare alla diversità, mentre io vedevo Vini in una condizione rivoltante e misera, che mi parlava con le sue frasi nauseanti che prima forse mi divertivano e ora invece mi facevano inorridire. Essere presente a quella scena mi ha fatto veramente male, forse la punizione che mia moglie aveva scelto per me era proprio quella, di farmi assistere al male vero. Non so quante volte nella sua vita, Vini sia passato attraverso quella situazione, forse un’infinità; ciò che per noi è diversità, spettacolo, per altri può essere routine, normalità; ma io che fui presente quell’unica volta da spettatore, ho tutto impresso nella mente e rivivo la scena cui ho assistito in carcere tutte le volte che la racconto ai miei amici. Per quanto riguarda me e mia moglie, beh, siamo tornati insieme e non le ho più dato uno schiaffo, anche se un paio di volte la tentazione è stata forte; ho imparato la lezione. Francesco Morelli - Il sesso in carcere quello che non si dice… e non si fa Qui si impara forzatamente a vivere facendone a meno: naturalmente si soffre, per questa privazione, ma nella maggior parte dei casi si cerca almeno di sopportarla con dignità Luglio 2001 Abbiamo trattato diversi temi "difficili" però del sesso in carcere non parliamo mai… anche perché, obiettivamente, come si fa a scriverne? Non me la sento di intervistare un compagno chiedendogli: "Mi dici qualcosa sulla tua vita sessuale?"; nemmeno posso trasformare il giornale in un diario intimo… Credo sia possibile affrontare questo argomento solo attraverso dei discorsi ragionati, sorretti dall’osservazione e dalla conoscenza delle espressioni (o non espressioni) che assume la sessualità nelle persone detenute. Il fatto che se ne parli pochissimo alimenta, com’è ovvio, la curiosità di quanti non conoscono il carcere da vicino e a volte questa curiosità inappagata si trasforma in ipotesi molto fantasiose, basate sul "sentito dire", o magari sulle immagini del cinema carcerario americano. La realtà (per quanto ne so) è molto diversa, deluderebbe senz’altro un interesse di natura morbosa, perché in carcere di sesso se ne fa pochissimo, se ne parla altrettanto poco e, con il tempo, si smette addirittura di pensarci. Semplicemente si impara a vivere facendone a meno: naturalmente si soffre, per questa privazione, ma nella maggior parte dei casi la si sopporta con dignità. I rapporti omosessuali rappresenterebbero la conseguenza più prevedibile, mancando la possibilità di intrattenere relazioni intime con persone dell’altro sesso, eppure io ritengo che questo fenomeno sia molto circoscritto… anche se, evidentemente, non posso essere al corrente di tutto ciò che accade. In una decina di anni, nelle otto carceri che mi hanno ospitato, ho conosciuto quattro - cinque compagni che praticavano rapporti omosessuali senza preoccuparsi di tenere segreta la cosa; altrettanti di cui "si diceva" avessero rapporti. Di casi di violenza sessuale, tra tutti gli istituti (nei periodi in cui mi ci trovavo) ne è accaduto "solo" uno. Chi pratica il rapporto omosessuale solo perché non ha alternative, spesso lo fa sotto l’effetto dell’alcool o di qualche droga (perché a mente lucida non se la sentirebbe) e questo vale per gli etero, ma anche per gli omosessuali, quando manca una vera motivazione affettiva: il sesso senza amore, già poco gratificante tra persone libere di scegliere il "genere" del partner, diventa terribilmente deprimente e degradante, per chi questa scelta non può farla. Credo questo sia il motivo principale per cui le pratiche omosessuali sono, tutto sommato, rare; in particolare, lo sono negli istituti dove molti detenuti hanno pene elevate, cosa che può apparire paradossale. Si spiega benissimo, invece, se pensiamo che, proprio nel corso delle detenzioni più lunghe, le persone sviluppano quel rispetto per se stessi che permette, a molti, di smettere l’uso dell’alcool e del tabacco, che porta a curare il proprio corpo con lo sport e la propria mente con lo studio. La controprova, se vogliamo, è nel fatto che la maggior parte degli episodi citati prima è avvenuta in carceri circondariali e riguardava persone da poco arrestate. Tra i detenuti vi sono persone effettivamente omosessuali, com’è logico sia, e di solito vengono trattate con rispetto dai compagni: non sono discriminate in quanto "diverse" e nemmeno si approfitta delle loro preferenze sessuali per avere rapporti facili. Episodi come quello raccontato da Marco Rigamo nel numero di giugno di Ristretti Orizzonti, del transessuale che, arrivato in sezione, "ha fatto felici molti detenuti", sono accaduti e accadono ancora, ma credo rappresentino l’eccezione, in un quadro complessivo ben diverso: i transessuali, di solito, non sono nelle sezioni comuni, e comunque mi lascia perplesso il fatto che una persona si metta "a disposizione di tutti", semmai trova un amante e gli altri detenuti non si intromettono nella loro relazione. Il luogo comune, un po’ compiaciuto ed un po’ sadico, del vecchio galeotto "omosessuale per bisogno", oltre ad essere falso, rende problematiche anche le manifestazioni del più semplice affetto amicale, che possono essere fraintese e determinare dicerie, prese in giro, etc., in un ambiente chiuso ed intriso di pregiudizi com’è quello del carcere. Il timore di apparire troppo affettuosi determina anche degli eccessi di "cautela": tra compagni, non c’è quasi alcun contatto fisico e, visto che con gli agenti è proibito stabilire una conoscenza che vada oltre i saluti di cortesia, le sole persone che si possono "toccare" sono i parenti, durante i colloqui. Dipende anche dalla cultura di provenienza, questo è vero, perché i nordafricani si salutano baciandosi sulle guance, i meridionali si stringono la mano ogni giorno, noi settentrionali ci scambiamo un "ciao" a due passi di distanza… Con il passare del tempo, in carcere l’assenza di "sensazioni tattili" diventa un guaio serio Potrebbe sembrare un problema di poco conto, eppure con il passare del tempo questa assenza di "sensazioni tattili" diventa un guaio serio: c’è il bisogno di sentire un altro corpo che vive (qui non ci sono nemmeno gli animali, da toccare), c’è il bisogno di essere toccati, ed allo stesso tempo ci sono gli ostacoli ambientali e culturali che impediscono di farlo. Di una situazione simile (seppure con caratteristiche molto diverse), venni a conoscenza alcuni anni fa, quando ero in corrispondenza con alcuni ricoverati in un istituto per malati terminali di A.I.D.S. I medici e gli infermieri non li toccavano mai a mani nude: per regolamento portavano guanti di gomma, che servivano, ovviamente, ad impedire la trasmissione di malattie. Però i ricoverati soffrivano per questo trattamento, che li faceva sentire già "un po’ morti". Tornando al carcere, ed al sesso in carcere, personalmente ripongo poca fiducia nelle proposte di distribuzione dei preservativi, per ridurre il rischio di contagi derivanti dai rapporti non protetti. Pensate un attimo a ciò che può essere un rapporto sessuale in carcere, fatto di nascosto (ed è difficile nascondersi, in una cella di pochi metri quadri, dove perfino il bagno è controllabile in ogni momento dall’agente), fatto con una persona che, probabilmente, non corrisponde proprio ai tuoi gusti sessuali, fatto in condizioni di stress e squallore estreme. È difficile parlare per via ipotetica ma credo che, se mi trovassi in questa situazione, non sarei particolarmente motivato e vivrei come ulteriore elemento di disagio l’utilizzo del preservativo. Siamo tutti perfettamente al corrente del rischio di trasmissione dell’H.I.V. e di altre malattie, eppure non so chi lo userebbe (o chi chiederebbe al partner di usarlo), anche se l’avessimo a disposizione, e questo non allo scopo di avere sensazioni particolari, nel rapporto non protetto, ma appunto perché rappresenterebbe altra costrizione, altra deprivazione. E questo è un ulteriore problema, dentro alla spinosa questione del sesso in carcere. Il dibattito sulla distribuzione dei preservativi nelle carceri va avanti da qualche anno. Risultati concreti, però, non ve ne sono, in quanto i rappresentanti dell’istituzione obiettano, semplicemente, che il sesso in carcere è un reato (atto osceno in luogo pubblico), quindi non si può mettere a disposizione uno strumento per "favorire" la consumazione di un reato. È vero, però il reato può avvenire, con o senza lo "strumento" in oggetto, e forse sarebbe meglio che ci fosse. Ripeto, io non so chi lo userebbe, tuttavia ritengo giusto che chi lo voglia utilizzare l’abbia a disposizione. Questo non significa che auspico una "crociata" a favore dei preservativi nelle carceri, perché il tema è troppo facile, in un certo senso: facile per chi lo porta avanti come battaglia culturale, facile anche per l’istituzione, che ribatte "sarebbero utili, a qualcuno, ma la legge non lo permette". Nessuno nega che le campagne culturali (e politiche) sulla prevenzione vadano fatte, il mio timore è che questi obiettivi "alti" distolgano l’attenzione da altri problemi, magari più seri ma meno "nobili", riguardanti la salute dei detenuti. Ad esempio, chi mai si occupa dell’alimentazione in carcere? L’ha fatto, un paio di anni fa, Domenico Nucci, allora direttore della Casa di Reclusione di Porto Azzurro. Denunciò lo scandalo degli appalti al ribasso sulle forniture del vitto: una ditta si era impegnata a fornire ai detenuti tre pasti completi, con 3.000 lire al giorno. Al direttore sembrava una cifra insufficiente a garantire un’alimentazione adeguata. A seguito delle sue proteste scoppiarono feroci polemiche ed alla fine Nucci diede le dimissioni. Se un direttore perde il posto in questa maniera significa che il problema è scottante. Non mi pare che il dibattito sui preservativi abbia mai causato dimissioni… forse rischia di essere un po’ un parafulmine, su cui si scaricano energie e richieste "riformatrici", con buona pace di tutti. Tossicodipendenza Noemi (Empoli) - Noemi si racconta Testimonianza tratta da Fuori Binario Marzo 2004 Vi invio questa mia storia, sperando vi possa aiutare nell’intento di realizzare uno spazio per tutte quelle persone che, come me, si trovano detenute e private non solo della libertà ma di tante cose: emozioni, gioie, dolori e affetti reali. La vita all’interno di un carcere non è vita reale, è un’altra dimensione, realtà a parte. La vera realtà, la vita, si trova al di là di queste mura. Ove tu sei padrone delle tue scelte, azioni e pensieri. Mi chiamo Noemi, ho 27 anni e questa è la mia prima esperienza carceraria. Sono stata arrestata il 5 maggio 2003 a seguito di uno scippo. Purtroppo il mio complice riuscì a darsi alla fuga, così io restai l’unica imputata del reato con lesioni e ricettazione, visto che io e il mio complice eravamo in possesso di un ciclomotore rubato. Tutti e tre gli articoli mi sono stati dati in concorso. Ho fatto il processo per rito abbreviato e sono stata condannata a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Mi trovo alla casa circondariale attenuata di Empoli dal 5 agosto 2003, dove mi sono subito adattata all’ambiente e alle compagne. Le mie giornate sono tutte organizzate fra lavoro (mattina) e i vari corsi e studi (pomeriggio). So che se mi trovo in carcere è perché stavo vivendo una realtà diversa, distorta. Da tossicodipendente. La tossicodipendenza giorno dopo giorno mi stava annientando. Mi ero isolata da tutto e da tutti ed il mio primo pensiero era divenuto l’assumere sostanze stupefacenti; volevo che il mio primo pensiero fosse rivolto alla vita ma non fu così: la mia dipendenza era troppo forte da permettermi di poter vedere oltre. Ho iniziato a usare l’eroina a 25 anni e mezzo. Dopo varie sventure sono cascata in questo diabolico vizio in un periodo alquanto nero della mia esistenza trascorsa. Sono andata via dalla mia casa genitoriale a 18 anni per seguire colui che credevo essere l’uomo della mia vita. Ahimè quanto mi sbagliavo! Nei sette anni di convivenza con G. ne ho passate tante, forse troppe! A 21 anni sono rimasta incinta del mio primo figlio, T., che attualmente ha 7 anni e vive con la famiglia adottiva a Capannori, Lucca. Quando conobbi G. studiavo presso una scuola privata per conseguire il diploma di assistente socio sanitario, che poi mi avrebbe permesso l’internamento alla scuola d’infermieri. Inoltre, lavoravo in una discoteca di Firenze nelle pubbliche relazioni. Andai a vivere con lui presso amici comuni, poi andammo in un affittacamere, che io pagavo con i soldi guadagnati con il lavoro di pubbliche relazioni che già svolgevo per la discoteca, ed in più iniziai ad occuparmi della gestione pubblicitaria di alcune ditte, tra le quali anche Radio Studio 54. Guadagnavo abbastanza bene da permettere al mio compagno di non lavorare. Dopo 1 anno e 7 mesi di convivenza rimasi incinta. La mia famiglia non volle aiutarmi, quella di G. non poteva. Andai a Capannori in una casa famiglia con mio figlio T. Ero ingenua, desiderosa e bisognosa di avere vicino a me un punto di riferimento che trovavo nel mio compagno (anche se poi, non lo era). Dopo 5 giorni lui mi telefonò e mi intimò di raggiungerlo perché sarebbe partito per Sarno (SA), il suo paese di origine, se non lo avessi raggiunto. Stupidamente, ingenuamente, corsi da colui che ritenevo il mio grande amore. T. restò lì a Capannori. Mi maledico per aver anteposto un uomo a mio figlio, sangue del mio sangue. Iniziò per me un periodo strano, irreale. Non mi rendevo conto ero stata l’artefice di un gesto disumano. Non avevo più un impiego e così iniziai a fare “colletta” in stazione. Per un po’ di tempo andò abbastanza bene, certo riuscivo a far fronte ai bisogni primari miei e del mio compagno, ma spesso mi ritrovavo a dover dormire nelle sale d’attesa della stazione o nei vagoni in deposito. Preferisco non dover spiegare come, ma mi ritrovai a esercitare la prostituzione. Avevo bruciato tutto ciò che avevo di umano, andando contro ai miei principi. Non avevo più stima di me stessa, non avevo orgoglio, ma soprattutto volevo o credevo di amare solo il mio compagno e non me stessa. Nel marzo del 1997 rimasi incinta per una seconda volta. Avendo subito un taglio cesareo e con la paura di poter perdere quel futuro figlio, abortii. Nel giugno dell’anno successivo, rimasi incinta per un terza volta. Fortunatamente trovai lavoro presso un’agenzia pubblicitaria di un conoscente che mi diede anche un alloggio. A febbraio del 1999 mio padre mi prese in affitto un bilocale ad Empoli, mi comperò tutto l’occorrente per la bambina e provvide al mio mantenimento, del mio compagno e di mia figlia. Questo per due mesi, dopo i quali trovò anche un impiego al mio compagno. P. è tuttora per me la cosa più bella al mondo, quella che io abbia amato veramente. Anche se oramai sono 2 anni che non la vedo e non ne ho notizie. Purtroppo, un giorno mi suonarono alla porta due poliziotti e due assistenti sociali con un decreto di allontanamento dalla minore da me e G. Fu affidata all’Istituto degl’Innocenti dove, dopo tanto lottare, sono riuscita a raggiungerla. Dopo 11 mesi di permanenza in quell’istituto ci fu un’udienza, a seguito della quale P. fu resa adottabile. Mi cadde il mondo sotto i piedi. Avevo perso la mia bambina, la seconda creatura che avevo messo al mondo. Ero sola, non mi interessava più niente. Ero senza un alloggio, senza un lavoro e… sola. Iniziai a prostituirmi e per cercare di non pensare, cominciai a fumare eroina con amici e/o compagni di sventura. Una sera, ero nella macchina di un amico “femminiello” ed un altro ragazzo. Il “femminiello”, A., usava la roba da quasi dieci anni e se la iniettava. L’altro ragazzo non tossicodipendente si fece fare da A. un piccolo “schizzo”. Io non avevo gli “attrezzi” per fumarla, così quando vidi che A. sciolse con la sua busta anche la mia dicendomi: “Noemi, domani ti ridò i soldi”, presi una decisione, volevo provare anch’io le sensazioni che si hanno facendosi in vena. Così A. mi fece il primo buco della mia vita. Per 3 giorni stetti sempre con A. e il suo amico. Era un continuo bucarsi. Una notte io ed A. restammo soli e mi invitò a trascorrere qualche giorno presso la sua abitazione. Fu un’esperienza indimenticabile. Ai piano inferiore la cucina, fuori uso, il frigo staccato. Al piano superiore una stanza con un letto matrimoniale (i cui lenzuoli e la trapunta erano sempre, perennemente i soliti, sudici e logori). Un bagno in cui non funzionava l’acqua, dove era pieno di mosche e moscerini per la sporcizia. Sui muri del bagno una quantità infinita di schizzi di sangue. Dopo aver vissuto quella realtà ero sicura che mai e poi mai avrei fatto la stessa fine. Ahimè l’ho fatta! N.B. Ora ho la possibilità di riscattarmi creandomi una nuova esistenza: sana e umana! Paola M. - Dalla tossicodipendenza non si scappa Possiamo solo stare accanto a chi, attraverso vari segnali, ci comunica il suo “male di vivere”, accettando anche la nostra incapacità di trovare soluzioni alla sofferenza Novembre 2007 Riuscire ad essere obiettivi nello scrivere qualcosa riguardo la tossicodipendenza quando ci sei passato molto vicino e hai visto troppa gente, anzi troppi compagni di percorso, prima rovinarsi e poi morire di droga, non è mai facile. Mi è stato detto che sono cinica, cattiva: io penso, ma forse sbaglio, di essere solo realista. E questo perché penso che dalla tossicodipendenza non si scappa. Una mia amica, ora trentaseienne, tossicodipendente da “pere” a tredici anni, che ha smesso di farsi a quindici, sostiene che se sei stata tossica, anche dopo anni ogni mattina quando ti alzi dal letto devi dirti “oggi non mi faccio”. E non è assolutamente facile! Questo vale per tante dipendenze. Ma quali possono essere considerate dipendenze? Nei paesi anglosassoni hanno coniato un termine “workalholic” per descrivere lo stakanovista. Quello che è “malato” di lavoro. Ed il lavoro non è necessariamente una cosa piacevole. Come non lo è qualsiasi dipendenza, di qualsiasi tipo, per una persona “libera”. Il problema quindi si sposta, secondo me, sulla capacità degli esseri umani di sentirsi liberi. Di avere il CORAGGIO di essere liberi. Perché la libertà è un “lavoro”. Bisogna continuare a faticare per mantenerla. Qualsiasi dipendenza è una forma di schiavitù, e noi viviamo in una società che ha la tendenza a rendere schiavi (e ora la schiavitù più “in voga” è il consumismo), e la capacità di annientarti, un annientamento di tipo “legale”, ma estremamente più subdolo. Quello che osservo è che anche le cose che si decide facciano bene o male, siano lecite oppure no, dipendono spesso dal periodo storico in cui si vive, dipendono dalle mode, dalla morale comune. Stefano è morto. Io non conoscevo Stefano se non attraverso i suoi articoli. Lucidi, intelligenti, senza pietà. Stefano era una persona che voleva essere libera, e non ci riusciva. E da persona lucida e intelligente qual era se ne rendeva conto. Perché io sono convinta che dalle dipendenze non si esca a meno che una persona non abbia degli strumenti “enormi”, una gran forza personale e soprattutto una concomitanza di eventi fortunati, che vanno tutti ad incastrarsi, che entrano in gioco in quell’esatto momento, per cui ci si libera dalla schiavitù che si vive in quel preciso istante, ma senza andare a cercarsene un’altra (ce ne sono tante di “sostitutive”, dall’alcol, dagli psicofarmaci, da altro ancora). Se però da parte della persona non c’è quella spinta alla LIBERTÀ, quel voler essere assolutamente liberi, che fa in modo che non si cada preda di nuove schiavitù, di altre dipendenze, dalla droga non si uscirà mai. Alla fine la scelta più facile sembra quella di rinunciare a pezzi di libertà in cambio dello “star bene” che ti danno le sostanze, in realtà è una scelta che a lungo andare si rivela la più difficile, ma vai a saperlo prima! Vai a sapere che poi la fatica di vivere diviene immane. Qualcuno può osservare che non tutti diventano tossicodipendenti, pur non essendo delle persone “libere”. Vero. Forse hanno scelto un’altra schiavitù, che non fa necessariamente vivere meglio. Anzi, forse l’eroina, e voglio sottolineare che non l’ho mai provata, fa stare bene nel momento in cui uno se l’inietta, è dopo che riprende, si accentua, non ha più limiti la sofferenza. Quando qualcuno muore, vorremmo essere razionali per non soffrire troppo. Ma è uno sforzo vano, di fronte alla morte non c’è pensiero razionale che tenga, c’è la sofferenza prima di tutto. Ma noi uomini “moderni” non siamo più capaci di pensare alla morte, e appena ci sfiora ne rimaniamo sorpresi e attoniti. Non sappiamo come “maneggiarla”. Quando ho trovato mio marito, il padre di mia figlia, l’uomo che ho amato più di me stessa, morto, sul pavimento impersonale di una cucina di un appartamento impersonale in un condominio impersonale dove era andato a vivere dopo che ero fuggita perché non riuscivo più a reggere il suo “male di vivere”, le viscere mi si sono strappate. Un dolore lancinante, senza possibilità di scampo, senza la capacità da parte mia di accettarlo, per molti anni. Perché di fronte alla morte siamo impotenti, davanti al male di vivere siamo impotenti, davanti alla sofferenza siamo impotenti. Vorremmo poter controllare tutto ma non ne siamo in grado, vorremmo anche “aiutare” gli altri che soffrono e che noi amiamo ad uscire dalla sofferenza. Beh, accettiamo che a volte questa impresa è impossibile. Solo accettandolo saremo in grado di stare vicini e sostenere chi, attraverso vari segnali e mezzi, ci comunica il suo “male di vivere”, senza caricarci di sensi di colpa per la nostra incapacità di “risolvere”, di trovare soluzioni alla sofferenza. So di non essere giunta a nessuna conclusione, di non aver dato nessuna “ricetta”, ma sono queste le sole riflessioni che so fare davanti ad una persona giovane che ci ha lasciato per sempre. Andrea Andriotto - Droga: il brutto arriva quando ti piace lo "sballo" che ti crea Febbraio 1999 Parlare di tossicodipendenza non è mai facile. Ci sono troppe "correnti di pensiero" su questo argomento, io non me la sento di criticarne o di condividerne pienamente nessuna, quello che non mi piace è quando questo problema subisce una generalizzazione. Sono convintissimo che su un tema così complesso non si debba e non si possa generalizzare. Io la tossicodipendenza l’ho vissuto in prima persona, e dalla mia poca esperienza mi sono reso conto che ci sono tipi diversi di tossicodipendenti. So solo che all’origine ci sono sempre dei problemi di varia natura ... ma sono appunto dei veri e propri problemi, e neppure su questo me la sento di generalizzare. Ognuno di noi vive e reagisce in modo diverso di fronte alle difficoltà. non è sempre una questione di debolezza! Farsi di eroina per la prima volta non ti dà dipendenza fisica. Di tutte le droghe che conosco io nessuna ti dà dipendenza fisica alla prima, alla seconda o alla terza volta che la usi (forse il crak, ma non lo conosco e quindi non mi posso esprimere). Il brutto delle droghe, secondo me, non è trovarsela in mano e provarla… il brutto arriva quando capisci e ti piace lo "sballo" che ti crea questa sostanza. Sempre secondo il mio punto di vista, sono in polvere o in cristalli, le droghe che sarebbe bene evitare. "Sì dai… provala, tanto per una volta non ti fa niente!". In effetti è vero: per una volta non ti fanno male. Spera, però, che ti prenda male. Spera di non capire lo "sballo". Spera di non capire le "belle" emozioni che nascondono quelle polverine "magiche". La seconda volta, se ami il rischio, puoi anche riprovarci, stai pur tranquillo che passato l’effetto non sentirai nessun disturbo a livello fisico. Capirai solamente come… farti prendere… ed allora forse inizieranno i guai. Tutto è condizionato dal tuo livello e stato psicologico. C’è gente che se la fa ogni tanto, quando ne ha voglia, e può farne senza quando più lo desidera: la prende una volta ogni 15-20 giorni e questo gli basta. La maggior parte inizia così: assumendola quando vuole, senza essere condizionato da un’astinenza. No, la usa quando gli fa più comodo e quando più ne ha voglia. Credono di restare forti talmente tanto da poterla dominare per sempre. Poi basta un momento di sconforto, uno di quei momenti no, dove le persone normali si danno alla disperazione piangendo o ubriacandosi o facendo a scazzottate con un rivale… Chi conosce il benessere psicologico che crea l’eroina non piange, non si ubriaca, non fa a cazzotti con nessuno… si fa una "pera" e basta, sperando che la situazione di sconforto finisca presto. Ma non fa poi tanto per prendere in pugno la situazione, deve finire tutto senza molto sforzo altrimenti state pur tranquilli: ci sarà solo un tossico in più! Ma che problemi avete?! Tanto ci sono le comunità terapeutiche poi che guariscono questi "malati"! Ah…, sì perché ci sono molti che sostengono l’effetto positivo che danno queste comunità di recupero. Io non posso portare dati o statistiche, posso solo portarvi la mia breve, e forse, poco significativa, esperienza. Mi è sempre parso strano il fatto che per curare un malato di mente lo si debba necessariamente inserire in un contesto predefinito e contornato da altri malati di mente. E mi sono sempre chiesto come si possa sapere di riuscire a curare certi individui mettendoli a vivere assieme ad altre persone con gli stessi loro problemi. Credo esista ancora il detto "chi va con lo zoppo impara a zoppicare", allora chi va con un "malato di mente" … e se sono entrambi malati? Il tossico per me è un malato e di questo in tanti sono convinti da moltissimi anni. Allora se vogliamo non curarlo mettiamolo pure assieme ad altri che hanno gli stessi problemi! Questa non vuole essere una provocazione. Si tratta solamente del pensiero di uno fra i tanti. Forse non è giusto paragonare i tossici a persone malate di mente o psicologicamente instabili? Mah, secondo me un tossicomane è poco stabile con la sua psiche. Ragazzi, per uno che l’ha provata la droga è la miglior medicina, è la migliore amica, è la presenza che copre quei buchi di solitudine… insomma: per un tossico non esiste miglior cosa della "roba"! Da quanto ne so non si riesce a venir fuori da quel tunnel (tutti lo chiamano così) se non si è veramente convinti, se non lo si vuole veramente. Non esistono comunità, Ser.T. o altre terapie che possano levare quella voglia di roba. Non è difficilissimo superare l’astinenza fisica (oddio non sto sostenendo che sia una passeggiata anzi), la cosa più brutta da far passare è l’astinenza psicologica. È difficilissimo far capire ad un tossico che si può vivere benissimo anche senza l’eroina (io porto sempre come esempio l’eroina, ma non perché sia la droga più brutta, no: ce ne sono di droghe anche peggiori di questa, solo che io questa la conosco meglio e posso parlarne con più convinzione senza sparare cazzate), bisognerebbe mettere di fronte al malato un’alternativa valida, qualcosa che lo coinvolga completamente, che gli piaccia. Franco Garaffoni - La verità è che amavo la droga A favore della legalizzazione - Ora che sono in carcere è facile dire che era tutto sbagliato, che ero troppo innamorato della droga, che non ne valeva la pena Novembre 2007 Cosa spinge una persona a fare uso di stupefacenti, a legare la propria esistenza a doppio filo con la droga? Quali sono le motivazioni, e perché pur capendo che in funzione di una scelta, che sappiamo sbagliata e durissima, sopportiamo dei costi fisici e psicologici devastanti, non troviamo dentro noi stessi la capacità per dire: Io non sono tutto qui, deve esserci altro in me? Quante volte mi sono posto queste domande, da solo, in compagnia, davanti ad uno specchio, fissando il soffitto, e mentre pensavo avevo la cocaina che mi guardava dal tavolo di casa, dal cruscotto della mia auto, dalla tasca del mio abito. La verità è che amavo la droga, era la fidanzata che mai tradiva, l’amica fedele a cui rivolgersi nei momenti del bisogno, la porta sempre aperta per entrare nel mondo dei balocchi, della felicità, dell’onnipotenza. Ora che sono in carcere è facile dire che era tutto sbagliato, che ero troppo innamorato della droga, che non ne valeva la pena, che la libertà è un valore assoluto, che la famiglia e i figli vengono prima di ogni cosa nella vita di un uomo, ora sono convinto di quello che dico, ma sono sicuro che sia veramente quello che penso? Vi dico la verità, in carcere è facile fare previsioni positive, pensare di essere cambiato, di avere capito gli errori, ma rimane sempre una paura, la più dura da combattere, la paura della libertà. Una volta libero la mia vecchia fidanzata, la cocaina, sarà li ad aspettarmi, si insinuerà di nuovo nella mia testa? Il mio punto di vista allora è uno solo: legalizziamola. Perché questo comporterebbe una assunzione di responsabilità da parte di chi la consuma, che saprebbe di avere un problema, e di poterlo affrontare a viso aperto. Del resto alcol e sigarette creano danni e dipendenza pari, se non superiori alla droga, e però si acquistano liberamente. Per una persona che fa uso di sostanze stupefacenti entrare in una farmacia per acquistare un qualsiasi tipo di droga credo che comporterebbe il rilascio delle generalità, e questo secondo me eviterebbe la possibilità di false giustificazioni con se stessi. Eviterebbe allo stesso tempo la ricerca disperata di uno spacciatore. Ed è proprio il rapporto sistematico con lo spacciatore che inevitabilmente, col tempo, porta il consumatore a prendere in considerazione la possibilità di procurarsi la droga in modo diverso, cioè spacciandola. Così ci si abitua a una consuetudine all’illegalità in funzione di una necessità, e ci si giustifica pensando: che male faccio se non a me stesso? Dimenticando che spacciare crea vittime, crea dipendenza e prepara il terreno ad un prossimo spacciatore. Io sono convinto che si deve legalizzarla, avendo cosi la possibilità di essere a conoscenza del problema dei cittadini che usano droghe in modo preciso, indirizzando risorse e idee su situazioni accertate. Oggi sono i media, tv e giornali che, a seconda del momento, accendono o spengono i riflettori su questa emergenza, ma nel frattempo la droga circola dappertutto, anche nelle scuole, e sono sempre più giovani i consumatori, ai quali, non riuscendo a intervenire con coraggio, stiamo preparando un futuro da tossicodipendenti e di conseguenza da criminali. Legalizzare la droga vuol dire controllo sanitario, vuol dire assunzione di responsabilità, vuol dire evitare reati ai più deboli, vuol dire meno decessi dovuti alla cattiva qualità, vuol dire impedire a un minorenne di procurarsela facilmente, vuol dire evitare l’arricchimento di organizzazioni criminali sempre più spregiudicate e presenti sul territorio, vuol dire contare su uno Stato che si assume la responsabilità di un rapporto chiaro con i cittadini e garantisce loro sicurezza sui loro problemi. Ricordiamoci che prevenire, con intelligenza e senza rigidità, resta pur sempre meglio che curare. Bambini in carcere Le donne della Giudecca - Storia di Emiliana una "detenuta" di tre anni Quando la scarcerazione è un dramma. Eppure lei non voleva proprio andarsene dalla galera Gennaio 2002 Emiliana ha appena compiuto tre anni, e quello è stato un gran brutto giorno. Il giorno che ha ricevuto l’annuncio di dover "essere dimessa" dal carcere. Dunque c’è qualcuno che può non voler uscire dal carcere, ed essere costretto a farlo: una bambina di tre anni, per esempio, perché per lei il carcere è vivere con Maria, sua madre, e uscire significa essere staccata da lei inesorabilmente. E infatti è appena arrivata una carta del Tribunale, che ha decretato quello che Maria temeva più di tutto: l’affidamento della figlia a un istituto o a una famiglia italiana. La storia di Maria, albanese, va un po’ di pari passo con quella di Giuliana, italiana: erano detenute insieme nel carcere della Giudecca pochi mesi fa, solo che Giuliana i figli li aveva fuori, affidati alla sorella, e Maria l’unica figlia se l’era portata dentro. Ma c’è un’altra differenza tra queste due donne, ed è quella che forse peserà di più: Maria è albanese, e tutto allora per lei è e sarà più difficile. Ora Giuliana è fuori, il suo è uno dei pochi casi di applicazione della legge sulle detenute madri, che le ha permesso di vivere a casa, in detenzione domiciliare, per accudire i figli. Per Maria invece è arrivato quello che più temeva: il compleanno più brutto, tre anni, la fine di quello strano periodo in cui un bambino può essere carcerato. Un mese fa avevamo parlato con lei, e ci aveva detto: "Quando mi portano via la bambina, divento matta". Era terrorizzata da tutto: le volontarie, che venivano a prendere Emiliana per portarla un po’ fuori, le vedeva con sospetto, diceva che la portavano a conoscere famiglie italiane a cui affidarla. Non aveva fiducia neppure nei suoi parenti che stanno in Italia, temeva che non fossero in grado di aiutarla. Il fratello che vive in Australia, invece, le sembrava l’unica soluzione: meglio che la piccola se ne andasse così lontano, ma con un parente, piuttosto che finisse in una famiglia italiana. Le straniere temono l’affidamento dei figli come la peste: forse non fanno nemmeno tante differenze fra affidamento e adozione, pensano che l’affidamento sia un fatto inesorabile, che poi i figli nessuno glieli restituirà più. E se hanno i bambini con loro in carcere, aspettano come il peggiore degli incubi il giorno che compiono tre anni. Succede che gli ultimi mesi il rapporto tra madre e figlio diventi addirittura morboso: e come non capirlo, con questa separazione incombente, inevitabile e che si consuma ogni giorno un po’? Ma come è stata, la carcerazione di Emiliana? Una vita sempre e solo con donne: agenti, detenute, suore, l’assenza pressoché completa di figure maschili. Alla sera, quando le agenti chiudevano la porta blindata della cella, c’erano le urla perché a Emiliana non piaceva essere rinchiusa. Se succedeva poi che la madre alzava troppo il volume della televisione, la bambina le diceva: "Abbassa, che se no viene l’agente e ti sgrida". E poi le piaceva imitare i gesti di tutti quegli adulti che aveva intorno: anche lei aveva imparato a fischiare e gridare "Terapia!!!" quando lo faceva la suora, che ogni giorno passa e distribuisce le gocce tranquillanti alle donne che non ne sanno fare a meno perché stanno troppo male. Poi, è successo quello che doveva succedere: è arrivata una carta, qualcuno ha dovuto staccare la bambina dalla madre e decretare la fine della sua carcerazione. Ma per la madre la "scarcerazione" della figlia ha finito per essere la condanna a una pena aggiuntiva, una separazione con davanti solo l’ignoto. Ma che ne è stato di Emiliana, "detenuta" dimessa dal carcere quando ha compiuto tre anni? Emiliana qualche giorno fa è stata portata in un Istituto vicino al carcere, in attesa di una difficile decisione su quello che sarà il suo destino, ed ora in carcere entra come tante altre persone, che ogni giovedì e sabato vengono a fare i colloqui con i propri familiari, con la differenza che la Direzione del carcere le ha concesso qualche ora in più per stare a colloquio con la madre. Maria non ha molti soldi in questo momento, e tutte noi che siamo in cella con lei cerchiamo di aiutarla, comprando succhi di frutta, dolci, brioches perché questi lunghi incontri diventino più piacevoli. Ma non è facile un colloquio in carcere per una bambina di tre anni, perché a quell’età dover stare due ore e più nello stesso posto senza potersi muovere liberamente è sempre un tormento. La bambina è seguita dai volontari, dalle suore e dalle agenti che ogni giorno si recano all’istituto per salutarla e vedere come sta. Dalle notizie che noi abbiamo lei non ha affatto difficoltà di inserimento con gli altri bambini. Non si è ancora resa conto, però, che questo carcere non è più la sua "casa". Quando arriva non ha paura del posto, anzi, chiede alle agenti di farla salire nella sua cameretta (che sarebbe la cella che divideva con la madre), chiede di salutare altre detenute con cui aveva instaurato un rapporto affettivo, trova ogni scusa per farsi "arrestare" di nuovo e continua a domandare alla madre: "Perché non mi vuoi più qui con te?". Finito il colloquio, al momento del distacco, piange perché sa, è ben consapevole, nonostante l’età, che non tornerà più a mangiare, dormire e vivere qui con sua madre, e non avrà per lungo tempo carezze, baci e sgridate da lei. Noi pensiamo che, qualsiasi opinione si possa avere della madre, la realtà è una: la bambina è bene educata, è sensibile, è tranquilla, e gli anni passati in carcere non sembra che le abbiano lasciato ferite troppo profonde.. E allora è giusto dire che tutto questo è dovuto davvero alla madre, che ha dimostrato grande capacità e amore nell’educare la figlia. Sono tante le domande che noi ci facciamo quando vediamo Maria ed Emiliana, o le altre detenute che stanno al nido del carcere con i loro bambini: è davvero inevitabile strappare la figlia ad una donna, anche se ha sbagliato? E’ possibile accettare finalmente l’idea che una donna che ha sbagliato può essere però nello stesso tempo una madre che ha dato amore e ha saputo crescere bene la propria figlia? E’ giusto spezzare il legame tra una figlia ed una madre, che grazie a questo legame sta trovando l’aiuto e la forza per cambiare la sua vita? Se questa donna perderà la bambina, quale stimolo potrà avere per migliorare se stessa e per continuare a vivere? Giuliana - Mamme e bambini in carcere: il "nido" penitenziario della Giudecca Ma cosa vedono questi bambini, che stimoli hanno? Sempre gli stessi muri Marzo 2001 Sono rientrata in carcere, da definitiva, l’anno scorso a gennaio, lasciando fuori quattro figli di dieci, nove, due e un anno. Ero molto combattuta sulla scelta se portarmi appresso i due più piccoli, mi dicevo: "Li tengo vicini, li proteggo, l’ultimo lo allatto ancora, come faccio a separarmi da loro?". Mia madre me lo ha proibito, per fortuna, a parte che non sapevo che ero tra l’altro destinata all’Alta Sicurezza (questa è stata un’ulteriore sorpresa). Ma credo che, anche se li avesse portati con me, li avrei subito fatti uscire: io ho la fortuna, che ad esempio non hanno le straniere, di poter contare su una famiglia vicina. I bambini sono sottoposti allo stesso regolamento delle madri. Il "nido" di Venezia è strutturato anche bene: c’è una grande sala, dove i bambini "potrebbero" giocare, la cucina dove le mamme cucinano i pasti per loro. Le celle sono fatte per due persone, ma ci sono stati periodi in cui ci stavano tre madri, più tre figli. I bambini possono stare all’aria come le madri, cioè quattro ore al giorno. L’aria di Venezia è grande, ci sono delle aiuole, ma cosa vedono questi bambini, che stimoli hanno? Sempre gli stessi muri. Dopo la visita del Ministro Fassino, in occasione dell’otto marzo, leggevo sul Gazzettino un riferimento alla presenza dei bambini in carcere, dove dicevano che c’è un giardino con dei giochi per loro. Quello, in realtà, è il giardino dei colloqui speciali, i colloqui delle madri con i bambini che le vengono a trovare da fuori. I bambini del nido di solito non ci vanno a giocare, ma poi chi dovrebbe portarli? Al nido c’è la puericultrice, è vero, forse potrebbe farlo lei? Ciò che più mi turba sono i rumori e "le voci alte" che ci sono in questo reparto (io sono isolata al nido): non mi riferisco al vociare dei bambini, ma alle discussioni che ci sono spesso tra madri, tra le madri e la puericultrice, tra le madri e le agenti. Questi bambini sono dentro questa vita "ristretta", e la cosa peggiore, per loro, io ritengo sia il vedere lo stato di impotenza delle loro madri, la loro costretta sottomissione. Che effetto avrà in un bambino, per il quale la madre, oltre che l’oggetto affettivo principale, è anche l’unico punto di riferimento? Guardando, però, queste donne e i loro figli, a volte mi chiedo: è tutto male? Qui fanno pasti regolari, hanno vestiti puliti, riscaldamento, acqua calda, cure mediche. Entrano non sempre in buono stato, dopo qualche settimana rifioriscono. Sono bambini belli, intelligentissimi e sani, vorrei sperare che non sia proprio il carcere a costituire un miglioramento alla loro condizione di vita. La nuova legge difficilmente risolverà il problema dei bambini in carcere Fortunatamente non è un problema di ampie dimensioni, ma coinvolge oltre 50 bambini, in tutta Italia. Questo non significa, però, che ci siano solamente cinquanta donne con figli piccoli, su un totale di 2.326 donne detenute (dati del 31 dicembre 2000). Ad esempio, a Venezia, su un totale di circa 100 donne, sono presenti "solo" sette bambini, ma di madri con figli sotto i tre anni ce ne sono altre quattro e con figli di età inferiore ai dieci anni ce ne sono altre undici. Nel carcere di Venezia esiste la sezione nido, ovvero il reparto dove sono alloggiate le mamme con i bambini, ma a causa del sovraffollamento e della struttura edilizia dell’istituto nel "nido" vengono effettuati pure gli isolamenti giudiziari, quelli punitivi e sanitari. Attualmente ci sono rinchiuse otto mamme, con sette bambini: cinque di etnia Rom, una Sinta e una straniera. Usciranno queste mamme? Ipoteticamente potrebbero uscire libere, ma l’applicazione dei benefici, nella realtà del "nido" di Venezia, sarà difficile. Tre delle madri presenti avevano ottenuto il beneficio della detenzione domiciliare, concesso grazie alla legge Simeone, ma sono nuovamente rinchiuse perché non hanno rispettato l’obbligo e sono evase. Un’altra detenuta non è ancora definitiva, per cui non può ottenere al momento nessun beneficio e la richiesta degli arresti domiciliari le è stata respinta. Un’altra, con una figlia che compirà tre anni tra due mesi e che praticamente è cresciuta in carcere (è dentro, con la madre, da quando aveva venti giorni), non ha beneficiato neppure della legge Simeone in quanto dichiarata estremamente pericolosa (cioè con troppi precedenti penali). Infine due detenute madri sono qui da poco e aspettano la Camera di Consiglio, il cui esito dipenderà da quanti precedenti penali hanno. Una sola, con un bambino di sette mesi, ha la certezza di uscire, ma la Camera di Consiglio per ottenere la sospensione della pena le è stata fissata per la fine di aprile. Da rilevare anche un nuovo, recente ingresso di una mamma Rom con un bambino di 40 giorni. È molto delicato parlare della condizione delle donne Rom, sarebbe importante riuscire a farlo con loro, e discutere dell’accusa che viene loro mossa, di utilizzare a volte la loro maternità come una sorta di precondizione per avere l’impunità. I mass media hanno dato la notizia del varo della nuova legge con i soliti titoli ad effetto, del tipo "Mai più bambini in carcere": speriamo che ciò non provochi invece nuove entrate di bambini. Da quando c’è la legge a Venezia ne sono già entrati quattro… Stranieri Marianne - Stranieri in depressione, tra avvocati d’ufficio e documenti da firmare senza averne capito una parola Ottobre 1999 Quando uno straniero viene arrestato e messo in carcere, a volte può accusare solo se stesso, soprattutto quando si tratta di reati di droga. I corrieri della droga lo fanno per lucro, oppure perché amano la vita rischiosa, ma il più delle persone lo fa per la molta povertà che c’è nel loro paese. Queste persone, pur sapendo il pericolo a cui vanno incontro, accettano di rischiare pur di riuscire ad aiutare i propri familiari a procurarsi il minimo necessario per sopravvivere. Così, sono in molti come me a ritrovarsi lontani dalla propria casa e famiglia, in un paese sconosciuto. Qualche anno fa, quando venni arrestata e messa in un piccolo carcere con altre venti donne, mi sentii doppiamente carcerata. Le mura e le sbarre furono il primo duro impatto con il carcere, ma il secondo, anche più duro, venne dal fatto che non conoscevo nemmeno una parola di italiano e non potevo comunicare con nessuno: c’era una terribile barriera costituita dalla lingua. Per quanto posso vedere stando in questo carcere, in Italia con il francese, o l’inglese, o il tedesco, non vai molto lontano. Io mi sono trovata handicappata in Italia, paese che vuole appartenere all’Europa, procedendo in mezzo a una grande burocrazia di domandine e documentazioni che ero costretta a firmare senza conoscerne il contenuto. Ho avuto bisogno di cure mediche e per spiegarmi ho utilizzato il dizionario, non sapendo poi se il medico mi aveva capito. Per almeno due mesi mi ha prescritto della vitamina B per curarmi dei disturbi al cuore e la pressione del sangue alta: ero vicina alla disperazione. Lo stesso vale per il mio primo interrogatorio: mi è stata affiancata una interprete francese, invece che olandese, così non ho potuto spiegarmi bene. Dietro richiesta del mio avvocato, che sottoponeva al giudice il problema dei documenti scritti in una lingua che io non comprendevo, il giudice rispose che io potevo ottenere i documenti scritti nella mia lingua pagandoli. Come potevo pagare, essendomi stato sequestrato tutto il contante che avevo, e non avendolo più riavuto indietro? Anche trovare un buon avvocato è stata per me una cosa quasi impossibile. Mi hanno affiancato un legale d’ufficio, il quale invece di prendersi cura della mia difesa, tutte le volte che lo incontravo mi spiegava che lui non poteva vivere con quello che gli passava lo Stato. Nel rimanente tempo dell’udienza mi parlava di una punizione da un minimo di dodici a un massimo di venti anni. Tutte le volte che lo incontravo, con questi discorsi, alla fine mi sentivo depressa almeno tanto quanto lui e l’angoscia mi chiudeva la gola fino a togliermi il respiro. In carcere le altre detenute mi hanno detto che la mia punizione sarebbe stata non più di sei-sette anni e mi hanno fornito i nomi di diversi legali a cui ho scritto chiedendo se volevano assistermi, ma con mia somma delusione nessuno si è fatto vivo per paura di non riscuotere la propria parcella, essendo io una straniera e non avendo famigliari vicino. Alla fine una mia cara amica mi ha presentato al suo legale, che ha accettato di difendermi. Con questo avvocato potevo solamente "parlare" usando le mani, con la porta aperta e alla presenza di un’agente che poteva ascoltare tutto quello che dicevamo. È stata una grande sorpresa per me, questi metodi nel mio paese non sono in vigore, ma l’avvocato mi ha spiegato che in Italia sono normali. Di positivo ho trovato, circa due mesi dopo l’arresto, di poter frequentare un corso di lingua italiana. Imparare una nuova lingua è stato molto divertente (un po’ come ricevere una nuova personalità) e gli italiani sono tanto simpatici e mi hanno dato l’impressione che potevo parlare bene la lingua in pochi mesi. Però ho perduto la mia lingua nella bocca: l’italiano è una lingua cantata, per me molto difficile. I miei pensieri, così semplici ed eleganti nella testa, escono piatti ed infantili, ma soprattutto senza colore ed espressione. La sensibilità di scelta del tono giusto, tra l’ironia e il cinismo, non mi è chiara in italiano. Tutte le frasi hanno costruzioni che non sono le mie naturali. La consapevolezza di esprimerli in modo incomprensibile e la confusione delle mie idee mi fanno paura. Mi fanno pensare di essere strana, bizzarra, ingiusta o sentimentale, nel caso migliore di essere una straniera "divertente". Ci sono momenti in cui capisco tutto quello che dicono gli altri, altre volte capisco solo la metà e il mio cervello non lavora. Talvolta perdo totalmente la traccia e in questi momenti vorrei scoppiare in lacrime e scappare. Nonostante trascorrano gli anni la solitudine pesa di più: mai poter parlare nella propria lingua mi sembra orrendo. A conclusione di questa mia avventura penso che la legge debba essere uguale per tutti e non lasciar soffrire di più lo straniero, perché pene giuste dovrebbero prevenire la sofferenza inutile. Mentre il carcerato italiano, comportandosi bene, può usufruire di pene alternative, di qualche permesso per andare a casa, di due telefonate al mese con poco costo, dei colloqui con i famigliari, lo straniero di tutto questo non può avere niente e può solo aspettarsi di essere espulso alla fine della pena. Olga - Il mio zio italiano Dall’Ucraina in Italia, a fare la schiava di uno "zio italiano" Giugno 2000 Il mio nome è Olga, sono nata in Ucraina. A diciassette anni sono andata a Mosca per studiare, ho frequentato una scuola tecnica e poi mi sono sposata. Mio marito era un uomo buono, lavorava forte e con lui stavamo benissimo, io e i nostri due bambini. Il suo lavoro stava al primo posto, al secondo posto stavano i bambini e al terzo io. Cinque anni fa ebbe un incidente, e io rimasi sola con una figlia di nove anni e un figlio che dipendeva ancora da me. E questo a Mosca nel 1995, dove nel frattempo da tre anni o più regnava l’anarchia e la vita diveniva di giorno in giorno più difficile. Mia sorella nel frattempo conosce un italiano, un certo Mario. Ed è grazie a lui che ho ricevuto un visto e immediatamente mi sono ritrovata in Italia. Un giorno infatti Mario mette per me un annuncio breve su un giornale italiano: "Donna tranquilla, 38 anni, cerca calore e attenzione, richiede poco. Non parla italiano". Arrivano 150 risposte. Mario le seleziona. Gli chiedo di scegliere un uomo maturo, preferibilmente con una casa in campagna. Spero che un uomo un po’ vecchio, all’infuori di un po’ d’atmosfera, di aiuto nell’orto, un buon pasto e una casa pulita, non pretenda tanto. Alla fine la scelta di Mario cade su un uomo di 60 anni, robusto e con occhi penetranti. Desta fiducia. Vado con lui, con quello che io chiamo "il mio zio italiano". Lui ha una casa abbastanza grande, un orto, mucche, polli, cani alle catene e conigli in una gabbia di legno. Questo posto si trova un po’ fuori città. L’abitazione e le dipendenze sono vecchie e mantenute abbastanza male, piene di cianfrusaglie e oggetti fuori uso. Penso che il mio italiano sia innamorato. Mi porta in giro per negozi, e naturalmente lui stesso sceglie e acquista le cose più urgenti, tutto a buon mercato. Le cose di prima necessità come la carne, le verdure e le uova provengono dalla produzione della fattoria. Il modo italiano di mangiare è tanto diverso da quello russo. In Italia mi sembra che mangino pochissimo, ma grazie a Dio non sono una gran mangiatrice. Però in casa non c’è neppure il sapone e tanto meno lo shampoo: scopro che non gli piace lavarsi le mani e raramente fa la doccia. Mia sorella mi consiglia di chiedergli di portarmi ad un grande magazzino per comprare qualche vestito e nel frattempo prendere anche sapone e shampoo. "Se ti farà fare questi acquisti senza storie, vuol dire che è un buon uomo", mi dice mia sorella. Scelgo roba a buon mercato, un paio di scarpe economiche e anche il sapone e lo shampoo, arriviamo alla cassa, lui si volta. Io stessa devo pagare, e lì se ne vanno i miei ultimi soldi. Il primo mese che viviamo insieme scorre veloce. Spero che voglia ospitare a casa mia anche mia figlia. Il periodo di prova è proseguito bene, lui mi accompagna anche alla polizia per regolare la mia presenza in Italia. Dopo, essendo in regola, faccio la visita dallo specialista, il quale mi assicura che devo mangiare di più, sono troppo magra. Per colazione posso prendere solamente un caffè. Fa più freddo adesso, non ci sono più frutti, i polli che ha sono piccoli, ma fanno abbastanza uova. Le uova grandi si vendono, le piccole le mangiamo. Quando ne cuocio due, lui ne prende uno e lo butta tra i polli che l’hanno fatto, e quando voglio versarmi ancora una tazza di caffè, non mi da il permesso: "Costa troppo". Un giorno arrivano ospiti. Lui esce. Ritorna con un pezzo di formaggio e delle salsicce. Magari, arrivassero tutti i giorni ospiti, penso rallegrata. Finalmente qualcosa di buono a casa. Non posso aspettare e prendo subito un pezzo di salame. "Fa sempre così", dice lui agli ospiti. Loro abbassano gli occhi. Sprofondo nella vergogna e non oso toccare più niente. Gli ospiti partono. Ciò che resta viene riposto. Quando esce di casa, il giorno dopo, vado a cercare il formaggio. Non riesco a trovarlo da nessuna parte. La fattoria è grande, ci si può nascondere qualsiasi cosa facilmente. Trovo solamente una confezione di polvere su cui è stampato un teschio, e nello stesso armadio trovo anche una pagina di un vecchio giornale polacco. Per me, che vengo dall’Ucraina, è facile leggere il polacco. Vedo lui a figura intera. Una delle sue donne polacche racconta quali incubi ha vissuto e avvisa le altre di non avere fiducia in questo mascalzone. Vivo come uno zombie, non so dove cercare, non so cosa devo fare. Ho fame e sono ammalata. Se mi gettassero un pezzo di pane sul pavimento lo mangerei come un cane. Ma questo non succede. Quando gli chiedo qualcosa da mangiare, mi dice: "Levati dalle scatole. Ci sono tante altre straniere". La fame è una sensazione terribile, ma ancora più spaventoso è che vuole sempre fare all’amore. Le poche volte che lui mi lascia fare la doccia esige di toccarmi e di fare altre porcherie. Mi vergogno a subire queste cose, mio marito non mi ha mai chiesto cose del genere. Mario, invece, mi spiega che sono una straniera e se racconto quello che lui fa nessuno mi crederà, e aggiunge "Basta che dica che mi hai rubato soldi, e andrai in carcere". Siccome mangio troppo poco e dormo poco, divento insensibile. Per la prima volta ho pensato ad una corda. Non posso ritornare in Russia ed essere di peso ai miei figli, è meglio se m’impicco qui. Ma ho paura. Piano, piano, metto un po’ di veleno nel caffè e nel brodo. Per lui questo brodo è così gustoso che ne mangia tutti i giorni una mezza pentola. Le sue unghie diventano blu. I suoi capelli cadono. Un giorno si stende sul divano e dopo poco inizia ad uscirgli una schiuma bianca dalla bocca e gli occhi gli si rovesciano indietro. Ho avvisato la vicina di casa. Ora mi trovo in carcere. Francesco Morelli - Stranieri in carcere: diritti teorici e problemi concreti Agosto 1999 Quando parliamo di pene umanizzate, di misure alternative alla detenzione e di integrazione sociale, dobbiamo ricordarci che un terzo di tutti i carcerati è costituito da stranieri ed essi sono, quasi sempre, esclusi di fatto dalle opportunità di recupero che la legge offre. Negata dunque spesso la libertà provvisoria, negate le misure alternative, gli arresti domiciliari, il lavoro esterno e, per i tossicodipendenti, nessuna possibilità di accedere alle comunità terapeutiche, Ma va sottolineato che, nel distretto di Padova, la condizione degli stranieri detenuti è migliore che altrove: alcuni di loro sono ammessi al lavoro esterno, alla semilibertà, all’affidamento ai servizi sociali e un buon numero esce in permesso premio. Straniero, extracomunitario, immigrato, clandestino o irregolare? Questi sono termini che utilizziamo spesso e nemmeno ci chiediamo più se il loro uso sia appropriato, quindi credo valga la pena di dare una definizione precisa per ciascuno di essi. gli stranieri sono tutti coloro che non hanno cittadinanza italiana, compresi quindi gli immigrati residenti in Italia: gli extracomunitari sono tutti gli stranieri che non sono cittadini di un paese dell’Unione Europea, quindi anche gli svizzeri, gli statunitensi, etc: gli immigrati sono generalmente persone che arrivano in Italia con un progetto di vita nel nostro paese, oppure che vi transitano diretti in altri paesi nei quali intendono stabilirsi; i clandestini sono stranieri entrati illegalmente in Italia, generalmente privi di passaporto e di altri documenti di identità; gli irregolari sono stranieri privi, per qualche ragione, del permesso di soggiorno perché è scaduto, o perché glielo hanno revocato. Dai fenomeni migratori vanno senz’altro distinti gli ingressi collegati ad episodi di criminalità internazionale: i contrabbandieri di armi, i trasportatori di clandestini e i corrieri della droga che portano una determinata "merce" dove il mercato la richiede, poi tornano al proprio paese e preparano un nuovo viaggio (oppure si mettono a riposo, se hanno già guadagnato abbastanza), Anche gli zingari, che vengono dall’estero e mantengono abitudini itineranti, non possono certamente essere considerati immigrati, i veri immigrati sono una percentuale ridotta sul totale degli stranieri presenti nelle carceri italiane e, senza dubbio, sono quelli che della pena sperimentano solo gli aspetti afflittivi. Passeggeri di seconda classe sui treni della giustizia Gli immigrati si fanno per intero la custodia cautelare: in attesa di giudizio per piccoli reati in carcere ci rimangono soltanto loro. "Per la sua condizione di straniero", recita spesso il magistrato nel negare la libertà provvisoria, "non è affidabile, potrebbe lasciare l’Italia rendendosi irreperibile oppure commettere altri reati, essendo privo di fonti di sostentamento", Quello del magistrato, del resto, è un ragionamento molto lucido: quando un giovane si trova senza lavoro, senza scuola, senza affetti e assistenza sanitaria, se manca insomma quella rete sociale che normalmente dovrebbe sostenerlo, ci sono molte probabilità che si metta a rubare, o a spacciare, e questo a prescindere dal colore della sua pelle. Gli immigrati che si incontrano in carcere provengono spesso da una vita di strada e molti di loro sono tossicodipendenti: qualcuno ha conosciuto momenti effimeri di benessere derivanti dalle attività illecite, i più soltanto stenti e disperazione quando, nei loro sogni, l’Italia doveva assomigliare a un paradiso terrestre. Al processo hanno trovato difensori d’ufficio che si sono impegnati il minimo indispensabile, hanno spesso incontrato difficoltà nel farsi comprendere (nonostante la presenza dell’interprete) e, di solito, hanno preso il massimo della pena. Durante la detenzione vengono trasferiti spesso da un istituto all’altro, poiché non hanno legami in nessuna città: trascorrono anni senza ricevere visite di parenti, a volte anche senza poter telefonare. La spirale prosegue con l’abuso degli psicofarmaci e con gli atti di autolesionismo, che servono di solito per attirare l’attenzione e reclamare i propri diritti, ma in qualche occasione anche per ricercare la morte, a volte perfino quando sono prossimi alla fine della pena, perché per loro finisce qualcosa di terribile, ma sta per iniziare un futuro altrettanto privo di prospettive. Sulle loro morti di solito non indaga nessuno. Quando escono, trovano l’espulsione ad attenderli, oppure rimangono in Italia come clandestini e non possono essere accolti in una struttura pubblica, ne lavorare in regola: riprendono spesso a drogarsi e poi a spacciare: quando durano un anno senza tornare in carcere è già molto, le condanne che ricevono vanno generalmente dai tre ai cinque anni, in un ciclo immutabile come le stagioni. Il desiderio di libertà e il rispetto delle regole A Padova, e in particolare qui alla Casa di Reclusione, gli stranieri trovano condizioni migliori, rispetto alla norma degli istituti italiani, perché partecipano numerosi a tutte le attività culturali, dalla rassegna stampa, al giornale, al laboratorio teatrale, ai corsi scolastici e professionali. Ma la cosa più importante è che riescono ad ottenere permessi e misure alternative alla detenzione questo grazie a iniziative concertate con gli enti locali, con cooperative e associazioni di volontariato. Naturalmente c’è anche chi ha approfittato delle uscite per evadere e la proporzione tra gli stranieri e gli italiani non rientrati al termine dei permessi è nettamente "favorevole" ai primi. E’ un dato che non deve meravigliare, se pensiamo alle prospettive concrete che un immigrato si ritrova al termine della pena. se è irregolare lo aspetta l’espulsione, oppure il ritorno a una vita di clandestinità. Per la verità anche i regolari non hanno prospettive molto più rosee, ma almeno sono paragona bili a quelle di ogni italiano che sia privo di sostegno da parte della famiglia: un lavoro poco gratificante e poco compensato, il pregiudizio della gente, la sopravvivenza come obiettivo primario. La decisione di rientrare al carcere e quindi di chiudere i conti con la giustizia dipende molto dalle condizioni nelle quali una persona si trova e in ciò che può ragionevolmente aspettarsi dal proprio futuro. Creare opportunità di integrazione sociale che siano concrete anche per i detenuti stranieri significherebbe diminuire di molto il rischio che essi scelgano di evadere, perché diventare latitanti rappresenta comunque l’ultima spiaggia. Fulvio Santagata - Quando l’immigrazione parlava calabrese Bologna, anni ‘60, una scuola di quartiere e un giovanissimo immigrato: "E’ arrivato il marocchino, finalmente!", gli dicono accogliendolo in classe. Ma il "marocchino" di Calabria non si offende, perché non sa neppure chi è o cos’è un marocchino Gennaio 2001 Siamo un paese che ha faticato molto ad accettare e ad accogliere la sua immigrazione interna, dal sud al nord, dalla Puglia e dalla Calabria a Torino, destinazione Fiat, ma anche a Milano, a Bologna. Immaginarsi la fatica che facciamo, a trent’anni di distanza, a non rifiutare ragazzi che arrivano dal Marocco, dalla Tunisia, dall’Albania. La storia si ripete: "non si affittano case ai meridionali", c’era scritto nei condomini dei quartieri popolari di Torino, ora non c’è scritto "non si affitta a marocchini e tunisini", perché siamo diventati più eleganti, ma la sostanza è la stessa. E tante storie, allora come ora, finiscono in carcere: i ragazzi più giovani, nelle carceri italiane, oggi arrivano dall’Africa o dall’est europeo, ma le carceri sono anche piene di uomini che hanno cominciato la loro "carriera" di delinquenti quando erano ragazzini, emigrati dal sud, dal "nostro" sud, nelle periferie delle grandi città del nord. Ci piace allora raccontare, accanto alle vicende di tanti giovani immigrati stranieri, anche le loro storie, che sono storie tutte di casa nostra: di quando gli immigrati parlavano calabrese o pugliese. Una tranquilla giornata invernale, il sole tiepido ancora ci permette di giocare fuori coi calzoncini corti. In Calabria il clima è mite, l’inverno può considerarsi come la primavera del nord. E’ il 1962, siamo in attesa di nostro padre che ha già accompagnato parte della nostra famiglia proprio al nord, a Bologna. Siamo rimasti con la nonna, i miei tre fratelli ed io. I nostri discorsi evitano di affrontare l’argomento della partenza, ma sappiamo, senza dircelo, che dispiace a tutti andar via. Mio fratello più grande ha 12 anni, il secondo 10, io 6 ed il più piccolo solo 4 anni. Ci sediamo a tavola per mangiare qualcosa prima di partire, arriva in quel momento mio padre, fa le porzioni, si siede con noi e ci fa fretta poiché il treno partirà nel giro di qualche ora. Prendendo alla lettera ciò che ci ha detto, ricordo, ho mangiato d’un fiato il mio piatto di spaghetti ancor prima che la nonna mi mettesse sopra il sugo… occasione, questa, per farci un’ultima risata. Poi i preparativi, le valige (le "mitiche" valige di cartone) stipate all’inverosimile, legate con lo spago da pacchi, nodi alla marinara, come piaceva dire a nostro padre, una grande busta di cotone contenente tutto quanto occorreva al sostentamento durante il viaggio, enormi ruote di pane casereccio, qualche soppressata, qualche etto di mortadella, un po’ di formaggio, un buon fiasco di vino e qualche bottiglia d’acqua. Ci viene a prelevare nostro zio con la sua seicento multipla, carica tutto, un po’ sul tettuccio un po’ incastrato tra noi nell’abitacolo, e andiamo alla stazione. Guardando da quello spicchio di finestrino che mi è concesso, mi vengono quasi le lacrime agli occhi vedendo passare i volti dei miei amici che, sapevo, non avrei più rivisto, guardavo quei luoghi a me familiari e mi immaginavo cosa poteva aspettarmi là, dove mio padre mi stava portando, sapevo già allora che nulla avrebbe potuto competere col "bello" che mi stava toccando lasciare ed ero triste, molto triste anche quando si rideva tutti insieme delle battute che si facevano riguardo all’eldorado che ci prospettavano... Il treno, affollatissimo… Ci siamo sistemati sul pianerottolo appena dopo la scaletta, seduti sulle valige e sui cartoni, parecchia gente intorno a noi era in piedi, guardavo gli occhi degli altri ragazzi che come me seguivano i desideri dei loro padri, tristi anche loro, ma ridevano, come me e con me, perché il gioco lo imponeva. Dopo non so quanti chilometri, né quanto tempo, siamo riusciti ad appropriarci di uno scompartimento, così abbiamo potuto sistemarci un po’ meglio. Mia nonna ha cominciato a tirare fuori il pane ed il companatico, mio padre ha aperto il suo coltello a serramanico e con dovizia particolare, come fosse il migliore dei chirurghi, ha cominciato a far fette come se venissero fuori dall’affettatrice, una fetta di mortadella, una fetta di provola un paio di fette di soppressata, la nostra cena. Ogni boccone masticato coi ricordi di quanto lasciavamo dietro le spalle, già quello scompartimento era un mondo nuovo. Fuori dalla porta si scorgevano volti di persone sconosciute, si sentiva parlare una lingua diversa, l’atteggiamento della gente, poi, non era il solito con cui avevo avuto a che fare fino a quella mattina. Tristezza nel mio cuore, anche se sapevo che quel viaggio mi avrebbe condotto da mia madre e dalle mie tre sorelle che erano partite quasi un mese prima. La voglia di riabbracciare mia madre mi fece addormentare che ancora dovevo finire il panino… poggiando la testa sul finestrino e guardando le luci che mi correvano incontro ricordo di aver sognato un mondo fantastico dove eravamo tutti riuniti a giocare e a mangiare, tutti, la mia famiglia e i miei amici che sapevo ormai lontani. Il viaggio durò più di ventiquattro ore, man mano che ci avvicinavamo al nord, il freddo si faceva sempre più intenso, la nonna tirò fuori dei maglioncini per coprirci un po’ meglio, ma i pantaloncini rimasero corti, in quanto proprio non ne avevamo di lunghi. Era gennaio del 1962, non ricordo un inverno più freddo di quello, la neve aveva preso il posto del verde, il paesaggio ai miei occhi era stupefacente, non avevo mai visto la neve. Mio padre mi prendeva in giro perché ne avevo troppo paura, per me era qualcosa che mi nascondeva tutto quello che conoscevo meglio, la natura, gli alberi, le case, e il treno con la sua velocità rendeva ancora più difficoltoso, per me, realizzare dei punti di riferimento in mezzo a quella distesa accecante. Arrivammo a Bologna nel tardo pomeriggio di una gelida giornata di gennaio, c’era ad attenderci un signore, amico di mio padre, che con la sua seicento era arrivato quasi sotto lo sportello del treno. Io rimasi sul predellino della scaletta a guardare le operazioni di carico di tutto quanto ci eravamo portati dietro, poi salirono i miei fratelli e mia nonna, ma quando avrebbe dovuto toccare a me, mi attaccai al passamano del treno e urlando dissi che non volevo andare da nessuna parte, che non sarei andato in mezzo alla neve, c’era letteralmente mezzo metro di neve, ed io, se non ricordo male, arrivavo a superare quella misura solo per qualche centimetro. Mio padre fece per un attimo la voce grossa, credendo che stessi facendo i capricci, poi, quando si rese conto che effettivamente se mi fossi buttato giù sarei stato sommerso dalla neve, venne e mi prese in braccio e mi pose in macchina. Un freddo bestiale e la sensazione di non poter più vedere il sole è il primo ricordo che ho di Bologna. Il signore che guidava la macchina, parlando con mio padre, lo metteva al corrente di quanto era avvenuto durante la sua assenza, tranquillizzandolo al riguardo delle nostre sorelle e di nostra madre, mentre noi dietro ci tenevamo stretti e cominciavamo a valutare il nuovo posto dove avremmo dovuto vivere. La macchina si fermò davanti al portone di un vecchio palazzo, un paio di colpi di clacson e dopo poco ecco materializzarsi nell’androne nostra madre con la più piccola in braccio, dietro di lei le altre due bambine che si tenevano aggrappate alla sua gonna e sbirciavano impaurite la scena di noi che uscivamo dalla macchina tutti anchilosati e stanchi del viaggio. Appena scesi ci infilammo immediatamente dentro al portone dove nostra madre ci abbracciò e ci bacio parecchie volte prima di lasciarci salutare le nostre sorelle. E subito venimmo a saper, da loro, che si stava male, che il posto non era bello come quello che avevamo lasciato. Che i bambini che c’erano non volevano avere a che fare con noi, che ci chiamavano "marocchini", perché venivamo dal sud. Cominciammo a salire una rampa di scale, poi un’altra rampa, poi ancora e ancora scale, cinque piani e dopo l’ultimo piano una rampa di scale in assi di legno e la soffitta: ecco la nostra abitazione. Ricordo che mio padre e mia madre dovevano camminare leggermente curvi per potersi muovere. Il tetto era a spiovente su tutti e due i lati, solo nel mezzo loro potevano stare diritti sfiorando ugualmente con la testa l’architrave che sorreggeva il tetto. Appena dentro sulla sinistra una cucina economica appoggiata su una pila di mattoni, nel centro della stanza un tavolato che serviva da poggia cose, ma che al momento del desinare diventava la tavola dove mangiare. Più avanti una porticina che si apriva in una stanza un po’ più piccola con il letto grande dei miei genitori, attorno un paio di culle per le sorelle più piccole, un’altra porticina dava accesso ad un’altra stanza dove c’erano un letto per mia nonna e tre letti per gli altri cinque figli, due a due i maschi ed uno piccolino per mia sorella grande. Sopra di noi si apriva un abbaino che ci dava la visione del cielo plumbeo di quei mesi invernali. Al centro della stanza una stufa a carbone che sfiatava dall’abbaino leggermente aperto. Mangiammo qualcosa di caldo, dopo mia madre e mia nonna cominciarono a preparare i letti e gli scaldaletto. Prendevano la brace dalla stufa, la mettevano nello scaldaletto che poi ficcavano dentro ad un letto, qualche minuto per togliere freddo ed umidità e subito ci si infilava sotto, poi un altro e così nel giro di poco tempo eravamo tutti sotto le coperte. Parlando con mio fratello, che dormiva con me, ricordo quanto ci era sembrata strana tutta la procedura, ma quanto caldo faceva sotto le coperte, poi dopo un po’ cominciammo a risentire freddo e non riuscivamo a darci pace per ciò che avevamo lasciato, il caldo tepore del clima calabrese. Ci ripromettemmo che appena possibile saremmo tornati in Calabria, anche se nostro padre non fosse stato d’accordo. Arrivò giorno, il primo giorno a Bologna. Mia madre ci prese e ci portò ognuno alla scuola a cui ci avevano assegnato, io facevo la prima elementare… entrai in classe e tutti sembrava aspettassero me, ero abbronzatissimo al loro confronto, naturalmente il primo commento che ho sentito è stato: "E’ arrivato il marocchino, finalmente!". All’inizio non mi arrabbiavo neppure, in quanto per me non poteva essere un’offesa, non sapevo neppure chi era o cos’era un marocchino, poi ci pensarono i miei compagni di classe a farmi capire bene che non poteva non essere un’offesa e così ho cominciato a fare a botte ogni volta che qualcuno si rivolgeva a me con fare sprezzante. E più cercavo di farmi rispettare e più nemici mi facevo, ma non me ne fregava nulla. Solo contro tutti. I primi giorni sono andati via su questa falsa riga, tornando a casa a mia madre dicevo che non mi piaceva stare a Bologna, alle sue domande più precise rispondevo però che a scuola andava tutto bene. Piano piano ho cominciato comunque a farmi apprezzare nonostante "l’onta" di essere meridionale e così si faceva gruppo con altri bambini per i giochi o per fare un po’ di cagnara durante la ricreazione… solo che io dovevo sempre dimostrare qualcosina in più degli altri, vuoi per recuperare una certa posizione nell’ambito del gruppo, vuoi, forse, perché ero un casinista di prima qualità. Sta di fatto, che tra una marachella e l’altra riesco a finire la prima elementare facendo una collezione di punizioni a casa e a scuola, che mi portano a fare la seconda elementare in collegio. Ma questa è un’altra storia. Nabil Tayachi - Mamme italiane e mamme straniere, ma sempre mamme Ovvero: i consigli della mamma sono sempre preziosi Dicembre 1999 E’ tutta colpa mia: i miei genitori mi avevano consigliato di non venire in Italia. Mia madre mi diceva sempre: - Se vuoi andare via, vai in Libia, tu conosci un mestiere per cui là troverai certamente lavoro, rimanendo in un paese arabo. Io così potrò stare tranquilla. Cosa vai a fare in Italia? Guarda la televisione: si vedono soltanto programmi con ballerini seminudi, maleducati che sono. Non sanno che noi vediamo queste trasmissioni e non potremmo guardarle. Noi non siamo mica senza dignità come queste ragazze quasi nude che non hanno famigliari a controllarle e non si vergognano davanti alle loro madri, ai loro padri, ai loro fratelli. - Mamma, queste cose si chiamano libertà, democrazia! - Spostati di qua, altrimenti ti spacco la testa: ma quale libertà e democrazia, quelli sono maleducati e basta, non hanno dignità. Guarda per esempio quanti omicidi si vedono in televisione, non passa un giorno senza che ci sia una sparatoria, senza che si parli di mafia e di camorra. Senza aver bisogno di andare in Italia le abbiamo conosciute tutte queste cose! Se ti lascio andare loro ti ammazzano! Qui non ti manca niente: non ti abbiamo mai lasciato senza soldi, la casa ce l’hai. Ti piace la pasta? Ti ho sempre preparato la pasta. Ti piace la pizza? Vai in città e trovi le pizzerie: non hai bisogno di andare in Italia! Puoi anche stare a casa senza lavorare, tu che sei disoccupato ti vesti meglio di quelli che lavorano. - Senti mamma, non è che l’Italia mi piaccia particolarmente, ma è l’unico paese nel quale non serve avere il visto per entrare, il resto dei paesi europei ha chiuso le frontiere e non è facile avere il visto d’ingresso: chiedono molti documenti, perché hanno già molti immigrati. - Se loro hanno chiuso le frontiere vuol dire che non ti vogliono! - Non è che non mi vogliano, il problema è che non possono ospitare tutti quanti, l’immigrazione è un fenomeno molto vasto e da quasi tutti i paesi del terzo mondo gli immigrati si spostano verso l’Europa. In Europa vengono ammessi solo in pochi, solo il numero necessario a svolgere i mestieri che la gente di là non vuoi più fare. - Ah, allora ti sei informato bene! Dimmi una cosa, che lavoro vorresti fare in Italia? - Quello che trovo, mi arrangio finche trovo un lavoro che mi piace. - Non hai risposto alla mia domanda: che lavoro vorresti fare in Italia? - Ho sentito che è la stagione della raccolta del pomodoro, poi c’è quella delle olive. Anche il lavoro come manovale o come operaio mi andrebbe bene. - E così vuoi andare in Europa per fare dei lavori che ci sono anche da noi e qui non li vuoi fare: li fanno i terroni che arrivano dal sud, voi giovani della capitale preferite emigrare in Europa! - Mamma, in Europa non mi vede nessuno a fare questi lavori, e quando ritorno ho la macchina e il portafoglio pieno, e racconto una bugia dicendo che ho il lavoro in qualche ufficio. - Ma sei matto, non è possibile nascondere niente perché tutti guardano la RAI e conoscono la lingua italiana. Non è possibile prenderli in giro. Pensa a tutti quelli che hanno rimandato indietro, che non hanno nemmeno potuto mettere piede in Italia. - Tu parli di quelli che hanno la "faccia non buona": in dogana, quando noi tunisini arriviamo tutti assieme, con il passaporto e i soldi, la polizia non fa passare tutti e qualcuno lo rimanda indietro, senza motivo. Allora, quelli mandati indietro li chiamiamo "faccia non buona", sicuramente se avessero una faccia migliore sarebbero passati. Secondo te, io ho la faccia non buona, loro hanno un altro come me? - No figliolo, un altro come te non ce l’hanno certamente. Ma voglio sapere che cosa ti manca, perché vuoi andare a tutti i costi? - Voglio andare a cercare la mia fortuna, che qui non ho trovato. Ho sentito parlare molto di questi paesi in cui c’è la democrazia. - La democrazia di cui parli ne ha combinate di tutti i colori, invece qui nessun poliziotto ti ha mai fermato, tuo padre ha molti amici e anche se finisci in carcere loro ti tirano fuori. - Adesso basta, oramai mi sento grande e non mi serve più nessuno, voglio costruirmi da solo il futuro. - Figliolo, tutti quelli che sono andati sono tornati poveri, e questo non ti basta? - Io non sono come gli italiani, che quando hanno bisogno di qualcosa vanno dai loro padri e gli chiedono soldi: soldi per comperare la macchina, per andare in discoteca, per sposarsi. Io sono diverso, anche per la nostra tradizione: voglio fare tutto da solo e voglio sposare la donna che amo, quella che scelgo io, quindi le spese per il matrimonio voglio pagarle io. - Figlio mio, tunisina o italiana, la moglie che prenderai per me è uguale. In Tunisia, lo sai meglio di me, ci sono ragazze di tutti i tipi: ce ne sono di bionde, con gli occhi azzurri e anche verdi. Cosa vai a fare in Italia, che da noi c’è già tutto? - Anche molti italiani vivono in mezzo a noi da tanti anni. gli italiani sono stati i primi ad essere emigranti e, ancora oggi, gli italiani all’estero sono numerosi come metà della popolazione dell’Italia. - Ma allora tu sei matto: se anche loro emigrano vuoi dire che nel loro paese non c’è lavoro. Tu che diavolo vai a fare dove non c’è lavoro? Se tu vai in Italia ritorni in una bara, come tanti altri tunisini che sono finiti nei giri della droga. Molti sono finiti in galera, molti sono morti. - Ma mamma, secondo te io vado a spacciare droga!? Dopo l’educazione che mi hai dato e tutto quello che ho imparato della droga voglio conoscere solo il nome, non la toccherò mai! Non voglio morire e non voglio ammazzare nessuno. Questo era il mio "ottimistico" punto di vista: finche non sono finito in galera, in Italia naturalmente! Maledetti questi occidentali, hanno rovinato i nostri figli! Madri tunisine e nipoti occidentalizzati a confronto Febbraio 2000 Insomma, eccomi qui, in Italia, un paese che ho amato tramite la televisione. Da piccolo avevo altri desideri, volevo imparare il tedesco perché avevo una grande voglia di andare in Germania, per vivere in mezzo alla "razza ariana". Mi piaceva anche la Francia, vedendo gli emigranti che rientravano da quel paese a Tunisi per le vacanze con macchine di lusso e raccontavano di aver comprato perfino la casa e di avere il conto in banca: roba da non credere! Famiglie molto numerose, che avevano bisogno di un capitale per fare le vacanze: alcuni erano in undici, come una squadra di calcio, altri perfino in diciotto; che avessero meno di otto componenti, tra genitori e figli, non ce n’erano. Il problema di queste famiglie quando tornano in patria è che spesso i figli non sanno parlare l’arabo, ma solo il francese, e quando sono ospiti dai loro parenti rimasti in Tunisia non riescono a farsi capire da loro. Anche mia madre, quando arrivano i nostri parenti dalla Francia, è contenta di ospitarli, ma si stanca molto per la difficoltà di parlare con i bambini vissuti in Europa. Quando uno di loro, alle dieci del mattino, un giorno le ha chiesto di portargli le scarpe perché voleva uscire a giocare, lei gli ha fatto il cappuccino, perché il francese non lo conosce. Lui ripeteva che voleva le scarpe e lei gli ha portato una brioche; lui insisteva con le scarpe e lei metteva più zucchero; finché il bambino è stato costretto a prenderla per mano e portarla dove si trovavano le scarpe, per farle capire cosa le chiedeva. Da quel giorno, mia madre pensava di aver capito tutto: secondo lei, chi le chiede qualcosa verso le dieci del mattino, vuole sicuramente le scarpe. Il giorno dopo, arriva il fratello del bambino che voleva le scarpe e le chiede, in francese, una bibita: lei, naturalmente, va sicura e gli porta le scarpe, ma lui non vuole quelle, insiste a chiedere la bibita e poi comincia a piangere. Lei cerca di calmarlo, lo prende per mano, gli mostra i vestiti, ma lui dice di no; gli mostra i giocattoli, e lui dice ancora di no; lo porta al bagno, neanche quello; alla fine lo porta in cucina e il bambino comincia a sorridere, allora mia madre apre il frigorifero e lui indica la bibita: meno male che c’è! Con mia madre, si deve parlare l’arabo, perché solo quello capisce e, da quando i nipoti vengono a trovarla, le sono diventati i capelli bianchi per le preoccupazioni: per l’anno prossimo, o imparano l’arabo, oppure vengono accompagnati dai genitori. "Meno male che non portano gli orecchini: giuro che, se ci provano, gli taglio l’orecchio!" Un giorno, i due nipotini cominciano a piangere perché vogliono andare a giocare con i figli dei vicini di casa. Mia madre non capisce, pensa di avergli detto qualcosa di sbagliato e di averli fatti arrabbiare, poi alla fine li lascia uscire e si ferma sulla porta di casa per controllarli mentre giocano: "Tu stai attento di non cadere", "Tu fai piano, altrimenti gli fai male e lo dico a tua madre", "Tu vai via di qua che sei cattivo". La vicina di casa esce, trova mia madre, la saluta e poi dice al figlio che gioca di fare il bravo e di trattare bene quei due gioielli, come fossero suoi fratelli. Mia madre le si avvicina e le racconta sconsolata: "Sai, cara, sono figli di emigranti ed hanno dimenticato la lingua dei loro genitori. Pensa che uno arriva alle dieci del mattino e mi chiede le scarpe, ma io gli porto una bibita; l’altro mi chiede una bibita ed io gli porto le scarpe". "Eh, lo so", risponde la vicina, "sono abituati a consumare molto, grazie ai loro genitori che possiedono i franchi francesi. I miei figli, dopo la colazione, escono di casa e non tornano prima di mezzogiorno". "È logico, se tu li avessi educati bene, gli avessi comprato le scarpe da calcio e un altro paio per passeggiare, allora anche loro rientrerebbero alle dieci del mattino per cambiarle, ma quando ne hanno solo un paio usano per forza quelle! Guarda quel bambino, il figlio dei vicini, che gioca a piedi nudi: lui è molto intelligente, ha un solo paio di scarpe e, se si rompono, rimane senza e i suoi genitori lo picchiano anche. Per questo gioca a piedi nudi e, quando diventa uomo, sa cosa vuol dire la povertà e, quando ha i soldi, sa bene come spenderli. Non come i miei figli e nipoti, che vogliono mettere questo o quell’altro paio di scarpe, che vogliono seguire la moda, che non fumano neanche le sigarette nazionali, ma vogliono quelle estere, che costano il triplo. In più non vogliono lavorare, si svegliano a mezzogiorno e vogliono sempre soldi. Pensa che il loro padre fa brutta figura con gli amici, quando si impegna a trovare un lavoro per i ragazzi e loro, alla fine, rispondono di no, che preferirebbero essere morti, oppure restarsene disoccupati, che fare quel tipo di lavoro. A scuola sono andati male tutti quanti, così adesso non possono neanche lavorare come impiegati di banca, o nelle assicurazioni. Sono meglio le femmine, che studiano con più impegno, accettano volentieri di lavorare e, quando sono di riposo, aiutano pure nelle pulizie di casa. Mia figlia, quando le dico che una cosa non va fatta, lei non la fa. Invece, i maschi, quello che gli dici gli entra da un orecchio e gli esce dall’altro, sai, è difficile educare i figli di questa generazione: hanno la testa dura e dicono che noi abbiamo una mentalità troppo vecchia. Pensa, che con i soldi di uno stipendio sono capaci di andarsi a comperare un paio di jeans tagliati sul ginocchio e pure dietro; dicono che questa moda viene dall’occidente. Maledetti questi occidentali, hanno rovinato i nostri figli. La stessa cosa per i capelli, ogni mese un taglio diverso, un vera tortura, ma loro dicono che va bene così. Meno male che non portano gli orecchini: giuro che, se ci provano, gli taglio l’orecchio! Ci manca solo che diventino come le femmine, così non troverei nemmeno più i miei, di orecchini. Sai, cara, non ci sono più i maschi di una volta: non c’è più religione!". Nicola Sansonna - Quando gli extracomunitari eravamo noi... Maggio 1998 Era l’estate del 1960, io ero piccolissimo, l’unico brandello di ricordo che ho del mio viaggio verso Torino, proveniente dalla Puglia, è che ero stanco e volevo dormire, in treno non c’erano posti, quindi mi addormentai su una delle "valigie" di cartone che mio padre portava con se. lo e mio padre eravamo "l’avanguardia" della nostra famiglia e seguivamo il fratello di mio padre, zio Domenico, già da alcuni anni residente in Piemonte con l’ambito posto di "operaio FIAT". Mio padre aveva lasciato la nostra terra natia perché allora come ora il lavoro era scarsissimo e mal pagato. Aveva fatto il bracciante e prima di partire per il Piemonte lavorava nella "pietraia" (così l’ha sempre chiamata) come cavato re di pietre, mi diceva che era un lavoro massacrante. In Piemonte io fui affidato alla moglie di mio zio (non conservo un ottimo ricordo di quel periodo) e mio padre trovò lavoro in una ditta, la Viberti, che faceva tubi di cemento per condotti. Riuscì risparmiando a trovare casa e mobilio, una vecchia casa cantoniera immersa nel verde, ma con dei topi grossi come i gatti e senza energia elettrica. . Mia madre ci raggiunse nel 1961 dopo che nacque mio fratello Ruggero, così la famiglia si riunì: mio padre, mia madre, mia sorella Teresa ed il piccolo Ruggero. Finché restammo in campagna non ci furono problemi di sorta, giocare nei pioppeti, raccogliere frutti di bosco erano le mie attività preferite. Mio padre e mia madre, applicando un antico detto contadino "Tanti figli tanta ricchezza" mi diedero la gioia di vivere in una famiglia numerosa. Nel 1968 avevo 6 tra fratelli e sorelle, io, Teresa, Ruggero (i pugliesi) e Celestino Gianni Mimmo Lucia (i piemontesi), tutti più giovani di me, in casa nostra la tristezza e la noia non erano ammesse. I primi problemi di integrazione li ebbi quando iniziai le scuole, infatti parlavo pochissimo e male l’italiano. Il primo anno di scuola fu per me molto duro... e fui regolarmente bocciato. Mia madre fu chiamata in direzione e pregata di cercare di parlare l’italiano in casa. Ci provammo, ma dopo pochi minuti si tornava all’armonico e melodioso pugliese! Andammo ad abitare in un paese vicino a Torino, nelle case diroccate nel centro storico. Lo facemmo perché mio padre cambiò lavoro, anche lui come mio zio lavorava ora per una fabbrica che produceva balestre per auto e camion FIAT. Lavorava vicino agli alti forni dove venivano forgiate le balestre, e andò in pensione con grossi problemi ai polmoni. Noi meridionali ci chiamavano "Napoli" La prima volta che sentii la parola "terrone" ci ridevo sopra, ma poi con l’andare del tempo litigavo con chiunque usava con me o i miei fratelli quel termine, ed erano parecchi... spesso sono tornato a casa con qualcosa di pesto... ma le ho anche date! A Cambiano noi meridionali ci chiamavano "Napoli": come mi faceva incazzare questo! Non perché io disprezzi Napoli, anzi, ma io sono pugliese!! Il primo vero impatto con l’intolleranza lo ebbi proprio lì a Cambiano, quando la madre di un mio compagno di scuola portò via il figlio dal giardino pubblico dandogli due schiaffi e dicendogli che non doveva giocare con noi meridionali. Ma tutto sommato la stragrande maggioranza dei piemontesi che ho conosciuto sono gente tollerante e raramente ho dovuto sentirmi "straniero" in Italia… Un cartello, quello sì lo ricordo bene, c’era scritto "Affittasi appartamento 4 camere servizio e cantina, no a meridionali e famiglie numerose". Era una bella zona, anche vicina alla scuola, peccato che non affittavano ai meridionali, ma ormai noi parlavamo bene l’italiano… però eravamo in 9. Ora immagino che, se c’è ancora quel cartello, ci sarà scritto: "Affittasi 4 camere servizio e cantina no a extracomunitari". Le famiglie numerose non le citano più… chissà! Sarà proprio per trovar casa che si è smesso di fare figli? Al nord ci sto bene ma il sud mi è rimasto nel cuore, credo che se potrò tornerò in Puglia. Chissà se i meridionali che vivono oggi a Torino, al quartiere San Salvario, hanno mai visto un cartello "affittasi" di quel tipo. Non perdiamo la memoria, allora gli extracomunitari eravamo noi! Arjan Goga Albania: quando il sogno diventa un incubo Ottobre 1998 Era la primavera del ‘91 quando immagini drammatiche dell’Albania giunsero attraverso la TV in tutto il mondo: si sparava nelle piazze principali delle città, ormai senza più regole ne ordine pubblico, si sparavano tra di loro, i miei paesani, e nessuno capiva più cosa stesse succedendo. Una voce sola ricorreva nelle strade: fuggiamo, presto, via via! Le migliori occasioni le fornivano le navi che provenivano da Durazzo, già cariche di clandestini con un sogno chiamato Italia o Grecia, dove regnava la pace, in attesa che le acque si calmassero, ma così non è stato. Non potrò dimenticare gli occhi delle donne, con i loro bimbi in braccio, e la luce negli sguardi di noi ragazzi, già uomini, che per soffrire meno seguivamo ogni onda, consapevoli che la nostra terra si perdeva dietro di noi, ma anche eccitati dalla prospettiva di qualcosa che sapeva già di nuovo, di bello, decantato da tutti, dimenticando le rivolte e le vendette, stanchi del governo comunista che fucilava militari disobbedienti agli ordini, e ne costringeva molti alla diserzione. Ero uno di quelli con un sogno chiamato Italia Bellissimo Paese: questo mi sono detto quando ho cominciato a girare, a sognare ad occhi aperti; mi sono stabilito definitivamente a Bolzano, dove ho trovato lavoro e mi sono sistemato. Le cose andavano meglio, ero contento e stavo bene con tutti, ma era destino che qualcosa non funzionasse. Dopo sei mesi la ditta in cui lavoravo ha chiuso per fallimento ed è diventato subito un calvario, un susseguirsi di azioni legate a stranezze ed incredibili sfortune, anche perché la fortuna mi aveva abbandonato del tutto. Non riuscivo più a trovare lavoro e sembrava che anche l’aspettativa di fare l’autista (purtroppo per lavorare falsificai la patente) non desse pace alla mia anima. Mi sequestrarono la patente. Molto probabilmente questo periodo segnò la mia vita: cominciai con le conoscenze sbagliate ed i primi furti di macchine, poi vennero i primi guai con la giustizia per la falsificazione della patente. Oramai la cosa non mi interessava più di tanto, visto che guadagnavo bene e rischiavo poco ed ero preso in considerazione. Ho cominciato con le rapine quasi per gioco, poi è diventato un "lavoro", con le mie tasche che si gonfiavano di giorno in giorno. Frequentai assiduamente night-club e casinò, cominciai con vizi delle donne e del gioco, era questa la vita che facevo e mi piaceva. Il mio paese era lacerato ancora da guerre intestine Quando nell’agosto del ‘94 i Carabinieri mi arrestano perché ricercato da sei mesi da un ordine di cattura per una rapina, che non era mia, mi cadde addosso il mondo. Perché, mi chiesi? Ero tranquillo, sapevo che quella rapina non l’avevo fatta io, eppure ero in carcere e ci rimasi venti mesi; mi domandavo chi fosse stato, come fosse potuto accadere e soprattutto perché, non vedevo l’ora di uscire. All’uscita dal carcere, nell’aprile del ‘96, volevo solo una cosa: "tornare a casa mia". Deluso dalla vita e da me stesso, promettendomi: "mai più cose del genere, basta con tutti e con tutto, pazienza, è andata male". Ma il colpo più duro, quello definitivo, mi venne dalla Tv e dai giornali: il mio paese era lacerato ancora da guerre intestine, da "crack" finanziari, abusi di potere di ogni tipo e truffe ai danni della povera gente. Cosa potevo fare? Molti altri miei connazionali si erano sistemati bene, avevano avuto più fortuna di me; ora cosa faccio, mi chiesi, deluso e amareggiato più che mai. E’ stato l’inizio della mia discesa che tuttora mi logora l’animo ed il cuore, sofferta e dolorosa, conseguenza dei miei errori e delle mie sfortune. Ma mi è stata data veramente la possibilità di fare bene, di realizzarmi in un altro Paese, visto che il mio quasi non esisteva più? Non ne sono sicuro, anche se questa non vuoi essere una scusante per me. Penso però che questa società, dal volto a volte doppio ed ingannevole, sia spesso la causa delle orribili vicende che troviamo quotidianamente sui giornali in prima pagina: la gente si sente tradita nei propri ideali, perde fiducia in se stessa e molti fuggono dalla loro terra lasciando tutto e trovando alle volte la dura realtà carceraria. Quello che in ogni caso non dimentico sono quegli sguardi, di quella nave e di altre, sguardi che vorrei penetrassero nel muro di ostilità di chi crede che in quelle navi siano raggruppate vite tutte uguali, di sfruttatori o rapinatori, che sono in realtà una assoluta minoranza. Forse per molti non rappresenterò mai nulla, ma dentro di me resterò sempre "uno di loro". Artur Sognavamo un paio di jeans Storia di uno scafista albanese Quello che segue è il racconto di un detenuto albanese che nella sua vita ha fatto anche lo scafista, è un’esperienza che in qualche modo lo ha segnato e di cui conserva anche dei ricordi dolorosi. Ognuno di noi, quando si racconta, cerca di trascurare le proprie miserie e di dare il meglio di se, e forse anche il nostro interlocutore lo ha fatto. Noi sappiamo che gli scafisti guadagnano molto, che alcuni fanno parte di organizzazioni criminali, ma sappiamo anche che ci sono ragazzi che fanno questo mestiere, spinti dalla voglia di guadagnare un po’ di soldi, in un paese in cui non ci sono grandi possibilità di scelta. La realtà è dunque più complicata di come, spesso, la descrivono quei giornali che amano le tinte forti e parlano solo di scafisti che buttano a mare donne e bambini. Agosto 1999 Sono nato in Albania in una città vicino al mare, Valona. La mia è una famiglia di operai molto numerosa, mio padre lavorava nelle cave di calce. Avere la possibilità di studiare sotto il regime comunista di Enver Hoxha non era molto facile. Gli studi erano riservati ai figli degli intellettuali o agli uomini del regime, oppure bisognava essere molto bravi per ottenere una borsa di studio, ed io lo ero. La mia casa è proprio vicino al mare, quando ero bambino i nostri giochi si svolgevano tutti lì, sulla spiaggia, ed il mare era la nostra unica fonte di divertimento. Modificando dei vecchi televisori riuscivamo a recepire il segnale italiano, anche se sotto il regime di Enver Hoxha la ricezione delle trasmissioni italiane era severamente vietata. Quelle immagini mi portavano la realtà di un mondo, di un paese che mi sembrava incredibile, quel tipo di vita la desideravo, ed anche quelli che per lavoro, come i camionisti, avevano la possibilità di uscire dall’Albania ci raccontavano di un paese delle favole. Noi sognavamo veramente un paio di jeans. Dopo la morte di Enver Hoxha, mentre frequentavo il primo anno di ingegneria meccanica, un giorno del febbraio ‘91 iniziava la rivolta di Valona che poi si estese in molti paesi dell’Albania: erano in molti a tentare di assaltare i porti per espatriare, ma i tentativi fallivano perchè i militari sparavano addosso. Le navi ed i pescherecci furono allontanati dai porti ed ancorati allargo, nella rada. In una notte del marzo ‘91 io e un mio amico del mio stesso quartiere, che lavorava su un peschereccio, ci provammo. Quella notte ci ritrovammo a casa mia una decina di ragazzi, attendevamo il segnale che doveva arrivarci dal peschereccio ancorato al largo. Doveva farlo il nostro amico, a quel punto lo avremmo raggiunto a nuoto. Ricordo le lacrime di mia madre, che si metteva letteralmente davanti alla porta per impedirci di partire: per quella notte sia per il casino che fece che per la sua determinazione riuscì a fermarci. Due miei fratelli maggiori arrivarono in Italia con il grande esodo del ‘91, io soltanto sei mesi dopo, riuscendo finalmente a salire su un peschereccio, dopo aver pagato cento dollari. Approdammo nel porto di Brindisi, conoscevo un po’ di italiano e riuscii a riunirmi con i miei fratelli. Sono rimasto in Italia sino ai primi mesi del ‘94, facevo il muratore ma avevo molta nostalgia di casa mia, mia madre, i miei fratelli, il mare. Alla fine, un giorno mi imbarcai a Trieste sul traghetto con destinazione Durazzo. Arrivato a Valona rimasi stupito del grande cambiamento che era avvenuto in quel breve lasso di tempo: negozi, grosse auto, gente vestita in maniera molto appariscente. Domandai agli amici come era stato possibile tutto questo, la risposta fu: il mare! Il mare che da bambini guardavamo con gioia e rispetto ora poteva cambiare la mia vita! Parlai con un mio amico che aveva alcune conoscenze ed iniziai ad inserirmi nel giro degli scafisti, il mio primo incarico fu di fare l’accompagnatore. Visto che parlavo l’italiano, salivo sul gommone con la gente che chiedeva di fare la traversata alla ricerca di fortuna e di condizioni migliori di vita, facevo il viaggio con loro sin qui in Italia, scendevo e li accompagnavo fino ad una stazione ferroviaria, provvedevo ai biglietti e tornavo in Albania con il primo traghetto. Durante questi viaggi imparai a portare il gommone: non è una cosa facile. Dopo poco, me ne affidarono uno. La paga era più del doppio di quella da accompagnatore. Con i soldi guadagnati in un anno mi comperai anch’io un gommone e mi misi per conto mio. Quello che mi stupiva, anche se pure io avevo fatto la stessa esperienza, era la determinazione che quelle persone avevano a voler partire ad ogni costo, spesso erano loro che tentavano di spingerci a partire anche se le condizioni meteorologiche erano pessime. La decisione era comunque mia, se le previsioni del tempo non erano buone non si partiva; mi consigliavo anche con anziani pescatori e non sbagliavano mai! Quando sento le storie di scafisti che gettano la gente in mare, resto male, perché so che noi non l’abbiamo mai fatto. Capita che qualcuno possa cadere in mare per qualche manovra improvvisa, ma non c’è volontarietà, gli scafisti sono responsabili della gente che trasportano, se si comportassero come tante volte si legge sui giornali, in Albania sarebbero puniti dagli altri scafisti, anche perché la loro attività ne verrebbe danneggiata. La prima volta che mi affidarono un gommone, sentivo molto la responsabilità che era caduta sulle mie spalle. Nelle mie mani c’era la vita di trenta persone, le loro vite e la mia dipendevano dalle decisioni che prendevo io. Un errore nell’affrontare un’onda avrebbe significato la fine. Purtroppo nel febbraio del ‘96 accadde proprio questo… Partimmo da Valona, il mare era calmo e le previsioni buone. Eravamo in trentatre sul gommone. Uscimmo dalla baia di Valona e il mare cambiò improvvisamente, ci ritrovammo tra onde alte ed un forte vento di tramontana veramente cattivo: pensavamo che superato quel tratto critico il mare sarebbe tornato navigabile, ma purtroppo non fu così Dopo alcune miglia decidemmo di tornare indietro, le onde superavano i quattro metri ed il vento era molto teso, proseguire era una pazzia. Cercai di impostare la virata ma nella manovra un’onda ci sommerse completamente, grazie aDio nessuno cadde in mare, con quelle condizioni atmosferiche avrebbe significato la morte sicuramente. A quel punto detti massima potenza ai motori, di modo che la prua del gommone si alzò facendo defluire da dietro l’acqua imbarcata. Puntai la prua verso la costa riuscendo a percorrere oltre venti miglia in quelle condizioni Finalmente si iniziarono ad intravedere le luci della costa, accolte da un urlo di sollievo da parte di tutti noi eravamo in salvo o almeno lo credevamo. Ma il mare non ci dava tregua. Un’onda più grossa delle altre si abbatte sui motori bloccandoli. era successo ciò che di peggio poteva capitarci in quelle condizioni, l’onda aveva rotto i serbatoi della benzina. La prima cosa che pensai è che stavamo tutti per morire. Mantenni la calma cercando di infonderla anche agli altri, dicendogli che il gommone era quasi inaffondabile, e infatti restò coperto d’acqua, ma galleggiava. Lanciai subito i razzi luminosi per chiedere soccorso, dopo di che attivai la radio, ma purtroppo non riuscii a contattare né la capitaneria del porto di Valona né quella di Otranto. Finalmente vedemmo una nave e iniziammo a sbracciarci ed a fare segnali per farci notare, veniva verso di noi… forse non ci vide… ma ci passò così vicino che rischiò di affondarci. Non so dire quale fosse la sua nazionalità. Le ore scorrevano ed eravamo in balia del mare, cercavamo di dirigere il gommone a remi aiutandoci con le mani ma la corrente era troppo forte. Arrivò l’alba, ci eravamo nuovamente allontanati dalla costa, continuavo a mantenere la calma e cercavo di infonderla agli altri nella speranza che qualche imbarcazione ci vedesse e potesse soccorrerci, ma trascorremmo anche quel giorno e la notte successiva in quelle condizioni disperate. Il giorno seguente verso le dieci del mattino vedemmo in lontananza il traghetto di linea Otranto-Valona, ma a causa delle condizioni del mare non fummo avvistati, anche perché eravamo semisommersi. Nel primo pomeriggio udimmo il rumore dei motori di un aereo e iniziammo ad agitare indumenti per attirare la loro attenzione. Fortunatamente l’aereo volava a bassa quota e ci vide, ci sorvolò alcune volte, dopo di che lanciò quattro segnali fumogeni per segnalare la nostra presenza. Ci avevano trovati, eravamo salvi. Dopo mezz’ora ci raccolse il traghetto di linea che in precedenza non ci aveva visto. Il gommone fu abbandonato sul posto e dopo quella avventura decisi di chiudere con il mare, smisi di fare lo scafista. La speranza è che in futuro non ci sia più necessità di rischiare la vita per attraversate clandestine, e io spero che con l’aiuto dell’Italia e di tutta l’Unione Europea, unita alla nostra determinazione di popolo, riusciremo ad avere prospettive di vita dignitosa anche in casa nostra. Hamid - Un clandestino in cantina Novembre 2000 "Alle nove di mattina, il giorno del mio fine pena, viene a prendermi in carcere la polizia che mi trattiene in Questura fino alle sette di sera. Penso che finirò in un campo di trattenimento prima di essere rispedito in Marocco. Invece un ispettore gentile, dopo molte telefonate, mi dà un foglio dove c’è scritto che ho 15 giorni per andarmene dall’Italia, da solo. Mi dice anche che il permesso di soggiorno è scaduto mentre ero in carcere e che non risulta che abbia chiesto la sanatoria. Ma anche se il permesso fosse stato ancora valido, avrei dovuto lo stesso andare via dall’Italia, perché ho l’espulsione in sentenza e non risulta che ne abbia chiesto la revoca. Non ci capisco niente: avevo chiesto di rinnovare il permesso e di poter fare la sanatoria! E poi, se sapevano che avevo l’espulsione e che dovevo per forza andare via, perché l’assistente sociale e l’educatrice mi hanno anche cercato lavoro (vabbè che non l’hanno trovato) senza dirmi che prima dovevo chiedere la revoca dell’espulsione? Che casino, che confusione…! Capisco solo che per 15 giorni sono autorizzato a rimanere in Italia. Quindici giorni per trovare un lavoro, un alloggio, un permesso di soggiorno, una cosa da niente per un ex detenuto, ex tossicodipendente, extracomunitario. Mi sono venuti in mente certi film di 007…". Hamid si ritrova sulle scale della Questura con indosso un paio di jeans, una maglietta ed un giubbotto (tutti gli indumenti li ha lasciati ai compagni perché tra loro si usa così); nel portafogli novecentomila lire, messe da parte lavorando in carcere, qualche tessera telefonica, comprata durante l’ultimo permesso premio, ed un biglietto pieno di numeri di telefono. Ma i cellulari sono spenti, disattivi o rispondono altre voci. Se lo aspettava perché sa che i telefonini devono essere cambiati spesso… Attorno alla stazione e ai giardini, non riconosce nessuno. "Chissà perché mi aspettavo di ritrovare tutti al loro posto, come li avevo lasciati il giorno del mio arresto, tre anni e mezzo fa e invece vedo solo facce nuove. I miei amici avevano come me attorno ai 30 anni, un’età drammatica, in cui si dovrebbero avere abbastanza soldi per tornare a casa e mettere su famiglia. Qualcuno c’è riuscito, molti hanno solo cambiato zona, molti sono in carcere, qualcuno è finito peggio, morto, tossico o malato". A settembre alle otto è ormai buio e Hamid deve pensare a come trascorrere la notte. Può scegliere tra la sala d’aspetto della stazione o uno dei vagoni ferroviari in sosta su binari periferici. "Quando si arriva in Italia o ci si trasferisce in una nuova città, si sa di dover passare almeno qualche notte in stazione ed io mi sento come uno appena arrivato. Nel vagone a quest’ora non c’è quasi nessuno: solo un paio di barboni, un tossico ed una ragazzina che attacca bottone. Si chiama Martina, ha diciotto anni e la sua famiglia ha un palazzo a Treviso, ma a lei piace vivere così… A forza di frequentare stazioni, dormitori e cucine popolari, ha imparato quasi a parlare l’arabo. E’ carina e pulita, dice che non è tossica e neppure matta, ma anche se sono appena uscito di galera, non mi fido. E poi mi addormento quasi subito". Solo ora Hamid si rende conto che il vagone è pieno zeppo di gente Martina lo sveglia che è ancora quasi notte. Gli dice che è meglio scendere adesso, se non vuole essere preso a pedate dalla polizia che arriverà tra poco. Solo ora Hamid si rende conto che il vagone è pieno zeppo di gente. Scavalcano corpi sdraiati sul corridoio, ciondolanti dai predellini, acciambellati, raggomitolati… Martina gli dice che qualcuno ben nascosto che non viene trovato dalla polizia finisce che si svegli a Salerno, perché dopo un po’ la locomotiva viene attaccata e il treno parte. "Sempre meglio però il treno delle case abbandonate, soprattutto se sei da solo" consiglia Martina. "Se ti trovano, certi poliziotti non ci vanno leggeri e proprio ieri ho saputo che un tuo paesano l’hanno quasi ammazzato di botte". "La mattina, mi viene in mente, come se fosse la cosa più urgente, di andare a ritirare la mia pagella nella scuola che tiene corsi in carcere. Una bella pagella, davvero. Il preside e i professori mi fanno i complimenti, mi incoraggiano, dicono che sono bravo e devo continuare a studiare in una scuola serale. Se penso alla notte prima, mi sembra di essere in un altro mondo. Una delle professoresse mi dice che ha un amico che mi prenderebbe a lavorare come muratore, solo che devo essere in regola. Le dico che con i miei documenti non ci capisco niente, allora lei mi consiglia di andare ad un Convegno sugli immigrati dove ci saranno degli avvocati che potrebbero aiutarmi. Mi sento meglio a questa idea e rimango ancora nella scuola, ma poi devo per forza andare via, perché chiude." Quando Hamid va al convegno, è la terza notte che dorme sul treno: ha la barba lunga, la stessa maglietta di quando è uscito e sente un forte prurito agli avambracci. Deve essere per questo che assistenti sociali, assistenti volontarie, educatrici, dopo averlo salutato con calore prendono le distanze. Una delle operatrici gli va incontro sparandogli una festosa raffica di domande. "Dove dormi? Hai trovato lavoro? Hai rinnovato il permesso di soggiorno? Guardami negli occhi: non hai bevuto, non ti sei fatto, non hai ricominciato a spacciare?". "Dormo alla stazione, non ho un lavoro e il permesso di soggiorno me lo dovevate rinnovare in carcere". "Alla stazione?" cambia discorso quella, "ecco perché ti hanno mangiato le zanzare!". Hamid ha il sospetto che si tratti di pulci, ma non lo dice. L’operatrice si scandalizza. Non può essere che non si trovi un posto dove dormire. E, visto che nell’auditorium ci sono assistenti sociali e volontari, comincia a chiedere: l’ostello di qua, la casa d’accoglienza di là, l’asilo notturno… ma gli ostelli si pagano, le case di accoglienza spesso non fanno accoglienza, e per il dormitorio bisogna avere documenti, permesso di soggiorno e anche prenotare. Comunque tutti sono commossi, anche se nessuno ha un posto libero." Vedendo il suo interessamento, Hamid dice: "Che fortuna averla incontrata, sono sicuro che, anche se in carcere non mi ha rinnovato il permesso di soggiorno, mi aiuterà". Non è uno sfacciato, ma la disperazione fa virtù. L’operatrice stavolta si arrabbia: "Adesso sta a vedere che è colpa mia se ti trovi in queste condizioni! Noi abbiamo inviato la richiesta di sanatoria, ma dalla Questura ci hanno mandato a dire che i documenti che avevi non bastavano! Che ne so, io?! E poi potevi pensarci due volte prima di venire in Italia a spacciare!" "Di colpo, apre la cerniera della borsa e per un attimo penso che ne tiri fuori una pistola per spararmi. Invece è un telefonino. Chiama preti, frati, suore e altra gente che non capisco chi sia. Ad un certo punto la sento dire: Grazie! E mi spiega che mi ha trovato posto da un amico, posso stare da lui finché non tornano i genitori dalle vacanze, in cambio di un piccolo aiuto in casa". Hamid si aspetta uno studente, invece Glauco è un quarantenne che vive in una bella villetta immersa nel verde. Solo che i genitori sembrano assenti da anni, invece che da un mese e il "piccolo aiuto" consiste nel fare opera di bonifica di giardino, bagno, cucina, dove bivaccano amici. "Sono tutti molto simpatici e mi accolgono come se ci conoscessimo da un sacco di tempo. Qualcuno di loro è stato in Marocco e conosce Casablanca meglio di me. Sanno che sono stato in carcere, mi danno pacche sulle spalle, come se fossi un reduce di guerra. Mi chiedono se ho bisogno di abiti e mi offrono qualche giro di spinello. Perciò, anche se devo pulire i vetri delle finestre, le vasche e i water, mi sento una specie di attrazione. Finché tra gli amici di Glauco non vedo una faccia che conosco: un mio ex cliente. Un architetto pieno di soldi e di donne. Qualche volta uscivamo insieme, avevamo addirittura trascorso un Capodanno a Cortina, lui portava le donne, io la coca, e in genere pagavo anche il conto, perché guadagnavo più di lui, minimo quattro milioni al giorno. Insomma eravamo quasi amici. Adesso mi vede accucciato a terra mentre cerco di scrostare una macchia di caffè che sembra gomma fusa e non mi riconosce… Meno male. Dopo due giorni Glauco annuncia che i genitori sono ormai al casello dell’autostrada e riconsegna Hamid con una borsa di indumenti usati all’operatrice. Questa gli annuncia che ha fissato un appuntamento con l’avvocato per il permesso di soggiorno e che ha un lavoro per lui. "Sto traslocando e tu potresti aiutarmi", gli dice luminosa, come se gli avesse trovato un impiego in banca… "E dove dormo?" chiede Hamid. Quella tira di nuovo fuori il telefonino, ma stavolta il primo tentativo va in porto, anche se con qualche ritocco nella forma, rispetto alla volta precedente. "Al frate che risponde dice sì che sono un ex detenuto, ma che tra qualche giorno avrà il permesso di soggiorno per motivi di studio come premio perché in carcere si è diplomato con il massimo e non appena le scuole apriranno, sarà ospitato da una anziana e ricca signora". Hamid pensa che non crederanno a una balla del genere e invece quei frati lo fanno dormire per una settimana con tutti i riguardi in un grande convento con vista sul fiume. "Nel frattempo sono tornato clandestino vero e proprio" "Intanto comincio ad aiutare l’operatrice nel trasloco che in realtà non è uno, ma tre, perché dobbiamo andare a prendere alcuni mobili dalla casa di un’assistente volontaria che sta lasciando la città e portarli a casa dell’operatrice e portare alcuni mobili dell’operatrice nella casa di Don Giulio, un sacerdote che sta traslocando pure lui. E poiché anche l’assistente volontaria e don Giulio hanno bisogno di aiuto, nell’imballaggio e nelle pulizie, guadagno un po’ di soldi. Pochi, ma quanto basta perché riesca a non toccare quelli che ho messo da parte in carcere. Inoltre quando lascio i frati Don Giulio mi dice che posso rimanere per qualche giorno a dormire da lui, così lo aiuto a portare i suoi vecchi mobili nella casa di alcuni profughi kossovari. Penso di essere stato fortunato ad uscire in un periodo in cui tutti traslocano. Quando anche il parroco ha smesso di traslocare, rimango praticamente disoccupato. Torno a dormire nel vagone del treno, nella sala d’aspetto della stazione, in una casa abbandonata. E’ il momento più brutto, perché nel frattempo sono tornato clandestino vero e proprio, il che significa che devo cercare di essere invisibile. E’ sufficiente che mi fermino e mi chiedano i documenti per essere espulso. Quindi devo evitare i paesani, le cucine, la stazione, proprio i posti dove si finisce sempre per ripararsi, perché comincia a fare freddo, perché si deve pure mangiare ed anche parlare con qualcuno! Trovare da spacciare sarebbe facilissimo, anche se la piazza in quattro anni è cambiata e molti paesani si sbarazzano dei concorrenti - magari quelli appena usciti dal carcere che pensano di ritrovare le zone di prima - denunciandoli alla polizia. Però se ci sai fare e ti fai stimare, basta un telefonino e qualche conoscenza. Io però in carcere non ci tornerò mai più. Lo so che tutti dicono così, però io vedo dei ragazzini che entrano ed escono come se niente fosse, mentre a me il carcere mi ha distrutto. Con l’operatrice ho appuntamento dall’avvocato. Dopo aver guardato le carte dice che si può provare a chiedere un riesame della pratica, anche se devo procurarmi un’offerta di ospitalità ed una di lavoro. Conferma anche che tanti casi si potevano evitare se in carcere avessero almeno provato a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. L’operatrice si arrabbia un po’ con l’avvocato dicendo che non è colpa sua, ma poi telefona ad altri frati Missionari che fanno accoglienza. Stavolta dice che ormai ho tutto pronto, permesso di soggiorno e lavoro, ho solo bisogno di un posto dove stare quindici giorni prima di iniziare a guadagnare. Assicura che allo scadere del tempo stabilito verrà lei in persona a prendermi. Padre Mariano insiste molto che io vada via a metà mese, penso perché dopo sarà inverno e non avrà il coraggio di sbattermi fuori. Io, comunque, riesco a rimanerci tre mesi". Nei tre mesi che rimane dai frati, Hamid lavora come muratore in nero, mentre continua a cercare offerte di lavoro che non trova. Compra una bicicletta e va a mangiare alle cucine ancora con gli abiti di lavoro. "Il cibo è piuttosto cattivo, ma non si può guardare tanto per il sottile e poi alle cucine ci sono dei medici volontari che ci danno medicine se ne abbiamo bisogno e ci fanno il vaccino contro l’influenza. Tutti pensano che le cucine siano piene di spacciatori, ma non è così perché quelli hanno i soldi per andare al ristorante oppure in uno degli appartamenti dove alcuni paesani cucinano il nostro cibo. Io invece, quando ho qualche soldo in più, compro un piatto di cous cous da Amor, un tunisino vecchio che gira a venderlo con l’automobile. Qualche giovedì sera vado alla stazione perché la Croce Rossa distribuisce cibo gratis a tutti, anche con il dolce. Non ho più tanta paura dei poliziotti, perché alla stazione sono sempre gli stessi e ormai mi vedono passare con gli abiti da muratore. Quando arriva il Ramadan mi compro un fornelletto a gas e cucino quand’è ancora notte. Penso che i frati sentiranno l’odore, ma da tempo non mi dicono più niente, al punto che spero che si siano dimenticati di me. Dopotutto l’Istituto è grandissimo, loro non mi vedono mai e padre Mariano è sempre via. Il venerdì vado alla Moschea, qualche sabato esco dalla finestra (perché l’Istituto chiude alle undici) e vado al Centro Sociale a sentire un po’ di musica, la domenica rimango chiuso nella mia stanza. Poi arriva Natale e il lavoro finisce. Ma non sono disperato perché la mia ex insegnante mi ha trovato una ditta disposta a farmi la dichiarazione di lavoro e, se don Mariano mi darà l’ospitalità, ho tutto pronto per chiedere il permesso di soggiorno. Ma le cose non vanno proprio così". Quando torna, Mariano con la faccia tirata gli dice che deve andarsene. Hamid allora gli chiede, come gli ha suggerito l’Operatrice, se può restare pagando l’affitto della stanza, visto che un po’ di soldi adesso ce l’ha. Ma il frate scuote la testa e aggiunge che neanche vuol più sentir parlare di quell’Operatrice che lo ha imbrogliato… "Io non capisco perché, se ci sono tante stanze libere, mi comporto bene e posso anche pagare, mi mandano via. Eppure lo sanno che senza documenti non posso trovare neanche un posto letto. Non capisco e neanche ho il tempo di capire perché, a fine gennaio, mi ritrovo un’altra volta per strada, anche senza lavoro perché il padrone si è ricordato che sono clandestino e dice che ha paura dei controlli. Sul vagone fa troppo freddo e, visto che la gente è sempre di più, la polizia la sfolla a calci. Così, dormo nella sala d’aspetto e poi a casa di una tossica che ho conosciuto alla stazione. Abita in una casa più fredda del vagone, ma è disponibile a farmi restare ed anche a farmi la dichiarazione di ospitalità, se le procuro un po’ di coca. Ma ho paura che se anche tocco una sola volta la roba mi porta sfortuna. Perciò prendo la bici e me ne vado. Ho fatto bene perché quando vado alle cucine trovo una sorpresa." La suora delle cucine gli dice che lo ha cercato la Franca, la cuoca dei frati: deve andare subito perché ha un lavoro per lui. "La Franca mi porta dalla Cecilia, una sua vicina di casa che deve sgombrare e far ripulire la cantina. E’ una vecchietta sveglia che parla sempre. Mi prende subito in simpatia e mi racconta dei suoi problemi con la nuora ed il figlio che abitano nel palazzo di fronte e che non la vanno mai a trovare… Lavoro volentieri nella cantina: la imbianco, sistemo gli interruttori della luce, monto un lavandino sotto il rubinetto dell’acqua, appendo due teli alle finestre (che ci sono, anche se hanno le sbarre) e gonfio un materassino da mare. Poi chiedo alla signora se me ne affitta una parte. Lei dice che suo figlio le ha già detto che non vuole un marocchino per casa, ma che in fondo non gliene importa niente perché lui si ricorda di lei quando gli pare. Solo che ha paura perché sono clandestino… Allora telefono all’operatrice che si presenta come una specie di poliziotta e assicura alla signora che, se rilascia una dichiarazione di ospitalità alla Questura, non corre nessun rischio, anche se sono ancora clandestino. Poi carica la vecchietta in automobile e la porta subito in Comune, tante volte dovesse ripensarci. Così, dopo essere uscito dal carcere, mi ritrovo sulle scale della Questura con in mano la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno come se fosse un trofeo. Non è sicuro che me lo daranno, ma intanto posso chiedere il libretto di lavoro. Non sono ancora un regolare, ma dopo sette mesi sono finalmente un clandestino autorizzato". Imed Mejeri - La festa della circoncisione in Tunisia Novembre 2000 Le feste, da noi in Tunisia, sono tante, ma due di queste sono festeggiate alla grande, il matrimonio e la circoncisione, che non essendo praticata in Europa è poco conosciuta, mentre per noi mussulmani è fondamentale. Ricordo bene la festa per la circoncisione nella quale i protagonisti eravamo io e mio fratello: avevo sei anni, mentre lui ne aveva quattro. Mio padre aveva tirato fuori tutti i suoi risparmi, ben sapendo che per tradizione alla fine della festa vengono fatti dei regali in denaro ai bambini neo-circoncisi ma, di fatto, i soldi li prende il papà, rientrando così in possesso delle grosse spese sostenute e guadagnandoci pure qualcosa. Per la festa, è necessario prenotare un complessino musicale che, girando per la città, pubblicizzerà la festa stessa, con grida dette "berrea", alternate da tremendi rulli di tamburo: tutti devono sentire per forza, così nessuno può affermare che non sapeva della festa. Inoltre, viene acquistata una mucca enorme, che resterà parcheggiata davanti a casa per cinque giorni, per fare capire a tutti che non si è badato a spese. Vengono anche noleggiati alcuni furgoncini che si occuperanno di andare a prelevare, a domicilio, parenti ed amici di famiglia che abitano lontano. Nel frattempo, mi ricordo che la nostra casa aveva subito un cambiamento radicale: tutti i mobili erano stati spostati per guadagnare spazio. Le donne della famiglia organizzavano la cucina e prendevano nota di ciò che mancava. Insomma, con tutto ciò che accadeva, la nostra casa per una settimana sembrò un campo di battaglia, in pratica un ristorante a ciclo continuo, che non chiudeva mai. Io e mio fratello, in quei giorni, eravamo coccolati da tutti e la cosa ci sembrava molto strana, però ci piaceva; mio fratello poi, essendo più piccolo di me, era diventato la mascotte della festa. Venivamo viziati, circondati dalle donne della famiglia e dalle loro amiche, e preparati per la festa. Questa preparazione consiste ancora oggi nel tingere i capelli di colore nero scuro e nell’imprimere dei disegni sulle mani e sui piedi, con la tintura dell’henné: sono colori prodotti in casa, utilizzando delle erbe. Questo viene fatto per tre giorni di fila, tutte le mattine. Il terzo giorno, ci fecero vestire come cavalieri, fatti salire su un cavallo tutto decorato di finimenti, e coperto da una grandissima bandiera tunisina. Mio fratello era davanti ed io dietro di lui, eravamo attorniati da ragazzini, dai parenti, dagli amici e da moltissimi curiosi. In testa al corteo, suonatori di pifferi e tamburi si sbizzarrivano coinvolgendo i passanti nella festa. In questo modo, abbiamo fatto il giro di tutto il quartiere, con le persone che si affollavano dietro di noi, attirate dalla musica, dal cavallo, tutto addobbato ed addestrato per camminare a passo di musica, dai nostri costumi e dalla mucca sempre parcheggiata di fronte a casa, che garantiva una grossa abbuffata. Il quarto giorno, è stata organizzata una piccola festa con un gruppo musicale di religiosi, una cena a base di pesci e tanti dolci fatti in casa nella maniera tradizionale, con bevande analcoliche e alla fine un bicchierino di tè verde con dei pezzi di mandorle e una foglia di menta, per mandare via gli spiriti maligni. Il quinto giorno, c’è stata una festa bellissima. Mio fratello, il più grande, aveva invitato dei suoi amici che suonavano musica folcloristica: erano cinque, uno suonava la cornamusa, da noi chiamata "musuid", due battevano su dei piccoli tamburi "darbouca", uno suonava su uno strumento simile al bongo "bindir", l’ultimo era il cantante. Nella sorpresa generale, sono state presentate le celebri ballerine Zina e Aziza: erano due sorelle, famose per la danza del ventre, eseguita in maniera molto seducente. È inutile sottolineare che gli applausi, per loro, sono stati molto prolungati. Avere queste due artiste in casa, a ballare per noi, era un grandissimo onore. Io, personalmente, le avevo viste soltanto in TV. Le due ballerine, prima di iniziare il loro numero, erano completamente coperte da un velo di seta multicolore, non si vedeva né il viso né il corpo, fatta eccezione soltanto per le caviglie, intorno alle quali erano legati dei monili d’argento. Ad un tratto iniziò un suono sempre più crescente dei tamburi, caddero i veli, e apparvero con il loro splendido corpo coperto da un reggiseno ricamato con delle piccole perle colorate e, intorno al collo, una collana d’oro, la gonna a strisce, lunga e trasparente, che lasciava vedere perfino le minuscole mutandine: siamo rimasti tutti senza fiato, con le bocche aperte e gli occhi spalancati. Erano bellissime. Chi ha avuto modo di conoscerle sa che le donne arabe hanno un fascino particolare, un misto di pudore e mistero. Una festa che coinvolge un intero paese, tutti i vicini… ma anche i "lontani" Nei festeggiamenti erano stati coinvolti tutti i partecipanti, perfino i bambini, la voce si era sparsa in tutto il quartiere, arrivavano i vicini… e i lontani… la casa ormai era sovraffollata, i miei zii mantenevano l’ordine, io non capivo più niente, di quello che stava succedendo in casa. La gente entrava, incuriosita, per vedere le ballerine. Fu una grandissima festa, che è rimasta sulla bocca di tutto il quartiere per molto tempo. Il penultimo giorno, era venerdì, fu una giornata faticosa per i miei genitori e zie. Come ben sapete, è una giornata sacra per tutti i mussulmani, tutta la famiglia era già sveglia dall’alba: per la mucca non c’era più scampo, l’avrebbero sgozzata e macellata, secondo il rito mussulmano. Ero triste per l’uccisione della mucca perché, vedendola per cinque giorni davanti a casa, ci avevo giocato insieme e c’ero oramai affezionato. Erano le sette del mattino, quando vidi mio padre e due miei zii, vestiti in maniera un po’ strana. Avevano indossato degli stivali invernali in piena estate, una canottiera bianca e una specie di pantaloni larghi, di colore blu. Uno dei miei zii aveva una corda in mano, mio padre portava due coltelli, uno enorme, uno piccolo, e una lima. Si avvicinarono piano piano a quella povera mucca e, con una grande rapidità, la misero giù in terra, legandole tre gambe, incrociate fra di loro in modo che non si poteva più muovere. Con un secchio d’acqua lavarono le zone intime e il muso della mucca, dopo una breve preghiera mio padre afferrò con la mano destra il coltello grande e con un colpo secco la sgozzò; uscì un fiume di sangue e mio padre chiamò sia me che mio fratello, ci intinse la mano destra nel sangue, per poi lasciare l’impronta sul muro di casa. Questo è uno dei tanti modi dettati dalle tradizioni per scacciare il malocchio. Dopo che finirono di dissanguare la mucca, essa fu issata con carrucole, per le zampe posteriori, a testa in giù. La tagliarono in mille modi, secondo i tipi dei piatti che si volevano realizzare. Due terzi della mucca la donammo, come prevedeva la nostra religione. La portammo in Moschea e lì fu donata ai poveri. Quel giorno era riservato esclusivamente a mangiare, cucinarono tutti i tipi di piatti tradizionali, e qualsiasi persona che entrava in casa doveva assaggiare ciò che era stato preparato, anche se non aveva fame, ma a non aver fame ce n’erano pochi, mangiavano tutti volentieri. L’ultimo giorno della festa, mi accorsi che qualcosa non quadrava, tutti mi guardavano con una faccia strana, mi coccolavano più del solito con un sorriso un po’ particolare… La mattina siamo andati a visitare il santo, che nel mio quartiere era il più amato (Sidy Mahres), anche questo fa parte della tradizione, rendere omaggio in un giorno di festa ad un uomo giusto. Fatto il giro del centro, nella mattinata avanzata abbiamo fatto ritorno a casa. Sia io che mio fratello siamo stati accolti come due Re. Davanti a casa, c’era una marea di persone, parenti, vicini e lontani; ho pensato subito che fossero tornate le ballerine, ma non le vedevo. Erano lì per noi! Lo sguardo strano, che avevo notato la mattina, da parte di un po’ tutti, continuava, e questo mi lasciava perplesso. Davanti a casa nostra c’era un gruppo musicale, l’impressione che avevo era che suonassero molto in fretta: gli era stata pagata un’ora di esecuzione (in Tunisia, puoi noleggiare e chiedere la musica anche solo per un’ora e, probabilmente, loro avevano un repertorio molto ampio e lo volevano eseguire per intero). Alla fine, ero inzuppato come un biscotto con la tintura di iodio e farcito al borotalco Appena siamo entrati in casa, mia madre e le mie zie ci fecero spogliare velocemente, totalmente nudi, ci infilarono un "jeba", una sorta di vestaglia che arriva sino alle caviglie, di colore bianco, un paio di ciabatte di pelle a punta, ci fecero salire sul letto matrimoniale, io in piedi, e mio fratello sdraiato dietro di me con la faccia voltata nell’altra direzione di modo che non potesse vedere cosa mi facevano. Ad un tratto entrò un uomo gigantesco, iniziò a fare battutine per farci sorridere, ma noi iniziavamo ad avere veramente paura, guardandolo meglio riconobbi quell’uomo gigantesco, era il barbiere del quartiere, odiato da tutti i bambini: ora iniziavo a capire il perché. Mi tirò su la vestaglia e con un sorriso fasullo e spaventoso, m’imbrogliò dicendomi: "Guarda su, la colomba!" ed io, come un fesso, alzai la testa. Sentii come un pizzicotto allo "zibi", con la vestaglia alzata non potevo vedere niente di cosa accadesse lì sotto, ma quando mi tamponò la ferita, vidi quello che credevo fosse sangue, in realtà ero inzuppato come un biscotto con la tintura di iodio e farcito al borotalco, in maniera esagerata. Mio fratello più piccolo, capito che eravamo in guai seri, tentò la fuga, ma fu subito afferrato, quindi iniziò a frignare, con uno dei pianti più sconvolgenti che ricordo. Io lo imitai immediatamente. Poi fu il turno di mio fratello che, pur senza cadere nella trappola della colomba che vola, fu colpito ugualmente. Finito di medicarci, ci rassettarono, facendoci stendere sul letto, uno ai piedi dell’altro. Ancora piangevamo, facendo la gara a chi urlava di più. Uscito l’odiatissimo barbiere, cominciarono ad entrare parenti ed amici, che lanciavano sul letto dei soldi, fortunatamente solo banconote: erano veramente tanti, io e mio fratello pensavamo già di poterci comprare tutti i giocattoli del mondo e, per un po’, non piangemmo più. Al nostro risveglio, la mattina, trovammo cinque dinari vicino al cuscino, l’equivalente di settemila lire italiane. Quella montagna di soldi altro non era che il capitale di mio padre investito nella festa, per comprare la mucca, per le ballerine, per i musicisti, per l’affitto dei furgoni, e per tutte le altre spese sostenute, che rientrava sotto forma di offerte. Al risveglio sembrava un giorno come tutti gli altri, come se non fosse successo niente. Gli unici che avevamo ancora dei "brucianti motivi" per ricordare, eravamo io e mio fratello, che ci aggiravamo per la casa come due cammelli feriti. Karim Ajili - La paura di tornare a casa a mani vuote L’Europa, sogno di molti immigrati, sempre più spesso si trasforma in incubo Marzo 2003 Mi chiamo Karim Ajili, sono tunisino, ho abitato a Tunisi con la mia famiglia sino all’età di venti anni. Ho deciso di venire in Italia nel 1996 per cercare di migliorare la mia condizione di vita. Dalla morte di mio padre, anche se ero molto giovane, sentivo la responsabilità di tutta la famiglia. Volevo fare qualcosa. Ero il figlio maschio più grande della famiglia, toccava a me occuparmi delle mie sorelle, di mia madre. Avevo aperto un negozio in cui vendevo cassette video, ma non bastava per farci vivere, quello che guadagnavo non era sufficiente per tutta la famiglia, anche se ero stato costretto ad abbandonare gli studi di scuola superiore per lavorare. Così decisi di partire per l’Italia. Non sempre però quello che si trova assomiglia a ciò che si pensava di trovare. È facile capire che molti degli immigrati extracomunitari arrivano in Italia nella speranza di migliorare le loro condizioni sociali, economiche e di stile di vita in generale. Per raggiungere questo obiettivo, ci vuole molta fatica. La speranza è quella di trovare la strada giusta che ti offre un futuro, l’obiettivo non è certo quello di venire in Italia o in Europa a fare le ferie… moltissimi di noi che poi siamo finiti in carcere volevamo lavorare per poter tornare alle nostre case, alle nostre famiglie con qualcosa in mano. All’inizio si spera d’incontrare qualcuno che ti può aiutare. A me avevano raccontato che in Italia ci sono molte possibilità di lavorare, e che si guadagna bene. Le uniche persone che conoscevo però erano clandestini, qualcuno lavorava in nero, altri semplicemente si arrangiavano come potevano, e qualcuno era già arrivato a spacciare. Non si può avere sempre quel che si desidera, e quando sei in una nazione di cui non conosci niente, nemmeno la lingua, la situazione diventa molto difficile, insostenibile a volte. Se non hai parenti o amici la vita si complica e la strada diventa più stretta ed è molto diversa da quello che tu pensavi. In quel momento ti senti solo, senza nessuno che ti da una mano. La forza la trovi nel fatto che sei ancora legato alla famiglia e a quel ritmo di vita che non c’è più, agli affetti lasciati, e ti dici: lo sto facendo anche per loro. Il distacco dalla famiglia ti crea nuovi problemi che non sei abituato ad affrontare senza il suo aiuto, anche nelle piccole cose. Ti accorgi subito di molte cose a cui tu prima non davi importanza. Per esempio prima c’era qualcuno che ti preparava da mangiare, ti lavava i vestiti, si preoccupava per te quando facevi tardi. Questo lo puoi trovare solo nella famiglia, soprattutto in quello che fa una madre. La sua presenza nella nostra vita è molto preziosa, non si può cambiarla con nessuna cosa al mondo. Ognuno di noi spera di affrontare l’esperienza dell’immigrazione con meno problemi possibile, e questo dipende certo anche dalla fortuna, ma soprattutto dalle persone che incontri. Se sei deciso a continuare ad andare avanti e scoprire cosa ti regalano i prossimi giorni, devi dimenticare le esperienze negative che quotidianamente ti accadono. Rimane nel pensiero quel che ti dà speranza per iniziare una nuova giornata, a me personalmente è rimasta una foto davanti ai miei occhi: quella della mia famiglia. L’unica certezza che ho è la presenza di Dio, nelle difficoltà spesso mi sono rivolto a Lui con la preghiera. Passano i primi mesi e ti rendi conto di avere imparato la lingua, magari non perfettamente ma quello che sai ti aiuta a comunicare con le persone, e non solo con i tuoi paesani. È essenziale per essere autonomi e sapere cosa pensano di noi, decidere da solo dove mettere i piedi. Per molti tornare poveri come quando si è partiti è una vergogna Le decisioni che prendi nel primo periodo sono importantissime, perché determinano tutto il resto. Tu sai che ci sono due strade. C’è una strada corta ma fuori dalla legge, che ti fa guadagnare molti soldi e una vita comoda, ma per molti finisce male e li porta dietro le sbarre a scontare anni e anni. La notizia che sei finito in carcere ferisce le famiglie lontane e fa pensare che il ritorno da loro si allontana sempre più. Diventa difficile realizzare il sogno che avevi, e in quel momento la tua vita cambia, i pensieri prendono solo una via, devi affrontare le difficoltà della scelta che hai fatto e sono difficoltà immense. Per quelli che hanno scelto una strada normale dentro i limiti della legge, la vita è certamente faticosa, con uno stipendio non altissimo come credevamo, ma appena sufficiente per vivere una vita serena. Se pensi di mettere da parte una somma di denaro, ti ci vuole molto tempo, ma sicuramente sei certo di godere della libertà. Questo non è poco per costruire un futuro, sapere di non far soffrire le persone che ti amano, poterle aiutare anche se limitatamente. Noi stranieri in generale abbiamo il problema che, se superiamo il primo anno di permanenza lontano dal paese d’origine, poi troviamo sempre più difficile pensare di tornare di nuovo senza aver realizzato qualcosa, che ci permetta di dedicarci a un progetto in patria, non per forza milionario, ma che dia la possibilità di andare avanti e non chiedere aiuto a nessuno. Per molti rientrare al proprio paese con le mani vuote è una vergogna. Perché sei messo a paragone con gli amici dello stesso quartiere che hanno avuto la stessa esperienza, con la fortuna però di tornare con macchine e tasche piene di soldi. Il mio giudizio su questa situazione è che per tanti di noi è diventata come una trappola. Non si può accettare la delusione e la rabbia di essere additati in patria come degli sconfitti, dei falliti. In questo caso si pensa solo a recuperare in fretta il tempo perso, e a scegliere un modo, per forza illegale, con cui facilmente riguadagnare dei soldi. Questo è quello che pensiamo noi all’idea di tornare nel nostro paese a mani vuote, mentre invece per la nostra famiglia l’importante è che torniamo a casa e basta. Perché le notizie che tante volte gli arrivano, sul fatto che spesso è difficile anche proteggere le nostre stesse vite, li lascia eternamente in ansia per noi. Alla fine sono tanti gli stranieri che finiscono in carcere, e molti anche con una pena lunga, tanto che gli capita spesso di perdere le persone più care senza poterle vedere, e questa è una gran tristezza, ferisce nel profondo e ti fa pensare che la vita non ti dà tanto spesso quel che desideri, a volte anzi può anche ingannarti e toglierti il gusto di continuare a vivere Reinserimento Francesco Morelli - I lavoratori - detenuti hanno davvero delle tutele? Ci sono, ma spesso è impossibile reclamarle Maggio 2003 Più mi confronto con persone che si occupano, in varie maniere, del reinserimento dei detenuti e più mi rendo conto di quanto sia difficile comunicare con loro in maniera soddisfacente, anche se magari perseguiamo gli stessi obiettivi, con la stessa buona volontà… Gli operatori esterni all’istituzione, per esperti che siano, non possono capire bene cos’è il "vivere in carcere", quello che accade (o non accade) ogni giorno e, soprattutto, le ragioni che determinano questi accadimenti: spesso si tratta di ragioni così connaturate nell’ambiente carcerario che nemmeno noi detenuti le sappiamo isolare e descrivere. Gli operatori dell’istituzione, invece, dovrebbero vedere e capire tutto, il problema è che lo valutano da un punto di vista differente dal nostro. E qui non si tratta di stabilire chi ha ragione e chi ha torto, il fatto è che, da prospettive diverse, si hanno ovviamente delle visuali diverse. Preparando la giornata di studi "Carcere: non lavorare stanca" (e anche a seguito di questa) abbiamo parlato tanto del lavoro, dentro e fuori del carcere, delle prassi migliori per dare un’occupazione ai detenuti, degli strumenti normativi al riguardo, e via dicendo. Una questione è rimasta un po’ in secondo piano: come sono trattati i lavoratori-detenuti? Il fatto che non si lamentino (quasi) mai vuol dire che sono contenti del loro lavoro, oppure che non possono lamentarsi? È vero che pure i lavoratori non detenuti hanno sempre meno "convenienza" a lamentarsi, che il lavoro è sempre più precario e "flessibile", che sul mercato della manodopera ci sono tanti immigrati disposti (o costretti?) a lavorare in qualsiasi condizione, e noi detenuti dovremmo solo starcene zitti, anche perché c’è già chi pensa al nostro bene… Però ho notato che le varie ricerche sul lavoro penitenziario hanno dei "buchi" proprio nel passaggio tra le leggi, necessariamente astratte, e la loro concreta applicazione. In questo caso particolare, tra l’enunciazione dei diritti dei lavoratori-detenuti e il loro effettivo esercizio. L’analisi, quando c’è, si arresta di fronte ad una doppia constatazione: 1. Manca il lavoro, quindi il solo fatto di uscire dalla cella è già una conquista; 2. Tra i detenuti manca la necessaria consapevolezza dei propri diritti. Entrambe queste ragioni sono condivisibili e, allo stesso tempo, presentano dei limiti evidenti. Prima cosa, va detto che il lavoro penitenziario non può essere valutato solo in termini economici: è uno degli elementi del trattamento, quindi dovrebbe insegnarci (o non farci dimenticare) cosa voglia dire "guadagnarsi onestamente da vivere". Questo concetto, però, lo metabolizzi meglio quando ti sono riconosciuti alcuni diritti basilari, perché se il lavoro diventa una forma di asservimento, se sei ricattabile da ogni punto di vista e quindi devi sempre dire di sì, non ti rieduchi affatto, semmai impari a tenere i nervi sotto controllo, in attesa del momento giusto per prenderti la tua rivincita… In carcere il lavoro è un dovere, perché se lo rifiuti senza avere un valido motivo (es. per problemi di salute) c’è una sanzione disciplinare, ma non è un diritto: "… salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro", recita l’articolo 15 della legge penitenziaria. Meno di un quarto dei detenuti lavora (13.474, di cui 11.213 alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria e 2.261 per cooperative, etc. – Fonte: Ministero della Giustizia), quindi l’eccezione è diventata la regola e, naturalmente, i posti disponibili sono quanto mai preziosi. Niente contratto Penitenziaria per chi lavora per l’Amministrazione La condizione di chi lavora per l’Amministrazione Penitenziaria è di non avere un contratto, quindi di poter essere "licenziati" in ogni momento (in gergo si dice, significativamente, essere "chiusi"), cosa che avviene di solito per motivi disciplinari, anche indipendenti dal comportamento sul posto di lavoro. Assieme al possibile rilievo disciplinare, l’altro assillo di chi lavora è il trasferimento in un altro carcere, che può arrivare per tanti motivi… a volte anche di difficile comprensione. Il compenso percepito dal lavoratore-detenuto si chiama "mercede" e, per legge, dovrebbe essere "non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro" (articolo 22 O.P.): la misura di questi compensi è ferma a circa 12 anni fa e, attualmente, arriva sì e no, al netto dei contributi, ai 3 euro l’ora, dai quali vengono ancora detratte le quote per il mantenimento (circa 52 euro al mese, il costo dei pasti che ci passa l’Amministrazione). Va anche detto che nel 1992, dovendo fare economie, l’Amministrazione ridusse gli orari di lavoro di molti addetti ai servizi domestici: gli "scopini", che prima lavoravano sei ore e mezza, ora lavorano tre ore e quaranta minuti. Gli addetti alla cucina, che prima lavoravano otto ore, ora fanno sei ore e quaranta minuti. Ma c’è anche chi, nei posti a rotazione mensile (che sono la maggior parte), ha un orario di lavoro limitato ad un’ora e mezza. Quindi, oggi, i posti di lavoro sono gli stessi del 1992 e per di più con orari sensibilmente ridotti, mentre i detenuti che usufruiscono dei servizi (prestati dai loro stessi compagni), sono quasi il doppio. Ne consegue che la qualità dei servizi domestici è peggiorata per forza: le pulizie delle sezioni più frettolose, la preparazione dei pasti meno curata, e via di seguito. Qualche rimedio, per fare fronte alla quotidiana emergenza, nel corso degli anni è stato escogitato: di solito consiste nel far lavorare (gratis) i detenuti oltre l’orario previsto, nella pausa pranzo, etc… ma senza che nessuno sia esplicitamente costretto a farlo, s’intende. È successo anche a me, quindi posso descrivere l’esperienza diretta. Funziona così: vai in un posto, che può essere la cucina, il sopravvitto, etc., e ti rendi subito conto che la mole di lavoro è sproporzionata, rispetto alle persone e agli orari ufficiali che ci sono. Quindi, per essere benvoluto dai responsabili, cominci a fare un po’ di "volontariato", come peraltro vedi fare ai compagni che stanno lì da più tempo. "Qui è come una grande famiglia", ti dicono… "tu aiuti noi e noi aiutiamo te". Ci sarebbe di che fare reclamo al Magistrato di Sorveglianza (articolo 69 O.P.), però non è pensabile mettersi contro l’Amministrazione, quando dipendi da lei in tutto e per tutto. Se questo sarebbe un caso nel quale avere facilmente ragione (il problema è solo… a quale prezzo), ancora più ardua è l’eventuale rivendicazione di altri probabili diritti, sui quali la legge non è esplicita e che dovrebbero essere "conquistati" attraverso cause civili, davanti al Giudice del Lavoro, o alla Corte di Cassazione. La legge Smuraglia (n° 193/2000) definisce il lavoro penitenziario "lavoro in senso stretto", però l’articolo 20 O.P., al sedicesimo comma, riconosce ai detenuti solo il riposo settimanale, la tutela previdenziale e assicurativa e una durata massima dell’orario di lavoro. Non si parla, ad esempio, di iscrizione al sindacato, di Trattamento di Fine Rapporto, di licenziamento per giusta causa, di sciopero, etc. Sarebbero diritti inconciliabili con lo stato di detenzione? Forse sì, o forse no. Ad esempio, nel 2001 c’è stata un’importante sentenza della Corte costituzionale (n° 158), con la quale si è stabilito che anche i lavoratori-detenuti hanno diritto al riposo annuale pagato (le ferie). Le cooperative che hanno dei laboratori all’interno delle carceri pagano le ferie e la tredicesima ai detenuti alle loro dipendenze. L’Amministrazione Penitenziaria, da quel che mi risulta, non si è ancora adeguata e, anche su questo, servirebbe un ricorso al Giudice del lavoro… Quindi la tutela del lavoro, all’interno delle carceri, è molto problematica, ma nell’area penale esterna non è molto migliore, perché anche lì il lavoratore semilibero, o affidato, è in una posizione di grande debolezza contrattuale, di fronte al datore di lavoro. Perdere l’occupazione per lui significa tornare in carcere, suscitare antipatie o malcontenti, vuol dire che, prima o poi, al magistrato arriva una nota negativa e chissà come la prende… Chi assume i detenuti in misura alternativa spesso si meraviglia di quanto sono bravi: arrivano al lavoro anche se hanno la febbre, non si lamentano mai, e via di questo passo. Finché reggono… perché ogni tanto qualcuno combina un disastro e, anche dopo tutto quello che ho visto a proposito della tutela del lavoro, certi episodi non mi meravigliano più. La scelta di tornare all’illegalità deriva, in larga parte, da quello che hai provato durante la detenzione, quindi dal tempo trascorso sentendoti totalmente nelle mani degli altri, nell’incertezza sul tuo futuro. Il carcere è scuola di criminalità soprattutto in questo senso, perché il rapporto con tutte le altre componenti dell’istituzione, dai giudici agli agenti, è di dipendenza assoluta: tu stai sotto tutti, una relazione verticale che facilmente riprodurrai appena sarai libero, naturalmente cercando di ribaltare le posizioni… spesso con qualsiasi mezzo. Francesco Morelli - Lasciate ogni speranza… o voi che uscite Ma chi riesce realmente a “reinserirsi nella società”, al termine della pena? Forse si potrebbe dire che, tranne qualche eccezione, ci riesce soltanto chi non è mai stato davvero “disinserito” Settembre 2004 “Lasciate ogni speranza… o voi che uscite”. Queste sono le parole usate dal criminologo Carlo Alberto Romano alla presentazione di una ricerca sulla recidiva postpenitenziaria, realizzata dalla associazione “Carcere e territorio” di Brescia, di cui è presidente. L’indagine ha preso in considerazione per un periodo di cinque anni (98/2002), l’attività del Tribunale Penale di Brescia ed i risultati sono sconcertanti: l’80 per cento di coloro che hanno terminato una pena detentiva sono nuovamente tornati a delinquere e ad essere condannati. Una percentuale che deve far riflettere e discutere, che deve indurre gli operatori della giustizia, ma anche il volontariato e noi detenuti, ad avere dei dubbi rispetto a ciò che si fa e che ci si attende sul versante del cosiddetto “reinserimento”. Oltre tutto questa cifra è, probabilmente, sottostimata: la ricerca si basa sui dati provenienti dal distretto giudiziario di Brescia, non considera che qualcuno, dopo avere scontato la pena nel carcere della città, può essere “emigrato” in altre province o regioni e lì avere commesso dei reati ed essere stato condannato. Poi c’è l’ulteriore problema della esatta identificazione di molti stranieri, dell’uso degli “alias”, che consente di figurare come incensurati (un tempo si otteneva anche la “condizionale”, oggi soltanto una espulsione più rapida…). E, infine, non dobbiamo dimenticare che, di tutti i reati commessi, solo nel 15 per cento dei casi viene individuato il responsabile (la percentuale aumenta per i reati più gravi ed è minima, ad esempio, per i furti: 4-5 per cento). Quindi, se l’esperienza conta qualcosa, è ragionevole supporre che un “criminale recidivo” sia un po’ più difficile da incastrare, rispetto ad uno alle prime armi: qualcuno che la “fa franca” ci sarà pure, insomma… Alla fine dei conti, chi realmente riesce a “reinserirsi nella società”, al termine della pena? A mio parere, tranne qualche eccezione, ci riesce soltanto chi non è mai stato davvero “disinserito”. Quindi quelle persone che finiscono in carcere per un incidente di percorso, non ci rimangono troppo a lungo e, all’uscita, trovano intatta (e magari rafforzata) la rete di affetti, solidarietà, e quant’altro. Invece la grande parte dei “devianti”, quindi poi dei detenuti, lo diventa per una serie di difficoltà: psicologiche, relazionali, economiche..., che il carcere aggrava e complica… e non vedo come potrebbe essere diversamente… Quando un ex detenuto viene nuovamente arrestato nessuno si scandalizza, i giornali ne fanno una notizia soltanto se era in misura alternativa, oppure se era uscito da pochi giorni (o ore…), perché in questi casi serve a solleticare l’ottusa indignazione dell’opinione pubblica. Se ha terminato la pena da un po’ di tempo smette di essere un “ex detenuto” e diventa un “pregiudicato”, parola che allude a colpe indelebili, debiti inestinguibili, futuri predestinati. Un “pregiudicato” preso in flagrante di reato è un episodio perfino rassicurante, per la gente: conferma l’idea che un delinquente rimane tale per sempre, che i crimini sono commessi sempre dalle stesse persone, che la polizia sa fare bene il suo lavoro… e poi arriva un giudice a far uscire tutti! Un ex detenuto deve essere preparato a combattere duramente, se vuole “stare a galla” in un mondo basato sulla competizione Gli “ex detenuti” ottengono l’attenzione dei media solo quando mettono in atto proteste clamorose per ottenere un aiuto: spesso un lavoro, a volte una casa. A Caltanissetta uno si è versato addosso della benzina, minacciando di darsi fuoco dentro il municipio; ad Avellino un altro si è incatenato nella piazza principale, a Torino un altro ancora si è arrampicato su una ciminiera, dicendo che si sarebbe buttato se non arrivava un “giudice” ad ascoltare le sue ragioni… A volte questi gesti ottengono l’effetto sperato, qualche amministratore pubblico impietosito (o semplicemente per evitare rogne) trova un “lavoretto” per l’ex detenuto: quello di Caltanissetta pare abbia avuto un “posto” dove guadagna ben 200 euro al mese, ad esempio.E, quando accade, poi si assiste alla sollevazione dei disoccupati “normali”, che scrivono ai giornali: “Dobbiamo commettere un reato, per trovare lavoro?!?”. Se le guerre sono, sempre e comunque, faccende tristi, le “guerre tra poveri” lo sono particolarmente… Del resto non c’è dubbio che un ex detenuto debba essere preparato a combattere duramente, se vuole “stare a galla” in un mondo basato sulla competizione. E non sempre questo è possibile, per ragioni di età, di salute di forza d’animo e via dicendo. O vogliamo davvero pensare che siamo tutti deficienti (noi detenuti, intendo), che ci piace stare in carcere… sì, sarebbe una spiegazione molto comoda per la coscienza, ma non è così. Di deficienti ce ne sono, come dal resto ci sono tra le persone libere, me la gran parte di noi diventa recidivo quando si arrende, quando decide che non ce la fa a vivere all’interno dei faticosi percorsi a cui è obbligato. Credo non si tratti di una scelta presa a cuor leggero, ma allo stesso tempo è anche una scelta dettata dall’incoscienza. E chi vive ai margini è incosciente del proprio ruolo sociale vero, si percepisce come una vittima e quindi è pronto ad autogiustificarsi quando fa azioni non proprio corrette. Sono disfattista? Qualcuno ce la può fare, ma deve pure avere una buona dose di fortuna, oltre a tutto il resto… E di me stesso, cosa posso dire? Solo un episodio, che vale più di tante chiacchiere: l’altra sera al rientro (lavoro all’esterno in articolo 21 e rientro in carcere alla sera) ho trovato una ingiunzione per il pagamento di circa 25.000 euro, “spese di giustizia” accumulate dal 1990 al 1996 (quindi quelle dal ‘96 in poi devono ancora arrivare?). Sapevo che c’erano, avevo chiesto pure la “remissione del debito”… ma sono arrivate lo stesso! Adesso ho due soluzioni: o trovare questi soldi entro 60 giorni, oppure chiedere una rateizzazione e farmi decurtare il 20 per cento dello stipendio per i prossimi 12 anni. Se fossi dell’umore giusto mi augurerei “buona fortuna” da solo… Alessandro Pinti - Perché, una volta usciti dal carcere, la maggior parte di noi torna a commettere reati? Chi commette un reato e finisce in carcere fa una specie di salto di una barriera etica, morale e culturale che lo fa precipitare molto in basso, e tutte le sue convinzioni, l’educazione ricevuta, le paure indotte, vengono a cadere inesorabilmente Dicembre 2000 Partendo dalla mia esperienza personale, e da quella di tantissimi ragazzi della mia generazione, proverò a dare un’interpretazione del perché una volta usciti dal carcere la maggior parte di noi ricommette reati, e spesso più gravi di quelli precedenti. Il carcere quindi che diventa una sorta di scuola di delinquenza, poco propenso al recupero e al successivo reinserimento dei detenuti nella società: nell’immaginario collettivo, ma anche nella realtà dei fatti, le cose stanno proprio così! Sarò molto sincero in questo mio ragionamento, partendo proprio da me, che dopo tantissimi anni di carcere, al termine di un percorso trattamentale interno intenso e vissuto con partecipazione, ottenni la liberazione condizionale, e mi ritrovo ora nuovamente in carcere con una condanna a vita. Non sono stato né costretto "dagli amici", o "dall’ambiente", insomma non condizionato da motivazioni esterne alle mie convinzioni, né ho ricommesso reati per necessità. Ma su questo tornerò più avanti. Chi commette un reato e finisce in carcere, fa una specie di salto di una barriera etica, morale e culturale che lo fa precipitare molto in basso, e tutte le sue convinzioni, l’educazione ricevuta, le paure indotte, vengono a cadere inesorabilmente. A questo punto ha due possibilità: la prima di ritornare presto libero, spaventato dall’esperienza, e con tutte le sue forze ricostruire la sua vita, le sue relazioni sociali, e tornare alla vita di prima ancor più terrorizzato dal carcere. Questa è una persona che difficilmente ricommetterà reati. Ma c’è una seconda possibilità, ed è che queste persone perdano nella disperazione tutte le loro remore morali e culturali, in poche parole una volta finite in carcere non ne abbiano più paura. Tornate libere, laddove precedentemente si fermavano al solo pensiero dell’illegalità, in questa nuova condizione saranno tentate per convenienza, e non più spaventate, a commettere reati. Sono una maggioranza silenziosa, nel senso che non sono visibili in quanto delinquenti occasionali e comunque prudenti e responsabili di piccoli reati. C’è poi la recidiva che riguarda il delinquente per eccellenza, il criminale professionale, che dell’illegalità ha fatto una scelta di vita, come il sottoscritto. Questo zoccolo duro è presente costantemente nelle carceri, e costituisce il "materiale" umano sul quale, una volta che si trova in espiazione di una pena definitiva, si riversano risorse rieducative e trattamentali,. Non intendo certo generalizzare, ma conti alla mano la maggior parte di queste persone ha avuto molte esperienze di recidiva, e in prospettiva saranno sempre loro i futuri detenuti, e forse ancora una volta si cercherà di "sottoporli a trattamento" per rieducarli! Sono convinto di una cosa: non esiste né rieducazione né consapevole ridefinizione degli errori commessi attraverso un processo autocritico del proprio passato, come invece è espressamente indicato nel nuovo regolamento penitenziario, in relazione alla concessione dei benefici alternativi al carcere. Non che questo sia in assoluto escluso, anzi ritengo sia possibile, ma sicuramente non generalizzabile! Ognuno di noi ha comunque l’occasione per cambiare vita, modelli di riferimento, e valori, e soprattutto per convincersi che il commettere crimini, ad un certo punto della propria esistenza, non conviene più. Questo complesso meccanismo "opportunistico", ma anche di sincero desiderio di dare un taglio col passato, necessita di percorsi dove siano esaltati i valori e la lealtà del detenuto nei confronti di chi lo aiuta in questo suo tormentato percorso, dove nessuno gli deve però "calare dall’alto un progetto" che non accetterebbe mai, e tantomeno pretendere pentimenti esistenziali di tipo religioso o uno snaturamento della sua personalità, una sorta di destrutturazione interiore con imprevedibili effetti una volta che sia tornato libero. Ogni progetto reinseritivo, ogni occasione interna per allontanarsi dalla convenienza a delinquere, devono essere certo favoriti, ma gestiti con criteri di assoluta "laicità" e tenendo sempre presente la personalità, quella vera e non di finzione, del detenuto "criminale professionale" o comunque tendenzialmente tale. Giulia - Ri/Educazione - Re/Inserimento Ma il carcere è piuttosto "educazione" a corazzarti contro il senso di impotenza e a non farti coinvolgere da tutto ciò che ti circonda fino a diventare cinico Luglio 2002 Rieducazione e reinserimento: due parole che si sentono spesso, o per meglio dire sono alla base dei discorsi degli "addetti ai lavori" che si occupano di carcere. Sono considerate come "fine" da raggiungere, ma… dovrebbe essere così, e non lo è! Dovrebbe (condizionale) con accanto il SE, se si verificano tutta una serie di circostanze, ma con i SE spesso non si va da nessuna parte, e tanto meno in carcere. RI/EDUCAZIONE: cos’è? Per molti detenuti, se non per la totalità, questa parola non ha molto senso. Del resto, "SE" fosse possibile RIEDUCARE, ci sarebbero sicuramente meno recidivi. Possiamo invece parlare di: "EDUCAZIONE" al crimine, questo è reale (forse per troppi): un esempio banale, quanto vero, è entrare in carcere per un semplice furto e uscire sapendo come poter fare una rapina. Tra i detenuti c’è scambio di informazioni su atti illegali, normale visto l’ambiente promiscuo in cui si vive "EDUCAZIONE" a corazzarsi contro il senso d’impotenza, contro l’impossibilità a scaricare impulsi emotivi, che portano rabbia e un’aggressività che va controllata. E per controllarla ci vuole razionalità: bisogna costruirsi dei muri a difesa della propria sopravvivenza. Ognuno ovviamente ha i suoi metodi. Chi si chiude, chi diventa iperattivo, chi piange, chi diventa amorfo, chi s’impasticca e si fa "scivolare" addosso il periodo di detenzione "EDUCAZIONE" a non farti coinvolgere da tutto ciò che ti circonda, a sdrammatizzare, fino (a volte) a diventare cinico o essere considerato tale. Poi, se di per sé una persona ha già un carattere considerato "forte", il carcere "EDUCA" ad esserlo di più, a coltivare la durezza, la ruvidità, la severità. Dunque realmente e nei fatti il carcere con fini "ri/educativi" non c’è, e non c’è poi il "re/inserimento" nel tessuto sociale. Prima di questo passo, che dovrebbe consistere nel reintegrarsi nella società, esserne accettati, tornare a farne parte, una persona reclusa dovrebbe infatti essere preparata. Quindi servirebbe un passaggio intermedio tra carcere e dopo carcere. Difficilmente accade. Si danno permessi per questo, ma generalmente non sono consoni allo scopo da raggiungere. Già, perché in permesso chi ha una famiglia in qualche modo inizia un riallacciamento dei legami affettivi, ma chi è solo o è detenuto lontano dal suo ambiente famigliare (facile che capiti) va in permesso presso strutture a loro volta chiuse o comunque in un certo qual modo protette e non trova le condizioni vere che dovrà affrontare all’uscita dal carcere. La vita reale fuori dal carcere non è statica, risucchia. Un "ristretto" dopo anni di chiusura totale vissuta a ritmi e spazi condizionati e determinati da altri, fa fatica, non è a suo agio, si perde. Questo provoca ansietà, paure, angosce. Una sensazione di vacillamento in uno spazio-tempo che non sente suo. Anche lì avrebbe bisogno di supporti: non dati "per forza" (ti costringo a farti aiutare), ma intesi come una porta aperta dove se vuole uno può essere libero di entrare o no. Questo fatto, questa esigenza di non essere "ributtati nel mondo" senza un aiuto, non vengono presi in considerazione. E anche il lavoro all’esterno con un articolo 21 "extramurario" o una semilibertà sono occasioni sì, ma fortemente condizionate a loro volta. Queste "opportunità" di lavorare fuori dal carcere dovrebbero servire a procurarti un "re/inserimento" futuro. A parole è facile, un detenuto esce in semi-libertà, svolge un lavoro, si guarda due negozi, rientra in carcere. Certo incontra persone che non vivono la sua stessa condizione, disposte ad accettare la sua situazione con (naturalezza mi pare esagerato) benevolenza. Un’altra specie di protezione. Ma quanti ristretti si ricostruiscono una vita nella città dove sono "ospiti temporanei" di un carcere? Credo pochi. Di conseguenza, seppure semiliberi o in articolo 21, quando a Fine Pena se ne andranno e torneranno nella loro città, si potrà dire di loro che sono "RE/INSERITI?". Certo la mia convinzione personale, e di tante altre detenute, sarebbe che bisogna costruire dal carcere un cammino futuro, ma in concreto non mi sembra attuabile. Perché? Ci sono prima di tutto i TRASFERIMENTI: spesso ti allontanano e non ti è dato certo di scegliere. E così un percorso iniziato si interrompe bruscamente e ti ritrovi a ricominciare tutto da capo. Poi manca spesso una FORMAZIONE LAVORATIVA adeguata (sono poche le strutture carcerarie in grado di darla). E in fine i PUNTI DI RIFERIMENTO, che una persona dovrebbe sempre avere, come gli affetti, un luogo in cui abitare, il lavoro, spesso vanno persi durante la detenzione. È un ripartire da zero! Sempre a parole ci si dice che esistono: i Servizi Sociali, le Cooperative di lavoro, le Associazioni "umanitarie". Ma chissà perché una volta che ci viene tolto l’appellativo di ristretti, torniamo ad essere un "NIENTE". Nessuno ha più interesse per noi! Dunque le uniche soluzioni possibili che ci rimangono sono accettare lavori poco qualificati, mal pagati e frustranti, comunque non in grado di consentirci una vita "decente", e una "riqualificazione" sociale, lavorativa, umana quantomeno dignitosa. Questo appiattimento della dignità personale spinge molte volte a non avere più speranza, a non credere più in niente, a considerare la propria vita come non degna di essere vissuta, se non nell’unico contesto che precedentemente ci ha portato in carcere. Paola M. - Oggi parto dalla felicità che provo a sentirmi di nuovo una persona libera Il percorso di reinserimento deve essere graduale - non si può “scaraventare” una persona di colpo in una società che non la vuole, che la vede come “diversa”. C’è bisogno assoluto di queste benedette “misure alternative”! di Paola Marchetti, settembre 2007 Non voglio dire ancora delle misure alternative cose che sono già state dette e ridette, penso che conti di più raccontare qualcosa sulla propria esperienza, vissuta sulla propria pelle. Forse le proprie sensazioni e le proprie sofferenze si possono ancora usare come punto di partenza per un discorso più ampio, che non sia solo tecnico, e che tenga conto dei fattori psicologici, che sono poi quelli che ci spingono a scegliere un certo tipo di vita anziché un altro, e poi a seguire un certo percorso invece che un altro anche durante l’espiazione della propria pena. Allora da qui parto, dalla felicità che provo a sentirmi di nuovo una persona LIBERA, dopo sei anni e mezzo di galera, pur se con gli ultimi sei mesi vissuti lavorando all’esterno, con un articolo 21 datomi dalla direzione, che per me è stato un riconoscimento importante del mio impegno in un percorso di cambiamento. Libera di farmi un documento d’identità; libera di portarmi a casa da mangiare quello che voglio e non solo “le cose nella lista”; libera dalle perquisizioni delle celle, dal vedersi le proprie cose, dagli abiti alle mutande alle fotografie, toccate, spostate; libera dalle perquisizioni degli astucci degli occhiali da vista ogni sera quando, rientrando dal lavoro per dormire in carcere, viene accuratamente controllato ciò che ci si porta in cella; libera dal dover fare la “domandina” anche per respirare; libera dal dover dare ragione a persone che magari sai che non ce l’hanno, solo per evitare ritorsioni, perché “il coltello dalla parte del manico” finché sei in carcere ce l’hanno sempre gli altri, mai tu. Ma felice anche perché tutto il lavoro, tutta la fatica di questi sei anni e mezzo sono stati riconosciuti con l’accoglimento della mia richiesta di affidamento ai servizi sociali. Il carcere è faticoso anche se non si fa nulla, figuriamoci poi se si tenta di fare un lavoro su se stessi, lavoro che per come sono strutturate le carceri italiane diviene a volte titanico, perché spesso ci si sente circondati dalla volontà che tutto rimanga com’è, che il detenuto non scocci più di tanto, che non pretenda di studiare, di pensare, di progredire, di diventare qualcosa di diverso da ciò che era. La fatica immane che io ho fatto, con l’aiuto di qualcuno e il boicottaggio da parte di altri, per affrontare gli studi universitari, che già di per sé è duro in una situazione di detenzione (anche se c’è ancora chi, senza conoscere la situazione reale, ti dice che tanto in carcere non si fa nulla per cui c’è tutto il tempo per studiare…), fatica che solo la mia ferrea volontà di proseguire e l’aiuto di pochi “illuminati” mi hanno permesso di superare; il fatto che ho preparato tutti gli esami universitari senza l’aiuto di alcun professore; il fatto che ho sempre lavorato, magari part time; il fatto che malgrado le avversità, che non sono state poche – dalla grave malattia di mio padre, all’errore del laboratorio di analisi che mi ha trovato positiva ad una sostanza che non prende più nessuno e che mi ha bloccato i permessi premio per quasi quattro mesi – non ho mai smesso di alzarmi presto la mattina per andare a studiare e a lavorare: tutto ciò, insieme a molto altro, ha dimostrato la mia volontà di cambiare vita. E questo credo sia il fine ultimo di un percorso di recupero carcerario: che il detenuto, arrivato a fine pena, si reinserisca nella società come cittadino onesto e non compia più reati. Bisogna affidarsi soprattutto a se stessi I meriti vanno riconosciuti e premiati e le “marachelle” vanno punite. È regola basilare nell’educazione di un bambino, ma è regola basilare anche nel recupero di una persona che ha sbagliato. Se si dimostra con i fatti che quelli senza meriti vengono premiati, allora non ci sarà alcuno sforzo a migliorarsi. E purtroppo molto spesso è ciò che accade nelle nostre carceri. Non vi sono sufficienti educatori, non vi sono sufficienti psicologi, non vi sono sufficienti figure che sostengano e che tengano monitorato il reale percorso di un detenuto. Ci sono Magistrati di Sorveglianza che conoscono le persone di cui poi si trovano a dover decidere le misure alternative da concedere oppure no, ma ce ne sono altri che si basano molto spesso sul tipo di reato commesso non tenendo forse in conto il “dopo processo” cioè tutto ciò che è stato fatto dal momento della condanna in poi, se non usando ciò che di negativo c’è stato. Allora dobbiamo metterci d’accordo: le buone intenzioni sono molte, i bei discorsi anche, i fatti sono spesso tutta un’altra cosa. Non si fanno grandi sforzi per far decollare questo benedetto “recupero” (non uso il termine “rieducazione” che mi ricorda molto i campi di lavoro della Cina maoista), si vive sul “già fatto e già visto”, c’è, anzi, chi rema contro, non per volontà ma per semplice ignoranza o impreparazione. Il detenuto che vuole “riemergere” deve affidarsi poco all’istituzione, e molto al volontariato o a coloro che con spirito quasi masochistico credono ancora di poter cambiare qualcosa, come gli insegnanti che lavorano in carcere. E soprattutto deve affidarsi a se stesso. Il che, assicuro, non è assolutamente facile, e chi non ha alle spalle un vissuto, un carattere, una volontà molto forti cederà. Ma proprio il fatto di essere finiti lì è una dimostrazione che forse chi è da recuperare questa gran forza non ce l’ha! Io credo che soprattutto le misure alternative siano necessarie, direi essenziali per un reale processo di reinserimento nella società. Le statistiche lo stanno a dimostrare. E per darle mi piacerebbe che i magistrati tenessero un po’ meno in conto l’opinione pubblica che, gonfiata da media non certo obbiettivi e ogni giorno più superficiali nel dare le notizie, diviene sempre più giustizialista senza peraltro conoscere veramente ciò di cui si parla. Il processo di reinserimento deve essere graduale, lunghezza della pena permettendo, perché, comunque, non è semplice neppure per chi è stato per del tempo dentro un’istituzione così “totale” rapportarsi nuovamente con il mondo esterno, dove non c’è nessuno che decida per te. Quindi ben venga prima il permesso premio, seguito dal lavoro esterno dove il denaro dello stipendio te lo gestisce ancora l’istituzione, per poi però essere seguito dai vari tipi di affidamento, perché solo così si arriva a gestire, almeno in parte, la propria vita, ad imparare a camminare di nuovo con le proprie gambe, a fare i conti con uno stipendio che non basta mai, a vivere cioè una vita “normale”, con qualcuno, nella fattispecie l’assistente sociale, che ti aiuta, che ti sta vicino. Immaginiamo infatti una persona che per due, tre, quattro anni – se è andata bene – è rimasta fuori completamente dal mondo, e immaginiamo che sia improvvisamente “scaraventata” in una società che, oltre al fatto che lei stessa non la riconosce più come sua – perché forse anche prima ne era un poco ai margini – non la vuole, la vede come “diversa”, come elemento da emarginare. Come reagirà questa persona se non tornando ai “margini” e quindi tornando a vivere come o forse peggio di prima? No, c’è bisogno assoluto di queste benedette “misure alternative”! Non siamo più capaci di pensare alla morte, non sappiamo come “maneggiarla” Tiziano Fabbian - Un’ordinaria giornata… di carcere Quarta puntata: hai bisogno di soldi? Abbiamo "lavoro" per te Ottobre 1999 "Un’ordinaria giornata di… carcere". La cronaca a puntate di 24 lunghissime ore di galera continua con il protagonista, T., impegnato a farsi raccontare da G. i motivi del suo rapidissimo rientro in carcere, a soli sessantasette giorni dalla scarcerazione. Sono stato scarcerato in novembre, il 28, ricordi? Mi sono trovato lì, nel piazzale antistante il carcere, con alle spalle il passato e il futuro in faccia, ma, forse a causa della fitta nebbia presente quella mattina, non riuscivo a scorgere chiaramente ciò che m’aspettava. In mano una sacca con pochi capi di vestiario, in tasca, poco più di 300 mila lire, in testa, la stessa nebbia che si trovava all’esterno e nella quale si muoveva una sola idea: tornare nella mia città B. Scuoti la testa, ed hai ragione! Che tornavo a fare lì se non avevo più nessuno? Mia madre non c’è più, quanto a mio fratello, dopo l’ultima condanna che ho preso, non s’è fatto più sentire. Vedi, a B. perlomeno ci sono strade con un nome che conosco; percorrendole so dove sono e dove mi portano. Nella mia vita ho percorso troppe strade che non conoscevo e mi hanno portato sempre in un unico posto: qui, in carcere. Così mi sono detto: fatti coraggio! E mi sono incamminato verso la fermata dell’autobus. Alla stazione, oltre al biglietto per il treno, dal giornalaio ho acquistato il maggiore quotidiano della mia città (oddio ne abbiamo solo due, ma questo è il più letto), era la prima copia che tenevo in mano dopo cinque anni. Non volevo arrivare ignaro di quanto stesse succedendo nel posto dove intendevo ricostruirmi una vita. Che fai, sorridi? Che vuoi che ti dica, al momento mi pareva un bell’inizio; poi, in viaggio, non sono riuscito neanche a sfogliarlo, troppi pensieri! Il viaggio non è stato come più volte me l’ero figurato: un riappropriarsi dei luoghi conosciuti, nel ricordo ormai consunto dall’uso. Oh si! Sono sempre stato al finestrino, ma in realtà non ho visto niente. Mi sentivo come un cane, di quelli che corrono dietro, abbaiando, a tutte le auto che passano, ma se riescono a raggiungerne una, poi non sanno che fare. Lo stesso per me; stavo finalmente tornando alla mia città, ma ora che le ero prossimo non sapevo proprio che fare. Ritornare nel "giro" avrebbe significato risolvere i problemi immediati e… a lungo andare, anche quelli futuri se ritieni il carcere una soluzione. M’è venuta quella barzelletta, sai… la frigida che dice al suo uomo tutto "sotto pressione": "…o dentro o fuori! Questo su e giù inizia a darmi fastidio!...", a me dava fastidio più il "dentro" che il "fuori" e su questo pensiero ho deciso di… Aspetta, se senti che t’incazzi, lasciami finire il discorso prima di dire la tua, o.k. ?! Allora, ho deciso di andare subito in Questura e dire loro: signori, sono stanco della galera e voglio ricostruirmi un’esistenza, quindi chiedo il vostro aiuto…! Aspetta t’ho detto! Lasciami finire! Senti "grillo saggio", che potevo fare nelle condizioni in cui mi trovavo, senza soldi, senza casa, senza lavoro, appena partorito dal carcere?! E poi ho pensato che non saranno mica lì solo per sbatterci dentro quando sbagliamo, no… Sarà ben interesse di tutti se ci danno una mano a ricostruirci una vita diversa dalla precedente… Spiritoso, la so la differenza tra sbirri e Assistenti Sociali, i secondi non portano la divisa. Era solo una battuta, ascolta! Arrivo ed esco dalla stazione; ora che sapevo che fare ero quasi convinto che le cose sarebbero andate bene. Ero carico, determinato e… nella mia città; un po’ fredda a dire la verità, e allora sono entrato in un caffè lì vicino ed ho investito quasi 5.000 lire nel sogno mattutino d’ogni detenuto: cappuccino schiumoso e croissant caldo. Solo che di croissant non ne avevano ed ho dovuto ripiegare su un Krapfen freddo. Mentre bevevo il cappuccino osservavo attraverso la vetrina del caffè le persone che passavano, velocemente affaccendate, e pensavo: ecco che mi distingue da loro, la velocità nel camminare. Al contrario di me hanno dove andare e sanno dove andare; la lentezza, in questa società, significa indigenza! Così, perché nessuno si accorga della mia situazione, esco dal caffè e velocemente mi avvio verso la questura… velocemente, e pensare che un tempo facevo un chilometro in più solo per non passarci davanti! Arrivo. Chiedo al piantone se c’è ancora l’ispettore C. C’è ancora, salgo e busso al suo ufficio, entro. Mi riconosce e dice: "Già fuori?!". Aveva ragione Einstein, penso, cinque anni a me son parsi un’eternità, per lui solo un "già fuori?!". Sorvolo su questa sua uscita e gli sciorino tutto il bel discorso che mi sono preparato: testa a posto… mai più nel giro… con il vostro aiuto. E lui, sai che mi dice? Anche se hai indovinato non ridere, stronzo! Aspetta che te ne dia io motivo. Allora si dice contento delle mie intenzioni; loro saranno ben felici di darmi tutto l’appoggio occorrente ma (è il "ma" che ti frega), innanzi tutto devo dar prova di voler veramente reinserirmi nella società. Dio mio, penso, vuoi vedere che dovrò sottopormi ad una prova d’iniziazione?! Quale sarà? Lui soddisfa immediatamente la mia curiosità: reintrodurmi nel "giro" e soffiare loro quello che sta per succedere! Ma come? gli dico, vengo a chiedere aiuto per evitare di essere nuovamente coinvolto in affari loschi e voi mi chiedete di riprendere la vita di prima? Non capisco proprio la vostra logica (se può essere una logica). Ma no! mi dice, solo per poco tempo, neanche un anno, e poi… una mano lava l’altra. Sì, però solo le mie mani hanno provato le manette ai polsi, anche quando mi hanno portato al funerale di mia madre. Volete togliermi quel poco di dignità che sono riuscito a conservare? "Tutti uguali i delinquenti!", così mi ha detto. Lì per lì stavo per saltargli addosso, ma mi sono trattenuto. Sono uscito sbattendo la porta, mi arrangerò da solo, mi sono detto. Così sono andato al dormitorio pubblico. M’hanno dato un posto letto, solo per una settimana però, e un pieghevole con indicati indirizzi e numeri di telefono di associazioni benefiche ed enti assistenziali. Meglio non lasciare la sacca, mi dice il custode, sai… Ed io mi chiedo il perché dobbiamo sempre fregarci tra poveracci. Dopo aver preso un caffè al distributore automatico esco per andare all’ente comunale d’assistenza come mi ha consigliato un ospite del dormitorio. Si trova dall’altra parte della città, ma decido per una passeggiata a piedi, voglio rendermi conto di quante cose sono cambiate durante la mia assenza. Tra un moto di stupore ed un altro, arrivo a destinazione. In attesa ci sono pochi uomini e tante donne con bambini che giocano su un corridoio sul quale si affacciano gli uffici. Siedo aspettando il mio turno che arriva dopo un paio d’ore d’attesa. Busso, entro e saluto, c’è un’impiegata che mi dice di accomodarmi. Siedo e le spiego la situazione nella quale mi trovo. Non batte ciglio, chissà quanti ex detenuti si sono seduti su quella seggiola. Inizia a compilare un modulo interrogandomi: le solite cose, dati anagrafici ecc. Poi inizia con le richieste: stato di famiglia, iscrizione alle liste di collocamento, certificato di nullatenenza (nullatenente? Nulla generale sono io, fin qui niente di complicato; domani mattina potrò fare tutto, penso) poi continua: certificato di detenzione… qui ho il foglio di scarcerazione, le faccio presente, CER-TI-FI-CA-TO-DI-CAR-CERA-ZIONE sillaba decisa (telefonerò all’educatrice in istituto forse potrà farmelo avere per posta), e per ultimo, dice, domicilio al quale sarà spedito l’assegno a proposta di sussidio accolta. Le spiego che non ho un domicilio e che per una settimana sto al dormitorio pubblico, poi… non so. Però, aggiungo, il problema non sussiste in quanto posso sicuramente passare di persona a ritirare l’assegno. Non si può, dice, gli assegni sono inviati rigorosamente tramite PO-STA, quindi serve il DO-MICI-LIO, risillaba. Bene, penso, andrò da qualche prete (caro, vecchio, bistrattato prete, ma quando c’è bisogno sei il primo al quale si ricorre), gli spiegherò la situazione e senz’altro mi presterà domicilio per la corrispondenza. Le chiedo quanto passerà tra la presentazione della richiesta e, sempre se accolta, l’invio dell’assegno. La commissione esaminatrice si riunisce ogni fine mese, quindi se avrà la mia pratica COM-PLE-TA entro una settimana… diciamo per la fine di gennaio. Cacchio… due mesi! Penso: ho circa 270 mila lire in tasca… diviso due… Senta, le dico, non ho soldi, né casa, né lavoro, non si potrebbe snellire la pratica? "NO!" è la risposta, ma come faccio, le chiedo. Avrà senz’altro qualche parente che la possa aiutare, mi dice. Nessun parente, dico io. Gli amici? Chiede lei. Sono proprio gli amici che devo evitare, dico io. Sono un’impiegata del comune, non una baby-sitter, dice lei, quello che mi compete l’ho fatto! E mi congeda. Esco con un modulo incompleto in mano. E ora che faccio, penso. Inizio a camminare perso in pensieri tutt’altro che sereni e, senza accorgermene, arrivo al quartiere popolare dove sono nato e cresciuto. Il casermone di cemento è lì, sempre più vecchio e macchiato. Guardo al quarto piano, quella finestra della cucina dalla quale mia madre chiamava per la cena, interrompendo le nostre partite di calcio, qui al campetto. Ora non c’è più mia madre e non c’è più il campetto, solo un grande parcheggio, nero asfaltato. E in quel momento mi cade addosso tutta la solitudine di questo mondo. Ma che ci sto a fare qui? Sono solo e a nessuno importa niente di me. Tengo ancora il modulo per la richiesta di sussidio in mano, l’accartoccio e lo scaglio a terra con un "‘fanculo!". Da una cabina telefonica chiamo un taxi. Arriva e mi faccio portare al bar "da M." Trovo lì R. e F. che come mi vedono mi abbracciano, mi fanno sedere alloro tavolo e mi offrono da bere, tra un "quando sei uscito…?", "racconta dai…", "hai bisogno di soldi?" e "abbiamo lavoro per te!" il senso di solitudine è sparito. Per farla breve, dopo 67 giorni, ad un posto di blocco, nel baule della macchina hanno trovato armi e passamontagna. Quattro anni e mezzo, ha detto il giudice… quattro anni e mezzo! "Non dici niente?". S’accende una sigaretta, s’avvicina alla finestra e soffia il fumo fuori, attraverso le sbarre. Lo guardo, è di spalle, mentre osserva l’esterno e penso. "Io ti conosco G., so che non sei un cattivo ragazzo, so che avevi veramente intenzione di rigare dritto e sistemarti nella tua città. Chi non ti conosce dirà senz’altro che alle prime difficoltà ti sei arreso, che non eri veramente intenzionato a cambiare vita; quella persona lo penserà stando nella sua casa e avrà una sua famiglia, avrà parenti ed amici. Non avrà mai provato a dormire in un dormitorio pubblico, non avrà mai dovuto vivere 60 giorni con 270 mila lire, non avrà mai provato a rimanere senza lavoro né la sensazione che può dare la vera solitudine, un senso di: perduto irrimediabilmente, un senso d’inutilità esistenziale. Quella persona, ti giudicherà! Io ti conosco G…". "F. scenda in rotonda 2!", mi distoglie da questi pensieri l’agente aprendomi il cancello… Prostituzione Lory - Mi chiamo Lory e sono nigeriana Testimonianza tratta da Progetto – Sermig Torino, gennaio 2004 Siamo in 5 tra fratelli e sorelle e io sono la più grande. Facevo la parrucchiera e i soldi non bastavano mai: non bastavano per l’affitto, non bastavano per la retta della scuola, a volte non bastavano per mangiare tutti. Il sogno di quasi tutti i ragazzi e le ragazze è quello di partire per l’America o per l’Europa per essere felici, per guadagnare un po’ di soldi e aiutare la propria famiglia. Un giorno nel negozio in cui lavoravo è arrivata un signora che mi ha detto: “Sei giovane cosa fai qui? Perché non vai in Italia? Ti aiuto io, conosco un ristorante in cui potresti andare a fare la cameriera. Ti anticipo i soldi per il viaggio aereo e poi tu me li restituisci col primo stipendio”. Ne ho parlato a casa ed è sembrata a tutti una cosa buona. Ho viaggiato per 7 mesi col fratello della signora che avevo conosciuto, all’inizio in macchina, poi ho fatto tanti chilometri a piedi e poi in nave, poi ancora a piedi. Una volta arrivata in Italia, a Torino, mi ha portata a casa di una donna e mi ha lasciata lì, con altre ragazze che erano appena arrivate. In questo appartamento ho assistito ad un via vai di donne nigeriane: entravano, prendevano una o due ragazze e poi se ne andavano. Poi è arrivato il mio turno: si è avvicinata una donna poco più grande di me e mi ha portato a casa sua. Mi aveva comprato ma io ancora non lo capivo. Il giorno seguente mi ha dato dei vestiti da indossare per il lavoro: un costume da bagno, una gonna corta e, visto che era freddo, un cappotto. Abbiamo preso l’automobile e mi ha portato sulla strada dicendomi: “Ho pagato 100 milioni per farti arrivare fin qui e ora me li devi restituire tutti e in breve tempo e l’unico modo per fare tanti soldi in poco tempo è questo qui. Se provi a scappare o a parlare con la polizia faccio uccidere i tuoi fratelli”. Di giorno dormivo facendo i turni con le altre ragazze per potermi coricare su un materasso steso per terra. Nell’appartamento della “mamam” eravamo in 10: in una stanza 8 ragazze, nell’altra lei con il suo uomo. I soldi che guadagnavo dovevo consegnarli tutti, ma non tutti venivano conteggiati per estinguere il debito. Una parte veniva tolta per l’affitto dell’appartamento in cui stavo, una parte per il cibo, una parte per pagare il posto sulla strada, che a sua volta la mamam doveva pagare a chi stava “sopra” di lei. In mezzo allo schifo, con la voglia di uccidere e la voglia di morire ho lavorato su quella maledetta strada con il freddo nelle ossa e con la paura di chi incontravo. Ho preso anche botte e insulti. Ero lì insieme a ragazze nigeriane e rumene, albanesi e moldave, maggiorenni e non che, come me, erano venute in Italia perché sognavano di essere felici. Francesco Morelli - Le prostitute straniere, sono schiave o sono "donne povere in cerca di una vita migliore"? Di prostituzione abbiamo cominciato a parlare negli ultimi numeri del giornale, e siamo intenzionati a tenere aperta la discussione perché si tratta di un tema forte, su cui pesano vecchi moralismi e nuovi desideri di "ripulire" le nostre città Ottobre 2001 Le notizie che riguardano le donne immigrate spesso parlano di condizioni di schiavitù, di sfruttamento, e sono corredate da immagini sempre uguali: la polizia che effettua controlli, che carica le donne sui cellulari. Storie come queste, anche se aggiungono ben poco a quanto già sapevamo, riscuotono un innegabile interesse, in bilico tra la compassione e la morbosità, quindi vengono raccolte, sfruttate (a proposito di "sfruttatori"…) e proposte regolarmente da giornali e televisioni. Dietro questa facciata, fatta di luoghi comuni, c’è uno dei mondi meno conosciuti del disagio sociale, ma anche situazioni molto diverse tra loro. Si è cominciato a parlarne, in maniera meno banale, soprattutto da quando la legge sull’immigrazione ha introdotto la possibilità di assistenza e regolarizzazione per le donne straniere che decidono di sottrarsi alle organizzazioni che le ‘controllano’. Però, sulla dimensione del fenomeno dello sfruttamento sessuale, non sappiamo nulla di preciso. Livia Turco, per esempio, che è stata, assieme a Giorgio Napolitano, promotrice della legge sull’immigrazione, oltre che ministro della Solidarietà Sociale, sostiene che l’80% delle prostitute siano costrette a svolgere questa attività. Anche se il termine "costrizione" può essere interpretato in vario modo, questa percentuale è ritenuta eccessiva dal Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, che calcola in circa 3.000, il numero delle donne realmente sottoposte a "coercizione violenta", su un totale di 50.000 prostitute, tra le quali più della metà sono straniere ed esercitano l’attività prevalentemente sulla strada. In una posizione intermedia, si collocano i dati forniti dall’associazione "On The Road" (legata al C.N.C.A.. e alla Caritas), che parla di un 30% di prostitute vittime della tratta. È molto difficile capire quale di queste posizioni si avvicini di più alla realtà, ma personalmente sono propenso a credere al Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, quando afferma: "Crediamo di conoscere bene le donne che si prostituiscono. La maggior parte sceglie liberamente la prostituzione, che prima di significare sfruttamento e schiavitù significa autodeterminazione. Pensiamo alle nigeriane, che vengono nel nostro paese addirittura contraendo un debito. Per loro farlo significa cambiare un destino che altrimenti le condannerebbe alla miseria. Esodo, fuga, come altro indicare questa forte volontà di inseguire un sogno di libertà dalla fame? No, non le vediamo come schiave. Le vediamo come donne povere, questo sì, sfruttate in patria, che premono per entrare nelle nostre cittadelle, guadagnare denaro, molto denaro, ed in fretta: non è anche il nostro desiderio? E pensiamo alle donne dell’ex blocco sovietico, che spesso contattano chi fa la tratta per essere portate in occidente a prostituirsi. Senza generalizzare, non possiamo nasconderci che queste donne, tra le più scolarizzate d’Europa, chiedano di entrare nei nostri paesi per guadagnare". Questa, invece, è la posizione di Livia Turco: "Le cifre ci dicono che oggi abbiamo all’80 % prostitute per costrizione. Certo, non sono tutte schiave. Quanto alla libera scelta non entro nel merito. So che ci sono donne che scelgono quella strada e le rispetto, anche se soggettivamente non condivido. Voglio dire che, da un punto di vista morale, io non penso che sia una libera scelta. Ma la riconosco oggettivamente. Il problema però è che oggi abbiamo una stragrande maggioranza di prostitute per forza, con vari gradi di coercizione, dai casi di vera e propria schiavitù a quelle che sono nel giro della criminalità anche se con degli spazi di manovra". C’è un elemento, in questo dibattito, che mi fa propendere per le posizioni del Comitato: quasi tutte le donne immigrate arrivano vengono da situazioni di povertà, comunque di difficoltà personale, causata da motivi diversi. Gli uomini, quando si trovano in situazioni analoghe, ricorrono più spesso delle donne a mezzi illegali per cercare di emanciparsi, di raggiungere il benessere che altrimenti non vedono alla loro portata (almeno in tempi brevi). Se in carcere ci sono oltre 50.000 uomini e circa 2.000 donne, a mio parere significa anche che la prostituzione rappresenta una ‘opportunità’, per coloro che vivono situazioni particolari di disagio e vogliono, o hanno bisogno, di guadagnare parecchio denaro in tempi brevi. Per ragioni culturali, le donne possono scegliere più facilmente questa strada, mentre gli uomini scelgono prevalentemente di dedicarsi ad attività illecite, lo spaccio di droghe, innanzi tutto. Un altro elemento avvalora questa ipotesi: se consideriamo soltanto le persone detenute per motivi non legati al denaro, vediamo che la presenza femminile è molto più consistente rispetto al totale dei carcerati: esempi significativi ne sono il terrorismo e i delitti consumati in famiglia. Invece, nella criminalità organizzata di tipo mafioso, il meccanismo è diverso: in quell’ambito la donna ha un ruolo preciso, deve stare nell’ombra, mentre ad agire, a mettere quindi in gioco la libertà e, a volte, pure la vita, sono quasi sempre gli uomini. Tra gli immigrati, è quasi assente la figura della donna che svolge attività illegali in Italia: tutt’al più, ci sono donne che fanno le "corriere" della droga, ma difficilmente quante sono già in Italia vengono arrestate per spaccio, o per altri reati (fanno eccezione le nomadi, anche in questo caso per motivi specifici della loro cultura). In definitiva, penso che la maggior parte delle prostitute scelga volontariamente (anche se, magari, non del tutto "liberamente") di svolgere queste attività, magari rischiosa, o degradante, (o anche "comoda", a seconda dei punti di vista), ma che a loro sembra comunque migliore rispetto alla vita che svolgevano nei paesi da cui provengono (o alla situazione in cui si trovano, per quanto riguarda le italiane, spesso in difficoltà economiche, o tossicodipendenti). E, soprattutto, fanno questa scelta in alternativa ad altre prospettive del tutto illegali, che comporterebbero il rischio del carcere e di un ritorno al punto di partenza, cioè nel disagio economico, sociale, personale. Aleksandar Stefanovic - La grande fuga dall’Est Oggi tutti sono disposti ad ascoltare le storie di donne-schiave redente e salvate, ma sono tante le donne che hanno scelto consapevolmente di liberarsi in fretta dalla miseria, anche prostituendosi Febbraio 2002 La testimonianza di Aleksandar è "dura" perché, di questi tempi, non è molto facile dire: le donne che arrivano dall’Est per prostituirsi molto spesso lo fanno consapevolmente. È più facile pensare che siano tutte schiave, ma è più onesto misurarsi con la realtà, e cercare di capire cosa succede davvero, lasciando da parte i moralismi e le storie edificanti. Le schiave ci sono, senza dubbio, le donne costrette a vendersi anche, ma la vita è sempre più complicata delle favole. E allora, qualche volta, è meglio dire come stanno le cose: che tante ragazze dell’Europa dell’est scelgono di battere le strade delle nostre città perché sanno che è la via più dura, ma anche la più veloce per uscire in fretta dalla miseria. Torniamo a parlarne perché pensiamo che non tutte queste donne, forse, vogliono essere "salvate", ma che a tutte va offerta una alternativa alla strada. Negli ultimi anni il problema della prostituzione viene trattato insistendo, con un senso di forte allarmismo, sulla questione delle donne-schiave tenute prigioniere e sfruttate dai loro protettori. E tutto questo si basa soprattutto sulle testimonianze delle ragazze più sfortunate, sulle indagini della Polizia, sui racconti di chi (associazioni, amministrazioni pubbliche etc.) si occupa di queste donne, e tutto sembra scritto da un unico giornalista o regista. La storia viene spesso accettata e venduta sotto forma della favola triste delle Cenerentole del nuovo millennio, poiché questo approccio fa comodo alla società, mentre quasi nessuno mostra interesse per la vera natura del fenomeno. Io vengo da un paese dell’Est europeo e ho una certa conoscenza del mondo della prostituzione, e ritengo che sarebbe ora di dire qualche parola di verità in più. È senz’altro vero che alcune di queste ragazze sono state portate via dal loro paese con l’inganno e, dopo una serie di maltrattamenti, sbattute sul marciapiede, ma credo vada chiarito che si tratta di una minoranza, mentre per la maggior parte le cose stanno così: la caduta del muro di Berlino, la fine del comunismo e l’arrivo della democrazia hanno trasformato la classe media borghese dei paesi dell’est in una cosa incomprensibile ed inspiegabile per la gente della ricca Europa occidentale. In poche parole, una buona fetta di popolazione si è trovata nelle condizioni che non le consentivano di acquistare il pane e il latte quotidianamente, per non parlare di altre cose meno necessarie, ma sempre importanti. I paesi come Ucraina, Romania, Moldavia e le parti della ex Jugoslavia distrutte dalla guerra sono stati colpiti in modo particolarmente duro. Basti pensare che un salario mensile valeva fino a poco tempo fa 10.000-15.000 lire. Gli investitori provenienti dall’occidente, soprattutto dall’Italia, potevano così acquistare a buon prezzo le fabbriche fallite, assicurando agli operai qualche briciola in più rispetto alle aziende pubbliche, ma tutto questo non permetteva un tenore di vita decente. Loro, gli stranieri, avevano portato però il sogno americano, sogno di una bella vita, e tutti cominciavano a parlare del denaro facile che si poteva guadagnare in Europa, che calcolato nelle valute locali suonava come una cifra astronomica. Tutto questo ha spinto al grande esodo. La prima ondata verso l’occidente era composta da donne di una "certa esperienza" nel campo. La stragrande maggioranza è venuta in Italia per un semplice motivo: la legge del mercato. Dopo pochi mesi molte tornavano con delle valige gonfie e una quantità di denaro inimmaginabile per i comuni mortali. Questo ha spinto anche le cosiddette "ragazze per bene" a pensare che partendo per un certo periodo, dimenticando la vergogna, l’educazione cristiana, la famiglia, avrebbero potuto tornare con una base economica sufficiente per iniziare una vita "normale". Un’industria ben collaudata per andarsene dalla miseria dell’Est Il fenomeno nel frattempo aveva cominciato a mostrare un aspetto imprevisto: molte di queste ragazze non tornavano, scomparivano oppure finivano come cadaveri sfigurati, storie tragiche per le quali la Polizia non trovava quasi mai un colpevole. Questi fatti hanno contribuito alla comparsa di gruppi di maschi, provenienti dalla stessa miseria, che vedevano la possibilità di un guadagno facile offrendo loro una protezione dai clienti violenti, organizzando i viaggi all’estero e l’ingresso nel paese per il quale occorreva un visto. Quasi tutti venivano in Jugoslavia per procurarsi i documenti, poiché grazie ad essi ottenevano lo status di profughi, allontanando così il pericolo di espulsione. Una città vicino a Belgrado, di nome Pancevo, era diventata un vero e proprio centro di reclutamento per le ragazze e i ragazzi, cosiddetti body guard, provenienti quasi esclusivamente dalle fila di ex sportivi, che nel vero senso della parola dovevano proteggere le ragazze, salvando molte volte le loro vite. Bisogna anche dire che l’aggravarsi della crisi economica faceva aumentare il numero di persone interessate ad andarsene all’estero. Ovviamente la parte del leone apparteneva a coloro che organizzavano queste donne e trovavano loro un "posto di lavoro" (un pezzo di marciapiede di una delle metropoli europee), con la garanzia di non essere disturbate nella loro attività. Vedendo la possibilità di enormi guadagni (media di un milione al giorno), vedendo che a volte c’erano anche clienti che offrivano il matrimonio e la salvezza, molte di loro hanno deciso di voltare pagina. Alcune poi sporgevano denunce alla Polizia, a volte basate su storie almeno in parte inventate, ottenendo in cambio il permesso di soggiorno. Così evitavano l’obbligo di versare la somma concordata prima della partenza dalla miseria (leggi: paese d’origine), dalla quale da sole non sarebbero mai potute uscire. Una volta sistemate tornavano ad esercitare il mestiere, dopo aver cambiato città, poiché potevano contare su una certa esperienza e spesso anche sulla protezione di qualche poliziotto in cambio di qualche favore. In carcere finivano sempre pesci piccoli, mentre i veri capi restavano e restano tuttora fuori dalla portata delle reti della giustizia, grazie soprattutto alla corruzione ben radicata nei paesi dell’est. A fianco di storie di violenza e sfruttamento, c’è dunque anche una realtà molto diversa, una vera e propria industria, ben collaudata, nella quale le parti conoscono bene le proprie posizioni, anche perché il livello di istruzione delle ragazze dell’Est europeo è molto spesso elevato, e quindi la storia dell’inganno nella maggior parte dei casi è da scartare. E poi è umano, è comprensibile che pochissime di loro accetterebbero di lavorare in condizioni pesantissime, faticare e logorarsi per una cifra alla quale possono arrivare in un solo giorno. Omicidi Graziano Scialpi - Nella testa di un uomo che ha ucciso Il racconto “in diretta” di cosa significa finire dietro le sbarre con un grave delitto che pesa sulla coscienza. Durante gli incontri con i detenuti, molti studenti hanno chiesto com’è l’impatto con il carcere, senza poter ricevere una risposta esauriente a causa dello scarso tempo a disposizione Febbraio 2005 Da quando ho iniziato a fare un giornale in carcere, e a discutere con i detenuti assolutamente di tutto, senza tabù, paure, chiusure, ho cominciato anche a misurarmi in modo diverso con l’“altra” informazione, quella fatta da giornalisti professionisti, e non, come Ristretti Orizzonti, da dilettanti. Una prima considerazione che mi viene in mente è che, avendo intorno, durante le riunioni di redazione, molte persone che hanno ucciso qualcuno, e spesso anche qualcuno di molto vicino, nelle loro famiglie, ho sentito da subito quanto sbagliato sia il concetto di “mostro” applicato automaticamente a chi uccide. La vita, per fortuna, è una cosa così complessa, che riserva sempre delle grandi sorprese a chi tenta di semplificarla. Eppure basta accendere la televisione per essere bombardati ogni giorno da notizie su omicidi, e in particolare omicidi in famiglia, dove chi uccide viene descritto come una specie di mostro lucido e spietato che brinda in cella se gli viene ridotta la pena (vedi caso Jucker). E questa idea è ben radicata anche nella testa di molti studenti che, negli incontri con i detenuti, quando chiedono “Ma tu perché sei dentro” e vorrebbero sapere il reato commesso, fanno capire che secondo loro un uomo che ha ucciso non può avere sconti di pena né benefici, e che uccidere ti mette fuori dalla società per sempre. Quella che segue è una testimonianza, per certi versi agghiacciante, di quello che succede “dopo”, dopo che un uomo fino a quel giorno assolutamente “regolare” (in questo caso, faceva proprio il giornalista) ha ammazzato una persona della sua famiglia e si ritrova, di colpo, nell’orrore della sua testa impazzita, della sua coscienza e del carcere. La pubblichiamo perché almeno qualcuno di quelli che parlano facilmente di “mostri” possa fare un salto sulla sedia leggendola, e sentirsi lo stomaco torcere non per l’orrore, ma per un po’ di vergogna per certi giudizi sommari. Ornella Favero - Redazione di Ristretti Orizzonti È il 21 dicembre, ed è sabato. Le strade sono invase da gente che si affanna da un negozio all’altro per gli acquisti di Natale. L’auto dei carabinieri corre come se rinchiudermi in carcere sia una questione di vita o di morte. Le gomme stridono e l’autista impreca mentre l’Alfa Romeo scansa strombazzando i pedoni che scendono dal marciapiede nella corsia preferenziale per superare gli ingorghi davanti alle vetrine. Registro ogni particolare senza emozione. Mi sento come un fantasma che vede continuare intorno sé una vita di cui non fa più parte. Il mio unico desiderio è raggiungere la prigione. Non mi interessa altro. Sono talmente concentrato sulla mia destinazione che riesco ad bloccare i pensieri, le immagini, le emozioni che sento premere con una prepotenza feroce. Non potrà funzionare ancora a lungo, ma non mi preoccupo. Prima che prendano il sopravvento troverò una soluzione drastica e definitiva. Ho le mani ammanettate dietro la schiena; a ogni sterzata vado a sbattere contro le portiere, a ogni frenata vengo proiettato addosso ai sedili anteriori. Il carabiniere al volante sta ripassando a mio beneficio l’intero corso di guida estrema. Con un’inchiodata ci fermiamo davanti al portone del carcere. Sbatto per l’ultima volta contro i sedili anteriori e mi raddrizzo: sono arrivato. Forse ora potrò trovare un po’ di quiete dopo questa giornata allucinante. I carabinieri aprono le portiere e mi fanno scendere. Prima di salire i quattro gradini che conducono al portone mi volto e osservo le vetrine e le decorazioni luminose. Mi riempio i polmoni dell’ultimo respiro di libertà. Ho la certezza che di lì non uscirò vivo, sto entrando nel mio sepolcro. Uno dei due carabinieri, il più giovane, coglie il gesto e si blocca. È un nanosecondo di acuta empatia. Mi guarda negli occhi e sembra che qualcosa sia dando una spallata alla sua bocca. Ma una simile parola non esiste, non può essere pronunciata. Gira lo sguardo verso il portone e riprende a camminare. Saliamo i gradini e passiamo sotto l’arco del metal detector con il cartello giallo che avvisa i portatori di peace maker che il loro cuore potrebbe fermarsi e attraversiamo il primo cancello. Riconosco l’atrio con la corona d’alloro sotto la lapide sulla parete di sinistra che ricorda le guardie di custodia massacrate nel 1945. Sono già stato qui per lavoro. I carabinieri mi fanno svoltare a destra, lungo uno stretto corridoio, fino all’ufficio matricola. Davanti al bancone mi tolgono le manette. Mentre compilano i moduli per il passaggio di consegne, continuo a guardare in giro: alcune scrivanie, dei vecchi schedari, calendari delle forze dell’ordine appesi al muro scrostato. Il mio sguardo si ferma su un attaccapanni d’acciaio dal quale penzolano tre lunghi sfollagente neri. Tornerò decine di volte in quel ufficio, ma non vedrò mai più manganelli. Anzi non li rivedrò più in assoluto, nemmeno durante le proteste. Ma queste cose non le so ancora. Penso che siano una dotazione standard. Non immagino che la loro sia una misura eccezionale presa in mio onore, nella previsione di un’accoglienza “movimentata”, basata su chissà quali voci che hanno preceduto il mio arrivo. Nel frattempo i carabinieri hanno sbrigato tutte le formalità burocratiche, salutano i colleghi e se ne vanno. Forse anche loro devono comprare i regali di Natale. Da questo momento sono “proprietà” del carcere. Nelle ultime ore il mio unico pensiero era arrivarci… ora che ci sono mi rendo conto di non avere idea di cosa mi attende. Forse, ora che i carabinieri non ci sono più, quegli sfollagente verranno usati per insegnarmi le regole della galera. Forse per gli assassini è riservato un trattamento speciale. In ogni caso il pensiero non mi turba, anzi, quasi mi attrae. Mi sento come avvolto in un bozzolo di nauseante irrealtà. Magari un po’ di manganellate potrebbero rompere il guscio e riportare le mie sensazioni a una parvenza di normalità. Magari mi sveglio e scopro che è stato tutto solo un orrendo sogno. Ma gli sfollagente rimangono sull’attaccapanni. Il sovrintendente invece mi invita a firmare le ricevute per i miei effetti personali e per le duecentomila lire che ho nel portafoglio. Quando prendo la penna mi accorgo che la mano trema. Anzi, no, tremare non è il termine esatto. Quando cerco di usarla si muove a scatti irregolari come se fosse dotata di una volontà propria. Devo tenerla con la sinistra per riuscire a fare uno scarabocchio sul grosso registro dalla copertina di tela grigia. Quindi mi prendono le impronte digitali e mi scattano le foto con una Polaroid. Foto di fronte, foto di profilo e poi mi fanno girare faccia al muro e scattano parecchie foto anche ai punti di sutura che ho sulla nuca, dove un carabiniere mi ha colpito una mezza dozzina di volte con il calcio della pistola nel vano tentativo di tramortirmi. Questa precauzione mi fa pensare che forse, dopotutto, non verrò bastonato. Ma la cosa mi lascia indifferente. E poi ci sono molti modi di picchiare senza lasciare segni. Terminate le foto il graduato mi dice bruscamente di togliermi cintura, lacci delle scarpe e cravatta. In pochi secondi mi libero di cintura e lacci e li poggio sul bancone, ma non riesco a togliere la cravatta. Il sangue, il mio sangue che ha impregnato il nodo si è ormai seccato e, per quanto mi sforzi con le dita tremanti, non riesco ad allentarlo. Lo spiego al sovrintendente e all’agente che sono in attesa e li prego di tagliare la cravatta con le forbici. I due si guardano perplessi e tergiversano. Il sovrintendente obietta che la cravatta si rovinerà. Rispondo che comunque è da buttare. Con molta cautela i due agenti escono da dietro il bancone, mi si avvicinano e la tagliano facendo passare delle lunghe forbici nei pochi millimetri che separano la tela dal mio collo. La loro preoccupazione non è per la cravatta. Non vorrebbero avvicinare le forbici alla mia portata, ma non hanno scelta: la cravatta deve essere tolta. Una volta risolto il problema della cravatta, sorge quello degli occhiali. Gli agenti me li fanno togliere e studiano con attenzione le leggere lenti di vetro al titanio. Mi chiedono speranzosi se posso farne a meno, rispondo che senza di essi non ci vedo. Altro scambio di sguardi perplessi, ma non c’è verso; anche se non vorrebbero, gli occhiali da vista devono lasciarmeli. Le procedure sembrano terminate e il graduato mi riaccompagna nell’atrio. Secondo le norme della buona educazione mi faccio da parte per lasciarlo passare. Ma lui mi dice bruscamente di camminare. Altra regola base del carcere: l’agente non deve mai dare le spalle al detenuto, che deve sempre precederlo. Impiegherò parecchio tempo per liberarmi dell’abitudine cortese di cedere il passo. Attraversiamo l’atrio fino a raggiungere un cancello speculare al portone d’entrata: è di ferro rinforzato da longheroni e dipinto di blu, l’unica apertura è uno spioncino di dieci centimetri sulla porticina al centro, serve per controllare chi vuole uscire, non chi entra. Un agente apre il cancello ed entriamo in uno spazio di un paio di metri quadrati, di fronte c’è un altro cancello, a sinistra una scala di pietra che sale ai piani superiori. Vado verso il cancello, ma mi dicono di andare a destra ed entro in una stanzetta male illuminata da una lampadina nuda da pochi watt che penzola dal soffitto. I muri sono scrostati e riscoperti di scritte e di segni neri lasciati dallo spegnimento di sigarette. Al centro della stanzetta c’è una sorta di paravento di compensato che un tempo doveva essere verniciato di grigio, sul pavimento una pedana di legno. L’idea della bastonatura di benvenuto riprende vita, sembra proprio il luogo adatto. Entro senza esitare e aspetto i colpi, ma mi viene ordinato di togliermi tutti i vestiti. Mi spoglio senza protestare e consegno i vestiti all’agente munito di guanti usa e getta, che li controlla, passando le dita anche lungo le cuciture. Quando sono completamente nudo il graduato mi ordina di fare le flessioni. Obbedisco e mi piego in avanti fino a toccare con le mani per terra. Lui scoppia a ridere e mi chiede se è la prima volta che entro in galera. Alla mia risposta affermativa mi spiega che devo allargare leggermente le gambe e poi accucciarmi sui talloni e rialzarmi per due o tre volte. Eseguo l’ordine. Quindi mi fa spalancare la bocca e spostare la lingua di lato e infine mi fa alzare le braccia per controllare sotto le ascelle. Posso rivestirmi. Però mi riconsegnano solo le mutande, le calze, le scarpe e i pantaloni. La giacca, la camicia bianca e anche la canottiera sono zuppe di sangue rappreso. Non mi ero reso conto di averne perso così tanto. In ogni caso le ficcano in un grosso sacco per le immondizie di plastica nera. L’agente esce dallo stanzino e rimango solo con il sovrintendente. Sono a torso nudo, fa molto freddo e tutto lo stress e gli shock della giornata mi stanno crollando addosso. Inizio a tremare. Il sovrintendente se ne accorge e mi intima più volte di stare calmo. Avverto un certo allarme nella sua voce e cerco di spiegargli di non avercela con lui. “Ah, meno male!” è il suo commento. Continuo a tremare e non riesco a fermarmi. Poco dopo ritorna l’agente e mi porge una felpa grigia. La infilo e i due agenti mi fanno uscire dallo sgabuzzino. Passiamo l’altro cancello. Mentre percorriamo il corridoio, reggo i calzoni con la mano sinistra e trascino i piedi, un po’ per non perdere le scarpe senza i lacci, un po’ perché le gambe mi stanno cedendo. Alla fine del corridoio mi fanno girare sinistra. C’è una rampa di scale con i gradini di pietra. Inizio a salirla. Ad ogni piano mi fermo e guardo gli agenti, che mi fanno cenno di proseguire, fino al terzo e ultimo piano. Di fronte alla scala un piccolo atrio, a sinistra il cancello tinto di verde che dà accesso a un corridoio di celle, di fronte l’infermeria. Mi fanno entrare. Il medico è piuttosto brusco, mi chiede i dati anagrafici, le malattie che ho avuto, dà un’occhiata alla ferita che ho sulla nuca e, infine, mi porge un bicchiere usa e getta con dentro del liquido. Lo bevo, dal sapore potrebbe essere Valium o qualcosa del genere. La “visita” dura in tutto un paio di minuti. Gli agenti mi riportano dabbasso. Sono a digiuno da almeno ventiquattro ore e quello che mi ha propinato il medico inizia immediatamente a fare effetto. Le gambe diventano sempre più pesanti. Scendo le scale lentamente e trascino i piedi. Il fatto di rischiare di perdere le scarpe a ogni passo non mi aiuta. Torniamo al piano terra e mi fanno girare a sinistra. Dopo pochi passi ci fermiamo davanti al cancello del reparto di isolamento. Un graduato esce da uno stanzino a sinistra del cancello e lo apre. È l’assistente di servizio nel reparto, a differenza degli altri agenti, indossa una mimetica grigia con gli anfibi. Mi fa cenno di precederlo lungo i corridoio, ma non sono abbastanza veloce per i suoi gusti, così mi spintona alla schiena usando la lunga chiave di ottone. Ma io continuo a trascinare i piedi. Mentre avanzo avverto la presenza dei detenuti affacciati sulla porta delle celle che si aprono ai miei lati. Percepisco i loro sguardi, ma non alzo la testa. Non ho la voglia né l’energia per sostenere qualsiasi tipo di confronto. Mi sento come uno di quei disertori o traditori del passato che, spogliati della divisa e umiliati, venivano fatti passare tra due file di loro commilitoni. Vorrei che quella sfilata terminasse, ma la mia cella è proprio l’ultima. Si trova a destra, in una specie di rientranza del corridoio. Di fronte ci sono la porta delle docce e la scrivania dell’agente. L’isolamento è l’unica sezione al cui interno è presente un agente ventiquattr’ore su ventiquattro. Mi fermo di fronte alla cella mentre l’agente armeggia con la serratura. Il cancello è dipinto con vernice verde scuro, mentre il blindato è color beige. Alzo gli occhi e sopra la porta vedo una targa verde con dentro scritto in bianco 8 G.S. Significa Grande Sorveglianza, ma sono anche le mie iniziali e per un attimo riconsidero l’intera mia vita come un percorso predestinato che mi doveva condurre qui, dove una cella col mio nome mi aspettava. Mentre il cancello si richiude con fragore alle mie spalle osservo la stanza: sarà lunga tre metri e larga meno di due. Sul lato sinistro, fissata sia al muro che al pavimento, c’è la branda di acciaio verniciato d’arancione. Nello spazio che avanza tra la branda e il muro su cui si apre la porta è incastrato un lavabo d’acciaio con sopra uno specchio incollato alla parete. Di fronte al lavabo, incastrato nell’angolo opposto, un water anch’esso d’acciaio. Sul soffitto, che sarà alto almeno tre metri, c’è una telecamera, puntata proprio sul water. La finestra, piccola e dotata di un vetro opaco che si apre a compasso solo per pochi centimetri, è piazzata al livello del soffitto. I muri, fino a un metro e mezzo d’altezza, sono dipinti con una vernice lavabile color beige. Ovunque ci sono schizzi di quella che presumo essere minestra. Sul lavabo è poggiata una ciotola di plastica ripiena di quello che sembra essere passato di piselli, dentro è immerso un cucchiaio di plastica: la mia cena. Nella cella non c’è niente altro, né uno sgabello, né un tavolino, né un armadietto. Ho perso l’olfatto a diciotto anni e mi chiedo che odore possa esserci. Non deve essere piacevole. Mi avvicino alla branda, sul ripiano d’acciaio bucherellato è poggiato un materasso di gommapiuma ingiallita dagli anni e sul materasso un cuscino di gommapiuma altrettanto vecchio. Mi siedo sul materasso e inizio ad aspettare. Non so che ora sia. Ho perso l’orologio quando mi hanno ammanettato. Mentre siedo a testa bassa comincia un viavai di agenti davanti alla porta della cella. Arrivano da soli o a coppie, mi osservano per qualche secondo, bisbigliano qualcosa tra loro e se ne vanno. Non so cosa abbiano detto in televisione, ma sembra che vengano a dare un’occhiata alla “celebrità”. Mi sento come un animale allo zoo, e forse è quello che sono diventato. Certo non sento più di far parte del consorzio umano. Ho oltrepassato una barriera che non consente di tornare indietro. Arriva anche il direttore del carcere. Ci conosciamo, l’ho intervistato un paio di volte. Non so dove trovo la forza, ma mi alzo e lo saluto. È visibilmente sconvolto e mi chiede cosa è accaduto. Gli rispondo che ho combinato un guaio enorme e che è giusto che paghi. Annuisce e se ne va. Spero di averlo sollevato dall’imbarazzo di dovermi spiegare che la nostra conoscenza precedente non conta più nulla e che non devo aspettarmi altro che di essere trattato come un qualsiasi detenuto. Se ci sono riuscito almeno avrò fatto qualcosa di decente in questo giorno da dimenticare. Mi sembra di aver già dato fin troppo disturbo al mondo intero. Non appena in direttore se ne è andato arrivano un agente e un detenuto che porta sulle braccia una specie di pacco. Sono la coperta e le lenzuola. Il nuovo arrivato discute per qualche minuto con il suo parigrado in servizio alla sezione. Non sanno bene cosa fare. Alla fine decidono di consegnarmi una vecchia coperta di tipo militare color marrone scuro e con le lettere AP bianche e la federa del cuscino, ma non le lenzuola. Dormirò senza lenzuola per sette mesi. Infilo il cuscino di gommapiuma nella federa, sistemo alla meno peggio la coperta sul materasso e torno a sedermi sulla branda. Chissà che ora è… non devono essere più delle otto di sera. Eppure mi sembrano passati secoli da quando sono uscito di casa questa mattina. Anzi, da quando la persona che ero e che non esiste più è uscita di casa. Quello che mi ha dato il medico mi intontisce, ma non abbastanza. Non so cosa fare, non so come comportarmi. Non ho nemmeno fame, ma prendo la ciotola con il passato di piselli e la mangio lentamente. È fredda e insapore, ma devo fare qualcosa, qualsiasi cosa che mi impedisca di mettermi a pensare a quello che è successo, a quello che ho fatto. Ma c’è solo una cosa sensata a cui posso dedicarmi: devo trovare il modo di portare a termine quello che non sono riuscito a fare quando mi hanno arrestato. Devo riuscire a porre fine a questa situazione che non sono in grado di affrontare. Perlustro la cella con lo sguardo attento di chi ha uno scopo. Niente da fare: è completamente nuda. Non c’è nulla che possa aiutarmi ad uccidere quello che resta di me. Impossibile stracciare la coperta e farne una corda e, anche se fosse possibile, non vedo dove potrei fissarla. Però mi hanno lasciato le calze. Sono lunghe fino al ginocchio e posso ricavarne un cordone robusto. Se ne faccio un anello ritorto da fissare alla spalliera della branda e poi ci faccio passare il collo, sedendomi a terra posso riuscire a strangolarmi. Funzionerebbe, ma ci vuole troppo tempo. Non è come saltare da uno sgabello con un nodo scorsoio che ti spezza le vertebre cervicali. Occorrerebbero parecchi minuti prima di morire, non è certo il modo migliore per farla finita. A preoccuparmi non è la sofferenza fisica e neppure l’eventualità un ripensamento dell’ultimo secondo, ma il fattore tempo. L’agente che sta di fronte alla porta della mia cella avrebbe tutto il tempo di intervenire. Per quanto ne so non si assenta mai. E se si assenta lo fa solo per pochi minuti. E poi c’è sempre la telecamera sul soffitto. C’è qualcuno che osserva il monitor in continuazione? Devo darlo per scontato. L’idea di strangolarmi con le calze deve essere scartata. L’unica altra possibilità che riesco a vedere è la piccola finestra. Salendo sul letto dovrei riuscire a raggiungerla. Anche se il vetro è spesso sono sicuro di riuscire a sfondarlo con un pugno. Ho spezzato tavolette di legno spesse tre centimetri, non può essere tanto più robusto. Il piano è semplice: se l’agente si assenta salto sulla branda, rompo la finestra, afferro una grossa scheggia di vetro e me la conficco nella giugulare, magari arrivo fino alla carotide. Non occorrerebbero più di trenta secondi. Anche se qualcuno mi osserva dalla telecamera farebbe appena in tempo a lanciare l’allarme. Potrei farlo anche subito, ma un dubbio mi frena: e se non fosse vetro? A guardarlo sembra proprio vetro, ma è possibile che dopo avermi negato le lenzuola mi abbiano lasciato una possibilità di armarmi così facile e scontata? Se fosse un materiale infrangibile speciale che accadrebbe? Come reagirebbero agenti dopo avermi sorpreso a sferrare pugni come un forsennato contro la finestra? Cosa fanno in questi casi? Legano il detenuto alla branda? Gli mettono una camicia di forza? Non posso rischiare, devo andare sul sicuro. Pazienza, devo avere un po’ di pazienza. Riuscirò a trovare il modo di farla finita. È curioso, ma neppure una volta mi viene in mente che potrei usare le lenti degli occhiali. Forse la mia dipendenza da questo oggetto è tale che nel subconscio penso di averne bisogno anche per vedere chiaramente nell’aldilà. Chiedo all’assistente se posso avere una sigaretta. I due pacchetti di Camel che avevo con me e l’accendino li ho dovuti lasciare fuori dalla cella. Ho un bisogno disperato di fumare, ma non oso disturbare l’agente troppo spesso. L’assistente si alza, estrae una sigaretta dal pacchetto aperto, prende l’accendino e percorre i due metri che separano la scrivania dal cancello della mia cella. Si ferma un metro prima, allunga il braccio e poggia la sigaretta sulla finestrella rettangolare che serve a far passare i piatti. Prendo la sigaretta, la metto tra le labbra e schiaccio la faccia contro la finestrella tenendo le braccia lungo i fianchi. Sempre tenendosi a distanza l’assistente allunga la mano con l’accendino e mi fa accendere, quindi mi dice di lasciare il filtro sullo spioncino quando ho finito. Capisco che la procedura è studiata perché non possa afferrarlo, quanto al filtro so che bruciandolo con un accendino e schiacciandolo è possibile ricavarne una specie di lametta. Ma sarebbe buona tuttalpiù per farsi dei graffi, e poi non ho l’accendino. Aspiro il fumo con avidità nella speranza che mi possa dare un po’ di conforto, ma è inutile, la sigaretta mi sembra finire in pochi secondi, lasciandomi con un bisogno di fumare più forte di prima. Poso il mozzicone sullo spioncino e raggiungo la branda. Mi stendo e mi copro con la coperta. Impossibile avere un po’ di buio. La luce deve restare sempre accesa, il blindato deve restare aperto perché l’agente mi deve controllare continuamente e, anche dal corridoio, i neon inondano la cella della loro fredda luce bianca. Ma sono stremato e finisco con l’assopirmi. Mi sembra di aver appena chiuso gli occhi che un rumore mi sveglia. Apro gli occhi: è l’agente che sta battendo con la chiave d’ottone sulle sbarre della porta. Appena alzo la testa smette, si gira e torna alla scrivania. Voleva accertarsi che fossi vivo. Va avanti così tutta la notte, tutte le notti per non ricordo quanto tempo. Sonni di pochi minuti tormentati da incubi e interrotti dallo sbattere del metallo contro il metallo. Più volte mi alzo, bevo un po’ d’acqua e chiedo una sigaretta al nuovo agente che nel frattempo ha dato il cambio al collega. Lui mi guarda con sospetto e segue la stessa procedura della distanza di sicurezza. Chiedo che ora è, ma mi risponde di dormire. Non ribatto che non posso dormire perché appena mi assopisco è proprio lui a svegliarmi. La notte mi sembra interminabile. Ma alla fine dalla finestrella inizia a filtrare la luce del giorno. Devono essere circa le sette e mezza. Mi alzo dalla branda con sollievo e mi sciacquo la faccia. Già ieri sera ho scoperto con sorpresa che dal rubinetto esce anche acqua calda. Non ho un asciugamano e mi asciugo con il fazzoletto che ho in tasca. L’agente mi dice che devo pulire la cella. Gli chiedo come posso fare. Lui si rende conto che dovrebbe consegnarmi scopa e spazzolone, ossia armi potenziali, e glissa sulla domanda. Poi ci ripensa e mi consegna uno straccio per pavimenti dicendomi di arrangiarmi con quello. Lo bagno, lo strizzo e mi inginocchio sul pavimento strofinandolo con le mani. Fortunatamente la cella è piccola e me la sbrigo in pochi minuti. Sento nel corridoio lo sferragliare di un carrello e una voce che annuncia: “Lattee! Caffèè!”. È il detenuto della cucina che porta la colazione. Dopo qualche minuto arriva alla mia cella. È un marocchino ed è gentile. Mi consegna un sacchetto di plastica traforata con tre panini, due arance e poi mi chiede se voglio il latte e il caffè. Rispondo che prendo solo il caffè, ma non ho il bicchiere. Lui si allontana e torna poco dopo con un bicchiere di plastica bianca, lo riempie di caffè con un mestolo e se ne va. Lo sorseggio lentamente. È una broda iperallungata e quasi senza zucchero, ma è calda e mi sembra buonissima. Ho appena terminato di bere e sto risciacquando il bicchiere che sento rumore di passi in corridoio e l’aprirsi e chiudersi di cancelli. Dopo qualche minuto arriva davanti alla mia porta una pattuglia di quattro-cinque agenti capeggiati da un ispettore. L’agente in servizio nella sezione apre il cancello e la pattuglia entra nella cella, riempiendola. Io mi appiattisco contro la parete in fondo, mentre l’ispettore si guarda intorno con sospetto. Alla fine posa lo sguardo sul water e sbotta a urlare chiedendomi dove ho nascosto la tavoletta e il coperchio. Mi coglie di sorpresa. Ma, prima che possa giustificarmi in qualche modo, un agente bisbiglia all’orecchio dell’ispettore che in quella cella la tavoletta del cesso non c’è mai stata. L’ispettore grugnisce qualcosa ed esce seguito dal resto della pattuglia. È l’ispezione che viene effettuata ogni mattina alle otto in tutte le celle del carcere. Quando è in servizio quel particolare ispettore viene effettuata anche di notte, tra le due e le tre. Il rituale mattutino non è ancora terminato. Sono passati solo pochi minuti quando davanti alla cella si ferma un altro carrello. È spinto da un’infermiera in camice bianco, è vicina ai sessanta e mi sorride con simpatia mentre mi consegna una manciata di pillole bianche e arancioni. Chiedo di cosa si tratta. Ma l’agente mi intima di ingoiarle immediatamente e senza discutere. Non discuto. Prendo il bicchiere lo riempio d’acqua e mando giù le pastiglie. La stessa scena si ripete per tre volte al giorno: alle otto di mattina, alle tredici e alle otto di sera. Impiegherò otto mesi a convincere il medico del carcere a togliermi la “terapia” che è stata stabilita per me senza nemmeno visitarmi. Ogni volta che la prego di eliminare le pastiglie dalla mia dieta lei (il medico titolare è una donna) mi guarda con costernazione e mi risponde che deve consultare il comandante. Gli psicofarmaci (chissà quali… non lo saprò mai) mi vengono propinati non per la mia salute, ma per la tranquillità delle guardie. Più volte mi chiederò in seguito come possa continuare a sussistere il diritto alla difesa quando l’imputato in custodia cautelare viene condotto agli interrogatori dei pubblici ministeri intontito da quantità industriali di tranquillanti più o meno potenti e privato del sonno. A metà mattinata, davanti alla mia cella si ferma un ragazzo che regge una cassetta di plastica gialla piena di qualcosa su cui è poggiato un blocco per appunti. Ha circa trent’anni, è stempiato e ha un po’ di barbetta. Si presenta come S., è lo spesino del carcere, cioè il detenuto incaricato di raccogliere le ordinazioni e consegnare i generi che si possono acquistare tramite il “sopravvitto”. In pochi minuti mi fornisce le indicazioni generali sul funzionamento della spesa, anche se alla mia “testa libera” occorrerà qualche tempo per afferrarne tutti i principi. In ogni caso capisco che la spesa viene consegnata il martedì e il venerdì e che la mattina seguente, cioè il mercoledì e il sabato, devo consegnare l’ordinazione per la spesa successiva scritta su un foglio di carta o, meglio, su un apposito quaderno. Siccome sono arrivato sabato sera ho il diritto di avere un anticipo, cioè mi è concesso di fare l’ordinazione in ritardo. Ovviamente non ho né carta né penna, per cui devo dettargli l’ordinazione. Cerco di fare velocemente mente locale su quello che mi serve e inizio ordinando la schiuma da barba. Vengo subito bloccato: niente bombolette, solo tubetti di crema e il vecchio pennello. Allora ordino crema e pennello, dopobarba, rasoi usa e getta, una saponetta, spazzolino e dentifricio, e una stecca di Camel. Lo spesino mi informa che le Camel non sono disponibili. Resto un momento interdetto, fumo le Camel da oltre quindici anni e so per esperienza che qualunque altro tipo di sigaretta mi provoca tosse e acidità di stomaco. Non ho scelta, devo ripiegare sulle Marlboro. S. prende nota di tutto e se ne va. È l’unico detenuto che può girare quasi liberamente in tutte le sezioni della casa circondariale. Si fermerà spesso davanti alla mia cella per fare quattro chiacchiere in amicizia, per offrire un consiglio, per chiedermi come è accaduto il fattaccio, per capire cosa intende fare il mio avvocato. Tre anni più tardi si scoprirà che, a tempo perso, faceva l’informatore per la procura e che registrava le confidenze degli arrestati con un registratorino nascosto nella sua cassetta di plastica. La giornata trascorre come in un sogno, intervallato solo dal passaggio dal carrello del pranzo e della cena e da quello dell’infermeria che mi propina manciate di pastiglie multicolore. Nel frattempo faccio conoscenza con il mio dirimpettaio. Mentre sono seduto sulla branda a fissare il muro sento una voce che chiama: “Otto! Numero otto!”. Impiego qualche istante a realizzare che è il numero della mia cella e che la voce sta chiamando me. Dal mio cancello, che è situato in una rientranza del corridoio, posso vedere la porta di sole due celle dell’altro lato: la numero sei e la sette. È appunto dalla sette che un uomo sui 45 anni, portati molto male, sta chiamando il mio numero. Si chiama P. e ha ucciso sua madre a martellate. A suo dire stava cercando qualcosa che i cinesi le avevano innestato nel cervello. È evidente che non c’è con la testa. Non appena mi affaccio mi chiede balbettando se ho una sigaretta. Gli spiego che non me le fanno tenere in cella e che le ha l’agente nella scrivania. P. non si fa scoraggiare e chiama a gran voce il “superiore”. L’agente in servizio gli chiede cosa vuole e lui gli spiega che vuole una delle mie sigarette che sono nel cassetto della scrivania. L’agente mi guarda e mi chiede se glie la voglio dare. Alla mia risposta affermativa commenta che non mi conviene, ma io alzo le spalle. Solo più tardi capirò cosa intendeva dire, quando P. con la faccia incastrata nello spioncino del blindato non si farà problemi a chiamarmi a gran voce alle tre di notte per chiedermi una sigaretta. È malato di fumo. L’unico suo pensiero è fumare. Sta tutto il giorno e gran parte della notte affacciato alla porta, pronto all’agguato per scroccare una sigaretta a chiunque passi. Quando va al gabinetto non chiude nemmeno la porta, continua la posta stando seduto sulla tazza del water e se in quel momento passa qualcuno balza in piedi, tira su mutande e calzoni senza nemmeno pulirsi e cerca di scroccare la sigaretta. Quando si deve arrendere al fatto che non è possibile scroccare più niente a nessuno chiede all’agente una domandina, l’arrotola e fuma quella, se non ci sono nemmeno domandine fuma la carta igienica (ecco perché non la usa…) e in quei momenti i suoi colpi di tosse intervallati da conati di vomito squassano il carcere dalle fondamenta fino al tetto. Più tardi scoprirò che gode di una pensione di invalidità che riscuote mensilmente. Naturalmente la spende tutta esclusivamente in sigarette. All’inizio quando gli arrivava la spesa era “festa grande”. Però dopo che si è fumato una stecca di Alfa in meno di tre ore, facendo scattare l’allarme antincendio per la coltre di fumo che si sprigionava dalla sua cella, gli agenti gli sequestrano le sigarette e glie ne danno solo una all’ora. Troppo poco per una smania come la sua. A dire il vero in questo momento lo capisco bene. Nel timore di seccare le guardie, chiedo anche io una sigaretta all’ora. Ma è poco. Mi sembra di averla appena accesa ed è già terminata, lasciandomi con la voglia di accenderne immediatamente un’altra. Appena mi fermo mi riappare davanti agli occhi il corpo di mia cognata riverso a terra in un lago di sangue. Morta. Morta per causa mia. Sono stato io… Ancora stento a crederlo. Mi guardo le mani e non le riconosco, mi sembrano due protesi, due oggetti estranei. È una sensazione sgradevole. Terribilmente sgradevole, nauseante… Ho sempre pensato che l’espressione “si sentiva le mani sporche di sangue” fosse una di quelle frasi fatte abusate a sproposito. Ma quello che provo guardandomi le mani è peggio, molto peggio. È come guardarsi allo specchio e vedere la faccia di uno sconosciuto. Una brutta faccia.. No, è peggio ancora, perché conoscevo le mie mani molto meglio del mio volto. Sono sempre state le mani che ho avuto davanti agli occhi in tutto il fare della mia vita, non la mia faccia. E ora non le riconosco più. Lo specchio è andato in frantumi e mi sembra un’impresa impossibile rimettere insieme i frammenti. Al momento dell’arresto mi sono puntato la pistola alla tempia e ho tirato il grilletto. Il colpo non è partito, ma lo scatto del cane è risuonato come un gong che ha fatto vibrare fino all’ultima cellula del mio corpo. Un urlo di molecolare e primordiale di incredulità per quello che stavo facendo. Ma non sarà mai il suicidio fallito a turbare i miei sogni. Perché c’è di peggio. I primi giorni li trascorro in un bizzarro stato d’animo di attesa. Sono in cella e aspetto. Non so cosa, ma mi sembra che qualcosa stia per accadere, debba accadere da un momento all’altro. Il lunedì vengo chiamato dall’educatrice e poi dalla psicologa. Parlo con entrambe per una mezz’ora. Il resto del tempo aspetto. Aspetto che qualcun altro mi chiami, aspetto non so che cosa. Ogni tanto l’agente infila la chiave nella serratura e io scatto in piedi pronto ad andare. Ma lui sta solo controllando che sia ben chiusa a doppia mandata e mi guarda con aria interrogativa. È un atteggiamento paranoico comune a tutti gli agenti di tutte le carceri. Ogni mezz’ora passano di cella in cella a controllare che siano ben chiuse. Con il tempo imparerò a ignorare questo insistente sferragliare di chiavi, ma per il momento continuo a sobbalzare. E aspetto. Aspetto perché non riesco ancora a rendermi conto che la mia è una condizione definitiva e non provvisoria, non comprendo che la mia nuove normalità è stare seduto su quella branda a fissare il muro. Mi sono capitate troppe cose e troppo traumatiche e se la legge e io stesso non abbiamo pietà per quello che ho fatto, qualche altra parte di me cerca di proteggermi, impedendomi di prendere atto della realtà del mio stato troppo bruscamente. Intanto sto imparando qualcocosa che non sapevo: il carcere non è un luogo tranquillo e silenzioso. Tutt’altro. È un inferno di urla, richiami, cancelli che sbattono, serrature che sferragliano, carrelli che cigolano, gente che piange. Non c’è mai pace, nemmeno di notte. Ogni schianto di cancello, ogni chiave che entra in una serratura ogni rumore di passi mi fa sussultare. È un luogo che produce una cacofonia di rumori che a un orecchio non allenato sembrano tutti violenti, aggressivi. Ci vuole tempo per imparare a decifrarli, a ordinarli, a catalogarli e ad escluderli come rumore di fondo. Solo allora l’orecchio impara a individuare lo straordinario in mezzo al caos ordinario. Bisogna avere l’udito allenato per isolare dall’innocuo concerto di urla e porte che sbattono quel particolare urtarsi di tavoli e sgabelli che annuncia che in una cella hanno iniziato a suonarsele di santa ragione. È da poco passato il carrello della terapia e ho appena ingollato una manciata di pastiglie multicolori quando l’agente mi dice che devo andare dal Gip. Quanto è passato dal mio arresto? Un giorno, due giorni, tre giorni? Mi muovo in un’atmosfera onirica, ricordo che la convalida dell’arresto deve avvenire entro cinque giorni, l’ho studiato per l’esame da giornalista. Ma non è passato tanto tempo. Non è ancora arrivato Natale. O sì? Prima di entrare nell’ufficio del carcere dove si terrà l’udienza mi viene concesso di parlare in privato con l’avvocato d’ufficio. Al termine dell’incontro mi spiega che chiederà gli arresti domiciliari. D’istinto gli dico di non farlo perché sto meglio in prigione. Nel momento in cui l’avvocato mi ha prospettato la possibilità di uscire mi sono reso conto che non potrei tollerare di incontrare la gente, gli amici, i miei genitori. Ho spezzato una vita umana, sono diventato un assassino, ho infranto il più sacro dei tabù: come potrei stare in loro presenza? Il confronto mi distruggerebbe. Il solo pensiero mi annichilisce. No, preferisco il conforto della cella. In prigione mi sento protetto, al sicuro, dagli altri e da me stesso. Se il procuratore sospettasse quanto mi terrorizza la sola idea, chiederebbe la scarcerazione immediata. In questo momento non potrei immaginare una punizione peggiore, meglio la morte… L’udienza è incubo. Il giudice mi sembra attento e comprensivo, il pubblico ministero sorride compiaciuto come un gatto che ha appena ingoiato il canarino. Iniziano ad interrogarmi e mi accorgo di non riuscire a pensare con chiarezza. Non riesco a raccontare quello che è accaduto. Tutti i miei ricordi sembrano tessere di tanti puzzle diversi che non riesco a ricomporre. Ogni tanto me ne torna uno in mente, ma non riesco a collegarlo con il resto in un insieme logico. Il pubblico ministero mi riferisce la versione di altri testimoni. Non ricordo assolutamente i fatti che mi vengono raccontati, ma rispondo: “Se lo hanno detto loro…”. Se mi dicessero che qualcuno mi ha accusato di aver sparato a Kennedy risponderei la stessa cosa: “Se lo ha detto lui… deve essere vero”. Al processo pagherò duramente questa leggerezza, non mia, ma del mio avvocato che ha permesso un confronto al quale non sono assolutamente in grado di reggere. Ma al momento non me ne frega niente, anzi, in qualche modo soddisfo le mie pulsioni autodistruttive. Al processo non ci penso per nulla. Sono convinto che non ci arriverò. Voglio solo che l’interrogatorio finisca. Sto male, chiedo più volte di andare in bagno. Voglio solo che si tolgano dai piedi, che mi lascino tornare nella mia cella, nella mia solitudine. Finalmente l’udienza termina. Il Gip, con quella che a me pare un’aria dispiaciuta mi comunica che deve confermare la mia custodia cautelare in carcere. Lo ringrazio sollevato. Finalmente posso tornare nella pace della mia cella. È Natale. Lo capisco perché più o meno tutti gli agenti in servizio fanno una capatina al reparto di isolamento, si fermano davanti alla cella di P. e con la voce cadenzata gli dicono: “Buon Natale, numero sette! Buon Natale!”. Stanno scimmiottando uno spot pubblicitario ambientato in una prigione messicana che è in gran voga. Terminato lo spettacolino se ne vanno sghignazzando a gran voce. P. non si scompone, per lui qualsiasi persona si fermi davanti alla cella, qualsiasi cosa dica, è solo un’occasione per scroccare una sigaretta. O almeno per provarci. Si capisce che è Natale anche dal fatto che a pranzo è stata distribuita una razione di arachidi. Per il resto è una giornata come le altre. Interminabile. Sento provenire dalle altre celle il rumore dei televisori. Ma nella mia cella non c’è e non ho neppure niente dal leggere. È la prima volta da quando ho sei anni che non ho nulla da leggere e non posso averlo. Sono in galera! Non sono libero! È il primo flash di consapevolezza della mia nuova condizione. Arrivano così… un lampo che ti lascia senza fiato e in un istante ti fa percepire il vero significato del cancello a doppia mandata che ti separa dal resto del mondo. Un significato che può essere solo “visto, tastato”, non spiegato a parole. Riprendo a respirare e cerco di non preoccuparmi, di non farmi schiacciare dalla nuova consapevolezza del mio stato. Ho altro a cui pensare, queste sono cose che non mi riguardano. Lo spesino mi ha portato la roba che avevo ordinato, ma mi fanno tenere tutto fuori dalla cella. Per lavarmi i denti o farmi la barba devo chiedere il necessario all’agente che rimane nei pressi del cancello finché non ho terminato e riconsegnato tutto. Ma non esistono ostacoli insormontabili. Oggi sono uscito per la prima volta all’ora d’aria che ci è concessa e ho parlato con P. Gli ho promesso un pacchetto intero di sigarette, in cambio domani mi porterà all’aria uno dei suoi rasoi… Altin Demiri - Se uccidi non puoi essere più lo stesso anche nel chiuso della tua coscienza Giugno 2006 È raro che uno si cacci in guai seri tutto d’un tratto. In genere nei guai ci si finisce alzando ogni giorno un po’ di più il livello della propria sfida alle norme di comportamento della vita “regolare”. Le prime volte va quasi sempre tutto bene e allora subentra una specie di febbre incosciente che ti spinge a osare sempre un poco di più. Il grave reato che mi ha portato in prigione, l’omicidio, non è il prodotto fatale di quel clima, e lo dimostra il fatto che la maggior parte dei miei amici di allora non sono diventati assassini. Ma di quel clima è comunque figlio, perché io non avrei mai ucciso se la parte razionale della mia personalità non fosse stata oscurata da quel progressivo, ubriacante distacco dalla vita “regolare”. Un uomo che uccide non può essere più lo stesso agli occhi degli altri, ma non può esserlo più anche nel chiuso della propria coscienza. È una consapevolezza che mi pesa ogni giorno addosso, e di cui so che non mi libererò neppure quando tornerò libero fra i liberi. Ma proprio perché sono consapevole della gravità del mio delitto, credo di poter dire che un reato di sangue avviene quasi sempre senza che ci sia una premeditata intenzione in chi lo commette. Nel mio caso è stato senz’altro così (una rissa, nata per futili motivi; un crescendo confuso di tensione, il sangue alla testa, un gesto irrimediabile, che mai avrei commesso dieci minuti prima o dieci minuti dopo), ma lo è anche nella maggior parte dei casi di cui sono venuto a conoscenza, parlando nei miei dodici anni di galera con persone che si sono macchiate di analoghi delitti. Questa considerazione non toglie gravità alle nostre azioni, ma le rende più “umane” di come in genere vengano astrattamente giudicate. Il più delle volte Caino non è poi tanto diverso da Abele: è animato dalla stessa sensibilità e si riconosce negli stessi valori, nonostante un devastante offuscamento di quella sensibilità lo abbia portato, un giorno, a calpestare quei valori nel modo più atroce. Giusto che paghi; ma giusto, anche, riconoscergli comunque di essere un uomo. Quando in carcere di recente ho incontrato gli studenti di molte scuole, sono convinto di avere fatto una cosa buona a parlare del mio reato, anche se mi è costato, perché non è affatto facile dire “io sono un assassino” davanti a una platea di facce che hanno gli occhi puntati su di te. Sono sicuro però che la mia sincerità ha lasciato qualcosa dentro a chi ha voluto capire. Ai ragazzi, giovani come ero io quando ho commesso il mio reato, non me la sento di dare consigli. Un invito, però, lo voglio rivolgere. Ed è l’invito a godersi fino in fondo, ora per ora, la libertà, perché vi assicuro che nessuno come chi l’ha persa è in grado di apprezzare il suo valore. E non dimenticare, però, che non esiste libertà senza responsabilità. Io l’ho capito troppo tardi, e ora ne pago le conseguenze. Malavita Andrea Andriotto - Vita spericolata... Ottobre 1998 Sono quasi le tre di notte e, per me, non c’è momento migliore per fare delle riflessioni sulla vita, sulla mia vita! Il mio compagno di cella sta dormendo da ormai un paio d’ore. Mi sento terribilmente solo. Avrei voglia di svegliarlo per scambiare due parole, per cercare di spiegargli come mi sento. Ma lui non capirebbe. Non è il tipo a cui piace ascoltare i problemi altrui. Sono sicuro che dopo averlo svegliato, e accennatagli un po’ la situazione, mi direbbe: "… Andrè… non ce pensà… vattene a dormì… Non è affatto facile dire quello… come mi sento in questi momenti, un misto di nostalgia e rabbia, solitudine e rancore… malinconia… ma… a dire il vero: non lo so. Il carcere è un periodo spinoso per la vita di un uomo, è un periodo abbastanza ostile, uno di quei "momenti" che sembrano non finire mai… uno di quei problemi insormontabili… uno di quei guai che non si augurano neppure al peggior nemico… è una parentesi di vita che non si dimenticherà mai! A me, una delle cose che fa più male è il sapere che a causa mia stanno soffrendo quelle persone che mi vogliono bene e che, magari, s’aspettavano da me qualcosa di positivo… e non queste terribili conclusioni! Ora… adesso, vorrei riuscire a fare qualcosa di buono! O.K., sono in carcere. Dovrò rimanerci ancora per qualche anno… ma: riuscirò mai a sfruttare questo tempo nel modo più giusto? E poi… cos’è più giusto? Nel mio piccolo ho delle buone intenzioni: finire la scuola e riuscire ad imparare qualcosa di buono è uno dei miei principali obiettivi… sì… ma qualche volta mi succede di perdere… di non avere più voglia! In fin dei conti, sì, il futuro fa parte anche di me, ma che diavolo di progetti potrò mai fare io?! Se il futuro non può essere una certezza per nessuno… lo può essere ancora meno per un detenuto! A volte manca lo stimolo giusto, quel qualcosa che riesca ad accendere quel fuoco… quel meccanismo che abbiamo dentro, che ci permette di iniziare e di portare a termine determinati progetti . lo credo che la brutale mancanza d’affetto che si viene a creare in questi posti sia uno dei punti più cruciali! Sì, è vero: chi è più fortunato può incontrare i famigliari una volta a settimana, intrattenere corrispondenze varie ... ma questo non può bastare ad un uomo, è poco… troppo poco! Sesso a parte: un uomo ha bisogno di sentirsi ammirato, cercato… valorizzato… sostenuto… coccolato… AMATO!! Esistono degli stati d’animo difficili da spiegare… anzi, forse non sono poi così difficili da spiegare ma sono impossibili da capire per una persona estranea… per una persona che non li ha vissuti . Adesso mi ritrovo, a 24 anni, rinchiuso in un carcere Certo che ‘sta vita è davvero strana, eh!!? Sto ripensando alla mia giovinezza… che pacco!! Adesso mi ritrovo, a 24 anni, rinchiuso in un carcere, seduto su uno sgabello scomodo con un caffè e una sigaretta in mano… è sabato. Penso alla morte. Mi fa paura la morte! Mi fa paura sapere che devo morire convinto d’aver sbagliato tutto. Sicuro d’avere, quella volta, sbagliato strada. Sì, c’è anche chi paragona la vita a una strada dove, dicono, si possono incontrare incroci, stop, semafori, diramazioni, segnali… autostoppisti… incidenti… ed anche qualche posto di blocco. Per sfiga, o per fortuna (questo dipende solo dai punti di vista), le strade non sono tutte uguali. A volte si è costretti a correre su una sdrucciolevole, o sterrata… altre volte si è più fortunati e ci si ritrova su una più agibile. Fin qui nulla di male, è la vita di tutti i giorni! C’è però (e t’assicuro che è un però grandissimo) chi non vorrebbe correre rischi, chi vorrebbe arrivare prima subito alla sua meta, e non gli va d’incappare in incidenti. posti di blocco, autostoppisti… ed è proprio per questi che esistono le autostrade! E’ facile entrare in queste strade, però, poi, non ne esci più sino a quando non decidi di pagare quel conto… Io, anni fa, entrai in una di queste strade… così, quasi per caso. Probabilmente volevo arrivare prima in un punto lontano, non ben definito, visto che tuttora lo ignoro. All’inizio mi sentivo un po’ spaesato… non riuscivo ad abituarmici. Il brutto, però, è arrivato quando ho scoperto le comodità di questa, per me nuova, strada: ho iniziato a correre follemente… mi divertivo quando vedevo gli altri rimanere indietro… era bello fare il "dito" agli autostoppisti… pigiavo forte sull’acceleratore, era troppo bello correre… Ogni tanto mi fermavo, per pochi minuti però, giusto il tempo per fare rifornimento. Ma se mi azzardavo a fermarmi per riposare, c’era subito qualcuno dietro di me che mi spingeva, che mi costringeva ad andare avanti. Quando capii che la situazione presto sarebbe divenuta pesante, iniziai a preoccuparmi: come potevo correre sempre senza fermarmi mai?!! Infatti presto mi stancai! A me era sempre piaciuto fare lunghi viaggi, ma ad una velocità moderata, fermandomi quando più mi faceva comodo e sapendo di poter tornare indietro, se necessario, senza dover rendere conto a nessuno di quelle che potevano essere le mie intenzioni. Beh, in questa nuova strada non potevo fare tutto questo. Dovevo solo correre senza guardare in faccia nessuno e non appena accennavo a dirigermi verso l’uscita venivo sistematicamente bloccato da chi, in quel momento, viaggiava accanto a me! A questo punto non potevo far altro che correre… A questo punto non potevo far altro che correre… sorpassare tutti e correre… Ci sono stati parecchi momenti in cui, a causa della stanchezza, perdevo il controllo del mio veicolo, ma sono sempre riuscito a rimettermi in carreggiata. Un giorno, poi, quando per forza di cose dovetti rallentare un po’, mi accorsi che poco più in là c’erano altre stradine, dove la gente non poteva correre fortissimo però poteva viaggiare tranquillamente… Ma fui subito costretto ad accelerare, l’ingorgo era finito, dovevo tornare alla mia solita andatura. Non riuscivo più a correre forte come prima… sembrava che l’auto perdesse colpi, ed io contemporaneamente perdevo posizioni. Per un po’ transitai sulla corsia preferenziale… sino a quando tentarono di buttarmi fuori. Allora cercai subito di riprendere velocità. La macchina sembrava impazzita… raggiungeva velocità elevatissime: sorpassai molte altre auto e mi ritrovai da solo, davanti a tutti, la strada era tutta mia… correvo come un folle… era bello correre… sembrava bello, correre! Cadde su di me la stanchezza. Inevitabilmente andai ad urtare uno spartitraffico, ma riuscii a riprendere la guida e continuai a correre… Successe ancora!!! Altre volte, poi, mi ritrovai ad affrontare i disagi provocati dalla stanchezza, ma ero sempre riuscito a cavarmela. Sino a quando, in uno di questi momenti di debolezza, invasi la carreggiata opposta. Mi ritrovai a dover schivare chi arrivava dalla parte opposta, alcune volte mi è anche andata bene… poi, però, inevitabile fu quello scontro frontale! L’urto fu fortissimo, un impatto terribile… Mi ritrovai in un campo incolto, steso… e con l’auto sopra di me. Riuscii, a stento, a sgusciare fuori… cercai di rimettermi in piedi, non fu facile… ma ci riuscii. Guardandomi attorno vidi solamente erbacce, buche e dossi… il terreno era sabbioso, era difficile anche solo rimanere in piedi. L’autostrada era là… io, però, non potevo più ritornarci, era impossibile! Ormai ne ero fuori, e per di più avevo la macchina scassata. Adesso?!?! Sto ancora spingendo quella maledettissima auto che una volta mi faceva "divertire" un sacco. T’assicuro che non è facile, il terreno è molto insidioso… ma io devo continuare a spingere. Sto cercando una stradina, anche sterrata. Una stradina che possa ricondurmi in una di quelle strade principali, ma normali. In lontananza ci sono delle strade… vedo passare e sorpassarmi quelli che una volta erano rimasti indietro… anche gli autostoppisti hanno trovato un passaggio… Per me, ora, non si ferma più nessuno! Quel ch’è peggio è che so che hanno ragione, fanno bene… me lo merito! Loro non fanno altro che seguire la strada senza pretendere d’essere i suoi padroni… Io, invece, una volta, avrei voluto esserlo! Per ora non posso far altro che spingere, poi… si vedrà! Claudio e Angelo - Banditi di domani Le carceri minorili del passato erano palestre di futuri delinquenti speriamo che non tornino ad esserlo Febbraio 2002 Negli anni settanta il mondo era scosso da grandi desideri di cambiamento, i giovani si riversavano nelle piazze, gridando slogan che inneggiavano alla libertà. Tanti aderivano a gruppi politici, di destra o di sinistra, perché così facendo pensavano di avere una maggiore indipendenza; altri protestavano usando la musica. Ma c’era anche chi, insofferente alle condizioni di povertà (che allora erano molto diffuse), si allontanava da casa per ritrovarsi con altri giovani che volevano provare emozioni in assoluta libertà, vivendo di espedienti e commettendo anche dei reati. Questa inaspettata ribellione giovanile creò un forte allarme sociale, che si tradusse presto in una indiscriminata repressione. Chi era sorpreso in situazioni o atteggiamenti "sospetti" era fermato e identificato (come i clandestini di oggi, anche noi eravamo senza documenti); una volta accertate le generalità "in base ai dati forniti dal minore", venivano chiamati i genitori, per una verifica delle dichiarazioni rese e perché venissero a riprendersi il figlio, se non aveva fatto niente di grave, altrimenti per lui si aprivano le porte del carcere. L’esperienza di Claudio La prima volta che mi arrestarono avevo 14 anni. Eravamo nel giugno del 1970 (erano in corso i campionati mondiali di calcio), abitavo a Verona e vivevo in modo spensierato, del tutto irresponsabile, assolutamente senza rendermi conto che commettendo dei reati sarei finito in carcere. Finché mi portarono in Questura e poi al minorile di Treviso, S. Bona Nova… qui la realtà mi si presentò in tutta la sua crudezza. Mentre percorrevo i lunghi corridoi che portavano all’accettazione, cercavo con lo sguardo e speravo di scorgere un viso amico, che mi rassicurasse e mi facesse rallentare il battito cardiaco. Ma l’unico viso che mi trovai davanti fu quello di un omone baffuto, dalla voce forte e autoritaria, e in quel momento compresi che i miei 14 anni non erano sufficienti a permettermi di mantenere un atteggiamento spavaldo… quasi mi tremavano le gambe. L’agente mi disse di seguirlo in una stanza vicina. sopra la porta c’era una scritta: "Ufficio matricola". Lì mi presero le impronte e mi fecero le fotografie. Poi passai al magazzino, dove ricevetti la "fornitura" (lenzuola, prodotti per la pulizia, etc.). A quel punto arrivò un "signore" senza divisa che mi spiegò: "Io sono il tuo educatore, così mi devi chiamare… né agente, né guardia e tanto meno secondino, capito!?". Poi mi disse di seguirlo, attraversammo alcuni cancelli fino ad arrivare alla sezione minorile, che si trovava di parecchio spostata rispetto al reparto maggiorenni. Arrivato davanti alla cella dov’ero assegnato guardai all’interno e, con immensa gioia, finalmente vidi un viso conosciuto, quello di un mio amico di Verona. Entrai in cella, subito lo abbracciai e, con quell’abbraccio, ritrovai tutta la sicurezza che avevo perduto: "Massimo, anche tu qui?!". Bastò che ci scambiassimo qualche battuta perché si creasse un clima di complicità, e scoprii così di poter contare sul sostegno dei miei coetanei detenuti. Il mattino seguente mi portarono dal Giudice dei Minori; il mio cuore ricominciò a battere forte non appena fui davanti al magistrato, che mi invitò a sedere e mi chiese come mi chiamavo. Il suo sguardo era severo, mi fece una infinità di domande e ben presto compresi che aveva un atteggiamento molto "rimproverante", ma soprattutto capii che non sarei tornato a casa tanto presto. Il Giudice mi chiese anche se da bambino ero stato in collegio, e quando gli risposi che c’ero stato volle sapere il motivo per cui mi avevano messo in collegio, quanto tempo ci ero rimasto e cosa mi ricordavo di quell’esperienza. Non pensai al "perché" di quelle domande, che mi sembravano avere poca attinenza con il mio arresto, e solo oggi, 32 anni dopo, sono riuscito a capirlo. Mario, un compagno di detenzione che ha la mia stessa età ed è stato pure lui nel carcere minorile, un giorno mi ha detto: "Ma lo sai, Claudio, che l’esperienza del collegio è stata la nostra prima carcerazione!? Il 20% dei ragazzi che sono stati in collegio, poi sono finiti nelle carceri minorili. Ti ricordi del numerino che la nostra mamma ci cuciva su ogni indumento?". "Come no, il mio numero era il 133", gli risposi, e Mario concluse: "Ecco, quello fu il nostro primo numero di matricola". Lui, come me, era stato portato in collegio a seguito di una segnalazione della S. Vincenzo (l’Ente che aiutava le famiglie in difficoltà economica). L’esperienza di Angelo Nel 1994 venni arrestato per la vendita di sostanze stupefacenti. Mentre ero in caserma e attendevo l’esito del fermo in una cella buia e sporca, pensavo a cosa ne sarebbe stato di me, dei miei affetti e di tutto il resto, se mi avessero convalidato il fermo. Dopo qualche ora di attesa vennero ad aprirmi e mi dissero che il Pubblico Ministero aveva convalidato l’arresto. Mi dissi: "Ci siamo! Ora ti aspettano tempi duri". Venni accompagnato, da Verona fino a Treviso, da quattro carabinieri in borghese. Durante il viaggio mi dicevano di non preoccuparmi, perché nel giro di poco tempo sarei tornato a casa, ma io non li ascoltavo nemmeno, continuavo a fissare le montagne, i paesaggi che si susseguivano, e pensavo a quando averi potuto ancora vederli. Arrivati davanti all’ingresso del carcere minorile, già vedere i cancelli alti e il perimetro esterno mi fece una certa impressione, passammo il cancello ed io rimasi a fissarlo mentre si chiudeva... I carabinieri mi lasciarono in portineria e gli agenti mi fecero entrare in una stanza, con una finestra alta e poca luce, dove rimasi due giorni, finché il Giudice dei Minori decise di spostarmi nelle sezioni dove alloggiavano gli altri ragazzi. La stanza dove ero rimasto due giorni da solo, lo seppi in seguito, la chiamano C.P.A (Centro di Prima Accoglienza). Nella sezione arrivai verso le otto di sera, quando ormai era buio, mi diedero un paio di lenzuola e niente più. Vicino al letto c’era un televisore, il soffitto era alto e la stanza molto piccola. Mi stesi sulla branda e rimasi fermo, immobile, a guardare il soffitto e la finestra, che aveva sbarre arrugginite e spesse. Al mattino gli agenti penitenziari, che al minorile non portano la divisa, mi dissero di andare a far colazione con gli altri ragazzi, nel refettorio. Mi preparai e, uscito dalla cella, vidi molti altri ragazzi che attendevano il consenso dall’agente per entrare in mensa. L’incontro con questi ragazzi non fu dei migliori, visto che lì non si usava dare il "benvenuto" ai nuovi arrivati. In mensa eravamo circa 30 persone, prendemmo i vassoi e un addetto alla cucina ci diede da mangiare. Al minorile il cibo arriva dall’esterno, perché ai ragazzi è vietato svolgere qualsiasi tipo di lavoro. Dopo aver mangiato andammo all’aria, fino alle undici. Poco dopo mi chiamarono gli educatori per fare il colloquio di primo ingresso. Gli raccontai la mia storia e mi feci spiegare le regole da seguire, riguardo agli orari per la doccia, ai colloqui con i famigliari, etc. Il sabato, giorno di colloquio, venne a trovarmi mia madre. Prima che riuscisse a parlarmi passarono una decina di minuti, perché non riusciva a smettere di piangere per il dolore di vedermi in quel posto. Nel vederla così, mi sentivo un fallito. Cercai di tranquillizzarla dicendole che non mi trattavano male, così si calmò un poco e riuscimmo a dialogare per il tempo rimanente, ma l’ora del colloquio finì in fretta e lasciarsi fu molto difficile. Dopo una settimana mi chiamò ancora l’educatore, che mi propose di partecipare a un corso di falegnameria. Io, senza farmelo ripetere due volte, accettai subito: potevo scegliere tra questo corso, uno di pelletteria, e la scuola media. Nel giro di un mese riuscii così a fare un po’ di amicizie e ad ambientarmi. Le carceri minorili del passato erano le palestre dei banditi di domani, il percorso di tanti ragazzi era: collegio, carcere minorile, carcere per adulti. Oggi si parla di accelerare il passaggio al carcere per adulti, al compimento del diciottesimo anno: ma non si rischia di accelerare così una futura vita da delinquente? Enrico Flachi - "Tirare la lima" La mattina era d’incanto, il pomeriggio favoloso, la notte… straordinaria, quando non ci si doveva alzare per andare a "tirare la lima" Dicembre 2000 Sono uno tra quelli che non hanno mai, fino ad un certo punto della loro esistenza, voluto volontariamente cambiare modo, tenore, idee, stile di vita! La mia scuola, come per tanti altri, è stata la strada… la via dell’illegalità, sono cresciuto con un altro tipo di valori, per molti aspetti diversi da quelli che può avere una persona, che nel nostro gergo definiamo "regolare". Già sin dalle elementari ho incominciato con i primi furtarellini, uscivo dall’aula per rovistare nelle tasche dei cappotti di ogni scolaro, i primi soldini che con goduria poi spendevo appena uscito di scuola… e successivamente l’idea era di osare di più, con il colpire la borsetta della maestra… per passare a "curare" il bidello, che appena si spostava, castigavo anche lui, e così via, via… Spiegare il perché si continua anche se poi, gira e rigira, si viene beccati, non è poi cosi difficile, sin da quei primi colpetti mi ERO subito fatto un idea tutta mia… vedevo con quanto sudore mio padre ogni giorno faticava per portare quattro lire a casa per sfamarci tutti, eravamo una famiglia di nove persone, ed io, che a quel tempo ancora ero un ragazzino col naso che gli colava, in una sola mattinata spesso avevo in tasca più di quello che lui in una settimana riusciva a guadagnare. Molti si domandano come può una persona, dopo anni di galera, uscire e ricominciare questa vitaccia… i perché e per come sono una infinità, ma la spinta più forte è quella del denaro, poi viene il fatto di essere giovane, affamato di tutto… l’ambiente in cui vivi, dove cresci con gente uguale a te e dove quelli più astuti vedi che possiedono quelle cose che tanto desideri… soldi in tasca, auto di lusso, moto, e chi più ne ha, più ne metta. La notte era bella, i pomeriggi altrettanto, e la mattina stupenda quando non ci si doveva svegliare per andare a tirare la lima! Non so se oggi mi posso definire diverso da tutti quelli che, in sostanza, non hanno nessuna intenzione di pensare ad una vita più serena, basata sulla regolarità, o non ne hanno nemmeno la possibilità, vuoi perché non li si aiuta concretamente, quando escono con le tasche completamente vuote, e tutto da dover ricominciare… o, ed è giusto dirlo, vuoi anche perché c’è chi è convinto che questa vita è l’unica in grado di gratificarlo… ma qui subentrano fattori psicologici, sui quali io sono ignorante. In questi anni, in tutti questi anni, trascorsi in galera, ormai 10 senza interruzione, ho di proposito guardato, passo, per passo, a ritroso. Ho visto i mutamenti all’interno di questo mondo, ho visto quelli che man mano entravano, uscendone poco dopo perché incapaci di assumersi le propria colpe, e pagare a proprie spese l’amaro peso che l’essere delinquente ti porta a dover provare. Con razionalità ho fatto un limitato bilancio di ciò che in realtà ho perduto e guadagnato… il risultato è per me spaventoso, ciò che ho perso alla fine è incalcolabile, ma oltre questo, ho una famiglia fuori, un figlio con molti, e seri, problemi fisici, una compagna che sta sacrificando la sua, di vita, per me, e i nostri figli… Non voglio apparire la solita vittima, quello che ho fatto sinora ho voluto, desiderato farlo, ma oggi ho un vero, sano motivo per dire basta con tutto questo, con questo genere di vita. So che molti vorrebbero dire, e fare, lo stesso, ma non hanno la mia stessa fortuna, con dei genitori disposti ad aiutarti economicamente, e sistemarti con un lavoro sicuro. Con una propria famiglia che non mi ha mai abbandonato, e fatto mancare amore, aiutandomi così in quel mio percorso di cambiamento, di maturazione interiore in vista di una vita futura diversa. Salute e salute mentale Francesco Morelli - Matti da slegare... Ovvero: come Gianfranco, un internato in "osservazione", ha vissuto il ricovero all’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia Dicembre 1999 Rientrando in sezione, trovo un insolito movimento. Nel mezzo del corridoio c’è il carrello che serve per i traslochi, vuoto. Un nuovo compagno è arrivato, andando ad occupare il posto che si era liberato soltanto ieri. In un Penale, l’arrivo o la partenza di qualcuno costituisce un avvenimento, cosicché vado ad accertarmi chi sia il nuovo giunto. Non occorre che arrivi alla sua cella, la curiosità viene soddisfatta prima perché "lui" mi piomba alle spalle (era infilato nell’ufficio dell’agente), soffiandomi nell’orecchio un saluto che riconosco subito: quel minestrone di accenti (perfino peggiore del mio) ce l’ha soltanto Gianfranco, nato in Sudamerica da genitori trevigiani, vissuto tra San Paolo del Brasile e Trento. - Ciao, Francesco, come va? - Tiro avanti. E tu, dove sei finito, che non ti vedo da mesi? - Torno adesso dal manicomio. - Cosa ti è successo? - Ho avuto una crisi epilettica e mi hanno mandato all’O.P.G.1 di 1 Ospedale Psichiatrico Giudiziario Reggio Emilia, ma adesso sono tornato e ho tante cose da raccontarti. - Come mai ti hanno lasciato andare, questo mi chiedo, non potevano tenerti un altro po’!? (Gianfranco è un gran rompiscatole, sa anche essere simpatico, ma con lui la pazienza serve in quantità industriali). - Cerca di essere serio. Leggo sempre "Ristretti" ed ho pure fatto l’abbonamento a mia sorella. L’ho fatto conoscere anche all’Ospedale Psichiatrico ed è piaciuto a tutti. Adesso mi devi intervistare, così divento famoso anch’io! - Non mi sbaglio, i dottori ti hanno dimesso perché non ti sopportavano più e adesso tocca a me reggerti tutto il santo giorno! L’intervista la possiamo fare, ma non posso garantirti che sarà pubblicata e che diventerai famoso, dipende molto da quello che hai da raccontare, devono essere cose interessanti e, soprattutto, sensate. - Voglio raccontare come sono finito al manicomio e quello che ho visto e vissuto là dentro. Va bene? - Per me va bene, ma dobbiamo parlare con calma. Stasera vieni in socialità nella mia cella, così possiamo stare tranquilli per due ore. Ore 17: apre la socialità e Gianfranco arriva di corsa. - Ciao, Francesco: sei pronto a scrivere? - Certo che sono pronto. Tu, piuttosto, cosa ci fai con i piatti e le posate? Mica ti ho invitato a cena, siamo qui per lavorare! - Li porto per abitudine, non si sa mai che ci scappi una fetta di torta, o qualcosa del genere, mentre lavoriamo. - Capiti male, io non mangio dolci. - Ho capito, ho capito, niente torta. Posso almeno accendermi una sigaretta? - No che non puoi!, vuoi togliermi il "libero respiro"!? - Allora, facciamo in fretta con l’intervista, lo sai che non resisto a lungo senza fumare. Da dove vuoi che cominci? Potresti cominciare dai tuoi guai giudiziari, ad esempio. Da ragazzo ero molto turbolento e ho frequentato a lungo una compagnia di sballoni, però ci facevamo solo qualche canna e in carcere ci sono finito una sola volta: pochi giorni, per oltraggio a un agente. Le droghe pesanti cominciai ad usarle a ventisette anni, dopo la morte di mia madre (il padre di Gianfranco è morto prima che lui nascesse - n.d.r.-). Ho provato anche a disintossicarmi e, per due volte, sono stato in comunità. Come mai il trattamento in comunità non ha funzionato? A San Patrignano rimasi cinque mesi, prima di scappare. Il "programma" era troppo duro, non ti consentiva di vedere nessuno, non potevi telefonare e neanche scrivere Mi sembrava di essere sepolto vivo e così ho deciso di tornare alla mia casa di Trento, anche se ero in affidamento e andarmene dalla comunità significava evadere. Appena arrivato a Trento sono venuti ad arrestarmi: fino ad allora ero riuscito a rimanere fuori dal carcere, aiutato dalle mie sorelle maggiori e da un buon avvocato, ma avevo diverse condanne in sospeso per reati legati alla droga furti e piccole truffe, più che altro. Rimango detenuto a Trento per circa un anno finché, a febbraio ‘98, mi concedono la sospensione della pena in attesa di un nuovo affidamento. Invece, dopo due giorni soltanto, mi arrestano di nuovo, questa volta a Padova: ero venuto per comperare un po’ di cocaina e finisco ai Circondariale, poi mi trasferiscono a Belluno, infine arrivo qui al Penale. Quando hai iniziato ad avere i problemi di salute che ti hanno portato all’O.P .G. ? Come arrivo in questo carcere mi mettono in cella con un compagno rumeno, con il quale comincio subito a litigare, venendo anche alle mani. Per non creare altri guai, a lui ed a me, vado dal medico e chiedo un sacco di sedativi, incoraggiato in questo anche dal concellino. Di solito, prendo solo una pastiglia per dormire e tutto quel miscuglio di farmaci mi manda fuori di testa: dopo tre giorni ho un attacco di epilessia e mi portano all’Ospedale, dove mi fanno vari esami, al termine dei quali mi consigliano le cure di uno psichiatra. Quindi, hai avuto un colloquio con lo psichiatra, al rientro in carcere? Non ho visto né lo psichiatra né un altro dottore: l’unico cambiamento è stata la sospensione della terapia. Un mattino, mi chiamano in accettazione "con tutta la roba", significa che devo partire e non so nemmeno con quale destinazione. A mezzogiorno sono già all’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, un Istituto che di ospedaliero ha solo il nome, perché nella struttura è identico ad un carcere, con portoni blindati, inferriate, agenti in divisa. Com’è la vita in quell’Istituto? Per quanto mi riguarda, non posso lamentarmi. Il personale ti tratta da malato, non da detenuto, anzi, là dentro non sei nemmeno un detenuto, ma un internato. Gli agenti, di norma, sono gentili e così pure i medici e gli infermieri, però se qualcuno fa troppo casino finisce legato alletto di contenzione e prende pure botte. La direttrice dell’Istituto conosce di persona tutti gli internati, circa duecento, entra spesso nelle sezioni ed ascolta i loro problemi. Sono rimasto solo un mese all’O.PG., eppure ho potuto svolgere delle attività dopo la prima settimana, ho chiesto di poter lavorare e subito mi hanno trasferito al "Piano Zero", una sezione nella quale sono organizzati corsi scolastici e altre iniziative, dal laboratorio di pittura alla redazione del giornale Effatà. Mi inseriscono in un corso accelerato (dura soltanto tre giorni) nel quale insegnano ad assistere i compagni che stanno male e, al termine dei tre giorni, ottengo la qualifica di "piantone volontario". Si tratta di controllare le persone che hanno tendenze suicide, o autolesioniste, per prevenire danni e per soccorrerle in caso di bisogno, in realtà il compito principale del piantone è quello di chiamare immediatamente l’infermiere, che poi se la sbriga lui. I piantoni dovrebbero essere compensati, come tutti i lavoranti, ma il Ministero non ha i soldi per pagarli tutti e per questo le direzioni organizzano queste iniziative di volontariato. Come funziona l’assistenza sanitaria in quell’O.P.G. ? In ogni sezione c’è un ambulatorio, con un infermiere presente giorno e notte, con il pronto soccorso e i farmaci necessari. I medici sono disponibili e passano ogni giorno nelle sezioni, qualcuno di loro si ferma anche a scherzare con gli internati, altri sono più formali, ma nel complesso non lavorano male. Le terapie vengono distribuite più volte al giorno, anche sotto forma di iniezioni che rimbambiscono per una settimana: le cose peggiori, là dentro, sono proprio le persone ridotte come automi, che camminano come al rallentatore, che si mettono a urlare in piena notte chiedendo altra terapia. I primi tempi ti spaventano, poi fai l’abitudine alle grida ed ai blindi che sbattono senza sosta, pensi che potresti ridurti così anche tu, se rimani là dentro a lungo. Personalmente di cure non ne ho ricevute molte, perché ero in osservazione: in un mese, tre colloqui con lo psichiatra e la solita terapia, la pillola per dormire che prendo sempre. Che tipo di persone ci sono, tra gli internati? Ce ne sono di ogni tipo: dai prosciolti per infermità di mente, con omicidi sulle spalle, ai barboni alcoolizzati finiti dentro per una sciocchezza, perché non avevano un altro posto dove ricoverarli: stanno tutti assieme, senza distinzione tra i criminali e i disadattati. Molte persone vengono internate in seguito a denunce dei loro familiari, che non sopportano più di averli per casa: chi vive in condizioni di disagio psichico è spesso violento, verso gli altri o verso se stesso. Ho conosciuto un internato rinchiuso dopo che aveva dato fuoco alla propria casa, un altro che si era piantato un coltello nello stomaco. Ci sono persone che non trovano altra sistemazione e sono destinate a morire là dentro, perché gli internati non hanno un "fine pena": al termine del periodo "di cura" previsto dal giudice (per i casi più gravi può essere di dieci anni) la sua pericolosità sociale viene rivalutata e, se ritenuto ancora pericoloso, continua a rimanere internato. Spesso, dopo anni passati in reclusione e sotto l’effetto degli psicofarmaci, una persona non riesce a comportarsi in modo normale e viene giudicata "ancora" pericolosa, ma più rimane internata e più le sue condizioni diventano anormali, così non esce mai. Dopo quello che ha raccontato, devo scusarmi con Gianfranco per averlo preso in giro. Comunque, durante le due ore dell’intervista, ho lasciato che fumasse mezzo pacchetto di puzzolenti Alfa Box, tanto per chiarire come sia facile rendermi indulgente. Elton Kalica Dal T.S.O. all’O.P.G. Come una semplice visita dallo psichiatra, può costare quasi due mesi di "manicomio criminale" Agosto 2003 Camminando lungo l’interminabile corridoio, ho incontrato un compagno di detenzione che chiamerò Mauro. So che è stato via per un bel po’, ma della sua assenza mi accorgo solo adesso che lo vedo, e mi incuriosisco, perché è una di quelle tante assenze silenziose che nessuno commenta mai, visto che qui c’è sempre gente che viene e che va. E allora gli chiedo di raccontarmi dove è stato. Capisco subito che lui gradisce l’idea di parlare e di sfogarsi con qualcuno, cosicché non posso fare altro che ascoltare in silenzio. La sua storia si rivela curiosa. Mauro, dopo più di tre anni di carcere, ha fatto una visita specialistica dallo psichiatra. Il dottore lo ha ricevuto con un sorriso e, dopo aver ascoltato con pazienza i suoi lamenti, ha fatto la diagnosi e prescritto la cura. In realtà la cura era il ricovero obbligatorio. "Sognavo sempre delle cose strane" confessa Mauro. "Mi svegliavo alla mattina con un senso di stanchezza e pensavo a quello che avevo appena sognato. A volte erano immagini tetre e buie. Soffrivo, mi angosciavo e mi svegliavo tutto sudato. Allora la mattinata era rovinata. Quella era per me già in partenza una brutta giornata: mi chiudevo in me e non parlavo con nessuno. Mi prendeva una tristezza che mi pareva irreversibile, e che di solito durava delle ore. Poi, spesso, riuscivo a dimenticare questo mio malumore scrivendo una lettera oppure ascoltando della musica. Ma non era sempre così. Altre volte i miei sogni erano belli, avventurosi o rilassanti. Allora mi svegliavo con la voglia di parlare a tutti, di scherzare, di divertirmi e andavo a fare qualche partita a carte coi miei compagni." Mauro racconta questi risvegli e mi guarda con degli occhi indagatori, come se cercasse di capire dalla mia espressione se c’è qualcosa di strano in lui. Rimango immobile per non influenzare e interrompere il suo racconto. "Dallo psichiatra ero andato a chiedere se era normale avere questi sbalzi d’umore. Gli spiegai tutto in maniera dettagliata, in modo da dargli più elementi possibile sulla mia condizione. Mi prescrisse subito dei farmaci. Seguii questa cura per circa una settimana, ma mi accorsi che le mattine erano sempre uguali: aprivo gli occhi ed ero triste e melanconico". Parla e mi rivolge uno sguardo dolce, come se volesse scusarsi con me della cattiva riuscita della cura e con gli stessi occhi volesse creare un sottofondo al suo racconto, come a dire che mica è colpa sua se la testa continua a fargli degli scherzi. "Chiesi un altro colloquio con lo psichiatra", continua Mauro. "Lui mi chiamò relativamente presto, dopo due giorni. Non mi diede il tempo di finire che si mise a scrivere qualcosa. Mi disse che era tutto apposto e che non mi dovevo preoccupare. Dopo nemmeno tre ore, mi chiamano in accettazione e mi comunicano che lo psichiatra ha raccomandato il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) in una struttura specializzata. La struttura specializzata naturalmente non può essere altro che l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario (O.P.G.) di Reggio Emilia. In pochi minuti mi trovo in un furgone blindato in viaggio verso il luogo di cura". Ferma il suo racconto, Mauro, come se tentasse di raccogliere per un attimo i ricordi sparsi nel suo cervello. Mauro è sui venticinque anni ma ne dimostra meno. Forse per la sua magrezza o forse per i capelli tagliati corti con il ciuffo che ricorda i bambini dell’asilo. Cerca di nascondere la sua altezza tenendo le spalle strette e curve come se stesse trasportando due pesanti e invisibili borse. Dopo un istante di pausa, sembra aver riordinato i suoi ricordi. Io aspetto che continui con il viaggio, invece la sua mente è già arrivata all’ospedale. "Appena arrivato al manicomio, l’ambiente mi si è presentato come una realtà molto crudele: pazienti legati sul letto, canti stonati di gente con le menti che sembravano del tutto assenti, grida strazianti provenienti da un altro tempo. Un vero incubo. Me la stavo facendo addosso. Tremavo dall’ansia. Sono riuscito a trovare un po’ di raccoglimento solo dopo essere entrato in cella. Per mia fortuna mi hanno messo in una cella dove ho trovato un ragazzo che, come me, era stato portato là per dei disturbi di poco conto. Veniva dal carcere di Torino, e si era visto trasferire per cura dopo una breve visita dallo psichiatra. Invece l’altro inquilino della nostra cella era proprio malato: disteso sulla branda c’era solamente un corpo abbandonato da ogni normale attività del cervello. Non c’era nessun tipo di controllo o di guida dentro quell’essere. Mi sono subito sentito molto dispiaciuto per quel ragazzo. Lo specialista, dopo avermi visitato, arrivò alla conclusione che io non soffrivo di nessuna patologia grave e quindi disse che, dopo i circa venti giorni d’osservazione che la procedura prevede, sarei tornato in carcere. Poi continuò con le prescrizioni: "Ti faccio uno scalo del Talofen e del Seroquen, poiché questa cura è inutile. Devi prendere poi solo l’Anafranin che è un antidepressivo, e il Tegratel che è uno stabilizzatore dell’umore. Con questo vedrai che sarai più sereno e tranquillo". Invece dei venti giorni d’osservazione, rimasi per cinquantadue, di giorni. Un vero incubo. Scene tremende che si ripetevano in continuazione. Facce sofferenti, corpi appesantiti dai farmaci, anonime vite che si trascinavano lentamente, appoggiate sui muri. Questo era lo spettacolo che mi somministravano ogni giorno per curarmi dalla mia grave malattia". E con questa breve descrizione di quel grosso contenitore di dolore che è l’O.P.G, con occhi da pianto, come per sottolineare che non sarebbe mai in grado di descrivere realmente quello che ha visto in quei cinquantadue giorni, ma soprattutto promettendomi che non andrà più a farsi visitare da nessuno psichiatra di nessun carcere, Mauro conclude il racconto della sua avventura. Ci salutiamo e ci diamo un abbraccio forte, da uomini sani. Danko Vukomanovic Un delinquente fuori dal comune Storia di Muhamed, ex insegnante della ex Jugoslavia ladro per caso Febbraio 2002 Durante numerosi trasferimenti per giustizia ho conosciuto moltissimi miei paesani provenienti da tutte le parti della "ex Jugoslavia". Il volto che non dimenticherò mai è di un uomo di nome Muhamed. Veniva da Mostar, città tristemente nota per la distruzione del ponte, dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità, che aveva dato il nome alla città stessa, perché in lingua slava la parola "mostar" significa guardiano del ponte. Passeggiava da solo, era magrissimo, aveva lo sguardo perduto ed impaurito, diffidente. Gli altri ogni tanto gli rivolgevano qualche parola ironizzando, prendendolo in giro. Aveva una cinquantina di anni, ma le rughe e la barba bianca erano di un settantenne. Qualcosa mi diceva che dovevo avvicinarlo e cercare di sfondare la sua fortezza, costruita per difendersi dagli altri, ma che contemporaneamente era la sua personale prigione. Appena mi accostai sentii che aveva un altro sistema difensivo, era l’odore insopportabile di un uomo che non si lavava da settimane. Il primo scambio di parole mi fece capire che non era un delinquente, aveva un linguaggio di una persona colta e non amava vantare imprese malavitose di soldi fatti in fretta, di macchine e gioielli e donne. Mi disse che era insegnante in un istituto tecnico superiore a Mostar, e che all’inizio della guerra aveva portato in un posto sicuro sua moglie e i due figli. Lui era rimasto ancora un paio di mesi a Mostar, poi chissà come e perché si era ritrovato a Trieste senza una lira in tasca, senza conoscere una parola di italiano. Disse che aveva girovagato per giorni, sporco, affamato, sbandato, finché era stato avvicinato da un paesano che gli aveva fatto la proposta di andare con lui a prendere lo stereo della macchina parcheggiata lì vicino alla stazione e venderlo per aver "soldi da mangiare". Lui, nella sua ingenuità, era convinto che la macchina e lo stereo fossero del suo "nuovo amico" che voleva aiutarlo. "L’amico" di Muhamed era invece convinto di aver trovato uno che gli facesse "da palo" mentre lui rubava. Il doppio errore di valutazione ebbe conseguenze catastrofiche per Muhamed. Durante la prima azione scattò l’antifurto, e il suo "amico" si mise a correre via e sparì in gran fretta. Muhamed, non capendo nulla, rimase fermo, ma, quando il guardiano del parcheggio l’afferrò cercando di trattenerlo, nel tentativo di svincolarsi gli diede una spinta e il guardiano, scivolando sull’asfalto bagnato, si procurò una distorsione della caviglia. Nel frattempo arrivò la Polizia e Muhamed, ex insegnante dalla ex Jugoslavia, finì in carcere. Con il solito "avvocato" d’ufficio, non avendo nessuna esperienza giuridica, con l’interprete che traduceva solo le domande rivoltegli dal giudice, fu condannato alla pena di "anni quattro mesi sei di reclusione per concorso in rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale". Se avesse saputo e potuto raccontare ai giudici tutta la storia, probabilmente sarebbe stato rilasciato con sospensione condizionale. Dopo aver sentito che la sua fortezza si era aperta ho deciso di rivolgergli la domanda che riguardava il suo odore. La risposta è stata forse più imbarazzante della sua vicenda giuridica. Mi disse di non aver fatto la doccia da quando era entrato in carcere (un paio di mesi prima) poiché temeva di essere sodomizzato, cioè gli altri vedendo un uomo perduto l’avevano convinto, per scherzo (bello scherzo), che il "sesso di gruppo" rappresentasse una specie di "battesimo carcerario". E lui, richiamando alla memoria le scene viste nei film americani girati ad Alcatraz, si era convinto della storia. Il giorno dopo io partii per Milano e lui rimase a Trieste. Quando sono ritornato ho saputo che l’hanno trasferito a Torino: non ho potuto verificare se sono riuscito a convincerlo a farsi la doccia. Elton Kalica Una piccola storia di "ordinaria" sanità penitenziaria Hassan al pronto soccorso Agosto 2003 Questa mattina, l’aria si presenta subito soffocante. Il desiderio generalizzato dei detenuti del primo braccio è quello di stare a letto e continuare a dormire ancora per un paio d’ore. Il caldo impedisce di prendere sonno durante la notte, cosicché la televisione diventa la migliore delle terapie. Solo verso le due o le tre, quando la temperatura cala un po’, si comincia a dormire, per poi far prolungare il sonno il più possibile, spesso fino a mezzogiorno. Ma questa stessa mattina, secondo il programma interno, è l’unico giorno della settimana durante il quale si potrebbe andare in palestra a giocare a calcetto. Spesso però il programma non viene rispettato per mancanza di personale, e si rimandano i detenuti alla loro solita routine. Ma questa statistica negativa non demoralizza tutti, anzi sono in tanti che si svegliano con l’idea che oggi c’è la palestra. Così, alcuni più fiduciosi si sono alzati dal letto, hanno fatto il caffè e si sono messi i pantaloncini per essere pronti nel caso si vada in palestra. Altri, quelli scettici per natura, sono rimasti nel letto per evitare altre delusioni. Ecco che in questa mattina di lunedì, mentre il sole con violenza riscalda la piccola cella aggiungendo alla sofferenza del caldo il ricordo del mare e della spiaggia, l’agente, per la gioia di tutti, grida "palestra!". Tutti giù dal letto e via a giocare. Se qualcuno dovesse fare la cronaca della partita in diretta, avrebbe molte difficoltà. La varietà dei colori delle magliette non dà la minima possibilità di distinguere le squadre. Il gioco entra subito in una accesa competizione. Tutti rincorrono con tenacia il pallone oppure seguono con entusiasmo lo schema che non c’è. Ci sono un paio capaci di palleggiare e poi, piazzati nelle rispettive difese, ci sono quelli più robusti, a volte pure grassi, che a fatica tirano su le gambe, ma che quando intervengono su qualcuno lo scaraventano come uno straccio contro il muro. Saltarli è facile, ma se non ci riesci, sei spacciato. Oltre al miscuglio di magliette, di stature e d’agilità c’è anche un miscuglio di caratteri. Alcuni ridono e si divertono calciando il pallone ogni volta che se lo trovano tra i piedi, altri si coinvolgono emotivamente e gridando con nervosismo impartiscono suggerimenti oppure ordinano a chi passare la palla. Ecco Hassan, un arabo alto, che vedendo una palla che gli vola vicino, cerca di fare una rovesciata, tipo Crespo. Riesce nel tentativo, anche se cade schiaffeggiando il pavimento, però manca il gol. Dopo tutto è stata una bella azione. Tutti hanno gradito il gol mancato. Ma c’è qualcosa che non va, Hassan è rimasto fermo per terra. Si è fatto male. Nessuno capisce cos’ha. Tutti i giocatori sono corsi ad assisterlo, due di loro si staccano dal gruppo per andare a chiamare l’agente, che si mette subito a parlare per radio. La sua conversazione con l’apparecchio è breve. Hassan ora è in un angolo del campo e la partita riprende. Hassan è marocchino. I suoi capelli neri, ricci e corti, assieme al viso lungo e scuro, mostrano chiaramente la sua origine. L’espressione della faccia, già di per sé stampata di tristezza, ora è esageratamente sofferente, mentre lui sta lì abbandonato in quell’angolo del campetto. È magro e alto, Hassan, e la sua schiena ha una naturale piega in avanti che di profilo lo fa assomigliare a un punto interrogativo che si è perso e non segue più la domanda. Ora però il suo corpo ha preso una forma molto strana. Nella caduta, il suo braccio destro è uscito fuori posto e pende senza controllo. Hassan si appoggia contro il muro e segue la partita con occhi bastonati. Nessuno sa quanto pesa un braccio, ma vedendo lui con la spalla inclinata si può dire che pesi una tonnellata. La partita continua come prima tra grida, litigi e risate. Passano una decina di minuti e Hassan viene accompagnato da un agente fuori dalla palestra. Sparito dalla nostra vista, bastano due minuti per dimenticarci di lui. La mattina è appena cominciata e bisogna pensare a correre e giocare. A mezzogiorno, appena finito di pranzare, l’agente del mio braccio mi informa che posso andare dal dentista. Perfetto. Sono più di otto mesi che ho fatto richiesta e finalmente posso andarci. Il dentista mi ha otturato un dente quasi un anno fa, ma nel giro di qualche settimana l’otturazione ha cominciato a disfarsi. Ho perso quasi la metà del materiale in poco più di un mese. A quel punto ho richiesto un’altra visita odontoiatrica. Ci sono voluti appunto otto mesi per essere chiamato e ora mi preparo veloce come se temessi che loro possano cambiare idea e rinviare la visita di altri otto mesi. Percorro scale e corridoi correndo. Giunto nel reparto infermeria mi indicano la cella d’attesa, poiché il dentista è occupato. Entro nella celletta e lì trovo seduto Hassan con quella stessa posizione deforme. L’espressione della faccia è sempre quella di un morente, ma d’altronde non riuscirei ad immaginarlo diversamente. "Ma cosa fai ancora qui?", gli domando. "Non ti hanno medicato?". Mi guarda dal basso in alto e mi risponde di no. Dopo qualche minuto di silenzio mi racconta che gli hanno comunicato che lo porteranno all’ospedale civile di Padova e che deve attendere la scorta. Guardo l’orologio. Sono le 12.45 e cerco di ricordare quante ore ha passato lì nell’attesa. Sono almeno tre ore di dolori. Ma a un certo punto gli hanno fatto delle iniezioni di antidolorifici e ora non sente più nulla. È seduto sulla panchina e, con il petto che riposa sopra le ginocchia, ha lasciato il braccio cadere fino al pavimento. Lo lascio in questa posizione scimmiesca, quando mi chiama il dentista, e lo trovo nella stessa posizione quando esco. Ho passato una mezz’ora dal dentista, un uomo basso e tarchiato, con la testa grossa e pelata che fa da cornice ad una faccia rotonda che sorride sempre. Lui mi ha dato un’occhiata al dente e mi ha assicurato che c’è ancora materiale dell’otturazione. Rispondo che, nonostante tutto, il buco nel dente è diventato comunque una caverna, ma il dentista preferisce convincermi che non c’è la necessità di rifare l’otturazione, piuttosto che rifarla. Gli chiedo con insistenza di riempire questo dente ormai per metà vuoto, ma la sua scarsa convinzione di farlo lo spinge in un lungo discorso in cui mi spiega gli ideali rilievi dei denti, il modo migliore per masticare e lavarli. Poi mi promette che, se dovesse fuoriuscire ancora del materiale oppure cominciare a farmi male, allora potrò ritornare, e lui mi rifarà l’otturazione. Ma come, dovrei aspettare che esca tutta l’otturazione, oppure faccia male un dente devitalizzato? Scappo via, perché più che un dentista, mi sembra un venditore ambulante che cerca di rifilarmi un pacco. Saluto Hassan augurandogli buona fortuna e mi incammino lentamente per i lunghi corridoi in direzione della mia cella. Ecco che in questa mattina di lunedì, mentre il sole con violenza continua a riscaldare la piccola cella, l’agente chiude il cancello dietro le mie spalle. Stranamente non penso più ad Hassan che aspetta con eroica pazienza la scorta per andare al pronto soccorso. Non penso neanche al dentista che non ha voglia di lavorare, cerco solo di capire se c’è qualcosa che si può cambiare in questo posto dimenticato anche da Dio. Infami Francesco Morelli - Codici di comportamento carcerari... Codici di comportamento carcerari, solidarietà tra detenuti, rispetto delle regole: Parliamone con un po’ di coraggio! Febbraio 2000 Le discussioni su temi, come i codici di comportamento carcerari, la solidarietà tra detenuti, il rispetto delle regole, sono quelle che fanno aumentare sensibilmente in redazione il cosiddetto "tasso di litigiosità". Ma Ristretti Orizzonti è un giornale nato proprio con l’idea di non avere tabù e di accettare di affrontare qualsiasi questione, anche la più spinosa: quindi litighiamo, ma parliamo di tutto, e lo facciamo anche sulle pagine del nostro giornale, pubblicando per esempio qui di seguito due interventi molto diversi, a volte contrapposti, su questi temi. Naturalmente la Redazione non ha e non vuole avere una "linea politica" in proposito: c’è spazio per tutte le opinioni, basta esprimerle in modo corretto e attento alle ragioni degli altri. A proposito di codici di comportamento carcerari Sono in carcere da circa otto anni e ho potuto constatare che il recupero sociale è quasi un’utopia. I dati ufficiali indicano nel 70% la percentuale dei recidivi, ma a questi andrebbero aggiunti coloro che tornano a svolgere attività illegali riuscendo a non essere scoperti: sono in pochi, ma ci sono, quelli che ce la fanno a reinserirsi per davvero. Gli ostacoli al reinserimento sociale sono molti, ma almeno si dovrebbe evitare che il carcere continui ad essere una università del crimine, attraverso l’omologazione ai modelli della devianza anche di persone che potrebbero essere recuperate, in special modo i giovani. Secondo me, se vogliamo cambiare in meglio il carcere, dobbiamo per prima cosa liberarci da una certa mentalità, che consiste nel sentirsi in contrapposizione con le istituzioni e orgogliosi della propria condizione di coatti, con l’adozione di propri codici di comportamento che non sempre hanno a che vedere con la civile convivenza. Le regole servono in ogni circostanza, quando due o più persone devono convivere, altrimenti è difficile andare d’accordo. Molte di queste regole sono dettate dalle leggi, che magari non sono garanzia di giustizia nei rapporti sociali, ma almeno delimitano in modo preciso quale debba essere il comportamento da tenere. Dove non arrivano le leggi, l’esperienza e la convenienza portano ad adottare una serie di convenzioni, accordi taciti che presentano maggiori rischi, ma pure una maggiore aderenza alle esigenze del momento ed ai bisogni delle persone: succede anche in una famiglia, dove si stabiliscono delle regole che, seppure basate sull’affetto e pensate in funzione del mantenimento dell’unione, a volte diventano insopportabili e determinano la rottura del rapporto. Però ci sono anche dei luoghi, come le caserme e le carceri, nei quali le regole non scritte a volte significano violenza e discriminazione; questo succede perché sono pensate per scopi diversi, di solito per imporre un potere alternativo a quello esercitato dall’istituzione, per affermare una identità culturale contrapposta ad essa. Queste regole possono significare violenza in quanto esistono soltanto se riconosciute e rispettate da tutti senza discussioni: o le accetti, e sei integrato nella comunità, oppure le rifiuti, e sei il disturbatore, una persona da emarginare. La violenza raramente si manifesta in modo esplicito, ma passa attraverso gli sguardi, le parole dette e quelle taciute, le malignità che condizionano la vita in carcere. Del resto, ogni detenuto è costantemente oggetto di violenza, attraverso la miriade di piccole e grandi ingiustizie che subisce, tra ritardi, rifiuti e incomprensioni; e questa carica di violenza accumulata è difficile non sfogarla da qualche parte: su se stesso, con l’autolesionismo ed il suicidio, ma a volte anche sugli altri, con il sopruso e l’intimidazione. Credo che la differenza tra la persona "recuperata" e quella difficilmente recuperabile consista soprattutto nella capacità di controllare le proprie azioni e reazioni. Il carcere non aiuta certamente a pacificarti, semmai impari ciò che conviene o non conviene fare e l’essere opportunisti spesso diventa una necessità di sopravvivenza, un’abitudine che ti accompagna anche quando torni libero: calcoli i possibili vantaggi e svantaggi di tornare a delinquere e decidi di conseguenza. Parlare di moralità è spesso difficile, per chi ha bruciato tanti anni della propria vita, per chi ha conosciuto la disperazione, per chi ha subito (e anche inflitto) umiliazioni e violenze di ogni tipo Quella che, nell’ambito della malavita, è chiamata "morale", è spesso la difesa di una particolare cultura che distingue tra reati accettabili e reati inaccettabili, tra persone degne di rispetto e persone da disprezzare. La filosofia malavitosa trova nel carcere uno spazio privilegiato per svilupparsi in tutte le ramificazioni e sfumature, perché in carcere la pratica criminale è sostituita dalla teorizzazione del crimine, dalla sua spiegazione e giustificazione: e capita allora che la "colpa" del reato venga spesso fatta ricadere su qualcun altro, che si ritenga di essere stati condannati a causa dell’ingiustizia sociale (anche se è vero che nel carcere confluiscono tutti i disagi sociali), di una famiglia disattenta ed egoista, di giudici insensibili, di "infami" senza moralità. Certo, il tema della collaborazione di giustizia è molto controverso e il pentitismo è spesso nient’altro che uno squallido calcolo di convenienza, praticato sulla pelle degli altri. Ma credo anche che, quella di poter cambiare vita, sia un’aspirazione legittima di ciascuno, a prescindere dal suo passato, e normalmente questo non è concesso a chi è stato legato ad associazioni criminali, perché i suoi compagni temono possa, presto o tardi, rivelare dei segreti, magari costretto dalle circostanze. Così accade che questa persona diventi collaboratore da subito, in modo da garantirsi almeno la protezione dello stato, perché l’alternativa sarebbe di rimanere nell’associazione, oppure di essere eliminato da essa (spesso, in questi casi, non potendo punirlo direttamente, gli ex complici si vendicano uccidendo i parenti del collaboratore, comprese le donne ed i bambini, quindi violando pure le regole morali, da loro stessi create, secondo cui donne e bambini devono essere rispettati). Un’altra considerazione in merito è che un uomo che abbia maturato un "normale" senso della giustizia può avere il desiderio di impedire che vengano commessi nuovi reati, senza per questo voler fare l’eroe o avere un’inclinazione poliziesca. Comunque bisognerebbe sempre distinguere le persone che denunciano i loro ex complici (che possono essere considerate, con ogni ragionevolezza, traditori) da quelle che, invece, denunciano persone estranee, che hanno usato violenza contro di loro, o contro altri, in ogni forma; come potrebbero difendersi, se non in questo modo: facendosi "giustizia" da sole? oppure accettando con rassegnazione di subire il sopruso? Alcuni crimini provocano sentimenti di rifiuto anche tra i criminali stessi, detenuti o non, ad esempio le violenze sessuali, lo sfruttamento della prostituzione, il matricidio: dipende forse dal fatto che nelle vittime di questi reati ognuno identifica i propri cari, o vede le persone più deboli e indifese come donne e bambini. Però, se ci pensiamo, ogni tipo di reato potrebbe colpire le persone a noi vicine, o noi stessi, dall’omicidio, alla rapina, al furto, al ricatto, e allora perché questi non provocano la stessa reazione? Nel carcere si crea a volte una gerarchia di valori, in base alla quale i detenuti sono suddivisi in una serie di sottocategorie Per logica, noi dovremmo occupare il gradino più basso della scala sociale, poiché godiamo di minori garanzie e diritti, spesso siamo anche i più poveri, comunque siamo soggetti alle decisioni di politici, magistrati e funzionari, operatori sociali ed agenti; tutti scelgono al posto nostro e noi non possiamo scegliere neanche per noi stessi. Però è umanamente difficile accettare di essere gli ultimi, e allora nascono le sottospecie di detenuti, contraddistinte da una serie di caratteristiche personali e sociali, cominciando da quella che viene chiamata "coerenza con le proprie scelte passate": al primo posto ci sono di solito gli irriducibili, poi vengono i dissociati, infine i "pentiti", o collaboratori di giustizia che dir si voglia. Un altro criterio di separazione è quello delle condizioni personali, dalla provenienza, alla cultura, alla salute, per cui ci sono situazioni in cui lo straniero è considerato inferiore all’italiano e lo zingaro inferiore a tutti, il tossicodipendente inferiore a chi non lo è, l’omosessuale all’eterosessuale, e così via, all’infinito, in modo ci sia sempre qualcuno inferiore ed ognuno possa costruirsi una sua personale "classifica". Infine c’è il criterio giuridico-morale, secondo il quale alcuni reati godono di maggiore considerazione, mentre altri sono stigmatizzati e, ancora, i criminali professionisti godono di una certa "rispettabilità" e sono tenuti in maggior conto dei dilettanti ed i dilettanti di quelli "casuali". Sul gradino più basso ci sono i violentatori, i magnaccia e altri simili "personaggi": questa realtà è comunemente accettata ma determina anche situazioni paradossali per cui succede, ad esempio, che un detenuto responsabile dell’uccisione dell’ex fidanzata sia accettato dai compagni, mentre se l’avesse "soltanto" violentata sarebbe considerato un infame, da relegare nelle sezioni protette. Poi leggo, in un libro che evoca il carcere dei tempi andati, la protesta risentita del nostalgico di turno contro le persone che "non sanno farsi la galera", che "pensano solo ad uscire". Trovo molto discutibile questa protesta: a cosa dovrebbero pensare, secondo l’autore del libro, i compagni detenuti? A "farsi un nome" nell’ambiente della malavita, garantendosi la galera fino alla vecchiaia!? Cambiare vita, modificare atteggiamenti e comportamenti, non è una scelta obbligata per nessuno ma è per me la sola scelta intelligente, contrapposta a quella di adattarsi a regole e mentalità che portano solo alla perdita della propria autonomia. Quello che, secondo me, manca a molti detenuti è la capacità e la voglia di mettersi in discussione, senza per questo dover perdere dei pezzi della propria vita, ma piuttosto per rielaborarli alla luce delle nuove esperienze e circostanze. È vero che l’ambiente stesso del carcere non aiuta molto in questo compito: poche le occasioni di confronto, molte le situazioni in cui si deve subire in silenzio e si impara a dissimulare la propria rabbia, a nascondere i propri sentimenti, a difendersi con la menzogna. Ci sono momenti nei quali il dialogo sarebbe possibile ma mancano gli stimoli adatti: all’aria o in socialità, sotto le risate forzate, sotto le battute spiritose ed i discorsi dotti, si respira una grande tristezza ed indifferenza, ognuno con i suoi problemi e pensieri, tutti insieme ma comunque soli. Suicidi e autolesionismo Elton Kalica - In carcere è capitato a tanti di essere testimoni di un suicidio Ci si accorge che qualcuno, nella cella accanto, ha smesso di gridare, di piangere… di respirare dicembre 2003 Avevo sopportato l’arroganza e la stupidità di Giuseppe diverse volte, finché quel giorno non potei più resistere e gli affibbiai un manrovescio sul muso facendogli sputare sangue per qualche minuto. È strano come con un semplice gesto – nel mio caso, il movimento di un braccio – si riesca a buttare fuori lo stress, l’avvilimento, l’odio che abbiamo accumulato nei confronti di qualcuno; l’idea di avergli fatto del male ti fa rilassare per qualche istante, sembra ripagarti della ingiusta sofferenza subita. Così ero abbastanza soddisfatto, mentre l’altro si puliva col fazzoletto il labbro spaccato; ma la mia soddisfazione trovò una sgradevole risposta la notte stessa. Giuseppe aveva raccontato tutto all’ispettore capo e quest’ultimo aveva fatto la dovuta relazione al direttore, che a sua volta aveva ordinato con urgenza che il detenuto, vale a dire il sottoscritto, fosse accompagnato in isolamento, nell’attesa del consiglio disciplinare. Camminai lungo il corridoio, a me già noto, in compagnia di tre agenti silenziosi trascinando il sacco nero, con dentro lenzuola, coperte e due cambi di biancheria. Nella fretta impostami, avevo trovato il tempo e l’abilità di infilare anche due libri dentro le lenzuola, ma non avevo potuto prendere la lettera per la mia ragazza, scritta a metà. Mi venne in mente per qualche secondo il mio viso rilassato mentre scrivevo pensieri ed emozioni speciali, con la convinzione che sarebbero giunti alla destinataria entro il tempo calcolato. E mi sentii ingenuo ad aver ipotecato il mio tempo: come facevo a fare calcoli quando sapevo che, rinchiuso in carcere, non avevo nessun dato certo riguardo alla mia esistenza, presente e futura? Troppe erano le circostanze che ne avevano il controllo assoluto, che se la contendevano tra loro, e non c’era mai certezza su chi effettivamente avrebbe prevalso: il direttore, gli agenti, i detenuti pronti a riferire qualcosa, il magistrato, il destino stesso; erano tutti elementi incontrollabili che potevano influenzare la mia esistenza a loro piacimento, in assenza totale di una qualche modifica da parte mia, studiata o istintiva. Anche l’istinto riesce a controllarsi quando riconosce l’ineluttabilità. Decisi quindi che non avrei più lasciato una lettera a metà: scrivere, imbustare, spedire prima, e poi aspettare le novità che il momento contingente mi avrebbe imposto a suo piacimento. Per mia fortuna, non mi abituai subito alla nuova temporanea abitazione, che non starò qui a descrivere: non si può descrivere una scatola di scarpe con dentro una branda, se non con il silenzio. Era proprio il silenzio quello che regnava nella cella d’isolamento, nei primi giorni della mia permanenza. Ne approfittai per leggere e meditare. Si legge e si pensa molto quando si ha il corpo immobile e la consapevolezza che si rimarrà così ancora per anni. Poi arrivò il mio tormento: un uomo che gridava con tutte le sue forze "voglio uscire da qui" e che poi, mentre recuperava fiato per ripetere urlando questo suo desiderio, bestemmiava a voce bassa, come se temesse più un’offesa terrena che divina. Con difficoltà mi abituai anche a questo, e continuai il mio impegno con i due romanzi, con l’accompagnamento di questo sottofondo eretico. Accadeva però che il grido di libertà fosse così acuto (invadeva, infatti, il piccolo corridoio seguito da un’eco che mi ritornava raddoppiando la tonalità del grido successivo), tanto da distogliermi dalla concentrazione ormai acquisita; allora non mi rimaneva altra scelta che affacciarmi al cancello e chiamarlo, invitandolo a fumare una sigaretta delle mie. "Non urlare cosi forte!" gli dicevo, "fuma una sigaretta con me e poi mettiti a letto." "No. Io non posso stare in isolamento, tu non capisci, devo uscire fuori di qui!", mi rispondeva, mentre allungava la mano fuori del cancello, per prendere la sigaretta che avevo buttato sul pavimento. Il primo giorno del suo arrivo questa scena si ripeté cinque, sei volte. Il secondo giorno cominciò con le solite bestemmie a voce bassa, quasi gemiti, ma abbastanza forti da essere sentiti da me. Io leggevo, steso sul letto, con il sottofondo delle sue sacrileghe affermazioni e domande e non mi accorsi quando lui, stanco di attendere invano risposte che non arrivavano, smise di sussurrare, regalandomi il silenzio dei miei primi giorni d’isolamento, quando ero solo. Non ricordo quando mi accorsi di questo improvviso silenzio; è facile dimenticarsi di uno sconosciuto che ti domanda una sigaretta nel lungo corridoio, oppure di qualcun altro con il quale scambi, magari nella attesa di una visita medica, un insignificante dialogo fatto di commenti futili e sfuggenti; così mi fu ancora più facile disinteressarmi di un uomo che per me non aveva un volto e nemmeno un nome, ma che si materializzava in una voce offensiva, in un grido che importunava, in sussurri disperati, soltanto per procurarmi l’emicrania. Ero steso, immobile, dentro una scatola di scarpe e mi dimenticai che, nella scatola affianco alla mia, qualcuno aveva smesso di gridare, di piangere, e di respirare. Ero nella mia singolare tranquillità, che solo l’isolamento sa regalare, quando un odore fetido invase le mie narici. Forse continuai a leggere fino alla fine del paragrafo, o forse, cercai per qualche istante di risalire mentalmente alla causa di quell’esalazione putrida che stava invadendo la mia cella e che aveva già impestato il corridoio. Il silenzio, da me fino a quel momento ignorato, non durò a lungo. Saltai dal letto e aggrappandomi al cancello cominciai a chiamare l’uomo senza volto e senza nome: "Ehi, amico, ehi, vuoi una sigaretta? Rispondimi!". Ma l’unico a strillare questa volta ero io, mentre l’altro voleva essere lasciato in pace. Non ricevere risposta mi convinse del mio iniziale timore, il silenzio che prima non aveva richiamato la mia attenzione ora era diventato eloquente, confermando quello che il mio intuito sospettava: l’odore putrido veniva dal suo corpo abbandonato. Avevo già assistito a due suicidi, uno dei quali era stato per impiccagione, e sapevo che spesso il corpo ancora caldo si rilassava dalla lunga tensione, e di conseguenza scaricava senza nessun imbarazzo tutto il contenuto dell’intestino ancora funzionante, come ultimo gesto terreno, preparandosi per uscire di scena, senza tracce di vita. Quel tanfo, che ora seguiva con accanimento il lungo silenzio, mi convinse che la voce della scatola accanto, il mio tormento del giorno prima, mi aveva lasciato in pace soltanto perché soffocato da un lenzuolo. "Agente! Agente! Agente! Corri!", chiamai a tutta forza, finché non fui raggiunto dall’agente al quale indicai la cella della voce ormai silenziosa. "Porca puttana!", esclamò lui alla vista di quello che io avevo sospettato a ragione, e corse via. Sparì per un paio di minuti, per tornare con i rinforzi che irruppero nella scatola da scarpe accanto alla mia, dove la voce che io conoscevo così bene non risuonava più. Arrivò una barella rumoreggiando, per via di una ruota che zigzagava ribelle; non sentivo più l’odore putrido di prima, eppure i due infermieri si coprirono il naso. Dopo un attimo, l’uomo era pronto a lasciare la scatola adagiato in posizione di riposo; speravo di vedere il viso, forse reso viola dalle vene intasate all’improvviso, oppure bianco per il vuoto rimasto dalla fuga della vita, ma la barella uscì silenziosa circondata dagli agenti e gli infermieri che m’impedirono di dare un volto alla voce che mi aveva parlato il giorno precedente. Potevo scorgere soltanto la ruota che ora traballava con difficoltà sotto il peso del corpo sconosciuto. Sentii gli agenti, o forse gli infermieri, commentare che aveva ancora polso, l’avevano salvato dalla morte che forse ora mi stava guardando con animosità, trovando in me la causa del suo banchetto mancato. Doveva capire che non era colpa mia se quello sconosciuto aveva deciso, forse aspettato, di offrirsi alla sua tavola, proprio mentre chi aveva il controllo momentaneo della mia esistenza aveva deciso di portarmi nello stesso luogo predestinato. È divertente pensare che la morte, come me che avevo lasciato a metà la lettera per la mia ragazza, non aveva calcolato certe influenze misteriose, sempre pronte a deridere gli ingenui. Ne deduco che d’ora in poi, anche la morte dovrà tentare d’avere la sua influenza tra quelle entità che, così cinicamente, si contendono il controllo delle nostre esistenze, private delle ragioni e degli istinti, altrimenti avrà di nuovo tra i piedi qualcuno pronto a gridare "Agente, corri!". Lassad Jlassi - Solitudine che taglia come una lametta Quando esplode la disperazione. Tre racconti sull’autolesionismo, tre storie di “ordinaria desolazione” carceraria, in cui chi non ce la fa usa il suo corpo per parlare della propria sofferenza testimonianze raccolte da Mohamed Ali Madouri gennaio 2006 A me, che sono tunisino, al mio paese hanno sempre raccontato che è in Egitto, negli anni ‘70, che le prime persone di razza araba e di religione musulmana cominciano a tagliarsi il corpo. Siamo in uno dei quartieri più poveri di Alessandria, quando i poliziotti arrivano con un autobus e con un altoparlante offrono lavoro agli uomini disoccupati. È una trappola, perché gli uomini che vanno agli autobus si ritrovano prigionieri ai lavori forzati, senza nessuna paga se non il misero cibo per la sopravvivenza. Qualche giorno più tardi un uomo si taglia le vene per non lavorare e gli altri lo imitano. Da quel momento, pian piano la consuetudine si diffonde anche negli altri paesi arabi. In carcere sono tanti i detenuti che si tagliano. Per capire meglio i motivi più profondi che li spingono a questi gesti, ho raccolto tre testimonianze di uomini che, per un motivo o per l’altro, in carcere si sono autolesionati. Ezzeddine è un tunisino, emigrato 23 anni fa, e che ha conosciuto bene l’Italia di allora e quella di oggi I primi anni in cui sono arrivato in Italia mi sentivo come se fossi a casa mia. Una volta gli italiani erano molto più umani e buoni di cuore. La gente era contenta di parlare con noi, era molto facile inserirsi nella società italiana. Venti anni fa non c’era tutto questo traffico di droga, tutta questa criminalità. Gli stranieri erano pochi, ma soprattutto noi africani eravamo pochissimi, per questo la gente di allora era affettuosa e aperta con noi. Dal lontano 1982 e fino al 1997 ho lavorato, anche se in nero. Ho lavorato come muratore, imbianchino, ferraiolo, saldatore e falegname. Mi sono sempre trovato bene, guadagnavo abbastanza, la mia vita era semplice e in più c’era mio fratello che lavorava in una cooperativa e mi dava una mano per andare avanti se non ce la facevo. Poi conobbi una ragazza tossicodipendente. Mi impegnai e mi presi cura di lei, accompagnandola ogni giorno, per tre mesi di fila, al Ser.T., fino a quando uscì dal tunnel della droga. C’eravamo ripromessi di realizzare una vita semplice e serena, volevamo costruire una famiglia come tutte le altre, quello era il nostro programma futuro. Ci riuscimmo con le nostre forze, perché tranne mio fratello nessuno ci aiutò. Le cose andavano sempre bene, anche dopo la nascita del nostro bambino, che ci portò molta felicità e serenità… Ad un certo punto successe però che entrarono nella nostra vita mia suocera ed una sua amica, che volevano strapparmi la mia ragazza e mio figlio. E lei, stressata dalle continue insistenze di sua madre, incapace di far valere la sua volontà, cedette ed una sera, quando tornai a casa dal lavoro, non trovai nessuno. Soltanto un bigliettino con sopra scritto: “Vado via ma torno fra tre giorni”. La chiamai sul telefonino ma era spento, quindi chiamai mia suocera che mi rispose di non sapere nulla e chiuse la comunicazione. Aspettai fino al giorno successivo senza ricevere nessuna notizia. A quel punto andai in questura e denunciai l’inspiegabile scomparsa della mia famiglia, e lasciai anche le loro foto ai poliziotti. Le cose andarono avanti così per un mese intero, fino a quando un giorno i poliziotti mi invitarono in questura. Andai di corsa e mi informarono che mio figlio e la mia compagna erano in una comunità, senza però fornirmi alcuna indicazione su come rintracciarli. Proprio in quel periodo mi era arrivato un invito dal Tribunale per i minorenni di Venezia: mi presentai all’udienza, il giudice, una donna, mi domandò che cosa volessi. “Voglio la mia famiglia”, risposi. Mi fu detto di trovarmi un lavoro ed avrei così potuto riunirmi con la mia compagna e nostro figlio, e quando obbiettai che un lavoro e anche una casa già li avevo, sentii pronunciare solo un “adesso vediamo…”. Proprio quando la situazione pareva risolversi, feci un incidente in moto che complicò tutto. Una brutta ferita ad una gamba, per la quale fui sottoposto anche ad un intervento chirurgico che comportò oltre un mese di ricovero ospedaliero. La mia ragazza veniva a trovarmi tutti i giorni, mi fu molto vicina, e in quel letto d’ospedale le parlai di tutto quello che avevano messo in opera sua madre e la sua amica per separarci. Una volta dimesso tornai a casa assieme a lei. Andavamo spesso a parlare con l’assistente sociale, con la speranza di vedere nostro figlio e stargli vicino. Lei ogni volta ci diceva che si sarebbe risolto tutto, ma la sofferenza alla gamba mi impediva di lavorare e ogni giorno vedevo che l’impegno che io e la mia ragazza dimostravamo non serviva a nulla. Cominciò una strada in salita, le cose iniziarono a peggiorare, mi assalì l’incubo di non vedere mai più mio figlio, e fui preso dalla disperazione di perderlo per sempre. Mi ero infilato in un mare di sofferenza e di malinconia. L’immagine di mio figlio era sempre nei miei occhi, e andò a finire che, con l’illusione di dimenticare il dramma che mi stava capitando, per estraniarmi da quella dura realtà, mi buttai sulla droga. Le cose andarono avanti così per otto mesi, fino a quando mi arrestarono e mi condannarono a un anno e otto mesi di arresti domiciliari, e dopo tre mesi mi portarono in carcere. Qualche giorno fa mi sono “tagliato”, ho bevuto candeggina e ho anche tentato di impiccarmi. L’ho fatto perché mi manca mio figlio, non faccio altro che pensare a lui. Mi hanno tolto la cosa più bella e più preziosa che ho mai avuto. Da mio figlio dipende la mia felicità o la mia sofferenza… Quando ho tentato il suicidio ho pensato spesso, sia prima sia dopo essermi salvato, che con quel gesto avrei fatto crescere mio figlio senza la mia presenza, senza suo padre. Però l’ho fatto comunque perché sono disperato e stufo di questa vita spietata, vedo tutto buio. Mi sono trovato in una marea di problemi, da solo, ma il mio cuore è più piccolo di tutto ciò. Il mio cervello non mi dà tregua, non vuole cancellare l’immagine di mio figlio nemmeno per un attimo. Fino ad oggi non ho nessuna sua notizia, spero che non passi ancora molto tempo perché la solitudine mi sta davvero ammazzando… Asir Mohamed è un ragazzo tunisino pieno di tagli, “tutti per motivi differenti”, racconta lui Nel lontano 1985, quando avevo 15 anni, mi trovavo nel carcere minorile di Bosco Marengo, in provincia di Alessandria. Eravamo in sei di nazionalità marocchina e facemmo una rissa con dei ragazzi italiani. In seguito a questa lite, per evitare altri scontri, ci divisero in due piani diversi, ma nonostante la precauzione i problemi non erano terminati. Ogni volta che per qualsiasi motivo ci incontravamo, ricominciavamo nuovamente a litigare. Qualche giorno più tardi, dopo che demmo fuoco alle celle, la direzione ci punì con l’isolamento. In isolamento avvertii forte la solitudine e la mancanza dell’affetto familiare di cui ha particolarmente bisogno un quindicenne: preso dalla disperazione, per la prima volta mi feci del male, provocandomi dei grossi tagli nelle cosce. La seconda volta che mi tagliai risale al 1987, ed avvenne a casa mia in Tunisia. Mi ero innamorato di una ragazza che a mia madre non piaceva, lei mi diceva in continuazione di non frequentarla, ma io ero pazzo di questa ragazza. L’insistenza di mia madre mi stressò al punto che un giorno, stravolto dalla rabbia, presi una lametta e mi tagliai le braccia. Da quella volta mia madre mi lasciò in pace e… quella ragazza divenne mia moglie! Le cose in Tunisia non andavano bene: oramai mi avevano arrestato un sacco di volte, anche per cose che non avevo commesso. Agli interrogatori mi tagliavo per evitare le botte e le torture dei poliziotti. Finii in ospedale parecchie volte. Tanti altri ragazzi si tagliavano dalla rabbia di aver subito un torto e di non poter reagire, o anche per aver ricevuto una brutta notizia e persino per il tradimento della propria ragazza o della propria moglie. Ma in carcere ci si taglia soprattutto per disperazione e per solitudine. Cristiano, infine, è uno dei pochi italiani che ha dei tagli in qualche parte del corpo. Lo chiamo “marocchino” perché l’autolesionismo è tipico dei nord africani Nel 1993 mi arrestarono con l’accusa di omicidio per aver picchiato a morte un ragazzo del mio giro, del mondo della tossicodipendenza. Questa accusa era partita dal gestore di un bar che aveva visto il ragazzo vivo per l’ultima volta salire nella mia auto, che tutti conoscevano perché abitavo in un piccolo paese. Quando mi hanno arrestato, per il pericolo di inquinamento delle prove mi hanno isolato completamente. Mi sono ritrovato da solo in cella, con il terrore di essere condannato per un omicidio che non avevo commesso, e con la disperazione del fatto che la persona uccisa, oltre che essere un mio caro amico, era anche un amico dei miei familiari. Pensare a sua madre, e anche ai miei genitori e agli amici, mi faceva stare molto male. Ero veramente provato, ero isolato da tutto e da tutti. Non potevo nemmeno guardare la televisione per svagare almeno un po’ la mente, non potevo ricevere posta né effettuare neppure i colloqui con i miei famigliari, mentre in quel momento avrei avuto molto bisogno di gridare ai miei cari, e a tutti quelli che mi conoscevano, che ero innocente. Preso dalla disperazione decisi allora di “tagliarmi” per poter attirare l’attenzione di qualcuno. Ma anche così facendo non riuscii comunque a far sentire la mia voce. Le ferite che mi procurai furono del tutto inutili, perché mi ritrovai di nuovo in cella con la consapevolezza di non aver risolto nulla. Mi sono rimasti soltanto tutti i tagli che mi ricordano sempre quanto funzioni poco la giustizia italiana, parlo per me, ovviamente, perché tre mesi dopo venne riconosciuta la mia innocenza, per la quale sto ancora combattendo per ottenere un risarcimento dei danni, fisici e morali. Non mi sono mai pentito di essermi “tagliato”, anche se non so nemmeno io perché l’ho fatto. Forse perché mi sono trovato in una situazione dove mi sono reso conto che per il sistema non ero niente, non contavo nulla, per il sistema ero colpevole e dovevo essere condannato e basta. Per questo, quando guardo questi tagli, penso sempre che non devo mai mettermi nella situazione in cui mi possono incolpare di qualcosa, e mi tornano in mente quei giorni interminabili vissuti con la paranoia e la paura di passare il resto della mia vita in carcere per responsabilità altrui. Il Ciclo Picaresco di Nabil Tayachi Storia di Nabil, la Tunisia, la Rai Maggio 1998 Non può essere sempre per caso, ma a volte sì, a volte succede per caso di emigrare. L’emigrazione non è un fenomeno nuovo ma qualcosa di troppo vecchio, che non ha però fine, perché? è questo il problema, c’è sempre un perché. Io sono un emigrato extracomunitario, e ho avuto questa esperienza di tanti anni di sofferenza e anche di disperazione, di discriminazioni e qualche volta di felicità. L’emigrato quando decide di partire ha un’idea fissa in mente, un obiettivo da raggiungere: è quello di andare dove si può vivere meglio, e dove c’è democrazia, lavoro e la possibilità di realizzare i propri desideri e smettere di soffrire. Il più difficile, poi, non è emigrare ma lasciare dietro di se tutto, famiglia e amici, moglie o fidanzata, la sua terra e anche le cose care per lui etc., etc., una scelta per rischiare, perché quello che aspetta ogni emigrato lo sa soltanto Dio. Quando ero ancora al mio paese, la maggior parte dei giovani aveva voglia di emigrare e di andare a cercare fortuna in un altro paese, e tutto questo per colpa della disoccupazione, del lavoro nero, dei salari bassi, del regime poliziesco e anche della dittatura del governo. È la democrazia che là non c’è, c’è solo, potremmo dire, una democrazia a modo nostro, e poi ancora, e questo è un punto fondamentale, c’è la RAI e ci sono anche i primi emigrati che tornano e sembra che abbiano fatto i soldi. A casa mia c’è lavoro senza assicurazioni e senza diritti. Per lavorare al mio paese, si diceva: se cerco un lavoro lo trovo, ho studiato, ho due diplomi di meccanico, ho lavorato in tanti posti. Ma il problema vero è che si guadagna poco. Quando lavoro, non so quanto dura il periodo di prova, un mese o anni, e in tutto questo lungo periodo lavoro in nero, senza assicurazioni e non ho nessun diritto, o se anche lavoro in regola, se protesto e chiedo i miei diritti mi mandano a casa e non posso avere nessun risarcimento. Ricordo che il nostro ufficio sindacale mi sembrava il più bello del mondo, quando parlavi ti ascoltavano tutti e ti davano ragione, ma per avere qualcosa poi dovevi aspèttare come minimo anni, se non mollavi prima, se non ti arrendevi. E pensare che quando qualcuno passava da quelle parti e non conosceva il sindacato, gli pareva di essere capitato in una discoteca, perché la piazza era sempre pulita, i muri imbiancati e c’era della bella musica ad alto volume. Con il salario che un operaio guadagna, si può vivere "normale", come si dice, mangiare e dormire e niente più, e ringrazia Dio se non hai una malattia, perché pagare un medico e le medicine è dura, sono sempre troppo cari, e anche per vestirsi, se si comprano le cose locali si paga "un po’ normale", ma se hai voglia di comprare qualcosa di marca estera, per esempio un paio di scarpe da tennis, ti costano un mese di lavoro, se hai voglia di risparmiare per sposarti devi lavorare, mangiare a casa e non far altro, e se hai il vizio di fumare sei obbligato a smettere. Il governo lo abbiamo avuto sempre di dittatura, il regime è poliziesco, il capo di stato ha un potere a vita da quando ha fatto un colpo di stato, il governo è "democratico", ma dov’è questa democrazia? Chi si lamenta va in galera, chi beve alcolici, e viene fermato da un poliziotto, può essere mandato in galera, se uno è disoccupato lo mandano ai lavori forzati con un salario di spiccioli, se baci la tua ragazza per strada ti possono arrestare, se parli di politica sei rovinato, se uno è sospettato di avere commesso un reato lo incarcerano e spesso sotto tortura gli fanno firmare di aver commesso quel reato, e poi si dice che la polizia tunisina è troppo forte nelle indagini e arriva sempre a scoprire i colpevoli. Il presidente, che è al potere da dieci anni, parla sempre di aiutare i giovani, parla di democrazia e di diritti dell’uomo, ha dato diritto ai giornalisti di parlare liberamente, ma loro, guarda caso, non si sono mai lamentati del governo, l’hanno sempre descritto come un gruppo di "eroi", e allora che democrazia è? Vedi la RAI e ti viene voglia di partire Rai Uno è il canale che va in diretta nel mio paese da una ventina d’anni, da quando il nostro governo ha cominciato ad avere un buon rapporto di amicizia con il governo italiano (e forse è per questo che il nostro governo ha dato asilo a Bettino Craxi). E proprio Rai Uno ha avuto un ruolo fondamentale perché ha dato il coraggio a molti tunisini di emigrare in Italia: perché quando uno guarda quei programmi, e vede quel modo di vivere, vede e sente la democrazia, e anche la bella vita. Poi ci sono i primi emigrati tunisini, che quando ritornano in vacanza nel nostro paese fan vedere che economicamente stanno bene, comprano case, hanno macchine vestiti di marca, conti i; banca, e allora gli altri pensano solo che dall’altra parte, in occidente, la vita sia migliore. Perché da noi invece, la macchina, l’abbigliamento di marca, i ristoranti, queste cose se le può permettere solo la categoria dei ricchi. Ci sono allora, mi sembra, tanti motivi che spiegano le buone ragioni di quelli che hanno scelto di emigrare. Vedi Napoli e poi muori Storia vera di un immigrato nella città del golfo Febbraio 1999 Napoli per me è come una seconda patria, una città che presenta grandi contraddizioni e proprio per questo interessante da visitare: la gente è spesso buona ed accogliente, però la città per come me la ricordo io, qualche anno fa, era anche sporca e violenta. Sono arrivato in Italia con una nave della Tirrenia ed i documenti in regola, sbarcando a Trapani e poi andando a Palermo, dove ho trascorso una settimana. ma la mia intenzione era già di raggiungere Napoli, dove speravo di trovare degli amici. Da quando, alla metà degli anni ‘80, noi tunisini abbiamo cominciato ad emigrare in Italia si è sparsa una informazione dettagliata sul vostro paese: in primo luogo sulla moda, perché a noi piace molto vestirci all’europea, e poi sul clima e sulle possibilità di lavoro, sull’accoglienza che potevamo aspettarci… anche se non era facile capire davvero come ci avrebbero trattato, perché in ogni paese c’è gente brava e gente che lo è meno! Però chi aveva esperienza di vita all’estero concordava nel consiglio di stare alla larga dai connazionali ed ora che sono in carcere devo proprio dargli ragione! Dei napoletani invece si parlava molto bene e per questo avevo deciso di andare a Napoli: ci arrivai in treno, verso le due di notte, e la prima immagine che mi si presentò furono i barboni che dormivano per terra alla stazione e la piazza antistante sporchissima. Non mi sembrava di essere Europa, ma in qualche povero Paese dell’Africa e, senza volerlo, esclamai: "Dio mio proteggimi!". Nei giorni successivi incontrai alcuni compaesani che lavoravano come operai agricoli stagionali, ma a me non piaceva perché il lavoro in campagna è pesante e poco pagato senza contare che si correva il rischio di essere rapinati e anche peggio. Io sono nato in una grande città e l’ambiente dei piccoli centri rurali non fa per me, così trovai lavoro a Napoli in un autolavaggio, dodici ore al giorno per 100.000 lire la settimana. Capivo che mi stavano sfruttando ma avevo assoluto bisogno di guadagnare qualcosa, nessuno mi aiutava e almeno riuscivo a stare lontano dai "giri" dei miei paesani: a Roma, ad esempio, evitai di andarci dopo aver sentito che parecchi immigrati lì non si comportavano granché bene. Nell’autolavaggio lavorai per sette mesi senza un giorno di riposo e divenni amico di tanta gente, clienti anche di buona posizione sociale: medici, avvocati, commercianti, poliziotti, siccome vedevano che lavoravo sodo tutti mi volevano bene. Tutti mi chiamavano con il soprannome di Alì. Un giorno passavo vicino ad un ospedale ed un vigile urbano che conoscevo bene mi chiamò per presentarmi ai medici, agli infermieri ed anche ai malati: tutti a chiedermi, per scherzare, se avevo fatto soldi, se avevo la ragazza, mi chiamavano con il soprannome di "Alì". Il vigile mi disse: "Qui tutti parlano bene di te e voglio aiutarti perché anch’io penso che sei un bravo ragazzo, ho proposto ad un amico di assumerti come posteggiatore e lui ha accettato. Ti darà una buona paga. da mangiare e un posto per dormire". Gli ho risposto di sì perché mi fidavo di lui, ma il proprietario dell’autolavaggio dove lavoravo mi sconsigliò di andarci, e anzi mi disse che mi avrebbe messo in regola e questo per me era importante poiché mi avrebbe fatto avere il permesso di soggiorno. Però non poteva regolarizzarmi dandomi 100.000 lire la settimana, e alla fine me ne offrì 150.000 ed erano sempre poche: con un lavoro part-time di scaricatore avrei comunque arrotondato a 200.000! Certo è duro fare due lavori, 15/16 ore al giorno, ma ero arrivato in Italia con un progetto, quello di lavorare e mandare soldi alla mia famiglia per mostrare loro che sono in gamba: giovane ed in salute, potevo anche resistere ad un po’ di fatica! Dopo due giorni, comunque, vennero a prendermi per portarmi al nuovo posto di lavoro: erano con una Mercedes accompagnata da quattro potenti moto, tutti giovani tra i 25 ed i 27 anni ed il vigile stava con loro. "Ciao Alì, sei pronto?". "Sì…". "Ti presento Alberto". "Piacere". (Era un ragazzo alto, biondo e muscoloso). "Mi ha parlato di te Antonio (che sarebbe il vigile), per me vai bene e ti garantisco tutto quello che lui ti ha promesso, oltre ad un milione al mese. Ok?". "L’ufficio" era l’ombrellone con il tavolino dove avevo mangiato Poi sono salito sulla macchina con Alberto, che era figlio del padrone del parcheggio. Scortato dalle moto mi sembrava di essere un diplomatico o un presidente, ma non dicevo nulla. Ci siamo diretti ai quartieri spagnoli, passando da un vicolo all’altro, fino a che siamo arrivati al posto di lavoro. Erano quasi le otto di sera. Scendiamo nel quartiere: c’era un uomo seduto sotto un ombrellone da spiaggia, che mi fu presentato come il padre di Alberto. Mi disse di sedermi con lui e poi chiese al figlio di portare una birra ed una pizza per me. Mentre mangiavo lui mi parlava di tante cose, si chiamava Franco, ma io ero impaziente di vedere il parcheggio dove avrei lavorato. Finalmente Alberto si decise a mostrarmelo: mi aspettavo di salire su una macchina o un motorino per raggiungerlo invece mi disse di seguirlo a piedi nel labirinto di vicoli e vicoletti. Mi mostrò le automobili addossate ai muri. 100 in questo vicolo, altrettante in quello che fa angolo. Quello era il "parcheggio…", mentre "l’ufficio" era l’ombrellone con il tavolino dove avevo mangiato, le chiavi delle macchine erano appese al muro sopra il tavolino. Tra me mi dicevo: "Dovrei difendere queste macchine da tutti i ladri di Napoli!? Qui si ammazzano per un motorino, forse è meglio che ci ripensi prima che sia tardi…". Ma Franco mi fece: "Alì, ti faccio vedere dove dormi". Partiamo con il motorino ed in 30 secondi siamo arrivati: in un cantiere edile, chiuso tra i palazzoni del quartiere, c’è la "mia" roulotte, pulita ed adatta alle mie esigenze. Alberto mi rassicura: "Qui tutti mi rispettano perciò non devi aver paura di niente, vedrai che ti troverai bene…". Io non osavo aprire bocca perché, da una parte, non credevo ai miei occhi, dall’altra mi sembrava una pazzia accettare quel lavoro, ma il mio carattere mi obbligava a rispettare gli accordi presi. a non tornare indietro: "Quando comincio a lavorare"? chiedo. "Questa sera", mi risponde (anche di notte si lavora, questa è proprio bella!) "Va bene", dico, accettando definitivamente. Ritorniamo in "ufficio" e lui se ne va dicendomi che sarebbe ritornato subito. Rimango così solo mentre cominciano ad arrivare le automobili con i clienti: mi chiedono chi sono ed io li informo che sono il nuovo parcheggiatore. Mi chiedono dov’è Franco, dico a tutti che tornerà presto: loro rispondono che non lo vedono da parecchio tempo. Mi lasciano le chiavi e se ne vanno. Per fortuna arriva Alberto a farmi vedere come vanno sistemate le macchine. Suo padre non si fa più vedere e con lui posso parlare liberamente tutta la sera. Mi sembra un bravo ragazzo. Arrivano anche molti suoi amici, un vero esercito, scherzano e ridono come matti, io cerco di essere serio ma loro continuano a sghignazzare. Capisco il motivo quando vedo che scaldano dell’hascish. Cominciano a fumare ed invitano anche me a farlo, mi dicono di non avere paura e che quella ‘roba" in fondo viene dal mio Paese. "Vi sbagliate", gli rispondo, "l’ho vista soltanto in Italia, in Tunisia non c’è: non sono mica algerino io!". Continuarono a fumare ed a scherzare fino alle quattro del mattino e prima di andare a casa usarono il collirio per cancellare dagli occhi il rossore causato dall’hascish nel timore di essere scoperti e rimproverati dai loro genitori. Rimasto ancora solo mi prese la paura e pensai che dovevo accettare di fumare con loro, almeno se fossi morto non me ne sarei accorto. pensavo seriamente che in quel posto sarei finito ammazzato! Come Dio volle arrivò la mattina e i clienti abbonati al posto macchina andarono a lavorare, arrivarono altri automobilisti che si fermavano solo qualche ora ed anche una signora bionda che Alberto mi presentò come sua madre. Passano così i primi due mesi e sono già diventato amico di tutta la gente del quartiere: uomini, donne, ragazzi e bambini, proprietari di negozi. Con Alberto ed i suoi amici ho imparato a fumare hascish, ma ho anche cominciato a sentire voci strane riguardanti suo padre: sarebbe tossicodipendente di cocaina. Per me fu un duro colpo. Una mattina era appena arrivato e provai a chiedergli il denaro che mi doveva, volevo depositarlo al sicuro in banca. Lui mi prese in giro e sparì dalla circolazione per evitare di pagarmi; suo figlio Alberto ne aveva paura perché aveva trascorso 15 anni in carcere, lo aveva lasciato che era bambino e rivisto quando oramai aveva vent’anni, e non aveva per lui vero affetto. La madre era nella stessa condizione: aveva aiutato Franco in tutti gli anni di carcere ed appena lui era uscito l’aveva tradita con un’altra donna, dalla quale aveva avuto un figlio. Fu proprio la madre di Alberto a dirmi: "Alì, ti voglio bene come un figlio, ecco i soldi che ti spettano e se Franco non ti paga a fine mese sei libero di andartene". Una notte mi trovai davanti due uomini intenti a rubare una delle "mie" macchine Nel frattempo era arrivata l’estate e nel tempo libero andavo a passeggio per i quartieri spagnoli scoprendo i misteri della città. Mi chiedevo da tempo dove andassero uomini e donne, che rimanevano fuori casa fino a tarda notte: parecchi si trovavano in bische clandestine per giocare a carte e sniffavano cocaina per non farsi vincere dal sonno. Loro stessi mi consigliarono di non giocare e di stare alla larga da quel "giro". Passato qualche giorno però mi offrirono un "tiro" di cocaina, e mi sembrò piacevole farlo con loro perché erano tutte persone simpatiche. Franco aveva cominciato a trattarmi bene, mi portava al ristorante e mi dava perfino soldi in anticipo ma un giorno abbiamo litigato e gli ho detto che sarei andato via. Tornai alla mia roulotte e dopo un paio di ore arrivarono tutti gli "amici" per convincermi a rimanere: Alberto, suo padre, sua madre e altre persone del quartiere. Alla fine mi convinsero. Una notte mi ero messo a dormire dentro una macchina quando sentii dei rumori insoliti, mi alzai e mi trovai davanti due uomini intenti a rubare una delle "mie" macchine. Gridai loro di andarsene ed uno dei due mi sparò due colpi di pistola. Non mi colpì, per fortuna: una delle due pallottole entrò in una finestra e l’altra si conficcò nel muro. Mi ero buttato a terra e quando arrischiai di alzarmi loro se ne erano andati. Non avevo avuto realmente paura perché ero pieno di cocaina. La gente del quartiere scese a vedere cosa era accaduto e mi dissero di non preoccuparmi perché una cosa del genere non sarebbe più successa: arrivò anche Franco, che si complimentò con me perché ero stato coraggioso impedendo il furto. Dopo aver detto questo tirò fuori un sacchetto di cocaina e sniffammo insieme. Da quel giorno mi offrì regolarmente la droga: secondo lui, con il mio coraggio mi ero guadagnato la sua riconoscenza. Una notte stavo seduto su un’auto e un ladro, avvicinatosi silenziosamente, mi puntò la pistola alla testa ordinandomi di dargli le chiavi. Io mantenni la calma e gli dissi che quella macchina era del "signor X", conosciuto in tutto il quartiere e che il parcheggio apparteneva ad uno dei suoi uomini. Quello non mi credeva e per convincerlo ho dovetti dirgli come si chiamavano il figlio e la figlia del "signor X". A questo punto il ladro si prese paura, capiva di aver sbagliato e si scusò per questo con me. Così anche quella volta me la cavai. Intanto quasi tutti i clienti erano partiti per le ferie estive; una sera arrivano due uomini in motorino, uno lo conoscevo bene e l’altro non lo avevo mai visto. il primo mi disse: "Ti presento il signor X!" Io non volevo credergli, ma quell’altro (il signor X) mi disse: "Ho sentito parlare molto di te, mi dicono tutti che sei un bravo ragazzo". Mi invitò a sedere al tavolo con lui e mi chiese se potevano fare una "sniffata": io gli risposi che tutto il parcheggio era a sua disposizione per fare ciò che voleva. Ne offrirono anche a me ed io accettai. Poi il signor X mi disse che se qualcuno voleva farmi del male o si comportava male con me dovevo dirgli che ero amico suo e questo sarebbe bastato a farmi rispettare da tutti . In seguito, ripensando a quella sera, capii il motivo per cui nei vicoli non si vedeva anima viva: il padrone era in giro! Dopo un po’ arrivò un taxi con quattro uomini che non avevo mai visto e che raggiunsero il signor X al tavolo. Prudentemente mi allontanai, mentre quelli si trattenevano a parlare e sniffare. Andai dal taxista, che conoscevo bene, e feci appena in tempo a salutarlo che lui mi disse in tono di rimprovero: Alì, sei venuto in Italia per guadagnare e mandare soldi alla tua famiglia ed ora sei un drogato, ti sei messo nel guai: stavi seduto con una persona "sbagliata" e già due volte hai rischiato la pelle. Vai via, Alì, va’ via di qua!". Quella sera rimasi molto scosso dalle sue parole, andai a sedermi lontano dal signor X e dai suoi amici per pensare alla mia situazione: ogni tanto mi chiamavano, andai a comprargli dei dolci ma evitai di tornare a sedermi con loro. Se ne andarono soltanto verso le cinque del mattino. Verso le 10 io andai a casa di Franco e lui mi disse: "Cosa hai fatto, hai lasciato il parcheggio incustodito!?". "Quale parcheggio?", rispondo io, "tutti i clienti sono andati in vacanza". Lui mi disse di sedermi e mi chiese cosa non andava. Io gli dissi che volevo andare in vacanza ad Ischia per una settimana. Tutti i ragazzi del quartiere erano andati ad Ischia e mi avevano detto di raggiungerli. Allora lui tirò fuori il sacchetto con la cocaina e cominciammo a parlare, finche si decise ad aprire una valigia e mi mostrò una pila di atti giudiziari e ritagli di giornale. Erano tutti documenti riguardanti i reati che aveva fatto e le condanne subite. Andammo a pranzo al ristorante e poi passammo dalla mia roulotte per prendere i vestiti leggeri che mi sarebbero serviti in vacanza. Da lì raggiungemmo il porto dove, salutandolo, gli promisi di tornare per l’inizio di settembre. Appena lui se ne fu andato tornai all’uscita e presi un taxi per farmi portare alla stazione ferroviaria. Saltai sul primo treno in partenza e la destinazione era Mantova! "Vedi Napoli e poi muori…". Un tunisino alla scoperta del profondo nord Giugno 1999 Per andare da Napoli a Mantova, bisogna prendere il treno per Milano e poi cambiare. Il treno è quasi vuoto, entro in una cabina e apro il finestrino, è troppo caldo, l’estate è quasi finita, è l’ultima settimana di agosto. Vengo a sapere dal controllore che il treno arriva verso sera, allora provo a dormire ma non ci riesco. Passano tanti film davanti ai miei occhi, il mio cervello è confuso, sono tanto agitato e forse ho paura. Credo, dopo quello che ho passato a Napoli, che non avrò più problemi di quel genere, ma penso al futuro: a Milano, a Mantova, nel Nord Italia dove la ricchezza e il lavoro ci sono dappertutto. Un buon stipendio, una casa tutta per me, poi mi compro la macchina, vado in vacanza ogni anno a Tunisi. AI massimo tre anni e mi sposo, porto mia moglie in Italia e viviamo bene. Il viaggio è troppo lungo e mi piacerebbe trovare qualcuno con cui parlare. Voglio chiedere altre informazioni sul nord. Il treno si ferma a Roma, ma questa città non la posso visitare, è più forte di me: io voglio lavorare in regola, sono arrivato in Italia per lavorare non per spacciare droga, la droga non l’avevo mai vista in vita mia, in Tunisia. Nel mio Paese non sono mai entrato in galera e adesso vengo qui per finirci dentro!? Mica sono scemo: Roma. niente, è una città troppo rischiosa! Non entro aRoma, e poi odio Roma e l’impero romano. Loro hanno distrutto Cartagine con tutti i cartaginesi, maledetti tutti. Chiedo a un ragazzo qual è la prossima fermata e lui mi risponde: Firenze. Mamma mia, niente neanche Firenze, non voglio andare a vendere droga, io vado a lavorare e basta. Firenze Centrale: il treno si riempie ancora di più, ma la cosa strana è che nessuno mi fa compagnia anche se il corridoio è pieno. Mi piacerebbe che il mio scompartimento si riempisse di fanciulle con le tette sode in mostra, le gambe lunghe e i fianchi asciutti come le ballerine di Raffaella Carrà. Niente da fare, speriamo alla prossima fermata. Il treno si ferma a Bologna Centrale: allora è vero che esiste un paese con questo nome!? Quando ero a Napoli avevo incontrato un gruppo di tunisini che mi avevano parlato di Bologna, io insistevo che loro si sbagliavano, che Bologna non esiste ma c’è invece la Polonia, un Paese dell’Est Europa. Loro fanno un lavoro non onesto, mi hanno detto come potrei guadagnare una barca di soldi. Allora, anche Bologna è da cancellare. Il treno continua la sua strada verso Milano, ma ancora nessuno entra nella mia cabina: possibile che nessuno sia stanco e voglia sedersi!? Ho cominciato a riflettere su questo tema: possibile che gli italiani abbiano superato gli arabi nell’ospitalità? Mi lasciano uno scompartimento tutto per me e loro se ne stanno in piedi per tutto il viaggio. L’unica cosa che non ho capito è perché nessuno mi ha chiesto come sto, dove vado, se ho fame, se voglio bere qualcosa. In questo gli arabi sono più bravi: chi ti ospita divide con te il pezzo di pane che ha, ammazza l’unico agnello che ha per far mangiare l’ospite, divide l’unico pezzo di coperta che ha, non ti senti mai straniero in quel posto. Per l’arabo l’ospite è una carissima persona, è uno che ha bisogno, e non c’entra il colore della pelle né la religione: questa è la tradizione e uno dei valori per cui gli arabi sono famosi. I pensieri mi hanno portato lontano, ma sono triste perché in tutto quel tragitto non ho parlato con nessuno. Il treno si ferma a Milano, tutti i viaggiatori scendono e anch’io. Cammino piano piano guardando la stazione, sento tante lingue e questo vuoi dire che ci sono molti turisti. Sento anche la lingua araba ma io non mi fermo, non la conosco. Arrivo davanti all’uscita, grazie a Dio sono arrivato a Milano, la seconda capitale, dopo Roma ladrona, come dice Bossi. L’unica cosa che l’immigrato non compra è la pianta delle città. Perché l’immigrato non è un turista Che gioia, sono arrivato nella capitale dell’economia e della moda! Nella più ricca città italiana, magari potrò vedere Naomi Campbell o Van Basten. Cammino per la città senza sapere dove mi trovo: Milano mi sembra pulita, le vie non finiscono mai, grandi boutique, ma la città è vuota. Non c’è quasi nessuno, sono tutti in vacanza: beati loro che vivono al nord! Ho camminato per ore e devo ritornare alla stazione ferroviaria. Sono molto lontano ma non ci sono problemi, l’unica cosa che l’immigrato non compra è la pianta delle città. Perché l’immigrato non è un turista e la città la scopre da solo. Arrivo davanti alla stazione, trovo tanti miei paesani, da lontano vedo un controllo della polizia. Mi ricordo dell’unico controllo di polizia a Napoli: appena arrivato mi fermano gli sbirri, mi chiedono i documenti, mostro il passaporto, dopo avere visto i documenti il poliziotto mi chiede che lavoro faccio. Rispondo che il mio mestiere è il meccanico. Lui non è convinto, mi chiede di mostrare le mani, gli mostro le mani e lui mi risponde: "Mi prendi per il culo?’.. Quella frase non la capisco, lui è agitato e mi dice di seguirlo al comando. Entriamo e si siede davanti al computer, comincia a scrivere, ogni tanto si ferma e mi dice: "Meccanico! Adesso ti dico io che cosa fai!". Un suo collega arriva e gli chiede chi sono, lui gli risponde. "Guarda le sue mani: secondo te questo è un meccanico?". L’altro mi dice anche lui di mostrare le mani, le metto in mostra e lui mi risponde: .’Mi prendi per il culo?". Ma come è possibile? cosa c’è di strano, che vuol dire culo? Quello del computer era nervoso, ha dato un calcio all’apparecchio e ho capito che non aveva trovato niente dentro su di me: è logico, ero appena arrivato in Italia. Ma ora sono a Milano, sono entrato in stazione, il treno arriverà verso le quattro del mattino. Alla sera la stazione si riempie di persone strane, sono simili a quelli di Napoli ma non lo so cosa prendano per ridursi così. Io d’ora in poi voglio solo pensare a Mantova e al lavoro. C’è qualcosa che non ho capito, come mai ci sono tante persone che dormono in stazione e per terra? Io che sono del terzo mondo non ho mai visto una cosa del genere. Sono dei punti oscuri che cerco di capire. Prendo il treno e verso le sei del mattino mi trovo a Mantova, la Terrasanta della ricchezza, la Terra Promessa. Non ho scelto Mantova per caso: quando lavoravo all’autolavaggio a Napoli, c’era un T.I.R. che arrivava ogni mese a fornire merce per il mercato napoletano, io aiutavo a scaricare la merce su un piccolo camion per portarla ai clienti e, parlando con l’autista, lui mi diceva che a Mantova si sta bene, che è un paese ricco, che c’è il lavoro e tutto in regola. Mi fermo davanti alla stazione, la prima cosa che chiedo è l’indirizzo dell’ostello, l’albergo della gioventù dove si paga poco per un posto letto. Appena entrato all’ostello chiedo di poter rimanere per un mese, ma non si può per più di sei giorni. Il mio problema è di ottenere la residenza, per avere il libretto di lavoro. All’ostello non è male, c’è tutto: letto, bagno, toilette. Giro per Mantova e ogni tanto trovo dei miei paesani: parlano poco e nessuno mi mostra o mi convince che qui si sta bene, ogni mattina vado all’ufficio di collocamento ma non c’è lavoro. Siccome sono sempre da solo ho scelto una persona che mi fa compagnia, un algerino che viene da Roma e che mi parla molto di Roma e di tunisini che guadagnano molti soldi e stanno bene. Lui è senza soldi e sta male, io ho ancora dei soldi e cerco compagnia: dopo la mattinata all’ufficio di collocamento andiamo in giro per Mantova da una strada all’altra, da un giardino all’altro. I parchi sono pieni di gay e di tossicodipendenti, i tossici mi chiedono delle "storie" ma io ribatto sempre: "Di quali storie parli?". Loro rispondono: "Roba!". Ma io in storia non ho mai studiato "roba"! Questo è stato il primo contatto con gli italiani. Il mio compagno mi chiede di smettere di dormire all’ostello e di andare a dormire da lui. L’ultima notte in ostello ho comperato tante cartoline, una delle quali era molto bella, una cartolina di un parco che ho mandato a tutti i miei amici in Tunisia. Quel parco visto in cartolina mi piace molto e voglio visitarlo: è un peccato essere a Mantova e non avere mai visto quel posto. E’ la prima notte che dormo fuori. Nel parco, sotto gli alberi, non sono da solo: sono in mezzo a centinaia di marocchini e tunisini. Da un’altra parte ci sono immigrati del Bangladesh e prima di dormire si tolgono tutti i vestiti, come fossero in camera da letto. Noi del Nord Africa, invece, facciamo diversamente e i vestiti li teniamo addosso, è logico: siamo in un giardino! I Carabinieri vengono per controllare e non svegliano nessuno, ma io sono sempre sveglio perché in quel posto non mi sento sicuro. Pensavo che i Carabinieri venissero per proteggerci, ma non è vero: nel parco ci sono molti italiani che si fanno le pere nei piedi, a quei tempi io non sapevo niente e mi sembrava tutto strano. Chiedo al mio amico algerino cosa fanno quelli lì e lui mi risponde: "Mi prendi per il culo?". Ancora questa frase: "per il culo". "Allora: questi qua sono tossici di eroina e si fanno le pere nei piedi per non farsi scoprire dai loro familiari". Prima pensavo che esistesse solo la coca, adesso ho scoperto che c’è della roba che si chiama eroina. Ma è possibile!? Al mio paese non c’è. Passano le giornate, ogni giorno scelgo una strada, cammino per chilometri e busso a tante fabbriche ma la risposta è sempre la stessa: "Non abbiamo lavoro". Ho sentito in giro che c’è la stagione della raccolta delle mele, mi informo e decido di andare in quel posto "X". I soldi sono quasi finiti e ho bisogno di lavorare. Prendo un autobus e, dopo quasi quaranta chilometri, arrivo in una piccola città. Scendo e imbocco l’unica via principale, basta un’ora per girarla e scopro che è piena di extracomunitari, marocchini e altri africani, e tutti hanno una casa. Allora decido di fermarmi in quel paese, perché l’unica cosa che conta è avere la casa. Entro in un bar per bere qualcosa ma il padrone mi risponde di no, gli chiedo il perché e lui mi risponde che "noi" lo sappiamo il perché. In ogni bar che vado la risposta è sempre uguale. Pensavo che loro sapessero che per noi musulmani è peccato bere alcolici, ma ho scoperto dopo che i marocchini del posto ne hanno combinate di tutti i colori dopo aver bevuto. Ma che c’entro io: io sono tunisino! "Ma come: sei tunisino e non sai queste cose!?". "Sono tunisino, ma non conosco queste cose". Sono stufo di dormire sotto un albero, quel pino alto e largo dove siamo sistemati io e l’algerino Cerco una sistemazione per passare la notte ma niente da fare, nessuno mi dà ospitalità. Poi scopro un piccolo albergo il cui padrone è italiano ma ha una moglie marocchina: ogni sera vado a bere in quel posto. Loro hanno capito che io e il mio amico marocchino siamo diversi dagli altri. Piano piano il padrone ci invita a guardare la televisione: noi beviamo da mezzogiorno fino a tarda sera senza creare problemi. La moglie, ogni mattina, ci offre la colazione e anche la doccia gratis. Il primo padrone che troviamo sceglie molti marocchini e anche il mio amico, ma io no. Perché!? Per un mese rimango disoccupato e intanto i soldi sono finiti: sono preoccupato. Non riesco a trovare un lavoro, né una casa. Sono stufo di dormire sotto un albero, quel pino alto e largo dove siamo sistemati io e l’algerino: abbiamo portato due letti e due materassi ricoperti, tutto regalato dalla Caritas. Fa troppo freddo e c’è molta nebbia. Quando piove siamo costretti ad andare in un parcheggio sotterraneo, ma rimaniamo svegli tutta notte perché ogni tanto arriva una macchina che deve entrare e tocca a noi spostarci. E’ veramente una vita di merda. Non lo so fino a quando devo resistere. Mi sveglio ogni mattina e cammino per una decina di chilometri girando da una zona industriale all’altra. La risposta alle mie richieste di lavoro è sempre uguale: "Per il momento non ne abbiamo". Altri mi chiedono l’indirizzo: quando loro hanno bisogno mandano un telegramma. Ma che indirizzo gli posso dare: "giardino X, primo albero a destra!?". Con l’algerino ho chiuso: da quando ha preso il primo stipendio è cambiato, non lo vedo più, beve e mangia da solo. Torna a "casa" ubriaco e comincia a provocarmi. Ma è possibile, dopo quello che ho fatto per lui, che adesso mi tratti così? Siccome non ho soldi non bevo e non mangio più, ma si sa che il freddo e la fame non sono amici. La notte non riesco a dormire, rimango sveglio per combattere il freddo e non morire congelato. L’algerino russa tutta la notte e così io mi arrabbio ancora di più e lo sveglio. "Chi credi di essere!? alzati che ti mostro chi sono io!". Così ci siamo massacrati di botte, ogni tanto una pausa ma le parole non finiscono mai: la mattina siamo stanchi e sanguinanti. Lui è andato a lavorare e io sono andato a lavarmi; dopo ho buttato i suoi mobili e così sono rimasto "singol". Con me ho sempre un pugnale, per proteggermi: non si sa mai, la notte fa brutti scherzi . Verso le dieci la marocchina dell’albergo viene a dirmi che c’è un padrone, amico di suo marito. che cerca operai per la raccolta delle mele. Accetto subito, perché sono quattro giorni che non mangio, non bevo e nemmeno fumo. La mattina seguente vado a lavorare: sul posto ci sono dieci persone, sette italiani e tre immigrati, gli italiani per la maggior parte sono studenti, tra noi immigrati c’è un marocchino, un ganese e io tunisino. La raccolta delle mele non è un lavoro pesante, ma quello che mi dà fastidio è di sentire in continuazione bestemmiare "…Dio". Bestemmiano tutti: da quando sono arrivato a Mantova ne sento di tutti i colori: "porco cane", etc., etc., ma è possibile!? E’ giusto bestemmiare!? Cazzo, hanno di tutto, sono ricchi, hanno la casa, la macchina, vanno in vacanza: la cosa è veramente strana! Io che non ho niente non bestemmio e loro che sono fortunati… se un integralista viene a sapere che da queste partì Dio viene umiliato non gliela fa passare liscia! Dopo una settimana di lavoro mi accorgo che una ragazza mi guarda sempre, ogni tanto i nostri occhi s’incontrano e lei mi sorride. E’ bionda, occhi verdi, capelli lunghi, alta circa un metro e settanta. Io rispondo al suo sorriso e il mio cervello subito si dà da fare, per indagare su cosa vuole quella ragazza da me. Osservando chi mi stava intorno ho capito che aveva motivo di guardarmi: ero il più bello, avevo ventitre anni, il corpo asciutto essendo costretto a fare la dieta per mancanza di soldi, alto un metro e settantacinque, colorito originale mediterraneo, capelli neri e occhi marrone: che meraviglia! Con la scusa di aiutarla a scendere dalla scala cor; il secchio pieno di mele mi avvicino e lei mi dice: "Merci!". Io rispondo stupito: "De rien, tu est francaise?". "No, je suis italienne, j’aime parler francais". "Je suis tunisien. Je m’appele Nabil, et toi?". "Stefanie". "Stefanie di Monaco?". "No, mais tu es fou". Lei poi mi dice: "Dopo il lavoro vieni, che andiamo a mangiare assieme?" A mezzogiorno sono andato da Stefania, che bel nome, con un chilo di mele. Lei mi guarda, io allora le dico che da una settimana mangio solo mele e dovrò mangiarle fino a quando prenderò lo stipendio. Lei era troppo sensibile, aveva quasi diciannove anni, si sentiva male quando io le raccontavo la mia storia. Da quel giorno siamo diventati amici e ci siamo messi d’accordo di non nasconderci niente. Per me è diventata tutto, mi ha conquistato con la sua simpatia, la sua bellezza. la sua femminilità, i suoi occhi e la sua voce sensuale. Ho vissuto come un sogno, ma molto bello. "Zio cane…" anch’io ho cominciato a bestemmiare, ma non bestemmio Dio, soltanto mio zio. Ogni giorno che passa mi innamoro di più, sono talmente legato a lei che ogni volta che vado a un appuntamento non ci vado con le gambe ma con il cuore. "Senti, Stefania, io ti amo. Non posso vivere o andare avanti senza di te. Non posso guardare la luce senza guardarti". Lei mi bacia e io le rispondo, ha un sapore meraviglioso. Siamo finiti nell’albergo della marocchina, abbiamo fatto l’amore. Da quel momento ho cominciato a pensare solo a lei. Siccome ogni giorno vado dalla marocchina, lì ho conosciuto Paolo, un imprenditore calabrese, che ha tanti muratori alle sue dipendenze, e in quell’albergo Paolo mi ha promesso un lavoro, ma in nero, come manovale. E un giorno Paolo mi dice: "Domani parti per Trento". Le peregrinazioni di Nabil in Italia alla ricerca di un lavoro TN come Tunisia, o come Trento? Agosto 1999 La mia vita a Mantova è sempre uguale, il giro quotidiano alla ricerca di lavoro, con risposte sempre negative. Nei primi tempi pensavo che si fossero messi tutti d’accordo per non dare lavoro agli extracomunitari, come fanno nei bar non servendo alcoolici ai marocchini, ma spesso hanno ragione, perché non c’è un bar in cui non abbiano fatto una rissa. Per colpa loro io e il resto di noi non possiamo bere più, e mi tocca di continuo aprire un discorso per convincere il barista che non sono violento e bevo per i cazzi miei. Ogni volta che mi trovo seduto a pensare mi passano per la testa brutte idee. Di fronte al piccolo albergo in cui sto io c’è una bella villetta disabitata e, siccome sono molto interessato, vedo ogni tanto qualcuno che viene a controllarla, o forse a portare qualcosa. Non ho più soldi e ogni giorno mi dico che domani notte salterò il muro ed entrerò in quella villetta, ma ho paura, perché in vita mia non ho mai rubato, e allora rimando la missione di giorno in giorno. Mi domando sempre perché questa vita è fatta così uno ha la casa che costa centinaia di milioni e la lascia abbandonata e altri, come me o anche tanti italiani, sono senza casa. Ma questo non conta niente e sono contento di non essere entrato in quella villetta. La fortuna ha bussato al mio albero e mi ha fatto conoscere Paolo, Mimmo e Franco. Sono ex muratori, titolari di una impresa edile, hanno lavorato sodo e hanno risparmiato tanto per riuscire ad aprire questa impresa, e ora chiamano molti muratori da Reggio Calabria per lavorare in cantieri del nord, ma in nero, niente lavoro in regola. I padroni pagano bene, anche l’albergo e il mangiare, possono permetterselo perché non danno niente allo stato. Un giorno mi spiegano che hanno bisogno di un manovale per un cantiere a Trento. La mia risposta è che sono disposto anche ad andare sulla Luna, pur di avere un lavoro. Loro mi dicono com’è il lavoro, che devo dormire in albergo e mangiare a spese loro, e lavorare dieci ore al giorno. Se ero d’accordo saremmo partiti subito, e a me stava bene così. Salgo in macchina con Paolo, un Mercedes 250 TD, prendiamo l’autostrada e intanto parliamo del mio paese. Lui mi racconta che è stato all’estero per lavorare, in Germania, Polonia e Libia. Della Germania mi dice che in molti cantieri i muratori sono quasi tutti italiani: della Polonia invece mi descrive le donne ed i divertimenti. Poi mi racconta una storia sulla Libia: era andato con un’impresa per costruire il porto di Tripoli, lì non c’erano né alcoolici né donne disponibili. Era molto dura, in un paese dove la temperatura arriva a cinquanta gradi: una volta mentre viaggiava in macchina e si era fermato ad una fontana pubblica per bere, nello stesso momento arriva una limousine con a bordo un libico, scendono molti bambini e donne che portano il chador, nonostante il caldo sono coperte dalla testa ai piedi, si vedono solo i loro occhi. Il marito, vedendo che lui le guardava, lo ha aggredito e quasi gli sparava ma come si era permesso di guardare le sue donne, bastardo! Lui si è difeso dicendo che non le guardava perché non c’era niente da vedere, solo i loro occhi. E il libico allora gli ha risposto che lui era fortunato perché era straniero e non capiva le regole del posto, se l’avesse fatto uno di lì, il suo corpo sarebbe stato servito su un piatto d’argento per i lupi del deserto i libici sono molto riservati e hanno una mentalità molto antica. Mentre facevamo questi discorsi non mi ero accorto che era cominciato a nevicare. La strada si era imbiancata e ai lati della carreggiata la neve era già alta, era come guidare nel deserto. Oramai eravamo in Tunisia, tutte le macchine erano targate TN che vuol dire Tunisia. Ma che cazzo dici, mi fa Paolo, quella è la targa di Trento. Arriviamo a Trento verso le sei del pomeriggio, dalla finestra guardo la gente che cammina per la strada con vestiti pesanti. fa molto freddo, la temperatura è di sette gradi sotto zero. Gli alberi, le macchine, l’erba, sono coperti di ghiaccio. per fortuna non sono venuto qui per cercare lavoro, se avessi dovuto dormire sotto un albero sarei sicuramente diventato un blocco di ghiaccio. Quando telefono ai miei famigliari, dico sempre che sto bene e abito in una bella casa Quando telefono a casa non dico niente ai miei famigliari, dico sempre che sto bene e abito in una bella casa, che tra poco comincerò a lavorare. Loro mi chiedono sempre quando ritorno a Tunisi e la risposta è sempre che torno entro l’anno. Non voglio che loro si preoccupino e se racconto la verità mi dicono di tornare subito, ma io ho la speranza che arrivi il giorno in cui troverò una casa e un lavoro, costi quello che costi. Però comincio a pensare che aveva ragione mia madre, quando diceva che in Italia non si sta bene, che ci sono soltanto gli spaghetti e la mafia. Paolo si ferma davanti a un albergo, entriamo. Al banco del bar c’è una bellissima ragazza, giovane, bionda, con gli occhi azzurri. Paolo parla con lei e le dice che sono uno dei suoi operai, io sorrido sentendo un dialogo dialettale tra un calabrese e una trentina. La ragazza mi chiede i documenti e mi dice: - Chi sei, Alì Babà? - Porco zio, non sai leggere, scusa? Prendo la chiave e vado nella mia camera, dormo con altri due muratori. Faccio la doccia e poi scendo al ristorante. La ragazza del bar mi fissa e il computer del mio cervello si mette in moto, il suo sguardo non è cattivo, quindi cerca il dialogo. Le chiedo dov’è Paolo e lei mi indica un tavolo, ci vado e mi siedo, loro sono in sei e al tavolo di fianco ci sono altre otto persone. Tutti mi guardano e io saluto, Paolo spiega che da domani faccio parte del gruppo, i ragazzi sono giovani, hanno la mia età. Ordino da mangiare, non conosco i prezzi e prendo spaghetti con il ragù, bistecca ai ferri, insalata mista e birra. Quel gruppo lo conosco per averlo visto a Mantova, abbiamo parlato alcune volte. Per avviare il discorso uno di loro mi dice come mai, se sono mussulmano, bevo ugualmente birra e mangio carne di maiale. La pasta ormai l’ho mangiata e bevo perché mi piace, lo so che è peccato bere, ma anche in Tunisia la maggior parte delle persone beve, anche mio padre. Il maiale invece non lo mangio perché quello è un peccato più grave, ho mangiato la pasta con il ragù perché non lo sapevo che conteneva maiale. Paolo mi dice di mangiare e di non preoccuparmi, che paga lui. Gli ho chiesto di mostrarmi il lavoro, ma lui mi dice di andare a dormire tranquillo che saremmo andati a vederlo il giorno dopo. Siamo andati in camera: gli altri dormono tutta la notte e russano, io non riesco a dormire, sono stanco ma non ci riesco. Il letto è morbido e la stanza molto calda, è una cosa nuova per me e il mio corpo da molto tempo è disabituato al letto. La mattina alle sette la sveglia suona ci laviamo e scendiamo al bar per la colazione, poi andiamo al cantiere. Non racconto bugie, al mio paese non avrei mai fatto questo tipo di lavoro, neanche se mi avessero pagato molto bene, piuttosto sarei rimasto disoccupato. A noi tunisini della capitale il lavoro non piace e ci vergogniamo quando una ragazza ci chiede che lavoro facciamo e dobbiamo rispondere il muratore. Lei direbbe: - Sei matto? Non ti vergogni a parlarmi, io non faccio amicizia con un muratore, e tanto meno penso di sposarlo, ma vai… Faceva molto freddo, nove sotto zero, porco zio. Al cantiere, il lavoro era rimandato di una settimana, ma il geometra trentino ci ha dato ugualmente un compito per non rimanere con le mani in mano. Io sono stato il più fortunato, mi è toccato pulire il cantiere: agli altri è toccato portare su per le scale le porte blindate. Sono proprio molto fortunato. A mezzogiorno andiamo a mangiare, uno di loro, che mi sembra il capo, mi dice di prendere il suo posto e che lui avrebbe fatto il mio lavoro. Ma come, il geometra mi ha dato quel lavoro. Forse tu non hai capito bene chi comanda la squadra? Il pomeriggio lo passo portando porte blindate in ogni stanza, mamma mia come sono pesanti. Finito il lavoro andiamo in albergo, mangio e mi metto a dormire. La mattina mi svegliano e sono l’ultimo ad alzarmi, corro a lavarmi al lavandino, riempio le mani con l’acqua calda e mi accorgo di non riuscire a piegare la schiena, provo un’altra volta, sono molto spaventato per la mia salute e temo di perdere il lavoro. Mi lavo in piedi bagnandomi i vestiti, scendo in fretta al bar. C’è Anna, la cameriera, che mi dice: - Buongiorno Alì Babà! - Ancora con questo Alì! - Ma perché ti arrabbi? - Lascia perdere, ne parliamo quando torno dal lavoro. - Ok, buon lavoro Alì Babà. Un altro giorno di lavoro forzato, è molto pesante ma sono costretto a farlo, non ho altra scelta, non ho un soldo in tasca e devo avere pazienza. Piano piano ritornerò in forma, sfiderò il passato e anche il presente, non lascerò che questi montanari e quei pecorai si lamentino del mio lavoro. La sera, tornando in albergo, la prima che incontro è Anna, che mi accoglie con un bel sorriso. - Ciao Anna. - Ciao Alì Babà. - Ma porco zio, non vedi che questo nome mi dà fastidio!? - A me piace. Cosa vuoi bere? - Una birra grande. - No, Alì Babà, tu sei mussulmano e per te è un peccato bere alcoolici. - Falla finita con questo nome, non lo sopporto più, ho un passato che voglio dimenticare e inoltre io sono un mussulmano di quelli che bevono. Di Anna mi piace il modo di parlare, la voce molto carina, che colpisce il cuore. - Anna, è un peccato che ti sei sposata così presto. - Ho capito, magari aspettavo te e così mi sposavo Alì Babà. - Non scherzo, sono felice per te. Con il gruppo non c’è un buon rapporto, non capisco il motivo ma continuo a lavorare in quel cantiere, anche se sono distrutto. Questo gruppo viene da un paesino, al massimo sono cinquecento abitanti e non sanno nulla del mondo: è la prima volta che lasciano il loro paese e quando non hanno lavoro come muratori portano a pascolare le pecore. Ogni tanto mi fanno arrabbiare, succede quando mi dicono che loro non sono razzisti. Che me ne frega, mortacci vostri. A fine mese il grande pecoraio mi chiede se voglio andare con lui a Mantova. Ci vado volentieri. Durante tutto il tragitto io rimango a guardare le montagne coperte di neve, gli alberi verdi che danno gusto a quella meravigliosa natura intatta come l’ha creata Dio. La città di Trento non mi è piaciuta, meglio Mantova e Napoli. Il pecoraio corre a duecento chilometri all’ora e io ho paura, durante tutto il percorso mi parla del suo paese che gli manca molto, delle cento pecore che ha lasciato in custodia a suo fratello. Mi parla di come fanno il formaggio, della moglie e dei suoi due figli. bel discorso, ma meno male che siamo arrivati. La sera verso le undici risalgo in macchina con il pecoraio per tornare a Trento. Arriviamo a tarda notte, dormiamo e la mattina andiamo a lavorare, avanti così per tre mesi. Dopo mi sono fermato perché ho capito il motivo per cui i pecorai non mi vogliono con loro. hanno un parente disoccupato e vogliono metterlo al mio posto. Grazie a Dio ho lavorato tre mesi e ho risparmiato un po’ di soldi, ma adesso devo decidere dove andare. Certo, a Trento non rimango. Paolo mi chiede di restare con lui e mi dice che ho lavorato molto bene, che il geometra gli ha detto di come si sono comportati con me gli altri del gruppo. Mi dice ancora che ha altri cantieri a Trento ed io accetto di prendere lavoro in un’altra squadra. Preparo la mia roba, sono incazzato, maledetti tutti, zio cane, maledetto il giorno in cui ho deciso di venire in Italia. La prima parte del mio soggiorno a Trento si chiude così con una gran rabbia. Nabil e le donne... Ottobre 1999 Paolo, il mio datore di lavoro, è un tipo molto in gamba. Somiglia a Saddam Hussein, scuro di carnagione e con i baffi folti, in confronto a lui io sono molto più bianco. È alto e con le spalle larghe, non parlo delle mani, che sembrano due mattoni. - Non preoccuparti, Nabil, basta che tu lavori bene e io sempre lavoro per te, se c’è qualcosa che non va telefonami. Adesso ti porto in un posto meraviglioso, dormirai in un albergo a tre stelle e con una ottima cucina. - Ma scusa Paolo, ci sono le donne per… - Stiamo andando in una zona turistica piena di donne, basta che sai come fare per portarle a letto. Voi siete furbi, venite soli e non portate le vostre donne, poi volete fare l’amore con le nostre. Io sono stato in Tunisia per un anno e non ho mai visto una coscia. Stiamo viaggiando, ci troviamo in un paesino di montagna a 1750 metri di altitudine, in vita mia non ho mai visto una pista di sci e oggi è l’occasione buona per vederla e anche per provare a sciare: con queste cose io non scherzo, voglio portare a casa un souvenir. La macchina di Paolo si ferma davanti ad un albergo a quattro stelle, molto grande con un grande parcheggio zeppo di macchine e autobus con targhe tedesche. Che meraviglia! Paolo aveva detto a tre stelle, adesso sono diventate quattro: lui tratta bene i suoi operai. Salgo in camera per fare la doccia, la mia camera è al terzo piano ed è per tre persone con la cassaforte, la televisione, etc. Davvero una meraviglia, ora serve solo andare d’accordo con questi due operai. Scendo al bar e trovo Paolo con gli altri due, con i vestiti da lavoro. Ma guarda che roba, al mio paese non li fanno entrare così neanche se pagano il doppio, qui invece sono tutti uguali basta pagare. I due hanno circa quarantacinque anni, sono scuri come Paolo, uno con i baffi l’altro senza. Paolo mi presenta loro e parla bene di me. Dopo andiamo al ristorante, non sembra di essere in Italia, ma in Germania: donne bionde di tutte le età, la cameriera arriva e tutti ordinano da mangiare. Nel frattempo loro parlano di lavoro ed io sto a guardare le donne, sono molto affamato di un corpo di donna, magari se su un piatto mi portassero una bionda cruda, mi ci butterei per ventiquattr’ore di fila. Mangiamo e bevo la mia solita birra: faccio fatica a capire il loro dialetto, ma lo stesso capisco che uno dei due operai ha viaggiato in molti paesi d’Europa, mentre l’altro è un pecoraio che non ha mai lasciato il suo paese in Calabria. Io sono molto intelligente e questa volta devo usare il mio cervello per rimanere a lavorare: bisogna studiarli e dopo userò la mie armi. La mattina alle sei ci svegliamo, facciamo un salto al bar e poi via, al cantiere dove stanno costruendo una pista di pattinaggio sul ghiaccio: siamo solo noi e un altro operaio che lavora sulla ruspa. Il mio compito è quello di manovale e loro fanno i muratori, questa è una fregatura perché mi tocca correre a destra e a sinistra e loro non sono mai contenti, sono veramente distrutto. Porco zio, lavoro come un matto, fa molto freddo ma sento il mio corpo come infiammato. A mezzogiorno andiamo a mangiare e così cominciamo a chiacchierare: come al solito tocca a me parlare del mio paese, del perché sono venuto in Italia. Uno dei due, di nome Toni, mi è piaciuto subito perché è un uomo di esperienza e ha viaggiato molto, sua moglie è polacca. L’altro è come un animale, mangia molto piccante come fanno gli arabi, ma non sa neanche parlare, quindi posso definirlo solo un pecoraio. Piano piano io e Toni siamo diventati amici, visto che anche lui non va d’accordo con l’altro, Salvatore. Il bello arriva presto, Salvatore fa il muratore ma non è molto bravo e quando buttiamo il cemento armato non se ne viene mai fuori. La mattina, quando togliamo le tavole di legno, i muri escono brutti, il geometra si incazza e anche noi perché ci tocca ogni volta rifinire il cemento con la pala ed è lavoro extra Litighiamo sempre, io e Toni trattiamo male Salvatore e lui è sempre zitto perché sa di aver fatto brutta figura. Ha preso in giro Paolo dicendogli che era del mestiere, invece era soltanto un manovale. Quando andiamo al ristorante Toni mi dice sempre di smettere di bere birra e di bere vino assieme a lui, così sono passato da un boccale di birra a tre litri di vino al giorno. Al cantiere io e Toni facciamo tutto il lavoro e Salvatore prepara il materiale, ma quando arriva il geometra io torno a fare il manovale, altrimenti si creerebbe un problema . Quando si tratta di buttare il cemento il geometra mi dice di farlo io di persona, perché i muri che avevo fatto io erano usciti puliti e non lo so come mai, forse per colpa del vino perché sul cantiere ero sempre ubriaco. Ma quello che conta è che il geometra parli bene di me e anche gli altri due. Sono passati tre mesi e non ho ancora visto donne… Sono passati tre mesi e non ho ancora visto donne, sono molto affamato, come una bestia. Un giorno arriva Paolo e ci chiede di trasferirci in un altro albergo che gli ha consigliato il geometra, ha lo stesso servizio e costa meno. Appena arrivati troviamo la padrona, una donna meravigliosa, indossa una minigonna ed una camicetta con un bottone di troppo aperto: mostra due gobbe più grandi di quelle di un cammello, che io me le mangiavo con gli occhi. Non ho smesso neanche cenando di osservarla, lei camminava in mezzo ai tavoli come una modella in passerella, mamma mia che donna! La padrona faceva anche la cameriera, suo marito faceva il cuoco e avevano un bambino di un anno. Gli italiani sono molto tirchi anche facendo i figli: se questa donna sposa un arabo lui le fa fare un esercito di bambini! L’albergo non è molto pieno, siamo alla fine della stagione sciistica e sta arrivando la primavera: io, da tre litri di vino al giorno sono passato a sei, sono sempre ubriaco eppure me la cavo bene sul lavoro: cammino sui ferri, sulle tavole, butto il cemento, e la mattina dopo non ricordo niente di quello che ho fatto il giorno prima. È lo spirito di vino, un miracolo. Piano piano la padrona si è accorta di me, di come la guardavo, e abbiamo un po’ più di confidenza: parliamo sempre di tanti argomenti, di come i due calabresi si incazzano quando lei li chiama terroni. Per me è normale, lei mi ha battezzato con il nome di Billy, grazie a Dio è finita la storia di Alì. La padrona mi dice di smettere di seguirla con gli occhi ma io non posso, mi piace, come una Madonna: mi fa impazzire. Lei mi ripete che con questi comportamenti non arrivo a niente. Allora, perché vuole impedirmi di sciacquarmi gli occhi? - Da molto tempo non tocco una donna e adesso per fortuna ho trovato te e sono molto innamorato, sono pazzo del tuo modo di camminare, della tua voce, aiutami, abbi pietà di me, non lo faccio più! Ho una bella idea, considerami come una lampadina della tua camera da letto, mettimi come un soprammobile sul televisore, come una coperta che ti dà calore quando dormi, come l’acqua quando fai la doccia. - Ma guarda che tipo sei, ti aiuto io a trovare una donna. - Io non voglio andare con nessun’altra donna, solo con te. Con me fai un casino di bambini. - Tu sei matto, cosa faccio con molti bambini, me ne basta uno. - Sei veramente strana, perché non fai come fanno tutti gli altri italiani. - Come fanno gli altri italiani? - Ogni donna ha un amante e ogni uomo pure e se un giorno lui scopre che stiamo assieme, puoi rispondergli che io faccio il lavoro che agli italiani non piace fare. - Ma cosa mi racconti, io sono felice con mio marito. - Va bene, io non ho detto nulla, ma almeno cambi genere, fuori dalla solita routine. - Guarda è meglio che te ne vai, altrimenti mi fai impazzire con la tua filosofia. - Aspetta, dammi un bacio e ricordati la tua promessa, che mi troverai una donna. - Va bene, te lo do ma sulla guancia, va bene? - Perché sulla guancia, cosa cambia se sulla bocca? È tutta carne! Sulla guancia ok, meglio di niente. Però com’è dura questa donna! Gli altri due sentono e non dicono una parola, ma appena lei se n’è andata mi hanno detto se sono matto. Ma perché, noi arabi, per le donne giovani, vendiamo tutto quello che abbiamo. Il nostro libro sacro, il Corano, scrive che il paradiso è sotto i piedi delle donne (ndr: precisamente dice sotto i piedi delle madri). Beviamo una bottiglia di vino, almeno da una parte andiamo in paradiso, anche se con quest’ultima bottiglia finiremo all’inferno. La sera la passiamo al bar, cercando di fare qualche conquista. L’albergo è pieno di tedeschi, ma sono tutti di mezz’età, alti e biondi e grossi, mangiano solo maiale e patate e bevono molto. Io e Toni ci buttiamo sui loro tavoli e cerchiamo di conquistare qualche donna, parliamo qualche parola di tedesco e qualche parola di italiano e di francese, il resto lo facciamo intendere con le mani, come tra muti. Continuano le avventure di Nabil, tunisino immigrato in Italia "Se ti fermano per un controllo…, devi dirgli che sei appena arrivato…" (E’ quello che consigliano i suoi "padroni" a Nabil, eterno lavoratore in nero. Continuano qui le sue vicende italiane: la mancanza di soldi, i luoghi precari in cui abitare, il lavoro mai in regola e naturalmente le donne… Dopo Napoli e Mantova, ancora Trento) Dicembre 1999 Ogni giorno andiamo a lavorare già distrutti, ma il miracolo continua. Dopo qualche mese Paolo, il mio datore di lavoro, arriva con un nuovo operaio: è anche il giorno di paga, ma prima ci presenta il nuovo manovale, il suo ruolo l’abbiamo capito subito: porta una valigetta con i soldi e la apre, però nel frattempo tira fuori la pistola. Poi chiama gli operai, uno alla volta, chiede loro quanto hanno lavorato, e li paga: arriva il mio turno, porco zio, mi sembra di essere in Texas. - Tu non hai ancora capito niente di noi italiani, qui non possiamo fidarci di nessuno. - Guarda, Paolo, ho capito fin troppo bene e il gesto mi è piaciuto, ma la prossima volta invece della pistola porta un mitra. - Dai, ragazzo, non stiamo mica scherzando: siamo in mezzo alla strada e possono fermarci i carabinieri. Se ti fermano per un controllo devi dirgli che sei appena arrivato e sei ancora in prova, che il tuo libretto di lavoro ce l’ha il mio ragioniere a Reggio Calabria. Non ti metto in regola altrimenti toccherebbe a te pagare le spese dell’albergo e del mangiare. - Io sto bene così. - Bravo ragazzo, continua così e vedrai che lavorerai sempre per me. - Inshallah! - Che vuoi dire questa parola? - Se Dio vuole. Ci lasciamo tutti contenti, le tasche sono piene di soldi e io devo pensare a come spenderli, Toni li vuol portare alla moglie e passare le vacanze con lei, Salvatore vuole andare al suo paese e passarvi una settimana. Anche il nuovo arrivato ha deciso di andare con loro ed io sono rimasto solo in camera. Una sera la padrona mi dice, servendomi il primo: - Comportati bene questa sera, ti ho trovato una ragazza. - Lo sai che io non voglio nessuna, voglio solo te. - Ma falla finita, altrimenti rimani senza del tutto. Adesso è andata a cambiarsi e poi scende a cena, chiamala al tuo tavolo e non preoccuparti. l’importante è che ti comporti bene. Il ristorante è ormai pieno, sono arrivati due pullman di tedeschi e l’unico tavolo libero è rimasto il mio, la lingua che si sente nella sala è solo il tedesco. Intanto il mio cervello è al lavoro, penso che tipo sarà questa donna, magari è buona e bella, come piacerebbe a Hitler di razza ariana. Qui sono l’unico diverso Ogni tanto qualcuno mi guarda, sono l’unico diverso, ma anche io li guardo e rispondo al saluto alzando il bicchiere per un brindisi. - Siete tutti bugiardi e mi prendete per il culo. - Billy, che cos’hai, perché parli da solo? Eccola qua, è tutta tua. Mi giro e guardo in su, porca miseria, è un armadio, avrà sui quarant’anni e non è molto bella, ma è bionda e ha gli occhi azzurri, come piacciono a me, inoltre è vestita in maniera molto sexy. - Guarda, lei parla un po’ di italiano così potete capirvi meglio. Cosa prendi di secondo? - Io prendo un fegato al sangue. - Ma scherzi, con questa ti basta un solo fegato, non fare lo spiritoso: cosa prendi? - Va bene, portami una bistecca di manzo e un’insalata di contorno. Please miss - lo mi chiamo Maria. - Questa è bella, Maria e Billy. - Cosa mangi? - lo non ho molta fame, mi basta un piatto freddo. - Ah, voi tedeschi, non avete mai fame, mangiate solo piatti freddi. Puoi mangiare quello che vuoi perché stasera offre la casa. - Billy, guarda che la casa non offre niente. - Sto scherzando, offro io. - Davvero, io non ho fame. - Dai, lo so, girate tutto il giorno a piedi e non è possibile che la sera tu non abbia fame. Non preoccuparti, sei mia ospite. Così, lei che non aveva fame, ha ordinato la pasta, la bistecca più un piatto di prosciutto con il melone, una fetta di dolce e il caffè, senza parlare del vino. Io oramai sono pieno, parliamo di tutto. Lavora in una casa automobilistica come operaia, ha un figlio di otto anni ma è divorziata e il figlio vive con il padre, così lei si può divertire. Il ristorante oramai è rimasto vuoto, siamo soltanto noi due: arriva la padrona e si meraviglia che siamo ancora lì. - Pazienza, sto studiando l’avversario, mica si scherza con questa tipa. Portaci un’altra bottiglia che chiudiamo la serata, ma in camera mia. - Ma perché non approfittate di questo tempo e andate a letto? - Il fatto è che io ho paura, perché non vieni con noi? - Smetti di scherzare, adesso devo chiudere. - Sei fortunata, io ho lavorato in un bagno turco e so fare bene i massaggi. - No grazie caro, i massaggi me li fa mio marito. Dai, Maria, portatelo via che oramai è fuori di testa. - Sai Billy, mi piaci tanto perché sei molto spiritoso, ti va sempre di scherzare e con te mi trovo a mio agio. Anche io mi sento a mio agio, nel frattempo andiamo nel corridoio che porta alle camere. - Maria, ma tu non sei…? - Non sono che cosa? - Te lo dico dopo in camera. Apro la porta e lei mi solleva tra le sue braccia di metalmeccanica: comincia bene ragazzi! Mi butta sul letto, la bottiglia di vino quasi mi scappa di mano e rischiamo di rimanere senza bere. - Adesso basta parlare, mi dice, mostrami quello che sai fare! Aiuto, mamma, ho passato cinque giorni e cinque notti con quella bestia. L’ultimo giorno mi ha detto che era stata a Tunisi e quando la padrona le aveva parlato di me spiegandole che ero arabo ha accettato subito perché era sicura che non sarebbe rimasta delusa. - Ti sono piaciuto? Porco zio. - Anca massa, bestemmi come gli italiani del nord. Io sono metà italiana e metà tedesca, mio padre è pugliese e mia madre tedesca. Ho passato cinque notti e cinque giorni con due nazioni. Al ventuno del mese i nostri soldi erano già finiti... Il pomeriggio sono andato a fare un giro in centro: c’è molta gente, tutti turisti, e fa perfino caldo. Faccio anch’io il turista, vado a piedi verso la prima collina, è tutta verde perché è arrivata la primavera. Sulla strada incontro molte persone di tutte le età che passeggiano per ossigenarsi i polmoni. Nel tardo pomeriggio torno in albergo distrutto, vado in camera e trovo gli altri operai che sono tornati. - Ciao ragazzi, com’è andata? Cosa mi avere portato di buono, non dite che non avete portato i dolci della nonna! - Ma quale nonna, i nostri sono morti. Abbiamo portato del vino buono. - Ma siete matti, volete ammazzarmi. - No, abbiamo anche del buon salame, ma tu non lo mangi. - Avete capito bene, il porco lo mangia solo il porco. Dai, andate a mangiare, che fra poco vengo. devo fare la doccia per farmi passare il male ai piedi che mi è venuto dopo l’ultima camminata, non camminavo tanto da quando stavo a Mantova! Dopo la doccia mi faccio la barba e mi profumo, per fare colpo sulle donne bisogna presentarsi così. Vado al tavolo dove sono seduti gli altri operai e sento uno strano odore, che mi dà fastidio: odore di salame. La padrona arriva e mi dice: - Guarda come sei brutto! - Tu sei solo gelosa, sono più bello di tuo marito. - Ma falla finita. Cosa mangi? - Voglio un petto tedesco e due gambe trentine, servito da una bella donna. - Billy, tu hai sempre voglia di scherzare. - Cosa vuoi farci, è nel mio sangue. Assaggia questo salame di porco, lo hanno portato questi qua, chiama anche tuo marito così lo assaggia anche lui. - Ma vuoi dirmi cosa ti devo portare? - Quello che piace a te. Dai ragazzi, beviamo questo vino. Allora, vi siete divertiti, avete trovato le vostre donne, le avete caricate bene, dopo sei mesi che mancavate da casa? Dopo cena ordino una bottiglietta di grappa alla ruta, la padrona mi dice se sono matto a voler bere anche la grappa dopo tutto quel vino già bevuto. Ma io la voglio, ho un ospite che non beve vino: si chiama Angelo ed è un nuovo operaio di Paolo. Dopo andiamo in centro ed entriamo in un bar pieno di gente, mentre Angelo va direttamente a dormire. Ordiniamo altra grappa alla ruta: dopo quattro bicchieri non ce la faccio più, la testa mi gira e voglio andare a dormire. - Bevi acqua la prossima volta, mi dice Toni, io gli rispondo di cantarmi una bella canzone. Vuol cantare "I giardini di Marzo", di lucio Battisti, ma la canta in una versione tutta sua "Quel carrello passava e Billy gridava cemento, al ventuno del mese i nostri soldi erano già finiti, se l’avesse saputo la finanza che lavoravamo in nero eravamo rovinati. Che vino è…? Che grappa è…?". Toni ha una bellissima voce e canta forte, tutti quelli che sono nel bar vengono intorno a noi e cominciano a cantare con noi quella canzone. Mi piacciono tutte le canzoni di Battisti e così continuiamo a cantare e riprendiamo a bere, un bicchiere va e l’altro arriva. Verso le due di notte usciamo dal bar sbandando a destra e a sinistra, i piedi camminano da soli e ci portano in albergo. Saliamo per una scala secondaria ed entriamo da una finestra che abbiamo lasciato aperta, perché l’albergo a mezzanotte chiude. In camera troviamo Angelo che sta dormendo in bagno, è stato male e non si è più rialzato da lì; cerchiamo di svegliarlo ma non ci riusciamo, così lo prendiamo mani e piedi e lo trasportiamo sul letto. La mattina dopo la mia testa sembra piena di marmellata, mi muovo come un robot, ho mal di testa e di stomaco. Sveglio Toni e poi vado da Angelo, ma lui mi dice che non ce la fa ad alzarsi, di andare solo noi al lavoro. Scendiamo al bar, la padrona ci dice che abbiamo una faccia orribile. Arriviamo al cantiere che siamo ancora intontiti e tocca a Salvatore iniziare il lavoro, ma dopo mezza giornata ancora non siamo riusciti a fare niente. A mezzogiorno torniamo in albergo per il pranzo e la padrona ci chiede com’è andato il lavoro. - Bene, bene, non preoccuparti: quando terminiamo, stasera, andiamo a ballare. Porta del vino e qualcosa da mangiare. - Volete ancora del vino? - Certo, ci farà sentire meglio. Dopo mangiato e bevuto il cervello sembra ritornato al suo posto, sul cantiere abbiamo iniziato a buttare il cemento. Di fronte al cantiere c’è una discoteca che ha appena aperto e decidiamo di andarci quella sera. Licenza di questo ebook Ebook sotto licenza Creative Commons Attribution-NonCommercialShareAlike 3.0 License. Logo Calomelano by Liz. Tu sei libero: Di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera. Di modificare quest'opera Alle seguenti condizioni: Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera. Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali. Condividi allo stesso modo — Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa. Per il testo integrale della licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it
Scarica