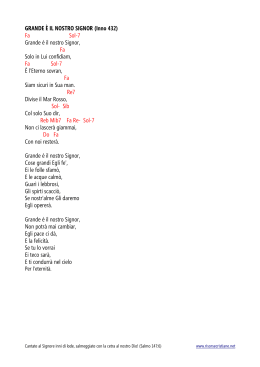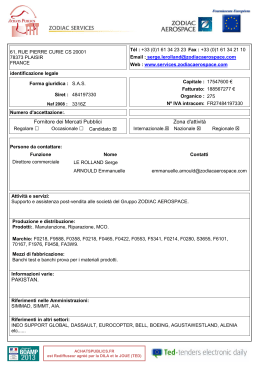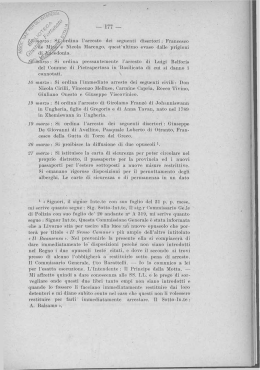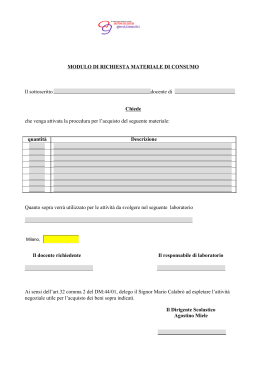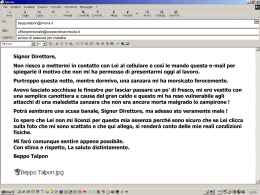JULES VERNE IL PILOTA DEL DANUBIO Copertina Hetzel – Al mappamondo dorato Tavole di Georges Roux Titolo originale dell'opera LE PILOTE DU DANUBE (1908) Traduzione integrale dal francese e note di VINCENZO BRINZI Proprietà letteraria e artistica riservata – Printed in ltaly © Copyright 1990 Gruppo Ugo Mursia Editore 3700/AC – Gruppo Ugo Mursia Editore – Milano – Via Tadino, 29 INDICE PRESENTAZIONE __________________________________ 5 IL PILOTA DEL DANUBIO __________________________ 10 Capitolo I _________________________________________ 10 Il concorso di sigmaringen_____________________________ 10 Capitolo II_________________________________________ 23 Alle sorgenti del danubio______________________________ 23 Capitolo III ________________________________________ 39 Il passeggero di ilia brusch ____________________________ 39 Capitolo IV ________________________________________ 54 Serge ladko ________________________________________ 54 Capitolo V_________________________________________ 67 Karl dragoch _______________________________________ 67 Capitolo VI ________________________________________ 77 Gli occhi azzurri ____________________________________ 77 Capitolo VII _______________________________________ 90 Caccia e cacciatori ___________________________________ 90 Capitolo VIII _____________________________________ 101 Un ritratto di donna _________________________________ 101 Capitolo IX _______________________________________ 121 I due scacchi di dragoch _____________________________ 121 Capitolo X________________________________________ 140 Prigioniero ________________________________________ 140 Capitolo XI _______________________________________ 153 Nelle mani di un nemico _____________________________ 153 Capitolo XII ______________________________________ 181 In nome della legge _________________________________ 181 Capitolo XIII _____________________________________ 191 Una commissione d'inchiesta__________________________ 191 Capitolo XIV _____________________________________ 210 Tra cielo e terra ____________________________________ 210 Capitolo XV ______________________________________ 228 Vicino alla meta ____________________________________ 228 Capitolo XVI _____________________________________ 240 La casa vuota ______________________________________ 240 Capitolo XVII_____________________________________ 254 A nuoto __________________________________________ 254 Capitolo XVIII ____________________________________ 263 Il pilota del danubio _________________________________ 263 Capitolo XIX _____________________________________ 276 Epilogo___________________________________________ 276 PRESENTAZIONE Teatro delle avventure narrate da Verne in questo suo romanzo è il bacino del Danubio, del grande fiume europeo che si snoda per tremila chilometri attraverso gran parte del nostro continente. L'abilissimo pilota che lo percorre a bordo di una chiatta, dalle sorgenti al Mar Nero, è Serge Ladko che, ricercato dalla polizia per il suo amor di patria, si è allontanato dalla sua casa allo scopo di procurare armi ai patrioti del suo paese che intendono sollevarsi contro il dominio dei turchi. Il patriota e galantuomo Ladko ha però un sosia di tutt'altra risma: Ivan Striga, considerato, dai più, un traditore del proprio paese. Striga, infatti, spende e spande a piene mani senza che si sappia come faccia a procurarsi tanto denaro; denaro che non riesce tuttavia a fargli ottenere l'amore della bellissima Natcha Gregorevitch, la quale preferisce sposare Ladko. Inimicizia e gelosia spingono allora Striga a sparare contro il rivale un colpo di fucile, in seguito al quale crede di averlo ucciso. Ma Ladko è morto davvero? Lo ritroviamo qui, ad apertura di pagina del romanzo, sotto il falso nome di Ilia Brusch. Ha mutato nome per sottrarsi alle ricerche della polizia e per tornare in patria partecipa, vincendola, alla gara di pesca che la Lega Danubiana di Sigmaringen bandisce periodicamente. E non solo vince la gara, ma annuncia pubblicamente ai soci della Lega — che lo applaudono con entusiasmo — che intende percorrere il grande fiume dalle sorgenti alla foce, vivendo con il ricavato della propria pesca. Un'impresa davvero originale e avventurosa. Partito pochi giorni dopo, Ilia Brusch inizia il suo viaggio romanzesco. A Ulm, tanto per cominciare, deve accogliere sulla sua chiatta un passeggero, Karl Dragoch, capo della polizia danubiana, che viaggia anche lui sotto il falso nome di Jaeger. Dragoch è alla ricerca di una banda di malfattori che da più mesi svaligiano ville e abitazioni poste in prossimità delle rive del Danubio, nel tratto che va dalla foce oltre la città di Vienna. In qualche caso la banda ha persino ucciso. Ciò che capita durante la discesa del fiume al nostro Ladko, alias Brusch, scambiato per Striga, costituisce il nocciolo del racconto, che grazie all'impareggiabile maestria dell'autore non mancherà di avvincere il lettore; il quale tra l'altro sarà portato a rivivere gli eventi storici svoltisi nella regione danubiano-balcanica, verso la fine del secolo scorso. Nel 1876 — anno in cui si svolge l'azione dei protagonisti — il Danubio attraversava infatti, politicamente parlando, due regni (il Württemberg e la Baviera), due imperi (Austria-Ungheria e Turchia) e tre principati (l'Hohenzollern, la Serbia e la Romania). I Balcani erano allora in subbuglio a causa dei moti d'indipendenza dei vari gruppi etnici che intendevano sottrarsi a ogni costo al giogo della Porta, e cioè dell'Impero Ottomano, che non si fece scrupolo, per soffocarli, di ricorrere ad alcuni massacri, dai quali non furono esclusi donne e bambini, suscitando ondate di indignazione e di orrore in tutto il mondo cristiano. Lasciamo al lettore il piacere di giungere da sé alla conclusione del racconto, che l'abilità dell'autore riesce sempre a rimandare alle ultime pagine. VINCENZO BRINZI JULES VERNE nacque a Nantes l'8 febbraio 1828. A undici anni, tentato dallo spirito d'avventura, cercò di imbarcarsi clandestinamente sulla nave La Coralie, ma fu scoperto per tempo e ricondotto dal padre. A vent'anni si trasferì a Parigi per studiare legge, e nella capitale entrò in contatto con il miglior mondo intellettuale dell'epoca. Frequentò soprattutto la casa di Dumas padre, dal quale venne incoraggiato nei suoi primi tentativi letterari. Intraprese dapprima la carriera teatrale, scrivendo commedie e libretti d'opera; ma lo scarso successo lo costrinse nel 1856 a cercare un'occupazione più redditizia presso un agente di cambio a Parigi. Un anno dopo sposava Honorine Morel. Nel frattempo entrava in contatto con l'editore Hetzel di Parigi e, nel 1863, pubblicava il romanzo Cinque settimane in pallone. La fama e il successo giunsero fulminei. Lasciato l'impiego, si dedicò esclusivamente alla letteratura e un anno dopo l'altro — in base a un contratto stipulato con l'editore Hetzel — venne via via pubblicando i romanzi che compongono l'imponente collana dei «Viaggi straordinari — i mondi conosciuti e sconosciuti» e che costituiscono il filone più avventuroso della sua narrativa. Viaggio al centro della Terra, Dalla Terra alla Luna, Ventimila leghe sotto i mari, L'isola misteriosa, Il giro del mondo in 80 giorni, Michele Strogoff sono i titoli di alcuni fra i suoi libri più famosi. La sua opera completa comprende un'ottantina fra romanzi e racconti lunghi, e numerose altre opere di divulgazione storica o scientifica. Con il successo era giunta anche l'agiatezza economica, e Verne, nel 1872, si stabilì definitivamente ad Amiens, dove continuò il suo lavoro di scrittore, conducendo, nonostante la celebrità acquistata, una vita semplice e metodica. La sua produzione letteraria ebbe termine solo poco prima della morte, sopravvenuta a settantasette anni, il 24 marzo 1905. IL PILOTA DEL DANUBIO CAPITOLO I IL CONCORSO DI SIGMARINGEN IL SABATO del 5 agosto 1876, una folla chiassosa gremiva l'osteria del «Ritrovo dei Pescatori». Canzoni, grida, tintinnar di bicchieri, applausi ed esclamazioni si mescolavano in un baccano indicibile che, a intervalli regolari, era dominato dagli hoch! con i quali di solito si manifesta la gioia dei tedeschi quando raggiunge il culmine. Le finestre dell'osteria davano direttamente sul Danubio, all'estremità dell'incantevole cittadina di Sigmaringen, capitale del territorio prussiano di Hohenzollern situato quasi alla sorgente di quel grande fiume dell'Europa centrale. Quasi obbedendo all'invito dell'insegna dipinta con belle lettere gotiche al disopra della porta d'ingresso, si erano là riuniti i membri della Lega Danubiana, società internazionale di pescatori appartenenti alle varie nazionalità rivierasche. Ma non vi è allegra riunione senza abbondanti bevute. Perciò si beveva la buona birra di Monaco e il buon vino d'Ungheria a grandi caraffe e a bicchieri stracolmi. Si fumava anche: il salone era infatti oscurato da una nuvola di fumo odoroso che s'innalzava senza tregua dalle lunghe pipe. Ma se i soci non si vedevano più, tuttavia si udivano, a meno d'essere sordi. I pescatori alla lenza, calmi e silenziosi nell'esercizio delle loro funzioni, sono in realtà le persone più rumorose del mondo appena depongono i loro attrezzi. Per raccontare le loro gesta, essi non sono da meno dei cacciatori, che è tutto dire. Si era al termine di una sostanziosissima colazione, che aveva raccolto intorno alle tavole dell'osteria un centinaio di convitati, tutti cavalieri della lenza, tifosi del gavitello, fanatici dell'amo. Le fatiche del mattino, a giudicare dal numero di bottiglie che si vedevano tra gli avanzi della tavola, avevano senza dubbio stranamente disseccato le loro gole. Adesso era la volta dei numerosi liquori inventati dagli uomini come ammazza-caffé. Sonavano le tre del pomeriggio quando i convitati, con il viso sempre più acceso, si alzarono da tavola. Ad essere sinceri, alcuni barcollavano e non avrebbero potuto fare del tutto a meno dell'aiuto dei loro vicini; la maggior parte però si reggeva solidamente in piedi, da bravi abituali frequentatori di quelle riunioni da epuloni che si ripetevano più volte all'anno, grazie alle gare organizzate dalla Lega Danubiana. Partecipare a quelle gare, molto seguite e festose, lungo il corso del celebre fiume giallo, e non blu come lo esalta il famoso valzer di Strauss, dava molto lustro. I concorrenti giungevano dal ducato di Baden, dal Württemberg, dalla Baviera, dall'Austria, dall'Ungheria, dalla Romania, dalla Serbia e persino dalle province turche della Bulgaria e della Bessarabia. La società aveva già cinque anni di vita. Molto bene amministrata dal suo presidente, l'ungherese Miclesco, essa prosperava. Le sue risorse, sempre crescenti, le consentivano di offrire importanti premi nelle gare, e la sua bandiera brillava delle gloriose medaglie conquistate, dopo aspra lotta, contro le associazioni rivali. Perfettamente al corrente della legislazione relativa alla pesca fluviale, il suo Comitato direttivo appoggiava i suoi aderenti sia contro lo stato sia contro i privati, e difendeva i loro diritti e i loro privilegi con quella tenacia, o meglio con quella testardaggine professionale, particolare al bipede che l'istinto di pescatore con la lenza rende degno di essere classificato in una particolare categoria del genere umano. La gara che si era appena conclusa era la seconda dell'anno 1876. Sin dalle cinque del mattino, i partecipanti avevano lasciato la città per raggiungere la riva sinistra del Danubio, un po' a valle di Sigmaringen. Tutti indossavano l'uniforme della società: camiciotto corto che lasciava libertà di movimento, pantaloni infilati negli stivali dalle suole robuste, berretto bianco ad ampia visiera; e possedevano, ovviamente, l'intera collezione dei vari attrezzi elencati nel Manuale del Pescatore: gavitelli, guadello, lenze impacchettate nella loro busta di pelle di daino, galleggianti, sonde, pezzettini di piombo fuso di ogni dimensione, mosche artificiali, cordoncino, crine di Firenze. La pesca doveva essere libera, nel senso che si poteva pescare qualsiasi tipo di pesce che abboccasse e che ogni pescatore poteva occupare il posto che più gli piaceva. Alle sei, novantasette concorrenti erano al loro posto con la lenza in mano, pronti a lanciare l'amo. Uno squillo di tromba diede il segnale e le novantasette lenze si tesero, con identico movimento, sopra la corrente. La gara era dotata di parecchi premi, dei quali i primi due, del valore di cento fiorini ciascuno, sarebbero stati attribuiti al pescatore che avrebbe avuto il maggior numero di pesci e a quello che avrebbe catturato il pesce più pesante. Non ci fu alcun incidente fino al secondo squillo di tromba che, alle undici meno cinque, chiuse il concorso. Ogni lotto fu allora sottoposto alla giuria, composta dal presidente Miclesco e da quattro membri della Lega. Che questi importanti personaggi prendessero la loro decisione imparzialmente e in modo da rendere impossibile alcun reclamo – anche se nel mondo particolare dei pescatori ci fossero molte teste calde – nessuno lo mise in dubbio neppure per un istante. Fu però necessario armarsi di pazienza per conoscere il risultato del loro esame coscienzioso e l'attribuzione dei vari premi, sia per il peso sia per il numero, perché esso doveva rimanere segreto fino all'ora della distribuzione dei premi, preceduta a sua volta da un pasto che avrebbe riunito tutti i partecipanti in agapi fraterne. Ma adesso l'ora era giunta. I pescatori, per non parlare dei curiosi venuti da Sigmaringen, aspettavano comodamente seduti dinanzi alla tribuna, sulla quale stavano il presidente e gli altri membri della giuria. E in verità, se seggi, panche e sgabelli non mancavano, non mancavano neppure le tavole, e, sulle tavole, boccali di birra, bottiglie di liquori d'ogni genere, bicchieri grandi e piccoli. Dopo che ciascuno ebbe preso posto, mentre le pipe continuavano a fumare a più non posso, il presidente si alzò. — Silenzio! silenzio! — si gridò da ogni parte. Il signor Miclesco vuotò, per cominciare, un grande boccale di birra, la cui schiuma gli imperlò la punta dei baffi. — Miei cari colleghi — disse in tedesco, lingua compresa da ogni membro della Lega, nonostante la loro diversa nazionalità — non aspettatevi il solito classico discorso con preambolo, sviluppo e conclusione. Non siamo qui per inebriarci di arringhe ufficiali; vi parlerò delle nostre piccole faccende da buon camerata, dirò anzi da fratello, se questa qualifica vi sembrerà giustificata per un'assemblea internazionale. Le due frasi, un po' lunghe come tutte quelle che si dicono di solito all'inizio di un discorso, anche quando l'oratore afferma di non voler fare discorsi, furono accolte con unanimi applausi, ai quali si unirono numerosi benissimo! benissimo! mescolati a qualche hoch! e cioè a qualche singulto. Poi, al bicchiere alzato dal presidente fecero onore tutti gli altri con i bicchieri pieni. Il signor Miclesco continuò il suo discorso ponendo il pescatore con la lenza al primo posto dell'umanità. Egli ne mise in evidenza qualità e virtù di cui lo aveva dotato la natura generosa; disse che al pescatore occorrono pazienza, ingegnosità, sangue freddo e un'intelligenza superiore per riuscire in questa sua arte, perché, più che un mestiere, la pesca è un'arte; un'arte che egli pose molto al disopra delle prodezze cinegetiche di cui si vantano, a torto, i cacciatori. — È possibile mai paragonare la caccia alla pesca? — esclamò. — No! no! — rispose l'assemblea. — Che merito c'è nell'uccidere una pernice o una lepre, quando sono a giusta portata, quando un cane — abbiamo forse cani, noi? — li ha scoperti per vostro conto? Quella selvaggina voi la vedete da lontano, prendete la mira con comodo, la riempite di un gran numero di pallini di piombo, la maggior parte dei quali va sprecata!… Il pesce, invece, voi non potete seguirlo con lo sguardo. Esso è nascosto sotto l'acqua… Quante manovre accorte occorrono, quanti adescamenti sottili, quanto spreco di intelligenza, quanti accorgimenti per indurlo a mordere l'amo, per uncinarlo, per tirarlo fuori dall'acqua, ora immobile all'estremità della lenza, ora guizzante come se, per così dire, applaudisse esso stesso alla vittoria del pescatore! Quelle parole furono sommerse da tuonanti «bravo». Il presidente Miclesco riscuoteva certamente le simpatie dei membri della Lega. Sapendo che non avrebbe mai esagerato abbastanza nel fare l'elogio dei suoi confratelli, egli, senza alcun timore, non esitò a porre il loro nobile esercizio al disopra di tutti gli altri, a innalzare fino alle stelle i ferventi discepoli della scienza piscatoria, a evocare persino la superba dea che nell'antica Roma presiedeva ai giuochi piscatori. Furono comprese quelle parole? Certamente, poiché suscitarono un entusiasmo incontenibile. Dopo aver ripreso fiato e vuotato un altro boccale di birra, egli proseguì: — Non ci rimane che felicitarci per la sempre crescente prosperità della nostra società, la quale recluta ogni anno nuovi membri e la cui reputazione è ben solida in tutta l'Europa centrale. Non vi parlerò dei suoi successi: voi li conoscete, sono in gran parte i vostri, ed è un grande onore figurare nelle sue gare! La stampa tedesca, la stampa ceca e quella romena non le hanno mai lesinato i loro elogi così preziosi e, io aggiungo, così meritati; faccio un brindisi, perciò, pregandovi di brindare con me, ai giornalisti che si votano alla causa internazionale della Lega Danubiana! Si brindò insieme con il presidente; le bottiglie si vuotarono nei bicchieri e i bicchieri nelle gole, con la stessa facilità con cui l'acqua del grande fiume e dei suoi affluenti si riversa nel mare. Ogni cosa sarebbe finita a questo punto, se il discorso presidenziale fosse terminato con quel brindisi. Ma altri brindisi erano necessari per motivi di evidente opportunità. Tra il segretario e il tesoriere, anch'essi in piedi, il presidente fece cenno, infatti, di voler riprendere la parola. Tutti e tre tenevano con la mano destra una coppa di champagne; la mano sinistra era posata sul cuore. — Bevo alla Lega Danubiana! — disse il signor Miclesco, abbracciando con lo sguardo l'assemblea. Tutti si erano alzati, con la coppa all'altezza delle labbra; alcuni erano saliti sulle panche, altri sulle tavole: tutti risposero all'unisono alla proposta del signor Miclesco. Vuotate le coppe, il presidente ricominciò con foga, dopo aver attinto dalle inesauribili bottiglie poste dinanzi a lui e ai suoi assessori: — Alle varie nazionalità, a quelli del Baden, a quelli del Württemberg, ai bavaresi, agli austriaci, agli ungheresi, ai serbi, ai valacchi, ai moldavi, a quelli della Bessarabia, a tutti coloro che la Lega Danubiana annovera nelle sue file! E quelli della Bessarabia, del Baden, del Württemberg, con bulgari, moldavi, valacchi, serbi, ungheresi, austriaci e bavaresi gli risposero, unanimi, tracannando il contenuto delle loro coppe. Il presidente pose termine alla fine alla sua arringa per annunciare che beveva alla salute di ogni membro della società. Ma tenuto conto che i soci erano quattrocentosettantatré, fu costretto suo malgrado a fare per tutti un solo brindisi. E tutti gli risposero con mille e mille hoch! che si prolungarono fino alla consunzione delle corde vocali. Ebbe così termine il secondo numero del programma, il primo essendo finito con l'abbuffata. Il terzo sarebbe consistito nella proclamazione dei laureati. Tutti attendevano con ovvia ansietà, perché, come è stato già detto, il segreto della giuria era stato mantenuto. Ora era venuto il momento di svelarlo in pubblico. Il presidente si fece il dovere di leggere l'elenco ufficiale dei premiati per le due categorie. In conformità agli statuti della società, i premi di minor valore sarebbero stati consegnati per primi, la qualcosa avrebbe dato alla lettura un crescente interesse. Alla chiamata del loro nome, i premiati si presentarono dinanzi alla tribuna. Il presidente diede a ognuno un abbraccio, un diploma e una somma di denaro che variava a seconda del posto ottenuto. I pesci contenuti nella rete erano del tipo di quelli che qualsiasi pescatore può catturare nelle acque del Danubio: spinelli, lasche, ghiozzi, passere, persici, tinche, lucci, cavedani e altri. Valacchi, ungheresi, cittadini del Baden e del Württemberg apparivano nell'elenco dei premi minori. Il secondo premio fu attribuito, per la cattura di settantasette pesci, a un tedesco di nome Weber, il cui successo fu accolto da calorosi applausi. Weber era molto noto ai suoi confratelli: molte volte, in passato, si era già classificato nei primi posti; quel giorno poi tutti ritenevano che nessuno gli avrebbe tolto il primo premio per il numero di pesci pescati. Ma non fu così: la sua rete conteneva soltanto settantasette pesci, contati e ricontati; un altro concorrente, più abile o forse soltanto più fortunato, ne aveva presi novantanove. Venne quindi reso noto il nome di questo maestro pescatore: era l'ungherese Ilia Brusch. L'assemblea, sorpresissima, non applaudì affatto nell'udire il nome di quello sconosciuto ungherese, entrato da poco tempo a far parte della Lega Danubiana. Poiché il vincitore non aveva ritenuto di doversi presentare per incassare il premio di cento fiorini, il presidente passò senz'altro indugio all'elenco dei vincitori della categoria del peso. I premiati furono rumeni, slavi e austriaci. Quando fu pronunciato il nome di colui al quale era stato attribuito il secondo premio ci fu un applauso come per il tedesco Weber. Il signor Ivetozar, assessore, trionfava con un cavedano di tre libbre e mezzo, che sarebbe certamente sfuggito a un pescatore meno abile e con meno sangue freddo. Il signor Ivetozar era un socio molto noto, attivissimo e devoto alla società: era lui che aveva ottenuto fin allora il maggior numero di premi. Perciò gli furono tributati unanimi applausi. Ora non restava che assegnare il primo premio della categoria: i cuori palpitarono nell'attesa di conoscere il nome del vincente. Quale non fu lo stupore, o meglio, quale non fu la meraviglia generale quando il presidente pronunciò queste parole, con voce di cui non riusciva a moderare il tremito: — Primo per peso, per un luccio di diciassette libbre, l'ungherese Ilia Brusch! Seguì un grande silenzio. Le mani pronte ad applaudire rimasero immobili, le bocche pronte ad acclamare il vincitore rimasero chiuse. La curiosità aveva immobilizzato tutti. Ilia Brusch si sarebbe fatto vedere? Sarebbe venuto a ritirare dalle mani del presidente i diplomi d'onore e i duecento fiorini che li accompagnavano? All'improvviso un mormorio corse di bocca in bocca. Un partecipante, che fin allora si era tenuto un po' in disparte, si diresse verso la tribuna. Era l'ungherese Ilia Brusch. A giudicare dal suo viso accuratamente rasato, coronato da folti capelli neri come l'inchiostro, Ilia Brusch non aveva ancora oltrepassato i trent'anni. Di statura al di sopra della media, spalle ampie, ben piantato sulle gambe, doveva essere insolitamente forte. Poteva sorprendere, a dire il vero, che un giovane di quella tempra amasse le placide distrazioni della pesca alla lenza al punto di avere acquistato in un'arte così difficile una tale abilità, di cui era conferma irrevocabile il risultato ottenuto nella gara. Altra particolarità abbastanza bizzarra: Ilia Brusch doveva soffrire di un qualche disturbo alla vista. Grandi occhiali neri gli nascondevano gli occhi, dei quali sarebbe stato impossibile vedere il colore. Ora, la vista è il senso più prezioso per colui che si appassiona agli impercettibili movimenti dei gavitelli, e buoni occhi sono necessari a chi voglia sventare le molteplici astuzie del pesce. Ma, stupiti o non stupiti, non c'era che da accettare il verdetto: l'imparzialità della giuria era insospettabile. Ilia Brusch era il vincitore delle due gare, e questo in condizioni che nessuno, a memoria di socio, era mai riuscito a mettere insieme. L'assemblea alla fine si disgelò e applausi abbastanza sonori salutarono il trionfatore nel momento in cui riceveva diplomi e premi dalle mani del presidente. Ciò fatto, invece di scendere dalla tribuna, Ilia Brusch parlò brevemente con il presidente; poi si volse verso l'assemblea, sempre di più incuriosita, e con un gesto chiese il silenzio, che ottenne subito come per incanto. — Signori e cari colleghi, — disse Ilia Brusch — vi chiederò il permesso di rivolgervi poche parole, autorizzato a farlo dalla cortesia del nostro presidente. Nella sala, poco prima così rumorosa, si sarebbe sentito volare una mosca. A che cosa mirava quella allocuzione non prevista dal programma? Desidero innanzi tutto ringraziarvi — proseguì Ilia — per la vostra simpatia e i vostri applausi; ma vi prego di credere che non inorgoglisco più di quanto convenga, per il doppio successo ottenuto. Non ignoro che tale successo, se fosse andato al più meritevole, sarebbe toccato a qualche vecchio socio della lega, così ricca di abili pescatori; più che al merito, io lo devo a un caso fortunato. La modestia di queste parole fu vivamente apprezzata dall'assemblea, dalla quale si levarono in sordina numerosi benissimo! — Questo caso fortunato dovrei qui giustificarlo, e a questo scopo ho fatto un progetto che ritengo tale da interessare questa riunione di illustri pescatori. «Come sapete, cari colleghi, sono oggi di moda i primati. Perché non dovremmo imitare i campioni degli altri sport, certamente inferiori al nostro, e tentare di stabilire il primato della pesca?» Esclamazioni soffocate corsero tra il pubblico. Con degli ah! ah!, dei toh! toh!, e dei perché no? i soci tradussero le proprie impressioni, a seconda del temperamento personale. — Quando per la prima volta — proseguì l'oratore — mi è venuta in mente tale idea l'ho fatta immediatamente mia e subito ho capito come essa avrebbe dovuto essere realizzata. Del resto, il fatto di essere socio della Lega Danubiana, facilitava la cosa. Pescatore alla lenza del Danubio, soltanto al Danubio dovevo chiedere la felice soluzione della mia impresa. Ho formulato perciò il progetto di discendere il nostro glorioso fiume, dalla sorgente fino al Mar Nero, e di vivere, durante il suo percorso di tremila chilometri, esclusivamente del prodotto della mia pesca. «La fortuna che oggi mi ha favorito accresce, ammesso che ciò sia possibile, il mio desiderio di compiere questo viaggio, di cui, sono certo, apprezzerete l'interesse; vi annuncio perciò sin da questo momento la mia partenza, fissata per il 10 agosto, e cioè per giovedì prossimo e, per quel giorno, vi do appuntamento nel punto preciso in cui comincia il Danubio». È più facile immaginare che descrivere l'entusiasmo suscitato da quella inattesa comunicazione. Per lunghi cinque minuti vi fu una tempesta di hoch! e di applausi frenetici. Ma una faccenda del genere non poteva finire in quel modo. Il signor Miclesco lo capì e, come sempre, agì da presidente. Si alzò dunque, forse un po' pesantemente, tra i suoi due assessori. — Al nostro collega Ilia Brusch! — disse con voce commossa, sollevando una coppa di champagne. — Al nostro collega Ilia Brusch! — rispose l'assemblea con un rumore di tuono, al quale seguì subito un profondo silenzio, dovuto al fatto che gli uomini, per una spiacevole imperfezione, non sono fatti in modo da poter gridare e bere nello stesso tempo. Il silenzio fu però di breve durata. Lo spumante donò presto alle gole riarse nuovo vigore e ciò permise loro di fare ancora molti altri brindisi, sino al momento in cui, nella generale allegria, fu dichiarata chiusa la famosa gara di pesca aperta quel sabato 5 agosto 1876 dalla Lega Danubiana, nell'incantevole cittadina di Sigmaringen. CAPITOLO II ALLE SORGENTI DEL DANUBIO NELL'ANNUNCIARE ai colleghi raccolti nel «Ritrovo dei Pescatori» il suo progetto di discendere il Danubio con la lenza in mano, Ilia Brusch aveva forse aspirato alla gloria? Se tale era il suo scopo, poteva vantarsi di averlo raggiunto. La stampa si era appropriata della notizia e tutti i giornali della regione danubiana, senza eccezione alcuna, avevano consacrato al concorso di Sigmaringen articoli più o meno lunghi ma sempre atti a solleticare piacevolmente l'amor proprio del vincitore, il cui nome stava per diventare popolare. Sin dal giorno dopo, nel numero del 6 agosto, la Neue Freie Press di Vienna aveva pubblicato ciò che segue: «L'ultimo concorso di pesca della Lega Danubiana si è chiuso ieri a Sigmaringen con un vero colpo di scena, del quale un ungherese di nome Ilia Brusch, ieri sconosciuto e oggi quasi celebre, è stato l'eroe. «Che cosa ha fatto dunque Ilia Brusch, vi chiederete, per meritare una gloria così improvvisa? «Questo abile uomo è riuscito ad aggiudicarsi i due primi premi, quello del peso e quello del numero, distanziando di molto i concorrenti; la qualcosa non era mai accaduta, a quel che sembra, da quando esistono concorsi del genere. Bene, ma c'è di meglio. «Quando si è raccolto una tale messe di allori, quando si è riportato una vittoria così splendida, sembrerebbe giusto godersi un meritato riposo. Ma non è questo il parere del nostro pescatore ungherese, il quale si Prepara a stupirci ancora di più. «Se siamo ben informati — ed è nota la fondatezza delle nostre informazioni — Ilia Brusch avrebbe annunciato ai suoi colleghi che si propone di discendere con la lenza in mano tutto il Danubio, dalla sorgente, nel ducato di Baden, sino alla foce, nel Mar Nero, un percorso cioè di circa tremila chilometri. «Terremo informati i nostri lettori degli sviluppi di questa originale impresa. «Ilia Brusch inizierà il suo viaggio giovedì prossimo, 10 agosto. Auguriamo a lui buon viaggio e a noi la speranza che il formidabile pescatore non stermini tutti i pesci che vivono nel grande fiume internazionale!». Così si esprimeva la Neue Freie Press di Vienna. Il Pester Lloyd di Budapest non si mostrava meno entusiasta, non più del Serbské Noviné di Belgrado e del Românul di Bucarest, nei quali la notizia veniva data con molti particolari. Quelle informazioni attiravano l'attenzione dei lettori su Ilia Brusch; e se è vero che la stampa è il riflesso dell'opinione pubblica, l'ungherese poteva ben aspettarsi di suscitare un sempre crescente interesse con il graduale procedere del suo viaggio. Non avrebbe forse trovato nelle principali città del percorso i membri della Lega Danubiana, i quali consideravano un dovere apportare il loro contributo alla gloria del loro collega? Senza alcun dubbio, in caso di necessità egli avrebbe ricevuto da loro assistenza e soccorso. Gli articoli della stampa ottenevano evidente successo tra i pescatori alla lenza. Agli occhi di tali professionisti, l'impresa di Ilia Brusch acquistava enorme importanza; numerosi pescatori, attratti a Sigmaringen dal concorso allora terminato, vi si erano attardati infatti nell'intento di assistere alla partenza del campione della Lega Danubiana. Il proprietario del «Ritrovo dei Pescatori» era quello che più ci guadagnava in tutta la faccenda. Nel pomeriggio dell'8 agosto, antivigilia del giorno stabilito dal premiato per l'inizio del suo insolito viaggio, più di trenta bevitori continuavano la loro allegra vita nella grande sala dell'osteria, la cui cassa, considerate le capacità di bere di quella scelta clientela, conosceva introiti insperati. Nonostante l'imminenza dell'avvenimento che aveva trattenuto quei curiosi nella capitale dell'Hohenzollern, la sera di quell'8 agosto, nel «Ritrovo dei Pescatori» non si parlava però del nostro eroe: un avvenimento, ancora più importante per i rivieraschi del grande fiume, serviva da tema alla conversazione generale e metteva quel mondo a rumore. Quell'agitazione non aveva nulla di esagerato e fatti piuttosto gravi la giustificavano ampiamente. Da vari mesi, infatti, le rive del Danubio erano razziate dal brigantaggio Non era più possibile enumerare le fattorie svaligiate, i castelli saccheggiati, le ville depredate, e anche i delitti, più persone avendo già pagato con la vita la resistenza che avevano cercato di opporre agli inafferrabili malfattori. Era evidente che quelle imprese criminose non erano state compiute da pochi individui isolati. Si doveva trattare certamente di una banda ben organizzata e senza dubbio numerosa, a giudicare dalle sue prodezze. Circostanza curiosa: la banda operava esclusivamente nelle immediate vicinanze del Danubio. Più in là di due chilometri dalle rive del fiume, non era stato legittimamente possibile attribuirle un solo delitto. Teatro delle operazioni della banda erano però soltanto le rive del fiume, dato che anche quelle austriache, ungheresi, serbe o rumene erano egualmente messe a sacco da quei banditi che nessuno, da nessuna parte, riusciva a cogliere sul fatto. Compiuto un colpo, essi sparivano fino al prossimo, commesso a volte a centinaia di chilometri dal precedente. Nell'intervallo, non si trovava alcuna traccia di essi: sembravano essersi volatilizzati, e sembravano essersi volatilizzati anche gli oggetti materiali, a volte molto ingombranti, che rappresentavano il loro bottino. I governi interessati avevano finito con il reagire a questi continui scacchi, imputabili verosimilmente a una mancanza di coordinamento nelle operazioni di repressione. Un accordo dapprima verbale, a quanto ne riferiva la stampa la mattina dell'8 agosto, aveva portato alla creazione di una polizia internazionale, suddivisa lungo il corso del Danubio, comandata da un solo capo. La designazione di quel capo era stata particolarmente laboriosa; alla fine però tutti si erano trovati d'accordo sul nome di Karl Dragoch, poliziotto ungherese molto noto nella regione. Karl Dragoch era infatti un investigatore di valore e la difficile missione affidatagli non avrebbe potuto essere posta in mani migliori. Aveva quarantacinque anni, era piuttosto magro, di media statura, dotato di grande forza morale più che di forza fisica. Possedeva abbastanza energia, tuttavia, per sopportare le fatiche della sua professione, e abbastanza coraggio per affrontarne i pericoli. Abitava legalmente a Budapest, ma assai spesso era altrove, occupato in qualche inchiesta delicata. La perfetta conoscenza degli idiomi del sud-est europeo, del tedesco e del rumeno, del serbo, del bulgaro e del turco, per non parlare dell'ungherese sua lingua madre, gli permetteva di non trovarsi mai in imbarazzo. Essendo oltre tutto celibe, non aveva neppure preoccupazioni di carattere familiare. La sua nomina ebbe accoglienza favorevole. Il pubblico, da parte sua, l'approvava all'unanimità. Nella grande sala del «Ritrovo dei Pescatori», la notizia poi fu accolta in modo particolarmente lusinghiero. — Non potevano scegliere meglio, — diceva nel momento in cui si accendevano le lampade dell'osteria il signor Ivetozar, quello che aveva preso il secondo premio del peso nel concorso allora terminato. — Lo conosco, Dragoch. E un vero uomo. — Abile — aggiunse il presidente Miclesco. — Speriamo che riesca a ripulire le rive del fiume — esclamò un croato chiamato Svrb (nome poco facile da pronunciare) proprietario di una tintoria in un sobborgo di Vienna. — La vita non vi è più tollerabile, a dire il vero! — Karl Dragoch ha una brutta faccenda per le mani — disse il tedesco Weber, scotendo il capo. — Bisognerà vederlo all'opera. — All'opera!… — disse il signor Ivetozar. — Vi è già, non dubitate. — Certamente! Karl Dragoch non è tipo da perdere tempo — approvò il signor Miclesco. — Se la sua nomina risale a quattro giorni fa, come dicono i giornali, almeno da tre giorni è all'opera. — Da dove comincerà? — chiese il signor Piscéa, un rumeno dal nome predestinato per un pescatore alla lenza. — Io sarei in imbarazzo, lo confesso, se fossi al suo posto. — È proprio per ciò che non vi siete stato messo, mio caro — disse scherzosamente un serbo. — Siate certo che Dragoch non è affatto in imbarazzo, lui. In quanto a dirvi il suo piano, è un'altra faccenda. Forse si è diretto a Belgrado, forse è rimasto a Budapest. A meno che non abbia preferito di venire proprio qui, a Sigmaringen, e che non sia in questo momento tra di noi, al «Ritrovo dei Pescatori». Questa supposizione suscitò grande ilarità. — Tra di noi? — esclamò il signor Weber. — Voi ce la volete dare a bere, Michael Michaelovitch. Che cosa verrebbe a fare qui, dove, a memoria d'uomo, non c'è mai stato alcun delitto? — Non fosse altro — rispose Michael Michaelovitch — che per assistere dopodomani alla partenza di Ilia Brusch. Forse quest'uomo lo interessa… A meno che, naturalmente, Ilia Brusch e Karl Dragoch non siano la stessa persona. — Come? La stessa persona! — si gridò da ogni parte. — Che volete dire? — Diamine! Sarebbe magnifico! Sotto i panni del premiato nessuno sospetterebbe il detective, che potrebbe così ispezionare il Danubio in perfetta libertà. Il fantasioso paradosso fece spalancare gli occhi agli altri bevitori. Quel Michael Michaelovitch! Soltanto lui avrebbe potuto avere un'idea del genere! Ma Michael Michaelovitch non ci teneva molto a quel paradosso. — A meno… — cominciò, usando un'espressione che gli era abituale. — A meno? — A meno che Karl Dragoch non abbia un altro motivo per venire qui — proseguì passando direttamente a un'altra ipotesi non meno fantasiosa. — Quale motivo? — Immaginate, ad esempio, che il progetto di discendere il Danubio con la lenza in mano gli sembri subdolo. — Subdolo! Perché subdolo? — Diamine, non sarebbe per niente stupido, per un ladro, nascondersi nei panni di un pescatore, e soprattutto di un pescatore così noto. La notorietà a volte protegge più dell'incognito. Si potrebbe commettere di tutto, a condizione di pescare tra un colpo e l'altro, nell'intento di trarre in inganno gli altri. — Sì, ma bisognerebbe saper pescare — obiettò con aria saputa il presidente, — e questo è un privilegio riservato alla gente onesta. La riflessione morale, forse un po' azzardata, fu freneticamente applaudita da tutti gli appassionati pescatori. Michael Michaelovitch approfittò con tatto del generale entusiasmo. — Alla salute del presidente! — disse alzando il bicchiere. — Alla salute del presidente! — risposero i bevitori, vuotando il proprio come un sol uomo. — Alla salute del presidente! — disse uno che sedeva, solo, a una tavola e che da alcuni istanti sembrava mostrare vivo interesse alle battute scambiate intorno a lui. Il signor Miclesco fu sensibile alla cortesia dello sconosciuto e, per ringraziarlo, accennò verso di lui un brindisi. Ritenendo che quel gesto cortese avesse rotto a sufficienza il ghiaccio, il bevitore solitario si ritenne autorizzato a comunicare le sue impressioni all'assemblea. Ben detto — rispose. — La pesca è certamente un piacere da gente onesta. — Avremmo forse il piacere di parlare con un confratello? — chiese il signor Miclesco, avvicinandosi allo sconosciuto. — Oh, con un dilettante, al più — rispose modestamente quest'ultimo, — che s'interessa ai buoni colpi, ma che non ha la presunzione di cercare di imitarli. — Tanto peggio, signor…? — Jaeger. — Tanto peggio, signor Jaeger, perché debbo ritenere che non avremo mai l'onore di annoverarvi tra i membri dalla Lega Danubiana. — Non si sa mai — rispose il signor Jaeger. — Forse un giorno o l'altro mi deciderò… per la lenza, e quel giorno sarò certamente dei vostri, se riuscirò a possedere i requisiti richiesti per l'ammissione. — Non dubitatene — disse subito il signor Miclesco, lusingato dalla speranza di reclutare un nuovo aderente. — Le condizioni, assai semplici, sono soltanto quattro. La prima è quella di pagare la modesta quota annuale: è la più importante. — Benissimo — approvò ridendo il signor Jaeger. — La seconda è quella di amare la pesca. La terza, di essere un compagno simpatico: io credo che questa terza condizione la possediate di già. — Troppo buono! — lo ringraziò il signor Jaeger. — La quarta consiste unicamente nella iscrizione del nome e dell'indirizzo sull'elenco della Società. Ora, conoscendo già il vostro nome, quando avrò l'indirizzo… — Vienna, via Lipsia 45. — Voi sarete regolare socio della Lega pagando venti corone all'anno. I due interlocutori si misero a ridere di tutto cuore. — Nessun'altra formalità? — chiese il signor Jaeger. — Nessun'altra. — Nessun documento di identità da presentare? — Signor Jaeger… — obiettò il signor Miclesco, — per pescare alla lenza!… — Giusto. Del resto, ciò non ha importanza. Tutti si conoscono nella Lega Danubiana. — Non è vero — rettificò il signor Miclesco. — Pensate, alcuni nostri camerati abitano qui, a Sigmaringen; altri sulle rive del Mar Nero, e ciò non facilita i rapporti di buon vicinato. — È vero! — Il nostro stupefacente primo classificato dell'ultimo concorso, ad esempio… — Ilia Brusch? — Sì, lui. Ebbene! nessuno lo conosce. — Ma non è possibile! — È possibile — affermò il signor Miclesco. — Fa parte della Lega da non più di quindici giorni. Ilia Brusch è stato una sorpresa per tutti noi; anzi, una vera rivelazione. — Ciò che si dice un outsider, nel gergo delle corse. — Proprio così. — Da quale paese proviene questo outsider? — È ungherese. — Come voi, dunque. Perché voi siete ungherese, credo, signor presidente? — Puro sangue, signor Jaeger, ungherese di Budapest. — Ilia Brusch invece?… — È di Szalka. — Da dove salta fuori Szalka? — E una borgata, una piccola città, se vi fa piacere, posta sulla riva destra dell'Ipoly, un fiume che si getta nel Danubio, a poche leghe a nord di Budapest. — Con quello, se non altro, signor Miclesco, potreste avere rapporti di buon vicinato — rilevò il signor Jaeger ridendo. — Non prima di due o tre mesi, in ogni caso — rispose sullo stesso tono il presidente. — Per il suo viaggio, gli occorreranno certamente due o tre mesi… — A meno che non faccia il viaggio! — insinuò il serbo scherzosamente, unendosi senza tanti complimenti alla conversazione. Poiché si erano avvicinati altri pescatori, il signor Jaeger e il signor Miclesco ora si trovarono al centro di un gruppetto di persone. — Che volete dire? — chiese il signor Miclesco. — Avete una brillante immaginazione, Michael Michaelovitch. — Scherzavo, caro presidente — rispose il serbo. — Tuttavia se Ilia Brusch non è, secondo voi, né un poliziotto né un malfattore, allora avrà voluto prenderci in giro, allora sarà semplicemente un burlone. Il signor Miclesco si fece serio. — Il vostro spirito è acido, Michael Michaelovitch — rispose. — Ciò vi giocherà un brutto tiro, un giorno o l'altro. Ilia Brusch mi ha dato l'impressione di un brav'uomo e di una persona seria. Del resto, è membro della Lega Danubiana: è tutto dire. — Bravo! — si gridò da ogni parte. Senza sembrare per nulla imbarazzato dalla lezione ricevuta, il serbo colse con ammirevole presenza di spirito l'occasione per un altro brindisi. — In tal senso — disse, sollevando il boccale — bevo alla salute di Ilia Brusch! — Alla salute di Ilia Brusch! — risposero i presenti in coro, incluso il signor Jaeger, il quale vuotò coscienziosamente il suo bicchiere fino all'ultima goccia. Il paradosso di Michael Michaelovitch non mancava però di logica. Dopo aver clamorosamente annunciato la sua intenzione, Ilia Brusch era sparito, non se ne era più sentito parlare. Non era strano che si fosse dileguato nel nulla? Non si poteva legittimamente supporre che egli avesse voluto darla a bere a quei creduloni dei suoi colleghi? L'attesa in ogni caso non sarebbe durata più a lungo: ancora trentasei ore e la verità sarebbe venuta a galla. Coloro ai quali interessava quell'idea non dovevano far altro che trasferirsi a monte di Sigmaringen. Vi avrebbero incontrato certamente Ilia Brusch, se era quella persona seria che il presidente Miclesco fiduciosamente sosteneva che fosse. Si poteva presentare però una difficoltà: la sorgente del grande fiume era stata determinata con precisione? La indicavano le carte con certezza? Non esisteva qualche dubbio su questo punto? Quando si sarebbe cercato di raggiungere Ilia Brusch in un certo posto, non sarebbe stato egli in un altro? Non c'è dubbio alcuno che il Danubio, l'Ister degli antichi, nasce nel granducato di Baden: i geografi dicono anche che è a sei gradi e dieci minuti di longitudine est e a quarantasette gradi e quarantotto minuti di latitudine nord. Ma questa determinazione, ammesso che sia giusta, è spinta fino al minuto e non al secondo, la qualcosa può dar luogo a una differenza di qualche importanza. Si trattava quindi di gettare la lenza nel posto esatto in cui la prima goccia d'acqua danubiana comincia a scorrere verso il Mar Nero. Secondo una leggenda che per lungo tempo ebbe il valore di un dato geografico, il Danubio nascerebbe nel giardino dei principi di Furstenberg e avrebbe per culla una vasca di marmo, nella quale numerosi turisti vanno a riempire il bicchiere. Bisognava dunque attendere Ilia Brusch, il mattino del 10 agosto, sul bordo di questa vasca inesauribile? No; non è quella la vera e autentica sorgente del fiume. Adesso sappiamo che essa è formata dalla confluenza di due ruscelli, il Breg e il Brigach, che scendono da un'altezza di ottocentosettantacinque metri, attraversano la foresta dello Schwarzwald e si uniscono a Donaueschingen, alcune leghe a monte di Sigmaringen, dove prendono il nome di Donau, il francese Danubio. Forse il Breg, che nasce nel Brisgau, essendo di trentasette chilometri più lungo dell'altro, potrebbe essere considerato la vera sorgente del Danubio. Ad ogni buon conto la maggior parte dei soci della Lega, con il loro presidente, e i curiosi più scaltri se ne andarono a Donaueschingen, convinti che Ilia Brusch — se effettivamente fosse partito – sarebbe partito di lì. Sin dal mattino del 10 agosto essi si misero di sentinella sulla riva del Breg, alla confluenza dei due ruscelli. Le ore passavano ma dell'uomo del giorno nemmeno l'ombra. — Non verrà — diceva l'uno. — È un imbroglione — diceva l'altro. — E noi tutti sembriamo degli stupidi ingenui! — diceva Michael Michaelovitch, che non aveva il trionfo modesto. Soltanto il presidente Miclesco continuava a prendere la difesa di Ilia Brusch. — No — diceva. — Non crederò mai che un socio della Lega possa ingannare i suoi colleghi! Ilia Brusch avrà dei buoni motivi per essere in ritardo. Bisogna avere pazienza: presto lo vedremo arrivare. Il signor Miclesco aveva ragione di mostrarsi fiducioso: un po' prima delle nove, un grido si alzò dal gruppo che stava alla confluenza del Breg e del Brigach. — Eccolo! eccolo! A duecento passi, a un gomito del fiume, una chiatta costeggiava fuori della corrente. Solo, a poppa, un uomo in piedi la governava con un remo da bratto. Era proprio lui, l'ungherese Ilia Brusch, colui che alcuni giorni prima, alla gara della Lega Danubiana, aveva vinto i due primi premi. Quando la chiatta ebbe raggiunto la confluenza l'ungherese l'ancorò con un grappino alla riva. Ilia Brusch scese a terra e tutti i curiosi gli si fecero intorno. Nel vedere tutta quella gente che evidentemente non si aspettava, egli parve un po' imbarazzato. Il presidente Miclesco lo raggiunse e gli tese la mano, che Ilia Brusch, dopo essersi tolto il berretto di lontra, strinse rispettosamente. — Ilia Brusch — disse il signor Miclesco con dignità presidenziale — sono felice di rivedere il grande premiato della nostra ultima gara. Brusch ringraziò inchinandosi. Il presidente aggiunse: — Dal fatto che siete qui alle sorgenti del nostro fiume internazionale, noi deduciamo che state per mettere in pratica il progetto di discenderlo, pescando alla lenza, sino alla foce. — Proprio così, signor presidente — rispose Ilia Brusch. — Ed è da oggi stesso che comincerete a discenderlo? — Da oggi, signor presidente. — Come contate di effettuare il percorso? — Abbandonandomi alla corrente. — Con questa barca? — Con questa barca. — Senza alcuna sosta? — Sì, alla notte. — Sapete che si tratta di percorrere tremila chilometri? — A dieci leghe al giorno, mi ci vorranno due mesi circa. — Vi auguro allora un buon viaggio, Ilia Brusch! — Vi ringrazio, signor presidente! Ilia Brusch salutò un'ultima volta e riprese posto nella sua imbarcazione, mentre i curiosi facevano ressa per vederlo partire. Egli prese la lenza, vi mise l'esca e la depose sul sedile; richiamò il grappino a bordo, spinse la barca con un vigoroso colpo di gaffa e poi, sedendosi a poppa, lanciò in acqua la lenza. Un istante dopo la tirava su: un barbo si dimenava attaccato all'amo. Sembrava un felice presagio! Mentre virava tutti i presenti applaudirono con frenetici hoch! il vincitore della gara della Lega Danubiana. CAPITOLO III IL PASSEGGERO DI ILIA BRUSCH ERA DUNQUE cominciata la discesa del grande fiume che avrebbe condotto Ilia Brusch attraverso il ducato di Baden, i due regni del Württemberg e della Baviera, i due imperi dell'Austria-Ungheria e della Turchia e i tre principati dell'Hohenzollern, della Serbia e della Romania. 1 L'originale pescatore non avrebbe faticato molto durante l'intero percorso di oltre settecento leghe: la corrente del Danubio lo avrebbe trasportato sino alla foce alla velocità di poco più di una lega all'ora, e cioè alla media di una cinquantina di chilometri al giorno. Tra due mesi, egli sarebbe stato così al termine del suo viaggio, a condizione naturalmente che nessun incidente lo fermasse lungo il percorso. Ma perché mai avrebbe dovuto subire ritardi? La barca di Ilia Brusch misurava una dozzina di piedi; era una specie di chiatta a fondo piatto, larga in mezzo quattro piedi. A prora si arrotondava una tuga, sotto la quale due uomini avrebbero potuto trovare riparo. All'interno della tuga due casse laterali, a destra e a sinistra, contenevano il ridottissimo guardaroba del proprietario. Una volta chiuse, i loro coperchi potevano trasformarsi in cuccette. A poppa, un'altra cassa faceva da panca e serviva 1 Questi due principati sono stati elevati a regni: la Romania nel 1881 e la Serbia nel 1882. (N.d.A). per custodire alcuni utensili di cucina. È inutile aggiungere che la chiatta era provvista di tutto quello che è indispensabile a un vero pescatore. Ilia Brusch non avrebbe potuto farne a meno; secondo il programma di cui aveva parlato con i soci il giorno del concorso, egli durante il viaggio sarebbe vissuto esclusivamente della sua pesca: avrebbe mangiato i pesci o li avrebbe venduti e con il ricavato avrebbe fatto pasti più variati, senza dover modificare il proprio programma. Per Ilia Brusch, data l'ormai raggiunta notorietà, sarebbe stato assai facile vendere il pesce catturato durante il giorno. Trascorse così la prima giornata. Se qualcuno però avesse potuto seguire a vista Ilia Brusch, sarebbe rimasto sorpreso, e con ragione, del poco entusiasmo che egli sembrava mettere nella pesca, unica vera ragione di quella stravagante impresa. Quando pensava che nessuno lo osservasse, lasciava la lenza per vogare energicamente, come se avesse voluto affrettare la marcia della barca. Se vedeva qualche curioso sulla riva o se incrociava qualche barcaiolo, afferrava la canna e, grazie alla sua destrezza, non tardava a tirare fuori dall'acqua, tra gli applausi degli spettatori, qualche bel pesce. Ma non appena i curiosi erano spariti dietro un promontorio o il barcaiolo dietro un gomito del fiume, egli riprendeva il remo e imprimeva alla pesante chiatta una velocità che si aggiungeva a quella della corrente. Ilia Brusch aveva dunque qualche motivo per cercare di abbreviare un viaggio che nessuno, tuttavia, l'aveva costretto a intraprendere? Comunque sia, egli procedeva abbastanza velocemente. Trascinato dalla corrente che alle sorgenti del fiume era più rapida, remando ogni volta che gli si presentava l'occasione favorevole, egli procedeva a circa otto chilometri all'ora, o poco più. Superate alcune località di nessuna importanza, egli oltrepassò anche Tuttlingen, centro abbastanza noto, senza fermarsi, benché alcuni suoi ammiratori gli facessero cenno di accostare. Ilia Brusch declinò con un gesto l'invito, rifiutandosi di interrompere la sua deriva. Verso le quattro del pomeriggio giungeva all'altezza della piccola città di Fridingen, a quarantotto chilometri dal punto di partenza. Avrebbe volentieri bruciato anche Fridingen, come le cittadine precedenti — se questa espressione si adatta a una via d'acqua — se l'entusiasmo popolare non glielo avesse impedito. Non appena apparve, molte barche, dalle quali s'innalzavano numerosi evviva, si staccarono dalla riva e circondarono il vincitore. Ilia Brusch si arrese con garbo. Non doveva forse vendere i barbi, le cantarelle, le lasche e gli spinelli che saltellavano ancora nella sua rete, senza contare i numerosi cefali, nome scientifico indicato con hottus? Non avrebbe potuto certamente consumare da solo tutto quel pesce. Non appena la chiatta si fermò, una cinquantina di persone gli si strinsero intorno, chiamandolo per nome, rendendogli gli onori che gli erano dovuti. — Di qua, Brusch! — Un boccale di buona birra, Brusch? — Compriamo il vostro pesce, Brusch! — Venti kreutzer, questo! — Un fiorino, quello! Il vincitore vendette il pesce a chi gli si faceva sotto, ricavandone alcune belle monete sonanti. Se tanto entusiasmo fosse durato per tutto il percorso, avrebbe messo insieme, con il premio già incassato del concorso, una bella sommetta. Ma perché mai sarebbe dovuto cessare? Perché non avrebbero dovuto più disputarsi i pesci di Ilia Brusch? Non era forse un onore venire in possesso di un pesce pescato da lui? Non avrebbe avuto neppur bisogno di andare a vendere la sua merce a domicilio: il pubblico se la sarebbe disputata sulla riva. La vendita era indubbiamente un'idea geniale. Oltre a vendere agevolmente il pesce, per quella sera fioccarono anche gli inviti. Ilia Brusch, che non voleva lasciare la sua imbarcazione, li rifiutò tutti, e rifiutò energicamente anche vino e birra che tutti lo pregavano di andare a bere con loro nelle osterie della riva. I suoi ammiratori dovettero rinunciarvi e separarsi dal loro eroe, dopo aver preso appuntamento per la partenza del giorno dopo. Ma il giorno dopo essi non trovarono più la chiatta. Ilia Brusch era partito prima dell'alba e, approfittando della solitudine dell'ora mattutina, remava energicamente tenendosi in mezzo al fiume, a eguale distanza dalle rive scoscese. Favorito dalla rapida corrente, egli passò verso le cinque del mattino dinanzi a Sigmaringen, ad alcuni metri dal «Ritrovo dei Pescatori». Un po' più tardi, qualche socio della Lega si sarebbe affacciato per spiare inutilmente l'arrivo del glorioso collega, che andando a quel ritmo sarebbe stato ormai molto lontano. Ad alcuni chilometri da Sigmaringen, Ilia Brusch si lasciò alle spalle il Louchat, il primo affluente di sinistra del Danubio. La relativa lontananza dei centri abitati lungo quella parte del fiume, indusse Ilia Brusch a remare vigorosamente per l'intera giornata, dedicando alla pesca appena il tempo necessario. Alla sera, dopo aver pescato quel tanto che gli bastava per il suo nutrimento, si fermò in piena campagna, un po' a monte della piccola città di Mundelkingen, i cui abitanti non immaginavano certamente che egli fosse così vicino. Le due giornate seguenti furono uguali alla prima. Ilia Brusch scarrocciò rapidamente dinanzi a Mundelkingen prima del levar del sole e ancora di buon'ora superò la grossa borgata di Ehingen. Alle quattro oltrepassava l'Iller, grosso affluente di destra, e prima delle cinque ormeggiava a un anello di ferro piantato nella banchina di Ulm, che dopo la capitale, Stoccarda, era la più importante città del Württemberg. Il suo arrivo non era previsto per quel giorno, ma per la sera tardi del giorno dopo. Non vi era quindi la solita folla e contento di non essere riconosciuto, Ilia Brusch decise di utilizzare il resto della giornata per una breve visita della città. Dire che la banchina fosse deserta non sarebbe del tutto esatto. C'era un uomo che passeggiava e tutto lasciava credere, anzi, che quell'uomo aspettasse proprio Ilia Brusch. Dal momento in cui la chiatta era apparsa, egli l'aveva seguita camminando lungo la riva. Con ogni probabilità il vincitore della Lega Danubiana non sarebbe riuscito a evitare le solite manifestazioni di simpatia. Dopo che la chiatta fu ormeggiata alla banchina, l'uomo non vi si accostò; rimaneva anzi a una certa distanza a osservare, preoccupandosi di non essere visto. Era un uomo di media corporatura, asciutto, con occhi vivaci, certamente di oltre quarant'anni. Vestiva all'ungherese e aveva in mano una valigia di cuoio. Senza prestargli attenzione, Ilia Brusch ormeggiò solidamente la barca, chiuse la porta della tuga, e si assicurò che il coperchio delle casse avesse il lucchetto; poi saltò a terra e s'incamminò per la prima via che conduceva alla città. L'uomo, dopo aver rapidamente deposto sulla chiatta la valigia di cuoio che teneva in mano, lo seguì. La sponda sinistra del Danubio, che attraversa Ulm, città tipicamente tedesca, fa parte del Württemberg mentre quella destra è bavarese. Ilia Brusch camminava per le antiche strade fiancheggiate da vecchie botteghe con uno sportello in vetro, attraverso il quale i clienti concludono le trattative restando fuori. Quando soffia il vento, le pesanti insegne a forma di orso, di cervo, di corona o di croce sferragliano rumorosamente ondeggiando dai loro sostegni. Superate le vecchie mura, Ilia Brusch percorse il quartiere dei macellai, trippai e conciatori; poi, gironzolando a caso, giunse dinanzi alla cattedrale, una delle più ardite della Germania. Il suo campanile pretendeva di essere più alto di quello del duomo di Strasburgo. Pretesa delusa, come tante altre umane: la punta della sua guglia è alta appena trecentotrentasette piedi. Ilia Brusch non era uno scalatore e quindi nemmeno pensò di salire sul campanile, da dove lo sguardo avrebbe potuto abbracciare la città e la campagna circostante. Se lo avesse fatto, sarebbe stato certamente seguito dallo sconosciuto che, a sua insaputa, gli era sempre alle calcagna. Lo seguì anche dentro la cattedrale, dove era entrato per ammirare il tabernacolo, che il francese Duruy aveva paragonato a un bastione con loggette e caditoie, e gli stalli del coro, sui quali un artista del XV secolo ha scolpito personaggi celebri dell'epoca. L'uno dietro l'altro, essi passarono dinanzi al municipio, antico edificio del XII secolo, e poi ridiscesero verso il fiume. Prima di giungere alla banchina, Ilia Brusch sostò un istante a guardare un gruppo di giovani che camminavano su alti trampoli, esercizio molto in voga a Ulm, anche se non imposto, come lo è ancora nell'antica città universitaria di Tubinga, le cui strade melmose e ineguali sono inadatte ai semplici pedoni. Per godersi meglio lo spettacolo — ragazzi e ragazze, giovani e giovanette, tutti allegrissimi — Ilia Brusch si era seduto a un caffè. Lo sconosciuto sedette a un tavolino vicino al suo, ed entrambi si fecero servire un boccale della famosa birra del paese. Dieci minuti dopo si rimettevano in cammino, ma in ordine inverso. Ora lo sconosciuto camminava in fretta per primo; e quando Ilia Brusch, che lo seguiva senza saperlo, raggiunse la chiatta, ve lo trovò seduto, come se lo attendesse da molto tempo. Era ancora giorno chiaro. Ilia Brusch l'aveva visto da lontano, comodamente seduto sulla cassa di poppa, con una valigia di cuoio giallo ai piedi. Sorpreso, affrettò il passo. — Scusate, signore — disse saltando nella sua imbarcazione — credo che siate in errore. — Niente affatto — rispose lo sconosciuto. — È proprio a voi che desidero parlare. — A me? — A voi, signor Brusch. — Per quale motivo? — Per proporvi un affare. — Un affare! — ripeté il pescatore, sorpreso. — Un eccellente affare — disse lo sconosciuto, invitandolo con un gesto a sedersi. L'invito era poco corretto, certamente, perché non usa invitare a sedersi chi vi riceve in casa sua. Ma la fermezza e la tranquilla sicurezza dello sconosciuto impressionarono talmente Ilia Brusch che obbedì senza dir nulla. — Conosco anch'io il vostro progetto — proseguì lo sconosciuto — e so, quindi, che volete discendere il Danubio vivendo esclusivamente del ricavo della vostra pesca. Sono anch'io un appassionato dilettante di pesca e desidererei vivamente interessarmi alla vostra impresa. — In qual modo? — Ve lo dico subito. Ma permettetemi prima di farvi una domanda. Quale valore date al pesce che pescherete nel corso del viaggio? — Che cosa potrò ricavare dalla pesca, volete dire? — Sì. Intendo dire, ciò che venderete, senza tener conto di quello che consumerete personalmente. — Un centinaio di fiorini, forse. — Io ve ne offro cinquecento. — Cinquecento! — ripeté Brusch sbalordito. — In contanti e pagati in anticipo. Ilia Brusch guardò colui che gli faceva quella strana proposta; il suo sguardo doveva essere sin troppo eloquente, perché quest'ultimo rispose al pensiero che il pescatore non aveva espresso. — State tranquillo, signor Brusch: non sono matto. — Qual è allora il vostro scopo? — chiese il campione, poco persuaso. — Ve l'ho detto — rispose lo sconosciuto. — Desidero interessarmi e partecipare alle vostre prodezze. C'è anche l'amore per il rischio del giocatore: puntare su di voi cinquecento fiorini, e vedere la somma rientrare un po' per volta, ogni sera, con il ricavo delle vostre vendite. — Ogni sera? — insistette Brusch. — Avreste dunque l'intenzione di imbarcarvi con me? — Certamente — disse lo sconosciuto. — Il mio imbarco non sarebbe ovviamente compreso nei nostri patti e vi sarebbero pagati altri cinquecento fiorini. Mille fiorini in tutto, in contanti e in anticipo. — Mille fiorini! — disse nuovamente Brusch, sempre più sorpreso. La proposta era certamente tentatrice; ma il nostro pescatore voleva evidentemente restare solo, perché rispose brevemente: — Mi dispiace, signore. Rifiuto. La risposta, categorica, era stata espressa con tono perentorio: non c'era che da accettarla. Ma l'appassionato dilettante di pesca non era di quel parere e non parve affatto sorpreso del rifiuto. — Mi permettete, signor Brusch, di chiedervi il perché? — chiese tranquillamente. — Non ho alcun motivo di darvi delle spiegazioni. Rifiuto, ecco tutto. Ne ho il diritto, credo — rispose Ilia Brusch con un po' d'impazienza. — Ne avete il diritto, certamente — confermò l'interlocutore senza scomporsi. — Ma io non rinuncio al mio, e vi prego di farmi conoscere i motivi della vostra decisione. La mia proposta non aveva nulla di scortese, e pretendo di essere trattato con cortesia. Il tono non era intimidatorio, ma così fermo e autoritario che Ilia Brusch ne fu impressionato. Teneva alla sua solitudine, ma teneva ancor più a evitare una discussione fuori luogo; e l'osservazione gli sembrava perfettamente giustificata. — Avete ragione — disse. — Ma non voglio esporvi al rischio di un'operazione sbagliata. — È una faccenda che riguarda me. — Riguarda anche me, perché intendo pescare non più di un'ora al giorno. — E il resto del vostro tempo? — Remare per andare più in fretta. — Avete premura, dunque? Ilia Brusch si morse le labbra. — Premura o no — rispose seccamente — è così. Perciò accettare i vostri cinquecento fiorini sarebbe un vero furto. — Non più, ora che lo so — obiettò il compratore, conservando una calma imperturbabile. — Non lo sarebbe — rispose Brusch — se io mi costringessi a pescare ogni giorno, sia pure per un'ora. Ma non lo farò: voglio essere libero, voglio fare quello che voglio. — Lo farete — dichiarò lo sconosciuto. — Pescherete soltanto quando ne avrete voglia. Ciò accrescerà il piacere del rischio. So che siete abile; due o tre colpi fortunati e io avrò il mio utile: perciò considero l'affare sempre eccellente. Persisto nell'offrirvi cinquecento fiorini, e cioè mille fiorini, imbarco compreso. — E io persisto nel rifiutarli. — E io vi ripeterò la domanda: perché? Quella insistenza aveva certamente qualcosa d'insolito. Ilia Brusch, calmo per temperamento, cominciava tuttavia a perdere la pazienza. — Perché? — rispose con vivacità. — Credo di avervelo detto. Aggiungerò, giacché lo pretendete, che non voglio persone a bordo. Non è proibito, immagino, amare la solitudine. — Certamente — rispose il suo interlocutore senza dar segno di volersi alzare dalla panca sulla quale sembrava incollato. — Con me sarete solo. Non mi muoverò dal mio posto e non dirò una sola parola, se lo pretenderete. — E la notte? — rispose Brusch, che cominciava ad arrabbiarsi. — Credete che due persone starebbero comode nella mia cabina? — È abbastanza grande — rispose lo sconosciuto. — Inoltre, mille fiorini possono ben compensare un po' di fastidio. — Forse lo possono — rispose Brusch sempre più irritato — ma non lo voglio. No, cento, mille volte no. È chiaro, credo. — Chiarissimo — approvò lo sconosciuto. — Allora? — chiese Ilia Brusch, indicando la banchina. Ma il suo interlocutore non mostrò di comprendere il gesto, nonostante fosse chiaro. Aveva tirato fuor di tasca una pipa e la riempiva con cura. L'indifferenza esasperò Ilia Brusch. — Dovrò dunque trascinarvi a terra? — esclamò fuor di sé. Lo sconosciuto aveva finito di riempire la pipa. — Avreste torto — disse, senza che la sua voce tradisse timore. — E ciò per tre motivi. Il primo è che una baruffa provocherebbe l'intervento della polizia, che ci obbligherebbe ad andare dal commissario, dare le generalità e rispondere a un interminabile interrogatorio. Io non mi ci divertirei, lo confesso; e a voi non farebbe abbreviare il viaggio, come sembra che desideriate. L'ostinato dilettante contava molto su quell'argomento, e la sua speranza non andò delusa. Ilia Brusch si raddolcì immediatamente e parve disposto ad ascoltare sino alla fine l'arringa. Il facondo oratore, occupato ad accendere la pipa, non si accorse dell'effetto delle sue parole. Mentre stava per riprendere la sua tranquilla perorazione, un tizio che Brusch, preso dalla discussione, non aveva visto avvicinarsi, balzò nella chiatta. Il nuovo venuto indossava l'uniforme dei gendarmi tedeschi. — Il signor Ilia Brusch? — chiese il rappresentante della forza pubblica. — Son io — rispose l'interpellato. — I vostri documenti, per favore? La richiesta cadde come una pietra in uno stagno tranquillo. Ilia Brusch parve chiaramente annichilito. — I miei documenti? — balbettò. — Ma io non ho documenti, tranne qualche lettera e la ricevuta dell'affitto della casa dove abito a Szalka. Vi bastano? — Questi non sono documenti — rispose il gendarme con aria infastidita. — Il certificato di battesimo, il libretto di circolazione, la carta di lavoro di un operaio, un passaporto, questi sono documenti! Avete nulla del genere? — Assolutamente nulla — disse Ilia Brusch, desolato. — È un pasticcio per voi — mormorò il gendarme, il quale sembrava sinceramente dispiaciuto di dover infierire. — Per me! — protestò il pescatore. — Ma io sono una persona onesta, vi prego di crederlo. — Ne sono persuaso — asserì il gendarme. — Non ho nulla da temere, da nessuno; e del resto sono molto conosciuto. Sono il vincitore dell'ultima gara di pesca della Lega Danubiana di Sigmaringen, di cui hanno parlato tutti i giornali; e anche qui, qualcuno avallerà ciò che dico. — Lo cercheremo, state tranquillo — assicurò il gendarme. — Nell'attesa, sono costretto a pregarvi di seguirmi dal commissario, il quale accerterà la vostra identità. — Dal commissario! — esclamò Ilia Brusch. — Di che cosa sono accusato? — Di nulla — spiegò il gendarme. — Solo che io ho l'ordine di sorvegliare il fiume e di condurre dal commissario coloro che trovo sprovvisti di regolari documenti. Siete sul fiume? Sì. Avete documenti regolari? No. Quindi vi debbo condurre da lui. Il resto non mi riguarda. — Ma è un'indegnità — protestò Brusch, disperato. — È così — dichiarò il gendarme, con flemma. L'aspirante passeggero, la cui arringa era stata bruscamente interrotta, e che aveva ascoltato così attentamente, tanto da lasciare spegnere la pipa, ritenne che fosse venuto il momento di intervenire. — Se rispondessi io del signor Ilia Brusch? — chiese. — Basterebbe? — Dipende — disse il gendarme. — Voi chi siete? — Ecco il mio passaporto — rispose il pescatore dilettante porgendogli un foglietto spiegato. Il gendarme gli diede un'occhiata e di colpo il suo comportamento mutò completamente. — La faccenda ora è diversa — disse. Piegò con cura il passaporto e lo restituì al suo proprietario. Poi, saltando sulla banchina: — Arrivederci, signori — disse, rivolgendo un rispettosissimo saluto al compagno di Brusch. Sorpreso tanto dall'improvviso incidente quanto dal modo inatteso in cui era stato risolto, Ilia Brusch seguiva con lo sguardo il nemico che batteva in ritirata. Nel frattempo il suo salvatore, riprendendo il filo del discorso dal punto stesso in cui era stato interrotto, proseguiva impietosamente: — Il secondo motivo, signor Brusch, è che il fiume, per ragioni a voi sconosciute, è strettamente sorvegliato, come avete potuto vedere poco fa. La sorveglianza aumenterà quando giungerete a valle, e più ancora, se possibile, quando attraverserete la Serbia e le province bulgare dell'Impero Ottomano, paesi in grande agitazione e che sono persino ufficialmente in guerra dal 1° luglio. Durante il vostro viaggio potrebbe nascere qualche incidente e, in tal caso, non dovrebbe dispiacervi di poter contare sull'aiuto di un onesto borghese, che per di più gode di una certa autorità. L'abile oratore conosceva l'importanza di questo secondo argomento, confermata dall'incidente di poco prima. Ma senza dubbio non sperava in un successo così completo. Più che convinto, Ilia Brusch era deciso a cedere; cercava solo una scusa plausibile per salvare la faccia. — Il terzo e ultimo motivo — continuava intanto il candidato passeggero — è che mi rivolgo a voi da parte del signor Miclesco, vostro presidente. Poiché avete posto la vostra impresa sotto il patronato della Lega Danubiana, questa vuole sorvegliarne lo svolgimento, così da poterne garantire, in caso di necessità, la regolarità. Quando il signor Miclesco ha saputo che avevo intenzione di unirmi a voi, mi ha dato l'incarico quasi ufficiale. Mi rincresce di non aver previsto la vostra incomprensibile resistenza e di avere rifiutato le lettere di raccomandazione che egli voleva darmi per voi. Ilia Brusch emise un sospiro di sollievo. C'era forse miglior scusa per acconsentire a ciò che aveva rifiutato con tanto accanimento? — Bisognava dirlo! — esclamò. — In questo caso, la cosa è molto differente; non sarebbe gentile da parte mia respingere oltre le vostre proposte. — Le accettate, dunque? — Le accetto. — Benissimo! — disse il pescatore dilettante, tirando fuori di tasca alcuni biglietti di banca. — Ecco i mille fiorini! — Volete una ricevuta? — chiese Brusch. — Se ciò non vi dispiace. Il pescatore trasse fuori da una cassa inchiostro, penna e taccuino, dal quale staccò un foglio; poi, alle ultime luci del giorno, si mise a scrivere la ricevuta, leggendola nel frattempo ad alta voce. — Ricevo, in pagamento per quanto pescherò durante tutto il mio viaggio e per pagamento d'imbarco da Ulm al Mar Nero, la somma di mille fiorini dal signor… — Dal signor…? — ripeté con la penna in aria. Il passeggero di Ilia Brusch stava riaccendendo la pipa. — Jaeger, via Lipsia 45, Vienna — rispose tra due boccate di fumo. CAPITOLO IV SERGE LADKO DEI MOLTI territori che dall'inizio della storia sono stati particolarmente colpiti dalla guerra — ammettendo che qualche paese possa vantarsi di aver beneficiato di un certo favore — il sud e il sud-est dell'Europa meritano senza dubbio il primo posto. Per la loro posizione geografica queste regioni sono, in realtà, insieme con quel pezzetto d'Asia compreso tra il Mar Nero e l'Indo, l'arena in cui vengono fatalmente a scontrarsi le razze che popolano il vecchio continente. Fenici, greci, romani, persiani, unni, goti, slavi, magiari, turchi e tanti altri si sono disputati, in tutto o in parte, quelle disgraziate contrade, per non parlare delle orde allora selvagge che le hanno attraversate per andare poi a stabilirsi nell'Europa centrale e occidentale, dove, con lenta elaborazione, hanno generato le moderne nazioni. Secondo sapienti profeti il loro avvenire sarà tragico quanto il loro passato. Con l'invasione gialla torneranno necessariamente, un giorno o l'altro, le carneficine dell'antichità e del medioevo. Quel giorno, la Russia meridionale, la Romania, la Serbia, la Bulgaria, l'Ungheria, la stessa Turchia, stupita di recitare una parte del genere — se quel paese allora sarà ancora dei figli di Osman — saranno per forza di cose l'avamposto avanzato dell'Europa e a loro spese si decideranno i primi scontri. Nell'attesa di tali cataclismi, per fortuna molto lontani, le varie razze che nel corso dei secoli si sono susseguite tra il Mediterraneo e i Carpazi hanno finito per sistemarsi, e la pace — oh, la pace delle cosiddette nazioni civili! — non ha cessato di estendere il suo impero verso l'Oriente. I torbidi, i saccheggi, gli omicidi allo stato endemico sembrano ormai limitati alla parte della penisola dei Balcani ancora governata dagli osmanidi. Penetrati per la prima volta in Europa nel 1356, padroni di Costantinopoli nel 1453, i turchi si scontrarono con i precedenti invasori, che, venuti dall'Asia centrale prima di loro e da molto tempo convertiti al cristianesimo, cominciavano sin d'allora a fondersi con le popolazioni indigene e a organizzarsi in nazioni stabili e regolari. Sempre ricominciando l'eterna battaglia per la vita, quelle nascenti nazioni difesero con accanimento ciò che avevano sottratto ad altri. Slavi, magiari, greci, croati, teutoni opposero all'invasione turca una barriera vivente che, se cedette da qualche parte, non poté essere completamente abbattuta. Contenuti al di qua dei Carpazi e del Danubio, gli osmanidi non seppero mantenere quell'ultima posizione, e la Questione d'Oriente non è che la testimonianza della loro ritirata secolare. Contrariamente agli invasori che li avevano preceduti e che essi pretendevano di sloggiare, questi musulmani asiatici non sono mai riusciti ad assimilarsi i popoli da loro sottomessi. Dopo la conquista, essi continuavano a essere i conquistatori, i padroni. Aggravato dalla differente religione, tale metodo di governo non poteva avere altra conseguenza che la rivolta permanente dei vinti. La storia è piena infatti di rivolte di questo genere che dopo secoli di lotte avevano dato origine, nel 1875, all'indipendenza più o meno completa della Grecia, del Montenegro, della Romania e della Serbia, mentre le altre popolazioni cristiane continuavano a subire il dominio dei seguaci di Maometto. Nei primi mesi del 1875 quel dominio divenne ancora più pesante e più vessatorio. In seguito a una reazione musulmana che allora trionfava nel palazzo del sultano, i cristiani dell'Impero Ottomano furono sovraccaricati d'imposte, malmenati, uccisi, torturati in mille modi. La risposta non si fece attendere. All'inizio dell'estate, l'Erzegovina si ribellò ancora una volta. Bande di patrioti batterono la campagna e, comandati da capi valorosi come Peko-Paulowitch e Luibibratich, inflissero molti scacchi alle truppe regolari mandate contro di loro. L'incendio si propagò in fretta, raggiunse il Montenegro, la Bosnia e la Serbia. Una nuova sconfitta subita dai turchi nelle gole della Duga, nel gennaio del 1876, finì con l'infiammare il coraggio del popolo, mentre il furore popolare cominciava a rumoreggiare in Bulgaria. Come sempre, la rivolta ebbe inizio con cospirazioni segrete e riunioni clandestine, alle quali partecipava di nascosto la focosa gioventù del paese. L'oratoria, l'intelligenza o l'ardente patriottismo fecero emergere ben presto i veri capi: in poco tempo, ogni gruppo e, al disopra del gruppo, ogni città, ebbe il suo. A Russe, importante centro bulgaro posto sulla riva del Danubio, quasi esattamente di fronte alla città romena di Giurgievo, la scelta cadde, senza contestazioni, sul pilota Serge Ladko. E non sarebbe stato possibile fare scelta migliore. Quasi trentenne, di alta statura, biondo come uno slavo del nord, di forza erculea e di agilità poco comune, rotto a ogni sforzo, Serge Ladko aveva le qualità fisiche del capo. Ma ciò che più conta, ne possedeva le qualità morali: prontezza di decisione, prudenza nell'esecuzione, amore appassionato per il suo paese. Serge Ladko, nato a Russe ove esercitava la professione di pilota del Danubio, non aveva mai lasciato la sua città, se non per pilotare o verso Vienna e ancora più su, o fino al Mar Nero, barconi e chiatte che venivano affidati alla sua perfetta conoscenza del grande fiume. Fra una navigazione fluviale e una marittima egli dedicava il tempo libero alla pesca, in cui era abilissimo, grazie anche alle sue doti fisiche. Quanto guadagnava con la pesca insieme con gli onorari di pilota, gli assicuravano una larga agiatezza. Costretto dal doppio mestiere a trascorrere sul fiume i quattro quinti della sua vita, l'acqua era diventata a poco a poco il suo elemento. Attraversare il Danubio, largo a Russe come un braccio di mare, era un gioco per lui; non si potevano più contare i salvataggi compiuti da questo meraviglioso nuotatore. Un'esistenza così limpida e dignitosa, aveva reso Serge Ladko popolare a Russe ancor prima dei torbidi anti-turchi. Contava moltissimi amici, a volte a lui sconosciuti. Si potrebbe dire che tutti gli abitanti della città gli erano amici, se Ivan Striga non fosse esistito. Ivan Striga era anch'egli figlio di quel paese, come Serge Ladko, del quale era l'antitesi vivente. Fisicamente i due non avevano nulla in comune e tuttavia le caratteristiche sul passaporto sarebbero state identiche. Come Ladko, Striga era alto, con spalle ampie, robusto, biondo di capelli e di barba. Aveva anch'egli occhi azzurri. Ma la rassomiglianza si limitava soltanto a questi dati somatici. Tanto i tratti nobili del viso dell'uno esprimevano cortesia e franchezza, quanto i tratti tormentati dell'altro rivelavano astuzia e fredda crudeltà. Dal punto di vista morale la differenza era ancora più accentuata. Mentre Ladko operava alla luce del sole, nessuno avrebbe potuto dire in qual modo Striga si procurasse il denaro che spendeva a piene mani. Non sapendo nulla di preciso, la gente fantasticava senza freno. Si diceva che Striga, traditore del paese e della sua gente, facesse la spia al servizio del turco oppressore; si diceva anche che, quando si presentava l'occasione, facesse pure il contrabbandiere, e che merci di ogni genere passavano spesso, per opera sua, dalla riva rumena alla riva bulgara e viceversa, senza pagare dogana; si diceva ancora, e si scuoteva il capo, che ciò era niente, che Striga traesse la maggior parte delle sue ricchezze da volgari rapine e dal brigantaggio; si diceva inoltre… Ma che cosa non si diceva? Il fatto è che non si sapeva nulla di preciso sul conto dell'inquietante personaggio; il quale, se le supposizioni della gente rispondevano alla realtà, aveva avuto, comunque, la grande abilità di non farsi mai prendere con le mani nel sacco. Quelle supposizioni, del resto, la gente se le confidava con discrezione. Nessuno avrebbe osato pronunciare ad alta voce una sola parola contro un uomo del quale si temeva il cinismo e la violenza. Striga poteva fingere dunque di ignorare l'opinione che si aveva di lui, scambiare per ammirazione generale la simpatia che molti gli dimostravano per viltà, usare la città come un paese di conquista e turbarla, in compagnia di gente della peggiore risma, con lo scandalo delle sue orge. Tra tale individuo e Ladko, che conduceva un'esistenza così diversa, sembrava che non potesse stabilirsi un qualsiasi rapporto; per lungo tempo, infatti, essi non seppero l'uno dell'altro che ciò che si diceva. La logica faceva supporre che sarebbe stato sempre così, ma il destino se ne infischia della logica, ed era scritto da qualche parte che i due uomini si sarebbero trovati a faccia a faccia, trasformati in avversari irreconciliabili. Natcha Gregorevitch, celebre in città per la sua bellezza, aveva vent'anni. Prima con sua madre, poi sola, ella abitava vicino a Ladko, che conosceva sin dalla prima infanzia. Da molto tempo la sua casa era priva dell'aiuto di un uomo. Quindici anni prima dell'epoca in cui ha inizio questo racconto, suo padre era caduto sotto i colpi dei turchi, e il ricordo di quella morte faceva ancora fremere di indignazione i patrioti oppressi, ma non asserviti. La vedova, dovendo contare soltanto su se stessa, si era posta coraggiosamente al lavoro. Esperta nell'arte del ricamo e dei merletti, con i quali anche la più modesta contadina slava si adorna volentieri, ella era riuscita così ad assicurare il sostentamento suo e della figlia. Ma è soprattutto ai poveri che i torbidi sono funesti; più di una volta la ricamatrice avrebbe dovuto soffrire dell'anarchia che regnava continuamente in Bulgaria, se Ladko non le fosse venuto discretamente in aiuto. A poco a poco, una grande intimità si era stabilita tra il giovane e le due donne, le quali offrivano l'accogliente ospitalità della loro tranquilla dimora alle ore d'ozio del giovane. Spesso alla sera egli bussava alla loro porta e la veglia si prolungava intorno al samovar bollente. Altre volte era lui che ricambiava la loro affettuosa ospitalità, accompagnandole in una passeggiata o ad una partita di pesca sul Danubio. Quando la signora Gregorevitch sfinita dalle fatiche andò a raggiungere il marito, Ladko continuò a proteggere la fanciulla con tanto affetto che la giovane non ebbe mai a soffrire per la scomparsa della madre che aveva dato due volte la vita alla sua bambina. Di giorno in giorno, senza che essi neppure se ne rendessero conto, l'amore era sbocciato nel cuore dei due giovani. Ne dovettero la rivelazione a Striga. Invaghitosi di quella che tutti chiamavano la bellezza di Russe, Striga, abituato a voler tutto e subito, era andato a casa della giovinetta e le aveva chiesto di sposarlo. Ma per la prima volta in vita sua, fu respinto con un netto rifiuto. Senza tema di inimicarsi quell'uomo pericoloso, ella dichiarò che non l'avrebbe mai sposato. Striga tentò ancora di convincerla ma, al suo terzo tentativo, gli fu rifiutato il permesso di entrare in casa. Il suo selvaggio temperamento esplose allora con tale collera che Natcha ne fu spaventata. Confidò i suoi timori a Serge Ladko, che imprecò con rabbia contro colui che aveva osato alzare gli occhi su di lei. Ladko riuscì infine a calmarsi; e un'ora più tardi, dopo aver confusamente parlato di tante cose con il cielo negli occhi e la gioia nel cuore, scambiavano il loro primo bacio di fidanzamento. Quando Striga apprese la notizia mancò poco che non morisse di rabbia. Si presentò audacemente in casa Gregorevitch a offendere e minacciare. Cacciato decisamente fuori, capì che in quella casa c'era un uomo pronto a difenderla. Era stato vinto! Lui, Striga, così orgoglioso della sua forza atletica, aveva trovato qualcuno più forte di lui! Poiché l'umiliazione gli riusciva insopportabile, decise di vendicarsi. Con alcuni avventurieri del suo stampo, una sera attese Ladko sulla riva del fiume. Non si trattava più di una semplice rissa questa volta, ma di un assassinio in piena regola. Gli assalitori avevano in pugno il coltello. Ma fallì anche questo attacco. Ladko, usando un remo a mo' di mazza, obbligò gli aggressori a ritirarsi; Striga, stretto da vicino, si diede a una fuga vergognosa. La lezione fu senza dubbio sufficiente a rintuzzare ogni altro tentativo del losco individuo. Agli inizi dell'anno 1875 Serge Ladko e Natcha Gregorevitch si sposarono e andarono a vivere nella comoda casa del pilota. Dopo un anno di continua luna di miele, nei primi mesi del 1876 accaddero gli avvenimenti di Bulgaria. L'amore profondo che Serge Ladko nutriva per la moglie non poteva fargli dimenticare il dovere verso il suo paese. Senza esitare, egli si unì a tutti coloro che si trovarono per discutere il modo di porre termine alle sventure della patria. Occorreva prima di tutto procurarsi delle armi. Molti giovani a questo scopo attraversarono il fiume e si sparsero in Romania e persino in Russia. Serge Ladko fu tra questi. Con il cuore straziato, ma risoluto a compiere il proprio dovere, parti, lasciando colei che adorava esposta ai pericoli che minacciano, in tempi di rivoluzione, la moglie di un capo partigiano. In quel momento, il ricordo di Striga gli tornò alla memoria, accrescendo le sue inquietudini. Non avrebbe approfittato il bandito dell'assenza del felice rivale per colpirlo in ciò che aveva di più caro? Era possibile, ovviamente. Ma Serge Ladko superò questo legittimo timore. Del resto, sembrava che da più mesi Striga avesse lasciato definitivamente il paese. A credere a ciò che si diceva, egli aveva trasferito più a nord la zona principale delle sue operazioni, anche se le notizie erano incoerenti e contraddittorie. Lo si accusava di tutti i delitti senza che se ne specificasse uno solo. La partenza di Striga sembrava, se non altro, certa: era ciò che importava a Ladko. La sua decisione coraggiosa fu premiata: durante la sua assenza, nulla minacciò la sicurezza di Natcha. Ritornò, ma dovette subito ripartire, e quella seconda spedizione sarebbe stata più lunga della prima. I trasporti di armi erano piuttosto scarsi poiché quelli che provenivano dalla Russia erano effettuati via terra, attraverso l'Ungheria e la Romania, e cioè attraverso zone allora scarsamente provviste di linee ferroviarie. I patrioti bulgari pensarono di mandare uno dei loro a Budapest per rispedire le armi arrivate fin lì per ferrovia, su delle chiatte cha avrebbero poi disceso rapidamente il Danubio. Incaricato di tale missione di fiducia, Ladko si mise in cammino sin dalla stessa sera. Insieme con un compatriota, che avrebbe riportato il battello sulla riva bulgara, attraversò il fiume, nell'intento di raggiungere al più presto, attraverso la Romania, la capitale dell'Ungheria. Accadde però un incidente che diede molto da pensare al delegato dei cospiratori. Era con il compagno a cinquanta metri dalla riva, quando udì uno sparo. Il proiettile era indirizzato a loro, senza alcun dubbio: lo avevano sentito fischiare molto vicino. Il pilota ne fu quasi sicuro, avendo creduto di riconoscere nell'incerta luce del crepuscolo colui che aveva sparato: Striga. Era dunque tornato a Russe? L'angoscia mortale che lo colse, non scosse però la sua decisione: la sua vita apparteneva alla patria. Se necessario, avrebbe sacrificato anche la sua felicità, mille volte più preziosa della vita. Al rumore dello sparo, si era lasciato cadere in fondo all'imbarcazione: era un'astuzia di guerra, per scoraggiare un nuovo attacco; l'eco dello sparo non si era ancora spento che la sua mano, afferrato strettamente il remo, spingeva rapidamente il battello verso la città romena di Giurgievo, le cui luci cominciavano a picchiettare la crescente oscurità. Giunto a destinazione, Ladko si occupò attivamente della sua missione. Si mise in rapporto con gli emissari del governo dello zar, alcuni alla frontiera russa, altri stabilitisi in incognito a Budapest e a Vienna. Varie chiatte, fatte caricare da lui d'armi e di munizioni, discesero il Danubio. Riceveva spesso lettere di Natcha, inviate al nome di battaglia da lui scelto, e portate in territorio romeno con il favore della notte. Inizialmente buone, quelle notizie non tardarono a farsi inquietanti. Non che Natcha facesse il nome di Striga; ella sembrava persino ignorare che il bandito fosse tornato in Bulgaria. Ladko cominciò a dubitare perciò che i suoi timori fossero fondati. Per contro, egli era certo di essere stato denunciato alle autorità turche; la polizia infatti aveva fatto irruzione a casa sua, facendovi un'accurata perquisizione, del resto senza risultato. Egli non doveva aver fretta, quindi, di tornare in Bulgaria, perché il suo ritorno sarebbe stato un vero suicidio. Si sapeva quale parte egli recitasse, era spiato giorno e notte, e non avrebbe potuto farsi vedere in città senza essere immediatamente arrestato. Farsi arrestare dai turchi voleva dire essere giustiziato; bisognava dunque che Ladko non si facesse più vedere fino al momento in cui la rivolta fosse scoppiata, per non attirar mali peggiori su di sé e sulla moglie, che finora non era stata per nulla infastidita. Quel momento non tardò a giungere. La rivolta scoppiò nel mese di maggio, troppo presto a parere del pilota, che da quella fretta non traeva buoni auspici. Qualunque fosse la sua opinione al riguardo, egli doveva correre in aiuto del suo paese. Il treno lo condusse a Zombor, ultima città ungherese nelle vicinanze del Danubio servita dalla ferrovia, ove si sarebbe imbarcato e non avrebbe avuto da far altro che lasciarsi trasportare dalla corrente. Le notizie avute a Zombor lo costrinsero a interrompere il viaggio; i suoi timori erano più che giustificati: la rivoluzione bulgara era stata soffocata sul nascere. Già la Turchia concentrava numerose truppe nel vasto triangolo le cui punte erano costituite dalle città di Russe, Widdin e Sofia: il pugno di ferro si appesantiva maggiormente su quelle infelici contrade. Ladko dovette tornare indietro e aspettare giorni migliori nella cittadina in cui aveva stabilito la sua residenza. Dalle lettere che Natcha gli aveva subito scritto, capì che non poteva fare altrimenti. La sua casa era sorvegliata continuamente, tanto che sua moglie doveva considerarsi virtualmente prigioniera; era atteso più che mai al varco e doveva, nel comune interesse, astenersi da qualsiasi passo imprudente. Ladko fu costretto controvoglia all'inazione, avendo dovuto cessare qualsiasi invio di armi in seguito al fallimento della rivolta e alla concentrazione di truppe turche sulle rive del fiume. Ma l'attesa, già penosa, si fece intollerabile quando, verso la fine del mese di giugno, non ricevette più notizie dalla moglie. Non sapeva che cosa pensare; le sue inquietudini con il passare del tempo si trasformarono in angosciose torture. Temeva il peggio. Il 1° luglio la Serbia aveva ufficialmente dichiarato guerra al Sultano e, da allora, la regione danubiana era attraversata da truppe, il cui incessante passaggio dava luogo a terribili eccessi. Natcha era tra le vittime di quei torbidi? Oppure era stata arrestata dalle autorità turche quale ostaggio o quale complice presunta del marito? Dopo un mese, egli non riuscì più a sopportare quel silenzio e decise di sfidare ogni cosa, pur di rientrare in Bulgaria e conoscerne la vera causa. Nell'interesse della moglie, era necessario però agire con prudenza. Farsi prendere scioccamente dalle sentinelle turche non sarebbe servito a nulla. Il suo ritorno sarebbe stato utile soltanto se fosse riuscito a entrare nella città di Russe per circolarvi liberamente, nonostante i sospetti di cui era oggetto. Avrebbe agito meglio in seguito, a seconda delle circostanze. Nel peggiore dei casi, se fosse stato necessario ripassare precipitosamente la frontiera, egli avrebbe avuto almeno la gioia di stringere la moglie al cuore. Per più giorni Serge Ladko cercò una soluzione a quel difficile problema. Credette alla fine di averla trovata e, senza dir nulla ad alcuno, mise subito in azione il piano immaginato. Gli sarebbe riuscito? L'avvenire glielo avrebbe detto. Bisognava in ogni caso tentare la sorte. Per questo motivo, la mattina del 28 luglio 1876 i vicini di casa del pilota, del quale nessuno conosceva il vero nome, videro ermeticamente chiusa la casetta nella quale, da più mesi, egli aveva protetto la sua solitudine. Qual fosse il piano di Ladko e quali i pericoli a cui si sarebbe esposto nel tentativo di metterlo in esecuzione; in qual modo gli avvenimenti di Bulgaria e di Russe in particolare si collegassero con la gara di pesca di Sigmaringen, è ciò che il lettore saprà leggendo il seguito di questo racconto tutt'altro che immaginario: i suoi principali personaggi vivono ancor oggi sulle rive del Danubio. CAPITOLO V KARL DRAGOCH NON APPENA ebbe messo in tasca la ricevuta il signor Jaeger pensò a sistemarsi. Dopo aver chiesto quale delle due cuccette gli era stata assegnata, sparì con la valigia sotto la tuga. Ricomparve dopo dieci minuti, trasformato da capo a piedi in perfetto pescatore: giubbotto, robusti stivali e berretto di lontra — sembrava la copia di Ilia Brusch. Il signor Jaeger fu un po' sorpreso nel constatare che nel corso della sua breve assenza il suo ospite aveva lasciato la chiatta. Rispettoso degli impegni assunti, non fece alcuna domanda quando Brusch, mezz'ora dopo, fece ritorno. Senza esserne sollecitato, Ilia Brusch gli disse che aveva mandato una lettera ad alcuni giornali per annunciare il suo arrivo a Ratisbona per il giorno seguente, e a Neustadt per la sera del giorno successivo. Ora che c'erano di mezzo gli interessi del signor Jaeger, bisognava far accorrere gente, non come a Ulm. Ilia Brusch manifestò anche il suo rincrescimento per non potersi fermare nelle città che avrebbero attraversate prima di Neustadt, particolarmente a Neuburg e a Ingolstadt, che sono importanti. Tali soste non rientravano purtroppo tra quelle da lui pianificate ed era perciò costretto a rinunciarvi. Il signor Jaeger parve più che contento della propaganda fatta nel suo interesse e non manifestò alcun rincrescimento per le mancate soste a Neuburg e a Ingolstadt. Al contrario, approvò e diede all'ospite nuove assicurazioni che non era suo intendimento mettere alcun ostacolo alla sua libertà. I due compagni cenarono poi seduti l'uno di fronte all'altro a cavalcioni di un sedile. A titolo di benvenuto, il signor Jaeger ringagliardì persino il pasto con un superbo prosciutto, tratto fuori dall'inesauribile valigia: il prodotto della città di Magonza fu molto apprezzato da Ilia Brusch, che cominciò a credere che nel compagno ci fosse qualcosa di buono. La notte trascorse senza alcun incidente. Prima del levar del sole Ilia Brusch sciolse l'ormeggio, evitando di disturbare il sonno del cortese passeggero. A Ulm, dove finisce di attraversare il piccolo regno di Württemberg per penetrare in Baviera, il Danubio è ancora un modesto corso d'acqua. Non ha ancora ricevuto i grandi tributari che a valle accrescono la sua possanza, e nulla lascia credere che esso diventerà uno dei più importanti fiumi d'Europa. La corrente, già molto placida, raggiungeva press'a poco una lega all'ora. Barche di ogni dimensione, tra le quali alcuni pesanti battelli carichi fino all'orlo, la discendevano aiutandosi a volte con una grande vela che la brezza del nord-ovest gonfiava. Il tempo si annunciava al bello e non c'era minaccia alcuna di pioggia. Non appena fu nel centro della corrente, Ilia Brusch manovrò il remo e sollecitò la marcia dell'imbarcazione. Alcune ore dopo, il signor Jaeger lo trovò ancora dedito a quella occupazione, che proseguì fino a sera, tranne una breve sosta al momento della colazione, durante la quale non fu interrotta neppure la deriva. Il passeggero non chiese spiegazioni su tanta fretta e si tenne la meraviglia per sé. Nel corso della giornata furono scambiate poche parole. Ilia Brusch remava energicamente; il signor Jaeger, da parte sua, scrutava con un'attenzione che avrebbe certamente stupito l'ospite — se fosse stato meno assorto nel suo compito — i battelli che solcavano il Danubio e le due rive del fiume che si erano sensibilmente abbassate. Il Danubio mostrava tendenza anche ad allargarsi a spese della terraferma. La riva sinistra, a metà sommersa, non si distingueva più con esattezza, mentre sulla riva destra, sollevata artificialmente per costruirvi la strada ferrata, passavano i treni trascinati da locomotive sbuffanti che univano il loro fumo a quello dei battelli a vapore, le cui ruote battevano l'acqua con fracasso. A Offingen, davanti al quale passarono nel pomeriggio, la ferrovia piegava verso sud, allontanandosi definitivamente dal fiume; la riva destra si trasformava a sua volta in una vasta palude, della quale nulla indicava la fine. Alla sera si fermarono a Dillingen per trascorrervi la notte. Il giorno seguente, dopo un andare pressante quanto quello del giorno prima, il grappino fu lanciato in un punto deserto, ad alcuni chilometri a monte di Neuburg: l'alba del 15 agosto si alzò quando la chiatta era già in mezzo alla corrente. Ilia Brusch aveva annunciato il suo arrivo a Neustadt per la sera di quel giorno. Si sarebbe vergognato di presentarvisi a mani vuote. Le condizioni atmosferiche erano favorevoli e la tappa sensibilmente più breve delle precedenti: Ilia Brusch decise dunque di pescare. Sin dalle prime ore del giorno, egli controllò accuratamente i suoi attrezzi. Seduto a poppa, il suo compagno osservava con interesse, come si conviene a un vero dilettante. Pur lavorando, Ilia Brusch non disdegnava chiacchierare. — Come vedete, signor Jaeger, oggi mi preparo a pescare e i preparativi sono un po' lunghi. Il fatto è che il pesce è diffidente per natura e non si prendono mai troppe precauzioni per attirarlo. Alcuni pesci, tra cui la tinca, sono molto intelligenti. Bisogna giocare d'astuzia con essa; la sua bocca è talmente dura che si corre il rischio di rompere la lenza. — La tinca non è saporita, credo — fece notare il signor Jaeger. — No; preferisce le acque melmose che danno alla sua carne un cattivo sapore. — E il luccio? — Il luccio è eccellente — disse Brusch — purché non pesi meno di cinque o sei libbre. Più piccoli sono tutte spine. Comunque, non si può dire che il luccio sia un pesce intelligente e astuto. — Davvero, signor Brusch? Perciò i pescecani d'acqua dolce, come essi sono chiamati… — Sono bestie stupide come quelli d'acqua salata. Sono veri bruti, allo stesso livello del pesce persico e dell'anguilla! Catturarli può dare guadagno, mai onore… Sono, come ha scritto uno che se ne intendeva, pesci «che si prendono» ma «che nessuno prende». Il signor Jaeger non poteva che ammirare la persuasiva convinzione di Ilia Brusch, non meno della cura minuziosa con cui preparava i suoi attrezzi. Per prima cosa aveva preso la canna flessibile e leggera, l'aveva piegata fino al punto di rottura per poi lasciarla raddrizzare come prima. La canna si componeva di due parti: una forte, alla base, di quattro centimetri che si riducevano a un centimetro nel punto in cui cominciava la seconda, il cimino, sottile e resistente. In legno di nocciolo, la canna era lunga quasi quattro metri, il che consentiva al pescatore di adescare, stando sulla riva, i pesci di fondo, quali la cantarella e la lasca rossa. Nel mostrare al signor Jaeger gli ami che aveva finito di fissare con la setola all'estremità del crine di Firenze, Ilia Brusch disse: — Vedete, signor Jaeger, sono ami numero undici, dal corpo finissimo. Come esca, non c'è nulla di meglio per la lasca; si tratta di grano cotto, bucato soltanto da una parte e ben ammollito… Ho finito, non ho che da tentare la fortuna. Mentre il signor Jaeger si appoggiava contro la tuga, egli sedette sul banco con il guadello a portata di mano e lanciò la lenza con un ondeggiamento bilanciato ed elegante. Gli ami affondarono nell'acqua giallastra, tenuti verticali dal piombino. Sopra galleggiava il gavitello di piume di cigno che sono ottime perché non assorbono l'acqua. È superfluo dire che a partire da quel momento si fece un profondo silenzio nell'imbarcazione. Le voci spaventano troppo facilmente il pesce; del resto, un pescatore serio ha ben altro da fare che abbandonarsi alle chiacchiere. Deve badare a ogni movimento del gavitello per non lasciare sfuggire l'istante preciso in cui uncinare la preda. Fu una buona mattina, quella, per Ilia Brusch. Non soltanto pescò una ventina di lasche, ma prese anche una dozzina di cavedine e alcuni bardi. Se il signor Jaeger fosse stato veramente quell'appassionato dilettante che si era vantato di essere, avrebbe ammirato la rapida precisione con la quale il suo ospite uncinava la preda, come occorre fare con i pesci di quella specie. Con l'imperturbabile sangue freddo che distingue ogni pescatore degno di questo nome, appena sentiva che il pesce «mordeva» non lo tirava subito fuori dell'acqua; lo lasciava stancare sul fondo nell'inutile tentativo di staccarsi dall'amo. La pesca ebbe termine verso le undici. Durante la bella stagione il pesce, infatti, non morde nelle ore in cui il sole, raggiunto il suo punto culminante, fa scintillare la superficie dell'acqua. Il bottino del resto era abbondante. Ilia Brusch temeva persino che fosse troppo per Neustadt, una piccola città ove la chiatta si fermò verso le cinque. S'ingannava. Venticinque o trenta persone lo aspettavano e lo applaudirono, non appena si fu ormeggiato. Non sapeva a chi dare ascolto: in pochi istanti i pesci furono venduti per ventisette fiorini, che Ilia Brusch versò seduta stante al signor Jaeger, quale primo dividendo. Cosciente di non aver diritto alla pubblica ammirazione, questo si era modestamente ritirato sotto la tuga, ove Ilia Brusch lo raggiunse appena gli fu possibile. Era meglio infatti, non avendo molto tempo a disposizione, mettersi subito a dormire. Poiché voleva raggiungere di buon'ora Ratisbona, Ilia Brusch aveva deciso di partire verso l'una di notte per percorrere i circa settanta chilometri che lo separavano da quella città: avrebbe avuto la possibilità di pescare anche nel corso della giornata, nonostante la lunghezza della tappa. Prima di mezzogiorno Brusch aveva già pescato una trentina di libbre di pesce. I curiosi che si affollavano sulla banchina di Ratisbona non rimpiansero di essersi scomodati. L'entusiasmo cresceva visibilmente: furono addirittura create all'aria aperta vere e proprie aste e le trenta libbre di pesce fruttarono quarantuno fiorini. Il campione della Lega Danubiana non aveva mai immaginato una tale abbondanza e pensava che il signor Jaeger poteva aver fatto, in fin dei conti, un ottimo affare. Nell'attesa di chiarire questo punto, Ilia Brusch voleva versare i quarantuno fiorini al legittimo proprietario, ma gli fu impossibile. Il signor Jaeger infatti era sceso a terra, lasciando in evidenza un breve scritto con il quale pregava di non attenderlo per la cena, perché sarebbe tornato tardi. Ilia Brusch ritenne normale che il signor Jaeger avesse voluto approfittare di quella occasione per visitare una città che per cinquant'anni era stata sede della Dieta imperiale. Sarebbe stato, forse, meno soddisfatto e più sorpreso se avesse saputo a quale occupazione si era dedicato il suo passeggero e se ne avesse conosciuto la vera identità. «Signor Jaeger, via Lipsia 45, Vienna», aveva scritto docilmente Ilia Brusch, sotto dettatura da parte del nuovo venuto. Ma quest'ultimo sarebbe stato imbarazzatissimo se il pescatore si fosse mostrato più curioso, e al pari dell'indiscreto gendarme avesse avuto la spiacevole idea di chiedergli di mostrargli i documenti. Ilia Brusch avrebbe giustamente potuto farlo, ma non l'aveva pensato e questa dimenticanza gli sarebbe costata cara. Quale nome il gendarme tedesco aveva letto sul passaporto del signor Jaeger nessuno lo sa; ma se quel nome era proprio quello vero, il gendarme vi aveva letto quello di Karl Dragoch. L'appassionato dilettante di pesca e il capo della polizia danubiana non erano, infatti, che una sola persona. Deciso a salire a tutti i costi sull'imbarcazione di Ilia Brusch, Karl Dragoch, prevedendo la possibilità di un'invincibile resistenza, aveva preparato i suoi piani: l'intervento del gendarme era stato predisposto e la scena recitata come a teatro. L'avvenimento dimostrava che Karl Dragoch aveva colpito giusto: Ilia Brusch, infatti, riteneva ora una grossa fortuna avere, tra tanti pericoli, un protettore così potente. Il successo era stato così completo che Dragoch ne era rimasto turbato. Perché, dopo tutto, Ilia Brusch aveva mostrato tanta preoccupazione dinanzi all'ingiunzione del gendarme? Perché aveva preferito sacrificare il suo amore — anche eccessivo — per la solitudine, pur che un fatto del genere non si ripetesse? Un uomo onesto, diamine!, non deve aver tanta paura di comparire dinanzi a un commissario di polizia. Il peggio che possa capitare è di perdere alcune ore o alcuni giorni al più, e quando non si ha fretta… Ma Ilia Brusch aveva anche fretta e questo dava da pensare. Diffidente per temperamento, come ogni buon poliziotto, Karl Dragoch rifletteva. Ma egli aveva anche troppo buon senso per lasciarsi sviare dai piccoli particolari, semplici forse da spiegarsi. Egli si limitò a registrarli nella sua memoria, e diresse tutte le sue risorse alla soluzione molto più seria del problema. L'idea di diventare il passeggero di Ilia Brusch non era tutta sua. Il vero autore ne era Michael Michaelovitch, che però non lo sapeva. Quando il faceto serbo aveva scherzosamente insinuato, al «Ritrovo dei Pescatori», che il campione della Lega Danubiana poteva essere, a scelta, sia il malfattore ricercato sia il poliziotto che lo cercava, Karl Dragoch aveva prestato molta attenzione alle supposizioni fatte con tanta leggerezza. Non le aveva certamente prese per oro colato. Aveva buoni motivi per sapere che il pescatore e il poliziotto non avevano nulla in comune; e analogamente, il pescatore e il malfattore ricercato. Ma se una cosa non è stata fatta non è detto che non si possa fare; Karl Dragoch aveva subito pensato che l'allegro serbo avesse ragione, e che un poliziotto che volesse comodamente sorvegliare il Danubio sarebbe stato veramente in gamba a nascondere la sua vera identità sotto i panni di un noto pescatore. L'idea era buona, ma bisognava rinunciarvi. Vincitore del concorso di Sigmaringen, Ilia Brusch aveva annunciato pubblicamente il suo progetto, e certamente non si sarebbe prestato volentieri a una sostituzione di persona, difficile oltretutto, poiché i suoi tratti somatici erano noti a tutti. Ma se pur bisognava rinunciare all'idea di intraprendere il viaggio sotto le mentite spoglie di Ilia Brusch, esisteva forse un'altra possibilità per raggiungere lo scopo. Karl Dragoch poteva accontentarsi di ottenere un passaggio sulla sua imbarcazione. Chi avrebbe mai prestato attenzione al compagno di quell'uomo ormai celebre e che di conseguenza attirava su di sé l'attenzione di tutti? E se anche qualcuno avesse per caso lasciato cadere lo sguardo sull'ignoto compagno, come poteva stabilire un qualsiasi rapporto tra lo sconosciuto e il poliziotto che svolgeva la sua missione nell'ombra? Esaminato il progetto a lungo, Karl Dragoch lo giudicò in ultima analisi eccellente e risolse di attuarlo. Abbiamo visto con quale maestria egli avesse organizzato la scena iniziale, che, se necessario, poteva essere seguita da molte altre. In caso di necessità, Ilia Brusch sarebbe stato condotto dal commissario, imprigionato con false accuse, spaventato in mille modi: sicuramente Karl Dragoch avrebbe commesso senza rimorso qualsiasi abuso per convincere il pescatore atterrito di essere il suo salvatore. Il poliziotto, comunque, era contento di averla spuntata senza adoperare alcuna violenza morale e senza altre farse. Ora egli era certo che se avesse finto di voler abbandonare la chiatta il suo ospite si sarebbe opposto alla sua partenza con la stessa insistenza con la quale prima lo aveva respinto. Occorreva sfruttare quella situazione. Per fare ciò, Karl Dragoch non doveva che lasciarsi trasportare dalla corrente: mentre il compagno pescava o remava, egli avrebbe sorvegliato il fiume, senza lasciar sfuggire nulla al suo occhio attento. Strada facendo, avrebbe parlato con gli uomini da lui disseminati lungo le rive. Alla prima notizia di un delitto oppure di un crimine, avrebbe abbandonato Ilia Brusch per correre sulle tracce dei malfattori; e avrebbe fatto la stessa cosa, all'occorrenza, se un qualcosa di sospetto avesse attratto la sua attenzione. Tutto ciò era stato predisposto con molta cura; più vi pensava, più Karl Dragoch si compiaceva della sua idea; la quale, assicurandogli l'incognito lungo tutto il Danubio, moltiplicava le sue possibilità di successo. Ma il poliziotto, troppo razionale, non teneva conto del caso. Egli non immaginava che un susseguirsi di eventi insoliti avrebbe, pochi giorni dopo, indirizzato le sue ricerche in una direzione imprevista e dato alla sua missione una inattesa estensione. CAPITOLO VI GLI OCCHI AZZURRI LASCIATA la riva, Karl Dragoch raggiunse i quartieri del centro. Conosceva Ratisbona e senza esitazione si cacciò attraverso le vie, fiancheggiate qua e là di torrioni feudali, di questa città un tempo rumorosa, alla quale ora la popolazione ridotta a ventimila anime non dà più vita. Karl Dragoch non intendeva visitare la città, come credeva Ilia Brusch; egli non viaggiava da turista. A poca distanza dal ponte si trovò dinanzi alla cattedrale dalle torri non finite, ma egli diede soltanto un'occhiata distratta al suo strano portale del XV secolo. Non sarebbe certamente andato al palazzo dei principi di Tour e di Taxis ad ammirare la cappella gotica e il chiostro ogivale, e neppure la biblioteca delle pipe, bizzarra curiosità dell'antico convento. Non avrebbe visitato neppure la Rathaus, l'odierno municipio, un tempo sede della Dieta, la cui sala è ornata di vecchi arazzi, e ove la camera di tortura con i suoi vari strumenti è fatta visitare, non senza orgoglio, dal portinaio. Egli non avrebbe speso un trinkgeld, la mancia tedesca, per un cicerone: non ne aveva bisogno, e senza aiuto alcuno si recò all'ufficio postale, dove lo aspettavano varie lettere. Dopo averle lette senza batter ciglio, Karl Dragoch stava per uscire quando un uomo vestito dimessamente si avvicinò a lui. I due si conoscevano; Dragoch fermò con un gesto le parole che il nuovo venuto stava per dire, gesto che evidentemente significava: «Non qui». Tutti e due si diressero verso la vicina piazza. — Perché non mi hai atteso sulla riva del fiume? — chiese Karl Dragoch, quando si ritenne al sicuro da orecchie indiscrete. — Credevo di mancarvi — gli fu risposto. — E poiché sapevo che sareste venuto alla posta… — Eccoti, comunque, e questo è ciò che importa — lo interruppe Karl Dragoch. — Nulla di nuovo? — Nulla. — Neppure un piccolo furto nella regione? — Né nella regione né altrove; lungo il Danubio, s'intende. — A quando risalgono le ultime notizie? — Due ore fa ho ricevuto un telegramma dall'ufficio centrale di Budapest. Calma assoluta su tutta la linea. Karl Dragoch rifletté per un attimo. — Andrai in Procura da parte mia; darai il tuo nome, Friedrich Ulhmann, e li pregherai che ti tengano al corrente, se capitasse qualcosa. Poi partirai per Vienna. — E i nostri uomini? — Me ne occuperò io. Li vedrò nel passare. Appuntamento a Vienna, tra otto giorni: questa è la parola d'ordine. — Lascerete dunque la parte alta del fiume senza sorveglianza? — chiese Ulhmann. — La polizia locale basterà — rispose Dragoch. — Accorreremo al minimo allarme. Finora, del resto, non è mai capitato nulla di nostra competenza al di qua di Vienna. I nostri amici non sono così stupidi da operare lontano dalla loro base. — La loro base?… — ripeté Ulhmann. — Avete notizie precise? — Ho comunque la mia opinione. — E cioè?… — Troppo curioso! Ti dirò comunque che esordiremo tra Vienna e Budapest. — Perché là e non altrove? — Perché è là che l'ultimo crimine è stato commesso. Sai, quel fattore che hanno fatto «scaldare» e che è stato ritrovato bruciato fino alle ginocchia. — Ragione di più perché operino da un'altra parte, la prossima volta. — Perché? — Perché penseranno che il distretto in cui il crimine è stato perpetrato dev'essere particolarmente sorvegliato e andranno a tentare la fortuna da un'altra parte. È ciò che hanno fatto sinora. Mai due volte di seguito nello stesso posto. — Hanno ragionato da somari, e tu li imiti, Friedrich Ulhmann — rispose Karl Dragoch. — E proprio sulla loro stupidità che io faccio assegnamento. Tutti i giornali, come avrai letto, mi hanno attribuito un ragionamento analogo. Hanno pubblicato con perfetto sincronismo che lasciavo l'alto Danubio dove, secondo me, i delinquenti non si sarebbero arrischiati a fare ritorno, e che partivo per l'Ungheria meridionale. È inutile che ti dica che non c'è una sola parola di vero in tutto ciò, ma puoi star certo che queste notizie tendenziose hanno colpito gli interessati. — Che cosa ne deducete? — Che non andranno dalla parte dell'Ungheria meridionale per gettarsi nelle fauci del lupo. — Il Danubio è lungo — disse Ulhmann. — C'è la Serbia, la Romania, la Turchia… — E la guerra? Da quella parte non c'è nulla da fare per essi. Del resto, lo vedremo. Karl Dragoch rimase un istante in silenzio. — Le mie istruzioni sono state puntualmente seguite? — Puntualmente. — La sorveglianza del fiume è proseguita? — Giorno e notte. — Non è stato scoperto nulla di sospetto? — Assolutamente nulla. Tutti i battelli e tutte le chiatte hanno i documenti in regola. A questo proposito, debbo dirvi che le operazioni di controllo sollevano molte lamentele. I fluviali protestano; se volete la mia opinione, a me pare che non abbiano torto. I battelli non hanno nulla a che vedere con quello che noi cerchiamo. I crimini non sono commessi sull'acqua. Karl Dragoch aggrottò la fronte. — Secondo me è molto importante ispezionare chiatte, battelli e anche le più piccole imbarcazioni — rispose seccamente. — Aggiungerò una volta per tutte che le osservazioni non mi piacciono. Ulhmann fece un lieve inchino. — Benissimo — disse. Karl Dragoch riprese: — Non so ancora ciò che farò. Forse mi fermerò a Vienna; forse mi spingerò fino a Belgrado. Non ho deciso. Poiché è necessario non perdere i contatti, tienimi al corrente con le informazioni che darai a tutti i nostri uomini scaglionati tra Ratisbona e Vienna. — Bene, signore — rispose Ulhmann. — E io? dove dovrò vedervi? — A Vienna, tra otto giorni, te l'ho già detto — rispose Dragoch. Rifletté per qualche istante e poi aggiunse: — Puoi andartene. Non dimenticare di passare dal commissariato e poi prendi subito il treno. Ulhmann già si allontanava allorché Karl Dragoch lo richiamò. — Hai sentito parlare di un certo Ilia Brusch? — chiese. — Il pescatore che intende discendere il fiume con la lenza in mano? — Precisamente. Ebbene, se mi vedi con lui, fingi di non conoscermi. Si separarono: Friedrich Ulhmann andò verso i quartieri alti, mentre Karl Dragoch si diresse verso l'albergo della Croce d'Oro, ove si era proposto di andare a mangiare. Una decina di persone che parlavano del più e del meno erano già a tavola, quando egli prese posto a sua volta. Dragoch mangiò con appetito, ma non prese parte alla conversazione: si limitò ad ascoltare, da uomo che ha l'abitudine di prestare orecchio a ciò che si dice intorno a lui. Non poté fare a meno di udire, quindi, ciò che un convitato chiese al suo vicino: — Della famosa banda non si ha dunque più notizia? — Non più di quanto si sappia del famoso Brusch — rispose l'altro. — A Ratisbona si aspettava il suo passaggio; non è stato ancora segnalato. — La cosa è strana. — A meno che Brusch e il capo della banda non siano la stessa persona. — Dite per ridere? — Eh, chissà! Karl Dragoch aveva subito alzato il capo. Era la seconda volta che quella ipotesi, decisamente assurda, veniva sottoposta alla sua attenzione. Alzò impercettibilmente le spalle e finì di cenare senza dire una sola parola. Roba da ridere. Quel chiacchierone era così bene informato che non sapeva neppure che Ilia Brusch era già arrivato a Ratisbona. Dopo aver cenato, Karl Dragoch ridiscese verso la banchina. Quando raggiunse il fiume, invece di salire sulla chiatta si attardò per qualche istante sul vecchio ponte di pietra che unisce Ratisbona a Stadt-am-Hof, suo sobborgo, e lasciò vagare lo sguardo sul fiume, ove alcuni battelli scivolavano ancora velocemente, approfittando della luce morente del giorno. Era assorto a guardare quando una mano gli si posò sulla spalla, mentre una voce familiare gli diceva: — Debbo credere, signor Jaeger, che tutto questo vi interessi. Karl Dragoch si volse e vide accanto a sé Ilia Brusch che lo guardava sorridendo. — Sì — rispose. — Il traffico sul fiume è affascinante; non mi stanco mai di osservarlo. — E vi interesserà ancor di più — disse Ilia Brusch — quando arriveremo sul basso fiume, dove i battelli sono molto numerosi. Vedrete, quando saremo alle Porte di Ferro! Le conoscete? — No — rispose Dragoch. — Bisogna vederle! — dichiarò Ilia Brusch. — Se al mondo non c'è fiume più bello del Danubio, in tutto il corso del Danubio non c'è posto più bello delle Porte di Ferro! Nel frattempo la notte era completamente calata. Il grosso orologio di Ilia Brusch segnava le nove passate. — Ero nella chiatta, quando vi ho visto sul ponte — disse. — Sono venuto a disturbarvi soltanto per ricordarvi che partiamo domani di buon'ora e che faremmo bene, quindi, ad andare a dormire. — Vi seguo — approvò Karl Dragoch. Discesero entrambi verso la riva. Nel girare l'estremità del ponte il passeggero disse: — E la vendita del pesce, signor Brusch? Siete soddisfatto? — Più che soddisfatto! Debbo darvi quarantuno fiorini! — Che con i ventisette già incassati, fanno sessantotto fiorini. E siamo appena a Ratisbona! Signor Brusch, l'affare non mi sembra affatto cattivo! — Comincio a crederlo anch'io — disse il pescatore. Un quarto d'ora dopo tutti e due dormivano, l'uno accanto all'altro. Al levar del sole l'imbarcazione era già a cinque chilometri da Ratisbona. A valle di questa città le rive del Danubio presentano aspetti molto differenti. Sulla destra si seguono a perdita d'occhio fertili pianure, un'ubertosa campagna ove non mancano fattorie e villaggi; sulla riva sinistra si estendono foreste profonde e colline che vanno poi a saldarsi al Bohmerwald. Nel passare, il signor Jaeger e Ilia Brusch riuscirono a scorgere, al disopra del borgo di Donaustauf, il Palazzo d'estate dei Principi di Tour e di Taxis, e il vecchio castello episcopale di Ratisbona; poi, più in là, sul Salvatorberg, il Walhalla, o «Soggiorno degli eletti», voluto dal re Luigi, specie di Partenone sperduto sotto il cielo bavarese, ma che non ha nulla a che vedere con quello dell'Attica. L'interno, molto meno bello dell'esterno con le sue opere architettoniche, ospita un museo con i busti degli eroi tedeschi. Se il Walhalla non vale il Partenone di Atene, è più bello però della «vecchia affumicata» che gli scozzesi hanno costruito su una delle colline che circondano Edimburgo. La distanza che separa Ratisbona da Vienna è lunga, se si seguono le sinuosità del Danubio; su questa strada liquida di quasi quattrocentosettantacinque chilometri, le città di qualche importanza sono rare. Sono da segnalare Straubing, silos della Baviera, ove la chiatta si fermò la sera del 18 agosto; Passau, ove vi giunse il 20, e Linz, oltrepassata nella giornata del 21. Oltre a queste città, di cui solo le due ultime hanno qualche importanza strategica, ma nessuna raggiunge i ventimila abitanti, non esistono che insignificanti agglomerati. Non ci sono costruzioni di alcun genere e il turista può vincere la noia ammirando le rive sempre diverse del grande fiume. Dopo Straubing, ove ha una larghezza di quattrocento metri, il Danubio comincia a restringersi, mentre le prime pendici delle Alpi Retiche s'innalzano a poco a poco dalla riva destra. A Passau, costruita alla confluenza del Danubio, dell'Inn e dell'Ils, di cui i primi due fanno parte dei più grandi fiumi d'Europa, si lascia la Germania; la riva destra, a valle della città, diventa austriaca e soltanto alcuni chilometri oltre, alla confluenza con la Dadelsbach, la riva sinistra entra a far parte dell'impero degli Asburgo. Da quel punto fino a Vienna, il letto del fiume diventa uno stretto nastro di circa duecento metri, che ora si allarga in veri laghi disseminati di isole e isolotti, ora si restringe ancor più e tra le sue pareti l'acqua rumoreggia impetuosa. Sembrava che Ilia Brusch non mostrasse alcun interesse a quella mutevole successione di spettacoli stupendi; pareva soltanto preoccupato di sollecitare con il vigore delle sue braccia la marcia dell'imbarcazione. L'attenzione che bisognava prestare alla guida della chiatta sarebbe bastata, del resto, a scusare la sua indifferenza. Oltre ai banchi di sabbia, frequenti sul Danubio, egli doveva superare altre difficoltà più gravi. Già alcuni chilometri prima di Passau aveva dovuto affrontare le rapide di Wilshofen; poi, centocinquanta chilometri sotto Grein, una delle città più povere dell'Alta Austria, incontrò quelle molto più pericolose dello Strudel e del Wirbel. In quel punto la valle diventa uno stretto passaggio tra pareti selvagge, fra le quali precipitano le acque gorgoglianti. Un tempo numerosi scogli rendevano il passaggio molto pericoloso e non era raro che le imbarcazioni subissero gravi danni. Ora sono stati fatti saltare con le mine quelli più pericolosi che si estendevano da una riva all'altra e minore è il pericolo. Le rapide non sono più così impetuose, i vortici meno travolgenti e quindi le catastrofi sono diventate meno frequenti. Tuttavia le imbarcazioni, grandi o piccole che siano, debbono ugualmente essere molto prudenti. Tutto ciò non metteva in difficoltà Ilia Brusch. Egli seguiva i passaggi, evitava i banchi di sabbia, superava i gorghi e le rapide con stupefacente maestria. Karl Dragoch, pur ammirando la sua abilità, era sorpreso che un semplice pescatore conoscesse così bene il Danubio e le sue trappole traditrici. Se Ilia Brusch stupiva Karl Dragoch, questi stupiva a sua volta il compagno. Il pescatore si meravigliava, senza nulla capirci, delle numerose conoscenze del suo passeggero. Per minuscolo che fosse il paese scelto per la sosta serale, era raro che il signor Jaeger non vi trovasse qualche conoscente. Non appena la chiatta era ormeggiata, egli scendeva a terra e quasi subito era avvicinato da una o due persone. Quelle conversazioni non erano mai lunghe; dopo aver scambiato poche parole, gli interlocutori si separavano e il signor Jaeger tornava sulla chiatta. Alla fine Ilia Brusch non riuscì più a contenersi. — Avete amici un po' dappertutto, signor Jaeger, a quel che vedo — gli chiese un giorno. — Proprio così, signor Brusch — rispose Karl Dragoch. — Ho percorso spesso queste contrade. — Da turista? — No, signor Brusch — rispose Karl Dragoch. — Viaggiavo allora per conto di una ditta commerciale di Budapest. Quel mestiere non soltanto permette di vedere i paesi, ma anche di stringere numerose relazioni, come saprete. Questi furono i soli incidenti — se così si possono chiamare — che segnarono il viaggio dal 18 al 24 agosto. Come al solito, all'alba di quel giorno, dopo una notte trascorsa lungo la riva a valle della cittadina di Tulln, lontano da qualsiasi villaggio, Ilia Brusch si rimise in cammino. La giornata non sarebbe stata come le precedenti: alla sera, infatti, avrebbero raggiunto Vienna. Per la prima volta dopo otto giorni, Brusch avrebbe pescato per non deludere gli ammiratori che certamente avrebbe trovato nella capitale, dove aveva avuto cura di far diffondere l'annuncio del suo arrivo attraverso la stampa. Non occorreva pensare, del resto, anche agli interessi del signor Jaeger, troppo trascurati durante quella settimana di accanita navigazione? Benché non si lamentasse, mantenendo fede agli impegni, Jaeger non doveva essere soddisfatto. Ilia Brusch, naturalmente, lo capiva ed era per dargli almeno un contentino che aveva programmato che, l'ultimo giorno, avrebbe percorso non più di una trentina di chilometri. Nonostante la velocità ridotta, gli sarebbe stato possibile raggiungere Vienna abbastanza di buon'ora, così da poter vendere il pesce. Nel momento in cui Karl Dragoch uscì dalla cabina, il bottino era già abbondante, ma il pescatore avrebbe fatto ancora meglio. Verso le undici la lenza tirò su un luccio di venti libbre, un pezzo regale che i viennesi avrebbero certamente pagato ad alto prezzo. Incoraggiato dal successo, Ilia Brusch volle tentare la fortuna ancora una volta, ma si sbagliava, e i fatti lo provarono. Come accadde? Non avrebbe saputo dirlo. Il fatto è che lui, sempre così abile, per un attimo di distrazione o per altra causa, fece un lancio infelice e l'amo gli graffiò con violenza il viso, tracciandovi un solco sanguinoso. Ilia Brusch lanciò un grido di dolore. Dopo avergli lacerato la carne, l'amo agganciò nella sua traiettoria i grandi occhiali neri che il pescatore portava notte e giorno, occhiali che — strappati come una piuma — presero a vorticare turbinosamente sopra il pelo dell'acqua. Ilia Brusch soffocò un'esclamazione di dispetto e, data un'inquieta occhiata al signor Jaeger, si affrettò a raccogliere gli occhiali e a rimetterseli sul naso. Soltanto allora parve soddisfatto. L'incidente era durato pochi secondi, che però erano bastati a Karl Dragoch per accorgersi che il suo ospite aveva dei magnifici occhi azzurri, con uno sguardo vivo che non aveva nulla di malaticcio. Il poliziotto non poté fare a meno di notare quei particolari; il suo temperamento lo induceva a elaborare tutto ciò che sollecitava la sua attenzione. Le sue riflessioni continuarono anche dopo che gli occhi azzurri sparirono nuovamente dietro gli occhiali neri che li nascondevano. È superfluo dire che Ilia Brusch smise di pescare. Medicata sommariamente la ferita, più dolorosa che grave, rimise a posto con cura gli attrezzi, mentre il battello seguiva il filo della corrente. Poco dopo giunse l'ora di far colazione. Pochi istanti prima la chiatta era passata ai piedi del Kalhemberg, alto trecentocinquanta metri, che domina Vienna. A mano a mano che procedevano, l'animazione delle rive preannunciava la vicinanza dell'importante città. Le ville si addossavano ormai le une alle altre; le officine annerivano il cielo con il fumo delle loro alte ciminiere e ben presto Brusch e il suo compagno notarono le prime carrozze che davano alla periferia una nota chiaramente cittadina. Nelle prime ore del pomeriggio la chiatta oltrepassò Nussdorf, ove si fermano i battelli a vapore a grande pescaggio. La modesta imbarcazione del pescatore non necessitava di molto fondo e non trasportava passeggeri, perciò non aveva bisogno di arrivare nel cuore della città attraverso il canale. Libero nei suoi spostamenti, Ilia Brusch seguì il grande braccio del Danubio. Prima delle quattro si fermava vicino alla riva e si ormeggiava a un albero del Prater, notissima passeggiata di Vienna come lo è il Bois de Boulogne per Parigi. — Che male avete agli occhi, signor Brusch? — chiese in quel momento Karl Dragoch, che dopo l'incidente degli occhiali aveva detto pochissime parole. Ilia Brusch interruppe il suo lavoro e si volse verso il passeggero. — Agli occhi? — chiese a sua volta. — Agli occhi, sì — disse il signor Jaeger. — Immagino che non sia per capriccio che portate gli occhiali neri. — Ah, i miei occhiali! — disse Brusch. — Ho la vista debole e la luce mi fa male, ecco tutto. La vista debole? Con quegli occhi! Data quella spiegazione, Ilia Brusch finì di ormeggiare la chiatta. Karl Dragoch seguiva il suo lavoro con aria pensierosa. CAPITOLO VII CACCIA E CACCIATORI ALCUNE PERSONE animavano, in quel pomeriggio d'agosto, la riva nord-est del Danubio, ultimo tratto della passeggiata del Prater. Stavano forse aspettando Ilia Brusch? La cosa era probabile, avendo il pescatore anticipato sui giornali il luogo e quasi l'ora del suo arrivo. Ma come avrebbero fatto i curiosi sparsi su un così vasto spazio a trovare la barca che non aveva caratteristiche particolari? Ilia Brusch aveva previsto anche questo. Non appena l'imbarcazione fu ormeggiata, egli si affrettò ad alzare su una pertica una lunga banderuola sulla quale si poteva leggere: Ilia Brusch, vincitore del concorso di Sigmaringen: e poi espose sul tetto della tuga i pesci catturati nel corso della mattina, dando al luccio il posto d'onore. La mostra all'americana ebbe un immediato successo. Alcuni sfaccendati si fermarono dinanzi alla chiatta e la osservarono con curiosità; a questi ne seguirono altri, e in pochi minuti l'assembramento fu tale che i veri interessati non poterono fare a meno di notarlo. Accorsero in fretta, mentre altri, nel vedere tante persone andare nella stessa direzione, si misero a correre dietro di loro senza saperne il motivo. In meno di un quarto d'ora cinquecento persone si erano raccolte dinanzi alla chiatta. Ilia Brusch non aveva mai immaginato un tale successo. Il dialogo tra il pubblico e il pescatore non tardò ad avere inizio. — Il signor Brusch? — chiese uno spettatore. — Eccomi — rispose l'interpellato. — Permettetemi di presentarmi. Sono Claudius Roth, vostro collega della Lega Danubiana. — Felicissimo, signor Roth! — Sono presenti qui molti altri nostri colleghi. Ecco i signori Hanisch, Tietze e Hugo Zwiedinek, senza contare quelli che non conosco. — Io, per esempio, Mathias Kasselick, di Budapest — disse uno spettatore. — Ed io — aggiunse un altro — Wilhelm Bickel, di Vienna. — Felicissimo, signori, di essere tra di voi — esclamò Ilia Brusch. Le domande e le risposte si incrociarono e la conversazione si fece generale. — Avete fatto buon viaggio, signor Brusch? — Eccellente. — Avete fatto presto, però: non vi aspettavamo così presto. — Sono quindici giorni che viaggio. — Sì, ma la strada è lunga da Donaueschingen a Vienna! — Circa novecento chilometri, il che fa una media di sessanta chilometri al giorno. — La corrente li fa in ventiquattro ore, e non sempre. — Dipende dai luoghi. — È vero. E il vostro pesce? Lo vendete con facilità? — A meraviglia! — Siete contento, dunque? — Contentissimo. — Oggi, il pesce è bellissimo, il luccio magnifico. — Non è male, infatti. — Il suo prezzo? — Lo pagherete quanto vorrete. Se siete d'accordo, metterò il pesce all'asta: il luccio per ultimo. — Per gli intenditori — puntualizzò uno scherzosamente. — Buona idea! — esclamò il signor Roth. — Chi acquista il luccio, invece di mangiarlo, può farlo impagliare in ricordo di Ilia Brusch! Quelle battute ottennero grande successo e l'asta fu animata. Un quarto d'ora dopo il pescatore aveva incassato una bella sommetta, alla quale il luccio aveva contribuito con trentacinque fiorini. Finita l'asta, ci fu uno scambio d'idee tra il pescatore e gli ammiratori che si affollavano sulla spiaggia per conoscere le future intenzioni di Ilia Brusch, che rispondeva con compiacenza e annunciava, senza farne mistero, che dopo aver dedicato a Vienna la giornata seguente, alla sera sarebbe andato a dormire a Presburg. Con il passare del tempo, i curiosi uno alla volta se ne andarono a mangiare. Costretto a pensare al suo pasto, Ilia Brusch si cacciò nella tuga, lasciando il suo passeggero in pasto alla pubblica ammirazione. Due individui che passeggiavano, attratti dalla folla che contava ancora un centinaio di spettatori, poterono notare soltanto Karl Dragoch seduto sotto la banderuola che annunciava urbi et orbi 2 il titolo e il nome di Ilia Brusch. Uno dei due era un uomo robusto di circa trent'anni, dalle spalle ampie, con capelli e barba di quel biondo che è caratteristico della razza slava. L'altro, altrettanto robusto e notevole per l'insolita ampiezza delle spalle, era meno giovane; i capelli sale-pepe rivelavano che aveva superato la quarantina. Dopo aver lanciato uno sguardo sulla chiatta, il più giovane trasalì e fece qualche passo indietro, trascinando con sé il compagno. — E lui — disse con voce soffocata non appena usciti dalla folla. — Credi? — Ne sono sicuro. Non lo hai riconosciuto? — Come riconoscerlo, se non l'ho mai visto? Seguì un breve silenzio: i due riflettevano. — È solo nella barca? — chiese l'anziano. — Solissimo. — Ed è proprio la barca di Ilia Brusch? — Non è possibile sbagliarsi: il nome è scritto sulla banderuola. — Non ci si capisce nulla. Dopo un'altra breve pausa, il più giovane disse: — È lui dunque che compie il viaggio sotto il nome di Ilia Brusch? — A quale scopo? Quello dalla barba bionda alzò le spalle. — E chiaro: allo scopo di scendere il Danubio sotto falso nome. 2 Alla città e al mondo. (N.d.T.) — Diamine! — rispose il compagno. — Ciò non mi stupisce — disse l'altro. — Dragoch è furbo e il suo piano sarebbe certamente riuscito, se il caso non ci avesse fatto passare di qua. Il più anziano sembrava poco convinto. — Sa di romanzo giallo — mormorò. — Proprio così, Titcha, proprio così — approvò il compagno. — Dragoch si diverte a usare queste farse da romanzo. Comunque, chiariremo la faccenda. La gente intorno a noi diceva che la barca rimarrà a Vienna per tutta la giornata di domani; non dobbiamo far altro che tornare. Se Dragoch ci sarà ancora, è evidente che si nasconde sotto i panni di Ilia Brusch. — Che faremo, in tal caso? — chiese Titcha. Il compagno non rispose subito. — Ci penseremo — disse poi. Si allontanarono in direzione della città, lasciando la chiatta circondata da sempre meno gente. La notte trascorse tranquilla per Ilia Brusch e per il suo compagno. Quando questo uscì dalla tuga, vide Ilia che controllava gli attrezzi da pesca. — Tempo bello, signor Brusch — disse Karl Dragoch a mo' di buon giorno. — Magnifico, signor Jaeger — approvò Ilia Brusch. — Intendete approfittarne per visitare la città? — No, signor Jaeger, non m'interessa, e qui ho da fare per tutto il giorno. Dopo due settimane di navigazione, è indispensabile mettere un po' d'ordine. — Come volete, signor Brusch. Io non la penso come voi, e resterò a terra fino a stasera. — Fate bene — approvò Ilia Brusch — poiché avete casa qui, la vostra famiglia, se ne avete una, avrà piacere di vedervi. — Vi sbagliate; sono scapolo, signor Brusch. — Male; in due il fardello della vita si porta meglio. Karl Jaeger si mise a ridere. — Diamine! Non siete allegro stamane, signor Brusch. — Tutti abbiamo il nostro giorno sbagliato — rispose il pescatore. — Ma voi cercate di divertirvi come meglio potete. — Cercherò di farlo — rispose Karl Jaeger, allontanandosi. Attraversò il Prater per raggiungere la Haupt-Allée, punto d'incontro della Vienna elegante durante la stagione. Ma a quell'ora e in quel periodo dell'anno la Haupt-Allée era quasi deserta ed egli poté camminare in fretta senza essere intralciato dalla folla. C'era abbastanza gente però, perché non notasse due individui che, tra gli altri, lo incrociarono all'altezza del Costantins Hugel, colle artificiale con il quale si è pensato bene di mutare la prospettiva del Prater. Senza vedere i due, Karl Dragoch proseguì tranquillamente per la sua strada e, dieci minuti dopo, entrava in un caffeuccio della piazza rotonda del Prater, la Prater Stern. Vi era atteso; un consumatore infatti, nel vederlo si alzò e gli andò incontro. — Buon giorno, Ulhmann — disse Dragoch. — Buon giorno, signore — rispose Ulhmann. — Nulla di nuovo? — Nulla di nuovo. — Benissimo. Questa volta abbiamo tutta la giornata per ragionare su ciò che dobbiamo fare. Se Karl Dragoch non aveva notato i due della Haupt- Allée, essi invece, che erano poi gli stessi che il caso aveva guidato il giorno prima vicino alla chiatta di Ilia Brusch, avevano perfettamente visto lui. Avevano contemporaneamente fatto dietro-front e seguito il capo della polizia del Danubio, a debita distanza, per evitare sorprese. Quando Dragoch era sparito nel caffeuccio, essi erano entrati in un locale sull'altra curva della piazza, decisi a rimanervi tutto il giorno, se necessario, per spiarlo. La loro pazienza fu messa a dura prova. Dopo aver dedicato alcune ore a stabilire i particolari delle loro azioni, Dragoch e Ulhmann pranzarono senza alcuna fretta. Poi, per sfuggire alla calura soffocante della sala, si fecero servire all'aperto il caffè, insostituibile chiusura di ogni pasto. Quando stava per portare la tazzina alle labbra, Dragoch fece improvvisamente un gesto di meraviglia e, come se non volesse essere riconosciuto, rientrò in fretta nel ristorante, e dalle tendine, spiò un uomo che attraversava la piazza. — È lui, Dio mi perdoni! — mormorò Dragoch, seguendo con gli occhi Ilia Brusch. Era proprio Brusch, infatti, perfettamente riconoscibile nel viso rasato, occhiali e capelli neri come quelli di un italiano del Sud. Quando Brusch ebbe imboccato la Kaiser-Josephstrasse, Dragoch ritornò da Ulhmann, gli ordinò di aspettarlo e si mise sulle tracce del pescatore. Ilia Brusch procedeva senza pensare a girarsi, come chi ha la coscienza tranquilla. Andò fino in fondo alla KaiserJosephstrasse, poi attraversò in linea retta il parco di Augarten e giunse alla Brigittenau. Qui esitò per un attimo, poi entrò in una miserabile botteguccia, la cui vetrina dava su una delle vie più povere del quartiere operaio. Ne uscì mezz'ora dopo, sempre seguito senza saperlo da Karl Dragoch che, nel passare, aveva letto l'insegna della bottega nella quale il suo compagno di viaggio era entrato, e imboccò la Rembrandtgasse; poi risalì la riva sinistra del canale e raggiunse la Praterstrasse, che seguì fino alla piazza rotonda, ove girò deliberatamente a sinistra e si allontanò lungo la Haupt-Allée, sotto gli alberi del Prater. Tornava evidentemente a bordo della chiatta e Dragoch ritenne inutile continuare a pedinarlo. Il poliziotto fece allora ritorno al caffeuccio nel quale lo aspettava Friedrich Ulhmann. — Conosci un ebreo di nome Simon Klein? — gli chiese. — Certamente — rispose Ulhmann. — Chi è? — Nulla di buono: rigattiere, usuraio e, quando capita, ricettatore. Credo che queste tre parole lo dipingano perfettamente. — È ciò che pensavo — mormorò Dragoch, che sembrava immerso in profonde riflessioni. Dopo un attimo, disse: — Quanti uomini abbiamo qui? — Una quarantina — rispose Ulhmann. — Bastano. Sta' a sentire. Bisogna fare tavola rasa di tutto ciò che abbiamo detto stamane. Cambio piano, perché ho il presentimento che la faccenda si concluderà proprio là dove sarò anch'io. — Dove sarete voi? Non capisco. — È inutile che tu capisca. Scaglionerai i tuoi uomini a due a due, sulla riva sinistra del Danubio, ogni cinque chilometri, cominciando da venti chilometri dopo Presburg. Non dovranno far altro che badare a me. Non appena gli ultimi due mi hanno scorto, dovranno correre cinque chilometri oltre i primi due e così di seguito. Capito? Che non mi perdano d'occhio, soprattutto! — E io? — chiese Ulhmann. — Farai in modo di non perdermi di vista. Poiché sarò su una barca in mezzo al fiume, non ti sarà difficile… Raccomanda ai tuoi uomini di prendere tutte le informazioni possibili, prima di montare la guardia. In caso di necessità, la postazione a conoscenza di un fatto grave ne informerà le altre, e ne diventerà il punto di raccolta. — Ho capito. — Ci si metta in marcia fin da questa sera; domani intendo trovare gli uomini al loro posto. — Vi saranno — disse Ulhmann. Karl Dragoch espose il suo piano varie volte, finché fu certo di essere stato perfettamente capito dal suo subordinato, poi, data l'ora tarda, si decise a raggiungere la chiatta. Nel caffè dall'altra parte della piazza, i due individui del Prater continuavano a spiare. Avevano visto Dragoch uscire senza immaginarne il motivo, poiché non avevano notato passare Ilia Brusch. Avrebbero voluto mettersi alle sue calcagna, ma la presenza di Ulhmann li aveva dissuasi. Tranquillizzati poi dall'attesa di costui, avevano atteso anch'essi, persuasi che non avrebbero tardato a veder tornare Dragoch. Il ritorno del poliziotto dimostrò la validità del loro ragionamento; quando Dragoch e Ulhmann rientrarono nel caffè, essi rimasero in agguato, fino a quando il capo della polizia e il suo subordinato si separarono. Nel lasciare che quest'ultimo risalisse verso il centro, i due tornarono a seguire Dragoch per la Haupt-Allée, già percorsa la mattina in senso opposto. Dopo tre quarti d'ora di cammino si fermarono: la fila d'alberi della riva del Danubio non lasciava dubbi: Dragoch tornava alla sua imbarcazione. — È inutile andare oltre — disse il più giovane. — Ormai sappiamo che Ilia Brusch e Karl Dragoch sono la stessa persona; continuando a seguirlo, corriamo il rischio di essere notati. — Che cosa faremo? — chiese il compagno dalle spalle di lottatore. — Ne parleremo — rispose l'altro. — Ho già un'idea. Mentre i due sconosciuti si allontanavano verso il Prater Stern elaborando piani la cui esecuzione non poteva essere rimandata a lungo, Karl Dragoch risaliva sulla chiatta senza neppure immaginare di essere stato pedinato così a lungo nel corso della giornata. Trovò Ilia Brusch che preparava da mangiare: un'ora dopo i due compagni dividevano come al solito la cena, a cavalcioni del sedile. — Siete soddisfatto della vostra passeggiata? — chiese Ilia Brusch quando le pipe cominciarono a diffondere nuvole di fumo. — Contentissimo — rispose Dragoch. — E voi, signor Brusch, non avete cambiato idea? Non vi siete deciso a gironzolare un po' per Vienna? O a fare qualche visita? — No, signor Jaeger — disse Brusch. — Non conosco nessuno qui. Da quando siete andato via, non ho messo piede a terra. — Davvero? — Proprio così. Non ho mai lasciato la chiatta, ove del resto avevo tanto lavoro da tenermi occupato fino a sera. Karl Dragoch non disse nulla. I pensieri che la sfacciata bugia dell'ospite poteva suggerirgli egli li tenne per sé; i due parlarono perciò del più e del meno, fino al momento di andare a dormire. CAPITOLO VIII UN RITRATTO DI DONNA ILIA BRUSCH aveva mentito premeditatamente o aveva cambiato idea per capriccio? Comunque sia, le informazioni fornite da lui sul suo itinerario erano della più evidente inesattezza. Partito due ore prima dell'alba, la mattina del 26 agosto, non si era fermato a Presburg, come invece aveva preannunciato. Venti ore di accanito remare lo avevano condotto, in un sol fiato, a più di quindici chilometri oltre quella città; dopo un breve riposo egli aveva ricominciato la fatica sovrumana. Perché tanti sforzi per abbreviare il viaggio? Ilia Brusch non ritenne di dirlo al signor Jaeger, i cui interessi peraltro ne risultavano gravemente compromessi. Ciò nonostante, il poliziotto, rispettoso degli accordi presi, non manifestò in alcun modo il suo disappunto. Le preoccupazioni di Karl Dragoch annullavano quelle del signor Jaeger. Il danno che il secondo rischiava di subire era cosa da nulla se paragonato alle preoccupazioni del primo. La mattina del 26 agosto Karl Dragoch aveva infatti notato un particolare piuttosto strano, che aggiunto a quelli dei giorni precedenti, lo aveva turbato profondamente. Era capitato verso le dieci del mattino. Immerso nel suoi pensieri, Dragoch guardava soprappensiero Ilia Brusch che remava in piedi, a poppa della chiatta, con la testardaggine di un bue al giogo. Essendo costretto a dirigersi verso nordovest a causa di un'ansa del fiume, il pescatore aveva il sole alle spalle. Per il gran sudore, buttato ai suoi piedi il berretto di lontra che gli copriva abitualmente il capo, era rimasto a testa nuda; la luce faceva risplendere la sua abbondante chioma nera. Karl Dragoch fu colpito a un tratto da una stranissima particolarità. Ilia Brusch era incontestabilmente bruno, ma solo in parte. Neri alla punta, i suoi capelli tradivano alla base, per una lunghezza di alcuni millimetri, un innegabile colore biondo. La diversità di colore era naturale? Forse, ma verosimilmente si trattava di volgare tintura, che non era stata rinnovata. E i sospetti nutriti da Karl Dragoch furono ben presto confermati. La mattina seguente, infatti, i capelli di Ilia Brusch non avevano più la doppia colorazione; il pescatore aveva evidentemente posto rimedio alla propria negligenza nel corso della notte. Gli occhi che il loro proprietario nascondeva dietro gli impenetrabili occhiali, la bugia relativa alla sosta fatta a Vienna, l'incomprensibile fretta che contrastava con lo scopo apparente del viaggio, i capelli biondi fatti diventare neri, tutto ciò costituiva un insieme di presunzioni dalle quali si doveva necessariamente concludere… Che cosa si doveva concludere? Dopo tutto, Karl Dragoch non sapeva nulla. Che la condotta di Ilia Brusch desse adito ai sospetti era troppo evidente, ma quale conclusione bisognava trarne? Un'ipotesi tuttavia, cento volte respinta, finì per imporsi nell'animo di Dragoch, che non cessava di riflettere sul problema posto alla sua sagacia. L'ipotesi era quella che il caso gli aveva suggerito già due volte. L'allegro Michael Michaelovitch prima, gli ospiti dell'albergo di Ratisbona poi, non avevano avanzato l'ipotesi tra il serio e il faceto, che sotto l'abito preso in prestito dal campione si nascondesse il capo dei malfattori che terrorizzavano la regione? Bisognava decidersi dunque a esaminare seriamente una supposizione alla quale anche coloro che l'avevano formulata non accordavano sicuramente la minima credibilità? Perché, dopo tutto? I particolari osservati fin allora non offrivano alcuna certezza, ma autorizzavano tuttavia molti sospetti. E a dire il vero, se in seguito altre osservazioni avessero confermato il sospetto più fondato, sarebbe stata una divertente avventura che lo stesso battello trasportasse, per tanti chilometri, il capo dei banditi e il poliziotto incaricato di arrestarlo. Da questo punto di vista il dramma tendeva a diventare un'opera buffa e Karl Dragoch non voleva ammettere la possibilità di una così assurda coincidenza. Ma la tecnica della farsa non è proprio quella di concentrare in uno stesso luogo e in un breve spazio di tempo i lati comici e gli imprevisti che non si notano, o che nemmeno fanno sorridere nella vita reale, proprio perché diluiti nel succedersi degli eventi? Però non è logico respingere de plano un fatto soltanto perché sembra anormale o inverosimile. Bisogna essere più umili e ammettere che le combinazioni del caso sono infinite. Sotto l'assillo di tali preoccupazioni, la mattina del 28, dopo una notte passata in piena campagna, ormeggiati ad alcuni chilometri a valle di Komorn, Karl Dragoch portò la conversazione su un argomento che fin allora non era stato mai sfiorato. — Buon giorno, signor Brusch — disse quella mattina nell'uscire dalla cabina, ove aveva preparato il piano d'attacco. — Buon giorno, signor Jaeger — rispose il pescatore, continuando a remare con energia. — Avete dormito bene? — Magnificamente. E voi? — Ma… così così. — Davvero! — si stupì Ilia Brusch. — Se vi siete sentito male, perché non mi avete chiamato? — Sto perfettamente bene, signor Brusch — rispose il signor Jaeger. — Ma ciò non ha impedito che la notte mi sembrasse lunga. Vi confesso che non mi dispiace di averne visto la fine. — Perché? — Perché non ero tranquillo, ora posso dirlo. — Non eravate tranquillo? — ripeté Ilia Brusch con tono di sincero stupore. — Non è la prima volta che non sono tranquillo — spiegò il signor Jaeger. — Non sono mai stato tranquillo da quando avete avuto la magnifica idea di trascorrere la notte lontano da città e villaggi. — Dovevate dirmelo; mi sarei comportato diversamente — disse Brusch, che sembrava cadere dalle nuvole. — Dimenticate che mi sono impegnato di lasciarvi libero di agire a modo vostro? Ogni promessa è debito, signor Brusch! Ciò non impedisce che io non mi sia sentito mai tranquillo. Che volete? Sono cittadino e mi turbano il silenzio e la solitudine della campagna. — Questione di abitudine, signor Jaeger — rispose allegramente Ilia Brusch. — Vi abituereste, se il nostro viaggio dovesse essere più lungo. In realtà, c'è meno pericolo in aperta campagna che non nel cuore di una grande città, in cui pullulano gli assassini e i vagabondi. — Probabilmente avete ragione — approvò il signor Jaeger, — ma i timori non si comandano. Del resto, i miei non sono del tutto infondati, visto che attraversiamo una regione particolarmente malfamata. — Malfamata! — esclamò Ilia Brusch. — Chi vi ha detto queste cose? Io abito qui e non ho mai sentito dire che il paese fosse malfamato! Questa volta toccò al signor Jaeger mostrare viva sorpresa. — Dite sul serio? — esclamò. — Sareste dunque il solo a non sapere ciò che tutti sanno, dalla Baviera alla Romania? — Che cosa? — chiese Ilia Brusch. — Diamine! che una banda di inafferrabili malfattori ruba e ammazza lungo le due rive del Danubio, da Presburg alla foce. — È la prima volta che ne sento parlare — disse Ilia Brusch, con accento sincero. — Possibile! — si stupì il signor Jaeger. — Non si parla d'altro da un capo all'altro del fiume. — Ogni giorno se ne impara una nuova — osservò tranquillamente Ilia Brusch. — Ed è da molto che i furti sarebbero cominciati? — Da circa diciotto mesi — rispose Jaeger. — Se almeno si trattasse soltanto di furti. Ma i malfattori non si contentano di rubare; all'occorrenza ammazzano. In questi diciotto mesi, sono stati attribuiti loro almeno dieci delitti, i cui autori sono rimasti sconosciuti. L'ultimo assassinio è stato compiuto esattamente a meno di cinquanta chilometri da qui. — Ora capisco la vostra inquietudine — disse Ilia Brusch. — Forse l'avrei anche condivisa, se fossi stato meglio informato. Da oggi in poi alla sera ci fermeremo, se possibile, nelle vicinanze di un villaggio o di una città. Cominceremo dalla sosta odierna, che faremo a Gran. — Gran è una città importante: vi staremo tranquilli — approvò il signor Jaeger. — Ne sono felice — proseguì Ilia Brusch — soprattutto perché la prossima notte conto di lasciarvi solo. — Volete assentarvi? — Soltanto per alcune ore. Da Gran, ove spero di giungere di buon'ora, vorrei fare una scappata a Szalka, che non è molto lontana, dove abito, come sapete. Del resto, sarò di ritorno prima dell'alba. La nostra partenza domattina, comunque, non subirà ritardo. — Come volete, signor Brusch — concluse il signor Jaeger. — Capisco perfettamente che abbiate voglia di fare una corsa a casa vostra. A Gran, comunque, non c'è nulla da temere. Per una mezz'ora nessuno aprì bocca; poi Karl Dragoch riprese: — È strano — disse — che non abbiate mai sentito parlare dei malfattori del Danubio. Ed è ancora più strano perché ci si è occupati di questa faccenda proprio pochi giorni dopo la gara di pesca di Sigmaringen. — A che proposito? — chiese Ilia Brusch. — A proposito della formazione di una brigata di polizia speciale, agli ordini di un capo ritenuto molto capace, un poliziotto di Budapest di nome Karl Dragoch. — Avrà un bel da fare — disse Ilia Brusch, al quale quel nome non parve fare alcuna impressione. — Il Danubio è lungo e non è facile sorvegliare gente sul conto della quale non si sa nulla. — Forse vi sbagliate — rispose il signor Jaeger. — La polizia ha già qualche informazione. Dalle testimonianze raccolte pare ci sia una descrizione somatica molto attendibile del capo della banda. — Come è fatto? — chiese Ilia Brusch. — Il suo aspetto è quello di un uomo del vostro stampo… — Grazie! — lo interruppe Ilia Brusch, ridendo. — Sarebbe press'a poco della vostra statura — proseguì il signor Jaeger — e della vostra corporatura, ma per il resto non c'è altra coincidenza con voi. — Per fortuna! — sospirò Ilia Brusch, con un'aria comicamente soddisfatta. — Sembra che abbia occhi azzurri molto belli e non porti occhiali come siete costretto a portare voi. Inoltre, mentre voi siete bruno e accuratamente sbarbato, egli ha la barba, e bionda. Su quest'ultimo punto le testimonianze raccolte sono certe, a ciò che si dice. — È un'indicazione, senza dubbio — convenne Ilia Brusch, — ma molto vaga. I biondi sono molto numerosi e se bisogna passarli tutti al setaccio… — Si sa ancora un'altra cosa. Si dice che sarebbe di nazionalità bulgara… come voi, signor Brusch! — Che volete dire? — chiese Ilia Brusch con voce turbata. — Dal vostro accento — si scusò Karl Dragoch con aria innocente — vi ho creduto di origine bulgara. Mi sono sbagliato, forse? — Non vi siete sbagliato — rispose Ilia Brusch dopo una breve esitazione. — Il capo sarebbe dunque un vostro compatriota. Il suo nome è sulla bocca di tutti. — Davvero! Allora, se si sa il suo nome… — Ma ciò non ha nulla di ufficiale, beninteso. — Ufficiale o ufficioso, quale sarebbe il nome del nostro uomo? — A torto o a ragione, i rivieraschi incolpano di tutti i misfatti sofferti un certo Ladko. — Ladko! — ripeté Ilia Brusch, che, in preda a una violenta emozione, smise bruscamente di remare. — Ladko — confermò Karl Dragoch, sorvegliando con la coda dell'occhio l'interlocutore. Ma Brusch si era già ripreso. — È strano — disse soltanto, mentre con il remo riprendeva il suo interminabile lavoro. — Che cosa vi sembra strano? — chiese Karl Dragoch. — Conoscete per caso Ladko? — Io? — protestò il pescatore. — No. Ma Ladko non è un nome bulgaro. Questo mi sembra strano. Karl Dragoch non continuò l'interrogatorio: spinto oltre, poteva essere controproducente. Era peraltro abbastanza soddisfatto. La sorpresa del pescatore nell'udire la descrizione del malfattore, il suo turbamento nell'apprenderne la probabile nazionalità, lo sconvolgimento manifestato nel conoscerne il nome, tutto ciò dava nuova e innegabile forza alle supposizioni precedenti, senza tuttavia apportare alcuna prova decisiva. Come Ilia Brusch aveva previsto, non erano ancora le due del pomeriggio quando la chiatta giunse a Gran. A cinquecento metri dalle prime case, il pescatore sbarcò sulla riva sinistra per evitare, disse, ritardi a causa della curiosità popolare, e pregò il signor Jaeger di essere così gentile di condurre la chiatta sulla riva destra e di ormeggiarla nel cuore della città. Il passeggero acconsenti volentieri. Dopo aver traghettato, Dragoch tornò ad essere poliziotto. Ormeggiata la chiatta, saltò sulla banchina per andare a cercare qualcuno dei suoi uomini. Dopo appena venti passi s'imbatté in Friedrich Ulhmann. Tra i due uomini ebbe inizio un rapido colloquio. — Tutto bene? — Tutto. — Occorre restringere il cerchio, Ulhmann. Le postazioni di due uomini a un chilometro l'una dall'altra, ormai. — Comincia a far caldo? — Precisamente. — Tanto meglio. — Domani cerca di non perdermi di vista. Credo che stia facendo caldo. — Ho capito. — E che non ci si addormenti! Nervi saldi! E che ci si muova! — Contate su di me! — Se saprai qualcosa, fai un cenno dalla riva. — D'accordo. I due interlocutori si separarono e Karl Dragoch fece ritorno alla chiatta. Se il suo riposo non fu turbato dall'inquietudine che diceva di provare solitamente, lo fu nel corso della notte dal fracasso degli elementi scatenati. A mezzanotte una tempesta iniziò a oriente e crebbe di intensità da un'ora all'altra, mentre la pioggia imperversava. Verso le cinque del mattino, quando Ilia Brusch raggiunse la chiatta, la pioggia cadeva sempre a torrenti e il vento soffiava furiosamente in direzione opposta alla corrente. Il pescatore tuttavia non esitò a partire. Mollato l'ormeggio, si spinse subito in mezzo al fiume e riprese a remare. Bisognava aver coraggio per mettersi al lavoro in quelle condizioni, dopo una notte indubbiamente faticosa. Nel corso delle prime ore del mattino, la tempesta non accennò a diminuire d'intensità. Nonostante l'aiuto della corrente, la chiatta avanzava faticosamente contro quel terribile vento; dopo quattro ore di sforzi, aveva percorso a malapena una decina di chilometri. Il confluente dell'Ipoly, sulla riva destra del quale è posta Szalka, ove Brusch diceva di essere andato la notte precedente, non poteva essere molto lontano. In quel momento, la tempesta raddoppiò di intensità, al punto da rendere la situazione effettivamente critica. Il Danubio non è il mare, ma è abbastanza ampio perché, sotto la violenza del vento, vi si formino vere e proprie onde. Quel giorno fu proprio così; nonostante la fretta, Ilia Brusch fu costretto a cercare rifugio presso la riva sinistra. Ma non doveva raggiungerla. Più di cinquanta metri lo separavano ancora da essa, quando si verificò un pauroso fenomeno. Più a monte, gli alberi che costeggiavano la riva, come tagliati da una falce gigantesca, furono divelti di netto alla base e scagliati nel fiume. L'acqua, sollevata da una forza incommensurabile, precipitò sulla riva, si sollevò poi in un'enorme ondata che rotolò all'inseguimento della chiatta. La tromba d'aria, che si era evidentemente formata negli strati dell'atmosfera, faceva scorrere sulla superficie del fiume la sua irresistibile ventosa. Ilia Brusch comprese il pericolo. Con un energico colpo di remo fece girare la barca e cercò di accostarsi alla riva destra. Non ci riuscì, ma la manovra bastò a salvare pescatore e passeggero. Raggiunta dalla meteora che continuava la sua corsa sfrenata, la chiatta riuscì a evitare la montagna d'acqua che essa sollevava al suo passare. Senza la manovra di Ilia Brusch sarebbe stata ineluttabilmente travolta. Presa nelle spire più esterne del turbine, essa fu soltanto scagliata con violenza in una curva ad ampio raggio. Sfiorata appena dall'aerea piovra, il cui tentacolo aveva questa volta mancato il bersaglio, l'imbarcazione fu quasi subito libera dalla presa. In pochi secondi la tromba era passata e l'onda si precipitava a valle ruggendo, mentre la resistenza dell'acqua neutralizzava a poco a poco la velocità acquisita dalla chiatta. Disgraziatamente non erano ancora sfuggiti a questo pericolo, che all'improvviso se ne presentò un altro. Al dritto di prora, che tagliava l'acqua con la velocità di un rapido, il pescatore improvvisamente scorse uno degli alberi strappati dalla riva, che con le radici in aria seguiva lentamente la corrente. Scagliata nel groviglio di quelle radici, l'imbarcazione si sarebbe senz'altro capovolta o gravemente danneggiata. Ilia Brusch lanciò un grido di spavento nel vedere quell'ostacolo imprevisto. Anche Karl Dragoch si era accorto dell'imminenza del pericolo. Senza esitazione si precipitò a prua, con le mani afferrò le radici che uscivano dall'acqua e, arcuandosi sulle reni per meglio opporsi alla spinta della barca, con tutta la sua forza cercò di allontanarla dalla direzione pericolosa. Vi riuscì; la chiatta, deviata dalla sua rotta, sfrecciò in avanti sfiorando le radici, e poi la testa dell'albero coperta di foglie. Ancora un istante, ed essa si sarebbe lasciata dietro il verde relitto mollemente trascinato via dalla corrente, allorché Karl Dragoch fu colpito in pieno petto da uno degli ultimi rami. Cercò inutilmente di resistere all'urto. Perduto l'equilibrio, cadde al di fuori della chiatta e scomparve sott'acqua. Alla prima caduta ne seguì immediatamente un'altra, voluta. Nel vedere il passeggero cadere in acqua, Ilia Brusch si era buttato in suo aiuto senza un attimo di esitazione. Ma non era facile scorgere qualcosa nelle acque limacciose e agitate dalla furiosa tempesta. Per circa un minuto, Ilia Brusch si sfiancò inutilmente; già cominciava a disperare di riuscire a scorgere il signor Jaeger, quando alla fine riuscì ad afferrare il disgraziato, che galleggiava svenuto. Da una parte, meglio così. L'uomo che sta annegando di solito si dibatte e accresce così, involontariamente, la difficoltà del suo salvataggio. L'uomo svenuto è, invece, un corpo inerte la cui salvezza dipende soltanto dall'abilità del suo salvatore. Ilia Brusch per prima cosa sollevò fuori dell'acqua il capo del signor Jaeger; poi, con colpi vigorosi, nuotò verso la chiatta che nel frattempo si era allontanata di una trentina di metri. La raggiunse in poche bracciate, che parvero un gioco per il robusto nuotatore, ne afferrò l'orlo con una mano, mentre con l'altra sosteneva il passeggero ancora svenuto. Ora bisognava issare il signor Jaeger fin sulla chiatta e ciò non era facile. Tuttavia, dopo molti sforzi, Ilia Brusch vi riuscì. Appena deposto il passeggero su una cuccetta della tuga, egli lo spogliò e dopo aver preso da una cassa qualche indumento di lana, cominciò a massaggiarlo energicamente. Il signor Jaeger non tardò ad aprire gli occhi e a riprendere i sensi. L'immersione non era stata lunga e c'era da sperare che non avesse spiacevoli conseguenze. — Signor Jaeger! — disse Ilia Brusch, non appena vide che il passeggero riprendeva conoscenza, — ve ne intendete, voi, di tuffi! Il signor Jaeger sorrise senza dir nulla. — Non accadrà nulla — proseguì Ilia Brusch continuando a massaggiarlo energicamente. — Non c'è niente di meglio per la salute di un bagno nel mese di agosto! — Grazie, signor Brusch — balbettò Karl Dragoch. — Non c'è proprio da ringraziare — rispose allegramente il pescatore. — Son io che debbo ringraziarvi, signor Jaeger, perché mi avete dato l'occasione di fare un eccellente bagno. A Karl Dragoch le forze facevano ritorno a vista d'occhio. Un buon sorso d'acquavite e tutto sarebbe stato a posto. Più emozionato di quanto non volesse apparire, Ilia Brusch mise inutilmente sottosopra le sue casse: la provvista di alcool era purtroppo esaurita; non ne era rimasta neppure una goccia. — Ecco una cosa spiacevole! — esclamò Ilia Brusch. — Nella nostra cambusa non c'è più una sola goccia di acquavite! — Non importa, signor Brusch — disse Karl Dragoch, con voce debole. — Ne posso fare a meno, vi assicuro. Karl Jaeger, a dispetto delle sue assicurazioni, batteva i denti per il freddo; un cordiale gli avrebbe certamente fatto bene. — Vi sbagliate — rispose Ilia Brusch, il quale non si faceva illusioni sulle condizioni del passeggero — non ne farete a meno, signor Jaeger. Lasciatemi fare; non sarà una faccenda lunga. In un attimo, il pescatore si tolse gli abiti bagnati e ne indossò altri asciutti; alcuni colpi di remo portarono poi la chiatta sulla riva sinistra, dove fu solidamente ormeggiata. — Abbiate un po' di pazienza, signor Jaeger — disse Ilia Brusch, saltando a terra. — Conosco il paese: siamo alla confluenza con l'Ipoly. A meno di mille e cinquecento metri c'è un villaggio, dove troverò ciò che occorre. Tra mezz'ora sarò di ritorno. Ciò detto, Ilia Brusch si allontanò senza attendere risposta. Quando fu solo, Karl Dragoch si lasciò ricadere sulla cuccetta. Stava più male di quanto non volesse confessare e, per un istante, chiuse gli occhi: era stanco. Ma la vita riprendeva rapidamente il sopravvento, il sangue gli pulsava nelle arterie. Presto riapri gli occhi e volse in giro lo sguardo, di minuto in minuto più fermo. La prima cosa che attrasse il suo sguardo ancora incerto fu la cassa che Ilia Brusch, per premura, non aveva richiuso. Tutto per aria per la ricerca infruttuosa del pescatore, l'interno della cassa offriva alla vista un ammasso di oggetti disparati. Abiti grossolani, biancheria da poco prezzo e scarpe robuste vi erano ammucchiati disordinatamente. Perché gli occhi di Karl Dragoch improvvisamente cominciarono a brillare? Quello spettacolo così poco interessante lo attirava dunque tanto da spingerlo a sollevarsi sul gomito, per guardare più comodamente dentro la cassa spalancata? Non erano certamente né gli abiti né la biancheria che potevano suscitare la curiosità dell'indiscreto passeggero: tra i capi di abbigliamento l'occhio esperto del poliziotto aveva scoperto un oggetto meritevole di attrarre la sua attenzione. Si trattava di un portafoglio gonfio, dal quale uscivano alcune carte. Un portafoglio! Documenti! E cioè un'indubbia risposta alle domande che Karl Dragoch poneva a se stesso da alcuni giorni. Il poliziotto non riuscì a controllarsi. Dopo una breve esitazione, conscio di venir meno alle leggi dell'ospitalità, allungò la mano e tirò fuori dalla cassa il portafoglio tentatore con il suo contenuto, e cominciò subito l'inventario. Karl Dragoch non perse tempo a leggere le lettere, che erano indirizzate al signor Ilia Brusch, a Szalka; esaminò le ricevute, tra le quali c'era quella dell'affitto, a lui intestata. Nulla d'interessante, dunque, in quei documenti. Karl Dragoch avrebbe forse rinunciato a proseguire le sue ricerche se un ultimo foglio non lo avesse fatto trasalire. Apparentemente era innocentissimo; soltanto un poliziotto poteva non provare alla vista di quel foglio un'emozione che non fosse di simpatica ammirazione. Era il ritratto di una giovane donna, la cui perfetta bellezza avrebbe entusiasmato un pittore. Ma il poliziotto non è un artista; il cuore di Karl Dragoch non batté perciò di ammirazione per quel bellissimo viso, al quale aveva dato appena un'occhiata. A dire il vero, aveva visto soltanto un rigo in lingua bulgara, tracciato sotto la fotografia: «Al mio caro marito, Natcha Ladko». Questo, Karl Dragoch lesse. I suoi sospetti, dunque, erano giustificati e logiche erano le sue deduzioni basate sulle stranezze notate! Era proprio con Ladko che egli discendeva il Danubio, da tanti giorni. Era proprio quel pericoloso malfattore, inutilmente ricercato fin allora, che si nascondeva sotto l'innocua personalità del campione della Lega Danubiana! Quale sarebbe stata la condotta di Karl Dragoch dopo tale constatazione? Non aveva ancora preso una decisione quando un rumore di passi sulla riva gli fece buttare il portafoglio in fondo alla cassa, della quale richiuse il coperchio. Il nuovo venuto non poteva essere Ilia Brusch, il quale era partito da non più di dieci minuti. — Signor Dragoch! — chiamò una voce dalla riva. — Ulhmann! — mormorò Dragoch. Riuscì con fatica a mettersi in piedi e uscì barcollando dalla cabina. — Scusatemi se vi ho chiamato — disse Ulhmann, non appena ebbe visto il capo. — Ho visto il vostro compagno che poco fa si allontanava e sapevo che eravate solo. — Che cosa c'è? — chiese Karl Dragoch. — Novità. Questa notte è stato commesso un delitto. — Questa notte! — esclamò Karl Dragoch, pensando subito che Ilia Brusch aveva trascorso la notte precedente lontano dalla chiatta. — È stata saccheggiata una villa nelle vicinanze e il guardiano è stato colpito. — È morto? — No; è gravemente ferito. — Bene — disse Karl Dragoch, imponendo con un cenno il silenzio al suo subordinato. Rifletteva. Che cosa bisognava fare? Agire, certamente, e per farlo la forza non gli sarebbe venuta meno: la notizia allora appresa era la medicina migliore. Non rimaneva in lui alcuna traccia dell'accidente di cui era stato vittima; ora non aveva più bisogno di sorreggersi al tramezzo della cabina. Sotto la frustata dei nervi, il sangue gli tornava a fiotti sul viso. Bisognava agire, ma come? Doveva attendere il ritorno di Ilia Brusch, o meglio di Ladko, poiché questo era il suo vero nome, e in nome della legge mettergli di colpo la mano sulla spalla? Forse era la cosa più saggia da fare, poiché ormai non poteva esistere alcun dubbio sulla colpevolezza del sedicente pescatore. La cura con la quale dissimulava la sua vera personalità, il mistero del quale si circondava, quel suo nome che era anche quello di colui che la voce pubblica indicava quale capo dei banditi, la sua assenza dell'ultima notte che coincideva con la scoperta del nuovo delitto, tutto diceva a Karl Dragoch che Brusch era proprio il bandito ricercato. Quel bandito però gli aveva salvato la vita e ciò complicava stranamente la situazione! Possibile che un ladro, anzi un assassino, si fosse gettato nel fiume per salvarlo? E anche se questa cosa incredibile fosse stata vera, era possibile, a colui che era stato strappato alla morte, ricompensare in quel modo il sacrificio di colui che lo aveva salvato? Quale rischio si correva, del resto, a non arrestarlo? Ora che il falso Ilia Brusch era stato smascherato e che la sua identità era nota, gli sarebbe stato impossibile sfuggire alla polizia disseminata lungo il fiume; e nel caso in cui l'inchiesta fosse arrivata al sedicente pescatore, egli avrebbe avuto a sua disposizione un maggior numero di persone che ne avrebbero facilitato e assicurato l'arresto. Nel corso di cinque minuti, Karl Dragoch esaminò sotto ogni aspetto il suo caso di coscienza. Andarsene senza rivedere Ilia Brusch? Oppure rimanere, nascondere Ulhmann nella cabina e all'apparire del pescatore saltargli addosso, rimandando a dopo ogni spiegazione? No, assolutamente no. Rispondere con il tradimento a un atto di abnegazione? No, il cuore gli si ribellava. A rischio di lasciare al colpevole una possibilità di salvezza, sarebbe stato meglio cominciare l'inchiesta, dimenticando temporaneamente ciò che credeva di sapere. Se l'inchiesta lo avesse condotto a Ilia Brusch, se il suo dovere lo avesse costretto a trattare da nemico colui che gli aveva salvato la vita, avrebbe allora combattuto a viso aperto, dopo avergli dato il tempo di mettersi sulla difensiva. Accettando con un gesto le conseguenze della sua decisione, Karl Dragoch rientrò nella cabina: sapeva che cosa fare. Con poche parole poste in evidenza, avvertì Ilia Brusch che aveva necessità di allontanarsi, e lo pregò di aspettarlo almeno ventiquattr'ore. Poi si preparò a partire. — Quanti uomini abbiamo? — chiese uscendo dalla cabina. — Ne abbiamo due sul posto, ma stiamo per chiamare tutti a raccolta. Ne avremo una decina prima di sera. — Bene — approvò Karl Dragoch. — Mi hai detto che il luogo del delitto non è lontano? — Circa due chilometri — rispose Ulhmann. — Guidami — disse Karl Dragoch, saltando sulla riva. CAPITOLO IX I DUE SCACCHI DI DRAGOCH I CARPAZI descrivono nella parte settentrionale dell'Ungheria un immenso arco la cui estremità occidentale si divide in due rami secondari, uno dei quali va a morire al Danubio, all'altezza di Presburg, mentre l'altro raggiunge il fiume nei dintorni di Gran, per proseguire sulla riva destra con i settecentosessantasei metri del monte Pilis. Ai piedi di questa bassa montagna era stato commesso un crimine e lì Karl Dragoch si sarebbe trovato per la prima volta alle prese con i pericolosi malfattori che aveva il compito di perseguire. Alcune ore prima quando, lasciata la compagnia del suo ospite, nonostante la debolezza, faceva violenza a se stesso per seguire Ulhmann, una carretta sovraccarica si era fermata dinanzi a una misera locanda costruita ai piedi di una di quelle colline che sono la ramificazione del monte Pilis nella valle del Danubio. La posizione della locanda era economicamente ottima. Si trovava all'incrocio di tre strade che conducevano al Danubio; quella a nord, alla curva che il fiume descrive dinanzi al monte Pilis; quella a sud-est, al borgo di Sant'Andrea; e quella a nord-ovest, alla città di Gran. L'alberghetto, così situato tra i rami di un ampio compasso liquido, traeva profitto dal traffico stradale che si aggiungeva a quello fluviale. Il Danubio, che uscendo da Gran scorre sensibilmente da ovest a est, piega verso sud a qualche distanza dalla confluenza con l'Ipoly, poi, dopo aver disegnato una breve semi-circonferenza, risale in direzione del settentrione. Ma quasi subito ritorna su se stesso e prende la direzione nordsud, verso valle e non l'abbandonerà più, per moltissimi chilometri. Nel momento in cui il veicolo si fermava, il sole cominciava ad alzarsi. Nella casa, dalle grosse imposte ermeticamente chiuse, tutti dormivano ancora. — A voi dell'albergo!… — chiamò, battendo alla porta con il manico della frusta, uno dei due uomini che conducevano la carretta. — Vengo! — rispose dall'interno il locandiere, svegliato di soprassalto. Un istante dopo, una testa arruffata appariva da una finestra del primo piano. — Che volete? — chiese l'albergatore con voce astiosa. — Prima mangiare, poi dormire — disse il carrettiere. — Vengo — ripeté il locandiere, sparendo nell'interno. Quando dal portone spalancato la carretta penetrò nel cortile, i suoi conducenti si affrettarono a staccare i due cavalli e a condurli nella scuderia, dove fu distribuito loro da mangiare abbondantemente. L'albergatore intanto continuava a girare intorno a quei due clienti mattinieri con l'evidente voglia di chiacchierare, ma i carrettieri non ne avevano alcuna intenzione. — Giungete di buon mattino, amici — disse l'albergatore. — Avete viaggiato tutta la notte? — Sembra — disse uno dei due. — Andate lontano? — Lontano o vicino, è una faccenda che riguarda solo noi — gli fu risposto. L'albergatore tacque. — Perché maltratti questo brav'uomo, Vogel? — intervenne l'altro carrettiere, il quale non aveva ancora aperto bocca. — Non abbiamo motivo di nascondere che andiamo a Sant'Andrea. — Non abbiamo nessun motivo di nasconderlo — rispose Vogel con tono burbero — ma ciò non riguarda nessuno. — Sicuramente — approvò l'albergatore, adulatore come ogni buon commerciante. — Lo chiedevo così, per dire qualcosa. I signori vogliono mangiare? — Sì — rispose il più gentile dei due carrettieri. — Pane, lardo, prosciutto, salsicce, ciò che avrai. La carretta doveva aver percorso un lungo cammino, perché i due conducenti fecero molto onore al pasto. Erano anche stanchi e quindi non si attardarono a tavola. Dopo l'ultimo boccone, si affrettarono ad andare a dormire, l'uno sulla paglia della scuderia accanto ai cavalli, l'altro sotto il telone della carretta. Sonava mezzogiorno quando riapparvero per reclamare subito un altro pasto che fu loro servito, come il precedente, nella grande sala della locanda. Riposati, mangiavano senza fretta. Alla frutta, i bicchieri di acquavite si susseguirono numerosi, come se fossero d'acqua. Nel corso del pomeriggio numerose vetture si fermarono alla locanda e molti avventori entrarono per bere un bicchiere. Erano quasi tutti contadini che, con la bisaccia sulle spalle e il bastone in mano, si recavano a Gran o ne tornavano. Erano clienti dell'albergatore che, ben soddisfatto di avere la testa sulle spalle, come richiedeva la sua professione, trincava a turno con tutti i clienti. Così gli affari prosperano: bevendo, si chiacchiera, chiacchierare secca la gola, e si beve di nuovo. Quel giorno la conversazione non mancava di argomenti. Il delitto commesso durante la notte metteva i cervelli in subbuglio. La notizia era stata portata dai primi passanti, ciascuno dei quali raccontava un particolare inedito o riferiva un parere personale. L'albergatore apprese così, un po' alla volta, che la magnifica villa del conte Hagueneau, a cinquecento metri dalla riva del Danubio, era stata completamente svaligiata e che il guardiano Christian era gravemente ferito; che quel crimine era senza dubbio opera dell'inafferrabile banda di malfattori alla quale erano attribuiti tanti altri delitti impuniti; che la polizia perlustrava la campagna e che i criminali erano ricercati dalla squadra recentemente creata per la sorveglianza del fiume. I due carrettieri non si univano alle chiacchiere che erano accompagnate da esclamazioni e da grida. Essi si tenevano silenziosi in disparte, ma senza dubbio non perdevano parola di ciò che si diceva intorno a loro, non potendo non interessarsi a ciò che appassionava tutti. Il chiasso a poco a poco si calmò; verso le sei e mezzo della sera, essi rimasero nuovamente soli nella grande sala, dalla quale l'ultimo avventore si era allora allontanato. Uno dei due chiamò il locandiere che stava risciacquando i bicchieri e che si affrettò ad accorrere. — Che cosa desiderano i signori? — chiese l'oste. — Cenare — rispose un carrettiere. — E anche dormire, dopo, non è vero? — interrogò l'albergatore. — No — rispose il più socievole dei due carrettieri. — Contiamo di ripartire questa notte. — Di notte? — si stupì l'albergatore. — Allo scopo — proseguì il cliente — di essere all'alba sulla piazza del mercato. — Di Sant'Andrea? — O di Gran. Dipenderà dalle circostanze. Aspettiamo qui un amico che è andato a prendere informazioni e che ci dirà dove avremo maggiore possibilità di vendere bene la nostra merce. L'albergatore lasciò la sala per occuparsi dei preparativi del pasto. — Hai sentito, Kaiserlick? — disse a bassa voce il carrettiere più giovane, piegandosi verso il compagno. — Sì. — Il colpo è stato scoperto. — Speravi forse che non lo sarebbe stato? — La polizia batte la campagna. — La batta pure. — Sotto la guida di Dragoch, si dice. — Questa è un'altra faccenda, Vogel. Secondo me, coloro che debbono temere soltanto Dragoch possono dormire tra due guanciali. — Che cosa vuoi dire? — Ciò che ho detto, Vogel. — Dragoch sarebbe dunque?… — Che cosa? — Soppresso? — Lo saprai domani. Fin allora, acqua in bocca — concluse il carrettiere vedendo tornare l'albergatore. La persona attesa dai due carrettieri giunse a notte fatta. Un rapido colloquio ebbe allora inizio fra i tre compagni. — Si dice che la polizia sia sulla pista — disse a bassa voce Kaiserlick. — Cerca, ma non trova. — E Dragoch? — Reso inoffensivo. — Chi si è incaricato dell'operazione? — Titcha. — Allora, c'è del buono… E noi, che cosa dobbiamo fare? — Attaccare i cavalli senza perdere tempo. — Per… — Per Sant'Andrea, ma a cinquecento metri da qui tornerete indietro. La locanda allora sarà chiusa e, ripassando da qui, nessuno vi vedrà. Prenderete la strada del nord. Mentre vi crederanno da una parte, voi sarete dall'altra. — Dov'è la chiatta, dunque? — Nell'ansa di Pilis. — È lì l'appuntamento? — No, un po' più vicino, nella radura, a sinistra della strada. La conosci? — Sì. — Vi si trovano già una quindicina dei nostri. Andrai a raggiungerli. — E tu? — Io torno indietro per raccogliere il resto dei nostri uomini, lasciati di sorveglianza. Li porterò con me. — Su, muoviamoci — dissero i due carrettieri. Cinque minuti dopo la carretta si metteva in movimento. L'oste salutò cortesemente i clienti, mentre teneva aperto un battente del portone. — Allora, è a Gran che volete andare? — chiese. — No — risposero i carrettieri — andiamo a Sant'Andrea, amico. — Buon viaggio, ragazzi! — disse l'oste. — Grazie, amico! La carretta girò a destra e prese la strada di Sant'Andrea. Quando sparì nel buio della notte, l'uomo che Kaiserlick e Vogel avevano atteso tutto il giorno, si allontanò a sua volta in direzione di Gran. L'albergatore non se ne accorse. Senza più occuparsi di quei clienti, che probabilmente non avrebbe più rivisti, si affrettò a chiudere il portone e ad andare a dormire. Dopo cinquecento metri la carretta, che nel frattempo si era allontanata al passo tranquillo dei suoi cavalli, si rigirò e seguì in senso inverso la strada già percorsa. Quando fu nuovamente all'altezza dell'albergo, ora chiuso, avrebbe proseguito senza incidenti se un cane che dormiva in mezzo alla carreggiata non fosse scappato di corsa, abbaiando così forte che il cavallo di testa, spaventato, scartò da una parte della strada. I carrettieri fecero presto a rimettere l'animale nella giusta direzione e, per la seconda volta, la carretta scomparve nel buio della notte. Erano le dieci e mezzo circa quando, abbandonando la strada, essa penetrò in un boschetto, la cui massa scura s'innalzava sulla sinistra. Fu fermata immediatamente. — Chi va là? — chiese una voce. — Kaiserlick e Vogel — risposero i carrettieri. — Passate — disse la voce. Dopo i primi alberi la carretta sboccò in una radura, ove una quindicina di uomini dormivano distesi sul musco. — C'è il capo? — chiese Kaiserlick. — Non ancora. — Ci ha detto di aspettarlo qui. L'attesa non fu lunga. Dopo una mezz'ora, il capo, e cioè la persona che era venuta all'albergo sul tardi, giunse a sua volta accompagnato da una decina di compagni. Ora la compagnia contava più di venticinque uomini. — Ci siamo tutti? — chiese. — Sì — rispose Kaiserlick, che sembrava avere una qualche autorità. — E Titcha? — Eccomi — disse una voce sonora. — Ebbene? — chiese con ansia il capo. — Vittoria su tutta la linea. L'uccello è in gabbia sulla chiatta. — In tal caso, andiamo e cerchiamo di far presto — ordinò il capo. — Sei uomini vadano avanti ed esplorino la strada; il resto starà di retroguardia. La carretta in mezzo. Il Danubio è a cinquecento metri da qui e lo scarico sarà fatto in pochissimo tempo. Vogel condurrà allora la carretta e quelli del paese torneranno tranquillamente a casa. Gli altri prenderanno posto sulla chiatta. I suoi ordini stavano per essere eseguiti, quando un uomo che aveva il compito di sorvegliare la strada accorse in fretta. — Allarme! — disse soffocando la voce. — Che cosa c'è? — chiese il capo. — Ascolta. Tutti tesero l'orecchio e udirono il passo di truppe che marciavano sulla strada. A quel passo si unirono presto alcune voci lontane. La distanza dalla quale provenivano suoni e rumori era di un centinaio di tese. — Restiamo qui — ordinò il capo. — Quella gente passerà senza vederci. Protetti dalla profonda oscurità, certamente non sarebbero stati visti, ma c'era una possibilità preoccupante: che poteva essere una squadra di poliziotti diretta verso il fiume. Poteva anche non scoprire il battello; e se anche lo avesse visto, avrebbe potuto perquisirlo da cima a fondo senza trovarvi nulla di sospetto. Tuttavia, anche ammettendo che quella squadra non arrivasse a sospettare l'esistenza della chiatta, però poteva ugualmente rimanere appostata nelle vicinanze: in tal caso, non sarebbe stato prudente fare uscire la carretta. Si sarebbe agito, ad ogni buon conto, secondo le circostanze. Dopo aver atteso, se necessario, tutto il giorno successivo, alcuni uomini sarebbero discesi durante la notte fino al Danubio per assicurarsi che la polizia non c'era. Era necessario per il momento non essere visti e che nulla mettesse in allarme gli uomini che si avvicinavano e che non tardarono a raggiungere il punto in cui la strada costeggiava la radura. Nonostante l'oscurità, fu possibile vedere che la squadra era costituita da una decina di uomini, chiaramente armati, lo denunciava un rumore d'acciaio. Avevano già oltrepassato la radura, allorché un incidente fece cambiare totalmente le cose. Spaventato dal passaggio di quegli uomini, un cavallo sbuffò e lanciò un lungo nitrito, ripetuto subito dall'altro. La truppa si fermò di colpo. Era una squadra di poliziotti che scendeva verso il fiume al comando di Karl Dragoch, completamente rimesso dall'incidente del mattino. Se le persone nella radura lo avessero saputo, forse la loro inquietudine sarebbe aumentata. Ma come abbiamo visto, il loro capo riteneva che il temuto poliziotto fosse fuori combattimento. Perché era caduto in quell'errore e perché contava di non dover più affrontare un avversario che gli era invece vicinissimo, è ciò che il seguito del racconto non tarderà a far capire al lettore. La mattina di quello stesso giorno, Karl Dragoch era saltato sulla riva, dove lo attendeva Ulhmann, quest'ultimo lo aveva condotto con sé. Dopo due o trecento metri, i due poliziotti avevano raggiunto un canotto nascosto tra l'erba alta della riva, e vi erano saliti. Ulhmann, remando vigorosamente, aveva portato in breve la leggera imbarcazione sull'altra riva del fiume. — È su questa riva, dunque, che il crimine è stato commesso? — chiese allora Karl Dragoch. — Sì — rispose Friedrich Ulhmann. — Da che parte? — Nei dintorni di Gran. — Nei dintorni di Gran! — esclamò Dragoch. — Non mi dicevi poco fa che c'era poca strada da fare? — Non è lontano — disse Ulhmann. — Ci saranno tre chilometri, da qui. Ce n'erano quattro, a dire il vero, e quella lunga tappa non poté essere percorsa senza difficoltà da un uomo che era appena sfuggito alla morte. Più volte Karl Dragoch fu costretto a riposarsi per riprendere fiato. Erano quasi le tre del pomeriggio quando raggiunse, alla fine, la villa del conte Hagueneau, dove lo chiamavano le sue funzioni. Non appena si fu ripreso, anche per merito di un cordiale che si affrettò a chiedere, prima cura di Dragoch fu quella di farsi condurre al capezzale del guardiano Christian Hoël. Medicato alcune ore prima da un chirurgo dei dintorni, il ferito, pallido e con gli occhi chiusi, ansava penosamente. Benché la sua ferita fosse molto grave, esistevano tuttavia buone speranze di salvarlo, a condizione però che gli fosse risparmiata qualsiasi fatica. Karl Dragoch riuscì a ottenere alcune informazioni, che il guardiano gli diede a monosillabi, con voce soffocata. Con molta pazienza, egli apprese così che una banda di malfattori, composta da cinque o sei uomini, a dir poco, nel corso della notte precedente aveva fatto irruzione nella villa, dopo aver sfondato la porta. Svegliato dal rumore, il guardiano aveva avuto appena il tempo di alzarsi, perché subito colpito da una pugnalata tra le spalle. Ignorava quindi che cosa fosse accaduto in seguito, e non era nella possibilità di dare indicazioni sui suoi aggressori. Sapeva tuttavia che il loro capo era un certo Ladko, poiché i suoi compagni ne avevano pronunciato più volte sfacciatamente il nome. Aveva il viso mascherato, ma era un giovane alto, dagli occhi azzurri e con un'abbondante barba bionda. Quest'ultimo particolare, che invalidava i sospetti che aveva avuto sul conto di Ilia Brusch, non mancò di turbare Karl Dragoch. Che Ilia Brusch fosse biondo, egli non ne dubitava affatto; ma il biondo era stato tinto in nero e nessuno può eliminare la tintura alla sera per rimetterla il giorno dopo, come se fosse una parrucca. Su quella grave difficoltà, Karl Dragoch si riservò di indagare a tempo debito. Il guardiano non poté fornirgli, del resto, altri particolari; riguardo agli altri aggressori, non aveva notato nulla di speciale; come il loro capo, avevano avuto la precauzione di mascherarsi. Ottenute quelle informazioni, il poliziotto fece altre domande intorno alla villa del conte; seppe così che l'abitazione era ammobiliata con magnificenza principesca. Gioielli, argenteria e oggetti preziosi abbondavano nei cassetti; gli oggetti d'arte sulle mensole dei camini e sui mobili; arazzi e quadri di grandi maestri alle pareti. Titoli erano stati lasciati nella cassaforte del primo piano. Nessun dubbio, quindi, che gli invasori avessero fatto un preziosissimo bottino. La qualcosa Karl Dragoch poté agevolmente constatare percorrendo le varie stanze della villa. Era stato un saccheggio in perfetta regola, compiuto con metodo. Da buoni intenditori, i ladri avevano scartato ciò che non aveva valore: erano scomparsi soprattutto gli oggetti preziosi. Al posto degli arazzi apparivano le pareti nude; private delle tele più belle tagliate con arte, pendevano le cornici vuote. I saccheggiatori avevano portato via le tende più sfarzose, e persino i tappeti più belli. La cassaforte era stata forzata e il suo contenuto scomparso. «Tutta questa roba non può essere stata portata via a spalla», disse Dragoch tra sé. «Ce n'era tanta da caricare una vettura. Non ci resta che scovarla». L'interrogatorio e le prime ricerche avevano richiesto molto tempo; la notte si avvicinava. Prima che fosse buio, occorreva trovare la traccia, se possibile, del veicolo del quale i ladri, a parere del poliziotto, avevano dovuto fare necessariamente uso. Dragoch si affrettò quindi a uscire. Non ebbe bisogno di andare lontano per avere la prova che cercava. Sul terreno del vasto cortile della villa, larghe ruote avevano lasciato impronte profonde proprio dinanzi alla porta fracassata; a poca distanza, la terra era calpestata, come se alcuni cavalli avessero atteso a lungo. Fatte tali constatazioni con un colpo d'occhio, Karl Dragoch si accostò al luogo in cui sembrava che i cavalli avessero sostato. Esaminò il suolo con attenzione, poi attraversò il cortile e si avvicinò al cancello che dava sulla strada, dove fece un altro minuzioso esame, alla fine del quale seguì la strada per un centinaio di metri. Rientrato nel cortile, chiamò Ulhmann. — Signore? — rispose l'agente, avvicinandosi. — Quanti uomini abbiamo? — Undici. — Sono pochi. — Ma il guardiano dice che gli aggressori erano cinque o sei — disse Ulhmann. — Il guardiano ha la sua opinione, io ho la mia — rispose Dragoch. — Comunque, bisogna accontentarsi di quelli che abbiamo. Lascerai un uomo qui e prenderai gli altri dieci. Con noi due, saremo dodici. È già qualcosa. — Avete qualche indizio? — chiese Ulhmann. — So dove sono i ladri… o meglio, da che parte sono. — Potrei chiedervi… — cominciò Ulhmann. — Da dove provenga la mia certezza? — terminò la frase Dragoch. — Nulla di più semplice. È roba da ragazzi. Per prima cosa ho detto a me stesso che avevano portato via troppe cose per non aver bisogno di qualche mezzo di trasporto. Ho cercato il veicolo e l'ho trovato. È una carretta a quattro ruote tirata da due cavalli, e a quello di testa manca un chiodo dallo zoccolo anteriore destro. — Come fate a saperlo? — chiese Ulhmann, stupito. — Perché la notte scorsa è piovuto e la terra umida ha conservato perfettamente le impronte. Ho anche saputo nello stesso modo che la carretta, nel lasciare la villa, è girata a sinistra, e cioè in direzione opposta a quella di Gran. Noi andremo dalla stessa parte e seguiremo all'occorrenza la pista del cavallo al quale manca il chiodo. Non sembra che questi malfattori abbiano viaggiato durante il giorno. Si saranno cacciati senza dubbio da qualche parte, in attesa della sera. La regione è poco abitata e le case non sono numerose. Se necessario, frugheremo quelle che incontreremo lungo la strada. Raccogli gli uomini: la notte si avvicina e la selvaggina deve cominciare a prendere aria. Karl Dragoch e la sua squadra dovettero camminare a lungo prima di scoprire un altro indizio. Erano quasi le dieci e mezzo quando, dopo aver frugato inutilmente due o tre fattorie, giunsero, all'incrocio delle tre strade, alla locanda in cui i due carrettieri avevano trascorso la giornata, e dalla quale erano partiti tre quarti d'ora prima. Karl Dragoch batté con forza alla porta. — In nome della legge! — disse Dragoch quando vide l'albergatore apparire dalla finestra. Era scritto che quel giorno il suo sonno sarebbe stato disturbato. — In nome della legge! — ripeté l'albergatore, spaventato nel vedere la sua locanda circondata dai poliziotti. — Che cosa ho fatto? — Vieni giù e te lo diremo. Fai presto, soprattutto — rispose Dragoch con impazienza. Quando l'albergatore mezzo vestito ebbe aperto la porta, il poliziotto procedette a un rapido interrogatorio. Quella mattina era venuta una carretta? Quante persone erano alla sua guida? Si era fermata? Era ripartita? Da che parte si era diretta? Le risposte non si fecero attendere. Una carretta condotta da due uomini era venuta all'albergo di buon mattino. Vi era rimasta fino a sera e ne era ripartita dopo l'arrivo di una terza persona, attesa dai due carrettieri. Si era allontanata dopo le nove e mezzo, in direzione di Sant'Andrea. — Di Sant'Andrea? Ne sei sicuro? — insistette Karl Dragoch. — Ne sono sicuro — disse l'albergatore. — Ti è stato detto, oppure lo hai visto? — L'ho visto. — Uhm!… — mormorò Dragoch. — Torna a coricarti, ora, e non parlare di noi ad altri. L'albergatore non se lo fece dire due volte. La porta si chiuse e i poliziotti rimasero nuovamente soli sulla strada. — Un momento! — ordinò Dragoch ai suoi uomini, mentre alla luce di una pila esaminava minuziosamente il suolo. In principio non rilevò nulla di sospetto, ma quando, attraversata la strada, raggiunse la carreggiata laterale, che meno battuta e meno asciutta, aveva conservato maggiore plasticità, alla prima occhiata Dragoch scoprì l'impronta dello zoccolo senza un chiodo e constatò che quel cavallo non andava verso Sant'Andrea e neppure verso Gran, ma direttamente verso il fiume, per la strada del nord. Su tale strada procedettero, a loro volta, Dragoch e i suoi uomini. Dopo circa tre chilometri, percorsi senza incidenti attraverso una contrada completamente deserta, a sinistra della strada risonò il nitrito di un cavallo. Fermati i suoi uomini con un gesto, Dragoch andò sino al margine di un boschetto che appena si indovinava nel buio. — Chi è là? — gridò. Poiché non ebbe risposta, ordinò a un agente di accendere una torcia di resina. La fiamma fuligginosa brillò nella notte illune, ma il suo chiarore cessò dopo pochi passi e non riuscì a fendere l'oscurità, resa più cupa dal fogliame degli alberi. — Avanti! — ordinò Dragoch penetrando nel folto alla testa dei suoi uomini. Ma il boschetto era difeso: ne avevano appena superato il limite, quando una voce imperiosa intimò: — Ancora un passo e sparo! La minaccia non fermò Dragoch, anche perché alla vaga luce della torcia gli era parso di vedere confusamente una carretta, intorno alla quale c'era un numero imprecisato di uomini. — Avanti! — ordinò nuovamente. A quest'ordine, i poliziotti ripresero ad avanzare con molta incertezza nel folto del boschetto sconosciuto, ma le difficoltà non tardarono ad aggravarsi. La torcia fu strappata di colpo dalle mani del poliziotto che la reggeva e l'oscurità tornò ad essere completa. — Maldestro! — lo rimproverò Dragoch. — Fa' luce, Franz! Luce! La sua rabbia era accresciuta dal fatto che all'ultimo chiarore della torcia aveva intravisto la carretta che si allontanava sotto gli alberi. Non c'era alcuna possibilità di inseguirla, purtroppo. E una muraglia vivente si parava davanti ai poliziotti: ciascuno di loro doveva lottare contro due o tre avversari. Dragoch inoltre si rese conto che non aveva abbastanza uomini per assicurarsi la vittoria. Fino a quel momento non era stato sparato alcun colpo di arma da fuoco, né da una parte né dall'altra. — Titcha! — chiamò in quell'istante una voce nel buio della notte. — Presente! — rispose un'altra voce. — La vettura? — Partita! — Allora è meglio finirla! Dragoch registrò quelle voci nella sua memoria. Non le avrebbe più dimenticate. Subito dopo quel breve dialogo, le rivoltelle fecero risonare la campagna delle loro secche detonazioni. Alcuni agenti furono raggiunti dai proiettili e allora Dragoch, rendendosi conto che sarebbe stata follia insistere, decise di ordinare la ritirata. I poliziotti tornarono sulla strada, senza che i vincitori osassero inseguirli, e la notte tornò calma. Per prima cosa, fu necessario occuparsi dei tre feriti; per fortuna, le loro condizioni non erano gravi. Dopo una sommaria medicazione, furono mandati indietro, accompagnati da quattro loro camerati. Dragoch, con Ulhmann e altri tre agenti, si diresse attraverso i campi verso il Danubio, piegando un po' in direzione di Gran. Ritrovò facilmente il luogo in cui era sceso a terra alcune ore prima e l'imbarcazione con la quale Ulhmann e lui avevano attraversato il fiume. I cinque uomini vi presero posto e, riattraversato il Danubio, ne discesero il corso lungo la riva sinistra. Karl Dragoch aveva subito uno scacco, ma intendeva prendersi la rivincita. Che Ilia Brusch e il famoso Ladko fossero lo stesso uomo, non c'era ombra di dubbio, secondo lui, ed era al suo compagno di viaggio, ne era persuaso, che il crimine della notte precedente doveva essere addebitato. Con ogni probabilità Ladko, dopo aver messo al sicuro la refurtiva, si sarebbe affrettato a riprendere la sua falsa personalità, che ignorava fosse stata già scoperta, e che gli aveva consentito fin allora di sviare le ricerche della polizia. Prima dell'alba avrebbe certamente raggiunto la chiatta per attendervi il ritorno del suo passeggero, così come avrebbe fatto l'inoffensivo e onesto pescatore che pretendeva di far credere d'essere. Avrebbe allora trovato cinque uomini ad attenderlo. Quei cinque uomini, sopraffatti da Ladko e dalla sua banda, avrebbero avuto facilmente ragione di quello stesso Ladko costretto a recitare da solo la parte di Ilia Brusch. Il piano, ben concepito, purtroppo non poté essere realizzato. Dragoch e i suoi uomini esplorarono minuziosamente la riva senza riuscire a trovare la chiatta del pescatore. Dragoch e Ulhmann non fecero fatica a riconoscere il posto preciso nel quale il primo era sbarcato: della chiatta però nessuna traccia: era scomparsa e, con essa, era scomparso Ilia Brusch. Dragoch era stato preso in giro, senza alcun dubbio. Con incontenibile rabbia, il poliziotto disse al subordinato: — Friedrich, non ne posso più. Mi sarebbe impossibile fare ancora un solo passo. Dormiremo sull'erba per riprendere le forze. Uno dei nostri prenderà il canotto e andrà subito a Gran. Non appena l'ufficio sarà aperto, metterà al lavoro il telegrafo. Accendi la pila e scrivi ciò che ti detto. Friedrich Ulhmann obbedì in silenzio. «Crimine commesso questa notte dintorni di Gran. Bottino caricato su chiatta. Effettuare con rigore visite prescritte.» — Questo è il primo — disse Dragoch. — Ora all'altro. E riprese a dettare: «Rilasciare mandato contro nominato Ladko, sedicente Ilia Brusch dichiarantesi vincitore della Lega Danubiana all'ultimo concorso di Sigmaringen. Detto Ladko, alias Ilia Brusch, accusato dei crimini di furto e assassinio». — Che ciò sia telegrafato subito a tutti i comuni rivieraschi, senza alcuna eccezione — ordinò Karl Dragoch, allungandosi a terra, sfinito. CAPITOLO X PRIGIONIERO I SOSPETTI concepiti da Dragoch, e confermati dalla scoperta del ritratto, non erano del tutto infondati. È tempo che il lettore lo sappia, per una migliore comprensione del racconto. Almeno su questo punto, Dragoch aveva ragionato bene. Ilia Brusch e Serge Ladko erano la stessa persona. Dragoch si sbagliava, però, nell'attribuire al suo compagno di viaggio i furti e i delitti che da tanti mesi affliggevano la regione del Danubio e, in particolare, il saccheggio della villa del conte Hagueneau e il ferimento del guardiano Christian. Ladko, da parte sua, non immaginava che il suo passeggero nutrisse simili sospetti. Sapeva soltanto che il suo nome era anche quello di un famoso criminale, senza riuscire però a capire come si era verificata una confusione del genere. Allarmato in un primo momento da questo omonimo, che per colmo di sventura era anche suo compatriota, si era ripreso dopo un attimo di istintivo spavento. Che importava alla fin fine che un malfattore avesse in comune con lui il nome? Un innocente non ha nulla da temere. E innocente di quei delitti egli lo era con certezza. Senza inquietudine, Serge Ladko — gli daremo ormai il suo vero nome — si era assentato la notte precedente per recarsi a Szalka, come aveva detto. In quella cittadina, infatti, sotto il falso nome di Ilia Brusch, egli aveva fissato la sua residenza, dopo la partenza da Russe, ed era là che per lunghe settimane aveva atteso notizie della sua cara Natcha. L'attesa, come sappiamo, gli era diventata insopportabile ed egli si torturava l'animo nel cercare un mezzo per penetrare di nascosto in Bulgaria, quando il caso gli aveva fatto cadere sotto gli occhi un numero del Pester Lloyd, nel quale era annunciata con molta evidenza la gara di pesca di Sigmaringen. Nel leggere l'articolo dedicato al concorso, l'esiliato, abile pescatore, e pilota molto stimato, aveva avuto l'idea di un piano d'azione la cui bizzarria gli avrebbe forse assicurato il successo. Sotto il nome di Ilia Brusch, il solo che avesse portato a Szalka, si sarebbe iscritto alla Lega Danubiana per partecipare alla gara di pesca, sicuro che la sua abilità di pescatore gli avrebbe fatto vincere il primo premio. Dopo aver dato in tal modo al falso nome una certa notorietà, avrebbe annunciato ai quattro venti, accettando anche eventuali scommesse, la sua intenzione di discendere il Danubio, con la lenza in mano, dalla sorgente sino alla foce. Era sicuro che quel progetto avrebbe suscitato la rivoluzione nel mondo dei pescatori, apportando all'autore qualche notorietà anche nel rimanente pubblico. Provvisto da quel momento di uno stato civile al disopra di ogni sospetto, perché solitamente si concede cieca fiducia alle persone famose, Serge Ladko avrebbe disceso il Danubio. Ovviamente, avrebbe fatto il possibile per forzare l'andatura del battello, dedicando alla pesca il tempo strettamente necessario per salvare le apparenze. In ogni caso, avrebbe fatto parlare molto di sé lungo il percorso, perché nessuno si dimenticasse di lui e per essere nella possibilità di sbarcare apertamente a Russe, sotto l'egida di una notorietà consolidata. Affinché lo scopo della sua impresa fosse felicemente raggiunto, occorreva che nessuno sospettasse del suo vero nome e che nessuno potesse riconoscere il pilota Serge Ladko nei tratti del pescatore Ilia Brusch. La prima condizione era facile da realizzare. Trasformato nel vincitore della Lega Danubiana, sarebbe bastato recitare la sua parte senza commettere errori. Serge Ladko giurò a se stesso di essere Ilia Brusch nei confronti di tutti e contro tutti, qualunque cosa potesse accadere. Era da supporre, del resto, che il viaggio si sarebbe compiuto lentamente, ma con sicurezza, e che nessun incidente gli avrebbe reso difficile tener fede al giuramento. Realizzare la seconda sarebbe stato più facile ancora. Un colpo di rasoio per la barba, una tintura per cambiare il colore dei capelli e grandi occhiali neri per nascondere gli occhi: nulla di più. Serge Ladko procedette a quel sommario cambiamento la notte prima della partenza; poi si mise in cammino prima dell'alba, sicuro di non essere riconosciuto da coloro che non sapevano del suo cambiamento. A Sigmaringen le cose erano andate com'egli aveva previsto. Vincitore della gara, l'annuncio del suo progetto era stato favorevolmente commentato dalla stampa dei paesi rivieraschi. Diventato un personaggio troppo noto perché la sua identità potesse venire ragionevolmente sospettata, sicuro inoltre di trovare aiuto in caso di bisogno presso i colleghi della Lega Danubiana sparsi lungo il corso del fiume, Serge Ladko si era affidato alla corrente. A Ulm aveva ricevuto la prima delusione, constatando che la sua celebrità non lo proteggeva dai fulmini dell'amministrazione. Era stato perciò felice di imbarcare un passeggero dai documenti in perfetta regola e del quale la polizia sembrava apprezzare l'onorabilità. Quando a Russe avrebbe smesso di essere quello che non era, la presenza di quell'estraneo avrebbe potuto certamente creargli qualche fastidio. Ma ci avrebbe pensato allora; per il momento quella presenza avrebbe accresciuto le probabilità di successo del viaggio che Serge Ladko desiderava ardentemente portare a buon fine. L'aver saputo che il suo nome era anche quello di un feroce bandito, per di più bulgaro come lui, aveva fatto provare a Serge Ladko la seconda, spiacevole delusione. Per quanto fosse innocente e con la coscienza a posto, si rendeva però conto che quella omonimia poteva far nascere spiacevolissimi errori e anche gravissime complicazioni. Se il nome che egli celava sotto quello di Ilia Brusch fosse venuto a conoscenza, non soltanto avrebbe compromesso il suo sbarco a Russe, ma l'avrebbe notevolmente ritardato. Contro tali pericoli Serge Ladko non poteva far nulla. Del resto, anche se gravi, non bisognava neppure esagerarli. Era poco probabile, infatti, che la polizia sprecasse, senza un preciso motivo, la propria attenzione per un inoffensivo pescatore: soprattutto per un pescatore protetto dagli allori raccolti nella gara di Sigmaringen. Venuto a Szalka dopo il tramonto e ripartito molto prima dell'alba senza essere visto da alcuno, Serge Ladko era rimasto a casa sua appena il tempo di constatare che nessuna notizia di Natcha vi era pervenuta. Il persistente silenzio della moglie era in realtà preoccupante. Da due mesi la giovane non scriveva più. Che cosa le era capitato? I torbidi popolari sono spesso causa di sciagure personali; il pilota si chiedeva con angoscia se, ammettendo che fosse riuscito a sbarcare felicemente a Russe, quello sbarco non sarebbe avvenuto troppo tardi. Quel pensiero gli spezzava il cuore e centuplicava la forza dei suoi muscoli. Era stato quel pensiero a dargli, alla partenza da Gran, la forza di resistere alla tempesta e di lottare vittoriosamente contro il vento; era quel pensiero che lo aveva spinto ad affrettare il passo, mentre faceva ritorno alla chiatta, con il cordiale per il signor Jaeger. Fu molto sorpreso di non trovarvi il passeggero lasciatovi in non buone condizioni; le poche parole del biglietto non diminuirono la sorpresa. Quale motivo impellente poteva avere il signor Jaeger per allontanarsi, nonostante la sua estrema debolezza? Com'era possibile che un borghese di Vienna avesse affari urgentissimi in aperta campagna, lontano da ogni centro abitato? Era un problema che i ragionamenti del pilota non riuscirono a risolvere. A parte la causa, l'assenza del signor Jaeger presentava comunque l'inconveniente assai grave di prolungare un viaggio già molto lungo. Senza quell'inatteso incidente, la chiatta avrebbe raggiunto subito il centro del fiume e prima di sera molti chilometri sarebbero stati aggiunti a quelli fin allora lasciatisi alle spalle. La tentazione di non tener conto della preghiera del signor Jaeger e di spingersi al largo per proseguire subito un viaggio il cui scopo attirava Serge Ladko come la calamita attira il ferro, era troppo forte. Il pilota decise tuttavia di aspettare. Aveva qualche obbligo verso il passeggero e, a conti fatti, riteneva meglio perdere una giornata piuttosto che fornire pretesti ad altre contestazioni. Per trascorrere l'altra metà della giornata, il lavoro per fortuna non gli sarebbe mancato. Non gli sarebbe neppure bastato per riordinare la chiatta e per riparare alcuni danni di poco conto causati dalla tempesta. Serge Ladko cominciò per prima cosa a mettere ordine nelle casse di cui aveva messo sottosopra il contenuto, nel corso delle sue infruttuose ricerche del mattino. Ciò non avrebbe richiesto molto tempo se, nel riordinare l'ultima, lo sguardo non gli fosse caduto su quel portafoglio che già aveva attirato l'attenzione di Karl Dragoch. Il pilota aprì il portafoglio, proprio come aveva fatto il poliziotto, e come questi, ma spinto da ben altro sentimento, ne trasse il ritratto che Natcha gli aveva dato al momento di separarsi, con la tenerissima dedica. Serge Ladko contemplò a lungo il viso adorabile della moglie. Era lei! Erano i suoi occhi limpidi, le sue labbra socchiuse come se stesse per parlare, i suoi tratti tanto amati! Ripose la cara immagine nel portafoglio e il portafoglio nella cassa, richiudendola e mettendone in tasca la chiave. Uscì poi dalla tuga per accudire ad altri lavori. Ma ora non aveva più voglia di lavorare. Le sue mani rimasero inoperose; seduto sul banco, con le spalle rivolte alla riva, lasciò vagare lo sguardo sul fiume. Il suo pensiero volò verso Russe: vide sua moglie, la ridente casetta piena di canti… Non aveva rimorsi, certamente: aveva sacrificato la propria felicità alla patria… lo avrebbe rifatto, se necessario… Quale amarezza, però, al pensiero che un sì crudele sacrificio fosse stato inutile! La rivolta era scoppiata in anticipo ed era stata schiacciata inesorabilmente; ancora per quanti anni la Bulgaria avrebbe dovuto gemere sotto il giogo degli oppressori? Gli sarebbe riuscito di attraversare la frontiera? e, in tal caso, avrebbe ritrovato la donna che amava? I turchi non si sarebbero già impadroniti, quale ostaggio, della moglie di un loro accanito avversario? E, in questo caso, che avevano fatto di Natcha? Ohimè! l'umile dramma intimo spariva nello sconvolgimento che scoteva la regione balcanica. Contava assai poco il dolore di due creature umane nel pericolo e nel dolore di tutti. La penisola era percorsa in quel momento da orde feroci. Ovunque il galoppo selvaggio dei cavalli faceva tremare la terra; nei villaggi più poveri erano passate la devastazione e la guerra. Due pigmei lottavano contro il colosso turco: la Serbia e il Montenegro. Questi due David sarebbero riusciti a vincere Golia? Ladko capiva che la battaglia era impari; riponeva ogni speranza nel padre di tutti gli slavi, il grande zar di Russia che un giorno, forse, si sarebbe degnato di stendere la mano possente sul capo dei figli oppressi. Assorto in tali pensieri, Serge Ladko non si rendeva neppure conto di dove si trovava. Un intero reggimento avrebbe potuto sfilare sulla riva, alle sue spalle; non se ne sarebbe accorto. A maggior ragione non si accorse dell'arrivo di tre uomini che si avvicinavano cautamente, alle sue spalle. Ma se Ladko non vide i tre uomini, essi lo videro benissimo, non appena la chiatta apparve loro alla svolta del fiume. Il trio si fermò immediatamente e tenne conciliabolo a bassa voce. Dei tre nuovi venuti, uno è stato già presentato al lettore con il nome di Titcha, quando la chiatta aveva fatto scalo a Vienna. Era quello che, con un altro, aveva seguito i passi di Karl Dragoch, quando il poliziotto aveva pedinato da parte sua Ilia Brusch, recatosi dall'intermediario che curava la spedizione di armi in Bulgaria. Come il lettore ricorderà, quel pedinamento aveva condotto le due spie nelle vicinanze della chiatta; sicuri di riconoscere l'abitazione galleggiante del poliziotto, i due uomini si erano poi allontanati, ripromettendosi di trar partito dalla loro scoperta. Si trattava ora di mettere in esecuzione il progetto allora formulato. I tre uomini si erano distesi sull'erba della riva e di là spiavano Serge Ladko, il quale, sempre soprappensiero, ignorava la loro presenza e non aveva sospetto del pericolo che incombeva su di lui. Il pericolo era grande; i tre facevano parte della banda di malfattori che allora infestava la regione danubiana e che non sarebbe stato piacevole incontrare in luoghi solitari. Titcha era importante nella banda; poteva essere considerato il braccio destro del capo, le cui gesta avevano dato al pilota una triste celebrità. Gli altri due, Sakmann e Zerlang, erano semplici comparse: braccia, non teste. — È lui! — mormorò Titcha, fermando con la mano i compagni, non appena avvistata la chiatta. — Dragoch? — chiese Sakmann. — Sì. — Ne sei sicuro? — Sicurissimo. — Ma non puoi vedere il suo viso, poiché ci volta le spalle — disse Zerlang. — Se ne vedessi il viso, non mi aiuterebbe affatto — rispose Titcha. — Non lo conosco. È già tanto se l'ho visto a Vienna. — In questo caso!… — Ma riconosco perfettamente il battello — lo interruppe Titcha. — Ho potuto esaminarlo comodamente quando io e Ladko eravamo confusi tra la folla. Sono certo di non sbagliarmi. — Andiamo, allora! — disse uno dei tre uomini. — Andiamo — approvò Titcha, svolgendo un pacchetto che teneva sotto il braccio. Il pilota continuava a non accorgersi della sorveglianza di cui era fatto oggetto. Non aveva percepito l'arrivo dei tre uomini, e non udì neppur ora il loro avvicinarsi cauto e silenzioso sull'erba spessa della riva. Smarrito nel suo sogno, lasciava che il pensiero vagasse, con la corrente, verso Natcha e verso il suo paese. A un tratto numerosi lacci inestricabili gli avvinghiarono il corpo, immobilizzandolo, accecandolo, soffocandolo. Scattò in piedi, si dibatté istintivamente e inutilmente, ma un colpo violento sul capo lo fece crollare, stordito, sul fondo della chiatta. Ebbe il tempo, però, di vedere che un giacchio, una grande rete che era servita anche a lui più volte per pescare, lo teneva prigioniero. Quando si riprese, Ladko non era più avvolto nella rete che l'aveva ridotto all'impotenza. Tuttavia, era strettamente legato con molti giri di solida corda, non poteva fare il minimo movimento; se avesse voluto gridare un bavaglio avrebbe soffocato le sue grida, e una spessa benda gli impediva di vedere. Appena tornato in sé, Ladko si sentì tutto stordito. Che cosa gli era capitato? Che significava quell'incomprensibile attacco? Che cosa volevano fare di lui? Anche se, tutto considerato, poteva stare tranquillo: se avessero avuto l'intenzione di ucciderlo, lo avrebbero già fatto. Poiché era ancora vivo, voleva dire che i suoi aggressori non intendevano privarlo della vita e che non avevano altra intenzione se non quella di impadronirsi della sua persona. Ma perché e a che scopo? A tale domanda sarebbe stato difficile rispondere. Erano ladri? Tanta fatica per legarlo in quella maniera, quando con un colpo di coltello avrebbero fatto più presto e con più tranquillità. Del resto, il povero contenuto della chiatta quanti ladri avrebbe potuto tentare?! Una vendetta? Impossibile. Ilia Brusch non aveva nemici. I soli nemici di Ladko erano i turchi, i quali non avrebbero potuto immaginare che il patriota bulgaro si celasse sotto il nome del pescatore; e se ne fossero stati informati, Brusch non era personaggio così in vista da far loro commettere un atto di violenza lontano dalla frontiera, nel cuore dell'impero austriaco. I turchi peraltro lo avrebbero ucciso con assoluta certezza, come i ladri. Persuasosi che almeno per il momento il mistero sarebbe rimasto insoluto, Serge Ladko, da persona pratica, smise di pensarvi e consacrò la sua intelligenza per ciò che sarebbe accaduto in seguito e per cercare i mezzi, se possibile, che gli consentissero di riacquistare la libertà. La sua condizione non gli consentiva molte osservazioni. La stretta a spirale della corda avvolta attorno al corpo non gli permetteva alcun movimento; la benda sugli occhi era talmente stretta che non avrebbe saputo dire se era giorno oppure notte. Soltanto da alcuni rumori, si rese conto di giacere sul fondo di una barca, la sua senza dubbio, che avanzava rapidamente sotto lo sforzo di braccia robuste. Percepiva chiaramente infatti il cigolio dei remi contro il legno degli scalmi e lo sciacquio dell'acqua che scivolava sui fianchi dell'imbarcazione. In quale direzione si muovevano? Anche a questo secondo problema trovò con facilità la soluzione, notando una sensibile differenza di temperatura tra il lato destro e il lato sinistro del suo corpo. Le scosse che la chiatta gli comunicava a ogni colpo di remo gli rivelavano che era disteso nel senso della marcia; e poiché il sole non era molto lontano dal meridiano al momento dell'aggressione, ne dedusse senza difficoltà che una metà del suo corpo giaceva all'ombra della parete dell'imbarcazione e che questa dall'ovest si dirigeva all'est, continuando quindi a seguire la corrente. Nessuna parola era stata scambiata tra coloro che lo tenevano in loro potere. Nessun suono umano giungeva alle sue orecchie, tranne gli ahn dei vogatori quando facevano forza sul remo. Quella navigazione silenziosa durava da circa un'ora e mezzo quando il calore del sole raggiunse il suo viso, facendogli capire che si procedeva verso il sud. Il pilota non ne fu sorpreso. Conosceva così bene il fiume, che capì che si cominciava a seguire la curva che esso descrive di fronte al monte Pilis. Presto, indubbiamente, si sarebbe ripresa la direzione dell'est e poi quella del nord, sino al punto estremo in cui il Danubio comincia a scendere direttamente verso la penisola balcanica. Quelle previsioni si realizzarono soltanto in parte. Nel momento in cui Serge Ladko credeva che fosse stata raggiunta la parte centrale dell'ansa di Pilis, il rumore dei remi cessò di colpo. Mentre la chiatta avanzava sul proprio abbrivo, udì una voce aspra. — Prendi la gaffa — ordinò uno degli invisibili assalitori. Quasi subito ci fu un urto, seguito dallo sfregamento del fasciame contro un corpo duro; poi Serge Ladko fu sollevato e passato da una mano all'altra. Era evidente che la chiatta aveva accostato un battello di dimensioni più notevoli, a bordo del quale il prigioniero era stato trasportato come un sacco. Ladko tendeva inutilmente l'orecchio per afferrare qualche parola. Nessuno aprì bocca. I carcerieri si tradivano soltanto con il contatto delle loro mani brutali e con il soffio dei petti ansanti. Sballottato e stiracchiato in tutti i sensi, Ladko era incapace persino di riflettere. Dopo averlo tirato su, lo fecero scivolare lungo una scala che gli straziò crudelmente le reni. Dagli urti che lo martirizzavano comprese che lo stavano facendo passare attraverso una stretta apertura; alla fine, dopo avergli strappato benda e bavaglio, lo mollarono come un pacco, mentre lo sbattere sordo di una botola risonava sul suo capo. Stordito dal colpo, Ladko ebbe bisogno di un po' di tempo per riprendersi. Quando vi riuscì, gli parve che la sua situazione non fosse migliorata, anche se aveva ritrovato l'uso della parola e della vista. Se gli era stato tolto il bavaglio, era evidente che nessuno avrebbe potuto udire le sue grida; né la mancanza della benda gli sarebbe stata di maggior aiuto. Inutilmente spalancò gli occhi. Tutto era buio intorno a lui. E che buio! Il prigioniero, che dai colpi ricevuti aveva la sensazione di essere stato gettato nella stiva di un battello, faceva inutili sforzi per trovare uno spiraglio di luce attraverso le giunture di un pannello. Non vedeva nulla. Non era l'oscurità di una cantina, nella quale l'occhio riesce a percepire qualche vaga luce: era il buio assoluto, paragonabile soltanto a quello della tomba. Quante ore trascorsero in quella situazione? Ladko ritenne che doveva essere notte fonda quando giunse fino a lui un baccano, attutito dalla distanza. Qualcuno correva, scalpicciava. Poi il baccano si fece più vicino. Pesanti pacchi venivano trascinati sul suo capo; avrebbe giurato che soltanto lo spessore di un'asse lo separava dagli sconosciuti lavoratori. Il fracasso si fece ancora più vicino. Ora parlavano accanto a lui, senza dubbio dietro una di quelle pareti che delimitavano la sua prigione, ma non riusciva a capire ciò che dicevano. Il fracasso ben presto cessò e il silenzio si fece nuovamente intorno al disgraziato pilota che il buio impenetrabile circondava. Serge Ladko si addormentò. CAPITOLO XI NELLE MANI DI UN NEMICO DOPO AVER costretto Dragoch e i suoi uomini a battere in ritirata, i vincitori erano rimasti in un primo momento sul luogo del combattimento, pronti a opporsi a un eventuale ritorno offensivo. La carretta, nel frattempo, si allontanava in direzione del Danubio. Soltanto quando il tempo trascorso rese certo l'allontanamento definitivo delle forze di polizia, il capo ordinò alla banda dei malfattori di mettersi in marcia. Gli uomini raggiunsero presto il fiume, che scorreva a meno di cinquecento metri dal boschetto. La carretta li aspettava dinanzi a una chiatta, che si scorgeva confusamente a pochi metri dalla riva. I malviventi coprirono la modesta distanza in pochi minuti, trasportando su due barche in varie riprese il contenuto della carretta a bordo della chiatta. Dopodiché la carretta si allontanò, e la maggior parte dei combattenti della radura si dispersero attraverso la campagna, dopo aver ricevuto la propria parte di bottino. Del crimine commesso non esisteva altra traccia che un mucchio di colli ammonticchiati sul ponte della nave da trasporto, a bordo della quale si erano imbarcati soltanto otto uomini. La famosa banda del Danubio era composta, in realtà, soltanto da quegli otto uomini. Il resto era gente che veniva racimolata qua e là a seconda della necessità e a seconda della regione in cui la banda operava. Questi uomini erano tenuti sempre all'oscuro dell'esecuzione del colpo vero e proprio, e la loro partecipazione, limitata alla funzione di facchinaggio, vigilanza o di guardia del corpo, aveva inizio soltanto nel momento in cui si trattava di trasportare il bottino carpito verso il fiume. L'organizzazione era quasi perfetta. In questo modo la banda disponeva su tutto il percorso del Danubio di innumerevoli affiliati, pochissimi dei quali si rendevano conto del genere di operazioni alle quali portavano il proprio contributo. Reclutati tra i più ignoranti, quasi tutti dei veri bruti, essi credevano di partecipare ad operazioni di normale contrabbando e non cercavano di saper altro. Non avevano mai pensato di collegare colui che comandava la spedizione alla quale prendevano parte al famoso Ladko che, pur celando il suo nome, sembrava stranamente compiacersi di lasciare qualche traccia del suo stato civile sui luoghi dei suoi crimini. La loro indifferenza sembrerà meno sorprendente se si considera che quei crimini, commessi lungo tutto il corso del Danubio, avvenivano su un'estensione immensa. Tra un crimine e l'altro l'emozione pubblica aveva dunque il tempo di placarsi. Era soprattutto negli uffici della polizia, dove si accentravano le proteste delle regioni rivierasche, che il nome di Ladko aveva acquistato la sua trista celebrità. Nelle città la borghesia, anche a causa dei titoli vistosi sui giornali, s'interessava ancora molto a quel personaggio. Ma per la massa del popolo, e ancor più per i contadini, si trattava di un delinquente come un altro, con il quale si ha a che fare una volta e che poi non si rivede più. Al contrario, gli otto uomini rimasti a bordo della chiatta si conoscevano bene e costituivano una vera banda. Con il loro battello, risalivano e discendevano continuamente il Danubio. Non appena si presentava l'occasione di un buon colpo, si fermavano, reclutavano nei dintorni gli uomini necessari, e poi, messo il bottino al sicuro nel loro nascondiglio galleggiante, ripartivano alla ricerca di nuove imprese. Quando la chiatta era piena raggiungevano il Mar Nero, dove un vapore di loro fiducia veniva a incrociare nel giorno stabilito. Trasportate a bordo del vapore le ricchezze rubate, a volte a prezzo di un delitto, diventavano merce pulita e perfettamente legale, tanto da poter essere scambiata contro pagamento in oro in lontane contrade, alla luce del sole e con gente onesta. Era stata una cosa insolita che la notte precedente la banda avesse fatto parlare di sé a così breve distanza del precedente saccheggio. Di solito non faceva mai errori del genere, che, ripetuti, avrebbero potuto far nascere il sospetto nell'animo degli ignari complici assoldati nel paese. Questa volta il capo della banda aveva avuto un particolare motivo per non allontanarsi; e se il motivo non era quello attribuitogli da Karl Dragoch, quando a Ulm ne aveva parlato con Friedrich Ulhmann, il poliziotto non vi era tuttavia estraneo. Riconosciuto a Vienna dal capo della banda, allora accompagnato da Titcha, suo vice, Dragoch da quell'istante era stato seguito a vista, senza rendersene conto, da un gruppo di complici locali, ai quali era stato detto soltanto l'essenziale, mentre la chiatta del pescatore veniva preceduta soltanto di pochi chilometri dall'imbarcazione della banda. Lo spionaggio, non dei più facili in una contrada spesso scoperta e dove numerosi erano in quel momento i poliziotti, era stato necessariamente intermittente; il caso poi aveva fatto sì che mai Karl Dragoch e il suo ospite fossero visti nello stesso momento. Nulla aveva dunque permesso di supporre che la chiatta avesse due passeggeri e, di conseguenza, di ammettere la possibilità di un errore. Nel disporre quella sorveglianza, il capo dei banditi sognava un colpo da maestro. Uccidere il poliziotto? Non ci pensava affatto. Per il momento, pensava solo a impadronirsene. Karl Dragoch in mano sua, egli avrebbe avuto il coltello dalla parte del manico per trattare alla pari se un vero pericolo lo avesse minacciato. Per vari giorni, l'occasione per il rapimento non si era mai presentata. O la chiatta si fermava alla sera a troppo breve distanza da un centro abitato, oppure capitava di riconoscere nelle immediate vicinanze alcuni degli agenti sparpagliati sulla riva, la cui identità non poteva sfuggire al professionista del crimine. La mattina del 29 agosto le circostanze erano apparse favorevoli. La tempesta che la notte precedente aveva protetto la banda durante l'attacco alla villa del conte Hagueneau, doveva aver disperso in buona parte i poliziotti che precedevano o seguivano lungo il fiume il loro capo, che forse era momentaneamente solo e senza difesa. Bisognava approfittarne. Partita la carretta, Titcha era stato mandato con due uomini risoluti a sbrigare la faccenda. Abbiamo già visto come i tre avventurieri avevano svolto la loro missione e come il pilota era stato fatto prigioniero al posto di Dragoch. Titcha aveva potuto comunicare al suo capo il felice esito della missione solo con qualche parola scambiata nella radura, nel momento in cui il gruppo di poliziotti era sopraggiunto. Avrebbero ripreso il discorso, ma in quell'istante non era possibile parlarne. Per prima cosa bisognava far sparire e mettere al sicuro i numerosi colli ammucchiati sul ponte; a ciò posero mano, senza perdere tempo, gli otto uomini che formavano l'equipaggio della nave. Sia a mano, sia facendoli scivolare su dei piani inclinati, i colli furono prima portati all'interno del battello; in pochi minuti poi si procedette allo stivamento definitivo. Per fare ciò fu sollevato l'impiantito della stiva che nascondeva una buca, proprio là dove ci si sarebbe legittimamente aspettato di trovare l'acqua del Danubio. Una lanterna calatavi dentro, illuminò un mucchio di oggetti disparati che la riempivano già in parte, ma che lasciavano ancora abbastanza spazio perché le cose rubate al conte Hagueneau trovassero a loro volta sistemazione nell'insospettabile nascondiglio. Ingegnosamente truccata, l'imbarcazione serviva infatti come mezzo di trasporto, come abitazione e come magazzino inviolabile. Al disotto del battello che si vedeva era stata costruita un'imbarcazione più piccola: il fondo del primo costituiva il ponte dell'altra. Questa seconda imbarcazione, di circa due metri di profondità, aveva un dislocamento tale da renderla capace di sostenere la prima e di sollevarla di un paio di piedi al disopra della superficie dell'acqua. Per porre rimedio a quest'inconveniente, che avrebbe tradito l'inganno, l'imbarcazione sottostante veniva zavorrata in quantità sufficiente a mantenerla interamente sott'acqua, di modo che la chiatta superiore conservasse la linea di galleggiamento che avrebbe dovuto avere vuota. Vuota la sua stiva lo era sempre; le merci rubate andavano ad ammucchiarsi nel doppio fondo e vi costituivano la zavorra, così che l'aspetto esteriore non appariva modificato. Ma mentre la barca senza carico avrebbe dovuto pescare appena un piede, così affondava nell'acqua per quasi sette piedi. Ciò creava serie difficoltà nella navigazione sul Danubio e rendeva necessario l'ausilio di un esperto pilota. Il pilota della banda era un certo Yacoub Ogul, un israelita nato a Russe. Praticissimo del fiume, Ogul avrebbe potuto competere con Ladko per la perfetta conoscenza dei passi, dei canali e dei banchi di sabbia; con mano sicura, egli governava il battello attraverso le rapide cosparse di rocce che a volte s'incontrano lungo il corso del fiume. La polizia avrebbe potuto controllare il battello da cima a fondo, misurarne l'altezza interna ed esterna senza trovarvi la minima differenza; avrebbe potuto saggiare dappertutto senza scoprire il nascondiglio sotto la linea d'acqua: ogni indagine l'avrebbe condotta alla constatazione che la chiatta era vuota e che, di conseguenza, pescava quel tanto d'acqua strettamente sufficiente per stare a galla. Per ciò che riguarda i documenti, le misure prese non lasciavano a desiderare: in ogni caso, sia che l'imbarcazione discendesse o risalisse il fiume, sia che andasse a caricare le merci, sia che, sbarcate le merci, facesse ritorno al porto d'attracco. A seconda delle circostanze, essa apparteneva ora al signor Constantinesco e ora al signor Wenzel Meyer, commercianti, il primo di Galata e l'altro di Vienna. I documenti, muniti dei timbri ufficiali prescritti, erano a tal punto in regola che nessuno si era mai sognato di andare a fare un controllo. E se anche qualcuno lo avesse fatto, avrebbe accertato l'esistenza di un Constantinesco o di un Wenzel Meyer, nell'una o nell'altra delle città indicate. In realtà, il vero proprietario si chiamava Ivan Striga. Il lettore si ricorderà, probabilmente, che quel nome apparteneva a un individuo di Russe assai poco raccomandabile, il quale, dopo aver inutilmente cercato di impedire il matrimonio di Serge Ladko e di Natcha Gregorevitch, era poi scomparso dalla città. Voci imprecise l'avevano poi accusato di ogni delitto. Una volta tanto, quelle voci non si sbagliavano. Con altri sette delinquenti della sua risma, Ivan Striga aveva costituito, infatti, una banda di pirati che, d'allora, infestavano letteralmente le due rive del Danubio. Aver trovato la strada per arricchirsi facilmente era già qualcosa; ma assicurarsi l'impunità era ancor meglio. A questo scopo, invece di nascondere nome e viso, come avrebbe fatto un volgare malfattore, aveva fatto in modo che le sue vittime gli dessero un nome, che non era ovviamente il suo, ma astutamente quello di Serge Ladko. Attribuire i propri misfatti a un'altra persona è un'astuzia abbastanza comune, ma Striga aveva scelto con intelligenza il nome giusto. Il nome di Ladko era — né più né meno di un altro — capace di creare confusione e quindi, a parte il caso di flagrante colpevolezza, di stornare i sospetti dal vero colpevole: inoltre aveva alcuni vantaggi suoi propri. Per prima cosa Serge Ladko non era un mito. Esisteva, se il colpo di fucile che lo aveva salutato quando era partito da Russe non lo aveva definitivamente ucciso. Anche se Striga si vantava volentieri di avere ucciso il suo nemico, il fatto è che non ne sapeva nulla. Ciò importava poco, del resto, al fine dell'inchiesta che poteva essere fatta a Russe. Se Ladko era morto, la polizia non avrebbe capito nulla delle accuse che gli sarebbero state imputate. Se era vivo, essa avrebbe trovato un uomo in carne e ossa, di onorabilità così indiscussa che l'inchiesta si sarebbe arenata. Si sarebbero ricercati, allora, coloro che avessero avuto la sfortuna di essere suoi omonimi. Ma prima di passare al setaccio tutti i Ladko del mondo, quanta acqua sarebbe passata sotto i ponti del Danubio! Se per caso, a furia di essere rivolti nella stessa direzione, i sospetti fossero riusciti a scalfire la corazza di onorabilità di Serge Ladko, il risultato sarebbe stato doppiamente felice. Oltre al fatto che un bandito è sempre contento di sapere che un altro è sospettato al posto suo, è ancora più contento se nutre per la sua vittima un odio mortale. Anche se queste deduzioni fossero state sbagliate, la sparizione di Serge Ladko, del quale nessuno conosceva la patriottica missione, le avrebbe rese logiche. Perché il pilota era partito senza dir nulla? La locale sezione di polizia del fiume cominciava a farsi questa domanda esattamente nel momento in cui Karl Dragoch scopriva ciò che egli credeva essere la verità; e, come tutti sanno, quando la polizia comincia a farsi delle domande, c'è poca speranza che essa vi risponda con benevolenza. La situazione, nella sua drammatica complicazione, era perciò chiarissima. Una lunga serie di delitti volutamente attribuiti a un certo Ladko, di Russe; il pilota dallo stesso nome finora sospettato vagamente, molto vagamente, a causa della sua sparizione, di essere il colpevole; mentre a centinaia di chilometri un certo Ladko, accusato da più gravi indizi, depistava le indagini sotto il travestimento del pescatore Ilia Brusch; e Striga, nel frattempo, che dopo ogni spedizione banditesca riprendeva il suo vero nome, per circolare liberamente sul Danubio. Perché la sua sicurezza non fosse minacciata però bisognava far sparire qualsiasi traccia compromettente e nel più breve tempo possibile. Ecco perché quella sera il recente bottino fu, come al solito, accatastato in fretta nell'insospettabile nascondiglio. Era il rumore dello stivamento quello che il vero Serge Ladko udiva dalla sua prigione ricavata nella stiva sott'acqua, in fondo alla quale nessuna forza umana sarebbe stata in grado di aiutarlo. Rimesso a posto il pavimento, gli uomini risalirono sul ponte, le cui serrette furono richiuse. La polizia poteva venire, ormai: non avrebbe trovato nulla! Erano quasi le tre del mattino. Stanco per le fatiche di quelle due notti, l'equipaggio avrebbe avuto bisogno di riposo: ma ciò non era possibile. Striga voleva allontanarsi al più presto dal luogo del suo ultimo crimine; diede perciò l'ordine di mettersi in cammino, approfittando delle prime luci del giorno. L'ordine fu eseguito di buona voglia perché tutti si rendevano conto delle ragioni che lo avevano dettato. Mentre si salpava l'ancora e si cercava di spingere il battello in mezzo al fiume, Striga chiese i particolari della spedizione del mattino. — Ogni cosa è andata benissimo — gli rispose Titcha. — Dragoch è stato catturato al primo lancio della rete, come un luccio. — Vi ha visto? — Non credo; aveva ben altro da pensare. — Ha lottato? — Ha cercato; l'ho dovuto quasi accoppare per farlo star fermo. — Non lo avrai ammazzato, spero — disse Striga. — No! Stordito, al più. Ne ho approfittato per legarlo come un salame. Non avevo ancora finito di impacchettarlo che già tornava a respirare. — E ora? — È nella stiva. Nel doppio fondo, naturalmente. — Sa dove è stato trasportato? — Dovrebbe essere troppo furbo — disse Titcha, ridendo. — Puoi ben immaginare che non ho dimenticato né il bavaglio né la benda. Glieli abbiamo tolti quando è stato messo in gabbia, dove, se vuole, potrà cantare romanze e ammirare il panorama. Striga sorrise, senza dir nulla. Titcha proseguì: — Ho fatto ciò che mi hai ordinato, ma dove ci condurrà questa faccenda? — Se non altro, a disorganizzare la brigata, rimasta priva del suo capo — rispose Striga. Titcha alzò le spalle. — Ne nomineranno un altro — disse. — È possibile, ma forse non varrà quello che abbiamo nelle nostre mani. In ogni caso, potremo contrattare. Se sarà necessario, potremo restituirlo in cambio dei passaporti che ci serviranno. Occorre perciò mantenerlo vivo. — Lo è — disse Titcha. — Hai pensato a dargli da mangiare? — Diamine! — disse Titcha, grattandosi il capo. — Ce ne siamo dimenticati. Ma dodici ore di digiuno non hanno mai fatto male a nessuno: gli porterò da mangiare non appena saremo in cammino. A meno che non voglia portarglielo tu stesso, per renderti conto di persona… — No — disse Striga con vivacità. — È meglio che non mi veda. Io lo conosco ed egli non mi conosce. È un vantaggio che non voglio perdere. — Potresti mettere una maschera. — Con Dragoch la maschera non conta. Non è necessario fargli vedere il viso. L'altezza, la corporatura, un piccolo particolare gli bastano per riconoscere la gente. — Allora sto fresco, io che debbo portargli da mangiare! — Bisogna che qualcuno lo faccia… Del resto, Dragoch ora non è pericoloso; se tornerà ad esserlo, vorrà dire che noi saremo al sicuro. — Amen! — disse Titcha. — Per il momento — proseguì Striga — lo lasceremo nella sua cassa. Non per molto tempo, perché potrebbe morire asfissiato. Lo porteremo in una cabina del ponte, non appena avremo oltrepassato Budapest. Domani mattina, dopo la mia partenza. — Vuoi allontanarti? — chiese Titcha. — Sì — rispose Striga. — Ogni tanto lascerò la nostra chiatta per assumere informazioni sulla riva. Sentirò ciò che si dice della nostra ultima faccenda e della scomparsa di Dragoch. — E se ti pizzicano? — Non c'è pericolo. Nessuno mi conosce; la polizia del fiume dev'essere in pieno marasma. Per gli altri avrò, se necessario, una nuova identità. — Quale? — Quella del celebre Ilia Brusch, insigne pescatore, vincitore della Lega Danubiana. — Che idea! — Eccellente. Ho la chiatta di Ilia Brusch; non devo far altro che prendere a prestito i suoi panni, come ha fatto Karl Dragoch. — E se ti chiedono il pesce? — Ne comprerò, se occorre, per rivenderlo. — Hai una risposta per ogni domanda. — Diamine! Quelle parole misero fine alla conversazione. Il battello aveva cominciato a seguire il filo della corrente. Soffiava una lieve brezza dal nord che sarebbe stata molto favorevole quando, un po' prima di Visegrad, il Danubio, ripiegando su se stesso, avrebbe seguito la direzione del sud. Ma, per il momento, ritardava la marcia del battello; volendo allontanarsi sollecitamente dalla zona delle sue gesta, Striga diede l'ordine di sistemare due lunghi remi per aiutare la marcia contro vento. Ci vollero tre ore per percorrere dieci chilometri e raggiungere il primo gomito del fiume, altre due ore per seguire la curva che il Danubio disegna prima di prendere decisamente la direzione del sud. Un po' prima di Waitzen fu possibile lasciare i remi e, sotto la spinta della vela, la marcia del battello fu notevolmente accelerata. Verso le undici si passò dinanzi a Sant'Andrea, dove i conducenti della carretta Kaiserlick e Vogel la notte precedente avevano detto di volersi recare. Poiché non c'era motivo di fermarsi, la chiatta continuò a scivolare verso Budapest, ancora lontana una trentina di chilometri. A mano a mano che si procedeva, l'aspetto delle rive si faceva più duro. Le isole piene d'ombra e di verde si moltiplicavano, lasciando a volte, tra l'una e l'altra, stretti canali interdetti ai battelli ma utilizzabili dalla navigazione di diporto. In quella parte del Danubio i battelli da trasporto svolgono una notevole attività. Si verificano frequenti ingombri, anche perché il corso del fiume è chiuso tra le prime ramificazioni delle Alpi Noriche e le ultime ondulazioni dei Carpazi. A volte capita qualche arenamento o, per un attimo di distrazione dei piloti, un abbordaggio di poco conto, che fa solo perdere un po' di tempo: ma quante grida e quanti litigi al momento della collisione! La chiatta comandata da Striga era tra quelle meglio governate. Stazzava oltre duecento tonnellate, sul ponte aveva uno spardeck, una soprastruttura che a poppa formava il tetto della tuga abitata dal personale. A prua, un piccolo albero serviva per issarvi la bandiera nazionale; a poppa, un timone a pala larga permetteva al pilota di mantenere il battello nella giusta direzione. A mano a mano che si seguiva la corrente, il traffico sul fiume andava aumentando, come succede in prossimità delle grandi città. Leggere imbarcazioni a vela o a vapore, cariche di turisti o di passeggeri, scivolavano tra le isole. Presto il fumo dei camini delle officine oscurò il lontano orizzonte, annunciando la periferia di Budapest. In quel momento accadde un fatto strano: Striga fece un cenno a Titcha che entrò nella tuga di poppa con un altro membro dell'equipaggio. I due uomini ne uscirono quasi subito, scortando una donna slanciata, il cui viso era seminascosto da un bavaglio. Con le mani legate dietro la schiena, la donna camminava tra i due senza cercare di opporre una resistenza che sapeva inutile. Discese docilmente nella stiva e poi in una sezione del doppio fondo, la cui botola fu chiusa sul suo capo. Titcha e il suo compagno ripresero subito le loro occupazioni. Verso le tre del pomeriggio, la chiatta s'inoltrò tra le alzaie della capitale dell'Ungheria. A destra era Buda, la vecchia città turca; a sinistra, Pest, città moderna. A quell'epoca Buda era, più di quanto non lo sia oggi, una di quelle vecchie città pittoresche che il progresso livellatore tende a far sparire. Per contro, Pest, pur essendo già importante, non aveva ancora raggiunto il prodigioso sviluppo che ha fatto di essa la più bella e più importante metropoli dell'Europa orientale. Sulle sue rive, e particolarmente su quella sinistra, si susseguivano le case ad arcate e terrazze, dominate dai campanili delle chiese dorati dai raggi del sole, e i due lungofiume non mancavano né di nobiltà né di grandiosità. L'equipaggio della chiatta non prestava alcuna attenzione all'incantevole spettacolo; poiché la traversata di Budapest avrebbe potuto procurare spiacevoli sorprese a gente così poco raccomandabile, tutti non avevano occhi che per le numerose imbarcazioni che incrociavano lungo il fiume. Precauzione che permise a Striga di notare tempestivamente, tra gli altri, un battello con quattro uomini che puntava direttamente su di loro. Avendo riconosciuto il battello della polizia fluviale, con un'occhiata avvertì Titcha, che senza far domande, si calò nella stiva. Striga non si era sbagliato; pochi minuti dopo il canotto aveva raggiunto la chiatta. Due uomini salirono a bordo. — Il capo? — chiese un poliziotto. — Sono io — rispose Striga, facendo un passo avanti. — Il vostro nome? — Ivan Striga. — Nazionalità? — Bulgara. — Da dove viene la chiatta? — Da Vienna. — Dove va? — A Galata. — Chi ne è proprietario? — Il signor Constantinesco di Galata. — Carico? — Nulla. Facciamo ritorno vuoti. — I documenti? — Eccoli — disse Striga, esibendoli. — Benissimo — approvò il poliziotto, dopo averli esaminati attentamente. — Andiamo a dare un'occhiata alla stiva. — Come volete — disse Striga. — Mi permetto di farvi notare che questa è la quarta perquisizione che la chiatta subisce da quando siamo partiti da Vienna. Non è piacevole. Il poliziotto, esecutore di ordini, declinò con un gesto la propria responsabilità, e senza dir nulla discese attraverso il boccaporto. Quando fu nella stiva, fece qualche passo, si guardò intorno e poi rìsalì: nulla gli aveva fatto sospettare che sotto i suoi piedi giacevano due creature umane: un uomo da una parte, una donna dall'altra, entrambe ridotte all'impotenza e nell'impossibilità di chiedere aiuto. La visita non poteva essere né più lunga né più coscienziosa: la chiatta era vuota e non c'era motivo, quindi, di indagare sulla provenienza del carico: il che semplificava le cose. Il poliziotto tornò all'aperto e senza ulteriori domande raggiunse il canotto, che si allontanò per fare altre perquisizioni, mentre la chiatta proseguiva il suo cammino. Quando l'imbarcazione si ebbe lasciate dietro le ultime case di Budapest, parve venuto il momento di occuparsi della prigioniera. Titcha e un suo compagno scesero nell'interno del battello per uscirne poco dopo con la donna che vi era stata rinchiusa poche ore prima e che ora fu riportata nella tuga. Gli altri uomini dell'equipaggio non parvero prestare attenzione all'operazione. Alla sera la chiatta fece sosta tra il villaggio di Ercsin e quello di Adony, trenta chilometri al disotto di Budapest, per ripartire all'alba del giorno dopo. Nel corso del 31 agosto, la discesa del fiume fu interrotta da alcune fermate, durante le quali Striga lasciò il battello per usare la chiatta di Ilia Brusch. Invece di nascondersi, egli si avvicinava ai villaggi, si presentava ai loro abitanti come il famoso vincitore della Lega Danubiana, la cui fama non poteva non essere giunta fino a loro, e chiacchierava con essi cercando astutamente di portare la conversazione sugli argomenti che gli stavano a cuore. Le informazioni raccolte furono poche. Il nome di Ilia Brusch non sembrava molto noto nella regione. Senza dubbio, a Mohacs, Apatin, Neusatz, Semlin o Belgrado, che sono città importanti, non sarebbe stato così. Ma Striga non aveva l'intenzione di arrischiarvisi e contava di assumere informazioni soltanto nei villaggi, dove la polizia esercitava necessariamente una sorveglianza meno efficace. Gli abitanti, purtroppo, non erano al corrente della gara di Sigmaringen e rifiutarono qualunque intervista. Del resto, non sapevano nulla; nulla di Karl Dragoch, e ancora meno di Ilia Brusch; e Striga usò inutilmente le arti della sua diplomazia. Com'era stato stabilito il giorno precedente, durante un'assenza di Striga, Serge Ladko fu trasportato sul ponte e rinchiuso in una piccola cabina, la cui porta venne chiusa a chiave. Precauzione esagerata, forse, se si pensa che il prigioniero, strettamente legato, non poteva fare alcun movimento. Dal 1° al 6 settembre le giornate trascorsero tranquillamente. Sospinta dalla corrente e dal vento favorevole, l'imbarcazione proseguiva la discesa del fiume percorrendo una sessantina di chilometri ogni ventiquattr'ore. Ne avrebbe percorsi di più se le assenze di Striga non l'avessero costretta a sostare ripetutamente. Se le sue assenze risultavano sempre sterili di informazioni, almeno una volta egli riuscì a renderle utili sotto un altro aspetto. Ciò accadde il 5 settembre, quando la chiatta andò a ormeggiarsi durante la sera dinanzi al piccolo villaggio di Szuszek. Striga scese a terra, come di consueto; i contadini, che hanno l'abitudine di andare a letto quando c'è ancora il sole, erano quasi tutti a casa. Nel passeggiare in compagnia dei suoi pensieri, notò a un tratto una casa dall'aspetto abbastanza signorile, il cui proprietario, fiducioso nella probità del prossimo, aveva lasciato la porta aperta per recarsi nelle vicinanze. Senza esitare, Striga entrò in quella casa. Si trattava di una bottega di vendita al minuto: ne faceva fede l'esistenza del banco. Prendere dal cassetto del banco l'incasso della giornata richiese appena un istante. Non soddisfatto di quel modesto furto, scoprì poi nella parte inferiore di uno stipo, la cui effrazione fu per lui un giuoco, una sacca rotondetta che emise, nel maneggiarla, un suono metallico di buon augurio. Tranquillizzato sul suo contenuto, Striga si affrettò a raggiungere la chiatta, la quale, all'alba, era già lontana. Fu questa l'unica avventura del viaggio. A bordo Striga aveva altre occupazioni. Ogni tanto spariva nella tuga ed entrava nella cabina di fronte a quella in cui era stato rinchiuso Serge Ladko. A volte la sua visita durava pochi minuti, a volte di più. In quest'ultimo caso, non era raro che giungesse fin sul ponte l'eco di una violenta discussione, nella quale si distingueva la voce di una donna che rispondeva con calma a un uomo arrabbiatissimo. Il risultato era allora sempre identico: indifferenza generale da parte dell'equipaggio e uscita furibonda di Striga, il quale si affrettava a lasciare la nave per calmare altrove i nervi irritati. Era soprattutto sulla riva destra che egli svolgeva le sue ricerche; rari sono infatti i villaggi e le borgate della riva sinistra, al di là della quale si estende a perdita d'occhio l'immensa puszta. La puszta è la pianura ungherese per eccellenza, limitata a quasi cento leghe di distanza dalle montagne della Transilvania. La strada ferrata che la serve attraversa un'infinita distesa di terre deserte, di vasti pascoli e di paludi immense in cui pullula la selvaggina acquatica. La puszta è la tavola sempre abbondantemente rifornita per innumerevoli convitati a quattro zampe: migliaia e migliaia di ruminanti che costituiscono una delle principali ricchezze del regno d'Ungheria. E già tanto se vi s'incontrano alcuni campi di grano e di granturco. Qui il fiume si allarga considerevolmente e numerose isole e isolotti ne suddividono il corso. Alcune isole sono abbastanza estese e lasciano ai lati due braccia dove la corrente acquista una certa velocità. Queste isole non sono fertili; sulla loro superficie crescono soltanto betulle, tremole, salici, in mezzo al limo deposto dalle frequenti inondazioni. Vi si raccoglie tuttavia fieno in abbondanza che le barche, cariche fino all'orlo, trasportano nelle fattorie o nelle borgate della riva. Il 6 settembre la chiatta si ormeggiò al cader della sera. Striga era assente in quel momento. Se non aveva voluto correre rischi mettendo piede a terra a Neusatz o a Peterwardein, che la fronteggia, cittadine abbastanza importanti e quindi pericolose, si era però fermato, per le sue indagini, nel borgo di Karlovitz, posto a una ventina di chilometri più a valle. Per suo ordine, la chiatta si era ormeggiata due o tre leghe più a valle per attenderlo e lui l'avrebbe raggiunta con l'aiuto della corrente. Verso le nove di sera egli non ne era molto lontano. Non aveva fretta; abbandonandosi a piacevoli pensieri, lasciava che l'imbarcazione seguisse la corrente. Il suo stratagemma era pienamente riuscito. Nessuno aveva sospettato di lui ed egli aveva potuto assumere liberamente informazioni, poche, a dire il vero. Ma la generale ignoranza, che confinava con l'indifferenza, era dopo tutto un sintomo favorevole. In quella regione si era sentito parlare molto vagamente della banda del Danubio; si ignorava persino l'esistenza di Karl Dragoch, la cui scomparsa, quindi, non poteva suscitare emozione. D'altra parte, o a causa della scomparsa del suo capo o a motivo della povertà della regione attraversata, la vigilanza della polizia sembrava notevolmente diminuita. Da più giorni Striga non aveva scorto nessun sospetto agente, e nessuno parlava della sorveglianza fluviale, così attiva due o trecento chilometri più a monte. Sperava dunque che la chiatta giungesse felicemente al termine del suo viaggio, e cioè al Mar Nero, dove il suo carico sarebbe stato trasferito a bordo del solito vapore. Il giorno dopo l'imbarcazione avrebbe superato Semlin e Belgrado; in seguito sarebbe bastato costeggiare preferibilmente la riva serba per mettersi al riparo di qualsiasi spiacevole sorpresa. La Serbia doveva essere più o meno disorganizzata a causa della guerra sostenuta contro la Turchia, e non sembrava affatto che le autorità rivierasche perdessero il loro tempo ad occuparsi di una chiatta che scendeva vuota il corso del fiume. Chi potrebbe dirlo? Quello sarebbe stato, forse, l'ultimo viaggio di Striga. Dopo aver fatto fortuna, forse si sarebbe ritirato lontano, ricco, stimato… e felice, sognava, pensando alla prigioniera della chiatta. Era a questo punto delle sue fantasticherie, quando i suoi occhi caddero sulle due casse simmetriche, i cui coperchi erano serviti per tanto tempo da cuccetta a Karl Dragoch e al suo ospite; a un tratto si rese conto che da otto giorni, da quando cioè era padrone della chiatta, non l'aveva ancora esaminata a fondo. Era tempo di mettere riparo all'assurda dimenticanza. Cominciò con la cassa di destra, che scoperchiò con destrezza. Vi trovò ammucchiati in bell'ordine, capi di biancheria e abiti. Striga, che non sapeva che fare di quella roba, richiuse la cassa e passò all'altra, il cui contenuto non differiva molto dall'altra; deluso, stava per richiuderla quando vide in un angolo un oggetto che attirò la sua attenzione. Vestiti e biancheria non lo interessavano, ma quel grosso portafoglio, che sembrava contenere carte e documenti, forse sì. Gli incartamenti non hanno l'uso della parola, ma in certi casi non c'è nulla che eguagli la loro eloquenza. Striga aprì il portafoglio; ne vennero fuori, come sperava, numerosi fogli, che si mise a esaminare pazientemente. Lettere e ricevute, tutte a nome di Ilia Brusch, passarono per le sue mani; poi i suoi occhi, spalancati per la sorpresa, si soffermarono sul ritratto che aveva già attirato i sospetti di Karl Dragoch. In un primo momento, Striga non riuscì a capire. Che nella chiatta ci fossero carte intestate a Ilia Brusch e nessuna al poliziotto era cosa già abbastanza stupefacente. Ma questa stranezza poteva essere spiegata facilmente. Karl Dragoch, invece di diventare il doppione del vincitore della Lega Danubiana, come Striga aveva fin allora creduto, forse d'accordo con il vero Ilia Brusch, aveva assunto la personalità del pescatore e ne aveva conservati i documenti per giustificare, in caso di bisogno, la propria identità. Ma perché il nome Ladko? Perché quel nome con il quale, con abilità diabolica, Striga firmava i suoi crimini? E che cosa ci stava a fare il ritratto di quella donna alla quale egli non aveva mai rinunciato, nonostante i suoi tentativi fossero stati respinti sempre? Chi era dunque il legittimo proprietario di quella chiatta per essere in possesso di un documento così personale e così strano? A chi apparteneva l'imbarcazione? a Karl Dragoch, a Ilia Brusch o a Serge Ladko? quale di questi tre uomini, due dei quali lo interessavano moltissimo, era tenuto prigioniero sul suo battello? Era convinto di aver ucciso Ladko, la sera in cui, con un colpo di fucile, aveva colpito uno dei due uomini che su una barca si allontanavano furtivamente da Russe. Non è che avesse mirato bene, quella sera; avrebbe preferito, invece del poliziotto, tenere tra le mani il pilota: e in questo caso, la seconda volta, non avrebbe più sbagliato mira. E nemmeno ci sarebbe stato motivo di tenerlo come ostaggio: una pietra al collo e la faccenda era chiusa; si sarebbe sbarazzato in una sola volta di un nemico mortale e di un ostacolo che gli impediva di realizzare i suoi progetti. Impaziente di conoscere la verità, mettendo via il ritratto appena trovato, Striga prese il remo e affrettò la marcia dell'imbarcazione. La sagoma del battello apparve presto nella notte. Accostò in fretta, saltò sul ponte e si diresse verso la cabina che fronteggiava quella da lui visitata solitamente. Introdusse la chiave nella serratura. Serge Ladko, che ne sapeva molto meno del suo carceriere, non aveva neppure la possibilità di scegliere tra le varie spiegazioni della sua disavventura. Il mistero gli sembrava assolutamente impenetrabile e aveva rinunciato a fare congetture sui motivi che potevano aver portato al suo sequestro. Quando si era svegliato in fondo alla sua cella, la prima sensazione provata era stata quella della fame. Erano trascorse più di ventiquattr'ore dal suo ultimo pasto e la natura non perde mai i suoi diritti, qualunque sia la violenza delle emozioni. Dapprima cercò di pazientare; poi la fame si fece più imperiosa ed egli perdette la calma che lo aveva fin allora sostenuto. Volevano forse farlo morire di fame? Chiamò; nessuno rispose. Chiamò a voce più alta; si sgolò in urla furiose, ma tutto fu inutile. Esasperato, cercò di spezzare i suoi legami: erano solidi ed egli si rotolò inutilmente sul pavimento cercando di spezzarli. Durante quei movimenti convulsi, il suo viso urtò contro un qualcosa che era accanto a lui. L'olfatto reso acuto dalla fame riconobbe un pezzo di pane e del lardo che indubbiamente erano stati deposti accanto a lui mentre dormiva, ma non era cosa facile afferrarli, legato com'era. Ma la necessità aguzza l'ingegno: dopo ripetuti tentativi, riuscì a fare a meno dell'aiuto delle mani. Soddisfatta la fame, le ore trascorsero lente e monotone. Nel silenzio, giungeva alle sue orecchie un mormorio, qualcosa che sembrava il fremito delle foglie agitate dal vento. Il battello sul quale si trovava era, evidentemente, in cammino e fendeva come un cuneo l'acqua del fiume. Quante ore erano trascorse, quando la botola fu sollevata sul suo capo? Sospesa all'estremità di una cordicella, una razione di pane e di lardo oscillò nell'apertura, che un'incerta luce rischiarava, e si posò accanto a lui. Trascorsero altre ore e poi la botola tornò ad aprirsi. Un uomo discese; si avvicinò al suo corpo inerte e gli chiuse la bocca con un ampio bavaglio. Avevano paura dunque che egli gridasse e che potesse essere sentito? Senza dubbio; il prigioniero udì infatti, non appena l'uomo tornò sul ponte, che si camminava sul soffitto della sua prigione. Volle gridare aiuto, ma nessun suono uscì dalle sue labbra. Il rumore dei passi cessò. Chi poteva eventualmente aiutarlo doveva essere già lontano, quando, poco dopo, l'uomo fece ritorno e, senza alcuna spiegazione, gli tolse il bavaglio. Se lo mettevano nella possibilità di gridare aiuto, significava che non era possibile essere udito. E allora, a che sarebbe servito? Dopo il terzo pasto, identico ai due precedenti, l'attesa fu più lunga. Era notte, senza alcun dubbio. Serge Ladko riteneva che la sua prigionia durasse da circa quarantott'ore quando dalla botola venne calata una scala e quattro uomini discesero nella sua cella. Serge Ladko non ebbe il tempo di distinguerne i tratti del viso. In fretta gli furono bendati gli occhi e messo un bavaglio sulla bocca; ridiventato un pacco cieco e muto, fu passato nuovamente di mano in mano. Dai colpi che prendeva riconobbe la stretta apertura — una botola, lo capiva perfettamente — che ora riattraversava in senso inverso. La scala che aveva martirizzato le sue reni durante la discesa, le massacrò nuovamente mentre la risaliva. Fu portato per un po' in senso orizzontale e poi, dopo essere stato gettato brutalmente sul pavimento, sentì che gli ritoglievano benda e bavaglio. Mentre apriva gli occhi, sentì che una porta si chiudeva con fracasso. Serge Ladko si guardò intorno. Gli avevano soltanto cambiato cella, ma questa era di gran lunga migliore della precedente. Da una piccola finestra penetrava la luce; accanto a lui c'era il solito cibo che, prima, era costretto a cercare a tentoni. La luce del sole gli infondeva coraggio; la situazione gli appariva ora meno disperata. Dietro quella finestra c'era la libertà: bisognava soltanto conquistarla. Disperò a lungo di riuscirne a trovare il mezzo, allorché volgendo lo sguardo per la millesima volta intorno alla piccolissima cabina che gli serviva da prigione, vide sulla parete un ferro piatto che dall'impiantito s'innalzava verticalmente sino al soffitto, e che serviva probabilmente a tenere insieme i tavoloni del fasciame. Quel ferro sporgente, benché non presentasse alcuno spigolo tagliente, gli sarebbe forse servito per logorare i suoi lacci, se non per tagliarli. Per quanto difficile, l'impresa meritava se non altro di essere tentata. Dopo essere faticosamente riuscito a trascinarsi fino a quel pezzo di ferro, Serge Ladko cominciò a limarvi la corda che gli legava le mani. L'impossibilità quasi assoluta di muoversi dovuta alle pastoie rendeva il lavoro penosissimo: riusciva a muovere le braccia soltanto contorcendo tutto il corpo e quindi per brevissimo tempo. L'estenuante operazione progrediva lentamente, perché ogni cinque minuti il pilota doveva riposarsi. All'ora dei pasti, era costretto a smettere. Il cibo gli veniva portato sempre dallo stesso carceriere; Serge Ladko lo riconosceva dai capelli grigi e dalla notevole larghezza delle spalle, anche se il suo viso era celato da una maschera di tela. Pur non riuscendo a distinguerne il viso, aveva l'impressione di aver già visto quell'uomo. Non ne era sicuro, ma le spalle imponenti, il passo pesante e i capelli grigi sopra la maschera gli erano noti. Il cibo gli era servito a ora fissa e nessuno, se non in quella occasione, entrava mai nella sua prigione. E niente ne avrebbe rotto il silenzio, se ogni tanto non avesse sentito aprirsi la porta della cabina di fronte alla sua. Quasi sempre una voce d'uomo e quella di una donna giungevano allora fino a lui. Serge Ladko interrompeva il suo paziente lavoro e tendeva l'orecchio, cercando di distinguere meglio quelle voci che svegliavano in lui vaghe e profonde sensazioni. A parte questi episodi, il prigioniero, non appena uscito il carceriere, mangiava e poi si rimetteva ostinatamente al lavoro. Erano ormai trascorsi cinque giorni da quando lo aveva iniziato, e ancora si chiedeva se faceva o meno qualche progresso, quando, al cader della sera del 6 settembre, la corda che gli legava i polsi si spezzò di colpo. Il pilota dovette trattenere il grido di gioia che stava per sfuggirgli: stavano aprendo la porta. L'uomo che ogni giorno gli portava il cibo entrò e gli posò accanto il solito pane e il solito lardo. Non appena solo, Serge Ladko provò a muovere le membra liberate, ma non vi riuscì immediatamente: immobilizzate da una lunga settimana, mani e braccia sembravano paralizzate. A poco a poco riprese faticosamente a muoverle e sempre di più. Dopo un'ora di sforzi, con gesti insicuri riuscì a liberare anche le gambe. Era libero o, quanto meno, aveva fatto il primo passo verso la libertà. Il secondo passo sarebbe stato quello di uscire dalla finestra, che ora poteva raggiungere e dalla quale scorgeva l'acqua del Danubio, ma non la riva, resa invisibile dall'oscurità. Le circostanze erano favorevoli. Fuori il buio era fitto. Sarebbe stato bravo colui che fosse riuscito a riprenderlo in quella notte senza luna in cui, a dieci passi, non si vedeva più nulla. Subito una grossa difficoltà, o meglio ancora una impossibilità materiale, lo fermò al primo tentativo. Abbastanza ampia per un adolescente agile e snello, la finestra era troppo stretta per un uomo della sua corporatura. Dopo inutili sforzi, Ladko dovette rassegnarsi davanti all'ostacolo insuperabile e si lasciò cadere ansante sul pavimento della cella. Era dunque condannato a non uscirne più? Guardò a lungo l'oscuro pezzetto di cielo inquadrato dalla finestra e poi, deciso a fare un altro tentativo, si svesti e si cacciò nell'apertura con furore, deciso a uscirne a qualunque costo. Le ossa scricchiolarono, si macchiò di sangue, ma prima una spalla e poi un braccio passarono; lo stipite della finestra s'imbatté allora contro l'anca sinistra. Purtroppo anche la spalla destra non riusciva a superare l'ostacolo: ogni ulteriore sforzo sarebbe stato perciò inutile. Con una parte del corpo sospesa a mezz'aria sul fiume sottostante, l'altra incastrata, con le costole schiacciate dalla pressione, Serge Ladko non tardò a capire che in quella posizione non avrebbe resistito a lungo. Poiché la fuga da quella parte sembrava impossibile, bisognava cercarne un'altra; forse avrebbe potuto scardinare un montante della finestra per ingrandirne l'apertura. Ma per fare ciò doveva rientrare nella cella e Ladko capì che non gli era possibile: non poteva andare né avanti né indietro; o chiamava aiuto, o era costretto a rimanere in quella scomoda posizione. Si dibatté invano: tutto fu inutile. S'era cacciato in quella trappola tutto da solo! Ladko stava riprendendo fiato quando un rumore insolito lo fece trasalire. Si stava annunciando la minaccia di un nuovo pericolo. Cosa mai successa a quell'ora, da quando occupava quella prigione, qualcuno si era fermato dinanzi alla sua porta e una chiave cercava al buio il buco della serratura… Con la forza della disperazione, il pilota tese i muscoli in uno sforzo sovrumano… Fuori, la chiave girava nella serratura, il catenaccio cedeva… faceva fare un primo scatto… CAPITOLO XII IN NOME DELLA LEGGE APERTA la porta, Striga si fermò esitante sulla soglia. La cella era immersa nel buio. Non vedeva nulla, tranne un quadrato d'ombra più chiara, vagamente disegnato dall'apertura della finestra. Da qualche parte, in un angolo, doveva trovarsi il prigioniero, ma non era possibile scorgerlo. — Titcha! — chiamò Striga con impazienza. — Luce! Titcha si affrettò a portare una lanterna, la cui luce tremolante rischiarò a malapena la cella. I due uomini, dopo una rapida occhiata, si scambiarono uno sguardo allarmato. La cabina era vuota. Sul pavimento si vedevano le corde spezzate e i vestiti sparsi qua e là. Del prigioniero non c'era traccia. — Vuoi spiegarmi? — chiese Striga. Prima di rispondere Titcha andò alla finestra e passò un dito sul montante. — Fuggito — disse, mostrando il dito rosso di sangue. — Fuggito! — ripeté Striga con una bestemmia. — Da non molto, però — proseguì Titcha. — Il sangue è ancora fresco. Non sono nemmeno due ore che gli ho portato da mangiare. — Non hai visto nulla di anormale in quel momento? — Assolutamente nulla. Era legato come un salame. — Imbecille! — lo rimproverò Striga. Titcha aprì le braccia, esprimendo chiaramente con quel gesto la sua sorpresa e la sua innocenza. Striga non accettò la comoda scusa. — Imbecille! — ripeté aspramente, strappando dalle mani del compagno la lanterna e facendo il giro della cella. — Bisognava perquisire e sorvegliare il prigioniero e non fidarsi delle apparenze. Toh! guarda questo pezzo di ferro lucido. È qui che ha sfregato la corda. E vi ha impiegato più giorni. E non ti sei accorto di nulla! Non si può essere stupidi fino a questo punto! — Beh! finiscila… — esplose Titcha, sopraffatto a sua volta dalla collera. — Credi che io sia il tuo cane? Se ci tenevi tanto al tuo Dragoch, potevi sorvegliartelo da te! — Avrei fatto meglio — approvò Striga. — Sei sicuro che il prigioniero fosse proprio Dragoch? — Chi vuoi che fosse? — Che ne so io? Debbo aspettarmi di tutto, visto il modo in cui fai le cose. Lo hai riconosciuto, quando lo hai catturato? — Non posso giurarlo — confessò Titcha — dato che mi voltava le spalle. — Toh! — Ma ho riconosciuto perfettamente il battello. E quello che tu mi hai indicato a Vienna. Ne sono sicuro. — Il battello! il battello! Com'era dunque il prigioniero? Era alto? Serge Ladko e Ivan Striga avevano in realtà la stessa altezza. Ma un uomo disteso sembra molto più alto di un uomo in piedi, e Titcha aveva sempre visto il pilota disteso sul pavimento. In perfetta buona fede, rispose: — Era più alto di te di tutta la testa. — Allora non è Dragoch — mormorò Striga, che sapeva di essere più alto del poliziotto. Rifletté per qualche istante e poi chiese: — Il prigioniero rassomigliava forse a qualcuno che conosci? — Qualcuno che conosco? — protestò Titcha. — Proprio no! — A Ladko, forse? — Che idea! — esclamò Titcha. — Perché vuoi che Dragoch somigli a Ladko? — E se il nostro prigioniero non era Dragoch? — Non per questo sarebbe Ladko, che io conosco abbastanza per non sbagliarmi. — Rispondi alla mia domanda — insistette Striga. — Gli rassomigliava? — Tu sogni — protestò Titcha. — Per cominciare, il prigioniero non aveva barba, mentre Ladko ce l'ha. — La barba si taglia — fece notare Striga. — Non dico di no… E poi il prigioniero portava gli occhiali. Striga alzò le spalle. — Era bruno o biondo? — chiese. — Bruno — rispose Titcha, con convinzione. — Ne sei sicuro? — Non è Ladko! — mormorò di nuovo Striga. — Potrebbe essere Ilia Brusch… — Quale Ilia Brusch? — Il pescatore. — Bah! — disse Titcha senza capirci nulla. — Ma se il prigioniero non è Ladko e non è Dragoch, che ci importa che sia fuggito? Striga non rispose; si accostò alla finestra e, dopo aver esaminato le tracce di sangue, si sporse sforzandosi inutilmente di scrutare nelle tenebre. — Da quanto tempo è fuggito? — chiese sottovoce. — Da non più di due ore — disse Titcha. — Se è scappato da due ore, dev'essere lontano — gridò Striga, padroneggiando con difficoltà la collera. Dopo un attimo di riflessione aggiunse: — Non c'è nulla da fare per il momento: la notte è troppo buia. Poiché l'uccello è volato via, buon viaggio. Ci metteremo in cammino prima dell'alba, in modo da oltrepassare Belgrado al più presto. Rimase un istante a riflettere, poi, senza dir altro, lasciò la cabina per entrare in quella di fronte. Titcha tese l'orecchio. Non udì nulla, all'inizio; presto però, attraverso la porta chiusa, giunsero fino a lui scoppi di voci che a poco a poco crescevano di volume. Alzò le spalle sdegnosamente e poi si allontanò per andare a coricarsi. Aveva fatto male Striga a non fare ricerche immediate del fuggitivo; forse non sarebbero state inutili, perché il prigioniero non era lontano. Nell'udire il rumore della chiave che girava nella serratura, Ladko con uno sforzo disperato aveva superato l'ostacolo. A forza di muscoli, prima la spalla e poi l'anca avevano attraversato la finestra ed egli era volato come una freccia a testa in giù nell'acqua del Danubio, che si era aperta e richiusa sul suo corpo, senza rumore. Tornato a galla dopo una breve immersione, vide che la corrente lo aveva trascinato a qualche distanza dal punto in cui era caduto. Un attimo dopo si portava oltre la poppa della chiatta, evitando la prua. Dinanzi a lui la strada era libera. Non c'era da esitare. Bastava lasciarsi trasportare dalla corrente ancora per un po'. Non appena sicuro di non poter essere ripreso, avrebbe nuotato vigorosamente verso la riva. Vi sarebbe giunto quasi nudo, il che gli poteva causare notevoli difficoltà: ma non aveva altra scelta. Importava soprattutto allontanarsi dalla prigione galleggiante nella quale aveva trascorso giorni penosi. Non appena messo piede a terra, avrebbe pensato a ciò che doveva fare. A un tratto si parò dinanzi a lui, nel buio della notte, la sagoma scura di un'altra imbarcazione. Che emozione nel riconoscere la sua chiatta, ammarrata da una barbetta, tesa dalla spinta della corrente al battello. Si aggrappò al timone e, per un istante, rimase immobile. Nel silenzio della notte, giunse fino a lui un suono di voci. Stavano indubbiamente discutendo sulla sua fuga. Attese con il capo solo fuori dell'acqua nera, che lo copriva di un velo impenetrabile. Le voci crebbero di tono, poi tacquero: il silenzio tornò a regnare sul fiume. Aggrappandosi al capodibanda, Ladko si issò lentamente sull'imbarcazione e sparì sotto la tuga. Tese l'orecchio, ascoltò di nuovo, ma non udì più nulla. Intorno a lui, tutto era silenzio. Sotto la tuga l'oscurità della notte era ancora più spessa. Serge Ladko cercò a tentoni di riconoscere gli oggetti che gli erano familiari. Pareva che non fosse stato toccato nulla: gli attrezzi di pesca erano al loro solito posto, il berretto di lontra pendeva ancora dal chiodo al quale lo aveva attaccato. A destra c'era la sua cuccetta, a sinistra quella sulla quale aveva dormito il signor Jaeger… Ma perché erano aperte le casse i cui coperchi facevano da cuccetta? Erano state forzate, dunque? Le mani esitanti fecero nel buio della notte l'inventario delle sue modeste ricchezze. Non era stato portato via nulla. Abiti e biancheria sembravano in ordine, come li aveva lasciati. Ritrovò persino il coltello nel suo stesso posto. Aprì il coltello, poi, strisciando il ventre sul fondo della chiatta, si trascinò verso prua. Che viaggio! L'orecchio teso e gli occhi inutilmente spalancati nelle tenebre, fermandosi con il fiato mozzo al minimo sciabordio dell'acqua, gli ci vollero dieci minuti per raggiungere la prua. Finalmente la sua mano afferrò la barbetta e la tagliò con un sol colpo. Recisa, la corda sferzò l'acqua rumorosamente. Con il cuore in tumulto, Ladko si lasciò ricadere sulla chiatta. Non era possibile che qualcuno, in quel silenzio così profondo, non avesse sentito. Ma non accadde nulla. Il pilota si rialzò cautamente e si rese conto di essere già lontano dai suoi nemici. Appena libera, infatti, la chiatta aveva cominciato a seguire la corrente ed era bastato qualche istante perché tra le due imbarcazioni si elevasse il muro inespugnabile della notte. Quando si ritenne abbastanza lontano da non aver più nulla da temere, Serge Ladko prese un remo e con pochi colpi rapidi aumentò la distanza che lo separava dal battello. Soltanto allora si rese conto che batteva i denti dal freddo e cercò qualcosa per coprirsi. Effettivamente niente era stato toccato nelle casse, dove trovò facilmente la biancheria e gli abiti che gli occorrevano. Poi riprese il remo e cominciò a remare rabbiosamente. Dov'era? Non ne aveva idea. Non c'era nulla che potesse indicargli il percorso effettuato dalla chiatta nella quale era stato incarcerato. La sua prigione galleggiante aveva disceso o risalito il fiume? Lo ignorava. In ogni caso, era nel senso della corrente che ora doveva andare per raggiungere Russe e Natcha. Se lo avevano portato indietro, avrebbe dovuto riguadagnare il tempo perduto a forza di braccia, ecco tutto. Per il momento, avrebbe cominciato a navigare tutta la notte, in modo da allontanarsi il più possibile dai suoi nemici sconosciuti. Aveva ancora circa sette ore di oscurità a suo favore, e in sette ore, se ne fa di strada! Appena giorno, si sarebbe fermato nella prima città che incontrava per riposarsi. Remava vigorosamente da una ventina di minuti, quando udì nella notte un grido affievolito dalla distanza. Troppo lontano quel grido, per capire se era di gioia, collera o terrore. Eppure, per quanto vaga, quella voce che gli giungeva dai confini dell'orizzonte, gli riempi il cuore di un oscuro turbamento. Dove l'aveva già udita? Avrebbe quasi giurato che fosse la voce di Natcha. Aveva cessato di remare, l'orecchio teso ai sordi rumori della notte. Il grido non si ripeté. Intorno alla barca che la corrente trasportava in silenzio, lo spazio era tornato muto. Natcha! Non aveva che quel nome nella testa… Con un gesto delle spalle, Ladko allontanò da sé l'idea fissa che lo ossessionava e riprese a remare. Il tempo passò. Intorno alla mezzanotte, sulla riva destra del fiume apparvero confusamente alcune case: era il villaggio di Szlankament, che Ladko si lasciò alle spalle senza averlo riconosciuto. Alcune ore dopo, quasi all'alba, apparve un altro borgo, Nove Banoveze. Non riconobbe nemmeno questo e lo sorpassò egualmente. Poi le rive si rifecero deserte: era l'alba. Non appena fu giorno chiaro, Ladko si affrettò a rimediare ai danni che la lunga prigionia aveva causato al suo trucco. In pochi minuti i suoi capelli tornarono neri dalla radice alla punta, il rasoio eliminò la barba nascente e gli occhiali rotti furono sostituiti con altri nuovi. Ciò fatto, ricominciò a remare con instancabile coraggio. Ogni tanto dava uno sguardo all'indietro, ma non vedeva nulla di sospetto. I nemici erano indubbiamente lontani. Liberato lo spirito da ogni immediata preoccupazione, il riconquistato senso di sicurezza lo indusse a pensare nuovamente alla stranezza della sua situazione. Chi erano i nemici che lo costringevano a fuggire? Che cosa volevano da lui? Perché lo avevano tenuto per tanti giorni in loro potere? Domande alle quali gli era impossibile dare una risposta. Non conosceva i suoi nemici, ma doveva comunque diffidarne: questa preoccupazione avrebbe spiacevolmente complicato il suo viaggio, a meno che non decidesse di chiedere, nella prima città che attraversava, la protezione della polizia contro i suoi sconosciuti rapitori, nonostante i rischi che un passo del genere comportava. Quale sarebbe stata questa città? Questo proprio non lo sapeva e non c'era nessuno su quelle rive deserte, dove ogni tanto si scorgeva qualche povero casolare, che potesse dirglielo. Soltanto verso le otto del mattino, sempre sulla riva destra, alcuni alti campanili punteggiarono il cielo, mentre dinanzi alla chiatta, lontano, un'altra città appariva all'orizzonte. Ladko sussultò di gioia. Quelle città egli le conosceva e bene. La più vicina era Semlin, ultima città danubiana dell'impero austro-ungarico; l'altra, proprio dinanzi a lui, era Belgrado, capitale della Serbia, posta anch'essa sulla riva destra, dopo un brusco gomito del fiume, alla confluenza con la Sava. Durante la sua prigionia, dunque, egli aveva continuato a discendere il fiume; la prigione galleggiante lo aveva avvicinato alla meta: senza neppure rendersene conto, gli aveva fatto percorrere più di cinquecento chilometri. Semlin rappresentava la salvezza, per il momento. In caso di necessità, vi avrebbe trovato aiuto e protezione. Ma avrebbe mai deciso di chiedere aiuto? Se avesse raccontato le sue inspiegabili avventure, non avrebbero aperto un'inchiesta, della quale egli sarebbe stato la prima vittima? Avrebbero voluto sapere, probabilmente, chi era, da dove veniva, dove andava, e forse sarebbero riusciti a scoprire il nome che egli aveva giurato a se stesso di non rivelare mai, a qualsiasi costo. Rimandando qualsiasi decisione, Serge Ladko sollecitò la marcia della sua imbarcazione. Gli orologi della città sonavano le otto e mezzo nel momento in cui si ormeggiava a un anello della banchina. Poi procedette rapidamente a mettere un po' d'ordine e ricominciò a esaminare il problema: parlare o tacere? Si decise alla fine per il silenzio: tutto sommato, sarebbe stato meglio tacere, e andare a cercare, sotto la tuga, il meritato riposo, per poi allontanarsi da Semlin senza essere notato, così come vi era giunto. In quel momento, quattro uomini apparvero sulla banchina e si fermarono dinanzi alla barca; poi saltarono a bordo e uno di essi, avvicinandosi a Serge Ladko che lo guardava stupito, gli chiese: — Siete il nominato Ilia Brusch? — Sì — rispose il pilota, con uno sguardo inquieto. L'uomo schiuse la giacca allo scopo di fargli vedere la sciarpa dai colori della bandiera ungherese che gli serrava i fianchi. — In nome della legge, siete in arresto — disse toccandogli la spalla. CAPITOLO XIII UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA KARL DRAGOCH non aveva memoria di essersi mai occupato, durante la sua carriera, di una faccenda così ricca di incidenti imprevisti e dall'apparenza misteriosa come quella della banda del Danubio. L'incredibile dinamicità dell'inafferrabile banda, la sua ubiquità, la fulmineità dei suoi colpi avevano già qualcosa d'insolito. Ed ecco che il suo capo, non appena rintracciato, diventava introvabile e sembrava farsi beffe degli ordini di comparizione emessi contro di lui da tutte le parti! Sembrava svanito nel nulla. Non c'era più traccia di lui, né a monte né a valle. Nonostante l'incessante sorveglianza la polizia di Budapest, in particolare, non aveva segnalato nessuno che gli rassomigliasse. Doveva essere ben passato da Budapest, tuttavia, se fin dal 31 agosto era stato visto a Duna Fòldvar, e cioè a quasi novanta chilometri di là dalla capitale dell'Ungheria. Non sapendo che la parte del pescatore fosse recitata in quel momento da Ivan Striga, al quale la chiatta garantiva rifugio, Karl Dragoch non ci capiva nulla. Nei giorni successivi la sua presenza era stata segnalata a Szekszard, poi a Vukovar e infine a Cserevics. Ilia Brusch non si nascondeva; tutt'altro, diceva il proprio nome a chi voleva conoscerlo e a volte vendeva persino alcune libbre di pesce. Alcuni, però, sostenevano di averlo sorpreso nel momento in cui ne comprava, la qualcosa non un'infernale abilità. Non appena informata della sua comparsa, la polizia aveva un bel darsi da fare: giungeva sempre troppo tardi. Solcava inutilmente il fiume in ogni senso, senza riuscire a trovare la minima traccia della chiatta, che sembrava letteralmente volatilizzata. Karl Dragoch apprendeva con amarezza gli scacchi subiti continuamente dai suoi subordinati; la selvaggina gli sarebbe decisamente sfuggita di mano? Due cose erano certe, comunque: che il preteso pescatore continuava a discendere il fiume e che sembrava tenersi lontano dalle città per timore, evidentemente, della polizia. Karl Dragoch fece raddoppiare la sorveglianza in tutte le città di qualche importanza poste a valle di Budapest, quali Mohacs, Apatin e Neusatz, e stabilì il suo quartier generale a Semlin. Quelle città costituivano in tal modo una specie di sbarramento sulla strada del fuggitivo. Sembrava però, purtroppo, che costui si facesse beffe degli ostacoli predisposti dinanzi a lui. Non appena si veniva a sapere che era passato a valle di Budapest, la sua presenza era segnalata, ma sempre troppo tardi, a valle di Mohacs, di Apatin e di Neusatz. Spinto dalla rabbia e comprendendo che giocava la sua ultima carta, Dragoch riunì allora una vera flottiglia. Più di trenta imbarcazioni incrociarono per ordine suo, giorno e notte, a valle di Semlin. Ben abile sarebbe stato l'avversario che fosse riuscito a superare quello sbarramento! Per quanto notevoli, quelle disposizioni non avrebbero avuto tuttavia alcun successo se Serge Ladko fosse rimasto prigioniero nel battello di Striga. Ma per la tranquillità di Dragoch le cose avrebbero avuto, per fortuna, un seguito diverso. Il 6 settembre era trascorso senza che fosse capitato nulla di nuovo. Sin dalle prime ore del giorno 7 Dragoch si era preparato a raggiungere la sua flottiglia quando vide un poliziotto venirgli incontro. Il ricercato, finalmente arrestato, era stato rinchiuso nella prigione di Semlin. Si affrettò a raggiungere la questura. L'agente aveva detto il vero: il celeberrimo Ladko era proprio in prigione. La notizia si diffuse con la rapidità del lampo e mise la città in agitazione. Non si parlava d'altro; sulla banchina, numerosi gruppi di curiosi rimasero tutto il giorno dinanzi alla chiatta del famoso malfattore. Questi assembramenti non mancarono di attirare l'attenzione di un battello che, verso le tre del pomeriggio, passò al largo di Semlin. Il battello, che discendeva il fiume con l'aria più innocente di questo mondo, era quello di Striga. — Che cosa è successo a Semlin? — chiese il malfattore al fedele Titcha, nel notare l'affollamento delle banchine. — Una sommossa, forse? Preso un binocolo, lo allontanò quasi subito dagli occhi. — Il diavolo mi porti, Titcha — esclamò, — se non è proprio la chiatta del nostro amico! — Credi? — fece Titcha, strappandogli il binocolo. — Bisogna che lo sappia con certezza — proruppe Striga agitato. — Vado a terra. — Per farti arrestare? Bravo furbo, se l'imbarcazione è quella di Dragoch, vuol dire che Dragoch è a Semlin. È come gettarsi in bocca al lupo. — Hai ragione — approvò Striga, cacciandosi nella tuga. — Ma noi prenderemo le nostre brave precauzioni. Un quarto d'ora dopo, veniva fuori «camuffato» da una mano maestra, se ci si consente l'espressione, presa in prestito dai modi di dire comuni ai malfattori e agli agenti di polizia. Si era tagliato la barba e si era messo dei posticci, una parrucca in testa, e una larga benda che gli ricopriva un occhio; per di più, si appoggiava penosamente a un bastone come se fosse allora uscito da una grave malattia. — Che te ne pare? — chiese compiaciuto. — Meraviglioso! — disse Titcha. — Ascolta — proseguì Striga. — Mentre sarò a Semlin, voi proseguirete; vi ormeggerete a un paio di leghe oltre Belgrado e aspetterete il mio ritorno. — Come farai a raggiungerci? — Non preoccuparti. Di' a Ogul di portarmi a terra con il battellino. Nel frattempo il battello si era lasciato alle spalle Semlin. Messo piede a terra lontano dalla città, Striga tornò in fretta verso le abitazioni. Non appena le ebbe raggiunte moderò il passo e, unendosi ai gruppi fermi sulla riva del fiume, ascoltò avidamente ciò che si diceva intorno a lui. Non si aspettava ciò che apprese. Nessuno parlava di Dragoch, e tanto meno di Ilia Brusch. Non si parlava che di Ladko. Di quale Ladko? Non del pilota di Russe, il cui nome era stato utilizzato da Striga nel modo che sappiamo, ma di quel Ladko immaginario da lui creato, del Ladko malfattore, del Ladko pirata, e cioè di se stesso. Argomento della conversazione generale era il suo arresto. Egli non riusciva a capire. Non c'era nulla di sorprendente nel fatto che la polizia commettesse un errore e arrestasse un innocente invece del colpevole; ma quale rapporto aveva quell'errore, del quale meglio di chiunque altro egli poteva garantire la realtà, con la presenza della chiatta che ancora il giorno precedente era attaccata al suo battello? Penserete senza dubbio che fosse una debolezza mostrare interesse per quell'aspetto della faccenda; ciò che importava era il fatto che un altro fosse perseguito al posto suo. Finché un altro era sospettato, nessuno si sarebbe occupato di lui. Questa era la cosa essenziale; il resto non contava. Verissimo, ma egli aveva i suoi bravi motivi per cercare di capirci qualcosa. A giudicare dalle apparenze, tutto lasciava credere che l'arrestato e il proprietario della chiatta fossero la stessa persona. Chi era quello sconosciuto che, dopo essere stato per otto giorni prigioniero a bordo del battello, ne sostituiva compiacentemente il proprietario nelle mani della polizia? Striga non avrebbe certamente lasciato Semlin prima di aver chiarito la faccenda. Doveva armarsi di pazienza. Il signor Izar Rona, giudice incaricato, non sembrava disposto a sbrigare alla svelta l'istruzione della pratica. Trascorsero tre giorni senza che egli desse segno di vita. L'attesa preliminare faceva parte del suo metodo. Secondo lui, era un'ottima cosa lasciare inizialmente l'accusato alle prese con se stesso. L'isolamento distrugge il sistema nervoso; alcuni giorni di solitudine deprimono magnificamente l'accusato con il quale il giudice avrà a che fare. Quarantotto ore dopo l'arresto, il signor Izar Rona esponeva quelle idee a Karl Dragoch, venuto a chiedergli informazioni. Il poliziotto, ovviamente, non poteva che approvare le teorie del suo superiore. — Allora, signor giudice, quando contate — si arrischiò a chiedere — di procedere al primo interrogatorio? — Domani. — Verrò domani, quindi, per conoscerne il risultato. Credo che sia inutile ripetervi su che cosa si fondano le mie supposizioni. — È inutile — disse il signor Rona. — Ricordo perfettamente le nostre precedenti conversazioni. Del resto, le mie annotazioni sono più che complete. — Volete permettermi tuttavia, signor giudice, di ricordarvi il desiderio che mi son preso la libertà di manifestarvi? — Quale desiderio? — Quello di tenermi estraneo alla faccenda, almeno fino a nuovo ordine. Come vi ho già esposto, l'accusato mi conosce sotto il nome di Jaeger. Ciò potrebbe esserci utile, eventualmente. Quando saremo dinanzi alla Corte dovrò certamente dire il mio vero nome, ma ancora non siamo a questo punto; per il momento mi sembra preferibile, per la ricerca dei complici, di non bruciarmi ancora… — D'accordo — promise il giudice. Nella cella in cui era stato chiuso, Serge Ladko aspettava che qualcuno si occupasse di lui. Le due recenti sventure, una appresso all'altra e una non meno inspiegabile dell'altra, non avevano fatto venir meno il suo coraggio. Senza opporre resistenza al momento dell'arresto, si era lasciato condurre in prigione, dopo aver inutilmente formulato una domanda rimasta senza risposta. Che cosa rischiava, del resto? Il suo arresto era certamente dovuto ad un errore che sarebbe stato chiarito non appena l'avessero interrogato. Ma l'interrogatorio, purtroppo, si faceva stranamente attendere. Tenuto rigorosamente isolato, Serge Ladko rimaneva solo giorno e notte nella sua cella, dove ogni tanto una guardia veniva a dare un'occhiata furtiva attraverso lo spioncino della porta. Il guardiano, che obbediva agli ordini del signor Rona, sperava forse di constatare i primi cedimenti dovuti all'isolamento? In tal caso, non c'era motivo di essere soddisfatti. Le ore e i giorni passavano senza che nulla mutasse nell'atteggiamento del prigioniero. Seduto sulla sedia, con le mani appoggiate sulle ginocchia, gli occhi bassi e il viso impenetrabile, sembrava riflettere profondamente, mantenendo un'immobilità quasi assoluta, senza dar segni d'impazienza. Sin dal primo momento Serge Ladko aveva deciso di mantenersi calmo, a qualunque costo; ma con il passare del tempo cominciava quasi a rimpiangere la prigione galleggiante che, se non altro, lo avvicinava a Russe. Il terzo giorno — era il 10 settembre – finalmente la porta si aprì ed egli fu invitato a lasciare la cella. In mezzo a quattro soldati con la baionetta in canna, percorse un lungo corridoio, discese un'interminabile scala, attraversò una via e arrivò al Palazzo di Giustizia, costruito proprio di fronte alla prigione. La via brulicava di gente che premeva trattenuta da un cordone di poliziotti. Quando il prigioniero apparve si alzarono delle grida feroci che esprimevano tutto l'odio per il malfattore da tanto tempo impunito. Le ingiurie immeritate lasciarono impassibile il volto di Serge Ladko. Entrò con passo fermo nel palazzo e, dopo un'altra attesa, alla fine si trovò dinanzi al giudice. Il signor Izar Rona era un ometto mingherlino, biondo, dalla barba rada e dal colorito giallognolo. Era un magistrato dalle maniere forti. Procedeva per affermazioni categoriche e negazioni violente, attaccava con accuse spietate, desideroso di ispirare all'accusato terrore più che di ottenerne fiducia. A un cenno del giudice, le guardie si erano ritirate. In piedi, in mezzo alla stanza, Serge Ladko aspettava che il magistrato lo interrogasse. In un angolo, il cancelliere era pronto a scrivere. — Sedetevi — disse il signor Rona con tono brusco. Serge Ladko obbedì. Il magistrato riprese: — Come vi chiamate? — Ilia Brusch. — Dove abitate? — A Szalka. — Che mestiere fate? — Il pescatore. — Mentite — disse il giudice, fissandolo. Un lieve rossore colorì il viso di Serge Ladko, i suoi occhi ebbero un rapido lampo. Si contenne e rimase in silenzio. — Mentite — ripeté il signor Rona. — Vi chiamate Ladko e abitate a Russe. Il pilota sussultò: conoscevano dunque la sua vera identità. Com'era potuto accadere? Il giudice, al quale non era sfuggito il sussulto dell'imputato, proseguiva intanto con voce tagliente: — Siete accusato di tre furti semplici, di diciannove furti perpetrati con l'aggravante dello scasso e della scalata, di tre omicidi e di sei tentativi di omicidio: crimini e delitti compiuti con premeditazione, nel corso di quasi tre anni. Che avete da dire? Il pilota aveva ascoltato, stupito, quell'incredibile enumerazione di reati. Possibile? La confusione da lui temuta nell'apprendere dalla bocca del signor Jaeger dell'esistenza di un criminale suo omonimo, era dunque realmente avvenuta? Che importava confessare allora che si chiamava Serge Ladko? Un attimo prima aveva avuto il pensiero di confessarlo, implorando la discrezione del giudice. Ora capiva che quella confessione gli sarebbe stata più nociva che utile. Era proprio lui, Serge Ladko, di Russe, e non altri, l'accusato di tutti quegli orribili crimini. Senza dubbio, dimostrata la sua vera identità, sarebbe riuscito certamente a dimostrare anche la sua innocenza. Ma quanto tempo ci sarebbe voluto per riuscirvi? Meglio allora sostenere sino in fondo la parte del pescatore Ilia Brusch che, se non altro, era innocente. — Debbo dirvi che vi sbagliate — rispose con voce ferma. — Mi chiamo Ilia Brusch e abito a Szalka. È facile del resto per voi accertarvene. — Sarà fatto — disse il giudice, prendendo nota. — Intanto, vi farò conoscere alcune accuse che gravano sulle vostre spalle. Ladko si fece più attento: si era a un punto interessante. — Per il momento — cominciò il giudice — metteremo da parte la maggior parte dei crimini che vi sono addebitati, per occuparci soltanto degli ultimi, di quelli cioè che sono stati commessi durante il viaggio nel corso del quale siete stato arrestato. Ripreso fiato, il signor Rona proseguì: — La vostra presenza è stata segnalata per la prima volta a Ulm. Diremo perciò che il vostro viaggio ha origine da Ulm. — Signor giudice — lo interruppe vivacemente Serge Ladko — il mio viaggio è cominciato molto prima di Ulm, avendo vinto due premi nella gara di pesca di Sigmaringen, e avendo risalito il fiume sino a Donaueschingen. — È vero, infatti — rispose il giudice — che un certo Ilia Brusch è stato proclamato vincitore del concorso di pesca istituito dalla Lega Danubiana a Sigmaringen, e che il detto Ilia Brusch è stato visto a Donaueschingen. Ma o voi a Sigmaringen avete preso a prestito un altro nome, oppure vi siete sostituito al detto Ilia Brusch mentre si recava da Donaueschingen a Ulm. Chiariremo questo punto a tempo debito, state tranquillo. Serge Ladko spalancò gli occhi per la sorpresa: ascoltava come in sogno quelle fantastiche congetture. Ancora un po' e avrebbero compreso nel numero delle sue vittime l'immaginario Ilia Brusch! Senza preoccuparsi di rispondere, alzò sdegnosamente le spalle. Il giudice lo guardò fissamente e gli chiese a bruciapelo: — Che cosa siete andato a fare a Vienna, il 26 agosto, dall'israelita Simon Klein? Senza volerlo, Ladko sussultò una seconda volta. Toh, sapevano anche di quella visita! Essa non aveva certamente nulla di riprovevole, ma ammetterla sarebbe stato come ammettere la sua vera identità; poiché aveva deciso di negarla, occorreva persistere nel diniego. — Simon Klein?… — ripeté con l'aria di chi non capisce. — Negate? Lo immaginavo — disse il signor Rona. — Ve lo dirò dunque io, che andando dall'israelita Klein — e nel dire ciò il giudice, per dare alle sue parole uno schiacciante peso, si sollevò sulla seggiola — andavate a mettervi d'accordo con il ricettatore della vostra banda. — Della mia banda!… — ripeté il pilota, sbalordito. — È vero! — rettificò con ironia il giudice. — Voi non capite che cosa voglio dire, voi non fate parte di alcuna banda, voi non siete Ladko ma l'inoffensivo pescatore Ilia Brusch. Ma, se vi chiamate veramente Ilia Brusch, perché allora vi nascondete? — Io, nascondermi! — protestò Serge Ladko. — Diamine! Ne avete tutta l'aria — rispose il signor Izar Rona, — a meno che non sia nascondersi il celare sotto gli occhiali neri occhi che sembrano i migliori del mondo (a proposito, vogliate avere la cortesia di togliervi gli occhiali) e tingersi di nero i capelli che sono biondi per natura. Serge Ladko era sopraffatto. La polizia era bene informata e la rete gli si chiudeva intorno. Senza mostrare di rilevare il suo turbamento, il giudice approfittò del vantaggio. — Eccovi meno vispo, giovanotto mio! Non credevate che sapessimo tante cose sul vostro conto! Continuo: a Ulm avete preso un passeggero con voi. — È vero — rispose Ladko. — Come si chiamava? — Jaeger. — Precisamente. Volete dirmi che ne è stato di lui? — Non lo so; mi ha lasciato in piena campagna, quasi alla confluenza con l'Ipoly. Tornato a bordo, sono stato sorpreso di non trovarvelo più. — Tornato a bordo, avete detto. Vi eravate dunque allontanato? Dove eravate andato? — In un villaggio dei dintorni per procurarmi un cordiale per il passeggero. — Stava forse male? — Moltissimo. C'era mancato poco che non annegasse. — Siete stato voi a salvarlo, immagino? — Chi avrebbe potuto salvarlo, se non c'ero che io? — Uhm!… — fece il giudice, un po' imbarazzato. Si riprese subito: — Credete di commuovermi con la storia del salvataggio? — Io? — protestò Ladko. — Voi m'interrogate e io rispondo. — Benissimo — concluse il signor Rona. — Ditemi: prima di quell'incidente, avevate mai lasciato la chiatta? — Una sola volta, per andare a casa mia, a Szalka. — Potreste precisarmi la data in cui vi siete andato? — Perché no? Bisogna che ci rifletta. — Vi aiuterò io. Non sarebbe stato forse durante la notte dal 28 al 29 agosto? — Potrebbe darsi benissimo. — Non lo negate? — No. — Lo confessate? — Se lo volete… — Siamo d'accordo, allora. Se non erro, Szalka si trova sulla riva sinistra del Danubio — disse il signor Rona, con aria bonaria. — Infatti. — Era buia, credo, la notte dal 28 al 29 agosto. — Molto buia. Il tempo era pessimo. — Ciò spiega perché vi siete sbagliato. È per un errore quasi del tutto naturale che, credendo di scendere sulla riva sinistra, siete invece sbarcato sulla riva destra. — Sulla riva destra? Il signor Rona si alzò e, guardandolo negli occhi, sentenziò: — Sì, sulla riva destra, esattamente dinanzi alla villa del conte Hagueneau. Serge Ladko cercò in perfetta buona fede nei suoi ricordi. Hagueneau? Non conosceva quel nome. — Siete forte — dichiarò il giudice, deluso di non essere riuscito a intimidirlo. — Allora è la prima volta che sentite il nome del conte Hagueneau; e che nel corso della notte dal 28 al 29 agosto la sua villa è stata saccheggiata e il suo custode, Christian Hoël, gravemente ferito; voi non ne sapete niente. Ma dove diavolo ho la testa? Come potreste saperlo, se questi crimini sono stati commessi da un certo Ladko? E Ladko, diamine, non è il vostro nome. — Il mio nome è Ilia Brusch — confermò il pilota con voce meno sicura della volta precedente. — Perfettamente!… d'accordo… Ma, allora, se non vi chiamate Ladko, perché siete scomparso proprio dopo quel crimine, e avete ripreso la vostra identità — e ancora con molta riservatezza — soltanto a rispettabile distanza dalla zona in cui esso è stato commesso? Perché nessuno vi ha più visto — voi che prima vi mettevate così generosamente in mostra — né a Budapest, né a Neusatz, né in alcun'altra città di qualche importanza? Perché avete rinunciato alla messinscena del finto pescatore, al punto persino di acquistare a volte il pesce nei villaggi in cui decidevate di fermarvi? Era come se parlasse arabo, per l'infelice pilota. Se era sparito, era stato contro la sua volontà. Nella notte dal 28 al 29 agosto non era stato sempre prigioniero? che cosa c'era di sorprendente nel fatto che non fosse stato visto? Il sorprendente, invece, era che qualcuno pretendesse di averlo visto. Quell'errore, se non altro, si sarebbe potuto chiarire facilmente. Sarebbe bastato raccontare con sincerità l'incomprensibile avventura di cui era stato vittima. Forse la giustizia ci avrebbe visto più chiaramente e sarebbe riuscita a dipanare quell'intricata matassa. Deciso a raccontare ogni cosa, Serge Ladko aspettava con impazienza che il signor Rona gli permettesse di aprir bocca. Ma il giudice era ormai lanciato a tutto vapore e ora passeggiava in lungo e in largo nel suo ufficio, lanciando in faccia al prigioniero un'infinità di argomenti da lui ritenuti inconfutabili. — Se non siete Ladko — diceva con crescente veemenza — come mai dopo il saccheggio alla villa del conte Hagueneau, saccheggio avvenuto per un caso disgraziato proprio nel momento in cui avevate lasciato la chiatta, un furto, oh! un semplice furto questo, è stato commesso a Szuszek nella notte dal 5 al 6 settembre, notte in cui voi avete dovuto per forza passare dinanzi a quel villaggio? Se voi non siete Ladko, che cosa faceva nella vostra chiatta il ritratto indirizzato al marito da Natcha Ladko, vostra moglie? Il signor Rona aveva colpito giusto, questa volta: l'ultimo argomento era infatti determinante. Annientato, il pilota aveva chinato il capo, grosse gocce di sudore gli bagnavano il viso. Ma il giudice proseguiva a voce sempre più alta: — Se non siete Ladko, perché quel ritratto è scomparso dal giorno in cui vi siete sentito minacciato? Era nella vostra cassa, questo ritratto; preciso: nella cassa di destra. Non c'è più. La sua presenza vi accusava; la sua scomparsa vi condanna. Che cosa avete da dire? — Nulla — mormorò Ladko con voce sorda. — Non capisco più nulla di quel che mi capita. — Comprendereste perfettamente, se voleste prendervi la pena di farlo. Per il momento, interromperemo questo interessante colloquio. Vi riporteranno in cella, dove avrete il tempo di riflettere a lungo. Nell'attesa, ricapitoliamo l'interrogatorio di oggi. Voi dite: 1°. Di chiamarvi Ilia Brusch; 2°. Di avere vinto il premio della gara di pesca di Sigmaringen; 3°. Di abitare a Szalka; 4°. Di essere andato a casa vostra la notte dal 28 al 29 agosto. Tutto ciò sarà controllato. Da parte mia affermo: 1°. Che il vostro nome è Ladko; 2°. Che abitate a Russe; 3°. Che nella notte dal 28 al 29 agosto, con l'aiuto di numerosi complici, avete saccheggiato la villa del conte Hagueneau, rendendovi colpevole del tentativo di assassinio nella persona del custode Christian Hoël; 4°. Che il furto del quale è stato vittima il nominato Kellermann, di Szuszek, nella notte dal 5 al 6 settembre, dev'essere messo sul vostro conto; 5°. Che numerosi altri furti e omicidi, avvenuti nelle regioni bagnate dal Danubio, debbano esservi imputati. L'istruzione di quei crimini è aperta. I testimoni sono stati citati. Voi sarete messo alla loro presenza… Volete sottoscrivere il vostro interrogatorio? No?… Come volete… Guardie, riconducete l'imputato! Per raggiungere la prigione Ladko doveva passare nuovamente attraverso la folla e subirne ancora le grida ostili. La collera popolare nel frattempo sembrava essersi accresciuta: la polizia fece fatica a proteggere il prigioniero. Nella prima fila di quella folla urlante appariva Ivan Striga, che divorò con gli occhi colui che prendeva il suo posto con tanta compiacenza. Il pilota passò a un paio di metri da lui e poté vederlo benissimo. Ma in quell'uomo senza barba, con i capelli neri, e con il viso nascosto da un paio di grossi occhiali neri, non riuscì a riconoscere nessuno, e le sue perplessità non ne furono attenuate. Quando le porte della prigione si furono richiuse, Striga pensieroso si allontanò con il resto della folla. Decisamente non conosceva l'arrestato. Non era, in ogni caso, né Dragoch né Ladko. E poi, che cosa gli importava che fosse Ilia Brusch o un altro? Chiunque fosse l'accusato, l'essenziale era che egli accentrava l'attenzione della giustizia e Striga non aveva più motivo di rimanere a Semlin. Decise perciò di partire il giorno seguente per raggiungere il suo battello. Ma il giorno dopo, la lettura dei giornali gli fece cambiare idea. Il rigoroso riserbo con il quale la faccenda Ladko era condotta induceva la stampa a cercare, con qualsiasi mezzo, di scoprirne il mistero. E vi era riuscita; la messe delle informazioni raccolte era ampia. I giornali riferivano infatti, con sufficiente precisione, il primo interrogatorio dell'imputato, con commenti che non si potevano dire favorevoli all' accusato. In generale, si meravigliavano della sua ostinazione nel sostenere di essere soltanto un pescatore di nome Ilia Brusch, abitante nella cittadina di Szalka. Quale interesse poteva avere nel sostenere una tesi del genere, di così evidente fragilità? Secondo la stampa, il giudice istruttore Rona aveva già mandato a Gran una commissione inquirente. Tra pochissimi giorni dunque un magistrato sarebbe andato a Szalka per svolgervi un'inchiesta che avrebbe invalidato le affermazioni del detenuto. Si sarebbe cercato questo Ilia Brusch e lo si sarebbe trovato… se esisteva, la qualcosa, però, era assai dubbia. La notizia indusse Striga a cambiare i suoi progetti. Mentre leggeva, gli era venuta una strana idea, che finito di leggere, aveva preso corpo. Era certamente una buona cosa che la giustizia avesse tra le mani un innocente; ma sarebbe stato ancora meglio se lo avesse trattenuto. Per raggiungere tale scopo, che cosa bisognava fare? Fornirle un Ilia Brusch in carne e ossa, la qualcosa avrebbe provato ipso facto 3 che il vero Ilia Brusch, prigioniero a Semlin, era un impostore. Questa accusa si sarebbe aggiunta a quelle che ne avevano determinato l'arresto e sarebbe probabilmente bastata a condannarlo definitivamente, con grande vantaggio del vero colpevole. Senza attendere oltre, Striga lasciò la città. Ma invece di raggiungere il battello, con una veloce vettura si fece portare alla stazione ferroviaria per prendere un treno che lo avrebbe portato verso Budapest e il nord del paese. Nel frattempo, Serge Ladko contava con tristezza le ore. Dopo il primo interrogatorio, era tornato in cella allarmato dalla gravità delle accuse che pesavano su di lui. Era certo che con il tempo sarebbe riuscito a far trionfare la sua innocenza. Ma doveva avere molta pazienza, perché si rendeva conto che gli indizi erano contro di lui e che la giustizia aveva costruito con logica la sua impalcatura di 3 Sull'atto stesso. (N.d.T.) ipotesi. C'è però una bella differenza tra semplici sospetti e prove formali. Prove contro di lui non sarebbero riusciti mai a raccoglierne, non avendo egli commesso alcun crimine. L'unico testimone che poteva temere, per quanto riguardava il segreto del suo nome, era l'israelita Simon Klein. Ma Simon Klein, che professionalmente era uomo d'onore, non avrebbe verosimilmente consentito mai a riconoscerlo. Del resto, ci sarebbe stato proprio bisogno di metterlo in presenza del suo vecchio corrispondente di Vienna? Non aveva detto il giudice che avrebbe chiesto informazioni a Szalka? Poiché quelle informazioni sarebbero state certamente eccellenti, il prigioniero di sicuro sarebbe stato rimesso in libertà. Trascorsero parecchi giorni durante i quali Serge Ladko riesaminò a lungo le sue considerazioni, con crescente preoccupazione. Szalka non era lontana e non occorreva molto tempo per avere qualche informazione. Erano trascorsi sette giorni dal suo interrogatorio, quando fu condotto nell'ufficio del signor Frantz Richter. Il giudice sembrava molto occupato e per dieci minuti lasciò il pilota in piedi, come se ne avesse ignorato la presenza. — Szalka ci ha risposto — disse alla fine con indifferenza, senza neppure alzare gli occhi sul prigioniero, controllandolo però di soppiatto attraverso le ciglia abbassate. — Ah! — disse Ladko con soddisfazione. — Avevate ragione — proseguì il signor Rona. — Esiste a Szalka un tale di nome Ilia Brusch, il quale ha un'ottima reputazione. — Ah! — disse il pilota per la seconda volta, che vedeva già spalancata la porta della sua cella. Con tono distaccato e indifferente il giudice, quasi non volesse dare importanza a ciò che diceva, mormorò: — Il commissario di polizia di Gran incaricato dell'inchiesta ha avuto la fortuna di parlargli di persona. — Di persona? — ripeté Ladko, senza capirci nulla. — Di persona — affermò il giudice. Serge Ladko credeva di sognare. Come poteva aver trovato a Szalka un altro Ilia Brusch? — Non è possibile — balbettò. — C'è un errore. — Giudicate voi stesso — rispose il giudice. — Ecco il rapporto del commissario di polizia di Gran. Risulta che un magistrato, conformandosi alla commissione inquirente da me indirizzatagli, si è recato a Szalka il 14 settembre ed è andato in una casa all'angolo con l'alzaia e la strada di Budapest… È l'indirizzo che ci avete dato, non è vero? — s'interruppe il giudice. — Precisamente — rispose Serge Ladko con aria smarrita. — … e la strada di Budapest — riprese il signor Rona — ed è stato ricevuto nella detta casa dal signor Ilia Brusch in persona, il quale ha dichiarato di essere tornato in quei giorni, dopo lunghissima assenza. Il commissario aggiunge che le informazioni che ha potuto raccogliere sul conto del detto Ilia Brusch confermano la sua perfetta onorabilità e che nessun altro abitante di Szalka porta quel nome. Avete qualcosa da dire? Non abbiate timore, vi prego. — No — balbettò Serge Ladko, credendo d'impazzire. — Ecco un primo punto chiarito — concluse con soddisfazione il signor Rona, guardando il prigioniero come il gatto guarda il topo. CAPITOLO XIV TRA CIELO E TERRA TERMINATO l'interrogatorio, Serge Ladko raggiunse la propria cella senza neppure rendersi conto di ciò che faceva. Era già tanto se aveva capito le altre domande del giudice dopo che questi gli aveva riferito la conclusione della commissione inquirente, e vi aveva risposto con aria ebete. Ciò che gli capitava superava i limiti della sua intelligenza. Che si voleva da lui, alla fin fine? Rapito, imprigionato a bordo di un battello da misteriosi nemici, aveva riacquistato la libertà per perderla subito; ed ecco che a Szalka saltava fuori un altro Ilia Brusch, e cioè un altro se stesso, in casa sua! Tutto ciò aveva del fantasmagorico! Stupito e sgomento dal susseguirsi di quegli avvenimenti inspiegabili, egli aveva la sensazione di essere alla mercé di potenze ostili e più forti di lui; di essere incappato, preda inerte e senza difesa, negli ingranaggi di quella formidabile macchina che si chiama Giustizia. Depressione e annientamento di ogni energia erano stampati sul suo viso con molta eloquenza: persino uno dei suoi guardiani, pur considerandolo un indegno criminale, ne fu commosso. — Non va dunque come vorreste, amico mio? — chiese con tono di pietosa simpatia, pur essendo disincantato di fronte alle miserie umane. Se avesse parlato a un sordo, il risultato sarebbe stato lo stesso. — Su! — riprese compassionevole il guardiano — bisogna farsene una ragione. Il giudice Rona è un buon diavolo; forse ogni cosa si aggiusterà meglio di quanto crediate… Nell'attesa, voglio darvi questo… Vi si parla del vostro paese. Vi distrarrà. Il prigioniero non si mosse. Non aveva neppur sentito. Non udì neppure il chiavistello che girava nella toppa e tanto meno vide il giornale che la guardia, nell'andarsene, aveva lasciato sul tavolo della cella, dimenticando, in buona fede, che il prigioniero doveva essere tenuto nella segretezza più assoluta. Le ore passarono; il giorno finì, lasciando posto alla notte, e spuntò di nuovo l'aurora. Intontito, seduto sulla sedia, Serge Ladko non aveva coscienza del trascorrere del tempo. Quando la luce del giorno gli batté sul viso, parve uscire dal suo accasciamento. Aprì gli occhi e il suo sguardo incerto vagò per la cella. Scorse quasi subito il giornale lasciato il giorno precedente dalla pietà del guardiano. Aperto sul tavolo così come l'aveva lasciato il guardiano, il giornale metteva in evidenza un articolo in neretto il cui titolo: «I massacri di Bulgaria», attirò immediatamente lo sguardo di Serge Ladko. Trasalendo, afferrò febbrilmente il giornale: gli tornò di colpo l'intelligenza. A mano a mano che leggeva, gli brillavano gli occhi. Gli avvenimenti dei quali veniva a conoscenza in quel momento erano stati resi noti in tutti i paesi europei nello stesso tempo, sollevandovi un coro di riprovazioni. Sarebbero poi entrati nella storia, scrivendovi una pagina non certamente gloriosa. Come abbiamo detto all'inizio del nostro racconto, l'intera regione balcanica era allora in fermento. Sin dall'estate del 1875, l'Erzegovina si era ribellata e le truppe ottomane mandate contro di essa non erano riuscite a domarla. Nel maggio del 1876, la Bulgaria si era ribellata a sua volta e la Porta aveva risposto all'insurrezione concentrando un numeroso esercito in un vasto triangolo, le cui estremità erano costituite da Russe, Widdin e Sofia. Il 1° e il 2 luglio dello stesso anno, infine, la Serbia e il Montenegro, entrati in scena, avevano dichiarato guerra alla Turchia. Comandati dal generale russo Tchernaief, i serbi, dopo alcuni successi iniziali, avevano dovuto ritirarsi al di qua della loro frontiera e il 1° settembre il principe Milan era stato costretto a chiedere un armistizio di dieci giorni, durante il quale aveva sollecitato alle nazioni cristiane un intervento che esse purtroppo tardarono ad accordare. «Allora — scrisse Edouard Driault, nella sua Storia della Questione d'Oriente — si verificò il più spaventoso episodio di quelle lotte, che richiama alla memoria i massacri di Chio, al tempo dell'insurrezione greca: i massacri di Bulgaria. Durante la guerra contro la Serbia e il Montenegro, la Porta temette che l'insurrezione bulgara, alle spalle dell'esercito, ne compromettesse le operazioni. Chefkat Pascià, governatore della Bulgaria, ebbe ordine di soffocare a qualunque costo l'insurrezione? Probabilmente, sì. Bande di Basci-Buzuki e di circassi chiamati dall'Asia furono mandate in Bulgaria, ed esse in pochi giorni misero a ferro e a fuoco il paese, appagarono a piacere le loro selvagge passioni, bruciarono villaggi, massacrarono gli uomini tra raffinate torture, sventrarono donne e fecero a pezzi i bambini. Le vittime furono circa trentamila.» Mentre leggeva, gocce di sudore imperlavano il viso di Serge Ladko. Natcha!… Che ne era stato di Natcha in quel terribile sconvolgimento? Era ancora viva oppure era morta, e il suo cadavere sventrato, fatto a pezzi come quello di tante altre vittime innocenti, trascinato nella melma, nel fango e nel sangue, calpestato dai cavalli? Serge Ladko si era alzato; come una bestia feroce chiusa in gabbia andava su e giù per la cella come se cercasse un'uscita per poter correre in aiuto di Natcha. L'accesso di disperazione durò poco. Tornato presto alla ragione, con terribile sforzo si costrinse alla calma e razionalmente pensò al mezzo per riacquistare la libertà. Andare dal giudice, confessargli la verità, implorarne se necessario la compassione? Non sarebbe servito a nulla: come poteva sperare di ottenere la fiducia del giudice già prevenuto, dopo aver perseverato così a lungo nella menzogna? Come poteva cancellare con una sola parola il sospetto legato a Ladko, il suo vero nome, e distruggere in un istante tutte le accuse che gli erano state fatte? No. Sarebbe stata necessaria un'inchiesta, per lo meno, e l'inchiesta avrebbe richiesto settimane, se non mesi. Bisognava tentare la fuga, dunque. Per la prima volta da quando vi aveva messo piede, Serge Ladko esaminò la cella. Bastarono pochi istanti. Quattro pareti, due buchi: la porta da un lato, la finestra dall'altro. Dietro altre pareti, altre celle, altre prigioni; oltre la finestra, lo spazio e la libertà. L'altezza del parapetto di quella finestra (il cui architrave raggiungeva il soffitto) superava il metro e mezzo e quello che avrebbe potuto dirsi il davanzale nel caso di un'apertura normale era irraggiungibile, poiché una fila di grosse sbarre murate negli stipiti impediva di avvicinarvisi. D'altro canto, quand'anche si fosse superata tale difficoltà, ne sarebbe rimasta un'altra. All'esterno, una specie di cappa, i cui lati venivano ad appoggiarsi a destra e a sinistra della finestra, bloccava gli sguardi e permetteva la vista solo di un ridotto rettangolo di cielo. Quindi, non tanto per tentare la fuga ma soltanto per mettersi nelle condizioni di cercare il modo, bisognava per prima cosa superare l'ostacolo delle sbarre e poi issarsi a forza di braccia alla fine di quella specie di scatola onde riuscire a dare un'occhiata ai dintorni. A giudicare dalle scale discese in occasione delle convocazioni del signor Rona, Ladko riteneva di essere rinchiuso al quarto piano della prigione: era quindi a una dozzina di metri o poco più dal suolo. Gli sarebbe stato possibile superarli? Impaziente di accertarlo, decise di mettersi subito all'opera. Innanzi tutto però bisognava procurarsi uno strumento di lavoro. Gli avevano tolto ogni cosa, quando lo avevano incarcerato, e nella cella non c'era nulla che gli potesse essere d'aiuto. Un tavolo, una sedia e un modesto pagliericcio che ricopriva un incavo in muratura, costituivano il mobilio della cella. Serge Ladko continuava a cercare invano quando, tastandosi per la centesima volta gli abiti, la sua mano percepì un qualcosa di duro. Proprio come i suoi carcerieri, egli fin allora non aveva dato peso a quella cosa insignificante che è la fibbia dei pantaloni: ma quale importanza acquistava ora quell'unico oggetto metallico in suo possesso! Staccata la fibbia, Ladko attaccò senza perdere tempo la parete ai piedi di una sbarra, e la pietra, ostinatamente graffiata dai puntali d'acciaio, cominciò a cadere in polvere. Quel lavoro, già così lento e penoso, era reso ancor più difficile dall'incessante sorveglianza a cui era sottoposto. Non passava ora che un guardiano non mettesse l'occhio allo spioncino della porta. Doveva perciò tenere l'orecchio sempre teso ai rumori provenienti dall'esterno e interrompere, al minimo segno di pericolo, il lavoro facendo sparire ogni traccia sospetta. A questo scopo, Serge Ladko utilizzò la mollica del proprio pezzo di pane, che mischiata con la polvere che cadeva dalla parete prendeva un colore quasi simile a quello della pietra, e la usò come mastice per occultare il buco a mano a mano che lo scavava. Il resto dei detriti lo nascose sotto il letto. Dopo dodici ore di fatica, la sbarra era scalzata per un'altezza di tre centimetri, ma la fibbia non aveva più punte. Ladko la spezzò e ne utilizzò i rottami. Dodici ore dopo, anche quei pezzettini di acciaio erano inservibili. Ma la fortuna che già aveva sorriso al prigioniero pareva non volerlo abbandonare. Al primo pasto che gli fu portato si arrischiò a tenere il coltello e poiché nessuno si accorse del piccolo furto, lo rifece, con eguale fortuna, il giorno seguente. Possedeva adesso due strumenti migliori di quelli avuti fino allora, anche se erano pessimi coltelli; ma le loro lame erano abbastanza buone e il manico ne facilitava il maneggio. Da quel momento il lavoro proseguì più in fretta, anche se ancora troppo lentamente. Man mano che scavava il cemento diventava sempre più duro e più difficoltoso da raschiare. Doveva poi interrompere il lavoro a ogni istante, sia a causa della ronda, sia per i frequenti interrogatori del signor Rona. Il risultato di questi interrogatori era sempre lo stesso. L'istruttoria segnava il passo. Ogni volta era una sfilata di testimoni le cui dichiarazioni non apportavano alcun contributo. Se qualcuno credeva di ravvisare qualche vaga rassomiglianza tra Serge Ladko e il malfattore visto più o meno bene il giorno in cui ne era stato vittima, qualche altro negava invece categoricamente qualsiasi rassomiglianza. Inutilmente il signor Rona faceva camuffare l'accusato con ogni specie di barba posticcia, l'obbligava a mostrare gli occhi o a nasconderli dietro lenti nere; non riusciva a ottenere alcuna testimonianza decisiva. Aspettava perciò con impazienza che le condizioni di salute di Christian Hoël, ferito nel corso dell'ultimo crimine della banda del Danubio, consentissero a quest'ultimo di recarsi a Semlin. Serge Ladko non mostrava alcun interesse per questi interrogatori: docilmente si prestava agli esperimenti del giudice, metteva parrucche e barbe posticce, metteva o toglieva gli occhiali, senza osar fare la minima osservazione. Il suo pensiero non era in quell'ufficio; era nella sua cella, dove la sbarra che lo separava dalla libertà usciva a poco a poco dalla pietra. Gli ci vollero quattro giorni per riuscire a svellerla. Soltanto la sera del 23 settembre egli ne raggiunse l'estremità inferiore. Ora doveva segarne l'estremità opposta. Quella parte del lavoro era la più faticosa. Sospeso con una mano all'inferriata, con l'altra Serge Ladko si dava da fare a muovere il suo attrezzo, quella lama di coltello che come sega non valeva niente e intaccava il ferro lentamente. D'altra parte, la posizione scomoda lo obbligava a riposarsi spesso. Il 29 settembre, dopo sei giorni di sforzi eroici, Ladko ritenne sufficiente la profondità della tacca. Il ferro era quasi del tutto segato e in qualsiasi momento avrebbe potuto vincerne la resistenza. Era tempo: la lama del secondo coltello era ridotta ormai a un filo. Il mattino dopo, subito dopo il passaggio della prima ronda, la qualcosa gli avrebbe assicurato un'ora di tranquillità, Serge Ladko proseguì con metodo il suo lavoro. Come aveva previsto, la sbarra si piegò senza difficoltà. Attraverso quell'apertura egli passò dall'altra parte dell'inferriata e, sollevandosi a forza di braccia, raggiunse l'estremità della cappa, dalla quale guardò avidamente attorno. Come aveva immaginato, circa quattordici metri lo separavano dal suolo. Se avesse avuto una corda sufficientemente lunga, non sarebbe stato difficile superare questa distanza. Calarsi a terra era il problema meno grave, le vere difficoltà sarebbero cominciate solo dopo. Come Serge Ladko poté constatare, la prigione era circondata infatti da un vicolo per le pattuglie di guardia, delimitato in fondo da un muro alto circa otto metri, oltre il quale si vedevano i tetti delle case. Una volta a terra, avrebbe dovuto scavalcare il muro, la qualcosa a prima vista appariva impossibile. A giudicare dalla distanza, la prigione era probabilmente separata dalle case da una strada: se l'avesse raggiunta, l'evaso avrebbe potuto considerarsi salvo. Ma esisteva la possibilità di raggiungerla sani e salvi? Alla ricerca di una qualsiasi soluzione, Serge Ladko cominciò a esaminare attentamente ciò che poteva vedere sulla sinistra. Non vi scorse la soluzione che cercava, ma ciò che vide gli fece battere il cuore per l'emozione. Da quella parte egli vedeva il Danubio, le cui acque giallastre erano solcate da numerosi battelli di varia dimensione. Alcuni seguivano o risalivano la corrente, altri tendevano la gomena all'ancora o all'ormeggio che li tratteneva alla banchina. Tra questi ultimi il pilota riconobbe subito la sua chiatta. Niente la differenziava dalle imbarcazioni vicine, né pareva che fosse fatta oggetto di particolare sorveglianza. Che fortuna se fosse riuscito a riprendersela! In meno di un'ora, avrebbe oltrepassato la frontiera, e in territorio serbo si sarebbe fatto beffe della giustizia austroungarica. Guardando verso destra, l'attenzione di Serge Ladko fu attirata da un particolare: trattenuto a intervalli da robusti ramponi piantati nel muro, un cavo di ferro — quasi certamente quello del parafulmine — scendeva dal tetto, passava vicino alla finestra e spariva nel suolo. Se avesse potuto raggiungerlo, quel cavo gli avrebbe facilitato la discesa; e forse ciò era possibile. Proprio a livello del pavimento della sua cella un cornicione decorativo, largo all'incirca venticinque centimetri, correva lungo tutto il muro. Tenendovisi in equilibrio con abilità e sangue freddo forse sarebbe riuscito a raggiungerlo. Disgraziatamente, anche ad esser capaci di tanta follia, restava sempre l'invalicabile muro esterno. Prigioniero in una cella o nel cammino della ronda, era pur sempre in prigione. Esaminando il muro ancora più attentamente, Serge Ladko notò che la sua parte superiore, appena al disotto della cappa, era decorata internamente ed esternamente da un bugnato, formato da pietre squadrate semincastrate nella costruzione. Serge Ladko contemplò a lungo quel fregio architettonico; poi si lasciò scivolare sul davanzale della finestra e rientrò nella cella, dove si affrettò a far sparire ogni traccia compromettente. Aveva già deciso che cosa doveva fare, aveva trovato il modo di tornare libero. Anche se rischioso, quel mezzo poteva e doveva riuscire. Del resto, meglio morire piuttosto che vivere con simili angosce. Attese con pazienza il passaggio della seconda ronda e poi, certo di un nuovo periodo di tranquillità, cercò di completare i suoi preparativi di fuga. Con l'aiuto di ciò che rimaneva del coltello, tagliò le lenzuola in strisce di alcuni centimetri di larghezza. Per non attirare l'attenzione dei sorveglianti, mise una parte della tela nella sua cuccetta perché conservasse il solito aspetto, anche se era sicuro che a nessuno sarebbe venuta l'idea di sollevare il copriletto. Fece una treccia di quattro strisce, annodandovene delle altre quando le prime erano alla fine. Il lavoro richiese un'intera giornata. Il 1° ottobre, prima di mezzogiorno, Ladko era in possesso di una solida corda lunga una quindicina di metri, che nascose sotto la cuccetta. Poiché ogni cosa era pronta, egli decise di tentare l'evasione alle nove di quella stessa sera. Ladko trascorse la giornata a riesaminare ogni particolare dell'impresa e a calcolarne rischi e pericoli. Quale esito avrebbe avuto: la libertà o la morte? Tra poco, ogni cosa sarebbe stata decisa. In qualsiasi caso, egli avrebbe tentato la fuga. Prima che scoccasse l'ora di agire, il destino volle riservargli però un'ultima prova. Verso le tre del pomeriggio, i chiavistelli della porta furono aperti con fracasso. Che cosa volevano da lui? Un altro interrogatorio, forse? L'ora solita era già trascorsa, però… Non si trattava di un'altra convocazione da parte del giudice. Dalla porta spalancata, Serge Ladko vide nel corridoio, oltre ai soliti guardiani, tre persone a lui sconosciute, tra le quali una giovane di circa vent'anni, dal cui viso spiravano dolcezza e bontà. I due uomini che l'accompagnavano erano il marito e il direttore del carcere, come facilmente si poteva indovinare dalle parole e dall'atteggiamento del guardiano. Si trattava evidentemente di una visita. A giudicare dal rispetto con cui erano trattati, i visitatori erano probabilmente una coppia principesca in viaggio, alla quale il direttore faceva da cicerone. — L'attuale occupante di questa cella — disse ai suoi ospiti — è il famoso Ladko, capo della banda del Danubio, il cui nome sarà certamente giunto alle vostre orecchie. La giovane rivolse una timida occhiata al celebre malfattore. Non aveva affatto l'aria terribile, il celebre malfattore. Mai si sarebbe immaginato il capo di una banda di leggendaria crudeltà sotto l'aspetto di quell'uomo smagrito e macilento, dall'aria sparuta e i cui occhi esprimevano angoscia e disperazione. — E vero che egli si incaponisce a dichiararsi innocente — aggiunse con imparzialità il direttore — ma noi siamo abituati a ritornelli del genere. Egli fece in seguito osservare la pulizia e l'ordine che regnavano nella cella; accalorandosi nel discorso, ne varcò persino la soglia e andò ad appoggiarsi alla parete della finestra, nell'intento di guardare in faccia gli ospiti. A un tratto il cuore di Serge Ladko cessò di battere. Senza rendersene conto, l'oratore sfiorava il punto della parete intaccato dal prigioniero e un po' di sottile polvere di cemento cominciava a cadere. Un altro movimento, e stavolta fu il tampone di mollica a staccarsi e a cadere sul pavimento. Ladko ebbe un brivido di spavento nel vedere che l'estremità della sbarra segata appariva in fondo alla cavità. Qualcuno se ne era forse accorto? Sì, qualcuno aveva visto. Mentre il marito e il direttore esaminavano la misera tavola come oggetto di altissimo interesse, mentre i guardiani, rispettosamente voltati, sembravano guardare in fondo al corridoio, la giovane teneva gli occhi fissi sul buco scavato nella parete e l'espressione del suo viso rivelava che ella ne comprendeva il misterioso linguaggio. Ella avrebbe parlato… con una parola, avrebbe rovinato ogni cosa… Ladko aspettava e, poco alla volta, si sentiva morire. Pallida, la giovane alzò gli occhi sul prigioniero e lo sfiorò con il suo limpido sguardo. Vide le grosse lagrime che sfuggivano lentamente dalle palpebre dell'infelice? Comprese la sua tacita supplica? Intuì la sua tremenda disperazione? Trascorsero dieci drammatici secondi e all'improvviso ella si volse, con un grido di dolore. I due uomini le furono subito accanto. Che cosa le era capitato? Nulla di grave, ella disse con voce incerta, sforzandosi di sorridere. Aveva preso scioccamente una storta al piede, ecco tutto. Mentre Serge Ladko, senza essere notato, andava a mettersi dinanzi alla sbarra per occultarla, il marito, il direttore e un guardiano le si fecero accanto premurosamente. I primi due uscirono sostenendo la giovane, mentre il terzo si affrettava a chiudere la porta della cella. Serge Ladko era nuovamente solo. Quale slancio di gratitudine per la dolce pietosa creatura gli gonfiò il petto! Doveva a lei la salvezza. Le doveva la vita; più della vita, le doveva la libertà. Si era disteso, prostrato, sulla cuccetta. L'emozione era stata troppo violenta. Quest'ultimo colpo del destino gli faceva vacillare la mente. Il resto della giornata trascorse senza altri incidenti. I lontani orologi della città sonarono, finalmente, le nove. La notte era sopraggiunta. Grosse nuvole percorrevano il cielo, accrescendone l'oscurità. Nel corridoio, un rumore annunciava l'avvicinarsi della ronda, che giunta dinanzi alla sua porta, si fermò: un guardiano mise l'occhio sullo spioncino e se ne andò soddisfatto. Il prigioniero dormiva con la coperta fin sotto il mento. La ronda proseguì il proprio servizio: il rumore dei passi si allontanò e poi si spense. Il momento di agire era giunto. Serge Ladko saltò giù dalla cuccetta e sistemò le coperte in modo che nella penombra della cella potessero simulare il corpo di un uomo addormentato. Poi prese la corda, s'insinuò come già la prima volta di là dall'inferriata, si tirò su e si mise a cavalcioni sull'orlo superiore della cappa. All'altezza di ogni piano si allungavano i cornicioni che ornavano la costruzione; Serge Ladko dominava da quasi quattro metri quello sul quale doveva mettere piede. Aveva previsto quella difficoltà: passò la corda intorno a una sbarra dell'inferriata, e tenendone in mano entrambe le estremità, si lasciò scivolare senza troppa fatica sino alla sporgenza esterna. Con il dorso appoggiato al muro e la mano sinistra attaccata alla corda che lo sosteneva, il fuggitivo prese fiato per un istante. Come mantenere l'equilibrio su quella stretta superficie? Non appena mollato il sostegno, sarebbe precipitato sul cammino della ronda. Con estrema prudenza, con movimenti quasi impercettibili, riuscì a prendere la corda con la mano destra, mentre con la sinistra tastava la parete della cappa: non poteva star su da sola, quella cappa dinanzi alla finestra, doveva esserci per forza un sostegno. E a furia di cercare, la sua mano urtò in un ostacolo nel quale riconobbe, dopo qualche incertezza, un fermo piantato nella costruzione. Per debole che fosse la presa, doveva accontentarsene. Aggrappandovisi con le dita contratte, tirò lentamente un capo della corda, facendola a poco a poco ricadere sulle sue spalle. Dietro di lui ormai i ponti erano rotti. Se anche lo avesse voluto, non gli sarebbe stato più possibile raggiungere la cella. Ormai bisognava andare avanti. Serge Ladko si arrischiò a voltare un po' la testa verso il cavo del parafulmine, sul cui aiuto contava. Ma quale non fu il suo spavento nel constatare che quasi due metri separavano il cavo dalla cappa, dalla quale non poteva allontanarsi, se non a rischio di morire! Bisognava prendere una decisione, comunque. In piedi su quella stretta sporgenza, con le spalle appoggiate al muro, trattenuto sul vuoto da quel pezzetto di ferro che l'estremità delle sue dita riuscivano a malapena a stringere, non poteva rimanerci. Tra pochi minuti le sue dita rattrappite avrebbero mollato la presa e sarebbe inevitabilmente caduto. Meglio dunque morire nel tentativo di un ultimo sforzo verso la salvezza. Piegandosi nella direzione della finestra, il fuggitivo ripiegò il braccio sinistro come una molla pronta a distendersi; poi, abbandonando ogni appoggio, si spinse di colpo verso destra. Cadde. La spalla urtò la sporgenza del cornicione, ma grazie allo slancio, le sue mani protese erano riuscite ad aggrapparsi al cavo. La prima difficoltà era stata vinta. Occorreva vincere la seconda. Ladko si lasciò scivolare lungo il cavo e si fermò su un rampone che lo fissava al muro. Fece una breve sosta e si concesse il tempo di riflettere. Il terreno era invisibile a causa dell'oscurità della notte, ma dal basso giungeva fino a lui il rumore di un passo cadenzato. Era evidente che una sentinella montava la guardia e, a giudicare dal rumore che di volta in volta s'avvicinava per poi allontanarsi, la sentinella, dopo aver costeggiato quel lato del carcere, svoltava sull'altro lato, per poi tornare a ricominciare il suo avanti-indietro senza interruzione. Ladko calcolò che la sentinella s'allontanava per la durata di tre o quattro minuti; doveva dunque superare la distanza che lo separava dal muro esterno in quel breve tempo. Intravedeva sotto di lui il biancore del muro che si stagliava vagamente nell'ombra, ma non poteva distinguere le pietre sporgenti che ne coprivano la sommità. Serge Ladko si lasciò scivolare più in basso e si fermò su un rampone inferiore. Da quel punto egli dominava ancora di almeno un paio di metri l'orlo del muro che bisognava superare. Ora, aggrappato al cavo, si poteva muovere più rapidamente. In un istante srotolò la corda, la fece passare dietro il cavo del parafulmine e ne annodò le due estremità in modo da renderla più lunga possibile. Calcolata approssimativamente la distanza, egli lanciò la corda al disopra del muro di cinta e, come se fosse un laccio, ne tirò l'estremità a forma di anello cercando di agganciare una delle pietre sporgenti di cui il muro era esternamente ornato. L'impresa era difficile; a causa della profonda oscurità non poteva vedere le sporgenze del muro, e quindi non poteva contare che sul caso. Aveva lanciato la corda più di venti volte senza risultato, quando alla fine oppose resistenza. Serge Ladko tirò con insistenza: la presa non cedette. Il tentativo era dunque riuscito. L'anello della corda si era chiuso intorno a un fregio: una specie di passerella era ora gettata al disopra del cammino della ronda. Passerella fragile, certamente! Non si sarebbe rotta oppure staccata dalla pietra che la tratteneva? Nel primo caso, ci sarebbe stata una paurosa caduta dall'altezza di dieci metri; nel secondo, scattando come un elastico contro il muro della prigione, il suo fardello umano sarebbe andato a schiacciarvisi. Serge Ladko non esitò neppure un attimo dinanzi al pericolo. Tese fortemente la corda e ne riunì nuovamente le estremità; poi, pronto a lanciarsi, prestò orecchio ai passi del soldato di guardia. Costui era proprio sotto al fuggitivo. Si allontanò. Girò l'angolo e il rumore dei suoi passi cessò. Bisognava approfittare della sua assenza, senza perdere un solo secondo. Ladko avanzò sul cammino aereo. Sospeso tra cielo e terra, procedeva con mosse eguali ed elastiche, senza preoccuparsi dei cedimenti della corda, la cui curva si accentuava a mano a mano che egli si avvicinava alla metà del percorso. Voleva passare. Sarebbe passato. Passò. In meno di un minuto, superato il vertiginoso abisso, raggiunse la cresta del muro. Senza prendere respiro, si diede da fare febbrilmente, eccitato dalla certezza del successo. Erano trascorsi soltanto dieci minuti da quando aveva lasciato la cella, ma quei dieci minuti gli sembravano più lunghi di un'ora: temeva che una ronda andasse a ispezionare la sua cella. Si sarebbero accorti della sua fuga, nonostante il trucco della cuccetta? Doveva essere lontano, prima che ciò accadesse. La chiatta era a due passi da lui! Pochi colpi di remo e sarebbe stato fuori della portata dei suoi persecutori. Interrompendo il suo lavoro a ogni passaggio del soldato di guardia, Ladko sciolse febbrilmente la corda, arrotolandola la tirò a sé e poi, doppiandola un'altra volta, fece presa intorno a una sporgenza interna del muro e cominciò a scendere, dopo essersi assicurato che la via era deserta. Giunto felicemente a terra, fece subito ricadere la corda ai suoi piedi e l'arrotolò. Tutto era finito. Era libero; della sua audace evasione non sarebbe rimasta traccia. Stava per andare alla ricerca della sua chiatta quando nel buio udì improvvisamente una voce. — Diamine! — disse qualcuno a pochi passi da lui, — è il signor Ilia Brusch, parola mia! Serge Ladko ebbe un brivido di gioia. Il destino gli era decisamente favorevole: ecco che gli mandava l'aiuto di un amico. — Il signor Jaeger! — esclamò con voce allegra, mentre qualcuno usciva dall'ombra e veniva verso di lui. CAPITOLO XV VICINO ALLA META IL 10 OTTOBRE, da quando la chiatta aveva ripreso a discendere il Danubio l'alba si alzò per la nona volta: nel corso degli otto giorni precedenti, erano stati percorsi quasi settecento chilometri. Russe era vicina; sarebbe stata raggiunta prima di sera. A bordo, nulla sembrava cambiato; sulla chiatta c'erano come in passato Serge Ladko e Karl Dragoch, tornati ad essere il pescatore Ilia Brusch e il brav'uomo Jaeger. Il modo con cui il primo recitava ora la sua parte rendeva più difficile all'altro sostenere la propria. Spinto dal desiderio di arrivare a Russe, remando giorno e notte, Serge Ladko trascurava infatti le più elementari precauzioni. Non portava più gli occhiali, non si rasava e non si tingeva più i capelli, permettendo a quei cambiamenti che già si erano manifestati durante la sua detenzione, di mostrarsi in tutta la loro evidenza. I capelli neri si schiarivano di giorno in giorno e la barba bionda cominciava a raggiungere una lunghezza rispettabile. Sarebbe stato naturale che Karl Dragoch manifestasse stupore per quella trasformazione, ma non diceva nulla. Risoluto ad arrivare fino in fondo al vicolo nel quale si era cacciato, aveva deciso di fingere di non vedere ciò che l'avrebbe messo in una situazione imbarazzante. Nel momento in cui si era trovato dinanzi a Serge Ladko, le precedenti idee di Karl Dragoch erano fortemente vacillate: ora si sentiva meno portato ad ammettere la colpevolezza del suo compagno di viaggio. L'incidente provocato dalla commissione d'inchiesta di Szalka era stato la prima causa del cambiamento. Karl Dragoch aveva proceduto infatti a un'inchiesta personale. Più difficile da accontentare del commissario di polizia di Gran, egli aveva interrogato a lungo gli abitanti della città e le risposte ottenute erano riuscite a turbarlo. Che un tale Ilia Brusch, la cui vita era del resto più che regolare, avesse eletto domicilio a Szalka e avesse lasciato la cittadina poco prima della gara di Sigmaringen, era fuor di ogni dubbio. Ilia Brusch era stato di nuovo visto dopo la gara, particolarmente nella notte dal 28 al 29 agosto? Su questo punto le testimonianze furono evasive. Anche se i vicini credevano di ricordare che verso la fine di agosto avevano visto la luce accesa nella casa del pescatore, chiusa da oltre un mese, tuttavia non osarono affermarlo. Quelle notizie, per quanto vaghe ed incerte, accrebbero ovviamente le perplessità del poliziotto. Rimaneva un altro punto da chiarire. Chi era la persona che aveva parlato con il commissario di Gran, in casa dell'accusato? A tale riguardo, Dragoch non riuscì a raccogliere alcuna informazione. Poiché Ilia Brusch era molto conosciuto a Szalka, e poiché nessuno l'aveva visto, per forza di cose, se vi era venuto, doveva essere arrivato e ripartito durante la notte. Questo mistero, già strano di per se stesso, lo divenne ancora di più, quando Karl Dragoch ebbe messo la mano sul proprietario di un alberghetto, al quale, nella sera del 12 settembre, trentasei ore prima della visita del commissario di polizia di Gran, uno sconosciuto aveva chiesto l'indirizzo di Ilia Brusch. La faccenda si complicava. Si complicò ancora di più quando l'albergatore, incalzato dalle domande, fornì le caratteristiche somatiche dello sconosciuto, che rispondevano perfettamente a quelle che la voce popolare attribuiva al capo della banda del Danubio. Tutto questo diede da pensare a Karl Dragoch. Egli fiutò qualcosa di losco. Ebbe istintivamente l'impressione di essere di fronte a una macchinazione tenebrosa, di cui gli rimaneva oscuro lo scopo, ma della quale non era impossibile che l'imputato potesse essere la vittima. Quell'impressione si rafforzò quando, tornato a Semlin, seppe come procedevano le indagini. Dopo venti giorni di segretezza, non era stato fatto un passo avanti. Nessun complice era stato scoperto, nessun testimone aveva formalmente riconosciuto il prigioniero, contro il quale esisteva soltanto l'imputazione di aver cercato di modificare i suoi connotati e di essere stato in possesso di un ritratto di donna sul quale c'era scritto il nome di Ladko. Le congetture sostenute da altre avrebbero avuto un grande valore, da sole perdevano gran parte della loro importanza. Dopo tutto, il travestimento e il ritratto potevano avere una giustificazione. Quelle considerazioni rendevano l'animo di Karl Dragoch particolarmente accessibile alla pietà. Ecco perché non aveva potuto impedire a se stesso di essere profondamente commosso dall'ingenua fiducia di Serge Ladko, in una circostanza in cui sarebbe stato scusabile se avesse diffidato dell'amico più intimo. Era impossibile, dunque, conciliare la pietà con i doveri della sua professione e riprendere, come prima, il proprio posto sulla chiatta? Se Ilia Brusch si chiamava effettivamente Ladko, e se Ladko era un malvivente, Karl Dragoch, stando con lui, avrebbe depistato i suoi complici. Se innocente, lo avrebbe forse condotto al vero colpevole, al quale l'incidente di Szalka provava, in tal caso, che dava fastidio. Questi ragionamenti, un po' speciosi, non mancavano però di una certa logica. Il misero aspetto di Serge Ladko, il coraggio sovrumano dimostrato nel compiere la sua straordinaria evasione, e soprattutto il ricordo del servizio resogli con eroica semplicità, fecero il resto. Karl Dragoch doveva la vita a quel pover'uomo che ansava dinanzi a lui, con le mani che gli sanguinavano per la fatica e con il sudore che gli colava sul viso scarno. Lo avrebbe, come ricompensa, ricacciato nell'inferno? Il poliziotto non sapeva che cosa fare. — Venite! — disse, rispondendo all'esclamazione gioiosa del fuggitivo, trascinandolo verso il fiume. Poche parole erano state scambiate tra i due compagni nel corso degli otto giorni passati insieme. Serge Ladko stava quasi sempre zitto, concentrando ogni sforzo nel cercare di accrescere la velocità dell'imbarcazione. Con frasi spezzettate, che occorreva strappargli faticosamente di bocca, egli raccontò tuttavia le sue inspiegabili disavventure, dalla confluenza con l'Ipoly in poi. Disse della sua lunga prigionia nel carcere di Semlin, dopo il sequestro ancora più strano a bordo del battello sconosciuto. Mentivano dunque coloro che dicevano di averlo visto tra Budapest e Semlin, poiché in quel frattempo egli era prigioniero in quel battello, con mani e piedi legati. Quel racconto fece evolvere ancor più le congetture iniziali di Karl Dragoch. Egli stabiliva, senza volerlo, un accostamento tra l'aggressione subita da Ilia Brusch e la presenza di un sosia a Szalka. Senza alcun dubbio, il pescatore dava fastidio a qualcuno ed era nel mirino di un ignoto nemico; purtroppo i suoi dati segnaletici sembravano corrispondere a quelli del vero bandito. A poco a poco Karl Dragoch s'incamminava verso la verità. Era nell'impossibilità di verificare le sue deduzioni, nondimeno sentiva diminuire di giorno in giorno i vecchi sospetti. Non pensò neppure per un istante di abbandonare la chiatta per tornare indietro a ricominciare da capo l'inchiesta. Il suo fiuto di poliziotto gli diceva che la pista era quella buona e che il pescatore, forse innocente, era in un modo o nell'altro legato alla storia della banda del Danubio. Sull'alto fiume la tranquillità era perfetta, del resto; la successione dei crimini commessi provava che anche i loro autori avevano disceso la corrente, almeno sino ai dintorni di Semlin. C'era dunque ogni probabilità che essi avessero continuato a discendere il fiume anche durante la detenzione di Ilia Brusch. Su questo punto Karl Dragoch non si sbagliava. Ivan Striga continuava infatti ad avvicinarsi al Mar Nero, con dodici giorni di anticipo, alla partenza da Semlin, sulla chiatta. Ma quei dodici giorni egli li stava perdendo a poco a poco: la distanza che separava le due imbarcazioni diminuiva di giorno in giorno: ad ogni ora, ad ogni minuto, la chiatta, sotto lo sforzo rabbioso di Serge Ladko, guadagnava implacabilmente tempo sul battello. Ladko aveva una sola meta: Russe; una sola idea: Natcha. Se non prendeva più le precauzioni di un tempo per non farsi riconoscere, era perché non ci pensava proprio più. Del resto, quale importanza avrebbero avuto ora? Dopo l'arresto e l'evasione, chiamarsi Ilia Brusch doveva essere compromettente tanto quanto chiamarsi Serge Ladko. Sotto un nome o sotto l'altro, ormai poteva entrare a Russe soltanto di nascosto, pena l'arresto immediato. Assorto nella sua idea fissa, in quegli otto giorni egli non aveva prestato alcuna attenzione alle rive del fiume. Se si era accorto di passare dinanzi a Belgrado — la città bianca disposta a piani sulla collina dominata dal palazzo del principe, il Konak, e preceduta da un sobborgo dal quale transita un'immensa quantità di merci — era perché Belgrado rappresentava la frontiera serba, dove finivano i poteri del signor Izar Rona. Dopo non guardò più nulla. Non vide Semendria, antica capitale della Serbia, celebre per i vigneti che la circondano; non vide Colombals, dove il turista può visitare una caverna nella quale, secondo la leggenda, San Giorgio avrebbe deposto il corpo del drago ucciso; non vide Orsova, al di là della quale il Danubio scorre tra due antiche province turche, divenute in seguito regni indipendenti; non vide le Porte di Ferro, famosa gola chiusa tra pareti verticali alte quattrocento metri, dove il Danubio urge e si rompe furiosamente contro le rocce di cui il suo letto è cosparso; non vide Widdin, primo villaggio bulgaro di qualche importanza; non vide Nikopoli né Sistowa, le altre due città che erano a monte di Russe. Costeggiava di preferenza la riva serba, ove riteneva di essere più al sicuro; infatti, sino all'uscita delle Porte di Ferro, egli non fu disturbato dalla polizia. A Orsova, per la prima volta, un canotto della brigata fluviale intimò alla chiatta di fermarsi. Inquieto, Serge Ladko obbedì, chiedendosi che cosa avrebbe risposto alle domande che inevitabilmente gli sarebbero state fatte. Non fu neppure interrogato. Bastò una parola di Karl Dragoch e il capo del distaccamento salutò con rispetto, senza nemmeno accennare a una perquisizione. Il pilota neppure si stupì per il fatto che un borghese di Vienna usasse a suo piacimento la forza pubblica. Felice di cavarsela a buon mercato, trovò del tutto naturale che un'onnipotenza si desse da fare per il suo interesse; non si stupì, ma divenne sempre più impaziente per il prolungarsi del colloquio tra l'agente e il passeggero. In seguito agli ordini ricevuti sia dal signor Izar Rona, furioso per l'evasione del detenuto, sia da Karl Dragoch in persona, la polizia del fiume era stata notevolmente rinforzata. Di tratto in tratto, la navigazione era costretta a superare una serie di sbarramenti, tra i quali quello di Orsova era molto importante. La stretta del fiume in quella parte facilitava la sorveglianza; era impossibile infatti che un battello riuscisse a passare senza essere stato minuziosamente perquisito. Karl Dragoch interrogò il subordinato ed ebbe la spiacevole sorpresa di apprendere che le perquisizioni non avevano dato alcun risultato e che un nuovo crimine, un furto di una certa gravità, era stato commesso due giorni prima in territorio rumeno, alla confluenza del Jirel, quasi esattamente di fronte alla città bulgara di Rahowa. La banda del Danubio era dunque riuscita a passare tra le maglie della rete. Poiché aveva l'abitudine di rubare non soltanto oro ed argento, ma anche oggetti preziosi di qualsiasi natura, il suo bottino doveva essere ingombrante; era del tutto inconcepibile quindi che non si riuscisse a trovarne traccia, se nessun battello era sfuggito alla perquisizione. Eppure era così. Karl Dragoch era stupito di tanta abilità, ma bisognava arrendersi all'evidenza, visto che i malfattori, con altri furti, davano la prova di essere più a valle. La sola conclusione alla quale si poteva giungere era che bisognava far presto. Il luogo e la data dell'ultimo furto segnalato dimostravano che gli autori avevano meno di trecento chilometri di vantaggio. Se si teneva conto del tempo durante il quale Ilia Brusch era stato prigioniero, tempo che la banda aveva certamente messo a profitto, bisognava supporre che la velocità del suo battello era appena la metà di quella della chiatta. Non era dunque impossibile raggiungerlo. Partirono subito e sin dalle prime ore del 6 ottobre avevano oltrepassato la frontiera bulgara. Da quel punto Serge Ladko, che fin allora aveva fatto del suo meglio per seguire la riva destra, si accostò il più possibile alla riva rumena, alla quale, a partire da Lom-Palamka, una serie di paludi larghe da otto a dieci chilometri impediva l'accosto. Per quanto Ladko fosse assorto in se stesso, il fiume in acque bulgare doveva per forza metterlo in sospetto. Lo solcavano un certo numero di navi a vapore e persino delle torpediniere, ossia delle cannoniere, battenti bandiera ottomana. In previsione della guerra che sarebbe scoppiata meno di un anno dopo con la Russia, la Turchia cominciava già a sorvegliare il Danubio, nel quale avrebbe fatto affluire in seguito una vera flottiglia. Il pilota preferì tenersi lontano dalle navi turche, a costo di gettarsi nelle grinfie delle autorità rumene, contro le quali il signor Jaeger sarebbe stato capace probabilmente di proteggerlo, come già aveva fatto a Orsova. L'occasione di mettere a nuova prova il potere del passeggero non si presentò; nessun incidente turbò l'ultima parte del viaggio. Il 10 ottobre, verso le quattro del pomeriggio, la chiatta giungeva finalmente all'altezza di Russe, che si vedeva confusamente sull'altra riva. Il pilota raggiunse allora il centro del fiume e poi, smettendo di remare per la prima volta dopo tanti giorni, diede fondo all'ancorotto. — Che cosa c'è? — chiese Karl Dragoch, sorpreso. — Io sono arrivato — rispose laconicamente Serge Ladko. — Arrivato? Non siamo ancora al Mar Nero. — Vi ho ingannato, signor Jaeger — dichiarò Serge Ladko con franchezza. — Non ho mai avuto l'intenzione di andare fino al Mar Nero. — Bah! — disse il poliziotto, la cui attenzione si era risvegliata. — Sono partito con l'idea di fermarmi a Russe. Ci siamo. — Dov'è Russe? — Là — rispose il pilota indicando le case della città lontana. — Perché non ci andiamo, allora? — Perché debbo aspettare la notte. Sono braccato, perseguitato. Di giorno rischierei di farmi arrestare dopo qualche passo. La faccenda si faceva interessante. I sospetti inizialmente avuti da Dragoch erano dunque giustificati? — Come a Semlin — mormorò a bassa voce. — Come a Semlin — assentì Ladko per nulla turbato, — ma non per lo stesso motivo. Sono un uomo onesto, signor Jaeger. — Non ne dubito, signor Brusch, benché le ragioni che fanno temere l'arresto raramente sono buone. — Le mie lo sono — disse con freddezza Ladko. — Scusatemi se non ve le dico. Ho giurato a me stesso di mantenere il segreto e lo manterrò. Con un gesto di assenso Karl Dragoch espresse assoluta indifferenza. Il pilota proseguì: — Capisco, signor Jaeger, che non abbiate alcuna voglia di essere immischiato nelle mie faccende. Se preferite, vi farò scendere in terra rumena. Eviterete in tal modo i pericoli ai quali potrò essere esposto. — Quanto tempo contate di rimanere a Russe? — chiese Dragoch, senza rispondere direttamente. — Non lo so. Se le cose andranno secondo i miei desideri, tornerò a bordo prima che faccia chiaro. In questo caso, non sarò solo. Diversamente, non so quello che farò. — Vi seguirò sino in fondo, signor Brusch — disse senza esitare Karl Dragoch. — Come volete! — concluse Ladko. E non aggiunse altro. Al cader della notte riprese il remo e si avviò verso la riva bulgara. Quando accostò, un po' a valle delle ultime case della città, l'oscurità era fitta. Tutto teso verso il proprio scopo, Serge Ladko si moveva come un sonnambulo. Con gesti secchi e precisi faceva senza esitazione ciò che doveva fare; faceva ciò che gli sarebbe stato impossibile non fare. Non vedeva niente di quel che lo circondava e perciò non vide neppure il compagno sparire sotto la tuga, non appena salpato l'ancorotto. Il mondo esterno aveva perso ogni realtà. Esisteva soltanto il suo sogno, un sogno folgorante di sole, a dispetto della notte: la sua casa, e nella sua casa, Natcha! Oltre a Natcha, non c'era più nulla sotto il cielo. Non appena la ruota di prora ebbe toccato la riva, egli saltò a terra, fissò saldamente l'ormeggio e si allontanò rapidamente. Karl Dragoch uscì immediatamente dalla cabina: non aveva perduto tempo. Chi avrebbe mai riconosciuto il poliziotto dalla figura energica e asciutta in quel balordo dal passo pesante, esatta copia di un contadino ungherese? Il poliziotto saltò a terra e seguì ancora una volta le tracce del pilota. CAPITOLO XVI LA CASA VUOTA POCHI minuti dopo, Serge Ladko e Karl Dragoch raggiungevano le prime case. Nonostante la sua importanza commerciale, Russe non possedeva allora illuminazione pubblica; sarebbe stato perciò difficile, anche volendolo, che essi potessero farsi un'idea della città irregolarmente raggruppata intorno a un vasto imbarcadero, in fondo al quale si ammucchiavano piccole costruzioni malandate che servivano da magazzini o da bettole. Ma essi non se ne preoccupavano; il primo camminava rapidamente, guardando fissamente dinanzi a sé, come attratto da una meta che brillava nel buio. Il secondo era così preoccupato nel seguire il pilota da non accorgersi che due uomini erano sbucati da una stradetta laterale. Non appena furono sulla via che costeggiava il fiume, i due uomini si separarono. Uno di essi andò a destra, a valle. — Buona sera — disse in bulgaro. — Buona sera — rispose l'altro, che voltando a sinistra tagliò la strada a Karl Dragoch. Il suono di quella voce fece sobbalzare il poliziotto, il quale, dopo un attimo di esitazione, rallentò istintivamente il passo. Poi, rinunciando a seguire Ladko, si fermò di colpo e si volse. Un investigatore per non marcire nelle funzioni più umili della sua professione deve possedere un insieme di doni naturali o acquisiti. Ma quello più prezioso fra i tanti, è una perfetta memoria visiva e uditiva. E Karl Dragoch l'aveva molto sviluppata. Vista e udito erano in lui veri e propri apparecchi di registrazione; egli non dimenticava mai certe sensazioni, qualunque fosse il tempo trascorso. Dopo mesi o anni, riconosceva subito un viso scorto di sfuggita, o una voce che aveva fatto vibrare una sola volta i suoi timpani. Era stato esattamente così per la voce appena udita; non era trascorso molto tempo da quando si era trovato dinanzi al suo proprietario, perché potesse sbagliarsi. Quella voce, che era risonata al suo orecchio nella radura ai piedi del monte Pilis, era il filo conduttore inutilmente cercato. Per quanto ingegnose, le deduzioni relative al suo compagno di viaggio erano dopo tutto soltanto delle ipotesi. La voce, al contrario, gli dava finalmente la certezza. Tra il probabile e il sicuro non ci poteva essere esitazione, perciò il poliziotto abbandonò il pedinamento e si lanciò sulla nuova pista. — Buona sera, Titcha — disse Karl Dragoch in tedesco, quando l'uomo gli fu vicino. Titcha si fermò, scrutando nel buio. — Chi mi parla? — chiese. — Io — rispose Dragoch. — Chi, io? — Max Raynold. — Non vi conosco. — Ma io vi conosco, avendovi chiamato per nome. — D'accordo — disse Titcha. — Dovete avere buoni occhi, amico. — Eccellenti, infatti. Il dialogo cessò per un istante. — Che cosa volete da me? — riprese Titcha. — Parlarvi — disse Dragoch. — Voglio parlare a voi e a un altro. Sono a Russe proprio per questo. — Non siete di qua, dunque? — No. Sono giunto oggi. — Avete scelto un bel momento — sogghignò Titcha, alludendo certamente all'anarchia che regnava in quel momento in Bulgaria. Con un gesto d'indifferenza, Dragoch aggiunse: — Io sono di Gran. Titcha non disse nulla. — Conoscete Gran? — insistette Dragoch. — No. — E stupefacente: ci eravate così vicino! — Vicino? Che cosa vi fa credere che io ci sia stato vicino? — Diamine! — disse Dragoch ridendo — la villa Hagueneau non è lontana dalla città. Questa volta toccò a Titcha sobbalzare. Cercò tuttavia di giocar d'azzardo. — La villa Hagueneau? — balbettò con voce che voleva rendere scherzosa. — Non la conosco, come non conosco voi. — Davvero? — disse ironicamente Dragoch. — Non conoscete neppure la radura di Pilis? Titcha si avvicinò al suo interlocutore e gli afferrò il braccio. — Parlate sottovoce, diamine! — disse senza cercare stavolta di nascondere il proprio turbamento. — Siete matto per gridare in questo modo? — Ma se non c'è nessuno! — disse Dragoch. — Non si sa mai — rispose Titcha. Poi chiese: — Che cosa volete da me? — Voglio parlare con Ladko — rispose Dragoch senza abbassare la voce. Titcha gli strinse più forte il braccio. — Zitto! — fece guardandosi intorno impaurito. — Volete forse farmi impiccare? Karl Dragoch si mise a ridere. — Beh! — disse — non sarà facile capirsi se dobbiamo parlare stando zitti! — Non si può avvicinare qualcuno nel cuore della notte, senza nemmeno avvertirlo di stare in guardia! — brontolò sordamente Titcha. — Ci sono cose che non si urlano in mezzo alla strada. — Non ci tengo a parlarvi per la strada — rispose Dragoch. — Andiamo altrove. — Dove? — Non importa dove. C'è un'osteria nelle vicinanze? — A pochi passi. — Andiamoci. — Seguitemi — disse Titcha. Dopo una cinquantina di metri, i due raggiunsero una piazzetta. Dinanzi a loro, una finestra brillava debolmente nell'oscurità della notte. — È là — disse Titcha. Aperta la porta, si trovarono direttamente nella sala deserta di un modesto caffè, con una decina di tavolini. — Qui staremo benissimo — disse Dragoch. Il padrone andò incontro agli insperati clienti. — Che cosa si beve? Son io che offro — disse il poliziotto, battendo la mano sul borsellino. — Un bicchiere di racki? — propose Titcha. — Vada per il racki!… E del ginepro?… Ciò non vi dice nulla? — E buono anche il ginepro — approvò Titcha. Karl Dragoch si volse verso il proprietario che attendeva. — Avete sentito, amico? Serviteci, e alla svelta! Mentre l'oste se ne andava, Dragoch pesò con un'occhiata l'avversario. Fece presto a giudicarlo. Spalle ampie, collo taurino, fronte stretta rosicchiata dai folti capelli grigi; in poche parole, un perfetto esemplare di lottatore da baraccone, un vero bruto. Non appena furono portati bicchieri e bottiglie, Titcha riprese la conversazione dal punto in cui era cominciata. — Avete detto, dunque, che mi conoscete. — Ne dubitate? — E che sapete della faccenda di Gran. — Anche. Vi abbiamo lavorato insieme. — Non è possibile! — Invece sì. — Non ci capisco nulla — mormorò Titcha, frugando in buona fede nei suoi ricordi. — Ma se eravamo soltanto in otto… — Scusate, eravamo in nove, poiché c'ero anch'io — lo interruppe Dragoch. — Avevate le mani in pasta? — insistette Titcha, poco convinto. — Sì, nella villa e anche nella radura. Ho persino guidato la carretta. — Con Vogel? — Con Vogel. Titcha rifletté un istante. — Non è possibile — protestò. — Con Vogel c'era Kaiserlick. — No, c'ero io — rispose Dragoch tranquillamente. — Kaiserlick era rimasto con voi. — Ne siete sicuro? — Assolutamente — affermò Dragoch. Titcha stava vacillando. Il bandito non brillava proprio per intelligenza. Non solo aveva fatto i nomi di Vogel e di Kaiserlick a quel sedicente Max Raynold, ma considerava come valida la prova che questi conoscesse i loro nomi. — Un bicchiere di ginepro? — propose Dragoch. — Non si rifiuta mai — disse Titcha. Vuotato il bicchiere d'un fiato, mormorò quasi convinto: — Però è strano. E la prima volta che un estraneo entra nei nostri affari. — C'è una prima volta per ogni cosa — rispose Dragoch. — Non sarò più un estraneo, quando sarò accettato nella banda. — Quale banda? — È inutile fare il furbo, amico. Vi dico che è cosa stabilita. — Che cosa è stabilito? — Che sarò dei vostri. — Stabilito con chi? — Con Ladko. — Tacete, perbacco — lo zittì brutalmente Titcha. — Vi ho già detto di tenervelo per voi, quel nome! — Me lo avete detto per strada; ma qui? — Qui e ovunque, in tutta la città, s'intende. — Perché? — chiese Dragoch, seguendo il suo istinto. Titcha era ancora diffidente. — Se qualcuno ve lo chiede — rispose prudentemente — direte che non lo sapete. Voi sapete molte cose, ma non sapete tutto, lo vedo, e non riuscirete certamente a far cantare una vecchia volpe come me. Titcha si sbagliava: non aveva la capacità di lottare con un uomo della forza di Dragoch; la vecchia volpe aveva trovato il maestro. La sobrietà non era il suo forte e, non appena il detective se ne rese conto, cercò di trarre vantaggio dal punto debole dell'avversario. Le sue ripetute offerte vinsero la resistenza piuttosto debole del bandito. Ai bicchieri di ginepro fecero seguito i bicchieri di racki, e viceversa. Gli effetti dell'alcool cominciavano a farsi avvertire; l'occhio di Titcha si annebbiava, la lingua si impastava e la sua prudenza cedeva. Come tutti sanno, l'ubriachezza è una strada in discesa: più si beve e più si ha sete. — Dicevamo, dunque — riprese Titcha con voce alquanto pastosa — che il capo è d'accordo? — D'accordo — dichiarò Dragoch. — Ha fatto bene… il capo — affermò Titcha, e sotto i fumi dell'alcool cominciò a dare del tu al suo interlocutore. — Hai l'aspetto di un bravo compagno. — Puoi ben dirlo — approvò Dragoch, dandogli corda. — Il capo, però, non lo vedrai… ecco! — Perché? Prima di rispondere, Titcha prese la bottiglia e si versò due bicchieri di racki. Finito di bere, disse con voce rauca: — Il capo… è partito. — Non è a Russe? — insistette Dragoch, deluso. — Non c'è più. — Vi era venuto, dunque? — Quattro giorni fa. — E ora? — Discende il fiume con il battello sino al mare. — Quando farà ritorno? — Tra una quindicina di giorni. — Quindici giorni di ritardo! Sono sfortunato! — esclamò Dragoch. — Hai tanta premura di far parte della compagnia? — chiese Titcha, con una grande risata. — Diamine! — disse Dragoch — faccio il contadino e con il colpo di Gran ho guadagnato in una notte quello che non riesco a guadagnare in un anno zappando la terra. — Ciò ti ha fatto venire la voglia — concluse Titcha scoppiando a ridere. Dragoch notò che il bicchiere del compagno era vuoto e si affrettò a riempirlo. — Ma tu non bevi, amico! — esclamò. — Alla tua salute! — Alla tua! — ripeté Titcha, vuotando il suo di colpo. Le notizie raccolte dal poliziotto erano abbondanti. Egli sapeva di quanti membri era composta la banda del Danubio: otto, secondo Titcha; il nome di tre di essi, anzi di quattro, comprendendovi quello del capo; la sua destinazione: il mare, ove indubbiamente il bottino sarebbe stato caricato sopra una nave; la base delle sue operazioni: Russe. Al suo ritorno, tra una quindicina di giorni, Ladko avrebbe trovato ogni cosa predisposta per il suo arresto immediato, a meno che non si fosse riusciti a mettergli le mani addosso alle foci del Danubio. C'erano però altre cose da chiarire. Karl Dragoch ritenne che gli sarebbe stato possibile, approfittando dello stato di ebrietà del suo interlocutore. — Perché — chiese con indifferenza, dopo qualche istante di silenzio — non volevi poco fa che io pronunciassi il nome di Ladko? Ormai ubriaco, Titcha guardò con occhi umidi il compagno, e gli tese la mano, in un improvviso slancio di tenerezza. — Te lo dirò — balbettò — perché sei un amico! — Sono un amico! — confermò Dragoch, rispondendo alla stretta dell'ubriaco. — Un fratello! — Un fratello. — Un buontempone, un ragazzo in gamba. — Proprio così. Titcha cercò con gli occhi le bottiglie. — Un bicchiere di ginepro? — propose. — Non ce n'è più — rispose Dragoch. Poiché riteneva che l'avversario fosse più che ubriaco e temendo di vederlo scivolare sul pavimento da un momento all'altro, aveva rovesciato per terra, di nascosto, parte del contenuto delle bottiglie. Ma Titcha non si diede per vinto; fece una smorfia di delusione e implorò: — Un bicchiere di racki, allora? — Ecco — disse Dragoch avvicinando sulla tavola la bottiglia con ancora poche gocce di liquore. — Fa' attenzione, amico!… Non dobbiamo ubriacarci. — Io!… — protestò Titcha, scolando la bottiglia. — Non potrei neppure se lo volessi! — Dicevamo dunque che Ladko?… — suggerì Dragoch, riprendendo con pazienza il cammino tortuoso che portava alla meta. — Ladko? — ripeté Titcha, il quale non sapeva più di che cosa stavano parlando. — Già… Perché non bisogna farne il nome? Titcha fece una risata da avvinazzato. — Ti interessa eh, ragazzo mio? Il fatto è che qui Ladko si pronuncia Striga, ecco tutto. — Striga? — ripeté Dragoch, non riuscendo a capire. — Perché Striga? — Perché quello è il suo nome… Così come tu ti chiami… Già! come ti chiami? — Raynold. — Sì, Raynold… Ebbene! Io ti chiamo Raynold… Lui si chiama Striga… È chiaro. — A Gran, però… — insistette Dragoch. — A Gran era Ladko — lo interruppe Titcha, — ma a Russe è Striga. E strizzò l'occhio, con aria d'intesa. — Allora, capisci, mai visto, mai conosciuto. Che un malfattore si nasconda sotto un falso nome per compiere i suoi misfatti, non stupisce un poliziotto; ma perché proprio Ladko, lo stesso nome con cui era firmato il ritratto trovato nella chiatta? — Esiste però un altro Ladko — esclamò Dragoch, spazientito, formulando in tal modo la conclusione del suo pensiero. — Diamine! È la cosa più bella della faccenda — disse Titcha. — Chi è Ladko? — Una canaglia! — disse Titcha con forza. — Che cosa ti ha fatto? — A me? Nulla. A Striga… — Che cosa ha fatto a Striga? — Gli ha soffiato la ragazza… la bella Natcha. Natcha! lo stesso nome del ritratto. Sicuro di essere sulla buona strada, Dragoch ascoltava avidamente Titcha che parlava senza farsi più pregare. — Da allora non sono più amici, come puoi immaginare! E per questo motivo che Striga ha preso il suo nome. Striga è furbo. — Tutto questo però — obiettò Dragoch — non spiega perché non debbo pronunciare il nome di Ladko. — Perché non è prudente — spiegò Titcha. — A Gran… e altrove tu sai a chi si riferisce… Qui, invece, è quello di un pilota che si è messo contro il governo. L'imbecille cospira… E a Russe le vie sono piene di turchi! — Che ne è di lui? — chiese Dragoch. Titcha fece il gesto di chi non sa niente. — È sparito — rispose. — Striga dice che è morto. — Morto? — E dev'essere vero, perché Striga ha in mano sua moglie, ora. — Quale moglie? — La bella Natcha… Dopo il nome, anche la moglie… La colomba però non è contenta! Ma Striga la custodisce a bordo del battello. Per Dragoch tutto appariva chiaro. Non era in compagnia di un volgare malfattore che egli aveva trascorso tanti giorni, ma in quella di un patriota in esilio. Quale doveva essere, in quel momento, il dolore dell'infelice nel trovare la casa vuota, dopo gli sforzi fatti per raggiungere la moglie! Bisognava correre in suo aiuto. Riguardo alla banda del Danubio, Dragoch, ormai bene informato, non avrebbe fatto fatica, in seguito, ad acciuffarla. — Fa caldo! — sospirò, fingendo di essere ubriaco. — Molto caldo — approvò Titcha. — È il racki — balbettò Dragoch. Titcha batté il pugno sulla tavola. — Non hai la testa solida, ragazzo! — lo canzonò Titcha. — Io, vedi, sono pronto a ricominciare. — Non posso competere con te — convenne Dragoch. — Sei un merlo!… — continuò a canzonarlo Titcha. — Usciamo, se ti fa piacere. Pagato il proprietario, i due compagni si ritrovarono sulla piazza. Il cambiamento non parve giovare a Titcha. Non appena all'aria aperta, la sua ubriachezza peggiorò notevolmente. Dragoch temette di aver forzato la dose. — Dimmi — chiese — e questo Ladko?… — Quale Ladko? — Il pilota. Abita da quella parte? — No. Dragoch si volse dall'altro lato della città. — Da questa? — Neppure. — Da quest'altra, allora? — chiese Dragoch. — Sì — balbettò Titcha. Il poliziotto sorreggeva Titcha che, traballante, si lasciava trascinare borbottando parole incoerenti; dopo cinque minuti di marcia, si fermò bruscamente, sforzandosi di stare in equilibrio. — Perché Striga diceva — balbettò — che Ladko era morto? — Ebbene? — Non è morto; c'è qualcuno in casa sua. E Titcha indicò poco lontano delle strisce di luce che filtrando attraverso le fessure di un'imposta, rigavano la strada. Dragoch si affrettò a raggiungere la finestra e con Titcha guardò da una fenditura. Videro una stanza di modeste proporzioni, ma ammobiliata confortevolmente. Il disordine e la spessa polvere che ricopriva i mobili lasciavano supporre che in quella camera, da molto tempo abbandonata, si era svolta qualche scena di violenza. Il centro era occupato da una grande tavola, sulla quale appoggiava i gomiti un uomo che sembrava riflettere profondamente. Le dita contratte affondate nei capelli in disordine esprimevano eloquentemente il tormento penoso del suo animo. Dagli occhi di quell'uomo sgorgavano grosse lagrime. Dragoch riconobbe in lui il suo compagno di viaggio. Ma non fu il solo a riconoscerlo. — E lui!… — mormorò Titcha, facendo energici sforzi per allontanare l'ubriachezza. — Lui? — Ladko. Titcha si passò la mano sul viso e parve ritrovare un po' di sangue freddo. — Non è morto, canaglia! — disse fra i denti. — Ma è come se lo fosse… I turchi mi pagheranno la sua pelle più di quanto non valga. Striga ne sarà felice! Non muoverti di qui, amico — disse a Karl Dragoch. — Se vuole uscire, ammazzalo! Chiama aiuto, se necessario. Io vado a cercare la polizia. E Titcha si allontanò di corsa, senza attendere risposta. Zigzagava, appena: l'emozione gli aveva reso l'equilibrio. Non appena fu solo, il poliziotto entrò nella casa. Serge Ladko non fece alcun movimento. Karl Dragoch gli mise la mano sulla spalla. L'infelice alzò il capo. La sua mente era assente; lo sguardo spento rivelava di non aver riconosciuto il passeggero. Costui disse una parola: — Natcha! Serge Ladko si alzò di scatto. Gli occhi lampeggianti erano inchiodati, interrogativi, a quelli di Dragoch. — Seguitemi — disse il poliziotto — e spicciamoci. CAPITOLO XVII A NUOTO LA CHIATTA volava sulle acque. Ebbro, esaltato, in preda a una specie di rabbia, con più forza che mai, Serge Ladko premeva sul remo. Affrancato dal suo violento desiderio dalla soggezione a qualsiasi legge umana, la notte si concedeva soltanto qualche ora di riposo. Cadeva allora in un sonno di piombo e si svegliava all'improvviso due ore dopo come chiamato dal suono di una campana, per riprendere immediatamente la sua massacrante fatica. Testimone dell'accanito inseguimento, Karl Dragoch si stupiva che un organismo umano potesse avere tanta resistenza. Era sì un uomo che gli dava quel prodigioso spettacolo, ma un uomo che attingeva quell'energia sovrumana da una spaventosa disperazione. Per risparmiare all'infelice pilota la più lieve distrazione, il poliziotto cercava di non rompere il silenzio. Ciò che doveva dire l'aveva detto alla partenza da Russe. Non appena la chiatta era stata spinta sul filo della corrente, Karl Dragoch aveva dato infatti le spiegazioni indispensabili. Per prima cosa gli aveva rivelato la sua professione. Poi, in poche parole, gli aveva spiegato il motivo del suo viaggio, all'inseguimento della banda del Danubio, il cui capo, diceva la gente, era un certo Ladko di Russe. Il pilota aveva ascoltato distrattamente, manifestando una febbrile impazienza. Che cosa gliene importava? Non aveva che un pensiero, uno scopo, una speranza: Natcha. La sua attenzione si era risvegliata solo nel momento in cui Karl Dragoch aveva cominciato a parlare della giovane, dicendo di avere appreso dalla bocca di Titcha che Natcha discendeva il fiume, prigioniera a bordo di un battello comandato dal capo della banda, il cui vero nome era Striga e non Ladko. Nell'udire quel nome, Ladko aveva cacciato un ruggito. — Striga! — aveva gridato stringendo con forza il remo. Non aveva chiesto altro. Da quel momento, si affrettava senza respiro, senza tregua, senza riposo, le sopracciglia aggrottate, gli occhi da folle, e l'animo proiettato verso la meta. Quella meta, in cuor suo, era sicuro di raggiungerla. Perché? Era incapace di dirlo: ne era certo, ecco tutto. Sapeva che al primo colpo d'occhio avrebbe trovato il battello, fosse stato tra mille, sul quale Natcha era tenuta prigioniera. Come? Non lo sapeva. Ma lo avrebbe trovato. Ciò era indiscutibile, fuori di ogni dubbio. Ora si rendeva conto perché mai gli era parso di conoscere il carceriere che gli portava da mangiare quand'era prigioniero, e perché le voci udite confusamente avevano trovato eco nel suo cuore. Il carceriere era Titcha. Le voci, quelle di Striga e di Natcha. Anche il grido udito nella notte era di Natcha che invocava inutilmente aiuto. Perché non si era fermato, allora? Quanti rimpianti e quanti rimorsi si sarebbe risparmiati! Era già tanto se al momento della fuga aveva scorto nel buio la massa scura della prigione galleggiante, nella quale abbandonava, senza saperlo, colei che amava. Ma non aveva importanza, era più che sufficiente. Non avrebbe potuto passare accanto a quel battello senza che una voce misteriosa, dal profondo del cuore, l'avvertisse. La speranza di Serge Ladko, a dire il vero, era meno presuntuosa di quanto si fosse tentati di credere. Le possibilità di sbagliarsi infatti, erano minime, poiché le chiatte che solcavano il Danubio erano poche. Già dopo Orsova erano diminuite, dopo Russe erano pochissime, le ultime poi si erano fermate a Silistrie. A valle di questa città, che la chiatta avrebbe oltrepassata fra ventiquattr'ore, sul fiume erano rimasti soltanto due battelli, gli altri ormai erano tutti bastimenti a vapore. Il fatto è che all'altezza di Russe il Danubio è immenso. Sulla riva sinistra si estendono interminabili paludi e il suo letto supera le due leghe. A valle è ancora più vasto; tra Silistrie e Braila raggiunge a volte i venti chilometri di larghezza. Questa distesa d'acque è un vero mare, al quale non mancano né le tempeste né le onde coronate di schiuma; è quindi comprensibile che i battelli a fondo piatto, poco adatti ad affrontare le onde del largo, esitino ad avventurarvisi. Per Serge Ladko era anche un'ottima cosa che il tempo si mantenesse stabilmente al bello. Con un'imbarcazione di così piccole dimensioni e così poco marina, se il vento avesse soffiato con qualche violenza, egli sarebbe stato costretto a cercare rifugio in qualche anfratto della riva. Pur partecipando di tutto cuore alle preoccupazioni del compagno, Karl Dragoch, che mirava anche a un altro scopo, non cessava di essere turbato dal deserto di quella triste distesa d'acque. Forse Titcha gli aveva dato delle false informazioni? Tutti i battelli a fondo piatto si erano fermati, ma egli temeva che Striga non l'avesse fatto. La sua inquietudine giunse al punto di indurlo a parlarne con Serge Ladko. — Un'imbarcazione a fondo piatto può andare fino al mare? — Sì — rispose il pilota. — Capita di rado, ma succede. — Vi è capitato di condurvene? — A volte. — Come fanno a trasferire a terra il loro carico? — Riparando in qualche insenatura. Ne esistono al di là delle foci: ed è là che i vapori vanno a caricare. — Le foci, avete detto. Ce ne sono parecchie, infatti. — Le principali sono due — rispose Serge Ladko. — A nord c'è quella di Kilia; a sud, quella di Sulina, la più importante. — Non potremmo esserci sbagliati? — chiese Dragoch. — No — disse il pilota. — I clandestini non passano mai per Sulina. Seguono il braccio settentrionale. La risposta tranquillizzò Karl Dragoch soltanto in parte. Mentre si seguiva una strada, la banda poteva tranquillamente scappare dall'altra. Ma che fare contro tale eventualità se non affidarsi al caso, visto che erano nell'impossibilità di sorvegliare tutte le foci del fiume? Come se avesse indovinato ciò che pensava, Serge Ladko completò le sue rassicuranti spiegazioni. — Inoltre, oltre la fóce di Kilia, esiste un'insenatura nella quale un battello può procedere allo scarico. Seguendo la foce di Sulina, invece, sarebbe costretto a scaricare nel porto che ha lo stesso nome e che è situato sulla riva del mare. Per quanto riguarda il braccio San Giorgio, più a sud, esso è appena navigabile, anche se più importante dal punto di vista della larghezza. Non è possibile sbagliarsi. Nella mattinata del 14 ottobre la chiatta raggiunse finalmente il delta del Danubio. Lasciandosi a destra il braccio di Sulina, essa imboccò decisamente quello di Kilia. A mezzogiorno passava dinanzi a Ismail, ultima città di qualche importanza da superare. Nelle prime ore del giorno dopo, la chiatta sarebbe sboccata nel Mar Nero. Avrebbero raggiunto prima la chiatta di Striga? Nulla autorizzava a crederlo. Dopo aver abbandonato il braccio principale, il fiume si era fatto completamente deserto. Fin dove giungeva lo sguardo, non si vedeva una vela né un fil di fumo. Karl Dragoch era divorato dall'inquietudine. Se Serge Ladko era inquieto, non lo dimostrava affatto. Sempre piegato sul remo, spingeva infaticabilmente avanti la chiatta, soltanto preoccupato di seguire il canale che la lunga pratica gli permetteva di riconoscere tra le rive basse e paludose. Il suo ostinato coraggio fu premiato. Nel pomeriggio dello stesso giorno, verso le cinque, videro finalmente un battello ormeggiato a una dozzina di chilometri al disotto della piazzaforte di Kilia. Serge Ladko smise di remare, prese il cannocchiale e guardò attentamente il battello. — E lui! — disse con voce soffocata. — Ne siete sicuro? — Sicurissimo — disse Serge Ladko. — Ho riconosciuto Yacoub Ogul, un abile pilota di Russe, anima dannata di Striga, del quale conduce certamente il battello. — Che faremo? — chiese Karl Dragoch. Serge Ladko non rispose immediatamente. Rifletteva. Il poliziotto riprese: — Bisogna tornare indietro sino a Kilia; se necessario, fino a Ismail, per procurarci i necessari rinforzi. Il pilota scosse negativamente il capo. — Risalire fino a Ismail controcorrente o anche soltanto fino a Kilia — disse — richiederebbe troppo tempo. Il battello guadagnerebbe terreno e in mare, poi, non ci sarebbe più possibile rintracciarlo. Restiamo qui e aspettiamo la notte. Ho un'idea. Se mi riesce, seguiremo il battello da lontano e quando sapremo dove sosterà, andremo a cercare aiuto a Sulina. Alle otto l'oscurità si fece completa. Serge Ladko lasciò che la chiatta andasse alla deriva fino a duecento metri dal battello, e poi calò silenziosamente l'ancorotto. Infine, senza una parola di spiegazione a Karl Dragoch che lo guardava con stupore, si tolse gli abiti e si tuffò nel fiume. Nuotando con poderose bracciate, si diresse deciso verso il battello. Lo superò quel tanto per non essere visto, poi, vincendo la forte corrente, tornò indietro e andò ad aggrapparsi alla larga pala del timone. Rimase in ascolto. Quasi soffocato dallo sciabordio serico dell'acqua che ciangottava sui fianchi della chiatta, il motivo di una canzone giunse fino a lui. Sopra il suo capo, qualcuno canticchiava a mezza voce. Aggrappandosi con i piedi e con le mani alla superficie vischiosa del legno, Ladko si sollevò con sforzi misurati fino alla parte superiore della pala e riconobbe Yacoub Ogul. A bordo, tutto era tranquillo. Dalla tuga, nella quale Ivan Striga si era certamente ritirato, non usciva rumore. Cinque uomini dell'equipaggio chiacchieravano tranquillamente, allungati sul ponte a prua. Le loro voci erano un indistinto mormorio. Soltanto Ogul era a poppa. Salito sulla tuga, si era seduto sulla sbarra del timone e si lasciava cullare nella pace notturna, canticchiando un motivo familiare. Il motivo si spense all'improvviso. Due mani di ferro stringevano la gola del cantante, che oscillando sopra il coronamento, andò a cadere sulla pala. Era morto? Gambe e braccia penzoloni, il suo corpo inerte pendeva come uno straccio a cavallo dello stretto spigolo. Serge Ladko allentò la stretta e afferrò l'uomo per la vita; poi, riducendo la pressione delle ginocchia contro la pala, si lasciò scivolare a poco a poco e sparì silenziosamente in acqua. Sul battello nessuno aveva avuto il sospetto dell'aggressione. Ivan Striga non era uscito dalla tuga; a prua, i cinque uomini continuavano a chiacchierare tranquillamente. Nel frattempo Serge Ladko nuotava verso la sua chiatta. Il ritorno richiedeva maggior fatica dell'andata: oltre a risalire la corrente, egli doveva sostenere il corpo di Ogul che, se non era morto, lo sembrava certamente. Il freddo dell'acqua non lo aveva rianimato: il suo corpo era sempre inerte. Ladko cominciò a temere di aver avuto la mano pesante. Se erano bastati cinque minuti per andare dalla chiatta al battello, occorse più di mezz'ora per rifare il percorso in senso inverso. Il pilota ebbe anche la buona sorte di non smarrirsi nel buio della notte. — Aiutatemi — disse a Karl Dragoch, attaccandosi all'imbarcazione. — Eccone uno, se non altro. Con l'aiuto del detective, Ogul fu issato a bordo e deposto sulla chiatta. — È morto? — chiese Ladko. Dragoch si chinò sull'uomo. — No — disse — respira. Ladko emise un sospiro di sollievo e prendendo subito il remo cominciò a risalire la corrente. — Legatelo saldamente — disse — se non volete che, quando vi avrò deposto a terra, se ne vada senza salutarvi. — Stiamo dunque per separarci? — chiese Dragoch. — Sì — rispose Ladko. — Vi lascerò a terra, tornerò nelle vicinanze del battello e domani cercherò di introdurmi a bordo. — In pieno giorno? — In pieno giorno. Ho la mia idea. State tranquillo, almeno per un certo tempo non correrò alcun pericolo. Non dico che quando saremo vicini al Mar Nero le cose non rischieranno di mettersi male. Conto su di voi in quel momento, anche se cercherò di fare in modo che giunga il più tardi possibile. — Contate su di me? Che cosa potrò fare? — Portarmi degli aiuti. — Farò il possibile, non dubitate — disse calorosamente Dragoch. — Non ne dubito, ma forse incontrerete qualche difficoltà. Farete ciò che potrete, ecco tutto. Tenete presente che il battello lascerà l'ormeggio domani a mezzogiorno e che, se nulla lo fermerà, sarà in mare verso le quattro. Sappiate regolarvi. — Perché non restate con me? — chiese Karl Dragoch, inquieto sulla sorte del compagno. — Perché voi potreste tardare e ciò permetterebbe a Striga di portarsi avanti e di sparire. Non deve raggiungere il mare. Non lo raggiungerà, anche se arriverete troppo tardi per portarmi aiuto: in questo caso, però, probabilmente io sarò morto. Il tono della voce del pilota non ammetteva replica; comprendendo che nulla gli avrebbe fatto cambiare idea, Karl Dragoch non insistette. La chiatta fu quindi condotta alla riva, dove Yacoub Ogul fu deposto a terra, svenuto. Ladko spinse al largo l'imbarcazione e la chiatta scomparve nell'oscurità della notte. CAPITOLO XVIII IL PILOTA DEL DANUBIO DOPO la scomparsa di Serge Ladko nell'oscurità della notte, Karl Dragoch esitò un istante pensando a ciò che gli conveniva fare. Solo nella notte alla frontiera con la Bessarabia, con il fastidio di quel corpo inerte che il dovere gli impediva di abbandonare, la sua situazione continuava ad essere difficile. Poiché tuttavia era evidente che non avrebbe mai trovato aiuto se non fosse andato a cercarlo, doveva decidersi a fare qualcosa. Il tempo stringeva. La salvezza di Serge Ladko poteva dipendere da un'ora, forse da un minuto. Abbandonato per il momento Ogul, sempre svenuto e sufficientemente legato perché non potesse fuggire nel caso si fosse ripreso, risalì il fiume con la sveltezza che la natura del terreno gli consentiva. Dopo mezz'ora di cammino in una zona completamente deserta, quando cominciava a temere di doversi spingere sino a Kilia, scorse per caso un'abitazione sulla riva del fiume. Non fu facile farsi aprire la porta di quella che sembrava una grossa fattoria. A quell'ora e in quel luogo una certa diffidenza era normale; si può quindi capire perché i proprietari non avessero alcuna voglia di lasciarlo entrare. Le difficoltà erano aggravate poi dall'impossibilità di comprendersi: infatti i contadini usavano il dialetto locale, che Karl Dragoch, benché conoscesse più lingue, non capiva. Usando un linguaggio tutto inventato fatto di un terzo di rumeno, di russo e di tedesco, riuscì ad accattivarsi la loro fiducia e la porta così energicamente difesa finì per schiudersi. Quando fu entrato, dovette subire un interrogatorio dal quale venne fuori con onore: non erano ancora trascorse due ore dal suo sbarco, infatti, che una carretta lo conduceva da Ogul, che non aveva ancora ripreso conoscenza. Non diede segno di vita neppure quando fu caricato sulla carretta che riparti subito verso Kilia. Sino alla fattoria fu necessario andare a passo d'uomo; dopo, un sentiero, anche se in pessime condizioni, permise loro di accelerare l'andatura. Era già mezzanotte passata quando Dragoch entrò in Kilia. La città dormiva e rintracciare il capo della polizia non fu facile. Tuttavia vi riuscì e si assunse la responsabilità di svegliarlo; l'alto funzionario, senza nemmeno troppo cattivo umore, si mise cortesemente a sua disposizione. Dragoch ne approfittò per mettere al sicuro Ogul, che cominciava ad aprire gli occhi; poi, finalmente libero di agire, poté occuparsi della cattura del resto della banda e della salvezza di Ladko, alla quale teneva maggiormente. Sin dall'inizio incontrò insormontabili difficoltà. A Kilia non c'era alcun vapore e il capo della polizia si rifiutava energicamente di mandare i suoi uomini sul fiume. Poiché quel braccio del Danubio era allora in comune a Romania e Turchia, era da temere che il loro intervento provocasse da parte della Sublime Porta reclami spiacevolissimi, in un momento in cui c'erano in aria minacce di guerra. Se il funzionario rumeno avesse potuto sfogliare il libro del Destino, avrebbe visto che quella guerra, voluta da sempre, sarebbe scoppiata soltanto pochi mesi dopo, e ciò lo avrebbe reso indubbiamente meno timido; non conoscendo il futuro, egli tremava al pensiero di essere immischiato in un qualsiasi modo in complicazioni diplomatiche, e perciò si uniformava al saggio precetto: «Niente grattacapi», che è, come si sa, il motto dei funzionari di ogni paese. Tutto quello che egli osò fare fu di consigliare a Karl Dragoch di andare a Sulina e gli indicò l'uomo capace di guidarlo in quel difficile viaggio di quasi cinquanta chilometri attraverso il delta del Danubio. Andare a svegliare quell'uomo, persuaderlo, preparare la carrozza, portarla sulla riva destra richiese molto tempo. Erano quasi le tre del mattino quando finalmente il poliziotto se ne andò al trotto di un cavallino le cui qualità erano, per fortuna, superiori all'apparenza. Il capo della polizia di Kilia aveva avuto ragione nel definire difficile la traversata del delta. La carrozza avanzava con difficoltà sulla strada fangosa, a volte ricoperta di vari centimetri d'acqua; e senza l'abilità del conducente si sarebbe smarrita più volte su quella pianura priva di qualsiasi punto di riferimento. Perciò non si avanzava in fretta e ogni tanto bisognava pure lasciar riposare il cavallo affaticato. Sonava mezzogiorno quando Dragoch giungeva a Sulina. Il termine fissato da Ladko sarebbe scaduto tra poche ore! Senza perdere tempo per mangiare, egli corse a parlare con le autorità locali. Diventata rumena dopo il trattato di Berlino, Sulina era turca all'epoca in cui si svolgevano questi avvenimenti. Poiché le relazioni tra la Sublime Porta e le potenze occidentali erano allora molto tese, Karl Dragoch, suddito ungherese, non poteva sperare di essere persona grata,4 nonostante la missione d'interesse generale di cui era investito. Accolto un po' meglio di quanto sperasse, non fu però sorpreso di trovare presso quelle autorità un aiuto assai modesto. La polizia locale, gli fu detto, non possedeva un'imbarcazione da potergli dare; poteva contare perciò soltanto su quella della dogana che, date le attuali circostanze, con un po' di buona volontà poteva far passare per una banda di ladri, per una banda di contrabbandieri. La nave a vapore della dogana, abbastanza rapida, non era purtroppo in porto: incrociava in mare, ma sicuramente a poca distanza dalla costa. Dragoch non doveva far altro che noleggiare una barca da pesca e, senza alcun dubbio appena fuori della gettata, l'avrebbe incontrata. Disperato, il detective si rassegnò a fare a quel modo. All'una e mezzo del pomeriggio, issava la vela e doppiava il molo alla ricerca del vapore della dogana. Aveva a sua disposizione appena centocinquanta minuti per giungere all'appuntamento di Ladko. Quest'ultimo, mentre Dragoch affrontava le sue disavventure, proseguiva con metodo l'esecuzione del suo piano. Nascosta la chiatta tra le canne della riva, era rimasto tutta la mattina a spiare per assicurarsi che il battello non si preparasse a partire. Si era impadronito, un po' brutalmente forse — ma non aveva altra scelta – di Yacoub Ogul per uno scopo ben preciso. E come aveva previsto, Striga non 4 In italiano nel testo. (N.d.T.) osava avventurarsi senza pilota in una navigazione così difficile, che numerosi banchi di sabbia rendono impossibile a chi non ne ha grande esperienza. Si doveva supporre che i pirati, nell'impossibilità di dare una spiegazione alla scomparsa del loro pilota, alla prima occasione l'avrebbero sostituito. Ma i piloti non abbondano sul braccio di Kilia; fino alle undici del mattino, fatta eccezione per il battello sempre fermo e per la chiatta invisibile di Ladko, le acque del fiume rimasero deserte. Soltanto alle undici giunsero due imbarcazioni dal mare. Serge Ladko le esaminò con il cannocchiale e in una riconobbe quella di un pilota. Ivan Striga poteva trovare l'aiuto che probabilmente attendeva con impazienza. Il momento di intervenire era dunque giunto. La chiatta uscì dal canneto e si accostò al battello. — Eh voi del battello! — chiamò Ladko quando fu a portata di voce. — Oh! — gli fu risposto. Un uomo apparve sulla tuga: era Ivan Striga. Quale furore sconvolse il cuore di Serge Ladko quando vide il nemico della sua felicità, il vile che da mesi teneva Natcha nelle sue mani! Ma egli era preparato a quell'incontro che aveva voluto. Era pronto. Dominò il furore e, facendo uno sforzo su se stesso, chiese: — Avete bisogno di un pilota? Invece di rispondere, Striga, riparandosi gli occhi con la mano, esaminò per un lungo momento colui che lo interpellava. A dire il vero, gli era bastato un solo sguardo per capire chi era. Ma il trovarsi davanti il marito di Natcha gli pareva una cosa talmente straordinaria e talmente insperata, se così si può dire, che esitava dinanzi all'evidenza. — Non siete Serge Ladko di Russe? — chiese a sua volta. — Sono proprio io — rispose il pilota. — Non mi riconoscete? — Bisognerebbe essere ciechi per non riconoscervi — rispose Serge Ladko. — Vi riconosco perfettamente, Ivan Striga. — E mi offrite i vostri servizi? — Perché no? Sono pilota — dichiarò Ladko con indifferenza. Striga esitò un istante. Che colui che egli odiava più di ogni altro al mondo venisse a mettersi nelle sue mani di sua spontanea volontà, gli sembrava troppo bello. C'era da temere un tranello, forse? Ma quale pericolo poteva far correre un uomo solo a un equipaggio numeroso e deciso a tutto? Guidasse pure il battello fino al mare, se era così stupido da chiederlo! Raggiunto il mare… — Sali! — disse il pirata, con un ghigno crudele che non sfuggì a Ladko. Costui non si fece ripetere l'invito: accostò e sali a bordo. Striga gli si fece incontro. — Sono stupito — disse — di vedervi alle bocche del Danubio. Il pilota non disse nulla. — Vi si credeva morto — riprese Striga — da quando siete scomparso da Russe. L'insinuazione non ebbe maggior successo della precedente. — Dove eravate andato a finire? — chiese Striga senza scoraggiarsi. — Non ho mai lasciato i dintorni del mare — rispose Ladko. — Così lontano da Russe?! — esclamò Striga. Ladko aggrottò le sopracciglia. L'interrogatorio cominciava a esasperarlo. Seguendo la linea di condotta che si era ripromessa, tenne a freno l'impazienza e spiegò tranquillamente: — Rivolte e agitazioni non sono propizie agli affari. Striga lo guardò con occhio beffardo. — Dicevano che eravate un patriota! — esclamò con ironia. — Non faccio più politica — disse seccamente Ladko. In quel momento gli occhi di Striga caddero sulla chiatta che la corrente aveva fatto girare sull'ancora a poppa del battello. Sussultò; non poteva ingannarsi: era la chiatta che aveva usato per otto giorni e che aveva trovato ormeggiata alla banchina di Semlin. Ladko mentiva, dunque, dicendo che non aveva lasciato il delta del Danubio? — Da quando avete lasciato Russe, non vi siete allontanato da questi paraggi? — insistette Striga scrutando l'interlocutore. — No — rispose Ladko. — Mi stupite — disse Striga. — Perché? Credete di avermi visto altrove? — Voi, no; ma quella imbarcazione… Giurerei di averla vista sull'alto fiume. — È possibile — rispose Ladko, con indifferenza. — L'ho acquistata tre giorni fa da un uomo che diceva di venire da Vienna. — Com'era quest'uomo? — chiese Striga, che pensava con sospetto a Dragoch. — Un uomo bruno, con occhiali. — Ah! — disse Striga con aria pensierosa. Le risposte del pilota lo avevano chiaramente scosso. Non sapeva a che cosa credere. Ma non tardò ad abbandonare ogni preoccupazione. Che importava, dopo tutto? Che Serge Ladko dicesse o meno la verità, era però nelle sue mani. L'imbecille si era cacciato in bocca al lupo! Dal battello egli non sarebbe più uscito vivo. Erano mesi che Striga mentiva a Natcha dicendole che era vedova. Non appena in mare, quella menzogna sarebbe diventata verità. — Partiamo! — disse a mo' di conclusione di ciò che pensava. — A mezzogiorno — rispose tranquillamente Ladko. E tirando fuori alcune provviste dal sacchetto che teneva in mano, cominciò a far colazione. Il pirata ebbe un gesto d'impazienza, che Ladko finse di non vedere. — Vi avverto — disse Striga — che voglio raggiungere il mare prima che faccia buio. — Ci saremo — confermò il pilota, determinato a non cambiare la sua decisione. Striga si allontanò verso prua. A giudicare dall'espressione pensosa del viso, gli restava ancora una preoccupazione. Che Ladko si offrisse di pilotare il battello nel quale sua moglie era prigioniera, era una coincidenza troppo strana. Ma Serge Ladko a bordo era inequivocabilmente solo contro sei uomini ben decisi; Striga non doveva pensare ad altro. Però quell'inconfutabile ragionamento non gli bastava: aveva l'assoluto bisogno di sapere se la scomparsa di Natcha fosse nota al principale interessato. La sua morbosa curiosità doveva essere soddisfatta. — Avete avuto notizie da Russe, da quando siete venuto via? — chiese tornando verso il pilota, che continuava tranquillamente a mangiare. — Mai — rispose questo. — Tale silenzio non vi ha sorpreso? — Perché avrebbe dovuto sorprendermi? — chiese Ladko fissando il suo interlocutore. Per quanto audace, quest'ultimo si sentì imbarazzato sotto lo sguardo fermo del pilota. — Credevo che aveste lasciato vostra moglie a Russe — balbettò. — E io credo che sarebbe meglio cambiare argomento — replicò Ladko freddamente. Striga tacque. Pochi minuti dopo mezzogiorno il pilota diede l'ordine di levare l'ancora; poi, issata la vela, prese la barra del timone. In quel momento Striga gli si avvicinò. — Devo avvertirvi che il battello ha bisogno di fondo — gli disse. — È in zavorra — obiettò Serge Ladko. — Due piedi d'acqua basteranno. — Ce ne vogliono sette — disse Striga. — Sette! — si stupì il pilota, che capì improvvisamente tutto. Ecco perché la banda del Danubio era sempre sfuggita a tutte le ricerche! Il battello era abilmente truccato. La parte fuor d'acqua era finta: il vero battello era sotto; e lì venivano nascosti i frutti delle rapine. E quel nascondiglio, Serge Ladko lo sapeva per esperienza, poteva anche diventare un'inviolabile cella. — Sette — aveva ripetuto Striga, in risposta all'esclamazione del pilota. — D'accordo — disse quest'ultimo senza fare altre osservazioni. Nei primi momenti dopo la partenza, Striga, non del tutto tranquillo, sorvegliò rigorosamente il pilota. Ma il comportamento di Ladko lo tranquillizzò. Manovrava attentissimo, non manifestava alcuna cattiva intenzione e dimostrava anzi che la sua nota abilità era largamente giustificata. Sotto la sua guida il battello si moveva docilmente tra gli invisibili banchi di sabbia, seguendo con precisione matematica le tortuosità dei passaggi. A poco a poco gli ultimi timori del pirata svanirono. La navigazione proseguiva senza incidenti; presto avrebbero raggiunto il mare. Alle quattro lo avvistarono. Dopo un ultimo gomito del fiume, cielo e mare si congiunsero all'orizzonte. Striga disse al pilota: — Bene. Potete lasciare la barra al nostro timoniere. — Non ancora — rispose Ladko. — Il difficile deve ancora venire. A mano a mano che ci si avvicinava alla foce, il fiume si allargava. Fissando oltre a quell'orizzonte mobile che a poco a poco si apriva, Striga teneva lo sguardo ostinatamente rivolto verso il mare. A un tratto egli prese il cannocchiale e guardò un vaporetto di circa quattro o cinquecento tonnellate che doppiava la punta settentrionale; poi, dopo il breve esame, diede ordine di issare una bandiera in testa all'albero. Un segnale identico apparve sul vaporetto che, dalla destra, cominciò ad avvicinarsi all'estuario. In quel momento, avendo Ladko spinto la barra tutta a sinistra, il battello accostò sulla destra e, tagliando obliquamente la corrente, prese l'abbrivo verso sud-est, come se volesse accostarsi alla riva destra. Stupito, Striga guardò il pilota, la cui impassibilità lo rassicurò. Un ultimo banco di sabbia obbligava indubbiamente i battelli a seguire quella rotta capricciosa. Striga non s'ingannava. C'era veramente un banco di sabbia nel letto del fiume, ma non verso il mare: e proprio direttamente su quel banco Serge Ladko puntava con mano ferma. A un tratto ci fu un formidabile schianto. Il battello tremò fino alla chiglia. Il colpo fece cadere l'albero, spezzato di netto alla scassa, e la vela si abbatté sugli uomini che si trovavano a prua, ricoprendoli con le sue larghe pieghe. Il battello, irrimediabilmente arenato, rimase immobile. A bordo, tutti erano stati rovesciati, compreso Striga, il quale si rialzò pazzo di rabbia. Il suo primo sguardo fu rivolto al pilota, che non era per niente emozionato dall'accaduto. Aveva abbandonato il timone e con le mani nelle tasche del camiciotto sorvegliava il suo nemico con occhio vigile. — Canaglia! — urlò Striga e con la rivoltella in mano corse verso poppa. A tre passi di distanza, sparò. Serge Ladko si abbassò. Il proiettile gli passò sul capo senza colpirlo. Si raddrizzò di scatto, con un salto fu sull'avversario e con il coltello lo colpì al cuore. Ivan Striga cadde, inerte. Il dramma si era svolto così fulmineamente, che i cinque uomini dell'equipaggio, ancora alle prese con la vela, non avevano avuto il tempo di intervenire. Nel veder cadere il loro capo, cacciarono un urlo terribile. Serge Ladko si slanciò verso la parte anteriore della contro-coperta, e corse verso di loro. Di là dominava il ponte, verso il quale accorrevano gli uomini in tumulto. — Indietro! — gridò, armato di due rivoltelle, una strappata allora a Striga. Gli uomini si fermarono: non avevano armi e per procurarsene avrebbero dovuto entrare nella tuga, passare cioè sotto il fuoco di Ladko. — Una parola, amici — riprese Ladko, sempre minaccioso. — Ho undici colpi a disposizione, più di quanti ne occorrano per uccidervi tutti. Vi avverto che se non tornate subito a prua, sparerò. Indeciso, l'equipaggio si consultò. Ladko comprese che se si fossero gettati tutti su di lui, sarebbe riuscito certamente a ucciderne alcuni, ma sarebbe stato a sua volta ucciso dagli altri. — Attenzione! Conto fino a tre — disse, senza lasciar loro il tempo di riflettere. — Uno! Gli uomini non si mossero. — Due! — disse il pilota. Il gruppo si agitò: tre uomini mostrarono di voler combattere; due batterono in ritirata. — Tre! — disse Ladko, tirando il grilletto. Un uomo cadde, la spalla attraversata da un proiettile. Gli altri si affrettarono ad allontanarsi. Senza abbandonare il suo posto di osservazione, Serge Ladko lanciò un'occhiata al vapore che aveva risposto al segnale di Striga. Il bastimento era a meno di un miglio di distanza. Quando fosse stato a fianco della chiatta e il suo equipaggio si fosse unito ai pirati, dei quali era necessariamente più o meno complice, la situazione sarebbe diventata gravissima. Lo steamer continuava ad avvicinarsi. Era ad appena tre gomene dal battello quando virò bruscamente sulla destra e descrivendo un ampio semicerchio si allontanò verso l'alto mare. Che cosa significava quella manovra? Si era spaventato per qualcosa che Ladko non poteva vedere? Il pilota attese, con il cuore che batteva forte. Trascorsero alcuni minuti: un altro vapore, con il camino che vomitava torrenti di fumo, spuntò velocemente dalla punta meridionale dirigendo verso il battello. A prua Ladko riuscì a riconoscere una figura amica, quella del suo passeggero, il signor Jaeger, ossia il poliziotto Dragoch. Era salvo! Poco dopo la polizia invadeva il ponte della chiatta il cui equipaggio si arrese senza opporre resistenza. Intanto Serge Ladko correva verso la tuga. Aprì le cabine una dopo l'altra. Una sola porta era chiusa: la spalancò con una spallata e, smarrito, si fermò sulla soglia. Natcha gli tendeva le braccia. CAPITOLO XIX EPILOGO IL PROCESSO alla banda del Danubio, nel divampare della guerra russo-turca, passò inosservato. I briganti, compreso Titcha che fu catturato a Russe, furono impiccati, senza attirare l'attenzione del pubblico, interessato a ben altre tragiche circostanze. Il dibattimento fornì ai principali interessati la spiegazione di ciò che era rimasto loro fin allora incomprensibile. Serge Ladko seppe così in seguito a quale equivoco era stato imprigionato nel battello al posto di Karl Dragoch; e che Striga, appreso dai giornali dell'invio di una commissione inquirente a Szalka, si era introdotto nell'abitazione del pescatore Ilia Brusch per rispondere alle domande del commissario di polizia di Gran. Seppe ugualmente che Natcha, rapita dalla banda del Danubio, aveva dovuto lottare contro gli attacchi di Striga, il quale, ritenendo di aver ucciso il suo nemico, non cessava di ripeterle che era vedova. Una sera, in particolare, Striga, a sostegno delle sue parole, aveva fatto vedere alla giovane il ritratto da lei mandato al marito, dicendole di averlo conquistato dopo un'accanita lotta con il legittimo proprietario. Ne era seguita una scena violenta, nel corso della quale Striga aveva osato persino minacciarla. Era stato allora che Natcha aveva lanciato il grido udito dal fuggiasco nel cuore della notte. Ma tutto ciò era storia vecchia. Serge Ladko non pensava più a quei giorni di pena, dopo che aveva avuto la felicità di ritrovare la sua cara Natcha. Poiché il territorio della Bulgaria le era interdetto, la felice coppia, dopo gli avvenimenti già narrati, si era stabilita in un primo momento nella città rumena di Giurgievo. Si trovava là quando, nel maggio dell'anno seguente, lo zar dichiarò ufficialmente la guerra al sultano. Non è necessario dire che Serge Ladko fu tra i primi ad arruolarsi nelle file dell'esercito russo, al quale, per la sua conoscenza della zona delle operazioni, rese importanti servigi. Finita la guerra e liberata la Bulgaria, egli tornò con Natcha nella casa di Russe, dove riprese il mestiere di pilota. Entrambi vi abitano ancor oggi, felici e rispettati. Karl Dragoch è rimasto loro amico. Per molto tempo ha disceso il Danubio, almeno una volta all'anno, per andare a Russe. Oggi la ferrovia, la cui rete si è continuamente sviluppata, gli permette di abbreviare il viaggio. Ma è sempre con il seguire le sinuosità del fiume che Serge Ladko, quando il suo lavoro gliene fornisce l'occasione, gli fa visita a Budapest. Dei tre maschietti che Natcha gli ha dato e che attualmente sono uomini fatti, il più giovane, dopo un severo tirocinio agli ordini di Karl Dragoch, è sulla buona strada per raggiungere i più alti gradi nell'amministrazione giudiziaria bulgara. Il cadetto, degno erede di un campione della Lega Danubiana, si è dedicato alla piscicoltura. Egli ha però rinunciato alla lenza e ha perfezionato i metodi di lotta. Egli deve alle sue peschiere di storioni una celebrità mondiale e una fortuna che promette di diventare considerevole. Il maggiore, invece, succederà al padre, quando giungerà l'età del riposo per quest'ultimo. Vapori e battelli saranno allora condotti da lui da Vienna al mare, lungo i passaggi sinuosi e tra i perfidi banchi di sabbia del grande fiume; con lui si perpetuerà la razza dei piloti del Danubio. Ma nonostante la diversa posizione sociale, i cuori dei tre figli di Serge Ladko battono all'unisono. Condotti dalla vita lungo strade divergenti, essi si incontrano sempre a questi crocicchi: la stessa venerazione per il loro padre, un'eguale tenerezza per la loro madre, un identico amore per la patria bulgara.
Scaricare