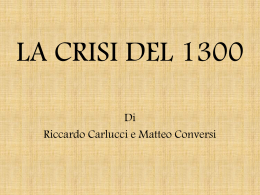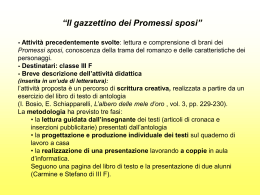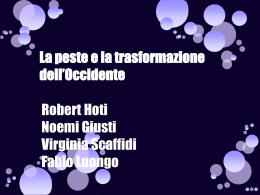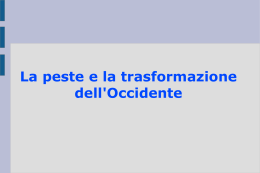unità II L’autunno del Medioevo Riferimenti storiografici 1 Nel riquadro miniatura del xv secolo che raffigura la battaglia di Crécy, combattura tra francesi e inglesi nell’ambito della guerra dei cent’anni. Sommario 1 2 3 Le origini asiatiche della peste La peste: una malattia socialmente ingiusta L’appropriazione del tempo da parte dei mercanti F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012 4 5 6 L’industria tessile nel Tardo Medioevo La centralità della morte nella religiosità tardo medievale Urbanistica e potere nell’Italia del Quattrocento 1 Le origini asiatiche della peste UNITÀ II Prima di colpire l’Europa, la peste dilagò in Cina. La sua diffusione verso Occidente venne facilitata dal fatto che le grandi pianure della Russia e dell’Asia centrale, appartenendo all’immenso Impero dei mongoli, potevano essere attraversate con relative regolarità e velocità dalle carovane dei mercanti. l’autuNNo del medioevo 2 Nel periodo del massimo potere (1279-1350) gli imperi mongoli comprendevano l’intera Cina e quasi tutta la Russia (solo la lontana Novgorod restava indipendente), nonché l’Asia centrale, l’Iran e l’Iraq. Una rete di comunicazioni costituita da messaggeri postali capaci di percorrere cento miglia al giorno per intere settimane di seguito, e carovane di mercanti ed eserciti, che procedevano più lentamente percorrendo avanti e indietro enormi distanze, tennero uniti questi imperi fino al sesto decennio del XIV secolo, quando la rivolta divampò in Cina determinando nel 1368 la completa espulsione dei Mongoli dalla loro più ricca conquista. [...] Le comunicazioni istituite dai Mongoli ebbero un’altra importante conseguenza. Numerose persone non solo viaggiarono per lunghissime distanze, attraversando frontiere culturali ed epidemiologiche, ma percorsero l’itinerario più settentrionale che fosse mai stato intensamente battuto. L’antica Via della seta fra la Cina e la Siria attraversava i deserti dell’Asia centrale, passando da un’oasi all’altra. Ora, oltre a questo vecchio itinerario, le carovane, i soldati e i corrieri postali percorrevano a cavallo l’aperta prateria. Essi crearono una rete umana che copriva un vasto territorio e che univa i quartieri generali mongoli di Karakorum con Kazan e Astrachan sul Volga, con Caffa in Crimea, con Kambaliq in Cina e con innumerevoli altri caravanserragli situati lungo il percorso. [...] Dai documenti cinesi non emerge nulla di inconsueto prima del 1331, quando un’epidemia scoppiata nella provincia di Hopei, secondo le fonti, uccise i nove decimi della popolazione. Analogamente, (negli anni 1353-54) l’epidemia infuriò in otto diverse e distanti zone della Cina, e i cronisti riferiscono che morirono fino a «due terzi della popolazione» [...] Dopo il 1331, e più particolarmente dopo il 1353, la Cina iniziò un periodo disastroso della propria storia. La peste coincise con la guerra civile nel periodo in cui iniziò a svilupparsi una reazione della popolazione cinese contro la dominazione mongola, che culminò col rovesciamento dei sovrani stranieri e con l’instaurazione di una nuova dinastia Ming nel 1368. La combinazione di guerra e pestilenza compì una devastazione tra la popolazione cinese. Secondo le valutazioni più attendibili vi fu una diminuzione di popolazione dai centoventitré milioni intorno al 1200 (prima che iniziassero le invasioni dei Mongoli) a soli sessantacinque milioni nel 1323, una generazione dopo l’estromissione definitiva dei Mongoli dalla Cina. Nemmeno alla ferocia dei Mongoli può attribuirsi una diminuzione così drastica. È certo che le malattie giocarono un ruolo rilevante nel dimezzare la popolazione cinese, e la peste bubbonica, che dopo le devastazioni apportate inizialmente si ripresentò a intervalli relativamente frequenti, proprio come avvenne in Europa, è con ogni probabilità la miglior candidata a tale ruolo. [...] Sembra quindi estremamente probabile che la Pasteurella pestis avesse invaso la Cina nel 1331 [...]. Poi l’infezione deve aver percorso le vie carovaniere dell’Asia nel corso dei successivi quindici anni raggiungendo la Crimea nel 1346, dopo di che il bacillo salì a bordo e procedette alla penetrazione di quasi tutta l’Europa e del Vicino Oriente lungo le vie che dai porti si irradiano nell’entroterra. W. McNEILL, La peste nella storia. Epidemie, morbi e contagio dall’antichità all’età contemporanea, trad. di L. COMOGLIO, Einaudi, Torino 1981, pp. 137-138, 147-149 Quale ruolo ebbe l’esistenza dell’Impero mongolo nella diffusione della peste verso Occidente? Che effetti provocò la peste, all’interno della Cina? Quale fattore di tipo politico si aggiunse alla peste e contribuì alla drastica diminuzione della popolazione cinese nel Trecento? F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012 A causa delle pessime condizioni igieniche e della cronica sottoalimentazione, i poveri erano colpiti dalla peste in modo molto più micidiale dei borghesi o dei nobili. Pur non risparmiando nessuno, la peste trovò nei poveri un magnifico terreno per attecchire, predisposto da una prolungata sequenza di carestie: «Dopo la fame domina la peste» ripete un detto popolare. L’insistenza dei cronisti nel mostrare, come gli artisti delle danze macabre, un’eguale vulnerabilità del ricco e del povero, è corretta dalle testimonianze del triste primato della povertà. La malattia colpì dapprima i quartieri poveri, per esempio a Rimini, a Orvieto – dove i ricchi beneficiarono di una tregua di tre mesi –, a Narbonne, tra i tintori delle rive dell’Aude. Altrove la peste accentuava i suoi danni fra i poveri: a Lincoln i notabili furono praticamente risparmiati, a Lubecca la media della mortalità fra i possidenti (25%) è inferiore del 50% alla media generale (50%) nelle città tedesche. Sembra che nella Francia del Nord siano morti, nel 1348-49, due poveri per ogni ricco: si può parlare così di «epidemia proletaria». Alcuni contemporanei constatarono il carattere selettivo di quelle mortalità. Guido di Chauliac, il più celebre medico di quel tempo, fu testimone della Peste Nera e del suo ritorno nel 1361 e annotò questa differenza fra le due epidemie: «Nella prima morirono più popolani, nella seconda più ricchi e nobili». Il suo collega, Simon de Couvin, che partecipò alle consultazioni della Facoltà di Medicina di Parigi in occasione della peste, mostrò una perspicacia molto rara, con una punta di psicologia sociale: «Colui – scrisse – che era nutrito di alimenti poco sostanziosi cadde colpito al più piccolo soffio della malattia. L’uomo del volgo molto povero (pauperrima turba) accetta volentieri la morte, perché per lui vivere è morire. Ma la Parca [dea pagana della morte, n.d.r.] crudele risparmiò i principi, i cavalieri e i giudici: pochi fra loro morirono, perché era stata data loro una vita dolce in questo mondo». […] Simon de Couvin aveva ragione quando poneva sotto accusa soprattutto la malnutrizione. Il regime alimentare dei poveri, a Firenze, per esempio, mostra gravi carenze energetiche e vitaminiche: carenze di pro- teine e di lipidi, di calcio e di vitamine antiscorbuto (A, C) e antirachitiche (D). Un artigiano negli anni 1340-1347 a malapena poteva aggiungere al pan bigio, fatto essenzialmente di orzo e spelta, un quantitativo sufficiente di carne, formaggio, latte e legumi. Un’intera popolazione urbana affrontò la peste in uno stato di grave deperimento. Il caso di Firenze non è isolato e sembra condiviso dalla vicina Orvieto; gli indizi raccolti in altre città dell’Occidente non smentiscono questi dati. Nella campagna la malnutrizione superava la sottoalimentazione, grazie a cereali poveri, a una proporzione eccessiva di salumi rispetto alla carne fresca, di legumi ricchi di fecola (piselli, fave, farinate), di vino acetato e di acqua malsana. Dovunque si era lontani, soprattutto fra i poveri, dal regime sofisticato prescritto dalla Facoltà (di Medicina di Parigi) per sfuggire alla peste: pane di buon frumento, carni bianche, agnelli d’un anno, pochi legumi, evitando porri, cipolle e rape, «che provocano gran ventosità», in breve alimenti «fini e leggeri». […] Sarebbe servita una certa igiene dei vestiti e della pelle per tener lontana la pulce, autentico vettore della peste, data la sua stretta simbiosi col ratto. Solamente i ricchi potevano permettersi le novità della moda verso il 1310. Quanti contadini e salariati di città portavano una camicia di tela – e soprattutto la cambiavano – sotto i panni di grossa lana, spesso comprati da un rigattiere, o sotto le pellicce comuni (coniglio, gatto, volpe o montone) sempre più diffuse nel XIV secolo? L’uso di indossare le pelli con il pelo all’esterno non era sufficiente per eliminarne i parassiti. Inoltre non ci si lavava e i consigli medici di non bagnarsi erano per molti superflui; tutt’al più, sconsigliando la frequentazione dei bagni pubblici, si poteva evitare occasioni di contagio; ma i contadini non vi andavano mai. Delle altre indicazioni della Facoltà i poveri non sapevano che farsene: lavorare meno, accontentarsi di sforzi moderati, dormire con la testa sollevata da drappi «buoni e ben odorosi», usare disinfettanti aromatici costosi, incenso, mirra, aloé di Socotra, irrorare la propria camera d’acqua di rose. M. MOLLAT, I poveri nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 221-224, trad. it. M. C. DE MATTEIS, M. SANFILIPPO Che cosa intende sottolineare Michel Mollat, nel momento in cui definisce la peste una «epidemia proletaria»? Quali comportamenti e quali fattori avrebbero potuto attenuare la violenza dell’epidemia? Perché i consigli dei medici appaiono del tutto privi di senso, per la maggior parte della popolazione? F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012 UNITÀ II La peste: una malattia socialmente ingiusta 3 RIFERIMENTI STORIOGRAFICI 2 3 L’appropriazione del tempo da parte dei mercanti UNITÀ II A fianco del tempo della Chiesa, alla fine del Duecento fece la sua comparsa il tempo del mercante, finalizzato a rendere più rigido l’orario di lavoro degli operai dell’industria tessile. Scandito, in una prima fase, da un’apposita campana, il tempo del mercante trovò infine il proprio simbolo nell’orologio meccanico. l’autuNNo del medioevo 4 L’unità del tempo di lavoro nell’Occidente medievale è la giornata: agli inizi, giornata del lavoro rurale [...] e, a sua immagine, giornata del lavoro urbano, definita mediante il riferimento mutevole al tempo naturale, dal sorgere al tramonto del sole, e sottolineata approssimativamente dal tempo religioso, quello delle horae canonicae [= i momenti di preghiera dei monaci – n.d.r.], derivato dall’antichità romana. [...] All’ingrosso il tempo del lavoro è quello di un’economia ancora dominata dai ritmi agrari, esenti dalla fretta, senza scrupolo di esattezza, senza preoccupazioni di produttività e di una società a sua immagine, «sobria e pudica», senza grandi appetiti, poco esigente, poco capace di sforzi quantitativi. [...] Ora, a partire dalla fine del secolo XIII, questo tempo del lavoro è messo in discussione, entra in crisi. Offensiva del lavoro notturno, asprezza soprattutto nella definizione, nella misura, nella pratica della giornata di lavoro, conflitti sociali, infine, intorno alla durata del lavoro: così si manifesta in questo campo la crisi generale del XIV secolo, un progresso d’insieme attraverso gravi difficoltà di adattamento. [...] I padroni infatti, di fronte alla crisi, cercano dal canto loro di regolamentare quanto meglio possono la giornata di lavoro, lottando contro gli imbrogli degli operai in questo campo. Allora si moltiplicano le campane di lavoro (Werkglocken), di cui ricordiamo alcuni esempi. [...] A Amiens, il 24 aprile 1335, Filippo VI accoglie favorevolmente la richiesta del sindaco e degli scabini (= funzionari del governo cittadino, preposti alla giustizia – n.d.r.), che gli hanno chiesto «che essi possano fare un’ordinanza su quando gli operai nella detta città e suo distretto (banlieue) andranno ogni giorno di lavoro alla loro opera il mattino, su quando dovranno andare a mangiare e su quando dovranno tornare all’opera dopo mangiato; come pure la sera, su quando dovranno lasciare l’opera per la giornata; e che per la detta ordinanza che faranno, possano suonare una campana, che hanno fatto appendere alla torre della detta città, che è differente dalle altre campane». [...] A Aire-sur-la-Lys, il 15 agosto 1355, Giovanni di Picquigny, governatore della contea di Artois, accorda [...] di costruire una torre campanaria con una campana speciale a causa «del mestiere di drapperia e altri mestieri dove convengono parecchi operai a giornata, che vanno e vengono all’opera in certe ore». La nostra ricerca non è certo esauriente, ma essa è sufficiente a indicare che il problema della durata della giornata di lavoro è soprattutto acuto nel settore tessile, dove la crisi è più sensibile e dove la parte dei salari nel prezzo di costo e nei guadagni dei padroni è considerevole. Così la vulnerabilità alla crisi in questo settore di punta nell’economia medievale ne fa il campo di elezione di un progresso nell’organizzazione del lavoro. Lo dice bene il testo concernente Aire, che spiega la necessità della nuova campana «perché la detta città è governata dal mestiere di drapperia». Conferma a contrario: dove la drapperia non ha una posizione dominante, non si vedono apparire Werkglocken. Fagniez l’aveva giustamente notato già per Parigi. Così, almeno nelle città produttrici di panni, un tempo nuovo incombe sulla città: il tempo dei drappieri (= i grandi mercanti-imprenditori, che forniscono la materia prima agli artigiani ed esportano il prodotto finito – n.d.r.); perché questo tempo è quello della dominazione di una categoria sociale. È il tempo dei nuovi padroni. [...] Alla fine del secolo [XIV – n.d.r.] e all’inizio del secolo successivo vediamo bene che la durata della giornata di lavoro – non il salario direttamente – è la posta delle lotte operaie. [...] Resta il fatto che la campana del lavoro, spinta certamente da corde, cioè a mano, non presenta alcuna innovazione tecnica. Ma il progresso decisivo verso le «ore certe» è evidentemente l’invenzione e la diffusione dell’orologio meccanico, del sistema a scappamento, che promuove infine l’ora in senso matematico, come la ventiquattresima parte della giornata. Senza dubbio, proprio il secolo XIV supera questa tappa essenziale. Il principio dell’invenzione è acquisito alla fine del secolo XIII, il secondo quarto del secolo successivo ne vede l’applicazione in quegli orologi urbani, la cui area geografica è appunto quella delle grandi zone urbane: Italia del Nord, Catalogna, Francia settentrionale, Inghilterra meridionale, Fiandre, Germania. Una ricerca più approfondita permetterebbe forse d’intravedere che, più o meno, le regioni dell’industria tessile in crisi ricoprono l’area di diffusione degli orologi meccanici. Dalla Normandia alla Lombardia s’installa l’ora di sessanta minuti che, all’alba dell’età preindustriale, sostituisce la giornata come unità del tempo di lavoro. J. LE GOFF, Tempo della Chiesa e tempo del mercante e altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo, trad. di M. ROMANO, Einaudi, Torino 1977, pp. 26-36 In quale settore produttivo, e per quali ragioni, il lavoro non è più scandito dal sorgere e dal tramontare del sole, bensì dal suono di una campana? Che cosa intende dire J. Le Goff mediante l’espressione «il tempo dei drappieri (...) è quello della dominazione di una categoria sociale. È il tempo dei nuovi padroni»? Quale innovazione tecnica renderà ancora più rigido e preciso il «tempo dei drappieri»? F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012 Quella tessile fu l’unica vera attività che, nel Medioevo, assomigliasse alla moderna produzione industriale. La principale materia prima utilizzata era la lana, trasformata in pregiati tessuti che, insieme alle spezie, costituivano la voce più significativa del commercio di lusso su lunghe distanze. Non abbiamo cifre precise sul grado di occupazione, ma è probabile che più della metà dei cinquantamila abitanti che, secondo certe stime, formavano la popolazione di Gand e facevano di essa la più grande città dell’Europa nordoccidentale traessero il loro sostentamento, direttamente o indirettamente, dall’industria della lana. La percentuale era, forse, ancora più alta a Ypres, una città di dimensioni un po’ più ridotte che, nel 1313, esportava non meno di 40000 pezze di panno, secondo i calcoli più recenti. Lovanio e Malines ne producevano 25000 ciascuna. (Per fare un confronto, si può ricordare che Troyes, uno dei maggiori centri di produzione della Champagne, raggiunse appena – nello stesso periodo – le duemila pezze all’anno, mentre l’intera Inghilterra, che attraversava allora un periodo di depressione, esportò in dodici mesi, nel 1347-48, non più di 4422 pezze). Le proporzioni erano ancora largamente inferiori a quelle della rivoluzione industriale, ma avevano ormai superato in modo definitivo i limiti della tradizionale produzione di mestiere del Medioevo. [...] Anche il saggio [= tasso – n.d.r.] di meccanizzazione raggiunse un valore intermedio fra quello delle comuni imprese artigiane e quello del primo stadio della rivoluzione industriale. Nel secolo XII, come nel XVIII, la prima grossa trasformazione si ebbe nei processi di filatura e tessitura, così strettamente intrecciati fra loro che una qualsiasi accelerazione introdotta nell’uno esigeva un’eguale accelerazione nell’altro. Mentre nel corso della rivoluzione industriale furono introdotte, una dopo l’altra, tutta una serie di innovazioni meccaniche, nel corso de- gli anni della crescita preindustriale il progresso si limitò a due dispositivi semplici e poco costosi, che consentirono un notevole risparmio di lavoro: il telaio a pedale al posto del telaio a mano, la ruota a filare al posto della rocca e del fuso. Si sarebbe potuto facilmente fare un altro passo avanti impiegando il mulino ad acqua per azionare ruote a filare e telai a pedale; la forza motrice dell’acqua venne infatti impiegata a questo scopo agli inizi della rivoluzione industriale del Settecento. E già intorno alla metà del secolo XIII il principio del mulino ad acqua fu applicato in Italia al torcitoio che preparava il delicato filo destinato all’industria della seta. Non venne invece impiegato per il filo di lana – più rozzo e meno costoso – probabilmente perché non conveniva investire denaro in un dispositivo complicato quando si poteva far filare la lana a domicilio da filatrici miseramente pagate. [...] Nel Medioevo come nel Settecento (anche se in minor misura) alla meccanizzazione si accompagnò una crescente divisione del lavoro e l’integrazione industriale conferì una direzione unificata alle sparse operazioni della produzione artigiana. Non vi fu, tuttavia, alcuna fusione dei laboratori e delle botteghe artigiane in imprese industriali di grandi dimensioni, simili alla fabbrica moderna. Intorno alla metà del secolo XIII le fonti testimoniano l’esistenza di più di trenta fasi successive nella produzione dei tessuti e di quasi altrettante corporazioni o gruppi non organizzati di lavoratori ai quali era affidata la lavorazione di ciascuna fase. [...] Gli attrezzi, in genere, non erano così pesanti e i processi di lavorazione così interdipendenti da rendere necessaria la concentrazione di tutti i lavori sotto lo stesso tetto; l’imprenditore si limitava a fornire successivamente la materia prima a ciascuno degli artigiani a cui era affidata una determinata fase della lavorazione. R. S. LOPEZ, La rivoluzione commerciale del Medioevo, trad. di A. SERAFINI, Einaudi, Torino 1975, pp. 168-172 Quali dimensioni aveva l’industria tessile nell’Europa del tardo Medioevo? Com’era organizzata la divisione del lavoro? F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012 UNITÀ II L’industria tessile nel Tardo Medioevo 5 RIFERIMENTI STORIOGRAFICI 4 5 La centralità della morte nella religiosità tardo medievale UNITÀ II La Morte occupa il centro dell’immaginario religioso dei secoli compresi fra la peste nera del 1347-1350 e la Riforma protestante. Ma pensare alla Morte significava soprattutto, per l’uomo del Quattrocento, riflettere sul giudizio che, dopo la fine della vita, ogni individuo avrebbe dovuto sostenere davanti a Dio. l’autuNNo del medioevo 6 Sembrava che la morte dominasse l’intera esistenza; essa era per gli uomini quasi come il pane quotidiano. Media vita in morte sumus: nella vita siamo circondati dalla morte. La morte era l’oggetto dell’esperienza umana del XV secolo. Ed è significativo che le prime volgarizzazioni tedesche di quell’antica antifona [= ritornello cantato durante una liturgia di preghiera monastica – n.d.r.] abbiano luogo proprio in questo periodo. Il tetro sentimento della morte intravista fa sì che il pensiero dell’uomo del tardo medioevo si volga incessantemente alla morte. A partire dal XIV secolo e sino alla Riforma, osserviamo un ampliarsi crescente delle espressioni e delle testimonianze intorno alla morte. In nessuna epoca come questa il pensiero di ciascuno fu incessantemente fisso sulla morte: memento mori, pensa che devi morire. Fra tutte le forme e figure intorno alle quali si volgono il pensiero e la devozione, la fiducia e l’angoscia, l’amore e il timore degli uomini, una è più vivida e rilevata, quella della morte, anzi, del «Sire Morte». Le «danze macabre» riproducono quello che l’esperienza dell’epoca ha connesso con la morte. Dappertutto, ben presto, si trova una copiosa [= abbondante – n.d.r.] diffusione della sua immagine, ora oggetto di rappresentazione drammatica, ora di pittura, ora di incisione su legno. Raffigurazioni delle danze macabre ricoprono le pareti delle cappelle cimiteriali, degli ossari, dei conventi, dei chiostri, e sembra quasi che da quei luoghi vogliano presentarsi come una predica rivolta a tutti; oppure sotto una forma di foglio miniato o di libretto popolare, pervengono sino al singolo individuo, raggiungendo il borghese nel suo salotto, come il monaco nella sua cella. Nata originariamente come una ridda [= ballo – n.d.r.] del morto col vivente, la danza macabra si trasforma in danza della morte con l’uomo, che essa sorprende da solo, in coppia o in folla. Artisti, piccoli e grandi, raffigurano, in variazioni sempre nuove, la predominante potenza della morte, la sua minacciosa vicinanza e la sua forza livellatrice. Ora la morte sta sui rami di un albero, sotto cui amoreggiano il garzone e la sguattera, ora afferra il con- tadino tra i buoi nell’atto di arare, ora abbraccia il corpo di una donna che si guarda allo specchio, ora si pone in agguato della coppia d’amanti che passeggiano spensierati, ora sbalza il cavaliere dalla sella, e non risparmia neppure il bambino. La morte prende tutto, davanti ad essa tutti gli uomini sono eguali, tutte le classi sociali vengono passate al suo vaglio: papa, imperatore, cavalieri, contadini, signori, servi, mendicanti, «tutto quello che è nato ha in sorte di dover soffrire l’amara morte». Così, alle danze macabre viene a collegarsi una tendenza democratica; esse finiscono, infatti, con il rivestire il carattere di una satira sociale, nel contesto dei fermenti e dei rivolgimenti del tempo. [...] La morte non viene avvertita (tanto – n.d.r.) come un predatore della vita, quanto piuttosto come un predatore della salute [= salvezza – n.d.r.] dell’anima. E perciò l’intensa esperienza della morte, sul finire del medioevo, non conduce ad un arricchimento e ad un approfondimento della vita, ma, al contrario, trascina i pensieri degli uomini proprio in direzione dell’aldilà e stimola in loro, ancora più profondamente, la preoccupazione della vita eterna. Un aspetto condiziona l’altro, ed è come un circolo vizioso: quanto più intensamente gli uomini temono la morte, tanto più appassionatamente, per ciò stesso, si preoccupano della salvezza della loro anima e, di converso, quanto più appassionatamente si preoccupano della salute della loro anima, tanto più temono la morte. Ne scaturisce l’espressione del giudizio così terribilmente paventoso [= spaventoso – n.d.r.] e della temuta penitenza, che risuona sino a noi attraverso le note del canto dei flagellanti: «Or sollevate le mani ché Dio conduce la grande morte. Or levate il braccio e che Dio abbia di noi pietà. Gesù con il tuo rosso sangue preservaci dalla nera morte». È questa l’impressione che l’esperienza vissuta e generalizzata della morte produce allora nella maggior parte degli uomini: il castigo di Dio incombe; il suo sdegno deve essere placato. H. ZAHRNT, Il tempo dell’attesa, trad. di F. VOLTAGGIO, Coines, Roma 1973, pp. 63-66 In che senso la «danza macabra» (che fu la rappresentazione più diffusa della potenza della morte sugli uomini) aveva una «tendenza democratica» e un significato di «satira sociale»? La «grande morte» del canto dei flagellanti si riferisce alla «peste nera»: come viene interpretata quest’ultima? Chi l’ha inviata contro gli uomini? F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012 Nel corso del xv secolo, l’Italia centro-settentrionale assiste al fiorire dell’urbanistica, cioè della pianificazione dello spazio urbano. L’edificazione di palazzi, chiese e strade non è più lasciato al caso, ma rispetta le esigenze del signore, le necessità difensive e quelle abitative della corte. Gli edifici – la loro genesi, conformazione e sito – costituiscono uno dei più eloquenti documenti di una società ed una sua eccellente base di lettura e di interpretazione. Tra le varie forme di creazione artistica, quella architettonica è senz’altro – con quella teatrale – una di quelle dotate di più densi significati collettivi. Né sembra dubbio che la deliberata utilizzazione degli edifici a scopo di prestigio privato e pubblico abbia avuto nella Penisola un incremento rinnovato e molto rilevante nel corso del XV secolo. Non è questa la sede per valutare in modo adeguato se la gerarchia dei vari tipi di costruzione sia stata più accentuata nel periodo comunale o in quello dei principati. È certo comunque che nel Quattrocento essa è stata perseguita e realizzata in maniera manifesta ed intenzionale, al punto da potersi sostenere che essa abbia rappresentato uno dei modi di concretare un processo di aristocratizzazione in atto su vari altri piani [la struttura degli edifici e l’impianto urbanistico diventano lo specchio evidente del fatto che il potere non è più nelle mani del popolo, ma di un pugno di aristocratici: i signori e i principi, n.d.r.]. Se cioè il contesto costituito dalla comunità cittadina rimaneva lo sfondo di riferimento, su di esso si tendeva a far campeggiare sempre meglio e sempre di più la presenza di attori singoli. […] In altri termini il dominio politico si manifestò – certo in gradi diversi e nelle forme più svariate da una città all’altra – e si tradusse regolarmente ed in larga misura sul piano urbanistico ed architettonico. I centri che furono maggiormente investiti da tale fenomeno furono innanzitutto quelli ove risiedevano i signori e i principi, cioè in genere le capitali degli Stati, oltre a quelli ove il potere centrale intendeva proiettare l’immagine e segnare l’impronta della propria supremazia. A Milano ed in varie altre città lombarde i Visconti avevano impresso già nel secolo XIV le tracce visibili del loro dominio: basterebbe citare in merito il castello di Pavia. Alla morte dell’ultimo loro duca, Filippo Maria, i milanesi cercarono di realizzare il sogno di restaurare il precedente regime municipale. Molto breve fu nondimeno la stagione della loro Repubblica ambrosiana [di sant’Ambrogio, patrono di Milano, n.d.r.] (14471450), che dovettero capitolare di fronte alle milizie del condottiero Francesco Sforza. Quest’ultimo operò subito in modo da ridurre alla soggezione i suoi nuovi sudditi proprio intervenendo in modo decisivo sul tessuto urbano della metropoli milanese [Milano è chiamata metropoli in quanto (come Venezia e Napoli) aveva circa 200 000 abitanti, in un momento storico in cui Genova e Firenze ne avevano 60 000, Bologna e F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012 Palermo 55 000, Roma appena 25 000, n.d.r.]. Per fissarvi la propria residenza egli scelse – come già avevano fatto i Visconti – un sito al margine del centro abitato, alla cerniera fra la zona popolosa dell’agglomerato ed il suburbio circostante. Vari signori d’Italia e di altri paesi avevano già optato per una soluzione del genere ed a metà del Quattrocento, nel suo trattato De re aedificatoria [Sulle modalità del costruire, n.d.r.], Leon Battista Alberti consigliava al principe proprio questo tipo di residenza. Resta il fatto che la colossale mole del Castello sforzesco, innestata nella cerchia delle mura milanesi, corrispose pressoché perfettamente alle esigenze del nuovo duca e dei suoi successori. Con le sue possenti strutture e le sue vaste dimensioni si rivelò adatta a svolgere tanto la funzione di cittadella che quella di fastosa struttura. […] L’azione degli Estensi a Ferrara fu in certo modo più originale, per quanto anch’essi si fossero fatti costruire verso la fine del Trecento la propria sede in un castello che rimase al margine della città per quasi tutto il secolo XV. Nel 1492, nondimeno, il duca Ercole I diede inizio alla più grande operazione urbanistica cui si assistette nella Penisola a quell’epoca. Quel principe decise un ingrandimento tale della superficie di Ferrara che essa ne risultò quasi triplicata. Il suo castello si venne allora a trovare pressoché nella parte centrale dell’abitato, fra il nucleo medioevale ed il nuovo spazio creato dall’ampliata cerchia delle mura. Questo ampliamento prese il nome di Addizione erculea e risultò improntato a caratteristiche inabituali, rese possibili anche dalla pressoché completa libertà di cui godé Biagio Rossetti di tracciarvi arterie rettilinee e di ritmarlo con piazze adeguate. Il criterio al quale l’architetto s’ispirò fu di collegare la zona della residenza ducale ai nuovi quartieri a settentrione per mezzo di vie larghe e diritte, punteggiate da dimore dai vasti cortili interni. La più notevole toccò ad un membro della famiglia estense, Sigismondo, e fu detta Palazzo dei diamanti per il singolare rivestimento decorativo a cuspidi della facciata. […] Fra le nuove arterie, una delle più importanti fu proprio quella che collegava il giardino del castello ad una residenza esterna di sollazzo posta all’estremità dell’Addizione. Questo permetteva al duca di sfilare in mezzo ai propri sudditi ogniqualvolta intraprendeva quel percorso. Di non minore spicco fu l’intervento dei nuovi signori di Urbino, i Montefeltro, e particolarmente di Federico (morto nel 1484) che vi governò per circa un quarantennio. Condottiero come Francesco Sforza, egli era titolare di una signoria limitata in quanto il suo territorio era subordinato alla sovranità dello Stato pontificio. Il carattere singolare dell’iniziativa che egli prese verso la metà del Quattrocento consistette nella struttura del tutto diversa ch’egli volle dare alla sua residenza: non più un castello e tanto meno una cittadella (anche se vi erano annessi di possibile impiego militare) UNITÀ II Urbanistica e potere nell’Italia del Quattrocento 7 RIFERIMENTI STORIOGRAFICI 6 ma un palazzo. Le imponenti strutture di quest’ultimo sposarono in modo felice la conformazione topografica ed il sito seducente. Il palazzo costituì il centro di gravitazione di un vero e proprio quartiere che, oltre alla cattedrale, comprendeva delle scuderie modello, una piazza d’armi contigua e dei sotterranei abilmente si- stemati. Questo insieme urbanistico, completato da una vicina arteria fiancheggiata da dimore per funzionari e cortigiani, venne a costituire una delle realizzazioni più alte e riuscite del Quattrocento italiano. A. TENENTI, L’Italia del Quattrocento. Economia e società, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 8-11 UNITÀ II Quali scopi si proponevano di raggiungere i principi, promuovendo una vasta azione urbanistica, nelle loro capitali? Che cosa distingue la residenza di Francesco Sforza da quella dei duchi estensi? E che cosa, invece, distingue la residenza del duca di Urbino da quelle dei duchi di Milano e di Ferrara? l’autuNNo del medioevo 8 F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012
Scaricare