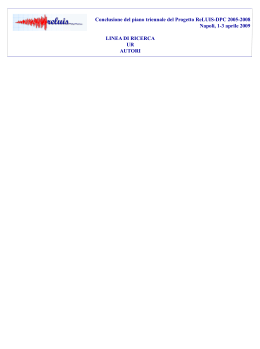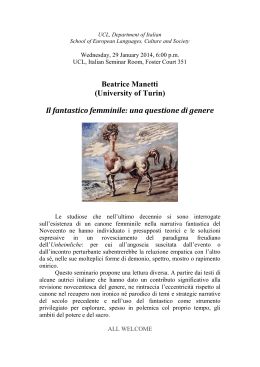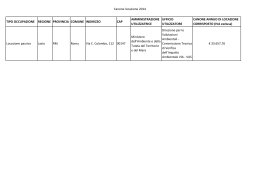I CLASSICI CHE HANNO FATTO L’ITALIA I II FABRIZIO GOVI I CLASSICI CHE HANNO FATTO L’ITALIA Per un nuovo canone bio-bibliografico degli autori italiani Con un saggio introduttivo di Giovanni Ragone ed una nota di Umberto Pregliasco Soliera Giorgio Regnani editore 2010 III IV Indice Prefazione dell’Autore....................................................................... p. VII Dal canone al mainstream, la nostra memoria attraverso i libri di Giovanni Ragone............................................................................ p. XIII I Quattrocento colpi di Umberto Pregliasco........................................ p. XXXIII I Classici che hanno fatto l’Italia............................................................ p. 1 Bibliografia......................................................................................... p. 345 Elenco alfabetico degli autori e delle opere descritte...................... p. 359 Indice analitico................................................................................... p. 377 V I miei ringraziamenti vanno a Eugenio Sidoli, Paolo Bongiorno, Gianfranco Varcasia, Leandro Cantamessa, Enrico Zanoni, Lucia Panini, Antonio Pettini, Anna Paola Mulinacci, Umberto Pregliasco, alla prof.ssa Franca Cattelani e, soprattutto, ai miei due maestri: l’amico Axel Erdmann e mio padre Alberto. Tutti loro sono stati prodighi di preziosi consigli. Ringrazio inoltre mia moglie Francesca e i miei figli Lorenzo ed Alessandro, che mi hanno permesso di portare a termine questa fatica. Un ringraziamento speciale va infine a Giorgio Regnani, che ha avuto l’idea originaria dell’opera e ha reso possibile la sua realizzazione. VI Prefazione Nel 1464, coll’arrivo nel monastero benedettino di Subiaco dei monaci tedeschi Conrad Sweynheym e Arnold Pannartz, lavoranti della bottega magontina di Peter Schöffer, insieme al loro prezioso carico di matrici e punzoni metallici per la fusione dei caratteri mobili (il torchio, troppo ingombrante, venne probabilmente costruito sul posto), inizia per l’Italia la straordinaria avventura della stampa. Dopo aver impresso un “Donato”, diffusissima grammatichetta latina ad uso delle scuole, il De oratore di Cicerone, un Lattanzio (il primo libro datato -1465- pubblicato nel nostro paese) e un Sant’Agostino, i due si trasferiscono a Roma, dove impiantano la loro officina nella casa dei nobili Piero e Francesco de’ Massimi e cominciano a collaborare con Giovanni Andrea Bussi, il primo umanista a rendersi conto della straordinaria portata culturale della nuova invenzione. Nel frattempo giungono in Italia altri maestri dell’arte, quasi tutti tedeschi, che si stabiliscono in vari luoghi della penisola. Il primo Italiano a stampare in proprio è il messinese Giovanni Filippo De Lignamine, che inizia la sua attività a Roma nel 1470. Le officine tipografiche sono delle vere e proprie imprese commerciali. I tipografi cercano di interpretare le esigenze del mercato locale e decidono di conseguenza i testi da stampare e le tirature. A volte falliscono e per sfuggire ai debiti si trasferiscono in altre località. Nei primi anni Settanta del secolo vedono la luce tutti i maggiori testi volgari della letteratura italiana. Nel giro di qualche decennio l’Italia, grazie alla sua fitta rete commerciale e alla presenza di numerose e prestigiose università, diviene un grande centro di irradiazione della stampa, finendo per superare la stessa Germania: 4157 sono le edizione italiane stampate nel Quattrocento (con tirature che variano dalle trecento copie degli esordi alle oltre mille di fine secolo) contro le 3232 della Germania, le 998 della Francia e le 395 del Regno Unito. Nel frattempo la produzione a stampa si va progressivamente differenziando (diritto, medicina, letteratura volgare e d’intrattenimento, bandi, documenti ufficiali, calendari, libri liturgici e devozionali) e il mercato da locale si fa internazionale. I librai e gli stessi editori stringono relazioni commerciali con colleghi di altre città europee, contribuendo alla formazione e all’allargamento del mercato. Ma è solo con il Cinquecento che il libro a stampa diviene veramente popolare. Nel corso del secolo vedono la luce milioni di libri (Venezia da sola ne produce quasi la metà), i prezzi di produzione crollano, le tirature aumentano, nascono i primi tascabili, le prime collane editoriali e nuovi generi letterari, indissolubilmente legati alla stampa. Se l’Orlando innamorato del Boiardo (composto fra il 1476 e il 1482), solo per fare un esempio, risente ancora dell’oralità dell’ambiente di corte, dove veniva declamato e copiato a mano per la biblioteca del duca e solo secondariamente impresso, il Furioso dell’Ariosto tradisce invece una genesi libraria e viene subito dato alle stampe (1516). Dopo la riscoperta dei classici e degli autori medievali che caratterizza la prima produzione quattrocentesca, con il Cinquecento conquistano la supremazia i testi di autori contemporanei e fanno la loro prima apparizione opere che segnano la rifondazione del sapere scientifico e la riforma dei generi letterari. Inoltre la larga diffusione delle opere delle Tre Corone fiorentine (Dante, Petrarca e Boccaccio) e il dibattito sulla lingua, dominato dalla figura di Pietro Bembo, impongono in modo perentorio quel codice linguistico basato sul fiorentino letterario trecentesco che è alla basa dell’italiano moderno. L’Italia continua a mantenere il primato della produzione libraria in Europa almeVII no fino alla metà del secolo, quando le riforme restrittive del Concilio di Trento si diffondono su tutto il territorio nazionale, acuendo quel lento ed inesorabile processo di declino, che i più acuti osservatori contemporanei avevano già cominciato a percepire e denunciare a partire dalla discesa di Carlo VIII nel 1494. Questa dà infatti avvio alle rovinose guerre di conquista e all’occupazione straniera di gran parte della penisola, che durerà ininterrotta fino al 1861. Il Cinquecento è anche il secolo nel quale l’anatomia trova nelle prestigiose sedi universitarie di Padova e Bologna una schiera di geniali innovatori, le cui scoperte segnano la nascita della medicina moderna. Durante il Seicento, nonostante la perdita di potere economico e culturale, l’Italia gioca senza dubbio un ruolo fondamentale nello sviluppo delle scienze sperimentali, come testimonia il gran numero di scienziati italiani che nel corso del secolo pubblicano opere di altissimo rilievo in ogni campo del sapere. Con il Settecento il provincialismo italiano si approfondisce ulteriormente e, pur mantenendo una certa varietà ed originalità, soprattutto in campo economico e sociale, la nostra cultura subisce l’influenza di idee e scuole di pensiero che vengono da fuori, in particolare dall’Illuminismo francese. Nella seconda metà del secolo, tuttavia, il paese vive una straordinaria stagione di riformismo. La Lombardia austriaca di Maria Teresa e poi di Giuseppe II, il Regno di Napoli e la Toscana granducale di Pietro Leopoldo sono i principali scenari in cui si dispiega l’azione dei maggiori economisti italiani, i quali, attraverso i loro scritti e il loro impegno nelle amministrazioni locali, gettano le basi dello stato moderno. Se fino alla fine del Settecento la produzione del libro era rimasta praticamente invariata, nell’Ottocento si assiste alla nascita dell’editoria industriale. Con l’introduzione nelle cartiere francesi di Essonnes della produzione a macchina (1798) e con l’invenzione tedesca del primo torchio da stampa a cilindri mossi dal vapore, si entra in una nuova era della tipografia, che permette tirature di decine di migliaia di copie. In Italia il primo ad utilizzare la nuova tecnologia è Giuseppe Pomba a Torino nel 1834, ma la mancanza di un mercato nazionale e la scarsa alfabetizzazione degli Italiani impediscono la nascita di una moderna editoria. È solo dopo il 1861 che si va lentamente formando un vero mercato in lingua italiana e cominciano a fiorire le prime case editrici industriali, in particolare Treves e Sonzogno a Milano, indiscussa capitale italiana della carta stampata. Parallelamente allo sviluppo del libro di massa (manuali, romanzi d’appendice, resoconti di viaggio, ecc.), si verifica l’esplosione dei giornali e delle riviste, che spesso del libro sono un indispensabile supporto promozionale. Il processo perdura nel Novecento grazie all’aumento progressivo dell’alfabetizzazione e alla lenta formazione di un sentimento nazionale. Tre libri in particolare, pubblicati allo scadere del secolo e considerati come veri e propri capisaldi della cultura italiana postunitaria, esercitano un ruolo decisivo nello sviluppo della coesione nazionale almeno fino alla seconda guerra mondiale: Pinocchio di Collodi, Cuore di De Amicis e La scienza in cucina di Pellegrino Artusi. Nel primo Novecento si assiste anche alla nascita del libro come oggetto d’arte, promosso soprattutto dal Futurismo, unico vero movimento d’avanguardia italiano. Nel secondo dopoguerra l’editoria italiana acquista quella fisionomia che mantiene all’incirca ancora ai nostri giorni. Nonostante i continui dati allarmanti sulla scarsità di lettori, essa sta conoscendo una prosperità ed una diffusione mai conosciute in precedenza. Cos’è questo libro? Nato dal confronto con un celebre testo degli anni Sessanta, il Printing and the Mind of Man, in cui sono descritte più di quattrocento opere a stampa che hanno segnato la storia dell’uomo in tutti i principali campi del sapere, I classici che hanno fatto l’Italia si propone come una sorta di biblioteca ideale di soli VIII autori italiani (per nascita o di adozione), ma nello stesso tempo ambisce ad illustrare la storia della nostra cultura, dal Duecento ad oggi, attraverso una selezione di opere e di edizioni. Le vicende editoriali di un testo (sia esso un capolavoro assoluto, un’opera pioneristica o il successo di un’epoca) hanno infatti una duplice valenza: da un lato informano sulla ricezione e sulla diffusione di una certa opera dopo la sua uscita (tirature, ristampe, contraffazioni, privilegi, accordi commerciali, ecc.); dall’altra aiutano a capire i mutui rapporti fra stampa e lettori, mettendo in evidenza come il libro stampato abbia influenzato la maniera stessa di scrivere e leggere degli uomini. Ogni opera si offre al lettore anche nella materialità del libro, sollecitandone contemporaneamente l’occhio e la mente attraverso precise strategie editoriali (formato, tipo di carattere, presenza o meno di illustrazioni, dediche, ecc.). I classici che hanno fatto l’Italia non è quindi un elenco generico dei principali testi della nostra storia, né tantomeno una storia del libro italiano da un punto tipografico, quanto piuttosto una rassegna cronologica di quei testi nelle edizioni a stampa che li hanno trasmessi e fatti conoscere. Per quanto riguarda i criteri di selezione, si è ritenuto opportuno di non inserire più di un’opera per ciascun autore, pur sapendo di far torto a certuni che avrebbero sicuramente meritato di figurare più volte: questo per dare spazio ad autori meno conosciuti senza aumentare a dismisura le dimensioni del volume. La scelta è ovviamente del tutto opinabile e ci scusiamo preventivamente per le eventuali dimenticanze (nessuno è onnisciente!) e per le deliberate omissioni, che possono essere state dettate o da motivi editoriali o da valutazioni personali. La decisione poi di spingersi sino al campo minato della contemporaneità, dove gli arbitrî sono ancor più difficili da evitare, si spiega con la volontà di valorizzare il presente nelle sue espressioni più emblematiche, cosa che noi Italiani dovremmo meglio apprendere dai nostri amici Americani. I classici che hanno fatto l’Italia non si rivolge esclusivamente ad un pubblico di collezionisti, ma pensiamo possa attirare la curiosità anche di chi non abbia mai provato l’emozione di sfogliare un libro antico o di leggere un testo nella sua edizione originale. Per ogni opera selezionata si fornisce un’edizione di riferimento (in genere, ma non sempre, la prima), di cui vengono spiegati i pregi e, laddove vi siano e si conoscano, gli eventuali retroscena. In alcuni casi si fa un breve accenno anche ad altre edizioni particolarmente significative. Ogni scheda descrive poi il significato storico-culturale dell’opera presa in esame e si conclude con la biografia sommaria dell’autore. In appendice si trova la descrizione fisica dell’edizione. Collazione, formati ed abbreviazioni. Nella sezione riservata alla descrizione fisica delle opere prese in esame, si trova, nell’ordine, il numero dei volumi, il formato, la numerazione delle pagine o delle carte, il numero e il tipo delle eventuali figure, tavole o tabelle inserite nel testo o poste fuori testo, la descrizione dell’antiporta e del frontespizio qualora presentino caratteristiche peculiari e l’indicazione di varianti o differenti tirature dell’edizione. Per quanto riguarda i formati, il sistema antico, che è valido per i libri stampati fino circa agli anni Trenta dell’Ottocento, si basa sulla piegatura del foglio e sul senso dei filoni della carta. Per tutti i libri posteriori è solitamente in uso il sistema moderno che prende in considerazione solamente l’altezza del foglio. In questa sede si è scelto di fornire i formati all’antica, piuttosto che le misure, anche per le edizioni moderne. Per facilitarne la comprensione, si forniscono qui di seguito le misure dei libri secondo il sistema moderno: folio, oltre 38 cm; 4°, da 28 a 38 cm; 8vo°, da 20 a 28; 16°, da 15 a 20 cm; 24°, da 10 a 15 cm. Per quanto riguarda invece le collazioni delle opere, esse sono state condotte, quasi sempre, partendo da un esemplare da me personalmente visionato. Anche nei casi IX in cui non mi è stato possibile vedere direttamente il libro, le collazioni fornite nascono comunque dal confronto di almeno due repertori bibliografici, siano essi banche dati informatiche, annali tipografici o cataloghi cartacei. Per le opere del Novecento la collazione è quasi sempre limitata alle sole pagine numerate. Ciò che si è inteso fornire, è dunque la descrizione fisica di un esemplare “ideale”, quello cioè che dovrebbe rispecchiare le intenzioni ultime dell’editore. I libri prodotti dalle tipografie dell’epoca preindustriale (le tecniche e gli strumenti di stampa dalla metà del Quattrocento sino alla fine del Settecento sono rimasti pressoché invariati) sono tuttavia manufatti artigianali, che possono essere compresi a fondo solo se si conoscono le procedure con cui venivano realizzati. In alcuni casi, quindi, ricostruire l’esemplare ideale di una certa edizione risulta molto arduo o addirittura impossibile. Un utile esempio in questo senso è costituito dall’edizione bresciana del 1599 dell’Architettura militare del De Marchi, dove quasi ogni esemplare è lievemente diverso dall’altro nel computo complessivo delle tavole fuori testo. Ma, al di là di questo caso estremo, tra una copia e l’altra della stessa edizione (senza considerare i problemi legati alle varianti e alle tirature) vi sono spesso piccole, ma significative differenze, dovute per esempio alla presenza o meno di un ritratto o di un errata. Solo se si prendono in considerazione di volta in volta i meccanismi di produzione e commercializzazione delle singole edizioni, queste caratteristiche possono essere chiaramente distinte dalle “mancanze”, che si creano eventualmente dopo l’uscita dell’edizione per circostanze indipendenti dalla volontà dell’editore e dell’autore. Il fatto che alcuni esemplari rechino apparati iconografici aggiuntivi, per esempio, non implica necessariamente che quelli che ne sono privi, siano scompleti. Può trattarsi di copie speciali o che beneficiano di un elemento introdotto dal tipografo a stampa già avviata. All’interno di una stessa edizione vi sono poi piccole varianti testuali che sono riconducibili a correzioni condotte in corso di stampa. Diverso ancora è il caso di un tipografo che, avendo esaurito tutte le copie e volendo far fronte alle richieste di un’opera da lui pubblicata, per poterla ristampare è costretto a ricomporre integralmente il testo. Benché egli sia portato a farlo rimanendo il più possibile fedele alla composizione della prima emissione, tra questa e la seconda emissione emergeranno inevitabilmente delle differenze, più o meno rilevanti. In questo caso non si parla di nuova edizione, ma di nuova tiratura o emissione. I compositori delle tipografie dell’ancien régime avevano a disposizione un quantitativo limitato di caratteri a stampa. Terminata l’impressione di un certo numero di fogli, essi erano quindi costretti a disfare la forma per rendere disponibili i caratteri, con i quali componevano una nuova forma e proseguivano in questo modo il lavoro. Benché abbia cercato di utilizzare al minimo le abbreviazioni per privilegiare la leggibilità del testo, una breve legenda può comunque essere utile: vol. (volume); cc. (carte); pp. (pagine); tavv. (tavole); rip. (ripiegato); f.t. (fuori testo); n.t. (nel testo); antip. (antiporta); sovraccop. (sovraccoperta); [i.e.] (sta per id est e, come l’analoga dicitura recte, indica che “in realtà” il numero effettivo di pagine è diverso da quello indicato nella numerazione del volume). Quando il nome dell’autore e i dati tipografici sono posti entro parentesi quadra significa che essi non compaiono direttamente nell’edizione, ma sono stati ricavati per mezzo di elementi esterni all’edizione stessa. Quando invece i dati tipografici si trovano entro parentesi tonda, significa che essi non sono espressamente indicati sul frontespizio, ma comunque figurano all’interno del volume, per lo più nel colophon o, per la data, nell’imprimatur. I numeri di pagina posti entro parentesi tonda indicano invece che le pagine non contengono una numerazione propria. Per quanto riguarda gli autori, nel caso in cui il loro nome non figuri sul frontespizio, ma in calce alla dedica, nella prefazione o in un altro luogo del testo, si è deciso di non X indicarlo attraverso le parentesi tonde per non appesantire eccessivamente la lettura. Le schede sono disposte in ordine cronologico per anno e subordinatamente in ordine alfabetico. Si è preferito non prendere in considerazione il mese di stampa, in quanto in molti casi non conosciuto. Fabrizio Govi XI XII Dal canone al mainstream, la nostra memoria attraverso i libri di Giovanni Ragone La prima traccia del termine “classico” riferito a uno scrittore risale a un intervento di Frontone, nelle Notti attiche di Aulo Gellio; la parola si riferiva alla gerarchia delle classi sociali, e “classico” era l’appellativo attribuito a chi apparteneva alla prima, la più elevata. Il “canone” degli autori “classici”, un uso già stabile nella Atene dei tempi di Pericle, procede dalla cultura antica verso di noi, modificandosi via via nel tempo; si tratta della compagine di quei libri che è assolutamente obbligatorio leggere nelle scuole; e per la scolastica medievale, derivata da quella dei grammatici di età imperiale, si tratta di autori latini saldamente ancorati alle quattro categorie degli “aurei”, come Virgilio o Orazio, degli “argentei”, come Plauto o Cicerone, di quelli “di stagno”, come Esopo, e infine dei minori e “di piombo”. Da questa selezione e gerarchizzazione discende la nozione (moderna, ma già attiva nel Quattrocento) dei “classici”, che è rimasta viva, e tuttora sopravvive, ancorata come sempre all’apprendimento soprattutto liceale, ma anche testimoniata con passione estrema dai momenti più alti di quella disciplina così tipicamente novecentesca che continuiamo a chiamare critica letteraria, fino alla celebre scelta di Harold Bloom: ventisei scrittori considerati “grandi”, gli autori delle opere che Bloom intende stabilire come il canone occidentale. Cambiando, naturalmente, il criterio di selezione: non più il valore esemplare per forma e contenuto, se la tradizione stessa va morendo, ma “la singolarità, un tipo di originalità che non può essere assimilata […] la loro misteriosità, la loro capacità di far sentire il lettore un estraneo a casa sua”, ciò che salva alcuni testi dalla rovina delle molte centinaia che un tempo costituivano il canone occidentale, nella Grande Disgregazione che ha colpito quello che si usava definire “il mondo dotto” (The western Canon. The Book of the Ages, 1994). Se il classico rinvia di per sé alla “prima classe”, all’élite, al dominio, e quindi a una struttura nella quale vi sono norme esemplari, il canone viene invece dal kanón, la canna, o meglio la serie di canne infisse come segnali nel terreno della storia a indicare i punti notevoli da ritrovare; rimanda quindi ad una operazione che si rinnova continuamente, allo scrutare, al disseminare segnali, al lasciare tracce per un cammino futuro. Semanticamente, il canone non si identifica dunque con la pratica scolastica, ed è più intrinseco alle scienze dell’uomo (la filosofia, la storia, la moderna antropologia e sociologia, per non dire delle scienze del testo). Del resto, già con i primi umanisti il classico è un autore antico e autorevole, degno di essere letto e consultato come fonte di verità, non tanto sul piano soprattutto linguistico e retorico come in antico, quanto per la sua autorevolezza di pensiero e di ispirazione morale per la vita presente, e così per esempio dall’ultimo Quattrocento al medio Cinquecento il grande Erasmo sceglie Luciano e scalza il modello di Cicerone; così il circolo di Lorenzo il Magnifico inaugura il primato di Platone; e Giusto Lipsio restaura e incorona Seneca; ma lo stesso Erasmo viene ormai canonizzato a livello europeo, e in Italia si inizia a inserire fra i classici non solo Dante, già prima della diffusione della stampa, ma anche Petrarca, Boccaccio, e assai presto Ariosto. Di lì in avanti il canone, come profilo ben segnalato dell’antico autorevole (salvo inserti contemporanei eccezionali), si riproduce via via nel tempo, con una netta prevalenza - soprattutto in Italia e Francia - della serie letteraria, e soprattutto della poesia, considerata la sintesi più alta tra la forma della lingua e il contenuto narraXIII tivo, filosofico, di immaginazione e di riflessione sul sé. Naturalmente, stabilire il canone è una operazione che genera periodici conflitti e ritorni a basi di consenso più o meno generalizzato; per esempio il contrasto fra petrarchisti e dantisti, già vivace ai tempi di Manuzio e del Bembo, che sembra non doversi mai chiudere – nemmeno ora! Nel tardo Cinquecento un modello normativo stilistico-letterario per la cultura italiana tende a stabilizzarsi, con Robortello, Castelvetro, lo Scaligero e tanti altri teorici, lungo una serie limitata e rigorosa di pochi grandi autori grecoromani, più pochissimi autori in volgare da destinare alla lunga durata. Più avanti, soprattutto l’ultimo Settecento tedesco, che intrecciava il culto neoclassico degli antichi con la sperimentazione moderna di Goethe e Schiller, ha originato la tendenza a ridiscutere periodicamente il canone degli autori moderni, per ogni nazione dell’Europa. E i canoni nazionali hanno continuato a riversarsi dagli strati alti della cultura verso la cinghia di trasmissione dei manuali scolastici e della ulteriore selezione dei testi praticata dagli insegnanti, fino ai tempi nostri. L’antico autorevole, dunque. Ma come ha osservato Maurizio Bettini (I Classici nella bufera della modernità, in “Critica del testo” III, 1, 2000), il primo dei due termini che nei secoli motivavano l’inserimento di un autore o di un’opera è praticamente collassato: di ciò che teoricamente consideriamo antico, vale a dire profondamente relegato nel passato, noi non siamo più adatti a valutare e decidere gerarchie, perché tutto, nelle culture della post-metropoli, torna disponibile. Tutto – passato, presente, futuro - si può riattivare, generando immaginario e senso. L’idea dell’antico è in crisi. Questo spirito del tempo, questo nostro mood e spleen, era stato anticipato e sperimentato in modo esplosivo dal barocco, la grande turbina testuale che inaugurava il collezionismo, le wunderkammer di oggetti fisici e di oggetti intellettuali, il recupero di minori e frammenti, la libera versatilità nel ridefinire auctoritates e generi, rimescolandoli di continuo, il plagio universale e il riuso senza scandalo di ogni simbolo e metafora (a nessi labili con i testi “classici” di partenza), e infine la parità dei ranghi degli antichi e dei moderni - tra i classici stessi – a voler tirare i conti delle celebri querelles. Il canone barocco, che irride quello modellizzante e statico del tardo Cinquecento, si risolve in una fantastica mistura tra l’antico e il moderno, tra il serio e il riso, tra l’autorevole e il meraviglioso, tra il religioso e il libertino, tra il vero e il falso. Un modello resistente, e sempre riaffiorante, che non sarà riformato granché dal razionalismo illuminista, quanto piuttosto dal severo restauratore dell’ordine, vale a dire l’ottocentesco storicismo, che in Italia approda, degnamente, da un lato alla narrazione integrale della cultura come storia della letteratura, e dall’altro alla selezione progressiva delle celebri corone: Dante, Petrarca, Boccaccio; Machiavelli, Ariosto, Tasso; Foscolo, Manzoni, Leopardi (e si supponeva: Carducci, Pascoli, D’Annunzio…). Ma quando anche l’Italia approda ai fasti dei media, dei flussi post-metropolitani, ecco che la turbina (neobarocca) riparte. Lasciamo per un momento aperto questo ragionamento: il canone dei classici prevale nella lunga durata della cultura manoscritta, e resta una delle tendenze dominanti nella civiltà della stampa; ma si indebolisce quando la modernità mercantile, industriale, cittadina e già spettacolare si afferma in tutta l’Europa. Andiamo avanti. Il nostro canone è rimasto anche nel XIX e XX secolo essenzialmente letterario, come ognuno sa per aver subito a scuola la tradizionale scissione tra l’«italiano», risolto in una letteratura italiana in storia e testi (entrambi canonici), e la «storia», che è (ancora!) piattamente evenemenziale e politica, italocentrica nel contesto eurocentrico. Del resto, fino più o meno agli anni della prima guerra mondiale, l’educazione e le pratiche delle classi dominanti si basavano saldamente sulla stampa; anzi in Italia ancora prevalentemente sul libro, almeno fino alla fine dell’Ottocento. E non era in discussione l’unità dell’universo di senso del libro: c’erano cose serie ed XIV effimere, “letteratura” e “letteratura amena”, c’erano letture morali e letture immorali, c’erano la poesia, il romanzo, il libretto operistico, e i trattati di scienza, costumi, filosofia e diritto; ma ogni testo, nella sua variabile miscela di conoscenza e immaginazione, rimandava all’albero unitario delle lettere, con le sue radici ancora fertilissime nella sapienza antica, mista di dialoghi, poemi e idilli, e testi di filosofia. Così era sempre stato nei secoli della stampa con il torchio a mano, e così continuava ad essere, sebbene problematicamente, nel primo Ottocento, quando i romantici Foscolo, Giordani, Leopardi, Tommaseo, Manzoni, cercando a ritroso l’unità di un sentimento nazionale italiano, rivitalizzavano nella nostra memoria culturale il ruolo della parola poetica antica e autorevole, da Dante e Petrarca ad Ariosto e Tasso. Quel privilegio letterario, che obnubilava i canoni più misti e largamente librari della storiografia illuministica, se anche si integrava con il tentativo di “fare gli italiani” imponendo una ideologia ufficiale del nuovo stato – Ministro della Pubblica Istruzione il De Sanctis, che alla mitologia dei poeti sommava l’eredità più laica e realista di Boccaccio e Machiavelli - , non rispondeva però al cambiamento di una società che doveva dedicarsi a costruire strade, ferrovie, scuole, navi, burocrazia, ospedali, e soprattutto industrie, negozi, palazzi e giornali. L’Italia prosaica e borghese fin de siècle, posta a ludibrio da Carducci e D’Annunzio, provvedeva di fatto a spezzare quella plurisecolare continuità, surriscaldando ma anche rimettendo in discussione l’egemonia di un’identità tradizionale sub specie letteraria. L’effetto, paradossale, che ne è derivato è di una sovraesposizione del canone dei letterati, contrapposto alla cultura positivista prima e scientifica poi. In seguito avviene l’allargamento, ma su base ideologica, al novero dei grandi pensatori, per l’ ”idealismo”, secondo quel dover essere, astratto, che ha tenuto banco irrimediabilmente e a lungo per il Novecento, con un work in progress che assumeva come base le scelte di Benedetto Croce e degli Scrittori d’Italia Laterza. Croce risistemava a sua volta la storia letteraria tracciata da De Sanctis, ma intanto andava per bancarelle e antiquari, arricchendo con le sue scoperte - fra l’altro - un Seicento italiano quasi estinto dall’oblìo illuminista e dal moralismo cattolico o puritano dei primi storiografi come Tiraboschi e Gioberti. Il canone di Croce era parzialmente contestato da tendenze alternative, come quella dei Classici del ridere selezionati e stampati da Angelo Fortunato Formìggini dal 1913 e per una ventina d’anni; ma anche da quella rappresentata da Giovanni Papini nelle collane della piccola casa editrice Carabba, o da Prezzolini con le edizioni della Voce. E anche la prima grande storia letteraria italiana, la Vallardi, organizzata per secoli, riuscì nonostante la politica culturale del regime ad allargare gli orizzonti: partita nel 1907, funzionò da ponte tra gli studi di eredità positivistica sui “generi” e il meglio di una nuova generazione, quella gobettiana – per esempio con Natalino Sapegno. Ma nel complesso anche l’influsso di Gobetti e poi di Gramsci non metteva in discussione l’alveo canonizzante di De Sanctis e Croce, – almeno per quella che essi stessi consideravano la linea maestra dello spirito italiano, da Dante attraverso i secoli giù fino ai grandi dell’Ottocento, Leopardi e Manzoni. E dopo la seconda guerra mondiale, attraverso gli epigoni professori e letterati - gobettiani e gramsciani, per non dire dei crociani e gentiliani - la critica e la storia letteraria si è attenuta in sostanza a quel canone, nell’insegnamento universitario e nei manuali per le scuole dell’Italia antifascista e repubblicana (dove resta vivo ancora oggi). Si arriverà fino agli anni Settanta perché qualcosa cambi. Verso il passato, dopo quegli anni Settanta (in Italia, ma altrove anche assai prima), guardiamo con occhi diversi. In modo ambivalente: i testi antichi ci possono apparire vicini, come il Principe, o per la corruzione della nostra politica come i trattati di Savonarola, che non a caso vengono riportati alla luce dei giornali quotidiani. Ma ci possono apparire anche assolutamente lontani, mere testimonianze di aspetti insoliti, sorprendenti, e perfino commoventi di culture ormai scomparse, come può acXV cadere – a citare alcuni dei libri di cui si fa menzione in questo volume – per la Legenda aurea di Jacopo da Varazze, o le arti della memoria della Phoenix di Pietro da Ravenna, e in certo senso le performances canore in calco petrarchesco di Giusto de’ Conti. La prima tendenza (leggere il nostro presente nel passato, e scoprire che – nel bene e nel male - i pensieri e le azioni dei nostri antenati ci somigliano molto) risulta piuttosto in calo. Sembra prevalere invece il secondo habitus mentale, la prospettiva tipicamente antropologica, secondo la quale le culture sono molto differenti tra loro, nello spazio ma anche nel tempo. Così leggiamo i classici sentendoli lontani da noi e oggettivati in un altrove, come testimonianze di entità culturali organiche, tenute insieme da miti e simboli, dalle loro istituzioni e da immaginari che sono loro propri. Fascinosamente ricostruibili dai testi della letteratura, come dalle altre testimonianze di memoria, dalle arti, dagli artefatti… Mentre sul versante opposto, quella sensazione di una contemporaneità dei classici antichi, che giustificava il canone, è stata scavalcata da una tendenza radicale verso il presente assoluto, che si è condensata in quegli anni Settanta - un momento di altissimo profilo della critica dei testi - sotto il segno, per fare qualche nome, di Eco, Calvino, Barthes, Orlando e Lacan, nell’interpretazione semiotica o psicanalitica. E anche di lì viene l’idea, non priva di rischi, della “centralità del testo”, se non dell’autonomo fluire del discorso in un eterno atemporale. In entrambi i casi: i classici avvertiti come vicini o lontani, come nostre estensioni quotidiane (mai più, comunque, come nostri padri) o come abitanti di paesi esotici, le operazioni di ristrutturazione del canone italiano nell’ultimo Novecento sono andate più o meno in una direzione: vale a dire, allargare impetuosamente la rosa. Il lavoro di Calvino redattore della Einaudi, l’influenza del grande esempio saggistico della Geografia e storia della letteratura italiana di Carlo Dionisotti, l’antologia scolastica Il materiale e l’immaginario, che entusiasmando gli insegnanti giovani offriva una visione più complessa e problematica dell’evoluzione delle culture scritte, e la Letteratura italiana diretta da Alberto Asor Rosa che assolveva in chiave più scientifica e specializzata alla stessa funzione coinvolgendo il meglio delle conoscenze innovative in ambito universitario ed ereditando anche la storiografia francese delle Annales e la nascente mediologia e sociologia dell’immaginario, sono forse gli episodi più visibili. Così il canone dei classici, si può dire, dagli anni Settanta è proliferato, ed è divenuto proteiforme. E lo stesso tipo di canonizzazione debole ha investito la letteratura “contemporanea”, quel Novecento italiano riguardo al quale gli architravi crociani della Letteratura della Nuova Italia non potevano reggere, sostituiti dalla visione “forte” della critica letteraria lukácsiana degli anni Sessanta (D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Moravia, il neorealismo, Pavese…), e poi semi-sommmersi dalla conoscenza capillare e quasi esaustiva di ogni movimento, con la diffusione soprattutto negli anni Ottanta-Novanta delle cattedre nelle università, e con la commistione tra critica accademica, pagine letterarie dei giornali, linee editoriali, e ruoli attoriali e comunicativi degli stessi autori. Lì, più o meno, si è rimasti, con sviluppi successivi di specialismi per secoli o per generi, mentre la critica e la storia letteraria hanno perso la spinta propulsiva e non sembrano in grado di costruire nuovi paradigmi. La canonizzazione “debole” infatti non ha veramente smantellato gli architravi già fissati, anche se ha accumulato conoscenze sugli ambienti letterari, umanistici, cortigiani, editoriali, e ha rintracciato infiniti prestiti intertestuali. Spesso senza capirne il senso. Riapriamo la questione lasciata in sospeso. La serie canonica dei “classici” maggiori e minori, fissata nel tardo Cinquecento ma già indebolita nel secolo successivo e barocco, e poi ristrutturata e stabilizzata dallo storicismo otto-novecentesco. E infine di nuovo travasata, in altra chiave, dal canone “debole”, in prevalenza di marca Einaudi, degli anni Settanta-Ottanta, sempre rimanendo sostanzialmente fedele alla centralità della letteratura e del testo letterario. XVI Qui è il punto. Il modello – la metafora – del canone dei classici letterari è una delle soluzioni per il nostro scrutare e tracciare il passato, non la sola. La lettura di qualsiasi Biblioteca selecta seicentesca o settecentesca, dal Possevino a Apostolo Zeno mostra che già il barocco aveva inventato una forma molto aperta, fondata - più che sull’autorevolezza e sulla letterarietà – sul criterio dell’utilità pratica, della valenza del medium della carta stampata in termini di egemonia, di potenza immaginativa o di consumo. E in modo non molto dissimile, la tendenza si è ripetuta con l’indebolirsi del fondamento storicistico del canone, negli anni Settanta. Dopodiché si è passati alla sua proliferazione/implosione, irrefrenabile a partire dagli anni Novanta. Credo che tutto questo sia da interpretare non come la rovina della nostra venerabile cultura occidentale (fondata sulla continuità della sintesi tra pensiero e forma letteraria), ma come il pieno emergere di una diversa struttura dello stesso occidente, sotto il segno fluido di un paesaggio mediale e multidimensionale. Nel mondo proteiforme delle reti, la funzione regolatrice, il travaso di riferimenti, esempi e norme dagli strati elevati della cultura a quelli intermedi e all’apprendimento scolastico perde infatti gran parte del suo senso. Si è smesso di scrutare e tracciare il passato, allora? La risposta è no: anzi, si intensificano le pratiche di un ceto intellettuale riflessivo, per declinare e costruire identità e storie, in senso opposto all’idrovora del presente assoluto, e contro la violenta virtualizzazione di ogni spazio di vita, gestita dall’industria della comunicazione. Ma se milioni di individui tentano di risalire la corrente del tempo passato, con la sensibilità di oggi nutrita di una rafforzata competenza sugli immaginari, allora più che di un canone, in senso tradizionale, sarà il caso di occuparci del mainstream. Ritrovare, riscoprire i flussi principali della cultura; ricostruire gli immaginari. Riproiettarli, facendoli nostri. I segnali di questo cambiamento di paradigmi nel (ri)pensare il passato affiorano da tempo; e anche il nostro volume, nato da una passione individuale e professionale, lo testimonia, portando altri tasselli al mosaico, e accennando anche nella sua struttura a una pratica culturale che con tutta probabilità caratterizzerà gli intellettuali del XXI secolo. La scelta dei testi, infatti, funziona qui come un wiki, a partire dai libri che individualmente o in piccoli ambiti e reti settoriali sono considerati come degni di considerazione, piccoli microcosmi che generano senso e si collegano ad altri. È una selezione bottom up, dal basso e in rete, che procede ricercando ed elaborando individualmente, ma con l’intenzionalità di chi comunica, di chi lancia il primo messaggio e si apre alle controproposte, non di chi si impone. Naturalmente, una pratica del genere modifica lo sguardo d’insieme su ogni secolo della nostra storia, proponendo un post-canone che si riforma in modo molecolare e comunitario, sulla base della libera capacità di contribuire (ancora “autorevolmente”) di ciascuno. Ma vediamo i vantaggi di un simile anti o post-canone in spirito wiki. Il principale è quello della scoperta: navigando nelle schede di questo volume ogni lettore, anche quello esperto, può incontrare una marea di libri che non ha mai visto. E il suo percorso si organizzerà più o meno consapevolmente su due livelli: da una parte c’è il paesaggio che si è già abituati a riconoscere, il profilo dei testi “grandi” o rilevanti, letterari e filosofici soprattutto (l’immaginazione e la conoscenza teorica); dall’altra parte ci sono quelle zone che nessuno può aver frequentato bene e tutte, dal diritto all’arte, dalla matematica alla musica, dalla tecnologia alla gastronomia, dalla medicina alle scienze occulte, e così via. Sappiamo benissimo che anche quelle zone dovrebbero entrare a pieno titolo nella nostra memoria, ma non c’è niente da fare, solo con qualche episodio e qualche autore di quel secondo livello avremo a che fare nella nostra vita. E anche se l’imprinting del canone storico-letterario tradizionale è ancora abbastanza influente, tuttavia proprio lì, sul lato relativamente oscuro, ci accadranno spesso gli incontri più eccitanti: tra gli incunaboli, per cominciare, a chi non verrebbe voglia di dare uno sguardo alla Phoenix di Pietro da Ravenna, XVII 1491, con le sue arti della memoria; o al De honesta voluptate del Platina, 1474, stampato agli albori dell’arte tipografica in Italia, un libro di cucina. O alla presentazione, ancora prima, […]Di questo mirabile et singular ostensorio chiammato horologio; e al trattato di agricoltura di Pier de’ Crescenzi, stampato nel 1471 in terra tedesca; e a quello di geografia di Francesco Berlinghieri, 1482. Fra i tanti altri libri importanti, anche se non mainstream, prendiamo ancora un esempio: L’Alitinonfo di m. Gasparo Scaruffi Regiano, per fare ragione, et concordanza d’oro, e d’argento: che servirà in universale; tanto per provedere a gli infiniti abusi del tosare, et guastare monete; quanto per regolare ogni sorte di pagamenti, et ridurre anco tutto il mondo ad una sola moneta. Stampato nel 1582 a Reggio Emilia, l’Alitinonfo (il “vero lume”) è stato scritto da un mercante e cambiavalute, tesoriere del Comune, attivo sotto Ercole II d’Este e poi sotto Alfonso II, in una fase storica di sconvolgimento dei prezzi e di eccessivo numero di monete in circolazione. “Ridurre il mondo ad una sola moneta”, e creare una “Zecca universale”: Scaruffi - pressocché illetterato, ma considerato da Schumpeter come uno dei maggiori studiosi dell’economia monetaria del XVI secolo, insieme a Bernardo Davanzati e a Jean Bodin - proponeva in anticipo sul nostro Euro una “lira imperiale” comune a tutti gli Stati europei, in base a un accordo pratico tra principi e mercanti, tra esportazioni e mercati, tra monete “grosse” e monete “piccole”. E anche per i secoli seguenti il lavoro di Govi ci propone moltissimi testi interessanti su ogni versante delle scienze, delle scienze umane e del costume, in buona parte dimenticati. Di quasi nessuno ci sono edizioni moderne; una anastatica esiste invece per il trattato di geologia di Antonio Lazzaro Moro, De’ crostacei e degli altri marini corpi che si trovano su’monti, 1740. Uomo di chiesa deciso a descrivere e teorizzare senza ritrosie dogmatiche sulle sue scoperte, il Moro segue le idee di un altro grande, il Vallisnieri: il diluvio universale non può funzionare come spiegazione dei fossili marini, che sono rinvenibili anche in cima alle montagne, per effetto dell’innalzamento di antichi fondali. C’era stata l’eruzione del vulcano di Santorini, con la formazione di una nuova isola, dal 1707, e casi storici precedenti erano ormai ben documentati; non mancarono tuttavia le polemiche in campo religioso, in un periodo di forte secolarizzazione e di affermazione della scienza moderna. Se lo stile si presenta ancora lutulento, tardo-barocco, è pur vero che anche per questi rivoli la cultura italiana si inseriva nel fiume europeo, a direzione, sul piano scientifico, soprattutto inglese e francese. I sistemi neurali del nostro universo culturale – a XXI secolo inoltrato – sono sensibilissimi alle immagini, ai link, ai viaggi nel tempo, e alle tecniche della comunicazione che ci permettono istantanee immersioni sensoriali. Comunicazione fluida, cultura fluida: adesso il nostro modo di generare senso è fatto così, volatile, curioso, immaginifico, pronto eventualmente a stabilire contestualizzazioni ed ipotesi anche senza che le auctoritates le abbiano codificate… Per questo, probabilmente, risulta sempre stimolante la possibilità di nuove entrate fra i “classici”. Se vogliamo utilizzare una formula, allora, possiamo individuarla con una certa chiarezza: il vecchio canone si scioglie nel mainstream. Dunque non sarà il caso – come ogni lettore colto pensa da anni – di rivederla a fondo, quella maledetta storia letteraria scolastica (ancora - per altro – toscanocentrica, e recentemente troppo filo petrarchesca, magari per reazione al realismo dantesco e novellistico della linea De Sanctis – Russo)? Ecco infatti che con questo volume ci si risveglia una gran curiosità per dei libri che sospettiamo di dover andare a vedere, per diverse ragioni. E alla riscoperta si accompagna il fascino delle storie che essi finiscono per generare, le storie dei loro autori, dei loro ambienti, spesso delle loro vicende editoriali: l’immaginario del passato, di cui il libro ci trasmette le ombre, ma che siamo disponibilissimi a ricostruire, con tutte le forze e le abilità ereditate da molti secoli di romanzo, teatro, melodramma e giornalismo, e da più di un secolo di spettacolo audio visuale XVIII artificiale. Ecco la giovane e coltissima Cassandra Fedele, veneziana, figlia di un umanista e di una Barbara Leoni (ah!, D’Annunzio…), che riceve, per esempio, a Padova le insegne dottorali al posto di un parente, e ottiene di pronunciare in vece sua davanti al Senato Accademico, come d’uso, un’Oratio, che stampata poco dopo a Venezia (1488), propaga la fama dell’evento straordinario in tutta Europa. Le scrivono o vanno a trovarla umanisti, professori, regnanti. Diventa il vanto della Serenissima. Finirà, però, in ristrettezze, costretta a sposare un medico, a seguirlo – superata la cinquantina – e ad affrontare un naufragio. Vedova e sempre più povera, entrerà nel 1547 da anziana superiora al Convento di San Domenico a Castello, dove resterà senza mai smettere di studiare e scrivere. Storie di libri che si intrecciano. Nel gennaio del 1492, Cassandra riceve una lettera di Alessandra Scala, poetessa e a sua volta figlia di un umanista, Bartolomeo, che con Poliziano e Ficino era uno degli ammiratori fiorentini. Alessandra è incerta se dedicarsi completamente agli studi o sposarsi. Cassandra le risponde di seguire la sua natura, facendo ciò che più le è gradito, senza costringersi a una scelta che col tempo diventerebbe una prigione. A corteggiarla è proprio il Poliziano, ma Alessandra sposa, nel 1497, Michele Marullo, che la celebra negli Epigrammi e Inni, pubblicati definitivamente nello stesso anno, sotto il nome di Neera (ah! Neera, la Anna Radius Zuccari bestseller dell’Italia appena dopo l’Unità!). Marullo, nato a Costantinopoli e cresciuto a Napoli, amico del Pontano e del Sannazaro alla corte di Alfonso d’Aragona e di Lascaris alla corte di Lorenzo il Magnifico, godrà Alessandra solo per tre anni, finendo annegato nel Cecina. E anche per lei si apriranno le porte del convento. Il rimpianto e il mito della città di origine perduta, la condizione dell’esule (ah! Foscolo!), la morte del fratellino Giovanni (ah! Carducci!), la durezza della vita militare, il ricordo degli eroi morti per la patria e le poesie d’amore per Neera, in versi latini splendidi, convinsero Croce al recupero, ma nel mainstream il Marullo non è mai veramente entrato. Che splendidi romanzi impliciti evocano i libri del nostro wiki! Sono le avventure degli uomini e degli ambienti in cui sono stati scritti, e anche degli ambienti e degli uomini che li hanno accolti, curati, stampati, piratati, camuffati, riscoperti, rilanciati, e così via. Vale per i grandi testi – come ho provato a raccontare nel mio Classici dietro le quinte (Roma-Bari, 2009), ma vale, per la nostra immaginazione che oggi dispone di un patrimonio immane e del web come strumento versatile per rintracciare oggetti e relazioni, ancora di più per opere e autori che anche un lettore medio-colto difficilmente può aver frequentato. Del grande Bessarione, per esempio, ecco nella nostra lista l’Adversus Platonis calumniatorem, una stampa eseguita nel 1469 dai primi tipografi calati in Italia: Sweynheym e Pannartz. Due anni prima, dal monastero benedettino di Subiaco a cui i due garzoni della bottega di Gutenberg erano approdati nel 1464, l’officina si era spostata a Roma, nel palazzo dei nobili Pietro e Francesco de’ Massimi vicino a Campo dei Fiori. Loro auspice e protettore era un alto prelato, Giovanni Andrea Bussi, il più entusiasta per la nuova invenzione fra gli umanisti di Curia e i più stretti collaboratori del vecchio cardinale. Il libro, tradotto dal greco in latino - probabilmente in modo cooperativo - dalla ”accademia” che si riuniva intorno al Bessarione per discutere di filosofia, teologia e filologia, segna il recupero finale del pensiero di Platone, in modo svincolato dalla scolastica medievale. Intanto, negli stessi mesi, trenta casse arrivavano a Venezia, e venivano chiuse in una stanza al Palazzo Ducale. Contenevano centinaia di manoscritti greci e latini, solo una parte di quelli accumulati in tanti anni di viaggi e missioni del cardinale, provenienti dall’Oriente ormai in larga parte perduto in mano ai Turchi (Costantinopoli, Nicea, la Morea, Mistra, Negroponte), dai monasteri basiliani e di altri riti bizantini dell’Italia meridionale e adriatica, e dalle decine di diocesi e città XIX da lui amministrate o visitate per incarichi ecclesiastici e politici quasi dovunque in Italia e in Europa. I suoi libri andavano a Venezia perché da almeno trent’anni il cardinale esule d’Oriente era convinto che solo la Serenissima potesse essere il fulcro della resistenza contro l’invasione, arrivata a lambire fin l’Ungheria, ma anche della riunificazione delle due culture cristiane, separate da un millennio, nel segno della tolleranza, del recupero della comune radice filosofica antica, e della caritas. La biblioteca del Bessarione - il resto dei manoscritti e dei libri a stampa arriverà a Palazzo Ducale in esecuzione del suo testamento dopo il 1472 – verrà custodita come un tesoro, e sembra che lo stesso Erasmo, arrivato apposta per visitarla nel 1508, ospite di Aldo Manuzio, non sia riuscito a penetrarvi. Finché, nel periodo di maggior splendore della industria tipografica, libraria e culturale veneziana, a metà Cinquecento, i manoscritti saranno trasferiti nella sede appositamente disegnata dal Sansovino: il nucleo iniziale della Biblioteca Marciana. E se non avete mai letto nulla sulla incredibile vita del Bessarione, provvedete: c’è materia per innumerevoli storie e avventure, di ogni genere. Qualche considerazione e valutazione generale sulle scelte di questo volume, frutto della ricerca appassionata di un uomo che passa la vita tra i libri, e ne è conquistato al punto di cedere al fascino, all’aura che ognuno di essi emana. Su circa 400 titoli, quasi 200 sono probabilmente noti, se non al grande pubblico, al lettore colto – però veramente colto. Solo la metà, un centinaio, sono i “classici italiani” nel senso tradizionale del canone. Altri cento e più vanno considerati nel mainstream. E fra i più di ulteriori 200 che probabilmente nemmeno i coltissimi hanno letto, ne ho contati circa 60 – una valutazione naturalmente molto soggettiva – che veramente sarebbe il caso di ripubblicare, divulgare e studiare, per il loro straordinario interesse. L’ampliamento è dunque imponente; anche se aggiungerei ai criteri utilizzati da Govi almeno un’altra zona di interesse, quella dei bestseller effettivi, secolo per secolo alcuni ci sono, altri no - che sono in grado di dire molto sul pubblico, la società, il consumo, i circuiti commerciali, le trasformazioni della cultura e dell’editoria. Chiediamoci: la ricerca dei libri che costituiscono i geni, le basi effettive di una nostra cultura nazionale dovrebbe essere una pratica continua delle scienze umane, ma allora perché dell’ampia area di testi fondamentali qui rappresentata si sa così poco, a volte quasi nulla? La tradizione della cultura, si sa, è soprattutto oblìo, arte di eliminare, semplificare e dimenticare, e finora queste operazioni erano facilitate dalla scomparsa materiale dei libri – in percentuali altissime per i manoscritti, ma sorprendentemente alte anche per i libri a stampa, inclusi quelli più recenti. Nel nostro XXI secolo digitale, ci si assicura – volendo – la possibilità di conservare, recuperare e accedere in tempo reale a giganteschi patrimoni testuali; e sembra allora che sia concessa una più flessibile capacità di valutare e decidere. Sfruttiamo dunque il portato del secolo precedente, che ci ha lasciato, oltre alle prove di parossismi ideologici non inferiori a quelli delle antiche e moderne lotte religiose, anche una agguerrita filologia, storia delle mentalità, antropologia, sociologia, mediologia e scienza del libro, che permette di situare e contestualizzare con ricchezza di senso ogni singolo testo del passato. Tra il molto che è possibile oggi e la base ristretta dei vecchi canoni, quello che ancora manca ma possiamo intravedere è una cultura diffusa della cura e della divulgazione, una cultura che sappia uscire dagli specialismi, recuperando la tensione umanistica e civile che ha nutrito tanti fra i nostri antenati, gli autori di molti fra questi libri. Incontreremo diversi esempi, giù per i secoli, riguardo alle potenzialità dell’allargamento del canone in mainstream. Il Cinquecento è forse il tratto in cui la nostra idea della corrente è più o meno passata e accettata: ce la raffiguriamo tradizionalmente – e giustamente – assai ampia, tra numerosi bracci e affluenti: il Cortegiano del XX Castiglione e la Civil conversazione del Guazzo ma anche il Principe di Machiavelli e la Storia d’Italia di Guicciardini; il Folengo ma anche l’Ariosto; Sannazaro, Tasso, e le antologie poetiche assemblate dal Giolito, principe dei tipografi veneziani; Marsilio da Padova o Bernardino Telesio; il Vasari e il Borghini, e il Palladio e il Vignola; le navigazioni del Ramusio o gli emblemi dell’Alciati. Ma ecco una proposta interessante, fuori dai nostri soliti itinerari: le Decades de orbe novo di Pietro Martire, nell’edizione completa di Alcalà, 1530. Un libro affascinante, che finalmente è possibile leggere anche in traduzione italiana (Genova 2005), ma solo per pochi eletti, e chissà quando ci sarà una vera riscoperta editoriale. Un altro dei nostri grandi italiani-europei, nel periodo in cui il primato umanistico, mercantile e civile della penisola si travasava nella civiltà ormai continentale delle corti e delle città. Nato da una famiglia di Arona sul lago Maggiore, attivo da giovane presso Gian Galeazzo Sforza a Milano e nell’Accademia romana di Pomponio Leto, Pietro parte nel 1487 per la corte di Spagna, dove vive l’assedio di Baeza, la presa di Grenada, l’innamoramento per la fatata città dei Mori. Conosce Cristoforo Colombo, è assunto come gentiluomo di camera della regina Isabella, tiene lezioni a Salamanca con più di quattromila uditori, assiste al trionfale ritorno dello scopritore del Nuovo Mondo, diventa il grande cronista delle scoperte e delle conquiste, in rapporto diretto con Caboto, de Gama, Vespucci, Cortés, Magellano. Viaggia in missione per conto della regina presso il sultano d’Egitto nel 1501, e assiste, da consigliere e storiografo ufficiale alle vicende del re Ferdinando e del giovane Carlo V. Un altro testo sembra invece ormai semi-assimilato nel canone ufficiale, dopo le riedizioni degli anni Sessanta, anche se non è mai veramente entrato nell’immaginario colto: la Calandra di Bernardo Dovizi, una commedia con tutti i crismi del calco classico ma anche della comicità vera, opera di una mente eminentemente politica, come spesso avveniva nel primo Cinquecento. Il giovanissimo Dovizi da Bibbiena, assunto da Lorenzo de’ Medici, dopo aver dato buone prove di capacità diplomatiche, si trova ad orientare le mosse dell’incerto Piero, successore del Magnifico, nel tentativo di coalizzare il papa e gli Aragonesi di Napoli per evitare l’imminente calata dei francesi di Carlo VIII. Ma Firenze si rivolta, e così i Dovizi, insieme con Piero de’ Medici, sono banditi. Cercano aiuto dai veneziani e progettano una spedizione militare, che provoca invece il saccheggio di Bibbiena, da dove il colpo doveva partire. Bernardo viaggia per l’Europa insieme al giovane cardinale Giovanni de’ Medici e ne diventa il segretario, a Roma nel 1504. Insieme al Bembo, che era in missione diplomatica per la sua Venezia, passa diverso tempo alla celebre corte di Urbino, con Baldassar Castiglione, mentre si prepara la cosiddetta lega “santissima” fra il papa Giulio II, gli spagnoli e i veneziani per eliminare la repubblica a Firenze. Seguendo il suo cardinale a Bologna per i preparativi militari, il Bibbiena prova in seguito a dirigere la politica della lega secondo gli interessi medicei, ma i francesi resistono e anzi sconfiggono la coalizione a Ravenna e prendono prigioniero Giovanni. Alla fine, nel 1512, Giuliano de’ Medici rientra a Firenze e abbatte la repubblica. Poco dopo muore Giulio II, e Bernardo organizza i maneggi per l’elezione del suo signore. Divenuto papa, Leone X lo nomina tesoriere, conte, abate, e infine, quasi subito, cardinale e segretario particolare, con i simboli medicei nello stemma e i proventi del santuario di Loreto. Personalità dominante della Curia e capo della diplomazia vaticana, il Bibbiena cura fra il 1513 e il 1520 l´allestimento di feste, cacce e balli, soprattutto in spettacoli carnevaleschi e rappresentazioni teatrali, all´insegna di un piacere epicureo. E vive nel palazzo apostolico, dove si fa decorare da Raffaello, che delega l’opera a Giulio Romano e Perin del Vaga, un appartamento, suggerendo i temi e le scene. Presto deve però rimettersi a organizzare una coalizione contro la seconda imminente calata dei francesi, alleati dei veneziani; anche questa volta fallisce, i francesi arrivano e Francesco I vince a Marignano; il papa deve barcamenarsi, mentre Dovizi si concentra sulle vicende di XXI Urbino, contesa tra lo stato pontificio e i Della Rovere; prova ad accordarsi con lo stesso Francesco I per una coalizione anti-turca, e manovra per far nominare lo stesso Francesco I imperatore, nel 1519. Si trova in Francia quando viene invece eletto Carlo d’Asburgo, e torna sconfitto e malato a Roma, dove passa gli ultimi mesi frequentando l’amico Castiglione. Quanto alle sue opere letterarie, va detto che mentre è notissimo il suo ruolo come personaggio del Cortegiano, i testi del Bibbiena non lo sono altrettanto. Il Sommario di alcuni ricordi generali, un regesto interessantissimo di precetti per il buon diplomatico e cortigiano, steso in parallelo a quello dell’amico, è circolato solo manoscritto, come le centinaia di lettere (fino alla pubblicazione dell’Epistolario, Firenze 1955), che confermano la verve comica della Calandra, rappresentata per la prima volta ad Urbino nel 1513, con la regia – diremmo oggi – di Castiglione, e le scenografie del grande Gerolamo Genga, allievo di Raffaello. Più volte messa in scena in molte città e corti e pubblicata a stampa la prima volta nel 1521, la commedia racconta la vicenda plautina di due gemelli, separati dalla sorte e travestiti ognuno nel sesso opposto, con le ovvie conseguenze di intrigo erotico-paradossale, mentre il vecchio sciocco Calandro viene costantemente raggirato dal servo Fessenio, a suon di motti di derivazione decameroniana (anche nel Cortegiano, del resto, il Boccaccio funziona come controcanto al petrarchismo, ed è incarnato pour cause dallo stesso Bibbiena). Ma per questo come per altri titoli della nostra lista è del tutto matura l’inclusione a pieno titolo nel mainstream. E in effetti, sono state numerose le riprese e le messe in scena della commedia negli ultimi anni. In casa di quel medesimo cardinale Bibbiena, a Roma, venne accolto nel 1518 come giovanissimo “scholarus et clericus” Pietro Carnesecchi, gentiluomo fiorentino di parte medicea votato alla carriera di Curia, che distinguendosi a sua volta negli incarichi diplomatici doveva arrivare – seguendo la buona scuola del maestro – alla carica di Segretario del papa con Clemente VII, nel 1534. Siamo negli anni successivi al Sacco di Roma, quando la Riforma manifesta tutta la sua portata, mentre anche in Italia, dove è ancora forte la corrente erasmista, si diffondono il disagio religioso e la riprovazione della deriva secolare e mondana della Chiesa. L’imperatore Carlo V, che spesso è a Napoli, protegge Juan de Valdés, il suo consigliere, l’erede di Erasmo; e Carlo spera che dal Concilio di Trento derivi un riorientamento anche dottrinale della Chiesa per riassorbire la Riforma o almeno per attenuare i conflitti. Il Carnesecchi, intanto, nell’estate del 1535 fa visita a una gentildonna di straordinaria bellezza, Giulia Gonzaga, nel suo castello di Fondi. Giulia, sposa a tredici anni e vedova a quindici, immortalata da Bernardo Tasso, Ludovico Ariosto e miriadi di altri celebri poeti, è scampata l’anno prima fuggendo di notte, miracolosamente, al corsaro Barbarossa reggente di Algeri, che ha organizzato una scorreria per rapirla e darla al sultano Solimano I; a Fondi, in quella stessa estate 1535, arriva il Valdés, mentre si avvelena o viene avvelenato il nipote del papa, Ippolito de’ Medici, innamorato di Giulia ma obbligato a diventar cardinale. Poco dopo a Clemente VII succede papa Paolo III, e Carnesecchi nel 1536 abbandona i suoi incarichi trasferendosi a Firenze. I suoi riferimenti sono ora i cardinali dell’ala riformista: Sadoleto, Morone e Reginald Pole, e poi Bernardino Ochino, Marcantonio Flaminio, Vittoria Colonna e Giulia Gonzaga, entrambe seguaci del Valdés. Giulia, che si è trasferita a Napoli e si è dedicata a diffondere manoscritte le opere valdesiane, segna l’esistenza di Pietro; si scambieranno lettere per tutta la vita. Nel 1540 a Napoli, il Carnesecchi incontra tutti costoro e si converte alla dottrina di Valdés della giustificazione per fede. Tra i primi, può leggere in manoscritto un altro dei testi che andrebbe considerato come fondamentale nella corrente della cultura italiana: il Beneficio di Cristo. Poi l’ex-Segretario pontificio peregrina tra Firenze, la corte viterbese del Pole, Venezia (dove ospita numerosi transfughi filo-Riforma o sospetti di eresia), la Francia, di nuovo Padova e Venezia, Roma e Napoli, ancora Venezia e Firenze. XXII Ritroviamo le sue tracce all’epoca del terzo dei processi a cui fu sottoposto dall’Inquisizione. Le sorti della Chiesa erano rimaste ancora in bilico fino al 1551, quando il Pole fu vicino ad essere eletto papa, ma in seguito pencolavano verso l’ala più intransigente, sotto Paolo IV Carafa, eletto nel 1555, per volontà del quale Carnesecchi fu condannato a morte in contumacia nel 1559 per eresia, venendo poi graziato da Pio IV Medici. La svolta decisiva per il mondo cattolico è l’elezione nel 1566 di Pio V, alias il cardinale inquisitore Ghislieri (in alternativa al capo dei riformisti, Giovanni Morone, vicinissimo alla dottrina valdesiana, e già incarcerato e processato da Paolo IV). Le carte sequestrate in casa di Giulia Gonzaga, morta lo stesso anno, svelano la trama di tutti i rapporti del circolo riformista, e Pietro, sebbene protetto da Cosimo I de’ Medici, non sfugge alla tortura, alla confessione estorta di eresia, e alla condanna a morte per decapitazione e rogo, eseguita a Ponte S. Angelo. Il verbale della sua confessione intreccia di nuovo il suo destino con il Beneficio, del quale era stato probabilmente il curatore delle prime edizioni a stampa veneziane nel 1543: “Il primo autore di questo libro fu un monaco negro chiamato don Benedetto da Mantova, il quale disse di averlo composto mentre stette nel monastero della sua religione in Sicilia presso il monte Etna; il qual don Benedetto, essendo amico di messer Marcantonio Flaminio, li comunicò il detto libro pregandolo che lo volesse pulire e illustrare col suo bello stile acciò fusse tanto più leggibile e dilettevole…”. Così gli Inquisitori gli estorcono il nome dell’autore, rigorosamente tenuto segreto, del testo messo all’Indice nel 1548, uno dei bestseller assoluti del Cinquecento: secondo la testimonianza del Vergerio ne uscirono 40.000 copie in dieci anni solo a Venezia. Di quei libretti ne sono sopravvissuti pochissimi, per l’accanita opera di distruzione organizzata dal S. Uffizio, mentre la fortuna in tutta Europa era enorme, nelle traduzioni francese, inglese, spagnola, tedesca e croata. Sul valore anche stilistico del Beneficio, Carnesecchi aveva ragione, perché la lettura – forse in parte per merito del Flaminio, fine letterato amico del Castiglione, del Valdés, del cardinal Pole e di Vittoria Colonna – è ancora oggi affascinante e carica di pathos. La tesi valdesiana secondo la quale il cristiano che ha fede nella salvazione dell’uomo da parte di Cristo è salvo a sua volta, opposta alla dottrina cattolica della salvazione attraverso le opere e i sacramenti, ma anche alla posizione calvinista sulla predestinazione, si fonda sulla spiritualità fraterna e caritatevole degli erasmisti e su una rilettura antidottrinale delle lettere di San Paolo e dei Vangeli: in Cristo è la salvezza, e non nella legge, che danna l’uomo perché lo porta a confidare arrogantemente in se stesso e non in Dio. Una cultura in buona parte perduta, che rimanda a una storia d’Italia e d’Europa che poteva essere e non fu, nel passaggio da Carlo V a Filippo II; e una vicenda – quella evocata dal Beneficio – fatta di sconfitta, fede orgogliosa e clandestinità, che dopo gli splendidi saggi che le hanno dedicato Cantimori, Ginzburg, Prosperi potrebbe entrare più direttamente nell’immaginario collettivo. A partire dall’enigma ancora non del tutto risolto dell’autore del libro: fra Benedetto. Si sa della sua formazione in un convento benedettino sul Po, in un ambiente vicinissimo al protestantesimo, del quale faceva parte il Folengo; lo si rintraccia a San Giorgio Maggiore a Venezia, poi a Nicolosi, ai piedi dell’Etna, tra il 1537 e il 1542; lì scrive il Trattato utilissimo del beneficio di Christo verso i Christiani, e lì, secondo una testimonianza resa a un altro processo dell’Inquisizione “Benedetto Fontanino in seguito Benedetto di Mantoa” tradusse dal dialetto in italiano i libri di Giorgio Siculo, che era nello stesso monastero, e fu impiccato a Ferrara come eretico nel 1551. Poi sembra che fra Benedetto si sia spostato a Pomposa, dove era abate Luciano degli Ottoni, uno dei delegati ufficiali dei benedettini al Concilio, che nel 1546 vi sostenne le tesi della giustificazione per fede, e fu costretto dalla assemblea ad abiurarle. A quel tempo fra Benedetto è di nuovo nel convento di San Benedetto Po, insieme a Giorgio Siculo, che di lì indirizza una lettera all’Ottoni, in cui condanna duramente l’idea luterana e calvinista della predestinazione; ma nel 1547 XXIII il Concilio condanna definitivamente la dottrina valdesiana. Giorgio Rioli – il Siculo – la predica ancora tra Riva del Garda e Ferrara, teorizzando la liceità della dissimulazione a fin di bene, il nicodemismo; e alla fine nel 1550 il Siculo, fra Benedetto e l’Ottoni, insieme ad altri, vengono arrestati. Nel marzo del 1551, di fronte a una grande folla radunata alla presenza di Ercole d’Este, l’Inquisitore e futuro papa Michele Ghislieri legge la sentenza di morte per il Rioli, reo confesso, che poi ritira l’abiura e viene strangolato in carcere; l’Ottoni è rimosso da priore, mentre fra’ Benedetto, del quale tutti ignorano ancora il ruolo di autore del bestseller antiortodosso, sconterà due anni di carcere e morirà in convento, nel 1556. Spostiamoci in età barocca, dove è matura per un definitivo inserimento nel mainstream la veneziana Modesta Dal Pozzo, alias Moderata Fonte, con il suo dialogo (postumo) Il merito delle donne, Venezia 1600: due giornate di discussioni sulla ragione per cui le donne, dolci, pazienti, benigne, in tutto superiori, in grado di esprimersi autonomamente in ogni arte e ufficio e capaci di donarsi, siano schiave volontarie degli uomini fino alla morte. Un libro recuperato negli ultimi trent’anni del Novecento, come la commedia del Bibbiena; ma il motivo, naturalmente, è un altro, e deriva dalla nuova cultura femminista. Poco dopo, le Lettere di una straordinaria e splendida attrice, cantante e letterata, a cui si inchinavano signori e poeti, scomparsa nel 1604: Isabella Andreini, la regina della Commedia dell’Arte in versione elevata – la sua compagnia dei Gelosi recitava, più che altro, per le Corti (e anche di questa, il recupero, la rimessa in scena e il riuso nell’immaginario collettivo è fatto recente, con le operazioni teatrali di Ronconi e con il film di Salvatore Maira: Amor nello specchio). E per il Seicento, a parte i classici e la linea sempre interessante dei viaggi e della cartografia e geografia, sono ancora femminili e/o teatrali le altre indicazioni più interessanti di questo volume, a segnalare una precisa tendenza del barocco: La semplicità ingannata di suor Arcangela Tarabotti, gli scritti filosofici di Elena Cornaro, il Teatro delle favole rappresentative di Flaminio Scala, la Pratica di fabricar scene del Sabbatini, il trattato teorico del Barbieri. Sono testi, soprattutto i capostipiti della Tarabotti e dello Scala, ormai entrati nell’uso costante dell’insegnamento universitario (un altro segnale di cambiamento, sempre post-’68). Seppure marginalmente, l’Autobiografia di Girolamo Cardano nel mainstream era in un certo senso entrata, come testimonianza di uno spirito libero introdotta quasi di soppiatto nel corso del nostro primo Novecento, fino alla edizione Einaudi nel 1945, in un momento-chiave di ridisegno della strategia editoriale della casa torinese erede dell’antifascismo laico ma anche valdese e modernista; in seguito – invece - la sua fortuna è stata scarsa. L’opera pubblicata in pieno Seicento, quasi settanta anni dopo la morte dell’autore, uomo fino in fondo cinquecentesco, può in qualche modo essere considerata nel campo dell’immaginario barocco: a stampare a Parigi l’inedito De propria vita liber fu nel 1643 il Naudé. Per i libertini, il Cardano era del resto una vera e propria icona, il suo profilo di scienziato ésprit fort anticipava molto dello spirito laico ed epicureo primo-seicentesco: un medico enciclopedista antidogmatico, e inoltre inventore di tecnologie, matematico, fisico, meccanico, astronomo e astrologo, filosofo naturalista e animista non lontano da Giordano Bruno, teorico della politica in chiave machiavellica e naturalistica, poligrafo, accanito utilizzatore della stampa (oltre cento titoli pubblicati), in fama di omosessualità, e condannato dall’Inquisizione per la sua irriverenza più che per evidente eresia, per aver scritto un oroscopo di Gesù Cristo e un encomio di Nerone. E di certo dovremmo inserire a pieno titolo nel mainstream del barocco un bestseller affascinante, i Viaggi di Pietro Della Valle, patrizio romano. Grande romanzo, il suo itinerario in Oriente dal 1614 al 1626. In preda da giovane ad affanni amorosi e trascinato per anni dalla sorte in mare a combattere pirati e corsari, ma anche fine letterato e umanista, mentre durante e dopo il viaggio si farà scienziato, grammatiXXIV co, linguista, orientalista e traduttore, musicologo, collezionista, politico e diplomatico, archeologo ecc. ecc., Pietro salpa da Venezia imbarcandosi in abito da pellegrino. L’evento della partenza e l’apparato che manterrà per tutto il viaggio sono già di per sé scenografie teatrali sfarzose, un meraviglioso che si coniugherà con il meraviglioso dei luoghi, dei paesaggi, degli usi esotici, e delle corti. Dopo le isole dell’Egeo, i luoghi in cui si credeva fosse Troia, e visitata Istanbul, Della Valle risale il Nilo fino al Cairo e alle piramidi, sale sul Sinai, e arriva in Palestina e infine a Gerusalemme. Poi Damasco, Aleppo, Bagdad, Isfahan, Ashraf sul Caspio dove è ricevuto dallo scià Abbas, poi ancora Shiraz, Persepoli, e Ormuz contesa tra inglesi e portoghesi. Muore la sua sposa di Bagdad, una cristiana nestoriana che lo ha accompagnato per cinque anni, e con lei imbalsamata si imbarca su una nave inglese per l’India: Calcutta, Goa, poi di ritorno la penisola arabica, ancora in territorio turco, ad Antiochia ed Aleppo, e infine in patria. A Roma celebra fastosamente il funerale della prima moglie conservata per cinque anni, e sposa l’ancella di lei, nonostante il grande scandalo. Torna a partecipare alla accademia degli Umoristi, anzi la sposta nel suo palazzo, frequenta quella del Capranica, dove conosce Tommaso Campanella, ed è accolto tra i Lincei. Esiliato per un paio d’anni dai Barberini per aver ferito un loro domestico, vive nello splendore dell’immaginazione e della cerimonia barocca fino alla fine dei suoi giorni, nel 1652. Quando Pietro prepara le varie parti del suo racconto di viaggio per la stampa, siamo all’epoca dell’enorme successo commerciale del primo genere moderno di consumo, il romanzo barocco europeo - quello che inizia con l’Eromena del Biondi (1624, giustamente nella nostra lista), o forse più correttamente con il Persiles y Sigismunda di Miguel de Cervantes (1615), e che assume nel medio Seicento una discreta versatilità di forme, compresa quella epistolare, pur mantenendo in generale la peregrinazione, la macchinazione e la spettacolarizzazione come assi portanti. Dei Viaggi, in forma di lettere a un colto corrispondente, il medico Mario Schipano, si stampò la prima parte sulla Turchia nel 1650 a Roma con il Mascardi; poi Pietro morì, e gli eredi riuscirono sulla base dei manoscritti a fare uscire sempre dal Mascardi i due volumi sulla Persia nel 1658, e poi quello su India e ritorno, non revisionato da Pietro, nel 1663 (di una quarta parte annunciata nel primo volume non c’è più traccia). Bestseller, anche nella traduzione francese, inglese, olandese e tedesca, ma poi caduto nel silenzio, come avveniva per la quasi totalità dell’immaginazione letteraria più diffusa del barocco italiano, ne è stato ripubblicato soltanto un piccolo assaggio da Sansoni nel 1942, poi la prima parte della Persia nel 1972 (Poligrafico dello Stato), e della Turchia nel 2001 (Città Nuova). Insomma, il testo è stato naturalmente riscoperto in epoca recente da parte degli orientalisti, ma non è possibile nemmeno leggerlo integralmente, mentre non c’è stato nessun lancio nel circuito dell’editoria maggiore, che lo legittimi come uno dei nostri classici ritrovati. Eppure merita assai, immerso in un mondo che fino dall’inizio brulica di persone e di cose, in quella visione panoramica dall’alto e contemporaneamente sincrona con la voce del soggetto narrante e celiante che altrove – non da noi – sarà rigenerata e resa definitivamente moderno dalle penne di Defoe e di Swift: … la domenica agli otto di giugno del presente anno 1614, nello spuntar dell’aurora, partìi dal porto di Malamocco, imbarcato nel galeone detto il Gran Delfino, vascello grande da guerra, armato con quarantacinque pezzi d’artiglieria e fornito d’ogni altra cosa necessaria a proporzione, dove aveva conversazione di circa a cinquecento altri, fra uomini e donne, soldati, marinari, mercanti e passaggieri; e tra questi v’erano cristiani cattolici, eretici di varie sette, greci, armeni, turchi, persiani, ebrei, italiani di quasi tutte le città, francesi, spagnoli, portoghesi, inglesi, tedeschi, fiamminghi, e per concluderla in poche parole, di quasi tutte le religioni e nazioni del mondo. La mescolanza di questa compagnia sarebbe stata in vero gustosa se con il soverchio numero non avesse partorito quella confusione e quelle angustie che V.S. può pensare ruducendo tanta gente in così poco luogo, le quali, in progresso di tempo, cagionarono nella nave una XXV specie d’infezione, che generò molte malattie che più volte mi fecero dubitar di me stesso… … Per andar da Pera a Costantinopoli si potrebbe andar ancor per terra, ma bisognerebbe camminare intorno a dodici miglia, che tanto a punto gira il porto co’l suo canale lungo e stretto, che finisce poi in una lingua d’acqua, dove entra un fiumicello di acqua dolce. Onde, per non far tanto giro, tutti quei che passano da una banda all’altra vanno sempre per mare; et a questo effetto vi è una quantità innumerabile di certe barchette sottilissime che chiamano perame, le quali, a due e a quattro remi, governate da uno o da due uomini, - che sedendo bassi nel pavimento della barca vogano all’indietro con le braccia incrocicchiate, maneggiando ciascuno due remi assai lunghi, e anche bene spesso a vela, quando il mare e il vento lo comportano -, traghettano continuamente infinità di gente, uomini e donne da una riva all’altra. …Alla turchesca ancora, col turbante, vesto qualche volta in casa per gusto, massimamente quando qualche dama turca mi viene a visitare, ma a dire il vero la barba all’italiana non confà con quell’abito. Le turche mi pregano che la lasci crescere all’usanza loro, e dicono che io sarei più bello assai – che così è veramente, secondo il gusto loro – ma insomma io non mi ci posso accomodare, che mi pare una sporcheria, e dico loro, burlando, che da questo e dal tagliar la pellecchia [il prepuzio] in poi (come direbbe Coviello), del resto le servirò in ciò che vorranno. Passiamo al Settecento, il secolo della nostra subalternità all’egemonia culturale francese, alla quale le storie letterarie contrappongono - secondo la vulgata canonica – una non insignificante fioritura del moderato illuminismo italiano. Visione tradizionale, contraddetta parzialmente da alcuni episodi da recuperare in pieno, seguendo le proposte di questo volume, come per il romanzo avventuroso di Pietro Chiari, per il fascino malefico di Giuseppe Balsamo, alias Alessandro Cagliostro, e per la memorialistica oggi misconosciuta di un grande rivoluzionario, il conte Giuseppe Gorani. L’abatino mondano Pietro Chiari, galante e frivolo erotomane nella sua gioventù modenese, e poi in viaggio per l’Italia come segretario di un cardinale, approda nel 1747 a Venezia, ancora cosmopolita, e ancora capitale della stampa e del teatro. Inizia a scrivere lettere satiriche, e soprattutto commedie, molte delle quali rifanno il verso a Goldoni, alcune addirittura parodiandolo, tanto che lo scontro fra i due dura per anni, dividendo l’Italia nei due partiti dei chiaristi e dei goldonisti; decine di operazioni teatrali del Chiari sono invece riduzioni dei romanzi alla moda di Prévost, Marivaux, Richardson, Fielding ecc., o rappresentazioni di argomento storico antico. Nel 1753 esce e viene preso d’assalto dal pubblico il suo primo romanzo italiano di tipo “moderno”, il capostipite, vale a dire La filosofessa italiana, o sia le avventure della Marchesa N.N., scritte in Francese da lei medesima. Anonimo ma dell’abate Chiari, che di qui in poi partorirà due romanzi all’anno, più o meno, e sarà in assoluto l’autore di bestseller del nostro Settecento, rimanendo fedele più o meno allo stesso genere. L’abate galante adotta una tecnica seriale, sfruttando l’eccitazione, la curiosità, la sorpresa programmata, e spostando di continuo le belle protagoniste - “filosofe” riflessive e prudenti - da una capitale europea all’altra, in un periodo in cui romanzo, giornale e rivista iniziano in tutto il continente ad accumulare l’immaginario di consumo, e a strutturane i tempi, il ritmo, le abitudini alla serata dedicata alla svago, nel contesto di una primitiva ma assai efficace industria culturale dello spettacolo a pagamento e del libro a basso prezzo e in formato tascabile per la lettura da notte e da viaggio in carrozza. Con la Filosofessa, stampata da un piccolo editore, Angelo Pasinelli, anche l’Italia si tuffa così nel novel, abbandonando il romance che da noi e altrove aveva avuto un enorme sviluppo tra il 1630 e il 1660, ma che nel resto d’Europa era stato via via sostituito dalla forma più realistica (Chiari stesso traduce il Tom Jones di Fielding). E nonostante il testo sia orchestrato su una proliferazione sfrenata di avventure, quasi un marchio che ricorda la vecchia fioritura seicentesca, prolungata ancora fino al primo Settecento da epigoni come il Leti, questa e tutte le eroine successive del Chiari XXVI si incontrano splendidamente con la mentalità del nuovo lettore di romanzi. I protagonisti dei quali, veri e propri avatar del lettore, peregrinando per un numero sterminato di pagine (tre volumi nella prima edizione della Filosofessa, che diventano quattro nella seconda), vi riversano di continuo quella sintesi fra l’apertura al nuovo, allo straordinario e al sorprendente da un lato, e il ragionamento, il confronto interessato e perfino banale dall’altro, che si esercita nella quotidianità prendendo ogni volta piccole decisioni, lo spirito dei tempi moderni. Il libro è diventato a metà Settecento in pieno il medium unificante e pervasivo delle classi colte, permeando fino in fondo anche l’immaginario del quotidiano, il senso della realtà e dell’utile, e la sfera erotica. I lettori, dimostra Chiari, ci sono. Manca se mai – ed è una questione che invariabilmente e periodicamente si pone per l’Italia – l’infrastruttura adeguata. Il tema di lì a poco l’evoluzione economica e politica lo avrebbe posto in termini di aspirazione ad un mercato librario nazionale unificato, senza più dazi tra uno stato e l’altro, e di introduzione di nuove tecnologie della stampa (in Veneto si dovevano in seguito realizzare i primi tentativi di stabilimenti tipografici moderni, prima che Campoformio decretasse la fine dell’industria veneziana, e il passaggio del know how e dei circuiti commerciali a Milano). Così ogni testo che abbia fortuna è soggetto ad essere piratato da editori e tipografi di altri domini, soprattutto a Napoli, come accade alla Filosofessa, sotto il nome di Filosofante... Sul Chiari calò nell’Ottocento l’oblìo, interrotto solo in tempi recentissimi; il primo romanzo “moderno” italiano è stato riedito da Manni nel 2004 a cura di Carlo Madrignani. Diverso il caso di Cagliostro, che nel mainstream dell’immaginario ottonovecentesco, non solo nazionale ma mondiale c’è entrato, eccome, soprattutto attraverso il ponte romanzesco del bestseller di Dumas, backstage degli innumerevoli ritorni letterari, biografici, melodrammatici e cinematografici. Palermitano, di origini disagiate come Chiari, e come lui mandato in seminario, Giuseppe Balsamo ne uscì ben presto, intorno al 1760, per iniziare la sua incredibile vicenda di truffatore e seduttore sull’itinerario Roma-Barcellona-Madrid-Lisbona-Londra-Parigi-Bruxelles-Palermo-Napoli-Marsiglia, per diverso tempo in compagnia della bella moglie romana, la Serafina. Dai tempi di Marsiglia, nel 1776, e anche prima, Balsamo compare con false identità e roboanti autobiografie: conte di Fenix o di Harat, marchese Pellegrini o Balsam, principe di Santa Croce. Passa di nuovo in Spagna, quasi sempre truffando o venendo truffato, e inseguito da ordini di cattura o da sicari, poi a Londra, lo stesso anno, diventa il conte Alessandro di Cagliostro, taumaturgo, depositario della sapienza dell’antico Egitto, dove sostiene di essere nato e dove avrebbe appreso le verità segrete, passando poi al seguito del Gran Maestro dei Cavalieri di Malta, a sua volta taumaturgo e alchimista… Sempre a Londra entra con la moglie in una loggia, nel momento in cui si afferma in seno alla massoneria una corrente mistica e alchimistica di origine francese e tedesca che sostiene di derivare dai Templari e dai Rosacroce. La coppia Cagliostro fonda una setta massonica nuova, di rito “egiziano”, diretta dal “Gran Cofto” e dalla “Regina di Saba”, e la promuove attraversando tutto il continente fino a Pietroburgo, mietendo successi, accumulando denaro e mistero. Accolti trionfalmente alla corte di Varsavia nel 1780, i due guariscono gratis nel 1781 a Strasburgo - o almeno così fanno credere – alcuni ammalati, ma la medicina ufficiale si ribella e allora via in Svizzera, Napoli, Bordeaux, e Lione, dove installano la loggia principale del nuovo rito, in una sede splendida e con l’adesione dei notabili, e poi a Parigi dove diventano le grandi stelle esoterico-mondane del 1785. Sul periodo parigino si basa il romanzo di Dumas, che racconta l’”affare della collana”: una bella avventuriera sfrutta a suo vantaggio i tentativi galanti di un cardinale nei confronti della regina Maria Antonietta, e arrestata, indica come regista dell’imbroglio Cagliostro, che viene rinchiuso nella Bastiglia, ma ritenuto innocente dal popolo in procinto di prenderla – la Bastiglia – si scagiona con una orazione al XXVII processo e viene trionfalmente liberato. Esiliato però in Inghilterra, scrive lì la sua Lettre au peuple français – il libro incluso nella nostra lista, che meriterebbe una buona traduzione e diffusione. È un atto d’accusa contro la corrotta giustizia francese, ma anche una profezia impressionante della Rivoluzione che sta per arrivare: assalto alla Bastiglia, Stati generali, cambiamento istituzionale. La conclusione prevista da Cagliostro, naturalmente, rispetta le aspettative massoniche: verrà un re saggio e illuminato, allusione probabile al futuro Philippe Égalité, gran maestro delle logge francesi. Alla Lettre il governo e la polizia francese reagiscono violentemente, facendo uscire un libello che smaschera la vera identità del Conte truffatore. Seguono polemiche furibonde sulle gazzette, nuove fughe e peregrinazioni, da medico come da maestro e fondatore di sempre nuove logge. Balsamo finisce nel Nord Italia, e poi a Roma, proprio nel 1789, ma viene guardato con sempre maggior sospetto. Serafina ha ritrovato i parenti e inaspettatamente sembra presa da scrupoli religiosi; in realtà è diventata l’amante del segretario della loggia egizia di Roma appena fondata, un cappuccino svizzero, e finisce per rivelare in confessione a un altro sacerdote parecchie cose compromettenti… Arrivano arresto, processo, tentativi di fingere ravvedimento e devozione cristiana, ma per Cagliostro è proprio l’epilogo: viene condannato a morte, commutata in carcere perpetuo, nell’orribile torre di San Leo nel Montefeltro, senza luce e con bastonature quotidiane, dove vegeta dal 1791 al 1795, e dove ormai folle non sopravvive abbastanza per vedere arrivare le truppe di Napoleone. Icona del mago, dell’avventuriero illusionista, del medium ipnotizzatore, del mistero e dell’occulto, e alla fine anche della follia violentata e violenta, anticipando il marchese de Sade, credo che anche il suo libretto possa trovare spazio nel mainstream, ora che la sfera dell’Altro, dell’Ombra, di cui il Conte è un archetipo, è divenuta quotidiana esperienza di consumo (e tanto vale allora rintracciarne i processi e i miti). E infine i Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernements et des moeurs des principaux États d’Italie del Gorani, scritti in buona parte durante un viaggio lungo la penisola negli ultimi mesi del 1787 e nei primi del 1788, e pubblicati a Parigi nel 1793, in piena Convenzione – uno dei molti libri, trattati e libelli, in parte ancora da tradurre, sopravvissuti alla sua vita tumultuosa. Il contino Giuseppe, pavese, inizia le sue peregrinazioni scappando dall’imperial collegio dei nobili di Milano per arruolarsi. Due anni di guerra (quella dei Sette Anni), e viene preso prigioniero dai prussiani, ciò che gli permette di restare quattro anni in terra tedesca e di completare gli studi, di incontrare Kant e di affiliarsi alla massoneria. Dal 1763 è di nuovo in Italia, dove gli scatta il sogno rivoluzionario di trasformare la rivolta dei Corsi di Pasquale Paoli in un nuovo stato monarchico, ma illuminato e giusto, dedito alla felicità dei cittadini, comprendente anche la Sardegna e l’Elba, di cui lui stesso, Gorani, avrebbe dovuto essere il re. Si imbarca e gira per tutto il Mediterraneo, continuando a osservare, riflettere e scrivere; non trova i denari necessari per la sua impresa, e finisce per sbarcare a Lisbona, come collaboratore del primo ministro, il futuro marchese di Pombal, quello che espulse i Gesuiti e incamerò i beni ecclesiastici. Ma il rapporto con il dispotismo pure illuminato del Pombal e poi dell’Imperatrice Maria Teresa – a Vienna si sposta nel 1767 – non doveva essere così semplice per il nostro eroe, prima inviato in missioni diplomatiche in tutta l’Europa, e poi sospettato di aver scritto una satira in versi contra la stessa sovrana e i suoi protettori, e di fatto licenziato. Segue una lunga pausa, quasi vent’anni di astinenza dall’impegno diretto in guerre, politica e diplomazia. Il conte, che torna a vivere tra Milano e la Svizzera, assume un ruolo di teorico e philosophe, frequentando il Beccaria e gli intellettuali del Caffè, ma anche Voltaire e i fisiocratici attivi a Ginevra. Teorizza ancora una “totale riforma”, guidata da un despota illuminato, che arrivi a contrastare il diritto di proprietà, fonte di tutti i mali, e a garantire una libertà economica, civile e di parola XXVIII in grado di contrastare l’arroganza dei poteri e dei potenti; poi fa sua la visione fisiocratica sulle imposte e scrive di pubblica educazione, di “scienza dei governi” e di riforme. Ma irrequieto, e insofferente delle corti e dei notabili degli staterelli italiani e dei domini stranieri, vende tutti i suoi beni e si rimette in viaggio nel 1787’88, raccogliendo una discreta congerie di memoriali scandalosi su corruzione e affari di letto, in giro per i palazzi del potere: un materiale impubblicabile almeno per il momento. La base dei Mémoires. Con l’ ‘89 si riaprono i giochi. Come molti altri intellettuali europei, Gorani accorre a Parigi, e partecipa alla Rivoluzione, da seguace di Mirabeau e poi dei girondini, scrivendo opuscoli e svolgendo incarichi diplomatici all’estero. Nel 1791 viene bandito dai domini austriaci. L’anno successivo – unico italiano – riceve solennemente la cittadinanza francese, insieme, tra gli altri, a Bentham e George Washington. Elabora un suo progetto di repubblica costituzionale per lo stato di Milano, ma restando girondino e ostile all’accentramento dei poteri imposto dalla Convenzione, si ritrova inserito in una lista di possibili cospiratori, e dunque a rischio di ghigliottina. Nell’ultima parte della sua autobiografia in francese (tradotta e ripubblicata nel 1999: un altro libro godibile e spesso romanzesco), Gorani sostiene di esser stato costretto a consegnare alcuni volumi della sua opera sulle corti italiane – e ne aveva pronti diversi altri sugli stati europei, che aveva visitato quasi tutti. Racconta di esser stato tradito dal libraio e stampatore Buisson: questi pubblica il libro con il nome del suo autore, e non anonimo secondo gli accordi sottoscritti, e ne cambia il titolo da Tableaux philosophiques, historiques et critiques a Mémoires secret et critiques, aggiungendovi anche un’epigrafe incendiaria non concordata. La vicenda segnerà gli anni successivi, poiché Gorani ottenne fortunosamente un nuovo incarico all’estero, ancora in Svizzera, e riuscì ad abbandonare Parigi prima della Grande Terreur; ma anche lì si ritrovò braccato sia dagli agenti di Robespierre che da quelli di Maria Carolina d’Austria, regina delle Due Sicilie, furiosa per lo scandalo del libro appena pubblicato a Parigi. Per parecchio tempo fu costretto a fuggire tra baite e valli, con una parrucca e sotto falsi nomi, e solo verso la fine del 1795 potè tornare a Ginevra, dove passò ancora più di vent’anni della sua lunga esistenza a scrivere moltissimo, anche se una buona parte delle sue opere le distrusse o andarono perdute. Via via che ci avviciniamo al presente, il mainstream risulta assai più largo e complesso, anche nel sentire comune medio-colto, cosicché la lista di Govi assomiglia sempre più al paesaggio ben noto: Pietro Metastasio, Gioacchino Belli, Giambattista Bodoni, Ludovico Antonio Muratori, Giuseppe Parini, Giovan Battista Pergolesi, Giambattista Vico, Giacomo Casanova, Lorenzo da Ponte, Pietro Verri, Cesare Beccaria, Vincenzo Monti, Gian Domenico Romagnosi, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, Antonio Rosmini, Vincenzo Gioberti, Niccolò Tommaseo, Cesare Balbo, Carlo Cattaneo, Silvio Pellico, Camillo di Cavour, Massimo d’Azeglio, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Giovanni Meli, Carlo Porta, Carlo Collodi, Edmondo De Amicis, Francesco De Sanctis, Giosue Carducci, Giovanni Pascoli, Giovanni Verga, Pasquale Villari. Cosa altro si intende aggiungere? Abbastanza recuperato alla nostra corrente è il romanzo filosofico di Zaccaria Seriman, I viaggi di Enrico Wanton, sia per gli studi di storia letteraria che per la storia dell’editoria. Altre presenze sono ormai costanti nei manuali scolastici, più che nelle letture effettive, e comunque riguardano autori ripubblicati di recente, come l’Algarotti, la pittrice Rosalba Carriera, l’osceno Giorgio Baffo, il Filangieri, il Genovesi, Pietro Giannone, naturalmente la Storia della letteratura italiana del Tiraboschi, assai rivalutata dagli anni Settanta, e poi via via l’Artusi, il Lombroso, l’ilare scienziato Mantegazza, l’economista Maffeo Pantaleoni, il matematico e filosofo Giuseppe Peano, e il grande Emilio Salgari, di cui si stanno preparando le celebrazioni per il centenario. Ulteriori e ampie operazioni di allargamento risulterebXXIX bero difficili, per un secolo come il XIX, oggetto di culto e di attenzione quasi religiosa fino alla prima svolta degli anni Settanta e alla reazione ideologica antiunitaria, con la svalutazione e quasi rimozione dell’epopea risorgimentale a cui si è assistito negli ultimi tempi. Ma almeno un paio di altri libri dell’età della Restaurazione meriterebbero di emergere, come il racconto di viaggi e esplorazioni in Egitto di Giovanni Battista Belzoni, o il Giannetto di Alessandro Parravicini. Il caso del Belzoni, come quello di cui si è detto del Gorani, ci mette di fronte a un altro italiano-europeo, celebre forse ancora oggi fuori dai nostri confini piuttosto che in patria. Un’altra vita romanzesca: barbiere nella bottega padovana del padre, archeologo in erba a Roma, ramingo durante l’invasione napoleonica in Italia, venditore ambulante a Parigi, “Sansone della Patagonia” in un circo di Londra dove sollevava undici uomini, scenografo e regista di spettacoli e di giochi d’acqua al seguito dell’esercito britannico in giro per l’Europa, Belzoni viene assunto come ingegnere idraulico dal Sultano d’Egitto, e poco dopo come agente dgli Inglesi per le missioni archeologiche. Esplora monumenti e rovine, invia statue e reperti al British Museum, scopre la tomba di Setis I nella Valle dei Re e il tempio di Abu Simbel, penetra per primo nella piramide di Chefren. Diventa celebre, idolo della stampa e del bel mondo londinese. E scrive il suo rapporto di viaggio ed esplorazioni, pubblicato nel 1820, riccamente illustrato (e tuttora da tradurre). Riparte nel 1823: prova a dirigersi dal Marocco verso il cuore del continente, poi sbarca in Guinea, quasi da solo, e marcia ancora verso l’interno, dove si ammala e muore. La storia del Giannetto di Parravicini, segnalata anni fa da Marino Berengo (in Omaggio a Piero Treves, Padova 1983) è invece una vicenda tipicamente Restaurazione. Il 23 dicembre del 1835 la «Società formata in Firenze per la diffusione del metodo di reciproco insegnamento» deve assegnare il premio di 1000 lire all’autore di «un’opera originale italiana la quale serva ad un tempo d’esercizio di lettura e d’istruzione morale per i fanciulli». In lizza restano due concorrenti: Il buon fanciullo, Il buon giovanetto, Il galantuomo», che in seguito diventeranno le Letture giovanili di Cesare Cantù, e il Giannetto. Sono i libri che per molti anni si contenderanno il ruolo di testo scolastico sussidiario per i ragazzi avviati all’alfabetizzazione nel Centro-Nord. Vince il milanese Parravicini, contro il brianzolo Cantù, autoritario e conservatore, ma anche patriota e intellettuale di opposizione (entrambi erano insegnanti a Como). Parravicini compila i suoi testi con buon senso quotidiano e innocuo enciclopedismo, politicamente e ideologicamente non schierato, anche se è in confidenza con Vieusseux (cui è stato presentato da Tommaseo); ed è capace di astuzia e mediazione, visto che almeno fino al ’48 resta ben accetto ai liberali mentre rende delicati e riservati servizi al governo austriaco. Il Giannetto avrà un enorme successo, in decine di edizioni autorizzate e abusive. Poco più tardi Parravicini redige per il Ticino un piano per la pubblicazione di libri di testo elementari, di manuali «di metodica pei maestri, pei padri di famiglia, per le autorità ecclesiastiche, amministrative e scolastiche», e infine un dizionarietto italiano per «migliorare l’ortografia e la lingua degli scolari, de’ maestri, de’ bottegai, de’ piccoli mercanti e possidenti, in generale del popolo». Nel Ticino, come in molte parti dell’Italia, la scuola elementare è delegata ai preti «che credonsi maestri di diritto senza obbligo di subirne gli esami». Il rafforzamento delle amministrazioni comunali costituiva l’unica risposta possibile, e il sussidiario di Giannetto si rivela come uno degli strumenti più semplici da utilizzare in quel primo e già notevole movimentoi di estensione dell’istruzione. A cui seguirà cinquant’anni dopo, la seconda gigantesca ondata in tutta Italia di maestri e coraggiose maestrine, di cui si sentono i riflessi nell’epopea del Cuore deamicisiano. Con il Risorgimento, l’Italia unitaria e poi il Novecento, il mainstream dei testi-base della cultura italiana si allarga naturalmente a dismisura, diventa un golfo, percorXXX so infinite volte e in tutte le direzioni dei processi di memoria collettiva e di immaginazione. La distanza tra i “classici” e i minori quasi si annulla, la stessa possibilità di considerare e valutare su piani gerarchici la rilevanza, l’autorevolezza di un testo è oggi assai limitata, anche perché il travaso dalla ricerca specializzata al recupero di migliaia di episodi in una cultura condivisa e spesso mediata da televisione e giornali avviene di continuo, in modo caotico. Se qualche personalità, e soprattutto qualche libro degno di essere letto rimanesse fuori, vorrebbe dire – almeno per il Novecento – che ci sono ragioni storiche ben precise. E in questo senso, fra le proposte di questo volume, concluderemo su due casi emblematici. Il primo è quello di uno dei protagonisti assoluti dell’Italia unitaria, e della sua autobiografia: Giovanni Giolitti. Quando nell’ottobre del 1922 escono le Memorie della mia vita, il fondatore della grande casa editrice che pubblica il libro, Emilio Treves, è morto da tempo, e i fascisti stanno impadronendosi del potere. Tra breve favoriranno la rapida ascesa di Arnoldo Mondadori a semi-monopolista del mercato editoriale, in sostituzione della vecchia Treves, nata si può dire con l’Unità e il mercato unico nazionale del libro e delle riviste illustrate. Ed elimineranno dalla direzione dell’influente quotidiano La Tribuna Olindo Malagodi, che scrive la prefazione delle Memorie. Sono anni durissimi; una campagna di odio e diffamazione nei confronti del leader storico del pallido liberalismo italiano - iniziata con l’interventismo d’anteguerra da D’Annunzio e proseguita nell’agitato e violento dopoguerra, in cui Giolitti non era riuscito a garantire stabilità né a contrastare l’aggressività fisica e politica del fascismo – sta arrivando al suo sbocco, alla fine di un intero ciclo politico e di un regime costituzionale. E anni ancora più duri sono quelli che si preparano. Il nome stesso di Giolitti è destinato a rimanere nella propaganda di regime come sinonimo di ridicolo, di vecchia italietta, di pacifismo vigliacco e borghese. Malagodi, tra i fondatori del partito socialista, divenuto liberale e poi grande giornalista, uno dei più stretti sostenitori del leader piemontese, vuole che nelle Memorie emerga, in extremis, un Giolitti sconosciuto: non l’uomo a cui si attribuivano trame, segreti, manovre sempre dietro le quinte, arti parlamentari raffinatissime, non il cinico e lo scettico della leggenda, il genio della furbizia politica, ma il gentiluomo “chiaro diritto e semplice”. Vorrebbe rovesciare la costruzione mitologica dannunziana e mussoliniana, mostrando la vecchia fibra di un uomo che è rimasto fermo nelle sue convenzioni, e ha lottato per il suo progetto di moderazione e di tolleranza – ma sotto l’egemonia dei liberali – nei confronti dei socialisti dell’ala riformista turatiana. Il ritratto che l’ottantenne Giolitti offre di sé vorrebbe risultare così tipicamente piemontese e apparentemente dimesso: Le memorie della mia vita di famiglia nella fanciullezza, e della mia educazione sono semplici assai e di tipo comune, senza niente di particolare o di eccezionale… la nostra insomma era una famiglia di contadini-montanari, che deve aver vissuto per secoli in quella vallata che ebbe sempre una fiera indole democratica… Ma molto meno dimesso, pur mantenendo un impeccabile understatement è il suo racconto serrato delle vicende della sua lunghissima carriera di funzionario del nuovo stato nazionale dal 1862, di deputato di Cuneo dal 1882, di ministro della Sinistra (nominato da Crispi) dal 1889, di capo del governo,dal 1892, e poi ancora varie volte di ministro e presidente del consiglio, tra fasci siciliani, scandali finanziari, scontri sociali violenti, l’invasione della Libia, l’impresa di Fiume, l’occupazione delle fabbriche e la definitiva sconfitta del suo programma politico. Si tratta di pura storia evenemenziale, precisa fino al dettaglio, con le ragioni di ogni decisione, solo a tratti venata di buon umore, più spesso di un certo appuntito risentimento. Del resto, nel 1921-22 in cui le Memorie vennero scritte, i fatti scorrevano tumultuosi, fuori dai meccanismi consueti della politica. Il futuro era oscuro. XXXI Un altro libro che andrebbe assolutamente recuperato – insieme probabilmente ad alcuni altri di area artistica, come il Manifesto bianco di Fontana, presente nella nostra scelta - è Kn di Carlo Belli, uscito nel 1935, e ripubblicato da Vanni Scheiwiller nel 1988, con in appendice diversi passi censurati originariamente dallo stesso autore. Un manifesto dell’arte di avanguardia, su un terreno ampiamente “bruciato” dai quasi quarant’anni di manifesti, a partire da quelli futuristi, ma ancora in grado negli anni Trenta di provocare reazioni furiose, in un mondo intellettuale tutto sommato ancora vitale nonostante la pressione delle istituzioni di regime. Vicino agli “astratti furori” di altri giovani che all’epoca immaginavano una rigenerazione antiborghese, anti-idealista, collettivista del fascismo, Belli confeziona un attacco frontale al “900”, la cifra dominante delle arti visive italiane dopo il “ritorno all’ordine’ degli anni Venti: con una prima parte di aforismi brucianti e a calembour (“Bach sì, Beethoven no”; “Non esiste comicità all’infuori dell’uomo. Un’arte che prende a modello l’uomo è quindi ineluttabilmente comica”); una seconda e una terza parte argomentate e teoriche; e una quarta direttamente autobiografica e politica, infervorata per il momento straordinario, quel “cambio di pelle” che la grandeur imperiale di Mussolini sembra produrre anche sul piano estetico, in architettura anzitutto. Belli cerca uno scossone morale che inverta la deriva verso una rovina e un prossimo cataclisma derivante dal benessere ottuso; e sul piano artistico, l’idea del “Kn”, appunto, è quella di operazioni in cui gli elementi e le opere (k1, k2, k3…) non mostrino nessi antropomorfici. L’arte deve essere “astratta, universale, collettiva, splendente di pura beltà” (gli archetipi di Belli sono in Braque e Kandinsky, i suoi bersagli polemici nell’avanguardia sono il “barocchismo” di Picasso, il “pittoricismo” di Strawinsky, la povertà inventiva di Mondrian), e proprio perché assolutamente pura, sarà assolutamente “popolare”; la libertà totale dell’artista e della sua percezione e immaginazione si dovrebbe risolvere in una coincidenza spirituale con il mondo ordinato e socializzato di un fascismo integrale… Poeta, musicista e pittore in proprio, Belli suscitò, come voleva, un vespaio. Rileggendo la lista del Novecento in questo volume, quasi nulla mi pare effimero, di molti libri resterà probabilmente anche nelle prossime generazioni una traccia profonda. Un grande narratore contemporaneo, Abraham Yehoshua, ha scritto della necessità assoluta di leggere i grandi romanzi. Lì è infatti la percezione della nostra storia, tanto più incisiva attraverso l’identificazione con le persone inventate dall’autore, che ci accompagnano nella comprensione dei fatti. All’invito di Yehoshua ne aggiungiamo allora un altro, più esteso, a partire dall’appassionato lavoro di un libraio, che ci trasporta direttamente nel flusso della nostra grande cultura passata. Cercateli e leggeteli, i libri mainstream. Di lì passa la nostra identità, quella che ancora ci aiuta a dire un salutare “noi”. XXXII I quattrocento colpi Parafrasando il titolo di un classico della storia della bibliografia 1, questo prezioso ed utile volume si sarebbe potuto intitolare Il genio italico nell’arte tipografica. Si tratta di un libro atipico nella produzione dei repertori bibliografici, scritto da un libraio antiquario, giovane ma di antica tradizione, ed atipico anch’egli nell’ambiente, tanto frenetico nei propri viaggi di ricerca quanto riflessivo nelle schede dei propri cataloghi. Quest’opera vuole a mio parere rappresentare soprattutto la prova tangibile di quello che è il lavoro quotidiano di Fabrizio sull’oggetto-libro: uno studio approfondito dell’opera e dell’esemplare, che prescinde dalle implicazioni strettamente commerciali. Un qualsiasi catalogo di vendita di un libraio antiquario costituisce comunque un formidabile strumento di cultura, in grado di suscitare curiosità non solo nel collezionista ma anche in un semplice lettore: immaginiamoci le sensazioni che può provocare in un bibliofilo un volume come questo, che riunisce le più importanti produzioni di cinque secoli di stampa create dall’ingegno degli Italiani. Poter pubblicare un catalogo con questi titoli in vendita sarebbe poi il sogno di qualsiasi libraio. In quanto mercante, non potrei che scoraggiare un bibliofilo che si affidasse a me per mettere insieme una biblioteca comprendente tutti questi titoli, quali che siano le sue disponibilità economiche, in quanto impresa quasi impossibile. Ma, allo stesso tempo, gli direi che una buona metà di queste edizioni originali possono essere reperibili sul mercato nell’arco di pochi anni, ed alcune di esse a prezzi non esorbitanti; non sempre l’importanza testuale corrisponde ad un costo elevato. E’ ovvio che si potrebbe discutere all’infinito a proposito della presenza di alcuni autori, dell’assenza di altri, oppure della scelta di un’opera piuttosto che di un’altra nella produzione letteraria di alcuni scrittori. Ma in pochi campi come nella lettura e nel collezionismo, i gusti e le scelte sono così strettamente personali ed opinabili; i 400 colpi che, come Truffaut 2, ha “tirato” Govi, costituiranno uno straordinario strumento di lavoro, di lettura e di piacere. In quanto collezionista a mia volta – di prime traduzioni italiane – avrei voluto vedere compreso un esempio della prima diffusione in Italia di un testo straniero. Essendo Cesare Pavese – inarrivabile traduttore di un capolavoro come Moby Dick 3 – già presente con Paesi tuoi, avrei scelto l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters 4 nella versione della grande Fernanda Pivano, che ci ha fatto conoscere tutta la letteratura americana contemporanea. Mentre, per ciò che concerne l’altra parte della mia collezione, cioè la diffusione all’estero della cultura italiana, la mia scelta cadrebbe sulla traduzione di Pinocchio, non tanto la più celebre, quella americana, quanto quella oscura in lingua spagnola 5, pubblicata per la prima volta non a Madrid, ma addirittura a Bogotà nel 1913. In questo periodo di diffusione dei supporti informatici, vorrei che fosse attribuito un giusto riconoscimento alla funzione culturale svolta dai librai come Govi. La figura del mercante è infatti spesso vista con una certa diffidenza, ma è indubbio che, nei secoli, i librai hanno avuto un ruolo fondamentale nella conservazione dei manoscritti e dei libri: hanno contribuito a salvare dall’oblìo e dalla deperibilità migliaia di volumi, grazie alle loro ricerche ed ai restauri commissionati; a diffondere la cultura e l’arte italiana nel mondo ed a reimportare in Italia tesori grandi e piccoli; ed hanno avuto un ruolo primario nella formazione di importanti raccolte private di studiosi e di collezionisti, prima smembrandole e poi ricostituendole in forma diversa; nonché nell’arricchimento delle formidabili biblioteche pubbliche di XXXIII cui è ricco il nostro paese. Ritengo che le centinaia di cataloghi che i librai dell’ALAI pubblicano ogni anno contribuiscano a lasciare una traccia documentale di grande valore per studiosi, collezionisti e bibliotecari. Govi sa bene che per redigere in maniera adeguata un catalogo ci vuole una quantità esagerata di tempo, nonché una certa cultura, costanza, capacità di utilizzare i supporti bibliografici e di documentare le caratteristiche tipografiche delle edizioni antiche; ed ora anche la capacità di utilizzare i programmi di grafica e di impaginazione per rendere l’offerta più accattivante. Quando iniziai la mia avventura nell’antiquariato librario – e non parliamo della preistoria – i computer e gli scanner non si potevano neppure ipotizzare: i testi, dattiloscritti con i grassetti o i corsivi evidenziati a matita rossa o blu, venivano composti dal tipografo con la linotype; le illustrazioni erano riprodotte su cliché di zinco applicati su spessi blocchi di legno per essere inseriti nelle forme tipografiche. Confrontando le descrizioni pubblicate in un bel catalogo con la schedatura che si riserva ad un libro per un’offerta su internet, non si può non notare come questa sia meno accurata e precisa anche dal punto di vista grafico, proprio per le caratteristiche effimere che comporta. La rivoluzione provocata oggi da Internet, è paragonabile soltanto all’invenzione della stampa, che quasi sei secoli orsono offrì al mondo una democratizzazione della cultura senza precedenti. Internet non solo ci sta cambiando la vita, offrendoci una moltitudine di informazioni e di fonti, la cui attendibilità è comunque da verificare, ma sta radicalmente modificando anche il commercio librario: la proposta on-line di un grandissimo numero di titoli antichi o esauriti ha senza dubbio prodotto una maggiore trasparenza rispetto al passato. Leggendo i cataloghi antiquari di qualche anno fa, ci si può accorgere che spesso le nostre schede terminavano con l’affermazione “edizione rara”, oppure “introvabile”. Era più che legittimo domandarsi in che modo dimostrare che tale affermazione fosse oggettiva: l’unico modo poteva essere l’individuazione dell’ “indice di rarità” di un edizione, che si misura nel rapporto tra l’ampiezza della tiratura iniziale e il numero di copie superstiti. Ora è assai più agevole: se nei vari motori di ricerca si trovano soltanto uno o due esemplari di quel dato libro, la sua definizione di rarità è oggettiva; qualora sia proposto in cinque o dieci esemplari, vuol dire che proprio raro in fondo non lo è. Ma l’opportunità di sfogliare un catalogo cartaceo ben fatto è una sensazione non paragonabile alla digitazione di un titolo su un motore di ricerca: le orecchiette che posso fare per ricordarmi di un lotto interessante, le sottolineature per una collazione particolare, lo stesso odore della carta. Se interrogare Internet mi consente oggi di scovare, presso un libraio sconosciuto di un altro continente, un titolo che cercavo da anni, la compulsazione di un catalogo mi consente tuttora di venire a conoscenza di libri di cui non immaginavo neppure l’esistenza. Se mi si permette il paragone, è una sorta di prova della teoria kantiana della conoscenza: “non è l’esistenza a determinare la conoscenza di qualche cosa”, come sostenevano gli empiristi, bensì “la conoscenza a determinarne l’esistenza”: quel libro antico viene ad esistere – per me – soltanto nel preciso momento in cui leggo su un catalogo che, secoli fa, qualcuno l’ha scritto e pubblicato. Un volume è, per definizione, un oggetto difficile da esporre: il catalogo è a mio parere una vera e propria vetrina del libraio antiquario, che ne esprime le conoscenze, le capacità e la serietà; oltre a costituire una garanzia per il cliente, che ha il diritto di conoscere con precisione le ragioni per cui quel determinato esemplare dovrebbe valere cento o mille euro. Ritengo che l’insieme dei cataloghi di una libreria costituisca un vero e proprio testamento spirituale del libraio, la storia della sua vita, di come ha saputo “vendere l’anima” 6. È un peccato ad esempio, che un grande libraio italiano del passato abbia pubblicato due soli cataloghi – rammaricandosi XXXIV peraltro di averne pubblicato uno di troppo – perché le sue notevoli conoscenze bibliografiche, le sue scoperte, sono rimaste un fatto privato tra lui e l’acquirente di quel libro. Ma, allo stesso tempo, la mancata condivisione dell’informazione con i bibliografi ed i colleghi non ha neppure consentito di attestare la veridicità delle affermazioni di quel libraio. Il libro è per sua definizione un multiplo, quindi la pubblicazione di una informazione bibliografica, una collazione particolare, una scoperta inedita può e deve essere utile al confronto con altri esemplari. Il catalogo rappresenta inoltre per me un alibi, che mi rende meno doloroso il distacco da quei libri che amo particolarmente e sono costretto a vendere per poterne acquisire degli altri. Averne fatto uno studio ed averne pubblicato la descrizione su uno dei miei cataloghi, fa sì che quel determinato esemplare, con quella legatura, con quelle note di possesso, quelle gore d’acqua e quei tarli, resti comunque per sempre anche un po’ mio, indipendentemente dai passaggi di proprietà che potrà fare in futuro. Mio nonno pubblicò il primo catalogo 7 quasi novant’anni fa: il libro più caro, un incunabolo figurato, era prezzato ben 650 lire. Questo del 1921 è tuttora per me un talismano, una sorta di monetina Numero Uno di Paperone. Il libraio non smette di essere tale quando la sera chiude la sua bottega: il tempo del suo lavoro è la sua stessa vita, con l’abitudine alla ricerca bibliografica, alla conservazione del libro, alla rivalutazione di quanto ancora è poco noto o dimenticato, con una passione che va ben oltre il valore economico dell’oggetto. Questa pubblicazione sui libri che hanno fatto gli Italiani è una prova più che evidente di quanto questa sia un’attitudine ben radicata nella famiglia Govi. E mi auguro possa essere tradotta presto in inglese, per potere riaffermare nel mondo quello che è stato e continua ad essere il fondamentale contributo italiano alla civilizzazione occidentale. Umberto Eco sta per inaugurare al Louvre la Vertige de la Liste, un grande evento con esposizioni, conferenze, concerti, tutti dedicati al tema della lista, nella storia, nella cultura, nell’arte, nella vita. Nel bel volume Vertigine della lista che ha appena pubblicato da Bompiani ne spiega con l’abituale, originale acutezza, gli elementi che la differenziano dal Catalogo. Riallacciandomi al precedente saggio del mio illustre omonimo, Non sperate di liberarvi dei libri, di ottimo auspicio per il futuro di noi librai antiquari, formulo a Fabrizio l’augurio reciproco di non liberarci proprio mai dai libri... Umberto Pregliasco Presidente dell’Associazione Librai Antiquari d’Italia 1 CARTER, John-MUIR, Percy M. Printing and the Mind of Man. A descriptive catalogue illustrating the impact of print on the evolution of Western Civilization. Cambridge, 1967. 2 TRUFFAUT, François. Les quatre-cents coups. Cannes, Festival, giugno 1959. Palma d’oro per la miglior regia. 3 MELVILLE, Hermann. Moby Dick o la balena. Traduzione di Cesare Pavese. Torino, Frassinelli, 1932. 4 LEE MASTERS, Edgar. Antologia di Spoon River. A cura di Fernanda Pivano. Torino, Giulio Einaudi editore, 9 marzo 1943. 5 COLLODI, Carlo. Las aventuras de Pinoquio. Historia de yn tìtere. Traduzione di Antonio José Restrepo. Bogotà, Imprenta de “La Tribuna” editorial, 1913. 6 MONTRONI, Romano. Vendere l'anima. Il mestiere del libraio. Bari, Laterza, 2006. 7 PREGLIASCO Libreria Antiquaria. Catalogo di Libri Antichi. Nr. 1. Cherasco, Tipografia Raselli, giugno 1921. XXXV Errata corrige. La scheda nr. 206 è posta per errore fuori ordine cronologico. Si prega quindi il lettore di voler ripristinare idealmente la disposizione corretta. XXXVI
Scaricare