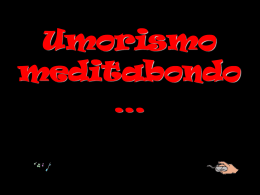ENZO BIAGI. L’ALBERO DAI FIORI BIANCHI. Il sole del tramonto è magnifico ma la notte si avvicina. Dinastia Tang, Una sosta sul ponte. Era un piccolo albergo dal nome fiabesco: “La casa azzurra”. Il colonnello vi alloggiava dalla fine della guerra. Suppongo, anche per i modi confidenziali della cameriera e, considerando le sue rendite di pensionato, che godesse di un trattamento amichevole. Ma dava in qualche modo decoro al locale. Il colonnello conosceva le buone, vecchie famiglie di Monaco, era abbonato ai concerti e invitato ai ricevi menti, accoglieva ogni tanto qualche riservato genti luomo che aveva avuto una certa parte nella Berlino di Hitler o addirittura in quella dell’imperatore. Aveva fatto carriera per caso e, ironia, addirittura nelle SS. Si trovava a Roma dove studiava la storia della Chiesa quando arrivò Hitler: all’ambasciata tedesca si accorsero, all’ultimo momento, che mancava l’inter-prete. Chiesero il suo aiuto. Non finì mai al fronte ma, anche con qualche diver-timento, si mosse nei salotti aristocratici e nei comandi, tra generali, nobildonne, monsignori e gerarchi. Era un vaso di coccio e si proteggeva con il cinismo. Del resto aveva capito per tempo la fine dell’avventura. Piaceva ai superiori, e lo si vedeva dal ritmo delle promozioni e dagli incarichi: doveva tradurre addirittura le conversazioni del Duce e del Fuhrer. Li trovava drammatici e buffi: con gli intimi li chiamava “i promessi Sposi”. Gli era simpatico invece il grosso Hermann Goring, il capo della Luftwaffe, che indossava divise strampa-late, colore dominante il bianco, sfoggiava più decora-zioni di un domatore, era furbo e spregiudicato: una specie di satrapo, molle e invadente che, dopo un ban chetto con tripudi di cacciagione e di boccali di birra, apriva una cassetta e se la spassava a dividere i brillanti dai rubini e dagli smeraldi.” Un Marcantonio,” diceva il colonnello “ma senza Cleopatra”. Alle pareti della sua stanza pendeva qualche riproduzione del Canaletto: scene di una Venezia lontana, maschere, gondole, dame in crinolina, popolane, bambini; c’è sempre in quelle tele, mi pare, un cagnetto che corre alla ricerca di un angolo. Nostalgia, forse. Sul comodino, in una cornice d’argento, c’era la fotografia di un giovane e un po’ torvo attore del cinema, discinto e muscoloso come gli eroi delle pièces mitologiche. Si accorse che la osservavo con curiosità. “Un ni pote” spiegò con disagio. • • Ha rimpianti, colonnello? Verrà ancora in Italia? chiesi. “Non bisogna mai ritornare dove si è stati felici” so-spirò. Ci ho ripensato, qualche volta. Ho una spiccata propensione per i ricordi, e condivido quello che mi disse, durante una intervista, un fa moso scrittore: “Invecchiare è quello che ho fatto di più importante nella vita”. La mia è passata in fretta: ieri ero un ragazzo, ma non posso recitare neppure le orazioni che mi ha insegnato mia madre e che ripetevo ogni sera. “Mio Dio, mi pento”: ma di che? Non mi sento colpevole di niente. Un’ora non è la stessa cosa per tutti. Appartengo a una generazione che è stata segnata, purtroppo, dagli eventi: e rni incanta invece la gente normale, quella che festeggia gli anniversari, crede nei proverbi, nel ri-sparmio, nelle vacanze e sa che nessuno è perfetto e che, prima o poi, si deve morire. Sono stato testimone di alcune vicende che hanno cambiato le carte geografiche e il destino del mondo. Ero giornalista; e la cronaca ha scelto per me incontri e itinerari. Ho girato in lungo e in largo l’America, ad esem-pio, ma non ho mai visto le cascate del Niagara. Ho ascoltato Joséphine Baker, ommai al tramonto - era assurda, un po’ oscena, solo le cosce, lucide di su-dore, suscitavano ancora maliziosi pensieri; forse lo ca-piva e invocava uno spettatore munito di binocolo: “Si-gnore, conservi le sue illusioni” -, ma non sono mai entrato alle “Folies Bergère”. Ho conosciuto briganti e geni, santi e impostori, ma forse capita anche ai baristi, ai commessi viaggiatori o ai portieri d’albergo. Tutti hanno bisogno di parlare, di confidarsi: “Per favore,” disse l’uomo da]la faccia len-tigginosa, una domenica, in un giardinetto “mi tocchi, mi faccia capire che sono vivo”. Quando finisce la stagione delle speranze si apre lo spazio per le memorie. Non sono il protagonista di un romanzo, e non tento bilanci; come quel nobile fran cese scampato alla rivoluzione, potrei dire: “Eccomi qui. Ho vissuto”. Una volta, sono disordinati i pensieri, mi manda-rono a trovare un santone indiano che, sfuggito alle leggi della Califomia, si era rifugiato, con un corteo di devoti, soprattutto giovani donne, a Katmandu. Aveva una grande barba bianca e occhi spiritati. La tunica era omata di gioielli e scintillava. Predicava il libero amore e, nei suoi limiti, lo praticava. Era contro le religioni, non credeva ai miracoli di Gesù, e il fatto che Cristo trasfommò, alle nozze di Cana, i boccali d’acqua in vino dimostra che non era il figlio di Dio, ma un sofi-sticatore. I fedeli lo ascoltavano con reverenza, le ragazze si offrivano alle sue carezze, riceveva doni e assegni: non se li è goduti. Mi sembrò un simpatico tipo di farabutto, ma non bisognerebbe mai giudicare. Sul marmo della tomba ha voluto che fosse scolpita una frase che, in fondo, rivela la sua distaccata saggezza: “Mai nato mai morto. Ha soltanto visitato il pianeta Terra”. Solo gli innocenti sentono il rumore dell’erba che cresce. Ho mai visto qualcuno felice? Il ragazzino che mi disse: “Dio viene col vento”, e il bambino cieco che rabbrividiva nel freddo e nella nebbia di novembre, su un argine del Po, durante un’alluvione. Piangeva: “Ho dimenticato il mio pallone”, e un pompiere tomò indie tro, nella casa invasa dall’acqua, e glielo portò. Il bam-bino lo accarezzava, inseguiva il rimbalzo della palla e rideva sgangheratamente. Arrivai a Picunda che stava calando la sera. La spiaggia era sporca di sterpi anneriti, su un costone pascolavano vitelle magre. Ansimando, un camion si femmò vicino a una barca capovolta. Scesero le conta dine russe e saltarono nell’acqua alzando le gonne: urla-vano allegre. Più lontano, c’erano una bellissima ragazza, alta e bruna, e un giovanotto forte: si tuffavano fra le onde schiumose, si spruzzavano, si baciavano, si sentivano soli e felici, la loro purezza era commovente. Sembrava davvero l’ultimo Eden; le api sui tigli, i gridi delle cico-gne, fra i cespugli maturava l’uva spina. Mi sentivo leg-gero e lieto, lontano da tutto. Istanti. I giorni che passai in Sudafrica, al Kruger Park. Mai le stelle, nelle lunghissime notti, mi sono apparse tanto vicine. E il mondo, attorno a me, così sem plice e incontaminato, faceva pensare al paradiso terre-stre. I leoni, richiamati dall’odore della carne arrostita sulla brace, arrivavano a branchi e strisciavano contro le porte dei bungalow: sembravano grossi gatti che chiedono una carezza. Vidi un imponente elefante che si era ubriacato con una scorpacciata di bacche rosse eccitanti; dondolava goffamente, era buffo, non minaccioso. Alcuni uccelli azzurri, verdi, bianchi si posavano sul collo delle giraffe. All’alba, le zebre, gli ippopotami, le scimmie si davano appuntamento al ruscello per l’abbeverata. Navigai sul Mississippi, nelle grigie giornate d’au tunno, quando le sponde scompaiono, dice un antico viaggiatore, “cancellate dal velo della lenta pioggia”. Il fiume era femmo e silenzioso nella nebbia, gonfio d’acqua gialla. I rimorchiatori trascinavano le chiatte cariche di grano, di rottami, di fusti di benzina. Li ac-compagnava, con il battito dei motori, il volo degli ai-roni e dei martin pescatore, il ronzio delle zanzare, il rumore lontano delle fabbriche o le urla dei ragazzi che giocano davanti alle fattorie. Io ero solo, inseguivo il passato; quello dei battelli a vapore con la grande ruota che imbarcavano cercatori d’oro, cacciatori di pellicce, bari, biondine che esibi vano le giarrettiere, domatori di cavalli, gentiluomini falliti, traffficanti d’armi, giocolieri e musicanti, pelle grini che sfuggivano alle persecuzioni. Il piccolo palcoscenico, sui piroscafi, era illuminato dalle lampade a petrolio. Nei libri ricordano ancora le esibizioni della “bellissima Magnolia Revenol”. Chissà com’era? Che cosa ne sarà stato? Amante di un biscazziere, onesta sposa di un coltivatore di cotone? Un pomeriggio di domenica a Varsavia, nel cadente Hotel Bristol sentivo solo il cigolio del vecchio ascensore. Sul comodino una Bibbia e l’elenco del telefono: quanti Walewski. C’era anche una Walewska Kune gonda e una Walewska Krystyna e addirittura una Wa lewska Lodovica Colonna. Mi chiesi: “Questa è nobile; ma cosa fa oggi una contessa in Polonia?”. Composi il numero; rispose una voce gentile di donna. • Parente?--chiesi. Pensavo al volto bianco di Greta Garbo, a Maria Walewska e al Napoleone un po’ obeso del cinema, a slitte che corrono sulla neve verso castelli illuminati dalle fiaccole mentre i campanelli dei cavalli scuotono l’aria. “Sì” disse. “Signore, che cosa vuole da me?” Parlava il francese di chi ha fatto buoni studi. • Mi piacerebbe vederla, incontrarla—dissi. “Sente queste voci? Abito in un caseggiato popo-lare. Giocano a pallone, giù nel cortile. Niente nella mia casa suggerisce il passato.” Un attimo di silenzio, di imbarazzo. Un orologio batté le ore: “Di allora è rimasta solo questa pendola, ha quasi due secoli. E inutile fermare le lancette”. Mi appassiona inseguire i fantasmi. Una piccola ri-cerca. Il 12 gennaio 1807, Napoleone Bonaparte in viava questo messaggio alla contessa Walewska: “Ve nite, vi prego, venite! Tutti i vostri desideri saranno esauditi. La vostra Patria mi sarà cara se avrete pietà del mio povero cuore “. I personaggi della storia, quando scrivono alla di-letta, sono impudichi come gli autori di canzonette. La signora, forse anche per servire il suo Paese, aderisce; e due giorni dopo l’imperatore soddisfatto replica con ul teriori invocazioni: “Maria, mia dolce Maria, il mio pen-siero è per te, il mio primo desiderio è di rivederti. Ma tu ritornerai, non è vero? Me lo hai promesso. Sennò l’aquila volerà verso di te.” Gli amanti, si sa, non hanno il senso del ridicolo: ecco un rapace che, indossato il camicione da notte, con stemmi e corone, volteggia per una stanza e piomba su un canapè. Giuseppina, Maria Walewska, Maria Luigia: ritor nano le loro immagini nel vento e nella desolazione di Sant’Elena. Nessun cenno a una certa signorina Patter-son che pure fu amica dell’esule. La storia l’ha trascu rata. Donne: la più intollerabile crudeltà è dimenticarle. La ragazza che vendeva giornali nel grande albergo di Dallas (Texas) ed era appassionata del melodramma: ogni mattina - aveva capito da dove arrivavo - mi ac coglieva con un sorriso e il verso di una romanza: “Ad dio del passato bei giorni, giorni ridenti”, “Mi chia-mano Mimì”: già, non le chiesi mai il nome. Indossava una blusa sbracciata, si vedevano le ascelle. Ricordo le fatue, non c’è dubbio, ma appassionate discussioni giovanili: meglio depilate o con il pelo? Qualcuno sosteneva il forte richiamo del ciuffetto, al-meno nella stagione invernale. Tornai a cercarla, ero da quelle parti quando ucci-sero il presidente Kennedy; ma non c’era più. Il reverendo Elisabeth Djurle aveva gli occhi molto chiari, un’ombra di cipria sul volto pallido e un mite sorriso autunnale. Era prete luterano, a Stoccolma. Pioveva e le campane delle boe rintoccavano nella foschia, l’orologio del presbiterio batteva il tempo, luc cicava il campanile di rame. Guardavo il collettino bianco del pastore e la crocetta d’argento che le pen deva sul petto. Bello, nel mio pensiero sacrilego. Si in tuivano due capezzoli arroganti. Dicono che Gesù non è nato bambina e che tra gli apostoli non c’erano fanciulle. E allora? Il pastore Djurle mi parlò della sua vita, della sua vocazione, spiegò: “Che importa se ad accogliere un’a-nima sarà la mano di una donna o quella di un uomo?”. Gli alberi stavano cambiando il colore del fogliame, la borraccina, sulle vecchie tombe del sagrato, era di un verde cupo. Passeggiammo. Non feci cattivi pen-sieri. Al momento del congedo mi chiese: “Che cosa posso fare ancora per lei?”. • Non saprei, forse pregare. Mi diede la mano: “Pregherò”. Perché mi è venuta in mente, proprio oggi? Perché lei, e non la ballerina della Compagnia “Made in Italy” che ritrovai a Copenaghen? Andammo una sera al Tivoli. Il frastuono del grande Luna Park; c’è una pagoda indiana, una torre cinese, un laghetto, il toboga è alto, e con una lunga e comoda galleria buia per i fidanzati, girano i bianchi ca-valli delle giostre al suono di una musichetta celeste. Avevo letto un romanzo in cui si parlava dei gusti delle fanciulle nordiche; il loro più forte desiderio è “stendersi nude sull’erica del prato”, ma io sono goffo e imbarazzato. “Che italiano sei?” disse la cortese e permalosa amica. “Non tenti neppure di baciarmi; vuol dire che sono molto brutta.” L’erica: quando ho scoperto che esistono cespugli di una pianticella che si chiama così? In un film, una voce di ragazza urlava nel turbinio delle foglie un nome: “Heathcliff, Heathcliff!”, inseguiva nella brughiera e nella nebbia un amore. Forse era Cime tempe-stose. Poi mi sono accorto che fiorisce anche sui miei monti; ma noi non siamo romantici e l’adoperiamo per far scope. E rivivono in me certi odori: un miscuglio di erbe, di acque, di pietre e di cortecce. Si è dunque chiuso un ciclo: e ripenso a quell’umida sensazione della giovinezza, adesso che cammino nell’ultimo au-tunno. Io in Danimarca ritrovavo la malinconia di Amleto e le favole e la figura allampanata di Hans Christian Andersen, il figlio di un ciabattino ubriacone e di una lavandaia, con i suoi personaggi, i corvi, le volpi, le ci-cogne, le fatine dai piccoli seni rosei che volavano nei cieli di porcellana. “Sono come l’acqua,” diceva Ander-sen “tutto si riflette in me.” In questo forse gli assomi-glio. Nell’infanzia e anche, mi sembra, nel carattere. Ero bambino quando si poteva ancora ascoltare il raglio dell’asino e il canto del gallo; la pioggia si annunciava con il volo basso delle rondini e la primavera con stri-sce di margherite bianche nel campo, quando il postino urlava “Telegramma” anticipava il destino, le cornac-chie facevano il nido su un pioppo, dalla cucina del prete usciva il profumo del ginepro e lo sfrigolio dei merli infilati allo spiedo che sgocciolavano sulla brace. Andersen aveva paura della sorte: teneva accanto al letto una corda per scappare dalla finestra in caso di incendio. Un’ossessione: lo capisco. Credo soffrisse la premonizione di una indovina. Anch’io sono stato male: una notte venne in reda-zione una chiromante. Lesse la mia mano: la fine era scritta, sui quaranta. L’ho fregata. Certo, avrebbe do-vuto dare una occhiata anche al palmo di Mussolini, che qualche decisione l’aveva presa per me. Non credo alle carte, altrimenti il solitario, quel gioco con il mazzo che combinava Napoleone, avrebbe dovuto avvertirlo non soltanto del sole di Austerlitz ma anche delle foschie di Waterloo. Eppure, raccontano, Calpurnia, la moglie di Cesare, vide, il giorno prima, spalancarsi d’un tratto le porte della camera da letto: nessun rumore, nessuna folata. Poi il volo di strani uccelli: erano quelli del malaugurio. Poi i pugnali. Ma lasciamo perdere i classici: Cicerone ha chiuso a sessantasette, Platone a settantatré. Per fortuna, io sono un contemporaneo. Ma anche l’incanto della fiaba è finito. Altri pro-digi. Braccio di Ferro, al servizio della pubblicità, mangia gli spinaci e diventa robustissimo, il pulcino Cali mero, nero e brutto, usa il detersivo e diventa bianco. Io non sono più candido e non so se, come il bimbo del Vestito dell’imperatore, ho sempre sbugiardato i corti-giani servili e ho gridato: “Il re è nudo”. Anche nei rac conti di Andersen cala sempre “la notte bianca e ge-lata” e porta con sé lo sgomento. I fantasmi fanno ri-brezzo. La ragazza che conobbi alla stazione di Cracovia sa lutava un mio giovane collega svizzero. Chi ha scritto: “Non mi piacciono le stazioni; sanno sempre di separa-zione”? Terribili, per me, sono i fanalini rossi dell’ul-timo vagone che si allontana nella notte. Parlava poco, ricordo, portava una borsa di plastica nera, lucida, un soprabito molto aderente, di quelli che non usano più, sulle labbra aveva un po’ di rossetto. I polsi erano segnati da due piccole cicatrici. L’avevano trovata svenuta nella camera che divideva con un’a mica, in una di quelle umide case dove i muri odorano di lisciva e di patate bollite. “Ci rivedremo” diceva il mio giovane collega. Lei lo ascoltava in silenzio, pareva distratta o as-sente: “Forse, se tornerai”. Difficile, pensavo, ma non è bello dire: “Mai più”. Si rivolse a me: “Lei che cosa ricorderà della Polo-nia?”. • Il suo volto e il vento, credo. E poi quella can zone che dice: “E un giorno come gli altri. Fuori fa buio e il lavandino sgocciola”. “è molto triste” disse. Non credo alle passioni o alle infinite, avventurose conquiste dei fotografi e degli inviati speciali: in fondo lo stesso Casanova ne conteggia 116 e Georges Sime-non, ma non c’è controllo, addirittura diecimila. Di si-curo esagerava. Pur calcolando le mercenarie. Penso invece alle figurette che compaiono anche per un attimo nell’albo color seppia dell’inevitabile rim pianto. Dice un proverbio cinese: “Anche una scintilla può dare fuoco alla prateria”. Una locanda sul mare del Nord. Il villaggio si chiama “Totendorf”; una volta trovarono sull’arenile i corpi gonfi di alcuni marinai, affogati nella tempesta. La Gasthaus di Frau Margot aveva un’insegna - “All’Oasi” - estremamente lontana dalla realtà: niente sole, palme, ma una spiaggia deserta, qualche capanno di vimini, onde grigie, cielo grigio e il maledetto mae strale e l’urlo dei gabbiani. La figlia dai grandi occhi chiari aveva imparato un successo di Modugno e can-tava: “Ciao, ciao, bambina!”. Mangiavo le anguille del Baltico e il prosciutto di Westfalia, e intanto ascoltavo le vicende di Frau Mar got e l’enorrne seno, con i sospiri, incombeva sempre più, mentre rievocava il passato: possedeva un’osteria in terra di Prussia, accanto al castello di un principe, e arrivavano per le cacce tanti signori che inseguivano i caprioli nel bosco o andavano ad aspettare il passo del gallo cedrone. Poi fu la guerra. La ragazza continuava a cantare: “Ciao, ciao, bam bina!”. Chissà se si scrive proprio così: Zsuzsa. Recitava al Teatro dell’Operetta di Budapest: era addirittura la soubrette. La incontrai a una conferenza: conosceva al-cuni italiani. In ungherese italiano si dice “OIasz”. Pos sedeva una Volkswagen, perché anche nei regimi co munisti apprezzano le belle gambe e i valzer di Kálmán o di Franz Lehár. Disse: “Non sei mai stato sul Balaton? Voglio mo-strarti la torre di Salomone”. Le barche avevano le vele ammainate, passeg giammo tra le erbe fradicie, in mezzo ai ruderi: non guardavo al paesaggio, ma a Zsuzsa, che mi dava la mano per farmi da guida e mi parlava del suo bam bino, e io le regalai la mia sciarpa. Non era ridicolo, al-lora. L’idea non è mia, è di un cinese, un certo Cheng: “Quello che è stato vissuto / sarà sognato. E ciò che è stato sognato / rivissuto”, ma a me pare che proprio il dottor Freud abbia detto che anche i sogni non sono mai innocenti. Mi è tornata in mente la signorina Albina: mia ma dre le aveva affittato una camera. Io avevo forse tredici anni; lei tanti, tanti di più. Sul comodino teneva la foto di un fidanzato, morto a Fiume, durante l’avventura di Gabriele d’Annunzio. Non so se ci fu poi qualcun altro. Mi pareva avesse la fronte bassa e tanti riccioli, come una parrucca. Lavorava alla manifattura tabacchi. La signorina Albina la domenica stava a letto di più. E prendeva sotto le coltri anche me e il mio fratellino. Ripenso al caldo del suo corpo, al tepore delle len zuola: c’è un odore del sonno? Ci raccontava delle storie, canticchiava buffí motivi: “Un giorno el re de China, / ghà perso l’ombrelin, / el ghà ciapà la piova, / se ghà bagnà el codin. / La moglie sua vedendolo / ch’el ghà el codin bagnà, / l’ha preso le forbisi / e glielo ghà tajà”. Non so perché se ne andò, ma non mi sembra che la mamma ne fosse scontenta. Mi piace una struggente canzone russa che recita: “Ti attendo, vento dell’infanzia, accarezzami ancora i capelli”. Ma è inutile inseguire immagini e rimpianti. Ho amato tanto la vita, ma non ho ancora capito cos’è. Quando ho avuto la sensazione del peccato? Padre Carlo ci preparava alla comunione. Era una piccola chiesa di un vecchio quartiere popolare. Le fiammelle delle candele illuminavano facce di santi incazzati; Gesù, con un dito, indicava il suo cuore sanguinante. Una fanciulla virtuosa, Agata, poi assurta alla gloria del paradiso e celebrata da un brutto quadro su un altare, esibiva, deposte su un vassoio, le ragioni del suo marti-rio: i pagani le avevano tagliato le mammelle. I suoi occhi erano rivolti al cielo, i nostri a quelle due tette sode che ogni tanto ci distraevano dalle mas-sime della dottrina. Padre Carlo in confessione mi chiese: “Hai mai vi sto donne nude?”. La domanda mi sorprese e mi sgomentò. Risposi di no; no, non mi toccavo. Fu dopo, quando mi mandarono a Rimini, alla Co-lonia della Decima Legio. Ospitava molti bambini di fa miglie bisognose e con le tonsille gonfie: allora di solito le strappavano, qualche volta il dottore diceva: “Ci vuole il mare”. Era come andare soldato: un addio alla casa e alle care abitudini, e avanti in fila per due. I vagoni del treno avevano i sedili di legno, le madri sui marciapiedi sventolavano i fazzoletti e piangevano. Eravamo tutti in divisa e nella valigetta la mamma aveva messo la biancheria con le mie iniziali ricamate con il filo rosso: “Non la perdere, è tutto quello che hai”. Le vigilatrici comandavano con modi energici e di-spettosi: bagno, dormire, passeggiata, gabinetto, merenda. Come in caserma. Vedevano le altre ragazze sulla spiaggia che scherzavano con i giovanotti e la sera si sentiva un’orchestra lontana; le bidelle inseguivano il motivo, canticchiavano: “Tango, per chi non sa l’a more, / tango sei come un laccio al cuore”. Soffrivano. Io ero molto triste, molto solo. Mia madre si era raccomandata: “Non dimenticare le orazioni”, ma mi veniva in mente la mia famiglia e faticavo a prendere sonno. Quel mese fu lunghissimo. Una domenica venne a trovarmi il babbo, con il treno popolare. Portava cami-cia, cravatta e giacca. Non si slacciò neppure il colletto, ci sedemmo in un angolo, dietro i capanni. Ci siamo sempre parlati poco. Aveva infilata in tasca una botti-glia di birra. “Hai sete?” mi domandò. Io mi vergognavo un poco; i miei compagni ci sta-vano osservando; mio padre era goffo, impacciato, così poco balneare, e dissi di no. “Sei contento?” mi chiedeva. “Vi divertite?” A me sarebbe piaciuto tornare a Bologna con lui, ma aveva pagato 120 lire per via delle adenoidi; sem-bra che l’acqua salata e lo iodio facciano bene, e gli rac-contai che avevo vinto la gara di corsa. Nella valigia c’era la medaglia, con il Duce con l’elmetto. Ecco: ricordo il mare che vedevo per la prima volta, era proprio come nelle cartoline; risento un acuto odore di marmellata di susine gelatinosa, l’ora della re fezione; e rivedo le due signorine assistenti che gioca vano, nude, nella doccia. La signorina Margherita, squadra Aquilotti, potrei disegnarla: aveva i denti radi, tanti riccioli biondi e due grosse tette. Non capivo perché le piacesse tanto fregarle furio-samente contro quelle piatte della signorina Cecilia, squadra Lupetti, che aveva la frangetta, era piccola, bruna e sospirava: “Mi fai morire”. I gabinetti erano senza porte, c’era una tabella an-che per quelle necessità: tutti insieme e sbrigarsi. Ero capitato nei bagni fuori orario e mi avevano incuriosito certi mugolii. Non capii tutto l’erotismo della situazione, mi sem-brò che la signorina Margherita si comportasse da pre potente; raccontai quello che avevo visto ad Aldro-vandi, il mio compagno, figlio del barbiere, che invece commentò con sicurezza: “Sono due grandi troie”. A me parve, oltre che irrispettoso, eccessivo: erano pur sempre le nostre maestre. Avevo quattordici anni quando mi resi conto dav vero delle donne, di come sono fatte e perché mi piac ciono. Facevo parte del coro del Teatro Comunale, sta-gione lirica: mio padre, nella Bohème, era Parpignol e guidava “il carretto tutto a fiorn. Odiavo Wagner, troppo lungo e quanto sonno: il Parsifal finiva all’una dopo mezzanotte, e al mattino c’era la scuola e io non volevo dire: “Signor professore, sono stanco, ma ieri sera facevo il paggio del cavaliere Parsifal, sempre alla ricerca del Graal che, mi hanno spiegato, è il ca}ice usato da Gesù durante l’ultima cena. Mi scuso, ma l’inchiesta è stata assai complicata”. C’era, naturalmente, un corpo di ballo: nella me moria mi sembra che le ragazze fossero tutte platinate e tutte triestine. Ridevano sempre. Noi ragazzi, negli intervalli, ci piazzavamo dietro le casse di costumi e spiavamo la sala dove si truccavano. Mi è rimasto impresso un gesto: si incipriavano con cura il seno e le ascelle. Bellissime. Erano tutte bianche, le tuniche di veli, la pelle can dida e spesso in testa portavano un diadema. Come le fate. Meglio, pensai. Non ricordo in quale parte del mondo, ma lessi in una mattonella, fissata nel muro di un antico convento, credo a Ipat’ev, questa massima: “Quando una cosa muore un’altra nasce”. Una volta a Bombay conversai con un vecchio ((parsi”: c’è un posto dove esponevano alla voracità dei corvi i cadaveri. Si chiama “Torre del silenzio”; sostitui sce, in qualche modo, le imprese di pompe funebri. Dallo sterco degli uccellacci, mi spiegò, nasce un fiore, dal fiore un seme e basta anche un po’ di brezza a portarlo in un solco; e anche i vermi hanno una storia, e così le mosche e i lombrichi. La mia vicenda volge all’epilogo. Carl Gustav Jung parla di una svolta: quando arriva il momento in cui si comincia a pensare al finale? Dante a trentacinque anni tenta il primo bilancio; la vita si è allungata: Woody Allen a quaranta: “Delle idee bizzarre mi passano per la testa e credo di attraver sare una crisi o qualcosa del genere”. Rossini, nello stesso momento, smette di comporre. Ha chiuso. Che cosa accade? I capelli cominciano a cadere, la vista cala, ammaina anche la sensualità. Il Vangelo parla del “demone meridiano”: certe tentazioni sono, più che altro, insidiose; una ribellione per la giovinezza al tramonto. Qualcuno teorizza il fascino delle “volpi grigie”: ma via... Si comincia a pensare alla morte. Per tre volte sono entrato in sala operatoria: cuore. Lo sfarfallio di una lampada che diffonde una luce crudele, poi più nulla. Deve essere più o meno così. L’attrice che era stata bellissima e famosa mi disse: “C’è l’angoscia della memoria che se ne va: quel nome, quel giorno, quando? E un inseguimento, ma io voglio farmi compagnia e avrò sempre un progetto, fino all’ul timo. Perché ho sempre viaggiato nel presente”. “Quanti anni ha?” domandò un giornalista sciocco al comico che ormai non faceva più ridere. Risposta: “Non ne ho più”. E accaduto tutto, e molto in fretta. Ieri: come è vi cino. Ritrovo i profumi dell’adolescenza: le rose del mese di maggio, le litanie la sera, i grembiuli a qua dretti azzurri delle ragazzine, che lasciano intravedere le piccole poppe dure. La Madonna schiaccia la testa del serpente. All’uscita della parrocchia, che corse. An-che il sudore è eccitante. Il caldo del loggione, l’incanto del palcoscenico. Memo Benassi, una sera, nel monologo di Amleto, “Es sere o non essere?”, piazza una pausa e una fischiatina. Del resto, c’è qualche altra alternativa? Un personaggio, ho ancora chiara la battuta, af-ferma: “Come è duro, come è amaro diventare uomini”. Crescevamo: che fatica. E che ne sarà stato della piccola soubrette Silvana KoMer che interpretava parti trascurabili nella compagnia di operette “Poker d’assi”? Mi piaceva, era fragile e gentile, qualcuno mi disse che da vecchia aveva un negozio di giocattoli, mentre la pri-madonna incantava il mio amico Giancarlo perché, di ceva, “ha due cosce come i cavalli di Gondrand”. Scherzi dei ricordi, basta un raggio di luce, un colpo di vento, ed emergono dalla nebbia: uno squarcio biz-zarro su un paesaggio sfumato. E vero che la memoria è un filtro, e forse noi, ma-gari per difesa, e in buonafede, accettiamo certi fatti o li respingiamo. Vorrei essere leale con me stesso. Non ingannarmi, non ingannare. Ormai il mio mondo è il passato. Sono quello che ho detestato, fatto, amato. Ma quando è il momento in cui si avverte che ci sarà ormai soltanto una stagione, e che la calda, clamo rosa estate è finita? Quando è che il silenzio fa più paura delle grida? Nei diari di uno scrittore che amo, lo strano catto lico Georges Bernanos, si legge: “Comincio a invec chiare e vorrei anch’io prepararmi a morire”. E quello che mi disse un sacerdote che si ritirò nel deserto: fui stupido e mi dimenticai di chiedergli se aveva paura. Ma forse c’era in lui la tranquilla certezza che Dio esiste. E andata così. L’orologio segna ore diverse. La vec-chiaia raggiunse il campione del ciclismo, detto anche “la Locomotiva umana”, alle 17 e 12 precise del 6 giugno 1948. Fu alla seconda curva del Falzarego: si voltò per un attimo e vide che lo stava raggiungendo “la Pulce dei Pirenei”. Era un contadino dalla faccia rugosa, un torace esiguo, due gambette muscolose, ma niente al-tro: uno straccio. Il campione non voleva arrendersi a quell’ometto che aveva lucidi solo gli occhi: spingeva, ma sentiva un incredibile peso sulle spalle. Anzi: gli sembrava di so gnare. Sai, quando devi fuggire, perché l’assassino ti in segue, ma le gambe sono bloccate, sprofondano, come quelle degli evasi della Guyana nei film, quando arri-vano alle paludi. Li accompagna l’angoscia e il fischio tristissimo di un uccello tra le canne. Il campione non capiva perché: sembrava una gior-nata come tante altre, la stampa lo dava favorito, i tec nici gli accordavano anche un arrivo con distacco. Ci fu, infatti, ma sbagliarono il nome del primo. Il cuore, come aveva letto in un libro, gli batteva davvero in gola. Cosa era cambiato? Aveva anche dormito bene e l’abbondante colazione non gli pesava sullo stomaco: solito riso in brodo, pollo bollito, frutta cotta (per via dell’intestino), spremuta, una bistecca, anche un bic-chiere di vino rosso. Il cieco che lo massaggiava non disse nulla; eppure lo conosceva tanto bene che si accorgeva perfino se “la Locomotiva” sbuffava per qualche oscuro pensiero. Gli aveva anche ordinato di pisciare nel lavandino: nessuna traccia di sangue per quel fastidioso disturbo. Vinse ancora qualche corsa, poi lo invitavano alle feste paesane, ospite d’onore, ma una volta pianse leg gendo una cronaca: il suo nome era sbagliato. La famosa attrice drammatica aveva goduto anche delle attenzioni di Gabriele d’Annunzio; non si capì mai se gliela aveva mollata. Diceva che era tormentata da un dramrna: “Scelgo l’uomo o il poeta?”. Recitava Lafglia di Iorio, Lafaccola sotto il moggio, specialmente d’estate. E dal Vittoriale le arrivavano messi e doni; più tardi, quando il bisogno fu più forte dell’umana vanità, mandò quelle creazioni di un “Ma-stro orafo”, come diceva l’Imaginifico, al Monte dei pe gni. Quei gioielli, testimonianza della sua arte e forse un po’ - ma non si è mai chiarito - della sua condiscen denza, erano falsi. Ma non fu l’umiliazione più atroce. Restò bella a lungo: qualche ruga sul collo, ma le nascondeva con le collane strepitose di Gabriele. Un po’ più molle, un po’ più larga, forse aveva perduto quello che un attento cri-tico drammatico chiamava “lo sguardo sbottonatore”. Le tette sembravano ancora sontuose e le cosce tiepide. Cercava lavoro e andò a trovare l’impresario che l’aveva, un tempo, tanto corteggiata. Ebbe molta difficoltà per fissare l’appuntamento, il dottore era quasi sempre in riunione o fuori stanza. E pensare che una volta le era saltato addosso perfino so-pra la scrivania e a lei dispiacque un po’ per le calze. Fu gentile ma, come al solito, esplicito: “Cara, non me lo fai più tirare. Ti darò una parte da madre”. Il maggiore Canu era un rispettato cliente del Caffè del Pavaglione. Prendeva il solito espresso con il bic chier d’acqua, leggeva il solito giornale. Dicevano che scriveva poesie, ma nessuno le aveva lette. “Dopo la mia morte” spiegava con un sorriso che lasciava inten dere: “Ve ne accorgerete”. Il maggiore Canu si avvicinava ai sessanta, ma ben portati. Magro, scattante, baffetti scuri appena velati da un filo di bianco, occhi orientali. Conobbe la vedova Stupazzoni in latteria; una bella donna, fresca, sana e abbondante, dai modi espliciti: si capiva subito che aveva scarsa inclinazione per l’amore platonico. Il maggiore Canu invece era un sentimentale, e in più timido: faceva ancora il baciamano, le regalò delle violette, poi scoprì che la signora preferiva i cioccolatini alla crema; si fece avanti con un libro di versi di Pré-vert; pensò: li capisce anche lei, ma ebbe più successo un fazzoletto di seta decorato con staffe e cavalli. Insomma: combinarono. “A casa mia;” disse la ve dova Stupazzoni “smonto dal turno delle otto.” Il maggiore era molto emozionato; la desiderava tanto. Andò anche dal parrucchiere, comperò una bot-tiglietta di profumo “Soir de Paris”. Un pensierino. In dossò l’abito borghese, che gli stava stretto, ma non vo-leva che l’incontro avesse il crisma dell’ufficialità. La signora aspettava in vestaglia. Aveva anche pre-parato il caffè e messo in mostra la bottiglia del Fernet. Il cuore del maggiore Canu galoppava all’impazzata; vi-brava tutto, baffi, ciglia, ma anche l’intestino. La ve-dova invece sorrideva: “Fai con calma, spogliati; ti aspetto di là, in camera”. Il maggiore si guardò attorno: non aveva neppure osservato l’ambiente. C’erano alcune litografie con scene del melodrarnma, qualche ricordo di escursioni turistiche: gondoline, palle di vetro con nevicata incor-porata su un paesaggio montano, roba del genere, e una fotografia, in una cornice dorata, di un gigante dalla fronte bassa ma dal torace possente: il defunto. Mente di intellettuale. “Uno stracciaculo qualsiasi” pensò il maggiore. Era nudo ma con i calzini: aveva buttato la bianche-ria alla rinfusa sul sofà. Guardò ancora una volta i pe-dalini: aveva l’ossessione dei buchi. Entrò nella stanza: la vedova era sdraiata, a gambe aperte e lo aspettava: “Vieni, caro”. Lo colpì quella foresta di pelo nero, lei si girò con malizia per mostrare anche la schiena e intanto gioche-rellava con i capezzoli. Il maggiore Canu sudava e l’intestino prese il so-pravvento anche sul cuore e si scatenò un’irrefrenabile tempesta. La vedova, che non perdeva mai il senso della realtà, si alzò per aprire la finestra; si infilò la vestaglia e disse: “Amore, devi andare a cagare a casa tua”. La storia flni poi, non si sa come, ai tavolini del Pa-vaglione e il maggiore Canu traslocò per qualche tempo al Caffè dei Cacciatori. Quando il discorso degli amici finiva inesorabilmente sulle avventure amorose non riusciva a nascondere il fastidio. Basta anche poco per distruggere sentimenti e desiderio. Il grande manager aveva dedicato la vita all’a-zienda. Era quello che si dice “un duro”. Dormiva in una brandina da campo - eredità del passato militare - come il maresciallo Radetzky, spiegava, perché conce piva l’esistenza alla stregua di una compagnia di fanti: chi comanda, chi obbedisce. Portava perfino braghe strette, da cavallerizzo, ed era convinto che il dipen dente non deve pensare; per lui provvede il superiore. Non era cattivo ma la sua testa funzionava così. Per mezzo secolo fu sempre il primo a passare i cancelli della fabbrica: che non considerava dei padroni, ma sua. L’aveva fatta lui con i loro soldi, ma soprattutto con il suo lavoro, con le sue idee e anche con qualche trucco vergognoso: ma quello che conta è il fatturato. Non diciamo sciocchezze: il profitto. Non andava mai in vacanza, neppure per Ferrago-sto e neppure a Natale: che erano, tuttavia, per il grande manager una occasione di indicibile gioia. Finalmente solo: andava in giro per i reparti, acca-rezzava le macchine, accendeva le luci, prendeva ap punti, gli sarebbe anche piaciuto far scattare la sirena, ma non osava; quando usciva, regalava diecimila lire al guardiano di turno e ripeteva la solita frase: “Oggi siamo in pochi”. Non sapevano come fargli capire che il suo lungo momento era finito. I padroni non volevano parlargli o scrivergli: era lui che dopo la guerra aveva salvato l’im-presa. Li aveva visti bambini, era anche intervenuto quando si erano trovati nei guai, magari per qualche ragazza. Ci pensò senza turbamenti il capo del personale; il grande manager lo aveva assunto e diceva compiaciuto: “Ha carattere. Mi assomiglia”. Lo dimostrò. Diede ordine di staccare tutti i fili dall’ufficio del vecchio: suonava il campanello, ma non si presentava nessuno. Insisteva: niente segretaria, niente usciere. Neppure il telefono funzionava e una sera non si accese neanche la luce. Restò al buio, solo, con gli occhi chiusi. Ascoltò le voci degli operai che uscivano. Prese la borsa e si alzò. Morì di niente, disse il grande clinico che lo curava, non aveva un male preciso. Ai funerali c’erano tutti i rappresentanti della proprietà: era agosto, ma non ri-nunciarono all’abito scuro e alla cravatta nera. Come inviato speciale aveva visto tutto: trarme la possibile fine di un famoso corrispondente. Aveva guadagnato molto e speso tutto; si era inva-ghito di una squisita intellettuale, e per lei vendette an-che i ricchi poderi che gli aveva lasciati la madre, tante biolche di buona terra segnata dai pioppi e dagli olmi nella pianura padana. Voleva che perfino il colore del-l’automobile si intonasse agli occhi della signora, che erano di un pervinca intenso. Ormai viveva della pensione (modesta perché aveva largheggiato in anticipi, e tutto gli sembrava non abbastanza bello per la sua donna) e con l’aiuto di qual-che collaborazione. Doveva misurarsi: rinunciò al whi sky, ad esempio, e passò al più economico “ameri-cano”. Non c’era stato fatto del secolo che non lo avesse trovato sul posto: le rivoluzioni gli riuscivano meglio delle guerre ed era imbattibile nei matrimoni. Quando descriveva i corredi e i doni che riceveva la sposa era insuperabile. Sui bambini morti, invece, doveva cedere il passo: non faccio nomi, ma B. era più forte. Riciclava più che altro ricordi: ma ne aveva tanti. Un brutto giorno la sua testa andò in tilt. “Devo partire per Gibuti”, si mise a urlare, e cominciò a tirar giù le valigie. “Non dimenticare come l’ultima volta il frustino,” sgridava la cameriera “penso che dovrò andare molto a cavallo.” Lo lasciavano fare; preparava i soliti quadernetti per gli appunti, i blocchi di stenografia: due cartelline scritte a mano diventavano una pagina a macchina. E il dizionario dei sinonimi: odiava le ripetizioni. Poi la borsetta con le medicine: c’era di tutto, con tro la malaria, il morso del serpente, la dissenteria. “Mai verdure crude e acqua solo per la barba” ripe-teva. Poi si calmava. Fissava con sguardo apparmato gli oggettini sparsi tra i libri: “Io sono come i capitani di lungo corso, conosco le taverne e le puttane di tutti i porti” diceva. “So perfino come sono vestite le languide ragazze della Louisiana: di mussolina; quelle bionde del mare del Nord, calze e sottoveste nere, perché esaltano le cosce maestose come quelle di Marlene. O le sgual drinelle con gli abiti di organza celeste di Cartagena.” “Una noche con tigo, a Cartagena” diceva la canzone. C’era un corno di bue: glielo avevano regalato in Georgia, patria di Stalin. Serviva per i brindisi. Un piccolo busto in bronzo di Majakovskij: aveva conosciuto Lili Brik, la passione del poeta. Due minuscole ampol-line di cristallo, per l’olio e l’aceto: erano tra i giochi di una sorellina morta bambina. Una tavoletta di oroscopi cinesi, con i segni del destino: la signora di Pechino, chissà se c’era anche il suo. Un cavallino di marmo, dono di un allevatore di purosangue arabi, un antico scarabeo inciso nella pietra, era in Egitto quando si am mazzavano con gli ebrei, glielo aveva regalato un foto grafo, chissà dove era stato rubato. Dicono che porta fortuna. Poi c’era una fotografia di lui piccolo stampata su cartoncino color seppia: sua madre sfoggiava un enorme cappello, con mazzetti di fiori sull’ala, e una povera volpe spelacchiata sulle spalle; il padre aveva gli occhi da matto, forse colpa del lampo di magnesio. Lui, faccina rotonda, frangetta, occhi che stanno per pian-gere, rivelava già l’aria smarrita di chi dalla vita non si aspetta niente di buono. Ogni mattina, dunque, il famoso inviato speciale si metteva al tavolo e dava lo stesso ordine: “Non voglio essere disturbato. Devo lavorare”. Si sentiva il picchiettio della portatile; poi silenzio. Erano parole senza senso, ma allineate con ordine e perfino intercalate da qualche citazione, o da massime, o forse addirittura da sue invenzioni. “Che forma avrà Dio?” legge esterrefatto il primo redattore che intra-vede la crisi. “Probabilmente ovale.” E ancora: “La morte tanto difficile e tanto facile”. E dopo: “Non si viene sulla terra per vivere”. E poi: “Pian-gono anche i topi?”. Chiudeva il suo scritto in una busta, con cura, l’indi rizzo era giusto, la raccomandazione la solita: “Subito, all’ufficio romano. Lo aspettano”. Ogni mattina apriva il giornale e cercava l’articolo che nessuno aveva trasmesso. Così, fino all’ultimo. Mi mandarono a intervistare il tenore: non c’era ag gettivo per definirlo. Uno dice: tenore; e basta così. Passava i giorni ad ascoltare la registrazione del suo ultimo concerto, a Parigi. Rimetteva il disco, più volte, da quando scoppiava l’applauso finale - un uragano - e in quel momento le lacrime gli bagnavano la faccia sconvolta. Perché era anche stato bellissimo. Quante recite di Otello? Forse trecento, forse più. Aveva guadagnato molto, conosceva il mondo, po teva descrivere l’entrata degli artisti della Scala, del Metropolitan, del Colón, dell’Opera di Berlino, del Ly ceum di Barcellona. Aveva litigato con la divina Callas: al momento di raccogliere i tributi calorosi della platea, si scambiavano calci e insulti. E scomodo dover spartire la gloria. Mi raccontò, come è ovvio, della carriera: la leg-genda vuole che, di solito, comincino in chiesa, lui invece fu scoperto da un colonnello che amava la musica, quando era militare. Sfogliammo insieme il solito libro di ritagli ingialliti; io gli dissi: “Ho conosciuto un soprano, una vecchia dama, che si chiamava Borghi Mamo ed era stata, fan ciulla, sulle ginocchia di Rossini. Conservava una spi-netta del maestro”. Mi mostrò, come cimelio, il suo fastoso costume per l’Otello: “Voglio che me lo mettano quando me ne andrò”. Era malato, e senza illusioni. Il volto che fu bellis simo pareva segnato da invisibili rughe e soprattutto dal dolore. “Vorrei cantare ancora una volta e poi morire” disse mentre mi accompagnava al cancello. Era, oltretutto, un giorno d’autunno. Scrivo solo il suo nome, ma no; lo invento: Gia-como. Imbattibile nei ruoli comici. Quello che la gente chiama “un simpaticone”. La parte dell’ottimista era la sua, non solo nei film o in palcoscenico, anche nella vita. Era rimasto vedovo e già si avviava a quella che oggi si chiama, per gentilezza, “la terza età”. Nessuno sa che cosa ci aspetta nella quarta. Aveva conosciuto a Cinecittà una ballerina vien-nese. Dolcissima e con gambe che suggerivano l’idea della Provvidenza: infmite. Gisela, mi pare. Si giustificava, con colorito linguaggio meridionale, rispondendo a presunte riserve che nessuno peraltro osava manifestare: “Meglio una torta in due che una merda da solo”. Ricordava la Bibbia: i patriarchi si riscaldano por tandosi a letto giovani donne. Pare che certi impacchi favoriscano la circolazione. Fu fregato da una paralisi che lo condannò alla car-rozzina. Bloccati i movimenti, non le voglie. Diceva alla moglie: “Io ti aiuterò a vivere, tu mi aiuterai a morire”. La pregava di spogliarsi: “Più adagio e guardami” sospirava. Lei obbediva: ogni sera lo stesso spettacolo. Poi an dava nella sua stanza a piangere. Ma lui era diventato sospettoso e la gelosia lo tor mentava. Quando suonava alla porta il controllore della luce o del gas, il postino del telegrafo, la signora doveva andare ad aprire cantando. “Voglio sentirti” or dinava. Gisela non usciva mai; credo che gli rimase fe-dele. Il commediografo era finito in archivio; l’editore non aveva trovato niente di meglio per il vecchio amico. Doveva riordinare le fotografie, quelle che non avevano didascalia, con facce che le impiegate non riu scivano a identificare. Era quasi infallibile: “Questo seno sontuoso” il suo linguaggio era sempre compito “appartiene a Letizia Bonini. Fece compagnia con Corrado Racca, un buon attore. Questo signore dall’aria fiera è Michele Bianchi, quadrumviro, fu amico di LydiaJohnson, chanteuse”. “Che cosa vuol dire quadrumviro?” gli chiedevano. “Uno dei quattro capoccioni fascisti che portarono le camicie nere a Roma. Il più simpatico era Italo Balbo: un matto.” Non disse mai che lo avevano rappresentato anche a Berlino e a Praga; che era citato da Benedetto Croce, che aveva redatto la critica teatrale nella più autorevole rivista dello spettacolo. Era perfino commendatore. Si considerava un sopravvissuto; spiegava: “Si scrive sempre lo stesso articolo, la stessa commedia. Non vo-glio essere uno di quelli che sono morti, ma nessuno osa dirglielo”. Un giorno una ragazza gli corse incontro festosa, mostrandogli una istantanea che lo ritraeva accanto a Pirandello: “Ma com’era magro!”. La guardò per un istante: “Sono stato qualcuno”. Mia madre non era illustre, non era nota: per me diventò vecchia la mattina del 28 ottobre 1942, alle 4 del mattino, quando mio padre chiuse gli occhi in una corsia d’ospedale. Aveva quarantacinque anni; si vestì di nero e non smise più perché nella nostra famiglia accaddero tante disgrazie: non solo il solito cancro e il consueto ictus, ma anche una fucilazione. Ora rni vergogno: ho capito tardi che era una donna che poteva ancora vivere, con il desiderio di un compagno, con la speranza di un incontro, che so. Ho letto nel diario di una giovane ebrea finita ad Auschwitz: “Vorrei potere condividere il mio spazzolino da denti con lui”. Ma è vero che i minuti ci passano so-pra come anni e non c’è rimedio. E se percorro la galle-ria dell’esistenza, quanti personaggi, quanti quadri in completi o appena sfumati dal tempo. Foto di gruppo in tuta da ginnastica: una qualun que Terza B. Diciotto, diciannove anni. Prima della guerra. Posso ricostruire il registro quasi completo; un dubbio: Muller o Moller? Finì, dopo l’8 settembre, con i tedeschi. Forse lo decise il cognome. Era alto, forte, bravissimo in tutto, anche in atletica: la madre un don-none berlinese che si tingeva, allora, i capelli color pla tino e raccontava di aver affrontato sette o otto aborti prima che il ragazzo Muller o Moller riuscisse a sfuggire alla inesorabile clinica. Forse una svista. Il padre era rappresentante di una ditta che produ-ceva polvere per fare i budini. Quando andavo a stu-diare da quello strano compagno era una festa. Diffon-deva un senso di sicurezza. E che spanciate. Non so come gli è andata. Numero uno: Albertazzi Gino. Bravissimo in tede-sco. Sapeva a memoria anche le canzoni di Marlene Dietrich. Una comincia: “Ich habe eine Koffer in Ber-lin”; ho una valigia laggiù. Andò volontario in Russia, ufficiale di collegarnento con la Wehrmacht, per via della lingua. Deve essere rimasto dalle parti di Stalin grado. Andai una volta a trovare la madre; aveva conser vato tutto di Gino. Libri, vestiti, qualche disco. Sulla porta della camera da letto c’era un cartello: “Stanza dell’Eroe”. Poi una fila di fotografie: Gino sul vaso; con la spiegazione: “L’Eroe a undici mesi”; Gino con il grembiule scolastico: “L’Eroe a sei anni”; con i panta loni alla zuava: “l’Eroe all’esame di maturità”; una ac canto a una ragazza dalle gambe grosse, a cui era stata cancellata la faccia; e una sola parola: “L’Eroe”. Mi disse la signora Albertazzi: “Si è risposata”. Antonioli Vincenzo: tornò, invece. Morì nel 1945 l’ultima notte dell’anno, durante un veglione. Uno stu-pido osso di pollo gli si infilò in gola e non ci fu niente da fare. Siccome era un burlone, e faceva sempre le imita zioni, non si accorsero subito che stava soffocando. Qualcuno rideva. Pensavano che fosse un nuovo “nu mero”, quello del balbuziente. Bandini Giovanni. Alleva castori sull’Appennino, vi cino al fiume. Ci siamo incontrati una volta in treno. Mi disse: “Niente figli”, e non capii come era andata con la moglie. Disse solo: “Di notte non si sta bene da soli”. Mi parlò dei suoi animali: “Non hai un’idea di come costruiscono le loro tane nell’acqua per difendersi dai l predatori. Ho capito la lezione. Ho fatto così anch’io”. Ho saputo che adesso vive con una polacca; l’ha co nosciuta a Bellaria a un convegno di allevatori. Costa, cancro, Danti anche, Fantoni - biondo, sim patico, bello, abbastanza ricco, scapolo - suicida. Nessuna spiegazione. Era coraggioso e amava la montagna e le esplorazioni. Conservo una statuetta maya: affrontò non so più quale foresta, villaggio o cima dello Yucatán. Trovarono solo un biglietto con un nome, Maria, e una frase, non si capisce se gli era rimasta in testa da una scoperta dei suoi lunghi viaggi; diceva: “Il fiume non può cambiare il suo corso; gli argini lo conducono verso il suo mare”. Galli Vincenzo era figlio di un sarto; l’eleganza ce l’ha nel sangue, dicevano. Indossava anche gilè stram palati che suo padre confezionava con i campioni di tessuto multicolori che gli mandavano le ditte. Doveva accompagnare la figlia all’altare e si fece confezionare un tight. Lo aveva sempre desiderato. Con quello lo seppellirono. Mi sembra di riscrivere Il ponte di San Luis Rey, un romanzo di Thornton Wilder: magari. Solo una piccola analogia: racconta la storia di una carrozza che preci pita in un fiume e del destino dei viaggiatori. Già: chi erano? La mia è una sosta sul cavalcavia. Tra i ragazzi di al lora c’è anche chi è stato ucciso da un fascista o da un partigiano: ci fu un lungo momento in cui si usava. Uno venne impiccato con il filo di ferro, ai cancelli dei giar-dini pubblici, perché tutti vedessero; l’altro venne fuci lato per la stessa ragione, ma in piazza. Durante il macello c’è sempre chi si sente più umano e razionalizza la morte: quando scoppia il Ter-rore il dottor Guillotin inventa uno strumento comodo e pratico che taglia le teste in un colpo. Niente dolore. Più tardi, colpo alla nuca o camera a gas. Dolcemente. Hanno appena proclamato i Diritti dell’Uomo, che subito se li mangiano. Di regola così succede con gli apostoli della felicità per tutti. Cambiano costumi e calendari e lanciano la parola “rivoluzione”. Il giorno di santa Cecilia diventa giorno della rapa, quello dedicato a santa Caterina viene desti-nato al maiale. L’ape regina si adegua: ape ovaiola. Non c’era forse la festa della “madre e del fanciullo”? E quella del pane? Gennaio diventa nevoso; e quando cade la nebbia siamo in brumaio. Quelli che si chiamano Luigi, accidenti al re, diventano Bruto o Spartaco. C’è anche qual-che innocente che deve rispondere quando sente chia-mare Rabarbaro o Costituzione. Niente più “madame” o “monsieur”: ma cittadina, cittadino. Più tardi compa gno, camerata. Niente lettere con il finale “vostro obbligatissimo”, ma “salut et fraternité”. Poi “saluti camerateschi” o an che “Heil Hitler”. C’è sempre stato un modello di abbigliamento per il contestatore: dai “sans culottes”, niente brache corte, all’eskimo. Con il passar del tempo si perde il senso della mera-viglia, dello stupore. Credo di avere assistito a tutto, o quasi. Quando erano di moda le camicie nere, imper-versavano in Romagna gli Ardito e i Labaro, i figli gli anarchici li denunciavano come Fiero e Ordigno, quelli dei repubblicani si chiamavano Ellero, tra i socialisti cir-colavano perfino Oriente e Vindice. Succede dappertutto. In Cina ho incontrato altri in-felici che scontavano le colpe dei padri: un “Conquista-tore spaziale”, ad esempio, e un “Impareggiabile sol-dato rosso”. Ho vissuto in un mondo saturo di violenza e di morte. Il peggio è quando arriva a cavallo dei grandi ideali: non è pietosa. Meglio, credo, l’incidente stra-dale, meglio la storia di Zani Filippo - era formidabile in matematica, nel calcolo - che aveva sposato Can-dida. Una passione: “E materna a cena” confidava con orgoglio “e focosa a letto”. Fu in montagna: una spinta. Si era convinta che lui la tradiva con la figlia della portinaia che d’estate an-dava a stirargli le camicie e a sistemare la stanza. Non era vero. Si può morire per un capello biondo su una giacca scura. Filippo, raccontò poi lei ai giudici, preci pitò urlando: “Ma perché?”. E uscita di recente dal carcere per buona condotta: tutte le domeniche sale su un tram e va a portare una rosa sulla lapide di Filippo Zani 1920-1956. Qualcuno mi sa spiegare che cosa c’è dentro di noi? Qualche volta ci ritrovavamo per ricordare cinque, dieci, vent’anni dalla maturità. Da tempo nessuno si fa più vivo. Non si radunano fantasmi, basta con gli ap pelli. I fascisti, ai funerali, rispondevano: “Presente!”. Che trovata stravagante. La cena era una specie di radiografia collettiva, con un bilancio fallimentare: guarda come siamo ridotti. E in più serpeggiava anche qualche rancore: “Che car riera ha fatto quel fesso che non sapeva risolvere nep pure un’equazione”. Poi la litania del “Ti ricordi?”, con la rievocazione di episodi ritenuti degni di memoria imperitura. Purtroppo, mancava sempre qualche protagonista. Quella volta che invece che alle consuete lezioni di cultura militare e di religione andammo in quattro o cinque in pellegrinaggio a San Luca, con alcune “ra gazze” di via San Marcellino. Del gruppo facevano sem pre parte una Mary, una Luana, perfino una Strana: erano gentili e disponibili con i “signorini”, come li chiamava la signora Mandibola, proprietaria del rino mato locale. La gita le aveva stordite: il mattino insolito - of fIimmo il caffellatte con la ciambella -, l’odore di fieno appena tagliato, quello di incenso, di olio di pavimenti, di ceri che si consumavano e dei corpi accaldati nella basilica forse le turbavano. Ci fu solo un tentativo di corteggiamento realistico, ma sembravano collegiali in vacanza, pregarono con devozione, accesero molte can-dele. Senza trucco, avevano le facce paUide di chi non è abituato all’aria e alla sveglia di buon’ora. Comparve un prete per la benedizione con la vene-rata Madonna, che ha lo sguardo stupito delle conta dine orientali, e rivolse parole di circostanza al grup petto dei giovani devoti saliti al sacro colle. “Siate sem-pre buoni come oggi” concluse. E le signorine di via San Marcellino erano com-mosse e dovettero ricorrere al portacipria e al rossetto. “Che tempi” diceva qualcuno rievocando con un sospiro. La normalità, come è noto, non si presta al rac-conto. Ma il mio amico dottor Zucchini aveva, per fare un caso, un ottimo posto in banca, un figlio che fre-quentava l’Accademia di Modena, era proprietario di un appartamento in città e di uno a Riccione. Si abbandonò, ricordo, a qualche confidenza: “Ci insegnavano che Muzio Scevola, quel fesso che metteva un braccio nel caldano, era un eroe”. Che lo era Enrico Toti, bersagliere ciclista senza una gamba, che andava a fare la guerra solo per lanciare la stampella, che del resto gli aveva sempre dato noia, contro il nemico. “Io sono un prode: trentasette anni a uno sportello, sole, pioggia o neve non importa, a contare banconote e a mettere timbri. “Poi hanno scoperto che non sono una macchinetta e mi hanno passato all’”Ufficio sofferenze”, lo chia mano proprio così, senza ironia. Inseguo le cambiali non pagate.” Ridevamo, ma non tanto, del passato, del ragazzo che fummo. Dei piccoli giochi delle tenerezze: la com pagna con la quale andavamo a ripetizione di algebra, la Ketty, indossava sempre maglioni candidi che cele bravano la sua grazia e quando si chinava per indicarti una pagina, e ti sfiorava la spalla, ti dava un brivido. Io non ho mai osato prenderle una mano. “Ce la siamo lasciata scappare,” diceva Vitale Al berto “sta in America. Ha sposato un “liberatore”.” Vitale Alberto ha combattuto con la Xa Mas, con quelli di Salò; non volevo discutere con lui, che del re sto è una brava persona. Pareva che tra noi fosse il solo ad avere il senso dell’onore. Ha anche una protesi in una gamba: una pallottola partigiana. Ma non celebrava il sacrificio, perché per fortuna odiava quelli che chiamava “i compromessi”, ma anche la retorica. Tirò fuori dal portafogli una foto che mostrò solo a me, e con soddisfazione: una prova ulteriore che il suo culto della virilità di discendente dei romani non era proprio sprecato. Una donna nuda, le gambe accavallate, le mani die-tro la testa che valorizzavano certi particolari: il volto era nascosto da un mare di capelli. “Ventidue anni” fu il suo commento. E aggiunse: “Laureata in lettere classiche”. Voleva in qualche modo giustificarsi: “Una volta di-cevano: ti amerò per tutta la vita. Ma a quaranta ave vano chiuso. E poi Dio, l’ho letto su Famiglia crzstiana, non ci chiede di castrarci per evitare il peccato contro il sesto comandamento”. Smisi presto di andare a quelle “riunioni conviviali” o “agapi fraterne” o “ranci camerateschi”, dipende dai momenti che si trascinavano nella notte. Sotto i portici deserti echeggiava solo il mio passo e quello di Cesare, il mio vecchio compagno di banco. Ci abbandonavamo a quei discorsi che sanno della nostalgia del tempo vis suto e del poco che rimane. Dicevamo: “C’erano ancora i tram che facevano scintille. Le lucciole. Le venditrici di carrube, di lupini, di semi di zucca. In ogni casa c’era il macinino da caffè, la macchina da cucire Singer, poi arrivò per i più ricchi la radio. Facevamo i “fioretti”: niente gelati”. “Nei paesi arrivavano tre giornali: il prete, il dot-tore, il benestante del posto. “Si mangiava il pancotto, il castagnaccio, l’insalata condita con la pancetta fritta: l’olio costava troppo. C’e rano i poveri. C’erano lo spazzacamino, l’arrotino, l’im-pagliatore di seggiole. La verginità e i casini. La Patria. La Marcia funebre di Chopin accompagnava, suonata dalla banda, i funerali dei pompieri vittime del dovere e dei generali in pensione. “Con una lira si andava a teatro, in loggione, e al ci-nema: doppio programma e, qualche volta, anche nu-meri di varietà. In prima fila si poteva anche vedere il pelo della contorsionista quando faceva la spaccata. “Il Duce aveva sempre ragione. Alla premilitare in segnavano quell’inno che dice: “Bei fanti di Savoia, gri-date evviva il Re”. Anche i mendicanti avevano un certo stile, una divisa con le toppe. C’erano i suonatori che andavano in giro con un organetto di Berberia e una scimmia che aveva in testa un ridicolo cappellino. Suonavano Tripoli, bel suol d’amore e Ramona. “Arrivava ogni tanto un circo: ne vidi uno con cento leoni, tedesco, e il proprietario era il capitano Schneider. Sul pennone per la prima volta sventolava una bandiera con la croce uncinata. Fallì a Napoli; ven-devano un leoncino per cinquanta lire. Qualcuno li prese come simbolo dell’impero; al Littoriale, a Bolo-gna, si accontentarono di due aquile catturate da un mio zio e dalla guardia forestale. “Le dive del cinema erano Greta Garbo e Marlene Dietrich: considerate le Grandi Amatrici. Tutte e due con irrefrenabili tendenze lesbiche. Quanti imbrogli.” Ci lasciavamo quando sbiadivano le insegne al neon e cominciava ad albeggiare. Non l’ho più visto; non l’ho nemmeno cercato. Sembravamo inseparabili: si cam-bia, anche le amicizie. Ed è impossibile ritrovare quello che non c’è più. Viene anche l’ora del riepilogo: ma non mi fido neppure di quello che scrivo. Tutto, forse, è rarefatto dal rimpianto. E ormai mi mancano i riferimenti, i te-stimoni. Ogni tanto telefono a qualche anziano collega: chi era quel giudice, quel ministro, quell’attore? Cosa dis-sero, perché? Una volta nelle redazioni, si tramanda-vano storie e leggende: chi sa chi furono Silvio Negro o Cesco Tomaselli? Non mi preoccupo per me: mi sono dedicato solo ai contemporanei. Nella mia vita c’era un grande bosco e molti alberi sono caduti. Il mio paesaggio è cambiato; ho letto certi libri, ho visto certi film, ho assistito a certi spettacoli, ho cantato certe canzoni. A proposito: chi ha scritto il romanzo Incontrarsi e dirsi addio? Era un giorno d’agosto, quando ritornai, per qual-che ora, al mare, in un luogo della lontana fanciullezza. Non vidi la spiaggia, ma entrai in un ospedale. Il mio amico aveva un nome, posso dirlo?, glorioso. Lo conoscevano in tutto il mondo. Raccontava sé stesso, la vita di un borgo, e tutti si ritrovavano. Ma i malati si assomigliano, anzi: sono tutti uguali, non c’è distinzione. Indossava un camicione bianco, aveva la bocca de-formata e parlava a fatica. Una coroncina del rosario di cristallo pendeva dalla spalliera del letto. “Forse prega” pensai. Aveva accanto una giovane infermiera: assomi-gliava a Ingrid Bergman. Gli teneva la mano paraliz zata, sorrideva. La faccia del mio amico era stravolta: e le parole gli costavano fatica. Non mi parve decente portare il discorso sul futuro; mi chiese che cosa facevo, da dove arrivavo. Poi disse alla signorina che ascoltava, con complicità: “Ha girato tutto il mondo; e ha tante cose da raccontare ai suoi ni poti”. Restammo un momento soli. Mi fissò con uno sguardo appannato e, forse per aggrapparsi alla speranza, disse con un respiro: “Innamorarsi ancora una volta”. Ma non ci credeva più. Dicevamo, scherzando, che nel finale saremmo finiti insieme su un’isola, e senza annoiarci. Anche lui, come me, non si era mai allonta-nato dal paese dove era stato bambino. In un film di Orson Welles il protagonista, il re della stampa americana, nel rivedere la sua esistenza ritrova il passato in uno slittino: l’innocenza perduta. In un film di Ingmar Bergman il personaggio prin-cipale, ormai vecchio, ripensa al “posto delle fragole”. Quel bosco, quei sentimenti: deve ritrovarli. Io ho in mente l’albero dai fiori bianchi, dietro la casa un ciliegio selvatico che faceva frutti dolcissimi e gli volavano attomo nugoli di merli golosi. Vuol dire mio nonno Marco, il suono delle campane, le veglie d’invemo, i mercanti di maialetti e di pignatte con il bi roccio, le processioni, la festa del santo protettore, i fu nerali con le donne che cantano: “Miserere nostri, Do-mine”, e non sanno che cosa vuol dire. Sto ritornando. La fossa dei serpenti. La redazione è una “fossa dei serpenti”? La chiacchiera corre tra i giomalisti di New York, ma circola anche da altre parti. “La colleganza è odio vigilante” confermava un vecchio cronista della “giudiziaria”. Sono piccoli mondi che le frustrazioni e la concor renza esasperano: c’è di mezzo la vanità. E se è ridicolo Narciso, che trova simpatica la sua facciotta riflessa nell’acqua, terribili sono le esaltazioni che si possono vivere quando è in gioco “la firma”. Una volta c’era un penoso cerimoniale prima che sotto l’articolo comparisse il tuo nome. Si cominciava con le sigle E. B., poi En. Bia. e, finalmente, vittoria: Enzo Biagi. Sono entrato nei giomali dalla porta principale: non lo dico per orgoglio, ma non conoscevo nessuno. Avevo diciassette anni, una aria goffa, un vestito decorosa-mente povero e un articolo da piazzare. Affrontavo un angosciante problema letterario: “Marino Moretti è crepuscolare?”. Avevo letto i suoi libri e lo avevo conosciuto. Era un anziano signore romagnolo che passava qualche mese dell’anno a Parigi e nei garbatissimi discorsi arroton dava la erre: pronunciava con femminea dolcezza an che giudizi crudeli. Mi raccontò che Edmondo De Amicis era un uomo molto cattivo, odiato dalla moglie, che tradiva regolar-mente, e scrisse Cuore non solo per far piangere milioni di bambini indifesi, ma per guadagnare buoni diritti d’autore. Edmondo dei Languori, come lo battezzò un critico acido, spiegava all’editore il suo progetto in una lettera: un romanzo a puntate che avrebbe coinvolto sentimen talmente tutti gli italiani. Era, in fondo, un precursore della Lega ed esaltava le virtù regionali. “La piccola ve-detta lombarda”, “Il piccolo scrivano fiorentino”, “Il tamburino sardo”. L’argomento che trattavo in quel “pezzo” non aveva alcuna urgenza: ma c’è anche chi ha cominciato con un “Bisanzio tra Oriente e Occidente”. Lo lesse un anziano professore di filosofia che cu rava la terza pagina dell’Avvenire d’Italia e lo pubblicò. Mi pagarono anche venticinque lire e lo firmarono per intero. Segnarono, si può dire?, un destino. L’interrogativo su Marino Moretti è rimasto e non credo che i suoi romanzi contino più estimatori; forse lo aveva anche previsto. Tra i suoi titoli ricordo: Scrivere non è necessario. Nemmeno leggere. Poi passai a un quotidiano del pomeriggio, e con una storia a puntate. Anche il soggetto rientrava nelle mie possibilità: la biografia di un tenore che avrebbe potuto essere più grande di Caruso o di Gigli, ma che il Fato, e una maligna sifilide, aveva colpito proprio alle corde vocali: e mentre stava andando, su uno di quegli infiniti treni russi, a esibirsi alla corte dello zar. Nel suo vagone era capitata una maliarda, sembra una barzelletta e invece era una tragedia, che emanava il rinomato fascino slavo e il giovanotto bolognese riempì la monotonia del lungo percorso e le difficoltà di comunicare con i passatempi che gli erano più con-geniali. Il cantante sfortunato era una persona compita, che viveva della benevolenza dei colleghi famosi: quando arrivavano al Comunale, ricevevano una sua vi sita in camerino e lo accoglievano calorosamente, an che perché capeggiava la claque. Nessuno sapeva scate-nare l’applauso travolgente come lui; era dotato di un raffinato senso dei tempi che lo rendeva quasi sponta-neo. Il suo consenso era dunque ambito e remunerato: ma in quei giorni c’era tanta gente che batteva le mani a comando. E per niente. La redazione ha un sovrano, il direttore, ma gover-nano molti feudi: c’è lo sport e la finanza, gli spettacoli e la politica estera. Ci sono, ovviamente, come in ogni società, i vecchi al tramonto e i giovani che spingono: e i vecchi sono tristi e disincantati, perché pensano che non c’è niente di nuovo, è già tutto accaduto. Non c’è più fatto che li stupisca. Si formano ogni tanto delle consorterie, determi-nate da affinità o da interessi concreti: sono stato testi-mone perfino di una divisione del mondo. Chi preten-deva l’Africa, chi l’America, chi l’Europa settentrionale: ma si poteva mandare uno in Arizona senza offendere la suscettibilità del corrispondente da New York? Quando ho cominciato, comandavano i fascisti e a Bologna c’era un federale cafone: “Non devi impressio-narti, il primo che salta è lui” diceva il mio capo. Ho cercato di resistere anche in seguito. Facevo l’estensore; è quello che trascrive gli ap-punti dei reporter, che di solito hanno più dimestichezza con i marescialli dei carabinieri e con i cancel-lieri del tribunale che con la lingua italiana. Al mio superiore premeva soprattutto non avere noie con le Autorità: aSiamo proprio sicuri? Il questore lo sa?” era la sua ossessione. Del lettore gli importava poco, anzi: in fondo lo di sprezzava. Il nostro giornale era padrone della piazza, la nostra forza i necrologi e la distribuzione dei generi ali mentari. Stavamo per entrare in guerra. Del resto, anche in seguito mi sono reso conto che il rispetto per il pubblico non è l’impegno principale di chi vende notizie: i francesi, delicati, lo considerano un grand enfant; un alto dirigente della nostra televisione valutava invece i bambinoni abbonati “venti milioni di teste di cazzo”. C’è una mitologia del mestiere: ogni ragazzo sceglie il suo modello. Io avevo una galleria di maestri: Paolo Monelli e Orio Vergani, Malaparte e Montanelli, Bar-zini e T.illi. Lavoravo accanto a un collega ebreo che il ministro Grandi, il nostro editore, proteggeva. Era un bravo im paginatore e, con la scusa che faceva il tecnico, non gli rompevano troppo le tasche. Non poteva inquinare l’i-deologia. Ricordo che camminava quasi strisciando ac-canto ai muri, come per non farsi notare. Penso che il giornale gli facesse un po’ schifo: ogni tanto mi diceva: “Hai visto il Corriere? Leggi Malaparte in “terza””. Poi Malaparte l’ho conosciuto, a Roma. Era estate e gli faceva compagnia una stupenda ragazza americana. Una indossatrice, dicevano. Aveva gli occhi azzurri come il vestito, gambe nere e lunghissime, sfoggiava sandali che assomigliavano ai calzari. Malaparte non la portava in giro, la esibiva. Lui era un bell’uomo con una bellissima donna. Abbronzato, capelli in ordine, begli abiti. “Invecchiando, niente ca-micie:” diceva “segnano il collo rugoso; magliette, ci vogliono.” Ne aveva di tutti i colori: insisteva sul giallo. Si por-tava dietro la leggenda del bastian contrario, dell’intre pido, del maledetto. Io lo avevo ammirato quando leg gevo le sue corrispondenze dall’Unione Sovietica, indi menticabili. Era stato un gran fascista, era l’inventore dei versi: “Spunta il sole e canta il gallo /o Mussolini monta a cavallo”. Poi aveva criticato il regime e lo avevano mandato al confino: per le “grandi firme” usavano un certo ri guardo e sceglievano località amene. Capri, ad esem-pio. Giuseppe Prezzolini mi raccontò che durante una vacanza lo aveva incontrato in esilio a Forte dei Marrni. “Vorrei presentarti la mia fidanzata,” disse Curzio “è un’americana. “ Era la madre di Gianni Agnelli, si chiamava Virgi-nia, vedova dell’ingegner Edoardo. Prezzolini la ricor dava innamoratissima, non sapeva nulla di letteratura, ma guardava incantata il suo azzimato cavaliere, sedu cente e beffardo: guerre e polemiche, duelli e bravate da squadrista. Vanno tutti nella villa che Virginia possiede davanti al mare. Siedono sotto gli alberi. “Vedi” dice Malaparte “quei due individui che pas-seggiano davanti al cancello? Sono spie al servizio del senatore Agnelli. Sorvegliano per vedere se rimango anche di notte, perché non vuole che la sposi. Mi ha fatto sapere che in ogni caso non darebbe neppure una lira.” Appena può, il senatore licenzia lo scrittore toscano dalla direzione della Stampa. Pretende che sia presente il redattore capo. Poche chiacchiere, l’indispensabile: “Malaparte, qui dentro ci sono i soldi della liquida-zione; li prenda, per favore, e mi restituisca la busta”. Non gli porge la mano. Dicono che Curzio, poi, ri masto solo, si è messo a piangere e a gridare. L’indossatrice, a Capri, dall’alto della roccia, si gettò nel vuoto. Poi Malaparte ebbe altre avventure, e sempre clamorose. Lo incontrai al fronte, dopo il 1943: scriveva per l’Unità. Firmava, mi pare, Gianni Strozzi. Sempre bravo, accidenti. E morto con accanto un frate e un co munista. Non era di quelli che mi piacevano: troppo forte, per la mia natura, il suo gusto della ribalta, una esistenza urlata, come le sue pagine, come le sue inven zioni geniali. Il bambino ebreo che risponde all’ufficiale tedesco: “Il suo occhio che mi piace di più è quello a si nistra” ed è di vetro, collabora alla creazione del mo stro. Mi commuove Cechov, la scrittura casta, i senti menti che parlano sottovoce. Poi sono cresciuto in una terra dove la cosa che più offende un uomo è una pa-rola: voltagabbana. La girandola non ci piace. Siamo per le conversioni sofferte, non declamate. Il peccatore sta in fondo alla chiesa e si batte il petto: non sale sul pulpito. Altro esempio: ho conosciuto William Faulkner; e lo preferivo a Hemingway. Ero andato quasi in pellegri-naggio a vedere la sua casa, Garfield Avenue, nel pro fondo Sud: Oxford, Mississippi. Cadeva a pezzi; credo avesse finito di pagarla con il Nobel. Marcivano il patio, lo steccato dei cavalli. La cassetta della posta era arrugginita. Avevano messo su un piccolo museo: c’era una sua fotografia in tenuta da cacciatore, marsina rossa, pantaloni e cravatta bianchi, guanti di pelle chiara. Non c’è molta iconografia su di lui: né di quando la-vorava e si ubriacava a Hollywood, né di quando liti-gava con la moglie e si sbronzava nella soffocante citta dina che gli ha suggerito tante storie. “Per scrivere” diceva “mi basta un po’ di pace e una cassa di whisky. “ Credo che per la gente Ernest Hemingway, “Papa” come lo chiamavano gli intimi, abbia contato molto di più. Ho davanti un album di fotografie: tra i tori di Do minguin, o a pescare al largo di Key West, o a sbevazzare con Fidel Castro a Cuba, o in giro per i bistrò di Pa-rigi con Gary Cooper, o nella solitudine di Torcello, con i pensieri tristi, gli amori impossibili e tante botti-glie di Valpolicella. C’era in Hemingway qualcosa che mi ricordava D’Annunzio; le pose, le sfide, la vita eroica. Una istanta-nea lo ritrae mentre lavora; torso nudo, braghe corte, in piedi, davanti a un leggio. Mi faceva venire in mente una vecchia stampa, Pe trarca che compone “Chiare, fresche, dolci acque”, stessa scena. Un’ostentazione, pensavo: ma la mia vi-sione romantica è sbagliata. García Márquez dice che soffriva di banali disturbi da sedentario, emorroidi, lui che aveva esplorato le verdi colline d’Africa e visto da vicino le nevi del Kilimangiaro. Per scrivere, del resto, ognuno segue la propria li-turgia: Fellini mi raccontò che Simenon doveva avere davanti certe risme di una carta speciale, una caraffa di tè, alcune matite bene appuntite. E in mente un pro-fumo, il verso di una canzone, un muro con un cartel-lone, una portineria, un volto. Le sorelle Bronte, ho letto, volevano che sulla scri vania ci fosse un vaso con rose gialle. Io, come molti altri, non sopporto cancellature, al-meno nelle prime righe: allora butto via, e qualche volta il cestino si riempie. Nevrosi, credo. Andai a trovare Norman Mailer, una specie di Hemingway aggiomato: “Amaro, comico, ribaldo” si leggeva in un profilo. Fa tutto: il cronista, I’attore, il re-gista, il conferenziere. Un po’ marxista, un po’ conser-vatore. Piaceva ai giovani contestatori, ai negri, ai dro gati: lui era stato del ramo. Quattro mogli nella sua vita: una piccola ebrea, Beatrice, psicologa; una peruviana recitava; una lady inglese, Jeanne, nipote di Lord Beaverbrook, che si beccò anche una coltellata, ma da vera signora disse ai medici dell’ospedale che era caduta su dei vetri; l’ul tima, almeno credo, che conobbi, era Beverly, rag giante e gentile, che mi offrì il caffè e aggiunse alle cin-que bambine nate dai matrimoni precedenti final-mente Michael, un maschietto. Norman Mailer si giustificava: “Siamo pieni di matti: Hawthorne, Henry Miller, anche Hemingway e Faulkner”. Dicevano che la sua vita era un concentrato di scon-fitte. Ma continua a combattere le sue battaglie. Spes-so perde e cade. Oltre ai romanzi - indimenticabi-le Il nudo e il morto, sulla guerra nel Pacifico ha scrit-to anche poesie. Ricordo un verso che spiega la sua violenza: “Finché usi il coltello c’è ancora un po’ d’a-more”. Il rancore o il rimpianto lasciano un segno per sem-pre. Così le passioni. A Herthoniemi feci visita a Frans Eemil Sillanpaa, premio Nobel, ma ormai dimenticato. Era vecchissimo: una voce profonda, una lunga barba candida da profeta, gli occhi allucinati, la papa lina nera che gli proteggeva il capo, le mani forti da contadino che tremavano un poco. Mi tornava in mente un personaggio di Cechov, il comico che recita e vive il suo ultimo atto e ritrova, per un breve istante, le parole e le passioni delle creature che ha impersonate, ma quei sentimenti non lo riani-mano perché sa che tutto è inutile, non c’è che da aspettare la fine. Mi faceva impressione il grande vecchio che ricor-dava, con un dolore non sopito, le tre donne che aveva amato, con gioia o senza felicità. “La prima ragazza” diceva “si chiamava Luli; ha ca-pito bene? Luli: nella mitologia vichinga questo nome significa “vittima”. Mi respinse: non ero abbastanza im-portante per lei. Se le avessi dato retta avrei fatto il commerciante e guadagnato tanti soldi, ma non sarei mai stato uno scrittore. “La mia passione era così forte che non potevo por-tarla tutta dentro di me, così l’istinto mi spinse a rac contarla agli altri, volevo che anche gli altri sapessero quanto può soffrire un uomo. “Luli sposò un incisore, però il giorno che ricevetti il Nobel andai a trovarla e le dissi: “Adesso, ti andrei bene? Mi vorresti adesso, Luli?”. “E morta tanti anni fa. Come Sigrid Maria. Vede questo quadro della Vergine? Lo ha dipinto un amico. Il volto della Madonna è quello di Sigrid Maria, mia moglie, una serva. “Era una serva, le ho detto: io pensavo a Luli e non mi ero accorto di quella ragazza che portava le vivande in tavola, nella mia casa, laggiù al villaggio. “Pensavo a Luli e piangevo, ma Sigrid Maria si stancò della mia indifferenza e mi buttò addosso un portafiamrniferi d’argento: non le sfuggirà il simbolo, una fiamma che si accende. L’abbracciai e diventò la mia sposa. Morta anche lei, tanti anni fa. “Quando Sigrid Maria se ne andò conobbi... Ma non voglio parlarne, non lo merita. Che cosa erano gli uomini per lei? Passava dall’uno all’altro, come un por tafogli, dico bene? un portafogli.” “Portefeuille” ripeteva a tratti, in un lento francese, “portefeuille”; gli occhi fissavano immobili un punto nella stanza. Prese le corone del premio e cominciò a bere, senza tregua, per scordare la casa del padre con le assi fradi-cie; si sfasciava la vecchia sedia del nonno, le erbacce crescevano nelle stoppie incolte, beveva per dimenti-care la faticosa giovinezza, come Sibelius, il musicista, come Waltari, quello di Sinuhe l’egiziano, perché, mi disse un amico finlandese senza cattiveria, “i nostri grandi vecchi nell’alcol si mantengono meglio”. Un giorno la sua mente si fece confusa, era come si fosse avvolta nella foschia che stagna sulle paludi, tutti i pensieri si accavallavano in disordine. Lo portarono in una clinica, rimase là dentro per giorni e giorni... “Portefeuille” ripeteva a tratti, in un lento francese. Uscimmo a passeggiare nel breve giardino. Nei via-letti abbandonati correvano i bambini di Anna, la figlia che lo assisteva; i panni del bucato asciugavano al sole. Le mani da contadino di Sillanpaa (c’è ancora il suo nome nelle enciclopedie?) si posavano leggere sulle tre mule foglie screziate di un alberello, sembrava le acca rezzasse. Mormorava: “La canzone è finita: chi lo ha scritto?”. Ci ripenso: Prezzolini mi raccontò che anche Gio vanni Papini aveva sposato una domestica, bellissima. Ci rideva sopra: “Molti prendono una moglie per avere una serva, io ho fatto il contrario”. Le insegnò pazientemente a leggere, e fu una buona compagna per una lunga vita. Benedetto Croce ebbe, in gioventù, una storia con una di quelle signorine; delle mie parti, credo. Sempre Prezzolini la ricordava silenziosa e attenta a certi incon tri di intellettuali e ne rievocava anche l’aspetto sedu cente e le maniere compite. Morì di una malattia improvvisa e violenta e il filo sofo la rimpianse. Sono stato amico di Guareschi e sono contento che ancora oggi abbia lettori fedeli. Non ci legava la politica, ma mi piaceva il suo disinteresse per i rico noscimenti ufficiali (ha avuto, credo, in tutto, un paio di articoli, di recensioni: sono mie), il suo carattere, che lo induceva anche a commettere errori, ma mai bassezze. Quando la testardaggine lo portò in carcere, al ristorante Bagutta certi letterati brindarono per la gloia. Una sera andammo in una osteria sul Po: culatello, lambrusco, tortelli e “pesciolini puttana”, quelli minu scoli che agitano furiosamente la coda nel grande fiume. Ci cadde addosso la nebbia e ci fermammo un po’ a chiacchierare in macchina, come isolati da tutto, e il fiato appannava i vetri. Mi confidò che una volta aveva incontrato una donna - ovviamente degna di molta considerazione, come in tutti i racconti - che gli voleva un bene infi nito. Una prova: passeggiavano abbracciati mentre nevi-cava, lui sentiva un urgente bisogno, come si dice con finezza emiliana, di cambiar acqua alle olive, e glielo fece capire. Provvide lei e con grazia: “Lo tirò fuori e fece in modo di scrivere su quel candore, mentre mi liberavo: “T’amo””. Non gli chiesi come aveva superato le difficoltà del-l’apostrofo. Ha ragione Tolstoj: le infelicità sono diverse. Inutile dire chi era: un commentatore di politica molto seguito, con tutti i regimi. Geniale, colto, scettico, spre giudicato, ironico. Quanti aggettivi: anche tormentato dagli errori del passato e dai compromessi del pre-sente. L’omissione, diceva, è la sola forma di menzogna largamente praticata. Una volta, a Bombay, lo sorpresi davanti a una ban-carella che vendeva semi e bevande troppo colorate: “E roba da colera, butti via”. Continuò imperterrito: “Ho digerito il massimali-smo, poi il fascismo; sto digerendo la Democrazia cri stiana. Cosa può accadere?”. Nulla. Può accadere invece che un vecchio cinico si innamori di una leggiadra danzatrice di vent’an-ni. “Una farfalla” confida ai pochi amici, e scrive e telefona ai direttori dei settimanali perché pubbli-chino qualche fotografia, meglio se a colori, della balle-rina. Era patetico e un po’ ridicolo, ma anche i giornalisti hanno un cuore. Si giustificava: “Sono grosso, enorme, sudo tanto e non penso proprio di andarci a letto. E colpa di due date che non coincidono: non ci sarà mai un appuntamento”. La paralisi gli fece ritrovare la pace della famiglia. Ricordo il piccoletto: aveva intuizioni e battute fol goranti. Geniale. Diceva, ad esempio: “Noi italiani siamo animali feroci e casalinghi”, “Veterani si nasce”, “Bisogna trovare un fratello al Milite Ignoto”. Capiva tutto e non gliene importava niente. Si invaghì perdutamente, come nelle canzonette, di una signora; alta, bionda, simpatica. Per inseguirla dila-pidò un patrimonio in taxi perché non aveva la pa-tente. Era anche moglie di un amico: allora? “Allora con chi?” si giustificò. Morì suo padre, ma non resi stette: piantò la veglia funebre e corse da lei. Poi si portò dentro il rimorso. Diceva Nina Berberova: “Solo il presente ha signifi cato”, e ancora: “Il futuro è più importante di ciò che è stato”. Aveva seguito da cronista il processo Krav cenko, l’ingegnere russo accusato di avere vilipeso l’U-nione Sovietica, mentre anticipava le rivelazioni di Ni-kita Chruscev sui delitti di Stalin. Ha lasciato una avvincente autobiografia, Il corsivo è mio, ma non ha detto tutto: che forse era stata amante di Kerenskij e anche collaborazionista dei tedeschi nella Parigi occupata. Aveva confessato al suo editore: “Prima o poi dovrò deciderrni a confidare il segreto della mia vita”. E morta a novantadue anni; quando l’ho incontrata a Philadelphia, uno di meno. Un piccolo appartamento; su una parete un Matisse bisognoso di restauro. In lei resisteva tutto: memoria, figure, parole, e anche avversioni e simpatie. Aveva vissuto da donna libera, indipendente: “L’a-more” diceva “è camminare a un passo l’uno dall’altro, è mangiare in due la stessa foglia di carciofo”. Parlammo della Russia che fu, del 1917 e anche di dopo. Facevo dei nomi e delle domande: • Ha conosciuto il principe Jusupov, l’assassino di Rasputin? (Diceva il mio caro Giovannino Guareschi: “Un arti colo su Rasputin si legge sempre”.) aL’ho visto una volta, era in un palco a teatro, con alcune signore, e poi a qualche riunione politica degli emigrati, ma non ero sua amica.” • Anna Achmatova? “Sì. Era di passaggio a Parigi. Andai a salutarla in stazione, credo alla Gare du Nord. Camminava a fatica, era terribilmente grassa per il cibo che aveva mangiato e così cambiata che non l’avrei riconosciuta. Viveva nella mia stessa città, San Pietroburgo. “Quando entrai nel vagone letto stava mezza sdra iata nella cuccetta e l’accompagnava una giovane donna, la figlia del suo ex amante. “La nostra era una conoscenza superficiale, ma io le corsi incontro e la strinsi tra le braccia e le dissi: “Sono Berberova”, e lei mi parlò: “Che bello che sei venuta e ti posso vedere e toccare”. Le chiesi: “Come stai?”. E lei ri spose: “Male, molto male”.” • Majakovskij? “L’ho completamente dimenticato. Non mi inte ressa.” • Solzenicyn? “Mi spiace dirlo, ma non mi attirano per niente i suoi scritti e le sue idee. Non sono d’accordo con il suo stile di vita. E gli auguro il meglio, dopo quello che ha passato. “ • Perché ha lasciato la Russia nel 1922? “Perché avevo un compagno e non volevo rimanere con i genitori, e volli tentare l’avventura.” Scappò in Occidente con il poeta Vladislav Choda-sevic, un amore. Berlino, Praga, Sorrento, dove sog giorna Gor’kij con una amante, la baronessa Budberg, forse spia sovietica. Poi la Parigi degli anni Venti, con migliaia di “russi bianchi”, miserie e canzoni tzigane. Dopo la guerra, si imbarca per l’America: l’accu-sano anche di avere piantato il marito infermo. Ultima domanda; le chiesi: • Come vede il futuro del suo Paese? “Niente di buono.” Dicono che l’invidia non è volere quello che un al-tro, il nemico, già possiede, ma addirittura si sogna di cancellarlo come persona: non deve esistere. Arnoldo Mondadori, quando parlando si riferiva a Rizzoli, quasi inconsciamente lo chiamava Erre. Era talmente bella l’amica di un collega che il capo cronista disse: “Deve avere il fiato pesante”. Di uno che lavorava tanto sussurravano: “Ha di si curo dei negri”. Per licenziare un direttore politicamente fastidioso, gli fecero sapere che c’era in giro una fotografia di sua moglie nuda. Per ottenere la posa si era prestato il di-rettore amministrativo. Eppure ho nostalgia di quelle notti e di quella gente. Risento il profumo delle bozze bagnate, di aran-cia e di sigarette Macedonia, le chiacchiere aspettando che la rotativa giri e quel rumore che ti dà il senso di un lavoro compiuto, l’eccitazione quando arrivavano le notizie: le brutte cancellano sempre le buone. Quando l’insonnia mi tormenta - ma accade di rado, perché di solito appoggio la testa e dormo -, ri percorro i corridoi del Carlino: Bonuzzi, a sinistra, di fronte a me. Mi costrinse a diventare socio della Protezione ani-mali; mentre i tedeschi marciavano su Varsavia e la ca-valleria polacca affrontava i carri armati di Hitler, la sua tenerezza era tutta rivolta ai gloriosi destrieri. Della prima guerra mondiale, lo arnmetteva, altro che Redi-puglia, lui venerava soprattutto il monumento al mulo degli alpini. Tibalducci era altissimo, scriveva poesie, un titolo, se ben ricordo, assai impegnativo: “Latinità”. E mi ri corda un altro collega con propensione per la lirica; la raccolta si intitolava: Il canto del cuculo. La critica di un raffinato recensore fu breve, ma esplicita: “C’è una sil-laba in più”. Mario Bonetti mi aiutò. Faceva un giornaletto per una compagnia di assicurazioni: pagavano poco, ma su bito. Diceva: ((Non fare, far fare, non lasciar fare”. Una posa. Il mio primo maestro si chiamava Eugenio Ferdi-nando Palmieri: grande conoscitore del teatro veneto e del vecchio cinema muto. Scrittore bizzarro, pieno di umori: diceva che Flaubert passava una notte per cer care un aggettivo. Lui ne trovava tanti, oggi qualcuno direbbe troppi. Tutto il contrario di Giannino Zanelli, grande amico di Riccardo Bacchelli e scrittore casto, sottile. Piccoli avvenimenti, sfumati, tersi; allora andavano molto gli “elzeviri”, la terza pagina era considerata “il salotto buono”, e qualche volta ci si poteva anche fare un son-nellino. Riccardo Bacchelli, roseo, bastone, cravattino, qual-che volta, quando era di passaggio in città, veniva a tro varlo. Io lo contemplavo in silenzio. Parlava volentieri di sé, del tempo che fu. Degli uomini che aveva cono sciuti. Ammirava l’impegno morale di uno scienziato, Alessandro Codivilla, l’ortopedico. Moriva di cancro al-l’intestino e gli disse: “Portami dei libri da leggere per uno che tra sette mesi se ne andrà”. Si comportava come uno stoico antico; Bacchelli scelse Guerra e pace e Madame Bovary. Con Benedetto Croce, ammetteva, i rapporti non furono molto teneri. “Con Giorgio Morandi” raccontava “invece siamo stati arnici: la notte, dopo la sosta al Caffè San Pietro, andavamo dalla Wanda, dalla “Cesira dal gran nes”, la Cesira dal gran naso era famosa, e in via dell’Orso: non dia retta alle chiacchiere, le ragazze gli piacevano, eccome, e a mangiare all’osteria di Monte Adone.” Quando è morto, in una libreria del centro, a Mi-lano, esposero in vetrina due copie, le sole che avevano, del suo romanzo più famoso: Il mulino del Po. Nessuno se ne accorse. Ha vissuto gli ultimi anni con un assegno dello Stato: inchiodato in un letto, senza pa-rola. Ma aveva detto: “La morte non la so definire: fa paura. E il terribile dell’esistenza umana, ed è ciò che la fa fecondare”. Di solito gli scrittori da noi muoiono due volte: per l’anagrafe e per i lettori. Chiuso. Non voglio fare il nome: era un brav’uomo, ma pro-prio non c’entrava. C’erano parole che lo terrorizza vano, come equo, innocuo, iniquo. Risolveva saltando il tasto fatale: c o q? Il dramma insuperabile, quello che lo faceva su-dare, erano i maledetti titoli: proprio non gli venivano. Allora ricorreva a un espediente: leggeva la notizia ad alta voce e chiedeva educatamente a un compagno di stanza: “Lei, che titolo farebbe?”. Inventarono un fattaccio che era un condensato di malvagità: un cacciatore andava in bicicletta, seguito dal suo setter, lungo un canale. Un capogiro e ci finiva dentro. Annegato. L’animale, impazzito, si dava alla fuga, addentava i testicoli di un passante che cercava di calmarlo e alla fine soccombeva, travolto da una auto-mobile. Nessuno volle soccorrerlo e dovette arrangiarsi. Ti-tolo: “Tragica fine di un cane”. Uscivo che era quasi l’alba. Incontravo le donne che andavano a lavorare in una fabbrica di carne in scatola per i soldati. Poi la solita puttana che faceva ser-vizio davanti al Cinema Teatro Verdi. “Manina calda” diceva per invogliare i clienti d’inverno, perché andava in giro premurosamente con uno scaldino. A casa mi aspettava una fetta di castagnaccio o un panino con la mortadella, che era diventato duro e secco. Mia madre, per farmi sapere che era sveglia, tos-siva. Voleva che andassi a letto. Io per un po’ continuavo a leggere: la bocca cattiva, la stanchezza e i sogni diventavano incubi. Ognuno di noi, credo, deve qualcosa del suo gusto, e anche del suo carattere, e della sua morale, alle let-ture dell’adolescenza. Dobbiamo a certi libri e a certi film se noi, che apparteniamo a una generazione in via di estinzione, non siamo cresciuti del tutto stupidi, di-ceva Federico Fellini. Per me, contano i russi, poi Jack London, qualche americano e il Joyce di Gente di Du-blino. In un tema scolastico scrissi che, da grande, volevo fare il giornalista: pensavo che avrei potuto essere utile anche agli altri, battermi per cause giuste. Scrivevo: “Si gnore, mi piacerebbe scrivere, anche se dovessi essere infelice”. Nelle Edizioni Barion di Sesto San Giovanni, prezzo di copertina lire 4, trovai molte prove dei rischi del me-stiere: c’erano gli autori che amavo e conobbi anche il loro destino. Dostoevskij è condannato a morte perché ha scritto un testo considerato sovversivo: all’ultimo momento so stituiscono il plotone di esecuzione con la Siberia. De-portato. “Guasta la gioventù” disse poi Stalin a Milovan Gilas. Turgenev inventa il nichilista, ed è costretto a espa triare. Puskin muore in un duello provocato da un de-spota. Cechov attraversa tutta la Russia per andare a descrivere la vita degli esiliati nella tajga. Andai a Novjerusalimsk, poco lontano da Istra, dove il dottor Anton Cechov era stato medico condotto: vidi il bosco dove ancora tremano “le care, mo-deste betulle” e la villa tra i campi, sotto gli alberi rossi di autunno, dove vivevano tre sorelle che gli suggeri-rono la storia e il dolore di Masa, di Irina e di Ol’ga. Entrai nella sua casa di Mosca. La direttrice era una mite signora dal pallido sorriso: aveva perso il marito e il figlio a Stalingrado. Anche il dottor Cechov ormai le apparteneva come quei due soldati dispersi nella batta glia del Volga. Innaffiava le pianticelle della camera da letto, ag-giustava le lenzuola con le cifre che la madre dello scrit-tore aveva ricamato, spolverava una lumiera di porcel lana azzurra. Mi mostrò un calamaio, dono di una am-malata che il dottor Anton curò rifiutando il compenso. Si sa che prima di chiudere gli occhi Cechov mor morò in tedesco: “Ich sterbe”, io muoio. “Noi russi” disse la piccola signora “sappiamo morire.” Conobbi Il’ja Erenburg a un congresso di scrittori europei, nel 1963, a Leningrado. Io c’ero come inviato. Erenburg non era amato nella sua patria e veniva insul-tato all’estero. Mi piacque perché disse, allora, qualche verità: aVi sono membri di questa Unione che non sanno scrivere. Ma non abbiamo mai detto che intendevamo eliminare gli incapaci, ma soltanto gli sfruttatori”. Poi difese l’arte aimpegnata”: anche Dante, diceva, esprime le angosce e i drammi del suo tempo, ma non arrivò a precisare: aNon per ordine del principe o del papa”. Bisognava capirlo; ha confessato nelle sue memo rie: aChe cosa non si adatta a fare un uomo soprattutto nelle epoche definite storiche?”. Longanesi, acuto, scettico e contraddittorio, lancia il motto: “Mussolini ha sempre ragione”; quando passai all’Ufficio interni, ricevetti le consegne: “Tutto maiu scolo, per la Madonna”: Signor Prefetto, Signor Mae stro, Signor Maresciallo, Camerata, Capofabbricato. Qualcuno arrivò a scrivere: “Duce, se la sera le no-stre mamme non pregano per te, noi ci sentiamo orfani”. E il culto del potere, che in Italia è un sentimento estremamente diffuso. In nessuna parte del mondo esi-stono, come da noi, cartelli che avvertono, negli stadi, o nei parcheggi, o nei teatri: “Riservato alle Autorità”. Assistei, a Lugo di Romagna, a un comizio di un onesto deputato repubblicano: l’onorevole Cino Macrelli. Era domenica e sulla piazza si era raccolta una piccola folla di estimatori dell’edera. Macrelli era un parlatore; qualche volta gli chiedevano anche il bis. Pia-ceva. Alla fine, dal fondo, avanzò un ometto che teneva per mano la moglie e si diresse al palco dell’oratore. Mostrandogli la consorte, gridò: “Cino, prendila, met-tila incinta, falle fare un figlio come te”. Ogni paese ha un suo culto della personalità. L’appartamento di Erenburg sulla via Gor’kij era quasi un museo: mi mostrò - lo teneva sopra il letto - il ritratto di una petite russe eseguito da un giovane pittore italiano: si chiamava Amedeo Modigliani, lei Anna Achmatova, si erano incontrati a Parigi. E ancora un bozzetto di Picasso, aveva frequentato anche lo studio di Matisse: era un testimone della Francia del Fronte popolare, e di quelle illusioni. “Di tutti gli scrittori che conobbi prima della rivolu-zione” disse con freddezza “non è rimasto nessuno. “Credo che solo Pasternák sia morto contento: pen sava di avere ragione. E almeno all’estero avevano pub-blicato Il dottor Zivago.” Adesso, sull’edificio dove Erenburg abitò, c’è una targa che lo ricorda: ma non hanno starnpato più nulla. Ho conosciuto Lara; Pasternák così la descrive: “Una intelligenza limpida, un carattere mite ed era molto graziosa”. La signora che ha ispirato questa figura letteraria si chiama Ol’ga Ivinskaja; quando incontra Pasternák ha poco più di trent’anni, lui poco meno di sessanta. “Era” rievoca “snello, sorprendentemente giovanile, con una voce grave e sorda e un bel collo robusto.” Ammette subito: “Ho fatto piangere molte donne”. Anche lei ha conosciuto tante infamie, ma le confessa: “Ho vissuto molte esaltazioni e sofferto molti dolori”. Un marito che si impicca perché lei lo tradisce con il suo avversario, il secondo che muore tra le sue braccia, e forse ha mandato sua madre nel “gulag”. L’ho ritrovata a Mosca: fuori dal piccolo apparta mento di un caseggiato popolare, nel corridoio, c’era un secchio di bottiglie da vodka svuotate. Il salotto era anche camera da letto: mi offrì for maggio, una rarità, e cognac armeno. Era gonfia, gli occhi acquosi, i mobili denunciavano la decadenza, qualche fotografia documentava il passato. Una di lei, bionda, un po’ misteriosa; forse scattata nel giorno in cui Boris le disse: “Come ha fatto bene Dio a farti na-scere donna”. Ricordava le passeggiate nella neve, sotto i tigli del vicolo Patapovskij, sotto la pioggia, accanto a uno sta gno: il profumo di miele, il concerto delle rane. Parlavano di tutto, anche di quello che era stato. Durò quattordici anni, contrasti, abbandoni, pentimenti, e la moglie di Pastemák che urlava: “Su questo amore io posso sputare”. Non vissero mai insieme, ma si vedevano ogni giorno in una casetta fuori città, e pensarono alla trama del Dottor Zivago. Litigavano e si ritrovavano: “Non l’ho mai tradito” mi disse. Per questa storia lei aveva affrontato la Lubjanka e il lager: anni e anni da prigioniera. E lui che le scriveva: “Per meritarti lavorerò e potremo tomare alla piccola casa dove mi sento felice”. Boris Pastemák aveva il presentimento della morte. “Soffriva” disse Ol’ga Ivinskaja “di un’ansia che non lo abbandonava mai; era offeso dagli attacchi, dalla cac-cia che gli davano. Diceva: “Non aspettarti mai i guai, tanto arrivano da soli”. “ Non ebbe un solo premio, una sola decorazione in tutta la vita. Solo il Nobel, e fu una condanna. Nella mia vicenda di cronista, ci sono tante vedove; ho sempre cercato, e non mi pare un errore, di seguire il consiglio di un grande giomalista francese: raccon-tare i problemi con i fatti, e i fatti attraverso i perso-naggi. E una trovata, dice qualcuno assai più raffinato e impegnato di me, da stampa popolare, ed è vero. Ma mi consola il pensiero che l’applicava anche un personaggio molto dotato, Gesù: che ricorreva alle pa rabole per spiegare ai pescatori e ai contadini della Ga lilea la via per raggiungere la pace del cuore e la sal vezza. Cosa c’entra il figliol prodigo con la questione della tolleranza, o il soldo della vedova, l’unico, per far capire che cos’è la generosità? Del resto, io mi dedico ai contemporanei; quelli che lavorano per i posteri non lo sanno. Io sono solo un cronista: racconto la storia mentre Si svolge. Antonina Nikolaevna Pirozkova, ingegnere e capo costruttore della Metropolitana di Mosca, era stata la seconda moglie di Isaak Emmanuilovic Babel’, l’autore de L’armata a cavallo, il racconto dei folli cosacchi di Bu dennyi lanciati contro i villaggi polacchi, i morti abban-donati nelle pianure, tra gli stagni, gli amori osceni nelle chiese abbandonate, girasoli e betulle, cieli rossi nel tramonto o turgidi di nuvole. Babel’ mi avvince: non è un calligrafo, ha sangue. “Proust” diceva “è un grande scrittore. Però annoia.” Narrava anche la crudeltà e cercava di spiegarla: “Non può fare a meno di sparare perché essa è la rivo luzione”. Ma, dice una puttana nelle sue trame: “Gli uo mini sono buoni, ma gli hanno fatto credere che sono cattivi”. Non è vero, non è così. Se ne accorse, forse, quando un mattino arrivarono a Peredelkino, il villaggio degli artisti e dei poeti, a prelevarlo. Era un giorno di maggio del 1939, alle 5 del mattino. Lui diede un grosso bacio ad Antonina e disse: “Un giorno ci rivedremo”. Invece no: fu condannato per tradimento della Pa tria, complotto o spionaggio. Non si è mai saputo esat-tamente quando è morto. Aveva confessato le sue attività antisovietiche, di-scorsi eretici con scrittori e con registi, infommazioni passate ad André Malraux sull’Armata e sull’Aeronau tica, rapporti con i trotzkisti, congiure con altra gente dell’intelligencja, come Esenin ed Erenburg. Ma al processo si pente, è tommentato dalle menzo-gne e dalle denunce false che lo ossessionano. Sa che cosa lo attende, ma rinnega le sue deposizioni; dice al giudice: “Ho commesso un crimine; ho calunniato al cune persone”. Perché? “Per il mio comportamento vile. Sotto coercizione ho denigrato me e altri inno centi. “ Nessuno sa dove è stato sepolto. Miserie e casi di coscienza ce ne furono anche da noi. Cedimenti al bisogno o alle lusinghe. La sera del 26 luglio 1943, nel cortile del vecchio Carlino si incon-trarono un redattore e un cronista, inebriati dalla li bertà o da troppi Campari. Cominciarono a discutere. Uno disse: “Taci, tu che sei stato una spia dell’Ovra”. L’altro rispose: “Vergogna per te, che eri infommatore della questura”. Sono morti e sono convinto che non erano delatori. Uno cadde fucilato, all’altro provvide il cancro. Ma ci sono momenti in cui le situazioni sono compromettenti o ti coinvolgono. Si creano, nel mestiere, rapporti umani che diven-tano involontarie complicità. Il più giovane aveva molto ingegno e un grande talento per il teatro. Vinse un concorso per un copione e gli consegnò il simbolo d’oro, una “M”, il segretario del Partito fascista, Achille Starace, pronunciando una frase lapidaria e stupida: “Roma doma e premia”. Il ministero della Cultura popolare gli passò anche un assegno: 1200 lire ogni mese, ricordo, e io che da praticante ne guadagnavo la metà lo invidiavo. Doveva mandare tre articoli, che di solito non scri veva, e compilare certi rapporti, mormoravano, sulla si tuazione: che si dice, che cosa si pensa in giro. L’opi-nione pubblica, insomma. Avrà riferito qualche chiacchiera, descritto qualche atmosfera, ma non denunciò nessuno. Conosceva un commendatore che era il capo della misteriosa Ovra e aveva un figlio all’università: penso fosse quello il “con-tatto”. Barzellette, credo; non era Graham Greene, non frequentava Fidel Castro, non andava a Cuba, ma sentiva i discorsi del Caffè Zanarini: “Non se ne può più!”, oppure: “Mussolini ha l’uccello più lungo del mondo: lui sta sul balcone di Palazzo Venezia e i coglioni sono in piazza”. Nel settembre del 1943, quando i fascisti torna-rono, pubblicarono un elenco dei loro beneficati; qual cuno aveva tradito. Lo intitolarono: “I canguri giganti”. Nel marsupio erano finite alcune migliaia di lire. Cono-scevo un paio di camerati che avevano ricevuto i soc-corsi: c’era un padre di dieci figli e l’altro aveva una bimba paralizzata dalla poliomielite. Disgraziati, non corrotti. Non ricordo più chi lo ha detto, ma è vero: non c’è lavoro più solitario dello scrivere. Ripenso a Tommaso Besozzi: l’ho conosciuto quando lui era un celebre in viato, io un giovane redattore di un quotidiano di pro-vincia. Aveva l’aria pacata di un qualunque professionista - un medico, un funzionario statale -, portava un lungo cappotto nero da ferroviere. Era riuscito a dimostrare l’innocenza di un italiano condannato a morte in Fran-cia, si chiamava Gino Corvi, mi pare, e a smentire la versione ufficiale sulla fine del bandito Salvatore Giu liano: l’aveva accoppato, per incarico della mafia, il cu gino Pisciotta, non un capitano dei carabinieri. Non gliene importava nulla della notorietà, non ci credeva. All’albergo di Perugia, dove eravamo per uno dei tanti processi del dopoguerra, stavamo dichiarando le nostre generalità. “Besozzi” disse. “Come no!” rispose il portiere. “Nino.” Nino Besozzi era un bravo attore. Mi voleva bene e anch’io a lui. Avevo una lesione a un polmone e dovevo curarmi. Voleva che al mattino mi alzassi più tardi: all’udienza andava il famoso Be sozzi e mi portava un taccuino con gli appunti. Un giorno si mise davanti alla portatile, infilò il fo glio, accese la sigaretta e come sempre buttò giù la prima riga: che fu l’ultima. Rimase bloccato: non sa-peva, non poteva più andare avanti. Le idee si confon-devano, la pagina restava bianca e gli veniva da pian-gere. Era una persona seria e scrupolosa: per conoscere Parigi, quando lo mandarono a fare il corrispondente, la percorse tutta a piedi. Mi pare fosse laureato in chimica, di sicuro aveva studiato il problema: costrùì un ordigno, una miscela speciale, e se lo legò al petto. Fu un attimo. Non basta il talento: contano anche la buona salute e il carattere. E una certa tranquillità economica. Tommaso Besozzi e Giancarlo Fusco, secondo me, in certi “servizi” erano bravi come Hemingway. Gian carlo, del resto, gli assomigliava anche nella vita: amore per l’avventura e anche qualche inclinazione per le panzane. Pur che fossero straordinarie, eccessive: sfide con l’eroe malandrino, che picchia e magari uc cide, poi se la spassa con le dorme dai capezzoli che tol-gono il fiato, e in compagnia, magari, di altri malfat-tori. Aveva fatto il pugile e, quando arrivò all’Europeo, organizzarono una colletta perché andasse dal dentista. Insieme scrivemmo una commedia, E vissero felici e con-tenti, e se la gioia del pubblico fu relativa, i due autori invece trascorsero in letizia alcuni mesi, o meglio, una sterminata serie di notti, inventando o raccontando trame fragorose, con in più il naturale abbandono alle confessioni. Ebbe molte vicende d’amore, oltre a una brava mo-glie e a una brava figlia. Mi diceva che in Francia aveva vissuto con una delle protagoniste di un film molto am-mirato: Prigione senza sbarre, una biondina pallida ed esile. Fece finta, penso, di riconoscerla in una storia del cinema. Poi era stato compagno, durante i giorni della guerra e dello sfollamento, in una casa abbandonata della Versilia, di una celebre attrice di prosa non più giovanissima, ma che aveva ancora un culo indimenti-cabile. Acquistava, diceva Giancarlo, un particolare ri salto mentre la signora, che era emiliana, stendeva la pasta per le tagliatelle. C’è un rapporto tra cucina e lus suria? Visse una tresca con la moglie di un architetto, una intellettuale - “Mi rompe un po’ i coglioni” confessava “perché ogni tanto vuole che andiamo a vedere l’alba” -, ma nessuna, penso, lo ha amato come l’Erina. Era figlia dell’unico facchino della stazione di Forlì e leggeva soltanto fumetti. Ma lo aspettava per ore e ore, sempre disponibile a tutto, anche ad accompa-gnarlo all’inaugurazione di mostre d’arte e perfino a qualche conferenza sui crimini della censura. Aveva molta dignità e, quando si accorse che Gian-carlo inseguiva altri sogni, se ne andò lasciandogli gli anellini che le aveva regalato e i soldi per arrivare alla fine del mese. Tanto tempo fa mi ha telefonato da un grande al bergo: fa la cameriera. C’era in Giancarlo tanta prodigalità e molta inno-cenza: costruiva ogni momento la sua leggenda. La sua presenza era ambita nei salotti: lui parlava e loro se la spassavano. “Com’è bravo” dicevano; e a me sembrava che l’offendessero. Non so se gli diceva di suo padre ammiraglio, bra-v’uomo napoletano, credo, ma di cui non aveva tanta considerazione, e di sua madre ebrea spagnola, forse da lì arrivavano i capelli crespi, e cavallerizza da circo, intelligentissima, che durante un volteggio sbagliato aveva perso un occhio. Lavorava per passatempo il le gno, capiva tutto e pronunciava giudizi fukninanti. Qualche sera andavamo in giro: magari con Gar belli, un boxeur intelligente, ormai fuori carriera, o con Antonio Delfini, lo scrittore la cui grandezza è stata sco-perta, accade, a decesso avvenuto. Le ragazze del night lo conoscevano anche perché, quando era in quattrini, largheggiava in prestiti senza ritorno e senza la pretesa di qualche prestazione. Mi parlava delle sue esperienze di gestore di un lo cale notturno a Viareggio, quando arrivarono gli Alleati: serviva champagne falso agli inglesi e agli ameri cani e whisky di giomata fabbricato in cantina alle truppe di De Gaulle. Poi, con un serpente al collo, travestito da fachiro, andava tra i tavoli a leggere la mano. Era una povera biscia d’acqua e ogni tanto si addor-mentava: doveva tenerla vispa con qualche pillola di simpamina. Interpretando il destino degli altri, guada-gnò tanti soldi, ma non si preoccupò mai del suo. Fini-rono presto, però continuò a divertirsi. Una sera guardavamo la televisione: c’era una com media, recitava una svampita creatura dal naso imper tinente, dalle tette incombenti, con un falso nome stra niero. Giancarlo scoppiò a ridere - quando era allegro batteva i piedi -: “Ma guardala, la pupa, la Serena, come è brillante, spiritosa. E distinta. “Io l’ho vista, quand’era giovinetta, ebbe un piccolo guaio: facendo l’amore con un veterinario, rimase inca-strata. In automobile, poi. A lui non veniva più fuori e lei urlava: “O Dio, o Dio”. “Provarono a mettergli attomo un pezzo di ghiac-cio, ma non si sgonfiava. Corse anche la mamma di Se-rena che piangeva: aLa mia bambina”. “Li portarono all’ospedale con l’ambulanza, avvolti in una coperta. Non fare lo stronzo, è vero: il termine tecnico è “penis captivatus”, si potrebbe anche tra-durre: auccello in gabbia”.” Guascone, improbabile, geniale. Generoso con tutti, tranne che con sé stesso. Sono arrivato al punto in cui amo discutere soprat tutto con chi è d’accordo: ma ho sempre cercato la compagnia, anche nelle letture, di uomini che avevano vissuto. Mi commuoveva Martin Eden, lo scrittore in cui Jack London ritrovava sé stesso: e mi piacevaJack con la sua leggenda. Fece tanti mestieri, anche pericolosi, mozzo e cercatore d’oro, e sognò, da socialista anar chico, la rivoluzione mondiale. E se Martin Eden, mi pare, si annega in mare, London affogò nell’alcol. Una vocazione appagata al prezzo di una infinita solitudine. Quando andai in Norvegia, cercai quello che rima neva di Knut Hamsum. Ci risiamo: ciabattino, carbonaio, commesso e maestro di scuola, spaccapietre, ven-ditore ambulante, giomalista fallito: poi raccontò con Fame le sue imprese di vagabondo. “Egli” ha detto Henry Miller “sapeva come creare musica dall’infeli-cità.” Piaceva anche a me per il suo nichilismo: i perso-naggi erano i beats, i maledetti, i bohémiens, gli sconfitti del primo Novecento: quando abbordavano una dorma dicevano: “Dio mi castighi se ho mai visto una ragazza così bella”, e impazzivano quando riuscivano ad acca rezzare il seno di una sartina o si sfogavano con “le mo-gli dei marinai, quelle grasse pollastre da mercato che si stendevano sotto il primo portone per un boccale di birra”. Hamsum ha vissuto novantasette anni ed è finito, per la sua gente, da traditore. Gli piacevano i tedeschi; anche nel 1914 stava dalla loro parte. E gli andava bene anche Hitler “per quello che faceva per i bam-bini”, mi disse una sua vecchia amica. Si può essere dei creatori, possedere un ingegno ec-celso, vincere il Nobel, ma non capire nulla di politica. Diceva Flaiano che anche da noi abbondano i cretini di talento. Venne ricevuto dal Fuhrer, si commosse per le cor tesie di Adolf, non si rese conto - lui che aveva condan-nato l’ingiustizia - di quello che significava l’ideologia dei nazisti. Andai a Norholm, nel sud della Norvegia dove è vissuto e dove è morto. Vi abita Arild, uno dei figli, che di mestiere è boscaiolo e fa pagare un biglietto d’in-gresso; l’altro, Tore, dipinge e gestisce un camping. “Non era un estremista” mi disse Arild. “C’erano in lui molti contrasti, primitivo e rafffinato, umile e sde gnoso.” Un tribunale gli aveva confiscato tutti i suoi averi, ma non aveva voluto avvocati, si era difeso da solo: “Chi osa affermare che io, a questa età, andavo alla ri-cerca di onori? Giovani giudici, volete punire il vostro vecchio poeta nazionale?”. Non lo avevano ascoltato. La sua tomba è in giar-dino, sotto un albero dai fiori gialli. La baracca di legno dove lavorava è rimasta come allora: il tavolo che si era fatto, la lampada verde, gli occhiali a pince-nez, la cannuccia per scrivere e il rozzo calamaio, i suoi romanzi tradotti in diciannove lingue e le sue letture preferite: Dostoevskij, Strindberg e Nietz-sche. Qualche fotografia: alto, calvo, i baffi, severo; sordo, mi dissero, e con la voce forte. Attorno ci sono aceri, rose, viole mammole che tre-mano al soffio sottile dei primi freddi, e davanti alle rocce il mare. Il paesaggio incorrotto della sua solitu-dine. Quanti fallimenti. Sono portato alla sconfitta, vado a cercarla. A Varsavia mi sarebbe piaciuto incontrare Marek Hasko, andare in giro con lui. Mi dissero che era finito in Israele, beveva e non riusciva più a scri-vere. Chiuso, e non aveva ancora trent’anni. Lasciò la Polonia in segno di protesta o perché, a Berlino, si era innamorato di una attrice. Fece un monte di chiac-chiere - comunismo, dittature, democrazia -, ma, quando disse che voleva ritomare, trovò la porta sbar-rata. E Marek beveva, e gli editori aspettavano inutil mente i suoi racconti, e i giomali disdicevano gli impegni. Non aveva più niente da dire. Hasko, la speranza della letteratura polacca, consu mava le ore in qualche stanzetta di Tel Aviv facendosi corrodere dalla nostalgia. Ma non si può tomare indie tro. Ha scritto un piccolo capolavoro: L’ottavo giorno della settimana. Del resto anche Radiguet, a vent’anni, poteva morire: lasciava un’altra storia di amore cru-dele: Il diavolo in corpo. Marek Hasko sopportava la condanna dei suoi eroi: gli ubriachi che non riescono a ribellarsi alle bottiglie di vodka, gli idealisti che il conformismo umilia o distrugge, i poveri innamorati che non possono mai es-sere soli perché, come diceva il giovanotto Petrek, asulla terra non c’è posto per loro”. A Budapest passeggiavo una sera, quando il cielo si riempiva dei riverberi di tante stelle rosse, sul viale della Repubblica popolare. Per me era sempre viale Andrassy, luogo d’incontro degli amanti infelici di Zi lahy e di Kormendi, la fioraia offriva ancora ai fidanzati mazzetti di miosotis e l’aria sapeva di acacia. La mia finestra, all’Hotel Duna, guardava sul Danu-bio e al tramonto, sulla riva, sfumata dalla nebbiolina, un uomo e una donna si abbracciavano. Dice una poe-sia di Endre Ady: “Amo l’amore che muore, amo ba ciare chi se ne va”. Ci penso: in quante camere di albergo si è consu-mata la mia storia. E io non ho alcuna vocazione per i viaggi: cerco sempre, a New York o a Pechino, lo stesso ristorante, lo stesso hotel, le stesse strade perché mi sento più protetto. Ho vissuto da emigrante: anche quando lasciai Bo-logna per andare a Epoca; Milano mi sgomentava. Finii in una pensione con Alberto Cavallari e Mino Monicelli: sembrava di essere in convento. La padrona non voleva che si usasse la doccia: lavandino e arran giarsi. Tra gli ospiti c’era una commessa, amante di un droghiere: ogni tanto si sentiva odore di capelli bru ciati, si faceva i riccioli. L’amico, quando veniva in visita, le portava pacchi da bottega e le diceva anche i numeri che la moglie, in terprete dei sogni, giocava al lotto. La signorina vinse; e per me questo resta un caso di adulterio, di tradi-mento perfido. Hotel Duna, Ungheria: la biondina che mi diceva: “Olasz, italiano? Tu conosci Giovarmi?”. Giovanni commerciava, da quello che capii, in be stiame, aveva promesso di sposarla. Ma tardava ad arri vare. Hotel Bristol, Varsavia: conobbi al bar l’attore Cy bulski. Era bravo come Marlon Brando, come Montgomery Clift, aveva recitato in Cenere e diamanti; uno strano ragazzo, portava gli occhiali anche nella vita, in dossava abiti senza pretese, poteva essere uno di quei giovanotti che si incontrano nei caffè intellettuali di Pa-rigi o un allievo dell’Actor’s Studio di New York. Ren deva benissimo l’eccitazione nevrotica, gli abbandoni, la solitudine della gioventù. Stava in un angolo, bottiglie e sigarette, un po’ scontroso: “Io non conto nulla,” mi diceva “sono stati d’animo che si respirano; forse il regista mi ha ordinato di vivere”. Ha esagerato con le bottiglie, il treno si è mosso troppo in fretta. Hotel St. Moritz, New York: che ne sarà stato del vecchio “generico” di Hollywood, quello che faceva sempre il gangster cattivo, e lo trovavo spesso mentre acquistava pacchi di sigari e faceva la corte aUa giorna-laia? Quanti Hotel Mandarin, Excelsior, Grand Hotel; quante Bibbie nel cassetto del comodino e magari qualche rivista pornografica; odori di bagnoschiuma e di dopobarba, ascensori che vanno e vengono: davvero la mia vita è anche una serie di cartoline illustrate? Fu in un motel lungo il Mississippi che, aperta la te-levisione, seppi dell’attentato a John Fitzgerald Ken nedy. Ho alloggiato al Caravelle di Saigon: dall’ultimo piano, dalla terrazza, si scorgevano nella notte le luci di posizione degli elicotteri che stavano bombardando, servivano birra ghiacciata e champagne e negli ascen sori si incontravano fragili fanciulle vietnamite che ri devano con gli ufficiali americani perché bisogna pur vivere. Una volta l’Intourist mi ha fatto trovare un posto al National di Mosca. Vi alloggiò anche Lenin quando ar rivò da San Pietroburgo per amministrare il potere dei Soviet. Potevo vincere la noia guardando la fila dei tovarisc, dei compagni, davanti al suo mausoleo. Niente tovarisc adesso, tutti signori, tutti gospodin. Al piccolo Rembrandt, ad Amsterdam, passai una domenica divorato dalla febbre; si sta più male da soli. Si accavallano, come in un album, le figurine; basta una parola: stanchezza, o ambiguità, o inganno, meglio: mistero del cuore, e i fotogrammi si animano. La signora dai capelli candidi mi fece sedere sul di vano sotto romantici quadri ottocenteschi, paesaggi verdi di boschi e di acque; si chiamava Olga Scheinpflu-gova, era attrice ed era moglie del dottore in filosofia Karel Capek, di professione scrittore. Aveva i modi della gran dama, contava nella vita di Praga, negli occhi lucidi si specchiava un altro mondo che il tempo ha cancellato. Raccontava: “Il suo difetto era l’ingenuità. Aveva fede in tutti e in tutto. Per diciarmove anni siamo stati amici, veniva ogni giorno a trovarmi: io recitavo, lui scriveva. Per tre marito e moglie, poi l’incomprensione ci divise. Le creature sono deboli, vero? “L’accordo di Monaco lo sconvolse, decadde anche fisicamente. Capì che si avvicinava la fine, vedeva giu sto, vedeva prima degli altri. Lo amavano, sentivano che parlava per tutti, anticipava nelle sue pagine il co mune destino. “Le salamandre di un suo romanzo stavano per di-lagare nelle nostre campagne, distruggevano le spighe e le sementi: indossavano la camicia bruna; i “robot” senza cuore - lui aveva inventato questa parola - vole-vano imporre la loro regola agli altri. Karel Capek aveva capito tutto. “Soffriva di disturbi cardiaci, peggiorava sempre. Scendeva in giardino a innaffiare i bulbi, a strappare le erbacce, ma sempre più con affanno. Karel aveva venti sei amici: tredici sono spariti con la guerra. Cadde per terra, svenuto, e non si riprese. Aveva quarantanove anni. “Nel primo giorno dell’occupazione suonò il campa nello: entrò un ufficiale della Gestapo con la scorta. Non sapevano che non c’era più, erano venuti per arre-starlo. L’ufficiale scivolò sui gradini di legno, rotolò giù.” La signora, poi, fu amante diJan Masaryk, l’ultimo ministro degli Esteri liberale, il suicida del Palazzo Czer nin. Lo gettarono, dice qualcuno; si buttò, dicono altri. Due grandi passioni, dunque; due grandi sconfitte. Lo ha detto Lee Master: “Questo è il dolore della vita: / che per essere felici bisogna essere in due”. E Paul Léautaud, che odiava le donne, ha armotato nel diario: “Tutte le storie di amore si assomigliano”. Arthur Miller ha avuto tre mogli: purtroppo non ho visto la seconda, Marilyn, la ragazza che un romanziere inglese aveva definito “il più potente mito sessuale del secolo”. Ho conosciuto il giovane Arthur nel 1952, fresco dei primi grandi successi teatrali: magro, occhiali, faccia da intellettuale sofferente, un tipo che “amava il si-lenzio contemplativo e viveva in un mondo in bianco e nero”. Era il tempo del maccartismo e forse aveva paura. Anche lui aveva fatto molti lavori: carpentiere, camio-nista... Sono precedenti che a me piacciono; da ragazzo qualche mestiere l’ho fatto anch’io. Ci siamo rivisti dopo un quarto di secolo, quando c’era già stata Marilyn, la leggenda e la morte. Ne par-lammo, con pudore, naturalmente. “Se sapessi perché mi innamorai,” disse “potrei ri solvere tutti i problemi del mondo. Per me è stata una grande gioia e un grande tormento. Non c’è stato nes-suno che abbia patito, agonizzato più di lei. Un disastro, dal principio alla fine. I giornalisti l’hanno ferita più di quanto un essere umano possa ferire un’altra crea tura.” Ferire gli altri con le parole, o i giudizi impietosi, o la battuta. “Il comista sportivo”, si diceva in redazione di un collega che scriveva di calcio, pensando alle sue sventure coniugali. Forse l’ho detto io, e ancora mi ver gogno: non resse alla fatica di vivere. Un giorno ho saputo che cosa c’era dietro la cu-pezza e la solitudine di uno degli scrittori che ho amato di più: per il rigore e la coscienza. Aveva diretto anche giomali, ma con poco successo: non si adattava all’arn biente e soprattutto ai compromessi. Aveva sposato una ragazza russa e l’aveva portata al suo paese, sulle montagne del Sud: un’Italia antica e miserabile, chiusa dalle cime e dalle tradizioni. Il fratello si era invaghito di quella strana creatura che veniva da lontano; credo andasse a caccia, lo trova-rono appoggiato a una quercia. Solo un forellino nella giacca di fustagno, all’altezza del cuore, e un biglietto nel portafogli: “Riposo nel bosco. Quello che è stato è stato”. Storie tristi, torbide, forse bisogna sapere accettare. “Non era facile essere sua moglie” mi disse Katia Mann. Aveva l’orgoglio del suo valore e amava che gli altri lo riconoscessero. Trovava Einstein “simpatico, tran-quillo, con qualcosa di molto infantile”. I discorsi di Charlot lo facevano ridere fino alle lacrirne. Bruno Wal-ter lo accompagnava in carrozza ai suoi concerti. Era ospite di Roosevelt e la regina d’Olanda lo invitò a prendere il caffè. “Il loro matrimonio” ha scritto il fi-glio Klaus “fu una alleanza tra due persone sensibili e sole.” Una stroncatura lo faceva soffrire per giorni in-teri; del resto anche Andersen piangeva per una critica ostile. A Venezia Thomas Mann intravede un bellissimo adolescente, che gli ispira un romanzo, e se ne invaghi sce. Ricordava Katia: “Ebbe un faible per quel ragazzo che lo aveva letteralmente affascinato, e ci pensava molto spesso”. Il genio, l’egoismo della creazione giustificano tutto? Katia mi disse: “Gli sono stata fedele per tutta la vita”. Lui, in occasione di un compleanno, le aveva de-dicato un brindisi: “Noi rimarremo assieme, la mano nella mano, anche nel regno delle ombre”. Una volta aveva scritto a Heinrich, il fratello: “La letteratura è la morte”. Il sesso, quasi un’ossessione. Era un saggista, uno straordinario narratore di paesi e di peccati; proprio quello che si dice uno squisito indagatore dell’animo umano. Un giorno, in redazione, lo videro tutto preso dai suoi pensieri, concentrato. Stava compilando un elenco. Si rivolse al vicino di scrivania: “Scusa, tu ci sei stato a letto con mia moglie?”. L’altro non rispose: era anche un po’ offeso, forse perché si sentiva il solo escluso dalla festa. Amo James Joyce e a Dublino ho ripercorso, e con una certa commozione, i suoi itinerari. I racconti, letti nell’adolescenza, hanno segnato un punto incancella bile. Era una domenica un po’ triste come ovunque e la baia di Sandy Mount appariva ancora più mesta e de serta, con la sabbia bianca scoperta dalla marea: un uomo, un bambino e un cane si muovevano sul fondo. Passai davanti all’abitazione che fu del dottor Wil-liam Wilde, chirurgo; si rovinò la reputazione perché aveva sedotto una minorenne, poco più di una bam-bina. Forse questa storia ebbe un peso nel destino di Oscar. Ogni immagine riportava a James Joyce, aveva qualche riferimento con le sue pagine: gli aceri mette vano le foglie rosse, fiorivano le siepi di biancospino, i meli erano una nuvola. Gli usci di Merion Square, dipinti in modi diversi e stravaganti, con le maniglie di ottone che brillano, na scondono tanti segreti. In questa cappella lo studente James ascolta un’i-rata omelia sui peccati e sull’inferno che lo turba pro fondamente; dietro a questo angolo, era ancora liceale, ha l’incontro con la sgualdrinella che scatena con sen sazioni torbide le sue invenzioni. Quando ha ventidue anni conosce Nora Barnacle, “bel fiore selvaggio di macchia”, che ne ha venti: fa la cameriera in un hotel. Si piacciono, si ritrovano ed è la rozza ma vibrante fanciulla che lo fa “diventare uomo”. E la vicenda amo-rosa che più conta nella sua vita. Come si ripetono certe favole. Il programma di artista di James Joyce è: “Non la-sciare intoccata nessuna verità”, e lo rispetta anche nelle vicende personali. Hanno scoperto, e pubblicato, le lettere mandate a Nora dall’estero, quando l’aveva lasciata per andare a tentare la fortuna, per esplorare altre, più accoglienti contrade. Sono confidenze vibranti un po’ allucinate, terribil-mente sincere, un gioco eccitante con le frasi e con il sesso, esaltato e descritto con una crudezza che di si curo ancora offende quelli che lui chiama i “fetidi” bor-ghesi. Quella donna che ha un fisico da bambina è invo-cata come una “puttanella, canaglia, sporcacciona e de-pravata”. Non la sposa se non quando si pongono pro-blemi di eredità, perché entrambi respingono le con-venzioni e i riti, ma sono legati dall’ardore e dalle sven-ture comuni. Lei, per James, è tutto: e lui la rievoca con slancio, tenerezza e ironia: “Mi viene da ridere, ora, a pensare ai piccoli seni ridicoli che hai”; “Descrivimi le cose più minute di te, ma che siano oscene, segrete e sporche”; “Vorrei che tu portassi sottovesti nere; vorrei che tu imparassi a piacermi, a provocare il mio desiderio”. James scriveva ancora a Nora: “E strano da quali pozzanghere fangose gli angeli traggano uno spirito di bellezza”. Di che stupirsi? Un altro irlandese, il citato Oscar Wilde, diceva che tutto è concesso, anche sulla strada, purché non si disturbino i passanti e non facciano im bizzarrire i cavalli. Zelda, la tormentata e noiosissima consorte di Fran as Scott Fitzgerald, prima di fare l’amore ama passeg glare nei cimiteri, trova eccitazione nelle ombre e nei crepuscoli: poi commenta: “A letto siamo stati formida bili”. Ricordo un fatto di cronaca che passai in tipografia. C’era un bizzarro personaggio che aggrediva le donne sole e imbarazzava la polizia. Non le toccava, non era violento, ma esigeva che gli consegnassero le mutan-dine. Fu fermato, in auto, a un blocco stradale. Gli fe-cero aprire il baule. Un campionario, di tutte le fogge, tessuti, pizzi e colori. Che vergogna. Un notissimo me-dico, era anche commendatore, padre di famiglia e gli usammo il riguardo delle iniziali. In questa materia non c’è autorità o ruolo che ten-gano: la contessa di Castiglione assisteva a una sfilata aperta da Napoleone III, naturalmente a cavallo. “Quella testa orgogliosa” confidò a una amica “io l’ho avuta tra le gambe.” Un personaggio di García Márquez dice sconsolato: “Il sesso è talento, e io non lo possiedo”. Gabriel García Márquez sostiene anche che “si nasce con le proprie scopate contate, e quelle che non si realizzano sono per-dute”. Un altro che mi piace. Il testo che più ammira è Don Chisciotte. Passa per estremista perché ogni tanto va a trovare Fidel Castro e gli porta una valigia di libri; ma bisognerebbe essere nati dalle sue parti e poi cercare di capire. L’ho incontrato al bar del Camino Real, a Città di Messico. E un uomo dall’aspetto forte, la faccia leale, baffi e capelli grigi. Parla con misura e con umore, non c’è bisogno di fare tante questioni, e ogni pausa è un sorso di whisky annacquato. Mi fece bere la “marghe rita”, che è un miscuglio di tequila, cointreau e limone, sembra niente, ma si fa sentire. Parlava della Colombia dove io dovevo andare, ed era un po’ quella che avevo immaginato leggendolo: sperduti villaggi con l’alcade, le guardie, il giudice, il parroco e il dottore, case con pareti di fango o di canna selvatica, piazze desolate, mosche, aria che sa di sonno, di caffè e di cuoio, giovani donne mulatte scatenate nell’amore, zanzare e formiche volanti, rumori di stivali e di arrni, un senso di immobilità e di putredine, cam-pane che battono le ore, ma nulla cambia, sono sempre gli stessi che comandano perché “la vergogna ha la me-moria debole”. Tutto laggiù sembra una magia: i gigli sanguinosi e le salamandre dorate, il canto dei galli che annuncia il nuovo giorno e i racconti dei patriarchi che parlano di fatti lontani e meravigliosi, vicende di spiriti e di disgra-ziati sempre in balìa del destino. Mi disse che a Bogotá c’era una corruzione che po-teva stare alla pari con quella messicana e che i poveri stavano diventando ancora più poveri, nonostante l’e norme quantità di denaro che entrava con il traffico della droga. “Non scandalizzarti,” disse “sono orgoglioso anche di questo. La mia gente trova sempre un modo per non morire. Da noi si dice: “E la puttana vita”.” Gli chiesi: • Cos’è la sinistra? “L’unica forma di promozione umana possibile.” • E la destra? “Tutto il contrario.” Allora era esule e sperava di ritomare alla sua terra, alla mitica contrada di Macondo, perché, dice José Ar-cadio Buendía in Cento anni di solitudine, “non abbiamo ancora un morto. Non si è di nessuna parte finché non si ha un morto sotto terra”. E vero. Lo so, lo sento. Passeggiai poi una notte per le strade quasi deserte di Bogotá. C’erano bambini che vendevano sigarette e rabbrividivano nell’aria gelida, sporca di grasso, di unto, vibrante di un detestabile suono di chitarre. Un uomo, in un androne, avvolto negli stracci. Tanti, tanti poliziotti. Un custode, con il poncho scolo rito, sonnecchiava nella garitta. Al night “Tierra colombiana”, per qualche tavolata di turisti, quattro giovanotti equivoci e quattro balle rine dalle grosse natiche danzavano su una musica as-sordante l’esile intrigo di una ribellione di schiavi. Su uno schermo apparivano diapositive con mari azzurri, chiese barocche, campi di fiori e contadini ras-segnati che andavano a cavallo di pazienti muli su itine rari sconosciuti. Parlando del suo Paese e del potere, Gabriel diceva: “Loro harmo l’esercito, io la penna”. Un po’ serve. Non mi sono mai sentito un missiona rio, né un profeta, ma un uomo del mio tempo, com presi i pregiudizi, ma la notte, se i denti non mi infasti discono, voglio dormire. Chissà quante volte ho sbagliato, ma non ho mai scritto una riga che non corrispondesse al mio pensiero. Condivido una frase del Diario di Jean Cocteau: aVolevo essere creduto”. Felicità e dolore Non so dove l’ho letto: “Felicità è seguire un cane man-giando ciliegie”. C’è anche l’interpretazione di Snoopy, il bracchetto saggio dei fumetti: aE una coperta calda”. Cerco di ricordare qualche fatto. Le massirne sono troppo perentorie. Una scena che vidi all’Opera di Pechino. Un barca-iolo dalla barba bianca traghettava all’altra sponda una fanciulla che andava incontro all’amore. Mimavano il viaggio e li accompagnava il suono di uno stridulo vio-lino. La ragazza abbracciava l’aria. Oppure i vecchi che alzavano, in una sera ventosa, i loro aquiloni sulla piazza Tien An Men. Erano draghi di carta, farfalle che palpitavano in un intreccio di colori, uccelli impossibili; i vecchi vestiti di nero correvano storditi come bambini. I due fidanzati di Hyde Park: forse avevano litigato, lei piangeva e lui le leccava le lacrime. La signora spudorata che diceva: “Non ho mai in-contrato un uomo che non mi piacesse”. Forse era vero. Ecco. Il comunista di Parma che era contento di vi vere con i matti. Aveva inventato per loro una casa e una vita. Il posto si chiamava Fattorie di Vigheppio; sui muri avevano dipinto rondini azzurre che andavano chissà dove, c’era un laghetto per pescare, alcune voliere, una stalla con cavallini dal pelo lucido, pecore, il recinto dei maiali costruito con le sbarre del manicomio. Gli aveva comperato anche alcune giostre, ridevano e urlavano nell’inutile inseguimento al suono delle mu-sichette. C’era un uomo senza storia: l’avevano portato e chiuso nell’ospedale psichiatrico che aveva sette anni, non aveva ricordi, non conosceva nessuno, era uscito dopo cinquanta, portava il miglio alle tortore o passeg giava solo sotto i pioppi. Vidi anche una coppia di innamorati: lei dolce, defi-ciente, che lo accarezzava; lui iroso, che diventava buono, e passeggiavano tenendosi per mano. Si erano conosciuti prima, là dentro. Lei lo condu ceva sotto gli alberi, in silenzio, e aspettavano insieme di morire. Avevano solo paura della sirena dell’ambu lanza. Sono i risultati di un’inchiesta: i preti e i medici, di-cono, sono i più terrorizzati dalla fine. Non sempre, non credo sia vero. Padre Augusto Gianola aveva la leb bra ed è stato ucciso dal tumore. Quando lo conobbi, nella foresta dell’Amazzonia, dove era andato a predicare, era il abianco” del villag-gio, mi parve lieto e con la pace nel cuore. Era un pomeriggio, nell’ora del tramonto, dondola vamo su una barchetta tra le erbe lacustri del Rio delle Amazzoni. Alcuni ragazzi si tuffavano lontano, da una capanna usciva il fumo della sera. Una luce rossastra sfiorava le cime degli alberi. • “L’uomo”—dissi—“è fatto per la donna.” Sta scritto. Nelle lunghe notti, quando la solitudine è an cora più forte, vengono quelle immagini? “Sì, vengono.” Non volevo confessarlo e ho paura a entrare nel mi-stero degli altri. Mi bastano i miei peccati. Ma padre Gianola parlò: “Un sacerdote con gli oc-chi di una donna, con l’amore di una donna, può fare molte cose. Bisogna stare attenti a non isolarsi, a non chiudersi. Non saprei spiegare il problema del sesso; se il tuo orizzonte non va oltre questa terra, diventa pre ponderante: uomo, donna, figli, e questo basta; la pic-cola storia si esaurisce in qualche decennio. ((Ma se guardi all’eterno, e intravedi un’altra esi stenza, la tensione dei sensi si attenua, quasi scompare. “Io voglio bene alle donne, mi piacciono, mi aiu tano, ma non le considero un ostacolo, un’ossessione. Gesù dice che nell’altra vita saremo come angeli di Dio. Non avremo questi affanni.” Padre Augusto era bello e forte: costruiva capanne, insegnava a seminare e a pescare, curava i malati e at-torno al fuoco raccontava le meraviglie compiute da un certo Gesù che resuscitava perfino i morti. Chissà se la felicità è distacco, tolleranza o indiffe-renza. Stoccolma, tanto tanto tempo fa. Con Lars fi-nimmo al Djurgarden. Il silenzio del parco era rotto sol tanto da qualche risata femminile. C’erano molte auto mobili ferme sul bordo della strada. Disse Lars: “E venerdì, giorno di paga. Bevono, si divertono”. Sedemmo su una panchina, le onde del lago si fran-gevano dolcemente fra i rami cadenti dei salici. Qual che anatra selvatica spiccava brevi voli. “Ancora un sorso” mi invitò Lars. Aveva nella tasca dell’impermeabile una bottiglia di acquavite Skane, che ha il profumo dell’anice. • Penso mi faccia male—dissi.—Non posso bere tanto. “Dopo i gamberetti ci vuole” spiegò Lars. “Ci vuole perché è notte e viene l’affanno, ci vuole perché fa freddo e l’autunno sta arrivando.” Scricchiolavano già per terra le foglie secche dei faggi. La confidenza era totale.—Lars, --chiesi— perché ce l’avete tanto con noi? Siamo diversi; gente del Sud, il senso del peccato ci insegue. “Non vi capisco. Vedete una ragazza, ma che dico?, vedete una gamba e diventate matti. “Senti questa” raccontò Lars, sempre più avvolto nel profumo dell’anice. “C’è un matrimonio. La sposa ha già un figlio. Il particolare non disturba il marito. Alla festa è invitato anche il padre del bambino. Il gio-vane pastore che celebra le nozze, commosso, confida a un testimone: “E pensare che il primo fidanzato della si-gnora sono stato io”. Non siamo gelosi. “ Nella penisola di Bygdoy, il quartiere elegante di Oslo, dove è situata anche la residenza del re, ci sono alcuni musei dedicati all’epopea marinara; gli scafi delle leggende. Quello del Fram, che andò a indagare la vita tra i ghiacci polari, quello della Kon-Tiki, la zattera che attraversò il Pacifico dal Perù alla Polinesia. Il legno è secco, prosciugato dal tempo e corroso dalla salsedine e le vecchie polene hanno una irraggiun-gibile gentilezza. Una donna fiorente dai capelli rossi, forse una regina, con lo scettro d’oro e le vesti bordate di azzurro, stringe due rose rosse in mano, guardando orizzonti infiniti. E una raccolta di battelli, argani, fiocine e foto in giallite è dedicata anche ai “grandi Leviatani del profondo”. La balena è stata a lungo il simbolo della Norvegia: hanno dedicato monumenti all’inventore del cannone che spara l’arpione. Da quell’immenso cetaceo, il più grande essere vivente, ricavavano barili d’olio, stecche per corsetterie, rossetto per labbra, creme, saponi; c’e rano in gioco soldi, poi la sfida. “Mio padre” mi confidava Grete, una ragazza dagli occhi chiari e dal volto lentigginoso “senza le balene non avrebbe potuto vivere. Per lui era una scelta di vita, e fu vita felice.” Figlio di contadini, a sedici anni si era imbarcato come mozzo; lo incantavano i racconti che aveva ascol tato nelle stalle: parlavano di Drang, quell’essere strano e favoloso che, secondo la leggenda, naviga da sempre su una barca tagliata a metà e porta alla morte ogni peccatore che la scorge. Gli piaceva la vita di bordo, dura, piena di pericoli ma con buone paghe che molti si bevevano nelle taverne o dissipavano con le puttane. Si tassavano con ge-nerosità per le famiglie dei compagni che sparivano nei flutti o per i vecchi che restavano nei porti a rimasti-care memorie e a guardare lontano. “Partiva” raccontava Grete “a novembre, ritornava ad aprile; quattro figli, uno a ogni ritorno. Mia madre allevava i bambini e attendeva. Noi lo vedevamo com parire con una lurlga barba e con i regali. E narrava le sue storie: quella della balena blu, ad esempio, che pe-sava centocinquanta tonnellate. Non si doveva mai col-pire la madre con i figli. “Per fare il baleniere bisognava avere carattere e prestanza. C’è un racconto famoso che narra del naufragio della Essex di Nantucket, e dice che mai tra loro si vide un timido e chi si mostrava codardo ne sarebbe stato bollato per sempre. “Papà diceva: “Dobbiamo smetterla prima di ucci derle tutte. Il mare è buono: che cosa saremmo senza il mare?”. “ Aprì le pagine di un libro dalla bella rilegatura di cuoio, un diario, credo, e lesse: “”Stanotte la gente è al-legra. Di una letizia totale, in piena purezza di spirito e di cuore. Tutta la storia degli ardori e dell’inquietudine è abbandonata laggiù, nella città lontana e addormen-tata. Non resta che il desiderio di partire. Senza altro pensiero che la manovra. Senza altra speranza che il vento in poppa. Non importa per dove””. “Capisce?” mi chiese. Qualche volta è accaduto anche a me. Come una voglia, un bisogno di fuga. Magari da me stesso. Ac cade un fatto, da qualche parte: andiamo a vedere. O la curiosità: ecco un nome che evoca letture o fantasie. Finlandia, ad esempio. Gli italiani, anche nell’Otto cento, si mettevano in viaggio per andare a cercare l’ul-tima Thule e per vedere come viveva la gente laggiù. Erano suonatori di organino, saltimbanchi, funam-boli; una carovana arrivò con due cammelli e fu una meraviglia, perché nessuno li aveva mai visti. Facevano i fuochi d’artificio, il Teatro delle scimmie e dei cani, il Museo delle statue di cera: Napoleone e lo zar di Rus-sia, Benjamin Franklin e Robespierre. Di solito i posti sono più belli quando li immagini. Ma la Finlandia non ti delude: ti sorprende. I finlandesi sono, all’apparenza, imperturbabili. Fin da piccoli irn parano a non piangere; non si deve. Sono chiusi e si sciolgono solo dopo molti brindisi. Non hanno tra guardi da inseguire o simboli da venerare. Amano la luce e accendono le candele nelle tavolate delle cene, alle finestre e sulle tombe la vigilia di Natale. La liturgia di chi è immerso nel buio. Ho visto le ragazze felici la notte di San Giovanni. Ci sono riti che vanno rispettati: si decorano con fra-sche le porte, i tram, si infiocchettano anche le corna delle vacche. Le fanciulle si rendono seducenti e si rotolano sul l’erba umida a mezzanotte. Poi, se recitano formule magiche, nude, attorno a una fonte, nel tremolio della corrente possono vedere la fisionomia dell’innamorato che arriverà. “Cosa vuol dire lappone?” disse Aslak. Ero a Inari, alloggiavo in una locanda oltre il circolo polare artico. Le betulle avevano già i colori dell’autunno: giallorosso, c’era ancora qualche fiore dell’ultimo Nord: il rododen dro con i petali rosa fragola, e il ranuncolo glaciale, che è l’arnica alpina. Sul tavolo una bottiglia di Polar: è un’acquavite fatta con le bacche. Facilita i rapporti. “”Lappone”” spiegava Aslak “in svedese significa correre, e noi siamo grandi camminatori, in finlandese aterre remote”, o anche sconosciute, per altri significa “ultima frontiera”. “Non si sa da dove veniamo: forse i miei nonni erano mongoli. Siamo i più piccoli di statura, e ab-biamo inventato gli sci: perché vagabondando, an dando contro la natura e l’ignoto, siamo più felici di chi sta fermo a sudare nel campo. Dice un nostro prover bio: “L’acqua stagnante è fangosa”. “Noi inseguiamo i salmoni che risalgono la corrente per seminare le uova, o la renna randagia che va a cer care il lichene o la foglia. Devi essere come lei: che scava, e sotto mezzo metro di neve trova il suo cibo. Per noi il tempo non è denaro. Le nostre bluse, i nostri cal zari non hanno tasche perché il soldo conta poco; il ber-retto ha quattro punte perché quattro sono i venti: tutte le strade ti sono aperte.” E con Aslak vissi un giorno fausto; pensavo agli eroi di Jack London, che venivano qui a sfidare le streghe e il Fato, pensavo a quanto poco basta per vivere. Aslak volle dammi una prova della sua benevolenza: aSe vuoi,” disse “andiamo a Heikkila a trovare mia ma dre. Sta sola nella capanna. Tomeremo che sarà notte”. Cercammo un vecchio finlandese di nome Jaako, nessuno come lui conosceva il fiume. Il Fasku è largo e disteso, scivola tra il verde, ma c’è l’insidia delle secche e dei massi che la corrente sfiora. Jaako tirò fuori la barca da un carmeto, mise una ta-nica di carburante sotto una incerata, perché minac-ciava la pioggia, e si piazzò al timone, la pipa tra i denti, fisso a scrutare le sponde, le insenature, i mulinelli; non sentii mai la sua voce. Mi tomava in mente Capitani co-raggiosi: le avventure dell’adolescenza. Era bello andare così, anche se ogni tanto ci assali-vano nuvole di zanzare, mosquitos, diceva Aslak, osser vando il guizzo dei salmoni, i voli radenti di sconosciuti uccelli dal piumaggio bianco e nero, il muso sospettoso di un alce dietro una macchia di larici. Ascoltavo il rumore un po’ cupo del motore che la sciava dietro di sé una sottile scia spumosa e l’aria odo rava di umido e di terra, di muffe e di erbe lacustri; per ore e ore nessun grido, nessuna presenza, qualche frul lio d’ali, forse un commorano che aveva puntato la sua preda, un tasso o una martora curiosi, su un ramo, e il vento che faceva rossa la pelle e spostava in cielo grandi cirri neri. Quando attraccammo, due cani ci vennero incon-tro abbaiando: riconobbero Aslak e gli fecero festa. La capanna stava su un poggio; si sentiva fievole il campano della renna che fa da guida. E un animale ca strato, allevato per condurre le mandrie durante le mi-grazioni: cerca l’uomo e il gregge lo segue. La vecchia Inga venne ad accoglierci; indossava una sottana coperta di fiori e un berrettone di lana rossa. Non ci furono abbracci: toccò una spalla di Aslak e lui le sorrise. Jaako le passò la bottiglia e la vecchia buttò giù un sorso. Poi ci fece entrare e mise sul tavolo fettine di came affumicata, pane e pomodori. Parlò con il figlio. “Vuole sapere da dove vieni” disse Aslak. “E proprio vero che c’è sempre il sole?” chiese la vecchia. • Quasi—dissi. Nello stanzone tutti gli amesi erano di abete e da un palo pendevano mazzi di code di volpi rosse. “Mamma” disse Aslak con orgoglio “sa dove mettere le trappole.” Cominciò a piovere a dirotto, si sentiva lo scroscio sulle foglie, sui rami, sul tetto, e l’acqua tirava fuori il sapore verde del legno. Chiesi se la vecchia non aveva paura a restare sola. “Anche il troppo ragionare” disse Aslak “vuol dire paura.” Inga mi fissò con gli occhi socchiusi e raccontò che aveva sognato Isak, il suo uomo, che le diceva: “Quando una notte vedrai le renne con il fiocco bianco, quella volta scenderanno dagli alti pascoli per te”. Una volta caricavano il defunto sulla slitta e le renne del traino sventolavano sulle coma una specie di vessillo candido e guai a fermarle: tutti le lasciavano passare. “Mamma” disse Aslak “non vuole case di mattoni, né chiavi; dice che non c’è nessuna porta per chiudere fuori il futuro.” Il finlandese si alzò in piedi e fece capire che biso gnava ripartire. Lei rimase sulla riva a guardarci: Aslak agitò per un momento la mano. Poi la nebbia coprì ogni cosa. Qualche volta ho pensato che la capitale della feli-cità è Parigi. Sono un provinciale e per tanti anni ho creduto alla leggenda. Ha scritto Hemingway: “Qual-siasi dono tu le portassi ne ricevevi qualcosa in cam-bio”. Ci pensavo da giovane: e l’idea nasceva dai libri e dai film francesi; i romanzi populisti e i film di Carné ci insegnarono, tra le tante certezze del fascismo, il dub bio. Stavamo con gli operai del Front Populaire, e ce li siamo portati dietro. Adesso è un appuntamento con la memoria e con la nostalgia. Tutti avevano trovato da quelle parti un’i dea e un rifugio: il russo Chagall, l’italiano Modigliani, il giapponese Foujita. E negli anni folli Simenon faceva il cronista di “nera”, Jean Gabin il ballerino alle “Folies Bergère”, Sylvia Beach stampava l’Ulysses di Joyce, al 14 di rue de Tilsety stavano i Fitzgerald e Zelda, già mezza matta, chiedeva a Hemingway: “Ernest, non credi che AlJolson sia più grande di Gesù?”. C’erano gli americani Dos Passos, Pound, Thornton Wilder: si ritrovavano alle Sei Giorni, agli incontri di pugilato, alla rivista negra che lanciava le gambe eterne diJoséphine Baker; alle esposizioni e alle corse dei cani e dei cavalli, o alle aste dell’Hotel Drouot. “Parigi” ha scritto Hemingway “è una festa mobile.” Nella suggestione, forse, entra anche la retorica e perfino l’operetta. In Eva, di Franz Lehár, un ritornello attacca così: “La parigina è bella ed elegante, / così ca-rina, così affascinante, / col suo sorriso fa innamorar, / col suo profumo fa inebriar”. In poche parole: le famose “donne nude” o, se vo lete, Brigitte Bardot. Tra le scritte sui muri del 1968 una proclamava: “Godere senza ostacoli”. Dal Moulin Rouge si è passati al Crazy Horse, da Emma Bovary a Emmanuelle. Questa Parigi delle godurie non l’ho conosciuta. L’ho vista, la prima volta, di notte: anzi l’ho attraversata. Andavo in Inghilterra, passavo da un treno all’al-tro per arrivare al Pas de-Calais. A Londra si sposava la principessa Elisabetta, futura regina. Intravidi appena le strade di René Clair e di Duvi-vier e le piazzette di Utrillo, ma conosco appena, e da fuori, la Parigi della “gioia di vivere”, quella della moda e dei profumi che si chiamano “Femme”, “Vertige”, “Eau folle”, ((Je reviens”, quella che inventa il taglio corto, le mèches, la permanente. Domandai a Manouche, una vecchia cortigiana che fu ritratta anche da van Dongen, e nella cui storia c’e rano artisti, gangster, politici, industriali e banchieri, che cosa avrebbe consigliato a una ragazza che si affac ciava alla vita: “Di far bene l’amore; è essenziale”. • E per un giovanotto?--chiesi. “Avere un bell’arnese da dare alle signore.” Non credo sia così, o solo, o tutto. Sono stato a Taizé: è un villaggio quasi sconosciuto, poco lontano da Ars, la parrocchia che ebbe un curato che poi diventò santo, e dall’abbazia di Cluny, da dove partì un’avven turosa crociata. Qui accorrono a cercare la pace gio-vani cattolici, ebrei, miscredenti; fratello Roger, il fon-datore, è protestante. Offre a tutti silenzio e preghiera. C’è una cappella dell’XI secolo, umida e buia, e una chiesa dalle vetrate che narrano la storia sacra, attorno alla quale, nella buona stagione, si alzano le bianche tende di coloro che inseguono, tra la paura e l’ango scia, “la speranza dei disperati”. Fratello Roger ha una pacatezza che incanta e un sorriso candido: “Cerchiamo con Cristo e con i Vangeli di avere un cuore aperto a tutto il mondo. Per avere questo bisogna andare a pregare e a vivere con persone molto povere. Si cerca Dio, si tenta di comprendere i più infelici; e con questo l’anima si rallegra”. Questi discorsi mi riportano al mio primo viaggio: Roma, Perugia, Assisi. Un itinerario mistico. Avevo tre dici anni e vinsi un concorso di religione dell’Azione Cattolica. Non ricordo proprio i miei meriti, ma il pre mio era una udienza dal Santo Padre. Non esisteva an cora la direttissima Bologna Firenze; partimmo di notte, con due amici più grandi, e mio padre mi com però un cuscino da viaggio. Porretta, Pistoia, Firenze e finalmente Roma. Allog giai da una mia zia portinaia, in via Tor di Nona, a Tra stevere. Nella casa viveva anche una contessa decaduta a cui la zia mi presentò con orgoglio: “Va dal papa”. C’erano nella stradetta bancarelle con venditori d’olive, mi portarono alla zoo e in San Pietro, risento l’umido delle catacombe, al Colosseo e finalmente en trammo nei Giardini vaticani per la foto di gruppo. Poi vidi da vicino papa Ratti: un vecchio vestito di bianco, dalla voce affaticata, che mi consegnò un gagliardetto. Chissà cosa ne è stato di quel vessillo con la croce. Fece un discorso, ma non so più che cosa disse. Nel ritomo passammo da Perugia per salutare un monsignore, entrammo in una bella chiesa - chissà qual era -, ma sui muri mi colpì, messa sotto vetro, la firma di Giosue Carducci tracciata con il lapis. Ne de dussi, con semplicità infantile, che anche i poeti pos-sono essere maleducati. Assisi, all’alba, mi commosse: soprattutto per il suono delle campane. E poi san Francesco che parlava agli uccelli; mi diedi una spiegazione: si era accorto che gli uomini non gli davano retta. So anche di un signore che morì felice. Dicono che prima di chiudere si rivede tutto, almeno quello che conta, velocemente, come in una pellicola. Il cavaliere del lavoro se ne stava andando e nel l’ora suprema aveva attomo i suoi cari. Era una per sona semplice e generosa, aveva fatto tutto da solo: un piccolo genio della meccanica, specialità le pompe. C’è una iconografia sui decessi illustri: le stampe mostrano l’Aiglon agonizzante, su una poltrona, con at tomo tre cortigiani che piangono. Vittorio Emanuele II, padre della Patria e anche di alcuni bastardi, ha accanto, oltre ai soliti dignitari, come si addice a un robusto peccatore, un prete che gli amministra il viatico. Il cavaliere era assistito dall’unico figlio, Giovanni, che gli teneva una mano, e dalla moglie, che pregava in un angolo. Fu preso da un delirio evocativo, e a sfondo erotico, assai insolito per un agonizzante. Sospirava: “Quando andavo in giro con il campionario, quante scopate. A Ferrara la Yvonne: che tette, che tette”. E Giovanni: “Papà, c’è la mamma!”. E il morente: “E a Parma, la Maria, che matta; non stava ferma un momento. Ma che culo, la Maria”. Continuò fino all’ultimo sospiro, elencando le virtù di figurette, o figurone, femminili che avevano rallegrato la sua operosa esistenza. Né volle risparmiare al-l’erede - colto, amante delle arti e della contempla zione - un ultimo consiglio: “Chiava, Giovanni”. Non si era mai visto un funerale con tanta parteci-pazione di popolo: il cavaliere si era distinto anche per le opere benefiche. Intervistai il regista Truffaut, era giovane, simpa-tico e geniale. Mi disse: “Non sono un uomo di idee ma di sensazioni”. E una definizione in cui un po’ mi ritrovo. Non so dire che cosa è il dolore; credo che neppure i fatti siano uguali per tutti. Dondola la lampada, mossa dal vento nel duomo di Pisa; la vedono il sagrestano e Galileo Galilei. Il sagre-stano pensa: “Devo decidermi a spolverarla e a control-lare la catena”. Galileo pensa: “E la terra che gira attomo al sole”. La mela che cade per Newton è la legge di gravità, per il contadino un’angoscia: come andrà il raccolto? Il dolore per me è qualche figura, impressione, mo mento: qualche episodio e qualche dramma. Che so: il bimbo che piangeva perché aveva ormai consumato la matita azzurra e non poteva colorare il cielo. Una volta ero a Praga, in una triste domenica, e passeggiavo in piazza San Venceslao; in una vetrina avevano esposto un manifesto turistico, rappresentava la Tour Eiffel, due fidanzati che bevevano Pemod e at-tomo tanti oleandri in fiore. Una piccola folla contem plava quel sogno in silenzio. Irraggiungibile. La donna vestita di lino bianco che celebrava un rito funebre buttando nel Gange petali di rosa e ver sando latte: a quali dèi la corrente avrebbe portato il la-bile omaggio, e per quale anima? Gli occhioni sbarrati dei bambini affamati di Moga-discio: tutti in fila, due tre anni, né una lacrima né un sorriso, mentre aspettano la distribuzione della pap petta. La bambina egiziana che aveva le treccine bionde e gli occhi azzurri. Della troupe televisiva, non so perché, scelse me. Giravamo un documentario su Sadat, nella campagna. Sua madre era fuggita con un uomo, suo padre era stato ucciso dal calcio di un cammello. Mi prendeva la mano, mi guardava e mi sorrideva, mi seguiva. Credeva che la portassi con me. Quando si accorse che andavamo via, mi voltò le spalle e scappò piangendo. Vorrei parlare di Linda. L’ho conosciuta al Policli-nico San Matteo, a Pavia. Inchiesta sull’Aids. Sono un campionario di ricordi, e nell’archivio delle emozioni, Linda, con quel volto affilato, con quei di scorsi strani, penso che non si cancellerà mai. La ascol tavo e avrei voluto abbracciarla. L’aveva contaminata la droga. Era assistente sociale e interpretava con eccesso il suo ruolo: si era messa con un ragazzo tossicodipendente, forse pensava di salvarlo. Cominciò anche lei, ci provò: “Per curiosità, lui era già perduto e io cercavo di aiutarlo. Abbiamo continuato fin che siamo stati insieme: sei o sette Natali. Una vita maledetta: fatiche, strapazzi, umiliazioni”. Parlava con distacco, come se lei non fosse Linda. E un giorno scoppiano i linfonoduli: una parola che non capisce. Allora le spiegano che si tratta di quello. Il ra gazzo - si chiama Marco - la pianta: perché lui ha biso gno di avere accanto una persona che lo tenga su, e ne ha trovata una giusta che è anche più giovane di Linda, e piena di soldi. E fortunato, ma non troppo. Linda sorrideva. “E mi ha stroncata. I dispiaceri non fanno bene a nessuno. Da quel momento, sempre peggio. Mi fa pena, perché vedo anche lui mezzo morto. “Abbiamo avuto anche momenti felici, ma c’era sempre un continuo affanno a cercar quattrini, con l’in-cubo di soffrire. Quella polvere ti trasforma: volevo ammazzare tutti. Penso di aver preso il male con la si ringa; eravamo tutti pieni di ghiandole. Marco, pove-rino, ha cominciato a diciotto anni, è stato anche in carcere. Io sono rimasta incinta, e ho perso anche il fi glio. “Meglio interrompere” dissero i medici. “L’ultimo legame con Marco era un cane. Me lo ha portato via, ed era di tutti e due. Stanotte l’ho sognato, e urlava, urlava. “Faccio sogni strani, spesso un cavallo simpaticis simo, un po’ pazzo, abbastanza allegro: stavolta voleva andare in un appartamento, saliva le scale voltandosi indietro e rideva. “Ho paura della sofferenza fisica, l’incertezza mi fa soffrire, ho sempre timore del peggio. Non frequento mai la chiesa ma prego Gesù Cristo, di solito. Niente te-levisione, niente letture. Non mi voglio distrarre, devo affrontare eventualmente la morte.” Disse “eventualmente”, e si mise a piangere. “Mi piace la natura, gli animali, gli uccelli invece mi spaventano. Non ho rancori né rimpianti: mi sembra anche di avere vissuto abbastanza. Non si pensa mai alla morte e ci si arriva impreparati. “Credo nella reincarnazione: penso che è una for-tuna nascere uomini, perché c’è la possibilità di raggiungere Dio. Ho sprecato qualcosa. “ Non arrivò alla fine dell’estate. La casa di riposo dei vecchi attori, a Bologna. Dalle finestre si vede la Madonna di San Luca e, mosse dal vento, le cime dei cipressi della Certosa. Ogni ospite ha la sua stanza, dove i bauli che viaggiavano da un teatro all’altro, da un grande albergo a una pensioncina, sono stati vuotati per sempre. Le parti che vennero recitate sul palcoscenico re-stano distribuite anche nella vita; e la primadonna si chiude nel suo orgoglio, e la comprimaria si promuove, nel cartellone dei ricordi, a ruoli più prestigiosi. Ho ascoltato i racconti di tre comici che pretende-vano di avere stretto tra le loro braccia la divina Eleonora Duse, smarrita, nell’agonia, laggiù, nella nebbiosa Pittsburgh. Mimy Aymer mi mostrò le immagini che le erano più care: foto di scena, nella villa che possedeva a Viareggio; con in braccio un leoncino: fu scattata a Can-nes. Poi gli autografi: da Pirandello a Trilussa, da Al-fredo Testoni al critico Simoni, che le dedicò perfino due versi: “E fu presa una rosa, il sole vi si unì, / vi ag giunse anche il talento, e fu fatta Mimì”. “Che peccato, la vecchiaia” diceva la signora sfo-gliando le pagine. Aveva avuto tanto, tutto. Case a Milano, Roma, in Versilia e sulle montagne svizzere, ed era ancora prigio niera di quella stagione: “è cambiato tutto e molto in fretta”. Cominciò a sedici anni, nel “varietà”; fu la prima a presentarsi con le gambe nude, come si usava a Parigi. Cantava in francese. Che tempi: colazione al Savini; tè danzanti, l’orche-stra suonava gli hesitatiorls, lei indossava abiti di pizzo e aveva al collo una volpe azzurra, la consideravano “una donna di lusso”. Il marchese Ricci di Civitanova schiaf-feggiò il conte Gerbini perché aaveva detto cose poco carine sul mio conto”. Per le serate d’onore riceveva fiori e gioielli a profu sione: preferibilmente brillanti e rose baccarat; passò alle operette, e Lehár la prese per mano per dividere gli applausi, ma con Ruggero Ruggeri debuttò addirit tura al Globe di Londra. Poi gli incontri fatali: un certo Ambrogio, avvocato milanese, che lei battezzò subito Lorry, che aprofu mava di buone sigarette orientali”, poi un tale mago Cester previde l’incontro con un altro uomo di legge che asapeva di gardenie”, e che lei chiamò immediata-mente Pouffy. aNotti di pianti e d’amore” rievocava con tene rezza, magari su un divano coperto da un manto di er mellino. E ancora un certo Didik, all’anagrafe Aldo, fatuo, ambizioso e amatto da legare”. Anche Umberto di Savoia l’ammirava. Le piaceva, ammetteva, perfino fisicamente, ma solo pettegolezzi. “Era splendido, il principino. In Sudamerica la stampa lo aveva definito ahermoso muchacho”. Mi mandava delle corbeilles. Ma posso giurarlo: non ho mai fatto niente di male con Sua Altezza.” Inseguiva i ricordi. E ancora ci fu “un bel ragazzo bruno. Me lo presentò Armarldo Falconi: “Ecco la nostra stella nascente” disse. Voleva diventare scrittore. Si chiamava Galeazzo Ciano. Era buono, simpatico, te-nero e molto intelligente. La sua voce carezzevole mi scendeva nell’animo. Nacque tra noi una forte simpatia che ci portò piuttosto lontano e che impensieri il suo grande padre. Era furibondo per la gelosia. Pensava che mi abbandonassi a Umberto. Furono tremende sce nate. Io gli dissi: “Non ti voglio più vedere”. Diventò di-plomatico e fu la sua rovina. Povero Galeazzo, cosl caro”. In guerra Mimy aveva perduto tutto: la macchina rossa con cui correva la Mille Miglia, i pezzi di antiqua riato, le collane e gli anelli. “La sola cosa per cui vale la pena di tirare avanti” disse “è l’amore. Qualche volta ho pensato anche di suicidarml.” Diventammo amici; la vecchia attrice non aveva nessuno al mondo: Natale, Pasqua, una scatola di cioc colatini, dei fiori. Lei mi scriveva ogni tanto: “Caro commendatore”. Non poteva credere che non lo fossi: lo erano, suppongo, tutti i signori che aveva conosciuto. Una volta mi dissero: “Non mandi più nulla, non c’è più”. Ci sono momenti in cui il mestiere ti pesa e ti vergo-gni di provocare certi discorsi, specialmente quando hai davanti facce pallide che sanno ancora sorridere e conoscono il pudore delle parole. Milano, corso Plebisciti, quarto piano. Una casa di piccoli borghesi. E una sera che ha i lievi tremori della primavera. E accaduto il 19 maggio 1980, nel pomeriggio: due colpi di pistola, poi l’esplosione di un candelotto fumo-geno e Guido Galli, giudice, è caduto a terra, avvolto da una nebbia arancicne. Diceva la sentenza, affidata al solito volantino, “perché appartiene alla frazione rifor-mlsta e garantista”. Parlai con la signora Bianca, la moglie, con le ra gazze che facevano l’università. La signora Bianca disse: ((Mi manca lo sbattere della porta, e quando en trava il suo “ciao””. C’erano anche i bambini che stavano per andare a dormire: Giuseppe e Paolo. Il più piccolo, Paolo, aveva sette anni e camminava un po’ goffo: aveva voluto che gli dessero le ciabatte del papà. Anche questo è rim-pianto, è dolore. Andai anche dalla vedova del suicida: lo stesso giorno. Mi dissero che era disposta a parlarmi. Si era ucciso in carcere, nella doccia, infilando la testa in un sacchetto di plastica. E il secondo caso che conosco: così aveva concluso la sua storia la moglie di Sabin, lo scopritore del siero antipolio. Era stato presidente dell’Eni, un grande burocrate (o tecnico) socialista, finito dentro per la consueta tan gente. Dieci miliardi, pare, ai soliti insaziabili partiti. Alla fine di un interrogatorio gli avevano promesso che nel giro di qualche giorno sarebbe stato liberato; poi il magistrato aveva cambiato idea. Forse lo aveva stremato quella promessa non rispettata. Centotrentatré giorni in cella, centotrentatré lettere d’amore alla signora Bruna. Poi cominciò con le poesie. Si abbandonava ai rimpianti, alla tenerezza. L’ultimo messaggio diceva: “Cara Bruna, perdo-nami. Sono pronto a un atto di ribellione”. Nessuno dei suoi compagni si accorse che agoniz-zava: lo scroscio dell’acqua copriva il suo affanno. La signora Bruna aveva un volto impenetrabile; prese il pacchetto delle lettere e le rinchiuse in un cas setto: “Questi pensieri” disse aappartengono solo a me”. Anche la sofferenza degli altri mi fa paura; qualche volta ho pensato che è forse una forma di vigliaccheria. Ma non è cosi. Parlai con Peter Townsend, uno dei pi loti della Raf della Battaglia d’Inghilterra, e gli chiesi che cosa si prova quando si vede un nemico precipi-tare. Mi disse: aQuando tutto era finito, uno degli incubi peggiori era la visione di un caccia che andava giù. Me ne restavo immobile a gridare: “Salta, salta”, vorresti vedere spuntare un paracadute: qualche volta succede. E triste vedere cadere un uccello”. Non ci si abitua mai alla tragedia. A Buenos Aires andai a trovare le amadri di plaza de Mayo”; parlai con loro, ascoltai storie di giovani donne, di ragazzi, di bam bini portati via una notte, e mai più ritornati. Su una parete c’erano fotografie, istantanee for-mato tessera, come quelle che venivano mostrate nelle stazioni, al ritorno dei treni dei reduci, nel 1945: aNe sapete niente di mio figlio?”. Poi, dopo l’avvento della democrazia, i generali hanno detto che i 30.000 desaparecidos sono morti ed è inutile che ogni sera queste donne continuino a sfilare davanti alla Casa Rosada, con i loro fazzoletti candidi che nascondono capelli dagli spenti colori e sottoli neano facce segnate dalla fatica di vivere. Un comunicato cerca di seppellirli per sempre. Dice un proverbio russo: aA chi riesce a vedere solo il passato bisognerebbe cavare gli occhi”. E vero: ma la-scia segni che non si cancellano. Sono stato testimone di quelli che si chiamano gli aerrori della Storia”, e ho capito che tutti pagano una parte del conto. Ho conosciuto i signori che rappresentavano il po tere; e qualcuno l’ho incontrato nell’ora solitaria della sconfitta. Andai a trovare, nello Schleswig-Holstein, tra bo-schi di faggi e di abeti, l’ultimo Fuhrer del Terzo Reich. Aveva lasciato da poco Spandau: dieci anni bruciati in quel grigio palazzone. Toccò a lui, al Grande Ammira glio, dare alla radio la straordinaria notizia: aUomini te deschi, donne tedesche, soldati, il nostro Fuhrer, Adolf Hitler, è morto”. Sulla targhetta della porta del modesto apparta-mento soltanto un nome: Donitz. Aveva passato gli ottanta: ancora fiero, la faccia magra, dura e impenetrabile. Aveva combattuto fino all’ultimo senza dubbi, senza pentimenti, senza perdere i nervi. Diceva Churchill: aE l’unico che mi fa paura”. La moglie, la signora Inge, non c’era più. I suoi due unici figli erano scomparsi in mare. aIl loro sacrificio” mi disse anon è stato vano. Con-tribuirono alla difesa della Patria”. Più di 800 sommergibili ubbidirono ai suoi ordini; soltanto 40, alla fine, attraccarono agli ormeggi. Su un piccolo tavolo c’era una statuetta; rappresen tava due ragazzi nudi, i capelli agitati dal vento, che dandosl la mano si dirigevano, forse su una spiaggia, verso I lgnoto. Appeso a una parete un dipinto riproduceva due vascelli dalle vele tormentate che navigavano nella tempesta. Anche le luci dei fanali erano spente. A bordo, pensai, non c’è ormai più nessuno. C’ero quando le vicende di un mezzo secolo arriva-vano in redazione e provocavano le inevitabili ascese e cadute. C’è sempre stata anche nella mia categoria una diffusa tendenza a essere seguaci. Diceva Franco, il Caudillo, parlando ai giomalisti spagnoli: aNon posso lamentarmi di come la stampa mi ha trattato”. E andata così, tante volte, anche da queste parti. La mattina del 26 luglio, dal Corriere della Sera partiva una lettera con una firma assai conosciuta, diretta a Bado-glio, che diceva press’a poco: aSignor Maresciallo, sono sempre stato dalla sua parte: mi dia da dirigere un quo-tidiano”. Fu in quella lontana estate del 1943 che da giovane redattore assistetti alla prima contestazione del capo, con preventiva distribuzione di ruoli. Vidi reduci della aMarcia su Roma”, squadristi, li chiarnavano, scoprire e rivelare insospettabili aneliti liberali. Mi accorsi che esistono persone che hanno facce di ricambio e spesso ne abusano. Il tempo mi diede poi altre conferme. Fuori dal Carlino tumultuava una piccola folla di ar-rabbiati; urlavano: aPenne vendute”. Chiedevano i ri tratti del Duce: ce n’era uno in ogni ufficio. Furono ac contentati: li bruciarono. Ma vennero risparmiate le cornici: c’è sempre la possibilità di mettere qualcuno in mostra perché, come dice un valoroso collega ameri cano, molti hanno il loro dittatore preferito. Volevo bene a Giovanni Telesio, il mio direttore: mi aveva assunto, mi stimava. Veniva da Londra: era stato corrispondente e gli piacevano più gli inglesi dei tede schi. Non lo sentii mai fare discorsi fascisti. Lo accusavano, come è ovvio, di avere rappresentato il regime: in realtà i suoi interessi erano più per il calcio e per le cantanti dell’Orchestra Angelini che per le direttive del partito. Mi ha seguito con affetto per tutta la vita: è andato a morire in Inghilterra. Mi ha fatto sapere da un nipote che voleva salutarmi: un congedo; al telefono sentii una voce che mi fece piangere. Nei quarantacinque giorni, davanti a incredibili conversioni, è l’ora di confessarlo, mi sentii in dovere di rivalutare certi fascisti. Mi veniva in mente un film di René Clair: il prota-gonista, durante i tumulti, saltava da una barricata al l’altra cambiando semplicemente il cappello. Quanti guardaroba ben riforniti ho visto e sto ancora vedendo. Un vescovo che è anche giornalista ha scritto: “Da-vanti a Dio una bugia è una bugia, un servilismo è un servilismo; un silenzio colpevole è un silenzio colpevole; un avvenimento piegato alle nostre convinzioni è una colpa come le altre”. Di quanti peccati mi sarò macchiato? Spero di avere l’attenuante della buona fede. Non tento bilanci: si patteggia, si tende a cancellare. Le memorie si ac-compagnano alla vecchiaia: sono mazzetti di fiori sec chi. Qualche petalo cade. Con il mio amico Oreste del Buono, abbiamo fatto gli inviati insieme e diretto anche un settimanale, ci siamo trovati a parlare di questa ultima stagione che stiamo vivendo. Claudio Altarocca voleva scrivere un articolo. Io dissi: “Una volta nuotavo e guardavo la riva, adesso solo per stare a galla”. La vecchiaia non la prendo in considerazione: o al meno, faccio finta. Oreste, invece, dice che la contempla, si definisce una “cozza”, un asuperstite”, firma Bepi Alzheimer una rubrica dal titolo fortemente allusivo: aLettera e testa-mento”. Si è sempre difeso con l’ironia; io, penso, con la rassegnazione. Ha alcuni fastidi con l’occhio e con il ginocchio sinistro: “La parte sinistra” commenta ami ha sempre fregato: è la più debole”. Con del Buono ci conosciamo da più di quaran-t’armi; ma le nostre storie non interessano più a nessuno. Facevamo dei nomi: il colonnello Stevens, quello di Radio Londra, ad esempio, o il Fronte popolare; io dicevo: aE come se tu raccontassi la battaglia delle Ter-mopili”, e Oreste: “Anche a parlare del ‘68 si trovano delle facce ostili”. Decidemmo che la cosa migliore, quando senti-varno certi impeti, era discuterne tra noi. Io, lo riconosco, sono uno specialista in niente; Ore-ste sa tante cose, dai gialli al cinema, ai fumetti, alla let-teratura, ha tradotto e ha scoperto autori. Ma abbiarno avuto maestri in comune: come Marotta, come Zavat-tini. aIo devo tutto a Emanuelli” dice del Buono. Con Enrico Emanuelli, nel 1947, andai in Inghil-terra: si sposava Elisabetta. Scendemmo in una miniera e all’ingresso un cartello avvertiva: aE stata nazionaliz-zata in nome del popolo”. Ci fecero entrare a Dowring Street e ci mostrarono un’enorme bottiglia di spu-mante, ovviamente vuota: avevano brindato per la fine della guerra. Conservo un quadretto, un drago, che mi portò da un viaggio in Cina. Lo vidi una settimana prima che il cuore lo tradisse; era contento. aNon sono mai stato così bene” mi disse. Il discorso continua:--La vecchiaia c’è, arriva e te la tieni. E tutto è passato così in fretta. Se tu potessi af fibbiarla a qualcuno... “Non gliela darei” dice Oreste. “Ho sempre pensato che non sarei arrivato ai quaranta. Sai, quelle cose romantiche, da giovani. Sono in riserva.” Trascrivo, copiando da Altarocca, le nostre chiac-chiere; non saprei ricostruirle. Io:--La vecchiaia è come un grande bosco, dove hanno buttato giù tanti alberi. Se io ti dico: aTi ricordi Raffaele Carrieri, ti ricordi Alfonso Gatto e Ciccio Alta-villa, con cui si andava a mangiare dal napoletano?...”. Dove sono andati? Nessuno muore come in Italia. Nes-suno ricorda niente. “Niente, niente.” • Se io parlo con te dopo sei mesi che non ti vedo, è come se ci fossimo visti tre giorni prima. I tuoi ricordi sono i miei. Noi abbiamo vissuto e abbiarno scritto, ma non vissuto per scrivere... Tu ti sei fatto il tuo bel lager, io mi sono fatto il resto. “Per me il lager è stata una cosa misericordiosa. Ho imparato a non aver tanta paura della miseria. Coltivo l’illusione d’essere il primo del Buono che muore senza debiti.” • Oreste, la vecchiaia qui da noi è doppiamente triste: non è una delle stagioni più allegre e se hai biso-gno di un’infermiera... “Primo Levi s’è ammazzato per questo” interrompe del Buono. “Aveva la madre e la suocera, due vecchie. Il suo tormento era quello lì, non il lager che ritoma, come s’è scritto.” • Questo Paese non ha memoria. Quando dicevo Fellini senatore a vita... “Dicevi una cosa seria, positiva.” • Guardi i tuoi amici, e ti sembrano vecchi, e tu non ti vedi. “Ci sono delle ore in cui incontri solo vecchi. Perdi-più, dacché zoppico, vedo che c’è una quantità infinita di zoppetti. Ogni tanto mi metto a ridere. Quando cado, quando non riesco a vedere il pisello, quando non tiro su la gamba e non esco dal taxi, vuoi che mi metta a piangere? Rido. Il cadere è l’essenza della co-micità. I vecchi cadono e sono curvi. Ci sono certe ore di mattina in cui vengono fuori con il sacchettino di plastica gelosamente conservato e vanno a fare la spesa. Siccome faccio la spesa anch’io, li incontro. E poi attorno a casa mia, in piazza Tricolore, ci sono i barboni. Ce n’è uno che parlava sempre da solo: adesso s’è fatto il telefonino finto, con un legno tinto di nero.” • Ce n’è uno—dico—che viene a dormire sotto la gronda a casa mia e ha una bambolina con la quale parla, la sera. E stato in un lager e ha l’ossessione del chiuso. E anche nitido, pulito. C’è una fontanella e lui si lava, si tiene. Quando si è vecchi, si deve essere molto puliti e bisogna stare attenti a non avere i calzini rotti, perché se vai all’ospedale... Li ho visti, i calzini rotti, in quelli ammazzati a Modena dalla polizia nel ‘48... Cal zini in ordine, Oreste. “Sai, non è sgradevole, la vecchiaia. Tu pensa ai miei vecchi all’Elba, che stanno a guardare il mare. Per me è un’idea fantastica.” • Quando vado al cimitero, che è dietro casa mia, a Pianaccio, e vedo quelle facce in maiolica - li cono scevo tutti - è come andare a veglia: ciao, ciao, ciao. Hemingway diceva che pensava a Dio qualche volta di notte: io anche di giorno. “Sì, anche di giorno. E molto naturale. Io credo.” • Ho sempre pensato che non sono un lombrico. “Signore, perdona le mie miserie” dico tutte le sere. “Io mi inginocchiavo anche duramente. Adesso fac-cio più fatica. Pregavo di crepare prima degli altri. è una forma di egoismo, perché ero affezionato ai miei. Adesso son morti tutti e non chiedo più niente. Trovo molto volgare chiedere. “Morire è la natura, è il ritorno alla natura e la vec-chiaia ha una sua dolcezza. Siccome sono diventato or-mai cane completamente, mi metto spesso sul tappe tino e dormo pochi minuti senza cuscino e non mi viene in mente niente. La vecchiaia non è drammatica. Se è una disfatta, nasce con noi. Abbiamo un con-tratto.” • • Mi dà una gran tristezza guardare i miei nipotini dico.—Diventeranno vecchi. Questa è la sorte. “Ricordando... Io ricordo sempre di più mio padre. Mentre avevo creduto per tutta la vita che mia mamma fosse una vittima, ho scoperto che vittima era più mio padre.” • Anch’io ricordo di più mio padre. Ho grandi complessi nei suoi confronti. Penso che avrei voluto dare a lui, che è morto giovane, quello che ho potuto dare dopo a mia madre. “Io ho avuto la fortuna” dice del Buono “che lui è sopravvissuto di poco tempo a mia mamma. Ho potuto testimoniargli questo mio sentimento.” • Io no. E un mio rimorso. Sei istintivamente dalla parte di tua madre, specialmente se sei maschio. Non voglio fare del freudismo d’accatto. “No, no. E la conquista del padre. Ora sono diven-tato come mio padre, che però era bello. Non è più morto.” • In certi momenti, ho l’impressione di parlare con tutti e due. Dico: “Papà, mamma, che faccio?”. Mi danno forza. “Anch’io parlo con tutti e due. Però mia mamma mi ha spedito volontario in guerra e mio padre invece mi voleva imboscare. “ • Diventar vecchi... Proibirsi di diventar vecchi vuol dire accettarsi. “Certi aspetti della vecchiaia fanno davvero ri-dere.” • Ti ricordi i film di Macario? La mia segretaria Pierangela ha ritrovato le foto di Macario con le dedi che affettuose. Macario e Bagolini, un altro comico, bo-lognese, brutto. Quando tornava da Roma... C’era un’attrice che mi piaceva tanto: Luisella Beghi. Un poeta strano scrisse dei versi pazzi su di lei. “Era Orazio Napoli. Scrisse: “Luisella Beghi nel La-zio antico / foglia di fico sull’ombelico”...” Si diventa vecchi, ma non è sicuro che si diventa saggi. Ma c’è un’ora della verità, in cui sei solo con te stesso. E non puoi ingannarti. Lo sapevo da quando mi mandarono a un batta glione universitario, a Sassuolo: stetti male e dissero che la colpa era del cuore. Per due volte ho subìto qualche riparazione: spie gano che, in fondo, non si tratta che di una pompa. Qualche intoppo alle condutture. Lo conosco bene: ca-pisco quando proprio non ne può più. Così una mattina invece di un taxi ho chiamato una autoambulanza. Certo, per tutti viene il momento dei riepiloghi, del distacco. Come corre in fretta la tua storia: tutto era ieri, il sorriso di una donna, il profumo delle stagioni, la speranza. Anche Dante, pensavo, anche Leonardo, hanno vissuto queste ore, provando lo sgomento della resa, come i poveri vecchi bacucchi abbandonati nei ri coveri. Una notte, nel box della rianimazione, mentre aspettavo il nuovo giorno, che non arriva mai, e vedevo ombre che si muovevano in una luce azzurrina, io, che non recito preghiere da quando ero ragazzo, ho ritro-vato e ripetuto le parole del Padre Nostro. Mi sono ad-dormentato mentre albeggiava mormorando: “Non ci indurre in tentazione”. Ero in pace. I pensieri si accavallavano: le mie montagne, casta-gni, faggi, abeti, sentieri, il rumore dei fossi; quei monti sono fatti da miliardi di conchiglie, ogni goccia finisce al mare: anch’io sono un mollusco, una stilla, ma posso piangere. Rivedevo i miei compagni di scuola: sorridenti, pan taloni alla zuava, chi aveva i soldi portava maglioni come Robert Taylor, che fu un bellissimo di Holly-wood. Pensavo a mia madre che morì mentre ero a Parigi a intervistare il professor Toni Negri; mi dissero che aveva invocato mio padre, da vecchia non ne parlava quasi mai: “Dario, abbracciami, vengo”. Pensavo a mio padre, che non ha letto i libri che ho letto io, e alla sua dignità: morì in una corsia di ospe dale e mi fece l’ultima raccomandazione: “Prendi l’oro logio che è attaccato alla sponda del letto, se no te lo fregano”. è andato perso in un bombardamento. In sala operatoria ho contato le luci del lampadario che sfolgorava: sette. Per molte ore io non c’ero più. Era il 21 dicembre 1993. Il giorno di Natale, nel vas-soio, oltre alla minestrina, c’era anche una fetta di pa nettone. Non ne sentivo voglia. Rimase nel piatto. Avevo perso la voce: è ritornata. Sono cambiato. Ho segni sulla pelle e anche dentro. Ho rimesso i de biti: senza fatica perché non mi sono mai sentito un creditore. Ho avuto molto, da tanti. Continuo a lavorare: non so fare altro. Un foglio di carta e una biro: e mi faccio compagnia. Ogni giorno è una sorpresa e una meraviglia. E ogni notte la stessa preghiera: “Abbi misericordia”. Viaggio tra i peccatori. Mi dissero: “Vai all’Abetone a intervistare Zeno Colò. Ma prima passa da Modena: hanno appena chiuso i ca sini”. Zeno Colò era un campione degli sci, i casini una ri spettata istituzione. Non dimentico il garbo e l’accoratezza della signora che, per dimostrarmi il danno e il dolore, riaprì il locale per me e per il fotografo Breveglieri. Spalancò addirit-tura le finestre: tutto era in ordine. Non si sa mai. “Senta,” diceva “senta che materassi.” E faceva rimbalzare le molle. “E guardi che pulizia.” Tutto era rimasto come prima: la casa, i salottini, la sala da pranzo per le pensionate; mancavano soltanto le signorine. C’era ancora un lieve sentore di acqua di Colonia, di disinfettante, di sudore. “Che male facevamo?” si chiedeva la padrona. “Pa gavo le tasse e non mancavano le mie offerte alla par rocchia. C’era ordine, niente malattie, nessuna vio lenza. Ogni quindici giorni si cambiava: pensi, ho avuto anche una mulatta e perfino una inglese. Nessuna va leva però Mary detta “La Grande”: rimane due anni in fila, ha sposato un geometra di Spilimbergo. E adesso abbiamo gli allievi dell’Accademia e cinquecento sol dati della caserma di fanteria disorientati. Cosa fa ranno quei poveri giovanotti?” Potevo dare il mio appassionato contributo, se non ai lamenti, alla rievocazione: pensai a San Marcellino e alla gentile signora Irma. Quando dovette smontare l’a-zienda, organizzò una piccola festa e, pensando ai clienti, sospirava: “Hanno fatto tutti carriera. Come sta il dottor Bini?”. Impedito da superiori esigenze di servizio, mandai un affettuoso telegramma di saluto e mi vergognai per alcuni stupidi scherzi del passato lontano. Quando ero in cronaca, ricevevo spesso comunicati che erano accompagnati da biglietti da visita con le for-mule rituali di ringraziamento. Esempio: Dottor Gio-vanni G., Prefetto di Bologna. E poi: “Molto grato per l’accoglienza che vorrà riservarmi”. O anche: Aw. Francesco C., Federale di Bologna: “Con saluti fascisti”. Avevo anche quello del cardinale; ma non osai. Li portavo infatti a Marilù che li infilava nella spec-chiera per dimostrare che aveva estimatori nei migliori ambienti della città. La domenica mattina la signora Irma usciva per la consueta passeggiata in via Rizzoli, accompagnata dai nuovi arrivi: ci passava davanti con molta dignità e non riconosceva nessuno. Rispettava le forme anche nel look, si direbbe adesso, delle ragazze. Niente stravaganze: giarrettiere regolamentari, tuniche di satin bianco con ampi spac-chi, qualche piccolo travestimento, ma solo a richiesta; c’era il professore di diritto che le voleva, conto a parte, vestite da collegiali. Solito rituale erotico, ma non sguaiato: c’era quella che si passava la lingua sulle labbra o che faceva ballon-zolare cospicue tettone. Quando arrivava qualche persona di riguardo, si chiudevano tutte le porte: quelli che aspettavano sui di vani rossi, magari rileggendo le dispense, commenta vano: “Passa un prete”. Ricordo certe mattine livide trascorse con qualcuna delle ospiti che ti accoglieva a letto, per “capriccio” di-ceva, o per simpatia. Una luce opaca filtrava daUe per-siane chiuse. Ho scritto molte lettere a collegi di suore per avere notizie della salute e degli studi di una bam-bina, firmate, che so: Trentin Maria, o Degli Esposti Venusta, annunciando che seguiva vaglia. Credo che nessuno abbia raccontato quel mondo con la stessa umanità di Maupassant in Maison TeUier. Quando il racconto uscì, più di cento anni fa, un critico parlò di “spazzatura”. Non c’era ancora la televisione. Bisogna distinguere. Anche aUora, tra “le belle pol-lastrelle”, c’era un’Alphonsine Plessis, più nota come Marguerite Gautier, che si invaghì di un giovanotto perché “preferiva la sua anima al suo corpo”. Quando morì misero all’asta tutto quello che era stato suo; Eugène Sue si assicurò il libro di preghiere. Il mio andare per il mondo non contemplava, ov-viamente, anche l’itinerario dei bordelli, ma se capiti ad Amsterdam vai a dare di sicuro anche una sbirciata alle ragazze in vetrina: leggono, fumano, ogni tanto ti-rano la tenda. Se sel ad Amburgo, capiti alla Reeperbahn, con i SUOi marmal e i turisti e i vari Colibrì, Salammbo, Safari. L’enorme statua di Bismarck vigila sui casini, i night, le scritte al neon, l’odore di salsicce, le cartacce spazzate via dal vento, la cellulite delle mature bellezze messe in mostra, la fissità delle passeggiatrici con le facce bianche da Pierrot. La città puritana ha relegato il vizio in un quartiere: St. Paul. Al Colibrì c’è il negro che si fa la biondona lat tiginosa. Un disgraziato, la musica gli impone anche il ritmo: venti minuti di esercizio tutte le sere. Una volta, mi dissero, al suo posto si esibiva un piccolo calabrese: si chiamava Peppino. La sua rovina ebbe origine dalla fragilità sentimentale degli italiani: si innamorò, e lei non volle più sapeme. Anche Reno (Nevada) deve molto a un “son of Italy”, un figlio d’Italia: Joseph Conforte, detto Joe. E padrone del Mustang Bridge Ranch, una serie di roulot tes piazzate tra i campi, che ospitano una trentina di ra-gazze dai nomi gentili: Rebel, Meryl, Carmen, messi cane nervose, negrette da copertina, mulatte dagli oc chi languidi, americane del Texas floride e rosee che miagolano: “Baby, dolce cuore, miele”. Joe è amico di tutti: del governatore, di un magi-strato, di un generale che comandava le truppe in Ger mania, e mostra le foto firmate dai divi di Hollywood accanto alla Madonna di Pompei. Un cartello all’ingresso principale informa: “Ti ri cordi quando l’aria era pulita e il sesso sporco? Adesso è vero il contrario”. Forse è vero che le miserie dell’erotismo non provo cano più indignazione. Viene in mente Girotondo, la vec-chia e ironica commedia di Schnitzler: tutti salgono sulla giostra delle passioni. La grande dama e la com-messa, la cocotte e l’attrice, l’ufficiale e il personaggio illustre e l’ometto senza fortuna dicono le stesse frasi e credono alle stesse lusinghe, in una trama senza sor-prese, che lascia dietro di sé noia e disgusto. Ma spesso nel peccato c’è dramma. Penso a Saigon, a quelle notti. Dal cielo scendevano grappoli di bengala che gettavano una luce bianca sul fiume, sui boschi e sulle capanne della periferia. Dalla mia stanza, al quarto piano del Caravelle vedevo, lontane, le scie dei traccianti, poi il vento portava il rombo cupo delle bat terie. A mezzanotte cominciava il coprifuoco. Le jeep della Military Police pattugliavano le strade. Via Tu Do si nempiva di cyclos, caricavano le ragazze che uscivano dal night. Piccoli uomini dagli occhi furbi e dai denti coperti d’oro aggredivano gli americani e offrivano la loro mer canzia: “Bill, ti serve una bella donna per questa notte?”. Continuava la caccia ai G.I. e ai maledetti dol lari, e anche i mendicanti e i lustrascarpe miglioravano la loro razione di benessere: “Cinque piastre, per fa vore. Bill, accidenti a te!, dammi cinque piastre”. Quarantamila ragazze avevano messo da parte gli antichi precetti; una bar girl guadagnava 40 dollari per sera, un impiegato, con tre figli, 30 in un mese. Sono belle le vietnamite: fiere e delicate, snelle, il portamento da principessa; hanno maniere graziose e i giovanottoni dell’Ohio, che sedevano al banco per ore e ore, ascoltando parole sommesse, si sentivano impor tanti. Come i legionari francesi, del resto, che canta vano un motivo che dice: “Non c’è rimasto che il tempo di morire”. “Ehi, tu!” diceva la ragazza per incominciare. “Vieni, siediti, tu sei il Numero Uno. Sei forte. Dammi la mano, lasciami guardare. Vedo in questi segni una storia meravigliosa: la tua. “Io mi chiamo Than Van. Sai che cosa vuol dire? “Nuvola azzurra”. E tu? Senti, John: andrà tutto bene. Ti prego, offrimi da bere. “ John ride e ordina scotch con ghiaccio, mentre ronza il ventilatore e sulle foreste e sui campi cadono le bombe al napalm, e “Nuvola azzurra” sorbisce in-vece tè freddo e sciroppo di menta, e parla, senza dire nulla, e dall’altoparlante piove una voce stridula, una canzone vietnamita, e “Nuvola azzurra” traduce: “Ricorda il tuo villaggio e il colore del mandorlo vi cino alla casa”. Le altre guerre fecero la fortuna, o l’infelicità, di 60.000 geishe giapponesi, di 10.000 coreane e di 13.000 Madchen tedesche; poi venne l’ora del Vietnam. Non ho la passione dell’Oriente, il gusto dell’eso-tico: non mi piace il fritto di serpente, veder tagliare la testa alle tartarughe per bere il sangue che sgocciola, le infinite decorazioni con i rami di pesco, le povere pian ticelle nane, i bonsai, e il Kabuki, il teatro dove gli uo mini interpretano anche le parti da donna, mi ha sem-pre sgonfiato. Ho conosciuto, dunque, le cosiddette “sacerdotesse del piacere” giapponesi, quelle fanciulle educate a sol-levare lo spirito del maschio. Evidentemente il mio era così depresso che non avvertii apprezzabili migliora-menti. Entrarono le ragazze con le faccine ovali di porcel-lana, il trucco assurdo e pesante, il volto, il collo e le spaUe coperti da una biacca gessosa, le labbra segnate da un rosso sanguigno, i capelli nerissimi, il kimono de-corato dai consueti crisanterni. La più giovane cantava una nenia accompagnandosi con la chamisen, la chi tarra. Una geisha venne a sedere accanto a me; mi fis-sava, aveva l’aria estatica delle figure disegnate da Uta maro: ci guardammo per un po’ e considerai una for-tuna il fatto che non potevamo parlarci. A Tokyo c’è un cimitero dove vengono sepolti i bambini mai nati, i risultati degli aborti: e c’è chi porta giocattoli sulle tombe, suppongo per chiedere perdono. A Formosa sono meno rispettosi delle tradizioni: of frono anche sui giornali charming girls e attractive hostes-ses. Per ogni iniziativa delle signorine, dal bagno, che è un gesto di riguardo, alle effusioni, che sono una prova d’amore, c’è una tariffa. Del resto il presidente Mao chiese alla giornalista Agnes Smedley: “Ma cos’è l’a-more?”. Con un collega inglese facemmo l’esperienza, quasi inevitabile, del “bagno turco”, detto anche “il regno del sapone”. La villetta che ospitava i convegni, mi dissero, una volta apparteneva a un mandarino; nel giardino c’e rano i soliti fiori e delle ninfee. Nella sala d’attesa si muovevano grandi pale di legno, un po’ come nel film Casablanca. Da un bruciatore di bronzo uscivano nuvo-lette d’incenso: per me un mistico richiamo all’immi-nente peccato. Una vecchia servì l’inesorabile tè. Poi arrivarono le ragazze disponibili. Scelsi la più piccola: indossava un costume di tela azzurra, con un drago ricamato sul petto. Con molti inchini mi fece en trare nella mia stanza: dietro un paravento decorato con orgogliosi pavoni c’era la vasca. Si spogliò: aveva la pelle bruna, il seno scoperto, si tolse le mutandine rosse: il colore della passione. Per me la scena aveva aspetti comici; disse: “My name is Little Flower”, e cominciò a lavarmi la schiena. Ogni tanto, con soave gestire, “Piccolo fiore” cambiava zona, finché l’aspetto ludico prese il sopravvento su quello igienico. Non ci fu alcun commento di tipo occidentale, tipo: “E stato bello”, o anche: “Siamo formidabili”; ho in mente solo alcune salviette che profumavano di gelso-mino. Il mestiere è lo stesso; ma che differenze tra le ve trine di Amsterdam e le “gabbie” di Bombay, da un sa-lotto quasi decoroso, da messa in scena, alla degrada zione dell’India. Cinquantamila tra prostitute e travestiti, un grande zoo, con gli odori acuti dell’Oriente, l’afrore di frutti maturi, di fiori sfatti che si mescola con il piscio, i gio-chi dei bambini sui marciapiedi e le puttane che si pet-tinano alla finestra. E tra loro anche ragazzine di undici anni e vecchie orrende, che urlano per richiamare i clienti o mimano amplessi osceni. Una specie di Kama-sutra spiegato al popolo: c’è anche la posa della Sacra Vacca, e la signora si dispone, come dire?, a quattro gambe. Quando le signorine ricevono si accende una lan terna rossa. Gli infelici, di solito, sono pericolosi; ma qualche volta ti sembrano immacolati o indifesi. Quando i russi invasero Praga, mi mandarono a Bu-carest; sembrava che da un momento all’altro toccasse alla Romania. Non c’ero mai stato, ma avevo ascoltato i racconti dei miei colleghi più vecchi capitati da quelle parti ai tempi di re Carol e della sua leggendaria favorita, Magda Lupescu. Dicevano che le ragazze di piccola virtù, per invo gliare i passanti, sussurravano: “École francaise”. Mi resi subito conto che era una specialità molto praticata anche dalle nostre parti: non solo champagne, in somma, anche lambrusco. Tutti gli inviati alloggiavano nello stesso vecchio al-bergo, l’Athénée-Palace, aspettando l’invasione: come nel Deserto dei tartari di Buzzati, ma l’attesa era molto più allegra. Ritrovai uno del France Presse - che avevo cono sciuto in Vietnam -, e un inglese del Daily Mirror - c’eravamo incontrati al “Presse Club”, a Berlino, quando costruivano il Muro: viaggiatori in disgrazie, quasi sem-pre gli stessi. “Quando arriviamo noi,” diceva l’inglese ale persone perbene dovrebbero scappare.” Pagavamo in dollari, e con la facoltà di scegliere portate che solo Ceausescu, il dittatore, poteva consen tirsi: caviale e fagiani, vino ungherese “Sangue di toro” e Calvados di annata. Era un continuo viavai di ragazze: noi rappresenta-vamo il sogno della libertà e le valute pregiate. Una notte bussarono alla mia porta: non stava arri-vando l’Armata rossa. Era una ragazzina pallida, due grandi occhi, capelli sottili e vaporosi, un sorriso sfumato. Si slacciò il maglione, senza parlare, il reggiseno di tela era grigio, scarseggiavano, credo, i detersivi. Non sono virtuoso, ma mi vennero in mente le donne di Atene che durante l’occupazione si davano per una pagnotta militare, e le tedesche della Germa nia distrutta che si concedevano per una stecca di Camel e, ricordando i bombardamenti aerei, si giustifica-vano: “Meglio un rosso sulla pancia che un americano sulla testa”. Non riusciva a capire; avrà pensato che non mi pia-ceva, chissà che gusti hanno i democratici. Se ne andò con un po’ di soldi che non voleva; mi chiese se poteva invece prendere le riviste straniere che erano sul mio tavolino. Potrei disegnarla: era fragile, molto garbata. In tutti i drammi, in tutte le storie, c’è da cercare la donna; anche negli incontri che resistono al tempo per ché due vite non possono sempre combaciare. Succede solo in alcuni momenti. Trascorsi alcuni giorni nell’antica fortezza di Gaeta, trasformata in penitenziario per i soldati. Tra i prigio-nieri c’erano Kappler (Fosse Ardeatine) e Reder (Marza-botto). Uno dei posti più tristi del mondo; era autunno, il mare sporco e schiumoso e i lamenti dei gabbiani, e quelle vecchie mura che avevano visto tanto dolore sa-pevano di muffa, di salsedine, di ripulitura di gavette. Il maggiore Walter Reder era un omone senza un braccio, un gigante: un metro e 84. Allevava in un pic colo acquario pesciolini bizzarri, di tutti i colori, che si muovevano in una luce fosforescente. Nascosta dietro a un calendario c’era la fotografia di una donna nuda sugli scogli. La vidi per caso, e non gli dissi nulla. Parlammo della guerra; per lui era stata un’avven-tura straordinaria. Mai avuto paura, mai pensato di morire. Non andava all’assalto urlando: “Heil Hitler”, ma “Caramba, caracho, ein Whisky”, e con tanto entu-siasmo che si trascinava dietro il plotone. Capiva, prima dell’assalto, quelli che dovevano ca dere. aI loro occhi” mi spiegava “guardavano oltre di me, erano di vetro, c’era l’ombra del presentimento. aSi dice che nella fossa provocata da una granata non ne cade subito un’altra. Il mio sostituto consegnò l’orologio all’attendente: “Dàllo alla mia mamma”. Saltò nella buca e fu subito colpito da un altro proiet-tile.” E dopo molti discorsi: come da boy scout era en-trato nella Hitlerjugend, perché facevano più marce e più gare, come si era arruolato nelle SS, come si era di vertito quando andarono a occupare l’Austria, e poi la Cecoslovacchia: che meraviglia. C’erano bellissime rap-presentazioni d’opera, buon vino, buona birra, beUe si gnorine, e il suo motto era sempre stato, guarda un po’, vivi e lascia vivere. Durante l’avanzata in Francia si lavava i denti con lo spumante. Accompagnò Hitler sul treno speciale che lo portava in Spagna e il capo gli disse: aVada al va gone ristorante”. Lo rese felice. Ma tutto passa e in Ucraina, mentre stava contem plando un’isba e un ruscello, un proiettile gli troncò netto l’avambraccio sinistro che rimase attaccato solo con un tendine. Un medico gli infilò in bocca una bottiglia di co gnac e tagliò il moncone, che cadde in un cestino. Lui disse: “Attenzione, c’è un anello”. Gli amici lo chiamavano Bubi, e Bubi il 29 settem-bre 1944, un venerdì, lo ricordava benissimo, ricevette l’ordine di ripulire le colline di Marzabotto. Non volevo sapere quello che era accaduto nei vil-laggi, nelle chiese, se i morti erano mille, 1500 o di più. Volevo sapere, invece, della sua “notte d’amore” perché conoscevo gli atti del processo. Disse il maggiore: “Avevamo bevuto; io stavo dor mendo, un amico è venuto a svegliarmi e mi ha detto: “C’è una ragazza; io ci sono stato”, ma io non l’ho vio-lentata: ero ubriaco, avevo sonno, non ho fatto nulla. Ho in mente solo donne di mezza età, c’era anche una bambina, non ricordo più”. Raccontò la ragazza ai giudici, ma rivolgendosi quasi rispettosamente al maggiore Reder: “Ricorda? Lei si coricò nel letto dove io mi trovavo e cercò ripetu tamente di unirsi con me tenendomi stretta e cercando di vincere la mia resistenza. “Ricorda che di fronte alla mia opposizione, mentre non riuscì a violentarmi, mi obbligò a compiere certi atti? Che rimase al mio fianco diverse ore, durante le quali ogni tanto si addormentò?” Le SS uccisero bambini, donne, preti perché, come recita un loro proverbio: “Quando si pialla i trucioli ca-dono”. Ma io quando sento parlare di Marzabotto, di tutti quei morti, penso a quella ragazza, all’omone ubriaco e monco che le va addosso e si addormenta, e poi, I quando ha un attimo di lucidità, ordina: aFammi go-dere”, anzi: aGioisci con me”. Forse è la storia più sporca che conosco. Lo hanno definito “boss dei due mondi”. E anche “il primo gola profonda della mafia”. Si chiama Tommaso Buscetta; ed è mio amico. Spiego: non mi ha detto tutto, ma non mi ha mai mentito. L’ho incontrato più volte, e ho vissuto alcuni giorni con lui, in una villetta a qualche ora di automobile da New York; volevo raccontare la sua vita. Non ricordo, anche perché non lo so, non volevo sa-perlo, il nome del posto: attomo molti alberi e nella casa dovevano esserci stati dei bambini perché nella stanza dove mi sistemarono trovai giocattoli. Una bam bola Barbie, delle leggende di Natale. Mi venne a prendere al St. Moritz uno della Dea; sono gli agenti federali che danno la caccia ai traffl canti di droga. Lo chiamavano Hubert, aveva l’aria di un intellettuale, un professore di college o un “crea tivo”, come si chiamano quelli della pubblicità. Era stato a Saigon, pilota di elicotteri, e parlammo di quelle ragazze gentili e avide. Ma i custodi della casetta di legno erano altri tipi: grassoni, cordiali, ricordo Mario, che passava la notte sul sofà dell’ingresso, con accanto le parole incrociate e la pistola, e Johnny, che preparava il breakfast. Masino cucinava la sera. Un fratello di Buscetta ha detto: “Ha sempre avuto in testa le donne”. Tre mogli e una serie non catalogata di avventure: qualche attrice e diverse signore. Piaceva. Ha otto anni quando una matrona dalle tette soffo-canti se lo tira addosso e quasi lo soffoca con gli abbracci e il fiato, che è un condensato di aglio; ne ha se-dici quando sposa Melchiorra, che ne ha tre di più. A Buscetta hanno sterminato la famiglia: figli, fra telli, nipoti, intendo dire. Ha ucciso. Ha spiegato i segreti del potere di Cosa Nostra. Ha cambiato spesso nome - Manuel Lopez, Adalberto, Tomás Roberto -, ma è rimasto sé stesso. Quando comincia la sua deposi zione dice: “Sono un mafioso e non ho niente di cui pentirmi”. Quando il magistrato gli chiede: “Il suo primo cri mine?”, risponde: “Eh, vostro onore, avevo fatto le corna a mia moglie”. Parlavamo tanto, giorno e notte, e una volta mi disse: “Quando saremo di là, e toccherà a me per primo, perché mi uccideranno, le farò i nomi dei poli tici, e anche allora lei rimarrà sorpreso”. Diceva un altro siciliano, Vitaliano Brancati: “I di-scorsi sulle donne davano maggior piacere che le donne stesse”. E un tema che di solito gli italiani trattano volen tierl. Solo una volta andò con una puttana, perché se lei gli diceva: “Come scopi bene”, lo diceva per i soldi, e questo lo bloccava e lo rendeva impotente. Fu precoce, come ho detto, ma era molto svilup-pato e tanto curioso. La donnaccia gli mostrava il pelo, lo toccava, scopriva un capezzolo e gli faceva promesse strabilianti: “Portami dell’olio e io ti faccio delle cose belle”. Il primo bacio a Pina, a Giuseppina, la collegiale. A quattordici anni. Una immagine casta: “Le ho voluto bene, non l’ho vista plU. Chissà se è ancora viva. La penso sempre, era il mlo sogno”. Nella confessione di don Masino c’erano i toni pica reschi e quelli patetici: aLe donne sono state un vizio, lo riconosco. Non ho inseguito niente altro”. Non aveva, come molti suoi compaesani, il com plesso della vergine, ma ne ha trovate: “Io cercavo il calore umano, e me lo hanno dato”. Niente smargiassate per arrivare alla conquista: fiori, profumi, ma solo le gioie del talamo provvisorio. Solo per Cristina un anello, una collanina, ma spiega: “Io amo adesso, da vecchio, e credo sia possibile una volta sola”. Chi ha scritto: “Era vecchio, ma il suo amore era giovane”? Due volte lo hanno anche piantato, ma senza drammi. Ha una sua filosofia che non gli faceva nep-pure sprecare tempo: “L’uomo si accorge subito se una ci sta”. Era divertente e anche un po’ tragico quando mi illustrava la dura e misera esistenza dell’adultero, con doppia abitazione, doppio guardaroba, stessi vestiti, stessi colori, guai a fare confusione con il dopobarba. Odiava, ed è un rancore comprensibile, certe feste, e in particolare Natale e Capodanno: “Cominciavo con una cena, per San Silvestro, e poi verso mezzanotte di cevo: “Basta, non ne posso più, scoppio e vado a fare un giro”, e via in macchina, correvo come un demente per ripetere il rito con l’altra. Panettone, zampone, len-ticchie e spumante mi uscivano dagli occhi”. Ha vissuto, don Masino: night e teatro, Costa Az zurra e mari del Sud. Aveva anche modelli femminili: Ava Gardner e Brigitte Bardot, e non volle dirmi, da gentiluomo, chi era quella francese bellissima, diva dello schermo, che gli disse di sì. La cattiva reputazione lo aiutava. Del resto era un momento felice per gli italiani: Roberto Rossellini con quistava Ingrid Bergman che piantò Hollywood e corse verso l’amore e Cinecittà, il produttore Peppino Amato, un napoletano, che non sapeva la lingua nazio nale ma “come se fa ‘o cinematografo”, fece altret tanto con Linda Darnell, “la bruna dallo sguardo bru ciante”, come la definiva la pubblicità, o, per i più casti, “la fidanzata d’America”. Chi favorì Tommaso per l’incontro galante fu Joe Adonis, un rimpatriato che il senatore Estes Kefauver, in una celebre inchiesta sulla delinquenza, aveva de scritto come “il più pericoloso bandito degli Stati Uniti”. Il vero nome diJoe Adonis era Joseph A. Doto, ma una ballerina, quasi nuda, sbucando all’improvviso da una enorme torta alla fine di un banchetto, vedendolo gli gridò: “Sei bello come un Adone”. Dunque: c’era una cantante-danzatrice che aveva molto successo in televisione, dove si esibiva con l’or-chestra dell’anziano marito e, rievoca modestamente don Masino, “moriva per venire a letto con me. C’è riu scita e ci sono andato”. Un tipo molto sexy: gambe stupende, seno messo giustamente in evidenza, capelli di fiamma. La signora sperava di avere a che fare con un vero gangster, inse guito dalla polizia, e Buscetta aveva commesso l’imper donabile errore di nascondere il revolver in una scarpa. Non gli sembrava gentile presentarsi nudo e con la pi-stola. Fu una delusione. Quando le disse: aGuarda qua, ce l’ho”, lei voleva ricominciare, si era accesa di nuovo. Lo voleva arrogante, violento, brutale, e Masino è uno che non ha mai alzato la voce. Cosa Nostra è puritana e severa: e non transige sulla fedeltà che i coniugi si devono. Anche per ragioni di sicurezza: l’”uomo d’onore” non può concedere spa-zio alle tentazioni, e deve rispettare i comandamenti. O almeno alcuni. Buscetta, peccatore tenace, mentre è all’Ucciar-done viene a sapere che è stato espulso dalle cosche. Colpa: adulterio. Totò Riina, forse il più crudele dei boss, è uno sposo esemplare. Ognuno ha il suo con cetto dell’”immoralità”. Se non si ha in mente la Sicilia, non si può capire il personaggio Buscetta. Un figlio impotente è una vergo-gna per tutta la famiglia. Il bell’Antonio, il romanzo di Brancati, narra questa ossessione. C’è il culto della viri lità e quello dei gesti spavaldi: la vita come sfida. “Fic-caloru” chiamano i siciliani il dongiovanni in servizio permanente, il Casanova di paese. E allora le fughe verso mondi sognati e lontani, i grattacieli e la pampa argentina, Acapulco e Copacabana, anche alla ricerca di quell’incontro che consente di vivere, come dice Leonardo Sciascia, “in quelle po che ore tutta una vita”. E così l’adolescente Buscetta incontra la ragazza Melchiorra, “bella no, ma passabile”. Si fidanza quasi senza accorgersene, ma in casa sua sono contrari. I pa-renti di lei, no: anzi. Tommaso è ferito nell’orgoglio, si sente offeso: “Dissi a Melchiorra: “Fuggiamo”, e Mel chiorra: “Fuggiamo”, e per le mie terre accadde l’inelut-tabile”. Poi la stanchezza, una moglie che ingrassa, le inte ressano soltanto i figli che crescono bene. Un giorno - grandi, forti, belli -, spariranno: più nulla. Una madre superba, diceva Buscetta, una pessima sposa: fare l’a more non le importava, anche una volta ogni sei mesi. E a Saint-Vincent che conosce Vera; hanno in co-mune una passione: la roulette, lo champagne, le notti brave, l’imprevisto. Lei, in quel momento, è l’amica del batterista di Renato Carosone, che la ricorda “bella, elegante, molto generosa e simpatica”. Si vedono, dun que, al Casinò, e Masino dice a Vera che gli piace e se vuole andare con lui. Lei risponde di sì. Scappano a New York; Tommaso con un passaporto falso. Per l’occasione assume il nome di Tullio Saracino. Una fuga continua. Mettono al mondo due bam-bine, Brigitta e Silvana, poi lei una mattina gli dice: “Sono stanca di scappare. Io mi fermo, non ce la faccio più. Le piccole tienile tu: io vado incontro all’ignoto”. E finalmente arriva Maria Cristina da Almeida Gui maraes. Vent’anni di meno, bionda, colta, di buona fa miglia, brasiliana, molto graziosa e tenace: lui la chiama “la tedesca”. Copacabana fatale: discorsi da spiaggia, e decidono di alcuni destini. Dice Cristina: “E il mio uomo, non c’è più rimedio. O lui o nessun altro”. E incinta, e la polizia militare preleva Buscetta. Lui la prega di lasciarlo perdere perché non c’è futuro. Lei invece prende con sé anche Brigitta e Silvana. La spo serà più tardi nel carcere di Cuneo. Testimone un com pagno di cella: Turatello, un assaltatore di banche, te nutario di bische, pieno di soldi, anche dentro pasteg giava a caviale e spumante. Voleva sposare una vergine: ce l’ha fatta, ma lei è rimasta signorina perché Francesco Turatello è morto, accoppato, con cinquanta coltellate, da un detenuto. Sul cartoncino delle partecipazioni nuziali aveva fatto stampare un motto classico: “Omnia vincit amor”. Per “liberare” Cristina, Tommaso Buscetta tenta il suicidio. Scrive una lunga lettera e ingoia il cianuro che porta con sé: “Mia cara, ancora una volta ti procuro dei dispiaceri, ma spero che sia l’ultimo. Quando leggerai questo scritto io non ci sarò più. Vi abbandono perché vi amo, m’ammazzo perché possiate vivere”. Buscetta credeva che essere mafioso volesse dire di fesa dei più deboli, fedeltà, stima. Aveva diciassette anni quando entrò nell’”onorata società”: “E come es sere prete,” spiegava “è per sempre”. L’esame era severo: guai se uno aveva parenti tra i magistrati o tra i carabinieri; e poi c’era il banco di prova: bisognava eliminare qualcuno: “La prima im-pressione che si ha quando si spara a una persona non è se l’hai ferita o uccisa: badi a te stesso”. In Brasile Buscetta ha vissuto giorni felici. Allevava cavalli, possedeva mandrie di vacche, diboscava la fore sta, i suoi figli gli cavalcavano accanto, era uno come tutti gli altri e non doveva nascondersi. Un solo incon veniente: il nome. Buscetta, laggiù, vuol dire quella parte della donna a cui si inneggia spesso anche sui muri. Anche per don Masino vale una possibile giustifica zione; dice un personaggio dei Viceré, il grande ro manzo di Federico De Roberto: “Ma noi non scegliamo il tempo in cui veniamo al mondo. Lo troviamo com’è”. Vent’anni fa, a Londra, conobbi il maggiore Pal mer, bracciante del mitra, sempre alla ricerca di un esercito e di un ingaggio. Jack era il solo inquilino di una casa in demolizione e aveva un maledetto bisogno di soldi. Bastava guardare la stanza: pavimento in disse-sto, odore di muffa e di gas. Un ampio divano: “Qual che volta viene a trovarmi una ragazza”. In una piccola vasca allevava, anche lui, pesci rossi. Erano la sua preoccupazione: “A chi li lascerò?”. Jack Palmer, soldato di ventura, aveva passato i cin-quanta, ma si difendeva. Magro, in ordine, composto, con l’aria distinta di un impiegato della City. Il sorriso esangue sottolineava il suo definitivo di-stacco dalle vicende umane: assisteva, ma non parteci-pava. Nessuna domanda poteva turbarlo: il tono di voce non si alterava né quando ordinava il tipo di birra scura preferita né quando distruggeva alcuni secolari princìpi morali. Poteva essere considerato un residuato del secondo conflitto mondiale. Faceva parte delle truppe speciali da sbarco del maresciallo Montgomery. Tra i suoi svaghi, la lettura: di preferenza testi clas SlCi, appoggiava spesso il ragionamento con dotte cita-zloni. • Mister Palmer,--attaccai—qual è la sua pro fessione? “Mercenario. “ • Ha qualche preferenza per i datori di lavoro? “Dipende da quanto pagano.” • In passato chi sono stati i suoi padroni? “Brutta parola; diciamo superiori: ho lavorato in Congo, in Rhodesia e in Angola.” • Chi largheggiava di più? “Il governo del Congo.” • Lei è disponibile solo per la guerra, o si offre an-che per imprese meno totalitarie? “Tutto, perdoni la volgarità, è in rapporto con quanto sono propensi a spendere.” • Sarebbe disposto a eliminare un individuo, an che qui a Londra? “Lei mi sottopone un caso ipotetico, ma se la somma lo giustificasse non vedo perché non dovrei ac cettare l’incarico.” • Preferisce sparare da vicino o da lontano? “Dipende dall’arnese che uso.” • Cosa pensa dei negri? “Negri, bianchi, gialli, rosa: per me non esiste diffe-renza. “ • Quanta gente ha ammazzato durante la sua car-riera? “Non so: probabilmente tre, quattrocento.” • Qual è il suo grado? “Maggiore. Non sono mai sceso sotto. Non mi con viene.” • Perché non ha scelto un mestiere più convenzio nale? “Perché dovrei farlo? Sono già tanti quelli che scel gono un lavoro normale. Non lo dimentichi: sono un ri-belle.” • Lei ha, diciamo, una sua filosofia? “Esatto. Non accettare troppe limitazioni, non su-bire imposizioni. Mi piace mangiare bene e mi piace leggere. E le donne, oh sì, ma non sono troppo impor tanti.” • A che età pensa di andare in pensione? “Finché riuscirò a coordinare i miei sensi conti nuerò. Poi, qualunque cosa succeda, non ha importanza. Ricorda Shakespeare? “I vili muoiono molte volte prima della loro fine; i prodi non provano la morte che una volta sola”. E nel Giulio Cesare.” • Quanti atti di coraggio ha compiuto? “Sono riuscito a mettere in salvo quaranta suore missionarie, in Congo. Di questo fatto vado molto orgo-glioso.” • Perché tiene i pesciolini rossi? “Guardarli mi dà un senso di pace. Mi fanno sentire sereno. Conosce Carlyle? “La natura non tollera menzo gne.” Nei Pamphlets, mi pare.” • Lei è sincero, mister Palmer? “Che cosa dovrei nascondere? Quale vergogna? Prima mi sono arruolato per la Gran Bretagna; poi per Jack Palmer. Non è forse un nobile scopo?” Sulla porta mi disse: “Nessuno di noi è mai diven-tato ricco. E neppure, per quanto ne so, vecchio. Me glio così”. Era considerato “il più grande mercante d’armi del mondo”, il successore di Sir Basil Zaharoff, il misterioso personaggio che all’inizio del secolo diede il via al com-mercio dei cannoni. Samuel Cumming non ha niente del cinico, dell’in-trigante: né l’aspetto né i modi. Potrebbe fare anche il pediatra o il coltivatore di rose; all’Università di Wa-shington, prima di entrare in affari, studiava storia del l’arte. Stava a Montecarlo, “in esilio economico”, preci-sava, per via delle imposte. La seconda moglie si chiama Irma, ed è una giovane donna svizzera che de-scrivono “slanciata e bellissima”; l’altra era tedesca, ma non sopportava un marito che per otto mesi era in viaggio a piazzare macchine da guerra. Cumming non fuma e non beve; e per il resto non lo so. “C’è in me” mi disse “una vena puritana.” Infatti il motto della sua società - l’Interarmco - è: “Esse Quam Videri”, essere piuttosto che sembrare. Entrammo subito in argomento: “Non esercito” spiegò Sam “la funzione di guardia morale dell’uma nità. Chi fabbrica automobili non è responsabile degli incidenti stradali; e io non ho nessuna colpa di come la gente adopera i fucili. Se lei crede che smerciare carri armati e munizioni è un male, rifiuti anche di pagare le tasse. Ci sono governi che impegnano due terzi del bi-lancio per l’esercito”. Sam è un uomo tranquillo: niente sale da gioco, niente ristoranti di lusso. Ama i cibi semplici, di preferenza gli hamburger, mai visto a una riunione mon-dana. Un hobby. Colleziona antiche pistole e archibugi: proprio una vocazione. Non ha mai fatto distinzioni tra la clientela. Nehru o lo Scià di Persia, il Pakistan o la Thailandia. E neppure discriminazioni politiche: “I dittatori hanno il senso dell’ordine e pagano pronta cassa”. Cominciò da studente: era un appassionato racco-glitore di armi leggere. Un amico gentile gli fece dono di una mitragliatrice della Wehrrnacht e lui l’aggiustò. “Comincia così” racconta “la mia abominevole for-tuna.” Poi fece un viaggio in Europa e trovò del vecchio materiale da piazzare. Un paese asiatico gli ordinò cen-tomila fucili tutti in una volta. Non aveva problemi morali, non si sentiva respon-sabile del male che c’è nel mondo: “I contratti dell’Interarmco non sono basati sulla saggezza ma sul-l’umana follia”. Rifiutava il paragone con Zaharoff: “I Basil Zaha-roff non esistono più. Al tempo in cui lui lavorava, i mercanti potevano permettersi di dire: “Voglio spedire queste cartucce alla Bulgaria” e, ricevuto il denaro, irn pacchettavano e mandavano a destinazione. Adesso al suo posto ci sono gli alti funzionari delle potenze mon diali”. Avevo un caro amico a New York, Saverio Turiello detto Savy. Ogni volta che andavo stavamo insieme: quando aveva il “Piccolo Club”, e anche dopo. Be’, la clientela non era male: il duca di Windsor e Sinatra, Marilyn e Hemingway, e anche la povera Annamaria Pierangeli, l’attrice: “Sempre il bicchiere in mano,” di ceva Savy “ma senza gusto, aveva paura. Molte volte l’ho presa in braccio per portarla a casa, era leggera. L’hanno lasciata troppo sola”. Io lo chiamavo il “Grande Bambino”. Sapeva tutti i guai del mondo, ma non lo avevano sporcato. Dimenti cavo: al “Piccolo Club” capitavano anche Frank Co-stello e Gianni Agnelli: lo aveva aiutato in un momento difficile. Due volte campione d’Europa, fu battuto da Marcel Cerdan, ma era stato sul ring trecento sere. Sapeva tutto sulla boxe americana, dagli intrallazzi ai retro-scena. Gli dicevo: “Mitri e La Motta come andò? Con Frankie Carbo avevate arrangiato la sceneggiatura?”. “Non dirmi queste cose, devi credermi. Il giorno prima vidi Tiberio con la moglie, Fulvia Franco, era bel lissima, su un prato, lei aveva voluto a tutti i costi an-dare a trovarlo e facevano l’amore. Non fa bene all’a tleta.” Savy si rovinò perché, va riconosciuto, era un pa triota. C’era un tenente della polizia che ogni settimana andava a trovarlo e chiedeva una mancia, una buona mancia, altrimenti erano noie, ma Turiello, testardo, diceva di no. Allora una notte il tenente si lasciò andare: gli scappò “italiano bastardo”, e non c’è bisogno di tradurre, testa di brillantina, e perfino dago, che è un in-sulto anche per i portoricani. Il “Grande Bambino” si arrabbiò: “Senti, ragazzo, a me italiano bastardo non lo ha mai detto nessuno. Aspetta che chiudo il locale, poi metti la pistola sul ta-volo, se no te la infilo nel culo, e non vorrei che il gril letto ti disturbasse, e io ti faccio vedere la luna meglio che alla televisione”. Andò proprio così e il vecchio Saw lasciò l’avversa rio tra i bidoni dell’immondizia: vinse il match e perse la licenza. Ma io ho conosciuto anche il poliziotto che non ha mai preso un dollaro, mai concesso una protezione: si chiama Frank Serpico, e la televisione e il cinema hanno raccontato la sua straordinaria avventura. Suo padre e sua madre venivano da Napoli, il fra tello aveva una drogheria a Brooklyn. Abitava al Village, in un sordido appartamento che divideva con due cani, due vasche di pesci (sono quasi una nota costante della solitudine) e, ogni tanto, qualche ragazza. Dicevano di lui: “E una specie di puro folle. Non sopporta l’imbroglio, le ingiustizie. Si butta nei pasticci e più c’è pericolo, più ci dà dentro”. Scoprì che era troppo ingenuo. Faceva parte di una plain cloth, una squadra di agenti che vanno in giro in borghese. Dovevano controllare che fossero rispettate le leggi sul gioco d’azzardo, sugli stupefacenti, sul vizio. Bel lavoro. “La prima scoperta che feci,” racconta Frank “fu che ogni membro del reparto riceveva una tangente su quegli affari. Una signora ospitava in casa sua delle amiche disponibili e dei signori facoltosi; bastava chiu-dere un occhio, in fondo che male c’è?, e ti arrivavano casse di whisky: per chi, come me, è astemio, c’erano buste con moneta corrente. “La prima che mi passarono era di trecento dollari: dissi di no, e un collega la intascò tranquillamente. “Prima o poi” spiegò agli altri apasserà dalla nostra parte.” Non ho fatto il salto. “Andai a spiegare la faccenda al sergente Durk, Da-vid Durk, un uomo come si deve. Mi ascoltò e disse: “Facciamo visita al boss; provvederà”. “Il capo non batté ciglio: una normale vicenda di corruzione. Mi diede anche un consiglio: “Senti, Frank, a meno che tu non voglia finire nell’East River, tieni la bocca chiusa”. “Provai a battere ad altri usci. Mi rispondevano: “Ho ancora un anno di servizio: perché vuoi rovi narmi?”. Oppure: “Ma tu chi sei, san Giorgio? Lascia perdere, se no il drago ti fa fuori”. “Dovevamo mettere dentro le puttane, ma quelle che adescano, quelle che ti promettono bei passatempi. Così sta scritto. La quota era una per notte. Allora ve-devo miei compagni che saltavano dalla macchina, af-ferravano una donna all’angolo della strada e poi in tri-bunale testimoniavano che li aveva provocati. Non era vero, e questo mi faceva schifo. Odiavo fare il pussy posse, che nel gergo vuol dire portare dentro le sgual-drine dei marciapiedi. “Un giorno mio fratello mi disse che due piedipiatti volevano un po’ di soldi per permettergli di tenere aperto il sabato. Io mi misi dietro al banco e registrai la proposta. Quei due furono cacciati, ma da quel mo-mento il disgusto dei camerati nei miei confronti di-ventò ancora più forte.” Nessuno lo avvicinava o gli rivolgeva la parola. Lo disprezzavano perché aveva rivoltato la frittata. Non mollava: diede alle autorità tutte le informazioni che aveva raccolte, ma non accadde niente. Alla Sezione in vestigativa dicevano che era pazzo. Andò dal sindaco, parlò con i suoi assistenti. Nulla. Si rivolse ad alcuni or gani dello Stato. Silenzio. Alla fine pensò di rivolgersi ai cronisti del Times; qualche volta i giornalisti servono. Trovò un alleato nell’ispettore Denise, che gli diede retta. Scoprirono un ometto curioso, calvo, insignifi cante, un maniaco dell’elettronica, che scriveva sulle ri viste specializzate e costruiva apparecchi speciali per captare suoni e parole. Era un suo hobby. Nascondeva il microfono nella spilla della cravatta, dentro una falsa oliva. Gli chiesero di collaborare: si entusiasmò, per lui era un nuovo svago. Lo spedirono in un ritrovo sospetto: la padrona lo accoglieva con simpatia, l’ufficiale dei poliziotti, che passava a far visita ogni giorno, lo guardava invece con astio, con diffidenza. Una volta lo afferrò per il bavero e lo scrollò furiosamente: “Ma quando è che te la squa-gli, maledetto rompitasche?”, e l’omino, contento, in tanto registrava. Poi, un colpo calibro 22 in faccia: “Alcuni agenti mi chiesero di aiutarli a entrare nel rifugio di un trafficante di eroina. Mi dissero di andare avanti e, quando entrai, qualcuno mi tirò, all’improvviso. Anch’io feci centro, ma riuscì a scappare. I miei non ce la fecero a prenderlo. Era un certo Edgar Echevaia detto Mambo. “All’ospedale ricevetti molte cartoline, molte let tere piene d’insulti: bastardo, mi dicevano, e mi auguravano una felice ricaduta. Già: un bastardo. Mezzo Na-poli e mezzo Brooklyn. “Ci sono andato molto vicino, e questo mi ha inse gnato che non vale la pena di preoccuparsi. Quello che deve accadere accade comunque.” Sparì in un ascensore e credo che non lo rivedrò mai più. Ho conosciuto personaggi inquietanti e sono stato testimone di mutamenti del costume sorprendenti. Ba sterebbe sfogliare le collezioni dei quotidiani degli ul-timi cinquant’anni, pagina degli annunci economici: si passa dalle illibate che cercano un marito alle massag-giatrici che offrono assistenza e compagnia. Chiesi a Nigel Nicholson, editore molto reputato e autore del libro Ritratto di un matrimonio, in cui narra le vicissitudini di una strana coppia, i suoi genitori, lei le-sbica, e amante di Virginia Woolf, lui gay, che cosa era per lui il peccato: “Mio padre, quando eravamo bam bini, ci spiegò che sono tre: la crudeltà, la mancanza di sincerità e l’indolenza. Vorrei sottolineare un aspetto più sottile della crudeltà: è l’indifferenza”. Be’, credo di avere conosciuto proprio in Gran Bre-tagna due sposi fuori del comune: Rose e Tony Cohen. Se ne parlò sui giornali e anche alla tv. Tony Cohen stava diventando donna, gli era spun-tato il seno, si era tutto depilato, anche se restava qual-che duro segno della barba, ed era in attesa di affron-tare il fatale atto chirurgico che doveva completare la trasformazione. Avevano deciso di rimanere insieme e di adattarsi al nuovo ruolo; per la parte, diciamo così, pratica, si sa-rebbero arrangiati. Avevano poi all’attivo molte espe nenze, e in dieci anni di matrimonio erano nati tre bambini: la più piccola, Esther, di quindici mesi. Parlai con la signora Rose. Si considerava, nel com-plesso, soddisfatta: “Perché siamo stati molto felici in sieme”, anche se lei si era concessa qualche distrazione “qualcuna, ma non molte”, ma le considerava un fatto positivo: “Mi hanno dato una vita più piena” disse “e Tony questo lo ha capito benissimo. Mi hanno fatto ap prezzare la famiglia, perché ero più contenta”. • E Tony—chiesi—ha avuto storie con donne? “Non con le donne. “ Tony mi confidò che fin dalla prima infanzia si sen tiva diverso, ma si era deciso alle nozze perché voleva dei figli e perché, allora, amava Rose. Tony riconobbe le difficoltà che creava il suo stato: attirava gli omosessuali e, nello stesso tempo, veniva ri-fiutato dalle signore. Avevano già pensato al futuro: avrebbero diviso i letti e le amicizie. Ma purtroppo c’era sempre qualche difficoltà ad affrontare la gente senza essere messi in ri-dicolo. Dissi a Tony:--Quando lei sarà completamente donna, come la chiameranno i suoi ragazzi? “Mah: allora, immagino, mi chiameranno zia, o qualcosa del genere.” Un secolo fa, dopo le ipocrisie vittoriane, Oscar Wilde finì dentro perché non rispettò quelle regole di discrezione che la società esigeva; intanto il principe di Galles in un casino si faceva ammirare perché riusciva a trastullarsi contemporaneamente con ben sei “signo rine”. Le legge contro la pederastia era stata concepita per le classi inferiori; Oscar Wilde dimostrava che certe debolezze potevano prendere piede anche tra gli aristo cratici. Ora questa colpa è considerata “normale”, un avvo cato che difendeva un noto gentiluomo esordì: “Si tratta solo di un caso irrilevante, perfettamente cor-rente, di un signore accusato di condotta oscena con quattro o cinque guardie”. E noto che a Green Park, dove si assiste ad “ab-bracci completi”, si sono dati talvolta appuntamento sentinelle di Buckingham Palace e onorevoli deputati e la tv riprende spesso le orgogliose sfilate dei gay che proclamano i loro diritti e ostentano la loro condizione. Ricordo certi colloqui con Pier Paolo Pasolini: aLa mia psicologia” confessava “mi porta a deragliare dai codici, da qualunque codice”. Spiegava la sua angoscia con i soliti traumi infantili: “Può essere tipico l’eccessivo amore per mia madre, la rimozione della figura del padre nei primi armi di età, l’incomprensione tra i miei genitori, non la mancanza di affetto, perché si amavano, ma non si capivano, que-sta tragedia che ha provocato in me la tendenza a una forma di nevrosi, che però non si è mai esplicata. è stata, semplicemente, un elemento sentimentale. Per questo, lo scrivere per me è soprattutto raggiungere un equilibrio”. Dai discorsi scaturiva la sua grande tristezza: “Vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più squal-lido. Non ho sogni, quindi non mi disegno neppure una visione futura”. Nelle sue parole vi era innocenza e bisogno di ve-rità. Non temeva la vecchiaia e non aveva più neanche paura della morte: “Ne ho avuta molta a vent’anni. Ma era giusto perché allora, attomo a me, venivano uccisi dei giovani, venivano uncinati. Adesso non l’ho più. Vivo un giorno per l’altro, senza quei miraggi che sono alibi. La parola speranza è completamente cancellata dal mio vocabolario”. Il volto dello scrittore era scavato, gli occhi erano malinconici o febbricitanti. Jean Marais, quando gli parlai, era ancora bello e aitante, recitava meglio di una volta, la maturità aveva dato compostezza a quel suo fascino lezioso ed equi voco e più spessore alla sua figura. Era rimasto fedele alle antiche passioni. Nel 1940, mentre era richiamato alle armi, ricevette un biglietto di Jean Cocteau che diceva: “Neppure l’apocalisse ci potrà separare. Sono il più soddisfatto del mondo per-ché sono felice di amarti”. Chiacchieravamo in quello che fu il salotto di una sua grande amica, Coco Chanel. Era sdraiato su un di vano di pelle e rievocava senza imbarazzo il passato: “Devo tutto a Cocteau, il mio modo di vivere, di pen-sare, di parlare, di essere contento; tutto, gli devo tutto. Per me ha scritto I parenti terribili, L’aquila a due teste, Bacco. “L’ho amato nel vero senso della parola e non provo alcun senso di vergogna: perché dovrei arrossire dei miei sentimenti? Si dice che Dio è il Creatore: Jean è il mio, e l’amo quasi quanto Dio, è l’essere umano che ho amato di più, questo è certo.” Li rivedo insieme a Venezia, durante uno dei primi festival cinematografici: portavano a spasso per le Pro-curatie un fiero cane lupo e i passanti si voltavano a guardarli con ironia. Un refrain di una rivista di Garinei e Giovannini, ambientata a Parigi, diceva: “Vi saluta Jean Cocteau, / con l’amico Jean Marais, / vi saluta Chevalier, / vi sa-luta place Pigalle”. Oggi non si girerebbe nessuno. Diceva Tolstoj che le tragedie più cupe sono quelle che si svolgono nel mistero della camera da letto. Ma credo che il problema del sesso sia vissuto in modo di-verso anche a seconda delle latitudini: anche se le pas sioni sono le stesse. A Taiwan, nella casa dell’anziano signore che espor-tava vino di cereali, conobbi la vecchia concubina. Aveva la pelle rugosa e gli occhi socchiusi e i capelli candidi erano tenuti in ordine da forcine adorne di perle. Entrò silenziosa, posò la teiera, scomparve dietro a un paravento. In una gabbia cantavano uccellini dalle piume variopinte, su una cassapanca erano abbando nati ventagli e mandole. “Non ci sono più concubine nella Cina moderna,” disse il mio ospite “non si possono più tenere sotto lo stesso tetto accanto alla sposa. Peccato: si abituavano, finivano per andare d’accordo. “Nella Cina moderna ci sono le amanti e le sgual drine. Hanno il biglietto da visita con il numero del telefono e sanno bere whisky e chiedere dollari.” In India feci visita alla maharani di Jaipur: entrai nel magico palazzo e fui ricevuto con molta cortesia dalla grande signora. Quand’era giovane era apparsa nell’elenco delle donne più belle del mondo e conser-vava ancora, oltre al fascino e alla grazia, prestigio e ric-chezza. Principessa era nata, e crebbe in un sontuoso edifi-cio a Cooch Béhar, con cinquecento servi, e aveva ap-pena dodici anni quando uccise la prima tigre. Aveva avuto una giovinezza felice, con viaggi in Eu-ropa e cacce sull’elefante, e poi una segreta storia d’a more con Jai, un giocatore di polo di fama internazio-nale, che era anche un maharaja: il corteggiamento era durato sei anni. Poi le nozze e il suo ingresso nella “città rosa” di Jai-pur. Raccontò: “Era il 1940; e a quei tempi, in diverse zone dell’India, gli uomini avevano più di una moglie: faceva parte del costume. E io trattavo le due più an-ziane con rispetto perché erano di alto rango e perché mi ero molto affezionata a loro, specialmente alla più giovane, una carissima amica. La vita era molto piacevole, anche se c’erano molti doveri da rispettare ogni giorno. “Poi si pensò di unificare il Paese e quasi tutti i ma-haraja, con poche eccezioni, unirono di buon grado i loro stati. Gli furono assicurati diritti e privilegi che do vevano durare per sempre: ma nel 1972 vennero can cellati. Fu un atto meschino che colpì non solo i prìn cipi ma anche le persone che li circondavano. Mio ma rito non c’era più.” Gayatri Devi frequentava la regina d’Inghilterra e Jacqueline Kennedy: aveva fondato anche una scuola progressista per ragazze e una signora, Indira Gandhi, era diventata primo ministro, e lei stessa era stata eletta al Parlamento di Delhi “con più voti” disse John Kennedy “di quanti una donna abbia mai ottenuto in una elezione”. Quando il sole tramonta, una calda luce rosa inve ste Jaipur e le campane del tempio annunciano l’ora della preghiera della sera e i fedeli accendono il sacro fuoco agli dèi. Allora la maharani immagina che Jai, l’uomo che lei ha diviso con altre due spose, “appaia per cenare con me e insieme ci incamminiamo verso Rambazh Palace”. “L’inferno” ha detto lo scrittore cattolico che più amo, Georges Bernanos “è non amare.” Ho letto di un giovane parroco francese, stava in un posto abbandonato, nessuno si presentava mai alle fun-zioni, i suoi confratelli lo ignoravano, la curia anche. Era solo. Aveva unicamente un canarino. Una mattina, disperato, ha aperto la gabbia, poi si è impiccato. “Il dramma maggiore per un prete,” mi ha spie-gato un teologo “come per qualunque uomo, è la solitudine.” Oggi un giornale racconta la confessione di don Carlo, che da undici anni è innamorato di Michelina, che gli ha insegnato “cosa è l’amore e che cosa è il sesso”. E una vicenda nascosta, che non dà scandalo: e tutti la accettano, anche i superiori. Conosco un episodio che ebbe per protagonista Paolo VI, quando era monsignore in Vaticano. Era con siderato “la persona meno socievole del mondo”. La vigilia di un Natale lo videro uscire frettoloso, avvolto in una mantella che nascondeva un pacco, dalla Città del Vaticano. Andava a cercare la soffitta dove si era rifugiato con la sua donna un sacerdote spretato che era stato suo compagno in seminario. Sa peva che faceva la fame. Bussò alla porta, consegnò in fretta l’involto che conteneva del cibo e scappò pian gendo. Ho ascoltato le confidenze di un giovane sacerdote delle mie parti: non saggezza ma, credo, un privilegio dell’età. Pensava che avendo vissuto e girato il mondo potessi aiutarlo. Era stato malato e in ospedale una suora, più vec chia di lui, lo curava. Sentiva dentro di sé che tra loro era nata una complicità proibita. Gli pesava e ne sof friva. Non me la sentivo di dirgli una battuta crudele: “Sembra una barzelletta: il prete e la monaca”, capivo che era innamorato dell’amore. Chi ha detto che “una vita non vale niente, ma niente vale una vita”? Continuò a dire messa e si portò dentro il suo dramma. Poi tra le fedeli che frequentavano la parrocchia c’era una bella ragazza bruna; e don..., cosa importa il nome?, lasciò il collarino inamidato e andò a fare l’im-piegato d’ordine per mantenere una moglie e un bam bino. Era un cuore semplice e io, che vedo Dio come la nostra immagine, penso che il Signore lo ha certamente capito e perdonato. Perché, dice sempre Bema nos, “tutto è grazia”. L’albero dai fiori bianchi Fiorisce a primavera. E un ciliegio selvatico, cresciuto accanto alle robinie, nell’orto. Tante volte mi sono chiesto chi avrà gettato il seme: un merlo o il vento. Per me quell’albero è l’infanzia, la magia di certe ore e di alcuni racconti, e forse anche il senso della mia vita. E Pianaccio: con il fonte battesimale e il campo-santo. Il mio non è neppure un paese: è definito “fra-zione”. Una parte minima, dunque, insignificante. Se lo fosse di New York o di Milano sarebbe un conto: invece si tratta di Lizzano in Belvedere. Forse non è neppure indicato sulle carte. In una mappa antica, che trovai in una botteguccia di Berlino Est, era segnato come Lizzan Matto. Da qui, forse, certe nostre caratteristiche sulle quali sarebbe opportuno sorvolare. Siamo sugli Appennini, al confine tra l’Emilia e la Toscana: chi è venuto, tanti e tanti anni fa, a cercare rifugio in fondo a una gola, tra due fossi, dove il sole scompare presto, da che cosa fug-giva, da chi era inseguito? Recita un nostro proverbio: “Triste è l’uccello che nasce in cattiva valle”. Ho pensato che una volta, prima che ci fosse la scuola e il registro parrocchiale, tra i boschi di castagni e le macchie di faggi venivano a cercar rifugio i banditi. Uomini con le lunghe barbe nere vestiti di fusta gno, con l’accetta e l’archibugio: e le loro donne, pal-lide e silenziose, filavano la lana, badavano alle pecore, allevavano bambini che sapevano distinguere le im-pronte della volpe ed era primavera quando le aquile insegnavano ai loro piccoli a volare dal nido per andare a cacciare le bisce. Forse un giorno le felci e le erbacce sommerge-ranno tutto: e i rampicanti che soffocano gli arbusti co priranno la lapide dei caduti. D’inverno si contano quaranta abitanti: ma c’è un Caffè Gentilini (miei parenti) e c’era un Ristorante Biagi (mio cugino): ora è chiuso. Per questo, nella zona, il mio nome gode di una certa notorietà. Nel cimitero una croce di legno ricorda un Ing. Enzo - mio zio - e molti altri si chiamano come me. Il prete, i carabinieri, il dottore, i lavori pubblici sfiorano saltuariamente il villaggio: lo Stato, di solito, si fa vivo con le cartelle delle imposte e la cartolina per la chiamata alle armi. Destinazione consueta: truppe al pine. Sono stato un’eccezione: fanteria. Niente penne in testa e quasi astemio: fisico trascurabile. Posso dirlo? Brava gente che ha costruito strade in Persia, scavato miniere e abbattuto foreste in Sardegna; cibo: polenta, formaggio e, la domenica, un unto di pancetta insaporito con l’aglietto selvatico. Hanno spazzato strade a Chicago, coltivato rose in Germania, sgobbato a Roma: manovali, portinaie, ca meriere, sigarette fatte con il trinciato, una sbornia la domenica. Forti bestemmiatori, ma che portano in proces-sione la statua di terracotta colorata di san Giacomo, vissuti con la fiducia nei santi e con quella del botte gaio, che per mesi dava pasta, olio, zucchero e surro gato del caffè (e segnava nel libretto), arrabbiati per vi-vere e rassegnati a morire. I miei compaesani hanno l’aria e la faccia di quelli che pagano le tasse, che hanno fatto tutte le guerre e conservano ancora la buonafede e la voglia di discutere le notizie del telegiornale. In genere, nessun avveni-mento o minaccia li scompone: neppure l’atomica per ché non riescono a immaginarla. Non ho mai sentito parlare di ladri: tra l’altro, non c’è niente da portar via. Forse solo un vecchio che aveva un nome nobile: Virgilio; rubacchiava un po’ di legna, ma era solo e aveva tanto bisogno. Lo avevo visto spennare due fal chetti per arrostirli. Nessuno protestava: era come se lo avessero auto-rizzato. Mio padre lo invitava sempre a pranzo il giorno di Natale; lui arrivava con la camicia pulita e un sacco di ciocchi. Qualche volta veniva a veglia. A me piaceva perché aveva sempre tante storie da raccontare. Diceva: aSe incontri il lupo, non devi voltargli le spalle: guardalo negli occhi, non fargli capire che hai paura. E non scap pare: lui è più veloce di te”. Sapeva tutto degli animali e dei fiori, perché la montagna era il suo mondo. Aveva un binocolo, glielo aveva regalato un ufficiale alla fine della guerra, e pas sava ore a scrutare il cielo, specialmente nelle stagioni di passo. Le aquile, mi spiegava, vengono daUa Russia e tornano sempre aUo stesso nido, fanno due uova, ma aUevano solo un piccolo: l’altro deve arrangiarsi. Capita anche tra gli uomini. Gli scoiattolini nascono ciechi e nudi: e hanno biso gno di protezione. Poi gli cresce il pelo, che ha il colore della scorza degli alberi, così si confondono. Sono ingegnosi: fanno il nido con erbe e foglie, neUa cavità di una pianta. E di autunno si imbottiscono di ghiande, di noci e di pigne. Diventano grassi; ci pensa poi l’inverno a farli dimagrire. Saltano da un ramo aU’altro e la coda fa da timone: non sbagliano una mossa. Un giorno, in Fiammineda, dove c’erano i campi di mio nonno Olindo (ma ora nessuno semina segala o marzuolo, e crescono selvaggi gli abeti), Virgilio mi fece assistere da un poggio a una cerimonia funebre: “Metti a fuoco e guarda”. Due scoiattoli stavano scavando una fossa. Poi si al lontanarono e ricomparvero tra le frasche trascinan dosi dietro un compagno morto: la vecchiaia, chi lo sa?, o le prepotenze di qualche predatore. Lo calarono neUa buca, lo ricoprirono di terra e di foglie, poi si aUontanarono tristi. aAttento!” disse Virgilio. “Uno mostra aU’altro il pelo bianco deUa pancia: è segnale di pericolo.” Si sentì il fischio deUe marmotte che andavano a nascondersi tra le pietre, poi i falchi volteggiarono so pra di noi e rimasero per qualche istante immobili: “Cercano” disse Virgilio. Non gli piaceva il cuculo - aveva deUe simpatie e io le ho ereditate - perché è uno sfruttatore: non fa il suo nido, ma si piazza in queUo delle passere, e considerava il cervo troppo orgoglioso perché le corna sono un sim-bolo di dominio e, a differenza di queUo che significano per noi, di superiorità sessuale. Quando arrivava la buona stagione, e spuntavano le primule e i giacinti selvatici, blu violetto, rosa, bian-chi, ne portava alcuni mazzetti aUa serva del prete; non faceva distinzione tra i santi. E d’estate sapeva tante cose, e purtroppo molte le ho dimenticate; mi insegnava a distinguere le farfaUe: mi pare che la vanessa abbia cerchi colorati neUe ali, come certe cravatte che si usano adesso, la vulcano ha fregi rossi su un fondo marrone, la cavoletta è tutta az-zurra. Pianaccio fa parte di una piccola Italia sconosciuta che si accontenta di poco perché ha fatto l’abitudine a non avere mai niente e conserva ingenui ideali: se vo tava Dc si sentiva cristiana, se votava Pci si sentiva più giusta. Non è un mitico paradiso: scoppiano liti furibonde per un paniere di castagne o per un confine nel bosco, che magari i temporali hanno spostato, ma i problemi si riducono aU’essenziale. Affrontano la bufera di neve per andare a prendere il medico condotto, o a chiamare la levatrice, o per salvare un cervo rimasto prigioniero del filo spinato. Si danno il cambio per assistere un malato e non negano l’elemosina a nessuno: aUo scemo che imita il chicchirichì del gaUo o aU’eremita che vive di solitudine e di carità. Noi abbiamo due Madonne da portare in proces sione: queUa deU’Acero e queUa del Faggio. Hanno strane facce segnate daUa fatica e dal dolore. Non le pensi in estasi mistiche, ma che lavano un bambino neUa tinozza o infilano pagnotte nel forno, e suUa testa, invece che aU’aureola, pensi a una fascina di stecchi. Dicono che l’acero fu piantato alcuni secoli fa da un crociato che se lo era portato dietro daUa Terrasanta; e lì accanto c’è il santuario, costruito dai pastori e dai bo-scaioli, e sono molti i devoti che hanno pregato e sono stati esauditi. Quattro statue di legno rappresentano padre, ma dre e due bambini; la sposa si chiamava Lupa, lui Bru netto Brunori. Arrivarono qui per rendere grazie dopo la battaglia di Gavinana (1530), quella che è finita nei libri perché Ferrucci, l’eroe, disse al vigliacco Maramaldo che gli in filava la spada nel petto mentre giaceva ferito: “Tu uc-cidi un uomo morto”. I Brunori erano sfuggiti alla strage. L’eremita stava sul crinale di fronte, dove c’è un piccolo santuario con l’altra Beata Vergine, con l’altare, la fioriera, le padelle per le candele. Una volta all’anno, per la festa dell’Ascensione, la portavano in spalla a benedire la gente di Monte Acuto, cantando le litanie: Rosa mystica, Refugium peccatorum. L’eremita io lo ricordo come un vecchietto dalla barbetta assai sporca, una tonaca stinta e il tricorno in testa: non era prete, ma recitava il rosario e andava in giro per la questua. Ognuno dava quello che poteva: patate, due uova, una formetta di cacio, qualche soldo. Lui ringraziava, biascicava un’Ave Maria e riprendeva la strada. Quando, si dice, non ce ne è, va male anche per la chiesa. Gli bastava poco: zappava e seminava un pezzo di terra che chiamavano “il campetto della Madonna”, mungeva la vacca e la capra e aveva per compagnia un cane, battezzato Baruffo. “Nei giorni di festa” raccon-tava “abbaia in un altro modo.” D’estate arrivava qualche pellegrino, ma l’inverno era lungo e il solo rumore era quello dei rami che ca dono sotto il peso della neve. L’eremita, che si chiamava Pietro, pregava e par lava con Baruffo, con il quale divideva il pasto e la solitudine. La cucina era nera di fumo e la sola luce la fiamma del caminetto. Prima di addormentarsi Pietro passava a dare un saluto alla sua Madonna: i lumini a olio disegnavano lunghe ombre sulle pareti e gli prendeva un senso di sgomento, specialmente quando sillabava l’ultima ora zione: “Prega per noi peccatori adesso, e nell’ora della nostra morte”. Invecchiava e cercò un aiutante; e arrivò Gino. Il falso don Pietro lo presentava come “il mio servo” o an-che, per chissà quale reminiscenza del latino, “il mio fa mulo”. Era un giovanotto mite e gentile: suonava l’orga nino e aiutava il padrone a preparare infusi e unguenti contro tutti i malanni. Cercavano insieme erbe e radici e c’era sempre qualcuno che ricorreva ai loro decotti. Di certo male non facevano. Un giorno don Pietro fu allontanato dal santuario e verme il turno di Gino. E Gino, che era arrivato alla chiesetta da giova notto, vi rimase fino alla vecchiaia. Non chiedeva niente, andava a suonare nelle feste e tomava alla sua stamberga con un pezzo di salsiccia, un fiasco di vino, qualche pagnotta. Se lo invitavano a tavola, si faceva il segno della croce, mangiava in silenzio e, fosse giorno o sera, ripartiva. Qualcuno lo aspettava. Congedandosi diceva: “Dio ve ne renda merito”. Nel cammino gli facevano spesso compagnia le creature della notte. Le conosceva. Ecco, nel buio, il richiamo dell’allocco: il battito delle ali come un sottile fruscio nell’aria, il volo silen zioso, e l’uccellaccio sentiva anche lo squittio di un topo e gli piombava addosso all’improvviso. “Un brigante” pensava Gino. Incontrava poco gli uomini e gli piaceva dare agli animali una vita, delle virtù o dei peccati che assomigliavano tanto a quelli dei padroni dell’universo. Un guizzo attraversava il bosco: “Deve essere una donnola, corre come una matta, e chissà chi sta inse-guendo, l’assassina”. D’inverno, ragionava, cambia pelliccia e diventa bianca come la neve: “Anche l’arciprete, però, mette i paramenti d’oro quando viene il vescovo”. Non credeva, come dicevano, che la civetta annun cia la sventura; non è malefica, c’è chi lo pensa per via di quegli occhietti gialli, ma è puttana: “Canta per atti-rare gli altri uccelli, e per conto dei cacciatori”. Le lucciole lo rallegravano: in alto le stelle, e Gino sapeva che quelle piccole luci che si accendevano e si spegnevano lungo il sentiero erano inviti all’amore. Nessuno può dire se pativa per il desiderio di una donna. Gino non aveva timori: “Male non fare, paura non avere”, e sul suo cuore non pesava la tristezza. Ma venne il momento, dopo quarant’anni, del con-gedo: gli tolsero le chiavi, lo mandarono via. L’arciprete gli disse: “Sei malato, sei stanco. Non puoi rima nere”. “Ma la Madonnina” replicò Gino costernato “ri marrà sola.” Finì all’ospedale, poi in un ricovero per quelli che non hanno più nessuno. La nostalgia lo perseguitava; un carabiniere trovò un vecchio che vagava da giorni nella nebbia, per la campagna, senza mangiare, non aveva in tasca nessun documento e non sapeva dire altro che “Faggio... Ma-donnina...”. Lo ricoverarono e gli promisero che sarebbe tornato. Si acquietò. Forse la rivide quando gli impartirono l’ultima benedizione prima del lungo viaggio. Ora Maria Santissima non c’è più: i ladri hanno rubato il quadro. Non porta bene. Uno dei primi articoli che scrissi da ragazzo si intito-lava: “Pianaccio è una favola”. C’è qualcosa di misterioso e di antico nei muri di sasso, nel cielo che opprime, nelle credenze e nella ras-segnazione: quelli che nei testi scolastici figurano come gli “eventi”, qui diventano vicende personali e rappre-sentano il prezzo che ognuno paga, senza colpa, per co-struire la storia. Io so, ad esempio, che non è vero che esiste l’Homo economicus, ma ho sempre capito Zobbi Alfonso, il mio compagno di banco, che dopo aver fatto per un quinto di secolo il minatore nel Sulcis non ha mai presentato domanda di iscrizione al Partito liberale. Il passato è scritto in qualche lastra di marmo - morti e dispersi - o nelle croci di legno del cimitero: ci sono le vittime di tutte le crudeltà, gli sconfitti predesti-nati, ci sono l’Isonzo e il Tomori, l’Amba Alagi e la Rus-sia, il partigiano e il fedele del Duce. Ogni tanto ritomo quassù e mi rendo conto di quanto la sorte è stata generosa con me, e spero di conservare fino all’ultimo quel senso del relativo, della po-chezza dei nostri traguardi che i miei paesani non smar-riscono mai. Dicono: “Muoiono le foglie, ma fanno vi-vere gli alberi”. Aspetto con serenità il momento di aggregarrni: ma è uno scatto che le statistiche demografiche non avver-tiranno. In fondo, che cos’è un’esistenza che si con clude nel paesaggio, nei colori e con le voci tra le quali è cominciata? Proprio un fatto da gente comune. Una volta il mio amico Alfonso mi disse: “Mi sa-rebbe piaciuto andare con una tedesca”. Pensava, suppongo, a un’emozione, a un piacere che non gli era stato concesso. O alla mia fortuna. Forse aveva visto qualcosa in televisione, una spiaggia, immagino, o ricordava l’attrice di un vecchio film. Gli raccontai di quella dama inglese che la prima notte di nozze, entusiasta, chiese al nobile consorte (al-tri tempi, naturalmente): “Anche la servitù fa come noi?”. Mente di speciale, ma Alfonso mi guardava con sospetto. Ricordai allora certe conversazioni con un grande attore: Ugo Tognazzi. Tema abbastanza consueto. “Quando uno smette di far l’amore,” diceva “la morte è vicina.” Per consolarlo, le raccontai al mio amico. La prima avventura, si fa per dire, Ugo l’aveva avuta a diciotto anni, secondo le regole di una volta, nel consueto locale accogliente, e l’emozione fu tale che già salendo le scale e, contemplando le lunghe gambe e le natiche trionfanti della ben disposta fan ciulla, consumò l’effimera gioia. Accade. Poi era diventato una specie di eroe di Fellini, uno di quelli che sognano di essere immersi in una enomme bagnarola con tante premurose ragazze attomo che gli lavano amorevolmente la schiena. Aveva avuto quattro figli da tre madri, e nella lista delle conquiste c’era l’irlandese Pat, la spagnola Eslava, le francesi Caprice ed Hélène, la norvegese Margareth e infine una bella compatriota, Franca Bettoja, che gli è stata accanto fino all’ultimo. Dunque, molte compagne, ma ho l’impressione che siano più le fregature che ha preso di quelle che ha di stribuito. Aveva l’apparenza di un sultano, ma era sem pre nelle mani di astute favorite. “Non mi piaccio” diceva. Poi: “Mi perdono”. E si giustificava: “Il successo è tutto”. Così uno psicologo gli faceva un ritratto poco lusin-ghiero e anche scarsamente attendibile: “Satanasso ses suale, crapulone, invidioso dei colleghi, rapace nell’ac caparrarsi i film degli altri”. Era lui che lo riferiva. Invidiava Frank Sinatra perché aveva “il cinismo e la freddezza” che gli mancavano. Era meno ipocrita di al tri divi ed esplicito e sincero fino all’autolesionismo. “La vita” diceva “è come un risotto: tanti ingredienti.” Forse eccedeva nelle dosi. Un altro amatore da esportazione è Vittorio Gass-man: padre tedesco e vizi italiani. Ma, anche lui, leale con sé stesso fino alla denigrazione: record, quattro figli da quattro diverse mamme. Genio e fecondità. Ha compilato un catalogo delle conquiste: c’è Elvi, “superba topa dalla chioma fulva”, che anche nel ricordo conserva il primato delle tette, mentre Nora Ricci, la prima sposa, si impone per “le mani”, c’è Shel ley Winters, l’americana, aspra e severa, che minaccia le rivali con le forbici, e Juliette Mayniel, “gli occhi”, e Anna Maria Ferrero, il “sex appeal”: Vittorio non regge al desiderio e, per la furia erotica, le strappa le luttuose vesti e le salta addosso al ritomo dal funerale della madre: il nero eccita; e poi Annette Stroyberg, “la pelle”, e Diletta, “le gambe”. Basta niente a cancellare un amore: con Anna Maria fu sufficiente una briciola che si posa inopportuna-mente sopra il labbro dell’amata. Sette anni di passione cancellati dalla noia e da un tè con la torta. Ma Gassman è capace di gesti delicati e, ne sono testimone, di insospettabili generosità. “Felicità” mi disse una volta “è la giovinezza.” Alfonso è rimasto vedovo: ha in camera da letto la fotografia della moglie e un ritratto di Berlinguer. Non è di quelli che cambiano idea. La casa gli sembrava troppo vuota e cercava una compagna. Non perché non sapesse arrangiarsi. Al mattino faceva la spesa, metteva la biancheria nella la-vatrice, cucinava: sempre la stessa pasta e la stessa bi stecca. E sempre la solita televisione. “Ma come è lunga la giomata” sospirava. “Non è che con la povera Maria parlassimo tanto, ma mi ba stava sentire il suo passo, sapere che c’era. Pareva che una postina, la incontravo ogni tanto, ci stesse, mi disse che doveva pensarci. Una qualità l’ha di sicuro: è molto riflessiva. Non ho più saputo niente. “ Una volta, in stazione a Bologna, vide una bella ra-gazza, disinvolta, fumava. Si fece coraggio: “Mi dai un bacio?”. La signorina lo guardò meravigliata: “E tu che cosa mi dai?”. “Sono un pensionato.” Era il bollettino di una resa. “Capita a tutti, anche a quelli che vanno in giro per il mondo” dissi. Mi ricordai dell’indossatrice finlandese che conobbi a Stoccolma. Affittava una stanza in casa di un italiano. Fu lei che venne ad aprirmi: portava solo il reggiseno e le mutandine. Pensai: è estate. Sorrise della mia meraviglia. La guardai con la do-vuta curiosità: era tanta. Tanta di tutto. Non ho più in mente neppure il nome: rivedo solo un volto con le lentiggini, due occhi grandi, capelli neri, la frangetta, come Louise Brooks, ma non ne sono si-curo. Io in tedesco so esprimere solo alcuni concetti, o al-cuni bisogni elementari: dov’è la stazione? quanto? destra o sinistra? Pane e uovo cotto alla coque e, per l’aspetto sentimentale del discorso, mi sono sempre appoggiato a qualche verso di un Heine scolastico: “Du bist wie eine Blume”, so anche il seguito: “Tu sei come un fiore”; e poi si prosegue, bello, puro, e avanti ancora. Sbrigai il mio repertorio e mi parve di trovare una favorevole accoglienza. Mangiammo piccoli pani con gamberetti, frutti di mare, anguilla affumicata, serviti su un foglio di lattuga in un chiassoso ristorante di Strandavagen. Tra noi piombavano cupi silenzi, il linguaggio era proprio ele mentare. E poi: che dire? Si faceva tardi e il mio aereo al mattino partiva al-l’alba. Posi in modo rude e riassuntivo la domanda con clusiva: “Gehen wir schlafen?”, anche se domlire non era proprio la mia intenzione. Recitò amabilmente la parte, con una battuta che doveva far parte del galateo locale: “Eine Dame sagt immer vielleicht - Una signora dice sempre forse”. Mo-strai l’orologio, ma continuò a sorridere. Vorrei anche raccontare di quella povera cantante di cabaret dalla voce profonda, nella quale sentivo come un velo di pioggia, che narrava vicende di con-trabbandieri e di malandrini, di donne perdute dal cuore generoso e di soldati che partono per la guerra. La conobbi a Varsavia al Pod Baranani. Un palco-scenico assai modesto, improvvisato, la luce di un riflet-tore le batteva sugli occhi, era avvolta dal fumo, dall’o-dore un po’ acre di sigarette e di alcol. Sembrava la scena di una pellicola Ufa, dell’altro dopoguerra, un film impressionista; ma la ragazza non aveva le gambe di Marlene, il fascino penerso di Lola-Lola, solo un volto sbiadito, due grandi occhi azzurri. Passò la fioraia e le mandai un mazzo di violette. Dopo venne a sedersi al mio tavolo; ero con un collega della televisione. Seppi che si chiamava Lisa. Portarono la solita bot-tiglia di vodka ghiacciata e il caviale che i ferrovieri russi rubano e dopo finisce sui mercatini polacchi. Era quasi l’alba, dalle finestre entrava una luce gri-gia. Il pianista si era addormentato, la testa abbando-nata sulla tastiera. E Lisa continuava a parlare. Nel suo passato c’erano tante ombre. L’aiutai a indossare un cappottino di panno troppo leggero; cera tanta nebbia e lei rabbrividiva. Tro vammo un taxi; l’accompagnai dalle parti di Stare Miasto. Sentii le sue dita che armeggiavano per slacciarmi i pantaloni. Non si vedeva nulla, neppure la sua faccia. Lisa pensava che c’era un conto da pagare. Le presi la mano. “Vado a dormire” dissi, e volevo proprio dire che avevo sonno ed ero tanto stanco. Sono andato molte volte a Praga: nessuno amava Stalin come i compagni cecoslovacchi. Sui monti Tatra c’era una vetta che lo ricordava; un francobollo portava in giro per il mondo la sorridente e ironica immagine del grande compagno. Un monumento di cui non si vide mai l’eguale si specchiava nelle placide acque della Moldava; il succes-sore di Lenin guidava un corteo di beneficati: il mina-tore, l’intellettuale marxista, il contadino, il soldato, la madre e, attorno al duro comunista georgiano, intrec ciavano folli voli i gabbiani e le anatre selvatiche. Lo vidi erigere e ho sentito il rumore dei martelli pneumatici che lo demolivano. C’ero quando comandava Antonin Novotny, e ho intervistato quello scrit-tore dalla limpida coscienza che è Vaclav Havel. La mia interprete era una anziana signora che aveva conosciuto l’Europa ed era stata tante volte in Italia. Di sé parlava poco: del passato niente. Era ve-dova di un medico, anche i vestiti giù di moda, ma di gusto, rivelavano una storia borghese. Le chiesi:--Lei ha conosciuto una attrice che si chiama Hana Vitova? interpretò, tanti anni fa, un film, che si intitolava Lafalena, era bellissima. Mi piaceva molto, indossava, ricordo, un abito di lu strini e attorno al collo portava lunghi boa che si dissol vevano nella luce. Ero studente e mi piaceva Hana Vitova come mi piaceva Michèle Morgan, con l’impermeabile e il basco: rappresentavano le evasioni e l’insicurezza dei ra-gazzi di allora. La signora una sera mi accompagnò in un cabaret di terz’ordine; sul piccolo palcoscenico apparve, inqua-drato dalla crudeltà del proiettore, il volto malinconico di una ex bella donna che, accompagnata da un violini sta, cantava una ballata piena di disperazione. Uscii perché io voglio, nonostante tutto, conservare qualche vecchio sogno. Andammo a bere in memoria della bellissima Hana Vitova e della nostra giovinezza perduta. Bisogna insegnare, credo, non a essere felici, ma ad accettare il dolore. Cos’è una donna? La dolcezza, la sensualità, l’im-maginazione, un rimpianto, un profumo. Da bambino m’incantava quella che per me era la signora del calendario. Una bellezza meridionale, con una rosa nei capelli e una casta scollatura che esaltava due spalle candide: come quelle di Martha Eggerth, l’attrice che faceva l’innamorata di Schubert nel film Angeli senza paradiso. Dopo, le illustrazioni del Doré nella Divina commedia che mia nonna maestra conservava nella sua piccola bi-blioteca, con la Bibbia, i Miserabili e i racconti di Renato Fucini. Rivedo Paolo e Francesca, i lussuriosi infelici: il tur binio infernale scopriva le grosse cosce e l’inguine depi lato della sventurata amante. Più tardi, la condanna mi parve eccessiva. Una pagina di un romanzo di Orio Vergani: Recita in collegio. Un ragazzino, mi pare fosse proprio così, bacia le mutandine della sua amichetta. Uno di quei giochi ingenui che avviano la perdita dell’innocenza e la sco-perta della vita. Una stampa della signora Récamier, su una coper-tina di un libro francese: torturò con il suo fascino Ben jamin Constant e Chateaubriand perché, diceva il bio-grafo, “mescolava il candore con la voluttà”. Un esempio classico difemmefatale. Fece tanto sof-frire i suoi spasimanti che alla sua morte si sentirono sollevati. Non c’è da ridere o da demoralizzarsi: avevo un caro amico, un severo professore, che non si riprese mai da una risata sguaiata, risposta a una sua patetica dichiarazione d’amore. Che vuole sempre dire: “Ho bi sogno di te”. Aiutavo Iride a ripassare le lezioni di storia; terza media, mi pare. Aveva le treccine, era magra, insignifi cante, solo gli occhi le brillavano. Mi prese una mano: “Toccami, più giù”. Non c’è nulla da imparare sull’argomento (Adamo ed Eva sapevano già tutto), anche se ognuno pensa di essere protagonista di una vicenda unica e irripetibile. Una volta andai all’isola di Elephanta, di fronte a Bombay: in una grotta, scolpite nella roccia, erano rap presentate, già prima che nascessero Gesù e il senso del peccato, molti dei possibili atteggiamenti che un uomo e una donna nudi possono concedersi. Dicono che gli esquimesi provano gusto a sfregarsi il naso; i piedi fasciati, piccoli, rattrappiti scatenavano la passione sessuale dei cinesi. Le anatre mandarine, perché viaggiano a coppie, simboleggiano ancora l’a-more. Già Confucio sosteneva che tre sono gli istinti del l’uomo: mangiare, bere e spassarsela a letto. I ricchi erano poligami, i poveri, se non avevano soldi, restavano scapoli. La concubina doveva provvedere allo svago, la moglie agli eredi. Un maresciallo, al tempo dei “signori della guerra”, disponeva di ottanta ragazze. Ma, recita un proverbio locale: “Una donna giovane che ha un ma-rito vecchio è in realtà la moglie di un altro”. Tutto previsto, anche da quelle parti. Nel Libro delle odi una giovane sposa canta: “E dolce il mio signore, ma la vera soavità della vita è nella varietà delle pose”. E vero; tutto il mondo è paese: anche se c’è chi celebra il lutto con il crespo bianco e gli altri con veli neri. Al mio paese, dopo il funerale, c’è l’elemosina del pane: all’uscita della chiesa ogni famiglia riceve una pa gnotta e la sera recita un rosario. In Svezia al mesto rito segue un ricco banchetto, con abbondante supplemento di alcolici. Sul vasellame che si noleggia sono impresse lugubri foglioline. Gli amici e i congiunti del defunto ricordano con brio, piacevolmente, le più belle imprese di colui che ha fornito il motivo per il gradito convegno: “Ricordi quella volta che...”. E intanto si mangia, e soprattutto si beve, e nessuno si scandalizza per qualche risata perché, in fondo, biso gna pure farsi coraggio. è regola distribuire non i “santini”, le “memorie” (mia madre li infilava nel libro della messa), ma dei confetti: naturalmente neri. Tante figure si allontanano e tante sensazioni si ac-cavallano: come si annuncia la fine? “Beato l’uomo per-ché non conosce la sua sorte” sta scritto. Nelle ore diffi-cili mi sono chiesto: “Come avranno affrontato la prova Leonardo, o Dante, o Napoleone?”; quel mascal zone di Nerone in fondo era un coraggioso: “Pugna-lami” disse al liberto. Lasciamo stare le ultime parole: “Aria, più aria” dice Goethe, ma è un pensiero che ricorre nelle corsie di ospedale, quando poi decidono per la bombola di os sigeno. Ci sono antologie di battute: “Vado a raggiungere un forse”; o anche, si dice: “è andato a raggiungere i più”. Ho sempre considerato un imbroglio la teoria della “bella morte”. Mi disse il dottor Sabin, lo scopritore del siero antipolio: “Bisogna dare dignità alla fine”. Uno se ne va, “tra bisbigli che non riesce ad affer-rare”. Lo scrive Hemingway, e abbrevia la cerimonia con un colpo del fucile da caccia. Cesare in un libro di Thornton Wilder diceva: “Io che governo tanti uomini sono governato da uccelli del malaugurio e dai tuoni”. E accaduto ancora. Conosco la reggia di Potsdam: in quelle stanze, tra decorazioni rococò, tra putti un po’ gonfi, un poco idropici, stucchi dorati e le spinette sulle quali furono eseguite per la prima volta le sonate di Bach, è nato il militarismo prussiano. Raccontano che gli orologi con il carillon che ripe-tono un minuetto si fermarono per sempre quando Fe-derico, il grande sovrano, emise l’ultimo respiro. Conservano la sua poltrona: è coperta da una seta color argento che il tempo e le vicende hanno consu-mata; c’è anche il segno di qualche bruciatura. Fede rico stava con il capo abbandonato sulla spalliera; dal parco giungeva ogni tanto il grido di un uccello not turno. L’avvertimento. In un angolo sostavano silen-ziosi i cortigiani; nel caminetto bruciava un ramo di quercia e ombre improvvise si disegnavano sulle tap pezzerie che coprono le pareti. Temeva la morte l’uomo che aveva guidato tanti giovani sudditi in batta-glia, e molti non erano ritornati? Lui che diceva ai suoi soldati: “Non sparate finché non vedete il bianco dei loro occhi”? I morti non sono belli. Per mestiere, o perché la fac-cenda ci riguarda, ne ho visti tanti. Da chierichetto ac compagnavo monsignore al manicomio per la benedi zione dei parrocchiani matti: anche loro avevano biso-gno di un’ultima raccomandazione. Il primo defunto che vidi era anche illustre: un ge nerale. La bara era scoperta: con un fazzoletto legato alla testa gli tenevano la bocca chiusa. Pare dicesse alle infermiere cose irriferibili. Un picchetto gli presentò le armi. Le presentarono anche ai sei tedeschi che erano stati fatti prigionieri a Ronchidos: avevano ucciso più di ottanta “civili”. Uno andava in giro sotto la pioggia con le spalle coperte da una pelliccia di astrakan: l’aveva strappata a una donna. Vennero falciati, per rappresaglia, in una macchia di quercioli. I contadini gli tolsero gli stivali: non si ha un’idea di quanta gente va in giro con le calze rotte. Anche Luciano Bianciardi, che andai a salutare alla camera mortuaria, era così: e, chissà perché?, fu il par-ticolare che accrebbe la mia tristezza. Ero stato con lui qualche giorno prima, non imma ginavo che fosse così stanco di vivere. Cominciavano le prime rivolte giovanili e lui disprezzava certi espropri: “Dovrebbero essere come il compagno Stalin” diceva “che assaltava le banche, non le salumerie.” Ho visto gli assiderati: andavano a cercar olio in To-scana e la tormenta li aveva assaliti. Li tirarono giù dal camion: rigidi come baccalà. Il peggio sono gli anne gati: gonfi, blu. Poi ci sono i luoghi e i simboli della morte, e spesso i contrasti sono insopportabili. Sono stato un pomeriggio a Dachau; oggi i dépliant turistici la segnalano come “località famosa per le trote e per il vino”. C’era una grande pace nella campagna. Il tiepido sole dell’autunno batteva sulle torrette delle sentinelle, sui capannoni grigi, sulla stella di David che ricorda gli ebrei, sulla croce che ricorda i cristiani. Vidi un nastro di carta colorata, un nastro da co rona sbiadito, attaccato alla sbarra di un forno. C’è chi non sa dove portare un fiore. Due bimbetti americani, biondi e allegri, si insegui vano urlando nella camera a gas, le loro grida si diffon devano nell’aria tesa e silenziosa. Arrivarono le madri e li portarono via. Ad Auschwitz mi colpì l’edificio dove alloggiavano le SS. Avevano anche la cantina e il dentista e ricevevano visite: ragazze. C’era uno scaffale per i libri e le ri-viste. Una, in carta patinata, si intitolava Schonheit, la bellezza. Pubblicava versi, anche in onore del Fuhrer, afori-smi di Oscar Wilde e molte fotografie: riposti cortili di Granada, fanciulle della Polinesia completamente sve stite e qualche nudo di assorti giovanotti ariani, fissati nel bronzo da scultori che non trascuravano nessun particolare. Ammucchiati in uno stanzone migliaia di pennelli da barba, centinaia di valigie, quelle di fibra dei pove racci, quelle di pelle con le etichette dei grandi alber-ghi, i vasini dei bambini ebrei, dei bambini zingari, ga-melle di latta, grembiuli, vestaglie con la stella di Da vid, con il triangolo, con la scritta “Jude”. Chiesi a Primo Levi che cosa vuol dire lager, perché esiste anche la normalità del male. “In tedesco almeno otto cose diverse, compresi i cu scinetti a sfera. Significa accampamento, luogo in cui si riposa, giaciglio, magazzino, ma nella terminologia at-tuale, anche in Germania, è il campo di concentra mento, un luogo di distruzione. “Auschwitz era qualcosa di poco reale, lo sbarco in un mondo imprevisto, in cui tutti urlavano. Siamo stati privati dei bagagli prima, degli abiti poi, delle famiglie subito. “Penso che mi abbia aiutato a sopravvivere soprat tutto la fortuna, perché non c’era una regola che stabi lisse chi doveva farcela: il più colto o il più ignorante, il più grasso o il più magro, il più devoto o il più incre-dulo. “In un giorno di sole, di luce, durante una marcia, ho cercato di insegnare l’italiano a un mio compagno di prigionia - era un francese - recitandogli il canto di Ulisse che non sapevo bene, così a brandelli, e avevo capito quanto era importante ripescare in fondo alla memoria un ricordo di scuola, una poesia. “E poi il giorno del Kippur, del digiuno, che nessuno rispettava perché eravamo tanto affamati, davanti a me c’era un lituano che si è presentato al Kapo, un poli-tico, un comunista tedesco, un omaccione pieno di ci catrici, molto svelto con i pugni, e il piccolo ebreo li-tuano, sull’attenti, come era prescritto, ha detto: “Si gnor superiore, per piacere, non mi dia la razione, me la tenga fino a domani, perché non posso mangiare”. “E l’altro, quasi sconvolto, ha detto di sì e gli ha chiesto: aPerché lo fai?”. “E quello: aPerché sono credente e privandomi del cibo non solo faccio ammenda dei miei peccati, ma an-che di quelli degli altri, e forse anche dei suoi, Herr Kapo”.” Le anime del purgatorio, secondo l’iconografia po polare, sono avvolte dalle fiamme; ma c’è già un anti-cipo per i nostri sbagli, che precede il castigo divino: è il rimorso. Chiesi a Michelangelo Antonioni se aveva mai avuto occasione di pentirsi di una cattiva azione: “Sì,” rispose “litigai con una amica con la quale avevo una storia e le rivelai che ero stato anche l’amante di sua madre.” Raccolsi qualche confessione di una “diva” di Holly-wood: Gloria Swanson. Ai suoi tempi, per il fasto con cui viveva, la chiamavano “Regina Gloria”. Aveva avuto tutto: perfino una vasca da bagno tutta d’oro e cinque mariti, tra cui il marquis de La Falaise de Con dray, che si facevano regolarmente mantenere. L’ultima memorabile interpretazione fu Viale del tramonto: la trama narrava di una folle star del cinema muto che cercava di mantenere viva la sua leggenda mantenendo un gigolò. Nel finale il devoto autista-factotum, interpretato mirabilmente da Erich von Stroheim, recitava una battuta che era come una lapide: “Le stelle sono eterne”. Si lasciò andare: “Invecchiando sono incline a pen-sare che tutto quello che è successo lo abbiamo voluto; non amo dare la colpa agli altri per quelli che definisco ai miei errori”. “Ebbi con Joseph Kennedy, il padre diJohn, una re lazione, e non soltanto d’affari. Sì, ho anche abortito. “Una volta ero al quarto mese, non riuscivo nem meno a vedere i miei piedi: come avrei potuto lavorare ancora? Avrei dovuto interrompere per un anno, forse anche di più. Avevo sposato uno che non era in grado di mantenermi. Avrebbero sghignazzato alle mie spalle. “Mi scusi: non riesco ad andare avanti su questo ar-gomento. Da allora ho sempre rimpianto quella deci sione. Sogno spesso di vivere a Manhattan, il fiume Hudson da un lato e l’East River dall’altro: bambini fatti a pezzi scivolano sull’acqua verso l’oceano”. Ho parlato con alcuni terroristi - pentiti, dissociati, omogenei -, ma non sono uno studioso della materia. Mi hanno colpito più i casi umani che le ragioni politi-che. Mi importava poco se erano della “sinistra ever-siva” o della destra: nel conto ci sono quattrocento omi-cidi. Ricordo il cinismo di Francesca Mambro quando di-ceva: “La mia generazione non conosce la parola rimorso”. E l’ironia emiliana e la schiettezza di Alberto Franceschini. Più di dieci anni in galera. Con Renato Curcio decisero una sera all’osteria, mentre mangiavano il risotto, di dedicarsi all’opposi zione armata: nascono così le Br. Si era scoperto “rivo-luzionario di professione” e trovava che il Partito comu-nista era soltanto “revisionista”. Una volta, in tribunale, durante un processo, disse: “Io sparo a una toga e, se dentro c’è un uomo, che colpa ne ho?”. A me spiegò: “Si mira sempre a un sirnbolo”. Sapeva che aveva perduto, che non c’era futuro per il suo programma, e scriveva a un prete amico: “Io credo che solo l’uomo sconfitto può veramente cono-scere l’uomo”. è vero che il sangue della Storia secca in fretta. Die-tro a Franceschini c’era una nonna contadina che gui-dava le rivolte dei braccianti e un padre operaio e anti fascista che era finito in manette. Un filo rosso lo le-gava al passato, ma ho sempre pensato a ciò che le cir-costanze possono fare di ognuno di noi. Non so più chi lo ha detto: il caso fa tre quarti di lavoro in questo mise rabile universo. E c’è perfino una virtù e una morale che varia a se conda delle latitudini: in America si preoccupano per quello che i politici fanno di notte, noi per quello che combinano di giorno. Ogni popolo ha le sue caratteri stiche e le sue tradizioni: quando c’era il Terzo Reich, Hitler si liberò del generale von Fritsch accusandolo di omosessualità; il poveretto andò a morire, invece che in un tabarin, come soldato semplice in Russia. Von Blomberg, invece, ci rimise i gradi perché aveva sposato una prostituta: i nazisti perseguitavano i mariti di puttane, in altre contrade premiano, al con trario, i figli. Ogni generazione ha i suoi modelli e i suoi valori. Cuore è stato un po’ il breviario sentimentale di quella di mio padre. Non credo abbia fatto tanto male. La Maestrina dalla penna rossa insegnava la lealtà, il sacri ficio, la gioia che premia i generosi. Le maiuscole, allora, si sprecavano: Dio, Patria, Fa miglia. La banda accompagnava i pompieri caduti nel l’adempimento del Dovere. I bravi bambini si butta-vano nelle acque limacciose per salvare le lavandaie. Se uno riusciva a stringere la mano del Re non se la lavava mai più. Quelle vicende in me si associano a un odore di in chiostro che si secca e di vecchio legno, di patate bollite e di caldarroste. Più tardi ho scoperto che di bravi Garrone e di “in. fami” Franti è piena la vita: o, meglio, che in ognuno di noi c’è un po’ di Franti e un po’ di Garrone, perché siamo capaci di grandi gesti e di inconfessabili meschi nità. Noi, i nati subito dopo la prima guerra, abbiamo avuto altri eroi ed altri esempi: forse Nemecsek, il bion dino dei Pagazzi della via Pal, il solo soldato semplice in un esercito di generali, che nel giorno della Battaglia, pur divorato dalla febbre, andava a combattere tra le cataste di legno della segheria e moriva per salvare l’o-nore della sua bandiera. Era il figlio del povero sarto, un escluso, e pagava per tutti e più di tutti. Poi, sul telone bianco, arrivò l’intrepido Tom Mix che puniva gli sceriffi traditori e sbaragliava i ladri di bestiame e sposava palpitanti ragazze dai capelli con la frangetta. Più tardi, quando venne la stagione del primo amore, fu la volta diJean Gabin: ci insegnò il dubbio, il pessimismo, ci preparò alla sconfitta. Scoprimmo che esistono gli infelici e imparammo a credere nelle pic-cole idee. Si dice che la gioventù è ora tanto diversa da quel lo che noi fummo. Più sicura, più studiosa, più informata. Il mitico Sessantotto è ormai lontano: molti hanno capito che “l’immaginazione al potere” era uno slogan stupido. Sono svanite le infatuazioni di allora: non erano neppure capaci di ridere quando Radio Pechino raccontava che i medici facevano camminare i parali-tici leggendogli le massime del Libretto rosso. La venerazione di Mao, Figlio del cielo, produceva effetti disgustosi: comici, letterati, politologi da delega zione ritomavano da viaggi, opportunamente organiz-zati, esaltando la democrazia che regnava attorno ai vecchi palazzi imperiali, inni alle giovani guardie che buttavano via gli spartiti di Beethoven, il repertorio del-l’Opera di Pechino con il Gran Khan e le cortigiane, e sotto con i contadini e gli operai. Chiusi i musei, tra-sformati in officine i templi, vietato anche allevare in casa uccelli cantori e pesci rossi. La chiamavano “Rivo-luzione culturale”. Quanti corruttori abbiamo incontrato, quanti spac-ciatori di false promesse e come era difficile criticarli. Occorreva quello che un grande giornalista, Silvio Ne-gro, chiamava “il coraggio del buonsenso”. E dietro alle parole e ai manifesti milioni di morti. Qualcuno ha detto: “Non bisogna far giocare gli intellettuali con i fiamrniferi”. Ecco: Jacques Prévert. Quanti irnbrogli e che ricerca di complicità. “Gott mit uns” era stampigliato sulla fibbia dei cinturoni dei soldati di Hitler. Il Kaiser Guglielmo, ai suoi tempi, lo chiamava confidenzialmente “Unser alter Gott”, il no-stro vecchio Dio, che a Parigi era invece “le Dieu de la France”, mentre lo zar Nicola, a Mosca, affermava con enfasi: “Grande è il Dio della terra russa”. I comandamenti venivano per il momento accanto-nati e i cappellani benedicevano tutte le bandiere. Non sono un eroe e non ho mai sognato di diven-tare un personaggio. Ma come è faticoso cercare di avere rispetto di sé, del proprio passato, sbagliare ma con la grande attenuante della buonafede. Ci ho pro-vato. Leggo in una lettera di Hemingway: “Saremmo pri-gionieri più volte al giorno se non adoperassimo la te-sta e quelle due ghiandole a forma di uovo che con fa-tica abbiamo fatto calare”. E aggiungeva: “Non seguo le mode in politica, lette-ratura, religione ecc. Nello scrivere non c’è sinistra e non c’è destra. Al diavolo tutti gli specialisti in svolte”. Le notizie “buone” non funzionano, ma forse ho co nosciuto anche qualche candidato alla santità. E proba-bile che padre Pio da Pietrelcina si avvii alla gloria degli altari. Ho assistito alla messa che celebrava all’alba. Du-rava due ore. Gli autobus scaricavano sul piazzale di Santa Maria delle Grazie, a San Giovanni Rotondo, lun ghe file di pellegrini assonnati. Molti venivano da lon-tano. C’erano anche tante donne vestite a lutto. Il frate cappuccino si avviava all’altare con fatica, due novizi lo sorreggevano. Si sentivano i sandali strisciare sul pavimento; nel volto, illuminato dalle can-dele, si leggeva il dolore. Tanti anni prima, mentre pregava sotto un olmo, sentì che gli bruciavano le mani; passò del tempo e una mattina di settembre comparvero le stigmate. I medici non sapevano spiegare il perché di quelle piaghe; padre Gemelli, un terribile convertito, disse che si trattava di un fenomeno di isterismo mistico. Di lui raccontavano molti prodigi: aveva il dono del-l’ubiquità e aveva sconfitto il demonio che gli si era av-ventato contro travestito da cane nero. Tutta la sua vita se ne era andata in una cella di convento, solo qualche breve passeggiata nell’orto. Non pareva possedere doti speciali: non era un gran predicatore, non ostentava la sua perfezione: “Gua-glio’,” diceva ironico “i santi stanno in paradiso”. Le sue maniere erano brusche, si spazientiva perché sa-peva leggere nel pensiero. E faceva miracoli. Riceveva migliaia di lettere e tante offerte, e cinque fraticelli erano impegnati a rispondere. Poi c’è un altro virtuoso che ho conosciuto bene: un piccolo professore siciliano che portava gli occhiali e i calzerotti bianchi dei domenicani, e che qualcuno chia-mava ail bolscevico del Vangelo”, e fu spesso oggetto di critiche aspre e di ironia, e della scarsa considera-zione dei benpensanti: a me sembrava un saggio dall’a-nimo puro. Non lo sgomentavano gli attacchi e l’ho sempre vi-sto lieto e sereno. Credeva nei miracoli: “Io risorgerò con il campanile di Giotto” diceva sorridendo. Lo consideravano un visionario perché credeva nei prodigi: “Le rondini” spiegava “non volano forse da un continente all’altro?”. E ancora: “Le stagioni non le fa il contadino; le aiuta. Si orientano tutte verso l’estate, i giorni del rac colto, quando le messi maturano. Così si fa la storia. Il contadino sa che un po’ di pioggia non cancella la pri-mavera”. Diventò sindaco di Firenze; accettava il comunismo come “una prospettiva che può rientrare nella Bibbia”; e osservava che Marx era ebreo. Pensava che la cosa più urgente era ridare al po-polo la speranza: vedeva nel povero un oppresso e nel ricco uno che non è libero dentro. Capiva i tempi e in-travedeva il futuro. Nei suoi vivi occhi meridionali c’era la gioia. Anch’io, come tanti, gli devo ore serene. Ho scritto queste pagine per ritrovare qualcosa di me stesso, finché la mente è capace di riepiloghi: è pas-sato tutto molto in fretta, e non c’è più tempo per spe rare. “La vita” diceva un vecchio delle mie parti “è af-facciarsi alla finestra.” E la notte di San Lorenzo e mi avvio a concludere. Dicono che dovrebbe essere il mio santo protettore: lo ringrazio. Le stelle sui monti sono più vicine; ogni tanto una scia segna il cielo. Ho percorso la stradetta che porta al cimitero: i rampicanti soffocano i castagni e av volgono un ciliegio selvatico. Per me diventa quasi un simbolo. Sulla tomba di mia madre c’è una rosa che si sta disfacendo. Questa mattina sono andato a Vidiciatico a cercare la lapide che ricordava il principe di Carovigno: sparita. Nessuno sapeva perché era venuto a finire quassù. Di-cevano che aveva scritto un poema e che era un genio. Assomigliava ai Savoia e la moglie era una baronessa inglese. Conosceva sette lingue e insegnava senza com penso (qualche uovo, un coniglio e dei fiori di carnpo per la nobile signora) l’inglese. Portava sempre i guanti e indossava giacche di tweed un po’ consumate. Parlava solo con i bambini, ai quali mostrava la cassa dell’orologio: c’era inciso uno stemma gentilizio. Chissà perché mi è venuto in mente: dove sono fi-niti i suoi versi; e se fosse stato davvero un grande? Si può piangere non per quello che è stato, ma anche per quello che avrebbe potuto essere. La finestra è aperta e sento il rumore della fon-tana: non bisogna bere dopo l’Ave Maria, perché tocca agli spiriti. Mio nonno Olindo disse che una volta, ritornando con il calesse dopo la mezzanotte, arrivato al fosso che chiamano del Fischio, gli com-parve accanto un uomo molto alto, vestito di panno che, senza dire una parola, lo accompagnò per un pezzo di strada. Da quella volta, cercò di arrivare prima del tramonto. Nello stesso posto mio padre, in una notte come questa, mentre andava a Lizzano a prendere la leva trice perché stavo per nascere, vide un grande frate bianco che sparì dietro la curva. Non meravigliatevi: c’è un santo, di nome Pellegrino, a cui continua, raccontano, a crescere la barba. Bisogna credere: e io da bambino, in certe conchiglie trovate sulla spiaggia, sentivo il rumore del mare. FINE.
Scarica