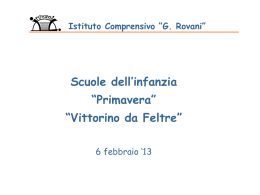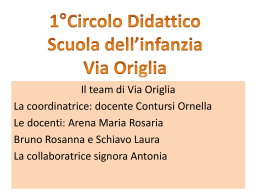VITTORINO E ANTONIA VITURÌN e TUGNÈTA Parte prima Fiocca in quest’alba gravida Fiocca, fiocca proprio intensamente in quest’alba gravida di neve, che scende copiosa e lieve a tingere di candido biancore questa campagna intirizzita e sonnolenta, che si lascia lambire contenta da questo soffice manto che la ricopre lentamente, interamente, senza tregua. Simpatici giganti dalle bianche barbe gelate, custodi invernali dei magazzini del cielo, si divertono a scaricare sulla terra infinite gerle stracolme di neve. E sotto la neve riposano mansueti campi di grano, che a suo tempo daranno il pane, frutto saporito e fragrante di quel frumento che sa attendere pazientemente la stagione rigogliosa e clemente. Solitari stocchi di granoturco s’adornano di raffinati cristalli. Alberi sparsi s’incipriano vanitosamente e tendono le braccia nude, orlate di candidi ricami. La neve abbondante forzerà le loro nervature per saggiarne la consistenza. Esco verso la campagna dall’antico portone di corte e larghe falde m’investono festose e m’accompagnano compatte mentre calco il dorso della collinetta, che si erge alle spalle della casa colonica e poi scivolo giù, curioso, dal Ronco del Zara, un sopraffino contadino, verso l’ampia valle sottostante e a me, che affronto decisamente la voglia di lasciarsi cadere di questa gelida neve e corro libero e felice incontro alle sue capricciose infinite giravolte e la scalfisco ingiustamente con mille faticose zampate, il fitto del bosco s’inchina riverente e m’incorona solenne mentre cauto l’attraverso. Tutto è ammutolito e soavemente sonnolente in questo mattino incipiente. Le balze protese del Ronchetto si lasciano ricoprire ampiamente distese. Più in là non vedo, scendo lungo il consueto sentiero fra gli alberi innevati e mi sorprende l’inatteso fluire del ruscello che a tratti è sospeso. Bisbiglia, mi parla e mi accende questo immenso manto di neve, che un cielo cupo e generoso rende copioso fino là in fondo, sulle colline e sui monti, che alimentano di nuovi bagliori le fioche luci che li rendono presenti. pg. 1 Sono tornato faticosamente in corte, dove la coltre è già alta e intatta e gli archi, le case, la chiesa e il palazzo, sono ancor più belli e festosi ed i tetti si livellano stretti, serrati da mille coppi che pur ricoperti permangono rossi. La linea spiovente è adorna di mille taglienti candele di ghiaccio, che paiono aguzzi denti pronti a mordere tutti i viventi. Scendi, scendi abbondante o cristallina neve dicembrina e ricopri, come tenera madre, tutte le impurità d’anime e di corpi di questo pugno di case, finché ci sorprenda turgida e vigorosa primavera, carica di rinnovate promesse e moltiplicate speranze. Sono stanco di banalità e bassezze che vengono a turbare questa nostra quiete secolare. Attendo con ansia che il ramo fiorito del pesco oltrepassi il muro di cinta! Un lume solitario accende la scena, accentua questa furia travolgente e mi fa da compagno, nell’attesa paziente dei primi scalpiccii di zoccoli sordi, che poi cedono il passo al battere dei saliscendi (alzapee) e al cigolio dei chiavistelli (caenascioeu). E si spalancano porte al giorno nuovo. Fra poco si risveglieranno, tossendo, gli antichi solenni camini e riprenderanno a sbuffare prorompendo da ogni lato, al di sopra di un mondo lontano. La tormenta di neve ne smorza l’ardore, ma loro gareggeranno all’infinito, a volte col respiro più corto, incrociando affratellati, sui culmini dei tetti, i loro afflati. I focolari avidi e ghiotti riscalderanno mani e cuori, fra tanti delicati colori ed i crepitii di mille vivide fiamme illumineranno i volti corrosi dalla quotidiana fatica e allontaneranno ombre oscure dai muri freddi e duri. Scoppiettanti faville si eleveranno danzando per perdersi sempre più in alto. Le prime voci Sentite?... Corrono già le prime voci, i primi concitati richiami, gli incipienti rumori di chi traccia solchi tra la neve per raggiungere le stalle, per governare gli animali, per rubare il tiepido latte alle vacche che rivendicano trepide il secco foraggio. Anche Viturìn e Tugnèta sono già desti e all’opera, dopo aver tracciato un ampio segno di croce sui loro corpi ristorati dal sonno: “Sègness Viturìn, sègness” ed elevano concordi, al cielo, il mattutino sentimento di ringraziamento e di supplica: “Signûr, Ve ringràzzi de tánti gràzzi, de tánti benefízzi ch’hoo ricevuu in quésta sánta nòcc. Ve dumándi la grazia de passà una buna giurnàda, mì, mia mám, ul mè pà e toeucc quíj de la mia cà”! “Signore, Vi ringrazio di tante grazie, di tanti benefici che ho ricevuto in questa santa notte. Vi chiedo la grazia di passare una buona giornata, io, la mamma, il papà e tutti quelli della mia casa”! pg. 2 E questa preghiera restava immutata nel tempo anche quando i genitori erano già nell’aldilà liberi e contenti. E pure i ragazzi delle famiglie d’intorno, al loro risveglio reciteranno ul patêr pregando così: “Vi adoro, mio Dio, Vi amo con tutto il cuore, Vi ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Vi offro tutte le azioni della giornata…” Dritta e mancina Ora lei è in “casa”, a sbrigare le usuali faccende domestiche, lui nel suo stallino a mungere la mucca. Vittorino è piccoletto, magro e irrequieto (piscinèla, màgher e gnervusètt), con gli zoccoli di legno chiusi sul davanti (zacuròtt) e come si diceva un tempo, con i calzoni “tiraa soeu cun la rüzzéla”, tirati su con la carrucola, cioè fin troppo. Guardalo, munge seduto sullo sgabello (scagnèll) col secchio fra le gambe, premendo alternativamente la mano destra e la sinistra, morsicando simultaneamente la sua lingua in perfetta sincronia, prima a destra e poi a sinistra. Esprime così la quotidiana fatica del vivere che diverte tantissimo noi ragazzi, che lo scrutiamo apposta nella lunga mungitura serale, godendo della sua improvvisa esplosione di rabbia non appena lo sorprendono i nostri risolini ed il nostro coro: “Drízza e manscína, drízza e manscína, èl impiendìss la tazzína”! (Destra e sinistra, dritta e mancina, riempie la terrina”). A volte il suo istinto aveva avuto il sopravvento ed il secchio colmo di latte era volato via nel tentativo di colpirci e la sua Antonia lo aveva duramente redarguito perché non le restava più nulla ed aveva messo in guardia i nostri genitori, che manifestavano il loro disappunto cogliendoci di sorpresa con un improvviso scapaccione (scupazzùn), piuttosto che un sonoro ceffone (s’giafùn o slaviòtt) o un irritante scappellotto (pelòcch). Tugnèta Tugnèta, cioè Antonietta se preferiamo la traduzione letterale, era una donna alta, previdente e paziente, gentile ma ferma, di sani princìpi morali e d’una fede ardente che permeava positivamente tutti gli eventi della sua magra vita quotidiana. I due si incontrarono, nella loro trepida gioventù, in quel di Usmate dove lei abitava e dove i contadini portavano quanto era d’obbligo al fattore e nella mia mente si allineavano i capponi, destinati al padrone, che venivano sdegnosamente rispediti al mittente per via d’un pizzico di catarro. Vittorino, giovanotto vivace e insofferente, glieli avrebbe sbattuti sul muso, ma non si poteva per non perdere tutto e finire nella più nera miseria e lei lo supplicava e cercava pacatamente ma fermamente di fargli usare il buon lume della ragione. Tutti sapevano che il pane del padrone è duro da guadagnarsi perché ha sette pg. 3 croste e poi un crostino ancora (“ul pán del padrùn èl gh’ha sètt cróst e peu un crustìn amò”). Non sappiamo se ci fu un intermediario per favorire il loro incontro e il loro sogno d’amore; non ci è dato insomma sapere se ci fu il famoso “cinch e mèzz”, ma coincidenza vuole che proprio ad Usmate si fosse accasato il fratello di Vittorino, un giovane alto, distinto, intraprendente, con baffetti spioventi e ben curati, di cui andava fiero e la sigaretta ovale che traeva dal portasigarette color argento e che fumava con l’elegante bocchino nero. Sappiamo comunque che Vittorino ed Antonia si sposarono felici e contenti pur nella loro consunta povertà e lei venne ad abitare qui nei pressi della corte del palazzo, entro la casa colonica della cascina dove lui abitava: un grappolo di vecchie case, posato dalla Provvidenza e dalla mano dell’uomo su questo dolce declivio. La “casa” o cucina Al pianterreno un locale unico, detto “la cà”, la casa o meglio la cucina: un soffitto di robuste travi di rovere (rúgura, rúgula) ed un pavimento di mattonelle (tavèj) ben curato; un grande camino, un tavolo robusto, qualche sedia (cadréga) impagliata di lisca e una madia (marna) per impastare farine di segale (ségra) e granoturco (furmentùn), macinate dal mugnaio (murnee) di Velate e per conservare in un candido panno il lievito madre (ul levaa) e il pangiallo, che veniva cotto nel forno comune, una volta alla settimana. C’era poi il cassone della farine, con i vari scomparti, per l’alimentazione degli animali (ul cassùn de la farína cun la crüsca, ul panèll, ul rugioeu, la curúbia); una piccola credenza (un büfferìn) e l’asse su cui stagionavano i formaggini (l’assa di furmagìtt) posta sulla parete laterale. È per questa ragione che si diceva di una persona con gli occhi strabici, non senza un pizzico di cattiveria e di pungente ilarità: “Èl varda in soeu l’assa di furmagìtt”! Sopra lo stipite superiore del camino, al centro, un cane di gesso, un tocco di rara bellezza, laccato di lucidi colori; a sinistra il macinino del caffè (ul masnìn del cafè) col suo cassettino e la saliera del sale grosso (la pilótta de la saa gróssa); a destra il ferro da stiro, la soppressa (la supréssa), che quando serviva, veniva alimentata con la brace viva (brâs o brasca) e poi la scatola degli zolfanelli (zufranèj) che non andavano mai sciupati. Sul focolare la catena, nera di fuliggine, per sostenere la pentola di rame per cucinare o il pentolone (stegnaa) per scaldare l’acqua e le farine per gli animali (i bésti), con le fascine di stocchi di granoturco (mergàsc-melgàsc-margàsc) e con i tutoli (luìtt-cüchìtt-burlìtt); il treppiede (tripee), la molla per levare i tizzoni accesi (la moeuja), la paletta per togliere la cenere (ul bernàsc), lo scopino di meliga pg. 4 (scuinètt) per ammucchiare la cenere raffreddata; a lato la panchina di sasso per scaldarsi da vicino e in bella vista il robusto pentolino di rame del caffè (ul pignatìn o pügnatìn del cafè), sempre tirato a lucido (sguraa, sèmper bèll lüster) con la cenere (scèndra) inumidita e strofinata con paglia di frumento (la pàja del furmeent). Nell’angolo esterno del camino, la regina della casa, sempre pronta all’uso: la scopa di meliga (la scua o ‘l scuìn de mélga) che Vittorino sapeva realizzare e intrecciare magistralmente con giunchi di salice (brucajoeu de sàles, strópa). Più in là l’angolo di raccolta della legna, con ceppi e fascine (ul cantùn di lègn cunt i sciócch e i fassìnn), ricavati dal bosco nella precedente stagione invernale. Su di un’apposita mensola: l’asse del battuto, in particolare del lardo (pestalârd), il mestolo (cazzuu), l’imbuto (ul pedrioeu), la schiumarola (scümaroeula); la padella e il paiolo di rame (stegnaa de la pulènta) per la polenta che placava la fame: “la pulènta la cuntènta” (la polenta accontenta, soddisfa); ul stüìn (pentolino in alluminio per andare a prendere il latte appena munto per la colazione) e ‘l zingherìn (pentolino in alluminio più ampio, per il latte e per la zuppa o minestra che veniva portata a mezzogiorno ai contadini al lavoro nei campi). Nella credenza, in basso, un bel servizio di piatti e le posate più belle; nel ripiano superiore, in buon ordine, le stoviglie d’uso quotidiano: tre piatti, tre fondine, tre scodelle, tre bicchieri (trii piàtt, trii tundìtt, tree tazzìnn e trii büceer), due terrine (dó marmìtt); la scatola dello zucchero, merce assai rara e quella del caffè, con in fianco un pacchetto di amarissimo estratto (ul strât), più nero del carbone, che veniva aggiunto al caffè macinato, quello buono, per risparmiarne un po’; nella credenza in alto, in bella vista, dietro i vetri disegnati, i bicchieri più belli, per gli ospiti e le grandi occasioni e i bicchierini del liquore (i bicerìtt del licûri), poi sei chicchere e sei tazzinette da caffè (sees chícher e sees chicherìtt bèj del cafè). Nel cassetto del tavolo: il taglialardo (tajalârd) o battilardo, tre cucchiai, tre forchette e tre coltelli (trii cügiaa, tree furcelìnn e trii curtèj) e qualche cucchiaino (cügialìn o cügiarìn). Nel grezzo armadio a muro (vestee) le scarse provviste alimentari: una terrina di cagliata (un baslutèll de cagiàda), la farina per la polenta, il sacchetto del riso, due lattine di salsa e un pezzetto di lardo, una treccia d’aglio ed un mazzetto di cipolle (una trézza d’aj e un mazzètt de scigóll o scigój), un vaso di fagioli secchi (fasoeu sìcch), un salame (un salamètt), la bottiglia del vino, qualche padellino (paelìn) o tegamino (bielìn) e altre cosucce. Sulla parete di fronte al camino, due grandi quadri ovali con le foto dei defunti più cari ed un quadretto della Sacra Famiglia (Gesoeu, Giüsèpp e Maria e toeutt i poor môrt in cumpagnía), mentre sulla parete verso l’uscio (oeurc, oeurs’c), il secchio di legno (ségia) o di zinco (siéla) appeso ad un gancio, con l’acqua prelevata dal pozzo, sia per bere che per cucinare, con la tazza di metallo lì vicino, in modo da poter attingere liberamente ma moderatamente. pg. 5 Supplica e devozione Fuori un portichetto comune, pavimentato di ciottoli (rísciu o rizzàda) e proprio sulla parete d’entrata, fra l’uscio di Vittorino e Antonia e quello dei loro vicini Celestino ed Eugenia, la “balorda”, cioè totalmente sorda (Celestrìn e Ügenia balúrda), ecco un’antica nicchia (incúna) con una venerata statua della Madonna, quotidiano punto di riferimento di supplica e devozione, in particolare mattutina e serale, per tutti coloro che vi transitavano o che appositamente vi si radunavano. E questa nicchia, che la mano di un giovane venuto da lontano voleva qualche anno fa murare, è tuttora presente! La camera da letto era al piano superiore, proprio sopra la cucina e vi si accedeva tramite una breve scalinata di legno, comune a tutti i vicini che si avviavano al riposo notturno, passando per il ballatoio (lóbia), biascicando sommessamente una preghiera (ciarfüjàven sottvûs ul patêr). “Signûr, Ve ringrazzi de tánti grazzi ch’hoo ricevuu in quésta sánta giurnàda. Ve ufríssi toeutt a vósta sánta glòria, in bèn de l’ánima mia, in penitènza di mee pecaa, in süfràgi di poor môrt”. “Signore, Vi ringrazio di tante grazie che ho ricevuto in questo santo giorno. Vi offro tutto per la vostra santa gloria, per il bene dell’anima mia, in penitenza dei miei peccati, in suffragio dei poveri morti”. E quindi una sequenza di “Requiem” per i propri cari defunti, sempre presenti nel cuore, nella mente, nel ricordo, nelle azioni di ogni giorno e nella preghiera personale e collettiva. Grande era anche la devozione, in particolare serale, agli angeli custodi. “In lècc mi voo, quatr’ánger trueroo, duu de pee e duu de coo. Ánger bùn, ánger câr, tegnîm tüta la nòcc fina ch’èl vègn ciâr”. “A letto io vado, quattro angeli troverò, due ai piedi e due a capo del letto. Angeli buoni, angeli cari, sostenetemi tutta la notte finché la luce riappare”. La “casa”, la camera e quanto contenevano, erano di proprietà di una zia di lui, una lontana zia, che non s’era mai sposata e che li aveva amorevolmente accolti, confidando anche in qualche futuro nipotino che purtroppo non arrivò, con grande amarezza dei due sposini, che di questo si vergognavano un po’. “Ghiàzza” L’anziana zia Enrica, detta Richèta, ma che tutti in verità chiamavano col soprannome di “Ghiàzza”, era piccola di statura ma ben messa, capigliatura folta e riccia, occhi sereni, simpatica, gentile, sempre sorridente e ciò contribuiva a rasserenare il clima familiare. La sua semplice ma profonda saggezza e ancor pg. 6 meglio la sua sapienza, che è l’espressione massima della saggezza, permeava i consigli che distribuiva con discrezione ai molti che si rivolgevano a lei spontaneamente. Per i due la zia era anche un sostegno economico e fra i tre regnava una buona intesa quotidiana. Ghiàzza dormiva in una camera situata a metà del ripido e lunghissimo scalone di legno che portava al grande granaio (granirùn): una camera ordinata, con poche cose ma di buon gusto, un ampio letto in ferro battuto con belle coperte da lei pazientemente e appassionatamente ricamate, il quadro della Madonna, il comodino (ul cifunìn), un bel comò (cifùn), la poltroncina (la pultrunéta), il portacatino (pórtacadìn) e una stupenda “petineuse”, in dialetto la “sciscè”, davanti alla quale amava soffermarsi a lungo al mattino per specchiarsi, pettinare la sua rigogliosa capigliatura e agghindarsi, particolarmente nei giorni di festa. E una bella finestrella, con due vivaci tendine, dava proprio sulla corte e le consentiva di osservare inosservata il quotidiano svolgersi della vita. I lunghi giorni invernali Sonnolenti e pigri come i gatti di casa di oggi, ma non altrettanto grassi, erano i giorni invernali, che gocciolavano lentamente come i panni di lana stesi ad asciugare vicino al focolare. L’attività agricola era limitata e le molte ore passate in casa, accanto al camino, intristivano il nostro Vittorino che si sentiva come albero spoglio che sopravvive all’inverno tra le nebbie dell’incertezza. Riparava nel più assoluto silenzio, con la solerte compagnia del fuoco scoppiettante, gli utensili da lavoro (udesèj) per la buona stagione e preparava scope di meliga (scûf de mélga), dopo averne raschiato i chicchi rossastri per le galline e predisponeva ramazze per il portico e la stalla, con i rametti giovani e flessibili delle betulle che macchiettavano il bosco. La zia e la moglie, con lo scaldino di brace ardente ai piedi, rammendavano i calzerotti (mendàven i scalfaròtt) con l’aiuto dell’uovo di legno e sferruzzavano a maglia (fàven ul scalfìn), anche loro in silenzio e ogni tanto allungavano l’occhio sul suo lavoro. I suoi pensieri, dopo averlo torturato a lungo, facendolo vagare per mondi a lui sconosciuti, lo abbandonavano repentinamente, lasciando il posto ad altri pensieri ancora più oscuri e fuggivano altrove in cerca di nuova accoglienza, come le volute di fumo che imboccavano la via della libertà. Le fiamme prima ardenti e poi sonnolenti del camino e la brace viva gli seccavano lentamente ma inesorabilmente la gola e siccome “l’acqua fra tremare e il vino fa cantare” (“l’aqua la fa tremà, ul vìn èl fa cantà”), lui andava cercando proprio ciò che lo aiutasse a cantare. Era un’anima in pena perché il vino gli mancava veramente, nel suo cantinino non ce n’era e lui ne avvertiva l’impellente necessità. Gli pungeva dentro una vera insopprimibile urgenza, come la voglia di liberarsi immediatamente da un groviglio pg. 7 di spine. Céser Magnoeula, che abbiamo già conosciuto e che abitava dall’altra parte del cortile, proprio di fronte a lui, non lo invitava mai nella sua cantina per non avere poi discussioni con la moglie di lui. Infatti l’Antonia non perdeva mai d’occhio il suo Vittorino e lo accompagnava anche quando andava a portare il latte della sera e quello appena munto del mattino ai primi Lattai del paesello, i Malurìtt, che lavoravano il latte, come ci ricorda Emilio, per farne formaggini da vendere in particolare a Milano e dintorni ed in seguito quando lo portava, qualche passo più in giù, ai “Lacee” del patriarca Luigi Galbusera, che dal 1948 proseguirono ufficialmente l’attività in maniera più estesa. Per evitare che Vittorino deviasse spontaneamente verso l’osteria, la sua Antonia lo seguiva passo passo, ma lo faceva anche per controllare di persona il peso del latte, che aumentava decisamente in primavera e che veniva segnato su di un apposito libretto, con saldo in contanti a fine mese, che veniva interamente riscosso e intascato da lei. Quando usciva di casa Vittorino doveva giustificarsi, precisare dove sarebbe andato e a fare cosa, ma solo nel caso in cui non avesse già ricevuto direttamente ordini perentori o precise sollecitazioni e indicazioni e se non tornava nei tempi previsti e stabiliti, lei l’andava a cercare. Sapeva bene infatti che all’osteria di Annunciata e Agostino (Nunziàda e Güstìn), che era a pochi passi da casa, regnava piena solidarietà a tutela generale, fino a negare anche la più palese evidenza. C’era sempre qualcuno che proprio lì, in de l’ustùn (il grande oste), gli offriva un bicchier di vino, ben sapendo che era quello che lui gradiva, non gli interessava infatti né il “griogioverde” (grappa e menta), né la “mandurlàda” (grappa alle mandorle), né “un marsalìn” (un bicchierino di marsala) e la sua soddisfazione, dopo aver inzuppato il becco, era fortemente condivisa e replicata fino a vederlo in difficoltà, fino a quando a lui sembrava che tutti gli gracchiassero contro come uno stormo di corvi irrequieti. La sua Antonia gli ricordava sempre che: “La trópa cunfidènza la teu la riverènza”, la troppa confidenza toglie la riverenza, ma lui non ci sentiva affatto da quell’orecchio perché il compiacimento dei suoi compagni di ventura ed il gusto della trasgressione gli erano indispensabili! E quando il vino contingentato in casa mancava, era lei, l’Antonia, a provvedere direttamente all’acquisto, recandosi di persona all’osteria con la bottiglia vuota, a chiusura ermetica (la butèglia cun la machinéta), che veniva riempita per tre quarti di vino e per un quarto di acqua, con una tacita ed ormai consolidata intesa con l’oste e che doveva bastare per almeno due giorni. Ma lui s’accorgeva immediatamente dell’annacquamento perché il sapore (ul fà, ul bucàtu) era diverso, non era pieno e lui lo faceva rimarcare immediatamente, a pg. 8 volte anche rabbiosamente, ma la sua Tugnèta negava, arrossiva un po’, ma negava e negava ripetutamente. Cominciarono così a nascere i primi tradimenti serali Con l’avvento dell’estate cominciarono a nascere i primi tradimenti serali! Dopo la devota e monotona recita del rosario e la cadenzata supplica delle litanie, la consueta cantilena che storpiava la nobile lingua latina e la conclusione delle preghiere della sera lungo le scale, i due si coricavano presto, troppo presto, per volere dell’Antonia e l’osteria invece rimaneva aperta ancora a lungo e a volte giungeva al fine udito del nostro Vittorino l’euforia degli amici che l’aspettavano. Ben accertatosi che lei dormisse profondamente e meritatamente, lui scivolava leggero fuori dalle lenzuola, si fermava un attimo, trattenendo il respiro per verificare il buon andamento della fuga e poi in punta di piedi, con la massima attenzione, i pantaloni e la camicia fra le mani, si avviava verso la porta che allora, specialmente di notte e nella bella stagione, non si usava chiudere a chiave. Ma, fattala franca le prime volte, veniva poi quasi sempre colto in flagrante, perché anche l’Antonia aveva ben imparato a fingere e proprio quando lui stava superando il confine fra la prigionia e la libertà, veniva beccato, richiamato e umiliato proprio lì sulla soglia, sul valico di frontiera e lui si bloccava di colpo, con un passo a metà, la rabbia fra i denti e il fumo negli occhi! E la voce inaspettata della moglie, che lo richiamava all’ordine alle sue spalle, gli ricordava quella autoritaria di un generale di corpo d’armata ed ogni parola pronunciata con sottile ironia, era per lui un’improvvisa infuocata pallottola che si conficcava profondamente nelle sue carni scoperte e gli bruciava dentro: “Viturìn, indè veet?!... Vaa che t’hoo vìst!... Fà minga ‘l balòss, ánzi fà minga l’asen che l’è câr ul fèn”! – “Vittorino, dove vai?!... Guarda che ti ho visto!... Non fare il furbo, anzi non fare l’asino che il fieno costa”! Ed anche la scusa del bisognino fisiologico non reggeva: “No, l’è minga véra, perchè ul bucaa, l’urinàri, l’è chì sótt al lècc”! “No, non è vero, perché il pitale, l’orinale, è qui sotto al letto”! Lei aveva anche pensato di serrare la porta e metterne la chiave sotto il cuscino, ma le sembrava troppo, anche se alla disperata prima o poi l’avrebbe fatto! Lui comunque non si scoraggiava mai e meditava sempre nuove strategie, che qualche rara volta portavano ad esito positivo, fra il plauso degli amici dell’osteria. Ma lei l’aveva avvertito severamente e ripetutamente: “Attento, Vittorino, che prima o poi ti chiudo fuori e ti lascio lì tutta la notte! E ti assicuro che lo faccio pg. 9 veramente e proprio per il tuo bene!... Vittorino attento che non tira aria buona, non spira buon vento”! E qualche volta provò veramente a chiuderlo fuori, ma di fronte alle sue ripetute suppliche: «Dèrva, Tugnèta, dèrva per piesè! Te pruméti…» - “Prumètt un bèl nieent, Giüda”! «Apri, Antonietta, apri per favore! Ti prometto…» – “Non promettere un bel niente, Giuda”! «Dèrva, Tugnèta, dèrva, se no troo gió la porta…» «Apri, Antonia, apri, altrimenti butto giù la porta…» e per la preoccupazione, ancora una volta, di disturbare i vicini e di pubblicizzare ulteriormente l’accaduto, lei alla fine desisteva, anche se al mattino la predica, fitta di rimproveri, suppliche, pianti e lamenti, era davvero straziante e interminabile! E lui si sentiva come un merlo in gabbia, attaccato da un gatto ostinato e i sensi di colpa gli tiravano raffiche di pugni nello stomaco e alla fine si dimostrava pentito e prometteva di comportarsi bene per un lungo periodo, tirando finalmente un sospiro di sollievo. Una grande epidemia influenzale Qualche anno dopo sopraggiunse, nella stagione invernale, una grande epidemia influenzale (un broeutt malascètt), una pandemia si direbbe oggi, che colpì parecchia gente e fra i tanti anche il nostro amato Vittorino. Dovette rimanere a letto e la sua Antonia gli riservava tutte le premure del caso, ma la febbre, nonostante i continui brodini caldi, non voleva proprio abbandonarlo e la faccenda si faceva seria, finché lei ritenne opportuno chiamare il medico condotto, una persona molto stimata, un omone che incuteva soggezione, ma che aveva un cuore grande, l’unica presenza sanitaria per decenni nel territorio casatese, molto attento e disponibile verso tutti, ma in particolare verso la povera gente che era tanta! Il giorno calava e l’ossequiosa Antonia, dopo aver messo tutto in ordine e cambiato lenzuola e federe (quatacoo), attese pazientemente il medico e lo accompagnò su per le scale dal suo Vittorino che dopo un po’, per poter colloquiare più liberamente, invitò la moglie, con un pretesto, a scendere un momento dabbasso. Fu allora che Vittorino confidò apertamente al medico, suo superiore in scienza, sapienza e conoscenza, tenuto al segreto professionale almeno quanto un confessore, la sua grande arsura, ulteriormente accentuata dal mal di gola, dalla febbre prolungata e dai diversi giorni di astinenza e il dottore (ul sciûr dutûr), molto professionale ma molto umano, lo comprese pienamente e con un pizzico di pg. 10 indulgenza, ben conoscendo le abituali trasgressioni di Vittorino, gli lanciò una simpatica sfida: “Uhej bersaglieer, gh’hoo amò duu malaa de nà a truà e peu hoo fenii. Mì, tra un quârt d’ura, in toeutt i maneer, soo a l’usteria e se te troeuvi là t’en paghi un quartìn. Varda tì, Viturìn!”... “Ehi, bersagliere, ho ancora due ammalati da visitare e poi ho finito. Io, tra un quarto d’ora, ad ogni modo, sono all’osteria e se ti trovo là te ne pago un quartino. Vedi tu, Vittorino!... La sfida era stata lanciata La provocazione, la sfida, la competizione, era stata lanciata e per Vittorino era ad alto rischio ma di grande profilo, mentre il medico ben sapeva che la stretta vigilanza della Tugnèta avrebbe reso l’operazione praticamente impossibile! Il medico salutò Vittorino col sorriso sulle labbra, scese a tranquillizzare l’Antonia, le lasciò la ricetta per la farmacia, le chiese di lasciar riposare tranquillamente il marito e gentilmente si accomiatò. Quel quartino di vino Vittorino lo vedeva già davanti agli occhi e lo pregustava e lo assaporava inumidendosi in continuazione le labbra, come se lo stesse già sorseggiando. Lui doveva assolutamente raggiungere il traguardo, ma come?... Il tempo assegnato era ristretto, l’obiettivo arduo, il risultato incerto, ma quest’occasione propizia non poteva assolutamente lasciarsela sfuggire, essendo digiuno da parecchi giorni del prezioso liquido, grande consolazione dei poveri. Non poteva avventurarsi per le solite scale perché la moglie, la zia o qualche loro amica spia, l’avrebbero sicuramente colto in fallo, comunque ed in ogni caso lui doveva assolutamente provarci usando tutta la sua arguzia ed abilità. Ma non riusciva proprio a venirne a capo finché, involontariamente ma fortunatamente, la soluzione gliela indicò proprio l’Antonia che era salita a tranquillizzarlo. “Ul dutûr èl t’ha urdenaa i medesìnn. Adèss ghe doo la rizzéta a Ingiulètu, inscì dumán matína quând èl va in del Vismara a laurà, èl passa deent in del spizziee e ‘l mi je porta a cà. Tì per adèss stà lì bèll quiètt, stà quataa e te vedaree che te guarísset a svêlt… Vaa, Viturìn, ufèndess minga neh, ma mì preferíssi sarà soeu la porta a ciâf, inscì tì te requíett püssee bèn e mì soo püssee sicüra! Urmài l’è squasi sira… Se te gh’hee de bisoeugn d’un quejcòss te píchet gió e mì vègni soeu sübet e se pròpi te gh’hee quèjcòss de dìmm, te peu dervì l’üsell* là in cantùn, te me ciámet e mì te sculti”! “Il dottore ti ha prescritto le medicine. Adesso io do la ricetta ad Angioletto, così domani mattina quando va alla Vismara a lavorare, entra dal farmacista e ce le porta a casa. Tu per ora rimani lì tranquillo, stai coperto e vedrai che guarirai in fretta… Guarda, Vittorino, non offenderti nevvero, ma io preferisco chiudere la porta pg. 11 a chiave, così tu riposi meglio e io sono più sicura! Ormai è quasi sera... Se hai bisogno di qualcosa picchia sul pavimento e io salgo immediatamente e se hai proprio qualcosa da dirmi, puoi aprire la botola là in angolo, mi chiami e io ti ascolto”! Detto e fatto, senza lasciare il benché minimo diritto di replica o di appello, un paio di mandate affrettate e via a testa bassa, con la chiave nella tasca del suo grembiule nero! • Nota - L’ “üsèll” era un’apertura quadrata o rettangolare, una botola, chiusa da un coperchio di legno, che metteva in collegamento e in comunicazione due locali sovrapposti evitando così di fare un lungo giro esterno. Era presente fra la camera e la grande cucina sottostante, ma anche su alcuni fienili, con lo scopo di calare il fieno direttamente nella mangiatoia o quantomeno nel portico della stalla. Una via d’uscita c’era Ora l’Antonia era tranquilla e per Vittorino non sembrava esserci più scampo, non sembrava proprio ci fosse più alcuna via d’uscita… e invece no, anzi sì, una c’era ed era piuttosto ardua, ma lui che aveva da perdere?... E allora all’improvviso eccolo in piedi, in piena effervescenza, con i calzoni infilati sopra i mutandoni di lana, la camicia sbottonata e il gilè sopra: toglie i due lenzuoli praticamente nuovi dal letto e si contorce tutto, mordendosi la lingua, per poter fare un nodo resistente, poi trova il modo di legare la lunga striscia all’asta di ferro che attraversa gli stipiti della finestra e infine la lascia cadere all’esterno, sul retro della camera, per poter verificare quanto manchi a terra. Non vede bene, ma pare non manchi molto perché si tratta di un solo piano, abbastanza basso e quindi può calarsi fra i campi, dove, complice la sera imminente, nessuno lo vedrà! La forza della disperazione da una parte e, dall’altra, la trepida speranza di una buona riuscita lo rendono assolutamente euforico e incosciente: sale sulla sedia e poi a fatica sul davanzale della finestra, s’aggrappa alla sbarra di ferro e poi alla lunga striscia, si sporge all’esterno ed avverte immediatamente un gran giramento di testa e lo assalgono all’improvviso anche le vertigini, la fiacchezza fisica e la paura dell’altezza e quindi barcolla, trema tutto dal freddo, sente che la presa gli sfugge, ma con un energico scossone, guardando verso l’alto, inizia una difficoltosa discesa, che gli sembra lunga, infinita, quasi eterna e per sua fortuna le ante della cucina sottostante sono già chiuse, così non possono vederlo ed il tessuto a cui è aggrappato regge data la sua esigua figura. Stremato, senza nemmeno stare a guardare, si butta infine fra le ortiche, rotolando e urticandosi completamente le mani e il viso. Si rialza prontamente, una veloce ripulitina e via quatto quatto verso il portone che lo conduce in corte e di lì, pg. 12 dopo aver attentamente spiato le mosse degli ultimi ritardatari, via veloce verso l’osteria. Al suo apparire improvviso, con i calzoni, le mani e la faccia tinti del verde delle ortiche, ampia meraviglia e grande sorpresa da parte di tutti, soprattutto del medico che, incredulo ed in verità anche pentito di aver lanciato la sfida, mantenne pienamente fede alla sua promessa e poi si avviò scuotendo la testa e raccomandando vivamente a Vittorino di recarsi subito a casa. Ma così non fu perché i “cattivi” compagni non persero l’occasione per portarlo a piena ebollizione e, come si sa, non ci volle molto in verità. E quando la fredda notte era prontamente scesa a occupare il suo posto, lui, stanco, tremante e malfermo sulle gambe, si incamminò sulla breve ma irta via del ritorno, accompagnato per un breve tratto da un complice che poi lo stette a guardare. Una pallida e malinconica luna lo osservava silente e lui ben sapeva che invece lei l’aspettava a muso duro e si preparò mentalmente ad affrontare la cruda realtà. Adesso ti sistemo io! La Tugnèta, infatti, lo sentì salire lentamente e affannosamente le scale, aprì immediatamente le ostilità e riversò su di lui tutta la scarica della rabbia che aveva in corpo e fu assolutamente irremovibile: “Te me l’hee pròpi fada, o broeutt porcu, ma te se l’hee fada depertì, perchè adèss te sistèmi mì, ciuchetùn d’un ciuchetùn!!! L’è minga ura de finíla?!... E gh’heet minga vergúgna di geent o broeutt pelandrùn?... Gh’hoo vergúgna mì per tì!”... - «Dèrva, Tugnèta, dèrva chéla porta lì per piesè, che stoo pròpi minga bèn»… - “No, stavoeulta te dèrvi pròpi minga, se l’è per mì te peu crepà lì indè te see… Te me l’hee fada trópa gróssa, o broeutt desgrazziaa d’un desgrazziaa!... Adèss te stee lì de foeura tüta nòcc e inscì te impàret e te passa ánca la voeuja e la cióca, datu che te see pièn ‘mè ‘n oeuf”!... “Mi hai proprio ingannato, o brutto porco, ma in realtà ti sei ingannato da solo, perché adesso ti sistemo io, ubriacone d’un ubriacone!!! Non è ora di finirla?!... E non ti vergogni della gente o brutto pelandrone?... Mi vergogno io per te!”... - «Apri, Antonia, apri quella porta per favore, che non mi sento per niente bene»… - “No, stavolta non ti apro assolutamente, per quanto mi riguarda puoi crepare lì dove sei… Me l’hai combinata troppo grossa, o brutto disgraziato d’un disgraziato!... Adesso stai lì di fuori tutta notte e così impari e ti passa anche la voglia e la sbornia, dato che sei pieno come un uovo!”.... Ma lui insisteva, alzava la voce e batteva forte alla porta, poi cambiava tattica e supplicava dolcemente, sperando che lei, per non disturbare i vicini e non vergognarsi poi di fronte a loro, alla fine gli aprisse. Ma così non avvenne: lei fu pg. 13 assolutamente irremovibile e lui era lì fuori, stanco e provato, al buio, a tremare ancor più dal freddo per la febbre che aveva indosso. Minacciò ripetutamente di gettarsi giù per le scale, ma niente da fare. Allora smise all’improvviso di parlare e già lei all’interno cominciava a preoccuparsi che lui stesse veramente male sia per il vino che per l’influenza. E Vittorino, ormai rassegnato, si sedette sul gradino d’accesso alla camera e mentre pensava a come passare quella lunga gelida notte, poggiò una mano su qualcosa che stava lì in fianco, poi chinò la testa e vi ci si abbandonò e confusamente intuì che quello era il mastello di legno (segiùn) usato per il bucato (la bügàda). Pur non essendo del tutto lucido, il suo cervello cominciò a frullare, a rimuginare, a macinare, mentre lei all’interno stava in piedi ad origliare per intuire le mosse di lui, per percepire in qualche modo cosa stesse combinando. All’improvviso Vittorino fece rotolare silenziosamente il mastello di legno fino ai gradini delle scale, sostò un attimo, supplicò ancora una volta di poter entrare e di fronte all’ennesimo energico rifiuto, diede una spinta al mastello che rotolò fragorosamente giù per le scale, mentre lui era corso frettolosamente ad appiattirsi contro la parete esterna della camera, a lato della porta. La Tugnèta, sentendo quel gran baccano, aprì velocemente e corse fuori nel buio, gridando con le mani nei capelli, verso l’imbocco delle scale: “Viturìn, o Viturìn, s’heet cumbinaa, seet mai faa, seet faa maa?... O póra mì, me dispiâs, me dispiâs debùn, te dumándi perdún… Ma indè seet casciaa induè?... Respúndum, Viturìn, respúndum per piesè!”… “Vittorino, o Vittorino, cos’hai combinato, cos’hai fatto, ti sei fatto male?... O povera me, mi dispiace, mi dispiace veramente, ti chiedo perdono… Ma dove ti sei cacciato?... Rispondimi, Vittorino, rispondimi per favore!”... E mentre cominciava a scendere frettolosamente le scale, udì confusamente sbattere una porta alle sue spalle e una voce eccitata ed acuta che diceva: «Mì soo chì dedeent, Tugnèta e adèss sari soeu a ciâf, inscì mì foo una bèla durmída e tì te stee lì de foeura tüta nòcc, al mè pòst, a barbelà del frècc. Heet capii, Tugnèta?!... Un poo per oeun fa maa a nessoeun!»... «Io sono qui dentro, Antonia e adesso chiudo a chiave, così io faccio una bella dormita e tu stai lì di fuori tutta notte, al posto mio, a tremare dal freddo. Hai capito, Antonia?!... Un po’ ciascuno non fa male a nessuno!»… Passò alla storia… E passò alla storia il fatto che Vittorino, uomo buono e mite, chiuse fuori, senza alcuna pietà, la moglie per l’intera gelida notte e lei non ebbe nemmeno la pg. 14 possibilità di rifugiarsi in casa perché la chiave stava sul comodino, all’interno della camera. Cercò allora di entrare nel granaio lì di fronte al pianerottolo, per ripararsi in qualche modo; la porta era aperta ma una comprensibile grande paura di quell’enorme spazio, suddiviso in tante paratie di cannucce di bambù, la fece desistere! Trovò fortunatamente sulla soglia qualche sacco vuoto e una vecchia coperta con cui, in qualche modo, ripararsi, ma la nottata, nonostante la sottoveste di lana, fu lunga e terribile. Lui, complice la sbornia, dormì profondamente per l’intera notte. Solo all’alba ebbe un vago presentimento di una donna che piangeva sommessamente sul pianerottolo e seppure a malincuore diede due mandate indietro alla chiave e la Tugnèta entrò curva, umiliata e intirizzita, appena in tempo per non incrociare gli sguardi ironici e compassionevoli di chi si stava già alzando e sarebbe passato proprio di fronte a lei per scendere le scale! Musi lunghi e assoluta astinenza dal vino accompagnarono gli interminabili e mesti giorni successivi, ma le ripetute scuse del medico, che mai avrebbe immaginato quel che sarebbe successo, il tenero affetto dell’anziana zia nei confronti di ambedue e forsanche il discreto intervento del parroco (ul sciûr cürât), uomo saggio che ben conosceva le miserie umane delle sue pecorelle, fecero riattizzare il fuoco purificatore del perdono e prevalse ancora una volta, seppur faticosamente, quell’amore che covava sempre pur sotto la cenere. Fine parte prima Angelo Galbusera Rimoldo di Casatenovo, aprile 2014 Enrica – “Ghiazza” – 1882-1967 / Antonia Brivio 1913-1988 Nota: Tutti i diritti sono interamente riservati a Sentieri e Cascine e all’autore. pg. 15
Scaricare