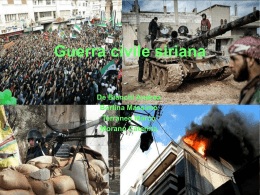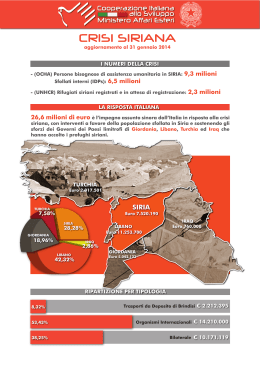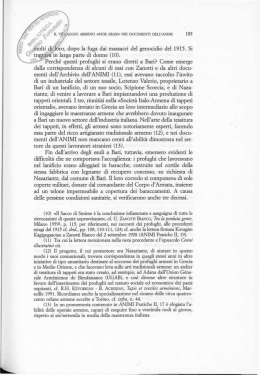Italia / italie e tra a cura di Gabriele Dadati direzione editoriale: Calogero Garlisi redazione: a cura di Pierfrancesco Majorino e Caterina Sarfatti Elena Chiappara Eugenio Nastri comunicazione: Gabriele Dadati commerciale: Marco Bianchi progetto grafico: Officine Gutenberg, Piacenza MILANO COME LAMPEDUSA? dossier sull’emergenza siriana Finito di stampare nel mese di luglio 2014 presso Officine Gutenberg, Piacenza ISBN 978-88-95411-76-7 Novecento Editore è un marchio Novecento media srl Copyright © 2014 Novecento media srl via Carlo Tenca, 7 - 20124, Milano www.novecentoeditore.it - [email protected] Novecento Editore 1. Il punto di domanda Indice 1. l punto di domanda di Pierfrancesco Majorino 5 2. Il “Caso Siria”: i numeri, le difficoltà, le strade percorribili 22 3. La nostra voce 37 4. Le opinioni, le idee, le esperienze 41 Pierfrancesco Majorino è l’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano. Scrittore, ha pubblicato recentemente il romanzo Maledetto amore mio (Laurana), che racconta di fragilità e conflitti nei quartieri popolari. Caterina Sarfatti, 30 anni, è laureata in Teoria Politica. Ha collaborato con la Federazione Internazionale per i Diritti Umani e il Consiglio Italiano per i Rifugiati. Lavora al Comune di Milano occupandosi di Relazioni Internazionali e Politiche Comunitarie. Alla fine abbiamo deciso di aggiungerlo, il punto di domanda. Perché l’affermazione “Milano come Lampedusa” ci appariva insufficiente. E pure un poco ingenerosa. Innanzitutto verso l’isola siciliana e le vite (e le morti) che ha dovuto raccogliere. E però il dubbio ci viene e il quesito va posto. A tutti: alle Istituzioni, alle comunità, alle coscienze individuali. Le nostre città sono attrezzate per fare fino in fondo i conti con le migrazioni? E, ancora prima, noi, noi tutti: siamo fino in fondo consapevoli del fatto che, ben al di là delle leggi, dei volti feroci o compassionevoli dei ministri di turno, la spinta da una parte del mondo, quello che si “affaccia sul Mediterraneo” come potremmo scrivere un poco semplificando (e spesso anche in barba alla geografia), non è questione di una stagione breve? Ecco allora che “Milano come Lampedusa?” è un quesito che cerca una risposta. La risposta la devono dare in tanti e decidere che a Milano, come e forse ancora prima a Lampedusa, giunga l’efficacia di una politica riguardante le migrazioni radicalmente nuova. Una politica che sappia tenere insieme i fili delle strategie europee, delle scelte nazionali, delle risorse locali. Tutte cose che oggi marciano da sole, distanti le une dalle altre. Quasi che ci si possa permettere il lusso, in un mondo dallo sviluppo così squilibrato come quello in cui viviamo, di ritenere che le decisioni di Strasburgo, Bruxelles, Roma, Milano e Lampedusa possano seguire strade parallele. Facevamo dell’allarmismo Il 27 agosto del 2013 ci siamo permessi, attraverso un freddo e scarno comunicato stampa, di dire che di lì a poco ci saremmo trovati, a Milano, in Lombardia, di fronte a una nuova emergenza: quella dei 5 profughi. Lo abbiamo fatto animati da una cosa banalissima: la preoccupazione di non avere a disposizione un numero sufficiente di posti dove “accoglierli”. Non avevamo sulla scrivania particolari valutazioni o dossier confezionati magari dal Viminale. Semplicemente guardavamo i telegiornali e leggevamo gli articoli, non tantissimi e non sempre dettagliati, di quello strano, e apparentemente lontanissimo, flusso che si compiva tra la Siria e la Libia. In altre parole e per farla breve ci permettevamo di dire che fosse semplice immaginare gli sbarchi, gli arrivi, i viaggi disperati o della speranza. Non sapevamo, almeno certamente non io, niente di particolare sui “siriani”. Sapevamo solo che la situazione in Siria era drammatica e che in Medio Oriente o nel nord dell’Africa già da tempo campi profughi stracolmi esplodevano di donne, uomini e bambini. E così chiedevamo una mano. Al Governo, alla Regione, a chiunque la potesse dare di lì a poco. In pratica dicevamo che tutte le Istituzioni “devono fare la propria parte nell’affrontare un’emergenza oggettiva e imminente” e ancora ci permettevamo di lanciare un appello “per non sottrarci all’impegno di accogliere ma per richiamare ognuno alle proprie responsabilità”. Infine concludevamo con un pensiero accorato rivolto in particolare al governo Letta (e al suo ministro, frutto delle larghe intese: l’onorevole Angelino Alfano): “confidiamo in una programmazione efficace e tempestiva da parte del Ministero dell’Interno affinché sia possibile avviare percorsi di accoglienza certi”. In altre parole noi, semplicemente, domandavamo attenzione. Leggere oggi le risposte di quei giorni di agosto fa sorridere e un pizzico rabbrividire: Simona Bordonali, assessore regionale alla Sicurezza e all’Immigrazione, replicava dopo qualche ora che “non è un’emergenza, stiamo parlando di flussi non programmati”. L’ex Vicesindaco di Milano Riccardo De Corato aggiungeva che “prima di 6 lanciare allarmi ed emergenze” dovevamo dire “chi sono coloro che hanno lo status di «profughi» e chi invece di clandestino”. E il Governo? Taceva. E si trattava di un silenzio a cui abbiamo amaramente fatto l’abitudine per molti dei mesi successivi. Nel mare dove si muore Nei pressi dell’Isola dei conigli si raccolgono i corpi. Sono i primi giorni di ottobre. La sindaca di Lampedusa, quella donna tenace e generosa che è Giusi Nicolini, fin dalle prime ore, mentre è impegnata nei soccorsi, racconta che “il mare è pieno di morti”. Si tratta di donne, di uomini, di ragazzi. Giunti sin lì a bordo di un barcone andato in fiamme, con quell’incendio nell’acqua, causa probabile del tragico epilogo in mare. Giunti sin lì dall’Eritrea, dall’Etiopia, dalla Somalia. Le televisioni, i siti, i social, giorno dopo giorno forniscono informazioni e ci restituiscono le immagini del rito funebre: i volti tetri dei rappresentanti delle Istituzioni, la faccia sconvolta e fiera, praticamente quella di una statua di pietra, di una donna africana bellissima che fissa un punto nel vuoto, una suora che prega con il rosario che penzola dalla mano. Laura Boldrini, presidente della Camera, rendendo omaggio alle vittime di quel terrificante naufragio – la strage del 3 di ottobre – in più di un’occasione afferma che “nulla dovrà esser più come prima” e arriva a scomodare, mentre i razzisti nostrani la additano vigliaccamente come “responsabile morale della tragedia”, papa Francesco, che proprio in occasione della sua storica visita a Lampedusa, svoltasi nel luglio precedente, aveva ricordato quanto il nostro mondo, e quindi noi, noi tutti, siamo vittime della “globalizzazione dell’indifferenza”. Semplici e inequivocabili, ancora una volta, le parole di papa Francesco qualche mese prima dell’ennesima ecatombe erano state pronunciate di fronte a un mondo che osservava stupito il pontefice muoversi in quel punto di Europa circondato dal mare: “Domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, sulla crudeltà che c’è nel mondo, in noi, anche in coloro che nell’anonimato prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada a drammi 7 come questo”. A Milano, in quei giorni, le comunità, e in particolare quella eritrea, si mobilitano per piangere con dignità i propri morti. Lo fanno soprattutto coloro che reclamano, giustamente, di essere riconosciuti come italiani: le ragazze e i ragazzi “di seconda generazione”, di fatto ventenni milanesi dall’accento molto ambrosiano e dallo slang irrimediabilmente giovanile, che organizzano diversi momenti di raccoglimento. Un sabato pomeriggio come tanti, grazie a loro, un corteo attraversa le strade del centro per finire in piazzale Oberdan, nel cuore del quartiere dove i loro padri e le loro madri hanno avviato attività commerciali, ristoranti etnici e le semplici vite di tutti i giorni. Lo slogan che apre la manifestazione e che viene ripetuto alla fine attraverso i discorsi pronunciati con passione e dolcezza dice l’essenziale: “Siamo tutti su quella barca”. Guardando bene, poi, scrutando tra i volti delle ragazze della “Rete G2” o tra quelli degli studenti degli istituti tecnici dei quartieri popolari milanesi, non si trovano solo figli delle famiglie eritree, ci sono anche i frutti della migrazione dalla Somalia, dall’Etiopia. Chiedono insieme rispetto, giustizia. Leggono le agenzie stampa e ricordano i numeri sconvolgenti: “siamo di fronte a centinaia di morti, forse 366, decine di dispersi”. Dicono che la barca è la stessa proprio per tutti e mentre lo fanno esigono che il loro, di Paese, l’Italia, non si giri da un’altra parte o non si limiti a piangere nel giorno dell’esibizione del lutto. In altre parole chiedono a “noi” e in particolare proprio a quelli che tra “noi” svolgono una qualche forma di rappresentanza di non cavarsela con la commozione di fronte alle bare. Ascoltarli zittisce, fa pensare e (se è concesso affermarlo) fa anche ben sperare. Per una strana ironia della sorte è proprio in quei momenti in cui siamo lì, “in Oberdan”, che ricevo su facebook un messaggio di Sumaya Abdel Qader, giovane palestinese del CAIM, un coordinamento che riunisce diverse realtà islamiche presenti a Milano. Mi ripete, Sumaya, come aveva fatto ore prima, quel che accade in 8 Stazione centrale. Mi ricorda, come mi avevano già segnalato anche semplici cittadini in quella settimana e come aveva cominciato a fare la stampa, riferendosi a episodi che ritenevamo isolati, che sulle panchine della grande stazione milanese famiglie siriane si accalcavano, in balia di un destino difficile da decifrare. Il marmo è freddo La Stazione Centrale, pur nella sua ultima versione un po’ goffamente restaurata, è bella ed enorme. Quelli che si occupano di urbanistica o di architettura ne lodano la funzione storica, il tratto e l’imponenza. È attraversata di continuo da viaggiatori frettolosi che la scalano partendo, e ha una biografia ricca e complicata insieme. Fu inaugurata il primo luglio del 1931. E così, con quel suo colore chiaro, il bianco opaco diffuso e la linearità delle sue pareti e della sua struttura, spesso le danno della “fascista”. Tuttavia sulla necessità di una nuova stazione si fa riferimento, in numerosi documenti, nella seconda metà dell’Ottocento, ben prima del Ventennio, e la sostituzione di quella vecchia presente in Piazza della Repubblica è oggetto di appassionati dibattiti tra numerosi rappresentanti delle Istituzioni politiche e culturali meneghine nel Diciannovesimo secolo. La storia della stazione diventa, spesso, la storia di Milano. L’Esposizione Universale, l’EXPO del 1906, vide il re Vittorio Emanuele terzo porre la prima pietra, ancor prima che il progetto definitivo fosse realmente ultimato. E nel corso della Seconda guerra mondiale il binario 21, all’epoca il binario 1, come una ferita che è sempre bene guardare in faccia, venne impiegato per far partire i treni degli ebrei italiani destinati ai campi di concentramento e sterminio. Il 13 novembre del 2010, alla presenza del sindaco Letizia Moratti e dei cardinali Dionigi Tettamanzi e Tarcisio Bertone, è stata dedicata a Santa Francesca Cabrini. La lapide, regalata alla memoria della “Celeste patrona degli 9 emigranti”, porta con sé parole dure da dimenticare: “Da questi binari tante volte si avventurò per le strade del mondo Francesca Cabrini Santa per la fede cattolica, apostola di solidarietà per tutte le genti in cammino”. E di solidarietà la stazione ne ha vista tanta negli anni. Negli spazi che si liberano nel suo vasto e articolato corpo operano il Centro Aiuto, attraverso cui il Comune organizza la gestione dell’accoglienza di centinaia di senza dimora, la Caritas, che ha riaperto l’antico rifugio che fu di Fratel Ettore e che dà sollievo e riparo a tanti senza casa, Fondazione Exodus, con uno spazio unico in Italia che fa da luogo di aggregazione di clochard e dove i ragazzacci militanti della “Bar Boon Band” suonano e sollecitano interventi a favore di chi vive al margine. Numerose poi sono le associazioni presenti con unità diurne o notturne che passano qualche ora cercando di lasciare un segno positivo. I Medici Volontari, i City Angels di Mario Furlan, la Comunità di Sant’Egidio, Ronda della Carità e tantissimi ancora: impossibile citarli tutti. La Stazione Centrale, dunque, è luogo di attraversamento e attesa. Meta e base di riferimento. Resiste a se stessa, al modo non facile di comprenderne la gestione, al mancato utilizzo di tanti dei suoi spazi che restano chiusi e immobilizzati da un Paese che di questo tema enorme, quello delle stazioni come punti di approdo organizzato e assistito nell’era della globalizzazione e delle sue nuove ferite, non sa bene che farsene. E così finisce per essere il tutto e il marmo a disposizione dei profughi siriani. Quando arrivo nel vasto atrio della stazione con Caterina Sarfatti e la funzionaria del Comune Giancarla Boreatti, proprio dopo la manifestazione che ricorda i morti del Mediterraneo, trovo viaggiatori assolutamente particolari. Ci colpiscono subito i bambini. Tantissimi, piccoli. Che giocano e ridono e salgono sulle scale mobili divertendosi. E poi i loro padri e le loro madri. Persone apparentemente abbastanza agiate, diciamo del “ceto medio”. Dignitose e serene. 10 Stanchissime. I ragazzi della Comunità di Sant’Egidio avevano ragione: da giorni ci spiegavano di darci una mossa, di fare in fretta. La famiglia è sempre una e una soltanto Dalle parti dell’Assessorato alle Politiche sociali siamo tutti abituati ad avere a che fare con le emergenze migratorie. Nel 2011 abbiamo partecipato (rivendicando, prima Città d’Italia, il ruolo di regia del Comune, anche nei confronti della Prefettura) alla gestione della cosiddetta “Emergenza Nord Africa” accogliendo i migranti arrivati nel Belpaese a seguito della crisi libica. Accogliendo, cioè, centinaia di persone a seguito della richiesta e dell’iniziativa del ministro dell’Interno Roberto Maroni. Chi lavora in Comune, poi, come fa la dottoressa Boreatti da anni, è abituato ad aver a che fare con gli “stranieri”. Questa volta però non è come nel 2011. Qui si tratta di famiglie. Donne, uomini, bambini. Questa volta dovrebbe essere per tutti, a partire dalle Istituzioni, più facile, l’aiuto. Qui di fronte a noi, lo ripeto, ci sono le famiglie. Quelle fatte da un padre, da una madre e da tantissimi figli. Ma si sa, questo Paese sulla pelle degli affetti gioca strane partite. La famiglia, rigidamente al singolare, è evocata a regola d’arte se si tratta di contrastare l’estensione dei diritti civili e poi spesso viene rimossa se porta con sé la storia di una migrazione. Ecco allora che quel che accade da quel giorno di ottobre ad oggi è essenzialmente qualcosa di piuttosto bizzarro. Invisibili e lievi Il 27 agosto abbiamo lanciato un allarme, rozzamente. Dai primi giorni di settembre sono stati intravisti, in Stazione Centrale, i primi siriani. Qualche famiglia, piccoli gruppi. Presenze invisibili, lievi. Alessandra Coppola, nelle pagine del “Corriere della Sera”, il 27 settembre 2013 ne parla così: “sono fuggiti da Erbin, quartiere alla periferia di Damasco, dopo l’attacco dell’esercito di Assad con le armi 11 chimiche. Hanno raggiunto Latakia, la cittadina portuale a nord di Homs”, e racconta che si tratta di “gente semplice, dignitosa, con qualche risparmio. Scappati per le bombe, non per la miseria”. Nei primi giorni di ottobre la Comunità di Sant’Egidio si rivolge a noi, ci avvisa, ci rimprovera. “Guardate che non state capendo”. Il 12 di ottobre ci rechiamo in stazione, dopo il corteo che dice che “Siamo tutti su quella barca”. A partire da quella sera iniziamo, effettivamente, a occuparcene. Lo fanno con noi Fondazione Progetto Arca, la Croce Rossa, Protezione Civile, Sant’Egidio e i Giovani Musulmani, che, realizziamo compiutamente in quei primi momenti in stazione, in realtà si occupavano della cosa da giorni offrendo, anche loro silenziosi, informazioni e un primo aiuto ai viaggiatori. Dal 18 di ottobre la nostra accoglienza si fa più robusta. Mettiamo a disposizione degli spazi, in particolari luoghi che abbiamo utilizzato nell’esperienza dell’accoglienza dei senzatetto. Siamoaffiancati dagli operatori della Caritas Ambrosiana e dal suo direttore, don Roberto Davanzo. La loro presenza ci rassicura. Sviluppiamo, a quel punto, una Convenzione con la Prefettura di Milano che si mostra, attraverso il prefetto Tronca, attenta e pronta a fornirci lo strumento grazie a cui poter fare fronte alle spese sostenute dalle organizzazioni del Terzo settore chiamate a gestire i centri. In quelle settimane di ottobre, con l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli e il sindaco Giuliano Pisapia, decidiamo di dare vita a un sistema originale di accoglienza durante il “transito”, una sorta di assistenza fornita ai viaggiatori. Ci diciamo che la cosa è irrinunciabile e che non si tratterà di una passeggiata. Durerà a lungo. Dal 18 di ottobre del 2013 al 2 luglio del 2014 la rete milanese per l’emergenza profughi ha accolto 11.244 cittadini siriani, di cui 3.250 bambini (“che nemmeno si sognano di piangere o di fare i capricci”, scriverà su “la Repubblica” Zita Dazzi). Il numero è in continuo movimento. Il flusso prosegue e non si ferma. Dal Governo “romano” non è arrivata, sino al 2 di luglio del 2014, 12 nessuna scelta particolarmente significativa. Ma che intenzioni hanno In quelle prime giornate autunnali abbiamo tutti da fare per il programma riguardante i senzatetto. Siamo fieri, pur consapevoli di non disporre di una bacchetta magica, del lavoro effettuato dal Comune e dalle esperienze del Terzo settore. Abbiamo più che raddoppiato i letti per le persone senza dimora. Il tutto è avvenuto grazie a un fitto lavoro di squadra che ha visto (e vede) fianco a fianco operatori del Comune e dell’associazionismo. I senzatetto non sono semplici da gestire. Alcuni di loro sembrano non cercare aiuto, altri convivono con gigantesche problematiche di carattere psichiatrico, molti non si fidano. Cercare di convincerli a dormire in una Casa d’accoglienza o in un edificio recuperato come dormitorio non è facile. Contribuire a rimetterli “in piedi” affinché percorrano autonomamente la propria strada in un tempo devastato dalla crisi è una scommessa dura da vincere. In due anni, del resto, il Comune di Milano ha registrato un aumento del 300% delle domande riguardanti le azioni contro le povertà. Chi vive al margine aumenta di numero e va aiutato, dunque, come spessissimo anche nei discorsi più “importanti” e “formali” ricorda alla città il sindaco Pisapia. I profughi siriani ci chiedono di loro e osservandoli dal punto della stazione dove si raccolgono, quell’ammezzato o “mezzanino” che appare a metà dell’ampio atrio d’ingresso, divenuto presto la loro base temporanea, ci domandano chi siano quelle persone senza dimora che ogni tanto si siedono sulle panchine. Così, con Cosimo Palazzo e gli altri operatori “pubblici” e “privati” che tradizionalmente si trovano a gestire l’accoglienza dei cittadini più poveri di Milano, lo spieghiamo ai profughi. I profughi, in cambio, in quelle prime giornate in cui tentiamo di capire, si raccontano. Ci dicono del viaggio, lungo, lungo anche proprio dei mesi, che dalla Siria può averli portati in Libia, dove a migliaia sono stati radunati 13 nei campi. Ci dicono del passaggio dall’Egitto. Delle bombe, della repressione di Damasco. Ci spiegano del Mediterraneo, dell’Italia. Lampedusa, Pozzallo, Taranto e i treni, e i pulmini. Ci portano in una realtà costituita da famiglie distrutte dalla guerra civile, da risparmi impiegati per la fuga, da viaggiatori che perdono i bagagli in mare e vengono assistiti dalle strutture del volontariato, maltrattati o aiutati, un po’ a seconda dei casi, dai poliziotti e dai carabinieri. Non vogliono fermarsi a Milano e nemmeno in Italia. Su questo sono molto chiari, sempre. Il loro è un transito. Lungo e faticoso. “Il vostro è un Paese bellissimo, ma qui non ci vogliamo stare”. Come rocciatori incerti che cercano comunque di arrivare in vetta provano a trovare gli appigli con le mani, un po’ a tentoni e non sempre legati in cordata. Le loro mete sono i Paesi scandinavi, oppure la Germania, l’Olanda. I motivi, invece, non sempre coincidono. In alcuni casi, infatti, cercano di raggiungere i propri famigliari, attuando degli approssimativi e informali “ricongiungimenti” che prescindono dalla norma. In altri tentano banalmente la fortuna. Spendono migliaia di euro, per raggiungere il nord. E il nord lo raggiungono: a volte da soli e a volte grazie ai “passeurs”, i “passatori”, come li definiamo in maniera un po’ grezza. Reti illegali che organizzano a pagamento il transito. Scafisti da terra, da pulmino, da passaggio di confine. I passatori: in gran parte italiani dall’accento meridionale o magrebini che, i primi giorni d’autunno, si gettano sui profughi come le api sul miele. L’atmosfera diventa così quasi surreale e si compie una strana partita sulla pelle dei cittadini siriani. I passatori tentano di contattarli e spesso, lo si comprende osservandoli solo qualche istante, scambiano con loro numeri di telefono e informazioni. 14 I volontari, gli operatori pubblici, i cittadini milanesi, cercano di offrire un approdo diverso. Un centro d’accoglienza appena allestito, un medico volontario cui rivolgersi. Migliaia di euro per un viaggio, dunque. Alcune centinaia per il biglietto. Altre per il passatore. L’importante, ovviamente, è sfuggire ai controlli. I controlli comportano l’identificazione. L’identificazione, grazie alle regole europee “di Dublino”, impongono che il primo Paese in cui si forniscono le proprie generalità e ci si fa “fotosegnalare” sia poi quello dove si è destinati a rimanere facendo “richiesta di asilo”. Ecco, allora, che tutto si spiega. E anche buona parte dell’atteggiamento dello Stato. Nessuno deve occuparsi dei profughi siriani. Perché se lo Stato se ne occupa li deve identificare. Se li identifica non permette loro di andare oltre il proprio confine. Se se ne vanno, in sintesi, non sono più un problema. Ma chi li conduce verso il centro e il nord Europa? Un po’ di buona sorte e qualche buon consiglio arrivato sullo smartphone se va bene, la criminalità organizzata se va male. L’idea che mi sono fatto, ma è solo un’idea e come tale potrebbe essere smentita, è che se si tratta di siriani nessuno li identifica praticamente mai. E questo, inevitabilmente, coinvolgerebbe gli apparati dello Stato. Se, infatti, l’Italia gira la testa dall’altra parte, può pensare che prima o poi non ci saranno più, saranno andati “altrove”. E pazienza se questo significa generare allarme presso le popolazioni delle diverse città, lasciar dormire i bambini sul marmo freddo delle stazioni, non prestare adeguato aiuto e soccorso, non occuparsi della migrazione di questa strana folla di aspiranti europei. Emerge, in pratica, un paradosso gigantesco, frutto dell’insensatezza delle regole del Vecchio Continente e amplificato dall’immobilismo del governo italiano (almeno fino al giugno del 2014). Per aiutare i siriani a raggiungere le mete auspicate bisogna, infatti, far finta di non vederli. (E del resto tutto il mondo è Paese se, come 15 scrive Ilaria Sesana in un reportage da Istanbul: “Come tanti altri rifugiati siriani in città, Hasan tiene in bella vista il passaporto. Per alcuni abitanti molti dei mendicanti che da qualche tempo affollano le strade sono degli impostori: non siriani in fuga dal regime di Assad, ma curdi che si spacciano per profughi per ottenere un’elemosina più generosa. Il libretto dalla copertina blu con l’aquila d’argento è la prova della loro disperazione”.) Non vederli, insomma. Augurarsi che non rechino troppo disturbo alla “quiete pubblica”, che non divengano oggetto di eccessivi conflitti locali. E tanto, al massimo, per i conflitti locali, ci sarà sempre un sindaco o un amministratore pronto a metterci la faccia di fronte ai cittadini. E lo Stato? Questa domanda di dove sia finito lo “Stato” me la sono rivolta spesso e continuo a farlo. L’immobilismo del ministro dell’Interno, incapace di indicare scelte chiare sul terreno delle azioni di coordinamento nazionale dell’accoglienza o dell’assistenza dei profughi, parla davvero da solo. Sarò il primo a dire “finalmente” ai rappresentanti del Governo quando assisteremo a novità significative. Ad oggi, e da quei giorni di agosto in cui “facevamo dell’allarmismo”, è passato quasi un anno e di significativo non ho visto quasi nulla. Quel “quasi” non è un escamotage o una riserva lasciata apposta in una riga per alimentare una speranza. Nei mesi appena aperti, quelli della Presidenza del Semestre europeo, c’è infatti una grande occasione da non perdere. In questi mesi il presidente Renzi, del resto, sulla necessità di praticare un’importante discontinuità sul terreno delle politiche migratorie e della loro gestione condivisa si è soffermato in modo autorevole e, come di consueto, piuttosto chiaro, in particolare rispetto al ruolo dell’Europa e quindi, immagino, a quello che l’Italia vuole giocare in Europa (definita perfino un Continente “che salva le banche e fa morire i bambini”). Inoltre, in alcune prime uscite pubbliche del prefetto Morcone, nominato nel mese di giugno a capo del Dipartimento Immigrazione 16 e Libertà civili, abbiamo trovato indubbiamente il segno di una nuova consapevolezza. Queste “parole”, i principi esposti dai massimi vertici delle nostre Istituzioni, speriamo portino con sé atti materiali importanti e conseguenti. Di ciò c’è particolarmente bisogno dopo mesi davvero, sotto questa luce, incredibili. E perfino noi, “da qui”, qualche proposta ci siamo permessi di avanzarla. A partire da quali azioni sviluppare in sede europea (come si leggerà di seguito) o rispetto a quanto realizzare anche “semplicemente” su scala nazionale. Basti pensare che nel tempo trascorso rispetto all’arrivo degli undicimila profughi siriani, per non parlare degli oltre duemila profughi eritrei (a cui facciamo riferimento successivamente), non abbiamo mai ricevuto nemmeno una “telefonata”. E non faccio riferimento alle liturgie delle relazioni tra le Istituzioni, ma proprio alle telefonate che ci avvisassero, ad esempio, che sui treni provenienti da Catania, Taranto, Lecce, Napoli, fossero presenti loro, i profughi. Così la rete dei Giovani Musulmani Italiani o Save the Children o gli “amici su facebook” sono stati e sono al momento oggettivamente molto più efficaci di questure, prefetture e Polfer nel segnalare gli arrivi. C’è qualcosa di davvero grottesco in un Paese nel quale per comprendere quanti profughi sono stipati sul treno si debba scomodare un amico di vecchia data sul social network. Ci vuole davvero tanto a costruire una rete nazionale o un “sistema” magari gestito da una onlus che monitori i viaggi, i transiti, segnali i casi preoccupanti sul piano delle condizioni di salute oppure il numero di bambini? E ancora: è tanto difficile dire ai cittadini mediorientali presenti sui treni di scendere a Firenze, Roma, Bologna, per passare nel centro d’accoglienza tal dei tali qualche notte? O offrire loro, giusto per proseguire, un trasporto organizzato (e liberato quindi dalle reti criminali) con pulmini che li facciano arrivare 17 in alcune città del nord in forma stabilmente coordinata e condivisa tra le città di provenienza e quelle di destinazione? E poi, non voglio fare della retorica sulle pelle dei bambini, ma davvero questi figli del nostro tempo di due, tre anni, meritano di essere trattati come un impaccio, della merce scomoda o dei soggetti da rendere invisibili? Infine, alcune richieste le abbiamo poste pure sul tema dell’utilizzo dei luoghi, degli spazi. Ho già detto della Stazione Centrale. Non si può nemmeno capire quale sia la fatica nell’interlocuzione con i diversi soggetti a cui compete la gestione degli spazi, anche di quelli vuoti, della stazione. Ma tra quelli rilevanti alla voce “spazi” non vi è assolutamente solo un aspetto simile. Decidere di punto in bianco di trasformare una scuola in disuso o dei locali adiacenti a un Centro anziani in un centro per i profughi, come siamo stati costretti a fare, non è facile. Specie quando le nostre città, e quindi anche Milano, sono piene di edifici come le caserme, rimaste vuote a seguito delle scelte operate rispetto all’Esercito o alla leva, che questo Stato potrebbe (come giustamente sostengono da tempo, anche per vie formali, il sindaco Pisapia e Lucia De Cesaris, il vicesindaco della nostra città) destinare a uso sociale (per i profughi o anche per gli sfrattati e i disoccupati italiani rimasti senza casa). O ancora, per dirla tutta e scomodare l’esempio che dalle parti del Viminale e di “Roma” dà di più sui nervi: perché non metterci nelle condizioni, come domandiamo inascoltati, di utilizzare per l’accoglienza il CIE di via Corelli, inutilizzato da tempo e naturalmente “progettato” per ospitare camere, camerate, servizi igienici condivisi e spazi dove poter mangiare? Ecco, allora, tornando alla domanda sulla presenza dello Stato, che quel quesito non può restare freddamente eluso, e anzi i suoi “confini” andrebbero in qualche modo estesi. Ci sono tematiche, infatti, come ad esempio quelle riguardanti la salute, che vengono affrontate dal peggior teatrino della politica in modo sorprendente. Tutti cavalcano le notizie sui rischi di contagio quando appaiono 18 supposizioni sulle “malattie delle migrazioni” attraverso l’ultimo dei blog, tuttavia, sulla base dell’esperienza concreta domando: dove sono i programmi organici, strutturati, effettivamente definiti secondo prassi certe e inequivocabili, messi in campo dalle ASL, giusto per fare un esempio, nella leghista Regione Lombardia (responsabile della gestione della Sanità) in materia di verifica e controllo della salute dei profughi? Confesso di non averlo capito. Per chiudere, un ultimo paradosso. Quel che diciamo da mesi è che il problema in questo caso non sono, almeno non ancora, stati i “soldi”. Se nel campo delle Politiche sociali, come l’ANCI spessissimo afferma, anche attraverso il suo presidente Piero Fassino, i Comuni hanno dovuto fare sacrifici importanti a causa dei tagli subiti dagli Enti locali ecco che, in questo caso, i “soldi”, quelli, in buona parte sono arrivati. Il Comune infatti “di suo” sin qui ha messo personale e spazi. Lo Stato, invece, ha finanziato le spese riguardanti i costi vivi della gestione dell’accoglienza. In altre parole allo Stato l’“Emergenza profughi” sta costando. Fino al 30 di giugno, solo per quel che riguarda gli interventi relativi a Milano, sono infatti stati impiegati circa 2,5 milioni di euro. Sono pronto a scommettere che con una diversa forma di coordinamento e assistenza nell’organizzazione del viaggio di questi cittadini “in transito” i costi sostenuti dalla collettività diminuirebbero (e magari, mi permetto di dire, quei soldi potrebbero perfino andare a irrobustire il nostro welfare), fino quasi ad azzerarsi se venisse riconosciuto loro un permesso temporaneo capace di renderli “normali” frequentatori di stazioni, treni, aeroporti. I ragazzi eritrei arrivano scalzi Non è finita. Nel gioco di strane coincidenze a cui assistiamo la piazza dove è terminato il corteo dei ragazzi che ricordavano i morti di Lampedusa alcuni mesi dopo diventa uno dei poli di attrazione di un altro “flusso” di cittadini in transito. Si tratta prevalentemente di ragazzi, per lo più proprio di giovani 19 maschi, sui vent’anni, che arrivano dall’Eritrea, come arrivarono i padri, e le madri delle “seconde generazioni”. Il Comune, attraverso le sue strutture e le realtà del Terzo settore convenzionate o la Comunità di Sant’Egidio, ne ha accolti o assistiti, a partire dai primi giorni del maggio 2014, circa 2.430. Un ruolo cruciale lo hanno avuto e lo hanno i frati dell’Opera di San Francesco. Anche in questo caso siamo di fronte a viaggiatori in transito. Più poveri dei siriani, spesso stipati nel “fondo” dei barconi, in una sorta di ultima classe della migrazione, sono giunti in condizioni di precarietà evidente. A volte non hanno scarpe con cui camminare, i loro vestiti sono lerci, rovinati. La comunità eritrea, da cui i profughi hanno cercato riparo poiché molto diffidenti verso le Istituzioni, ha prestato da subito (e ben prima di “noi”) soccorso. Appaiono come molto differenti dai siriani. Non si tratta di famiglie, non sono musulmani. I bambini a carico, almeno nelle prime settimane, sono pochi. La capacità economica è estremamente ridotta. Come detto non si fidano e a volte raccontano di torti e pestaggi subiti nelle città di costa che, se confermati, non farebbero che gettare un’ombra ulteriore sul nostro “sistema”. Spesso non riusciamo a “collocarli tutti” nei centri d’accoglienza, non perché siano terminati i posti, ma perché non si fanno trovare agli appelli, non rispettano le procedure definite per svolgere i primi censimenti. In via Tadino, in via Lazzaro Palazzi, al Lazzaretto, in quel quartiere che tanti milanesi chiamano “africano”, hanno ricevuto una mano, qualche sorriso, un po’ di solidarietà. Per i cittadini, i residenti, la situazione però è difficile da sopportare. I commercianti scrivono in Comune e lanciano appelli. Molti milanesi ci tengono a dire “di non essere razzisti”. E in fondo, ricordano, quello in questione è storicamente il quartiere più “etnico” del capoluogo lombardo. Proprio nelle ore in cui chiudiamo questo testo siamo impegnati a irrobustire la nostra rete relativa a questa emergenza nell’emergenza. 20 E sappiamo bene che comunque non è finita. Ci sono fronti ulteriori che domandano risposte. Penso al tema gigantesco dei “minori stranieri non accompagnati”, tanto per dire di una di quelle questioni che, come un fiume carsico, può affiorare all’improvviso rompendo la terra. Ramadan Sono giornate di Ramadan, quelle in cui scriviamo. Aver a che fare per poco tempo con molti dei profughi siriani non ci permette sempre di addentrarci in alcune questioni centrali, e sicuramente, tra queste, vi è quella di approfondire quale sia il “loro” rapporto con la religione e in particolare con quella musulmana. Un aspetto enorme e affascinante che ancora una volta sta segnando la storia dell’uomo e del Mediterraneo. Questo, in questi mesi, ce lo diciamo spesso. In fondo talvolta aiutiamo, e lo facciamo senza capire. Il Ramadan prevede il digiuno dall’alba al tramonto. Richiede la rinuncia. I profughi siriani lo sanno bene, ma rassicurano i volontari milanesi che a volte non capiscono come comportarsi: chi è coinvolto da simili viaggi può cibarsi regolarmente, a patto, mi spiegano Mohamed e Maryan della comunità somala cittadina a margine di un confronto sulle moschee, che tutto, anche lo stesso digiuno, venga recuperato quando il “transito” finisce. Per diversi di loro, dei profughi siriani, il viaggio è terminato. Sui cellulari di ultima generazione arrivano foto da Göteborg, Amsterdam, Berlino. Si tratta di foto di persone sorridenti che ringraziano chi non si è girato dall’altra parte. Si tratta di ragazze giovanissime con figli in braccio, papà allegri, bambini appiccicati alle gambe dei propri genitori. Quei volti valgono davvero di più di tante altre parole. 21
Scaricare