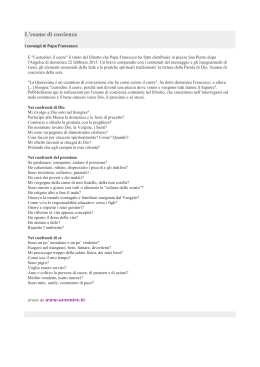Domenica La di DOMENICA 30 GENNAIO 2005 Repubblica l’inchiesta Le piazze della nuova domenica EDMONDO BERSELLI, GABRIELE PORRO e CINZIA SASSO le storie L’uomo che scoprì il rigore perfetto GABRIELE ROMAGNOLI Saddam Hussein da 400 giorni sta in una cella tre metri per quattro dove scrive poesie e cura una piccola palma. Questo è il racconto della sua vita in carcere, ricostruita attraverso le testimonianze dirette di chi lo ha incontrato Il prigioniero di Bagdad Inchiesta di copertina a cura di: CARLO BONINI FORT HOOD (USA) A. FLORES D’ARCAIS WASHINGTON (USA) ATTILIO BOLZONI RENATO CAPRILE D. MASTROGIACOMO BAGDAD (IRAQ) ELENA DUSI IL CAIRO (EGITTO) STEFANIA DI LELLIS GINEVRA (SVIZZERA) CLAUDIA FUSANI RICCARDO STAGLIANÒ ROMA (ITALIA) R accontano che il prigioniero sia un corpo di vecchio. Avvolto nella tunica della tradizione, un’ampia dishdasha alle caviglie, di un bianco immacolato. Il volto scavato, acceso da improvvisi lampi, ora di furia, ora di paura. Solo. «Forse pazzo», nel ciabattìo di un paio di sandali di gomma che da 415 giorni si trascinano in una cella di tre metri per quattro. I giorni di Saddam Hussein sono un segreto intermittente che appartiene all’Esercito degli Stati Uniti. L’Esercito non mostra e non dà accesso al prigioniero. L’Esercito è padrone delle informazioni che danno conto del suo isolamento. Decide quali dare. Come darle. E dunque. Saddam prega genuflesso su un materassino rivolto alla Mecca. Tre volte al giorno, a orari comandati, mangia in silenzio il cibo dei suoi nemici. A cominciare dalle ipercaloriche razioni di sopravvivenza liofilizzate Mre, Meal ready to eat, confezionate in buste color cachi dai contractorcivili del Pentagono. «Ha imparato ad apprezzare» i muffinse i cookies. Alterna riso, patate, pesce, carne e broccoli cucinati nelle pignatte della mensa da campo dei suoi carcerieri. Saddam ha diritto a una doccia, al barbiere e ogni giorno gli concedono tre ore di aria in un piccolo giardino dominato da una giovane palma circondata da siepi basse, dove ha deposto delle piccole pietre. E qui è sollecitato a una ginnastica spontanea che lo sottragga all’anchilosi. Divide le altre 21 ore del giorno tra il letto pieghevole della cella e la piccola scrivania che ne occupa un lato. Dietro lenti dalla montatura spessa, scrive poesie che leggono solo i suoi censori e lavora al romanzo cui si dice abbia cominciato a metter mano negli ultimi giorni da Raìs e che nessuno pubblicherà, Andatevene dannati!. Pagine in cui si vaneggia di un tempo che forse è stato. Di un’epica mesopotamica da anno Mille, di re, cavalieri, del sangue degli infedeli. (segue nelle pagine successive) FOTO REUTERS i luoghi Matera, i pionieri del passato EMANUELA AUDISIO e MARIO PIRANI cultura La MuseoLand di Hong Kong FEDERICO RAMPINI e SALVATORE SETTIS spettacoli Buscaglione, la faccia del Boom GIORGIO BOCCA, GINO CASTALDO e PINO CORRIAS l’anniversario Monopoli, 70 anni di successo STEFANO BARTEZZAGHI e ILARIA ZAFFINO 22 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 GENNAIO 2005 la copertina Carcere speciale La cella del Raìs, tre metri per quattro, è a Camp Cropper, vicino a Bagdad, in quello che era il suo complesso residenziale preferito. Ma su di lui, l’Esercito Usa ha steso un velo di mistero. “Repubblica” ha parlato con i testimoni diretti per ricostruire la vita del prigioniero più famoso Poesie, preghiere e rabbia i 400 giorni in catene (segue dalla copertina) B akhtiar Amin, 46 anni, provvisorio ministro iracheno per i diritti umani è un curdo di Kirkuk. Ha studiato alla Sorbona in Francia, e in Svezia. Saddam ha sterminato 60 tra uomini e donne della sua famiglia. La vendetta privata è stato bussare alla sua cella. «A Bagdad le voci continuavano ad inseguirsi: “Saddam è stato portato fuori dal Paese”. “Ha un cancro”. “Ha avuto un infarto”. “È stato violentato”. Decisi di vedere con i miei occhi e, come ministro, ne avevo titolo». «Saddam mangia meglio di un iracheno medio — racconta dunque Amin — e vede i medici due volte al giorno». Lo auscultano quotidianamente, ne prelevano periodicamente il sangue, lo sottopongono a cicli di antibiotici, perché l’uomo non muoia o non decida di darsi la morte prima di aver conosciuto il proprio destino e quello della sua gente. I bollettini trasmessi dal Comando americano alla Croce rossa internazionale di Ginevra documentano un «paziente» in «una condizione di salute generalmente buona». Diagnosticano «pressione alta», «problemi alla vista», un’ernia, una «prostata ingrossata» e annotano il «rifiuto» del prigioniero ad una biopsia in grado di escluderne degenerazioni cancerose. «Ma sì, sì — si spazientisce il ministro — l’operazione di ernia, la pressione al- ta, la prostata ingrossata. E allora? Le analisi dicono che non è preoccupante. Che non dovrebbe esserci tumore. Il 30 per cento degli uomini della sua età ha lo stesso problema. C’è un detto in Francia: “Se hai 50 anni e non hai acciacchi di cui lamentarti vuol dire che sei morto”. Saddam ne ha 60 e sta benone per la sua età». Bakhtiar e Saddam non hanno scambiato una sola parola. Si sono fissati in silenzio. «Avrei potuto dirgli o chiedergli qualcosa — racconta il ministro — ma non l’ho fatto. Mi è bastato vederlo depresso, sapere che la notizia della creazione di un nuovo governo in Iraq lo aveva gettato nello sconforto. La verità è che ad un certo punto ho avuto voglia di vomitare. Mi faceva schifo vedere l’uomo che ha ucciso milioni di iracheni avvicinarsi alla sua piccola palma come un amorevole giardiniere. Proprio lui che con gli uomini ha offeso anche la natura, distruggendo l’Eden di paludi, allevamenti, pesca a ovest di Bassora per vendicare la ribellione durante la prima Guerra nel Golfo...». *** La cella di Saddam Hussein è a Camp Cropper, dieci chilometri a occidente della zona verde, sulla verticale dell’aeroporto. Un cerchio di filo spinato e alte torri di guardia all’interno di Camp Victory, ieri oasi del regime, oggi casa di 14 mila fanti americani. Nella scelta del luogo del contrappasso l’America ha messo del metodo. Assegnato al terzo corpo di armata di Fort Il ministro dei diritti umani Amin ha visto il suo nemico di un tempo: “Sta bene e mangia meglio del nostro popolo”. In cella legge, scrive e cura una piccola palma DAL CUNICOLO ALL’AULA In alto, la buca in cui Saddam è stato catturato e l’ex dittatore iracheno al momento della visita subito dopo il suo arresto. Sotto la sequenza del suo primo interrogatorio pubblico Hood, Texas, il capitano David Olson è appena rientrato dall’Iraq. È un ragazzone del Nebraska e nell’oasi diventata guarnigione dei vincitori e prigione del vinto ha trascorso sei mesi. «Camp Victory e Camp Cropper — racconta — erano il cuore del regime. Magnifici palazzi dagli immensi saloni rivestiti di marmi che affacciavano su un lago artificiale, alimentato da condutture che pescavano acqua nel Tigri. E poi, una fittissima piantagione di palme, che i figli di Saddam avevano voluto come riserva di caccia, dove tirare ai leoni e alla selvaggina africana che lì veniva ripopolata. Nella gerarchia del Baath, il rango si misurava in chi era ammesso o meno a tanta bellezza». Oggi, quei palazzi si sono fatti prigioni. «Il lago — sorride Olson — è diventato uno stagno, la riserva di caccia una legnaia per le truppe, la rete di pompaggio dal Tigri un ammasso di tubature arse, portate in superficie e tranciate dai cingoli dei carri armati Bradley». Saddam Hussein è qui. La sua cella tre per quattro, il suo spicchio di cielo, la sua palma solitaria, sono stati ritagliati in uno dei palazzi del potere abbattuto. E separati da altri angoli di reggia diventati prigione, dove altri undici dignitari del regime, con lui apparsi in aula e come lui in attesa di processo, conoscono un rigore meno assoluto di quello cui è sottoposto il Raìs. Che li ammette alla socialità del backgammon, del domino e degli scacchi. Ma non gli risparmia l’obbli- Quando l’inviata della Croce Rossa lo visitò, lui la fissò con stupore poi le consegnò una lettera per le figlie go di svuotare le latrine. Dicono si salutino tra loro come nel tempo che non c’è più. Con deferenti inchini e sussiegosi appellativi. *** Bakhtiar Amin non è stato il solo civile ammesso al cospetto di Saddam. Il 21 febbraio 2004 anche una donna ha attraversato il confine di Camp Cropper. Senza uniforme. In cerca del prigioniero tra i prigionieri. E da allora cinque volte ancora. Ad intervalli di quarantacinque, sessanta giorni. Da ultimo, il 15 gennaio scorso. Cinque ore in 415 giorni. È una svizzera tedesca dal nome slavo e l’arabo fluente. Lavora a Ginevra negli uffici della Croce Rossa Internazionale, che ne protegge l’identità. Quel giorno di febbraio, il prigioniero fissò in silenzio la donna, chiedendosi se dovesse credere a chi dopo due mesi e otto giorni di isolamento lo sollecitava a riferire delle condizioni del suo corpo, della sua mente, impegnandosi a mantenere il segreto su quanto avrebbe ascoltato. E per giunta lo invitava a chiedere sigarette se ne avesse desiderio, a servirsi della biblioteca di 170 volumi in lingua araba cui di lì in avanti avrebbe avuto diritto e cui oggi continua ad avere diritto. Libri di avventura e di viaggio. Non fu semplice. Gli Stati Uniti avevano ceduto alle pressioni della Croce Rossa soltanto il 9 gennaio del 2004. Quando il segretario alla Difesa, Donald Rumsfeld, non era riuscito a difendere oltre le «ragioni» per sottrarre il DOMENICA 30 GENNAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 23 LA GUERRA DEL GOLFO Il 2 agosto 1990 le truppe irachene invadono il Kuwait: l’Onu intima il ritiro e, al rifiuto di Saddam, scaduto l’ultimatum il 17 gennaio 1991 Bush senior dà inizio all’operazione Desert Storm. La guerra dura poco più di un mese: il 28 febbraio gli iracheni si ritirano dal Kuwait tiranno alla Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra, quale Saddam era. «Offrimmo a Washington la garanzia che qualunque obiezione avessimo ricevuto o mosso alle condizioni di detenzione ne avremmo fatto oggetto di esclusivo confronto con le autorità americane — racconta Antonella Notari, portavoce della Croce Rossa Internazionale — In cambio ottenemmo l’impegno a poter condurre le visite restando soli con il detenuto». A Saddam venne consegnato un cartoncino dal layout prestampato. La donna svizzera che aveva di fronte lo invitò a scrivere ciò che volesse, indicandone il destinatario. Ventidue righe per raccontare due mesi e otto giorni. Il Raìs si fermò a riga quattordici. E nel riconsegnarle alla donna, chiese che venissero recapitate a Raghad e Ala, le figlie riparate in Giordania. Di quattordici righe, la censura americana ne cancellò nove. «Il mio spirito e il mio morale sono alti, rendendo grazie a Dio», lesse Raghad lungo le linee risparmiate dai tagli. E ancora: «Io sono il Presidente dell’Iraq». Mohammed Najeeb al Rashdan, avvocato giordano incaricato dalle figlie di Saddam, avrebbe sostenuto che quei tratti di pennarello nero con cui era stata cancellata «la voce del Presidente» nascondevano il segreto delle sevizie e delle ferite ricevute in carcere nel gennaio del 2004. E in una telefonata da Amman spiega: «È tagliato fuori dal mondo: le lettere che gli sono state spe- dite sono arrivate con mesi di ritardo. E altre che lui ha scritto non sono mai giunte a destinazione. Inoltre ho ricevuto un rapporto confidenziale della Croce Rossa che documenta torture fisiche e psicologiche». «È assolutamente falso che esista un rapporto della Croce Rossa consegnato al signor al Rashdan — replica la Notari — Abbiamo soltanto recapitato un messaggio di Saddam ai familiari. Ogni osservazione sulle condizioni di detenzione è stata girata alle sole autorità americane perché provvedessero». Almeno fino al 30 giugno scorso e quindi nei mesi a seguire, quando Saddam Hussein ha cessato di essere un «prigioniero di guerra» per diventare il primo dei detenuti dell’autorità di governo provvisoria dell’Iraq. *** Il prigioniero continua a incombere come un insopportabile fardello. Ma sui nemici di oggi, più che sui liberati di ieri. I suoni, la gioia e i profumi che ne salutarono la cattura sembrano memoria di un tempo lontanissimo. Sadr City, lo sterminato quartiere di Bagdad dove vivono più di 2 milioni di sciiti, la casba dove ogni famiglia ha un padre o un figlio o una parente da piangere, qualcuno fatto giustiziare da Saddam, è tornato luogo inaccessibile alla Coalizione che ha abbattuto il tiranno. Non ci sono più dolci di miele da offrire a mani occidentali e lungo la Djawadir, la grande strada lunga e dritta che taglia IL SECONDO CONFLITTO A più di 10 anni dalla campagna del padre, Bush jr. torna in Iraq per risolvere il “problema” Saddam. Nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2003 inizia l’operazione Iraqi Freedom: il 9 aprile cade Bagdad e viene abbattuta la statua di Saddam, il 22 luglio vengono uccisi i figli del Raìs in due il quartiere, la gente ha smesso di chiedere vendetta sul Raìs e combatte chi pure li ha messi in grado di consumarla. Il 13 dicembre 2003 è diventato il giorno in cui tutto è cominciato e non finito. Lo sanno bene a Bagdad. Ma quel che importa è che ne sembra consapevole l’uomo che quella notte, ai piedi di una botola nascosta in una piantagione di datteri nella regione di Tikrit, si disse avesse scritto la Storia. E oggi, al contrario, dice di esserne soltanto «un paragrafo». L’uomo si chiama James Hickey. Ha 44 anni, è nato a Chicago e parla un inglese pulito, ricco, che segnala un’intelligenza vivace. È un colonnello dell’Esercito degli Stati Uniti. Comanda la prima brigata della quarta divisione di fanteria. È l’ufficiale che ha catturato Saddam Hussein. Per arrivare al suo ufficio-comando nella base di Fort Hood, Texas, si sfila lungo il «muro della memoria e dell’omaggio». Una statua in bronzo sorveglia ottantuno placche per ottantuno nomi. «Sono i ragazzi della divisione che non abbiamo riportato indietro vivi — spiega Hickey — La statua, invece, è un’altra storia. È un pezzo di Saddam: feci tirare giù dal piedistallo una sua statua equestre a Tikrit, e chiesi ai miei soldati di farla a pezzi, sapevo che se ne poteva fare qualcosa di meglio». Ci pensò poi un artigiano iracheno a fonderla e a tirarne fuori una nuova statua: una bambina che appoggia la mano sulla spalla di un fante inginocchiato LA CATTURA Nella notte del 13 dicembre 2003 Saddam viene catturato in una fattoria vicino Tikrit, con la barba lunga, senza opporre resistenza. Il primo interrogatorio è all’aeroporto di Bagdad: l’ex dittatore dichiara di non aver mai posseduto armi di distruzione di massa mentre piange i suoi morti. Il Saddam di carne e di ossa, Hickey se lo trovò di fronte il 13 dicembre. «Alle 20 e 15 di una sera fredda e senza luna…», racconta lui sorridendo, come fosse l’incipit di una fiaba in grado di rassicurarlo. «Era la dodicesima volta che uscivo per la caccia. Che dicevo a me stesso che quella sarebbe stata la notte. Sentivo che eravamo a un passo. I prigionieri che avevamo catturato nei giorni precedenti avevano dato l’indicazione. Alle tre del pomeriggio del 13 avevo chiesto di incontrare in privato il generale Odierno, il comandante della divisione. “Forse ci siamo davvero”, gli dissi. “È per stasera”. Il generale mi guardò in silenzio e dopo qualche istante mi congedò con tre parole: “Mi faccia sapere…”». Lo sguardo del colonnello si accende. «Decisi di guidare in prima persona le due squadre d’assalto. La zona del raid era stata sigillata da terra e dal cielo. Io e i miei raggiungemmo su tre humvee la piantagione di datteri che ci era stata indicata. Ci dividemmo. Alle 20 e 05 scoprimmo che i due luoghi che ci erano stati indicati dagli informatori erano vuoti. Però le tracce di un passaggio fresco portavano verso una botola mal camuffata. Quel che accadde dopo, lo sapete… ». Non tutto. Non quello che è rimasto nella memoria di Hickey. «Saddam vestiva lo stesso abito della prigionia di oggi, una dishdasha di tela grezza. Aveva le braccia al cielo e una Uno dei suoi legali, il giordano al Rashdan, parla di torture e dice: “È tagliato fuori dal mondo” pistola infilata nella cintola. Disse: “Sono Saddam Hussein, Presidente dell’Iraq e intendo negoziare”. Poi, tacque. Non c’era più traccia del dittatore arrogante per cui ero finito in quel posto. Avevo di fronte un uomo improvvisamente vecchio, sporco nella barba e nei capelli, docile. Lo feci bendare e ammanettare ai polsi. Chiesi un elicottero Apache per l’evacuazione immediata. Alle 20.26 chiamai il comando di divisione via radio e dissi una sola cosa: “Abbiamo il jackpot”». Una pausa. E quindi senza neanche lasciar finire la domanda: «Sì, certo, fu un’emozione. Ma ogni volta che ripenso a quei 26 minuti della mia vita riconosco che non mi diedi troppo tempo per pensare a quel che stava accadendo. Tornai a fare il comandante dei miei uomini. A preoccuparmi di un’imboscata di cui eravamo stati avvertiti e ci dovevamo guardare, e che nessuno invece aveva preparato. Mi calai nel buco di Saddam e affondai le mani in quel che restava del suo tesoro. Una cassa con 750 mila dollari in biglietti da cento, che feci caricare su un Humvee prima di chiamare una seconda volta il comando per dire ridendo: “Il jackpot è in aria, io vi sto mandando un milione in contanti da terra”. Poi radunai i ragazzi, gli strinsi la mano e continuammo a lavorare fino all’alba. In un altro quadrante. Con altri raid». (segue nella pagina successiva) 24 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 GENNAIO 2005 la copertina Carcere speciale (segue dalla pagina precedente) Dalla notte del 13 dicembre la strada di James Hickey e quella di Saddam Hussein non si sono più incrociate. «Se proprio dovessi dire, da cittadino americano e non da ufficiale, sarei curioso, oggi, di stargli di fronte. Chi sa…». Già, chi sa. La prima brigata della quarta divisione di fanteria tornerà in Iraq al più presto entro la fine di quest’anno, al più tardi entro l’inizio del prossimo. «Se per allora avrò ancora il privilegio di comandare questi uomini sarò con loro. Come ho detto, il lavoro non è finito. Saddam deve essere ancora processato, l’Iraq deve ancora trovare la pace. E noi del 13 dicembre siamo diventati soltanto un paragrafo della Storia…». *** Che Saddam debba essere processato, è asserzione che viene ripetuta con la sicurezza riservata alle ovvietà. Lo è assai meno che qualcuno riuscirà poi davvero a farlo, chi debba farlo e come e dove e in nome di quale legge penale. In questi primi 415 giorni di prigionia — come riferisce una qualificata fonte dell’Antiterrorismo americana — il Raìs, «già inutile sotto il profilo dell’intelligence» perché «impermeabile» agli interrogatori della Cia, si è dimostrato materia «complicatissima» anche per gli uomini del Fbi spediti da Washington a Camp Cropper con l’incarico di trasformare un trofeo di guerra americano in un imputato in attesa di giudizio della giustizia irachena. Saddam ha molti avvocati (venticinque) che dicono di difenderlo. E quei po- Durante un colloquio di quattro ore, un altro suo avvocato, Khalil Duleimi, gli ha annunciato la morte di Arafat. L’ex dittatore avrebbe rivendicato il suo ruolo nella guerriglia: “È la mia profezia che si realizza” chi che ha accettato di incontrare hanno avuto accesso alla sua cella soltanto nel dicembre scorso. Sei mesi dopo la sua formale incriminazione e soltanto una volta. Alla presenza di due funzionari del governo americano che hanno registrato in audio e in video l’intero colloquio tra il prigioniero e i suoi legali. Curtis Doebbler è uno di loro. È un americano di Buffalo, un pacifista che non fa mistero di esserlo, cui dal 30 dicembre scorso, si è associato Ramsey Clark, già Attorney General degli Stati Uniti durante la presidenza di Lyndon Johnson. Doebbler si anima. Dice: «È tutto da vedere se il processo si farà in Iraq o, come noi chiediamo, Saddam non dovrà invece essere giudicato da un tribunale internazionale che garantisca l’imparzialità del giudizio. Quel che vediamo è che questo processo è illegale e non rispetta neppure gli standard minimi previsti dalle leggi internazionali. A cominciare dal tribunale che dovrebbe giudicare l’imputato». Gary J. Bass insegna Politica e Affari Internazionalialla Woodrow Wilson School della Princeton University e con il suo Stay the Hand of Vengeance — The Politics of War Crimes Tribunals, è tra i più riconosciuti esperti americani in diritto penale internazionale. «Allawi ha fretta — dice — ma non ricordo un solo Paese in cui ci sia stato un processo per crimini di guerra mentre è in corso un conflitto civile. Esiste il grave pericolo che i Baathisti uccidano i giudici della Corte». Una preoccupazione che non sembra togliere il sonno a Michael Scharf, direttore del Frederick K. Cox Una fonte riservata dell’antiterrorismo Usa riferisce che il Raìs “è inutile sotto il profilo dell’intelligence, perché impermeabile agli interrogatori della Cia” International Law Center della Case Western Law School. Scharf è uno dei cinque «consulenti internazionali» cui Washington ha affidato l’addestramento e la formazione dei giudici iracheni del tribunale speciale che dovrà giudicare Saddam. Dice: «Sono stati fatti molti progressi. Il processo comincerà presto e si terrà in una località sicura dell’Iraq. Sarà aperto al pubblico e alla stampa. E forse alle televisioni. Forse. Il Tribunale speciale iracheno deve completare le norme di procedura. Saddam deve essere formalmente accusato e alla difesa deve essere data la piena opportunità di preparare il processo, compreso l’accesso a ogni prova in possesso dei procuratori. In ogni caso, non se ne parlerà prima dell’estate del 2005». «Estate del 2005? Direi che è molto difficile... ». Cherif Bassiouni è Professor of Law e presidente dell’International Human Rights Law Institutedella De Paul University di Chicago. Ha diretto la commissione delle Nazioni Unite che accertò le violazioni della legge umanitaria internazionale nella ex Jugoslavia e quella incaricata di dare vita al Tribunale Penale Internazionale che oggi processa Milosevic. Parla un perfetto italiano. Spiega: «Superate le elezioni in Iraq si insedierà la nuova Assemblea Costituente che resterà in carica fino al 30 agosto. E non è possibile fare il processo prima che venga varata la nuova Costituzione. In ogni caso, sarà comunque necessaria una legge che abroghi quella in vigore, che porta la firma di Paul Bremer e dell’Autorità politica provvisoria, un soggetto istituzionale che ha cessato di esiste- Secondo alcune voci, non confermate, in questi giorni sarebbe stato trasferito in Qatar re». «La legge “Bremer” è un “pasticcio”— aggiunge Bassiouni — Fissa i reati di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Gli stessi previsti nello statuto della Corte Penale Internazionale. Bene, il codice penale iracheno non li prevede e, soprattutto, gli Stati Uniti non hanno sottoscritto lo statuto della Corte Penale Internazionale». A Washington, una fonte del ministero di Giustizia americano sostiene che la nuova legge per processare Saddam è già allo studio in grande segretezza, ma aggiunge che anche i tecnici che la stanno materialmente stendendo dubitano che possa essere approvata entro il 30 agosto dall’Assemblea Costituente. «E quello che succederà da qui al 30 agosto — conviene la fonte — Dio solo lo sa... ». Anche perché, non esiste solo un problema tecnico. Se ne rintraccia uno di merito. Secondo una fonte del Dipartimento di Stato, «un processo ci sarà solo quando saranno pronti a testimoniare contro Saddam un numero sufficiente di alti esponenti dell’ex regime. In carcere ci sono altri 43 papaveri che stanno trattando». Uno di loro è l’ex ministro degli Esteri e numero due del regime Tareq Aziz. «Provate a immaginare che colpo sarebbe se il primo a testimoniare fosse lui». *** Oggi l’Iraq voterà e il prigioniero non sarà della partita. Lunedì 17 gennaio il quotidiano libanese Al Mustaqbal, citando fonti anonime vicine al governo provvisorio iracheno e al comando Usa, ha accreditato l’ipotesi che Saddam possa la- DOMENICA 30 GENNAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 25 Le schede della Croce Rossa A fianco i moduli usati dalla Croce Rossa durante le visite nelle carceri, gli stessi compilati da Saddam Hussein. In basso, il più piccolo è il “modulo di cattura” e contiene i dati personali del prigioniero, che Ginevra adopera per monitorare la situazione. L’altro invece, in quattro fogli, viene utilizzato per far arrivare messaggi personali del prigioniero ai familiari, messaggi che vengono filtrati dalla censura e poi riconsegnati alla Croce Rossa Se l’Islam processa il capo L’orgoglio e la vendetta KHALED FOUAD ALLAM BERNARDO VALLI significativo che gran parte del vocabolario della terminologia politica araba (siyasa) rimandi all’esercizio del potere: ad esempio sultan (“potere”), malik (“re”: deriva da mulk, altro sinonimo di “potere”), raìs, etc. L’iconografia usata per rappresentare il potere si basa costantemente su due elementi: il color verde, che simboleggia l’islam, dunque il registro religioso; e la sciabola, con cui nasce e muore ogni potere. La ricca e complessa storia della genesi del potere politico nell’islam è legata all’invenzione di norme che hanno l’unica funzione di legittimare il potere; tali norme si argomentano in funzione delle circostanze storiche del momento. In tutta la storia dell’islam, il potere ha inventato le proprie norme; ciò è avvenuto anche nei vari sultanati della periferia dell’islam (Asia e Africa subsahariana). E quelle norme hanno avuto sempre la stessa funzione: costruire il potere politico intorno all’elemento essenziale che struttura le società musulmane, la dinastia; e dinastia significa filiazione, genealogia, vale a dire il sangue. La sciabola ha la doppia funzione di conquistare il potere rovesciandolo per poi mantenerlo con l’uso della forza. Il concetto di dinastia va riferito a un nodo fondamentale, al fatto che le società musulmane sono formate da gruppi, le tribù. Dalla tribù esce il leader, che può divenire re, emiro, sultano o presidente. Nella storia politica dell’islam la leadership è sempre stata emanazione di un certo gruppo etnico-tribale o religioso, gruppo che esercita il suo dominio sugli altri gruppi, che li costringe all’obbedienza attraverso l’esercizio del potere. Esiste dunque nella trattatistica arabo-islamica tutta una letteratura sul dovere dell’obbedienza, un problema che si è sempre posto nell’islam. La contestazione nei confronti del principe si è sempre manifestata in funzione del suo comportamento: se il principe non si comporta da buon musulmano, se il suo comportamento non è di esempio, che cosa deve fare il popolo, deve obbedirgli oppure no? Già intorno al 1200 la scuola filosofica e teologica del mutazalismo affermava che di fronte a un sovrano empio, il dovere del popolo era obbligarlo a comportarsi da buon musulmano. Più tardi, ancora a Bagdad, quando Gengis Khan stava per metterla a ferro e fuoco, il teologo e giurista Ibn Taymiyya nel celebre trattato Siyasa al-shari’a (Politica musulmana) radicalizzò la problematica legittimando l’assassinio politico: affermò fosse dovere dei musulmani mandare via o condannare a morte l’emiro che non si comporta da buon musulmano. Questa tesi sarà ripresa dall’ideologia del fondamentalismo, per estenderla al concetto di stato islamico. La letteratura politica araba ha posto costantemente in rilievo la relazione fra il potere politico e la sua genesi, spesso lamentando l’uso della forza. Ad esempio al-Bukhari, celebre giurista dell’islam, mette in rilievo il fatto che il potere conquistato con le armi può mantenersi solo attraverso la tirannia. Una leadership ottenuta ed esercitata essenzialmente attraverso la forza rappresenta un fenomeno perpetuatosi fino ai giorni nostri: molti esperti hanno affermato che lo stato moderno nell’islam si è costruito contro la propria società. Il gruppo (kabila, tribù) tende a mantenere il proprio potere favorendo ed aiutando la gente che di esso fa parte, vale a dire la gente della propria genealogia, della propria regione. E questo fenomeno è alla base di un vuoto nella storia politica dell’islam: manca ciò che è chiamato società civile, quell’elemento fondamentale per mantenere l’autonomia dei diversi poteri e la fabbrica della democrazia. Mi chiedo spesso perché questi elementi abbiano connotato così pesantemente le società musulmane: probabilmente perché nelle nostre società è mancata la fase di transizione tra feudalismo e capitalismo, è mancato quel corpo intermedio che è all’origine della modernità politica in occidente, vale a dire la borghesia. Certo, l’attuale processo di democratizzazione attraverso le elezioni può apparire come una forzatura, per la preoccupante assenza di sicurezza del territorio, e l’assenza del corpo intermedio della borghesia. La democrazia può apparire zoppicante, ma la necessaria transizione tra nazionalismo tirannico e democrazia si è già indirettamente compiuta, perché per la prima volta nella storia del mondo islamico il potere è transitato dai fastosi palazzi alla prigione di Saddam; ed è anche la prima volta che il potere non viene sostituito con la sciabola o con il colpo di stato. È anche la prima volta che quel potere, sprovvisto della storica rete protettiva, è costretto a confrontarsi con il suo popolo e con il diritto. Quella che si sta creando è una prospettiva totalmente nuova, perché attraverso il diritto il popolo diventa soggetto della storia, in una democrazia che costruirà la sua legittimità nelle stanze di un tribunale. Oggi in Iraq ci troviamo di fronte a un cambiamento storico: vale a dire una rivoluzione per delega. E per la prima volta nel mondo islamico un potere politico messo a nudo dovrà confrontarsi con il popolo e con la storia. Si tratta di un vero trauma per il mondo arabo e per i musulmani; ma può rappresentare una chance, può significare il loro brusco ingresso nel XXI secolo. È sciare Camp Cropper diretto nella base americana di Al-Adid, vicino a Doha in Qatar. Un’ipotesi che non trova conferme. Il capo del team di avvocati Mohammed al Rashdan dice: «Questa voce è circolata varie volte in passato, tanto che si è parlato pure di brevi spostamenti del prigioniero da Bagdad a questa base o addirittura in Giordania. Ma adesso non ho alcuna indicazione in proposito». E lo stesso dice il ministro Bakhtiar Amin. Di certo l’ex Raìs non voterà. «Saddam ne avrebbe il diritto perché non ancora giudicato — spiega il presidente della Commissione elettorale Abdel Hussein — Ma ragioni di calendario hanno impedito di allestire seggi mobili nelle carceri». Non voterà e non conoscerà neppure il risultato. Non ha televisioni da ascoltare, quotidiani da leggere. I suoi carcerieri hanno l’obbligo di non rivolgergli la parola. Le notizie, dunque, soprattutto le notizie della politica lo raggiungono in ritardo e frammentarie. Della morte di Yasser Arafat, del ritiro del contingente spagnolo dalla Coalizione, ha saputo soltanto il 16 dicembre scorso. Da Khalil Duleimi, l’ultimo degli avvocati che ha avuto accesso alla sua cella. Un colloquio durato quattro ore e ricostruito nel dettaglio dalla newsletter vicina ai servizi israeliani Debka File. Saddam ha chiesto di portare i suoi omaggi e il suo grazie a Ramsey Clark, l’ex attorney general americano che ha deciso di unirsi al collegio difensivo. All’ex primo ministro malese Mahatir Mohammed, all’amico scozzese George Galloway. Al giornalista egiziano Mustafa Bakri. Si è lamentato della «scarsa gentilez- za e rispetto» mostrati nei suoi confronti dai funzionari della Croce Rossa, chiedendo di farne cessare le visite. Ha parlato da Presidente dell’Iraq, leggendo a Duleimi uno dei versi delle sue poesie della prigionia: «Se non puoi essere in cima, non essere in fondo. Perché in fondo c’è solo la coda». Ha quindi rivendicato a se stesso, alla sua ultima decisione da Raìs, il dopoguerra di violenza che stanno conoscendo gli americani. «Bagdad — ha detto Saddam all’avvocato Duleimi — non si è arresa, né è stata conquistata. Bagdad è stata presa prigioniera. Quando l’11 aprile del 2003 i miei comandi militari mi informarono che non avevamo più uomini sufficienti ad opporci, ordinai il passaggio dalla guerra convenzionale alla guerriglia. Dissi ai miei ufficiali: gli americani si allungheranno sull’Iraq come una vipera e quello sarà il momento di attaccare, sezionando il serpente in pezzi da eliminare uno ad uno. È esattamente quel che sta accadendo... ». Si è quindi congedato con una profezia. Che è anche un’indicazione politica e una chiamata alle armi. «Non mi sorprende che quei traditori dei persiani (gli sciiti iraniani ndr) abbiano attraversato il confine per partecipare alle elezioni (di oggi ndr), ma sunniti e sciiti iracheni ora devono trovare la loro unità contro il conquistatore americano. Devono sapere che oggi è toccato all’Iraq e domani toccherà alla Siria. L’ho fatto sapere anche a Bashar Assad (il presidente siriano ndr) che il prossimo sarà lui... ». L’ apparizione di Saddam Hussein sui teleschermi, nel luglio scorso, suscitò in molti iracheni indignazione e dolore, collera e vergogna. Fu come se la figura del Raìs prigioniero, interrogato da un giudice, riesumasse nelle menti e nei cuori trent’anni di storia nazionale. Alcuni, soprattutto sunniti, in preda all’emozione, si dissero pronti sacrificare la vita, o addirittura la famiglia, per salvare Saddam. Altri, non soltanto sciiti o curdi, le due comunità da lui represse, non nascosero il desiderio di vendetta. L’avrebbero voluto, subito, morto. Quel tumulto di sentimenti contrastanti, che alimenta da un anno e mezzo la violenza, fu visibile, palpabile, nei minuti della trasmissione, che doveva essere l’introduzione al futuro processo. Il giudice lesse a Saddam davanti alle telecamere le pesanti imputazioni cui dovrà rispondere. E lui reagì con vivacità, astuzia, come uno sperimentato attore chiamato a interpretare il ruolo di un dittatore che ha perduto il potere ma non il coraggio. Le immagini di sei mesi prima, al momento della cattura, di quando fu stanato come un coniglio, ridotto allo stato di barbone, lo sguardo stralunato e la barba incolta e zeppa di pulci, furono cancellate dalla nuova esibizione, in cui l’assenza totale di autocritica, di un ripensamento, di un minimo tentativo di introspezione, poteva anche essere confusa con la dignità. Questa è la chiave per capire quel che rappresenta ancora oggi Saddam per molti iracheni. Da un lato il desiderio di vedere condannato, e magari giustiziato, il sadico despota di un tempo. Dall’altro la nostalgia del Raìs, un tempo crudele incarnazione della patria, e quindi dell’orgoglio nazionale. Il quale si confonde spesso con la fedeltà tribale. Senza decifrare quest’ultima, vale a dire il mosaico delle tribù, con le annesse lealtà e complicità, non si entra nella realtà irachena. Come senza la password non si entra nel computer. Questo vale anche per leggere quel che Saddam ha rappresentato per molti iracheni, e quel che di lui è rimasto nelle memorie. Molti, nel luglio scorso, daSU TUTTE LE TV Una televisione trasmette vanti al Raìs inil primo interrogatorio corniciato nel pubblico dell’ex Raìs teleschermo, cercarono i suoi occhi. Lo fecero per istinto. Fu come una sfida. Equivaleva a violare un antico tabù. Pochi osavano o potevano fissarli quegli occhi, quando era al poter. I soldati ai quali appuntava una decorazione sul petto, e lui prediligeva quel tipo di cerimonia, inclinavano la testa su una spalla e rivolgevano lo sguardo al suolo. Lo affondavano nella polvere, a terra. Ed era come prostrarsi, stando impalato sull’attenti. Sarebbe stato un affronto incrociare lo sguardo del Raìs. Poteva costare la vita. Una curiosità morbosa ha spinto anche me a cercare sul teleschermo quegli occhi che potevano fulminare i sudditi audaci o imprudenti, e che hanno ipnotizzato, terrorizzato o fulminato per decenni il Paese. Senza contare che lo sguardo dell’allora Raìs seppe prima sedurre e poi inorridire l’Occidente. Da strenuo e utile difensore di una laicità musulmana opposta alla vicina rivoluzione islamica dell’Iran, quale era considerato negli anni Ottanta, Saddam diventò nel decennio successivo il concreto simbolo del Male, per l’America di Bush e i suoi alleati. Non è dunque lo sguardo di un decaduto tiranno regionale che cercai, ma quello di un capo arabo che, sempre restando un personaggio sanguinario, passò dal ruolo di complice a quello di demonio, al punto da mobilitare come tale la più forte armata dello storia. Un’armata che ora occupa il suo Paese ma che non è ancora riuscita, dopo quasi due anni, a domare gli uomini rimastigli fedeli. Credo che nessuno (neppure tra gli insorti) creda alla possibilità di un ritorno di Saddam. Ma quando gli verrà fatto il giusto processo, molte verità risulteranno scomode anche per coloro che prima lo trattarono come un alleato, obiettivo se non formale, e poi come il più detestabile dei nemici. 26 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 GENNAIO 2005 l’inchiesta Riti moderni Centri commerciali sempre più imponenti, cittadelle dello shopping a prezzi scontati, mega-cinema fuori porta dove trascorrere anche l’intera giornata: sono i luoghi che hanno definitivamente rivoluzionato il fine settimana degli italiani, le cattedrali di un culto che ha messo sullo stesso piano e confuso la tradizionale voglia di incontrarsi e l’irresistibile attrazione del consumismo Le piazze della nuova domenica GABRIELE PORRO e CINZIA SASSO P L’orologio pazzo della città I popoli del “mega” sono infatti anche il nuovo popolo della domenica. «La domenica — spiega Sandra Bonfiglioli, ordinario di Pianificazione territoriale al Politecnico di Milano — è insieme alla notte la nuova frontiera del tempo. Il tramonto dell’economia industriale ha mutato radicalmente la vita delle persone e sovvertito i ritmi fissi che la fabbrica imponeva». Non esiste più il sincronismo statico tempo libero-tempo di lavoro, come non esiste più la città chiusa d’agosto, le ferie in massa e tutti in coda ai caselli per l’esodo estivo. «Adesso la città ha un orologio pazzo, basato sulla flessibilità degli orari e dei giorni di lavoro. Stiamo vivendo una rivoluzione post-industriale sull’uso del tempo». Bonfiglioli, che collabora alla stesura delle politiche sui tempi della città non solo a Milano ma anche in altri centri italiani, vede ancora la domenica come un giorno «particolare» — «non più il giorno del Signore, ma ancora il giorno del vestito buono» — nel quale vivere alla grande, altro che riposare. Marta Boneschi, nel suo Poveri ma belli, racconta così l’Italia del dopoguerra: «Nel ’54, quando l’Europeo pubblica un’inchiesta Doxa sul tempo libero degli italiani, la gran baraonda dei divertimenti non è ancora cominciata. Quando gli italiani non lavorano, non fanno nulla. Riposano o, al massimo, giocano a carte o ascoltano la radio». È solo all’inizio degli anni ’60, quando le grandi aziende come Olivetti e Fiat congedano operai e impiegati già il sabato pomeriggio, che il tempo del riposo — una giornata e mezza — sarà troppo lungo per essere vuoto di attività. Ancora Boneschi: «Occorrerà cominciare a riempirlo con viaggi, soggiorni, gite, spostamenti, visite turistiche e quant’altro è alla portata della propria curiosità e del proprio bilancio». Mezzo secolo dopo, è un’indagine del Censis, promossa dalla Conferenza episcopale italiana, interessata per sua parte a capire che cosa minacci oggi il rito della messa, a tratteggiare la nuova domenica degli italiani. Anche secondo il Censis la domenica resta, per l’85 per cento degli italiani, il tempo della famiglia, dei parenti, degli amici. Il pranzo è in casa per l’82 per cento mentre il 13 mangia da un familiare. La casa resta il luogo «più rappresentativo dell’atmosfera della domenica» per il 66,5 per FOTO PEPI MERISIO er cercare il nuovo popolo della domenica bisogna dimenticare la piazza, dimenticare la messa, dimenticare la città. E mettersi in auto. Bisogna farsi guidare da cartelli che misurano la distanza in minuti e non più in chilometri. Fino ad arrivare nel mega posteggio, parcheggiare senza difficoltà. E scoprire che altri templi e altri riti occupano ora il settimo giorno degli italiani. Templi con nomi che appena cinque anni fa avrebbero detto pochissimo anche ai più informati: “shopping mall”, “outlet”, “multiplex”. E che raccolgono sempre più adepti. L’ultima notizia riguarda proprio i multiplex: i frequentatori, cioè il pubblico degli spettatori di cinema che scelgono i mega-store con otto o più sale tutte insieme, nati come cattedrali solitarie fuori dalle città, sono diventati maggioranza e l’80 per cento di chi sceglie di vedere un film sceglie anche di vederlo in un complesso multisala. I vecchi cinema Paradisosono destinati a trasformarsi in arnesi di archeologia culturale. Domenica pomeriggio, Europlex Bicocca, Milano. Claudio, 20 anni: «Qui ho più possibilità di scelta, e l’orario va sempre bene. È il massimo come qualità e poi posso mangiare e bere mentre sto vedendo il film». Multiplex Move In Medusa, Cerro Maggiore. Massimo, 17 anni: «Mi piace perché incontro sempre qualche amico e poi ci ho conosciuto diverse ragazze. Vengo al multiplex perché c’è più divertimento, ci sono i negozi, le sale giochi, si mangia bene, c’è la focacceria». E il film? Quello, si capisce, conta sempre meno. Il 73 per cento dei frequentatori dei multisale della catena Warner Village ha tra i 18 e i 44 anni e nell’84 per cento dei casi ha il diploma di scuola media superiore o (20 per cento) la laurea. Un mercato davvero interessante tanto che una multinazionale francese (450 schermi in Francia e 50 in Spagna) tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo aprirà fuori Roma una Mecca del cinema: l’Ugc Fiumicino, con 24 sale per 6.100 posti. Sarà il complesso più grande d’Italia, di un terzo più capiente dei già sterminati Warner Village Parco de’ Medici a Roma e Europlex Bicocca a Milano che di sale ne hanno 18. Piazza Duomo, a Crema, in una domenica mattina degli anni Sessanta IERI cento del campione. Ma le novità di cui parla Bonfiglioli si fanno avanti anche nelle statistiche: ormai lavora di domenica il 31,3 per cento della popolazione e lo fanno soprattutto giovani (42 per cento tra i 30 e i 44 anni) e laureati (47,5 per cento). Sono le upper class che indicano la tendenza, le fasce di popolazione più svincolate dalle tradizioni, impegnate nelle nuove professioni. Ma i numeri descrivono anche un’altra novità: il 33,3 per cento degli italiani ha fatto acquisti di domenica, gli adolescenti sono il 73,8 per cento. Per negozi si va «in compagnia» nel 72,6 per cento dei casi: o con la famiglia (52,9) o con gli amici (19,7) e comunque quasi il 30 per cento ritiene che frequentare i negozi sia «un modo divertente di trascorrere la festa». Al solito, chi meno ha più vorrebbe e così è dal Sud e dalle Isole, dove ancora non esistono centri commerciali, che la domanda è più pressante: il 51,8 per cento considera l’outlet il luogo eletto degli incontri. Percentuale che sale al 64,3 per cento tra gli adolescenti. Il centro commerciale, dunque, che è poi la realizzazione materiale del sogno del «popolo delle griffe», come lo chiama- no gli spin doctors del marketing, si avvia sempre più a diventare la nuova «piazza» degli italiani. Sottolinea il Censis: «Perfino i nuovi templi del consumo sono frequentati non tanto perché esiste un virus consumista che attanaglia gli italiani, ma perché vengono trasformati in occasioni di incontro». Per preparare l’apertura del primo centro commerciale in Italia, McArthur Glen, società che nei suoi 13 poli sparsi per l’Europa mette insieme 50 milioni di visitatori l’anno, ha stabilito che il progetto ha possibilità di successo se poggia su un bacino di utenza di almeno 12 milioni di abitanti distribuiti nel raggio di 90 minuti. Ma quello che è importante soprattutto è che il centro diventi un punto di richiamo nel suo insieme, non solo per quello che vende. I prodotti hanno sì importanza, ma solo per definire il target dei visitatori. Se ad Ashford, in Inghilterra, il Designer Outlet è stato progettato dall’architetto che ha fatto il Millenium Dome di Londra, a Serravalle Scrivia — sull’autostrada dei Fiori, tra Milano e Genova, 35mila metri, 150 negozi — è nata una città fatta di parcheggi, case, viali alberati, piazze con panchine e fontane, ristoranti, bar con i dehors. «Il nostro consumatore medio — dice Stefano Stroppiana, direttore generale per l’Italia — è una coppia sui 38 anni che nel centro trascorre tre ore, visita 14 negozi e che ci passa undici volte l’anno, quasi una volta al mese». Il centro commerciale diventa la meta della gita domenicale, la fuga dalla città, dal traffico, dai problemi. Giampaolo Fabris, ordinario di sociologia dei consumi allo Iulm di Milano, a proposito di questo fenomeno parla di «incantamento» e dell’importanza del fare «l’esperienza»: «Entrare in uno shopping center significa venire irresistibilmente proiettati in un’atmosfera emozionalmente calda e spettacolare. Superata la soglia, il sentimento più diffuso che sopravviene è l’incantamento. Il consumatore è investito improvvisamente da un’atmosfera di festa, di benessere, di stimolazioni poli-sensuali, è come essere sempre a Natale. O come essere a un casinò di Las Vegas, dove non sai mai se è giorno oppure notte». Famiglie come al luna park Al “Barlumeria” del Fidenza Village, vecchi tavoli di legno come in un’osteria emiliana originale, menù su carta paglia, prodotti tipici dal parmigiano al culatello di Zibello, un’intera parete di forme di Reggiano, domenica Luca e Massimo, manager romani in trasferta per lavoro, i sacchetti dello shopping sotto il tavolo, bevono Nabucco dell’azienda “Monte delle Vigne” e si confidano sulle fidanzate: «Non siamo venuti per comprare, siamo venuti perché questo posto è bello. Poi è anche capitato di trovare l’occasione…». Hanno 30 anni e raccontano di essere visitatori affezionati di Castel Romano: «La domenica — dice Luca — vado a fare un giro in moto con gli amici e al ritorno ci fermiamo lì. Si sta bene, e questo è tutto». I commessi raccontano che le famiglie si presentano come fosse il luna park. Mirella, che lavora all’outlet Franciacorta, osserva che il picco degli ingressi è il pomeriggio: «Questa è una terra di tradizioni: prima si pranza in famiglia, poi si caricano i nonni e i bambini e si viene nella grande giostra». Qui è venuto Patrick del Grande Fratello e quelli di Zelig; qui, fino a metà dicembre, c’è stato il Planetario e per tutto l’inverno i bambini hanno a disposizione una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Se poi non è l’outlet, va bene anche il fratello minore, il centro commerciale. Secondo un’indagine della Camera di commercio di Milano svolta sulla città e sulla provincia più ricca d’Italia, nell’ultimo anno la domenica si sono registrati aumenti di presenze con punte fino al 40 per cento; la domenica, ormai, è il giorno che fa registrare l’affluenza più alta di visitatori. Ma anche più giù nella scala del commercio, la domenica è diventata un giorno da allarme rosso: all’Esselunga di viale Papiniano, il primo supermercato milanese a restare sempre aperto, già luogo di leggendari incontri per single, le code alla cassa sono di mezz’ora almeno e tutta la via è bloccata da auto in seconda e terza fila, dopo che il grande parcheggio è perennemente esaurito. Laura, impiegata, vive a Milano e viene da Treviso: «Dalle mie parti non esiste ancora, ma è talmente comodo fare la spesa quando si ha del tempo libero che io non mi lascio scappare l’occasione». DOMENICA 30 GENNAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 27 33,3% 31,3% Un italiano su tre fa acquisti di domenica. La percentuale di chi dedica il giorno festivo allo shopping cresce in misura notevole tra gli adolescenti: a utilizzare la domenica per frequentare negozi e centri commerciali è il 73,8 per cento FOTO AGF EDMONDO BERSELLI FOTO AFP L Glossario MULTIPLEX I cinema multiplex sono quelli progettati esplicitamente per mettere a disposizione più sale di proiezione (almeno otto), dotati di ampi parcheggi e attrezzati anche con altri servizi di intrattenimento (ristoranti, bar, sale giochi, negozi) OUTLET Sono centri commerciali nei quali le aziende (in prevalenza di abbigliamento) vendono direttamente i propri prodotti. Si tratta di collezioni degli anni precedenti e proprio per questo i prezzi sono particolarmente convenienti SHOPPING MALL La definizione arriva dagli Stati Uniti e indica i centri commerciali più grandi che nascono fuori dalle metropoli, vere e proprie cittadelle degli acquisti dove è possibile trovare prodotti di ogni tipo ma anche luoghi di aggregazione e di intrattenimento Il cinema multiplex che sarà aperto a Fiumicino, a poche decine di chilometri da Roma, entro gli inizi di marzo sarà il più imponente d’Italia. Potrà contare infatti su 24 sale e 6.100 posti, oltre che su parcheggi, ristoranti ed esercizi commerciali Quei templi laici dove i nostri figli assaggiano la vita OGGI L’outlet di Castel Romano, ritrovo degli abitanti della capitale 6.100 La domenica è diventata una giornata lavorativa per il 31,3 per cento degli italiani. Lo rivela una ricerca Censis per conto della Cei, realizzata con metodo Cati su un campione di 1.000 persone dai 16 anni in su fra il 13 settembre e il 1 ottobre 2004 IL SORPASSO Negli ultimi mesi nei multiplex italiani sono stati staccati più biglietti che in tutti gli altri cinema. Se ad essi si aggiungono anche i multisala tradizionali si tocca l’80 per cento del totale a preghiera domenicale dell’italiano moderno è riprodotta in uno scontrino, alla cassa di un centro commerciale? Certo sarebbe più facile ricorrere alle statistiche sulla frequenza religiosa per rilevare le modalità con cui la società italiana si è secolarizzata. Ed è interessante cercare le tracce della perdita della religione tradizionale nelle scritture pubbliche della sensibilità collettiva, nei film come nei romanzi: ad esempio, nell’ultimo libro di Tullio Avoledo, Lo stato dell’unione, il protagonista, un pubblicitario, un professionista dell’immagine, un individuo perfettamente inserito nella contemporaneità come qualsiasi italiano evoluto di oggi, a un certo punto commenta fra sé: «Non conosco nessuno che vada a messa». Tuttavia, per riscontrare sul piano dei comportamenti generali che l’estremo riflesso del sacro, almeno in quanto ritualità, si è spostato dalle chiese alle cattedrali del consumo, è proprio necessario compiere lo sforzo di parcheggiare l’auto negli spazi immensi di un ipermercato: nei nonluoghi che si stendono davanti allo stile artificiale dei prefabbricati, a quel finto neoclassico che può ricordare i vecchi cinema, e lasciarsi prendere dal flusso incessante del popolo che scorre all’interno. Un vecchio calembour sostiene che nelle regioni rosse si è compiuta la perfetta trasformazione dei comunisti in consumatori, che ha equiparato le feste dell’Unità ai megamarket. Ma più in generale ciò che colpisce è il trionfo silenzioso di quella che gli apocalittici hanno chiamato la “Coca-colonization” del mondo contemporaneo, la globalizzazione omologatrice nel segno del logo. E nello stesso tempo la diffusione ormai pervasiva dello schema che il sociologo americano George Ritzer ha descritto come la “mcdonaldizzazione” della società. I quattro comandamenti del McWorld sono l’Efficienza, la Calcolabilità, la Prevedibilità, il Controllo, e presiedono un processo apparentemente inesorabile, dalle regole ferree, in cui il futuro è una derivata del presente. Sicché l’effetto principale, l’immagine che domina il supermercato, non è tanto l’impressione della quantità, del consumo vistoso, eventualmente dello spreco, come veniva classificato dai critici moralisti del capitalismo: è piuttosto la sensazione che fra ciò che viene venduto e ciò che viene indossato non ci sia nessuna differenza, che le commesse siano modelli di stile per la generalità delle ragazze e delle clienti, insomma che non esista un diaframma tra ciò che viene esposto nelle vetrine e ciò che si vede nelle corsie del passeggio continuo, fra due ali di negozi dalle luci aggressive e di isole architettoniche disegnate per il fast food (in modo analogo, negli outlet dove vengono smerciati come in allegre lotterie i campionari delle griffe di moda, si assottiglia l’ammontare di danaro necessario per adeguare il proprio look alle immagini della televisione, e si accresce la chance di approssimarsi al glamour di massa). Ciò che è dentro è uguale a ciò che è fuori. L’acconciatura alla moda di un parrucchiere, «hair stylist», in una delle sale di tendenza presenti in loco sarà il punto di riferimento dei giovani che ci passano davanti. Gli abiti sono uguali dentro e fuori i negozi. I gadget decorativi, le borsette, pure. La bigiotteria è identica ai piercing. Ma il senso dell’identificazione totale, ciò che può rivelare l’omologazione integrale lo si coglie alla fine soprattutto nei comportamenti: negli spazi commerciali si realizza infatti una variante spazio-temporale e tematica dei «distretti del piacere», come Aldo Bonomi ha definito i parchi dell’intrattenimento come Gardaland, Canevaworld o Mirabilandia. C’è in sostanza una generazione piuttosto ampia che ha scalfito la scansione settimanale del ciclo di lavoro e tempo libero. Che per certi aspetti tende a ripetere le ritualità famigliari delle domeniche del tempo andato, il pranzo in casa o in famiglia, ma ha trasferito nei centri commerciali il luogo degli incontri e delle relazioni personali. Non si tratta dell’uso ludico degli ipermercati che praticano a loro modo anche le generazioni molto più anziane (bastano un autobus e un’ora di esplorazione per ingannare il tempo e vedere un po’ di movimento), e nemmeno dell’utilizzo dei luoghi del commercio come oasi estiva, secondo ciò che aveva suggerito il ministro Girolamo Sirchia per ridurre grazie all’aria condizionata gratuita la mortalità da calura. No, il supercentro, l’ipermercato è il teatro di una fitta rete di occasioni interpersonali, in cui le nuove generazioni mettono alla prova le loro strategie comunicative. Modellato dalla pubblicità e dalle leggi del mercato, il centro commerciale diventa così anche un luogo sottratto alla logica esclusiva del profitto: è anche lo spazio in cui si muove guardinga la generazione secolarizzata. Cioè quella parte della società, ha scritto il sociologo cattolico Pier Paolo Donati, abituata a vedersi in azione dentro momenti emozionali, «eroi» di un attimo, presi dal desiderio di vivere con la massima intensità la situazione che stanno sperimentando, capaci di interpretare nel modo più appropriato una società «adiaforica», in cui la tecnica sostituisce l’etica. Detto in parole più miserabili, che «ci provano». Fanno le loro prove di educazione sentimentale. O almeno si trovano, si mostrano, si scrutano, si misurano, talvolta cuccano. Salvo poi che anche i loro genitori, vale a dire la generazione precedente, subiscono in modo analogo la fascinazione di un luogo che è insieme catalogo delle meraviglie, esposizione permanente del mutare della tecnologia, così come reinterpretazione del mercato ortofrutticolo, una vuccirìa standardizzata, magazzino degli alimenti junk ma anche megasantuario dello slow food, con preziosità introvabili vent’anni fa, grande reparto formaggeria, buona enoteca, riserva di specialità gastronomiche «glocal», ma anche palcoscenico delle interazioni sociali. Se è vero che nell’Ottocento i membri della classe altoborghese si osservavano a vicenda dai palchi dei teatri, confrontando gli abiti e i collier, e fino ai primi anni Settanta la brava gente si salutava alla messa grande delle 11, mentre oggi i «vincenti» della lotta di classe che perdura sotto altre forme si confrontano nelle feste in casa e nei ristoranti plasmati dalla dittatura modernista di Ferran Adriá, oggi la vasta «bolla di ceto medio» che secondo Giuseppe De Rita ha sostituito la borghesia trova se stessa, i propri parametri, il proprio eclettico stile nel melting pot dei centri commerciali, provando un abito da modella o da buttafuori in un outlet (senza contare che il confronto può cominciare già nel parcheggio, auto contro auto). Trovare un fuori catalogo di Armani o di Dolce & Gabbana a un decimo del prezzo atteso consente evidentemente di lucidare il proprio status, la consapevolezza sociale, la propria condizione, perfino l’autostima. Ma alla fine dell’esperienza ritualizzata dell’esplorazione e dell’acquisto c’è soprattutto come risultato il chiudersi di un cerchio, in cui la pubblicità e il consumo coincidono, i comportamenti individuali si sposano a quelli collettivi, e nella grande società secolarizzata il privato e il pubblico si identificano senza residui nella grande liturgia del mercato. 28 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 GENNAIO 2005 le storie/1 DALLE OLIMPIADI ALL’ASSEDIO L’8 febbraio 1984 iniziano a terribile assedio di Sarajevo: la Sarajevo i Giochi olimpici guerra civile dura dal 6 aprile invernali: il monte Bjelasnica 1992 al novembre 1995 (m. 2.070) è la sede delle gare quando vengono firmati gli di sci alpino. La stessa accordi di Dayton che dividono montagna da dove, per il paese in Federazione croatoquattro anni, sono partiti gli musulmana e Repubblica spari dei cecchini durante il serba di Bosnia Ritorno alla pace Sciare sul monte dei cecchini cendono sci in spalla fra i minareti della città vecchia in una fredda giornata di sole, lungo ripide strade in selciato. I loro scarponi scricchiolano sulla neve fra casette, panetterie, legnaie, piccoli cimiteri, botteghe e moschee grondanti di lumini come un presepe austriaco. Sono i sarajevesi che tornano lassù, nel nido del cecchino, a sciare sulle piste olimpiche del 1984, riaperte dopo la guerra. Sfida, esorcismo, voglia di dimenticare: chi lo sa. Ma oggi andare lassù è facilissimo: basta prendere il bus sul fiume alle otto e mezza del mattino. A Sarajevo tutto incombe, le piste e i mortai. La montagna ti assedia anche in tempo di pace. Il forestiero deve imparare in fretta: qui il dislivello è assassino. Per quattro anni quelli in alto hanno ammazzato quelli che stavano in basso. Se sali, trovi piazzeforti. Se scendi, scopri un arcipelago di camposanti coperti di neve fresca e fiori viola: prati senza muri di cinta, coperti di candidi obelischi coetanei, in maggioranza di uomini, segno di un unico cataclisma. In mezzo alle lapidi, donne salgono controluce, ciascuna in un’aureola di vapore. La vista sulla città è scandalosamente bella. A Sarajevo morte e paesaggio coincidono, e la vita, per ricominciare, ha scelto proprio i luoghi della morte. Nella parte serba, belvederi e grill sulle spianate dei mortai; in quella bosniaca ristoranti panoramici accanto ai cimiteri. Il bus parte con destinazione Jahorina, la prima delle montagne olimpiche, quella con le piste più belle. Sulla tua destra, il colle imbiancato di Bistrik, fumante di comignoli e sovrastato dal fronte. A destra la città innevata che risplende con la biblioteca rimessa a nuovo, l’antico mercato di Bascarsija, il caravanserraglio, i chioschi asburgici. Lontano dalle devastazioni della periferia i restauri sono andati avanti, qui Sarajevo pare una strana Svizzera con i muezzin. È da poco finito il Bajram, il natale dell’Islam, e nella cattedrale semivuota l’organista si sbraccia, spreme dalle canne una musica guerriera, che maschera l’inquietudine dei cattolici in una città sempre più piena di minareti. Una gola gelida ti inghiotte tra due torrioni di roccia e una curva improvvisa del fiume. In alto, sul lato sud, c’è la pista di bob del monte Trebevic, olimpica pure quella. Ma è ancora off limits: campi di mine sbarrano la strada a quasi dieci anni dalla guerra. «Da lì potevamo scendere con gli sci, fino al ’92», mi dice uno sul sedile accanto. Come a Oslo, Innsbruck e Grenoble, qui si poteva rincasare sciando. Sarajevo ebbe, prima in Europa, piste illuminate. Nei fine settimana le pizzerie chiudevano all’alba perché era di moda sciare di notte e dormire di giorno. Era una pacchia la Sarajevo d’antan. Vai verso Est, e i segnali d’Oriente anziché intensificarsi cessano di colpo. Entri nella Repubblica serba e finiscono i minareti. Non c’è nessuna sbarra, offensiva serba del ’94. Babin Dol, la stazione di partenza dell’unica seggiovia, non è il nido intatto del cecchino. Tutto quello che vedi è post-bellico, nuovo di zecca. Il resto è macerie, rimosse dai bulldozer o coperte di neve. Dalla stazione meteorologica si spalanca la Bosnia intera. Il mondo danubiano da una parte, i monti adriatici dall’altra. In mezzo, a est, la ferita profonda scavata dal fiume Drina. Poi un labirinto di cocuzzoli tutti eguali, come un mare in tempesta. La Treskavica misteriosa, mille volte presa e perduta, oggi chiusa agli umani per le troppe mine. In basso, le piste olimpiche di fondo e i due trampolini. Subito oltre, l’Igman, difeso con le unghie, per quattro anni unica via d’accesso alla città. Poco a destra, più distante, a picco su Sarajevo, il Trebevic, ancora disseminato di roba inesplosa. La città è là sotto, inerme nel suo catino, sigillata da un banco di nubi. La topografia del fronte è tutta lì, come su una carta militare. Di nuovo bellezza e morte coincidono. Scendo con Samer in neve fresca. Sotto c’è la selvaggia gola della Rakitna, dove nemmeno la guerra ha mai messo piede. Lontano, le casette di Lukomir, il villaggio più alto della Bosnia, dove l’elettricità è arrivata solo da tre anni. L’inverno, lassù, dura sei mesi, e d’estate vi pascolano cavalli liberi. A nordest, la Roccia delle Vergini, con la sua triste leggenda balcanica. Quella di due giovani amiche, innamorate dello stesso uomo, che «si gettarono da una roccia per non farsi torto a vicenda». Dall’altro lato, la valle percorsa nel gennaio del ’42 dalla Prima Brigata Proletaria, in un’epica marcia contro i tedeschi. Samer è nato nel ’78, ma delle olimpiadi si ricorda benissimo. «Non nevicò fino alla vigilia, avevano chiamato l’esercito per fronteggiare la penuria. Poi, la notte, ne scese così tanta, che l’esercito fu mobilitato per sgomberarla. Mio nonno mi portò a vedere la discesa del bob. Erano astronauti, venivano giù come missili. Dieci anni dopo, in quello stesso luogo, la guerra si è portata via centinaia di uomini». Scende un po’ di nevischio, al rifugio — costruito da soli tre anni — hanno acceso il caminetto e sfornano micidiali frittelle al kajmak, un mascarpone di tradizione anatolica. Incontro Darko, un fan della Bjelasnica. Ci andava sempre lassù, prima della guerra. Poi una pallottola gli ha massacrato un ginocchio e addio montagna. «Da allora — ghigna addentando una sigaretta — non pianifico più nulla». Esce la luna, passiamo sotto la moschea in legno che ricorda i caduti dell’Igman, poi è di nuovo Sarajevo, con il suo odore di camini accesi e carbone solforoso, l’aeroporto, la periferia ovest, la più martoriata. Fa meno dieci, un gruppo di anziani beve birra all’aperto, in piedi attorno a un gran fuoco. Riprende a nevicare fitto e fine, le macerie si vestono da sposa. Nella birreria “Hs”, dove una granata provocò una strage, giovani a fiumi mandano a quel paese la memoria, i Balcani, la guerra. Fuori da una taverna di Skenderija due innamorati si baciano su una scalinata in pietra. Quando usciamo, un’ora dopo, sono ancora lì, incollati nel gelo. Sarajevo, la leggenda continua. FOTO RIKARD LARMA/AP S SARAJEVO La gente di Sarajevo torna a fare sport sulle piste olimpiche del 1984, riaperte dopo la guerra. Qui il dislivello è assassino: per quattro anni quelli in alto hanno ammazzato quelli in basso, se sali trovi piazzeforti e se scendi un arcipelago di camposanti ma tutto cambia: polizia, alfabeto, le distruzioni che cessano. È sempre intatto il nido del cecchino. Non c’è nessuna bandiera, ma un market-duty free sta lì al passaggio tra i due mondi. Un monumento all’ipocrisia di Dayton, la cosiddetta pace che ha ibernato la divisione della Bosnia. Jahorina, oggi, non è più la montagna olimpica di Sarajevo. È solo la «montagna serba». Arrivi sull’altopiano e la vista si spalanca su pascoli e foreste. Il cartello in cirillico dice «Pale», il quartier generale del super ricercato Radovan Karadzic. Il luogo dove è stato concepito il peggio del peggio, l’urbanicidio, è un agreste villaggio con covoni, casette di vacanza, contadini ed ex combattenti in libera uscita. Qui nacque “Vucko”, il lupetto di pelouche con sciarpetta biancorosso-blu che fece da mascotte ai Giochi del 1984. Oggi è solo la tana del lupo, ancora sorvegliata dalla polizia internazionale. Gli americani la chiamerebbero «paese-canaglia». Sali ancora e a 1200 metri, oltre un bosco di abeti smisurati, ecco la sorpresa. La Serbia primitiva scompare, e ti trovi davanti un circo di impianti e piste di funzionalità austriaca. Niente più cirillico sulla segnaletica e sui menù, gatti della neve in funzione, maestri di sci e camerieri depurati da ogni scoria di rudezza balcanica. Una pacchia da 16 euro al giorno, il costo dello ski-pass. All’hotel “Dva Javora”, grandi vetrate e legno di pino, senti Sole mio con Pavarotti e ti scodellano spaghetti al dente. Venghino venghino signori. Croati, sloveni, musulmani che importa. Il denaro non puzza. Ti chiedi se quella appena finita sia stata un’illusione ottica, una guerra dei bottoni. Tutto è perfetto, tranne una cosa. Per venire qui è meglio non avere memoria. Se ce l’hai, sei fregato. Vedi la scritta «Wanted» sopra ogni casa. Ti disturba che la gente si diverta e persino che le case siano intatte. Ti chiedi se il proprietario della seggiovia sia un criminale di guerra, oppure se lo chef che dà ordini secchi alla cucina del tuo risto- FOTO CORBIS PAOLO RUMIZ LA RICONQUISTA DELLA NORMALITÀ Nella foto grande, i colpi dei cecchini ancora visibili sulla struttura utilizzata per le premiazioni olimpiche. Sopra, caschi blu dell’Onu impegnati nella missione in Bosnia rante non abbia comandato con la stessa voce l’alzo dei mortai. Pensi ai conti in banca di Karadzic e della vedova di Zeljko Raznjatovic detto Arkan, costruiti sui furti della pulizia etnica. Difatti, metà Sarajevo non ci mette piede. Beca, una ragazza di 19 anni, è qui per la prima volta e non vuole più tornare. Dice: «Mi fa male pensare che in questo incanto sono accadute tante porcherie». Mustafa, un altro sarajevese, ghigna: «Qui tutto è in mano ai boss che hanno gestito prima la guerra di rapina e poi gli aiuti umanitari. La guerra è una merda ma anche la pace lo è. Non è cambiato nulla». Ma Samer, un venticinquenne che fa la guida escursionistica, spiega che a lui importa solo il paesaggio e la montagna. Ha passato due anni e mezzo senza uscire di casa, sotto le bombe, e ora ha fame di spazio, aria, luce. Mustafa è alto e biondo come tanti da queste parti, e sa che nessun serbo potrebbe riconoscerlo dalla faccia come musulmano. La discesa con lui da Ogorjelica, una delle cime più alte, è una lussuosa vertigine, senza code agli impianti e affollamento sulla pista. In basso distribuiscono fumante vin brulé alle prugne, gli alberghi all’ora di pranzo profumano di zuppa di cipolle. L’hotel “Bistrica”, che era un sogno, oggi è un rudere spolpato dai profughi, ma il resto luccica, funziona. La neve c’è e avanza, sui Balcani ne viene anche troppa, come in Abruzzo. Fa anche un freddo becco, appena una nube oscura il sole. Dalla Jahorina Sarajevo non si vede. È un oggetto di desiderio — o un senso di colpa — rimosso e lontano. Per vedere la città dall’alto devi uscire dal territorio serbo e andare sull’altra montagna olimpica, quella delle discese libere. Bjelasnica, 2067 metri, mitica, solitaria, rotonda e battuta dal vento. Bjelasnica della guerra partigiana e dei villaggi d’altri tempi, cima bella e maledetta dove si combattono i climi e gli eserciti. L’altra faccia della Luna, devastata dalle granate nella tremenda DOMENICA 30 GENNAIO 2005 le storie/2 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 29 Pallone e scienza Se Baggio avesse avuto i suoi consigli, l’Italia avrebbe vinto il Mondiale ’94. Chi poteva cambiare l’albo d’oro è un professore di fisiologia e biofisica, che da anni cerca il segreto del tiro infallibile. Ora giura di averlo trovato e ci sono squadre che pensano davvero di metterlo sotto contratto ERRORE DECISIVO Anno 1994, Pasadena. Lo sconforto di Roberto Baggio subito dopo il decisivo rigore sbagliato nella finale Italia-Brasile qui arriviamo a Usa ’94, Italia-Brasile: la schioppettata al cielo di Baggio, le lacrime di Baresi e, secondo la fisiologia del rigore, gli errori di Sacchi. Disse poi Baggio: «Non sentivo più le gambe». E Baresi rientrava dopo un’operazione al menisco, non tirava da due anni, avendo sbagliato l’ultimo e decisivo in finale di coppa Italia contro la Juventus. Sacchi li mise nei punti chiave della sequenza: primo e ultimo. Dove andrebbero, dati alla mano, non solo i più precisi (e Baresi non lo era), ma quelli in migliori condizioni fisiche (nessuno dei due). Bastano pochi secondi per valutare l’acido lattico, nessuno lo fa. Baggio era sotto stress da settimane, stanco e imballato. Dagli studi di Ranvaud l’ultimo tiratore dev’essere un cinico, una iena. Non esattamente il Codino. Se proprio doveva tirare (avesse sbagliato un altro per lui che avrebbero detto di Sacchi?) allora per secondo, nel momento più rimediabile. Fuori Baresi, la sequenza slitta. Ma chi mettere nei punti cardine, primo e ultimo? La soluzione Ranvaud è questa: i più freschi. Quindi? Alla fine Evani, entrato da poco (che infatti segnò, ma per terzo). E per primo? Pagliuca. Motivazione: se lo alleni, un portiere è perfetto, sa più degli altri sull’avversario, lo mortifica, segna e va in porta con due mosse, scacco matto. Tutto è facile, dopo. Ma davvero anche il rigore è una scienza prevedibile? E se un tizio, da vaghezza punto, dichiara (e poi esegue): «Mò je faccio er cucchiaio?». GABRIELE ROMAGNOLI L In principio, la fisica L’uomo che studia i rigori è nato a Firenze e si è laureato in fisica a Oxford. Poi, dottorato negli Usa e ricerche all’Istituto Max Planck di Grenoble. Specializzato in campi magnetici intensi, ha finito per essere calamitato da quelli di calcio e per scovare l’intensità nel momento del rigore. Docente di fisiologia e biofisica all’università di San Paolo del Brasile, da quattro anni lo studia come fenomeno dell’attenzione. Valuta l’influenza dello stress, la percezione visuale del tiratore, la sua soglia di non ritorno, oltre la quale se cambia strategia zappa (Costacurta alla finale intercontinentale di Tokyo). Ha effettuato alcune curiose scoperte. Due su tutte. La prima: l’esistenza della macchia cieca per il rigorista. Volgarizzando: ognuno di noi ha un occhio dominante, poniamo il sinistro. Prendiamo un rigorista con quella condizione. Mettiamo che sia del tipo a ciclo chiuso, ossia di quelli che aspettano la mossa del portiere per mettere la palla dall’altro lato. Facciamolo correre verso il dischetto fissando il portiere, che s’inclina verso il palo alla sua destra. Il tiratore mira dall’altra parte ma, a due metri dalla palla, il palo sinistro scompare dalla sua vista, “risucchiato” nella regione in cui il nervo ottico esce dal globo oculare. Il tiratore non se ne avvede, ma ha perso un punto di riferimento e ha più possibilità di sbagliare. Per evitarlo occorrerebbe verificare l’occhio dominante dei rigoristi e reagire di conseguenza. Qualcuno l’ha mai fatto? No. Perché? Questa è la seconda scoperta del professor Ranvaud: nessuno (o quasi) prepara il rigore. Gli allenatori trascurano, gli attaccanti sono troppo presi da spot e vallette. Gli unici a provarci sono i portieri, infatti la percentuale di rigori parati sta aumentando. Di poco, perché essendo una punizione (massima) è concepita in modo da favorirne l’efficacia. Ogni giorno, l’allenamento Dalle interviste fatte a centinaia di rigoristi è risultato che non uno sa in quali zone i portieri sono più vulnerabili e che rapporto esiste tra velocità e precisione. I rigori rappresentano, nelle statistiche di Ranvaud, circa il 15 per cento dei gol segnati, decidono finali che spostano patrimoni e creano miti, eppure l’allenamento specifico è minimo. Nel momento della verità tutta la strategia di un allenatore pagato milioni per le sue scelte consiste nell’avvicinarsi a un capitano stanco e chiedergli: «Te la senti?». Quello, incapace di verità e presunta viltà, trotta nell’area piccola e tira “come gli viene”. Poi una città intera resta con la memoria sfregiata da una vangata del pur coraggioso Graziani. Quale rimedio? Come disse il giovane carioca: allenarsi di più. Ranvaud ha metodi specifici. Due su tutti: uno per i tiratori, l’altro per i portieri. Il primo parte dal principio per cui il rigore non è un gesto d’artista, ma da artigiano. Va provato e riprovato: cento volte alla fine di ogni se- FOTO LA PRESSE a storia non si fa con i “se”, ma se Arrigo Sacchi avesse portato con sé ai Mondiali del ’94 il professor Ronald Ranvaud, l’Italia li avrebbe (probabilmente) vinti. Adios al cliché “lotteria dei rigori”. Come disse a Ranvaud un giovane centravanti brasileiro: «Certo, ci vuole fortuna, ma ho notato che più mi alleno e più sono fortunato». Questa è la storia di una quadriennale ricerca, in cui la scienza è stata portata a 11 metri da una porta per misurare sguardi e riflessi, un milione di esecuzioni sono state catalogate, un migliaio vagliate millisecondo per millisecondo, sono stati ascoltati tiratori, portieri e allenatori. Alla fine è, anche, l’esito (segnato) di un duello tra il caso e la logica, la demistificazione del fatalismo per cui «Ho tirato dove mi veniva», «Mi son buttato dove mi sentivo» e , quindi, «Era destino». C’è una spiegazione, va da sé rigorosa, per (quasi) tutto. Esiste una fase oscura in ogni percorso e un punto di non ritorno per qualsiasi scelta. È possibile crescere, giungendo alla relativa perfezione. A questo punto, se il migliore dei tiratori possibili va contro il migliore dei portieri possibili, ossia una “forza irresistibile” incontra un “ostacolo insormontabile”, chi vince? La risposta arriverà, ma non saltate alla conclusione, occorre prendere la rincorsa, insieme con Totti e Palermo, Mihajlovic e, inesorabilmente, Roberto Baggio. L’uomo che scoprì il rigore perfetto duta, dichiarando dove si tirerà. Niente finte, ripensamenti, improvvisazioni. Una videocamera per misurare la velocità e rapportarla alla precisione, innescando le traiettorie ideali, da cui non deviare mai. Per i portieri, altra corvée: cinquanta tiri a destra e cinquanta a sinistra, dichiarati. Scopo del gioco: quando in partita l’attaccante prenderà la rincorsa, il cervello del portiere avrà registrato inconsciamente i movimenti visti cento volte di uno che tira a destra o a sinistra e Il segreto: una macchia cieca che distrae il bomber durante la rincorsa darà al corpo il suggerimento opportuno. Altroché la suggestione para-normale: «Mi sono buttato dove mi sentivo». Quel pomeriggio, Baggio Un po’ di ortottica e tanta pratica posson bastare? La risposta di Ranvaud è una sfida (che ha attirato l’interesse di alcuni club, tra cui il Liverpool): «Datemi una squadra per un mese prima di un torneo. Se va ai rigori contro un’altra che non ha avuto la stessa preparazione, vince». E All’improvviso, il cucchiaio Di tutti i modi in cui battere un rigore il cucchiaio (palla colpita sotto e spedita al centro) è il più irrituale. Totti-gol contro l’Olanda nella semifinale degli Europei 2000 è l’esempio che tutti ricordano (il suo “negativo” è Totti contro il Lecce, che imbocca l’immobile portiere Sicignano). In apparenza il gesto sembra un azzardo assoluto. In realtà, mettere la palla in mezzo non è folle come può sembrare. Quando il tiratore supera la soglia di non ritorno i portieri si buttano. Tutti quelli intervistati da Ranvaud l’hanno confermato. Perché, lo ha spiegato un brasiliano: «Dobbiamo mostrare impegno». Con precisione merceologica che sa di cicatrice d’esperienza ha aggiunto: «Altrimenti quei bastardi sulle gradinate ci tirano le pile delle radioline». La sola ragione per cui Sicignano non si buttò è che ci si poteva aspettare da Totti quella possibilità per chiunque altro remota. Anche il più accanito tifoso, benché carico di batterie, avrebbe capito, avesse incassato un tiro angolato, che l’immobilità non significava disinteresse. Dopodiché, il cucchiaio resta un episodio, non un modello. Infine, la perfezione In quei 50 nastri contenenti un milione di esecuzioni esiste quella giudicata perfetta. La partita è Fiorentina-Lazio, tredicesima di ritorno del campionato ’99-’00, poi vinto dai biancazzurri. Al dischetto va per gli ospiti Mihajlovic. Di fronte c’è Toldo. Il serbo lascia partire uno dei suoi missili terra-terra. Il portiere si distende in tutta la sua non comune lunghezza. Botta e tuffo scoccano all’unisono. Le mani di Toldo si protendono verso la palla che schizza con traiettoria angolata. Riesce a sfiorarla con la punta delle dita. Basta per deviarla: fuori. Dov’è la perfezione? Sta nel fatto che la Lazio ottiene, più tardi, un secondo rigore. Dare fiducia allo stesso tiratore è considerato un rischio. È la cosidetta “sindrome di Palermo”, dal nome dello sventurato attaccante argentino che detiene il record negativo: sbagliò tre rigori nella stessa partita. Mihajlovic se ne infischia e riprova. L’esecuzione è identica: missile terra-terra, Toldo che si distende all'unisono nella sua inusuale lunghezza, eppure stavolta non ci arriva: gol. Cos’è cambiato? A occhio nudo sembra che Mihajlovic abbia ripetuto il medesimo gesto. Ma quando il professor Ranvaud scompone la ripresa e ne conta i frammenti scopre che ne manca uno: il secondo rigore dura 17 millisecondi in meno, la palla viaggia a una velocità superiore del 7per cento. Mihajlovic ha accelerato la battuta, quel tanto che basta perché Toldo non possa arrivarci. Una macchina dotata di strumentazioni? No, un uomo che sa quel che fa. Ha talento, ma con la preparazione ne acquisisce il controllo. In definitiva quel gesto viene a dirci che, nel campo delle intense situazioni umane, una forza irresistibile, se gestita a dovere, supera un ostacolo apparentemente insormontabile. Benché la storia non si faccia con i “se” occorre aggiungere: se le viene concessa una seconda occasione. 30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA i luoghi DOMENICA 30 GENNAIO 2005 Città-palcoscenico Il primo ad innamorarsi di queste case scavate nelle grotte è stato il cinema italiano, poi è arrivato Mel Gibson. Ma i Sassi non sono un film, sono una specie di esperimento sociale con un gruppo di persone che ha deciso di provare a vivere nella storia. Con qualche ostacolo da superare Matera, i pionieri del passato EMANUELA AUDISIO O MATERA cchi pesti, occhi bui. Uno sopra l’altro, che ti guardano. Lanciandoti un’eternità di sassi, pietre, caverne. Senti che dietro a quei buchi, a quelle pupille nere, c’è una raucedine antica, un’architettura saggia. Il sangue della terra che continua a scorrere. Qualcosa di primordiale, che oggi è anche tuo, ma che tossisce in maniera moderna. I Sassi di Matera, primo luogo al mondo ad essere decretato «paesaggio culturale». Un centro abitato strano, con una novità immensa. Tremila persone che tornano a vivere in un c’era una volta ristrutturato: in grotte, cavità, case trogloditiche scavate nella roccia. Pioneri del passato. Gente che ha rifiutato il condominio, la casetta comoda, il garage, la macchina. Che preferisce i cunicoli, i dislivelli, salire e scendere ogni volta cento gradini, avere il tetto al di sopra di una strada, di una scalinata, pur di restare abbracciata agli avi. È buffo: in genere gli esperimenti, gli ecosistema, si tentano con gli strumenti della modernità, qui invece cercando di recuperare un ritmo di vita antico. Arrivano i pullman pieni di giapponesi, di australiani, di americani. Il film di Gibson, certo. Ma soprattutto la voglia di vedere come ha fatto l’uomo della caverna a cavarsela da solo e se è possibile farlo ancora oggi. Nello stesso ambiente, migliorato. Un record a bassa voce: 90 mila biglietti staccati per il circuito delle chiese rupestri. I Sassi di Matera hanno sempre meritato la maiuscola. Davanti a rughe fresche, sane, piene di futuro, ci si toglie il cappello. Tufo ossidato, grotte, rovine. Ma anche bellezza indelebile, originalità, nulla di artificiale. Caro marziano, ti scrivo, di case il cui tetto è la base dell’altra casa. Un West italiano, canyon medioevali, dove leggi la fatica dell’uomo, dove senti il fiato consumato. Dove la luce nello scavo era studiato: d’inverno i bassi raggi del sole arrivavano al fondo della grotta, d’estate invece non ne superavano l’ingresso. Il set perfetto per un tempo immobile, senza tempo, quasi metafisico. Ha scritto la sorella di Levi: «L’Inferno di Dante, come lo immaginavamo a scuola». Quando il sud nel set doveva venire arretrato, drammatico, misero, c’era Matera. Qui sono venuti i registi quando hanno avuto bisogno del Settecento (Il sole anche di notte), dell’Ottocento (Allonsanfan), di un paese basco del Novecento (L’albero di Guernica), di Gerusalemme (King David), di un’atmosfera fiabesca (C’era una volta) della Sicilia (La Lupa e L’Uomo delle stelle), di una terra sacra e drammatica (Il Vangelo secondo Matteo e La Passione di Cristo). Qui Lina Wertmuller girò I Basilischi, versione meridionale dei Vitelloni, con il suicidio ‘‘ ... mi misi finalmente a cercare la città. Allontanatami ancora un poco dalla stazione, arrivai ad una strada, che da un solo lato era fiancheggiata da vecchie case, e dall’altra costeggiava un precipizio. In quel precipizio è Matera. [...] La forma di quel burrone era strana; come quella di due mezzi imbuti affiancati... CARLO LEVI da “Cristo si è fermato a Eboli” freddo di una vecchia che prima di lasciarsi andare dal balcone fa segno a una bambina di stare zitta e di non dare l’allarme. Qui Pier Paolo Pasolini nel 1964 fece saltare una cava con una mina, qui Mel Gibson nel 2002 per simulare il sudore ha spalmato glicerina sul volto del suo Cristo. E dopo tre ore di discussione con padre Gavazzeni, che gli diceva di essere pronto a dare la vita per Gesù, ha risposto «Me too». «Io anche». Certi Sassi induriscono la fede. E fanno pensare che Kiefer nell’hangar della Bicocca con i suoi Sette Palazzi Celesti li ha reinventati di cemento. Matera è dal ’93 con i suoi rioni più caratteristici, il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano, nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Come recita una guida da viaggio inglese: «L’unico posto al mondo dove gli abitanti possono dire di vivere nelle stesse case dei loro avi di novemila anni prima». Per Sasso s’intende un quartiere scavato nella roccia, e qui i Sassi sono intagliati a ridosso di un profondo burrone, la Gravina. Se un grande architetto come Mario Botta si lamenta in generale dei progetti attuali perché «sono un disimpegno verso la storia, perché si abbandonano le città vere per farne delle false, perché manca la memoria e la stratificazione dei segni», si accomodi a Matera, dove appunto i Sassi stanno rinascendo, lontani da quella indifferenza che fece fermare Cristo ad Eboli. Allora, ai tempi del confino di Carlo Levi, le abitazioni erano promiscue e in molti casi ospitavano persone ed animali, non c’erano condotte per l’acqua corrente, né fognature. Le condizioni di vita erano drammatiche: se nel ’49 in Italia nascevano 112 nati morti su mille nati vivi, a Matera la cifre era quadrupla, 463 su mille nati vivi. «Una vergogna nazionale», decretò in visita Palmiro Togliatti. «Un trogloditismo di ritorno», sentenziarono gli antropologi. Insomma, uno schifo per tutti. Tanto che De Gasperi nel 1952 dopo aver fatto un giro in città, firmò la prima Legge Speciale per lo sfollamento dei Sassi. I due terzi degli abitanti furono costretti ad abbandonare 30 ettari di Sassi e a trasferirsi in nuovi rioni per decisione dello Stato. Era la prima volta che veniva presa una decisione così drastica. I più grandi architetti e urbanisti del tempo, tra cui Piccinato, Quaroni, De Carlo e Aymonino, vennero chiamati a progettare i nuovi quartieri della città che avrebbero accolto i 18 mila sfollati che non persero però le vecchie abitudini: coltivare il basilico nella vasca da bagno. Nacquero tre borghi rurali, La Martella, Venusio e Picciano, per alloggiare le famiglie dei braccianti. In cambio della nuova casa, gratuita, veniva espropriata la vecchia nei Sassi che diventava demaniale. Altri quartieri urbani furono costruiti nel pieno rispetto del Piano Regolatore, che Matera fu la prima ad avere nel meridione, a firma di Piccinato. Così Matera diventò una città viva con un centro storico morto. Poi i riflettori si spensero. La coscienza nazionale si placò, non c’erano più uomini che vivevano accanto agli asini. Nessuno ci mise più piede. I Sassi anche se ventre di uno stesso corpo erano un luogo oscuro da evitare, un peccato di cui DOMENICA 30 GENNAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31 I Sassi, teatro fossile del ritorno alla vita MARIO PIRANI LA PASSIONE DI GIBSON Il regista australiano Mel Gibson, che a Matera ha girato numerose scene del suo “The Passion” ha detto: “Alcune parti della città sono antiche di duemila anni e ricordano il paesaggio che doveva esserci in Giudea ai tempi di Gesù” Anche se qualche fico sul tetto si vede ancora. Ha scritto su Matera prima del risanamento attuale Cesare Brandi: «Vivi che vivono nei sepolcri di grotte murate senza quei dannati ferri battuti che hanno ridotto le vie di Assisi come una donna vecchia e artefatta». Silvia Padula, sovrintendente al patrimonio artistico e storico di Matera, sottolinea: «Facendo richiesta al comune, si ha gratuitamente in concessione per 99 anni un immobile nei Sassi, a condizione che lo si risani, e dei soldi per la ristrutturazione, una cifra che va dal 40 al 60 per cento è data dallo Stato a fondo perduto. Una parte dei Sassi sta trasformandosi in sistema museale: della civiltà contadina, demo-antropologico, circuito delle chiese rupestri, mostre d’arte. Palazzo Lanfranchi, primo assegnamento scolastico di Giovanni Pascoli, è un centro che lavora bene. Questo è un pezzo di sud lontano, nascosto, ma legale. Santa Lucia alle Malve è stata la prima chiesa rupestre restaurata mantenendo gli affreschi in loco. Ora abbiamo il problema della manutenzione, delle fluorescenze, nonostante i bioacidi, perché l’afflusso dei turisti rovina gli affreschi». Michele Morelli, assessore alla cultura, di Rifondazione, parla di 150 mila presenze di visitatori l’anno, con un aumento del 30-40 per cento. I Sassi stanno lì: nudi e belli, abitati. Ma da fuori il paesaggio sembra un Truman Show dell’antichità, non senti voci, non vedi un pallone tra i vicoli, nessun bambino che si azzuffi, mancano le chiacchiere domestiche. Tutto magnifico, ma dov’è il rumore imperfetto della vita? La sensazione è quella di un museo I all’aria aperta. Di un presepe per raffinati cultori di atmosfere.Vendesi tour nella Las Vegas dell’antichità:3.012 abitazioni, di cui 665 con ingresso al di sotto del piano stradale a cui si accede solo da botole, 1672 con accesso al livello del piano, 362 con ingresso sopraelevato al piano stradale, 307 al primo piano e solo 8 al secondo. Oltre la metà, 1645, interamente scavate nella roccia. Prego notare il sistema di ventilazione naturale delle grotte che serviva ad eliminare l’umidità, e in più la capacità di raccogliere acqua piovana. Chi è tornato ad abitarci è una generazione tra i 40 e 50 anni, fortemente motivata a livello intellettuale, decisa a restaurare la casa dei nonni e a conservare la propria anima. L’architetto Mattia Antonio Acito, che ha appena vinto a Monterey, in California, un progetto di sostenibilità sociale con un modello (senza auto) ispirato a Matera, è stato tra i primi nel 1983 a scegliere di abitare i Sassi. Dice: «Ci vuole tempo, perché questo diventi anche un laboratorio sociale e non solo architettonico. Vedremo come reagiranno i nostri figli all’essere cresciuti in un ambiente senza macchina, con i marciapiedi sconnessi, sottobraccio alle pietre del passato. Vedremo se un giorno la scelta che noi abbiamo fatto anche per loro sarà vissuta come propria e non imposta. Se la vita reale si insedierà nei Sassi e se la palla di un bambino rimbalzerà su questi gradini, come in un qualsiasi vicolo di città. Noi abbiamo riacceso le luci, ora deve arrivare la gente». E il rumore del pallone che rimbalza, del vetro che si rompe, del ragazzo che fugge, della parolaccia che segue. FOTO TOMMASO BONAVENTURA/CONTRASTO pentirsi, una vergogna del passato. Una cisti, una brutta malattia da nascondere. Per più di 35 anni chi ci era nato e cresciuto non tornò più a vederli. Ora invece l’imbarazzo è quello di aver abbandonato una parte della propria storia. Ora c’è voglia di tornare ad accarezzarla quella storia, di frequentarla, di rivitalizzarla, di farsi perdonare il tradimento così sciocco. Renato Donno, 76 anni, convertitosi nel ’97: «Io sono uno di quelli che aveva voltato le spalle ai Sassi, poi ho capito, li ho amati e li ho scelti. Adesso ci vivo, felice. È grazie a noi privati, se stanno rinascendo. Non mi frega se mi devo arrampicare sui gradini, se non posso usare l’auto, se devo scarpinare per buttare l’immondizia. Mi piace qui, c’è silenzio, nessuno mi rompe l’anima». I Sassi sono tornati di moda, come certi cactus, splendidi nella loro solitudine. Molto ha fatto l’architetto Pietro Laureano nel sottoporre all’attenzione internazionale la diversità dei Sassi. Hollywood non spinge masse di turisti, ma incoraggia. Ciak: il regista Francis Ford Coppola è nato a Bernalda, a 30 chilometri da qui. Matera, Basilicata è un sud composto, non troppo disgraziato, a bassa criminalità, anche se l’industria dei divani è in crisi e Barilla chiuderà il pastificio nel 2006. Sui Sassi si investe, sono un mattone antico, si recuperano: alberghi, bar, locande (anzi bed and breakfast), pizzerie, ristoranti, negozi di artigianato, abitazioni. Le case si travestono da loft antichi, ampi spazi su vari livelli, volte a non finire. Tutto diventa carino, più gentile, meno selvatico, quasi una Todi del sud. l mio rapporto con la Lucania si dipana lungo l’arco di lettura di due bellissimi libri. Il primo, oggi reperibile solo in antiquariato, si chiama Paese lucano. A cura di Leonardo Sinisgalli e del fotografo Mimmo Castellano, venne edito nel 1965 da Amilcare Pizzi a Milano sotto il patrocinio dell’Eni, di cui dirigevo allora l’ufficio stampa. Mattei era già morto da tre anni ma la sua politica, in cui rientrava una connessione intelligente tra industria e cultura, non era andata del tutto dispersa. Per questo venne accolta l’originale idea di Sinisgalli di celebrare l’entrata in produzione di un grande stabilimento chimico a Pisticci con un libro strenna, che nulla aveva a che fare con la tematica industriale ma servisse, invece, come testimonianza ultima di una civiltà agreste in rapidissima disparizione. Sinisgalli, nativo di Montemurro, un paesino di quella regione allora sperduta, oltre il Vallo «dove Cristo si era fermato», era noto come raffinato poeta e poligrafo e altresì ingegnere. In questa poliedrica veste aveva fondato e diretto una rivista dell’Iri, di grandissimo prestigio — Civiltà delle Macchine — prima di essere chiamato da Enrico Mattei ad ispirare la pubblicità dell’Agip. Il volume era scandito da poesie di poeti lucani, a cominciare da Sinisgalli e da Rocco Scotellaro, che accompagnavano le straordinarie fotografie di Castellano, immagini e luoghi, a cominciare dai Sassi, di volti, di oggetti antichi, di ex voto, di squarci ultimi di vita di paese destinati a sparire. Non vi è dubbio che gli autori volevano fissare nel verso e nella foto l’istantanea estrema di un trapasso senza ritorno. Recita Sinisgalli: «Al pellegrino che s’affaccia ai suoi valichi, /... all’emigrante, al soldato, / a chi torna dai santuari o dall’esilio, / a chi dorme negli ovili, al pastore, al mezzadro, al mercante / la Lucania apre le sue lande, / le sue valli dove i fiumi scorrono lenti / come fiumi di polvere. / Lo spirito del silenzio sta nei luoghi / della mia dolorosa provincia... /... cumuli di macerie restano intatti per secoli: / nessuno rivolta una pietra per non inorridire. / Sotto ogni pietra, dico, ha l’inferno il suo ombelico...». Sono passati quarant’anni ma le cose non sono andate, almeno in parte, come il poeta temeva. Per uno di quegli inattesi miracoli che la storia compie quando meno lo si aspetta, sotto quelle pietre non ci celava l’ombelico dell’inferno ma il segreto della rinascita. La sorprendente metamorfosi è narrata in un secondo libro: Giardini di pietra. I Sassi di Matera e la civiltà mediterranea (edizione Bollati Boringhieri) scritto dall’architetto Pietro Laureano. Ne ho già parlato su queste colonne (I Sassi di Matera nell’età del chip, Repubblica 15 novembre u. s.) per indicare come il recupero in chiave futuribile del passato abbia rappresentato l’elemento propulsivo non del tutto espresso ma potenziale di una rinascita basata sulla ricchezza agrorupestre del Materano. Il nesso più significativo di quest’originale rapporto tra passato presente e futuro è Ipogea, un centro di alta qualifica che dalla città lucana procede, per conto dell’Onu e dell’Unesco, all’inventario su scala mondiale delle conoscenze tecniche tradizionali e ai progetti sul loro possibile uso innovativo. Scrive Laureano: «Basta affacciarsi oltre la passeggiata del corso principale di Matera per trovarsi immersi in un mondo alieno, primordiale, dove passato e presente, natura e conoscenza s’incrociano e confondono in uno scenario grandioso. E siamo in Italia, in una moderna cittadina del Sud, dentro il cuore pulsante dell’Occidente. L’importanza dei Sassi e della Gravina è dovuta al perpetuarsi dei principi su cui si fonda la pratica insediativa per un periodo lunghissimo dalla preistoria fino al secolo XVIII». Il libro prosegue raccontando la decisione del 1950 di dislocare gli abitanti dei Sassi nei nuovi villaggi del circondario per porre fine a quella che era considerata «una vergogna nazionale». L’espulsione fu «un fenomeno comparabile all’abbandono improvviso delle grandi capitali precolombiane... E l’ultima grande diserzione urbana della storia. Una città fino a quel momento abitata e viva, sotto la pressione di uno shock culturale e violento, è rapidamente svuotata. Le strade divengono mute, le luci si spengono, tutte le case vengono forzatamente murate... I Sassi divengono il più grande centro storico abbandonato che si conosca». Infine la cronaca avvincente del ritorno: «E’ sera, nei Sassi si accendono le lampade di case nuovamente abitate... Nel corpo fossile di questo teatro del mondo, in cui sparisce la differenza tra palchi e scena, attori e spettatori, dove tutte le età sono contemporanee, rifioriscono i giardini di pietra, torna la vita a rappresentare la millenaria vicenda umana». 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 GENNAIO 2005 Il progetto urbanistico è pronto, il concorso lo ha vinto l’architetto inglese Norman Forster: su tutto il Distretto dei Musei sarà sospeso un cielo di plastica trasparente che garantirà un perfetto microclima. La posta in gioco sono 40 ettari di lungomare in uno degli angoli più costosi del pianeta. Guggenheim, MoMA, Beaubourg, Victoria and Albert sono pronti ad esportare il loro“know-how” La MuseoLand di Hong Kong I HONG KONG l piano è così ardito da sembrare stravagante. Trasformare Hong Kong, questa città di mercanti bische e finanzieri, da «paradiso di capitalisti filistei», nella capitale culturale dell’Asia? Nella Cina di oggi tutto sembra possibile, e anche questo progetto attira attenzioni speciali. Il Beaubourg e il MoMA, il Guggenheim e il Victoria and Albert Museum sono mobilitati per conquistarsi uno spazio sul mercato asiatico, in una operazione che non ha precedenti. Il segretario agli Interni Patrick Ho la collega idealmente alle visioni sociourbanistiche della New Geography elaborate da teorici come Joel Kotkin: «L’economia globale un tempo era fondata sullo Stato nazione ma ora si evolve verso il primato delle città-regioni. I gangli vitali del pianeta si concentrano in non più di trenta città-regioni. Sono quelle che hanno accumulato un dinamismo culturale e un pluralismo così forti da attirare i capitali e le nuove élite professionali urbane, ingredienti essenziali per vincere nella competizione globale». Qui a Hong Kong i capitali non sono mai mancati; in quanto all’élite professionale, in passato doveva stabilirsi qui per forza chi voleva occuparsi della Cina e al tempo stesso godersi gli agi della modernità, cominciando dalla “rule of law” cioè lo Stato di diritto. Ora la rendita di posizione sta scomparendo e la rinascita di Shanghai sottrae linfa vitale alla ex-colonia britannica. A Hong Kong non rimane che sfruttare ciò che ancora la distingue: la libertà. L’assenza di censura e di un potere centrale totalitario, la circolazione delle idee, la società civile multietnica. Di qui la decisione — inaudita per quest’isola di banchieri che non ha mai avuto un museo appena decente — di lanciare un investimento massiccio nella cultura. Per sprigionare verso la Cina continentale e verso tutta l’Asia quell’attrazione che hanno da noi Parigi Londra e New York, con la loro ricchezza di esposizioni, teatri, orchestre. Non ci si improvvisa per decreto città d’arte, la vocazione di Parigi è il frutto di una storia; ma Hong Kong è convinta che nell’era della delocalizzazione anche il know how culturale è esportabile: dopo Disneyland vuole far nascere una MuseoLand subappaltata in franchising alle più grandi istituzioni culturali e artistiche del mondo occidentale. Naturalmente Hong Kong rimane se stessa, per avere finanziatori questo progetto poggia su una speculazione edilizia importante che interessa i tycoon dell’isola come Li Ka-shing. Questo aspetto suscita controversie, e l’amministrazione di Hong Kong ha dovuto aprire un’ampia consultazione con la cittadinanza. La posta in gioco: 40 ettari di lungomare in uno degli angoli più cari del pianeta, sulla penisola di Kowloon tra il Victoria Harbour e Canton Road, sono all’asta al migliore offerente. Èun magnifico tratto urbano di costa che dalla terraferma guarda verso la Discovery Bay e quindi il mare della Cina meridionale. Chi lo avrà potrà costruirci e gestire per trent’anni palazzi residenziali di lusso, grattacieli per uffici, alberghi e shopping mall. A condizione di riservare 315mila metri quadri al futuro Distretto Culturale di West Kowloon: quattro musei di 75mila metri quadri, tre teatri da tremila spettatori, un auditorium da 10mila posti, un padiglione per esposizioni itineranti, un anfiteatro sull’acqua. Il progetto urbanistico è già pronto e anche questo non è banale. Il concorso internazionale lo ha vinto l’architetto ingle- se Norman Foster che fra i suoi tanti lavori ha firmato il Carré d’Artdi Nimes, il nuovo Reichstag di Berlino e il Millennium Bridge di Londra, ma soprattutto due fra le opere più belle di Hong Kong: in centro il grattacielo della Hong Kong Shanghai Bank of China, e a Lantau il nuovo aeroporto Chek Lap Kok. A 70 anni Foster vuole coronare la carriera con il progetto di Kowloon, la più audace delle sue creazioni: su tutto il distretto culturale sarà sospeso un “cielo” di plastica trasparente, come un immenso baldacchino etereo, morbido e poroso, che sposa tutte le cur- ve degli edifici. Il “cielo” da solo costerà 400 milioni di euro, ma servirà ad avvolgere tutto il distretto nell’intimità di un ambiente a misura d’uomo, e anche a garantire gradevoli passeggiate fra i musei in un microclima riparato sia dall’afa estiva che dagli scrosci dei monsoni tropicali. Foster è convinto che il suo cielo sinuoso adagiato sul West Kowloon Cultural District diventerà il luogo-simbolo di Hong Kong come la torre Eiffel per Parigi o il Golden Gate a San Francisco. Per inventarsi una città-museo, calaFOTO CORBIS FEDERICO RAMPINI GUGGENHEIM Il Solomon R. Museum di New York progettato da F. L. Wright. É la più completa documentazione dell’arte europea e americana del dopoguerra VICTORIA AND ALBERT Londra, la costruzione (1899-1909) si deve a Sir Aston Webb. Il primo finanziamento per il Museo ammontava a 186mila sterline MOMA Fu fondato nel 1929 a New York. Le risorse si devono a tre signore: Lillie P. Bliss, Mary Quinn Sullivan e Abby Aldrich Rockefeller BEAUBOURG Il Centre Georges Pompidou è firmato da Renzo Piano e Richard Rogers: centomila metri quadrati nel centro della capitale francese DOMENICA 30 GENNAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 LA PENISOLA La penisola di Kowloon, tra il Victoria Harbour e Canton Road, affacciata sulla Discovery Bay e sul mare della Cina meridionale, è uno dei terreni urbani più costosi del pianeta. Ora quaranta ettari di questo pregiatissimo lungomare sono all’asta, tra vivaci polemiche, per costruirci sopra palazzi residenziali, grattacieli per uffici, alberghi, shopping mall e, in cambio, la futura MuseoLand di Hong Kong FOTO REUTERS mita di un nuovo turismo intellettuale, Hong Kong rimedia all’inesperienza con una scorciatoia che non si sa se definire post-moderna o coloniale. I costruttori in lizza per aggiudicarsi il progetto devono allearsi con grandi musei stranieri, che garantiscano di costruire e gestire la nuova città dell’arte nel cuore dell’Asia. Quest’idea di trasportare musei da un angolo all’altro del pianeta raccoglie una tendenza già in forte sviluppo. Il Guggenheim è diventato una multinazionale che clona modelli di museo esportando un know how collaudato nell’organizzazione di grandi mostre: dopo New York e Venezia c’è stato Bilbao, e poi a ruota San Pietroburgo, Berlino e Las Vegas. Il Boston Museum of Fine Arts ha aperto una succursale a Nagoya, Giappone. La Tate Gallery si è allargata a Liverpool e poi si è sdoppiata con la Tate Modern nella stessa Londra. I dirigenti del Guggenheimhanno già le idee chiare su Hong Kong. Oltre a farne la tappa asiatica privilegiata per le grandi esposizioni itineranti dall’Occidente, gli americani puntano ad agganciare per primi il grande risveglio della Cina, sia nel recupero di un patrimonio antico ancora mal valorizzato, sia nell’esplosione di creatività degli artisti di avanguardia. «La storia culturale di questa parte del mondo è immensa — ha dichiarato al New York Times il direttore della Fondazione Guggenheim Thomas Krens — e il centro dell’arte contemporanea non è necessariamente New York. Per la dimensione e la collocazione il distretto culturale di Kowloon è la più eccitante opportunità del mondo». I rivali storici del business americano dei musei privati in franchising sono i francesi, con i loro grandi musei ancora sotto il controllo dello Stato. Tuttavia anche la Francia è in gara per creare e gestire il distretto culturale di Kowloon. Il presidente Jacques Chirac si è impegnato personalmente in un’offensiva diplomatica. Dopo aver proclamato l’anno della cultura cinese in Francia, alla sua visita di ottobre a Pechino Chirac ha aggiunto appositamente una tappa finale qui a Hong Kong. Nell’isola ha portato in prestito la Parade di Picasso, e alla fine ha presentato alle autorità locali la sua richiesta: che almeno uno dei musei di Kowloon sia affidato in gestione al Centre Beaubourg- Le vetrine dell’arte-merce e il felice ritardo dell’Italia SALVATORE SETTIS FOLLA E TRAFFICO Scene di folla al mercato e di traffico nelle strade di Kowloon, la zona sulla baia di Hong Kong destinata ad ospitare la nuova MuseoLand ‘‘ tendenza Su una città-limite si innesta quella tendenza alla delocalizzazione dei musei che dà mille avvisaglie FOTO ZEFA A che serve un museo a Hong Kong, terra doppiamente bruciata, dal colonialismo e dalla speculazione edilizia? Ovviamente a intrattenere (entertainment), forse a educare (education), o a tutt’e due (edutainment). Ma edu-intrattenere chi? Evidentemente, non i cittadini ma le volatili folle di viaggiatori per affari o per turismo. S’innesta così sul tessuto di una città-limite quel movimento alla delocalizzazione dei musei che sta dando mille avvisaglie. Fallito (per ora) il progetto di fare del Guggenheim una sorta di meta-museo con tante sedi (cioè senza sede), e le opere in perpetuo viaggio, si parla di aprire qua e là «vetrine» dei maggiori musei del mondo. Non bastano più le mostre, dove vengono esposte singole opere, ma anche ampie scelte (per esempio, capolavori dell’Hermitage), badando sempre meno ai danni che possono venirne (per esempio ai dipinti su tavola). Presto vedremo una sezione del Louvre a Kyoto, un pezzo del British Museum a Brasilia, un segmento dell’Hermitage a Canberra? Il museo è travolto, volente o nolente, da un movimento mimetico verso le regole del mercato. Girano le merci, cadono i confini. Anche per le opere d’arte, tende a cadere il confine fra quelle sul mercato (che seguono i destini, e gli indirizzi, degli acquirenti) e le opere museificate che, in quanto «fuori mercato», sembravano più sedentarie. Ma anche le opere in museo sono sempre meno al sicuro: i musei americani (per esempio il MoMA) vendono alla chetichella qualcosa, magari per acquistare qualcos’altro. Per un residuo di pudore, non si usa la parola «vendita», ma l’eufemismo de-accessioning: proprio come (commenta H. Zerner) uccidere dei civili in guerra si chiama ormai collateral damage. La «vetrina» di un museo in un’altra città servirà a invitare i giapponesi a Parigi e i brasiliani a Londra, o prelude a una fase ulteriore, in cui «vetrina» non sarà più una metafora ma (letteralmente) una campionatura di merce in vendita? C’è da temerlo, quando si sente dire che a questi musei-dépendance andrebbero destinate le opere «minori», quelle che nella concezione scientifica del museo vanno esposte a rotazione e devono essere visibili nella study collection come in quella, esemplare, della National Gallery di Londra. I musei italiani sono i più restii del mondo ad adeguarsi a questo trend, e per due ragioni, una cattiva e una buona. Prima la cattiva: perché i nostri musei sono ingessati in una crescente paralisi istituzionale, nel triangolo delle Bermude fra Stato, regioni e privato, e mostrano in genere scarsa capacità progettuale. La buona ragione è che i musei in Italia, più che in qualsiasi altro paese (tranne forse la Grecia), sono, persino quando accolgono collezioni private, espressione assai più del territorio che del mercato. Perciò il nostro sistema di tutela prevede le Soprintendenze, che tutelano sia il Caravaggio in chiesa che quello in museo (pessima idea scardinare questa essenziale unità coi “poli museali”). Perciò opere «alte» e «basse», nel museo e fuori, in Italia si legano in un tessuto organico, e spezzarlo vuol dire impedirsi di capire. Se mai gli Uffizi, Capodimonte o l’Accademiadi Venezia dovessero aprire una «vetrina» a Hong Kong, non dovrebbe essere per contribuire alla moda dello sradicamento delle opere d’arte, della loro mercificazione sotto la dubbia bandiera dell’«arte per l’arte», ma solo per trasmettere e diffondere, con coscienza e con orgoglio, il modello italiano della conservazione contestuale, del nesso forte fra musei e città, del legame essenziale fra patrimonio culturale e cittadinanza. Sarebbe, se ne avessimo la capacità, una bella sfida. Georges Pompidou. Ha gettato sulla bilancia il fatto che il Beaubourgpuò fare arrivare in Cina anche opere in prestito dal Louvre. Sarebbe la prima volta che un museo di Stato francese crea una filiale in terra straniera. Parigi ne fa una questione di prestigio nazionale, e naturalmente anche di battaglia politica contro l’egemonia culturale americana nel mondo. Sono volati giudizi pesanti. «Per il Centre Pompidou sarebbe il primo ed unico progetto all’estero — ha detto il suo direttore Alfred Pacquement — noi non apriamo filiali come fossero fabbriche della Coca Cola». Il soprintendente del Beaubourg Alain Sayag ha rincarato la dose definendo il Guggenheim «un museo di seconda classe». La curatrice dell’arte contemporanea, Camille Morineau, ha contestato il ruolo dei privati: «Sono bravi a far pagare cari i biglietti d’ingresso, e a vendere cataloghi costosi. Ma se si tratta di prendere rischi, di fare scelte coraggiose e impopolari, sono i musei pubblici a osare di più». A sorpresa poi il Beaubourge il Guggenheim hanno finito per coalizzarsi, con una dichiarazione d’armistizio consegnata dal Consolato francese di Hong Kong. I due ora puntano a spartirsi il distretto culturale di Kowloon partecipando con lo stesso gruppo di costruttori edili privati (Dynamic Star International). L’irresistibile attrazione cinese è riuscita perfino a realizzare il miracolo di un’alleanza francoamericana. Perché nel frattempo le cordate concorrenti hanno ingaggiato altre due rispettabili istituzioni: il Museum of Modern Artdi New York (MoMA) e il Victoria and Albert Museumdi Londra. Tutti convertiti all’idea di esportare il proprio know how aprendo succursali nel vecchio porto d’ingresso degli occidentali in Cina. Il professore Cheung Bing-leung della City University di Hong Kong non è affatto persuaso: «Possiamo anche darci dei musei di classe internazionale, dei grandi teatri e delle esposizioni dal resto del mondo. Ma ancora non abbiamo risposto alla domanda più elementare: quali arti e quale cultura vogliamo sviluppare con l’impronta di Hong Kong?». In fondo l’operazione del Distretto culturale di Kowloon è già riuscita nel passato ad alcune città americane come Chicago e Dallas: pur avendo una storia giovane, le loro ricchezze hanno consentito di costruire grandi musei con opere dal resto del mondo. La Cina però ha una civiltà più antica di quella greco-romana. Forse scavando con più coraggio in quel passato Hong Kong potrebbe dare una risposta alla questione della sua identità. Ci guadagneremmo tutti qualcosa. L’alternativa è un mondo in cui viaggeremo trovando gli stessi Matisse e Van Gogh esposti a rotazione in ogni continente, come oggi il caffè Starbucks ci aspetta nella Città Proibita. 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 GENNAIO 2005 Il 3 febbraio di quarantacinque anni fa muore a Roma in un incidente, mentre rientra in albergo sulla sua Thunderbird rosa decappottabile, il più americano dei cantanti italiani. Due milioni di lire a serata, il sogno a colori dell’Italia in bianco e nero, è stato l’interprete di gioielli come “Eri piccola”, “Che bambola!”, “Teresa non sparare”. Iniziava la corsa economica, l’era del frigorifero e della Cinquecento. Che lui raccontava giocando con lo swing PINO CORRIAS F Buscaglione red Buscaglione è un duro alla boia fauss. Vagabondo di cuore e romantico di sguardo. Dondola le bionde foderate di lamé. Canta dentro al fumo delle sigarette. Fronteggia Buck la Peste, Jack Bidone e Billy Karr. Ha un sinistro da un quintale. Vince al tressette. Indossa smoking. Ha la mimica, ha la sagoma. Ha la voce rauca. Respira Gauloises e qualche volta lacrima Cutty Sark. È senza duplicato. È un duro. È inimitabile. Ferdinando Buscaglione è un giovanotto dritto, magro e allampanato. Nato nel gelo della portineria di piazza Cavour 3, Torino, il 23 novembre del 1921. Timido di sguardo e fragile di cuore. Solfeggia la musica, ubbidisce alla mamma. Tifa Juventus, è un po’ monarchico, suona il violino. Parte per la guerra. Finisce in Sardegna a fare musica con gli Alleati. Gli piacciono Frank Sinatra e Gilbert Becaud. Beve Dolcetto, fuma Alfa. S’è innamorato di una sola donna, Fatima Robbins, pescata al Cécile di Lugano, acrobata e cantante, con sangue marocchino nelle vene e il coltello della gelosia nella borsetta. L’uno e l’altro, Fred e Ferdinando, all’alba di mercoledì 3 febbraio 1960, corrono lungo via Paisiello, Roma, dentro ai sedili in pelle di una solitaria Ford Thunderbird rosa, decappottabile. La Thunderbird ha i parafanghi cromati e gli interni crema. Viaggia a 100 chilometri all’ora. Ha navigato tra via Margutta e i night di via Veneto, ora sta filando verso il Rivoli Hotel dei Parioli. Sono quasi le 6.20. Mancano dieci incroci all’alba. L’uno e l’altro, Fred e Ferdinando, la maschera e l’anima, il duro e il morbido, non sono mai stati così distanti tra loro, così separati dentro alla stessa pelle. Anche se il re della criminalsong e il cantantino di balera torinese, emanano una sola luce, sono la star dei nuovissimi Anni Sessanta: ecco a voi Fred Buscaglione, il cantante dell’anno, 2 milioni di lire a serata, il sogno a colori dell’Italia in bianco e nero. La luce è un riflettore. Lo ha acceso il successo di quegli strani sketch musicali che suonano dentro la scatola magica del televisore, lungo gli ingranaggi americani del juke box, e in un milione di dischi già venduti, che fanno scintillare, a 78 giri, gioielli tipo Eri piccola, Porfirio Villarosa, Teresa non sparare. È l’alba del Boom, l’inizio della grande corsa economica italiana, la fatica rurale che diventa fabbrica, l’era del frigorifero, dell’automobile, della plastica, del sogno americano. Nilla Pizzi porta fiori esangui. Il grande Fred li raddrizza dentro al whisky. Modugno vola nel blu. Lui atterra nel jazz. Canta il cielo dei bar. Gioca con lo swing. Si porta dentro la verità della gavetta, gli spigoli della strada, e l’immaginazione di Leo Chiosso, altro torinese di ballatoio, ma con il genio del racconto in due righe, un bacio, una promessa, uno schiaffo, un addio. Leo Chiosso ha un anno più di Fred. Ha studiato da avvocato, ma ha letto tutt’altro, i romanzi di Dos Passos, i gialli di Mickey Spillane e di Damon Runyon. Conosce la malinconia di Philip Marlowe. Ha visto i musical di Fred Astaire. Inventa storie di bulli e pupe ambientate alla Viscosa. Oggi che ha 84 anni e sta scrivendo il libro della vita I giorni di Fred, racconta: «Lui aveva questa faccia alla Clarke Gable. Gli Fred, Ferdinando e il Boom IL PERSONAGGIO A destra, Buscaglione in uno scatto del ’59. Sotto, una scena di “Noi duri” con Totò e Linda Sini. Nella foto grande, il musicista al Covo di NordEst, storico locale di Santa Margherita Ligure mancava la brillantina e un po’ di Be Bop. Eravamo giovani, tutto ci sembrava a portata di mano, compresi i sogni. Fred ci mise il pianoforte, io l’America». All’inizio c’è solo il Dopoguerra. A Torino aprono 50 sale da ballo. Ci sono le macerie e c’è la voglia di dimenticarle. Il maestro Angelini dirige l’orchestra della sala Rai. In radio canta il Trio Lescano. Nasce la casa discografica Fonit Cetra. Fred si arrangia con il contrabbasso. Racconta Leo Chiosso: «L’ho conosciuto al Caffè Ligure. Non aveva ancora i baffi. Era mingherlino, con un vestito azzurro due taglie più grande. Nell’intervallo dell’orchestra, lui prendeva il violino e con il pianista faceva Polvere di stelle e Blue Moon». Racconta il pianista Dino Arrigotti, classe 1923, che ai tempi suoi suonava con un mazzo di rose sul pianoforte: «Nel 1949 ho il mio quintetto. Suono alla Tavernetta che è un dopo teatro un po’ di classe con il trio spagnolo che fa il flamenco e le entraîneuse ai tavoli. Una notte, al Bar Sandro di via Verdi, incontro Fred. Sto cercando un violinista e lui mi fa: l’hai trovato. Cominciamo così, ma si capisce che è un leader. In capo a un paio di anni, lui fonda il gruppo e io gli faccio da pianista». Il gruppo si chiamerà Asternovas. Nasce nel 1955, quando cominciano gli anni d’oro, quelli che corrono verso il successo. Alle spalle ci sono le ‘‘ Faccia alla Gable Aveva la faccia alla Clarke Gable. Eravamo giovani, tutto ci sembrava a portata di mano, compresi i sogni. Fred ci mise il pianoforte, e io l’America LEO CHIOSSO tournée in Svizzera, Olanda, Germania. C’è l’ingaggio a 2.500 lire a sera al Dancing Florida. C’è la carriera di Fatima, cantante e moglie, che per un po’ sembra il centro di tutto. E ci sono i riflettori che lentamente si spostano su di lui, Fred, ostinato e sgobbone come tutti i buoni torinesi, con la sua voglia di arrivare, di cantare le sue canzoni, scalando le serate, i contratti, gli applausi. Di notte, o all’alba, nascono le canzoni. Che bambola!, il primo successo, è del 1956. Racconta Chiosso: «Venne come quasi tutte le altre, lui in canottiera al pianoforte, io con la matita». Racconta Arrigotti: «Provavamo le nuove canzoni a fine serata, quando i ragazzi della pista si erano stancati di limonare. Le cose di Fred non erano quasi mai ballabili. All’inizio la gente si scocciava, poi ci fu il passaparola». Nascono Che notte, Il dritto di Chicago, Eri piccola. Più sale la stella di Fred, più s’appanna quella di Fatima. L’amore si fa vetro, il vetro si incrina. Dirà Gino Latilla, cantante e amico della coppia: «È brutto dirlo, ma lei era gelosa del suo successo». Fatima fa serate con altri gruppi perché negli Asternovas non c’è più posto. Racconta Arrigotti: «Fred un po’ ci soffriva e un po’ se la godeva. Era solo. Era un bel mammifero. Tutte le donne se lo mangiavano con gli occhi». Le belle donne volano sui rotocalchi, con i loro occhi affamati di luce, Anita Ekberg che ancora deve infilarsi nella vasca del cinema italiano, ma intanto fa la bionda carrozzata con Fred, poi Hanna Rasmussen, Maria Grazia Buccella, Jane Russel e Scilla Gabel, la biondissima. Dice Fatima in una intervista: «L’improvvisa celebrità ha calamitato attorno a Fred dozzine di bambole… Me le vedo ovunque, nelle canzoni, nei film e qualcuna anche nella vita reale. Più passa il tempo e più Fred mi trascura. La nostra vita coniugale è ormai diventata un fantasma del passato». Il futuro per Fred, che a fine ’59 compie 38 anni, sembra molto più reale di qualunque morbido fantasma del passato. Suona una sera al night romano Le Grotte, lo vede Mario Riva, quello del Musichiere, e dice: «Mandatemelo domani sera in trasmissione». Fred, la prima volta in tv, canta circondato da un mucchio di bambini, anche se indossa il gessato e fa le smorfie di Whisky facile. Al secondo passaggio compare con il panciotto e la pistola. La Rai lo scrittura per il sabato sera di Musica alla ribalta. Per strada gli chiedono l’autografo. Lo vogliono i registi del cinema e quelli dei caroselli pubblicitari per la birra Asso e gli sciroppi Fabbri. Lo ingaggiano i locali migliori, il Grillon di Ginevra, la Bussola di Viareggio, l’Embassy di Rimini. Suona una sera a Paraggi, davanti al giovane Giovanni Agnelli, che fa il playboy e non ancora l’Avvocato. Va al suo tavolo a fine serata. Gli dedica la sweet song che ha appena composto al pianoforte del Carillon: Love in Portofino, che diventa uno standard in- ternazionale per la penombra dei night. Un omaggio al re della Fiat e un addio alla vecchia 1400 Fiat che cade in pezzi. Fred spende 6 milioni di lire per un’automobile da fumetto americano la Thunderbird. In Italia c’è solo un altro modello in circolazione. La guida l’astro nascente dei presentatori, Mike Bongiorno, che gira l’Italia con Campanile sera e viene davvero dall’America. Fred lavora molto, beve molto, dorme poco. Fred comincia a vivere troppo dentro alle sue canzoni. Fred viaggia lungo i rettilinei dei suoi luoghi immaginari. Dice Dino Risi, che lo ha diretto in Poveri milionari: «Raccontava amori senza lieto fine. Faceva ridere, ma era anche struggente». Nella notte di Capodanno del 1960, Fred gira per feste romane. Chiama Fatima al telefono senza trovarla. Ha appena finito di girare il primo film da protagonista, Noi duridi Camillo Mastrocinque. Ha contratti e serate già firmate per i prossimi due anni. Ha il pubblico in tasca. Ha amori veloci. E albe solitarie nella sua camera di albergo al Rivoli Hotel, singola con bagno, letto a una piazza. Si sfoga in un’intervista: «Da vent’anni suono nei night e nelle sale da ballo. Ho conosciuto i locali di quart’ordine, le pensioni più scadenti, le trattorie dalle quali esci con l’appetito. Ho capito che se riesco a durare ancora un paio di anni sono a posto… Poi prima che la gente mi volti le spalle, Fred ridiventerà Ferdinando Buscaglione, di professione pensionato». Il gennaio 1960 corre come un’autostrada. Racconta Piero Vivarelli, autore di canzoni celebri come 24 mila bacie regista dei primissimi film musicali: «Fred lavorava come un dannato e non dormiva mai. Aveva voglia di tutto, anche di dimenticarsi». Fred ha comprato una delle prime pianole elettriche e in albergo ha scritto una delle sue canzoni più tristi, Notte di pioggia, dedicata a Fatima. Racconta Arrigotti: «Noi siamo partiti per Torino. Lui doveva vedersi con Mina che allora cantava con le braccia dietro alla schiena, pesava 35 chili, ma era già fantastica». Fred la vede al ristorante di via Margutta. Poi segue un paio di musicisti al night, dove entra tra gli applausi, beve, sparisce al Bristol, riappare all’alba. È stanco, ha freddo, ha sonno. L’ultimo incrocio della sua vita, ore 6.20 di 45 anni fa, è una frenata e uno schianto contro un camion che porta blocchi di tufo. Dirà l’autista: «È sbucato, ho frenato, ha sbattuto». C’è un carabiniere davanti all’Ambasciata americana, che corre verso l’ammasso di lamiere rosa. C’è l’autista dell’autobus 90 che aiuta il carabiniere a estrarre il corpo, per poi partire di corsa verso il Policlinico. Il ferito respira ancora. Nessuno sa chi sia. Il carabiniere ha detto che forse è un americano. Chi diavolo guida una Thunderbird rosa a Roma? I medici che gli chiudono gli occhi hanno la risposta. E la risposta fa piangere l’Italia e tutti i musicisti da balera, tutti i duri da night, e le donne bellissime e Fatima che è rimasta sola. Morto per sempre Ferdinando Buscaglione, di professione direttore d’orchestra, fragile di cuore e romantico di commiato. Andato via come un eroe notturno, come un solitario, come Fred. Andato via per tornare, ogni volta che sale l’orchestra, scendono le luci, e ricomincia la vita. DOMENICA 30 GENNAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 L’eroe della Torino che faceva squadra GIORGIO BOCCA C he differenza c’è fra la Torino dell’industria, della Fiat, degli Agnelli, dei comunisti Negarville e Roveda, del maestro Angelini, del paroliere Chiosso, del cantante Buscaglione che all’alba del 3 febbraio 1960 va a schiantarsi con la sua Thunderbird rosa confetto contro un camion carico di tufo in una strada dei Parioli e la Torino di oggi tecnologica, finanziaria, delle olimpiadi invernali, che si inventa, giorno dopo giorno i lavori che per noi vecchi non sono veramente lavori, che aspetta la linea ferroviaria veloce con Lione senza sapere bene quale sarà il vantaggio di metterci qualche minuto in meno? La differenza è che nella prima tutto si teneva, automobili e canzoni, affari e politica, padroni e operai, tutto era causa-effetto subito ravvisabile. Buscaglione aveva fatto l’alpino con il paroliere Chiosso, e la prima persona che incontra nella Torino del 25 aprile, della caccia ai cecchini fascisti è proprio Chiosso anche lui con il fazzoletto verde di GL, che sta riannodando i rapporti con gli altri musicisti di avanguardia. E dove lo incontra? Nella casa del senatore Giovanni Agnelli, il fondatore, perché in quella Torino partigiani padroni e operai stanno assieme, perché insieme devono fare la Cinquecento voluta da Valletta e da Togliatti. E quella Torino divisa nella politica ma unita nella ricostruzione ha la gente che occorre, gente di prima qualità, come Ferdinando, FredBuscaglionediplomatoalConservatorioGiuseppeVerdi.Ancheluihafatto il militare in guerra, catturato dagli americani come il giovane Gianni Agnelli, ha dovuto aspettare un po’ di più per essere liberato ma insomma, un destino simile, delle vite che si tengono, un futuro torinese per entrambi. Buscaglioneeraunbell’uomosomigliante a Clark Gable e Chiosso gli disegnò addosso il personaggio del duro dal cuore tenero, del bevitore di whisky e conquistatore. «Mi trovavo per la strada circa all’una e GINO CASTALDO trentatrè / l’altra notte mentre uscivo dal mio solito caffè / quando inquei tempi a colpi di swing si poteva contro un bel mammifero modello demolire tutto un mondo fatto di 103 (fischio). Che bambola / riemedere, vecchi scarponi e malinconipiva un bel vestito di magnifico ci autunni. Buscaglione portò quel suo lamé / era un cumulo di curve come sfrontato vento americano nella sonnacal mondo non ce n’è. Che bambochiosa canzone italiana con un vigore oggi la». È il primo successo seguito da inimmaginabile. Che Bambola! arrivò alla Teresa non sparare, Porfirio Rubiroragguardevole cifra di un milione di copie sa che faceva il manovale alla Viscovendute. Oggi un pezzo così i discografici sa. non lo prenderebbero neanche in consiLa morte di Buscaglione fu una derazione. Ma quel seme gettato con didelle morti in cui quella Torino avesinvoltura tra le melodie nazionalpopolava come la rivelazione della sua ri è rimasto vivo, insidioso e disturbante unità, della sua compattezza, come come un virus indistruttibile. In fondo erala scomparsa a Superga del grande no piccole sceneggiate, ma condite con Torino, come la morte dei giovani umorismo moderno, tanto cinema, una Agnelli e poi dell’Avvocato, come la valanga di slang americano e il carisma inmorte di Valletta e di Togliatti. domabile dell’antieroe. La vena è sopravMomenti trafiggenti di stupore e vissuta in certe gag celentanesche, è rimdismarrimento,pezzidellacittàche balzata nei balbettii beat, adottata come se ne vanno, la cognizione improvsottofondo dai primi cantautori, è stata rivisa di quanto quei morti erano stascoperta dal rock demenziale quando ti importanti da vivi anche come neFreakantoni degli Skiantos, assumendo mici, come facevano parte di un cotemporaneamente lo pseudonimo di Pepmune tessuto di vita, di memorie, di pe Starnazza, si mise addirittura a ricantadestini. In quella Torino i musicisti e re quel repertorio. i cantanti, come gli eroi sportivi i L’influenza di Buscaglione è cresciuta, si Coppi, i Bartali, i Meazza, i Gabetto è ingigantita quando qualcuno volle leggerappartenevano a un divismo che ne delle tracce nella originalità dell’altro stava ancora in quella compattezza, grande piemontese Paolo Conte, è tracimaerano degli eroi normali, alla mano. ta in sberleffi meteorici come il “Sabato itaI cantanti alla Latilla, Carosone, Toliano” di Sergio Caputo, nell’irriverenza gliani li incontravi dal parrucchiere, convinta di Francesco Baccini e nella follia al bar, il maestro Angelini era un lostralunata di Vinicio Capossela. ro zio bonario. Oggi, cinquant’anni dopo, ancora non si Ilprimostrappoversoundivismo riesce a prescindere dal mitico Fred quandiverso, nevrotico, miliardario lo fedo ci si lancia nel divertimento swing, vedi ceMinaunaseradel1961.QuellasePaolo Belli e soprattutto il travolgente Roy ra aveva una chioma folle e un abito Paci che addirittura di Buscaglione riprosu cui brillavano le paillette. Si torduce anche il celebre baffetto. Ma in fondo ceva le mani per vincere la tensione in fondo anche Renzo Arbore un piccolo dedella folla incombente, in una sala bito con Buscaglione non farebbe fatica ad da ballo della Barriera di Milano, già ammetterlo. Viene quasi un dubbio. Ogni fuori le mura. Per inaugurarla le avevolta che c’è di mezzo humour e swing forvano dato mezzo milione, cifra se bisogna tornare sempre lì. Per favore, Teastronomica per allora. Il guadagno resa, non sparare. di un operaio in un anno. E per vederla quella sera gli operai del quartiere avevano pagato cinquecento lire a testa, la paga di due giornate di lavoro.L’antroèimmenso,fumoso,c’èuncaldodasoffocarci.Intornotuttitendono cartoline e foglietti per gli autografi e implorano con voci roche «firmacela Mina, per piacere». Un fotografo smilzo e spelacchiato la prega di accarezzare una bambina. «Ehi voi — dice Mina — non vedete che schiacciate mia madre?», i giovanotti si ritraggono di pochi centimetri. Un tale in un abito viola è salito sul palco e annuncia che Mina sta per cantare. Lei lascia cadere la pelliccia di visone fra le mani di sua madre, umile e taciturna ancella. Poi sale di corsaigradinidelpalco,afferrailmicrofono,rispondealleacclamazioni.Ascolto la sua famosa voce, intermittente come le luci dei flipper e con singhiozzi che secondo i suoi biografi «danno un brivido lungo». Stasera per cinquecentomila lire a Torino, domani per un milione a Rimini, poi alla sei giorni ciclistica di Milano e poi in Giappone. Poco lontano dalla sala da ballo, in corso Giulio Cesare c’era la casa del bandito Cavallero, un altro personaggio della Torino integrata che non c’è più. Andai a casa sua pochi giorni dopo che lo avevano arrestato in un casello della ferrovia vicino a Casale. Piero Cavallero è a San Vittore, sua moglie Anita mi dice: «Stiamo in piedi per non cadere. Ma perché la vita è così schifosa?». Lavora in casa, per campare cuce le asole, attacca perline, bottoni, lavoro a domicilio. Su una parete della cucina c’è una piccola libreria. Accanto a un libro di Ostrovskji, Come fu temprato l’acciaio, sui soviet di Leningrado che Piero comprò quando dirigeva la gioventù comunista, vedo la mia Storia della guerra partigiana, perché anche io ho vissuto e lavorato in quella Torino, anche io faccio parte della sua trama stretta e precisa, delle sue cause-effetto. Ricordate l’attentato a Togliatti? I partigiani di Rocca erano tornati sulle colline del Monferrato; Piero voleva raggiungerli. Era il giovane comunista più in gamba della barriera di Milano. Un capo ma non un militante. Sapeva solo comandare non obbedire. Così un brutto giorno del ’55 il partito lo molla e non c’è un lavoro che vada bene per lui. L’unico che vada bene a lui e a quelli come lui è di improvvisarsi banditi, fino alla pazza corsa in auto per Milano sparando sulla polizia e sulla gente che non si scansa. Rapinatori, cantanti, Fred Buscaglione e Piero Cavallero, il partito di Gramsci e Togliatti, le Stelle rosse della Fiat nella notte, la Torino che si tiene, la Torino che non c’è più. Quel seme swing tra edera e scarponi FOTO GILLO FAEDI/ PER GENTILE CONCESSIONE DELL’EUROPEO A DOMENICA 30 GENNAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 spettacoli IL PERSONAGGIO Laura Pausini è nata il 16 maggio 1974 a Solarolo (Ravenna). Da bambina accompagna il padre cantante nei piano bar. Primo successo “La solitudine” nel 1993 Canzone italiana CARLO MORETTI I RAVENNA l sogno americano di Laura Pausini s’è spezzato due anni fa in una camera d’albergo a Miami. La radio era accesa. C’era un discografico in lacrime e, a terra, una minigonna e un paio di scarpe con il tacco a spillo. Laura non voleva diventare la nuova Shakira. La radio intanto passava un’irritante versione dance della sua Surrender: anche a Laura venne un po’ da piangere. Era la prima volta che l’ascoltava. E così Laura Pausini ha chiuso il sogno americano in un cassetto. Le 27 versioni di Surrender le ricordano ormai soltanto le classifiche dance di Billboard. Nel 2004 ha inciso un album in italiano, Resta in ascolto. Ha scelto una band tutta italiana. E, a quattro anni dal suo precedente giro di concerti, il 5 febbraio partirà da Torino per il suo nuovo tour mondiale. Un mese in Italia, poi tra marzo e aprile le date in tutta Europa; quindi Cile, Venezuela, Brasile, Messico, Portorico e una coda americana con i concerti di New York, Miami e Los Angeles. Per ora sotto i piedi ci sono le strade di casa ma la testa vola già alla coda negli Stati Uniti e il pensiero agita il cuore, una delusione riemerge e si trasforma in rabbia e voglia di rivalsa: «Quest’anno nel gruppo che mi accompagnerà non ho voluto musicisti stranieri. Chi lo dice che un batterista americano sia meglio di un italiano? Solo perché si chiama Steve invece di Stefano?». Qualche tempo fa Laura Pausini è tornata negli uffici della sua casa discografica a Miami, l’Atlantic dei sogni. Ma è cambiato tutto: «C’erano 120 dipendenti, ora sono rimasti in due e si occupano di dance». Inutile andare a cercare i pezzi del sogno rimasti in quell’albergo, perché non c’è più modo di metterli assieme. Resta il ricordo delle lezioni d’inglese all’Università, l’anno trascorso con lo zainetto sulle spalle, e quelle folli Pausini.“Che delusione il mio sogno americano” attraversate in macchina in cui il discografico faceva da manager, autista, e mentre guidava registrava in un microfono lo spot che avrebbe passato alle radio. E poi il truccatore per gli stati della costa est, quello per gli stati della costa ovest, che poi erano gli stessi che truccavano Gwen Stefani. Cartoline da un’America di provincia dove una cantante italiana è una mosca bianca, e dove tante volte si è ritrovata a fare concerti sul cubo come fosse in una discoteca. «Vorrei fare un tour dai suoni puliti, niente superproduzioni, niente americanate», dice. E capisci che non si riferisce soltanto alla scenografia. Anche se poi rivela che l’idea della scena essenziale con i sei schermi che si muovono, creando moduli e fondali diversi, l’ha avuta dopo ‘‘ Steve e Stefano Un batterista americano è meglio di un italiano solo perché si chiama Steve invece di Stefano? aver visto uno show di Robbie Williams. Un americano per scelta. Laura Pausini prende le distanze da quell’album in inglese così poco apprezzato dagli anglosassoni, eppure proprio con From the insideha raggiunto mercati che prima le erano preclusi, come quello sterminato della Russia, di solito attento alle produzioni italiane ma dove lei era presente solo tra i dischi d’importazione. Grazie a quell’album ora là è nato il primo fan club; e dalla Russia è arrivato il ventunenne Boris Filkin, che ha vinto il viaggio e soggiorno premio a Ravenna per il raduno del fan club ufficiale e per l’anteprima della tournée mondiale. In platea, al Pala De André, ci sono seicento fan, la maggior parte italiani ma i più assidui, una ventina, sono arrivati dal Belgio e dall’Olanda, i primi Paesi a darle il successo all’estero, dalla Francia, dalla Spagna. Il discorso dell’estero è una costante, e il ricordo dell’America ancora brucia. Come un conto che non torna. «Io non mi spiego perché un’artista straordinaria come Elisa che canta da sempre in inglese e che è stata prodotta da Glen Ballard, non debba funzionare in America. Potrebbe essere più grande di Alanis Morissette, che tra l’altro ha il suo stesso produttore, ma anche più grande di Bjork». E Giorgia? «Ecco, di Giorgia non capisco perché non vuol fare un disco in inglese, con le doti che ha e il genere che interpreta sarebbe perfetta per quel mercato, anche se di artiste r’n’b negli Stati Uniti è pieno così. Ma mi piace, ha fatto quello che voleva fare e ci vuole coraggio a far così, quando hai dietro tanta gente che ti vuole consigliare». Quello con gli Stati Uniti è un amore frustrato. «Avevo il mito dell’America, per la sua storia, per la sua musica. Ma è ora che noi artisti italiani capiamo che bisogna smettere di pensare che là suonano o cantano meglio di noi. Dopo dodici anni di successo internazionale voglio essere me stessa. Lo dico continuamente a Eros Ramazzotti: “Facciamo un duetto insieme e vediamo se hanno il coraggio di ignorarlo”». Pochi si sono accorti che la critica agli Stati Uniti da parte della Pausini è diventata radicale, fino al punto di parlare di «attacco terroristico contro il terrorismo» per l’intervento in Iraq spiegando il brano Dove l’aria è polvere dal nuovo album: «L’aquila non dorme mai/ sacrifica i suoi eroi/ mette in mostra le sue stelle e i suoi trofei/ il bambino è orfano di casa e di poesia/ per l’indifferenza che/ la guerra ha dentro sé», canta la Pausini ricordando Alì Ismail Abbas, il bambino iracheno cui un bombardamento ha portato via le braccia e l’intera famiglia. 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 GENNAIO 2005 l’anniversario Passatempo da tavolo Nato negli Stati Uniti nel 1935, dall’idea di un ingegnere disoccupato, il gioco più celebre del mondo compie 70 anni e continua ad appassionare con la sua semplice strategia bambini e adulti. È stato tradotto in 26 lingue ed è diffuso in 80 Paesi: 160 milioni le scatole vendute in tutto il mondo. Una delle ultime edizioni è quella russa postcomunista in caratteri cirillici Giochi Vecchio Monopoli che passione ILARIA ZAFFINO L e sfide più memorabili restano quelle consumate per ore sott’acqua, giornate intere in un ascensore in movimento, persino utilizzando come tabellone il soffitto di casa. Oppure trasformando strade e marciapiedi, come hanno fatto gli studenti di un campus universitario della Pennsylvania, in un immenso tavolo da gioco: 170 metri per lato. Con persone in carne e ossa che si muovono avanti e indietro come segnalini. Il Monopoli compie 70 anni e a dispetto dell’invasione dei nuovi giochi che dalla tv rimbalzano nelle vetrine dei negozi — da Affari tuoi all’Isola dei famosi — il capostipite dei passatempo da tavola non perde terreno. Anzi, continua ad appassionare grandi e bambini, dagli 8 agli 80 anni e più, come si legge ancora sul libretto delle istruzioni. Ad inchiodare in salotto, specie nelle serate di pioggia, generazioni a confronto. Semplici le regole, banconote alla mano tutto è permesso: vendere, comprare, ipotecare i terreni su cui si è costruito quando il denaro comincia a scarseggiare. L’abilità è indispensabile ma ci vuole fortuna: ad ogni giro di tabellone, sono i dadi a decidere dove il segnalino capita e chi compra Parco della Vittoria — nella versione originale la proprietà più costosa, ma anche quella che rende di più — è già a metà dell’opera. Ma poi intervengono imprevisti e probabilità e in un istante tutto può cambiare: non è escluso persino un salto in prigione. Tradotto in 26 lingue (recente l’edizione russa in caratteri cirillici), venduto in 80 paesi, più di 160 milioni le scatole che circolano in tutto il mondo. La versione più costosa, con tanto di casette d’oro e d’argento, è stata comprata per 25mila dollari. Per i golosi ne hanno inventata addirittura una tutta di cioccolato. In Italia l’ultima arrivata è quella dedicata alla Ferrari: quattro circuiti al posto delle classiche stazioni, stabilimenti e scuderie sostituiscono case ed alberghi, automobiline in miniatura, in metallo fiammante, fanno da segnaposto. Settant’anni dunque, ma non li dimostra: è il 6 febbraio 1935 quando il Monopoly viene messo per la prima volta in vendita negli Stati Uniti dalla Parker Brothers. L’inventore è un ingegnere disoccupato — sono gli anni della grande depressione — Charles B. Darrow che, in realtà, si ispira a giochi brevettati già nei primi anni del secolo. Perché dietro a tutto c’è la mano di una donna, Elizabeth Magie, e il suo “game” del proprietario terriero: 40 caselle, 4 ferrovie, un centinaio di copie fatte a mano per gli amici. Nulla di più. Non pensava certo di far soldi così. Anzi. A mancare era persino lo scopo capitalistico del gioco, quella possibilità di costruirci su case ed alberghi, che nel tempo non è rimasta immune da critiche. Da noi il Monopoly arriva l’anno dopo: un giornalista della Mondadori lo traduce ispirandosi ai nomi delle vie della Milano dell’epoca. Ed è subito amore: alla Rinascente vengono indette dimostrazioni per insegnare le regole, le poesie di Carlo Porta recitate in sottofondo durante le partite. Luigi Barzini jr. lo consacra sulle pagine del Corriere della Sera: è il battesimo ufficiale. Tutto il resto è storia: spuntano tornei come funghi, vengono creati dal nulla club dedicati al padre di tutti i giochi. Che di anno in anno si rinnova, si adegua all’euro che avanza, mette sul mercato sempre nuove edizioni, con i lungometraggi Disney o i personaggi di Guerre Stellari. Ma la chiave del suo successo resta ancora racchiusa in una frase di Aldous Huxley: «La gente si diverte a mandare al tappeto il migliore amico». Magari senza fargli veramente male. Perché «uno nel gioco vuole delle alternative. Vuole credere che facendo la scelta giusta vincerà quella maledetta partita». Dadi e segnalini Indimenticabili il funghetto, la candela e il fiasco giallo e rosso: nell’edizione del 1940 tutti i sei segnalini erano in legno. Poi, arrivato l’euro, gli oggettini sono stati sostituiti dalle miniature dei monumenti più famosi delle capitali europee. Nell’edizione Guerre stellari (1999) sono sbarcati Luke e la principessa Leila, nel 2003 è stata la volta dei personaggi Disney: Dumbo, Pinocchio, Cenerentola. Nell’ultimo nato Monopoli-Ferrari si gioca con i modellini Le banconote Il Monopoli si adegua ai tempi che passano e sostituisce le vecchie banconote colorate in lire (dalle famose 100 lire di carta azzurre, le mille lire verdi, fino alle 50mila lire rosse) con quelle in euro: introdotte anche le monete da un euro, in plastica bicolore che sembrano vere. Nella versione Disney sulle banconote è raffigurato zio Paperone: non si poteva immaginare personaggio più azzeccato Risiko Nato in Francia negli anni ’60, è un gioco da tavolo e di simulazione. Su una mappa geografica i piccoli carri armati colorati si muovono alla conquista dei territori CLASSICI & NUOVI Scarabeo Il gioco di parole più amato: lo scopo è comporre la parola più lunga sfruttando le caselle che permettono di moltiplicare il valore di una lettera o dell’intera parola Fantacalcio Consente di simulare una intera stagione con tanto di fantamercato: il gioco ha 500 schede tra giocatori e pagelle. Si parte con l’asta per l’acquisto dei giocatori Affari tuoi Dalla tv al salotto di casa: la trasmissione di Bonolis racchiusa in una scatola con tanto di pacchi, riprodotti in plastica, che contengono cifre esorbitanti o fagioli DOMENICA 30 GENNAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 La censura 160 milioni Il cinema I record Lo spazio Superano i 160 milioni le scatole vendute in tutto il mondo: più di 480 milioni di persone hanno giocato a Monopoli, 5 miliardi le casette verdi costruite dal 1935 26 lingue Troppo capitalistico: il Monopoli viene vietato a Cuba e in Unione Sovietica. Salito al potere, Castro ordina la distruzione di tutte le scatole in circolazione Dal tavolo da gioco al grande schermo: il Monopoli viene citato anche in “Qualcuno volò sul nido del cuculo” e ne “Il re dei giardini di Marvin” con Jack Nicholson Sono 26 le lingue in cui il Monopoli è stato tradotto, cirillico compreso, 80 i Paesi in cui è venduto. L’edizione giapponese ha i nomi americani delle strade, quelle in arabo e cinese i nomi di Londra Ben 70 giorni: tanto è durata la partita più lunga. Quella più lunga giocata invece in un ascensore in movimento 240 ore, 99 in una vasca da bagno e 36 ore a testa in giù Monopoli sbarca nello spazio: su richiesta della Nasa già pronte due scatole speciali, con carta ignifuga e case ed alberghi in alluminio per giocare anche su Marte LE CURIOSITÀ Le case e gli alberghi Le casette verdi e gli alberghi rossi cambiano aspetto al passo coi tempi: diventano astronavi nella versione Star Wars, il castello di Cenerentola nel Monopoli Disney, stabilimenti e scuderie nell’edizione Ferrari I contratti Quando un giocatore capita su un terreno che ancora non appartiene a nessuno lo può comprare, se ha tutti i terreni di un colore può costruirci su. Il nostro Parco della Vittoria, la proprietà più costosa, in America si chiama Boardwalk e nell’edizione Ferrari è diventato Schumacher campione del mondo Il piano di gioco Comprare, vendere, ipotecare le proprietà sul tabellone: tutto è permesso pur di trarre profitto e diventare il giocatore più ricco, anzi addirittura il “monopolista”. Partendo dal “Via”, ogni giocatore sposta il segnalino sulle caselle secondo la gettata dei dadi. Chi possiede una proprietà ha diritto a goderne la rendita, costituita dal pedaggio che gli altri, quando vi si fermano sopra, sono costretti a pagare Ripetitività strategica e controllo sull’avversario: i segreti del successo N on è vero che l’ansia dell’aggiornamento, il brivido del ritocco, il mercato del reload è una legge generale. Si ridisegnano i corpi e le abitudini, cambia il giornale preferito, si rinnova il telefonino, si rivoluziona il cruscotto dell’automobile, i giocattoli si mettono a parlare: eppure qualcosa riesce a star fermo, e zitto. Le storie dei giochi raccontano che il Monopoly (questo il nome originale del gioco che in Italia conosciamo come Monopoli) è uscito nel 1935, per la Parker Brothers: consapevolmente o meno, clonava un brevetto precedente, e precocissimo, del 1904. La versione che ebbe successo fu quella del 1935, e come spesso succede nella storia dei giochi del Novecento la data di nascita da prendere in considerazione (in linea di principio) non è quella dell’idea iniziale ma quella della sua commercializzazione più geniale, e vincente. È successo lo stesso con il cruciverba, di cui si ebbero precursori anche italiani (e infatti in provincia di Como una via è dedicata a Giuseppe Airoldi, “inventore del cruciverba”), ma che si diffuse a partire dalla sua incarnazione newyorkese del 1913. I giochi sono tombini in cui precipita un’immagine di quel che passa di sopra: quello che conta non è il primo tombino che è stato aperto ma quello in cui cade l’immagine più rappresentativa, capace di trascinare con sé i fantasmi del grande pubblico. Il Monopoli: evoluzione capitalista, o per meglio dire novecentesca, del rurale gioco dell’oca. Un percorso obbligato e ciclico, da ripetere numerose volte secondo schemi di ricorsività alienante, con pedaggi, trappole, imprevisti: è l’im- L’evoluzione capitalista dell’andirivieni dell’oca STEFANO BARTEZZAGHI magine della città e della vita cittadina come corsa competitiva e in tondo, dove non vince chi arriva alla meta per primo ma chi riesce a controllare i nodi principali del percorso. Il capitalismo, dunque, è reso come una concorrenza sulle rendite di posizione, un’evoluzione moderna del feudalesimo: “di qui, devi passare” (ivi profeticamente compresi, soggiorni fugaci e non compromettenti dalle carceri municipali). La storia italiana del Monopoli pare mito, e non lo è. Già dalla metà degli anni Venti l’importazione delle mode americane aveva subìto, sull’onda dei massmedia e dello spirito modernista del tempo, un’accelerazione prima impensabile. Accelerazione oltretutto osteggiata dal fascismo, che diffidava dei prodotti importati dagli Stati Uniti, e dello spirito ludico applicato alla scottante materia del capitalismo e della rendita finanziaria. Già nel 1936, un anno dopo il successo, il Monopoly viene proposto dagli editori americani ad Arnoldo Mondadori, che però non ha intenzione di diversificare la sua produzione e gira la proposta ai suoi collaboratori. L’offerta viene accettata dal capo del suo ufficio stampa, il giornalista Emilio Ceretti, che assieme al figlio di Arturo Toscanini, Walter, e a un altro amico decide di produrre il gioco. Il lancio, alla fine di quell’anno, avviene grazie alla rete di relazioni che i tre amici possono vantare. Il poeta Delio Tessa dà loro la disponibilità degli uffici, e della macchina da scrivere, del suo studio di avvocato in via Rugabella, a Milano; il gioco viene presentato alla Rinascente e in numerose serate mondane, a cui lo stesso Arturo Toscanini partecipa — a quanto si dice più per il piacere di ascoltare Tessa recitare le poesie di Carlo Porta che per l’ansia di conquistare Parco della Vittoria o Viale dei Giardini (o come allora si chiamavano). Nel gennaio 1937 Luigi Barzini jr. dedica al gioco un elzeviro del Corriere della Sera, con il ritratto sornione di un Vecchio Finanziere che spiega al giornalista come sia stato battuto nelle partite con i figli adolescenti e come tutto sommato sia più quieto e riposante il proprio lavoro, fatto di soldi veri. E sull’Eco di Bergamo si celebra il momento solenne in cui i giocatori possono dire all’amico «Caro, sei fallito». Nel gioco è così possibile reintrodurre il tabù luttuoso della bancarotta e della rovina, un tabù che proprio l’universo dei giochi aveva prestato a quello della finanza e che sul tavoliere del Monopoli viene gentilmente restituito. Dentro alle regole del gioco è infatti prevista l’infrazione massima alla regola del Buon Giocatore: la distruzione dell’avversario, evidentemente contraria a ogni possibile fair play. Da allora a oggi non tutto è rimasto immutato: la toponomastica del gioco originale è stata almeno leggermente corretta; la grafica ha avuto qualche ritocco; nel 2001 si è ovviamente passati dalla lira all’euro. Dopo la perestrojka si è avuta la sospirata edizione russa, e in generale il marketing ha avuto le sue trovate: edizioni per petrolieri con tavoliere d’oro e diamanti, lussuosi campionati mondiali, giustificati solo dal desiderio dell’autocelebrazione visto che l’agonismo del gioco è irrimediabilmente inficiato dal grande ruolo che ci gioca il caso. Quel che è rimasto è la forma, anche esteriore, del gioco: il Monopoli ha continuato a raccontare la sua favola di successo e di rovina, di iattanza e di dileggio. In molti giochi l’egoismo dei giocatori è previsto e istigato. Nel Monopoli l’identità di ogni giocatore è definita dalla ricchezza e dalla capacità di accrescerla e farla fruttare a discapito degli altri: si gioca, dunque, con la propria antipatia. Poterla esibire per gioco, in una cornice che ormai deve la propria ingenuità anche agli invecchiati connotati iconografici (stazioni, casette, alberghini), aiuta anche sé stessi: possiamo illuderci che sia essa stessa un gioco, e di averla messa fra parentesi. DOMENICA 30 GENNAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 le tendenze Le ultime sfilate a Parigi e Milano l’hanno dimostrato: lui si vergogna sempre meno di concedersi accessori un tempo squisitamente femminili. E così, tramontato il vecchio borsello anni Settanta, ecco tascapane, bandoliere, borsoni da viaggio, messenger bag e zainetti tecnici Nuove mode L’uomo con la borsetta ora non fa più paura L AURELIO MAGISTA’ a crisi del maschio avrebbe adesso un’ulteriore conferma, se questa tesi non fosse ormai da archiviare come mitologia di comodo, o almeno chiave di lettura troppo approssimativa ma utile per spiegare la grande metamorfosi virile degli ultimi dieci anni. Lui sta cambiando, confusamente, con concessioni alla promiscuità dei ruoli, come dimostrano il vertiginoso aumento di cosmetici per lui e le non rarissime richieste di aspettativa per paternità, e si vergogna sempre meno di dettagli un tempo squisitamente femminili, soprattutto quando queste concessioni non sono dettate dal caso della moda ma dalle necessità della vita. La borsa, per esempio, oggetto che non si può definire accessorio quando si tratta di donne, poiché è piuttosto estroflessione della personalità, prolungamento fisico dell’io, contamina le proposte per lui: forme, colori, soluzioni progettuali storicamente femminili contagiano molte delle novità per l’uomo come hanno appena confermato Pitti Uomo e le sfilate milanesi. Quella del maschio e della borsa è una relazione storicamente dialettica, se non proprio sofferta. La borsa infatti è pratica, risponde a un bisogno reale, ma ha sempre avuto un richiamo equivoco: corollario dell’identità femminile, mette l’uomo in imbarazzo. E così, dopo la parentesi del borsello, sperimentata in quegli anni Settanta ansiosi di varcare frontiere e violare confini, ma goffa fin dal nome (l’imposizione grammaticale del genere maschile), lui sembrava essersi rassegnato alle borse tecniche e professionali, le ventiquattrore, i portacomputer, al limite gli zainetti rivisitati in chiave urbana, nei casi più impegnativi i borsoni e i trolley da weekend, per finire poi ogni estate, sparite giacche, giacconi, cappotti e con essi tutte le relative comode tasche, a invidiare la borsetta della compagna. Invece adesso, accanto alle virili bandoliere di The Bridge, ai seriosi tascapane Lacoste, appaiono messenger bag a motivi floreali gialli (Bally), borsoni turchesi (Jill Sander) tracolle arancio (Prada Sport), zainetti dal design spudoratamente femminile (Piquadro) e perfino borse come la quadrangolare di Gucci: oggetti ibridi, di confine, androgini se non proprio ermafroditi. Qualcuno leggerà in questi stilemi il declino e la caduta del maschio. Spiriti meno conservatori vi troveranno il segno che l’uomo può finalmente permettersi di giocare con i dettagli femminili proprio perché sta uscendo dall’antica ossessione della propria virilità. DUE MANI, UNA TRACOLLA Due mani che suonano una chitarra: graffiti stile murales per la tracolla Paul Smith, di piccole dimensioni ma grandi aspirazioni BISACCIA AMBIVALENTE Nostalgie retrò nella forma ma funzioni adeguate alla modernità, come segnala la tasca portacellulare. Firmata The Bridge, la bisaccia monospalla in cuoio pieno fiore COME UNA VOLTA Il primo amore non si scorda mai: Keepall, la capiente tracolla Louis Vuitton con impugnature in cuoio e doppia bandoliera in corda, è la reinterpretazione di una storica borsa della maison. Evidenti i richiami ai grandi viaggi del primo Novecento COME UNA CINTURA, PER L’ESTATE Ideale per l’estate, quando alleggeriti dagli abiti non si sa dove mettere le cose, la cintura con tasche Dior in camoscio nero con rifiniture e fibbie in metallo PER GLI INDECISI Sportiva, da portare senza formalizzarsi. La piccola borsa con doppia tasca, dedicata agli indecisi tra cintura e marsupio, è realizzata in tela di cotone, giocando sui toni del marrone. Lacoste by Samsonite SPORTIVE TRENDY LO ZAINO INTELLIGENTE Evoluzione dello zaino in chiave ergonomica, Flight Series è dotato di pannello dorsale in materiale espanso che ridistribuisce il peso in maniera uniforme. Eclettico, si adatta alle esigenze di ogni sportivo. Di North Face DETTAGLI ANDROGINI Perfino la pochette diventa per il maschio il contenitore più comodo per chiavi e cellulare. Un nuovo segno di emancipazione dalla virilità? Design sofisticato, con una implicita citazione di Mondrian, la borsa di Gucci risolve stilemi femminili scegliendo la ruvidezza della tela. I dettagli sono in pelle nera e la fibbia spicca su un nastro in tessuto bicolore DUE BUONI MOTIVI PER UN WEEKEND COLORATISSIMA PER VOCAZIONE Adatta per fine settimana al mare, almeno per due buone ragioni: le dimensioni — vera 48ore da diporto — e il colore, un turchese intenso. In pelle, Jill Sander Per gli uomini che non amano passare inosservati, Prada Sport ha fatto questa borsa arancio, con tracolla e profili a contrasto URBANO, SULLA SPALLA O ALLA MANO Classico zainetto urbano da portare a spalla o alla mano, in poliestere, grigio e giallo con stampa del logo Sergio Tacchini sulla capiente tasca anteriore. Anche nella versione blu/rosso/bianco NON DITELO AL POSTINO Messenger bag: il nome si deve al modello originale cui questa e altre borse si rifanno: la sacca del postino. L’antica sobrietà diventa bizzarria nella stampa floreale e nel colore giallo fluo. In tela, di Bally 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 GENNAIO 2005 i sapori Una volta si bevevano, oggi si degustano. Nonostante le raccomandazioni dei salutisti e la crisi economica, gli italiani continuano a regalarsi a fine pasto il piacere dei superalcolici. A patto che il brivido distillato in fondo al bicchiere sia di ottima qualità Alta gradazione Friuli itinerari Appassionato di cocktail e distillati, Alessandro Giani lavora come maître all’Enoteca Pinchiorri, ristorante di Firenze che vanta una delle più prestigiose cantine Emilia Romagna LA GRAPPA Dopo anni di ghetto alcolico, è stata sdoganata dai friulani Nonino con un paziente lavoro su qualità e immagine. Dal bottiglione si è passati alle pregiate ampolle di vetro soffiato, mentre il “torcibudella” è stato sostituito da monovitigni, cru, barricati, distillati di uva e di miele. Primario l’uso degli alambicchi discontinui Sardegna IL BRANDY I pionieri sono stati Jean Bouton, Lionello Stock, Ausano Ramazzotti, Antoni Carpené, i Branca. La famiglia Zarri di Bologna, proprietaria del marchio OP-Pilla ha riportato il brandy italiano a uno stato di grazia. Il segreto? Uve Trebbiano di prima qualità e alambicco discontinuo “Charantais”, come i cognac più prestigiosi IL MIRTO Liquore sardo per eccellenza. Si ottiene per infusione idroalcolica delle bacche o delle foglie del mirto, da cui la doppia tipologia (rosso o bianco). La pianta cresce in tutta la regione. Se ne producono 2 milioni di bottiglie l’anno. Marchio di punta, il “Zedda Piras” di Sella&Mosca (Campari) DOVE DORMIRE HOTEL MONTE DEL RE, via Monte del Re 43, telefono 0542-679078, Dozza (Bologna). Camera doppia da 85 euro, colazione inclusa DOVE DORMIRE HOTEL CARLOS V, Lungomare Valencia 24, telefono 079-979501, Alghero. Camera doppia con colazione da 150 euro www.hotelcarlosv.it DOVE MANGIARE AGLI AMICI, via Liguria 250, telefono 0432-565411, Godia (Udine). Chiuso il lunedì, menù da 40 euro, vini esclusi DOVE MANGIARE IL SOLE -ANTICA LOCANDA del TREBBO (con camere), via Lame 67, telefono 051-700102, Trebbo di Reno (Bologna). Chiuso sabato a pranzo e domenica, menù da 45 euro, vini esclusi DOVE MANGIARE ANDREINI, via Arduino 45, telefono 079- 982098, Alghero. Chiuso il lunedì, menù da 40 euro, vini esclusi DOVE COMPRARE LA CASA DEGLI SPIRITI, via dei Torriani 15, telefono 0432-509216, Udine DOVE COMPRARE ENOTECA ITALIANA, via Marsala 2/b, telefono 051-235989, Bologna DOVE COMPRARE GASTRONOMIA MANGATIA, via Università 68, telefono 079-234710 Sassari. www.mangatia.com DOVE DORMIRE SCACCIAPENSIERI, via Morpurgo 29, telefono 0432-674907, Buttrio (Udine). Doppia con colazione a 100 euro Liquore Sono i litri del volume di mercato nel settore superalcolici 7,5litri È di 7,5 litri il consumo pro capite di superalcolici in Italia +5,2% È l’aumento complessivo della spesa per i superalcolici Poco ma molto buono così cambia il dopocena LICIA GRANELLO S 48 mln tate terminando una cena deliziosa: piatti riusciti, un bicchiere giusto per accompagnarli, compagnia all’altezza. La domanda, pudica, attesa, quasi retorica, arriva puntuale insieme a una ciotola tentatrice, colma di biscotti-cioccolatini-scorzette candite: chi vuole un liquore? E sia, visto che malgrado gli allarmi a cadenze fisse, tesi a dipingerci come un popolo di potenziali etilisti, le statistiche ci assistono benevole: fortunatamente lontani dai numeri che condannano Stati Uniti, Nord ed Est europeo nella classifica delle patologie da abuso di alcol, amiamo regalarci qua e là il piacere di un brivido distillato. Già. Ma quale? Il ventaglio delle scelte, per tipologie, marche, valore, non è mai stato tanto ampio come in questi primi anni del secolo, comprendendo liquori allegri e raffinati, chicche di pregio assoluto e piccoli rituali irrinunciabili, mediocri novità senza futuro e vecchie ricette mai sconfitte dal tempo. Certo, se è vero che la crisi sta dimezzando i consumi voluttuari, i superalcolici più pregiati sono a rischio massimo. Racconta Gianola Nonino, la donna che ha ridato dignità e valore alla grappa («nostra signora delle grappe», per dirla con Gianni Brera), padrona di casa, ieri, del trentesimo celebre premio culturale: «Abbiamo lavorato tanto per creare la grappa da cru di monovitigno, e oggi ce la comprano solo all’estero». È la triste sorte comune a molti grandi distillati, che la crisi economica induce a comprare con sempre maggior parsimonia. Però, se nella quotidianità dei pasti casalinghi, finanze e salute consigliano di non andare oltre il “resentìn” di tradizione veneta (la minidose che serve a “sciacquare” la tazzina dove abbiamo appena bevuto il caffè), l’arrivo di ospiti cambia la prospettiva. Perché il dopocena induce a ritualità più intime e meditate. Ci si attarda a tavola, o ci si accoccola in poltrona. Per quel momento, per quel gesto, vale la pena investire qualche euro in più. Così, se il bere giovane & veloce coincide con bicchierini meno pretenziosi come il limoncello o più netti nel gusto come la vodka, chi ha qualche anno in più vira sui liquori ambrati, morbidi e complessi. Non la quantità, ma la qualità a fare la differenza, anche nei bicchieri, sempre più tecnici — per esaltare aromi e profumi — ma anche belli da vedere, da toccare, da rigirare tra le mani. Una ritualità capace di coinvolgere anche l’universo femminile, a cui sono dedicati i superalcolici meno aggressivi — rum agricoli, ottenuti da canna da zucchero e non da melassa, distillati d’uva — che ben si affiancano ai più tradizionali vini liquorosi, dal porto allo sherry. Cambiano anche i verbi, se è vero che i superalcolici, soprattutto quelli di qualità più alta, non si bevono ma si degustano. A volte, accompagnati in maniera forte da un sigaro. Più spesso (e meglio per la salute) in abbinamento al cioccolato. Non più all’interno delle praline (gli storici “cuneesi” al rum), ma serviti accanto uno all’altro, in un gran bell’alternarsi di aromi e sentori. Un “vizietto” che trasmigra facilmente da casa al ristorante. Siamo in grande compagnia: dalla Francia all’Inghilterra, i paesi a più alta tradizione alcolica vantano ristoranti con carrelli di superalcolici così ricchi da risultare irresistibili. Da una parte cognac, armagnac, calvados. Dall’altra, whisky — di solo malto o assemblati — e gin. Resistono, comunque, le chicche nazionali, a cui siamo affezionati e fedeli, a patto di non metterle in concorrenza con i Grandi Stranieri: il mirto, la sambuca, gli amari. E la grappa, che invece ha messo le ali e vola alto nelle enoteche di tutto il mondo. Un secolo fa, la usavano per darsi coraggio prima di andare in battaglia. Molto meglio godersela sorseggiandone un poco con le “chiacchiere” dolci di Carnevale. 31,3% È la quota di consumo nel Nord-ovest, l’area dove si beve di più Rum Demerara 1980 Whisky Port Ellen Distillery 1978 Cognac Delamain Reserve de la Famille Prodotto nella Guyana francese 25 anni fa a partire dalla canna da zucchero (da cui la denominazione “agricole”), è stato imbottigliato in Inghilterra. Morbido ed elegante: 110 euro È un single malt con 25 anni e 50 gradi alcolici. Distillato nel settembre del 1978 e invecchiato nelle botti dello sherry, imbottigliato due anni fa. Ha gusto dolce. Costa 90 euro Riserva pregiata, vanta la denominazione “Tres vieille Grand Champagne” (vecchissima grande campagna). Il vitigno utilizzato è il Pinot de Charente. Prezzo consigliato in enoteca 180 euro DOMENICA 30 GENNAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 GRAPPA Per la grappa cru monovitigno Picolit, l’uva-culto radicata in Friuli, i NONINO usano vinacce fresche e selezionate. Le bottiglie sono numerate. La rivista “Wine Spectator” l’ha eletta distillato-principe per il brindisi di inizio millennio. Costa 74 euro in enoteca. Usa gli alambicchi discontinui anche la famiglia BERTAGNOLLI, che produce DECEM, blend di quattro vinacce, in barrique per dieci anni. A 80 euro. Il designer austriaco Willsberger ha messo a punto un calice perfetto per la degustazione olfattiva. Costo: 30 euro. La discussione era finita, ma Feodor Pavlovitc... si accigliò e tracannò ancora un bicchierino di cognac, il qual bicchierino era proprio di troppo MIRTO Il mirto dell’azienda BRESCA DORADA di Paolo Melis è realizzato vicino a Cagliari, ed esiste bianco - derivato dalla foglia - e rosso, prodotto a partire dalla bacca. Le uniche aggiunte sono miele e zucchero. È in vendita a 9 euro. Altro mirto di qualità, il TIU PEDRU. È prodotto in Gallura da Giuseppe Mangatia, gourmand con punto vendita a Sassari. Costo: 10 euro. Il bicchiere da mirto è studiato per esaltare i particolari sentori della bacca o della foglia. Il “Quinta Essentia” di Spiegelau costa 22 euro. FEODOR DOSTOEVSKIJ da I FRATELLI KARAMAZOV La solitudine significa anche: o la morte o il libro. Ma innanzitutto significa alcol MARGUERITE DURAS da SCRIVERE BRANDY VILLA ZARRI, MILLESIMATO 1987: un’annata speciale per il brandy romagnolo che si ispira ai cognac. Armonioso e speziato al naso, morbido, con note di cuoio, in bocca: 45 euro. Alto livello anche per il brandy della famiglia ANTINORI: una produzione speciale, realizzata in trent’anni solo quattro volte e in piccole quantità. È in vendita a 24 euro. Il bicchiere da degustazione soffiato a bocca, che esalta i profumi vinosi, costa 30 euro (calice Willsberger Brandy & Cognac). Il piacere del bere: così cambiano le abitudini degli italiani Frammenti di storia nel bar del salotto GIAMPAOLO FABRIS L Quindici uomini sulla cassa del morto. Yo-ho-ho, e una bottiglia di rum! Il vino e il diavolo han già fatto il resto. Yo-ho-ho, e una bottiglia di rum R. L. STEVENSON da L’ISOLA DEL TESORO Vodka Grey Goose Gin Bombay Sapphire Una vodka insolita, perché prodotta in Francia. Arriva dal cognac, dove subisce un processo reiterato di distillazione (5 volte!), a partire da cereali coltivati in terra di Champagne. Costo sui 40 euro Un distillato di dieci tra erbe e spezie di tutto il mondo, dall’iris al coriandolo, con un melange segreto. Molto piacevole anche bevuto in purezza. Costo: 13 euro e motivazioni e le tipologie del bere da parte degli italiani forniscono una ulteriore, importante cartina di tornasole di quanto incisivamente sia cambiato il Paese. Una premessa anzitutto. L’analogia, tanto cara a Sirchia il Talebano che minaccia nuovi divieti sul fronte dell’alcol, tra l’Italia e quei Paesi in cui l’etilismo è davvero una piaga sociale — e dove anomia e solitudine si annegano letteralmente nel bere — è del tutto infondata. Non si registrano infatti, da noi, incrementi nel numero degli alcolisti, le quantità di alcol consumate sono rimaste stabili o in leggero regresso. Si diffonde, semmai, un positivo atteggiamento di chi non vuole rinunciare a uno dei possibili piaceri della vita ma in modo responsabile. Un atteggiamento di moderazione tanto diverso e lontano dagli eccessi così frequenti nel Nord d’Europa e l’Est europeo. Un tempo i consumi di alcolici degli italiani si orientavano prevalentemente verso grappa e brandy. La prima — oltre che per radicate tradizioni e una vasta produzione autoctona — per il costo più abbordabile rispetto a qualsiasi altro alcolico. In alcune aree del Paese la grappa si affianca al caffè nei consumi mattutini. Il secondo — siamo già nell’epoca dei Caroselli — presidia l’immaginario degli italiani con cacce alla volpe, camini accesi, atmosfere kitsch di status, incauti consumatori che fanno richiesta di brandy senza marca squalificandosi davanti a tutti sullo sfondo di una sfida epocale tra Stock 84e Vecchia Romagna. Una immagine caricaturale che purtroppo condizionerà a lungo — dopo gli iniziali successi — l’immagine e il vissuto di un prodotto pur tanto straordinario come il brandy. Sono gli anni in cui, per gli italiani, il consumo di alcolici mantiene ancora qualcosa di peccaminoso e il mondo degli amari ben si presta a fornire un potente alibi salutistico. Con gli amari — un fenomeno di mercato tutto italiano e sconosciuto nei paesi industriali avanzati — l’alcol che fa male si tramuta — per gli effetti presunti, per la composizione organolettica — nell’alcol che fa bene, che consente di superare l’impasse digestiva ed ha anche una contenuta gradazione. I consumi sono elevati e, ripeto, propongono una tipologia di alcolici tutta italiana. Il bar casalingo invece è presidiato da una eterogenea famiglia di liquori dolci — talvolta la stessa bottiglia dura anni — stereotipicamente destinati ad improbabili ospiti e ad un pubblico femminile. L’epoca del whisky segna una vistosa discontinuità rispetto agli alcolici di produzione italiana. Il whisky è uno dei prodotti più esemplari del diffondersi della modernità, di quell’american way of life la cui attrattività riesce persino a far aggio sulle pregiudiziali ideologiche nei confronti degli Usa. All’inizio è il mero possesso/consumo a qualificare socialmente, i whisky più diffusi sono tutti blended. Poi cominciano a farsi strada i puro malto e l’intenditore per antonomasia si chiama Michele (Glen Grant) anche se “abbiamo l’esclusiva” — una delle campagne più emblematiche dei valori degli anni Ottanta, “Milano da bere” non regge il confronto — è appannaggio, per gli yuppies di allora, di una marca più titolata (The Glenlivet). Il passo successivo, che ci porta ai nostri tempi — ma il trend di consumo è costantemente in discesa — è verso i whisky di Islay, torbati, con nomi in gaelico impronunciabili ma, anche per questo, di culto. Negli ultimi anni i white spirits — vodka e gin — e il rum acquisiscono il testimone dell’attualità culturale ma sono soprattutto cocktail a bassa gradazione a divenire popolari fra i più giovani: dal Campari mix al Bacardi breezer. E le rumerie e il rapido, travolgente diffondersi dei locali happy hour con nuove modalità aperitivali segnano l’ingresso in una nuova epoca. L’autore è ordinario di Sociologia dei consumi alla Uilm 44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 GENNAIO 2005 l’incontro Tecnologie ribelli A dicembre il suo iPod, regalato in milioni di esemplari, lo ha trasformato nel primo Babbo Natale della globalizzazione. Ora ha un nuovo sogno: “dare a tutti un computer”, sfida che rischia di vincere con il Mac mini. Ma lui, l’uomo in jeans, alla vigilia dei cinquant’anni, si definisce solo “fortunato”. Non per le soddisfazioni e i soldi accumulati nel 2004, ma per aver sconfitto la malattia e poter contare sulla “miglior famiglia del mondo” Steve Jobs ica male, eh?». L’uomo in jeans scoloriti e girocollo nero strizza l’occhio soddisfatto al gruppetto di giornalisti che lo hanno seguito quando, sceso dal palco, è andato a raccogliere i saluti e gli abbracci dei familiari e degli amici più intimi. Nella grande sala del Moscone Center di San Francisco i grandi altoparlanti neri stanno ancora lanciando nell’aria ad alto volume le note di canzoni rock mentre migliaia di persone sfollano con calma. Steve Jobs non può nascondere la propria soddisfazione mentre Al Gore gli si avvicina e lo abbraccia. Ci sono diversi volti noti in platea, ma per una volta anche un ex vicepresidente che è stato quasi presidente passa quasi inosservato, lui come gli altri vip presenti. Tutta l’attenzione è per quell’uomo in jeans, quell’eterno ragazzo visionario, uno dei pochissimi al mondo che può far parte di quell’incredibile club di scienziati-inventori che ha provocato la grande rivoluzione del fine-secolo scorso: la rivoluzione dei computer. «La presentazione è finita ragazzi», aggiunge sorridendo mentre familiari e colleghi cercano di fargli da guardie del corpo, e con passo svelto si avvia verso l’uscita stringendo mani ignote e salutando con il piglio da rockstar. «Ci dica almeno come è andato l’anno che è appena finito, è contento?». Il viso del guru della Apple si fa per un attimo serio, sembra concentrarsi su qualcosa, come se stesse vedendo immagini lontane. «È stata una bella sfida, sì. Credo di essere proprio un uomo fortunato». In quel momento, mentre l’attore Robin Williams lo abbraccia quasi commosso, si intuisce che il “miliarda- ta libertaria che mal sopporta i lacci del conformismo e del perbenismo ufficiale, Bob Dylan come artista favorito — «è un vero poeta» — l’essere vegetariano. Quando un anno fa lancia iTunes, quei due mondi si ritrovano nel grande universo dell’iPod, così come ha fatto incontrare (grazie alla casa di animazione Pixar) Hollywood e la Silicon Valley, un connubio che già qualcuno chiama «Silliwood». «Anche professionalmente è stato un anno veramente straordinario», aggiunge quasi in colpa per aver deviato dai suoi compiti ufficiali — promuovere i nuovi prodotti Apple al McWorld, la annuale fiera dei “mcmaniaci” — «e io mi sento veramente molto bene». Gli anni difficili sono lontani, la battaglia, persa, contro John Sculley — il manager che veniva dalla Pepsi Cola e che nominato presidente lo esiliò in quella che Steve chiamò «la mia Siberia» — è un ricordo sbiadito, forse ancora più piacevole perché addolcito dalla vendetta finale. Il periodo nero, che lo ha portato ad essere estromesso dalla sua stessa società, è alle spalle, i vip fanno la fila per salutarlo e lui può voltarsi indietro e dire: “Sono proprio soddisfatto” FOTO CORBIS «M SAN FRANCISCO rio in jeans” non sta parlando dei clamorosi successi del suo business 2004; si capisce che il “babbo natale della globalizzazione”, l’uomo che ha portato milioni di regali (in forma di mini iPod) sotto gli abeti addobbati di tutto il mondo, si riferiva a una sfida molto più importante, a un regalo di Natale che nessun negozio — neanche quei posti da sogno post-moderno che sono i negozi della Apple — avrebbe potuto vendere o regalare: stava parlando di quanto successo l’estate scorsa, quando è finito sotto i ferri del chirurgo per un cancro pancreatico. «Sì, sono stato fortunato, in questi casi impari ad apprezzare tutto ancora di più». E così a settembre è potuto tornare al lavoro con una voglia di rivincita verso la vita ancora più grande del solito: «Ho capito che amo la vita, la amo veramente. Ho la migliore famiglia del mondo, ho il mio lavoro. E mi basta. Non sono il tipo che socializza molto, non mi piace andare in giro a tenere conferenze, amo la mia famiglia, amo dirigere Apple». «Un fortunato» Steve Jobs lo è stato in diverse occasioni, nei suoi cinquant’anni di vita e la sua fortuna forse è iniziata proprio lì dove per altri possono iniziare le difficoltà, in una nascita che avrebbe potuto renderlo infelice per sempre. Anche se nelle biografie ufficiali è un orfano adottato da una famiglia californiana e nei suoi ricordi è nato a San Francisco, Steve Jobs è in realtà nato — il 24 febbraio del 1955 — a Green Bay, Wisconsin, da una donna che si chiamava Joanne Simpson e da un padre egiziano di cui nessuno ha mai saputo il nome e che è scomparso nel nulla. Quel che è vero è che, nato da poco, viene adottato da Paul e Clara Jobs, una coppia di Mountain View, California, oggi cuore della Silicon Valley, «un posto dove c’è un capitale umano di straordinario valore». Steven Paul Jobs non è felice nella scuola di Mountain View, così «papà Paul e mamma Clara» si trasferiscono nella vicina Los Altos, dove il futuro ragazzo-prodigio frequenta la Homestead High School: non eccelle negli studi ma il suo insegnante di elettronica lo ricorderà per «avere sempre un modo diverso di guardare le cose». Crescere in Northern California — così diversa da quella del sud, la California di Los Angeles — segna il carattere e il futuro di Steve, che diventa uomo in mezzo a due universi solo apparentemente in contraddizione: quello della innovazione tecnologica e quello della musica psichedelica e del rock della West Coast. Degli anni Sessanta — «tutto quello che succedeva aveva successo, l’America mi sembrava così giovane e ingenua, un posto dove tutto era possibile» — assorbe tutto il meglio, del mondo degli hippies gli restano ancora delle eredità: il suo modo informale di vestire, una vi- Dopo la high-school Steve va al Reed College di Portland, Oregon, dove studia fisica, letteratura e poesia, ma che abbandona dopo appena un semestre. Tornato in California diventa uno dei più assidui frequentatori del “Homebrew Computer Club”, insieme a un altro ragazzo di qualche anno più grande di lui, che con lui divide la visionaria immagine del mondo del futuro: Steve Wozniak. E saranno proprio i due Steve — dopo una parentesi di lavoro alla società di giochi elettronici Atari — a fondare nel 1976 (quando Jobs ha solo 21 anni) la Apple. Di quei primi anni gli restano l’entusiasmo, il successo, i tradimenti che lo portano fuori dalla società da lui fondata, la voglia di rivincita. Gli resta “anche una figlia”, Lisa, avuta a 23 anni da una madre che non ha mai sposato e che da teen-ager va a vivere con il padre. Nel 1991, prima del grande ritorno da protagonista a capo della Apple, sposa Laurene Powell, conosciuta all’università di Stanford dove era andato a tenere una conferenza; con cui ha altri tre figli e con cui vive nella villa (degli anni Trenta) da quattro milioni di dollari di Palo Alto, orgoglio della cittadina che ospita Stanford. Risale a molti anni fa anche la scoperta di una sorella naturale, che cerca fino a quando non la trova; una sorella — «che oggi è una delle sue migliori amiche» — Mona Simpson, scrittrice di successo e autrice di The Lost Father, romanzo che ha molto di autobiografico; come molto reale è il personaggio di un altro libro che sembra la copia fiction di Steve Jobs. Nel familiare ambiente del Moscone Center Steve Jobs è tornato per lanciare il più ambizioso obiettivo della Apple nei suoi ormai quasi trent’anni di storia: «Dare a tutti un Mac». Ha parlato a braccio per quasi un’ora e mezza, con il suo abbigliamento preferito, che a guardare le foto nel corso degli anni sembra quasi il suo unico modo di vestire: jeans scoloriti, maglia a girocollo nera, scarpe da runner. Gesticolando in piedi, o stando seduto dietro un iMac ha illustrato il nuovo rivoluzionario «computer per tutti da 499 dollari», un iPod da 99 dollari, nuovi software e un sistema operativo ancora più semplice e ricco. «I nuovi prodotti?». Ci pensa un attimo, quasi a voler dire «ma non li avete visti?», poi scuotendo la testa spiega: «Sono qualcosa di veramente nuovo». Storicamente il cliente Apple è un «professionista creativo», uno che non si preoccupa troppo se deve pagare di più, in cambio vuole — e ottiene — alta qualità. Questa volta le novità di cui parla Jobs si rivolgono a un mercato di massa, a quelli che definisce gli switchers, gente che vorrebbe passare al Macintosh ma è frenata dai costi, oppure che vuole aggiungere il Mac al Pc come secondo computer, quasi fosse la «seconda casa» quella delle vacanze o delle grandi occasioni: «Noi pensiamo che il Mac mini, lo abbiamo chiamato così dopo il grande successo del mini iPod, rimuoverà l’ultima barriera per chi vuole avere un Mac. Adesso tutti ne potranno avere uno al prezzo più abbordabile che si sia mai visto». Prezzo abbordabile senza nulla perdere in qualità, «anzi gli diamo qualcosa di più, perché nel Mac mini ci sarà il nuovo sistema operativo Tiger, con un proprio motore di ricerca». Come rivoluzionario è il nuovo piccolissimo iPod Shuffle, che in realtà non è neanche un iPod ma un lettore di Mp3, solo più bello, più leggero, più semplice da usare e più economico. «Ci siamo domandati se ci sarebbero stati problemi senza il display per leggere i titoli delle canzoni», poi hanno scoperto che la stragrande maggioranza degli Ipodisti non lo guarda, una volta scaricata la musica mette la modalità shuffle, per sentire le canzoni così come capitano, random: «La gente ha scoperto un nuovo modo per ascoltare musica. Non sei tu che la cerchi è lei che ti trova». Sorride ripensando a quello che gli dicevano gli analisti quando lanciò il colorato mini iPod da 4 gigabyte a 249 dollari, un «prezzo troppo alto, non sfonderà». E invece aveva ancora una volta ragione lui. Del resto dal 2001, anno in cui ha fatto la sua comparsa il primo iPod, di quell’oggetto ormai cult ne sono stati venduti più di dieci milioni, di cui 8,2 solo nel 2004; una crescita del 500 per cento annuo. «L’era della musica digitale è appena iniziata e sarà un mercato enorme», aggiunge mentre fa segno con la mano che deve andare. La Apple diventerà una company di musica digitale? «No, ma è un grande mercato. Ogni anno in America ci sono 800 milioni di cd venduti, il che significa circa dieci miliardi di canzoni vendute legalmente. E noi le vendiamo a 99 cents l’una». «Sì sono proprio soddisfatto». ‘‘ ALBERTO FLORES D’ARCAIS
Scarica