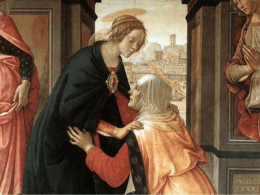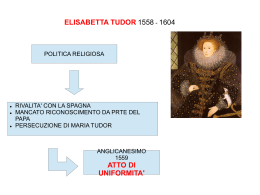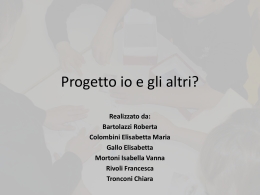Anonimo Fiorentino Tanghi lontani (Breve prontuario in forma di romanzo d’arte d’amor perduto e tango (con una breve appendice poetica)) 1 2 Nome: Elisabetta Diminuitivo: Elisa, o anche Lisa Significato: il mio Dio è perfezione. Origine: ebraica. Onomastico: 5 novembre. Nome distribuito in tutta Italia in modo omogeneo. L’origine ebraica era un composto di El, Dio, e Sheba, che vuol dire sette, numero che in ebraico è sinonimo di perfezione. 3 Nella vita siamo pronti a tutto, meno che a quello che effettivamente ci succede. Il protagonista, sentendosi confuso. 4 Il fatto che non succeda nulla non esclude che questo non possa avvenire in modo anche molto complicato. Il protagonista, sentendosi ancora più confuso. Se il mondo fosse fatto per godere ci sarebbe un comandamento che proibisce di nascere. Il protagonista, bevendo per dimenticare. Via via che si invecchia si perdono tutte le certezze. L’unica che resta è che andando avanti si invecchierà ancora. Il protagonista, in compagnia di una sbronza triste che gli ricorda una per una tutte le cose che voleva dimenticare. Oh no! Anche per oggi ho fatto tardi a quella c…o di riunione! Il protagonista, ricordandosi di colpo che tutto quel che bevendo gli riesce di dimenticare è di essersi iscritto agli Alcolisti Anonimi. La vita è una valle di lacrime: e io ho anche finito i fazzolettini… Il protagonista, mentre si prepara un battuto di cipolla. Cosa sono poi in fondo gioia e dolore, se non due facce del medesimo culo?. Il protagonista, in uno dei suoi in fondo non poi così rari momenti di gioia. 5 Guardati dall’avvicinarti alle donne: la vista non è abbastanza attenta per scrutarle: è un attimo breve come un sogno, ma si raggiunge la morte per averlo conosciuto. 6 Consigli di Ptahhotep al figlio, Antico Egitto, V Dinastia, circa 2500 A. C. Può l’uomo se vuole trascinare il suo desiderio Per una vena di coralli o di nudo celeste. Un giorno gli amori saranno rocce E il tempo una brezza che si addormenta sopra i rami. F. G. Lorca Ma, poiché questa bizzarra sofferenza possiede un’autorità inquietante, dobbiamo sinceramente desiderare che quest’anima, sperduta fra noi tutti, e, pare, vogliosa della morte, trovi in quell’istante serie consolazioni, e sia dignitosa! A. Rimbaud Non illuderti, la passione non viene mai perdonata: non ti perdono nemmeno io, che vivo di passione. P. P. Pasolini (La passione amorosa è un delirio; ma il delirio non è poi così straordinario; tutti ne parlano e ormai non fa più paura. Enigmatica è semmai la perdita del delirio: dove porta?) R. Barthes …ma lasciamo perdere. In fondo, siamo tutti mortali. W. Shakespeare 7 22 dicembre 2007, ore 18.24, Libreria Martelli, Firenze. 8 1. Mi sono innamorato di Elisabetta – che ben presto avrei soprannominato semplicemente Ella d’Essa – con ogni probabilità in data mercoledì 1 novembre 2006, in un orario che, se non vado errato, si colloca fra le nove e venti e le nove e quarantacinque di sera. Mi ero iscritto a un corso di tango, che ancora frequento, al Circolo del Boschetto (il Boschetto sarebbe un parco limitrofo a un celebre quartiere fiorentino, quello di S. Frediano), che era iniziato verso la metà di settembre. Il maestro era e resta Ignacio Elizari, un vero argentino d’Argentina, trasferitosi da Buenos Aires a Firenze circa dodici anni fa e che, strano a dirsi, il tango lo aveva imparato più che altro durante il suo soggiorno italiano. Fin da subito venni colpito dal suo stile, che mi pareva, come dire, un po’ bizzarro: uno stile insieme sommesso e impetuoso, rigoroso epperò, al tempo stesso, subdolo, insinuante, minacciosamente felino, capace di comporre coreografie anche molto complicate e ardue e di come per magia dissolvere la complessità della struttura e le difficoltà tecniche connesse in un incanto di maschia spontaneità, forte e insieme sottile, sobria ed elegante, in una facilità magica, potente e insieme quasi incredibilmente schiva. Guardandolo ballare scoprii, con una certa sorpresa, che la sua curiosa interpretazione del tango mi ricordava una poesia e un autore che in sé e per sé con il tango non c’entrano proprio niente, ma che, evidentemente, in un altro senso ci devono entrare per forza, dato che ad ogni figura che Ignacio intrecciava nel nebuloso e languido labirinto delle note di Pugliese (era questo l’autore che udii la prima volta entrando al circolo) come una cascata di gemme mi tornavano in mente i versi dedicati da Garçia Lorca al poeta statunitense Walt Whitman nella celebre Ode: “Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman he dejado de veer a tu barba llena de mariposas, ni a tus hombros de pana gastados por la luna, ni a tus muslos de Apollo virginal, ni a tu voz como una columna de 9 ceniza…. Ni un solo momento, Adan de sangre, macho, hombre solo en el mar, viejo hermoso Walt Whitman…”1 2. Eh si, il tango di Ignacio doveva avere davvero qualcosa di sia pur vagamente negromantico, o di ipnotico, se quasi non mi accorgevo che, ovviamente, stava ballando in coppia con qualcuno. Di ciò spero non si offenda la Bruna, la maestra che al corso si occupava di tecnica femminile e che quella sera, come al solito, ballava con lui per esemplificare alla classe i passi che si andavano a imparare. Che non la notassi più di tanto non credo voglia significare che ballava meno bene di Ignacio, ma, con ogni probabilità, soltanto che io sono stato e probabilmente rimarrò per tutto il resto della mia vita una sorta di eterosessuale ad alto rischio. Tanto a rischio mi sentivo in quel momento e così rapito mi ritrovai che, oltre il vertiginoso e vorticoso succedersi delle metafore di Garçia Lorca, oltre la mia sessualità – o quello che è – in perenne via di definizione, ecco che guardando Ignacio mi tornava in mente l’arcaico e immaginifico mondo delle milonghe argentine dei magici anni “enta” e “anta”, che pure non avevo mai visto neppure in fotografia (anche se, ovviamente, ne avevo sentito più volte parlare). Ignacio ballava col suo passo lento, imperioso e felpato, e simili a ombre cinesi le sue figure mi parevano galleggiare in oscure e tempestose nubi di fumo, di vino e di mate, in cui intravedevo brillare gli sguardi ambigui e calienti delle prostitute-ballerine, le luci fioche e pesanti delle lampade a olio, in cui sentivo risuonare le voci, i rumori e la miseria dei suburbios e dei barrios porteñi, e in cui vedevo incrociarsi i focosi insulti e i litigiosi coltelli dei gauchos insolenti e dei marinai ubriachi. Voglio dire, come poteva anche solo 1 Nemmeno un momento, bel vecchio Walt Whitman, ho cessato di vedere la tua barba piena di farfalle, né le spalle di velluto rose dalla luna, né le tue cosce di Apollo vergine, né la tua voce come una colonna di cenere… Nemmeno un momento, Adamo di sangue, maschio, uomo solo sul mare, bel vecchio Walt Whitman… 10 passarmi per la testa l’idea di non iscrivermi a questo corso, che pareva per di più, anche nel suo vago presente, situarsi in una sorta di non luogo fuori dal tempo e dallo spazio, dato che, forse per aggiungere incanto alla magia, il circolo in cui aveva sede era una struttura consunta, antiquata, di quelle che ancora oggi ricordano che vi furono un tempo luoghi e giorni in cui gli uomini erano uomini, e non un sorta di più o meno futile accessorio di quei computer che chissà, forse loro stessi hanno davvero, come si dice, costruito (lo ha scritto Günther Anders già negli anni ’50 nel suo omonimo e ormai celeberrimo saggio, che da almeno un paio di secoli – ahimè – “L’uomo è antiquato”, che il suo maestoso volo di gotico e terribile rapace si è smarrito in quello arzigogolato e fastidioso di una mosca, di un Icaro o un acaro non è chiaro se più bruscolo, minuscolo o corpuscolo, comica e impotente marionetta appesa al filo di ali troppo grandi per essere guidate, e troppo cervellotiche per poter essere capite, ali ronzanti che come e in contrario che nel mito non verso il sole della volontà di potenza lo trascinano, ma verso il polveroso baratro del suo misero e grigio destino di borghese – come sempre mortale si, però – ahi! – però – non più come un tempo avveniva – nella maschera gloriosa di un eroe tragico – ma invece nella museruola di una strana sorta di animale da compagnia, ormai inesorabilmente costretto al guinzaglio da quegli imperscrutabili robot che un tempo uscirono – chissà come – dalle sue favolose mani: quattro mura come quelle di quel circolo e una danza come il tango forse mi parevano tanto meravigliose e affascinanti perché – immersi come siamo nell’anonimato massmediatico e massmacchinico di questa nostra quasi inconcepibile éra moderna come in un maelstrom si può essere risucchiati e come resuscitati da simboli e archetipi sopravvissuti all’imperversare della tecnica, simboli che, quasi increduli di sé stessi e del loro avito potere, ancora rimandano alle passate glorie della nostra ex magnifica razza, ex umana, e ai suoi ormai quasi inimmaginabili, eroici splendori, o, più umilmente, ad “Anni di scogli e di orizzonti stretti, a custodire vite ancora umane e gesti conoscibili”2). 2 E. Montale, da “La bufera e altro”. 11 3. Mah! Comunque sia, catastrofi antropologiche e mutazioni epocali o, soprattutto, reminescenze letterarie e umanistiche a parte (conoscevo allora il mondo del tango più che altro attraverso il grande poeta e scrittore argentino Josè Luis Borges, un nome che avrò modo di pronunciare ancora molte volte e per diversi motivi andando avanti in questo racconto), devo riconoscere che a quel tempo ero del tutto inesperto di questo a tutt’oggi e non ostante tutto piuttosto eccentrico tipo di arte e di ambiente, ed era anche per questo motivo che volevo frequentare più di un corso: perché reputavo che un’ora settimanale non sarebbe senz’altro stata sufficiente per apprenderne le formule e gli incanti in modo degno e decentemente rapido nemmeno a un apprendista stregone di talento quale ero o credevo, o, comunque sia, mi vantavo d’essere (in effetti, in quel momento, come del resto anche in questo, frequentavo e frequento anche un altro corso, oltre a quello di Ignacio, quello di Patricia e Matteo, ma siccome quanto ivi accadde non ha rilevanza alcuna quanto alle losche vicende che si verificarono al Boschetto, trascurerò d’ora innanzi di accennarvi). Fu così che, seduta stante, mi iscrissi e presi a frequentare la lezione che si svolgeva fra le otto e trenta e le nove e quarantacinque, che era quella dedicata ai principianti o primi passi che dir si voglia. Verso le dieci, dopo qualche minuto di pausa dedicata per solito ad alcolici, sigarette e alle quattro chiacchiere annesse e connesse, iniziava quella per gli allievi avanzati, che durava fino alle undici. Vi era un solo appuntamento settimanale, che era e resta, appunto, quello del mercoledì. 4. 12 Mi sembra che fu già verso la terza o quarta lezione, o chissà, forse da subito che osservando il variegato e incostante panorama degli aspiranti ballerini (il corso era piuttosto informale, e si poteva accedervi a piacere, senza obblighi di frequenza di alcun tipo) ebbi modo di notare una ragazza che assomigliava in modo caratteristico a un’altra, che avevo conosciuto intorno ai miei quindici anni, una ragazza che faceva la modella e che per ovvi motivi mi è rimasta molto impressa. Una peculiarità di quel volto antico e meravigliosamente ormai perduto era senz’altro l’andamento della curva degli zigomi, che partiva un po’ sopra le sopracciglia e che si allungava dolcemente, interminabilmente, fin quasi sotto alle labbra, morbide, sensuali, che formavano un cuore talmente perfetto da ricordare quello di certe protagoniste dei fumetti (ora come ora mi vengono in mente solo quelle di Jessica Rabbit, chissà, forse è perché si tratta dell’unica protagonista dei fumetti con le labbra a forma di cuore che sia mai esistita). La lunghissima curva dello zigomo era accompagnata da un simile, interminabile incurvarsi dell’ovale, che andava a perdersi in un mento anch’esso, strano a dirsi, di forma che vagamente ricordava un cuore: una forma dunque altrettanto o forse addirittura più caratteristica che quella delle labbra, che mentre parlava sembravano accompagnare ogni parola con un bacio dato, chiesto, o sognato. Il suo sguardo poi era un vero e proprio mare aperto: le sue splendide iridi, enormi, luminose, insondabili, sembravano a volte tracimare in una sorta di glauco orizzonte, in specie quando rideva, di una risata lieve, argentina, che zampillava di una gioiosa, giocosa e fin quasi insopportabile grazia muliebre. E, quasi a contrappuntare tanta sfuggente e struggente delicatezza, c’era la forza quasi maschia del suo profilo, caratterizzato dalla fronte alta, e da un naso aquilino di forma molto decisa e forte, che però, siccome piuttosto piccolo, riusciva in quella sorta di gioco di prestigio estetico che si produce quando una parte quasi riesce a confondersi quanto a contrastare con l’insieme (un effetto simile lo creano, per esempio, le diverse gradazioni dei rossi nel celebre Innocenzo X di Velasquez, che tanto fu di ispirazione a Francis Bacon, o lo sfumato dello sfondo in controcanto e in coro allo sfumarsi del volto della Gioconda (la Gioconda è, in questo senso, 13 uno dei quadri più attuali e moderni che esistano, forse, in un certo senso, ancora più attuale e moderna dei quadri di Bacon, non ostante i quasi cinque secoli trascorsi dalla sua realizzazione: vedi come in quel ritratto la forma del viso, e di ogni suo tratto, lo sfondo e ogni singolo elemento dello sfondo si perdano l’uno nell’altro, sfumandosi e trascolorando nella diafana ambiguità del gioco delle luci e delle ombre dove pare perdersi la solidità della materia, che nello sfuggente scivolare di luce e di colore perde indefinitamente i suoi confini, la sua quasi inconsistente consistenza (la Gioconda è dunque la teoria della relatività fatta simbolo, opera d’arte, estetica, dato che nella relatività si afferma proprio questo, che materia e luce, ovvero, massa ed energia, sono la stessa cosa, e dunque vista e tatto, ancora, la stessa cosa, e dunque il vicino e il lontano, il qui e l’altrove, l’io e il tu, ancora di più, la stessa cosa (lasciatemelo dire, anzi, esclamare: ah, Leonardo..!))). 5. Beh, comunque sia, Einstein e Leonardo a parte, la ragazza che avevo notato al corso di tango mi ricordava molto questa rara bellezza del mio ormai lontano o lontanissimo passato, anche se il suo aspetto mi pareva – ahimè – assai meno inebriante. La curva gemella degli zigomi e dell’ovale si allungava in modo molto simile a quella, certamente, ma sembrava allungarsi troppo, finendo in un mento ancora una volta troppo fine, e di certo non a forma di cuore, come neppure la bocca lo era: non che fosse brutta, questo no. Era una bocca piuttosto grande e sensuale, a suo modo bella, certamente, ma che nondimeno non aveva proprio nulla di caratteristico. Il naso era aquilino, come quello della ragazza dei miei quindici anni, ma anche in questo caso si faceva notare più per la sproporzione che per la proporzione: in effetti, il naso del presente, in relazione a quello del passato, mi pareva troppo slanciato in avanti, e insieme troppo affilato, così che ricordava un becco, questo è vero, però con tratti assai più gallinacei che aquilini (a parlar male si direbbe: quel naso sembrava esprimere una sorta di vacua fissità piuttosto che un 14 carattere deciso e una sensualità potente e trattenuta). Inoltre – ancora – troppo grandi mi parevano anche gli occhi, oltre che di un color castano scuro piuttosto anonimo, tanto che infine il tutto mi pareva assomigliare, più che alla ragazza così tanto sognata e così poco sfiorata della mia adolescenza, a certe banali e diffusissime immagini degli extraterrestri che, nella vista di fronte, vengono rappresentate con occhi enormi e mento minuscolo: magari belle, in certo modo, ma di una bellezza aliena, non umana, e certamente non seduttiva, o almeno non erotica: non propriamente femminile insomma! Guarda un po’, riflettevo scrutandola di sottecchi, come è vago e fragile il concetto di ciò che consideriamo “bello”: aggiungi un mezzo centimetro qui, lo togli di là, cambi il colore e il taglio degli occhi, la sfumatura e il tipo dei capelli, ed ecco che di un volto meraviglioso ne hai fatto uno qualsiasi, o, chissà, forse addirittura un po’ bruttino. 6. Roland Barthes aveva senz’altro ragione: provarsi a raccontare una storia d’amore significa in realtà provarsi a raccontare una nonstoria. L’amore non è fatto di mutamenti catastrofici, di novità epocali, di salvezze o apocalissi, o comunque di quantità e qualità tangibili e universalmente significanti. L’amore è fatto di sfumature indefinibili, di simboli privatissimi e sensazioni intraducibili, di frasi e situazioni che vogliono dire tutto e nulla, di gesti ineffabili e inafferrabili, di terrori suscitati da circostanze apparentemente del tutto innocue, quali uno sguardo che per un attimo assume una sfumatura di freddezza, l’agonica attesa di una telefonata che non arriva, l’inspiegabile ritardo a un appuntamento importantissimo – così importante che forse porterà a un altro appuntamento! L’amore cresce nutrendosi di entusiasmi per un sorriso, per un saluto, di infantili, tormentose, crudeli gelosie per persone, animali o addirittura per oggetti che possono anche essere del tutto insignificanti (come le celebri pere del Werther, che forse null’altro e nulla di meno simboleggiavano che le puppe a pera della sua dolce 15 Lotte), di sgomenti e gelidi sussulti per un’alzata di ciglia o di sopracciglia, magari colta di sfuggita, di grida soffocate nel cuscino per una scenata che forse non significava la fine di tutto ma solo l’inizio del periodo mestruale – una non-storia appunto, fatta dunque di non-eventi, che proprio per questo è così difficile e imbarazzante raccontare, o anche solo ricordare (Rousseau ne “La nuova Eloisa” sostiene, con ogni sorta di buona ragione mi pare, che nella lettera dettata da un genuino amore non si troverà mai “Niente di rilevante, niente di notevole; non si ricordano né parole, né modi, né frasi; non si ammira niente, non si è colpiti da niente.” (in questo senso possiamo dire che non c’è mai stato al mondo storia d’amore o innamorato che non assomiglino in modo del tutto caratteristico alla madre di tutte le commedie dell’Assurdo, “Aspettando Godot”, non meno che alle surreali non-vicende dei suoi protagonisti, Estragon e Vladimir: ma, anche in questo caso, avremo modo di tornare sull’argomento). Pure, strano a dirsi, per quanto l’amore effettivamente vissuto abbia una consistenza che pare a volte sfiorare quella impalpabile del nulla, lo stesso non si può dire di un’istituzione ad esso correlata, la letteratura erotica – lettere, racconti, o poesie d’Amore – intendo – fenomeno che, contraddittoriamente, sembra assumere sostanzialità profonda e significato rilevante per l’Umanità tutta, Umanità la cui Storia, come tutti sappiamo, è fatta – questa si! – di eventi grandi e importanti, e degni perciò di gloria ed epopea. Ed è proprio questa sconcertante non meno che inesauribile fonte di idee e immagini universali a riscattare, almeno in alcuni casi, la sdolcinata e puerile vacuità degli amori individuali, che però, di nuovo, sono i soli da cui può nascere quella grande e autorevole istituzione – la letteratura erotica appunto – che da secoli celebra, per esempio, i Dante e i Petrarca con gli sterminati apparati storico-critici, l’accavallarsi e lo stratificarsi delle interpretazioni, dei convegni, delle polemiche, dei saggi critici, e, perché no, delle cavillose e feroci interrogazioni a incolpevoli studenti del liceo o dell’università, che nulla ne sanno e meno ne vogliono sapere del perché Beatrice la dava non si sa bene a chi piuttosto che a Dante, o di elucubrare sul fatal dilemma se Laura fosse una persona realmente esistente o semplicemente una fantasia 16 di masturbazione del Petrarca. E, a proposito di non-storie, chi si rende conto oggi, fra i critici di Dante, che se Beatrice fosse morta a cinquant’anni di noia invece che a venticinque di parto, con ogni probabilità la “Divina Commedia” non sarebbe mai stata scritta, dato che questo viaggio nell’aldilà venne compiuto da Dante, con buona verosimiglianza, solo per ritrovare o ripensare la di lei diletta e ormai perduta immagine? Da questo punto di vista, sia pure per via traslata, anche la mia nonstoria con Elisabetta può assumere una qualche rilevanza e può essere meritevole di un sia pur labile non-racconto, non fosse altro che per quel barlume di luce che può gettare su quell’istituzione così importante, così umanamente rilevante che sembra essere la letteratura erotica – nella società occidentale in particolare – ma anche nel mondo umano in generale, cinesi, sumeri e aborigeni australiani compresi (tanto per dare una sia pur pallida idea della diffusione spazio-temporale della problematica di cui ci accingiamo a trattare in queste pagine, andiamo in Egitto, un paio di millenni prima di Cristo, quando un ornitorinco innamorato celebrava così le grazie della sua diletta ornitorinca: “Nera è la sua chioma, più nera della notte, più delle bacche del susino. Rosse sono le labbra, più dei grani del diaspro, più dei datteri maturi…”). Però! Come è curioso notare che una simile sterminata, millenaria, interminabile impresa vada in ultima analisi a fondarsi su nonsenserie tanto minime, tanto infantili – quali Beatrice che da e toglie il saluto a Dante – in tutto e per tutto simili – almeno nella loro comica e cosmica insignificanza – alle vaghe e melanconiche reminiscenze che un volto estraneo, osservato di straforo durante un corso di tango periferia – amaramente e dolcemente mi suscitava! Anche se devo riconoscere che tali alate sensazioni, per quanto inizialmente molto intense, durarono infine assai poco. 7. 17 La contemplazione del volto della ragazza fu all’inizio, come si può immaginare, del tutto estatica e disinteressata, portatrice di lacrimevoli rimpianti quanto alla perduta giovinezza, le perdute illusioni, le perdute ambasce – rimpiante queste ultime quanto e più che le gioie, di cui alla fine si scopre che, se mai vi furono, durarono lo spazio di un mattino (cosa strana questa, non meno che antica, o addirittura classica, dato che già se ne era accorto e l’aveva cantata Sofocle, più o meno cinquecento anni prima di Cristo3 (Calderon de la Barca, nell’apertura del suo celebre capolavoro “La vita è sogno” addirittura non esita a far recitare a Rosaura i seguenti versi “que tanto gusto había en el quejarse, un filósofo decía, que, a trueco de quejarse, habían la desdichas de buscarse”4). Per alcuni splendidi, pungenti, commoventi minuti, mi tornarono in mente passeggiate mano nelle mano lungo crepuscoli e lune teneramente condivisi, canzoni tristi allegramente fischiettate recandomi tremante ad appuntamenti dall’esito incerto, cene romantiche, tantalici scolli e oscuri spacchi, che sembravano porte socchiuse su un così lontano eppur così vicino paradiso! Cos’altro dire ormai di quelle perdute sere della mia adolescenza, se non quel che disse Leopardi dei perduti orizzonti della sua perduta infanzia, “lingua mortal non dice quel ch’io sentiva in seno”? Ma, come capita, ben presto l’estatica contemplazione si interruppe e il presente impoetico prese rapidamente il sopravvento sul poetico passato. In effetti, a ben pensare, io mi recavo a quel corso per imparare il tango, non per coltivare più o meno leopardiane rimembranze, e dunque cominciai prontamente a prender mentalmente nota delle abitudini della sconosciuta allieva più o meno come facevo con tutte le altre, ovvero più che altro per rendermi conto di quale livello fosse la ballerina in questione. La prima volta, se non ricordo male, colei che avrei ben presto soprannominato Ella d’Essa arrivò intorno alle nove e trenta, o comunque in un orario che si trovava praticamente a ridosso della 3 Ne “L’Edipo a Colono” Medea esclama piena di sgomento e meraviglia: “anche delle sofferenze vi è infine nostalgia!” 4 “Tanto c’è gusto a lamentarsi che pur di farlo si vanno a cercare le disgrazie per farsene un pretesto” 18 lezione successiva alla mia, quella per gli allievi avanzati, che si svolgeva fra le dieci e le undici. Ciò mi aveva fatto pensare che fosse “una di quelle brave”, e per questo, almeno all’inizio, evitai accuratamente di ballarci, per paura di rimediare qualche prevedibile non meno che sgradevole brutta figura. Ma poi, verso la metà di ottobre mi sembra, la vidi arrivare alle otto e trenta in punto, e la volta successiva anche prima, e ne dedussi che probabilmente non doveva essere di un livello molto superiore al mio, e che avrei potuto ballare con lei senza sfigurare, o, almeno, senza sfigurare troppo. Incoraggiato anche dai buoni risultati del mio primo mese di addestramento, che mi facevano sentire un po’ più sicuro di me, il primo mercoledì del novembre 2006 (o forse era l’ultimo, o, addirittura, il penultimo di ottobre?), al momento del cambio delle coppie, ebbi l’occasione e il coraggio di invitarla a ballare, invito che la ragazza accettò con un sorriso che mi parve tanto profondamente quanto sorprendentemente magnetico: dolce, confidente e, strano a dirsi quanto a una perfetta sconosciuta, persino familiare. Si avvicinò con passi leggermente tremanti, forse addirittura un po’ nervosi (sono il classico tipo la cui corporatura si definisce, di solito “alta e atletica”, e può darsi che, mio malgrado, le incutessi un po’ di aprioristica soggezione), ma quando fu vicina mi sorrise ancora con rinnovata dolcezza mentre con gesto tanto ampio come timidamente soave poggiava la mano sinistra sul mio braccio destro. Fu a quel punto che io, senza che niente di più fosse accaduto e, soprattutto, senza che potessi veramente credere a quanto mi accadeva, rabbrividii fino alle lacrime, fino alle ossa. Come i protagonisti di certi orribili romanzi rosa sentii subitaneamente scorrere in me da quel tocco tanto lieve e fatato da parermi sul momento quasi inumano, qualcosa che mi parve una sorta di fluido magico: un dorato infuso di sensualità e pudore, di timidezza e slancio, di infantile grazia e infantile goffaggine. Come andava via leggera, come si affidava, si avvitava e quasi si annidava nel mio abbraccio! Facemmo non più che pochi passi e la mia mente prese a vaneggiare come un veggente in preda alla più sconvolgente e luminosa delle 19 visioni: “La tempesta ha benedetto i miei risvegli in mare. Più leggero di un sughero ho danzato sui flutti”5! Preso come da un sorta di delirio desiderai subitaneamente e selvaggiamente di abbracciarla, di baciarla, di spogliarmi, di spogliarla, di stringerla e di non lasciarla più, mai più! Sentimenti questi che, oltre a parermi del tutto incongrui e ineducati in relazione a una perfetta sconosciuta, per di più molto male si accoppiavano con l’emergenza del momento, ovvero quella di guidare la ragazza per la sala per almeno un quarto d’ora. Così, stringendo i denti, mordendomi la lingua, richiamando all’ordine il mio improvvido fantasticare a furia di indignate autoesortazioni e severe autocritiche (del tipo “ma brutta testa di c…o, cosa c…o ti prende, vedi di ballare in modo decente invece di…” etc. etc.), riuscii a sopportare senza commettere atti inconsulti o impuri il mio incredibile e dunque anche un po’ increduto delirio d’amore, che durò e proseguì ben oltre il sospirato cambio di coppia, giunto infine dopo ben sei estenuanti tanghi. Confusamente, mentre ancora vittima di un lieve postumo di shock tentavo al tempo stesso di osservare la ragazza e in qualche modo di proseguire la lezione, mi tornò in mente un film che avevo visto, guarda caso, anche quello da adolescente – (o, se, dopo, quanto dopo?) – un film, comunque, che si intitolava “Ballando con uno sconosciuto” (o almeno mi pare). In particolare, ricordai vividamente un’immagine fatale, in cui il tipo, che non mi ricordavo chi fosse, stringe la tipa ed entrambi i tipi si scrutano con uno sguardo tipo: ehi! ma come abbiamo fatto a resistere fino ad ora l’uno senza l’altro? E ora che siamo allacciati in questo disperato abbraccio, come anche solo sperare di riuscire a slacciarci? Dio mio, ragionavo fra me, ma come è possibile che la vita umana reale possa avere tanta fantasia da spingersi fino al punto di assomigliare alle fantasie più irreali, o surreali o financo farneticanti degli esseri umani? 5 A. Rimbaud, dalla celebre poesia “Il battello ebbro”. 20 8. “E da allora mi sono immerso nel Poema del Mare, intriso d’astri e lattescente.. ove tingendo a un tratto le azzurrità, deliri e ritmi lenti.. più forti dell’alcol, più vasti delle nostre lire, fermentano gli amari rossori dell’amore!6”. Ebbene si, devo tanto liricamente quanto vergognosamente confessarlo: quell’improvvisa infatuazione, troppo pericolosamente simile a un film o a un romanzo rosa per poter essere presa in seria considerazione financo da un bambino di due anni, mi lasciò tuttavia sul momento del tutto sconvolto, assolutamente sgomento nonché per lunghi minuti quasi del tutto incapace di intendere e di volere (della serie “portatemi un bambino di due anni, perché io non ci capisco niente!” (Groucho Marx)). Oggi, con uno sguardo retrospettivo, posso ipotizzare che il fenomeno non fosse così improvvido e incredibile come mi era parso sul momento. Forse, fin da quando avevo notato la caratteristica somiglianza di quella sconosciuta ballerina con quell’amore tanto magico e rimpianto della mia adolescenza la mia mente aveva preso a fantasticare febbrilmente, e il momento del contatto fisico era servito soltanto a rendere coscienti dei sentimenti che si erano già fatti strada nel mio inconscio, a causa e in seguito della marea sensuale dei dolci ricordi da cui quel volto presente era stato come subissato – non lo so! Di certo c’è solo che in quel momento non ero capace di formulare simili raffinate ipotesi esplicative. Per tutto il resto della lezione infatti restai come in preda a una sorta di strano capogiro, che non mi impediva di ballare, questo no, ma che comunque trascinava il mio sguardo e soprattutto i miei passi a seguire la fatale scia delle fatate evoluzioni della sconosciuta ballerina come gli occhi di un bambino seguono quelle di un aquilone, cosa che, prevedibilmente, mi portò a sbattere un paio di volte contro altre coppie e a commettere tutta una serie di errori difficilmente perdonabili anche a un principiante come me. Durante l’intervallo scesi al bar del circolo a bere e a fumare, ma, per quanto 6 A. Rimbaud, ancora da “Il battello ebbro”, poesia a cui faremo ulteriormente riferimento nel corso della narrazione citando il poeta francese. 21 abbondassi in entrambe queste operazioni assai più del solito, lo stratagemma riuscì solo in parte a correggere quella sorta di lapsus calami erotico in cui ero improvvisamente caduto. Ciò fece si che al termine della lezione non potetti – ahimè – resistere alla tentazione di presentarmi alla ragazza e di chiedergli se per caso fosse interessata a fare con me qualche “pratica” (una pratica sarebbe una sorta di lezione in cui però non si impara nulla di nuovo, e invece si mette – appunto – in pratica e si perfeziona ciò che si è già imparato: a questa lezione ci sono comunque dei maestri, ma molto spesso ci si reca in coppia e questo era precisamente quello che ambivo di fare in quel caso). Non appena ebbi formulato la mia improvvida richiesta mi pentii istantaneamente di tanta fretta, perché, come tutti o quasi tutti sanno, la fretta è una pessima consigliera sempre, ma in specie quando si tratta di corteggiare una donna. Imberbe adolescente avevo letto ne “Il tempo ritrovato” delle osservazioni sul tema che mi avevano lasciato sul momento alquanto stupito, se non proprio del tutto sconvolto: “Le relazioni con una donna che amiamo possono anche restare platoniche per una ragione diversa da quella della virtuosità della donna o della natura poco sensuale dell’amore da lei ispirato. Tale ragione può consistere nel fatto che l’innamorato troppo impaziente per la violenza del proprio desiderio, non sa aspettare con sufficiente simulazione di indifferenza il momento in cui potrebbe ottenere quanto desiderato (..) e a chi, troppo nervoso per nasconderlo i primi giorni, ha lasciato indovinare il proprio insanabile desiderio, esse (“esse”: ovvero le donne desiderate, ovvero quelle maledette non-fatemi-dire-cosa N.d.A.) sanno di potersi offrire il lusso di non darsi mai”. Era il tempo della mia splendida e incredula innocenza quello in cui leggevo e rileggevo questo incredibile passo, e ogni volta mi sentivo come entrando e uscendo da uno strano tunnel degli orrori, non so dire se più sconcertato, spaventato, o perplesso. Ma ben presto, nel corso della consueta e dura “éducation sentimental” cui la vita, volenti o nolenti, gaudenti o dolenti, infine tutti inesorabilmente sottomette, ebbi modo di rendermi conto di persona che il buon vecchio Proust era stato fin troppo ottimista nel dipingere le relazioni 22 fra i sessi: tanto poco sono affini il maschio e la femmina del malcapitato genere umano che, a differenza dell’uomo, il massimo piacere della vita la donna non lo ricava affatto con il coito ma – chissà perché, forse a causa del peccato di Adamo – nel veder sbavare fino alla morte un uomo di lei apertamente, perdutamente nonché incontrollabilmente infatuato (ricordo a me stesso e al lettore che, secondo la Bibbia nella versione dei Settanta, il peccato di Adamo consistette essenzialmente nel tentare di conquistarsi le grazie di Eva con la fatidica frase “tanto ti amo, oh Eva, che oso senza tema proclamare davanti a tutti che tu sei per me l’unica donna al mondo”; Eva si incavolò tanto che intentò una causa di divorzio ad Adamo senza nemmeno averlo sposato, e accettando le avance del famoso serpente della famosa mela, con le amare conseguenze che tutti conosciamo, partorire con dolore, lavorare con sudore, magari con un computer Apple in un ambiente con l’aria condizionata che te lo gela addosso e ti fa morire di raffreddore). Ma, a parte queste sacrosante non meno che irritanti considerazioni, a preoccuparmi era anche un’altra cosa. Fatta l’idiozia e segnato il punto a mio sfavore, divenni infatti anche di colpo consapevole che, con ogni probabilità, al momento in cui la sconosciuta avesse cominciato a farsi conoscere i miei subitanei sentimenti nei suoi confronti avrebbero potuto cambiare non meno subitaneamente che radicalmente: cosa impediva che dietro a quelle movenze leggiadre e soavi non si nascondesse un’oca acida, o frivola, o vanitosa, o tutte e tre le cose insieme? E, anzi, pensandoci bene, c’era forse da aspettarsi qualcosa di diverso? Quante persone mi è mai capitato, non dico di amare, ma anche solo di stimare minimamente in vita mia? Nemmeno una su cinquanta. Ma allora come sperare che un incidente del genere potesse evolversi in qualcosa di diverso da una terribile delusione? Ma ormai era troppo tardi: sorridendo gentilmente la ragazza mi rispose che si, era interessata a fare queste pratiche, e mi dette il suo numero di cellulare, che a quel punto non potevo più non registrare sul mio. Fu così che, contro le appena formulate sagge ponderazioni e contro la mia coscienza di adulto razionale e vaccinato, fremendo e stringendo al cuore come un talismano il telefonino, in cui avevo inserito quelle 23 banali cifre che però in quel momento mi sembravano la segreta formula di una specie di rivelazione talmudico-cabalistica, ecco che appena uscito dal circolo caddi in preda ad una sorta di deliquio, simile in tutto o forse insino in peggio a quello che subitaneo colse Romeo alla vista di Giulietta. 9. “Oh, essa insegna alle torce come splendere. Sembra pendere sul volto della notte come ricca gemma dall’orecchio d’una Etiope!7”. Preda di un’inspiegabile, agonica euforia, la memoria non poteva trattenersi dal tornare a quel magico sentire che la sconosciuta ballerina mi aveva donato, e tanto incontenibile era la gioia che mi squassava il petto e le meningi che ben presto si tramutò in una sorta d’insopportabile tormento. Con quella parte di me che in quel momento di imprevista esaltazione ancora sembrava conservare un minimo di ragionevolezza cercavo di nuovo di richiamarmi all’ordine, argomentando che quella tempesta emotiva, nel bel mezzo della quale stavo disperatamente annaspando, quasi certamente non era stata scatenata dalla ragazza, di cui non sapevo niente, ma da una mia situazione personale. In effetti, erano molti anni che stavo da solo, e poteva darsi che tutto quell’amoroso “Sturm und drang” fosse più che altro dovuto al mio desiderio così lungamente represso e insoddisfatto. Forse tutte quelle appassionate immaginazioni stavano insorgendo in me così prepotenti non perché l’oggetto ne fosse degno in sé e per sé, ma perché io avevo bisogno di provarle! Certo, è vero senza meno quel che Platone fa dire a Socrate nel “Fedro”, che “la testimonianza degli antichi ci dice che la follia degli dèi è più bella della saggezza di origine umana”, ma è non meno vero che la saggezza umana, nella sua terrena pesantezza, brinda di solito ai suoi successi con lo champagne, e non con la cicuta! E così riflettendo intanto mi ripetevo come un mantra protettivo questa 7 Per chi non lo ricordasse, è proprio questo il delirio che colse il malcapitato Romeo alla vista della non meno malcapitata Giulietta. 24 semplice formula: è una sconosciuta, so solo come si chiama, è una sconosciuta so solo come si chiama, eccetera, eccetera, eccetera. Presto, ne ero certo, al massimo in mezzora, anzi meno, in un quarto d’ora, tutto quel gran fantasticare si sarebbe calmato, e sarei tornato a vedere e ad accettare la mia consueta e cruda realtà di persona introversa e solitaria, se non proprio del tutto vuota e incapace di amare, ovvero, in ultima analisi, di quel misero misogino misantropo che in vita sua ha conosciuto quel che di solito la gente chiama “amore” sol perché e chissà perché un paio di volte lo ha ricevuto. 10. Devo però riconoscere che tali autoesortazioni, per quanto altamente illuminate e profondamente sagge, non ebbero fin da subito gli effetti auspicabili e sperati. Al contrario, il mattino dopo, appena alzato, mi sorpresi ancora tanto profondamente e inaspettatamente sconvolto che fui costretto ad attaccarmi e scolare la per fortuna ancor mezza piena bottiglia del whisky per trovare un minimo di pace ed equilibrio, proprio come avevo fatto la sera prima con l’altra metà, il tutto solo per trovare la forza di andare a letto e di restarci, anche se in effetti non avevo dormito più di due o tre ore. A dispetto della bottiglia ormai vuota, la splendida, febbrile e dolorosissima fantasticazione erotica non ne voleva sapere di scendere a patti con la realtà, ma – Dio mio! – che detto da un ateo è un detto che dice proprio tutto – in ogni caso dovevo assolutamente calmarmi: a parte il fatto che, come qualsiasi persona normale, dovevo recarmi a lavoro e, possibilmente, anche lavorare, già a quel punto l’esperienza aveva avuto tutto il tempo di insegnarmi alcune tanto antiche e risapute quanto ardue e neglette verità – fra cui anche quella forse più importante ai fini di una vita, non diciamo felice, ma, almeno, non troppo infelice, ovvero la solenne e dura massima che ci avverte che, onde evitare disastrose delusioni, non bisogna mai lasciarsi andare a insensate quanto pericolosissime illusioni. Quindi dovevo riafferrare il prima che fosse possibile l’inesorabile realtà che si nascondeva dietro i fremiti di quel per me ormai piuttosto inusitato 25 delirio (sappia il lettore che il mio motto, almeno fino a cinque minuti prima di quello strano incontro, era una non so quanto celebre frase del “Caligola” di Camus che suona: “Ciò che più mi commuove è la mia indifferenza”), ovvero convincermi che quanto era successo la sera precedente era soltanto uno scherzo dei lunghi anni di disamore e solitudine, della forzata astinenza connessa, o magari del mio inconscio, o della magia del tango, oppure, che so, della macumba della rumba, della samba della Standa, o, al limite, di un demonio disoccupato che non aveva trovato sul momento nulla di meglio da fare che mandarmi completamente fuori di testa! Di solito si dice che i demoni passino il tempo che spendono su questa valle di lacrime a far seccare le piante che stanno nei giardini degli umani, a far fuori animali domestici (chissà perché lasciano in pace piante e animali selvatici), o, ancor meglio e più volentieri, a far vomitare robaccia color nero ossidiana e verde smeraldo nonché parlare lingue esotiche e possibilmente morte e sepolte al primo disgraziato che gli capita a tiro, non prima di avergli trasformato la faccia in qualcosa di simile alla robaccia che ha appena vomitato – oltre ad altre orrende e tremende non meno che del tutto inutili meraviglie: perché dunque un demonio non dovrebbe incaricarsi infine di far perdere la testa a uno sconosciuto per una sconosciuta, così, tanto per variare il menù di esorcisti, demonologi e psicoanalisti? Comunque sia, samba o Standa, rumba o macumba, qualsiasi cosa poteva essere successa, ma, di certo, quell’innamoramento che ancora così intensamente mi turbava, no, non poteva essere assolutamente nulla di concreto, di possibile e, soprattutto, nulla di nulla di reale! Dunque, tanto per fare un esempio, avrei dovuto guardarmi bene dall’usare quel numero di telefono che così improvvidamente avevo chiesto: nel caso che Elisabetta avesse effettivamente accettato il mio invito (ora sapevo il nome della sconosciuta ballerina, che non per questo però restava molto meno sconosciuta) nell’ora o due che avremmo passato insieme alla pratica non mi sarei trovato di fronte a quella sorta di Fata Turchina che il mio vaneggiamento aveva prefigurato, ma bensì quella ragazza che avevo notato un mesetto prima. Una ragazza dunque che mi sarebbe apparsa – oltre che mediocre o, chissà, forse persino un po’ bruttina – 26 con ogni probabilità anche stupida e antipatica, dato che stupide e antipatiche mi sono risultate infine quasi tutte le donne che ho incontrato in vita mia, eccetto due o tre, a esagerare quattro. Poteva forse non essere così? Ma no, ma certo, doveva essere così! – questo mi ripetevo pieno di fervore ma – ahimè – va da sé che sul momento non riuscivo a trovare il verso, non dico di credere, ma anche solo di prendere in sia pur minima considerazione quelle mie proprie e mie stesse massime di saggezza, tanto l’euforia dei sensi sembrava capace di assordare ogni facoltà dell’anima in generale e la Ragione in particolare, che, come tutti sanno, è quella dotata della voce più sobria e sommessa, degli argomenti più saggi e ponderati e che, proprio per questo, non riesce a farsi intendere quasi mai, in particolare quando sarebbe indispensabile che lo facesse: non ce lo dimostra questo perfino la storia della filosofia, e proprio col suo personaggio più celebre e saggio? 11. Nel “Fedro” Platone ci racconta quel che pensò o che comunque disse Socrate di questa curiosa materia, o, chissà, forse, per bocca del suo maestro ci racconta in quel che lui stesso ne pensa, chi può dirlo. Comunque sia, in quel celeberrimo dialogo Socrate parla al giovinetto Fedro e per spiegargli che sia l’essere innamorati e dunque anche l’amore, come prima cosa gli parla dell’anima umana e di quali siano le celesti vicende che essa trascorre prima di nascere, quando eravamo “puri e privi di questo sepolcro che portiamo in giro e che chiamiamo corpo, imprigionati in esso come nelle valve di un’ostrica”. Socrate paragona l’anima a un carro alato, in cui l’auriga rappresenta ciò che di solito si chiama “intelletto”, o “ragione”, e questo auriga è chiamato a guidare il carro che viene trainato da due cavalli, uno dei quali rappresenta ciò che modernamente si chiamano “sentimenti”, fra i quali sono appunto da annoverarsi l’amore, la tenerezza, l’ammirazione per il bello, sentimenti che Nietzsche ha visto come tipici di quel modus dell’anima antica che ha definito “apollineo”, mentre l’altro cavallo rappresenta gli istinti più bassi o 27 le passioni violente, che il solito Nietzsche di cui sopra definì caratteristiche di quell’altro modus dell’anima antica cui dette il nome di “dionisiaco” (per avere un’idea sintetica di questi due stati fondamentali dell’anima antica possiamo pensare il modus apollineo come incarnato dall’immortale donzelletta che vien dalla campagna con cui si inizia “Il sabato del villaggio” di leopardiana memoria, mentre il modo di vivere dionisiaco ci sembra meglio descritto dal bunga-bunga di osservanza arcoriana). Quest’anima, così elegantemente composta e disposta, prima di entrare in un corpo abitante la valle di lacrime di cui tutti sappiamo, senza che noi ce ne possiamo ricordare ha passato vicende meravigliose, che però sono rivelate a coloro che, come lo stesso Socrate, hanno accesso ai misteri (orfici o eleusini, questo non è chiaro: in seguito ci occuperemo piuttosto a lungo di quelli orfici), che rivelano ai loro adepti quale fu il loro mirabolante e meraviglioso passato anteumano e transumano “Tutto ciò che è anima si prende cura di tutto ciò che è privo di anima e percorre tutto il cielo, ora in una forma, ora in un’altra. Quando dunque è perfetta e alata l’anima vola in alto e domina il mondo intero, ma quando perde le ali precipita finché non si afferra a qualcosa di solido. Qui prende dimora, assume un corpo terreno, che, grazie alla potenza dell’anima, sembra muoversi da sé. L’insieme fu denominato essere vivente, anima e corpo connessi l’uno all’altra, e assunse l’appellativo di mortale. L’appellativo di immortale, invece, non deriva da un ragionamento, eppure noi immaginiamo il dio, pur senza vederlo e comprenderlo a pieno, come un essere vivente immortale, dotato di anima e di corpo, con l’insieme di questi due elementi insito per sempre nella sua natura. Ma queste cose siano e siano dette come è gradito al dio. Occupiamoci invece della causa della caduta delle ali, per quale motivo esse si separano dall’anima. La ragione è pressappoco la seguente. L’attitudine naturale dell’ala è quella di portare in alto ciò che è pesante, innalzandolo là dove ha sede la stirpe degli dei. Delle cose che hanno a che fare con il corpo, è soprattutto l’ala che partecipa in certo modo del divino. Il divino è bello, sapiente, buono, e dotato di 28 ogni qualità analoga. Di queste si nutre e si accresce moltissimo la parte alata dell’anima, mentre deperisce e va in rovina a causa di ciò che è brutto, cattivo, e contrario a quelle qualità. Il grande condottiero che è nel cielo, Zeus, guida il carro alato e incede per primo, conferendo ordine e sovrintendendo a tutto. Lo segue un esercito di dei e di demoni, sistemato in undici schiere. Rimane a casa, infatti, soltanto Estia. Degli altri dei, inquadrati come capi in numero di dodici, ciascuno guida la schiera che gli fu assegnata. Molte e beate sono le figure e le evoluzioni all’interno del cielo che la stirpe felice degli dei descrive volteggiando, facendo ciascuno la sua parte. Li seguono quelli che di volta in volta vogliono e possono, perché l’invidia rimane fuori dal coro divino. Quando poi vanno a banchetto e a festino, procedono tutti in direzione della vetta, alla sommità interna del cielo, dove i veicoli degli dei, che sono ben equilibrati e di agevole guida, avanzano con facilità, mentre gli altri avanzano a stento, perché il cavallo cattivo è di peso, inclina verso terra e grava sull’auriga che non l’ha addestrato bene. Qui l’anima fronteggia la fatica e la prova estrema. Infatti le anime che sono chiamate immortali, una volta arrivate alla vetta, procedendo verso l’esterno, si ergono al di sopra del dorso del cielo e, in questa posizione, il moto circolare le fa girare, ed esse contemplano ciò che si trova al di fuori del cielo. Nessuno dei poeti di quaggiù ha mai celebrato né mai celebrerà in modo appropriato questo luogo iperuranio. E il modo è questo – bisogna avere il coraggio di dire la verità, specialmente quando si parla della verità. Infatti in questo luogo si trova la sostanza che realmente esiste, priva di colore, priva di forma, non percepibile al tatto, che può essere contemplata solo dal pilota dell’anima, l’intelletto, e che è oggetto del genere della vera scienza. Dunque il pensiero del dio, che si nutre di intelletto e scienza pura, e così quello di ogni altra anima a cui sta a cuore ricevere ciò che le è proprio, vedendo per un certo tempo l’Essere, lo ama e, contemplando la verità, se ne nutre e gode, finché compiuto il ciclo, il moto circolare non la riporti al punto di partenza. Durante il suo giro vede la giustizia in sé, vede la moderazione in sé, vede la vera scienza, non 29 quella che ha a che fare con il divenire, né quella che è diversa in ciascuno dei diversi oggetti ai quali noi ora diamo nome, ma la scienza che riguarda ciò che realmente è. E dopo aver contemplato nello stesso modo le altre idee che realmente esistono ed essersene cibata, si immerge di nuovo nel cielo e torna a casa. E una volta tornata, l’auriga ferma i cavalli alla greppia, mette loro innanzi ambrosia e poi, da bere, nettare.” 12. Con ogni evidenza, l’anima così costretta alla vita terrena dopo cotanta avventura astrale, anela a volte segretamente, a volte apertamente, a liberarsi da ogni pesantezza e a librarsi di nuovo in volo, per tornare così a contemplare le meraviglie del mondo iperuranio che furono, chissà, forse per un istante eterno, la sua gioia. Secondo Socrate, noi dobbiamo considerare l’amore come il mezzo principe perché di nuovo l’anima nostra possa incamminarsi sul sentiero tracciato dai carri alati degli dei. Non però un amore qualsiasi è mezzo per intraprendere questo viaggio spirituale, non un amore di quelli per cui più o meno razionalmente “ci si sistema”, o ci si soddisfa sessualmente: questi sono senz’altro da considerare come una sorta di annacquamenti, se non veri e propri tradimenti di quella che è o sarebbe la vera essenza dell’amore, che non scaturisce, non deve o non dovrebbe scaturire da ben miseri e meschini bisogni umani, ma da quella follia divina che ispira gli oracoli, mette gli occhi ai veggenti, che muove la mano o soffia la parola degli artisti. Tramite l’amore l’uomo deve in altre parole perdere il contatto con il mondo, o, meglio, con la mondanità, ovvero con tutto ciò che nel mondo è considerato ragionevole e conveniente, e lasciarsi andare, lasciarsi innalzare sprofondandosi in quell’estasi che non è da considerarsi neppur lontana parente della malattia mentale, ma dono prezioso della saggezza degli dèi “quella per cui, quando si scorge la bellezza di quaggiù e ritorna alla memoria quella vera, si acquisiscono le ali e, nuovamente alati, presi dal desiderio di librarsi in volo, ma incapaci di farlo, si punta lo sguardo verso l’alto come 30 uccelli, si trascurano gli interessi terreni e si è accusati di follia. Il discorso arriva dunque a dire che questa è la più alta tra tutte le forme di possessione divina, che si genera, in chi ne è preso e in chi la condivide, da quanto c’è di più nobile nell’anima, così che chi ama i belli (ovvero i maschi adolescenti), in quanto è affetto di follia, è chiamato innamorato.”. 13. I sintomi di questa possessione divina che Socrate narra al giovinetto Fedro sono quelli più o meno tipici di ogni innamoramento, e che sono stati in modo simile descritti dagli innamorati di ogni epoca e ogni cultura, compreso naturalmente quel me stesso che in preda a un ansia che per l’appunto mi viene spontaneo di definire “folle” si aggirava quel fatale giovedì mattina dell’anno del Signore 2006 fra il bagno, la camera e il salotto non riuscendo a trovare la borsa neppure dopo avervi inciampato tre o quattro volte, scordandosi il portafoglio e le chiavi ovunque le appoggiasse, scordandosi insino di trovarsi in casa propria e non in qualsiasi altro posto al mondo e dunque domandandosi di fronte ad ogni porta e cassetto cosa diavolo ci potesse essere dentro, o dietro, o sotto o sopra, e dove è che fosse esattamente da collocarsi il sopra o il sotto, oltre che, naturalmente, il davanti e il dietro – fatto quest’ultimo particolarmente imbarazzante per chi al mattino esordisce facendo pipì e pupù ma infine normalissimo per un innamorato, dato che, come Socrate spiega a Fedro, quando un essere umano più o meno particolare ricorda a un altro le sue prenatali passeggiate nell’iperuranio “dapprima viene preso da brividi e gli si insinua dentro uno sgomento simile a quello che provò allora (“allora”: ovvero quando contemplò l’Idea del Bello In Sé N.d.A), poi, fissandolo lo venera come un dio e, se non temesse di passare per completamente folle, offrirebbe sacrifici all’amato come si fa con una statua votiva e con una divinità. Mentre lo guarda al brivido segue una sorta di alterazione e lo prende un sudore e un accaloramento insolito perché, accogliendo attraverso gli occhi il 31 flusso della bellezza, si surriscalda nel punto in cui l’ala viene irrorata e, per effetto del calore, la zona intorno al germoglio diventa malleabile, mentre prima, serrata per la durezza, impediva all’ala di spuntare. Con il fluire del nutrimento, il fusto dell’ala si irrobustisce e comincia a germogliare dalla radice, sotto l’intera estensione dell’anima, che infatti prima era tutta alata. In questo frangente, dunque, ribolle tutta ed erompe, e l’anima di colui al quale cominciano a venir fuori le ali prova la stessa sensazione che avvertono i bambini ai denti, quando cominciano a spuntare: pizzicore e infiammazione delle gengive. Alla crescita delle ali, l’anima ribolle, si irrita e prova prurito.”. La metamorfosi descritta da Socrate è veramente impressionante, una sorta di licantropia al contrario si direbbe, dato che per immaginare quel che succede all’anima nel mentre si innamora mi viene del tutto spontaneo riandare alla celebre scena della non meno celebre pellicola di John Landis “Un lupo mannaro americano a Londra”, in cui il protagonista si trasforma da studente americano arrapato e con i brufoli in una bestia tanto feroce e vorace da reggere bene il confronto con un assessore alla cultura socialista dei beati anni ottanta. E, se quanto alla ferocia del sentimento in questione Socrate era lì pronto a darmi torto, il buon vecchio Cioran bussava alle porte delle mie divagazioni pronto a darmi ragione, dato che non esita un istante ad affermare che “All’interno di ogni desiderio erotico lottano un monaco e un macellaio.” 8. Era questo quello in cui mi ero trasformato dunque, in un lupo mannaro con le ali, in un macellaio travestito da monaco e viceversa? Quali potenze del cielo o della terra mi avevano ridotto in quelle condizioni, a sudare, a tremare, a non dormire, ad agitarmi per qualcosa che non sapevo cosa fosse, come se sul mio di solito così banale futuro incombesse una sorta di imminente Apocalisse in cui tanto gli angeli quanto il drago con le nove teste e le dodici corna annesse erano rappresentati da una sconosciuta allieva “primi passi” di un non meno sconosciuto corso di tango di un ancor meno conosciuto circolo di periferia di una città invece molto conosciuta, si va bene, ma per tutt’altri motivi 8 E. Cioran, Sillogismi dell’amarezza, Adelphi, p. 94. 32 che le sue connessioni con il più prestigioso articolo di esportazione argentino che la storia ricordi? Una licantropia alata: se il primo, l’originario e forse il massimo dei filosofi, ovvero degli amanti del sapere, ovvero della religione della ragione, descrive e prescrive la follia amorosa come il dono più generoso che gli dèi possano fare a coloro che aspirano a intraprendere il cammino astrale verso il Vero, quale arma mi rimaneva ancora per difendermi da quella sorta di febbre quartana che da qualche ora stava cominciando a far declinare ogni mio senso comune verso la lontana e notturna provincia del delirio? 14. Quel fatidico mattino di un giorno che, ora come ora, mi sembra già più lontano della East Coast come appariva a Lindberg mentre avvistava la Tour Eiffel, nel quarto d’ora che come d’abitudine mi separava dallo scendere nel garage e tirare fuori la macchina – siccome avevo già fatto colazione a base di ansia e Ballantines – oltre a cadere in ogni sorta di lapsus calami che il mio inconscio fosse capace di inventare, ebbi anche tempo di guardare fuori dalla finestra, fumare e riflettere profondamente. Nel mentre lentissimi anelli di fumo galleggiando si disfacevano davanti ai miei occhi abbacinati da una luce molto più forte di quella del giorno che nasceva, udivo una voce suadente ed insieme potentissima che mi suggeriva: lasciati andare, gettati in questo nuovo sogno e sogna, che te ne frega della tua solita vita, grigia, arida, vuota, inutile? Abbandonala e innalzati come un angelo sui cieli di questo Nuovo Amore, coglilo al volo e in volo, quando mai potrà tornare? Perché adagiarsi in una morta e inutile saggezza quando le porte stesse della vita paiono così miracolosamente e quali vergini divinità per la prima e unica volta intimamente aprirsi? “Nessuna massima.. ma vivete e godete, che il tempo stringe e l’ora s’avvicina che ogni cosa vi sarà tolta!” (questo è Carlo Michelstaedter in una delle interlocuzioni introduttive del “Dialogo della salute”: un simile concetto, in effetti, avrei potuto trarlo da qualche altro centinaio di opere poetiche e/o 33 filosofico-polemiche, e, in particolare dagli ultra celebri e ultra celebrati versi di Orazio “Ecco, mentre parliamo è già trascorso il tempo che ci contende con la sua fuga, di assaporare la dolcezza dell’istante: cogli al volo la gioia dell’oggi, senza porre alcuna fiducia nel domani.”; il fatto che mi venisse in mente il dubbioso argomentare di Michelstaedter – destinato così poco tempo dopo aver scritto queste alate righe a una così precipitosa fine – invece che la capziosa ovvietà del’oraziano carpe diem, già allora mi metteva in grave allarme, se l’augure sempre trema a tanto sfavorevole planare degli uccelli (l’augure in questione è quello che, osservando il volo degli uccelli per conoscere il futuro, si ritrova di colpo con una cacca di piccione nell’occhio). In effetti però, col finire della sigaretta e il caldo tambureggiare nel sangue degli effluvi del Ballantines che, sia pur faticosamente, si faceva strada fino alle tempie, con un certo sollievo, notavo che la mia mente, da qualche ora in bilico sull’orlo di un piuttosto ridicolo e infantile abisso, ancora pur tuttavia trovava in qualche modo la forza di trattenersi dal fare il fatidico ultimo passo. Un’altra voce, l’altra voce, quella dell’esperienza e della ragione, sia pur meno suadente e affascinante della prima, si ostinava richiamarmi all’ordine e alla disciplina, ripetendomi in continuazione di stare attento, ribadendo che potevo e dovevo rendermi conto che la mia condizione era particolarmente perigliosa, che le follie pregresse cui mi ero nella vita lasciato andare mi avevano portato dappertutto meno che nel luminoso iperuranio di cui parlava Socrate, che il grigio per quanto mediocre e superficiale è meglio assai delle luttuose profondità del nero, che arrivare alla fine di un giorno senza aver passato un guaio è già qualcosa di più del massimo che si possa legittimamente sperare dal mondo e dalla vita, e così avanti e ancora oltre finché, a furia di simili auto ammonimenti e autosuggestioni, ancorché riottoso e renitente, volli infine ascoltare la voce di quella ragion borghese che così poco ha a che fare con quella del buon vecchio Werther, non foss’altro che per evitare la ridicola evenienza di trovarmi contemporaneamente con le tempie brizzolate di saggezza e il cervello invasato dalla stupidità di un ragazzino: no, non dovevo lasciarmi andare, a nessun costo! Con paziente fermezza e serena 34 avvedutezza rimembrai e ripercorsi tutte le volte in cui per troppa fretta avevo fatto ignobilmente fiasco, con angosciosa severità mi rimproverai le disgrazie che mi ero attirato sulla testa e sulle parti basse ogni volta che mi ero arrischiato in passioni imprudenti, con ironico orrore rividi gli altissimi e purissimi cieli dell’illusione trasformarsi subitaneamente in baratri di sterco – per non dire di merda – e infine, a forza di autoesortazioni alla ragionevolezza e al principio di realtà – che avrei volentieri di nuovo innaffiate con un bel po’ di whisky – se solo ne fosse rimasto almeno un goccio – cominciai lentamente a convincermi che quanto mi stava succedendo non era nulla di più e nulla di meno che un attacco di per nulla divina follia – augurabilmente passeggero – e dunque dovevo fare in modo che all’arrivo della settimana nuova di tutto quel magico e tangheggiante vagheggiare non rimanesse traccia più significativa che il numero che avevo trascritto nella rubrica del telefonino. Un numero che mi dovevo decidere a cancellare quanto prima, onde non soccombere a insensate fantasie, che non avrebbero raggiunto altro scopo che fare del male a me e, chissà, forse anche alla sconosciuta con cui avevo vissuto, pur senza condividerli, quegli strani, stranissimi, fin quasi inconcepibili momenti di estasi e passione. 15. Ciò stabilito, scesi sia pure un po’ barcollante verso le scale che mi portavano verso il seminterrato, misi in moto e uscii infine in retromarcia dal garage con la consueta, quotidiana sicurezza, credendo che finalmente quella sorta di sogno-incubo che mi aveva invasato durante il notturno tango fosse già svanito nelle prime brume di ragionevolezza del mattino, ma, mentre guidavo con alcolizzata prudenza verso il lavoro, mi resi conto che il vertiginoso e quasi incredulo ricordo della sera precedente, non ostante tutto, continuava a spingermi in modo piuttosto ossessivo a importune e rischiosissime curiosità su quanto mi era solo poche ore prima accaduto, dato che, a parte la spada evidentemente di Damocle che tutta la situazione sospendeva sul mio capo, di certo mi restava 35 ancora una cosa da chiarire: che mi era esploso dentro (e dentro dove?) nel fatale momento in cui quella ragazza mi aveva toccato, o, per meglio dire, quasi come una brezza o una carezza quasi irrealmente sfiorato? Era stata davvero, come riflettendo più tardi mi sembrava, una sorta di privatissima allucinazione, di alterazione percettiva, o davvero qualcosa di altro, o di alto, mi era giunto per quella via misteriosa eppure così luminosa che è talvolta la nuda e cruda pelle, il nudo e crudo combaciare della carne? Si, lo sapevo, era cosa buona e giusta nonché sommamente salubre e prudente sottoporre quello spropositato evento ad ogni sorta di analisi razionale e di argomentazione critica, ma, d’altra parte come mettere in dubbio che quello che mi era successo era successo per davvero? Quella ragazza, chiunque fosse, mi aveva effettivamente procurato un delirio, se il delirio contro cui argomentavo in quel momento non era a sua volta un falso ricordo, frutto di un presente delirio in cui lo immaginavo come proveniente dal passato (come tutti sanno, gli stati deliranti sono interminabilmente fonte di altri deliri, in cui colui che delira si immagina cause immaginarie delle sue immaginazioni (o no?)). Comunque sia, se questo era vero, ed era vero, il tutto significava come minimo che vi sono in giro per il mondo delle donne capaci di avere su di me quegli stessi effetti che il pejote produce su Diego Abatantuono in una celebre scena di “Puerto Escondido”: che diavolo di significato può avere un fatto di questo genere, forse che vi sono al mondo delle droghe che vanno in giro su due gambe e che, a differenza di quelle che si comprano dai consueti spacciatori, possono avere effetto su una, o due, o tre persone in tutto (in effetti, anche in quello stato di scarsa lucidità era per me piuttosto difficile immaginarmi che la tipa in questione avesse dei consimili effetti su tutti quelli con cui ballava il tango: in caso contrario a quest’ora avrebbe già sposato e divorziato da un tot di milionari, non prima di avergli mangiato, bevuto nonché digerito ed evacuato tutto il patrimonio)? Ma a che serve che in giro per il mondo ci sia questo strano genere di droghe, che si innalzano sorridenti e fatate sui chilometrici e pungenti tacchi del tango? Mentre mi scervellavo su tale improbabile e forse da sempre improponibile dilemma, senza alcun apparente nesso con le mie 36 elucubrazioni e per di più con la grave intonazione di un coro greco, mi tornò in mente una frase che Estragon pronuncia alla fine del Godot: “Tutti nasciamo pazzi. Alcuni lo restano.”. Dio mio, pensai pieno d’improvvisa gioia e di non meno improvvisa, raccapricciante nostalgia, e se qualcun altro – magari ballando il tango con una sconosciuta – a un certo punto pazzo potesse ritornare (ma quando era stata l’ultima volta in vita mia che ero stato pazzo? doveva essere accaduto qualche volta, in qualche modo, certamente, ma come è che non ero capace di rimettere insieme – nemmeno come finzione lirica o messinscena mnemonica – il come e il quando? e non era quella una ottima occasione per ricordarsi che cosa diavolo fosse questa benedetta follia, di cui Socrate parla tanto bene? se non è un veicolo alato per tornare nell’iperuranio, in cui per altro non ho mai creduto, non potrebbe darsi che lo fosse per tornare almeno un po’ più giovani?)? Come il lettore avrà già immaginato, o starà testé immaginando, quel giorno parcheggiare la macchina al solito posto in cui la parcheggio da circa vent’anni risultò un’impresa piuttosto difficoltosa e tormentata, che invece dei consueti quindici secondi richiese alcuni angosciosi e interminabili minuti, in cui accaddero cose che di solito si vedono accadere all’autoscontro oppure in certi film particolarmente disastrosi che hanno per protagonisti Stanlio e Ollio. 16. In effetti, non ci fu nulla da fare. Per quanto mi sforzassi di tornare al mio stato d’animo normale, nel trascorrere lentissimo e quasi irreale delle ore di quel giovedì fatale della mia già allora forse troppo lunga vita, notai che quel fastidioso, febbrile e fin quasi nevrotico autointerrogarmi del mattino proseguiva ostinato e imperterrito nell’amara incertezza addolcita dalla sera, a dispetto del whisky bevuto, anzi, per meglio dire “tracannato”, e del ragionevole e umanissimo desiderio di un balsamico e modesto oblio. La mia focosa perplessità – che altro non era, ora lo so, che il pallido riflesso 37 del fulgore intollerabile di quell’inusitato incendio che i miei tentativi di spegnere non riuscivano altro che a viepiù nutrire (“È il fuoco che si ravviva col suo dannato” che altro poteva esser mai?9) – il mio amletico dubitare, stavo dicendo, anziché dissiparsi, montava instancabilmente in una sorta di crescendo beethoveniano anche se, prevedibilmente, rimaneva piuttosto deludente in quanto ai risultati: ogni risposta o ipotesi di risposta, interminabilmente prolifica come un pestone dato a un formicaio, portava con sé una confusa nidiata di nuove domande, nuovi dubbi, e la mia inquietudine, invece che saziarsi, veniva ad ogni istante maggiormente turbata, intrigata e stimolata da ogni parvenza di risposta che riuscivo a trovare – anche se era questa, a ben vedere, un’eventualità piuttosto prevedibile, se non propriamente logica (è vero, la logica è stata inventata sulla terra, ma, a quanto pare, funziona in modo decente solo in un pianeta che ancora attende di essere scoperto). Il fatto è che, come meglio di tutti sanno gli storici, i momenti iniziali, gli albori, le cause prime – le origini dunque – sono quasi per definizione inafferrabili e perciò anche imperscrutabili – o, come si dice, “misteriose” – ed è per questo che ogni civiltà, quando comincia a raccontare la sua storia, si tiene di solito piuttosto sul laico quando si volge a descrivere il presente o il passato prossimo, ma, come diceva Tocqueville, è costretta a tacere o a sconfinare nel mito quando si tratti di narrare i propri inizi dato che “lo spirito analitico si è sviluppato nelle nazioni mano a mano che invecchiavano, sì che, quando esse si sono interrogate sullo loro origini, il tempo le aveva già avvolte in una nube, l’ignoranza e l’orgoglio le avevano circondate di favole, dietro le quali si nascondeva la verità”10. E bravo Tocqueville: ma non potremmo far valere il medesimo ragionamento, oltre che per le civiltà e le epoche storiche, anche per le vite dei singoli esseri umani? Tanto il presente si mostra facile e banale, quanto il passato appare magico e imperscrutabile: la moglie noiosa e fastidiosa che si trova tutti i giorni a letto e in cucina (soprattutto a letto però, bisogna 9 A. Rimbaud, “Una stagione all’inferno”. A. Tocqueville, “La democrazia in America”. 10 38 riconoscerlo) diviene un enigma, o addirittura un mito, quando si debba ricostruire il modo in cui ci è arrivata! Fu – credo – proprio per questo che durante la settimana che trascorse dal mercoledì del mio innamoramento a quello in cui aspettavo (si, quasi non potevo e certo non volevo credere a quanto mi accadeva, ma, senza neppur sapere chi “lei” fosse, stavo già aspettandola, anche se in quel momento non mi rendevo conto di ciò che questo strano fatto significasse (significava più o meno questo: “Io aspetto dunque amo” (Roland Barthes)), così che in quei giorni in cui mentre senza saperlo amavo, senza neppur sapere chi stessi amando, quasi sempre feci molta fatica ad addormentarmi, turbato come ero non tanto e non solo dal mio innamoramento in sé e per sé, credo, ma, devo riconoscerlo, proprio da quella sorta di petulante ed ansiosa perplessità che con veemente impotenza si rivolgeva alle sue origini (perché proprio “quella lì”, voglio dire, e non la segretaria della palestra, che ha sempre quello scollo vertiginoso che ogni volta suggerisce complimenti sfacciati e tuffi carpiati? perché non l’estetista, quella con quel genere di deretano che ha spinto qualcuno ha inventare l’aggettivo “michelangiolesco”, sempre con quel body asfissiante e sempre lì a invitarmi a una prova gratuita di body massage? perché non la ballerina di lap dance, che mi accompagnava a volte anche per un’ora nelle immobili passeggiate con la cyclette? perché eccetera, eccetera, eccetera? (non mi ricordavo in quel momento quel che diceva Bataille in proposito, una cosa che, ahimè, almeno nel mio caso, doveva rivelarsi drammaticamente o quasitragicamente vera: “Semplici coincidenze dispongono l’incontro e compongono la figura femminile del destino alla quale un uomo si sente legato, qualche volta fino a morirne. Il valore di questa figura dipende da esigenze a lungo sperimentate in modo ossessivo e così difficili da soddisfare che alla loro luce l’essere amato prende i colori della chance estrema.”). Fu così che – mentre declamavo mentalmente inefficaci massime filosofiche abbeverandomi intanto alle sacre fonti del whisky e della vodka – cercando in questo modo e il più delle volte inutilmente di conciliarmi il sonno ristoratore – ogni volta l’onda oscura del mio inconscio, o quel che fosse, mi distoglieva dai buoni propositi e mi 39 spingeva a interrogarmi con imperterrita mancanza di costrutto su quale fosse o dovesse o potesse essere il motivo preciso di quel fulmineo e perciò così strano sentimento – di quel desiderio duro, inappellabile, quasi crudele che, seppur notavo andar con estenuante lentezza attenuandosi, continuava sordamente e carsicamente a tormentarmi. Così passavo ore e ore, quelle ore preziose che avrebbero dovuto essere dedicate al sonno ristoratore, lambiccandomi e alambiccando con ogni sorta di cavillosa ipotesi esplicativa, ma, prevedibilmente, qualsiasi cosa pensassi, qualsiasi immagine o parola o frase o associazione o allocuzione mi traversasse la mente, sempre mi sembrava quasi ridicolmente inadeguata a spiegarmi quelle tempestose emozioni che per la prima e spero ultima volta mi trovavo a dover fronteggiare in vita mia: ancora non ero consapevole che quel labirintico fantasticare altro non era che il fantasmatico ingresso che porta a quel groviglio di rose e fiamme, di rovi e ceneri, in quell’enigmatico meandro che qualche secolo fa gli stilnovisti chiamarono col terribile e leggiadro nome di “Amore”. Quella divinità cui Omero dette il nome di Perdizione e di cui nell’Iliade cantò con versi immortali : “vellutati passi della dea: non sul terreno incede, ma la sua strada è sulle teste d’uomo.”11, quell’ambigua passione che Shakespeare, per bocca di Romeo, volle indimenticabilmente definire con ogni sorta di lapidari ossimori: “O litigioso amore! O odio amoroso! Sempre creato dal nulla! O pesante leggerezza! O seria vanità! Caotico inganno di leggiadre forme! Piuma di piombo, lucido fumo, gelido fuoco, inferma salute, insonne dormire, non è mai ciò che è!”. 17. 11 Omero, Iliade, XIX, 92 sgg. 40 Stando così le cose, non credo si stupisca o si adonti il lettore se già da un po’ nel cielo brontolante e temporalesco di questo libro hanno preso a lampeggiare situazioni ed espressioni, locuzioni ed interlocuzioni, aforismi e sentenze che parranno senz’altro, mi immagino, almeno in prima istanza, anacronistici, per non dire del tutto ridicoli e surreali. Come diceva Barthes, l’Amore, in quest’epoca di mercati, di efficienze e utilità, è diventato osceno, osceno proprio perché completamente inutile, dato che la sua oscenità non può nemmeno essere recuperata come merce a livello di attrazione scandalistica o di pornografia (l’oscenità dell’innamorato non è come quella di un De Sade che descrive il papa che sodomizza un tacchino: questa è un’offesa al pudore – o, per meglio dire – al comune sentimento dell’ipocrisia borghese, o di quel che ancora ne rimane, ed è dunque possibile renderla in un modo o nell’altro commestibile e commerciabile, quella dell’innamorato consiste invece in un pudore immaturo o addirittura infantile, e spinge soltanto a voltare altrove lo sguardo). E’ proprio per questo, perché immerso e sommerso da questa sorta di incommerciabile e incommestibile indicibilità, che posso andare avanti in questa improbabile esposizione soltanto o quasi soltanto per reperti letterari e letterari artifici – perché altrimenti neppur so immaginare la stralunata impresa di narrare gli impacciati e antiquati dolori di quel Lancillotto che fu un tempo un eroe, si, ma che oggi come oggi appare inesorabilmente come un clown obeso e imbranato, che schiatta e sbuffa in un’armatura troppo stretta, disarcionato infine da un ronzino svogliato e anoressico mentre saluta la sua bella coperta di veli trasparenti e televisivo pudore prima di un torneo che non riuscirà neppure ad iniziare – ovvero la malinconica epopea di un Don Chisciotte che nella sua follia ha smarrito, oltre che ogni dignità e ogni lume di ragione, anche l’amichevole compagnia e gli inutili consigli del saggio Sancio Pancia, troppo preoccupato dalla sorte dei bond Parmalat per pensare di andargli dietro. Non so. Sarà che l’amore istupidisce la gente, sarà che sono un tipo senza grande esperienza letteraria, o con poca fantasia, ma non ho trovato altro modo che questo – zoppicare, inciampare, balbettare, divagare – si, soprattutto questo, vagare, divagare – per esprimere o 41 tentare di esprimere l’esperienza tragicomica, vertiginosa e – direi – oniricamente crudele di quella persona che sul piano sociale ed economico amava definirsi ormai “arrivata” e sul piano umano ben più che arrivata, me invece del tutto cinica e disillusa – di quel grigio contabile dell’esistenza quando si trovò di colpo e senza colpa proiettato nel bel mezzo di un amore ancillare – risuonante di spade, inni, preghiere, squilli di trombe e serafici sonetti dedicati a una donna angelicata, rapita da un non meglio precisato demone o drago – a una madonna dunque, non a una donna vera e propria – da un inesplicabile colpo di fulmine che stramazzato a terra cadere mi fe’ per una ragazza qualsiasi o – chissà – forse perfino un po’ bruttina – mentre intanto – ahi intanto! – nel secolo e nel mondo in cui vivevo e vivo (o faccio finta di vivere?) una velina qualsiasi, a furia di rapporti clintoniani con premier-proprietario tv, diventa ministro per le pari opportunità (pari opportunità fra chi? ovviamente, fra primi ministri e veline)! Quanto mi stava capitando e – ahimè – mi stava per capitare – su questo almeno convenga colui che d’ora innanzi diverrà testimone delle mie stilnovistiche ambasce – era qualcosa di troppo sgraziatamente insolito, dunque di troppo sottilmente vago e incomunicabile perché il linguaggio con cui mi appresto oggi a descriverlo non ne venga deformato, trasformato, traslato, contagiato. Le cose che ci succedono possono cambiarci, l’incontro con Elisabetta me lo ha dimostrato nel modo più chiaro e limpido che sia possibile: dove è andata a finire quella persona completamente e spietatamente sola, fredda, distaccata e disingannata che mi gloriavo di essere? Dove è andato a finire quel professionista incravattato che nella ventiquattrore impeccabile teneva un libretto di istruzioni che ad ogni rigo e ad ogni pagina gli ripeteva che tutto a questo mondo si può pagare e si paga, si può comprare e si compra? In effetti, sono appena all’inizio di questa strana storia o non-storia d’amor perduto e tango, e già piangendo e ridendo (ma più che altro piangendo) mi rendo conto che il modo in cui scrivo non è quello solito, quello in cui mi riconosco, quello familiare, non è più il mio, come, in un certo senso, colui che scrive non sono più “io”: innamorarsi, ora lo so, significa in fondo contemplare, almeno per un attimo, il volto 42 accecante della divinità, e nessuno che lo abbia visto può sperare di rimanere in vita, o, perlomeno, di rimanerci allo stesso titolo e nello stesso modo in cui, ancorché straniero e straniato, vi rimaneva prima. 18. In quel periodo fra l’altro, guarda un po’ la coincidenza, per mera curiosità ma anche per facilitare la mia iniziazione alle formule, ai riti e alla magia del tango, stavo per l’appunto leggendo dei libri che riguardavano proprio le sue origini – proprio le da sempre imperscrutabili, misteriose origini – così che, mentre vagavo sbattuto a destra e a manca da quel desiderio inusitato e perciò sul momento del tutto indecifrabile, mi venne in mente una piuttosto geniale ovvietà, ovvero che una causa primaria dei travolgenti sentimenti per la fatata e fatale ballerina, a parte tutte le mie private circostanze astro-psico-socio-illogiche, era senz’altro la mera esistenza nell’universo mondo di questa danza, il tango: se io e la sconosciuta non ne fossimo stati entrambi affascinati e non avessimo voluto perciò iniziarci ai suoi delicati eppur facinorosi incanti non ci saremmo mai iscritti a quel corso, e dunque non avrei potuto mai confrontarla con un magico amore della mia adolescenza, e dunque non avremmo mai ballato insieme, così che lei non mi avrebbe mai toccato, abbracciato, seguito, etc. Dunque, all’origine del mio piuttosto surreale invasamento per l’apprendista stregona o milonguera che fosse vi era, fra l’altro, proprio il tango in persona, persona le cui origini, esattamente come quelle delle mie inquietudini amorose, parevano a loro volta non solo del tutto o quasi del tutto sconosciute, ma anche ormai del tutto o quasi del tutto inconoscibili. Scoprii infatti – e anche con una certa sorpresa devo dire – che sul tema in questione abbondano i miti oscuri e affascinanti, le ipotesi colte e laboriose, le brillanti e ingegnose supposizioni – tanto quanto scarseggiano le comprovate e verificabili fonti storiche. Quanto agli strumenti, si sussurra che il bandoleon (che sarebbe una sorta di fisarmonica senza tastiera) fosse uno strumento usato per seguire i cortei funerari e passato poi ad accompagnare i violini e le 43 chitarre dei musicisti di strada dapprima nell’allegria della milonga, poi nella lugubre e oscura sensualità del tango vero e proprio. Quanto alla musica si vagheggiano influssi più o meno sotterranei del fado e del valzer, si accenna a certa ritmica nera giunta più o meno incidentalmente dai porti di Cuba (di recente ho ascoltato un pezzo di pianoforte di un compositore cubano di fine ‘800 che sembrava proprio un tango, anche se per l’autore, con ogni evidenza, si trattava soltanto di una traduzione in linguaggio “classico” di un pezzo da lui ritenuto “popolare”) o da quelli del Brasile a quello di Buenos Aires – anche se non c’è al mondo persona musicalmente ineducata e dotata di orecchio per quanto ruvido che non si renda conto degli abissi che separano il tango da qualsiasi altra musica popolare – sudamericana e non – non foss’altro che per la spaesante impossibilità di separare gli strumenti e le parti ritmiche da quelle armoniche. Quanto alla tecnica di danza, con particolare riferimento alle modalità dell’abbraccio, subito viene in mente il valzer (e questo è l’unico punto su cui, almeno a livello personale, non nutro grossi dubbi), un influsso che con ogni evidenza si estende almeno alla coreografia più semplice, il quadrato basico, anche se c’è da notare che le somiglianze si fermano qui, e paiono perciò tutto sommato del tutto episodiche e minimaliste, stante il fatto che il tango è una danza di improvvisazione e che la varietà come la complessità delle coreografie – pur basandosi come al solito su una base relativamente modesta (ricordo che le note musicali sono sette eppure…) – può diventare incredibile: oltre al fatto che nel valzer non si trovano le sacadas, i voleos, i planeos, gli ochos, le rastradas, gli enrosques, le colgadas, le paradas, etc. Giunti a questo punto, forse non sarebbe più neppure il caso di aggiungere che nessuno ha a disposizione la più discutibile delle fonti storiche o la più vaga delle ipotesi critiche che possa illuminarci quanto all’identità di chi abbia creato questi passi con le relative variazioni coreografiche. 19. 44 Ma, come molti forse già sanno, c’è da dire che il mito del tango non si alimenta tanto dell’imperscrutabilità della sua genesi o sulla pur indiscussa singolarità della tecnica in sé e per sé, ma sulla sua neppur tanto sotterranea carica erotica, che viene di solito addebitata all’ambiente in cui nacque, che non è affatto misterioso, ma ben conosciuto e, come si direbbe con metafora letteraria, “maledetto”, o, come fa più direttamente Borges, nulla di meno che malavitoso. Il tango nacque infatti nella Buenos Aires della fine dell’800, in connessione con l’arrivo di un’enorme massa di immigranti, che portò in poco tempo la città da circa duecentosettantamila a un milione e duecentocinquantamila abitanti, il settanta per cento dei quali maschi solitari, che, a parte la consueta e fedele mano destra, non avevano altro mezzo di soddisfare le loro passioni erotiche e di svagarsi che la frequentazione di bordelli di basso o bassissimo rango, locali bisunti e a volte anche un po’ macabri, dove di solito si trovava, oltre che la scarna e prevedibile coreografia dell’amore mercenario, anche quanto necessita all’uomo per espandere i limiti di quell’io che tanto e tanto oscuramente lo tormentano, ovvero i mezzi per ubriacarsi e l’occasione di ballare. Fu così che le prime ballerine di tango della storia furono, a quanto pare, delle prostitute o, per chiamarle così, delle cameriere di dubbia moralità (non so perché la gente le chiami in questo modo: conosco personalmente donne inibitissime che, quanto alla quantità di acido e malumore che sono in grado di spargere per il mondo sono capaci di fare concorrenza al collaboratore di Saddam Hussein noto con il famigerato pseudonimo di “Alì il Chimico”), il che faceva sì che tanto gli atteggiamenti reciproci dei ballerini prima e durante la danza quanto i testi stessi dei tanghi fossero espliciti a volte ben oltre i limiti dell’osceno, dato che servivano più che altro come preparazione a volte neppur tanto simbolica all’atto sessuale mercenario e occasionale che si sarebbe consumato di lì a poco. Tanto per dare un’idea di ciò di cui stiamo parlando, nei pezzi che si collocano nell’oscura aurora del tango troviamo titoli che suonano “El choclo” (in argentino “choclo” vuol dire “pannocchia”, ma è anche un nome volgare dell’organo sessuale maschile) “El movimiento continuo” (che sarebbe quello del coito), “Dejalo morir adentro” (no comment), titoli che, come si dice, sono 45 già tutto un programma, mentre invece occorre precisare che la non meno volgare “Siete pulgadas” allude con orgoglio sfrontato e maschilista a un organo sessuale di 17,2 cm (beh, in fondo in fine nulla di eccezionale: per alludere a quello di Rocco Siffredi, in proporzione, non basterebbero due tanghi). L’ambiente dei bordelli era per di più frequentato in massa non solo da povera gente, ma anche e soprattutto da quelli che oggi come oggi si definiscono di solito dei teppisti o anche proprio da delinquenti matricolati, che però allora portavano i romantici nomi cui sopra si accennava: gauchos, compadritos, guapos. Personaggi disdegnosi, irascibili, provocatori e svelti di mano, dotati per di più di una memoria minuziosa e instancabilmente votata al servizio di rancori interminabili, che di solito terminavano nei celebri e celebrati duelli col machete o la navaja che scintillavano irreali e furibondi alla luce ebbra della luna. Borges sostiene senza mostrare incertezza alcuna che i gauchos non duellavano affatto per dei motivi estrinseci, ma puramente e semplicemente per il puro e semplice gusto della sfida con l’altro, e con la morte (che è forse il vero Altro con cui ogni giorno ognuno nella vita si confronta): in ballo non c’erano dei veri rancori, degli autentici interessi materiali, ma, più che altro, la pura e vergine passione per la sfida, il nudo e incorrotto rancore del coltello. E la cosa pare tanto più credibile se pensiamo che un vecchio gaucho, confessando a Borges di essere andato più volte in galera, si giustificò dicendo che lui, uomo onorato e onestissimo, non ci era andato per motivi ignobili, quasi avesse rubato bestiame, o rapinato banche, o per altre consimili bassezze, ma solo per omicidio (sfide del genere avvenivano fra i samurai in quello che possiamo chiamare il Medioevo giapponese, come fra i nobili durante il nostro: a noi oggi sembra impossibile, ma vi sono stati innumerevoli tempi e culture in cui la guerra e la morte erano un gioco tanto terrifico quanto del tutto gratuito e fine a sé stesso). Data la sua ambientazione originaria si capisce facilmente come il tango, anche quando fu sdoganato dall’atmosfera borghese e festaiola di Parigi, diventando così una moda di dimensioni mondiali, non perse mai del tutto quell’aura di inquietante e cieca sensualità che a tutt’ora volente o nolente lo circonda. E che nella leggenda ci 46 dovesse essere qualcosa di vero lo stavo sperimentando io stesso, in quel principio di insonnia che mi spingeva a chiudere il manuale di storia del tango verso le due di notte, a fumare e bere molto più del solito, a scoprirmi ad allucinare il volto di una sconosciuta nei momenti più importuni e impensabili della giornata. Pure, con un certo sollievo, anche notavo che il mio sommovimento interiore si stava in qualche modo calmando, e già verso la domenica successiva a quel piuttosto pazzesco mercoledì da leoni della mia vita mi sembrava di aver del tutto o quasi del tutto ripreso il controllo di me stesso, stante il fatto che quella disturbante eccitazione che mi aveva colto durante la danza con la sconosciuta sembrava essersi allontanata e la cara, vecchia, buona melanconia, il buon vecchio male di vivere, quel dolcissimo, irresistibile pessimismo metafisico che mi accompagna da quando la memoria è capace di riafferrare un qualsivoglia attimo passato erano tornati a prendere o a pretendere il loro avito e usuale posto nella sedia vuota accanto alla mia, nello specchio del mattino e, soprattutto nel cuscino stanco e agognato della sera (il lettore deve sapere che io sono il classico tipo di persona che, se per disgrazia si alza dal letto pieno di buon umore e ottimismo, subito si preoccupa, comincia ad agitarsi prima, a domandarsi poscia cosa c’è che non va e infine, compiangendosi e lagnandosi in ogni modo e su tutti i toni, si reca precipitosamente dal dottore di fiducia per farsi prescrivere dei farmaci in grado di procurargli almeno un po’ di provvidenziale mal di testa, onde venga ristabilito al più presto l’ordine universale sconvolto dal perfido e mellifluo attacco di ottimismo e fiducia nell’esistenza annessa da cui era stato incolpevolmente sorpreso durante il sonno (in effetti, le uniche volte in vita mia in cui senza alcun senso di colpa o di disagio ho visto e sentito “La vie en rose”, la vita in rosa, è stato mentre guardavo scene particolarmente affollate di certi film porno che furono, ai tempi dei giovanili brufoli e furori, di mio gusto e ispirazione (ma si consoli il lettore pensando che, contrariamente a quanto di solito si pensa, il pessimismo metafisico è una delle più raffinate forme, se non l’unica possibile, di umana felicità, come tristemente ci conferma un forse allegro Pessoa ne “Il libro dell’Inquietudine”: “Fortunati i costruttori di sistemi pessimisti! Non 47 solo si rifugiano in quello che hanno fatto, ma si compiacciono pure di quello che hanno spiegato, e si includono nel dolore universale. Io non mi lamento del mondo. Non protesto in nome dell’universo. Non sono pessimista. Soffro e mi lamento, ma non so se quello che esiste in generale sia dolore e non so neanche se sia umano soffrire. Che mi importa sapere se è giusto o no? Io soffro. Non so se meritatamente. (Capriolo inseguito). Io non sono pessimista, sono triste.”12 (beh, io invece sono pessimista, un pessimista molto convinto, devo dire, uno di quelli che pensano che il bicchiere non è affatto mezzo vuoto, ma mezzo pieno di m…, e dunque, almeno a sentire Pessoa, sono allegro, anzi, molto allegro, anche se magari alla maniera del più celebre e già citato pittore del ventesimo secolo, Francis Bacon, che nella sua opera pittorica, che pare a un primo sguardo invero altrettanto solare e soave che un attentatore suicida durante l’esplosione, si diceva accompagnato da uno strano non meno che costante buon umore, da lui stesso caratterizzato come “exilarant despair” (esilarante disperazione)))). 20. Il mercoledì successivo arrivò dunque senza essere infine eccessivamente sospirato, ma il caso o il suddetto demonio sfaccendato di cui sopra volle che rivedessi la ragazza, ovvero colei che era già diventata la misteriosa “lei” dei più banali e triviali romanzi rosa del mondo, mentre ancora aspettavo che il circolo aprisse, dato che entrambi, per qualche strana o fatale o dannata coincidenza, eravamo arrivati in anticipo. “Lei”, appunto, era in motorino, e, con il casco addosso, il suo naso aquilino troppo fine e troppo pronunciato – che, ora che potevo osservarlo da presso e con calma, pareva anche leggermente storto – mi sembrò ancora più goffo e sproporzionato del solito. Riaffiorò alla mente l’immagine della modella che avevo conosciuto o sognato tanti anni prima, e la ragazza del presente mi parve ancora una volta e ancor di più solo e 12 F. Pessoa, “Il libro dell’inquietudine”, paragrafo 125. 48 soltanto una sua mal riuscita imitazione. Così, con un sospiro insieme di delusione e di sollievo, divenni finalmente certo che il mio sogno d’amore non era stato altro che il frutto di un momento di debolezza, e che quella ragazza non sarebbe stata mai altro per me che una delle tante che andavano e venivano in quella lezione di tango del mercoledì. Rimaneva però il fatto che, a dispetto del naso troppo lungo, troppo fine e persino un po’ storto, con la sconosciuta di nome Elisabetta ci avevo ballato veramente bene – “bene” nel senso che avevo trovato con lei un’intesa ritmico-corporea che con nessun altra avevo prima sperimentato – e decisi perciò di stare po’ lì a chiacchierare, tirandola più in lungo che potevo, per poter poi avere il pretesto per invitarla a ballare insieme almeno per la prima parte della lezione (come avevo già in parte scoperto e come scoprii ancor meglio in seguito, nel tango un’intesa di tal genere è evento piuttosto raro, un po’ come nella vita l’intesa sessuale, ancorché la danza risulti all’apparenza molto semplice (quindi, in un certo senso, facevo molto bene a cercare di ripetere l’esperienza, stante il fatto che appare in ogni caso molto difficilmente ripetibile)). E’ vero, avevo perso l’occasione di gettarmi nel celeste abisso di un novello grande amore, per mia fortuna, ma forse avevo trovato quella danzante anima gemella di cui comunque abbisognavo per inoltrarmi nel misterioso tango, un ballo che, proprio come la sconosciuta di nome Elisabetta, mi aveva fin dal primo momento intrigato come poche, o, forse, come nessuna cosa al mondo. 21. Curiosamente, quando feci la proposta, la ragazza accettò il mio invito con un entusiasmo tanto malcelato da spingermi a pensare, pur se con un certo ormai quasi infastidito e distratto disinteresse erotico, che anche lei avesse sviluppato in quei pochi minuti della nostra fresca conoscenza un qualche debole per me: addirittura, nelle due chiacchiere fuori dal circolo aveva avuto il tempo di chiedermi con aria perfino un po’ delusa se per caso alla pratica non ci ero andato da solo, cosa che mi fece pensare che forse anche lei, sia pure in 49 modo assai meno fervido che il sottoscritto, aveva desiderato che la invitassi. Scossi la testa e mi strinsi nelle spalle – e mi ricordo bene che pensai, sia pure in modo un po’ sbadato e confuso: che peccato, che peccato che non mi sia innamorato per davvero: forse questa poteva essere la persona giusta! Ma poi, una volta entrati in sala, nel mentre si cambiava le scarpe continuavo ad osservarla e continuava a crescermi dentro una sorta di grigioamara disillusione. No, decisamente quella ragazza non mi piaceva affatto, non era assolutamente il mio tipo: ma guarda un po’ che scherzi può fare la fantasia anche a una persona ormai matura, che nella vita ne ha passate di tutti i colori e che si credeva diventata immune a qualsivoglia lusinga del cuore come dei sensi! Con tenera, luttuosa non meno che voluttuosa melanconia vennero a consolarmi gli sconsolati versi di Baudelaire “Ogni isolotto avvistato dall’uomo di vedetta è un Eldorado promesso dal destino; ma la Fantasia, che un’orgia subito s’aspetta, non trova che un frangente alla luce del mattino.”. A questo genere di triviali autoinganni ci si riduce dunque pur di vaticinare, anche solo per un attimo, un qualche miserando brandello di senso alla vita! Basta un qualche anno di cercata riservatezza e di voluta e forse persino, in un certo senso, beata solitudine, ed eccolo già sprofondato in quella “quieta disperazione” di cui parlava Henry Thoureau, anche se non mi ricordo più dove, eccolo crogiolarsi in quella segreta e lugubre morte dell’anima in cui tutti o quasi senza saperlo attendiamo la pubblica e pleonastica morte del corpo, squallido abisso per uscire dal quale anche colui che si pretendeva armato delle invincibili corazze della sua filosofica morale è perciò da sempre pronto a innamorarsi della prima o seconda ballerina di tango che passa, a tormentarsi, a soffrire, a non dormire, purché le vertigini dell’amore lo rendano cieco alle inevitabili e metafisiche miserie della sua umana condizione – oltre che – questo andava sottolineato – alla comica sproporzione di un naso che, visto da vicino, come si dice dalle mie parti, “sembrava un quarto d’agnello”! Ma perché stupirsi? “Quanto più l’uomo di spirito 50 è stanco e disilluso, quanto più rischia, se l’amore lo sorprende, di reagire come una sartina.” 13. Deluso e persino un po’ depresso dal come e quanto quel momentaneo “lapse of reason” testimoniasse quanto e come la mia pretesa, cinica saggezza non fosse altro che una vernice di belle parole sopra una vita qualsiasi – e dunque sopra un’anima forse addirittura men che qualsiasi – attesi senza più ansia alcuna che la sconosciuta finisse di cambiarsi le scarpe. Fu un’operazione che mi sembrò, strano a dirsi, studiatamente, insopportabilmente lenta, onde ragion per cui mi ritrovai alquanto irritato e sarcastico anche verso di lei, oltre che verso me stesso, nel momento in cui l’abbracciai per iniziare a ballare e fu così che venni doppiamente colto alla sprovvista quando di nuovo – di colpo – sentii il mio corpo traversato come da una lama di fiammeggiante dolcezza: “felicità, piaceri, trasporti, quanto pungono le vostre frecce? Chi le può sostenere?”14. Quelle mani, quel tocco, quel magico, levitato impaccio dei suoi giri, dei suoi passi, mio Dio, che cosa mi stava succedendo, perché stavo fremendo in quel modo, cosa era quel calore che si espandeva lento e inesorabile dalle parti basse fino al cervello, fino all’estasi? Ebbene si, di nuovo stavo cadendo, di nuovo ero caduto e di nuovo ancor caddi nel medesimo deliquio in cui ero caduto sette giorni prima: di nuovo sentii crescere in me come un’onda di tempesta il desiderio di stringerla, di baciarla, di toccarla, di prenderla e portarla “via, via, vieni via con me…” (Paolo Conte, “Vieni via con me”, un autentico capolavoro, se mi si permette il diminutivo). Il cambio delle coppie venne di nuovo come una liberazione, ma, per quanto impegnato dalla danza, non riuscivo a distogliere gli occhi dal mobile incanto dei suoi sorrisi, dei suoi abbracci, dei suoi passi. La osservavo ballare con gli altri, e, senza che quasi me ne fossi accorto, si era come trasformata, o addirittura trasfigurata: ora non mi pareva più la pallida imitazione di qualcun altro. La divina modella, o il modello di divinità della mia adolescenza (o, chissà, 13 14 E. Cioran, “Sillogismi dell’amarezza”, Adelphi, p. 98. J. J. Rousseau, “La nuova Eloisa”. 51 forse è proprio l’adolescenza in sé e per sé a rendere divine le cose) era stata cancellata di colpo da un atroce e lievissimo raggio di luce: quel viso, come era meraviglioso, meraviglioso come il corpo, come il profilo (ma come, come avevo potuto anche solo sognarmi che quello splendido nasino fosse addirittura anche solo molto leggermente storto?) come le gambe, come le mani, come il ventre, come le spalle, come il collo, come tutto, o il Tutto che dir si voglia! Quella sera tanto magica quanto terribile del nostro, o forse – ahimè – come avrei ben presto scoperto, del mio secondo tango, il delirio erotico che quasi mi aveva travolto il mercoledì precedente ritornò ancora, ancora più violento, ancora più insopportabilmente gioioso, glorioso e doloroso. Di nuovo, giunto a casa, ci fu bisogno della bottiglia per ritornare a una calma decente, che mi permettesse, se non di dormire, almeno di star disteso sul letto senza agitarmi troppo. 22. Inevitabilmente nei giorni successivi giunsi, dovetti giungere alla conclusione che quella strana ragazza poteva, anzi doveva davvero essere per me qualcosa di importante, anche se non capivo assolutamente il motivo di quell’ardente, quasi insopportabile desiderio che Elisabetta o Ella d’Essa che dir si voglia (fu poco dopo la fine della seconda puntata del mio furore erotico che presi a soprannominarla così, con questo nomignolo, si, lo so, lo so, scemo, osceno e anacronistico, avendo però a quel punto compreso, sia pure in modo carsico e confuso, che quanto mi stava capitando era la resurrezione dal profondo del mio inconscio (inconscio?) di altre epoche, altri linguaggi e altri e alti lignaggi, di trine e rime che il nostro mondo ha seppellito forse per sempre nella marea montante delle veline e letterine che, portando al petto siliconato medaglie al valor civile ottenute a furia di calendari svestiti e servizietti di vario genere a registi e ministri vanno infine a fare le ministre, o le minestre (non mi ricordo mai come si dice)), quale fosse, stavo dicendo, l’origine di quell’insostenibile brama, che “lei” – la mia 52 adorata! – la mia diletta! – sembrava capace di suscitare in ogni mia cellula, che cosa avesse di tanto magico la sua immagine per suscitare in me tanta passione, quel vero e proprio delirio che da quel momento in poi prese a tormentarmi di giorno come di notte, nei frangenti più inaspettati, insospettabili e inopportuni: la vedevo nello specchio mentre mi facevo la barba, la immaginavo seduta accanto a me in macchina, o a sorseggiare un caffè al bar. Addirittura, una volta mi venne in mente mentre che ero in preda a un insopportabile urgenza di orinare: immaginavo occupasse il bagno e che a causa sua me la sarei fatta addosso! Non potendo ulteriormente sopportare la sua assenza il lunedì la invitai alla pratica con un sms, e naturalmente mi rispose che non poteva. Mi aspettavo una cosa del genere (le donne non dicono mai di si al primo invito, posto che lo dicano al secondo), pure, infatuato come ero, non potei fare a meno di prendere fin da subito a divincolarmi furibondo e disperato in quell’abbraccio di morsi, ortiche e punture che si chiama “dubbio d’amore”. Cominciai a bere e a fumare dapprima un po’ più del solito, poi ad attaccarmi al collo della bottiglia e al filtro delle mitiche Gauloises come un vitello alla tette della mucca (beh, più che altro al collo della bottiglia devo dire, e tanto crebbe in me questa malsana passione che non mi sarei sorpreso di sorprendermi in un momento qualsiasi della giornata, ivi compreso durante il fino ad allora sacro e imperturbato orario di lavoro, a cantare a squarciagola come un Atrace impazzito “Godi, barbaro amor, perfido godi, col rimirar gl’effetti della tua tirannia, delle tue frodi. Dell’amor mio la sete voi, cristallini umori, almen spegnete. Su correte, o miei fidi, e dei ricchi torrenti non siate avari a dispensare gli argenti. Che l’incessante ardore del petto estingueran, se non del core!”15 (tanto per esser chiaro, in quel periodo mi alzavo, vuotavo la mezza bottiglia di vodka che mi era avanzata la sera e andavo a lavorare: non so come, ma ci andavo: e il bello è che lavoravo pure!)). Divenni nervoso e distratto, quasi nessuna delle mie attività quotidiane rimase immune da quel tormento, tanto che, 15 Atrace, uno dei tanti innamorati delusi de « L’empio punito » dramma per musica di Filippo Acciaiuoli. 53 quale un Amleto che nella pazzia d’Amore davvero sia caduto e non si finga, i miei giorni presero a trascorrere “prima per la melanconia, poi per la mancanza d’appetito, poi per l’insonnia, poi per l’anemia, poi per l’inedia e il delirio e quindi, sempre più declinando, nella pazzia pura e semplice” (beh, no, per essere sinceri al delirio e alla pazzia non ero ancora arrivato: per assistere a questo invero assai inverecondo epperò divertente spettacolo il lettore dovrà ancora pazientare per qualche pagina). La mia angosciosa agitazione, che non mi lasciava neppure quando mi recavo umilmente in bagno e, anzi, strano a dirsi, si dibatteva in modo particolarmente frenetico nel profondo delle mie viscere irrefrenabili proprio quando stavo sopra il cesso, dando luogo a immaginabili effetti di cui, come si suol dire, tacere è bello, si placò solo in parte il mercoledì successivo, quando di nuovo ci incontrammo all’inizio della lezione, fatto che, preso come ero dalle mie esaltate fantasie, mi sembrò l’immancabile risposta a una sorta di tacito appuntamento (e invece come sarebbe stato più saggio ripetermi le sacrosante parole dell’innamorato di Giulia “scambio i miei desideri per speranze: l’ardore delle mie brame conferisce al loro oggetto la possibilità che gli manca.”!16). Ci sedemmo accanto per cambiarci le scarpe (dimenticavo: per chi non lo sapesse, per ballare il tango occorrono calzature speciali, tacco alto per le donne e suola in pelle adatta a scivolare in modo controllato sia per gli uomini sia per le donne). Siccome lei di nuovo ci metteva un bel po’ a cambiarsi, vedendomi innervosito, quasi ridendo rispose alle ansiose questioni a lei poste dalla mia evidentemente fin troppo esplicita mimica facciale “lo sai come siamo noi donne, no?” e io le risposi “no, io non lo so come è che siete voi donne” e lei “facciamo aspettare”, parole che, non c’è bisogno di dirlo, in preda come ero ininterrottamente alla mia dissennata esaltazione, volli a tutti costi interpretare in modo a me favorevole (una cosa tipo: se avrai pazienza di aspettare prima o poi mi concederò). Ballammo insieme per una quarantina di minuti (a volte il cambio di coppie, in specie durante il corso per principianti, veniva posticipato) e ad ogni 16 J. J. Rousseau, “La nuova Eloisa”. 54 capolavoro di aerea dolcezza dei suoi passi, dei suoi giri o dei suoi abbracci il mio Amore cresceva e si consolidava, passando da un etereo e febbrile vaneggiamento a qualcosa che potrei definire “roccia eretta a divino simbolo nel deserto smisurato dell’esistere vuoto”, o, almeno qualcosa di simile: che so, “treno che in orario giunga non ostante lo sciopero dei COBAS”, “politico che tangenti non chieda pur se giudice ultimo del concorso”, “soubrette che a far carriera rinunci pur di non concedere al vile regista le sue grazie”, e altri consimili divine altezze, quali poche volte l’uman vivere consegue (non guadagnando peraltro in questo modo, a quanto sembra, un molto maggior valore e una molto maggior dignità rispetto al modo infame in cui di solito vanno le cose: anche i nobili, i saggi e gli innamorati, non finiscono anche loro, prima o poi, anzi, di solito più prima che poi, a contemplare i fiori dalla parte delle radici? (“Sali sui cumuli di antiche rovine e percorrili avanti e indietro; guarda i crani degli uomini di un tempo e di quelli del tempo presente: chi è il malfattore, chi l’amabile filantropo?”: questo non è, come anche si potrebbe credere, un tardo imitatore di Shakespeare che si ispira fino al limite del plagio ai discorsi dell’Amleto ignaro davanti alla fossa che si prepara per la suicida Ofelia, ma un brano dell’Enuma-elish, un poema babilonese scritto circa 4000 anni prima)). 23. “Sono sette giorni che non vedo la mia amata: il languore m’ha invaso, il corpo s’accascia, dimentico me stesso. Anche se verranno i medici a che serviranno i loro rimedi? La mia amata è la sola medicina, la sua venuta è la mia salute.”17: nel perdurare lento e straziante dell’interminabile settimana successiva, non sopportando oltre la sua ormai già insopportabile assenza, commisi il fatale errore strategico di cui Proust parlava ne “Il tempo ritrovato”, e la invitai 17 Tanto per non allontanarci troppo da Babilonia, almeno sul piano temporale, questa è una poesia d’amore egiziana, ~ 1500 AC. 55 ancora una volta alla pratica del martedì (comunque sia, a parte quel che avevo letto in giro per romanzi, nella mia vita reale o irreale o surreale che sia ho avuto più e più volte modo di constatare che se mostrare a un essere umano qualsiasi un eccesso o anche solo un accesso di dedizione è un errore strategico fatale o peggio che fatale, il dare a una donna l’occasione di dire di no a un invito è un po’ come dare a una gallina l’occasione di fare coccodè, ma non è da stupirsi che l’esperienza trascorsa non servisse a nulla in quel caso specifico: ricordi il lettore che se sbagliare è umano, perseverare, ahimè, lo è molto di più, e che, soprattutto, “amore” fa rima con “dolore”, non con “strategia”, che invece fa rima, che so, con “mia zia” (dev’essere per questo che Bataille scrisse che “Per gli amanti è più probabile non riuscire ad incontrarsi, piuttosto che gioire di una contemplazione senza limiti dell’intima fusione che li unisce”18: perché di solito l’amante, preso da irragionevole frenesia commette tante di quelle sciocchezze che è praticamente impossibile arrivare ad altro che a qualche disastroso invito), invito che, come volevasi dimostrare, di nuovo ebbe come risposta il famoso due di picche: a quel punto non erano nemmeno tre settimane da che la conoscevo (senza peraltro sapere di “lei” nulla di più che per lei ero, appunto, del tutto o quasi del tutto deragliato) e già soffrivo, soffrivo – soffrivo e speravo e disperavo, e mi rotolavo insonne nel letto, al punto tale che per dormire dovetti ben presto farmi prescrivere dei farmaci (“In queste notti immense tu dormi e ti esili milione d’uccelli d’oro, oh futuro Vigore?”: tu che dici mio buon vecchio Arthur, è in queste notti o dove, o in che altro? (questo è, naturalmente, Arthur Rimbaud, ancora una volta da “Il battello ebbro”)). Passarono in questo disdicevole modo altre due settimane, fatte di giorni che, simili a stazioni di un immaginifico e facilmente immaginabile calvario, mi portavano al sospirato mercoledì sera a furia di ansiose sigarette e angosciosi alcolici. Ogni volta trovai la mia adorata puntuale alle otto e trenta ad aspettarmi (che mi “aspettasse”, è logico, lo credevo io: è un articolo che fa parte della 18 G. Bataille, “L’erotismo”, saggio già citato in precedenza e a cui faremo costantemente riferimento d’ora innanzi ogni volta che alluderemo a quest’autore. 56 fede religiosa di quasi tutti gli innamorati, insieme a quello che si è fatti l’uno per l’altro, che come lei non c’è nessuno, che come me nessuno la capirà o l’amerà mai, e via svenevolendo): e vennero così altri tanghi d’estasi e di pena, altre magiche non meno che imperscrutabili e futilissime quattro chiacchiere, oltre che, naturalmente, altri due di picche ad altri due inviti alla pratica (già allora comunque, tutto era matematicamente chiaro: quattro (chiacchiere) meno due per due (di picche) è uguale a zero). Venne epperò infine anche la promessa di rivedersi a un party che il nostro venerabile maestro Ignacio Elizari, prima dell’interruzione del corso per le feste natalizie, offriva agli aspiranti allievi nella sua casa di campagna vicino a Siena, party a cui sarebbe seguita una milonga nella balera di un paese vicino. 24. Al party la ex sconosciuta che oramai potevo senz’altro definire quasi-sconosciuta, arrivò verso le sei e mezza (io, com’è ovvio, ero lì già da almeno tre ore). Indossava degli occhiali di forma rettangolare (l’avevo sempre vista senza, e ne dedussi che di solito doveva portare le lenti a contatto: che fosse questo il segreto di quel suo strano sguardo, immenso, dirupato, come le notturne vetrate dei siderati, sideranti non meno che siderali abissi del cosmo?) e dal mezzo della folla degli intervenuti mi guardava con occhi che dietro gli inusitati occhiali sembravano dirmi: perché non vieni qua, così che parliamo un po’? E io, ovviamente, andai là e parlammo un po’, che cos’altro potevo fare (è una cosa che poco si nota, ma parlare, ovvero scambiarsi segni e simboli per il mezzo di onde sonore codificate che il timpano traduce a sua volta in un codice di segnali elettrici che per mezzo del nervo uditivo arrivano al cervello che infine li trasforma nel fenomeno corrente che chiamiamo “parola” o “parlare”: questa è ciò che dicesi una “relazione”, altrimenti detta un rapporto umano, o simili; Dio mio, non è incredibile tutto questo, che un rapporto umano si riduca a impulsi elettrici, movimenti neuronali, Elisabetta, amore mio, eri questo tu infine per me e sono infine questo io per te 57 un movimento di neuroni, che poi, se tutto va bene, da origine a movimenti pelvici? (verso la fine del “Godot” Beckett, forse per sintetizzare ciò che è successo durante commedia, che è poi la Vita e la Storia Umana in simbolo, mette questo esemplare dialogo: “Vladimir: Dimmi, che cosa abbiamo fatto ieri sera? Estragon: Cos’abbiamo fatto? V.: Cerca di ricordarti. E.: Bé… dobbiamo aver chiacchierato. V.: A proposito di che? E.: Oh… di tutt’un po’, forse del più o del meno. Ecco, adesso ricordo, ieri sera abbiamo chiacchierato del più e del meno. Sarà mezzo secolo che non facciamo altro.” (beh, un atteggiamento in fondo infine non del tutto improduttivo, se è vero che “Non si fa lega con la vita se non quando si dice – con tutto il cuore – una banalità” (Cioran))) Dunque, come accade sempre o quasi in questi casi, ovvero in tutte quelle commedie dell’Assurdo che, suppongo, a tutti o quasi tutti capita prima o poi di recitare nella vita, parlammo, appunto, un po’ di tutto e un po’ di nulla prima, e un po’ di nulla e un po’ di tutto poi (quanto al più e al meno non mi ricordo, credo di aver evitato l’argomento, non sono mai stato forte in matematica). Lei mi raccontò del suo lavoro (come mi sono scordato di specificare nelle pagine precedenti, Elisabetta mi aveva detto che faceva l’interprete per sordomuti, oltre che un bel po’ di cose al riguardo, che però ora non mi ricordo più di tanto), che amava inoltre anche la poesia e il teatro per sordomuti (rimasi all’inizio un po’ basito nel venire a sapere dell’esistenza di cose del genere, ma poi pensai che nell’universo vario, insensato e sterminato era logico che potessero esistere, o forse addirittura necessario: un giorno, ne sono certo, qualcuno riuscirà a inventare anche la pittura per ciechi, o il salto in alto per paralitici, o l’onestà per politici, l’assicurazione per gli assicuratori, etc.), in modo piuttosto dotto mi accennò alle differenze fra il “nostro” mondo e il “loro”, e il tutto mi interessò molto, non solo perché era lei a parlarmene (devo riconoscere che in quel momento Elisabetta sarebbe riuscita a interessarmi anche parlando di logica e semantica dell’assorbente intimo femminile), ma anche perché io – per non aver nulla di meglio di cui parlare – mi occupo, giustamente, di filosofia del linguaggio, e in quel periodo – vedi la coincidenza! – stavo facendo astruse ricerche quanto alla capacità di 58 un linguaggio gestuale di diventare un metalinguaggio di sé stesso (roba tipo: come si fa con un gesto a simbolizzare che quel gesto è una parola, e non, appunto, un gesto? (guarda tu cosa deve fare per riuscire a stare in qualche modo al mondo un essere uscito dallo strano incontro (strano più che altro in quanto ai modi e al luogo) fra un ovulo e uno spermatozoo!). Verso la fine della conversazione, che si svolse in due trance e che durò complessivamente un’oretta e mezzo, e che fu arguta, affascinante e piacevole – più che altro perché mi aveva fatto per lunghi minuti fantasticare quanto a positivi riscontri e sdolcinate conseguenze – Elisabetta trovò subito il modo di darmi una prima, pungente delusione. Stavamo piluccando qualcosa da un vassoio, e versando qualcos’altro nei canonici bicchierini di plastica (per me whisky, me lo ricorderei anche se non me lo ricordassi per niente, per lei invece non me lo ricordo proprio), quando la mia dolcissima creatura (forse stavo mordicchiando un pasticcino) con modi un po’ bruschi e con una svolta d’umore che mi parve non meno improvvisa che improvvisata, cambiò di colpo il registro delle sue discorsive inclinazioni: tutto d’un tratto, il suo angelico volto prese un’aria inspiegabilmente ansiosa ed irrequieta e cominciò a parlarmi, o, per meglio dire, ad alludere in modo piuttosto sibillino ed enigmatico, all’oscuro e inquietante fatto che – guarda un po’ – proprio quel mattino, non appena si era svegliata, aveva provato angoscia, ma proprio tanta angoscia, mamma mia, quanta angoscia aveva provato! Sbiancava e si agitava nel mentre ripeteva quelle funeste, inquietanti frasi, che per di più non c’entravano nulla con quello (cosa?) di cui avevamo chiacchierato fino a trenta secondi prima, ma a mia pronta e ansiosa richiesta la cotale non seppe o non volle precisare il perché o il per come e nemmeno il per quanto (nel senso che aveva ancora in quel momento un momento di angoscia o che?). Ebbi perciò il terribile sospetto che io, si, proprio io, ovvero Me Medesimo Stesso, fossi alle origini di tali oscuri sommovimenti interiori (se non ricordo male fu proprio da quel punto in poi che presi a soprannominarmi in questo sgraziato e disgraziato modo, ovvero Me Medesimo Stesso: non potevo lasciare Elisabetta, ovvero Ella d’Essa, sola con quello strano, stilnovistico nomignolo che le avevo appiccicato! dove c’è 59 una Beatrice un Dante deve accompagnarla, dove c’è una madonna minacciata da un drago ci deve essere un cavaliere errante, talmente errante, ovvero in errore, da non essere capace di accorgersi che il drago in questione era proprio la suddetta madonna, che in quel momento, fumando dalle narici ed eruttando fuoco dalle orecchie, sembrava accusarlo di una qualche imperscrutabile mancanza (di che?) nei suoi confronti), ovvero di aver inopinatamente a che fare con tali dolorosi ed inesplicabili tormenti mattutini, se non proprio di esserne addirittura la causa più o meno diretta ed efficiente (il modo e il tono con cui me ne aveva accennato mi lasciavano pochi dubbi in proposito: le sue parole parevano quasi un atto d’accusa, ancorché velato dall’oscuro mantra di illusorie allusioni che può essere un’espressione vocale e facciale). Ma, in ogni caso, per quanto mi prodigassi in illazioni, insinuazioni e allocuzioni, nulla venne fuori di più concreto e preciso. Dopo l’oscuro accenno a questa non ulteriormente decifrabile angoscia del risveglio, continuammo a parlare, come avevamo fatto fino a un momento prima, e parlammo, suppongo, ancora di noi, dei nostri interessi, della nostra vita (noi, la nostra vita: in fondo è questo il tutto e il nulla di cui si parla innanzi tutto e per lo più, senza peraltro porvi alcuna attenzione più precisa, (il nulla pare comunque un’espressione senz’altro più precisa: chi è che ha detto “Un nulla ci consola, perché un nulla ci opprime”? (ah, si, dev’essere proprio lui, dev’essere Pascal)))), di come andavano le cose (come vanno le cose? e dove vanno? e vanno davvero da qualche parte? mah!), e parlammo, parlammo ancora, “verba sesquipedalia” ci scambiammo in modo tenero e amichevole, al punto che, a dispetto delle di lei non meglio chiarite ancorché mattutine angosce, la serata sembrava alfine promettere bene. 25. Così, al momento in cui il party si sciolse – “ignaro del mio fato, e quante volte questa mia vita dolorosa e nuda volentier con la morte 60 avrei cangiato”19 – ebbi il coraggio di chiederle se voleva venire alla milonga insieme a me, dato che ero solo in macchina e che così…, così…, ehm, così mi avrebbe fatto compagnia (in vita mia non ho mai sopportato praticamente nessuno: come è che in quel momento avevo bisogno proprio di quella compagnia? mah e doppio o triplo mah!): ed ella accettò, si, accettò, si Ella d’Essa mia di Me Medesimo Stesso, accettasti sorridendo (un mio ex compagno di università, che adesso si può tranquillamente definire “un promettente giovane critico” mi ha fatto notare che questo spaventoso soprannome che mi ero auto-affibbiato – “Me Medesimo Stesso” – suona male, anzi, peggio che male, malissimo, e rischia perciò di rovinare, insieme a quello che ho appioppato a Elisabetta, tutto l’interno equilibrio semeiotico (non ho la più pallida idea di che cosa sia) nonché la coerenza stilistica del testo e dunque il lettore mi scusi per averlo già usato per ben due volte: l’ho fatto solo per completezza di cronaca, e giuro solennemente sulla testa dei figli di Berlusconi – che a tanto questo punto deve essere ridotta come una sedia di Barbie usata da Giuliano Ferrara per schiacciare un pisolino – di non farlo per nessuna ragione mai più! (a proposito, lo sapete come si fa distinguere il Ferrara giornalista dalla Ferrara città? il giornalista occupa molto più spazio))! Così – mentre pensavo con un certo sollievo che le mattinali angosce non impedivano alla mia amata di appartarsi con me notturnamente in macchina, e che in ragione di ciò le mie possibilità di un approccio come minimo amichevole restavano infine intatte – continuando a chiacchierare ci avviammo alla macchina prima e verso la balera poi, e tutto sembrava procedere per il meglio, salvo andare a sfociare in quello che mi sento di definire una sorta di “simpatico incidente”. Il lettore deve sapere che, siccome ho sempre avuto difficoltà ad orientarmi su strade sconosciute, e a volte perfino in quelle conosciute, in specie di notte (lo spaesamento e la meraviglia sono, credo, la forma più profonda del mio carattere), non appena uscito dalla strada sterrata che portava dalla villa alla statale mi resi conto che non sapevo più esattamente cosa fare, e fu così che 19 Dal Canto “Le ricordanze”, di Giacomo Leopardi 61 chiesi a Elisabetta se per caso non si ricordasse la direzione che dovevamo prendere per andare al paese dove si sarebbe svolta la milonga (ci trovavamo in piena campagna senese, in un punto in cui le indicazioni, per fortuna, non abbondavano). La mia adorata, mettendo in mostra uno dei suoi celestiali, sovrumani non meno che enigmatici sorrisi, mi rispose che si, che se lo ricordava molto bene: dovevo solo svoltare prima a destra e poi a sinistra, poi ancora a destra e proseguire per un paio di chilometri, istruzioni che seguii docilmente finché, passati un po’ di incroci, non comprendemmo di aver perso totalmente la bussola, al punto che per un tragitto che avrebbe dovuto richiedere un massimo di dieci minuti, impiegammo più o meno un’ora e un quarto, se non un’ora e mezzo o più. E fu precisamente in quell’ora e un quarto o mezzo o forse più che il mio dolce fato ebbe a compiersi, anche se solo per trasformarsi ben presto, ahimè, troppo presto, in un amaro calice! Fino a quel momento, in effetti, avevo avuto con la mia adorata solo contatti brevi ed occasionali, che ancora non mi avevano del tutto e fino in fondo convinto che la mia passione non fosse da considerarsi infine una sorta di allucinazione frutto del mio disperato bisogno di sentirmi innamorato, e non vero amore. Quella sera invece, per tutto il tempo che restò seduta accanto a me, Elisabetta mi trasmise quel dolce e terribile segnale che indica – non so se ad altri, ma senz’altro a me stesso – che un grande amore è in corso. A beneficio del lettore, penso di poter tradurre efficacemente questo segnale in linguaggio corrente facendo accenno a quella eccentrica sensazione per cui una persona che si sa razionalmente essere una più o meno perfetta sconosciuta viene sentita come da sempre conosciuta, o meglio, o peggio: come una parte di noi stessi, del nostro futuro come del passato, fenomeno strano questo, o financo borderline, che spinge i più fanatici cultori dell’amore romantico a credere che neppure la morte potrà mai separare dall’amata (in effetti, nel caso che la morte fallisca si può sempre provare col divorzio). 62 26. Alla milonga provai a ballare con la mia adorata, ma siccome non avevo ancora appreso quel minimo di tecnica necessario per guidare una donna nella ressa delle coppie, dovetti quasi subito lasciar perdere (sappia il lettore che vi è una differenza fondamentale tra il guidare una dama in una sala semivuota e in una in cui le altre coppie vengono continuamente a intralciare il cammino: il tango è una danza di improvvisazione e oltre a star dietro alla musica bisogna stare continuamente attenti allo spazio che si rende disponibile o che viene occupato nei propri dintorni, cosa che costituisce uno degli aspetti più difficili di questa strana e affascinante o, direi, del tutto unica ipostasi dell’Idea della Danza). Fu così che per tutta la sera fui costretto a starmene seduto a contemplare la mia amata volteggiare divinamente abbracciata ad altri ballerini che – molto probabilmente solo per farmi dispetto – non la lasciavano mai per più di un decimo secondo a sedere, e la stringevano, e la coccolavano, e la tentavano e la portavano, e io quasi avrei voluto mettermi a gridare tanto era folle e impotente la mia gelosia – si, la gelosia! la gelosia! – forse il più cervellotico, enigmatico, labirintico e proteiforme mostro che da sempre ora et labora et sopratutto divora l’anima dell’innamorato, dato che – ahimè – “Come geloso, io soffro quattro volte: perché sono geloso, perché mi rimprovero di esserlo, perché temo che la mia gelosia finisca per ferire l’altro, perché mi lascio soggiogare da una banalità: soffro di essere escluso, di essere aggressivo, di essere pazzo e di essere come tutti gli altri.”20 (fra l’altro, preso com’ero da quella sorta di isterica follia, non mi rendevo conto di star in quel momento vivendo, “last but not least”, anche uno degli ultimi splendidi, lancinanti e folgoranti fulgori della mia di lì a poco per sempre perduta giovinezza. Dopo, anche in seguito alle strane vicende di questo bizzarro innamoramento, mi è successo quel che succede forse un po’ a tutti, ovvero quel che decanta al pubblico un malincomico Vladimir verso la fine del “Godot”, cioè verso la fine – 20 Questo è ancora Roland Barthes, da “Frammenti di un discorso amoroso”, testo da cui sono tratti i riferimenti che a lui abbiamo fatto e ancora faremo nel corso dell’esposizione (esposizione di che? mah…). 63 in simbolo – della vita umana: “Abbiamo tempo di invecchiare. L’aria risuona delle nostre grida. Ma l’abitudine è una grande sordina.” (Michelstaedter, pur poco più che ventenne, era già anche lui di questa opinione: “Poi la vita s’incarica di stordirli; l’essere vivi si fa un’abitudine – le cose che non attraggono non si guardano più, le altre sono strettamente concatenate, la trama si fa uguale – il bambino si fa uomo – le ore degli spaventi sono ridotte al sordo e continuo, misurato dolore, che stilla sotto tutte le cose.” (perché Michelstaedter si è ammazzato, se era tanto saggio? secondo me il problema deve essere stato proprio questo, che tanta saggezza gli è arrivata tra il capo e il collo quando era ancora troppo giovane per sopportarla: un ventenne saggio è come un settantenne pazzo, una cosa orrida e contro natura, che necessariamente deve condurre a una morte atroce e precoce, se la saggezza non è infine altro che una strana forma di morte che si insinua nella nostra spenta ancorché ironica sopravvivenza che precede di poco l’infine forse sospirata ed effettiva dipartita))). 27. Seduto in disparte, fremendo impotente mentre Elisabetta sorrideva al suo cavaliere di turno e lo seguiva, sottile e inesorabile come l’ombra seguendo i passi che vanno al sole che tramonta, tormentato dai miei impotenti desideri, ogni secondo mi sembrava durare come un secolo. Alla fine, dopo un paio d’ore ovvero, calcolando il tempo in base ai parametri della gelosia, dopo 7200 secoli di tale estenuante martirio (si, ho detto esattamente così, ho detto martirio, e non esagero affatto, e, comunque sia, anche se il mondo intero volesse darmi torto, beh, rimane almeno il buon vecchio Cioran a darmi ragione: “Nella ricerca del tormento, nell’accanimento alla sofferenza, solo il geloso può competere con il martire. Eppure si canonizza l’uno e si ridicolizza l’altro.”21), verso il tocco e trenta decisi di concedermi una pausa e di tornarmene a casa. Mi recai 21 E. Cioran, “Sillogismi dell’amarezza”, Adelphi, p. 93. 64 sorridendo a salutarla ma la mia diletta, strano a dirsi, parve – come dire? – alquanto irritata per la mia prematura dipartita: così che, quasi sentendomi un po’ in colpa (altro sintomo patognomonico del mal d’amore, la donna vista non più come fonte di piacere ma, in qualche modo, di fondamento morale (cfr., per es., Dante ne “La vita nova”)), con tono un po’ intimidito e vagamente giustificatorio le spiegai che vivevo lontano da lì, molto lontano, e che per tornare a casa ci avrei impiegato più di due ore. Approfittai del colloquio anche per chiedergli se potevo invitarla per la pratica del martedì successivo e lei rispose che certo, che si, che potevo, anzi, dovevo invitarla, il che naturalmente avvenne – ahimè e doppio ohimè – sol perché e perch’io potessi ricevere il terzo o il quarto due di picche consecutivo (a quanto pare ci sono certi mazzi di carte che sono composti da quaranta due picche, più un paio di jolly che ridono, certamente, ma che però, strano a dirsi, ridono e stringono in mano un cetriolo di dimensioni paragonabili a quelle di un Patriot…). Un segno questo veramente brutto per il proseguo della relazione, dato che con ogni evidenza Elisabetta pareva intenzionata a rifiutarmi ogni intimità che non fosse occasionata, diciamo così, da motivazioni “ufficiali” o “pubbliche” che dir si voglia: alla lezione ballava con me, ma di certo non ci veniva per me, e similmente al party era stata con me, ma non ci era venuta né con me né per me. Invece, alla pratica sarebbe venuta con me e forse anche per me, e sembrava proprio questo il messaggio che la beffarda tentatrice voleva tassativamente rifiutarmi: ma allora perché mi aveva chiesto di invitarla, perché mi aveva concesso di accompagnarla in macchina alla balera (addirittura mi era sembrato che mi avesse a bella posta spinto a sbagliar strada per stare da sola con me un po’ tempo in più)? Non si rendeva conto che ero cotto di lei come un tacchino americano nel Giorno del Ringraziamento (a proposito, ringraziamento di che? che cosa ha da ringraziare un tacchino che finisce arrosto, del contorno di patatine?), cosa stava facendo, stava giocando al gatto col topo, o invece alla gatta che va al lardo e ci lascia lo zampino, così che poi deve andare con lo zoppo per imparare a zoppicare (e cose del genere)? Ancora nessuno l’aveva resa edotta che un cotal pedestre genere di scherzi da prete 65 pedemontano, pederasta e pedofilo – almeno su di un pover’uomo perdutamente innamorato quale io ero in quel momento – ha il medesimo dolce effetto di un cactus ancor dotato di tutte le sue spine infilato su per il retto anale umettato all’uopo con catrame, polvere di marmo e pepe di cayenna? Quando il mercoledì successivo a lezione ci salutammo mi ritrovai perso, immerso e disperso nei più tristi pensieri e nelle più fosche previsioni che uno spasimante possa spasimare, spasmi che come un coro tragico presero a rimbombare cupamente nella mia mente annunciando tristi accadimenti: la mia amata tornava a casa per le vacanze di Natale (dimenticavo: Elisabetta viene da Torino (ragione questa dell’allusione al prete pedemontano etc.), anche se, strano a dirsi, parla con un piuttosto marcato accento perugino, a dispetto del fatto che la sua permanenza in Toscana si è svolta interamente a Firenze e di Perugia non ha mai visto nemmeno una cartolina (mi viene in questo momento un dubbio: che sia davvero un marziano?)) e al momento del congedo la baciai sulla guancia pieno di languido desiderio e orride premonizioni. 28. “Mite, mite, o demone tu sia, se alla terra materna oscuro evento adduci. Che propizio io ti incontri, che vuota grazia io mai non colga…”: coi giorni che passavano, ecco che il coro genericamente tragico che avevo udito pria che la mia “lei” partisse si trasformava in uno di quelli più belli e terribili fra quelli sofoclei, che veniva a turbare l’intimo silenzio della mia tormentosa attesa con i funesti versi dell’Edipo, echi che mormorando accarezzavano maestosi e cupi abissi del mio cuore come il fruscio d’ala d’un angelo dell’Apocalisse planando sulla valle di Giosafat – mentre intanto – ahi! – intanto, lentamente ma inesorabilmente le cosiddette vacanze natalizie si trasformavano in interminabili deserti, deserti che non nascondevano dietro alcuna duna il miraggio di un prossimo mercoledì – da leoni o da domatori, che importa? – in cui avrei potuto rivederla e riabbracciarla, non foss’altro che per qualche 66 sperato o disperato tango, dolceamara e disarmonica armonia che fin dall’inizio allude e prelude alla funerea nota del suo addio. Tanto mi sentivo solo e abbandonato che per Natale, non potendo tollerare oltre la sua assenza e la mia impotenza, le spedii un sms di auguri che suonava più o meno “buon Natale alla mia ballerina preferita”, messaggio a cui la mia adorata rispose poche ore dopo ricambiando gli auguri anche se – ahimè – con assai minore entusiasmo che il mio, dato che non si parlava di ballerino preferito o di persona che comunque sia potesse da lei aspettarsi alcun tipo di speciale attenzione. Per l’ultimo dell’anno, dopo sei giorni di interminabile agonia, di nuovo non potetti e non voletti resistere, e gli spedii un nuovo sms con quasi identico testo che quello spedito per Natale, ma questa volta – oh morte, morte, perché tardi? non ti servirai per caso delle Ferrovie Italiane? – non arrivò alcuna risposta, fatto che confermò la peggiore delle mie peggiori supposizioni. Era ovvio infatti che questa mancata risposta non era dovuta a un qualsiasi mio comportamento o atteggiamento, a nessuna parola o espressione o smorfia sbagliata, dato che lei si trovava a Torino e io invece a Firenze, e nemmeno potevo pensare – ahimè – a una qualche eventuale manchevolezza letteraria nel testo del mio sms, dato che era pressoché identico a quello che le avevo spedito per Natale e a cui, sia pur senza accento di calore alcuno, la mia adorata aveva comunque con laconica stringatezza corrisposto. Il motivo si trovava dunque solo e soltanto nelle psiche della fanciulla che, con ogni evidenza, giudicava di avermi fatto troppo avvicinare: come spesso succede, pensai, il mio amore ingrato aveva goduto delle mie avances fino al punto in cui non era stata da me improvvidamente costretta a pensare che avrei potuto chiederle qualcosa di più che una semplice amicizia, e a quel punto si era tirata indietro senza troppi complimenti. E, quasi certamente, dietro questo improvviso e improvvido dietrofront c’era un ragazzo o un fidanzato che dir si voglia, probabilmente un torinese, che, tenuto sullo sfondo dalla distanza e dall’apparente innocenza della lezione di tango, era ritornato prepotentemente alla ribalta con il ritorno a Torino e la richiesta di intimità più o meno implicita nella pur timida insistenza del mio secondo sms. Era tutto finito dunque, questo ormai era 67 certo, e l’unico dubbio che ancora mi restava, montalianamente parlando, era se la vita fosse “crudele più che vana” o invece “vana più che crudele” o se invece vanità e crudeltà non facessero pari e patta e alla fine uscissero a cena insieme! Come che sia, quel che c’era da aspettarsi era che al suo ritorno a Firenze e dunque al corso di tango del Boschetto la mia adorata, la Beatrice dei miei sogni sognati ad occhi aperti nella chiusa prigione delle mie notti insonni, la visione che galleggiava nel fumo lento della milionesima Gauloises, che si avvitava dolce nel vertiginoso vortice della vodka, del whisky e del cognac, lei, la mia lei, la mia diletta, la strabenedetta e stramaledetta “lei” non mi avrebbe salutato nemmeno, o, comunque sia, lo avrebbe fatto con freddezza, o fastidio, o imbarazzo, o tutte e tre le cose insieme. Non ci saremmo più seduti accanto per cambiarci le scarpe, non più sorrisi e parole a perdere, non più danze strettamente abbracciati, se non per malaugurato scherzo di un fato ormai inutilmente crudele e beffardo. “Povero innamorato di terre chimeriche! Bisognerà incatenarti e buttarti in mare, marinaio ubriaco, scopritore d’Americhe il cui miraggio fa l’abisso più amaro?”: Baudelaire aveva ragione, anzi, aveva avuto ragione fin dall’inizio, fin da quando prima del secondo fatidico ballo mi aveva avvertito che, senza neppur bisogno di iniziare, era tutto finito (beh, per la verità, lo dice anche Aragon, e chissà quanti altri lo ripetono milioni di volte, da nessuno ascoltati, meno che tutti da sé stessi “Non c’è amore che non sia appassito. Non c’è amore che non si nutra di dolori. Non esiste un amore felice.” (il che, in ultima analisi, vuol dire che l’amore non è altro che una delle infinite forme che può prendere questo infinito Proteo che è l’umana sofferenza; ma allora perché lo si cerca con tanta ansia e tanto ardore? Chissà, forse perché, a differenza delle altre, è una forma di sofferenza che sembra altamente e grandemente significativa). Ebbene si, il mio Amore, il mio Grande Amore si era rivelato infine una Grande Beffa, e, come era prevedibile – e come avevo più o meno inconsciamente previsto – le cose erano andate male, anche se seguendo un percorso diverso – ovvero ben più lungo e tortuoso – da quello che mi ero prefigurato all’inizio. 68 29. Avevo accennato poco sopra alla rilevanza e alla grandezza della Storia dell’Umanità, e avevo sottolineato come essa proceda, questa si, per fatti rilevanti e drammatici, per crisi e sommovimenti e rivolgimenti epocali (Tocqueville diceva appunto che “gli uomini sono piccoli, ma gli avvenimenti sono grandi”: la banalità del nostro privato è dunque, per così dire, trasfigurata e redenta dalla totalità che produce? ma chi è che osserva dall’alto dei cieli questo grandioso spettacolo, un dio, un demone, un regista televisivo o chi altri o nessuno? e se nessuno l’osserva, questo grandioso spettacolo esiste o non esiste? boh..). Avevo però trascurato di precisare che al cospetto di tanta maestosa e spesso e più che altro catastrofica grandezza mai mi sono in vita mia un granché commosso: il personal computer rivoluziona l’economia mentre imperversa la guerra fredda, il crollo del muro di Berlino sancisce la fine di un’epoca, l’inizio delle migrazioni dall’Africa e dall’Europa dell’Est verso l’Europa Occidentale, lo tsunami che stermina centinaia di migliaia di persone, guerre africane stupide e interminabili in cui milioni di negri – fra cui vecchi, donne e bambini – trovano morti non è chiaro se più atroci o assurde, guerre e stragi etniche nei Balcani, crisi economiche annuncianti l’Apocalisse con successivo rimbalzo delle borse e, non si sa mai, anche degli zaini, delle tracolle e delle valigie: tutti fatti grandiosi, meravigliosi e orrendi, bisogna scriverlo e magari anche sottolinearlo, come anche mi sento costretto da onestà, sincerità e schiettezza a scrivere, sottoscrivere e sottolineare che in fondo in fine di tutti questi grandi avvenimenti a me non me ne è mai importato un granché, o, comunque sia, mi hanno sempre commosso e infastidito molto meno della polvere che si accumulava e che – ahimè – ancora si accumula nella mia lussuosa e solitaria casa di scapolo (sappia il lettore che sono uno scapolo di quelli talmente scapoli che non arrivano a sopportare in casa nemmeno l’ombra di una donna, fosse pure quella di servizio, dato che, sebbene mi trovi immerso nel presente moderno ho la naturale inclinazione a pensare 69 dell’argomento quel che ne pensavano i teologi cattolici circa un millennio fa: “Subito, all’inizio, la donna fece prigioniero l’uomo, allontanandolo dal paradiso e colei che fu creata da Dio per essere suo aiuto, si trasformò in una terribile causa di rovina. (..) Satana ha esteso la sua naturale malizia fino a noi. Ha cercato di abbattere col matrimonio colui che non poté far cadere con la lussuria”22 (beh, quello citato in questa sede non è un teologo, ma una celebre monaca ex innamorata di un altro celebre monaco: spero che la signora non si offenda se le dico che mi trovo perfettamente d’accordo con lei)). I mutamenti epocali, le grandi tragedie della Storia e dell’Umanità, certamente, scrivete pure dei libri sul tema e magari li leggerò, ma è davvero troppo chiedere a una misera anima di singolo essere umano di abbracciare simili, smisurate entità – o, almeno, è troppo chiederlo alla mia. Troppi uomini muoiono ogni giorno, troppi casi disperati si disperano nel mondo per potersi soffermare su ognuno o, peggio, sulla totalità di essi. La Storia, non ostante o forse proprio a causa della sua grandezza, non è mai riuscita a suscitare in me sentimenti anche solo vagamente paragonabili a quelli che scatenarono nel mio povero cuore innamorato i trascurabili non-eventi della mia nonstoria con Elisabetta. Ah, come avrei voluto in quel momento essere uno Iago sarcastico che l’ingenuo Rodrigo apostrofa e irride sghignazzando “Io, piuttosto che annegarmi per una gallina faraona, preferirei essere mutato in una scimmia”23!. Al contrario, laggiù, sprofondando nel fondo senza fondo della più infondata nonché ridicola angoscia che si possa immaginare, ovvero nel pieno del vuoto delle vacanze natalizie venivo assalito da conati di vomito, da improvvise e improvvide lacrime, soffocate solo in riguardo della mia vera o presunta maturità e della mia vera o presunta forza di maschio latino, che di latino, evidentemente, non ne aveva saputo mai nemmeno una parola. La malinconia mi tormentava ad ogni ora del giorno e della notte, soprattutto della notte devo dire, e a furia di bere per calmarmi oramai non distinguevo più grappa e vodka dall’acqua minerale naturale e, a volte, nemmeno da quella gasata. 22 P. Abelardo, “Lettere di Abelardo e Eloisa”, lettera quarta, di Eloisa ad Abelardo. 23 W. Shakespeare, “Otello”, I; III: 70 “Mai, mai, su niente sorga l’aurora o splenda il giorno o indori sul declivio – ho avuto piacere che durasse poco più di niente, la perdita, prima ch’io ne godessi.”24: dunque era tutto vero, ogni mia più fosca previsione era pronta a trasformarsi in dura realtà! Altro che oraziano carpe diem, altro che “godi il giorno e la notte, danza e canta da mattino a sera” (no, questo non è Orazio, anche se lo sembra: è “Gilgamesh”, piuttosto noto poema babilonese), altro che “chi vuol essere lieto sia, del doman non c’è certezza” (no, questo non è “Gilgamesh”, anche se lo sembra, ma un noto componimento della Rinascenza fiorentina)! “Vanità delle vanità… Ciò che già fu è quel che sarà, ciò che si fece è quel che si farà: non c’è nulla di nuovo sotto il sole” (a parte forse, qualche nuovo tipo di crema solare)! Non più balli leggiadri, suadenti e soavi, non più sogni ad occhi aperti, non più il suo corpo tenue e vellutato seduto proprio lì, accanto al mio, mentre la sua voce di topino dei cartoni animati (era e suppongo sia rimasto questo il suo tono di voce normale) mi indica con sicurezza il modo più diretto e semplice per perdermi nel bel mezzo della campagna senese! Dov’era finita la mia ridente ipocrisia, dove il mio gaio e languido cinismo? “Ogni agonia è curiosa di per sé, ma la più interessante resta quella del cinico, di colui che in teoria la disprezza”25. Mentre che ero intento a piangere il mio perduto amore, barche di clandestini naufragavano nell’Adriatico in tempesta, centinaia di morti annegati, centinaia di sbarchi di disperati, fra cui donne e bambini, affamati, infreddoliti, terrorizzati a Pantelleria, e io che mosso da una sorta di disperato e solitario demone fissavo lo schermo con gli occhi umidi e il groppo alla gola di chi guarda solo per trovare consolazione alle sue privatissime agonie nei guai altrui (come dice il proverbio, mal comune mezzo sindaco (o era mezzo assessore alla cultura? boh..))! Io, si, io, proprio io, ovvero un uomo che si supponeva maturo e disincantato, che fra tutti gli auguri possibili non riuscivo altro che ad augurarmi che il messaggino che 24 25 F. Pessoa, “Il mondo che non vedo: poesie ortonime”, poesia 169. E. Cioran, “Il funesto demiurgo”, Adelphi, p. 155. 71 doveva rispondere al mio di capodanno si fosse perso nell’infinito traffico di sms che si disperdono nell’etere in quell’ora fatale! Pascal, si – proprio lui, ancora lui! – aveva ragione, aveva troppa ragione: “Chi volesse conoscere appieno la vanità del mondo non avrebbe che da considerare le cause e gli effetti dell’amore. La causa è un non so che, e gli effetti sono spaventosi” (con altre parole e ben altri intendimenti, è quel che sostiene anche Roland Barthes: “I fatti della vita amorosa sono talmente futili che accedono alla scrittura solo con uno sforzo immenso: ci si scoraggia di scrivere ciò che nello scriversi, rivela in pieno la propria banalità: “Ho incontrato X… in compagnia di Y…”, “Oggi, X… non mi ha telefonato”, “X… era di cattivo umore”, ecc.: chi potrebbe vedere in questo una storia? Il fatto, insignificante, non esiste altro che per le enormi ripercussioni che esso ha: Diario delle mie ripercussioni (dei miei dolori, delle mie gioie, delle mie interpretazioni, delle mie ragioni, delle mie velleità): chi riuscirebbe a capirci qualcosa? Solo l’Altro potrebbe scrivere il mio romanzo.”)! Chissà perché, chissà, forse solo per dar ragione in pieno a Pascal, contro le ambiguità di Barthes – che in effetti, ammette anche l’esistenza di alcune per quanto velleitarie, trascurabili e dunque questionabili “gioie” – angosce atroci non meno che minuziose mi tormentarono da quel momento in poi per giorni e giorni, e, come appeso per parti del corpo innominabili alla corda di pianoforte della delusione, già prefiguravo quel che sarebbe successo di lì a poco. Il corso sarebbe ricominciato verso la metà di gennaio, ma Elisabetta, si, il mio già perduto Amore, non sarebbe di certo ritornata alla prima lezione, forse nemmeno alla seconda. Quando poi – chissà quando – fosse eventualmente tornata mi avrebbe evitato con il massimo scrupolo, o, più probabilmente, mi avrebbe salutato con un’espressione e un tono di voce che sarebbero stati una via di mezzo fra il gelido, l’impaurito e l’imbarazzato e, ammesso che avesse risposto al mio saluto (di certo non avrebbe preso lei l’iniziativa) mi avrebbe congedato quanto più freddamente e rapidamente fosse possibile. Come subito si vede, questo era un ragionamento, come si suol dire, molto ma molto ragionevole, ma solo chi non è mai stato 72 innamorato può immaginare che il cuore si conformi tanto presto ai dettami dell’intelletto, e dunque, come era del tutto tragicamente logico, per quanto preparato al peggio, continuavo inesorabilmente – “spes contra spem” – a sperare il meglio (anche se, a dir la verità, non mi ricordo bene che cosa vuol dire “spes contra spem”: forse “spesa contro sperma”? boh…). 30. Come avevo fin troppo facilmente previsto, alla ripresa del corso Elisabetta mancò alla prima, alla seconda e poi anche alla terza lezione. Quando si fece di nuovo vedere era già febbraio e naturalmente (“naturalmente” nel senso che avevo previsto anche questo) non si presentò alle otto e trenta, ovvero all’orario di quello che per un paio di mesi avevo creduto, forse almeno in parte a ragione, quello del nostro tacito appuntamento, ma verso le nove e trenta, quando la sala era già piena di gente e non era neppure poi così facile notare il suo arrivo che però, immancabilmente, io registrai all’istante con un tuffo al cuore. “Ma silenzio! Ecco la bella Ofelia! Ninfa, ricordati di tutti i miei peccati, nelle tue orazioni.”26 (il più grosso, naturalmente, era stato quello di perdere la testa per lei e di farglielo capire). Dopo un attimo di sospesa, amletica o quasi amniotica incertezza, siccome vedevo ch’Ella d’Essa, visibilmente imbarazzata, distoglieva lo sguardo dai miei occhi già pronti a grondare di disperate non meno che gioiose e inebetite lacrime, in un impeto di inevitabile quanto inutile fervore di nuovo fui io ad avvicinarmi (solo l’Amore rende così forte la percezione di questo per altro così anonimo pronome personale, “io”, perché solo l’Amore ci rende coscienti in modo tanto terrifico del fatto di solito piuttosto banale che esistiamo (io penso, dunque sono, e a chi gliene può fregare di meno? io amo, dunque soffro atrocemente, di questo invece, inevitabilmente, frega a tutti, ed era questo che ero andato lì, quasi a 26 W. Shakespeare, “Amleto”. 73 gridarle, io esisto perché tu mi fai esistere), a dirle che ero felice di rivederla, a baciarle inutilmente la guancia divenuta pallida per qualcosa che mi parve un misto di timore e di ostilità. Era evidente che non sapeva cosa dirmi e, siccome non ebbi la prontezza d’animo di togliermi di torno all’istante, la mia ingrata adorata, e forse proprio per questo ancor più adorata, non seppe far di meglio che invitarmi timidamente al bar del circolo dove, disse, mi avrebbe presentato una sua amica (una sua amica? ma è pazza questa qui? non si è resa conto che sono cotto, stracotto e ricotto di lei? che me ne frega della sua amica?). Ma, adesso lo capisco, queste parole non erano altro che un modo, forse il più gentile possibile, di comunicarmi quel che sapevo oramai da più di un mese, ovvero che fra noi, posto che qualcosa fosse iniziato al di fuori delle mie deliranti fantasie, tutto era davvero finito. Giunti al bar Elisabetta non ebbe neppure il tempo di presentarmi la sua amica, che fra l’altro conoscevo già da un pezzo. Appena entrati, dopo aver pronunciato pochissime e, per quanto mi ricordi, del tutto insignificanti frasi di circostanza (l’unica cosa degna di nota che mi disse è che aveva passato le vacanze di Natale con suo padre, e che dunque le aveva passate bene: “dunque” che significava “dunque”?) dunque si disperse nella folla dei suoi amici e conoscenti del corso (non mi ero accorto, fino a quel momento, che ne avesse così tanti) e non mi considerò più per tutto il resto della serata. Da quel momento in poi fui così libero di sprofondare senza più remora o dubbio alcuno nella disperazione erotica, abisso gemello e contrario a quello del sogno erotico, dove l’instancabile spossatezza assume le sembianze del vuoto irreparabile, del dolore inconsolabile, della malinconia desolata, dello spasimo abbattuto, della depressione atterrata, dello smarrimento introvabile – insomma, del più acerrimo, lacrimevole e mesto lutto che l’essere umano possa conoscere, quella morte in vita che si chiama Amore Deluso (Bataille sosteneva che non ci si innamora per essere felici ma per contemplare l’infinito dal punto di vista del finito, la morte dal punto di vista della vita, così che amare significa non altro che sporgersi sull’abisso della scomparsa del proprio sé che, nel momento in cui si è innamorati, si fonde con quello dell’amata: non la felicità dunque è lo scopo di chi ama, ma 74 l’angoscia, il terrore della perdita, la solitudine: beh, almeno da questo punto di vista, potevo dire che ero stato accontentato). Erano passate solo poche settimane dall’inopinato sorgere della mia luminosa passione, e tutto quel che ne restava era quella risaputa saggezza che mestamente ripete che il tempo lenisce le ferite, anche se non con la stessa rapidità con cui riesce a farlo con le gioie, e che, chissà, nei mesi o negli anni, o almeno nei secoli dei secoli a venire avrei forse potuto in qualche modo trasformare la delusa e dolorosa passione in una qualche forma, che so, di “tenera amicizia”? Forse avrei avuto l’occasione – a furia di incontri o scontri accidentali, party di Natale o di fine corso, cambi di coppia più o meno forzati – di parlarle ancora, di conoscere più a fondo i suoi interessi, le sue inclinazioni, le sue esperienze, le sue speranze, i suoi gusti letterari, musicali, cinematografici, la sua storia o non-storia che dir si voglia, il modo in cui si svolgeva la sua vita quotidiana, chi fosse quel maledetto fidanzato torinese (esisteva, ne ero certo, anche se non torinese di qualche altra dannatissima parte!) e che cosa avesse di tanto meglio di me (lo sapevo già che cosa aveva di meglio: era il suo fidanzato da un tot e sul rapporto aleggiava la almeno dal punto di vista femminile raggiante promessa e sicurezza di un futuro matrimonio). In questa sia pur goffa e sfortunata maniera speravo ancora di poter soddisfare – ahimè, anche se non più in senso biblico – quel desiderio di conoscere a cui in fondo può anche ricondursi o almeno sublimarsi il desiderio erotico propriamente detto. 31. Le cose sono andate male, questo mi ripetevo continuamente, continuamente sbagliandomi. Perché, naturalmente, mi sbagliavo: le cose non erano andate male, come previsto, erano andate assai peggio, come mi accingevo a scoprire di lì a poco. Il mercoledì successivo, dopo che, per evitare il prevedibile e reciproco imbarazzo, l’avevo accuratamente sfuggita, mi andai a sedere mestamente in un angolo nascosto della sala, riflettendo che per almeno un mesetto avrei fatto bene a lasciarla completamente in 75 pace, per fargli capire che non le chiedevo niente e che rispettavo la sua decisione di allontanarsi da me per tutto il tempo che voleva. Fu proprio quando mi stavo malinconicamente e dolorosamente ripetendo per forse la miliardesima volta in una settimana (di tanto e di più ci vuole per convincere un desiderio atroce della sua certa, anzi, certissima delusione) che la ragazza doveva aver qualcuno – anzi, molto peggio che “qualcuno” – che doveva avere un fidanzato! – e dunque con le mie attenzioni non avrei fatto altro che allontanarla ulteriormente, oltre che infastidirla inutilmente, minacciando la sua tranquillità relazionale – fu proprio allora che me la trovai imprevedibilmente davanti, mentre tremando come una foglia al vento gelido d’autunno mi chiedeva “come stai?”, domanda che trovai invero assai pleonastica (come deve stare un innamorato deluso? bene, molto bene, è ovvio, se solo non mi si fosse inceppata la pistola mentre mi stavo sparando starei ancor meglio, maledetta…) domanda a cui risposi come un automa “bene” (?!?!) senza neppur sapere che cosa e a chi lo stessi effettivamente dicendo. Perché mi cercava? Perché tremava? Ora addirittura mi chiedeva di andare a fumare insieme una sigaretta! Era impazzita? Ci aveva ripensato e aveva deciso di lasciare il fidanzato torinese, magari per entrare in un convento di clausura? L’unico modo di risolvere tali decisivi enigmi era seguirla, fumare la sigaretta e far finta di nulla sentendo quel che avesse da dirmi, dato che, se mi invitava ad appartarsi con lei, sia pure con la miserabile scusa della sigaretta, qualcosa da dirmi ci doveva essere per forza. Ma, come scoprii ben presto, con l’aggiunta di una certa cocente delusione, Elisabetta non aveva nulla di particolare in serbo per me, e, se è per questo, neppure in croato. Appena giunti fuori della sala si mise a sedere su un gradino e continuando a tremare – a questo punto forse solo per il freddo – chiusa e rannicchiata come un passerotto nel suo piumino la mia adorata mi diceva e mi chiedeva cose del tutto banali e insignificanti. Non mi parlava di un eventuale ragazzo, né dei motivi per cui all’ultimo messaggino non mi aveva risposto, che erano le cose che più di tutte mi preoccupavano in quel momento. Per parte mia invece, mi sentivo in imbarazzo a introdurre la scottante questione, scottante credo, come un bel paio di tenaglie arroventate 76 appese dove non si può dire: che cosa facevo, interrompevo così, di punto in bianco, una splendida conversazione del tutto insignificante per chiederle come stava il suo fidanzato o cose simili? Certo, a ripensarci adesso, la cosa non sembra poi così illogica o incivile, e, a ben vedere, a trattenermi non fu tanto il timore di apparire brusco o maleducato, quanto quello di ricevere qualche poco lieta novella, dato che l’imprevisto presentarsi di Elisabetta al mio incredulo cospetto aveva riacceso le mie ancora non del tutto sopite speranze. Perderla andava pur bene, ma, voglio dire, con calma, in qualche mese ancora, in qualche settimana, o in qualche giorno, al limite, in qualche ora, ma non così, non mentre il suo inatteso “come stai?” aveva di colpo rimesso in moto il mio deliquio! 32. Così, rientrando in sala gli chiesi se voleva ballare, e lei mi rispose con palpabile nervosismo, si, certo, balliamo, balliamo, ma, ahimè, le sorprese della serata non erano finite e dopo una sia pur parzialmente gradita ecco che subito ne seguiva un’altra che dette a me altrettanta gioia che il ritorno del figliol prodigo al vitello grasso. La ballerina lieve e appassionata che avevo conosciuto quattro mesi prima sembrava scomparsa. Quella che stringevo fra le braccia era una creatura rigida, fredda, con la quale era impossibile comporre delle coreografie decenti: dunque non ci aveva ripensato sul serio, dunque c’era davvero un ostacolo fra di noi, anche se a quel punto non ero più sicuro di quale fosse, dato che, per quanto ne sapevo fino a quel momento, molto difficilmente una ragazza impegnata torna a cercare un uomo che oramai non dubita più essere di lei perdutamente infatuato. Restavano però la sua paura, i suoi tremiti, era lì che continuamente si bloccava e si irrigidiva: non mi voleva più, se mai mi aveva voluto, questo era chiaro. Ma allora perché era tornata a cercarmi? Per di più, per un qualche diabolico complotto del fato, che a quanto pare si preoccupa di far piovere sul bagnato, di irrigare sul fradicio, di allagare sull’inzuppato, di diluviare sull’alluvionato, e vai 77 così, di traboccare sull’inondato, tracimare sul naufragato, di esondare sul sommerso, straripare sull’annegato, eccetera, quella sera il buon vecchio Ignacio Elizari mise tutti i “nostri” pezzi, ovvero tutti quei tanghi sui quali il mio amore per Elisabetta come un ingenuo infante era nato e mi aveva regalato i primi sorrisi e i primi pianti (stavo per scrivere: i primi vagiti e i primi pianti, il che è tutto dire…): Ignacio fece girare sullo stereo e, di conseguenza, anche sulle mie parti basse, tutti i pezzi migliori della celebre orchestra di Oscar Pugliese, “Color tango”, fra cui il mio preferito fra i preferiti, “Gallo ciego”, nonché il primo tango che ballai con Elisabetta, “Vida mia”, di cui ora come ora non mi ricordo l’autore, ma di cui con dolorosa nostalgia mi ricordo le parole, perché da allora mille e mille altre volte le ho ascoltate, sognate, fischiettate e cantate: “vida mia, lejo mas te quiero, vida mia piensa in mi regreso, sé que el oro no tendrà tu besos, y es por eso que te quiero mas, vida mia, hasta apuro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad, sos my vida y quisiera llevarte a my lado prendida y asì aogar my soledad”27. Elisabetta, mia adorata, mia diletta, my vida, vida mia, con tutto il mio distrutto amore, con tutto il mio delirante ardore tentavo di portarti in alto a tentare le volte ineffabili del cielo – o almeno quelle del soffitto del circolo – appesa alle ali di quelle note lievi ed ispirate, ma non ci fu verso. Quella sera la mia adorata era bloccata, rigida, il suo tocco dolcissimo era puramente e semplicemente scomparso. Scomparsa sembrava quella magia che mi permetteva con lei di osare dei passi degni di un vero professionista, quali la sacada di tacco sul giro a sinistra con successiva rastrada dopo l’ocho all’indietro, e altri simili archetipici e funambolici acrobatismi del tango. Di tutto e di più tentai, e anche il tutto per tutto, ma tutto fu inutile: quel corpo solo poche settimane prima sensibile alle mie marcas come una piuma al vento si era trasformato in una sorta di blocco di granito. Avrei voluto piangere, se la situazione me lo 27 Vita mia, più sei lontana più ti voglio, vita mia, aspetta il mio ritorno, so che l’oro non avrà i tuoi baci, ed è per questo che ti amo ancora di più, vita mia, accelera il respiro quando si avvicina il momento di accarezzare la mia felicità, SOS vita mia, vorrei portarti via tenendoti al mio fianco, e così annegare la mia solitudine. 78 avesse consentito, ma anche questo sarebbe stato inutile e pleonastico. La miglior cosa, lo sapevo, era dimenticarla, ma sapevo anche che non ce l’avrei fatta, almeno finché non fossi riuscito a conoscerla un po’ più a fondo. Se di mercoledì in mercoledì avessi continuato a parlarci, a fumarci qualche sigaretta, a ballarci, sia pure nello stile lieve e sensuale tipico di una coppia di bradipi ricavata da una fusione in blocco unico di bronzo – che era quello che aveva caratterizzato i tanghi di quella disgraziata sera del suo ritorno – alla fine forse sarei riuscito a tirare fuori qualcosa che mi spiegasse i motivi del suo improvviso allontanamento: se non era un fidanzato torinese, qualche problema di qualche altro genere – che so, vasi sanguigni intasati dai gerani, ciclo passato da mestruale a bisettimanale, raffreddore da fieno cresciuto fino alle dimensioni di un pagliaio – non so, qualcosa, qualsiasi cosa mi spiegasse il perché di tutta quella terribile sofferenza che stavo passando! Si, perché anche quella sera, come per tutte le vacanze di Natale, per tutte le lezioni a cui e in cui era e mi era mancata, e quando era tornata, e dopo, in ogni ora, in ogni minuto, avevo patito e stavo patendo quella puntuale, precisa, cavillosa agonia che infligge l’Amore agli amanti in attesa di... (attesa di che? nessuno al mondo, e men che meno un innamorato, può dirlo di preciso, anche se tutti instancabilmente e indiscutibilmente continuano ad attenderlo). Non potevo averla, mi ripetevo, cercando disperatamente di convincermi – e non c’è al mondo orecchio più sordo di quello di un innamorato deluso da un’interprete per sordomuti – ma almeno il fato mi avrebbe concesso di sapere esattamente il perché? 33. Beh, come detto e sottolineato fin da principio, questa che sto raccontando non è una storia, ma bensì una non-storia, e quindi il lettore non si adonti se mi permetto di anticipare che la risposta a quelle sospirate domande non l’ho mai avuta (suppongo che questa è una cosa che si è capita già da diverse pagine: comunque sia, una non-storia che si rispetti si svolge ovviamente attraverso una non79 trama in cui il finale può situarsi all’inizio e viceversa, tanto il punto del racconto non è e non può essere quello di vedere come va a finire (una non-storia, in effetti, non può avere neppure un vero finale, anche se non per questo può essere infinita)). Ma, a dispetto di tutto, in quel momento qualche sia pur flebile speranza la nutrivo, pur se, appunto, a forza di flebo, o, più probabilmente, con quel genere infernale di macchine che servono a tenere in vita artificialmente la gente in coma, compresi quelli che non sono affatto di Como (c’è solo una cosa al mondo più banale che essere in coma a Como, che è essere una nuora a Nuoro). Attendevo così angosciato e fremente il sospirato e temuto mercoledì successivo, sperando disperatamente di poter parlare ancora con Elisabetta e, naturalmente, fantasticando su possibili modi e strategie per poter entrare nella sua vita intima senza ferirla e, soprattutto, senza ferirmi troppo (dovevo, in altre parole, trovare il modo di farmi dire che era fidanzata senza che la ferale notizia provocasse sul mio viso un eccesso di pallore o, peggio che peggio, un qualche principio di svenimento). Ma il tempo dell’attesa, come tutti sappiamo, è un tempo lento, lentissimo, quasi agonico e dunque, tanto per distrarsi un po’ e alleviare l’insopportabile tensione, mi permetto di aprire una parentesi, per sottolineare come già a quel punto avevo avuto modo di rendermi conto che il fatto di essere innamorato, a parte i predetti sintomi di quasi-follia e quasi-malattia che minacciano la salute psichica e quella fisica più o meno come una settimana ininterrotta di toga party alla coca e bunga-bunga ad Arcore, può, in aggiunta a ciò, avere anche tutta una serie di effetti collaterali minori più o meno surreali e stravaganti su colui che da cotale stato di più o meno momentanea debolezza mentale venga più o meno incolpevolmente invaso. A parte tutto il resto (pericolosa propensione all’abuso di alcolici e tabagismo sfrenato, insonnia e uso e abuso a ciò connesso di sonniferi e calmanti, tremori alle mani, irritabilità, lapsus e distrazioni di ogni sorta, diminuzione dell’efficienza in qualsiasi attività quotidiana che non sia il pensare e ripensare all’amata fino al sopraggiungere d’un qualche provvidenziale mal di testa, etc.) per uno che si trovi nell’incertissima aurora della sua magari nemmeno troppo promettente carriera di milonguero il rischio grave o 80 addirittura gravissimo è che venga alterata e alienata la percezione stessa della musica, ovvero del tango. Già, perché devo registrare che ancora adesso che dalle vicende sunnominate è passato all’incirca un anno (lo so che il gentile lettore è ansiosissimo di sapere come è andata a finire: d’altra parte lo sono anch’io (ansioso di vedere come è andata a finire intendo), e non per questo c’è qualcuno in grado di dirmelo e men che meno di spiegarmelo…), mi rendo conto di conservare a tutt’oggi, a dispetto del tempo passato e passante, la piuttosto maniacale tendenza a rimanere più o meno indifferente, o comunque piuttosto freddino ascoltando più o meno qualsiasi tango che non sia la già citata “Vida mia”, nella versione di Roberto Ray, e un paio di pezzi di Osvaldo Pugliese, ovvero i sunnominati “Gallo ciego” e “Zum”, che invece mi mandano a tutt’oggi in brodo di giuggiole nel giro di due secondi o anche meno (non so cosa siano le giuggiole e men che meno come si faccia a ricavarne un brodo, anche se devo riconoscere che Elisabetta è stata bravissima a ricavarne da me un’intera cisterna). Il motivo, ovviamente, è che questi sono quei tanghi che più ho sentito o che comunque sia più mi hanno colpito mentre ballavo e ballando mi innamoravo della sconosciuta milonguera. A tutt’oggi, nel mentre odo le note di cotali afrodisiaci capolavori vengo preso da attacchi tellurici di un esaltato non meno che languido misticismo erotico, attacchi che mi spingono a invitare per la tanda in questione la prima o, se è per questo, anche la seconda o terza o quarta o quinta o anche sesta milonguera che trovo (la sesta è la migliore di tutte, soprattutto se per “sesta” si intende la misura del reggiseno) e di stringerla fremente e furente come Giulietta strinse e sospinse nel suo vigineo petto quel freddo pugnale che l’avrebbe ricongiunta al suo Romeo. Un simile atteggiamento mi pare invero piuttosto limitato e limitante, un po’ perché non si può passar la vita ad ascoltare solamente tre tanghi, e poi anche per un’esigenza di completezza storico-culturale, stante il fatto che il tango ha avuto almeno tre epoche fondamentali, con numerosi e geniali compositori ed esecutori, e relative tradizioni e innovazioni, evoluzioni e involuzioni, restaurazioni e rivoluzioni, etc. Atmosfere di ogni tipo, passioni di ogni sorta sono state in mille sfumature espresse e interpretate (anche se nei testi l’amore deluso o 81 disperato che sia ha una piuttosto preoccupante tendenza a prevalere su qualsiasi altro tema e problema): perché non ascoltavo e, soprattutto, a tutt’oggi non ascolto altro che quei tre pezzi sunnominati, o altri che me li ricordino fin troppo da vicino, e di tutto il resto faccio strame, accomunando gli autori e le poetiche musicali più diverse in un’informe marmellata ovvero in una notte dove tutte le vacche sono nere (a giudicare dallo stato mentale in cui mi trovavo e in cui ancora almeno in parte mi trovo il problema non è tanto quello della notte in cui tutte le vacche sono nere, ma quella in cui sono tutte troie: diceva bene il buon vecchio Cicerone, “oh tempora, oh mores!”, anche se io, a dir la verità, ho sempre avuto una discreta preferenza per i “lampones”)? 34. Da tempo ormai cerco e mi sforzo di correggere le fissazioni che mi sono preso nei brevissimi ma troppo lunghi mesi passati a vagheggiare, aleggiare e tangheggiare con Elisabetta. Acquisto cd didattici, contenenti selezioni di pezzi storicamente ordinate e orientate, e, a furia di insistere, scopro che l’originale di “Vida mia” è stato scritto e interpretato per la prima volta da certo Osvaldo Fresedo, un autore a quanto pare storicamente ed esteticamente più importante del suo interprete, fatto di cui, stante il funesto permanere delle mie ombrose, amorose ossessioni, continuo a fregarmene bellamente e ad ascoltare e a riascoltare, in spregio a qualsiasi intendimento storico-didattico, sempre e comunque quella stessa versione che a Elisabetta come un drago di incendiate farfalle lievemente aleggiando e volteggiando e – soprattutto – ahimè – atrocemente fiammeggiando e tangheggiando mi riporta. Nei manuali del tango che mi sono premurato di consultare si spiega doverosamente che Osvaldo Pugliese, il mio artista preferito, ha scritto nei circa settanta anni in cui ha accompagnato l’evolversi del tango, un bel po’ di pezzi a quanto pare ben più diffusi, famosi e celebrati che quei due con cui consumo da un annetto i miei non mai esausti timpani (sul manuale trovo citati, per esempio, “Recuerdo”, 82 con testi di E. Moreno, poi “Negracha”, “Malandraca”, etc., tutta roba a quanto pare molto più fondamentale e famosa che “Gallo ciego” e “Zum”, anche se, a mia parziale discolpa, posso dire che alle milonghe fiorentine questi due pezzi li mettono quasi sempre). Così chino la testa e cerco di fare il mio dovere di aspirante milonguero, di ascoltare tutto, e tanto mi piace quest’autore che una volta ho retto addirittura un’ora intera ad ascoltare pezzi di ogni sorta – ivi compresi i da me non molto amati tangovals e milonghe – anche se devo riconoscere che di solito, nei casi normali, dopo aver finto un ascolto attento e concentrato per non più di cinque minuti, ritorno a quei soliti due che amaramente e dolcemente, stancamente e inesorabilmente mi ripetono nella misteriosa lingua del bandoleon e del contrabbasso, del violino e del pianoforte il nome più dolce fra tutti i nomi: “Elisabetta”, naturalmente, o “Ella d’Essa” che dir si voglia. 35. Pure non voglio arrendermi, non devo arrendermi, non posso arrendermi e dunque non mi arrendo e non mi arrenderò mai! Quasi come una cura, cerco di appassionarmi alla storia del tango, come per spiegare a me stesso che gli orizzonti di un uomo possono essere ben più ampi che gli occhi di una dolce fanciulla, per quanto grandi o, almeno in questo caso, per quanto enormi ce li abbia. Insisto così a consumare le pagine del manuale, mi getto nel capitolo che racconta della crisi degli anni cinquanta e sessanta, ove l’autorevole, prestigioso non meno che costoso manuale racconta dell’arrivo del rock con il giovanilismo, il progressismo e il modernismo connessi, che tendono a mettere in un angolo il tango diventato di colpo un genere “vecchio e superato” (il manuale sarà pure autorevole e prestigioso, ma le ragioni che offre di una tale crisi del tango mi paiono in patente contraddizione con le parallele crisi economiche che sconvolsero l’Argentina con dittatori militari annessi e dittature connesse, che non pare lasciassero poi molto spazio a giovanilismo, progressismo, modernismo e cose del genere (questi dittatori erano 83 dei tipi strani che, a quanto pare, per motivi non molto comprensibili, se la prendevano col tango e lo accusavano di più o meno latente “comunismo” (!?): non è chiaro cosa c’entri il comunismo con il tango, chissà, forse i tangueri del tempo e del luogo volevano togliere una televisione ai dittatori in questione, o magari si scandalizzavano se andavano con le escort minorenni, o se mescolavano la cocaina comprata con tangenti sugli appalti pubblici con le loro pompinare private, boh…). Ma, comunque sia, l’epoca della crisi non è poi molto interessante, dato che, a ben vedere, non produce nulla di particolarmente buono, se non qualche pezzo sparso e disperso di Astor Piazzolla e poco più. Così, per eccitarmi un po’ nella lettura, debbo andare al capitolo precedente (sappia il lettore che è mia costante abitudine di leggere i libri andando all’indietro, dato che non sopporto la tensione di andare a vedere come vanno a finire: meglio sopporto la tensione di vedere come vanno a iniziare) ovvero al capitolo che parla degli anni che si trovano fra il ’30 e il ’40, ovvero niente popò di meno (anzi: tanta popò di più!) che dell’Epoca o Età dell’Oro del Tango che dir si voglia, con le orchestre che si ingrandiscono, diventano “professionali”, nel senso che i musicisti sono oramai dei professionisti che conoscono la musica in senso tecnico, e, stante anche le dimensioni dell’orchestra, con quattro o cinque bandoleon, quattro o cinque violini, etc., nessuno si può più permettere di suonare a orecchio, o di improvvisare (e questa sarebbe l’Epoca d’Oro, il trasformarsi di un cuore che batte in una penna che scrive? mah…): il tango si diffonde via radio, diventa un travolgente fenomeno di massa, sorgono grandi, ma che dico, immensi personaggi che, essendo quell’inqualificabile cialtrone che sono, mi rassegno a citare a caso, ovvero nel modo piuttosto distratto e confusionario in cui li ho letti e ascoltati: Carlos di Sarli, Lucio Demare, Azucena Maisani, Hector Pacheco, Cézar Strocho, Homero Manzi, Anibal Troilo, Hector Maria Artoila. Di quel periodo felice il citato Cézar Strocho – bandoleonista di genio – ricorda pieno di nostalgia che furono attive in Buenos Aires più di trecento orchestre, che vi furono indimenticabili collaborazioni fra poeti, musicisti e cantanti, indimenticabili esecuzioni di indimenticabili pezzi, 84 indimenticabili serate, indimenticabili amori scoppiati in modo simile a quello in cui scoppiò il mio per Elisabetta (a quanto pare non sono stato il primo e probabilmente non sarò l’ultimo ornitorinco che ha perso la testa al primo tango per la prima ornitorinca che passava (per il significato della parola “ornitorinco” si rimanda a una successiva nota in parentesi)). Comunque sia, si, va beh, ti ringrazio Cézar Strocho, racconta pure quel che ti pare, ma tanto è inutile, è tutto inutile: leggo e rileggo il libro al capitolo in oggetto, ascolto e riascolto orchestre dell’Epoca d’Oro del tango, ripasso i nomi di poeti e cantanti ma non c’è niente da fare: per quanto mi sforzi di indirizzarmi altrove nella mente torna sistematicamente il cantato di “Vida mia”, le lacrime mi salgono agli occhi, scendono per le gote, inzuppando infine il manuale che costa quasi cinquanta euro e che quindi meriterebbe di essere utilizzato in modo diverso che come sostituto di un fazzolettino. Tossisco, cerco di darmi un contegno, ma non ci riesco, è più forte di me. Scusate: ma a me che me ne frega della storia del tango, delle interpretazioni coreografiche durante la ronda, se esista o meno il “Tango nuevo”, visto che in ogni caso io sono un tipo all’antica, e dunque, anche se esistesse, non me ne potrebbe fregar di più che del fatto che la NASA ha scoperto forme di vita intelligente al Tg 4 (pare che siano degli esseri monocellulari che si annidano nel microfono di Emilio Fede e che ogni tanto lo fanno guastare (è da questo precisamente che i tecnici della NASA hanno dedotto che sono “intelligenti”: o, almeno, più intelligenti di quelli che lo stanno ad ascoltare (con questo non voglio svalutare la professionalità e la buona fede del buon vecchio Emilio, al contrario: essendo io stesso, come vedremo meglio in seguito, uno studioso di filosofia, per quanto scassato, scalcinato e dirupato, ben mi ricordo che della sua futura e fulgida opera di direttore di una testata giornalistica – ancora più dura della testa di Bossi – parlava già più o meno nel 400 a.C. nulla di meno che un arcigno e arcinoto arcirivale di Platone, il celeberrimo Gorgia, quando diceva che “Nulla è. Se qualcosa fosse, non sarebbe conoscibile. Se fosse conoscibile non sarebbe comunicabile. Se fosse comunicabile, sarebbe comunicata al Tg 4.”))). 85 36. Forse per districarmi da quei tre pezzi che proprio come Elisabetta hanno preso a ossessionarmi fino alle ossa, anche se, almeno spero, non fino alla fossa, ho bisogno di qualcosa di più forte, di più profondo, di più originario. Ma certo! Certo! Il tango, appunto, originale, quello dei suburbios, dei bordelli, dei peringundines, dei gauchos e dei compadritos, questo è quello che mi ci vuole, quello che il grande Borges celebra con parole alate: “Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo…”28: un ballo che, come Borges scrive in “Evaristo Carriego”29, era praticato dai machos, ovvero da uomini duri, ancor più duri della suddetta testa di Bossi che, come è noto, è il vero zoccolo duro della Lega; uomini senza legge, che ballavano fra di loro al tintinnare del coltello perché le donne non erano disposte ad arrischiarsi in questa nuova danza, maleducata, spavalda, dissoluta e maledetta. Si, forse è proprio questo il tango di cui ho bisogno per risollevarmi dalla Grande Depressione in cui il ricordo d’Elisabetta mi sprofonda! Faccio dunque ancora un salto indietro nel mio manuale e mi dirigo intrepidamente verso il suo inizio, e intanto che leggo mi faccio una lista dei dischi da comprare, ma solo per scoprire poco dopo che non è che questi tanghi delle origini si trovino poi così facilmente. Gira e rigira ne ho trovato solo delle versioni recenti, interpretazioni di musicisti che poco o nulla hanno a che fare con gli ultimi anni dell’800 e i primi del ‘900. Dovrei farmi coraggio e provare a scaricare qualcosa da Internet dove, a quanto pare, si riesce a trovare di tutto, compresi i cori che dall’eternità i cherubini cantano all’Eterno nonché gli sbadigli dell’Eterno Stesso, che dei cori dei cherubini non ne può proprio più e, senza farsi vedere, si è messo le cuffiette per ascoltare “Hell’s Bells”, noto capolavoro degli ancor più noti “AC/DC” (a proposito, ma che vuol dire la sigla “AC/DC” 28 Tango che ho visto ballare contro un tramonto giallo da coloro che eran capaci di un altro ballo, quello del coltello. 29 Cfr. in particolare il cap. XI, “Storia del tango”) 86 Avanti Cristo/Dopo Cristo o che?). È solo che io intrattengo con le diavolerie della modernità più o meno lo stesso rapporto che i condannati alla ghigliottina con il mal di testa: comincio a cercare le versioni antiquate di pezzi come “El choclo”, “Señor comisario”, “No le hagas caso”, “Queco”, “El Entreterriano”, ma, ahimè, l’unica cosa che riesco a ottenere sono dei virus di nuova generazione che, come mi ha spiegato il gentile tecnico dell’assistenza on site, sono in grado bloccare il computer fino al giorno del Giudizio Universale, o in alternativa, fino alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, nel caso il Giudizio Universale dovesse arrivare troppo presto (anche se, mi si assicura, arriverà senz’altro prima di quello di Berlusconi). Per di più, la lista dei nomi della Vecchia Guardia del tango, quella che per convenzione si fa partire dal 1880 e terminare con il 1920, comincia bene ma finisce male, molto male. Citando di nuovo cialtronescamente a caso incontro nomi come quello del violinista Casimiro Alcorta, del pianista Rosendo Mendizabal, un altro violinista, Ernesto Ponzio, Sebastian Ramos Mejia, che il mito decanta come colui che per primo introdusse il bandoleon nelle orchestre dei payadores – musicisti di strada che all’inizio avevano solo chitarre e che la tradizione – ma non Borges! – vuole all’origine del tango, e avanti così: Tano Genaro, Juan Maglio Pacho, Juan Carlos Cobian, Francisco Canaro, fino – ahimè – al maledettissimo e stramaledettissimo Osvaldo Fresedo, musicista che si situa a cavallo fra la Vecchia Guardia e l’Epoca d’Oro, compositore della versione originale di “Vida mia”, titolo fatale che, com’è del tutto ovvio, mi fa pensare di nuovo a Elisabetta e sollevare lo sguardo dal ponderoso e autorevole Manuale di Storia del Tango Argentino prima che cominci a inzupparsi eccessivamente di lacrime anche nei primi capitoli (ormai mi manca di infradiciare anche la prefazione, poi il mio compito a casa di studente del secondo anno può considerarsi soddisfacentemente concluso). 87 37. Ma, provvidenzialmente, mi rendo conto di dover saltare a piè pari l’Introduzione (almeno qualche pagina rimarrà asciutta, che diamine!), dato che, a furia di strafalcionare e cialtroneggiare con la storia del tango, il mercoledì successivo al riaffacciarsi di Elisabetta sulla da lei sconvolta mia esistenza è finalmente arrivato. Giorno fatale, temuto quasi quanto agognato, carico di un’interminabile settimana di impotente quanto impaziente ed angosciosa attesa, che il mio studio storico e teorico non riusciva e non riesce – ahimè – in nessun modo ad alleviare: era chiaro che non potevo più invitarla alle pratiche, era chiaro che non potevo telefonarle o fare nulla di più che aspettare, aspettare, aspettare! E quando finalmente la rividi (anche questa volta era arrivata sul tardi, chissà perché) mi recai a salutarla, aspettandomi di tutto ma sperando ovviamente di aver di nuovo l’occasione di parlarle ancora un po’. Ed effettivamente la ragazza si mostrò disponibile, anche se sembrava ancora piuttosto timorosa. Di nuovo, nell’intervallo fra la prima e la seconda lezione, ci appartammo a fumare e parlammo un po’, ma di nuovo il colloquio, di nuovo contro ogni mia aspettativa, non aggiunse nulla di nuovo a quel nulla di vecchio che già non sapevo. Io speravo e disperavo che la ferale notizia del fidanzato torinese mi giungesse spontaneamente da lei: mi sembrava un mio diritto! Non si può chiedere a un innamorato di formulare la richiesta nero su bianco dei motivi della sua prossima delusione, e, se è per questo, nemmeno grigio scuro su grigio chiaro (il grigio medio su grigio medio era, in effetti, il modo in cui Elisabetta si stava esprimendo, e infatti, grazie a Dio, in quel momento non ci stavo capendo un tubo): non si può chiedere a nessuno una cosa del genere, come nemmeno a un assassino si può chiedere di pronunciare la propria condanna a morte! Ma la temuta, l’attesa, la forse agognata notizia, che tutto era da sempre ormai perduto, non arrivò. La sigaretta finì senza nessuna novità significativa di nessun genere anche se dopo, ballando, Elisabetta mi sembrò molto meno rigida della volta precedente, pur se non era tornata la ballerina fatata che avevo conosciuto quattro mesi prima. 88 Di nuovo in preda a una speranza non più così folle e disperata, quel fine settimana pensai di tentare il tutto per tutto, ovvero, in quel caso, più che altro, il lutto per lutto, e provai di nuovo a invitarla alla pratica, questa volta a quella del sabato sera, si, la leopardiana sera del dì di festa, giorno simbolico in cui il vero innamorato o vero str..zo che dir si voglia sempre invita la sua bella per farle capire quanto è importante per lui (in questo senso un invito di lunedì mattina risulta, più che inefficace, credo, piuttosto offensivo). In risposta al mio sms “o la va o la spacca” ne arrivò uno che, pur lasciandomi piuttosto felicemente stupefatto anche solo per la sua nuda e cruda esistenza (in effetti mi aspettavo che Elisabetta rispondesse al mio avventato o quasi sconsiderato invito con un molto significativamente gelido silenzio), conteneva però una risposta che mi parve tanto cripticamente ambigua quanto oscuramente sibillina: scusami ma stasera non posso (“stasera” no: ma allora un’altra sera si? (addirittura si scusava!)), perché lunedì ho un esame, forse possiamo andare domani, ma mi sa che rimando tutto (“tutto” cosa?). Già il fatto piuttosto incredibile che la ragazza mi avesse puramente e semplicemente risposto a torto o a ragione mi confermò di nuovo nelle mia oramai di nuovo febbrile e ansiosa speranza: se non altro aveva preso in considerazione la mia proposta, e, chissà, forse l’esame che doveva dare non era una men che banale e pretestuosa scusa, forse davvero se non avesse avuto l’esame sarebbe venuta con me alla pratica (è incredibile quanto l’Amore possa rincoglionire la gente: secondo me il suo potere tanto evocativo quanto rincitrullente è talmente poderoso e inarrestabile che avrebbe convinto Einstein che “E” non è uguale a “mc²”, ma bensì, semplicemente a “Elisabetta”, oppure, come io avevo genialmente intuito, a “Ella d’Essa” )! Così il giorno dopo le inviai un sms di auguri per l’esame, che di nuovo ricevette una risposta che – addirittura – mi parve calda e piena di gratitudine (!!!), anche se ora come ora non mi ricordo più esattamente come suonasse (forse, come la mia testa suonata). A quel punto presi a pensare che in effetti il mio corteggiamento potesse ancora raggiungere un risultato un po’ meno deludente che l’amara scoperta delle ragioni per cui Elisabetta di me non ne voleva sapere 89 nulla o quasi (e il nulla è molto meglio del quasi in certi casi, se il lettore ci scusa l’involontaria rima ma non troppo!). 38. Il mercoledì, ancora una volta tanto temuto quanto agognato, giunse di nuovo (penso che dopo una storia di questo genere il mercoledì si meriti di prendere il posto del giovedì nel celeberrimo proverbio), e ancora ballammo e parlammo, parlammo e ballammo, ma mi resi conto di non aver fatto alcun genere di progresso. La ragazza era gentile, dolce, ma manteneva inequivocabilmente le distanze. Mi ringraziò ancora degli auguri per il suo esame (le avevo spedito una frase tratta dai “Quaderni in ottavo” di Kafka, tanto cripticamente paradossale quanto chiaramente allusiva: “Nella tua lotta contro il mondo vedi di stare dalla parte del mondo”, ove la parola “mondo” faceva ovviamente le mie veci, dato che con quella frase gli volevo dire: nella tua lotta contro di me, vedi di stare dalla mia parte! ma era ovvio che la ragazza non voleva starci manco a pagarla, come vedremo poi) così che alla fine della lezione, al momento del congedo, invece che quell’invito a invitarla che io in maniera piuttosto insensata pur tuttavia ancora speravo, mi arrivò, sia pure accompagnato da un sorriso dolce e affettuoso, un piuttosto deludente “ci vediamo mercoledì”, frase che io interpretai in quel melanconico modo che mi pareva in effetti, se non l’unico possibile, senz’altro il più ragionevole: “Guarda che è inutile che mi inviti alla pratica di sabato prossimo, o, se è per questo, neppure in nessun altro posto, perché tanto non vengo. Tutto quello che ho da offrirti, se li vuoi, sono questi tanghi e queste amichevoli sigarette del mercoledì, con le quattro chiacchiere annesse e non necessariamente connesse. Quattro chiacchiere, naturalmente, del tutto eroticamente insignificanti che ti prometteranno, come del resto quelle che abbiamo appena fatto, solo altre quattro chiacchiere, e così via, nei secoli dei secoli. Se sarai tu fortunato e io generosa, forse un giorno mi consentirò di permetterti di offrirmi qualcosa, penso un caffè, dato che un alcolico contiene in sé allusioni all’estasi e all’ebbrezza 90 che, nel nostro caso, sarebbero del tutto mendaci e fuori luogo, etc., etc. Dunque, raffredda i bollenti spiriti nel modo che ti pare e, di nuovo, a mercoledì”. Certo di una tale, fatale interpretazione del messaggio subliminale, profondamente addolorato ma finalmente calmo, mi rassegnai al mio tragicomico destino di tenero amico, e questa volta la settimana passò in uno stato d’animo che doveva essere un misto fra quello di un Cyrano de Bergerac che finalmente riesce a vedere al di là del proprio naso e un Gobbo di Notre Dame che scopre infine che quello che vede al mattino nello specchio è lui stesso, e non un dromedario che tenta di pettinarsi la coda stando sdraiato sul lavandino. Serio e compunto, tutto preso dalla mia maestosa, decorosa non meno che romantica tristezza, tanto alta e solenne che quasi non aveva più bisogno di sigarette e alcolici per poter essere dignitosamente sopportata, mi recai alla lezione successiva convinto di fare le solite chiacchiere più o meno insignificanti, in cui difficilmente avrei capito qualcosa di più della situazione affettiva della mia amata (ma oramai la situazione era – ahimè – fin troppo chiara), e di ballare con lei qualche tango un po’ triste e ingessato e fine lì. Ma no, che le cose andassero in questo modo, così tristemente semplice e banalmente lineare, proprio non era possibile. 39. Era passata solo una settimana da quel dolce e amichevole “ci vediamo mercoledì” (“solo una settimana”, dal punto di vista di me che l’aspettavo, voleva dire più o meno, “solo un paio di ere geologiche”: ma dal suo punto di vista si trattava pur sempre di “solo una settimana” (o no? boh, stiamo un po’ a vedere)) e qualcosa era di nuovo cambiato in Ella d’Essa. Al momento in cui sorridendo mi recai a salutarla – imprevedibilmente! – la vidi impallidire, in un modo che mi parve nulla di meno che drammatico. Fece un piccolo passo indietro, addirittura come temendo un’aggressione fisica (!?!?), di nuovo la vidi tremante e imbarazzata, di nuovo, come al momento del suo primo ritorno al corso, colsi in lei il desiderio di sfuggirmi 91 quanto prima con un pretesto qualsiasi: ma no, pensai insensatamente, ancora fiducioso che una qualche logicità dovesse o potesse regnare nell’animo femminile, queste sono di sicuro delle mie false sensazioni, delle fantasie ostili e paranoiche! Lei stessa, Ella d’Essa, mi aveva detto “ci vediamo mercoledì” e io ho rispettato rigorosamente e dolorosamente il suo “dictamen”: perché dovrebbe avercela con me? Così, richiamandomi piuttosto insensatamente alla ragione e al principio di realtà (credere che una donna abbia qualcosa da vedere col principio di realtà o, peggio ancora, con la ragione, è come credere che – siccome uno abita a Cattolica – debba perciò andare a fare la comunione a Ostia (oppure, come altrimenti si potrebbe dire parafrasando Flaiano, che parafrasava a sua volta Mussolini, capire le donne non è solo impossibile, ma anche inutile)) eppure non volli cedere alla prima impressione, per quanto potente e convincente mi avesse assalito, e la seguii nel suo percorso verso la borsetta, che aveva come al solito abbandonato sullo scalone che fiancheggiava uno dei lati lunghi della sala. Mi sedetti accanto a lei mentre vi frugava dentro e in quel mentre ebbi modo di accorgermi definitivamente che la mia presenza non era gradita, ma proprio per nulla gradita. Mentre eravamo seduti un tale basso e grasso e con l’alito puzzolente di non so che, ma puzzolente, le si avvicinò e le chiese di andare a fumare fuori, richiesta cui Elisabetta aderì con la prontezza di chi si afferra a una ciambella di salvataggio in un mare in tempesta (stante le dimensioni del tipo in questione non si trattava di una ciambella in quel caso, ma proprio di un bombolone, ma insomma…). Avendo cura non solo di non invitarmi verbalmente, ma neppure di rivolgermi un mezzo sorriso o la metà di un sedicesimo dell’un percento di uno sguardo di intesa, Elisabetta si alzò, uscì, poi tornò nervosamente alla borsetta, perché aveva dimenticato le sigarette (era un pentimento della sua improvvisa e improvvida fuga? no, faceva tutto in fretta e furia e scansava il mio angosciato sguardo in direzione ora del tetto ora del pavimento…), e di nuovo si guardò bene di rivolgermi qualsiasi invito esplicito o implicito che fosse a seguirla fuori. Quando tornò in sala si mise a ballare con il tizio basso e grasso, e, incredulo dei miei stessi occhi, non potei fare a meno di registrare la netta impressione che ogni 92 tanto sollevasse la testa dall’abbraccio, allo scopo, a quanto pareva, di scrutarmi con fugaci occhiate che mi parvero, più che impaurite, addirittura terrorizzate: che poteva significare tutto questo (significava, come vedremo, quel che significava questo molto significativo scambio di battute del “Godot”: “Vladimir: Tutto questo comincia a diventare senza senso. Estragon: Ne ha ancora troppo.”: ma appunto, vedremo, vedremo…)? Quando dopo la pausa la lezione riprese, incredulo delle mie strane non meno che stranite sensazioni (in quella settimana non avevo preso alcuna iniziativa che potesse in qualsivoglia modo minacciare la sua vita affettiva: perché poteva avercela con me?) provai in qualche modo a, diciamo così, “verificarle” cercando nel corso della danza di “incrociare” le sue immense pupille, che a tratti parevano nulla di meno che inorridite, con le mie, accennando al contempo un sorriso di intesa tipo “dopo balliamo io e te vero?”. Ma ahimè, lungi dall’ottenere alcun effetto rassicurante, il mio tentativo di agganciare una qualsiasi linea di comunicazione, ancorché solo a rispettosa distanza, provocò un ulteriore peggioramento della già piuttosto tragica vicenda (tragica per chi scrive, ovviamente: a leggere frasi questo genere, mi rendo conto, c’è da scompisciarsi da ridere fino al succitato Giorno del Giudizio di Berlusconi, che arriverà il giorno del mai, nel paese del poi, all’epoca del nemmeno per sogno). Ricevendo i miei piuttosto disperati sguardi di intesa, e forse perciò sentendosi, come dire – sotto osservazione? – Elisabetta mi sembrò per un attimo addirittura sul punto di crollare: incontrando i miei occhi, di nuovo, con mio sommo sgomento, sbiancò in modo tale da fare invidia a Dash, che lava così bianco che più bianco non si può, e quindi – ahimè – mi dovetti tenere i due fustini che volevo darle in cambio del suo, e cacciarmeli dove dire non si può, anche se proprio per questo nessun luogo è tanto nominato al mondo. 40. “Cara beltà che amore lunge m’ispiri o nascondendo il viso, fuor se nel sonno il core ombra diva mi scuoti, o ne’ campi ove splenda più 93 vago il giorno o di natura il riso…”, ebbene si: anche oggi, anche adesso che gli istanti delle fulgide e dolenti vette del mio Amore si sono trasformati in sordide paludi di vuoto e di abbandono – un abbandono privo di grandezza alcuna ormai, abbandonato da tutto e da tutti, persino dal dolore – inesorabile e violento come un’estasi a questi splendidi e melanconici versi di Leopardi il pensiero di Elisabetta splendidamente e melanconicamente mi riporta. E questi versi ancora più lontano, ancora più indietro mi rimandano – come un’eco svanendo in altra eco rimanda al grido originario che in essa muore e si dipana – all’antichissimo mito di Pandora che a sua volta, come in un gioco di specchi, infine mi pone davanti agli occhi il celebre commento che Albert Camus ne fece nei suoi “Quaderni”. Il mito originale narra che quando dal vaso di Pandora uscirono tutti i mali, solo uno vi rimase e ivi fu richiuso, la speranza, falsa virtù e falso bene che, secondo Camus, sarebbe al contrario il più maligno di tutti mali, male da cui i greci in qualche modo si salvarono con la visione tragica della vita, infermo inferno a cui invece avrebbe dannato l’epoca moderna il cristianesimo (in effetti, la Speranza non fa una bella figura nemmeno nella mitologia che caratterizza la nostra cultura Occidentale, nordica e faustiana, dato che nella sua forse più celebre “summa”, l’ “Edda” di Snorry, essa viene descritta come una sorta di creatura dannata di Farnir, il lupo figlio del malvagio Loki, da lui generata quando gli dèi, venuti a conoscenza che questa spaventosa belva crescendo li avrebbe uccisi, la imprigionarono con l’inganno e la sprofondarono negli abissi della terra, da dove uscirà solo nel giorno del Ragnarӧk, il Crepuscolo degli Dei, ovvero la fine del mondo norrena che tanto assomiglia, strano a dirsi, alla descrizione di una guerra atomica (descrizione che, trovandoci in un libro che riguarda l’amor perduto e il tango, faremo bene a risparmiare al lettore, non foss’altro che perché l’amor perduto è uno di quei guai che, a volte, fanno caldamente rimpiangere le guerre atomiche, fredde o calde che siano): “Il lupo spalancava le fauci in modo terribile e faceva disperati tentativi e cercava di azzannarli. Gli infilarono in bocca una spada, l’elsa premeva sulla mascella inferiore e la punta sul palato, essa è dunque il suo morso. Il lupo ulula spaventosamente e la saliva gli scorre 94 fuor della bocca: e questo è il fiume che si chiama Speranza.” (beh, ragazzi, adesso avete, come si dice, una discreta possibilità di scelta; quando vi capita di essere nei guai, eppure continuate, come diceva San Paolo, a sperare contro ogni speranza, potete pensare 1) di essere afflitti dal male che più profondamente alberga nel vaso di tutti i mali, il vaso di Pandora, oppure, in alternativa, che 2) vi state abbeverando al fiume generato dalla rabbia impotente del più malvagio e potente degli déi norreni quando si trovò messo nell’incapacità di nuocere: a voi la scelta (è da storie come queste che si capisce che stare al mondo non è quella cosa semplice e simpatica che appare quando si guardano i programmi tv della domenica pomeriggio e la gente non fa altro che ridere e sorridere, o quando i politici vanno da Vespa e, senza tema di smentita, spiegano che faranno il traforo dell’Etna con un trapano da dentista, il Ponte sullo Stretto con Vinavil e fiammiferi usati per accendere i ceri a Santa Lucia, non prima di aver ridotto le tasse del quaranta per cento finanziando la riduzione con una colletta natalizia fra i parenti degli impiegati di Montecitorio e del Quirinale)). 41. In effetti, non saprei dire se Camus aveva ragione o no (in vita mia non ho mai coltivato particolari speranze, men che meno di quelle metafisiche). Però mi domando: questa specie di Santo Graal al contrario, il vaso di Pandora appunto, come altro possiamo interpretarlo se non come un’allusione a Pandora stessa, la donna originaria, l’Eva della mitologia greca? Tutti i mali del mondo possiamo sperimentare stando soli, ma per sperimentare il più terribile, il più oscuro e tentatore, la speranza, dobbiamo tornare a Pandora, dobbiamo tornare ad amarla! E non amarla nel modo platonico cui Leopardi allude nei versi della canzone sopra citata, quando si rivolge alla “Cara beltà” con espressioni che la ritraggono come mera fantasia, mito e fantasma (“Se dell’eterne idee l’una sei tu cui di sensibil forma sdegni l’eterno senno esser vestita etc.”), ma nella concreta figura di una donna in carne e ossa, come poi 95 tragicamente testimonierà nei canti del cosiddetto “Ciclo di Aspasia”: è solo così infatti che la speranza, questa febbre immortale dell’anima mortale, si può impadronire di noi e bruciare e bruciarci fino al cielo, fino all’inferno, fino alla follia (perché un uomo tanto arde al desiderio di eiaculare in una donna, in quest’oggetto tanto antieconomico, oscuro, ironico e sfuggente, se il medesimo risultato può ottenerlo così facilmente con la fedele mano destra entro un rassicurante e illuminato lavandino? si insegue e si vuol penetrare una donna, infine, non per un generico desiderio di piacere, ma per poter toccare nell’attimo ineffabile e straziante dell’orgasmo quest’orrore sorridente d’estasi, questo male dagli occhi di fata, per dissetarsi del più dolce di tutti i veleni, la Speranza (la Speranza che alimenta e tormenta tutti gli amanti è forse tanto inesprimibile, o tanto difficilmente definibile, perché allude in modo inevitabile a quella Porta dove portano tutte le porte, a quella fine che sembra infine il solo mezzo per attraversare quel baratro (baratro di che? forse di solitudine?) che inevitabilmente divide i singoli esseri viventi dal tutto: non a caso Bataille sosteneva nel suo saggio sull’erotismo che, siccome è il tentativo di colmare questa nostalgica lontananza fra gli esseri e con l’Essere, l’amore implica sempre e comunque una violenza, ovvero una connessione inevitabile con l’idea e, certe volte, con la pratica della morte (il lasciarsi, la fine di un amore, è tanto dolorosa non solo e non tanto perché si perde l’amore di quel certo essere umano, ma perché si torna inesorabilmente nella quasi insopportabile originaria separazione dell’anima col tutto e da tutti (e non è terribile il pensiero che gli amori finiscono sempre, e per sempre, in un certo senso, anche quando durano tutta una vita?))). 42. Pandora non viene all’uomo col suo vaso, è il suo vaso, ovverosia il suo materno ventre, il terrestre abisso dal quale la vita sorge e al quale forse troppo presto e sempre troppo tardi torna. Essere posseduti dall’amore, anzi, dall’Amore, significa dunque essere 96 posseduti dalla Speranza: ma Speranza di che? Se è vero che essa allude alla rottura della discontinuità fra gli esseri e con l’Essere, è dunque alla Morte che l’Amore allude, ed è per questo che tanto risulta difficile il definirlo, visto che dal tempo di Epicuro in poi è diventato una sorta di luogo comune filosofico il pensiero che la morte è impensabile, e che dunque risulti perciò anche indescrivibile, se il Nulla resta alieno ad ogni immagine. È, crediamo, proprio per questo che lo scopo dell’Amore e dunque il suo linguaggio, le sue metafore, non sono mai state chiare a nessuno, forse meno di tutti a chi abbia avuto la strana ventura di inventarle. I suoi vaticini, i suoi simboli, le sue illusioni e allusioni appaiono da sempre enigmatici, imperscrutabili, e si negano al potere razionale del concetto, come volentieri e spesso anche a quello irrazionale del sentimento, o dell’intuizione (solo un innamorato può capire che cosa sia l’Amore, non certo l’occhio freddo dello scienziato, o, peggio ancora, l’impersonale registro della macchina: a che sarebbe servito a Dante sapere che, quando vedeva Beatrice e sveniva, si attivavano certe zone del suo cervello e certe altre si disattivavano? l’eros non si può osservare senza parteciparvi, come non si può capire che cos’è una poesia senza lasciarsi andare al trasporto lirico di chi l’ha scritta (il poeta, la poesia, e il lettore di poesie, sono, in un certo senso, la stessa cosa, la stessa persona (la stessa musica?))). Infatti, anche a voler fare i razionalisti, che cosa possiamo effettivamente e razionalmente capire e carpire dai versi che, per esempio Leopardi, dedica alla donna ideale diventata donna reale, ovvero ad “Aspasia”: “Raggio divino al mio pensiero apparve, donna la tua beltà. Simile effetto fan la bellezza e i musicali accordi ch’alto mistero d’ignorati Elisi paion sovente rivelar.”? Forse, alla fine, solo questo: che, come suona evidente dal tono elevato delle parole che l’amante è spinto a impiegare nel suo canto, la Speranza che Amore insuffla nel cuore è la porta ad Altri mondi, ad Altre felicità, che si affacciano in indistinte immagini che il poetico lamento febbrilmente dispiega ma che – ahimè – la ragione, siccome non le sente, dunque per forza di cose è destinata a non comprenderle. Tutto è confuso in quest’abisso, il vaso che senza fondo Pandora ci dischiude, se non la luce incerta che tutto rischiara e tutto confonde, che tutto promette e nulla mai 97 mantiene, se non il sempiterno rinnovarsi del suo male, la Speranza appunto: male orrendo e senza rimedio perché – ahimè – quale fondamento può avere mai la Speranza, se poco o punto troppo spesso ne hanno anche le speranze con la “s” minuscola? Borges conclude la lirica “Religio Medici”, che inaugura con la drammatica non meno che suggestiva invocazione “Defiendeme Señor…” con questi terribili ultimi versi “Ni de la espada, ni de la roja lanza defiendeme, sino de la esperanza.”: e io, giunto a quel punto della mia non-storia con Elisabetta, che cosa dovevo fare, se non proprio questo, difendermi, con tutte le mie forze e a tutti i costi da questo male enigmatico e inconcepibile che si era impadronito di me al momento in cui mi ero innamorato di questa enigmatica e inconcepibile ragazza? Si, dovevo farlo, dovevo difendermi e difendermi dovevo, pena il prolungarsi di un tormento che, in caso contrario, mi avrebbe senz’altro condotto a pensieri insani e a comportamenti malsani di ogni sorta. Perché, non è forse proprio da questo falso bene, la Speranza, che proviene il vero Male, che altro non è che il suo effetto inesorabile, o, meglio ancora, la sua immagine rovesciata nello specchio, la Disperazione, quella che fa gridare agli amanti delusi quel che gridò Giulietta credendosi tradita “Quale drago abitò in un corpo così bello?... Corvo con ali di colomba, agnello famelico come un lupo! Lurida materia d’apparenza divina! Perfetto contrario di quello che sembravi!”? Nell’improvviso rovesciarsi delle metafore shakespeariane – nella colomba che diventa corvo, nella gemma di troppo valore che diventa lurida materia – non si indovina forse il rovesciarsi improvviso dell’anima dell’innamorato, il cielo dell’Amore che si muta nell’abisso del Disamore, l’Eden della pienezza e dell’altezza che si muta nella brutale “descensio at inferi” ovvero nella cacciata verso il vuoto e il nulla del rifiuto, l’incanto dell’aurora col disincanto feroce del tramonto, l’una dell’altro specchi, l’un dell’altro promessa come l’un dell’altro negazione? 98 43. Fu così amaramente ragionando che quella sera, tornando a casa – dopo un faticoso e amleticamente e quasi atleticamente tormentato percorso di dubitosi pensieri – sentendomi infine come uno specchio quando si accorge che non c’è più tempo per riflettere – decisi che era giunto il momento di dare un taglio a quella situazione: un taglio netto, che non concedesse allo “stanco mio cor” alcuna speranza di poter disperare ancora, nemmeno un’ultima volta. Ormai, al termine di settimane e settimane di dolci e, soprattutto, atroci attese, di appassionata e passiva passione, oltre a non aver ottenuto nessun progresso nel mio tentativo di seduzione, nemmeno ero riuscito a stabilire con la mia amata un legame anche solo vagamente somigliante a un’amicizia – dato che le quattro chiacchiere post fine 2006 erano risultate sempre del tutto insignificanti nonché prive di qualsiasi tono veramente intimo o anche solo amichevole – né era subentrato a quello fra corteggiante e corteggiata qualsiasi altro genere di etereo o solido rapporto, che so, di compagnoneria o di solidarietà fra colleghi di corso, o cose del genere. Eppure avevo usato ogni mezzo dialettico a mia disposizione, in ogni modo avevo cercato di comunicarle la mia passione, come peraltro il desiderio di sentirla vicina in qualsiasi modo e a qualsiasi costo, compreso quello di rinunciare a qualsiasi scopo genuinamente erotico o sensuale o sessuale o simili! La mia dedizione era giunta al punto che, pur di avvicinarla, mi ero abbassato a compiere un atto che in situazioni consimili avevo giudicato indegno di un vero come peraltro anche di un falso gentiluomo: in un momento di, devo sottolineare, estrema debolezza le avevo comunicato, sia pure di sfuggita, in modo un po’ vago e apparentemente del tutto casuale – per non darle la sensazione che stessi cercando di comprarla (e invece era proprio quello che stavo cercando di fare, devo dire) – la mia invero piuttosto solida condizione economica di professionista di un certo successo. Ebbene si: pur di averla, o almeno di continuare a sperare di averla, ero giunto fino a questo punto, il punto più basso di tutta la mia peraltro assai poco gloriosa carriera di seduttore, abisso dal fondo del quale speravo di istigare la mia amata a darmi l’occasione di ripetere, 99 amaro e ironico la celebre frase di Forster che suona, mi pare di ricordarmi, “Entravano i dividendi, salivano gli alati pensieri” (beh, più o meno in quello stesso periodo Rimbaud ebbe a scrivere ancor più chiaramente ne “Una stagione all’inferno”: “Non amo le donne. L’amore è da reinventare, si sa. Loro non possono far altro che volere una posizione assicurata. La posizione è conquistata, ed ecco che cuore e bellezza sono messi da parte: non resta che il freddo disprezzo, l’alimento del matrimonio, oggi come oggi.”: hai letto una cosa così, e ci credi, eppure l’amore ancora rimane capace di spingerti a offrire la posizione assicurata pur di avere in contraccambio (cosa? forse, amore? Eloisa non sarebbe stata d’accordo, dato che secondo lei “Colei che sposa più volentieri un ricco che un povero e desidera più la ricchezza dello sposo che lo sposo deve essere giudicata avida: a qualsiasi donna che si lasci condurre alle nozze da questi desideri, è dovuta una paga e non certo l’amore. Una donna simile, in realtà, vuole le ricchezze, non l’uomo e, se potesse, si prostituirebbe al più ricco”30 (mi domando se non sia per caso questo il motivo per cui il mondo, e il parlamento in particolare, appare sempre più affollato di figli di, ehm, diciamo così, di una grandissima escort (che, da quando frequentano parlamento e ministri e primi ministri, sono diventate persone ben più rispettabili di qualsiasi innamorato, oltre che di ministri e primi ministri (beh, questo lo erano anche prima))))). 44. Il mio invero alquanto timido e preventivamente disperato tentativo di prostituire, o, come direbbe il candidato premier, di escortare Elisabetta, come dicevo sopra, lo feci nel momento in cui, ricevuto senza tanti complimenti l’ennesimo due di picche, avevo già raggiunto la più o meno inconscia certezza che la mia e non mia, la maledetta “lei” non mi amava affatto e che – ahimè – con ogni 30 P. Abelardo, “Lettere di Abelardo e Eloisa”, lettera seconda, di Eloisa ad Abelardo. 100 probabilità non mi avrebbe mai amato. Quindi mi ero ridotto a fantasticare che potesse avvicinarsi a me spinta da un altro genere di interessi, meno sentimentalmente soddisfacenti ma non per questo meno efficaci. In effetti una volta – non so bene perché, forse lo fece solo in via amichevole e confidenziale – Elisabetta aveva accennato a suoi per quanto forse non proprio tragici problemi economici, dovuti più che altro alla costante precarietà del suo lavoro, uno di quelli con cui – alla faccia del progresso supposto continuo e inesorabile della nostra cosiddetta civiltà – che invece pare trasformarsi ad ogni supposto progresso in una sempre più gigantesca supposta – il capitalismo in crisi sta cominciando lentamente a trasformare il lavoro salariato in schiavitù della gleba e per cui si viene assunti per un massimo di tre mesi e poi lasciati a casa per uno, i giorni di malattia non vengono pagati, e via così regredendo (mi permetto da questa umile sede di avvertire i nostri politici, troppo impegnati a sollazzarsi con coca, escort e trans a carico dell’erario per pensare a cosa succede fuori dallo studio televisivo dove, dopo aver finito con escort e trans, vanno a farsi pubblicamente spompinare dal giornalista indipendente di turno, che mettere in concorrenza duecento milioni di lavoratori occidentali dotati di diritti civili e sindacali con due miliardi di schiavi cinesi e indiani, non trasforma gli schiavi in lavoratori con diritti, ma i lavoratori con diritti in schiavi: ciò significa, come minimo, che vi sono problemi ben più urgenti per la nostra ormai esausta democrazia che l’immunità per presidenti, ministri, deputati, segretari, sottosegretari, consiglieri e altre simili e affini categorie di gangster). Come a voler rincarare la dose, la mia amata aveva poi aggiunto che a volte le capitava di non lavorare per tre o quattro mesi, e che le era persino successo più di aver paura di non arrivare alla fine del mese, o di non riuscire a pagare l’affitto, dato che spesso riceveva lo stipendio in ritardo, etc., e allora io, sentendomi sul punto di essere definitivamente respinto, avevo osato sperare che, se proprio non mi desiderava e non mi amava, diciamo così, in quanto corpo e anima, ci potesse almeno essere la sia pur misera prospettiva di averla (“averla”? ma davvero si può avere qualcosa a questo mondo, a parte la propria vita, e soprattutto, la propria morte?) in cambio del vil metallo (in effetti, 101 non si trova al mondo metallo che possa definirsi coraggioso). Ma non c’era stato nulla da fare: nemmeno la prospettiva di un futuro di sicurezza economica in cambio di un presente che appariva invero alquanto stringato era riuscita ad avvicinarla alle mie braccia avide sol di stringerla e non lasciarla mai più (sappia il lettore che l’umile scriba di queste deliranti note è stato e resta probabilmente a tutt’oggi il classico tipo d’uomo inattendibile, inaffidabile e irresponsabile che le donne amano stringersi al seno con lo stesso fervore di solito riservato a un tumore al seno: in effetti, stante il fatto che non mi è mai passato per la testa in vita mia di rovinarmi una banale scopata con una splendida amicizia (il lettore non si scandalizzi troppo: voglio dire, tutti siamo stati giovani, tutti abbiamo avuto i nostri anni ruggenti, anche se, a dir la verità, guardandoli a posteriori non si capisce più tanto bene cosa ci fosse di tanto considerevole per mettersi a ruggire), se quale tenero fidanzato o “surdato ‘nammuratu” che dir si voglia la mia credibilità non supera quella di un licantropo autoproclamantesi vegetariano, posso in compenso orgogliosamente affermare che, quanto al marito fedele e al padre premuroso, essa risulterebbe largamente inferiore a quella di un conte Dracula che, per supportare la sua candidatura alla presidenza dell’Avis, giurasse sulla testa dei già citati figli di Berlusconi di seguire una dieta a base di acqua minerale non gasata e radicchio scondito, o come il suddetto Berlusconi che si candidasse come comandante in capo della buoncostume dopo aver garantito che, una volta eletto, si farà promotore di una legge per punire gli utilizzatori finali delle escort pagate con le tangenti della sanità: pure in quel periodo ero andato talmente fuori di testa che volevo a tutti i costi tanto sposare quanto avere figli da quella strana ragazza (a pensarci bene, forse è andata meglio così: chissà che cosa poteva uscir fuori da un’interprete per sordomuti che parla perugino senza aver mai visto Perugia e un conte Dracula presidente dell’Avis: magari un cannibale anoressico, un politico onesto o, peggio del peggio, un comunista che si pente e si iscrive a Forza Italia (beh, questi in effetti esistono già, e paiono già troppi)). 102 45. La probità e il distacco dai beni materiali manifestato da Elisabetta, è inutile sottolinearlo, accrebbero ancor più la mia stima, il mio amore e il mio rispetto nei suoi confronti, dato che se effettivamente l’avessi potuta avere in quel modo basso e ignobile da me vilmente progettato, in un altro senso l’avrei in ogni caso perduta per sempre, dato che mai come in casi come questi ci si rende conto che “Nulla è avuto, tutto è sprecato se il nostro desiderio è ottenuto senza gioia: è meglio essere ciò che distruggiamo piuttosto che, grazie alla distruzione, vivere in gioia dubbiosa.”31. Ma la nobiltà della mia amata a che serviva, se altro non rappresentava per me che un chiavistello ai portoni del suo amore e – ohibò, ohimè e doppio ahimè – un altro lucchetto alla sua cintura di castità (in effetti, la risposta negativa, o, meglio ancora, la totale indifferenza di Elisabetta ai miei fin da principio piuttosto sfiduciati input di tipo economico non mi aveva stupito per nulla e, anzi, intuendo quale fosse il suo carattere, l’avevo abbondantemente prevista: ma, come che sia, un tentativo lo avevo fatto lo stesso, sia pure con lo stesso stato d’animo di chi, giunto alla bancarotta, tira l’ultima moneta che gli è rimasta per decidere quali numeri giocare al superenalotto (la piuttosto balzana idea mi era venuta nel momento in cui, nel bel mezzo dei postumi di una disperata sbronza notturna, frammisti a una risata sgangherata e solitaria, ultrasganasciata e follemente schiamazzante, mi erano tornate in mente le vicende della celebre farsa di Johann Nestroy “Il talismano” – che non a caso ricordavo citate da Freud – in cui le fortune di un povero diavolo coi capelli rossi variano con l’acquisto e la successiva perdita di una parrucca nera (beh, nel mio caso, visto che io ho i capelli neri, la parrucca doveva al contrario essere rossa, ovvero io non dovevo essere al verde, pur se il verde del portafoglio e il rosso del conto corrente si prestano comunque a significati contiguamente ambigui): alla fine, non poteva darsi che questa pur così venale rivelazione potesse invece mutare in modo decisivo le sorti della mia immagine nella 31 W. Shakespeare, “Macbeth”, III; ii. 103 mente di Elisabetta, magari nel senso di convincerla a troncare di colpo e una volta per sempre qualsiasi relazione di qualsiasi tipo con il sottoscritto o Me Medesimo Stesso che dir si voglia una volta indovinata la del tutto indelicata intenzione di pagare i suoi sentimenti, ovvero di prostituirla? In fondo, gente famosa e molto seria ha creduto senza meno che bastasse girare intorno a Gerico per farne cadere le invincibili mura: non c’è da stupirsi dunque che l’Amore disperato si conceda dei tentativi di seduzione che hanno le stesse possibilità di riuscita che una formica di gonfiare un dirigibile a forza di scoregge (beh, come si fa a dire che non ha proprio nessuna possibilità? in fondo in fine fa bene a provarci, tanto per quel che costa..). 46. La situazione era o pareva dunque senza alcuna via d’uscita, oltre che, ehm, evidentemente, senza alcuna via di entrata.. (è un fatto che è difficile per me come per tutti confessare la natura senz’altro anche inconfessabilmente carnale dei desideri che provavo verso la mia adorata: “Ci sono prestazioni che perdoniamo solo a noi stessi: se immaginassimo gli altri nel pieno di un certo grugnito, ci sarebbe impossibile tendere ancora loro la mano.” 32: ti immagini Dante in quella certa situazione con Beatrice o, se è per questo, con qualsiasi altra, e quando mai e quando più ti viene voglia di leggere le sue poesie? (l’unione fra anima e corpo non sarà mai tanto moralmente imperdonabile e filosoficamente impensabile come quella fra sesso e sentimento)). In aggiunta a ciò, mi rendevo conto che nel corso delle estenuanti quattro chiacchiere durante l’intervallo fra le due lezioni, banalità eppure precedute da angosciose ed estenuanti attese che si risolvevano puntualmente in altre e ancor più estenuanti ed angosciose attese, oltre a non udire nessuna buona notizia, per sovrappiù nemmeno si era decisa ad arrivare quella cattiva, ovvero una reale, aperta e sincera chiarificazione dei sentimenti di Elisabetta 32 E. Cioran, “Sillogismi dell’amarezza”, Adelphi, p. 95. 104 nei confronti di qualcun altro, ovvero dell’ormai incombente ancorché a tuttora fantasmatico fidanzato torinese. A ciò era da sommarsi il fatto che, con mia somma incredulità, la mia adorata sembrava spaventarsi al mio cospetto per motivi inafferrabili, e, soprattutto, del tutto indipendenti dalle mie intenzioni e da quelli che erano o mi sembravano essere i miei comportamenti. Questo sarebbe stato sopportabile, o anche del tutto indifferente, se non fossi stato completamente innamorato di lei. Ma in quella situazione simili inspiegabili mutamenti d’umore mi avrebbero ben presto ridotto nello stato di quel tale che Edward Munch prese a modello per il suo celebre urlo (la disperazione d’amore, in questo senso, è ben peggiore che un altro genere di crisi esistenziali, come sarebbe, per esempio, accorgersi di aver perso sé stessi: in un caso come questo, basta non pagare le bollette per sei mesi e ci pensa Equitalia a ritrovarti in cambio di una modica penale o, in alternativa, del sequestro di casa, macchina, moglie, figli e parenti tutti, suocera esclusa). Dunque, prima che il disastro avesse luogo, era il caso di prendere provvedimenti radicali, ancora più radicali di quelli che avrebbe preso Marco Pannella in persona, provvedimenti che si concretizzarono nella granitica decisione di cominciare ad evitare Elisabetta come la peste, il colera e il virus Ebola messi insieme a partire dal mercoledì successivo. Da quel momento, se mi fosse capitato di incontrarla, l’avrei salutata gentilmente, le avrei sorriso, questo si, ma non le avrei rivolto più la parola, anzi, me ne sarei tenuto il più distante possibile, oltre ovviamente a non chiederle più di ballare. Ero certo che così facendo in un tempo brevissimo sarei stato nella condizione di non aver mai più a che fare con lei, dato che le donne, come tutti sanno per comune esperienza, quando si sentono indesiderate non osano neppure avvicinarsi: all’uopo basta che il maschio dia un sia pur minimo segno di ostilità – un tono di voce un po’ brusco, uno sguardo anche solo vagamente torvo, un saluto minimamente freddo – ed ecco che il desiderato effetto di allontanarle o di levarsele dal famoso posto dove non batte mai il sole e dove in grazia di ciò entra sempre il dottore (a Livorno, siccome il sole c’è quasi sempre, si dice “culo”) si produce senza 105 meno. Ma nel mio strano caso – che probabilmente ricorda in qualche punto quello più celebre del “Dottor Jeckyll e Mister Hyde” – le cose, come il lettore avrà già a questo punto capito, se non altro a partire dal numero di pagine che ancora mancano alla sospirata fine di questa sospirosa non-storia, non si rassegnarono a finire neppure in questo modo. Per un paio mercoledì Elisabetta, come risposta alla mia improvvisa disaffezione, si limitò a fissarmi con aria che mi parve dapprima di dolorosa sorpresa, poi di inaccettabile scacco, che ben presto dette l’impressione di trasformarsi in vera e propria disperazione. Mi guardava da lontano, dall’altro capo della sala, e con quei suoi grandi occhi di uccello marziano caduto dal suo celeste nido astrale “all’aiola che ci fa tanto feroci” (questo, per chi abbia la fortuna di non aver fatto il liceo classico è Dante Alighieri, personaggio storico che si trova in perfetta consonanza con questa disastrata vicenda: non è un caso che di solito l’asino caschi dove un altro asino è già cascato: ma avremo in seguito modo di approfondire le di lui disgrazie e le di lui disperazioni), sperduto spazio donde mi lanciava sguardi che parevano non meno allucinati che lancinanti; sguardi che sembravano ripetermi: ohibò, cosa mai ti ho fatto, perché non mi cerchi più, perché non balli più con me? Ma, proprio perché tali sensazioni mi facevano tutto sommato piacere – anzi, per dirla tutta, mi facevano molto, ma proprio molto piacere – dato che il suo disappunto significava una sia pur parziale e men che insufficiente vendetta delle mie interminabili agonie, proprio per questo, dicevo, ne dubitai profondamente, al punto che infine conclusi che no, quello che percepivo, quello che credevo di intuire, o – addirittura! – di constatare con i miei stessi occhi, no, non era proprio possibile, non esisteva, doveva essere per forza di cose un’allucinazione prodotta dal sangue ribollente del mio cuore ferito per occhi fin troppo desiderosi d’ingannarsi. Se davvero Elisabetta soffriva a causa del mio peraltro prevedibilissimo allontanamento, questo avrebbe voluto dire che anche lei mi desiderava, o addirittura che si era innamorata di me: e una cosa del genere non era nemmeno vagamente ipotizzabile, dato che le avevo dato tutte ma proprio tutte le occasioni del mondo se non altro per uscire insieme o anche solo per 106 conoscerci in una situazione del tutto neutra, innocente e amichevole come il tempo che passavamo insieme a lezione. Dunque quelle mie impressioni dovevano essere senz’altro una sorta di allucinazione erotica dovuta ancora una volta al fatto che il mio improbabile e improponibile innamoramento, lungi dall’esser cessato con l’irrevocabile decisione di evitarla, ancora sopravviveva, e gridava, e si dibatteva, sia pur sepolto sotto quell’apparentemente lapidaria risoluzione, altrettanto granitica, probabilmente, che una scenografia di Hollywood di cartapesta garantita. Se il mio deliquio mi spingeva a vaneggiare come vero e reale un evento impossibile la mia situazione era ancora quella di un malato molto grave, non quella di un malato in via di guarigione, onde ragion per cui era cosa buona e giusta rafforzare ulteriormente la terapia. 47. Fu così che pensai bene di starle lontano non solo durante le pause della lezione, ma anche nel mentre ballavo con Chicchessia (“Chicchessia” era qualunque donna o ballerina di tango non fosse stata “Ella d’Essa”), in modo che un caso malevolo non avesse complottato a che ci trovassimo vicini proprio al delicatissimo momento del cambio delle coppie. Un’eventualità del genere mi avrebbe praticamente costretto a stringermi a lei, anche se solo per ballare, esponendomi così al rischio concreto di un devastante ritorno di fiamma del mio mal d’amore, e dunque dovevo assolutamente usare la massima cautela: ne andava della mia salute mentale a breve e forse anche a lungo termine. Così pensai, così decisi e, dunque, così feci. Ma, strano a dirsi, neppure questa strategia tanto minuziosa e massimalista conseguì lo sperato effetto di allontanare definitivamente da me quella strana ex sconosciuta che tanto profondamente si era impressa nell’animo mio sgomento da somigliare infine a un sigillo di bronzo incontro alla bollente ceralacca. Infatti, con mia somma incredulità, notavo che il suo sguardo smisurato si faceva ogni volta più prominente, e si ostinava a 107 inseguirmi per la sala ancora più incredulo del mio, ogni mercoledì più smarrito e desolato (ma davvero – mi domandavo attonito – l’amore deluso può produrre allucinazioni di questa raffinatezza, di questa onirica precisione, di questa delirante chiarezza?) e, anzi, una volta ebbi addirittura l’impressione che la ragazza non si sentisse da me banalmente frustrata, ma addirittura mortalmente offesa (?!?). In effetti, in uno di quei fatali e surreali mercoledì sera di quel fatale e surreale 2007 della mia vita, notai con sentito stupore che dopo averla bensì salutata, ma piuttosto di lontano (avevo preso la ragionevole precauzione di non tenermi mai e poi mai a meno di quattro o cinque metri dalla mia ex diletta, sempre, ma particolarmente in quegli oramai ansiosi, ansiogeni non meno che tristissimi minuti di attesa che preparavano la lezione vera e propria con chiacchiere, sorrisi timidi o sfrontati, allusioni a prossimi tanghi condivisi o condivisibili, future pratiche o milonghe da frequentare insieme, tutte cose che ormai, almeno da parte mia, non la riguardavano evidentemente più, posto che mai l’avessero, fuori dal mio “possente errore”, riguardata), ma ciò non ostante Elisabetta, evidentemente cercando di riprendere in qualche modo e quasi a qualunque “costo” il perduto contatto, prese dapprima a passarmi vicino, poi sempre più vicino, troppo vicino, e continuò in questo o in ancor più sfacciato modo a blandirmi e tentarmi durante la lezione vera e propria, in specie nel delicatissimo momento dei cambi delle coppie, finché infine, non ottenendo in questo modo alcun risultato, addirittura mi venne “casualmente” a urtare con la spalla un paio di volte con la stessa gentilezza di un giocatore di football americano che sta placcando il runner in corsa verso la sospirata meta. Naturalmente, la crudele Crudelia non mancò di approfittare dell’occasione da lei stessa così rudemente creata per gettarmi sguardi che mi sembrarono inviti tanto taciti quanto quasi aggressivamente espliciti a farmi avanti, a invitarla a ballare, o, addirittura, a parlare (di che?), inviti che, pur sentendomi in quel momento come un Cristo digiunatore nel deserto in balia di un Tentatore in veste di bistecca, riuscii a ignorare con la più ferma e fredda determinazione che mi fosse in quel momento possibile. La ragazza però non sembrava demordere, continuava a passarmi vicino, 108 finché, dopo una terza spallata con annesso e fallimentare sguardo di invito, la mia ex diletta, che pareva davvero furibonda, si andò a sedere con fare coreograficamente grandioso e scenograficamente offeso (da cosa, dal fatto che di me non ne voleva sapere nulla? boh…) in un angolo lontano e sperduto della sala, dove in un attimo, simili ad avvoltoi, iene, sanguisughe, od altre simili e necrofile creature delle tenebre, altri tre pretendenti che aveva al corso si recarono per porgerle i loro omaggi, visto che i miei non aveva potuto (o voluto?) ottenerli (questi pretendenti erano rimasti nell’ombra finché al sole c’ero stato io: poi erano venuti fuori come i giornalisti e i magistrati indipendenti al tempo di Mani Pulite). Se non ero del tutto pazzo, questo era o essere pareva il significato della messa in scena o messa in c… o come altrimenti dir si voglia cui avevo appena assistito: che “lei” si sentiva da me trascurata!?!? Un significato questo, non c’è bisogno di dirlo, che mi pareva talmente privo di significato che, sia pure con una certa timidezza, cominciai a pensare che la mia ex diletta potesse soffrire, sia pure in modo non gravissimo, di una qualche sorta di problemuccio mentale, sia pure di quel genere non molto facilmente perscrutabile e ancor meno facilmente classificabile che non impedisce a nessuno di fare mestieri che richiedano scarsa applicazione mentale, come lo spazzino, il tassista o, in mancanza di meglio, il primo ministro (Rocco Buttiglione, tanto per fare un esempio, non riuscendo neppure a fare il giornalista come la sorella o il fratello che fosse, venne nominato dal buon Berlusca capogabinetto del consiglio dei ministri: il suo ruolo, naturalmente, era quello di tirare lo sciacquone). Tanto mi appariva confusa la situazione che cominciai a pensare che per liberarmi di quella ragazza avrei dovuto decidermi a prendere provvedimenti ben più risolutivi e decisivi che il semplice evitarla – come, che so, emigrare in Patagonia, chiudermi in un convento di clausura, offrirmi volontario in un esperimento di ibernazione, o, al limite, fare in modo che lo facesse lei. D’altra parte “Quel che par bene agli occhi di un uomo può esser male per una donna, quel che par male al cuore di un uomo può esser bene per una donna. Chi può comprendere i voleri delle donne, quando l’umanità ha imparato a conoscere le celesti e sotterranee vie delle femmine?” 109 (se alla precedente frase sostituite “donne” con “déi” avete un poemetto babilonese di circa quattromila anni fa, probabile origine del racconto biblico riguardante la famosa pazienza di Giobbe). Dubbi informi e angosciosi mi tormentarono per giorni e notti, dubbi che galleggiavano nell’alcol come barchette di carta in mezzo alla tempesta, finché un ennesimo fatale mercoledì sera la già delicata situazione precipitò in modo alquanto improvviso e drammatico. Mentre durante l’intervallo fra la prima e la seconda lezione parlavo con un’amica, Elisabetta, senza tener in sia pur minimo conto le mie costanti e minuziose manovre per evitarla, venne a sedermi accanto, e con quel suo sguardo che si faceva con l’esausto passare dei mercoledì sempre più tapino e stupefatto mi chiese “ma allora…., come stai?” (!?!?). Dio mio, non aveva ancora capito la situazione? Che cosa voleva ancora da me? Preso da una sorta di sotterranea, sbalordita furia le risposi nel modo più freddo, distaccato e laconico possibile che stavo bene, anzi, benissimo, dopodiché ripresi a parlare con la mia amica e non le prestai più la benché minima attenzione. Naturalmente, ero più che certo che a quel punto Elisabetta si sarebbe alzata e si sarebbe allontanata finalmente e per sempre, dato che gli avevo inflitto uno smacco che, se per una donna normale costituisce un’onta insopportabile, per quella minimamente suscettibile diventa la ragion sufficiente per scatenare un attacco nucleare: ma di nuovo, incredibilmente, mi sbagliavo. Inverosimilmente, inconcepibilmente, Elisabetta continuava a starmi seduta vicino e accanto mentre io – sia pur con la coda dell’occhio – contemplavo basito l’immensità apparentemente disperata dei suoi occhi intenta ora a fissare me – dunque la sua sinistra – ora il cielo vuoto – che stava in alto invece, alla sua destra. “Though this is madness there is method in it!”33 avrei voluto esclamare come Polonio fece udendo gli argomentati e salaci deliri di Amleto, ma – ahimè – la scena si stava svolgendo sul palcoscenico della realtà quotidiana, non in un dramma shakespeariano, e dunque la follia della mia amata non sembrava poter avere nessun metodo e 33 “Sebbene questa sia follia c’è del metodo in essa!”. 110 soprattutto nessuno scopo, se non quello di rovinare in via definitiva il mio ormai piuttosto consunto sistema nervoso (e in quel caso, questo va ben sottolineato, il metodo era da definirsi nulla di meno che perfetto). L’unica certezza che mi rimaneva era che l’impero dei sensi che solo pochi mesi prima avevo prefigurato nelle mie febbrili fantasie tangoerotiche si er rapidamente trasformato in un impero di nonsensi che col passare dei mercoledì assomigliava sempre di più a un quadro di un Salvador Dalì in preda a schizofrenia, paranoia con delirium tremens annesso, oltre che al consueto LSD della colazione, e dunque, non ostante tutto, non volli a nessun costo desistere da quello che mi sembrava un giusto e lucido proposito. Pur per l’ennesima volta sconvolto e quasi allucinato di fronte a un simile, inusitato comportamento (ma è una donna questa qui, o un attore pornografico in erezione mascherato da ballerina di tango?), che sembrava una sorta di accanimento terapeutico crudamente e crudelmente applicato al mio povero cuore infranto da un cardiologo con l’hobby del serial killing, non volli a nessun costo abbandonare la mia risoluzione: mettermi a parlare con Elisabetta significava rianimare un rapporto che non aveva alcun futuro di alcun tipo, posto che mai avesse avuto un passato. Non appena la musica ricominciò ballai con la mia amica e alla mia incomprensibile e ingrata “lei” non rivolsi più nemmeno l’ombra di uno sguardo. 48. Con mio gran sollievo, il mercoledì successivo Elisabetta non venne a lezione e io fui così libero di sperare che l’essersi sentita così bruscamente e quasi maleducatamente evitata e respinta la tenesse lontana dalla lezione almeno per un po’, almeno per altri quindici giorni – o magari per un mese! – un tempo comunque che mi desse modo di moderare, se non proprio di superare del tutto, il lutto per la sua perdita. Lutto aggravato da quella strana e per me di certo del tutto imperscrutabile situazione di stallo che si era venuta creando, per cui non mi era riuscito né di diventare il suo ragazzo, né un suo 111 amante, o un suo amico o conoscente qualsiasi che dir si voglia, e nemmeno mi era riuscito o mi riusciva di togliermela puramente e semplicemente dalle balle. Sperai dunque, non diciamo che quella strana faccenda fosse finita, ma che mi fosse concessa almeno una prolungata pausa di riposo, per rimettermi un po’ in sesto, dormire un po’ meglio, bere e fumare un po’ di meno, etc. anche se, lo devo riconoscere, questa pur ragionevole speranza era come intorbidita e ottenebrata da ogni sorta di dubbi, irrazionali e quasi superstiziosi, certamente, ma che, proprio per questo mi parevano, strano a dirsi, del tutto credibili e ben fondati (come il giorno che leggi sul giornale che il debito pubblico diminuisce dello zero venti per mille e ti domandi: è una luce in fondo al tunnel quella che si vede, o sono i tuoi parenti morti che ti vengono incontro dall’al di là? a quel punto puoi star sicuro che non è né l’uno né l’altro: sono i denti di Berlusconi che promettono a tutti gli italiani di abbassare le tasse (e in effetti le abbasserà, certo, ma bisogna ricordare che nei discorsi di Berlusconi l’espressione “tutti gli italiani” è sinonimo di “Silvio Berlusconi”)). In effetti, le mie speranze andarono piuttosto goffamente deluse, perché Elisabetta si ripresentò di nuovo il mercoledì successivo e di nuovo ebbi la sensazione, che questa volta era praticamente una certezza, che mi guardasse davvero con aria smarrita e addirittura molto addolorata. Con la coda dell’occhio di nuovo vidi che mi fissava ossessivamente, con quel suo strano, smisurato sguardo da extraterrestre dei cartoon, e a quel punto davvero non sapevo più cosa fare né cosa inventarmi, dato che andarla a salutare e tentare di parlarci fingendo un rapporto meramente amichevole era a questo punto solo una forma di ipocrisia. E, d’altra parte, cosa dovevo fare, prenderla per il collo e dirgli in italiano corrente: guarda che sono un po’ di mesi che sono cotto di te, dunque fammi il favore di prendere una decisione: o diventi la mia ragazza o mi lasci definitivamente in pace? Era questa, naturalmente, la soluzione migliore non foss’altro perché “cosa fatta capo ha”, come disse quello che inventò la ghigliottina (o era quello che tagliò la testa al toro? in questo momento il dettaglio mi sfugge), ma – ahimè – “com’è terribile la 112 saggezza quando non è più di nessun aiuto per il saggio!” 34: per qualche senz’altro poco saggio motivo non ebbi la forza di metterla in atto, chissà perché, chissà, magari forse per puro, infantile e semplicissimo timore di apparire ridicolo. Nessuno di noi due aveva più quindici anni ormai, io in particolare, devo dire, ma nemmeno Elisabetta era più una ragazzina. Da quel pochissimo che potevo dedurre da quel quasi nulla che avevo potuto rimettere insieme sul suo conto, più che altro a partire dal suo curriculum lavorativo e scolastico, la mia a questo punto ormai meno diletta piuttosto che maledetta “lei” doveva avere come minimo ventisei anni (anche se a me sembrava che ne avesse diversi di più, senz’altro più di trenta: l’età precisa non gliela ho mai chiesta perché, come si dice, non si chiedono mai gli anni a una signora e nemmeno a una signorina, in specie se si ambisce a entrare nelle sue grazie) e a una certa età non ci dovrebbe essere bisogno di dichiarazioni d’amore o disamore esplicite, che fanno appunto più parte della Storia propriamente detta (in questo caso della Storia della Letteratura) piuttosto che delle nonstorie in cui si trovano effettivamente immersi gli esseri umani in carne e ossa, in specie se stiamo parlando di questo “secol tetro”, con tanto di “aer nefando” annesso (questo è ancora, naturalmente, Giacomo Leopardi, ancora dal canto “Alla sua donna”: buon vecchio Giacomino, quanta ragione avevi tu, che ti dicevano che era colpa della gobba: te lo dice uno che, lungi dall’aver la gobba, a vent’anni faceva il fotomodello e non stava meglio che te mentre facevi il conto alla rovescia sul letto di morte in attesa che la cosmica carrozza partisse per chi sa dove! (beh, comunque sia e dovunque ti abbia portato, starai meglio lì che in questo mondo e in quest’epoca), secol di cacca che a me, francamente, più che tetro, pare proprio bigio e grigio, e in cui – giustamente – tanto l’Amore quanto gli innamorati sono stati messi non molto cortesemente alla porta – e se e quando mai si provino a rientrare dalla finestra – vengono universalmente condannati e/o derisi come ingenui, immaturi, 34 Sofocle, “Edipo re”, nella traduzione non letterale usata da LuciferoRobert De Niro nel film “Ascensore per l’inferno”. 113 anacronistici, inopportuni, infantili, inutili, superati rottami della storia, e chi più ne ha più ne metta. Così, non volendo riprendere un rapporto (rapporto? era stato quello un “rapporto”? mah…) che, oramai, lo sapevo, non avrebbe portato altro che nove illusioni e novelle delusioni, dato che Elisabetta già per due volte si era avvicinata per poi spaventarsi e allontanarsi precipitosamente (o allontanarsi prima e spaventarsi poi? ora come ora non saprei proprio dirlo, mi sento confuso, sprofondato come sono in una di quelle situazioni di dubbio e perplessità in cui non si sa bene se sterminare la famiglia prima e buttarsi dalla finestra poi, o se buttarsi dalla finestra prima e sterminare la famiglia poi (comunque sia, come già sapete, io vivo da solo, e, in effetti, l’unico dubbio possibile che mi resta è quello se buttarmi o meno)), dunque, stavo dicendo che… boh, non mi ricordo proprio più. 49. Beh, qualsiasi cosa volessi dire prima, fatto sta che dopo qualche tormentato giorno di sempre più amletica indecisione, mi resi conto che quel punto tornare indietro era impossibile (“Ormai è tardi! Non si torna!”, come giustamente e disperatamente grida il Blasco nazionale nella nota e omonima canzone) e mi risolsi infine a continuare a ignorarla. E le cose andarono bene, o bene sembrarono andare, almeno per un paio di volte, dato che riuscii nella in quel momento eroica non meno che ardua impresa di evitare con la mia ingrata amata insino un incrociarsi fuggevole di sguardi (io so che quanto sto scrivendo corrisponde in tutto e per tutto alla piena o vuota verità dei fatti realmente o irrealmente o surrealmente accaduti, fate voi, anche se, nel mentre ne scrivo o li ascrivo, vi inscrivo o li descrivo mi sembra niente di meno che di star contando balle: possibile che sia accaduto nel mondo reale, o addirittura al Boschetto, che una sconosciuta, all’apparenza del tutto sana di mente, si sia appiccicata a uno sconosciuto, forse non del tutto sano di mente, con lo scopo di ottenere da lui un bel niente di niente? eppure è così, Elisabetta non voleva amicizia, non voleva amore, non 114 voleva uscire, non voleva star lì, forse voleva solo che questo suo disgraziato spasimante continuasse a spasimare senza che da tutti questi spasmi uscisse fuori un qualsivoglia contatto decentemente reale che potesse in qualsivoglia modo minacciare il suo fidanzamento dei miei maroni (provo comunque sia a consolarmi, come fece Montale, ripetendomi sconsolato che “resta che qualcosa è accaduto, forse un niente, che è tutto”35 (scolio: “un niente” che è anche tutto quel che resta?))). E’ solo che, a dispetto della mia quasi fanatica circospezione, una stronzissima sera, nel bel mezzo di un tango qualsiasi, quando con una certa tranquillità stavo ballando con un’altra ballerina, ovvero con Chicchessia e non mai e mai più con Ella d’Essa, Ignacio Elizari, il nostro maestro argentino d’Argentina, in pratica mi obbligò a fare un cambio di coppia e a ballare con lei. Il lettore non pensi che il mio maestro fosse, come forse può apparire, un sadico tormentatore di cuori e c… già abbondantemente spezzati e infranti. Anzi, il vecchio Ignacio era un buon amico che probabilmente si era accorto che fra me ed Elisabetta era successo qualcosa: avevamo ballato insieme per quasi due mesi, e ora era da un bel po’ che ci evitavamo, e il maestro doveva averlo senz’altro notato, complici anche gli oramai smisurati non meno che disperati sguardi della ragazza che traversavano la sala in mia direzione silenziosi e discreti come missili da crociera. Forse, in buona fede, il mio maestro sperava di rimettere insieme una coppia separata da qualche più o meno banale incomprensione; forse pensava che fosse il mio stupido orgoglio di maschio ferito a impedirmi di ballare ancora con Elisabetta, o forse no, forse no, forse fu un caso, o, chissà, semplice e banale ordinaria amministrazione: in effetti Ignacio aveva sempre avuto cura che tutti ballassero con tutti, che non si creassero coppie fisse, dato che questo è un fatto assolutamente controindicato per apprendere bene il tango, onde ragion per cui, a volte, usava la sua peraltro molto dolce autorità di maestro per formare a suo genio coppie che il caso o il reciproco imbarazzo ostacolassero regolarmente. Sta di fatto che, dopo quasi due mesi di astinenza, mi trovai di nuovo fra le braccia la ballerina 35 E. Montale, da “Satura”. 115 dei miei sogni, e questa volta dovetti fare uno sforzo non solo e non tanto per trattenere il mio slancio erotico, quanto l’astio, l’imbarazzo, i rimpianti, i rancori nonché la pura, semplice e perfetta disperazione. Negli intervalli fra un tango e l’altro, quando le coppie momentaneamente si slacciano e si ha qualche momento di tempo per parlare, scambiarsi qualche convenevole o qualche impressione di ballo, mi sforzavo di fare l’indifferente e di parlare esclusivamente di tango: di cosa ci era riuscito, di quello che avevamo sbagliato, e via così, mentre Elisabetta per parte sua continuava a fissarmi con la sua aria incredibilmente incredula e dolorosamente addolorata, non meno che, naturalmente, sgomenta, sconfortata e implorante, mentre che io intanto continuavo sotterraneamente a desiderare di prenderla per il collo e sbatterle la testa contro una delle due colonne che stavano e ancora stanno al centro della sala: non per farle male intendiamoci, assolutamente no, ma solo per controllare se per caso il materiale con cui era costituita la sua materia grigia fosse grezzo e solido granito oppure puro e semplice cemento armato. Ma – ahimè – le circostanze mi costrinsero a trattenere la curiosità, e così al momento del successivo cambio di coppia le detti addirittura un bacio sulla guancia, quasi a voler sottolineare di nuovo che fra me e lei nulla era cambiato, che tutto quel tempo in cui a malapena ci eravamo salutati era stato solo frutto del caso, che in realtà io e lei non eravamo mai stati altro che amici, etc. Ma, naturalmente, al di là dell’atroce insignificanza di quelle poche, ipocrite, falsissime parole, quei due o tre estenuanti tanghi in cui sudando le celebri sette camice di Ercole (o erano canottiere? ora come ora il dettaglio mi sfugge) avevo fatto finta di nulla non avevano fatto altro che rafforzare la mia già granitica decisione di evitare a tutti i costi quella strana ragazza che, da possibile Grande Amore, minacciava di trasformarsi in un vero e proprio cataclisma (sta scritto nel Libro dei Proverbi “Vi sono tre vie troppo meravigliose, anzi quattro che non capisco, quella dell’aquila nell’aria, quella del serpente sulla roccia, quella della nave sul mare e quella dell’uomo verso una giovane donna”: per piacere, qualcuno me ne può prestare una quinta? perché io le prime tre non le ho a disposizione e la quarta mi è venuta proprio a noia). Quella sera, nonostante sonniferi e whisky in abbondanza, i 116 più fondi e lugubri rimbombi del più dissennato rancore e i violini più acuti e stridenti della più dissonante e straziante delle malinconie mi impedirono di prender sonno fino a notte inoltrata. Al mattino ero conciato talmente male che al lavoro qualcuno dovette scambiarmi per una controfigura uscita fuori da certe poco simpatiche riprese de “La notte di morti viventi”. 50. Pure, per quanto piuttosto abbattuto e stupefatto dell’insistenza d’Ella d’Essa, che, proprio come la vita umana, non pareva avere altro scopo che sé stessa, non volli però scoraggiarmi a causa di tanto incidente e pensai che fosse cosa buona e giusta non demordere dalla mia causa. Alla fine, mi ripetevo, quello strano fumetto dell’orrore in cui ero andato a cacciarmi sarebbe finito, come finite erano infine altre circostanze passate, ancora peggiori di questa (in effetti, nella vita si può stare solo meglio, non mai bene: e si può sempre stare meglio sol perché, grazie a Dio, al peggio non c’è fine (d’altronde, lo dice anche Shakespeare in un celebre passaggio del “Re Lear”: “Il peggio non è peggio finché ancora si può dire «Questo è il peggio»”; e se lo dice Shakespeare, no, voglio dire…). Ripresi così di nuovo a evitare quegli ex momenti magici che oramai si erano trasformati in brutti incontri con la chirurgica accuratezza con cui si suppone che un chirurgo eviti di farsi scivolare il bisturi nella patta, artificiosa e faticosa strategia questa, che ovviamente mi causava ogni sorta di impacci, di fastidi, di imbarazzi anche con altre persone che con questa piuttosto surreale situazione non c’entravano nulla e che perciò si chiedevano come mai mi comportassi in modo tanto strano, ma tant’è, comunque sia tenevo duro, a qualsiasi costo, sperando infine di aver la meglio sulla perseverante persecuzione della ex sconosciuta, che continuava a guardarmi fissa con quei suoi incredibili fanali di venusiana civetta – che mi spingevano a silenziosamente esclamare “Tormentose faville che nel mio seno ardete, non più crescete il foco, ch’a sì gran fiamma un picciol core è 117 poco!”36 – e quella non meno incredibile aria mestamente interrogativa che sembrava domandarmi ininterrottamente “ma che cosa ho fatto di male, perché mi stai evitando, che cosa è successo fra di noi?” (che cosa è successo? – avrei voluto risponderle io impugnando un manganello – è successo che mi sono innamorato di te come un vero coglione e che tu a furia di andare e venire senza costrutto, a furia di spaventi senza senso mi stai rovinando il sistema nervoso, ecco che cosa sta succedendo! (è in casi come questi che viene fuori in modo chiaro l’abisso che divide il mondo maschile da quello femminile, dato che un uomo, al cospetto di un similare comportamento si domanda inesorabilmente: ma perché tutta questa fatica per avvicinarsi, se poi si deve allontanare? al che la donna, se potesse, risponderebbe: ma se non riesco prima ad avvicinarmi, come faccio poi ad allontanarmi (e viceversa)?). Per colmo di sfortuna, a dispetto di ogni mia cautela in proposito, una volta al momento del cambio di coppie ci trovammo accanto in un punto in cui la sala era praticamente deserta, e io, forse convinto di aver almeno in parte smaltito i miei travagli d’amore, non volli compiere l’unico gesto davvero sensato, ovvero scansarla ancora una volta, in modo clamoroso e insultante, tale da sconfiggere in modo definitivo la di lei offensiva riconciliatoria. Non so bene perché non lo feci. Chissà, forse tutto fu a causa della dannatissima educazione nobil-romanticon-suicidale a cui sono stato piuttosto e ad ogni costo sottoposto, e che mi ha incul(c)ato, per esempio, che le donne non si picchiano nemmeno con un fiore – proposizione questa che ha sempre trovato il mio consenso, non foss’altro riguardo alla manifesta inefficacia dello strumento – che alle dame il cavaliere deve sempre e comunque cedere il posto, pagare il ristorante, offrire il braccio – anche se quest’ultimo magari solo in prestito – non lo so, non ne sarò mai certo, anche se mi sento di avanzare la non troppo peregrina ipotesi che la spina e la spinta decisiva a compiere tale atto evidentemente autolesivo furono probabilmente le residue braci dell’ancora non sopito incendio che aveva devastato i miei giorni e le 36 Così grida Acrimante ne “L’empio punito”, dramma per musica di Filippo Acciauoli. 118 mie notti, riducendo praticamente in cenere il mio povero cuore sedotto e abbandonato. Resta il fatto che non solo gentilmente le sorrisi e ballai con lei, ma ballando volli tentare di tentarla, sperando per l’ultima volta di infiammarla con quella stessa passione che lei aveva scatenato in me con i suoi abbracci incantati e la goffa e portentosa levità del suo passo milonguero: così la strinsi più appassionatamente che potei, appoggiai la sua fronte alla mia guancia e ballai i tanghi più languidi e struggenti che forse mai mi capiterà di ballare in vita mia (lungo momento di pausa…). Non so quali effetti provocò in Elisabetta la mia prestazione, quali pensieri e sentimenti giunsi a suscitarle, se riuscii almeno per un attimo a sciogliere quel cuore e, soprattutto, quella testa evidentemente più duri della pietra: quel che posso dire con sicurezza è che riuscii nella purtroppo non molto ardua impresa di commuovere ulteriormente Me Medesimo Stesso – così, tanto per rompere per una volta la promessa di non usare mai più questo orrendo soprannome che mi ero autoaffibbiato – e commuovermi ben oltre il fatidico limite della commozione cerebrale. Tanto ero sconvolto che, al momento in cui mi slacciai dalla sua tenera, ardente e fin quasi innominabile, insopportabile stretta, i miei palpiti ruggenti e struggenti, i miei laschi e loschi sguardi – da triglia surgelata prima e cotta a puntino poi – per un pelo non mi costarono un subitaneo e ignominioso svenimento nel bel mezzo della sala. 51. Sono passati circa sei mesi da quel momento a quello in cui scrivo queste righe (siamo nel dicembre 2007, se non ho perso del tutto la testa e con essa il senso insensato, il nonsenso del tempo), “e già molte lacrime ho pianto, già molte strade ho percorso vagando col pensiero”37 ma – ahimè – ancora sono qui a chiedermi, senza peraltro riuscire a trovare una risposta decente, che cosa esattamente ci 37 Ancora una volta si tratta di Sofocle , ancora una volta, naturalmente, da “L’Edipo re”. 119 trovassi in quella ragazza per arrivare sull’orlo della perdita dei sensi. A furia di pensarci sono forse riuscito a organizzare qualche straccio di un lacerto di un brandello di risposta, che, se non ha convinto me, probabilmente non convincerà nemmeno il lettore. Ma mi proverò ugualmente a esporla, nella speranza che possa gettare un po’ di luce su uno degli argomenti più ombrosi e spinosi con cui ha da intrattenersi l’umana esistenza – almeno nella misura in cui si abbia la tanto poco ragionevole quanto comunemente accettata intenzione di riprodurla (parafrasando S. Agostino, potremmo chiederci: perché cerco una donna? se non me lo domando, lo so; se me lo domando, non lo so (oppure, parafrasando Dio potremmo affermare: “Non è bene che l’uomo sia solo: dunque facciamo la donna, in modo che sia male accompagnato”)). L’amore umano, l’amore erotico in particolare, credo che possa essere dedicato a due tipi di oggetto che, pur somigliandosi esteriormente in modo del tutto caratteristico, possono però essere considerati anche molto diversi. Infatti nell’amante può insorgere un sentimento dedicato non a questa o a quella signora o signorina in particolare, ma bensì all’Idea Universale – e dunque alla Donna in Generale – e in questo caso può risultare persino molto facile per chiunque il chiarire che cosa ci trovi di bello in una donna particolare: sono certe ben definite caratteristiche universali dell’Idea che in quella particolare ipostasi si trovano meglio incarnate che in un’altra (dolcezza, pazienza, erotismo, capacità di cuocere a puntino bistecche e spaghetti, etc.). E, come subito si vede, il lato positivo di amare l’Idea è che sempre e comunque si potrà trovare un suo prezioso o amabile frammento più o meno in qualsiasi donna singola, specifica o particolare che dir si voglia. Sarà dunque piuttosto facile per un uomo incline a un tal genere di atteggiamento il passare da una donna all’altra senza sentire troppo la differenza, dato che per lui non conta quel che si trova di individuale e particolare in questa o quella donna, ma invece l’Idea che in ognuna di esse più o meno soddisfacentemente si manifesta o si incarna (c’è da dire però che vi sono dei maschi tanto affamati e rapaci a questo mondo che sarebbero capaci di vedere un qualche barlume dell’Idea Universale anche in un secchio della spazzatura contenente assorbenti femminili 120 usati, escrementi di qualsiasi origine e un cane morto in via di decomposizione, purché in tale contenitore si trovi da qualche parte una fessura di forma oblunga e dai bordi non troppo taglienti). Ma quando invece l’amore sia diretto verso l’Individuo, quando il Genere o l’Idea e le sue correnti ipostasi risultino del tutto o quasi del tutto indifferenti – e questo è precisamente il mio disgraziato caso – oltre a non essere per nulla facile passare da una donna all’altra – dato che ogni Individuo si definisce insondabilmente e indefinibilmente «tale» proprio in ciò che lo distingue da tutti gli Altri – risulta anche molto difficile spiegare al resto dell’umanità, come peraltro anche a sé stessi, le ragioni o cause del proprio Amore, dato che ragioni e cause si costituiscono per definizione proprio di categorie universali e universalmente comprensibili. Come scriveva Montale ad Irma Brandeis – che si apprestava a trasformarsi nell’alata e inafferrabile Clizia de “Le occasioni” – “tu conoscevi l’essenziale ma non i particolari, che sono tutto”. Ma la suddetta Irma-Clizia avrebbe potuto rispondere a Montale che – ahimè – era quella impresa bene più che ardua, dato che del particolare, come già argomentava l’antico ma non mai vecchio Aristotele, non si da definizione né discorso e dunque nemmeno conoscenza: il linguaggio ammette solo predicati universali e dunque solo permette la comprensione dell’Idea, che di tali predicati si adorna e in essi si specchia e vi risplende. Ne viene di conseguenza che chi si senta portato dalla Natura, o dal Fato o puramente e semplicemente dalla Sfiga, quest’ultima essendo una delle divinità più potenti, se non la più potente, fra gli Dei del Parnaso (e sappia il lettore che sopra gli Dei del Parnaso ci sono solo quelli della Parfronte!) ad amare Individui o donne singole che dir si voglia, percepite o più probabilmente allucinate come del tutto diverse da tutte le altre, ebbene, un tal sfortunato soggetto si troverà a disposizione espressioni ed esplicazioni che saremo inesorabilmente costretti a condannare come insipienti, banali, generiche – ovvero indefinite fino al punto di risultare, in sé e per sé, del tutto o quasi del tutto inespressive. Tali sarebbero frasi fatte, rifatte e strafatte quali, per esempio: “ma non vedi, è meravigliosa!” (si, ma che cosa è che la rende tanto meravigliosa?), oppure “è semplicemente fantastica” 121 (idem come sopra), ovvero tutta una collezione di luoghi comuni che si riducono infine, come direbbe il Wittgenstein delle “Ricerche Filosofiche”, a una sorta di vano gesticolare con il linguaggio. Un atto semanticamente vuoto e gnoseologicamente disperato, che altro risultato non consegue che il sottolineare in modo sol leggermente diverso dal tono della voce e l’arrossare della gota l’enfasi con cui il nostro cuore riguarda quel particolare essere umano, che non possiede o non sembra possedere altrimenti alcuna qualità universalmente definibile e percepibile come veramente esaltante se non, appunto, quella di riuscire, in qualche modo non facilmente esprimibile, ad esaltare noi (scriveva Bataille che “Sembra all’amante che solo l’essere amato – legato a corrispondenze difficilmente definibili, in cui la possibilità di unione sessuale si aggiunge all’unione dei cuori – possa, in questo mondo, attuare ciò che i nostri limiti proibiscono, la piena fusione di due esseri individuali (…) l’essere amato equivale per l’amante, e senza dubbio solo per l’amante (ma cosa importa questa limitazione?) alla verità dell’essere”: naturalmente, mi permetto di aggiungere, questa nostra privata non meno che mistica esperienza della “verità dell’essere” non impedisce, che so, al migliore amico di considerare la nostra esaltazione alla stregua delle visioni prodotte da LSD e altri similari farmaci dell’ottimismo, dato che lui la nostra amata non saprebbe distinguerla, che so, da un contenitore per la raccolta di pile usate, o da una chiosco per la rivendita di cocktail vegetariani in disuso, e cose del genere (in effetti, non tutti sono fortunati come Dante, che di Beatrice poté scrivere “Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand’ella altrui saluta c’ogne bocca divien tremando muta e gli occhi non ardiscon di guardare. Ella s’en va, sentendosi laudare..” più o meno come succedeva a Eloisa, che del buon vecchio Abelardo poté scrivere “Ciò che fu sempre illusione per le altre donne, fu una verità certa per me. Quelle qualità che solo le spose vedono nei loro mariti, in te, invece, non le vidi solo io; il mondo intero non credette di vederle, ma ne fu sicuro. Così, il mio amore per te è tanto più vero quanto più è lontano dall’illusione.”38)). 38 P. Abelardo, “Lettere di Abelardo e di Eloisa”, lettera seconda, di Eloisa 122 52. Questa dialettica fra universale e particolare, come molti sanno, fa parte, oltre che delle più o meno moderne storie d’amore che si ricordino, anche della storia della filosofia in senso proprio, e già da un paio di millenni e mezzo, ovvero da quando Socrate scoprì la dialettica fra il concetto e l’individuo che cade sotto quel concetto, una dialettica che, qualunque parte si prenda, finisce sempre per scivolare più o meno insensibilmente nel suo opposto, e dunque non concede a nessuno una vera via d’uscita. Pascal scrisse in proposito che “quando si vuol dimostrare una tesi generale, conviene di darne la regola particolare di un caso; ma se invece si vuol dimostrare una tesi particolare, converrà cominciare dalla regola generale… perché, quando si propone una cosa da dimostrare, si parte sempre dal presupposto che essa sia oscura, e che, al contrario, quella che deve dimostrarla sia chiara”. Ebbene, io penso che l’innamorato sia qualcuno che considera chiaro il (suo) caso particolare, ovvero gli pare del tutto ovvio che la sua adorata sia adorabile, e poco o nulla vede, non diciamo di adorabile, ma anche solo di apprezzabile nelle altre (tanto per fare un esempio, l’amica che Elisabetta aveva intenzione di presentarmi al suo ritorno da Torino l’avrei gettata in quel momento tranquillamente fra le fiamme in cambio di un suo bacio, di una sua carezza, o anche solo di un suo tango). Elisabetta era dunque per me in quel momento unica, irripetibile, insostituibile, una sorta di dea incarnata si direbbe, ma “come amare il corpo e l’anima se non per quelle doti, che tuttavia non costituiscono l’io (cioè l’individuo N.d.A.), perché sono caduche? Si può forse amare l’anima di una persona in astratto, indipendentemente dalle sue qualità? Non si può, e sarebbe ingiusto. Non si ama dunque mai una persona, ma le sue qualità.”. Stando così le cose, come ancora una volta sottolinea il buon vecchio Blaise, a quale mai definizione potrò io ricorrere per squadernare agli occhi ad Abelardo. 123 stupiti e sgomenti del lettore, che la mia adorata Elisabetta non mai l’ha vista nemmen per un volatile istante, i singolarissimi e perciò del tutto o quasi del tutto indefinibili, incomunicabili incanti ch’ella o Ella d’Essa che dir si voglia mi offriva o sembrava offrirmi, anche se solo per sottrarmeli da sotto il naso non appena mi provassi a dargli un’occhiata più da vicino? A volte ci penso anche molto a lungo, vago a tentoni in ogni meandro, labirinto e abisso del pensiero, ma ciò che mi torna sempre, continuamente, inesorabilmente e dolorosamente in mente, è la portentosa, stranissima gestualità di questa mai avuta e ormai perduta dea dei sensi: le sue movenze insieme passionali ed eleganti, lievi e soavemente goffe, che nello straziante farsi e disfarsi dell’abbraccio e della melodia del tango si mischiavano in modo inestricabile con quello che potrei definire la sua vibrazione tattile, una qualità che solo nell’abbraccio del tango si può scoprire (e, mi si creda, anche solo per questo conviene provarlo, perché altrimenti a certi segreti aspetti dell’essere umano di cui questa misteriosa danza concede le misteriose chiavi non si può avere accesso, nemmeno facendoci l’amore). Come accade con l’odore, o con le impronte digitali, ogni individuo possiede, appunto, la sua vibrazione tattile, unica e irripetibile, e dunque ogni ballerino si sentirà stretto e seguito da ogni ballerina in modo simile epperò inesorabilmente diverso: in modo diverso si poserà la di lei mano sul suo collo, in modo diverso la di lei destra si stringerà alla di lui sinistra, in modo diverso il suo petto si appoggerà al tuo petto: con battito inimitabile palpiterà il suo cuore, in modo inesprimibile si sfumerà di pallori o rossori la sua gota, con moti ineffabili si stringerà o prenderà altro spazio, ancora, nell’abbraccio (l’abbraccio del tango varia di molto a seconda delle figure che si intende eseguire, e perciò, durante la coreografia, si creerà un ritmo di vicinanze e lontananze dall’andamento enigmaticamente diverso per ogni coppia). E come dimenticare il fatto che anche la ricezione che può avere il ballerino delle singolari caratteristiche della dama è diversa, a seconda del singolare carattere e delle singolari caratteristiche del ballerino? Ciò che per l’uno rappresenta una qualità, per l’altro rappresenta un difetto, ciò che esalta l’uno lascia del tutto 124 indifferente l’altro, dato che, come già si erano accorti i babilonesi circa 4000-4500 anni fa, “Ciò che piace all’uno è sgradevole all’altro”: invano si discuterà su istinto, sensibilità, sensualità e bravura di questa o di quella, perché colui che preferisca una compagna che guidar si faccia con minima pressione, male sopporterà colei che preferisce o addirittura pretenda una guida decisa; colui che apprezzi il volo di prontezza male sopporterà colei che dalla lentezza e dalle pause della musica si lasci ognor tentare, stante il fatto che quello che potremmo chiamare il sentimento del tempo è decisivo per il livello e la profondità dell’intesa nella coppia, oltre che per l’interpretazione della musica. 53. Dunque la vibrazione tattile di Elisabetta, la sua singolarità in relazione alla mia, come posso a beneficio del lettore, e, soprattutto, di me stesso definirla? Potrei farlo in mille modi, ma quello che più subitaneamente si impone alla mente è che Elisabetta, non so come facesse, fin dal primo tango che ballammo insieme, sempre e comunque si trovava dove volevo si trovasse, si muoveva sempre come volevo si muovesse, e ad ogni mia “marca” (la “marca” sarebbe il modo con cui il ballerino segnala alla ballerina il passo che intende fare, non l’etichetta stampata sul reggiseno avidamente spiato durante una pausa particolarmente lunga e significativa della danza) rispondeva sempre con il tempo e con il modo che desideravo e che mi aspettavo. Così che, pur essendo un miserabile principiante, almeno in quel genere di ballo (in effetti, in passato mi ero avventurato anche in altri generi, e, per esempio, nell’hip hop ero in quel momento un ex quasi-professionista), ballando con lei non sbagliavo praticamente mai, nemmeno nei passaggi più difficili: il suo corpo mi pareva fatto di pura e semplice ricettività, di pura e semplice passione di essere dove io volevo che fosse, di fare ciò che io volevo che facesse (mamma mia, ancora in questo momento per poco non mi svengo al pensiero di cotanta sensuale, corporea eppure quasi incorporea, eterea intesa!). 125 A questa sorta di armonia prestabilita fra quello che abbiamo sopra definito come il nostro “sentimento del tempo”, Elisabetta aggiungeva la magica morbidezza delle sue strette, dei moti della sua mano sul mio collo e lungo il braccio – che mi parevano sempre e soltanto dolcissime, romantiche carezze – che miste con il suo odore vago, dolce e insieme aspro e penetrante (“oh, gorgo di ginepro albeggiante del tuo fiato, oh altera e perduta giraffa del tuo collo, in quale silenzio, in quale antro di giada sei svanita?”39), andavano a formare infine una sorta di pozione magica che, tango dopo tango, mi ha posto ai suoi piedi in catene come un vero e proprio schiavo (fatto strano questo, visto che nel tango l’uomo guida la donna praticamente in ogni frangente, e dunque, almeno in teoria, dovrebbe essere la donna a sentirsi una schiava: ma, con ogni evidenza, vi sono delle schiave capaci di trasformare la loro tenera obbedienza nel più duro degli ordini). E fu così che fatalmente, dopo che tango dopo tango l’ebbi tattilmente conosciuta, la sua gestualità prese anche visivamente a incantarmi in ogni per quanto quotidiano e banale frangente, non solo più durante la danza: il modo in cui anche solo e semplicemente stava in piedi o si voltava, quello in cui teneva la sigaretta tesa o appesa fra le dita, quello in cui tanto enigmaticamente sorrideva mi paiono a tutt’oggi semplicemente meravigliosi (esempio di fase fatta, rifatta e strafatta di cui sopra: ma mi consola pensare che Bataille sostiene senza tema che “anche se si sceglie una donna che la maggior parte degli uomini avrebbe scelto, ciò che interviene è spesso un elemento inafferrabile, non già una qualità oggettiva di quella donna che, se non fosse stata in grado di toccare il nostro essere interiore, non avrebbe avuto la nostra preferenza”). Prendendo appunti per questo racconto avevo scritto da qualche parte – cito testuale – che “persino il suo modo di vestire un po’ banale e trasandato mi pareva, in contrappunto alla prodigiosa eleganza delle sue movenze, qualcosa di splendido”. Un fatto talmente strano questo, talmente inconsueta questa contrapposizione estetica ci appare, che conviene forse di approfondirla un po’, sperando con ciò 39 Beh, in questo caso la nota serve per avvertire il lettore che l’identità del poeta in questione è quella stessa dell’autore che lo cita: così, tanto per dargli l’avviso di quanto lo aspetta nell’appendice in fondo a questo libro. 126 di chiarire almeno in parte gli sconcertanti meccanismi e le insolite alchimie di quel mistero nazional-popolare che, senza por molta riflessione sul merito e sul metodo, si chiama di solito “amore”, con la minuscola, o, se si è dei devoti dell’argomento “Amore” con la maiuscola. 54. La prima volta che l’ho vista Elisabetta (stavo per scrivere “Beatrice”, pensate un po’…) indossava jeans e camicetta, e in questo laico, sconsacrato e insino un po’ trasandato costume l’avrei vista agghindata il novantanove percento delle volte che avrei avuto la grazia e/o la disgrazia di rivederla. Una divisa, come fin da subito si arguisce, del tutto comune e ordinaria e, in aggiunta a ciò, non molto adatta per il tango, dato che la vera tanguera dovrebbe sempre sfoggiare vestiti molto più sensuali, rapaci, notturni: di raso o simil raso, caratterizzati da spacchi e scollature profondi come quel mare di sensi che il tango instancabilmente muove agli adirati e vorticanti nembi di tempesta o ai vaghi, estenuanti e languidi dondolii della risacca. E, visto che di mare e marinai ognor si tratta (eh si, nel caso del tango vale proprio quel che disse Pompeo Magno “Navigare necesse est, vivere non necesse”), di vele si abbisogna, fatte di veli lievi, dai colori sempre molto forti, in particolare il nero e il rosso (che simboleggerebbero Amore e Morte), o, al limite, il viola e l’azzurro (che starebbero invece per Fiorentina e Forza Italia). Ma, comunque sia, Elisabetta, che in opposizione a tali tassative esigenze estetiche ed estatiche del tango compariva sistematicamente in jeans e camicetta, non stava in questo modo affatto male, anche se a volte giocavo a immaginare il suo corpo soave, fine e fin quasi spirituale – tanto mi pareva in specie danzando assomigliarsi alla quintessenziale impalpabilità dell’anima – adornato in modo più consono a tali sensuali e sensitive circostanze. E, ovviamente, mi sembrava che così come da me immaginata potesse essere molto più bella e ancora più seducente. 127 Per intendersi, Elisabetta è il tipo della ragazza piuttosto esile, con il seno piccolo, però dotata, diciamo così, di un sedere assai ben disegnato, di quelli un po’ corti, che hanno perciò la delicata tendenza ad allargarsi in modo più pronunciato vicino all’attaccatura delle cosce; anche le gambe sono belle, lunghe, ben tornite, pur se molto leggermente a ics e con i polpacci un po’ troppo fini. Se la immagino con una blusina giropetto, possibilmente di raso o simil raso, possibilmente nera e piuttosto bassa e con spalline molto fini, accompagnata da una gonna lunga, oppure, meglio ancora, da un paio di pantaloni in stile arabo – stretti in vita e ai glù-glù-glutei, svolazzanti sotto il ginocchio e allacciati intorno alle caviglie – che ne valorizzino l’armonioso didietro e nascondano tanto la leggera ics delle gambe quanto i polpacci un po’ troppo fini, ecco che Elisabetta diventa una ragazza veramente discreta. Se poi aggiungessimo infine, quale ciliegina sulla torta, un qualche velo al posto giusto, ovvero quel tantalizzante effetto “vedo non vedo” che tante fiamme scatena in cuori che altro non chiedono che di potersi infiammare – beh, messa così Elisabetta risulterebbe allora veramente un bel pezzo di figliola, e degna forse di orbitare in quello stesso cielo della modella menzionata nelle prime pagine di questa stessa non-storia. Anzi, a pensarci bene, il fatto che prima di innamorarmi di lei la giudicassi addirittura “un po’ bruttina” dipendeva probabilmente in massima parte dal fatto che quel suo modo di vestire un po’ rustico e banale tendeva ad annacquare la sua bellezza e a mimetizzare la sua grazia e la sua femminilità (ai jeans e alla camicetta – a volte scelti con gusto, ma che a volte, strano a dirsi, stante la giovane età, la facevano sembrare quasi una vecchina – si aggiungevano di solito un paio di scarponi talmente pesanti e ineleganti che avrebbero trasformato la lieve passeggiata di Claudia Schiffer sulla passerella in un bombardamento a tappeto: è una fortuna che per ballare il tango Elisabetta fosse costretta a indossare scarpe adatte). 128 55. Un giorno la mia adorata, quasi indovinando i miei pensieri (questo è un modo di esprimersi ironico ovviamente), decise infine di smettere il suo consueto abbigliamento casual e di cambiare radicalmente immagine. Solo che, lungi dal mostrarsi a me in tutto il suo splendore, riuscì al contrario a mettere insieme una mise il cui avvilente cattivo gusto poteva rivaleggiare soltanto con il modo quasi sadico in cui riusciva a svalutare le sue fatali e raffinate forme. Quella volta che lasciò nell’armadio gli usuali jeans e camicetta, non trovò di meglio o di peggio che mettersi un paio di pantaloni neri – e il colore era giusto, questo bisogna riconoscerlo – solo che, contrariamente alle esigenze del tango, il tessuto era pesante e peloso, con tanto di rovescia e riga, particolare quest’ultimo che conseguiva il disastroso effetto 1) di rovinare il delicato equilibrio formale del suo deretano, creando addirittura nell’ignaro spettatore l’illusione ottica che si trattasse di uno di quelli un po’ sfatti o, come a volte si dice, “a pera”, 2) di esagerare la leggera e fin quasi raffinata x delle sue gambe fino a farle parere addirittura un po’ storte, e infine 3) anche a sottolineare in modo ingiusto e indecoroso la sottigliezza dei polpacci. A tali spropositati pantaloni la mia amata ebbe poi cura di aggiungere un non meno improbabile maglione verde pisello – colore questo che sta all’atmosfera del tango come la sega a motore al negozio di manicure – per di più, di nuovo, di una lana irsuta e pesante come un Giuliano Ferrara spettinato e con le tasche riempite di sassi (chi è Ferrara? è uno di quelli che quando Steve Jobs disse “Stay hungry!” non colse il senso metaforico del detto). Per sovrappiù, a perfezionare l’opera di autodemolizione, sopra un tale piuttosto incredibile maglione la mia dolce Tersicore ebbe infine il lampo di genio di sovrapporre l’unico pezzo intonato all’occasione, un velo nero che però, sopra l’orrendo maglione verde pisello e i quasi surreali pantaloni pelosi con la riga e la rovescia, non faceva altro che sottolineare lo spaesante non meno che raccapricciante cattivo gusto di tutto il resto del corredo: così malconcia pareva in tale acconciatura o sconciatura che dir si voglia 129 che al momento in cui la vidi entrare in sala per poco non mi uscì un grido di spavento. Beh, che dire di più? A dispetto dell’agghiacciante inestetismo della sua vestita immagine, l’inebriante flessuosità dei suoi passi, l’ubriacante insidia dei suoi giri, il tenero incanto del suo abbraccio, la vaporosa e quasi irreale dolcezza che scaturiva da ogni pur minimo suo gesto ancora una volta prevalsero su ogni terrena pesantezza, innalzandosi sui catastrofici ritrovati del suo abbigliamento come uno malinconico stormo di rondini migranti sulle rovine di una città devastata e in fiamme: come in quadro di Caravaggio, la divina luminosità dei suoi gesti veniva esaltata dall’ombra inquietante che si allungava minacciosa dalla tetragona ineleganza dei suoi indumenti; come nel Giudizio Universale di Michelangelo l’armoniosa beatitudine delle sue movenze era glorificata dalla dissonante perdizione degli inferi accozzamenti della sua divisa. Al termine della serata la contemplai insieme estasiato e sconvolto. Comicamente e agonicamente desiderai di non essermi mai innamorato di una creatura tanto improbabile, capace di passare da scarponi degni di un ciclope con l’hobby del trekking ai raffinatissimi tacchi a spillo del tango con la stessa naturalezza con cui era passata dal dialetto torinese a quello perugino abitando cinque anni in quel di Firenze: oh mio Dio, che senza incertezza esisti, quale segreto volesti rivelarmi tramite la catena con cui a cotanta creatura mi legasti, catena acerba come ortiche o rovi, o livida e aspra come lingua di capra, fatta di anelli ora ardenti ora gelidi come gli abissali gironi del tuo Inferno? Forse che nelle imperscrutabili profondità della Bellezza si fa Uno e Lo Stesso ogni contrasto? Che ogni per quanto strana creatura è sempre e comunque specchio enigmatico del Creatore, sia essa un cherubino intento all’arpa o un telegiornalista nel mentre che in nome della libertà di stampa lecca il deretano in diretta al primo ministro-proprietario della rete e dunque del TG (ogni riferimento alla storia italiana recente è puramente casuale)? E’ in frangenti come questi, credo, che gli uomini si chiedono perché Dio abbia creato il mondo: e, contemplando l’inconcepibile abbigliamento della mia amata, probabilmente se lo sarà chiesto anche Dio. 130 56. In effetti, non so se Dio o Chi per Lui abbiano le risposte alle domande di cui sopra, se è vero come è vero quel che si diceva dalle parti di Babilonia qualche migliaio di anni fa che “La volontà degli déi non può essere intesa, le vie divine non possono essere conosciute.”. Le mie sono quelle che già avete letto e così, in certo modo, anche udito. Se proprio devo fare uno sforzo che il segreto del misterico amore per Elisabetta possa in qualche modo disvelare, mi viene infine in mente che a cotale sconvolgente effetto estetico – ottenuto per mezzo dei più goffi e inusitati contrasti che si possano immaginare – si aggiungeva anche l’ovvio e schiacciante senso di tenerezza che un simile maldestro modo di abbigliarsi faceva sorgere nel mio cuore, che, già perdutamente innamorato, non aveva peraltro bisogno di alcun genere di incoraggiamento. Quasi mi pareva di vederla, mentre tormentata da ogni sorta di dubbio estetico la mia diletta pellegrinasse di negozio in negozio e ne perscrutasse ogni più nascosto meandro e inaccessibile recesso – ivi compreso il cesso – nell’ansiosa ricerca di un qualche capo adatto alla sua figura, finché infine, stregata da una sorta di Genio del Male della Moda, la sua sofferta e travagliosa scelta non cadesse inesorabilmente su un qualche capodopera in grado di rovinare l’aspetto a uno spaventapasseri. Oppure, ancora, con la mia immaginazione insieme febbrilmente sovreccitata e perdutamente commossa, la contemplavo mentre a casa svaligiava il suo guardaroba prima e cogitava ore e ore davanti allo specchio poi – finché non se ne usciva infine per strada con qualche asinino assemblaggio di capi di vestiario del genere di quelli che, probabilmente, ispirarono a Mary Shelley la stesura di “Frankenstein” e a Mel Brooks quella di “Frankenstein junior”, e che in ogni caso aveva spinto me a ripetere, sia pure a voce molto bassa, quello che il Wittgenstein nei “Pensieri diversi” ebbe a dire quanto alle sinfonie di Mahler: “ci è voluto davvero del talento per mettere insieme un tale orrore”! 131 La donna, di solito, usa spietatamente il proprio corpo e ciò che lo riveste come mortale arma di seduzione, come strumento per piegare ai suoi voleri – che nessuno ha mai capito bene quali siano – l’uomo infiammato dalle sue forme insieme tanto più assatananti quanto più eteree e inafferrabili: tutto il contrario della mia adorata tersicorea dunque, che mi appariva, al confronto di tali sordide adescatrici, luminosa, pura, ingenua e disarmata (vedremo fra breve quanto poco queste mie deliranti fantasie fossero aderenti a una forse ancor più delirante realtà)! Tanta era la premurosa dolcezza che la sua evidente inettitudine al glamour, allo charme e al branding mi ispirava che da quel momento in poi mi trovai, oltre che – come al solito – ad agognare di abbracciarla, stringerla, baciarla, sbottonarla e – ehm – e… così via, dicevo, anche a desiderare intensamente di proteggerla: dalle insidie del mondo in generale, naturalmente, e, più precisamente, dai disastrosi danni che il suo snaturato modo di concepire la moda poteva produrre alla sua tanto luminosa e fatata quanto delicatissima bellezza. E c’è al mondo pozione d’amore più efficace ed inevitabile di quella che spinge l’amante in un abisso insieme di sensi e tenerezze? Quale uomo potrà mai provare desiderio più potente di quello derivante dalla furia di possedere un corpo sommata alla premura di vegliare su un’anima? Un desiderio paragonabile potrebbe forse insorgere solo dall’incontro, plausibile come la congiunzione contemporanea di tutti i pianeti del Sistema Solare, con una fanciulla che unisse le fattezze di Pamela Anderson con il conto corrente di Paris Hilton, fatto questo che, in caso accadesse veramente, non preannuncerebbe senz’altro l’inizio di un Grande Amore, ma, più semplicemente, quello del Giudizio Universale (o magari quello di Berlusconi che, quando ci sarà, a Milano o dove che sia, si porterà nella catodica catastrofe senza meno l’universo tutto). 57. A quanto detto sopra posso forse aggiungere ancora un’altra ultima improbabile ma in fondo possibile ragione del mio Amore a prima 132 vista, che, giustappunto, a prima vista pare proprio del tutto folle, ovvero il fatto – tanto inquietante quanto, credo, piuttosto comune fra gli appassionati di filosofia – che dal giorno in cui sono nato in poi, ovvero fino a questo in cui scrivo queste scombinate note d’amor perduto e tango e, certamente o quasi, insino a quello della certa, temuta e sospirata morte, sempre e comunque mi sono sentito fuori posto a questo mondo, al punto che ho buone ragioni di temere che in questo stesso modo anche mi sentirò nell’Altro, che esso esista o meno. Dal dì del mio nascimento, simile al redivivo o redimorto Rousseau delle “Rêveries du promeneur solitaire” (almeno mi sembra) continuamente ho pensato di me stesso: “Tutto quello che mi è esterno ormai mi è straniero. In questo mondo non ho più prossimi, né simili, né fratelli. Sono sulla terra come in un pianeta straniero dove caddi dal pianeta dove abitavo”, frase che forse ha dato origine al romanzo preferito della mia adolescenza, che giust’appunto si intitola “L’uomo che cadde sulla terra”. Ovunque e sempre, per quanto la catena di specchi della memoria indietro mi riporti, mi ricordo di me stesso come di un intruso, estraneo a qualsiasi stanza o circostanza che mai gli fu dato di abitare. Così, una terra d’esilio sempre ho calcato coi miei da sempre stanchi piedi, ovunque e dovunque mi sia trovato, o ovunque e comunque mi trovi o mi perda, financo in quella casa mia (mia?), dove, naturalmente, vivo da solo, financo guardando quel tale che si fa la barba nello specchio, financo sprofondato nel mio (mio?) stesso corpo osservando mani straniere e lontane che un mondo straniero e lontano mi obbliga a definire mie prendere o lasciare cose viste o sognate, che dubito d’esser io a vedere o a sognare. Ovunque mi sia trovato o mi trovi la prima domanda è “ma che ci faccio qui?” (e dove è di preciso che si trova questo posto, quello che la gente chiama “qui”?) e il mio primo pensiero fu sempre e sempre resta quello del nomade che pensa che, se sono qui, è solo per andare là, ovvero altrove o Altrove che dir si voglia, a fare qualcosa o Qualcosa che non so dire, ma che comunque devo fare e che non è mai quella che sto facendo, in un altro tempo, in un altro spazio, lontano di certo da questo insensato e sperduto “qui ed ora” in cui mi trovo stretto e costretto senza perché, né quando. Come il Pessoa-Soares de “Il 133 libro dell’Inquietudine” sto nella vita come in un letto in cui, non trovando mai la posizione giusta, neppure riesco mai ad addormentarmi, pur se mi trovo ad aver sempre sonno così che “Non aspiro a nulla. Mi duole la vita. Sto male dove sto e sto già male dove penso di poter stare.”40. Dunque i miei luoghi “familiari” non mi dicono nulla, mi sembrano appartenere a un altro, gli stranieri che mi salutano e mi parlano, che so, dei “vecchi tempi”, mi sembrano delle persone di cattivo gusto in vena di fare scherzi da prete a uno che non è in vena di capirli (chi sono questi che si definiscono miei amici o, addirittura, miei parenti, da dove esce questo esercito di marionette che come da dietro il vetro di un acquario mi sfila innanzi osservandomi con irreali occhi dipinti? come oso definirmi un uomo, se da sempre “sono stato uguale agli altri senza somigliare a nessuno, fratello di tutti senza appartenere alla famiglia”? 41)). Pure, con tutto quello che sono o non sono, che sento e che non sento, quando ballavo con Elisabetta, con le sue mani sul collo, sul braccio, sul palmo, sulla schiena, con sul petto il tenue suo fremere di siderale farfalla, con le mie labbra inondate dall’abisso ineffabile del suo respiro, ecco che finalmente, sia pure solo per pochi miseri minuti, mi sentivo come per la prima volta entrando in un luogo familiare, ebbene si, come tornando a casa: esultavo pensando che il mio lungo viaggio era per finire, che la mia solitudine era stata quella di un fiume che scorreva per finalmente sfociare nell’oramai increduto mare aperto o, usando una delle celeberrime e mediterranee metafore di Montale “come uno scemato di memoria quando si risovviene del suo paese”. Comunque sia, al di là, come peraltro al di qua di ogni commovente e/o compromissoria immagine poetica, ancora una volta mi si può e ci si può, mi e ci si deve domandare: va bene, ma perché con lei si e con le altre no? Forse – e tento questa risposta come chi giocando d’azzardo abbia perso tutto e lanci un ultimo, elemosinato gettone sull’ultimissimo giro dell’implacabile roulette – fra le tante cose, il fatto che lei fosse un’interprete per sordomuti aveva qualcosa 40 41 F. Pessoa, “Il libro dell’Inquietudine”, paragrafo 180 F. Pessoa, “Il libro dell’Inquietudine”, paragrafo 430. 134 da vedere con i miei sentimenti (or mi sovviene che avevo avuto quest’informale informazione il mercoledì successivo al primo esplodere del mio innamoramento, poco prima che una seconda esplosione mi confermasse definitivamente, diciamo così, dello scoppio della guerra: e forse questo non fu un caso). I sordomuti, come lei stessa mi aveva fatto notare, sono persone che vivono in una sorta di dimensione parallela, persone che non hanno percezioni dello spazio, del tempo e dunque del mondo e delle usuali interazioni e sensazioni umane “normali”, ovvero paragonabili alle nostre (le barzellette nel linguaggio dei gesti, che causano fra di loro delle gran risate, sono completamente intraducibili nei nostri schemi comici usuali, ed è un fatto che le persone normali, comprese quelle che fanno da interpreti, non sono in grado di capirle nel loro senso emotivo, cioè di riderne): dunque, quelle persone, che in un certo senso sono proprio come noi, stanno lì, in mezzo a noi, ma la loro diversità percettiva li trasforma in dei quasi-estranei, in alieni che con sguardo interrogativo osservano i non molto comprensibili mutamenti del mondo intorno a loro (chissà che cosa prova un sordo quando vede le modificazioni nell’espressione del viso di uno che sente la musica, o i movimenti di qualcuno che balla). Anche se da sempre vivono accanto alle persone cosiddette “normali” non condividono – non possono condividere – il loro linguaggio con il nostro, le loro percezioni con le nostre, i loro gesti con i nostri: un sordo sarebbe dunque infine uno che sente o si sente come me, anche se, ovviamente, per ragioni ben diverse da quelle che da sempre mi costringono in questa strana condizione di “apolide dell’esistenza”, secondo la crudele non meno che credibile definizione che Massimo Fini ha appioppato all’umano troppo umano Friedrich Nietzsche. Dunque, stante ciò, può darsi che nel mio più o meno profondo inconscio possa aver pensato che Elisabetta, che di persone che vivono in una sorta di mondo parallelo si occupava da anni e anni, poteva essere per me, che ci vivo probabilmente fin dalla nascita, una sorta di compagna ideale (e, ahimè, senz’altro idealizzata!), un’amica della mia lontananza, un’interprete della mia perfino per me stesso enigmatica e così difficilmente dislocabile alterità, così stranamente simile a quella che il Pessoa-Soares canta melanconico nel passo 135 almeno per me più inquietante de “Il libro dell’Inquietudine”: “Sono qualcosa che è stato. Non mi trovo dove mi sento e se mi cerco, non so chi mi cerca. Un tedio per tutte le cose mi fa rammollire. Mi sento espulso dalla mia anima.”42 (Scolio: motivi di spazio e di decenza mi spingono qui così come mi spingeranno altrove a evitare di riferirmi in alcun modo al mio piuttosto tragicomico passato – più tragico che comico43, devo dire – di persona – appunto – “con un passato”, anche se, come scolio dello scolio, o, se proprio si vuole, come scolo dello scolo, posso aggiungere che il mio passato non riesco a distinguerlo da quello di tre o quattro stranieri esiliati e dispersi che, a parte il non potersi assolutamente né intendere né tantomeno sopportare fra di loro – oltre che, naturalmente, con nessun altro – hanno il comune solo il fatto che ai mefistofelici sottintesi di Macbeth, finalmente d’accordo su qualcosa risponderebbero in coro, con altero furore e dolente freddezza: “Io sono uno, signore, che i vili colpi e insulti del mondo hanno inasprito a tal punto che non m’importa cosa faccio in suo dispregio.”44 (beh, per fortuna però questo passato, comunque sia, ora come ora è davvero passato, talmente “passato” che, a dire il vero, non mi ricordo più nemmeno se devo chiamarlo prossimo, remoto o participio, o come o che altro, e l’unica traccia che in effetti mi ha lasciato è l’astratta nozione che il capo del detto che suona “muore giovane chi è caro agli dei” risulta più completo e convincente con l’aggiunta della doverosa coda “e chi gli è ancora più caro non nasce proprio”, (il giovane critico di alcune pagine fa mi ha accusato, fra l’altro, di rimanere troppo oscuro quanto “all’identità concreta, storica, dell’io narrante”, cosicché “questo personaggio, che è anche l’unico e il solo protagonista, rimane, oltre che senza nome, anche senza spessore alcuno: i suoi sentimenti non hanno sfondo e, dunque, nemmeno gli si può attribuire profondità alcuna”: a me, naturalmente, dispiace di deludere chiunque, e in particolare i giovani critici, ma, a parte le 42 F. Pessoa, “Il libro dell’Inquietudine”, paragrafo 180 A beneficio mio e del lettore ricordo che il comico è stato definito da Jean Genet come il tragico preso alle spalle, mentre invece il tragico è stato definito da me come il comico che lo prende nel culo. 44 W. Shakespeare, “Macbeth”, III; I. 136 43 presenti e pressanti ragioni di spazio, spero che basti a giustificare la mia scivolosa e quasi viscida discrezione quanto a quell’illustre sconosciuto che chiamo di solito “me stesso” il fatto che nel raccontarne le passate vicende di cui sopra la paura che insorge non è tanto quella che gli altri ridano, o non mi credano, ma piuttosto quella di non crederci, o di riderci io (beh, comunque una cosa l’ho già chiarita poco sopra: sono un appassionato di filosofia, anzi, un filosofo, o tale mi reputo, e questo, a ben vedere, può essere indizio non da poco per chi abbia la sia pur minima esperienza della forma piuttosto informe che possono assumere un certo tipo di esseri umani, talmente umani troppo umani da risultare infine alquanto spesso piuttosto disumani))))). 58. (a dir la verità, giunto ormai alla zona cesarini di questo piuttosto sragionato e stralunato ragionamento, mi torna in mente in extremis che la prima volta che vidi Elisabetta, guarda un po’, fu proprio nel momento in cui entrava nella sala del Boschetto: aprendo la porta fece un attimo di sosta, si guardò timidamente intorno e, come incrociammo gli sguardi, le sorrisi e mi sorrise, con quel suo sorriso luminoso, tenue ed insieme accecante, rimanendo come per un attimo perfettamente incorniciata nella porta, e diventando perciò molto simile a uno di quei ritratti per intero che andavano di moda nel ‘600, almeno credo, o mi pare, se non mi ricordo male e – beh – come che sia, potrebbe essere proprio questa una delle piuttosto irragionevoli “ragioni” che hanno scatenato il mio delirio amoroso, se è vero quel che dice Roland Barthes a proposito del celebre caso letterario scatenato da Goethe “Scendendo dalla vettura, Werther vede per la prima volta Carlotta (di cui s’innamora), incorniciata nella porta di casa sua (lei sta tagliando delle fette di pane ai bambini: celebre scena, spesso commentata: per prima cosa noi amiamo un quadro. Giacché il colpo di fulmine del segno vive della sua subitaneità (che mi rende irresponsabile, sottoposto alla fatalità, travolto, rapito): e fra tutte le combinazioni di oggetti quello che 137 sembra vedersi meglio la prima volta è il quadro: improvvisamente si apre un sipario: ciò che non era stato ancora mai visto viene scoperto per intero, e da quel momento divorato con gli occhi: l’immediato vale per il tutto; io sono iniziato: il quadro consacra l’oggetto che io amerò.”. (scolio: ma che significa quel che dice Barthes, che, ammesso che abbia ragione, vi sono dei casi in cui è la cornice a dipingere il quadro, ovvero, in altre parole, che nella misura in cui un essere umano si trova inquadrato in una cornice diventa un quadro, diventa oggetto di contemplazione, diventa bello?)) 59. (come ultimo commento prima di affogare, mi viene in mente che il mio caso particolare possa essere un esempio particolare di un fenomeno invece abbastanza diffuso, quello della ribellione della Natura alla Tecnica, dell’Uomo Antiquato contro l’Uomo Adeguato, del Prometeo in Catene contro lo scatenato Prometeo Tecnologico in grazia del quale tutto nella vita è profeticamente, prometeicamente previsto (Prometeo infatti significa in greco “colui che vede avanti”, ovvero colui che conosce, anticipa in sé il futuro), che evade continuamente dal presente verso un domani ove tutto è calcolato, misurato, commisurato, depurato, addomesticato: un ignoto e onnipotente burocrate da qualche sconosciuto ufficio nascosto in un kafkiano castello situato a Bruxelles (dov’è?) può impedirmi di fare le mozzarelle di bufala a Roma, la pizza alla napoletana a Napoli, la rivendita di vino e trippa per le strade di Firenze, che senza vino e trippa non sembrano più strade di Firenze: ma nemmeno tutti i comitati, i collegi, le commissioni, le sottocommissioni, le segreterie, gli uffici, i ministeri, i clisteri e i dicasteri e chi più ne ha più ne metta in universale complotto possono impedirmi (almeno per ora) di innamorarmi a prima vista della prima interprete per sordomuti che passa nella prima scalcinata pista di tango che capita, di soffrire quindi atrocemente per lei per uno, due, tre, quattro o quanti anni per me decida il fato più classico e antiquato, e alla fine del salmo di suicidarmi per la disperazione causatami dai di lei per me del tutto 138 incomprensibili sussieghi e dinieghi – ovvero, in altre parole – nessuna legge umana, nessun regolamento potrà mai impedire alla mia mente calcolata e calcolante di farsi anima, di trasformare il caso banale in accadimento tragico, il grigiore del caos nello splendore di un destino (“L’essere amato in questo mondo disciolto è divenuto la sola potenza che abbia conservato la virtù di riportare al calore della vita. Se questo mondo non fosse percorso incessantemente dai movimenti convulsivi degli esseri che si cercano l’uno con l’altro, se non fosse trasfigurato dal viso «la cui assenza è dolorosa», avrebbe l’apparenza di una derisione offerta a quelli che fa nascere: l’esistenza umana vi sarebbe presente allo stato di ricordo o di film dei paesi «selvaggi»” (questo è ancora George Bataille, dal non molto celebre eppur splendido saggio che ha per nome “Il labirinto”; con parole molto meno autorevoli però mie, mi sento in grado e in dovere di aggiungere con lui concordando che l’Amore, con tutta la sua virulenta irrazionalità, con quella che Barthes definiva “l’economia dello spreco” contro “l’economia del profitto”, è l’unica vera via che sia rimasta per fuggire da questa ristrettissima non meno che ridicola prigione che è diventata la vita umana in questa società talmente disumana, talmente imborghesita da aver tolto qualsiasi significato alla parola “borghese” (contrapposta a che?): l’unica via che conduca lontano dalla pura estensione senza significato, via, dal freddo deserto del pragma-linguaggio della tecnica, verso un silenzio dove finalmente l’anima possa ascoltarsi ed ascoltare un canto che non viene da qui!) 60. Un canto che non viene da qui? Boh, non so, davvero, non so e dunque non so dire se quanto ho detto e citato spiega davvero qualcosa, se davvero adesso mi è e vi è più chiaro perché così profondamente, languidamente e disperatamente amai questa strana creatura, e perché una nostalgia inconsolabile eppure splendida, come “la pozzanghera nera e fredda” quale appare agli occhi del divin Rimbaud, l’adolescente dalle suole di vento, “quando nell’ora 139 del crepuscolo odoroso un bimbo malinconico vi abbandona in ginocchio un battello leggero, come farfalla a maggio” aleggi a tutt’ora, e a tutt’ora tangheggi intorno al suo ricordo, e dunque anche al ricordo dell’Amore che per lei atrocemente e amabilmente, dolcemente e amaramente provai. Tanto mi sento a tuttora commosso e sconvolto che, alla fine, qualsiasi spiegazione mi venga in mente, logica o assurda che sia, tendo spontaneamente a denegarla, e risolvere il tutto o il niente che forse nemmeno mi è successo semplicemente ripetendo in sconsolato coro con me stesso: “Un giorno mi sono svegliato, cieco come il destino.”45. No, proprio non lo saprei dire che cosa avesse di tanto speciale quella ragazza, come non so dire, in generale, se le nostre passioni, le nostre emozioni, possano essere spiegate da qualcosa di diverso che da una sorta di – come dire – di metafora di sé stesse. Una volta, parlando con un amico di una canzone dei Nirvana, “Come as you are” nella versione cosiddetta unplugged, mi è capitato di sottolineare la prestazione del Grande Kurt dicendo: senti qui la sua voce mentre grida “memoria… memoria…”, non sembra più quella di un essere umano, pare quasi il respiro di un abisso; il timbro si fa talmente e fatalmente viscerale, talmente e fatalmente sofferto che sembra uscire non più da una gola umana, ma dalle fessure intemporali di una tomba! Il che, come si suol dire, è forse un’immagine che “funziona”, va bene, ma ora io mi domando: che cosa ci troverei di veramente bello in una voce che davvero uscisse da una tomba? Forse, in un caso del genere, non solo non mi soffermerei in ammirata contemplazione, ma mi prenderei un cosiddetto croccolone, e, molto probabilmente, fuggirei o prenderei comunque dei provvedimenti molto seri, come chiamare l’esorcista, la mamma, o almeno i pompieri: ma allora perché un paragone siffatto, una metafora del genere, in relazione alla prestazione canora del Grande Kurt sembra tuttavia poter dire qualcosa di più o di diverso che la voce stessa? Se dico qualcosa di profondo dicendo che quella voce sembra uscire dalla tomba, di una voce che uscisse 45 Questo sarebbe Pozzo, uno dei personaggi minori del “Godot”. 140 effettivamente dalla tomba direi qualcosa di profondo dicendo che sembra quella di Cobain? 61. L’estetica è una materia complessa, sfuggente, enigmatica. I suoi sibillini labirinti possono anche risultare infernali, almeno per chi non sia un diavolo e voglia comunque fronteggiare la strana sfida di percorrerne gli oscuri e contorti corridoi e uscirne vivo o, almeno, sano di mente: i feroci minotauri delle contraddizioni in adiecto, delle tautologie per quanto apparentemente espressive, delle delucidazioni che risultano ancor più opache di ciò che vorrebbero delucidare, questi e altri mostri più o meno logici e mitologici sono sempre lì, pronti ad ingoiare ogni mio, tuo o nostro per quanto coraggioso argomentare, e, ahimè, una volta dentro non c’è Teseo che venga a ricercarti, né filo d’Arianna che possa trarti in salvo. I fianchi di Elisabetta, mobili e fluenti nella danza, ah, come vorrei paragonarli alla morbidezza di un’onda! Pure, sono stato al mare decine di volte in vita mia, e osservando le onde il 99,99% delle volte non ci ho trovato nulla di morbido o comunque di particolarmente bello e ammirevole! Anzi, devo confessare che in simili frangenti e luminosi e formosi catarifrangenti ero e resto per lo più attratto e a volte persino commosso dalle centinaia di deretani femminili che popolano la spiaggia, in specie nel caso che a coprirli – si fa per dire – ci sia uno di quei tanga che, pur nulla avendo a che fare con il tango, tanto appeal donano a certe ballerine brasiliane, che tanto sono dotate da quel magico punto di vista che non si riesce nemmeno bene a capire perché ballino: ma allora cosa dovrei dire, se trovandomi per caso sulla spiaggia di Copacabana a un certo punto distogliessi lo sguardo dal carnoso panorama femminile e mi volgessi alla contemplazione del mare lievemente mosso e commosso: che le onde s’incurvano dolci come i deretani delle ballerine brasiliane? E, se lo dico, dico qualcosa di significativo o di comico, oppure non dico nulla? 141 Io, come tutti i filosofi (questa è, almeno, la materia in cui, come ho già detto e che se non ho detto dico ora, mi sono non so quanto onorevolmente laureato e per cui vengo chiamato con l’enfatico e pomposo appellativo di “dottore” (che è una cosa che sembra logica: dottori in filosofia quanti ne volete, ma chi lo ha mai visto in giro, che so, un “infermiere in filosofia”?)), sono particolarmente dotato quando si tratta di pormi delle domande a cui peraltro non so abbozzare nemmeno un principio di risposta. L’amore, come la bellezza in generale, erano e restano per me un altissimo mistero, oltre che un profondissimo clistere. Dal mio personale e ristretto punto di vista, devo dire che Elisabetta, naturalmente, aveva anche altre potenti attrattive, oltre a quelle che ho sopra fin troppo a lungo descritto. Per esempio intuivo che fra di noi (“noi”!? vedremo, vedremo poi…) esisteva un complesso sistema di affinità elettive dovuto a passioni che avevamo in comune, quali la poesia, il teatro, la riflessione sull’Io e sul Mondo (ma Mondo o mondo? boh…) e il tango, appunto. E, mentre di tali ameni argomenti discorrevamo dicendo non mi ricordo neppur io cosa, eppure percepivo, o, più probabilmente, m’illudevo di percepire che di tali passioni ci occupavamo entrambi da un punto di vista simile, o almeno paragonabile (in effetti, si può avere in comune la passione per la musica, ma è possibilissimo che ognuno la concepisca in modo talmente diverso da detestare l’altro in questa e in tutte le altre vite che si è destinati a vivere e a rivivere, almeno fino all’avvento del Nirvana, o, almeno, dei Nirvana, due eventi che sembrano capaci di mettere tutti o quasi tutti d’accordo). Ma è anche vero che nel momento in cui mi sono innamorato di lei di tutte queste affinità, vere o presunte che fossero, non ne sapevo un bel nulla: Elisabetta era solo e unicamente per me un corpo danzante, un tenero abbraccio, una mano destra fremente nella mia sinistra, e una sinistra nivea e lievissima sul mio collo; e poi, e poi (“gente viene qui e ti dice”, dice Guccini) un piccolo seno appoggiato sul mio petto, un respiro, un rossore, un sorriso, un socchiudersi lentissimo di ciglia, uno sguardo ubiquo e irreale come il cielo, un attimo abissale e fluente di silenzio, un’agonia riarsa di interminabile, smaniosa attesa di scarmigliate tempeste fra rifranti 142 coralli di sirena e lugubri auspici di ninfa sorpresa nel mistico svenarsi di sé stessa (e smeraldi tristemente invaghiti di cosmici vampiri e allotropici licantropi, e marziani del ferroso liquame del candore, e altre cose o non cose del genere fantasy-romantico che non sto qui a citare). 62. Ma, se quanto detto è vero, forse allora le cose stanno proprio così! Che un essere umano, la sua anima, il suo carattere, è un’entità che non si può mai cogliere nel suo intimo, unitario essenziare, ma solo intuirla, ricostruirla attraverso le sue esterne, molteplici e spesso anche contraddittorie manifestazioni! Pascal sosteneva che “essendo tutte le cose causate e causanti, adiuvate e adiuvanti, mediate e immediate, e tutte collegate da un legame impercettibile che unisce le più lontane e le più diverse, ritengo impossibile conoscere le parti senza conoscere il tutto, come anche conoscere il tutto senza conoscere in particolare le parti”. Ma se Pascal aveva ragione, forse allora il volto segreto di Elisabetta, il suo spirito, o la sua psiche, come a volte si dice, mi si è comunicato per intero nel levitato mistero della danza, nella magica vibrazione dei suoi gesti, e tutto quello che di lei ho scoperto dopo era in fondo qualcosa di pleonastico, come, che so, leggere lo spartito di una musica già ascoltata: se tanto amavo il suo tango, se tanto gioivo a lei stringendomi, a me stringendola, era forse del tutto logico che, appunto, il suo spirito, la sua anima, la totalità profonda del suo essere insomma, fosse destinato ad essere desiderato dal mio. Perché dico questo? Ma perché, starei per dire, i suoi interessi coi miei così almeno apparentemente tanto compatibili – insieme al suo inelegante e quasi surrealistico modo di abbigliarsi, alla sua voce da topino dei cartoon, e alle mille chincaglierie che infine compongono il maestoso disegno di un carattere, il dialetto perugino parlato a Firenze da una torinese che a Perugia non era mai stata, etc. – erano qualcosa di strutturalmente, organicamente incluso nel suo modo di muoversi, di sorridere, come il paesaggio diafano e la luce soffusa e diffusa sono 143 magicamente inclusi, magicamente soffusi e diffusi nel magico sorriso della Gioconda! Non è forse d’accordo con questa mia tesi anche Carlo Michelstaedter, che nei suoi appunti ci spiega appunto che “nei momenti di grazia uno comunica con le cose, le intuisce nel loro vero essere, ha verso di loro l’amore e l’interesse universale: e allora crea e ricrea l’universo”? E non è d’accordo anche Montale quando in uno dei tanti capolavori della raccolta “Satura” scrive “Accade che le affinità d’anima non giungano al gesto e alla parola ma rimangano effuse come un magnetismo. È raro ma accade.”? Mi domando se, per caso o per necessità non stia comunque esagerando. Forse sto sragionando, arzigogolando romanticherie da pazzo e da strapazzo, trascinato dagli ultimi palpiti del mio amor perduto? In effetti, sono il primo ad ammettere che le soprascritte ipotesi esplicative del mio amoroso delirio paiono a un primo sguardo e, se è per questo, anche a un secondo e a un terzo, non meno che a un quarto, deboli, contorte ed irrazionalistiche, anche se, in effetti, pur producendo ogni sorta di sforzo e di ipotesi, devo rassegnarmi al tristo fatto che non so trovarne di migliori, di più credibili, di più razionali, posto che la ragione abbia qualcosa a che fare con la vita e, soprattutto, con l’amore umano. Ma, a ben vedere, non credo di essere né il primo né l’unico innamorato al mondo ad essersi più o meno disastrosamente scontrato con la frustrante e ammaliante cripticità del suo stesso Amore. Scrive magnificamente in proposito un già citato specialista del ramo, Roland Barthes: “E’ un enigma che non riuscirò mai a risolvere: perché desidero il Tale? Perché lo desidero persistentemente, languidamente? E’ tutto lui che desidero (una sagoma, un’aria)? O è solamente una parte di quel corpo? E, in tal caso, cos’è che, in quel corpo, ha per me valore di feticcio? Quale porzione per quanto esigua sia, quale sua caratteristica? Il taglio di un’unghia, un dente leggermente rotto di sbieco, una ciocca di capelli, un certo modo di muovere le dita mentre parla, mentre fuma? Di tutte queste caratteristiche del corpo, ho voglia di dire che sono adorabili. Adorabile vuol dire: questo è il mio desiderio, in quanto esso è unico: «E’ questo! E’ esattamente questo (che io amo)!» Tuttavia, più provo la specialità del mio desiderio, meno sono in 144 grado di precisarla; alla precisione di ciò che voglio dire corrisponde uno sfocamento del nome; il proprio del desiderio non può che produrre un improprio dell’enunciato. Di questo fallimento linguistico, resta soltanto una traccia: la parola «adorabile» (la buona traduzione di «adorabile» sarebbe l’ipse latino: proprio lui in persona)”. E’ triste concludere, all’irrazionale sospinti e rassegnati un così lungo ponzare della “ratio”, ma, davvero, devo da ultimo riconoscere che non so spiegare nulla di più a nessuno e men che meno a me stesso che cosa avesse Elisabetta di tanto particolare, di tanto diverso, che so, dall’amica che mi voleva presentare (e che poi non mi ha nemmeno presentato), per turbare i miei sensi al punto di sconvolgerli fino alle radici. Devo forse irritarmi per la mia ignoranza, devo considerarla il frutto di una mia specifica inettitudine, di una mia particolarmente spiccata ottusità? Forse no, dato che a ben vedere, tutto questo è normale: una non-storia – svolgendosi attraverso un’interminabile sequela di non-eventi – deve venire per forza di cose recitata da non-personaggi, ovvero da entità che poco o punto si prestano al discorso critico, all’inquadramento generale, alla morale universale, al ragionamento oggettivo. Naturalmente, ciò non impedisce che durante una non-storia, d’amore o di nulla che sia, le paure e le angosce possano essere non meno gloriosamente apocalittiche di quelle provate dall’ultimo dei Trecento di fronte alla marea persiana alle Termopili, o nella segreta e ansiosa tenda in cui Napoleone prendeva le sue finali, fatali ed epocali decisioni a Waterloo. 63. Ma, appunto, appunto, non divaghiamo, o, almeno, non divaghiamo troppo – se Amore altro non è che una lunga e dolorosa divagazione nel mare di non si sa bene che che chiamiamo nostra vita – e riprendiamo la narrazione di questa almeno per me a tutt’oggi strana ed enigmatica non-storia dal punto in cui l’avevamo interrotta. O, anzi a pensarci meglio e meglio ancora! Visto che ci siamo, anche se 145 spesso sembra di non esserci, non sarà meglio riassumere tutta la nostra non-storia fino al punto in cui è arrivata, dato che, a dispetto della già disperatamente lunga ed estenuante litania di pagine fin qui pedissequamente recitata, a ben vedere, i non-eventi che la costituiscono sono pochissimi? Però, siccome suppongo e sospetto che, data l’entità dell’interruzione, essi siano ormai sul punto di svanire dall’orizzonte giustamente svagato dell’attenzione del lettore – posto che non siano da tempo e meritoriamente già svaniti – riassumerò in breve i fatti e i misfatti narrati in queste cento e passa pagine, dato che, alla fine, il tutto o il nulla che è successo si riduce a 1) che mi sono innamorato di una sconosciuta al primo tango che ci ho ballato, anzi, appena mi ha abbracciato per ballare, 2) che questa sconosciuta, pur non volendone sapere di corrispondere ai miei sentimenti e presentimenti amorosi non voleva neppure saperne di lasciarmi in pace, al punto che mi era diventato impossibile avere con lei tanto un rapporto di qualsiasi genere quanto l’evitarla 3) che non riuscendo in altro modo a comunicarle il mio amore né qualsiasi altra cosa, e neppure trovando altra possibilità di provarmi a sedurla, mi ero deciso infine a ballare con lei un “tango pasion” talmente appassionato che per un pelo non sono crollato a terra svenuto nel bel mezzo della sala. Beh, suppongo che il lettore sarà felice di sapere che a partire da questo quasi-svenimento, causato da mio maldestro nonché malsinistro tentativo di seduzione, riuscii finalmente nell’improba impresa di evitare la mia ex-adorata sempre e sistematicamente, senza che altri incidenti di alcun genere venissero più a turbare il mio contraddittorio bisogno di lontananza e di oblio – contraddittorio perché un bisogno del genere esiste e resiste, ovviamente, proprio perché e finché esiste e resiste il desiderio opposto. Per fortuna, dopo ulteriori due mesi circa di cotale dolorosa non meno che fastidiosa cura, verso la fine di giugno il corso stesso finì e con esso finì anche il tormento più o meno sommesso che comunque ancora mi suscitava il vederla ogni settimana stretta e sorridente fra le braccia di altri ballerini. A furia di dolori e delusioni, a furia di pillole di quell’amara ma efficace medicina che si chiama “lontan dagli occhi lontan dal cuore” (meglio si dovrebbe dire “lontan dagli 146 occhi lontan dal c…”, ma insomma…), sembrava che la mia passione fosse definitivamente morta, o comunque giunta al lumicino (ma, come ben presto vedremo, si trattava di un’illusione, nemmeno infine troppo pia). Rimaneva solo un ultimo scoglio da superare all’onda del mio scorno, un ultimo amaro brivido dovevo ormai sopportare del celebre “inverno del nostro scontento”46, prima che potesse disperdersi infine “in questo splendido sole di York”, ovvero nell’agognata ultima spiaggia della pausa estiva, scoglio costituito dalla tradizionale cena di fine corso con successiva milonga, problemuccio che per un po’ avevo pensato semplicemente di scansare, adducendo un pretesto qualsiasi alle amorevoli insistenze del mio buon maestro Ignacio Elizari. Ma, ragionavo: perché lasciarmi andare a una debolezza similmente indegna di un vero uomo? In verità, se non fosse stato per quello sfortunato e per di più così poco credibile incidente erotico, a quella cena ci sarei andato, eccome, e probabilmente mi sarei anche divertito: dunque, perché progettavo di non andare? Evidentemente, quel che mi rendeva tanto amleticamente ansioso e dubitoso era il timore di vedere ancora Elisabetta al di là dell’esigenza pur non tassativa del corso, e più a lungo che in quella di solito piuttosto anonima circostanza: timore non solo di vederla dunque, ma anche e soprattutto di incontrarla, dato che in tutto quel tempo le occasioni si sarebbero inopinatamente moltiplicate. Ma non dovevo cedere alla debolezza, non dovevo, come si dice a volte, permettere alla ragazza di invadere il mio territorio. Sarei andato, l’avrei come al solito evitata, concedendomi e concedendole al massimo, come al solito, un mezzo saluto da lontano, e avrei passato la serata meglio che fosse possibile. Poi ci sarebbe stata una lunga estate per dimenticare le mie grane amorose, e, ne ero certo, ben presto di questa brutta storia ne avrei conservato al massimo un labile e ridicolo ricordo (che è poi in effetti quel che è successo alla fine, anche se è successo in un modo che in quel momento neppure sotto l’effetto dell’LSD avrei saputo immaginare). 46 Celeberrimo attacco del “Riccardo III” di William Shakespeare. 147 64. Ma, come tutti sappiamo, la fiera fermezza della morale e i freddi rigori della logica funzionano soltanto o quasi soltanto in settori della vita che siano o possano essere immuni dall’onnipotente ruggir delle passioni, e dunque faceva bene Amleto a dire, forse senza crederci troppo nemmeno lui, lui, così agitato da così enigmatiche e contrastanti tentazioni, a rivolgersi a Orazio dicendo “datemi un uomo che abbia lo stesso viso di fronte alla disfatta o alle palme, e io gli darò il mio cuore” (anche l’intelligentissima e profondissima Eloisa ricorda al suo ormai perduto Abelardo, che gli chiede di pensare non più a lui, ma solo a Cristo suo sposo, che “Nulla è così poco in nostro potere come le emozioni, alle quali io sono costretta ad obbedire piuttosto che in grado di imporre il mio volere. Quando le passioni ci tormentano, nessuno può opporsi ai loro improvvisi attacchi al punto che esse si trasformino rapidamente in azioni o sgorghino ancora più facilmente in parole.”47). Così, a dispetto dell’apparente irremovibilità della mia decisione, al momento di recarmi effettivamente alla cena caddi di nuovo in preda a incertezze ed inquietudini di ogni sorta, che di nuovo fecero sorgere in me delle angosciose, e giustamente indecifrabili preoccupazioni. Dovevo riconoscerlo: a dispetto della mia granitica risoluzione di liberarmi della mia ex diletta con qualsiasi mezzo, mezzo o intero che fosse, avevo non ostante tutto ancora paura: ma paura di che, si domanderà il lettore, se tanto eri deciso a tagliare i ponti con questa persona? Ecco, devo riconoscere che in effetti si trattava di una paura piuttosto indefinibile. Tutto quanto fino a quel momento mi era accaduto era qualcosa che non aveva paragone alcuno con qualsiasi altra esperienza che avessi avuto in precedenza nella vita, e perciò temevo che potesse di nuovo succedere qualcosa di strano, di imprevedibile, quasi che più o meno inconsciamente attribuissi a Elisabetta una sorta di potere magico – un potere trasformatosi in 47 P. Abelardo, “Lettere di Abelardo e Eloisa”, lettera sesta, di Eloisa ad Abelardo. 148 poche settimane da positivo in negativo – un potere in grado comunque di scagliarmi addosso una qualche enigmatica maledizione, un qualche impalpabile e imparabile malocchio. Così, preso da oscure preoccupazioni e non meno oscuri presagi, al momento di recarmi al ristorante dove era stata fissata la cena della scuola cominciai a tirare in lungo i preparativi. Mi fermavo in ogni bar in modo di avere il tempo e il whisky sufficienti per riflettere ancora sull’opportunità della mia partecipazione a quella festa, che per me sarebbe stata, ad andar bene, simile a un funerale. A furia di pensare e ripensare, finì che mi presentai in netto ritardo rispetto all’orario prestabilito, quando la cena era già da una buona mezzora iniziata così che ebbi occasione di ripetere, sia pure a bassa voce, il celebre detto che Gesù pronunciò durante l’ultima cena, “Beati gli ultimi, perché saranno i primi, e beati i primi, perché gli antipasti sono già finiti!” (per chi non l’avesse capito, causa una deprecabile ignoranza dei santi evangeli, non ostante le virgolette la seconda parte della frase è mia). Sempre più in preda a sempre più enigmatiche ansie e preoccupazioni, cominciai a percorrere i tavoli salutando amici e conoscenti e notando con crescente apprensione che erano tutti ma proprio tutti occupati, finché, giunto all’ultimo di quelli riservati alla scuola, vidi i di lei occhi ridenti e fuggitivi invitarmi a sedere al capo del tavolo nell’ultimo posto rimasto (!?). Incredibile ma vero, vero com’è vero Dio, e, soprattutto, vero com’è vero un istrice inerpicantesi su per il retto anale facendo la ruota con le spine previamente intinte in una mistura a base di curaro e peperoncino rosso, eccomi qua: era proprio vicino a lei, a Elisabetta, l’unico e ultimo posto libero rimasto in tutto il ristorante che, grazie a una di quelle maledizioni di cui si accenna nel “Libro dei morti tibetano” – una di quelle per cui l’anima condannata a vagare inquieta per il mondo può essere multata ovunque per divieto di sosta – si trovava in un punto in cui dal di lei radioso e – ahimè – ancora troppo sospirato sorriso mi divideva e difendeva solo una persona. Con sottomesso e rispettoso amor fati mi sedetti, dovetti sedermi, e, per fortuna, subito mi accorsi che l’assordante brusio che regnava per tutto il locale impediva fisicamente di comunicare con un minimo di naturalezza – ovvero senza gridare con tutte le proprie forze – con 149 chiunque non si trovasse immediatamente accanto al proprio posto, e questa fortunata circostanza si trasformò per me nell’agognato pretesto per non rivolgerle neppure una mezza parola in tutta la serata. Speravo in questo modo di superare la cena indenne da traumi, cosa che però in un certo senso, devo riconoscere, fortunatamente non avvenne. 65. Accanto a Elisabetta si trovava un collega del corso, un avvocato, probabilmente del diavolo, visto il favore che senza volere mi fece. Sarà stato il rumore, sarà stato il troppo vino, il ragazzo aveva dopo un po’ di tempo abbandonato l’aplomb che sembravano suggerire la sua camicia immacolata e la cravatta fantasia (fantasia di avvocato, ovviamente, ovvero, nessuna fantasia) e, a quanto pare si stava lasciando andare a qualche avance un po’ troppo sessualmente inoltrata. Vedevo Elisabetta farsi sempre più agitata, sempre più nervosa, fino a che a un certo punto la udii distintamente sbottare a voce molto alta, tanto alta da coprire col suo acuto e topesco rimbombo il molesto ronzio che rimbombava per tutta la sala: “Ehi!!! Ma io sono fidanzata!” (attimo interminabile di assoluto e abissale silenzio, a dispetto del rumore del luogo, mentre la cinepresa si fissa sul volto sgomento e furibondo del protagonista, poi l’azione riprende sullo sfondo di una pianura squassata dalla furia degli elementi). “Soffiate venti, squarciatevi le gote! Infuriate! Soffiate! Voi cateratte e uragani, sgorgate dal cielo a sommergere i nostri campanili!”48: come Re Lear alla notturna tempesta dopo il tradimento delle figlie, così io pur gridavo, sia pur silenziosamente, immerso nella ben più modesta ma non meno funesta tempesta di rumori di fondo che rombava nel sottofondo del ristorante affollato. Si perché, come è facile capire, questa improvvisa ancorché imprevedibile rivelazione di un tale e cotale segreto di Pulcinella 48 W. Shakespeare, “Re Lear”, III; II. 150 eppure mi gettò su tutte le furie: avevo infine conosciuto di prima mano e con certezza, oltre che nel più improbabile dei modi, di aver sofferto tutti quei mesi per una ragazza che fin dal primo momento non era disponibile. “Ah, vergogna, dov’è il tuo rossore?”49: eppure questo millesimo nome di Satana mi aveva pur detto di essere interessata a fare le pratiche con me, mi aveva dato il suo numero di telefono, si era appartata in macchina con me, indicandomi per di più la strada sbagliata, mi aveva invitato a invitarla per poter respingere i miei inviti (la zoccola infame o infame zoccola che dir si voglia!)! Per di più, lei stessa aveva reso inutile con la sua incomprensibile non meno che insistente opera di stalking (“stalking”, espressione inglese che significa: rompere i coglioni in modo ininterrotto a un poveraccio che non ha fatto nulla di peggio che innamorarsi di te e fartelo capire) i miei per quanto sofferti tentativi di respingerla: a più riprese aveva proseguito a tampinarmi con costanza e abnegazione degni invero di ben altro scopo, o, almeno, di uno scopo qualsiasi, alimentando in questo modo un’illusione che, a dir la verità, aveva altrettanto bisogno di alimenti che la signora Dini dopo un eventuale divorzio: e invece sarebbe bastato dirmi una sola frase, forse una sola parola per evitarmi mesi di angoscia e notti insonni! Maledetta, settanta sette volte maledetta! Come il già citato Re Lear tradito, abbandonato e disperso nella landa desolata nonché squassata da quell’indicibile tempesta di cui solo l’inimitabile e illimitato Shakespeare seppe dire, avrei voluto gridare allora e ancora e viepiù verso quel cielo che, per l’appunto, in quel momento a Firenze era, strano a dirsi, immerso nella melassa immobile dell’afa “E tu, tuono che tutto scuoti, schiaccia il ventre rotondo del mondo, spezza lo stampo della natura, spargi e disperdi tutte le sementi che fanno l’uomo ingrato!” (per non parlare poi delle donne!)! Che ero piuttosto follemente innamorato di lei la scellerata fedifraga doveva averlo capito fin da subito, altrimenti al mio messaggio di auguri di fine anno avrebbe risposto senza alcun imbarazzo e – soprattutto! – senza alcun timore e tremore avrebbe ripreso il rapporto che esisteva prima delle vacanze. Dunque lei, l’amata, l’agognata, la svergognata 49 W. Shakespeare, “Amleto”. 151 e mille volte maledetta “lei” (settanta volte sette sono solo quattrocentonovanta, e allora non mi bastavano), pur conoscendo l’arcano, dopo avermi sdegnosamente allontanato era tornata a cercarmi, a tentarmi, a sfibrarmi senza precisare nulla di nulla (comunque questo fidanzato torinese, almeno a giudicare da come Elisabetta si stava comportando, sembrava per l’appunto proprio un nulla di nulla da precisare (“la donna, schiava, vile superba e stupida s’ama senza disgusto e s’adora senza vergogna” e poi i risultati sono questi: “l’uomo, tiranno ingordo, duro, lascivo e cupido, si fa schiavo della schiava, rigagnolo di fogna”, buon vecchio Baudelaire, fortuna che ci sei tu a chiarire un po’ come stanno le cose a fidanzati, spasimanti, e spasmi e fantasmi vari ed eventuali!)! Beh, questa era la mia situazione, come potremmo dire, interiore e profonda, ma che stava succedendo al mio corpo, o, per essere più precisi, dalle parti della mia faccia? Beh, sappia il lettore che il più alto degli ideali del mio carattere è stato da sempre e senz’altro resta come resterà per sempre la ricerca e l’affermazione del più rigoroso e severo autocontrollo: che mai e poi mai al cuore, per quanto si voglia ardente – “ardente” – naturalmente – nel senso che la parola assume parlando dello spaghetto “ar-dente” – o scotto o come che sia o come che mai e poi mai possa essere, sia permesso di risolversi all’azione, al gesto o alla parola senza che i luminosi dettami dell’intelletto – a sua volta guidato dalle più ispirate massime di saggezza gli fosse dato di traudire – non avesse dato il suo sovrano imprimatur. Pure, devo riconoscerlo: in quel disgraziato frangente ci mancò un pelo che la ragazza non finisse sul piatto al posto dell’arrosto (che in effetti non era nemmeno un granché). Bevvi qualche bicchiere di vino in più, mi alzai e uscii a fumare una sigaretta, cercai di calmarmi meglio che potevo e almeno in parte ci riuscii, anche se le disavventure della serata non erano ancora finite. Incredibilmente, spietatamente, spudoratamente, al termine della cena, mentre gli studenti del corso di tango ed io a loro malinconicamente mescolato se ne uscivano a gruppi dal locale per recarsi alla milonga, vidi comparire accanto a me la sordida ingannatrice, che con un sorriso invitante pareva annunciarmi il contenuto del suo prossimo sfacciatissimo tranello “Allora, come stai? Adesso ci fumiamo una 152 sigaretta e balliamo un po’ insieme, eh!”. Avrei voluto prenderla per il collo, picchiarla, stuprarla, ridurre la sua faccia nello stato in cui si trova il portafoglio del consumatore italiano dall’avvento dell’euro o, al limite, in quello in cui si trova il retto anale del contribuente a partire dal Mesozoico, ma sarei finito in galera. Realisticamente, l’unica cosa che potevo fare era mettermi a gridare insulti, improperi e contumelie al suo indirizzo – non potendo inviare allo stesso un pacco bomba o una lettera all’antrace di quelle che tanto andavano di moda nel settembre del 2001 – ma capii subito che un tale cedimento alle lusinghe della mia disamorata rabbia era del tutto inutile, oltre che socialmente sconveniente: forse nemmeno se le avessi sparato col cannone questa sorta di Pippi Calzelunghe senza trecce ed evidentemente cerebrolesa avrebbe smesso di avvicinarsi sorridente e chiedermi “allora, come stai? etc.” per i prossimi otto millenni. Così, semplicemente, accelerai il passo, e mi allontanai più in fretta che potei senza dir nulla e senza voltarmi, anche se con la coda nell’occhio ebbi tempo di notare che il volto di Elisabetta assumeva di nuovo quell’espressione di addolorata e quasi costipata sorpresa che aveva assunto alcuni mesi prima, probabilmente con un contratto a tempo indeterminato, visto che ancora non l’aveva licenziata. 66. “Se fossi morto avanti un’ora a questo strazio, avrei pur vissuto un tempo benedetto, perché da quest’istante nulla rimane serio nella mortalità. Rinomanza e grazia sono morte, il vino della vita è versato, e solo la vanità rimane da vantare a queste volte!”50. Come un Macbeth disperato al cospetto dell’insensata e in fondo ridicola inanità del suo pur orrido delitto, così mi rotolavo io nell’ormai insensata e squallida banalità dei miei insensati, squallidi e infine del tutto ridicoli inferi d’Amore: dunque non si era accorta di nulla? Io soffrivo così e, per una qualche beffa della così poco seria vita mortale, lei non capiva? O invece non voleva capire! Oppure la mia 50 W. Shakespeare, “Macbeth”, II, iii. 153 diletta Elisabetta, come stavo cominciando a credere, era semplicemente, completamente pazza, anche se con un’apparenza di normalità non meno ingannevole che quella dei vicini di Erba, che con le loro famigerate e quasi shakespeariane gesta hanno ispirato al sarcasmo fiorentino il forse già in tutto il mondo celebre detto “l’erba del vicino è sempre meglio dei vicini di Erba”? Che cosa dovevo fare per darle a intendere quello che era successo, quello che mi era successo, quello che sentivo e che avevo sentito per lei, ammazzarla di botte e poi suicidarmi (nessuno si stupisca o si adonti per tali impronti accessi di impotente furia, dato che, come Shakespeare insegna, “a voler definire la vera pazzia, che cosa occorrerebbe se non l’esser pazzi?”: io potevo dare della pazza a lei solo perché stavo diventando o ero già da un po’ di tempo pazzo anch’io (comunque sia, penso che Bataille aveva davvero ragione quando scriveva che “se manca l’elemento di violazione, o persino di violenza, che la costituisce, l’attività erotica tocca con maggiore difficoltà la propria pienezza”: io ora so che davvero amavo Elisabetta perché se i suoi dinieghi erano in grado di suscitarmi quelle smisurate ondate di violenza, amare come il fiele, anche l’assenzio del suo assenso le avrebbe infine e ancor più e ancor meglio provocate: a pensarci bene, quale violenza più entusiasmante e sconvolgente che sconvolgere con la fanatica ed estatica brutalità dell’atto sessuale un corpo tanto soave, tanto fine, tanto aereo, armonioso ed etereo, tanto (apparentemente) docile?)). Comunque sia, alla milonga entrai, mi risolsi a entrare, ma ero troppo depresso e sottosopra per anche solo sognarmi di mettermi ballare, o anche solo a parlare con qualcuno. Rimasi dunque seduto nell’angolo più buio e lontano della sala, osservando le coppie che volteggiavano per la pista: Elisabetta, languida, lenta e lieve come un tramonto sereno nell’inverno, perfetta e fatale come una foglia nel volo dell’autunno, si stringeva a un tale che non sapevo chi fosse, e gli sorrideva come una primavera sul punto di farsi estate (il tutto in effetti mi ricordava il gusto di una pizza quattro stagioni completamente bruciata e/o andata a male) mentre il tango che me l’aveva messa fra le braccia me la portava via per sempre. Avrei voluto urlare e piangere, o, in alternativa, piangere e urlare fino allo 154 sfinimento, fino al sangue ma, come diceva Seneca “nelle situazioni estreme, non ci sono lacrime”51. Dunque io l’avevo amata fino a questo punto e lei non se ne era nemmeno accorta? Davvero era successo questo? Gli auguri non corrisposti, gli inviti chiesti e declinati, i tremiti e le paure, tutto questo perché, se lei davvero non si era accorta di nulla? Aveva ragione Oscar Wilde, che per definire la donna coniò il celeberrimo ossimoro di “sfinge senza enigma”, o invece ce l’aveva Holderlin quando nell’ode “Tränen” scriveva “So muss übervorteilt, alber doch überall sein die Liebe”, sempre sciocco, ingannato, soverchiato, così, sempre, dev’essere l’Amore? O invece aveva ragione il mio alter ego, il Pessoa-Pessoa di non mi ricordo più quale capolavoro quando sottolineava che la saggezza è impossibile, dato che “Non ci sono norme. Tutti gli uomini sono un’eccezione a una regola che non esiste”? Mi alzai infine, dopo una mezzora circa di dubbioso e disperato argomentare dal mio angolo oscuro, fattosi col dubitare e domandare viepiù oscuro e neghittoso, e curando di non farmi vedere da nessuno, come un lebbroso o comunque un qualche reietto dell’umanità purchessia – che sempre e da sempre così si sente un amante per sempre respinto – mi avviai verso l’uscita, consolato e sconsolato solo dal pensiero che il corso era finito e non avevo più da temere di rincontrarla e ricominciare a sperare, e a soffrire. Quel solo, incredibile, increduto pensiero restava ancora lì a tormentarmi, incessante e fastidioso come una zanzara ronzante nell’estenuazione dell’insonnia o come una mosca nel bruciare pungente del sudore: davvero mi ero innamorato di lei in quel modo selvaggio, spasmodico, atroce, e non ero riuscito a comunicarglielo nemmeno in minima parte? (“Comunicare, comunicazione, parole che se frugo nei miei ricordi scuola non appaiono. Parole inventate più tardi, quando venne a mancare anche il sospetto dell’oggetto in questione52”: perché quando penso a Elisabetta mi torna sempre in mente questa poesia di Montale, forse perché è stato grazie a lei che ho capito che il linguaggio è uno strumento inventato dagli uomini per avere la 51 52 Frammento della sua versione de “L’Edipo re”. E. Montale, da “Poesie disperse”. 155 possibilità di fraintendersi?). Possibile che quella creatura che mi era parsa tanto dolce, tanto intelligente, tanto compassionevole e profonda, fosse al contrario una sorta di strega gelida e crudele che gioiva nel tormentare l’incauto cuore che fosse caduto nei di lei languidi tranelli? Questo, per quanto mi paresse piuttosto improbabile, non era infine da definirsi caso del tutto impossibile, dato che non c’è persona al mondo che abbia passato anche da poco l’oscuro confine degli “anta” senza esser diventato amaramente consapevole che “gli anni migliori sono passati. Macchinazioni, vuote apparenze, tradimenti e ogni sorta di disordini travagliano il nostro cammino verso la tomba” 53, anche se, a ben vedere, non si poteva a quel punto neppure escludere dal campo delle ipotesi il Giacomo Leopardi del celebre “Ciclo di Aspasia”, quando, tracannato fino alla feccia l’amaro calice della delusione, scriveva pieno di fiele che “non cape in quelle anguste fronti egual concetto. a meno che non lo si sottolinei piuttosto energicamente con una mazza da baseball” (per chi non l’avesse capito, la seconda parte della citazione è una mia aggiunta originale)? Oppure, no, ma no, ma che andavo macchinando, lambiccando e alambiccando con tutte quelle complicazioni e labirintificazioni mentali? Magari, le cose stavano moooolto più semplicemente di.., di.. (di come?) e, comunque sia, non c’era affatto bisogno di scomodare filosofi e poeti e commediografi, e il fatto era soltanto che la ragazza, abituata da anni e anni a lunghi ed estenuanti colloqui nel linguaggio dei muti, evidentemente non era più capace di intendersi con le persone che ci sentono, e il problema era infine solo quello? O, più semplicemente ancora, tutta la vicenda poteva, anzi, doveva essere un episodio di candid camera ancor non giunto alla sua logica agnizione! Si, certo, doveva essere questa la risposta: da un momento all’altro sarebbe comparso un attore televisivo che con sorriso smagliante mi avrebbe ripetuto la celebre frase che Dio pronunciò all’indirizzo di Adamo non appena lo ebbe generato dal fango: salve, sei su “Scherzi a parte”! (beh, se non altro il tutto costituiva la certa 53 Questo è ancora Shakespeare, per bocca di uno dei personaggi minori del “Re Lear”. 156 dimostrazione di quel che diceva in proposito Bataille ne “Il labirinto”: “E’ vero, al di là della prostituzione o del matrimonio, il mondo degli amanti è ancora più abbandonato alla frode di quello del gioco. Non c’è limite preciso, ma numerose sfumature fra l’incontro ingenuo di personaggi incapaci di doppiezza e la civetteria impudente che ordisce senza respiro soperchierie e manovre.”: beh, a giudicare dalla situazione, io dovevo essere capitato in una di quelle sfumature in cui l’amante trova il sistema di prenderlo sistematicamente nel culo dall’amata, senza neppur trovare il modo di riuscire a dire “ahi!” (consoliamoci pensando che la tremenda vendetta degli innamorati è nel prosieguo di quella stessa frase di Bataille, dato che “l’incoscienza ingenua ha sola il potere di conquistare il mondo di miracoli dove gli amanti si ritrovano”: se è vero che “in un rapporto quello che ama di più è il debole che soffre, quello che ama di meno è il forte che si annoia”54 dunque, tiè e tiè Elisabetta infame: che tu sia per tutta la vita quella che si annoia! (comunque sia, non so se prima o dopo quest’incresciosa vicenda ho visto un film55 dove la protagonista femminile, certa Carolyn Polemhus se ben mi ricordo, era caratterizzata da una simile doppiezza che la mia ex amata: avvocato dedito alle cause da sempre perse, protettrice dei deboli e dei diseredati d’ogni sorta, donne stuprate, bambini abusati, sfruttati o picchiati etc., al contrario, in quanto amata ed amante la troviamo invece dedita a sedurre tutti i malcapitati maschi ricchi e/o potenti che fossero che gli capitassero a tiro di sottana, indi a sfruttarli senza alcuna remora o rimorso, e a lasciarli infine senza alcuna pietà non appena si fosse resa conto di avergli spremuto tutto ma proprio tutto quello che da loro si poteva spremere, strana ambiguità questa, che mi spinge a domandarmi per l’ennesima volta: che cosa ha spremuto o cosa voleva spremere da me Elisabetta? e, soprattutto, quando è di preciso che mi ha lasciato?)))). 54 Nota battuta tratta dal film “Harry ti presento Sally”, film a suo modo molto istruttivo quanto all’origine e al destino dei rapporti di coppia. 55 “Colpevole d’innocenza” con Harrison Ford? Boh, in questo momento non sono sicuro del titolo, ma Harrison Ford c’era di sicuro e, ragazzi, se c’era Harrison Ford vuol dire che c’era davvero tutto. 157 67. Va beh. Come il lettore avrà forse già capito a partire dal sottotitolo di questo romanzo (romanzo? ah, già, non l’avevo scritto da nessuna parte: è questa in questione una storia completamente vera, dal principio alla fine, il che, in ultima analisi, altro non significa che la vita stessa è o può essere un romanzo, o almeno: un brutto romanzo) una delle mie passioni o passatempi preferiti che dir si voglia è appunto, scrivere poesie e, come si può facilmente immaginare, in quei pochi eppure interminabili mesi – fatti di incertezza, di abbandoni, di pomeriggi vuoti, di deliri e speranze, di agoniche attese, di abissi galleggianti costituiti per lo più dai fumi spessissimi di alcol e sigarette – l’unico nume che dal cielo era disceso in mio soccorso era stato l’alchemico e lirico cherubino del verso (un fatto che sembra logico questo, dato che, come ci spiega Socrate nel già citato “Fedro”, “Chi giunge alle soglie della poesia immune dalla follia delle Muse, convinto che per essere poeta la tecnica gli sarà sufficiente, sarà un poeta imperfetto e la poesia di chi è in senno sarà oscurata da quella di chi è in preda alla follia” (beh, io non so se la tecnica basti a essere poeta, ma se per caso bastasse la follia, in quel momento io ero in uno stato tale che avrei potuto oscurare Omero e Pindaro, e Dante e Leopardi in un colpo solo)). Per sfogare la mia passione insoddisfatta, quasi senza accorgermene, avevo scritto pagine e pagine di componimenti alla mia ingrata amata dedicati, e siccome un bel po’ di essi erano molto brevi, non più di tre quattro versi, mentre tornavo a casa mi resi improvvisamente conto che avrei potuto spedirglieli via telefonino. Ma si, certo, quello poteva essere un sistema adatto per comunicare con lei, che pareva voler comunicare in modo tale che nulla di importante potesse venir mai comunicato, nemmeno in quel modo così vago e dunque così poco soddisfacente, almeno per un innamorato, che è l’allegoria gestuale, o anche solo la più tenue e allusiva metafora d’illanguiditi sguardi! Ovviamente, per garantirmi l’anonimato avrei usato un nuovo numero telefonico – dato che quello che uso di solito Elisabetta lo 158 conosceva fin troppo bene – e a quel punto avrei potuto comunicare con lei usando il diabolico connubio delle parole esplicite con un’identità oscura e diaframmata. Questa risoluzione, me ne rendo conto, potrà parere a qualcuno alquanto strana, in specie in relazione al fatto che il tutto doveva servire ad una chiarificazione dei rapporti con la ragazza. In effetti, se davvero il mio scopo era metterla a conoscenza delle ambasce a me causate dai suoi dal mio punto di vista piuttosto incredibili atteggiamenti, allora perché non spedirle apertamente le mie poesie con il mio numero solito, in modo che non ci fosse più spazio alcuno per dubbi e incertezze? Questo, in effetti, sembrava quello che al tempo di Omero si sarebbe senz’altro chiamato il tallone d’Achille della soluzione e della situazione (ricordo al lettore ignaro delle vicende narrate ne “L’Iliade” che il tallone d’Achille sarebbe quella celebre opera d’arto che rimarrà famosa per i postumi), ovvero un punto di debolezza in grado di trasformarla in un ennesimo problema. Ma, a dispetto di ogni razionale considerazione, in ogni caso scelsi senza esitare questo sia pur modernissimo genere di riservatezza per le mie poetiche considerazioni, ferrea non meno che fervida decisione i cui fondamenti non mi erano chiari in quel momento, anche se devo confessare che ora sono in grado di capirli abbastanza bene, e, anzi, mi sento di paragonarli ai motivi per cui l’Alighieri comunicava con la sua Beatrice (stavo per scrivere: la sua Elisabetta!) a mezzo di sonetti senza esplicita dedica, anche se i miei – ahimè – lo riconosco – sono indegni financo di leccare un deretano eventualmente calciato dalle nobili ciabatte del grande fiorentino. Beh, il fatto è che, come ognun sa, i sentimenti sono nell’uomo una parte che, strano a dirsi, risulta infine ancora più delicata e vulnerabile che i suoi stessi coglioni, se il lettore ci consente questo delicato francesismo. Che sarebbe accaduto se l’adorata e celeste dea dei miei pensieri e dei miei sensi avesse trovato i componimenti alle sue grazie e alla mia disgrazia dedicati fiacchi, noiosi o, peggio che peggio, imbarazzanti e fastidiosi? O, peggio che peggio che peggio ancora, se avesse trovato fastidioso e imbarazzante il fatto che proprio io ne fossi l’autore? In casi come questi, quando l’orrido fantasma della più nera sfiga aleggia sull’amante come una 159 squadriglia di B 52 sullo squittire di un criceto, l’anonimato serve all’autore di presumibilmente vane composizioni erotiche – siano esse lettere, racconti o poesie – sul piano difensivo, per proteggersi da eventuali ulteriori umiliazioni, e, su un piano offensivo, per rendere i propri componimenti, nel caso che siano graditi, ancora più carichi di misterioso fascino – stante il fatto che probabilmente non c’è donna al mondo che non venga tormentata nei secoli dei secoli dalla curiosità di sapere con assoluta certezza chi sia l’autore di un verso a lei dedicato, in specie, naturalmente, se il verso le piace. Le mie poesie sarebbero state dunque, così neppur tanto sotterraneamente mi auguravo, anche una sorta di vendetta: io sono stato tormentato dall’amore per te, che almeno tu lo sia dalla tua stupida e ridicola curiosità di oca superficiale, frivola, superba e leziosa e vanitosa, e-ccetera, eccetera (sono questi i momenti in cui si pensa che costruire un computer intelligente come un uomo non sarà mai tanto difficile che costruirne uno stupido come una donna). Ma, insisterà il lettore, se la ragazza non fosse stata proprio sicura dell’identità del mittente, come potevo sperare di raggiungere il sospirato scopo di levarmela per sempre dai cosiddetti? 68. Il summenzionato dubbio ha, in effetti, almeno all’apparenza, un qualche fondamento, ma, a ben vedere, non avevo alcuna ragione profonda di credere che il mio piano non avrebbe raggiunto lo scopo prefissato. E’ vero, Elisabetta non avrebbe mai saputo con certezza assoluta chi fosse il mittente dei versi. Ma, almeno su un piano di relativa ragionevolezza, ero certo che avrebbe capito che l’anonimo emissario del poetico lamento ero proprio io, e nessun altro. Nel corso dei nostri per quanto esigui colloqui di alcuni mesi prima, le avevo parlato largamente dei miei interessi filosofici e letterari, e oltre a ciò, sia pure per vie traverse, quasi certamente si era fatta un’idea abbastanza chiara della vena creativa di questo suo disgraziato spasimante, al punto che, commentando il mio modo di vestire, aveva detto che avevo l’apparenza di un “vero artista” 160 (infame creatura, è così che si trattano i veri artisti? e che cosa gli fai a quelli falsi allora? infame creatura...). In questo modo dunque, così speravo, si sarebbe resa conto senza più alcuna vera ambiguità o decisiva incertezza della alquanto delirante natura dei miei sentimenti nei suoi confronti. E allora, come minimo, così pensavo e m’illudevo, a questo punto l’avrebbe fatta finita di cercarmi e scappar via continuando ipocritamente a far finta di credere che fra me e lei non ci fosse altro che amicizia – quando, come si dice, “si avvicinava” – e a sbiancare terrorizzata quando, con ogni evidenza, vedeva in me una sorta di connubio fra un serial-killer, uno stupratore etnico e un Giuliano Ferrara a digiuno di pastasciutta da due mesi, e si allontanava (a quanto pare, questa è una delle attività preferite dalle donne nei confronti degli uomini: se producessero un chilowattora ogni volta che si avvicinano e si allontanano si sarebbe risolto il problema dell’energia pulita). Al momento in cui presi la fatale decisione avevo già scritto un bel po’ di poesie brevi, e naturalmente, lì per lì progettavo di spedirgliele tutte (a questo livello di idiozia può spingere un uomo dunque l’amore, deluso o illuso che sia? (comunque sia, per chi non lo sapesse, “lì per lì” fa “lì al quadrato”)). Ma, per fortuna, nei giorni successivi al febbrile invio della prima missiva – che avvenne due giorni dopo la tragica e definitiva rivelazione del suo status sociale di fidanzata e che, per fortuna, non sortì effetto alcuno – riflettei molto saggiamente che l’assai poco diabolico piano che andavo macchinando era, con ogni probabilità, diventato a quel punto del tutto pleonastico. Oramai non avevo più da sperare o temere di rivedere Elisabetta per un bel po’, di sicuro fino a che il corso non fosse ricominciato, e forse nemmeno di quell’eventualità c’era più davvero da temere. In fondo, chi mi diceva che Elisabetta avesse ancora voglia di imparare il tango, o che sarebbe tornata proprio a quel corso, e che, una volta tornata, avrebbe ricominciato con la summenzionata non meno che scellerata e assurda tiritera di avvicinamenti con allontanamento incluso? Forse quell’ultimo rifiuto che aveva subito l’aveva definitivamente offesa, se non era del tutto fuori di testa in quel momento doveva aver finalmente capito la natura dei miei desideri, senza più bisogno di ulteriori manovre. A 161 settembre, se sfortunatamente l’avessi rincontrata al corso o in qualunque altro ambiente tanguero, con ogni probabilità mi avrebbe lasciato in pace comunque, e quella poesia che le avevo già inutilmente spedito e a maggior ragione quelle che avevo intenzione di spedirle sarebbero risultate infine inutili, pleonastiche e dunque anche ridicolmente ridondanti. In fondo, tutte le cose umane sono umane perché trovano infine un limite e una fine: dunque doveva avere un limite anche l’ingenuità, o la stranezza, o, forse, la stupidità o, chissà, chissà, chi può dirlo, forse proprio la follia di quell’incomprensibile ragazza, che tutto il mio amore e la mia passione, con ogni evidenza, non erano bastati per capire, nemmeno un po’. 69. Giunto a questo punto speravo dunque che questa strana commedia degli equivoci o dell’Assurdo che dir si voglia fosse finalmente giunta al termine e che Godot, in qualche modo, fosse finalmente arrivato, anche se portando, com’era del resto prevedibile e abbondantemente previsto, una brutta notizia: le ferie da passare in qualche modo, in cui trovare qualcosa da fare, un posto dove andare, fumare, bere, dormire, lettere e testamento, alla fine ce l’avrei fatta senz’altro a scordarmi di tutto (in realtà, avevo più che altro voglia di fuggire, ma come arrivai davanti all’entrata del solito ultimo rifugio per disperati in fuga dalla realtà che si trova su internet, ovvero al sito dei viaggi last minute mi tornarono in mente gli atroci versi di Baudelaire a questo tema dedicati, versi che duramente ammoniscono l’incauto che nel partire cerchi alla prigionia del vivere una definitiva liberazione “Amara verità si ricava dal viaggio! Monotono e uguale il mondo ci mostra, ieri come oggi come domani e sempre, l’immagine nostra: che siamo un’oasi d’orrore in un deserto di noia.”: brrr, forse era meglio trovar qualcosa da fare lì a Firenze…). Ma l’auspicato oblio, questo Godot che arriva e con noi felicemente resta ogni volta che non lo aspettiamo, come presto 162 vedremo, non arrivò e, sfortunatamente, la comprensione del finale di questa strana e interminabile non-storia necessita per di più, se non proprio del racconto, almeno dell’accenno ad altri eventi che con essa non ebbero direttamente a che vedere, ma che, inevitabilmente, influenzando me influenzarono anche quello che sentivo per Elisabetta, diletto nome, adorato nume, fiore del mio abbraccio, la benedetta e maledetta “lei”, la perduta e mai avuta Ella d’Essa, mia croce e mia delizia, mia estasi, mio volo e, soprattutto, naturalmente, mia agonia. L’estate del 2007, già così come stavano le cose, non era iniziata nel modo migliore. L’amara ancorché scontata rivelazione con cui si era concluso, diciamo così, il corso di tango mi aveva lasciato dapprima e per un po’ giorni completamente furioso e sconvolto, poi, come capita, presi invece a sentirmi stanco, quasi sfinito, oltre che profondamente depresso. E, siccome le disgrazie non vengono mai da sole, ma vanno in giro a mo’ di quelle simpatiche comitive di turisti giapponesi, in file di cui, se sei fortunato, conosci il terrifico inizio ma non mai la sospirata fine, ecco che verso la metà di luglio, a completare il disastro iniziato dalle mie invero alquanto disdicevoli disavventure amorose, venne un lutto gravissimo, il più grave e irreparabile che mi potesse capitare. Per ovvi motivi di spazio e, perché no, anche di discrezione, non posso neppur tentare di tracciare sia pur per linee generalissime il terrificante senso e nonsenso dell’improvvisa anche se oramai da tempo aspettata dipartita di una persona che per anni e anni avevo e, soprattutto, mi aveva amato, una persona che forse resterà l’unica che mai – attraverso le piuttosto tragiche vicende di una vita che sarei incline a definire maledetta – se solo trovassi qualcuno disposto a maledirmi – l’unica, dicevo, che mai abbia sentito veramente amica e vicina. La scomparsa di questa persona avvenne per di più in circostanze, per così dire, basse, ignobili, impudiche, ovvero alla fine di un decadimento fisico indotto dall’eccesso di alcol e dal disagio psichico, causato e causa di interminabili scontri con un mondo esterno diventato oramai solo il pretesto per percorrere quella straziante via verso il nulla che la vita umana si rassegna infine ad essere o non essere, questo è il problema (la risposta, come tutti sappiamo, soffia nel vento: più probabilmente, 163 il vento di una scoreggia). Il modo peggiore, più tragico, ma forse quello esteticamente più significativo di prendere congedo da questa valle di lacrime e risate, da questa valle di tedio e giorni uguali, di spaventose commedie e comiche tragedie da nulla, e del nulla e di nulla e poco più. 70. “Agonia, agonia, fermento y sueño, este es el mundo amigo, agonia, agonia. Los muertos se descomponen bajo el reloq de las ciudades, la guerra pasa llorrando con un milion de ratas grises, pequeños moribondos iluminados dan los ricos a sus queridas, y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada.”56: queste arcane, buie e terrifiche parole del grande Garcia Lorca aiuteranno me a spiegare e il lettore a capire come l’orrido lutto mi travolse, a intendere che, pur grattando oltre il fondo più fondo il fondo del barile di me stesso, non potei trovare le forze per opporre una per quanto labile resistenza alla marea montante dell’angoscia e del vuoto che mi sopraffacevano da ogni parte e in ogni istante? Penso di no. E allora mi permetto di aggiungere anche quelle della povera Eloisa, che forse risulteranno più convincenti, se non altro perché ben più esplicite e abbondanti “Oh clemenza inclemente! O Sorte sfortunata che esaurì contro di me tutte le su frecce, al punto che non ne ebbe più per infierire su altre vittime; svuotò contro di me l’intera faretra così che ora la sua malevolenza non spaventa più nessuno. D’altra parte, se le restasse ancora qualche freccia, non saprebbe più dove ferirmi. La Sorte esitò soltanto di fronte alla ferita mortale che porrebbe fine alla mia sofferenza; essa non smette mai di torturare, 56 “Agonia, agonia, fermento e sogno, questo è il mondo amico, agonia, agonia. I morti si decompongono sotto l’orologio delle città, la guerra passa piangendo con un milione di topi grigi, piccoli moribondi illuminati danno i ricchi alle loro amanti, e la vita non è nobile, né buona, né sacra” (F. G. Lorca, “Ode a Walt Whitman”). 164 ma teme proprio quella morte che sembra voler infliggere.”57. Mi sono espresso adesso? Le parole pur da sempre inefficienti sono dunque ora sufficienti, tanto per finire in rima e tornare al discorso di prima? Non lo so. In fondo ognuno di noi, anche il lettore suppongo, è dannato alla sua solitudine, e dalla sua “una sola moltitudine58” a significati incomunicabili, a sfumature imponderabili, fosse pure quelli che differenziano i berlusconiani e rossoneri miliardi del Milan dai morattiani e nerazzurri miliardi dell’Inter. Dunque, rassegnandomi ad essere al tempo stesso capito e non capito, dirò solo che per lunghi, interminabili giorni mi abbandonai alla più indegna, più alta, più nera disperazione e – finalmente – alle lacrime, al pianto dirotto – mentre con l’ultima parcella di intelletto che in me restava ancora accesa scoprii quanto fosse vero quel che scrisse Cioran, probabilmente, in un momento, molto simile a questo “Non è Dio, è il Dolore a godere dei vantaggi dell’ubiquità” (l’aspetto più tragico di cotali tragedie è che, dopo un bel po’ di lacrime, ti domandi se, come a volte si ride per non piangere, altre volte si pianga per non ridere59). Nel vano tentativo di risollevare il mio spirito – che ogni giorno assomigliava sempre di più a un pugile al tappeto in una fabbrica di tappeti dopo un bombardamento a tappeto – provai, più che altro per dar prova di buona volontà, a ripetermi il motto degli stoici – “abstine et sustine”60 – condendolo con la celeberrima frase che Ulisse si ripeteva per incoraggiarsi al terribile finale della sua, giustappunto, odissea “cuore pazienza! Cose da cane già tu patisti!”61. Ma – ahimè – quest’accenno alle peripezie e al coraggio del più celebre degli eroi dell’Occidente non solo non mi portò alcun giovamento ma, al contrario, mi suscitò le più funeste 57 P. Abelardo, “Lettere di Abelardo e Eloisa”, lettera quarta, di Eloisa ad Abelardo. 58 Celebre titolo che è stato dato a una celebre antologia di poesie dei più famosi eteronimi di Fernando Pessoa. 59 Il lettore arguto avrà commentato giustappunto che questa battuta è troppo arguta per essere davvero dell’autore: e infatti questo è ancora Beckett, ancora e sempre dall’inimitabile “Aspettando Godot”. 60 Astinenza e sopportazione. 61 “Odissea”, XX, 17-18. 165 associazioni con cui si possa mai socializzare, eccetto forse che con un assessore socialista dei ruggenti anni ’80 (particolarmente tremendi erano, chissà perché, quelli alla cultura). Oscuri flutti del fiume oscuro dell’orrore gli omerici versi mi riportarono in mente quel celeberrimo mito che Platone mette in bocca ad Aristofane nel “Simposio”, ove in effetti ricordavo essere fra l’altro citata questa frase de “L’Odissea”. Quivi il caustico commediografo, che per una volta si rassegna a parlare seriamente, per spiegare il motivo per cui gli esseri umani cadano in “stato di eros” ovvero siano o possano essere sessualmente o sensualmente o spiritualmente attratti da altri esseri umani, racconta che un tempo essi erano ermafroditi, ovvero due anime che condividevano lo stesso unico corpo, che altro non era che la curiosa non meno che mostruosa fusione di due corpi di uomo e/o di donna così come li vediamo adesso. Questi esseri, racconta Aristofane, si provarono a sfidare gli dèi, uno degli sport preferiti delle creature mitologiche della grecità a quanto pare, e, risultando come al solito sconfitti, ricevettero la giusta punizione per la loro Giove, non trovando di meglio o di peggio, decise di tagliare a metà questo essere doppio in modo tale che per l’eternità patisse la mancanza dell’altro con cui era fuso. Per questo, sostiene Aristofane, vi sono uomini che erano fusi con un uomo che sono attratti dall’uomo, quelli che erano fusi con una donna dalle donne, e, specularmente, donne attratte dall’uomo o dalla donna. Si verifica a volte un caso straordinario, ossia che, a furia di incontri, scontri, sforamenti, sfioramenti e accoppiamenti vari, avvenga infine una sorta di miracolo, ovvero: “che un tipo così (cioè un ex ermafrodito, N.d.A.) rincontri la sua antica metà; e sia lui un pederasta o un altro tipo, in quell’attimo sono fulminati – ed è un mistero – da un riconoscersi interiore, fondo, che è eros, e non ammettono, si può ben dirlo, di essere separati, neanche per una briciola di tempo. Questi sono gli individui pronti a invecchiare insieme, fino a morte: non importa loro di saper definire lo scambio di necessità, o di desiderio che li collega. Non si può certo dire che è il puro impulso erotico, l’abbraccio, come fosse lo scopo unico per cui la coppia sta stretta con tanta intensità. No, no, traspare l’anima in ciascuno, vuole qualcos’altro, che però non riesce a definire, ne parla ambiguamente, 166 per oracoli, quasi indovinelli.”. Il ricordo di queste parole – in sé e per sé, lo riconosco, non particolarmente gravi – pure riuscì a farmi vacillare – ebbene si – cavalcando con brividi di vacuo gelo siderale il mio corpo nell’angoscioso pensiero rattrappito e quasi mortalmente irrigidito, pur se il calendario saggiamente mi segnalava che ci trovavamo in piena ed abbaiante canicola estiva, per di più in una città dove l’afa regna incontrastata da maggio a ottobre: ma – ahimè – tali brividi sembravano in tutto e per tutto giustificati! Aristofane si riferiva evidentemente proprio a quel genere d’Amore o “stato di eros” da cui ero stato preso per Elisabetta, e lo spiega come un reciproco riconoscersi di anime che un tempo erano state unite! Seguendo questa concezione, ciò significa senza meno che perché quel genere di scintilla scocchi c’è bisogno che due poli siano reciprocamente attratti, non uno solo: ma allora come è che io, pur per nulla o quasi per nulla corrisposto, avrei potuto rispondere a Efesto “ecco, proprio questa è la mia febbre, da sempre, confondermi, liquefarmi col mio amore, farmi uno da quei due che siamo”? Se questo mito corrisponde al vero, mi ripetevo sazio di ogni sorta di mitico terrore, che significava questa mia passione atroce, che anche prima che Giove mi punisse io ero unito non con un altro essere umano, ma col suo rifiuto, con la sua assenza e ora – innamorato com’ero di una che di me non voleva sapere null’altro che di lei spasimavo e arrivederci – con questa sempiterna e irrimediabile assenza mi ero ricongiunto? 71. “La morte è oggi dinanzi a me come la guarigione per il malato, come l’uscire all’aperto dopo esser stati rinchiusi, come il profumo della mirra, come lo sdraiarsi sotto una vela in un giorno di vento; come la fragranza dei fiori di loto, come il giacere sulle rive dell’ebbrezza.” (poesia egiziana, ~ 2000 AC). Più oscure ancora che le porte dell’inferno si spalancarono allora per me le atroci visioni di colui che infine vede la sua vita, ovvero quel poco di tempo che gli è resta, quel tempo breve come la pipì di una farfalla, mostrarsi infine 167 come il vano trastullarsi degli oceani del caso con le sue passeggere schiume, così che in mente vengano le sagge parole dei pirati in un celebre fumetto di Asterix, mentre confabulano ansiosi sul da farsi innanzi all’incombente abbordaggio di Obelix: “Autoaffondiamoci: otterremo lo stesso risultato evitando un bel po’ di sberle!” (beh, a chi veda offesa da cotale fumettistica e infantile intromissione la solenne luttuosità di un momento tragico, posso ricordare il modo e il motto molto più maestoso con cui armato di tutto punto Macbeth si offre alla vendetta dei figli di Duncan: “Spegniti, spegniti breve candela! La vita non è che un’ombra errante, un povero attore che si fa avanti tronfio, smania la sua ora sul palco e poi non se ne sa più nulla. E’ una storia raccontata da un’idiota, piena di grida e di furia, che non significa nulla!”62). Accompagnandosi a cotali orridi pensieri tornarono, tanto prevedibili quanto interminabili e acerbe, le nere veglie e le nere voglie dell’ancor più nera insonnia, e con esse il fumo, il whisky, e più e più volte, sprofondando nei viscerali abissi dell’interna angoscia, più e più volte venni accarezzato, e, se è per questo, anche abbracciato e baciato nonché sodomizzato dall’idea del suicidio, ovvero dall’orrida idea cui comicamente alludono i pirati di Asterix, ovvero il più grosso dei cetrioli da cui la posteriore umana insalatiera può immaginare di venir mai sconvolta. La mia disperazione giunse a un punto tale che non credevo possibile di risollevarmi. Le notti si popolarono di lacerati e gelidi fantasmi, che turbinando come le ombre nel quinto girone del dantesco inferno mi ricordavano stridendo, oltre alle spiacevoli conseguenze dell’umana lussuria, fra l’altro, anche i più tremendi fra i cori sofoclei: “O generazioni dei mortali, la vostra vita e il nulla in pari conto io tengo! Quale, quale uomo attinge felicità più salda di un’illusione che balugina e subito declina? (oh, cazzo, cazzo… N.d.A.) Non veder mai la luce vince ogni confronto, ma una volta venuti al mondo tornare subito là donde si giunse è di gran lunga la miglior sorte (oh, cazzo, cazzo… cazzo… N.d.A.): quando tramontano di giovinezza i dolci errori chi non vaga fra dolori infiniti? Quale pena resta fuori di noi? (già, quale?) e sopravviene in ultimo, da tutti 62 W. Shakespeare, “Macbeth”, V, v. 168 maledetta, l’impotente, l’inaccostabile, l’arida vecchiaia, essenza del male, ove tutti i mali coabitano (oh, cazzo, cazzo, cazzo, e stracazzo!!! N.d.A)”. Giunto a questo punto, quale altra consolazione invocare se non proprio “lei”, quell’Altra, ultima “lei”, “colei che tutti eguaglia, la morte, quando dall’Ade emerge la Parca, senza danze, senza cetre, senza imenei.”? 72. A dar man forte ai cori dell’Edipo e alla Parca, con relative Porche annesse, giunse poco dopo, tanto per non farmi mancar nulla, anche l’immancabile, funereo Amleto, che tradizionalmente vestito a lutto e tenendo il consueto teschio in mano (di chi era il teschio? Forse proprio quello di Edipo: o forse quello di uno dei pirati di Asterix) ripeteva come al solito: “Essere o non essere, questo è il problema (come avevamo già accennato sopra, N.d.A.). Se più nobile sia per l’anima soffrire gli oltraggi, i sassi e dardi di Fortuna, o prender l’armi contro questo mare di mali e opponendosi distruggerli? (già, che cosa è meglio? N.d.A.). Morire, dormire… nulla più. E dirsi così con un sonno che noi mettiamo fine al crepacuore ed alle mille ingiurie naturali, retaggio della carne (e a volte anche della verdura N.d.A.)!… E chi vorrebbe sopportare i malanni e le frustate… (segue da qui la celebre non meno che interminabile lista dei malanni e delle frustate che la vita umana riserva all’uomo, lista che pietosamente risparmio al lettore, solo osservando che con l’andar del tempo si sono aggiunte alla già terrifica litania amletica anche altro genere di sventure, ovvero roba tipo la tassa sui rifiuti che nessuno porta via, quella sulle comunità montane che non esistono più, quella sulla fuoriuscita dal nucleare mentre si progettano nuove centrali, quella sulla guerra d’Abissinia che, con ogni evidenza, si abolirà con l’introduzione di quelle con l’Afghanistan, il Libano e la Libia, etc.), chi lo potrebbe mai se uno può darsi quietanza col filo d’un pugnale (già chi lo potrebbe mai? N.d.A.)?” Così in preda ai più antichi e foschi pensieri che abbiano turbato ciò che sta sotto il turbante dell’Umanità, mi spinsi infine a meditare 169 sulla più antica e fosca sentenza della filosofia Occidentale, che, pur nella scalcinata situazione dell’attuale istituzione universitaria italiana, ogni iscritto alla facoltà di filosofia è tenuto ad imparare, quel detto di Anassimandro che sconsolato da secoli risuona “là da dove tutte le cose vengono devono anche ritornare, secondo necessità; esse pagano infatti l’una all’altra il fio delle loro colpe secondo l’ordine del tempo”. Mormoravo fra me questa sentenza atavica fissando l’Arno scorrere oscuro, putrido e lento dall’alto del ponte alla Vittoria, udendo lo straziante fischiare di un treno che si avvicinava alla banchina, fissando con occhi d’angoscia ciechi il cieco abisso spalancato dalle vorticanti vertigini d’uno spaesato terrazzo, oppure sommerso dal muggito dei tir che svanivano sotto un come me dimenticato e solitario ponte d’autostrada, disperso nella smisurata e quasi deserta campagna. Mormoravo fra me, tetro, queste parole tetre, mentre intanto – ahi! – intanto – pensavo che per me, qualunque fosse il termine delle mie interminabili fantasie sterminatrici, tutto era finito (senza peraltro – non dico precisare – ma anche solo domandarmi cosa e quando fosse mai iniziato). Ma, come c’era forse da immaginarsi, quello fu precisamente il punto in cui avvenne in me un mutamento tanto imprevedibile quanto radicale. 73. La sera del tre agosto 2007, una di quelle rimarranno per me assolutamente indimenticabili, almeno fin quando non me ne sarò dimenticato63, scoprii con gran disdetta di aver terminato i sonniferi e che era troppo tardi per andare a comprarne, e mi aspettavo perciò, complice anche il gran caldo, di passare l’ennesima notte agitata e insonne. Invece, contro ogni mia aspettativa, le cose non andarono così. Mentre già tremavo al pensiero delle ore e ore d’interminabile insonnia condite d’amari ricordi e da brevi tratti di sonno epperò infestati dall’atroce legione dell’incubo, contro ogni mia aspettativa 63 Battuta tratta dal celebre componimento di Borges “Las cosas”. 170 invece, non appena spenta la luce, mi tornò in mente – chissà perché – una vecchia storia di tanti anni prima, un’antica amante, che mi recavo a visitare di solito il fine settimana, di solito una volta al mese, o, al massimo, ogni quindici giorni (la ragazza, guarda un po’, era una bolognese che viveva però a Torino). Mentre con occhi inutilmente dilatati fissavo il buio silenzioso della camera, come lampi accecanti mi tornarono in mente l’eccitazione furibonda di quei convegni carnali che andavano avanti per ore e ore, conditi dai giochi erotici più rischiosi e innominabili e, come sgomento al pensiero che quelle cose le avevo fatte proprio io, e non qualcuno che conoscevo appena e che ricordavo alla lontana, mi domandai stupefatto e quasi del tutto incredulo: “Dio mio, ma cosa mi metteva addosso quella ragazza, come si spiegano quelle cose incredibili che facevo?”. La notte restò silenziosa per alcuni attimi interminabili e poi una voce inaudita, limpida, grave, ironicamente calma e luminosamente misteriosa mi rispose “Mah, molto probabilmente ero diventato matto”. Non appena pensato questo strano pensiero mi addormentai e la mattina successiva – era il quattro agosto del 2007 – mi alzai di umore molto diverso da quello orrido e tetro che aveva caratterizzato gli ultimi due mesi, anche se ancora non ero capace di definire quale. Sbadigliando, lavandomi i denti e facendomi la barba presi a pensare con la ferrea lucidità della logica e la retorica inesorabile del sogno che fra tutti i desideri, i desideri erotici sono per l’umana progenie la massima fonte di tormento, se non proprio l’unica: non è forse Eros definito fin da Platone o da molto prima di Platone il più folle di tutti i tiranni, il più crudele di tutti i supplizi, quello “la cui violenta natura distrugge se medesima e, più che ogni altra passione sotto il cielo, guida la volontà a imprese disperate” (beh, questo qui che parla è, circa duemila anni dopo Platone, il grande Shakespeare, ma, va beh, secondo me ci sta bene lo stesso)? E cosa restituiscono all’uomo, in cambio di tanti spasmi questi tiranni, questi persecutori? Il più delle volte nulla; rare volte quasi nulla; rarissime volte istanti o minuti o forse ore di felicità (questa è di sicuro un’esagerazione), che però sono immancabilmente pagate con ogni sorta di ambasce. E’ vero, dopo che avevo incontrato Elisabetta avevo cominciato a 171 soffrire atrocemente per la sua mancanza, ma in questo modo accadeva forse qualcosa di veramente nuovo nella mia vita, se non l’esacerbarsi della sua quotidiana insoddisfazione, della sua metafisica follia (il coro rispondeva al lamento di Antigone che gridava “Una pena mi opprime!”: “Ma già prima un’altra non ti opprimeva?”64)? In fondo, se Elisabetta avesse condiviso la mia passione, che cosa sarebbe sostanzialmente cambiato nella mia vita? Quel mattino, con lei o senza, sarei stato lì a lavarmi i denti e farmi la barba, poi avrei fatto colazione, poi qualche altra cosa, e infine anche quel giorno, come tutti gli altri che furono e saranno, come tutti i giorni della vita, sarebbe finito in un altro, e poi in un altro ancora, fino alla morte, certa e inevitabile. Elisabetta o meno, che mai poteva cambiare nella mia misera condizione di mortale, se non l’essere tragicamente distratta o addirittura invasata da un “pensiero dominante” in grado, chissà perché, di occupare tutto l’orizzonte e di cancellare, come una sorta di droga, l’infelicità e la miseria del mio metafisico destino, e di farla parere invece una sorta di empirico accidente? Nei “Pensieri” Pascal notò molto acutamente che “Senza esaminare tutte le occupazioni particolari, basta comprenderle come distrazioni… Qualcuno passa la vita senza annoiarsi giocando tutti i giorni un po’ di denaro. Dategli tutte le mattine il denaro che può guadagnare ogni giorno, a patto che non giochi più: lo renderete un infelice.”. Proprio come il giocatore di Pascal, in passato l’amore mi aveva donato, oltre che i consueti, famigerati, amletici tormenti, anche, devo confessarlo, momenti impagabili e implacabili di indescrivibili, celestiali estasi, ali fugaci che per attimi eterni mi avevano reso empirea divinità ai miei stessi, increduli occhi di creatura misera e mortale. Ma, in omaggio all’oscuro destino che vuole gli uomini dannati all’infelicità o al tedio, dopo quei momenti apparentemente così perfetti, pieno di sgomento e stupore avevo scoperto che il sia pur traboccante calice dei sensi è sol pochi istanti dopo causa certa nell’anima di inquietudini altrettanto o forse addirittura più sottilmente prepotenti che il nudo e crudo squarciarsi del dolore, che noi siamo portati a 64 La battuta è tratta da “L’Edipo a Colono”. 172 considerare un danno ma che, strano ma vero, al suo cessare è fonte di indubitabile e a volte impagabile piacere (è da cose come queste che anche il filosofo più stacanovista finisce per rassegnarsi al fatto che la vita umana non è altro infine che un quintessenziale paradosso che, ove si tenti di scioglierlo, si suddivide in infiniti paradossi). Il timore che la fonte dell’estasi si dissecchi, o che ci venga tolta, sono i minori dei mali. Il più e il peggio, come Freud spiegava in un celeberrimo e ormai quasi antico saggio, “Al di là del principio del piacere”, è che la mente umana tende come tutto l’universo all’entropia (anche se ultimamente pare tendere più che altro all’esco(r)troia), ovvero a un equilibrio che produce infine l’immobilità assoluta, la pietrificazione della morte (i fisici in effetti, parlando di questo fenomeno dicono spesso che l’universo tende alla “morte termica”). Ma il piacere, essendo un moto vitale e dunque anticaotico dell’anima, disturba questa sua incoercibile tendenza al “caos calmo” che sembra essere il suo scopo ultimo non meno che il suo ultimo destino, ed ecco dunque che esso piacere viene sentito infine più o meno inconsciamente come un disturbo, un disturbo di pari e a volte di maggior grado, appunto, che il puro e semplice soffrire (tanto è vero che Rousseau, un secolo prima di Freud, fa dire al protagonista de “La nuova Eloisa”: “Ebbro d’amore e di voluttà il mio cuore nuota nella tristezza; soffro e languo di dolore nel seno stesso della suprema felicità, mi rinfaccio come un delitto l’eccesso della mia felicità. O Dio! Che spaventoso tormento è di non potersi abbandonare del tutto a nessun sentimento, di combatterli senza posa l’un con l’altro, di sempre mescolare l’amarezza al piacere! Sarebbe cento volte meglio essere soltanto infelici.”). Dunque, in fondo in fine, cosa davvero ci rimane da rimpiangere? Ah, com’era saggio, forse ancor più di Rousseau, il nostrano Montale di “Satura” quando carico della sua a un tempo lieve ed impiombata ironia scriveva: “Vedo un uccello sulla grondaia, sembra un piccione ma è più snello, ed ha la cresta, o forse è il vento, chi può dirlo, i vetri sono chiusi. Se lo vedi anche tu – quando ti svegliano i fuoribordo – questo è quanto ci è dato di sapere della felicità. Ha un prezzo troppo alto, non fa per noi e chi l’ha non sa che farsene”. 173 Beh, detto questo, l’unica cosa cui un essere umano si può ragionevolmente rammaricare è dunque di esser nato, anche se il nascere non è propriamente un evento della vita, come del resto non lo è neppure la morte, dato che inizio e fine non sono una parte del percorso: ma se il percorso è dal nulla al nulla attraverso il nulla, mi ripetevo instancabilmente, c’era forse qualcosa che Elisabetta o, se è per questo, qualsiasi altra donna, passata, presente o futura che fosse, potessse davvero aggiungere alla mia vita? “Siamo ridicoli ad affidarci alla compagnia dei nostri simili; miserabili come noi, impotenti come noi, non ci daranno nessun aiuto; moriremo da soli”65: ma, se questo è vero – e, Dio mio, chi potrebbe negare una verità tanto evidente? – che cosa mai ha davvero da perdere o da guadagnare un uomo a questo mondo, se non la pace che può trovare solo nel fondo di sé stesso, se qualsiasi evento gli capiti non può infine provocare altro che dolore o, al limite, tedio, disinganno e indifferenza? 74. Al termine di questo aspro, duro e asciutto percorso di pensieri, mentre sorbivo il caffè al bar di fronte a casa, venni come travolto da una sorprendente, quasi inconcepibile ondata di calma, che mi sommerse per i giorni successivi, interminabile, immensa, al punto che credetti fermamente che nulla al mondo potesse mai più scuotermi da questo gesto di statua, da questa tempesta di ghiaccio che tanto pareva immobile da esser sempre esistita. Qualche pensiero angoscioso provò ancora un assalto in quell’insperato mattino di pace, ma lo respinsi citando le sagge parole del troppo giovane e troppo saggio Carlo Michelstaedter: “Come quando affievolendosi la luce nella stanza, l’imagine delle care cose, onde il vetro vela l’oscurità esterna, si fa invisibile; così quando la trama dell’illusione s’affina, si disorganizza, si squarcia, gli uomini, fatti impotenti, si (..) trovano a voler fuggire la morte senza più aver la via consueta che 65 Pascal, “Pensieri”. 174 finge cose finite da fuggire, cose finite cercando”66. Già. Ma perché fuggire di cosa in cosa, di corsa in corsa, di oblio di me in altro oblio di me cercando una pienezza che non si può mai raggiungere, se non con la morte? A che dannarsi l’anima e danneggiarsi il corpo, a che tanto disperarsi intorno a delle congiunture del mondo, a dei miraggi dei sensi che di illusione in delusione rimandano sempre al altre simili, vane e dolorose congiunture ed illusioni? Io, ex adolescente pericolosamente incline a una sorta di narcisistico culto della fragilità, ex giovane sensitivo, confuso, ridondante e classico e poi adulto romantico e passionale fino al più freddo, crudo e financo riprovevole cinismo (in effetti, come nota giustamente Leopardi, il cinismo più assoluto, risoluto e dissoluto può essere infine null’altro e nulla di più che la languida depravazione di una sentimentalità tragica, fragile e tradita), mi trovavo infine improvvisamente immerso in un mare piatto d’indifferenza – vacua, silenziosa, bianchissima: il mondo mi pareva oramai un deserto di pura luce, nudo di tutto meno che della sua accecante, perfetta nudità, mentre io, di me stesso stupito, scoprivo di non aver più sete di alcunché di diverso che la monotona distesa delle dune. «Bene non seppi fuori dal prodigio che schiude la divina Indifferenza»67: mentre come al solito, eppure così diverso dal solito, mi recavo alla libreria Martelli per piluccare qualche libro, vagavo fra le mie vecchie e sagge conoscenze e reminescenze dei tempi in cui frequentavo l’università, fra le quali cercavo delle frasi che potessero descrivere il mio nuovo stato d’animo. Cercai a lungo, e, alla fine, me ne vennero in mente due, entrambe, chissà perché, di derivazione cinese antica. La prima era una sentenza di Lao-Tzu, che avevo letta in una delle infinite traduzioni del “Tao-Tè-Ching” che il cinese antico rende possibili e che suona “il saggio non teme la morte, perché è già morto”. La seconda era ancora di un filosofo taoista, ma non ero e non sono a tutt’ora certo di chi fosse (a occhio e croce mi pare che fosse Chuang-Tzu). La frase potrebbe rendersi più 66 C. Michelstaedter , “La persuasione e la rettorica”. Eugenio Montale, da uno dei più celebri dei suoi celeberrimi “Ossi di seppia”. 175 67 o meno così: “vi sono uomini che scelgono di vivere immersi nelle città affollate e altri invece che scelgono la solitudine e si ritirano in remoti eremitaggi: il saggio è colui che sceglie di vivere da eremita immerso nelle città affollate”. Cullato nel silenzio di quelle antiche massime da quel momento in poi – contro ogni mia passata abitudine, contro ogni logica, e quasi contro la mia stessa volontà – mi scoprii a non provare alcun desiderio di nulla che non fosse interamente in mio potere: non un solo istante di tristezza, o di angoscia, o di gioia venne a turbarmi. Per tutta la durata di quel giorno e poi nei giorni successivi di quelle così dolcemente immobili vacanze estive ebbi a scoprire che in qualche modo misterioso il mio tempo quotidiano si era trasformato in una bonaccia interminabile di una quasi divina, quasi perfetta e quasi lasciva atarassia. Era quella la saggezza di cui parlavano gli stoici, e io così, senza quasi alcuno sforzo di autoriflessione e disciplina, l’avevo raggiunta? 75. Schopenhauer sosteneva che l’amore non è altro che un inganno che la natura usa per convincere gli esseri umani a propagare all’infinito la Volontà di Vivere, ovvero, in ultima analisi, il nulla, il dolore e la morte. Che dietro tale inganno, dietro le sue fasulle altezze, le sue visioni di celeste cartapesta, altro non si celano che delusioni e tormenti; i suoi dolori, come peraltro ogni dolore, sono effettivi e realissimi, i suoi piaceri ineffettivi e immaginari (si pensi, tanto per fare un esempio, che a Montale ci vorranno sei anni e più d’inferno autentico o peggio che autentico per trasformare l’Irma Brandeis di qualche appuntamento e un paio di scopatine ospedaliere nella divina Clizia delle sue “Occasioni” presumibilmente già perdute in partenza). E’ vero quel che sostiene Schopenhauer? Diciamo che, se non lo è, lo sembra. Ma, se è vero, perché mai la Volontà di Vivere dovrebbe voler propagarsi in questo modo, e non in un altro? La Volontà di Vivere, per quel che si può capire, si propaga, che so, anche attraverso il respirare, che, a dir la verità, non 176 abbisogna di similari inganni, e lo stesso dicasi del mangiare, del bere, del defecare, e di tutte quelle funzioni essenzialissime che tengono in vita le nostre illusorie speranze e le nostre effettive miserie. Perché dunque la Volontà, o la Natura, a un certo punto cessano di servirsi del puro e semplice non meno che implacabile bisogno? Perché, se un tale mezzo funziona in modo tanto inesorabilmente efficace, passare dalla necessità ineludibile alla labile blandizie di tali neghittosi miraggi per spingere l’uomo a cavalcare inutilmente l’inutile deserto, a propagare nel tempo le sue dune, a gravare di future delusioni il vuoto suo presente? Non è più certa dello scopo, invece della labilità dell’inganno, la dura impellenza del minimo necessario, l’umiliazione dell’obbligo fisiologico, gli inevitabili doveri della fame piuttosto che il lussuoso miraggio di una felicità che ben presto si scopre inconsistente? Schopenhauer, da buon filosofo, di fronte alle domande essenziali si rifugia in risposte degne di un arcivescovo o di un astrologo, e in tutta la sua opera non fa altro che ripetere che la Natura o la Volontà di vivere ci ingannano: si, va bene, ma perché lo fanno? Chi era Elisabetta, quella che rifulgeva altissima nell’illusione, o quella oscura dell’abisso di vuoto e di nulla della delusione? Illusione si definisce quel che poco dura, realtà quel che inesorabile prosegue: ma anche l’Elisabetta della disillusione svanirà, com’è svanita quella dell’illusione! Termineranno infine queste mie parole, terminerà la mia vita, si cancelleranno le sue tracce e i miei ricordi. Dunque anche la disillusione si rivelerà illusoria, bene o male, presto o tardi, a ragione o a torto. Dunque, ancora, chi era Elisabetta, chi era colui che l’adorava, chi è colui che dolorosamente la ricorda, chi sarà colui che senza accorgersene l’avrà dimenticata? 76. Invidio chi crede la nostra anima immortale, invidio chi pensa che un giorno compariremo di fronte all’Immobile Artefice del Tempo, perché questi credono anche che in quel medesimo giorno, oltre a dover affrontare la sgradevole incombenza di dover rispondere di 177 fronte al di Lui tribunale di vizi, nequizie e liquirizie, potranno anche finalmente porre a Qualcuno in grado di rispondere, si spera molto meglio di Schopenhauer, a tutte le capitali e, se è per questo, anche le provinciali e comunali domande che affannano, a parte tutto il resto, l’umana esistenza o insistenza che dir si voglia. Non solo dunque, perché viviamo, perché si desideri la felicità e solo il dolore esista (quel filosofo che diceva che questo è il migliore dei mondi possibili doveva essere nato e non mai uscito da Beverly Hills), ma anche quest’altra: perché siamo costretti a dubitare di tutto, perché di nulla, nemmeno del Nulla, si possa restar certi? Presto svanirò, irreparabilmente; la morte prepara per me il suo abbraccio di ineffabile, bianchissima conchiglia, di intemporale, interminata rosa: perché, dopo tanto inutile soffrire neppur potrò conoscere chi fosse Elisabetta, e il primo e profondo ragionar che ad amarla mi sospinse? E ancora: perché – fra le tante altre cose che la mia ex adorata poteva fare per divertirsi, fra le quali cacciarsi un vibratore dove non si può dire masturbandosi e guardando un porno strettamente avvinghiata con il suo stramaledettissimo fidanzato torinese – perché Elisabetta, stavo dicendo, dopo avermi sedotto e abbandonato mi ha voluto ancora e senza scopo sottoporre al tantalico supplizio dei suoi richiami, dei suoi sguardi, fino a farmi dubitare che per qualche oscuro motivo mi odiasse e che per questo mi volesse punire e tormentare? I giorni vanno via inutili, vuoti, ieri come oggi, come domani. Perso nella sabbia precipitosa e friabile della deserta clessidra del tempo insino e persino la certissima morte mi appare un vaneggiare di miraggi. Sono al mondo per propagare il nulla, adesso lo so, questo è il mio fine, Elisabetta fu solo uno strumento di tale metafisico, nonché metachimico inganno. Che farò ora dei miei giorni, quando più neppure un lume o un barlume d’illusione viene a consolarmi, quaggiù, nel fondo dell’abisso dove regna incontrastato il mostro, il buio eterno della Verità? 178 77. Ma allora, ovverosia circa quattro mesi fa (ora come ora mi sembrano più o meno quattro secoli) non ero ancora giunto a queste tristi ancorché del tutto ovvie conclusioni. Sebbene il mio spirito sembrasse oramai aver trovato l’agognata purificazione dall’atroce fiammeggiare del vago e derisorio amore in un supremo tumulo di grigie e fredde ceneri, verso la fine delle ferie mi resi conto che ancora non ero diventato del tutto impermeabile alle ignobili, oscene lusinghe del mondo. Trionfante e bianchissimo preludio ai colori incantati dell’autunno, settembre si annunciava coi suoi bagliori radenti e lancinanti, coi suoi tramonti sempre più estenuanti ed elegiaci: il corso di tango stava per ricominciare e, pur cercando di non farci caso, o di far finta di nulla, mi rendevo conto che il mare serenamente piatto e dolcemente indifferenziato della dolce, luminosa e quasi increduta atarassia aveva preso ad incresparsi. Non un filo di vento si muoveva in superficie, ed era dunque piuttosto facile dedurne che le onde che cominciavano a farsi udire, pur se ancora quiete e tranquille come un sospirare di risacca, provenivano da quell’inquieto abisso dove le umane passioni si nascondono a silenziosamente tendere i loro furibondi e vaneggianti agguati. Il corso di Ignacio stava per ricominciare, poi ricominciò e io, chissà perché, decisi di iscrivermi – anche se avrei potuto andare da qualche altra parte, anche se avrei potuto contentarmi di quello di Patricia e Matteo, anche se… – e alla prima lezione, per quanto mi sforzassi di far l’indifferente, mi resi conto che il fatto di non vedere la mia ex adorata aggirarsi per la sala coi suoi occhi di celestiale crisalide, col suo incantato incedere di terrena libellula, era per me motivo di un piuttosto triste senso di sollievo (sollievo da che, visto che non sentivo o credevo di non sentire altro che nulla? (?!?)). La successiva settimana poi mi sentii, come dire, come angosciosamente in salvo, ma intanto – ahi, intanto! – perché scongiuravo me stesso di non sperare che…, di non desiderare che…, perché tutto (tutto cosa?) era inutile, tutto era già sciupato? Forse “lei” non sarebbe più tornata, forse non l’avrei più rivista, forse davvero quel lungo tormento era per finire per sempre, ma – ahimè – nel corso di quella fatidica 179 seconda lezione, come più o meno sotterraneamente mi aspettavo e ancor più sotterraneamente speravo, Elisabetta ricomparve con dolce e maestoso sorriso sulla porta della sala e con ciò anche in quella della mia indomita, innamorata debolezza. Fu così che il temuto, previsto, e odiato e adorato brivido del folle desiderio traversò di nuovo la mia anima, in cui da più di un mese regnava un cristallino velo di imperturbabile silenzio. La vidi, vidi il suo volto fra la ressa dei ballerini (quella sera c’era, per fortuna, molta gente) come si può vedere una luce intensa e purissima in un buio perfetto. Ma chiusi gli occhi e perseverai, volli a tutti i costi perseverare sulla strada della saggezza: fuori dal silenzio dei sensi – da quella sorta di involontaria stasi che quasi come un dono del Cielo mi ero ritrovato in cuore – non c’era, finalmente ne ero certo, il canto dolce della felicità. Non c’era nemmeno il grido furioso del piacere: c’era solo il morso atroce della passione insoddisfatta, dell’agonia, della vana attesa! No, non sarei andato a salutarla. Avrei evitato anche solo la tentazione di riprendere in qualsiasi modo qualsiasi rapporto, e lei (questa volta ne ero davvero certo!) avrebbe intuito e fino in fondo capito quali fossero o fossero stati i miei sentimenti nei suoi confronti e mi avrebbe finalmente, come minimo, lasciato andare in santa pace a quel paese, che proprio santo non è, ma piuttosto tranquillo deve essere, dato che nessuno ci vuole andare di sua spontanea volontà. Quella non-storia, ammesso che avesse avuto un passato, non aveva alcun futuro, ed era dunque giusto che finisse in quel modo, in quella distanza e quel silenzio che la sua strana, improvvida somiglianza con un amore del mio passato aveva non meno improvvidamente interrotto. In fondo, alla fine di tutto, pensandoci bene, proprio quella doveva essere la vera ragione del mio temporaneo stato di infermità mentale, e null’altro: i ricordi che Elisabetta mi aveva consciamente o inconsciamente suscitato. Quando tanto enigmaticamente avevo perso la testa per lei, un anno o forse un secolo fa, o domani, chi può dirlo, che altro potevo saperne, cosa di più poteva avermi impressionato, se non la sua vaga e stralunata somiglianza con un volto amato di tanti, di troppi anni prima? Forse avevano ragione Freud e Leopardi, quando 180 affermavano in inconsapevole coro che l’amore presente altro non è che il ricordo-ripetizione di amori passati – gli amori dell’infanzia – anche se – devo sottolinearlo – a me questa definizione così precisa, così empiricamente circoscritta non riesce tutt’ora a convincermi del tutto. Se scrivessi io un trattato sull’amore direi, molto più genericamente, che l’amore presente non è altro che il ricordo che un tempo si è amato, e, anzi, mi è sempre venuta spontanea l’ipotesi che il tempo cui il ricordo amoroso si riferisce sia da collocarsi totalmente fuori dalla scena del tempo quotidiano, quello in cui di fatto le persone si incontrano e si innamorano, quasi che la persona di cui ci innamoriamo non sia altro che una porta verso una diversa dimensione della vita, e, con ciò, anche del mondo (Dante pensava che Amore non fosse altro che l’annunciarsi della divina salvezza attraverso un simbolo terreno, Socrate, come abbiamo visto, un ricordo della divina cavalcata verso e attraverso il mondo iperuranio: ma non può esserci un divino senza nome, un divino senza Dio, per così dire, cui il ricordo o la profezia amorosa si riferisce? Io credo di si). In effetti, più ripenso a questa storia o non-storia che sto raccontando, più mi convinco che, in generale, i fatti rilevanti che riguardano un amore siano sostanzialmente inconoscibili: la coscienza è un palco i cui attori sono i nostri sentimenti, che però recitano un testo che hanno imparato Altrove. Il sentimento amoroso entra in scena e ci annuncia – per mezzo di languori, rossori, entusiasmi, angosce, nostalgie e frasi, rime ed immagini di ogni sorta – che siamo innamorati di una certa persona, e così esultiamo, e tremiamo, e ci rannicchiamo e ci rammarichiamo, mentre assistiamo allo svolgersi di questa strana recita: ma chi e perché abbia scritto quel testo, in cui magari alla fine si mette in scena il nostro stesso suicidio, non lo sapremo mai. Il Testo, o, se si vuole, la Recita, la possiamo, anzi, la dobbiamo ascoltare dall’inizio alla fine, e, in un certo senso, non abbiamo nessuna possibilità di intervenire sul suo svolgimento (anche le deviazioni che tentiamo, anche le improvvisazioni che ci inventiamo, fanno parte del Destino da sempre inscritto nel Testo). Ma invano ci domanderemo, magari per anni e anni, magari per tutto il resto della vita, chi possa essere 181 l’Autore che a tale Recita ci spinga e ci costringa, tanto come Spettatori che come Attori, o meglio: come Attori costretti ad assistere da Spettatori alla loro stessa predestinata Recita. Il nostro destino ultimo non è il Nonsenso, ma bensì e benpeggio, l’Inconsapevolezza, il Nonsapere e l’Ignoranza o Chissà Che (ammetto però che alla fine tutte queste iniziali maiuscole non mi dicono più un Cazzo). 78. Comunque sia, intimorito com’ero al pensiero di ricascare nei miei da troppo poco passati deliri, per non vedere Elisabetta e non farmi da lei vedere, per non parlarle e perché non mi parlasse, cercai per quanto è possibile a una persona che supera il metro e novanta di altezza di occultarmi, di mimetizzarmi nella ressa dei ballerini come un morto si occulta e si mimetizza nella foto in cui ci sorride, chissà, forse per la prima volta in modo sincero, dalla lapide. Quell’ora, quell’interminabile ora di lezione sarebbe ben presto finita, mi ripetevo a mo’ di incoraggiamento, e nel non salutarsi, nel non guardarsi, nel non parlarsi più, quell’amore iniziato quasi un anno prima sarebbe dunque e ordunque finito per sempre. Ma, oh polvere da polvere alla polvere! oh niente da niente verso il niente! appunto, niente di niente accadde di quanto da me ragionevolmente deciso e previsto: ogni mia interna soluzione e risoluzione, assoluzione o dissoluzione, risultò infine, ahimè, completamente inutile. Con ogni evidenza, ci sono dei casi della vita che non sono destinati in ogni caso a concludersi in modo semplice, e, anzi, quanto più si cerchi di abbreviarne l’agonico finale quanto più esso dura e perdura in un annodarsi sempre più labirintico, sempre più intricato e inestricabile. Nonostante le mie manifeste manovre tese a evitarne financo lo sguardo Elisabetta – incredibilmente! – mi cercava fra la ressa dei ballerini e delle ballerine, sorrideva con aria felice (che bello rivederti! sembravano dire i suoi occhi con espressione insieme soavemente luminosa e innocentemente idiota) e non sembrava aver capito che desideravo 182 che mi stesse lontana, il più lontana che fosse possibile! Mi portai al lato opposto della sala e, addirittura, controllavo i suoi movimenti per fare in modo di essere sempre alla massima distanza possibile dalla di lei vellutata pelle, dal suo magico abbraccio, dai suoi passi di terrena farfalla, ma non ci fu niente da fare. Al momento dell’inizio della seconda lezione, mentre gli allievi formavano un largo cerchio intorno al maestro – che stava spiegando il passo che avremmo dovuto imparare quella sera – Elisabetta, sotto lo sguardo attonito di tutti, traversò quasi di corsa l’intera sala che ascoltava in silenzioso rispetto gli insegnamenti del buon Ignacio, indi mi poggiò delicatamente la sua mano maledetta, stramaledetta e fatata sull’avambraccio e mi chiese poscia con la sua voce inimitabile, dolcissima, da topo dei cartoni animati: “come stai?”. Di nuovo sentii nel sangue quel fluido infernale – di desiderio, di dedizione, di ilarità e fantasmi – che un anno prima mi aveva sottomesso come un incantesimo. Le risposi come un automa: “sto bene, grazie”, e, per mia fortuna, a quel punto quello stranissimo cartone animato umano se ne tornò al suo posto, pur continuando a guardare di tanto in tanto in mia direzione e a sorridere. Come suscitato o resuscitato da un’inesorabile, impalpabile droga il mio delirio riprese “quello che avevo scambiato per la freddezza d’un amore spento non era che l’accanimento della disperazione”68. Quella sera Elisabetta ballava con l’avvocato che alla cena di fine corso le aveva fatto quelle avances pesanti che mi avevano consentito di udire dalla sua stessa voce che, ehi!!!!, lei era fidanzata (già, e allora cosa vai in giro per tutto il mondo d’Egitto a rizzar obelischi come una sfinge allupata, fidanzata torinese dei miei ornitorinchi! (per chi non l’avesse capito, l’obelisco sarebbe quello che sta fra i due ornitorinchi, e il tutto serve di solito essenzialmente a far pipì)): forse fu per questo che in quel momento avrei fatto volentieri con il gargarozzo di entrambi una bella composizione di nodi da marinaio, possibilmente in stile astratto-espressionistico, anche se devo confessare che la mia ira era in quel momento diretta più che altro verso l’avvocato, non so bene perché, forse è proprio la professione in sé e per sé che mi viene 68 J. J. Rousseau, La nouvelle Eloise, Parte III, lettera xviii 183 spontaneo di ritenere infame (pochi sanno che fare l’avvocato del diavolo è un mestiere particolarmente difficile perché e sol perché non c’è un solo diavolo al mondo che non sia anche un avvocato), non lo so. So solo che – forse invasato dallo spirito stesso di Evaristo Carriego, ovvero “da quell’istante supremo in cui s’adempie la terrena mission delle canaglie” – per un paio di interminabili minuti dovetti reprimere rabbie cerbere, acerbe e innominabili, e tanto mi imbufalii che arrivai fino al punto di immaginarmi nel bel mezzo di Palermo, gaucho, guapo o compadrito, fate voi, l’importante era solo avere un coltello tintinnante appeso alla cintura e un pretesto purchessia per avviare un’animata discussione con il mio odiosissimo rivale, discussione che mi desse infine una scusa – per quanto cavillosa, cavallina o cavillante – per sovrapporre alla composizione di nodi da marinaio di cui sopra un tormentato ritratto cubista ricavato direttamente dal vivo della sua faccia (per chi non lo sapesse, Palermo sarebbe un celebre barrio o quartiere di Buenos Aires, ma in quel momento a me andava bene anche la Palermo nostrana, dove, a quel che si dice, si incontra a tutt’oggi una certa tolleranza per coloro che prendono a schioppettate i rivali in amore). Ma, nonostante la rabbia impotente che mi rodeva e mi torturava – o forse proprio a causa di quella – la passione per Elisabetta che avevo insensatamente creduto per sempre sopita – e che invece era stata solo duramente repressa o momentaneamente sospesa – risorse dal profondo della mia anima esaltata e sconvolta, e con così dirompente forza da suscitarmi addirittura delle visioni: incredulo di quanto mi accadeva, mentre la osservavo ballare credevo di vederla, o, meglio, la contemplavo in estasi attorniata da una sorta di sfera luminosa (sic!), che pareva emanare misteriosamente dal suo corpo, ‘sì che “Quale è colui che suo dannaggio sogna e che sognando desidera sognare sì che quel ch’è come non fosse agogna” 69 mi pareva che lo spazio della sala si incurvasse e quasi si genuflettesse davanti e intorno alla di lei esile figura, che mai mi era sembrata così meravigliosamente aerea, leggiadra, fatata, così fatale, sfumata, così perdutamente e disumanamente astrale. Mi pizzicai forte, dapprima 69 Dante Alighieri, “Divina Commedia”, Inferno, XXX. 184 su un braccio poi addirittura su una guancia, nel tentativo che credevo ormai disperato di riprendere contatto con una sempre più mitologica e irraggiungibile realtà, ma che invece, contrariamente alle mie aspettative, andò a buon fine, anche se non immediatamente. 79. Uscendo dalla sala infatti, diversamente da un anno prima, ebbi grazie al Cielo o all’Inferno – anche se più probabilmente devo benedire il Purgatorio, con particolare riferimento a Guttalax, Dolce Euchessina, pastiglie Falqui e simili – ebbi, stavo dicendo, la forza di porre un qualche freno allo tsunami del mio farneticante desiderio, e di calmarmi: almeno parzialmente, almeno fino al punto di sovrapporre una chiara e limpida ribellione razionale a tali assurdi, inconcepibili, incontenibili e quasi incredibili eventi (“Conosco cieli che esplodono in lampi, e le trombe e le risacche e le correnti: conosco la sera, l’Alba che si esalta come uno stormo di colombe! E ha volte ho visto ciò che l’uomo ha creduto di vedere!”, si va beh, buon vecchio Arthur, ma quando mai si è visto lo spazio incurvarsi e quasi genuflettersi intorno all’aura luminosa emanata da un’interprete per sordomuti che balla il tango? (beh, se non altro l’episodio dimostra quanto avesse ragione il buon vecchio Cioran quando esclamava “Vitalità dell’Amore! Non si può, senza essere ingiusti, parlare male di un sentimento che è sopravvissuto tanto al romanticismo quanto ai bidet.” 70). D’altra parte, come giustamente nota Roland Barthes, essere innamorati significa essere pazzi, ma il fatto di arrivare a pensarlo, a poterselo dire, consente senz’altro di sdoppiare la propria immagine, di contemplare la propria pazzia come dall’esterno, di farsene un’immagine chiara e distinta in modo da discettare su di essa, di raccontarla, di criticarla, di esecrarla infine e, in questo modo, di evitare di essere inghiottiti dal suo tenebroso non meno che ironico vortice (allo stesso fenomeno allude Bataille quando afferma che “La 70 E. Cioran, “Sillogismi dell’amarezza”, Adelphi, p. 94. 185 nostra esperienza segreta non può entrare direttamente nella parte chiara della coscienza. Perlomeno, la coscienza distinta ha il potere di discernere il movimento mediante il quale essa scarta ciò che condanna.”). E io, per salvarmi (si, ma da che?), proprio questo presi a fare: a osservarmi, a descrivermi, a criticarmi, irridermi, esecrarmi. Dunque mi condannavo, e condannandomi mi assolvevo, mi salvavo dalla prigionia di quel delirio tanto intimo e silenzioso quanto assorbente e assordante, ma, non ostante tutto, non ostante il subentrare di un certo autocontrollo e di un minimo di calma, sul treno per tornare a casa dovetti tanto constatare quanto arrendermi al fato e al fatto che Elisabetta era ritornata di nuovo al centro nonché alla periferia dei miei pensieri, anche se ora mi sentivo più forte, o meno vulnerabile di qualche mese prima, non fosse altro che per un bel po’ non ci avevo pensato quasi per nulla. Pure, incontestabilmente, stavo di nuovo soffrendo le passate pene, e pieno di ogni sorta di dubbi tanto erotici che filosofici, cominciavano a vacillare quelle ferree conclusioni cui, solo poche settimane prima, il buon vecchio Pascal mi aveva inesorabilmente spinto: davvero potevo considerare quella sorta di stanza della tortura che l’Amore stava apparecchiando per il mio fin troppo prossimo futuro, una sorta di distrazione dalla mia misera condizione di mortale? “Si cerca il riposo combattendo diversi ostacoli; ma quando si sono superati, il riposo diventa insopportabile; perché si pensa o alle miserie che si hanno o a quelle che ci minacciano. E quand’anche ci si vedesse al riparo da ogni parte, la noia, con la sua autorità privata, non tralascerebbe di affiorare dal profondo del cuore… l’uomo è tanto infelice, che si annoierebbe lo stesso anche senza nessuna causa di noia, per lo stato stesso della sua conformazione”: Dio mio, era vero davvero e veramente tutto questo? Davvero io mi stavo più o meno incoscientemente procurando quel devastante genere di del tutto evitabile autoillusione solo per non entrare in contatto con delle miserie inevitabili, metafisiche, contro cui nulla al mondo avrebbe potuto fornirmi un vero rimedio (in effetti, al mio mal d’Amore un rimedio pur a questo punto del tutto improbabile esisteva, ovvero che Elisabetta, che so, invece che limitarsi a poggiare la sua fatata manina sul mio avambraccio si fosse decisa, diciamo così, ad 186 appoggiarla un po’ più in basso, o, ehm, al limite, se proprio non voleva o poteva far di più, ad abbracciarmi e baciarmi: invece, in effetti, a quel genere di mali cui allude Pascal non c’era allora e non c’è altro rimedio oggi che il non esser mai nati)? Ma, pensandoci meglio, guardando più a fondo, confessandomi più intimamente, non poteva invece essere vero il contrario? Non poteva darsi che un mese e mezzo prima fossi andato a inventarmi Pascal, gli stoici, i taoisti e compagnia bella solo per proteggere la mia anima sconvolta dal dolore di aver perso per sempre la milonguera dei miei sogni? Davvero aveva ragione, o davvero credevo che avesse ragione, in coro con il Pascal dei “Pensieri” il Kafka dei “Quaderni in ottavo”, quello da cui avevo tratto uno dei primi, tanto goffi quanto speranzosi sms a Elisabetta, quando affermava che vivere significa essere rinchiusi in un infinito carcere, in cui l’unica libertà concessa è quella ogni tanto di poter o dover passare da una cella all’altra (mentre si è nel corridoio può accadere che Dio si rivolga al secondino che ci scorta e gli dica: questo lasciatelo andare, viene con me: beh, ma quando è che arriva Dio, santo Dio?)? Tormentato com’ero da questa sorta di dubbi eretici, erotici ed esistenziali, l’unica cosa di cui rimanevo certo era invece che, ancora una volta, dovevo tanto umilmente quanto furiosamente riconoscere che non ostante tutta la mia passione, non ostante questa che oramai potevo definire una vera e propria ossessione, non ero riuscito e non riuscivo a venire a capo di niente quanto all’identità profonda della mia adorata: non ero riuscito a conoscerla, a capirla, a sentirla, questo era chiaro, perché i suoi comportamenti mi riuscivano a tuttora completamente incomprensibili. Era fidanzata, si, ma chi era questo fidanzato, che non era capace di tenerla lontano nemmeno da un poveraccio che aveva avuto la disgrazia di innamorarsi di lei? Oppure era proprio questo il problema, che non aveva capito i miei sentimenti? Si, è vero, le avevo spedito quella poesia qualche mese prima, ma il numero era anonimo e poteva darsi che la ragazza, con ogni evidenza particolarmente dura di comprendonio, avesse pensato a un’altra persona, o a uno sbaglio di numero, a un refuso della Telecom o qualcosa del genere, non c’era da stupirsene: se il linguaggio fosse uno strumento di comunicazione veramente 187 soddisfacente gli esseri umani non avrebbero inventato la bomba atomica. Dunque dovevo fare qualcosa: ma cosa? Qualsiasi tentativo di liberarmi di lei era miseramente fallito, anche se, a dir la verità, notavo alcuni promettenti mutamenti: se all’inizio di questa strana storia o non-storia che dir si voglia mi sentivo in quello stato che l’Ecclesiaste definì come “abominio della desolazione”, adesso mi trovavo nello stato contrario, che sarebbe giustappunto quello della “desolazione dell’abominio”: mica male no? A me sembrava un bel progresso. 80. Fra l’altro, nel corso dei lunghi, quasi eterni giorni della mia benedetta atarassia, avevo riflettuto anche sull’assurdità, diciamo così, sociale della mia passione, ricordando il modo invero piuttosto “ragionevole”, se non proprio razionale, in cui molti miei colleghi si erano in vario modo sentimentalmente sistemati o addirittura accasati. Forti del loro status economico si erano accoppiati con femmine del loro medesimo livello, oppure dotate di caratteristiche non facilmente reperibili nel corso di un “random searching” (uno in questo senso da me particolarmente invidiato conviveva da un paio d’anni con una spogliarellista dell’Est il cui deretano dovrebbe essere dichiarato, come minimo, specie protetta, parco nazionale, o cose del genere (l’ottava meraviglia del mondo è caduta un po’ in disuso)). E io, ovvero quello scapolo d’oro impenitente e impertinente che mi gloriavo d’essere, avrei dovuto prendere in casa un’interprete per sordomuti in vari sensi e da vari punti di vista piuttosto scalcinata (forse non avevo pensato, osservandola senza indossare le lenti deformanti della farneticazione amorosa, che trattavasi di femmina piuttosto anonima, o forse, addirittura, un po’ bruttina?), che come unica caratteristica notevole aveva quella di ballare il tango in modo che mi pareva divino? E, in effetti, a pensarci bene, non poteva darsi che quell’innamoramento – nato da un tango casuale – non fosse infine da considerarsi come il delirante frutto di sensazioni oniriche, del tutto occasionali e passeggere, quindi ancor più inadeguate a 188 fondare una convivenza di lungo periodo che il deretano della sunnominata convivente del sunnominato collega che, in caso di imprevedibile decadimento, poteva essere aggiustato con fitness e silicone? In fondo, non è che in tutto quel tempo in cui ero stato innamorato, alla fine avessi avuto modo di conoscerla bene, di raggiungere con lei anche un minimo di intimità, fosse pure di genere e stile meramente amichevole o compagnonesco. Che altro poteva essere dunque quella non dichiarata e perciò così ferrea decisione di averla e addirittura sposarla (!?!?!?!) se non il frutto di una sorta black out del senso comune, di un sonno della ragione che, come tutti sanno, genera mostri (in effetti, quell’innamoramento non mi stava facendo forse passare delle sofferenze paragonabili a quelle che potrebbe causare un vero e proprio incubo, ovvero, appunto, un mostro?)? Nel mentre mi affrettavo verso la stazione mi tornò in mente una situazione simile, che avevo incontrato in un romanzo il cui titolo è, suppongo, ormai assai più famoso del suo contenuto, ovvero “L’insostenibile leggerezza dell’essere”. Si racconta ivi la storia di un chirurgo prestigioso, un certo non meglio precisato Tomas, che si innamora perdutamente di una cameriera di provincia, certa Tereza, una femmina che, in teoria, causa uno status sociale alquanto basso, se non proprio degradato, non avrebbe dovuto né potuto avere nessuna chance di suscitare in lui alcun genere di durevole attrattiva. Invece, guarda un po’, questa ragazza fragile e male in arnese in breve tempo riesce nell’ardua impresa di andare a vivere con lui – scapolo ancor più di me impenitente e impertinente – e poi addirittura a farsi sposare, evento quasi impensabile questo, dato che il chirurgo in questione appare come un estremista libertino che non si capisce bene dove trovi il tempo di operare i suoi pazienti, visto il numero di amanti che frequenta senza posa, senza spesa e, naturalmente, senza sposa (l’enigma può venir risolto solo immaginando che amanti e pazienti siano le stesse persone e che Tomas si occupi di loro contemporaneamente dal punto di vista medico e sessuale). 189 81. Comunque sia, questo luminare del sesso non meno che della medicina – scoprendosi perdutamente innamorato e addirittura sul punto di scoppiare in impudichi singhiozzi, mentre curvo e in ginocchio si inebria del fiato profumato dai sogni e dalla febbre di questa donna dotata di una posizione sociale tanto inconsistente – giunge fino al punto di sentirsi un piuttosto ridicolo impostore, un crasso ipocrita in quello che avrebbe dovuto essere invece uno dei momenti più veri e importanti della sua vita, quello dell’eternamente virginea scoperta dell’Amore, dunque della più rara, incantevole e sconvolgente delle passioni umane. Ma come è possibile che un uomo del suo livello possa essersi addirittura innamorato di una creatura tanto insignificante e inadeguata? che cosa ci fa una cameriera di provincia nel glorioso e invitto divano a una piazza di un chirurgo e Casanova di successo? Era Amore quello, o non stava invece ingannando sé stesso con una sorta di recita a soggetto, solo per poter credere, almeno per una volta, almeno per un attimo, di non essere quella persona frivola e superficiale che la monomaniaca passione e la fatua dipendenza dall’ottusa, ripetitiva e quasi macchinica aggressività del sesso ogni giorno gli testimoniava che fosse? Pure, nessuna riflessione razionale riuscirà a distogliere Tomas da questa relazione tanto improbabile da sfiorare l’improponibile e il grottesco: lui non vedeva, non mai vedrà, come forse non mai aveva visto una cameriera di provincia piombata in casa sua a rovinare la rocambolesca leggerezza delle sue innumerevoli relazioni libertine. Tereza fin dal primo istante gli appare come alla moglie del faraone apparve Mosè, come un bimbo portato dalla corrente in un cesto di vimini ricoperto di pece, un bimbo che il fiume della vita aveva depositato dolcemente sulle rive del suo letto. Rapito da questa commovente immagine, Tomas viene sopraffatto fin nelle più intime profondità di sé stesso dalla tenerezza e dalla compassione (che in questo senso viene vista come un patire-con.., dunque come un sentire-con.., dunque infine come un essere la stessa cosa con l’amata (che è quello stesso che accade all’amante di Giulia nel già 190 citato romanzo di Rousseau “Ah, se tu sapessi amare come me, la mia felicità ti consolerebbe come la tua pena mi addolora, tu sentiresti i miei piaceri come io sento la tua tristezza! (..) Io non mi appartengo più, lo confesso, la mia anima alienata vive tutta in te.”), e, stando così le cose, non aveva potuto fare a meno di prendersene cura con tutte le attenzioni del caso, oltre che con quelle della necessità, naturalmente (se la moglie del faraone non fosse stata sopraffatta dalla tenerezza e dalla compassione Mosè sarebbe morto, e tutta la storia dell’Occidente sarebbe cambiata, o forse non ci sarebbe neppure mai stata, sottolinea Milan Kundera, con non si capisce bene quanta ironia (Pascal, d’altra parte, sosteneva che se il naso di Cleopatra fosse stato appena più piccolo, parimenti, la Storia sarebbe cambiata, e più di uno studioso gli ha dato ragione senza riderci nemmeno troppo su (forse sarebbe stata diversa anche la storia d’Italia, se il pappagallino del Presidente di tutte le Presidenze fosse stato anche solo un po’ meno affamato)). Ma, mi domandavo io mentre pensosamente disperato mi avviavo verso la stazione, se l’amore nasce davvero così, come dice Kundera, ovvero nasce quando un incontro, una persona e una situazione qualsiasi si fissano in noi in forma di immagini poetiche, ovvero di metafore, quale metafora era diventata per me quella strana ragazza? A quale metafisica entità poteva oscuramente alludere un’interprete per sordomuti che balla il tango “perfetta e fatale come una foglia nel vento” (così l’avevo vista svanire alla milonga di fine corso solo tre mesi prima, e forse proprio così l’avevo vista arrivare nel momento in cui per la prima volta posò la sua mano lieve, fatata e fatale sul mio braccio (o che sarebbe successo se l’avessi vista, al contrario, “ridente come un’alba, vergine e pura come verde foglia sul vergine e verde protendersi al vento del ramo alato della primavera”?)? Chissà, forse la magica gestualità di questa ragazza mi aveva fatto pensare alla libera, luminosa, voluttuosa leggerezza che può liberarci talvolta da questa sorta di Vergine di Norimberga che è la vita umana, utero stretto e soffocante quanto più all’infinito l’universo si estenda e si dilati? O alla fatua eppur ferrea, inesorabile casualità che regge il nostro fato, e dunque i nostri amori, le nostre passioni più invincibili, ovvero le cose di cui consiste il senso della nostra vita, o, 191 addirittura, la nostra vita stessa (ricordo che una foglia nel vento può essere l’immagine di un dolce abbandono, come della tragica sottomissione al destino di cui, in gioia e dolore, sempre e comunque siamo schiavi)? Se è ragionevole paragonare la vita umana a una foglia trascinata dal vento, non era forse allora in quel momento logico e ragionevole pensarmi appunto come una foglia per la quale un certo momentaneo refolo aveva assunto il volto oscuro e dorato, il moto turbinoso e languido delle onde di miele in tempesta – ovvero del tango incantato e ammaliatore di un’interprete per sordomuti per altro verso squattrinata, giovane si, ma non più giovanissima, fisicamente mediocre o, chissà, forse persino un po’ bruttina? Comunque sia, era deciso: dovevo riprendere in mano le redini della mia vita: “Dipende da noi soltanto essere in un modo piuttosto che in un altro. Il nostro corpo è un giardino e il suo giardiniere è la nostra volontà” (in quel momento in cui con ogni evidenza mi faceva comodo, mi fu facile dimenticare che l’ottimista della volontà in questione fece una fine ancora peggiore del beneamato grande statista Bettino Craxi (si tratta di Iago, l’eroe negativo dell’Otello, che finisce i suoi giorni in vario modo condito e cucinato, anche se il buon vecchio Shakespeare, giunto oramai alla fine del dramma, non si attarda in sgradevoli precisazioni (scuoiato, impalato o peggio? il grande statista invece, pur se morto in esilio, alla fine è riuscito persino a farsi dedicare qualche via qua e là in giro per l’Italia (e che quest’uomo fosse ben più che un grande statista, ma addirittura un quasi-santo, lo si scopre percorrendo queste vie perché, pare, a tutti i fedeli che intensamente lo ricordino passando per la strada col suo nome battezzata, lui in contraccambio fa miracolosamente sparire il portafoglio)))? Così, una volta salito sul treno, affacciato al finestrino per prendere un po’ di vento che dalla soffocazione dell’angoscia potesse per un attimo fingere di liberarmi e guardando al contempo in direzione della stazione che si allontanava e diventava una piccola luce persa nella notte, pensai intensamente al deretano della spogliarellista dell’Est con cui conviveva il mio collega, e, pizzicandolo e accarezzandolo mentalmente, argomentai che, in fondo infine, al mondo ci sono foglie e foglie, venti e venti, e che era giusto che il 192 mio dovesse, in qualsiasi modo e a qualsiasi costo, cambiare direzione, non foss’altro che per obbedire all’inevitabile imperativo categorico di proteggere la mia a quanto pare assai labile e pericolante salute mentale. L’importante non era tanto decidere cosa fare, ma la direzione in cui andare e, in qualche modo, i mezzi per arrivare dove volevo arrivare li avrei trovati (già, ma come può una foglia decidere quale direzione deve prendere il vento? questa è solo una metafora, si potrebbe obbiettare, ed è una giusta obiezione: ma non potrebbe darsi allora che la vita umana tutta non sia altro che un’interminabile metafora? e, se questo è vero, non può darsi che la metaforica spirale sia infinita, stringendosi verso l’interno come dilatandosi verso l’esterno, e che dunque ogni metafora alluda sempre e solo a un’altra metafora, e questa a un’altra, e questa a un’altra ancora, e così via, all’infinito, tutto il regno dell’Essere nulla di più o di meno o di diverso da questo: metafore che fra loro si rincorrono senza mai raggiungersi, ognuna nell’altra sfuggendo, in un’infinita catena di impotenti allusioni?). 82. Beh, comunque sia, alla fine, a furia di dubitare, di pensare, di alambiccare e almanaccare con le mie oramai esauste meningi, nei giorni successivi a quella sorta di mistica visione decisi che, per almeno tentare di risolvere quell’improbabile, indescrivibile e fin quasi innominabile situazione, potevo e dovevo tornare al mio primitivo progetto: da un lato, continuare la mia strategia di evitare, o, almeno, cercare di evitare a lezione ogni contatto verbale o fisico che fosse (con una creatura del genere anche le cose più banali sembravano trasformarsi, mi si creda, in imprese complicate a volte fino all’incredibile); dall’altro di spedirle, che so, una poesia alla settimana, sperando che Elisabetta in questo modo riuscisse a connettere le due cose, e comprendesse infine e fino in fondo le ambasce che a causa sua mi era toccato di sopportare. A causa sua? – si domanderà il lettore arricciando il naso insospettito – si, certo a causa sua! – risponderò io furibondo siccome una biscia e nel tempo 193 medesimo afferrando il suddetto naso del suddetto lettore e torcendolo simil cavatappi: si, tutto quanto era successo a causa, anzi, proprio per colpa sua! Perché? Ma perché sarebbe bastato che otto mesi prima mi avesse detto, al suo ritorno da Torino, che aveva passato il fine anno con il fidanzato (la subdola ammaliatrice mi aveva detto che lo aveva passato con il padre: che fosse quello il fidanzato?) e io mi sarei risparmiato mesi e mesi di inutili sofferenze! In fondo, la gratificazione di sentirsi corteggiata, desiderata e di rifiutarmi l’aveva avuta abbondantemente (pare che le ragazze fidanzate vivano più che altro a questo preciso scopo: nascondere accuratamente il fatto di esserlo, farsi corteggiare il più a lungo e il più caldamente possibile per infine congelare il corteggiante dicendo che hanno il ragazzo, l’uomo, o il convivente, il marito, o quello che è: questo, naturalmente, se si è fortunati, come io non fui; ma analizzeremo più oltre la ragione di questo apparentemente assurdo passatempo con cui la pedissequa vanità delle donne intrattiene probabilmente da sempre l’incurabile stupidità dei maschi): per mesi l’avevo cercata, per mesi avevo ballato appassionatamente e perdutamente con lei, per mesi l’avevo inutilmente invitata a uscire! Dunque, che cosa voleva ancora da me? Cosa dovevo fare ancora perché mi lasciasse finalmente in pace? 83. Poco sopra, o molto sopra, comunque sia, prima di adesso, accennavo al fatto che Schopenhauer avrebbe disvelato all’umanità illusa, la verità, o addirittura, la Verità quanto all’insidiosa e scurissima sostanza che si nasconde dietro le luminose e celestiali apparenze dell’Amore. La Verità? Ho scritto proprio io proprio questa parola, la Verità? Ma si, ma certo! Io, proprio io, incapace in tutta la vita e con tutta la mia filosofia di produrre altro che castelli di cartacei e incartapecoriti dubbi in aria, sono arrivato a dire proprio questo! Pur preso alla gola e quasi soffocato dalle mie innominabili eppur fin troppo nominate pene d’amore ho pronunciato qualche pagina sopra la fatale parola, ho detto Verità! In appoggio alla tesi di 194 Schopenhauer ho confermato da parte mia che l’Amore non sarebbe altro che un inganno che la Volontà di Vivere usa per spingere il genere umano ad accoppiarsi e riprodursi, questa sarebbe la Verità! Ma la Verità è la cosa più importante del mondo e non conviene di lasciarsi convincere troppo facilmente! Forse, prima di abbandonarsi al buio eterno è meglio lasciare accesa un attimo la luce della ragione – o almeno quella del bagno – e vedere o tentare di vedere un po’ meglio in che consista, questa supposta Verità, che ha giustappunto l’apparenza di una supposta di metafisiche dimensioni. Se andiamo ad analizzare il problema in ambito storico-critico, come prima cosa dobbiamo riconoscere che Schopenhauer non fu il solo né il primo e – ahimè – nemmeno l’ultimo a giungere tali amare conclusioni riguardo all’amore umano (l’ultimo, per quel che ne so, sono io: il che vuol dire, come minimo, che di tipe come Elisabetta vanno in giro un po’ per tutte le epoche e distribuite per tutti i continenti, un fatto questo facilmente dimostrabile: per esempio, in un libro di antropologia ho scoperto che, per esempio, nel mondo mesopotamico “l’ardat lili è «una vergine senza latte», una femmina che si unisce senza poter diventare madre, e che, dopo aver acceso nell’uomo la lussuria, non lo soddisfa”71 (in effetti l’espressione accadica “ardat lili” si può rendere in italiano, meglio che con l’espressione “vergine senza latte”, con “interprete per sordomuti torinese in cerca di distrazioni da un fidanzamento lungo come la fame con un fidanzato evidentemente molto barboso”). Scartabellando fra tutte le concezioni concepite dai vari filosofi nel corso dei vari millenni, delle Weltanschauung altrettanto o maggiormente pessimistiche che quella di Schopenhauer le possiamo ritrovare in molte filosofie orientali, in molti mistici cristiani di varia ispirazione e setta, come in molti filosofi greci e latini: già da gran tempo nel mondo classico pre-platonico si era individuato nelle passioni in generale e in Eros in particolare una delle maggiori fonti, se non proprio la maggiore, dell’infelicità e della depravazione umane (l’orfismo, una religione misterica che ha ispirato, a quanto sembra, tanto Platone quanto Socrate, predicava una rigorosa 71 F. Thureau-Dangin, Rituels Accadiens, Parigi, 1921, p.161. 195 astinenza dai desideri, in particolar modo da quelli sessuali, ai fini della purificazione necessaria a riunirsi alla Sostanza Originaria distaccandosi dalla quale gli uomini sono o sarebbero caduti nella loro infelice condizione, appunto, umana, dannata dalla corruttela del corpo e dei sensi traditori, oltre che dalle femmine ammaliatrici e traditrici: più oltre vedremo come questa strana sorta di religione filosofica abbia un interesse anche più ampio ai fini del nostro discorso). Schopenhauer fa dunque parte di un coro in cui la voce più simile alla sua la possiamo ritrovare, strano, anzi, stranissimo a dirsi, nel nostrano filosofo e poeta Giacomo Leopardi, che pur avendo un’ontologia radicalmente diversa da quella di Schopenhauer – dato che il suo stretto materialismo si contrappone nettamente al soggettivismo sia pur non estremistico del suo coevo tedesco – su questo argomento, molto ma molto sorprendentemente, giunge a conclusioni che sono in tutto e per tutto simili a quelle di colui che, in teoria, dovrebbe essere un suo acerrimo avversario sia pratico che teoretico: il che fa pensare seriamente che il diluvio universale della sfiga possa essere argomento in grado di mettere sotto lo stesso ombrello anche le visioni del mondo più radicalmente concorrenti e disparate che si possano immaginare, al punto che verrebbe spontaneo di proporla come fondamento di una costituzione mondiale in grado di unire popoli e culture in secolare conflitto fra di loro al canto di “Achille infame, barbaro e boia, basta per sempre con l’assedio a Troia, lasciamo a Elena il cavallo, e si trastulli col di lui pisello!” (qualcuno avrà già notato la fatale coincidenza della “E” iniziale fra Elena e Elisabetta o Ella D’Essa che dir si voglia). Infatti, essendo il celebre recanatese appunto un materialista, nella sua filosofia non avrebbe dovuto né potuto far riferimento ad una forza antropomorfa – come sarebbe una Volontà qualsivoglia, di vivere, o di potenza, o, che so, magari di passare il week end a pescare o a giocare a rubamazzo o simili. Eppure, anche in quell’universo del tutto cieco e caotico da lui preconizzato, ecco che troviamo una Natura crudele e matrigna, talmente matrigna da risultare infine addirittura peggio di una suocera. Essa infatti si preoccupa di ingannare l’uomo ostacolando la di lui ragione con ogni sorta di illusioni, che lo distolgono o dovrebbero distoglierlo dalla 196 nuda verità che suona o suonerebbe – ahimè – più o meno così: “Amaro e noia la vita, altro mai nulla” (in effetti, contemplando la nuda verità, subito si nota che ha le tette rifatte). L’Amore sarebbe uno dei suoi più potenti raggiri, se non addirittura il più potente, e, naturalmente (dico “naturalmente” perché stiamo parlando della Natura) viene attuato perché l’infelice progenie di Adamo nel vuoto del cosmo ancora si propaghi e nel prolungarsi dei secoli continui ad offrire ad un ignoto Dio lo spettacolo delle sue sofferenze, in quella sorta di cosmico Colosseo che sarebbe da considerarsi il mondo umano o, almeno, quello di cui parlano i Tg (è bello scoprire che anche il Creatore non ha un granché di diverso da fare che le sue disgraziate creature, che ultimamente le disgrazie hanno occasione di contemplarle dall’alto di un teleschermo). Conclusione questa che, come subito si vede, fa il paio e il verso a quella di Schopenhauer anche se, da un punto di vista metafisico, il punto di partenza dei due filosofi o sfigologhi che dir si voglia non avrebbe potuto essere più lontano e contrastante. 84. Ma viene spontaneo osservare che quest’onnipotente nume, la Natura Suocera o Matrigna che sia (ma a volte anche le Cognate non scherzano, perlomeno la mia), di cui l’uomo in teoria dovrebbe essere del tutto schiavo, si rivela infine fallibile proprio nel fatto che quella stessa mente, da lei fagocitata con le sue false immagini, può – sia pur sprofondata in questa oscura e miserrima condizione di ignoranza – scoprire infine la Verità e dunque ribellarsi al suo volere, rifiutandosi di aderire ai suoi disegni, e in particolare, a quello di propagare e moltiplicare quella tracimante fiumana di tapini che sarebbe in ultima analisi l’umanità. Ciò è tanto vero che uno come Leopardi, tanto per fare un esempio, non ebbe figli, come del resto non ne ebbe lo stesso Schopenhauer, come in generale non ne ebbero tutti quelli che, a ragione o a torto, hanno creduto bene di far cessare con sé stessi quella catena di Sant’Antonio della rogna iniziata con 197 Adamo ed Eva ed arrivata dopo milioni di millenni a comprendere anche l’autore di queste umili note. Ma, se prendiamo per buona questa teoria e vogliamo svolgerla fino in fondo, a questo punto possiamo e dobbiamo domandarci: a che serve un inganno che può essere disvelato? Perché la Natura non si è premurata che i suoi raggiri fossero invulnerabili a qualsiasi indagine o riflessione del raggirato? Come Leopardi e Schopenhauer un giorno tutti gli esseri umani potrebbero scoprire l’amara verità e, invece di inghiottirla, sia pure obtorto collo, con l’ausilio di un qualche dolcificante dietetico, potrebbero al contrario ribellarsi in unanime coro al loro solo apparentemente ineluttabile destino: che ne sarebbe allora del Volere dell’onnipotente Volontà, o Natura, o quello che è o non è? Ma, qualcuno potrebbe ancora così obbiettare alla nostra obiezione: i casi da noi portati a esempio del fallimento del celeste e dolce inganno sono dei tipici casi limite. In generale la truffa della Natura, Matrigna o Suocera o Cognata che sia, proprio come quella del fisco alla fine non fallisce e prima o poi raggiunge sempre e comunque il suo scopo comandato, dato che – come noto – gli esseri umani di solito si fanno abbindolare e, dopo essersi innamorati, si sposano e procreano, non foss’altro che per poi pentirsene amaramente, magari dopo nemmeno un quarto d’ora, al primo pianto del disgraziato infante che dal sonno ristoratore li distolga. Ma – domandiamoci – è proprio vero tutto questo? Siamo davvero e fino in fondo certi che le cose vadano nel modo chiaro, semplice e Recoaro in cui vanno in questa semplice e chiara e Recoamara immagine? Non può darsi che la realtà sia più complessa, più sfuggente, più enigmatica e difficilmente comprensibile di quanto non siamo inizialmente disposti a credere? Prima di accettare una Verità tanto conclusiva e generale non sarebbe meglio andare illuministicamente a illuminare i dettagli di qualche caso particolare, per vedere se questi non possano a loro volta in contraccambio gettare un po’ di luce ai nostri faticosi passi nel mentre siamo intenti a percorrere, sia pur arrancando, inciampando e zoppicando, quell’oscuro labirinto che si chiama “condizione umana”? 198 85. In effetti, ragionando di “Amor che nella mente mi (s)ragiona” – che naturalmente, per quanto mi riguarda – da un bel po’ di tempo sol di Elisabetta alquanto sragionando mi ragiona – fino ad adesso l’unico o quasi unico esempio di Grande Amore che mi è venuto spontaneo di fare, manco a dirlo, è quello famosissimo non meno che enigmatico di Dante Alighieri, che cadde innamorato di Beatrice di Folco dei Portinari in modo talmente improvviso e virulento che viene spontaneo di pensare a un vero virus piuttosto che a un vero Amore. Talmente gravi sorgono gli inevitabili sospetti di fronte a tale inusitato e quasi spropositato accadimento che, se non stessimo parlando del Poeta fra i Poeti, verrebbe voglia di parlare di un caso, sia pure non gravissimo, di schizofrenia con delirio paranoico annesso. Narra la storia che a diciotto anni l’Alighieri vede passare la signorina di Folco de’ Portinari, che lo saluta gentilmente, e il poeta cade ex abrupto in preda a un deliquio, in tutto simile a quello in cui io stesso caddi in seguito al mio primo tango con Elisabetta (che bello scoprire nei manuali di Storia dei famosissimi Fessi di fesseria uguale o addirittura maggiore che la propria!). Spaventato dall’insorgere di tanto sentimento ei si rifugia in camera, si addormenta e in sogno vede un vecchio avvolto in una nube rossastra che tiene in grembo una bambina coperta sol d’una veste leggera, un sottile e quasi inconsistente velo. Mentre la culla il vecchio tiene in una mano un oggetto fiammeggiante, che Dante non riesce a distinguere bene (forse si tratta di un cuore), con cui nutre l’infante, che l’ingoia rapidamente e avidamente. Nel mentre nel sogno queste due inquietanti figure dispaiono Dante si risveglia di soprassalto in preda a una sorta di meraviglioso orrore: ma non ostante ciò il Bardo fra i Bardi e le alabarde interpreta senza incertezze questo sogno come una visione di Amore (già, Amore non fa solo rima con Dolore, ma anche con Orrore: come diceva Bataille, “L’amore ha come essenza e meta la fusione di due individui, dunque di due esseri frammentati. Ma si tratta di una fusione che si manifesta soprattutto nell’angoscia, vale a dire negativamente, nella 199 misura in cui è inaccessibile, nella misura in cui è perseguita nell’insufficienza e nel tremore.”). Il primo sonetto dedicato a Beatrice venne scritto nei giorni immediatamente seguenti al suo fatale innamoramento, e, in effetti, non è altro che 1) la descrizione del suo incontro con la sua personale ipostasi di Amore nonché 2) di questo strano, febbrile sogno, che fu la prima conseguenza di cotale e cotanta inconcepibile esperienza: da quel momento il fervido e fertile immaginare intorno a questo fatto – che diventerà una sorta di centro di gravità permanente della sua opera poetica e della sua vita spirituale – non cesserà più per tutto il resto della sua vita. 86. Ma, per quanto il fatto appaia di enorme importanza e ridondanza sul piano privato e psichico, a quanto si capisce, sul piano sociale e pratico gli effetti di tale innamoramento furono infine piuttosto limitati e stravaganti. Se andiamo a vedere quel che lo stesso Dante ci racconta in proposito, in tutta la sua vita egli non ebbe modo di scambiare con la suddetta signorina de’ Portinari altro che qualche occhiata e qualche saluto, finché anche questo gli fu tolto, pare, a causa dell’eccessivo slancio con cui il povero innamorato manifestava in pubblico una falsa passione per un’altra. Era infatti di gran moda all’epoca di nascondere tanto alla donna amata quanto al pubblico degli amici e dei conoscenti il vero oggetto del proprio Amore e, per nasconderlo meglio, si proclamava a gran voce di amare un’altra donna, che invece serviva come schermo ai propri veri sentimenti: uno stratagemma questo che appare ai nostri giorni tanto logico quanto chiamare l’idraulico e, per nascondere il rubinetto che gocciola, fargli revisionare accuratamente quello che funziona. Comunque sia, a Firenze comincia a circolare la voce che l’Amore per questa donna-schermo o scherno che dir si voglia sarebbe passato dallo stadio della pura contemplazione a quello dell’assaggio del prosciutto, e questo equivoco crea uno sconquasso. Data la morigeratezza dei costumi correnti, una fanciulla virtuosa poteva sensatamente temere che un figuro del genere – capace cioè 200 di assaggiare il prosciutto dell’amata invece che limitarsi a cantare le sue lodi – un figuro del genere, dicevamo, potesse arrivare a infastidire infine anche la di lei virtù e reputazione. Fu così che Beatrice tolse il saluto al suo devoto ammiratore, spingendolo per mesi e mesi ben al di là dell’orlo della disperazione, dimostrando in questo modo, fra l’altro, quanto i secoli siano capaci di cambiare i costumi e le abitudini degli esseri umani, e, dunque anche il declinarsi storico e sociale dei loro sentimenti. Oggi come oggi Beatrice, in un caso simile, avrebbe probabilmente approfittato dell’occasione per un bacio lesbo in TV con la sua concorrente, bacio che le avrebbe procurato poi un calendario nudo che a sua volta le avrebbe garantito un posto, se non proprio al sole, almeno ne L’isola dei Famosi, magari proprio insieme a Dante, dove, stanti i costumi correnti avrebbe potuto, oltre che, naturalmente, togliersi il costume, anche amoreggiare con altri per farlo ingelosire, per poi litigare e infine riconciliarsi, magari facendo un bello scambio delle coppie con Laura e Petrarca e, chissà, magari anche con Cavalcanti e la sua cavalcatura. 87. Ma quelli erano proprio altri tempi, ahimè, povero Dante! Tempi in cui il poveraccio, sedotto e abbandonato – sia pure a rispettosa e incolmabile distanza in entrambi i casi – tenterà di riconquistare la di lei stima a furia di sonetti, ma non ci riuscirà mai più e, stante la situazione, va da sé che Beatrice finì per sposare un altro, anche se l’unione non le portò più fortuna che i saluti dati e negati a Dante. Infatti, per quel che se ne sa, l’attrice protagonista de “La Divina Commedia” morì di parto poco dopo le nozze, contribuendo dunque a propagare la crudele non meno che beffarda Volontà di Vivere senza bisogno alcuno di dolci inganni, possenti errori, e nemmeno di ispirazioni poetiche né nei confronti del marito né nei confronti di qualcun altro (a tutt’oggi possiamo notare che un certo numero di zeri nel conto corrente risulta dare origine a “errori” ben più possenti di quelli generati da saluti più o meno casualmente erogati a più o 201 meno casuali sconosciuti incontrati per strada e, anzi, questo fenomeno è tanto diffuso che a diciotto anni se ne era accorto, come abbiamo visto sopra, anche un tipo strano come Rimbaud, che non a caso preferì indirizzare i suoi deliri d’amore a esponenti del suo stesso sesso). Dante, per parte sua, convolò parimenti a nozze con diverso soggetto che quello del suo amor cortese, nozze dalle quali ebbe due figli (addirittura, pare esista ancora in giro per la Toscana qualche suo più o meno diretto discendente). A parte la moglie, egli ebbe, a come sembra e si dice, anche diverse altre donne, alle quali, al pari che alla moglie, non dedicò mai nemmeno un verso, a meno che con la parola “verso” non si intenda qualcuno di quelli inevitabilmente “scappano” in certi assai poco poetici frangenti (mugolii, ansimi, uh, uh, ah, ah, oh, oh: versi cioè che, anche a sommarli tutti non si fa nemmeno un terzo di una terzina della Commedia). Bene, in questo celeberrimo caso, constatiamo con tanto indubitabile sconcerto quanto con sgomenta sicurezza che l’illusione della Volontà o l’inganno della Natura che dir si voglia, per quanto profondissimamente creduto, altamente celebrato, e addirittura venerato quale manifestazione del divino nell’umano, ovvero come fonte di fede e virtù cardinali, papali e vescovili e chi più ne ha più ne metta, comunque sia, non è servito proprio a niente, almeno sul piano genital-generativo. Dante, proprio come la sua adorata Beatrice, si è premurato di propagare tanto il dolore quanto la morte per vie diverse e di certo più impoetiche che quelle tanto vigorosamente indicate dal celeste inganno, che in questo caso si è rivelato, non tanto e non soltanto tragico, orrendo, spaventoso, etc., ma, più che altro, del tutto pleonastico, stante il fatto che, come pochi sanno, a dodici anni Dante era stato solennemente promesso dai suoi facoltosi genitori come sposo a un’altra donna, quella che appunto diventò sua moglie, e quelli erano tempi in cui infrangere un certo genere di promesse costava quanto oggi costerebbe dar della testa di cavolo a Mike Tyson: ne viene di conseguenza quindi che l’eventuale disponibilità di Beatrice avrebbe avuto in ogni caso come effetto una faida come quella che colpì il povero Bontalento de’ Bontalenti, succintamente ma efficacemente descritta dallo stesso 202 Dante nel canto – mi pare - ventitreesimo dell’Inferno, e non un matrimonio (il caso di Dante fu del tutto simile a quello del suo amico Cavalcanti, che si sposò ed ebbe due figli da una donna che non era quella a cui aveva dedicato le sue splendide poesie e le sue forse ancor più splendide malinconie, mentre Petrarca, avviatosi a una carriera ecclesiastica che implicava il celibato, ebbe comunque un figlio naturale da una sconosciuta qualsiasi, non certo dalla misteriosa Laura dei sonetti, un figlio che forse per questo ebbe cura di morire molto giovane). Stante il fatto che “Amor che a nullo amato amar perdona” in questo come in molti altri casi perdonò – eccome se perdonò (anzi, a giudicare da come andavano le cose ai tempi di Dante, sembra proprio che “perdonare” fosse una sorta di Suo secondo lavoro)! – il massimo effetto che poteva infine sperare di produrre in quelle poco propizie circostanze fu quello che di fatto provocò, ovvero la redazione del più famoso poema che la letteratura italiana e forse anche quella mondiale ricordino, ovvero nulla di più o di meglio o di meno che una sia pur spettacolare e pletorica amplificazione di sé stesso. 88. Ma – ehi!!! – come esclamerebbe Elisabetta a questo punto – anzi, ancor più incisivamente, ehi!!!!!!: a proposito di spettacolare e pletorica amplificazione di sé stesso, a furia di riflettere sul buon vecchio Alighiero fra gli Alighieri (un altro, se non mi ricordo male, fu un certo Noschese), sto colpevolmente omettendo di informare il lettore sui fatti, misfatti e strafatti che continuavano purtuttavia ad accadere in quel momento fra me e, giustappunto, la suddetta Elisabetta, anche se, a ben vedere, non si trattava propriamente di ciò che comunemente si intende per “fatti”, o, almeno, di fatti rilevanti e interessanti (forse si trattava di “fatture”, non è chiaro se nel senso magico o fiscale del termine). Quanto a Elisabetta, in effetti, stante la strategia da me prescelta, di costante evitazione di qualsivoglia contatto fisico e/o verbale purchessia, unita al comico non meno che 203 disperato invio di suonati sonetti che le spiegassero la devastante entità e la delirante natura dei miei sentimenti nei suoi confronti, quel che le stesse succedendo e/o passando per la testa non lo sapevo, e, a questo punto, penso che non lo saprò mai più. Quanto a me, in quella strana sospensione del tempo in cui attendevo di constatare quale sarebbe stato lo scopo raggiunto dalla mia piuttosto cervellotica strategia allontanatoria, non potevo in realtà fare null’altro che aspettare ch’Ella d’Essa – finalmente – si allontanasse, anche se non posso nascondere che tramite le poesie speravo anche di convertire Elisabetta a un qualche genere di relazione per quanto miseramente e tristemente platonica, speranza questa ancor più disperata di quelli che votano Di Pietro sperando che abbia la testa dura come pietra, mentre invece in realtà è – ahimè – molto più dura (a ben vedere però non si trattava di una speranza proprio del tutto del tutto insensata; tu vai a vedere quel che è successo, che so, a Properzio, invece che a Cyrano de Bergerac, e vedi che al celebre latino le cose alla fine andarono bene “Non l’ho avuta con l’oro e le perle dell’India ma con l’omaggio di una vincente poesia. Le muse sono vere e Apollo ama chi ama, e io ho fede in loro: Cinzia, la perla è mia!”: beato te Properzio che godi e canti, mentre io canto e me lo gratto!!). Naturalmente, oltre ad aspettare, avevo anche altre cose molto interessanti da fare: per esempio, vagare per i meandri più neri del mio amore deluso e dal fato deriso, sentendomi perciò abbandonato e solo non come un cane, ma – ahimè – come solo un uomo può esserlo (i cani sono di solito molto più fortunati di qualsiasi essere umano, almeno da questo punto di vista, se non altro perché la loro vita media è ben più breve). Aspettavo dunque, aspettavo e ancora aspettavo, senza peraltro poter essere più preciso quanto all’oggetto della mia attesa e, dunque, propriamente parlando, non stavo aspettando nulla, un nulla che era però precisamente quello che stava accadendo: quindi perché aspettare? E così, intanto che aspettavo quel nulla che non accadendo accadeva continuamente, stanchi o stanchissimi se ne andavano via incurvati e a passi lenti, verso il fondo della memoria prima e verso il baratro dell’oblio poi, i mesi crudeli della speranza, i giorni interminabili dell’agonia, gli istanti eterni del disio di Amore e Morte 204 in fraterna mano omai congiunti (perché Amore e Morte sono tanto strettamente congiunti? beh, forse perché, a parte dormire, sono due fra le poche cose al mondo che si fanno bene da sdraiati: se scopi in piedi duri una fatica boia, in specie se lei somiglia ad Ave Ninchi; se muori stando in piedi cadi a terra e ti fai male; se dormi in piedi, beh, allora probabilmente sei un impiegato comunale e allora…) Pure, con tutto ciò, la mia grigia, banale e stupidissima vita quotidiana continuava a percorrere i suoi bravi e pravi sentieri fatti di fatti insignificanti, di abitudini ossessive, di quella noia lastricata di fastidio e polvere che conduce infine al marcio e agognato festino della tomba. I vermi scarmigliati dell’insonnia uscivano sgangherati dalle orbite abissali dello sguardo, le unghie e i capelli continuavano a crescermi all’anima come ad ogni scheletro che si rispetti o si disprezzi, cosa importa (non è che per lo scheletro le cose cambino poi molto in ciascuno dei due casi: si è mai visto uno scheletro andare in giro a farsi prestare forbici e tagliaunghie?). Il gelido silenzio delle sepolcrali profondità del cosmo rimbombava nelle oramai sempre più rare e dubbiose frasi che scambiavo non sapevo più nemmeno bene con chi, dato che gli esseri umani che più o meno casualmente incontravo mi si paravano innanzi come una nebbia pesante e indistinta, satura di sbadigli, depressione e mal di testa. A onor del vero, non posso dire che stessi precisamdente soffrendo, o, comunque sia, come si dice o si urla fra poeti, che stessi soffrendo atrocemente. Pure, non ostante ciò, ero in preda a un piuttosto ansante e ansioso desiderio di lamentarmi, desiderio che però reprimevo costantemente più che altro perché non riuscivo io stesso a capire di cosa in effetti mi volessi o mi potessi lamentare. Soffrivo, probabilmente, della pura e semplice meschinità dell’umana esistenza, quando ormai si rassegna a solo esistere, a durare solo per durare, una pena sorda che, a quanto pare, spinse Carlo Michelstaedter al suicidio, e Fernando Pessoa a scrivere cotali e cotanti immortali versi: “Umilia come se fossi stato umiliato, pesa, sia quel che sia, né, come il grande dolore, ha il piacere d’esser grande.”72. 72 F. Pessoa, “Poesie ortonime”, 150. 205 Ma, non ostante tutto, devo riconoscere che anche in quel periodo non mancarono gli incontri e le occasioni, non dico per avere altre donne, ma almeno per innamorarmi e soffrire per qualcun’altra dato che, vivaddio, anche nelle sofferenze un po’ di varietà non guasta, sennò si trasformano alla svelta anche quelle in tedio (“Una cosa è certa: il tempo è lungo, in queste condizioni, e ci spinge a popolarlo di movimenti.”73: ma allora perché nella mia vita non si muoveva un tubo?). In effetti, a dispetto della mia sempre più rassegnata disperazione d’Amore o di che altro fosse, dovevo comunque e in ogni caso vivere, e, vivendo, come diceva il buon vecchio Montale, “anche senza volere mi disloco”. E così, pur senza volere dislocandomi, mi capitava, ebbene si, di incontrare qualche altro essere umano nei miei stessi infelici pressi dislocato, essere umano o umano essere (o non essere? questo è ancora una volta e come sempre il problema), con cui a volte scambiavo occhiate più o meno distratte, o, addirittura, con cui mi spingevo insino al fatal punto delle fatali quattro chiacchiere, fatto strano ma vero, se è vero che finché l’uomo vive “dà e chiede, entra nel giro delle relazioni – ed è sempre lui qui e là il mondo diverso da lui” (questo è sempre il buon vecchio Michelstaedter, anche se non mi ricordo più da dove, chissà, magari proprio dall’oltretomba, località da cui, dicono, si vede ancor meglio come vanno le cose a questo mondo, se non altro per quanto riguarda i numeri del lotto). Ma, nel mio caso, di quale mondo si parla, di quali relazioni? Le risposte sono, almeno in apparenza, facili e spontanee. Per esempio, mentre cercavo di tenermi in forma facendo un po’ di aerobica e di pesi un giovane virgulto iscritto all’Accademia di Belle Arti – cui l’Artefice di ogni Arte aveva disegnato uno splendido sedere che si stagliava nell’orizzonte color scatola cioccolatini della palestra con la caratteristica forma del boero – ebbene, per quanto strano ciò possa parere, tale capolavoro della pasticceria fiorentina, chissà perché, non andava mai a fare gli esercizi a una distanza superiore ai tre metri da dove li facevo io. Poi, finito di far palestra, una bionda, aitante, statuaria svedese dagli 73 Questo è, naturalmente, l’ormai ben noto Vladimir del “Godot”. 206 occhi di un inequivocabile azzurro Forza Italia e dall’improbabile nome di Gisella mi provocava all’aperitivo, facendo sventolare i suoi luminosi occhioni come alate bandiere in un manifesto del sempiterno candidato premier. Poi, ancora, andando in giro per biblioteche, ecco una napoletana dagli occhi arabi, dalla pelle indiana e dalle tette di cui, dato il volume e la consistenza, è del tutto indifferente e pleonastico di specificare la nazionalità, amabil fanciulla che, trovandosi per caso sempre costretta a sedersi al mio stesso tavolo, si dilettava a discettare con me di argomenti psico-ecotecno-teologici. Alcune altre ragazze del medesimo corso di tango di Elisabetta (non più il mio dunque, ma il suo, come io, del resto, ero già suo) si aggiravano furtive nei miei dintorni con fare che poteva anche sembrare tentante e suadente. Infine, gente conosciuta e sconosciuta qua e là in bar e strade più o meno accidentalmente frequentati offriva sia pur transitori agganci, labili pretesti, frettolose conclusioni. Pure, niente di niente succedeva al mio cuore infranto se non di continuare a infrangersi sul medesimo, invincibile scoglio, dolorosa onda di lacrime, sudore e sangue contro una roccia ineffabile di nebbiosa carne, come un fragile cristallo incontro agli zoccoli o alle zoccole del famoso rinoceronte entrato nel proverbiale negozio del proverbio (a proposito, lo sapete che cosa ci fa un rinoceronte in una cristalleria? vuol comprare un vaso di Gallé). 89. Perché queste ragazze che ho appena ricordato e le altre che non sono nemmeno capace di ricordare non mi facevano lo stesso effetto di Elisabetta, o almeno un effetto anche solo vagamente simile? Perché non mi innalzavano agli stessi cieli e non mi sprofondavano negli stessi infermi e disperati inferni? Devo riconoscere che, come prima non sono stato capace di dare concrete e convincenti ragioni al “perché si”, neppure ora sono capace di spiegare più di tanto il “perché no”. File interminabili di volti inutili, unici anche quelli certo, ma identici infine nella loro inutilità, anonimi e quasi spietati nella loro piatta e banale diversità che laconicamente mi ripeteva che 207 l’uno non era l’altro e che tutti erano nessuno, volti che all’infinito mi sfilavano e a tuttora innanzi mi sfilano come grani indifferenti e insignificanti di quel deserto in cui nacqui e in cui spero almeno di trovar presto “quest’invocata morte” – anche se – ahimè – mi vedo costretto a supporre che quel troppo implorato giorno, se arriverà troppo tardi a consolarmi, sarà ancora in perfetto orario per aggiungere tormento alla disperazione, angoscia al mio terrore, etc. etc. (sappia il lettore che la mia vita è stata “bella” più o meno come il film di Benigni “La vita è bella”, con particolare riferimento al tempo secondo, quando il protagonista finisce in un campo di sterminio nazista: in effetti, questa con Elisabetta è stata una sorta di ciliegina sulla torta della m… dei miei rapporti con il prossimo e, se è per questo, anche con il successivo, il seguente, e quello dopo: ma questa è tutta un’altra storia e, forse, anche tutt’altra geografia che quella di cui stiamo trattando): non dubito infatti che il mio destino, crudele quasi quanto Elisabetta, vorrà ancora cuocermi a fuoco lento o meglio ancora lentissimo in queste inutili, tetre, trite, noiose, ingloriose pene, che a null’altro tendono che alla mia propria nonché, suppongo, all’universale consunzione e disfazione. Ahimè, ohimè, Elisabetta, mia diletta, mio bene, mia adorata, perché il tuo nome tanto è riuscito e ancora riesce – ohibò – a tormentarmi? Perché le altre donne mi parevano così vane e indifferenti e a tuttora così appaiono e scompaiono dalla mia vita senza un sussulto che sia uno, tanto che sono oramai perfino incapace di pormi il fondamentalissimo problema di quali ragioni stiano alla base del mio generico disamore, del mio intemerato e interminabile disprezzo per quel che mi appare il loro vano, fuggitivo e futile solcare il mar morto e disseccato del mio cuore? Elisabetta, Elisabetta, fiore delle mie delizie e del mio affanno (beh, più che altro del mio affanno devo dire) perché fuori di te, della tua grazia, mi sentii dannato a quest’immoto e monotono mare di bonaccia? 208 90. Beh, in effetti, a ben vedere, qualche sia pur vaga ragione la posso pur trovare. Per esempio, con la biondona svedese dovevo parlare in inglese, dopo una ventina di minuti la testa mi faceva male perché questo è l’effetto che mi causa parlare lingue straniere in generale, e, soprattutto, perché questa ventenne timida ed insicura come un passerotto al primo volo a dispetto della sua monumentale, imponente e quasi terrifica bellezza, restava ad ascoltarmi con su fisso sulla bocca un sorriso da statua di cera di Marylin Monroe colta da paresi (ma allora perché non la faceva finita di girarmi intorno con quel sorriso Durban’s sulla faccia e facendo costantemente tintinnare il ghiaccio nel bicchiere quasi a voler risvegliare la mia attenzione che, una volta sveglia, altro non aveva da ascoltare che gli interminati e quasi cosmici silenzi di quella bocca così ben disegnata da sembrare quella di una qualche divinità greca travolta da una wagneriana sindrome da crepuscolo?). In compenso, per consolarmi di tali piuttosto irritanti frustrazioni, potevo sconsolarmi con il fatto che la studentessa di Belle Arti, dopo aver scoperto che portava l’omerico nome di Elena (questa parola almeno è riuscita a pronunciarla), mi fece ben presto desiderare di telefonare a Paride o a un figlio di Troia o troia qualsiasi che dir si voglia per chiedergli se per piacere non mi dava una mano a levarmela di torno (ma forse, andando come andavano le cose, a Troia, quella con la “t” minuscola, era meglio se ci andavo io), dato che anche questa strana ragazza sembrava afflitta da una sorta di cronico mutismo, che però, curiosamente, non le impediva e non le impedisce a tuttora di fissarmi ininterrottamente per tutto il tempo che stavo e sto in palestra da una distanza, come accennavo sopra, non mai superiore ai tre metri e a volte inferiore ai vitali cinquanta centimetri che pare siano in ogni caso indispensabili per non sentire invaso il proprio spazio vitale, e non sentirsi perciò scassare i sopradetti maroni non della Lega. E parlo di cotale Elena solo per non parlare di una alquanto surrealistica liceale a nome Melissa, che mi inseguiva e a tutt’oggi continua a seguirmi nei miei bar preferiti al semplice scopo di fissarmi con uno sguardo che pareva e a tuttora pare emergere da 209 un abisso di fondotinta, mal di testa e insonnia, condividendo con la suddetta Elena l’inclinazione all’immota contemplazione dei miei credo piuttosto incolpevoli lineamenti con l’incapacità di pronunciare verbo quand’anche interrogata su argomenti invero tanto banali quanto pleonastici (tipo: come stai? come va? che tempo fa? roba così intendo, non le origini del debito pubblico italiano): roba dunque et ordunque tanto trita e ritrita da risultare triturabile, infine, in quanto pretesto di grigia e bigia conversazione, probabilmente anche a un bronzo di Riace (uno di quelli, per intendersi, che paiono esser culturisti riempiti di steroidi), o anche solo di Botero (che sarebbero invece quelli che paiono obesi sfatti e strabordanti, farciti dal cibo ipercalorico dei tipici fast food statunitensi (sappia comunque, il lettore che questi casi da me esplicitamente citati sono solo gli esempi più incredibili ed eclatanti di un esercito di mute che in quel periodo prese ad assalirmi, assillarmi ed assediarmi più o meno in ogni luogo e da ogni parte, un’eventualità assai fastidiosa ma che ha avuto senz’altro il merito di darmi un’idea del contesto in cui può essere nato il celebre detto “Ah, vita umana! Così poco tempo e così tanta gente da mandare affanculo!” (a proposito, chi l’ha detto questo detto? non i ricordo più, ma sono certo che doveva trattarsi di un qualche genere di genio). Comunque sia, dato che, come tutti oramai sappiamo, Elisabetta faceva l’interprete per sordomuti, per un certo periodo mi sono figurato che tutte queste controfigure femminili del Commendatore o Convitato di Pietra del celebre capolavoro di Tirso da Molina facessero tutte parte di un complotto cosmico per farmi credere di essere sordo e rivolgermi così alla mia amata in via professionale invece che sentimentale (in realtà, il tutto sta a dimostrare che volersi liberare di una donna frequentandone altre è, diciamo così, atto tanto sensato che pulirsi il sederino con la cacca, volgarità banale questa, lo ammetto, ma che, presa sul serio, significa più o meno lo stesso di quel che con ben più alate parole Pavese scrisse ne “Il mestiere di vivere”: “Chiodo scaccia chiodo: ma quattro chiodi fanno una croce”.). Al contrario delle suddette ammutolite creature, devo però riconoscere che la fascinosa e raffinata napoletana cui accennavo sopra pareva davvero ansiosa di comunicare, e forse era per questo 210 che parlava e parla invece a tuttora e in continuazione, con l’unico difetto a tanta eloquenza di non riuscire ad aprir la rosea boccuccia – una di quelle che per la stesura del rossetto richiedono quel tipo di pennelli che sono in dotazione agli stradini per verniciare le strisce pedonali – senza riuscire immancabilmente nell’ardua impresa di dire con una sola parola almeno due cazzate (l’unico lampo di genio lo ebbe nel momento in cui, parlando del significato della parola “teodicea” ella ebbe a chiedermi: si, ma se è vero che esiste una Provvidenza, come è che aiuta sempre la Juventus? (ancora non era scoppiato il caso Moggi)). Quanto alle altre ragazze del corso di tango esse erano – ahimè – come sommerse dall’onda di miele in tempesta dei passi di Elisabetta, quelle agganciate nei bar si sganciavano troppo rapidamente per poter sperare da esse qualcosa di più di due inutili chiacchiere destinate a perdersi nell’oblio nel giro di qualche ora e, a volte, di qualche minuto. Poi, a parte queste summenzionate donzelle, continuavo a conoscere una marea di donne già impegnate (fidanzate, sposate, conviventi, conmorenti, e simili), con cui vi è di solito una pari probabilità di un qualche seguito concreto alle loro eventuali lusinghe che di un politico a mantenere le promesse elettorali (se l’inferno dei politici, come scrisse Dante, sarà giustappunto il dover mantenere le promesse elettorali, c’è da pensare che quello delle donne consisterà senz’altro nel dover darla a tutti quelli a cui l’hanno fatta annusare (quello degli assicuratori, detto di passaggio, sarà senz’altro dover vendere assicurazioni nel loro stesso girone, mentre quello degli avvocati sarà il farsi assistere da quel diavolo che fu loro cliente)). Dunque che dovevo, che potevo fare, se non attendere che un qualche miracolo accadesse, qualcosa che infine mi strappasse a quell’interminabile, assurdo tormento, a quel tedio, a quella solitudine senza più nemmeno un’ombra d’orizzonte (di solito non si è mai soli, nemmeno quando si è soli: solo gli innamorati delusi lo sono veramente, e questo resta, a quanto pare, l’unico privilegio che tocca in sorte a chi si innamora, oltre a quello di assaporare la feccia dell’amaro calice di Pandora, la schiuma velenosa di Farnir, ovvero il furibondo fiele della Speranza, ché “solo a chi spera, chimera il gioir, 211 di speme fallace seguace è il martir; ma, folle, invan pavento, è presago di gioie il mio tormento!”74)? 91. In effetti, visto che negli ultimi tempi ho cominciato a credere in un qualche Dio che in qualche modo incomba sull’umano destino (la cosa non è frutto di paura, rassegnazione, senso di colpa o simili; il fatto è che, come sostiene il Pessoa-Soares, “Ci siano o no gli dei, di essi siamo servi” se è vero che, come precisa il Pessoa-Pessoa “Non avere dèi è pur sempre avere un dio”), e avrei potuto dunque affidarmi a Lui. Sfortunatamente il Dio in cui mi onoro di riporre la mia fede più cieca e assoluta deve avere lo spirito umanitario di un Adolf Hitler quando pensa a come risolvere il problema ebraico (certa gente non deve proprio aver alcun problema nella vita per inventarsene uno di questo tipo: non poteva mettere il buon vecchio Adolf altrettanto impegno nel risolvere, che so, il problema del raffreddore con emicrania annessa?) e dunque un tal genere di divinità, Chiunque Egli Sia, non è certo il tipo di Persona o Pessoa75 a cui si possano confidare i propri guai impunemente, a meno di non sperarne una risposta simile a quella che dette il dottore all’ammalato di cancro nella barzelletta più crudele del mondo. Conosce il lettore questa barzelletta? Suppongo di no, dato che io stesso ne sono il segreto autore e perciò mi permetto di raccontarla in questa sede, sperando in questo modo di ravvivare la piuttosto sconsolata narrazione di queste mie, lo riconosco, piuttosto scalcinate e ineleganti disgrazie. Dunque: un tale che ha un cancro va dal dottore a farsi una visita di controllo e il dottore gli dice che deve dargli due notizie, una buona e una cattiva. L’ammalato gli dice, dottore, non mi tenga sulle spine, me le dica tutte e due insieme. E il dottore: beh, la notizia buona è che lei un cancro non ce lo ha più, quella cattiva è che ne ha due: ahahahahah!!! (!?!?!). 74 Questo è il solito Acrimante di cui sopra, sempre più depresso. Il significato del cognome del celeberrimo poeta portoghese è appunto questo,” persona.” 212 75 Il lettore non mi accusi di cinismo o di eccessivo pessimismo. In fondo anche io sono capace di trovare qualche lato positivo nella vita umana: per esempio, è una splendida occasione per scrivere poesie disperate. Ma, a parte questi rari momenti di luce, devo riconoscere che sono un po’ di mesi che mi sbatto solitario di qua e di là, incapace di provare altri sentimenti che la noia, la malinconia e il rimpianto, non so più nemmeno bene io di che, al punto che fin troppo bene, per quanto cieco come il destino, troppo bene mi vedo io descritto dai celebri versi degli “Ossi di seppia” che suonano “Se un’ombra scorgete, non è un’ombra – ma quella io sono”. Tanto sfiduciato e depresso mi sento che a malapena riesco a trovare la forza per masturbarmi (una volta la settimana, il lunedì mattina, poi, fino al lunedì successivo è tutta una discesa (nessuno osi accusare lo scriba di volgarità per l’allusione a questa di solito disprezzata attività sessuale, non solo perché essa, come diceva il gran maestro Woody Allen, consiste nell’avere rapporti sessuali con qualcuno che stimi molto, ma anche perché, che so, secondo la teologia solare di Heliopolis il dio Rê-Atum-Khepri attuò la creazione appunto masturbandosi (quindi state attenti a quel che fate: che in un momento di impudica lussuria non vi scappi dalla lurida cavità l’inizio o anche solo il più vago indizio di un nuovo e nuovamente disgraziato universo!)). Ma allora, se l’amore o Amore che dir si voglia può spingere un povero essere o non essere umano che sia fino a questo punto, chi e come può credere sensatamente che il dolce inganno serva addirittura alla riproduzione (ammesso che non ci si riferisca con tale espressione ellittica – “riproduzione” – alla “riproduzione della sfiga”)? Se l’infame ingannatrice ovvero la mia ex adorata, ovvero Elisabetta non mi avesse ingannato i miei spermatozoi non avrebbero avuto una maggior probabilità di finire i loro giorni in località più adatte al loro scopo che i miei stessi coglioni o il fondo anonimo e freddo di un lavandino (il lettore ci scusi, ma in certi momenti un po’ di volgarità rende l’idea più di qualsiasi tartufo che si possa scovare nel più fornito dei dizionari)? 213 92. Ho scandalizzato qualcuno? Spero di no, e comunque sia, se vi siete scandalizzati, bisogna che facciate come l’arcivescovo di Costantinopoli quando si è disarcivescovizzato e dunque discandalizzatevi subito, dato che, invece che prendersela per tale innocente scurrilità, non più grave o greve di quando in fronte a un tremebondo Dante un demoniaco cul fece trombetta, domandiamoci invece: in quanti casi il dolce inganno ha sbagliato mira, oltre che in quello mio personale e oscuro o in quello mai troppo celebrato del Poeta fra i Poeti? Per esempio, come abbiamo già accennato in precedenza, anche nel quasi altrettanto celebre e celebrato caso di Francesco Petrarca, troviamo che l’amore o Amore che dir si voglia per la misteriosa Laura dei suoi versi non produsse appunto altro che quelli, senza neppure il sia pur cosmicamente insignificante quanto umanamente tragico contorno di saluti dati e tolti, gabbi e gabbati e altri simili, infantilmente ridicoli e orridi condimenti. Ma non vogliamo portare il suo caso a sostegno delle nostre tesi, dato che questa Laura, chiunque fosse, a giudicare dal tono con cui viene cantata e decantata, più che una donna in carne e ossa, pare piuttosto un pretesto qualsiasi per scrivere sonetti (sembra perciò del tutto evidente che avrebbe potuto essere efficacemente sostituita in quanto Musa o Muso del suddetto Petrarca da un merluzzo surgelato di una sottomarca qualsiasi). Andiamo allora ad un altro caso di innamoramento che è stato celebre quasi al pari di quello celeberrimo dell’Alighieri, ovvero al caso Werther. Il lettore istruito subito noterà che trattasi in questo caso di innamoramento puramente “letterario”, dato che il povero Werther non è affatto personaggio reale, e dunque non dovrebbe servire in alcun modo a portare avanti la nostra argomentazione, che tratta di gente in carne e ossa, e non delle loro più o meno credibili fantasie letterarie. Ma qui possiamo rispondere tranquillamente che il personaggio del romanzo e la sua trama, come è noto, altro non sono che la sintesi letteraria di ben due innamoramenti tragici e infelici vissuti a poca distanza l’un dall’altro dal celebre inventore del celeberrimo personaggio, il grande Goethe, che con questo suo 214 romanzo, come molti sanno, dette a quanto pare un pessimo esempio alla gioventù dell’epoca. Lui, per salvarsi la vita, scrisse un romanzo in cui il protagonista, deluso dall’amata si suicida (in pratica il disperatissimo Goethe, che per due volte aveva perso la testa per il bel faccino di due ragazze già impegnate, per non suicidarsi lui si inventò un alter ego letterario che lo facesse al suo posto). È solo che ben presto questo surrogato imaginifico di un’azione non mai compiuta divenne poi, ahinoi, un esempio pratico e concreto per i giovani dell’epoca che, innamorandosi e andandogli le cose a quel paese – e non essendo altresì capaci di scrivere un romanzo dove un personaggio per quanto inverosimile e irrealistico si suicidasse al posto loro – si suicidarono dunque in tutta serietà e in prima persona. E che riproduzione sarebbe mai questa, in che senso questi innamorati romantico-gotico-goethiani dettero una mano alla Natura nel generare nuovi infelici esemplari della genia di Adamo? Qui sembra che il dolce inganno, in dozzine di casi (se non ricordo male la cifra si può ragionevolmente descrivere in questo modo), lungi dal raggiungere scopi riproduttivi, sia servito al contrario a scopi preservativi, se il lettore ci consente il poco romantico ma molto efficace termine (beh, a dir la verità, non sono proprio sicuro che i casi fossero dozzine: ma, comunque sia, furono abbastanza per far notizia in un mondo in cui raccolte di spazzatura differenziata del genere dei Tg moderni non erano ancora stati inventati). 93. Accettiamo fin da subito – pur non credendola fino in fondo verità assodata – l’obiezione che in questo caso realtà e letteratura si sono troppo frammischiati fra di loro, ingenerando un genere di allucinazioni che non è propriamente quello che la Natura maleficamente saggia di solito produce. Allora, procedendo a furia di inciampi, strafalcioni, lapsus calami e distrazioni, come è ormai costume di questo sconclusionato non-libro, facciamoci animo e andiamo in cerca di altro materiale utile alla nostra indagine. Prendiamo, che so, la tempestosa e peccaminosa passione che 215 travolse Eloisa e Abelardo, e che infine, invece che due sposi pronti a moltiplicare il numero dei figli carnali di questo mondo, produsse infine due spirituali Figli della Chiesa, i suddetti Eloisa e Abelardo appunto, quest’ultimo costretto al voto di castità e al chiostro dal di lei zio, che, per evitare ulteriori infrazioni alla cintura di castità della sua adorata nipote, che doveva avere dei grossi problemi al lucchetto, pensò bene di privare il poveraccio dell’arnese che serve giustappunto alla riproduzione, oltre che a forzare i lucchetti delle cinture di castità in questione (i due finirono entrambi in convento e, a quanto pare, a partire dalla sua riduzione all’infelice stato di eunuco il buon Abelardo si rifiutava di contattare la bella Eloisa, la qual cosa fece sospettare a lei che l’inganno che li aveva in celestiali catene incatenati non fosse, almeno dalla parte di lui, così elevato come poteva sembrare a prima vista, dato che Abelardo non ne volle sapere più nulla delle di lei celestiali virtù a partire dalla privazione delle proprie parti basse (beh, però in questo caso un figlio, sia pur come indesiderato epifenomeno della passione carnale infine nacque, anche se non si sa bene che fine abbia fatto). Non basta ancora? Allora facciamo girare la trottola, lasciamo ticchettare l’orologio, saltiamo qualche secolo, e, puntando il dito a caso nel vasto e vario mappamondo dell’amorosa sfiga, andiamo a vedere quel che successe nel celebrato – a torto, molto a torto celebrato – triangolo amoroso che sorse, insorse e si contorse fra Paul Rée, Friedrich Nietzsche, e Lou Andreas von Salomè. Beh, al di là delle apparenze scandalistiche scopriamo che il suddetto triangolo – non sappiamo se isoscele o rettangolo o come o cosa o che altro – oltre a non produrre matrimoni o eredi del nulla di nulla che è o che si dice che sia l’umana prole da quando uno dei componenti della suddetta triade, il buon vecchio Friedrich Nietzsche, annunciò al mondo la morte del suo Eterno Fattore – ebbene, come stavamo dicendo, neppur produsse questo triangolo non diciamo – almeno – un tentativo di riproduzione – ma nemmeno un singolo bacetto sulla guancia, o sulla fronte, dato che codesta funesta gorgone, Lou von Salomè, era a quanto pare rigorosamente contraria a che Amore si esprimesse in altro modo che nella più rigorosa astinenza dai sensi, così che le anime potessero meglio fra di lor dialogare sotto il cielo 216 dello spirito, reso puro da una castità che fu, così si racconta, ancor più rigorosa di quella che di solito si respira e sospira nei recinti claustrali (a prima vista questo sembra, più che un triangolo amoroso, una sorta di triangolo delle Bermude, ma va beh…). Che dire di questo nuovo caso, a che è servito il dolce e più spesso amaro inganno, se non a produrre e riprodurre frasi romantiche, erezioni, disperazioni, ansiose attese, angosciose contese e via così? 94. Ma – lo devo riconoscere – il lettore potrebbe obbiettare che nei casi che abbiamo appena citato entrano in gioco dei fattori piuttosto rari ed eccezionali che hanno imprevedibilmente ostacolato gli scopi dell’onnipossente Natura: nel primo caso, appunto, il feroce zio di Eloisa, nel secondo le conclamate difficoltà sessuali di entrambi i protagonisti maschili della filosofica tresca. In effetti il buon vecchio Friedrich, ancorché nel celebre “Zarathustra” auspicasse l’uso della frusta con le femmine, in fatto di sesso era a quanto pare assai più sensibile di una monacella, e in tutta la vita non toccò donna nemmeno con la canna da pesca, mentre il suo carissimo amiconemico Paul Rée, da parte sua, era messo appena appena un po’ meglio di lui (beh, lui almeno la moglie sembra che riuscì infine in qualche modo a toccarla). Lou von Salomè invece, come più o meno tutte le femministe che la storia ricorda, e che forse farebbe meglio a scordare, era la più frigida, rigida, isterica e fanatica delle castratrici che un obelisco eretto o meno potesse avere la disgrazia di incontrare. Ciò non ostante, per qualche motivo che personalmente mi risulta del tutto incomprensibile, la zoccola infame o infame zoccola che dir si voglia in questione fece innamorare quasi tutti i grandi (grandi!?) uomini che ebbero la disgrazia di incontrarla, grandi uomini (uomini!?), appunto, che, pur nella diversità delle occupazioni artistico-intellettuali (si trattò di poeti, scrittori, musicisti, etc.) ebbero fra di loro il minimo comun denominatore di non riuscir neppure ad annusare un singolo pelo della marmotta dell’amata (non mi attardo a fare la lista dei disgraziati in questione: 217 per una volta il lettore mi risparmi la fatica e, se non ha voglia di andare in biblioteca, vada su Google e se la faccia da solo, da solo aggiunga tutta l’interminabile casistica che ritrova intorno a questa strana tipa – famosa per aver rotto gli ornitorinchi e lasciato a obelisco ritto i più celebri intelletti a cavallo fra due secoli – alla precedente e successiva e trista lista di amori celebrati e celebri e, non ostante ciò, andati a male senz’altra eco che quella letteraria (quando ci fu)). 95. Lasciamo dunque questa fatale e fatidica Lou Andreas von Salomè, che almeno dal mio punto di vista, a giudicare dalla foto, l’unica cosa di bello e affascinante che possedeva era il nome (che suonava bene, di certo meglio, che so, di “Ella d’Essa”, lo devo umilmente riconoscere) alla fatidica fatica del lettore e muoviamoci ancora e ancorché a caso nel desolato panorama degli “amori ridicoli” di kunderiana memoria (“kunderiana” vuol dire: di Milan Kundera, per chi non conoscesse il nome del geniale romanziere praghese prima e parigino adesso). Se peschiamo a caso nel sacco in cui sono caduti gli innamorati celebri che – chissà perché – la Storia ricorda, è facile trovare una marea di casi simili e similmente degni di infamia più che di lode. Lasciamo passare ancora qualche decennio dal triangolo barboso e amoroso di cui sopra e troviamo che un’altra grande passione fra grandi filosofi, pur giungendo all’agognato stato della consumazione erotica, non ebbe infine miglior fortuna riproduttiva che il sopradescritto e filosofico triangolo di cotali fin troppo vestite Bermude. Infatti, la celebre non meno che angosciosa e angosciata infatuazione fra Martin Heidegger e Hanna Arendt produsse e fu di stimolo (grazie a Dio?) non alla nascita di altri sfortunati componenti del genere cosiddetto umano, ma solo a quella di “Essere e tempo”, quel noto capolavoro di Heidegger che sarebbe l’equivalente filosofico di una fabbrica di mattoni (il vero titolo doveva essere, secondo me, “Essere e (molto) tempo (da perdere)”) mentre, da parte sua, Hanna Arendt non seppe far di meglio che partorire una tesi su 218 “Il concetto di amore in Agostino: tentativo di un’interpretazione filosofica”, opera che, già sfinito verso la metà del chilometrico titolo, il lettore ha la tendenza ad abbandonare con l’aria di chi ha appena finito di scaricare una mandria di Tir (ho scritto sopra che il rapporto fra Heidegger e Arendt giunse all’agognato stato della consumazione erotica, dato che questo è quel che in giro si dice, nell’ambiente si vocifera, o in corridoio si sussurra, etc., ma poi, sfogliando a caso una celebre opera di Heidegger, si scopre che cotale cima di intelletto è capace di scrivere un passo filosofico geniale come questo: “Quando diciamo: «l’acqua è fredda» addiciamo qualcosa all’ente. Certamente, ma ciò accade in modo che, nell’attribuire qualcosa all’acqua, in ciò che viene ad-detto, viene dis-detto il caldo. In fondo, però, nella differenza fra caldo e freddo, ciò che è in questione non è la distinzione fra ad-dire e dis-dire ma ciò che, conformemente al proprio , è ad-dicibile e disdicibile.”. Questo passo del grande (grande?) filosofo (filosofo?) tedesco (tedesco, tedesco…), che si muove con la lieta e lieve levità stilistica di un vagone piombato con l’emicrania martellante al ritmo di un martello pneumatico, pare alludere a qualcosa come la scoperta dell’acqua calda, poi messa bollire per cuocere gli spaghetti, o per fare il caffè, chi può dirlo? come che sia, non è facile immaginare un tale che scriva un tal genere di deliranti e pompose assurdità con l’obelisco in erezione, e men che meno che una donna sia disposta a riceverlo in qualsiasi orifizio del suo corpo, orecchie in particolare (che cosa gli ha detto Heidegger alla sua Hanna per spiegargli quel che aveva intenzione di fare “cara, per favore, non vorresti per caso ad-toglierti le mutande e dis-stringere le cosce, che voglio ab-farti una visitina?” (non so a voi, ma leggendo tali inimmaginabili nonsensi a me viene il dubbio che Elisabetta, quando ha saputo che sono un “filosofo”, gli è tornato in mente un passo tipo questo e ha perciò deciso di punire me in quanto filosofo a nome di tutte le persone normali che sono state costrette per vari anni e per incomprensibili motivi a sorbirsi, a liceo o università, non importa, amenità del genere? (ah, dimenticavo: a proposito di filosofi celebri, il celebre dialogo platonico “Il simposio”, oltre che il già citato “Fedro”, che hanno per tema appunto l’amore, riecheggiano 219 carsicamente di tutta una serie di amori più o meno passionali fra i partecipanti alla conversazione, ma, ahimè, si tratta di amori fra uomini che, per quanto travolgenti, non avevano e a tutt’oggi, a dispetto di ogni progresso scientifico, non hanno alcuna speranza di riprodurre qualcosa di diverso da quello che di solito produce un pistola a schizzo usata su un centro per freccette (un grande amore del genere fu, per esempio, quello che in modo piuttosto burrascoso unì il grande Verlaine col grandissimo Rimbaud, che quanto a scopi connessi con la riproduzione riuscì solo ad allontanare per qualche tempo il suddetto Verlaine dalla legittima e forse perciò legittimamente incazzata o incazzatissima moglie – per non parlare poi dell’interminabile sequela di amori del genere di cui fu protagonista il grandissimo Garcia Lorca e altri di cui il suddetto non si perita di citare il nome nelle poesie loro dedicate, anche se nella celeberrima “A los cinqo de la tarde” ben si capisce che il cotale in questione è un torero di successo)))). 96. Ma, ora che Heidegger è riuscito a spiegarci in modo perfetto come mai è cosa buona e giusta tenersi a ir-rispettosa dis-tanza da un certo genere di “filosofi” vogliamo far passare un altro po’ di tempo e scoprire che cosa è successo a un’altra celebre coppia di anime pensanti (anche se nessuno sa dir bene a cosa)? Ma si, lasciamolo passare, ed ecco che, dopo nemmeno venti anni, scopriamo che non miglior fortuna riproduttiva ebbe nei suoi rapporti con il gentil sesso il mio filosofo preferito, il buon vecchio Ludwig Wittgenstein (che, come pochi sanno, era un omosessuale di vecchia data), geniale figlio dell’idealismo di Vienna e dell’empirismo di Cambridge, che, pur convivendo da qualche anno con un suo studente, imprevedibilmente si innamorò di un’amica della sua intemerata, temibile e temutissima sorella, una certa Marguerite Cazzonomiricordopiùilcognome: a parte i noti e ignobili tormenti amorosi, la corte del più geniale filosofo occidentale degli ultimi due millenni e mezzo a codesta Marguerite non riesce ad ottenere nulla di 220 più o di meglio di qualche chiacchierata nel salotto della sorella di cui sopra (di cui aveva lo stesso nome, Marguerite appunto, guarda un po’ quale edipica coincidenza), con il condimento di alcune a quanto pare del tutto innocue passeggiate in giro per Vienna – il tutto, naturalmente, senza arrivar neppure a tener per manino la sua bella, che, saggia come molte donne sono capaci di restare di fronte alla follia filosofica dei maschi quand’anche fossero acclarati geni della materia, si guardò bene dall’accettare le sue piuttosto insensate profferte di matrimonio per accettare quelle di un suo molto meno geniale amico – certo Talla Sjogren – che non era una cima, certamente, ma che a quanto pare non era nemmeno quel mattoide para-schizofrenico che il buon vecchio Ludwig mostrava essere non appena metteva un dito fuori dai suoi argomenti preferiti (l’intenzionalità, il solipsismo, il problema del linguaggio privato: tutta roba capace di far venire il mal di testa a una statua di granito, figuriamoci a una tranquilla signorina viennese priva di particolari ambizioni e fantasie metafisiche). Ma lasciamoci andare, lasciamo passare ancora un paio di decenni, passiamo dalla filosofia alla semiologia e come – ahimè – c’era da aspettarsi, subito incontriamo il pluricitato e da me profondamente amato Roland Barthes, il mitico strutturalista fra gli strutturalisti. Lo incontriamo e – c’è da stupirsi? – lo sorprendiamo nel mentre si diletta fare ai cozzi con quel almeno per noi lettori perfetto sconosciuto (anche il Grande Roland è stato uno dei tanti geni appartenenti alla cosiddetta Altra Sponda: sembra che un tale traversata abbia la tendenza a rendere la gente più intelligente anche se non molto più felice) che, infliggendogli una delle delusioni più atroci e cocenti della sua vita – talmente cocente che a quanto pare, il buon vecchio Roland venne per lunghi mesi scambiato da quasi tutti i suoi amici per un pollo alla diavola ambulante – gli dette però anche lo stimolo decisivo per comporre quel sommo capolavoro che ha l’inquietante titolo di “Frammenti di un discorso amoroso”, un monumento all’innamoramento e agli innamorati che, proprio come la dantesca “Commedia”, se da un lato ci consola quanto alla possibile sorte e sopra i possibili frutti di un amore deluso, da un altro lato ci affligge e ci spinge al triste pensiero che la grandezza di 221 un uomo e delle sue opere deriva di solito in modo abbastanza diretto e proporzionale dalla grandezza delle sue disgrazie (più in generale, la grandezza dell’Uomo sembra proprio la grandezza della sua Disgrazia, che pare consistere infine nell’essere l’unico animale che sa di esserlo (George Bataille intendeva, credo, la stessa cosa quando nella “Teoria della Religione” scriveva che “il mondo animale è quello dell’immanenza, dell’immediatezza: questo mondo, che ci è precluso, lo è nella misura in cui non possiamo discernere il potere di trascendersi”, cioè, in parole povere, di conoscersi per quello che è, ovvero, un animale (ma, alla fine, non si potrebbe infine definire l’uomo come quell’animale che ha orrore della sua animalità? tutti i tabù riguardanti il pudore in migliaia di culture anche molto primitive passate e presenti sembrano dimostrarlo)). Beh, comunque sia, proseguendo oltre nella nostra indagine ma restando nei paraggi di Barthes, troviamo anche un altro autore che tramite l’opera con cui è universalmente identificato in tutto l’universo, ci ha fatto compagnia e che ancora ce ne farà nel corso di questo nostro non-racconto, ovvero quel Samuel Beckett che col suo “Aspettando Godot” ha sancito per sempre – o, almeno, fino al lancio del prossimo I-Pad – l’insensatezza dell’umano destino in questo mondo e, probabilmente, anche in qualsiasi altro o Altro che dir si voglia, anche se, a dispetto di quel che potrebbe far pensare la sua opera, le sue relazioni umane in generale e col sesso femminile in particolare sembrano piuttosto meno tormentate che quelle che hanno caratterizzato la vicenda umana, che so, di un Roland Barthes, o di un Nietzsche, o di un Dante Alighieri. Pure, a questo punto è per noi nulla di meno che inevitabile il notare e il sottolineare come da moglie legittima e amanti sparse, a parte ispirazioni e aspirazioni letterarie varie, non nacque altra progenie. Il che significa che anche quest’altro formidabile genio del secolo ventesimo è morto e fu sepolto senza contribuire in alcun modo alla continuazione di quella tragica commedia umana che tanto bene aveva saputo rappresentare on stage con il suo lavoro di scrittore e di regista (facendo riferimento a un altro autore citato nel corso della presente non-storia ricordiamo che anche Eugenio Montale, dalla sua unione pluriennale e stabile con la celebrata Mosca, protagonista del suo forse massimo 222 capolavoro “Satura”, non trasse altro mai – appunto – che poesie, e lo stesso è accaduto a Kundera, a Pessoa, a Kafka, e che, probabilmente, lo stesso accadrà ed è già accaduto a chissà quanti altri, scrittori e non scrittori, famosi e non famosi, come accadrà anche a me, almeno con Elisabetta (dopo, chissà, chi può dirlo? (il mio sogno è diventato quello di spogliare una spogliarellista dell’Est, che è una cosa non facile, perché, anche quando riesci a trovarne una, oltre a costar tanto, è anche già spogliata)). 97. Ma non soffermiamoci troppo su tali supposizioni e supposte di metafisica dimensione e continuiamo nella nostra ancorché asistematica e cialtroneggiante indagine sull’Amore. Andiamo all’esempio forse più eroticamente efficace di celeste inganno che la storia o Storia che dir si voglia abbia mai offerto agli occhi stupiti dei suoi spettatori, ovvero quello che subitaneamente e reciprocamente colse Henry Miller e Anais Nïn in un bar di Parigi una cinquantina di anni fa. In questo caso la relazione, oltre a non rimanere meramente e melanconicamente platonica, al contrario, è diventata forse giustamente celebre proprio per la fervente e quasi furente passionalità con cui venne vissuto e letterariamente celebrato il suo lato fisico (dopo tanto Stil Novo ci voleva un po’ di Stil Vecchio, che diamine!). Ma, a dispetto di ciò, anche in questo caso dobbiamo constatare che l’inganno della Volontà – se da un lato appare efficace quanto alla florida produzione di furibondi accoppiamenti fra gli ingannati – fallisce proprio al momento di conseguire il suo scopo ultimo, dato che da tale turbolenta e turbinosa relazione col turbo non nacque infine alcun figlio. Entrambi i protagonisti della storia erano peraltro già sposati, ed è curioso notare come il dolce inganno o possente errore che dir si voglia non fu capace nemmeno di rompere i rispettivi matrimoni, nemmeno di impedire a entrambi di avere molteplici altre relazioni! – relazioni che pure non ebbero una ridondanza anche solo minimamente paragonabile a quella che in modo variamente truculento li legò per circa venticinque (25!) anni. 223 Tanto per dare un’idea di ciò di cui stiamo parlando Henry Miller scrisse alla sua amata nel solo primo anno della loro relazione circa novecento (900!!) pagine di lettere erotico-romantiche, un’impresa paragonabile alla “Divina Commedia” dunque, anche se, evidentemente, solo e soltanto dal lato quantitativo. Ma, allora, a che è servito l’amore di Henry Miller ed Anais Nïn? E’ servito a produrre appuntamenti, baci, carezze, amplessi, orgasmi – qualcuno a quanto pare addirittura non simulato – e, oltre a ciò, sbronze, racconti, pensieri, lettere ed evoluzioni intellettuali ed erotiche di ogni sorta, ma, ancora una volta, nulla di veramente utile alla propagazione della famigerata Volontà di Vivere, ovvero nessuna generazione di nuovi e sfortunati infanti, destinati a loro volta a ripetere all’infinito questo fallito esperimento del Cosmo che si chiama umanità (scolio: per quel poco o niente o meno di niente che in mezzo a questa molto onorevole lista può contare, posso informare il lettore che prima di innamorarmi di Elisabetta ho avuto io stesso una storia lunghissima, non so se d’Amore o di che altro, con una ragazza, cui avevo peraltro alluso alcune pagine sopra, storia il cui decorso erotico è stato forse ancor più possessivo, aggressivo e trasgressivo di quello fra Henry Miller e Anais Nïn – con tutto un vulcanico erompere di atti impuri e scene innominabili cui non accenno neppure onde non far vietare questo povero libro ai minori di diciotto secoli – ma infine sono costretto registrare, con un certo sollievo devo dire, che tutto questo materiale a luci rosse – capace di far arrossire come un semaforo perfino la santissima trinità composta da Moana Pozzi, Ramba e Cicciolina – di effetti riproduttivi ne ha avuti in medesima quantità e misura che un pomeriggio intero passato a masturbarsi davanti a una copertina di “Playboy”). 98. Come ultimo esempio alla sequenza di casi umani in cui il dolce inganno fallì quello che oramai possiamo a questo punto definire senz’altro il suo presunto scopo, porterò quello più tragicomico, surreale e forse – ahimè – più ridicolo, ovvero, guarda caso, quello 224 del mio scrittore preferito, quel Josè Luis Borges di cui ho letto le opere complete in lingua originale almeno una diecina di volte. Un personaggio che, causa la letteraria ossessione, ho infine deciso di conoscere anche a livello biografico, scoprendo, con non minore incredulità che inorridito sgomento, che cotanto lume di supremo ingegno visse praticamente tutta la vita con la iperprotettiva nonché iperasfissiante genitrice in un piccolo appartamento di Buenos Aires. Questa sorta di piovra insaziabile l’accompagnò ovvero non lo mollò nemmeno durante i suoi lunghi viaggi in Europa, e i suoi inesorabili ed estenuanti tentacoli tanto subdolamente si allungarono sul figlio e tanto strettamente lo avvinghiarono che, ogni volta che questi usciva di casa, pretendeva di essere informata sul programma, sull’ora del rientro e, se vi fossero state eventuali improvvise variazioni, era preciso obbligo del niño di avvisarla per telefono dei suoi ancorché minimi spostamenti (un amico di Borges fu testimone di una piuttosto surreale scena familiare in cui una domestica chiese al grande Josè Luis (“grande” nel senso che in quel momento aveva da un pezzo superato i sessant’anni) se volesse del vino, al che la poderosa madre rispose al suo posto con le testuali parole “el niño no toma vino”: e poi ti dicono genio e sregolatezza, ti dicono….). Ma, a dispetto o forse proprio a causa di questa alquanto edipica e molto poco edificante relazione con la madre, troviamo che, in conversazioni di vario genere, intime o meno, questo grandissimo non meno che sfortunato poeta, narratore e saggista confessa che fu per tutta la vita innamorato di una qualche esponente del gentil (gentil!?!?) sesso, ora questa ora quella, si, ma tutte, benché diverse, gli parvero uniche (si, vabbe’, questo però lo dicono tutti, l’avrei detto anch’io: su Josè, fai uno sforzino dicci qualcosa di un pochettino più poetico e originale!). A più riprese egli parla dell’amore come di una sorta di esperienza di rivelazione, in cui tutto l’universo sembra alludere a un solo volto, e un solo volto a tutto l’universo (oh, qui si che ti riconosco, mio venerato aedo!), che è meglio essere delusi piuttosto che non amare (qui si scade di nuovo un po’ nel banale, ma passiamola…), che l’amore fu la sua grazia e la sua disgrazia, ma che i brevi momenti di felicità sono bastati a compensare tutti i dolori (ehi, Josè, oggi si vede che proprio non è la 225 tua giornata: casomai non te ne fossi accorto qui siamo in un romanzo, non al Festival di S. Remo!) e tanto venne ossessionato da questa passione che non esita ad ammettere in un’intervista che “Con una certa tristezza scopro che ho passato tutta la mia vita pensando a una donna o a un’altra. Ho creduto di vedere paesi, città, però ho sempre avuto una donna che disturbava le mie visioni.” (non ci stupisce che alla fine sia diventato cieco). 99. Abbiamo definito questo poeta solo poche righe sopra “grandissimo non meno che sfortunato”. Ma con queste parole non volevamo dire che le cose gli siano andate realmente male, nel senso che venne o venisse più o meno malamente fiutato e indi rifiutato dalle sue Muse, che fu precisamente quel che accadde invece e sistematicamente al povero Giacomo Leopardi (di cui la grazie a lui celebre Fanny Targioni Tozzetti – intervistata sul tema – disse che del celebrato poeta non sapeva bene che farsene come uomo perché “puzzava!”). Al contrario, si sa con certezza che, oltre a due mogli, questo devoto del tango e suoi dintorni – le cui milonghe in rima sono state musicate niente popò di meno che da Astor Piazzolla (quanto al tango, a quanto pare, il buon vecchio José Luis si comportò più o meno come quanto al sesso, ovvero come una sorta di “credente non praticante”) – ebbe anche un tot di fidanzate di cui si proclamò innamoratissimo, sebbene si dica che i rapporti furono sempre piuttosto tormentati, caratterizzati da incomprensioni e scontri di vario genere (le incomprensioni sembrano peraltro la regola nei rapporti fra uomo e donna, la cui tanto proclamata complementarità a me ricorda non tanto, che so, quella fra il sole e la luna, ma più che altro quella fra Napoli e i fuochi artificiali (Spengler sostiene che quando l’uomo e la donna non si cercano per trovare il padre e la madre dei loro figli, ma il compagna/o della vita, e dunque anche e sostanzialmente comprensione, compenetrazione, rispetto, amore, piacere, estasi, etc., ciò significa che una civiltà è vicina al tramonto, alla morte, ovvero che si sta trasformando da nascente ed 226 esultante civiltà in vecchia e grigia civilizzazione: uno dei sintomi patognomonici di questo processo di degenerazione e di invecchiamento di un mondo storico è che i matrimoni non superano mai o quasi mai la fatidica soglia del settimo anno e, a volte, nemmeno quella del settimo minuto)). Ma, non ostante l’innamorato avesse ottenuto da molteplici amate il più sospirato dei “si” – a quanto pare nemmeno in questo caso la Volontà di Vivere è riuscita a raggiungere i suoi scopi periscopici, ovvero a scopare o anche solo dare il cencio, passar lo straccio, strofinare, strigliare, spazzolare, o almeno spolverare o cose del genere. A ennesimo esempio del Trionfo della Sfiga – oltre che di quello piuttosto scontato della Morte – che, come noto, non fa e non ha mai fatto sconti a Nessuno, nemmeno al buon vecchio Odisseo – possiamo affermare che il massimo scrittore che la breve storia d’Argentina ricordi, una volta avuto a disposizione l’oggetto della sua passione, non seppe o non volle mai andare oltre qualche castissimo non meno che imbranatissimo bacio. Estela Canto, una bella e disinibita giornalista iniziò all’età di ventotto anni una relazione con il già famoso Borges quarantacinquenne, relazione che durò ben sette anni, sette anni in cui il lirico e romantico innamorato non seppe o non volle far altro che tenerla per manina e sbaciucchiarla con baci che quella crudele e pettegola megera d’Argentina definisce timidissimi, impacciati e neppur degni del più goffo e inesperto dei ragazzini. Le cose non parvero andar meglio con le due mogli, Elsa Millan e Maria Kodama, dato che ci sono piuttosto credibili testimonianze che in entrambi i casi le coppie dormissero addirittura in letti separati, il che ci permette a questo punto di aggiungere alla lunga lista di fallimenti della Volontà di Vivere di proseguire sé stessa tramite le alate fiamme del “celeste foco” anche questo in cui, pur non esistendo ostacoli di alcun genere alla riproduzione – ma, al contrario, risultando infine quasi un obbligo derivante dall’odioso non meno che inevitabile dovere coniugale – constatiamo però che l’eccesso di romanticismo e sentimentalismo nella contemplazione dell’amata non solo non è servito a niente, ma, addirittura, è parso artificio che impedisse all’aratro di scavare il solco, cosicché di nuove vite neppur si potesse 227 tentar l’incauta e infausta seminagione (la per quarantacinque anni segretaria del buon Josè afferma senza troppe remore e incertezze che, per quanto ne sapeva lei, il sesso, più che non interessarlo, lo atterriva positivamente, così che, quasi certamente, “el señor muriò virgen”). 100. Al termine di questa lunga e speriamo non troppo noiosa disamina, possiamo ora tentare di arrivare a una sintesi generale, e dunque domandandoci: quanti, fra gli sfortunati figli di Adamo che con la loro miserabile presenza calcano questo surrealistico Golgota che chiamiamo “mondo”, sono stati quelli davvero generati a partire da illusioni alte e celesti? A parte i matrimoni combinati (che sono a tutt’ora la larga o larghissima maggioranza in posti come l’India o il Giappone, e molti altri paesi dell’Estremo Oriente, come lo furono in passato in Europa e più o meno un po’ dappertutto (fra l’altro, pochi sanno che circa il cinque per cento della popolazione mondiale è frutto di matrimoni fra cugini incrociati, matrimoni che sono perciò decisi non tirannicamente dalla volontà autoritaria dei genitori, ma, quasi ontologicamente, dalla collocazione parentale stessa), a parte ogni stranezza di stampo etnologico si possa mai citare, quante libere unioni nascono dalle convenzioni, dalla convenienza, dalla noia, dalla ripetizione, dalla costrizione, dall’incoscienza, dalla stupidità, dal caso? E dalla mia celeste Elisabetta, dalla mia adorata Tersicore che cosa è nato, se non un angoscioso turbine di notti insonni, sbronze, sigarette, inutili attese, delusioni, e, appunto, poesie, poesie, e ancora poesie (quelle pubblicate in fondo a questo sconclusionato volume non rappresentano nemmeno un ventesimo del totale)? Tirare conclusioni su un tale argomento non è facile per nessuno, ma provo comunque ad arrivare alla mia, che mi pare dover essere per forza di cose questa: che gli inganni, i tranelli e gli orpelli più o meno celesti che la Natura o la Volontà propinano all’uomo non hanno, proprio come l’Arte, altro fine che sé stessi. Il mondo umano e non, di loro privo, resterebbe più o meno il medesimo, proprio 228 come più o meno il medesimo rimarrebbe privo della Divina Commedia o del carteggio Henry-Anais o, naturalmente, di quelle poesie che, belle o brutte o, addirittura, del tutto insipide che siano, seguiranno come appendice a questa sorta di prolissa introduzione (parlare di una storia o non-storia che sia, in questo caso, non mi pare proprio il caso: è stato tutto un caso). L’amore dunque, o, meglio, l’Amore non serve alla Volontà di Vivere per propagarsi nel tempo, ma semmai solo a dilatare fino alla follia – ovvero fino al parossismo, fino all’insolenza, fino all’eccedenza, fino allo splendore, fino alla noia, fino alla fine – la sua pura e semplice Inutilità. 101. Va beh, come ho spiegato o cercato di spiegare già all’inizio, essendo questa non una storia, ma bensì una non-storia, non c’è da sperare che possa concludersi con un vero e proprio finale, ma, come c’era da aspettarsi, solo in un inutile e melanconico non-finale: il che però non significa che essa sia o possa essere infinita, tutt’altro! Così mi rendo conto che il motivo di queste mie continue divagazioni, di questo mio continuo tergiversare, esitare, deviare, titubare, rinviare, tentennare, storicizzare, intellettualizzare, dialettizzare e chi più ne ha più ne metta, altro non è che il fin troppo prolisso frutto di una una sorta di infantile non meno che intollerabile horror vacui. Passo a passo, parola per parola, mi sto avvicinando alla fine di questo futile non-racconto, e con tale simbolica fine si approssima la definitiva fine della mia non-storia con Elisabetta. L’ultima pagina oramai incombe inesorabile, è qui, con le sue ultime frasi e un’ultima parola che si staglia all’orizzonte alta, maestosa e terrificante come la ghigliottina incontro al condannato a morte. In realtà, lo so adesso, come peraltro l’ho sempre saputo: tutte queste parole, tutte queste frasi, tutte queste pagine, tutte queste tetraggini e lungaggini, altro non sono che un interminabile fantasmatico congedo da quest’Amore che oramai, nella nuda e cruda realtà, so essere per sempre e da sempre ormai perduto. Tanto si dilata questo vuoto e fin quasi 229 impensabile orizzonte – “ove per poco il cor non si spaura” – che, mi rendo conto, nel tentativo di evitare un “naufragar” che non mi pare per nulla, ma proprio per nulla “dolce” ho passato questa volta ogni limite umanamente comprensibile e sopportabile, e che la divagazione è andata davvero un bel po’ troppo per le lunghe. Così, mi trovo costretto, spero per l’ultima volta, a ricordare al lettore e soprattutto a me stesso il punto a cui troppe pagine fa ero giunto nel racconto della presente non-storia. Il punto, come mi ricordo o mi sembra di ricordarmi, era quello piuttosto tragicomico in cui, vista l’incoercibile determinazione con cui Elisabetta persisteva a importunarmi simil zanzara, tafano o mosca o rubinetto gocciolante et cetera, avevo deciso infine di mettere in atto un diabolico piano per liberarmi della sua importuna insistenza – diabolico, almeno, dal punto di vista di Topolino, o Paolino Paperino. Il piano era quello che avevo escogitato il giugno precedente e che aveva il modesto e solo apparentemente semplice scopo di potermi definitivamente allontanare dal palcoscenico di questa strana commedia dell’assurdo che era iniziata con il mio improvvido innamoramento di circa un anno prima. Il diabolico piano consisteva infine nello spedirle via sms una poesia la settimana e nel continuare ad evitarla, aspettando per il resto l’evolversi degli eventi (il che dimostra, fra le tante altre cose, che stare al mondo può essere una faccenda molto più complicata di quanto a prima vista non si possa credere). Muovendomi all’azione (azione?!?!) non mi sentivo più in grado di formulare alcuna speranza di alcun genere, tanto sembrava inconcepibile, incoercibile e quasi folle l’insistenza con cui la mia ex diletta continuava a cercarmi per cercare di ottenere, peraltro riuscendoci perfettamente, una sorta di non-rapporto, che consisteva più o meno nel guardarmi fisso, nell’avvicinarsi e chiedermi – chissà perché – “come stai?”, e nello svanire poi nel nulla, o in qualcosa di simile, non appena un eventuale colloquio minacciasse di prendere la sia pur minima consistenza. Un atteggiamento questo che era infine riuscito a sconvolgere il mio sistema nervoso, incrinare il mio senso comune e, con ciò, la mia capacità di distinguere il mondo reale da uno scherzo da prete all’italiana, da una barzelletta di Berlusconi o, a limite, da uno sciopero della fame di Mastella – fatto effettivamente 230 accaduto eppure tanto credibile che lo sciopero della sete di una grondaia (in effetti, mi rendo conto che, più che di Elisabetta in sé e per sé, stavo in quel momento tentando di liberarmi anche e soprattutto da quello strano innamoramento verso una persona che infine non ero riuscito a conoscere in modo minimamente concreto – cosa che faceva si che oramai non riuscissi più a distinguere – oltre che il mondo reale da uno scherzo da prete all’italiana etc. – anche il mio innamoramento stesso, vero o presunto che fosse, da un mal di testa con nausea e crisi di vomito annesse: in tutto il “Godot” non ho trovato degli elementi di maggior assurdità che in quegli eventi che mi stavano tanto irrealmente quanto surrealmente non-accadendo (l’unico lato positivo di tutta la faccenda era comunque il fatto che, almeno fino a quel momento, non avevo dovuto pagare il biglietto per assistere alla commedia dell’Assurdo in questione: sono grazie e disgrazie queste che capitano solo agli attori)). 102. Ma, a dispetto della mia sfiducia, dapprima con stupore poi con incerta gioia, osservavo che la mia strana tattica (non parlare più con una persona, spedirgli poesie via sms e attendere gli eventi sarebbe una tattica? ma che cavolo di tattica è, di cavolo lesso, bollito o che?) la mia strana tattica, stavo dicendo, prendeva ad avere lentamente effetto. Dapprincipio Elisabetta cominciò ad avvicinarsi con più difficoltà – come se si sentisse in imbarazzo a causa di qualche oscuro pentimento – o impedimento – poi prese a guardarmi più di rado, meno fissamente e da più lontano, con aria oramai più interrogativa che sgomenta e, inoltre, smise anche di far di tutto pur di incontrarmi “per caso” e salutarmi “amichevolmente”, finché un giorno, dopo aver cambiato scheda per spedirle la non mi ricordo se quarta o quinta poesia, il telefonino squillò e, sorpresa delle sorprese, mi accorgo che la mia personale Beatrice ha risposto all’ultima composizione a lei dedicata addirittura con due sms! Preso da un orgasmico desiderio di non so che, probabilmente solo di un orgasmo, stavo per azionare il comando “vedi messaggio”, ma sul 231 punto di schiacciare il pulsante mi sentii di colpo come paralizzato: scoprii d’improvviso che anche solo l’idea di leggere quelle parole ignote mi spaventava a morte, che qualunque fosse stato il loro contenuto mi avrebbe reso ancor più infelice: se mi avesse dato qualche segno di affetto, sarei di nuovo sprofondato nell’abisso luminoso e atroce della speranza, se fosse stato un nuovo rifiuto sarei semplicemente sprofondato di un altro paio di metri in quell’altro abisso, quello tetro e orrendo in cui peraltro già mi trovavo, quello scavato dal disincanto, dal disamore e dalla solitudine, oltre che, naturalmente, dalla ormai familiare disperazione, che a quel punto avrei saputo solo notare per la sua assenza. Elisabetta aveva qualcuno, adesso lo sapevo con certezza, e dunque non c’era più nulla da fare né da sperare, dato che non c’è seduttore al mondo che non conosca quanto sia improbabile la speranza di sedurre una ragazza che è già seduta. Così, dopo circa ventiquattro ore di dubbi e ripensamenti le spedii un sms che voleva essere di addio e che suonava più o meno in questo modo: “Perdonami, ma non ho letto i tuoi messaggini. Troppo mi è costato dimenticare per ricordarmi anche solo una parola di più, bella o brutta che sia. Chi ama vuole il corpo, l’anima e l’ultimo respiro, e io invece posso solo sperare che le mie poesie ti siano piaciute, dirti che il mio nome non è quello con cui mi sono presentato, che anche questo numero è falso e sta per scomparire. Peccato, te ne avevo scritte tante. A presto, Thomas”. 103. Queste parole meritano, così credo, una qualche spiegazione, soprattutto quanto alla seconda parte del messaggio, in cui, mentendo spudoratamente, dicevo a Elisabetta che vivevo costretto in una sorta di falsa identità (il nome con cui mi presento è quello vero, se qualcosa degno di questo nome al mondo ancor resiste), e anche va sottolineato il fatto che, in generale, il contenuto del mio sms non rifletteva il mio stato d’animo in maniera fedele, in particolare quel “a presto” finale che celava il quanto e, soprattutto, il come si fossero trasformati i miei sentimenti nei suoi confronti. Se solo pochi mesi 232 prima la mia vita consisteva nella pura e semplice speranza di rivederla, adesso le cose erano cambiate fino al punto che, in modo più o meno inconscio, la mia vita consisteva nello sperare puramente e semplicemente di non rivederla mai più. E, in effetti, l’allusione ad una presunta falsa identità non aveva altro scopo che far morire l’infame ingannatrice, se non di delusione, come avrei voluto ardentemente, almeno di curiosità. Non solo non avrebbe mai saputo con sicurezza chi, fra i suoi conoscenti, fosse lo sconosciuto autore degli amorosi versi, ma quand’anche l’avesse arguito (e l’aveva arguito, eccome se l’aveva arguito!) gli sarebbe rimasto per sempre nel gozzo il desiderio di sapere chi fosse veramente quel colui che colei oramai poteva ben credere di conoscere del tutto falsamente (a questo scopo firmarsi con un qualsiasi nome straniero risulta strumento più efficace che firmarsi, che so, Zorro, Ercole, o Berlusconi). Di mettermi a combattere schermaglie amorose a suon messaggini non ne avevo più voglia, perché non avevo più voglia di coltivare inutili speranze. Elisabetta, oltre a essere dichiaratamente fidanzata, mi aveva sia pur parzialmente conosciuto, aveva avuto modo – diciamo così – di “assaggiarmi” – e non mi aveva trovato di suo gusto. Se le andavo bene o comunque rapportarsi a me le fosse servito per conseguire qualsiasi altro scopo che quella delirante messa in scena di andirivieni a vanvera che andava avanti e – soprattutto – indietro ormai da un anno, avrei avuto già il modo di constatarlo. L’unica speranza che seriamente potevo coltivare era che Dio, il Fato, o il Caos, o il Nulla prestassero infine ascolto al mio lamento e, visto che in nessun modo mi volevano concedere un aiuto quanto all’ottenimento delle di colei grazie, per piacere, che almeno mi concedessero che si togliesse dai cosiddetti tre passi (non quelli del tango, sia ben chiaro, che sarebbero longitudinale, laterale e ocho, variati per le diverse direzioni: è strano come gli elementi fondamentali di una danza tanto complicata possano essere, in sé e per sé, semplicissimi, come la vita stessa, in un certo senso lo è, dato che anch’essa si costituisce di tre passi principali: inizio, svolgimento e fine (la sola differenza è che di questi ultimi tre solo il secondo può variare)). 233 104. Beh, a dir la verità non ho ancora scoperto chi fra i quattro sunnominati numi fosse l’autore dell’incredibile impresa, ma, comunque sia, o Dio o il Caso o il Caos o il Nulla, in separata sede o in combutta, chissà come o perché (“Quel che riguarda gli déi è difficile da scoprire” come recita un poco noto proverbio babilonese), decisero che il mercoledì successivo Elisabetta – in effetti – non si presentasse a lezione. Lì per lì (che fa sempre lì al quadrato) non osavo sperare che la sua assenza fosse frutto di un successo per quanto parziale della mia tattica, o men che meno se si trattasse – meglio ancora! – di un colpo apoplettico o qualcosa di simile: ma scoprii che, quale che fosse il motivo, ne ero tristemente felice. Finalmente anche le ultime propaggini di quella sfortunata passione stavano svanendo, e, come ora svanivano dalla lezione del mercoledì in particolare, prima o poi sarebbero svanite anche dalla mia vita in generale. Elisabetta mancò ancora una volta, poi due, poi tre. Infine, proprio quando ero davvero certo di non vederla mai più, ecco che il suo volto un tempo adorato e ancora, ahimè, assai rimpianto, ecco il suo volto, come dicevo, ricomparire sulla porta della sala, quella stessa porta da cui mi aveva per la prima e forse ultima volta sorriso, inquadrandosi in questo modo in una barthesiana cornice che la renderà forse per sempre indimenticabile, anche se non mai più veramente amata. Ma il volto che inquadro è – ohibò – un volto ben diverso da quello che conoscevo, e anche il suo corpo sembra cambiato: sembra paurosamente dimagrita, pallidissima, ha un’aria triste, fiacca, svagata, quasi malata, anche se, strano a dirsi, questa malattia quale che fosse faceva sì che la sua lieve e quasi incorporea presenza si facesse ancora più eterea del solito, ancora più abbacinante, in poche parole, ancora più bella, tanto che per l’ennesima volta in vita mia mi trovai a dover dare ragione al grande Shakespeare: “il dolore sarebbe rarità fra le più ricercate e adorate, se 234 a tutte si addicesse altrettanto.”76. E, sebbene quella indebolita fosse lei, a sentirmi quasi svenire fui proprio io, preso alla gola da una turbinosa, indistinta commozione, fatta di talmente tante cose che non riuscivo ad afferrarla, a dominarla, a definirla, così che ne fui, almeno per alcuni istanti, costretto, dominato, definito. Perdutamente, amaramente, dolcemente, mi sentii come sprofondare in un abisso di tenerezza, di paura, di appassita passione e compassione. La terra sotto i miei piedi, anzi, la terra sotto le mie scarpe da tango cedeva, pezzo a pezzo, centimetro per centimetro, ed io sprofondavo, immobile, impotente, con ululati di dolore, con sghignazzi di giocosa e gioiosa rivincita, con riluttanti rivoli di prigionia e soffocazione ed ultimi accecanti accenti di notte brava e morte: ma, a parte ciò, di nuovo volli evitarla, a qualsiasi costo! Il terrore di venir ancora una volta ghermito da fauci invisibili di notti insonni e inutili attese vinse anche la mia pietà, e le voltai le spalle. “Mors tua vita mea”, come dicevano i latini: qualunque fosse il motivo delle sue ambasce, dovevo ignorarla, dovevo pensare a salvare me stesso, a qualsiasi costo! Solo che, ahimè, sfortunatamente, a dispetto dei miei sforzi di ancora e sempre evitarla, durante la lezione ci fu un momento in cui rimanemmo vicini, troppo vicini, sia pure solo per qualche istante, e questa istantanea, incauta contingenza, dette di nuovo alla mia ex adorata la possibilità di avvicinarsi ulteriormente e, con voce sia pur flebile, intimidita – piena di sgomento dolore e sommesso, incoercibile rimprovero – il tutto condito da un sorriso stentato e rigidissimo – di approfittare dell’occasione per salutarmi, con accento di sofferente rimpianto, e di morbido, profondo e ormai quasi moribondo lamento. E io, naturalmente, a quel punto oramai più incredulo che furibondo, mi vidi praticamente costretto a ricambiare il saluto, cosa che feci nel modo più superficiale, ringhiosamente mendace, indifferente e freddo che mi potesse riuscire. Ma oscuramente, sotto la maschera della mia recitata noncuranza, sentivo che dentro di me qualcosa, ancora una volta, si stava muovendo. 76 W. Shakespeare, “Re Lear”, IV, III. 235 105. E infatti, poco dopo, uscito dalla lezione, l’angoscia e i sensi di colpa di colpo mi travolsero. Dio, mio, Elisabetta sembrava stare male sul serio e, in fondo, oramai cosa rimaneva in me di veramente vivo, di veramente e arduamente doloroso e pungente della forse già antica passione che verso di lei avevo pur nei mesi precedenti tormentosamente alimentato – al punto di sentirmi come la bimba del sogno sognato dall’Alighieri, ovvero come un infante che inghiotte un cuore che batte furiosamente fra le fiamme? Ero davvero così sicuro che la evitavo per non farmi del male e non per fare del male a lei, ovvero per puro e semplice rancore, per pura e semplice vendetta? Si, è vero, lei mi aveva fatto soffrire. Ma ora il carsico fiume della mia annosa indifferenza e insofferenza sentimentale aveva finalmente ripreso il suo antico, sotterraneo, arido corso: non avevo più alcun vero motivo di far finta che non esistesse. E poi, a ben pensare, come potevo essere certo che in tutta questa faccenda anche lei non avesse in qualche modo sofferto, o che non ne soffrisse ancora, anche se magari per motivazioni del tutto diverse dalle mie? Così, giunto a casa, sia pure a malincuore, le spedii un sms per darle il bentornato al corso (questa volta, naturalmente, non con il numero anonimo), con parole che, alludendo in modo nemmeno troppo labile a quanto fra di noi era successo recitava: “Come disse Gesù agli apostoli, è più facile che un cammello passi dalla cruna dell’ago, se l’ago non è quello da cercare in un pagliaio; comunque sia, bentornata”. A questo ironico ma anche affettuoso sms Elisabetta, con mio sommo stupore, rispose nel giro di pochi minuti, e, se non ricordo male, addirittura con un certo calore, dato che il messaggino recitava: “Grazie caro (caro?!?!?), a lezione non ci siamo nemmeno salutati! A presto. Un bacio.” (un bacio?!?!?!?). 236 106. Il mercoledì successivo arrivò oramai più fitto di perplessità che di attese: un bacio? Ma perché mai voleva baciarmi? Era impazzita del tutto, aveva bollito il fidanzato torinese nell’acido muriatico e ora voleva provarci con me? Non sapevo più cosa pensare, e dunque, semplicemente, aspettavo che di nuovo Dio, il Fato, o il Caos o il Nulla, mi svelassero i loro sempre più imperscrutabili decreti. Il mercoledì successivo Elisabetta si presentò al corso verso le nove e trenta e si mise seduta guardando da un’altra parte e insieme – gesto tecnico in cui le donne sono assai più specializzate che nel preparare gli spaghetti – dedicando alla mia figura l’ammaliante coda dei suoi occhioni, che con ogni evidenza scodinzolava tentatrice: perché non vieni a salutarmi? Non seppi resistere, credo, più di trenta secondi. Mi congedai per un momento dalla ballerina con cui stavo praticando, e mi recai a salutarla. La baciai quindi delicatamente sulla guancia, le chiesi poscia come stava, e le diedi infine appuntamento per uno dei balli successivi. Quando iniziò la seconda lezione lei era seduta nel medesimo punto, ancora da sola, e pareva aspettarmi. Allora di nuovo mi avvicinai e le chiesi di ballare: con un sorriso insieme fragile e radioso la ragazza accettò e cominciammo il nostro ennesimo ultimo tango, anche se – ahimè – non a Parigi. Ballammo insieme per circa trenta minuti e in tutto quel tempo, per prima cosa mi resi conto che non ero più pazzo di lei (“Il dio fa impazzire coloro che vuol perdere” diceva Euripide: che significava questa improvvisa calma, che il dio, qualunque esso fosse, mi aveva ritrovato?) dato che mi rendevo conto che la danza non mi dava più quelle estatiche sensazioni a cui solo pochi mesi prima non riuscivo ad abituarmi. Ero ancora, come dire – felice? – di abbracciarla, questo si, ma oramai il delirio erotico si era annacquato di troppe inutili attese, di troppi dubbi, di troppa malinconia, e forse anche di troppa tenerezza per poter lasciar spazio alla nuda e cruda, intollerabile, violenta e cioè vera passione (nel vero amore, credo, vi è un insopprimibile elemento di incoscienza, cioè di animalità; nella “Teoria della Religione” Bataille sosteneva che, dal nostro punto di vista, il punto di vista umano, l’animale sta nel mondo “come acqua 237 nell’acqua”: ma non è proprio allo stesso modo, ovvero “come acqua nell’acqua” che l’amante, attraverso l’Amore, scorre nell’amato, e si sente da lui – e proprio dal punto di vista di sé stesso – indistinguibile?). Scoprii anche che la sua magrezza e il suo pallore non erano una proiezione illusoria o una mia errata impressione, ma che effettivamente aveva dovuto di recente subire un’operazione a un’ovaia (e com’è strano, si vorrebbe dire, che una donna tanto amata, una semidea fonte di estasi tanto supreme possa avere qualcosa come un’ovaia prima e un’operazione alla stessa poi!), e che a causa di questa aveva perso un po’ di colore e circa sette chili di peso. 107. Andammo avanti a chiacchierare, manco a dirlo, di tutto e di nulla, come già ci era successo e come succede forse da sempre quando un uomo e una donna sono in qualche modo eroticamente interessati fra di loro, e si corteggiano, facendo forse solo finta di parlare, parlare, parlare, finché io, per continuare sul tema di questa inevitabile finzione, le chiesi se per caso il braccialetto che portava al polso sinistro fosse “maya” (il lettore faccia molta attenzione da questo punto in poi). Lei, curiosamente mi rispose che non era un braccialetto “manga” (manga? ma cosa vuol dire “manga”?), ma “bensì” (bensì?!?!) un braccialetto maya (ma io cosa avevo appena detto?), e che lo aveva comprato a Praga. Io, un po’ confuso dal tono della risposta, le dissi che non sapevo nemmeno cosa fosse un braccialetto manga, e che credevo, appunto, che fosse un braccialetto maya, al che la ragazza, con tono insospettabilmente duro e irritato mi rispose di nuovo che no, che si trattava di un braccialetto maya e non manga e che lo aveva comprato a Praga. Io, stupefatto, con tutta la dolcezza che potevo provai di nuovo a spiegarle che in effetti “maya” era proprio ciò che io intendevo dirle, ma lei si irrigidì se possibile ancor di più e di nuovo ripeté che avevo detto “manga”, che “io e te”, o forse addirittura “noi (!?!?!?) eravamo destinati a non capirci”, e che dunque quello che si stava testé svolgendo era “un 238 dialogo fra un sordo un muto”, senza peraltro precisare chi di noi due fosse il sordo, chi il muto, e chi stesse parlando e chi ascoltando (se a parlare fosse stato il muto e ad ascoltare il sordo il nostro dialogo non aveva prospettive: in caso contrario qualcuna ne conservava, non foss’altro che per il fatto che Elisabetta era appunto un interprete per sordomuti (comunque sia, voglio anche sottolineare il fatto che Praga è la capitale della repubblica ceca: che cosa ci va a fare un interprete per sordomuti nella repubblica ceca, ivi si reca forse a completare il disastro?). Incredulo di fronte a tanta insensata e, così mi pareva, del tutto incongrua irritazione, provai a insistere ancora sommessamente con la mia tesi, ovvero che io, appunto avevo detto fin da principio che il braccialetto era maya, ma la mia insistenza irritò Elisabetta fino a spingerla ad asserire che, oltre al fatto che io avevo detto manga e non maya, lei aveva potuto capire che io stavo parlando del suo braccialetto “solo perché aveva letto i miei pensieri e non aveva ascoltato le mie parole (!!?!?!)!”!!!! 108. Il lettore minimamente esperto di quella stranissima parte del mondo che sono i rapporti di coppia, avrà già capito il nocciolo della situazione: il nostro colloquio, all’inizio banalmente e stucchevolmente amichevole, stava prendendo le interessanti, intricate e intriganti pieghe di un litigio fra amanti, nulla di meno. Le chiesi se fosse del capricorno, e mi rispose molto irritata che no, non era del capricorno, se fosse del toro, e con tono parimenti irritato mi rispose che no, non era del toro – e io ridevo, pazzo e felice, convinto di aver finalmente aperto una breccia nel suo cuore. Anche se ero già lì, anche se già stavamo andando abbracciati nel magico e lento incantesimo del tango, sussurrai fra me e me col tono insensibile del pensiero, come travolto da un’onda di dolorosa, incontenibile dolcezza “oh, fossi una colomba che rapida vola come procella!”77. 77 Si tratta ancora di Sofocle, ancora una volta da “Edipo Re”. 239 Ma l’insorgere delle mie speranze venne quasi subitaneamente sommerso da quell’oceano di inquieta perplessità in cui ero sprofondato per tutta la precedente settimana. Semplicemente, quanto stava accadendo non era possibile, e dunque non poteva essere reale. La ragazza era – come si suol dire – impegnata e, a quanto pare, assolutamente decisa a rispettare i suoi impegni. Dunque, qualsiasi cosa potesse significare quel piuttosto surreale litigio, di certo non si trattava di amore o, comunque, non era la promessa di nulla di diverso da quanto accaduto in passato. Anche alcuni mesi prima si era a più riprese allontanata e avvicinata a mo’ di yo-yo, e, ammesso che quel colloquio avesse effettivamente avuto un substrato erotico, la settimana successiva, no, non ne ero certo, ne ero certissimo, Elisabetta non si sarebbe ripresentata al corso: questo sconosciuto fidanzato torinese, alla fine, sembrava davvero importante, se non per i suoi sentimenti, almeno per i suoi progetti matrimonial-riproduttivi; a trenta o più o meno anni, quanti Elisabetta ne dimostrava, una ragazza che vuole avere figli non lascia un porto tranquillo e sicuro per il mare aperto di un nuovo amore, quand’anche prometta un attracco migliore di quello in cui si trova. Così pensando, la gioia in petto scese ben presto giù nelle viscere sotto forma di una sommessa, finale e sibilante angoscia. A pochi minuti da questo strano screzio ci separammo. Elisabetta sembrava, più che stanca, addirittura distrutta, e andò a mettersi a sedere dicendo che il suo turno di ballare era finito (quella sera c’erano più ballerine che ballerini, e a turno le ragazze dovevano stare fuori): non so se questo fosse veramente vero, o se invece era semplicemente stanca, come sembrava, oppure imbarazzata, o irritata o che: so solo che, se avesse voluto, avrebbe potuto ancora continuare a ballare, o, almeno, a parlare con me. Al momento in cui me ne andai a prendere il treno mi recai a salutarla e la carezzai con dolce e luttuosa tristezza sulla testa. Non l’avrei vista per molto tempo, mi ripetevo, ma solo per non confessare a me stesso quello che veramente pensavo nel profondo: che non l’avrei vista mai più. In preda a una sorta di luminosa, tragica, lamentosa calma, mi recai alla stazione mentre con profetica tristezza mi tornava in mente un’altra celebre battuta del “Godot”, che in quella situazione ci cascava a fagiolo, o, meglio 240 ancora, proprio come il cacio sui maccheroni o, se proprio si vuole, come il calcio su Zaccheroni, o – ancor meglio! – come una cravatta color canapa per il compleanno del condannato all’impiccagione: “Che stiamo a fare qui, ecco quello che dobbiamo chiederci. Abbiamo la fortuna di saperlo. Si, in quest’immensa confusione solo una cosa è chiara: noi aspettiamo Godot”. 109. La funesta profezia era stata – devo riconoscerlo – fin troppo facile. Talmente facile che, in effetti – pur continuando dolorosamente ad aspettarla, ovviamente con la stessa irreale, de-reale e surreale incredulità con cui sul palco di Beckett si aspettava l’arrivo di Godot – devo infine confessare che non provai alcuna vera delusione quando Elisabetta il mercoledì successivo, e quello dopo, e quello dopo ancora, non si presentò al corso, senza peraltro dare segni di vita o di morte di altro genere: non un messaggino, non un un’amica che casualmente passando venisse a dirmi, sai Elisabetta non è potuta venire perché…, e nemmeno mi riuscì di trovarla “per caso” andando in giro per milonghe. Per parte mia, non mi azzardavo a telefonarle o a fare passi di alcun genere, stante il fatto che in passato qualsiasi mia iniziativa in tal senso non aveva fatto altro che ottenere due di picche in serie, al punto che da un pezzo mi ero scordato che nel mazzo potesse esserci anche qualche altro genere di carta. Avrei voluto disperarmi, provare dolore ancora e ancora, ardentemente, furiosamente, eroicamente, atrocemente, ma mi rendevo conto che anche il tempo del dolore era passato, che, pur con ogni buona volontà, non veniva e non sarebbe venuto mai più. Come scrisse Cavalcanti a un’anonima di cui giammai sapremo il nome “Tanto è distrutta già la mia persona ch’i’ non posso soffrire” e dunque tanto valeva rassegnarsi e passare al Baudelaire che invocava e scriveva alla donna fatale che prima o poi conoscerà per sempre il nostro nome “O Morte, vecchio capitano è tempo! Su l’ancora! Ci tedia questa terra, o Morte! Verso l’alto, a piene vele!”. Così il mio antico malumore prese a richiamarmi all’ordine delle mie beneamate 241 abitudini, ovvero al mio buon vecchio tedio, al buon vecchio spleen, al fastidio, all’estenuazione, e che per sempre la si finisse col morso acuto, ancorché paradossalmente vitale della disperazione (già, perché, come diceva Pasolini “non c’è disperazione senza un po’ di speranza”, e dunque come non riconoscere infine che la disperazione è una forma sia pur ultima e catacombale del male che per ultimo insorse e insorge dal mitico eppure fin troppo reale Vaso di Pandora?). Ero finalmente stanco. Finalmente arrivavo a sentirmi definitivamente sfinito e ultimamente consunto. A furia di non poter dire nulla, ascoltare nulla, afferrare nulla, di non poter capire nulla mi ero esaurito, si, ma di quell’esaurimento che tanto assomiglia alla pace da poter essere per essa scambiato, e con una certa dolcezza abbracciato come una sorta di surrogato dell’impossibile e quasi impensabile felicità. 110. Che cosa era mai successo nella testa di Elisabetta nel mentre pronunciava fatali e fatate parole quali “io e te”, o, addirittura, “noi (sic!) eravamo destinati a non capirci”, o “ho potuto capire che parlavi del mio braccialetto solo perché leggevo nei tuoi pensieri e non ascoltavo le tue parole”? Chissà, forse in quel mentre pensava davvero che fra “noi” potesse accadere qualcosa di diverso che quell’ignobile via vai di avvicinamenti e allontanamenti senza costrutto, che quell’inspiegabile abisso di incomunicabilità che sembrava effettivamente separarci potesse essere in qualche modo o da qualche volo valicato (scolio: “Ma si può, lo sai, amare un’ombra, ombre noi stessi”78: mio buon vecchio Montale, ma davvero “si può”, davvero io per tutto questo tempo ho amato solo questo, solo un’ombra? (e un’ombra di che, davvero, forse solo di me stesso?)). Non so. Chissà, forse anche lei, come me, in qualche oscuro modo, aveva dovuto arrendersi alla dura verità che fra le marmoree sentenze di Seneca risuona “Tutto va per un sentiero fisso, e il primo giorno 78 Eugenio Montale, dalla raccolta “Satura”, Xenia II. 242 ha fissato l’ultimo”. Accade a volte che desideri potenti e violenti si contrastino, e che di volta in volta affiori alla coscienza quello che si trova in quel momento insoddisfatto. Per esempio: “ehi!!!!!”: Elisabetta era fidanzata e in questo modo soddisfaceva il suo bisogno di futuro e di sicurezza, ma, come tutti ben sappiamo, non è quel che già si possiede a fare la nostra felicità. La nostra felicità non è qualcosa di reale, di effettivo, di presente, è il vano vaneggiare, il funesto vaticinio del nostro desiderio insoddisfatto, del nostro esser da sempre e per sempre bambini incontentati: dunque l’immagine idealizzata di ciò che non si ha e che si vorrebbe rappresenta per noi l’impossibile meta, la felicità. Ma siccome io rappresentavo per Elisabetta qualcosa di lontano, qualcosa – chissà cosa? – che appunto non aveva, ecco che intorno a me, per qualsivoglia purché strano e imperscrutabile motivo, si era creato quell’alone di ingannevole magia che, insieme a dolori talvolta poetici, e sempre atroci o addirittura atrocissimi, portano con sé in dote i desideri insoddisfatti. Leopardi è un riconosciuto maestro tanto nella descrizione come nella comprensione di questa situazione così tanto umana troppo umana, che pure, anche quando mille e mille volte capita, commentata, sceverata, analizzata, non manca eppure della forza di riprodurre forse per l’eternità i suoi inganni, financo nello stesso individuo. Ma lasciamo la parola al Grande Recanatese, perché ci illumini e ci delucidi: “Dalla mia teoria del piacere seguita che l’uomo, desiderando sempre un piacere infinito e che lo soddisfi interamente, desideri sempre e speri una cosa che non può concepire. E così è infatti. Tutti i desideri e le speranze umane, anche dei beni ossia dei piaceri più determinati, ad anche già sperimentati altre volte, non sono mai assolutamente chiari e distinti e precisi, ma contengono sempre un’idea confusa, si riferiscono sempre a un oggetto che si concepisce confusamente. E perciò e non per altro, la speranza è meglio del piacere, contenendo quell’indefinito che la realtà non può contenere. E ciò può vedersi sommamente nell’amore, dove la passione e la vita e l’azione dell’anima essendo più viva che mai, il desiderio e la speranza sono altresì più vive e sensibili, e risultano più che nell’altre circostanze. Ora osservate che per l’una parte il desiderio e la speranza del vero amante è più confusa, vaga, 243 indefinita che quella di chi è animato da qualunque altra passione: ed è carattere (già da molti notato) dell’amore il presentare all’uomo un’idea infinita (cioè più sensibilmente indefinita di quella che presentano le altre passioni) e ch’egli può concepir meno di qualunque altra idea etc. Per l’altra parte, che appunto a cagione di questo infinito, inseparabile dal vero amore, questa passione in mezzo alle sue tempeste, è la sorgente dei maggiori piaceri che l’uomo possa provare.”79. 111. Chissà, chissà come davvero sono andate le cose “se fu inganno, fu scelta, fu comunicazione, chi di noi due fosse il centro a cui si tira con l’arco al baraccone”80. Forse posseduta da un nostalgico e faustiano pathos della distanza Elisabetta, in quanto ente desiderato, sognato, fantasmagorizzato, davvero mi voleva e mi cercava, ma, ovviamente, ogni volta che si trovava sul punto di soddisfare il desiderio insoddisfatto, ecco farsi di colpo minacciato l’importantissimo e forse decisivo desiderio soddisfatto – di matrimonio, di sicurezza, di futuro, di protezione, nido, etc., storia vecchia, ahimè – (“Fragilità il tuo nome è donna!” si lamentava Amleto di fronte al tristo spettacolo delle affrettate nozze della madre, che probabilmente aveva sposato lo zio per paura della solitudine e non per disprezzo verso il primo marito e, di certo, non per la mitologica femminil lussuria, che esiste soltanto o quasi soltanto nelle più ridicolmente infondate e infantili fantasie dei maschi). Messo a rischio con l’avvicinamento il desiderio soddisfatto con quello insoddisfatto, a questo punto tornava precipitosamente indietro, verso il porto sicuro del suo stramaledetto fidanzato torinese, erratica entità a cui devono essere fischiate ben bene le orecchie, con il fischio degli Stukas in picchiata, intendo dire: se a questo ragazzo gli sono arrivati sulla zucca anche solo un quarto 79 80 G. Leopardi, Zibaldone, nota del 6 maggio 1821. E. Montale, “Satura”. 244 degli accidenti che gli ho mandato a questo punto deve trovarsi nelle stesse condizioni di una fabbrica di petardi dopo un bombardamento al napalm: chissà se è venuto o se mai verrà in qualsiasi modo a sapere di tutto quello che, fra l’altro anche per causa sua, mi è toccato di passare (a furia di ingurgitare alcol sono ingrassato di dodici chili in dodici mesi, e continuavo intanto a bere e a ingrassare senza neppur intravedere all’orizzonte il momento in cui avrei trovato la forza di smettere). 112. Il più delle volte sono questi i pensieri con i quali cerco di spiegaregiustificare quanto mi è accaduto. Ma altre volte mi vengono in mente altre ipotesi, molto meno immaginose e generose di queste. Mentre un brivido mi sale su per la schiena gelido come una stalattite su per il retto anale, ricordo che nel celebre caso della “Gradiva”, Jensen immagina un innamorato che, in preda al delirio, scambia l’amata per una statua. La donna, anche lei innamorata – però lucida e matura (non è chiaro come si possa essere lucidi maturi e al tempo stesso innamorati: ma le donne sono maestre in questo genere di acrobazie psicologiche) – non lo sottrae immediatamente alla sua illusione, ovvero non lo risveglia subito dal sogno: un risveglio troppo brusco non liberebbe, bensì distruggerebbe l’amore che Norbert nutre per lei, anzi, forse distruggerebbe il sogno insieme al sognatore (un sognatore senza più sogni è come un corpo senza più vita). Allora Zoe, con femminile, lenta ed assennata cautela, si inserisce nel labirinto delle immaginazioni del suo innamorato e, passo dopo passo, imprigiona e uccide il Minotauro della sua follia e lo conduce all’aperto, svelandogli infine la vera natura dei suoi desiderata (“vera” e dunque “deludente”? Leopardi non avrebbe avuto alcun dubbio, e forse, sotto sotto, non lo aveva nemmeno Jensen: la realtà e la delusione sono due mondi molto più vicini di quanto non saremmo in prima istanza disposti ad ammettere). La donna di Jensen è dunque una sorta di spirito benefico, di angelo salvatore, o, come forse giustamente osserva Freud nel suo 245 celeberrimo saggio, una sorta di antesignano della cura psicoanalitica. Ma non sempre gli oggetti amati si comportano in questo modo, materno e benigno. Roland Barthes nota molto giustamente che “La Gradiva è una figura di salvezza, propiziatrice, una Eumenide, una Benevola. Ma così come le Eumenidi non sono che delle vecchie Erinni, dee della vendetta, anche nella sfera amorosa esiste una Gradiva malvagia. Anche se inconsciamente e per delle motivazioni che possono aver origine nel suo tornaconto nevrotico, l’essere amato sembra allora volermi spingere sempre più addentro nel mio delirio, sembra voler mantenere viva ed esulcerare la mia ferita d’amore: (..) per esempio, l’altro si adopera a mettermi in contraddizione con me stesso (il che ha per effetto il paralizzare in me ogni linguaggio); o anche, alterna atti di seduzione ad atti di frustrazione (episodio consueto nella relazione amorosa); passa senza preavviso da un regime all’altro, dalla tenerezza intima, alla freddezza, al silenzio, al commiato;”. Frasi come queste mi fanno sospettare che il buon vecchio Roland si sia imbattuto, se non proprio in Elisabetta, in qualcuna che gli somigliasse molto, dato che la mia ex diletta si è comportata con me proprio come una sorta di Gradiva al contrario, spingendomi in vari momenti a pensare a lei come una vera e propria Erinni, ovvero come una rompi-ornitorinchi e rizza-obelischi patentata che non avesse altro scopo nella vita che spingere tutti quei poveri innamorati che cadessero nelle sue losche trame a perdersi per sempre nel labirinto in cui i suoi smisurati occhi venusiani e il suo accento perugino imparato e/o perfettamente imitato senza aver mai visto Perugia lo hanno perdutamente attratto. A tutt’oggi non ho ancora sciolto il dubbio, che offro al lettore così come ancora oggi dentro di me rimane, demone di nebbia, verme di ludibrio e morte, mentre il tempo inesorabile trascorre e con esso anche le residue possibilità di giungere a un qualsiasi genere di conclusione che non sia appunto, la Conclusione. 246 113. Dunque i motivi di Elisabetta, posto che fossero conoscibili, ormai non ho quasi più speranza di conoscerli. Quanto ai miei, il solo dubbio che veramente mi rimane è il perché in questo momento, ancora sperimentando il mal sottile della sua fatale assenza, io abbia dato l’avvio alla stesura di queste umili note, fino a questa amara pagina. L’unica risposta che mi viene in mente è che scrivo quanto sto scrivendo non per diventare uno scrittore, non per il mero gusto della narrazione, ma solo e soltanto per non perderla del tutto, per non perdere la memoria di quanto in questo strano, stranissimo anno della vita mi è accaduto che accadesse, si, ma non solo: scrivere questa ingloriosa non-storia d’Amore o non so che è servito e servirà anche e soprattutto a soddisfare il proditorio bisogno di pormi e di porre delle domande che mi paiono in tutto e per tutto fondamentali, quanto alla mia vita e quanto alla condizione umana in generale, o almeno, in colonnello, sergente maggiore o quello che è. Anche se, prima di affrontare questa erculea impresa – erculea in particolare quanto al “cul” – mi permetto di aprire e chiudere il più presto che mi riesca l’ennesima parentesi di questo libro che ormai mi pare fatto soltanto di parentesi (d’altra parte lo è anche la vita umana, dico, un libro fatto di parentesi frapposte fra il nulla prima di nascere e quello dopo il morire, e nessuno, a quanto pare, fa poi tante storie al riguardo (a parte il Pessoa-Soares che variando su questo tema senza tema scrisse “La vita è l’esitazione fra un punto esclamativo e uno interrogativo. Nel dubbio, c’è un punto finale.”). 114. Io credo che fra le cause più o meno accidentali dell’accidente che è successo fra me ed Elisabetta, nonché di tutti gli accidenti che ho mandato a lei e al suo fidanzato torinese – torinese o quello che è – è quello che vorrei chiamare il triste fenomeno dei fidanzamenti grigio-chiari, fenomeno che ritengo strettamente imparentato a quello dei matrimoni bianchi. Un matrimonio bianco, come tutti sanno, 247 sarebbe un matrimonio non consumato, mentre un fidanzamento grigio chiaro sarebbe un fidanzamento che viene consumato, si, ma che poi – stante la gaussiana che regola inesorabilmente il desiderio sessuale umano ove sia rivolto verso una sola persona – nel giro di qualche mese comincia a diventare sempre più simile a un matrimonio bianco, al punto che certi fidanzamenti grigio chiari, a volte dopo nemmeno un anno, diventano chiari al punto che non si distinguono più da quei matrimoni bianchi lavati con Dash, che lava così bianco che più bianco non si può. All’inizio della relazione, di solito, il fidanzato è abbastanza entusiasta di far la festa alla fidanzata, e la fidanzata è di solito abbastanza disposta ad assecondarlo, anche se non è chiaro quanto effettivamente si diverta sul piano puramente e semplicemente sessuale. Le donne godono in modo diverso da come lo prefigura la fantasia maschile, il piacere deriva loro essenzialmente dallo stimolo di fantasia e clitoride, possibilmente in contemporanea, e dunque le vanterie maschili quanto al numero, l’energia e la durata degli accoppiamenti è del tutto fuori luogo, stante il fatto che, almeno nel novanta per cento circa dei casi, un martello pneumatico infilato nella femminil ornitorinca è capace di smuovere la fidanzata media come un fresco vento di primavera la sedia ove sia seduto Giuliano Ferrara (è una vera fortuna, almeno dal punto di vista delle fortune riproduttive del genere umano, che le donne non abbiano alcun bisogno di un vero talento artistico per simulare il piacere, nel mentre sono manualmente impegnate col telecomando e mentalmente con l’agenda degli appuntamenti, con particolare riguardo a quelli di decisiva importanza con il parrucchiere e l’estetista: tanto si divertono gli uomini a infilarlo che questo da a loro la piuttosto onnipotente non meno che stupefacente sicurezza che le donne si divertano altrettanto a farsi infilare81 (l’ignoranza maschile quanto ai 81 E’ del tutto degno di nota che Lotta Continua, noto movimento della sinistra estrema degli anni ‘70, venne sciolto proprio per motivi di questo strano stampo. All’ultimo convegno del movimento venne infatti presentata una mozione delle donne che protestavano perché con il pretesto del libero amore i dirigenti le spingevano e quasi le costringevano ad accoppiarsi a destra e a manca, anche se loro non ci trovavano nulla di divertente a darla a 248 moti e alle motivazioni profonde della sessualità femminile è tanto biologicamente utile quanto psicologicamente sconcertante: una volta, tanto per farmi un’idea su come vanno le cose a questo mondo, ho provato a chiedere a un po’ d’amici se la loro compagna fosse vaginale o clitoridea, e la risposta più sensata che ho avuto è stata “a dirti la verità, io ho sempre creduto che fosse un’italiana”). Ma, orgasmi a parte, la prima parte della relazione è di solito abbastanza soddisfacente per le fidanzate perché, se non produce altro effetto, il pipì costantemente eretto del fidanzato le fa sentire belle e desiderabili, senza contare che a tale strano fenomeno naturale si accompagnano di solito frasi d’amore, regali o regalini e certe volte addirittura regaloni, cene pagate, fiori, cioccolatini, bacioni, bacini, bacetti, etc. Ma, ahimè, dopo pochi mesi il miracolo erotico cessa, e la relazione si trasforma in quello che tutti o quasi chiunque gliela chiedesse – per di più del tutto aggratis: loro avevano bisogno che qualcuno si occupasse del clitoride, sennò il libero amore serviva solo a soddisfare l’egoismo narcisista e interclassista dei maschi! Non è chiaro se Sofri abbia capito la situazione, almeno sul piano strettamente sessuale, ma siccome era andato a quel congresso con la volontà aprioristica di sciogliere il movimento, che stava pericolosamente sbandando verso il terrorismo, prese a pretesto l’insoddisfazione sessuale delle donne, che almeno quella risultava chiara, beata lei, e sciolse seduta stante LC. Ciò ci spinge a consolarci pensando che per una volta nella storia il clitoride insoddisfatto ha evitato qualcosa come una guerra civile, invece di produrre le consuete guerre familiari con lancio di piatti e accuse d’incomprensione e/o d’infedeltà annesse (l’intervento sul tema della radicale Emma Bonino in parlamento invece non ebbe alcun risultato pratico: non solo i provvedimenti da lei auspicati per far contento l’equivalente in scala 1/10 del pisello non vennero mai presi, posto che qualcuno possa mai capire quali essi potessero in ogni caso essere, Bonino compresa (diffusione di film porno fin dalle case d’infanzia, corsi di aggiornamento per fidanzati torinesi o meno o che altro?), ma la quasi totalità dei parlamentari, per la quasi totalità maschi, non capì come mai si dovesse discutere in quella consacrata sede della “tiroide femminile”, e ancor meno come questa fosse o potesse essere in grado di provocare l’orgasmo, questo sconosciuto che, se provocato, rischia di arrabbiarsi e prendere a botte l’incauto provocatore). 249 tutti sanno: una specie di rapporto di amicizia che comporta cene e vacanze con altre coppie nelle stesse condizioni, progetti per il futuro, litigi per motivi del cazzo e così via, fino a trasformarsi in evento altrettanto appassionante e coinvolgente che una fila di quattro chilometri all’ufficio delle poste o imposte dirette o indirette e poco importa (da questa umile sede mi permetto di avvertire tutti quei romanticoni che vanno in giro per il mondo sognando di trovare l’amore di tutta la vita di stare molto attenti a quello che fanno, perché c’è il rischio che lo trovino per davvero (non sono io che sono cinico, è Eloisa che me lo ha suggerito, ricordando al grande filosofo e teologo Abelardo, suo celeberrimo amante che volle a tutti i costi trascinarla nella follia di un matrimonio riparatore, alcune vecchie questioni quanto al contrasto inevitabile fra pensiero e passione, da una parte, e matrimonio e figli dall’altra “Chi, mentre è intento nella meditazione di argomenti sacri e filosofici, può sopportare i pianti dei bambini, le nenie delle nutrici che cercano di calmarli, la folla numerosa dei servi, uomini e donne, come può tollerare la sporcizia dei neonati repellente e continua? (..) come sarebbe stato più dolce per lei e meno infamante per me che fosse chiamata la mia amante, piuttosto che mia moglie, perché allora il mio amore per lei sarebbe stato libero, e non costretto dai lacci del vincolo matrimoniale. Inoltre, dopo ogni separazione avremmo potuto godere nei nostri incontri gioie tanto più gradite perché più rare.”82 (un tipo molto interessante questa Eloisa, è un vero peccato che sia morta un migliaio di anni fa e che, comunque sia, tanto era fuori di testa per questo Abelardo che per amor suo si rinchiuse in convento, non perché ne avesse alcuna voglia, ma solo per non contrariarlo (sic!), così che, anche a poter aver modo di contattarla, non credo che nessuno potrebbe nutrire molte speranze))). 82 P. Abelardo, “Lettere di Abelardo e Eloisa”, lettera prima, in cui Abelardo racconta ad un amico la storia delle sue sventure. 250 115. Che fare dunque? Stante la quasi inevitabile monogamia cui la Natura onnipossente costringe psicologicamente le donne, che pensano all’uomo non tanto come amante, ma come padre certo di non si sa bene di quanti e – soprattutto – di quali futuri figli (in effetti, se la madre del buon vecchio Adolf, invece di essere quel che era, ovvero una sessuofoba, frigida, non meno che intemerata e integerrima e isterica sposa piccolo-borghese, fosse stata invece una gran baldracca, amante di fumo, alcol, droghe varie e sesso godereccio, morta precocemente e senza figli, domandiamoci: il mondo ci avrebbe perso o guadagnato? ai posteri l’ardua sentenza), l’unico espediente che le fidanzate hanno a disposizione per sfuggire alla a volte mortale monotonia che incombe sulla loro vita erotica è quello di smutandarsi, a volte in modo degno di una spogliarellista dell’Est o dell’Ovest che sia dopo un quarto d’ora di spogliarello e, come già accennato in precedenza, andare in giro per tutto il mondo d’Egitto a rizzar obelischi come sfingi allupate, sperando di ricevere dagli eccitati corteggianti tutti quei complimenti e quelle attenzioni più squisitamente erotiche che ormai dal fidanzato – troppo impegnato – ahimè – a dargli tutta la dolcezza e la sicurezza del mondo – non possono più sperare di ricevere. Così, cotali allupate e allupanti promesse spose, si danno a lasciar numeri di telefono, ad alludere in modo scopertamente ambiguo a tutti sanno bene che, a far complimenti e mezze promesse, a far capire e non capire, finché non ricevono un invito a cena o qualcosa di simile, invito che naturalmente viene più o meno sdegnosamente rifiutato, di solito non prima di aver accusato l’ingenuo corteggiante di aver frainteso le loro intenzioni (magari gli avevano detto che col fidanzato non scopavano più da tre o quattro anni, che anche per fare un figlio unico oramai si erano ridotte a confidare nell’inseminazione artificiale, ma non importa, chi le invita a cena in ogni caso ha frainteso le loro intenzioni (beh, questo alla fine non deve stupire e non stupisce più di tanto, dato che il fraintendimento o malinteso che dir si voglia è la forma più civile e normale di comunicazione che si possa riscontrare fra due esseri apparentemente così diversi e 251 inconciliabili come un uomo e una donna, tanto è vero che, di solito, quando arrivano a capirsi reciprocamente, passano dal fraintendimento al lancio di stoviglie direttamente e senza passare dal via). Questo giochino è di solito talmente scoperto che non ci casca quasi nessuno che non sia completamente idiota, a meno che la donna non sia un’attrice da oscar oppure, come fu, credo, e soprattutto spero, il caso di Elisabetta, una persona completamente o quasi completamente ingenua e all’oscuro delle sue proprie motivazioni – ignoranza questa che produce gli stessi effetti che il più strabiliante talento per l’impostura e per l’inganno (non ci si illuda: forse una certa donna è innocente, ma la natura femminile non lo è mai). Comunque sia, a parte il mio specifico caso, i danni che in questo modo si verificano nella psiche del maschio intrappolato in tali losche ragnatele si riducono di solito a un po’ di giramento di ornitorinchi, qualche contumelia all’indirizzo della rizza-obelischi di turno, e fine lì, sempre che il maschio non sia di quel tipo generoso e altruista che si getta in avances addirittura esagerate per puro e semplice spirito umanitario, pari a quello di certi missionari che si recano nei più sperduti e impronunciabili nomi del mappamondo per porgere aiuto a popolazioni che muoiono di un altro genere di fame (a volte, la pena provata per certi soggetti particolarmente bisognosi ha spinto anche me a fare cose del genere: l’umana compassione mi ha a volte soggiogato fino al punto di regalare fiori, cioccolatini, o, addirittura, a dedicare poesie). 116. Quanto alle donne invece, l’agognata avance ha più o meno lo stesso desolante effetto di una sassata in un pollaio: un bel po’ di sbatter d’ali, grandi scoccodellate, penne che volano a destra e a manca, e nulla più. La fidanzata media, una volta respinta l’avance quale che sia, si mette a strillare, come si dice a Firenze, che lei “c’ha l’omo”, che lei è una brava bambina che la darebbe solo a lui – se solo lui la prendesse (quindi non la da nemmeno a lui, N.d.A.) – e 252 infine viene il momento più bello e agognato, quando va a sfogarsi in modo chilometrico con complici amiche possibilmente nella sua stessa infelice situazione, avendo in questo modo l’occasione per esaurire le centinaia di euro in omaggio che la Tim o chi per lei offre a chi cambia gestore mantenendo lo stesso numero (vi sono dei casi di arrapamento femminile talmente gravi cui le strabordanti e quasi oceaniche offerte Tim, o Vodafone o che, non bastano più, e hanno un bisogno impellente e improcrastinabile di ricorrere alla Posta del Cuore dei più disparati e disperati giornali, come dei più incredibili e increduli settimanali e mensili nonché delle semestrali, annuali e certe volte anche decennali riviste di destra o sinistra o di centro di questa terra, e forse anche di qualche altro pianeta, dato che quelle di questo esondano ad ogni uscita di tali pensosi e penosi casi umani che, in preda a una sorta di isterico furore erotico represso, si sfogano col dottore o con la dottoressa di turno giurando sul tempio di Venere e Giove accoppiati che loro stanno benissimo con il fidanzato, che non ne possono fare a meno etc., ma che un collega di lavoro, un vicino di casa, un palestrato della palestra, gli stanno facendo osservare che “una parte di lei” rimane, chissà perché, “inespressa”: mi domando come mai gli psicologi o sessuologi in questione, a furia di ricevere similari questioni sulla medesima questione, non siano impazziti o non si siano suicidati o – almeno – non si siano recati all’indirizzo di una qualche mittente per vedere di dargli una mano a risolvere il problema con un esempio pratico di come il divano di Freud possa essere usato per tutt’altri scopi che per produrre associazioni libere). Forse il lettore mi vedrà come un osservatore non propriamente obbiettivo e disinteressato, ma io trovo che questo scandalo al sole, indecoroso sempre, lo sia particolarmente e specialmente in una città d’arte come Firenze, dove questa torma di fidanzate sessualmente insoddisfatte, frustrate e frustate che vanno in giro starnazzando come oche del campidoglio “oh, ma io c’ho i’mmì omo!” (oppure, alla classica maniera di Elisabetta “ehi!!! ma io sono fidanzata!!”) risulta particolarmente antiestetica. A parte l’inquietante e satanistica coincidenza che le due ultime parole della frase tipicamente fiorentina si pronunciano allo stesso modo anche lette al contrario (e 253 come non notare che “omo”, se scritto con la “o” maiuscola altro non è che il nome di un famoso e potente detersivo?), il caos in questo modo ingenerosamente generato rischia di disturbare la contemplazione delle immortali opere d’arte che la nostra città custodisce nel suo antico seno e dunque, ancorché io sia elettore che non si reca alle urne più o meno dal quaternario inferiore, mi proclamo pubblicamente disposto a tornarvi e a dare il mio voto, il mio appoggio e, se necessario, anche la mia candidatura, a una lista che si presenti con un programma atto a risolvere il problema: programma che pretendo, ovviamente, adeguatamente pubblicizzato dai classici cartelloni di sei metri per tre dove il consueto politico dal tipico sorriso di caimano con il mal di denti prometta a gran voce, che so, “Più vibratori per tutte!” (beh, da tutto questo almeno si induce come mai ultimamente ci sono tutte queste donne italiane che vengono stuprate da extracomunitari: il fatto è che ormai ci sono dei lavori che gli italiani non vogliono più fare (e il perché si capisce fin troppo bene, almeno in questo caso)). Avendo capito dunque il motivo per cui le donne amano avvinarsi o avvicinare l’uomo, pur quando un tale avvicinamento non ha altro scopo che un precipitoso allontanamento e così via, motivo che, come si è visto, è quello stesso per cui i serpenti serpeggiano, possiamo chiudere anche questa noiosissima parentesi, e tornare finalmente ad un argomento un po’ più serio. 117. Che cosa è, o a che cosa serve l’Amore? Perché a un certo punto un certo o incerto individuo compare sul mare infinitamente deserto e morto dell’esistenza stagliandosi all’orizzonte maestoso e salvifico come la nave negli occhi del naufrago? Tanto sono potenti i suoi inganni, le sue lusinghe (ma davvero si tratta di inganni? sono così ben riusciti che inganni non sembrano, ma invece piena e splendente verità) che anche la loro simulazione letteraria o teatrale ha un inesorabile potere anticatartico. Quand’anche l’esperienza o la pratica religiosa più rigida ci spingano a diffidarne, sostiene Pascal, 254 nessuna forza ci trattiene dall’ammaliante potere delle sue vaghezze, così che “si ritorna da teatro con il cuore tanto ricolmo di tutte le bellezze e di tutte le dolcezze dell’amore, e l’anima e lo spirito tanto persuasi della sua innocenza, che si è già preparati a ricevere le prime impressioni, o piuttosto a cercare l’occasione di farle nascere nel cuore d’altri, per godere gli stessi piaceri e soffrire gli stessi dolori che si sono visti così ben dipinti sulla scena”. Ma da dove può nascere una così poco plausibile stregoneria, come mai uno sconosciuto, un totale estraneo, sembra a un certo punto addirittura miracolosamente trasformarsi in parte di noi stessi, e quindi in un essere unico, insostituibile, impareggiabile, in magica fonte di indescrivibili gioie e anche – a quanto pare, soprattutto – di feroci, atroci, luminosissimi dolori, che paiono incomparabilmente più alti, più nobili, più degni di qualsiasi altra gioia nonché, naturalmente, di qualsiasi altro dolore? Per rispondere a queste domande occorre, credo, tornare a quell’idea che abbiamo frettolosamente esplorato molti paragrafi fa attraverso il mito di Pandora, cioè l’idea che l’Amore sia un’immagine, o un nucleo di immagini, che contengono un’enigmatica allusione a una non meglio definita Speranza – non trascurando nemmeno di ritornare alle infelici non meno che infeconde vicende di quegli Amori celebri non meno che ridicoli che abbiamo rapidamente esplorato qualche pagina fa e – in particolare – a quello che abbiamo definito come il più celebre innamoramento della Storia, che fu notoriamente vicenda profondamente infelice, se non proprio tragica, dato che Beatrice (che giustamente fa rima con “infelice”) non volle mai saperne di beatificare il povero Alighieri altro che con qualche fuggevole saluto. Un Amore che dunque, almeno per questo rispetto e dispetto assomiglia, sia pure in modo solo un po’ vago, a quello che colse me per quella dolce rosa del tango, una rosa – ahimè! – fatta quasi solo di spine, che ebbe a nome Elisabetta (a proposito, il cognome non l’ho mai saputo: ma questo è logico, dato che se attraverso una ballerina senza nome mi è stato rivelato, in un tango senza memoria e senza futuro, il nome del Dio che non ha nome, che cosa mai poteva rivelarmi ancora il di lei cognome?). 255 Di Beatrice Dante, come già detto, ebbe solo il saluto. Perso anche questo, nel modo goffo e quasi vertiginosamente ridicolo che abbiamo sopra descritto, egli volle in tutti i modi cercare di rientrare nell’orbita del suo personale ma non per questo meno lussureggiante e divin Sole, ma ogni volta andò incontro a dei piuttosto dolorosi fallimenti. Il Poeta fra i Poeti, come ci testimonia lui stesso ne “La vita nova”, nonostante la sua dimestichezza impareggiabile nelle manovre amorose o meno con il linguaggio scritto (cioè, in rapporto con la pagina bianca, che è una donna simbolica a quanto pare assai più malleabile che le donne reali o già scritte che dir si voglia) rimane come paralizzato e ammutolito di fronte al vivo e semovente oggetto della sua passione: arrossisce intensamente, la vista gli si abbassa, il cuore gli balza tanto furiosamente in petto da arrivare fin quasi a soffocarlo. I sintomi che lui stesso descrive arrivano al punto di renderlo incapace di sostenere la mera presenza fisica di Beatrice (Dante racconta che una volta, trovandola a una festa in cui non si aspettava di trovarla, ebbe un quasi-svenimento simile in peggio a quello che colse me al termine degli appassionati abbracci con cui avevo tentato di sedurre la mia dea del tango: a me è bastato abbracciarla, a lui addirittura avanzava l’anche solo il vederla…). 118. Così, vedendosi freddamente e sdegnosamente ignorato, per reagire all’amara situazione Dante non può fare nulla di più o di meglio che scrivere sonetti in cui implora la sua amata di perdonarlo e di riammetterlo nella grazia del suo saluto. Nella Firenze di quel periodo il sonetto non era, come oggi, un atto privato, un grumo di parole rimate destinate all’ombroso, intimo e a volte anche polveroso silenzio di un libro. Era una forma di comunicazione ordinaria fra persone di una certa categoria sociale, che si scrivevano e si rispondevano in rima e, dato che Firenze era una città piuttosto piccola, non ci voleva molto perché un componimento arrivasse all’orecchio della persona a cui era dedicato. Ma quelle rimate, splendide implorazioni – oggetto nei secoli passati, in quello presente 256 e, presumibilmente, ancora per molti di quelli futuri dell’ammirazione e fin quasi dell’adorazione della critica o dei semplici amanti del genere – quei capolavori scolpiti nella memoria letteraria umana come le piramidi sul deserto di Giza, strano a dirsi, non ricevettero il sia pur minimo ascolto proprio da quegli orecchi per cui furono tanto dolorosamente poetate. Al contrario, lo stato di estrema debolezza che coglie il poeta in vista di Beatrice – comune peraltro a molti giovani e non, quando innamorati – tocca, questo si, la giovinetta, ma in modo un po’ diverso da come ci si potrebbe anche aspettare. Lungi dal suscitare tenerezza o affetto o, almeno, una qualche forma di pietà, la dedizione di questo strano amante a un certo punto si trasforma in motivo di derisione tanto per lei quanto per le sue amiche, che non esitano a gabbarsi dei suoi rossori, dei suoi tremiti e dei suoi impotenti silenzi. Dunque, quei versi appassionati e disperati non sono serviti nemmeno a far nascere una mera stima intellettuale nei confronti dell’innamorato (un tal genere di apprezzamento comunque sarebbe stato un contentino da nulla: gli innamorati aspirano alla stima sessuale, e del proprio e altrui intelletto sanno poco che farsene, non fosse altro che l’amore presuppone una perdita più o meno duratura dello stesso). Al contrario, a quanto è dato di capire dalle pagine de “La vita nova”, i sonetti del povero innamorato non fanno altro che accrescere il disprezzo nei suoi confronti, quasi che la ragazza veda in essi l’espressione, non tanto di un profondo amore, quanto di un’imperdonabile e quasi insopportabile debolezza: e capita spesso che un certo tipo di donne disprezzino tanto l’amore e ancor più la sottomissione di uomini che giudicano deboli. 119. Ma, non ostante i dinieghi, le pubbliche umiliazioni, non ostante “il gabbo”, Dante non demorde, anche se i suoi rinnovati tentativi di riconciliazione non ottengono altro che rinnovate delusioni, che il poeta non descrive direttamente, ma di cui abbiamo però un riflesso testuale piuttosto chiaro, dato che delle amiche di Beatrice viene 257 detto che “sapeano bene lo mio core, però che ciascuna di loro era stata a molte mie sconfitte”. Il significato della parola “sconfitte” non viene ulteriormente chiarito, ma viene facile pensare che, nei casi migliori, Dante sia stato freddamente ignorato, oppure, nei casi peggiori, che sia stato oggetto di altri gabbi, ovvero di beffe, frizzi, lazzi e derisioni varie. Pure, a dispetto di tutto, la sua dedizione per Beatrice non cessa, e dunque non cessa il profluvio di laudanti metafore, di genuflesse rime e imploranti allegorie, non meno che di vergini vertigini dedicate alla sua personale ipostasi d’Amore. Questa umiliata, irrisa, rifiutata, e perciò tanto strana devozione, dopo aver provocato disprezzo e ilarità, come accade spesso quando comportamenti inusitati e almeno apparentemente autolesivi vengono indefinitamente reiterati, alla fine giunge a suscitare curiosità e stupore nel gruppo delle amiche di Beatrice, tanto che a un certo punto si sentono irresistibilmente spinte a interrogare questo strano innamorato, che preferisce ricevere pernacchie piuttosto che nulla (forse il pensiero chiave è proprio questo, “piuttosto che nulla”, dato che, come sottolinea Estragon “Troviamo sempre qualcosa, eh Didi, per darci l’impressione di esistere!” e se non lo troviamo, mi permetto di aggiungere io, sono guai seri, ma proprio seri: ma svilupperemo in seguito questo argomento). Vedendolo passare lo chiamano e Dante, che era a quel punto addirittura atterrito all’idea di incontrare Beatrice, per paura di essere deriso, o, peggio, di svenire, dato che le ultime volte non era riuscito a reggersi in piedi al suo cospetto, dopo aver controllato che la sua amata non fosse presente si avvicina al gruppo delle ragazze, alcune delle quali stanno manifestamente ridendo di lui, sia pure in modo un po’ trattenuto. Un simile atteggiamento – rido di te, ma ti fo capire che non vorrei fartelo capire – causa a volte ulteriore imbarazzo in chi si senta al centro di tale sgradevole attenzione, in quanto un riso falsamente trattenuto appare come una sorta di doppia derisione (perché significa in effetti: rido di te, che sei tanto ridicolo che non sei degno nemmeno che qualcuno ti rida in faccia, ovvero di essere, diciamo così, sfidato in quel duello simbolico che è in fondo un’aperta e reciproca derisione: dunque mi prendo gioco di te, e non ti do neppure la possibilità di reagire): ma Dante non sembra irritato 258 più di tanto dalla penosa faccenda e si avvicina (forse non nota la derisione perché incontrarsi con le amiche è un modo per quanto collaterale di comunicare con Beatrice: quanto dirà sarà senz’altro a lei riferito, la sua amata ascolterà le sue parole, anche se di seconda mano, e dunque questa sembra un’occasione, forse irripetibile, di poter dichiarare il suo Amore alla Sua Donna). La ragazza che lo aveva invitato lo interroga in questo modo «A che fine ami tu questa tua donna, poi che non puoi sostenere la sua presenza? Dilloci, ché certo lo fine di cotale amore conviene sia novissimo» (si noti la raffinata, insinuante e quasi feroce ironia contenuta nella domanda: ma Dante di nuovo non si scompone N. d. A.). E poi che m’ebbe dette queste parole, non solamente ella, ma tutte l’altre cominciaro ad attendere in vista la mia risponsione. Allora dissi queste parole loro: «Madonne, lo fine del mio amore fue già lo saluto di questa donna forse di cui voi intendete, e in quello dimorava la beatitudine, ché era fine di tutti li miei desideri. Ma poi che le piacque di negarlo a me, lo mio segnore Amore, la sua merzede, ha posto tutta la mia beatitudine in quello che non mi puote venire meno». Allora queste donne cominciaro a parlare fra loro; e sì come a volte vedemo cadere l’acqua mischiata di bella neve, così mi parea udire le loro parole mischiate di sospiri (qui c’è da dubitare che Dante abbia frainteso la situazione e che le amiche di Beatrice continuassero a deriderlo in altro senso e in altro modo: se sospiri in effetti vi furono, c’è da pensare che fossero piuttosto di invidia per l’amica, amata a dispetto di qualsiasi derisione e di qualsiasi rifiuto, e non certo di commozione o compassione N. d. A.). E poi che ebbero parlato alquanto fra di loro, anche mi disse questa donna che m’avea parlato, queste parole: «Noi ti preghiamo che tu ne dichi dove sta questa beatitudine». Ed io, rispondendo lei, dissi cotanto «In quelle parole che lodano la donna mia» 259 120. Dante considerava originariamente il fine del suo Amore, il saluto di Beatrice. Dunque non è mai stato essenziale per lui essere corrisposto in qualcosa di più: come, che so, fare di Beatrice la sua promessa sposa o la sua amante, o anche solo un’amica. L’oggetto dell’Amore allora, a quanto sembra, non è un certo tipo di relazione intima con l’amata, ma l’Amore stesso, quel pensiero dominante capace di leopardianamente innalzarsi come torre smisurata sul deserto dell’umana esistenza. Tanto alto pare all’innamorato il suo sentire, la sua estasi, la sua dedizione, il suo stesso dolore, che è grato alla “sua” donna non perché gli dona sé stessa (in questo senso, si può dire, è essenziale che non sia mai “sua”, posto che qualcuno possa mai appartenere altro che a sé stesso, o al proprio fato, o alla propria morte), ma perché gli offre la pura e semplice possibilità di amarla. E questo è tanto vero che quando anche il saluto, ovvero il puro e semplice riconoscimento della sua esistenza, gli viene bruscamente sottratto, pure gli rimane ancora qualcosa che, a differenza del saluto, non può essergli tolto: poetare in lode di lei. Ma che significa avere la possibilità di lodare qualcuno? Che cosa c’è di interessante in una situazione siffatta? Forse questo: che se vi è qualcosa da lodare questo qualcosa è alto, è grande, è un lampo che rompe il grigio della vita quotidiana con una luce potente, qualcosa come un’alba nella notte insonne e incessante che sembra il tempo della vita umana. Vivere non è più solo e principalmente noia e fastidio, non è più solo quotidiana consunzione, inutile fatica: è anche e soprattutto Amore, per quanto respinto, irriso e disperato (fa dire Rousseau alla protagonista femminile de “La nuova Eloisa”: “Caro amico, intendo dalla tempra delle nostre anime e dall’affinità dei nostri gusti che l’amore sarà la cosa più importante della nostra vita. Se ha prodotto una volta le profonde impressioni che ne abbiamo ricevute, bisogna che spenga o che assorba tutte le altre passioni; il minimo raffreddamento sarebbe ben presto per noi un languore mortale: un invincibile disgusto, una noia eterna succederebbero all’amore estinto, e non vivremmo più a lungo una volta scomparso l’amore. Per quanto mi riguarda, capisci che 260 soltanto il delirio della passione riesce a velarmi l’orrore della mia situazione attuale, e che devo amare con trasporto oppure morire di dolore.”). Certo, se un essere umano, donna o uomo che sia, è tanto importante, ciò significa che si tratta di una figura che da noi si distacca: è più elevato, più nobile, più ispirato, un angelo si direbbe. Ma noi possiamo ugualmente accompagnarlo nel suo volo battendo furiosamente o lentamente, amaramente o dolcemente le ali della lode. Il nostro sentire si innalza così al pari dell’oggetto amato, anche se continua a parerci irraggiungibile, dato che è proprio il nostro prostrarci e inginocchiarci di fronte alla sua irraggiungibilità che ci spinge insino al Cielo. Beatrice non si dona a Dante: non gli offre il corpo, né l’anima (ovvero, in altre parole, l’intimità del pensare o del sentire), a un certo punto gli toglie persino il saluto, lo deride insieme alle amiche, disprezza la debolezza che deriva dalla sua passione, rifiuta qualsiasi tentativo di riconciliazione. Pure Dante ancora si sente in debito con lei di quell’altissimo sentire che, non ostante tutto, gli viene donato, e che prima della comparsa di Beatrice era impossibile, se non proprio impensabile. La lode dunque ringrazia l’essere lodato per il suo nudo esistere, dato che dona grandezza e perciò senso alla vita. Beatrice è in questo simile a un Dio lontano e crudele. Rida pure delle sue creature, le disprezzi, le umili, e infine, come il Dio di Agostino e di Lutero, persino le condanni (secondo questi due celebri teologi la stragrande maggioranza degli uomini è stata predestinata alla dannazione, fatto che ha spinto uno dei celebri bambini arzanesi citati nella raccolta “Dio ci ha creato gratis” a domandarsi: “ma se Dio sapeva che quasi tutti andavamo all’Inferno allora che ci ha creato a fare?” (azzardo una risposta: forse si annoiava a vedere i programmi della domenica pomeriggio e voleva solo distrarsi un po’, vedendo che cosa succedesse uscendo ed esclamando ad alta voce frasi come, che so, “Sia la luce!”): infine, ciò che salva l’uomo, ciò che redime dalla sua banale e grigia esistenza mondana – nonché dai programmi della domenica pomeriggio – non è l’amore della divinità, è la sua perfezione. Che il Paradiso esista, pure se il mio luogo è l’Inferno: che Beatrice mi ignori, purché Amor perduri e mai e poi mai non cessi. 261 121. (l’antica religione orfica – cui abbiamo accennato sopra – suppone una sostanza divina originaria di cui un tempo l’individuo era parte indivisa, pensiero arcaico questo, ma non troppo, o non così tanto come sembra, visto che possiamo fin troppo bene chiarirlo con questa modernissima osservazione di Bataille “Alla base della nostra esistenza sta una serie di passaggi dal continuo al discontinuo e dal discontinuo al continuo. Noi siamo esseri frammentari, individui che muoiono isolatamente nel corso di un’avventura inintelligibile, colmi di nostalgia per la perduta unità. Sopportiamo a stento la condizione che ci inchioda a un’individualità casuale, a quella individualità peritura che noi siamo. E se abbiamo il desiderio angoscioso della durata di quest’essere separato e destinato a perire, abbiamo ugualmente l’ossessione di una totalità originaria, che ci unisca all’essere complessivo.”. Secondo la dottrina orfica, proprio come secondo Bataille, l’infausta esistenza che conduciamo in questa valle ove regnano pianto e stridore di denti, non meno che le risate dei venditori di fazzolettini e dei dentisti (con tanto di parcelle differenziate, a seconda se si desidera o meno la fattura), altro non sarebbe che l’inevitabile frutto di una dolorosa non meno che misteriosa separazione da questo stato di comunione. Lo scopo dei riti misterici come dell’ascesi morale dell’adepto altro non rappresentavano che la strada da percorrere per ricongiungersi con la sua perduta origine, e porre così fine al doloroso esilio della sua esistenza intramondana, cui nessun bene è dato se non la possibilità di esserne redenti (concezioni simili sono per esempio quelle upanishadiche, o quelle taoiste, e, in generale, tutte le varie e complicate ramificazioni di quella forma di pensiero che viene di solito classificata come “gnosi”). E’ del tutto possibile dunque che abbia ben ragione Bataille, quando afferma che un innamorato non vede affatto in colei che ama un banale essere umano, ma bensì una porta verso quella totalità, verso quella sostanza orfica, ossia quella Madre trascendente da cui la nascita come una sorta di inesplicabile 262 peccato originale lo abbia tragicamente separato: per una persona questo stato dell’anima – quel che Platone definiva lo stato di Eros – non è da considerarsi come di semplice e volgare eccitamento sessuale ma di vera e propria estasi religiosa (ricordo che per i greci Eros non era certo da considerarsi un peccato, o, peggio una trasgressione, ma un dio), e l’atto carnale cui ardentemente aspira o può aspirare non è affatto qualcosa come un atto lubrico o ludico, ma una sorta di rito bacchico-misterico attraverso il quale la dolorosa separazione dall’Origine viene almeno per un po’ di tempo ricomposta (il desiderio sessuale non è, almeno nell’innamorato, un’animale, incontenibile e idiota brama di godere: è febbrile e dolorosa nostalgia di unità, nascosta e dolcissima avidità di morte, perché finché l’individuo vive, con esso viva e lancinante rimane l’insopportabile ferita della separazione, che nessuna forma di conoscenza astratta sembra poter guarire (è del tutto possibile che un innamorato sia da paragonarsi a quel Virgilio deluso dalla Ragione che compare nell’omonimo romanzo di Hermann Broch: solo che l’innamorato, invece che morire di morte naturale, preferisce farsi uccidere dall’Amore)) 122. (nella concezione di Bataille vediamo che l’eros appare come una sorta di introduzione a un rito sacrificale in cui la donna fa la parte della vittima e l’uomo quella del sacerdote uccisore: oltrepassando il tabù riguardante il sesso, la morte, lo sporco e la violenza, l’eros rigetta l’individuo in quel tutto da cui si è separato diventando individuo: dunque l’eros spinge al silenzio e alla solitudine, essendo la comunicazione fra individui fondata sul linguaggio, che presuppone quella separazione che l’eros abolisce. Al contrario, vediamo che Platone – seguendo le concezioni orfiche – concepisce l’autenticità dell’eros come una radicale negazione di tutto quanto sia corporeità, attaccamento ai sensi, e in questa estrema spiritualizzazione del rapporto, che ha come suo culmine il logos filosofico – in cui il linguaggio ritrova il suo fondamento e la sua 263 origine – gli amanti si aiutano in quel viaggio di ritorno verso il tutto e la sostanza originaria che è l’autentico scopo della vita: abbiamo dunque da una parte l’affermazione radicale della bontà del sesso, contro a una non meno radicale condanna dello stesso per raggiungere l’identico scopo di tornare all’unità con l’origine. Che cosa hanno in comune questi due atteggiamenti così estremi e così radicalmente opposti? (forse, la radicale affermazione di una radicalità e l’estremo imporsi di un estremismo quale che sia contro la mediocrità che a questa valle di lacrime, di pochi, porci, borghesi, maledetti e subito così mediocremente e tediosamente ci lega) 123. (per quel che mi riguarda, se devo proprio esprimermi in proposito o in sproposito che dir si voglia, direi che Amore allude effettivamente al Divino, ovvero al Dio che è, con ogni probabilità, proprio quello di cui parla Pascal nei “Pensieri”: un Dio ridotto all’osso e al paradosso, quel Dio ch’è fuori di noi ma al tempo stesso dentro di noi, quel Dio ch’è un Altro, l’Altro della teologia e della dialettica negativa (cfr., per esempio, Max Horckheimer, “La nostalgia del totalmente altro”), un Altro che pure è più noi di noi stessi. E’ per questo che l’oggetto amato è più me di me stesso, per questo conquistarlo è conquistare noi stessi, perdersi in lui è ritrovare noi stessi, perderlo è perdere noi stessi (scrive Eloisa ad Abelardo “Sai, o carissimo, come sanno tutti, quanto persi perdendo te, e quale enorme tradimento, ormai noto ovunque, sottrasse a me non solo te ma anche me stessa”83): è l’altro che amiamo, con un amore che però altro non è che un riflesso, dato che il nostro amore non è il nostro, ma il suo, è lui, il suo nome è il nostro vero nome (Dio mio, possibile che per alcuni mesi il Tuo nome sia stato Elisabetta, il suo, il mio adorato nome, il mio adorato nume? (con la parola “Dio” qui non si intende quel signore grande e grosso con la barba bianca che 83 P. Abelardo, “Lettere di Abelardo ed Eloisa”, lettera seconda, di Eloisa ad Abelardo. 264 Michelangelo ha dipinto sulla Cappella Sistina, ma, al contrario, Qualcosa o Qualcuno cui con l’immagine poetica, mitica o filosofica non posso fare altro che alludere, senza mai poter dire, fuor di metafora, che cosa sia (chi è questo dunque, il metaforico Dio che ha metaforicamente creato le metafore, quell’infinita catena cui ogni anello all’altro rimanda interminabilmente, così che liberarci mai sarà possibile, se anch’essa liberazione esiste solo come metafora?)))) 124. (comunque sia, in una cosa fondamentale mi trovo completamente d’accordo con Barthes e Bataille e in opposizione a Platone: che esperienze eccessive, radicali e spropositate come l’innamoramento e l’erotismo sono al di fuori del linguaggio, che parlarne significa parlare della loro indicibilità per mezzo dell’oscuro vaticinio della poesia, che altro non è in realtà se non qualcosa come un gesto, un magnifico gesto, con cui si mette a tacere la banalità del linguaggio quotidiano e si introduce lo splendido e terrifico tacere dell’abisso. Dunque il linguaggio che allude all’amore è come una danza, come un rito – come un tango! – ovvero come una scala che deve essere gettata dopo che vi si è saliti – proprio perché, come dice Wittgenstein nel “Tractatus Logico-Philosophicus”: “Il senso del mondo deve essere fuori di esso. Nel mondo tutto è come è, e tutto accade come accade; non c’è in esso alcun valore, né, se vi fosse, avrebbe valore alcuno. Se c’è un valore che ha valore, esso dev’essere fuori da ogni accadere ed esser-così. Infatti ogni accadere ed esser-così è accidentale. Ciò che li rende non-accidentali non può essere nel mondo, perché altrimenti sarebbe, a sua volta, accidentale. Deve essere invece fuori del mondo. (T. 6.41)”: beh, se uniamo Barthes, Bataille, Horkheimer e Wittgenstein, ecco che arriviamo a una conclusione simile a quella del Dante della “Vita nova”, ovvero che l’Amore è una sorta di evento trascendentale che vela e svela nel mondo qualcosa come un Altro mondo) 265 125. (per finire, o almeno tentare di sfinire questo decisivo argomento, voglio notare che nella traduzione piuttosto innovativa proposta dal grande, anzi, grandissimo e a tuttora misconosciuto ancorché defunto filologo Giovanni Semerano, il celebre detto di Anassimandro, quello stesso che così a lungo mi ha accompagnato lungo le strade e i ponti delle mie fantasticherie suicide, appare piuttosto diverso da come lo hanno tradotto, che so, Nietzsche e Platone, e, invece che la sintesi aneddotica di un sistema concettuale astratto, sembra piuttosto una variazione sul tema e al tempo stesso una generalizzazione del racconto biblico della creazione. Nella traduzione di Semerano il detto di Anassimandro suona infatti più o meno in questo modo “In quella stessa polvere84 da cui ogni cosa sorge, ogni cosa deve infine tornare, secondo necessità: ognuna paga infatti alle altre il fio della sua colpa, secondo l’ordine del tempo.”. Ricordiamo che, secondo il “Libro della Genesi”, la materia non esiste da sempre e per sempre, eterna e increata, ma viene bensì tratta dal nulla dalla parola divina. Dal cosmo terracqueo così generato Dio dà forma agli esseri viventi, Platone interpreterà il termine anassimandreo come “indefinito” o “infinito”, perché ai suoi tempi non esisteva quella che oggi chiamiamo la linguistica storica, e si credeva che il passare del tempo non avesse effetti sul significato delle parole. Invece, a quanto pare, la parola greca che al tempo di Platone significava “indefinito”, o “infinito”, al tempo di Anassimandro significava appunto “terra da riporto”, ovvero quella terra lasciata in deposito dalle inondazioni che è composta di polvere talmente fine che, per esempio, lanciata in aria perde consistenza e si disperde, nell’acqua si scioglie, ma che camminandoci su ha la tendenza a rimanere compatta e solida, quasi dura: un tal genere di materia appare indefinita, appunto, dato che appare ai sensi di volta in volta come solida, liquida e gassosa. Fu dunque attraverso quello che potremmo definire il suo uso metaforico che questo “nome di una cosa” nel giro di un secolo prenderà un significato astratto, tanto come aggettivo che come sostantivo, appunto quello di “indefinito”, o “infinito” (il termine greco deriva in modo diretto, secondo Semerano, dall’accadico “aperù” che vuol dire appunto “terra da riporto”). 266 84 buon ultimo l’uomo sua immagine, che prendono vita dal suo soffio (la parola “anima” deriva infatti dal latino “animus”, che è la traduzione dal greco “psiche”, che vuol dire appunto “soffio”, o “respiro”). Invece, secondo Anassimandro – la cui visione si pone, per così dire, in una via di mezzo fra l’orfismo e le concezioni israelitico-babilonesi che troviamo nel Vecchio Testamento – le cose, ossia la totalità degli enti individuali e individuabili, compreso l’uomo, insorgono secondo modalità imperscrutabili da una sostanza indifferenziata e increata, e in questo imperscrutabile insorgere ogni ente viene gettato e costretto a sé stesso e in sé stesso, cioè alla vita e nella vita, una vita che, ci spiega Anassimandro, è nella sua più intime origini ed essenza una colpa. Colpa che consiste in primo luogo nel fatto che la vita vive sempre a spese di altra vita (Re Lear dice in tono quasi laudativo a un Edgar seminudo che si finge un pazzo indemoniato “Tu non sei debitore di seta al baco, né di pelle alla bestia, né di lana alla pecora né di profumo allo zibetto.”); in secondo luogo perché vivere, oltre che nel distruggere altre vite, consiste essenzialmente nel separarsi dalla sostanza unitaria, divina eterna e originaria, che dall’individuo viene in questo modo e con questa colpa negata, spodestata, contraddetta. Siamo all’alba del pensiero tragico. Il concetto che troviamo in Eschilo e Sofocle, di eroe tragico, ovvero di singolo essere umano che gli déi e il fato costringono ad un dilemma morale senza via d’uscita, ovvero ad una colpa atroce che sarà senz’altro e senza meno punita con un’atroce e ignominiosa morte, viene radicalmente generalizzato dal primo filosofo dell’Occidente, o che l’Occidente ricordi, che non a caso pensa questo pensiero e scrive queste parole più o meno in contemporanea con la nascita in Atene della tragedia in quanto opera teatrale sacra, ovvero, diciamo così, di Divina Commedia pubblicamente recitata (come è noto la tragedia ebbe origine e durò finché visse come parte di un solenne rito religioso dedicato a Dioniso (l’espressione greca , significa infatti “canto del capro” o “sul capro”, e il capro era a quanto pare l’animale simbolo del dio). Ma, al contrario degli scrittori tragici, ovvero dei tragediografi, Anassimandro non crede all’accidentalità ovvero alla particolarità ed unicità della condizione tragica: la colpa 267 abominevole, ignominiosa e inevitabile non ricade solo ed essenzialmente su un uomo-eroe, ovvero su un Agamennone, un’Antigone, o un Edipo, a causa di una volontà particolare degli déi o del fato, no: un eroe tragico è ogni ente intramondano e dunque ogni uomo che per mezzo di questa colpa nasce e a causa di quella stessa colpa dovrà morire, dato che il propagarsi della vita altro non è infine, in questa concezione, che l’interminabile propagarsi di una colpa! Ma ora io mi domando: non è forse l’Amore una resurrezione del pensiero tragico nell’epoca più comica, anzi, più ridicola e surreale che il fato o chi per lui abbia destinato all’Uomo, ovvero nell’epoca in cui i catodici deretani di soubrette, presentatori, giornalisti, politici, in cui le foto di Facebook hanno sostituito ogni viva e concreta realtà? Quest’io innamorato che per mezzo dell’Amore anela a fondersi, a cancellarsi nel Tu dell’Amata non è forse in fondo infine un ente anassimandreo che anela a cancellare la sua colpa – che consiste nell’essere separato – o nel non-essere l’Amata – in essa cancellandosi? Quella volontà di sottomissione che troviamo in Dante e in ogni innamorato che si rispetti – e che invece di solito si disprezza – non è forse la volontà di pagare all’Amata il fio della colpa di essere da lei inevitabilmente, tragicamente distinto dal proprio, sia pur disperatamente innamorato, essere-un-io? E quest’Amata non è forse il simbolo della madre, di nostra madre, e questo umile essere umano non è forse il simbolo della Madre Universale, e questa infine non è forse l’umana traduzione e tradizione di quella sostanza indicibile, di quella terra-elemento, di quella terra-sostanza dalla quale ogni cosa viene e dove deve dunque tornare? Di quella terra dunque in cui infine dovrà pagare il fio della sua colpa, che non è e non può essere altro che il suo stesso essere in quanto distinto e altro dal Tutto e dagli altri esseri, con cui lotterà e che per sopravvivere ucciderà, volendolo o meno, fino alla sua stessa morte, ovvero fino all’espiazione finale, fino alla fine? (nota sconsolatamente sullo sconsolato tema il poco tempo dopo suicida Carlo Michelstaedter ne “Il dialogo della salute”: “(..) il vostro amore non c’è chi lo possa saziare – né baci né amplessi, né quante altre dimostrazioni l’amore inventi vi possono compenetrare più l’uno nell’altro”: saziare l’Amore non si può in nessun modo, perché 268 l’Amore consiste essenzialmente non nell’amare l’Altro, ma nel voler essere l’Altro (in un certo senso, possedere una donna non vuol dire altro che desiderare invano di essere da lei posseduti) 126. (prima di concludere questa volta spero in modo definitivo la presente non meno che interminabile digressione-regressione sul tema dell’Amore, ricordo che il nome “diavolo” deriva dal verbo greco , che significa più o meno “gettare fuori”. Ma chi è che viene per definizione “gettato fuori”, se non il nascituro che nel ventre della madre scalcia furibondo e impaziente? Quel nascituro, metafisico volersi che tragicamente scalciando vuole, pretende e implora di esistere in quanto entità distinta da quel Tutto che in quel momento è per lui la madre (Chrétien de Troyes spiega l’incapacità di Perceval di riconoscere il Santo Graal con un peccato da lui commesso contro la madre abbandonandola: “Fratello, t’ha nuociuto un peccato che ignori. E’ il dolore che provocasti a tua madre nel momento in cui la lasciasti. Ella ne cadde svenuta a terra a capo del monte, davanti alla porta, e di quel dolore morì. E’ per tal peccato che tu nulla domandasti né della lancia né del graal.”)? Dunque il diavolo che altro è, che altro può essere, se non questa volontà di uscire fuori, di uscire alla luce, di farsi luce, che spinge l’inconscia coscienza a diventar cosciente, a quella nuda esposizione al mondo che è la nostra vita? E dunque l’Amore che altro è, che Altro può essere mai se non un modo fra i tanti tentati e da sempre e per sempre falliti di pagare alla madre, e dunque alla Madre e dunque infine alla terra-elemento, alla terra-sostanza il fio della propria, universale colpa? (l’Amore è una tragedia inconclusa, perché per quanto dolcemente, violentemente, atrocemente vissuto non mai riuscirà a pagare quell’enigmatico debito che solo si può estinguere con la vita, ed è probabilmente per questo che, come scrisse Leopardi nel canto “Amore e Morte”, insieme ad esso un oscuro e disperato desiderio di defungere subitaneo insorge: perché nell’Amore e con l’Amore si vorrebbe pagare pur restando “io”, pur dovendo 269 tragicamente restare un io, la colpa di non essere un tu, il tu, quel Tu che eravamo e che nascendo abbiamo oscuramente, diabolicamente denegato e rinnegato)) 127. Ma, metafisiche parentele a parte, con loquele, querele e lamentele annesse, perché ho avuto l’improntitudine di raffrontare il non mai troppo celebrato Amore dell’Alighieri per Beatrice, che tanto profonda traccia ha lasciato nella Storia Umana, a quello mio per Elisabetta, che, prevedibilmente, ne lascerà solo nella mia, personale o impersonale che sia? Perché ho avuto bisogno proprio di questa pietra di paragone e non di un’altra? Beh, in primo luogo, lo confesso, anche solo per tirarmi un po’ su il morale, dato che vedere o allucinare dei tratti comuni fra sé e un personaggio tanto famoso abbellisce la propria miserabile iella fino al punto di farla parere quasi un frammento d’immortalità colto vivo in vita. Poi perché si tratta di un Amore Infelice, o Deluso, proprio come il mio, e in terzo luogo perché mi è parso infine di comprendere che la vicenda umana di Dante Alighieri abbia come minimo uno sfondo simile a quella che fu mia, anche se i punti in comune, almeno a un primo sguardo, sembrano davvero pochi, a parte l’amara e finale delusione. Al contrario di Beatrice, Elisabetta non mi ha mai deriso, né mai mi sono sentito da lei disprezzato o svalutato in alcun modo: al contrario, ho avuto molte volte la sensazione che le paure ch’Ella d’Essa con ogni evidenza manifestava in vari modi nei miei alquanto stupefatti confronti derivassero da una sorta di eccessiva valutazione della mia invero alquanto trascurabile persona, o, in ogni caso, da una sua propria autosvalutazione al sempre più stupefatto mio cospetto. In aggiunta a ciò, anche mi sento di affermare senza esitazione alcuna che alla sua celestiale presenza non provavo sintomi di svenimento o debolezza di sorta, e quello che sol per un pelo della famosa marmotta non si verificò avvenne per una serie di concause accidentali e sfortunate: ballare un tango passionale con una donna che non ti vuole è una di quelle aspirine in grado di 270 piegare le ginocchia a un elefante, il corno a un rinoceronte, o, al limite, l’organo sessuale ad un attore pornografico, e dunque il mio momentaneo quasi-mancamento deve senz’altro considerarsi almeno parzialmente giustificato e senz’altro tollerabile anche dal maschio più esigente in fatto di virilità. Al contrario, oltre a sostenere la sua presenza in modo più che soddisfacente, di solito il suo tenero e aereo corpicino stimolava in me ben altri sentimenti che il desiderio di svenire o svanire che dir si voglia, tanto è vero che il più delle volte i tanghi con lei li ballavo, diciamo così, con tre gambe, se il lettore mi permette l’eufemismo, e che quello che neppur troppo nascostamente bramavo di riceve da lei non era solo e principalmente il suo sia pur graditissimo saluto, ma anche e soprattutto qualcosa di, diciamo così, meno nobile e più prevedibile, che di solito si trova ben nascosto sotto più o meno firmati pezzi di biancheria intima (è un fatto che la firma sui capi o cappi intimi che dir si voglia la si nota quando infine non interessa più di tanto quel che c’è sotto). Inoltre, c’è da notare che le mie poesie via sms – di certo di valore neppur paragonabile a un refuso di quelle composte dallo sfortunato Alighieri – hanno ottenuto infine un qualche effetto, una qualche risposta, anche se non ebbi e a tutt’ora non ho il coraggio di andare a vedere quale fosse (in un certo senso comunque so bene di che si tratta: quei due sms, qualunque cosa dicessero, volevano significare più o meno questo: sono fidanzata, dunque mettiti il cuore in pace e un dito in c…: il che è più o meno quello che è successo e sta succedendo), oltre al fatto che Dio, il Caos, il Caso e il Nulla mi hanno concesso il sia pur terribile piacere di conoscere da vicino questa mia strana Beatrice milonguera, anche se in modo piuttosto accidentato e di certo molto più limitato rispetto al mio desiderio: non ho potuto parlare con lei di tutto quello che avrei voluto, solo in modo ridicolmente ridotto e riassuntivo conosco la sua storia. Ma, infine, che dire di quell’intimo, misterioso colloquio che avviene e avvenne fra i due corpi abbracciati nella malia del tango, in quella oscura e silenziosa compenetrazione delle sensibilità che accompagna ogni passo, nel diadema di fremiti e carezze che come un astro splende insopportabile in ogni istante di languido orrore e di bruciante dolcezza che il corpo dell’amata dona al milonguero che la 271 stringe (la danza, lungi dall’essere una distrazione, è forse la più antica ed archetipica forma di conoscenza che nella sua forse già troppo lunga avventura su questo sperduto granello di polvere che chiamiamo “terra” l’orgogliosa e angosciata umanità abbia inventato; come osserva Galimberti “Lontani da quel “presso di sé” che pure noi siamo, abitiamo il nostro corpo disabitandolo, e nella non identità con noi stessi si nasconde l’unica nostra possibilità di vita. Forse per questo la danza è, tra le forme culturali, la più diffusa e forse la prima a far la sua comparsa all’alba della vicenda umana. Dissolvendo nel gesto successivo l’equilibrio appena raggiunto, la danza cancella di continuo l’identità e l’immobilità ad esso connesse e, distanziandolo ad ogni passo da sé, è perfetta immagine della coscienza come presa di distanza da sé, onde evitare quella coincidenza con sé che è poi l’immagine della morte.” (scolio: ma non è forse disabitando sé stessi che quest’essere vago, astratto e spaesato che chiamiamo “uomo” anche solo per un attimo può riuscire ad abitare il mondo?)? 128. Già, la danza, già, l’abbraccio del tango… L’abbraccio del tango, la passione, l’estasi, il tormento dell’abbraccio: è questo il tema segreto della danza, che per lo spettatore che non ha mai praticato è invisibile e impercettibile, addirittura inimmaginabile, e che invece per i ballerini è tutto. E’ l’essere uniti, incatenati all’altro e all’altra a rendere questa forma della danza così unica e così giustamente leggendaria, dato che per una volta “la leggenda” è forse addirittura inferiore a ciò che di solito si definisce “la realtà”, perché in nessun’altra danza la connessione che si può creare fra i corpi e le anime dei ballerini è tanto intima, 272 tanto struggente, stringente, costringente: tanto profonda, tanto emblematica, enigmatica e così abissalmente viscerale. Il tango crea ed abbisogna di un abbraccio del genere – è un abbraccio del genere – perché l’uomo deve guidare la donna essenzialmente con i movimenti del busto trasmessi al busto di lei appunto attraverso l’abbraccio che deve perciò creare una connessione piuttosto solida fra i due corpi. In questo modo la reciproca interdipendenza fra i ballerini diventa totale, dato che la donna non può muovere un sol passo se l’uomo non lo marca, e, viceversa, anche il campione del mondo in carica nulla può fare se la ballerina non lo segue, non lo sente. Fra la di lei fronte e la di lui gota, fra la di lui man sinistra e la di lei man destra, fra il di lui braccio destro e la di lei a volte così languida, immensa e denudata schiena: fra il di lei braccio sinistro e le di lui spalle, fra la di lei man sinistra e il di lui collo, fra i due petti l’un l’altro ora dolcemente, ora strettamente appoggiati, ora lontani e poi vicini – troppo vicini – si crea un dialogo di aromi e fremiti, di sguardi e tremiti, di recondite paure e carsica eccitazione – eccitazione della paura, paura dell’eccitazione – un invitarsi e un incontrarsi, un velarsi e rivelarsi di sguardi, di rossori, di palpiti, di assensi e di rifiuti che solo i praticanti del tango possono capire, perché altro non c’è al mondo che il tango che spinga la conoscenza tra il proprio e l’altrui mondo interiore fino a questo livello di profondità: ogni sia pur minimo palpito, ogni sussulto, ogni timidezza e ogni arroganza – e ogni arroganza mascherata da timidezza e ogni timidezza mascherata d’arroganza – ogni forza e ogni debolezza – e dunque ogni forza mascherata di debolezza e ogni debolezza mascherata di forza – dunque ogni e qualsiasi maschera, e qualsiasi maschera che ogni altra maschera copre fino a quel velo immenso e sommerso che chiamiamo nostro volto, nostro spirito, nostra anima, nostro io: in questo abisso si sprofonda e vagando e divagando ci esplora e ci conosce il tango, nota per nota, languore per languore, timore per timore, tremore per tremore. 273 129. Quelli che – forse per sentito dire da qualcuno che lo ha sentito raccontare da qualcun altro che l’ha visto leggere – dicono che nel tango l’uomo ha la parte principale e che la donna conta poco, non hanno capito nulla di questa danza chimica, lirica, alchemica, frenetica, di questa ebbrezza lenta, violenta, di questo vagare cieco e implacabilmente sensuale come di chi proceda bendato e nudo in una stanza buia cercando a tentoni un altro corpo bendato e nudo. E’ vero, su un piano che potremmo definire “tecnico” l’uomo ha il triplice, gravoso compito di guidare la donna, di interpretare la musica a livello coreografico, oltreché emotivo, di tenere sotto controllo la situazione della ronda (la “ronda” non è quella delle guardie padane, ma bensì il movimento con cui viene in senso antiorario percorso lo spazio della sala), e sulla base di questa, di nuovo, calibrare la sua interpretazione coreografica. Dunque, a livello di senso comune, si può dire senz’altro che l’uomo abbia un ruolo dominante, dato che la donna altro non deve fare, sul lato tecnico, che seguire le sue marcas. Ma questo compito, che pare a prima vista così semplice, è in realtà quello psicologicamente più importante dato che seguire non significa qualcosa come farsi trascinare da una forza esterna, o estranea. Al contrario, la ballerina deve abbandonare il suo corpo, i suoi sensi, la sua volontà in modo tale da identificarsi con il corpo e l’anima dell’uomo che la guida: deve sentire i suoi sentimenti, restituirglieli come in uno specchio, muoversi dei suoi moti, farsi sedurre e così sedurlo, eccitare la di lui fantasia all’ascolto emotivo della musica, infiammare i suoi sensi e, sulle aperte ali di tali lievi fiamme, spingerlo a volare in uno con lei e nel cielo della musica. Così la donna e l’uomo diventano la stessa cosa, un abbraccio sensuale, ebbro, mobile, danzante. L’abbraccio non sono io che abbraccio, non è lei che mi abbraccia: è quel sottile, impalpabile trascorrere di due rivoli nello stesso fiume, è giorno e notte che si fanno alba e tramonto, sottile duetto che infine si muta in mutuo controcanto. Così, in un senso profondo, è completamente sbagliato dire che l’uomo ha la parte dominante e che la donna deve limitarsi a seguire. Un uomo che guidi senza sentire la 274 di lei anima, i di lei sospiri, il di lei sentimento del tempo, il di lei rispondere al di lui corpo, non è un ballerino di tango: è un volgare e cigolante cingolato, un trattore di quelli che trainano le macchine incidentate dallo sfasciacarrozze. 130. Uno sconosciuto intravede una sconosciuta nell’oscurità della sala. I loro sguardi per un attimo si incontrano e lui si alza e la invita. Forse è perché la vede bella, o, chissà, forse è proprio perché la vede non molto bella, e così meno forte è il timore di essere rifiutato. Forse è un caso, un’inezia, forse è da molto tempo che desidera e che teme di invitarla, forse non ha incontrato altri sguardi, o forse non li ha visti, o forse ha creduto di riconoscere una persona che invece non è quella, ma quando è arrivato lì oramai era troppo tardi per farsi indietro. Come che sia, forse si scambiano qualche convenevole, qualche sorriso più o meno suadente, lieve, oppure rigido e un po’ imbarazzato (questo prologo al vero e proprio racconto può avere infine un’importanza anche molto relativa). Poi la musica inizia: lui offre la mano sinistra, la donna concede la sua destra, e con l’altra sceglie il modo in cui vuole essere abbracciata. E’ il primo contatto ed è anche l’inizio vero e proprio della storia. Le mani forse sono rilassate, oppure tremano, a volte sono rigide, sudate, e il sudore può essere caldo o freddo: questo può esprimere nervosismo, timidezza, eccitazione, ansia, o, chissà, forse lo stupidissimo fatto che in sala c’è troppa gente, il termostato non funziona, e dunque fa caldo, troppo caldo. Anche l’abbraccio prescelto può essere molto diverso: a volte è serrato ma morbido, oppure stretto, ancora, ma nervoso, duro, quasi impaurito; oppure può essere anche molto ampio, quasi distante, si direbbe, ma con tutto ciò non manca di amichevole o addirittura complice intimità: quante sfumature sono già possibili in questa prima fase della danza! Tante, forse, quanti sono gli individui a questo mondo! Comunque sia, i due si stringono e si inseriscono nella ronda. 275 Le parole e i convenevoli scambiati solo pochi istanti prima diventano a quel punto quel nulla che forse sono sempre stati. La parola e con essa la coscienza, in cui freddamente e cartesianamente domina l’io penso dunque esisto, nel tango impallidiscono fin quasi a cessare interamente, almeno negli attimi veramente intensi della coreografia, e solo il senso, solo il corpo stretto all’altro esiste: io abbraccio dunque esisto, io danzo dunque esisto, tu esisti, dunque esisto. E’ il corpo sconfinato in un altro corpo, che ora trema, forse, di eccitazione e di paura, o di sfida, ma poi, forse, via via si scioglie, si fida e si affida (il tremito dell’altro è il mio tremito, la sua fiducia è la mia fiducia, la sua eccitazione la mia eccitazione). Una camminata, una salida, un giro, probabilmente di quelli più intuitivi e semplici, probabilmente in un punto in cui la sala è particolarmente “larga”. Andando avanti l’intesa può diventare più solida. I corpi, passo dopo passo, portano avanti il loro silenzioso dialogo di turbamenti, tremiti e trasalimenti, via, nel brivido lento, impalpabile e implacabile della musica (il tango, cielo senza orizzonte, non consente orientamento: il ritmo è in ogni dove, nel pianoforte ora, poi anche nel basso, poi nel violino e nel bandoleon, poi in tutti gli strumenti in coro, poi di nuovo si scioglie e procede con diverso tempo in ogni strumento, e così via). 131. Ogni corpo, lo abbiamo visto sopra, ha la sua vibrazione tattile e purtroppo – o per fortuna! – accade spesso che tale vibrazione non si armonizzi con quella dell’altro: così l’abbraccio va avanti rigido, impacciato, imbarazzato, o, più banalmente, poco intenso (a volte una situazione come questa si verifica per del tutto accidentali motivi tecnici o di complessione fisica). Oppure un’armonia in qualche modo nasce, si, ma superficiale, banale, piatta, ripetitiva: lui “sente” poco o nulla, forse perché non è la serata, forse perché la musica non è la sua preferita, forse perché lei gli offre una stretta sfuggente, diffidente: lui risponde sfuggendo e, con maschia diffidenza, si affida alla forza della tecnica, e la porta e lei, affidandosi alla di lui come 276 alla sua propria tecnica, si fa portare: la tanda finisce i due si salutano, ma la scintilla non è scattata. Una coreografia comunque è venuta fuori, ma, non c’è nulla da fare: come accade con le canzonette fatte in serie, nessuna magia si crea e l’intera e invincibile, la solita solitudine ancora ha perdurato nel profondo dell’abbraccio. L’alba non si è accesa, le ali sono rimaste nascoste dentro il nido. Ma alcune rare, preziose volte, da questo segreto di carezze, da questo cielo di piume arruffate, da questa avventura di mani e schiene e gote che si sfiorano, si navigano, si esplorano, scaturisce una soffusa, incantevole, turbinante negromanzia d’intesa, come di mani estranee che casualmente si appoggino sul pianoforte e, senza preventivo accordo, misteriosamente collaborino alla stessa armonia. E’ qualcosa come una vertigine nascosta dietro l’angolo, un’estasi di reliquia, un non esser mai nati, una cecità mai sazia d’altrui visioni, e di nascoste palpebre e pupille. Il corpo si scalda, vibra col suo con ogni e ad ogni nota, ad ogni moto, nei celesti chiarori della pelle dove finalmente sorge l’anima in un brivido: oh profondità nascoste in un vortice di sciarade, dove siete andate, perché si fissa il mio sguardo sulla palma vuota? Come può un istante eterno degradarsi nel tempo, farsi memoria e passato se la sua impronta fatata l’oblio non mai cancella, se il ricordo eppure sempre torna, tenue e inesorabile come lama fatata di vertiginose ciglia, di malcelati e flebili sospiri, e aridi e alti vortici di socchiusa porta? Elisabetta, amore mio, così, lo so, tu mi entrasti nell’anima, con il tuo magico abbraccio, lieve in quelle note che mai e poi mai potrò dimenticare, vida mia, tango lontano e ormai perduto, vellutato amplesso di astrali pampini e di giade, crotali occhiuti di rubino e purpurei e svenati barbagli di falena che mai, mai e mai più non tornerai! Così ci incontrammo, così, almeno, io ti incontrai nel tango profondo, oscuro e febbrile di me stesso. 277 132. Il magico abbraccio del tango, si, ma che dire del tuo magico abbraccio, Elisabetta delle mie brame, milonguera più dolce del reame? Cosa aveva questo tuo abbraccio di tanto più magico di qualsiasi altro abbraccio per suscitare in me tanta emozione? “A parte subjecti” ho già detto qualcosa, anche se, probabilmente, qualcosa di non troppo chiaro. Ma, “a parte objecti” posso aggiungere ancora qualche nota, dato che mi sono dato la pena di osservare Elisabetta anche nel mentre ballava con altri, non solo e non tanto perché ero geloso, ma anche e soprattutto perché ero incuriosito da quella che mi pareva una sorta di sua straordinarietà, e proprio dal punto di vista motorio, gestuale, oltre che, come ho già detto, tattile. Nel mentre si avvicina al milonguero che le ha chiesto di ballare, Elisabetta sorride in modo dolce, modesto, sottomesso, indicibilmente luminoso e al tempo stesso tenue. Al momento in cui prende la mano che gli viene offerta e circonda con il braccio l’altrui spalla, spesso va con la fronte alla sua gota, poggiando infine il piccolo seno all’altro petto con l’inesorabile levità di una foglia che si posa. La sua mano sinistra è sempre aperta, aperta, voglio dire, con una certa forza, e la pressione che esercita col palmo sul collo o sulla schiena del milonguero da l’idea di una energia tanto intensa quanto trattenuta (è del tutto possibile che quella parte di energia che viene trattenuta venga impiegata proprio nella tensione con cui la mano resta aperta, aperta con le dita anch’esse ben divaricate e tese, a volte addirittura leggermente incurvate all’insù). Questa tensione si perde del tutto nel momento in cui l’abbraccio comincia a scorrere per diventare più ampio, o per tornare a stringersi: a quel punto la mano si ammorbidisce, il suo scorrere è sempre una carezza sensuale, una sensualità caratterizzata ancora una volta da una sorta di timidezza, di pudore. La mano destra invece appare sempre e comunque rilassata e la presa sulla sinistra dell’uomo di nuovo si mostra timida, a volte perfino un po’ debole, ma di quella timidezza e di quella debolezza 278 che servono per sedurre e non per respingere (vi è in effetti una sorta di timidezza e debolezza isterica che mette l’uomo profondamente a disagio, perché lo fa sentire un intruso indesiderato, quando invece la timidezza autenticamente femminile, quella che eccita e seduce, è quella che si vela, svelando in questo modo il desiderio). Dunque anche la sua forse solo apparente debolezza è profondamente attraente, dato che spinge l’uomo a sentirsi forte e padrone della situazione (come per la timidezza, vi è parimenti una debolezza femminile che invece blocca l’uomo, perché lo colpevolizza: vi è invece una debolezza profondamente erotica che altro non è nella donna che l’espressione del desiderio più o meno inconscio di essere dominata). 133. E’ questa di solito la conditio sine qua non del rapporto sessuale, e dunque anche del tango, visto che il tango è una danza altamente erotica, la più erotica fra tutte quelle esistenti, probabilmente, fra tutte quelle immaginabili, più erotica del sesso stesso allo stato puro (forse il tango è sesso liberato dalla paura di non avercelo duro e di non essere abbastanza bella da farglielo diventare duro, di non bagnarsi e di non durare abbastanza, e cose simili: frenesia dinamica senza movimenti pelvici, orgasmo indeterminato, senza eiaculazione): in questo senso, non ho mai trovato una ballerina che tanto mi abbia mandato in visibilio, non solo e non tanto dal punto di vista erotico, ma anche e soprattutto dal punto di vista della percezione dionisiaca del ritmo. Ciò dipende non solo dal suo abbraccio, ma anche da una dinamica particolarissima della sua camminata. Nel tango, a parte il voleo e il rimbalzo, i movimenti devono procedere in modo lineare, ovvero senza che il momento iniziale e finale del passo vengano sottolineati da un’accelerazione o da una frenata (il movimento, diciamo così, deve scorrere liscio come l’olio, in specie in un’interpretazione intima, tipicamente milonguera, “argentina” come quella del grande Ignacio Elizari). In questo senso il passo di Elisabetta ha un piccolo 279 difetto, talmente piccolo che però non si può chiamare un difetto, ma si definisce invece come una sua peculiarità, e, almeno dal mio punto di vista, come un luminoso, febbrile, febbricitante pregio: in pratica, al momento in cui appoggia il piede a conclusione del passo, in specie quello all’indietro, Elisabetta opera una leggerissima frenata, un quasi insensibile rimbalzo che si trasmette al petto sotto forma di un’imperscrutabile incertezza, o, se si vuole, ancora una volta, di seducente timidezza, che fra l’altro produce anche una particolarissima, estasiante sottolineatura del ritmo della danza. Per altro verso, la sua sequela alle marcas è perfetta, la sua sensibilità alla musica e all’interpretazione dell’uomo divina, e la sua tecnica non è tecnica, no: è, semplice, vergine, pura gioia quella che si esprime ad ogni passo. La gioia di abbracciare e di sentirsi abbracciata, di stringere e di sentirsi stretta, di carezzare e di essere carezzata, e poi la gioia di sentirsi portata, beh, quella no, neppure mi provo a descriverla: girate per le milonghe fiorentine, forse la troverete, forse la riconoscerete, forse potrete anche voi chiederle di ballare, e solo così vedrete una ragazza con un gusto piuttosto discutibile quanto all’abbigliamento alzarsi da sedere con movimenti vellutati, sorridere con la luce intollerabile di un mattino di settembre e gettarsi nel vostro abbraccio con l’infantile, istintivo e impacciato entusiasmo di una bimba che abbraccia il padre per seguirlo ovunque vada. Mi fermo qui, perché so che le parole non bastano mai: sono sempre troppe, o troppo poche, troppo alte, troppo basse, troppo e solo e soltanto parole per giungere mai a toccare davvero la realtà. Il tango, e in particolare il tango di Elisabetta, come tutte le esperienze estetiche genuinamente divine, non si può descrivere: vi si può partecipare, alludere, invitare, lo si può lodare, ricordare, rimpiangere, ma mai e poi mai veramente afferrare. 134. “Ma è vero, ho pianto troppo! Le Albe sono strazianti, ogni luna è atroce e ogni sole è amaro: l’acre amore m’ha gonfiato di stordenti 280 torpori. Oh che esploda la mia chiglia! Ch’io vada a infrangermi nel mare!”, si! si! così! Vai, vai così! buon vecchio Arthur, così o ancora più in basso, o in alto o in Altro, purché in un mare, in un abisso tu ti muova e muoia, si, perché il volo è finito e torno a terra, perché – non ostante tutto – solo io ti incontrai e invece tu forse nemmeno mi notasti, Elisabetta delle mie brame, delle mie trame, delle mie amare lacrime, dei miei tormenti, dei miei lamenti e, soprattutto, delle mie lame – lame fredde e affilate con cui a lungo e invano accarezzai le pulsanti vene del mio polso, senza tuttavia mai trovare altro coraggio che quello di tremare e non mai di affondare e di così recidere quei lenti lacci cui disperate si aggrappano queste povere, ultime mani, che reggono, finché possono, questa penna con cui la memoria ti insegue e ti scolpisce. Icaro discende, mia adorata, mio sole che hai sciolto la cera alle mie piume, e così solo resto e solo mi resta di constatare l’arido e laico fatto che la conoscenza fra di noi, se così vogliamo azzardarci a definirla, raggiunse ben presto un’insuperabile punto di empasse, talmente insuperabile che vagando su questa terra deserta, pesa, spessa e senza più speranza d’ali, mi viene a questo punto quasi spontaneo di pormi una domanda, molto semplice e molto simile a quella che, gonfia di femminil sarcasmo, l’amica di Beatrice rivolse al Poeta fra i Poeti: ma visto che – ahimè e ohimè! – e ohibò e Rio Bo! – Elisabetta non ci stava e, soprattutto, non ci sta, perché mai hai continuato ad amarla per tutto questo tempo, e, soprattutto, perché sei ancora qui a occuparti di lei, sia pure a un livello che potremmo anche definire oramai puramente e semplicemente speculativo e letterario? Addirittura ammetti di essere praticamente anche se non poeticamente certo che non la rivedrai mai più: dunque, perché ancora pensare di lei, scrivere di lei, sognare di lei? Confesso che a questo punto non sono più sicuro di niente (non lo sono mai stato in vita mia, nemmeno di esser vivo), ma è probabile che, a dispetto di tutte le constatabili e contestabili differenze, anche per il sottoscritto valga quel medesimo ragionamento fatto da Dante alle amiche di Beatrice: amo Elisabetta perché con lei sono entrate nel grigiore della mia vita delle luci e delle altezze che credevo perdute o che forse avevo completamente dimenticate, come 281 dimenticato mi sono la mia infanzia, la mia adolescenza e – ahimè, doppio ohimè e triplo Rio Bo – anche la mia giovinezza: così che “In fuga van l’ombre e le sembianze dei dilettosi inganni; e vengon meno le lontane speranze ove s’appoggia la mortal natura.” (buon vecchio Giacomino, oh immenso leopardo fra i leopardi, se becco quello che t’ha dato del gobbo mi prenderò cura di dargli tante di quelle legnate da ridurlo nelle condizioni di Andreotti!). Così, tanto per proseguire in tono con Leopardi, mi afferro ancora una volta alla mano che Shakespeare generoso mi porge e insisto e persisto sul tema tristo, così che inconcludentemente posso concludere soltanto rispondendo a un me stesso che non vuol sentire: “una volta spenta la tua luce, magnifica opera della perfezione della natura, non so dove potrei trovare il fuoco di Prometeo capace di riaccenderti!”85. 135. Ma allora, forse proprio questa è la verità: che io insisto e resisto a parlare, a cantare, si, di lei, di Elisabetta, d’Ella d’Essa sol perché se tolgo il suo caro nome non mi rimane più alcun nome, forse neppure più il mio, forse più nemmeno alcun’altra parola da pronunciare! Penso a lei perché altrimenti non ho niente a cui pensare, scrivo di lei perché altrimenti non ho niente di cui scrivere, sogno di lei perché altrimenti non ho niente di cui sognare. Dunque mi ricordo di lei perché altrimenti non ho niente da ricordare, e mi attacco alla sua effige come in un deserto ci si attacca a un miraggio, come annegando ci si attacca all’ultimo respiro, come nell’al di qua ci si attacca all’aldilà: voglio che il mio cuore continui a battere, che Amore non ostante tutto viva, e che il suo tenero seno possa così nutrire i miei giorni di mistica dolcezza, per quanto amaro sia il fiele che a causa di tanta illusione si debba per questo deglutire. Dunque io non solo di lei mi ricordo e per lei ardo, ma combatto per ricordarla e ardere, non solo l’amo disperatamente, ma combatto per amarla e disperare, non solo le dedico poesie, ma combatto per 85 W. Shakespeare, “Otello”, V; II. 282 continuare a scriverle. E combatto perché non voglio che dentro in me si insinui – e mi uccida – disseccando la mia anima, il mio cuore, i miei sensi, il verme abissale, putrido e orrendo di ciò che il PessoaSoares cupamente definisce “la Decadenza”. Ma che cosa è mai questa Decadenza – si domanderà il lettore – che tanto è decadente da meritarsi addirittura la “d” maiuscola? E’ una domanda difficile questa, ma, per fortuna, è il Pessoa-Soares stesso a darci una risposta: “La Decadenza è la perdita totale dell’incoscienza; perché l’incoscienza è il fondamento della vita. Il cuore, se potesse pensare, si fermerebbe.”86 (tanto per rinforzare la tesi di Pessoa, che a partire da un paio di secoli è diventata tanto diffusa da sfiorare la filosofica banalità, ricordiamo che Beckett, nel “Godot” conferma senza saperlo la tesi del suo quasi-epigono portoghese quando fa dire a Vladimir: “Il terribile è di aver pensato”, che Cioran, che so, nel “Taccuino di Talamanca” afferma senza troppi giri di parole che “Il vuoto che le nostre infermità suscitano nel nostro essere è colmato dalla presenza della coscienza; anzi – questo vuoto è la coscienza stessa.”, che Leopardi nello “Zibaldone” accusa per qualche migliaio di pagine la civiltà di aver portato la conoscenza della nullità della vita umana fino a un punto tale da rendere insostenibile qualsiasi passione che non sia la noia, che Pirandello chiarifica la dicotomia disperata e irriducibile che già si annuncia nella tragedia shakespeariana fra l’arte pur ancora possibile e la vita, diventata un’impossibile maschera dell’arte, che il mentore di Pirandello, ovvero l’appena citato William Shakespeare, nel più celebrato e celebre monologo della storia del teatro, fa dire al più celebre e celebrato personaggio della storia del teatro, ovvero al buon vecchio Amleto, che “tutti ci rende vili la coscienza, e l’incarnato naturale della risoluzione è reso malsano dalla pallida tinta del pensiero, e imprese di gran momento e conseguenza, deviano per questo scrupolo le loro correnti e perdono il nome d’azione”, che Spengler, figlio legittimo di Nietzsche e Goethe, argomenta per centinaia di pagine – senza mostrare nemmeno per un rigo dubbio alcuno – che 86 F. Pessoa, dall’introduzione dell’eteronimo Bernardo Soares a “Il libro dell’Inquietudine”. 283 qualsiasi cultura, nel tristo e inevitabile passaggio dalla luminosa gioventù della civiltà alla vecchia e stanca civilizzazione, perde la sua vitalità, si “intellettualizza” e così si fa decrepita e si estenua fino al pietrificarsi nella morta coscienza di ciò che fu, o che Pasolini, che so, ne “Le ceneri di Gramsci”, tanto per dirne una, si chiede come la sua consapevolezza di essere umano storico gli permetterà di continuare a vivere “se la nostra storia è finita”, che Montale negli “Ossi di seppia” parla della sua “malinconia di bambino invecchiato che non doveva pensare”, che eccetera, eccetera, (eccetera, eccetera…), anche se, a dire il vero, le parole forse più nette e profonde sul tema, per di più accompagnate e chiarificate dalla conseguenza pratica più logica e terribile che da esse si possa trarre, sono state sparse fra i pensieri che Carlo Michelstaedter disperse qua e là, prima di concludere la sua carriera di scrittore con la celeberrima tesi di laurea; sono parole in cui adombrava in modo nemmeno troppo ombroso la profonda assennatezza di quell’imminente suo gesto, chissà perché così poco diffuso fra gli esseri umani, il suicidio, pagine la cui ultima pagina fu grandiosamente sigillata dal sangue esploso dalla sua stessa, indifesa tempia, a causa di un crudele quanto forse pietoso colpo di pistola: “E se pur pensi, ben miserevole cosa sei, che volgi le spalle ad ogni forma di vita più forte, per illanguidirti nelle piccole gioie della tua solitudine: – non l’amore, non la lotta, non la gloria; hai distrutto in te ogni umanità. (..) Quale è la libertà dell’uomo in natura? è la libertà che tutte le parti dell’universo hanno: in quanto vivono secondo la loro legge senza averne coscienza. Ma se ne acquistano coscienza hanno nello stesso tempo la conoscenza che questa legge è la loro perché deve esser la loro e che tanto sono schiave quanto dura la loro vita.” (non so se questo c’entra con il resto, ma, per dire, la grande cantante argentina Violeta Parra, scrisse la sua canzone più celebre “Gracias a la vida”, poco dopo una terribile delusione d’amore e poco prima di suicidarsi (c’entra questo? ai postumi l’ardua sentenza..)). 284 136. Dunque che fare, quando nulla si può fare, quando nulla si può nemmeno forse più sognare, o anche solo sognar di fare? Non so voi, ma io combatto. Combatto comunque, e ordunque – e quantunque! – combatto con tutte le mie forze, con tutte le mie debolezze, con tutte le mie sfinitezze, ma – ahimè – non più per vincere ormai – ma solo per stringere l’ultimo brano, bramito o brandello di incoscienza che ancora mi tiene in vita, quello che ancora – non so per quanto – consente al mio cuore stanco di battere e sbattere, ancorché a strappi, ancorché inciampando sfinito lungo una salita che mi sembra quella di un Calvario, si, ma senza più Passione né passione alcuna. Così combatto, certamente, ma ormai solo per sopravvivere, al mondo o a me stesso – chi può dirlo? – impresa tanto ardua e titanica quanto comune e banale si direbbe, certo, ma che altro posso, che altro ancora dovrei fare quando solo mi resta di gridare rotolando, rantolando, precipitando, sprofondando, inabissandomi non so come, non so dove “Tutto muore in me, persino il sapere che posso sognare!” (Pessoa-Soares, ancora, ancora una volta da “Il libro dell’inquietudine”, un libro che mi sembra e che vorrei aver scritto io e che invece, ahimè, non scriverò mai)? Pure, non ostante ogni sforzo, ogni premessa e promessa, ogni devozione, commozione e dannazione, infine devo arrendermi al fato e al fatto che anche questa tenera, soave, adorata, estrema immagine sta sfumando. Oggi Elisabetta non è più donna di carne e sangue, di agonia e di tango, di cui sono fin quasi crudelmente innamorato: è diventata un simbolo – un simbolo, si, ma di che? Forse, il simbolo enigmatico e amaro della Felicità, straziante, struggente, sfuggente presenza, che quanto più cerchiamo quanto più ci ignora, che quanto più ignoriamo quanto più ci blandisce. Oppure, forse, di quel cosmico mare in cui noi, miserabili gocce sollevate da una furia d’onde irose e inappellabili, accecati, accecanti, per un attimo brilliamo di quell’eterno Sole che ci accende, ci incendia e che ci ignora. O, chissà, forse solo il simbolo di quell’unione mistica con l’ignoto lume e nume del tango, quel misterioso dio che nel vento 285 percorre la sterminata pampa e che ad ogni tanda promette ad ogni piè danzante il suo delirio: chi può dirlo? Io non so più chi Elisabetta sia, e io stesso, devo ammetterlo, oggi sono un altro: il nulla perfetto della disperazione senza più dolore ha invaso la mia anima, l’accecante oscurità della compiuta Indifferenza è oramai capace di ottenebrarmi in pieno giorno. Ero uomo che con ferrea disciplina e stoica abnegazione riusciva a ostentare olimpica calma sul viso e nel gesto quand’anche il cuore languisse o fremesse, quand’anche l’oscena solitudine o la morte lo tormentassero con deserti di abbuiato carcere, o con demoni di acuminata e furibonda rabbia. Oggi il mio sorriso immoto, i miei toni sarcastici, didascalici e freddi, il mio volto calmo, trascolorato e stanco non sono nulla di più che lo specchio nero, puro e profondo di quell’immobilità, di quella stanchezza e di quel disdegnoso distacco che nel fondo dell’alma deserta per dune ininterrotte si dipana. 137. I giorni hanno preso ad assomigliarsi, e ad assomigliarmi, a diventare grigi, come grigi stanno diventando i miei capelli. Non chiedo né mi aspetto dal tempo futuro epifanie o agnizioni, salvezze o dannazioni. La morte stessa, un tempo maledetta quale estremo danno, o invocata quale fatal consolazione, ha infine smesso la lunga e tetra vestaglia, il color terreo, la cavernosa voce, i simboli, le effigi, i vaticini che svelano ai mortali il loro abisso. La sua maschera non è quella di un teschio e noto con preoccupazione che più non protende l’enfatica, ricurva e sanguinosa lama, né stringe nell’ossuta, eterna mano, l’arcadica, archetipica ed enigmatica clessidra. Oggi la legittima proprietaria del settimo sigillo mi si para innanzi indossando un borghese doppiopetto, l’austera ventiquattrore si sporge in vece della falce, e le due coppe contrarie dell’inesorabile rena hanno lasciato il posto a un orologio da polso ordinario e usuale, ancorché svizzero nel sembiante. Non più le vuote orbite mi fissano negli occhi, ma l’espressione compunta e avvilita di un broker quando la borsa crolla: la vita si è già presa il novantanove per cento, 286 e Lei, la oramai ex Nera Signora, incasserà solo l’ultimo barbaglio di ciò che fu il mio spirito. Così vado, vago per uno smisurato, banalissimo deserto, per quel morto silenzio che un giorno fu viva parola, mentre Bataille ripete al mio posto in un libro che non avrò mai più il coraggio di aprire le parole che non saprò mai più ricordare o reinventare: “L’incontro con una donna non sarebbe che un’emozione estetica senza la volontà di possederla e di rendere vero ciò che la sua immagine sembrava significare. Solo una volta conquistata o perduta l’immagine del destino cessa di essere una figura aleatoria per divenire realtà che fissa la sorte”87: ora e solo ora che ti ho per sempre perduta, mia Elisabetta, solo ora lo so, solo ora capisco che fra noi qualcosa di più e di diverso è successo che un incontro fatuo in un corso di tango casuale. Solo ora intendo che sei venuta per fissare il mio destino, per sigillare la mia sorte, che mi hai cambiato non per un giorno o per un anno, ma per sempre, anche se non riesco a dire esattamente in che cosa tu mi abbia trasformato: da mesi insonne ormai balbetto a tentoni pensieri diversi e dispersi in cerca di me stesso, ma ancora non so né trovarmi né trovare parole adatte per descrivermi. Lo specchio non rimanda altro che vani riflessi di un altro che non fui e che dunque mai e poi mai non sono – di uno straniero che blatera un idioma sconosciuto, di un nessuno che non ho mai visto e che dunque non riconosco e non capisco. Così, un paio di giorni fa, come implorando la voce e la luce di un oracolo, ho aperto a caso il primo libro che mi è capitato a tiro, e gli occhi mi sono caduti su alcune parole di Montale – si ancora e sempre loro, le sempre le stesse e sempre diverse “parole, parole, parole…”88 – si, lo so, mio vecchio amico Amleto, parole, parole, sempre parole, ancora parole: parole che però da quel momento hanno preso a svegliarmi, a svogliarmi, a turbarmi e a tormentarmi, rimbombando in echi sempre più vicini e sempre più lontani, sempre più interminabili e innominabili nei gelidi e sterminati abissi della mia anima, al proprio 87 G. Bataille, “Il labirinto”. Per chi non lo ricordasse, questo è un Amleto ironico che, fingendosi pazzo, risponde a un Polonio perplesso che gli chiede che cosa stia leggendo. 287 88 stesso silenzio abbandonata. Parole, si, mio prima illuso e poi deluso Amleto, lo so, lo so, solo parole: però gravi, grevi ed ossessive, come una litania funeraria, come una profezia funesta, o un’algebra che comunque nasconda e riveli il mio destino: “Sono colui che ha visto un istante e tanto basta a chi cammina incolonnato come ora accade a noi, se siamo ancora in vita o era un inganno crederlo. Si slitta.”. 19 settembre 2010, ore 21.05, libreria Edison, Firenze 288 Una breve appendice poetica: INTRODUZIONE 1. La storia o non-storia che sia con Elisabetta, come il lettore avrà forse già intuito, non è finita nel momento e nel modo in cui ho descritto sopra. Questa piuttosto vertiginosa non meno che surreale e macchinosa trama di irriducibile amore e ancor più irriducibile incomprensione è proseguita per altri sette-otto mesi, fino ad un epilogo deludente: ci siamo semplicemente persi di vista. In tutto questo tempo, poco più di un anno e mezzo, ho scritto circa duecento poesie, che da questo amore sono state in vario modo ispirate. Solo poche fra queste, strano a dirsi, hanno come oggetto Elisabetta e l’amore che a lei mi legava. La maggior parte sono invece dedicate a sparsi, diversi e dispersi argomenti esistenziali, alcune sono dedicate addirittura ad altre donne, una delle quali appartenente al mio ormai mitico passato, il cui ricordo è stato però vivificato dal presente amore per Elisabetta – altre ancora ad altre ballerine che mi hanno in modo diverso coinvolto ed emozionato con il loro tango. Ma questa lontananza di argomento è solo apparente. In realtà non vi è stato un solo verso fra quelli che seguono che non sia stato scritto sullo sfondo del vago e terrifico paesaggio costituito dalla passione per Elisabetta, e perciò, anche le poesie di argomento più distante descrivono in realtà tale passione e tale paesaggio. Nubi e montagne sono entità fra di loro le più eterogenee possibili; pure, in un certo senso, sono entrambi parte del cielo, le prime galleggiandovi, le seconde in esso trascolorando e azzurrandosi: allo stesso modo, un sonetto dallo spunto arcaico come quello che si intitola “Penelope” non è diverso da quelli che ai vivi e vividi tanghi con Elisabetta sono dedicati. Anche la lunga lirica che dal titolo “Signora delle vallate dagli occhi tristi”, una variazione sul tema costituito da una non troppo nota canzone di Bob Dylan, pur avendo cominciato a scriverla più o meno ventisette (27) anni fa, l’ho infine dedicata ad Elisabetta, semplicemente perché la sua atmosfera forse me la ricordava già nel 289 momento in cui avevo cominciato a scriverla (Elisabetta era forse un verso già scritto incontrato sotto forma di ballerina di tango: non è un caso che il Verbo si faccia Carne, entrambi sono il riflesso di uno Stesso di cui non si può dire nulla di più, o, almeno, nulla di veramente significativo di quanto di esso non ci dica il silenzio). 2. Le poesie che ho scritto in quello strano periodo della mia vita si dividono sostanzialmente in due categorie, che corrispondono a due periodi piuttosto ben definiti di questa sfortunata passione. Quelle del primo periodo, in cui ho usato la forma immaginifica dell’associazione libera, derivata appunto proprio da Bob Dylan e anche da Garcia Lorca, poesie che sostanzialmente non furono altro che una sorta di grido della mia dolorosa speranza di riuscire infine a ottenere le ingrate grazie della mia amata. Quando mi resi conto che poco o nulla c’era rimasto da fare, che Elisabetta non mi amava e non mi restava altro oramai che la rassegnazione, sono passato alla forma classica e composta del sonetto, o comunque del verso rimato, che meglio si adattava al luttuoso ricordo di un amore che riconoscevo ormai come irreparabilmente perduto. A rappresentanza del primo periodo ho inserito nel presente testo una sola poesia, la già menzionata “Signora delle vallate dagli occhi tristi”, semplicemente perché molto o forse addirittura troppo lunga, mentre a rappresentanza del secondo periodo vi sono sedici sonetti e due altre poesie di forma comunque piuttosto tradizionale, che ho trascelto semplicemente tenendo presente la vicinanza o meno del loro tempo e del loro argomento ai momenti e ai motivi più significativi della mia storia con Elisabetta (il lettore dotato di senso critico noterà una notevole differenza nella lunghezza dei versi dei sonetti, il che si riflette inevitabilmente nel “passo”, ovvero nel ritmo, nel tono e perciò anche, sia pur per sfumature, nello stile: ciò non è dovuto a improbabili crisi estetiche consumatesi nell’arco di poche settimane, ma semplicemente al fatto che i versi lunghi nelle tre pagine di un sms non ci entravano, e così, per spedire le poesie 290 via telefonino alla mia amata, mi sono dovuto rassegnare a uno stile compositivo diverso da quello che uso di solito). Il tono dei componimenti poetici, come si vedrà, è radicalmente diverso da quello con cui ho raccontato questa non-storia in forma di romanzo. Quello del romanzo è, almeno tentativamente, leggero, effervescente e quasi scherzoso, mentre il tono dei componimenti poetici è pesante, duro e, direi, quasi tragico. Sfortunatamente, i miei stati d’animo profondi, veri, nulla hanno avuto da vedere con il tono da mistero buffo con cui nel romanzo li ho raccontati, o, almeno, mi sono provato a raccontarli – anche se il contenuto oggettivo del racconto corrisponde ai fatti in modo praticamente perfetto, a parte qualche non molto significativo dettaglio (questo, dal mio punto di vista: dal punto di vista di Elisabetta non saprei proprio dirlo). Il romanzo è stato scritto in quel modo semplicemente per trovare una sorta di esilarante redenzione ai tanto poco credibili quanto drammatici non-accadimenti che hanno sconvolto la mia vita per più di un anno – mentre le poesie non avevano altro scopo che riflettere puramente e semplicemente ciò che davvero sentivo nel mentre lo sentivo: sentimenti dolorosi e a volte addirittura lancinanti di solitudine, di abbandono e di mancanza. E la redenzione attraverso la poesia, l’unica possibile, non è certo la trasmutazione del pianto in risata, ma quella di donare la marmorea eternità del verso alla vacua e fin quasi astratta temporalità del dolore. Scopo della letteratura è infatti quello di in qualsivoglia modo consolare: non sarebbe poca cosa se il lettore provasse attraverso il precedente racconto e nei versi che seguono anche una parte molto piccola della consolazione che hanno offerto al loro probabilmente indegno autore. Firenze, sabato 31 gennaio 2009. POSCRITTO DEL 3 DICEMBRE 2009 A ormai quasi due anni dalla conclusione del testo ho deciso di aggiungere alla seconda parte di questa breve raccolta di poesia anche due componimenti che appartengono a tutt’altro ambiente e a 291 tutt’altro stato d’animo che quelli che li precedono. Sono due odi alla danza moderna, che ho scritto quando frequentavo la scuola del Balletto di Toscana ed ero innamorato compagno di un’altra donna, con altri problemi e altre soluzioni e altre illusioni e altre delusioni. Pure le due odi, dedicate alla danza moderna, sono con ciò dedicate anche al tango, che credo si possa senz’altro definire “moderno”, dato che risale agli inizi del secolo scorso: e non è forse al tango a cui si deve e di che si incolpa per una storia come quella che precede queste poesie? Sia dunque ode al tango, anche se il fato la volle costellata di lacrime e eresie. 292 Parte prima: SONETTI 293 294 De’ ballatetta alla tua amistate quest’anima che trema raccomando, menala teco nella sua pietate a quella bella donna cui ti mando. De’ ballatetta dille sospirando quando le sei presente: questa vostra servente vien per ristar con vui partita da colui che fu servo d’amore. G. Cavalcanti 295 296 VIDA MIA Il cielo vuoto, si, quasi morente, eppure torni in mente: come un martello, come un ritornello, stella pallida e ardente, stasi di vele, vagamente, gorgo di miele e di mantello, stella cadente, turbinando, stella di stelle e fango caduta dal cielo o dall’inferno a inebriarmi di vino, candelieri y tango… 297 ANGEL DEL TANGO 1. Il cielo, ancora, del tuo abbraccio. Specchio di fragile miraggio, Febbre di colline, omaggio Di albori, che nominando taccio. La mano tua di neve sul mio collo, Il lento e tenue ardire del tuo passo, Estasi di gemma al suo midollo, Grazia di denudato, puro sasso. Va via il tempo su adagi di violino, Su echi di tramontato contrabbasso fino Alla lieve fatalità di canto e pianoforte: Ecco il tuo volto oscuro, estremo: ecco la morte. 298 2. Ecco la morte. Coi suoi lucori Di marmi, visioni, meraviglie, Il suo vento impuro, le sue flottiglie Di polveroso tempo, i suoi cori Spaventati, cupi, ossessi, Il suo franare di galassie, Musica e canto degli abissi. Il nero gorgo guarda fisso: Cerco invano un tuo senso, Invano domando, invano ti ripenso. Il silenzio dura – non so come – Anche al dolce sognare del tuo nome. 299 MILONGA Ali di seta. Ali lentissime di velo, Ali come di vellutato airone Planato su pianure di canzone Immobili e vuote come il cielo. Schiere di diafane e denudate schiene Di rilucente seta, di trina e tacchi alti, Di oscurità riflessa in scuri smalti, Occulto controcanto per le vene Ardenti di andanti e ritornelli, Tenue rifluire di tabacchi e vini, Di satinati satiri e ilari ospiti divini. E noi, lontani come migranti uccelli, Via da questo mondo vuoto e tragico, Che, s’è tuo, è alto, è puro: è magico. 300 SANGRE DE TANGO LLENA Simile effetto Fan la bellezza e i musicali accordi, Ch’alto mistero d’ignorati Elisi Paion sovente rivelar. Giacomo Leopardi La tua pelle, stendardo di seta e di biancore, Luna traboccante, via lattea di splendori. Solenne e fonda porpora della tua bocca, ori E notti nel tuo sguardo chinato in un pudore Che brilla in lame di socchiusa conchiglia, Cantico di essenze e assenzio che mi artiglia Con frenesia di comete il tuo respiro, fragore Carsico, di fonda fonte, fatale ardore Sulla mia guancia cuscino alla tua fronte: Petali le tue dita, rosa la tua mano, ponte Sul mio abbraccio, catena ebbra d’orizzonte. Il fiume scorre dei passi come in lenta piena Carne svelata che nell’anelito finale si disfrena: Naufrago in marea d’ali, sangre de tango llena. 301 ALMA DEL TANGO Quali colombe dal disio chiamate Con l’ali alzate e ferme, al dolce nido Vegnon per l’aere dal voler portate. Dante Alighieri Così ti attendo: perso fra musica dispersa Nel buio vago e sommesso che dipinge Di viva fiamma i suoi lucori: mano che si stringe, Malinconia di brezza, che ferrea ci sospinge. Tersa La translucida seta si accende di colori e sensi Di milonga: il viola e l’oro, il nero e il rosso; Trascolora il passo in rapsodia di chiaroscuri densi Di cieli arcuati di chitarra, abissi di cupo contrabbasso. Petto incontro al petto, e poi respiro con respiro: Brucia la pelle di profondo sale e d’agonia, Brucia il tu nell’io, nel noi, nel fragile sospiro Della ronda, nel tramontare d’incanti e frenesia Fra le spaesate note. Altero, incantato, stanco, Muore il serrato abbraccio, alma del tango. 302 GALLO CIEGO Dorme il sorriso sul tenue corallo Della tua bocca inebriata di gemme Di sospiri. Dorme sognando il cavallo Delle reni, scultoreo volo, Icaro indenne. L’avorio della luce si fa lucente giada Sul rame profondo e dolce dei capelli, E nera l’orchidea della notte di pupille Si accende, filo ridente di snudata spada. Fonda conchiglia il tuo segreto orecchio Mistero che ascolta e dove si ascolta il mare, Bianchissima la guancia, argenteo specchio Che il ritmo ripete del silenzio. Poi chiare E lontane scie i tuoi passi vanno dove si ridona Al corpo la sua luce, nume che avvince, ultima corona, Armonia che cresce, divampa e non perdona. 303 COLOR TANGO Come foglie, lievi, nel baratro lievissimo del vento. Inesorabili tremando, ebbre della vaga vertigine, Del vagabondo volo, luce in delirio di tramonto Sull’orizzonte paradiso e inferno, aquila vergine Così va la tua grazia se il mio ordinare altro non è Che un tuo comando; così fremendo salpa, ondeggia La gondola d’inviolate farfalle che vagheggia Il tango, gorgo di valva, numi di nuvole, senza perché. Come foglie, lievi, nel baratro lievissimo del vento: Ori di fiorito candelabro nei tuoi occhi, archetipo Di perduta luna il tuo sorriso, vasto riflesso all’alchemico Raggio del tuo seno, luna di carne dove ritorna il tempo. L’armonia traluce, atra, e altro più non posso, e alto E altro più non sento che un velo di lieto e puro smalto, Le tue mani come foglie, lievi, nel baratro lievissimo del vento. 304 PARA DOS L’anima fiamma poi viva, e non più il fumo vuoto della carne: Eccoti infine al suo segreto centro, al suo fondo, estremo Tutto, Al suo ultimo abisso. Mutevole superficie al nero flutto La tua pelle nel battito del bandoleon cresceva, carme Di ventosi fremiti, in gorghi di sospiri che della tempesta Del tuo ventre in estasi divelto erano le ondate in festa, Lampi che gli occhi scoloravano, nido a luci straniere, A errabonde furie di sensi risorti d’altri mondi, d’altre ere, In cui il vivere si stagliava alto e Altro dall’insistere così, A esistere esistendo, al muto lasciarsi andare all’esser qui Ormai null’altro che attendendo il sonno in cui del tempo Vuoto e inutile non conosceremo mai più bonaccia o vento. Y por eso que quiero otra vez oir al poema segreto de tu voz, Es por eso que quiero otra vez bailar ese tango: Para dos. 305 DESDE EL ALMA …danse, danse, danse, danse! Arthur Rimbaud …dunque perché non risolversi, dissolversi nel baratro Accecante, bianchissimo, del dolce, ultimo oblio? Perché vivere, se la morte ci assomiglia infine al dio Immortale che ci trasse dal fato onnipotente e atro Del suo imperscrutabile volere? Fiume immenso Ci percorrono le note, flutti ora in calma, ora cascate, Furiose onde di piena nei tuoi occhi, ombrose e dilavate Rive all’enfasi acuta del violino, lugubre incenso Prima, poi gioioso gorgo, vortice che ci piega in volteggi Sempre più lenti e lievi, in liete fantasie di pianoforte, Diafani, ebbri sensi di bandoleon, echi di tempo e sorte, Memorie di troppo perduti Aprile, ora risorti, se tu reggi Corone di tenerezza nell’abbraccio, ora in festa, ora in calma, E il silenzio che cresce come infinito ventre, desde el alma. 306 OTOÑO PORTEÑO Rosa. Rosa di spine, spine di rosa, strana, strana Cosa, che mai non posa, mai non posa… Rosa Di voci, atroci, portentose, mulinello di vana, Lievissima farfalla, butterfly, papillon, mariposa, Che mai non posa, mai, quelle ali di velo, di vele al vento, Vago mago di colori e luce che cuce e ricuce la rosa Con la spina, la spina con la rosa, dolce portento, Dolcissimo tormento, otoño porteño, brivido Bianco, stanco, come amando, amore che sento Scivolar via col sangue, addio di bastimento, livido Fiato di tedio, di lamento, grido di gioia, soffocata, Da sé stessa estasiata, da sé dilaniata, ultimo lido Prima del mare senza fine aperto, inarcata e fatata Sirena dell’onda che senza fine cresce, si posa, si dilata… 307 PARA PIAZZOLLA (LUNA) Ah, lentezza… pazza lentezza, vaghezza di spazi Che si propagano, funambolo di leggiadre perle, di giade, Azzurra, eterna adolescenza di zaffiri e topazi, Stanco fermentare d’incoscienti febbri, d’incrinate spade, E ancora e altro che più non so dire, no, non so dire Né dare, tango che ti chiudi e ti dilati in sciarade Strazianti di fisarmoniche e disarmoniche atmosfere, d’ire Gigantesche e tenui di passo e contrabbasso, chitarra, pianoforte Incanti di un mago che non so capire, né carpire, che nel fluire Di quest’orizzonte senza orizzonti mi trascina, languida morte Che di giro in giro ci bagna, ci accompagna, ocho adelante, De tras, tigre fatale, fatata, agonizzante delle contorte Rime di queste note ignote, remote, eco di pampa lancinante Dioses di nubi appese al vento, amore cupo, tetro, abbacinante. 308 A UN’OMBRA Solo l’amare, solo il conoscere conta, non l’aver amato, non l’aver conosciuto: da angoscia il vivere d’un consumato amore, l’anima non cresce più. P. P. Pasolini Anche sul giorno più glorioso splende infine Il sole del tramonto, e sull’armonia più alta Cala infine il sipario del silenzio. Così risalta La nostra intima essenza, la morte, nostro fine Nascosto, nostra certa e finale, arida speranza, Nostro ultimo dio, di cui pur si nutre il mistero Di saperci creati a un’inutile pena, a un’erranza Che di abisso in abisso ci conduce, erto sentiero Di spine sanguinose, di rose vaghe e immaginarie Tanto fragili e vane che solo una sognata mano In sogno può raccogliere. Se poi s’incontra l’umano Destino con l’increduta mirabilia d’una gioia, amare Fauci la strappano all’anima con lena di affamata Iena. Così, troppo presto sarà stato invano averti amata, Mio bene, mio Tutto, mia adorata. 309 PENELOPE Itaca lontana, dalle torri d’argento. Itaca cantata, nel tramonto silente, Foglia in cui galleggia la corrente, Infante di sogni in braccio al tempo. Itaca alata, salata, del dolore: Cuore di pietra, rifranto come l’onda, Mare senza tempo, senza sponda, Ebbra e perduta fragranza dell’amore, Confuso com’è confuso ogni ricordo. Oh diafana sera, oh morte in cui non credi, Il canto che odi non conosce accordo Se ciò che fu orizzonte è suolo indietro i piedi, Se il viaggio finisce nel suo dissolto incanto: Solo mi brucia il fatuo inferno del rimpianto. 310 ANASSIMANDRO Là da dove tutte le cose vengono, devono anche ritornare, secondo necessità. Esse pagano infatti l’una all’altra il fio delle loro colpe, secondo l’ordine del tempo. Anassimandro Ondate scure, lente, come l’orma al sasso: E’ l’intima, immota risacca della notte E’ il rifluire del Tutto a quelle grotte Ove l’amara vita anela al contrappasso. La nera vasca riluce di sempiterne Scie. Vascello armato di lanterne La Via Lattea adorna di sparuti raggi L’arcano domandare che istupidisce i saggi: Che resta di noi a noi stessi, supremo Tacere delle stelle, se svolta il remo All’atro porto, dove ogni luce è spenta, Se altro è il mare che voglio e che mi tenta Quello dove ogni simbolo si scolora e tace La morte che non giunge a darmi pace? 311 TANGO A VARSAVIA a S. Ah ! les haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les mille amours qui m'ont crucifié ! A. Rimbaud 1. Cielo di notturno silenzio dei tuoi occhi, sopito fuoco Fra lacrime d’ebbrezza, fiorito e dolce stupore del sorriso, Giglio sensuale come il loto, tentazione che fa il respiro roco, Sull’onda che disegna il torso, il collo che ripido e deciso Sale al morso di miele delle labbra, alla lingua di rosa Di fragola e ciliegia, al dente di levigato avorio che porto inciso Qui, nel mio cuore che duole se ti vedo, o se ti sogno, penosa Tenerezza, male che si dibatte quando ci sei, o se manchi, Perché Altrove è sempre il luogo dell’amore, e dolorosa La gioia degli amanti. Così, ecco il freddo rogo degli stanchi Versi, ecco queste parole, vuote e tristi come un commiato, Ecco il tocco tenue e stremato della nostalgia, ecco i suoi bianchi Doni, ecco un’immagine che lascia senza mani, senza fiato, Ecco un tuo gesto fatto di brezza, ridente, struggente, come alato. 312 2. Velo di seta in ebbrezza la tua pelle, volo di seta su seta La tua gonna, che avvolge e svolge la luna piena del sorriso, Vita che si avvita nel mistico caos del sangue, nella lieta Malinconia, nell’atra malattia del tango. Astri inondano il tuo viso, La lenta e tentante carezza dei tuoi passi, che lievi Tornano e vanno, tenue risacca, brezza, mare d’altro mare intriso, Farfalla che su farfalla si posa e prende il volo. Levi Un istante la testa, nel sigillato abbraccio dell’amante Nascosta e offerta come biancore di perla dalle grevi E socchiuse labbra dell’intima conchiglia, e in un istante Di nuovo la sprofondi. E come il delfino l’arco teso del salto Ridona al vago vortice dell’onda, così una nota tremula e distante Ti restituisce all’abisso, al gorgo di seta dei tuoi giri, alto Come il cielo quando dopo la pioggia il sole ne fa smalto. 313 3. Bellezza, dove si occulta il tuo spasmo, nel tutto o nella parte? Di dove inizia dunque a far male tua grazia, dall’umido e tumido Ardore della bocca, dal suo rosso denso, intenso, accesso d’arte Che strazia l’anima con estasi d’incenso? Oppure che scocca La segreta freccia è la luna d’oriente delle labbra, l’insinuante Curvare del sorriso? O è il biancore pazzo dell’avorio che la rocca Salda e acuta dei denti dissolve in una luce? Cosa ama l’amante Di te, il diafano velluto della pelle, la giunzione ammiccante Della vita con i fianchi, o il passo rotondo, elastico, ondeggiante? Oppure è la tua voce roca che dal fondo dell’anima vibrante Il filo delle tue forme avvolge e svolge in sensi di frusciante Seta, e velando e svelando fa di parti ottuse il tutto lancinante? Io non so dire di più, se non che tu sei bella, nostalgia danzante Di patria che ho perduto, seno di sole che s’offre dal levante, Armonia stupenda, che quanto più vicina sei distante. 314 4. Volerti afferrare, volerti stringere, o toccare, o anche solo Sfiorare, è volerti perdere, ultima sete e luce di speranza, Ultima stanchezza, ultima passione, che forse non sei che il volo Labile di un sogno, vaghezza d’un pensiero che nella vana danza Dei giorni m’accompagna perché nell’inganno lieve del suo velo Si celi questo deserto fatto di vento e tempo che si avanza Inesorabile a quel nulla che senza vedere eppure vedo Come sola eternità e solo essere a cui la vuota vita umana Nel suo breve sussulto si protenda. Così, solo sognando ti cedo Tenerezza, e solo con passi di sconsolata, grigia e quotidiana Nostalgia ti seguo nel tuo andare non so dove, stonato aedo Che questa sorda ballata affida al vento, al caso, alla strana Divulgazione del fato perché ti giunga, fato in cui non credo, Caso in cui non spero, vento che non amo, cui più mi nego Più mi lego. 315 VARIAZIONE (sul tema di una poesia di Ruggero P.) Il viaggio finisce qui: nelle cure meschine che dividono l’anima che non sa più dare un grido; E. Montale La tua storia finisce così, anima mia: sulla spiaggia cammini ombra smarrita e nuda, bianca memoria fatta solo di parole stranite, stremate, strappate al sonno o al delirio. Siamo così: ogni conchiglia parla la stessa lingua, ogni onda nasconde il suo segreto, conosciuto da tutti. Siamo così: senza dolore resta soltanto il male, un mare stanco, sciupato, uguale. 316 Parte seconda: SIGNORA DELLE VALLATE DAGLI OCCHI TRISTI 317 318 Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache Noire et froide où vers le crépuscule embaumé Un enfant accroupi plein de tristesse, lâche Un bateau frêle comme un papillon de mai. Arthur Rimbaud 319 320 SIGNORA DELLE VALLATE DAGLI OCCHI TRISTI Con i tuoi passi di cigno risorto dalle ceneri di danza coi tuoi pensieri come rupi annegate in un liquore di Bisanzio coi tuoi ricordi come fumo divelto in veglia funebre e il tuo ombelico come nido di polline che migra. Con i tuoi capezzoli come buio sepolcro di moneta con il tuo ventre di miele, di lontra e di ventaglio acuminato con il tuo inguine come delta di venere e mercurio e la tua fronte d’ira falcidiata da diamanti: con le tue dita di arabesco e la tua testa di vessillo. Con le tue mani di scrigno che divora il suo tesoro con i tuoi seni di limone segreto imbiancato dalla luna con i tuoi occhi di sconfinato delfino quando il cielo nuota ed i tuoi cantici di illuminato scorpione che si intrecciano nel vento. Con i tuoi sogni di cornice inchiodata alle sue nuvole con le tue tempie carezzate da pulpiti di aurora e di tramonto con le tue labbra festanti di cristallo impuro e le tue sopracciglia di riccio rinchiuso in ruote di sconforto: con i tuoi cori di fango e i tuoi sorrisi di carbonio. Signora delle vallate dagli occhi tristi dove è ora il demone fecondo del tuo alloro dove hai rinchiuso i tamburini di Manciuria come fermare questa frenesia di altare in fiamme? Coi tuoi monili dove tintinnano il ruscello e l’usignolo coi tuoi rimpianti di brina nel focolare appassito di Babele con le tue spalle di orgogliosa torre e di sigillo 321 ed i tuoi fianchi cui il mare fa il verso con le onde. Con le tue palme come specchiarsi di profumo con le tue natiche di cupola rivolta verso il vento con le tue guance di stanchezza erosa fra gli scogli ed il tuo fiato come un crepuscolo inciso nel risuonare della nebbia: coi tuoi sussulti di cerbiatto e le tue tenebre di trina. Con i tuoi lobi di fenicottero cinto in vita dalla notte con le tue ossa di cobra nascosto nelle orbite con le tue reni come un coro di vallate in piena e i tuoi sospiri come uccello scomparso all’orizzonte. Con i tuoi polsi come tempesta impigliata in mezzo ai rovi con le tue cosce di cerbiatto che si protende in dolce fuga con i tuoi piedi come giardino incatenato alla sua foce e le tue lacrime come perdute aurore di fachiro: coi tuoi saluti come un velo e le tue dita come calendario. Signora delle vallate dagli occhi tristi come cancellerò ora il tuo nome dal faro delle note come si racconterà questo stupore di satiro e sciamano chi monterà questi puledri di concerti inceneriti? Con le tue risa di fuco innalzato su nubifragi di violette coi tuoi capelli come strenuo sospiro di bandiera coi tuoi polpacci di avorio denudato dal martello ed il tuo sesso come cripta scavata tra le foglie. Con le tue grida di drago vergine sepolto nella roccia con il tuo sangue di vino tenue che si desta con i tuoi fasti di Biancaneve avvitata in un serpente e le tue palpebre che levano calici d’ebbrezza: con i tuoi vezzi di fosforo e le tue smorfie di farfalla. Con il tuo mento dove brucano scorie di armadillo 322 con le tue orecchie fra congiure di intangibile corona con i tuoi indici puntati a un nodo di fantasmi e le tue ginocchia piegate a un dio che si dissangua. Coi tuoi furori d’aquila segnata da rivoli d’inchiostro con le tue scapole come stemmi su anfore di schiume con il tuo collo di conchiglia cullata da brezze coloniali e le tue unghie percorse da sentieri di velluto: col tuo profilo di regina ed i tuoi pungoli di seta. Signora delle vallate dagli occhi tristi stalattiti di attesa si sospendono amare su un acuto stormire di cancrena: orge di manganese in volo si contendono il tuo vuoto. Col tuo avanzare fra nudi di sussurri fracassati coi tuoi avambracci poggiati su balconi di polvere annodata con le tue ire di specchio intrappolato in petali di squame e le tue sfere annichilite in un porto di vaghezze. Con le tue vene come un vello incantato da una rondine con la tua schiena come lontano bastione in controluce col tuo sudore di Saturno che gioca coi suoi anelli e la tua lingua come rubino proteso sugli scogli: con le tue narici di martora e i tuoi sapori di Calcutta. Con le tue ombre cinesi proiettate su un rantolare tamburo con le tue ciglia aperte su abissali conchiglie di rapina con le tue iridi arruffate in un astrale delirio di radici e le tue braccia di scongiurata fragola sospesa. Con il tuo cuore rapito da veglie di liquame con la tua peluria d’angelo che geme nella pioggia con i tuoi denti di reliquia in un trionfo di catene e le tue note di flauto che si meraviglia in un sudario: con la tua saliva di menta e le tue storie di sambuco. 323 Signora delle vallate dagli occhi tristi il libro aperto dei tremuli templi dell’abiura decanta le viole dei tuoi cirrocumuli scoscesi e freme, e resta e si commuove. Con i tuoi gomiti di tumulto di vernici fra le spore con le tue falangi di spade incrociate su alibi di spago con le tue vertebre esultanti di fragranze di sarcofago e i tuoi cortili perduti fra cattedrali di cobalto. Con la tua spina trattenuta fra refoli di tormentoso fiume con i tuoi palpiti di fata lanciata su prede di Murano con la tua lussuria orgogliosa fra una folla di mirtilli e i tuoi segreti come polvere su alfabeti di letizia: con la tua allegria di stranezze e i tuoi richiami d’acquavite. Con le tue furie di Cenerentola raggrumata in un ossario coi tuoi puledri assopiti su pistilli di aranceto con il tuo dorso come culla di sonno e di antimonio e il tuo bacino come demone illuminato dall’ebbrezza. Coi tuoi polpastrelli seminando incanti di scintille coi tuoi arcobaleni come promessa di archetipi e tempeste coi tuoi cuscini amareggiati di dolcissima sciagura e le tue giade acute di disorientato violino e saltimbanco: coi tuoi divani diroccati e il tuo palato di ametista. Signora delle vallate dagli occhi tristi perduta in una fonda nebulosa di fanghiglia vedo congiunte la rosa, l’oro e la cicuta la morte arida dei gigli e la sacra avidità dell’orco. Con il tuo muco d’ambra preziosa negli albori con il tuo femore come antico frammento fra le fronde con il tuo delirio su calici che vanno verso il nulla 324 e le tue vesti come luce distesa in una roggia. Con le tue giunture come un inno in frange d’alabastro con i tuoi amanti in urne di sfrenato corallo e di lentezze con il tuo ano come cratere in una danza di pianeti e il tuo orgasmo come folletto che gioca con cuccioli di rosa: con le tue stanze d’agonia e le tue gengive di frantoio. Con il tuo sterno come ardente trasporto di colomba con la tua gola come gondola che incanta il suo fantino coi tuoi intestini come catrame in un’ipnosi di vetrate e i tuoi argomenti di labirinto rappreso in un presepe. Coi tuoi polmoni di caravelle affittate a una bonaccia di sciarade coi tuoi palazzi di Biancaneve avvinghiata a un santuario coi tuoi colori sillabati da una zebra in perdizione e le tue stravaganze annunciate da un morso di circo abbandonato: con i tuoi assoli di tango ed il tuo stomaco di cornamusa. Signora delle vallate dagli occhi tristi dove tristi profeti narrano nessun uomo può giungere: potrò finalmente prostrarmi alle tue volte o dovrò ancora aspettare ai tuoi cancelli? 325 DUE ODI ALLA DANZA MODERNA 1. ODE DEL DEMONE Je me croix en enfer, donc je suis. A. Rimbaud Io penso… io… penso dunque non…. …..non esisto (esisto?)? eppure…. ….eppure vado. Vado: verso rogge fugaci in incredula e florida torsione di agonie andaluse assopite su bassifondi di circonfuso conio e ferramenta di lisergiche correnti di cornici e... ….io penso… …..io penso e dunque…. …..io…. 326 …io …non sono…. …non sono (non sono?)?… ….eppure scorro. Scorro: su are di vento distillate ardendo misconosciuti stracci di incoronato fulgore di olio minerale e di diafano tabacco di colonia, su fiumi di vino abbietto cantando su basi di tempesta elettrica urinante su computer portatili vanitosamente proni a un abisso di vati tuberosamente caleidoscopici e di salti al propilene infrangibili e infranti e poi…. ….poi….poi… ….poi mi immergo nel sotterraneo diluvio di frustranti codici di piñacolada e di cavillante eredità di torride costanti, annego in frane metropolitane crudelmente stereofoniche e biancori ansanti di secondo bagno in fuga, fra uno stanco galleggiare di scrivanie erette come un profluvio di avidi scorpioni e miserie stacanovistiche di flanelle abbandonate: e qui…. ….solo…. …..solo…. 327 ….qui…. …..alla fine…. ….finalmente…. …..vedo. Vedo moltitudini di moltitudini, popoli di popoli, mortitudini di mortitudini. E ognuno e tutti chiusi in un destino infame e raggiante di catapecchia assonnata e di pistillo sepolto fra misconosciuti archi di satura e sontuosa viscera di canzone e chiodi – ovunque – scacciati da altri chiodi e polvere – ovunque – scacciata da altra polvere e silenzio che annega nel silenzio. E – soprattutto – no! no! non una rivelazione ma piuttosto: una conoscenza. Una conoscenza, si, fatta dell’ardente e malinconica strage del giglio incancrenito, di scandalose canzoni di struggente clausura di melone, di gorgoni abbandonate al tormento registrato in playback 328 di sorgenti di scatolette roventi, rabbiose e rantolanti. Una conoscenza, si, ancora, fatta di canzoni di concubine perdute fra arcaiche strenne di ubiquitario curvare di mezzelune inaridite, e, si! si! fauci di Erinni innalzate dal cerchione in fiamme riflesso da specchi di pomate spalmate fra la corruzione di cosce inenarrabili di prostitute immonde e cieli che non conoscono fine al loro abisso si… Perché io so che il mondo non è altro che un immenso tribunale dove tutti e ognuno sono accusati e si accusano semplicemente del fatto di essere vivi e per ciò solo intenti a condannarsi reciprocamente a varie forme di morte una della quali la mia mia si ‘ché solo questo è mio mio solo… …solo… ….mio…. Ora……….. ………mi disperdo, si… 329 Perché chi conosce qualche altra cosa da fare, qualche altro demone da invocare, qualche altro dio a cui sacrificare qualche altra fortuna cui aspirare? Dunque mi disperdo. E seguo una nevrosi di scombinata segatura di neon in fuga in un’agonia di vie lattee claudicanti cosparse di pupille principescamente metalliche, mi getto in una dannazione di saltimbanchi contorti, contaminati e concavi, di autoclavi ammansite e sordide giunture di frattaglia, su ritratti di scafandri imprecisati fra nebbie di grondaie e su dislessiche ondate di cortigiane informi sature ormai di saliva stagnante e di corrida astrale, di eresie di acqua ragia e rotocalchi imperiosi di galeone e…. ….oh, che sorpresa, trovarti! ….proprio tu, proprio qui…. …..tu…..qui… ….qui, nella cantina dimenticata dal fuoco negro e appassito e dal sudato riccio folle di manganese, nel sussultante soliloquio del soldatino di piombo nutrito da uno psichedelico humus di portali, nella vergine prateria di ermetici streptococchi in perenne lotta per il trono conchiuso del furgone… …proprio tu, proprio qui……. 330 …….a scaricare una piantagione di consessi di assegno postdatato, di cirrocumuli squarciati dal letame di formicai impazziti, fra le stagioni neutroniche della cornice astratta e cinica, tu qui a denudare le cronache inchiodate dei fulgori marziani e gli albicocchi alati nella taurina neve del sodomita di cartone si…. Perché io so che il mondo intero non è altro che un immenso cimitero dove morti neppure troppo viventi abitano in tombe in affitto a volte perfino a prezzi ragionevoli, e abbastanza confortevoli, e ben arredate e ben scaldate in una wasted land di crudeli inverni di illuse delusioni e primavere uscenti di desideri impazziti, un cimitero di furie nutrite dalla loro stessa furia e di ombre e indecisioni e nebbie un cimitero dove a ogni domanda l’unica risposta possibile è non lo so si…. …non lo so…. ……eppure in fondo, laggiù proprio nel fondo più fondo nella fossa che inghiotte ogni altra fossa e ogni fede, ogni sogno, ogni speranza, ogni disperazione e ogni 331 rassegnazione, e ognuno e qualsiasi altro genere di conforto, ebbene qualche cosa la so: perché conosco questo cimitero meglio di tutti meglio di voi che mi guardate con un cannocchiale rovesciato solo per dire che sono un microbo e che niente e nessuno è più grande di una pulce si…. ….si… …. pulci eleganti e fragorose però in un manto rosso di Cristo flagellato dalla sua stessa brama di martirio, vere perle in vere conchiglie di vero sterco date in pasto a veri, evangelici porci in ermetica tonsura di ermeneutica santità. Foglie, si, solo foglie, che non sono in nessun senso di nessun ramo e di nessun vento: pulci che non hanno altro vizio che un destino di seme infranto dal creolo odore del lupo sazio e addormentato, pulci che non hanno altra virtù che dormire e sognare d’esser pulci, in un universo che non ha altro limite alla sua densa e incompresa follia di nullità che questo affondare verso tenebre adamantine, tenebre di generosa e alacre salsedine disperse nella loro stessa immensità di formicaio 332 si… Perché io so che il mondo intero non è altro che un cervellotico inferno di colombe intristite, strazio di Andorre e di fugaci ansie di suppurata ferita di unicorno, un inferno, di sconsacrati cocci di bottiglia, di rame fecondato da un sapore di scalo e di vetrina, un inferno, comunque, di distoniche carezze di sesamo e salvagente, di sporadici flutti di sopore di crotalo ammansito, e di spongiformi coronarie di scarabei in fiore. Ho percorso ogni sentiero di quest’incredibile, incredulo, increduto inferno. Ne ho visitato ogni angolo, ogni anfratto, e ho assaggiato ogni coda e ogni singolo capello e dente di ogni singolo demone, e poi, naturalmente, anche ogni singolo strazio di fiamma o di gelo che sia di ogni singolo girone, e ogni follia di ogni poeta che quest’antro di brume, sangue e salgemma ha generato. L’ho visto in viso…. ….quest’inferno….. Ne ho incontrato gli occhi, ne ho scrutato l’imperscrutabile abisso, 333 toccato il fondo senza fondo. Ne ho conosciuto la fame nerissima irta di sfortunate, intime rose, e di infranti microcosmi di scirocco. Ho conosciuto il pianto soffocato del bambino che annega nel gelo della palude ossessa e impudica, nella melma orrida e infame impastata di merda d’uomo e saliva di rospo della pedofilia. Ho conosciuto l’orco atroce e febbricitante in maschera di prefica o di prete, il gorgo untuoso e lascivo di una fede ch’è solo un miasma putrido di colpe crocifisse a croci marce di bestemmie travestite da preci, inni e invocazioni, a onore e lode e gloria d’un dio ignavo e pallido, nostalgico solo di propria e d’altrui morte. Ho conosciuto la solitudine senz’aria, senza patria e senza fine dell’esiliato, del reietto e dell’escluso. Ho conosciuto il grido stranito e straziato dell’amante con il cuore spaccato dalla freccia al curaro, e dal flagello di ortica e di rovi dell’amato. Ho conosciuto l’abisso d’illimitate sbarre del drogato 334 che dilania grida di verme pravo e calpestato, stretto nella bara di chiodi del rebound. Ho conosciuto le minuziose notti d’alcolizzata insonnia affondando in un baratro fermentato d’indemoniati spettri di uccello ridotto a macchia di crudo sangue per i cani. Ho conosciuto lo specchio senza ritorno dell’amico tradito e senza amici, la stella a sei punte dell’ebreo innocente epperò atrocemente colpevole d’essere un lurido, putrido, porco, dannato, maledetto, stupido, stronzo, corrotto, drogato, comunista, negro, frocio, tardo, complottardo d’un ebreo. Ho conosciuto la nera e folle risata della puttana che si ingegna di offrire al cliente una luna di sangue marcio ovvero un buco di culo libero da affanni in cambio di un danaro che altro non compra che un sordido e furente rimpianto di esser nato. Ho conosciuto l’innominabile, interminabile terrore di labirinti di vuoto impazzito e urlante scavati da fauci di angoscia insaziabile e saziata solo dal pasto feroce di sé stessa. Ho conosciuto sfinito, infine e per finire, 335 il tedio, l’orizzonte senza inizio, senza fine, senza orizzonti, il disseccato e cocente oceano di sbadigliante riflesso di meriggi, l’assillante vessillo che si avvita in lucidi, sudici e suicidi spasmi di serpenti intessuti lungo festivi e cronici deserti scolpiti di marmorea cancrena e morta polvere fra silenzi astrali e fantasie martirizzate da uno scheletro che reclama i suoi diritti di futuro nulla e di fantasma. Conosco quest’inferno, si: in ogni baratro, in ogni rivolo, in ogni goccia, in ogni palmo, in ogni fosso e dunque… …dunque… ……dunque rotolate, rotolate per me perle e comete perdute della danza, intrecciate collane di fumo inesorabile e di ansiosa steppa di collirio, virate in coro intorno a una Caballà di vento abbracciate a sirene infrante di psichedelica candela, scivolate su pianure di impensabile liuto di aeratore, innalzate un grido di fantasmatico piccione posato su un monumento al Piccione Qualunque Ignoto un grido che finalmente ci si doni un abbraccio, un abbraccio d’oblio, di scudo e di corona, un addio che mani e piedi e busto e collo e testa 336 possano finalmente celebrare, un addio in cui svanire in cui esultare con tenue e divino saltare di serpente! 337 2. ODE DEGLI ANGELI. Angeli travestiti da nubi e nubi travestite da comuni ospiti di strutto in un inverecondo ospizio di miserie e legnami profumati di candida e candita angoscia di futuribile scirocco. Cani giganteschi eppure bastardi e randagi orinano, annusano e se ne vanno, estraendo dal cilindro impensabili ozoni di ali di liquefatto pipistrello e riti celtici arguti e frastornati, masticando cervicale chewing-gum ferito dal cerino, e dissetandosi di bestemmie intinte nel fruttosio o nel carbone. Angeli…. Angeli travestiti da recalcitranti stemmi di ammaliato fantasticare di sauro ridipinto e di laccata insinuazione di fragile liocorno. Angeli senza più casa e senza più desiderio di cielo, inarcando vagli di ludibrio e scapole di ventoso uranio fra le ombrose fronde del cupo sospiro della rosa ammaestrata, angeli nascosti negli anfratti del leone incartapecorito, angeli che russano addormentati su un moribondo cuscino di stanchi fragori di stanchezze. Si, ma…. ….. angeli comunque… 338 Angeli, si, eppure attaccati alla terra con furia di postino squartato dal suo stesso spaventoso ventre di coriandoli, angeli che somigliano a un tramonto che sprofonda in abissi di concerto, angeli che lasciano impronte di Tantalo nel fango del diluvio e che accendono scavi di infartuata vetrata nelle fiamme di Sodoma e nell’archivio dei violini drogati di Gomorra. Angeli che non conoscono altro paradiso che il sogno insospettabile dell’onnipotente albore della fame, angeli che guardano in viso il dolore e l’agonia di un furibondo godere ch’è eco e nostalgia di Tutto e Nulla e un tenue sospiro di autunnale coro greco o di ramo appeso alle sue foglie. Angeli, si, lo ripeto. E lo ripete la cuspide musicale che in alto li trascina, ridente e violenta, anche forse solo per poterli un giorno precipitare in abissi di luminescente e lamentoso fiele, per seppellirli in un chiostro fatto d’ombre di lavatrice incastrata in un canyon di furie di cameriere ammaestrato. Angeli…. ….comunque… Angeli di debole e inafferrabile mercurio, angeli assetati di Cornovaglie impiccate al fragore fulgido del cartone insinuato nel ricordo perduto di un dedalo di champagne, o in una misericordia fragrante di sdentati succhi gastrici. 339 Angeli che giocano con monetine di menta solcata da fulgidi chiaroscuri di dolente brezza, angeli frementi di febbri ereditate da un crepitare di scirocco e da una malinconia di lussuriosa Venezia tra le foglie, angeli perduti fra fiabe di fangosi e illuminati mercanti di strenne, di cianuro e di scafandri, angeli che cerco con il ventre perduto della conturbante follia del corridoio assaltato da un vascello d’ombre pensili, e da un’eredità di scoperti sussurri di vitalba. Angeli: eppure privi di ali, eppure dimentichi di cielo, eppure nudi pur con ancora indosso le bianche vestigia della luna… Angeli senza cuore di tenebra e senza oro di nebbia, angeli senza più un soldo o un solo centesimo di memoria, profughi e perduti nella mistica parvenza di un tiro di cornuti bisavoli fra concerti di pallido elettroshock, e annegati in intrighi di scivolosi orpelli di lupanare sulle spine, angeli con ali spietate di vilipesa caffettiera, angeli sardonici e misticamente legati a un futuro di vetriolo angeli appesi a un vasellame di sconclusionata dentiera, angeli luminescenti con ali di confusa e risibile cometa, angeli chiunque siate portatemi via, via, vi prego, verso quell’Onnipotente Ovvero Ovunque che un tempo gli uomini chiamavan Paradiso. 340
Scarica