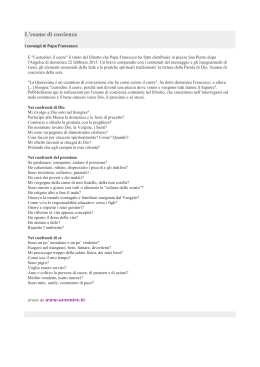Domenica La di DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 Repubblica la memoria Il voto alle donne compie sessant’anni MIRIAM MAFAI e SILVANA MAZZOCCHI il racconto Buffalo Bill, ultimo cowboy e prima star LEONARDO COEN e ANTONIO MONDA Il ritorno del golpista Repubblica Nazionale 25 19/02/2006 Venticinque anni fa il colonnello Antonio Tejero Molina prese in ostaggio le Cortes. Oggi racconta e scrive “j’accuse” contro Zapatero CONCITA DE GREGORIO S MADRID i riconosce dai baffi, poi dagli occhi. Le guance sono cadute, guance flosce di vecchio. I capelli non ci sono più, il corpo è appesantito. Gli abiti civili lo ingoffano come un vestito non suo, non ha mai imparato a starci dentro. I baffi però, ecco, quei baffi da cow boy sfortunato dei cartoni animati, sono identici: bianchi, ormai. Ingialliti dalle sigarette Fortuna, però uguali. E poi gli occhi. Alza lo sguardo e ballano come anguille, furibondi anche quando tace: occhi neri che scappano che non si fermano mai. Antonio Tejero Molina ha 74 anni, vive il furore che gli resta chiuso in questa casa di cemento nel cuore di Madrid, esattamente al centro del reticolo di strade che hanno scandito la sua storia e la sua dannazione. Laggiù il bar Galaxia, dove organizzò l’assalto alla Moncloa del ‘78. Più in fondo via General Cabrera, dove fumando e bevendo caffè corretto pensò il golpe dell’81. Cinque minuti a piedi, il Parlamento, dove dopo una notte intera col tricorno in testa e la pistola in mano pensò di arrendersi, sì, ma solo se i deputati, «quei caproni», fossero usciti in fila per uno e in mutande. La prima traversa a destra, via Martiri di Alcalà, il luogo dove ha passato in prigione quasi sedici anni. Venticinque anni sono trascorsi da quella notte: il 23 F è lontano un quarto di secolo e invece eccolo qui, coi baffi bianchi e una lettera in tasca. Tejero esce dal portone del numero 1 di via Santa Cruz de Marcenado, uno di quei complessi residenziali concepiti secondo l’idea di lusso dell’epoca: un casermone coi balconi di cemento armato simili a enormi mangiatoie grigie, rampicanti e edere pendenti che raccontano le cure di trentennali domestici. Telecamere a circuito chiuso spiano i passanti, un furgone bianco senza insegne staziona fisso davanti all’ingresso. Saluta il portiere con un gesto, s’incammina verso il negozio di fotocopie e fax dove va a spedire la lettera che ha appena scritto per maledire Zapatero: un uomo da niente, un traditore della Patria. Passa davanti alla Scuola di Guerra dell’esercito: in guardiola c’è una soldatessa bruna con gli orecchini di perla, la guarda in tralice. Donne in mimetica, un mondo invivibile. Si ferma a frugarsi le tasche proprio sotto un cartello che il quartiere Conde Duque, il suo quartiere, ha piantato lì per celebrare Cervantes: «Io voglio stare zitto perché non mi dicano che mento. Ma il tempo, scopritore di ogni cosa, dirà il vero quando meno lo aspettiamo». Verso 15, capitolo 37. Tejero, sul suo silenzio: «Non insista, signorina. Io del 23 febbraio non parlo. Non parlo perché non so cosa sia successo quel giorno. Chi avrebbe dovuto spiegare ha taciuto, qualcuno ha tradito, troppe ombre ancora pesano. Io ho fatto il mio dovere di spagnolo, ho pagato colpe che non ho. La storia dirà». (segue nelle pagine successive) con un servizio di ALESSANDRO OPPES i luoghi Pechino riscopre il suo cuore antico FEDERICO RAMPINI cultura Le poesie inedite di Charles Bukowski ANTONIO GNOLI la lettura In sella a una bici per fare l’Italia EDMONDO BERSELLI e PAOLO RUMIZ spettacoli Vampiri, il mostro torna in pantofole NATALIA ASPESI e GIUSEPPE VIDETTI 26 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 la copertina FOTO CONTRASTO/GAMMA Venticinque anni dopo Il 23 febbraio del 1981 un tenente colonnello della Guardia civile fece irruzione nelle Cortes con una pistola in mano e un tricorno in testa. Il suo putsch stralunato e fallimentare durò diciotto ore ma ancora oggi lui si domanda “chi lo tradì” ed è tornato in campo scrivendo lettere di fuoco contro Zapatero sulla “questione catalana” Madrid, nella casa di Tejero lo sfogo dell’ultimo golpista CONCITA DE GREGORIO (segue dalla copertina) nvece poi parla, l’ultimo cupo Don Chisciotte di Spagna. Parla il cavaliere nero dalla triste figura che ancora combatte contro il suo inesistente nemico. Parla infine perché «il cuore mi sanguina, stanno attentando all’unità patria ed è come se stessero accoltellando mia madre: lei resterebbe ferma, non reagirebbe se vedesse uccidere la sua propria madre?». La madre è l’unità nazionale, il coltello che la uccide è lo Statuto autonomo di Catalugna, l’assassino è Zapatero. Ecco qui la lettera, la missiva scritta a mano che sta andando a inviare al giornale di Melilla — patria di militari neri d’ogni dove, enclave marocchina, terra di legione straniera, anche uno come Ghira è venuto a morire qui. Va a spedirla dal negozietto di via San Bernardo. La lettera s’intitola «Fino a quando... Zapatero?». Quo usque tandem. Dice: «Spero solo che con questo Statuto non c’entri il Re, perché come parlò quel 23 febbraio per evitare la ribellione così dovrebbe parlare oggi, giacché stanno tentando di rompere la corona di Spagna di cui è depositario». Il febbraio ’81 come questo febbraio, quindi. Non ha cambiato idea, colonnello. «Cambiare idea? Non sa quello che dice, non si rende conto. L’amor patrio non è un’idea. È il sangue che corre nelle vene degli uomini degni di questo nome e io morirò da uomo. Difenderò Spagna finché avrò vita». La casa è buia anche se fuori c’è il sole. È la casa della figlia, una dei sei figli — tre maschi, tre femmine — che ha avuto dalla devotissima moglie Carmen: la donna che la notte del 23 F, mentre lui era ancora dentro l’emiciclo che urlava a Felipe Gonzalez, a Fraga e a Carrero Blanco «pancia a terra, cazzo», telefonava disperata alle amiche: «Lo hanno lasciato solo, lo hanno buttato via come un mozzicone di sigaretta». Gli altri, i generali lo avevano buttato via: i signori del golpe di cui Tejero è stato — in questa versione — solo una pedina. Il capro espiatorio. «Non so cosa sia successo quel giorno», appunto: dovevano arrivare i carri armati da Valencia e non arrivarono; doveva esserci il generale Armada a fianco del Re e invece arrivò nell’emiciclo a dettare un governo possibile — il suo — pieno di comunisti e di socialisti. Tejero, che aveva scatenato il golpe, lo fermò: lui lo fece, lui lo fece fallire. Le serrande in casa sono abbassate, la luce elettrica accesa. Una scrivania scura, una ciotola di cristallo con qualche caramella Sugus, cimeli alle pareti: in cornice il discorso che Franco inviò agli spagnoli prima di morire. Non c’è un computer, non una macchina da scrivere. La tecnologia è un vecchio tv color in salotto. Il colonnello scrive a mano, in stampatello. Si firma «Antonio Tejero Molina, carta d’identità numero 1317104D, tenente colonnello della Guardia Civile espulso dall’esercito per il 23F». La lettera su Zapatero è del 25 gennaio. In ordine sulla scrivania ce n’è un’altra scritta tre giorni dopo, il 28, ancora inedita. Sono sette cartelle, il titolo è «In uso dei nostri diritti». Dice che è uno scandalo che abbiano cacciato con violenza dall’Esercito il generale Josè Mena Aguado, poche settimane fa, «solo per aver detto» che lo Statuto catalano, se approvato, avrebbe legittimato il ricorso alle armi. «Uno scandalo, perché il generale si è limitato a recitare un articolo della Costituzione, sebbene omettendo un paragrafo». La verità è che a questi politici «noi serviamo solo un giorno ogni qualche anno, il giorno delle elezioni, per il resto ci vogliono ciechi sordi e muti come le scimmie. Ma no, in nome di Dio, non mi sentiranno tacere!». Gli occhi bruciano. «Vendono la patria per trenta voti o, chissà?, forse per qualcosa di ancor più vergognoso. Il signor Zapatero, i suoi amici, le sue riunioni segrete...». Le mani disegnano cerchi nell’aria, muovono il brillio della polvere nei raggi di luce delle persiane. Di quelli che c’erano quella notte di 25 anni fa Antonio Tejero è l’unico che ancora frema di indignazione identica, solo contro i suoi mulini. Aveva provato a dedicarsi alla coltivazione dell’aguagate in Costa del Sol, la sua terra natale. Lo fa. Da quando Gonzalez gli ha condonato la pena residua (quindici anni e nove mesi invece di trenta, cinque scontati per buona condotta: in carcere donava il sangue), ha messo su una coltivazione sperimentale vicino a Malaga. Alfonso Armada — il generale che fu per vent’anni istitutore del giovane Juan Carlos per conto di Franco, il vero ispiratore del golpe, uomo Opus dei che voleva sostituirsi a Suarez a capo di un governo di sicurez- FOTO AFP Repubblica Nazionale 26 19/02/2006 I za nazionale — coltiva camelie vicino a Santiago. Francisco Lanìa, allora direttore della Sicurezza di Stato, coltiva pomodori in una piccola fattoria in provincia di Avila. L’ex presidente del governo Adolfo Suarez, l’uomo colpevole per i militari di aver legittimato il Partito comunista, è afflitto da una malattia degenerativa fra la demenza e l’Alzheimer. Vive chiuso nella sua casa di Florida, vicino a Madrid: lo hanno trovato qualche volta che raccontava dettagli del golpe di Tejero ai giardinieri delle case vicine, lo hanno riportato dolcemente nella sua. Pazzi, vecchi e spaventati, muti: giardinieri che parlano coi fiori. Gli altri sono morti. Tejero no, il colonnello cammina spedito verso l’edicola ogni mattina, poi va in chiesa. «Hai almeno messo il crocifisso che t’ho mandato?», si spazientiva al telefono la moglie Carmen il primo giorno di prigionia, 24 di febbraio. Ce l’ha, il crocifisso. La figlia, come gli altri cinque educati nel culto del padre, ne protegge ogni passo. Gli consente di rado di andare al telefono, filtra le chiamate. Lui, quando finalmente risponde alla domanda «è lei, colonnello?», dice così: «Al aparato». All’apparecchio, formula marziale e desueta, oggi vagamente ridicola: nessuno chiama più il telefono «apparecchio». E però è la stessa formula degli sbobinati allegati agli atti del processo: il modo in cui Tejero 25 anni fa rispondeva al segretario del Re, Sabino Fernandez Campo, che gli chiedeva «per carità cosa sta facendo, colonnello, in nome di chi agisce?». Mentre Juan Carlos chiuso nel “Non so cosa sia successo quel giorno: chi avrebbe dovuto spiegare ha taciuto, qualcuno ha tradito Io ho fatto il mio dovere di spagnolo e ho pagato colpe che non ho” LA LETTERA DEL COLONNELLO Nelle foto della pagina, due immagini dell’assalto alle Cortes del 23 febbraio 1981 con al centro il colonnello Antonio Tejero Molina. Nelle foto a colori, Tejero (sopra) nel 1996 subito dopo la scarcerazione e (sotto) nel 2003 con la moglie Carmen Díez Pereira alla fiera di Malaga. A destra, accanto alla prima pagina de “El Pais” nel giorno del golpe, due pagine della letteraappello scritta da Tejero contro il presidente Zapatero e consegnata alla nostra cronista Nel montaggio di copertina, altre pagine dello stesso documento suo studio pretendeva che il figlio Felipe, allora dodicenne, rimanesse lì nella stanza tutta la notte, sveglio, con lui. «Perché vedi, figlio, questa notte potrebbe essere l’ultima e di certo sarà unica e tu devi sapere fin d’ora che essere re non vuol dire solo tagliare nastri». Il bambino piangeva, anche suo nonno Don Juan di Borbone dall’esilio portoghese piangeva. Ronald Reagan no, era andato a dormire e non lo svegliarono mentre Manuel Fraga urlava in aula ai militari con le mitragliette «adesso basta», e Alfonso Guerra il socialista pensava a suo figlio di un anno che non avrebbe forse visto più, e Santiago Carrillo il comunista si accendeva un’altra Peter Stuyvesant. Dal consiglio di guerra, in quel momento esatto, Lanìa stimava in «duecento morti approssimativi» l’esito di un’azione armata di liberazione del congresso che l’uomo col cappello a tricorno teneva in ostaggio con una pistola Astra in mano. Diciotto ore, durò il golpe. Carmen Tejero aveva capito ben prima del marito che lo avevano lasciato solo come un mozzicone spento. Consolava i figli, coraggio, nella stessa ora in cui lui rispondeva al generale Aramburu, il suo generale: «Non mi arrendo, mi generàl. Se si avvicina ancora di un passo le sparo e poi mi sparo io». Nel bando che lesse dallo scranno più alto, quella notte, risuonano le stesse parole delle sue lettere di oggi: «Spagnoli, le unità dell’esercito della Guardia civile che occupano il congresso non ammettono le autonomie separatiste». Ai soldati che aveva DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 27 IL “23 F” ORE 18 ORE 20 ORE 21 1.20 ORE 12.50 A capo di 200 agenti della Guardia civile Tejero fa irruzione in Parlamento dove si doveva eleggere il capo del governo Si ribella il capitano della III Regione militare Jaime Milans del Bosch: i militari impongono il coprifuoco nella regione del Levante e a Valencia Viene formato un governo provvisorio composto dai sottosegretari di Stato rimasti liberi che prende il controllo della nazione Il re Juan Carlos tiene un discorso in tv, vestito con l’uniforme di capo delle Forze armate, per condannare i golpisti e difendere la Costituzione Si conclude il colpo di Stato: tutti i deputati tenuti in ostaggio vengono liberati I responsabili saranno condannati Il racconto del generale Fernández Campo “In quelle ore fatali così salvammo il re” ALESSANDRO OPPES FOTO ANSA/EFE I “Stanno tentando di rompere la Corona di Spagna, stanno attentando all’unità della patria. E il mio cuore sanguina: è come se stessero accoltellando mia madre. Lei starebbe ferma se vedesse uccidere sua madre?” portato con sé nei sei autobus comprati per il bisogno aveva detto che il Parlamento era sotto attacco dell’Eta e bisognava difenderlo. Anche adesso dice così: «Vorrei proprio che qualche giudice chiedesse conto a questi saltacostituzione che cosa hanno fatto con Otegui e Batasuna, e allora ci renderemmo conto delle loro oscure intenzioni». Arnaldo Otegui, ex componente dell’Eta, ex parlamentare di Harry Batasuna. I giornali di oggi, quelli di sinistra, pubblicano «il piano in quattro punti» di Zapatero per chiudere le ostilità con Eta. Quelli di destra portano in prima pagina foto delle vedove e delle orfane del terrorismo («mai un accordo con Eta») e della nuova linea di moda di David Delfin ispirata alle divise delle SS, banda al braccio e mostrine militari incluse. Melilla Hoy, il giornale che ha pubblicato per esteso la lettera di Tejero contro Zapatero, ha ricevuto nei giorni successivi quaranta altre lettere. «Trenta a favore di Tejero e dieci contro», spiega il caporedattore Mustafa Hamed. Tejero a novembre, tre mesi fa, è andato in pellegrinaggio al Valle de los Caidos: la tomba di Franco. «Un referendum è il minimo che questi traditori della patria possano concedere al popolo sovrano. Io non ho votato una costituzione in cui appare la parola “aborto” e non compare il nome di Dio. Però, adesso che c’è, è di tutti, e dunque si dica che quello che sta succedendo è incostituzionale. Se si approvasse lo statuto catalano, Spagna non sarebbe più Spagna: la avrebbero uccisa proprio quelli che il popolo ha eletto perché ne avessero cura». I soldi, è una faccenda anche di soldi. «Lo dice uno che ha rifiutato milioni per le interviste, uno che non ha cura del denaro». Colonnello, si dice che lei sia pagato per tacere. «Infamia. Ne avrei bisogno, del denaro che mi offrono per parlare. Ma lo rifiuto, e denuncio lo scandalo della bancarotta a cui stanno portando Spagna: i catalani vorrebbero tenersi la metà delle loro imposte, milioni e milioni di euro che pagheremo tutti, e senza essere profeta dirò che dopo anche gli altri vorranno la medesima autonomia, i baschi, i galiziani, tutti, fino a totale liquidazione della Patria. Prego il re». Lei, prega il re? «Certo. Da repubblicano accetto la monarchia sempre che sia garante dell’unità di Spagna. Si pronunci su questo atto vandalico. Parli oggi come parlò allora». Allora, quando a mezzanotte e cinque minuti del 23 febbraio Juan Carlos disse in tv agli spagnoli «la Corona non può tollerare atti di chi pretende di interrompere con la forza il processo democratico». Tejero sentì il discorso mentre con l’Astra in mano pensava di salvare il Paese da «questi caproni democratici», e state a terra. Stamattina, venticinque anni dopo, ancora. Con una lettera in tasca, fermo impettito sul marciapiede di casa, i baffi bianchi che tremano un po’. Cola acqua dai terrazzi, i domestici stanno annaffiando i rampicanti. OSTAGGI ADOLFO SUAREZ Primo ministro dimissionario il giorno del golpe, è stato il primo capo del governo spagnolo ad essere eletto democraticamente dopo la caduta del regime franchista FELIPE GONZALEZ Nato a Siviglia nel 1942, l’ex primo ministro spagnolo nel febbraio 1981 è il leader dell’opposizione socialista: va al governo l’anno dopo e vi resta per 14 anni SANTIAGO CARRILLO Il leader del Partito comunista spagnolo nasce a Gijon, nelle Asturie, nel 1915. Costretto all’esilio durante la guerra civile, torna in Spagna dopo la morte di Franco MANUEL FRAGA Ex ministro dell’Informazione sotto Franco, anche dopo la caduta del Caudillo rimane per oltre dieci anni governatore della Galizia All’epoca del tentato golpe ha 58 anni MADRID l film di quella giornata scorre ancora limpido nella memoria del vecchio generale a riposo. Anche se, a venticinque anni di distanza, resta la confusione su come andarono realmente le cose, sulla vera genesi di quel golpe abortito. «Un rompicapo», lo definisce ancora oggi Sabino Fernández Campo, 88 anni, che in quei giorni del 1981 era il segretario generale della Casa Reale. In altre parole, il più stretto collaboratore del re. «È vero, io in quel momento ero in una posizione privilegiata, ho potuto osservare da vicino minuto per minuto l’evolversi della situazione, e parlare con tutti i protagonisti. Però continuo ad avere l’impressione che mi manchi qualche tessera di quel mosaico. Elementi che non coincidono, la probabile mancanza di un coordinamento tra chi aveva pensato l’azione e chi la stava realizzando. È significativo quello che disse il colonnello Tejero, mesi dopo, al momento del processo: «Io vorrei che qualcuno mi spiegasse che cosa è successo il 23 febbraio». Come dire che le cose andarono diversamente da quel che credeva l’uomo che era stato mandato in prima linea». Generale, lei fu la prima persona a parlare con re Juan Carlos quando si diffuse la notizia che qualcosa di grave stava succedendo nell’emiciclo delle Cortes. Quale fu la prima reazione del sovrano? «Quel pomeriggio era prevista l’investitura del nuovo capo del governo, Leopoldo Calvo Sotelo. Seguivamo, alla radio, la trasmissione in diretta, quando si cominciarono a sentire strani rumori, voci concitate. Il mio ufficio alla Zarzuela era a diversi piani di distanza da quello del re. Don Juan Carlos mi chiamò, mi precipitai da lui. «Sabino, che cosa succede?», fu la sua prima domanda. Che cosa stesse succedendo era ancora difficile capirlo. In quel momento la confusione era totale. E anzi, il primo sospetto fu che ci fosse di mezzo l’Eta. Era un periodo in cui i terroristi baschi avevano messo a segno parecchi attentati sanguinari. Temevamo una loro azione clamorosa». Ma non tardaste a scoprire che l’uomo che teneva sotto sequestro il Parlamento era un tenente colonnello della Guardia civile. «No, e per di più si trattava di una vecchia conoscenza. Antonio Tejero era già stato protagonista di un altro complotto golpista, la Operación Galaxia. Sapevamo che era un personaggio molto deciso e disposto a fare alcune cose, cose sbagliate, ma per le quali era determinato ad andare sino in fondo». Lei riuscì a parlare con Tejero, ma fu una conversazione che non contribuì a migliorare le cose. «È vero. Mi diedero il numero del telefono più vicino al punto dell’emiciclo in cui si trovava il colonnello. Quando rispose gli chiesi: «Che fai lì? Che sta succedendo? Perché ti sei presentato in nome del re? Sappi che il re non è assolutamente d’accordo con quello che stai facendo, e ti ordina di uscire immediatamente dal Parlamento». Notai tensione e nervosismo nella sua voce. Mi disse che lui non prendeva più ordini dal re, ma solo dal generale Milans del Bosch, il capitano generale di Valencia che aveva schierato i carri armati per le strade. Questa fu la sua risposta, poi mi chiuse il telefono in faccia». Che cosa faceva, nel frattempo, il sovrano? «Si metteva in contatto telefonico con tutti i più alti responsabili dei vertici militari, i capi di Stato maggiore, i capitani generali di tutte le regioni del paese. Cercava di capire qual era la reale portata del problema». Tra le persone che, in quelle ore, avevano un filo diretto con il re ce n’era una che alla fine si rivelò un uomo chiave del movimento golpista, il generale Alfonso Armada. «Armada era una persona di massima fiducia di Don Juan Carlos: era stato accanto a lui, come precettore, sin da quando, giovanissimo, il futuro monarca non era ancora principe. Ed era anche mio amico. Tra l’altro avevamo lavorato insieme nella segreteria del Ministero dell’Esercito». Ma né lei né il sovrano sospettavate che stesse tramando qualcosa? «Quel che sapevamo per certo era che la Spagna stava attraversando una situazione molto delicata. I militari non avevano perdonato al premier Adolfo Suárez non tanto il riconoscimento del Partito comunista, quanto il modo in cui venne deciso. Felipe González aveva già presentato una mozione di censura contro il governo, che non ebbe successo. È a quel punto che viene fuori il nome di Armada come possibile capo di un governo presieduto da una personalità «neutrale». Ma l’idea era quella di arrivarci attraverso una nuova mozione di censura, cosa che divenne impraticabile nel momento in cui Suárez presentò le dimissioni. È probabile che la designazione di Calvo Sotelo, considerata insoddisfacente dai militari, abbia accelerato il piano per imporre, a qualunque costo, un governo presieduto da Armada». Suárez aveva proposto, poco tempo prima, che il generale venisse allontanato dalla segreteria generale della Zarzuela. Evidentemente pensava che potesse costituire un pericolo. Non le risulta che il premier abbia mai espresso con chiarezza la sua preoccupazione al re? «Suárez si premurò di parlare con me perché io potessi testimoniare che si dimetteva per decisione propria e non per pressioni esterne. Ma si sapeva bene che uno dei motivi per cui decise di lasciare l’incarico era l’inimicizia insanabile che si era creata con i militari». Tutti gli storici sono concordi nell’attribuire a lei un ruolo chiave nel fallimento del golpe. Come andarono esattamente le cose? «Accadde un fatto del quale solo dopo capii la portata. Parlavo al telefono con il generale Juste, capo della divisione corazzata “Brunete”. Lo trovavo stranamente interessato ad avere informazioni sul generale Armada. Voleva sapere se Armada era con noi, se era già arrivato alla Zarzuela. Gli risposi semplicemente: “Non è qui, né lo stiamo aspettando”. Quando Juste mi disse che questo cambiava molto le cose, capii che la presenza di Armada a Palazzo era probabilmente il segnale che aspettavano per prendere in mano la situazione». È per questo che Armada insisteva tanto... «Sì, quando tornai nell’ufficio di Don Juan Carlos mi resi conto che stava parlando, ancora una volta, con Armada. Gli suggerii che gli ordinasse di restare al suo posto, allo Stato Maggiore della Difesa». E poi fece rafforzare la sicurezza ai cancelli della Zarzuela. «Certo, bisognava prendere tutte le precauzioni. Per questo ordinai, tra l’altro, che venisse proibito l’ingresso al generale Armada». Sono stati scritti libri che ipotizzano un coinvolgimento del Cesid, i servizi segreti, nel golpe. «Su questo non ho nessuna informazione. Il responsabile delle sezioni operative dell’intelligence, José Luis Cortina, venne anche processato, ma fu assolto. Quello che posso testimoniare è che Cortina, in quelle ore, non si mise mai in contatto con noi». Trascorsero 18 ore di tensione e paura prima che il re comparisse in tv per decretare il fallimento del golpe. Perché tanto tempo? «Quel messaggio venne redatto quasi subito. Ma c’erano due problemi da superare. Il primo era chiarire quello che stava accadendo: dovevamo raccogliere informazioni dettagliate sulle intenzioni dei militari, cosa che richiedeva tempo. Il secondo problema era che la sede della tv era occupata militarmente. Ci volle un lungo negoziato per ottenere che venisse sgomberata. Solo così Sua Maestà fu in grado di far arrivare agli spagnoli il suo pensiero. Alla fine, si può dire che il 23 febbraio ‘81 è stato un buon vaccino. È sempre meglio non dimenticare, perché tutto serve come esperienza. Quel che è certo è che la figura di re Juan Carlos ne è uscita enormemente irrobustita». 28 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 la memoria Svolte epocali Sessant’anni fa, il 2 giugno ’46 alle italiane fu concesso il primo “voto politico”: referendum Monarchia-Repubblica e Costituente Ora una mostra alla Camera racconta quell’appuntamento cruciale Il giorno che le donne si presero la Storia A SILVANA MAZZOCCHI rrivavano ai seggi con il vestito buono della festa, con i bambini in braccio, con il fazzoletto sui capelli. Emozionate, come si conviene per un appuntamento importante, decisivo. Quel 2 giugno del ’46 le donne votano per la prima volta e sono oltre dodici milioni. Un diritto, un adempimento ovvio per la democrazia, eppure una conquista difficile, inseguita fin dai primi movimenti femministi a cavallo del Novecento. In precedenza, il 1° febbraio del ’45, un decreto aveva esteso il suffragio alle donne che in alcune regioni avevano già potuto votare per le elezioni amministrative. Ma essere candidate ed esprimersi per i destini della nazione era tutt’altra cosa. Paese povero e caotico, il nostro, in quel primo dopoguerra. L’Italia era rimasta a lungo divisa in due (a Roma il governo Bonomi, il nord ancora occupato dai tedeschi e dalla Repubblica di Salò) e usciva dal conflitto con le ossa rotte. Il salario di un operaio toccava appena 10mila delle vecchie lire, il biglietto del tram ne costava 4, ma un chilo di pasta valeva 120 lire e un litro di latte ben 300. Quel 2 giugno si deve scegliere tra Monarchia e Repubblica e, contemporaneamente, eleggere l’Assemblea Costituente per disegnare la nuova identità istituzionale. Per le donne il salto è doppio: votano e possono essere votate. «Stringiamo le schede come biglietti d’amore», racconta la giornalista Anna Garofalo nella cronaca di quel giorno, «si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne timorose di stancarsi nelle lunghe file dinanzi ai seggi. E le conversazioni che nascono tra uomo e donna hanno un tono diverso, alla pari». All’inizio era stata soprattutto la Dc a premere per il voto alle donne; i comunisti e i socialisti temevano che la Chiesa potesse influenzare le coscienze femminili, ma la valenza di quell’irrinunciabile conquista aveva presto spazzato via ogni dubbio. E Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi (contrari i laici, compreso Benedetto Croce) avevano presentato insieme la proposta sulla quale Ivanoe Bonomi emanò il decreto legislativo. Nei mesi precedenti al voto i partiti mettono in campo ogni loro risorsa. Fino ad allora le donne erano rimaste escluse da ogni tipo di dibattito politico e molte candidature finiscono per rivelarsi solo di bandiera. Il Pci e il Psi pescano tra le partigiane e i quadri di partito, tra le militanti perseguitate durante il fascismo o esiliate. Mentre la Dc indica esponenti dell’Azione cattolica e donne legate ai movimenti popolari. Il voto era stato reso obbligatorio per iniziativa democristiana, ma l’imposizione non serve: le donne sono contente di votare e accorrono in massa. Già nella primavera di quell’anno erano state elette per la prima volta oltre duemila donne nei consigli comunali. Nessuno stupore quindi se alla Costituente, su 556 deputati, 21 sono donne: nove dc, nove comuniste, due socialiste e una della lista “L’Uomo qualunque”. Cinque di loro entrano nella “Commissione dei 75” incaricata di scrivere la Carta costituzionale: le dc Maria Federici e Angela Gotelli, la socialista Tina Merlin e le comuniste Teresa Noce e Nilde Jotti. «È il voto alle donne il punto di partenza» conferma Anna Rossi Doria, che insegna Storia delle donne all’Università di Tor Vergata a Roma ed è Teresa Mattei “Quelle battute infelici dei colleghi maschi” Avevo appena 25 anni. Con la Resistenza avevo perso mio padre e un fratello e io stessa avevo lottato. Ero stata eletta con moltissimi voti; ricordo ancora il primo giorno a Montecitorio. Ero entrata nella segreteria della Costituente, ma presto, per volontà di Togliatti, venni messa nell’ufficio di Presidenza. Che emozione, non avevo alcuna esperienza. Quante battaglie, quante sfide. E che soddisfazione quando riuscivamo a portare a termine qualcosa di positivo. Ma anche quanti ostacoli. Provammo ad aprire le porte della magistratura alle donne. In aula fui io a leggere la relazione. Mentre parlavo i deputati più anziani si misero a gridare: «Le donne? E, durante quei giorni, sì durante il ciclo mensile, come potrebbero giudicare con serenità?». Quando si votò per il ripudio della guerra, noi, tutte e 21, ci tenemmo la mano. Eravamo tutte per la pace, anche la collega qualunquista, che poi era monarchica. Fummo unite anche per rimuovere il divieto che avevano le infermiere di sposarsi. E ci riuscimmo. (Costituente eletta nelle liste del Pci) Filomena Delli Castelli “Quando prendevo la parola le piazze si riempivano” Io ho sempre avuto fiducia nelle donne. Prima delle elezioni del ’46 per mesi avevo girato in ogni paese d’Abruzzo e mi ero accorta del loro interesse. Quando parlavo nelle piazze, loro che non si presentavano mai per ascoltare gli uomini uscivano per ascoltare me. Mi chiamavano Memena ed ero una di loro. Per me le organizzazioni cattoliche e la politica sono state una forma di emancipazione femminile. Ricordo ancora la campagna elettorale; era la prima volta che le donne parlavano e si facevano sentire. Quel giorno del voto, il 2 giugno del ’46, fu un giornalista del “Messaggero” ad avvertirmi. Mi disse: «Memena sei stata eletta, preparati ad andare a Roma». E io che non sapevo neanche dove era la Camera. Eravamo consapevoli che il voto alle donne costituiva una tappa fondamentale della grande rivoluzione italiana del dopoguerra. Avevamo finalmente potuto votare e far eleggere le donne. E non saremmo state più considerate solo casalinghe o lavoratrici senza voce ma fautrici a pieno titolo della nuova politica italiana (Costituente eletta nelle liste della Dc) nella “Società italiana delle storiche”: «Quello è un momento importante soprattutto dal punto di vista soggettivo, in quanto fu una conquista di individualità oltre che di cittadinanza. Ci sono tante testimonianze di donne, intellettuali ma anche delle classi popolari e contadine. Tutte ricordano l’emozione provata quel giorno per aver conquistato un senso pieno di autonomia individuale, fuori dai ruoli. Quel “voto segreto” significava potersi finalmente sottrarre al controllo e alla subordinazione. Anche dagli uomini della famiglia». Alla Costituente le elette formano una pattuglia variegata ma compatta e riescono a realizzare una collaborazione trasversale e moderna, per l’affermazione, nella Carta, dei principi basilari di parità. Con un testo ispirato all’uguaglianza giuridica di tutti i cittadini, «senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali». E alle “madri” della Costituzione va riconosciuto il merito di aver contribuito in modo decisivo a scardinare la struttura patriarcale della famiglia, con il riconoscimento di pari doveri e pari diritti ai coniugi, primo fra tutti quello di educare i figli. Dal voto alle donne alla Costituzione. Dal diritto di cittadinanza acquisito nasce il seme per quell’evoluzione del diritto e del costume che avrebbe, nei decenni successivi, reso possibili tante conquiste di parità e di civiltà. Leggi fondamentali e innovative nel campo del lavoro, del diritto di famiglia e della dignità femminile come l’abolizione delle case chiuse nel ‘56, voluta da Lina Merlin e primo esempio di mobilitazione parlamentare trasversale. Le norme sulle lavoratrici madri e, nel lavoro, la parità di trattamento salariale per gli uomini e per le donne. Fino al divorzio e all’aborto legale. Momento particolarmente felice quello della Costituente per la collaborazione tra donne. Con il collante della necessità di ricostruire l’Italia, le elette, sebbene avversarie, non erano state mai nemiche. Un’alleanza sostanziale che viene meno già nel ‘48, quando con le nuove elezioni, l’Italia si spacca in due. «Anche se differenze ce ne erano sempre state» dice Marina D’Amelia che insegna Storia moderna all’Università la Sapienza di Roma, «basti pensare al diritto al lavoro (che aveva visto le cattoliche più preoccupate del rapporto famiglia-occupazione, rispetto alle comuniste), fu il ’48 con la forte contrapposizione tra Dc e Pci a creare tra loro solchi profondi. Che si aggravano quando le dirigenze dei partiti richiamano le donne al gioco di squadra. E quando, nello stesso tempo, inevitabilmente, si attenua lo slancio derivante dall’assunzione di responsabilità che le donne avevano patito, ma anche scelto durante il drammatico periodo della guerra». L’eterno tema della lotta dei diritti, un cammino non ancora concluso. «Se ancora oggi parliamo della necessità di dare equilibrio alla rappresentanza fra donne e uomini», sottolinea Anna Rossi Doria, «questa incompiutezza è la spia che qualcosa non funziona. E che il diritto di rappresentanza delle donne non è ancora pienamente realizzato». DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 29 LE CELEBRAZIONI Molte le iniziative per i 60 anni del voto alle donne e l’anniversario della Costituente. La mostra “La Rinascita del Parlamento”, a cura della Fondazione della Camera dei deputati, si apre a Roma il 23 febbraio a Palazzo Montecitorio nella Sala della Regina (fino all’8 aprile, in seguito si sposterà in altre città italiane), con documenti, video e immagini. E con un settore dedicato alle “Donne della Costituente”. Manifestazioni in programma anche per il “Comitato promotore per le celebrazioni del voto alle donne” a cui fanno capo l’Istituto Luigi Sturzo, l’Istituto Gramsci e la Fondazione Basso, oltre ad altre istituzioni culturali. Il 2 marzo il Comitato presenterà a Roma, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, il libro “Le donne della Repubblica. Italiane al voto 1946-2006” LE ELEZIONI Sopra, una donna al voto il 2 giugno 1946 A destra e nella foto grande a sinistra, manifesti di propaganda dell’epoca In basso nella pagina accanto, le 21 elette alla Costituente in un articolo pubblicato dalla Domenica del Corriere nell’agosto 1946 Per le immagini si ringraziano la Fondazione Camera dei deputati, l’Istituto Luigi Sturzo e l’Istituto Gramsci “Parlavo nel vuoto, a fantasmi in ascolto dietro le persiane” MIRIAM MAFAI el 1946 avevo vent’anni. Troppo giovane per votare, ma l’età giusta per fare la campagna elettorale: incontri con le donne nei cortili delle case popolari, a Trastevere e Testaccio, preparazione e distribuzione di volantini, comizi nelle lontane borgate e, la domenica mattina, in piccoli paesi della provincia arrampicati sui tornanti delle montagne, Vicovaro, Sambuci, Saracinesco, Castel Madama, di fronte a piazze semivuote («ma tu, parla lo stesso» ti incoraggiavano i compagni «le donne ti ascoltano dietro le persiane chiuse»). Il 2 giugno si votava per il referendum — Repubblica o Monarchia — e per l’Assemblea Costituente. Nei nostri comizi, di solito, si parlava in due. All’uomo spettava il compito di parlare delle riforme, delle istanze democratiche, della differenza tra i vari partiti. Alla donna il compito di ricordare le sofferenze passate, la fame, la guerra, i caduti. Colpa di Mussolini e del fascismo, ma anche colpa del Re che aveva chiamato Mussolini al potere e non aveva impedito il disastro... Nei paesi il comizio era un evento e veniva annunciato da un “banditore”, con squilli di tromba e rullare di un tamburo. E la presenza di una donna sul palco era sempre motivo di richiamo e di novità. La Federazione del Pci, il mio partito, era allora al secondo piano di un palazzetto di Sant’Andrea della Valle. Da lì partiva, la domenica mattina presto, un camioncino carico di materiale di propaganda, manifesti e volantini, e noi giovani e ragazze sistemati alla meglio sulle panche. Ognuno scendeva nella piazza del paese che gli era stato assegnato, faceva il suo comizio, poi la riunione in sezione e aspettava fino a sera che il camioncino tornasse a riprenderlo per portarlo a Roma. Bisognava parlare facile, parlare semplice, farsi capire. Credo di aver detto anche, qualche volta, che anche Gesù era venuto in terra per difendere i più poveri, gli schiavi, gli oppressi. Non certo per difendere i padroni. Fu una campagna elettorale intensa, appassionata. Ma non cattiva come quella che si svolse due anni dopo, per le elezioni del 18 aprile, che videro un intervento più pesante della Chiesa e la minaccia della scomunica. La campagna elettorale del 2 giugno del 1946 fu una ubriacatura di politica. Si discuteva di politica, delle colpe del Re e di Mussolini, dovunque. A Roma, la Galleria Colonna era diventata una sorta di Hyde Corner, luogo di incontro per tutti gli appassionati di dibattiti, appuntamento per improvvisati capannelli in cui chiunque prendeva la parola, diceva la sua, litigava, accusando o difendendo il Re che ancora occupava il Quirinale. Alla vigilia ormai del 2 giugno venni promossa e scelta per un comizio in città, in Piazza Sforza Cesarini, uno slargo alberato davanti alla Chiesa Nuova. C’era un vero palco, sia pure di proporzioni ridotte, un microfono che funzionava e molta gente. Io cominciai a parlare di slancio. Ma a un certo punto riconobbi, tra la piccola folla che mi ascoltava, la faccia incuriosita e un po’ ironica di mio padre, con il quale da un paio d’anni avevo rotto ogni rapporto. La sua presenza mi imbarazzò, chiusi rapidamente senza entusiasmo (e senza successo) il mio comizio più importante. Poi arrivò il giorno delle elezioni. Il segretario della Federazione, Edoardo D’Onofrio (chiamato «il più comunista dei romani, il più romano dei comunisti») decise, non so perché, che avrei dovuto occuparmi dell’ufficio che raccoglieva i risultati elettorali. A distanza di sessant’anni ricordo ancora quell’incarico e quella notte come un incubo. I risultati arrivavano, dalle sezioni, disordinatamente o per telefono o con un compagno che li aveva trascritti, malamente, su un pezzo di carta. Noi, in una stanza della Federazione, al secondo piano di Sant’Andrea della Valle, attorno a un tavolo sul quale si accumulavano quei foglietti, tiravamo le somme, a mano. O forse c’era anche una calcolatrice. Passavano lentamente le ore. Il disordine, il fumo, l’ansia di tutti noi addetti all’ufficio e dei compagni che si affacciavano per conoscere gli ultimi risultati, si facevano di ora in ora più insopportabili. In città risultava in testa la Democrazia Cristiana, e questo era prevedibile. Ma, dai pezzetti di carta che ci arrivavano dalle sezioni, risultava che il Partito Repubblicano (sì, l’Edera) stava conquistando più voti di noi. Incredibile. Ormai era notte fonda. E quando, gonfia di caffè e di nicotina annunciai questi risultati a Edoardo D’Onofrio, lui mi fulminò con lo sguardo e mi ordinò: «Vai a casa». Me ne andai a casa, naturalmente. Ma purtroppo avevo ragione io. L’Edera ebbe, nel 1946 più voti di noi. E a Roma, anche a Roma (che vergogna...), la Monarchia, nonostante il buon risultato dei repubblicani, risultò vincente. Repubblica Nazionale 29 19/02/2006 N 30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 il racconto Tre libri da poco pubblicati in America celebrano e analizzano Storia e leggenda la figura del grande cacciatore di bisonti che recitò se stesso sul palcoscenico, diventando celeberrimo anche nell’Europa di fine Ottocento. Per i contemporanei fu l’incarnazione dell’eroe della Frontiera; oggi viene visto piuttosto come il padre dei grandi spettacoli di massa Buffalo Bill, il cowboy che inventò lo show-business ANTONIO MONDA NEW YORK È nato con il nome di William Frederick Cody nella Scott County dello Iowa, uno di quei luoghi che gli americani definiscono senza pietà «il centro del nulla». Ha imparato ad amare la solennità silenziosa delle praterie molti anni prima di diventare Buffalo Bill, e sin dalla gioventù passata nel Kansas ha capito che il destino di chi vive in un paese di frontiera è quello di reinventarsi continuamente. Ha fatto mille mestieri e si è macchiato di crimini che vanno dal furto di cavalli all’omicidio, ma è diventato famoso in tutto il mondo come grande cacciatore di bisonti, uccidendone, come dice la leggenda che lui stesso ha propagato, ben 4280 prima di intuire che la vita che aveva realmente vissuto, per quanto avventurosa ed estrema, non rappresentava altro che il canovaccio di uno spettacolo ben più grande e leggendario e, soprattutto, immortale. È stato insieme personaggio reale e interprete di se stesso, il massimo architetto del mito del Far West e la personificazione della battuta di John Ford, che spiegava come «quando la leggenda supera la realtà», nel West «si stampa la leggenda». È impossibile discernere oggi quanto ci sia di vero nelle mille avventure e negli altrettanti aneddoti che lo circondano da quanto invece sia stato diffuso ad arte, ed è certamente un segno dei tempi il fatto che siano pubblicati in America a distanza di poche settimane ben tre libri che ne celebrano e analizzano il mito, invitando a una riflessione sui modelli epici fondanti del Grande Paese. Se i titoli presentano esplicitamente le tesi dei rispettivi testi, dilungandosi sul momento in cui Cody portò il suo spettacolo in Italia (Buffalo’s Bill America: William Cody and the Wild West Show; Buffalo Bill, Annie Oakley and the Beginnings of Superstardom in America; Buffalo Bill in Bologna: the Americanization of the World), due saggi apparsi rispettivamente sulla New York Review of Books e sul New York Times ne immortalano la realtà più intima, e l’intuizione, estremamente moderna, che trasformò il cacciatore di bisonti in un grandissimo uomo di spettacolo: Showman of the Wild Frontier e The Entertainer. Non è certamente un caso che William Cody sia diventato il protagonista di operazioni smitizzanti come il Buffalo Bill e gli indiani di Robert Altman, e è illuminante la sostanziale ambivalenza storiografica sulla tempra morale di un personaggio che sfruttò la propria popolarità per sposare cause drasticamente opposte, arrivando a difendere strenuamente gli indiani dopo averli combattuti ferocemente e essersi anche vantato di aver vendicato l’onore del generale Custer strappando lo scalpo a un pellerossa. Ma l’impatto culturale di questi nuovi libri dimostra come nessun revisionismo possa scalfire la popolarità di un personaggio che visse a cavallo tra due epoche e intuì le potenzialità spettacolari e commerciali del far rivivere in forma di farsa quelle avventure che la vita gli aveva proposto una prima volta in chiave epica e tragica. Cody si trasferì nel Kansas all’età di undici anni e lì cominciò a cercare lavoro per aiutare la madre, ridotta quasi in miseria dopo che il padre, convinto abolizionista, era morto per le ferite riportate in una rissa con un uomo che difen- Combatté contro i Comanche, poi recitò con Toro Seduto. Così salvò il West dal declino Repubblica Nazionale 30 19/02/2006 trasformandolo in kermesse CON I BUTTERI La sfida con i “cowboy italiani” nella tenuta Caetani, nel 1890. Qui sotto, l’americano e la sua troupe all’udienza del Papa in Vaticano, nello stesso anno deva il “diritto” di possedere schiavi. A tredici anni si unì a un gruppo di cercatori d’oro e l’anno successivo, dopo un breve periodo in cui si cimentò come domatore di cavalli e conduttore di diligenze, riuscì a farsi assumere come pony express. Nel giro di poco tempo si accreditò come il più spericolato e veloce pony del West, quindi cominciò a lavorare come scout nel Quinto Cavalleggeri, combattendo in prima linea nelle campagne contro i Comanche. La guerra civile lo vide scendere in campo con la stessa qualifica tra i soldati dell’Unione, che lo elessero mascotte e portafortuna, e alla fine del conflitto cominciò a lavorare come operaio alla costruzione della Kansas Pacific Railroad. Nel giro di pochi giorni comprese che quel lavoro frustrava il suo amore per i grandi spazi e convinse i capireparto ad affidargli la responsabilità dell’approvvigionamento degli operai. Cody era consapevole che l’unico cibo reperibile nella zona erano le gigantesche mandrie di bisonti (in inglese buffalos) che vivevano nella sconfinate praterie e promise agli ex colleghi che non avrebbero mai patito la fame. Scoprì di avere un innato talento di cacciatore e cominciò a sterminare gli animali delle praterie a un ritmo impressionante. La leggenda del giovane cacciatore si propagò rapidamente per tutto il West, finché un altro grande cacciatore di bisonti di nome William Comstock lo sfidò a una gara di otto ore per decidere chi si sarebbe potuto fregiare del soprannome di “Buffalo Bill”. Cody vinse il duello in maniera umiliante per l’altro William, abbattendo, secondo diverse versioni della stessa leggenda, otto, undici o addirittura venti animali nell’arco delle otto ore. Il momento della consacrazione popolare e la diffusione del soprannome coincisero con l’idea di trasformare la propria esistenza in un grande spettacolo, e a appena 26 anni Buffalo Bill cominciò a mettere in scena le proprie gesta, grazie all’aiuto di uno scrittore di nome Ned Buntline che usava amplificarne la portata sino all’inverosimile. Per i primi anni diede al proprio personaggio il nome di “scout delle praterie”, alternando il lavoro di attore-impresario con quello di autentico scout, sempre al seguito dei soldati del Quinto Cavalleggeri, che erano estremamente divertiti di avere con loro nella campagna contro gli indiani una grande star, circondata da un’aura di infallibilità e di fortuna spudorata. Ci vollero undici anni prima che lo spettacolo si trasformasse nel Wild West Show. Cody comprese prima di molti altri che l’epopea del West era giunta al crepuscolo e seguendo i consigli dell’amico Wild Bill Hikcock mise in scena uno show gigantesco, molto più simile al circo che al teatro. Arrivò a scritturare cinquecento artisti alla volta, tra i quali autentici cowboy, indiani Lakota, cosacchi, vaqueros messicani e, per una stagione, lo stesso Toro Seduto. Lo spettacolo era un antesignano dei grandi kolossal hollywoodiani e riproponeva per un pubblico osannante una versione in cartapesta di quanto avveniva nelle praterie, offrendo versioni a dir poco romanzate di episodi storici quali la morte di Custer a Little Big Horn. Furono molti gli artisti che divennero celebri grazie al Wild West Show (Irving Berlin dedicò molti anni dopo il musical Annie get your gun a Annie Oakley, partner di Cody), ma soltanto Buffalo Bill era dotato di quella che oggi viene definita “star quality”. Dopo il trionfale debutto ad Omaha e l’elogio pubblico di Mark Twain, lo spettacolo iniziò una lunghissima tournée europea e divenne l’attrazione principale dei festeggiamenti del DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31 Pellerossa accampati a Torino IN GONDOLA William Cody in visita a Venezia, anno 1890. Al centro e in basso, manifesti pubblicitari del “Wild West Show”, 1888 Giubileo d’oro della regina Vittoria. I libri raccontano con minuzia i dettagli del periodo europeo (lasciando tuttavia qualche dubbio sull’episodio che vide Buffalo Bill sconfitto in una competizione con i butteri della Maremma), sottolineando come l’avventura imprenditoriale di Cody segni l’inizio della cosiddetta “superstardom” e un momento determinante nell’americanizzazione del mondo occidentale. Alla fine del XIX secolo Buffalo Bill era l’uomo più celebre del pianeta e tra i grandi ammiratori del suo spettacolo si annoverarono Rosa Bonheur, Paul Gauguin e Edward Munch. La leggenda vuole che Buffalo Bill sia diventato in quel periodo anche amante della regina Vittoria e che attraverso l’amicizia con il grande attore inglese Henry Irving abbia influenzato in maniera significativa Bram Stoker nella stesura di Dracula. Il successo planetario del Wild West Show, basato su una celebrazione nostalgica e completamente reinventata di un mondo che stava cambiando rapidamente, generò il paradosso di fa- re di Buffalo Bill un punto di riferimento culturale e persino politico. Alla fine degli anni Ottanta del XIX secolo cominciò a prendere posizione pubblicamente a favore degli indiani, auspicando che il governo non facesse «una sola promessa che non fosse poi in grado di rispettare» e spiegando ripetutamente che ogni atto di violenza perpetrato dai pellerossa era stato generato dai terribili soprusi che avevano subito. Nel 1894 si pronunciò a favore del voto alle donne e lanciò un appello pubblico affinché il governo limitasse la caccia ai bisonti, lamentandone il crudele e dissennato sterminio. È lo stesso periodo in cui fondò nel Wyoming una città che porta tuttora il nome di Cody e grazie a degli investitori newyorkesi riuscì a far deviare il corso di un fiume in modo da poter rendere fertile tutto il territorio limitrofo. Tuttavia gli enormi costi dell’ambizioso progetto lo portarono sull’orlo del fallimento e segnarono l’inizio del suo declino. La presa di posizione pubblica a favore dell’impegno militare americano in paesi stranieri alienò a Cody le simpatie di Mark Twain e di molti intellettuali. La causa di divorzio con la moglie Lulu, pubblicizzata oltre misura su tutta la stampa e densa di particolari grotteschi quali un presunto tentativo di avvelenamento, si risolse in un fiasco mediatico di proporzioni clamorose che compromise la sua immagine di eroe americano. Negli ultimi anni Cody si consolò visitando le città dove venivano messe in scena le sue gesta, divertendosi a farsi fotografare con gli attori che lo impersonavano. A chi gli chiedeva se fosse stato lui a inventare il personaggio di Buffalo Bill, spiegava che lui non era «un attore bensì una star» e che «tutti gli attori possono diventare star, ma non tutte le star possono diventare attori». LEONARDO COEN O TORINO ggi il Circo Bianco delle Olimpiadi Invernali. Cent’anni fa, il Circo del Selvaggio West di Buffalo Bill. È passato giusto un secolo, ma il fervore e le emozioni sono sempre le stesse. Quando nel marzo del 1906 arriva a Torino l’imponente carovana del colonnello Cody, trasportata su quattro treni, dalle 59 carrozze ferroviarie sbarcano 500 cavalli e 850 persone, «fra rudi cavalcatori, amazzoni e comparse di ogni colore», scriveranno le gazzette dell’epoca. Un armamentario da riempire due piazze. Tutto avviene ordinatamente e razionalmente, come fosse una perfetta manovra militare. Gli ufficiali della Regia Cavalleria restano stupiti dalla perfetta logistica che governa la spedizione americana. Sanno che in Germania i loro colleghi la stanno analizzando per carpirne i segreti. Sulle riviste del nostro esercito c’è spazio per quest’esotica intrusione: si parla del mitico Winchester, il fucile a ripetizione col quale Buffalo Bill accoppò più di quattromila bisonti in 17 mesi. La Stampa si sofferma a descrivere il notevole impegno alimentare che stava dietro l’insolito evento: «Nel mezzo dell’accampamento indiano, verso il viale della Crocetta, spiccano due enormi paioli per il caffè e il tè. Generi di conforto quotidiano si accompagnavano alle duemila uova, ai cinque quintali di carne, a dieci quintali di pane, a trecento litri di latte e ai quattro quintali di patate occorrenti per i pasti di un solo giorno». Ma non è la prima volta che Buffalo Bill arriva in Italia. Anzi, si può dire che la sua tournée è diventata un appuntamento quasi annuale. Ormai non c’è piccola o grande città del centro nord che non abbia ospitato la sua numerosa carovana. Il circo di Buffalo Bill spesso si accampa nelle periferie, o ai margini delle campagne. Nei paesi della Padania è tutto un sognare, è tutto un parlarne. «Gli indiani! Non ne sanno tanto, ma li hanno visti disegnati su qualche giornale e conoscono la fama della loro ferocia, delle battaglie che hanno sostenuto per decenni contro gli uomini bianchi, nelle praterie sterminate dell’America» (Eraldo Baldini, Bambini, ragni e altri predatori, Einaudi). L’Italia piace a Cody. Ci viene spesso: con la figlia è stato persino in Sardegna, dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza a Capri. A Napoli è gran successo, nel 1890, l’anno del primo viaggio italiano: il circo fa doverosa tappa a Roma, occupa le rive del Tevere. Presenta il suo spettacolo a papa Leone XIII, in Vaticano, invitato da Sua Santità che sta festeggiando l’anniversario della sua incoronazione: spassosa la ricostruzione di Nate Salsbury, veterano della Guerra civile, attore, showman e impresario. Artefice dell’incontro John Burke, devoto cattolico che ha convinto gli indiani che si tratta di un solenne appuntamento, perché il papa rappresenta Dio in Terra. Il novanta per cento dell’organico di Buffalo Bill si assiepa ordinatamente lungo il corridoio che si snoda dalla Cappella Sistina sino alla Sala della Sedia. Il corpo diplomatico è a ranghi completi. Gli indiani sono attratti dai magnifici colori delle Guardie svizzere, esprimono la loro ammirazione con suoni «gutturali». Ma quando ritornano all’accampamento scoprono che uno di loro è salito ai grandi pascoli del cielo: morto per infarto. Allora convocano un consiglio dei capi, protestano: siamo stati dal Grande Capo che dice di essere l’emissario di Manitu sulla Terra, perché non ha salvato il nostro compagno? Le spiegazioni di Burke non convincono gli indiani, i quali pretendono che si celebri il lutto tradizionale della loro gente. Nasce poi un’altra grana. I romani pretendono che il colonnello Cody si esibisca con i suoi cowboy e gli indiani dentro al Colosseo. Buffalo Bill fa il sopralluogo, sentenzia: «È troppo piccolo per la mia troupe e pieno di buche e di sassi: non posso svolgere il mio numero più spettacolare, l’assalto alla diligenza da parte dei pellerossa». I romani si offendono. Ne nasce un caso diplomatico. Il conte Caetani di Sermoneta, per smussare le polemiche, organizza una sfida coi butteri maremmani. Mette in palio mille lire (dieci milioni di oggi), più l’incasso. Una bella sommetta destinata a chi è più bravo nel domare i cavalli degli altri. L’8 marzo 1890 Augusto Imperatore detto Augustarello vince la sfida ma Buffalo Bill protesta, sostiene che le regole erano confuse e che è stato truffato. Scappa con la cassa dileggiato degli spettatori. L’episodio entrerà nell’iconografia della storia nazionalpopolare italiana, come la disfida di Barletta o la beffa di Buccari. Persino Emilio Salgari si lascerà sedurre da Buffalo Bill e scriverà tre articoli su L’Arena, sempre in quel meraviglioso marzo del 1890, raccontando mirabilie dell’esibizione, salendo addirittura dentro la diligenza. Nella sua fertile fantasia, il romanziere veronese ha già in mente di scrivere la saga della frontiera. DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 le storie Tre preziosissime piastre che il Gran Khan aveva dato al mercante veneziano come salvacondotto e che a lungo sono state considerate una fantasia in più tra le tante attribuite al “Milione”. Ora va in mostra a Venezia il testamento originale di Matteo Polo che nel 1310 le descrive e ne dispone il lascito. Confermando una storia affascinante FOTO ELECTA Documenti Marco Polo e le tavole d’oro, una leggenda vera ROBERTO BIANCHIN Repubblica Nazionale 33 19/02/2006 S VENEZIA e ne andava in giro sconsolato da vecchio, parlava da solo e scuoteva la testa. Quelli che incontrava, e che lo riconoscevano, si davano di gomito e ridevano e si facevano beffe di lui. Non gli credeva nessuno. Non credevano a quello che raccontava né a quanto aveva scritto, dettandolo a Rustichello da Pisa nel 1298, in carcere a Genova, nelle pagine del Milione. Fu il suo più grande cruccio. Non era servito a nulla, a messer Marco Polo, «savio e nobile cittadino di Vinegia», come si definiva, scrivere nel prologo che «le cose vedute dirà di veduta e l’altre per udita, acciò che ‘l nostro libro sia veritieri e sanza niuna menzogna». «È davvero un singolare paradosso che un libro sostanzialmente così realistico e positivo potesse essere ritenuto un contesto di fiabe e di menzogne dai contemporanei e dai loro discendenti fino ad un’epoca a noi prossima», scrive Maurizio Scarpari, docente di cinese all’università di Cà Foscari, nella prefazione alla versione trecentesca del Milione appena uscita da Einaudi. Del resto era difficile credere, in quello che era stato battezzato il «livre des merveilles», a tutte quelle storie all’apparenza strampalate di diavoli e briganti, santi e monarchi e bestie gigantesche. A uccelli che ghermivano gli elefanti con gli artigli e li sollevavano in volo, a popoli che potevano avere fino a cento mogli e le offrivano in dono agli ospiti, a sovrani che si dilettavano con sei fanciulle alla volta, a uomini «che hanno la coda lunga più di un palmo», e a popoli che hanno «testa di cane e mangiano tutti gli uomini che riescono a prendere». Lo stesso sospetto di esagerazione, millanteria, mistificazione, gravava sulla «storiella» delle tavole d’oro, grandi, massicce, istoriate e preziosissime, che il Gran Khan avrebbe donato, come lasciapassare, a Marco Polo, al padre Niccolò e allo zio Matteo. Quelle tavole invece, raffigurate in una preziosa miniatura custodita alla Biblioteca Nazionale di Parigi, esistevano davvero. La prova è contenuta in un documento del 1310, il testamento di Matteo Polo, che da martedì 21 febbraio fino al 1° marzo verrà esposto al Museo d’Arte Orientale di Cà Pesaro nell’ambito della mostra Dalla Cina a Venezia, vesti imperiali, porcellane e giade della dinastia Qing (1644-1911), un itinerario «tra draghi cinesi e antichi documenti veneziani». La rassegna è stata organizzata dalla Soprintendenza speciale per il polo museale venezia- A CA’ PESARO DAL 21 FEBBRAIO Nell’immagine in alto, la miniatura tratta dal “Livre des merveilles”, custodita nella Biblioteca Nazionale di Parigi, mostra Marco e Matteo Polo mentre ricevono da un ministro dal Gran Khan una “tavola d’oro”. Nelle immagini in basso (a cura della Sezione di fotoriproduzione dell’Archivio di Stato di Venezia), il testamento di Matteo Polo e, in evidenza, le righe sulle “tavole d’oro”. Il documento sarà esposto dal 21 febbraio al 1° marzo al Museo d’Arte Orientale di Ca’ Pesaro nella mostra “Dalla Cina a Venezia, vesti imperiali, porcellane e giade della dinastia Qing” no e dall’Archivio di Stato di Venezia in occasione del festival Il Drago e il Leone della Biennale Teatro diretto da Maurizio Scaparro e dedicato alla Cina, che inizierà appunto martedì. Si tratta di un documento eccezionale, conservato in ottime condizioni nei depositi dell’Archivio di Stato, che torna alla luce dopo 52 anni. Fu esposto una sola volta, nel 1954, in occasione di una mostra dedicata a Marco Polo. Sono due grandi fogli di pergamena, redatti in latino dallo zio di Marco Polo, Matteo, il 6 febbraio del 1310 a Venezia, alla presenza del notaio Pietro Pagano e di due testimoni. Un testamento preciso, dettagliatissimo, in cui Matteo incarica i suoi due nipoti, Marco e Stefano, di eseguire una serie di disposizioni, tra cui vari lasciti in favore di chiese e monasteri come San Mattia di Murano, San Lorenzo di Venezia, Santa Caterina di Mazzorbo. Inoltre assegna ai nipoti varie somme di denaro, quantificate in lire veneziane dell’epoca, e stabilisce che debba essere divisa tra loro la proprietà del palazzo di San Giovanni Grisostomo, accanto al teatro Malibran, dove abitava. Ed è qui, dopo l’elencazione di una serie di altri beni e di gioielli, «zoie incasate», che parla, per la prima e unica volta, delle mitiche tre tavole d’oro del Gran Khan: le «tribus tabulis de auro que fuerunt magnifici Chan Tartarorum». Così le definisce. Le tavole sono inserite in un elenco di lasciti al nipote Marco, il viaggiatore. L’autore del Milione, secondo Alessandra Schiavon dell’Archivio di Stato che ha curato la trascrizione del testamento, le avrebbe poi lasciate, una ciascuna, alle figlie Fantina, Moreta e Belella. Poi chissà. Una tavola risalirebbe al primo viaggio dei Polo in Cina, le altre due al secondo. Marco Polo ne parla più volte nel Milione. La prima all’inizio del libro, quando racconta che il Gran Khan diede loro «una piastra d’oro su cui era scritto che ai messaggeri, in qualunque parte andassero, fosse dato ciò di cui abbisognavano... e in tutti i posti dove giungevano erano resi loro i maggiori onori del mondo grazie alla piastra d’oro». In un altro capitolo Marco racconta che per un nuovo viaggio il Gran Khan «fece dare loro due placche d’oro e ordinò che avessero libero passaggio in tutte le sue terre e fossero completamente spesati, loro e i loro servitori, dovunque andassero». E una volta anche il re dell’isola di Giava, Chiacatu, diede loro quattro piastre d’oro su cui era scritto che «andavano serviti e onorati». Il «mercante illuminato», come lo chiama il regista Scaparro, almeno sulle tavole d’oro non aveva mentito. Segno che forse, anche sul resto, per quanto potesse apparire incredibile, aveva raccontato il vero. 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA i luoghi Cina segreta DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 Il cuore della capitale nasconde il quartiere dei vicoli, ricco degli storici “siheyuan”: le dimore a un piano, disposte a quadrilatero attorno a un giardino centrale Adesso i municipi e le università di Roma e Parigi sono stati chiamati ad avviarne il completo recupero Pechino restaura il labirinto delle tremila case imperiali FEDERICO RAMPINI Repubblica Nazionale 34 19/02/2006 S PECHINO pirito maligno non entrerai in casa mia. Se ci provi vai a sbattere contro una parete di mattoni nerastri, scolpita con un carattere che esprime scaramanzia e buon augurio per gli abitanti. I fantasmi cinesi non conoscono la curva e la diagonale, non hanno l’accortezza di aggirare l’ostacolo e imboccare il corridoio laterale per introdursi in casa e portare la malasorte. Così le regole del feng shui, la geomanzia, dettano la forma dell’ingresso. Sotto un grande arco in muratura il portone dipinto di rosso si apre su una muraglia color antracite che è l’insormontabile barriera contro i dèmoni. A zigzag si penetra nell’universo arcano della casa a forma di quadrilatero, con le stanze disposte intorno a un cortile chiuso. Le colonne di legno rosso sostengono il tetto a forma di pagoda, con le grondaie in pietra dalle eleganti estremità a forma di prua di nave. Le grosse travi portanti — fissate con l’arte sapiente dell’incastro senza chiodi né viti di metallo — sono decorate da pitture di paradisi celesti, paesaggi verdi e dorati, fiumi e monti sacri, motivi floreali, uccelli, dragoni e figure leggendarie. Al centro del cortile c’è il giardino alberato. Questo è lo siheyuan — letteralmente “cortile chiuso da quattro lati” — la casa tradizionale cinese di un solo piano. Dopo mezzo secolo di furiose demolizioni e costruzioni che a ondate hanno stravolto la fisionomia urbana di Pechino, resta ancora nel cuore della capitale una zona segreta che nasconde tremila siheyuan. È la città degli hutong, il labirinto impenetrabile dei vicoli. I “bassi” di Pechino sorgono a ridosso del Palazzo imperiale perché erano i quartieri nobili dove vivevano i dignitari di corte, gli alti funzionari del mandarinato, e intorno a loro gli artisti e gli artigiani al servizio dei potenti. Alcuni di questi tesori architettonici sono così invisibili che ci vuole un lavoro da archeologi per riscoprirli e riportarne alla luce le bellezze. I turisti che visitano la città vecchia sui rickshaw a pedali passano di fianco a molti capolavori senza poterli riconoscere. Le dimore tradizionali sono sepolte sotto spessi strati di storia: il crollo dell’impero, l’occupazione giapponese, la guerra civile, il comunismo maoista, la Rivoluzione culturale e infine il boom economico hanno sedimentato scorie e volgarità sopra quei gioielli. La fuga dell’aristocrazia e dell’alta borghesia, la povertà, la sovrappopolazione, per decen- L’ingresso si apre su una muraglia che è la barriera contro i démoni Il vero percorso d’entrata è a zigzag ni hanno aggiunto ai siheyuan miriadi di costruzioni abusive: misere casupole hanno intasato i cortili signorili perché cinque o dieci famiglie potessero abitare dove prima ce n’era una sola, e poi botteghe, bettole e ristorantini, formicai brulicanti di vita e di attività si sono infilati in ogni spazio libero, occupando ogni interstizio nel dedalo dei vicoli. Ma sotto il tessuto molle e pasticciato dell’abusivismo povero, sotto la polvere della decadenza secolare, molti edifici storici sono miracolosamente intatti. La loro prima trama urbanistica risale addirittura al 1200, la maggior parte delle costruzioni superstiti sono del Settecento. In una di queste aree, fra il laghetto imperiale Houhai e la maestosa Torre del Tamburo, è iniziata un’operazione di restauro senza precedenti. Il governo cinese e le autorità municipali hanno finalmente capito che questo patrimonio ha un valore inestimabile, merita di salvarsi anziché essere raso al suolo per far posto a nuovi grattacieli (com’è accaduto nel resto della capitale). Hanno chiesto consulenze al Campidoglio e al Comune di Parigi, alle università di Sciences Politiques e La Sapienza, alla società Risorse per Roma specializzata nelle operazioni di recupero dei centri storici. Sono arrivati finanziamenti dall’Unesco e dall’Unione europea. In due anni di lavoro gli esperti cinesi e internazionali hanno catalogato le meraviglie nascoste in questo quartiere. C’è la villa principesca del generale Zhang Zhidong (1837-1909) che fu governatore della provincia dello Hubei nella tarda dinastia Qing, vicino a quella del generale Zhang Aiping, Signore della Guerra. C’è la casa dell’eunuco favorito dell’imperatrice Cixi, e c’è il siheyuan di En Hai che assassinò l’ambasciatore tedesco durante la rivolta dei Boxer del 1900. Alcuni abitanti del quartiere conoscono bene la storia di queste pietre. La signora Zhang Shuzhen, 81 anni, sa di aver abitato per tutta la sua vita nella casa del celebre generalegovernatore: «Un tempo il cortile interno era gigantesco e il viale d’ingresso arrivava fino al lago. La mia casupola è una di quelle che occupano l’antico giardino privato, dove cent’anni fa il proprietario invitava la troupe di attori-cantanti dell’Opera di Pechino per intrattenerlo nelle sue feste». In quello spazio ora sono accatastate aggiunte brutte e precarie che fungono da camere da letto, cucine, ripostigli. Non hanno riscaldamento centrale e neppure i bagni, le loro toilette sono quelle pubbliche. «Anche la ex casa padronale è così malconcia che ogni inverno il tetto cede e qualche stanza si allaga». Forse solo i piccioni ammaestrati che si alzano in volo coi primi tepori primaverili riescono a scorgere dall’alto le ultime vestigia di topografia delle gerarchie sociali di una Cina scomparsa: i colori dei tetti erano rigidamente definiti in base al rango, tegole gialle per l’imperatore, verdi per le dimore principesche e dell’alta aristocrazia, grigie per le case dei borghesi. Costruirsi un tetto del co- ‘‘ Lao She Dietro il muro a Sud si estendeva il piccolo cortile di un vecchio negozio di incenso e di candele dove venivano messi a seccare i bastoni di incenso destinati al culto di Buddha e dove erano stati piantati alcuni salici piangenti che riempivano lo spazio sul retro della casa dei Qi 1 Da QUATTRO GENERAZIONI SOTTO UN SOLO TETTO 1 CORTILE Qui accanto, lo schema di una casaquadrilatero Il cortile (a sinistra) è circondato dalle stanze e racchiude un’area verde lore sbagliato era un’arroganza imperdonabile, l’offesa valeva la pena di morte. Il quartiere a nord della Città proibita era ricco di ville principesche per una ragione precisa: l’imperatore viveva con un esercito di concubine custodite dagli eunuchi; non appena i suoi figli maschi raggiungevano la pubertà era indispensabile allontanarli dalle tentazioni; perciò si costruivano dimore sfarzose al di fuori delle mura del Palazzo. Queste residenze principesche, riproduzioni in miniatura della Città proibita, stabilivano il paradigma estetico dell’epoca. Attorno a loro, mandarini, generali e ricchi mercanti si facevano i loro siheyuan su scala più piccola ma imitando i canoni di bellezza dell’aristocrazia. Il codice degli status symbol di allora ha lasciato delle tracce per chi le sa deci- 2 TEGOLE Le tegole dei “siheyuan” avevano colori obbligati: gialle per l’Imperatore, verdi per le case della nobiltà, grigie per quelle dei borghesi DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 4 ‘‘ FENG SHUI Secondo le regole del feng shui, l’arco e il portone rosso si aprivano su una muraglia nera capace di bloccare i demoni L’entrata vera era invece laterale 2 4 Lao She Rispetto agli altri abitanti del vicolo, egli si considerava davvero fortunato: da oltre quarant’anni abitava nello stesso posto. I suoi vicini, invece, erano venuti da fuori o avevano dovuto traslocare e rari erano coloro che dimoravano in quel luogo da più di vent’anni Repubblica Nazionale 35 19/02/2006 Da QUATTRO GENERAZIONI SOTTO UN SOLO TETTO 3 US ILL 3 PORTONE Il portone si apriva sul reticolo dei vicoli ed era ornato con battenti di fattura squisita (foto) Nella foto grande, “siheyuan” a Pechino IO AZ TR N TA CO MIR NE GH I LIN ER frare. Quattro “lancette” di pietra ottagonale sopra il portone d’ingresso segnalano la casa di un mandarino di rango superiore (i proprietari attuali continuano la tradizione di appendervi alla festa della primavera i festoni di carta rossa con la calligrafia augurale: «Sentendo i fuochi d’artificio è l’anno vecchio che si conclude, vedendo sbocciare le prime gemme è l’anno nuovo che arriva»). Due marmi scolpiti a forma di tamburo, sovrastati da leoni, indicano l’ingresso del siheyuan di un ricco mercante. La dimensione del cortile interno è un altro segnale della posizione del proprietario nella piramide del potere imperiale. Alcuni erano veri e propri parchi “arredati” con piccole riproduzioni di catene montuose, ruscelli e cascate artificiali, ponticelli e vasche di pesci. Anche la più modesta delle case-quadrilatero custodisce piante deliziose: i melograni simbolo di fertilità, le magnolie e i cachi, i gingko dalla radice di ginseng, le giuggiole, i grandi salici e i superbi bonsai. Pechino pullula di alberi pregiati, il decano è una sofora della dinastia Tang che ha settecento anni, in uno studio dietro il giardino Beihai. I più belli sono protetti fra le mura dei cortili dei siheyuan, ma la regola imperiale che imponeva case di un solo piano offre a tutti il piacere di ammirare le loro chiome, che spuntano oltre i tetti e i muri di cinta dei cortili. Di qualunque rango sociale, gli abitanti della città vecchia si legavano di un affetto tenace a questi luoghi, chi era nato fra i vicoli voleva morirci. Qui aveva le sue radici il vero popolo di Pechino, con il suo dialetto e il suo umorismo, i proverbi e le leggende, che fu la materia prima della letteratura cinese del Novecento: nei siheyuan hanno vissuto i più grandi scrittori nazionali, da Lu Xun a Mei Lanfang, e lo spirito degli hutong è immortalato dal romanziere Lao She nella saga Quattro generazioni sotto un tetto degli anni Quaranta. La cultura dei vicoli è così forte che ha impregnato anche le generazioni affluite negli ultimi cinquant’anni, quelli che hanno invaso i cortili dei nobili per costruirci loculi e officine. Le vestigia del passato sono state riciclate per usi nuovi: un’antica stele di marmo con incisioni preziose, dove un tempo i domestici si sedevano ad attendere i mandarini per aiutarli a scendere dalla portantina, ora è usata come tavolo da gioco per le partite di mah-jong. Rivivono all’ombra delle calli le tradizioni dei mestieri di strada: arrotini e calligrafi, venditori ambulanti di patate dolci arrostite, barbieri e dentisti da marciapiede, guidatori di rickshaw e maestri di musica. Qualcuno di loro è un lontano erede della servitù imperiale. Pochi anni fa è morto centenario Sun Yaoting, l’ultimo eunuco della Città Proibita. Il professor Li, matematico in pensione, discendente dei cuochi di corte, in una rustica osteria con quattro tavole ricrea magicamente la tradizione della sofisticata cucina imperiale. Il vecchio calzolaio Peng che forniva pantofole su misura per il fondatore della Cina comunista Mao Zedong e il suo primo ministro Zhou Enlai, è l’ultimo a saper confezionare le scarpe di 12 centimetri per i “gigli dorati”, come si chiamavano i piedini fasciati delle donne dell’èra antica. Anche i più poveri hanno rispettato una delle regole sacre che presiedono la vita in uno siheyuan: le stanze esposte a sud, più riscaldate dal sole, toccano di rigore agli anziani della famiglia. È un popolo caparbio nel difendere i suoi riti come il nuoto nel lago Houhai in tutte le stagioni dell’anno (d’inverno vanno a bucare il ghiaccio col piccone): quando la polizia ha vietato la balneazione per motivi di igiene e salute pubblica, il club degli incalliti nuotatori ha portato una petizione fino al Parlamento. Ma la loro capacità di resistere ha un limite. Il grande piano di recupero del quartiere riporterà alla luce le bellezze dell’architettura antica, non salverà il tessuto sociale. Alle istituzioni internazionali le autorità locali hanno fatto credere che gli abitanti avranno il diritto di rimanere. Loro sanno che non è vero. Xie Guozhong, 45 anni, è nato in uno di questi siheyuan, la sua infanzia l’ha trascorsa in un cortile sotto le querce e i nespoli. «È il più bel posto al mondo dove potessi vivere, ricorderò per sempre questi fiori, i giochi da bambino nei percorsi segreti dei vicoli che conosciamo solo noi. Per ricostituire questa casa com’era cent’anni fa noi dobbiamo andarcene. Con i soldi che ci offre il comune non potremo mai più permetterci di abitare qui, dovremo andare in una casa popolare, alla periferia di Pechino». Quel che accadrà nei prossimi anni è già scritto nelle regole del mercato. Un autentico siheyuan d’epoca restaurato a regola d’arte e con l’aggiunta dei comfort moderni va a ruba tra le agenzie immobiliari. Non se ne trovano per meno di un milione di euro. Tra i nuovi abitanti della zona sono comparsi il magnate della televisione Rupert Murdoch, il fondatore di Yahoo Jerry Yang, l’ex presidente della Goldman Sachs John Thornton. Del resto il valore di queste case lo aveva perfettamente capito la nomenklatura comunista. Mao Zedong fece radere al suolo interi quartieri di Pechino per costruire autostrade urbane e orridi palazzoni in stile sovietico, ma abitò per tutta la sua vita in un siheyuan. Mao Zedong ha abitato per tutta la sua vita in un “siheyuan” Oggi se li disputano i magnati occidentali 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 Esce “Il primo bicchiere, come sempre, è il migliore”, una raccolta di poesie mai pubblicate in Italia che ricordano le inquietudini giovanili di uno scrittore entrato nella leggenda. Un artista convinto che le parole abbiano il potere di uccidere o resuscitare, un funambolo che viveva sull’abisso. Sono testi del ventennio Settanta-Novanta, che descrivono l’universo di un individuo tormentato, che ha sempre cercato di toccare l’inferno. Sicuro che fosse il solo modo di redimersi da un’epoca indecente le poesie CONDIVIDI IL DOLORE ho avuto uno scazzo con il padrone [e la padrona di casa perché non c’era nient’altro da fare. non dovresti far venire tutte quelle puttane [e quegli scoppiati a casa tua, ha detto la padrona. io e il padrone siamo usciti per menarci. lui mi ha preso [per il collo e io gli ho tirato un cazzotto in pancia e siamo andati a sbattere contro un albero e poi lei ha interrotto la lotta quando abbiamo spezzato l’albero. ti potrei ammazzare, ha detto il padrone, ma che ci guadagno? sei il mio inquilino. grazie compare, ho risposto. siamo rientrati e ci siamo seduti e il padrone aveva una grossa insalatiera a centro tavola. ci ha versato del whisky e ci ha versato del vino e ci ha versato della birra e poi ci ha versato due litri di 7-Up. già che c’era poteva buttarci dentro pure gli alka-seltzer. le tette spenzolano dalle vacche, ho detto, e la mia terra è la tua terra. maledetto imbecille, ha detto la padrona, [checcazzo ne sai di vacche? mi sa che non ci sei [neanche mai stato in una fattoria. sissignora, ho risposto, cioè, no, nossignora. dai, ha detto il padrone, pescaci dentro [e fatti un bel bicchierone. come un maledetto imbecille, ci ho pescato. [la rivoluzione era di là da venire. SPEZZATO non c’è nessuna giustificazione non c’è nessuna bugia nessuna verità nessun amore... non c’è nessun rimorchiatore, gatto, cane, pesce, cielo. perfino il vostro soffrire è un miraggio. non c’è nessun contratto non c’è nessun onore nessun mandante, e la ragione se n’è andata a pesca nel deserto. non c’è nessuna base razionale non c’è nessuna nobiltà. un laccio da scarpe spezzato è la tragedia: non le mani mie che strangolano quel minuscolo luogo che chiamate amore. Bukowski poesie inedite ANTONIO GNOLI Q uando gli anni Sessanta stavano per far esplodere la loro esistenza, c’era anche Charles Bukowski (1920-1994) con la mano sul detonatore. Aveva lavorato in un mattatoio, era stato portiere di un bordello, renitente alla leva. Perdigiorno. Sempre in bilico su un abisso di ricordi che gli picchiavano in testa come martelli. Aveva l’aria trasandata di uno che nella vita pensava solo a farsi male: alcol, donne, parole. La scommessa alla fine non era come ma quando sarebbe finito all’inferno. Bukowski è stato il meglio e il peggio della letteratura. Il meglio e il peggio delle frasi sferzanti dettate con disinvolta e micidiale acredine. Non ce l’aveva con il mondo. Ce l’aveva con l’universo intero, con le costellazioni, con le stelle morte, con i paradisi che la gente normale immagina come ricompensa. Lavorò per alcuni anni in un ufficio postale. Ma restava poeta e narratore del risentimento. Le sue poesie somigliano ai suoi racconti. Pallottole che crivellano la vita. Nessuna vera differenza troverete fra i racconti raccolti in Storie di ordinaria follia e le poesie di L’amore è un cane che viene dall’inferno. Bukowski fu la leggenda, perché in una società di miti scarsi e asfittici, era diventato l’icona della diversità. La reincarnazione di un piccolo dio capriccioso e provocatorio capace di ferire e di guarire come pochi. Pensava che le parole avessero il potere di uccidere e di resuscitare. Credeva che bastasse parlare di sé, per mettersi davvero ai margini della vita e palleggiare come un virtuoso solo sa fare. Ecco. Fu un grande palleggiatore: toc, toc, toc. Un’infinita meravigliosa capacità di tenere permanentemente la palla sospesa a mezz’aria. Vita da funambolo, ma da fermo. Quale continente ci ha restituito? Quale America ha preso di mira? Quali sogni ha voluto scardinare? Ora esce Il primo bicchiere come sempre è il migliore, una raccolta di poesie (Minimum Fax, traduzione di Damiano Abeni) che fa seguito a Seduto sul bordo del letto mi finisco una birra nel buio. Poesie a loro modo belle e grottesche. A loro modo esemplari. Il verso si deposita asciutto sulla pagina, come un racconto stringato. Stretto in un ritmo che musicalmente rimanda al jazz e per le atmosfere letterarie alla rudezza ironica di Fante e alla malinconia di Chandler. Sono poesie sull’adolescenza e sul turbamento: «Dovevamo avere 14 o 15 anni/e ce ne stavamo seduti al cinema/ed ecco che sullo schermo arriva una bionda/dagli occhi pallidi e vuoti/e il mio amico mi dà di gomito e dice:/ “Cristo, Hank, guarda che labbra!/ guarda come sono bagnate quelle labbra!/voglio baciare quelle DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 LA NUOVA RACCOLTA A sinistra, la copertina de “Il primo bicchiere, come sempre, è il migliore” la raccolta di poesie di Charles Bukowski in uscita in Italia per Minimum Fax. Si tratta del dodicesimo volume del “Progetto Bukowski”, dedicato dalla casa editrice alle opere dello scrittore Nella foto grande, “Hank” in una scena di “Bukowski: Born into This” il documentario realizzato nel 2003 da John Dullaghan. Nelle immagini sotto, Bukowski al lavoro davanti al computer e con una birra in mano abbracciato a una compagna occasionale le poesie FOTO AFP CENA, DOLORE & TRASPORTO Repubblica Nazionale 37 19/02/2006 FOTO J. LEVINE U. ALBERTS Pallottole sulla vita i suoi versi ritrovati La ricerca dell’eccesso FOTO FARABOLA viene considerata la cifra della sua esistenza Ma sullo sfondo c’è la profonda tristezza di una persona che ha smarrito il senso della bellezza del mondo labbra!”/“e dai, Cristo”, gli ho detto, “chiudi il/becco!”/tutta la gente che ci stava intorno lo/sentiva». C’è una nostalgia aggressiva, cosparsa di ricordi fulminanti che strappano bettole al neon e infime stanze d’albergo alle notti cui sono condannate: «La mia camera stava a un isolato di distanza/aprivo il bar alle 5 di mattina e/lo chiudevo alle/2 di notte/ spesso il buio e la luce mi si/ mischiavano/me ne stavo lì seduto e si era al bicchiere/della staffa/un attimo dopo il sole/era sorto e io me ne stavo/ancora lì.../ 5 anni di quel bar/e nessuno è venuto a/prendermi.../in realtà quello che mi ha portato via da/quel bar/è stato l’avvento della/ televisione/che proprio allora stava/iniziando.../qualcosa era morto/in America/per sempre/avevo finito i miei 5 anni/su quello sgabello/in fondo al bancone/appena in/tempo». Le poesie di Bukowski sono senza redenzione, ricordi che, in mancanza di futuro su cui sputare, prendono a pugni il passato. Il racconto che egli fa del mondo ha la stessa fatale necessità del gesto animale. Bracca un dettaglio come la leonessa il collo di uno gnu. Il suo stile è la sua fame: la presa diretta sulle cose da divorare: «Lo stile», scrisse, «è importante. Tanta gente urla la verità, ma senza stile è inutile, non serve». La forza muscolare dei suoi versi è fatta di resistenza e provocazione. Mai un’incertezza, mai un dubbio, mai un ripensamento. Mai un idillio che non fosse con la disperazione, la pietà e l’orrore. Bukowski ha indagato l’universo dal basso. Non ha mai cercato un centro, ma sempre un altro gradino da poter scendere, per avvicinarsi a quell’inferno che per lui era il solo modo di redimersi da un’epoca indecente. Ostentava disprezzo per la cultura ufficiale. Commentò in maniera impareggiabile: «I camerieri leggevano Truman Capote. Io leggevo solo i risultati delle corse». Alcol a gogò e ippodromi dove scommettere. Ha amato il whisky, le donne il baseball e i cavalli. Del vecchio Hank — così lo chiamavano gli amici — resta qualcosa più del colore, una lunga e irrisolta rabbia che animò racconti e poesie. È facile dire oggi che è stato uno scrittore maledetto. È facile dire che l’eccesso è stata la sua cifra. Quella faccia che sembrava tormentata da un trapano e su cui troneggiava un naso che ricordava un violaceo tulipano olandese nascondeva una tristezza infinita. La malinconia dell’uomo che ha smarrito le sue notti e il senso della bellezza del mondo: «La cosa più immensa della bellezza è capire che è scomparsa», disse. Erano gli anni delle sbornie infinite. E degli ideali degradati. Nessun prezzo fu mai talmente alto da vietargli di parlare quasi sempre di sé. Viveva teatralmente il proprio scrivere. Il suo corpo era la sua scrittura. Guardate quella foto di lui, davanti a un frigorifero, avvinghiato a una compagna di strada. Sembrano due naufraghi su una deriva urbana. Ecco il vero Bukowski: la lattina di birra strozzata in una mano, lo sguardo ironico e il pancione in vista tra una maglietta troppo corta e un pantalone troppo basso. È da lì che bisogna ripartire per entrare nel linguaggio della sua poesia. percorro adagio la strada delle streghe, banale e bruciante mangio in tavole calde dove i filobus passano sopra il tetto, e ricevo letterine del sindaco che mi chiedono di uccidere pallidi ragazzi in bicicletta; è un’epoca indecente quando i mitragliatori stanno zitti e le nuvole non nascondono niente in guance di bignè; posso profetizzare il male con la forza di un martello pneumatico che spacca una stupida strada; mi pulisco la bocca e conto le sbarre della balaustrata, contemplo lo spazio bianco tra le gambe del cameriere mentre corre a portarmi il conto; fuori, è lo stesso: i diavoli bevono dalle mammelle di vergini stupefatte; sta cominciando a piovere: macchia, macchia, macchia, le gocce sporche di vino tulipano... compro un giornale all’angolo, lo piego come un cobra addormentato e me ne sto lì me ne sto lì a disegnare figure per aria, figure zozze e cattedrali, lucertole scotennate, miracoli sbronzi; poi prendo il bus delle sei e un quarto e torno alla mia stanza; è una stanza che cattura mosche e carte e bicchieri polverosi, cattura me, e io ci dormirò per risvegliarmi sotto la mano [ dello specializzando dentro una luce malata, o sarà il sapore rosso del fuoco, il fumo che canta come questi uccelli nelle mie pareti. TUTTO QUELLO le uniche cose che mi ricordo di New York d’estate sono le scale antincendio e la gente che esce sulle scale antincendio la sera quando il sole tramonta dall’altra parte dei palazzi e alcuni si sdraiano lì a dormire mentre altri stanno seduti tranquilli al fresco. e su molti dei davanzali ci sono vasi di gerani o cassette piene di gerani rossi e la gente seminuda se ne sta lì sulle scale antincendio e ci sono gerani rossi dappertutto. in realtà questo è uno spettacolo da vedere piuttosto che da raccontare. è come un gran quadro multicolore e sorprendente che non è appeso da nessun’altra parte. 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 la lettura Il Touring Club nacque nel 1894 come associazione ciclistica. Tra i suoi 57 fondatori c’erano industriali, editori, professionisti della borghesia milanese. L’intento di quegli appassionati “velocipedisti” era far scoprire il paese da poco unificato ai cittadini di ogni ceto. Un volume a giorni in libreria ricostruisce questa storia Tempo libero Su due ruote per fare l’Italia EDMONDO BERSELLI arel’Italia pedalando: la “nazionalizzazione” del Paese, della sua società come della sua geografia, con il suo panorama di città, cattedrali, paesi, campanili, valli, montagne e colline, si può realizzare anche su due ruote. Era questo il pensiero di 57 pionieri della bicicletta, riunitisi l’8 novembre 1894 per costituire il Touring Club Ciclistico Italiano. La sede dell’incontro era il milanese Albergo degli Angioli, vicino al Duomo, e fra loro figurava la crema della borghesia milanese. Industriali come Luigi Bertarelli e Alberto Riva; un grande editore musicale come Giuseppe Ricordi; professionisti vari, una summa della haute meneghina. Erano tutti convinti che l’Italia nuova avesse bisogno di dinamismo, non di oziosità arcadiche; e che occorresse guardare alla modernità straniera, che in pochi anni aveva affollato di bicycle touring club l’intera Europa. In Italia i primi “velocipedisti” erano apparsi alla fine degli anni Sessanta dell’Ottocento. Quel meeting ambrosiano che fonde positivismo lombardo, orgoglio nazionale e passione sportiva, in un clima «da salotto buono della borghesia tardo ottocentesca», è ricordato dallo storico Giuseppe Pivato in un libro che esce in questi giorni per i tipi del Mulino. Si intitola Il Touring Club Italiano (pagg. 162, euro 12) e offre lo scorcio di un’Italia allo stato nascente. Se fino a qualche decennio prima la penisola era poco più che un’espressione geografica, e se dalla fine del Cinquecento era la terra del Grand Tour, il Touring nasce proprio con l’intenzione di cambiare la prospettiva: all’Italia «vista da fuori», vuole sostituire un’Italia «vista da dentro, percorsa e scoperta da chi l’abita». Pivato, che insegna a Urbino ed è uno studioso di storia sociale attentissimo ai fenomeni popolari (dall’onomastica politica agli inni politici), ricorda che il fondatore del Touring Club, Luigi Bertarelli, aveva ben chiari gli obiettivi della nuova associazione: «Adoperarsi perché non sia più, quella degli italiani, solo una platonica aspirazione alla conoscenza del loro Paese». Ossia fare in modo che «essi debbano conoscerlo davvero, non soltanto per udito dire, non soltanto per convenzionale abitudine di ripetere nomi noti di paesi che non si conoscono, di aprire bocca ad esclamazioni di stereotipa ammirazione per meraviglie che si dice esistano, ma che non si sono mai viste!». Mentre il proletariato solca i mari sulle rotte dell’emigrazione, cercando di sfuggire alla patria povertà, una borghesia emergente e modernista cerca la propria strada, e il veicolo per percorrerla. Se la scrittrice Matilde Serao, madre dell’italianità, prescrive i capi d’abbigliamento che il buon borghese di stampo nuovo, uno sportsman aristocratico ed evidentemente sfaccendato, deve mettere nel suo bagaglio delle vacanze («costume da cavallo, da velocipede, da tennis, da polo, da caccia, da canottiere, da alpinista, da bagno di mare, da scherma»), il panorama vacanziero è ancora costellato da abiti e costumi da ancien régime, anche in spiaggia: «Calze, ombrellini, velette». Ed è proprio al paese delle velette e degli ombrellini da sole che il Touring «oppone la fatica della pedalata e l’abbigliamento popolare del ciclista»: ossia una maglia a rete posta immediatamente sulla pelle; una di lana a collo dritto e sufficientemente alto; un panciotto e una giacca della medesima stoffa, larghi quanto basta per lasciare liberi i movimenti. Così bardata, si profila una figura inedita: il «tourista». L’emanazione di un’élite? In parte sì, naturalmente. Ma anche il protagonista «niente affatto secondario in quell’opera di costruzione dell’identità civile di massa che costituisce uno dei disegni principali delle classi dirigenti». Cioè il compito di fare gli italiani dopo avere fatto l’Italia, secondo il monito attribuito a Massimo D’Azeglio. Il fondatore Bertarelli lo aveva chiarissimo, se è vero che nel 1901, chiudendo un convegno a Bologna, «con una prosa dal sapore carducciano» aveva esclamato: «Datemi l’appoggio del sentimento, datemi l’anima infine, e con questa, perdio, sì l’Italia — e il Touring l’aiuterà — l’Italia farà gli italiani». Repubblica Nazionale 38 19/02/2006 FOTO ARCHIVI ALINARI - ARCHIVIO BALOCCHI, FIRENZE F IL LIBRO DEL MULINO E LE FOTO ALINARI SU INTERNET Il libro di Stefano Pivato “Il Touring Club Italiano” viene proposto dal Mulino con una particolare formula editoriale. Al costo di 4 euro per un anno, i lettori possono consultare il sito web www.fotografiaeturismo.alinari.it, che contiene una selezione di 400 fotografie degli Archivi Alinari sulla storia del turismo in Italia, come quella qui sopra Il Touring Club Ciclistico era «una missione». Missione deamicisiana, patriottica, risorgimentale, atletica, di un popolo «allenato alla modernità dei “giochi inglesi” che preparano la mente alla libera iniziativa». Un programma per l’Italia umbertina. Ma anche un programma per il secolo nuovo. E un programma a suo modo ideologico, perché gli scopi statutari del Touring sono espliciti: la bicicletta è un mezzo «tendente a diminuire la distanza sociale che divide le classi meno abbienti da quelle più ricche». Quasi una religione, un mazzinianesimo a pedali. Con l’Italia che infatti pedala, metafora di un impegno equivalente nello sport come nel lavoro, e con la bicicletta, scrive Pi- I cattolici guardarono il sodalizio con sospetto e proposero in alternativa il podismo, “metodo sportivo di san Francesco” vato, che è «veicolo di una filosofia popolare improntata all’etica della fatica e del sudore». Ma in questo modo l’interclassismo a due ruote contiene anche un valore insidiosamente sovversivo, benché Bertarelli si sforzi di rilevare l’anima borghese del suo club (da parte sua, il movimento socialista comincerà presto a organizzare i propri club ciclistici, i «ciclisti rossi», per differenziarsi anche dal nazionalismo del Touring, che avrebbe trovato il suo acme con i tour «sui campi delle patrie battaglie»). Inoltre, in un paese così religioso, furono ben presto i cattolici a guardare con sospetto alla filosofia del Club: «Le sue origini liberali (e dunque massoniche secondo una equazione diffusa nella mentalità cattolica del tempo) non fanno certo odorare d’incenso il Touring». Così, ricorda l’autore, il maître à penser dello sport cattolico agli inizi del Novecento, Giovanni Semeria, provvede a esorcizzare le due ruote, «utensile di lusso» inadatto a «quest’alba democratica» e invita a imitare «i metodi sportivi di san Francesco». Quindi: «Andate a piedi, moltiplicate le gite podistiche». Accompagnato dal parere pro veritate dell’Osservatore Romano, secondo cui «il velocipedismo è una vera anarchia del mondo», proprio come «l’anarchia è un vero velocipedismo nel mondo della vita sociale». Questo perché «il velocipedista non è un pedone, non è un cocchiere di carrozza, non è un macchinista di ferrovia, non è un animale da tiro o da soma: è un che di ermafrodito…». A cui seguono i vescovi che proibiscono la bicicletta al clero, minacciando pene severissime e perfino sospendendo a divinis i colpevoli. Proibizioni e castighi che provocano domande causidiche: può il prete nel caso di un malato grave inforcare la bicicletta «nonostante il superiore divieto», si chiede un parroco della provincia di Ravenna? E conclude questo primo caso di «morale ciclistica» con un pragmatismo tipicamente romagnolo: «Lo può». Altrove si costituiscono comitati di preti «pro bicicletta», che rivendicano l’uso del biciclo «levita», ossia con la canna da donna, necessaria per non rimboccare ignominiosamente la tonaca. Ma non ci si può opporre al carducciano Satana del progresso. Alla fine dell’Ottocento erano apparse numerose fabbriche di biciclette: dopo la storica azienda di Edoardo Bianchi fondata nel 1885, in pochi anni erano sorte Olympia, Velo, Maino, Dei, Frera, Lugia, Taurense Legnano, Atala, Torpado, Ganna. I comuni avevano emanato disposizioni per far fronte al traffico: «Chi usa il velocipede dovrà portare attorno al braccio destro una fascia nera, sulla quale sia trapunto o dipinto in bianco il numero della macchina, alto almeno dieci centimetri», intimava il municipio di Verona. Già nel 1900, mentre esordiva il secolo dell’automobile, il Touring avrebbe abolito la dicitura «Ciclistico»; ma solo un anno prima aveva esaltato l’uso del velocipede da parte delle donne. Su una rivista del Club venne pubblicata una poesia in latino, Muliebris birota velocissima, lanciando un premio per la migliore traduzione (vinse Lorenzo Stecchetti: «Monta la bicicletta veloce, fanciulla romana / tu, ancora, donna, vinci a la corsa i maschi; / ma pur vincendo i maschi non romper né nasi né braccia. / Ti basti solo romper le gambe ai cani / quando la bicicletta inseguon latrando rabbiosi…»). Poi sarebbe venuta l’immagine della diva Sarah Bernhardt sul sellino nei Campi Elisi, la moda, gli scandalosi pantaloni, la scomunica igienica dei medici perché la sella potrebbe indurre «soddisfacimenti genitali». E via via sarebbe cambiato il sentimento generale, con l’ode di Giovanni Pascoli dedicata al campanello sul manubrio, le elegie ciclistiche di Guido Gozzano, le prose di Alfredo Oriani, che fece un viaggio solitario dalla Romagna alla Toscana «in sella a una Bremiambourg da corsa a ruota fissa». Sarebbe arrivata anche la tassa sui velocipedi (10 lire per le biciclette e 15 per i tandem), sarcasticamente evocata sempre da Stecchetti: «Né molto andrà che per voler sovrano / avrete un contator fra i due ginocchi / e la marca da bollo al deretano» (nel 1909 il Touring riuscì a far ridurre l’imposta a sei lire). Ai primi del Novecento ci volevano cento giornate lavorative di un operaio per acquistare le due ruote. Ma intanto (nel 1909) nasceva il Giro d’Italia. Al tempo della Grande guerra le biciclette censite erano quasi un milione e mezzo. Sulle strade cominciavano a vedersi le moto e le automobili. Come scrisse un socio del Touring, era cominciata l’era «anippica», senza cavalli. Ma la bicicletta, come il Touring, avrebbe attraversato il fascismo, la guerra fredda, il boom economico, il centrosinistra, le autostrade, le domeniche a piedi, fino a noi. Chissà se le restrizioni energetiche riporteranno la nostra epoca a essere «il secolo della bicicletta». DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 TRA I SOCI UN FUTURO PAPA Questa pagina è illustrata da sei copertine della rivista del Touring Club Italiano, pubblicate tra il 1908 e il 1931. Qui sopra, l’iscrizione al TCI di monsignor Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII Il cicloturismo cento anni dopo Esploratori a pedali delle strade di nicchia PAOLO RUMIZ tatale 62 della Cisa, pianura alla spalle, temporale finito. Una finestra cobalto si apre su in alto, e già si riparte nell’aria fina, col Mediterraneo che chiama dall’altra parte. Bicicletta, penetrazione totale del paesaggio. Campanili e colline che si spostano, ogni colpo di pedali diventa triangolazione millimetrica dell’Italia minore. Non c’è lettore satellitare che mostri così fedelmente il terreno. Il tuo bracco meccanico gli è mille volte superiore. Va rasoterra, si infanga, cattura voci, odori, rumori. Li inanella come i grani di un rosario. Berceto, dopo il primo strappo. Intercetto un parroco, una donna bruna che stende i panni, una banda che prova gli ottoni oltre la finestra di una taverna. Odore di ragù italiano, un salumiere che saluta, un funerale. Percezione laterale, filmica, della vita. La salita riprende, si intorcica in tornanti, e subito, con la fatica, la visione si riduce. Ti chiudi nel tuo matra, uno-due-tre-quattro, vedi solo le chiappe di chi ti precede. La visione diventa frontale. Tutto sta in fondo alla stradone. Il passo. La birra all’arrivo. Il seno glorioso della cameriera che te la porge. La Cisa, il tuffo verso Pontremoli, con la percezione che, in discesa, muta ancora, diventa olfattiva; a sessanta orari non vedi niente, sì e no il battistrada. Profumo di pinete, resina, la temperatura che sale, fumo di carne alla brace, i castagni selvaggi di Lunigiana, l’odore del mare che ti arriva addosso trenta chilometri prima, ti lascia senza fiato a un curvone tra Aulla e Santo Stefano di Magra. All’arrivo sul Mare Tirreno capisci: la Parma-La Spezia è più corta in bici che in auto. Impossibile? Provare per credere. A bassa velocità il terreno ti si stampa in testa, la memoria te lo disegna con la fedeltà di un ormografo. Lo riempie di incontri, volti, odori. Lo rende familiare, vicino, e quindi lo accorcia. Del paesaggio visto in auto, invece, rimane poco o nulla. Figurarsi in autostrada, la “A 15” che corre parallela. La noia dilata lo spazio, lo rende interminabile. Potenza delle due ruote. La lentezza comprime spazi immensi. L’ho misurato con Francesco Altan ed Emilio Rigatti sulla Trieste-Istanbul, archetipo dei viaggi a puntate su Repubblica. Un secolo fa gli italiani l’avevano già capito. Il Touring chiese loro qual era il mezzo migliore per esplorare la loro terra, ed essi dissero in coro: la bici. Con quella vedi più cose che a piedi, e puoi fare dei paragoni. Ma vedi anche più che in auto: la quale è troppo veloce e non ti fa vedere niente. Esplorare necesse est, ieri come oggi. Ma oggi — va riconosciuto — è più difficile di un secolo fa. Magari hai l’asfalto, ma hai anche un traffico infernale. La grande distribuzione ha cancellato le locande, gli anni Sessanta hanno riempito il Paese di schifezze in cemento. E allora oggi, paradossalmente, devi essere più esploratore di allora. Devi saper cercare negli interstizi delle grandi reti. Ed è proprio qui che la bici si prende l’ultima rivincita sull’auto. Come qui sulla Cisa. Te ne accorgi all’incrocio con la “A 12 Tirrenica”. L’autostrada ha prosciugato il traffico della vecchia statale, e tu dal sellino puoi goderti, in splendida solitudine, il traffico dei gommati. Far loro una sonora, liberatoria pernacchia. Repubblica Nazionale 39 19/02/2006 S 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 Il musical del momento debutterà a Broadway ad aprile, e ci rimarrà forse per anni. Si chiama “Lestat”, è scritto da Elton John e Bernie Taupin, e porta a teatro la saga di Anne Rice consacrata al cinema in “Intervista col vampiro”. Siamo andati a vedere l’anteprima dello show. Per scoprire perché i padroni della notte hanno perso il fascino dell’immortalità, sono diventati “i mostri della porta accanto”. E non fanno più paura Vampiri Se il diavolo si risveglia povero diavolo GIUSEPPE VIDETTI I SAN FRANCISCO l vampiro fa la fila al botteghino. È mattino, strano che la luce del giorno non lo ferisca. Pallido, ha la pelle diafana, gli occhi infossati cerchiati di scuro, i capelli biondi ben pettinati, la camicia con le maniche a sbuffo, troppo leggera per questa San Francisco flagellata dal nubifragio. Un bimbo aggrappato al cappotto della mamma lo fissa, chissà se ha davvero i canini aguzzi? Il vampiro sorride beffardo, i due denti si piantano sul carnoso labbro inferiore in segno di sfida. Il piccolo rabbrividisce e cerca protezione sotto il braccio della madre: «Non aver paura, è solo un attore», dice lei scompigliandogli i capelli. Un altro vampiro sbuca dalla pesante tenda di velluto rosso che separa il foyer dalla platea: Repubblica Nazionale 40 19/02/2006 L’ALLESTIMENTO Nelle foto qui sotto e a sinistra, due momenti del musical “Lestat” al Curran Theatre di San Francisco. Lo spettacolo sbarcherà a Broadway il 25 aprile «Jack, non dovresti essere qui». «Devo assolutamente ritirare i biglietti per la mia famiglia, arrivano all’ultimo momento da Cincinnati, Ohio. Sarò da voi tra un secondo». Il Curran Theatre di San Francisco è il teatro ideale per i vampiri di Anne Rice. Piccolo, gotico, pieno di stucchi e di cariatidi dorate, tenebroso e sinistro quanto basta. Lestat, il musical scritto da Elton John e Bernie Taupin e ispirato alla saga dei succhiasangue della scrittrice americana (The Vampire Chronicles), debutta proprio nella città in cui la Rice ambientò le prime pagine di Intervista col vampiro, best seller e film di successo con Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas. In una tetra casa disabitata del quartiere Divisadero, il vampiro Louis racconta la sua estenuante, interminabile esistenza al giovane cronista Malloy, morbosamente attratto da una creatura che supponeva spettrale ed efferata e invece scopre tormentata, persino attraente, piena di “buoni” sentimenti. Louis è vittima e carnefice del più spietato Lestat, il vampiro vecchio di secoli che l’ha iniziato alla notte eterna in una villa stile coloniale nel bel mezzo di una piantagione di New Orleans, il secolo scorso: «Quando vidi la luna sul selciato, ne rimasi a tal punto incantato che restai lì un’ora, credo [...]. Quanto al mio corpo, non aveva ancora subito la completa trasformazione e non appena mi abituai a tutti quei suoni e a quelle visioni cominciò a dolermi. Tutti i fluidi umani venivano espulsi. Morivo come creatura umana, eppure come vampiro ero pieno di vita; e con i miei risvegliati sensi dovetti assistere alla morte del mio corpo con un certo disagio e, alla fine, con terrore. “Mi sta succedendo qualcosa”, gridai. “Stai morendo, tutto qui; non fare lo stupido”, disse Lestat mentre già ispezionava le carte della piantagione» (Anne Rice, Intervista col vampiro, Ed. Tea Due, 366 pagg., 8 euro). L’unico attimo di paura quel bimbo l’ha avuto davanti al botteghino, perché Lestat è un musical decisamente non vietato né da vietare ai minori. Anzi, lo spettacolo che il 25 aprile sbarca al Palace Theatre di Broadway (in preview dal 25 marzo), dove secondo l’idea dei produttori è destinato a rimanere per molti mesi, anni addirittura, ha ancora i denti da latte. Dopo una serie di preview al Curran di San Francisco, lo spettacolo è stato finalmente presentato alla stampa. Ed è stato un coro di «ai vampiri di Anne Rice sono caduti i canini». Non è bastato il nome Elton John, che per la prima volta firma un musical con Bernie Taupin (Il re leone e Aida li ha scritti con Tim Rice, Billy Elliot con Lee Hall), paroliere di fiducia dei suoi più grandi successi, a salvare dal linciaggio lo spettacolo più atteso della nuova stagione. Il primo a farne le spese è stato Jack No- seworthy, l’attore che si era mostrato in costume di scena al botteghino il giorno della prima. Il suo licenziamento non è certo da imputare al gesto incauto, ma al fatto che i produttori hanno deciso di cambiare radicalmente il carattere di Armand. A Drew Sarich, nuovo vampiro in carica, è toccata la sciagura di mettere i brividi a uno spettacolo che ha trasformato in Mary Poppins le Cronache del vampiro di Anne Rice. «Che significa morire quando si può vivere fino alla fine del mondo? Ormai ho già vissuto due secoli e ho visto le illusioni dell’uno completamente distrutte dall’altro, sono stato eternamente giovane ed eternamente vecchio, senza possedere illusioni, vivendo attimo per attimo come un orologio d’argento che batte nel vuoto», si lamenta Louis in Intervista col vampiro. Il musical messo in scena su libretto di Linda Woolverton e la regia di Robert Jess Roth già pluripremiato a Broadway per Beauty and the Beast (con canzoni confezionate da John & Taupin) banalizza all’eccesso il tormento umano che quelle creature terribili provano di fronte alla prospettiva di una vita eterna vissuta nelle tenebre, al punto che i vampiri sul palco perdono del tutto la loro connotazione diabolica e la loro eccezionalità per diventare comuni mortali, tutt’altro che temibili, afflitti dalle stesse problematiche della famiglia della porta accanto. E poi della morbosa ambiguità dei romanzi della Rice in Lestatnon c’è traccia. Hugh Panaro, nei panni del protagonista, è un innocuo bellone che pare uscito fresco fresco dal set di Beautiful. L’irresistibile impulso a mordere e bere sangue per sopravvivere si risolve con un vorticoso viaggio visuale all’interno del sistema circolatorio, immagini da angiografia come ne abbiamo viste da Piero Angela in tv. Anne Rice non la pensa allo stesso modo: «Questo musical è la realizzazione dei miei sogni». Non c’è da stupirsi: la scrittrice, 64 anni, ha preso le distanze Nello spettacolo i signori delle tenebre perdono la connotazione diabolica e l’eccezionalità: sono comuni mortali, afflitti dai nostri stessi problemi dal mondo delle tenebre che cominciò a conoscere nel 1969 a Berkeley e che ha esplorato a fondo in lunghe notti di luna piena a New Orleans. Leggenda vuole che per rendere più verosimili i suoi racconti, la Rice vivesse solo di notte, si aggirasse nei quartieri più equivoci della città e costringesse tutta la famiglia a una esistenza in penombra (suo figlio Christopher Rice è un giovane scrittore di successo; omosessuale dichiarato, ha esordito con il torrido Density of Souls e tiene una rubrica sul mensile gay Advocate). Oggi Anne Rice, che una volta si fece trovare in una libreria per la presentazione di un romanzo distesa dentro DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 LE OPERE LA SAGA NOSFERATU DRACULA L’INTERVISTA La saga letteraria con cui, nel ’76, esordisce la scrittrice Anne Rice è un insieme di racconti dedicati ai vampiri Il protagonista si chiama Lestat Il film muto realizzato dal grande regista Murnau nel 1922 è la prima pellicola dedicata al conte Dracula: si ispira al romanzo di Bram Stoker uscito nel 1897 È del 1992 e vince tre Oscar il film di Francis Ford Coppola con un cast formato da Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder e Keanu Reeves Dal best seller di Anne Rice, nel 1994 esce “Intervista col vampiro”, il film di Neil Jordan con Tom Cruise (Lestat) Brad Pitt e Antonio Banderas Lo stucchevole fascino dei succhiasangue NATALIA ASPESI ovendo scegliere, quanto a morsi sul collo, c’era chi si accontentava di quelli di Brad Pitt, il vampiro Louis, ma la maggior parte delle signore, nel buio incantatore del cinema, bramava quelli dell’allora divinamente pallido Tom Cruise, il vampiro Lestat. Era il 1994 e finalmente con Intervista col vampiro di Neil Jordan, il povero morto vivente transilvanico, tipico esempio di stupratore riluttante e talvolta di pedofilo sedotto, non aveva il volto orribile, con rivolino di sangue sul mento, di Nosferatu-Klaus Kinski (del film di Herzog); né quello antipatico, respingente di DraculaGary Oldman (del film di Coppola); e neppure quell’aria ridicola, da gentiluomo dalle chiome grigie con mantello nero foderato di rosso, del pur seducente, per dame sprovvedute, Frank Langella in un altro dei tanti Dracula anni Settanta. Se si calcola che a tutto il 2004, elencati dal dizionario Mereghetti, i film di vampiri sopravvissuti all’oblio sono almeno 133, si avrebbe il diritto di pensare che non se ne può più, anche di quelli comici, tipo Fracchia contro Dracula di Neri Parenti o Dracula morto e contentodi Mel Brooks (addirittura con comparsata di Ezio Greggio). Persino Anne Rice, massima signora della letteratura vampirica, esausta dopo le tante sanguinolente avventure del suo Lestat, ha almeno per ora abbandonato il buon giovane al musical, per, ritornata cattolica, scrivere di Gesù bambino (Christ the Lord: Out of Egypt). Però i vampiri sonnecchiano vigili, nelle loro bare da giorno, in attesa di svolazzare di notte quali pipistrelli e, essendo morti viventi, non muoiono mai: quindi ogni tanto ce li ritroviamo tra i piedi, per esempio nella moda appassionata di horror, vedi sfilate di John Galliano stile oltretomba, festeggiatissime. Oppure il video Fendi, 12 minuti, che sostituì la sfilata alle ultime presentazioni milanesi di moda maschile: si intitola Lo specchio d’oro, regia di Gadagnino (quello del popolarissimo Melissa), dove l’attore Malik Zidi, provvisto di lunghi dentini sporgenti e perfettamente abbigliato Inverno Fendi («cappotto reversibile in marmotta»), si getta su sue vittime maschili (con «cardigan di montone intrecciato») e se le pappa. Citazioni auliche, da Bava a Huysmans, tutte tendenti al gotico. Si tratta dei tanti esempi di vampirismo gay, a partire dall’irresistibile Polanski 1967 Per favore non mordermi sul collo, in cui il giovane vampiro biondo, figlio del vampiro castellano, cerca di sedurre l’assistente (il poco più che trentenne Polanski) dell’acchiappavampiri. Il connubio moda-Nosferatu è inscindibile ormai da decenni: e sia sulle passerelle che soprattutto nelle fotografie delle grandi riviste di culto, sono privilegiate modelle che probabilmente sono servite da antipasto e dessert a mai sazi Lestat: anoressiche, scarnificate, ceree, non solo, ma con quell’aria imbambolata e perversa delle creature filmate da Murnau o dipinte da Gustave Moreau, che da un momento all’altro possono a loro volta mostrare le zanne e piantarle su qualche gola di passaggio. Si sa come la vampira, in letteratura e nel cinema, abbia a un certo punto azzerato il collega maschio. Nel 1900 la scrittrice Rachilde scrisse il romanzo La buveuse de sang (e nel 1898 Joseph Ferdinand Gueldry aveva dipinto un macello in cui le signore malaticce si abbeverano al sangue delle bestie morenti, puro grand guignol). Negli anni in cui la donna cercava di uscire dalla soggezione maschile ci fu tutto un fiorire di romanzi, studi, dipinti che privilegiando la donna dissanguata dal vampiro, stabilivano il nuovo ideale femminile: la donna morta. Mentre la scienza e la poesia si ergevano preoccupate contro la donna emancipata, la donna sensuale, in pratica la donna-vampiro. Nel 1922 l’eminente professor Robinson del Bronx Hospital scrisse un manuale di felicità coniugale terrorizzante: «Mi riferisco alla donna ipersensuale, alla moglie con una eccessiva carica di erotismo. È a lei che il termine vampiro si può applicare. Come il vampiro succhia il sangue delle sue vittime nel sonno, da vive, così la donna-vampiro succhia la vita al suo compagno, o vittima, esaurendone la vitalità. Alcune di loro, il tipo più marcato, sono del tutto prive di compassione e considerazione». Il cinema draculiano non demorde, e in attesa di qualche Nosferatu contro Batman, oppure di un vampiro Armand interpretato da Massimo Boldi, ci dobbiamo accontentare di similvampiri, o di vampiri metaforici. Per esempio nel buio dorato di The libertine il secentesco poeta inglese Wilmot duca di Rochester, volto esangue, nere occhiaie attorno a sguardi mortuari da Theda Bara, tendenza a gettarsi sul collo di prostitute ed attrici (anche della sua sposa), ha tutte le caratteristiche fisiche del vampiro aristocratico. In più con i tratti di squisita perversione di Johnny Depp. E quando il giovane cortigiano muore tutto coperto di pustole, è come se una domestica distratta avesse sollevato sbadatamente il coperchio della bara in pieno giorno. E si sa quanto sia pericolosa, come l’aglio, il crocefisso e il punteruolo piantato nel petto, la luce del sole: basta un raggio e il morto vivente muore. E come non scambiare per Dracula lo scrittore Capote del film a lui dedicato, che sia pure con occhiali e guance grassocce vampirizza i due assassini condannati a morte, succhiandogli spietatamente ogni informazione utile per il suo libro rivelatosi di immenso successo, A sangue freddo, per poi versare qualche lacrimuccia al loro impalamento, cioè impiccagione? Anche l’arte però vampireggia: alla Tate Britain di Londra è appena iniziata la grande mostra Incubi gotici con 120 opere dei grandi pittori romantici fine Settecento, Füssli e Blake, maestri dell’orrore poetico, sensuale e ambiguo, completo dei celebri La casa dei morti e Il risveglio di Titania. Salgono le quotazioni degli inglesi fratelli Chapman con i loro bambini di plastica che paiono assolutamente veri, massacrati da bestiali Nosferatu che non si accontentano del loro sangue ma anche si divertono a tagliargli i genitali e a metterglieli nelle orecchie. Vampiresca anche l’opera dell’artista svizzero Gianni Motti, che nel 2005 ha esposto a Basilea l’opera Mani Pulite, venduta per 12mila euro: trattasi di una saponetta ottenuta dal grasso di Berlusconi. Non suzione ma liposuzione, non sangue ma ciccia, anche le abitudini alimentari draculiane peggiorano. D IL FILM Repubblica Nazionale 41 19/02/2006 L’immagine qui sopra è tratta dalla locandina del film “Dracula” di Francis Ford Coppola una bara, considera The Vampire Chronicles, 75 milioni di copie vendute nel mondo, «più che romanzi horror, storie esistenziali di personaggi esecrabili, un percorso spirituale, riflessi di me stessa persa e lontana da Dio, cosa che oggi non sono più». The Gothic Queen si sta comodamente riciclando in God Queen: l’ultimo romanzo, già best seller, s’intitola Christ the Lord: Out of Egypt (Cristo il Signore: fuori dall’Egitto). Eppure la Rice ha caldeggiato la realizzazione del musical, con quelli che la Woolwerton chiama «vampiri creati a nostra immagine e somiglianza». Tanto umani da risultare irriconoscibili. «Muori giovane, vivi per sempre», c’è scritto fuori dal teatro, ma poi Lestat fa scempio di quel mondo decadente descritto dalla Rice con tanta meticolosità da risultare quasi credibile, e di quei sexy-vampiri che affondano i denti sul collo e succhiano sangue con un’ingordigia quasi sessuale non resta quasi nulla. «La nostra intenzione era di fare un musical elegante, intelligente, ipnotico che evitasse tutti gli stereotipi sui vam- StudioUrania e Rai Cinema presentano alessio boni michele placido in un film di michele soavi arrivederci amore,ciao dal 24 febbraio al cinema piri», recitano in coro Elton John e Bernie Taupin. «Lo spunto dell’opera è la loro dannazione vista da una prospettiva estremamente umana e realistica». È lo stesso principio con cui la Rice ha costruito le sue Cronache: tutta la vita di Lestat è segnata dal rapporto con la morte (per non perdere sua madre la vampirizza quando lei sta per esalare l’ultimo respiro). Ma è difficile trovare nel dizionario del pop tanto macabro tormento. Per questo le canzoni di Elton e Bernie, come tutta la messa in scena, non riescono a far venire i brividi (anzi, trasformano tutto in parodia, più Per favore non mordermi sul collo di Roman Polanski che Intervista col vampiro di Neil Jordan). «Al Teatro dei Vampiri si entrava solo su invito, e la notte seguente il portiere controllò un istante il mio biglietto, intanto che la pioggia cadeva leggera intorno a noi: sull’uomo e sulla donna che si erano fermati davanti al botteghino chiuso; sui manifesti increspati che raffiguravano vampiri da romanzo dell’orrore con braccia e mantelli sollevati come ali di pipistrello, pronti a richiudersi sulle spalle nude d’una vittima mortale...», racconta Louis a Malloy. La ricostruzione del Teatro dei Vampiri poteva essere la carta vincente di Lestat: succhiasangue che si aggirano come ombre in una Parigi maledetta e incantata, e di notte sciamano nel teatro dove il rito si compie sul palcoscenico, quotidianamente, coinvolgendo umani ignari della diabolica messa in scena. A Parigi, Louis ci va in nave da New Orleans, con la piccola Claudia, la bambina trasformata da Lestat in una creatura delle tenebre (altro spunto formidabile). Neanche in questo caso però il musical si dimostra all’altezza delle pagine. Alla fine dello spettacolo non c’è nessuno in sala che, come il cronista Malloy, vorrebbe essere morso sul collo per porre fine a una piatta e insipida esistenza umana e diventare un bel tenebroso. Se Lestat non cambierà i denti, sul suo futuro non ci sono certezze (il debutto a Broadway, in attesa di nuovo sangue, è stato provvidenzialmente posticipato di un mese rispetto al calendario iniziale). L’unica certezza è che Anne Rice non scriverà mai più un romanzo sui vampiri. «Come potrei? Ormai mi sono convertita a Gesù Cristo. Sarei una pazza se non mantenessi fede alla mia promessa». La Rice abdica e passa lo scettro a Chelsea Quinn Yarbro, nuova regina dell’horror, americana anche lei, che ha già pubblicato Hotel Transilvaniae si appresta a far uscire in Italia un sequel, Il palazzo (ed. Gargoyle), protagonista Francesco Ragoczy Conte di Saint Germain, vampiro gentiluomo. Il magazine Christianity Today, giura che la contrizione è sincera e intitola un botta e risposta con Anne Rice Intervista col pentito. 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 i sapori Eccessi di stagione Fragranti, allegri, lievi: con nomi diversi si ripetono uguali dal nord al sud d’Italia e sono il simbolo della trasgressione gourmand dei giorni di festa che precedono il brusco confine tra martedì grasso e mercoledì delle ceneri. Ecco i trucchi per cucinarli al meglio, riducendo al minimo i rischi per i gastro-angosciati LICIA GRANELLO ono fragranti, allegre, lievi. Una tira l’altra, come e più delle ciliegie. Hanno nomi diversi, frizzanti, tanti: da regione a regione, da nord a sud vengono battezzate bugie, chiacchiere, lattughe, galani, crostoli, sfrappole, cenci, frappe, frijolas… Sono il dolce-simbolo del Carnevale che avanza in questi giorni, golosità per eccellenza di un periodo votato da secoli alla trasgressione gourmand (e non solo). Infatti, il nome di derivazione latino-medievale “carnem levare”, certifica l’obbligo, secondo i precetti della religione cattolica, di astenersi dalla carne nei quaranta giorni della quaresima. Ma prima che il mercoledì delle ceneri (il primo marzo) introduca il tempo della penitenza, occhi, cuore e palato hanno di che sollazzarsi, tra feste in maschera e buffet sontuosi. Non a caso, il giorno che chiude il Carnevale è detto martedì grasso (tranne a Milano, dove il rito ambrosiano introdotto da Sant’Ambrogio nel Quarto secolo prolunga i festeggiamenti fino al sabato). Un aggettivo che dice molto sugli intendimenti del Carnevale: dieci, quindici giorni di extraterritorialità alimentare, dove tutto è consentito, colesterolo permettendo. Certo, l’abbinamento è di quelli che fanno sussultare la bilancia: ma ancora affondati nei freddi grigiori dell’inverno, perseguitati dall’inquinamento e dalle paure dell’influenza aviaria, la tentazione del dolce&fritto riesce davvero poco resistibile. A cominciare dalle chiacchiere, sfoglie golose che i dannati della dieta mal si perdonano. Così i pasticcieri più sensibili alle gastro-angosce dei loro clienti, hanno inventato la versione al forno, tradimento imperdonabile per tutti quelli che hanno assaggiato almeno una volta la ricetta originale eseguita a regola d’arte. Certo, una volta steso e ritagliato in rettangoli dentellati il classico impasto di farina, uova, zucchero, nulla ci vieta di spennellarlo con uovo e latte, e di infornarlo per un quarto d’ora. Ma la chiacchiera dietetica è come mangiare il formaggio senza pane o dolcificare la panna cotta con lo sciroppo d’acero: una tristezza annunciata, che lascia frustrati e delusi artigiani e acquirenti. E allora, ecco il trucco: una volta fritti, i dolcetti sono poi messi ad “asciugare” in forno. Il gusto leggermente tostato e la consistenza biscottata illudono che il miracolo sia stato compiuto. E le chiacchiere casalinghe? Chi si vuol cimentare con struffoli e tortelli da offrire ad amici e piccini, deve decidere tra la trasgressione tout court e gli aggiustamenti dietetici. Se dev’essere fritto, ci si può confortare con qualche dettaglio a supporto. Per esempio la scelta del grasso di cottura: intere generazioni di bambini sono cresciute gustando le chiacchiere di Carnevale cotte nello strutto, che resta tra le opzioni migliori, insieme all’olio extravergine (basta comprarne uno delicato, dal ligure ai lombardo-veneti). Scorrendo gli oli di semi, invece, è da privilegiare quello di arachide, il più resistente alla temperatura di frittura (e anche il più caro, così da risultare poco popolare tra i pasticcieri). Altro atout, la pentola, che per i dolci di Carnevale sarà alta, stretta, riempita d’olio a metà. Perché si tratta quasi sempre di paste lievitate, che hanno bisogno di gonfiare in cottura e quindi di non appesantirsi appoggiati sul fondo. Il diametro contenuto impedisce anche di mettere troppi dolci al fuoco, pratica che abbassa la temperatura di cottura, producendo fritti unti e pesanti. Se siete tipi da pentimento tardivo, evitate di far piovere zucchero in quantità sui bignè appena fritti. Lo scarto calorico sarà minimo, ma il senso del sacrificio vi farà sentire subito più magri. S Cannoli Erano il dolce preferito delle suore del convento di Santa Caterina, a Palermo. A Messina e Catania, la ricetta viene arricchita con una diversa farcitura, a base di crema pasticciera, all’uovo o al cioccolato Cartellate La “cartiddata” nella tradizione pugliese contende al “bocconotto” (cuscinetto ripieno di cacao e canditi) il titolo di re dei dolci di Carnevale. Le girelle di pasta fritta sono ricoperte di miele o vino cotto Chiacchiere Altrimenti dette: frappe, bugie, stracci, sono fatte con un impasto aromatizzato con scorza di limone e liquore. La pasta viene tagliata in rettangoli lisci o annodati. Fritte, si spolverizzano con zucchero a velo Uno tira l’altro E poi viene la Quaresima Repubblica Nazionale 42 19/02/2006 Dolci Carnevale di Castagnole Cicerchiata Frittelle Ricordano grosse ciliegie, realizzate friggendo un impasto classico con aggiunta di lievito e rum. Esiste una variante “ricca” che prevede la farcitura con crema pasticciera Si taglia l’impasto in tocchetti grandi quanto un’unghia. Una volta fritte, le palline vengono girate in salsa di miele e limone, con mandorle a lamelle e frutta candita, e poi composte in uno stampo Nella versione più nota uniscono la classica pasta lievitata con le mele, che possono essere grattugiate, spezzettate o tagliate ad anello. I più golosi aggiungono all’impasto uvetta e pinoli DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 itinerari Luciano Stillitano è il proprietario di “Dany”, pasticceria-culto di Torino, dove tradizione e innovazione sono elaborate alivelli di eccellenza assoluta. Tra i dolci di Carnevale, spiccano le “bugie”, fritte in olio di arachidi e asciugate in forno Alessandria Venezia Palermo Le “dolci terre” testimoniano la presenza di una grande tradizione dolciaria, espressa da piccole industrie e artigiani. La regina di Carnevale è la “bugia” Già nel ‘600 i “fritoleri” impastavano farina, uova, zucchero, uvetta e pinoli. Una volta cotte, allora come oggi, le frittelle sono cosparse di zucchero Simbolo del Carnevale palermitano, il cannolo nel ‘600 venne battezzato “scettru di ogni re e Virga di Moisè”, per la sua forma caratteristica DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE HOTEL LUX Via Piacenza 72 Tel. 0131-251661 Doppia da 100 euro, colazione inclusa CASA DEL MIELE Ca’ Noghera, via Paliaghetta 2a Tel. 041-5416129 IL MEZZANINO DEL GATTOPARDO Via Alloro 145 Tel. 333-4771703 Doppia da 110 euro, colazione inclusa DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE PISTERNA Acqui Terme, Via Scatilazzi 15 Tel. 0144-325114 Menù da 50 euro LA CORTE SCONTA Calle del Pestrin 3886 Tel. 041-5227024 Menù da 60 euro LO SCUDIERO Via Turati 7 Tel. 091-581628 Menù da 30 euro DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE LABORATORIO ARTIGIANALE GIRAUDI Castellazzo Bormida, Via Liguria 26 Tel. 0131-275563 CAKE AND COFFEE via Bissuola 24 Tel. 041-5343262 PASTICCERIA ALBA Piazza Don Bosco 7c Tel. 091-309016 La foto qui a sinistra è stata gentilmente concessa dalla rivista “Sale & Pepe”, Mondadori editore L’alternanza storica fra cibi “di grasso” e “di magro” Olio e strutto alla guerra delle frittelle MASSIMO MONTANARI «T ‘‘ Ray Bradbury Dietro quella porta, la stufa stava preparando delle frittelle che riempivano la casa di un buon profumo di pasticceria e di sciroppo da CRONACHE MARZIANE ogli farina distemperata con ova et acqua, e assottigliata e stesa; tagliala a modo di foglie, o di fichi, o come vuoli, e friggile nel lardo, o oglio ad abbondanza; e cotte, mettivi su del mele bollito, e mangia». È la ricetta del dulcamine, ovvero «frittelle non quaresimali», contenuta in un libro di cucina italiano del XIV secolo, scritto in Toscana su un modello meridionale. Ma che significa «frittelle non quaresimali»? Ce lo spiega Maestro Martino, il più famoso cuoco italiano del Quattrocento, nel capitolo del suo ricettario dedicato a «far ogni frictella», dove si insegnano molti modi per preparare le frittelle (di fiore di sambuco, di bianco d’uovo con fior di farina e cacio fresco, di latte quagliato ovvero giuncata, di riso, di salvia, di mele, di fronde d’alloro, di mandorle…) con tutte le varianti «quaresimali». L’alternanza fra cibi «di grasso» e «di magro» è una costante della cucina medievale, che durerà a lungo. È un’alternanza imposta dai tempi liturgici della Chiesa, per alcuni giorni della settimana e alcuni periodi dell’anno: il Carnevale e la Quaresima ne rappresentano la sublimazione. Quaresima è il tempo di magro per eccellenza, in cui sono banditi i cibi di origine animale; Carnevale è il tempo della festa, a cui seguiranno privazioni e rinunce, ma anche un’attenta gestione gastronomica dei cibi consentiti. In realtà si tratta di cambiare qualcosa, non di stravolgere i moduli consueti di cucina: ogni carne sarà sostituita da un pesce (magari addobbato in forma di carne); uova e formaggi (consentiti durante l’anno nei tempi di magro, ma non durante la Quaresima) lasceranno il posto alle verdure; il lardo sarà sostituito dall’olio. Gli accostamenti, i sapori saranno comunque garantiti. Spiega, dunque, Martino che le nostre frittelle, «si fusse in tempo quadragesimale, le poi frigere in olio, et non gli mettere grasso né ova». Le frittelle di magro sono quelle senza uova e fritte nell’olio. È questo il sacrificio che si chiede; ma prima che scatti il mercoledì delle ceneri, che apre la Quaresima, si faranno «vere» frittelle con uova, fritte nel lardo. Questo fu, per secoli, il vessillo principale del «grasso» Carnevale: friggere nel lardo. «L’olio combatte con lo strutto», leggiamo nella Battaglia di Quaresima e Carnevale, un testo del XIII secolo da cui prese avvio un vero e proprio genere letterario. È questo il senso dell’alternativa lardo/olio prevista dalla ricetta trecentesca del dulcamine. Il gusto del fritto ha sempre accompagnato le feste di Carnevale: le nostre chiacchiere, sfrappole, cenci, o comunque vogliamo chiamarle, sono il punto d’arrivo di una tradizione lunghissima, che sicuramente risale al Medioevo e forse anche oltre, alle feste pagane di età romana. Ma più ancora del sapore dolce, più ancora del miele o dello zucchero che si aggiungeva alla pasta per farne un segno della festa, era il tipo di grasso a determinare il carattere carnevalesco della frictella. Oggi ci hanno insegnato che friggere nell’olio è meglio, e l’imperativo dietetico non ha tardato a trasformarsi in abitudine alimentare, modificando il gusto: abbiamo imparato ad apprezzare l’olio e il suo sapore acre (sia pure addolcito da zucchero e miele). Ancora qualche secolo fa, molti dei nostri dolcetti sarebbero apparsi un cibo da Quaresima più che da Carnevale. Graffe Tortelli È la versione napoletana del krapfen austriaco. I dischi di pasta vengono sovrapposti con un’intercapedine di marmellata di amarene e fritti a fuoco basso fino a diventare gonfi e rotondi Si preparano partendo da un impasto senza lievito, cotto, fatto raffreddare, ridotto in palline. Dopo la frittura e l’asciugatura in forno possono essere farciti con crema pasticciera. Si servono caldissimi 44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 le tendenze Baby eleganza Tutte le firme hanno ormai linee interamente dedicate all’infanzia e progettate avendo bene in mente il guardaroba dei genitori. Perché la barriera stilistica che divideva le generazioni è definitivamente saltata. Ma soprattutto perché oggi i più piccoli sono tanto attenti alle mode da voler cambiare look, come i grandi, ad ogni giro di stagione Bambini clone JACARANDA CARACCIOLO FALCK jeans a vita sempre più bassa e la lingerie di pizzo, le minigonne ultraridotte e gli abiti sottoveste, le camicette di voile e gli hot-pants di pizzo. E ancora i boxer a vista, gli stivali da cowboy, i blazer di lino. Ammettiamolo: i bambini del nuovo millennio si vestono ogni giorno di più come piccoli adulti. Per rendersene conto basta dare un’occhiata alle ultime proposte di stilisti e creativi. Che sfornano mise all’ultima moda per piccole lolite e manager versione mignon. Una volta, il mondo infantile e quello adulto erano rigidamente divisi. Almeno in fatto di moda. I piccoli si vestivano con abiti studiati appositamente per loro. E il massimo divertimento di ogni bambino era quello di frugare nell’armadio di mamma e papà alla ricerca di un qualche travestimento che lo facesse sembrare un adulto in miniatura. Oggi, invece tutto è cambiato. Sarà perché nell’era delle coppie mono-figlio i tanto attesi reucci della casa finiscono per diventare l’epicentro della vita famigliare. Anche in termini di consumi. O forse perché i bambini di oggi sono loro stessi più adulti. Ma una cosa è certa: gli under 12 sono diventati i cloni perfetti dei loro genitori. Attenti in modo quasi maniacale alle tendenze, a ogni stagione sono pronti a cambiare look. E, quindi, guardaroba. Secondo i dati di Pitti bimbo, solo in Italia nel 2004 sono stati spesi 3 miliardi 520 milioni di euro in moda junior. Il mercato è più che appetibile. Sarà per questo che tutti i grandi stilisti hanno ormai almeno una linea baby. Per i mini adulti c’è solo l’imbarazzo della scelta: i jeans di Diesel e i caftani di Antik Batik, i trench di Burberry e i giubbotti jeans di Dior, le polo di Fred Perry e le botton-down di Polo Ralph Lauren, gli abitini gipsy di Roberto Cavalli o le babydoll di Miss Blumarine. Per non parlare degli accessori. La varietà di calzature è infinita: si passa dalle sneakers monogrammate di Louis Vuitton ai sandali capresi firmati Pepè, dai classici scarponcini Hogan alle Lelly Kelly in tela e paillettes. L’espansione del mercato non riguarda solo il settore fashion. «I nostri clienti oggi prediligono case con spazi aperti che inglobano tutto dal living alla stanza da letto», racconta l’architetto Giorgia Dennerlein, proprietaria di Loto design, uno dei negozi più di tendenza della capitale, «per non parlare del reparto dedicato alla quotidianità ed al gioco del bambino». Non c’è allora da meravigliarsi se anche le grandi firme del design hanno cominciato a muovere all’attacco dell’universo baby. La Magis ha prodotto un’intera linea, battezzata Me Too dedicata ai più piccoli. Ikea ha lanciato la collezione PS: una decina di pezzi utilizzabili sia come complementi d’arredo sia come giocattoli. Kartell punta sulle sedie impilabili, come i pezzi Lego. Mentre Alessi produce set da tavola di mille colori diversi. I dati confermano il fenomeno. Negli Stati Uniti nel 2003 sono stati spesi 3 miliardi e 300 milioni di dollari in mobili per bambini. L’Europa si prepara a seguire a ruota. «Fino ad oggi le camere dei piccoli rimanevano isolate, in termini estetici, dal resto della casa», spiega Elisa Astori, responsabile prodotto di Driade che, quest’estate lancerà un’intera collezione per bambini. E aggiunge: «Noi vogliamo fornire ai nostri clienti un modo per coniugare il loro amore per la bellezza con complementi adatti allo spirito infantile». Ovvero come rimanere bambini, ma con stile. I Mini-adulti le griffe all’assalto Questo mercato è in grande espansione: per l’abbigliamento dei figli gli italiani spendono ogni anno tre miliardi e mezzo. Repubblica Nazionale 44 19/02/2006 E anche dal fronte dell’arredamento arrivano nuove idee TENNISTI IN ERBA PASSI BRILLANTI Suola in gomma bicolore e paillette dalle nuance accese, a forma di margherita, per le sneaker-ballerine in tela di Lelly Kelly PIOGGIA DI FRAGOLINE Il classico sandaletto viene impreziosito, a beneficio dei più piccoli, da una pioggia di fragoline applicate su fondo giallo. La scarpa fa parte della linea Naturino PICCOLI VIAGGIATORI Si chiama Square ed è prodotta da Cult Sul fondo della scarpa è sovraimpressa, ogni stagione, la mappa di una città diversa Quest’estate è il turno di Barcellona Troppo piccoli per impugnare la racchetta ma non per indossare le scarpe da tennis: ecco quelle della linea Chicco Jeans, dedicate a chi ha meno di un anno DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 SUPERESCLUSIVO Sono t-shirt, debardeur e culotte in pezzi unici e numerati. In vendita solo a febbraio e solo in tre negozi di Milano, Parigi e New York. Prodotte da Petit Bateau e disegnate a mano dall’artista Christophe Leroux VITA A COLORI Sono disponibili in sei varianti di colore, da abbinare ad ogni tipo di pantalone, le cinture di tela della nuova collezione junior Benetton PRONTE A PARTIRE Bauletto di acetato lucido per bambine con messaggio “fashion for ever” È firmato Barbie l’oggetto più trendy del momento ADESSO BEAUTY Le piccole Lolite viaggiano sempre, al pari delle loro mamme, con il beauty-case. Come quello a fiori della neonata linea MyMy di Trudy LAVARSI È UN GIOCO Repubblica Nazionale 45 19/02/2006 Un’idea per giocare anche in bagno? Lo spazzolino da denti a batterie Az Spin brush. Disponibile con diversi tipi di impugnatura: dalla principessa al robot IN PASSERELLA Top jeans e gonna lunga in chiffon a più strati: è la proposta di Nolita Pocket per la bimba elegante ma trasgressiva (a sinistra) Sembra appena sceso dallo yacht del papà il ragazzino griffato Ferré che sceglie il pinocchietto rosso, la t-shirt bianca bordata in rosso e un giubbottino leggero Sportiva in jeans bianco e t-shirt fantasia, la piccola griffata Cavalli può contare sull’assoluta somiglianza del suo look con quello materno Il rischio di allevare fragili tiranni ANNA OLIVERIO FERRARIS arrozzine aerodinamiche, seggioloni spaziali, pannolini “intelligenti”, salviettine ecologiche: questi alcuni dei numerosi gadget che rendono diversi i nuovi bebè dalle generazioni precedenti, spesso semplificando la vita dei genitori. C’è anche un mercato molto attivo che cura il look dei piccolissimi. Possono gattonare sul pavimento, ma devono farlo con pantaloncini a zampa di elefante o tutine con inserti in pelle. In seguito dovranno indossare magliette griffate, scarpette ad alta tecnologia, giubbetti di pelle metallizzata, gonne fatte a punte di chiffon, cravattini a farfalla, look “povero” e look principesco, insomma una ricca gamma di vestiti e accessori, generalmente molto costosi, che innalzano il bambino degli anni Duemila su un trono regale, anche se ovviamente a spingerlo sono ormai i grandi stilisti che hanno individuato nell’arco 0-2 anni e soprattutto in quelli 2-4 e 4-10 un campo fertile al cui centro c’è un Ego da gonfiare, quello del bambino ma soprattutto quello della sua mamma che, per documentarsi, ha a disposizione in edicola una raffica di riviste che propongono quella che è ormai l’alta moda infantile, al centro di defilè e di giornate “importanti” dal punto di vista del marketing. Che il bambino stia diventando un piccolo re, dipende in gran parte dal fatto che soprattutto nel nostro Paese, quando c’è, è anche facilmente un figlio unico e quindi al centro degli investimenti dei genitori che sovente vedono il Bene (leggi l’affetto) nei beni materiali. Vestendolo in maniera sontuosa e non facendogli mancare nulla, in primo luogo il superfluo, pensano di avere già assolto una buona parte del loro compito educativo. Solo che, ovviamente, i piccoli diventano sempre più esigenti, sempre più con l’occhio rivolto al bimbo a fianco, sempre più bizzosi e ovviamente sempre più frustrati: perché c’è sempre qualcuno che ha un paio di occhiali, una spilla di strass o un giocattolo più belli e più trendy di quelli che mamma e papà gli hanno comprato. Con queste premesse, ci sono buone probabilità che questi bimbi, viziati dal mercato e dai genitori, diventino quello che ormai gli psicologi chiamano il “bambino tiranno”: un simpatico viperino che ha ormai iniziato la sua carriera acquisitiva e non si vuol far mancare nulla. È impaziente. Le attese devono essere ridotte al minimo. Il premio deve essere immediato. L’aspettativa è costante. Non arriva il giocattolino del giorno? Lui è già un po’ stressato: che la mamma non gli voglia abbastanza bene? Ovviamente non tutte le mamme e non tutti i bambini vivono in questa atmosfera principesca e iperprotettiva; ma per i genitori che non si adeguano e per i bambini che non sono stati adeguati, la vita può sembrare un po’ più dura: anche se si può scommettere che i bambini che hanno subìto un addestramento alla pazienza e alle normali frustrazioni saranno più resilienti, vale a dire più in grado di padroneggiare quei piccoli stress e di affrontare quelle difficoltà che potranno essere invece vere mazzate quando cadranno sui principini. Ogni genitore dovrebbe sapere che per il bene dei figli qualche rinuncia è importante e che il loro benessere fisico e psicologico non deriva tanto dagli oggetti di cui riescono a venire in possesso, quando dall’atmosfera che vivono in famiglia, dalle attività che fanno, dai giochi, dalle relazioni con gli altri bambini. Certo può essere difficile giocare vestiti da defilè. Così come è difficile abbandonarsi ai movimenti e alla fantasia dei giochi spontanei quando si è troppo centrati su di sé, sulle proprie esigenze oppure sul giocattolo invece che sul gioco. L’autrice insegna Psicologia dello sviluppo alla Sapienza di Roma C 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 Krizia DARIO CRESTO-DINA Repubblica Nazionale 46 19/02/2006 C’ MILANO è una fotografia in cui è bellissima. Avrà sì e no trentacinque anni, è seduta alla sua scrivania di lavoro, tiene una sigaretta tra le dita, la sta avvicinando alle labbra, ha i capelli scuri raccolti dietro la nuca, una maglietta bianca a maniche corte e assomiglia a Faye Dunaway. Ancora adesso a settant’anni, Mariuccia Mandelli è una donna molto bella. Se è fragile, lo nasconde bene. Prega soltanto che le si parli con voce un po’ più alta. Indossa pantaloni neri, una t-shirt nera e una giacca nera. È senza trucco. È curiosa, vivace, a volte fa domande da ragazzina timida: «Non le sono piaciuta, vero?». Dice che è sempre stata affascinata dal cinema, dal suo modo di raccontare le storie. Il suo gioco preferito è essere se stessa interpretando qualcun’altra, ogni giorno diversa. Come in questo momento. Oggi Krizia ha la testa acconciata da principessa egiziana, una collana ad anelli che regge un disco di platino in mezzo al petto e due bracciali da gladiatore romano che le coprono per intero i polsi sottili e le arrivano fin quasi sotto i gomiti. Devono essere costosissimi. Mi spiega che li ha creati Marta Marzotto. All’anulare della mano sinistra porta una pietra triangolare, nera. È preoccupata, ansiosa. Dice: «Non credo di essere una persona interessante. Ho sempre paura di non essere capace di andare oltre pensieri banali, di deludere chi mi deve giudicare in una chiacchierata di non più di un’oretta. Sono una persona semplice». Nel quartiere generale di via Manin i luoghi solo suoi sono due, separati da una trentina di metri di corridoio a elle. Nello studio c’è un tavolo rettangolare lungo e stretto ingombro di tessuti e grandi sottili fogli da disegno. Regna un disordine costruito. Il suo ufficio di rappresentanza invece è lindo e minimale, piccolo e raccolto, la finestra d’angolo incornicia un pezzo di giardino. È appena un respiro. Da questo punto di osservazione si scorge pochissimo della Mila- no un tempo tanto amata. «È come se per pudore e vergogna avessi chiuso gli occhi su questa città. Non voglio vedere come si è ridotta. È orribile, sporca, degradata. È l’unica città al mondo dove le macchine vengono parcheggiate sui marciapiedi. I vecchi non osano più uscire di casa e nonostante il loro isolamento vengono truffati da sciacalli che gli portano via i risparmi anche dietro le porte di sicurezza, le giovani coppie una casa per andare a vivere insieme invece non riescono a trovarla, la povertà dilaga, lo smog ci uccide e nessuno se ne preoccupa. La borghesia si è chiusa nei suoi appartamenti, ha messo il culo nel burro, come si dice qui. Sono una che si indigna dalla mattina alla sera, ma mi sono accorta che non serve a nulla, non scuote la gente dall’indifferenza o, forse, dalla rassegnazione. Criticavamo Roma, ora dovremmo andare a lezione di civiltà dai romani. Qui invece abbiamo perso il senso di normalità, ecco perché spero che il prossimo sindaco sia semplicemente una persona normale. Non mi dispiace Ferrante, l’ho invitato qui da me per un dibattito, deve migliorare ma mi pare onesto e determinato, pieno d’amore per Milano. Letizia Moratti, invece, non mi interessa». Qualcuno ha definito Krizia la signora più «cattiva» del prêt-à-porter. Di certo non è una che le cose le manda a dire. Ha avuto in passato forti polemiche con la Camera della moda per l’organizzazione delle sfilate a Milano, si è scontrata senza esclusione di colpi con Anne Wintour, l’erinni di Vogue America, confessa che Prodi non è abbastanza passionale per i suoi gusti ma lo voterà perché il suo cuore batte a sinistra e che se Berlusconi diventasse mai presidente della Repubblica lei si trasferirebbe all’estero, magari in Giamaica dove si sposò, «in una portineria d’albergo», con l’imprenditore Aldo Pinto oppure sull’isola caraibica di Barbuda, alcuni chilometri quadrati di paradiso, dove ha costruito un posto da favola che pochi si possono permettere. In un libro di Isa Tutino Vercelloni a lei dedicato c’è un’immagine che la ritrae assieme a Valentino, Armani, Versace e Ferré. Sono al Quirinale, sono giovani e sono appena diventati commendatori. I grandi stilisti sono anche personaggi strani. Credono di essere come gli eroi e i desideri. Si illudono di non invecchiare con l’età. Non hanno stipulato un patto con il diavolo, ce l’hanno dentro, il diavolo, oppure gli scodinzola attorno per tutta la vita come un rimpianto, esibendo la sua faccia più pericolosa e ingannevole: la gioventù. La gioventù delle ragazze più belle del mondo sempre pochissimo vestite e degli adolescenti dai tratti efebici o dai muscoli scolpiti sotto le canottiere per l’abitudine alla palestra. Durante le sfilate per chi sta sotto le luci e attraversa la pedana il tempo sembra fermarsi, forse è per questo che, alla fine, chi le ha vestite esce abbracciato alle modelle. Crede di ricevere, assieme agli applausi, un po’ di quella polvere Ha cominciato a sette anni, disegnando e cucendo i vestiti per la sua bambola Adesso, che di anni ne ha settanta ed è un monumento vivente al Made in Italy, Mariuccia Mandelli è ancora una donna bella, vivace, curiosa, capace di fare domande da ragazzina timida. Ma anche di esprimere giudizi taglienti. Come quello su Milano, un tempo tanto amata: “Questa città è orribile, sporca, degradata. Criticavamo Roma, che ora ci dà lezioni di civiltà. Qui abbiamo perso il senso della normalità” d’invincibilità che galleggia sempre nell’aria quando passa la giovinezza. Dove sono gli eredi di Armani, Ferré, Valentino, Krizia? Mariuccia Mandelli spalanca i suoi grandi occhi celesti e ride: «Il futuro è dei giovani, presto appariranno sulla scena parecchi nomi nuovi e finirà questa oligarchia della moda. Ma, attenzione, se noi siamo ancora qui significa che non abbiamo smarrito il genio e che in giro, tra i possibili emergenti, ci sono troppi presuntuosi e troppi arroganti. E pochissima umiltà». Cerca una metafora, la trova: «Infilano troppe piume sui vestiti, e le piume, tra l’altro, portano sfiga». Le chiedo di fare la classifica dei suoi maestri. Il primo nome è quello di Walter Albini, il talento di Busto Arsizio scomparso nel 1983, che può essere considerato l’iniziatore della moda pronta in Italia. Krizia lo conobbe a Parigi all’inizio degli anni Sessanta. Fu un incontro fortuito, come raccontò lo stesso Albini: «Ci siamo conosciuti per errore. Avevo aperto per sbaglio un telegramma della Mandelli indirizzato a un amico comune. Sapevo chi era lei, l’amico non c’era e al posto suo, a prenderla all’albergo, quella sera sono andato io. Lei era perfetta, tornava da Megève, tutta in crêpe nero con un filo di perle al collo. Ab- Gli eredi? Presto appariranno nomi nuovi. Ma attenzione: se siamo ancora qui vuol dire che non abbiamo smarrito il genio. E poi fra i giovani ci sono troppi arroganti FOTO IMAGOECONOMICA Simboli della moda biamo passato una deliziosa serata insieme da Castel, dove suonava un’orchestrina di sole donne. Offrì lei, naturalmente, perché io a quei tempi mi nutrivo solo dell’aria di Parigi... Così la mattina dopo, per ringraziarla, sono passato al suo hotel per lasciarle in regalo tutto ciò che possedevo: una cartella piena di disegni». Mariuccia se la portò a Milano, qualche giorno dopo chiamò anche lui e con Albini cominciò una lunga e proficua collaborazione. «Poi — dice Krizia — nella lista ci metto Capucci, Coco Chanel, Dior, Balenciaga, Givenchy e Armani». Giorgio Armani e la Mandelli si vogliono bene. Si somigliano anche un po’. «Crediamo tutti e due che la moda non debba essere imposta, ma debba piuttosto assecondare il tempo che viviamo, le esigenze e le possibilità delle persone. Dobbiamo fare vestiti per gli uomini e le donne che vanno in ufficio, a scuola, a fare la spesa, in vacanza in luoghi normali. Non faccio alcuna fatica ad ammettere che Benetton e Zara, per esempio, sono bravissimi e producono abiti molto belli. Dobbiamo difendere l’eleganza, questo sì, perché l’eleganza è cultura». Krizia era una bambina ricca, poi è stata una ragazza povera perché la sua famiglia perse tutti i suoi beni «dal mattino alla sera», oggi è di nuovo ricca, soprattutto per merito, lei dice, di tanti mariti che hanno comprato i suoi vestiti per rendere felici le loro mogli e anche le loro amanti. «Al giorno d’oggi possediamo tutto, possediamo troppo. Da piccola i miei genitori mi hanno insegnato il dono dell’offerta. La gioia che si prova quando si è capaci di pensare agli altri. Dopo ogni Natale accantonavamo una parte dei miei giocattoli e li portavamo ai poveri». Spesso le vite prendono una certa strada per avventura, altre precipitano per sventura. La sua cominciò con una bambola ed è stata fortunata. «Era quella che amavo di più. Avevo sette anni e abitavo a Bergamo. Cominciai a fare vestiti per lei, prima di carta, poi di stoffa. Spesso mi ospitava e mi consigliava la signora Parietti che aveva una sartoria vicino a casa nostra. Fu lei, anni dopo, a dire a mia madre: “Non mandi sua figlia all’università, vedrà che diventerà qualcuno nella moda”. Io avevo il diploma di maestra, insegnavo in una scuola di Cassano d’Adda. Diedi retta all’amica sarta dei miei e andai a Milano. Avevo 23 anni, una lambretta che vendetti per pagare l’affitto di due camerette in via Pagano, una socia, Flora Dolci, lo sguardo spaurito e neppure un fidanzato con i soldi. Entravo nei negozi con il mio campionario sotto il braccio e non ho mai capito se mi davano retta perché ispiravo simpatia oppure mi ascoltavano per pietà». Viaggiò tanto, soprattutto in treno. La provincia, Bari e molto altro Sud, il Samia di Torino che fu un trampolino di lancio, Firenze dove allestì la prima sfilata vera tutta sua e venne premiata come migliore esordiente, Milano dove stava soprattutto a ammirare i colleghi già famosi, Parigi grazie all’ospitalità di un paio di amiche ricche che andavano ad accarezzare l’alta moda. «Volevo, e lo voglio ancora, vestire soprattutto le donne. Nel corpo femminile ho sempre visto la libertà. In Italia sono stata la prima a disegnare la minigonna, in contemporanea con Mary Quant. Facevo pantaloncini cortissimi per rendere le donne milanesi un po’ meno signore, andavo alla stazione centrale per studiare le francesi che giungevano con il treno a Milano ed erano così eleganti, così avanti rispetto a noi. Evitavo l’alta moda, mai attuale, mai realistica, sempre troppo costosa, mettevo nei miei vestiti un po’ di Greta Garbo, Magritte, Dalì, l’imperatrice Sissi, Malevic e Depero. Con il trascorrere degli anni ho modificato il carattere, sono diventata aggressiva. E ormai non mi sfugge nulla. È una disgrazia, questa. Sono malata di perfezionismo, una malattia gravissima. Chi lavora con me la deve vivere come un tormento». È esigente, è una rompiscatole. Mi spiega che lo è anche Armani, uno che la sera, quando scende il buio, lo si può incontrare in via Manzoni mentre controlla a una a una le vetrine dei suoi negozi. Mariuccia Mandelli è innamorata delle donne. E come succede nella storia di ogni grande amore ha ricevuto in cambio anche qualche delusione. «Una volta le donne esageravano nel vestirsi e noi abbiamo insegnato loro a spogliarsi. Oggi esagerano nello svestirsi. Ormai le guardi in tv e sembrano sempre in mutande. Sono nude fino all’inguine, mi fanno venire il sospetto che abbiano smesso di guardarsi allo specchio. Portare la minigonna può essere un segno di libertà, ma c’è chi esagera. Non tutte possono permettersi di mostrare il sedere». Le chiedo quali sono i cinque capi di abbigliamento che non possono mancare nell’armadio di una signora. Risponde subito, senza esitare: «Il tailleur, il pantalone, la camicia, l’abito con le spalline e il golf». Dice che nella nostra vita i colori devono essere tre: «Il nero, il beige e il bianco. Il più bello di tutti». E che loro, gli stilisti, oltre a essere strani sono egocentrici: «Abbiamo scelto questo mestiere perché volevamo prima di tutto vestire noi stessi». ‘‘ l’incontro
Scarica