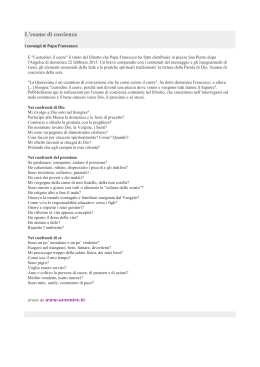Domenica La di DOMENICA 15 MAGGIO 2011/Numero 326 Repubblica l’attualità La vita segreta di mamma Obama VITTORIO ZUCCONI cultura Magni e l’ombra del Terzo uomo FILIPPO CECCARELLI e GIAN LUCA FAVETTO Il marito, la moglie, il detective A cinquant’anni dalla morte in anteprima mondiale un racconto sconosciuto del creatore di Sam Spade FOTO CORBIS Hammett inedito DASHIELL HAMMETT è gente che, quando incontra per la prima volta un detective, non può fare a meno di guardare i suoi piedi. Questi sguardi, a volte espliciti e beffardi, più spesso furtivi e quasi motivati da ragioni scientifiche, sono senza dubbio irritanti per un detective i cui piedi rientrano nella tradizione dei piedi piatti: a Fred Vitt, invece, piacevano. I suoi piedi erano piccoli e lui li calzava con cura in nere scarpe lucenti. Era un tipo pallido e grassottello, con le labbra rosse, gli occhi chiari e lo sguardo cordiale. Dieci anni prima, privo di una particolare formazione professionale, si era messo a cercare lavoro e si era ritrovato assunto in un’agenzia di investigazioni private. Ci era ri- C’ masto, diventando un agente piuttosto bravo, pur non essendo per temperamento troppo adatto a questo tipo di lavoro, che in gran parte gli risultava ripugnante. Gli piaceva, però, che fosse così insolitamente vario, che desse alla sua intelligenza quelle gratificazioni che capitano spesso a tutti i detective salvo a quelli che non ne azzeccano mai una e che, di tanto in tanto, offrisse quella caccia sfrenata a un fuggiasco che, finché un tribunale non avesse stabilito il contrario, era di certo e in qualche modo un furfante. E poi, un detective ha un certo prestigio in certi ambienti sociali, cosa che non si bilancia affatto con la sua totale mancanza di reputazione in altri, e infatti in genere evita di frequentare questo secondo tipo di ambienti o di rivelare in essi la propria professione. (segue nelle pagine successive) con un articolo di GABRIELE PANTUCCI spettacoli Blue Note, l’etichetta delle stelle MASSIMO VINCENZI i sapori L’irresistibile danza della paranza LICIA GRANELLO e MARINO NIOLA l’incontro Storaro, “La vera scrittura è la luce” PAOLO D’AGOSTINI Repubblica Nazionale 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 15 MAGGIO 2011 la copertina Ha inventato il prototipo di tutti gli investigatori, è diventato il re di Hollywood, ha sfidato il maccartismo. Ha cambiato il romanzo americano in quindici anni. Poi si è rinchiuso nel silenzio rumoroso di feste, alcol e donne. Ora, nel cinquantenario della morte, Scoperte in anteprima mondiale un racconto inedito svela a cosa stava lavorando il padre di Sam Spade Storie lasciate come indizi GABRIELE PANTUCCI © RIPRODUZIONE RISERVATA O ggi Vitt stava dando la caccia a un falsario. Un assegno da 200 dollari, firmato da H. W. Twitchell (della Twitchell Bocker Box Company), era stato girato da Henry F. Weber e incassato in banca. Vitt si trovava ora nell’ufficio di Twitchell e parlava con lo stesso Twitchell, che non ricordava di conoscere nessun Weber. «Mi piacerebbe vedere gli assegni che ha annullato negli ultimi due mesi» disse il detective. Il fabbricante di scatole era evidentemente a disagio. Era un omone e la sua faccia arrossì e sembrò gonfiarsi in un colletto troppo stretto. «E perché?» chiese sospettosamente. «Questo falso è troppo ben fatto per non essere stato copiato da quelli. L’assegno che più gli assomiglia dovrebbe portarmi al falsario. In genere, funziona». Vitt cercò, prima di tutto, gli assegni che avevano messo in imbarazzo Twitchell. Ce n’erano tre, circolari, girati da Clara Kroll ma, purtroppo, non avevano nessuna caratteristica di rilievo che li collegasse all’assegno falso. Il detective li mise da parte ed esaminò gli altri, finché non ne trovò uno che lo soddisfece: un assegno per 250 dollari a favore di Carl Rosewater. «Chi è questo Carl Rosewater?» chiese. «Il mio sarto». «Vorrei che mi prestasse questo assegno». «Non penserà che Rosewater…?». «Non necessariamente, ma sembra che l’assegno usato come modello sia questo. Vede: il Ca in Carl è più ravvicinato rispetto a come scrive in genere queste lettere e lo è anche il Ca della parola Cash in questo assegno falso. Quando lei scrive due zeri li unisce, ma nel falso non sono connessi, perché chi lo ha fatto copiava da questo assegno da 250 dollari, dove di zeri ce n’è uno solo. La sua firma sull’assegno a Rosewater prende più spazio del solito, ed è più obliqua… perché ha scritto in fretta, o in piedi… e la fir- HAMMETT “Né giudice né dio solo un detective” DASHIELL HAMMETT ma falsa fa altrettanto. Inoltre, l’assegno falso è datato due giorni dopo questo assegno. È quello che cerchiamo, ci potrei scommettere!». Nella sartoria Rosewater solo due uomini avevano avuto in mano l’assegno di Twitchell: il proprietario e il suo contabile. Rosewater era un uomo grasso e ben nutrito. Il contabile, invece, era evidentemente denutrito: Vitt puntò a lui. Il detective interrogò il contabile con aria indifferente, senza accusarlo, ma pronto a cogliere il minimo appiglio: era proprio il tipo di idiota capace di commettere un reato da poco che portava direttamente a lui e, se questo motivo non fosse stato sufficiente, era anche il sospetto più conveniente che avesse a disposizione. Questo contabile era alto e concavo, e aveva dei capelli secchi che giacevano sul suo cuoio capelluto più che spuntare da esso. Un paio di lenti spesse ingrandiva la confusione nei suoi occhi senza allargare nulla di ciò che i suoi occhi potevano vedere. I suoi abiti terminavano ovunque in sottili bordi sfilacciati, tanto che non si poteva dire esattamente dove ogni indumento finisse: l’abito e l’aria si mescolavano gradualmente in un modo tale che non era facile distinguerlo dallo sfondo. Si chiamava James Close. Ricordava l’assegno di Twitchell, ma disse di non essere a conoscenza della firma falsa e la sua scrittura non assomigliava minimamente alla girata di Henry F. Weber. Rosewater disse che Close era un uomo onesto e scrupoloso, che lavorava per lui da sei anni e abitava in Ellis Street. «È sposato?» «James?». Rosewater era sorpreso. «No!». Con l’aiuto di un biglietto da visita scelto nella vasta gamma che teneva in tasca, Vitt, fingendo di essere un agente di un istituto bancario che voleva fare al contabile una brillante quanto vaga proposta di lavoro, interrogò la padrona di casa di Close e diversi suoi vicini. Il contabile era indubbia- FOTO AP Q uest’anno segna il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Dashiell Hammett. Quando morì a sessantasei anni, nel 1961 in un ospedale di New York, vittima di un cancro ai polmoni, pochi ricordavano che alcuni decenni prima era stato salutato come il più grande scrittore americano vivente. Quando viveva a New York nel 1930 molti critici lo definivano «migliore di Hemingway», Dorothy Parker lo esaltava sul New Yorker e per Town and Countryera la celebrità letteraria del momento. Ma la sua produzione letteraria si concluse quando non aveva ancora compiuto quarant’anni, nel 1934. L’influenza che esercitò sulla letteratura americana si espresse in poco più di quattordici anni. Perché questo silenzio? Che cosa fece Hammett in quei trent’anni? Qualche indizio che squarcia il buio viene dai suoi inediti. Quello che Repubblica mostra in anteprima mondiale fa parte di una raccolta di dodici racconti mai pubblicati. Sono stati trovati con la collaborazione di Richard Layman nell’archivio di Hammett. Layman ha dedicato anni di studio e sei libri all’opera dello scrittore americano ed è riconosciuto come il maggior esperto sul tema. Layman li considera molto importanti soprattutto perché sembra siano stati scritti per riviste più importanti rispetto alle pubblicazioni popolari su cui aveva iniziato e portato avanti la sua carriera. Maggiore l’incentivo finanziario ma anche maggiori le ambizioni: Hammett voleva scrivere qualcosa che andasse oltre il racconto di genere, oltre la semplice costruzione della trama imprevedibile per inchiodare il lettore. Vissuto in condizioni finanziarie precarie, con la pubblicazione di Raccolto rossonel 1929 e poi definitivamente con Il Falcone maltese dell’anno dopo in cui nacque il suo personaggio più famoso, il detective Sam Spade, Hammett divenne una celebrità dal giorno alla notte, con più denaro di quanto potesse spenderne. Merito, o colpa secondo Layman, di Hollywood. L’alcol divenne un problema sempre più grave, poi feste, donne, quasi ogni forma di malattia venerea e infine un completo esaurimento nervoso. Ma c’era un altro Hammett, opposto e contiguo al primo: l’uomo che aderì al Partito comunista e delle battaglie per il sindacato degli scrittori. Nonostante la dissolutezza che caratterizzò tanti anni della sua vita, diede esempio di statura morale pubblica quando all’epoca delle persecuzioni maccartiste rifiutò di rivelare chi avesse contribuito a un fondo di cui era tesoriere per sostenere le spese legali di difesa dei comunisti. Il rifiuto gli costò cinque mesi di carcere. Tra questi due diversi Hammett c’era il suo silenzio di scrittore, un silenzio che, secondo Layman, era dovuto all’ambizione di scrivere qualcosa di diverso dal romanzo poliziesco. Lo provano sei tentativi che lasciò incompiuti e che Layman pubblicherà in futuro. E lo provano anche le dodici storie ritrovate, compresa quella pubblicata in queste pagine. La vis comica di Hammett è palese molto più che nella sua produzione “ufficiale”: alcune storie sono decisamente satiriche o umoristiche. Ma tutte si distinguono per l’autenticità della caratterizzazione, per la precisione dei dettagli realistici che ricostruiscono il mondo di quell’epoca con un commento morale — l’avidità, il cinismo, la falsità — sempre sottinteso. (segue dalla copertina) L’AUTORE Qui sopra, Dashiell Hammett in una foto storica In copertina, lo scrittore americano alla stazione dei treni di Hollywood nel 1940 Repubblica Nazionale DOMENICA 15 MAGGIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 I DOCUMENTI DISEGNO DI TULLIO PERICOLI A sinistra, le prime pagine del dattiloscritto di The Hunter di Dashiell Hammett Al centro, lo scrittore in un disegno di Tullio Pericoli mente un uomo dai costumi esemplari ma, stranamente, era sposato ed era padre di due figli, uno dei quali nato di recente. Abitava lì, al terzo piano di uno squallido edificio, da sette o otto mesi, dopo aver lasciato il precedente indirizzo di Larkin Street, dove il detective si recò. Pur essendo noto anche lì come un uomo totalmente privo di vizi, Close, a Larkin Street, risultava non sposato. Vitt tornò subito nell’edificio di Ellis Street, con l’intenzione di interrogare la moglie di Close ma, quando suonò il campanello, fu il contabile, tornato a casa per il pranzo, ad aprirgli la porta. Il detective non se l’aspettava, ma accettò la situazione. «Avrei qualche altra domanda da farle» disse, e seguì Close nel soggiorno-camera da pranzo (ora che il letto a parete era stato ripiegato). Dalla porta di fronte, intravide una donna con delle grosse braccia rosa che apparecchiava la tavola in cucina. Un bambino smise di costruire qualcosa con dei mattoncini in mezzo alla porta e guardò a bocca aperta il visitatore. Da qualche parte, un altro bambino piangeva senza ragione. Close mise i suoi attrezzi da lavoro in cucina, chiuse la porta e i due uomini si sedettero. «Close» disse il detective sottovoce, «quell’assegno lo ha falsificato lei». Il corpo del contabile si irrigidì e così il suo volto. Prima gli si allungò il mento, trasformando la bocca in un grumo imbronciato, poi gli si assottigliò il naso, ai cui lati comparvero delle piccole rughe, parallele alla parte superiore del naso stesso e incurvate verso l’angolo interno degli occhi. I suoi occhi si fecero più piccoli e si velarono dietro agli occhiali. Sotto l’iride, appena rivolto verso l’esterno, apparvero dei sottili archi bianchi. Le sopracciglia si sollevarono leggermente e le rughe sulla fronte divennero meno profonde. Non disse nulla, non fece alcun gesto. «Ovviamente» continuò il detective, «lei è in un mare di guai, e può fare quello che vuole. Ma se vuole un consiglio da uno che ne ha viste tante, sia ragionevole e confessi tutto. Io non lo so, non posso promettere niente, ma 200 dollari non sono un mucchio di soldi e forse ci si può mettere una toppa». Vitt lo disse con quella scioltezza che viene dalla pratica — era una linea d’attacco consolidata — ma in fondo lo pensava sinceramente: a livello emotivo, provava pietà per l’uomo che aveva davanti. «Non sono stato io» disse Close con aria malinconica. Vitt cancellò quella negazione con un breve gesto della sua mano bianca e grassoccia. «Ora mi ascolti: non ci guadagna niente costringendoci a scavare nella sua vita… e poi non c’è nemmeno molto da scavare. Per esempio, quando e dove si è sposato?». Il contabile arrossì. Quel rossore, che sicuramente non apparteneva al suo volto, lo faceva sembrare un fumetto a colori. «E questo che cosa…?». «Lasci perdere, allora» disse Vitt generosamente. Lo aveva in pugno. La sua intuizione era esatta: Close non era sposato. «Lasci perdere. Sto solo cercando di farle capire che le conviene essere ragionevole e confessare!». «Non sono stato io». La ripetizione irritò Vitt. La rigidità del volto del contabile, ravvivato per un istante dal colore che lo attraversava, lo irritava. Si alzò, vicino al contabile, e gli disse parlando più forte: «Lei ha falsificato quell’assegno, Close! Lo ha copiato da un assegno di Twitchell!». «Non sono stato io». La porta della cucina si aprì e la donna entrò nella stanza, mentre il bambino che prima giocava con le costruzioni si teneva a una piega della sua gonna. Era una donna dalla carnagione rosea, di una trentina d’anni, attraente, anche se trasandata: sciatta, è la parola che venne in mente al detective. «Che succede, James?». Aveva la voce roca. «Che succede?». «Non sono stato io» disse Close. «Dice che ho falsificato un assegno, ma non è vero». Vitt aveva caldo, e gli sudavano le mani. La donna e il bambino lo mettevano a disagio. Cercò di ignorarli, rivolgendosi di nuovo a Close, molto lentamente. «Lei ha falsificato quell’assegno, Close, e io le sto dando l’ultima possibilità per venirne fuori». «Non sono stato io». Vitt prese l’irritazione che l’idiozia di questa ripetizione suscitava in lui, la nutrì, si fece venire un piccolo attacco di rabbia, e il disagio che provava sotto lo sguardo della donna e del bambino diminuì. «Ascolti: sta a lei scegliere» disse. «Può intestardirsi o essere ragionevole. Per me, è lo stesso. Fa parte del mio lavoro. Ma non mi piace vedere un uomo che si fa del male, specialmente quando non è un delinquente per natura. Mi piacerebbe che se la cavasse con poco, ma se crede di sapere quello che sta facendo… faccia pure!». «Non sono stato io». Al detective venne il sospetto che tutto questo fosse ridicolo, ma allontanò questo pensiero. Dopo aver ottenuto la sua confessione, ripensandoci, ci avrebbe riso sopra. Intanto, per ottenere quella confessione, ci voleva un atteggiamento completamente diverso. Se fosse riuscito a raggiungere un certo grado di rabbia… Si girò di scatto verso la donna. «Quando e dove vi siete sposati?» chiese. «Non sono affari suoi!». Così andava meglio. Se c’era scontro poteva fare progressi. Sentì il sangue battergli nelle tempie e la sua eccitazione autoprodotta diminuirgli il campo visivo. Tutto si offuscò tranne il volto roseo e morbido della donna. «Certo!» disse. «Ma, se vuole sapere come stanno le cose, le dirò che voi non vi siete mai sposati… non tra di voi, se non altro!». «E allora?». Si mise tra il suo uomo e il detective, con le mani sui larghi fianchi. « E allora?». Vitt fece una risatina beffarda. Aveva lasciato crescere dentro di sé una quantità di rabbia davvero notevole, arma e anestetico al tempo stesso. «In questo Stato», disse scuotendo vigorosamente la testa, «c’è una legge che protegge la morale dei bambini. Potrebbe essere arrestata per favoreggiamento della delinquenza minorile! Ci ha mai pensato?». «Favoreggiamento… Perché, è pazzesco! Allevo i miei figli onestamente come tutti. Io…». «Lo so! Ma in California se vivi con un uomo che non è tuo marito, commetti un reato… perché gli dai il cattivo esempio, o qualcosa del genere». Dietro alla donna, ricomparve il contabile. «Ora basta!» ordinò. «Mi stia bene a sentire, ora basta! Amy non ha fatto niente!». Il bambino cominciò a piangere. La donna afferrò Vitt per un braccio. «Lasci che glielo dica!». Aveva perso il suo tono di sfida. «Mio marito mi lasciò quando scoprì che aspettavo un altro figlio. Uscì una domenica sera sotto la pioggia e non l’ho più rivisto. Nemmeno una volta! Non avevo nessuno che mi aiutasse eccetto James. Mi ha accolto in casa sua ed è stato buono con me come non lo era mai stato nessuno! I bambini stanno molto meglio con lui di quanto non lo siano mai stati con Tom. È più buono con loro. Io…». Il detective si divincolò. Un detective è un uomo pagato per fare certe cose precise: non è un giudice, un dio. Ogni ladro ha le sue giustificazioni, se lo stai a sentire. Tutta questa confusione rendeva il suo lavoro molto più difficile, senza essere veramente utile a nessuno. «Tanto peggio!». Mise nei gesti e nelle parole tutta la durezza che stava cercando dentro di sé. «Se le cose stanno così, se volete contraddirmi su questa storia dell’assegno, farò sì che finisca nel peggiore dei modi per voi due!». «Sta dicendo» urlò Close, «che se io non ammetto di aver falsificato quell’assegno, lei ci farà arrestare per questa storia… del favoreggiamento?». «Dico che se lei sarà ragionevole, io non le creerò più problemi del necessario. Ma, se vuole fare il duro, io andrò fino in fondo». «Ed Amy verrà arrestata?». «Sì». «Lei… lei…». Il contabile cercò di afferrare Vitt con le sue mani fatte per afferrare penne e libri mastri. Vitt avrebbe potuto trattenerlo senza troppa difficoltà perché, anche se grassottello, era abbastanza forte. Ma la passione che aveva cercato di dimostrare con il volto e con la voce alla fine era diventata reale. Strinse le dita di una mano in un pugno e colpì la pancia scavata del contabile. Il contabile si piegò su se stesso e cadde a terra contorcendosi. La donna si inginocchiò urlando accanto a lui. Il bambino che era entrato nella stanza con la donna e il piccolo che Vitt non aveva visto urlavano entrambi. Il campanello della porta cominciò a suonare. Dalla cucina arrivava un odore di cibo bruciato. Close si mise a sedere, appoggiandosi alla donna in ginocchio, con gli occhiali che gli pendevano da un orecchio. «L’ho falsificato io», disse in mezzo a quella confusione. «Dopo la nascita del piccolo, non mi bastavano i soldi per pagare le bollette. Ho detto a Amy che avevo preso i soldi in prestito da Rosewater». Rise amaramente. «Amy non lo conosce, per questo mi ha creduto. Comunque, le bollette sono state pagate». Vitt si affrettò a portare il suo prigioniero in carcere, lo fece registrare e rinchiudere, e poi si affrettò a raggiungere la zona commerciale. I grandi magazzini chiudevano alle cinque e mezzo e sua moglie gli aveva chiesto di portarle tre rocchetti di filo nero n° 60. Traduzione di Luis Moriones Brugo © 2011 The Dashiell Hammett Literary Trust © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 15 MAGGIO 2011 l’attualità Il suo primo nome era Stanley, perché il padre voleva un maschio. La sua prima casa fu il Kansas che ben presto lasciò per viaggiare per l’America e poi fino all’Indonesia e al Pakistan. Il suo primo marito era uno studente kenyota Yes, she can conosciuto alle Hawaii. Si chiamava Barack Obama senior Esce negli Usa la prima biografia della “First Mother” La vita segreta di Ann, “singular woman” e mamma del Presidente VITTORIO ZUCCONI (segue dalla prima pagina) FOTO AP ra la madre di Barack Hussein Obama. Una donna scandalosa che ha prodotto lo scandalo politico con il quale ancora oggi non tutta l’America si è davvero riconciliata. Il primo capo dello Stato meticcio, bianco e nero, afro e anglo, nella storia degli Stati Uniti. Anche dopo due anni e mezzo di presidenza, rievocazioni filiali, ricerche e lunghissimi articoli, la storia di Stanley Ann Dunham coniugata Obama, poi coniugata Soetoro, poi destinata a morire “single”, rimane un mistero di psicologia umana, e femminile, che neppure la ricostruzione dei fatti e l’uso elettorale fatto di lei dal figlio con la tragedia della sua morte per cancro alle ovaie, hanno davvero mai illuminato. Ci ha provato, ora, Janny Scott, scrittrice e reporter per il New York Times che ha consumato tre anni di lavoro e ore di interviste anche con Barack Obama per strappare finalmente la ragazzina del Kansas all’agiografia politica o alle insinuazioni malevole di chi odia suo figlio. La biografia che ne è uscita ha un titolo che, come la donna che racconta, presenta una voluta ambiguità di senso: A Singular Woman, dove quell’aggettivo singular si presta a molte interpretazioni diverse, singolare, unica, ma anche strana, diversa. Ann, che il padre aveva voluto battezzare con il proprio nome d’uomo, Stanley, perché aveva invano sognato un maschio, era nata nel 1942, in piena guerra, in una città anch’essa molto singular, Wichita, nel Kansas. Wichita, fino a quell’anno un qualsiasi crocevia nel mezzo del ventre agricolo del Midwest, sarebbe esplosa nella produzione di aerei militari, fino al B29 Enola Gay che avrebbe polverizzato Hiroshima. Da agricola a industriale, da sonnacchiosa a incubatrice del sindacalismo più duro, da super democratica rooseveltiana a ultra conservatrice reazionaria, fino al tentativo di mettere al bando l’evoluzionismo darwinista ed escluderlo dai corsi scolastici a favore del creazionismo biblico, Wichita è stata per mezzo secolo l’incubatrice delle inquietudini americane. In questa America apparentemente dai brividi ribellistici dei figli della guerra cresciuti nella stucchevole prosperità da American Graffiti anni Cinquanta, Stanley Dunham, che aveva abbandonato il nome maschile per farsi identificare da allora soltanto come Ann, è il ritratto della ragazzina in calzette bianche, ballerine senza tacchi e gonne con sottogonne a sbuffo ritratta nell’album del liceo. Non bella e non brutta, carina senza glamour nel visino affilato, con il mento appuntito FOTO REUTERS E WASHINGTON IL LIBRO Le immagini di queste pagine sono tratte dal libro A Singular Woman: the Untold Story of Barack Obama’s Mother, (Riverhead, 384 pagine, 26,95 dollari) uscito questo mese negli Stati Uniti che il figlio avrebbe ereditato da lei, era una donna destinata alla vita famigliare, alla casetta da telefilm nei sobborghi, ai sermoni domenicali e alle sagre della torta di mele. Se il padre, al ritorno dal fronte, non l’avesse infettata con il virus del wanderlust, dell’irrequietezza e degli spostamenti. Venditore di mobilio, archetipo del commesso viaggiatore senza pace, Stanley Dunham portò moglie e figlia verso l’Ovest, quell’orizzonte verso il quale l’America ruzzola come i tumbleweed, i cespugli senza radici. Prima la California, poi lo stato di Washington e poi oltre il Pacifico, alle Hawaii, dove Ann si iscrisse all’Università e segnò per amore la storia futura americana. Fu alle Hawaii che conobbe un giovane e brillante studente kenyano, il primo africano ammesso in quel college, Barack Obama senior, e se ne innamorò sposandolo e dandogli un bambino. Barack Obama jr. Ma il suo inarrestabile ruzzolare seguendo il corso del sole non era finito. All’abbandono da parte del marito, che la lasciò sola per seguire il prestigio di un titolo ad Harvard, a Boston, e poi per tornare in Kenya al momento dell’indipendenza dall’impero britannico, Ann si staccò anche dall’ultimo brandello di territorio americano per seguire un nuovo marito, Lolo Saetoro, uno studente indonesiano, a Giakarta. E neppure l’Indonesia, il mondo tanto lontano e diverso, esotico, acco- gliente, crudele, dove da poco tempo il massacro sistematico dei comunisti aveva insediato il regime di Suharto alla guida della più grande nazione musulmana del pianeta, le bastò. Lasciò il marito, insofferente al familismo opprimente della cultura locale, affidò il bambino Barack ai nonni che lo cresceranno senza di lei nelle Hawaii, e si gettò, con ogni forza, nell’antropologia, nello studio della gente, e nella sociologia della povertà nel Terzo Mondo, fino a un dottorato. Nella sua dissertazione finale, teorizzò per prima quella formula dei microcrediti per le aziende famigliari e soprattutto per l’artigianato femminile che oggi è strategia internazionale ufficiale. Divenne, inesorabilmente, una figura lontana per il figlio, che infatti nelle memorie investe i nonni nella Hawaii del suo affetto e della sua riconoscenza. Nella sua prima autobiografia, Ann, la madre, è a malapena ricordata, con appannato affetto, e con il rimpianto di avere poco conosciuto lei, come per niente conobbe il padre. «Il mio rammarico è di non essere stata una buona madre, di non avere goduto degli anni più belli di mio figlio, quando prese la laurea in legge ad Harvard e poi cominciò la carriera politica a Chicago» ricordava, anche qui con una formula bivalente, che può essere letta come un rimprovero al figlio, per averla esclusa dalla sua vita, o come un rimpro- Repubblica Nazionale LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 FOTO THE WYLIE AGENCY/THE INTERNATIONAL LITERARY REPRESENTATIVES OF JANNY SCOTT DOMENICA 15 MAGGIO 2011 IL PIRATA Nell’altra pagina dall’alto, Barack Obama accanto alla mamma, al patrigno indonesiano Lolo Soetoro, e alla sorellastra Maya negli anni Settanta; Ann Dunham in posa in Indonesia nello stesso periodo Nella foto grande, Barack a dieci anni vestito da pirata con la mamma e a destra, Ann con in braccio il figlio all’inizio degli anni Sessanta vero a se stessa. Tornò a vivere, con sospetta prepotenza, nella vita del figlio dopo la morte, nel 1995, alla Hawaii dove era tornata dal Pakistan, sempre incapace di restare troppo a lungo radicata in un luogo. Divenne, nella campagna elettorale obamiana del 2008, il triste e un po’ trito santino dello scandalo sanitario nazionale. Barack la usava per denunciare la crudeltà del sistema assicurativo privato, narrando che Ann aveva consumato gli ultimi anni della propria vita lottando contro un colosso delle assicurazioni, la Cigna, che voleva toglierle ogni copertura sospettando che lei fosse già malata quando aveva sottoscritto la polizza. Eppure lei, la piccola ingenua venuta dal Kansas che confessò di essere ancora vergine quando conobbe il primo marito e il primo uomo della sua vita, Barack senior, l’antropologa che aveva lasciato tutto per seguire la sua vocazione di pacifista e internazionalista dedita alla lotta contro la povertà, avrebbe confidato regolarmente alla figlia avuta dal secondo marito indonesiano l’orgoglio, l’amore insoddisfatto, per quel ragazzo divenuto uomo di successo, all’altro capo del mondo. «Barack era un bambino brillantissimo, intelligente, irrequieto, ansioso di conoscere e di vedere tutto, nelle scuole private e pubbliche di Giacarta» raccontava alla figlia. «Cercò di sapere e di leggere tutto di lui, da lontano», ricordano gli amici, impresa non facile negli anni in cui l’informazione erano i ritagli di giornali arrivati per posta. «Io sentivo il suo amore immenso, che mi ha sempre seguito nella vita», dice oggi il Presidente all’autrice del libro, ma non serve essere troppo cinici per avvertire un sapore artificiale, in questa dichiarazione d’amore postuma. «È stata lei a insegnarmi che sotto la superficie siamo tutti esseri umani, con il bene e il male dentro di noi. Capisco che questo fosse il suo idealismo ingenuo, figlio di un’altra epoca, ma molto di quel suo idealismo lei lo ha passato a me. Sono il figlio di mia madre». Poco prima di morire, Ann Dunham nata Stanley lesse il manoscritto delle memorie del figlio, I sogni di mio padre e scoprì che era tutto centrato sulla figura di quell’uomo che pure Obama non aveva mai davvero conosciuto, se non per un breve incontro alla Hawaii quando il futuro presidente aveva dieci anni e il padre lo aveva portato a un concerto di Dave Brubeck, il grande pianista di jazz. «Non si lamentò, non protestò, non fece sapere a Obama se si fosse dispiaciuta, perché lei non era fatta così» dirà la figlia SaetoroNg. Morì sola, alla Hawaii, a diecimila chilometri dal figlio che ora dice di portare il rimorso di quella lontananza. Come sempre, per madre e figlio, troppo tardi. Anche per un Mister President. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 15 MAGGIO 2011 CULTURA* C’erano “Coppi l’airone” e “il Ginaccio Bartali”: due stili, due campioni, due italie. Ma c’era anche un altro genio della bicicletta altrettanto forte, ma più controverso. Processato per una strage di partigiani, si portò dietro una vita i sospetti sulla sua assoluzione. Oggi lo storico John Foot ha trovato documenti che potrebbero riabilitarlo. Anche se a novant’anni l’ultimo eroe del ciclismo dice: “Ho la coscienza a posto” Fiorenzo Magni IL LEONE DELLE FIANDRE Vince tre Giri delle Fiandre consecutivi (dal ’49 al ’51), tre Giri d’Italia (’48, ’51, ’55), tre Trofei Baracchi, tre Campionati nazionali e tre Giri del Piemonte Fausto Coppi IL CAMPIONISSIMO Ha vinto cinque Giri d’Italia (’40, ’52, ’53), due Tour de France (’49 e ’52), tre Milano-Sanremo, una Parigi-Roubaix e nel ’53 un campionato del mondo Gino Bartali IL PIO È primo a tre Giri d’Italia (’36, ’37, ’46), a due Tour de France (’38 e ’48), quattro campionati italiani (’35, ’37, ’40, ’52), due Giri di Svizzera e tre di Lombardia Il terzo uomo Fiorenzo Magni e la sua ombra GIAN LUCA FAVETTO rail terzo uomo e, spesso, arrivava primo: settantanove volte in carriera. Tenacemente, faticosamente primo, contro i due miti più amati di ogni tempo. Ed è diventato anche lui un mito. Sempre come terzo. Non si fugge alle etichette, nemmeno se ti alzi sui pedali e scatti. Non possono fa rci niente i muscoli. Le etichette rimangono addosso fino alla fine, anche dopo il traguardo. Fausto Coppi era l’Airone, il Campionissimo. Gino Bartali era l’Uomo di Ferro, il Pio. E lui, Fiorenzo Magni, era il Leone delle Fiandre, il Terzo Uomo. Lo è ancora adesso, che da poco ha compiuto novant’anni. I due soprannomi se li è guadagnati con la vittoria al suo primo Giro d’Italia, nel 1948, infilandosi nel duello fra i due giganti del cicli- E IL LIBRO Esce il 18 maggio per Rizzoli Pedalare! di John Foot (tr. italiana N. Stabilini, 394 pagine, 22 euro), la storia sociale del ciclismo italiano dalle origini a oggi smo mondiale, e con il triplice trionfo, dal 1949 al 1951, nel Giro delle Fiandre, solo contro tutti, ruggendo sui pedali. Il tre è un numero che gli si addice: oltre a tre Fiandre, ha vinto tre Giri d’Italia, tre Giri del Piemonte, tre Trofei Baracchi e tre Campionati nazionali. Ma Magni, allora, correva anche con un’altra etichetta, un’ombra pesante, accompagnato da fischi e contestazioni, inseguito da una sinistra nomea: negli anni della guerra civile in Italia, dopo l’8 settembre 1943, era repubblichino ed è stato accusato di essere coinvolto in una strage. Costretto ad abbandonare la sua Toscana, si è trasferito in Brianza. Una vicenda nera, diventata rosa solo con le vittorie al Giro e con la recente scoperta di documenti che sembrano riabilitarlo. La storia racconta che il Terzo Uomo o ha una faccia da joker come quella di Orson Welles e dice cose come nel film di Carol Reed, Il terzo uomo, uscito proprio nel ’49: «In Italia per trent’anni hanno avuto guerra, terrore, omicidi, stragi e hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera, con cinquecento anni di amore fraterno, democrazia e pace cos’hanno prodotto? L’orologio a cucù». Oppure ha la faccia di Fiorenzo Magni, la faccia di uno che ti serve un’insalata e un caffè al bar. Solo che quell’insalata è andata a scaricarla ai mercati generali alle quattro di mattina e quel caffè l’ha raccolto di persona in Brasile. Una faccia tutta fatica e lavoro, che ha sempre riconosciuto: «Gareggiare con quei due diavoli è stata una grande fortuna. Devo ringraziare Coppi e Bartali, che mi hanno insegnato a perdere». Loro si prendevano quasi tutto, vittorie, tifo, passione. Magni si guadagnava il resto. Ha corso quando il ciclismo non era ancora del tutto uno sport e neppure uno spettacolo, ma una ciclopica opera di fachiraggio, una battaglia di eroismi e sofferenze, un racconto epico e sociale. È il sopravvissuto dell’epoca d’oro. Con Alfredo Martini, suo grande amico, è l’ultima figura carismatica di quel mondo. Ha dovuto lottare per farsi accettare nell’Italia del dopoguerra. Ha sfidato accuse e polemiche. È stata una lunga rincorsa per rientrare in gruppo, la sua. A fine ’43 era un militare della Repubblica Sociale. Stava con fascisti e nazisti. Il suo nome è comparso nel primo fatto di sangue della guerra civile in Toscana, la battaglia di Valibona, vicino al suo paese natale, Vaiano, il 3 gennaio 1944. Un episodio che ha pesato sulla sua figura. Ora, un libro in uscita per Rizzoli lo rilegge alla luce di alcuni documenti. Si intitola Pedalare! Lo ha scritto John Foot, storico inglese, studioso di fatti italiani. In trecen- Repubblica Nazionale DOMENICA 15 MAGGIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 LE FOTO Nella foto grande, Bartali, Magni e Coppi alla partenza del Giro d’Italia del ’52; in basso, Magni mostra alla moglie la maglia rosa nel ’55 e l’immagine storica del Leone delle Fiandre: al Giro del ’56 nonostante una clavicola rotta non si ritira, usa un pezzo di copertone per attutire i colpi e va avanti. Le immagini sono tratte dal libro Tre uomini d’oro di Giuseppe Castelnovi, EditVallardi, 168 pagine, 40 euro Antagonismi da dopoguerra FILIPPO CECCARELLI i antagonismi vive l’immaginario dei popoli. Anche se poi tra Juve e Inter, Loren e Lollo, Ascari e Fangio, Fiat e Alfa, Roma e Milano, Togliatti e De Gasperi, più passa il tempo e più le contrapposizioni si stemperano e ci si scopre, ci si ritrova e fatalmente ci si riconosce all’interno di una stessa mitologia. Nel caso di Coppi e Bartali venne quasi naturale di estendere la contrapposizione a un’opposta appartenenza politica. Uno con il Pci, l’altro con la Dc. Ma anche qui, specie per chi non c’era, il sospetto è che tale rafforzamento sia il corredo postumo di un’unica grande leggenda popolare, o almeno di una storia venuta dilatandosi al di là del ciclismo per assecondare e insieme addomesticare un dualismo allora ben radicato nella società. Perché sì, certo, Bartali era molto religioso, iscritto all’Azione cattolica, terziario carmelitano, come si trova scritto. È certo che per le elezioni del 18 aprile 1948 Pio XII, in questo anticipando modalità di questo tempo, l’avrebbe voluto volentieri in lista con la Dc. E quando proprio quell’anno non solo “Ginettaccio” vinse il Tour, ma in una celebre tappa distolse l’attenzione infuocata del paese dall’attentato a Togliatti, De Gasperi volle incontrarlo e gli chiese quel che un uomo potente, ma anche prudente, chiede a una specie di eroe e cioè cosa poteva fare per esprimergli la sua gratitudine. Al che Bartali, che era un uomo molto concreto e allora già piuttosto benestante, gli rispose che gli sarebbe piaciuto non pagare le tasse per un anno. «Ma questo non si può fare», replicò il presidente. «E allora niente», concluse il corridore con un sorriso, quindi senza farla troppo lunga — oh gran bontà de’ cavallieri antiqui! Sulla fede di Fausto Coppi nel comunismo, d’altra parte, e sulla sua adesione al Pci i documenti e le testimonianze paiono senz’altro meno rilevanti. Vero è che l’Unità faceva il tifo per lui, inviando come cronisti al Giro d’Italia addirittura due poeti, Alfonso Gatto e Gianni Rodari. Ma una delle poche pezze d’appoggio, anche se oggi più significativa di quanto potesse sembrare a quel tempo, sta nella partecipazione di Coppi, insieme con Renato Guttuso, Massimo Girotti, Claudio Villa e il giovane Enrico Berlinguer, alla giuria per l’elezione di “Miss Primavera 1950”, la Miss Italia del Pci. Per cui viene da pensare che il vero e sostanzioso motivo dell’attribuzione del campione al campo della sinistra stia più che altro in quella complessa vicenda coniugale e sentimentale che lo portò, insieme con una donna già sposata, la “Dama Bianca”, al secolo Giulia Occhini, a sfidare la corrente ipocrisia, pure democristoide, affrontando davvero un sacco di guai (reati e carcere per Giulia, ritiro del passaporto per lui, nascita del figlio Faustino in Sudamerica). E però, si legge in certi splendidi pezzi di Giorgio Bocca e anche in un’acuta pagina della Storia dell’Italia repubblicana di Silvio Lanaro (Marsilio, 1992), dopo tutto tra Coppi e Bartali ce n’era già abbastanza per farci entrare anche la politica. Tanto l’uno era triste e laconico, «misero a piedi e airone sulla bici», quanto l’altro era beffardo e chiacchierone, attento a se stesso, ma soprattutto un lottatore che non si dava mai per vinto. Opposti anche sul piano tecnico: Bartali ciclista mai domo, incandescente e volonteroso, cuore e slancio in pianura e dovunque; Coppi, passista e scalatore, era tutto gambe, muscoli, polmoni e moderne, meticolose tabelle di marcia. Due giganti, due miti, appunto, così diversi e oggi così uguali, figli di uno stesso popolo che si dedicava al ciclismo su strada con la stessa lieta passione con cui si abbandonava alla militanza anch’essa fatta di fatica, polvere e pioggia, in un dopoguerra durato troppo poco per gustarselo fino in fondo. D CLN Due documenti di Cln e Clnai trovati da Foot: i partigiani scrivono che “il Compagno Magni Fiorenzo” con una “collaborazione non scevra di rischio [...] ha reso servizi notevoli che cooperarono alla causa della Liberazione” © RIPRODUZIONE RISERVATA tocinquanta pagine riepiloga dalla A alla Z il ciclismo italiano, da Adorni a Zanazzi, dagli ultimi anni del Diciannovesimo secolo al doping industriale, passando per Giradengo, Binda, Pantani, Coppi, Bartali e naturalmente Magni. Al Terzo Uomo è dedicato un lungo capitolo. Racconta il suo modo di correre, le vittorie, il rapporto con l’Airone e il Pio, ma anche la guerra civile, il massacro di partigiani a Valibona, le indagini e il processo di Firenze nel 1947: ventiquattro gli imputati, fra cui Magni, latitante. La richiesta contro il ciclista, nel frattempo sospeso dalla federazione, è trent’anni di galera. Il 24 febbraio viene assolto, perché non si può appurare che abbia preso parte all’azione e le altre accuse rientrano sotto l’amnistia del giugno 1946 approvata da Palmiro Togliatti, ministro di Grazia e giustizia e segretario del Pci. Magni può tornare alle corse. Ma come nota John Foot: «Buona parte della sua carriera sarebbe stata interpretata in termini politici, una dimostrazione dell’inscindibilità, in Italia, tra sport e politica, oltre che della passione per le teorie cospirative». Tuttavia, lo storico inglese sostiene che nel mistero di Valibona oggi si è giunti a una svolta. «Nel 2010 — scrive — recuperai alcuni documenti originali presentati al processo dalla difesa, i quali rivelavano una versione inattesa della vicenda». Secondo due lettere ufficiali del 1945, durante il suo soggiorno a Monza Magni aiuta attivamente la Resistenza. Quella datata 14 giugno attesta che «il Compagno Magni Fiorenzo» con una «collaborazione non scevra di rischio [...] ha reso servizi notevoli che cooperarono alla causa della Liberazione». Eppure, chiosa Foot, nessun resoconto ha mai fatto cenno a questo aspetto del processo e al presunto e sorprendente passato di Magni, nemmeno lui stesso. Non lo fa neanche ora, raggiunto al telefono. Parla di Coppi e Bartali, fenomeni inarrivabili che tiravano fuori il meglio di lui. Parla delle fatiche in salita e dei suoi leggendari recuperi in discesa. Di Valibona e del processo dice solo: «Quello che conta nella vita è la nostra coscienza, il resto non ha importanza». Davanti al televisore, guarda il Giro: «Certo che ci vado anche quest’anno. Sulle Dolomiti, sono lì ad aspettarli». Torna in visita al proprio passato sempre presente, su e giù per le montagne. Ha ancora quella faccia del ’56: con i denti stringe una camera d’aria legata al manubrio, clavicola e omero rotti; finisce la tappa e poi anche la corsa, sarà secondo al suo ultimo Giro d’Italia. In salita, magari arranca, ma in discesa li supera tutti. Era il migliore. Dopo quei due. fratelli in Italia arte cinema musica poesia teatro FABRIANO 20-21-22 MAGGIO www.poiesis-fabriano.it direzione artistica: Francesca Merloni organizzazione: Associazione culturale Deca – Kind Art Srl info: 0732 3455 con il sostegno di © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 15 MAGGIO 2011 È stata la più grande etichetta di sempre. Ha scoperto Thelonious Monk, John Coltrane, Ornette Coleman, Miles Davis, Bud Powell. Tutto era cominciato SPETTACOLI con un ragazzo ebreo fuggito dalla Germania che si portava dentro le note su cui ballavano i genitori. Ora un libro racconta quella storia blue note records ORNETTE COLEMAN WYNTON MARSALIS (1930) Uno dei fondatori del free jazz negli anni Sessanta, ancora oggi sperimenta ogni tipo di musica (1961) Tra le nuove leve della scena di New Orleans, cresciuto ispirandosi a Miles Davis, ha fatto parte dei Jazz Messengers Tutte le stelle del jazz MASSIMO VINCENZI he finest in jazz since 1939, c’è scritto sotto il logo. Il meglio da settant’anni a questa parte quando si parla di jazz. Raro caso in cui la modestia sarebbe ipocrisia. La nota blu, quel battito blues che sa di terra intrisa di lacrime e risate, è semplicemente questo: the best. Spiegare a un appassionato cos’è la Blue Note Records è inutile, come parlare dei Vangeli a un credente. Questione di fede, risparmia il fiato. Ma la storia passa di bocca in bocca sino a uscire dai confini della musica. Diventa storia di uomini. La storia di un gruppo di amici che crea all’ombra cupa della Seconda guerra mondiale la più grande etichetta jazz di sempre. «Le aziende non hanno una loro mistica» — scrive Richard Cook nella biografia definitiva (in uscita da minimum fax) — «Le case discografiche sì: emana dalle copertine, dalle fodere interne e dagli spessi dischi in vinile». Retorica giustificata per chi ha pubblicato, rilanciato e/o inventato tutti i più grandi nomi del sound afroamericano. Se fossero editori di libri nel loro catalogo (messi sotto contratto da vivi) ci sarebbero Dante, i romanzieri russi dell’Ottocento, il minimalismo di Carver e infine, tanto per gradire, avrebbero pure lanciato Franzen. Se avessero fatto libri. Invece il loro mare è la musica: un oceano. L’album delle figurine è pieno di nomi illustri, non c’è alcun “manca”, sono tutti “celo”: Thelonious Monk, John Coltrane, Ornette Coleman, Horace Silver, Miles Davis, Sonny Rollins, Bud Powell, Wynton Marsalis e via elencando. Non bisogna essere degli esperti per farsi rapire: basta digitare su youtube, a caso, Blue Traino Song for My Father e la musica gira subito intorno. L’idea di tutto questo è figlia del matrimonio tra la buona sorte e uno che si danna l’anima per conquistarla. L’abile fortunato in questione è un ragazzo ebreo arrivato a New York in fuga dalla Germania nazista. Si chiama Alfred Lion, ha appena ventinove anni, da emigrante fa un po’ di tutto, ma soprattutto ama la musica e una notte d’inverno finisce alla Carnegie Hall. Dove si sono dati appuntamento tutti i più bravi: dai pianisti swing Albert Ammons e Meade Lux Lewis a Count Basie. È solo un concerto, ma la potenza di quel che sente cambia per sempre la sua vita e la storia della musica. Scriverà qualche tempo dopo: «Quando avevo cinque anni i miei genitori mi portarono in una località di villeggiatura. L’albergo aveva una sala da ballo e una grande orchestra. Mamma e papà mi mettevano a letto e andavano a ballare. Io mi rivestivo e di nascosto raggiungevo il salone. I suonatori, divertiti, mi lasciavano entrare e rimanevo per ore accucciato accanto al batterista. Significò qualcosa sentire quel ritmo». Significa tutto. A lui si uniscono un altro esule tedesco, Frank Wolff (che la leggenda vuole in salvo sull’ultima nave in fuga) e Max Margulis, uno strano tipo: scrittore marxista, non capisce poi molto di jazz, ma viene conquistato dal sapore rivoluzionario che intuisce sotto quel cumulo di suoni. Lion e i suoi amici hanno fiuto, voglia e passione. E pazienza. Tanta. Non è un ambiente facile: i musicisti sono gente complicata, ai confini della follia. Gira molta droga, innaffiata da troppo alcol che inzuppa notti senza fine su e giù per la 52esima, la strada dei locali. C’è una foto che è un racconto. Perché il jazz va visto. Non solo ascoltato. È un’immagine in bianco e nero. È T THELONIOUS MONK DEXTER GORDON JOHN COLTRANE (1917-1982) Genio del pianoforte, dell’improvvisazione, tra tradizione e sperimentazione è stato tra i più grandi compositori della storia del jazz (1923-1990) Cresciuto accanto a Louis Armrstrong e Lester Young, grande sax tenore emigrato a Parigi È considerato uno dei padri del bebop (1926-1967) La storia del jazz si divide tra prima e dopo il suo A Love Supreme. Prima di fondare la Impulse Records, il suo sax suonò per la BN un pomeriggio d’estate, il 7 luglio del 1960, la Blue Note è al massimo del successo. Fa caldo. Un ragazzo di colore legge uno spartito, la sigaretta appesa al lato della bocca, il sassofono a tracolla, un maglione innaturale per la stagione, la camicia bianca stropicciata sul collo. Lo sguardo di un equilibrista prima del salto triplo. Lui è Hank Mobley e sta per incidere il suo capolavoro: Soul Station. Incollato alle sue spalle c’è Alfred Lion, le mani come ali, l’ombra riflessa di un angelo custode: santo protettore dei talenti scheggiati. Repubblica Nazionale DOMENICA 15 MAGGIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 PROTAGONISTI IL LIBRO E I CONCERTI Accanto, Hank Mobley legge uno spartito: sassofono, sigaretta al lato della bocca, la camicia bianca stropicciata Alle sue spalle c’è Alfred Lion della Blue Note Records È il 7 luglio 1960 e Mobley sta per incidere il suo capolavoro: Soul Station Esce il 18 maggio per minimum fax Blue Note Records: la biografia di Richard Cook (traduzione di M. Bertoli, 300 pagine, 16,30 euro) Il libro sarà lanciato da una serie di concerti: domani al Salone del libro di Torino alle 20,30 in Sala azzurra con gli Ideal Standard; domenica 29 all’European Jazz Expo - Sardinia Jazz Festival al Parco di Monte Claro alle 17 e martedì 31 alla Casa del jazz a Roma alle 21 FATS NAVARRO BUD POWELL FREDDIE HUBBARD (1923-1950) Tra i pionieri del bebop alla fine degli anni Quaranta a New York e amico di Miles Davis, è considerato uno dei primi trombettisti jazz moderni. Purtroppo la sua musica, piena anche di influenze caraibiche, rimase sulla scena solo quattro anni (1924-1966) Con Thelonius Monk è considerato il più importante pianista bebop Geniale quanto disperato (1938-2008) Ragazzo prodigio, ha suonato con i più grandi del mondo, Coltrane compreso Poi la sua carriera si è appannata prima di risorgere con Hancock “Entri”, racconta Art Hodes, “e trovi una borsa piena di cibo. Cominci a suonare e non hai più bisogno di uscire Ti sembra di essere a casa tua” Ecco la formula magica, immutata da sempre: l’amore, la devozione al culto della musica e ai suoi sacerdoti. Oltre vent’anni prima, il 6 gennaio del 1939, Lion incide la sua prima session. Convince i due che l’hanno fatto piangere e ballare alla Carnegie Hall, Albert Ammons e Meade Lux Lewis e li porta in uno studio di registrazione nel centro di Manhattan. Prima del via entra in un negozio e fa scorta di bourbon e scotch: «Devono sentirsi come nel loro locale preferito», pensa. E il pianista di Chicago Art Hodes conferma: «Entri e trovi una borsa piena di cibo. Una volta che cominci a suonare, poi, non hai più bisogno di uscire. Ti sembra di essere a casa tua». Semplice, come solo l’arte più raffinata sa essere. Senza contare che alla Blue Note sono gli unici a pagare anche i giorni di prova: così i musicisti hanno il tempo per perfezionare le loro performance. Ruth, la moglie di Lion, mette un altro tassello: «Alfred faceva tutto. Si occupava delle distribuzione. Andava alle prove. Andava alle audizioni. Lavorava almeno settanta ore a settimana. Senza giorni di riposo». Perché c’è sempre del metodo dentro la follia. A completare il mosaico, il balletto di Lion. Se una registrazione non va come dovrebbe, lui resta seduto. Immobile, i muscoli della faccia tirati nell’attesa dell’evento. Quando finalmente la band ingrana, Alfred inizia a dimenarsi in regia. Prima piccoli passi impercettibili, poi agita le anche, infine gambe e braccia. Un sorriso a scrivere il lieto fine. Con i musicisti che buttano l’occhio verso di lui e capiscono di avercela fatta. L’idea è quella di una famiglia. Che lui cura con la dedizione di un fratello maggiore. Come con Bud Powell portato a casa propria la sera della prima registrazione per evitare che si riempisse le vene di eroina. Peccato che il gatto di famiglia non abbia guizzo migliore che saltargli sulle gambe. Bud, con il sistema nervoso di cristallo, dà di matto e cerca di ammazzare la povera bestia. Non ci riuscirà e poche ore dopo (inclusa sosta in farmacia) inciderà il suo debutto per la Note. C’è un gatto di mezzo anche quando Coltrane sta per firmare il suo primo contratto. Al momento di mettere nero su bianco l’accordo, il micio che vive negli uffici dell’etichetta, balza dalla finestra aperta e tenta un’improbabile fuga nel traffico. Lion gli corre dietro trafelato. Al ritorno il sassofonista non c’è più. Ma Coltrane (che ama i gatti) sente che lì dentro, in quella stramba società, c’è un clima particolare, nonostante abbia siglato un patto con la concorrente più spietata, si ricorda della promessa e incide Blue Train. Buona la prima, un capolavoro. Dettagli e istinto animale, appunto. Come per le copertine. Indimenticabili. Raro e primo incrocio nella storia del design tra grafica e immagini (le foto scattate da Wolff durante le registrazioni). Paradosso solo apparente, a compiere il miracolo è un altro a cui il jazz interessa niente: Reid K. Miles. Artista e designer che in quel momento crea copertine per Esquire e che ascolta musica classica. Miles, racconta Cook, parte subito con il piede giusto: «Deve disegnare la ristampa di un disco di Monk. Lui ci pensa ed esegue: Thelonious è spezzato su due righe con un trattino fra la o e la n in un austero carattere nero mentre Monk si staglia in bianco su uno sfondo monocromo, giallo ocra per il primo volume e rosso arancione per il secondo. Un ritratto di Monk, opera di Wolff, è ritagliato in un piccolo rettangolo in cima al quadro. Genius of Modern Music scorre sulla sinistra in minuscolo e in corpo minore». C’è un bel libro, con la prefazione di Horace Silver: Blue Note Album, the Cover Art che prende tutte le copertine dell’etichetta e le mette in sequenza senza commenti: sono immagini che suonano, gracchiano come vecchi vinili. Giri le pagine e ti si riempiono occhi e orecchie. Un album da leggenda. Che il tempo non riesce a sbiadire nonostante le classifiche non sorridano più al jazz e la Blue Note adesso brilli di luce riflessa, come il riverbero di una stella lontana. Il declino è rapido. Semplice da raccontare: Lion produce la sua ultima session il 28 luglio del 1967 con la società già passata di mano. Alfred dice alla fine: «Non riesco a comunicare con queste persone. Io ho il mio modo di fare le cose poi di colpo ecco tutta questa gente, tutte queste procedure, queste regole». Dopo quasi trent’anni se ne va in pensione sull’altra costa degli Stati Uniti dove rimane sino al 1987 quando, il 2 febbraio, muore. Il New York Timesnel ricordarlo nella pagina degli Obituaryannota una sua frase: «I dischi Blue Note sono stati pensati per essere utili all’espressione non adulterata dello swing in generale. Qualsiasi stile che rappresenti in modo autentico il sentimento musicale è un’espressione genuina. La Blue Note intende individuare il suo impulso non i suoi orpelli appariscenti e commerciali». Questa è ancora la Blue Note. Anche senza i fondatori (Wolff muore nel 1971 ancora in piena attività, stroncato da un infarto) la magia non evapora mai del tutto. E visto che la musica (simile allo sport) è come la vita, solo un po’ più bella, ecco che arriva il lieto fine. Ha la faccia simpatica di Norah Jones figlia segreta del musicista in- SONNY ROLLINS MILES DAVIS (1930) Nato in una famiglia di talenti musicali, allievo ed erede indiscusso di Charlie Parker, sa stupire ancora oggi (1924-1966) Icona pop, rude, scontroso, cosmopolita: forse il più grande trombettista jazz della storia diano Ravi Shankar. Ragazza prodigio che riporta il jazz in vetta alle hit parade: milioni di dischi venduti e premi a non finire. L’età dell’oro che ritorna. E ora, Monk, Parker, Davis e tutti gli altri sorridono come alla fine di una registrazione, vedendo Alfred Lion ballare piano al ritmo del bebop. Una mano a dare il tempo sulla schiena dell’inseparabile gatto. Che rizza il pelo arruffato dalla nota più blu che un sax abbia mai suonato. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 15 MAGGIO 2011 le tendenze È da sempre il colore della passione e cura contro ogni tristezza. Esaltato da Valentino e convolato Hot a nozze con Roberto Capucci, è stato rilanciato dai tailleur made in Italy di Kate Middleton Ora la moda punta sulla sua carica di ottimismo per disegnare le forme della nuova stagione L’ABITO Per una donna che non vuole passare inosservata. L’abito rosso senza maniche, drappeggiato e asimmetrico di Pinko L’INFRADITO In pelle lucida color corallo Con nastri intorno alla caviglia L’infradito di Twin-Set Simona Barbieri Rosso Per un’estate di fuoco LAURA LAURENZI la nostra vita, il nostro sangue, il cuore, la passione, le emozioni. Colore segnaletico per eccellenza, il rosso ha la lunghezza d’onda più ampia di tutte le altre tinte visibili. È il fuoco, è la fiamma che arde, è il semaforo che ti ordina di fermarti, è la macchina che corre più veloce di tutte, è la silenziosa barca a vela da regata. È il colore simbolo dell’impegno politico a partire dal 1848, la camicia dei garibaldini, la bandiera della rivoluzione. Segnala pericolo di vita quando è codice rosso, indica un conto in banca ormai prosciugato, è il drappo del torero che volteggia nel sole, colore della sfida, della provocazione, dell’aggressività. È automaticamente anche il colore dell’amore, della festa commerciale degli innamorati, di cuori e cuoricini spesso troppo melensi, dei baci stampati col rossetto. Ma dalla seduzione al fascino del proibito il passo è breve, a schiudere i labirinti dell’universo a luci rosse. Di rosso vestivano le prostitute, e il colore diventava un ghetto se non un marchio d’infamia, come in quel ricamo cucito sul petto dell’adultera nella Lettera scarlatta. Ma rosso fuoco, con il suo strascico e le sue creste di mikado, è l’abito da sposa più arrogante e spettacolare mai disegnato da Roberto Capucci. Se ieri era simbolo della lotta di classe, oggi è stato sdoganato e regalato al marketing. E paradossalmente si impone come nuova tinta neutra globalizzata, buona per tutte le campagne pubblicitarie e per tutte le sfilate. Il rosso vende. Non a caso è il colore di Babbo Natale e della Coca Cola, cioè dei consumi. Prima che Valentino desse il suo nome al rosso assoluto, il suo collega americano Bill Blass teorizzò: «Se sei in dubbio indossa il rosso, la cura definitiva contro la tristezza». È il colore degli abiti da ballo quando sai di potertelo permettere, il colore rilanciato da Kate Middleton ribattezzata Lady in redper i suoi tailleur made in Italy, il colore della giacca militare delle Irish Guards esibita dal principe William davanti a due miliardi di telespettatori. Il colore della mondanità e del red carpet, dei charity benefici, del fiocco rosso simbolo della lotta all’Aids, ma è anche la porpora dei cardinali e delle gerarchie ecclesiastiche, così come è la tinta dell’inferno. Moda, arte, cinema, letteratura, musica, design lo divorano, e non da oggi. Proust descrive una dama con un abito che sembra «una specie di grande fiore di sangue». Sempre rossa era la firma di Frank Lloyd Wright, rosso nel titolo il libro più amato del Nobel Pamuk e Cappuccetto rosso sangue è l’ultimissima versione pulp della celebre fiaba. Rossa è la mela di Biancaneve, rosso è il pomodoro simbolo della dieta mediterranea, rosso il sipario, rossa la voglia di mettersi in mostra. In cromoterapia è la tinta perfetta per stimolare la circolazione. È il primo colore dell’arcobaleno e anche il primo che i neonati imparano a riconoscere. L’esposizione al rosso è eccitante, accelera il battito cardiaco, rafforza la volontà e il coraggio, e proprio come una medicina ha i suoi effetti indesiderati: è sconsigliato in caso di febbre, pressione alta, stati infiammatori acuti, ipertensione, ansia, insonnia. E naturalmente problemi di cuore. È LA CAMICIA Senza maniche, sciancrata e con jabou-rouche La camicia di Elisabetta Franchi Jeans per le sere d’estate IL SANDALO In vitello rosso il sandalo intrecciato con tacco vertiginoso È la proposta per l’estate firmata Rossetti IL BAULETTO Realizzato in cotone spalmato con finiture e manici in pelle rossa tono su tono e puntali oro. Di Piero Guidi L’ILLUSTRAZIONE Abito Rosso Valentino di David Downton inchiostro e guache Londra 2006 © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 15 MAGGIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 47 PRATICA Gonna e giacca in drill di cotone stretch Ecco la mise firmata Prada per chi sceglie un look total red GLI OCCHIALI Montatura rossa con caramella torchon in metallo e Swarovski sulle aste per gli occhiali da sole Moschino L’OROLOGIO Ha cassa rettangolare in acciaio e cinturino in vernice rossa stampa coccodrillo l’orologio Tissot Txl Lady Movimento al quarzo Swiss made MORBIDA INDIANA PREZIOSA Sul corpo cade morbida la tuta short in cotone, ovviamente rosso, con maniche a tre quarti che Sonia Rykiel propone per l’estate 2011 La gonna è in triplo crepe di organza Il top in triplo crepe di seta Per la donna che sceglie Costume National Una pioggia di macro-paillettes per rendere prezioso e brillante l’abito corto stile impero di Patrizia Pepe Laura Lusuardi/direttore creativo di Max Mara “Ma il vero colpo di teatro è il total look l’importante è unire minimal e tinte forti” SIMONE MARCHETTI LA BORSA È in materiale sintetico di colore rosso il bauletto che chiude con la zip Proposta di Carpisa enace, curiosa, informatissima. Laura Lusuardi, direttore creativo di Max Mara, è una figura unica nel panorama del Fashion system. Parte dell’azienda emiliana da quasi quarant’anni, ha dimostrato non solo una grande preparazione, ma soprattutto capacità d’adattamento e previsione eccezionali. Oggi è tra i pochi addetti ai lavori a contribuire attivamente alla formazione e alla scoperta di nuovi talenti. Lo scorso settembre è stata tra i primi designer a puntare sui colori forti per le passerelle della primavera estate 2011. Cosa pensa del ritorno del rosso nel guardaroba delle donne? «Contrariamente a quanto si creda, il rosso e i toni forti sono stati proposti da pochi stilisti. La loro consacrazione a tendenza, infatti, viene dai magazine di moda che li hanno promossi sulle copertine e negli editoriali. Il successo del carminio, in particolare, è legato soprattutto all’aurea d’ottimismo e di originalità che racchiude. Nella nuova stagione, infatti, le donne hanno bisogno di sentirsi più positive e insieme più particolari. Per questo hanno scelto il rosso: per la sua capacità di assecondare queste due esigenze. Devo ammettere, però, che è stata comunque una sorpresa vedere polverizzati i capi colorati appena arrivati in boutique». Esistono tanti tipi di rosso. Qual è la tonalità da raccomandare? «Il rosso proposto sulla passerella di Max Mara è un tono molto vicino all’arancio: è una mischia piena di luce, con mille sfaccettature. Parlare di un tono preciso, però, non ha molto senso oggi. Fino a ieri, infatti, si potevano T identificare due tipi di rosso: il “Valentino” e il “Marlboro”, quello del pacchetto di sigarette. Oggi tutte le sue sfumature sono diventate utilizzabili. Il motivo è molto semplice: dopo il bianco, il nero e il beige, il rosso è ormai considerato un colore neutro, qualcosa che sta bene a tutte e si può mischiare con tutto». Quali sono, allora, gli abbinamenti consigliati? «Direi di evitare il classico accostamento rosso-blu-bianco, un mix che ha un sapore troppo marinaio, oggi superato. Al contrario, bisogna puntare sul total look, con giacca, body, pantaloni e scarpe tutti nella stessa sfumatura. Chi vuole qualcosa di meno shocking, invece, può andare sul sicuro abbinandolo al bianco che ne enfatizza la leggerezza. Infine, poiché il rosso sarà di moda anche il prossimo inverno, nella stagione fredda raccomando di accostarlo a tutti i toni cammello: il mix risulterà sofisticato e molto moderno». Ci sono degli abiti particolari su cui puntare? «Sicuramente l’abito lungo, da indossare magari con una micro borsa di un tono neutro: è un po’ il contrario di quello che si faceva in passato, quando a un tubino beige si abbinava una pochette rossa. Bellissimo il cappotto o lo spolverino rosso, pezzi di grande fascino da abbinare a tutto. Il vero colpo di teatro, però, resta il total look carminio: l’importante è puntare sulla pulizia delle forme di giacca, top e pantaloni. Unire minimal e colori shocking è la tendenza più sofisticata del momento». © RIPRODUZIONE RISERVATA FLOREALE Abito in chiffon di seta ricamato con paillette a motivi floreali Da abbinare a una collana con piume e pendenti. Dior IL DECOLLETÉ Ha la forma di un rossetto l’originale tacco di questo décolleté in vernice Di Alberto Guardiani ROCK SEDUCENTE STAR Chiodo in pelle con zip in metallo dorato su abito décolleté in raso di seta con impunture geometriche Di Blumarine Top a fascia in viscosa su pantalone Seventies di jersey rosso e cardigan La proposta estiva di Max Mara Rosso fuoco anche per il trench impermeabile di Tommy Hilfiger che piace alle star: l’ha indossato, per esempio, Renée Zellweger Repubblica Nazionale 48 LA DOMENICA DI REPUBBLICA i sapori Trasgressioni DOMENICA 15 MAGGIO 2011 Dovremmo starne alla larga, ma ne siamo irresistibilmente attratti. Eppure, come spiegheranno a Genova quelli di Slow Food, un altro modo di gustare alici, sogliole e triglie croccanti, dorate, cotte nell’olio bollente e mangiate è possibile I PESCI Gamberi Calamari Acquadelle Alici Sgusciati, con o senza coda, devono essere privati del budellino scuro attraverso una piccola incisione sul dorso, prima di immergerli nella pastella Puliti e tagliati a rondelle, asciugarli bene per evitare schizzi in frittura Passaggio in farina di riso o semola per migliorare la croccantezza Si passano nella farina, setacciando per eliminare quella in eccesso. Una volta fritte e asciugate su carta assorbente si servono in cartocci di carta-paglia Togliere testa, viscere e lisca centrale, lasciandole aperte a libretto, prima di infarinarle e friggerle. Eccellenti marinate in vino, aceto e cipolla Pangrattato Uovo Pastella L’impanatura classica — uovo intero e pane grattugiato, come nella cotoletta — acquista fragranza sostituendo il pane normale con la mollica del pan carré Si utilizza intero, sbattuto, o solo il bianco, montato quasi a neve (frittura più lieve). L’immersione avviene prima o dopo il passaggio in farina o pangrattato Nella versione tempura, acqua ghiacciata insieme a uovo e farina o maizena, oppure farina e birra, acqua frizzante, zafferano e zenzero grattugiato Temperatura Sale La caramellizzazione di proteine e carboidrati comincia sopra i 140 gradi Per evitare la degradazione dell’olio, bisogna restare sotto i 180 I migliori sono marini integrali o colorati, ricchi di gusto e poveri di sodio. Comunque da aggiungere solo a fine frittura, per evitare di inumidirla LE TECNICHE Farina Qualche cucchiaiata in un sacchetto da gelo, pochi pezzi alla volta inseriti e scossi prima di passarli nel colapasta evitando che l’olio saturi le fibre LE REGOLE Padella Alta, coi bordi spessi, di ferro o alluminio, per diffondere il calore e mantenerlo in cottura. Per estrarre il pesce, cestello o mestolo bucato largo (ragno) Olio Extravergine, meglio se di gusto poco intenso (ligure, lacustre), per riempire due terzi della pentola Utilizzare la seconda volta solo dopo filtratura Frittura dipesce L’eterna lotta tra sano e buono LICIA GRANELLO 200 le calorie per 100 g di pesce fritto 210° il punto di fumo dell’extravergine 1912 scoperta della glicazione delle proteine iamo fritti! disse l’alice al calamaro. Difficile pensarli diversamente. Certo, l’una e l’altro possono soggiacere a cotture diverse: alla griglia, col pomodoro, in tortiera. Perfino offrirsi nudi e crudi, specie se di piccole dimensioni. Ma nessun’altra modalità suscita la stessa salivazione immediata, il richiamo del mare e quello della cucina vacanziera ritrovata nel giro di pochi bocconi, da gustare con avidità mal trattenuta. Il fritto è — come si dice — la morte loro. Nulla rappresenta meglio del fritto di mare l’eterna lotta gastronomica tra il bene e il male. L’ingrediente-elisir — meno carne e più pesce!, predicano i nutrizionisti — prigioniero della preparazione trasgressiva per antonomasia, la leggerezza della materia prima contaminata dalla pesantezza del grasso cotto, il cibo che abbatte il colesterolo cheek-to-cheek con chi il colesterolo — quello cattivo, per giunta — lo costruisce, molecola su molecola. Dovremmo starne alla larga, ne siamo irresistibilmente attratti, per quella summa di dettagli che costruiscono un mito gastronomico, addirittura a prescindere dalla qualità finale di quello che mangiamo. Non si spiegherebbe altrimenti la fama mondiale di fish&chips, merluzzo e patatine in cartoccio senza riguardo per la qualità delle materie prime, cotto in grassi pessimi: mangiarlo è un godimento che ci riporta indietro negli anni, cucina d’infanzia e attualissimo peccato di gola. Le antinomie, per fortuna, sono anche altre, dal contrasto morbido-croccante di polpa e impanatura alla miscellanea che apparenta pesci poverissimi e super crostacei, uniti nel sacro nome della pa- S ranza, madre di tutte le fritture di mare, perché tutto accoglie nel padellone di ferrifero annerito. Ce ne siamo dimenticati, ma il fritto di pesce nasce proprio lì, in riva al mare, ovunque arrivasse un gozzo con il suo carico più o meno generoso. Sfoltito il pescato delle varietà più pregiate, destinate al mercato, si friggeva quanto restava, senza troppo curarsi delle proporzioni tra uno e l’altro elemento di questa sorta di misticanza marina. Abbiamo guadagnato in tecnica — niente oli di bassa qualità, grassi che fumano, limone che ammolla la pastella — ma perso in varietà, votati come siamo ai comandamenti della pigrizia ittica: gamberi e moscardini, cozze e sogliole. Poco importa che siano quasi tutti di allevamento, oppure surgelati. Se volete sapere che cos’è il fritto verace, che riempie le narici e scrocchia sotto i denti, programmate una gita a Genova dove a fine mese si svolge la quinta edizione di Slow Fish, manifestazione di Slow Food dedicata alla cultura dell’acqua, ai suoi prodotti e alla sua gente. Che si traduce in dibattiti sulla pesca sostenibile e laboratori del gusto, cene didattiche e aste mattutine. Altro appuntamento prezioso quello con Biolfish — Monopoli, Bari, 1-5 giugno — incentrato su acquacoltura biologica e pesca sostenibile, con menù tematici dove il fritto di mare sarà re indiscusso. In caso di dubbi, sfogliate Il mare in cucina, manuale storico-sociologico di gastronomia ittica di Enrico Gurioli e Alessandro Molinari Pradelli, pubblicato da Gribaudo. Scoprirete la poesia delle sarde in saor, rigorosamente fritte prima di essere battezzate con aceto e cipolle. Un bicchiere fresco di pigato o di falanghina annegherà i sensi di colpa. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 15 MAGGIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 49 itinerari Napoli Cesenatico (Fc) DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE IL SALOTTO DI LUCILLA Passo Palestro 3 Tel. 010-882391 Camera doppia da 80 euro colazione inclusa PALAZZO TURCHINI Via Medina 21 Tel. 081-5510606 Camera doppia da 130 euro colazione inclusa CASINA LE CONSERVE Piazza delle Conserve 5 Tel. 0547-675581 Camera doppia da 130 euro colazione inclusa DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE OSTERIA DA PIPPO Salita alla Chiesa di Fontanegli 13 Tel. 010-809351 Chiuso lunedì, menù da 30 euro COMANDANTE DEL ROMEO HOTEL Via Cristoforo Colombo 45 Tel. 081-0175001 Sempre aperto, menù 70 euro LA BUCA & OSTERIA DEL GRAN FRITTO Corso Garibaldi 45 Tel. 0547-1860764 Aperto a pranzo e a cena DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE ANTICA FRIGGITORIA CAREGA Via Sottoripa 113/r Tel. 010-2470617 TIMPANI E TEMPURA Vico della Quercia 17 Tel. 081-5512280 FRIGGITORIA DA CIRO Viale Trento 39 Tel. 0547-83821 LA RICETTA Genova Chef per sette anni all’hotel Bulgari, Milano, Elio Sironi si è spostato in Sardegna, dove guida la cucina del “Madai” di Liscia di Vacca, Arzachena Crema fine di fagioli di Pigna, mozzarella e cozze fritte al curry Ingredienti per 4 persone gr fagioli di Pigna •• 300 1 gambo di sedano carota •• 11 cipolla bianca con 4 chiodi di garofano •• 1200patata polpa di cozze •• 20 grgrcurry gr semolino •• 100 100 gr latte scremato gr extravergine •• 200 1 mozzarella di bufala • maggiorana Cuocere i fagioli con la patata, aggiungendo carota sedano e cipolla, da togliere a fine cottura. Frullare il composto, emulsionando con l’olio Cuocere le cozze pulite al vapore qualche minuto, sgusciarle e immergerle nel latte, impanarle con semolino e curry prima di friggerle Nella scodella, mozzarella a tocchetti, trito di maggiorana, pepe, olio, crema di fagioli di Pigna e cozze fritte Fragranza, paranza e fish&chips MARINO NIOLA er fare un grande fritto il pesce va cotto in fragrante. Ma anche colto in flagrante. Perché l’essenza della frittura è proprio la flagranza, ovvero la vampata improvvisa che trascolora il cibo e incendia il gusto. A santificare un calamaro in pastella, ad accendere di gloria un merluzzetto infarinato, a far brillare di luce propria un gamberetto, a mettere l’aureola a una trigliozza, a trasformare un’alice in una meraviglia e una soglioletta in una lamina dorata e croccante è sempre e comunque la frittura. Che fa letteralmente risplendere il sapore. Lo fa deflagrare, ma proprio alla lettera. Perché la parola fritto discende da una lontana radice indoeuropea, che ha a che fare con il flagrare, cioè con tutto ciò che è ardente, sfavillante, incandescente. Calore e fulgore. La stessa radice da cui derivano flamen, nome dell’antico sacerdote romano del fuoco e del fulmine, e l’indiano Brahma. Come dire che un pescetto fragrante e un nume flagrante hanno qualcosa in comune. E infatti pochi cibi sono divini come una frittura eseguita come dio comanda. Umile e prelibato, semplice e raffinato, il pesce fritto è l’emblema di un mangiare democratico. Di una comunione evangelica, come quella dei psaria, i pescetti che Cristo moltiplica per sfamare le masse. Non a caso il cartoccio di frittura mista è sempre presente dove la vita popolare esplode allo stato fusionale, e confusionale. Nelle piazze, nelle feste, nei mercati. Non solo street, non solo fast ma anche fest food. Cibo schietto per una schietta umanità. Come le anciue e i gianchetti che si mangiano nelle friggitorie di Genova tra le volte fumose e lo scuro degli angiporti dove si insinua la nostalgia salata delle creuze de ma. E gli scartossi che si vendono nei tanti fritolini veneziani persi nel labirinto di calli e campielli. Mentre la fragaglia e la paranza napoletane hanno la stessa vitalistica mescolanza, la stessa concitata armonia della città che si specchia nel golfo delle sirene. E a Siviglia, la Feria de abril ha il suo climax nella noche del pescaíto dove si mangia esclusivamente pesce appena fritto, bruciante come il canto delle trianeras. Le gitane che friggono e trafiggono con secolare innocenza, con antico istinto sacerdotale. Dalla juderia di Siviglia al Barrio del pópulo di Cadice alle marisquerías di Malaga, la via del fritto attraversa tutta l’Andalusia e risale l’Europa seguendo il filo d’Arianna della diaspora sefardita. Fino alle atmosfere anseatiche del Fischmarkt di Amburgo con le sue friggitorie ambulanti che a partire dalle sei del mattino servono tonnellate di pesce fritto a un popolo da Soul Kitchen. E, last but not least, i templi londinesi del fish and chips, altro capolavoro di gastronomia pop, giunto in Inghilterra con l’arrivo degli ebrei migrati da Spagna e Portogallo portandosi dietro la tradizione arabo-andalusa del pescaíto. Che evidentemente è così buono da conquistare tutti i palati. Al di là delle religioni, delle gastronomie, delle ideologie e persino delle dietologie. Perché il fritto e mangiato è il basic istinct del sapore. P © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 50 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 15 MAGGIO 2011 l’incontro Viene visto come un capriccioso narcisista quando rifiuta di essere definito direttore della fotografia: “Sono un cinematographer, uno che scrive con la luce” Figlio di un proiezionista, a settant’anni e tre Oscar (Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore) ripercorre una vita fatta di disciplina e ricerca: “Non avrei mai ideato l’illuminazione del volto di Kurtz/Brando senza conoscere Caravaggio” Maestri Vittorio Storaro ittorio Storaro non cede volentieri all’aneddotica, non concede facilmente scorci e risvolti biografici, episodi di vita, insomma ciò che fornisce materia per comporre il ritratto di un personaggio. E non c’è dubbio che sia un personaggio. Per essere esatti, anzi, Storaro è assolutamente una star internazionale: a parte il prestigio che sfiora l’adorazione di cui gode in giro per il mondo secondo una globalità di fama che da un pezzo nessun nostro regista conosce, lo dicono inequivocabilmente le tre statuette dorate degli Oscar. Collocate su uno scaffale stracolmo di riconoscimenti che, senza ombra di civettuolo understatement, campeggiano al centro del salone di casa. Ricevute nell’ordine cronologico per Apocalypse Now, Reds (alla premiazione, alla chiamata di Storaro sul palco scattarono le note dell’Internazionale: incongruo e buffo effetto nel tempio dell’americanismo) e L’ultimo imperatore. Per raggiungerne il nucleo bisogna passare attraverso l’ascolto delle verità che gli stanno terribilmente a cuore, raggiunte attraverso un’elaborazione teorica paziente e puntigliosa, decenni di disciplinata ricerca, approfondimento, studio e pensiero. Da quando, a vent’anni, prese il diploma al Centro sperimentale (stessi anni di corso di Marco Bellocchio) ai settant’anni di oggi. Un caso raro per la tribù del cinema, tranne forse tra gli sceneggiatori che sono (meglio: erano) gli intellettuali e gli ideologi della settima arte; caso unico nei campi tecnico-artistici, dove anche i geni conclamati specialmente se delle generazioni più anziane hanno sempre glie»), di aspettare le occasioni giuste, di scegliere i lavori e gli interlocutori e, anche molto prima e non solo quando era già diventato Vittorio Storaro, «di dire tanti e difficili no». Dopo l’occasione che intorno ai ventotto anni gli dischiude le porte del futuro come lo vuole lui — il film è Giovinezza giovinezza, il regista è Franco Rossi — gli incontri decisivi saranno tre. Il primo è con Bernardo Bertolucci, verso il quale nutre e conserva un sentimento speciale che deve avere a che fare con la sete inestinguibile di cultura del giovane Vittorio quando si lega (soprattutto a partire da Il conformista) a quel coetaneo così diverso, sofisticato e un po’ viziato, di famiglia supercolta, abituato a trovare nel salotto di casa il gotha della cultura italiana. Bertolucci, dunque, e poi Francis Coppola e Warren Beatty. Il temerario avventuriero seguito nello sprofondo della giungla filippina (da dove l’altrettanto esigente Vittorio impose che il “girato” venisse settimanal- Nella mia carriera ho sempre trovato il gusto e il piacere di tornare ogni volta studente, prendendomi il giusto tempo per riflettere e le pause necessarie FOTO AGF V ROMA coltivato il vezzo dell’ignoranza, del tenersi un passo indietro al “dottore”, al regista, dell’insofferenza alle teorie e perfino della rozzezza. E unico in particolare tra i cineoperatori, tra i direttori o “autori” della fotografia. Infatti Storaro respinge tutte queste definizioni. «Io», dice battendosi come un tenacissimo guerriero solitario contro l’ormai inespugnabile vizio lessicale «che ha da sempre scambiato un ruolo per un luogo fisico, sono un cinematographer, come dicono a Hollywood: sono un cinematografo. Uno che scrive immagini in movimento, uno che scrive con la luce». L’incontro e l’ascolto hanno luogo a casa sua. Complesso residenziale nei pressi del sobborgo romano di Frattocchie, nome leggendario per chi sa che fu lungamente sede della scuola quadri del Partito comunista togliattiano. Nel corso di una visita durata diverse ore, compreso invito a pranzo da parte dell’ospitale signora Storaro, presenti due dei tre figli e due dei numerosi nipoti in un’atmosfera di via vai e di «c’è sempre un piatto caldo in tavola, per tutti». La lunga conversazione che precede ha luogo in una dépendance della villa, nel regno personale di Storaro, uno studio tutto in legno a forma ottagonale con al centro una tavola rotonda. Ambiente, ricercato ma non sfarzoso, che dice parecchio della sua ricerca di ordine esteriore e interiore. L’ispirazione viene dalla Biblioteca di Celso a Efeso, la concezione è di Mario Ceroli, la lavorazione a cura dei suoi artigiani. Tutto, ma proprio tutto intorno al padrone di casa trasuda un senso di conquista e di volontà, di cui fa parte anche l’idea di una famiglia che gioca compatta, stretta intorno al suo capo. Raggiungimento degli obiettivi. Soddisfazione per il lungo cammino compiuto da un ragazzo romano figlio della guerra e figlio di un proiezionista. Precocemente inappagato dall’istruzione professionale e limitata che la sua origine gli ha permesso. Immediatamente inappagato dall’impronta riduttivamente tecnica dei corsi di via Tuscolana destinati alle competenze diverse da quella di regista. Affamato di sapere e di cultura e subito convinto «che non si possa fare a meno di conoscenze pittoriche e filosofiche, letterarie e architettoniche e musicali» e tutto il resto — oltre che sapere tutto di lenti, obiettivi, esposizioni e di tecnologia specifica — per fare il suo mestiere, per esercitare la sua arte. «Non avrei potuto ideare l’illuminazione del volto di Kurtz/Marlon Brando senza conoscere e studiare la luce di Caravaggio». Ma anche capace, a costo di rimetterci e di tirare la cinghia («avevamo in tutto novantamila lire in tasca, con mia mo- mente spedito non ai laboratori californiani ma a quelli romani, di cui si fidava di più) dopo aver capito che «non si trattava solo del Vietnam ma di Conrad e di un viaggio al termine della follia umana». E il divo che dimostrò di non essere soltanto il piacione di prima categoria che è, ma anche un coraggioso disposto a mettere la propria faccia e la propria carriera a rischio, in piena era Reagan, con un monumento alla Rivoluzione d’Ottobre e al comunismo. La triade fondamentale. Ma tra le svolte, tra i fatti e gli incontri fondamentali Vittorio ne mette anche un altro e ci tiene tantissimo. All’inizio degli anni Ottanta comincia a frequentare L’Aquila dove un gruppo di giovani cinefili appassionati, sotto la guida di Gabriele Lucci, hanno dato vita alla prima iniziativa seria e qualificata che del cinema sceglie di indagare non gli aspetti più indagati — regia, scrittura, recitazione — ma le altre arti e gli altri mestieri, la fotografia specialmente. Diventa un polo di attrazione per i pezzi più grossi, nazionali e internazionali. Per dirne uno: Nestor Almendros, mitico collaboratore di Truffaut. Diventa via via, da associazione culturale e piccolo festival, molte altre cose. «Diventa una vera università del cinema, l’accademia delle arti e delle scienze dell’immagine, centro didattico di eccellenza». Presso il quale per molto tempo Storaro insegna (ma sul serio, e cioè non limitandosi a fare la guest starconferenziera che concede un’apparizione e via), e spinta propulsiva per un’attività editoriale di grande valore alla Electa-Mondadori. Storaro, dall’alto dei traguardi raggiunti, resta fedelmente e lealmente grato per i tre imponenti volumi su di lui pubblicati a partire dal 2001 sotto il titolo Scrivere con la luce, tanto che ora nel pubblicarne un quarto riassuntivo e definitivo con la sola Electa (incluso Dvd, 100 euro, onestamente non troppi per la confezione lussureggiante) ha voluto, dopo averne maniacalmente curato ogni minimo dettaglio, dedicarlo agli amici aquilani la cui attività è stata brutalmente interrotta dal sisma dell’aprile 2009 e, malgrado impegni di facciata e stanziamenti virtualmente disponibili, tuttora bloccata. «In barba a quello che dovrebbe essere sentito come un patrimonio che onora la città». A conoscerlo appena un po’ oltre la superficie (e oltre il suo smisurato piacere di ascoltarsi parlare) si vedono i tratti della sua coerenza, onestà, diciamo dirittura e anche semplicità di valori e sentimenti. Dice che la sua battaglia apparentemente nominalistica e apparentemente capricciosa e narcisistica — domanda: quante resistenze, quante diffidenze ha incontrato sulla sua strada; quanti colleghi hanno fatto dell’ironia sulle sue fissazioni e sui suoi proclami, quanti registi si sono sentiti un po’ minacciati e invasi dal suo protagonismo? — «è in realtà lo specchio della mia umiltà. Direttore è soltanto il regista. Solo lui, come il direttore d’orchestra, tiene i fili di tutto e ha diritto a questa qualifica. Del resto in inglese il regista si chiama director. Quindi cinematographer non è un vezzo di presunzione ma proprio il contrario». Consapevolezza di servire, certo non da tecnico ma da artista alla pari, un disegno più grande il cui titolare è un altro. Risulta abbastanza chiaro, seguendo il suo itinerario, che tra le tante cose che lo interessano, Storaro è molto attratto dalla spiritualità e dalle modalità per rappresentarla. Per illuminarla. Vedi Il piccolo Buddha. Si emoziona a rimettere insieme il filo di una concatenazione di casualità — pronto a interpretarle come segnali di conferma «che le cose prima o poi succedono se vuoi fortemente e fermamente farle succedere» — che ora, proprio ora, lo sta facendo incontrare con un film dedicato all’infanzia di Maometto. E che, forse, prima o poi, gli permetterà di arrivare al progetto dei progetti. Un film su Gesù. Volontà, applicazione, studio, ordine. Fermarsi, ogni tanto, quando si sente che le cose rischiano di girare tanto per girare: «È quello che ho fatto ciclicamente nel corso della mia carriera, con il gusto e il piacere di tornare ogni volta studente, prendendomi il tempo di riflessione e le pause necessarie». E tuttavia, cosciente del lavoro e dell’ambizione investiti e dei risultati raggiunti e soprattutto del proprio talento eccezionale, Storaro aggiunge un altro tassello: «Ho avuto anche molta, molta fortuna». © RIPRODUZIONE RISERVATA ‘‘ PAOLO D’AGOSTINI Repubblica Nazionale
Scarica