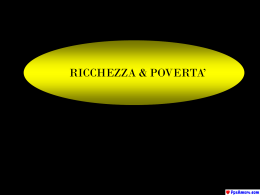RIPORTIAMO DI SEGUITO ALCUNI TESTI DI ARTICOLI FIRMATI DAL SEGRETARIO RESPONSABILE DEL SAB MARIO PERTICI SUI TEMI SOCIALI DI VOLTA IN VOLTA D’ATTUALITA’, A DIVERSO TITOLO SECONDO I RUOLI RICOPERTI NELL’ASSOCIAZIONISMO, SULLE VARIE TESTATE LOCALI. GLI ARTICOLI NON SONO IN ORDINE DI STAMPA E PERTANTO E’ POSSIBILE CHE LA LORO CONSEGUENZIALITA’ NON SIA COERENTE. OCCORRONO NUOVE OCCASIONI DI CRESCITA Nell’ultimo articolo pubblicato su La Spalletta del 10 Settembre a pagina 33, cercavo di sottolineare come per uscire dalla crisi, così come è avvenuto più volte nella storia, occorresse da una parte concedere alle famiglie (impresa di base della società) sicurezza economica e sociale e, dall’altra, eliminare in modo definitivo e strutturale gli agenti ostili a questo patrimonio da tutelare. Invece fino ad oggi ci siamo limitati ad attrarre la curiosità commerciale e ad aumentare la propensione a spendere del nucleo familiare. Non per investire in beni durevoli, ma in tecnologia, che ha senza meno causato “nuovi bisogni” ma che ha potuto comunque aumentare la qualità della vita dei singoli individui. Tutto ciò ha fatto indebitare le persone e il tasso di risparmio sul reddito prodotto in Italia (quanto si accantona di ciò che si guadagna) che nel 1975 era del 27-28% oggi è meno del 5%. Quindi abbiamo fatto crescere il PIL facendo indebitare le famiglie e facendole risparmiare meno perché la platea alla quale ci rivolgevamo era stazionaria. In molti dicono che la crisi economica globale sia dovuta al fatto che siamo in troppi sulla Terra, troppe bocche da sfamare, io credo che sia vero perfettamente il contrario, concordando con molti addetti ai lavori che, ovviamente, sono ben più attrezzati di me. La crisi economica è invece dovuta al fatto che da oltre trent’anni i Paesi ricchi del mondo occidentale non creano le condizioni affinché si facciano più figli e si cresca adeguatamente di numero. Ciò che invece accade ai così detti Paesi emergenti che prima erano poverissimi e adesso cominciano ad essere ricchi, come ad esempio la Cina. Il crollo delle nascite costituisce quindi un elemento fortemente negativo per la crescita economica. Infatti se la popolazione rimane stazionaria per un periodo di tempo significativo, tale stagnazione comporta un adeguamento della struttura sociale: aumentano le persone anziane che andando in pensione escono dal ciclo della produzione ed entrano in quello del costo. L’effetto economico è che aumentano i costi fissi della struttura sociale e quindi aumenta la spesa pubblica. Il primo rimedio che si è visto prendere per coprire la spesa pubblica (che d’altra parte si è adattata ai cresciuti bisogni della popolazione) è quello di aumentare le tasse: drammatico perché di fatto toglie ricchezza alla produzione e fa si che l’accresciuta spesa sia ancora più pesante rispetto alla produzione e quindi pretenda ancora più tasse. Il secondo rimedio che si è visto prendere, acclamato come una panacea, è il forzato contenimento della spesa pubblica e quindi il minore soddisfacimento dei bisogni della collettività. Invece che aprire il cassettone di casa per prendere i soldi e spenderli, lasciando la tavola del pranzo magari più povera e il libretto del risparmio sicuramente più vuoto, occorrerebbe farsi una domanda chiave: in un momento come questo, di crisi economica, di calo della produzione e dei consumi e di dilagante disoccupazione, quali sono le risorse che abbiamo a disposizione per far crescere il Paese e sostenere l’occupazione? Sembrerebbe puro buon senso se nel momento della difficoltà non tagliassimo indiscriminatamente imponendo tasse a tutti, né diminuissimo il sostegno a chi ha bisogno, ma cercassimo di eliminare il superfluo… e quanto superfluo oggi continua a fare mostra di sé! Attingiamo quindi in parte a questa riserva naturale, con una tassa sui grandi patrimoni ad esempio (escludendo le imprese ma considerando le stesse quale patrimonio delle persone fisiche proprietarie) e con una più stringente lotta all’evasione fiscale non solo di facciata. E ripetiamo l’operazione per almeno dieci anni. Poi, anno per anno, con il tesoretto così ottenuto, possiamo costituire un fondo per lo sviluppo, che può essere gestito ad esempio dalla Cassa Depositi e Prestiti. Quindi possiamo finanziare con il suddetto fondo decine di migliaia di piccole e medie imprese, attraverso il sistema bancario italiano, con le forme tecniche da decidere. In questa operazione evitiamo di drenare risparmio investito, ma assorbiamo solo quello accumulato in eccesso e improduttivo. Diamo una forte scossa allo sviluppo che rappresenta l’unica strada per diminuire il debito pubblico, senza diminuire la spesa pubblica che è indirizzata al sostegno dei più deboli (là dove non ci sono gli sprechi…). Provochiamo un rafforzamento competitivo delle nostre imprese che creano crescita, occupazione e ricchezza tassabile, giustamente tassabile. Questa è la mia opinione e non mi pare estremamente complessa o difficile, né può essere l’unica via, perché il lavoro è tanto per combattere evasione, sprechi, privilegi (da non confondere con i diritti) sacche improduttive, appesantimento burocratico, costi della politica ecc… Ma intanto potremmo iniziare da lì rafforzando la famiglia e l’impresa, il risparmio e la produttività… Una volta tanto senza restringere il palco delle nostre opportunità ma creando nuove occasioni di crescita. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ OCCORRE UNA SVOLTA DECISA E RESPONSABILE Mentre in apparenza, secondo le fonti di statistica ufficiali, il numero dei poveri non aumenta, esce il rapporto annuale della Caritas, che inizia proprio dal mettere in dubbio questi metodi di rilevazione. Non possiamo infatti fermarci alla fotografia dell’attuale, che è molto problematica, senza rileggere l’immagine che otteniamo in prospettiva e vedere, ad esempio, come la difficile condizione giovanile diventerà domani drammatica. Stiamo infatti distruggendo il tessuto sociale, privandolo della certezza del futuro e della possibilità di creare, all’interno delle famiglie, una progettualità per i figli. E nonostante tutto questo non rinunciamo a “tassare” tutte le generazioni, ma soprattutto questi giovani già poveri, con la più grande delle imposte: il consumismo, l’imposizione dei bisogni, la cultura miserrima della moda. E contemporaneamente realizziamo politiche che fanno concentrare la ricchezza e lo facciamo anche male, visto che il nostro reddito, in uno scenario complessivo internazionale che volge verso l’impoverimento, subisce un ulteriore impoverimento relativo, divenendo da 106/100 a 93/100 della media europea, media, come detto, sempre più bassa. Ma non consentiamo, tramite l’imposizione dei consumi, di ridimensionare la nostra propensione alla spesa, nemmeno quella delle famiglie più povere, tant’è che molte delle nuove povertà nascono proprio dalla rincorsa al possesso dei beni di consumo, numerosi indebitamenti derivano da un comportamento irresponsabile. D’altra parte, la diminuzione della spesa pubblica, tramite la contrazione dei servizi offerti alla popolazione, penalizza sicuramente i meno abbienti, i quali si trovano a dover spendere ancora di più (esempio la tata perché non c’è l’asilo) o a rinunciare a forme di reddito (la mamma non va più a lavoro). Spesso non c’è nemmeno bisogno di rinunciare al lavoro, perché non c’è e quindi si contrae drammaticamente sempre di più il panorama delle opportunità. Questo è un Paese soprattutto privo di opportunità e avaro di progettualità. I centri Caritas rilevano un aumento del 30% delle richieste di aiuto e criticano concretamente il metodo ISTAT di rilevamento della povertà (reddito medio inferiore a quello che consente una capacità di acquisto per due persone di 992 euro al mese) e non considera la grande schiera di coloro che superano questo limite di pochissimo grazie agli aiuti (pubblici o privati): se si contasse il fenomeno al netto degli aiuti si avrebbe la misura esatta del fenomeno. Poi ci sono quelli che non sono compresi nella lista grazie a contratti a termine o al lavoro al nero, ma che andranno domani a ingrassare la grande schiera dei poveri. Sono i poveri di domani, senza scampo, che costruiamo con le nostre politiche. Ed anche quelli più bravi, che riusciranno per decenni a svincolarsi grazie alla loro del tutto personale abilità di districarsi nel mercato del precario e del sommerso, saranno poveri senza scampo al momento della pensione che non avranno saputo e potuto costruirsi. Sempre che questi soggetti possano esistere visto che l’atipico oggi ha un reddito medio di 336 euro al mese: invece di dare lavoro ai poveri stiamo incrementando i poveri di domani, inducendo moltitudini ai confini della povertà, uccidendo ogni loro possibilità di cittadinanza reale. Qualche altro dato: oltre il 40% dei figli degli immigrati abbandona precocemente il lavoro e altrettanto precocemente viene sfruttato in un vortice di lavoro minorile (quando va bene); uno su cinque degli utenti Caritas ha meno di trentacinque anni e negli ultimi quattro anni i giovani assistiti sono cresciuto di quasi il 60%. I 50 miliardi all’anno di spesa sociale impallidiscono di fronte ai 130 miliardi di evasione fiscale (sottostimata). E quei 50 miliardi devono essere erogati tramite servizi e non prevalentemente come avviene attualmente con trasferimenti di denaro, oggi il 90%. I servizi infine possono essere sospesi per gli evasori, piccoli e grandi, come ad esempio l’assistenza sanitaria… si suggerisce che l’evasore se la paghi visto che non ha precedentemente contribuito. Ma soprattutto, sapendo che non si sfonda con la repressione, occorre ripensare modelli impositivi che promuovano, meglio dell’attuale, la correttezza dei più, perché conviene. Gli altri dovranno adeguarsi. E infine occorre migliorare i controlli, a tutti i livelli, per tutti gli ambiti, senza per questo cadere in uno stato di polizia ma per risvegliarsi così fra gente seria e responsabile. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ DISTRUZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI E AZZERAMENTO DELLA SPESA PER I DIRITTI E’ questo il sottotitolo di un “libro nero sul welfare italiano” presentato a inizio mese in Senato dalle campagne “Idiritti alzano la voce” e “Sbilanciamoci” che analizza gli effetti della legge di stabilità e degli altri correttivi economici decisi nel corso del 2011. Non solo “valuta gli impatti dei tagli sugli enti locali e i servizi ai cittadini, esamina la delega al governo per la riforma fiscale e assistenziale”, non solo ci presenta dati e informazioni, ma suggerisce anche una serie di proposte anche nel come reperire le risorse per definire i livelli minimi delle prestazioni sociali, i servizi che devono essere garantiti e i diritti esigibili da ogni cittadino. Insomma ridisegna lo stato sociale. La denuncia si può ricapitolare i questo riquadro: Descrizione GLI STANZIAMENTI COMPLESSIVI DEI FONDI SOCIALI NEGLI ANNI 2007-2013 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010- 2011 – 2012 - 2013 Fondo nazionale per le politiche sociale al netto della quota INPS Fondo infanzia e adolescenza Fondo a sostegno della non autosufficienza Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati Fondo per le politiche giovanili Fondo per le politiche della famiglia Fondo per la promozione delle pari opportunità 1.000 44 100 50 130 220 50 TOTALE 1.594 712 44 300 0 130 330 44 578 44 400 0 130 239 30 435 40 400 0 81 174 3 218 39 0 0 13 51 17 70 40 0 0 13 53 17 45 40 0 0 11 31 17 1.559 1.420 1.134 339 193 144 Il totale dei fondi si è quindi ridotto a meno del 10% di quanto era nel 2007, senza considerare l’influsso della svalutazione e quindi del valore effettivo di quanto stanziato. Il commento dei redattori del rapporto sfata il discorso che in tempi di vacche magre sono questi i costi che vanno tagliati. Anzi. “annichilire le politiche sociali in Italia, come sta facendo il governo da tempo, non ci farà uscire dalla crisi, ma aggraverà la situazione dell’economia. I provvedimenti adottati sono stati socialmente iniqui, colpendo le classi a basso e medio reddito e non toccando privilegi e ricchezze, risultano puramente di facciata per quanto riguarda il rilancio dell’economia, pesantissimi nel campo delle politiche sociali, lasciando così il Paese ancora più indifeso ed esposto alla crisi.” E allora? Ecco le proposte che i due Organismi sottopongono a Palazzo Chigi. “Aumentare la dotazione dei fondi nazionali per le politiche sociali, introdurre il reddito minimo di inserimento (2 miliardi di euro), stanziare un miliardo per l’avvio di almeno 3000 asili nido, istituire un fondo di 800 milioni di euro per garantire un’indennità di disoccupazione ai precari, prevedere uno stanziamento di 200 milioni per il sostegno sociale all’affitto e di 300 milioni aggiuntivi per il canone agevolato, alzare dai 113 milioni di euro del 2011 a 300 milioni lo stanziamento per il servizio civile.” Ma dove prendere le risorse per tutto ciò? Secondo le due Associazioni tali misure di promozione sociale che diverrebbero anche di crescita economica, andrebbero finanziate “attraverso una tassa patrimoniale, una revisione della tassazione sulle rendite finanziarie, il ritiro delle truppe dall’Afganistan, la rinuncia al programma di produzione di 131 cacciabombardieri, la chiusura dei Centri di identificazione ed espulsione (113 milioni da destinare all’integrazione dei migranti), la revisione delle convenzioni con le strutture sanitarie private”. Un segno di speranza, un vero progetto (migliorabile) per il futuro. Ed ecco che la crisi potrebbe trasformarsi in “un’occasione straordinaria per rivedere i nostri modelli economici e culturali, modificando gli stili di vita e mettendo da parte le teorie che hanno causato il disastro attuale”. Come dar loro torto? ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ COSI’ I CONTI NON TORNANO Abbiamo detto e ripetuto più volte che al centro delle politiche deve starci la famiglia, che solo la ricchezza dell’istituzione familiare è ricchezza vera e che se si vuol far riprendere l’economia quella è una strada forzata. Ma mentre lo si dice mettiamo in pratica in effetti tutto il contrario, infatti si sta realizzando un progressivo impoverimento irrefrenabile. Gli ultimi sono stati dieci anni di terrore. Tutto è iniziato dal 2002, con l’arrivo dell’euro e i mancati controlli sui prezzi: i cento beni e servizi di maggior consumo hanno avuto infatti un aumento medio del 53,7% fino ad oggi. Se l’aumento del reddito delle famiglie è aumentato del 2,3% rispetto al giugno 2010, i costi sono aumentati invece del 3,7%, continuando una tendenza che restringe sempre di più la possibilità di arrivare al fatidico 27 del mese: si spende sempre di più per comprare sempre di meno. Confcommercio ci dice infatti che, in 17 regioni su 20, si registrerà a fine anno un livello di consumi inferiore a quello del 2000 (considerate cosa significa pensando all’inflazione). L’ISTAT ci dice che anche la capacità di risparmiare è ritornata ad essere quella del 2000. Il risparmio complessivo delle famiglie si è ridotto di un miliardo l’anno e quindi di 20 miliardi negli ultimi venti anni, con un crollo complessivo del 60%. E se nel 1990 le famiglie potevano risparmiare in media 4000 euro, nel 2010 non sono andate più avanti di 1.700, ma la differenza è ancora maggiore se si attualizzassero quei 4000 euro, che nel 1990 valevano senz’altro più di oggi. Anche per il mangiare le famiglie spendano meno cercando soprattutto il risparmio nei discount. E a farne le spese non sono soltanto i prodotti superflui, ma anche quelli di prima necessità: addirittura il pane diminuisce e viene comprato di meno dell’8,5%, il pesce del 4,8% e la pasta dell’1,6%. Non basta più nemmeno tirare la cinghia perché la crisi è profonda. Le tariffe dei servizi pubblici locali e delle utenze domestiche (dalle quali nessuno può fuggire) sono aumentate del 6% in 4 anni e l’inflazione è stata del 2,3% in due anni. I nonni si adoperano intensamente e riescono a far risparmiare in media 200 euro a famiglia, soprattutto facendo i baby sitter. Il 30% delle famiglie NON risparmia, poco meno investe nella propria casa e comunque in immobili, intorno alla stessa percentuale mantiene la liquidità sul conto corrente perché ha paura della vita e delle sorprese che può presentare, solo il 10% investe in titoli e solo il 5% in consumi. Ma con un quadro di questo tipo come si può far ricrescere l’economia? Con solo il 5% della ricchezza (?) delle famiglie investito in consumi? Il 5% di una ricchezza che precipita anno dopo anno e che in 20 anni è diminuita del 60%? E cosa ci dicono gli economisti sul prossimo futuro? Ci dicono che, stanti gli attuali provvedimenti legislativi, la ricchezza nei prossimi anni calerà ancora di più, addirittura oltre il 6% entro il 2014. No: i conti così non tornano e non possono tornare. E’ inutile che il governo discuta di sviluppo (magari proponendo nuove tasse!) se al primo posto dell’agenda non c’è la difesa della capacità di spesa delle famiglie! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ IL LAVORO E IL MODELLO DI SOCIETA’ CHE CI OCCORRONO NON POSSONO DIPENDERE DAL MERCATO OCCORRE STIMOLARE LE IMPRESE A COMPIERE AZIONI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E FAMILIARE L’impegno di dar vita ad associazioni di lavoratori per la difesa dei propri diritti, oggi più di ieri, deve essere onorato più che mai dalla politica, che deve pretendere il massimo dell’etica nell’esercizio di una tutela così importante e delicata. Nel contesto della crisi, l’incertezza del lavoro porta difficoltà personali e sociali gravi, che offendono la dignità della persona e quindi le “esigenze della giustizia” richiedono, con rinnovata urgenza e rinnovato vigore, che si continui a perseguire quale priorità sia l’accesso al lavoro per tutti che il mantenimento del lavoro per chi ce l’ha. E’ evidente che tutto ciò non può che avvenire in una funzione dialettica, se non proprio antitetica, rispetto alla logica mercantile. Occorre una “civilizzazione dell’economia” rispetto alla forte tendenza speculativa che sta invadendo la società. Infatti una “economia civile” deve in ogni caso considerare la valenza sociale dell’impresa (come fa la costituzione italiana d’altronde) e la conseguente responsabilità nei confronti delle famiglie dei lavoratori, della collettività e dell’ambiente. Questa concezione dell’economia, con la conseguente tutela dei diritti sociali, è parte integrante della democrazia sostanziale e l’impegno a rispettare l’una e gli altri non può dipendere meramente dall’andamento delle borse e del mercato. D’altra parte, in questa prospettiva, guardare al lavoro significa vedere in esso ben più di un’occupazione o di una carriera, ma soprattutto l’esercizio della cittadinanza, la realizzazione di una vocazione, qualcosa di connesso direttamente al senso della vita. Altrimenti perché sarebbe così importante il lavoro? Perché dovremmo difenderlo con tanto impegno? E invece ci attendono tempi duri, perché i difensori della visone commerciale del lavoro e della vita ci diranno che un quarto della forza lavoro non potrà trovare in futuro spazio nelle aziende e che saranno scelti coloro che accetteranno lavori umilianti. Alle persone, prime fra tutte le donne, verrà chiesto di scegliere fra lavoro e famiglia e di adattarsi alle necessità delle imprese. E invece dobbiamo pretendere lavoro per tutti, decente e con tempi conciliati con la famiglia. Sarà l’impresa che dovrà adattarsi alla società che l’accoglie e non viceversa. Per ottenere ciò occorre prima cambiare il concetto di impresa. Imprenditore è chi crea “valore aggiunto”, non il profitto. E il terzo settore, pur essendo senza scopo di lucro, è forse quello che crea maggior valore aggiunto nella comunità. Cooperative, consorzi, fondazioni, sono imprese a tutti gli effetti e potrebbero assorbire gran parte della disoccupazione: per far ciò però occorrerà cambiare in questo il codice civile del 1942. Infine se concediamo alle imprese sociali gli sgravi delle onlus, potremmo avere in poco tempo cinquantamila aziende in più con una media di cinque addetti ciascuna, il tutto a zero costi per lo Stato, che anzi ci guadagnerebbe ovviamente in entrate. Una parte della sfida è quindi agevolare il terzo settore per dare lavoro a tutti. Un altro aspetto importante è anche decidere che lavoro vogliamo. In un’epoca post industriale non è ammissibile avere modelli mutuati dalla fabbrica. L’adattare quei modelli al mondo del lavoro di oggi significa umiliare i lavoratori. Per ultimo occorre smetterla di far passare quali politiche per la famiglia le leggi che incentivano il lavoro femminile, che è sacrosanto e va incentivato, ma spesso oggi avviene proprio a scapito della famiglia. Quello che occorrerebbe incentivare oggi, quello che occorrerebbe stimolare nelle imprese invece è “compiere azioni di responsabilità sociale e familiare”. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ DAL MEDIOEVO UNA RICETTA PER SUPERARE LA CRISI ECONOMICA (e sociale) Quando nel 1989 crollò il muro di Berlino tutti noi capimmo che era giunta la fine di un modello politico ed economico, non furono in molti a dire però che anche l’altro modello in competizione, quello del capitalismo, avrebbe raggiunto ben presto il proprio capolinea. E questa volta il travaglio sarebbe stato ben più doloroso, per prima cosa perché sarebbe mancato il competitor e quindi il crollo non sarebbe stato frutto di una sconfitta, ma di vere e proprie patologie interne, di un logorio crescente; e poi un conto è rimanere poveri, un conto è impoverirsi. Nel primo caso la speranza, il sogno del progresso rimane, nel secondo caso emerge soprattutto la delusione. Tutto ciò probabilmente accadrà, a meno che si riesca a comprendere la storia e ad auto correggersi. Ma è possibile trovare le giuste modifiche? Come spesso accade possiamo fare appello all’esperienza che la storia ci propone e possiamo guardarci indietro per capire come procedere in un futuro che non ci proponga il crollo del sistema occidentale, ma ci faccia scoprire l’altra faccia del progresso, ciò che fino ad oggi abbiamo trascurato fin troppo. In effetti il dibattito che sta prendendo campo in questi mesi fra i politici e gli economisti, si rivolge con insistenza, spero anche con attenzione, agli storici medioevalisti, per comprendere come allora siamo riusciti a mettere la parola fine alle distorsioni di un periodo piuttosto buio. UN TARDO MEDIOEVO MOLTO SIMILE AD OGGI - In quei tempi, la ricchezza era assai concentrata a danno della collettività. L’usuraio o il bargello del tempo ad un certo punto si rese conto di aver preso più di quanto dovuto e si chiese come fare a risarcire. Non bastava lasciare in punto di morte i propri beni ad un ente pio dedito alla carità, per salvarsi l’anima, ma occorreva fare qualcosa in vita. (‘) I potenti cercarono in un certo senso di ridistribuire la ricchezza con la creazione di Ospedali, Case di accoglienza, Sanatori e quant’altro. Questi sforzi erano tesi ad aiutare i più derelitti, vittime privilegiate di quel sistema perverso che vedeva al centro del malessere l’usura. Proprio l’Italia, nell’ultimo periodo del Medioevo, viveva una esperienza molto simile a quella attuale, con grandi speculazioni e una significativa spinta alla crescita. E gli ospedali rispondevano non solo al bisogno economico della collettività che non aveva i fondi per creare da sola le strutture per la sanità pubblica, ma accoglievano anche le persone anziane rimaste sole, le vedove, gli orfani: rappresentavano insomma la reazione della città che proteggeva le classi più deboli. Certo molti Ospedali erano stati fondati molto prima ad opera dei Vescovi (soprattutto per accogliere i pellegrini); ma verso la fine del Medioevo diventarono veri e propri istituti di “stato sociale”, oggi si direbbe strumenti di ridistribuzione del reddito. Senza un sistema di protezione sociale una società non può reggere alle proprie crisi. La protezione prescelta e attuata in quei tempi di per sé non modificò il sistema: si curavano i sintomi, ma la malattia rimaneva. LA SOCIETA’ PARTECIPO’ AL CAMBIAMENTO - Ed anche la cultura intervenne critica in questo processo di rinnovamento sociale, non risparmiando certo i propri giudizi. “Ecco la fiera con la coda aguzza, che passa i monti, e rompe i muri e l’armi; ecco colei che tutto ‘l mondo appuzza!” Dante inizia così il canto XVIII della Divina Commedia. Trovandosi nell’Inferno, vede gente seduta sul sabbione infuocato che, soffrendo e piangendo per questo a dirotto, cerca di difendersi con le mani nude da un’insistente pioggia di fuoco. Sono gli usurai, cioè coloro che in vita prestavano somme di denaro ad interesse e per questo ritenuti “peccatori contro natura”. Nel medioevo infatti, dal 1200 in poi, con l’economia italiana distrutta dalle guerre civili e straniere, ma fervente di operosa ricrescita, nonostante il divieto canonico dell’usura (‘’), è frequentissimo il caso di privilegi concessi, a prestatori singoli o a compagnie di prestatori, per aprire sulle pubbliche piazze un banco di prestiti su pegno. Anche a Volterra questi prestatori autorizzati erano per lo più forestieri, in massima parte Ebrei, ai quali era proibito di possedere immobili, per cui esercitavano il mestiere di accumulare denaro e imprestarlo al maggior tasso che potessero conseguire, senza preoccuparsi di guidare e neppure di rispettare minimamente la crescita economica della città che li ospitava: loro infatti non le appartenevano. Tale era ormai la penetrazione dell’usura nella società dell’epoca che non ne condizionava pesantemente solo i normali rapporti di potere all’interno delle diverse collettività, coinvolgendo tutti gli ambiti civili, ma era ormai assunta quale arma politica in grado di modificare gli equilibri di potere su vasta scala, nel contesto regionale e nazionale. L’esercizio dell’usura, rimase ad uso esclusivo degli Ebrei e dei Comuni i quali molto spesso si trovavano coalizzati, per condizionare l’economia e le politiche del territorio, per distribuire deroghe e concessioni, per accumulare ricchezze e beni a tutto scapito delle classi più povere della città, finché, il 18 dicembre 1494, non fu istituito il Monte di Pietà. Ecco: la istituzione dei Monti di Pietà costituì la cura grazie alla quale si riuscì a trovare la forza necessaria ad uscire letteralmente dal Medioevo. IL MONTE DI PIETA’ ANCHE A VOLTERRA - Quando si parla del Monte Pio di Volterra è molto difficile non andare con la mente a Raffaelo Maffei, detto “il Volterrano” il quale, con l’aiuto del vescovo Sederini, nonostante la marcata avversione della dominante Firenze, il 18 dicembre 1494 riuscì a fondare l’Istituto volterrano. Raffaello Maffei nacque a Volterra il 17 febbraio 1451 e sebbene di nobile e ricca famiglia, fu molto umile e portato “a sovvenire molto largamente alle necessità del prossimo”. Morì nel 1522 e fu sepolto nella chiesa di San Lino (da lui stesso fatta edificare) “in un onorevolissimo sepolcro di mano di Silvio da Fiesole, scultore eccellente dei suoi tempi, conforme alla grandezza del suo merito ed alla nobiltà della famiglia”. Ma una buona parte del merito della fondazione del Monte Pio a Volterra va anche a Fra‘ Timoteo da Lucca, al secolo Girolamo Medici da Moncigoli, il quale era ritenuto “illustre predicatore, uomo di governo, religioso austero, molto apprezzato dai privati e dal pubblico per la fama di santità che lo circondava, e cortese nei modi, tanto da sembrare nobile”, mentre dai Fiorentini, data la loro avversità alla creazione dei Monti di Pietà era considerato “homo scandaloso, il fomentatore di plebi, un pericolo più che notevole” perché con le sue prediche “poteva esercitare un influsso senza pari, divenendo meglio di chiunque altro consigliere e guida di popolo”. E’ ben certo comunque che Fra’ Timoteo, durante la sua permanenza a Volterra, lasciò una chiara traccia del suo passaggio, caratterizzata al favore del popolo e contro l’oppressione fiorentina, tant’è che partecipò all’istituzione del Monte Pio, ne compilò addirittura gli statuti, nei quali è indicato come fondatore del Monte stesso. Effettivamente con i Monti di Pietà si riuscì a dare una pronta risposta ai bisogni più urgenti delle classi meno agiate e da ciò riprese tutta l’economia nazionale. Nonostante che siano trascorsi i secoli, la grandezza dei personaggi che operarono è tutt’altro che spenta. Infatti, se il Monte Pio è inoperante, è pur vero che la Cassa di Risparmio di Volterra è la testimonianza storica della volontà e del sentimento civico di un cospicuo numero di insigni cittadini i quali, “pur ponzando, ponderando e studiando per tanto tempo…”, nel novembre del 1893, ad onore e vanto della Città, riuscirono nel loro arduo intento. E PER I NOSTRI TEMPI? - Qual è oggi la cura? Nessuno sa se da sola sarà sufficiente, ma di certo occorre capire che la famiglia non è soltanto una componente casuale sul palcoscenico economico del Paese, non è un soggetto esterno sul quale possono indirettamente ricadere i riflessi delle diverse manovre: non è una riserva dalla quale attingere per migliorare lo stato di salute della società. E’ questo un tragico malinteso! La famiglia è la società. La famiglia costituisce la cellula di base della collettività, l’impresa con la quale inizia ogni processo produttivo. La ricchezza vera è quella in possesso delle famiglie, il risparmio delle famiglie, il saldo attivo del bilancio famigliare: se tolgo dieci alle famiglie e lo reinvesto nella società, questo dieci non è più ricchezza e occorrerà verificare se è stato investito bene (e ritornerà ad essere ricchezza) o se andrà perduto in tutto o in parte. Così come fu per il Medioevo, la medicina è una sola: la politica deve sostenere la famiglia, rinforzandola e affiancandola nelle più diverse prospettive. Si sente parlare che per dare spinta all’economia occorre rendere il lavoro più precario e non si capisce che così facendo si precarizza ancora una volta la famiglia e con lei tutta la società. Per una società forte, fatta di imprese forti (in Italia soprattutto piccole e medie - spesso a conduzione familiare però anche le grandi) capace di investire, capace di reintegrare con la ricchezza diffusa anche il debito pubblico, capace di fare ricerca e di costruirsi il futuro, capace di immaginare una scuola ed una amministrazione pubblica che funzionano e una politica più diretta espressione del popolo, occorre che l’istituzione “famiglia” sia forte, abbia prospettive certe, un reddito assicurato, opportunità di investimenti, certezza di tutele anche sul piano dell’ordine pubblico. Tutto questo, nonostante tutto, si era ben compreso nel dopoguerra, mentre oggi, questa spietata economia ha una forte componente autolesionista e disperata, che tende a giustificare sistematicamente l’interesse privato con la demagogia, cerca di confondere i diritti con i privilegi e tende ad eliminare i doveri perché mettono i paletti al malaffare. La famiglia è il segreto. Noi tutti apparteniamo ad una famiglia, la nostra. Ripartiamo da qui. (‘) – Non si trattava solo di una crisi mistica. Anche se nella società di allora la componente religiosa era assai più forte di adesso, quella crisi di coscienza ebbe origini soprattutto sociali: derivò da una maggior cultura e da una più cosciente sensibilità. (‘’) - L’usura anche ai nostri tempi è proibita per legge e la legge ne determina i confini. Ma è bene chiarirne subito il concetto: al di là delle differenze interpretative che nella storia sono state date all’usura, più formali che sostanziali, è usura l’eccessivo compenso ottenuto grazie ad un prestito di denaro concesso approfittando dell’impellente stato di bisogno di una persona. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ MA QUALI TAGLI LINEARI ? Quante volte sentiamo parlare dei “tagli lineari” definiti così perché vengono immaginati come uguali per tutti e quindi, essendo indipendenti dalla capacità di reddito, di spesa e patrimoniale dei cittadini, colpiscono di più i più poveri. Non è questo un modo corretto di definire tali diminuzioni della spesa pubblica perché da l’idea di una ripercussione sulla popolazione falsa e volutamente ingannatrice. Infatti i tagli lineari colpiscono quasi esclusivamente i target più poveri non tanto perché essendo rivolti a tutti penalizzano i più deboli, ma proprio perché sono indirizzati esclusivamente a questi ultimi. Facciamo, fra i tanti possibili, l’esempio dei tagli “lineari” dei trasferimenti dell’amministrazione centrale a quelle periferiche di comuni, province ecc… Per prima cosa queste amministrazioni sono costrette a tagliare i servizi resi gratuitamente ai coloro che ne hanno bisogno, oppure ad annullare eventuali progetti a favore delle categorie più bisognose, ovvero a ridimensionare i contributi a sostegno delle gestioni di servizi pubblici che verranno quindi a mancare sempre per i meno abbienti, perché gli altri già non ricorrono a tali risorse o se lo fanno sanno dove poter trovare una valida alternativa con un onere, per loro, sostenibile. (PRIMO DANNO). Il rivedere i propri impegni di spesa da parte della pubblica amministrazione significa poi penalizzare fortemente il sistema della cooperazione sociale. Le quattordicimila cooperative sociali in Italia danno lavoro a 320 mila dipendenti, per il 54.5% appartenenti alle categorie svantaggiate. Minori trasferimenti quindi significa minore occupazione proprio in quelle categorie per le quali lo Stato dovrebbe essere in prima linea per sostenere l’integrazione sociale tramite il lavoro, perché questa consente, oltre ovviamente una tutela dei diritti alla persona e una crescita etica e civile della socialità, anche un forte risparmio sul fronte sanitario per la prevenzione che il lavoro stesso va a costituire in queste categorie “più deboli”. (SECONDO DANNO) Nonostante che in questi tempi di magra le cooperative abbiano aumentato il proprio contributo all’occupazione del 5.5% nell’ultimo biennio, la pubblica amministrazione, sempre più alle strette, è costretta a ritardare i pagamenti dei servizi, con una dilazione che ormai ha raggiunto i 270300 giorni, il che costituisce un onere insostenibile. A peggiorare le cose, l’amministrazione centrale ha visto bene di aumentare l’IRES dal 30% al 43%, rendendo per il futuro assolutamente impossibili nuove crescite di occupazione nel settore (TERZO DANNO). I contratti fra le cooperative e la pubblica amministrazione sono calati del 9% in un anno e di questi quasi il 70% erano destinati ai più bisognosi tramite servizi (45,2%) o tramite progetti mirati (23,”%) (QUARTO DANNO). In queste condizioni è sempre più difficile sostenere la ricerca della creazione di un valore aggiunto o di innovazione nell’opera di queste realtà economiche e sociali. Infatti il così detto valore aggiunto o innovazione che nel 2008 era dell’1,95% dei servizi e dei progetti realizzati, è passato all’1,45%. Ma cosa significa ciò? Significa che è diminuito il valore che si riesce a generare tramite una delle quattro aree di innovazione: 1) sviluppo di nuovi prodotti e servizi; 2) individuazione di nuovi clienti; 3) individuazione di nuove aree geografiche nelle quali operare; 4) miglioramento dei processi e dell’organizzazione interna (QUINTO DANNO). Per uscire da questa situazione di difficoltà, le cooperative sociali stanno spostando il fulcro dei rapporti dalla pubblica amministrazione alle aziende profit. Ciò significa che cessano di creare valore aggiunto nel sociale in via sistematica, per ricercare nella maggioranza dei casi preminentemente il profitto fine a se stesso. Ciò impoverisce i servizi offerti ai più bisognosi e cancella completamente alcune tutele. Ma nel fare ciò viene anche persa una grande parte della professionalità che nel no-profit gli operatori si erano creata e che non recupereranno mai più, perché nel no-profit, ben più che nel profit, le capacità si costruiscono con un percorso di conoscenza e di esperienza, che viene così cancellato. (SESTO DANNO). E potremo continuare all’infinito, ma fermiamoci a questi sei danni: dove vedete voi un taglio lineare? Io vedo che il taglio fatto ad esempio alle pubbliche amministrazioni ha danneggiato soprattutto le categorie più bisognose e non certo tutti nello stesso modo. IL PROGRESSO NON E’ UN PRIVILEGIO Uno dei mali peggiori della società italiana contemporanea è il precariato dei giovani lavoratori e in generale perché il contratto di lavoro precario non consente quella continuità necessaria a costruirsi una pensione per il domani ed una stabilità per l’oggi, tant’è che quella generazione rischia di essere mantenuta dai nonni prima e dai nipoti dopo. Non solo, ma l’incertezza del lavoro impedisce una valida progettualità per il futuro, per farsi una famiglia, avere dei figli, comprarsi una casa… bisognerebbe che adesso reintroducessero anche l’ICI per la prima casa e poi i giovani perderebbero davvero ogni speranza. Inoltre non avere una occupazione garantita mette il giovane in un rapporto con il datore di lavoro occasionale di estrema fragilità, di ricattabilità, di rinuncia di fatto ai propri diritti sancita da leggi e contratti. La precarietà impoverisce quindi il livello di cittadinanza della popolazione, il grado di cultura della collettività, la capacità progettuale delle giovani generazioni, l’opportunità di creare le nuove famiglie e la forza di avere e crescere i propri figli. Quindi, senza entrare troppo nei particolari, appare evidente che il precariato è una piaga sociale e riuscire ad eliminarlo rappresenterebbe un progresso non indifferente. Oltre alla precarietà del lavoro esiste la elasticità del lavoro, che prevede la mobilità da un lavoro all’altro senza per questo rimanere disoccupati. Per esperienza posso dire che non può esistere elasticità senza precarietà e chiudere così il discorso; ma accettiamo per mera ipotesi che sia possibile e realizzabile su larga scala una elasticità che non confluisca inevitabilmente nella precarietà: che dire? Il lavoro è inserito come pilastro della società anche nella carta costituzionale, ma non un lavoro qualunque, non si intende solo la parte remunerativa, ma come lavoro si intende anche la professionalità, il mestiere. Sono questi elementi che erano tenuti molto in considerazione dalle precedenti generazioni e che oggi, invece, vengono trascurati oltre il comprensibile. Il saltare da una occupazione all’altra significa essere gestiti dalla collettività come numeri, quasi che non sia importante l’esperienza che viene concretizzata in anni di attività. E’ chiaro che un lavoro così inteso, cioè privo di contenuti, è un lavoro di serie B, che impoverisce la personalità del cittadino, ma impoverisce anche la società dei suoi saperi. Il mestiere e la professionalità sono capacità importanti, sono patrimoni della collettività e quindi tutelarli è progresso, non certo privilegio. Ecco quindi che abbiamo acclarato come la lotta al precariato nelle sue diverse forme e accezioni, rappresenti una forma di progresso. E’ anche evidente che il progresso non potrà mai coinvolgere tutti contemporaneamente e quindi non possiamo dire che i lavoratori a tempo indeterminato, rispetto agli altri, godono di un privilegio, bensì che i precari vivono una situazione di disagio, che deve essere superata, che superarla costituisce il progresso e che l’obiettivo è quello di dare un lavoro ed un mestiere o professione a tutti i cittadini. Sono questi discorsi difficili? Non mi sembra. Credo che siano l’espressione di puro buon senso. E allora perché non si ragiona sempre così? Prima di tutto è facile intuire come la televisione e i giornali (ma soprattutto la televisione) nel rendere plausibile ogni opinione, nel tritare nel macinino insieme le ipotesi più diverse, da quelle ispirate appunto dal buon senso a quelle dettate dalle più bieche demagogie, rende tutto relativo, non esistono più le verità e i valori sono messi in continua discussione. E invece no! Il lavoro è un valore! Il miglior lavoro è progresso e lavoro precario è disagio e va combattuto. Chiunque dica diversamente è in malafede oppure è molto superficiale, in ogni caso tende a raggiungere risultati utili a pochi che intendono rafforzare la propria posizione a scapito di molti. La domanda in questi casi è sempre la stessa: a chi giova avere un mondo del lavoro fatto prevalentemente di precari? E invece: a chi giova avere una collettività supportata dal lavoro sicuro e professionale? La domanda la lascio a ciascuno di noi… ma certo è che occorre essere ben più fermi nelle nostre convinzioni, ancorati ai nostri valori, certi di ciò che vogliamo per i nostri figli.
Scarica