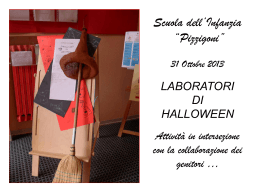Domenica La di DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 Repubblica il reportage Le quattro vite del barbiere di Pechino FEDERICO RAMPINI il racconto Matti da fotografare, cent’anni in mostra UMBERTO GALIMBERTI e MICHELE SMARGIASSI Che tempo farà VITTORIO ZUCCONI A BOULDER ll’ombra di tre monti piatti come un trittico d’altare, la bambina pallida si butta dentro un tornado. Un vecchio con occhi lacrimosi guarda bruciare il mondo e io scuoto la sfera della Terra fra le dita, spostando correnti in quota, nubi, pioggia: che faccio, inaridisco la Francia o inondo il Sahara? Per un’ora, tra i giochi seri e le simulazioni scientifiche, noi siamo i signori del tempo, del vento, dei ghiacci e della pioggia, qui dentro il santuario delle nuvole e del sole dove anche i turisti possono giocare a dio con il clima, diventare quel dio collerico del 2005 che ha martellato l’America di tempeste come mai aveva fatto prima, 23, addirittura più dei 21 nomi previsti per battezzarle, visto che dopo l’ultimo uragano, Wilma, si è dovuto ricorrere alle lettere greche, Alpha, Beta. Tuoni lontani scendono dalle pale d’altare e rotolano verso questo altipiano del Colorado intriso di sangue indiano. Scuotono le vetrate dell’edificio che I. M. Pei costruì quarant’anni or sono alla maniera degli Anasazi, dei Pueblo Indians, di quei “selvaggi” che cinquemila anni or sono sapevano già quello che oggi noi stiamo costretti a riscoprire con i supercomputers e i satelliti: che della Terra noi non siamo i padroni, ma i custodi. E che stiamo facendo un pessimo lavoro. Su una delle gibbosità rocciose che in Colorado chiamano “boulder”, sta appollaiato il più importante centro di ricerca, divulgazione e predicazione atmosferica del mondo, lo Ncar. Contiene la più grande biblioteca meteorologica del sistema solare, con l’equivalente di 3,6 miliardi di libri come quelli di Harry Potter, aperta a tutti, splendida come sa essere l’America quando è ancora l’America che amiamo. Solitario e un po’ superbo, come i nidi delle aquile che qui ancora volano e non sono finite impastate sui biglietti di banca, il National Center for Atmospheric Research, lo Ncar appunto, è il Vaticano della meteorologia e della climatologia. È il contenitore nazionale nel quale 66 università americane riversano e poi si contendono a borsettate, come coltissime comari al mercato, gli spiccioli dei finanziamenti pubblici concessi alla ricerca da un governo indifferente. Si arrangiano con un budget annuale ridotto a 150 milioni di dollari, peanuts. Meno di quanto costa una settimana di guerra in Iraq, per rispondere alla più semplice e fondamentale delle domande per la sopravvivenza dell’umanità: che tempo farà domani? Venire in pellegrinaggio fino al castello color sabbia e roccia che consacrò il nome di Pei nel mondo dell’architettura quattro decenni or sono, per chiedere se domani pioverà, può sembrare blasfemo come violare un Conclave per chiedere chi sarà il nuovo parroco di Piazza Brembana. (segue nelle pagine successive) con un servizio di ANTONIO CIANCIULLO FOTO ZEFA Repubblica Nazionale 29 30/10/2005 Uragani, siccità, Terra sempre più calda In Colorado 200 scienziati e il mega-computer Blue Vista studiano il clima futuro Siamo andati a interrogarli le storie Recanati, il collezionista dei suoni ATTILIO BOLZONI i luoghi Viaggio nella Los Angeles emiliana CARLO LUCARELLI cultura Gli anni del Made in Italy autarchico NATALIA ASPESI spettacoli L’occhio di Kubrick prima di Kubrick ENRICO FRANCESCHINI e MARIA PIA FUSCO 30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la copertina Emergenza meteo DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 A Boulder, sulle montagne del Colorado, dentro un edificio costruito a somiglianza dei pueblo indiani, sorge lo Ncar, il centro di studi climatologici più avanzato al mondo. Duecento scienziati tengono sotto controllo l’effetto serra, il riscaldamento della Terra e le sue conseguenze. Siamo andati a chiedergli che tempo farà nell’autunno del 2105 I sacerdoti del clima impazzito VITTORIO ZUCCONI (segue dalla copertina) a i duecento sacerdoti delle nuvole che lavorano qui dentro mi disingannano subito dal pregiudizio che indovinare le previsioni del tempo sia quell’esercizio che i telegiornali italiani affidano alle formule marmoree della «possibilità di precipitazioni anche a carattere temporalesco sui rilievi», cioè forse, magari, ma non è detto, pioverà. La previsione del tempo è uno dei problemi più complessi e sostanzialmente insoluti nella storia dell’umanità, come ognuno di noi terricoli può testimoniare quando, inzuppati di pioggia sulla spiaggia con la moglie furiosa e il bimbo in lacrime, malediciamo le previsioni «che non ci prendono mai». L’enigma del clima e del tempo, parola che nelle lingue romanze non distingue, a differenza dell’inglese, del tedesco, del russo fra “tempo atmosferico” (weather) e “tempo cronologico” (time) affonda le radici nella “teoria del caos”, popolarizzata nella immagine della farfalla in Amazzonia che battendo le ali produce pioggia in Ucraina o siccità in Oklahoma e dunque rende astronomiche le possibili variazioni. Il problema di valutarle tutte già affascinò il genio della matematica francese Poincarè. Attrasse il primo teorico riconosciuto del caos, Lorenz e appassionò i padri della cibernetica. Von Neuman, colui che inventò il linguaggio binario di “zero” e di “uno” che ogni calcolatore parla, pensò immediatamente di applicare il computer alle previsioni del tempo. Il suo ritratto, mi fa notare il dottor Joe Tribbia, che tra i sacerdoti delle nuvole è appunto il teologo del “caos”, osserva corrucciato la sala riunioni dello Ncar dalla parete. In questo autunno 2005, nell’America tramortita da un numero straordinario di uragani feroci oltre le profezie più pessimistiche, attonita dalla morte di una città come New Orleans, costretta a vedere che mai da quando si tengono con cura le temperature (1880) si vide un settembre così caldo nel mondo, una processione di convertiti e penitenti dell’“effetto serra”, persino politici di grande calibro come la senatrice californiana Barbara Boxer che telefona continuamente per avere notizie, hanno bussato a queste porte come villici terrorizzati da una nuova pestilenza, per chiedere lumi e rimedi. Come se questi uomini e queste donne, che spendono una vita soltanto per studiare le minuscole bollicine d’aria imprigionate da millenni nei ghiacci dei poli e capire così che cosa respirassero Giulio Cesare o Gengis Khan, fossero alchimisti con la formula in tasca. Cosa che fa infuriare due volte i sacerdoti delle nubi. «Primo — si rannuvola il dottor Trenberth, che della “mutazioni climatiche” è qui il massimo esperto — , perché tutti ci ignorano quando il tempo è perfetto e poi ci invocano quando piove troppo o troppo poco. Secondo, perché eventi come Katrina, Rita o l’aumento nel numero e nella potenza degli uragani sono facilmente fraintesi come segnali di catastrofi climatiche ormai in atto, mentre in realtà la prossima stagione potremmo non averne, in teoria, neppure uno e questo finirebbe per assolvere tutti dai peccati precedenti. La tragedia non è Katrina, è l’aumento del 30 per cento delle polveri sospese nell’atmosfera a causa del petrolio bruciato». Il punto dal quale Trenberth ci chiede di partire per non cadere nella tentazione del panico o nella ostinazione dello scetticismo, è tanto ovvio (per lui) quanto ignorato. «Il pubblico fa confusione tra tempo e clima. Il tempo è quello che si vede fuori dalla finestra. Il clima è la situazione atmosferica globale che deve essere valutata sui lunghi periodi, almeno di cinquant’anni in cinquant’anni. Si può avere un’estate rovente, senza che questo indichi nessun mutamento di clima; o un inverno statisticamente normale che nasconda invece mutamenti profondi di clima. Paradossalmente, per il consumatore, sembra più facile azzeccare il tempo di domani che il clima fra cento anni e invece è il contrario». Nessun meteorologo vero osa spingere una previsione attendibile oltre i tre giorni. Sei, sette, è il confine massimo per i più temerari. Bene, allora mi faccia le previsioni del clima per la mattina del primo settembre del 2105, quando i nipoti dei nipoti dei miei nipoti andranno per la prima volta a scuola. «Farà caldo, sicuramente più caldo, dai due ai quattro gradi centigradi in più». Soltanto? «Soltanto?» sorride il clima- M tologo. «Lo sa quanto è la temperatura media del nostro perché il CO2 ha una vita di cento anni. Stiamo già assipianeta?». Ovviamente, non lo so. «È di quindici gradi censtendo a grandi movimenti di popolazioni spinti dal clitigradi. Dunque tre gradi in più significherebbe il 20 per ma mutato. Nei fenomeni delle grandi migrazioni umane cento di aumento, un disastro». Per colpa nostra? «Anche non si tiene mai conto dell’effetto del clima sui moviper colpa nostra. Tutti i nostri modelli ci dicono che, se tomenti umani. Anche l’Impero Romano conobbe diffigliamo i fattori di inquinamento atmosferico, le proiezioni coltà climatiche crescenti che influirono sulla capacità di cambiano tutte e sempre, e semmai la tendenza naturale sfamare i suoi sudditi. Poiché tutto è così terribilmente della Terra sarebbe verso il raffreddamento. Non è detto complesso, è sempre facile trovare qualcosa a cui appiche eliminando tutti i gas e le polveri da combustibili fossigliarsi per negare», mi dice mentre mi porta a incontrare li che oggi vomitiamo nell’atmosfera tutto si invertirebbe, il personaggio più importante, il Papa blu di questo Vatiperché basta l’eruzione di un grande vulcano per cambiacano del cielo azzurro. «Lui ci darà risposte ancora più re il clima per alcuni anni. Ma è certo che, senza cambiare precise e speriamo definitive». i nostri comportamenti e prevedendo lo sviluppo indu«Lui» sono cinquanta armadi collegati tra loro e natustriale della Cina e dell’India le cose peggioreranno. Su ralmente battezzati e antropomorfizzati, come lo Hal 2000 questo, nessuno scienziato serio può avere dubbi». dell’Odissea nello Spazio. Si chiama “Blue Vista”, blue coStrano come il tempo, nel senso del “piove o non piove”, me il nomignolo della Ibm che ha costruito questo supersia divenuto materia per il consumo di massa proprio ora computer capace di 8,3 Teraflops, otto milioni di milioni che tanta parte dell’umanità vive come mai prima in bolle di operazioni matematiche al secondo. Ciascuno dei proartificiali, riscaldate, condizionate, appunto “climatizzacessori di “Blue Vista” ha cento volte la potenza del più vete”, e il maltempo è al massimo una seccatura. Rimorso? loce calcolatore personale e ne funzionano, in questi sotAnsia? Timore di essere diventati, come sorride malizioso terranei, migliaia in parallelo. Questo è il Pontefice, l’OraJoe Tribbia, una sorta di «virus» che l’organismo Terra sta colo, la Risposta. Forse già un sospetto di dio. cercando di scrollarsi di dosso con spallate sempre più vioLa finestra per guardare nella mente di “Blue Vista” è un lente, prima che noi virus impestiamo e uccidiamo lei? Formonitor al plasma da 50 pollici, sopra il quale, come la se, ma questi scienziati non sono Cassandre da talk show, pietra del Sinai, il Signore invia le sue decisioni. La mia sono osservatori e preferiscono evitare quel catastrofismo guida batte sulla tastiera e appare l’immagine della nostra sbeffeggiato da Michael Crichton, il romanziere degli scetTerra come era nel 1870, quando la rivoluzione indutici, nel suo Stato di Paura o prediche ideologiche. striale esplose. Vedo la sua pelle cominciare ad arrossarCertamente, qui è inutile perdere tempo a cercare tifosi a fine Ottocento, come il sederino irritato di un neonasi di Bush e del suo stizzoso «no» al trattato di Kyoto firmato, prima a piccole chiazze nell’Europa e nell’America to dai suoi predecessori democratici. «Questa in carica dal delle prime ciminiere. Poi le chiazze rosse sulla Terra si al2001 è la Presidenza più antiscientifica che abbia visto nellargano, divengono un eczema, a est, a ovest, a nord. Menla mia vita», tuona Trenberth. E Tribbia, l’uomo del caos, tre il calendario avanza, il rosso consuma regioni della è appena più moderato nella forma, non nella sostanza: terra, l’azzurro intenso dei mari impallidisce verso il rosa «Kyoto non era gran cosa ma era il primo segnale che i goattorno alle coste e il velo bianco dei Poli si ritira offeso. verni avevano finalmente capito che un problema esiste e Quando “Hal” disciplinatamente si ferma, nel 2100, la che può essere affrontato soltanto da tutte le nazioni, e Terra è un unico lago rosso, dalla Siberia all’Antartide. «I non alla spicciolata. Sarebbe prudente, prudent, cioè sagghiacciai — butta lì la mia guida — sono come aerei in augio, cominciare a cambiare i nostri comportamenti e i notopilota». Prego? «Se scatta il meccanismo che li fa sciostri consumi». Ma cambiare i comportamenti è qualcosa gliere e ritirare, si scioglieranno sempre di più». Ora hanche nessun governo vuol fare, soprattutto in un’America no raggiunto il “tipping point”, il punto critico. Volano in drogata dal petrolio a basso prezzo, perché puntando su autopilota verso l’autodistruzione. quei comportamenti ha vinto elezioni e potere. «Già», Deve essere l’altitudine, ma qui manca un po’ il respiro. mormora lo studioso del caos, allineando soprappensieUsciamo sulle terrazze che Pei costruì, copiando gli Indiaro come matite in un astuccio le patate fritte sparse sul ni Anasazi, per ricevere il vento dai monti detti del “Ferro piatto, nel caos della colazione. da stiro” ed evitare l’aria condizionata (ma non il riscaldaC’è una sorta di malinconia amara dietro questi scienmento, gli inverni qui sono duri). Nel dopo tempesta l’aria ziati che ogni giorno vedono e misurano lo stupro della è perfetta. Visibili come un cartone animato, all’orizzonte Terra e non possono fare altro che pubblicare studi consi alzano i grattacieli di Denver. «Sa quanto distano? Didannati a sfumare nella nostra attenzione, e dunque nelciannove miglia, trentuno chilometri appena. Poco, vero, la sensibilità dei politici, quando il cielo si rasserena. «Il clisembra di poterli toccare quando l’aria è trasparente». ma sta cambiando per colpa nostra» scoppia uno dei “moUna pausa e arriva la “punch line”, come si dice in teatro, dellisti” del clima, «ci sono specie animali, insetti, la battuta chiave. «La distanza che ci separa da quei rettili, uccelli, che avanzano da sud verso nord grattacieli è esattamente lo spessore di quella e che troviamo dove mai avevano abitato parte di atmosfera, la troposfera, che manprima; e gli animali non fanno politica, tiene la vita sulla Terra, tutto qui. Sottile, non votano. Altre specie, come il rospo le pare?». Sulla terrazza ci hanno ragd’oro del Guatemala si sono estinte giunto la bambina pallida che aveva perché la protezione delle nubi d’alabbracciato il tornado dentro la macSEMPRE PIÙ CALDO ta quota dove vivevano si è dissolta. china che li produce in miniatura, il Il 1998 è stato l’anno più Tra il 1950 e il 2000 si è registrata la vecchio con gli occhi sempre lacricaldo, ma il 2005 ha buone temperatura media più alta degli mosi, gli altri turisti della apocalisse probabilità di superarlo. ultimi mille anni e anche cominatmosferica. Respiriamo tutti a Per la Nasa la temperatura ciando ora a ridurre l’anidride carbocca aperta, inghiottendo grandi media crescerà di 0,4 gradi bonica dovremmo aspettare almeboccate di aria, come se volessimo fra il 2000 e il 2030 e di un altro no un secolo per vederne i benefici fare il pieno. Finché ce n’è. grado tra il 2030 e il 2100. Negli ultimi 100 anni era cresciuta solo di 0,2 gradi IL VERDE IN CITTÀ E IN CAMPAGNA Nel 2080 nelle città italiane scompariranno specie di alberi come il pino marittimo, quello di Aleppo, la quercia da sughero e il leccio. Entro il 2080 la superficie coltivabile in Europa diminuirà del 6,4 - 10,7 % GLI ANIMALI A RISCHIO AVANZA IL DESERTO Molte specie sono a rischio, tanto che gli esperti parlano di nuova estinzione di massa. Il riscaldamento del clima ha già modificato rotta e periodi di partenza degli uccelli migratori. Il deserto di Gobi in Cina si sta espandendo al ritmo di 10 mila km quadri all’anno: nel 2080 tra il 20 e il 38% della popolazione europea meridionale si ritroverà a vivere in zone con risorse idriche insufficienti DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31 TESTI A CURA DI ELENA DUSI E ILARIA ZAFFINO ILLUSTRAZIONE DI MIRCO TANGHERLINI COS’È UN URAGANO È una tempesta accompagnata da venti che soffiano a 300 km/h, da nubifragi e inondazioni. Si forma nelle regioni tropicali quando la temperatura del mare supera i 26 C°. Nasce da una perturbazione che ha origine quando l’aria calda e umida a contatto con il mare inizia a salire Venti fortissimi (corrente esterna) Lo storico dell’ecologia e del clima Pascal Acot Venti forti (flussi superiori) “Cambierà l’habitat della vita di tutti” ANTONIO CIANCIULLO alle cronache emerge il moltiplicarsi di allarmi climatici che vanno dalla violenza degli uragani al collasso della calotta artica; e la maggior parte degli scienziati indica il modello energetico basato sui combustibili fossili e sulla deforestazione come i colpevoli di questo dissesto atmosferico. Eppure il partito dei negazionisti, il fronte convinto che l’attuale oscillazione del clima sia un fatto naturale, ha scritturato recentemente un nome di peso come Michael Crichton. Chi ha ragione? «La dinamica dell’atmosfera è un sistema talmente complesso che attualmente non siamo in grado di dare una risposta matematicamente certa a questa domanda», risponde Pascal Acot, filosofo, ricercatore di storia delle scienze presso il Cnrs e autore di vari libri sulla storia dell’ecologia e del clima. «E perciò, rimanendo in un ambito formale, è possibile alimentare un dibattito». Perché formale? «Perché è un dibattito possibile solo sul piano astratto, come indagine intellettuale sui confini della nostra capacità di previsione scientifica. Di fatto è una discussione inutile perché si concentra sui dettagli ed elude i due punti centrali del problema. Primo: è estremamente probabile che gli esseri umani stiano modificando il clima. Secondo: le conseguenze che si profilano sono spaventose. Non è serio confondere i limiti dell’analisi teorica con un’incertezza reale sul che fare. Invece di perdere tempo bisognerebbe trovare le strategie utili per frenare il cambiamento climatico mantenendolo entro limiti in cui i danni siano sopportabili». Cosa rischiamo andando avanti così? «L’ipotesi di un riscaldamento che arrivi a quattro gradi entro la fine del secolo sta guadagnando consistenza. Sarebbe un processo sei volte più rapido di quello che ha segnato il ventesimo secolo. Al di là dell’impatto immediato e drammatico della risalita dei mari bisogna pensare alle conseguenze sul complesso degli ecosistemi. La vita dovrebbe spostarsi, lasciare gli habitat non più adatti per colonizzarne di nuovi. Ma gli alberi possono migrare solo molto lentamente, guadagnando poche decine di chilometri in un secolo: molti sistemi ecologici e molte specie non resisterebbero a una pressione come quella che deriverebbe da un aumento di tre o quattro gradi. Inoltre la destabilizzazione climatica, se l’aumento raggiungesse quei livelli, provocherebbe una catena di conseguenze decisamente spiacevoli: dall’estendersi delle aree soggette alle malattie tropicali fino all’incubo perenne di disastri stile New Orleans». L’allarme è stato lanciato già all’Earth Summit di Rio de Janeiro, nel 1992. Nel 1997, a Kyoto, è stato siglato il protocollo che rappresenta il primo passo in direzione di un cambiamento del modello energetico. Ma l’innovazione ambientale procede a ritmo lento. «Il rifiuto americano di adottare politiche di prevenzione del disastro climatico e la mondializzazione dell’economia hanno ridotto sensibilmente gli effetti positivi di quei passi diplomatici. La verità è che nessuno è pronto a fare quello che è veramente necessario, cioè smettere di usare i combustibili fossili che sono la radice del problema. Anzi la strategia geopolitica sta andando in direzione opposta: con il pretesto della democrazia si cerca di impossessarsi dei luoghi in cui è custodito ciò che resta delle grandi riserve di petrolio. Ieri è stato l’Iraq, domani potrebbe toccare all’Iran». Siamo ancora in tempo per cambiare rotta? «Dipende qual è l’obiettivo. Se l’obiettivo è mantenere il clima attuale, la risposta è negativa. La quantità di carbonio che è già stata immessa nell’atmosfera bruciando petrolio e deforestando ha messo in moto un meccanismo inarrestabile. Se però l’obiettivo è ridurre la portata del cambiamento climatico, cioè abbattere sensibilmente i danni, allora siamo ancora in tempo. A patto di agire subito perché il sistema climatico ha un’inerzia formidabile. È come se viaggiassimo su un camion che, una volta schiacciato il pedale del freno, ha bisogno di 50 o 100 anni per bloccarsi. E noi non abbiamo ancora cominciato a frenare». D Direzione dello spostamento TEMPESTE IN ARRIVO Gli uragani diventeranno sempre più frequenti: i cicloni tropicali di forza 4 o 5 sono quasi raddoppiati in 35 anni. Nell’agosto 2005 si sono avuti 12 tempeste e 4 uragani, la media dello stesso mese degli altri anni è stata di 4,4 tempeste e 2,1 uragani. Secondo “Science” stanno aumentando gli uragani di forza 4 e 5 LE MONTAGNE SENZA NEVE Entro la fine del XXI secolo la linea delle nevi sulle Alpi si sposterà dai 1300 metri di oggi a 1500-1750. Dal 1850 a oggi metà del volume dei ghiacciai alpini è scomparso Repubblica Nazionale 31 30/10/2005 PIOGGE SPARSE Nei prossimi 20 anni l’Europa si avvicina ad essere spaccata in due: a nord si registrerà una crescita delle precipitazioni a un ritmo di 1-2 per cento ogni dieci anni, mentre a sud, si avrà una diminuzione dell’1 per cento a decade LE NUOVE ONDE DEL MARE Uno scioglimento totale dei ghiacciai farebbe salire il livello del mare di 7 metri. Le attuali stime delle Nazioni Unite fanno prevedere una crescita del livello delle acque di circa un metro nel 2100. Negli ultimi 100 anni il livello dei mari è salito di 10-20 cm POVERI POLI Attualmente la calotta artica si assottiglia al ritmo di 5 centimetri all’anno. L’area ricoperta da ghiaccio al Polo nord è in calo per il quarto anno consecutivo LE VITTIME E I DANNI Secondo l’Onu tra il 1994 e il 2003 le catastrofi naturali hanno provocato oltre 600mila morti e una perdita economica di oltre 500milioni di euro. Gli uragani sono tra i principali responsabili, qui sotto le loro cinque categorie CATEGORIA 1/MINIMO CATEGORIA 2/MODERATO CATEGORIA 3/ESTESO CATEGORIA 4/ESTREMO CATEGORIA 5/CATASTROFICO Venti tra 120 e 153 km/h, rischi leggeri per le abitazioni Venti tra 154 e 177 km/h, tetti sollevati, coste inondate Venti da 178 a 209 km/h, molte case distrutte, alberi sradicati Venti tra 210 e 249 km/h, gravi danni alle case. Evacuazione consigliata Venti oltre i 250 km/h, molte case distrutte, danni sino a un km dalla costa 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 il reportage Protagonisti segreti Jing Qui ha 91 anni, da 77 rade e pettina i suoi concittadini Ha visto passare Kuomintang, giapponesi, Mao Zedong, nuova Cina. Ora un film sugli antichi quartieri lo ha reso celebre Il barbiere di Pechino e il rasoio della Storia L FEDERICO RAMPINI PECHINO Repubblica Nazionale 32 30/10/2005 e dita mi accarezzano il cranio, i polpastrelli premono sulla nuca con lenti movimenti circolari, massaggiano le tempie, le orecchie, affondano fino a distendere le vertebre del collo, poi più giù, finché un movimento secco mi stira il gomito ed è come se uscissero scosse elettriche. Eccomi posseduto dagli incantesimi di un vecchietto, un omino prodigioso nato a un’epoca in cui Pechino ancora pullulava di mandarini della burocrazia imperiale decaduta. Mi ero solo prenotato un taglio di capelli dietro l’angolo di casa. Un appuntamento col bisnonno di tutti i barbieri della Cina: Jing Qui, il novantunenne che da 77 anni rade e pettina i pechinesi. Jing è stato testimone di rivoluzioni, invasioni straniere, guerre civili e guerre tout court. La sua vita è un libro di storia che attraversa le tragedie del Ventesimo secolo. Di recente il regista-produttore Shi Runjiu ne ha fatto il protagonista di un documentario sul centro storico della capitale, l’antico quartiere che ha resistito intatto allo shock della modernizzazione, e così a novant’anni “il barbiere di Pechino” è diventato una celebrità. Ma nulla è cambiato nei ritmi austeri della sua vita. La giornata è scandita sempre dai servizi a domicilio per i suoi clienti fedeli (solo una ventina sono ancora vivi, sui quattrocento che lui ricorda per nome e cognome), appuntamenti ai quali Jing Qui arriva pedalando su un triciclo antidiluviano. Lo attendono regolarmente gli habitués come il Signor Zhang, 71 anni, padrone di una bettola sul lago Houhai: si fa accorciare i capelli nell’angusto retrobottega e intanto descrive problemi di salute, rivela pettegolezzi di quartiere, si sfoga di piccoli drammi familiari, chiede consigli al venerabile barbiere che è un confessore e maestro di vita per generazioni di anziani. Il vicolo vicino al parco Jing Qui vive nel vicolo Gao Wo vicino al parco imperiale Jingshan. Per arrivare da lui bisogna addentrarsi nei “bassi”, imboccare un vialetto angusto tra casupole modeste e fatiscenti, farsi strada tra barriere di biancheria appesa ad asciugare. È un salto nel tempo, un viaggio a ritroso che immerge nell’atmosfera dei romanzi del grande Lao She ambientati nel primo Novecento, come la trilogia delle Quattro generazioni sotto un tetto. La Pechino degli hutong (vicoli) ha conservato quasi intatta nel suo cuore quella città-villaggio di una volta, che era la vera protagonista delle storie di Lao She. C’è ancora lo stesso dedalo di stradine e cortili, i tetti di tegole verniciate, le case basse perché nessuna poteva superare l’altezza del trono dell’imperatore, i giardini interni affollati di magnolie e melograni, È il patriarca di un esercito di artigiani che vedi al lavoro a tutte le ore sui marciapiedi cinesi Polso rapido e lingua sciolta, sono i confidenti e gli psicologi della nazione acacie e mimose. Ci sono il dialetto arguto e beffardo dei pechinesi, i riti dei mestieri tradizionali, la melodia dei grilli e i fischi dei piccioni ammaestrati, i muri umidi e ammuffiti che sembrano fatti per nascondere gli intrighi di corte. Sua figlia Jing Xiufen, 60 anni, offre il tè e fa accomodare l’ospite su uno sgabello, nella minuscola cameretta che è il vano unico dell’abitazione, camera da letto e cucina, salotto e lavanderia, stiratoio e ripostiglio per gli attrezzi del lavoro, in un disordine razionale e accogliente. Jing Xiufen è cordiale e divertita ma si indispettisce di colpo quando la conversazione sfiora l’argomento del terzo matrimonio del padre — par di capire che sia stata regolarizzata una lunga convivenza con la domestica —, presumibile fonte di rancori per il “lignaggio” insufficiente della nuova moglie e di futuri litigi sulla misera eredità. Finalmente compare il padre, di ritorno da un taglio a domicilio: piccino e magrissimo, porta i capelli insolitamente lunghi e bianchi per un cinese. Si presenta con la giacchetta bianca che è la tuta di lavoro, i pantaloni che sembrano un pigiama, le espadrille blu. Dietro questa dignitosa povertà si nasconde il veterano di una corporazione vastissima, il piccolo patriarca di un esercito di barbieri di strada che vedi al lavoro a tutte le ore sui marciapiedi della Cina, nelle metropoli moderne e nei borghi rurali. Con il rasoio dalla lama d’argento, la bacinella laccata a fiorellini, la sedia di legno per il cliente, il polso rapido e la lingua sciolta, sono i confidenti e gli psicologi della nazione. Qualche volta affiancati da assistenti in un’altra antica e delicata mansione: i pulitori di orecchie. Il racconto di una vita È allegro Jing Qui, ha occhi vivaci che scrutano lo straniero. Sorride e racconta la storia, che comincia con una specie di riassunto della sua semplice filosofia: «In vita mia ho tagliato i capelli ad alti ufficiali della dinastia Qing, a diplomatici giapponesi e perfino a un rappresentante personale del loro imperatore, ma anche a tutti i poveri del quartiere, e nessuno di loro può dire di essere stato trattato peggio». I ricordi coprono l’arco di «quattro dinastie», dice il barbiere alludendo ai cambi di regime. «Quando arrivai a Pechino dai sobborghi di campagna avevo quindici anni, pare che la città avesse un milione di abitanti (oggi ne ha 17, ndr). Il quartiere tra le mura imperiali, qui vicino alla Torre del Tamburo, era come un paesone tranquillo, la vita scorreva lenta, non c’era tutta la gente e l’animazione di oggi. Il cortile dove abito io era occupato da una famiglia sola, ora ce ne sono sei. L’imperatrice Cixi era morta, a Pechino governavano i nazionalisti del Kuomintang e tra i miei clienti ci fu anche un Signore della guerra, il generale Fu Zuo Yi. Poi arrivarono i giapponesi e all’inizio avevamo paura di loro. A furia di conoscerli la paura sparì. Sotto l’occupazione non era molto diverso dal Kuomintang. Almeno qui a Pechino i giapponesi non fecero danni, non distrussero né costruirono granché. Perfino durante la guerra la vita nella capitale continuava quasi come prima, il fronte dei combattimenti era lontano da noi. Del 1949, l’anno della rivoluzione comunista, ricordo che si mangiò di più, c’era fi- DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 LA TRADIZIONE Nella foto grande, il rito del taglio dei capelli in una immagine di inizio Novecento Nella pagina accanto Jing Qui nella sua bottega a Pechino nalmente la farina. Per i giovani apprendisti barbieri la vita divenne migliore, scomparve l’abitudine dei padroni di picchiarli. Mao fece tirare giù le mura imperiali, un lavoro lunghissimo, ma nessuno aveva da obiettare. Nel 1966 il governo proibì tutte le attività private, anche le piccole botteghe come i barbieri dovevano essere dello Stato. Fummo tutti espropriati, e un solo membro per ogni famiglia veniva poi assunto dallo Stato per continuare lo stesso mestiere, come impiegato pubblico. Allora toccò a mia moglie essere assunta, quindi io non potevo continuare a esercitare. Così cominciai a fare servizio a domicilio. Di preferenza andavo a tagliare i capelli fuori dalla cinta urbana, c’erano meno controlli, non rischiavo di farmi chiedere la licenza. Da quel momento è cominciata la mia nuova vita da barbiere indipendente, sempre in viaggio da un cliente all’altro». FOTO CORBIS Il figlio dietro la porta Il figlio Jing Changming, sessantenne, stava origliando da tempo nel vialetto, sulla soglia della casupola. È a questo punto che si intromette di forza. Dà sulla voce al padre, si agita, discute. Intervengono una sorella, poi anche un’altra, per proteggere l’anziano e allontanare con fermezza l’intruso dalla nostra conversazione. La lite fra i tre figli si allontana, gli schiamazzi vanno a spegnersi in fondo al vicolo. Si capisce che l’uomo non sopporta di sentire dal padre una versione della storia edulcorata. Dopo il ‘66, a quanto pare, il barbiere fu cacciato da Pechino e deportato nel villaggio natale. Ci sarebbe di che lamentarsi, magari anche accampare qualche pretesa di indennizzo, per quella bottega mai più recuperata. Jing Qui sorride divertito e scrolla le spalle, mentre il figlio viene portato via dalle sorelle. Non si arriva a 91 anni per caso, e in questa forma. Il barbiere di Pechino ha imparato quell’arte della sopravvivenza che consiste nel purgare la memoria da tante esperienze avvilenti, tristezze e brutture. Il suo racconto scivola quieto sugli avvenimenti più tragici. La grande Storia gli scorre davanti agli occhi senza agitarlo, è un paesaggio sbiadito o un rumore di fondo che si sta affievolendo. Kuomintang, giapponesi, Mao Zedong, cita questi nomi come se non lo riguardassero più. Con il tempo si fanno più nitidi quei piccoli dettagli della vita che contano veramente. I costumi e le acconciature cioè il lavoro di un parrucchiere. Il cibo. I quattrini. «Quando ero ragazzo molte case erano fatte di fango, gli uomini e le donne portavano le tuniche lunghe tradizionali, i changpao e i qipao. I poveri rammendavano e rattoppavano all’infinito i loro stracci, adesso tutti buttano via vestiti seminuovi solo perché sono passati di moda. Da apprendista dovevo studiare solo tre stili di taglio: corti con la riga in mezzo, corti senza riga, rapati. Adesso gli stili sono così tanti che è difficile stargli dietro. Gli apprendisti lavoravano gratis per imparare, quando misi su negozio il primo taglio costava due centesimi, ora faccio pagare cinque yuan (mezzo euro, ndr)». Quali sono stati i più grandi cambiamenti nella sua Pechino? «La costruzione di tutte quelle strade, e il fatto che c’è tanto da mangiare». Si accende una sigaretta, la seconda da quando è arrivato — «ho cominciato a fumare a sedici anni e non ho mai smesso per altri settantacinque» — e il viso si illumina al momento di rivelare la sua dieta. Si lancia in un lungo e minuzioso elenco di semplici dolciumi, tipo biscottini e caramelle. Scoppia a ridere di gusto quando provo a suggerire il fumo e lo zucchero come gli ingredienti della sua longevità. La vera ricetta della sua salute, naturalmente, andrebbe cercata piuttosto nel sorriso gioioso da ragazzino: «Esclusi forse gli anni da apprendista, per via di tutte le botte che mi pigliavo, oggi posso dire che la mia vita è stata una bella vita. Tutto è andato per il verso giusto. Ho avuto da mangiare, non posso lamentarmi di niente. E il periodo più bello forse è questo, sì, penso proprio di non essere mai stato così bene». Il colloquio sta per concludersi. La grande sorpresa è riservata per la fine. Jing Qui mi studia con lo sguardo professionale. «Da apprendisti la prima cosa che ci insegnavano era il massaggio. Lo abbiamo sempre fatto gratis, anche se forse è più importante del taglio». Poi scandisce bene le sue ultime parole: «Io so come rimettere le tue ossa». L’eterno sorriso da bambino svanisce di colpo. Jing Qui chiude gli occhi per concentrarsi. Il volto del vecchio diventa una maschera immobile scolpita di rughe profonde. Appena mi afferra la testa le sue dita diventano artigli di acciaio. Per trenta lunghissimi minuti di massaggio, dal corpo di quell’omino esile e minuto di 91 anni si sprigiona una forza sorprendente. Mentre le mie vertebre vibrano e schioccano come le corde di uno strumento musicale, il canuto barbiere di Pechino si trasfigura in un santone zen, in un frate guerriero shaolin, in un cultore di kung-fu. Mi abbandono al potere magico, nelle mani del sacerdote di un’arte antica e misteriosa. Sogno che da un personaggio come questo sia nata un giorno la leggenda dei monaci ultracentenari di Shangri-La, custodi del segreto dell’eterna giovinezza. 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 il racconto Gli scatti dentro i manicomi accompagnano l’evoluzione della scienza medica: da quelli ottocenteschi usati come strumento totalizzante, oppressivo, all’irruzione negli anni Settanta dei reporter di denuncia oltre il “muro dell’indifferenza”, fino alla recente stagione che ritrae “i diversi tra noi”. Ora una grande mostra a Reggio Emilia raccoglie quel mondo di immagini Arte e malattia La verità nelle facce dei matti da fotografare «P Repubblica Nazionale 34 30/10/2005 MICHELE SMARGIASSI REGGIO EMILIA azzo melanconico» lo avevano classificato i medici del Manicomio di Reggio Emilia. Una delle molte fantasiose etichette della pignola nomenclatura positivista della malattia mentale. Pazzo, chissà: di certo non era tanto stupido, dal momento che si ribellò con tutte le sue forze, imprecando, all’obbligo di farsi fare il ritratto fotografico, rito d’ingresso a cui era sottoposto per decreto ogni degente. Gridava, il melanconico, protestava che «col ritratto si avrà il modo di perseguitarlo di più». Di lui, ricoverato attorno al 1870, sappiamo troppo poco (un vago accenno nel resoconto di un noto clinico in visita, Arrigo Tamassia) per capire quanto consapevole fosse la sua impavida ribellione. Di sicuro era fondata più delle risate dei medici che lo compativano. Aveva ragione, il melanconico: la fotografia perseguitò i matti. Peggiorò la loro segregazione. A lungo, e con metodica pervicacia. Come tutti gli oggetti e i saperi coinvolti nel funzionamento di un’istituzione totale, anche la fotografia della follia fu uno strumento totalizzante, oppressivo, usurpatore di diritti. Arma tagliente, qualche medico se ne rendeva conto: Henri Legrand du Saulle, in quegli stessi anni, vietava la circolazione delle foto dei suoi pazienti di Rouen, e faceva distruggere le negative. Dovette trascorrere più di un secolo perché la fotografia dei matti riuscisse a liberarsi da quel marchio d’infamia mutandosi nel suo contrario: uno strumento di liberazione. Una mostra, proprio a Reggio Emilia, dove l’ospedale psichiatrico San Lazzaro fu una città nella città (duemila ricoverati) fino agli anni Settanta, racconta ora tutta la sofferta, contraddittoria parabola della fotografia psichiatrica, dalle immagini che legano a quelle che sciolgono, dagli ordinatissimi “gabinetti fotografici” dei manicomi ottocenteschi all’irruzione dei reporter basagliani oltre «il muro dell’indifferenza»; fino alla terza stagione, la più sconosciuta e recente, e anche la meno sicura di sé: la fotografia del dopo-riforma, la fotografia dei “matti tra noi”, che paradossalmente ribalta tutte le certezze, rimette in causa le precedenti, facendoci apparire un po’ meno arrogante la prima, un po’ meno trionfale la seconda. Al San Lazzaro, uno dei più antichi manicomi italiani (lo volle il duca Francesco III d’Este nel 1755), la fotografia era stata ammessa precocissimamente, nel 1878, da un direttore, Augusto Tamburini, che aveva l’occhio attento alle novità terapeutiche europee. Il pioniere britannico Hugh Welch Diamond aveva sperimentato l’uso della fotografia come ausilio frenologico appena un ventennio prima, nel suo ospedale del Surrey. Ma la moda aveva fatto breccia un po’ ovunque, quasi che la scienza della mente deviata non aspettasse altro che il suo strumento mancante: l’unico in grado di offrire ai medici della psiche, ancora incerti sulla consistenza e i metodi della propria disciplina, qualcosa di paragonabile a ciò che per i colleghi del corpo era l’anatomia: un corpo da osservare, un oggetto fisico da misurare. La fotografia inverava il sogno, anticipato dalla fisiognomica di Lavater e Lombroso (anch’essa in attesa del Grande Strumento), di dedurre scientificamente la psiche dal soma, insomma l’anima dal volto. Inoltre, se al medico la fotografia offriva la possibilità di astrarre la malattia universale dal malato particolare (solo grazie alla fo- Le ultime foto raccontano di pazienti dispersi nel mondo, terrorizzati ma anche appesi alla mano amica di un’infermiera volenterosa tografia Jean-Martin Charcot riuscì a “inventare” l’isteria alla Salpetrière), per il medico psichiatra funzionava come salutare distanziamento rispetto ad un malato tra i più imbarazzanti, pericolosi, squilibranti, «poveri esseri che vegetano» e tuttavia sempre «guardati con misterioso terrore». Dolore assoluto, senza freni, la sofferenza del malato mentale rischiava (rischia ancora) in ogni momento di coinvolgere e di travolgere chi la osserva: dolore pietrificante come lo sguardo di Medusa. E come lo specchio di Perseo, la fotografia fece da schermo, prelevando la pazzia dal pazzo e mettendola a disposizione, spettro ormai inoffensivo, sulla scrivania del professore; mentre il suo originario possessore, ormai inutile, poteva “dar di matto” quanto voleva, ben legato al letto di contenzione. Perché potesse accadere, il fotografo dei matti doveva essere più artista che burocrate. Emilio Poli, semplice responsabile del guardaroba a cui Tamburini affidò il gabinetto fotografico del San Lazzaro, si rivelò tale. Il cortile del severo palazzo alla periferia della città si mutò in teatro di posa, sul cui palco, a credere al Tamassia, «accorrevano i poveri malati colla massima docilità», recitando senza copione la loro demenza, inscenando in un libero canovaccio di gesti ora patetici, ora drammatici, ora violenti, il loro misterioso, surreale squilibrio. Dovrebbero parlarci, queste immagini sopravvissute, nascoste e ora riscoperte, di un dramma del contenimento e della sorveglianza; riescono piuttosto a calarci in una scena magica di pietà sublimata. C’è da dire che il pazzo è il cliente ideale del fotografo. Le «bugie diplomatiche» del ritratto borghese, le sue finzioni identitarie, i petti rigonfi, gli sguardi artatamente fieri, i «poveri dementi» non li conoscevano. Affrontavano l’occhio di vetro del Poli «senza contraffare l’espressione del loro viso», senza cercare «quelle posizioni buffonesche, o tragiche, in cui vediamo drappeggiate la maggior parte delle fotografie dei sani». Bugiarda per vocazione, convenzionale per obbligo, la fotografia per assurdo guadagnò la sua libertà nel luogo dell’assoluta illibertà. Il paradosso si riallineò presto. All’alba del Novecento, con l’affermarsi della moderna psichiatria, la fiducia nella diagnosi visuale della malattia mentale andò rapidamente in crisi. L’inconscio, il subconscio, non impressionano le lastre ai sali d’argento. Ma la fotografia non uscì dalle mura dei manicomi, cambiò semplicemente mestiere: da aiuto medico a sorvegliante. Traslocò dall’ambulatorio alla portineria. I degenti venivano fotografati non più nella libera, perfino anarchica espressione della loro follia, ma nella razionalità panottica della posa frontale, che omologava ogni individualità nel tipo universale del Pazzo, icona della nostra cattiva coscienza. Spillata sulla cartella clinica, la fotografia del malato non era più la sua radiografia mentale, ma un attrezzo tecnico per il riconoscimento rapido. Aprì la strada, assieme alla cugina fotografia poliziesca, al moderno documento d’identità. Può essere spiacevole saperlo, ma la foto che ci guarda dalla nostra patente è la foto di un pazzo: quantomeno, la sua nipote. Morte della nosografia creativa, inizio della fotografia poliziotta: al San Lazzaro l’operazione diventò così standardizzata e ripetitiva che la si poté affidare addirittura ad un degente. Resurrezione della fotografia anti-psichiatrica: negli anni Sessanta furono a volte gli stessi ricoverati a far entrare i fotografi oltre il portone proibito, spacciandoli per pazienti in visita. Quei reporter che DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 RASSEGNA SULLA FOLLIA In queste pagine: una serie di fotografie dalla mostra “Il volto della follia, un secolo di immagini del dolore” in programma a Reggio Emilia dal 13 novembre 2005 al 22 gennaio 2006. La rassegna ospitata a Palazzo Magnani e Palazzo dei principi di Correggio (e curata da Sandro Parmiggiani), documenta la vita all’interno degli ospedali psichiatrici e il difficile processo di inserimento nella società degli ex degenti Repubblica Nazionale 35 30/10/2005 Un lungo cammino dalle galere della fisiognomica alla attuale contenzione chimica Animali, delinquenti, angeli caduti: il riscatto della follia UMBERTO GALIMBERTI el poderoso Archivio dell’“Ospedale dei pazzi”, aperto a scientifica le corrispondenze fisiognomiche tra folli e delinRoma nel 1561 e poi denominato “Santa Maria della quenti con un elenco così dettagliato: «Fig. 31 Donna omicipietà”, c’è un libro dell’epoca dove le fisionomie dei pazda. Labbra tumide, fisionomia virile. Fig. 32 Donna parricida. zi sono messe a confronto con quelle degli animali con conseArchi sopraccigliari e seni frontali assai sviluppati, rughe straguente attribuzione al folle della caratteristica più terribile prone, fronte sfuggente, zigomi e mascelle molto sviluppate, labpria di ogni animale. La filosofia sottesa a questa curiosa fisiobra sottili. Fig. 33 Conjugicida. Tumidezza delle labbra. Fig. 34 gnomica è quella rinascimentale che concepisce l’uomo come Feritore. Mascelle e orecchie voluminose. Fig. 35 Omicida. bestia e angelo; e quando la parte alta, spirituale, angelica è diFronte sfuggente, submicrocefalia, archi sopraccigliari enorvorata dalla follia, resta la bestia, i cui tratti somatici indicano la mi, mascelle, zigomi e orecchie molto voluminose. Fig. 36 Asspecificità dell’aberrazione che pervade il folle. sassino. Orecchie ad ansa, stenocrotafia, asimmetria del viso, Quando la follia da fatto demoniaco divenne disturbo sostrabismo, labbra assai sviluppate». ciale, quando uscì dall’interpretazione teologica per essere A partire da questa catalogazione, nel 1902 viene istituita a compresa nell’interpretazione giuridica, il folle, per il suo Roma la Scuola superiore di polizia scientifica sotto la direcomportamento, fu assimilato al criminale e perciò rinchiuzione di Salvatore Ottolenghi, assistente di Lombroso, che si so, al pari del delinquente, in prigione. A questo punto la compropone di «trasformare radicalmente i mezzi di lotta contro parazione fisiognomica mutò: non più il confronto del folle questi prodotti della degenerazione, della intossicazione, del con l’animale, ma la comparazione dei tratti somatici del folproletariato, onde ammansire le più feroci belve umane, i cole con quelli del delinquente. siddetti bruti del Codice Penale». Dobbiamo attendere il 1793 per vedere sorgere a Parigi il priOggi le cose sono cambiate molto? A giudicare dai tipi umamo manicomio ad opera di Philipe Pinel che liberò i folli dalle ni che affollano le carceri direi di no, quei luoghi così simili alprigioni in base al principio che il folle non può essere equipale carceri che sono i manicomi sono stati quasi tutti assegnati rato al delinquente. Con questo atto di nascita la psichiatria si ad altra destinazione, ma quanta follia oggi si agita ancora nel presenta come scienza della liberazione dell’uomo. Ma fu un atchiuso delle pareti domestiche e quanta nell’aperto delle notimo, perché il folle, liberato dalle prigioni, fu subito rinchiuso stre strade, dove come al solito miseria e follia si confondono? in un’altra prigione che si chiamerà manicomio. Certo ai metodi di contenzione esterni, così truculenti e inDi questa reclusione in manicomio ne approfittò Cesare digesti a vedersi, si sono sostituiti i metodi biochimici a conLombroso, non tanto per studiare l’insorgenza delle malattie tenzione interna. Tutto è più educato e più morbido, più civipsichiche e le più opportune terapie, quanto per esercitarsi, le e accettabile. I volti dei folli non hanno più l’aspetto che con l’aiuto della fotografia di cui non disponevano gli psihanno sempre avuto il proletariato e il sottoproletariato. chiatri del Settecento, a trovare le corrispondenze tra il pazzo Lombroso sarebbe confuso di fronte ai volti della follia di oge il delinquente. Nel Museo di antropologia criminale di Cegi: volti normali, fotocopie di volti televisivi. Una sola cosa li sare Lombroso, istituito con una delibera dell’Università di accomuna ai volti spaventosi catalogati da Lombroso: la soliTorino del 1892 e oggi illustrato da un bel libro di Giorgio Cotudine della loro mente, a cui nessuno si rivolge se non con le lombo dal titolo La scienza infelice (Bollati Boringhieri, 2000), parole inutili della pietà che sta al posto di un’infinita comuLombroso, con l’uso della fotografia fornisce alla polizia nicazione mancata. N avevano letto Laing e Goffman si chiamavano Carla Cerati, Gianni Berengo Gardin, Luciano D’Alessandro, Gian Butturini, Uliano Lucas, tutti a vario titolo e misura affascinati dallo “slegamatti” Franco Basaglia. Le immagini che si susseguirono in quegli anni sui libri e sui rotocalchi, terribili e affettuose, strazianti e tenere assieme, volutamente spogliate da ogni estetismo per puntare al cuore dell’emozione, furono il colpo d’ariete su cui lo psichiatra triestino contava per «usare l’istituzione contro se stessa» e aprire quelle porte inchiodate. Morire di classe, il pamphlet progettato da Franco e Franca Basaglia per la celebre “serie politica” Einaudi, con le foto di Cerati e Berengo, divenne il “libretto viola” della battaglia contro i manicomi: ma era fatto solo di immagini, intercalate a evocatrici citazioni da Brecht, Swift, naturalmente Foucault. La legge 180 è forse l’unica riforma sociale ad avere contratto un debito di gratitudine con la cultura visuale. Eppure anche su quelle immagini è giunto il momento di ragionare criticamente. Senza nulla togliere al coraggio, alla generosità, alla passione dei fotografi che le realizzarono, la mostra di Reggio (in particolare il saggio dello psichiatra Cosimo Schinaia, nel volume che è molto più di un catalogo di mostra) ne coglie, per la prima volta, forse grazie alla distanza storica, un rischio paradossale: la conferma dello stereotipo del pazzo. Un “matto da slegare”, beninteso: ma per mostrare a “quelli di fuori” l’ingiustizia delle sue sofferenze era necessario semplificarne l’immagine, uniformarla, mettere in ombra le facoltà “sane” ed esporre solo quelle “malate” e sofferenti alla pubblica e politicamente impegnata indignazione. Crani rasati, teste fra le mani ossute: il più celebre scatto di Carla Cerati è diventato icona della follia: non della liberazione. Ma è possibile fotografare la malattia mentale senza ingabbiarla di nuovo, seppure in una griglia di compassione? Ci si è provato. Ma è stato necessario mettere da parte ogni retorica, anche liberatoria, abbassare il tono e lo sguardo. “Fotografia debole” è forse quella del dopo-Basaglia, priva della sicurezza che le davano le teorie più o meno scientifiche prima, le battaglie politiche e umanitarie dopo. Incerto è l’occhio che ha seguito le tortuose strade di una riforma che ha rivelato i suoi affanni e incontrato molti avversari ben felici di amplificarli. I “matti tra noi”, terza categoria storica dell’iconografia della follia, non appaiono più come una classe omogenea da segregare o da liberare in blocco, ma come uno sciame di naufraghi dispersi nel mondo in cui si confondono, si mescolano, svaniscono. Seguirli uno per uno, raccontare storie sempre più uniche e divergenti è stata la scelta dei fotografi del “dopo”. Qualcuno (Giovanni Sesia) ha sentito il bisogno di ripartire da capo, di andare a cercare i ritratti seriali degli antichi malati del San Lazzaro, per risarcirli della perduta soggettività, quasi raschiando via a colpi di pennello la patina fotosensibile che li imprigionava. Altri hanno raccontato, semplicemente, i percorsi di vita dei “liberati”. Individui dispersi nel mondo. Sempre appesi a un filo sottile, assediati dal frastuono di un mondo ostile: stringe la testa fra le mani l’ex degente sorpresa da Butturini nell’attimo di terrore che sembra, che è, l’Urlo di Munch. Ma anche appesi alla mano amica di un’infermiera, come in una dolcissima immagine di Alex Majoli: cordone ombelicale, carezza rassicurante di chi non abbandona; e allora si può anche, finalmente, riposare, e allora il sole che illumina il mondo dei sani scalda e basta, non brucia più. DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 le storie LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 Mondi da ascoltare Ha cominciato 35 anni fa, registrando le note di un organo. E da allora non si è più fermato: il canto degli uccelli, il fischio dei treni, le campane delle chiese e perfino il pianto del figlio appena nato sono finiti nel suo immenso archivio. Che ora raccoglie in più di 32mila tracce audio le voci dell’uomo, delle macchine e soprattutto della natura Il collezionista dei suoni ATTILIO BOLZONI Repubblica Nazionale 37 30/10/2005 I RECANATI l cielo è nero, su una collina della bella campagna marchigiana cade un fulmine. E arriva anche il tuono. L’uomo afferra cavi e microfoni. Dice che è ora di andare: «Usciamo a sentire i rumori del temporale». Sta cominciando a piovere. E Màlleus sta cominciando a raccontare e a raccontarsi. L’ultimo suono che ha messo da parte è quello di una lattina che rotola sulla strada, spinta dal vento. L’altra settimana finalmente ha trovato il ruscello che cercava, un torrente che non fosse troppo ripido né impetuoso, un’acqua placida, lenta. E poi ha aspettato là in fondo sulla curva, all’uscita di quel paese dell’Appennino dove era stato alcuni mesi prima e aveva visto passare un vecchio camion che buttava fumo. Il rombo di un motore sfiatato gli mancava. Ha sistemato i suoi microfoni su un muretto, si è infilato la cuffia, quando il camion stava entrando nel tornante ha registrato anche il brontolio della sua arrugginita marmitta. Adesso ne ha trentaduemila di suoni. Di ogni specie. Le nocche di una mano che bussa alla porta, il sibilo di una freccia scoccata da un arco, la goccia che precipita su un vetro, una scarpa che calpesta la ghiaia, un fiammifero che brucia, un’onda che si rovescia, gli sci che filano sulla neve. Suoni. Tutti conservati nella memoria di sofisticati computer. Un archivio che è la sua vita. Il vero nome è Enrico, Enrico Ragni. Ma da quando ragazzino era batterista in uno di quei gruppi rock degli Anni Settanta, lo chiamano Màlleus. Fa musica da sempre. Con la chitarra, il basso, l’armonica a bocca, il pianoforte, l’organo a canne. Una volta era direttore di reparto in un mobilificio. Poi si è appassionato alle tecniche di mixaggio e ha lavorato per i pubblicitari milanesi. Da una ventina di anni ha aperto l’“Antica bottega amanuense”, uno scriptorium nella Villa Colloredo di Recanati, dimora cinquecentesca che il Comune ha acquistato dalla Santa Casa di Loreto e restaurato. Carta filigranata, raffinate pergamene per i diplomi di laurea delle Università del centro nord, pregevoli incisioni su pietra. Ma in un angolo della villa c’è quello che è lo scopo della sua esistenza: la “libreria” di suoni. Ne ha più di chiunque altro in Europa e forse anche nel mondo. Almeno tanti quanti quelli della Lucas film, la società californiana specializzata nell’acustica cinematografica. A volte Màlleus compra dalla Lucas alcune centinaia di “famiglie” di suoni, musicali soprattutto. E anche quelli più difficili da reperire nelle Marche, come certi venti dei deserti texani che trasportano in aria la sabbia provocando vortici stordenti. Molti, moltissimi li ha catturati lui, giorno dopo giorno con i suoi strumenti. Li ha selezionati, riascoltati, puliti. E poi immagazzinati nel suo tesoro informatico. «Mi dà felicità averne così tanti, sapere che in qualsiasi momento posso prenderne uno e utilizzarlo», bisbiglia Màlleus mentre ci mostra le schede, catalogo per catalogo, i cavalli al galoppo o al trotto o in carovana, i fischi vicini e lontani dei treni, le urla in una stanza e le urla in uno spazio aperto, le campane di una piccola chiesa di campagna e le campane di una cattedrale. Non è solo un collezionista di suoni Màlleus. È anche un compositore. Dopo Opera Prima e Opera Totale, sta finendo in questi mesi Le vie del cielo che è il viaggio di un pellegrino nel tempo, un pellegrino che racconta tutto ciò che vede. Il primo suono l’ha archiviato nel 1970 quando aveva sedici anni. Le note di un organo sono finite nel suo Geloso, uno di quei vecchi registratori che andavano di moda allora. Ricorda: «Era l’organo della chiesa di Albacina, il paesino medievale in provincia di Ancona dove sono nato cinquantuno anni fa». Poi ha cominciato a raccoglierli con metodo. Prima quelli orchestrali, le percussioni, i fiati, gli ottoni. E poi tutti gli altri. Quelli della terra, del cielo e del mare. Intorno al 1983 ne aveva già così tanti che ha dovuto farsi spedire dall’Australia una prima “macchina” per custodirli. Ricorda ancora: «Era un computer Fair Light serie 1 che costava 83 milioni di vecchie lire, pagavo più di 3 milioni al IL PERSONAGGIO Nella foto sopra, Enrico Ragni, in arte “Màlleus”, il collezionista di Recanati. A sinistra, l’elaborazione computerizzata di un suono mese di rata, un incubo. Per fortuna avevo trovato un buon lavoro a Milano». Faceva il fornitore di suoni per alcuni studi pubblicitari. Lo chiamavano su dalle Marche un paio di volte la settimana, gli chiedevano di tutto. Per lo spot che stava lanciando sul mercato la Lancia Thema si rivolsero a lui. Della pubblicità e degli effetti speciali si è stancato presto. Per qualche mese ha collaborato con alcuni cantanti come Zucchero e Renato Zero, anche loro volevano i segreti del suo archivio. Poi, con il dono di una straordinaria manualità, Màlleus ha cominciato a frequentare i corsi di incisione di un famoso maestro inglese, così si è inventato amanuense. Ha aperto la bottega che gli permette di vivere senza affanni. E intanto ha continuato a mettere insieme i suoi suoni. Uno che non vorrebbe mai avere è quello dell’esplosione nucleare. «E non ho “Catalogare i rumori mi dà felicità ma ce n’è uno che non vorrei mai avere: quello dell’atomica” neppure i pianti dei bambini, mi fanno orrore», aggiunge. Tranne uno, quello di suo figlio quando è nato: un pianto di gioia. Al momento delle doglie la moglie Silvana era in un ospedale di Ancona, Màlleus ha avvolto il suo registratore in una busta asettica e l’ha fatto portare dentro la sala parto da un’infermiera. Tra i trentaduemila suoni archiviati c’è anche il primo vagito di Morgan, che oggi è un ragazzo di 22 anni. L’altra figlia si chiama Micol e di anni ne ha 18. Come sono i suoni Màlleus? «Sono belli, duri, metallici, morbidi, stridenti, ovattati, trasparenti, grintosi, leggeri. Sono come gli uomini e come la vita». Tira fuori altre schede dalla sua “libreria”. Il colpo secco di un vecchio fucile, i passi sulle scale, lamenti, risate, i respiri, un rogo, un gufo, un usignolo. Spiega: «Per registrare il suono degli uccelli di solito vado in un bosco di querce e piazzo un cavo lungo centocinquanta metri, ci attacco i microfoni con un timer programmato dalle quattro del mattino fino alle sette e poi aspetto lontano». Nel suo studio di Villa Colloredo ci sono schermi giganti, scorrono immagini, risaltano grafici che sembrano tracciati di elettrocardiogrammi: sono le piste che disegnano le “forme” dei suoni. Màlleus li ferma, li scompone, li trasforma, modella i suoi suoni come fossero creta. Armeggia con i cursori, sposta tasti che illuminano spie, mischia rumori naturali e artificiali, gioca con i rumori. Da qualche anno a Villa Colloredo vanno a trovarlo poliziotti e carabinieri dei reparti investigativi. Gli chiedono perizie foniche. Vogliono che decifri certi fragori, che isoli una voce dall’altra per potere captare anche le parole più incomprensibili. Fuori dal suo laboratorio ascolta tutto con un orecchio speciale. Quando gli capita di dormire negli alberghi usa i tappi, non sopporta i rumori del traffico. Quando torna a Recanati si rifugia subito nel suo studio di registrazione, lì passa lunghe notti: «Il suono è una cosa viva che permette di trasmettere messaggi agli altri senza parlare». Sprofonda in una poltrona, accarezza con lo sguardo i suoi schermi, chiude gli occhi mentre una musica invade la stanza. E dice: «Sono un ingegnere del suono che è riuscito a crearsi una vita come l’ha sempre desiderata». 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA i luoghi Mappe letterarie DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 Il primo ad avere l’idea è stato Pier Vittorio Tondelli, poi l’hanno studiata all’università e infine l’ha rilanciata la nuova generazione di scrittori noir. L’idea è semplice ed affascinante: considerare la lunga strada che va da Piacenza a Cattolica, come il corso principale di un’unica grande città con milioni di abitanti, la Metropoli emiliano romagnola Sulla via Emilia, CARLO LUCARELLI no dei primi a parlarne era stato Pier Vittorio Tondelli. O almeno, molti di noi lo hanno sentito da lui per la prima volta e per la prima volta hanno cominciato a pensare alla loro città in un modo diverso. Ecco, già il termine città è sbagliato. Regione, forse, ma non va bene neanche quello. Zona o territorio funzionano ma sono brutti, roba da Assessorato alle Attività Produttive, buoni per fotografare cooperative e insediamenti e non per rendere l’anima di qualcosa che forse non esiste anche se noi sentiamo che c’è. Chiamiamola metropoli. La metropoli emiliano romagnola. «Vorrei semplicemente far notare come l’aspetto più seducente — soprattutto da un punto di vista narrativo — fu per me poter ambientare un romanzo non tanto in una città, ma in una metropoli balneare che non ha equivalenti in Europa: una grande città della notte e del divertimento che si estende per centocinquanta chilometri di costa e in cui si riversano milioni di persone per celebrare il rito di quell’unico, vero periodo di deroga carnevalesca che la nostra società odierna consente, cioè la vacanza». Lui, Pier Vittorio Tondelli, aveva appena finito di scrivere un libro che si chiamava Rimini, e aveva in mente soprattutto la riviera, tra Cattolica, o meglio, Gabicce mare, e i Lidi ferraresi, e li pensava d’estate. Ma bastava andare un po’ più in su per accorgersi che si poteva dire qualcosa di simile anche per la parte emiliana della regione, della zona, del territorio, insomma, di questa strana metropoli emiliano romagnola. A noi che saremmo diventati i narratori di questa metropoli, a me che ci vivevo dentro senza ancora accorgermene, succedeva. Dormire a Faenza, studiare a Bologna e andare a divertirmi a Rimini come se fosse la stessa città. Prendere il giornale e cercare un film, e che lo dessero in un cinema di Ravenna, di Imola o di Lugo era la stessa cosa, come se fossero soltanto nomi di quartieri, uniti da una strada che poteva chiamarsi via Emlia, Adriatica, A1 o A14 ma era FOTO EIKON U DAI COLLI ALL’ADRIATICO Di giorno le strade sono intasate dai pendolari, poi quando arriva il buio il popolo della notte conquista il territorio LA VIA EMILIA La strada simbolo dell’aerea collega Piacenza con Rimini FOTO FARABOLA Repubblica Nazionale 38 30/10/2005 L’area misura 16.880 km quadrati e conta oltre tre milioni di abitanti come se fosse il corso principale di un’unica città. «Metropoli è una parola grossa» dicevano gli autori di una rivista che si chiamava proprio ME, Metropoli Emilia, che nacque nell’aprile del ‘99 e dopo un po’ di tempo, come succede a volte alle riviste, morì. «Metropoli è una parola grossa. Metropoli è una città molto grande, con luci, suoni, smog, traffico, grattacieli… Metropoli di notte è una distesa di luci e di sirene. Ah, e criminali, appostati dietro ogni angolo buio… Metropoli Emilia ha traffico, criminalità, luci, sirene e smog. In più ha anche la nebbia. Però è diversa, è lontana da stereotipate immagini in bianco e nero, fumose e tristi». Loro pensavano solo all’Emilia, a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, e davano anche i numeri di questa enorme, strana città, e sono davvero numeri da metropoli. 1.213.300 ettari di superficie. 135.000 metri lineari di via Emilia che li attraversa. 2.371.921 cittadini. 12.415 posti in cui si mangia, di cui 4.063 ristoranti. 294 cinema. 148 teatri. 220 locali da ballo e 113 di musica dal vivo. 13.461 cuba libre bevuti in discoteca soltanto nel week end. Facciamo il doppio, aggiungiamo la Romagna di Tondelli ed ecco la metropoli, questa cosa strana che va quasi da Piacenza fino a Cattolica, una metropoli di duemila ettari di superficie e quattro milioni di abitanti, che si estende a macchia di leopardo senza un vero centro, come Los Angeles, ma tanti, e una periferia diffusa che si chiama Ferrara, Imola, Ravenna o la Riviera. Esiste davvero questa città? Se lo si chiede a molti dei suoi abitanti diranno di no, e se si considerano le scelte amministrative di molti dei suoi comuni si dovrà convenire che no, non esiste. Ma Tondelli aveva detto una cosa molto giusta, quando aveva parlato della sua metropoli. Aveva parlato di un aspetto seducente, soprattutto dal punto di vista narrativo. Allora, forse non esiste nella realtà, questa metropoli, ma di sicuro esiste nella fantasia, nell’immaginario, è una città invisibile, come quelle di Calvino, che sono ancora più reali di quelle vere perché sono luoghi dell’anima. Da questo punto di vista, la metropoli emiliano romagnola è una città RICCIONE LE DISCOTECHE LA BANDA DELLA UNO BIANCA DA LUCARELLI A QUO VADIS BABY È la spiaggia più nota e affollata della costiera romagnola Dal Cocoricò al Bandiera Gialla, la riviera ospita le più famose d’Italia I suoi crimini hanno determinato l’atmosfera “noir” della zona Nella zona si ambientano “Almost Blue” e l’ultimo film di Salvatores DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 genere, che cercano di spiegare perché nella nostra cronaca nera si possano trovare esempi da grande metropoli, come la banda della Uno Bianca, e anche serial killer ed efferati, inutili omicidi. E Mafia. Ma come, non è Bologna, non è Rimini o Modena, non sono piccole cittadine, paesi addirittura, cosa c’entrano questi comportamenti criminali da grande città? C’entrano, se Bologna, Rimini o Modena li concepisci come quartieri e sobborghi di una metropoli, in cui un gruppo di poliziotti assassini può scorrazzare lungo la via Emilia, e anche oltre, anche a Pesaro, come farebbe una gang per le strade di Los Angeles. Non importa se non sembra così. Agli scrittori di genere basta la verosimiglianza, soprattutto se non è banale, e alla realtà basta semplicemente che accada. Ma non è solo una città nera. È una metropoli piena di opportunità e di vita, e questo grazie alla sua gente che si è abituata a muoversi, ad andarsi a cercare quello che gli serve, e non importa se per farlo deve spostarsi in un posto che ha un altro nome, ma solo apparentemente, perché spostarsi da Bologna a Modena o da Bologna a Rimini non è viaggiare, è andare. Ed è significativo che ci si sposti non solo per andare a lavorare, per raggiungere un ufficio o una fabbrica, ma anche un cinema, un pub o un ristorante. Lavorare e divertirsi, in continuo movimento. È anche per questo, forse, che questa metropoli sembra diversa dalle altre. Esiste davvero questa città? C’è chi la studia, anche da un punto di vista più specifico e competente del mio e chi, dallo stesso punto di vista, ne rifiuta il concetto. Chi la vede come un laboratorio, anche sociale e politico, e chi la considera soltanto un’occasione perduta, ormai morta. C’è anche chi non si è mai mosso da Mordano, da San Pancrazio o da Formiggine e di tutto quello che c’è fuori, di metropoli e megalopoli, non sa niente, non se lo immagina neanche e forse neanche gli serve. Ma alcuni di noi così la vivono, come una metropoli, e altri così la raccontano. È una città che ci piace, anche quando crediamo di odiarla. Se anche fosse soltanto un luogo dell’immaginario, a noi basterebbe. I poliziotti assassini della Uno bianca, i serial killer e persino la mafia: DALLE GRANDI VALLI AL PACIFICO L’area di Los Angeles è ampia 88.000 km quadrati. Gli abitanti sono 17 milioni comportamenti criminali FOTO CORBIS da megalopoli LE FREEWAYS Il sistema di arterie con decine di corsie è l’emblema di Los Angeles FOTO WEBPHOTO Repubblica Nazionale 39 30/10/2005 incredibile. Intanto cambia a seconda delle ore del giorno e i suoi abitanti del mattino non sono gli stessi di quelli della notte. Basta prendere la via Emilia alle otto, vedere chi c’è in quella lunga fila di macchine che si muove al rallentatore, intasata in un ingorgo eterno, sono il popolo del giorno, i lavoratori, le colonne portanti del modello emiliano. Ma basta aspettare e col buio la gente cambia e di notte ha un’altra faccia, altri vestiti, altre velocità, ed è il popolo della notte, quello che va a divertirsi e anche lui è una delle colonne portanti del modello emiliano, e spesso le persone sono proprio le stesse che avevano percorso quella strada alla mattina. Una città strana, che esiste solo in certi momenti e in altri no, che la puoi vedere solo a certe ore del giorno e della notte, solo in certi ambienti e per certi motivi, solo per certe persone, perché in altre ore, con altra gente e in altre situazioni non c’è, ci sono i paesini, le cittadine, i quartieri, ci sono le piazze, i bar e i campanili, tutti separati l’uno dall’altro. È una metropoli virtuale che vive in un universo parallelo, visibile e concreta solo quando si manifesta. È una città di frontiera. Non solo perché ci devono passare tutti, da nord a sud e viceversa, per forza, e spesso ci restano, perché questa metropoli è come una rete che lascia passare tutto ma trattiene molto. È una città di frontiera anche perché in questa città convivono contraddizioni che in altri luoghi sembrerebbero insanabili. Qui, a distanza di pochi giorni e pochi chilometri si passa da un’estate tropicale ad un inverno siberiano, dalle torri di Kenzo Tange che fanno della Fiera di Bologna una piccola Tokio ai borghetti medioevali delle cittadine, dalle porcilaie ai musei, dalla città del lavoro a quella del divertimento. Basta una strada, come dice Eraldo Baldini, un altro dei narratori della metà oscura di questa metropoli, bastano i pochi metri di larghezza dell’Adriatica a separare il divertimentificio della riviera, tutto luci e colori, da una campagna che riesce a passare da un’agricoltura intensiva e industrializzata a punti in cui potresti credere che ancora ci sia la malaria e i sacrifici umani di qualche cultura arcaica. È una città nera, anzi noir, e non per nulla ci sono nati tanti autori di FOTO SIME la nostra Los Angeles DA ELLROY ALLE IENE LO SCANDALO DEGLI AGENTI RAZZISTI I CLUB MALIBÙ La città vive in libri come “LA Confidential” o nei film di Tarantino Il pestaggio che portò alla morte di Rodney King aprì una rivolta razziale I locali notturni di Santa Monica sono meta fissa dei giovani californiani È la località delle famose spiagge californiane amate da bagnanti e turisti 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 Esattamente settant’anni fa nasceva l’Ente nazionale della moda, con il compito di contrastare il dominio degli atelier di Parigi E così lo stile fu imposto per legge, ma grazie all’inventiva dei nostri sarti iniziò l’epoca del Made in Italy Moda autarchica I vestiti di regime della donna fascista NATALIA ASPESI uando è nato il made in Italy, la nostra potente fabbrica del lusso? Negli anni Settanta con Giorgio Armani e gli altri grandi, o ancor prima con disegnatori come Walter Albini o Kino Bert, oppure nei favolosi anni Cinquanta a Roma, quando le dive della Hollywood sul Tevere correvano a vestirsi dalle sorelle Fontana o da Schubert? O con Ferragamo negli anni di guerra, quando col talento si sostituiva la mancanza di materie prime e si facevano scarpe con la stagnola e vestiti con la ginestra? Esiste una data ufficiale e burocratica che ne sancisce l’inizio, ed è il 31 ottobre 1935, quando un decreto legge fonda l’Ente Nazionale della Moda, con sede a Torino. E per quanto l’Italia sia entusiasticamente fascista (ne prendiamo ogni tanto di queste cantonate, la passione per l’uomo nuovo, per poi pentircene), gli industriali lombardi che puntavano su Milano mugugnano; si allarmano le signore facoltose, abituate a farsi il guardaroba completo a Parigi; si disperano gli 800 sarti e sarte italiani d’alta moda, che comprano i modelli nell’unico luogo indiscusso dove si inventa ogni anno la moda, Parigi: da Chanel, da Schiaparelli, da Molineaux, anche dal declinante Poiret ormai sull’orlo del fallimento, e con arte sublime li riproducono. È un monopolio straniero che il fascismo non può tollerare. Tra l’entusiasmo popolare è già iniziata la guerra d’Etiopia e l’Italia sta per diventare un Impero; in più la Società delle Nazioni ha deciso contro il nostro paese sanzioni in verità molto blande e si sta già organizzando una fantasiosa autarchia. Da anni alcune ferventi eroine come Lydia de Liguoro che si definisce «indomabile fantaccina della nostra moda», lottano inascoltate per affermare un lusso nazionalista. Tramortita dall’emozione, la signora, il 24 maggio del 1930, in una delle tante adunate patriottiche, riesce ad incontrare il suo idolo, il Duce: «Il nostro cuore batteva come il motore di una cento cavalli lanciata sull’autostrada». Le affidano una battagliera rubrica sul Popolo d’Italiae finalmente Mussolini proclama: «Una moda italiana nei mobili, nelle decorazioni e nel vestiario non esiste ancora: crearla è possibile, bisogna crearla». La nostra industria dell’abbigliamento, che dopo aver sbaragliato da tempo la supremazia francese oggi regna ancora sul mercato del lusso malgrado il “pericolo giallo”, compie domani settant’anni, ed è nata fascista, anzi fascistissima. Dapprima auspicata dai nazionalisti, poi imposta per ideologia littoria, una moda italiana diventerà una necessità con la penuria dell’autarchia e arriverà a subire le leggi antisemite. Per quanto nata per ideali patriottici oltre che mercantili, ha faticato a imporsi: non la voleva nessuno, e allora la potente macchina della propaganda si mette in moto. È la stessa che divide i doveri delle donne secondo il loro censo e i loro compiti. Da una parte ci sono quelle che, escluse dalle università e dalle professioni, dovranno guadagnare la metà degli uomini in lavori comuni, risparmiare, fare figli, non contare. Dall’altra ci sono quelle, pur irrilevanti ma ricche, che dovranno contribuire all’economia nazionale spendendo fascisticamente in abiti, pellicce, gioielli, domestici, case, arredamenti, viaggi, arte, beneficenza. In quegli anni i giornali femminili sono una quarantina e tutti al servizio del fascio nella costruzione della perfetta doppia donna mussoliniana. E i massimi pensatori colgono l’ennesima occasione, su quotidiani o anche in loro preziosi tomi, per dettare legge alle donne che il regime sta cancellando chiudendole nei ruoli domestici, riproduttivi, decorativi. Le occasioni per infiammarle sono tante, per esempio il dono dell’oro alla Patria in guerra contro i selvaggi negri dell’Etiopia, e infatti accorrono generose nei luoghi di raccolta: 180mila fedi a Milano, 250mila a Roma, e per la patriottica anche se antipatica cerimonia, è stato suggerito a chi può di indossare «un vestito di velluto di un bel rosso cupo con larghe maniche, con un cordone alla vita, dalla breve scollatura». Convincere a vestire italiano le signore del regime, le aristocratiche, le donne dei gerarchi, le alto borghesi, le nuove ricche, le dive del teatro e del cinema, quelle che devono dare lustro alla nuova Italia imperiale, appare subito un’impresa titanica. Le sartorie poi non sanno da che parte cominciare a inventare una moda loro: qualche noioso suggerisce di ispirarsi ai nostri costumi regionali, fotografando la principessa di Piemonte addobbata da ciociara o meneghina, oppure alla nostra grande pittura. Purtroppo l’hanno già fatto a Parigi: la mostra sul Rinascimento italiano al Petit Palais ha suggerito a Chanel e ad altri suoi colleghi grandi cappelli leonardeschi, scarpine copiate da quelle di Sant’Orsola del Carpaccio. Alcune signore italiane per fortuna hanno accettato di posare alla mostra e tra loro c’è la bella contessa Nicky Visconti, che un sarto italiano, Ventura, ha vestito come una gentildonna del Pisanello. Ma il traffico con la moda parigina prosegue, anche le dame più fasciste disubbidiscono: non resta che obbligarle per legge a far contento il Duce. I metodi sono complicati, farraginosi, anche intimidatori: si inventa un marchio di garanzia che una speciale commissione assegna ai modelli «di ideazione e produzione nazionale» che le sartorie sono obbligate a inviare a proprie spese per Repubblica Nazionale 40 30/10/2005 Q La penuria di materiali trasformò l’operazione, partita per esigenze ideologiche, in una necessità Ma le resistenze delle italiane furono fortissime e il Duce dovette mettere in moto la macchina della propaganda DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 MODELLO ITALIANO Sotto, sfilata di modelli in tessuto raion fiocco organizzata dalla Snia Viscosa nel 1937 Accanto: un manifesto di Dudovich per “La Rinascente” (raccolta Bertarelli). A sinistra, una locandina pubblicitaria fascista sui prodotti italiani INNO ALLA SEDUZIONE Sandalo in rafia creato da Ferragamo nel 1935 A centro pagina, un olio su tavola di Cagnaccio di San Pietro intitolato “Ritratto della signora Vighi” (1930-1936) collezione privata ottenere l’approvazione politica. Nelle vellutate sartorie in stile rococò oppure razionalista, le collezioni devono presentare dapprima il 35%, poi il 50% di modelli con marchio di italianità, gli altri che siano pure di ispirazione francese se non addirittura originali parigini. Ma la disubbidienza dilaga, le donne, si sa, sono leggere, inconsistenti, non sufficientemente littorie. E per esempio L’Illustrazione Italiana che, con disciplina, molto si occupa di moda scrive nella cronaca di una sfilata: «Le sarte, presentando i modelli italiani confezionati con stoffe e guarnizioni di pura fonte italiana, davano un’occhiata inquieta e indagatrice alla cliente elegante, che mostrava di accogliere l’abito con sacrificio personale e lo sopportava come se avesse sopportato un saio, per un puro spirito di disciplina, mentre tutti i suoi sogni capricciosi di eleganza esotica si frangevano là, al confine, contro quelle porte ben chiuse». Per convincere tutte quelle zuccone disfattiste, l’Ente costituisce un corpo di veri e propri funzionari di polizia giudiziaria che irrompono nelle sartorie per controllare l’italianità della produzione, stabilendo multe pesanti per gli evasori: 500 lire a chi non denunci la sua attività all’Ente, da 100 a 5000 a chi sopprima il marchio di garanzia per far credere alla cliente che il modello sia francese, da 500 a 2000 lire a quei sarti con tendenze delinquenziali che mettono in collezione una percentuale di abiti italiani inferiore a quella richiesta dal decreto o che pure, vergognandosene, non li mostrano alle clienti nascondendoli in cantina. Tuttavia, anche se di pura razza italiana, la moda, espressione di autonomia femminile che potrebbe sfuggire all’imperio governativo, preoccupa molte grandi teste del pensiero fascista. E per esempio, in piena campagna demografica, il numero è potenza, c’è chi si chiede: il desiderio di eleganza non distoglierà i fragili cervelli delle donne dai compiti riproduttivi? Ai giornali femminili arrivano direttive per eliminare fotografie e disegni di indossatrici sottili quindi probabilmente sterili; alle case di moda viene chiesto di non far più sfilare modelle «col passo di levriero e quel curioso atteggiamento di stanchezza che incurva le spalle». Ci mette il naso anche lo scienziato Nicola Pende, quello che è contro lo sport e la cultura per le donne, che stabilisce quale debba essere l’indossatrice fascista ideale: altezza 1,56/1,60, peso 55/60. Mussolini già dal ‘32 rivolgendosi ai medici fascisti, aveva deplorato «la moda del dimagrimento eccessivo». E adesso studi e congressi demografici stabiliscono che «l’eleganza è nettamente sfavorevole alla fecondità». E anche la troppa, antipatriottica cura di sé. Infatti ecco il buon esempio di Grosseto dove sono più prolifiche le donne coi denti guasti, anche se, peccato, su 391 donne prolifiche solo quattro hanno folti baffi. È già cominciato l’ostracismo a tutto ciò che è straniero, subito Lidel, Dea, Per voi Signora, Sovrana, La donna, la prona stampa fascista femminile, ma soprattutto quotidiani e riviste culturali, rivolgendosi quasi sempre alle donne, si adeguano: bandire il tè e offrire rosolio, non ballare il fox ma riesumare la giga, eliminare dalla casa tutti i prodotti stranieri, parlare solo l’italiano e con stranieri il latino, non far entrare in casa libri e giornali stranieri. «Meglio l’ignoranza dello snobismo». E soprattutto affidare i figli a istitutrici nostrane, evitando «tutte le mercenarie oltre confine, che iniettano nei nostri fanciulli i primi germi della xenolatria». Lo scrive Umberto Notari, cui oggi un comune leghista potrebbe de- dicare una piazza. Nel settembre del 1936 l’Ente Nazionale della Moda pubblica un ponderoso, 500 pagine, Commentario Dizionario italiano della moda curato dal giornalista Cesare Meano. Il quale suggerisce come liberarsi dalle parole straniere in un campo, quello dell’abbigliamento, in cui il francese e talvolta l’inglese regnano, sostituendole con quelle italiane: per esempio non négligé ma disordine, non giarrettiera ma legacciolo, non damier ma scaccato, non jersey ma punto calza, non parure ma finimento, non piedde-poule ma mille zampe, non tight ma velada, non sweater ma vitamaglia, non trousse ma scarabattola, non chignon ma cignone, non popeline ma papalina. Si sorride, ma non troppo: infatti oggi le nostre riviste di moda sono per pigrizia e mancanza di fantasia praticamente scritte in inglese, come se l’italiano non lo conoscesse più nessuno o come se il nostro Paese non contasse più sul mercato dell’eleganza. C’erano mezzi meno coercitivi per convincere le ricche signore a vestire e parlare italiano? Con scarso successo l’Ente Moda pensò a quel mezzo popolare che è il cinema, e nel 1937 Alessandro Blasetti che avrebbe girato poi alcuni tra i più bei film anteguerra, accettò di dirigere La contessa di Parma: un film allora stroncato dai colti critici di Bianco e Nero(«sarebbe bene che Blasetti si impegnasse a non bazzicare più tra gli aristocratici, gli abiti alla moda, i grandi alberghi e le battute di spirito»), che oggi risulta affascinante e percorso da ironia poco fascista. Si svolge in una casa di mode torinese; la padrona è una milanesona di modi spicci; il direttore è un Umberto Melnati un po’ gay che infiora i suoi discorsi con termini francesi prontamente corretti dalla signora; le due indossatrici sono Elisa Cegani e Maria Denis, povere e maltrattate; il ricco calciatore (anche allora!) è Antonio Centa. Magnifici interni anni Trenta, abiti italiani bellissimi. Ma le spettatrici continuarono ad amare e copiare, finché fu possibile, la moda dei film americani, esaltata dalle sottili Marlene Dietrich, e Katherine Hepburn, persino da Deanna Durbin che pure vestiva malissimo. Si sa quali disastri portarono poi alla moda l’autarchia e infine la guerra, anche se proprio in quegli anni di tragedia e penuria, riviste di grande eleganza come Bellezza che il regime aveva voluto per sostenere il lusso autarchico, cominciarono a mostrare i progressi, la classe, la fantasia, l’audacia di una moda che avrebbe poi conquistato il mondo. Dal 1938, con le leggi razziali, la moda italiana ha un nuovo nemico: non più la moda francese ma quella giudea, e le giornaliste operose nei loro giornaletti femminili predicano l’eleganza della razza, il buon gusto ariano, segnalando che le modelle troppo magre devono essere certamente ebree. Molte industrie dell’abbigliamento hanno dirigenti ebrei e sono state fondate da ebrei: «Il fatto che gli industriali ebrei di Milano non contino molto nella grande massa laboriosa e intraprendente non vuol dire che anche qui non si debba vedere chiaro nei loro riguardi…», scrive il Corriere della Sera di quell’anno. A guerra iniziata, mentre il governo continua a predicare il dovere dell’eleganza per sostenere l’industria tessile promuovendo mostre di abbigliamento e feste lussuose, ovviamente riservate alle ricche signore del regime, si intensificano i moralismi di alcuni esponenti fascisti e soprattutto dalla Chiesa. Qualcuno accusa: il regime non fa abbastanza per difendere il pudore, e con la scusa della necessità di non sprecare tessuto si proibiscono, oltre lo strascico, anche i pantaloni femminili. La Donna Fascista giudica severamente i pantaloni, che sono borghesi, volgari e mascolinizzano: «L’estate scorsa sono state pure fischiate e costrette a ritirarsi alcune signore e signorine che per le vie di una città non balneare indossavano attillati pantaloncini…». La lunga battaglia contro il peccaminoso corpo femminile ingaggiata dalle gerarchie cattoliche culmina il 22 maggio 1941, quando Papa Pio XII indice «la crociata della purezza». E davanti alle 4000 socie della Gioventù Femminile dell’Azione Cattolica parla non della guerra, non dei bombardamenti della flotta inglese su Genova, non dei 60mila uomini partiti per la Russia, non della drammatica offensiva in Grecia, né della perdita di Addis Abeba, tragici eventi degli ultimi mesi. Altre sono «le spaventevoli minacce per l’ordine sociale e l’avvenire delle nazioni»: per esempio, «non è forse sotto gli occhi di tutti una moda ardita, indecorosa per una giovane cristianamente cresciuta?... Non è Nostro proposito di rintracciare qui il triste e troppo noto quadro dei disordini che si affacciano ai vostri occhi, vesti così esigue o tali da sembrar fatte piuttosto per porre in maggior rilievo ciò che dovrebbero velare…». Ma la moda non si arrende, né al Papa, né alla guerra, né alla fame, né alla mancanza di tutto, né alla certezza della sconfitta: Elsa Robiola sul numero di novembre del 1944 di Bellezza racconta del suo perigrinare di sfilata in sfilata, nelle macerie di Milano: «Vi sono momenti di smarrimento in cui ci si chiede come è possibile che tutto ciò esista ancora… Ma tutti soffriamo, e forse la moda esiste perché la sua immagine, di una bellezza che rinasce ogni giorno, ci aiuta a reprimere singhiozzi e lacrime…». Pochi mesi dopo la guerra è finita, tutto del fascismo (allora) viene cancellato. Ma la moda, che pure aveva disubbidito e resistito contro i diktat del regime, si scopriva, finalmente, italiana. 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 La prossima estate sarà aperto al pubblico l’archivio del grande regista, assegnato alla “University of the Arts” di Londra. Raccoglierà pellicole, sceneggiature, schizzi, manoscritti, libri e strumenti di lavoro. Ma non solo: fra i materiali esposti ci saranno anche le immagini scattate dall’autore di “2001 Odissea nello spazio” per la rivista “Look” all’inizio della carriera, dalle quali si intuisce l’attitudine a far recitare i suoi soggetti. Anche quando appartenevano alla realtà Lo sguardo di Kubrick Il primo talento del giovane Stanley ENRICO FRANCESCHINI Repubblica Nazionale 42 30/10/2005 C LONDRA he cosa ha voluto esattamente dire con 2001 Odissea nello spazio? Stanley Kubrick avrà letto e ascoltato questa domanda migliaia di volte, dal giorno del 1968 in cui il suo capolavoro apparve nelle sale cinematografiche. Se ne aveva voglia, di solito rispondeva così: «Non ho cercato di esprimere qualcosa a parole. “2001” è un’esperienza visuale, non verbale, un tentativo di aggirare il parlato per penetrare direttamente il subconscio con un contenuto emozionale e filosofico». È bello pensare che, quando l’Archivio Kubrick sarà inaugurato l’estate prossima alla University of the Arts di Londra, studiosi e appassionati di cinema avranno la sensazione di penetrare il subcosciente del grande regista: e frugandovi dentro, chissà, forse troveranno finalmente il pieno significato emozionale e filosofico dei suoi film. L’archivio comprende pellicole, fotografie, sceneggiature, schizzi, manoscritti, appunti, lettere, mappe, libri, schedari, più una enorme quantità di materiale vario, dalle sue predilette boccette d’inchiostro marrone a una sterminata collezione di cartoline, per citarne un paio: Kubrick non gettava mai via niente. Gli archivisti della University of the Arts hanno impiegato otto mesi a catalogare tutto quanto, lavorando da dodici a quindici ore al giorno nella sua fattoria dello Hertfordshire, nella campagna a nord della capitale, ma nessuno di loro sarebbe stato così folle da lamentarsi. L’Archivio Kubrick è uno dei più straordinari tesori della cinematografia mondiale: due decine di università e centri studi internazionali speravano di accaparrarselo, specialmente negli Stati Uniti, dove il regista era nato e cresciuto. Soltanto nei giorni scorsi la vedova, Christiane, ha preso la decisione di assegnarlo invece a un ateneo in Inghilterra, dove Kubrick si trasferì nel 1969 con la famiglia e da cui non si mosse più per trent’anni, rimanendovi fino alla morte, avvenuta nel 1999, quando aveva settant’anni e da pochi giorni aveva terminato di montare Eyes Wide Shut. La scelta è caduta così sulla prestigiosa università londinese che riunisce cinque “collegi” dedicati alle arti: nessuno dei quali, tuttavia, disponeva di uno spazio abbastanza grande per ospitare degnamente il monumentale archivio. Nel dubbio, la University of the Arts ha preferito costruire da zero un edificio apposito, a Elephant and Castle, che suona come il titolo di un film mentre è solo un quartiere a sud del Tamigi. In attesa che l’Archivio Kubrick spalanchi le porte, a una data ancora im- Amava mettere in posa i personaggi come attori sul set per fargli assumere l’espressione giusta: spesso più che semplici “click” i suoi erano veri e propri “ciak” precisata dell’estate 2006, ci si può già fare un’idea di che cosa conterrà consultando un magnifico, ingombrante e pesantissimo volume, The Stanley Kubrick Archives (Taschen Editore), pubblicato all’inizio di quest’anno negli Stati Uniti e ora in uscita anche a Londra e nel resto d’Europa. Tra la corrispondenza privata con la moglie di Vladimir Nabokov, l’autore di Lolita da cui Kubrick trasse l’omonimo film, le bozze di progetti mai realizzati, come quello di una pellicola su Napoleone, le lettere inviategli dai fans, con le copie delle sue risposte («caro mister William, grazie per avermi scritto. No comment su Arancia meccanica. Dovrà decidere da solo cosa pensarne. Sinceramente suo, S. K.»); tra le immagini che lo riprendono sul set accanto a Kirk Douglas in Spartacus, a Peter Sellers in Dottor Stranamore, a Malcom McDowell in Arancia meccanica, a Ryan O’Neal in Barry Lindon o a Jack Nicholson in Shining; tra le registrazioni delle sue interviste più famose, come quella lunghissima al mensile Playboy, le correzioni vergate a mano su testi dattiloscritti, le testimonianze di critici, colleghi, amici, le raffiche di battute che ad essi regalava («se è vero che Hemingway era ubriaco anche quando scriveva, dovrò procurarmi una di quelle bottiglie e mandarla ai miei sceneggiatori»), le cinquecento e passa pagine del libro sembrano effettivamente un viaggio nella psiche del regista. Riassumerlo da cima a fondo è impossibile, nello spazio di un giornale: è un viaggio che si può fare soltanto visitando l’archivio di pietra, non appena sarà pronto, o almeno sfogliando quello di carta. È però possibile rivisitare, attraverso il libro, un capitolo della sua storia: il primo. Che racchiude una sorpresa, almeno per i non addetti ai lavori che conoscono Kubrick soprattutto tramite i suoi film. Il regista aveva fama di recluso, appartato, solitario: eppure iniziò la sua carriera come fotoreporter, nella febbrile redazione di un grande giornale newyorchese. Kubrick era nato nel Bronx, in una famiglia ebraica. A dieci anni, suo padre, medico con la passione della fotografia, gli regalò una macchina fotografica, e fu un segno del destino. Stanley la teneva sempre in mano o appesa al collo. Insieme a un amico con la medesima passione, imparò a sviluppare e stampare fotografie in una rudimentale camera oscura. I suoi primi scatti furono per il giornale della high-school: piacquero, e divenne un’abitudine. A scuola era un disastro, marinava le lezioni, prendeva pessimi voti, rifiutava di studiare: ma una volta gli fecero un test per il quoziente d’intelligenza e risultò che ce lo aveva più alto di tutti i suoi compagni. Aveva 16 anni nell’aprile del 1945, poche settimane prima della fine della seconda guerra mondiale, quando l’America fu scioccata dalla morte del presidente Roosevelt. Stanley stava andando a scuola, con l’inseparabile macchina fotografica a tracolla, e rimase colpito dall’immagine di un edicolante con l’aria triste, il volto incorniciato dalle locandine dei giornali che annunciavano la scomparsa di Roosevelt. Scattò una fo- DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 I RITRATTI Le foto in queste pagine sono tratte dal volume “The Stanley Kubrick Archives”, edito da Taschen e uscito negli Stati Uniti nella prima metà di quest’anno. Sotto, i provini a contatto di una serie di autoscatti del regista. A sinistra, il regista con la macchina fotografica sul set del film “Spartacus”. In basso e nella pagina accanto, foto scattate da Kubrick negli anni della sua attività da fotoreporter e pubblicate dalla rivista americana “Look” In quelle carte un geniale paranoico MARIA PIA FUSCO n paranoico è qualcuno in pieno possesso dei fatti: era uno dei motti preferiti di Stanley Kubrick, la risposta a chi si stupiva dei dodici cartelli intimidatori — Keep out, No entry, Watch the dog, Go away, Strictly private, Don’t stop… — appesi in evidenza sul cancello della villa nello Hertfordshire, per altro lontana dalla strada principale, isolata. Kubrick era «un cinico convinto che il peggio dovesse ancora venire», come dice di lui Alexander Walker, uno dei pochi giornalisti con cui ebbe un lungo legame di amicizia, sia pure capriccioso, come quando Walker ricevette un’aspra telefonata notturna dal maestro che lo accusava della partecipazione al festival di Manila e del sostegno ad un regime corrotto: fu punito con due anni di silenzio. La paranoia e l’estrema diffidenza di Kubrick erano ancora più impressionanti se si aveva il privilegio di essere ammessi all’interno. Prima di tutto la cucina, grandissima, con un gigantesco tavolo rettangolare, usato sia per le riunioni di lavoro sia per i pasti, nei quali la cucina italiana era frequente, in particolare gli spaghetti alla puttanesca, ai quali lo aveva introdotto Riccardo Aragno, l’amico scrittore a cui affidava il doppiaggio italiano dei suoi film. Naturalmente con il massimo del controllo, era lui a scegliere le voci che Aragno gli inviava registrate ed era lui che, con lunghe telefonate Roma-Londra, ascoltava i dialoghi doppiati e selezionava. Non conoscendo l’italiano, giudicava non dalle parole bensì dall’armonia dei suoni. È leggenda l’attenzione pignola ai dettagli: quando Arancia meccanica fu invitato a Venezia, mandò alla Mostra i suoi macchinari per la proiezione; e quando seppe che in un cinema di Tokio, dov’era in programma un suo film, lo schermo era troppo vicino alla platea, fece eliminare le prime due file di poltrone. Se nella cucina il clima era in genere conviviale e la conversazione teneva conto delle caratteristiche degli ospiti — agli italiani era richiesta ogni informazione possibile sul lavoro, i film e i progetti di Fellini — il passaggio nell’immenso salone ricreava inquietudine: comode poltrone sparse senza ordine, spazi interrotti da alti scaffali, alcuni colmi di dischi e cassette, altri con le più moderne attrezzature video e audio, e un numero incalcolabile di armadi alle pareti, scuri, pesanti, misteriosi. Con un prezioso slancio di cordialità, il maestro svelava che le file di adesivi scritti a mano su un paio degli armadi erano per il film su Napoleone, divise con maniacale precisione in sequenze interne ed esterne, con o senza dialoghi, con uno o più personaggi, con animali o senza. Mentre parlava, il suo sguardo magnetico si accendeva, seduceva gli ospiti, ma guai a chiedergli il contenuto degli altri armadi, erano l’archivio personale di una vita, solo sua moglie Christiane ne conosceva i segreti. Con gli ospiti, se mai, si divertiva ad illustrare i codici segreti che inventava per comunicare con i collaboratori durante le riprese di un film, perché «è bene non fidarsi», diceva. «Su un set si infiltrano spie e mascalzoni, come su un campo di battaglia. Se Napoleone avesse usato più cautela nel comunicare con i suoi generali, il suo destino forse sarebbe stato diverso». Repubblica Nazionale 43 30/10/2005 U to, ma anziché proporla al giornale della scuola ebbe l’impudenza di andare a offrirla giù a Manhattan al caporedattore fotografico di Look, la rivista che competeva con Life per il fotogiornalismo migliore di quell’epoca. Gliela comprarono per 25 dollari, senza sapere che l’immagine non era del tutto spontanea: Stanley aveva messo in posa l’edicolante, sistemandolo nella posizione giusta, gli aveva spiegato che espressione doveva assumere. Insomma: lo aveva diretto, come un regista con un attore sul set. Era stato il suo primo “ciak”. Uscendo estasiato dagli uffici di Look, quel giorno del 1945, Kubrick notò l’arena, come si chiamava in gergo la stanza in cui i fotografi free-lance stavano ad aspettare un incarico. Ben presto entrò anche lui a far parte di quell’arena; e a nemmeno 18 anni, quando si diplomò con un voto così basso che la maggior parte delle università lo avrebbero rifiutato, venne assunto come apprendista fotografo a Look. Ci rimase quattro anni, salendo rapidamente di gradino in gradino fino a diventarne uno degli astri nascenti, uno dei giovani fotoreporter a cui si pronosticava un grande futuro. Fotografava di tutto: pugili sul ring, clienti nella sala d’aspetto di un dentista, passeggeri sulla metropolitana, zoo e gallerie d’arte, circhi e jazz bands, Babbi Natale e ballerine di night-club, monelli di strada e celebrità. Il suo modello di riferimento era Arthur Fellig, un eccentrico paparazzo dei tabloid popolari più noto col nome d’arte di “Weegee”, di cui si diceva che riusciva ad arrivare sulla scena di un delitto ancora prima della polizia. La specialità di Weegee era cogliere l’attimo fuggente, l’istante in cui il suo soggetto abbassava la guardia e rivelava se stesso: e Kubrick imparò a imitare la pazienza e l’invisibilità del suo maestro. Intanto affinava il suo stile visuale, il suo senso della composizione e del movimento, cambiando angolazioni, creando montaggi, alternando primi piani e campi lunghi, come se fra le mani aves- se già una cinepresa. Un giorno se ne procurò una e decise di girare sotto forma di cortometraggio di sedici minuti il reportage fotografico su un pugile che aveva fatto per Look. Il budget fu di appena 3.500 dollari, raggranellati sommando tutti i suoi risparmi a un prestito del padre e dello zio. Dopo varie tribolazioni riuscì a vendere il suo Day of the Fight (Giorno del combattimento) alla Rko, una casa di distribuzione cinematografica, che aveva bisogno di brevi documentari da trasmettere prima dei film nelle sale cinematografiche: ne ricavò un profitto di appena cento dollari, ma con l’aggiunta di un contratto per un secondo cortometraggio. Si licenziò da Look, abbandonò la macchina fotografica, imbracciò la macchina da presa: e il resto è storia. Come diavolo le è venuto in mente il finale di “2001”?, gli chiesero molti anni dopo. «Non lo so», rispose Stanley Kubrick. «Come viene in mente qualunque cosa a chicchessia?». DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 spettacoli LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 L’IMPERO DEEJAY Opinion maker ANTONIO DIPOLLINA S MILANO i è alzato, stamattina, ha preso atto del 48esimo anno d’età compiuto e poi, più o meno come sempre, si è messo a correre. E come spesso accade, c’erano anche molte altre persone che correvano con lui. Domenica prossima, saranno alcune decine di migliaia, ma quella sarà la Maratona di New York e lì, insomma, è piuttosto facile raccogliere le iscrizioni. Quella di stamattina, invece, a Milano in zona San Siro è la prima edizione della Deejay Ten, ovvero la maratonina di dieci chilometri che Linus ha organizzato in proprio, chiamando a raccolta amici e ascoltatori della radio per dimostrare che non ce n’è, si può essere il dj radiofonico più famoso d’Italia della radio più ascoltata, ma quando prende l’impallinamento per qualcosa — e la corsa è tra le più innocue del mondo — non ci sono santi che tengano. Quindi il buon Linus è indaffaratissimo e tutto mentre il panorama radiofonico italiano sta vivendo un periodo di sobbalzi come non si registrava da tempo immemorabile. Entrano grandi gruppi in gioco, si anima un mercato — quello dei conduttori — che prima non c’era e così via. Roba vera? «È una fase delicata, sono arrivate due nuove radio di impronta generalista, il rischio è che invece di diversificare l’offerta si vada verso la marmellata di stampo televisivo, con un’omologazione molto forte. Il rischio, insomma, è di sentire ovunque la stessa musica». Ma non era già abbastanza così: «Un po’, ma non c’è limite al peggio, se lo si vuole». Poi è successo che in piena estate la ridefinizione del quadro abbia scoperchiato qualche pentola: le radio hanno preso a rubarsi i conduttori l’un l’altra, in questi passaggi sono volate polemiche e frasi pesanti finite sui giornali e alla fine, in quelli che hanno seguito le vicende, è emersa la figura di un Linus definito come un mezzo despota, o anche di più. Va da sé che le accuse arrivavano da chi se ne andava dalla radio, ma insomma il padre-padrone di Radio Deejay prendeva a entrare nell’iconografia ufficiale come uno cattivo, cattivissimo: «Su questa rappresentazione di me stesso ci ho sempre giocato, in realtà, e chi mi conosce bene lo sa. Dopodiché ho un ruolo da allenatore e devo fare delle scelte. A quel punto scatta la sindrome da fidanzata delusa, e quelli che rimangono bocciati hanno solo due alternative: una è quella di dire che se ne sono andati loro». E l’altra? «Di dire che sono uno stronzo». Ecco. RADIO DEEJAY DEEJAY TELEVISION DEEJAY TV L’emittente nasce a Milano il 1° febbraio 1982 dalle ceneri di Radio Music. Il fondatore è il dj Claudio Cecchetto (foto). La prima voce a parlare è quella di Ronny Hanson Nel 1983 esplode la trasmissione a base di videoclip. Il conduttore storico è Linus Tra i personaggi lanciati anche Gerry Scotti, Fiorello e Jovanotti (foto) La nuova formula televisiva continua con il lancio del canale satellitare in chiaro Deejay Tv, che inizia le trasmissioni il 25 dicembre 2000. Nella foto Albertino Linus.Ho un’idea pazza una radio dentro la tv «Io non ricordo di aver mai litigato davvero con nessuno. Solo una volta, anni fa, forse, con Enrico Silvestrin, una cosa pesante. Poi è finita subito, siamo in buonissimi rapporti oggi». L’allenatore, diceva: «Si è capito che il migliore, per me, è Fabio Capello?». Non solo per questioni di Juventus, giusto? «Il bastone e la carota, ben alternati, saranno anche un metodo banale e antico, ma è quello che funziona di più. Altrimenti non sarai mai capace di far rendere uno come Cassano e subito dopo uno come Ibrahimovic». A onta della quasi mezz’età portata di corsa, Linus continua a essere uno dei più ricercati quando si vuole un parere sul pubblico, giovane e meno giovane, e tendenze varie. Il suo posto d’osservazione fisso, quello della mattina in radio, quando va in onda con Nicola Savino e si fionda sull’attualità in tutte le sue forme, e dall’altra parte piovono mail e sms, ecco, quello è da sempre ritenuto un posto d’osservazione privilegiato, anche se la media d’età degli ascoltatori tende fatalmente a salire. E che sta succedendo, ora? «Il cambiamento più forte è in peggio, inutile negarlo: sento un a u m e n t o sproporzionato della faziosità e dei toni forti. Contro tutto e tutti, purché si sia contrapposti. E tutto nasce dall’incrocio dell’aumento di superficialità nel valutare quello che succede, unito a quella che è ormai un’orgia di comunicazione, di possibilità di accesso immediato facendosi sentire: i messaggini, le mail, il voler esserci. E tutto porta ad aumentare il tifo da stadio, quello becero, le fazioni contrapposte a prescindere. Con regolarità mi danno del comunista di m... oppure Il padre-padrone di Radio Deejay oggi compie 48 anni “Più invecchio e più divento zen: non mi arrendo alla curva, non devi essere un barbaro per avere successo” DIRETTORE ARTISTICO Nella foto sopra, Linus (Pasquale di Molfetta), direttore artistico di Radio Deejay dello schiavo di Berlusconi, così tanto per fare qualcosa. Succedeva anche prima, chiaro, ma negli ultimi tempi la quantità di ultras della situazione sta aumentando a vista d’occhio». Bene, anzi male, malissimo. Come si resiste? «A seconda della propria indole. In radio c’è uno come Platinette che prende la questione in maniera frontale, se arriva una mail di insulti la legge e si mette a discutere. A me, nel corso della mattinata, arrivano almeno duemila messaggi, io metto dei paletti, la persona che mi seleziona le mail sa che deve cestinare quelle rissose a prescindere. E questo nasce anche dal fatto che più invecchio è più divento zen, sto nel mio, faccio il mio, come si dice, non mi nego un’opinione su nulla, batto sull’attualità e sulle cose che succedono e non mi arrendo alla curva, agli insulti contrapposti». Ma la radio non era un’isola felice? «Dipende, lo è nel momento in cui possiamo esprimere opinioni molto forti o pesanti su qualcosa: in quel momento dall’altra parte ho più ascoltatori di certi programmi televisivi, ma la medesima cosa detta in tv scatenerebbe magari interrogazioni parlamentari, in radio non succede nulla». Il punto è che la deriva di cui parla ha chiarissimi accenti televisivi: «Secondo me la causa principale è questo strabordare della possibilità di accesso da parte del pubblico. Poi è chiaro, il modello è quello del dividersi tra Albano e la Lecciso, o le dialettiche dei reality, in particolare quelli più scemi. Ma anche su questo tendo a manifestare tranquillità: facciano come credono, io faccio il mio, non è necessario essere barbari per avere successo». Stylos Pasha de Cartier www.cartier.com No? «È una questione di volontà, in tv ne hanno poca». Giusto, e la tv in senso più ampio? «Non me ne faccio un problema, tra poco lanceremo un esperimento di radio in tv ma sarà nello spirito giusto, per fare qualcosa di diverso, magari innovativo, con idee forse un po’ matte. Il problema in tv è che i matti non ci sono». Ne è certo? «Quelli che fanno del bene, come Enrico Ghezzi in Rai. La Rai, almeno ha lui. Mediaset non ha nessuno così». Ma come, e il direttore di Italia Uno Tiraboschi? «Non scherziamo, lui la sua follia la sfoga all’esterno, disegnando bei fumetti e scrivendo libri. Nel momento in cui torna in ufficio, il suo gruppo comico di riferimento rimane la Premiata Ditta». La tv è anche quella attuale del ciclone Celentano. Lei, nel 2001, è stato tra gli autori di 125 milioni di c…zate. Visto da fuori, ora? «A me ha fatto molto ridere la questione del paladino della sinistra e della libertà d’espressione». Sì? «Riferito a Celentano, al suo personaggio, c’è da ridere, certo. Lui è naif, è sempre lo stesso, si appassiona a quello che vede, non sa nulla di quello che non vede. È stato per trent’anni al centro della scena, poi i problemi della notorietà lo hanno costretto a vivere come un recluso. Si è adattato: guarda la televisione e parla con la televisione. Cioè, un po’ lo facciamo tutti, ma lui esagera. E quando ogni tot di anni ha il programma, butta dentro tutto quello che ha accumulato, ma è per forza di cose superficiale, fuori c’è tutto un mondo che lui non sa nemmeno com’è fatto. Ecco, a Celentano manca un bar, in fondo, dove andare a discutere con gli amici come faceva da giovane: se si potesse sfogare ogni tanto al bar, in tv potrebbe andare a fare ben altro». Mica male. «Lui ha una forza espressiva fuori dal comune, però piange il cuore a vederlo esaltare la Milano degli anni Sessanta: quella Milano faceva schifo, ma lui non è mai uscito da lì, dalla via Gluck, che era brutta anch’essa». Ma il tema che riguarda per esempio Santoro non era superficiale… «Lui sa che Santoro portato lì in quel modo fa colpo, sa che se ne parlerà. Ma la sinistra che lo esalta per quello, e la destra che lo attacca per gli stessi motivi, beh, loro fanno ridere». Ma il rock e il lento hanno funzionato, no? «Una buona trovata. E finisce lì. È quel genere di armamentario mediatico che funziona sui media, appunto, e che poi va a sbattere nella realtà. Immagino che se l’avesse fatto prima delle Primarie del centrosinistra, quello rock sarebbe stato Scalfarotto. Che poi prende lo 0,4 per cento. O magari che quello lento è Cofferati che difende la legalità. Invece Cofferati è rock, altroché se è rock…». 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA i sapori Autunno in tavola DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 Considerato da sempre “cibo povero”, l’ortaggio più robusto (e tra i meno calorici) della natura vive domani, notte di Halloween, il suo momento di gloria. Ma non sarà l’unico Riscoperta dai grandi chef, la sua polpa arancione è diventata negli ultimi anni protagonista di prelibatissimi primi piatti e di spumeggianti dessert LE VARIETÀ Marina di Chioggia Piena di Napoli Ornamentale La zucca di Cenerentola (cucurbita maxima) in versione mini ha la caratteristica forma globosa, schiacciata ai poli. Verde scuro, ha polpa asciutta. Adatta per la cottura al forno e per il ripieno dei tortelli La campionessa delle zucche torte (cucurbita moschata), simile a una lunga clava è di un bel verde striato d’arancio, ha polpa gialla, farinosa e dolciastra. Matura in inverno. Si usa nelle minestre campane Varietà come la Quintale americana, la Turbante e la Lagenaria sono perfette per decorare Già i Romani utilizzavano la zucca del Pellegrino, dopo averla essiccata e svuotata, come borraccia o per ciotole Trombetta ligure Coltivata a pergolato e raccolta acerba in estate, quand’è ancora piccola (tipo zucchina), tenera e dolce, vanta una forma allungata, ingrossata a una estremità. Verde chiaro-nocciola, è tipica della zona di Albenga La specie si chiama “cucurbita maxima”, cresce facilmente su tutti i terreni senza pesticidi, ed è una vera riserva di sali minerali zuccheri e vitamine Zucca la Èmagica, basta da sola a fare un menù LICIA GRANELLO otete comprarla già pronta. Oppure optare per il kit fai-da-te con tutto il necessario già dosato, un po’ come le parole crociate facilitate. Se invece siete maestri d’intaglio, affilate il coltellino: domani è Halloween, trick or treat, scherzetti o dolcetti? Tutto ruota intorno alla zucca, il vegetale più fertile dell’immaginario collettivo infantile. Quale ex bambina non ha sognato di salire sulla carrozza di Cenerentola, con o senza scarpina? Quale bambino non si è crogiolato nell’idea di infilare la testolina in una mega-zucca e stordire di paura maestro e compagni di classe? La festa d’importazione americana ci appartiene pochissimo: l’abbiamo subita come una moda vagamente scombiccherata, facendola nostra senz’altro scopo che disegnare orbite vuote in un paio di vecchi lenzuoli per il più scontato, finto-macabro travestimento da festa notturna. Ci appartiene molto, invece, la zucca, che vive i suoi giorni di gloria con l’addentrarsi dell’autunno nel tempo più prossimo all’inverno: dicono i contadini d’antan che la zuc- P ca più prelibata, ovvero asciutta, soda, dolce, farinosa, deve staccarsi naturalmente dal picciolo. E che questo succede più facilmente dopo la prima gelata. Aspettiamo che faccia freddo davvero? Possiamo tamponare gli effetti di questo autunno semi-tropicale comprando quelle più piccole e pronte, magari lasciandole qualche notte sul terrazzino. Pratica che però ci farà rinunciare al supporto meritorio dell’ortolano (se gentile), pronto a spaccare la zucca — ortaggio di rara durezza, roba da far invidia alle carote più robuste — e tagliarla a pezzi, così da risparmiarci pericolosi incontri ravvicinati con il coltello più grosso, e rischioso, della cucina di casa. Il gioco vale la candela, anzi la zucca. Perché se è vero che, come per quasi tutti gli ingredienti “poveri”, abbiamo disimparato a utilizzarla limitando il consumo ai fiori (quelli sì difficili da rendere gustosi), recuperarne le ricette è un esercizio benefico. Lo scrittore Giuseppe Pederiali sostiene che negare a un affamato l’esistenza della zucca è come negare a un uomo l’esistenza di Dio, cioè togliergli la fede e la speranza per continuare. Come dargli torto? Intanto lei, la zucca, è robusta e indipendente: si difende benissimo dai parassiti senza bisogno di additivi chimici, e cresce su tutti i terreni, compresi quelli meno vocati, rimandando al mittente anche i fertilizzanti. E poi è sana, sanissima: una vera miniera di sali minerali, zuccheri, vitamine, antiossidanti, potassio, selenio, betacarotene. Il tutto, con un carico calorico risibile, 17 kc per etto (i condimenti naturalmente vanno calcolati a parte): se siete a dieta, la crema di zucca è tra i piatti ipocalorici che meno vi faranno sentire reietti e depressi… In più, rispetto alle verdure biologiche, che vanno comprate fresche perché marciscono in un amen, e a quelle convenzionali, a rischio-pesticidi, la zucca la compri e te la dimentichi: purché lasciata intera, infatti, si conserva per intere settimane. Ci si allestisce un menù intero. E di grande soddisfazione gustativa: crocchette, minestra, tortelli, puré, torta. Oppure un piatto solo, che però vale il pasto: il risotto “all’onda”, arricchito di volta in volta con salsiccia, taleggio, fegatini è un unicum in grado di mandare contemporaneamente in orbita neuroni del palato e trigliceridi. Non a caso, i migliori chef in circolazione costruiscono intorno alla zucca le più golose, irresistibili ricette invernali. Vuoto come una zucca, dicono. Che marchiano errore di valutazione. DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 47 Murta (Ge) itinerari Lo chef Igles Corelli gestisce a Ostellato insieme alla moglie Pia una locanda di rara bellezza naturalistica e di golosità legata al territorio: piatti come i cappellacci di zucca con sesamo e arancia testimoniano la passione per erbe, spezie, fiori e frutti 45mila Le tonnellate di zucca prodotte in Italia 391kg Il peso della zucca record del 2005, coltivata a Udine Ostellato (Fe) Appoggiato sulle alture di Genova Bolzaneto, nella Valle Polcevera, fa parte della World Pumpkin Federation, che riunisce i luoghi del mondo votati alla cultura della zucca. Nel secondo e terzo weekend di novembre ospita “Dalla A alla Zucca” Fondata dai romani a un passo dal Po, ospita l’oasi naturale delle Vallette, estesa tra l’Idrovia ferrarese e i canali della bonifica, con oltre 150 specie di uccelli. L’evento “Zucca a tavola…e in piazza!” coinvolge la città e i suoi dintorni nei weekend di novembre La cittadina natale di Maria Goretti, circondata da una bellissima, intatta, cerchia di mura che risale al XV secolo e iscritta tra i cento borghi più belli d’Italia, ospita ogni fine ottobre la “Festa delle Streghe”, che l’anno scorso ha avuto 70.000 visitatori DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE AGRITURISMO DU SUI Via Belgrano 13-15, Bolzaneto Telefono 010-7170068 Camera doppia da 80 euro, colazione inclusa VILLA BELFIORE (con cucina) Via Pioppa 27 Tel. 0533-681164 Camera doppia da 90 euro, colazione inclusa I TIGLI Via Del Teatro 31 Tel. 071-7975849 Con cucina DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE ANTICA OSTERIA A NINA Via Fratelli Canepa 40, Castagna Tel. 010-75165 Chiuso domenica, menù da 25 euro LOCANDA DELLA TAMERICE (con camere) Via Argine Mezzano 2 Tel.0533-680795 Chiuso lunedì e martedì, menù da 40 euro AI 9 TAROCCHI Via Dietro le monache 8 Tel.0717-976277 Chiuso mercoledì, menù da 25 euro DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE ORTOFRUTTA NASSO Mercato Coperto Box 13-14 Via Oldoini Tel. 010-7457407 COOPERATIVA AGRICOLA BOTTEGA DELLE VALLI Via Argine Mezzano 1 Tel. 0533-680757 AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA S.LORENZETTO Via S. Lorenzetto 18/A Tel. 333-4315453 LE RICETTE Sud America, Cina, Europa, Stati Uniti: la “cucurbita” è protagonista Crema La minestra più morbida si ottiene dalla zucca tagliata a tocchetti e rosolata in extravergine con porri e patate a rondelle. Una volta coperta di brodo e portata a cottura, si frulla con poca panna liquida, sale e pepe Tortello La pasta ripiena più gloriosa della cucina mantovana prevede un ripieno di zucca cotta in forno e amalgamata con amaretti, mostarda, parmigiano, noce moscata. Condimenti: burro fuso e parmigiano Al forno La merenda dei bambini di ieri si prepara tagliando e affettando la zucca Una volta infarinate e disposte sulla placca unta d’olio, le fette si fanno dorare in forno a 200 gradi per un’ora con sale e rosmarino Risotto Due scuole: zucca a dadini, imbiondita in olio e scalogno, cotta nel brodo, frullata e aggiunta a metà cottura del risotto. Oppure zucca cotta con il risotto. Nei due casi, si serve morbido, mantecato con burro e parmigiano FOTO OLYCOM Repubblica Nazionale 47 30/10/2005 Corinaldo (An) Culla e sepolcro, un simbolo ambiguo MARINO NIOLA imbolo universale di stupidità e al tempo stesso nutrimento essenziale dell’intelligenza. La zucca è un tipico esempio dell’ambivalenza dei simboli. Nata in Sud America, la regina delle cucurbitacee si è diffusa in tutto il mondo conservando sempre una straordinaria capacità di colpire l’immaginario. Un po’ per la sua forma, talvolta sferica talvolta fallica, un po’ per le sue dimensioni imponenti che le hanno valso fra i botanici il nome di cucurbita maxima. È la somiglianza con la testa umana la ragione principale dell’associazione tra la zucca e l’intelligenza. Se infatti l’esterno della cucurbita non è che un contenitore, una calotta protettiva, quel che conta è ciò che si trova dentro: in senso reale la polpa, in senso figurato il senno. Dal Messico alla Cina, dall’Africa Nera al Mediterraneo i semi di zucca vengono da sempre considerati il carburante del cervello, un vero e proprio moltiplicatore di materia grigia. Un concentrato di potenza, materiale e spirituale che ha dato vita a un’infinità di miti e credenze. Gli stregoni hawajiani catturavano le anime, le imprigionavano nelle zucche e le davano in pasto, dietro lauto compenso, a coloro che volevano incrementare la loro performance psico-fisica. E ancora oggi gli sciamani sudamericani fanno risuonare la voce degli spiriti agitando i loro sonagli di zucca pieni di semi. Gli Apinayé, e altri popoli amazzonici, fanno addirittura discendere l’uomo dalla zucca. Secondo il loro mito cosmogonico, infatti, in principio erano le zucche che, gettate nell’acqua dal Sole e dalla Luna, divennero i primi uomini. Ma se in Sud America la cucurbitacea è la grande madre dell’umanità, nel- S l’Estremo Oriente essa non è da meno. Anche gli antichi abitanti del Laos si ritenevano nati da una zucca. E secondo un mito cinese l’eroe Fu-Hsi scampò al diluvio universale salendo su una grande zucca galleggiante, come Noè sull’Arca. Anche nelle tradizioni popolari europee il frutto dalla polpa gialla era considerato una sorta di contenitore soprannaturale, di ricettacolo delle anime dei defunti. Di questa antica credenza pressoché universale la notte di Halloween è solo l’esempio più conosciuto. Ma nell’Italia contadina l’uso di zucche con occhi, naso, bocca e tanto di lumino acceso all’interno era largamente diffusa ben prima che la mascherata made in Usa colonizzasse il nostro immaginario. Un esempio per tutti: la festa delle lucerne di Somma Vesuviana, nell’entroterra napoletano, in cui i morti si manifestano sotto forma di teste di zucca che brillano nelle tenebre. La differenza è che le tradizioni contadine erano delle tipicità rituali, espressioni di un terroir e di una cultura particolari. Halloween invece è un sabato del villaggio globale, un Mc Donald della paura. Il trionfo di questo sabba planetario fa dimenticare le ragioni e le radici delle biodiversità festive esattamente come avviene per quelle alimentari, messe fuori mercato dal dilagare di un prodotto confezionato altrove e distribuito su scala multinazionale. Il trionfo di questo merchandising cerimoniale conferma così il valore simbolico della zucca, che diventa emblema della sorte delle culture locali. Svuotate progressivamente e riempite di una polpa standard. Senz’anima, né sapore. 48 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 le tendenze Consumi di moda Abiti, accessori e mobili design realizzati apposta per il cliente: spopola tra i grandi marchi il bespoke. Un modo di orientare le scelte e soddisfare il desiderio di avere qualcosa di speciale Global su misura L’emozione di sentirsi unici JACARANDA CARACCIOLO FALCK o scorso agosto la Nike ha aperto un curioso negozio temporaneo nel cuore del quartiere di Soho, a Londra. Una villetta georgiana con grandi caminetti di marmo sempre accesi, pavimenti di legno e sontuosi sofà in pelle. Niente a che vedere, insomma, con quei fantasmagorici e ultramoderni templi dello shopping globalizzato, meglio noti come Niketown. Lo scopo? Invitare un numero ristretto di clienti “speciali” e guidarli nella scelta online delle loro scarpe da ginnastica su misura. Le cosiddette “Nike I.D.”, versione personalizzata dell’oggetto più popolare del mondo: le sneakers. Poco tempo prima, a New York, la Levi’s aveva lanciato Intellifit, uno scanner elettronico a onde radio che, in soli dieci secondi, studia la figura del corpo e suggerisce il jeans più adatto. La politica dei due colossi americani, noti in tutto il mondo per le loro campagne di marketing sempre all’avanguardia, è la punta dell’iceberg di un fenomeno molto più ampio: la rinascita del “su misura”. Il cosiddetto bespoke, ovvero quell’oggetto particolarmente prestigioso, abito o borsa, scarpa o cappello, realizzato appositamente per una persona. Una volta, fino agli anni Settanta, il “su misura”, era la norma. Almeno nel campo dell’abbigliamento. Poi, è arrivato il prêt-à-porter, la cosiddetta democratizzazione della moda e il boom delle griffe. E sarti e artigiani sono stati messi in disparte per un periodo. Almeno dal grande pubblico. Oggi però il mercato sta cambiando di nuovo. Sarà a causa della contrazione dei consumi. O forse solo perché ormai c’è troppa scelta. Ma una cosa è certa: per sopravvivere il mondo della moda deve avviare un processo di cambiamento. Secondo una previsione della banca d’affari Merrill Lynch, infatti, i consumi di beni di lusso che oggi negli Stati Uniti rappresentano il 25 per cento del totale diminuiranno nei prossimi dieci anni di sette punti. In Europa si passerà dal 26 al 20 per cento. Perché? Le grandi firme sono ormai troppo diffuse. Le si può acquistare a prezzo pieno nelle migliaia di boutique e department store di tutto il mondo. O accontentarsi delle imitazioni, vendute a poche decine di euro dalle grandi catene del basso costo, da Zara a H&M. «Cosa fare allora per non perdere quei clienti che vogliono a tutti i costi possedere qualcosa di speciale?», si devono essere chiesti i guru del marketing. La risposta è apparsa evidente: bisogna fare un passo indietro. E riscoprire l’oggetto unico, quello che ci fa sentire speciali e diversi da tutti gli altri. Che ci offre, insomma, un’esperienza sensoriale. Ecco allora che tutte le grandi marche hanno cominciato a offrire un servizio bespoke. Nelle boutique Gucci si possono ordinare abiti, ma anche mocassini. Versace produce l’alta moda e una collezione di borse su ordinazione. Giorgio Armani ha lanciato la linea Privè. Ermenegildo Zegna, oltre ai suoi celebri abiti, vende una collezione personalizzata di uniformi per yachts. Il designer di gadget in pelle Bill Amberg nel suo nuovo negozio londinese ha persino realizzato un bespoke bardove i clienti possono scegliere ogni minimo dettaglio, dal colore del filo alla finitura della pelle. E Brioni ha inaugurato nel 2003 un vero e proprio laboratorio, dove per ogni abito sono necessarie 32 ore di lavoro. Quello che rende il nuovo bespoke molto diverso da quello di una volta è però il fatto che, oggi, si può personalizzare praticamente qualsiasi cosa: dalle sneakers ai profumi, dallo snowboard alla bicicletta, dalla stoffa usata per tende o poltrone al passeggino per bambini. E ancora: carta da lettere e attacchi per gli sci, biancheria intima e portapassaporti, sacchi a pelo e tavolini. Ma non è finita qui. Per farlo, non sono più necessarie cifre da capogiro. Anzi. Basta saper usare la fantasia. E soprattutto i nuovi canali tecnologici. Internet in testa. Che hanno reso l’intero processo molto più semplice. E democratico. L Da Nike a Levi’s, da Armani a Versace, da Gucci a Zegna: sempre più spesso le collezioni sono personalizzabili ESCLUSIVA Repubblica Nazionale 48 30/10/2005 La New D-bag di Tod’s è ora disponibile (solo su richiesta) in coccodrillo, in pitone e in struzzo INCONFONDIBILI Sono tre i modelli di mocassini Gucci disponibili per il servizio “made to order” In coccodrillo o in vitello hanno le iniziali del cliente stampate in oro VARIAZIONI SUL TEMA Nike I.D., ovvero la versione personalizzata delle sneaker più popolari del mondo prodotte dalla Nike. Si sceglie online SEDUTA PERFETTA FIDO É CHIC Burberry offre ora un servizio per animali, “Custom canine” Si sceglie tessuto, fodera e colore dell’imbottitura e in sei settimane si ha il trench per Fido con monogramma Si chiama Size. È disponibile in tre misure (small, medium e large) e in una serie di combinazioni la poltrona disegnata da Luca Scacchetti per Poltrona Frau DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 49 PASSI FELPATI Si possono ordinare solo nella boutique parigina di Roger Vivier gli stivali kimono verde acqua con cristalli Swarovski cuciti a mano su seta E per chi volesse delle scarpe speciali ideate ad hoc non c’è che l’imbarazzo della scelta AGO E FILO EFFETTO STAR Da più di 100 anni nei laboratori Lubiam di Mantova vengono realizzati abiti da uomo di raffinata eleganza Un dettaglio: una volta prese le misure per averne uno bastano solo dieci giorni lavorativi Broccati e pizzi, ruche e pon pon, seta e damaschi: i sontuosi vestiti della nuovissima linea da sera “special order” di Gianfranco Ferrè sono decisamente scenografici E si ordinano in boutique L’altra faccia della globalizzazione: cercare il tratto distintivo ad ogni costo Cacciatori di originalità senza trasgressione LAURA LAURENZI n altro campo in cui deteniamo il primato. Il neo individualismo, il desiderio di non lasciarci schiacciare e omologare. «Da vent’anni faccio profumi su misura e posso dire per esperienza personale che gli italiani, più di ogni altro popolo, sentono dentro di sé la necessità di esprimersi attraverso qualcosa che sia assolutamente unico», afferma Laura Tonatto, uno dei nostri “nasi” più celebri e quotati. La notizia è che il su misura ormai è alla portata di tutti, o quasi. Non sa più di antico e solo artigianale, semmai si coniuga con le nuove tecnologie e con l’industria. Stanchi, standardizzati, oppressi dall’omologazione, cerchiamo di emergere senza tuttavia avere il coraggio di evadere completamente dalla gabbia. Il neo-individualismo promuove personalizzazioni ad ampio raggio. Per dire: puoi far stampare la frase o il nome che vuoi (purché non superino due righe di 27 caratteri) sull’I-pod e puoi persino avere la foto degli sposi “serigrafata” sui petali delle rose o dei tulipani che addobberanno il banchetto senza farli appassire. Puoi personalizzare addirittura le M&M’s, o lenti di cioccolato, con il motto che credi o, se in Canada, puoi persino far stampare dei francobolli del tutto validi e regolari con la foto del nipotino o del cane, basta pagare. È personalizzato addirittura il paracadute come peraltro il libro di fiabe, dove all’improvviso compaiono fra i personaggi anche i nomi dei piccini che volete voi. E il telefonino? Si salvi chi può dalle nuove suonerie che squarciano l’aria col vagito del figlio, il miagolio del gatto, la ola dello stadio a quel particolare gol, e vai con le colonne sonore della nostra vita. Nostra e solo nostra. E a ben vedere non è forse bespoke anche il caffè come lo chiediamo noi italiani al bar: lungo-ristretto-macchiato-schiumato-al vetro? Per chi ama navigare ecco il nuovo gioco online di scegliere la scarpa da ginnastica unica al mondo, fatta solo per noi, combi- U nando noi stessi i colori, la linguetta, il tipo e la lunghezza dei lacci, la suola, la fodera, le sospensioni secondo il nostro personale capriccio chiamato bespoke: ma in qualche angolo della nostra sneaker ci sarà sempre il logo, il marchio di fabbrica dell’azienda. Piccolo, non esibito magari, ma rassicurante. Il su misura è diventato trasversale e hi-tech, e viene praticato anche dai giovani e non è più soltanto un lusso per gli “happy few”. Sostiene Laura Tonatto: «Il bespoke ormai non è più una cosa legata soltanto al censo e al potere d’acquisto, un privilegio riservato a chi può permetterselo. È sempre più diffusa, sempre più comune, la voglia di sognare un sogno proprio, e non altrui». Il punto è tutto qui: che il sogno non si tramuti in un incubo. Cercare ad ogni costo il tratto distintivo all’interno di una globalizzazione imperante può produrre mostri, ed essere comunque una pratica molto faticosa. Si parte dalle piccole cose: per esempio il calendario o gli auguri di Natale con la foto dei bambini, per arrivare a vertici di narcisismo e auto-celebrazione che vengono indiscriminatamente imposti agli altri. Mia e solo mia è quella borsa con riprodotta una certa (non discreta) lettera d’amore, o una foto privata. Il bespokedi massa o quasi fa leva sul culto del nostro ego e anche sul desiderio di essere creativi, e di non sottostare per una volta a quei tiranni del gusto che sono gli stilisti. L’effetto paradosso però è che, di fronte a una paletta di possibilità così ampia, la mente si frastorni, la mano si paralizzi. Il mouse non sa su cosa cliccare: troppa scelta, troppe versioni possibili, troppe probabilità di sbagliare. Allora ci si blocca, allora si vagheggia, come una sorta di paradiso, il tutto bianco, il tutto grigio, il minimal chic, il non protagonismo, il basso profilo in questo inferno di iniziali, cifre intrecciate, frasi tatuate, numeri chiusi, pezzi unici only for you. Questa massima libertà di scelta ci rende diversi ma anche tutti uguali & omologati, di nuovo al nastro di partenza. IL TUO PROFUMO PRIMO PIANO L’incontro tra Lorenzo Villoresi e un nuovo cliente che richiede un profumo unico dura due ore Poi Villoresi si mette al lavoro nel suo atelier fiorentino Dopo quattro settimane la consegna La borsa di moda si chiama “Be a bag” ed è firmata dall’inglese Anya Hindmarch. Basta inviare a Londra una foto e dopo tre mesi arriverà la nostra borsa con l’immagine È realizzata con un pendente in argento di una scatola portaincenso del XIX secolo la collana firmata da Maria Calderara Collezione “Pezzi unici” SU LA TESTA Basta prendere appuntamento con uno stilista presso il negozio Borsalino di corso Venezia, a Milano, per farsi realizzare un cappello completamente personalizzato FOTO GETTY/RONCHI Repubblica Nazionale 49 30/10/2005 SINGOLE GIOIE L’ALBUM DEI RICORDI Più che un semplice album di foto quello che Agora crea su ordinazione è un vero libro dei ricordi personalizzato. Del quale si può scegliere formato, carta e layout delle immagini. Oltre ai testi, ovviamente 50 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 OTTOBRE 2005 l’incontro Ha vinto il premio come miglior protagonista femminile a Venezia, guiderà l’assalto italiano agli Oscar di Hollywood, è la più contesa dai registi, che le ritagliano ruoli complessi e inquietanti, eppure lei ci confessa: “Sono un’attrice semplice, non covo tormenti profondi Al personaggio presto poi lui sparisce Giovanna Mezzogiorno lae iocasa, mi rituffo nella confortevole banalità del quotidiano”. Con un solo rimpianto: “Aver perso il padre prima di iniziare a recitare” Star normali lei Michel?». La signorina inglese ha un bel visino, pallido e appena sfiorito, taglio alla Jean Seberg. Il sorriso scopre brutti denti piantati in bocca alla rinfusa. «Mi scusi», mormora, «stavo aspettando un signore che ho conosciuto in chat ieri sera, lei corrisponde alla sua descrizione». Il Cafè de Flore di Saint-Germaindes-Près non si è arreso alle mode, niente Happy Hour dalle 18 in poi, nessun segno di postmodernismo. Ha una tradizione da difendere, come tutto quel marciapiede del Boulevard che arriva fino al Deux Magots, pochi passi più in là. Un frammento di Parigi che Sartre e gli esistenzialisti scelsero come tempio del loro pensare. Giovanna Mezzogiorno aspetta nella saletta del primo piano, seduta davanti alla finestra oscurata da minuscole foglie di bambù. Appoggiata a un vecchio schienale a muro dove un tempo, magari, la Greco s’incontrava clandestinamente con Miles Davis. Gli artisti sono abili, fanno sempre in modo di rimanere in penombra rispetto ai loro interlocutori. La Coppa Volpi che la giuria di Venezia le ha conferito per la sua interpretazione nel film La bestia nel cuore, di Cristina Comencini, è roba di un’altra epoca. A Parigi è già su un altro set, dentro un’altra storia. Sta girando Les murs porteurs con Cyril Gelblat, regista esordiente di 28 anni. «Parla di quattro personaggi le cui vite s’incrociano, una storia affascinante. Poi sarò la protagonista di Lezioni di volo di Francesca Archibugi, nei panni di un medico impegnato in una organizzazione internazionale. Sono passati due mesi da Venezia, ma sembra l’anno scorso. Non lo dico per falsa modestia, ma questo premio non pensavo lo dessero a me. Dopo la proiezione ero tornata a Parigi, avevo disfatto le valige, avevo fatto la doccia, ero andata dal parrucchiere per cambiare il colore ai capelli e prepararmi a una scena del nuovo film. Invece il giorno dopo mi hanno richiamata». Era perfetta anche all’aeroporto di Venezia, quel giorno in cui una tempe- sul lettino dello psicanalista, anche quelli più suggestivi con kilim e lampade déco. «Abbiamo trascorso tanti anni a Parigi. Mio padre era costantemente impegnato con cinema e teatro, ce lo vedevamo passare davanti ogni tanto e raramente riuscivamo ad afferrarlo. Io e mia madre trascorrevamo interi pomeriggi al cinema. A nove anni avevo già visto La strada, Il Vangelo secondo Matteo. E Brasil di Terry Gilliam, che uscì nel 1984, quando avevo dieci anni. Ne rimasi traumatizzata, non parlai per una settimana intera. Io ho sempre visto film da grandi. Sono figlia di un attore e di un’attrice, mi sono nutrita di cinematografo, eppure mai una volta mi sfiorò l’idea che io potessi entrare in quel mondo. Ero ossessionata, anzi, da quelli che venivano a casa e dicevano: come sei bella Giovanna, anche tu vuoi fare il mestiere di mamma e papà? Erano parole che mi stordivano, perché creavano delle aspettative che ero sicura avrei disatteso». Nel 1994, Vittorio Mezzogiorno morì Diva? Ma non scherziamo. Non sono una che esce e i fan si strappano i vestiti di dosso. Per fortuna la mia notorietà non scatena isterismi: noi italiani lavoriamo con tranquillità FOTO AGF Repubblica Nazionale 50 30/10/2005 «È PARIGI sta di pioggia si è abbattuta sulla Laguna e tutti i voli sono stati ritardati. Stretta nel suo impermeabilino bianco di cotone masticato, una matita per tenere i capelli raccolti dietro la nuca, molte buste di patatine sparse sul tavolo. A poco servirono le esortazioni del suo accompagnatore: «Se dai un’occhiata a quello che contengono smetti subito di mangiarle». E lei, continuando a sgranocchiare: «Basta non leggere...». Finalmente chiamarono il suo volo e lei, proprio come una bella ragazza qualunque (non fosse stato per il set di Vuitton, con dentro quei cd, sempre quelli, che si porta in giro per il mondo: «Uno di canzoni napoletane, quattro di musica classica, Elis Regina, A love supreme di John Coltrane e Pino Daniele, che mi ricorda la mia infanzia»), si dileguò nella pioggia. Rilassata, un po’ annoiata, per niente segnata da un ruolo come quello di Sabina, una donna che dopo un incubo notturno si trova a ripercorrere i sentieri di un’infanzia molestata che come un tarlo comincia ad intaccare il presente. «Sono un’attrice semplice. Non mi covo dentro tormenti profondi per entrare in sintonia col personaggio che soffre, gli permetto semplicemente di abitare in me. Il cinema è un doppio assoluto, al personaggio presto la casa, poi lui sparisce e non lascia traccia. E io mi rituffo nella confortevole banalità del quotidiano. A un certo punto devi staccare, devi interrompere quel flusso di sentimenti forti che altrimenti ti distruggerebbe. Soprattutto se arrivi da un film come La bestia nel cuore, che in qualche modo ha cambiato la mia routine di attrice. In altre storie mi sono ritrovata sola sul set: in Virginia (la monaca di Monza), nella storia di Ilaria Alpi (Il più crudele dei giorni), ne La finestra di fronte. Nel film della Comencini, invece, Sabina si relaziona con tutti gli altri personaggi della storia». Arrivano i caffè («i francesi lo fanno malissimo»), dalla finestra si scorgono i tavolini del Flore sparsi sul marciapiede. La casa di Giovanna è a due passi. Quando ci venne ad abitare da Casalpalocco (Roma) con il papà e la mamma, l’attore Vittorio Mezzogiorno e l’attrice Cecilia Sacchi, aveva nove anni. «Da piccola volevo diventare ballerina, ho studiato danza classica per 17 anni. Dentro di me non accettavo di fare questo lavoro, mi creava molta sofferenza. Se non fosse stato Peter Brook a darmi la spinta definitiva, se non mi avesse detto “Vai!” in quella maniera così categorica, forse oggi non sarei qui. Lavoravo, registravo, facevo stage e spettacoli, vedevo che quel che facevo piaceva, sentivo che sul palcoscenico stavo bene e riuscivo a entrare in una parte senza grandi difficoltà, però non dicevo mai “voglio fare l’attrice”, anzi mi negavo a quel mestiere». Il caffè è da dimenticare, ma il primo piano del Flore è un luogo ancora magico. Ci si racconta più volentieri che a un’età, 52 anni, in cui un attore avrebbe ancora mille personaggi da far vivere. Giovanna aveva appena vent’anni, e col papà non aveva ancora mai parlato della possibilità di diventare attrice. «Già, sull’argomento cinema non ci siamo mai confrontati. È il mio più grande rimpianto: ho cominciato a lavorare due anni dopo la sua morte. Non mi ha mai visto in scena e non ha mai neanche saputo che io avrei voluto fare sul serio il suo stesso lavoro. Questi sono gli scherzi atroci che a volte il destino ci riserva. È assurdo, ma è andata così». La finestra incornicia uno sguardo triste, gli occhi di Vittorio ora incastonati in un malinconico, dolcissimo viso di donna che cerca di ricacciare indietro le lacrime. I ricordi parigini riaffiorano. «Non ho mai avuto un idolo. Ero una strana adolescente senza poster in camera. Ma posso dire di aver appreso più dagli attori maschi. Un’attrice però mi ha segnato con la sua mostruosa bravura, in un film che ancora rivedo e non finisce di stupirmi: Meryl Streep in Kramer contro Kramer». Ha trentun anni, ma non pensa di metter su casa. Eppure è nata in una famiglia equilibrata... «Equilibrata… Esistono famiglie equilibrate?», incalza. «Ho ricevuto una buona educazione, senza moralismi, senza assurdi valori sociali, ma con un’etica profonda e un antidoto efficace contro il consumismo. Anche oggi lo shopping è l’ultima cosa di cui ho voglia. I miei genitori, nei loro momenti di difficoltà, sono sempre stati aperti e onesti, tra di loro e nei miei confronti, fin da quando ero molto piccola. Ma nella famiglia come istituzione io non ci credo. Non mi sono mai sposata e non lo farò, perché non credo nel matrimonio inteso come raggiungimento di uno status. La famiglia, secondo me, è il luogo più insidioso della società. La bestia nel cuore mi ha fatto capire meglio a cosa si è disposti pur di non rompere una famiglia, pur di andare avanti, pur di non ammettere sconfitte, nevrosi e malattie. Non sempre una moglie e un marito sono disposti a chiedersi: quanto male ci facciamo? quanto ne facciamo ai nostri figli? perché ci stiamo spegnendo a vicenda e non facciamo nulla per porci rimedio? Anche io da adolescente ero molto autolesionista, oggi invece, se vedo allarme rosso, me la do a gambe. Mi crogiolavo nel sacrificio e nel dolore: nell’amore, nell’amicizia, ma anche nel lavoro. A un certo punto, invece, bisogna smetterla di remare nel deserto, continuare a far fatica anche quando l’acqua non c’è». C’è una deformazione professionale che “condanna” attori e attrici a razzolare nel pollaio, a confrontarsi sentimentalmente solo con gente del proprio ambiente. Una soap opera dell’amarsi tra belli che si perpetua da decenni ed è sempre in voga. La Mezzogiorno è stata la compagna di Stefano Accorsi (entrambi protagonisti de L’ultimo bacio di Muccino), che ora vive con una ragazza non proprio della porta accanto, Laetitia Casta. «Io ho dato e ho chiuso», taglia corto Giovanna. «Ma è vero: le persone che vivono a un certo livello hanno paura di uscire dal proprio limbo. Lì, in quell’agonia che li devitalizza, si sentono al sicuro. Lo fanno per snobismo e per classismo. Un partner normale, non del tuo status, potrebbe svalutarti, questo è il pensiero comune, roba da fiera di paese». Roba da Hollywood, forse. Ormai dietro l’angolo: La bestia nel cuore è il film italiano selezionato per l’Oscar. «Hollywood? Che orrore. È un mondo spietato, non credo valga la pena vendersi l’anima per un posto al sole. Non capisco tanti attori che pur di avere in curriculum un film americano, accettano indegne particine di dieci minuti». Meglio la televisione? «Ho un rapporto pessimo con la tv, non la guardo mai, a parte il Tg3 e Blob. La ringrazio per avermi dato l’opportunità di Virginia, un film in costume che il cinema non avrebbe mai potuto permettersi, ma non voglio esagerare. I reality show, i varietà domenicali per me sono (lo dico in francese così è più chic) merde». La parte di Virginia sembrava tagliata per lei, per il suo carattere ombroso, per la sua indole riservata, per lo sguardo innocente che i registi si sbizzarriscono a riempire di sentimenti contrastanti. Anche se di quel tormento mistico nell’attrice non c’è ombra. «Sono insofferente a qualsiasi disciplina religiosa. Credo nelle persone, la vera spiritualità è dentro ognuno di noi. In Italia il cattolicesimo, come la famiglia, è uno status: il matrimonio in chiesa, battezzare i figli, andare a messa la domenica. È la società che te lo chiede e tu ti metti sull’attenti, per non sentirti un outsider». Si avvia verso casa, direzione Deux Magots, jeans baggy, cinturone heavy metal. La signorina inglese, non più da sola, fa un cenno di saluto che vuol dire: «È tutto ok, lui è qui». Troppo presa dalla sua storia per prestare attenzione a una star in incognito. «Star? Ma scherziamo? Non sono una che esce e i fan le strappano i vestiti di dosso. La mia notorietà non scatena isterismi. Privi dello star system all’americana, noi italiani non siamo divi, ma solo attori che la gente guarda nei film. Dei miracolati a cui è ancora concesso di lavorare». ‘‘ GIUSEPPE VIDETTI
Scarica