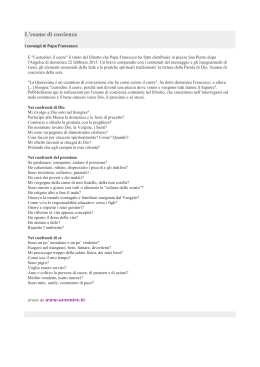Domenica la memoria Il bestiario elettorale del 18 aprile 1948 La di DOMENICA 6 APRILE 2008 FILIPPO CECCARELLI il racconto Repubblica Wu Zhao, l’imperatrice maledetta FEDERICO RAMPINI Nel trentesimo anniversario della sua storica scalata dell’Everest senza ossigeno il grande alpinista lancia un appello per il popolo dell’Himalaya EMANUELA AUDISIO T BOLZANO rent’anni fa andò e tornò dal futuro. In cima al mondo. La scienza diceva che non era possibile, quel confine era invalicabile, troppo per un uomo. I fisiologi giurarono: lassù c’è la morte, aria sottile e parole senza senso. Lui li smentì. Salì in fretta, con poche cose, e un compagno. Disegnò i suoi scarponi: in plastica, non in cuoio. Si fece fare una pellicola speciale in Inghilterra, non si spezzava al freddo. Così filmò la sua ascensione sull’Everest, 8.848 metri. La prima senza ossigeno. E in stile alpino. La quattordicesima della storia. Era l’8 maggio 1978. L’impossibile non esisteva più. Reinhold Messner e Peter Habeler ci avevano messo i piedi sopra. In appena quattro giorni. In vetta Reinhold si bruciò gli occhi. «Dimenticai di mettere gli occhiali. Una sofferenza». Habeler, che aveva sofferto di mal di testa, era impaurito dalle conseguenze, e quasi scappò. «Al ritorno ci separammo, lui andò per primo. Vidi la sua lunga traccia, stava scendendo di sedere sulla neve, come su uno slittino». Messner dice che la scienza non si volle rassegnare. «All’università di Zurigo insistevano che non era possibile fare a meno dell’ossigeno». (segue nelle pagine successive) con un articolo di LEONARDO BIZZARO FOTO LAIF/CONTRASTO Messner il tibetano REINHOLD MESSNER cultura S Pasolini, Milano e i teddy boys i pronuncia «laghielo», si scrive «lagyelo». È una parola tibetana. Significa «gli dei sono stati clementi». Io mi sento tibetano, perché la mia cultura, come la loro, vive di montagna. Anche Milarepa, che è stato il più grande poeta della montagna, era tibetano. «Lagyelo» è la parola con cui festeggiavo i miei ritorni dalle cime dell’Himalaya. Perché solo gli dei possono accettare che qualcuno salga nel loro regno. Vorrei che tutti gli atleti ai prossimi Giochi di Pechino — o almeno tutti quelli che saliranno sul podio — pronunciassero questa parola. Così alla Cina sarà chiaro che non può calpestare i diritti civili e sarà chiaro anche ai tibetani che il mondo è solidale con loro. Con una parola si può fare molto, si può non dimenticare. Allo sport non si può chiedere il boicottaggio, perché sarebbe un’ingiustizia nei confronti degli atleti, ma i governi possono fare pressioni sui dirigenti politici cinesi affinché aprano una trattativa con il Tibet, che non chiede indipendenza, ma autonomia. Io sostengo il Dalai Lama — la cui immagine nessuno in Tibet può tenere in casa, altrimenti viene perseguitato — e mi auguro che il mondo alzi la voce in sua difesa. Lagyelo. VINCENZO CERAMI e GIAN PAOLO SERINO la lettura I diari segreti di Marguerite Duras MARGUERITE DURAS e AMBRA SOMASCHINI spettacoli Le marionette, vite appese a un filo ANNA BANDETTINI e GUIDO CERONETTI i sapori Quando il cibo è buono e giusto LICIA GRANELLO e CARLO PETRINI Repubblica Nazionale 30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 APRILE 2008 la copertina Messner il tibetano “Io, Ulisse in cima al mondo” «D EMANUELA AUDISIO (segue dalla copertina) ue settimane dopo l’Everest — continua —accettai di salire in quota sul cielo di Baden-Baden. Stavolta su un aereo da turismo con un’équipe scientifica che mi fece un prelievo. Risultò che avevo il sangue di un morto. Ma io gli esperimenti li avevo già fatti per conto mio. Nel ’77 volai con il pilota svizzero Emil Wick fino a novemila metri e non misi la maschera di ossigeno. Sapevo di potercela fare, ma non ne avevo la sicurezza, la mia era solo un’intuizione». Il segreto in uno slogan: salire di più con meno. Detto in inglese: more with less. Leggerezza e velocità. Una piccola spedizione, due persone affiatate, autosufficienti. Ognuno si fidava dell’altro, nessun nazionalismo da far trionfare. «Anche per necessità. Io mi autofinanziavo, potevo permettermi tre spedizioni l’anno, dovevo tenere i costi bassi. quindici-diciotto chili di bagaglio: tenda, sacchi a pelo, fornello, provviste, corda da venti metri per emergenza. Ma c’era un problema: non avevo il permesso per scalare l’Everest. Così ci unimmo ad una spedizione già autorizzata dal club alpino austriaco, guidata da Wolfgang Nairz. Nessun problema, io e Peter eravamo la squadra per la vetta. Pionieri sì, ma in certe cose anche dilettanti e scapestrati. Al campo base ogni sera prendevamo dei sonniferi, un Valium per dormire e mezza aspirina per il sangue. Sul Colle Sud si scatenò una tempesta, c’era da assicurare la tenda con chiodi da ghiaccio, il frastuono era terribile, il vento peggio di un treno in corsa, dovemmo attaccarci ai paletti tutta la notte. Solo che Peter aveva cantato tutta la sera prima. Ora c’è una medicina dell’alta quota molto sofisticata, anzi meglio chiamarla doping, allora nessuno sapeva se avremmo riportato danni. Il punto chiave fu la preparazione sul Colle Sud, dove restammo bloccati per due giorni nella bufera, senza ossigeno né cibo. Fu dura, però ci servì a capire che eravamo acclimatati. Il secondo tema è stato tattico, non abbiamo messo il campo cinque a 8.500 metri, perché una notte lì ci avrebbe stremato, ma abbiamo scelto un campo intermedio a 7.100. Con una salita vertiginosa siamo arrivati in cima. All’epoca l’Hillary step, l’ultimo dente che porta sull’Everest, non era ancora assicurato. Noi eravamo lega- ti, se uno fosse precipitato, l’altro avrebbe dovuto lanciarsi dall’altro lato della cresta. Era l’unico modo per salvarsi. Su quel versante il vento soffia verso il basso, se cadi sei finito». Quell’avventura chiuse un secolo e ne aprì un altro. Il grande problema dell’Himalaya era stato risolto. La vera impresa però fu tenere insieme le due epoche. Messner strappò, ricucì, rilanciò. Fu il primo a capire l’importanza dell’allenamento specifico, ma anche il primo a rifiutare l’ossigeno. Vecchia anima, spirito nuovo. Capacità d’inventare, di sperimentare. «Sono stato l’ultimo Ulisse, ma ho perso. Ora il mondo della montagna è fatto dagli Spiderman. Interessano i record, la scritta game over. Il mio alpinismo è morto, solo in pochi vanno alla fine del mondo in maniera classica. Oggi si segue la pista e ci si cronometra. Io giocavo all’antica, per me contava il by fair means ottocentesco di Mummery. Non m’interessava forare roccia e ghiaccio sempre di più e arrampicare sempre di meno. Mia moglie Sabine ad ogni mia partenza si presentava con il testamento da cambiare, sai ci sono altri figli di cui tenere conto, giusto così. La vera avventura è quella in cui non è garantito il ritorno. Non è vero che ho ucciso il futuro, che non ho lasciato nulla alle nuove generazioni. Ma per essere creativi bisogna capire il passato e saperlo reinterpretare, con rispetto. Gli alpinisti attuali non li reggo né li leggo. Sono bravi, per carità, corrono come pazzi. Piacciono anche a mio figlio che ha diciassette anni. Ma non mi dicono niente, parlano di tecnica, di chiodi, di materiali. Sono artisti della verticale. E allora? Chissenefrega. E i pensieri dove sono? Io, quando studiavo da geometra, feci un tema su Walter Bonatti, anche se il punto di riferimento nella mia regione era Cesare Maestri. Io però volevo ispirarmi a Bonatti, alla sua eleganza, al fatto che sul Cerro Torre aveva saputo rinunciare, non era lì solo per una conquista, ma per trovare un’altra dimensione. Saper lasciare quasi tutto per privilegiare l’esperienza umana è da grandi». Messner e Habeler reagirono diversamente all’impresa. Il successo sull’Everest in un certo senso diede alla testa a tutti e due. E ricompensò almeno un po’ Reinhold che nel ‘70 sul Nanga Parbat aveva perso un fratello, Günther, e sette dita dei piedi. «Peter per quasi sei anni non scalò più un ottomila, scelse la famiglia. Io invece già mentre scendevo dalla cima pensai: ci ritorno presto, da solo. E nell’80 feci la solitaria. L’Everest a cui pensavo già dal ‘73 era la novità realizzata, non mi bloccò, anzi, mi L’Italia e il club degli ottomila metri LEONARDO BIZZARO AMORE PER L’HIMALAYA Nella foto qui sopra a sinistra, il Dalai Lama con Reinhold Messner I due appunti a penna sono di mano dell’alpinista: sopra, uno schizzo con il tracciato della via di salita all’Everest seguita con Peter Habeler per l’impresa del 1978. A sinistra, la parola tibetana «lagyelo», «gli dei sono stati clementi»: Messner propone che venga usata come uno slogan dagli atleti ai prossimi Giochi olimpici di Pechino. In copertina, l’alpinista davanti a una statua di Budda omincia presto la corsa alle grandi montagne. Dalle poltrone di cuoio dell’Alpine Club londinese alle vette della catena che gli dà il nome il passo è breve. Più di quanto sembra permettere il lungo viaggio di là dalla Manica, in carrozza sulle strade polverose della Francia e oltre i valichi infestati dai lupi. Ma la seconda metà dell’Ottocento — nel 1857 nasce l’Alpine Club, nel 1863 il Cai a Torino — non vede solo le cime di Alpi e Dolomiti cadere sotto i colpi di piccozza. L’India è inglese da un pezzo, quando i rilevatori del Grand Trigonometrical Survey si rendono conto che le montagne a settentrione sono le più alte del pianeta. «Fuori misura» scrivono increduli, allorché i calcoli certificano quote di ventiseimila e più piedi. La scoperta di un nuovo terreno di gioco manda in fibrillazione i circoli alpinistici. Osvaldo Roero di Cortanze, marchese della corte sabauda spedito a est tra il 1853 e il 1875 per le simpatie garibaldine poco consone al lignaggio, soffia sul fuoco nei suoi Ri- C cordi dei viaggi al Cashemir, Piccolo e Medio Thibet e Turkestan: «Mi reca meraviglia che fra tanti giovani attivi, intraprendenti, ricchi, robusti, educati, non sia nato ad alcuno il desiderio di intraprendere un viaggio per visitare le più alte e stupende catene delle montagne del globo, l’Himmalaya, presso le quali le nostre Alpi sono lilipuziane ed insignificanti». Il desiderio nasce di lì a poco, in silenzio e magari troppo in anticipo sui tempi. Dire che Roberto Lerco «tenta» nel 1890 il K2 forse è eccessivo. Ma certo il commerciante-alpinista di Gressoney sale sulla cresta sud-est fin dove nel 1907 arriverà il Duca degli Abruzzi, che invece con gran strepito mediatico alla seconda vetta del mondo aveva fatto più di un pensiero. Nel 1895 è la volta di Albert Frederick Mummery, che si presenta ai piedi del Nanga Parbat, accompagnato da due gurkha, in tweed e camicia bianca com’era solito fare nel gruppo del Bianco. Gli va male e il suo obituary va a sommarsi ai tanti pubblica- Repubblica Nazionale DOMENICA 6 APRILE 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31 Trent’anni fa la prima salita all’Everest senza ossigeno, poi la collana dei quattordici ottomila, le grandi traversate dei deserti di ghiaccio e di sabbia. Il più celebre alpinista vivente racconta la sua vita, le sue straordinarie conquiste e i suoi rimpianti. E lancia un appello per il Tibet, la terra circondata di montagne a cui si sente legato come alle Alpi SUL GHIACCIAIO Nella foto grande, la conca glaciale per la quale passa la via normale di salita all’Everest (la vetta è in alto a sinistra) Al centro, una vecchia figurina sulle imprese himalayane Qui sotto una carrellata fotografica dei quattordici “ottomila” con le vie di salita Nel trentennale della salita all’Everest in stile alpino, la rivista Alp dedica a Messner il primo numero di Alp ritratti (Vivalda Editore) fece ripartire con altri progetti. Anche perché quella montagna mi ossessionava da tempo, per lei avevo lasciato l’università e la ragazza. Ho capito subito che ingegneria non era la mia vita e che lo era invece esplorare l’Himalaya. E infatti sono rimasto geometra. Ho anche attraversato la contestazione del ‘68, con una Cinquecento, ma quei giovani studenti si annoiavano, io non li capivo, ero pieno di passione per la montagna, programmavo arrampicate. Li vidi sfilare con il libretto rosso di Mao. Mi fecero ridere, non erano nemmeno mai andati in Cina, che ne sapevano? Daniel Cohn Bendit, che ho conosciuto bene nei miei cinque anni al parlamento europeo di Strasburgo, ha avuto l’onestà di scusarsi per quelle sciocchezze. Fischer mi ha persino chiesto di candidarmi in Germania nel 2003, ma ho detto no». Messner sull’Everest divenne eroe, otto anni dopo essere stato Caino. Lo accusarono di aver lasciato il fratellino sotto una valanga, di non averlo cercato abbastanza. «Bestialità. Chi non sa di montagna pensa cose assurde, come quella che si può tagliare la corda per sbarazzarsi del peso del compagno, ma quando capitano le disgrazie non c’è tempo di pensare, sono frazioni di secondo. Io sul Nanga Parbat ho perso un pezzo di vita, ma il male più profondo è venuto dopo, con le accuse di vigliaccheria e tradimento. La stessa porcata la fecero a Bonatti sul K2, lo fregarono due volte, prima e dopo. Lo intrappolarono e lo offesero. E adesso il Cai dopo cinquantatré anni gli ha dato ragione. Ma noi alpinisti lo sapevamo già. Desio e Compagnoni erano fascisti, per questo si allearono. Bonatti era il più bravo e il più ragazzino, quello da sacrificare. Karl Herrligkoffer, capo della spedizione tede- ti dall’Alpine Journal. Sono esperimenti, poco si sa ancora della fisiologia alle alte quote, l’equipaggiamento si arrangia modificando gli attrezzi usati sui ghiacciai delle Alpi, abiti e sacchi a pelo sono quelli cuciti per le spedizioni polari. L’approccio alle grandi montagne è soprattutto di esplorazione. Nei gruppi che partono alla volta di Himalaya e Karakorum ci sono alpinisti, topografi, disegnatori e i soldati più forti dei reggimenti locali dell’esercito inglese. Le mete sono sempre le stesse, pur avendo i diligenti funzionari del Survey misurato quasi tutto. Nei sogni degli appassionati — e dei governanti britannici — ci sono un pugno di montagne, le più alte e quelle che meglio si vedono dai fondovalle, a maggior gloria dell’Impero. Il tetto del mondo, quindi, e il suo vice. Poi l’Annapurna. Poco altro, a parte il Nanga Parbat che dopo Mummery diventa una sorta di proprietà privata dei tedeschi. L’idea dei quattordici ottomila non sfiora nemmeno il più visionario degli sca, che dubitò della mia versione, era un nazista. Mi fece firmare un contratto dove solo lui poteva scrivere la relazione della spedizione, io ero inesperto e accettai. Una cosa ho capito nella mia sofferenza: prima si costruisce l’eroe, poi si gode a buttarlo giù. È la frustrazione della gente a fare danni: vogliono essere come te e se non ci riescono ti infangano. È il senso di colpa che li porta a reagire così, sono desiderosi di assolversi. Herrligkoffer non pensava che io riuscissi a scendere lungo la parete est, né si attrezzò a recuperarmi. Ma non poteva ammettere di avere sbagliato, meglio rimuovere la verità e accusarmi di ambizione sfrenata. Trentacinque anni dopo, nel 2005, hanno ritrovato i resti di Günther e mi hanno restituito l’onore. Non avevo mentito. Nel 2004 a Trento ho raccontato pubblicamente la storia del K2, non ho messo fotografie, solo il volto di Bonatti, in prima fila c’erano Compagnoni e Lacedelli. Hanno ascoltato la storia del loro tradimento senza fare una piega, fino all’ultimo. Poi però per posta mi sono arrivate lettere molto brutte, dove mi si auguravano molte cattiverie». Messner veniva dalla Val di Funes, Sudtirolo. Era un uomo di confine. Un po’ italiano e un po’ tedesco, ma molto montanaro. Suo padre Sepp era maestro. C’erano le vacche da mungere, il maso da portare avanti, il pollaio da guardare. In famiglia erano nove figli: Helmut, Reinhold, Günther, Erich, Walfraud (unica donna), Siegfried, Hubert, Hans Jorg, Werner. L’alpinismo se ne è presi due, Siegfried è morto nell’85, sulle torri del Vajolet, colpito da un fulmine. «Io mi definisco biculturale e mi sento tibetano. Sul museo dal castello di Firmiano ho alzato la loro bandiera. Hanno un altopiano fantastico, la città più bassa è a 3.600 me- esploratori. La collana che farà la fortuna di Messner ha bisogno di una “conversione” all’epoca impensabile, tanto più per un anglosassone: dal sistema imperiale britannico al metrico decimale. «Con le loro misure — spiega Roberto Mantovani, direttore della Rivista della Montagnae storico dell’alpinismo — il gioco dell’himalaysmo sarebbe stato possibile solo calcolatore alla mano». Il conto è presto fatto: a ventinovemila piedi arriva solo l’Everest, con ventottomila si prendono anche K2 e Kangchenjunga, il Lhotse finisce a ventisettemila. Per metterci tutte le quattordici vette più alte, convertite in metri, bisogna scendere a ventiseimila. «Tutto troppo ampio, troppo sfumato — commenta Mantovani nello speciale della rivista Alp dedicato a «I magnifici 8000» —. Per categorizzare in maniera evidente e immediata l’altezza delle montagne, occorrevano cifre più facili da mandare a memoria, e soprattutto più brevi». Ecco la fortuna degli ottomila. Per il resto del mondo, perché il più alto non poteva che andare, è il 1954, tri, il Tibet non è solo l’Himalaya ma anche altre vette, è circondato da catene montuose come nessun altro paese. La Cina ostacola la loro identità culturale e religiosa, anzi la massacra. Il Tibet si è trasformato, Lhasa si è imbruttita, i cinesi hanno costruito palazzi orrendi e centri commerciali e hanno trasferito lì molta gente dell’etnia han che gestisce quasi tutti i commerci. I tibetani non hanno libertà, il governo cinese disprezza i diritti umani. Non è giusto, non ci sto. Il mondo dovrebbe protestare di più, non basta mica stare a guardare. Magari sarà solo un granello di sabbia, però darà fastidio, soprattutto nell’anno olimpico. La Cina andrebbe colpita sugli affari, ma è una potenza economica importante e corteggiata da tutti». Messner oggi ha sessantaquattro anni. Ha moglie e tre figli. Festeggerà con gli amici l’impresa del 1978 nel castello-museo di Firmiano. Ha salito quattordici ottomila dal 1970 al 1986. «Alla fine non avevo più motivazioni. Andavo avanti, soprattutto perché i miei compagni di avventura, più giovani, mi spingevano verso nuove imprese e rilanciavano. Ma io non ero più lo stesso, non avevo la stessa forza. E promisi a mia madre, che aveva settantatré anni, che mi sarei limitato ai settemila metri. Lei aveva paura delle scalate, non delle mie attraversate. Trovai una nuova sfida nel mondo orizzontale, nell’infinito bianco dell’Antartide, nella traversata del Tibet, nel deserto del Gobi. E ovunque, se stavo in difficoltà, mi usciva dalla bocca il nome di Günther. L’ho sognato anche ieri notte, era con me, a Chamonix, mi chiedeva di andare su un ottomila. Ma il buffo è che lì non ci sono montagne così alte. Günther per me non se ne è mai andato, è sempre dove l’ho visto per l’ultima volta. Accanto a me, in montagna». ai sudditi di Sua Maestà britannica — e sarebbe stata una beffa se gli svizzeri nel 1952 ce l’avessero fatta. Poco importa se in realtà sono stati i francesi con Herzog e Lachenal ad aggiudicarsi nel 1950 «le premier huit mille», l’Annapurna. Con i suoi 8091 metri rimane comunque il decimo per altezza. La conferma viene scorrendo la lista di chi, dopo Messner, li ha saliti tutti. Altri tre italiani (Sergio Martini, Silvio Mondinelli e Fausto De Stefani, di cui è però contestata la vittoria sul Lhotse), due polacchi (Krzysztof Wielicki e Jerzy Kukuczka), il messicano Carlos Carsolio, due baschi, Juan Oiarzabal e Alberto Inurrategui, tre coreani, Park Young Seok, Hong-Gil Um e Han Wang Yong. Appena un inglese, Alain Hinkes, e un americano, Ed Viesturs. La palma della prima donna se la contenderanno Nives Meroi e Gerlinde Kaltenbrunner, che al momento ne hanno dieci. Un’italiana e un’austriaca. La basca Edurne Pasaban è arrivata a nove. Le anglosassoni più lontane. Scarse? No, disinteressate. Repubblica Nazionale 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA l’attualità Forme urbane DOMENICA 6 APRILE 2008 All’appuntamento con l’Expo appena conquistata, fra sette anni esatti, si presenterà una città radicalmente cambiata: una selva di grattacieli griffati, monumenti di archeologia industriale richiamati alla vita, battelli che scivolano su vie d’acqua urbane. Ecco un viaggio tra i quindici mega-progetti che ridisegnano il suo futuro Milano, metropoli verticale CINZIA SASSO MILANO I l vento di aprile soffia insistente sulle fronde chiare del betullino e il fruscio arriva fino a dentro, mischiato con il fischio delle foglie di una quercia ancora giovane. Entra anche il profumo intenso del gelsomino che ha messo i primi fiori, e la macchia di colore rosso delle bacche del cratego. È il momento migliore, per il bosco. Il momento del risveglio. Ma questo è un bosco speciale: siamo in un appartamento di città, al ventisettesimo piano della torre “D” di Porta Nuova Isola, pareti di vetro che danno sul terrazzo, davanti una quinta di verde. E questo è il “Bosco Verticale”, progettato dallo studio Boeri, novecento alberi alti fino a nove metri sovrapposti l’uno all’altro, salici e peri da fiore, ciliegi giapponesi e bambù, piantati piano sopra piano. Poco più su, sul tetto, volteggiano le pale eoliche che garantiscono energia. Molto più giù, invece, le sonde geotermiche pompano calore dal sottosuolo e da qualche parte le acque grigie, filtrate, tornano in circolo per l’irrigazione. Dalle finestre, tra le fronde, ecco a perdita d’occhio il profilo della città. Ed ecco, appena in là sull’orizzonte, a nascondere le cime delle montagne, un altro bosco, stavolta semplicemente pensile. A centosessanta metri di altezza, che vuol dire al trentunesimo piano. Sul belvedere, con ristorante, del grattacielo che è la nuova sede della Regione Lombardia e che quassù vuole attirare cittadini e turisti. Un parallelepipedo di vetro progettato dall’architetto cinese della Piramide del Louvre, immaginato per celebrare la trasparenza e il buon governo, al centro di una grande piazza coperta da una cupola, dove migliaia di persone passeggiano e fanno shopping negli elegantissimi negozi; ma anche se ne stanno semplicemente sedute ai bordi della fontana circolare, pc sulle ginocchia, collegate col wi-fi. Un’opera grandiosa: centomila metri quadri edificati per un costo di 320 milioni di euro. La più maestosa delle opere commissionate da un ente pubblico dal tempo degli Sforza; l’erede, nelle intenzioni, del Castello. Benvenuti a Milano 2015. Benvenuti nella città che ha vinto l’Expo e che per questo, da stanca metropoli post-industriale, smarrita e senza vocazione, ha ripreso a correre. Se l’iniezione di denaro prevista dal piano per l’esposizione — 4,1 miliardi di euro — permetterà la costruzione ex novo di un pezzo di città che oggi non esiste, il quartiere della fiera da più di un milione di metri quadrati, e il completamento di strade, linee di metropolitana, reti ferroviarie, una zona verde grande come tre Hyde Park e mezzo, perfino la creazione di una via d’acqua sulla quale scivolano i battelli, quella che fra sette anni si presenterà all’appuntamento con il mondo sarà in ogni caso una città completamente nuova. Ci saranno colline nel piatto della pianura; laghi là dove era asciutto. Ma sarà, soprattutto, una città verticale. Con grattacieli storti, sì anche sbilenchi; qualcuno colorato, altri con le guglie; certi che sembreranno essere lì lì per cadere, altri ancora perfino attorcigliati. Torri rivestite di vetro, acciaio, pietra, ma anche di bosco, addirittura di lamine d’oro. E tutti, questo è certo, saranno altissimi. È come se a Milano si fosse scatena- 2 NUOVO POLO EXPO Il master plan presentato al Bie prevedeva un edificio simbolo, la Expò Tower, che ora è in forse È a Pero-Rho, duecento ettari per i nuovi padiglioni ta una gara tra gli architetti di tutto il mondo per vedere chi inventa l’edificio più stupefacente. Spariti i vecchi immobiliaristi legati in qualche modo alla tradizione, ora anche i cantieri sono nelle mani di chi non ha mai avuto legami con la città, gli sviluppatori internazionali, che costruiscono a Londra come ad Abu Dhabi e che rispondono esclusivamente a logiche di profitto. L’obiettivo è diventato far rumore, farsi vedere, trasformare tutto in attrazione, vendere. Ma attrazione per chi? Per il mezzo milione di abitanti che negli ultimi trent’anni ha lasciato la città, che ci ritorna al mattino per lavorare ma che se ne va la sera? Nel 1972 Milano era una metropoli da un milione e settecentomila abitanti; oggi sfiora il milione e tre. Una città impoverita ma, soprattutto, una città che ha il drammatico problema del pendolarismo: 840mila ingressi ogni mattina, 510mila persone che arrivano in automobile, hanno dei costi altissimi. Far tornare i milanesi a Milano, smettere con l’edificazione delle città-satellite nell’hinterland, ricominciare a costruire solo al centro potrebbe essere un disegno per il futuro. Ma per costruire in centro, è necessario soprattutto farlo in verticale. Vediamola, questa nuova città, dal ventottesimo piano della torre “D”. All’orizzonte, a quel punto, i vecchi simboli saranno diventati insignificanti: la Madonnina, la Torre Velasca, il grattacielo Pirelli. Stracciati, in una classifica basata semplicemente sull’altezza, da almeno quindici nuovi “mostri” di acciaio, cemento, vetro e tanto verde. Disegnati dai più grandi architetti del mondo chiamati a operare ovunque, a riempire vuoti, a rein- 3 TORRE DELLE ARTI In via Principe Eugenio, è un progetto di Archea Associati: 93 metri, 26 piani, rivestimenti in pietra e una parte in cotto rivestito di lamina d’oro 3 2 1 1 CITYLIFE Il piano più discusso Qui sorgerebbero i grattacieli di Libeskind, Hadid, Isozaki, uno dritto, uno pendente, uno avvitato su se stesso SANTA GIULIA A sud, nella zona già occupata dagli stabilimenti Montedison, Norman Foster ha ideato una città nella città con appartamenti di super lusso, il Crescent, un centro congressi, una nuova chiesa, spazi commerciali PIAZZA ARDUINO VIA ROSSETTI Nella foto sopra ecco come appare la prospettiva della vecchia Fiera vista da piazzale Arduino e, nella foto sotto, come sarà nel 2011, quando il grattacielo di Zaha Hadid sarà terminato Nella foto in alto, i capannoni della Fiera Campionaria ora in demolizione e, nella foto sotto, gli edifici residenziali e gli uffici che fanno parte del complesso progetto City Life Repubblica Nazionale DOMENICA 6 APRILE 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 ventare aree dismesse, a costruire dove per trent’anni non si è fatto. Sono quindici progetti giganteschi e 147 piccoli interventi, che l’abolizione del vecchio piano regolatore e la scomparsa della destinazione d’uso ha liberalizzato. Nasceranno quartieri nuovi e altri abbandonati torneranno a vivere; anche i comuni limitrofi avranno i loro simboli. Come Rozzano, con la torre Landmark, alta duecento metri. Perfino le caserme cittadine troveranno una seconda vita; e cambieranno pelle gli scali ferroviari abbandonati. Il più grande piano di riqualificazione urbana si sta realizzando nella zona intorno all’Isola, vecchio quartiere tra la stazione Centrale e Garibaldi, che prevede l’edificazione di 350mila metri quadrati e la realizzazione di una delle aree pedonali più grandi della città, dentro la quale ci sarà la Biblioteca degli Alberi, un reticolo di percorsi tra piantumazioni di diverse essenze destinati a diventare anche percorsi didattici. Svetta, in questa zona, la nuova sede della Regione Lombardia, con i trenta piani, centosessanta metri, firmata dallo studio Pei. Il nuovo Pirellone si alza su un impianto formato da corpi allungati a serpentina, arrotondati, che si incrociano saldandosi in un unico edificio. Poco distante è Cesar Pelli a immaginare una torre che si innalza con tre guglie, stile Dubai estrema, e che guarda in una nuova piazza circolare e pedonale. I mega-progetti in fase di esecuzione non sono raggruppati in una zona, identificabili con un quartiere: toccano tutta la città, anche quella considerata oggi periferia, anche comuni esterni, come Sesto San Giovanni e Rozzano, appunto. 4 PIRELLONE DUE La nuova sede della Regione Lombardia, di Pei, Cobb Freed & Partners: 39 piani di vetro e cemento con un belvedere e un ristorante nel bosco pensile all’ultimo piano Ed è proprio questo il filo conduttore della Milano di domani, espresso chiaramente nel piano “Milano verso il futuro” dall’assessore allo Sviluppo del territorio Carlo Masseroli: superare il concetto centro-periferia, distribuire i servizi ovunque, creare una metropoli integrata e continua. Superare anche il confine tra città e hinterland, fare in modo che diventi una realtà «la grande Milano, nella quale Milano-città rappresenti il nodo 5 TORRE DNA Il nome evoca la forma della torre, 77 metri e 27 livelli, che l’architetto Caputo ha progettato a imitazione della doppia elica del dna. Colorato come un Mondrian 5 4 7 6 principale di una costellazione». A sudest, ad esempio, in un’area che ora è periferica, separata dal corpo metropolitano da ferrovia e tangenziale, la città cambierà volto con il progetto Santa Giulia, ideato da Norman Foster, l’archietto del St. Mary Axe, “The Gerkin”, il grattacielo a forma di cetriolo che per primo ha cambiato lo skyline di Londra. Santa Giulia, che prende il nome da una chiesa che verrà costruita, è immaginato per essere abitato da cinquanta-sessantamila persone, dunque sulla carta è già promosso come modello di città nella città e di metropoli nel verde. Qui nascerà il Crescent, una zona residenziale d’eccellenza, high tech e domotica, energia rinnovabile, con appartamenti i cui costi partono da due milioni di euro. Via le periferie, dunque. Come ha detto Renzo Piano, l’architetto che ha progettato l’area Falk, centocinquanta ettari di archeologia industriale, la città già delle fabbriche, degli altiforni e delle acciaierie, quella più intimamente legata alla storia della Milano operaia dove ogni mattina, al suonare delle sirene, arrivavano migliaia di persone in tuta blu. Piano vuole che la sua città resti una fab- brica: «Una fabbrica di idee, il mio Beaubourg a Sesto San Giovanni». È qui uno dei recuperi più straordinari di costruzioni di archeologia industriale, il laminatoio, destinato a diventare secondo il progetto della Provincia un museo di arte contemporanea, la nostra Tate Modern. Ed è qui che Carlo Rubbia sperimenterà gli “Elfi”, veicoli a trazione elettrica o a idrogeno. Due torri, anche qui: alte duecento metri, direttamente sulla “Rambla”, un ampio viale alberato che converge in un parco centrale. Il primato dell’altezza spetta al progetto City Life, che è forse il più vistoso, immaginifico, sicuramente il più griffato. Nel quartiere storico della vecchia Fiera — quella costruita nel 1906, proprio per un’esposizione universale — stanno prendendo corpo i tre spettacolari grattacieli dell’architetto iracheno Zaha Hadid, del giapponese Arata Isozaki, di Daniel Libeskind, il progettista di Ground Zero: lo “storto”, il “curvo” e il “dritto”, alto, quest’ultimo, duecentodiciotto metri, cinquanta piani. Accanto ai tre giganti è previsto l’edificio del Museo di arte contemporanea, e la pianta complessiva prevede percorsi in mezzo al verde, corsi d’acqua con ponti trasparenti. Saranno, l’acqua e il verde, i nuovi elementi di Milano. Se da una parte c’è la ricerca di un simbolismo stravagante, dall’altra la qualità della vita assume un posto di primo piano. Il verde è dappertutto: si immagina un anello intorno alla città, fatto solo di boschi. Il piano generale per l’Expo prevede addirittura la rinascita di una via d’acqua, che giunga diretta al centro. Ma non saranno progetti troppo ambiziosi? Non sarà che ancora una volta, al passaggio dall’effimero al concreto tutto si ferma? La storia dell’urbanistica milanese è storia di grandi incompiute. In ritardo sulle grandi città europee, su Barcellona e Berlino, sulla Parigi di Bercy e sulla Londra dei Docks, Milano sembra volere oggi ripensare a fondo il suo destino. Se davvero è uscita dalla crisi degli anni Novanta, se davvero la sua classe dirigente saprà non solo lasciare mano libera ai developers ma costruire un’idea di sviluppo, il momento è quello giusto. L’appuntamento con il mondo è fissato per il primo maggio del 2015. 6 GILLI HOTEL A Porta Nuova Garibaldi, entro il 2011 dovrebbe essere conclusa la costruzione di una torre di 95 metri e 25 piani Studio Benatti U ILL ION Z RA ST IRC IM ED 7 OT TORRE CESAR PELLI I LIN ER GH L’ILLUSTRAZIONE Nel disegno di Mirco Tangherlini, una libera ricostruzione di come i nuovi progetti urbanisticoarchitettonici potrebbero cambiare, di qui al 2015, lo sky-line di Milano Sulla mappa, nei cerchi numerati, l’ubicazione esatta delle principali opere in progetto AN Trentadue piani,139 metri e tre pinnacoli stile Dubai estremo. Il progetto prevede anche una piazza circolare con edifici che ne modellano la forma AREA FALCK È a Sesto San Giovanni, cuore della ex città operaia. Il recupero del laminatoio, firmato da Renzo Piano, potrebbe essere la sede ideale del Museo di arte contemporanea Nascerà come quartiere ecologico Repubblica Nazionale 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 APRILE 2008 la memoria Come eravamo L’asino per disturbare i comizi avversari; il lupo comunista sotto la pelle dell’agnello; Togliatti “caprone” secondo De Gasperi... Le elezioni di sessant’anni fa, le prime e le più ideologizzate dell’Italia repubblicana, generarono un fervore retorico e iconografico senza pari Un nuovo libro ricostruisce quel laboratorio politico Il bestiario elettorale del 18 aprile FILIPPO CECCARELLI hissà chi vinse allora il Totalvoto. Concorso nazionale a premi sui risultati del 18 aprile 1948. Lo lanciarono i Comitati Civici, contro l’astensionismo che avrebbe favorito il Fronte delle sinistre. «Vota anche se piove» era uno degli slogan; «Io non voto» diceva un somaro su un manifesto; «Essi non votano», e sotto si vedevano due bianchi conigli. Era ancora un’Italia agricola e gli animali avevano un senso. In verità ce l’hanno anche nelle odierne campagne pubblicitarie, ma è un uso sofisticato, simbolico, da cartoni animati. A quei tempi, invece, in mancanza di altoparlanti e sirene un asino era una straordinaria risorsa per disturbare i comizi avversari. Il record del raglio sabotatore venne localizzato nella rossa Rignano Flaminio: bastava che i compagni soffiassero nelle frogie dell’animale perché questo esplodesse in un baccano pazzesco, come ben sapeva il locale parroco che con questi sistemi si vedeva sistematicamente movimentare le funzioni religiose. In quel paese lì l’analfabetismo era ancora un nemico da battere. Le disposizioni propagandistiche del Pci nelle aree contadine si preoccupano che le scritte dei manifesti siano in caratteri grandi e sempre in stampatello. Eppure, fu proprio in quell’occasione che venne realizzato il primo sondaggio elettorale. C’è anche da dire che la Doxa sostanzialmente ci prese, giusto un piccola sottovalutazione della vittoria dc, ma a differenza di oggi i giornali gli diedero pochissimo risalto. Molto meglio comunque il Totalvoto della società “Sistema”, trovata fantastica, decisamente post-moderna. Ebbe un tale successo da indispettire i vertici della Sisal, titolare del popolarissimo Totocalcio. I partiti al posto delle partite di calcio, in entrambi i casi c’era da compilare una schedina, i concorrenti dovevano azzeccare l’esatto numero di seggi, per un totale di 574, sulla base dei risultati ottenuti dalle varie liste. Nel caso di rinvio delle elezioni, era spiegato sul retro, le giocate rimanevano valide; mentre solo nell’ipotesi di annullamento e sospensione, eventualità minacciata dallo stesso ministro dell’Interno Scel- C LE ILLUSTRAZIONI In queste pagine, manifesti, volantini, fumetti, vignette, cartoline elettorali della campagna del 18 aprile 1948 In un’Italia ancora contadina, la grafica faceva spesso ricorso a immagini di animali (come il lupo travestito da pecora, al centro, il gallo in alto a destra e l’asino in basso a destra, tutti poster dei Comitati Civici) ba, era previsto un rimborso. A una settimana dalle elezioni, d’altra parte, il Viminale fece conoscere alla pubblica opinione il numero delle armi requisite dalla Polizia a partire dall’inizio dell’anno e l’elenco si apriva con: «6 cannoni, 29 mortai, 4 lancia granate»... In politica allora si sparava e ogni tanto ci scappava pure il morto, quattro solo a San Ferdinando di Puglia proprio all’inizio della campagna. Insieme alle schedine, ai somari disturbatori, ai primi sondaggi e ai bellissimi cartelloni colorati c’erano tutti gli indizi della guerra civile. Anche per questo il governo mise all’ordine del giorno la questione che oggi si direbbe del look, ma che a quei tempi aveva a che fare con l’esistenza di formazioni para-militari, specie di ex partigiani. In pratica, Scelba vietò l’uso nelle manifestazioni elettorali di uniformi, cappelli, fazzoletti rossi o tricolori, bracciali, coccarde. Protestarono allora i comunisti che anche gli aderenti dell’Azione cattolica indossavano baschi verdi, per non dire gli scout con le loro divise. IL LIBRO Si intitola Le elezioni del Quarantotto il saggio di Edoardo Novelli in libreria in questi giorni che racconta la storia, le strategie e le immagini (in queste pagine ne riproduciamo alcuni esempi) della prima campagna elettorale dell’Italia repubblicana. Il libro è pubblicato da Donzelli (204 pagine, 82 tavole a colori, 16 euro) Antichità, utilità e suggestioni degli anniversari: 1948-2008, sessant’anni dal 18 aprile e un altro voto alle porte. Nulla di immediatamente paragonabile, anche perché, a differenza di quello che si sforzano di credere i giornalisti, la storia non si ripete mai. E tuttavia è certo interessante vedersi ricostruita la campagna elettorale più ideologica della recente storia italiana nel tempo meno ideologico che ci sia mai stato. Per scoprire che dopo tutto, forse, qualcosa in comune c’è, sebbene in forme indistinte, umbratili, oppure degenerate in caricatura. È un fatto di tic, di salti, dettagli e slittamenti. Qualcosa che rivive nei modi, nei tempi e nelle tecniche assai più che nei contenuti. La nascita e il frenetico sforzo organizzativo dei Comitati Civici, per dire, ricordano parecchio quelli di Forza Italia; così come è sessant’anni fa che si sperimentano con la maggiore efficacia modalità espressive che adattano la politica alla cultura di massa facendola reagire non solo con l’intrattenimento, lo spettacolo, il fotoromanzo, lo sport, i fumetti, il teatro dei burattini, ma anche traslocandola con qualche profitto nel campo impervio delle preghiere, delle sacre immagini, dei pellegrinaggi e delle processioni. Un po’ come sta riprendendo piede oggi. Reduce dallo studio della più evoluta Turbopolitica(Rizzoli, 2006), osservatore degli sviluppi e delle peripezie della comunicazione, nonché disincantato promoter accademico del Galà della politicà, Edoardo Novelli ha appena scritto Le elezioni del Quarantotto, sottotitolo Storia, strategie e immagini della prima campagna elettorale repubblicana (Donzelli, 189 pagine, 16 euro) con una preziosa appendice iconografica a cui rinvia il testo. Impossibile, si diceva, ogni compiuta analogia con il presente. Fu quello, eminentemente, un duro scontro tra capitalismo e comunismo, America e blocco sovietico. La guerra era appena finita, proprio nei giorni della campagna elettorale in Cecoslovacchia i comunisti prendevano il potere con sistemi truculenti, e di conseguenza non stupisce come nei duelli fra i leader l’elemento polemico andasse così rapidamente a parare sul concetto dello straniero. C’è uno scambio di colpi, ad esempio, tra De Gasperi e «il maresciallo Longo», così viene qualificato, in cui il democristiano l’accusa di voler stabilire una «dittatura balcanica» ricevendone in cambio l’oltraggiosa notazione secondo cui egli sareb- be «pieno di austriaco fiele», con il che si faceva riemergere nell’immaginario l’elemento germanico antirisorgimentale e poi nazista. Vedi anche i baffetti da Hitler posti sotto il naso dei capi dc. In questo quadro finisce per collocarsi la scelta, a suo modo geniale, di Garibaldi come simbolo elettorale del Fronte. Ma come si sa, in Italia il genio non è mai unico, con il che i democristiani sono costretti ad aguzzare l’immaginazione prontamente individuando il temachiave, lo strumento sottaciuto, o meglio l’implicito dispositivo che secondo Novelli gli consentì di battere l’avversario sul piano della persuasione. Ed è l’inganno, appunto, il Grande Inganno Comunista, l’argomento grezzo su cui lavorerà con sottigliezza l’Ufficio Psicologico dei Comitati Civici, la maschera che copre la realtà, il lupo che si è messo sotto la pelle dell’agnello, come in un altro celebre manifesto di quella stagione. Per cui sì, Garibaldi resta un grande personaggio, ma nulla ha a che vedere con il Pci o il Psi: «Non votate per me — gli fa dire la Dc su un poster — non ho mai aderito al Fronte». Dietro all’icona del popolare Giuseppe, che nell’emblema compare davanti a una sciagurata e tipica stella a cinque punte, in verità c’è Giuseppe Stalin, e in questo senso vengono spesi tesori di grafica, basta girare il disegno per cogliere i lineamenti inconfondibili di Baffone. Un lieve tocco di commedia, molto italiana, e nello specifico garibaldino anch’essa destinata a ricorrere nel futuro della vita politica, accompagna l’opera di demistificazione. Dell’Eroe dei due mondi viene sollecitato nell’agone uno dei tanti discendenti, il nipote, che si dissocia dal Fronte denunciando l’inedito sfruttamento dell’immagine. Quindi anche tracce del parente-testimonial pare di cogliere nella madre di tutte le campagne elettorali. Nel frattempo il leader qualunquista Guglielmo Giannini, che viene dal teatro e cura spasmodicamente il suo modo di vestire, usa un linguaggio sanguigno e sboccatissimo, «Ecco serviti i soliti coglioni» è il titolo d’apertura del suo giornale; e francamente, con gli occhi di oggi, l’Uomo qualunque somiglia un po’ a Libero. Il Santo Padre, al momento di formare le liste, suggerisce di candidare il super campione Gino Bartali. Perché quella fu anche, senza dubbio, guerra di religione. Pur con tutto il rispetto fanno sorridere, al confronto, le ingerenze del cardinal Ruini, Berlusconi che fa i suoi numeri davanti a Santa Ri- Repubblica Nazionale DOMENICA 6 APRILE 2008 ta, D’Alema in processione, lo spot di Boselli con Gesù o le preghiere della principessa Borghese. «Con Cristo o contro Cristo»: così la mette Papa Pacelli e a Milano il cardinale Schuster invoca la scomunica. È di Guareschi la vignetta: «Nell’urna Dio ti vede, Stalin no». Ben due orazioni specificamente elettorali ha scovato Novelli, che è anche un collezionista di questi materiali. Una sta in un santino da mettere nel portafogli e magari da tirar fuori nei momenti di raccoglimento politico: «Padre nostro, che sei nei cieli e governi l’universo, concedi alla nostra Patria la grazia di avere dei rappresentanti davvero cristiani...». L’altra, pur intitolandosi Il messaggio della Regina, sembra uno scherzo tipo Corrierino dei piccoli e così comincia: «Quando il voto avrai tu dato/ allo Scudo ch’è Crociato,/ sentirai dentro del core/ che non hai commesso errore». Ancora più drastica è la conclusione: «Sta sicuro che ad Alcide/ la Madonna gli sorride,/ che votar per lui ti dice/ la potente AUSILIATRICE», scritto in maiuscolo. Sono i giorni di Padre Lombardi, «il microfono di Dio», dei «frati volanti» che girano per le campagne su furgoni attrezzati per celebrare messa e sovente non si lasciano scappare l’opportunità di interrompere gli oratori del Fronte. È anche il tempo della «Madonna pellegrina». A Napoli, nel marzo, duecentomila fedeli partecipano alla traslazione del quadro della Madonna di Pompei. Quando è buio sfilano pregando per le vie della città, dalla sede del Pci esplodono mortaretti e fuochi di bengala. Dal cielo gli aeroplani fanno cadere centinaia di migliaia di volantini. Nelle stazioni i «treni dell’Amicizia» recano a un paese sostanzialmente affamato tonnellate di viveri giunti dall’America. Per le strade corrono i cine-camion che proiettano dovunque filmati politici. Anche le favole per i bimbi vengono arruolate nella battaglia elettorale. Novelli ha contato due Pinocchi, con Nenni e LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 Togliatti nella parte del gatto e la volpe, e un Cappuccetto Rosso del Fronte in cui l’Orco Mangiatutto è Truman e il demone Gasperaccio De Gasperi. Le macchine organizzative dei due schieramenti sono lente, ma a un dato momento sembrano incapaci di fermarsi. Lo scontro è selvaggio. Invano Terracini, ex presidente dell’Assemblea Costituente, tenta di istituire degli organismi di pacificazione. Per dare l’idea del clima basti il se- guente titolo dell’Unità: «Nove bambine violentate dal democristiano Malvolti». Ma si tratta, spiega bene Novelli, di un’atmosfera che scalda chi è già ben arroventato. Mentre la chiave segreta della vittoria la possiedono anche allora le fasce meno politicizzate dell’elettorato, quelle più nascoste e lontane e difficili da raggiungere. Scandali contro scandali, comunque: le sinistre agitano la vicenda Cippico, un prete che ha fatto impicci finanziari; i dc montano sulla storia dell’oro di Dongo, il tesoro fascista rubato dai partigiani. LE FOTOGRAFIE Nelle due foto in bianco e nero, comizi di Togliatti (a sinistra) e De Gasperi MicroMega 2/08 Marco Travaglio LE FREQUENZE RUBATE Pancho Pardi DUE ANIME PER UN VOTO Telmo Pievani LA MORATORIA DEI FATTI www.micromega.net SUL NUOVO SITO un video di MARCO TRAVAGLIO Per fermare Berluscaz Ferrara sfida Marino e poi scappa (audio) un video di STEFANO RODOTÀ L’eutanasia è un diritto civile e inoltre video, audio, testi di: Luciano Violante, Paolo Flores d’Arcais Nello Rossi, Antonio Ingroia UNA TAVOLA ROTONDA SULLA GIUSTIZIA Scott Turow, Gherardo Colombo CHI HA UCCISO LA GIUSTIZIA? Ignazio Marino DECIDERE SULLA PROPRIA VITA don Paolo Farinella CARTEGGIO CON LA MADONNA DI LOURDES Nicola Piovani Salvatore Borsellino Margherita Hack Oliviero Toscani Giulio Giorello Gianrico Carofiglio Pancho Pardi Carlo Bernardini Cristina Comencini ... e da lunedì un video/sorpresa di ANDREA CAMILLERI www.micromega.net IL NUOVO NUMERO DI MICROMEGA È IN EDICOLA Mostri contro mostri: De Gasperi evoca «le zanne e lo zoccolo da caprone» di Togliatti; questi prima attribuisce al presidente del Consiglio «fantasmi di torbida morbosità medievale» e poi nel comizio finale rivela di essersi fatto «risuolare gli scarponi facendomi mettere due fila di chiodi che mi riprometto di applicargli presto su parti del corpo che non nomino. Anzi, vi prego, dopo il 18 aprile fatelo pure voi». Dal diario di Andreotti: «Le sorti d’Italia sono affidate ai ventinove milioni di italiani. Iddio li illumini». Dal diario di Nenni: «Sono sfinito. Lo sforzo fisico degli ultimi comizi è stato quasi sovraumano. Facevo fatica a stare in piedi e a parlare ma m’è sembrato doveroso non sottrarmi alla lotta (...) Comunque è finita e per ora non ho che un desiderio: dormire, dormire, dormire!». A sessant’anni di distanza, e a pochi giorni da un altro voto, pare questa la valutazione più umana e rassicurante di tutta la turbinosa storia di quel 18 aprile. Repubblica Nazionale 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 APRILE 2008 il racconto Donne di potere Oltre duemila anni di tradizione confuciana hanno impresso alla società cinese un ordine patriarcale, dal vertice supremo fino al nucleo familiare. La sola eccezione è stata lei: vissuta dal 624 al 705, governò con pugno di ferro per quasi mezzo secolo Poi fu mitizzata, demonizzata, fatta oggetto di morbose fantasie E odiata, scrisse un contemporaneo, “in egual modo da uomini e dei” Wu Zhao, imperatrice maledetta V FEDERICO RAMPINI PECHINO issuto cinque secoli prima di Cristo, il Maestro Kung FuTzu — che in seguito i gesuiti “latinizzarono” come Confucio — non aveva davvero un’alta stima delle donne. Le scarne notizie che abbiamo su di lui ce lo descrivono decisamente come un misogino. Tra le ragioni che lo spinsero a lasciare un incarico politico e a dedicarsi alla filosofia, pesò il sospetto che il suo sovrano fosse irretito e manipolato da un gruppo di danzatrici. Nel dimettersi dal ruolo di consigliere del principe, Confucio citò un’antica canzone: «La lingua di una donna / Può costare all’uomo la sua posizione / Le parole di una donna / Possono costare all’uomo la sua testa». In una raccolta di biografie degli imperatori che gli viene attribuita, c’è questo passaggio: «La gallina non annuncia il sorgere del sole; il canto della gallina all’alba indica la sovversione della famiglia». Per oltre due millenni il confucianesimo ha impresso nella civiltà cinese un ordine patriarcale: come i figli devono rispettare l’autorità degli anziani, così le donne devono obbedienza ai mariti; solo queste regole garantiscono l’armonia sociale e rispecchiano sulla terra l’ordine dell’universo. E per oltre duemila anni, sotto il segno dominante del confucianesimo, la Cina ha sempre avuto imperatori maschi. Con una eccezione. Una sola. È Wu Zhao l’unica imperatrice della Terra di Mezzo, che visse dal 624 al 705 dopo Cristo, e governò la Cina con pugno di ferro per quasi mezzo secolo. Prima e dopo di lei ci furono sì delle mogli e concubine influenti, capaci talora di manovrare gli imperatori. Ci furono regine-madri e matrigne, reggenti come la vedova Ci Xi, la mamma dell’ultimo imperatore con cui si estinse la dinastia Qing nel 1908. Ma nessuna, salvo Wu Zhao, infranse mai il tabù confuciano che vietava a una donna di esercitare in proprio la carica imperiale. Perciò la figura dell’unica imperatrice cinese giganteggia nella storia. È stata mitizzata o demonizzata; ha suscitato curiosità inesauribili e spesso morbose, che ancora oggi riaffiorano nella letteratura o nel cinema popolare. Femministe e leader politici hanno cercato di impadronirsene e strumentalizzarla. Era ancora all’apice del suo potere quando uno storico caduto in disgrazia, Luo Binwang, le dedicava nell’anno 684 queste parole di fuoco: «Con il cuore di un serpente e il carattere di una volpe, ha arruolato sicofanti al suo servizio, ha rovinato i giusti. Ha ucciso sua sorella, massacrato i suoi fratelli, assassinato il suo principe consorte e sua madre. È odiata in egual modo dagli uomini e dagli dei». Al che lei rispondeva: «Hanno congiurato contro di me e li ho distrutti. Se siete più abili di loro, tocca a voi: provateci a sfidarmi. Altrimenti siate i miei servi, e risparmiate all’impero lo spettacolo della vostra ridicola disfatta». L’atmosfera torbida e scabrosa che circonda la sua biografia sembra aleggiare ancora adesso attorno al suo monumento funerario. A settanta km a nordovest dell’antica capitale di Xian (quella dell’esercito di terracotta), il visitatore riconosce da lontano la tomba dell’imperatrice per «le due Tutti gli altri sepolcri imperiali hanno una stele funeraria su cui sono scolpiti epitaffi elogiativi. La sua è una pietra liscia, vuota, dove neppure i figli sopravvissuti osarono incidere un pensiero mammelle», come i cinesi hanno soprannominato le due colline simmetriche che la circondano, ciascuna con una torre che da lontano può assomigliare a un capezzolo. C’è un primo segnale anomalo: tutti gli altri sepolcri imperiali hanno all’ingresso una stele funeraria su cui furono scolpiti epitaffi elogiativi; la stele della tomba di Wu è una pietra liscia, vuota, dove neppure i figli sopravvissuti osarono incidere un pensiero su di lei. È un’omissione che non ha eguali in due millenni di storia imperiale. «È un gesto sinistro — ha commentato il sinologo inglese Jonathan Clements — come se su quella tomba pesassero per sempre l’odio e il rancore dei familiari che lei dominò». Intorno, le statue dei dignitari di corte e degli ambasciatori stranieri sono state decapitate: quasi che una maledizione abbia voluto cancellare tutto ciò che accadde sotto il suo regno. L’immagine con cui viene evocata più spesso è «volpe traditrice». Ma il ritratto che emerge dalle cronache dell’epoca non è solo negativo, tutt’altro. Ce la descrivono bellissima, secondo i canonici dell’estetica femminile di allora: piacevano le facce rotonde e i fianchi generosi. Attraente doveva esserlo per forza visto che fu selezionata a tredici anni tra le concubine dell’imperatore Taizong (dinastia Sui): un riconoscimento equivalente alla vittoria in un concorso per reginette di bellezza ai nostri tempi. La sua sensualità ha eccitato per i secoli successivi la fantasia. I cinesi sono convinti che fece una rapida carriera all’interno dello harem imperiale perché «offriva prestazioni sessuali che nessun’altra donna osava». Era vanitosa fino al voyeurismo: amava guardarsi in uno specchio mentre faceva l’amore, un’abitudine che avrebbe conservato con vari amanti fino agli ottant’anni. Una spiegazione di quel ritratto di donna sessualmente liberata, perfino aggressiva a letto, è in chiave etnica: all’epoca delle dinastie Sui e poi Tang i cinesi si erano mescolati con tribù dell’Asia centrale, popoli nomadi turcomanni le cui donne portavano i pantaloni, andavano a cavallo e in famiglia avevano più peso delle cinesi. L’alcova ha un ruolo centrale nella scalata al potere di Wu Zhao. Nel 649, quando muore l’imperatore Taizong, teoricamente lei deve raparsi a zero la testa ed entrare in un convento di vedove imperiali. Così fanno tutte le concubine che non hanno dato un figlio al sovrano. Ma lei si è già assicurata una posizione con il successore. Macchiandosi di incesto imperiale, quando ancora Taizong era vivo lei è diventata l’amante del figlio, il principe Gaozong. Non appena quest’ultimo ascende al trono la concubina si fa mettere incinta. Gli regala il primo erede maschio: una mossa vincente nella lotta per l’influenza alla corte imperiale. Wu indebolisce la posizione della moglie di Gaozong che risulta essere sterile, la fa ripudiare e la sostituisce come prima consorte. Più tardi — per non correre rischi — le farà tagliare braccia e gambe, e l’annegherà in una botte di vino. Nel 660 l’imperatore Gaozong è colpito da un ictus, resta paralizzato. Già da quel momento è Wu Zhao a governare di fatto la Cina, per procura. Alla morte del marito, nel 690 lei osa l’impensabile: si fa incoronare come imperatrice. È un oltraggio alla tradizione patriarcale, una prevaricazione che dovrebbe scontrarsi con resistenze fortissime nella corte e in tutta la classe dirigente. Ma durante gli anni del suo pote- NATIONAL GEOGRAPHIC DI APRILE Uno straordinario speciale PRIGIONIERI DEL DESERTO Sahel: la regione africana che divide il deserto dalla foresta, gli arabi dai neri, i musulmani dai cristiani... • DESIGN DI NATURA. La frontiera più avanzata della tecnologia umana, che prende spunto dallo straordinario corredo in dotazione a piante e animali. ALLARME CLIMA Corredato da immagini spettacolari, da grafici e da ricerche, questo speciale fa il punto sui cambiamenti climatici con tutta l’autorevolezza di National Geographic. Ne indaga le cause, ne svela i meccanismi e soprattutto propone soluzioni pratiche, da mettere in atto subito. www.nationalgeographic.it A SOLI € 5,80 IN PIÙ IN EDICOLA Repubblica Nazionale DOMENICA 6 APRILE 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 re-ombra, quando era già lei a esercitare le veci del marito invalido, Wu Zhao si è costruita una formidabile rete di potere. Ha infiltrato la corte imperiale di suoi fedelissimi, spesso parenti, organizzati in una vera e propria polizia segreta: al suo servizio spiano, tramano, torturano e uccidono i potenziali avversari. La grandezza di Wu Zhao però sta altrove. Lei intuisce che il potere fondato solo sul terrore e sulle congiure di palazzo è fragile ed effimero. Per conquistarsi il consenso della burocrazia imperiale ha una trovata di genio: usa la religione. S’impadronisce del buddismo contro il confucianesimo. L’aiuta in questa operazione uno dei suoi amanti, un commerciante di droghe e cosmetici con cui ha una relazione a partire dal 680. Per poterlo vedere a suo piacimento l’imperatrice lo nomina abate a capo del monastero del Cavallo Bianco, vicino alla città di Luoyang. Con l’aiuto dell’amante-abate, la regina inizia la costruzione di un “culto femminista” per legittimare il proprio potere. Viene riscoperto e glorificato un oscuro testo minore della tradizione buddista, la Sutra della Grande Luna, dove si esalta una divinità femminile, la Signora Celeste Pura e Radiosa. Il testo sacro profetizza che sette secoli dopo la morte di Budda la dea rinascerà in terra incarnandosi in una principessa. L’imperatrice Wu investe generosamente le ricchezze del tesoro pubblico per finanziare nuovi monasteri, templi e statue — tra cui un Budda gigante di diciassette metri nelle celebri grotte di Longmen — tutti devoti al culto della Maitreya-Budda, la dea madre che regnerà in un futuro paradiso. Cioè lei stessa, secondo la sua consacrazione divina che diventa legge nei monaste- ri dal 694. Il nome di Wu Zhao, nell’ideogramma che lo esprime, è già denso di fascino: esprime il sole e la luna sopra il vuoto, la luce sospesa sul nulla. Dalla sua ascesa al trono l’imperatrice si attribuisce altri nomi sempre più impregnati di significati religiosi: si fa chiamare Ruota Dorata, Antichità Trascendente, Misericordiosa Bodhisattva, Scelta dal Cielo. Anche questa ubriacatura di titoli è una sorta di vendetta femminile. Nella tradizione patriarcale confuciana la lingua serve a discriminare tra uomini e donne. L’ideogramma femminile è usato per comporre caratteri negativi come schiavo, gelosia, prostituta, demonio, lussuria, indecenza, esibizionismo. L’imperatrice che trasforma se stessa in divinità buddista osa un esperimento di rottura radicale. Non le sarà perdonato. Alla sua morte — nel 705 viene deposta e assassinata da un golpe di palazzo — dilagano leggende che la dipingono come un essere immondo, dai vizi ripugnanti. La descrivono come una vecchia impudica e assetata di sesso che costringe più uomini a orge collettive nel suo letto, si droga di afrodisiaci «fino a che le ricrescono i denti e le sopracciglia». Ricostruzioni più attendibili considerano invece il suo regno come un’epoca di relativa continuità nella prima “età dell’oro” della civiltà cinese. In quegli anni a cavallo tra le dinastie Sui e Tang l’Impero di Mezzo raggiunge un apogeo di sviluppo e di potenza. Alla corte di Wu Zhao s’intrecciano relazioni diplomatiche con il mondo intero, arrivano in visita principi persiani, mercanti ebrei e indiani, missionari tibetani, ambasciatori dall’impero bizantino, artisti giapponesi. È un periodo di benessere e di notevole apertura verso il resto del mondo, a cui contribuisce una sovrana senz’altro capace e intelligente. Eppure la figura di Wu Zhao è rimasta troppo ingombrante per essere consegnata con serenità al bilancio degli storici. Dalla sua scomparsa non ha mai smesso di ossessionare i cinesi. Nel Sedicesimo secolo ispira un romanzo pornografico, Il Signore del Piacere Perfetto, ricco di dettagli osceni sui suoi amori senili. Nel Diciannovesimo secolo un altro romanzo, Fiori allo Specchio, la celebra invece come una vendicatrice di tutte le donne oppresse, una virago che impone la sua volontà perfino alla natura. Nel Novecento i comunisti riabilitano la sua memoria e s’impadroniscono del personaggio per propugnare l’emancipazione delle donne. A metà degli anni Settanta, sul finire della Rivoluzione culturale, quando Mao Zedong è ormai affetto dal morbo di Parkinson e nel partito comunista imperversa la lotta tra fazioni rivali, il simbolo dell’imperatrice donna viene gettato nel vortice della furiosa battaglia politica. Tutti usano il personaggio della storia antica per alludere a Jiang Qing, la moglie di Mao che fa parte della famigerata Banda dei Quattro, gli istigatori delle Guardie rosse. La corrente radicale ricostruisce la storia di Wu Zhao descrivendola come una moglie leale e fedele che governò de- gnamente la Cina sostituendo il marito malato. I moderati, nemici della Banda dei Quattro, rievocano dell’imperatrice una scandalosa immoralità. L’unica donna che salì al trono dell’Impero Celeste non ha smesso di eccitare le controversie fino ai nostri giorni. Un’autorevole femminista, Shu-Fang Dien, ha dedicato un’opera monumentale a L’imperatrice Wu nella storia e nella letteratura. È un’appassionata rassegna della condizione della donna cinese, riletta in filigrana attraverso tutte le reincarnazioni di Wu Zhan nell’immaginario della nazione, fino alle telenovelas che la raffigurano in varie versioni sugli schermi televisivi nel Ventunesimo secolo. Si conclude con queste parole: «È dai tempi dell’imperatrice del Settimo secolo che cerchiamo di superare l’eredità dell’ideologia confuciana e del suo familismo maschilista e patriarcale. La lotta continua». L’ultimo scherzo che il destino ha riservato all’antica imperatrice è venuto da una casa editrice. Nel 1996 una biografia di successo di Hillary Clinton, scritta da un autore cinese, è uscita in libreria con questo sottotitolo: «Una imperatrice Wu alla Casa Bianca». LE IMMAGINI L’illustrazione grande qui sopra è una delle rare raffigurazioni di Wu Zhao, l’unica imperatrice della Cina, vissuta nel Settimo secolo dopo Cristo. Nella pagina di sinistra, un dragone cinese Repubblica Nazionale 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 APRILE 2008 CULTURA* Tra il ’58 e il ’59 lo scrittore passò tre mesi con una banda di teppisti in vista di un film, “La Nebbiosa”, che non si fece mai, su “una notte di aggressioni, furti, rapine, stupri, orgie” tra i grattacieli di una Milano in crisi di crescita. Del casting restano un centinaio di foto inedite, specchio di quei “ragazzi bruciati” Pasolini e i Teddy Boys La mala gioventù al tempo del Boom GIAN PAOLO SERINO «U MILANO na gioventù insofferente e incattivita che alla superficialità risponde con la superficialità, alla crudeltà risponde con la crudeltà. Sono proprio i teddy boys i figli reali dei nostri avvocati, dei nostri professori, dei nostri luminari». Così scriveva Pier Paolo Pasolini in un articolo su Vie Nuove del 10 ottobre 1959: era stato ospite a un convegno a Venezia sul disagio giovanile nel settembre di quello stesso anno e il suo intervento diede scandalo. Perché descrisse non la gioventù bruciata che allora riempiva le pagine dei giornali con il proprio anticonformismo di facciata ma una «gioventù insofferente e incattivita». Per lo scrittore quella “meglio gioventù”, che si ribellava all’ombra della notte e si nascondeva dietro giubbotti di pelle nera e motociclette chiassose, era ciò che i loro padri si meritavano: dei “conformisti” che si ribellavano dalla parte del silenzio. Per Pasolini, che nel 1955 aveva ritratto i “ragazzi di vita” delle borgate romane, i teddy boys sono «il prodotto di una società ad alto livello economico, sociale e civile, e di tipo industriale: perché appartengono ideologicamente alla classe borghese e la loro è una protesta di tipo moralistico contro la stessa società che li ha prodotti e non gli dà ciò che desiderano». Dei bam- “Sono il prodotto di una società ad alto livello economico e di tipo industriale: appartengono alla classe borghese” Moretti & Vitali Editori www.morettievitali.it p. 320 €18.00 boccioni ante litteram, ma in giubbotto di pelle nera. «Il ragazzo nevrotico milanese, o torinese, o bolognese», scrive Pasolini, «si trova a lottare contro una società apparentemente buona, capace di offrirgli garanzie, ma, in sostanza, ingiusta, e quindi sotto le apparenze democratiche, noiosa, ipocrita, feroce». Giudizi che suscitarono più di una polemica, tanto che persino uno scrittore dalla vita spericolata come Giancarlo Fusco, che anni dopo descrisse la stessa violenza da vuoto pneumatico nel suo Duri a Marsiglia, nell’articolo Rimedi contrastanti per i teddy boys prese le distanze dalla «disamina lontana dalla realtà» di Pasolini. Ma la realtà dei teddy boys lo scrittore friulano l’aveva conosciuta da vicino proprio in quello stesso anno: tra il 1958 e il 1959 aveva vissuto per tre mesi al fianco di una banda di teppisti dell’alta società milanese, perché proprio su quei ragazzi sgangherati, che rombavano per le strade in sella alle loro Guzzi e Gilera, impomatati dalla brillantina e dal mito americano, aveva deciso di fare un film. Di quel progetto oggi rimangono poche pagine, antologizzate nel volume Pier Paolo Pasolini: Per il cinema, curato da Walter Siti e Franco Zabagli nei Meridiani Mondadori. La sceneggiatura originale, invece, non è mai stata pubblicata in versione integrale. A documentare le giornate di Pasolini tra i teddy boys milanesi sono centosedici immagini rimaste sino a oggi inedite, da cui sono tratte quelle che qui pubblichiamo, e che verranno esposte in una mostra durante il Festival di letteratura Satisfiction che il 3, 4 e 5 ottobre animerà dopo anni di silenzio turistico le strade, i palazzi e le chiese di Brera. Gli scatti appartengono all’archivio Giancolombo, fotografo che dalla metà degli anni Quaranta alla fine dei Sessanta immortalò i protagonisti della dolce e allora vivace vita culturale milanese. Nelle fotografie è ritratta quella “mala gioventù” che si muoveva tra Elvis Presley e il Cerutti Gino, tra il sogno americano di una vita a tutto rock e i trani a gogò delle periferie. La stessa gioventù che Pasolini aveva sognato di portare sullo schermo ne La Nebbiosa ma che per dissapori di natura economica con il produttore e i registi non riuscì a terminare. Nei suoi giorni milanesi, come testimoniano le fotografie, Pasolini si immerse completamente in quel mondo giovanile che nei ritmi del boogie woogie intravedeva gli unici passi di una ribellione che presto sarebbe sfociata in una spirale di teppismo e di violenza. La stessa violenza che Pasolini percepisce sui volti dei suoi teddy boys e che descrive nella sceneggiatura de La Nebbiosa, in cui anticipa le tematiche che sarebbero state al centro della Milano violenta descritta anni dopo nei romanzi di Giorgio Scerbanenco (considerato il padre del noir milanese e italiano). Fu Pasolini però il primo a raccontare «una notte di aggressioni, furti, rapine, stupri e orge» tra i bar luccicanti e i grattacieli di una Milano in pieno Repubblica Nazionale DOMENICA 6 APRILE 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 E in quegli anni rampanti la povertà divenne colpa VINCENZO CERAMI lcune di queste fotografie furono pubblicate su un giornale scandalistico nel 1960. Dalle didascalie risultava che a mettere sulla cattiva strada uno di quei teddy boys, finito in prigione per “precedenti reati”, fu Pier Paolo Pasolini, il famigerato scrittore delle borgate romane. In verità Pasolini non aveva passato molto tempo in compagnia di quei ragazzi: l’incontro con loro era stato organizzato per una documentazione realistica dei personaggi di un film sulla malavita milanese. L’ultimo titolo dato dal poeta alla sua sceneggiatura è La Nebbiosa. In una fotografia si riconosce il volto della giornalista Adele Cambria, molto amica di Pasolini, che in seguito fece anche un piccolo ruolo in Accattone. L’odio per l’omosessuale comunista, che stava riscuotendo uno scandaloso e irresistibile successo, era cieco: gran parte della stampa (non solo di quel tempo) si accanì contro di lui, con violenta aggressività, non certamente inferiore a quella dei giovani sbandati della Milano notturna qui ritratti. I teddy boys, da noi, a bordo delle macchine rubate cantavano il rock and roll Teddy Girl di Adriano Celentano. Erano figure di balordi tanto sbruffoni quanto fragili. Con il benessere, in Italia, i morti di fame si travestivano da “gioventù bruciata”. I soldi del contrabbando di sigarette e di qualche furto venivano nascosti dentro i tubi Innocenti arrugginiti e abbandonati nei cortili, oppure in una scatola di scarpe, insieme alla rivoltella dei padri scampati alla guerra. Il neorealismo, arrivato il soldo, aveva cambiato il panorama: non più il popolo povero, innocente e allegro, ma ragazzi che viaggiano sparati verso la frustrazione e la nevrosi. La povertà è già diventata una vergogna. Tutt’intorno gli immensi cantieri della ricostruzione. Si stava compiendo il grande scempio della nostra bellezza. Pasolini aveva già descritto, quattro anni prima di quelle foto del ‘59, in Ragazzi di vita, la fine del sogno di un’Italia giusta e umana, che la Resistenza aveva promesso. La cultura piccolo borghese imperava sempre di più in un contesto politico che si guardava bene dal rimuovere la centralità del potere clerico-fascista ereditata dal passato. La televisione era il principale strumento di alfabetizzazione e proponeva un modello di cittadino italiano chiuso nel proprio egoismo e nella propria casa, senza alcun interesse per la comunità e per la solidarietà. Nell’arco di tempo in cui si svolge la storia (dalla fine della guerra a Scelba) Riccetto, il protagonista, fa in tempo a passare dalla povertà innocente alla povertà colpevole, dall’eroismo alla viltà. Il racconto comincia infatti con i ragazzini che si tuffano in acqua per salvare una rondine caduta nel Tevere, e finisce con gli stessi ragazzi, ormai giovanotti, che osservano impassibili una persona che annega. Per Pasolini, nei cosiddetti anni della ricostruzione, le scavatrici inaugurano un’epoca che non conserva alcun legame con il passato. Da quel periodo in poi il poeta descrive, con la puntualità di un cronista, attraverso film, romanzi, discettazioni giornalistiche, saggi, tragedie ed altro, il rapido processo di “omologazione” della nostra società, dal tempo del Riccetto, fino alla metà degli anni Settanta. Quel mite e un po’ sperduto ragazzo in grigio e cravatta, poeta borghese che si mischia a personaggi testoriani, emarginati e barocchi, esplora una popolazione dialettale, letterariamente indegna, alla quale negli anni Cinquanta e inizio Sessanta è stato offerto un ruolo di protagonista, sia in letteratura che in cinema. Nel periodo dell’uscita del romanzo Una vita violenta (l’autore fu denunciato per oscenità dall’Azione cattolica di Milano), Bolognini prepara Una giornata balorda, dopo il successo di La notte brava (1959); Testori subisce un processo per scandalo con L’Arialda; e si proietta sugli schermi il capolavoro di Visconti Rocco e i suoi fratelli. Tutte opere che puntano lo sguardo su giovani della buia periferia metropolitana, qua e là illuminata dai neon e da sorrisi di ragazzi abbrutiti e spaventati da una vita difficile. Il cinema accende i fari sulle popolazioni emarginate, immobili e fuori della storia, per documentare la dinamica sociale più visibile e drammatica del tempo: il processo di acculturazione alla realtà piccolo borghese degli strati più bassi della società italiana. Storie di ambizioni sbagliate, di horror vacui, di esistenze sacrificate sull’altare del benessere. È una stagione che dura un decennio circa, dalla fine degli anni Cinquanta. Ma sul grande schermo trionfa la commedia all’italiana, la descrizione allegra e insieme spietata della piccola borghesia ambiziosa e padrona del mondo: antieroi che non disdegnano di accarezzare le natiche delle “serve”. Qui si vede meno il tempo che passa, la storia che travolge gli uomini: il piccolo borghese ha una tipicità universale e stabilizzata nel senso comune, un’anima eterna come una categoria dello spirito. È il gigantesco personaggio di gran parte del romanzo inglese, francese, e russo dell’Ottocento. È lui che ha di nuovo vinto, dopo i fasti marmorei del ventennio. Adesso sogna di diventare commendatore, e si fa chiamare ingegnere anche se è solo un geometra. Pasolini, così fuori luogo in quella Milano molto più dura di Roma, livida, non ha una faccia sorridente. Sembra prevedere in quei ragazzi un destino triste, una vita sempre povera ma “consumata” nella solitudine, e nella nevrosi del morto di fame che sa di essere un morto di fame. A RIBELLI Pasolini e i teddy boys milanesi negli scatti di Giancolombo. Le foto saranno in mostra al Satisfiction Festival (Milano dal 3 al 5 ottobre) nell'ex chiesa di San Carpoforo, Dipartimento arti visive dell'Accademia di Brera (www.satisfiction.org) boom non soltanto economico. Da una parte quelli che lo scrittore chiama «tipici milanesi medi», «commercianti e viaggiatori di commercio», dall’altra i teddy boys. Come Tony, detto Elvis in onore di Presley: «Ha un ciuffo spettacoloso, che gli sporge un palmo buono sulla fronte. Ha un viso dolce ma segnato, di timido e buono, che se compie azioni violente è solo per una specie di disperazione». Oppure Pucci, detto il Gimkana: «Ha una faccia pallida, torbida, segnata, con gli occhi cerchiati. L’aspetto è quasi di bravo ragazzo, riservato, educato. Ma c’è insieme, in lui, qualcosa di terribile, che fa pensare sia capace di tutto». Non mancano le teddy girls, agghindate con calze di nylon, che non si negano mai l’ultimo ballo nei locali desolati di una città di nebbia e di fumo: «Tutto è lucido, nuovo, fiammante: nichel e neon e marmo che scintillano. Il bar è vuoto: vi sopravvivono solo pochi clienti presi da una silenziosa e malinconica ubriachezza. E Pipetta. Che, fresca come una rosa, col suo vestito da teddy girl, la sua faccia da bambina arguta e innocente, balla deliziosamente il rock». Insieme con il Teppa, il Contessa e il Rospo, sono i ragazzi che Pasolini ha incontrato a Milano. Gli stessi ragazzi che con lui hanno vissuto le notti di una città ricca e violenta, cinica e sfavillante: una vita nebbiosa all’ombra di una Madonnina a tempo di rock. Gli stessi ragazzi non di vita che, durante il Satisfiction Festival, racconteranno per la prima volta La Milano segreta di Pasolini. Repubblica Nazionale 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la lettura Combattenti DOMENICA 6 APRILE 2008 Sono rimasti chiusi a lungo nei mitici “armadi blu” Sono pagine e pagine di appunti, ricordi, disegni che Marguerite Duras ha composto tra il ’43 e il ’49 Li chiamano i “Quaderni della guerra”, ma parlano anche di Indocina, padri, madri, fratelli e letteratura. Ora escono in Italia per Feltrinelli Esclusa e sola con la mia infanzia MARGUERITE DURAS orreivedere nella mia infanzia solo l’infanzia. E tuttavia non riesco a farlo. Non ci vedo addirittura alcun tratto caratteristico dell’infanzia. Vi è in questo mio passato qualcosa di compiuto e di perfettamente definito — e a proposito del quale nessuna illusione è possibile. Non mi ci ritrovo in alcun modo. È il periodo della mia vita che sento come il più arido, con l’eccezione di pochi anni dai quali, come da un tabernacolo, ho attinto forze per tutta la mia vita. Niente di più chiaro, di più vissuto, di meno sognato di tutta quanta la mia infanzia. Nessuna fantasia, niente di quelle leggende e di quelle fiabe che circondano quella prima età di un’aureola di sogni. Non vado a caccia di spiegazioni. È così per me e per i miei due fratelli, che hanno vissuto gli stessi anni. Eppure quell’infanzia mi tormenta, e accompagna la mia vita come un’ombra. Non mi attrae per il suo incanto, poiché non ne ha molto ai miei occhi, ma al contrario per la sua stranezza. Non ha mai condizionato la mia vita. È stata solitaria e segreta — ferocemente custodita e molto a lungo chiusa in se stessa. La dirò a seconda del vento che soffia in me quando la sento invadermi e ossessionarmi come un’avventura dimenticata — e mai chiarita. Non ho avuto lunghi anni di abitudini, né quella dolcezza che da esse deriva e dal suo ritmo, dalla sua lentezza a uscire dal tempo, a costruire il suo incanto. No, non ho avuto niente di tutto questo, non ho avuto né casa avita, né giardini frequentati abitualmente, né soffitte, né nonni, né libri, né amici insieme ai quali si cresce. Niente di tutto questo. Che cosa resta, vi domanderete. Resta mia madre. Perché nascondermelo? È di lei che voglio raccontare, della sua storia, del prodigioso mistero mai svelato, quel mistero che è stato molto a lungo la mia gioia, il mio dolore, in cui sempre mi ritrovavo e da cui spesso fuggivo per poi ritornarvi. Mia madre è stata per noi una grande pianura dove abbiamo camminato a lungo senza coglierne la misura. Non la vedo per niente circondata da quell’alone di dolcezza e di sollecitudine che si accompagna a ricordi di questo tipo quando se ne segue il filo. Del resto non è un ricordo. È una grande marcia senza fine. Non so niente della sua vita di donna, di ragazza, di sposa. La vedo come nostra madre, è tutto. Qui mi fermo perché vorrei poter dire quello che è stata e quello che è sempre questa maternità — e le parole mi sembrano vuote, illusorie. Vorrei, per vederla, allontanarmi da lei, respingere per un momento quella sua attualità sempre così assorbente. Ecco: doveva essere molto impura prima di noi, impura di tanta passione umana non santificata. È tutto quello che posso dire. E poi siamo venuti, noi tre; siamo stati il sale della sua vita, il sale di quella terra che fu, da allora, sontuosamente fecondata. Lei ha vissuto quella passione per noi, senza alcun freno. L’ha vissuta attivamen- V te. Senza quella pazienza, quella pace che è prodigata alle madri come una benedizione. Ha sostenuto il peso della sua passione, sola, con una violenza mai placata, e le sue spalle sono sempre così belle sotto quel pesante fardello. Fin da piccoli abbiamo partecipato alla sua vita. Siamo stati i suoi amici, e credo che abbiamo preso da lei il senso della realtà. La sua realtà era il nostro sogno. Siamo stati nutriti di lei come gli altri bambini lo sono di chimere. Abbiamo condiviso le sue disgrazie e le sue gioie in tutta la loro pienezza. * * * Venivamo da lontano, sempre da lontano. Arrivi e partenze si susseguivano nella nostra vita come in altre scorrono, regolari e lenti, gli anni saldati gli uni agli altri. Mio padre era funzionario in Estremo Oriente. Precisare sarebbe inutile e persino nefasto per l’idea che ci si potrebbe fare della nostra infanzia. Dappertutto c’è vita che spunta, bambini che vivono e sbocciano e si cercano, e [illegg.] — alcuni [soli] in grandi giardini recintati, altri nelle cucine, in grandi appartamenti austeri, e ce ne sono pure su marciapiedi esposti e riarsi dove tuttavia ci si può inventare delle intimità, persino dei misteri, forse. Noi, però, facevamo parte dei frequentatori abituali di vagoni e di porti. [In realtà] senza che ne derivasse alcuna rivelazione eccezionale. I bambini hanno la grazia delle piante e dalla terra prendono solo quello che può nutrirli. Le lasciano il resto. Avevamo stupori altrettanto puri e semplici di quelli di tutti gli altri. Le idee generali, le ignoravamo, non avevamo alcuna nozione del mondo e dei viaggi — perché vivevamo solo nell’attualità di tutti i giorni. Vedo sempre noi tre in una luce alquanto singolare. Sempre sparuti e stanchi, la mattina [illegg.] all’arrivo in certe stazioni strane e senza nome, tutti ammucchiati, rannicchiati contro mia madre, frutti di uno stesso grappolo, aggrovigliati gli uni agli altri con ancora la stessa carne e lo stesso sonno. La mamma ci teneva, ci covava senza distinguerci, e nella sua tenerezza c’era lo stesso disordine che nelle nostre carni. Siamo stati molto a lungo bambini piccoli. Un tempo infinito, incredibile, che mi sembra di non poter mai misurare. Eravamo tre, i miei due fratelli, Pierre e Paul, e io, l’ultima — ma non riesco a darmi un qualsiasi nome — sì, siamo stati molto a lungo bambini. Poi un giorno, e tutto d’un tratto, uno di noi, il più grande, Pierre, ci diventò estraneo. All’improvviso, spiccò il salto, oltrepassò il margine, uscì fuori dal profondo della nostra infanzia verso orizzonti molto più illuminati e definiti. Questo, per me, fu senza dubbio molto doloroso, perché sentivo che anche l’altro mio fratello sarebbe stato irrimediabilmente colpito dalla stessa fatalità, lasciandomi smarrita, tutta fasciata di tenebre, nel mio primo giardino. Poi altre circostanze, più tardi, mi tagliarono fuori da quel mondo [al quale] [aspiravo] e [che] invidiavo appassionatamente. Ciò che fino a quel momento regnava indistinto nelle nostre [vite] ben presto svanì per far posto a uno spaventoso separatismo che contagiò financo i nostri giochi più semplici. Malgrado sforzi sublimi da parte mia per [illegg.] il mio stato, ero esclusa e sola con la mia infanzia. Tutto questo [lo capii] in certi giorni memorabili. Eravamo molto liberi, ci lasciavano tranquillamente giocare in un grande giardino a Phnom Penh. Nostro padre era il direttore di un importante collegio alla vita del quale adeguavamo il ritmo della nostra. Quella grande scuola laboriosa e affollata ci ignorava e viveva intorno a noi senza che ne fossimo minimamente impressionati. Eravamo ancora nell’età sublime della perfetta ignoranza e la passione scolastica, pure così inebriante, non ci sfiorava. Ma sapevamo che intorno all’ora di pranzo il collegio si svuotava e all’improvviso diventava accessibile, e tutto nostro. La siesta ci aiutava, era nostra complice, [illegg.] una calma così penetrante, così eterna che ci [inondava] di libertà e di spazio. Niente al mondo poteva turbare il torpore di quelle ore, e questo, noi lo sentivamo perfettamente. Ci rimpinzavamo di quella libertà con un’ebbrezza che avevamo repressa nelle lunghe mattinate d’attesa. [...] * * * Ci mandò presso alcuni suoi parenti per essere sola, e partì alla volta di Platoriet per una quindicina di giorni. Lì trovò, credo, due domestici che l’aspettavano e che l’accolsero affidandole, insieme alle chiavi, la potestà incontrastata sui luoghi e su se stessi. Erano le sole persone che avevano condiviso intimamente gli ultimi giorni di mio padre, e ne parlavano con un rispetto e una devozione assoluti. Furono perciò in grado con rara delicatezza di illustrarle esattamente gli ultimi mesi della sua vita. Che erano stati molto tranquilli e straordinariamente sereni. Pur non avendoli vissuti, immagino DISEGNI Un altro dei quaderni di Marguerite Duras con il disegno di uno dei figli Repubblica Nazionale DOMENICA 6 APRILE 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 FOGLI In queste pagine gli originali dei Quaderni di Marguerite Duras contenuti nell’edizione italiana CAMMEO Nella foto in basso la Duras da giovane; a sinistra la scrittrice con il fratello Pierre FOTO CORBIS la loro luce e la loro dolcezza: quella del parco in autunno, quando gli ultimi vapori di umidità salgono dalla valle del Dropt, quando tutta la vita assolata e ronzante abbandona il parco e lo lascia silenzioso e calmo come il coro di una chiesa dopo le ultime funzioni. Mio padre era debole, molto debole, ed è morto di quella debolezza. Il suo male, senza essere grave in sé, lo ha sfinito a poco a poco. Quando la vita se ne va così, lievemente, senza scosse, come una corrente al rallentatore, la morte arriva simile a un sonno e smorza la vita piano piano, come dopo una sana e buona fatica. Per mio padre è stato così. Mio padre è morto dormendo in un bel pomeriggio dei primi giorni d’inverno. Dormiva anche il grande parco e il suo silenzio entrava nella camera come un incantesimo. Il soffio vi- In quei taccuini l’officina di una scrittrice AMBRA SOMASCHINI essun’altra ragione mi spinge a scrivere questi ricordi se non questo istinto di riesumazione. È molto semplice. Se non scrivo, a poco a poco dimenticherò». Tra il ‘43 e il ‘49 Marguerite Duras ha riempito quattro piccoli quaderni dalle copertine rigide e le pagine morbide, li ha chiusi in una busta bianca «dans les armoires bleu», negli armadi blu della sua casa a Neauphle-le-Château. Nei Quaderni della guerra e altri testi (traduzione di Laura Frausin Guarino, Feltrinelli, 336 pagine, 19,50 euro, in libreria dal 17 aprile) ci sono le radici della sua scrittura spoglia, efficace, struggente, ci sono le trame, i luoghi, c’è l’officina di romanzi e racconti. Ci sono dei disegni infantili attribuiti a Jean Mascolo, suo figlio, c’è Marguerite Donnadieu che stava diventando Marguerite Duras. Un “work in progress” che Laure Adler e Jean Valier hanno subito considerato un insieme omogeneo, un unico flusso di scrittura, la ragnatela di idee in cui il prodotto finale era già connesso. Nel quaderno rosa marmorizzato Duras torna all’infanzia in Indocina. È qui che comincia a definire i personaggi, la madre, il fratello, le sue botte («...picchiava con arte — lentamente, con una pausa dopo ogni colpo per godere appieno dell’effetto») «N IL LIBRO La copertina dei Quaderni della guerra e altri testi (Feltrinelli, 336 pagine, 19,50 euro, in libreria il 17 aprile) insieme alla prima versione della sua relazione con l’Amante: «...ero alquanto mortificata al pensiero che Léo si desse tanto da fare per piacermi. Tuttavia mi vestii meglio che potevo e, alle due, scesi per andare a scuola. Léo mi aspettava lungo la strada, appoggiato alla portiera dell’auto, sempre vestito con un completo di tussor». La fine è spezzettata, pochi frammenti di Una diga sul Pacifico. Il secondo journal, grigio azzurro, scrittura minuta e compatta, è la base di Théodora e la versione originaria de Il dolore poi concluso nel terzo Quaderno di cento pagine a righe. L’ultimo, beige, copertina telata, stile discontinuo, annotazioni a margine con il pennarello rosso, è lo studio de Il marinaio di Gibilterra e di Madame Dodin. In coda dieci testi autobiografici, corti, essenziali, scritti a matita su fogli piegati in quattro. L’archivio des armoires bleu approda all’Imec — Institut mémoires de l’édition contemporaine — nel ‘95 ma viene pubblicato insieme a P. O. L. Editeur dopo un lungo lavoro soltanto nel 2006. «I Cahiers — spiegano nella prefazione Sophie Bogaert e Olivier Corpet — sono un’espressione dell’opera allo stato nascente che contiene in modo sorprendente l’architettura originaria di tutto l’immaginario durassiano». tale di mio padre era così flebile che probabilmente bastò quel silenzio ad addormentarlo per sempre. Tutto doveva essere molto tranquillo nella grande casa vuota, solo la camera viveva ancora nell’infinito degli ultimi momenti. La finestra era aperta sui tigli, e le grandi tende rosse racchiusero in sé, nascondendolo, ciò che di sveglio restava nelle cose. Solo alcuni gridi di uccelli venuti dall’eternità furono per mio padre gli ultimi richiami della vita. Poiché tardava a chiamare il domestico, questi andò da lui spontaneamente. Bussò, tornò a bussare parecchie volte e capì che quello che si aspettavano fin dall’inizio era accaduto. Sapevano ciò che bisognava fare in quei casi. Lo fecero molto minuziosamente e con una sorta di nobiltà. Morto mio padre, furono padroni del luogo e tuttavia usarono di quella libertà con assoluta discrezione. Non si allontanarono dalla proprietà, perché sapevano di dovervi accogliere mia madre quando sarebbe arrivata. Mio padre non aveva che loro. Alla sua morte erano rimasti soli. Lo hanno vestito con il suo bell’abito da cerimonia nero. Era così magro e così leggero che pareva un bambino. Henri lo depose sul grande letto e andò ad annunciare ai ragazzi del villaggio che il suo padrone era morto. Jeanne restò vicino al letto fino a sera, e anche per tutta la notte. Vegliò il morto in una condizione di servitù da cui niente poteva affrancarla. Tutto ciò che doveva esser fatto fu dunque fatto. Seppellirono mio padre all’indomani, nel cimitero del paesino da cui dipende Platoriet. Molta brava gente che non lo conosceva seguì il feretro, perché sapevano che era solo e lontano dai suoi cari. È ancora laggiù. Mia madre aveva sempre voluto portare il suo corpo nel nostro parco. Era stato già scelto il posto, all’ombra delle bocche di leone, ma le cose andarono per le lunghe e Platoriet non ci appartiene più. Ci sono ritornata quando abbiamo venduto la proprietà. Ho fatto a piedi la lunga strada tutta inondata di sole. Era una splendida giornata d’aprile; il tempo era straordinariamente bello, tanto che le prime rose erano fiorite e già invase dalle api. Ne ho colto un gran mazzo i cui resti polverosi sarebbero ancora lì se qualche guardiano zelante non li avesse spazzati via. Poi, più avanti, forse qualche anima buona ha portato altri fiori. I giorni, le notti passano sul suo corpo, e le ombre dei tassi, che si stagliano meravigliosamente nette nel fulgore del sole, disegnano sulla sua tomba filigrane d’oro. E così tutto è molto calmo, e così lento che perfino il tempo si è dimenticato di scorrere. Sono cresciuta, ma la sua morte ha sempre per me la dolcezza di un sonno pomeridiano. Traduzione Laura Frausin Guarino (© 2006 P.O.L. éditeur/Imec éditeur © 2008 Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano) Repubblica Nazionale 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 APRILE 2008 SPETTACOLI La “Carlo Colla e figli” è la più antica e prestigiosa compagnia italiana di un genere teatrale molto speciale I loro antenati si inventarono il mestiere quando gli austriaci li cacciarono da Milano perché filofrancesi. Da allora fino a oggi c’è sempre stato uno della famiglia dietro a uno Shakespeare, un Molière o un Verdi allestiti in miniatura Ecco un viaggio nel loro backstage tra parrucche, abiti di scena e manovratori Marionette La dinastia dei Colla “La vita appesa a un filo” ANNA BANDETTINI I DONNE AL POTERE Tullia (1994) dallo spettacolo Il mondo alla roversa di Carlo Goldoni Tutte le marionette riprodotte in queste pagine fanno parte del patrimonio della compagnia “Carlo Colla e figli” “Necessitano cure particolari che vanno dalle ricuciture alle risuolature delle scarpe perché anche loro consumano le suole come gli attori veri” MILANO l glorioso sbarco di Garibaldi a Marsala, tra spari dei cannoni dalle navi e i siciliani sulla costa che salutano le camicie rosse suscita sempre uno stupore intenerito. Come il battesimo del Canale di Suez o l’esultante arrivo in scena di centinaia di aurighi, odalische, lancieri, guerrieri, sacerdoti, elefanti, cammelli, buoi, ragazzini della Marcia Trionfale dell’Aida. Quando si parla di magia e di meraviglia dello spettacolo, bisogna rifarsi a questa strabiliante famiglia di marionette che con i suoi turbini di incantesimi, splendori, prodezze old style, continua a destare sorpresa anche in occhi, come i nostri, assuefatti agli eccessi di immagini. La “Carlo Colla e figli” è la più antica e prestigiosa compagnia italiana di marionette in attività; un pittoresco mondo fatto di paladini, principesse, creature fantastiche che ci riporta a quell’antico e tenerissimo teatro non toccato dal tempo e dalle mode, in equilibrio perfetto tra la cura maniacale del dettaglio e il piacere del pittoresco, l’indulgenza ironica agli stereotipi e la poesia. O la grazia, come scriveva von Kleist. Basta guardare spettacoli come Il Ballo Excelsior,Aida, fiabe come Cenerentola,Il gatto con gli stivali, Il giro del mondo in ottanta giorni che oggi sono invitati a Broadway, Sidney, Berlino, Shanghai, dove gli spettatori rimangono senza fiato davanti allo splendore delle messe in scena, al piacere magari di una tempesta di pioggia e vento fatta solo con duecentocinquantamila perline di vetro appese ai fili. La suggestione dei Colla sta nella loro affascinante storia e in un patrimonio secolare, fatto di più di trentamila pezzi, manoscritti, scenografie, partiture, e poi calze, pugnali, parrucche, orecchini, corone, spade, e soprattutto sapienza che fa della compagnia la voce più qualificata e competente nel restauro e nella fattura artigianale del teatro animato. «Le marionette necessitano cure particolari che vanno, per esempio, dalla ricucitura di un orlo alla risuolatura di una scarpa, perché anche loro consumano tacchi e suole come gli attori veri. Le parrucche vanno acconciate, gli abiti ripuliti, le scene rinforzate. È un lavoro senza sosta». Lo racconta nell’atelier della compagnia, alla periferia sud di Milano, l’ultimo erede della famiglia, Eugenio Monti Colla, che prese la guida nel ‘66, allora ventiseienne, dopo che da otto anni il teatro si era forzatamente fermato. I primi capitoli risalgono addirittura al 1699, quando il più antico documento attesta già l’attività della compagnia. Attività domestica, perché, come testimonia Goethe nel Meister, secondo la tradizione aristocratica e borghese dell’epoca il teatro delle marionette si faceva in casa. «Ogni palazzo signorile aveva la sala teatro e lo spettacolo lo facevano famigliari e domestici insieme, senza distinzione di classe, tutti messi sotto, chi a cucire i costumi, chi a montare le parrucche — spiega Eugenio Monti Colla —. I preziosi materiali rimasti a Casa Borromeo nell’Isola Madre sono un raro documento di questa consuetudine». I Colla, milanesi, erano proprietari di una serie di rivendite di foraggi e legname, che commerciavano con gli austriaci. Dunque stavano bene. Il teatrino era nell’abitazione di vicolo San Martino, vicino all’attuale via del Corso: ne resta un canovaccio e poco altro. «Le cose co- LA FALCE La Morte (1867) Dallo spettacolo Gerolamo nel castello dei fantasmi di Carlo II Colla Repubblica Nazionale DOMENICA 6 APRILE 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 Guido Ceronetti. La fragile magia del teatro vivente ei ritiene, Guido Ceronetti, che il teatro di marionette abbia ancora un futuro nel corso di questo terzo millennio? Faccio rispondere, per me, il Futuro stesso. «In verità, dice il Futuro, io non so neppure se ancora avrò, io Futuro, un teatro, semplicemente. Tornate fra trentaquarant’anni». La stessa domanda, rivolta al Futuro, cento anni fa avrebbe avuto una ben diversa risposta. Il Ventesimo è stato un secolo di fantastica creatività teatrale, marionette e ogni altro modo di far teatro, fin quasi al suo ultimo decennio. Una frenesia di rinnovamento totale, una rivoluzione permanente… Sarebbero stati immaginabili, quando trionfava il teatro borghese di fine Ottocento, un Copeau, un Artaud, un Gor- L don Craig, un Mejerchold, uno Strehler? E nella marionetta, un Obrazov, la scuola di Charleville, il me stesso a partire dal 1987 — dopo diciassette anni di stagnazione? Era, forse, una febbre, un delirio agonico, una furente creazione del Genio teatrale all’occupazione del Cinema, alla rapina incessante di pubblico televisiva e audiovisiva, malattie risentite mortali. Una resistenza-renitenza eroiche, fino al rarefarsi delle idee, del respiro, di cui il Presente è indifferente, inconsapevole specchio. Il Futuro… mah… Può un teatro vivente, carne e ossa, attori che trepidano e sudano, sopravvivere dove tutto è Spettacolo, tutto è rivedibile e riascoltabile all’infinito? Chi, con questa smisurata pietra a schiacciargli il cuore, può sentire ancora il bisogno del contatto diretto, immediato con una scena vera? Per parecchi anni, (fino all’anno scorso, e vorrei riprovarci ancora) ho fatto teatro di strada, notando il progressivo degenerare dello spettatore: dieci anni fa chi si fermava e guardava-ascoltava non fotografava e filmava, oggi, con l’eccezione dei bambi- ni, il povero teatrante di strada ha davanti a sé non paia d’occhi incuriositi, ma ranghi di cellulari. Una volta presa l’immagine, una o sette-otto volte, se ne vanno. Del tuo affannarti per loro non apprezzano nulla. Lo scorso novembre, al Lucernaire di Parigi, era in programma lo spettacolo di un grande (ma grande davvero) marionettista italiano. Viene annunciato che non si farà perché la sala è vuota. Mandiamo a dire a Massimo Schuster — che ha base a Marsiglia, non in Italia — che, in attesa fuori della sala, ci sono due coppie di spettatori, tutti suoi amici. Generosamente, da attore autentico, Massimo comunica che farà lo spettacolo per noi quattro (in una sala da duecentocinquanta posti): lo regge da solo, è una ricreazione dell’Iliade omerica, un’ora di leggerezza e di bellezza, un capolavoro del marionettismo moderno. Quattro, ma senza lampi al magnesio né cellulari al posto degli occhi: veri spettatori per un vero spettacolo. Però, che facciamo? Si fa una scelta di vita (un marionettista è un galeotto incatenato al remo, un monaco trappista, non ha le risorse degli attori normali, che campano di non-teatro) per risultati di pura fame? Importante: la marionetta va talvolta in televisione, dove fa una retata di soldi, ma a sua volta paga un prezzo crudele, non è fatta per il teleschermo, che ne rimanda un’immagine di morte, di pura negazione d’essenza. Se un giorno a Shakespeare o a Cechov la scena mancasse, gli resterebbe la lunga vita del libro, col ricordo nella prefazione delle messinscene memorabili che furono. Alla marionetta, nulla: è figlia dell’istante. La sua storia comincia dalla preistoria, poco dopo i dinosauri. Si vedrà, domani. SENSIBILI A destra, due disegni di Guido Ceronetti ispirati alle marionette: un progetto per un teatro ambulante del 2004 e la locandina di una mostra del 2002 LA MASCHERA Gerolamo (marionetta del 1890; costume del 1906) ‘‘ La Marionetta e l’Angelo RAINER MARIA RILKE Era la scena un addio… E per primo/ Il Ballerino entrò./ Lui, no! Ne ho abbastanza. Per quel suo lieve/ Agitarsi gli occorre travestirsi,/ Va a cambiarsi, sarà un tizio qualunque,/ Tornato a casa attraversa la cucina./ Venga la Marionetta! Io non voglio/ Maschere mùtile: e questa è l’integra./ La spoglia, il filo e il volto-simulacro/ Che io li regga — qui, stando di fronte./ E si smorzino i lumi, e mi sussurri/ Qualcuno: — È ormai finito — non andrò via./ Resterò là anche se emana il Vuoto/ In una grigia corrente d’aria la Scena,/ E dei miei antenati silenziosi/ Nessuno mi sieda accanto, o una donna,/ O il ragazzo dall’occhio strabico:/ Sempre qualcosa c’è, da vedere/ Non è sbagliato tanto mio attendere!/ E il mio fissare ingordo la ribalta/ Finché non entri — commisurata/ Ai miei sguardi risposta — un Angelo,/ E sia l’Animatore che solleva/ I gusci inerti in alto. Finalmente,/ Nell’abbraccio coll’Angelo la Marionetta/ Dà vita al Dramma. Dalla QUARTA ELEGIA DUINESE Versione di Guido Ceronetti munque cambiarono dopo il 1815. Avendo commerciato anche con i francesi sotto Napoleone, tornati gli austriaci i Colla furono accusati di collaborazionismo. I loro beni confiscati, loro esiliati. Scapparono in Piemonte. Ma riuscirono a nascondere in mezzo ai pagliericci tra tavoli e sedie anche il teatrino con le marionette, perché per vivere cominciarono a fare i marionettisti. Ci sono registri del 1835 che attestano un’attività continuativa, spettacoli, spese, incassi». Il capostipite è Carlo Gioacchino Colla detto, vai a sapere perché, Giuseppe: i suoi spettacoli erano riduzioni dai classici, Molière, Goldoni, Shakespeare. Più avanti il repertorio venne preso dalla Scala. Anche perché, quando dal 1861 i Colla si dividono in tre compagnie, una per ogni fratello (da Giovanni nascerà la Gianni e Co- setta Colla, ancora attiva a Milano nel teatro ragazzi; Antonio morirà senza eredi; Carlo fonderà appunto la Carlo Colla e figli, primo marionettista che associa a sé i figli), qualcosa è già cambiato. «Da teatro aristocratico il teatro per marionette diventa via via teatro popolare. Dopo la seconda metà dell’Ottocento le compagnie si arrogavano il ruolo di mass media di allora, sentivano la responsabilità di divulgare la cultura. Per tutto l’Ottocento e fino a inizio Novecento, solo a Milano agivano sedici teatri e nell’arco Liguria-Piemonte-Lombardia-Veneto si contavano almeno centocinquanta compagnie. Gli spettacoli costavano poco, facevano piangere ma soprattutto divertire perché dalle marionette ci si aspettava qualche tiro mancino verso le autorità. «Fu dopo le due guerre che le compagnie iniziarono a diminuire. L’arrivo del cinematografo fece la sua parte. Negli anni Quaranta e Cinquanta c’eravamo noi e i Podrecca». Dal 1906 i Colla si erano stabiliti nuovamente a Milano, al Teatro Gerolamo. Si sa che ad applaudirli arrivavano Stravinsky e Simone Weil, perfino Gordon Graig. Visconti ci veniva con i suoi assistenti dicendo: «Imparate cosa è la polvere di palcoscenico». «Al Gerolamo restammo fino al ’57 — ricorda Eugenio Monti Colla —. Ci costrinsero ad andar via perché il teatro doveva essere buttato giù. Il trasloco, ricordo, pareva la marcia trionfale dell’Aida: le seicentocinquanta marionette, poi costumi, le parrucche, le scarpe...». Ma il nuovo corso della compagnia è lì davanti a tutti: una rivista semestrale, Boccascena, sul teatro di figura, un archivio informatico, spettacoli, tournée (il 26 IL BUFFONE Rigoletto (1988) per il film Rigoletto di produzione tedesca aprile al Piccolo di Milano tornerà Excelsior, a Siena si fa un Filemone e Bauci), la scuola per manovratori che si riaprirà, e il lavoro di ricerca per rinnovare il repertorio (quarantadue nuovi titoli) e i trucchi scenici. Oggi ci sono marionette anche con trenta fili, tanti sono i dettagli dei loro movimenti. Nella celebre Tempesta di Shakespeare, con la voce di Eduardo, solo per muovere Calibano servono sei persone perché anche le pelose sopracciglia hanno scatti d’umore. «Più si va avanti più ci piace complicare i movimenti: per esempio, se quando Aida canta trema un po’ il polso, è più realistica e affascinante. L’esempio resta Guaranay, lo spettacolo in cui Carlo scoprì il trucco di far scendere il sangue lungo la mano dal braccio ferito. Cioè quando noi ci divertiamo e il pubblico si chiede «ma come faranno?». Repubblica Nazionale 44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 APRILE 2008 i sapori Sembrano finiti i tempi in cui i prodotti del Commercio equo&solidale funzionavano per la coscienza ma non per il palato. E sono finiti L’altro global i tempi in cui era molto più facile per i furbi appropriarsi del certificato che garantisce un prodotto come eticamente corretto Per questo il consumo critico è sempre più diffuso e proverà a contarsi a “Fa’ la cosa giusta”, fiera milanese del prossimo weekend Buono &Giusto Mettersi a tavola senza sensi di colpa Caffè Eccellenti le produzioni in arrivo dalle cooperative di coltivatori e raccoglitori di America latina, India, Etiopia: dai chicchi di Huehuetenango, tostati dalla Cooperativa Sociale del carcere di Torino, al caffè rebelde del Chiapas LICIA GRANELLO a’ la cosa giusta!» strillano i manifesti da to questo resterebbe nell’ambito della coscienza personale, se una parte all’altra di Milano. Come se fosla differenza tra i prodotti delle piantagioni massificate e quelli se facile... La fiera in programma da vedelle cooperative eque, non si potesse vedere, annusare, mornerdì a domenica prossimi, quinto apdere, assaporare. Come per il biologico, all’inizio più che la puntamento nazionale con il consumo bontà ha contato la salubrità di ambiente e alimenti. Ma il temcritico e gli stili di vita sostenibili, cammipo del sano&giusto uguale ammaccato&tristanzuolo è finito. Le na sul sottile crinale che divide l’invito incoraggiante dall’impenuove tecniche di coltivazione e lavorazione, pur senza nulla rativo categorico di kantiana memoria. Da una parte, intuiamo concedere alle scorciatoie delle produzioni intensive, hanno che nutrirci, scegliere, abitare, supportare cibi e oggetaiutato i contadini a alzare gli standard. Così, il felice inti buoni, puliti&giusti ci apre a un futuro migliore. nalzamento della qualità e l’esplosione della cuciDall’altra, non abbiamo facoltà di scelta: o dina globale hanno indotto molti ristoranti d’auventiamo rapidamente eco-compatibili tore a inserire prodotti equi nella lista della con il pianeta che ci ospita, o finiremo maspesa. Oggi non c’è chef bravo e curioso che lissimo. si sottragga al piacere di creare un piatto Per fortuna, ogni giorno la tavola ci con la quinoa, di impreziosire una ricetIl prossimo weekend la vecchia aiuta a fare la cosa giusta senza troppo Fiera di Milano ospita Fa’ la cosa giusta, ta con l’olio di argàn, di corroborare pensarci. Perché cioccolato e caffè, una crema speziata caramellandola quinta edizione della rassegna dedicata zucchero e spezie, cereali e frutta ci con zucchero di canna. conducono nel sud del mondo, tra riIn più, i nutrizionisti gongolano, al consumo critico e agli stili di vita saie e giardini del tè, in un viaggio afperché obbedendo ai comandamensostenibili. Quindici le aree tematiche: fascinante e virtuoso. Bastano un ti dell’agricoltura arcaica la rotazione dalla bio-edilizia alla finanza etica, pizzico di attenzione e un palato godelle colture nutre la terra e mantiene loso per capire la differenza tra le prointatti oligoelementi e sali minerali, dal turismo solidale alla bio-agricoltura duzioni seriali e quelle diseguali, sanon si raffina nulla, la conservazione è Centinaia i prodotti, i alimentari e non, porite, diverse, in arrivo dai piccoli colaffidata a madre natura. Risultato: fibre tivatori. È così che abbiamo imparato a capaci di coniugare qualità e supporto intatte, vitamine e micronutrienti preconoscere sigle come Altromercato, senti in quantità, tossine ridotte al minisociale alle aree più disagiate Ctm, Altreconomia, Commercio mo. Come dire, inversione di tendenza ridel pianeta equo&solidale, Terre di mezzo, in una bella spetto ai cibi plastificati e lotta efficace all’inmiscellanea di solidarietà e ricerca del gusto. vasione della “nutriceutica”, la nuova frontiera Del resto, i confronti sono impietosi. Banane enordell’alimentazione che ci vuole consumatori di cimi, perfette, raccolte verdi e maturate (si fa per dire) in bi fortemente industrializzati e quindi impoveriti, a cui capannoni riscaldati e insufflati di etilene, oppure piccoli frutti un surplus di chimica restituisce le sostanze sottratte. pastosi, portati a maturazione appoggiando i caschi sulla terra, Unitevi alle decine di migliaia di visitatori che nel prossimo fisotto il sole, coperti dalle loro stesse foglie. Oppure noci grandi ne settimana affolleranno la fiera: curiosate, domandate, ma come uova, gusci splendenti e gherigli palestrati paragonate a soprattutto assaggiate. Oppure regalatevi un espresso coi fiocquelle piccole, opache, con un gheriglio consistente e profuchi a due passi dal veneziano ponte di Rialto, dove Bernardo Delmato… la Mea, scopritore del caffè di Huehuetenango, destina parte deNon è solo una questione di consapevolezza etica. Contrigli incassi all’associazione “Bambini del Caffè”. Per ogni tazzibuire a non avvelenare il pianeta, supportare le economie locana consumata, un pezzetto di scuolabus per i figli dei raccoglili, combattere il cancro del lavoro infantile è importante. Ma tuttori. Difficile immaginare qualcosa di più buono, pulito e giusto. «F L’appuntamento Frutta secca Cibo-simbolo delle lotte contadine per un salario equo, le noci amazzoniche (castañas peruanas) vantano contenuti nutritivi vicini a quelli della carne bovina In scia: anacardi, arachidi, semi oleosi, mango e datteri palestinesi Zucchero di canna Può essere cristallino o integrale in due tipologie: panela (succo scaldato, e condensato in panetti poi grattugiati) e moscavo, asciugato per mescolatura e definito dalla presenza di grani di melassa Tè India, Bangladesh, Sri Lanka, Kenya, Singapore, Indonesia, Uganda, Malawi: fuori dai circuiti di broker e multinazionali, il prodotto coloniale viene coltivato in tea garden secondo i principi della biodinamica e raccolto manualmente Riso Sono state censite oltre centoquarantamila varietà In Thailandia, Ecuador e India le produzioni tendono a preservare germe e crusca, ricchi di principi nutritivi Tra le tipologie più note: basmati, hom mali, indica Repubblica Nazionale DOMENICA 6 APRILE 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 Milano Bolzano itinerari Claudio Sadler, chef due stelle Michelin, è tra i protagonisti de “Il gourmet equo e solidale” (Gribaudo Editore): venti ricette d’autore con ingredienti “dell’altro mondo” Sua la speciale crema di mascarpone al tè verde con gelatina di rabarbaro e purè di castagne Una ventina di cooperative di commercio equo & solidale si sono costituite quattro anni fa come editori di Altreconomia. L’informazione per agire, mensile di supporto al passaggio dall’economia di profitto a una economia equa e sostenibile Qui nel 1992 è nato Commercio Alternativo, cooperativa no profit del Commercio equo e solidale (ComES). Cinquanta soci sparsi in tutta Italia commercializzano senza intermediari prodotti alimentari del Sud del mondo, con progetti di supporto sociale DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE HOTEL POST GRIES Corso Libertà 117 Tel. 0471-2790 00 Camera doppia da 98 euro, colazione inclusa BBMILANODUOMO Via Torino 46 Tel. 347-7796170 Camera doppia da 100 euro, colazione inclusa HOTEL CORTE ESTENSE Via Correggiari 4/A Tel. 0532-242176 Camera doppia da 80 euro, colazione inclusa DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE ZUR KAISERKRON Piazza della Mostra 1 Tel. 0471-303233 Chiuso domenica, menù da 60 euro RISTORANTE LIFEGATE CAFÈ Via della Commenda 43 Tel. 02-5450765 Chiuso martedì, menù da 30 euro MAX Piazza Repubblica 16 Tel. 0532-209309 Chiuso domenica a pranzo e lunedì DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE BOTTEGA DEL MONDO Via Alto Adige 6 Tel. 0471-971469 COOPERATIVA CHICO MENDES Via Padova 58 Tel. 02-26112636 FERRARA TERZO MONDO Via Darsena 170 Tel. 0532-774820 Gesti semplici come la spesa liberano i contadini dai coyote Cioccolato Sono oltre venti milioni i lavoratori del cacao Troppi i bambini, su cui si concentrano le campagne di Save The Cildren Il mascao è prodotto con cacao boliviano e domenicano e zucchero integrale filippino Olio Tra gli oli buoni e particolari, c’è quello marocchino di argan (quaranta chili di bacche per un litro d’olio), lavorato da una cooperativa di donne di Marrakesh Delicati quelli di sesamo e di noci peruviane, ricchi di omega6 e selenio Sale Dal Sud del mondo arrivano i sali grezzi di salgemma Tra i più pregiati quello rosa, estratto nelle terre dell’Oceano Primordiale (250 milioni d’anni) situate ai piedi dei massicci himalayani, ricco di elementi naturali e oligoelementi Ferrara Compirà vent’anni a Natale Altromercato, la più importante realtà italiana di commercio equo e solidale, nata nel cuore dell’Alto Adige come Ctm (Cooperazione terzo mondo). Oggi le botteghe sono trecentocinquanta e oltre cento le cooperative consorziate CARLO PETRINI e esiste un commercio “equo e solidale” significa che il commercio normale, di per sé, non ha nessuna connotazione etica? Nel 1825, all’interno della sua Phisiologie du goût, Jean-Anthelme Brillat-Savarin sosteneva che, tra una serie di discipline, «la gastronomia appartiene al commercio, per la ricerca del mezzo di comprare al migliore prezzo possibile ciò che essa consuma e di smerciare più convenientemente ciò che essa pone in vendita». Certo l’intuizione di inserire anche il commercio tra le materie che circoscrivono gli ambiti della scienza gastronomica fu rivoluzionaria, come la definizione stessa che il magistrato francese diede della gastronomia — scienza interdisciplinare e complessa inerente «all’uomo, in quanto egli si nutre» — ma sicuramente Brillat-Savarin non poteva immaginare che un giorno ci sarebbero stati gli intermediari coyote, che il sistema globale del cibo avrebbe amplificato ingiustizie terribili nei confronti di milioni di contadini e che gli equilibri ambientali della Terra sarebbero saltati. Un’irrisoria percentuale dei contadini che coltivano il cacao nel mondo ha assaggiato in vita sua la cioccolata, quelli che coltivano o raccolgono il caffè cercano di sopravvivere con i pochissimi centesimi di euro che del prezzo della nostra tazzina quotidiana giungono nelle loro tasche: i coyote sono i piccoli intermediari che comprano la materia prima a cifre ridicole, per poi farla confluire attraverso altri passaggi nei mercati internazionali, dove diventa commodity, un frutto della Terra il cui unico valore è il prezzo. Piccole oscillazioni verso il basso nelle borse mondiali possono compromettere l’esistenza di centinaia di migliaia di comunità contadine. Qualità del prodotto, valore culturale, sostenibilità ecologica e giustizia sociale sono considerati inutili orpelli che non fanno economia, quindi non dovrebbero essere interessanti per il commercio e chi lo fa. Tant’è vero che le ingiustizie verso i contadini non si registrano solo nelle piantagioni di caffè delle Ande o del Sud-Est asiatico o in quelle di cacao centroamericane e africane. A ben vedere il fatto che i prezzi del nostro cibo quotidiano, nazionale, aumentino inspiegabilmente al dettaglio mentre i nostri contadini lamentano di non riuscire ad arrivare a fine mese ci mette sotto gli occhi l’evidenza che qualcosa si è rotto nei sistemi commerciali dell’agro-alimentare, fino a spingersi nelle campagne appena fuori le nostre città. Parafrasando Brillat-Savarin forse è il caso di dire che non solo «la gastronomia appartiene al commercio», ma ormai ne è il suo ostaggio. Le comunità produttrici, i contadini e anche i cittadini, non riescono più a introdurre elementi di controllo nel sistema e ne sono succubi, esattamente come lo è l’ambiente. Il commercio equo e solidale ha avuto e ha il merito di portare queste problematiche all’attenzione dell’opinione pubblica: consente di non stare al gioco di chi ci impone un sistema ingiusto e in molti casi dà un consistente aiuto ai singoli produttori. Sembrano finiti i tempi in cui i prodotti dell’equo e solidale alla loro valenza etica non accompagnavano una qualità sufficiente, e anche il rispetto per l’ambiente sembra entrato come criterio guida in questo circuito alternativo. Le truffe sembrano oggi essere più controllabili. Il successo presso il pubblico, però, è tale per cui addirittura le grandi multinazionali, che hanno piantagioni nel Sud del Mondo, spesso ottengono questo riconoscimento in virtù di iniziative sicuramente meritevoli ma limitate rispetto all’ammontare del loro volume d’affari complessivo. Questo fa venire meno il principio alla base del commercio equo e solidale: quello di sostenere i piccoli produttori. Sta di fatto che l’equo e solidale è diventato una categoria dell’immaginario collettivo e rappresenta un’alternativa concreta in grado di rispettare sia il consumatore, sia l’ambiente, sia la giustizia sociale. Sono queste le tre caratteristiche qualitative che dovrebbe avere oggi un prodotto alimentare e che, in un mondo perfetto, chi fa commercio dovrebbe utilizzare per comprare e vendere «al miglior prezzo possibile». Ma se etica e commercio fanno ancora così fatica ad andare d’accordo non è il caso di perdere le speranze, in fondo siamo noi che compriamo e sono i contadini che producono: ecco perché andare a comprare — quando è possibile — direttamente dai contadini e privilegiare le produzioni locali e di stagione, può rivelarsi uno dei più semplici atti di commercio equo e solidale che possiamo compiere quotidianamente. S Legumi e cereali Dalla valle di Manduriacos, Ecuador, i fagioli di colori diversi cresciuti sulla stessa pianta. E poi lenticchie, ceci soia, fave, piselli, adzuki Altamente proteici e privi di glutine: la quinoa, dai chicchi sferici e croccanti e il dolciastro amaranto Spezie Oltre ai pepi colorati, aromi senza segreti (cannella, noce moscata, zafferano) e afrori meno noti (cumino, curcuma, cardamomo, coriandolo, originali miscele di curry) usati dagli chef A Modica la cooperativa Quetzal li miscela al cacao Repubblica Nazionale 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA le tendenze Nuovi arredi DOMENICA 6 APRILE 2008 Sta per aprire i battenti a Milano il Salone del mobile Una buona occasione per esplorare la frontiera avanzata del design e censire così i prodotti più futuribili e innovativi dal punto di vista delle forme, dei materiali e dei meccanismi che rendono più versatili gli elementi d’arredo destinati a case con sempre meno spazio PUZZLE D’AUTORE Un sistema composto da dieci moduli in legno serigrafato che si apre e si assembla con cinghie speciali come una matrioska È Assemblage di Seletti Se il tavolo cambia muscoli e pelle AURELIO MAGISTÀ sperimenti. Provare a fare una cosa per vedere che cosa succede. La curiosità del risultato domina sullo spirito ingegneristico che dirigerebbe il progetto a soddisfare un bisogno o a risolvere una funzione. Un designer sperimentatore, di questi tempi, è proprio quello di cui c’è bisogno. L’attenzione verso il design è cresciuta in modo enorme, perfino abnorme. Il design è un virus che sta contagiando tutti gli ambiti, anche il mangiare. Eppure, forse esausto da questo sforzo di colonizzazione, non riesce a esprimere un carattere preciso. Si rivela proteiforme. Neobarocco e residui minimalisti convivono senza imbarazzi, ma questo è possibile in virtù del loro limite: un’identità debole. Esperimenti. Forse diranno qualcosa di nuovo, qualcosa che sia più di un esercizio di stile. Dal Salone del mobile che sta cominciare, bulimico appuntamento milanese che è ormai la stella polare dell’arredamento per tutto il mondo, estraiamo qualche caso, inevitabilmente eterogeneo proprio per quello che si è appena detto. Esperimenti. Che si concentrano soprattutto su tre elementi: le forme, i materiali, i meccanismi/movimenti che rendono il mobile trasformabile, mutevole, adattabile. Alla famiglia degli esperimenti formali si può attribuire la poltrona nera di Altamoda che domina questa pagina, un trono neobarocco, un monolite che combina un protervo e incombente nero seicentesco con l’ironia e la bizzarria di frivole piume, glitter e gambe a coppie diverse. Ma ancora più interessante è Bouquet, di Patricia Urquiola per Moroso. La Urquiola quest’anno firma la principale collezione di Moroso, casa con cui ha un feeling speciale. Bouquet ne è esempio eccellente: una poltroncina che su un piedistallo tondo e un esile stelo di metallo cromato compone, appunto, un bouquet di moduli di tessuto quadrato, un puzzle sartoriale che diventa una complessa corolla di colori tenui. Tra gli esperimenti con i materiali, due casi esemplari, perché opposti, sono rappresentati da Bisazza e Poltrona Frau. Opposti perché Bisazza, proseguendo uno sviluppo fortemente voluto negli anni, declina il mosaico, tecnica antica e gloriosa come la ceramica, nella prima collezione di mobili, dopo aver fatto qualche esperimento con i sassi-seduta-tavolino Coffee Table. Invece Poltrona Frau sceglie il corian, innovativo materiale che si può definire la versione hi-tech della ceramica, per rinnovare grazie all’estro di François Russo la poltroncina da regista, quella con le gambe a X e lo schienale in tessuto che in questo caso, omaggio allo stile della casa, è di cuoio. Anche il nome è un omaggio: Helleu, da Jacques Helleu, direttore creativo storico di Chanel. Esperimenti su meccanismi e movimenti. Spesso sorprendenti, rispondono alla domanda di versatilità e sono salvaspazio. Assemblage, per esempio, mobile contenitore di Seletti, è composto da una serie di scatole-matrioska che, smontate, spariscono tutte nel relativo ingombro della più grande fra loro: montate, vengono tenute insieme da tiranti che gli conferiscono un curioso senso di provvisorietà. Square 2 Squaredi BBB Emmebonacina e Kada di Danese sono la dimostrazione di come, pur avendo in comune l’ispirazione, si possano trovare conclusioni diverse. Sia il primo, un tavolo progettato da Yotam Shabtai e Lidor Gil-Ad, sia il secondo, uno sgabello di Yves Béhar, hanno un evidente debito verso l’origami giapponese. Il tavolo si spiega fino a diventare più grande, per dodici. grazie a un sofisticato meccanismo: il piano ruota di sessanta gradi, la sezione quadrata centrale si abbassa e quattro sezioni triangolari si aprono a libro: dove c’era un lato, adesso si trova uno spigolo. Lo sgabello si piega praticamente a due dimensioni, pronto a scomparire negli interstizi tra mobili e pareti. E OCCHI INDISCRETI Un divanetto accogliente, che ospita e nasconde per creare intimità Alcova è stato disegnato dai fratelli Bouroullec per Vitra. A due o più posti, ha schienali pieghevoli PIETRE PREZIOSE Coffee Table è una famiglia di grandi “massi domestici”, tavolini decorati in mosaico di vetro. Ideati dal designer Marcel Wanders, fanno parte della prima collezione di oggetti d’arredo di Bisazza COME UN ORIGAMI Si piega come un origami giapponese il tavolo Square 2 Square di BBB Emmebonacina: il piano ruota di sessanta gradi permettendo alle ali di aprirsi a libro sul proprio asse Ospita fino a dodici coperti Repubblica Nazionale DOMENICA 6 APRILE 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 47 IL PIEGHEVOLE Kada è un sistema pieghevole che si presta a vari utilizzi: vassoio, sgabello, tavolino Per trasportarlo basta piegarlo Di Danese CURVE PERICOLOSE Un forma a nastro che si snoda come un’autostrada formando sedute e braccioli: Highway è la seduta da comporre di Segis Il designer Denis Santachiara “I miei oggetti fuori di testa mix di tecnologia e gioco” ALESSANDRA RETICO utodidatta, ha cominciato con le macchine. «Perché automobile è un po’ tutto: è tecnologia, è salotto, velocità, ergonomia». Denis Santachiara, classe 1950, nato a Campagnola (Reggio Emilia), è uno di quei creativi cui piace il design dell’invenzione, della sperimentazione. Le sue opere sono esposte al MoMA di New York, al Musée des Arts Decoratifs del Louvre di Parigi, al National Museum of Modern Art di Tokio, al Philadelphia Museum e al Vitra Museum di Berlino. «Mi interessa — dice — la capacità comunicativa delle cose». Ci spieghi. «Devo partire da una mostra che feci nell’84 alla Triennale di Milano e al Centre Pompidou a Parigi, si intitolava Neomerce, il design dell’invenzione e dell’estasi artificiale. Una mostra-manifesto che aveva l’obiettivo di superare il tradizionale concetto italiano di “buon design”: volevamo staccare l’estetica dalla funzione, far parlare non solo la forma ma mettere in luce la capacità performativa degli oggetti dal punto di vista linguistico. Il mio motto era: non bisogna disegnare solo il personaggio ma anche le sue gag. Mi interessava il prodotto più che il suo disegno, quello che un oggetto sa fare e comunicare, il suo “modo d’essere” piuttosto che la sua plasticità. Per me un oggetto intelligente e rispettoso dell’ambiente (in senso spaziale) è quello che sa trasformarsi con l’uso, sa essere organico al contesto e alla fine sa “essere”. Mi piace la ricerca delle possibilità, la tecnologia ne offre molte». In questo le sarà stato utile il suo esordio tra i motori. «Ho cominciato nella carrozzeria del gruppo De Tommaso. Nella mia zona, quando ero ragazzo, quello si faceva e poi l’auto era nell’immaginario di tutti noi, era il mito della velocità ma anche del salotto, era meccanica ed estetica. Ho imparato molte cose tecniche, mi è rimasto soprattutto l’incanto di poter realizzare prodotti sensati e insieme giocosi, prestanti ma anche con una dose di immaginifico, materiali e virtuali». Qualche esempio? «Il mio “Pisolo”, puf che diventa letto, l’appendiabito che si fa pulisciscarpa, o la poltrona che presenterò al Salone, creata per Dema: si gonfia, si sgonfia, si allunga e massaggia. Quando uno la compra, se la porta via dentro una valigetta, e spende poco». Oggetti trasformabili per generazioni nomadi? «Anche oggetti “fuori di testa” come dico io e come ho imparato da Alessandro Mendini. Tecnologia ludica, comunicazione di emozioni. Ho fatto una serie di cannocchiali usando un metodo assolutamente ortodosso, il sistema di Galileo, poi però ci ho infilato lo scherzo: le stelle si vedevano a colori. Un oggetto speciale, come ci piaceva chiamarlo con Mendini, e infatti nella sua rivista Modo cominciai a pubblicare i miei lavori. Dietro c’era una poetica: sperimentare attraverso la tecnologia nuovi usi e linguaggi delle cose. Tenendo nascosto lo sforzo tecnico per far emergere la sorpresa e l’effetto, come appunto nella poltrona di cui dicevo: l’imbottitura sembra normale, la seduta come le altre, e invece dietro c’è un meccanismo di aria compressa mutuata dall’ingegneria aeronautica. Sul sedile un sistema di placche vibranti per i massaggi: si anima e anima. “Good vibrations” si chiama. Mi piace questa organicità delle cose che si muovono come fossero vive. Parlano con chi le usa, vanno incontro. Merce di intrattenimento, simpatica, interattiva. Insomma, per me gli oggetti devono raccontare qualcosa, e saper fare qualcosa. Esprimere una performance comunicativa». Quali materiali si prestano meglio allo scopo? «Io utilizzo le cosiddette subfurniture, materiali finiti e pronti. Mi piacciono le fibre ottiche che uso già dagli anni Ottanta, la luminescenza dei tessuti, la sensitività di certe texture, i colori che sprigionano». Sostenibilità. Può rappresentare la prossima frontiera del design? «I temi ecologici stanno diventando sempre più centrali per molte aziende. Dal mio punto di vista non entrano nella creazione come linguaggio poetico. Come discorso etico e politico sì, ma è un’altra questione. Credo che, piuttosto, la sfida più concreta sarà quella di trovare soluzioni per abitare in spazi sempre più ristretti. Soluzioni concrete e insieme sognanti: dunque oggetti trasformabili ma che dentro contengano un racconto, una finzione, un’emozione». A A TUTTO TONDO Ispirato al mondo circense, Le Cirque di VGnewtrend è una grande seduta realizzata assemblando tasselli di legno tropicale TRAVASO D’IDEE CLASSICO DARK Altamoda propone una sedia dark che rivisita le linee classiche (gambe intagliate e schienale alto) con applicazioni di glitter e marabou IL MIO BOUQUET Sulla poltroncina Bouquet, disegnata da Patricia Urquiola, sbocciano petali in tessuto. Di Moroso Sembra la sezione di un grande vaso la seduta informale +13 di Casamania. A uno, due o tre posti, si usa in esterni e giardini ACCOGLIENZA ESTERNA La particolarità di Canasta, divano per esterni di B&B, sta nell’intreccio che dà origine alla struttura in nastro di polietilene. Disegno di Patricia Urquiola Repubblica Nazionale 48 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 APRILE 2008 l’incontro Femmes fatales Eterna insoddisfatta ma mai pentita, la “signora della porta accanto” detesta le medaglie, lo status borghese e le sicurezze che vengono dall’avere piuttosto che dall’essere E parlando degli uomini che ha avuto, si sbilancia: “Ho sempre legato l’amore alla follia, qualcosa che prende, inquieta, leva l’ossigeno L’amore è la ricerca dell’eccesso, dell’impossibile. E credo che un tempo la cura per una come me sarebbe stata l’elettroshock ” FannyArdant uando Fanny Ardant entra al Trocadéro Café in un sabato mattina come tanti, Parigi sembra fermarsi per un attimo. Il proprietario del bistrot smette di fare i conti e indossa precipitosamente una giacca per andarle incontro. Le signore, sedute ai tavolini, non parlano più e la guardano. Gli uomini trattengono il respiro. Solo lei corre. Arriva arruffata e trafelata. Anche se è in ritardo di appena cinque minuti. Una donna grande, imponente. Vera. Ha una giacca chiara e dei pantaloni classici. Gli occhiali da sole enormi. Muove l’aria velocissima e, quando si siede sul divano, il locale ricomincia a vivere. Come dopo un lungo sospiro. Anche lei sospira e gli occhi, che da vicino sono più neri del carbone, si stringono e diventano una fessura. Ha da pochi giorni finito di lavorare per il teatro, è stanca. «Il palcoscenico purifica il sangue di un’attrice e io devo recitare regolarmente proprio per ripulirmi dentro». Però è una fatica immensa. «Il teatro è violento e senza misericordia, il pomeriggio quando vado a lavorare mi sale una rabbia incontenibile e penso che sarà l’ultima volta, poi quando arrivo dietro le quinte capisco che è il più bel mestiere del mondo». Lei, del resto, che sarebbe voluta diventare attrice lo ha sempre saputo. Da ragazza ha studiato scienze politiche all’università perché era la facoltà più corta. «Ho scelto la via più breve per fare contenti i miei genitori che pensavano il mio fosse un capriccio di gioventù, la laurea è stata un passaporto per la libertà». Ma non è stata una perdita di tempo, anzi. «Penso che la vita ha più immaginazione di noi e quegli anni mi hanno arricchito di tante esperienze che poi sono tornate utili». Certo, quella dell’attrice poteva sembrare una bizza. Una stravaganza. Perché il capriccio “madame” lo ha nel dna. «Quando ero giovane dicevo di no a tutto e tutti e forse, solo oggi, capisco perché. Era la mia ribellione al fatto di essere cresciuta in un posto strano come Montecarlo». Il padre era ufficiale di cavalleria governatore del Palazzo Grimaldi e lei, guardandosi attorno, pensava una cosa sola: «Non sarò mai così». Ancora adesso difende i suoi valori di ragazza di provincia e rivendica la scelta di trattare tutti allo stesso modo. Beve un bicchier d’acqua. Tormenta la bottiglia e ricorda gli inizi sul palcoscenico, le lezioni, il corso di arte drammatica di Périmony a Parigi. «Nella mia carriera nulla è stato facile e ho sempre faticato perché sentivo che c’era qualcosa che volevo farmi perdonare. Non mi sono mai considerata arrivata, è come se ci fosse sempre una cosa che mi scivola dalle mani. Sono un’eterna insoddisfatta e, con gli anni, mi sono chiesta se la vita non sia proprio questo: raggiungere qualcosa che ci sfugge». Poi è passata al cinema. Decisamente più adatto alla sua natura d’impaziente. Con quella giusta schizofrenia che la cattura. La possibilità di essere un personaggio e, nel film successivo, il suo opposto. Ha esordito con L’uomo dei cani di Alain Jessua. Quindi La signora della porta accanto, La famiglia, Finalmente domenica, Bolero, Callas forever. L’hanno diretta i più noti registi da François Truffaut, Claude Lelouch, Ettore Scola, Michelangelo Antonioni, Sydney Pollack. Ha lavorato con attori come Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni. Sono stati grandi perché non erano attori, diventavano quello che recitavano. La loro potenza era far dimenticare la macchina da presa. «Recitare una volta sola con un attore non è mai abbastanza. Gassman era forse più impaziente di me, io al principio ero timida e lui mi ha come martellata nell’argilla. Philippe Noiret rappresentava l’eleganza ironica, JeanLouis Trintignant sembrava fatto per il set». E proprio di Gassman conserva un ricordo struggente: «Era il più intelligente di tutti, con la sua problematicità è stato il vero personaggio tragico ma ha sempre avuto la forza, anche quando stava molto male, d’incoraggiarmi». Insomma, Fanny potrebbe considerarsi una regina. Invece lei non accetta l’elogio. L’adulazione. Lo stato d’icona. Ancora una volta, con la stessa cocciutaggine con cui ha deciso di vivere, si accanisce contro i riconoscimenti. Si alza dal divano, si agita. La voce arrotata dall’accento francese sale di due toni: «Detesto le medaglie, il marito ricco, lo status, determinare chi nella vita ce l’ha fatta e chi no. Cosa vuol dire? O tutti riusciamo o tutti sbagliamo, la serenità non viene dall’avere ma dall’essere. Non ci deve essere avidità ma ricerca dell’intenso». I suoi film, comunque, le hanno dato tanto. Di più, lei è stata parte di loro. E viceversa. «Quello che prova la sfortunata eroina de La signora della porta accanto è esattamente ciò che io penso dell’amore. Tante volte mi sono domandata cosa poteva succederle di peggio e la risposta è sempre la stessa: tornare alla vita borghese, al marito che non ama, ai salotti ben arredati, la morte talvolta pulisce e non è vero che sia peggiore della vita». Una posizione dura e tetragona. La Ardant è una donna che non sembra conoscere pentimenti: «Non vorrei mai cambiare quello che ho fatto e l’importante è aver vissuto, come bene supremo. Io del resto sono convinta che tutto ha un prezzo e sono sempre pronta a pagarlo fino in fondo, non penso di essere vittima delle ingiustizie della vita». Anche nel suo lavoro non ha mai cercato di sembrare diversa. Migliore. L’eroina che tutti amano è un personaggio scontato. Molto più interessante stare dall’altra parte: «Posso tranquillamente recitare la parte di una donna che tutti detestano e che solo io amo». In questo suo modo ribelle, sopra le righe Il teatro èviolento, senza misericordia, ma purifica il sangue di un’attrice È per questo che io devo calcare il palcoscenico, recitare regolarmente per ripulirmi dentro FOTO EYDEA Q PARIGI e senza compromessi, ha fatto impazzire tanti uomini. Ha avuto tre compagni importanti che poi sono stati i padri delle sue figlie: Domenico Leverd, François Truffaut e l’italiano Fabio Conversi. E altri amori intensi come quello con Gerard Depardieu. Nelle storie non si è mai tirata indietro. Non conosce il verbo risparmiarsi. «Ho sempre legato l’amore alla follia, qualcosa che prende, inquieta, leva l’ossigeno. Considero assurdo pensare di associare il sentimento alla serenità e, al contrario, lo identifico con la ricerca dell’eccesso, dell’impossibile. La vita vissuta con gioia è il capolavoro di due persone che hanno realmente saputo cos’è l’amore». Nel suo modo estremo, non ricorda neanche gli addii. Chi ha lasciato, una volta che la passione è esaurita, diventa un dettaglio. Le sofferenze, quelle che alle altre donne fanno perdere il sonno, le strappano un sorriso indulgente: «Non mi ricordo dell’amore degli uomini nei miei confronti, ma solo del mio verso di loro. Di certo non posso dire che mi hanno adorato, sicuramente li ho più annoiati con i miei eccessi e le follie. Credo che un tempo la cura obbligatoria per una come me sarebbe stata l’elettroshock». Neanche per la bellezza la Ardant sembra voler accettare onorificenze. Lei che ha fatto dire a Truffaut: «Seduce con la sua grande bocca, i suoi grandi occhi neri, il suo viso in un triangolo». Lei cerca altro, quello che non si può descrivere. «Mi sono sempre vista come un animale e pensavo che la bellezza andasse coltivata. Ho cominciato a truccarmi quando avevo quindici anni e non ho mai smesso. Il fascino delle donne incanta per qualcosa che non si può definire, per un sorriso, un modo di toccare i capelli. In fondo è come un albero, non ti piace perché è bello ma per come il vento muove le foglie». Suona il cellulare, risponde garbatamente e si scusa. Quando sorride sembra una ragazza. E, invece, il prossimo anno compirà sessant’anni. Ma non ha paura dei compleanni. Meno ancora della vecchiaia. «Io aspetto costantemente di morire, quindi ogni compleanno è un regalo. Il mio timore è solo per quelle malattie che riducono il cervello. Annebbiano la mente. Temo di non poter più leggere, che è la mia droga. La vera paura è di non arrivare lucida alla fine. La nostra epoca ci costringe a mostrarci giovani sino a ottant’anni ma è un grande bluff, la società non aiuta. Invece credo di poter dire che la morte è l’ultima sfida appassionante che ci spetta, basta non nasconderla a se stessi». Fanny Ardant non è solo una femme fatale. È anche una madre. Ha infatti avuto tre figlie: Lumir, Josephine e Baladine. Con loro il rapporto è una composizione di pieni e di vuoti. In passato per tanti mesi, a causa dei film o delle tournée, è stata lontana da casa strug- gendosi dalla malinconia. Poi per periodi altrettanto lunghi è riuscita ad avere le bambine con sé. Vicine, vicine. Una corsa affannosa per recuperare il tempo e per giocare insieme. «Penso che la famiglia uccida, invece i bambini sono una cosa meravigliosa, fanno vedere la vita come un campo di rose e soprattutto fanno ridere. Delle mie figlie conservo le sensazioni delle piccole mani nelle mie quando le portavo a visitare Roma. L’impressione è di averle sempre trascinate con me, quasi tirandole incontro alla vita». Sulla Francia al centro di tanti pettegolezzi, soprattutto per le storie sentimentali legate a Nicolas Sarkozy, non si pronuncia se non con un commento tranchant: «Credo che le vere passioni siano clandestine». Per una donna così complessa la psicanalisi poteva essere quasi un passaggio scontato. Il lettino dell’analista un rifugio naturale. Ma al sol pensiero sorride: «Considero quella dell’analista una figura epica, quasi da romanzo russo. Nel mio palazzo c’è un analista e ogni tanto, nelle mie fantasie, vorrei suonare alla sua porta ma poi mi fermo perché mi vergognerei di raccontarmi ad un estraneo. La verità è che preferisco la mia strada con le pietre ad un sentiero liscio ed asfaltato». La luce di Parigi la illumina dalla vetrata del Trocadéro. La signora della porta accanto deve andare. Ma nonostante il clima mite non parte per il fine settimana. Non ama muoversi dalla città. «Detesto viaggiare perché ci sono troppi turisti e la mia gioia è stare a Parigi, che considero il centro del mondo. Adoro Tel Aviv mentre penso che alcune città, come New York, siano destinate a scomparire. Prima c’era la condizione operaia ora c’è quella di turista». Si alza, dimentica gli occhiali sul tavolo e, una volta arrivata fuori, torna precipitosamente indietro. Questa volta la vita del Trocadéro Café si è fermata due volte. ‘‘ IRENE MARIA SCALISE Repubblica Nazionale
Scarica