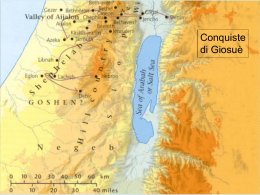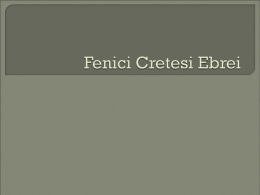Dalla parte di Israele, come discepoli di Cristo di Marcello Cicchese Per secoli gli ebrei sono stati considerati un gruppo sociale accomunato da una religione superata e opposta a quella vera, con un passato storico negativo e un presente politico che costringeva le nazioni in cui si trovavano a porsi ogni volta il problema della loro presenza su una terra che non apparteneva a loro. Dal 70 al 1948 d.C. gli ebrei non hanno più avuto una terra, non sono più stati una nazione e la loro presenza è stata considerata un continuo intralcio storico, qualche volta tollerato con benevolenza e con risvolti anche positivi, ma nella maggior parte dei casi subito come una specie di maledizione. «Gli ebrei sono la nostra disgrazia», è la conclusione che in molti casi si traeva quando le cose andavano male e la gente trovava conforto in una spiegazione semplice che accomunava tutti, a parte gli ebrei. L’avvento dell’Illuminismo, con il conseguente declino dell’influenza della Chiesa sulle società europee, rese sempre meno plausibile la diversificazione degli uomini sulla base della religione. Non si abolì del tutto l’idea di Dio: generosamente gli si lasciò il diritto all’esistenza, ma gli si tolse il diritto di parola. Da quel momento Dio, non potendo più parlare, non poté più dire qual è la religione giusta e quale quella sbagliata: dovette accontentarsi di aver creato il mondo e di continuare a produrre esseri umani tutti uguali tra loro quanto ai diritti, anche se suddivisi in vari gruppi socialmente e politicamente organizzati chiamati “nazioni”. Attenzione però: la suddivisione in gruppi nazionali non doveva avere niente a che fare con Dio, come ai tempi della “cuius regio, eius religio”: il riferimento a Dio doveva restare un fatto individuale, un diritto intangibile della singola persona che non doveva interferire con la struttura politica della nazione. Anche gli ebrei, quindi, da quel momento furono considerati come tutti gli altri: furono “emancipati”. Non poterono più essere esclusi per il fatto che si riferivano a Mosè e alla Torà invece che a Gesù Cristo, ma neppure dovevano pensare di avere diritto a un trattamento particolare. Si poteva essere ebrei, cristiani, atei o altro ancora, ma bisognava essere leali verso la nazione di cui si faceva parte. Così si pensava, almeno fino a un secolo fa. La maggior parte degli ebrei, anche se non tutti, accettò questa situazione. Dopo tanti secoli di emarginazione e limitazioni, l’idea di avere - come i non ebrei - libertà d’azione in una terra da poter considerare - insieme ai non ebrei - come loro patria, era troppo attraente. La cosa cominciò con Napoleone. “Napoleone, ormai Imperatore dei Francesi (dal maggio 1804) vuole avere il dominio e il controllo su tutti. Siccome le popolazioni dell’Alsazia e Lorena presentarono all’Imperatore le loro lagnanze attribuendo agli Ebrei la causa di tutte le loro sciagure, Napoleone volle esaminare il problema ebraico: nel 1806 esso fu discusso due volte al Consiglio di Stato; e in lui maturò l’idea di convocare il Sinedrio. Un Napoleone non poteva accontentarsi di una semplice Assemblea rappresentativa; doveva essere il Sinedrio, come nei tempi antichi, autorevole e venerando come l’antico Sinedrio, di cui doveva essere una copia precisa. Nel luglio del 1806 si riunì a Parigi l’Assemblea dei notabili ebrei composta da 112 deputati [...] Al Sinedrio fu presentata la seguente dichiarazione: "L’Ebreo considera il suo paese natale come sua patria, e ritiene suo dovere difenderla" . E tutti i delegati, in piedi, gridarono: "Fino alla morte!"1 Quasi mezzo secolo dopo, non più in Francia ma in Germania, nel 1848, il rabbino di Magdeburgo scrisse sul giornale “Allgemeine Zeitung des Judentums”, di cui era direttore, parole accorate in difesa della fratellanza ebraico- tedesca: 1 Breve storia degli Ebrei d’Italia, Morasha, internet “Smetteremo di considerare il nostro un caso speciale; è tutt’uno con la causa della patria: insieme i due vinceranno; insieme falliranno. Siamo tedeschi e non desideriamo essere altro! Abbiamo una patria tedesca e non ne desideriamo altre! Non siamo più israeliti se non nella nostra fede religiosa - in ogni altro rispetto apparteniamo davvero allo stato in cui viviamo”.2 Quanto all’Italia, la situazione era ancora più chiara: “In realtà, dal 1870 in poi, sino al fascismo e ancora dopo - per molti sino quasi alle persecuzioni razziali - la maggioranza degli ebrei italiani imboccò con estrema decisione e percorse a grandi passi la via dell’assimilazione, fondendosi organicamente con il resto degli italiani. Abbandonati i ghetti, abbandonate le tradizionali attività, andati a vivere tra gli «altri», entrati e rapidamente affermatisi nelle attività sino allora precluse - la burocrazia, l’insegnamento, la carriera militare, ecc. - e ovunque accolti senza resistenze e addirittura con simpatia, i più di questi ebrei si italianizzarono anche psicologicamente ed intellettualmente.” 3 Vi erano dunque francesi di religione ebraica, tedeschi di religione ebraica, italiani di religione ebraica. L’elemento primario a cui si prometteva lealtà era la nazione, mentre la religione restava un fatto individuale che non serviva più a delineare i contorni netti di un gruppo sociale, ma anzi era spesso causa di contrasti supplementari in seno alla nazione. Si videro dunque, durante la prima guerra mondiale, ebrei francesi, tedeschi e italiani ammazzarsi in piena coscienza fra di loro in quanto appartenenti a nazioni diverse in lotta, a cui ciascuno aveva giurato fedeltà. Lealmente mantennero la promessa di essere prima francesi poi ebrei, prima tedeschi poi ebrei, prima italiani poi ebrei. Il risultato fu che si trovarono insieme come ebrei, presi a calci da tutti: francesi, tedeschi e italiani. La motivazione di fondo addotta dai persecutori fu la scoperta che l’ebraismo non è soltanto una religione che regola il rapporto del singolo con Dio, ma è prima di tutto un’appartenenza a una realtà sociale che, non essendosi potuta chiamare per molti secoli “nazione”, è stata chiamata con i nomi di “razza”, “stirpe”, “tribù”, “genìa”, “internazionale ebraica” e altri titoli dalla risonanza più o meno sinistra. Nei momenti cruciali sorge quindi nei nazionalisti il sospetto - o torna utile sollevare strumentalmente l’accusa - che l’ebreo finga di essere fedele alla nazione a cui appartiene, mentre in realtà rivolge la sua fedeltà primariamente alla comunità dei suoi fratelli ebrei. Con conseguenze altamente dannose per la nazione. Può essere portato ad esempio proprio il caso degli ebrei italiani, che per molti anni hanno partecipato attivamente e in modo convinto prima al risorgimento e poi anche al fascismo. Quando il governo fascista decise di imboccare la strada della discriminazione razziale, cominciarono ad uscire sulla stampa articoli che non volevano presentarsi come manifestamente antisemiti, ma esponevano “perplessità” sulla fedeltà degli ebrei alla causa nazionale fascista. Il 12 settembre 1936, il giornale del gerarca Roberto Farinacci, «Il regime fascista», pubblicò un fondo dal titolo Una tremenda inquisitoria, in cui a un certo punto vengono nominati gli ebrei. “Dobbiamo confessare che in Italia gli ebrei, che sono una infima minoranza, se hanno brigato in mille modi per accaparrarsi posti nella finanza, nella economia e nelle scuole, non hanno svolto un’opera di resistenza alla nostra marcia rivoluzionaria. Dobbiamo confessare che hanno sempre pagato i loro tributi, obbedito alle leggi, compiuto anche in guerra il loro dovere. Ma essi tengono purtroppo un atteggiamento passivo, che può suscitare qualche sospetto. Perché non hanno detto mai una parola che valga a persuadere tutti gli italiani ch’essi compiono il loro dovere di cittadini per amore, non per timore o per utilità? Perché non dimostrano in modo tangibile il proposito di dividere la loro responsabilità da tutti gli ebrei del mondo, che mirano ad un solo scopo: al trionfo della internazionale ebraica? Perché non sono ancora insorti contro i loro correligionari, autori di stragi, distruttori di chiese, seminatori di odî, sterminatori audaci e malvagi di cristiani?... 2 3 “Allgemeine Zeitung des Judentums”, 12, 1848, p. 210. Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi 1993, p. 19. Si sta generando la sensazione che fra poco tutta l’Europa sarà teatro di una guerra di religione. Non se ne accorgono essi? Siamo già sicuri che da più parti si griderà: noi siamo ebrei fascisti. Non basta. Bisognerà dare la prova matematica di essere prima fascisti, poi ebrei.” 4 Ecco dunque l’accusa periodicamente ricorrente: la doppia nazionalità dell’ebreo, di cui la più importante non sarebbe la nazione in cui vive, ma l’internazionale ebraica o, adesso, lo Stato d’Israele. Quanto alla tenebrosa internazionale ebraica, ci si potrebbe chiedere come mai non si è sentito il bisogno di parlare, con altrettanto alone di mistero, di internazionale cattolica o internazionale islamica, anche in considerazione del fatto che i fedeli di ciascuna di queste due religioni superano il miliardo, mentre gli ebrei in tutto il mondo non superano i 16 milioni. Se si trovasse un libello in cui fosse scritto che il Vaticano sta coltivando il progetto di dominare il mondo attraverso la sua rete bancaria, la sua struttura gerarchica piramidale, i suoi ordini religiosi, le sue società più o meno segrete come la Compagnia di Gesù o l’Opus Dei, il suo accesso ai media internazionali con cui il Papa influenza tutti i giorni l’opinione pubblica, non sarebbe più verosimile dei “Protocolli dei savi anziani di Sion”? Sarebbe ragionevole pensarlo, ma sembra che quando si tocca il tema “ebrei” o “Israele” molti smarriscano gli usuali punti di riferimento logici e si avventurino in uno mondo fantasioso in cui non valgono più gli usuali principi di razionalità. Potrebbe essere un’anticipazione della profezia biblica in cui Dio dice, riferendosi agli ultimi tempi: «Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti» (Zaccaria 12:2). Potrebbe essere, ma non è detto. Però si direbbe proprio che per qualcuno una certa forma di stordimento sia già cominciata. Nostalgia della nazione ebraica Le considerazioni fin qui fatte possono aiutare a rendersi conto che dalla fine dell’Ottocento la cosiddetta “questione ebraica” si è posta in una forma nuova perché ha cominciato a ruotare intorno al concetto di nazione. Da allora non è stato più possibile esaurire il problema rispondendo alla domanda su come trattare gli ebrei come individui, o come gruppo sociale di persone aventi certe proprietà comuni tra cui, in modo particolare ma non esclusivo, il credo religioso. L’emancipazione avrebbe dovuto risolvere il problema individuale: gli ebrei sono cittadini come tutti gli altri. La libertà religiosa avrebbe dovuto risolvere il problema comunitario: gli ebrei possono aggregarsi come vogliono per rendere culto al loro Dio nelle forme che ritengono più opportune. Ma naturalmente tutto questo avrebbe dovuto svolgersi nell’ambito di ciascuna nazione, perché gli ebrei - così si pensava, e così molti ancora pensano - costituiscono un gruppo religioso con particolari usanze comuni, ma non una nazione. Poiché la nazionalità di ciascuno di loro è data dal paese in cui vivono, ci si aspetta che le credenze religiose non intralcino la partecipazione al comune sentimento nazionale. Per molti ebrei occidentali, in particolare tedeschi e italiani, questo è avvenuto. Fino alla Grande Guerra il processo di assimilazione è andato avanti in modo spedito e la maggior parte degli ebrei era pienamente soddisfatta di aver trovato una patria in cui essere accolti, di potersi sentire a casa propria e, se necessario, di soffrire con gli altri per la difesa dei sacri confini. Le cose invece sono andate diversamente nell’Europa dell’est. Anche in quelle zone si era avviato, sia pure molto lentamente, un graduale processo di emancipazione degli ebrei. Leon Pinsker (1821-1891) fu uno dei primi esponenti del mondo ebraico russo che poté accedere agli studi universitari. Si laureò in medicina e in un primo tempo fu tra quelli che cercarono di favorire il 4 Renzo De Felice, ivi, p. 207. processo di assimilazione. Si adoperò per la fondazione e la diffusione di periodici scritti appositamente in lingua russa al fine di favorire l’abbandono da parte degli ebrei dell’yiddish, la lingua del ghetto che impediva i rapporti con il resto della popolazione. Ma dopo il 1870 si susseguirono nell’impero zarista ondate di pogrom che indussero Pinsker a rivedere la sua posizione assimilazionistica e a pubblicare, nel 1882, un pamphlet in lingua tedesca, ormai diventato classico, dal titolo “Auto-emancipazione”. Più che nelle proposte operative, il punto fondamentale di questo magistrale libretto sta nell’individuazione del motivo profondo che secondo l’autore sta alla base dell’antisemitismo moderno: l’assenza di una nazione ebraica e la mancanza negli ebrei di un adeguato sentimento di identità nazionale. Varrà la pena di fare lunghe citazioni di questa opera, che in alcuni casi contiene parole dal tono quasi profetico. “Come nei tempi passati, l’eterno problema che si chiama questione ebraica agita ancora oggi gli uomini. Esso rimane insoluto come la quadratura del cerchio, con la differenza che continua ad esser tuttora il più ardente problema fra i problemi del giorno. Ciò è dovuto al fatto che non si tratta soltanto di un problema teorico, ma di una questione che la vita reale stessa rinverdisce quotidianamente e di cui imperiosamente chiede la risoluzione. Il problema, come noi lo vediamo, consiste essenzialmente in questo: che gli ebrei formano di fatto, in mezzo alle nazioni fra cui vivono, un elemento eterogeneo che non può essere assimilato, che non può essere facilmente digerito da nessuna nazione. [...] Agli ebrei manca la maggior parte di quegli attributi che costituiscono i caratteri essenziali d'una nazione. Manca loro quella sostanziale vita nazionale che è inconcepibile senza una lingua comune, senza costumi comuni e senza un territorio comune. Il popolo ebraico non ha patria, per quanto ne abbia molte; non ha un punto di raccolta, non ha un centro di gravitazione, né un governo proprio, né un istituto rappresentativo. Gli ebrei sono dappertutto e nessun luogo è la loro casa. I popoli non hanno a che fare con la Nazione ebraica, ma sempre e soltanto con gli individui ebrei. Gli ebrei non sono una nazione, poiché manca loro quel preciso carattere nazionale distintivo che posseggono tutte le altre nazioni; carattere determinato unicamente dalla convivenza in un paese unico, sotto un medesimo governo.”5 Qualcuno potrebbe osservare che se i popoli si trovano ad avere a che fare “sempre e soltanto con gli individui ebrei e non con la nazione ebraica, può dipendere dal fatto che questa nazione non esiste, che non è mai esistita, o che se un giorno è esistita adesso è scomparsa e non si sente alcun bisogno di farla ricomparire. Pinsker non argomenta su questo punto, non interroga il passato per trarne una dimostrazione di esistenza, ma sviluppa il suo ragionamento dando per scontato che la nazione è esistita e continua ad esistere, ma che l’allontanamento dalla patria e la dispersione nel mondo hanno fatto perdere ai suoi cittadini il sentimento della propria nazionalità, inducendoli a reprimere l’originario patritottismo per favorire il loro inserimento in altre nazioni. “Tale carattere nazionale non poteva certo svilupparsi nella dispersione: pare anzi che gli ebrei abbiano piuttosto smarrito ogni memoria della loro patria antica. Grazie alla loro pronta adattabilità, hanno potuto facilmente acquistare i caratteri dei popoli estranei, verso cui il destino li aveva spinti. È accaduto anzi che essi si spogliassero non di rado della loro individualità originale, tradizionale, per piacere ai loro protettori. Essi acquistarono, o credettero di acquistare, certe tendenze cosmopolite che non piacevano agli altri come non soddisfacevano agli ebrei stessi. Per il desiderio di fondersi con gli altri popoli, gli ebrei rinunciarono volontariamente, fino a un certo punto, alla loro nazionalità. Ma non riuscirono mai ad ottenere che i loro concittadini li considerassero eguali agli altri abitanti nativi del paese. Ma ciò che più di tutto impedisce agli ebrei di tendere alla riconquista di una esistenza nazionale indipendente, è che essi non sentono il bisogno di questa esistenza. E non solo non lo sentono, ma negano persino all'ebreo il diritto di sentirlo.”6 5 Leon Pinsker, Auto-emancipazione, il nuovo melangolo, 2004, pp. 39-40. 6 Leon Pinsker, ivi, pp. 40-41. Pinsker parla di “riconquista di un’esistenza nazionale indipendente”, dando dunque per scontato che tale esistenza ci sia stata nel passato e affermando che adesso è arrivato il momento di riaverla. Questa riconquista dell’esistenza nazionale deve però essere ottenuta con le proprie forze e non per la benevolenza delle nazioni ospitanti, a cui l’assenza di una nazione ebraica non provoca alcuna nostalgia. E invece di attardarsi a piagnucolare o a imprecare contro la cattiveria degli altri, Pinsker lancia un appello critico ai suoi connazionali. Il suo libro infatti ha come sottotitolo: “Appello di un ebreo russo ai suoi fratelli”. La mancanza di una patria - dichiara Pinsker - è come una malattia. L’autore non discute su che cosa l’abbia provocata, ma invita a ricercare attivamente le vie della guarigione. Per guarire però bisogna avere la consapevolezza di essere malati e desiderare ardentemente la guarigione. “Per un ammalato, non sentire il bisogno di mangiare e di bere, è un sintomo molto grave. Non sempre è possibile al medico evitargli tale pericolo. E se anche l'appetito ritorna, è sempre dubbio che il malato possa assimilare il nutrimento, ancorché lo desideri. Gli ebrei si trovano nella dolorosa condizione di un malato simile. Questo punto, che è il più importante di tutti, va energicamente sottolineato. Dobbiamo dimostrare che la cattiva sorte degli ebrei è dovuta anzitutto al fatto che manca loro il senso del bisogno dell'indipendenza nazionale; che questo desiderio deve esser in loro ridestato e ravvivato per tempo, se non vogliono essere esposti per sempre ad una esistenza disonorevole; in una parola, è necessario che essi diventino una nazione.” 7 Va sottolineato che per Pinsker diventare nazione non significa far nascere la nazione, ma farla guarire. Non si tratta di un passaggio dall’inesistenza all’esistenza, ma dalla malattia alla sanità. E della malattia tutti sono responsabili, ebrei e non ebrei. “In questo fatto all'apparenza insignificante - cioè che gli ebrei non sono considerati dagli altri popoli come nazione a sé - sta in parte il segreto della loro situazione anormale e della loro miseria infinita. Il solo fatto di appartenere al popolo ebreo costituisce già di per sé una stigmate incancellabile, ripugnante per i non ebrei stessi. Questo fenomeno, nonostante la sua stranezza, ha la sua profonda base nella natura umana. Fra le nazioni viventi oggi sulla terra gli ebrei rimangono come i figli d'una nazione morta da tempo. Con la perdita della sua patria, il popolo ebraico ha perduto la sua indipendenza, ed è giunto ad un tale grado di disgregazione che è incompatibile con l'esistenza di un organismo integro e vivente. Lo Stato ebraico, crollato sotto il peso della dominazione romana, scomparve agli occhi delle nazioni. Ma il popolo ebraico, anche dopo che ebbe perduto la speranza di esistere nella forma fisica e positiva dello Stato, come un'entità politica, non poté con tutto ciò rassegnarsi alla distruzione totale; non cessò anche dopo di esistere spiritualmente come nazione. Il mondo vide, in questo popolo, lo spettro pauroso d'un morto che cammina fra i vivi.8 Con un linguaggio che solo apparentemente è metaforico, Pinsker tocca qui un punto cruciale del problema ebraico presupponendo un dato di fatto che non molti sono disposti a riconoscere: la nazione ebraica costituisce un organismo unitario vivente e il suo popolo possiede una personalità corporativa. Non sono gli ebrei che costituiscono la nazione ebraica, ma è la nazione ebraica che genera i suoi figli; non sono gli ebrei che formano il popolo ebraico, ma è il popolo ebraico che iscrive gli ebrei tra i suoi membri. I figli della nazione possono essere degeneri, e i membri del popolo possono rivelarsi trasgressori, ma questo non altera né la posizione costitutiva della nazione, né la funzione statutaria del popolo. In una situazione di sana normalità una nazione è costituita da: 1) cittadini (il popolo); 7 8 Leon Pinsker, ivi, p. 41. Leon Pinsker, ivi, pp. 41-42. 2) patria (la terra); 3) sovranità (lo stato). La malattia della nazione ebraica sta nel fatto che ha perso la parte fisica della sua identità, cioè la terra, ma non ha perso, né poteva perdere, l’elemento vitale unitario, che indirettamente Pinsker denota come parte “spirituale”. Senza terra e senza sovranità, la nazione è fisicamente morta, ma il suo spirito continua a vivere nel popolo, la cui immortale anima corporativa si manifesta nell’impossibilità di disgregarsi, di disperdere irreversibilmente le sue cellule nella molteplicità delle nazioni circostanti. Contro tutte le aspettative, il popolo continua a mantenere nei secoli la sua unità “spirituale”, nel senso più ampio del termine. Ma è uno spirito senza corpo, e quindi è costretto ad aggirarsi per il mondo come un fantasma che incute terrore in chiunque lo incontra. “Questa apparizione spettrale, questa figura d’un morto errante, di un popolo senza unità organica, non legato ad una terra, non più vivo eppure vagante fra i vivi, questa figura strana, senza esempio nella storia dei popoli, diversa da tutte quelle che l'avevano preceduta o che l'avrebbero seguita, non poteva non produrre un'impressione strana e singolare sull'immaginazione dei popoli. E poiché la paura degli spettri è innata nell'uomo ed è in qualche modo giustificata nella vita psichica dell'umanità, non può destare meraviglia che quella paura si manifestasse così forte, alla vista di questa nazione ancora morta e pur viva insieme. La paura di questo spettro che rivestiva figura ebraica è stata tramandata e si è rafforzata nel corso delle generazioni e dei secoli. Essa porta al pregiudizio il quale, unito ad altri fattori che verranno esposti in seguito, ha condotto alla giudeofobia. Questa giudeofobia si radicò e naturalizzò fra tutti i popoli della terra con cui gli ebrei ebbero rapporti, insieme a tante altre idee inconsce e superstiziose, a tanti altri istinti ed idiosincrasie che dominano inconsapevolmente nei cuori umani. La giudeofobia è una forma di ‘demonopatia’: ma la differenza è che la paura dello spettro ebraico ha colto tutto il genere umano e non alcune razze soltanto; esso inoltre non è incorporeo, come gli altri spettri, ma è di carne e di sangue, e soffre le torture più atroci per le ferite inflittegli dalle folle terrorizzate che si immaginano di esser minacciate da lui. La giudeofobia è un morbo psichico. Essendo una malattia psichica, è ereditaria e poiché si trasmette già da due millenni, è incurabile.9 Per Pinsker dunque l’antisemitismo, che con linguaggio medico chiama giudeofobia, è un male incurabile fino a che permane la situazione storica in cui è costretto a vivere il popolo ebraico. L’emancipazione degli ebrei concessa dai governi di alcune nazioni è stato il massimo raggiungibile fino a quel momento, ma non ha risolto il problema perché non ha modificato il sentimento dei popoli, per i quali chi non è figlio della terra su cui vive è sempre considerato uno straniero. Affinché cambino i sentimenti, devono cambiare le cose. E il cambiamento non può essere soltanto un modo migliore di trattare i singoli ebrei nelle diverse nazioni. Quello che deve cambiare è il fatto che il popolo ebraico non ha una sua terra su cui possa vivere dignitosamente come nazione sovrana. “La nostra sventura maggiore è che noi non siamo costituiti in nazione, ma che siamo semplicemente degli ebrei. Siamo un gregge disperso su tutta la faccia della terra, senza un pastore che ci protegga e ci raccolga. Nella migliore delle condizioni arriviamo al grado di quelle capre che, in Russia, si usa porre nelle stalle insieme con i cavalli di razza. E’ il limite massimo della nostra ambizione. È vero che i nostri cari protettori hanno sempre fatto in modo che noi non avessimo mai un minuto di quiete e non potessimo riacquistare il rispetto di noi stessi. Abbiamo combattuto per secoli la dura ed ineguale lotta per l'esistenza nella nostra qualità di individui ebrei, e non nella veste di nazione ebraica. Ognuno per conto suo dovette, sprecare il suo ingegno e le sue energie per un po' di aria libera e per un pezzo di pane bagnato di lacrime. In questa lotta disperata non siamo stati vinti. Abbiamo resistito alla più gloriosa delle guerre di parte, contro tutti i popoli della terra, che, in un perfetto accordo, volevano sterminarci. Senonché questa lotta che combattemmo e che Dio sa fino a 9 Leon Pinsker, ivi, pp. 42-43. quando dovremo combattere ancora, non era fatta per conquistarci una patria ma per rendere possibile l'esistenza infelice a milioni di "Ebrei merciaiuoli ambulanti". 10 Pinsker sottolinea ancora una volta la distinzione tra piano individuale e piano nazionale. Rispetto al primo, gli ebrei hanno vinto la loro lotta per la sopravvivenza; rispetto al secondo, no. “Se tutti i popoli della terra non poterono impedire la nostra vita, essi riuscirono però a spegnere in noi il sentimento della nostra indipendenza nazionale. E così noi assistiamo con una indifferenza fatalistica, come se non si trattasse di noi, a questo spettacolo: che in molti paesi si negano agli ebrei quegli elementari diritti alla vita che non si negherebbero tanto facilmente neppure agli zulù. Nella dispersione abbiamo salvato, la nostra vita individuale abbiamo dimostrato la nostra forza di resistenza, ma abbiamo perduto il legame comune della coscienza nazionale. Nello sforzo di conservare la nostra esistenza materiale, fummo troppo spesso costretti, più di quanto non convenisse, a sacrificare la nostra dignità morale. Non ci siamo accorti che con questa tattica, indegna di noi ma che noi eravamo costretti ad adottare, ci abbassavamo sempre di più agli occhi dei nostri avversari e che essa ci esponeva sempre più all'umiliante disprezzo e alla proscrizione che diventavano ormai il triste retaggio secolare della nostra gente.” 11 E continua con una constatazione realistica e amara che dovrebbe essere motivo di riflessione e vergogna per chi non appartiene a quel popolo: “Nel vasto mondo non c'era posto per noi. Per avere modo di posare il nostro capo stanco e trovare un po' di tranquillità, chiedemmo un luogo qualsiasi. E così, riducendo le nostre aspirazioni, abbiamo gradatamente abbassato anche la nostra dignità ai nostri occhi ed agli occhi altrui, fino a vederla scomparire del tutto. Siamo stati la palla da gioco che i popoli si sono fatti rimbalzare a vicenda l'uno contro l'altro. Questo gioco crudele era per noi divertente, sia che fossimo accolti o respinti ed è diventato sempre più piacevole quanto più elastica e molle è diventata la nostra dignità nazionale nelle mani dei popoli. In condizioni tali, come poteva esser possibile una vita nazionale specifica o uno sviluppo libero ed attivo della nostra energia nazionale o la rivelazione del nostro genio originale?” 12 Emancipazione e assimilazione non risolvono il problema I vantaggi ottenuti dagli ebrei a partire dalla fine del Settecento con i vari editti di emancipazione che li equiparavano agli altri cittadini fece pensare a molti di loro che la risoluzione del problema ebraico consistesse nel percorrere fino in fondo la via dell’assimilazione. Abbiamo già visto come, nei decenni a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, molti ebrei di differenti nazioni europee erano fieri di poter essere cittadini a pieno titolo della nazione in cui vivevano, e in certi casi sembravano addirittura voler dimostrare di essere ancora più patrioti degli altri. La partecipazione convinta degli ebrei alla prima guerra mondiale, raccomandata dai dirigenti delle diverse comunità ebraiche come segno di fedeltà alla nazione, avrebbe dovuto sancire la definitiva omologazione degli ebrei facendo vedere chiaramente che per la loro patria erano pronti anche a morire. Si può citare, a conferma, la solenne frase con cui il giornale “Il Vessillo Israelitico” presentò l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915: Leon Pinsker, ivi, pp.48-49. Leon Pinsker, ivi, p. 49. 12 Leon Pinsker, ivi, pp. 49-50. 10 11 “L’Italia è in guerra e noi all’Italia daremo noi stessi interamente. Ogni sacrificio ci parrà dolce, ogni privazione un dovere. Daremo tutto noi - ebrei - alla patria nostra: daremo i figli, le sostanze nostre, le nostre vite. Tutto l’Italia ha diritto a pretendere da noi e tutto noi le daremo”.13 Quanto al sionismo, ben pochi in Italia lo vivevano come un desiderio di raggiungere la propria vera patria. A riprova di questo si può portare il fatto che tra il 1926 e il 1938 solamente 151 ebrei italiani sono emigrati in Palestina. Quelli che appoggiavano il sionismo dicevano di farlo per scopi filantropici, cioè per solidarietà verso gli ebrei che fuggivano dall’est o dalla Germania nazista a causa della persecuzione. Gli ebrei che invece avevano la possibilità di essere cittadini a pieno titolo di una nazione, come gli italiani, non desideravano un’altra patria, ma agivano spinti dall’obbligo morale di aiutare i loro correligionari meno fortunati ancora privi di una patria. Altri vi aggiungevano che il sionismo, come aspirazione a ritornare in Sion, poteva anche servire a risvegliare certi valori tradizionali dell’ebraismo che molti assimilati tendevano a dimenticare e trascurare, ma questo tuttavia non doveva né voleva sminuire l’attaccamento alla patria degli ebrei italiani. Questa forma di sionismo all’italiana è ben espressa da un intervento del sionista C.A. Viterbo in una riunione del consiglio dell’Unione delle Comunità Israelitiche del 9 gennaio 1935: “... il nostro sionismo è un’appendice della nostra ebraicità... noi cerchiamo di essere onesti, chiari, fuori dell’equivoco, ma non possiamo combattere coloro che hanno la stessa nostra tradizione di fede tramandata dai nostri maestri... è errato, fuori del mondo, negare l’italianità dei sionisti, italianità della quale da millenni essi sono permeati, italianità che essi non possono strappare a loro stessi perché il loro attaccamento alla Patria non è fedeltà, ma amore... Molti sionisti hanno combattuto nella grande guerra e molti sono camicie nere. Ma noi sionisti amiamo anche Israele. Il sionismo lo intendiamo non soltanto filantropico, ma anche fatto per noi stessi, perché dalla rinascita d’Israele rifluisce una vivificazione della lingua, della cultura, delle nostre più nobili tradizioni.” 14 Tre anni dopo, quella patria a cui gli ebrei italiani si sentivano attaccati non per sola fedeltà ma per amore, emetteva le leggi razziali precedute da un “Manifesto degli scienziati razzisti”. Al punto 9) di questo documento si legge: “Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempe rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.” Più di cinquant’anni prima Pinsker aveva previsto una situazione del genere: “Siamo scesi così in basso che esultiamo di giubilo quando in Occidente una piccola parte del nostro popolo viene posta allo stesso grado dei non ebrei. Però se qualcuno ha bisogno che altri lo tenga in piedi, vuol dire che la sua posizione è poco solida. Se non si bada alla nostra origine e ci si tratta al pari degli altri abitanti nati nel paese, siamo riconoscenti al punto da rinnegare completamente il nostro essere. Per vivere meglio, per godere in pace un piatto di carne, cerchiamo di far credere a noi e agli altri che non siamo più ebrei, ma figli legittimi ed autentici della patria. Vana illusione! Voi potete dimostrare di essere veri patrioti finché volete; vi ricorderanno ad ogni occasione la vostra origine semitica. Questo fatale memento mori non vi impedirà tuttavia di godere una larga ospitalità, finché un bel giorno non sarete cacciati dal paese e finché la plebe scettica della vostra legittimità non vi ricorderà che voi non siete, dopo tutto, altro che nomadi e parassiti, non protetti da nessuna legge. [...] Non vogliamo neppure ricominciare una nuova vita quale nazione a sé, onde vivere come gli altri popoli, perché i patrioti fanatici che sono fra noi credono necessario sacrificare ogni diritto all'esistenza nazionale indipendente, allo scopo di dimostrare una cosa che non ha bisogno di prove, cioè che sono leali cittadini delle terre in cui abitano. 13 14 Giampiero Carocci, Storia degli ebrei in Italia, Newton & Compton, 2005, p. 31. Renzo De Felice, ivi, p. 222. Questi patrioti fanatici negano il loro originale carattere etnico per mostrarsi figli di un'altra nazione qualunque essa sia, umile o alta. Ma essi non ingannano nessuno. Non si accorgono quanto impegno mettono gli altri per liberarsi da questa compagnia ebraica.” 15 Il concetto biblico di nazione ebraica E’ noto che alla domanda “chi è ebreo?” sono state date innumerevoli risposte. E’ un interrogativo che oggi travaglia in modo particolare lo Stato d’Israele, perché dalla risposta a questa domanda può dipendere l’ottenimento della cittadinanza israeliana. Ma prima ancora di questa domanda se ne può porre un’altra, che in forma volutamente piatta e banale può suonare così: chi viene prima, gli ebrei o il popolo ebraico? Di solito si procede così: dal magma confuso e disperso su tutta la faccia della terra di individui che per qualche motivo si dicono o sono detti “ebrei” alcuni scelgono una qualche proprietà comune a una parte di loro e arrivano alla conclusione che il vero popolo ebraico è costituito da coloro che soddisfano quella certa proprietà. E’ un processo di generazione dal basso che pone prima i singoli, poi la società. E’ chiaro che la quantità di “popoli ebraici” che si possono generare con procedimenti induttivi di questo tipo è «come la sabbia del mare, tanto numerosa che non la si può contare» (Genesi 32:12). Anche gli italiani sono diversi fra loro sotto moltissimi aspetti, e tuttavia l’elemento unitario del popolo italiano non è costituito da qualche proprietà etnica o morale comune a tutti, ma dall’appartenenza ad un’unica nazione, esistente da prima che tutti gli attuali italiani fossero venuti al mondo ed espressa formalmente da una precisa persona: il Presidente della Repubblica. Si può dunque dire che sul piano giuridico, che non è pura formalità ma è il piano reale su cui avvengono i rapporti fra gli uomini, esiste prima la nazione, poi il popolo, poi i cittadini. La stessa cosa è vera per gli ebrei: prima viene la nazione ebraica, poi il popolo ebraico, poi gli ebrei. Avere sottolineato questo aspetto trascurato della questione ebraica costituisce il valido contributo al sionismo dato da persone come Pinsker e altri dopo di lui. Qualcuno dirà che la sottolineatura del concetto di nazione può condurre a fenomeni di fascismo. come in Italia e in Germania. E’ vero: può avvenire, anzi è già avvenuto. Ma questo non significa che l’impostazione nazionale sia sbagliata. Si dice solitamente che il sionismo è un movimento che emerge e si sviluppa nella scia del generale risveglio dei sentimenti nazionali di vari popoli. Sul piano della mera osservazione dei fatti, questo è vero, ma sul piano dell’interpretazione della storia fornita dalla Bibbia, è il sionismo che ha prodotto, come necessità anticipatoria, il risveglio dei vari nazionalismi; ed è l’avvicinarsi dell’inevitabile ricostituzione politica e territoriale della nazione ebraica che ha provocato la diabolica contraffazione costituita dal Terzo Reich. Tra tutti gli studi fatti sul nazismo, sarebbe interessante trovarne qualcuno che esamini a fondo quella sorta di teologia della sostituzione presente nella falsificazione messianica dell’ideologia nazista. Le motivazioni di certe forme di antisemitismo risulterebbero più chiare se si capisse che si tratta dell’odio che l’imitazione sofisticata ha per il prodotto originale. Come beffa aggiuntiva, dopo il definitivo crollo di quella immonda falsificazione del regno di Dio messianico costituita dal Terzo Reich, la forza diabolica dell’equiparazione è ricomparsa nella nuova forma di ripetute accuse alla politica israeliana, a cui si rinfaccia di usare forme e metodi del nazismo! Non si vuole qui sostenere che l’attuale Stato d’Israele rappresenta il regno di Dio sulla terra, ma che la sua presenza oggi sulla scena politica mondiale è espressione di una precisa volontà di Dio all’interno del suo sovrano progetto storico. Di conseguenza, l’odio contro questo Stato, il tentativo o anche il solo desiderio di distruggerlo, sia che venga da ebrei laici o superortodossi, sia che venga da gentili cristiani, musulmani o di qualsiasi altra religione, è di natura diabolica. Ciascuno è libero 15 Leon Pinsker, ivi, pp. 51-52. di usare i criteri che ritiene più validi per interpretare la storia dei popoli, ma quando si tratta di Israele, i criteri più validi, quelli che anche a posteriori si confermano essere i più idonei a spiegare i fatti avvenuti e quindi in una certa misura anche a prevedere quelli futuri, sono i criteri biblici. Voler tentare di capire la storia del popolo d’Israele prescindendo dal Dio d’Israele che si è rivelato nella Sacra Scrittura, è impresa vana, destinata fin dall’inizio al fallimento. Quando si comincia a parlare di previsioni di fatti futuri qualcuno sorride, e in parte questo è comprensibile perché di “profeti” strampalati se ne incontrano dappertutto e in continuazione. Ma ci sono anche casi che dovrebbero far riflettere. Nel 1938 il regime nazista era all’apice del suo successo. Nel novembre di quell’anno ci fu la notte dei cristialli. Un cristiano evangelico che fino a quel momento era stato un moderato, ma convinto sostenitore del nazismo, cambiò radicalmente opinione. Da quel momento fu sicuro che il suo paese sarebbe andato incontro alla rovina. Non era un esperto di politica internazionale, ma un semplice credente che conosceva la Bibbia. Si ricordò di una frase del profeta Zaccaria: “... così parla l’Eterno16 degli eserciti: «E’ per rivendicare la sua gloria che egli mi ha mandato verso le nazioni che hanno fatto di voi la loro preda; perché chi tocca voi, tocca la pupilla dell’occhio suo»” (Zaccaria 2:8). Il suo paese andò incontro alla rovina, come aveva previsto sulla base della Scrittura Un altro esempio, ricevuto personalmente attraverso una testimonianza. Durante l’ultima guerra un’anziana signora tedesca, convinta cristiana evangelica, sentì che davanti a casa sua un gruppo di ragazzi stava gridando: “Morte agli ebrei” e altre frasi simili. Uscì fuori e disse: «Smettetela, perché tanto noi perderemo la guerra e gli ebrei avranno il loro Stato». Quanti uomini politici avrebbero osato fare una simile previsione del futuro? Non ci furono conseguenze probabilmente perché nessuno sporse denuncia in considerazione dell’avanzata età della donna. Abbiamo detto che l’elemento primario della questione ebraica non è l’ebreo come individuo e neppure il popolo come aggregato multiforme di singoli, ma il concetto di nazione ebraica. L’atto giuridico costitutivo di questa nazione si trova nella promessa fatta da Dio ad Abramo: “Io farò di te una grande nazione” (Genesi 12:2), che più volte è stata ripetuta ed espressa nella forma giuridica di un patto: “Quando Abramo fu d’età di novantanove anni, l’Eterno gli apparve e gli disse: «Io sono l’Iddio onnipotente; cammina alla mia presenza, e sii integro; e io fermerò il mio patto fra me e te, e ti moltiplicherò grandissimamente»" (Genesi 17:1-2). Quando si fa riferimento a quello che fonda l’unità politica di una nazione e ne stabilisce le regole di comportamento si parla di “patto sociale”. Questo semplice fatto evidenzia che per fissare i fondamenti di una comunità umana vivibile è necessario l’uso adeguato della parola, perché il semplice riferimento allo stato di natura non garantisce niente. O meglio, garantisce soltanto l’anarchia e il dominio del più forte. Non a caso si parla di legge della giungla. L’elemento unitario della nazione ebraica si trova dunque nella parola rivolta da Dio ad Abramo, comprendente anche le promesse per la sua discendenza. Ogni volta che il popolo trascura questo elemento unitario proveniente dall’Alto, la sua unità scompare e gli ebrei si disperdono in tutte le direzioni. Proprio questa è la situazione che osserva Pinsker quando esclama: “Siamo un gregge disperso su tutta la faccia della terra, senza un pastore che ci protegga e ci raccolga”17. 16 17 Il termine “Eterno” traduce il Nome corrispondente al tetragramma. Leon Pinsker, ivi, p. 48. E’ interessante osservare che un intellettuale laico come Pinsker ricorre, per descrivere lo stato del suo popolo, ad una pregnante immagine biblica. Il profeta Isaia, guardando da un punto di vista profetico posto nel futuro, descrive una scena simile come se appartenesse al passato: “Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via” (Isaia 53:6). Non è forse questa, ancora oggi e nonostante l’esistenza del nucleo unitario dello Stato d’Israele, la situazione degli ebrei nel mondo? Ciascuno segue la sua propria via. Questo semplice fatto dovrebbe far capire quanto sia irrealistica l’idea di immaginare un “complotto giudaico” per arrivare a dominare il mondo. Quando mai gli ebrei riuscirebbero a mettersi tutti d’accordo! Le parole di Pinsker sopra riportate esprimono il bisogno di protezione che ha il gregge. Ma se il gregge è “disperso su tutta la faccia della terra”, come potrà essere protetto? E inoltre, perché si continua a chiamarlo gregge se da secoli non esiste più perché le pecore si sono disperse in tutte le nazioni del mondo? Come mai le pecore non sono ancora riuscite a trovare una soluzione ai loro problemi esistenziali nei diversi paesi in cui hanno vissuto? Ancora una volta è Pinsker che risponde: “La pace sarà tanto più difficile da ottenere in quanto, a quel che sembra, non siamo capaci di fonderci con le altre nazioni se non in misura limitatissima.”18 Le pecore disperse non sono riuscite ad amalgamarsi con quelle di altri greggi, hanno continuato a sentirsi e ad essere considerate diverse. Sono quindi esposte al pericolo: hanno bisogno di protezione. Ma per essere protetti ci vuole unità; e per ottenere unità ci vuole una persona. Pinsker avverte la necessità di qualcuno come Mosè: “Uniti, in file serrate, compimmo una volta un esodo ordinato dall'Egitto, per sottrarci alla vergognosa schiavitù e per conquistare una patria! Ora erriamo fuggiaschi ed esuli, sotto il giogo nemico, con la morte nel cuore, senza un Mosè che ci guidi, senza una Terra Promessa che dobbiamo conquistare col nostro valore.”19 “Ci manca una guida geniale quale fu Mosè. La storia non elargisce di continuo al popolo condottieri simili. Ma la limpida coscienza di ciò che più ci abbisogna, cioè la coscienza della necessità assoluta di una patria, farà sorgere fra noi alcuni amici del popolo, energici, fervidi, nobili, che assumeranno insieme la direzione del loro popolo e riusciranno forse, non meno di quell 'unico e singolo genio, a redimerci dalla miseria e dalla persecuzione.”20 Anche in questo si può dire che Pinsker sia stato profetico. Dalla distruzione del Tempio in poi non è più sorto un “unico e singolo genio” come Mosè, ma con l’apparizione sulla scena del sionismo sono sorti “alcuni amici del popolo, energici, fervidi, nobili” che hanno reso possibile la ricostituzione di una certa unità nazionale. L’auspicio della venuta di una guida come Mosè assume una sembianza biblica se si considera che Mosè stesso nella Torà ha preannunciato la venuta di uno come lui. Nel suo discorso al popolo, prima che questi passasse il Giordano per entrare nella Terra promessa, Mosè aveva detto: “L'Eterno, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli; a lui darete ascolto” (Deuteronomio 18:15). Leon Pinsker, ivi, p. 57. Leon Pinsker, ivi, pp. 58-59. 20 Leon Pinsker, ivi, p. 61. 18 19 Sta scritto dunque nella Bibbia che un giorno arriverà un profeta come Mosè, ma sta scritto anche che Dio si aspetta che il popolo lo ascolti. Anche il desiderio di trovare qualcuno che raccolga il gregge ha risonanze bibliche. Fin dall’inizio Dio aveva pensato a una persona che avrebbe svolto questo compito, ben sapendo che il suo popolo sarebbe stato temporaneamente disperso. Quella persona è il “Servo dell’Eterno” di cui parla il profeta Isaia: “Ed ora parla l'Eterno che m'ha formato fin dal seno materno per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe, e per raccogliere intorno a lui Israele” (Isaia 49:5). Ma anche qui, affinché il programma di Dio vada avanti, occorre che Israele sia disposto a collaborare. La pietra di scandalo Il profeta come Mosè del libro del Deuteronomio e il Servo dell’Eterno di Isaia 53 sono due figure bibliche che corrispondono ad un’unica persona: il Messia. Ma chi è il Messia? E’ una persona, un sistema politico, una metafora linguistica? E’ già venuto? Deve ancora venire? Sulle risposte a queste domande le strade si dividono. E’ chiaro - ma non è inutile sottolinearlo con decisione - che dirsi cristiani significa confessare che il Messia è già venuto in Israele una prima volta nella persona di Gesù, come attestato negli scritti del Nuovo Testamento. Si sa bene che per molti questo è uno scandalo e una pietra d’inciampo. Certo, sarebbe auspicabile che a causa di questo argomento non volino pietre in direzione di chi ci crede, né si accendano roghi destinati a chi non ci crede, ma non è bene che per ragioni di buona educazione ecumenica ci si accordi nel non parlarne affatto. Il problema esiste, resta scottante, è centrale: non deve dunque essere evitato. In forma molto schematica si può dire che: - la soluzione dei problemi del mondo è collegata alla soluzione della questione ebraica; - il nocciolo della questione ebraica sta nel concetto di nazione ebraica; - la nazione ebraica ha il suo centro unificante nella persona del Messia. Non ha senso quindi sperare di risolvere alla radice i problemi del mondo trascurando la persona del Messia, e, viceversa, non si può riflettere in modo approfondito sulla persona del Messia senza essere indotti a prendere seriamente in considerazione i problemi del mondo. E’ vero che esiste un cristianesimo spiritualizzante ed edonistico che sembra interessarsi di Gesù soltanto per la possibilità che offre di strappare anime dalle fiamme dell’inferno e mandarle a godere in paradiso, ma è un Gesù ritagliato artificiosamente dai testi biblici per far emergere soltanto alcuni aspetti prediletti della sua figura, a scapito di tanti altri che restano colpevolmente trascurati, soprattutto quelli che hanno a che fare con Israele. Tenendo conto che la parola “eresia” proviene da un termine greco che significa “scelta”, si può dire che anche in questo caso si tratta di una vera e propria eresia. Si considerino allora i quattro Vangeli. Molti, anche tra gli atei, li trovano interessanti; i moralisti vi ricavano storielle istruttive, i credenti esempi edificanti, i teologi dottrine complicate. Ma leggendoli attentamente ci si accorge che i quattro Vangeli hanno un unico oggetto di interesse: la persona di Gesù. Sono stati scritti per rispondere a una precisa domanda: “Chi è Gesù?” E al lettore pongono a loro volta una precisa domanda: “E tu, chi dici che sia Gesù?” Dalla risposta a queste due domande dipendono tutte le dottrine e tutti gli insegnamenti pratici che se ne possono trarre. Non ha senso tirar fuori, qua e là, dai racconti evangelici, spunti di attualizzazione pratica senza prima prendere posizione sulla persona di Gesù. E non è possibile comprendere pienamente la persona di Gesù se non la si colloca nel suo contesto ebraico. Non è lecito, per esempio, fare del sermone sul monte (Matteo, capp. 5-7) un modello universale di condotta morale senza tener conto della persona che l’ha pronunciato e dell’ambiente storico e religioso in cui i fatti sono avvenuti. Gesù stesso ha espresso la necessità di una precisa presa di posizione a suo riguardo in un serio e grave colloquio avuto con i suoi discepoli verso la fine del suo ministero: “Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il Figlio dell’uomo?» Essi risposero: «Alcuni dicono Giovanni il battista; altri, Elia; altri, Geremia o uno dei profeti».” (Matteo 16:13-14) Le risposte, come si vede, sono tutte positive, ma nessuna di queste è quella giusta. Gesù allora interpella direttamente i discepoli: “Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?»” (Matteo 16:15). Chiede dunque una precisa presa di posizione. “Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».” (Matteo 16:16). Questa, e solo questa, è la risposta giusta. Tutte le altre sono sbagliate, anche se le intenzioni di chi le ha date erano buone. Gesù è il Cristo, cioè il Messia, il Figlio di Dio di cui si parla nelle Scritture. Pietro riceve conferma dell’esattezza della sua risposta: “Gesù, replicando, disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli.” (Matteo 16:17). Gesù non dice: «Bravo, Pietro! Risposta esatta!» E tanto meno promette un premio, come nei quiz televisivi. Quella confessione non è opera umana: a Pietro Gesù dice «Beato», cioè benedetto, toccato dalla grazia della rivelazione di Dio. Sulla base di quella confessione Gesù promette che fonderà la sua chiesa. L’istituzione politicoreligiosa che è sorta in seguito sfruttando illegittimamente le parole di Gesù è stata, e sostanzialmente è ancora, antigiudaica. E’ inevitabile, perché pretende di occupare un posto che Dio ha riservato soltanto a Israele. Pietro, il preteso primo papa, non solo era ebreo, ma la confessione su cui Gesù ha promesso di fondare la sua chiesa poteva essere fatta soltanto da un ebreo. Un pagano, potente o colto che fosse stato, non avrebbe mai potuto dire a Gesù “Tu sei il Messia” per il semplice fatto che non sapeva neppure che roba fosse il Messia. Tempi che si allungano, rapporti che si modificano La dichiarazione che Gesù è il Messia d’Israele fa sorgere molte domande e pone problemi non piccoli agli ebrei. Dov’è il regno messianico? Dov’è il trono di Davide su cui avrebbe dovuto sedere il Messia? Dov’è la liberazione dall’oppressione dei nemici? Dov’è la gloria promessa a Israele? Niente di tutto questo si è verificato e quindi - concludono molti - è chiaro che Gesù non può essere il Messia. Anche se in questa sede non sarà possibile rispondere in modo esauriente a tutte queste legittime obiezioni, è necessario prendere posizione su alcuni fatti di importanza fondamentale. Si può dire, innanzi tutto, che il prolungarsi in modo inaspettato e indesiderato dei tempi non è una cosa nuova nella Bibbia, ma corrisponde a un preciso modo di operare caratteristico di Dio. Ad Abramo, per esempio, Dio aveva detto: “Alza ora gli occhi e guarda, dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza, per sempre” (Genesi 13:14-15). Dopo queste allettanti promesse Abramo probabilmente si sarà aspettato che di lì a pochi anni sarebbe diventato un grande proprietario terriero mediorientale e che i suoi possedimenti sarebbero passati ai suoi successori di padre in figlio per sempre. Accadde invece che qualche anno dopo Abramo passò una nottata terribile: “Sul tramontare del sole un profondo sonno cadde sopra Abramo; ed ecco, uno spavento, un’oscurità profonda, cadde su di lui. E l’Eterno disse ad Abramo: «Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi, e saranno oppressi per quattrocento anni»” (Genesi 15:13-14). La delusione deve essere stata grossa. Certo, Dio aveva aggiunto anche una promessa: “... ma io giudicherò la gente di cui saranno stati servi; e, dopo questo, se ne partiranno con grandi ricchezze” (Genesi 15:15), ma non è detto che questo annuncio di un fatto che sarebbe accaduto secoli dopo sia stato di grande conforto per Abramo. Passarono gli anni e le cose si svolsero esattamente come l’Eterno aveva detto: gli ebrei scesero in Egitto e lì rimasero oppressi come schiavi per più di quattrocento anni. Occupati com’erano a cercare di mantenersi in vita nelle loro miserevoli condizioni, e a lamentarsi perché non ci riuscivano, probabilmente si erano del tutto dimenticati della promessa fatta secoli prima a un loro lontano antenato. Dio invece no: “I figli d’Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida; e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abraamo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli d’Israele e ne ebbe compassione” (Esodo 2:22-25). Dio allora andò da Mosè e gli disse: “E ora, ecco, le grida dei figli d’Israele sono giunte a me; e ho anche visto l’oppressione con cui gli Egiziani li fanno soffrire. Or dunque va’; io ti mando dal faraone perché tu faccia uscire dall’Egitto il mio popolo, i figli d’Israele»” (Esodo 3:9, 10). Dopo qualche obiezione Mosè ubbidì, e facendosi accompagnare da Aaronne andò dal faraone e gli disse di lasciare andare il popolo. Il risultato fu che il popolo non solo restò lì, ma il suo lavoro raddoppiò, le fatiche aumentarono e i gemiti si fecero ancora più alti. E Mosè si sentì arrivare addosso le imprecazioni dei suoi connazionali: “I sorveglianti dei figli d’Israele si videro ridotti a mal partito, perché si diceva loro: «Non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostovi giorno per giorno». Uscendo dal faraone, incontrarono Mosè e Aaronne, che stavano ad aspettarli, e dissero loro: «L’Eterno volga il suo sguardo su di voi e giudichi! poiché ci avete messi in cattiva luce davanti al faraone e davanti ai suoi servi e avete messo nella loro mano una spada per ucciderci»” (Esodo 5:19-21). Mosè allora girò la lamentela al suo mandante: “Allora Mosè tornò dall’Eterno, e disse: «Signore, perché hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi hai mandato? Poiché, da quando sono andato da Faraone per parlargli in tuo nome, egli ha maltrattato questo popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo popolo»” (Esodo 5:22-23). “Tu non hai affatto liberato il tuo popolo”: un grave rimprovero mosso a Dio da un uomo come Mosè, che in quel momento certamente era ben convinto di quello che diceva. Già da questi due esempi si può capire che una delle cose che possono indurre gli uomini a sbagliare nella valutazione delle parole di Dio è il non tener conto del fattore tempo. Quando Dio annuncia che un fatto che avverrà nel futuro, quel fatto è certo: è come se fosse già avvenuto e appartenesse alla immodificabilità del passato. Dio però non dice subito tutto quello che avverrà dal momento in cui la sua parola è uscita al momento in cui essa si compirà. Dio sa - e non si ritiene obbligato a comunicarlo immediatamente all’interessato - che il tempo intermedio è destinato all’avvenimento di altre cose che riguardano anche altri soggetti. Purtroppo però chi riceve la parola di Dio di solito è interessato soltanto agli affari suoi, e il tempo che passa per il compimento di fatti che riguardano altri gli sembra soltanto una perdita di tempo. Quando Abramo ricevette la “triste notizia” che i suoi discendenti sarebbero entrati nella Terra promessa soltanto alla quarta generazione, il Signore aggiunse come spiegazione: “perché l’iniquità degli Amorei non è giunta finora al colmo” (Genesi 15:16). Era necessario quindi, affinché il popolo pagano fosse cacciato fuori da quella terra che non era sua ma di cui Dio gli aveva concesso l’uso, che per motivi di giustizia l’iniquità di quel popolo raggiungesse il colmo sopportabile da Dio. Anche per Mosè si può dire qualcosa di simile. Non era sufficiente che Israele sperimentasse la potenza di Dio nella liberazione dall’oppressione della schiavitù, era necessario che anche gli egiziani facessero esperienza della potenza dell’unico vero Dio d’Israele che ancora non conoscevano. E’ anche per questo motivo che Dio non liberò subito il suo popolo. Quando Mosè ed Aaronne si trovarono davanti alla più alta autorità mondiale di quel tempo, senza tanti giri di parole gli dissero: "Così dice l’Eterno, il Dio d’Israele: Lascia andare il mio popolo, perché mi celebri una festa nel deserto" (Esodo 5:1). Si può immaginare la reazione del potente monarca: “Ma il faraone rispose: «Chi è l’Eterno ch’io debba ubbidire alla sua voce e lasciar andare Israele? Io non conosco l’Eterno, e non lascerò affatto andare Israele»” (Esodo 5:2). Il faraone conosceva bene gli ebrei, il suo regno ne era pieno e cominciavano anche a dargli parecchi fastidi, ma questo “Dio d’Israele” che osa dare ordini a lui, chi è? L’Eterno, il faraone non lo conosceva: era necessario quindi che si presentasse. Cosa che poi l’Eterno ha fatto, e per il faraone sono stati guai. C’è una costante biblica che continuamente si ripresenta nella storia: quello che avviene a Israele prima o poi ha una ripercussione su tutto il mondo. E’ un fatto che tutti fanno fatica ad accettare, sia Israele, sia il mondo. Si potrebbero portare altri esempi biblici, ma arriviamo subito all’avvenimento fondamentale: la venuta di Gesù. Un Messia che delude A ciascuno dei dodici apostoli Gesù aveva detto: “Seguimi”. Non era una proposta, era un ordine. Perché i dodici hanno ubbidito senza fiatare, anzi molto volentieri? Perché erano convinti che Gesù era il Messia, il Re d’Israele: dunque aveva autorità, e per loro era un onore essere stati scelti per seguirlo e servirlo. Da Lui evidentemente si aspettavano quello che era stato promesso dai profeti: l’instaurazione del regno messianico. Gesù stesso del resto ne aveva dato un solenne annuncio fin dall’inizio del suo ministero: “Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino».” (Matteo 4:17). Le cose però cominciarono ben presto a mettersi male: gli scribi facevano obiezioni teologiche, i farisei erano infastiditi per la perdita di autorità che subivano presso il popolo, i sadducei temevano che un possibile sollevamento del popolo sull’onda dell’entusiasmo messianico provocasse una violenta reazione romana. Giuda a un certo punto capì che le cose andavano a finire male, e anche Tommaso forse temeva che qualcosa di brutto si stesse preparando perché vedendo Gesù che si avviava deciso verso Gerusalemme disse agli altri: “Andiamo a morire con lui” (Giovanni 11:16). A parte questi due, tutti gli altri erano convinti che Gesù avrebbe lasciato agire gli avversari fino all’ultimo momento per fare in modo che tutti si scoprissero e venisse fuori chi aveva veramente creduto in lui fino alla fine e chi no. Pietro dunque era sincero quando disse convinto: «Quand’anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò» (Matteo 26:36). Non era una sbruffonata: poco prima aveva visto Gesù risuscitare Lazzaro. Quindi - avrà pensato - se Gesù vuole vedere chi è disposto a farsi uccidere per lui, io sono pronto. E quando nel giardino di Getsemani vide avvicinarsi una folla di centinaia di persone armate di spade e bastoni avrà pensato: questo è il momento. Erano lì per pregare, ma lui si era portato dietro una spada. Chiese a Gesù se dovevano colpire, ma come al solito non aspettò nemmeno la risposta e mirò alla testa di uno che stava davanti a lui. In seguito si scoprì che era il servo del Sommo Sacerdote. Gli staccò un orecchio, ma solo perché quell’altro fece in tempo a scansarsi. E’ certo che Pietro non voleva colpire di fino: lui voleva spaccare la testa. E questo, davanti alla forza preponderante di una folla armata e minacciosa, per lui significava morte sicura. Aveva mantenuto la sua promessa: aveva dimostrato di essere pronto anche a morire per Gesù. Aveva compiuto un atto di coraggio e di fede. Ma qui arriva la sorpresa: Gesù non lo loda. Ma neppure lo sgrida: sapeva fin dall’inizio che sarebbe andata a finire così. Semplicemente rifiuta l’atto di fede di Pietro. Gli dice: «Rimetti la spada nel fodero» (Giovanni 18:11). E aggiunge: «Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di dodici legioni d’angeli?» (Matteo 26:53). Appunto, proprio questo probabilmente si aspettava Pietro. Ricordava bene l’esperienza dei cinquemila nel deserto che avevano fame e non si sapeva come fare. Gesù aveva chiesto che gli portassero i pani e i pesci che avevano a disposizione e li aveva miracolosamente moltiplicati. Anche adesso qualcuno di loro avrà pensato - occorre che qualcuno metta a disposizione quel poco che ha. Questa volta i discepoli non aspettarono che Gesù facesse la richiesta: ormai avevano capito la lezione e si fecero avanti per primi: “Ed essi dissero: «Signore, ecco qui due spade!»” (Luca 22:38), e aspettarono che Gesù moltiplicasse le spade come aveva fatto con i pani. Ma se Gesù moltiplica le spade e le fa diventare migliaia, poi chi le brandisce? Con il riferimento alla legione di angeli probabilmente Gesù ha toccato nel vivo il pensiero di Pietro, proprio quello su cui aveva fondato la sua fede. Forse Pietro non avrà detto esattamente: Gesù farà così; per lui poteva essere sufficiente appoggiarsi sul fatto che Gesù se vuole può fare così. Gesù ha confermato questo pensiero; in sostanza ha detto: se volessi, potrei fare così. Ma ha aggiunto: non lo voglio e non lo faccio. A questo punto ai discepoli sono venuti a mancare tutti i puntelli della loro fede e sono scappati. E’ importante sottolinearlo: non sono le armi e i bastoni che hanno fatto scappare i discepoli, ma le parole di Gesù. Dopo aver annullato, con il riferimento alla legione di angeli, le aspettative dei discepoli, Gesù dà la vera spiegazione del suo comportamento davanti alla folla minacciosa: «Non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato?» (Giovanni 18:11). Quello che Gesù vuole è fare la volontà del Padre, perché la volontà di Dio compiuta sulla terra in Israele è la salvezza di Israele e di tutta la terra. Ma fino all’ultimo la popolazione di Gerusalemme è rimasta col fiato sospeso nella speranza, o nel timore, che qualche fatto prodigioso avvenisse a conferma della messianità di Gesù. Perfino quando sulla croce gridò: «Elì, Elì, lamà sabactàni», alcuni dissero: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo» (Matteo 27:49). Ma Gesù non scese giù di croce e la delusione dei discepoli fu grande. Il loro cupo stato d’animo è ben espresso dall’episodio dei discepoli sulla via di Emmaus: “Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme sessanta stadi; e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: «Di che discorrete fra di voi lungo il cammino?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: «Tu solo, tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Egli disse loro: «Quali?» Essi gli risposero: «Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele; invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. E’ vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire; andate la mattina di buon’ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo, e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne; ma lui non lo hanno visto»” (Luca 24:13-24). “Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele”, sospirano sconfortati i due discepoli. Viene in mente il rimprovero rivolto da Mosè a Dio: “... tu non hai affatto liberato il tuo popolo” (Esodo 5:23) . E’ illuminante la risposta di Gesù, che i discepoli considerano ancora come uno sconosciuto forestiero: “Allora Gesù disse loro: «O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette! Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria?» E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture le cose che lo riguardavano” (Luca 24:25-27) Gesù non rimprovera il materialismo dei discepoli, non dice che hanno sbagliato ad aspettarsi un regno politico terreno perché il suo regno è puramente spirituale; non li avverte dicendo che ormai il vecchio Israele sarà abbandonato da Dio e quindi adesso loro entreranno a far parte di un nuovo Israele che si chiamerà “Chiesa”. Gesù li tratta male, in un certo senso li insulta anche, ma non per contrapporre al loro materialismo terrestre il suo spiritualismo celeste. Quello che i contemporanei di Gesù non avevano capito Ancora oggi molti sostengono che gli ebrei hanno rifiutato Gesù perché si aspettavano un regno politico terrestre, e non avevano capito che il regno di Dio è invece di natura puramente spirituale. C’è un brano famoso del Vangelo di Luca chiamato “cantico di Zaccaria”: “Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò, dicendo:«Benedetto sia il Signore, il Dio d’Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo, e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti; uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abraamo nostro padre, di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza, tutti i giorni della nostra vita»” (Luca 1:67-75). Un esegeta protestante dell’inizio del secolo scorso commenta così queste parole: “Le vedute di Zaccaria intorno a questo avere «Iddio visitato e riscattato il suo popolo» dovevano essere molto indistinte e imperfette. E’ probabile che partecipasse alle idee prevalenti tra i suoi compatrioti intorno al regno terreno del Messia, e alla liberazione dai loro nemici con la spada e con la lancia; ma nel mentre le parole messegli in bocca dallo Spirito di Dio, avrebbero potuto naturalmente risvegliare tali immagini terrene nella mente d’un Giudeo dominato da siffatti pregiudizi, erano egualmente adatte ad esprimere i concetti più spirituali della redenzione che è in Cristo Gesù. Tale è il senso che noi dobbiamo dare al linguaggio di Zaccaria, sebbene possa darsi che egli non comprendesse appieno il significato delle parole che gli dettava lo Spirito Santo.“ 21 E per quanto riguarda i nemici di Israele, il commentatore dà questa spiegazione: “Che Zaccaria avesse, come pensano alcuni, o non avesse, in vista nemici temporali, quali erano stati in passato i Macedoni sotto Antioco, ed erano ai suoi giorni i Romani, è certo che lo Spirito d’ispirazione ci insegna in questi versetti che la principale benedizione contemplata nel patto con Abraamo non era il potere o lo splendore temporale dei suoi discendenti secondo la carne, ma, come si è detto, la liberazione della sua progenie da tutti i nemici spirituali; la salvazione dal peccato e dalla sua potenza.22 Questa contrapposizione tra supposto materialismo giudaico e cosiddetto spiritualismo cristiano, oltre ad essere una falsificazione del messaggio evangelico che non cessa di essere tale per il fatto di essere molto diffusa, costituisce il presupposto ideologico di un latente antisemitismo tanto più pericoloso quanto più inconsapevole. Molto facilmente un certo tipo di spiritualismo cristiano si allea con qualche forma di idealismo pagano e si pone in lotta con il cosiddetto materialismo ebraico. Nel suo Mein Kampf Hitler si esprime così riguardo agli ebrei: “No, l’ebreo non possiede nessuna forza creativa, poiché egli è privo di quell’idealismo senza il quale non è possibile uno sviluppo dell’umanità verso l’alto […] per la sua natura fondamentale l’ebreo non poteva trarre istituzioni religiose, perché gli manca completamente ogni forma di idealismo, e perciò ogni fede nell’aldilà”. Tornando all’episodio dei discepoli sulla via di Emmaus, si può notare che Gesù non li accusa di essere poco spirituali, ma di non aver capito quello che i profeti di Israele hanno detto: cioè che il Messia doveva soffrire e così entrare nella sua gloria. Gesù non comunica nulla di nuovo ai discepoli, e il suo discorso si muove tutto all’interno del mondo ebraico. Uno sconosciuto ebreo, come fino a quel momento Gesù era considerato dai discepoli, rimprovera ad altri ebrei di non aver capito che il Messia prima di entrare nella sua gloria doveva soffrire, morire e risuscitare. E cerca di convincerli di tutto questo spiegando loro le Scritture ebraiche, cominciando da Mosè. Non si tratta dunque di un contrasto tra Israele e Chiesa, o tra materialismo giudaico e idealismo ariano, ma di un contrasto tutto interno al messaggio ebraico veterotestamentario. Ad esso si collega una fondamentale domanda: il Messia promesso a Israele si presenterà come un mansueto agnello che si lascia immolare, o come un potente leone che sbaraglia i nemici del suo popolo? 21 Robert Stewart, Commentario di Luca, Claudiana, 1911, p. 25. 22 Robert Stewart, ivi, p. 26. La difficoltà di armonizzare, nelle profezie bibliche, la figura di un Messia sofferente con quella di un Messia trionfante è ben nota alla tradizione rabbinica. Un’interpretazione molto diffusa nel passato (non è noto a chi scrive quanto lo sia ancora nel presente) è che si tratti di due personaggi: il Maschiach Ben Yoseph, Messia sofferente, figlio di Giuseppe, e il Maschiach Ben David, Messia trionfante, figlio di Davide. Il Nuovo Testamento sostiene invece che queste due figure si identificano in un’unica persona che compare sulla scena in due momenti storici diversi. Sovranità e grazia di Dio Ci sono due aspetti dell’opera di Dio che il Messia avrebbe manifestato e portato sulla terra, esprimibili con i concetti di sovranità e grazia, che nella Bibbia compaiono con termini come “regno di Dio” e “perdono dei peccati”. Nel regno messianico Dio agirà come sovrano, la sua volontà sarà pienamente compiuta sulla terra come è fatta in cielo. Sarà dunque un regno di perfetta giustizia, dove Israele sarà il centro del mondo e Gerusalemme sarà il centro d’Israele. La profezia di Isaia presenta la nuova Gerusalemme come una città vuota preparata da Dio, in cui a un certo momento la nazione ebraica viene invitata ad entrare: “In quel giorno, si canterà questo cantico nel paese di Giuda: Noi abbiamo una città forte; l'Eterno vi pone la salvezza per mura e per bastioni. Aprite le porte ed entri la nazione giusta, che si mantiene fedele” (Isaia 26:1-2). La nuova Gerusalemme sarà dunque una città forte, preparata per essere il centro di un regno governato dalla perfetta e inderogabile giustizia di Dio. La nazione ebraica sarà invitata ad entrare, ma per poterlo fare dovrà essere una nazione giusta. Se così non fosse, il suo solo ingresso causerebbe la fine della perfetta giustizia di quel regno. E non basterà che sia presente una giustizia nazionale, cioè un governo che sappia regolare in modo equo il rapporto tra i suoi più o meno giusti cittadini: sarà indispensabile che tutti i membri del popolo siano giusti, uno per uno, perché sta scritto: “Il tuo popolo sarà tutto un popolo di giusti; essi possederanno il paese per sempre; essi, che sono il germoglio da me piantato, l’opera delle mie mani, per manifestare la mia gloria” (Isaia 60:21) Nel progetto di Dio Gerusalemme è pronta, preparata specificamente per la sua nazione, ma, viste le condizioni di ingresso, corre il serio rischio di restare una città vuota. Per il suo popolo Dio ha preparato una terra meravigliosa dove scorre il latte e il miele, con una città ben costruita e forte, ma ha anche redatto una carta costituzionale in cui sono fissate le norme legali per ottenerne la cittadinanza. E le condizioni stabilite da queste norme sono talmente elevate e restrittive che potrebbe esistere il rischio che nessuno riesca ad entrarvi. Il rischio effettivamente esiste, e Gesù quando ha cominciato il suo ministero non si è presentato al pubblico come uno che fa sconti. Il suo famoso sermone sul monte (Matteo, capp. 5-7) contiene una serie di colpi di maglio che si abbattono su tutti, nessuno escluso, con degli implacabili “Voi avete udito che fu detto... ma io vi dico” che non lasciano via di scampo. Davanti ai farisei che nella loro rigorosa religiosità rinfacciavano ai mondani laici il loro riprovevole lassismo, Gesù non reagisce manifestando benevola comprensione per i mondani, ma attaccando duramente i farisei sul loro stesso piano: “Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli” (Mt 5:20), e conclude: “Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5:48). Ecco dunque la condizione per entrare in quel regno: che sia fatta perfettamente la volontà di Dio“anche in terra come è fatta nel cielo”. I cittadini devono essere perfetti come Dio è perfetto. Chi ci riesce da solo, lo faccia. Ma c’è qualcuno che può riuscirci? E’ triste che anche molti ebrei messianici, per un comprensibile desiderio di essere più vicini al loro popolo, sminuiscano la portata di questo poderoso discorso mozzafiato di Gesù considerandolo quasi come un’appendice integrativa della legge mosaica. Non è questo il modo per piacere a Dio e manifestare amore per Israele. La richiesta di una perfetta giustizia pone a tutti il problema del peccato, in primo luogo per Israele. Perché in primo luogo per Israele? E’ chiaro - risponderà l’antisemita medio - perché Israele è il popolo più malvagio della terra. Non è così. Israele si trova sotto la luce dei riflettori di Dio: solo per questo i suoi peccati risaltano di più. Gli altri popoli invece giacciono stabilmente nelle tenebre: solo per questo i loro peccati si vedono di meno. Anzi, poiché i loro peccati non sono illuminati dalla luce della rivelazione di Dio, spesso sono addirittura scambiati per virtù. Ma la parola di Dio rivolta a Israele non è soltanto luce che consente un’esatta diagnosi del male: è anche ordine che richiede ubbidienza. Essendo Israele il popolo a cui Dio ha parlato, il suo peccato si manifesta allora non solo come generica tendenza al male, ma come precisa trasgressione di ordini dati da Dio. Questo, per motivi di giustizia, richiede la punizione. E così è avvenuto più volte, ma guai a chi pensa che questo sia dovuto a una particolare peccaminosità del popolo colpito, perché Israele rappresenta il paradigma di quello che è il mondo, e di quello che Dio si propone di fare con tutta l’umanità. Quando il mondo vede che Israele è colpito, cominci pure a tremare perché presto qualcosa di peggio si abbatterà su di lui. Per secoli il popolo d’Israele, nonostante i ripetuti richiami dei profeti si era mantenuto nel suo insieme in una tale situazione di peccato da attirare il giudizio di Dio sull’intera nazione. Ma anche in questo caso il fattore tempo ha svolto una parte importante. Prima di eseguire il grave giudizio della distruzione del Tempio e della fine dell’autonomia nazionale, Dio aveva mandato solenni avvertimenti: “L’Eterno, Dio dei loro padri, mandò loro a più riprese degli ammonimenti, per mezzo dei suoi messaggeri perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua casa; ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l’ira dell’Eterno contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Allora egli fece salire contro di essi il re dei Caldei, che uccise di spada i loro giovani nella casa del loro santuario, e non risparmiò giovane, né fanciulla, né anziano, né vecchio. L’Eterno gli diede nelle mani ogni cosa. Nabucodonosor portò a Babilonia tutti gli utensili della casa di Dio, grandi e piccoli, i tesori della casa dell’Eterno, e i tesori del re e dei suoi capi. I Caldei incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e ne distrussero tutti gli oggetti preziosi. Nabucodonosor deportò a Babilonia quanti erano scampati alla spada; ed essi furono assoggettati a lui e ai suoi figli, fino all’avvento del regno di Persia (affinché si adempisse la parola dell’Eterno pronunziata per bocca di Geremia), fino a che il paese avesse goduto dei suoi sabati; difatti esso dovette riposare per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i settant’anni” (2 Cronache 36:15-19). La Shekinah abbandona il Tempio Prima che su Israele si abbattesse il terribile giudizio della distruzione di Gerusalemme, era avvenuto un fatto ancora più grave e inquietante: la gloria di Dio (Shekinah ) aveva abbandonato il santuario. La Shekinah rappresenta la presenza sensibile dell’Eterno in tutta la sua purezza e sovranità. Vicino a lei l’impuro non può sussistere e il ribelle non può continuare a vivere. La Shekinah dimorava nel luogo santissimo, in cui nessuno poteva entrare se non il Sommo Sacerdote una volta l’anno nel giorno dell’espiazione, lo Yom Kippur, dopo aver compiuto scrupolosamente tutti i prescritti rituali di purificazione. Prima che il Tempio potesse essere contaminato e distrutto dai peccatori, era necessario che la Shekinah di Dio lasciasse la sua dimora, e questo è avvenuto. Nella descrizione che ne fa il profeta Ezechiele, la Shekinah lascia il luogo santissimo lentamente, in tre tempi, come esitando, come se aspettasse un ultimo, tardivo ravvedimento del popolo. Come primo movimento sale sui cherubini e si sposta sulla soglia del Tempio: “E la gloria dell’Eterno s’alzò sui cherubini, movendo verso la soglia della casa; e la casa fu ripiena della nuvola; e il cortile fu ripieno dello splendore della gloria dell’Eterno” (Ezechiele 10:4). Poi, portata sempre dai cherubini, s’innalza di nuovo e si posiziona all’ingresso della porta orientale del cortile del Tempio: “La gloria dell’Eterno partì dalla soglia della casa e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le loro ali e s’innalzarono su dalla terra; io li vidi partire, con le ruote accanto a loro. Si fermarono all’ingresso della porta orientale della casa dell’Eterno; e la gloria del Dio d’Israele stava sopra di loro, su in alto” (Ezechiele 10:18-19). Infine lascia la città e si ferma sul monte degli Ulivi: “Poi i cherubini spiegarono le loro ali, e le ruote si mossero accanto a loro; la gloria del Dio d’Israele stava su di loro, in alto. La gloria dell’Eterno s’innalzò in mezzo alla città e si fermò sul monte situato a oriente della città” (Ezechiele 11:22-23). Secondo una tradizione rabbinica, la Shekinah rimase tre anni e mezzo sul monte degli Ulivi, in attesa di un ravvedimento del popolo, dopo di che sparì. Il primo Tempio fu distrutto, e anche se dopo il ritorno di alcuni esuli da Babilonia ne fu ricostruito un secondo, in tutto l’Antico Testamento non è mai scritto che la Shekinah sia tornata ad abitare in esso. La gloria, espressione di santità e sovranità di Dio, aveva abbandonato Gerusalemme. Al popolo era arrivata a suo tempo la parola del Signore: “Parla a tutta la comunità dei figli d’Israele, e di’ loro: »Siate santi, perché io, l’Eterno, il vostro Dio, sono santo»” (Levitico 19:2). La mancanza di santità nel popolo aveva portato alla perdita di sovranità sulla terra ricevuta da Dio con il preciso scopo di manifestare in essa la sua santità. Si comincia allora a respirare pura aria biblica quando ci si allontana dai miasmi intellettualistici dei pagani e si arriva a capire che il binomio fondamentale non è spirito-materia, ma sovranitàsantità di Dio. Gli zeloti del tempo di Gesù e i sionisti combattivi di oggi accentuano l’aspetto della sovranità: Dio è sovrano, Israele è il suo popolo, quindi è nostro dovere - dicono - manifestare fede prendendo le armi e combattendo. Dio premierà la nostra fede facendoci vincere e manifesterà la sua sovranità instaurando il suo regno con potenza, dove saremo collocati ai posti di governo perché siamo stati i primi a muoverci con le armi. I farisei del tempo di Gesù e gli ortodossi di oggi accentuano invece l’aspetto della santità: Dio è santo, Israele è il suo popolo, quindi è nostro dovere mantenerci puri osservando scrupolosamente tutte le mitzvot prescritte dalla Torà. Dio premierà il nostro zelo instaurando il suo regno di purezza, dove saremo collocati ai posti di maggior prestigio perché siamo stati i più fedeli nell’osservanza dei precetti e nelle pratiche di purificazione. Nel caso si dovesse verificare uno di questi due casi, a chi andrebbe la gloria? Certamente non a Dio soltanto: nel migliore dei casi Dio dovrebbe spartirla con qualcun altro: o gli zeloti o i farisei. Ma su questo Dio non è d’accordo: “Per amor di me stesso, per amor di me stesso io voglio agire; perché infatti dovrei lasciare profanare il mio nome? Io non darò la mia gloria a un altro” (Isaia 48:11). L’importanza della gloria da dare a Dio probabilmente era presente alla mente dell’apostolo Paolo quando, nella sua lettera agli Efesini, nel presentare con parole profonde e sublimi l’opera di Cristo, per ben tre volte ripete l’espressione “a lode della sua gloria”. Gesù, e soltanto Gesù, è la Shekinah di Dio. Essa è indissolubilmente collegata con Israele, ma non può mai diventare prigioniera di Israele, come di nessun altro. Nel libro di Ezechiele l’avventura della gloria di Dio non termina con la sua sparizione dal monte degli Ulivi. Verso la fine del libro, al capitolo 43, la Shekinah rientra in scena. Il profeta, che si trovava in cattività a Babilonia, viene portato in visione ad osservare il Tempio che sarà costruito nella nuova Gerusalemme: “Poi mi condusse alla porta, alla porta che guardava a oriente. Ecco, la gloria del Dio d’Israele veniva dal lato orientale. La sua voce era come il rumore di grandi acque e la terra risplendeva della sua gloria. La visione che io ebbi era simile a quella che io ebbi quando venni per distruggere la città; queste visioni erano simili a quella che avevo avuta presso il fiume Chebar; e io caddi sulla mia faccia. La gloria dell’Eterno entrò nella casa per la via della porta che guardava a oriente. Lo spirito mi portò in alto e mi condusse nel cortile interno; ed ecco la gloria dell’Eterno riempiva la casa. Io udii qualcuno che mi parlava dalla casa; un uomo era in piedi presso di me. Egli mi disse: «Figlio d’uomo, questo è il luogo del mio trono, il luogo dove poserò la pianta dei miei piedi; io vi abiterò per sempre in mezzo ai figli d’Israele; la casa d’Israele e i suoi re non contamineranno più il mio santo nome con le loro prostituzioni e con i cadaveri dei loro re sui loro alti luoghi, come facevano quando mettevano la loro soglia presso la mia soglia, i loro stipiti presso i miei stipiti, così che non c’era che una parete fra me e loro. Essi contaminavano così il mio santo nome con le abominazioni che commettevano; perciò io li consumai, nella mia ira. Ora allontaneranno da me le loro prostituzioni e i cadaveri dei loro re, e io abiterò in mezzo a loro per sempre” (Ezechiele 43:1-9). La Shekinah ritornerà visibilmente a Gerusalemme e manifesterà la sovranità di Dio. Tutto il mondo dovrà riconoscere che Dio ha scelto Israele per manifestare la sua gloria. A tutte le nazioni dovrà essere chiaro che il Re del mondo è anche il Re d’Israele, e che Dio dà la terra a chi vuole senza consigliarsi con nessuno. L’allontanamento temporaneo di Israele dalla terra ricevuta in eredità è un segno della sovranità di Dio su Israele, ma il ritorno di quel popolo su quella medesima terra sarà un segno della sovranità di Dio su tutte le nazioni: “Perciò di’: «Così parla il Signore, l’Eterno: Sebbene io li abbia allontanati fra le nazioni e li abbia dispersi per i paesi, io sarò per loro, per qualche tempo, un santuario nei paesi dove sono andati». Perciò di’: «Così parla il Signore, l’Eterno: Io vi raccoglierò in mezzo ai popoli, vi radunerò dai paesi dove siete stati dispersi, e vi darò la terra d’Israele»” (Ezechiele 11:16-17). Tornano in mente le parole di Pinsker: “Siamo un gregge disperso su tutta la faccia della terra, senza un pastore che ci protegga e ci raccolga”23. 23 Leon Pinsker, ivi, p. 48. Il Messia, come Servo dell’Eterno, è venuto una volta sulla terra avendo ben chiaro fin dall’inizio del suo ministero qual era il suo primo compito: raccogliere il gregge disperso di Israele e ricondurlo a Dio, come preannunciato dal profeta Isaia: “Ed ora parla l'Eterno che m'ha formato fin dal seno materno per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe, e per raccogliere intorno a lui Israele” (Isaia 49:5) Proprio questo Gesù ha cominciato a fare, dando precise indicazioni ai dodici che aveva scelto: “Questi dodici mandò Gesù, dando loro queste istruzioni: Non andate fra i gentili, e non entrate in alcuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele” (Matteo 10:5-6). Un esempio per molti sconcertante è il modo in cui Gesù risponde alla richiesta di una donna non ebrea: “Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, Figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: «Mandala via, perché ci grida dietro». Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa d’Israele»” (Matteo 15:22-24). Il Messia ha il compito di manifestare la sovranità di Dio su Israele e, con Israele, su tutto il mondo. La sovranità di Dio, come emerge in modo netto e chiaro da tutte le pagine dell’Antico Testamento, non può esprimersi soltanto in forma “spirituale”, non può riguardare cioè soltanto l’intimo del singolo individuo, ma deve toccare anche l’aspetto politico-sociale della vita delle nazioni, e quindi, in primo luogo, della nazione ebraica. La salvezza di Israele consiste nell’accettazione della sovranità di Dio sulla nazione. Fino a che questa sovranità non sarà pienamente accettata, non ci sarà salvezza per Israele. Ma è stata accettata? Sicuramente no: su questo almeno forse tutti saranno d’accordo. Del resto, Gesù stesso lo conferma: era venuto per raccogliere le pecore perdute della casa d’Israele, ma alla fine del suo ministero deve tristemente ammettere che le pecore rifiutano di farsi raccogliere: “«Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto!” (Matteo 23:37). Il popolo, come insieme nazionale, ha rigettato il suo Messia. Ma come sempre nella storia di Israele, anche in questo caso si è trovato un nucleo di uomini fedeli “il cui ginocchio non s’è piegato davanti a Baal” (1 Re 19:18) che la Scrittura chiama “residuo”. Sarà proprio questo residuo che permetterà a Dio di continuare la sua opera di grazia in favore di tutto il popolo. Resta comunque il fatto che nel tempo della prima venuta del Messia il gregge non si è lasciato raccogliere intorno al suo pastore. Questo era stato previsto ed ha causato il cosiddetto “scoraggiamento del Servo dell’Eterno”: “Ma io dicevo: «Invano ho faticato; inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza»” (Isaia 49:4). Ma se Israele non ubbidisce, che dire della sovranità di Dio? Se l’espresso volere di un’autorità viene disatteso senza che accada nulla, è chiaro che si ha una perdita di sovranità. Una cosa sola può impedire in questo caso la perdita di sovranità: la punizione. Quando la legge prescrittiva è violata, entra necessariamente in gioco la legge punitiva: soltanto così può essere preservata la sovranità della legge. Israele come personalità corporativa A questo punto per alcuni le cose saranno del tutto chiare: Israele ha disubbidito a Dio e di conseguenza si abbatte su di lui la punizione divina, pesante, completa e definitiva. Che dire allora delle innumerevoli promesse fatte da Dio a questo popolo nella Bibbia? Alcune risposte date: 1) devono essere intese in senso allegorico e trasferite ad una realta istituzionale politicamente visibile chiamata Chiesa; 2) devono essere intese in senso spirituale e applicate personalmente a me; 3) devono considerarsi abrogate se contengono benedizioni per Israele e sempre valide se contengono maledizioni. Con risposte come queste, non può sorprendere che sia nato e continui a prosperare un antisemitismo cosiddetto cristiano, che qualcuno pensa di addolcire chiamandolo “antigiudaismo” o “antisemtismo teologico”. Sarebbe sorprendente il contrario. Occorre allora tornare a sottolineare che nella Bibbia il popolo d’Israele costituisce una personalità corporativa con cui Dio tratta come se fosse una singola persona. A Mosè Dio aveva ordinato: “Tu dirai al faraone: “Così dice l’Eterno: Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico: «Lascia andare mio figlio, perché mi serva»; se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito”»” (Esodo 4:22-23. Nell’Antico Testamento il termine “figlio di Dio” viene usato soltanto in due casi: per indicare il popolo d’Israele, come abbiamo visto sopra, e per indicare il suo Messia, come si legge nel Salmo 2: “Io annunzierò il decreto: l’Eterno mi ha detto: «Tu sei mio figlio, oggi io t’ho generato. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro; tu le frantumerai come un vaso d’argilla»” (Salmo 2:7-9). L’altra espressione usata per indicare sia il popolo d’Israele, sia il suo Messia è “servo dell’Eterno”, che compare nel libro di Isaia. Un passo in cui si intende certamente il popolo è il seguente: “Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe che io ho scelto, discendenza di Abraamo, l’amico mio, tu che ho preso dalle estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto: «Tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato, tu, non temere, perché io sono con te; non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio; io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati e confusi; i tuoi avversari saranno ridotti a nulla e periranno; tu li cercherai e non li troverai più. Quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra, saranno come nulla, come cosa che più non è; perché io, l’Eterno, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico: Non temere, io ti aiuto! Non temere, Giacobbe, vermiciattolo, e Israele, povera larva. Io ti aiuto», dice l’Eterno. «Il tuo salvatore è il Santo d’Israele” (Isaia 41:8-14). Un passo in cui invece si intende il Messia è il seguente: “Ecco il mio servo, io lo sosterrò; il mio eletto di cui mi compiaccio; io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade. Non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante; manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra; e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge” (Isaia 42:1-4). Con un accurato calcolo si arriva a stabilire che nella seconda parte del profeta Isaia il servo dell’Eterno viene nominato 19 volte: di queste, 12 si riferiscono al popolo, 7 si riferiscono al Messia. Esiste dunque un collegamento per così dire vitale tra il popolo e il suo Messia, che non è possibile tentare di rompere senza serie conseguenze per chi ci prova. Il Messia staccato da Israele si trasforma in qualcosa d’altro che ben presto assume le sembianze di un idolo; Israele staccato dal suo Messia diventa una realtà politico-sociale priva di identità e di speranza per il futuro. Il Nuovo Testamento conferma questo collegamento vitale quando cita un passo del profeta Osea: “Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d’Egitto” (Osea 11:1) applicandolo alla fuga di Giuseppe in Egitto: “Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d’Egitto chiamai mio figlio»” (Matteo 2:15). Il Messia è collegato indissolubilmente al popolo come suo rappresentante giuridico nel patto che Dio ha stabilito con Israele. E’ stato inviato a Israele una prima volta nella persona di Gesù di Nazaret. La luce apparsa ai pastori nella cosiddetta notte di Natale, e ai magi d’Oriente qualche tempo dopo, esprime la presenza della Shekinah di Dio che si avvicina al popolo in forma velata. Gesù viene a portare la santità di Dio sulla terra, anzitutto nella sua persona, avendo egli vissuto in tutto e per tutto come un irreprensible pio ebreo, e poi nel popolo, come possibilità ottenuta dal Padre di portare sulla terra il perdono dei peccati. Il popolo ha rigettato il suo Messia, ma il Messia non ha rigettato il suo popolo. Il peccato nazionale commesso dalla generazione di quel tempo è stato quello di avere rifiutato il Messia, non di avere ucciso Gesù. Il rigetto del Messia da parte di Israele è stato un atto di gravissima ribellione, un rifiuto netto e sfrontato della sovranità di Dio. “Non vogliamo che costui regni su di noi” (Luca 19:14) dicono i cittadini di una parabola in cui Gesù voleva chiaramente intendere i suoi connazionali di quel tempo. Per ristabilire la sua sovranità calpestata, Dio avrebbe potuto sterminare immediatamente popolo e nazione. Non lo ha fatto, e tuttavia la sua sovranità non ne è rimasta intaccata, perché la sua volontà era un’altra. A Israele Dio non aveva promesso soltanto di liberarlo dalle mani dei suoi nemici, ma anche di liberarlo dalla schiavitù dei suoi peccati: “Quale Dio è come te, che perdoni l’iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati” (Michea 7:18-19). “Nessun abitante dirà: «Io sono malato». Il popolo che abita Sion ha ottenuto il perdono della sua iniquità” (Isaia 33:24). In altre parole, Dio aveva promesso a Israele di farlo partecipe non solo della sua sovranità, ma anche della sua santità. Zaccaria, uno degli ultimi profeti attraverso cui Dio aveva parlato al popolo prima che il cielo si chiudesse nel suo silenzio per circa quattrocento anni, annuncia che un giorno Israele sarà partecipe della sovranità di Dio su tutto il mondo: “Manda gridi di gioia, rallegrati, o figlia di Sion! poiché ecco, io sto per venire, e abiterò in mezzo a te, dice l’Eterno. E in quel giorno molte nazioni s’uniranno all’Eterno, e diventeranno mio popolo; e io abiterò in mezzo a te, e tu conoscerai che l’Eterno degli eserciti m’ha mandato a te. E l’Eterno possederà Giuda come sua parte nella terra santa, e sceglierà ancora Gerusalemme. Ogni carne faccia silenzio in presenza dell’Eterno! poich’egli s’è destato dalla sua santa dimora" (Zaccaria 2:10-13). Ma come è possibile che Dio “scelga ancora Gerusalemme” quando la nazione è piena di peccato e i pagani intorno a lei trovano buoni motivi per accusarla? La risposta è contenuta nelle parole che seguono immediatamente: “E mi fece vedere il Sommo Sacerdote Giosuè, che stava in piè davanti all’angelo dell’Eterno, e Satana che gli stava alla destra per accusarlo. E l’Eterno disse a Satana: "Ti sgridi l’Eterno, o Satana! ti sgridi l’Eterno che ha scelto Gerusalemme! Non è questi un tizzone strappato dal fuoco?" Or Giosuè era vestito di vestiti sudici, e stava in piè davanti all’angelo. E l’angelo prese a dire a quelli che gli stavano davanti: "Levategli di dosso i vestiti sudici!" Poi disse a Giosuè: "Guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità, e t’ho vestito di abiti magnifici. E io dissi: "Gli sia messa in capo una tiara pura!" E quelli gli posero in capo una tiara pura, e gli misero delle vesti; e l’angelo dell’Eterno era quivi presente” (Zaccaria 3:1-5). Questo è un passo ben noto negli ambienti evangelici, ma purtroppo è anche un esempio di quella “teologia della sostituzione personalizzata” che, senza adeguata riflessione biblica, trasferisce immediatamente al singolo credente quello che nella Scrittura Dio ha promesso a Israele. Nel passo citato il Sommo Sacerdote Giosuè rappresenta il popolo d’Israele, e soltanto dopo che questo fatto è stato ben inteso in tutto il suo significato è lecito ringraziare il Signore per le conseguenze benefiche che ricadono anche su di me personalmente come conseguenza di quello che Dio ha fatto, e vuole ancora fare, per il suo popolo. Quello che invece non è lecito è il sistematico bypass di Israele, la pretesa di stabilire un rapporto diretto tra Dio e me con l’intermediazione di un Gesù degiudaizzato e privo di ogni collegamento con Israele se non per il fatto di essere nato ebreo. I cattolici sostituiscono indebitamente Israele con l’istituzione “Chiesa”; molti evangelici invece sostituiscono Israele con “me”. In un modo o nell’altro, l’Israele biblico scompare dall’orizzonte, sostituito nel primo caso dalla corporeità di un’organizzazione fin troppo concreta e visibile, nel secondo caso da un evanescente Israele di favola usato come riserva di materiale per raccontini moralistico-edificanti tratti dall’Israele del passato o per eccitanti immaginazioni di quello che potrebbe avvenire con l’Israele del futuro. Quando poi ci si imbatte nell’Israele concreto del presente, gli usuali schemi si scompigliano ed esce fuori di tutto. La quantità di sciocchezze che si sentono dire su Israele, molto spesso da persone convinte di padroneggiare pienamente l’argomento e di avere idee precise in merito, è inimmaginabile. Il Messia sofferente Israele si è presentato agli occhi di Dio come un popolo che non era soltanto genericamente malvagio, come tutti i popoli della terra, ma trasgressore di una precisa volontà rivelata da Dio. Per motivi di giustizia e di mantenimento della sovranità di Dio, doveva dunque esserci una punizione. E’ in questo momento che entra in gioco la figura del Messia sofferente. Come rappresentante giuridico di tutta la nazione, Gesù si è assunto davanti a Dio la responsabilità oggettiva di tutti i peccati del popolo. La punizione destinata al popolo è caduta su di Lui. “Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di lui e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via; ma l’Eterno ha fatto ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti” (Isaia 53:5-6). I primi che hanno capito e fatto proprie queste parole, per quello che era possibile individualmente, cioè l’ottenimento del perdono dei peccati, la guarigione dalla schiavitù del peccato e la pace, sono stati degli ebrei. Tuttavia è vero che Israele come nazione non è stato liberato dalla mano dei suoi nemici, che le promesse gloriose del regno messianico non si sono attuate, che Dio non sembra governare né su Israele né sul resto del mondo. Come si spiega tutto questo? Torniamo al binomio sovranità-santità di Dio. Esso può essere espresso anche nella forma sovranità-grazia di Dio perché, come emerge anche dal sermone sul monte di Gesù, il livello di santità richiesto da Dio per entrare nel suo regno non può in alcun modo essere raggiunto con sforzi umani. Si può allora esprimere la cosa in questo modo: nel piano di Dio il Messia è destinato a svolgere per Israele le funzioni di Re e Salvatore; quando questo sarà una realtà per Israele, si compirà anche la promessa fatta ad Abramo di essere strumento di benedizione per tutte le genti, perché il Messia inviato a Israele si manifesterà anche come Re e Salvatore di tutto mondo. La difficoltà sta nel mettere insieme, nel Messia, le due figure di Re e Salvatore, e nel collegare correttamente Israele e mondo. Il Messia è venuto a Israele nella persona di Gesù. Questo fatto grandioso non poteva che essere una “grande gioia” per tutto il popolo: “L’angelo disse loro: «Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà: “Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore” (Luca 2:10-11). Già in questo passo si riconoscono i due aspetti del Messia: Salvatore e Signore. In Gesù sono sempre entrambi presenti, anche se le forme della loro manifestazione sono diverse a seconda dei luoghi e dei tempi. Gesù ha cominciato il suo ministero come profeta e ha continuato dando ben presto segni di sovranità con il suo modo perentorio di dare ordini agli uomini e con la sua capacità di dominare gli elementi della natura. Ha dato poi segni di grazia mostrando, per esempio, di essere in grado di trasmettere purezza a un impuro che più impuro non si può: “un uomo tutto coperto di lebbra”: “Mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra, il quale, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: «Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi». Ed egli stese la mano e lo toccò, dicendo: «Lo voglio, sii purificato». In quell’istante la lebbra sparì da lui” (Luca 5:12-13). E’ ben nota la storia di Francesco d’Assisi che, secondo la leggenda, incontrò un lebbroso in campagna e lui, per superare una prova impostagli dal Signore, smontò da cavallo e offrì al lebbroso un denaro, baciandogli la mano. A lui andò bene perché superò la prova, ma non è detto che cosa è successo al quel lebbroso e a tutti gli altri che in seguito baciò. Tutto fa pensare che siano rimasti come prima. Il racconto evangelico si muove in un contesto del tutto diverso, e soltanto l’averlo sradicato da Israele ha permesso che si arrivasse a certe sdolcinate applicazioni. La lebbra in Israele significava impurità: la sua presenza quindi non era tollerabile all’interno del popolo di Dio. Il lebbroso doveva allontanarsi dalla comunità e andare in giro gridando “Impuro! Impuro!”, affinché nessuno, avvicinandolo e toccandolo, diventasse a sua volta impuro. La legge di Mosè ordinava di stare lontano da una persona simile, non di andare a baciarlo. Se questo oggi ci sembra egoismo e cattiveria, è perché siamo interessati soltanto ai rapporti fra noi uomini; Israele invece è, per vocazione, interessato ai rapporti degli uomini con Dio. Ma allora è proprio vero che il riferirsi a Dio indurisce e avvelena i rapporti fra gli uomini? Dipende. Dipende dagli uomini, non da Dio. Il lebbroso del racconto evangelico non fa una richiesta a Gesù e non parla di guarigione, fa un’affermazione in cui si parla di purificazione: “Se tu vuoi, tu puoi purificarmi”. La guarigione riguarda il rapporto fra me e il mio corpo, fra me e i miei simili; la purificazione invece riguarda in primo luogo il rapporto fra me e Dio, e soltanto in un secondo momento il rapporto fra me e il mio prossimo. Il lebbroso non accenna a particolari e difficili pratiche religiose, non nomina elevati concetti astratti come emarginazione, solidarietà, giustizia, pace, amore, libertà, uguaglianza, fraternità, ebraismo, umanesimo, nichilismo e altro ancora, ma risponde implicitamente alla domanda fondamentale che i Vangeli pongono a ogni lettore: “E tu, chi dici che sia Gesù?” Con le sue parole il lebbroso dichiara pubblicamente a Gesù: “Tu sei il Messia, il Figlio di Davide”, perché da quando la legge di Mosè era stata data non era mai successo in Israele che un lebbroso totale fosse purificato. E secondo l’insegnamento rabbinico soltanto il Messia avrebbe potuto fare una cosa simile. “Poi Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno. «Ma va’», gli disse, «mòstrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto; e ciò serva loro di testimonianza»” (Luca 5:14). Perché quest’ordine? Quale testimonianza avrebbero dovuto ricevere i sacerdoti? Nella Torà ci sono due interi lunghi capitoli, Levitico 13 e 14, dedicati soltanto alla lebbra. In essi non si parla di tecniche o riti di guarigione, ma di disposizioni con cui il sacerdote preordinato doveva verificare la possibile esistenza di lebbra in una persona. In caso affermativo, la persona doveva essere segregata fino a che, in una successiva verifica, non fosse stata accertata la completa sparizione della lebbra. In linguaggio odierno si potrebbe dire che il sacerdote non aveva funzioni terapeutiche, ma svolgeva il ruolo di medico legale. Le disposizioni legali erano molte e minuziose, e prima che una persona che era stata colpita dalla lebbra potesse rientrare in comunità doveva superare molti esami rigorosi e assoggettarsi a un complicato rituale di purificazione. Il centro dell’interesse non era dunque il benessere della persona, ma la santità del rapporto tra Dio e il suo popolo. La motivazione data da Dio per simili pratiche era questa: “Così terrete separati i figli d’Israele da ciò che li contamina, affinché non muoiano a motivo della loro impurità, contaminando il mio tabernacolo che è in mezzo a loro” (Levitico15:31). Gesù sapeva benissimo che con la sparizione della lebbra i guai del suo “paziente” non erano finiti. L’ex lebbroso avrebbe dovuto essere riammesso in società, e aveva bisogno per questo di una specie di patentino di circolazione che poteva ricevere soltanto dal sacerdote. Ma al “medico legale” questo caso avrebbe offerto sicuramente non pochi grattacapi. Avrebbe dovuto informarsi di come si erano svolte esattamente le cose, se veramente la persona aveva avuto la lebbra in passato e come mai adesso era sparita. E si sarebbe sentito dire dall’ex lebbroso che Gesù l’aveva toccato e che nel contatto non era stata l’impurità a trasmettersi da lui a Gesù, ma, al contrario, era stata la purità di Gesù a trasmettersi a lui. Incredibile! A meno che... a meno che la persona che ha toccato il lebbroso non sia davvero il Messia. Questa è la testimonianza che i sacerdoti dovevano ricevere. Questo episodio esprime in forma plastica il collegamento tra santità e grazia. Da una parte il livello di purezza richiesto da Dio è elevatissimo, e quindi irraggiungibile per l’uomo; dall’altra è Dio stesso che si preoccupa di trasmettere all’uomo la sua purezza. Abbiamo detto che i due aspetti apparentemente contraddittori in cui si presenta la figura del Messia nella Scrittura corrispondono a due sue funzioni fondamentali: Re e Salvatore. Esse sono sempre entrambe presenti nella persona di Gesù, ma si manifestano in modi diversi nella successione temporale. L’annuncio della regalità del Messia è presente nell’annuncio dell’angelo a Maria: “L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato Figlio dell’Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine»” (Luca 1:30-33. Qui è bene precisare che il trono di Davide promesso da Dio si trova sulla terra, non in un’evanescente sfera spirituale. E’ realistico quindi dire che oggi questo trono non è presente nel mondo. Non per questo però viene meno la sovranità di Dio: anzi, è per una sua precisa volontà che questo avviene. Nei Vangeli è presente anche, fin dall’inizio, il riferimento alla salvezza come possibilità di ottenere il perdono dei peccati. Nel noto cantico di Zaccaria del Vangelo di Luca, l’anziano sacerdote “ripieno dello Spirito Santo” rivolge al figlio Giovanni appena nato queste parole: “E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati” (Luca 1:76, 77). Quello che né Zaccaria né Giovanni Battista immaginavano era che il peccato più grande da cui Israele avrebbe dovuto essere perdonato dal Messia come Salvatore sarebbe stato il rifiuto del Messia stesso come Re. Stranamente, è stato invece un pagano a riconoscere che Gesù è il re dei giudei: “Era la preparazione della Pasqua, ed era l’ora sesta. Egli disse ai giudei: «Ecco il vostro re!» Allora essi gridarono: «Toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Crocifiggerò il vostro re?» I capi dei sacerdoti risposero: «Noi non abbiamo altro re che Cesare»” (Giovanni 19:14-15). Questi riferimenti alla regalità sono molto importanti, perché in essi si esprime il rifiuto della sovranità di Dio da parte dell’uomo, “del giudeo prima e poi del greco”. Gli ebrei dichiarano di voler essere sottoposti a un re pagano, piuttosto che al Re inviato loro da Dio. Il pagano Pilato invece riconosce che Gesù è il re dei giudei, ma esprime disprezzo per il popolo di Dio. Sulla croce fa scrivere il motivo della sentenza: “Gesù il Nazareno, il re dei giudei”. E’ come se dicesse: questo per me è il vostro re, e se inchiodo lui, vuol dire che posso inchiodare anche tutti voi. I capi di Israele capiscono l’antifona e tentano una reazione, ma senza risultato: “Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato: «Non lasciare scritto: “Il re dei giudei”; ma che egli ha detto: “Io sono il re dei giudei”». Pilato rispose: «Quello che ho scritto, ho scritto»” (Giovanni 19:21-22). Israele dunque ha rifiutato il Messia come Re, ma non ha potuto rifiutarlo come Salvatore. Non ha potuto perché Dio aveva stabilito che proprio attraverso il più grande peccato che Israele potesse commettere andasse in porto il suo piano di salvezza per il popolo e per tutto il mondo. Un principio è ben noto e chiaro nella Torà: l’espiazione di certi peccati può avvenire soltanto attraverso spargimento di sangue: “Poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull’altare per fare l’espiazione per le vostre persone; perché il sangue è quello che fa l’espiazione, per mezzo della vita” (Levitico 17:11). L’autore della lettera agli Ebrei esprime lo stesso concetto con altre parole: “Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue; e, senza spargimento di sangue, non c’è perdono” (Ebrei 9:22). Per questo motivo la legge prevedeva il sacrificio di diversi animali per compiere atti di espiazione in favore di particolari persone in particolari momenti. Ma nel programma di Dio era previsto un unico sacrificio, da farsi una sola volta e valido per tutte le persone e per tutti i tempi: il sacrificio di suo Figlio, mandato come Messia sofferente per compiere la purificazione del popolo e, come successiva conseguenza, di tutto il mondo. E’ questa la testimonianza che ne dà Giovanni Battista: “Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo! Questi è colui del quale dicevo: “Dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me”. Io non lo conoscevo; ma appunto perché egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua»” (Giovanni 1:29-31). In ambito cristiano giustamente si sottolinea che Gesù toglie il peccato del mondo, ma con troppa facilità si bypassa rapidamente il riferimento a Israele come se fosse irrilevante ai fini del discorso. In questo modo non si considera seriamente l’opera di Dio (Ecclesiaste 7:13) e non si manifesta un autentico desiderio di conoscerla pienamente al fine di dare a Lui la gloria. Eppure, la gloria di Dio che un giorno sarà manifestata apertamente al mondo sarà anche gloria di Israele. Simeone, “uomo giusto e timorato di Dio che aspettava la consolazione d’Israele”, quando ebbe il bambino Gesù tra le braccia, mosso dallo Spirito Santo esclamò: “Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola; perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele” (Luca 2:29-32). Che Gesù sia luce da illuminare le genti, molti sono pronti a riconoscerlo, ma quanti sono pronti ad aggiungere che Gesù è anche gloria del popolo Israele? A Gesù la gloria e a Israele il disprezzo: questo è il leitmotiv di fondo dell’antisemitismo cristiano. «Ma gli ebrei hanno ucciso Gesù», è l’accusa tradizionale che dovrebbe giustificare l’ostilità verso quel popolo. Ma stanno proprio così le cose? Se si vuole classificare l’uccisione di Gesù tra i crimini commessi da uomini contro altri uomini, è chiaro che la responsabilità giuridica ricade interamente su Pilato. A Gesù infatti aveva detto chiaramente: «Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti?» (Giovanni 19:10), e pur avendo riconosciuto pubblicamente di non aver trovato in Gesù alcuna colpa, ha usato il suo potere decisionale per farlo crocifiggere. La responsabilità dunque è sua. Ma se la morte di Gesù è vista come un atto sacrificale con cui si compie l’espiazione dei peccati, le cose stanno diversamente. Se Gesù è “l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo”, questo significa che la responsabilità della sua morte ricade su Dio stesso, perché è Lui che ha ordinato i sacrifici. E’ chiaro allora che Dio non rinfaccerà mai a nessuno di avergli ucciso il Figlio: né a Caiafa, né a Pilato. Gesù è morto per un’esplicita volontà del Padre che il Figlio ha prontamente accettato: “Per questo mi ama il Padre; perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest’ordine ho ricevuto dal Padre mio” (Giovanni 10:17, 18). E’ dunque per volontà di Dio che l’agnello doveva morire, affinché il peccato del mondo fosse tolto. Ma in ogni sacrificio la vittima non muore di morte naturale: qualcuno deve compiere l’atto sacrificale dell’uccisione, e questi non può che essere il sacerdote. Nel caso dell’agnello messianico, chi altri poteva svolgere questo compito sacerdotale se non il popolo d’Israele? La vocazione di Israele è di essere “un regno di sacerdoti, una nazione santa” (Esodo 19:6). Certo, il popolo non ha crocifisso Gesù come atto di ubbidienza, ma Dio ha usato proprio la sua disubbidienza per fargli svolgere il compito che gli aveva assegnato. E’ un modo di agire del Signore non nuovo: la Scrittura è piena di esempi come questo. Particolarmente significativa è la parte svolta da Caiafa nel processo di Gesù: “Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. I capi dei sacerdoti e i farisei, quindi, riunirono il sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Perché quest’uomo fa molti segni miracolosi. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui; e i Romani verranno e ci distruggeranno come città e come nazione». Uno di loro, Caiafa, che era Sommo Sacerdote quell’anno, disse loro: «Voi non capite nulla, e non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione». Or egli non disse questo di suo; ma, siccome era Sommo Sacerdote in quell’anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione; e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi” (Giovanni 11:46-52). Il Sommo Sacerdote, la più alta carica religiosa d’Israele, delibera la morte di Gesù perché è convinto - e non è lecito dubitare della sua sincerità in quel momento - che da quella morte dipenda la salvezza della nazione. Il suo è un discorso di realismo politico, come se ne fanno tanti anche oggi. Anche allora i governanti della nazione si ponevano il problema di come difendere la sovranità nazionale, e cercavano di farlo tenendo conto della forza degli altri popoli. Alla classe dirigente israeliana di quel momento sembrò necessario “sacrificare” Gesù alla potenza dominante di Roma. Secondo loro, se non si fosse agito tempestivamente tutto il popolo sarebbe stato trascinato nel “peccato politico” di insurrezione, e la nazione sarebbe stata distrutta insieme al suo popolo. Presentando invece all’autorità politica pagana come unico “peccatore”, cioè come sovversivo, l’uomo che sarebbe potuto diventare il capo dell’insurrezione, l’ira del Re umano si sarebbe placata abbattendosi su di lui e la nazione sarebbe stata salva. Forse non era proprio questo il pensiero dei puristi farisei, terribilmente irritati soprattutto per la loro perdita di autorità morale presso il popolo, ma certamente erano di questo tipo i pensieri della classe dirigente sacerdotale, molto più attenta alle questioni politiche di governo che non all’osservanza di minuziose e severe regole di purità. Il Sommo Sacerdote dunque ha deliberato la morte di Gesù affinché fosse salva la nazione nella sua sovranità sulla terra d’Israele. Questo però non si è avverato: qualche decennio più tardi la nazione perderà per secoli anche quel poco di sovranità che aveva, e la terra passerà sotto il governo totale dei gentili. Tuttavia, è stata proprio quella delibera del Sommo Sacerdote ad aver permesso la salvezza della nazione, ma non nel senso da lui voluto. La nazione è stata salvata dalla condanna che gravava su di lei per la sua secolare ribellione davanti a Dio. Questo è stato possibile perché “uno solo è morto per il popolo”, e in questo modo “la nazione non è perita”. Israele ha perso temporaneamente la sovranità sulla sua terra, ma ha acquistato davanti a Dio il diritto di entrarvi un giorno, e definitivamente, come “nazione giusta”: “In quel giorno, si canterà questo cantico nel paese di Giuda: Noi abbiamo una città forte; l'Eterno vi pone la salvezza per mura e per bastioni. Aprite le porte ed entri la nazione giusta, che si mantiene fedele” (Isaia 26:1-2). Per il suo peccato Israele ha perso temporaneamente sovranità, ma per grazia ha ottenuto definitivamente santità, perché qualcuno si è fatto responsabile delle colpe del popolo caricandosi dei suoi peccati. Un popolo perdonato, una nazione santa In ambito evangelico si sottolinea giustamente che Gesù è morto “per i miei peccati” e vuole diventare “il mio personale Salvatore”. Questo è vero, ma non è tutto. E in qualche caso quello che si tace può diventare tanto importante negativamente quanto è importante positivamente quello che si dice. Le parole “Gesù doveva morire per la nazione” (Giovanni 11:51) si riferiscono in prima battuta non a me personalmente, singolo gentile, ma a Israele come collettività. Soltanto in seguito l’evangelista aggiunge: “e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi”. Tra i figli di Dio dispersi posso esserci anch’io, se sinceramente ho creduto in Cristo e “l’ho accettato come mio personale Salvatore” (espressione che però non compare mai nella Bibbia). Di tutto questo posso lodare con tutto il cuore il Signore che mi ha salvato, ma non mi è lecito mutilare la Scrittura per ricavarne un riassuntino maneggevole per i miei propri scopi. Il “mio personale Salvatore” non deve diventare il patrocinatore dei miei personali interessi. L’accostamento di nazione e dispersione nel testo citato di Giovanni può anche fornire uno spunto interessante per valutare la contrapposizione, oggi attualissima nel mondo ebraico, tra nazione e diaspora. Dov’è il posto degli ebrei oggi? In Israele, rispondono alcuni, perché è lì che il popolo ebraico può sopravvivere e testimoniare al mondo dell’unico vero Dio; lo Stato ebraico è uno strumento che serve a questo scopo. Nel mondo, rispondono altri, perché è nella dispersione fra tutte le nazioni che si può essere presenti come un sale che conserva e comunica al mondo un aroma particolare del tutto unico; lo Stato ebraico è un intralcio al compimento di questa missione. Israele però non può accontentarsi di sopravvivere, non può sperare di ottenere il permesso di vivere come tutte le altre nazioni, né da Dio, né dal mondo. Al mondo il permesso l’ha chiesto Theodor Herzl con il suo sionismo diplomatico, seguito poi da quello più muscoloso di Ben Gurion e compagni, ma gli ebrei ultra-ortodossi in fondo non hanno torto quando dicono che il sionismo è una forma di assimilazionismo nazionale: gli ebrei, non essendo riusciti ad essere accettati nelle varie nazioni come singoli cittadini uguali a tutti gli altri, hanno tentato di essere accettati nel mondo come una nazione uguale a tutte le altre, e non ci sono riusciti. Israele infatti è l’unica nazione di cui si continua a discutere se ha o no il “diritto all’esistenza”. Si direbbe che anche per il mondo Israele non può esistere come nazione uguale a tutte le altre: deve essere una “nazione santa”. Solo la “santità” richiesta dalla comunità internazionale potrebbe darle il diritto all’esistenza. Riguardo a Israele le nazioni si dividono in due: le buone e le cattive. Le cattive lo vogliono distruggere, le buone lo vogliono educare. Al discoletto Israele le nazioni buone dicono: se non vuoi che le cattive ti distruggano - o, per meglio dire, che noi acconsentiamo a che loro ti distruggano -, tu devi fare quello che ti diciamo noi. Questo, lo chiamano “processo di pace”. Proprio come aveva detto Gesù in un altro contesto e ad altre persone, caricano Israele di “pesi difficili da portare”, mentre loro “non li toccano neppure con un dito”. Ma un giorno sarà smascherata la loro ipocrisia. Sia Dio sia mondo si aspettano da Israele la santità, ma con questa differenza: Dio, “splendido nella sua santità” (Esodo 15:11), dona a Israele la sua santità per grazia; il mondo invece, ripugnante nella sua immondizia, pretende da Israele una santità che lui stesso non possiede. Ma si avvicina “il giorno della vendetta dell’Eterno, l’anno della retribuzione per la causa di Sion” (Isaia 34:8). Gesù si è presentato a Israele come Messia sofferente perché doveva compiere la prima opera necessaria per la salvezza di Israele, come popolo e nazione: la purificazione dei peccati. “Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato l’universo. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi” (Ebrei 1:1-3). Il Messia Gesù, rigettato come Re, ha svolto la sua funzione di Servo sofferente dell’Eterno, come annunciato dal profeta Isaia: “Dopo l’arresto e la condanna fu tolto di mezzo; e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo?” (Is 53:8). Dio chiama Israele mio popolo prima ancora che ricevesse, per la morte di Gesù, il perdono dei peccati. Se prima era un popolo su cui gravava l’ira divina, a motivo della sua testarda disubbidienza, dopo il sacrificio di Cristo Israele è un popolo perdonato. Che vuol dire perdonato - chiederà subito qualcuno -, forse che tutti gli ebrei andranno in Paradiso per il solo fatto che sono ebrei? E’ una domanda che di per se stessa rivela una deformazione individualistica del piano di salvezza di Dio. Dire “popolo perdonato” non equivale dire “popolo di perdonati”. Il popolo costituisce una personalità corporativa con cui Dio intrattiene un rapporto del tipo padre-figlio o marito-moglie. L’Antico Testamento è la storia del rapporto tra Dio e il suo popolo, espresso nella relazione con alcuni personaggi chiave che sono importanti non per le loro più o meno eroiche qualità personali, ma per la posizione rappresentativa che occupano all’interno della relazione fra Dio e il suo popolo. Relazione che a sua volta è rivelatrice dei rapporti che Dio vuole avere con tutto il mondo. La lettura in chiave psicologico-individualistica di certi prediletti personaggi biblici molto spesso non coglie il centro del messaggio biblico e in qualche caso anzi lo deforma e mette il lettore fuori strada. Proprio perché in Cristo Dio ha perdonato Israele adesso i singoli israeliti possono appropriarsi personalmente del perdono concesso al popolo se si ravvedono e credono con tutto il cuore in Colui che è stato offerto a Dio come “propiziazione per la casa d’Israele” (Ezechiele 45:17). Certo, non tutti hanno creduto, anzi: “Chi ha creduto a quel che noi abbiamo annunziato? e a chi è stato rivelato il braccio dell’Eterno?” (Isaia 53:1), ma questo si è sempre verificato nella storia d’Israele e tuttavia Dio non ha mai cambiato l’obiettivo finale del suo progetto. Il debito dell’iniquità del popolo è stato pagato sulla croce e la maledizione dovuta al peccato è passata su Gesù. Dalla parte di Dio dunque è stato fatto tutto quello che si doveva fare; quello che avverrà in futuro non sarà un cambiamento di atteggiamento da parte di Dio, ma da parte del popolo che, ravvedendosi, si approprierà del perdono ricevuto e sarà salvato come nazione. Il rifiuto politico di Gesù da parte dei potenti della terra Vedremo in seguito le benefiche conseguenze che il perdono accordato a Israele ha portato anche a coloro che non appartengono a quel popolo, ma per ora rimaniamo in ambito ebraico ed esponiamo alcune tesi che restano sempre di attualità e non mancheranno di sollevare discussioni. E’ da rigettare l’idea che oggi Israele sia un popolo maledetto, anche se soltanto temporaneamente, a causa del suo rifiuto di Cristo. Al contrario, il Messia Gesù, come rappresentante giuridico di tutto il popolo, nella sua morte ha preso su di sé la maledizione e nella sua risurrezione ha portato benedizione. Israele dunque è un popolo benedetto da Dio e fonte di benedizione per gli altri popoli, secondo la promessa fatta ad Abramo: “Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra»” (Genesi 12:2-3). E’ da rigettare l’idea che i mali che hanno colpito e colpiscono ancora il popolo ebraico siano una dimostrazione dell’ira di Dio che incombe su di lui. Al contrario, la persistenza degli ebrei in mezzo a popoli che contro di loro hanno esibito il peggio della loro malvagità dimostra che Israele si trova sotto la misericordia di Dio. Ed è anche un avvertimento, affinché tutti si rendano conto che il progetto di Dio andrà avanti, quali che siano le decisioni prese dai potenti della terra che continuano a dare ordini a Israele e pretendono di decidere chi dovrà abitare sul monte Sion: “Perché tumultuano le nazioni, e meditano i popoli cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano assieme contro l’Eterno e contro il suo Unto, dicendo: Rompiamo i loro legami e gettiamo via da noi le loro funi. Colui che siede nei cieli ne riderà; il Signore si befferà di loro. Allora parlerà loro nella sua ira, e nel suo furore li renderà smarriti: Eppure, dirà, io ho stabilito il mio re sopra Sion, monte della mia santità. “Io spiegherò il decreto: L’Eterno mi disse: Tu sei il mio figlio, oggi io t’ho generato. Chiedimi, io ti darò le nazioni per tua eredità e le estremità della terra per tuo possesso. Tu le fiaccherai con uno scettro di ferro; tu le spezzerai come un vaso di vasellaio. Ora dunque, o re, siate savi; lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite l’Eterno con timore, e gioite con tremore. Rendete omaggio al figlio, che talora l’Eterno non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché d’un tratto l’ira sua può divampare. Beati tutti quelli che confidano in lui!” (Salmo 2). “Io ho stabilito il mio re sopra Sion, monte della mia santità” è una frase che coniuga sovranità e santità di Dio. Nessuno pensi di poter prendere decisioni riguardanti il monte Sion senza tener conto della volontà già espressa da Dio. Che cosa è avvenuto dunque, storicamente, con la venuta di Gesù sulla terra? Per rispondere naturalmente bisognerebbe prendere in considerazione tutto il Nuovo Testamento, ma in questa sede possiamo limitarci a citare un brano del prologo del Vangelo di Giovanni: “La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l’ha conosciuto. É venuto in casa sua e i suoi non l’hanno ricevuto; ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio: a quelli, cioè, che credono nel suo nome; i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma sono nati da Dio. E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre” (Giovanni 1:9-14). La gloria di Dio si è avvicinata a Israele nella persona del Messia in forma volutamente velata. “E’ venuto in casa sua” e non è stato ricevuto; ma anche il resto del mondo non l’ha ricevuto, perché sta scritto che “il mondo non l’ha conosciuto”. A chi gli faceva notare che “gli ebrei non credono in Cristo” un ebreo messianico ha risposto: “Ma perché, gli italiani credono in Cristo?”Analogamente, a chi facesse notare che lo Stato d’Israele non riconosce in Gesù il suo Messia si potrebbe rispondere: “Ma perché, lo Stato italiano ha riconosciuto in Gesù il Messia d’Israele?” Che differenza c’è, su questo punto, tra Israele e Italia, tra ebrei e italiani? Esiste forse una nazione al mondo che, in quanto tale, dichiara istituzionalmente di riconoscere Gesù come sovrano e di volersi riferire a Lui per ogni aspetto del suo governo? No, verrebbe subito fatto di rispondere, e invece bisogna fermarsi e modificare la risposta: una nazione che dichiara una cosa di questo genere esiste: lo Stato del Vaticano. I paramenti da imperatore medievale con cui va in giro il Papa non sono folclore, ma segni. Segni di regalità. Vogliono dire al mondo che la sovranità politica di Dio si è già realizzata sulla terra ed è presente nello Stato del Vaticano, il quale attende, con pazienza e costanza, il giorno in cui tutto il mondo lo capirà, a cominciare da quei testardi di ebrei che se non sono più “perfidi” come prima restano comunque un bel fastidio. Perché se il regno messianico sulla terra si è già localizzato a Roma ai piedi del monte Mario, che senso ha tutto il loro interesse per Gerusalemme e il monte Sion? Chi crede questo, resti pure o diventi cattolico. Ma sappia che si colloca in una posizione oggettivamente antiebraica, quali che siano i suoi sentimenti di personale simpatia per gli ebrei. Salvezza storica e salvezza personale E’ necessario, ancora una volta, eliminare la confusione sempre riemergente tra individuale e politico, tra salvezza personale e salvezza storica. Il Vangelo di Giovanni dichiara che sul piano della sovranità storico-politica la luce venuta nel mondo in Gesù è stata rifiutata da tutti, “dal giudeo prima e poi dal greco”, da Caiafa e da Pilato, da ebrei e da gentili. A questa netta affermazione Giovanni aggiunge un “ma”: “ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio: a quelli, cioè, che credono nel suo nome; i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma sono nati da Dio” (Giovanni 1:12, 13). Dal piano politico, in cui si muovono la casa d’Israele e il mondo, e in cui avviene il rifiuto della sovranità di Dio manifestatasi nel Re Messia, si passa ora al piano individuale, in cui diventa possibile ottenere il perdono dei peccati e acquisire addirittura “il diritto di diventare figli di Dio”. Questa possibilità è aperta a “tutti quelli” che credono nel Messia Salvatore, “al giudeo prima e poi al greco”. Torniamo allora al Servo dell’Eterno di Isaia che abbiamo lasciato scoraggiato perché, dopo aver cercato di svolgere fedelmente l’incarico ricevuto da Dio “fin dal seno materno” di “ricondurgli Giacobbe e raccogliere intorno a lui Israele, a un certo momento è costretto a dire amaramente: “Invano ho faticato; inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza” (Isaia 49:4). Poco dopo arriva la consolazione dell’Eterno: “Egli dice: «É troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati d’Israele; voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra»” (Isaia 49:6). La sovranità di Dio si manifesta anche nella sua capacità di usare la disubbidienza degli uomini per il compimento dei suoi scopi. Nella sua prima venuta come Servo sofferente dell’Eterno il Messia non ha potuto raccogliere intorno a Dio i figli di Giacobbe perché il popolo non ha voluto. E’ stato respinto e messo a morte, ma in questo modo ha svolto l’altro compito che Dio aveva preparato per lui: diventare luce delle nazioni facendo arrivare a tutti la “buona notizia” della possibilità di essere riconciliati con Dio e diventare suoi figli. Questo spiega la differenza tra i due mandati affidati da Gesù ai discepoli. Se all’inizio aveva ordinato: “Non andate fra i gentili, e non entrate in alcuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele” (Matteo 10:5-6), alla fine ordinerà: “Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo ad ogni creatura” (Marco 16:15) Proprio questo hanno fatto i primi discepoli: hanno predicato la buona notizia della salvezza che si poteva ricevere credendo nel Messia Gesù, cominciando dai giudei, perché a loro per primi doveva essere annunciata questa possibilità. Un esempio significativo è fornito dalla predicazione dell’apostolo Paolo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia: “Essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia; ed entrati di sabato nella sinagoga, si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: «Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo d’Israele scelse i nostri padri, fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto, e con braccio potente lo trasse fuori. E per circa quarant’anni sopportò la loro condotta nel deserto. Poi, dopo aver distrutto sette nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di quelle. Dopo queste cose, per circa quattrocentocinquant’anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. In seguito chiesero un re; e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per un periodo di quarant’anni. Poi lo rimosse, e suscitò loro come re Davide, al quale rese questa testimonianza: “Io ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere”. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio ha suscitato a Israele un salvatore nella persona di Gesù. Giovanni, prima della venuta di lui, aveva predicato il battesimo del ravvedimento a tutto il popolo d’Israele. E quando Giovanni stava per concludere la sua missione disse: “Che cosa pensate voi che io sia? Io non sono il Messia; ma ecco, dopo di me viene uno, al quale io non son degno di slacciare i calzari”. Fratelli miei, figli della discendenza d’Abraamo, e tutti voi che avete timor di Dio, a noi è stata mandata la Parola di questa salvezza. Infatti gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi non hanno riconosciuto questo Gesù e, condannandolo, adempirono le dichiarazioni dei profeti che si leggono ogni sabato. Benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Dopo aver compiuto tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno, e lo deposero in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti; e per molti giorni egli apparve a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri, Dio l’ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche è scritto nel salmo secondo: “Tu sei mio Figlio, oggi io t’ho generato”. Siccome lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia più a tornare alla decomposizione, Dio ha detto così: “Io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide”. Difatti egli dice altrove: “Tu non permetterai che il tuo Santo subisca la decomposizione”. Or Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, si è addormentato, ed è stato unito ai suoi padri, e il suo corpo si è decomposto; ma colui che Dio ha risuscitato, non ha subìto decomposizione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati; e, per mezzo di lui, chiunque crede è giustificato di tutte le cose, delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardate dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti: “Guardate, o disprezzatori, stupite e nascondetevi, perché io compio un’opera ai giorni vostri, un’opera che voi non credereste, se qualcuno ve la raccontasse”»” (Atti 13:14-41). Molti giudei e proseliti pii accolsero con gioia questo lieto annuncio, e la predicazione sembrò avere un grande successo perché sta scritto che “il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la Parola di Dio” (Atti 13:44). L’atmosfera però ormai era cambiata e la predicazione di Paolo incontrò una contestazione furibonda. “Ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente: Era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio; ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili. Perché così ci ha ordinato il Signore, dicendo: Io ti ho posto per esser luce dei gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino alle estremità della terra” (Atti 13:46-47). Paolo usa proprio le parole di Isaia 49:6 per dichiarare ai suoi oppositori che anche attraverso la loro furiosa contestazione si sarebbe compiuta l’opera che Dio aveva assegnata al suo Messia. A chi dovesse osservare che in questa loro reazione gli ebrei sono stati disubbidienti a Dio, Paolo risponderebbe che i gentili sono da sempre disubbidienti a Dio, e quindi non si vede quale superiorità morale possano vantare. Replicando alle osservazioni di ipotetici gentili, Paolo infatti osserva: “Come in passato voi [gentili] siete stati disubbidienti a Dio, e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch’essi [ebrei] sono stati ora disubbidienti, affinché, per la misericordia a voi usata, ottengano anch’essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti” (Romani 11:30-32). La salvezza viene dai giudei Per secoli gli ebrei hanno vissuto in diaspora e tuttora vi si trovano, anche se una parte minoritaria di loro è raccolta nello Stato d’Israele. E’ poco sottolineato il fatto che, dopo la morte di Cristo, la prima diaspora ebraica è stata costituita da ebrei che avevano creduto in Gesù come Messia: “Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. [...] Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della Parola” (Atti 8:1,4). Si noti però che come chiesa qui non s’intende la mastodontica multinazionale religiosa dei nostri tempi, ma un gruppo minoritario all’interno del popolo ebraico, che le circostanze hanno spinto a svolgere un compito specifico di Israele: essere luce delle nazioni. Il “lieto messaggio della Parola” infatti è stato accolto, con sorpresa di tutti, anche dai gentili, e anzi in misura maggiore che dagli ebrei. Pochi anni dopo, come conseguenza della conquista di Gerusalemme da parte dei romani, la quasi totalità del popolo ebraico andò in diaspora. Essendo stato distrutto il Tempio, è venuto di conseguenza a mancare l’elemento fondamentale per adorare Dio in modo conforme alla legge data da Mosè. Gesù però l’aveva preannunciato. Un giorno una donna “palestinese”, appartenente a una popolazione ostile che abitava nella Samaria, una zona contesa chiamata oggi Cisgiordania, ricordò a Gesù che tra ebrei e samaritani esisteva un contrasto insanabile a proposito dell’adorazione: per gli uni si doveva adorare Dio sul monte Sion a Gerusalemme, per gli altri sul monte Garizim, nelle vicinanze dell’attuale Nablus. Risposta: “Gesù le disse: «Donna, credimi; l’ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre»” (Giovanni 4:21). «Finalmente una parola chiara!» diranno con entusiasmo gli ecumenici. «Basta con queste dispute su luoghi e forme di adorazione, basta con la pretesa di possedere in proprio la verità! La verità è che ciascuno, ebreo, cristiano, musulmano o altro che sia, deve essere libero di seguire la propria strada che conduce a Dio, purché lo faccia con convinzione e serietà. Seguendo ciascuno la propria via, arriveremo tutti all’unico vero Dio!» Quelli che parlano e operano in questo modo hanno effettivamente una cosa in comune: che adorano tutti quello che non conoscono. Ciascuno dice di avere la luce e si muovono tutti nelle tenebre dell’ignoranza. Il discorso fra la donna palestinese e l’ebreo Gesù continua così: “Voi adorate quel che non conoscete; noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l’ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è Spirito; e quelli che l’adorano, bisogna che l’adorino in spirito e verità” (Giovanni 4:22-24). Gesù rimarca subito le linee di confine fra “noi” e “voi”, proprio sul tema dell’adorazione. E’ una questione che riguarda conoscenza, spirito e verità: tutte cose che Dio ha consegnato ai giudei, non ai gentili. Il fatto che sia Gesù stesso a dire che “la salvezza viene dai giudei” ha come conseguenza che chi nega o deforma la verità di questa affermazione non rifiuta soltanto i giudei, ma Gesù stesso. Davanti alla frase “l’ora viene, anzi è già venuta”, qualcuno potrebbe essere indotto a interpretarla in senso evolutivo-emancipatorio: dall’Antico Testamento degli ebrei, materiale e primitivo, si sarebbe passati al Nuovo Testamento dei cristiani, più spirituale ed evoluto. Ma questa, ancora una volta, è una lettura con occhi pagani di un testo ebraico. In questo passo, come in molti altri passi della Bibbia, l’ora è un tempo fissato da Dio per il compiersi di un fatto che Egli aveva già in precedenza stabilito. Alcuni esempi: “Gesù le disse: «Che c’è fra me e te, o donna? L’ora mia non è ancora venuta»” (Giovanni 2:4). “Cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché l’ora sua non era ancora venuta” (Giovanni 7:30). “Venne la terza volta e disse loro: «Dormite pure, ormai, e riposatevi! Basta! L’ora è venuta: ecco, il Figlio dell’uomo è consegnato nelle mani dei peccatori” (Marco 14:41). “Mentre ero ogni giorno con voi nel tempio, non mi avete mai messo le mani addosso; ma questa è l’ora vostra, questa è la potenza delle tenebre»” (Luca 22:53). “Gesù rispose loro, dicendo: «L’ora è venuta, che il Figlio dell’uomo dev’essere glorificato” (Giovanni 12:23). “L’ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me” (Giovanni 16:32). Le parole di Gesù alla samaritana non annunciano dunque un’evoluzione dall’ebraismo al cristianesimo, ma il sopraggiungere, all’interno del piano di Dio rivelato a Israele, di un tempo particolare che porta a compimento quello precedente e di conseguenza se ne diversifica, preparando quello successivo, che sempre per lo stesso motivo sarà diverso. Vivere il presente tra un passato originario ormai compiuto che si rammemora con costanza e un futuro preannunciato che si desidera con ansia, è un modo di intendere e vivere la storia squisitamente biblico. Per gli ebrei è abbastanza facile capirlo; per i cristiani gentili un po’ meno. Nella cena pasquale ebraica il passato emerge nel ricordo dell’uscita dal paese d’Egitto e il futuro si delinea nell’auspicio finale “L’anno prossimo a Gerusalemme”. Nella cena del Signore celebrata dai cristiani evangelici vengono lette spesso le parole di presentazione dell’apostolo Paolo: “... ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga” (1 Corinzi 11:26). La partecipazione all’atto viene di solito vissuta come un dramma intimo da interiorizzare nel segreto della propria coscienza. E’ una spiritualità cattolicheggiante di tipo pagano che rischia di essere assorbita anche da chi, volendo essere anticattolico senza preoccuparsi di essere veramente biblico, alla fine è costretto a imitare inconsciamente la mentalità e gli atteggiamenti di chi vuole contrastare. Si sarebbe molto più vicini alla spiritualità biblica se si tenesse conto del contesto ebraico in cui Gesù ha istituito questo rito. Anzitutto, non molti notano che nel testo biblico non si usa mai l’espressione “bere il vino”. Lo fanno notare gli antialcolisti, secondo i quali non si tratterebbe di vino ma di succo d’uva. Ma non è questo il punto. Il punto saliente sta nel calice. Le parole di Paolo sono queste: “Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga». Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini sé stesso, e così mangi del pane e beva dal calice;” (1 Corinzi 11:26-28). A Paolo sarebbe stato più semplice dire “... ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo vino”, per ben tre volte invece usa l’espressione “bere dal calice”. Perché questo fatto non viene attentamente osservato e adeguatamente commentato? Perché si pretende di essere biblici e non si pone seria attenzione al linguaggio usato della Scrittura? Alcuni sono convinti di essere gli ultimi credenti fedeli alla Bibbia rimasti in circolazione, ma poi non mostrano di essere davvero attenti a quello che la Bibbia realmente dice. Si rimane in un atteggiamento di tipo cattolico quando ci si appella formalmente alla Bibbia non per sottomettersi davvero alla sua autorità, ma per fondare sul richiamo ad essa la propria autorità. Il riferimento al calice è importante anzitutto perché Gesù ha istituito la sua commemorazione durante quello che gli ebrei chiamano il seder di Pessach, una cena solenne in cui si ricorda l’uscita del popolo dall’Egitto. Durante la cena viene offerta ai presenti una successione di calici, ciascuno dei quali ha un nome. Nel suo ultimo seder pasquale, a un certo momento Gesù ha compiuto un atto particolare: “... dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è versato per voi” (Luca 22:20). A questo si riferisce l’apostolo Paolo quando ricorda ai Corinzi: “Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga»” (1 Corinzi 11:25-26). Gesù ha detto “questo è il mio corpo”, ma non ha mai detto “questo è il mio sangue”. Ha detto invece: “questo calice è il nuovo patto nel mio sangue”: non è la stessa cosa. Il calice dirige l’attenzione sul nuovo patto, e il riferimento al sangue ne sottolinea l’importanza, perché se tutti i patti dovevano essere accompagnati da un segno esteriore, i patti particolarmente importanti dovevano essere siglati da versamento di sangue. L’importanza unica di questo nuovo patto sta appunto nel fatto che per siglarlo è stato necessario il versamento del sangue del Figlio di Dio. In che cosa consiste questo nuovo patto? Chi sono i contraenti? Uno di essi certamente è Dio, ma l’altro chi è? “Siamo noi”, ha risposto una volta un anziano di chiesa, intendendo naturalmente “noi veri cristiani nati di nuovo”. Che cosa dice invece la Bibbia? “Infatti Dio, biasimando il popolo, dice: «Ecco i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa d’Israele e con la casa di Giuda, un patto nuovo; non come il patto che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d’Egitto; perché essi non hanno perseverato nel mio patto, e io, a mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore. Questo è il patto che farò con la casa d’Israele dopo quei giorni, dice il Signore: io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori; e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello, dicendo: “Conosci il Signore!” Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati»” (Ebrei 8:8-12). L’autore qui cita quasi letteralmente un brano del profeta Geremia (31:31-34). Non si tratta dunque di una novità rispetto a Israele, ma di una successione temporale all’interno del piano salvifico promesso da Dio a Israele. Che questo patto, per sua specifica natura, sia in benedizione non solo agli ebrei ma anche ai gentili, corrisponde precisamente alla funzione di Israele di essere “luce delle nazioni”. L’apostolo Paolo parla di “calice della benedizione che noi benediciamo” (1 Corinzi, 10:16): il semplice fatto di bere da quel calice dovrebbe ricordare a chiunque vi partecipa che “la salvezza viene dai giudei”, e che su di lui scende la benedizione proveniente da un patto che Dio ha concluso “con la casa d’Israele e con la casa di Giuda”. Discernere i segni dei tempi Chi partecipa alla cena del Signore dovrebbe avvertirne l’humus ebraico, che è di tipo storico, non magico. L’importanza centrale dell’atto sta nel riportare alla mente la successione temporale degli interventi di Dio in una storia di cui si è partecipi. Si fa qualcosa nel presente (mangiare il pane e bere dal calice), che ricorda un fatto del passato (la morte del Signore), in attesa di un evento futuro (il ritorno di Gesù). Dio è sempre lo stesso e il suo progetto di salvezza è stato stabilito una volta per tutte prima dell’origine del mondo, ma il modo in cui esso si realizza nella storia avviene in un susseguirsi di tempi particolari in cui Dio si rapporta agli uomini in modi sempre diversi, ma finalizzati ad un unico obiettivo. E’ necessario dunque essere ben attenti e imparare a discernere i “segni dei tempi”, cosa che i contemporanei di Gesù non hanno saputo fare: “I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispose: «Quando si fa sera, voi dite: “Bel tempo, perché il cielo rosseggia!” e la mattina dite: “Oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo!” L’aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona». E, lasciatili, se ne andò” (Matteo 16:1-4). In quell’occasione Gesù, sapendo che sarebbe stato rigettato dal suo popolo, ha annunciato la venuta di un’ora nuova, di un tempo diverso da quello che Israele aveva vissuto nel passato e stava vivendo in quel momento, ma che era già stato annunciato dai profeti: “I figli d’Israele infatti staranno per parecchio tempo senza re, senza capo, senza sacrificio e senza statua, senza efod e senza idoli domestici” (Osea 3:4). Il Tempio sarebbe stato distrutto, Gesù l’aveva detto. E senza Tempio si possono fare molte cose, ma non quelle più importanti che la legge mosaica richiede: i sacrifici, con i quali i peccati vengono coperti davanti a Dio. Così vivono gli ebrei ancora oggi, da quasi duemila anni: senza capo, senza sacrificio. E’ un tempo lungo, ma non definitivo. Come altri tempi biblici, il presente si trova tra un passato e un futuro che sono entrambi diversi; è un tempo transitorio, ma non per questo è secondario. E non è neppure un tempo di lutto. Un ebreo che crede in Gesù può anche andare a pregare al Kotel, il cosiddetto muro del pianto, e se lì piangerà non sarà certo perché non ha un luogo dove poter adorare Dio. Le parole di Gesù alla samaritana possono essere per lui una consolazione: oggi non è necessario andare in un luogo particolare per incontrare il vero Dio e adorarlo, perché Gesù ha promesso: “... dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro»” (Matteo 18:20). E dove si trova Gesù, lì si può adorare il vero Dio in piena comunione con la sua santità, perché “il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato” (1 Giovanni 1:7). Adesso inoltre si può adorare Dio insieme ad altri che non sono ebrei, perché è avvenuto un fatto grandioso: Dio ha usato proprio la disubbidienza del suo popolo per farlo diventare “luce delle nazioni” quanto alla santità, perché attraverso il residuo fedele del suo popolo è arrivato al mondo l’annuncio del perdono dei peccati per chiunque crede nel Messia d’Israele. Questo è il motivo per cui si deve dire che “la salvezza viene dai Giudei”, e non soltanto perché Gesù è nato ebreo. La donna samaritana, insieme ai suoi connazionali con cui ha parlato, è stata salvata perché ha superato l’odio del suo popolo contro Israele e ha riconosciuto che il Salvatore del mondo viene dai giudei. E non dai “palestinesi”, popolo a cui lei apparteneva. L’accanimento con cui si è cercato e si cerca ancora oggi di staccare la persona di Gesù dal suo popolo, facendone a seconda dei casi un eroe ariano o un rivoluzionaro palestinese, è di natura diabolica: sottovalutarlo può avere conseguenze gravi: si pensi a che cosa ha portato il tentativo di “degiudaizzare” il cristianesimo. Il tempo in cui “i figli d’Israele” staranno “senza capo, senza sacrificio” può essere lungo, ma non è l’ultimo. Il profeta Osea continua così la sua profezia: “Poi i figli d’Israele torneranno a cercare l’Eterno, loro Dio, e Davide, loro re, e ricorreranno tremanti all’Eterno e alla sua bontà, negli ultimi giorni” (Osea 3:5). Il Messia trionfante Il popolo ebraico ritornerà al Signore e questo permetterà l’insediamento del “trono di Davide”, il ristabilimento di Israele come nazione, sulla sua terra e con il suo Re. E significherà anche la sconfitta di tutti coloro che, per qualsiasi motivo, anche “cristiano”, ne avranno cercato la distruzione. Sarà questa la manifestazione del Maschiach Ben David, il Messia Gesù trionfante che ritornerà sulla terra, come se ne parla negli ultimi versetti che precedono il famoso brano di Isaia 53: “Ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. Come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti (tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d’uomo), così molte saranno le nazioni, di cui egli desterà l’ammirazione; i re chiuderanno la bocca davanti a lui, poiché vedranno quello che non era loro mai stato narrato, apprenderanno quello che non avevano udito” (Isaia 52:13-15). Sarà stabilita sulla terra la sovranità di Dio in forma politico-giuridica, e non soltanto intimopastorale come oggi. Nel salmo 2 si parla di un “decreto” che sarà emesso da Dio: “Io spiegherò il decreto: L’Eterno mi disse: Tu sei il mio figlio, oggi io t’ho generato. Chiedimi, io ti darò le nazioni per tua eredità e le estremità della terra per tuo possesso. Tu le fiaccherai con uno scettro di ferro; tu le spezzerai come un vaso di vasellaio” (Salmo 2:7-9). Sarà un insediamento su un seggio regale: “L’Eterno ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. L’Eterno estenderà da Sion lo scettro della sua potenza: Signoreggia in mezzo ai tuoi nemici! Il tuo popolo s’offre volenteroso nel giorno che raduni il tuo esercito. Parata di santità, dal seno dell’alba, la tua gioventù viene a te come la rugiada. L’Eterno l’ha giurato e non si pentirà: Tu sei sacerdote in eterno, secondo l’ordine di Melchisedec. Il Signore, alla tua destra, schiaccerà dei re nel giorno della sua ira, eserciterà il giudizio fra le nazioni, riempirà ogni luogo di cadaveri, schiaccerà il capo ai nemici sopra un vasto paese; berrà dal torrente per via, e perciò alzerà il capo” (Salmo 110). Sarà un regno, non una democrazia. E se qualcuno dovesse storcere il naso perché è convinto che la suddivisione dell’autorità di governo nei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sia un’originale conquista dell’intelletto umano ottenuta nel secolo dei lumi, dovrà ricredersi: la Bibbia ha cominciato a parlarne molto prima del barone di Montesquieu. I tre poteri dell’autorità sono tutti citati dal profeta Isaia: “L'Eterno è il nostro giudice, l'Eterno è il nostro legislatore, l'Eterno è il nostro re” (Isaia 33:22). Certo, nella profezia i vari poteri restano tutti accentrati in una sola persona, ma di questo il popolo non avrebbe motivo di lagnarsi, perché nel medesimo versetto si aggiunge: “Egli è colui che ci salva”. Cosa che di nessun altro monarca sulla terra si può ripetere. In Israele la distinzione dei poteri si presentava con altri nomi: si parlava di re, profeti e sacerdoti. Con un po’ di attenzione, si potrebbe anche riconoscere una certa corrispondenza tra questi tre poteri e quelli degli attuali stati democratici. In comune con le moderne democrazie il governo di Israele aveva certamente il fatto che nessun uomo poteva esercitare tutte e tre le suddette funzioni. Nessuno, tranne il Messia. E Gesù presenta appunto tutte queste caratteristiche messianiche: ha svolto la funzione di profeta nella sua prima venuta sulla terra; svolge oggi la funzione di Sommo Sacerdote nel cielo, dove siede alla destra di Dio; svolgerà un giorno la funzione di re nella sua seconda venuta sulla terra. La prima predicazione apostolica Cerchiamo adesso di porci nei panni di coloro che hanno udito la predicazione di Pietro in quella festa di Pentecoste. Ai suoi connazionali l’apostolo ha rivolto un discorso sconvolgente che suona più o meno così: voi aspettavate un Messia che vi liberasse dalle mani dei vostri nemici; sappiate che il Messia è venuto, voi l’avete rigettato e consegnato nelle mani dei vostri nemici, e loro l’hanno ucciso. Il Messia però è risuscitato, è stato con noi una quarantina di giorni e poi se ne è ritornato in cielo. E adesso? Si saranno chiesti impauriti gli uditori, che succederà? Da quel cielo dove ora il Messia si trova non possono che pioverci addosso fuochi e fulmini. La conclusione di Pietro invece è un’altra: “Ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma ciò che Dio aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, cioè, che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli lo ha adempiuto in questa maniera. Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose; di cui Dio ha parlato fin dall’antichità per bocca dei suoi santi profeti. Mosè, infatti, disse: “Il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me; ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che chiunque non avrà ascoltato questo profeta, sarà estirpato di mezzo al popolo”. Tutti i profeti, che hanno parlato da Samuele in poi, hanno anch’essi annunziato questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abraamo: “Nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette”. A voi per primi Dio, avendo suscitato il suo Servo, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità»” (Atti 3:17-26). Pietro annuncia ai suoi fratelli israeliti che in Gesù si sono adempiute in modo inaspettato le profezie riguardanti il Messia sofferente. Dio ha voluto benedirci - annuncia l’apostolo - compiendo quello che aveva più volte promesso: l’espiazione dell’iniquità del popolo (Daniele 9:24). La benedizione del perdono dei peccati scende ora su Israele e presto si estenderà a tutti i popoli della terra perché sta scritto che “nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette”. Per ottenere personalmente il beneficio del perdono è necessario che ciascuno creda a questo messaggio e si converta dalle sue malvagità. Il cielo ora “tiene accolto” il Messia, ma un giorno Dio manderà di nuovo “il Messia che vi è stato predestinato” e arriveranno i “tempi della restaurazione di tutte le cose”. Saranno i tempi del ritorno in gloria del Messia trionfante, quando la Shekinah tornerà a posarsi sul monte Sion (Ezechiele 43:1-9) e si avvererà la promessa di benedizione politica per tutto il mondo annunciata dal profeta Isaia: “Avverrà, negli ultimi giorni, che il monte della casa dell’Eterno si ergerà sulla vetta dei monti, e sarà elevato al di sopra dei colli; e tutte le nazioni affluiranno a esso. Molti popoli vi accorreranno, e diranno: «Venite, saliamo al monte dell’Eterno, alla casa del Dio di Giacobbe; egli ci insegnerà le sue vie, e noi cammineremo per i suoi sentieri». Da Sion, infatti, uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola dell’Eterno. Egli giudicherà tra nazione e nazione e sarà l’arbitro fra molti popoli; ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d’aratro, e le loro lance, in falci; una nazione non alzerà più la spada contro un’altra, e non impareranno più la guerra. Casa di Giacobbe, venite, e camminiamo alla luce dell’Eterno!” (Isaia 2:2-5). Dov’è il centro del mondo? «Il centro del mondo è Israele. Il centro di Israele è Gerusalemme. Il centro di Gerusalemme è Mea Shearim, e il centro di Mea Shearim sono gli Stüblach», ha detto poco tempo fa un ebreo ultraortodosso a un giornalista che lo interrogava. Mea Shearim è il quartiere ebraico di Gerusalemme abitato da ebrei particolarmente pii che vogliono vivere secondo le regole stabilite dalle tradizioni rabbiniche; gli Stüblach sono, in lingua yiddish, le innumerevoli minisinagoghe del quartiere in cui i devoti si immergono giorno e notte nello studio della Torà. La dichiarazione dell’ebreo ultraortodosso è interessante, ma da un punto di vista biblico dovrebbe essere corretta così: «Il centro del mondo è Israele. Il centro di Israele è Gerusalemme. Il centro di Gerusalemme è il monte Sion». “Mea Shearim o Sion?” Un bel dilemma, che potrebbe esprimerne altri come “rabbinismo o sionismo?” “moralità o storia?” Per secoli l’ebraismo è vissuto in diaspora. In diaspora è vissuto e cresciuto nei primi secoli anche il cristianesimo, formato da gentili che si sono uniti agli ebrei che avevano creduto in Gesù come Messia. In diaspora avrebbe dovuto rimanere sempre anche il cristianesimo, nella convinzione di non avere alcun diritto - e di fatto alcuna possibilità - di anticipare i tempi stabiliti da Dio per il suo popolo Israele. La costituzione di una nuova centralità territoriale cristiana alternativa a quella ebraica rappresenta il peccato politico del cristianesimo ufficiale, perché pretende, senza averne alcun diritto, di essere l’espressione visibile della sovranità di Dio sulla terra. La natura di questo peccato può essere ben espressa dalle parole con cui inizia una parabola di Gesù: “Mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Disse dunque: Un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l’investitura di un regno e poi tornare. Chiamati a sé dieci suoi servi, diede loro dieci mine e disse loro: ‘Fatele fruttare fino al mio ritorno’. Or i suoi concittadini l’odiavano e gli mandarono dietro degli ambasciatori per dire: ‘Non vogliamo che costui regni su di noi‘“ (Luca 19:11-14). I cittadini ebrei del tempo di Gesù sono stati imitati nei secoli successivi dai cristiani gentili che hanno eretto un’istituzione ecclesiastica mondiale che pretende di essere la manifestazione pubblica del regno di Dio sulla terra. Anche loro, come i cittadini della parabola, vogliono il regno ma rifiutano il Re. Gli ebrei del tempo di Gesù avevano la promessa del trono di Davide e hanno impedito che il legittimo Re vi si sedesse sopra; i gentili di oggi pretendono di avere dalla loro parte il Re e negano che il suo posto del suo trono sia in Sion. Rifiutano il trono promesso da Dio a Davide, e così facendo rifiutano il Re pretendendo di regnare in sua vece. Ci sono due aspetti caratteristici e sempre ricorrenti della religiosità umana: il primo consiste nel tentativo di piacere a Dio e raggiungere la salvezza eterna mediante buone opere morali o cerimoniali; il secondo nell’esercitare potere su altri uomini esigendo da loro ubbidienza e sottomissione in nome dell’autorità che si dichiara essere stata ricevuta da Dio. Le persone possono essere in posizioni diverse, come ebrei e gentili, e il potere può essere esercitato in vari modi, sui corpi o sulle coscienze, ma si tratta sempre della medesima voglia di sostituire Dio nella sua sovranità. Il “lievito dei farisei” di cui parlano i Vangeli non è affatto una prerogativa ebraica: Gesù ha parlato di farisei perché erano quelli allora i suoi interlocutori, ma oggi potrebbe usare parole simili per una moltitudine di altri casi, particolarmente tra i cristiani. Tra la cristianità politica ufficiale e Israele ci sarà comunque, alla resa dei conti, una differenza sostanziale. In Israele al momento opportuno ci sarà riconoscimento di peccato, ravvedimento e ristabilimento del regno promesso a Davide. La cristianità ufficiale, che ha voluto occupare abusivamente un posto di sovranità a lei non spettante, conoscerà invece un crollo vistoso, pubblico e definitivo. Su questo punto gli ebrei possono stare tranquilli: se è vero che alla fine di questa epoca Israele riconoscerà in Gesù il suo Messia e dirà: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore!” (Matteo 23:39), è vero anche che prima di questo saranno svergognati i cristiani nominali che, disprezzando il popolo di Dio, si saranno seduti abusivamente su un trono a loro non riservato. Non si vedrà la scena di rabbini umiliati e pentiti che vanno a farsi battezzare in Vaticano. Si può esserne certi. La storia di Gesù I cristiani evangelici di una certa corrente hanno alcune cose in comune con gli ebrei ultraortodossi: entrambi i gruppi credono nella venuta del regno politifo di Dio con centro in Gerusalemme ed entrambi sono convinti che questo regno sarà instaurato dal Messia e non sarà il frutto di sforzi militari o politici umani. La differenza principale consiste, naturalmente, nell’individuazione della persona del Messia. Esistono però anche altre differenze che suddividono entrambi i gruppi, provocate dalle diverse risposte alla domanda: in che modo bisogna aspettare la venuta del Messia? In modo molto schematico si può dire che, riguardo ai tre dilemmi indicati sopra, gli ebrei ultraortodossi scelgono Mea Shearim, rabbinismo e moralità. Per prepararsi adeguatamente alla venuta del Messia, e forse anche per affrettarla, evitano l’arena politica mondana, si chiudono in un volontario ghetto religioso, studiano le interpretazioni rabbiniche della Torà e cercano di mettere in pratica le norme di condotta che da esse ricavano. Gli ebrei ultraortodossi, come molti cristiani evangelici, non hanno interesse per la storia: quello che conta per loro è unicamente il comportamento personale, da esaminare e vivere in un confronto continuo con quello che pensano, dicono e fanno gli altri appartenenti al gruppo. Quello che accade fuori non interessa, a meno che non abbia influenza diretta sul singolo o sul gruppo. Fuori ci sono i lupi, da cui guardarsi e a cui rivolgersi soltanto allo scopo di portarne qualcuno dentro il gruppo dopo un’adeguata revisione del suo modo di pensare e di comportarsi. Nell’ottica autenticamente biblica invece il riferimento alla storia è indispensabile. Parlare di Gesù, che è il centro del messaggio cristiano, significa parlare di storia. E parlare di storia in relazione a Gesù significa parlare di Israele. Può essere utile allora esaminare attentamente il linguaggio con cui per la prima volta nella storia un ebreo parla di Gesù a un gentile. L’apostolo Pietro, spinto da circostanze per lui imprevedibili, rivolge la parola a un centurione romano: “Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: «In verità comprendo che Dio non ha riguardi personali; ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Questa è la parola ch’egli ha diretta ai figli d’Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; vale a dire, la storia di Gesù di Nazaret; come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza; e com’egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nel paese dei giudei e in Gerusalemme; essi lo uccisero, appendendolo a un legno. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio; cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha comandato di annunziare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome»” (Atti 10:34-43). Pietro espone all’ignorante militare romano “la storia di Gesù di Nazaret”, informandolo che Dio ha rivolto la parola ai “figli d’Israele” affinché portassero a tutti “il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo”. Sono dunque i perdonati “figli d’Israele” che hanno annunciato ai gentili la possibilità di essere perdonati in Gesù. Il perdono è accessibile a tutti, ebrei e gentili, ma i gentili hanno dimenticato che “la salvezza viene dai giudei”; hanno dimenticato che fin dai tempi antichi a Israele era stata annunciata la venuta di un Messia attraverso il quale tutti avrebbero potuto essere perdonati, “il giudeo prima e poi il greco”. Questo fatto non è una novità, non è una deviazione o un’invenzione tardiva dei cristiani, ma fa parte del patrimonio donato a Israele e annunciato negli scritti dei suoi profeti. Infatti “di lui (Gesù) attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome” (Atti 10:43). Ecco dunque il primo modo in cui bisogna prepararsi alla venuta visibile del Messia sulla terra: entrare nella benedizione collegata al nuovo patto concluso da Dio con la casa d’Israele e la casa di Giuda, chiedendo e ottenendo il perdono dei peccati mediante la fede in Gesù come Signore e Salvatore. Dopo di che si ottiene il privilegio di partecipare, insieme ai figli d’Israele che hanno accolto il loro Messia, alla ”testimonianza di Gesù” (Apocalisse 1:9) in tutto il mondo. Nel fare questo occorre però essere molto decisi, perché non si tratta di un messaggio pubblicitario facilmente ignorabile, ma di un annuncio che oggi, in un clima di irenico ecumenismo, può infastidire molti, “il giudeo prima e poi il greco”. Bisogna saper usare, se necessario, le parole dell’apostolo Pietro. “Egli (Gesù) è «la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata, ed è divenuta la pietra angolare». In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati” (Atti 4:11, 12). La “storia di Gesù di Nazaret” ha nel fatto della croce il suo punto centrale, culminante, ma non finisce lì. E neppure finisce dopo l’ascensione di Gesù al cielo, dove invece vorrebbe farla finire il cosiddetto “Credo apostolico”, che conclude così il suo resoconto storico: “... salì al cielo, dove siede alla destra di Dio Padre onnipotente”. Dopo di che viene il gran finale: “Di là ha da venire a giudicare i vivi e i morti.” Nel frattempo, naturalmente, di Israele non si sa più che fine ha fatto. Cosa che per altro non sembra interessare molto i recitanti. Dopo la distruzione del Tempio e la repressione dell’ultima insurrezione contro i romani del 132-135 d.C. capeggiata da Simone bar Kochba, la nazione ebraica cessò di esistere e gli ebrei si dispersero in tutto il mondo. Ma rimase in vita il popolo ebraico, e la sua storia dev’essere considerata storia di Gesù, perché il collegamento tra il servo-popolo e il Servo-Messia si è interrotto solo nella volontà del popolo, non nella volontà del Messia. Abbiamo già visto qual è il primo compito ricevuto dal Servo dell’Eterno: “Ed ora parla l'Eterno che m'ha formato fin dal seno materno per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe, e per raccogliere intorno a lui Israele” (Isaia 49:5) Il Messia ha ricevuto l’incarico di “ricondurrre a Dio Giacobbe e raccogliere intorno a lui Israele” e quindi non è possibile che non giunga il tempo in cui questo incarico potrà essere eseguito. Al suo Unto l’Eterno aveva detto: “Io, l’Eterno, t’ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l’alleanza del popolo, la luce delle nazioni” (Isaia 42:6), Gesù è diventato “luce delle nazioni” perché molti nel mondo hanno creduto in Lui e sono stati salvati, ma Gesù è destinato ad essere anche “alleanza del popolo”, cioè Colui attraverso il quale saranno portati a compimento tutti gli aspetti del patto che Dio ha fatto con il popolo d’Israele, compresi quelli che riguardano la ricostituzione della nazione ebraica sulla sua terra. Lo Spirito Santo spinse Simeone, “uomo giusto e timorato di Dio che aspettava la consolazione d’Israele”, a esclamare con il bambino Gesù tra le braccia: “Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola; perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele” (Luca 2:29-32). Gesù è diventato “luce da illuminare le genti”, ma presto diventerà anche “gloria del popolo Israele”. Dovrà dunque finire il tempo del disprezzo delle nazioni per il popolo che Dio si è formato. Parlando della futura gloria di Gerusalemme, il profeta Isaia esclama: “Sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta, e la gloria dell'Eterno si è levata su di te. Poiché ecco, le tenebre ricoprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te si leva l'Eterno e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce e i re allo splendore del tuo sorgere” (Isaia 60:1-3). Considerazioni conclusive Anche se il presente scritto è risultato alla fine più lungo del preventivato e di quanto forse alcuni lettori avrebbero gradito, molti altri argomenti inerenti al tema avrebbero potuto o dovuto essere trattati più estesamente. L’autore ne è consapevole e tiene comunque a precisare che tutte le tesi sostenute, anche quando sono presentate in forma apodittica, sono il frutto di una riflessione sui testi biblici e non di visioni angeliche o di mere speculazioni filosofiche. Dalla Scrittura, e soltanto da essa, potrebbero in seguito essere corrette o confermate. Si ritiene utile concludere con l’enunciazione sintetica di alcune tesi. Il popolo ebraico costituisce una nazione per un’esplicita volontà di Dio che non si è modificata con il tempo. L’attuale Stato d’Israele, costituito sulla sua terra, non è il regno messianico promesso a Davide, ma esprime la precisa volontà di Dio di costituirlo in un futuro più o meno prossimo. Dio non si aspetta che gli uomini edifichino il suo regno con le proprie mani, ma vuole verificare quale posizione ciascuno prende davanti alla manifestazione della sua volontà. Con una serie di prodigi che possono soltanto essere chiamati miracoli, Dio ha fatto in modo che si ricostituisse sulla terra d’Israele la nazione ebraica. Anche se per la ricostituzione di questa nazione Dio ha usato la sua potente autorità, ha voluto tuttavia che la fondazione dello Stato d’Israele avvenisse secondo gli usuali criteri di giustizia umani usati dalle nazioni affinché fosse evidente che chi vi si oppone è un ingiusto che vuole “soffocare la verità con l’ingiustizia” (Romani 1:18). Dio ama tutti gli uomini, ma la Scrittura rivela che esiste una successione storica temporale che non può essere trascurata: Dio ama “prima il giudeo, poi il greco”, prima Israele, poi le altre nazioni, proprio come ogni uomo moralmente sano ama prima sua moglie, poi tutti gli altri. Si dovrebbe diffidare di chi dice di amare tanto il prossimo ma mostra di non essere capace di amare sua moglie. Per il gentile che ha ottenuto il perdono dei suoi peccati credendo in Gesù come Signore e Salvatore, è - o dovrebbe essere - del tutto naturale sentirsi dalla parte d’Israele e schierarsi in sua difesa. Poiché Gesù continua ad amare Israele e aspetta il momento di “ricondurre a Dio Giacobbe”, la comunione spirituale con Lui provoca - o dovrebbe provocare - sentimenti di solidarietà e particolare amore per i membri di quel popolo, indipendentemente da come reagiscono davanti alla testimonianza del Vangelo. I veri credenti in Gesù devono aspettarsi, e accettare serenamente come parte del loro servizio di testimonianza, eventuali manifestazioni di anticristianesimo ebraico, ma devono essere del tutto intolleranti davanti a ogni forma di antisemitismo cristiano. Il concetto di nazione ebraica è fondato giuridicamente sull’atto costitutivo della promessa di Dio fatta ad Abramo e costituisce un elemento fondamentale a sostegno dell’esistenza e dell’identità del popolo ebraico. L’antisionismo, presentandosi come negazione del diritto degli ebrei ad avere una loro nazionalità, costituisce l’ultima forma di odio antiebraico. Il suo nome potrebbe essere “antisemitismo giuridico”. Dopo l’antisemitismo teologico pseudocristiano e l’antisemitismo biologico pagano, quest’ultimo tipo di antisemitismo ha tutte le caratteristiche per diventare più esteso, più radicale, più viscido, e di conseguenza più pericoloso di tutti gli altri. Il fatto che espressioni come “figlio di Dio” e “servo dell’Eterno” siano usate dalla Bibbia per indicare sia il popolo, sia il Messia inducono a ricercare paragoni e analogie tra la storia di Gesù e quella d’Israele. Si pensi per esempio alle parole con cui Leon Pinsker riassume la storia degli ebrei: Nel vasto mondo non c'era posto per noi. Per avere modo di posare il nostro capo stanco e trovare un po' di tranquillità, chiedemmo un luogo qualsiasi.24 Al lettore dei Vangeli viene subito in mente il racconto del bambino Gesù che Maria “coricò in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo” (Luca 2:7). E anche quell’episodio in cui Gesù descrive la sua posizione sulla terra: “Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo»” (Luca 9:57-58). Perché allora non dire apertamente che la chiave con cui potrebbe essere spiegato l’enigma di Israele si trova nella persona e nella storia di Gesù? Perché non consolare il popolo di Dio dicendogli che il debito della sua iniquità è stato pagato dalla morte in croce del suo Messia e che la certezza della risurrezione di Israele come “nazione giusta” davanti a Dio, degna di entrare nella nuova Gerusalemme al seguito del suo Re, sta nel fatto che il suo Messia è risuscitato dai morti e come tale “non muore più, la morte non ha più potere su di lui” (Romani 6:9)? Dichiarare questo, insieme al fatto che per partecipare un giorno alla gloria di Dio nel suo regno è necessario ravvedersi e credere personalmente in Gesù, riconoscendolo come Messia d’Israele e 24 Leon Pinsker, ivi, p. 49. Salvatore del mondo, sarebbe un modo adeguato per essere “dalla parte d’Israele come discepoli di Cristo”. (Notizie su Israele - www.ilvangelo-israele.it, settembre 2009)
Scarica